
9 minute read
Chirurgo militarP- che pratica l'estrazione di un fcrr.o tli lancia dall'emitorace destro .sul ca,mpo·di bai.taglia. (Da una stampa
1111 i f.:ì, di forunazione in batta.glia e1•a, la faJ,a,n.ge, composta fli I(; q,,:i,drn,ti <li 2fi6 opliti ciascuno-, detti sintagnii. Tale formazione v.i IPvn, anche •per i peltasti ed i psi1iti) ,sicchè la falange completa <'l'a, costituita, cda ci1~a. 6000 uomini con pod1i repa,rti di cH,valJ~ri~ ai fianchi (pesa.nte : catafratti; mezzana : cavalleria greca). foggera: tal:entina), tutti senza staffe.
Generalmente l'eroe arrivava al campo sulla biga trainata da due cavalli e guidata, òall'auriga,, ritto accanto : balzato daJ. coc0 chio e incontrato l'avversario, gettava, contro di lui ·1a 1a,ncia g;>ode,rosa, ca,pace· di tra,passare .~udo e corazza,. Se il colpo falliva e non ipoteva 1•ipig1liare la. ]ancia, <hwa ma-no alla spada e ]a, lotta si faceva oorpo a corpo : il nemico abbattuto veniva spogliato deJle a,rmi da,l vincitore, che· Re ne faceva. ,m trofeo di g11P1Ta.
Advertisement
P.1"CUJ.essi questi pochi rico1xli. storici, indispemm,bili per meglio comprendere 1 'importanza, dei poemi omerici come fonte p 1rezi0Ra <li notizie rigua,1·danti ]a mediciua, e la chirurgia milita.re di quei tempi eroici, cercheremo ora, con una rapida, .seo1.'l*l, attraverso i libri dcli' Iliade, nella versione italiana del Monti1 di e~orrc fra 1]e nu1nerose lesioni qualche esempio di questa remota traullUl,tolo,gia, di guerra. Per maggior chiarezza, ,e semplicità, 1r;-.i,ggruppcrerno le v::t,r-ie fceite ripartendole f,ra le diverse 1·cgioni del c01~po.
Il F,ròlich ha fatto una sta.tIBtica di queste lesioni secondo la lor6 sede cd· ha, riscontrato che quelle (lella testa sono in proporzione del 21 %~ <111eLle del collo dell'lJ ,2, ilcl l.0N1f·,(~ ,,lP.1 r.1,21 , <1egli ar(i ,suiporiori d.,l 7,2-6 <.le~di inferim·i del 7,4.4.
Anzitutto accenneremo a,lle lesioni del cranio cd alle lo·ro ,letali consegucuze immediate, che sono d~sc1.·itte d ::L Omero con mirabile semplicità, ecl esattezza,.
Nel 11ibro IV si narra dell'uccisione del 'faliside Echepolo, c-Ollpito con un dairdo da, Antiloco,
« Nel cono del chiomato elmo ; s'infisse La ferJ·ca punta nella fronte, e l'osso Trapassò: ~·a,bbui:\r gli occlii a,l me<,chino _ ,
Ohe strepitoso (~ad-de come torre».
Nel libro VII1 (~ rioorda.ttL non meno efficacemente una lesione c,erehraJe inf.erta ad uno dei cavalli trainanti il cocchio del Gercnio N es.tore :
« Nella fronte ferì, Ja,dòove spunta Nel teschio dei cava1lt il primo crine, Ed è lefale il loco a.lle ferite. Inalberossi il ,co1nidor traifitto; Ohè .nel cerèbro · en l:ntta era ht frcooia E dintorno alla, rola per l'aeuto Do.lor si voltoland,o, in iscompiglio l\t[ettea gli altri ca.valli n.
Nel libro XI è rappres-entata oon tocchi da maestro un'altra ferita del ce,rvello prodotta da una frcx'.!Cia lanciata da, Aga.ni.ennone contro Oilleo. 11 da,r,do, attra,versa,to l'elmo, si confic.,cò nell'osso frontale e
((. . . . . . . . . . . . . ,tutt'internamente di sangue gli alla,gò il cer,èbro >J.
Nello stesso libro sono descritti con g,rwnde evidenza i fenomeni della commor.ionc cerebrale. Diomede, scag1Iiato un dairdo contro Ettore,

« Lo eolse al sommo del cimiser : ma i1 ferro Fu respinto dal f.erro, e non offese La bella fronte dell"e1,oe : ,chè il 1 ungo 'l"riplice elmetto l'impedì, fatato Dono d'Apollo. Sbalordì Ùel colpo }]tf,en·.~, e lungi ripa,rò tra suoi. Qui ca<lflc s11i gh1,occhi, puntclhn1do ()antro ii .suol la, gran palnrn, n tHnd>roso Su le pupille gli isi ,stese un velo>>.
Nel libro XV, con un verismo impressionante, è rip,r<;>dotta un'altra lesione cranica di coceziona1e giravità.:
(( Il colse Peneleo sotto le ciglia Dell'occhio a.Ila radice; e, la, pupilla, Scl1iw;a.udone, passar l'asta gli fece Via per l'occllio alla nuca. Jlionèo A1ssi,so cai<.lde con le ma,n dist,ese >>.
N,,~ meno raccapricciante e precisa nella sua concisa semplicità è fa, ùcscrizione della ferita cerebrale, che troviamo n·el libro XVI, sia, da,l punto di vista, anatomico che traumatologico:
cc Idomenèo la, laincia, nena boooa D''Erhnanto cacciò. fa1 ferrea cilna, Apertasi la via sotto al ceuèbro, Riuscì per Ja, nuca, spezzò l'osso Del gorgoz,mlc e sga,nghel'Ogli i denti; Taclchè di sangue s'cmpir .gli occhi e sangue Sofiiò dal nnso e dalle fauci aperte: (.,'losì ·concio il c-oprì. l'ombra di morte)).
Nel medesimo libro è accennata anche una lesione della faccia in seguito a violento colpo di asta, che provocò la frattura, dell'osso masceilare e oontempora,neamente (( la siepe sprofondò dei denti )).
Anche nel libro XVII è mirabi1lmente rapipresentata una mortale lesione dPJ cervello, inferta, con un colpo d'asta tremendo da Aiace su Ippotoo.
<< . • • • • • • . • • • .;u le girn.ncie .Dell'elmo Aia.ce diAse1·1·ogli un colpo Ohe tutto lo sp·ezzò: tanto dell'asta, l!'u il picchio e tanto delfa, nmno il pondo. Schizzftr per l'aria le c.e1•vella e il Ra,ngue Dall'a;pe1·fa ferita, e tosto a lui QuetfJ,rsi i poJ~"i : · dalle man gli cadde Del morto il piede, e sovra, il morto ei pure Boccon cadde, . . . . . . . . . . . . . l> .

Come è espressivo que] (e quetàrsi i poJ.si )), che indica il lento a11ìevolir-si del circolo e lo :spegnersi delle forze pe,r effetto dclii.a gra,vis;sima emo,rn.·agia ! · Questa. frase ci fa, sovvenire un'altJ:a non meno realistka descrizione dei va,ri sintomi · subbiettivi del ferito, a seconda della g·rnvità òella lesione, che il poeta ci_ offre nel libro XI, qmmdo parla del ,re Agamennone colpito da una freccia.
<e Finchè fu calda la ferita, il sire OoH'asta, oolla spada e con enormi Ciotti la pugna, seguitò : ma come Sta,gnossi H sangue e s'aggelò la piaga, D'acerbc ùoglie saettar sentissi)).
Fina.lmentc nel libro XX trovasi ùn'a.ltra terrificante descrizione di ferita letale del cranio :
<< • • • • • • • • • • • • lo J'èrì sùl polso Della tempia, nè valse alla dif~ La ferrea, gua,nda del polito elmetto. L'impetuosa- punta spezzò l'osso, Sgominò le cervella., che di sangue 'l'uti.e iusozziìil'Si : e così igiacque il fì.:ero >> .
Anche ac lesioni del coJlo sono riprodotte con esatta precisione di dati anatomici e con il'icchc½za. di nozioni chirurgiche : così nel libro XVII è <lese.ritta una. ferita òella, regione ~ rvicale inferta da lf.enela,o ad Euforbo ed un'altra da Ettore a Schedio, figlio d'Ifito, entrambe mortali; )fa dove .soprattutto Omero raggiunge le più a\te vette della potenza lfrica ed il più mirab.hle verismo è nel canto XXII, nella na,rra,7,i.one del mortale dne.l]o fra Etto,rc ed Acllille~ alla quaJle si , im,ipi,r~rono più tu.1·di Virgilio nel Iih1·0 XII dell'Eneide, nel de~;rivere lo scontro fra Turno ed Rnea e il Tasso nel canto VI della, ,Gernsalernme ~i.bcrn,ta., nel ra,ppr~ nta,1~ fa tenzone fra, Tancredi e Argante. Tl vaJoroso Rttore scende in 1izr.a, ,ricoperto idaJl'elmo, CO· ra,zza e sehinie·ri, già appartenenti a ll'ucdso Patroclo, e di cui si è fatto un trofeo di vj ttoria.

u 1Sol, <love il eolio all'-0mc.ro s'innesta, Nuda una parti~ della gola. ap):lare, Mortalissirna parte. A questa Ar,ltille L'asta diresse con furor: Ja. punta
Il collo tn1,passò ; ma non offese Della voce Ie vie, sì che ,precluso . F-oosc òel tutto o.ne parole il v.a,rco ».
E evidente che qui debbono eS8ere stati lesi i g·roosi vasi del collo, e chè, per l'importante emorragia, la morte deve esse-re stata. quasi istanta:nea.
Ed a questo proposito ricorderemo che la guerra si svolgeva allora spietataa:ne-.nte. Alcuni popoli, quaJi ad es. gl].i Epiroti, usavano ta.gliar·e a,i nemici il naRo, le orecchie e i genitali, che veniva,no poi dati in pasto ai cani. E perfino i cadaveri dei vinti erano sotto-
prn.:l.i a,1 lc prn mumane s·evizie, pokhè era diffusa creden:,;a che, ~<! al c-ot·po non veniva data onorata sepOiltura, lo spirito no,n potev;i, :i.vN· pace nè ripo:So, per cui anche dopo morti si poteva continuar la implaca.bUe vendetta contro i nemicL Oosì Achille sac rif1cò 12 vittime sulla tomha ,,fall'amico Pat1·oclo. Così il ca,davere di Etto;re fu t,rasci~ato dall perverso, vincitore attorno alle m~·a di Troia, ,col più g1rande scempio: << • •••• ùe' piè gli fora i nervi Dal c11lcag110 al tallone, ca un guinzaglio lnsertovi bovin<.1, al cocchio il lQga, Andar lasciando strascinato a terra H bel ca:po . . . . . . . , . . . >>.
E passiamo alle fo~·ite del torace, che sono 1iap.presentate nell'Iliade 0011 non minore esattezza delle altre lesioni, sotto l'asipetto a.natomico e ehirurgico.
Nel libro VIII 'l'eucro lm1cia rma freccia contro Gorgizione, :figlio di Priamo, e con una ,mRgnifica ,similitùdine della picoola pjanta che reclina per il pooo del proprio frutto, e dalla quale trassero im seguito isipirazione Catullo in un'ode saffica nel libro XI, Vfrgilio nel libro IX ,cle;ll'Eneide e 1' Ari<)sto nel canto XVIII dcll'ùrlando Furioso, d.e,scrive da maiestro ila morte dell'eroico giovane:

« Oomc, c:H·co ta,lm· dl~l proprio frutto F, di troppa rugiada a primavera, 11 papaver nell'orto il capo abbassa; Così l,a testa dall'elmo grH.vata Sulla spalla ,chinò quell'infelice.>>. ·
Nello stesso libro VIII Ett,ore, diooeso d'un bailzo dallo' splendido cocchio, afl'er,ra un sasso e lo scaglia violP.1itemente conko Tfmcro,
« ......•• .• E dove il collo S'innesta al petto, ed è letale il sito, Ooll'a,sJH'O sasso il ooglie, e, rotto il nervo. Gli inh;rpiclisce il bra,ocio. Dalle dita L'ar00 .gli ,sfugge, e sul ginocdrio ei casca)).
Si noti l'inciso (( ,ed è letale il sito )), che dimostra~ per parte del poeta, la perfetta conoscenza, anatomica della regione, ricca di vasi e di nervi di importaJ1zu, vitale, in ra.pporto alla gravità ed alla prognosi delile ferite.
Anche nel libro XIV è deooritta con g,rande precisione dj pad'ticoll:l,ri la morte di Achiloco, figlio di Antenore :
<< • • • • • • • • Lo colse U fata.I fel'ro Alla, vertebra estrema, ove nel collo S'innesta il capo, e ne precise il doppio Tendine. Ei cadde, e del meschht la testa Co'Ha bocca, davanti e le narici Prima a. terra, n\1,ndò, che J,a ,persona».
Non .si 1p,otrebbc inv,ero con maggior chiarezza, indicare· l'atlante, la vertebrH, co~pita dalla lancia. Ambiguo invece è il (( doppio timdine )), col qua.le te1·minc non sa,ppiamo se il poeta voglia, aJlnclere a va.si, a nervi oid a, foga.menti articolari della ,1·egione.
Nello stesso libro XTV è rappresentata con non minor verismo la ferita di Ettore colpito <la Aiace Tefa,rn<mio al torace con una g,rossa ipietra, :
« Ad 1111 s:1,sso, de' moUi che ritegno Delle navi gia,ccan sparsi pel campp D'e' comha.tten l:i al pi.è, dato di piglio, L'avventò, lo rotò ,come ;paileo E sul girone dello scudo, al p,etto L'a.vve1·sario ferì. Con qucJ. fragore Ohe, da.l fuoco di Giove fulmina,ta., Giù 1·uirn1, una, quercia, e grave intorno De-l gra,vc zolfo si diffonde il puzzo; L'ara.tor, che c,ulersi accanto vede La, folgo,,c ·l·rcml~nirla, imbiane.a e trema; Così strama,zza. Ettm·, l'a,;ta, a,bba,ndona La rna,h,'ma. die,tro gli va scudo ed elmo
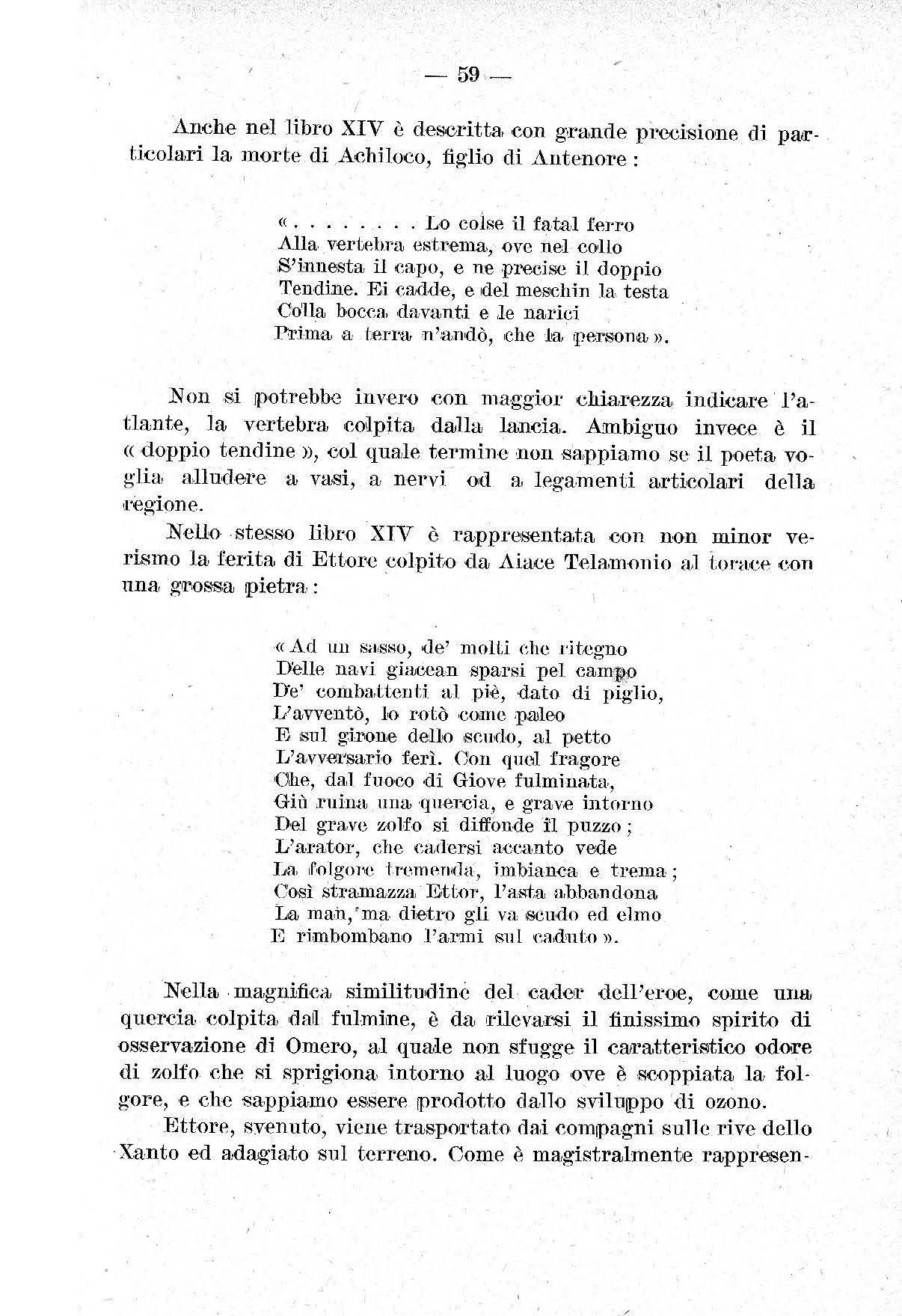
E rimbombano .l'.armi s11l ca.C:liuto l).
Nella . magnifica, similitudinè del, CMlor dell'eroe, come una quercia colpita dall f1Ìlmine, è da ,rilevarsi il finissimo spirito di osservazione di Omero, al qua.le non sfugge il caira,tteristico odore di zolfo che si sprigiona, intorno al luogo ove è scoppia.ta la folgore, ,e che ~a,ppiarno esser,e iprodotto cla,llo svilutppo di ozono.
Ettore, svenuto, viene trasportato dai comipa.gni sulle rive dello · Xanto ed a,daigiato sul terreno. Come è magistralmente rappù~sen-










