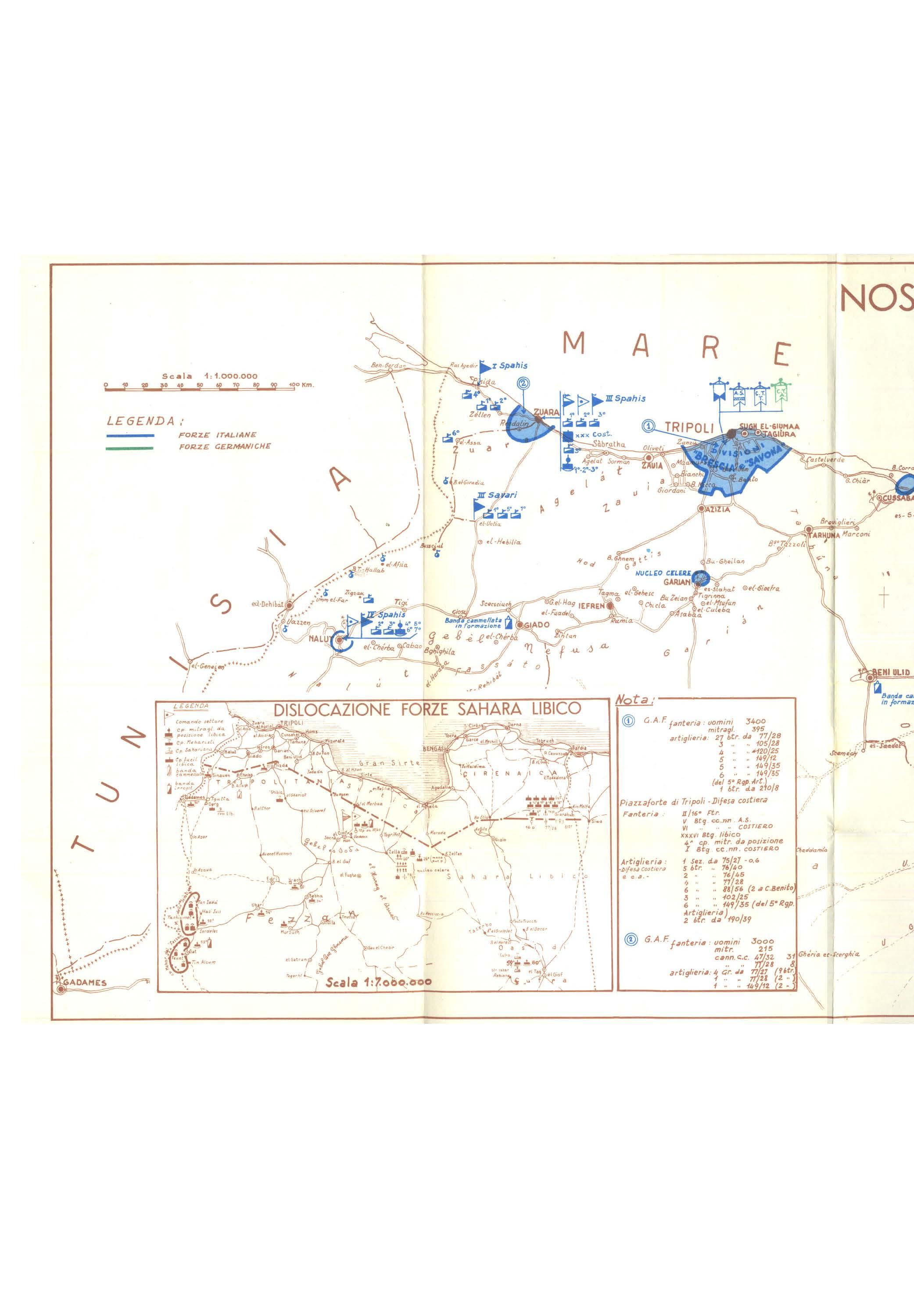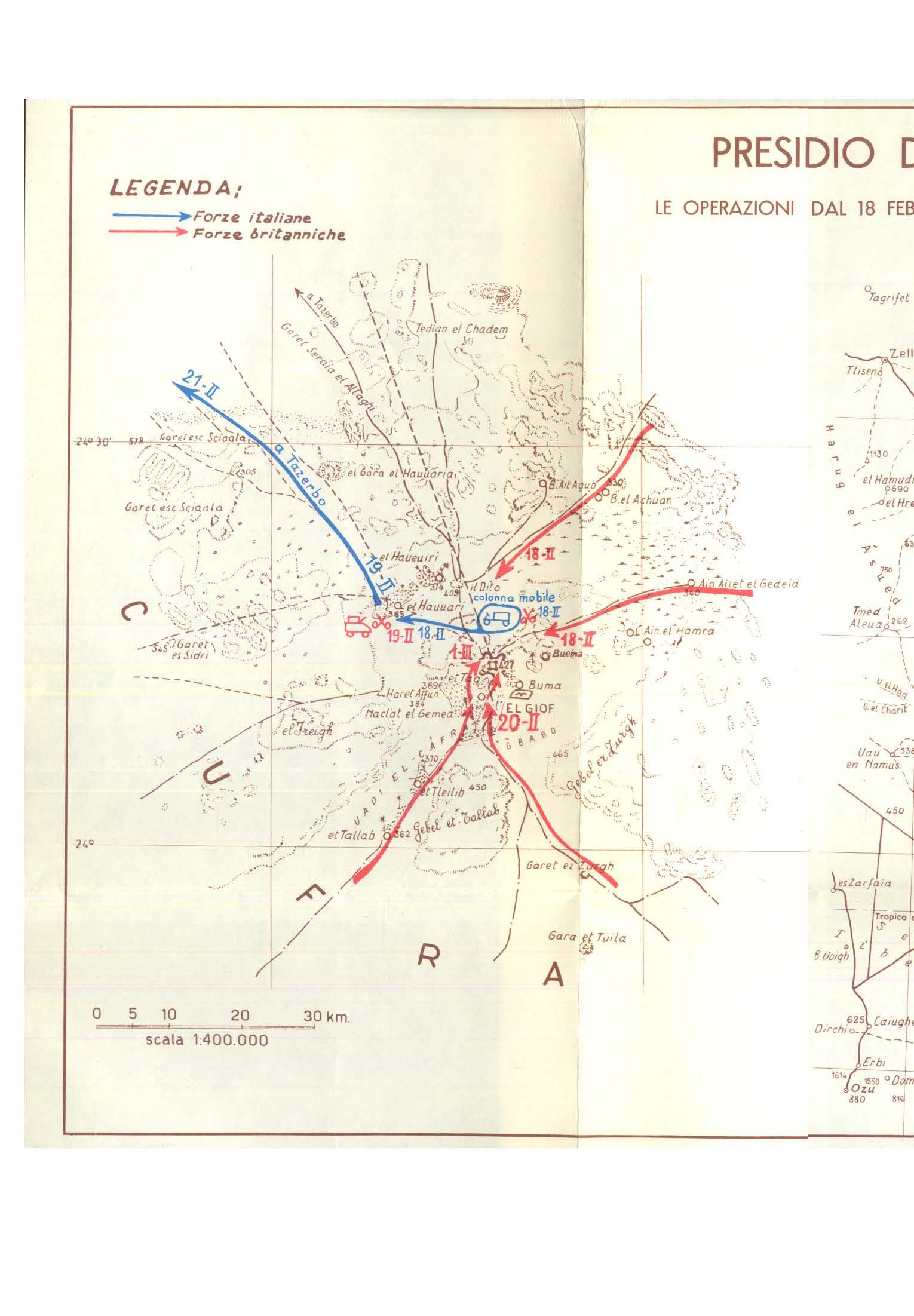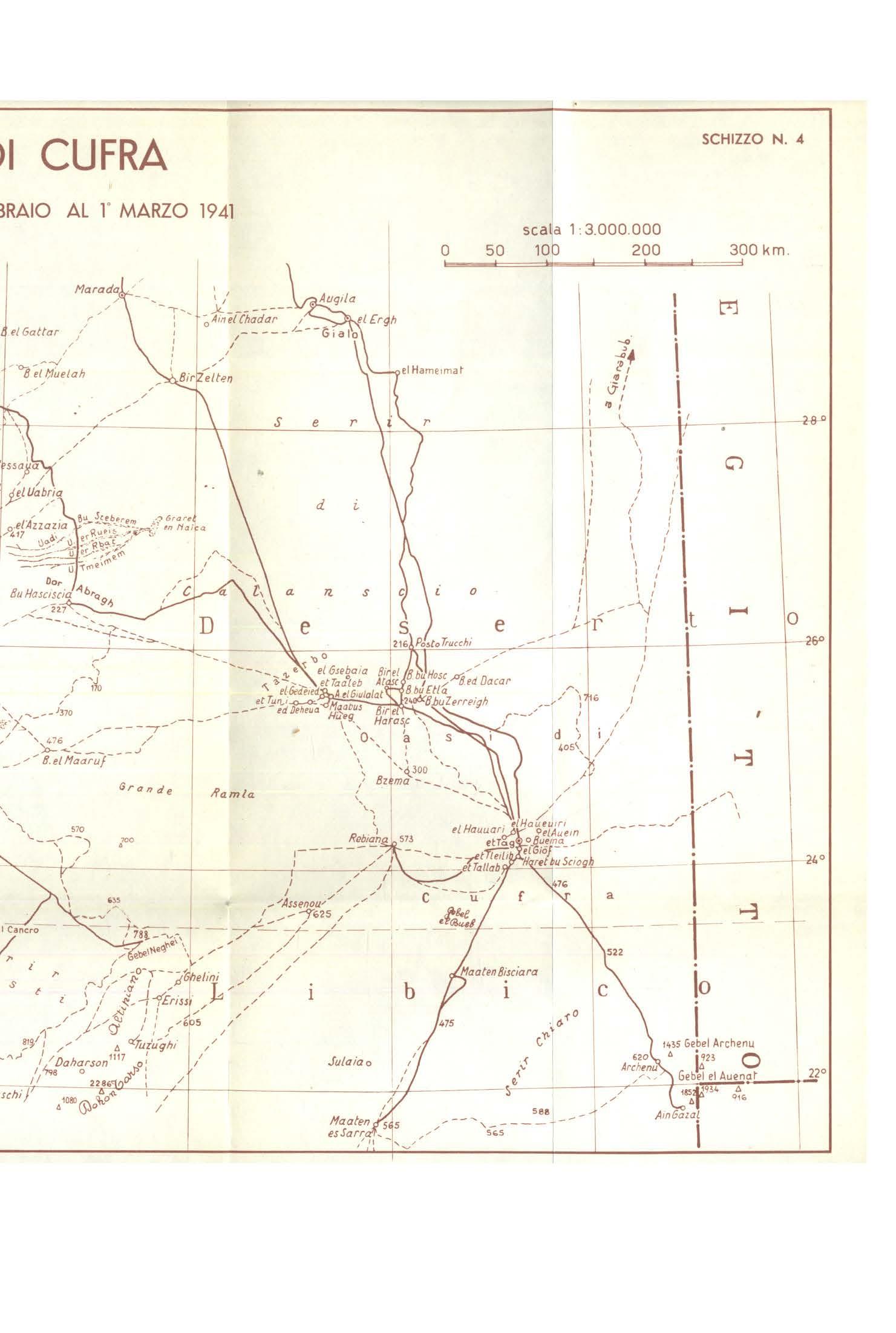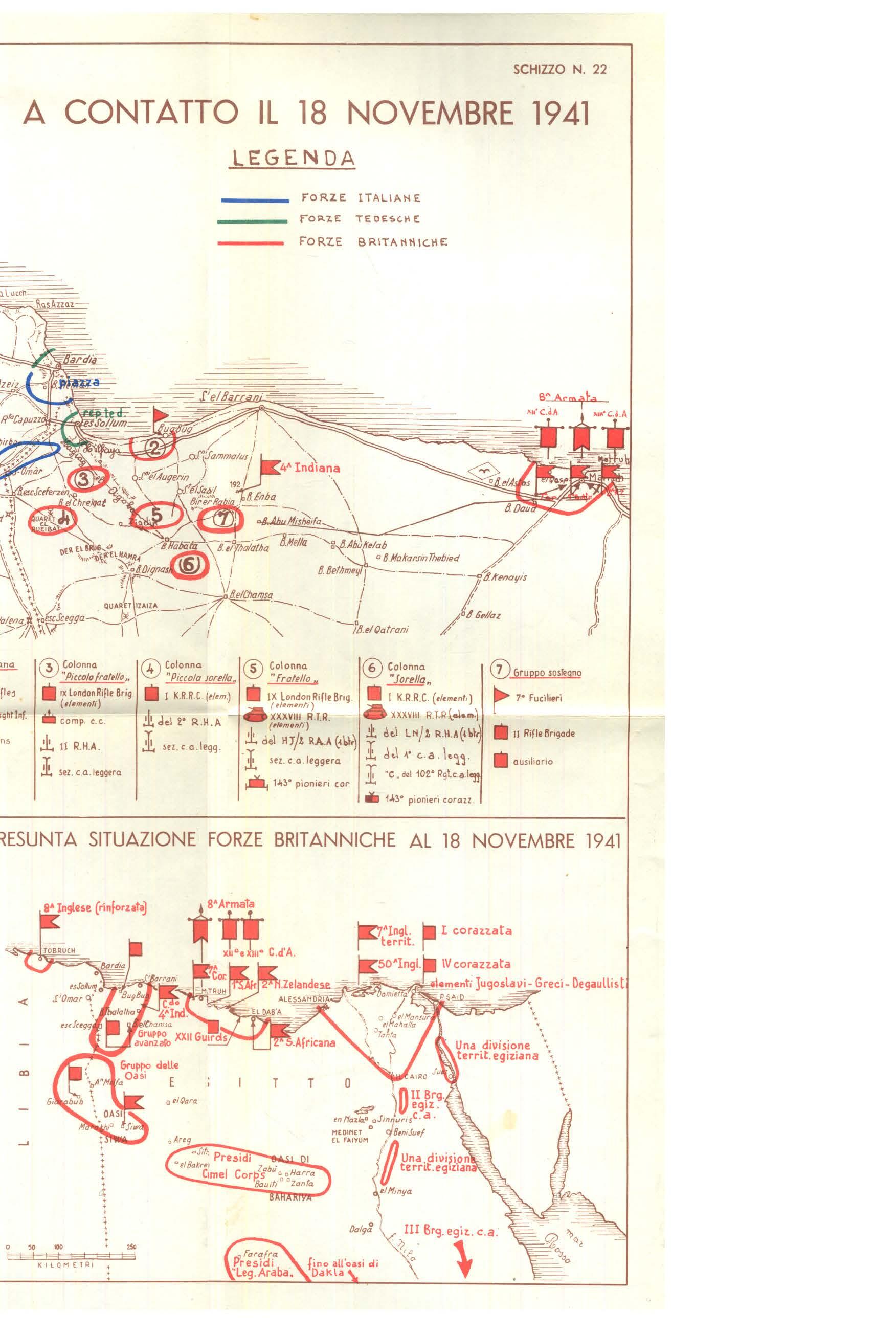MINISTERO DELLA DifESA
STATO MAOOIORE DEL L' t:St:RCI TO - UfflCIO STORICO

STATO MAOOIORE DEL L' t:St:RCI TO - UfflCIO STORICO
(15 fEBBRAIO - 18 NOVEMBRE 1941 ) ROMA
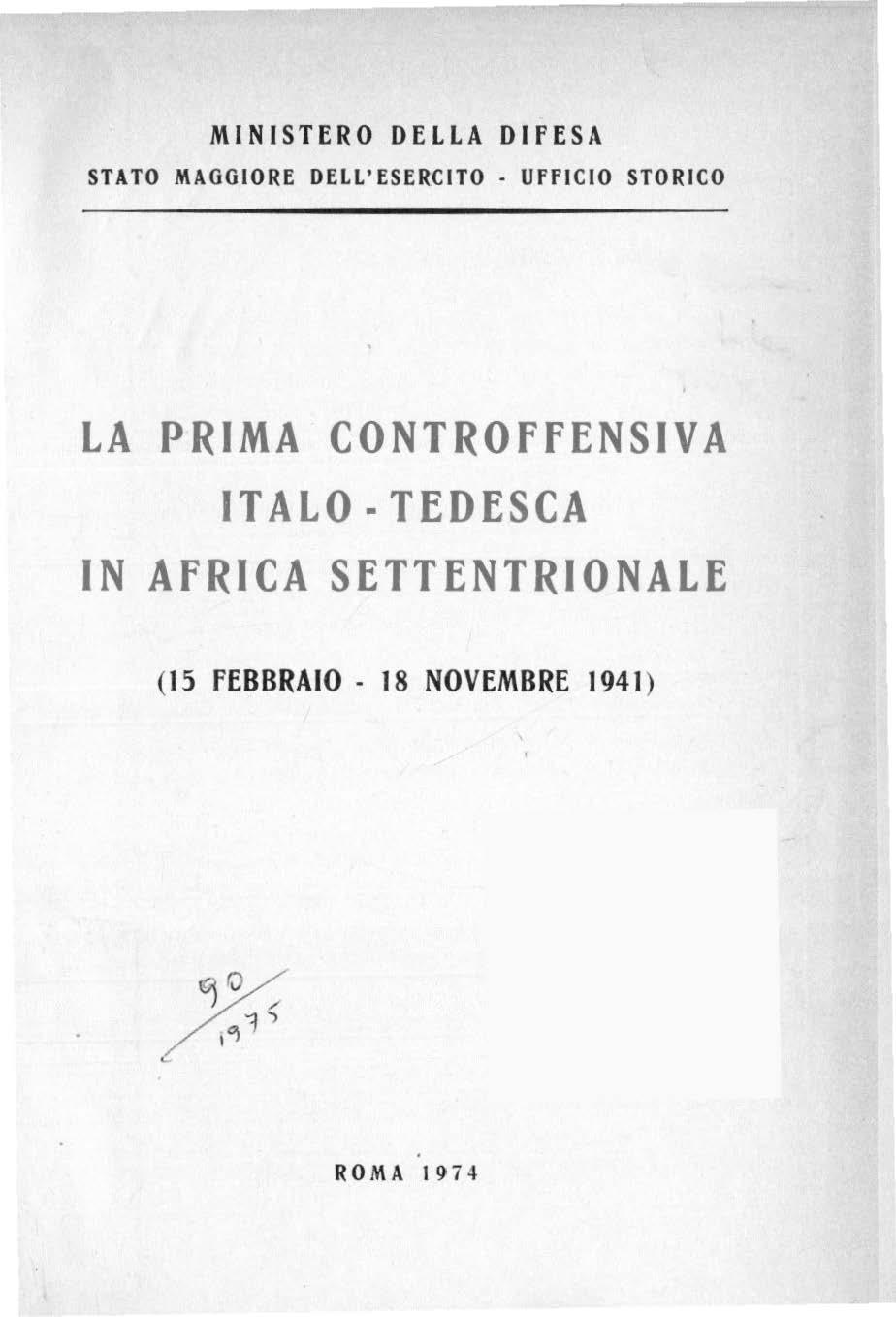
lA prima controfje?Jsiua italo- tedesca in Africa Settentrionale (15 febbraio - r8 nove mbre 1941)
..
Pag. 19, nota r :

- depennare t ' s· e 9a riga e sostituire con (( come comandante della 7" Divisione Panzer >>;
- 12a riga, depennare « al termine >> e << Francia n, sostituire con « all'inizio >> e << Po lonia >> :
- r4• riga , depennare dopo << Fiihrer n
>( Pag. 24:
- inserire tra la riga 25" e 26" : cc un rgt. carn s u 130 carn Il.
>( Pag. so:
- nota 2, correggere « 15 gennaw » in « 14 febbraio )) .
Y Pag. 70:
- riga 28\ correggere « 30 » in « circa 130 n .
X Pag. 73:
- ultima ri ga del testo, depennare cc un battag li on e mitra gl ieri n e sostituire con cc il III btg . dell'Bo bersaglieri n
X Pag. <)6:
- riga s·, correggere l< 8" )) in (( 2 ° ))
X Pag. roo:
- riga n \ correggere « 9• Divisione a ustralian a >> m (( 2• Di visione britanni ca ))
><.. Pag. 124:
- riga 22", correggere « 3 aprile » in cc 13 aprile n
> Pag. 136:
- riga 3", depennare « (Breda 201) n \ Pag. 155:
• a •
- nga 2, correggere « I) » m « 14 ».
')( Pag. 307 :
- riga 3., correggere (( 45" )) in h s· )) .
Pag g. 368- 370- 372 :
- nel titolo, dopo << Caratteristiche dei >> ag giun g ere « principali ».
LA prtswte monografia , terza della serie di sei volumi relativa alle operazioni in Africa Settentrionale, riguarda il ciclo operativo svoltosi fra il 15 febbraio e il I 8 novembre I 94I: vale a dire il periodo intercorso fra lo scatto deUa prima controffensiva italotedesca e l'inizio della seconda offensiva britatmica.
Nella primavera del '4I il « Corpo d'Armata Coraz z ato Rommel n , la grande unità italo - tedesca costituita il 17 febbraio c posta il giorno stesso agli ordini del generale Ertuitl Rommel, sviluppava l'ardita operazione controffensiva che Ìtl dodici giorni doveva portare alla riconquista dell'intera Cirenaica, ad eccezione della piazzaforte di Tobruch.
La travolgente ripresa dell'iniziativa, affidata prevalentemente ai mezzi moto- corazzati tedeschi, poco dopo il rovescio mbìto dalla nostra IO" Armata, destò grande risonanza in Italia c all'estero, diffondendo il convincimento che si trattasse di impresa esclusivamente o quasi esclusivamente tedesca (convincimento d'altronde accortamente sostenuto dalla propaganda tedesca e britannica: ansiosa la prima di esaltare, fino a monopolizzarlo, il successo delle proprie armi, avvolte ormai da un alone di invincibilità; sdegnosa l'altra di riconoscere ttna sia pttr modesta componente italiana nella spinta poderosa che aveva annullato di colpo i rimltati della recente vittoria).
Così scriveva il 26 luglio I 941 il generale Bastico, nt40VO Comandante Superiore in Africa Settentrionale:
« Bisogna dire in proposito e con tutta franchezza che, se anche non espresso a parole, il pensiero del Comando tedesco è quello che la "vera guerra" l'abbiano fatta soltanto le proprie truppe c che le nostre vi abbiano portato un ben modesto apporto e anche questo

più imposto dalle circostanze che non cercato; epperò ogni provvedimento inteso a sottrarre loro la diretta e completa condotta delle azioni non può riuscire gradito al Comando stesso » (r).
La venatura di amarezza che affiora nelle parole del Comandante Superiore deve essere tenuta in conto per l'obiettiva val utazione della collaborazio ne d'armi italo- tedesca nel teatro di operaziorzi nord- africano cara tterizza ta, sul piano materiale, da uno stridetzte squilibrio dello strumento bellico a disposizione dei due alleati e, ml piano psicologico, da una comprensi bile reazione italiana ( sensibile invero pii't a livello dei comandi superiori che nei reparti in linea) di fronte alla dolorosa necessità , sia pure onestamente riconosciuta e accettata, di dover cedere in casa propria il comando operativo al pirì potente alleato. Sen z a approfondire maggiormente, a questo pur1to basterà rilevare come, dopo l'arrivo dell' Afrika
Korps sul teatro nord- africano, la massa di manovra, cui per necessità di cose dovrà essere affidata la funzione risolutiva (e più brillante) delle operazioni, sarà costituita per la grandissima maggioran za da unità tedesche (e queste, qualitativam ente, assai superiori alle modeste consorelle italiatJe) merJtre il grosso, rappresentato quasi esclusivamente dalle divisioni di fanteria italiane, prive di mobilità , sarà co ndannato al ruolo logorante (e tanto meno appariscente) della difesa statica delle posizioni o dell'attacco frontale. Nel campo spirituale inoltre, nonostatJte la indiscutibile e indiscussa onestà del proposito di cooperazione, l'amarezza degli animi 11011 potrà certo giovare alla miglior soluzione di quel già tanto difficile problema che, i11 ogni tempo e in ogr1i coalizione, è stato posto dal buon funzionamento di un'armata interalleata.
Gli avvenimenti qui esposti sono stati ricostruiti sulla base della docummtazione ufficiale in possesso dell'Ufficio Storico (Relazione dell'Ufficio Operazioni del Comar1do Supremo; Diario del Coma11do Superiore Forze Armate Ì11 Africa Settentriouale; Diari delLe divisioni operanti).
(r) Relazione P.M. II in data 26 lugli o 1941 del Comandante Superiore Forze Armate Africa Settentrionale al Capo di Stato Maggi ore General e. V. anche: Comando Supremo Diario 1940 • 43 del Capo di S.M.G. Ugo Cavallero.

Nel proposito di presentare un quadro completo e per quanto possibile obiettivo, la presmte monografia integra inoltre i dati da fonte italiana attingendo alle annotazioni personali e agli appunti dello stesso Feldmaresciallo Rommd, tratti dall'opera « Krieg o/me Hass » (Guerra senz' odio) pubblicata dalla signora Lucie Maria Rom mel e dal generale Fritz Bay erlein, già Capo di S.M. del Corpo Corazzato d'Africa. L 'Ufficio è anche vetmto in possesso di copia di documenti e appunti del Feldmaresciallo, particolarmente attinetJti alla Campagna d'Africa r94r - 43 e che costituiscono, nel loro insieme, una specie di diario personale.
Importanti elementi di valutazione hanno anche fornito i rapporti di parte britannica ( Rapport o del gm. W avei! sulle operazioni nel Medio Oriente dal 7 febbraio al 15 lr4glio 1941; Relazione dd ge n. Neame sulle operazioni in Cirenaica dal 27 febbraio al 7 aprile 1941) e l'opera di Winston Churchill: t< La seconda guerra mondiale ,, Nel dovuto conto è stata infine tenuta la pubblicazione britannica cc The Mediterran eam and Middle East », edita a cura del gen. S.O. Pla yfair che, insieme ai propri collaboratori, ha avuto libero accesso alla documentazione ufficiale inglese.
L'Ufficio Storico dello Stato Maggiot·e dell'Esercito intende offrire con la presente monografia un concreto, obiettivo contributo alla conoscenza degli eventi qui conside rati, per tma più completa ed esatta valutazione storica. Confida che, nel rigoroso rispetto della verità storica, giusto risalto assumerà l'apporto delle nostre Unità c he, pure in condizione di penosa inferiorità operativa per l'armamento inadeguato e per difetto di mobilità tattica, nel corso delle operazioni qui considerate, così come in tutta la campagna, offrirono un generoso contributo di valore e di sangue, particolarmente elevato nelle azioni per la conquista di Tobruch e 11ella difesa delle posizioni al confine egiziano.
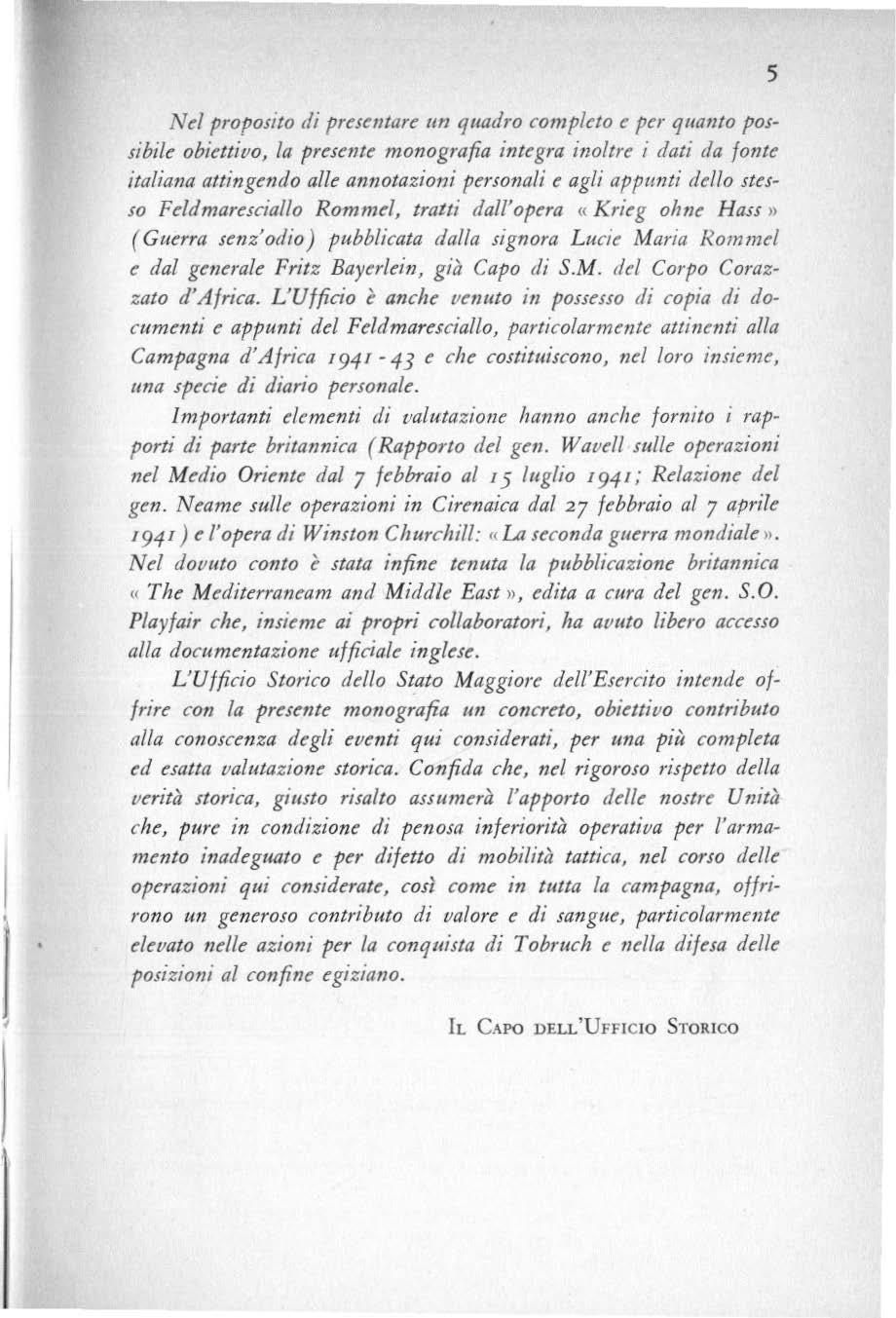

FORZE CO N TRAPPOSTE A FINE FEBB RA I O 194 1
Sit u az ion e delle forze Esaurita la carica prop ulsiva, la prima offenitalia ne. siva britannica in Africa Settentrionale, partita il 9 dicembre dalla zona di Sidi el Barran i, si era arrestata alle soglie della Sirtica, dopo i combattimenti di Beda Fomm (7 febbraio 1941), all'indomani della caduta di Bengasi (1). Si concludeva così nel giro di due mesi l'operazione inizialmente concepita dall'avversario con l'obiettivo di battere l'armata italiana schierata offensivamente oltre il confi ne egiziano e sviluppatasi poi nella conquista della Cirenaica.
Replicando uno stesso schema di manovra avvolgente per il sud, contro le nostre forze schierate difensivamente sulle successive posizioni (quantitativame n te sempre più ridotte ad ogni atto del progressivo ripiegamento) il gen. Wilson, cui era affidata la condotta dell'operazione, aveva raggiunto la Sirtica, come si è detto, con la « Western Desert Force » (Forza del Deserto Occide n tale) comandata dal ge n . O' Connor. Si era trattato di una ben e ideata e ben condotta operazione di forze moto- corazzate, modernamente equipaggiate ed ottimamen te addestrate, contro truppe assolutamente inidonee alla guerra di rapido movi m ento sui grandi spazi dello scacchiere nord- africano. Assunto ora un opportuno scaglionamento i n profondità, il gen . Wilson attendeva al riassetto delle unità e dei servi zi, posti in grave crisi dalla rapida corsa attraverso il deserto, a così forte distanza dal le basi.
All'inizio dell'offensiva il Comando Superiore delle Forze Arm ate italia ne in Africa Settentr ionale d isponeva di due Armate: la ro• in Cirenaica e la 5" in T ripolitania (2). Al termine dell'opera-
(r) L e operazioni relativ e al periodo ottobre
1940 - febbraio
1941 sono trattate nella Monografia dello Stato Maggiore dell'Esercito - Uffi cio Storico: << La prima offensiv.a britannica in Afri ca Seuentrionale »
(2) La Armata in Cirenaica comprendeva i C.A. XXI, XXII e XXIII , un Gruppo Divisioni Libi ch e e un Raggr u ppamento « Oasi Merid ionali H

zione la IO.. Armata doveva considerarsi praticamente annientata. In Tripolitania restava pertanto la sola 5a Armata, co n il X C.A. (Divisioni « Bologna» e « Savona ») e le Divisioni « Brescia » c « Pavia » del XX C.A. (prive però qu este ultime del Comando di :, C.A.). La 5"' Armata aveva perduto a sua volta la Divisione « Sabratha » (di cui invece si era salvato il Comando) e quasi tutte le artiglierie mobili e i m ezzi di trasporto che erano stati precedentemente assegnati di rinforzo alla 10" Armata. Erano andati perduti inoltre i depositi carburante, munizioni e approvvigionamenti della Marmarica e della Cirenaica.
L'avi azio ne era completamente a terra, dopo la perdita di circa 400 apparecchi ( r).
Il ro febbraio il Maresciallo Graziani cedeva il Comando Superiore al ge n. Garibaldi che, d'ordine del Duce , as sumeva anche la reggenza del Governatorato della Colonia (2).

Le truppe affluite in Tripolitania dalla Cirenaica assommavano a circa 7000 nazionali e 1300 libici, oltre a 2700 uomini sfuggiti isolatamente alla cattura che erano stati avviati a un centro di raccolta e riordinamento. Queste truppe disponevano complessivamente di 46o armi automatiche e 139 pezzi di vario calibro: poste agli ordini del comandante della Divisione « Sabratha >> erano state destinate ad Hom s, per organizzarvi uno sbarramento.
In base all e direttive di massima emanate il 6 febbraio dal Comando Supremo (allegato n. r) e confermate l'n dello stesso mese (allegati n. 2 e 3) il X C.A. (Divisione cc Pavia >>, « Bologna>> e Divisione Corazzata « Ariete>>, quest'ultima in via di affluenza a T ripoli) (3) veniva dislocato nella zona Sirte- Buerat- el Gheddaia. Questo dispositivo rispondeva anche al criterio espresso dalla missio ne tedesca guidata dal gen. Rommel che il giorno 13, accompag nata dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Roatta, riconosceva il fronte della Sirte per rendersi con to della situazione
La s• Armata in Tripol itania comprendeva i C.A. X (Divi sioni « Bologna >> e cc Savona >>) e XX (D ivisioni c< Sabratha », c< Brescia >> c « Pavia »).
(
1) Abbattuti in combattimento, distrutti al suolo dal n e Rli co, abbandona ti o distrutti sui campi, perduti in seguito ad incid e nti di volo o danneggiati gravemente in azioni belliche o per cause varie.
(2) Il gcn. Gariboldi verrà confermato Governatore G enerale della L ibia il 26 marzo.
(3) La Division e « Ari e te >> sbarcava a T ripoli nel periodo 24 gennaio26 febbraio 1941.
e determinare sul posto, d'intesa con il gen. Gariboldi, le postztoni da assegnare al Corpo Corazzato tedesco destinato in Libia ( 1).
Dopo il quasi totale an nientamento delle forze aeree della Libia, l'Aeronautica italiana ricostituiva la 5a Squadra Aerea, riuscendo a riportarla ed a mantenerla per tutto il 1941 ad una consistenza numerica leggermente superiore del passato (2). Così si esprime al riguardo il gen. S. A. Santoro (3):
« Dal punto di vista qualitativo la situazione, rimasta praticamente invariata in senso assoluto, era però peggiorata nei confronti di quella avversaria: infatti i nostri reparti aerei continuavano ad essere armati con i velivoli già in uso nella fase iniziale delle ostilità ... mentre le unità britanniche avevano ormai abbandonato il vecchio materiale c venivano man mano dotate di velivoli più moderni, anche dei recenti tipi americani ».
L'avversario frattanto, occupata Agedabia e raggiunta con elementi avanzati cl Agheila, non curava di riprendere il contatto con le forze terrestri e si asteneva anche dal compiere azioni c persino semplici ricognizioni aeree. Si legge in proposito nella Relazione del gen. O' Connor:
« Ad onta della situazione, del tutto nuova , si decise contro una ulteriore avanzata, benché il gen. Wilson avesse chiesto di spin-
( 1) P e r maggi o ri particolari circa le direnive e gli ordini impartiti per la di fes a della Tripo1itania subito dopo il ripiegam e n t o dei res ti della t o• Armata v. citata Monografia dell'Ufficio Storico.
(2) Efficienza m edia m e nsile della 5' Squadra Aerea dal febbraio al nove mbr e 1941:
( 3)
c n. S.A. Giuseppe Santoro: " L ' Aeronautica it aliana nella seconda guerra mondiale n, Ed. Esse, Milano, 1957, vol. Il, pagg. 123 e 130.

gersi fino alla Sirte. Il Governo non doveva deflettere dalla propria politica ed entro due giorni n e vedemmo i risultati.
« Il primo risultato fu il ritiro immediato dalla Cire naica del grosso delle forze della R.A.F. che lasciarono circa una sq uadriglia di << caccia» nell'intera zona. Il secondo fu un comunicato della Flotta secondo la quale, in seguito agli impegni che aveva altrove, essa no n era in grado di prestare le sue forze per fare di Be ngasi una vera e propria base navale di rifornimento.
<< La ragione del rifiuto del Governo di modificare la propria politica sta nel fatto che le possibilità e i vantaggi di un'avanzata su Tripoli non erano stati presi in considerazio ne, soprattutto per due motivi. Il primo era che ci trovavamo impegnati anima e corpo nel progetto balcanico mentre la campagna del Deserto Occidentale rappresentava, in un certo senso, soltanto un ostacolo alla realizzazione di tale politica. Perciò, quanto prima fosse finita la ca mpagn a, tanto meglio sare bbe stato.
u Il secondo motivo (conseguenza del primo) era che nessuna vittoria militare, quale era da prevedersi in Libia, sarebbe stata di importanza tale da rendere n ecessa ria una modifica delle operazioni previste per la Grecia, ad eccezione for se di anticipare la data del ritiro delle truppe dalla Cirenai ca e del loro trasferimento oltremare (r) mentre il rinvio o la rinuncia all'azione in Grecia e quindi la concentrazione di tutte le nostre risorse in una compag na contro Tripoli , non se mbrava essere stata presa in considerazione, nemm eno per un tempo avvenire».
Concorso di forze te- Le trattative per la partecipazione di forz e desc he. Prime trattati- terrestri moto -corazzate tede sche alle opeve. Affl uenza del X razioni in Afric a Sette ntrional e erano state
Corpo Aereo in Sicilia. iniziate nel settembre 1940.

Costituzione del Cor- Il 31 agosto il nostro Addetto Militare a po Corazzato Rommel Berlino, gen. Marras, era stato interessato a in A.S. richiedere una sollecita cessio n e di mezzi e materiali ed aveva prospettato la questi one al gen. Jodl , Capo dello Stato Maggiore Operativo presso l'Alto Comando delle Forze Armate tedesche (OKW). Il gen. Jodl era il
(t) L'entità delle forze inglesi che dalla Cirenaica c dall' Egitt o dove vano essere inviate in Grecia sarà indi cata a pag. 34• quando verranno riassunti i
consigliere personale di H itler e rappresentava, in certo modo, il Sottocapo dell'Alto Co m ando, retto dal Feldmaresciallo Keitel.
La richiesta traeva dunque origine dal riconoscimento dell'inadeguatezza della nostra attrezzatura materiale (e indirettamente anche della nostra preparazione addestrativa) di fronte alle esigenze della guerra di movimento, acuite dalle caratteristiche del vasto ambiente nord- africano, particolarmente idoneo allo sviluppo della manovra dei moto- corazzati mentre la ragione politica, da Roma, premeva per il raggiungimento di un succe sso militare da far valere al tavolo della pace, intorno al quale ci si illudeva allora di potersi adunare al più presto per spartirsi i frutti della vittoria. l Comandanti Superiori che si erano succeduti in Libia , dal Maresciallo dell'aria Balbo al Maresciallo Badoglio e al Maresciallo Graziani, avevano potuto constatare l'insufficienza dello strumento di c ui disponevano, in rapporto a qualsiasi obiettivo offensivo. Di qui il tentativo di ottenere dall'alleato, almeno in parte , i mezzi di cui eravamo carenti.
Il 3 settembre il gen. Marras aveva riferito al Maresc iallo Badoglio sull'esito del colloquio: dopo avere esposto il proprio pensiero in merito alla funzione strategica del Mediterraneo, il gen. Jodl aveva assicurato che la questione sarebbe stata subito presa in esame . A suo avviso, la Germania avrebbe potuto concorrere direttamente alle operazioni in Egitto con proprie forze terrestri, oltre che con la cessione di materiali. Egli riteneva, in via d'esempio, che si sarebbero potute impiegare anche a breve scadenza (pronte per l'imbarco ai porti italiani entro sei settimane dalla decisione) una o due divisioni corazzate.
Il gen. Marras faceva rilevare in proposito che:
« ... la proposta del gen. Jodl aveva anzitutto un aspetto politico . . . Lo Stato Maggiore tedesco r iconosceva tutta l'importanza dello scacchiere mediterraneo ma vedeva con favore anche un intervento della Germania nel Mediterraneo ... » .
Faceva considerare tuttavia che:
« ... le necessità logistiche delle unità germaniche dovevano essere attentamente pesate Si trattava di unità pesanti, dotate di mezzi abbondanti, abituate a larghi consumi e a vivere largamente sulle risorse locali ... >>
r isultati dei colloqui intercorsi ad Atene tra il Gov erno greco e il Minis tro degli Esteri del Regno Unito (Eden), il Capo dello Stato Maggior e General e (gen. Diii), il gen. Wavell c il g en. d'armata aerea Longmore

E' interessante rilevare come questo proposito (ancora non ufficiale) della Germania di partecipazione militare diretta nello scacchiere mediterraneo rappresentasse una prima deviazione dal criteno che, in assenza di un preciso accordo preventivo in materia, aveva finora praticamente presieduto alla ripartizione del campo d'azione fra i due alleati dell'Asse , in base al quale il Mediterraneo rientrava completamente nella sfera d'interesse italiana.
Il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Roatta, nel trasmettere il 9 settembre al Maresciallo Graziani il rapporto del nostro Addetto Militare, gli chiedeva di esprimere il proprio pensiero sulle seguenti questioni:
- opportunità (prescindendo da ogni considerazione di carattere politico e morale) di un concorso diretto tedesco con grandi unità corazzate organiche che avrebbero comportato un grave peso logistico (trasporti marittimi, rifornimenti vari, ecc.);
- convenienza di ottenere a preferenza dalla Germania la fornitura di materiali per costituire, con personale italiano, tre o quattro battaglioni carri pesanti (150- 200 carri) e di un certo numero di autoblindo pesanti.
Frattanto gli eventi premevano: il 13 settembre si era iniziata la nostra avanzata in territorio egiziano, esaurita dopo tre giorni all'altezza di Sidi el Barrani. Il 25 settembre il Maresciallo Graziani rispondeva ai quesiti del gen. Roatta nei seguenti termini:
« Stato Maggiore Esercito - Roma, 25 settembre 1940. N. 32 Op. j sp. At vostro 2427 del nove settembre. Risposta est implicita in mio n. or / 841 del 24 diretto Stamage. Impiego unità indicate con organico alquanto riveduto c corretto est indubbiamente utile. Ma esso può coesistere solo in funzione di una organizzazione logistica adeguata che con mezzi attuali non est possibile realizzare. Mi riservo preci sazioni in merito varianti per adattamento particolare ambiente questo teatro operazioni. Prego copia presente at Stamage. Graziani »

Il 5 ottobre il Capo del Governo redigeva una « Nota sullo sviluppo ulteriore delle operazioni in Egitto » nella quale era scritto:
« La presa di Sidi el Barrani è stato un indiscutibile brillante s uccesso tattico ed un altrettanto indiscutibile successo politico in quanto ha determinato una crisi del governo egiziano e rivelato una divisione nella classe politica di quel paese.
« Solo con la presa di Marsa Matruh il successo diventerà strategico e potrà avere conseguenze ancora più importanti dal punto di vista politico.
<l L'operazione su Marsa Matruh deve iniziarsi entro il 10- 15 di qu esto me se poiché è mia convinzione che i m ezzi di cui dispone attualmente Graziani sono sufficienti allo scopo e nel te mpo fissato ... » .
Nel trasmettere integral m ente la nota del Capo del Governo, il Maresciallo Badoglio informava il Maresciallo Grazia ni che il Duce, giudica n do i nostri mezzi suffi cienti per l'occupazione di Marsa Matruh, aveva declinato l'offer ta di aiuti germanici per la r ipresa dell'offensiva, che voleva im m in ente. « Tale aiuto - aggiungeva - in autocarri, carri armati, "Stuk as" (1), potrà essere ric h iesto quando sarà deciso di attaccare le forze inglesi che, secondo il pensiero del Duce , ci attenderanno al co mpl eto o qu asi sul Delta » .
Questo preciso riferimento del pe nsie ro di Mussolini i n materia operativa (che è da ritenere condiviso o quanto meno accettato nelle alte sfere direttive politiche e militari) mette i n evidenza un fatale errore ricorrente nell'impostazione della pianificazione operativa (lo si ritroverà infatti, ancora più palese, alla base dell'infausta decisione dell'attacco alla Grecia) derivandola dalla imprudente valutazione (che poi, alla prova dei fatti, risulte rà fallace), che l'avversario non opporrà resistenza. La decisione del D uce aveva comu nque posto fine a qu esto pri mo te ntativo di otten ere dall'Alleato u n 'apprezzabile concessione di m aterial i (da considerare in vero scarsame n te s uscettibile di successo) o magari il concorso diretto di alcune valide unità moto- corazzate .
Alla fine di novembre 1940, dopo il fallimento della battaglia aerea d'Inghilterra e svani to o rm ai il progetto d'invasione dell'isola , si erano rese disponibili forze tedesche, n on utilmente impiegabili durante l'inverno.
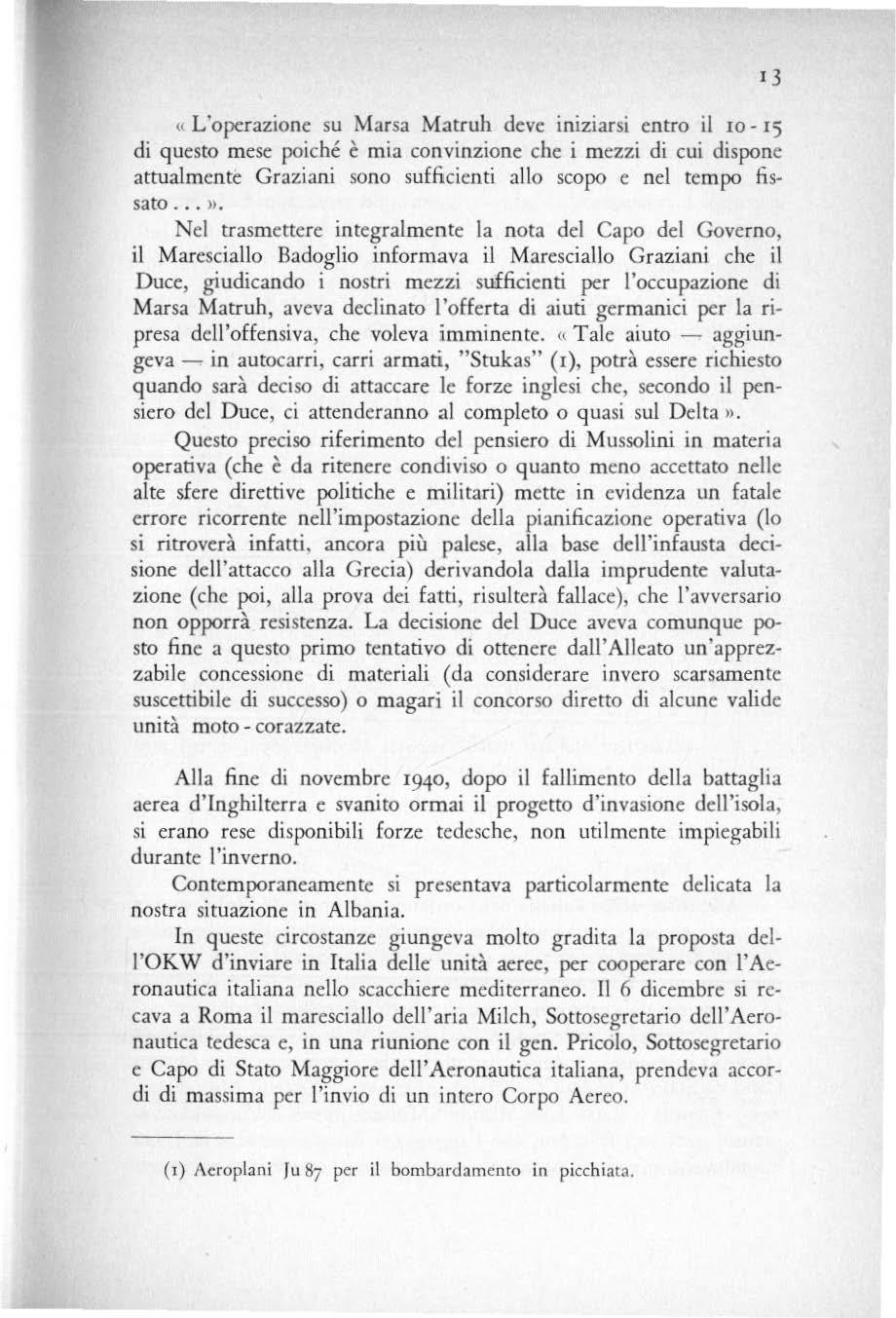
Contemporaneamente si presentava particolarmente delicata la nostra situazion e in Albania.
In queste circostanze giu n geva molto gradita la proposta dell' OKW d'inviare in Italia delle uni t à aeree, per cooperare con l'A eronautica italia n a nello scacchiere m editerraneo. Il 6 dicembre si recava a Roma il maresciallo dell'aria Milch, Sottosegretario dell'Aeronautica tedesca e, i n una riunione con il gen. Pricolo, Sottosegretario e Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica italia n a, prendeva accordi di m ass ima per l'invio di un intero Corpo A ereo.
(1) Aerop la ni Ju 87 per il bombardamento i n picchia ta.
Si trattava precisamente del trasferimento in Sicilia (con una piccola aliquota i n Calabria) del X C.A.T. così costituito:
2 gruppi bombardieri . Ju. 88 = 72 appar. a Catania
I gruppo bombardieri e siluranti . H e. III = 36 )) a Comiso

2 gruppi bombardieri << Stukas » . Ju. 87 = 72 )) a Trapani
1 gruppo caccia pesante . Me. IlO= 36 )) a Palermo
I squadriglia ricognizione . Ju. 88 = I 2 )) a Catania
r squadriglia posamine . He. Ili = 12 )) a Cata n ia
I gruppo trasporti . Ju. 52 = 36 )) a R. Ca!.
Sarebbero stati trasferiti inoltre 9 batterie pesanti e 5 leggere per la difesa c.a. degli aeroporti, reparti per i servizi delle trasmissioni, dei rifornimenti, ecc. In totale si trattava dell'afflusso di oltre ro.ooo uomtnl.
Il Comando del X C .A.T. avrebbe avuto sede a Catania (in un secondo tempo a Taormina).
L'affluenza in Sicilia dei reparti e servizi della grande unità aerea tedesca ebbe inizio nella prima metà di dicembre. Il 27 giungeva a Roma il comandan te, gen. Geissler, con il quale ve nivano presi accordi di dettaglio circa i compiti, le di pendenze e la funzionalità operativa. Al X C.A.T. erano affidati i seguenti compiti:
- attacco al traffico marittimo nel Mediterraneo, in collaborazione con le forze aeree itali an e;
- attacco della base navale di Alessandria e delle basi aeree e navali di Malta;
- minamento del canale di Suez e porti adiacenti.
Alle forze aeree italiane del Comando Aeronautica Sicilia veniva assegnato come compito specifico la protezione del traffico nazionale con la Libia. Era prevista una stretta collaborazion e co n il X C.A.T. per tutto quanto atteneva alla difesa aerea delle basi di schieramento ed al servizio di scorta con caccia ai reparti offensivi tedeschi.
Il I9 dicembre, vale a dire dieci giorni dopo l'inizio della prima offensiva britannica in Africa Settentrionale, il gen. Cavallero ( nuovo Capo di Stato Maggiore Generale) informava l'Addetto Militare tedesco a Roma e Capo della Missione Militare presso il Comando Supremo, gen. von Rintelen, che l'aggravarsi della situazione in Libia imponeva di prendere misure atte ad impedire l'eventuale co n giungi-
mento degli Inglesi con le forze francesi della Tunisia. Occorreva pertanto mettere in efficienza il campo trincerato di Tripoli ed avere il concorso di una divisione corazzata per la reazione manovrata, secondo l'offerta che ne era stata avanzata in altro campo (1).
Il 28 dicembre il gen. Gandin, Capo Reparto Operazioni del Comando Supremo, partiva in missione insieme al gen. Favagrossa, Sottosegretario di Stato alle Fabbricazioni di Guerra, per trattare in concreto la questione del concorso di forze terrestri tedesche in Africa Settentrionale.

In una riunione generale tenuta a Berchtesgaden il 20 gennaio 1941 alla presenza del Duce e del Fiihrer veniva deciso l'invio in Libia di una divisione leggera, dotata anche di uno speciale reparto cacciacarri (Panzerjager).
Due giorni dopo però si verificava la caduta di Tobruch e il 23 anche gli ultimi centri attivi della piazza risultavano eliminati. L'accentuarsi della minaccia avversaria sulla direttrice di Mechili - Bengasi, ponendo in crisi la situazione dell 'intero Gebel Cirenaico, induceva il Maresciallo Graziani ad ordinare il ripiegamento delle nostre forze dallo stesso Gebel.
In questa situazione, il 2 febbraio l'OKW faceva chiedere dal gen. von Rintelen al nostro Comando Supremo:
- le direttive date al Maresciallo Graziani e relative modalità dì esecuzione;
- per quanto tempo il Maresciallo Graziani riteneva di poter continuare a resistere in Cirenaica, di fronte alla pressione inglese;
- entro quale periodo di tempo sarebbe stata potenziata l'aeronautica della Libia;
- se si pensava di fronteggiare con forze navali di superficie eventuali tentativi di occupazione di basi navali da parte della flotta inglese;
- se le Divisioni italiane « Ariete » e « Trento » e la Divisione Leggera tedesca erano ritenute sufficienti per la difesa della Tripolitania.
Il gen. Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, rispondeva che:
- il Maresciallo Grazianj aveva già disposto il ripiegamento delle forze dalla zona Derna- Ci rene- Mechili, con le quali intendeva
(r) Ugo Cavallero - Comando Supremo - Diario 1940 - 43, pag. 27.
dare consiste nza alla difesa della Sirtica, affidata frattanto ad elementi della 5" Armata;
- non era possibile prevedere la durata dell'ulteriore resistenza in Cirenaica: le minacce di aggiramento escludevano comunqu e 1 • la possibilità di prolungata resistenza in posto;
---, l'avanzata nemica attraverso il deserto verso la Tripolitania sarebbe stata ritardata con mezzi adeguati, con successive difese;
- la difesa della Tripolitania non sarebbe stata attuata attorno a Tripoli: le forze disponibili sarebbero state schierate in modo da costringere il nemico a combattere con il deserto sirtico alle spalle, esposto alla reazione controffensiva di forze mobili, sul fianco e sul tergo;
---, si sarebbe provveduto alla copertura della frontiera occidentale e alla difesa del Sud Tripolino da incursioni di dissidenti francesi;
- era in corso il potenziamento dell'aeronautica, già rinforzata co n 6o apparecc hi da caccia;
- non era possibile l'impiego di forze navali di superfici e sufficienti a ritardare efficacemente l'eventuale occupazione di basi navali sulle coste della Cirenaica da parte della flotta inglese, preponderante;
---, con l'invio, già effettuato, di reggimenti di artiglieria della Divisio ne «Ariete » e l'affluenza della Divisio n e L eggera tedesca e della Divisione Motorizzata « Trento>> si sarebbe raggiunta la disponibilità di una massa mobile ragguard evole, in grado di fronteggiare il nemico, qualora decidesse di avanzare verso la Tripolitani a.
Queste delucidazioni inducevano l'Alto Comando tedesco ad inviar e in Africa Settentrionale, oltre la divisione leggera già stabilita, anche una divisione corazzata. Le due unità sarebbero state r iunite in un corpo corazzato, agli ordini del gen. Rommel (1).
L'II febbraio il gen. Guzzoni comunicava alle autorità interessate le direttive co ncord ate il giorno 5 tra il Comando Supremo italiano e l'O KW per l'impiego di truppe tedesche in teatri d'operazione italiani (in qu el momento si considerava anche l 'eve ntualità dell'invio di forze tedesche in Albania , eventualità che poi non si è realizzata):
( 1) I testi int egrali d e i docum e nti rela t ivi allo scambio d ' id ee sui poss ibi l i sviluppi delle operazioni ai primi di f ebbraio sono s tati pubbli cati nella c ita ta monografia: << La prima offemìva britannica in Afri c a Settentrionale ».

6339 - II febbraio 1941.
Alla Ecc. il Sottocapo di S.M. R. Esercito
Alla Ecc. il Capo di S.M. R. Marina
Alla Ecc il Capo di S.M. R. Aeronautica
Alla Ecc. il Comadante Superiore F.A.A.S.l.
Alla Ecc. il Comandante Superiore F.A. Albania
« L'Alto Comando delle F orze Armate tedesche e il Comando Supremo italiano hanno concordato le seguenti direttive per l'impiego di truppe tedesche su teatri di operazione italiani:
r) Le truppe tedesche in Libia e in Albania saranno tatticamente alle immediate dipendenze del Comandante Superiore sul posto. Per il resto esse dipendono dal Comandante dell'Esercito, il quale tiene il collegamento con i competenti comandi italiani locali.
2) Esse devono essere impiegate soltanto a unità complete, almeno a divisioni complete. Sono ammesse eccezioni solo se, a giudizio del comandante tedesco, sono minacciate direttamente prima che abbiano potuto completamente riunirsi o nel caso nel quale dovesse intervenire una tale crisi che, ove non fosse fronteggiata, potrebbe derivarne la perdita dell'intero teatro delle operazioni.
3) Una volta schierata secondo il piano previsto, l'unità tedesca deve rimanere riunita nelle mani del comandante tedesco e non deve essere ripartita in diversi settori della fronte di combattimento.
4) Nel caso in cui alle forze tedesche venisse affidato un compito la cui esecuzione, per convinzione del loro comandante, potrebbe portare so ltanto a un grave insuccesso e quindi alla menomazione del prestigio delle truppe tedesche, il comandante tedesco ha il diritto e il dovere, informando il generale tedesco di collegamento con il Comando Supremo italiano a Roma, di chiedere la decisione al Fuhrer, a mezzo del Comandante Superiore dell'Esercito.
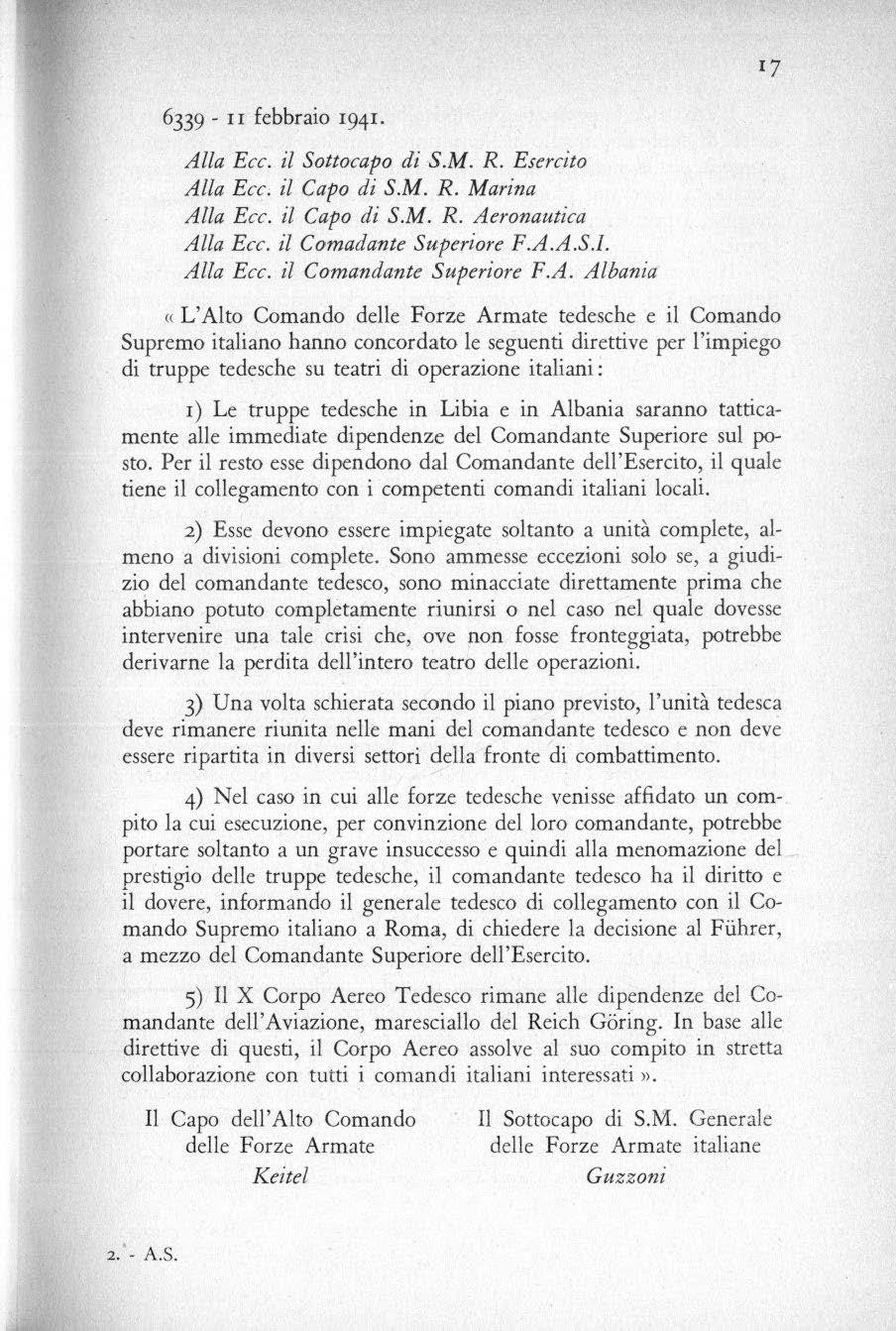
5) Il X Corpo Aereo T edesco rimane alle dipendenze del Comandante dell'Aviazione, maresciallo del Reich Goring. In base alle direttive di questi, il Corpo Aereo assolve al suo compito in stretta collaborazione con tutti i comandi italiani interessati » .
Il Capo dell'Alto Comando delle Forze Armate Keitel
Il Sottocapo di S. M. Generale delle Forze Armate italiane Guzzoni
L'arrivo delle prime truppe tedesche in Libia era previsto per la metà di febbraio, quello delle ultime aliquote della s• Divisione Leggera, per la metà di aprile. Gli ultimi elementi della 15" Divisione Corazzata dovevano giungere in territorio africano entro la fine di maggio. I primi reparti della 5• Divisione Leggera sbarcarono regolarmente a Tripoli il 15 febbraio.
Il giorno 17 lo Stato Maggiore Generale informava il Comando Superiore A.S. che il Duce aveva approvato la costituzione del Corpo Corazzato Rommel in A.S. e ne aveva definite le dipendenze:

N. 6)I0 / 0p. - 17 febbraio.
All'Eccellenza il Comandante Superiore delle Forze Armate A.S.l.
<< In relazione alle direttive per l 'i mpiego delle truppe tedesche in Libia e in Albania, trasmesse con foglio 6339 Op. in data II febbraio c.a., comunico che il Duce ha approvato quanto ha tratto alla costituzione e alle dipendenze del Corpo Corazzato Romm e l in Africa Settentrional e Italiana.
« Tale Corpo sarà costituito da tutte le forze corazzate italiane e tedesche esistenti in Tripolitania e sarà alle dipendenze della s• Armata che disporrà così del X Corpo d'Armata, del Corpo d'Armata Ro mmel e di unità varie, nazionali e libiche, di armata.
« La Divisione Corazzata « Ariete » passerà perciò subito a far parte del Corpo d'Armata Corazzato Rommel , unitamente alla s" Di visione Leggera tedesca in corso di affluenza e, successivamente, all'altra divisione corazzata germanica n
Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale
A. GuzzoniIl Comando della 5a Armata si identificava in sostanza con il Coma ndo Superiore A.S. che ne aveva assorbito gli uffici sotto la data del 16 febbraio (1). La formazione dell e grandi unità alla data ind icata e le unità da considerarsi disciolte risultano dall'allegato 4·
Il rapporto di collaborazione tra le forz e aeree italiane e tedesche doveva invece rimanere alquanto vago. .
In Libia, venivano dislocati reparti di Ju 87 e Me no del X C .A.T. agli ordini di un « Fliegerfi.ihrer Afrika » (Comandante Aviazione Africa = gen. Frohlich) che non dipendeva dal generale
( 1) I! Comando de lla 5" Armata vcrd poi il T5 aprile.
Rommel ma dal Comando X Corpo Aereo Tedesco, residente in Sicilia.
Il Comandante Sa Squadra Aerea (gen. Aimone Cat) restava alle dipendenze del Comandante Superiore A.S.: poteva inoltrare direttamente richieste di intervento alle forze aeree tedesche della Libia ma al Comando tedesco era lasciata facoltà di aderire o meno, a seconda delle possibilità.
Il mandato affidato al gen. Frohlich precisava però di agire in tutti i modi e con tutte le forze disponibili a co ncorso delle forze terrestri itala- tedesche operanti in Libia. II generale stesso prendeva personale contatto con il Comandante della 5" Squadra Aerea, impegnandosi alla più stretta cooperazione.
Prime impressioni e primi rapporti del gen.
Rommel.
Il 15 febbraio, vale a dire il giorno stesso dello sbarco del primo contingente di truppe tedesche in Libia, Rommel (1) annotava nel proprio diario personale: « Ho visitato una divisione italiana che mi ha fatto un'ottima impressione>>. Il 17 aggiungeva: « Abbiamo, i comandanti italiani ed io, una magnifica comprensione. I miei carri armati sono ora in prima linea sul fronte che è già stato spi nto in avanti di 550 chilometri verso oriente (2). Gli altri non possono far altro che filare».
(r) Il gen. Rommel era nato nel r891 nel Wurttemberg. Durante la prima guerra mondiale aveva ricevuto la massima ricompensa al valore, la croce dell'ordine « pour le mérite » come capitano comandante di una compagnia caccia tori da momagna, per la conquista del Matajur, sul fronte italiano, ciurante l'offensiva austro- germanica di Caporetto. Nella seconda guerra mondiale si era messo particolarm ente in luce nella campagna di Francia, come comandante della Brigata Corazzata che, co n l'audace puntata verso Abbéville, aveva creato le premesse per il crollo delle armate avversarie in territorio belga.
Aveva pubblicato un importante studio sul combattimento della fanteria nel quadro del « Blitzkrieg ».
Particolarmente st ima to da Hitler, al term ine della campagna di Francia gli era stato affidato il comando delle truppe a disposizione del Quartier Generale del Fiihrer, che deteneva all'atto della sua destjnazione in A.S.
(2) Il reparto esp lorante tedesco, raggiunto il 17 febbraio il presidio di Sirte, si era spinto il giorno stesso, insieme ad un nostro nucleo celere, a Nofìlia, circa 130 chilometri più ad oriente. Il gen. Rommel si riferisce evidentemente alla distanza da Tripoli.

Il 2 marzo scriveva all'Alto Comando tedesco a Berlino: « Gli italiani sono ottimi camerati, bravi e valorosi soldati: se avessero i nostri mezzi e la nostra disciplina potrebbero gareggiare con le nostre migliori truppe».
Purtroppo l'apprezzamento nei riguardi dei soldati italiani non risulterà sempre tanto benevolo nelle sue annotazioni ma risentirà anzi dei mutevoli aspetti della situazione, sia per una naturale tendenza ad attribuire l'insuccesso a difetto di esecuzione o a manchevolezze di esecutori, sia specialmente per la preoccupazione, prevalente nel suo stato maggiore, di salvaguardare di fronte alla storia il mito dell'invincibilità tedesca, caricando ogni fattore negativo sul conto dell'alleato.
Il 5 marzo spediva a Roma un primo rapporto sulle deficicmti condizioni dell'armamento italiano: « L'antiaerea è costituita da vecchissimi Skoda da 75 mm che risalgono alla guerra 1914- 18. Ho visto perfi no dei mortai di bronzo, antiquati già nell'esercito austroungarico. Gli aerei italiani sono logori e non vengono sostituiti; i piloti debbono fare miracoli. Gli apparecchi da ricognizione sono vecchi Caproni, inermi e lenti, micidiali solo per chi ci vola ... Gli aerosiluranti sono empirici e rudimentali. L'unica cosa viva è il valore ed il coraggio dei piloti: un nostro aviatore rifiuterebbe di volare con certi apparecchi che qui, a ragione, chiamano "casse da morto" ... ».
Una settimana più tardi tornava sull'argomento: « I fucili italiani si chiamano "modello 91" perché rimo n tano all'anno 1891. Gli italiani non possiedono mitra; i carri armati da 3 tonnellate sono semplicemente ridicoli >>.

Il 13 marz o faceva esplicitamente presente al Comando Superiore Forze Armate in A.S. che, per un redditizio impiego della Divisione « Ariete» nelle previste operazioni offensive, occorreva che entro lo spazio di quattro settimane la Grande Unità fosse attrezzata in maniera da avvicinarsi almeno all'efficienza di una division e corazzata tedesca.
Proponeva pertanto l'assegnazione di un gruppo di artiglieria pesante motorizzato da rso, l'assegnazione organica di un reparto esplorante corazzato, dotato di numerose autoblinde e di una squadriglia da osservazione aerea. Proponeva inoltre l'aumento del potenziale di fuoco del reggimento bersag lieri, da portare ad una brigata, e l'assegnazione di un battaglione zappatori e un battaglione collegamenti.
Il gen. Gariboldi rispondeva con la seguente lettera:
GovERNO
N. 01/2712 di pro t. Op. lì 16 marzo 1941 -XIX

Risposta al foglio n. 15-3-41 del 13-3-41.
Argomento: Composizione Divisione « Ariete».
Al Comando del Corpo Tedesco in Africa. Ufficio Opera zioni
Zona d' Operazt'one
La Divisione Corazzata « Ariete» è composta secondo l'organico stabilito dallo Stato Maggiore dell'Esercito, rinforzata di mezzi anticarro e di mitragliere contraerei.
Oltre al VII battaglione caHi M. 13, già in marcia, la Divisione riceverà fra qualche settimana un altro battaglione carri M. 13 in avanzata costituzione in Italia e i suoi carri leggeri saranno in gran parte armati con fuciloni anticarro.
Non sono in grado di assegnarle artiglierie di medio ·calibro tanto mobili da seguire la Divisione in marcia e nemmeno autoblindo. Se mi sarà consentito farlo in seguito, lo farò.
Fino allora, codesto Comando dovrà commisurare i compiti della Divisione alle sue possibilità di azione. A questo riguardo non ritengo conveniente aumentare le truppe autocarrate (bersaglieri) per non cambiare la fisionomia della Divisione e non appesantirla.
Circa l'aviazione da ricognizione e il servizio di aviocorriere siete a conoscenza di quanto ho disposto. In caso di operazioni offensive, l'aviazione da ricognizione sarà adeguatamente aumentata.
Infine i servizi sono stati commisurati alla forza della Divisione e alla necessità di un'adeguata autonomia. Soltanto se si rendesse necessario aumentare questa autonomia si potrà provvedere con particolari colonne di rifornimento e mezzi di sgombero.
Il Generale Designato d'Armata Comandante Italo
Garibaldi11 Comandante Superiore Forze Armate A.S. aveva in sostanza invertito i termini del problema: nell'impossibilità di procedere a un sostanziale potenziamento della Divisione, si imponeva la neces-
sità di commisurarne i compiti alla reale capacità d'azione. La saggia parola del gen. Gariboldi mette in luce una necessità purtroppo sovente trascurata del Comandante tedesco nel ca mpo dell'impiego e non soltanto nei riguardi della Divisione Corazzata ma più gene- J, ralmente per tutte le nostre sottili divisioni binarie: l'etichetta divisionale induceva facilmente a dimenticare la loro vera entità di semplici brigate miste.

Le forze tedesche e italiane occorrenti per la ripresa delle operazioni verranno precisate dal gen. Rommel in una relazione inviata a Berlino in data 20 marzo e trasmessa in copia al Comando Superiore F.A. A.S.I., di cui si riferirà più oltre. Può interessare tuttavia accennare fin d'ora , per una migliore comprensione della linea seguita dal gen. Rommel nella propria funzione di comando, al suo intimo pensiero sull'obi etti vo ultimo da raggiungere in Africa Settentrionale: « scopo di un'operazion e di attacco può essere solo il cuore dell'Egitto (Alessandria, il Cairo, Canale di Suez) ... >>.
Schie r a m ento de ll e forze i t a l o- tedesc h e alla da ta del 2 4 fe bbrai o 1941. (Schizzo
D'intesa con la parte ted esca, le linee generali della condotta della difesa erano state definite in base al criterio di schierarsi alla altezza di Sirte, in modo da costringere l'avversario ad attaccare con il deserto alle spalle, sotto la molestia continua della nostra
n. 1 ). av1azwne, partente dai vicini ca mpi dislocati fra Sirte e la region e di Misurata. In sintesi:
- posizione di arresto nella zona Sirte - Buerat- el H sun;
- linea prudenziale di raccolta: Homs- Tarhuna;
- se mplice vigilanza del campo trincerato di Tri poli;
- nucleo di protezione al Garian;
- normale copertura verso ovest;
- forze normali nel Sahara Libico , colonna autocarrata a Zella.
Da parte tedesca era stato preso l 'impegno di :
- bombardare quotidianamente. a iniziare dal 14 febbraio, le forze corazzate britanniche;
- portare forze aeree nei campi avanzati, Sirte co mpre sa;
- impiegare nel settore Sirte, appena sba rcati, i singoli reparti della 5a Di visione Leggera, usufruendo dei propri autocarri per il tra sporto;
- adottare per il trasporto della divisione di 2° scaglione il siste m a dei trasporti marittimi italiano, più rapido di quello usato dai ted eschi (allegato 11. 5).
In attesa che si perfezionasse il previsto pote nziamento dello scacchiere per la ripresa delle operazio ni, veniva assunto lo sc hieramento che qui so mmariamente si accenna e che risulta in mani era particolareggiata dallo schizzo n. 1 (Nostra situazione al 24 febbrai o 1941 ) :
Piazzaforte di Tripoli:
- Comando Superiore A.S. (gen. Gariboldi);
- Co m ando Tr uppe della Piazzaforte (gen. Spatocco) co n le Di visioni cc Brescia» e « Savo n a» e truppe de ll a Guardia alla Frontiera (G .a.F.) ;
- Comando Corpo T ede sco Africa (C.T.A.) (gen. Rommcl).
Caposaldo di Hom s:
- truppe della 10"' Armata, reduc i dalla Cire nai ca, agli ordini del comandante Divi sione << Sabratha » (gen. Della Bona).
Zon a Sirte- d Gheddaia:
-X Corpo d'Ar mata (ge n . Barbi eri) co n le Divisio ni << Pavia », « Bologna » e « Ariete », reparto caccia- carri tedesco e 16' raggruppam ento artiglieria, in corso di sbarco.
En Noftlia:
-g ru ppo es plorante tedesco, rinforzato da un nos tro nu cleo cele re , con ele menti spi nti in avanti, verso l'Arco dei F ileni.
Z ella e Hrm:
- presidi in corso di rinforzo (1).
Giarabu b, Cufra e Fe zza u :
- gli stessi presidi del dicembre 1940 (2).

( t) V. schizzo n. 1: dislocazione Forze Sahara Libi co.
(2) V. sch izzo n. 1 e pagg. 56 e 59·
Le Divisioni del X C.A. nella Sirtica erano così distribuite:
- Divisione « Pa via» (gen. Zaglio) rinfo rzata con elemen ti anticarro e contr aerei, immediatamente ad est e a sud di Sirte. Un distaccamento a Gars Bu Hadi , circa 20 km a sud di tale località. A cavaliere della rotabile era stato disposto un reticolato e un campo minato di circa 4 km; sul resto del fronte, per u no sviluppo complessivo di circa 10 km, erano in allestimento sistemazioni difensive e capisaldi;

- Divisione « Bologna >> (gen. Maggiani ) schierata a ca pisaldi fronte a sud lungo la rotabile ad ovest di Sirte, co n elementi celeri in esplorazion e fino all'Dadi T amet;
- Di visione « Ariete >> (gen. Baldassarre) a Buerat, con un distaccamento tra Buerat e il campo di aviazione di el T amet e un seco ndo distaccamento a el Gheddaia. In vista dell'impiego mobil e cui era des tin ata insieme alla s• Divi sione Leggera tedesca, era pe rò prevista la sua sostituzione co n la Divi sio ne « Brescia >> .
La co n sistenza num erica delle forze italiane in Libia alla data del 20 febbraio era di 5900 ufficiali e 123075 sottufficiali e truppa. Disponevano complessivamente di 5449 mitragliatrici, 1037 can noni, 209 carri armati e autoblindo. Per i trasporti disponevano di 7464 quadrupedi, 5270 automezzi ( di cui 1284 inefficienti) e 1714 motomezzi (di cui 424 inefficienti) (allegato n. 6).
La 5a Divisione Leggera tedesca, in corso di sba rco a Tripoli , aveva la seguente form azio n e: Comando Division e (gen. Streich); A 1(1,7, (A/1/(t J 1/ )/)O [1RR.I
1 gr up po esploran te (2 cp au tob lind o, r cp motociclisti , I cp. armi pesanti);
2 gruppi « caccia- car ri », ciascuno su 3 cp. di 9- 12 pezzi anticarro (da 50 o da 37 m m ): in totale 30 carri armati mod. 3, con carrello per il tr asporto in terreno sabbioso;
2 battaglioni m itraglieri motorizzati, con efficaci armi anticarro, 1 cp. pionieri per btg., tutti su automezzi bli nd ati; r gruppo misto contraereo (pezzi da 88 e da 37 mm);
15 colonne d i rifornimento.
La Divisione contava in totale 9300 uomini , 2000 automezzi, 1 1 I pezzi anticar ro.
All a stessa data del 24 febbraio le forze aeree italo- tedesche prese nti in Tripolitania assommavano a 231 apparecchi ( 151 i taliani e Bo tede sc hi) di cui 193 (113 italiani e So tedeschi) efficie n ti. Era pre-
vista l'affluenza di altre forze fino a un totale di 226 aerei italiani e 100 tedeschi.
L'aviazione poteva disporre in Libia dei seguenti campi:
- Bir Dufan (sud- ovest di Misurata) bene attrezzato ed efficiente: vi facevano scalo gli Stukas, dopo essersi riforniti di bombe a Trapani. I n via di allestimento un deposito sul posto;
- El Tamet e Sirte (campi avanzati): funzionamento come sede di piccoli reparti da caccia e da ricognizione italiani e come eventuale appoggio per formazioni italiane e tedesche;
- En Nofilia: io corso di organizzazione.
Erano inoltre in corso le predisposizioni per la sistemazione di reparti aerei italiani a Bir Dufan , Tauorga (sud di Misurata) e Misurata.
Per completare il quadro della situazione in Tripolitania dopo l'arresto della prima offensiva britannica si reputa interessante riportare i dati relativi alle scorte viveri , derrate, carburanti e lubrificanti per esigenze militari alla data del 20 febbraio 1941 , quali risultano dal grafico compilato dal Ministero dell'Africa Italiana nel mese di marzo dello stesso anno (allegato 11. 7). Tenendo conto delle più che limitate risorse locali, ne risulta con chiara evidenza la stretta dipendenza non soltanto della capacità operativa delle unità ma persino della vita stessa degli uomini, dal flusso dei rifornimenti dalla madrepatria, per la via di comunicazione mediterranea.
Sc hi eram ento e co n sist en za f orze britan nich e a fin e f ebb raio
19 4 1. (Schizzo n. 2 ).
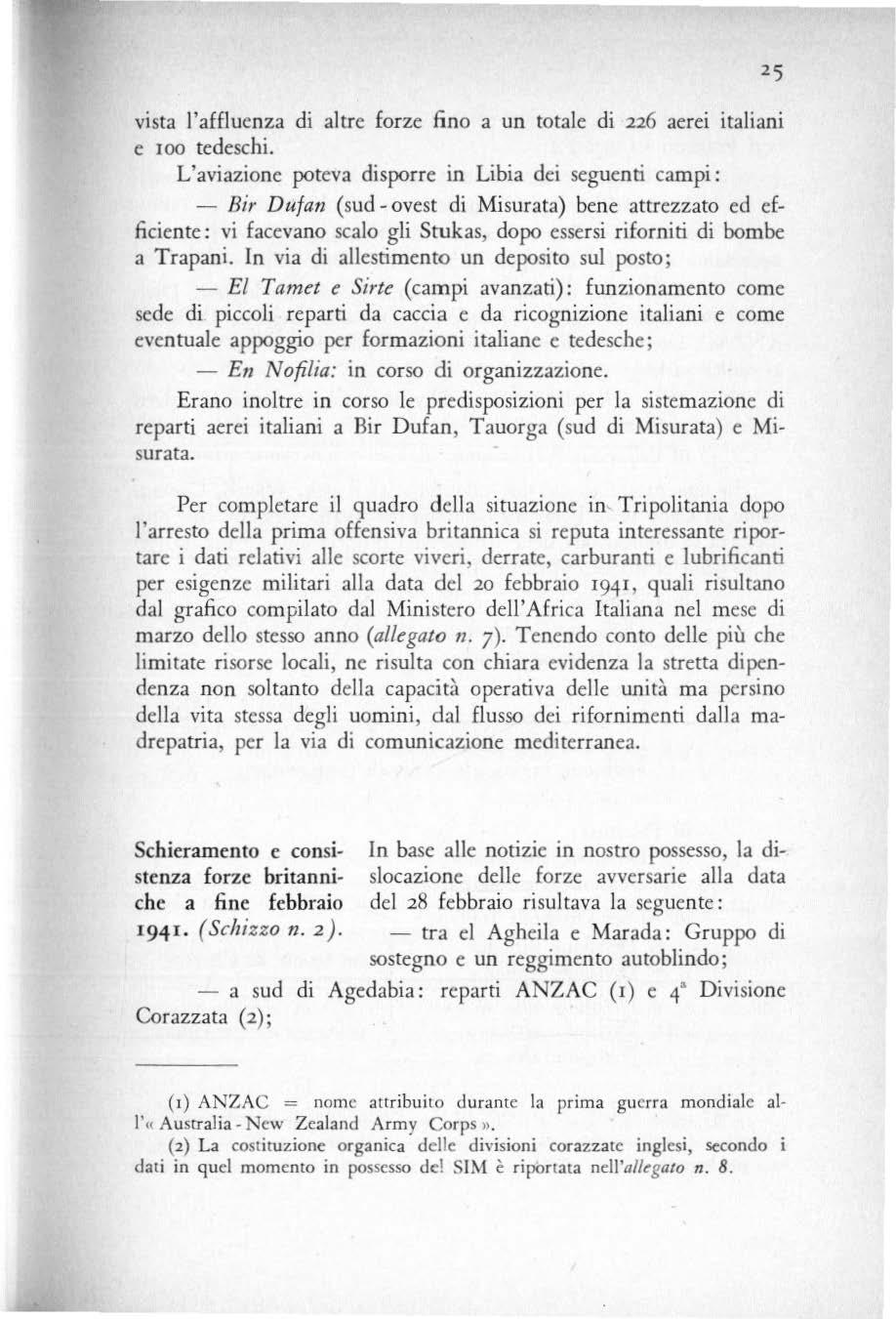
In base alle notizie in nostro possesso, la dislocazione delle forze avversarie alla data del 28 febb r aio risu l tava la segue n te:
- tra el Agheila e Marada: Gruppo di sostegno e un reggimento autoblindo;
Corazzata (2); di Agedabia: reparti ANZAC (1) e 4" Divisione
- a sud
(r) ANZAC = nom e attribuito durante la prima guerra mondiale all' (( Australia - Ncw Zealand Army Corps »
(
2) La cost ituzione organica del le divisioni corazzate inglesi, secondo dati in quel momento in possesso dd SIM è riportata n. B.
- nel sud Bengasino: 7" Divisione Corazzata e Brigata « Liberi Francesi » (un btg.);
-tra Bengasi e Derna: 2 ° Corpo ANZAC (due D ivisioni);
- a Tobruch : reparti i mpr ecisati;
- a Bardia e Marsa Matruh: 6" Divisione inglese, Divisione neozelandese, Divi sio ne anglo- i ndian a, Divisione polacca;
- nella zona del D elta: D ivisione Corazzata inglese, Divisione Motorizzata inglese « London », Divisione inglese, Divisione ANZAC, Divisione i ndiana, Divisione neozela nd ese, elementi di nazionalità varia;
- nella zona del Canale: D ivisione anglo- indiana, reparti inglesi imprecisati vari;
- in P alestina: 81 Divisione inglese, 1 Divisione australiana.
In una sua relazione del se ttembr e '41 il gen. Wavell, Comandante in Capo delle Forze Britanniche del Medio Oriente, così prospettava la dislocazione dell e truppe alla propria dipendenza, al termine della prima offensiva in A.S. (I):

- in Cirenaica:
.
1 Division e Corazzata;
6• Divisione australiana;
.
-in E gitto :
2 3 D ivisio ne Corazzata;
r• D ivisio ne n eozelandese;
6.. Di visio ne inglese (in corso di formazi o ne);
I a brigata polacca;
- in P alestina:
.
1 Di visione australiana;
9" D ivisio ne australiana;
.
- in Africa Orientale Italiana:
4" Divi sio ne indiana
s• Divi sione indiana
r "' Divisio ne sud- af ri cana
u • Divisio ne africana
12• D ivisione africana
} sul fronte di Ch er en nello scacc hiere Giub a
(x) Re lazione del gen. Wavell sulle ope raz ioni nel Medio Oriente, trasmessa in data 5 sette mbr e 1941 al Segretario di Stato per la Guerra, pubblicata nel Supplemento di cc Th e Londo n Gaz ettc » del 2 luglio 1946.In merito all'efficienza di queste unità il gen. W a veli faceva presente che :
- la 7" Divisione Corazzata, dopo otto mesi di attività operativa , era meccanicamente incapace di muovere ulteriormente e doveva pertanto essere momentaneamente considerata non disponibile come unità combattente;
- la 2 • Divisione Corazzata, giunta dal R eg no Unito il r '' gennaio, si componeva di due reggimenti carri pesanti « Cruiser», due reggimenti carri leggeri e un gruppo sostegno;
- delle tre Divisioni australiane, la 6• aveva preso parte alla intera campagna cirenaica ed era quindi agguerrita: era co mplet amente equipaggiata e non aveva sofferto gravi perdite. La t era ancora in corso di organizzazione e la 9", arrivata di recente, era assai deficiente di materia le;
- la Divisione n eozelandese era bene addestrata ed equipaggiata;
- la 6• Divisione inglese, addestrata per operazioni di sbarco co ntro il Dodecaneso italiano, mancava di artiglieria e delle armi di accompagnamento;
- la Brigata polacca non era al completo di material i.
Contrastanti indicaz io- Alla fine di febbraio si era ancora incerti, ni su g li orien tam enti o p erativi b ritannici.
da parte italiana, sui propositi operativi dell'avversario: se cioè intend esse proseguire l'offensiva, mirando alla conquista dell'intera Lib ia. Erano trascorse alcune settimane di inattività, dopo le ultime azioni nel sud bengasi no ma questo non costituiva una sicura indicazione poiché il Comando britannico aveva già dato prova di curare estremamente la preparazione logistica di ogni successivo atto offensivo, anche a scapito della continuità. La rapida sostituzione dei reparti più logorati nell'avanzata e l ' intenso afflusso di materiali ri levato dai nostri organi informativi, potevano avvalorare l'ipotesi di una prossima r ipresa offensiva che d'altronde doveva risultare allettante, oltre che per la legge dello sfruttamento del successo, anche per la prospettiva del congiun gimento con le simpatizzanti guarnigioni del Nord Africa francese. Contro questa ipotesi si doveva però tener conto delle gravi difficoltà d'ordine logistico (e conseguentemente anche operativo) di
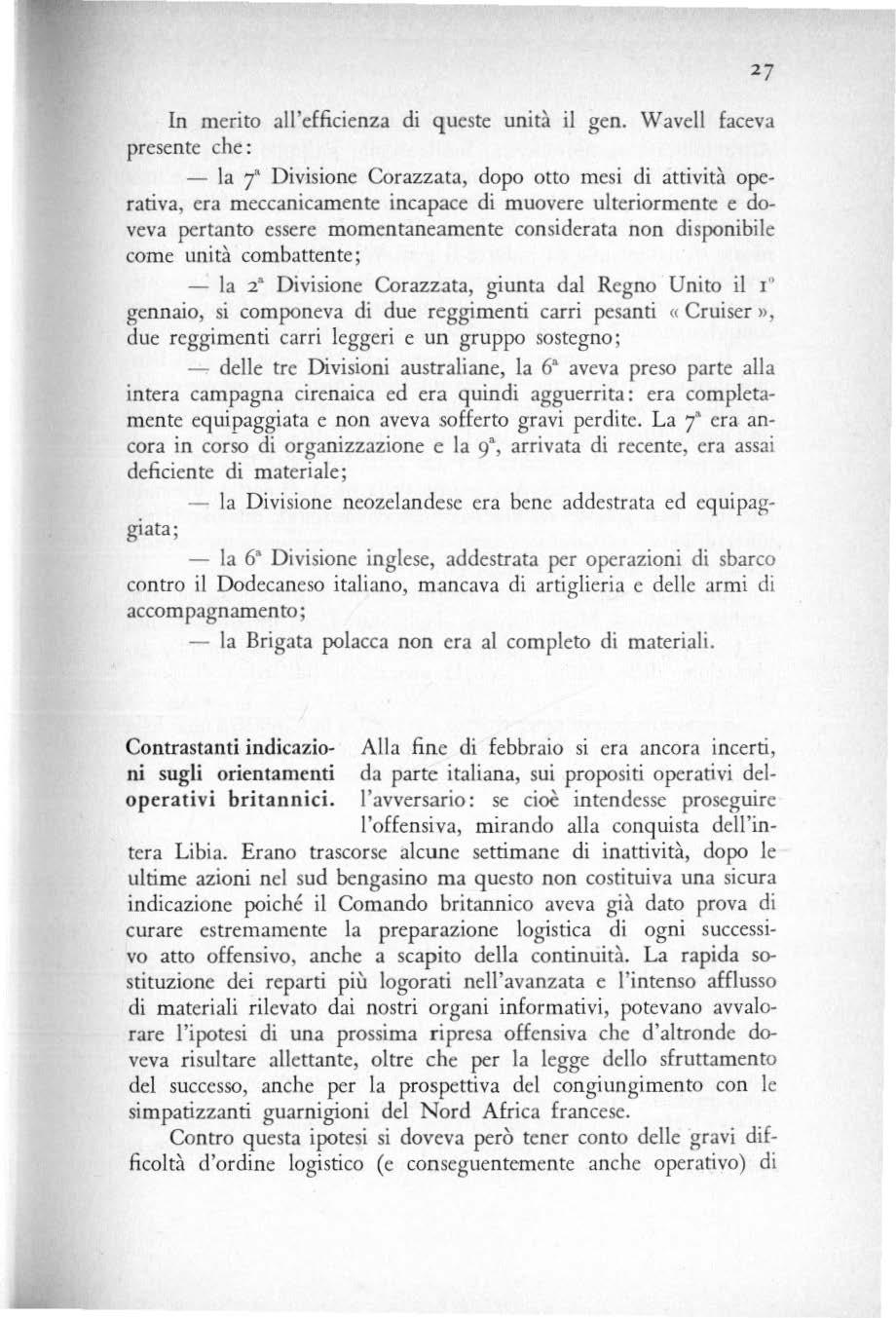
una sollecita ripresa offensiva a tanta distanza dalle basi di partenza. Altre indicazioni provenivano inoltre dallo sviluppo degli avvenimenti nel Vicino Oriente che andavano assumendo carattere palesemente preoccupante. L'incombente minaccia, ormai chiaramente percettibile, delle forz e tedesche nell'Egeo doveva essere indubbiamente di natura tale da indurre il gen. Wavell a considerare sfav orevolmente un maggior impegno delle propr1e forze verso ponente, nel momento stesso in cui forse l'apertura di nuovi fronti poteva co mpromettere il dominio del Mediterr aneo Orientale.
Il notevole movimento di navi n ei porti di Tobruch e di Bengasi dimostrava bensì che il Comando britannico stava provvedendo a portare avanti le principali basi logistiche ma il fatto non costituiva una prova determinante né per l ' una né per l'altra ipotesi.
Il gen. Wavell considerava a sua volta improbabile una ripresa offensiva delle forze dell'Asse prima della m età di aprile. Ritene va anzi che non potesse verificarsi prima del maggio, quando le sue unità dislocate in Cirenaica avrebbero ormai raggiunto un considerevole grado di co nsolidamento (1).
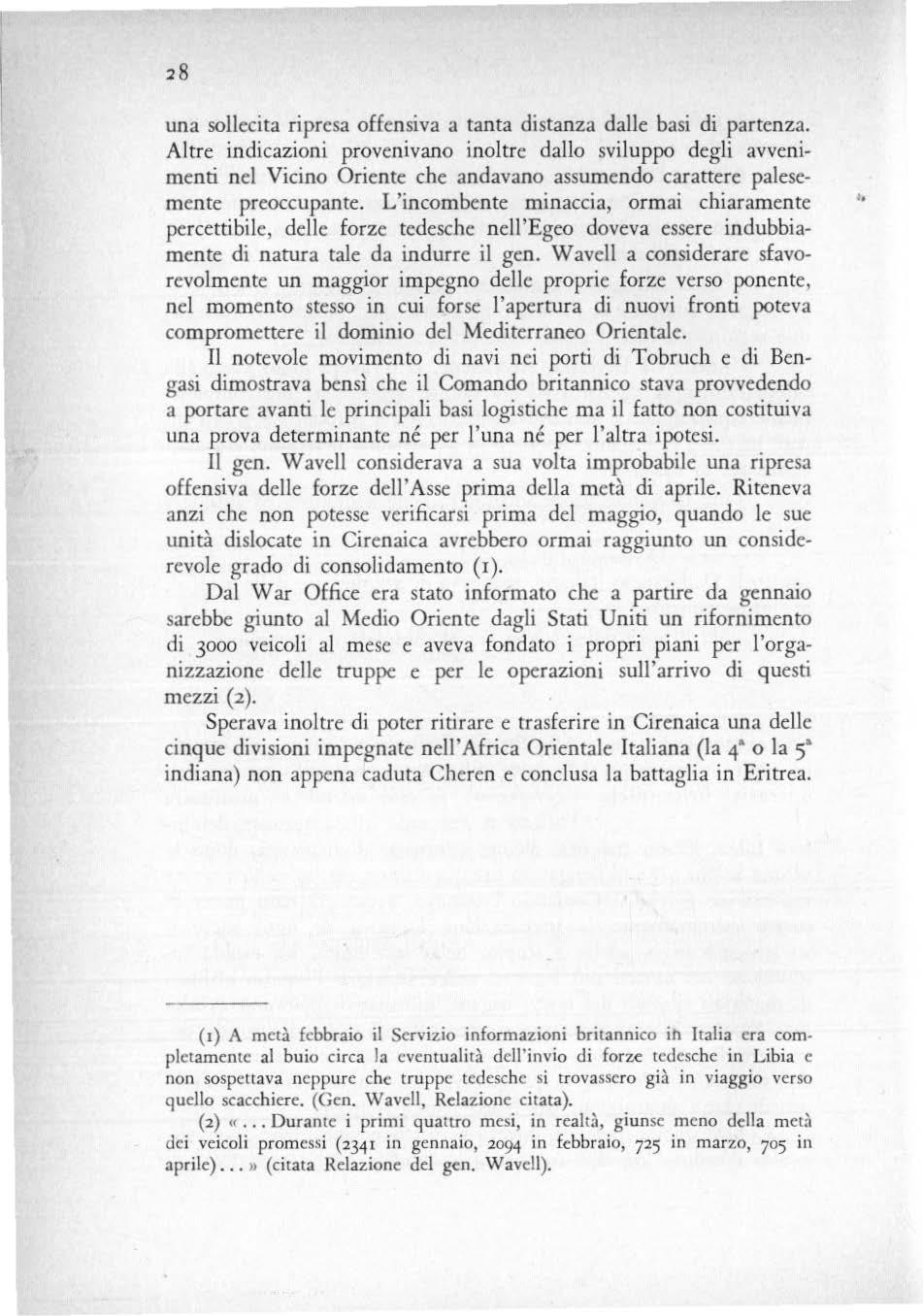
Dal War Offìce era stato informato che a partire da ge nnaio sarebbe giunto al Medio Oriente dagli Stati Uniti un rifornimento di 3000 veicoli al mese e aveva fondato i propri piani per l'organizzazione delle truppe e per le operazioni sull'arrivo di questi mezzi (2).
Sperava inoltre di poter ritirare e trasferire in Cirenaica una delle ci nque divisioni impegnate nell 'Africa Orientale Italiana (la 4• o la s• indiana) non appena caduta Chercn e concl usa la battaglia in Eritrea.
(1) A metà febb raio il Servizio informazioni britannico itl ltaHa e ra completamente al buio circa la eventualità dell ' invio di forze tedesche in Libia e non sospettava neppure che truppe tedesc he si trovassero già in viaggio verso quello scacchiere. (Gen. Wavell, Relazione citata).
(2) << ••• Durante i primi quattro in realtà, gi un se meno della m età dc i veicoli promessi (2341 in gennaio, 2094 in febbraio, 725 in marzo, 705 in aprile) » (citata Relazione del gen. Wavell).
Varianti nella dipend en za e ne ll o schieram ent o de lle uni tà ital o - tedesche nel la prima metà di marzo. Occup az ion e di M arada.
(Schizzo 11. 3).
Il 7 mar zo la D ivisione Corazzata « Ariete >l passava di fatto alle dipendenze d'impiego del Comando d el Corpo Tedesco in Africa. n giorno 9 raggiungeva la nuova dislocazio n e ad est di En Nofilia, dietro alla 5' D ivisione Leggera. Questa era raccolta n ella zona di Arco dei Fileni ed aveva distaccato il 33° gruppo caccia- ca rri, insieme al nucleo celer e italia no Santamaria, a sbarra m en to della stretta di Mugtaa, lim i t ata a sud dalla Sebca Chebira (1).
Il 10 marzo veniva costituito un Ufficio di Collegamento presso il Comando del C.T.A. con a capo il gen. Calvi di Bergolo. Lo stesso giorno il gen. Rommel informava verbalmente il gen. Gariboldi del proposito di creare una più favorevole situazione per la progettata offensiva: si trattava di assicurarsi il possesso della strada el Agh ei la- Marad a quale base di partenza per l'attacco.

In realtà egli aveva già dato, il giorno precedente, disposizioni in tal senso alla 5' D ivisione L eggera e alla Divisione « Ari ete » : si av rà occasio n e di constatare come questo procedimento di decisione autonoma, senza il preventivo consenso del Co m ando Superiore, posto così sovente di fro n te al fatto co m piuto, non costituirà affatto un'eccezione nel sis tema di comando del gen. Rommel. Premesso che la zon a di Agh eila doveva essere consi d erata come una base di esplorazione, i compiti fra le due Grandi Unità erano stati così ripartiti:
- alla s• Divisione Leggera: riconoscere il campo di ba tta glia sulla linea el AgheilaMn Giofer, allo scopo di assicurare la prevalenz a della nostra esplorazione terrestre;
. occupare M arada con un reparto di co m battimento rinforzato italo- tedesco (2);
. tenere sotto osservazione la pista M n Giofer- Marada, rend endola sicura m e diante continua attività esplorativa;
(x) Scbca = stagno, pa l ude sal ina.
(2) 11 reparto inviato a di M::trada comprendeva: una compagnia di formazione su Lre plotoni con armi an t icarro da 37• mitragliere c fuciloni da 20 mm. ; una sezione contraerei da 20 mm.; una batteria da 75 / 27; una sez io ne radio, un nudco automezzi e servizi
assicurare la difesa della postzwne principale, ad ovest di el Agheila, con il sostegno di una forte riserva mobile, destinata a reagire controffensivamente ad ogni tentativo di aggiramento da sud;
- alla Divisione « Ariete » : tenersi pronta con il grosso sulle posizioni di B. el Haddadia- B. Gahela per impegno offensivo in direzione sud - est od est;
. sistemare a difesa la zona assegnata verso sud e sud - est, sulla linea: q. 91 di B. Scemmer - q. n8 di Oglet ed Dornran - q. 100 di B. el Mueinia.
La ricognizione aerea doveva agire in stretta collaborazione con le unità esploranti terrestri.
Il 13 marzo Marada veniva occupata da un reparto misto ita1otedesco, senza entrare in contatto con l'avversario. Lo stesso giorno il gen. Rommel trasferiva il proprio Comando a Sirte. Il 16 marzo il Comando del Campo Trincerato di Tripoli assumeva la denominazione di Comando XX Corpo d'Armata, conservando le attribuzioni e la giurisdizione in atto.

Nel periodo qui considerato la situazione militare in Libia si inquadra nella più vas ta cornice del Teatro di Operazioni M editerraneo. Converrà pertanto procedere a una rapida rassegna degli avvenimenti in Grecia, Bulgaria e Jugoslavia, sullo sfondo dell'ampio panorama strategico di cui sono parte integrante. Si accennerà inoltre alla situazione aero - navale del momento nel Mediterraneo, come elemento essenziale dell'attività operativa in A.S. e infine agli eventi de Il' Africa Orientale Italiana nel primo trimestre del 1941, i nteressanti per l'indiretta connessio ne che ne risulta con la disponibilità di forze britanniche per il Medio Oriente.
Evoluzione del rapporto russo-germanico.
Occorre risalire alle origini degli attriti e dei reciproci sospetti che n el corso del 1940 si era no andati sviluppando fra i due eterogenei contraenti del Patto firmato a Mosca il 23 agosto 1939, alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale, strumento fondamentale e in dispensabile dell'iniziativa bellica della Germania.
Nel giugno 1940, m entre le forze tedesche erano im peg nate a fondo nella campagna di Francia, l'Unione Sovietica aveva proceduto all 'occupazion e della Lituania, seguita da quella dell'Estonia e della Lettonia. Nel P rotocollo Segreto allegato al Patto, la L ituania, confi nante con la P russia Orientale, era stata inclusa nella sfera d ' infl uenza tedesca: l'unilaterale decisione n on poteva non provocare il risentimento di H itler.
Il 26 giugno da Mosca era stato lanciato un ultimatum alla Romania : si esigeva la restituzione della Bessarabia e la cessione della
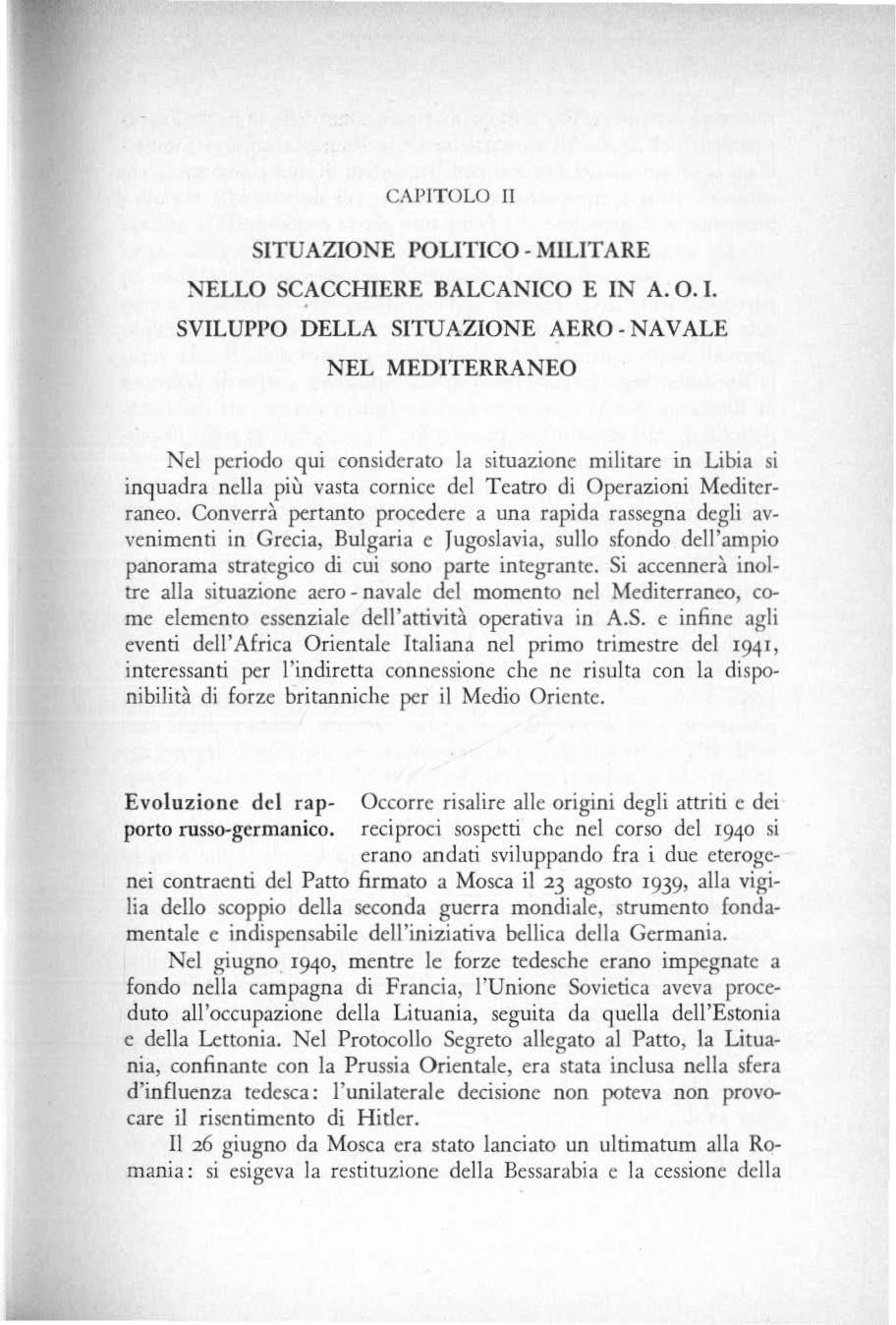
Bucovina settentrionale, a titolo di riparazione delle i n gius t e appropriazioni del 1918. All'accettazione della Romania seguiva l 'i mmediata occupazione dei te r ritor i con il risultato di una palese min accia co ntro i vicini campi petroliferi romeni la cui disponibilità era asso- :. lutamente indispensabile alla Germania per la co ndotta della guerra.

L a reazione di Berlino non si fece attendere. Dopo poche se ttiman e venivano rinforza te le truppe di occupazione della Polonia, particolarmente nella regio n e sud- orientale, co n 2 divisioni corazzate e I O divisioni di fanteria fatte affluire dall'Occidente: un valido ammonime nto contro eve n tuali vellei t à aggressive della R ussia verso la Romania. Seguiva poi l'invio di un con sistente corpo di sicurezza in Romania, per la diretta protezione (specie contraerea) dei pozzi petrolife ri , così dalle offese russe come da eventuali attacchi britannici, prove ni enti d all e basi del Medio Oriente (Creta, Cipro)
In quest 'a tm osfe ra di sospetti e di risentimenti cominciava a prender corpo , in settembre, l'idea dell'aggressione all'U nione Sovietica, con obiettivo l'annientamento dell'Armata Rossa.
E' del I8 dicembre la direttiva del Fi.ihrer: « ... le Forze Armate tedesche debbo no tenersi pron te ad annientare la R ussia nel corso di una rapida campag n a, prima della fi n e della g u erra co n l'Inghilterra ... ».
Mentre negli uffici dell' OKW si lavorava già intensamente alla preparazione del colossale piano della campagna, conver sazioni diplomatiche venivano co n dotte fra i due Governi, senza risultati concreti, allo scopo soprattut to di ma sc herar e i segreti intendime nti aggressivi. Al termin e di co lloqui svoltisi il IO dicembre a Berlino con Molotow, il comu ni cato finale parl ava di cc scambio d'idee, svoltosi in un'atmosfera di reciproca fiducia » che aveva condotto cc alla reciproca compre nsione di tutte le importanti questioni che interessano la G ermani a e l'U n ione Sovietica >>. In realtà, dalle dichiarazioni dei partecipanti tedeschi risulta che la Russia si era mostrata prope n sa a sottoscrivere il Patto T ripartito. Ad un acce nno ad un eventu ale i nterve nto germanico nei Balcani in appoggio dell'Italia, senza sollevare obiezioni, Molotow aveva contrapposto lo sta bilimento di un ' influenz a r ussa in Bul gar ia , analoga a quella . tedesca in Romania. I tedeschi avevano l asciato cadere la cosa.
In quanto alla « reciproca fiducia » è molto sig nificativa la segue nte disposizione che figura nella Direttiva n. 18 di H itler, in data 1 2 dicembre:
cc Si è proceduto all'avvio di conversazioni politiche co n l'obiettivo di chiarire quale sia l'atteggiamento della R ussia per l'imme-
diato futuro. Indipendentemente dai risultati di queste conversazioni tutti i preparativi per l'Est in merito ai quali sono già state date precise istruzioni verbali saranno continuati» (1).
Non risulta che la Russia coltivasse analoghe velleità offensive, almeno a breve termine.
L'attacco italiano alla G recia, nell'ottobre 1940, era riuscito particolarmente sgradito a Hitler in quanto in contrasto con il proprio programma di pressioni sui paesi balcanici che considerava compresi nella sfera d'influenza della Germania.

L'insuccesso militare italiano induceva poi Hitler ad intervenire direttamente, non tanto o non solo per l'opportunità di sostenere l'alleato fascista quanto per l'assoluta necessità, in vista di una campagna dell'Est, di eliminare i n via preliminare il pericolo che gli Alleati, accorrendo in soccorso dei Greci e stabilendosi solidamente in Macedonia, potessero rappresentare una grave minaccia alle spalle delle armate destinate ad operare contro la Rus sia. Era ancora vivo il ricordo della vitale funzione di Salonicco nella fase risolutiva della prima guerra mondiale. Si può pertanto affermare che non fu il fatto materiale dello sbarco inglese in Grecia a provocare l'azione tedesca nei Balcani ma la preoccupazione che questo potesse avvenire.
Era nato così il piano di operazioni, tendente ad assicurare il possesso della costa della Tracia meridionale, fra Salonicco e Dede Agac (Adrianopoli).
La 1 2 • Armata tedesca (gen. List) che disponeva di un Gruppo Corazzato (gen. Kleist) doveva entrare in Bulgaria e attaccare la Grecia sulla cosiddetta « linea Metaxas », naturalmente forte e robustamente organizzata, per aprirsi poi con le due al i, rispettivamente, su Salonicco e su Dede Agac.
Accadd e poi che alla vigilia della data stabilita si verificasse un colpo di stato a Belgrado, che portava a coinvolgere nel conflitto anche la Jugoslavia, contro le precedenti previsioni di neutralità, imponendo una immediata correzione del piano iniziale. Il Gruppo Corazzato Kleist della 12" Armata veniva immediatamente fatto convergere verso Belgrado, mentre si improvvi sava la costituzione di una 2• Armata (gen. v. Weichs) che penetrava in Jugo slavia dal Nord. Contemporaneamente si sollecitava il concorso attivo dell 'Italia.
La situazione 1n Dopo la controffensiva greca del gennaio Grecia 1941 che aveva portato l'avversario a Klysura, il fronte greco- albanese appariva momentaneamente stabilizzato.
A m età gennaio 1941 , in seguito ad ordine del War Cabinet, il gen . Wavell si recava ad Atene per trattare l'invio di forze corazzate, artiglieria da campagna, artiglieria anticarro e cannoni contraerei a sostegno della difesa di Salonicco e della Macedonia, contro un'ormai prevedibile aggressione tedesca. L'offerta fu declinata perché il Governo greco temeva che lo sbarco di truppe britanniche in territorio ellenico potesse provocare l'intervento tedesco, prima ancora che si fosse in grado di fronteggiarlo.

La morte del Primo Ministro greco, gen . Metaxas, avvenuta il 29 gennaio, veniva a mutare sostanzialmente l'atteggiamento prudenzial e del Governo d'Atene. L'8 febbraio all'indomani cioè della conclusione della prima offensiva britannica in Cirenaica, il nuovo Governo chiedeva agli Inglesi di preci sare l'aiuto che il Comando delle Forze del Medio Oriente avrebbe potuto fornire in caso di attacco tedesco.
Il Ministro degli E steri del R egno Unito (Eden) si recava immediatamente ad Atene con il Capo dello Stato Maggiore Generale (ge n. Diii), il gen. Wavell e il generale di armata aerea Longmore e il 23 concludeva un accordo per il quale il Governo greco accettava il concorso britannico, nella misura ed alle condizioni propostegli. Si trattava dell'invio di una brigata corazzata, tre divisioni di fanteria e un a brigata indi pendente che avrebbero dovuto affluire in Grecia seco ndo la seguente successio n e:
- 1" Brigata Corazzata (della Div. Cor.), dall'Egitto;
- Division e di Fante ria neozelandese, dall'Egitto;
- 6.. Divisione di F a nteria australiana: dalla Cirenaica;
- Brigata Autonoma polacca, dall'Egitto;
- t Divisione di Fanteria australiana, dalla Palestina.
Il trasferime nto aveva inizio il 5 marzo e il primo scaglio n e sbarcava al Pireo il giorno 7· Era composto dal 4° regg. Ussari (carri leggeri), 3o regg. carri « Cruiser », 2 " r egg. artiglieria pesante, Ussari del Northumberland (anticarro), 3o sq. genio del Geshire e btg. motorizzato « Rangcrs >>.
Il successivo scaglione (Divisione n eozeland ese) giungerà nella terza d ecade di marzo. All ' atto dell'aggressione tedesca alla Grecia
dalla Bulgaria (6 aprile) la 6" Divisione australiana si troverà ancora in corso di affluenza e il movimento della Brigata polacca e della 7" Divisione australiana verrà sospeso.
Gli avvenimenti in Bulgaria. Ripercussioni in Turchia.
Ai primi di febbraio una crescente propaganda comunista tentava di ostacolare a Sofia l'avvicinamento della Bulgaria alla Germania e spingeva alla conclusione di un patto di mutua assistenza con l'U.R.S.S. Tale propaganda, efficacemente neutralizzata dalla diplomazia tedesca, non sortiva l'effetto sperato.
Di fronte ai progetti operativi tedeschi Re Boris sollevava seri dubbi in merito al contegno della Jugoslavia, nonostante l'esistenza di un patto di non- aggressione fra i due paesi. La Jugoslavia era in condizione di esercitare una seria minaccia sul fianco dell'attacco e la situazione interna del paese non consentiva di considerare con molto affidamento le assicurazioni del regime attualmente al potere, esercitato dall'avversata reggenza del principe Paolo. La Germania riusciva tuttavia a vincere le esitazioni: il I 0 marzo la Bulgaria aderiva al Tripartito e autorizzava ringresso di truppe tedesche nel proprio territorio che seguiva l'indomani, cinque giorni prima dello sbarco del primo scaglione britannico al Pireo.

Il r8 febbraio veniva pubblicata a Sofia e ad Ankara una dichiarazione comune turco - bulgara che assicurava l'astensione da qu alsiasi aggressione e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato fra i due paesi, in una atmosfera di reciproca fiducia.
Nella terza decade di marzo il Primo Ministro turco Saragioglu veniva convocato dagli inglesi a Cipro. L'incontro era stato preceduto da uno scambio di messaggi tra il Presidente Ineonu e Hitler in seguito ai quali Saragioglu doveva dichiarare che l'intervento della Turchia nel conflitto era impossibile, per insufficiente preparazione bellica, anche nel caso di aggressione tedesca alla Grecia.
Gli avvenimenti tn Jugoslavia.
L'inattesa adesione della Bulgaria al Patto Tripartito aveva destato grande impressione in Jugoslavia, già agitata in seguito al viaggio compiuto il 13 febbraio dal Presidente Zvetkovic a Bercbtesgaden, che aveva reso evidente l'inizio di una politica di adesione all'Asse e in seguito alla firma del patto turco- bulgaro.
L'ambiente militare, antitaliano e an ti tedesco e filobritannico, traeva vantaggio dalla nostra situazione di crisi in Africa e in bania per opporsi alle pressioni germaniche. Misure militari biamente dirette contro l'Asse erano state adottate negli ultimi pi, in netto contrasto con l'orientamento dei circoli politici sa bili.
Il 25 marzo la Jugoslavia firmava l'adesione al Tripartito ma due giorni dopo, alla vigilia del progettato attacco tedesco alla eia, gli elementi militari contrari all'Asse effettuarono un colpo di stato, deponendo il reggente principe Paolo e portando sul trono il principe Pietro, ancora minorenne. Il potere veniva assunto da un Governo di concentrazione capeggiato da Simovic, favorevole ghilterra. Come già accennato, la Germania decideva mente di procedere all'invasione del territorio jugoslavo, non appena pronte le truppe e i mezzi necessari: forze tedesche e italiane vano la frontiera, rispettivamente il 6 e il 7 aprile.

Situazione nava- La presenza dell'aviazione tedesca nel le nel Mediterraneo . diterraneo, dal gennaio 1941, era valsa mediatamente a limitare la libertà d'azione dell'Inghilterra in quel mare.
A parte i danni provocati alla portaerei « Illustrious », l'attiva presenza della Luftwaffe rendeva insicure le rotte verso le basi del Vicino e Medio Oriente, costringendo i convogli britannici destinati a portare rifornimenti e rinforzi in Egitto a compiere l'intero plo africano, con l'aggravante di trovare all'arrivo il Canale di Suez minato. La comunicazione diretta attraverso il Mediterraneo tava rischiosa anche per il passaggio di convogli occasionali.
Contemporaneamente, i sistematici bombardamenti su Malta mitavano anche le possibilità offensive britanniche ai danni dei vogli italiani verso la Libia. Ai primi di febbraio forze aeree sche erano state distaccate, come già visto, dalla Sicilia in A.S. ed una delle loro prime imprese era stato il minamento del porto di Tobruch. Anche il porto di Bengasi era stato ripetutamente bardato e minato.
Alla fine di marzo, nel corso di un'operazione che rientrava nel ciclo di attività navale contro i rifornimenti britannici per la Grecia, si verificavano due scontri di nostre forze navali con unità della flotta britannica: uno nelle acque dell'isolotto di Gaudo, a sud di
Creta, punto di transito dell'intenso traffico di uomini e di materiali in quel momento in atto fra l'Egitto e la Grecia; l'altro allargo di Capo Matapan, estrema punta meridionale della Grecia. Nella battaglia di Capo Matapan avevamo riportato gravi perdite: la nave da battaglia << Vittorio Veneto » danneggiata, tre incrociatori da ro.ooo tonnellate e due cacciatorpediniere affondati (con la perdita di quasi 3000 uomini), una torpediniera colata a picco in seguito ad urto contro una mina, due mezzi da sbarco tedesco silurati.
La dura sorpresa sofferta dalla nostra Marina a Matapan è da attribuirsi, oltreché al pieno dominio del cielo da parte dell'aviazione inglese nel Mediterraneo Orientale (r), alla efficacia del radar, il nuovo prezioso mezzo tecnico di cui erano dotate le navi avversarie (2).
Nel bilancio complessivo dello stesso ciclo operativo navale avevamo potuto segnare al nostro attivo l'affondamento di due incrociatori ( « Bonaventura » e « York ») e di quattro piroscafi inglesi, provocato negli stessi giorni e nella stessa zona da nostri sommergibili e mezzi d'assalto.
L e oper azioni in Afri- Dopo 55 giorni di aspri combattimenti, il 27 ca Orienta le I taliana. marzo, si concludeva nello scacchiere nord dell'Africa Orientale Italiana la battaglia di Cheren che decideva delle sorti dell'Eritrea e, sostanzialmente, di tutta l'A.O.I. (la Somalia, con Mogadiscio, era stata occupata dalle forze britanniche fino dal 26 febbraio).
(1) !'\ella •• Storia della guerra nel Mediterraneo >> (1940- 43) dell'amm. Bcrnotti - Ed. Vito Bianco, Roma, 196o - si afferma (pag. 154): « Le cause del disastroso insuccesso dell'operazione tentata dalla Marina italiana si compendiavano essenzialmente nella mancanza della cooperazione aero- navale, benché sia fuori dubbio che da parte dell'aviazione i taliana e tedesca fu messo il massimo impegno per agire in conformità degli accordi prestabiliti. Ma era un problema insolubile il coordinamento della ricognizione e della protezione aerea fra un'aviazione operante da basi lontane ed una forza navale che agiva nella zona di predominio aereo del n emico. Anche se le condizioni meteorologiche non avessero contrastato l'intervento delle aviazioni dell'Asse, nella 1.ona di Creta non sarebbe riuscito il concorso aereo ad una forza navale che doveva manovrare con piena libertà di moviment i, in relazione al contrasto strategico e tattico con le forze navali nemiche>> .
(2) La flotta inglese era munita di radiotelemetri che consentivano il tiro di notte. Tale mezzo in Italia era noto soltanto teoricamente e la sua realizza -

Questi avvenimenti rendevano libero l'afflusso dei rifornimenti britannici all'Egitto per il Mar Rosso, turbato solo, nell'ulti m o tratto, dagli attac chi aerei tedeschi sul Canale di Suez, soggetto anch e all'azione di minamento.
Contemporaneamente il Comandante in Capo delle Forze Britanniche del Medio Orie nte poteva prend ere in considerazion e il r icupero di alcune grandi unità, disponibili per l ' impiego in Afr ica Settentrional e.
Valutazione britannica d ella situazione politico - militare generale.
Da parte britannica la si tuazione politicomil itare generale alla fine di marzo veniva così sintetizzata:

- com pleta ripresa dai rovesci subiti n ella battaglia delle Fiandre ;
- sco nfitta dell'aviazione tedesca nella grande battaglia aerea d'I nghil terra e aggiornamento del piano d'i n vasio ne dell 'isola;
- neutralizzazione della potenza naval e italiana nel Mediterraneo;
- co nquista della Cirenaica, dopo anni entamento di un 'armata e dell'aviazion e italiana in A.S.;
- isolamento dell'A.O.I. e progressivo sgretolame nto delle locali forze d'occupazione italiane;
- consolidamento delle forze imperiali, grazie allo sviluppo d ell'attrezzatura industriale e della produzion e bellica, con largo appoggio americano.
Si riteneva infine ch e i nuovi impegni tedeschi nei Balcani av reb bero reso m eno probabi le l ' attuazione del piano d'i n vasione del l 'isol a.
zione pratica formava oggetto di st udio: << Dal 1935 gli studi per gli appar ecchi radar furono intrapres i presso l'Istituto El ettron ico d eli ' Accademia Naval e di L ivorno ma per le co ndizioni d'inferiorità nel campo industr iale la re alizzazione di questi importanùssimi strumenti non poté riuscire tempestiva. (Arnm. Berno tti: ope ra citata, pagg. 9 c 27).
P ot e n z iamento della Il 3 marzo, m entre Mussolini co n il geneLibia. rale Cavallero si trovavano in Albania, il gen. Guzzoni, Sottocapo. di Stato Maggiore G enerale e Sottosegretario alla G uerra, riuniva a Ro m a i tre Capi di S.M. delle Forze Armate per esporre i prevedibili sviluppi del conflitto con la Grecia, che si riteneva ormai in fase di risoluzione.
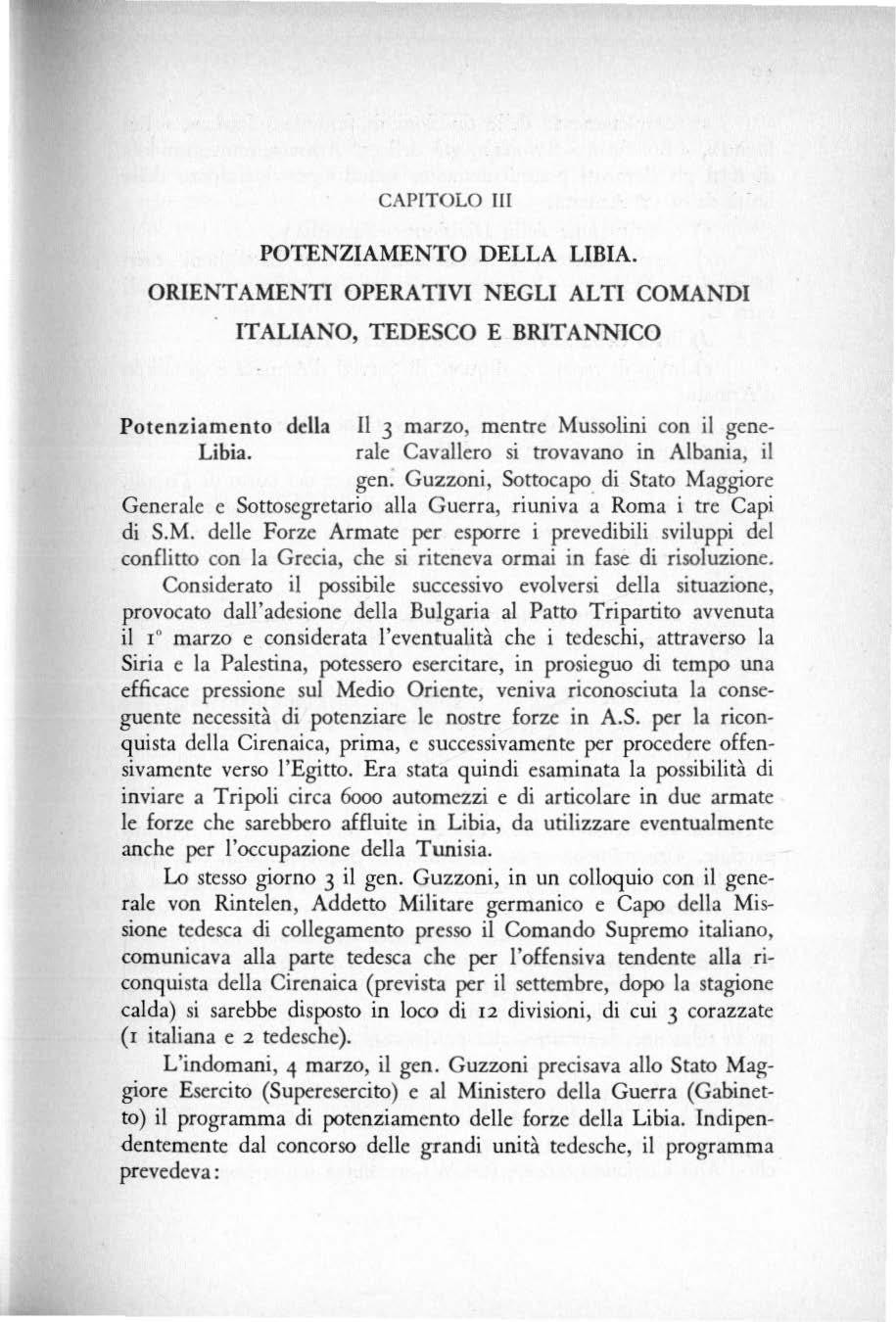
Considerato il possibile successivo evolversi della situazione, provocato dall'adesione della Bulgaria al Patto Triparti to avve nuta il I 0 marzo e con sidera ta l'eventu ali t à che i tedeschi , attraverso l a Siri a e la Palestina, potessero eserci tare, in p rosieguo di tempo un a efficace pressio n e sul Medi o Oriente, veniva ricon osci u ta la conseguente necessità di potenziare le nostre forze in A.S. per la riconqui sta della Ciren aica, prima, e successivam ente pe r procedere offensivamente verso l'Egitto. Era stata quindi esa minata la possibilità di inviare a Tripoli circa 6ooo au tomez zi e di arti colare in due arma te le forze che sare b bero affluite in Libia, da utilizzare eve ntu al men te anch e per l 'occ upazion e della Tunisia.
Lo stesso giorno 3 il gen. Guzzoni, in un colloquio con il generale von Rintelen , Addetto Militare germanico e Capo d ell a M issione ted esca d i collegamento presso il Comando Supremo italiano, comunicava alla parte tedesca ch e per l'offe nsiva tend ente alla riconqui sta della Cirena ica (prevista per il settembre, dopo la st agione calda) si sarebbe disposto in loco di 12 divi sioni, di cui 3 co razzate (1 italiana e 2 tedesche).
L 'i nd omani, 4 marzo, il ge n. G uzzo ni precisa va allo Stato M aggiore Esercito (Superesercito) e a l Ministe ro della Gu err a (Gabinetto) il programma di potenziamento delle forze della Libia. Indipend entemente dal con co rso dell e grandi unità tedesche, il prog ramma preve deva :
a) completamento delle divisioni di fanteria « Pavia», « Bologna », <<Brescia», « Savona », già della 5.. Armata, reintegrandole di tutti gli elementi precedentemente sottratti per il rinforzo delle unità della 10• Armata;
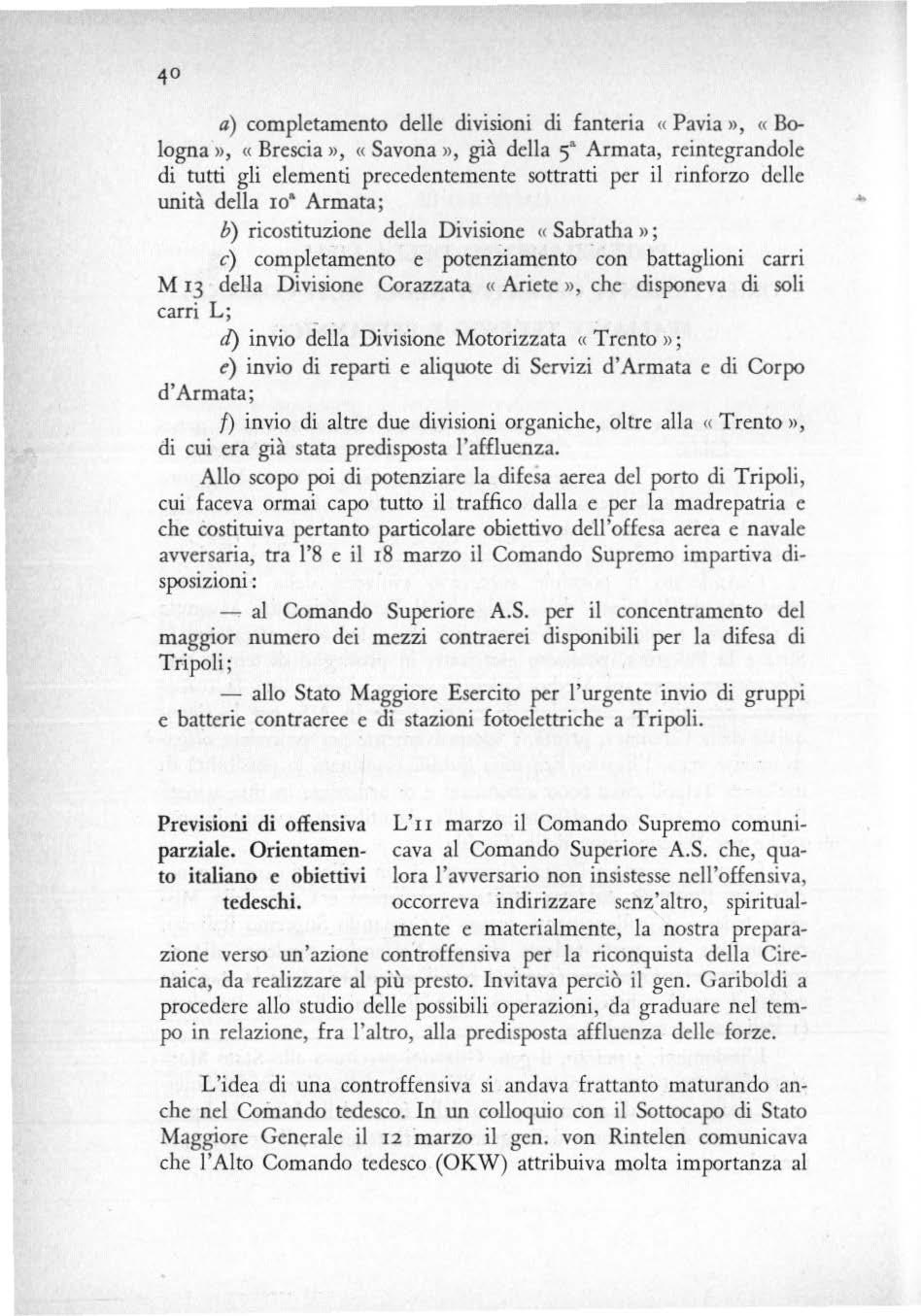
b) ricostituzione della Divisione « Sabratha >>;
c) completamento e potenziamento con battaglioni carri M 13 della Divisione Corazzata « Ariete », che disponeva di soli carri L;
d) invio della Divisione Motorizzata « Trento»;
e) invio di reparti e aliquote di Servizi d'Armata e di Corpo d'Armata;
f) invio di altre due divisioni organiche, oltre alla « Trento», di cui era già stata predisposta l'affluenza.
Allo scopo poi di potenziare la difesa aerea del porto di Tripol i, cui faceva ormai capo tutto il traffico dalla e per la madrepatria e che costituiva pertanto particolare obiettivo dell'offesa aerea e navale avversaria, tra 1'8 e il 18 marzo il Comando Supremo impartiva dispostzwru :
- al Comando Superiore A.S. per il concentramento del maggior numero d ei mezzi contraer ei disponibili per la difesa di T ripoli;
- allo Stato Maggior e Esercito per l'urgente invio di gruppi e batterie contraeree e di stazioni fotoelettriche a Tripoli.
...
Previsio ni di offensiva parziale. Orientamento italiano e o biettivi tedeschi.
L'n marzo il Comando Supremo comunicava al Comando Superiore A.S. che, qualora l'avversario non insistesse nell'offensiva , occorreva indirizzare scnz'altro, spiritualmente e materialmente, la nostra preparazione verso un'azione controffensiva pe r la riconquista della Cirenaica, da realizzare al più presto. In vitava perciò il gen. Gariboldi a procedere allo studio delle possibili operazioni, da graduare nel tempo in relazione, fra l'altro, alla predisposta afflu enza delle forze .
L'idea di una controffensiva si andava frattanto maturando anche nel Comando tedesco. In un colloquio con il Sottocapo di Stato Maggiore Generale il 12 marzo il gen. von Rintelen comunicava che l'Alto Comando tedesco (OKW) attribuiva molta importanza al
mantenimento dell'occupazione dell'oasi di Giarabub, specie in vista di una prossima controffensiva L'OKW stimava necessario non ritardare il trasporto in Libia della 15" Divisione Corazzata tedesca, anche a costo di un rallentamento nel trasporto delle divisioni italiane e si dichiarava favorevole ad una offensiva parziale, da iniziare prima della stagione calda. Il gen. Rommel che l 'aveva progettata giudicava di potersi trovare verso 1'8 maggio in ottime condizioni per affrontare l'operazione.
A Berlino si reputava inoltre che entro il 20 aprile, al più tardi, la 15• Divisione Corazzata sarebbe stata pronta in Africa Settentrionale e che per la stessa data potessero essere pronte anche le divisioni i taliane. Si stimava inoltre che tutte le divisioni, italiane e tedesche, destinate a operare dovessero essere motorizzate in tutti i loro elementi, così da poter eseguire lunghi e rapidi spostamenti. Entro il m ese di aprile si sarebbe dovuto spingere avanti l'attuale schiera' mento.
In uno studio datato 15 marzo, l'Ufficio Operazioni del Comando Supremo considerava che, secondo un calcolo approssimativo dei tempi di affluenza delle forze in programma (1), si doveva ritenere che la progettata offensiva non avrebbe potuto avere i nizio prima del mese di agosto. Il caldo eccessivo ne avrebbe però imposto il rinvio alla metà di settembre.
Lo studio stesso non escludeva di poter accogliere la proposta di Rommel per un'offensiva parziale ai primi di maggio, non appena disponibili la 15• Divisio n e Corazzata e la Divisione Motorizzata « Trento », purché l'operazione rimanesse limitata al raggiu ngimento di Agedabia, importante obiettivo dal quale si dipartono le piste della fascia pre.desertica, a sud de l Gebel: obiettivo però da non superare, per non esporsi all a minaccia avversaria lungo le piste med esi me.
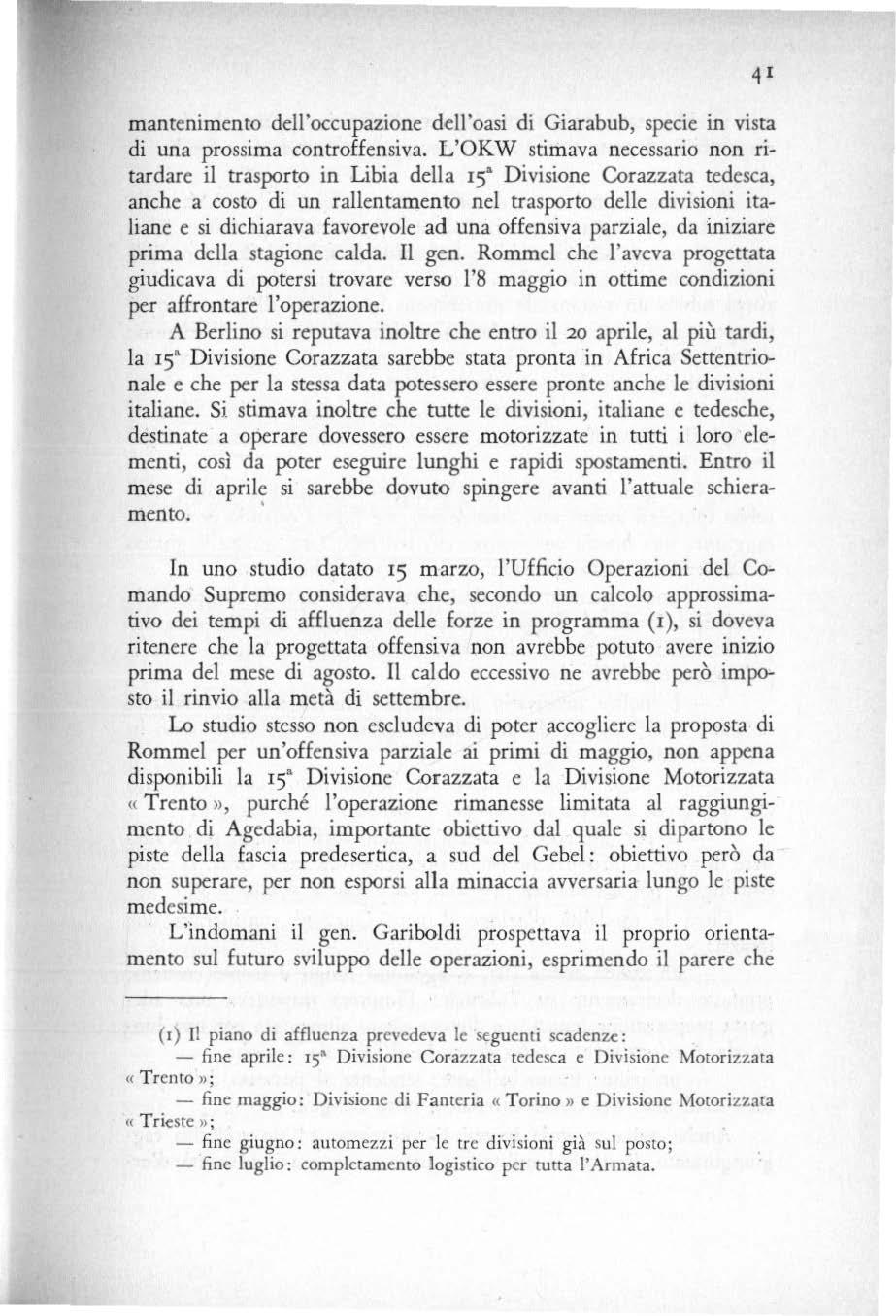
L'i n domani il gen. Garibaldi prospettava il proprio orientamento sul futuro sviluppo delle operazioni, esprimendo il parere che
(
r) Il piano di affluenza prevedeva le segu enti sca denze:
- fine aprile: 15' Divi sion e Cora zz ata tedesca e Divisione Motorizzata << Trento >>;
- fine maggio: Divisione di Fanteria << Torino >> e Divisione Motorizzata « Trieste>>;
- fine giugno: automezzi per le tre divisioni già sul posto;
- fine luglio: completamento logistico per tutta l'Armata.
non sarebbe stato convenie nte tmztare l'offensiva prima che fosse ro disponibili sul posto tutti i mezzi necessari per co ndurla a fondo.
Il 18 marzo, nel corso di una riunione dei Capi di S.M. delle .., Forze Armate, il gen. Guzzoni faceva il punto sulla questione. Riassunti gli eventi n ello sc ac chiere balcanico (i tedeschi dov evano iniziare ai primi di aprile la loro avanzata in Grecia, dove la situazione aveva subìto un sostanziale mutamento in seguito all'intervento di truppe inglesi; notizie varie facevano ritenere imminente l'adesione della Jugoslavia al Patto Tripartito) giungeva alla seg uente valutazione nei riguardi dello scacchiere libico:
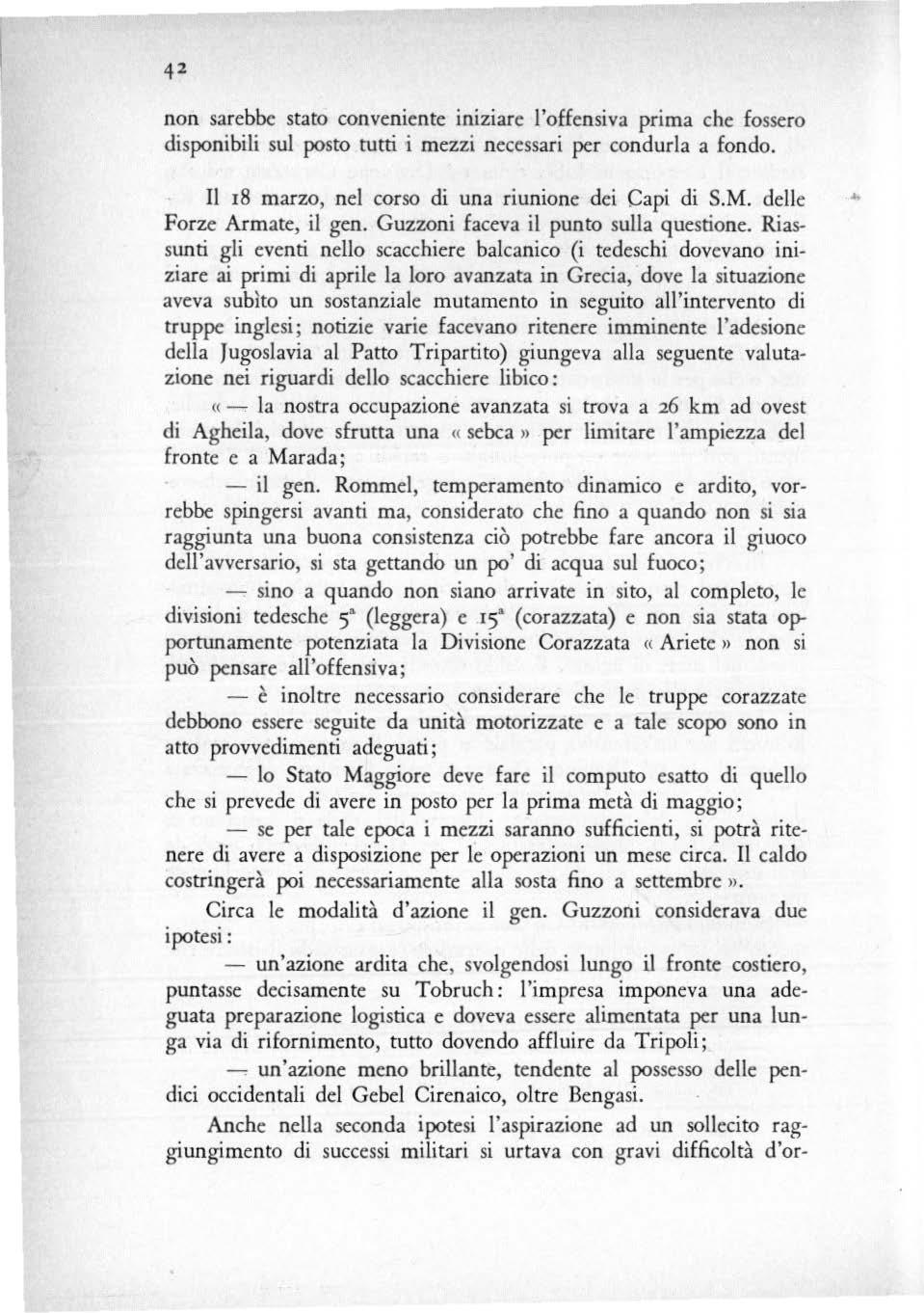
«
---.,. la nostra occupazione avanzata si trova a 26 km ad ovest di Agheila , dove sfrutta una « sebca » per limitare l 'ampiezza del fronte e a Mara da;
- il gen. Rommel, temperamento dinamico e ardito, vorrebbe spingersi avanti ma, co nsiderato che fino a quando non si sia raggiunta una buona co n sistenza ciò potrebbe fare ancora il giuoco dell'avversario, si sta gettando un po' di acqua sul fuoco;
- sino a quando non siano arrivate in sito, al completo, le divisioni tedesche 5" (leggera) e 15a (corazzata) e non sia stata opportunamente potenziata la Divisione Corazzata << Ariete>> non si può pensare all'offensiva;
- è inoltre n ecessario consid erar e che le truppe corazzate debbono essere seguite da unità motorizzate e a tale scopo sono in atto provvedimenti adeguati;
- lo Stato Maggiore deve fare il compu to esatto di quello che si prevede di avere in posto per la prima m età di maggio;
- se per tale epoca i mezzi saranno sufficienti, si potrà ritenere di avere a disposizione per le operazioni un m ese circa. Il caldo costringerà poi n ecessariame nte alla sosta fino a settembre>> .
Circa le modalità d'azione il gen. Guzzoni co nsiderava due ipotesi:
- un'azione ardita che, svolgendosi lungo il fronte costiero, puntasse decisamente su Tobruch: l'impresa imponeva una adeguata preparazione logistica e doveva essere alimentata per una lunga via di rifornimento, tutto dovendo affluire da Tripoli;
___,. un'azione meno brillante, tendente al possesso delle pendici occidentali del Gebel Cirenaico, oltre Bengasi.
Anche nell a seconda ipotesi l ' aspi razione ad un sollecito raggiungimento di successi militari si urtava co n gravi difficoltà d'or-
din e organizzativo, per il tempestivo ammassamento delle forze e de i m ezzi necessari per una grande battaglia. Il gen. Guzzoni giudicava pertanto indispensabile premettere ad ogni decisione un calcolo preciso delle forze e dei mezzi che si potevano fare affluire, considerando anche che un 'azio ne che ci avesse riportato a Bengasi avrebbe poi imposto una lunga sosta sulle posizioni raggiunte.
In complesso il gen. Guzzoni si rendeva conto dell'assoluta necessità di evitare insuccessi e questa considerazione lo faceva propendere per la soluzione più sicura, anche se meno brillante.
Il 20 marzo il gen. Rommel inviava dal proprio quartier general e di Sirte una relazione all'OKW, comunicata per con oscenza al Comando Superiore A.S. che a sua volta ne riferiva al Comando Supremo. La relazion e era intitolata: « Valutazione delle possibilità per un'operazione di attacco nel Nord Africa» (allegato n. 9) e risulta particolarmente interessante in quanto riflette il pensiero del Comandante C.T.A. alla vigilia dell'impresa cui egli darà poi corso con atto d'iniziativa unilaterale.
Premessa una situazione approssimativa del nemico alquanto superiore alla realtà (5 divisioni in Cirenaica, di cui 2 corazzate7 divisioni in Egitto, fino al Delta incluso - 5 altre al Canale di Suez) il Comando del C.T.A. considerava che il g ro sso delle forze britanniche del Mediterraneo Orientale e dislocate nel nord -est dell' Afri ca sarebbe stato impegnato per i prossimi due mesi, sia per l'azione in corso nell'Africa Orientale, sia per la minac cia che si andava allora delineando contro la Siria (vincolata ancora al Governo di Vichy): un loro concorso, in caso di rapido successo italo- tededesco, era quindi da considerarsi tardivo. Allo stesso modo doveva giudicarsi momentaneamente inverosimile un proposito di attacco contro Tripoli. Gli Inglesi faranno di tutto per tenere la Cirenaica, si argomentava, come elemento di sicurezza per il possesso dell'Egitto. Essi avrebbero certamente spinto lo sforzo per un a rapida conclusione vittoriosa dell'azion e contro l'A.O.I., al fine di ricuperar e la disponibilità di forze da reimpiegare o all'attacco di Tripoli o a rinforzo della difesa della Cirenaica, a seconda dell e circostanze. Di fronte a un rapido successo italo- tedesco tale rinforzo sarebbe giunto in ritardo e questa considerazione conferiva carattere di particolare urgenza alla nostra ripresa offensiva che avrebbe trovato d'altronde un limite imperativo nella sua durata dal sopraggiungere dei grandi calori estivi.
Tenendo conto di tali esigenze il gen. Rommel sc riv eva : « Per la condotta di tutte le operazioni non riman e disponibile che il solo

mese di maggio: è necessario quindi che ogni preparazione sia conclusa per la fine di aprile »
Passando a definire il carattere e l'obiettivo finale dell'attacco il gen . Rommel affermava (1): ....
« Lo scopo di un'operazione di attacco può essere solo il cuore dell'Egitto (Alessandria- Cairo- Canale di Suez). La limitazione alla riconquista della Cirenaica significa solo riconquista di terreno
« L'intera operazione deve essere divisa in due tempi: battere l'armata inglese in Cirenaica e irrompere sul Cairo »
E' indispensabile tener presente questo concetto che si ritrova co m e un chiaro filo conduttore attraverso tutta l'azione di comando del gen . Rommel , nelle mutevoli vicissitudini della campagna nordafricana: azione che occorre co n siderare costantemente inquadrata nella concezione (forse eccessivamente ampia, in relazione ai mezzi) della corsa in ava nti , ben oltre i confini della nostra colonia, fino alle lontane mete del Cairo e di Suez.

La relazione precisava in proposito:
« ... Per la continuazione dell'operazione offensiva verso l'Egitto è premessa il rapido, definitivo annientamento delle forze armate inglesi in Cirenaica. Perché que sto scopo sia ottenuto si deve, per mezzo dell'aviazione della Sicilia e della Grecia, come anche per mezzo del pieno impiego della Marina italiana, respingere la flotta inglese nel Mediterraneo Orientale, così che la via marittima per il trasporto dei rifornimenti approntati in Italia (Napoli) a Bengasi e a Tobruch sia assicurata per l'inizio delle operazioni in Cirenaica. Se co me sfruttamento del primo successo potrà essere effettua ta una rapida puntata con deboli forze verso l'Egitto risulterà dallo sviluppo della situazione ...
« . .. D al Comando Superiore Italiano deve essere inoltre assicurato che, n ello spirito di tutta la condotta di guerra, almeno le divisioni celeri italiane, l'Arma Aerea italiana e la Marina da guerra italiana per la co ntinu azione dell'offen siva verso l'Egitto vengano messe a disposizione »
Così veniva valutata la situazione delle forze contrapposte:
« Forze inglesi stanno in Cirenaica con la massa stretta alla costa e appoggiate sul corso della litoranea, in Agedabia- Derna
(1) Le citazioni, tratte n. 9, sono tutte di docu menti inviati al Comando Superiore I taliano in A.S. in traduzione ita lian a del testo originale tedesco, curata dallo stesso Comando C .T.A. Sono state qui riprodotte int eg ralm ente, nella loro forma linguisticamente alquanto approssimativa.
il Corpo Corazzato inglese e il Corpo australiano. Il Corpo Corazzato inglese dispone di 3 reparti corazzati, 6 reggimenti di esploratori corazzati, 2 btg. mot. e 6-9 gruppi di artiglieria. Il Corpo australiano ha 3 divisioni, ciascuna co n 9 btg. e ciascuna con circa 6 gruppi di artiglieria.
« L 'efficienza bellica di queste forze, specialmente per le esigenze del deserto, deve essere indicata come buona. Le perdite sofferte e le sostituzioni ricevute non sono precisabili. Di fronte a questo il Comando tedesco dispone, data l'attuale dotazione di reparti destinati all'attacco, in truppe tedesche solo la 5 Divisione Leggera e la 15• Divisione Corazzata, insieme a quattro gruppi corazzati, I reparto esplorante corazzato, 7 btg. e gruppi di artiglieria. Ciò corrisponde all'incirca alle forze del Corpo Corazzato inglese. Dell e forze italiane sono in questione in primo luogo per la condotta mobile dell'attacco 3 divisioni m o t. (di cui una divisione corazzata). Tre altre divisioni a piedi devono seguire con celerità, sia per mezzo di motorizzazione provvisoria o a marce forzate ».
In base al concetto di mettere fuori causa rapidamente il grosso delle forze avversarie presenti in Cirenaica, prima che potessero ricevere rinforzi, il Comando del C.T.A. si proponeva di battere successivamente le singole divisioni avversarie, largamente scaglionate in profondità lungo la litoranea. Stabilito che la direzione principale dell'attacco, attraverso lo schieramento avversario, doveva inizialmente puntare su Tobruch, principale porto di approvvigionamento Inglesi, il gen. Rommel formulava il seguente concetto d'azwne:

- impadronirsi preliminarmente della zona avanzata di sicurezza inglese, fra Agheila e Ageda bia;
- tendere inoltre a impadronirsi, possibilmente di sorpresa, degli avamposti inglesi di Marsa Brega e portarsi ad occupare la stretta di es Segira;
___, qualora il nemi co aves se già ripi egato, fare un balzo al punto più vicino, rappresentato dalle posizioni base di Agedabia. Con questo si aprirà la fase decisiva di tutta l'operazione, la battaglia per il possesso di Agedabia. Obiettivo della battaglia: l'annientamento del Corpo Corazzato inglese.
Qualora il n emico avesse accettato lo scontro, il gen. Rommel prevedeva probabile l'applicazione della tattica già praticata in passato : contenere frontalmente l'attacco per reagire con la manovr a dei carri armati. Avrebbe anche potuto disporsi a difesa con i soli
carri ma l'ipotesi appariva poco probabile nell'ambiente desertico, dove un attacco può manifestarsi da ogni direzione. In ogni caso il Comandante del C.T.A. stabiliva esplicitamente che il nemico doveva essere attaccato e annientato dalle divisioni corazzate, prima di pensare ad uno sviluppo dell'azione con operazioni a largo raggio, in direzione di Tobruch.
La battaglia di Agedabia doveva essere affrontata con estrema energia e rapidità di procedimenti per impegnare il Corpo Corazzato inglese ed impedirgli di ripiegare eventualmente sul Corpo australiano.
Una volta raggiunta una decisione ad Agedabia, l'azione sarebbe entrata nella seconda fase di sviluppo. L'urto frontale con la massa delle forze distribuite lungo la litoranea non appariva promettente di rapido e risolutivo successo: per una pronta decisione si imponeva l'aggiramento del massiccio gebelico, attraverso il deserto, per raggiungere la costa alle spalle degli Inglesi, chiudere la ritirata alle forze anglo- australiane presenti in Cirenaica e impegnarle in una battaglia decisiva, per impedir loro di sottrarsi, per il sud o sul mare. La protezione del fianco delle colonne avanzanti a nord di Agedabia contro possibili reazioni del Corpo australiano o da parte di forze ancora presenti più ad est, nonché la copertura delle comunicazioni doveva essere assicurata con speciali reparti.
La relazione del Comando del C.T. A. indicava anche le forze tedesche e italiane occorrenti per la prosecuzione dell'operazione, dopo l'annientamento delle forze britanniche della Cirenaica:

a) Per il C .T.A. (richieste già avanzate):
- 3 gruppi esploranti, particolarmente idonei all'azione autonoma a grande distanza, dotati di pionieri, batterie se moventi, caccia- carri, plotoni su « Volkswagen » ed anche di propri aerei da ricognizione e di collegamento (cicogne);
- 3 gruppi di artiglieria pesante motorizzata con I comando di reggimento;
- I gruppo ncbbiogeni;
- 3 btg. pionieri lanciafiamme dotati di fuciloni anticarro e montati su (( Volkswagen >> in sostituzione di carri -lanciafiamme;
----, 3 plotoni autonomi su « Volk swage n », armati con fuciloni anticarro, numerose mitragliatrici e pistole- mitragliatrici, con co mpito di caccia e azioni di commandos speciali nel deserto (possibilmente dotati ciasc uno di un aereo di collegamento);
-I reggimento paracadutisti;
- I comando per il quartier generale Libia
b) Per il potenziamento della 5" Divisione Leggera:
- I comando reggimento di artiglieria;
- I gruppo di artiglieria leggera , motorizzato;
- I gruppo artiglieria pesante, motorizzato;
I battaglione su « Volkswagen » (al posto del btg. motociclisti);
- I battaglione pionieri corazzato.
Per la parte italiana il Comando tedesco riteneva strettamente indispensabili le seguenti assegnazioni:
- artiglieria di Corpo d'Armata: 2 reggimenti motorizzati, possibilmente calibro ISO mm a sostegno del X Corpo italiano e del C.T.A.;
- artiglieria contraerea: un gruppo motorizzato per divisione , su 3 batterie pesahti e 2 leggere (in totale 6 gruppi art. c.a.);
- reparti anticarro, motorizzati: 2 reggimenti (ciascuno su 3 gruppi), possibilmente di grosso calibro, a sostegno dei due corpi d'armata, come sopra detto;
__,. truppe del genio: IO battaglioni (almeno in parte motorizzati) e 5 battaglioni lavoratori stradali (motorizzati) per i lavori connessi con l'avanzata delle truppe celeri;
- squadre idriche con impianti di sonde (motorizzate): urgente la costituzione immediata di 6 squadre, I per divisione.
Per l'aviazione il C.T. A. richiedeva:
___, per la ricognizione e il collegamento:

I squadriglia da ricognizione lontana, per la guida delle truppe, a disposizione del X Corpo d'Armata;
I squadriglia da ricognizione e I squadriglia di collegamento per la Divisione Corazzata « Ariete »;
- per il combattimento aereo:
I gruppo JU 87 (Stuka);
3 gruppi caccia- bombardieri;
2 gruppi bombardieri;
- per i rifornimenti:
3 gruppi da trasporto, su 30 apparecchi ciascuno;
- adeguata organizzazione a terra.
Per i rifornimenti, esclusa la possibilità di far capo a Tripoli una volta iniziate le operazioni, prospettava l'urgenza di procedere alla costituzion e di un deposito avanzato, al limite anteriore della posizione di attesa e di valersi quindi, finché possibile, dei trasporti ma- ... rittimi, in collaborazione con quelli terrestri. A questo scopo riteneva necessario l'approntamento di numerosi natanti da cabotaggio (facendo affluire dall'Italia un certo numero di battelli costieri) e l'aumento del tonnellaggio disponibile per i convogli, in relazione alle previste esigenze dei trasporti e rifornimenti dall'Italia e dalla Germania, come pure per agevolare lo spostamento in avanti dell'organizzazione logistica durante il procedere dell'avanzata. A questo scopo sottolineava il valore del possesso di un porto (Marsa H ilal, Derna, Bomba, Ain Gazala, Tobruch) per la costituzione di una nuova base logistica, indipendente da quella di Tripoli.
Il Comando del C.T.A. aveva approntato un piano teoricamente completo in ogni sua parte, in armonia con l'ardito concetto operativo da cui era derivato: si può forse osservare che le conclusioni e le conseguenti richieste, ineccepibili sul piano puramente astratto, trovava scarsa rispondenza nelle pratiche possibilità di realizzazione non soltanto nei riguardi del meno dotato all eato italiano ma anche in relazione all'impegno che la Germania intendeva assumere in questo lontano scacchiere operativo. Tant'è che le richieste dovevano rimanere in larga misura insoddisfatte, creando fin dall'inizio uno sfavorevole squilibrio che doveva imprimere all'intera campagna un costante carattere di rischio.
L 'orientamento verso l'inizio dell'offensiva entro maggio veniva confermato il 23 marzo in un colloquio svoltosi a Roma fra il gen. Guzzoni, il gen. Rommel (in viaggio di ritorno da Berlino) (t)
( 1) V ci tata opera: « Guerra senza odio )) : « Il 19 marzo mi recai in aereo al Quartier Generale del Fi.ihrer per fare il mio rapporto e prendere nuove istruzioni ... Il Comandante Supremo dell'Esercito mi com unicò che non vi era l'intenzione di sferrare prossimamente un colpo decisivo contro i britannici in Africa a che perciò non dovevo attendermi, per un certo tempo, alcun invio di ulteriori rinforzi. Dopo l'arrivo della 15a Divisione Corazzata (e cioè dopo la fine di maggio) dovevo attaccare a distruggere il n emico nella zona di Ag edabia. Poi si sarebbe potuto eventualmente prendere Bengasi. Affermai che non si doveva prendere so!tanto Bengasi ma l'intera Cirenaica poiché la sola zona intorno alla città non era difendibile. Ero poco soddisfano della tendenza del maresciallo von Brauchitsch e del gen. Halder a mandare soltanto poche truppe in Afr ica lasciando al caso l'ulteriore destino di questo teatro di guerra. La momentanea debolezza britannica nel Med io Oriente avrebbe dovuto essere sfrunata in Africa con ogni energia per assicurarsi definitivamente l'iniziativa '' ·

e il gen. von Rintel en. Il gen. Rommel insisteva sulla necessità di agire al più presto, per non trovarsi di fronte a maggiori forze inglesi, ricuperate eventualmente dallo scacchiere dell'A.O.I. A suo avviso la fine di maggio rappresentava il termine massimo per l'inizio della controffensiva.
Il gen. Guzzoni esprimeva a sua volta il proprio pensiero in merito allo sviluppo dell'operazione:
- primo tempo: battere le forze inglesi fra Agedabia e Bengasi, guardandosi sul fianco destro, all'altezza di Msus, dalle provenienze da Mechili;
- secondo tempo: proseguire su Tobruch.
Nel caso che l'azione del primo tempo fosse riuscita prontamente risolutiva, si sarebbero potuti invertire i termini del dispositivo: guardarsi dalle provenienze da Bengasi e puntare con il grosso delle forze moto- corazzate per M sus su M echili e Tobruch.
Occorreva però tener conto che l'offensiva era subordinata alla disponibilità di automezzi e al riguardo dichiarava che sarebbe stato fatto il massimo sforzo per inviarne, nel maggior numero e al più presto possibile.
Il giorno 24 il gen. Guzzoni segnalava al geo. von Rintelen, che si recava a Berlino, le questioni che più premevano al Comando Supremo italiano e che, per quanto riguarda l'A.S., consistevano nei seguenti punti :

- urgente invio di autocarri e carri armati francesi di preda bellica , già promessi dalla Germania, senza dei quali non sarebbe stato possibile autocarrare le divisioni di fanteria presenti in Libia alla seconda metà di maggio;
- accelerare i trasporti della 15.. Divisione Corazzata, in modo che questa potesse essere già sistemata in sito per la metà di maggio. P er l'offensiva era infatti previsto l'impiego di almeno 7 divisioni : 3 corazzate c 4 motorizzate.
Di ritorno a Tripoli il gen. R ommel informava il gen. Gariboldi che il suo piano d'azione era stato approvato: annientare il Corpo Corazzato inglese e procedere quind i nella Cirenaica. Per l'offensiva, che avreb be dovuto avere inizio alla fine di maggio, a R oma gli erano state promesse 7 divisioni di prima schiera.
Il Comandante Superiore in A.S. esprimeva il proprio accordo di massima ed inviava al Comando Supremo nuov e richieste di rifornimento di m ezzi e scorte ritenuti necessari, oltre alle unità e ai
mezzi già richiesti dal gen. Rommel. Con l'occasione faceva rilevare come dal ritmo dei trasporti effettuati fino a quella data (24 gennaio- 26 febbraio : Div. (( Ariete )); II febbraio- 20 marzo: s· Div. Leggera tedesca; 27 febbraio- 18 marzo: Div. « Trento» ) non si poteva trarre la sicurezza di poter disporre in sito di tutto l'occorrente per l'epoca stabilita e concludeva ribadendo l'opportunità di non iniziare l'offensiva prima dell'affluenza di tutti i mezzi necessari per condurla a termine.
Orientamento britannico nei riguard i di un'eventuale controffensiva ital o - tedesca.
Ordini del Comandan-
Nel tempo stesso in cui il gen. Wavell definiva il massimo contributo di forze da inviare in Grecia, il Comando britannico, come già accennato, escludeva la possibilità di una nostra ripresa offensiva in Cirenaica a te britannico in Cire- breve scade nza. L 'apertura di un nuovo naica . fronte balcanico poggiava infatti sulla premessa di poter solidamente assicurare il possesso d ell'o rlo del Deserto Occidental e in Africa Settentrionale (1), limite che sarebbe potuto essere stabilito all'altezza di Tobruch ma che, in vista della rapida occupazione della Cirenaica, il gen. Wavell aveva giudicato di poter fissare (per qualche tempo con poche forze) a el Agheila.
Tutti i mezzi corazzati e quasi tutte le artiglierie italiane erano andati distrutti o catturati e come già detto, fino alla metà di febbraio nessuna informazione precisa era pervenuta al Comando del Medio Oriente che facesse sospettare l'affluenza di forze tedesche in Africa Settentrionale. Le informazioni britanniche in proposito erano completamente negative. Quando lo sbarco dei primi elem e nti del C.T.A. divenne realtà (2), il gen Wavell stimava che sarebbero trascorsi almeno due mesi prima che le forze tedes che fossero in grado di intraprendere una ser ia offensiva. Giudicava per-
(t) Da CHuRCHILL: « La seconda guerra mondiale », Parte III, vol. l: << La Germania punta a Oriente >> , Ed. Mondadori, 1952: << Il fianco sul Deserto Occidentale er a il gancio al quale era appeso tutto il resto. Nessuno si sog nava di perderlo o di arrischiarlo per la Grecia o qualunque altro obietùvo balcanico >> .
(z) Lo sbarco a T ripoli della Sa Divisione Leggera era cominciato il 15 gennaio.

tanto che una brigata corazzata e una divisione sarebbero state sufficienti, come distaccamento fiancheggiante in Cirenaica e che queste unità avr ebbero potuto completarsi e perfezion are il proprio addestramento per la fine di ma ggio, termine entro i l quale sperava di poter disporre di qualche rinforzo: almeno una Divisio ne indiana dal Sudan. Ad aumentare frattanto l'efficienza d ello scarso presidio lasc iato in posto, il gen. W ave ll decideva di ricorrere alla costituzione di alcuni reparti con i carri medi italiani di preda bellica.
Nella terza d ecade di febbraio il potenziamento delle forze britanniche in Cirenaica si era reso più difficile a causa dei violenti attacchi aerei tedeschi su Bengasi, i cui effetti avevano indotto gli Alti Comandi inglesi a considerare che la Marina non dovesse più esporsi ai rischi che l'uso di quel porto comport ava. Ciò significava accentrare tutti i rifornimenti su T obruch, allungando di circa 300 chilom etri la linea di comunicazione fino all e trupp e ava nzate .
Il 2 marzo il gen. W avell, richiesto dal servizio informazioni britannico di una breve valutazione della situazione a seguito dell'arrivo di formazioni corazzate e di aerei tedeschi i n Tripolitania, ri spondeva esprimendo il parere ch e un'offensiva in g rand e stile da parte di due divisioni corazzate tedesche e una o due divisioni italiane di fanteria (massima forza alimentabile dalla lontana base di Tripoli) fosse da ritenere improbabile prima della fine dell'estate (1).
( 1) Nella ri sposta del gen. Wavcll si leggeva, fra l'altro: << Le ultimi ssime informazioni indi cano che i r ecenti rinforzi giunti in Tripolitania comprendono due Division i italiane di famer ia, due reggimenti di artigl ieria motorizzata e truppe corazzate tedesche, pari, secondo l e stim e, al massimo d egli effettivi di un gr uppo di briga te corazzate. Non si ha alc una prova ch e sian o stati sbarcati altri mezzi di trasporto; il nemico deve perciò essere an co ra a corto di autom ezz i. Tuttavia le ultime operazioni di ricognizione aerea segnalano un considerevole aum ento di m ezz i di trasporto meccanici sulla strada T ripoli- Sirte.
<< Da T ripoli ad Agheila inte rcorrono circa 76o ch ilometri e da T ripoli a Bengasi circa I045· Vi è un'unica st ra da e i pozzi d 'acqua sono insufficienti per oltre 650 chilom etri: questi fattori, insie m e con la mancanza di mezzi di trasporto, limi tano la portata d ell'attuale minaccia del nem ico Probabilmente esso può rifornire lungo la strada costiera una divi sione di fanteria c una brigata corazzata, in un periodo di circa tre settimane; contemporaneam ente può for se impi egare una seconda brigata corazzata, sempre che ne abbia un'altra disponibile, contro il nostro fianco, attraverso il deseno, lungo la pi5ta di H on e di Marada.
« Può essere che esso faccia qualche sondaggio ad Agheila, con pattuglie offensive e che, qualora ci trovi deboli, avanzi su Ag ed abia per portare più

Durante il mese di marzo, mentre si stava effettuando il concentramento delle truppe destinate alla Grecia, la situazione in Cirenaica forniva però al gen. Wavell motivo di crescente preoccupazione : si accumulavano le prove della presenza di forze corazzate .. tedesche in Libia me n tre contemporaneamente le informazioni dall'Italia e dalla stessa Libia erano così scarse da non consentire di trarne sicuri elementi per la valutazione delle intenzioni dell'avversano.
Il 24 marzo (il giorno stesso cioè della rioccupazione di el Agheila) il servizio informazioni del gen. Wavell così apprezzava l'entità delle forze italo- tedesche in Tripolitania: una divisione corazzata coloniale (leggera) tedesca (o aliquote di una normale divisione corazzata) -: D ivisione Corazzata «Ariete» con metà della propria dotazione di carri - forse Divisione Motorizzata « Trento» al completo - certamente Divisione di Fanteria « Pavia», « Bologna», « Brescia» e « Savona». In base a questi dati, il Comando britannico riteneva che prima di muovere all'attacco contro la Cirenaica le forze dell'Asse avrebbero dovuto far affluire rifornimenti per 30 giorni nella zona avanzata. Ne deduceva che per il 16 aprile avrebbero potuto essere pronte ad operare con la divisione corazzata tedesca e una divisione motorizzata italiana. Alla data del 14 maggio avrebbero potuto aggiungere a queste forze un'altra divisione coloniale tedesca e il successivo 24 una divisione corazzata o autoportata italiana. Lo stesso servizio informazioni riteneva che per al-
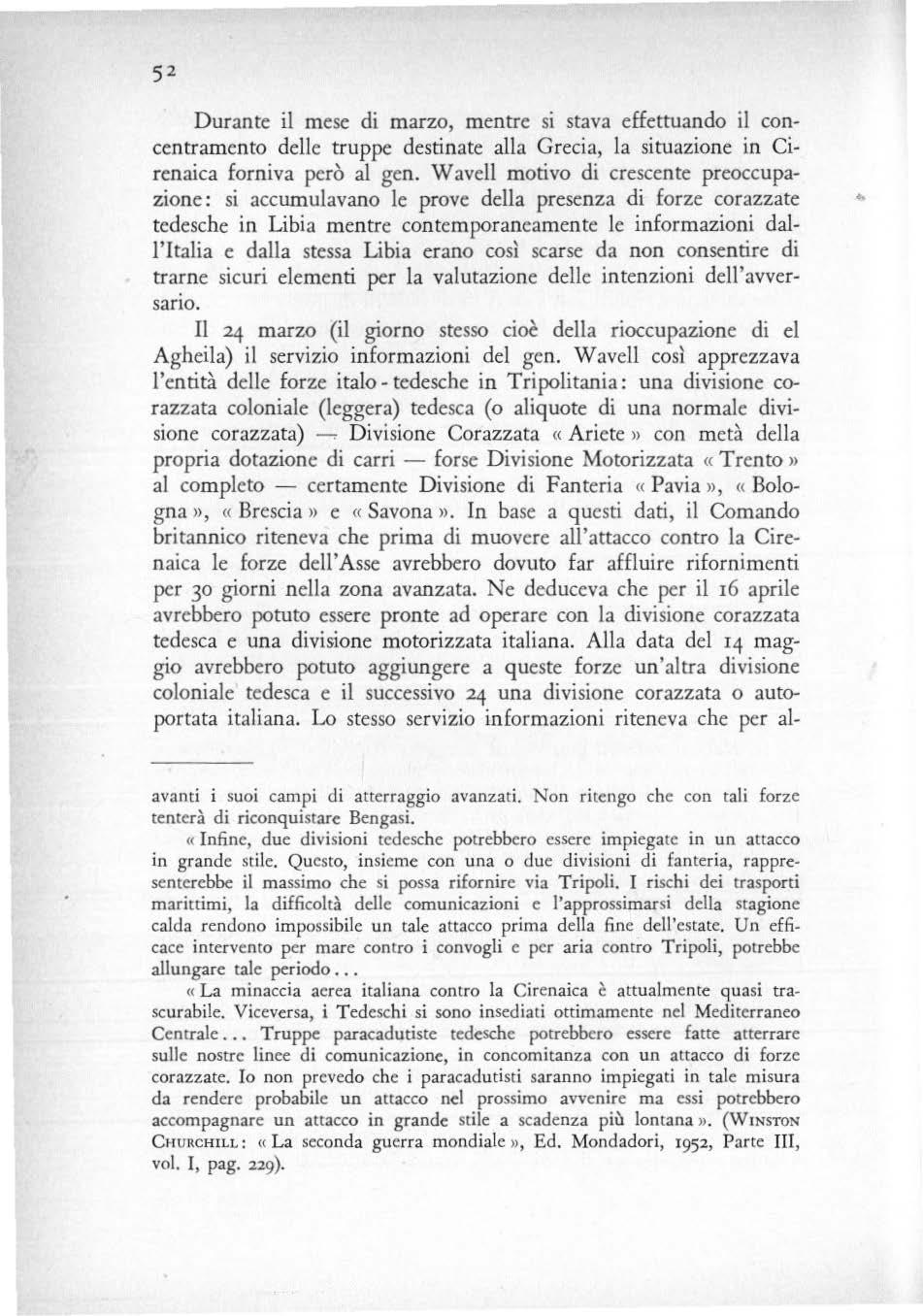
avanti i suoi campi di atterraggio avanzati. Non ritengo che con tali forze tenterà di riconqui stare Bengasi.
« Infine, due divisioni tedesche potrebbero essere impiegate in un anacco in grande stile. Questo, insi eme con una o due divisioni di fanteria, rappresenterebbe il massimo che si possa rifornire via Tripoli. l risc hi dei trasporti marittimi, la difficoltà delle comunicazioni e l'approssimarsi della stagione calda rendono impossibile un tale attacco prima della fine dell'estate Un efficace intervento per mare contro i convogli c per aria contro Tripoli, potrebbe allungare tal e periodo ...
« La minaccia aerea italiana contro la Cirenaica è attualmente quasi trascurabile. Viceversa, i Tedeschi si sono insediati ottimamente nel Mediterraneo Centrale . . . Truppe paracadutiste tedesche potrebbero essere fatte atterrare sulle nostre linee di comunicazione, in concomitanza con un attacco di forze corazzate. Io non prevedo che i paracadutisti saranno impiegati in tale misura da rendere probabile un attacco nel prossimo avv enir e ma essi potrebbero acco mpagnare un attacco in grande st ile a scadenza più lontana >> . (WtNSTON
CHURCHILL: «La seconda guerra mondiale )), Ed Mondadori, 1952, Parte III, vol. I, pag. 229).
meno un mese le difficoltà logistiche non avrebbero consentito di operare intensamente con più di una divisione corazzata tedesca e una divisione motorizzata italiana.
L a deduzione dell'improbabilità di un attacco nemico prima della metà di aprile veniva accolta dal gen. Wavell, il quale anzi sperava che questo termine non potesse cadere prima del maggio e nel frattempo contava di poter rafforzare sensibilmente le proprie truppe.
In relazione a tale orientamento e in base alle conseguenti direttive del gen. Wavell, il gen. Neame, comandante delle truppe britanniche in Cirenaica, impartiva a sua volta gli ordini alle unità dipendenti, secondo il seguente concetto:

- truppe mobili di copertura, nella zona di el Agheila, con compito di azione ritardatrice, se attaccate in forze, senza impegnarsi a fondo, infliggendo perdite al nemico e ripiegando lungo la costa, su Bengasi;
-
2 • Divisione Corazzata, con base ad Antelat, con compito di riconoscere la effettiva direttrice principale dell'attacco nemico, se rivolta su Bengasi oppure, attraverso il deserto, su Tobruch. Finché la direzione dello sforzo principale non fosse stata chiaramente riconosciuta, la Divisione doveva mantenersi in grado di operare da Antelat sia verso la costa, sia verso le piste desertiche che dalla zona di Agedabia adducono a Mechili e al Golfo di Bomba;
.....,. 9• Divisione australiana con compito di tenere la linea del gradino gebelico, da Tocra fino a sud di el Regima.
Ben diverso era invece il pensiero del Primo Ministro, Winston C h urchill, che esprimeva la propria preoccupazione che i tedeschi potessero attaccare senza attendere tanti rinforzi e suggeriva di tenersi pronti a opporre un'energica controffensiva. Nel suo colorito, efficacissimo stile così telegrafa il 26 marzo al gcn. W avell ( r):
« Siamo naturalmente preoccupati per una rapida avanzata tedesca su Agheila. E' loro abitudine andare avanti tutte le volte che non incontrano resistenza. Immagino che voi stiate soltanto aspettando che la tartaruga tiri fuori la testa quel tanto che basti per potergliela troncare. Ci pare enormemente importante dare ai tedeschi un primo assaggio del nostro valore ... ».
Vengono qui ricordate le azioni promosse dal Comando britannico in questo pe riodo (febbraio- marzo 1941) per il possesso delle grandi oasi da noi presidiate nel Deserto Libico. Si tratta di eve nti in se stessi di limitato rili evo, interessanti appena qualche centinaio di uomini ma strategicamente importanti nell'economia generale dello scacchiere, in quanto tendenti ad assicurare la piena disponibilità della direttrice operativa interna, essenziale per la realizzazione della manovra di forze moto- corazzate contro il fianco e il rovescio del grosso delle armate schierate lun go la costa, a cavallo della grande rotabile, secondo uno schema necessariamente uniform e, indipendentemente se rivolte fronte ad est e fronte ad ovest: appoggiata al mare l'ala nord e l'ala sud più o meno protesa entro il deserto e comunque esposta all'aggiramento dcii' avversario.
L 'Oasi d i C u fra . (Schizzo n. 4).
Al centro della sezione orientale del Deserto Libico, fra i meridiani di Tobruch e di Barce, a 900 chilometri dalla costa s'incontrano le Oasi di Cufra (r) costituite da un nucleo principale « Cufra » e da altri tre minori che si trovano, rispettivamente, a 130 chilometri ad ovest (Rebiana) e 130 e 250 chilometri a nord- ovest (Bzema e Tazerbo). L a popolazione, di diverse stirpi (Tebù, Tuareg, AraboBerberi , Cirenaici), non raggiungeva in complesso le 6ooo anime. Il nucleo di Cufra si trova nella conca di Cufra, nella depressione di el H auwari.
La conca di Cufra (dagli indigeni chiamata Uadi el Cafra) è un bacino di forma approssimativamente ellittica, con l'asse maggiore di circa 50 chilometri (diretto da nord- est a sud- ovest) ed il minore di 20. L'orlo è costituito da elevazioni che non superano i roo
(1) Il nome dì << Cufra » che signifi ca « infedeli » fu dato dai primi conquistatori musulmani che trovarono queste oasi abitate da gente Tebù, pagana. Usato anche « Zania » .
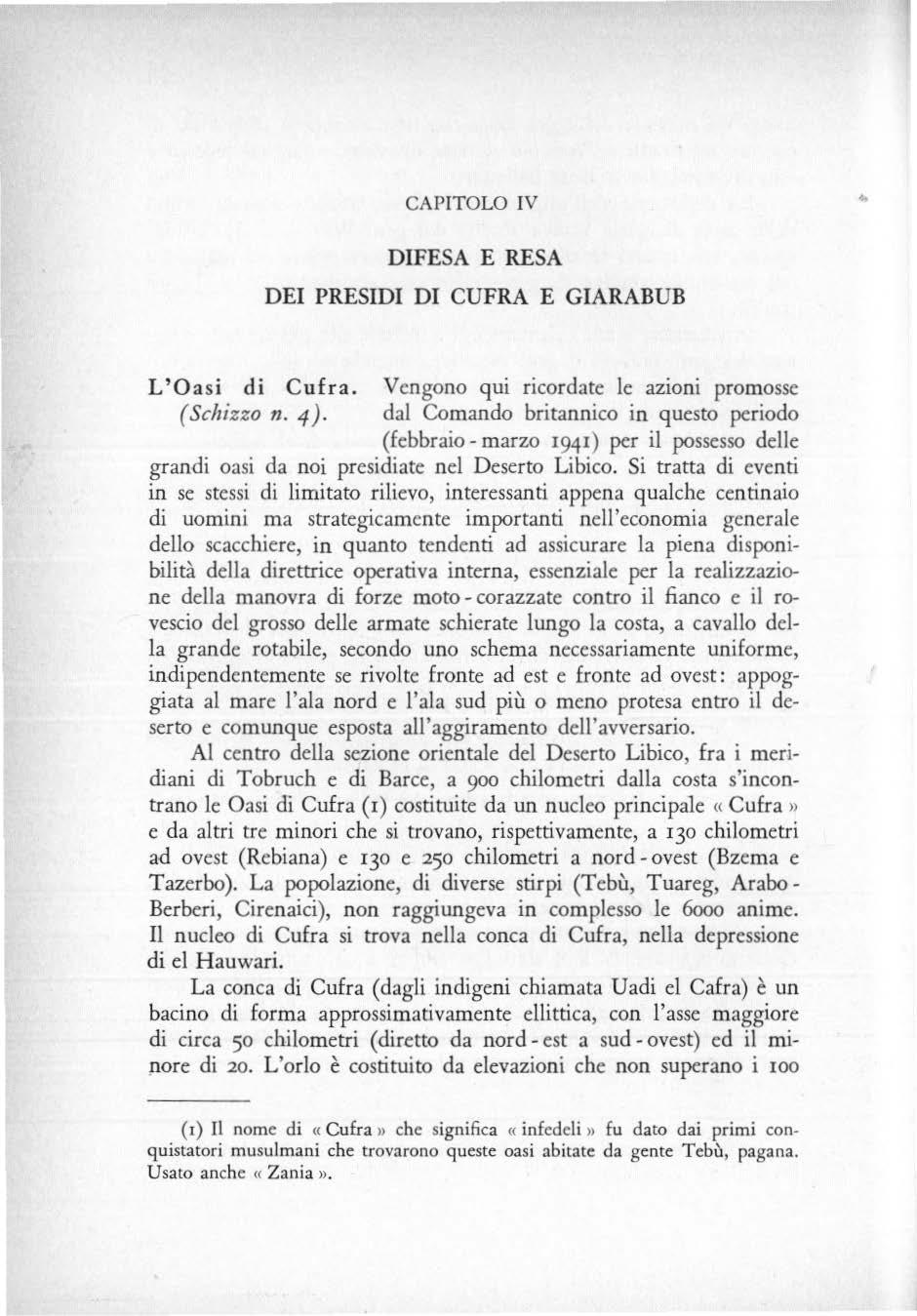
metri. Il fondo ineguale, con prevalenza di sabbia e di pietra rossastra, presenta delle depressioni, occupate da laghi salati o saline prosciugate. Comprende le seguenti oasi:
- el Giof, la maggiore (900 abitanti), situata all'estremità nord -est del bacino, lunga circa 5 chilometri, larga 2- 3, ricca di palme e di giardini. L'abitato è rappresentato da tre gruppi di case e una « zavia » (r) cui è annessa una moschea. Un folto cerchio di palme fa corona ad un lago salato;
- Buma e Buema (rispettivamente 200 e 70 abitanti) ad est della precedente: due piccole oasi, con ricca vegetazione, ciascuna con un villaggio di case in muratura e zeribe (2);
- ez Zurgh (140 abitanti) a sud di el Giof, formata da una linea di palmeti, priva di villaggio;
___, et Tleilib e et Tallab (rispettivamente 130 e ISO abitanti) a 15- 20 chilometri a sud- ovest di el Giof: poche case sparse e zeribe di col tivatori.
Sull'orlo settentrionale della conca, ad un'altitudine di 427 m etri, sorge il villaggio di et Tag ove, dopo la nostra occupazione, nel gennaio 1931 era stata costruita una ridotta difensiva. A nord si estende la depressione e l'oasi di el Hauwari, lunga circa I2 chilometri, con l'omonimo centro abitato (w8o abitanti).
L'Oasi di Rebiana (500 abitanti) è lunga circa 20 chilometri. Un fondo salato la divide da una catena di elevazioni. All'estremità nord è il villaggio di una diecina di case e una zavia.
L ' Oasi di Bzema (8o abitanti) si sviluppa a semicerchio intorno a? un lago salato lungo r8 chilometri, ai piedi di un cordone roccwso.
L'Oasi di Tazerbo (550 abitanti), lunga 25- 30 chilometri, larga IO, è solcata al ce ntro da un avvallamento con laghi salati e sali ne.
A circa 250- 300 chilometri a sud- est di Cufra, alla frontiera libico- egiziana si elevano sull 'altipiano i massicci di Archenu (m. 620) e di Auenat (m. 1934).
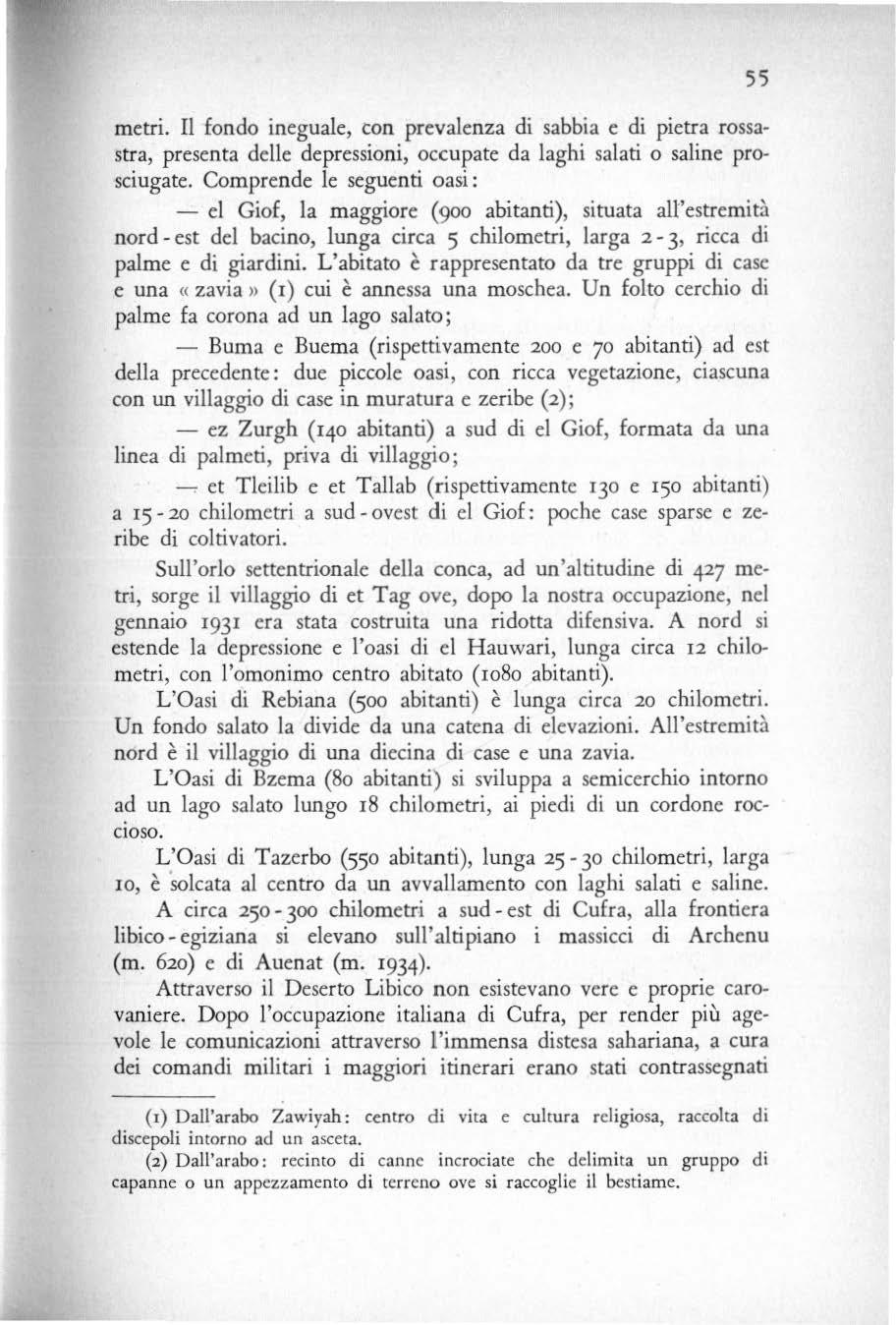
Attraverso il Deserto Libico non esistevano vere e proprie carovaniere. Dopo l'occupazione italiana di Cufra, per render più agevole le comunicazioni attraverso l'imme nsa distesa sahariana , a cura dei comandi militari i maggiori itinerari erano stati co ntrass eg nati
(r) Dall'arabo Zawiyah: centro di vita e cultura religiosa, raccolta di discepoli int orno ad un asceta.
(2) Dall'arabo: recinto di canne incrociate che delimita un gruppo di capanne o un appezzamento di terreno ove si raccoglie il bestiame.
con palifìcazioni (Gialo Cufra, Marada T azerbo, Zeli T azerbo, Cufra T azerbo, Cufra- Giarabub, Cufra- el Auenat, Cufra ten es Sarra , Cufra Rebiana): il percorso seguiva il terreno più percorribile, oltre che per le carovane, anche per automezzi oppor- ., tunamente attrezzati.
L e oper azioni n ell' O asi d i Cufra (I 8 fe bbra io- I o marzo I94I).
Il presidio di Cufra, al comando di un capitano, era costituito da due compagnie traglicri da posizione, una compagnia riana ed una batteria sahariana da 20 mm.
Il 28 gennaio, rilevata la prese n za di una stazione radio nemica a sud di Cufra, era stata organizzata una colonna mobil e per la ricognizione della zona desertica fra Cufra e Maaten Bisciara. Di fronte a nuovi sintomi della presenza di elementi avversari, il 4 febbraio il Comando del Settore ordinava di ripetere la ricognizione offensiva per eliminare, in collaborazione con una squadriglia aerea, eventuali infiltrazioni di nuclei meccanizzati avversari e difend ere il campo d'aviazione di Buma da eventuali attacchi terrestri (r).
La minaccia era effettivamente rappresentata da una formazione di « Francia Libera », agli ordini del colonnello gaullista Ledere che, dopo una puntata compiuta nella notte sull'8 febbraio (2) con un staccamento m eccanizzato rinforzato da pattuglie britanniche del « Long Range Desert Group >> (3), procedeva all'investime n to di Cufra.
( r) Per rendersi conto dell'entità materiale d i queste operaziom s1 nporta la formazione della colonna mobile, agli ordini di un capitano: 4 ufficiali , 6 sotrufficiali, 13 uomini di truppa nazionali e 51 l ibici. D isponeva di 15 automezzi (5 au tocarri c ro trattori) ed era armata con 4 mitragliere da 20 mm. e 5 mitragliatrici Fiat con due « unfoc », 4 mitragliere da 12,7 mm. e 6 mitragliatrici da 7,7 mm. con una sola « unfoc ». Aveva autonomia di viveri per tutto il mese, acqua per 5 giorni e carb urante per 6oo chilometri.
(2) Per i fatti d'arme del 31 genna io e 8 febbraio v. citata monografia: «La prima offensiva britannica in Africa Settentrionale >>
(3) Gruppo Esplorazione del Deserto a Largo Raggio: una molto efficiente for mazione di arditi, particolarmente organizzata e addestrata per imprese di cc commandos » attraverso il deserto. Il concorso britannico all'operazione di Cufra consisteva in due panug!ie (complessivamente 4 ufficiali, 38 combattenti, 22 conducenti, con un armamento di 4 fuciloni anticarro da 15 mm., 14 mitragl iatrici cc Lcwis », 4 mitragliatrici cc Wickers », 2 cannoni « Bofo rs >> da 40 mm., 2 mortai da 76 mm. c 22 automezz i). Il concorso rima se limitato nel tempo al 9 febbraio.
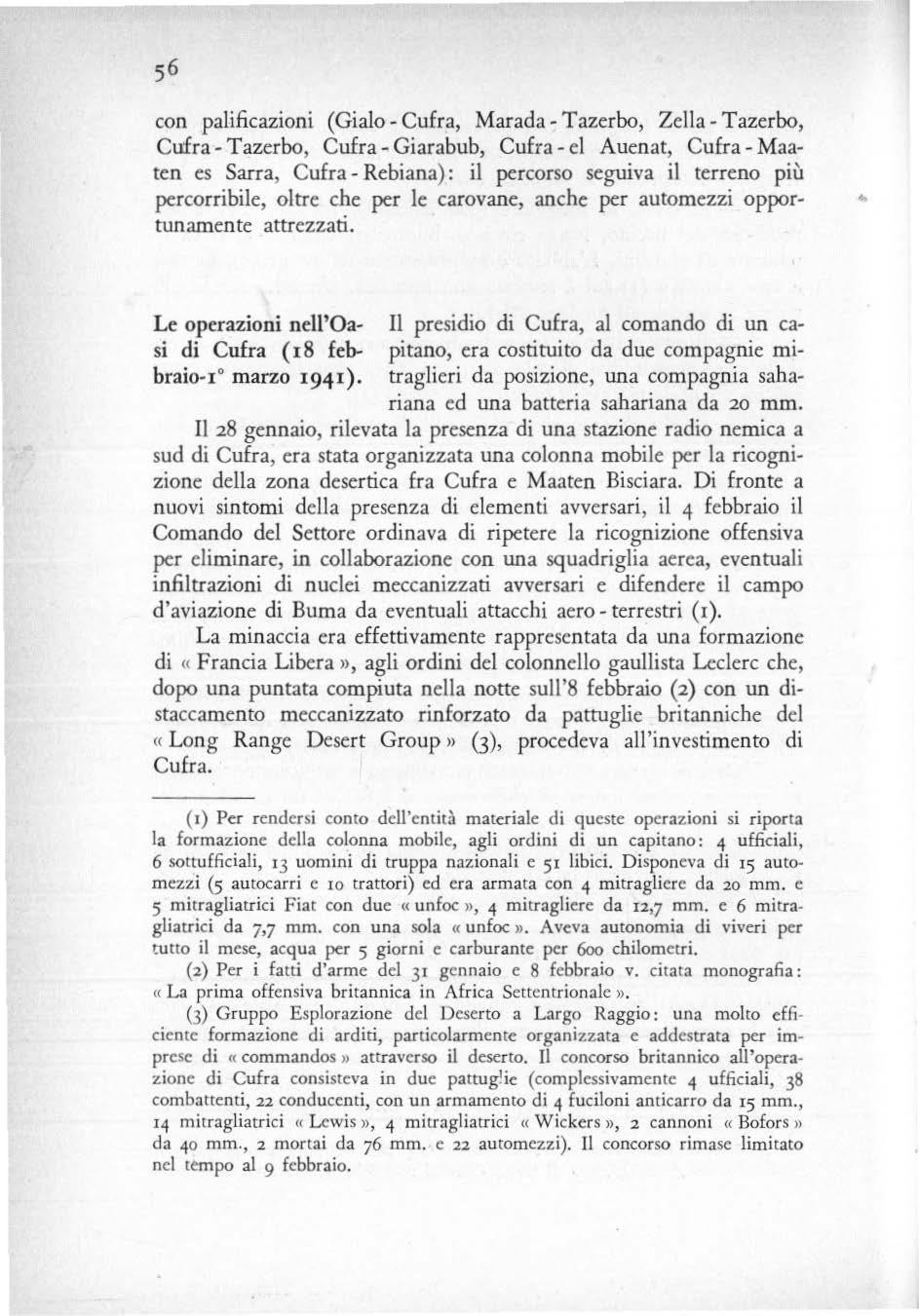
Il 17 febbraio la nostra ricognizione aerea avvistava e spezzonava in zona Maaten es Sarra una ventina di automezzi in marcia verso l'oasi. Il mattino successivo 35 automezzi venivano rilevati sulla stessa direttrice, presso il Gebel el Bueb e anche altri 20 nel Gebel es Zurgh.
La nostra colonna, dislocata a cavaliere della pista Buema- et Tag, prendeva posizione 6 chilometri a nord della ridotta, per contromanovrare fuori dell'oasi.
Alle ore 13 apriva il fuoco contro un 'autocolonna che puntava sul campo di aviazione: l'avversario reagiva ma veniva costretto ad allontanarsi e si sottraeva, sfruttando le anfrattuosità del terreno. Alle ore r8>3o la nostra colonna mobile sostava a sud -ovest di el Hauwari.
Profittando dell'oscurità, numerosi automezzi nemt ct penetravano durante la notte nell'Oasi di Cufra e all'alba del 19 avevano sbarcato degli elementi per il controllo delle vie di accesso. Un aereo « Ghibli » e un S. 8r inviati dal Comando Militare del Sahara Libico effettuavano spezzo nam enò e mitragliamenti da bassa quota sui concentramenti avversari. La nostra colonna mobile attaccava un gruppo di automezzi in sosta a sud- ovest di el Hauwari ma, ormai a corto di munizioni, doveva poi riportarsi verso nord.
Il gio rno 20 forze nemich e, prevalentemente di colore (presumibilm cnte senegalesi) occupavano el Giof e la zona d ell'oasi a nord della ridotta, tagliandone così ogni comunicazione con l'esterno. La n ostra colonna mobil e non era in grado di forzare l'accerchiamento e si raccoglieva l'indomani a Tazerbo.

Il 22 s'iniziava il cannoneggiamento d ella ridotta. Il 26 veniva fru st rato un colpo di mano su un nostro posto avanzato; pattuglie nemich e venivano respinte nella notte del 27.
Il 28 febbraio il comandante della ridotta comunicava:
« N emico continua bombardamento ridotta con obici, difesa esterna co n proietti li a tempo e mortai. Stamane atterrati tre aerei nemi ci da bombardamento. Nostra situazione peggiora ogni ora. Assicurateci invio aerei domani mattina e rinforzi terrestri imminenti per sollevare morale molto depresso ascari ».
L'indisponibilità di apparecchi idonei allo scopo non consentiva di portare alcun aiuto al lontano presidio e l'indomani il comand o della ridotta capitolava dopo aver co municato, alle ore 10, che avrebbe distrutto la stazione radio.
Lievi erano state le perdite : 3 libici morti e 4 feriti. Nella ridotta si trovavano II ufficiali, 15 sottufficiali e uomini di truppa na-
zionali, con circa 200 libici. Di questi ultimi 19 uomini, suddivisi i n due gr uppi , riuscivano il 25 a raggiun gere Agedabia, con l'aiuto di guide locali fornite di cammelli.
L'Oasi di Giarabub. (Schizzo n. 5).
L'Oasi di Giarabub, a circa 250 chilometri dalla costa, si annida in un bacino che fa parte della grande zona delle depressioni, abbracciante le Oasi di Marada, Agila, Gialo, Giarabub e Siwa. Il bacino, lungo 25 chilometri in senso meridiano, largo 6 chilometri in senso parallelo, è sparso di acquitrini, distese salmastre e paludi ed è attraversato da un costone roccioso, composto dal Garet el Barud e Garet el Cuscia. Il suo fondo giace a 6 metri sotto il livello del mare e scende in qualche punto fino a 14 metri.
L'Oasi si trova a circa 30 chilometri dalla frontiera egiziana. E' la culla dell'importante confraterni ta religiosa dei Senussi e si presenta ricca di pozzi, orti e palmeri. Gli edifici, con la moschea in cui è sepolto il fondatore della setta, risalgono alla seconda metà del secolo scorso e sono raccolti su di un'altura che domina l'oasi: legati l'uno all'altro da un muro di cinta a secco, alto circa quattro metri, senza finestre e con solo tre grandi porte di acceso, i fabbricati costituiscono nel loro insieme come un grande complesso fortificato.
Il possesso di Giarabub era stato riconosciuto all'Italia dall'Egitto con il regolamento dei confini fumato il 6 dicembre 1925 e l'occupazione ne era avvenuta il 7 febbraio 1926.
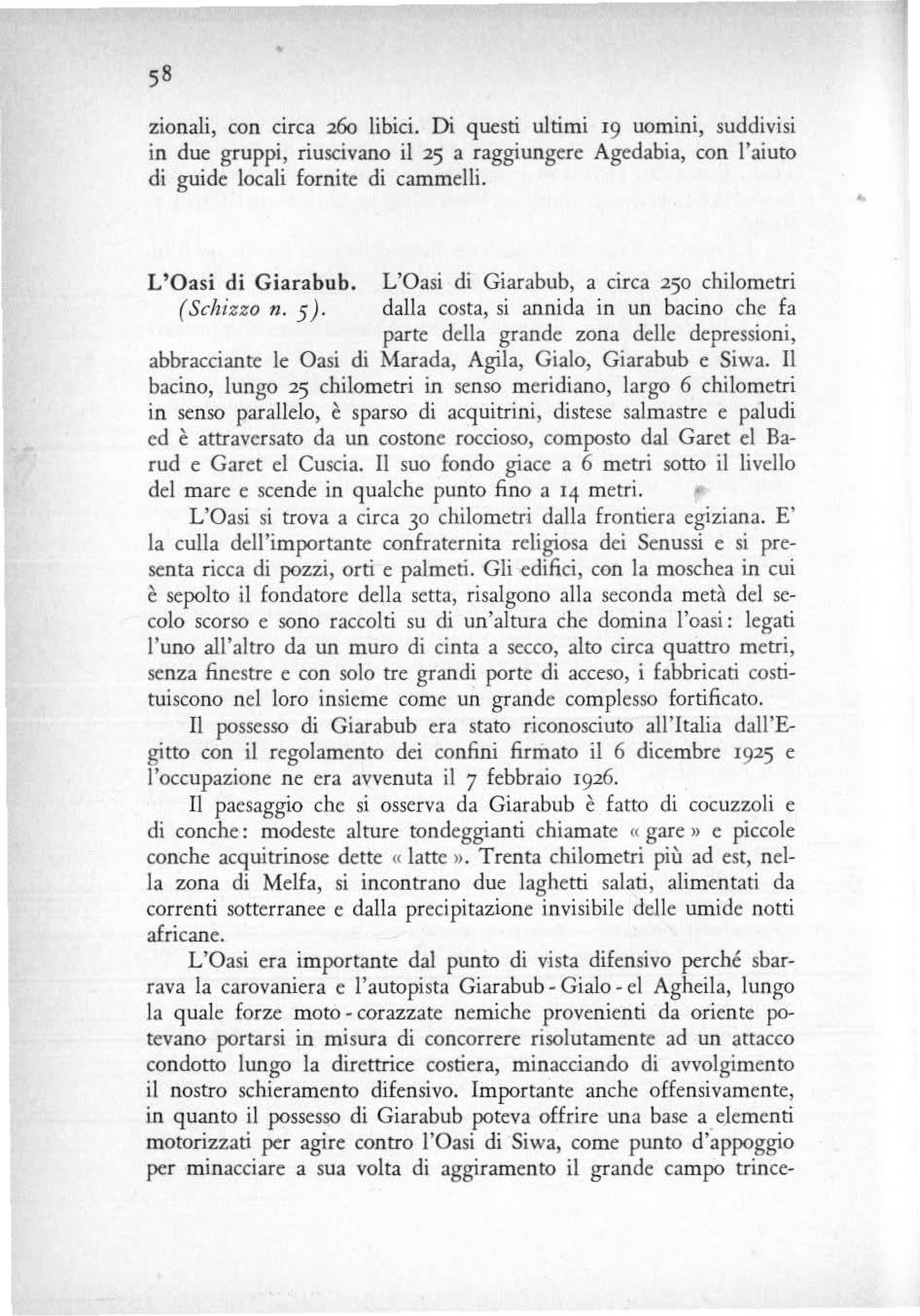
Il paesaggio che si osserva da Giarabub è fatto di cocuzzoli e di conche: mod este alture tondeggianti chiamate « gare » e piccole co nche acquitrinose dette « latte » Trenta chilometri più ad est, nella zona di Melfa, si incontrano due !aghetti salari, alimentati da correnti sotterranee e dalla precipitazione invisibile delle umide notti africane.
L'Oasi era importante dal punto di vista difensivo perché sbarrava la carovaniera e l'autopista Giarabub- Gialo- el Agheila, lungo la quale forze moto- corazzate nemiche provenienti da oriente potevano portarsi in mi sura di concorrere risolutamente ad un attacco condotto lungo la direttrice costie ra, minacciando di avvolgimento il nostro schie ramento difensivo. Importante anche offensivamcnte, in quanto il possesso di Giarabub poteva offrire una base a elementi motorizz ati per agire contro l'Oasi di Siwa, come punto d'appoggio per mina cciare a sua volta di aggiramento il grande campo trince-
rato britannico di Marsa Matruh. L'occupazione di Siwa avrebbe poi anche avuto un valore logistico complementare, per risolvere il problema dell'acqua potabile per il presidio di Giarabub (1).
Le operazioni nell'Oasi di Giarabub (16 febbrai0-2I marzo I94I).
Nel dicembre 1940, dopo che i presidi di frontiera (Sceferzen, Ridotta Maddalena, Uescechet el Heira , el Garn ul Grein) erano stati costretti a ripie gare su Giarabub, il caposaldo disponeva delle seguenti forze, agli ordini del maggiore

Castagna:
4 compagnie guardia alla frontiera;
5 compagnie libiche;
I compagnia cannoni da 47 su I4 pezzi;
I plotone genio libico;
I batteri a da 77/28 su 4 pezzi;
I sezione da 65 / I7 su 2 pezzi;
I batteria da 20 su I6 mitra gliere; personale per i collegamenti radio e telegrafici;
I ospedale da campo;
I ma gazzino sussistenza;
Si tPttava complessivamente di I350 nazionali e 750 libici.
Nel febbraio I94I la difesa era così organizzata:
- posizione di resistenza (4 chilometri di sviluppo) ripartita in 4 capisaldo di compagnia, rinforzato ciascuno con cannoni da 47 e mitragliere da 20. Era circondata da una fascia di -reticolato e protetta, in qualch e tratto, da campi minati e fosso anticarro;
- posti avanzati di vigilanza a Ain Melfa, Bahar el Arrascia e Baharia;
- posti di sbarramento a Garet el Barud, Garet Cuscet el Gazal, Garet en Nuss e Gara del Diavolo.
Il settore disponeva di un campo di atterraggio, 4 chilometri a nord del fortino di Giarabub.
Investita da forze mobili britanniche, la difesa interna di Giarabub era soggetta al fuoco dei cannoni da 88 che i no stri pezzi da 77 /28 non riusci vano a controbattere, per la minore gittata.
(1) I soldati libici bevevano l'acqua salmastra delle oasi. Ai nazionali era stata in primo tempo distribuita acqua minerale ma in seguito si erano adattlti anche loro, ufficiali e truppa, all 'acqua del posto.
Il 4 febbraio aveva luogo l'ultimo volo degli aerei di rifornimento, i quali provvedevano an che allo sgombero dei malati e feriti su Bengasi. Le condizioni gen erali degli uomini denunciavano già uno stato di denutrizione, in quanto posti a metà razione da oltre so gwrm.
Lo sgombero della Cirenaica aveva dato luogo a seri fenomeni di defezione nelle file dei libici, preoccupati per la sorte delle proprie famiglie. Ad evitare che disertassero con le armi, il Comando del Presidio era stato autorizzato a congedarli: oltre 6o avevano però chiesto di rimanere e con tinuarono a co mbattere con i na zionali. Con l'allontanamento dei libici la forza della guarnigione era scesa a meno di 1300 uomini. Era per contro aumentata di 5 giornate la dotazione viveri.

Il 17 febbraio il Comando Superiore rendeva noto che stava studiando la possibilità di rinforzare il presidio a mezzo aerei.
D opo la caduta della Cirenaica l'artiglieria britannica aveva intensificato la propria azione, specie all'alba, quando nostre colonne celeri uscivano per portarsi a distanza di tiro efficace per controbattere. le batterie avversarie con i pezzi da 47 mm. montati su autocarri.
Il 19 febbraio, dopo intensa preparazione d'artiglieria, il nemico attaccava con mezzi blindati e reparti autotrasportati il posto di Garet Cuscet el Gaza! che opponeva strenua resistenza finché, soverchiari, gli uomini avevano dovuto portarsi su un ciglione non accessibile alle autobli ndo. I britannici proseguivano allora verso Giarabub: contrattaccati da una nostra colonna cele re erano costretti a ripiegare, insieme al reparto che aveva occupato il posto di sbar ramento.
A partire dalla stessa data l'azione assumeva un ritmo se mpr e più serrato. La nostra difesa era soggetta a continue puntate di forze motorizzate, ad attacchi aerei ed al pressoché ininterrotto bombardamento dell'arti glier ia. Il gio rno 25 il maggiore Castagna comunicava:
« Rifornimento viveri promesso non ancora giunto. Ho una sola giornata di viveri. E' doloroso, dopo tanti sacrifici, doversi arrendere per fame >> .
Il successivo 27 poteva effettuarsi un lancio di galletta e scatolette. Il 2 marzo veniva respinto un invito alla resa, così come era avvenuto per una precedente sollecitazione in gennaio (r): la risposta
(r) L'invito alla resa era contenuto in volantini lanciati dagli aerei , così stilato:
vemva affidata alle nostre colonne celeri, con nuov e puntate offenSive.
Il 6 marzo autoblindo e fanterie britanniche, appoggiate da artiglieria, tornavano ad attaccare il posto di Garet Cuscet el Gazal il cui presidio riusciva a ripiegare, sotto la protezione della nostra colonna celere, appostata sul rovescio della posizione. L'azione veniva poi definitivamente fermata con il concorso di altra colonna celere inviata da Giarabub.
Nei giorni seguenti gli attacchi riprendevano in tutte le direzioni: più vigorosi quelli del 16 e 17, dopo i quali non ri sultava più possibile mantenere il possesso dei due posti di sbarramento di Garet Cuscet el Gazal e di Garet en Nuss.
Lo stesso giorno 17 Giarabub poteva ricevere un altro rifornimento aereo di viveri. Veniva contemporaneamente lanciato il seguente messaggio del gen. Rommel : « Saluto i valorosi difensori di Giarabub ed esprimo la mia ammirazione. Continuate a fare il vostro dovere. Fra pochissime settimane saremo da voi».

Ma l'avversario non concedeva oramai tregua: continuava ad ammassare mezzi davanti alla posizione di resistenza e la sera del 19 attaccava in forze, da sud- ovest, il caposaldo n. I. Riusciva a penetrarvi ma ne veniva ricacciato dopo aspra lotta. L'indomani la sua artiglieria imperversava per l'intera giornata sulle nostre posizioni, mentre l'aviazione, indisturbata, mitragliava e spezzonava truppe e automezzi.
All'alba del giorno 20 lo stesso caposaldo n. r veniva nuovamente investito per 45 minuti con un violento bombardamento che ne danneggiava gravemente le opere: l'assalto che ne seguiva poteva essere contenuto mentre la lotta si estendeva ai capisaldi n 2 e n. 4· Alle 9,30 il nemico riusciva ad impossessarsi della « ridotta vecchia >> e di quasi tutte le alture dominanti del caposaldo n. I, sulle quali venivano postati cannoni di piccolo calibro, mortai da 81 e pezzi contraerei che concentravano il tiro sui centri di resistenza ancora
« Difensori di Giarabub: i vostri capi probabilmente non vi hanno detto che abbiamo occupato l'intera Cirenaica, catturando n5 mila prigionieri cd ingent i quantità di materiali. Le nostre truppe marciano ora su Tripoli. Ogni vostro sacrificio è quindi inutile ed anche la via di ritirata è preclusa. Arren. detevi; noi vi tratteremo bene »
Subito dopo la caduta di Bardia (5 gennaio) erano stati lanciati volantini su Giarabub in cui si leggeva:
<<Ogn i vostra resistenza è inutile. Volete essere sch ia cciati dai nostri carri da So tonnellate? L'Impero non perdona. Arrendetevi!'' ·
attivi. La difesa reagiva lanciando ancora dei contrassalti: lo stesso Comandante restava ferito, alla testa di un reparto di libici.
Alle ore II gli ultimi difensori del caposaldo n. r venivano sopraffatti. La lotta si protraeva per oltre quattro ore negli altri capisaldi. Durante le ultime fasi del combattimento un aereo tedesco appariva sul cielo della battaglia: dopo aver sparato poche raffiche di mitragliatrice veniva colpito dal tiro contraereo ed era costretto ad atterrare nelle vicinanze.
Dopo mesi di strenua resistenza aveva così termine la valorosa difesa di Giarabub. Il numero complessivo delle perdite, in base ad una valutazione del comandante, superava i 400, tra morti e feriti, sui 1287 uomini rimasti in seguito all'allontanamento dei libici. Dopo il combattimento un nostro ufficiale presenziava al seppellimento di 84 caduti, 21 dei quali non identificati.

ALLA FINE DI MARZO
Occupazione di el Agheila. (Schizzo n. 3).
Prima di partire in volo per l'OKW per uno scambio d'idee sulle imminenti operazioni ( 19 marzo), il gen. Rommel aveva dato incarico al Comando della sa Divisione Leggera di preparare una azione per l'occupazione di el Aglieila, punta avanzata dello schieramento avversario, dalla quale irradiavano continue molestie alle nostre colonne di rifornimento per il gruppo di combattimento italo- tedesco dislocato nell'Oasi di Marada. Si trattava inoltre di impossessarsi del vicino campo di aviazione.
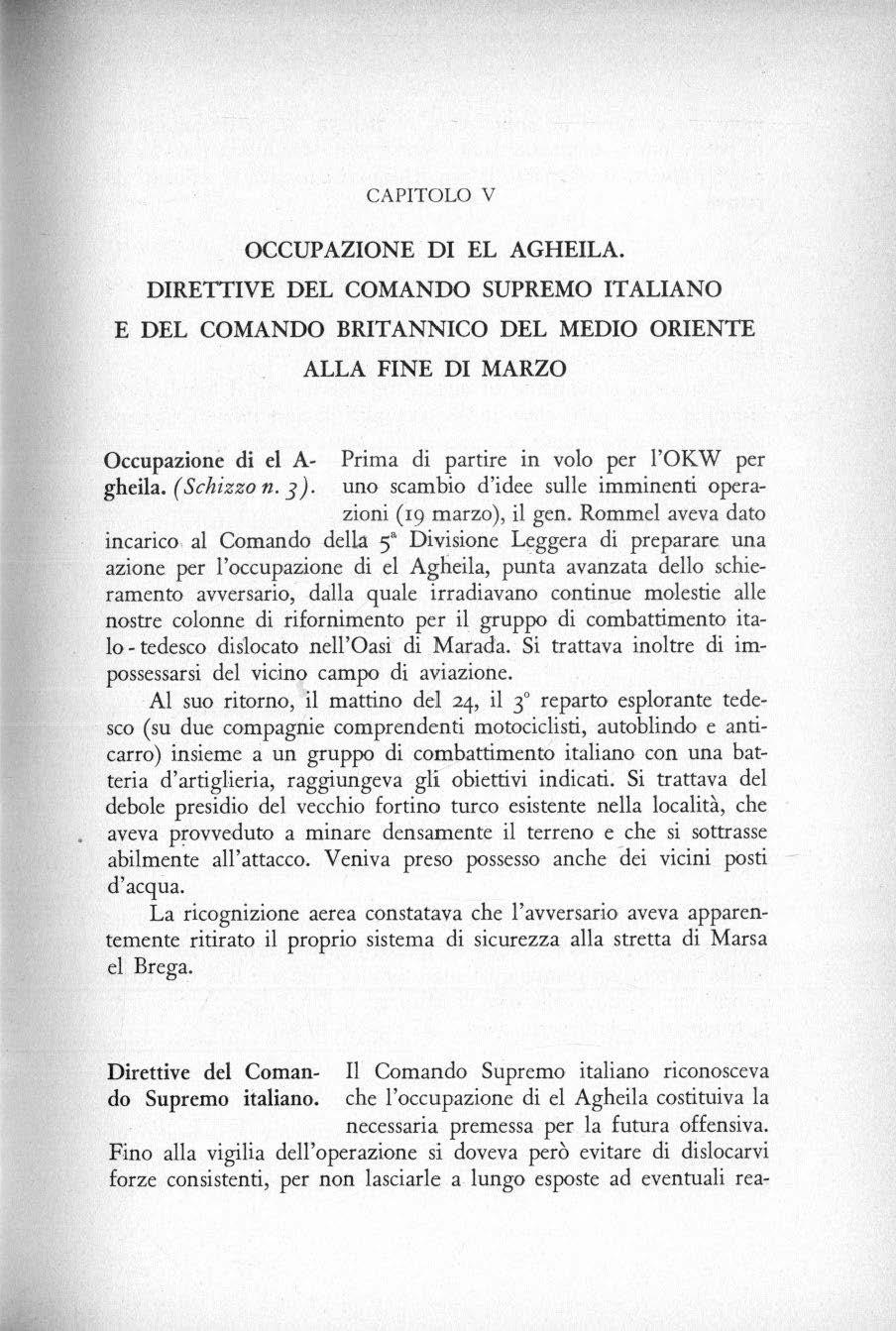
Al suo ritorno, il mattino dd 24, il 3o reparto esplorante tedesco (su due compagnie comprendenti motociclisti, autoblindo e anticarro) insieme a un gruppo di combattimento italiano con una batteria d'artiglieria, raggiungeva gli obiettivi indicati. Si trattava del debole presidio del vecchio fortino turco esistente nella località, che aveva a minare densamente il terreno e che si sottrasse abilmente all'attacco. Veniva preso possesso anche dei vicini posti d'acqua.
La ricognizione aerea constatava che l'avversario aveva apparentemente ritirato il proprio sistema di sicurezza alla stretta di Marsa el Brega.
Direttive del Coman- Il Comando Supremo italiano riconosceva do Supremo italiano. che l'occupazion e di el Agheila costituiva la necessaria premessa per la futura offensiva. Fino alla vigilia dell'operazione si doveva però evitare di di slocarvi forze consistenti, per non !asciarle a lungo esposte ad eventuali rea-
zioni dei corazzati britannici che, si riteneva, erano in condizione di potere più rapidamente di noi convergere e far massa fra Marada ed el Aghe.ila. Il 28 marzo il gen. Guzzoni emanava le seguenti direttive:
lì 28 marzo 1941
Dal Comando Supremo - Stato Maggiore Generale al Super Comando A.S.l.
Ri spos ta al foglio n. or f 2763 Op. del r6 marzo u.s.
Concordo pienamente su quanto mi riferite con il foglio a cui rispondo ed in particolare sull'opportunità di non iniziare l'azione offensiva se non quando saranno affluiti tutti i mezzi per condurla a fondo.
Così pure lo schieramento, ancora difensivo, dovrà gradatamente, con il migliorare della nostra situazione trasformarsi, fino a diventare decisamente offensivo nell'imminenza dell'azione.
Nella situazione attuale, in cui la nostra inferiorità di forze corazzate e motorizzate è ancora sensibile, mentre le G.U. mobili, facili allo sganciamento, possono e debbono (come avete fatto) essere spi nte in avanti, a contatto con il nemico, per sorvegliarlo e contrastarlo nell'eventualità di una ripresa offensiva, le G.U. di fanteria trovano ancora la dislocazione più opportuna sulla posizione scelta per la battaglia d'arresto.
In relazione a questo concetto, che è anche Vostro, Vi prospetto, Eccellenza, l'opportunità di non portare innanzi altre Grandi Unità non mobili oltre la « Brescia » che anzi converrebbe, prolungandosi la nostra situazione difensiva, ritirare sulle posizioni di Sirte, non appena potete sostituirla con la « Trento >> o con la 15a corazzata.
Quando riterrete il nostro attuale schieramento difensivo sicuramente solido ed una eventuale ripresa offensiva nemica poco probabile, potrete poi esaminare l'opportunità di ritirare una divisione, a turno, n ella zona delle oasi di Misurata e Zliten, per far riposare le truppe dalla loro permanenza nel deserto sirtico.
Il Sottocapo di S.M. Generale
A. Gu zz oni
Il gen. Gariboldi era pienamente consenziente al concetto di non iniziare l'azione offensiva finché non si disponesse a piè d 'opera di tutto l'occorrente e di manten ere frattanto urio schiera mento pru-
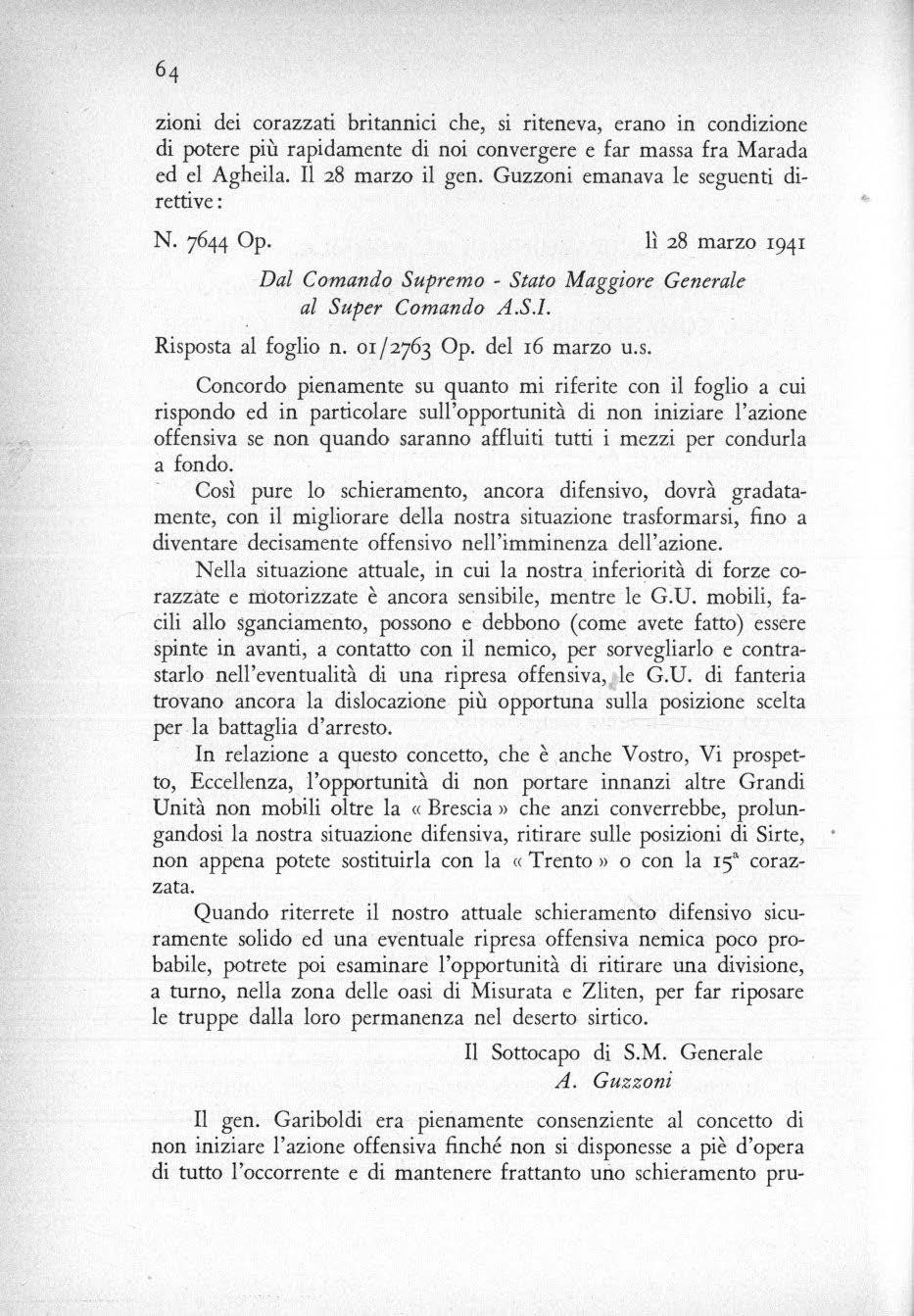
denziale, tale da non incorrere nel rischio di esporre una co nsistente frazion e ad eventuali colpi di mano avversari ma nello stesso tempo atto ad affrontare, occorrendo, n elle miglior i co ndizioni una battaglia d'arresto.
Considerato che:
- la posizione di Sirte non offriva alcun vantaggioso appiglio tattico, mentr e quella avanz ata di el Agheila e più ancora la stretta, più ad ovest, di Marsa el Brega, trovava nel terreno più valido appoggio, e quind i meglio si prestava alla difesa;
- la linea el Agheila- Ma rada si prestava a frustrare velleità offensive avversarie;
- l'occupazione, spinta un poco più avanti sulla litoranea, avrebbe garantito meglio la strada el Agheila- Marada, lungo la quale potevano comodamente affluire i rifornimenti a Marada d'onde, a sua volta, era possibile trarre un apprezzabile contributo per il rifornimento idrico;
giungeva alle seguenti conclusioni:
« Aggiungo qui , per inciso e per illuminare completamente la situazione, che ho alle mie dipendenze il gen. Rommel che, come noto, ha la febbre d ell'azione, verso la qual e è sempre teso e che per conseg uenza, sia per l'appr ovazio ne di Berlino, sia per le modalità degli accordi co ncretati costà circa la sua dipendenza, no n mi è sempre facile fermare gli impu l si dell'avanzata.

« Mi è stato proposto, in vista delle condizioni su accennate di térreno, di spostare gradatamente la nostra occupazione da Agheila alla stretta ad ovest di Marsa el Brega, sia per migliorare la difesa, rendendola più solida, sia per dare protezione alla strada AgheilaMarada. Ho aderito, purché la cosa si facesse progressivamente>>.
Perfettamente realistica e aderente è l'inclusione del « fattore Rommel » negli elementi della programmazione e dell'es ec uzione operativa per le forze dell'Asse . Come risulta dalle precedenti citazioni, il ritmo dell'avanzamento consentito alle sollecitazioni del gen. Rommel è già notevolmente più serrato di quello rispo nd ente alle prudenziali direttive del Comando Supremo (in armonia d'altronde con le vedute dcll'OKW): è questo un procedimento che occorrerà di riconoscere sovente n el processo evolutivo delle concezioni operative: un impulso iniz i ale suggerito dalla ferv ida fantasia e dalla febbre di azione del gen. Rommel, cui si contrappone una cauta presa di posizione del Co m ando italiano, seguita poi da una elastica azione di ritenuta, destinata a sboccare finalmente n el pieno
consenso (quando non debba assumere la forma dell'accettazione del fatto compiuto).
Nel caso concreto, l'iniziativa del ge n. Rommel (man man o approvata dai comandi superiori italiani) conferirà agli avvenimenti un corso ben più rapido di quello programmato: la data d'inizio della controffe n siva, già prevista per la fine di maggio, verrà praticamente anticipata al 31 marzo.
Direttive d el Coma ndo britannico del Medio Oriente.
Al Primo M inistro Churchill che l'aveva richiesto della propria opinione sulla situazione in Africa Settentrional e in relazione agli ultimi avvenimenti, così rispondeva il gen. W aveli in data 27 marzo :
«Non vi è alcuna prova che vi siano molti tedeschi ad Agheila; è probabile che sia no in maggioranza italiani, con un piccolo rinforzo di tedeschi .. .
« D evo riconoscere di essermi assunto in Cirenaica notevoli rischi, dopo l'occupazione di Bengasi, per dare il ma ssimo aiuto alla Grecia .. .
« Dopo che ci siamo assunta la responsabilità di soccorrere la Grecia, co minciarono ad accumularsi le prove dell'arrivo dei rinforzi tedeschi in Tripolitania, accompagnati da attacchi contro Malta che ci impedirono quel bombardamento insiste nte di Tripoli sul quale avevo fatto assegnamento. Gli attacchi aerei tedeschi contro Bengasi, che impedirono ai trasporti dei rifornimenti di servirsi del porto accrebbero le nostre diffi coltà (1).
« Il ri sultato è che attualmente in Cirenaica io sono debole e che non dispongo di alcuna riserva di truppe corazzate, assolutam ente indispensabile. D ella 2• Divisione Corazzata una brigata l'ho in Cirenaica, l'altra in Grecia. La 1 Divisione Corazzata sta tornando (al Cairo) e, dato che non esistono carri armati di riserva, dovrà attendere le riparazioni, le quali richiedono tempo.
(1) « Ciò significò - poi il gen. Wavell nel rapporto del settembre 1941 - che tutti i rifornimenti dovettero essere portati da Tobruch, aumentando la lin ea delle com unicazioni fino alle truppe avanzate di più di 200 miglia. La mobilit!l delle truppe avanzate ne fu grandemente infìciata. In particolare la 2 • Divisione Corazzata dovette essere rifornita dai depositi, invece di avere in proprio i relativi mezzi di trasporto: fatto questo che avrà serie ripercussioni s ull e operazioni ».
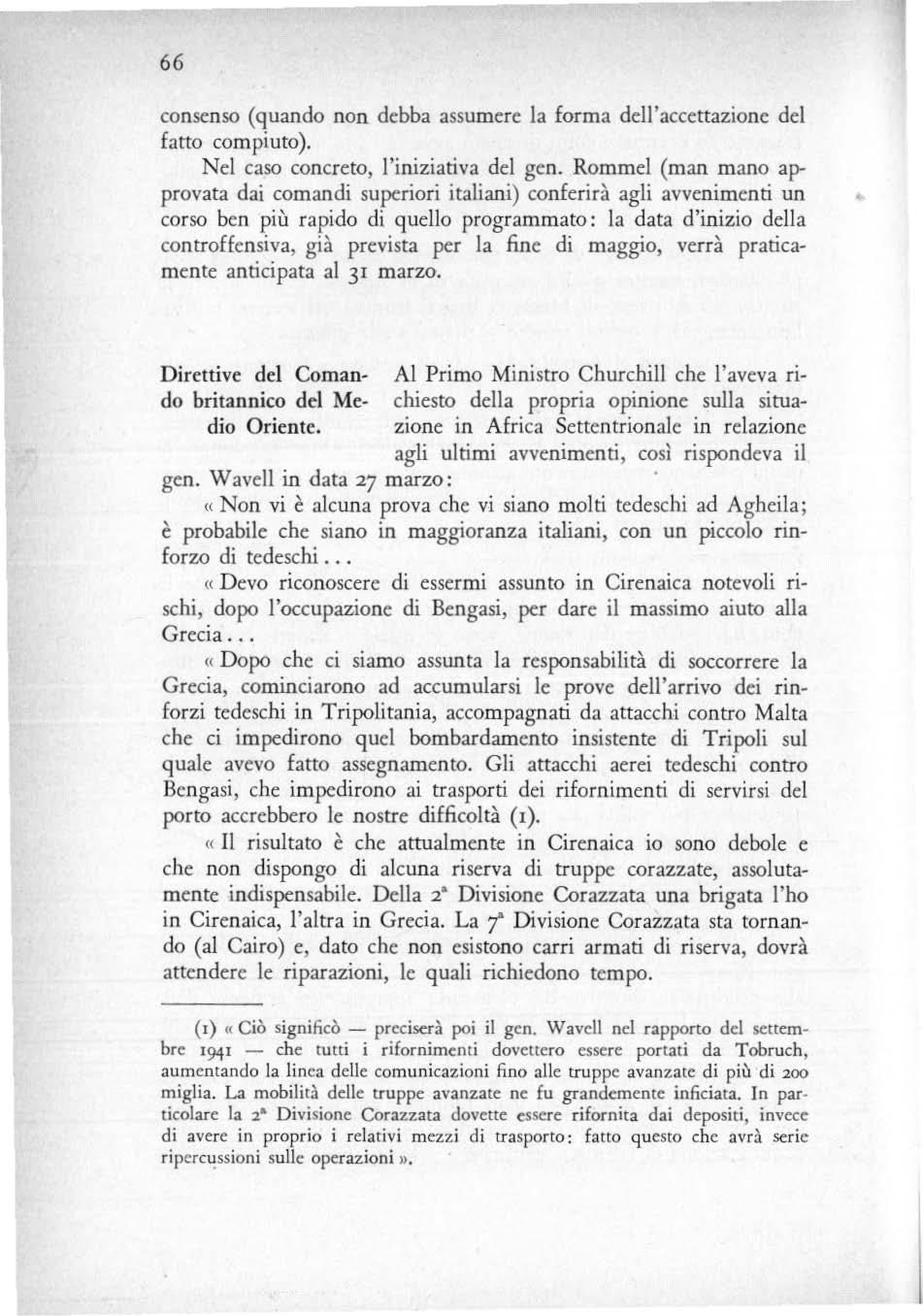
« Il prossimo o i due prossimi mesi, saranno mesi di zione ma anche il nemico ha problemi estremamente difficili ed io sono sicuro che le cifre dei suoi effettivi sono state molto esagerate. Non posso tuttavia permettermi per il m ome nto di impiegare le mie esigue forze corazzate così audacemente come vorrei.
«So no in corso provvedimenti per rafforz are la Cirenaica ... ».
Coerente a questa visione della situazione, il gen. Wavell impartiva al gen. Neame, comandante delle forze britanniche i n Cirenaica, le seguenti direttive generali, per il caso di un attacco nemico:
- svolgere azione ritardatrice nella posizione avanzata, ad est di Agheila e Bengasi, senza esitare a cedere terreno, fino alla città stessa di Bengasi, da sgomberare qualora la situazione lo des se;
- mantenere il più a lungo possibile il possesso ptano;
- risparmiare al massimo le truppe corazzate, senza le quali là posizione risulterebbe assolutamente compromessa, non essendo suscettibile di rinforzo prima del mese di m aggio.
Il 30 marzo il gen. Neame impartiva corrispondenti direttive alle unità dipendenti. Nella circostanza rilevava come « dopo pazione di el Agh eila non si era avuto da parte del nemico alcun segno riv elatore di progetti di ul teriore avanzata, alcuna conclusiva evidenza delle sue intenzioni di prendere l'offensiva su larga scala o che fosse verosimilmente in grado di farlo in un prossimo avvenire » (r).
Appena poche ore più tardi, l'iniziativa di Romm el sorpre ndeva in pieno il Comando Britannico (e gli Alti Comandi italiano e tede sco nello stesso tempo!).
(1) << Hi story of the sccond World War: Th e Mediterranean and Middle East », vol. II pag. 12, autore: Playfair I.S.O., London, 1956, H.M.S.O. Ed.

Al 27 marzo l'atteggiamento delle forze ita1o- tedesche sembrava dunque perfettamente definito: al coperto di una leggera linea di occupazione avanzata cl Agheila- Marada (eventualmente «s pinta un poco più avanti sulla litoranea », secondo l'ammissione del gen. Gariboldi) m antenere il più a lungo possibile lo schieramento difensivo, all'altezza di Sirte, compatibilmente con le esigenze dell'ammassamento delle forze per la progettata controffensiva, da sferrare nel mese di maggio.
Su questi termini sembrava esistere pieno accordo fra Comando Supremo e Coman do Superiore italiano in A. S. da una parte e OKW e lo stesso gen. Rommel dall'altra. Si tratta quindi di chiarire a questo punto le ragioni del repentino ed imprevedibile ripensamento del coman dante del C.T .A. che il 31 marzo metteva in moto, d'iniziativa, la travolgente azione che nel giro di due settimane doveva portare alla ricon quista dell'intera Cirenaica. Ne fornisce la chiave lo stesso gen. Rommel :
« La stretta di Marsa el Brega (su cui erano ripiegati gli elementi avanzati avve rsari) (r) era il pri mo obiettivo dell'offensiva ordinata per il maggio contro le forze avversarie nella zona di Agedabia. Dopo la cacciata da el Agheila i Britannici si stabilirono sulle alture dominanti presso Marsa el Brega e a sud della Sebca presso Bir Suera e là cominciarono a sistemarsi a difesa. Questi preparativi ci davano molta noia perché se si lasciava all'avversario il tempo di r affo rzare quel caposaldo già forte per natura, di ci rcondarlo di reticol ati e minarlo, egli sarebbe venuto in possesso di una posizione da contrapporre alla nostra di Mugtaa, che solo con difficoltà si poteva attaccare e aggirare da sud. Anche il terreno a sud dell'Dadi
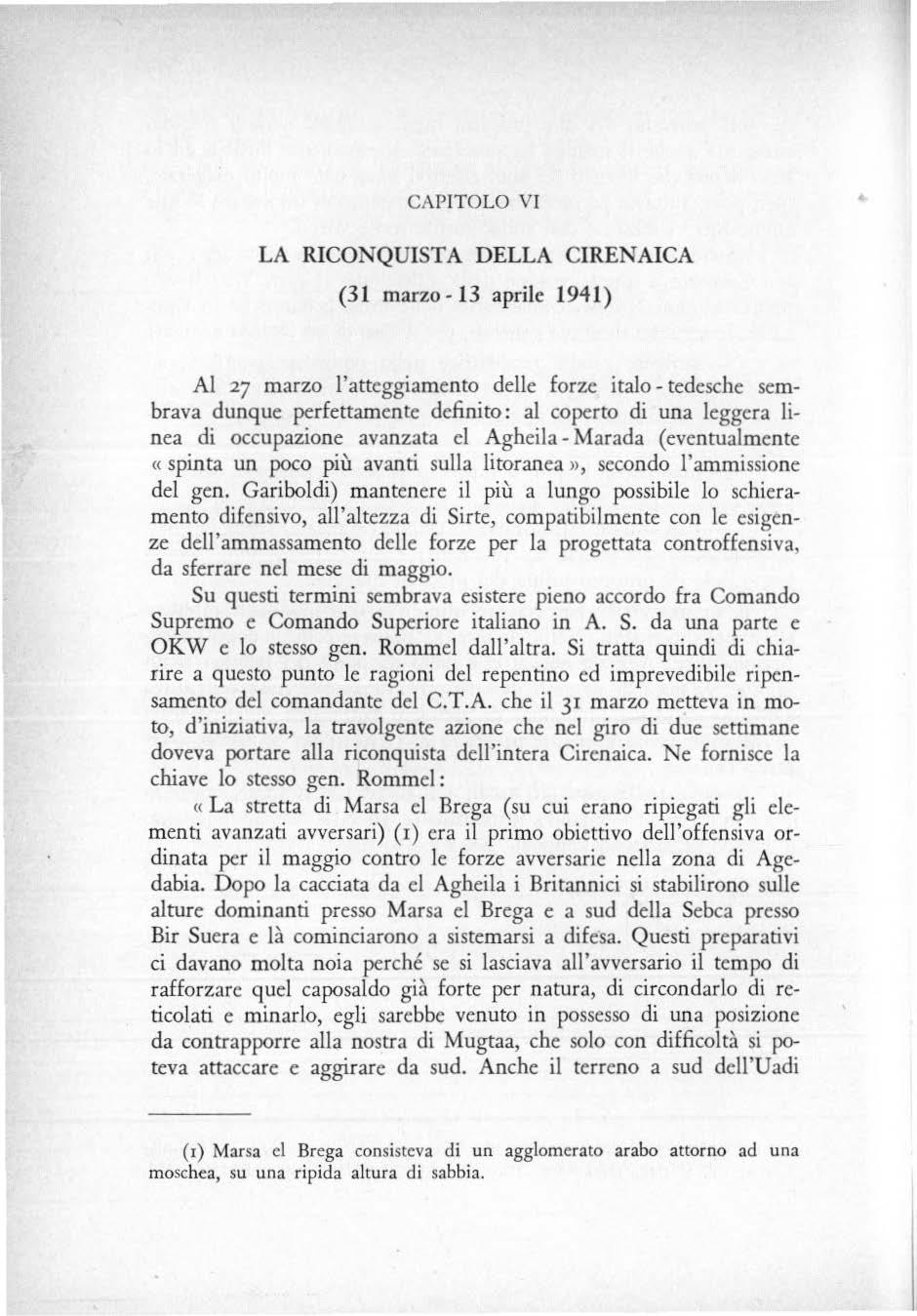
Farcgh, a circa 5 chilometri a sud di Marsa el Brega, era molto salr bioso e difficilmente transitabile con gli autoveicoli. Mi trovai dunque di fronte all' altern ativa di aspettare fino alla fine di m aggio l'arrivo di tutte le mie truppe , dando così ai Britannici l'opportunità di sistemare la posizione in modo ch e un attacco poteva difficil m ente av ere il desiderato successo, o d i attaccare con nos tr e modeste forze la posizione avversaria di Marsa el Brega non ancora fortifica ta.
« Mi decisi per la seconda soluzione, ritenendo che, nonosta nte la r elativa esigui tà delle no stre forze, attaccando in quel mom ento potessimo ancora assicurarci il possesso d ella stretta . Questa si prestava ai no stri scopi quanto il settore di Mugtaa e rapprese ntava n ello stesso tempo una posizione difensiva e offensiva favorevole per l 'attacco progettato per il maggio. Con un'azione contro Marsa el Brega potevamo anche assicurarci nuov i, importanti rifornime n ti d'a cqua ... » (r).
L'azione del 31 mar zo non era dunqu e con cepi ta come lo scatto anticipato della gr and e controffen siva ma com e sempl ice operazione di assestamento, in vista appunto della maggiore impresa, da affrontar e non prima della fine di maggio. Gli eccezionali ri sulta ti che ne derivarono erano in quel mom ento assolutam ente imprevisti e sono pertanto frutto d ' improvvisazione, un passo dopo l'altro, sulla via del pronto e felice sfruttamento d el successo.
Rimarrebbe infine da chiarire la ragione del silenzio serbato dal g en. Rommel in merito alle sue intenzioni verso i propri superiori , italiani e tedeschi di fronte ai quali si assumeva, evidentemente, la responsabilità di un vero e proprio atto di di subbidi enza o quanto meno di interpretazione eccessivamente lata d elle proprie prerogative di comando. E ' un argomento questo sul quale, ovviam ente, non sarà mai possibile raggi ungere con creti elementi di giudizio: è verosimile che si tratti della ri sultante di un co mple sso di concause nell e quali ri entra in primo luogo il carattere insofferente di soggezione e ansio so di azione del comandante tedesco, insieme al timore di vede r si opporre un rifiuto ad un ano tatti co pe r se stesso di non grande rilievo che tuttavi a egli giudicava essenziale per il successo dalla futura maggiore impresa. Non si può escl udere che il m odesto volume inizi ale dell'operazione potesse rientrare agli occ hi del gen. R o mm el nell 'ambito del la limitata spinta in avanti formalm ente autorizzata dal gen . Gariboldi.
 ( 1) EL: << Guerra se nz'odio » , Garzanti, 1952, pagg. 13 - 14.
( 1) EL: << Guerra se nz'odio » , Garzanti, 1952, pagg. 13 - 14.
Fasi dell'op erazione. Lo sviluppo della controffensiva si può articolare, per le sue caratteristiche, in tre fasi distinte, anche se immediatamente successive e senza soluzione di continuità:
I fase: sbalzo di sorpresa fino a Bengasi (31 marzo- notte sul 4 aprile 1941);
II fase: avanzata da Agedabia e Bengasi su Mechili- Deroa (4-8 aprile);
III fase: investimento di Tobruch e raggiungimento del confine egiziano (9- 13 aprile).
All'operazione par teciparono le seguenti Grandi Unità, agli ordini del gen. Rommel :
- s• Divisione Leggera tedesca ;
- Divisione Corazzata « Ariete »;
- Divisione di Fanteria « Brescia », rinforzata da un battaglione della Divisione « Bologna » (r).
Situazione iniziale del- Alla vigilia della controffensiva le forze ital e forze italo-tedesche. lo - tedesche presenti in Tripolitania (esclusi i lontani distaccamenti a protezione della frontiera sahariana) ammontavano complessivamente a 3 divisioni di fanteria e 2 divisioni corazzate, suddivise in due nuclei:
- 5• Di visione Leggera tedesca, « Ariete » e « Brescia » nella zona avanza ta di Agheila;
- Divisioni « Pavia >> e « Bologna >> in posizione arretrata, nella zona di Sirte.
La loro consi stenza compl essiva era di 37.000 uomini, 46 carri M e 209 carri L, 498 pezzi di artiglieria del X C.A. italiano; 9300 uomini, 30 carri armati, un numero imprecisato di autoblindo (2 com-
AbO .. pagnie), II I pezzi an ticarro, 2000 automezzi della s· Divisione Leg-
RR l ARli · gera tedesca ( 2).
La dislocazione particolareggiata risulta dallo schizzo n. 6.
( r) Il 17 marzo la Divisione «Brescia >> er a passata «pe r impiego temporaneo» alle dipendenze del C.T.A.
(2) Per l'ordine di battaglia dell e Forze Armate italiane in Africa Settentrionale alla data del 1° aprile 1941: v. allegato n. ro. Nell'allegato n. 11 è riportato inoltre l'ordine di ba tt aglia particolareggiato, con dati di forza e di
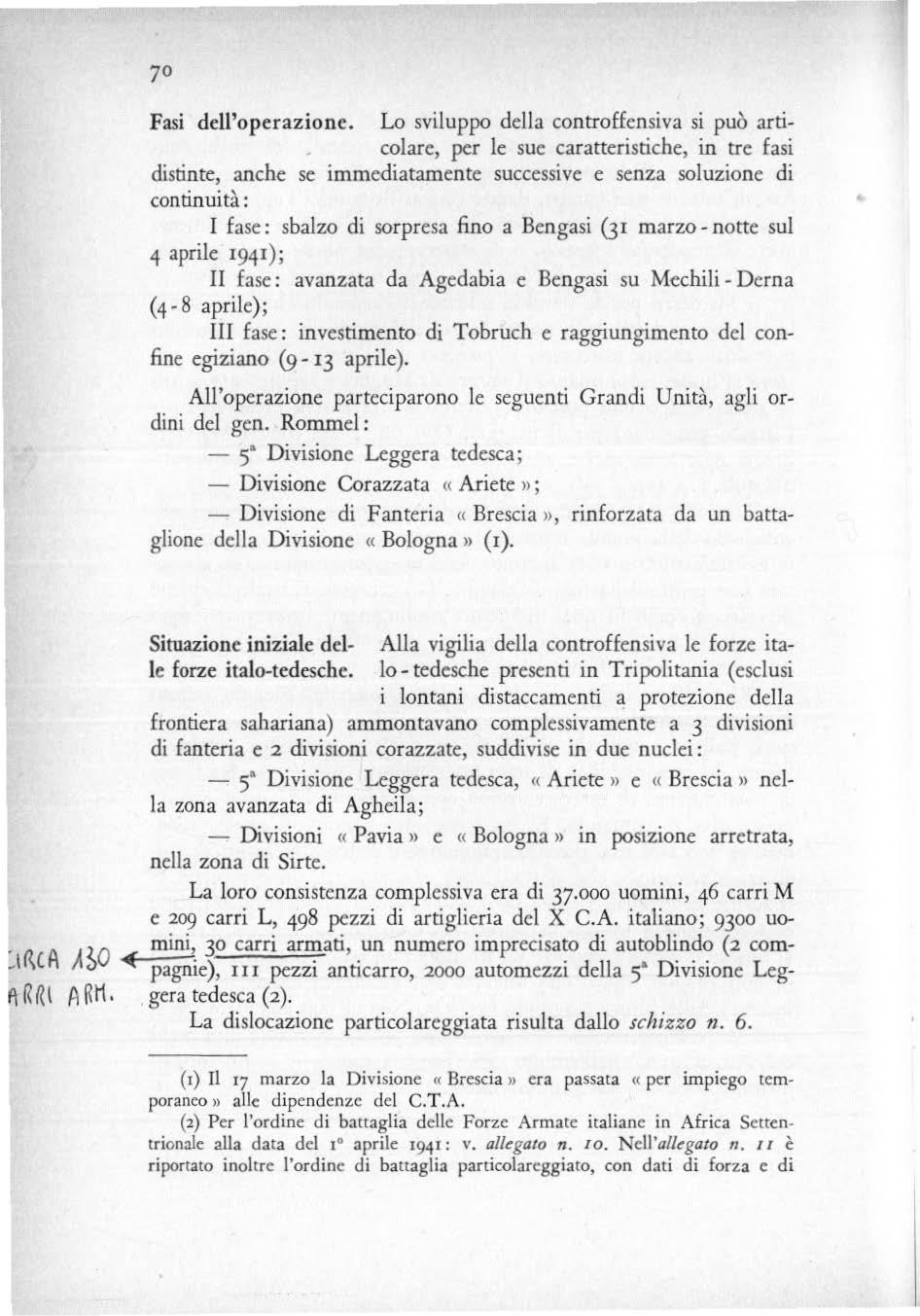
Secondo la valutazione dei comandi italotedeschi, le forze avversarie scagliona te tra el Agheila e Marsa Matruh ammontavano a circa 9 divisioni, per un complesso di 50.000 uomini, un migliaio di mezzi corazzati e intorno ai 200 pezzi di artiglieria. La loro distribuzione risultava essere la seguente:
- zona M arsa el Brega- Bir es Suera- Maaten Bclclcibat- Maaten Bettafal: 2 reggimenti cavalleria meccanizzati della t Divisione Corazzata britannica ( r• King Dragoon Guards e s• Ussari) e un btg. della XVII I Brigata australia n a;
- zona Ras el Ahmar - Bir Bila! -el Gtafia- el Haseiat: XVII Brigata della 6• Divisione australiana (meno un battaglione)
I brigata motorizzata francese (2 battaglioni?) e il grosso della 1 Corazzata;
- zona Agedabia: 4:' Divisione Corazzata (1);
- zona Cirene- Derna: 2 divisioni britanniche;
- zona Tobruch- Sollum: 2 divisioni indiane.
D al rapporto del gen. Wavell risultava invece che verso la fine di marzo le forze di copertura ad oriente di el Agheila erano rappresentate da:

armamento, della Divisione Corazzata « Ariete» mentre negli 11. I 2 c 11. 13 risulta la consistenza numerica delle nostre Unità. La composiz ione dclb 5 Divisione Leggera è stata riportata alla pagina 24.
(1) Da un documento nemico cad uto in nostra mano il 4 aprile il Corpo Corazzato britannico risultava composto delle seguenti unità: III Brigata corazzala (t• King Dragoon Guards, 8• Ussari, VI Royal Tanks) un battaglione fanteria francese motorizzato, due battaglioni fanteria motorizzati, un reggim ento artiglieria, una compagnia anticarro, una squadriglia d'aviazione.
L '8 aprile, sulla scorta di ulteriori informazioni, risultava che lo stesso Corpo Corazzato sul fronte cirenaico comprendeva parte dei reggimenti già appartenenti alla 4a e alla 7• Divisione Corazzata. Precisamente: due reggimenti cavalleria m eccanizzati (K ing Dragoon Guards e 8• Ussari), due battaglioni carri armati (V e VI Royal T:anks), cinque battaglioni fanteria motoriz zat i, due reggim enti artiglieria motorizzati (3• Royal Horse Artillery e 104'' regg. art.), una compagnia anticarro, una squadriglia d'aviazione
I rimanenti reparti delle Divisioni Corazzate 4• e f, probabilmente disciolte, si ritenevano trasferiti nel Delta e successivamente in Grecia, per la costituzione di due nuove divisioni corazzate. Risultava altresì che una delle divisioni del Corpo ANZAC era partita per la Grecia e che le due divisioni britanniche dislocate in zona Cirene- Derna avessero lasciato la Cirenaica: una si sarebbe imbarca ta a T obruch per la Grecia, l'altra sarebbe stata ritirata nel Delta.
- 2 Divisione Corazzata (meno la I Brigata rinforzata, inviata in Grecia) comprendente un reggimento autoblindo, la III Brigata Corazzata (r) e una parte del Gruppo Sostegno (2);
-9.. Divisione australiana su due brigate (la terza brigata era dovuta restare a T obruch per deficienza di mezzi di trasporto) (3);
- III Brigata Motorizzata indiana che, assegnata di rinforzo al gen. Neame, doveva raggiungere el Adem il 29 marzo.
Al manifestarsi dell'attacco italo- tedesco la 6" Divisione britannica, in via di addestramento per un'operazione da svolgere nel Dodecaneso, veniva destinata al presidio delle difese di Marsa Matruh, per far fronte a un eventuale sfondam ento in direzione del Delta. L a 7" Divisione australiana (meno una brigata mantenuta a Tobruch) veniva pure assegnata alla difesa del Deserto Occidentale e la Brigata polacca alle difese del Delta. Un'altra brigata corazzata, incompleta, era pure stata destinata alla difesa del Deserto Occidentale egiziano.

Dalla relazione del gen. Neame e dalla pubblicazione « The Mediterranean and Middle East » risulta la dislocazione particolareggiata delle forze di copertura:
- Gruppo di sostegno, su un fronte di circa 13 chilometri, a Marsa el Brega :
- III Brigata Corazzata, 8 chilometri a nord- est di Marsa el Brega, con compito di fiancheggiamento;
----, 9.. Divisione australiana, circa 180 chilometri più a nord, per la difesa del Gebel: aveva dislocato due brigate (cinque battaglioni) con i mezzi di trasporto disponibili all'intercettazione delle strade provenienti da Tocra e Regima. Come già ricordato, una terza brigata era rimasta a T obruch;
(1) La III Brigata Corazzata era così armata: 8° Ussari: carri leggeri, 5" Royal Tank s : carri c< Cruiser >> c 6° Royal Tanks: carri italiani di preda bellica.
(
2) Il Gruppo di Sostegn o era cost it uito d el I 0 Tow er Hamle ts, 104° Horse Artille ry , 3° Horse Artill e ry ( anticarro), una compagnia Reali Fucilieri del Northumberland (mitragli eri), due compagnie australiane con cannon i anticarro.
(3) Nella prima m età di marzo la 9• Di,·js ionc au straliana , già in Palestina, e ra affluita in Cirenaica per sostituire la 6• Divisione australiana, desti· nata in G recia.
- uno squadrone del Lon g Range D esert Group, giunto il 24 m arzo dall'Egitto, a Gialo, co n comp ito principale di osservare e seg n alare ogni m ovim ento da Marada verso est.
Il piano genera le britannico prevedeva la costituzione di depositi di r iforni m ento a Msus, T ecni s, M artuba, M echili e Tmimi (el Magrun e Bengas i g ià n e dispon evano). M sus, con sette giornate di viveri, benzina e acqua doveva assumere la funzione di deposito p rincipale per la brigata corazzata e i reparti m otorizzati del gruppo di sostegno.
I fase: da el Agheila a Bengasi (3 I marzonotte sul 4 aprile) (Schizzo n. 8).
Le operazioni dal 3 I marzo al 2 april e.
I n base agli ordini emanati dal ge n. Ro mm el il m atti no del 31 m arzo si iniziava l'azione, con carattere di ricognizione offensiva, verso la stretta di Marsa el Brega . Era sta ta affidata a un g ruppo di combattimen to composto di una compagnia carri armati, una co m pagnia cannoni anticarro e una batteria cannoni contr aerei (e anticarro) da 88 rom , della saDivisione L eggera, fianch eggia ta da colonn e miste italo- tedesche (3" reparto esplor ante e cosidde tto Gruppo Santamaria) ( r ) dirette su Bir es Sucra.
Su perata rapidamente la resistenza degli elementi avan zati n emici , anc he di carri, la colonna pri ncipal e era costret ta dal fuoco di artiglieria a fermarsi a sei chilometri da Marsa el Brega, mentre le colonn e fiancheggianti raggiungevano l'obiettivo di Bir es Suera. Rinfor zata con r eparti mitraglie ri e antic arro e sos tenut a dall'artiglieria della s• Divisione L eggera, dopo un intervento d i bombardieri in picchiata (Stukas) la colo nna principale riprendeva il movim ento e s'i m possessava della stretta. Le no str e perdite erano sta te insignifica n ti.
Consegue n te mente il grosso d ella sa D ivisione veniva spostato ad es t di cl Agheila battaglione m.itraglieFi dell '« Ariete», IL .ili D./f 8' fi.
(1) Il Gruppo << Santamaria ))' che prendeva il nome dal suo comandante Ten.Col. Santam ar ia, all'inizio del 1941 era rim asm a contatto con il nemico, nella Sine. Nelle vicende successive assume, a seconda delle es igenze, costituzioni diverse - sempre basate peraltro su piccole unità motorizzate o meccanizzate, con armi controcarro e mitragliere - a seconda dci compiti che gli so no di volta in volta af fidati.
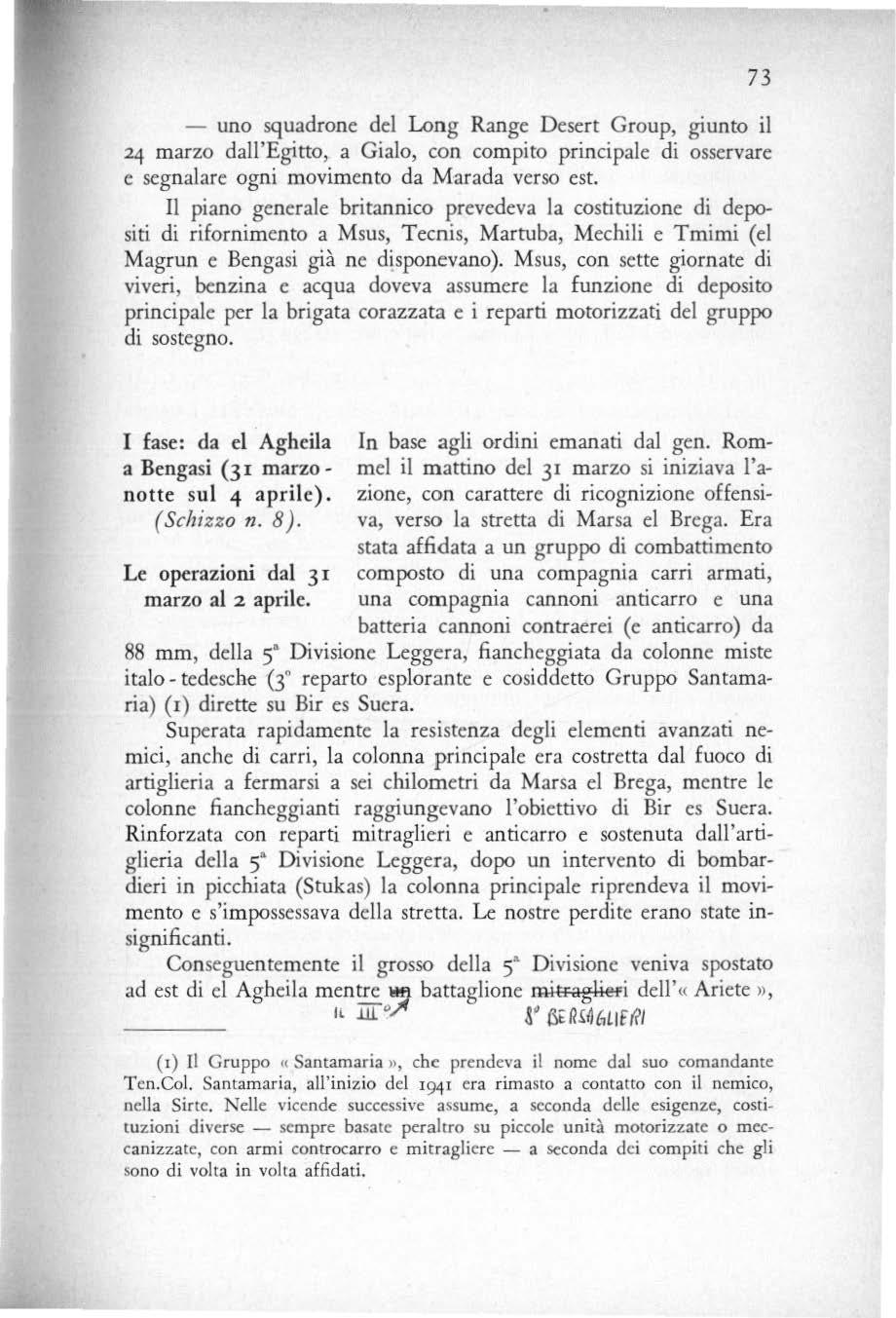
rinforzato da una compagnia anticarro da 47 mm e da una sezione mitraglieri da 20 mm veniva inviato a Maaten Giofer.
Durante la notte la 2a Divisione Corazzata britannica ripiegava su di una posizione a circa 30 chilometri a sud di Ageda bia.
E saurito il mandato della ricognizione offensiva, il 1° aprile non veniva svolta altra attività e non vi era co ntatto fra le opposte forze terrestri.
Lo sviluppo della situazione veniva così prospettato dal Comand ante del C.T.A. al Comando Su periore italiano:
N. 308 J4.41 segr. Quartier Generale 1.4.41
Da ricognizione in forze effettuata dalla 5a D ivision e Leggera il mattino del 31.3 in direzione di Bir es Suera et Marsa el Brega risultava, già dopo poche ore, che il nemico non opponeva resistenza all'attacco.
In seguito è stata presa senza difficoltà una posizione inglese, in corrispondenza della stretta, a 6 c hilometri circa a sud- est di M arsa el Brega. Anche qui il nemico volgeva in fuga. Soltanto sulla posizione della Cantoniera (via Balbia: Marsa el Brega) ha opposto una debole resistenza. Dopo breve combattimento qu esta posizione è stata presa nella serata da ele menti della 5a Divisione Leggera (una compagnia carri leggeri, un'aliquota del 6o5° reparto caccia- carri pesanti e un battaglione mitraglieri, con appoggio di artiglieria). Sonò stati fatti parecchi prigionieri, qualche autoblindo catturat a, ecc (1).
B1r es Suera è stata occupata la sera ste ssa del 31.3 dal 3° reparto esplorante insieme al reparto Santamaria.
L'aviazione, impiegata tre volte nella giornata, ha contribuito efficacemente al successo.
Il I 0 aprile risultava per tempo che l'avversario aveva incominciato ad abbandonare anche la zona compresa tra Marsa el Brega ed Agedabia. Sono stati da parte dell'aviazione tedesca effettuati con successo vari attacchi su colonne e concentramenti di automezzi a sud - ovest di Agedabia.
(1) Si tratta qui verosimilmente di un errore di trad uzion e. Sull'originale tedesco di «Guerra senz'odio >> (Rommcl, Verlag H eidenheimer ZeirungH eidenheim, Brenz, 1950, pag. 22), si parla di 50 Brenn Carriers (semici ngola ti coraz zati per trasporto delle fanterie) c circa 30 autocarr i che, nella citata traduzione italiana (Garzanti, 1952, pag. 14), diventano 50 autoblindo e 30 carri armaci leggeri.
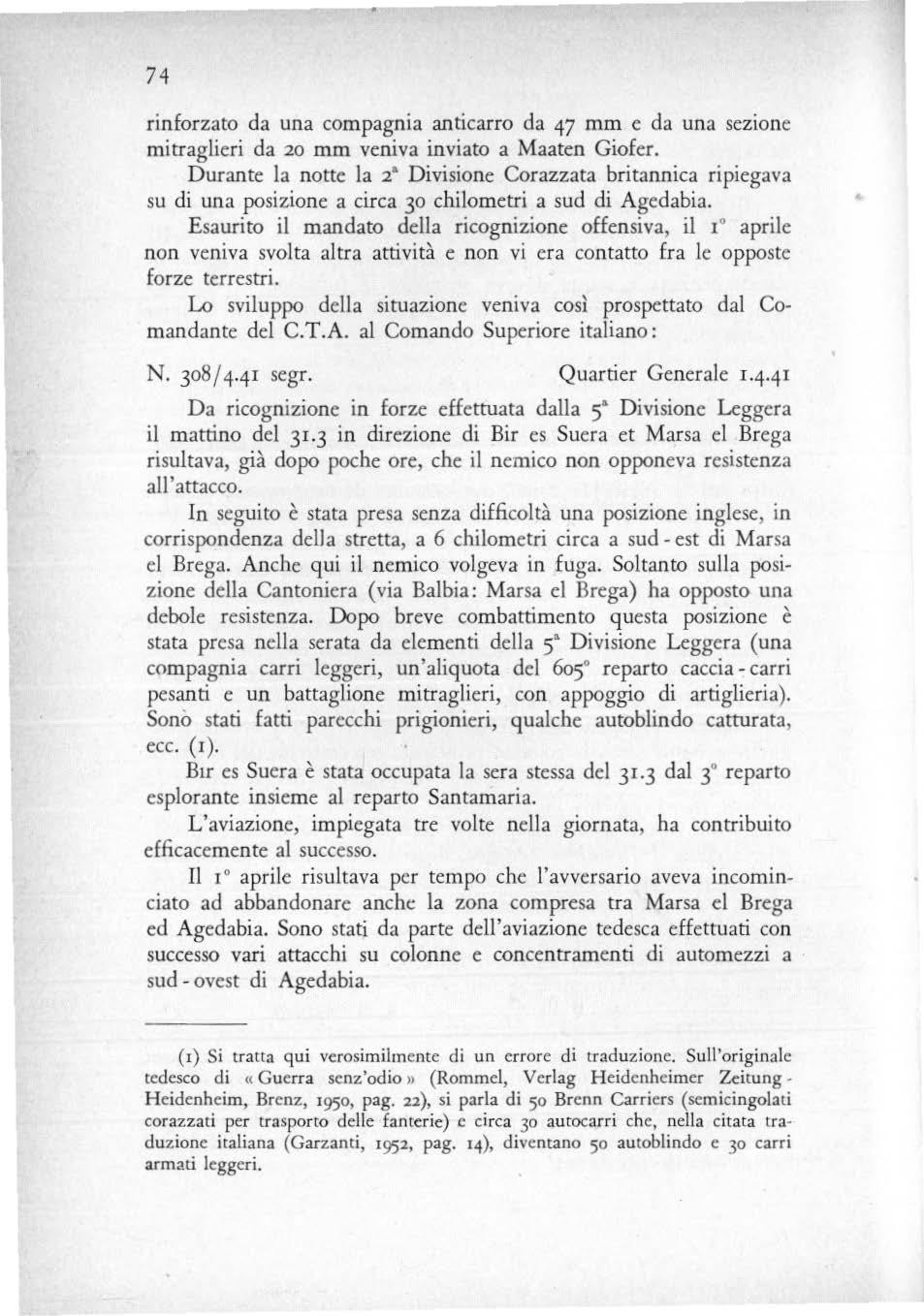
Il C.T.A., con un reparto avanzato, insegue il nemico in fuga in direzione di Agedabia, secondo le norme di combatti mento dell'esercito ted esco. Il grosso del Corpo, fino a chiarimento della situazione del nemico intorno ad Agedabia, raggiunge e rimane nella zona M arsa el Brega - Maaten Giofer - stretta ad ovest di el Agheila.
La 5a Divisione leggera si schiera nella zona di Marsa el BregaMn. Bescer, con elementi distaccati in avanti.
La Divisione « Brescia» nella zona di Mn. Bescer (essenzialmente)- el Agheila, sui due lati della via Balbia.
La Divisione Corazzata « Ariete » nel triangolo: incrocio 30 chilometri a sud di el Agheila -el Agheila- incrocio ad est di el Agheila.
Sì prega di spostare al più presto verso il C.T.A. i reparti già in Tripolitania della Divisione Corazzata « Trento » .
L'avanzata dei primi reparti della 15" Divisione Corazzata è già stata disposta. Inoltre si propone di far seguire anche le altre divisioni italiane del Corpo d'Armata.
Vale la pena di sottolineare quel breve, quasi pleonastico accenno: «Il C.T.A., con un reparto avanzato, insegue il nemico in fuga, in direzione di Agedabia, secondo le norme di combattimento dell'esercito udesco » In questo ovvio riferimento alla norma universale di tattica elementare dello sfruttamento del successo (non ce rtamente monopolio della dottrina tedesca) si nasconde, più che manifestarsi, quel fermo proposito di portare l'attacco fino alle estreme conseguenze che costituisce la caratteristica prima dell'azione di comando del gen. Rommel, non soltanto in qu esta circostanza. L'inseguimento sarà condotto con un reparto avanzato, afferma, senza contraddire dunque sostanzialmente alla direttiva base di astenersi dalle operazioni in grande stile, fino a quando non disponga a piè d'opera di tutte le forze considerate necessarie per impegnarsi a fondo. L'azione avrebbe dovuto continuare insomma sullo stesso tono minore della « ricognizione in forze » del 31 marzo. In effetti, si vedrà, il « reparto avanzato » si dilaterà, negli ordini, all'intera massa di manovra disponibile.
Date le direttive impartite dal Comando Supremo, pienamente rispondenti anche al pen siero dell'OKW, la notizia della mossa di Romm el giungeva a R oma completamente inattesa. Il 2 aprile Mussolini ne traeva argomento per esprimere il proprio compiacimento

ai reparti italiani e tedeschi che avevano partecipato all'azione e rivolgere un elogio al gen. Rommel che l'aveva diretta, mentre contemporaneamente invitava il gen. Gariboldi ad esporgli « il suo netto pensiero in merito a tali azioni, considerate nel quadro d'insieme della situazione : forze nostre, forze nemiche in Cirenaica, atteggiamento francese in Nord Africa, rifornimenti, condizioni sanitarie delle truppe dislocate in Sirtica con poca acqua e senza possibilità di turni di riposo in zona meno disagiata ». Avvertiva inoltre che « causa prossimi avvenimenti fronte giulio e albanese invio altre divisioni et altri autocarri doveva necessariamente ritardare »
Il gen. von Rintelen, interpellato, doveva ammettere di non conoscere l'obiettivo delle operazioni di Rommel: riteneva però che non si potesse pensare, per il momento, che a piccole operazioni.

Nella stessa giornata del 2 il gen Gariboldi così rispondeva alla richiesta del Duce:
« or / 3283/ Op. Esprimo parere che operazioni intraprese generale Rommel oltre raggio concordato sono imprudenti per tutte le considerazioni elencate nel telegramma al quale rispondo. Avevo concesso occupazione stretta ad ovest Marsa el Brega che migliorava nostra sistemazione difensiva ma con .fisonomia lentamente progressiva. Generale Rommel sempre anelante offensiva, trascinato da successo, si è lanciato più avanti. Gli ho ordinato ed ho ripetuto ordine di arrestarsi et parto per parlargli personalmente. Ritengo necessario ordine più autorevole per convincerlo rimanere nell'ambito d'azione stabilito. Salvo ordine in contrario per evitare nuovi motivi di nuovo slancio comunicherò ufficialmente elogio Duce unitamente ad eventuale Vostro ordine tassativo sospendere avanzata. Gariboldi » .
Da parte ingl ese (r ) risulta che « il comandante del Gruppo di Sostegno, incaricato della difesa di Marsa el Brega aveva richiesto alla III Brigata Corazzata di contrattaccare i tedeschi sul .fianco destro ma il comandante della divisione aveva ritenuto che non vi fosse tempo per montare la manovra prima di notte. Il Gruppo di Sostegno teneva la posizione per tutta la giornata e solo quando apparve chiaro il pericolo di essere tagliato fuori ripiegava a sud- ovest di Agedabia. La III Brigata Corazzata agiva in conformità ».
Il gen. W ave li scrive a sua volta ndla sua relazione: « Per i primi tre giorni la 2 • Division e Corazzata si ritirò lentamente verso nord e la sera del 2 aprile si trovava a nord di Agedabia ... Iniziai-
( r) V. opera citata Playfair I.S.O.: « History of the Second World War », Ed. H.M.S.O., Lond on , 1956.mente era intenzione del comandante della 2" Divisione Corazzata di contrattaccare il nemico a nord di Agedahia, se se ne fosse offerta l'opportunità, ma essendo stato avvertito che non c'era disponibilità di mezzi corazzati e che non doveva attaccare a meno che non gli fosse offerta un'occasione eccezionalmente favorevole, decise di tinuare la ritirata».
Ancora una volta il gen. Rommel registra l'evoluzione del prio pensiero nella giornata del ! 0 aprile, dopo aver ordinato lo stamento in avanti di tutte le forze a sua disposizione ( 1):
« Da segnalazioni dell'aviazione si rilevava chiaramente come i movimenti del nemico tendessero al ripiegamento. I reparti ranti che il gen. Streich (comandante della 5" Divisione Leggera) aveva inviato in ricognizione confer marono nostra impressione. Io non potei r esistere a questa favorevole occasione e diedi ordine di attaccare il nemico presso Agedabia e di impossessarsi della località, sebbene una tale impresa mi fosse stata ordinata solo per la fine di m agg10 ».
Il gen. Calvi di Bergolo, capo dell'Ufficio Collegamento presso il C.T.A., veniva a conoscenza del proposito di occupare Agedabia soltanto il mattino del 2 aprile, verso le 8,30, qu ando il rale Rommel i mparti va ordini verbali al comandante della Divisione « Ariete».

L'occupazione doveva essere effettuata dalle divisioni 5a gera e « Ariete » , entrambe in prima schiera:
- la s• Leggera doveva operare sulla sinistra della via bia, preceduta da due forti avanguardie, di cui la sinistra più zata;
- l' « Ariete » sulla destra della Balbia, anch'essa con due avanguardie, di cui la destra più avanzata.
L'abitato di Agedabia doveva cadere per doppio avvolgimento, ad opera delle due divisioni.
Base di partenza per l'avanzata doveva essere il sentiero che da Alizir est di Marsa el Brega) volge verso est, quasi malm ente alla litoranca. L'inizio dell'attacco era stabilito per le ore 7 dell'indomani, su ordine del Comando C.T.A. Al tri ordini colari sarebbero stati impartiti dal gen. Ro mm el ai comandanti di divisione in una riunione fissata per il pomeriggio del giorno 2 alla casa cantoniera, 16 chilometri ad est di Marsa el Brega.
Ma gli eventi dovevano anticipare i tempi stabiliti. Alle ore 13 la massa della sa Divisio ne Leggera aveva già oltrepassato la base di parte n za: saputo dalla ricognizione che i br itannici stavano ripiegan do, il comandante della division e aveva d eciso di p un tare se nz'altro, nella giornata stessa, su Agedabia con la propria unità, sicuro della superior ità sull'avversario.
Partecipavano all'azione un batt aglione del 200° reggimento mitraglieri, una com pag n ia carri, una compagnia anticarr o e il 3o reparto esplorante, rinforzato dal gruppo celere Santamaria.
Il nemico oppon eva una certa resistenza a sud -ovest di Agedabia ove si svolgeva un combattimen to di carri, conclusosi con lievi perdite da parte tedesca (3 carri medi) (I).
Agedabia, con le sue preziose sorgenti di acqua dolce, veniva occupata alle ore r6,3o mentre elementi avanzati si spostavano veloce m en te nella zona di Zuerina.
Ordini del gen. Rommella sera del 2 april e.
P erseverando nel co ncetto dello sfruttamento del successo il gen. Rommel, dopo avere esteso l'occupazione all'i n tera zona attorno ad Agedabia, fino a 20 chilomeri ad est di questa località, impartiva alle d ivision i dipen denti i seguenti ordini per i l giorno successivo, informandone il Coman do Superiore A.S.:
Ufficio Operazio n i
Alla 5o D ivisione Leggera
Alla D ivisione «Ariete»
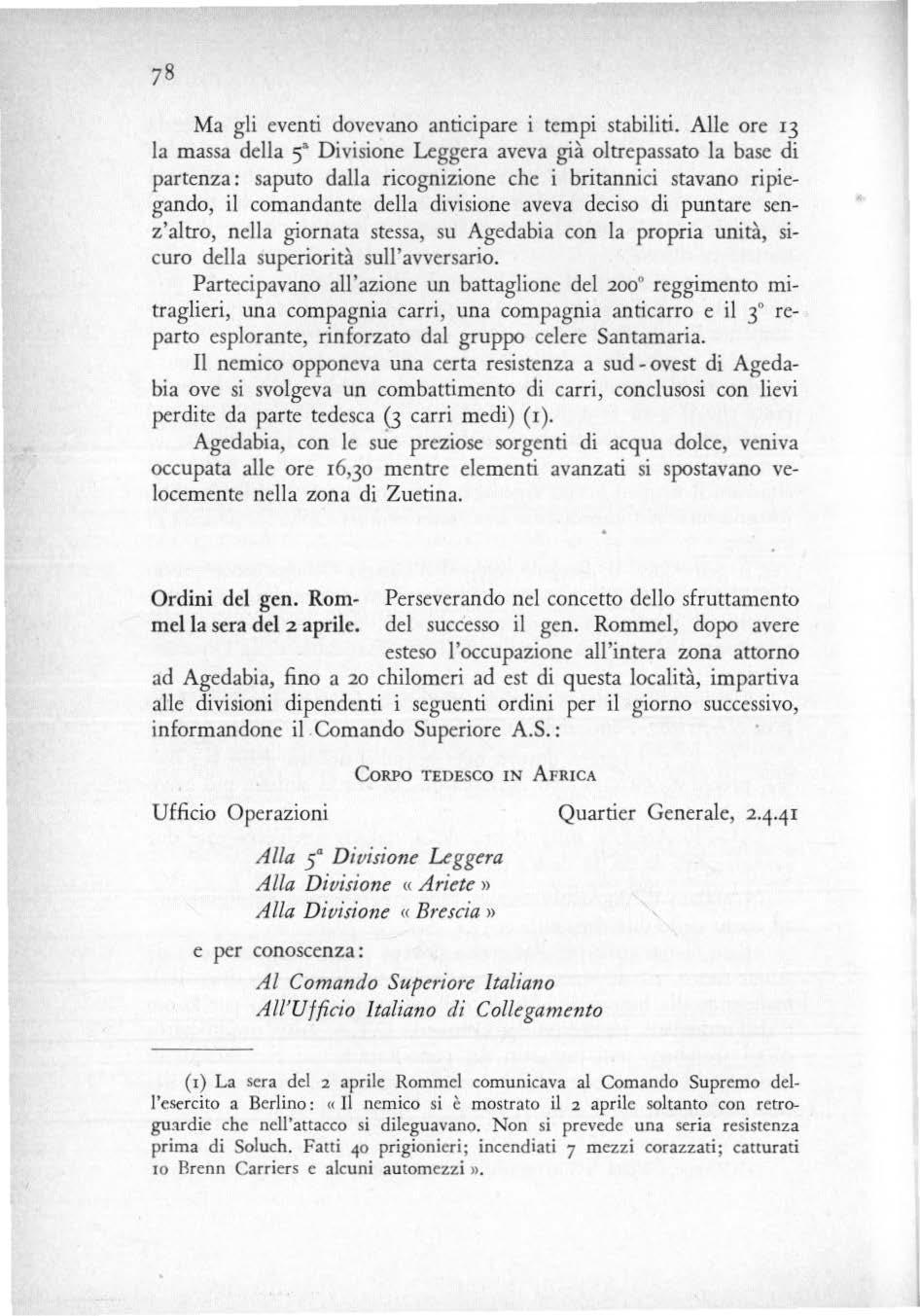
Alla D ivisione <<Brescia»
e per conoscenza:
Al Comando Superiore I taliano
Quartier Generale, 2.4.4 1
All'U fficio I taliano di Collegamento
(r) La sera del 2 aprile Rommel comunicava al Comando Supremo dell'esercito a Berlino: «Il nemico si è mostrato il 2 aprile so lta nto con retrogu:trdie che nell'attacco si dileguavano Non si prevede una seria resistenza prima di Soluch. Faui 40 prigionieri; incendiati 7 mezzi corazzati; catturati 10 Brenn Carriers e alcuni automezzi ».
1) La 5" Divisione Leggera terrà le posizioni attorno ad . Agedabia fino a che non sarà sostituita dalla Divisione « Brescia >> (circa il 4-4) - Reparti avanzati intorno a Zuetina.
In seguito si organizzerà a difesa a caposaldo a cavallo della strada, nel settore Agedabia (specialmente)- Zuetina.
Dovranno effettuarsi ricognizioni verso nord, lungo le due grandi strade per Antelat- Soluch e Ghemines- Bengasi.
2) La Divisione « Brescia " proseguirà il giorno 3·4 in direzione Agedabia. Reparti motorizzati devono essere mandati avanti in precedenza per rafforzare la posizione intorno ad Agedabia. Dopo lo spostamento della divisione nella zona di Agedabia essa dovrà sistemarsi, a mano a mano, nelle posizioni difensive attorno ad Agedabia, ora tenute dalla 5a Divisione Leggera.
Le modalità per la sostituzione e le consegne fra i Comandi saranno fissate nei particolari dal Comandante la 5.. Divisione Leggera. Lo scambio delle consegne nel settore di Agedabia dovrà essere comunicato da ambedue le divisioni al C.T.A. Il battaglione della Divisione « Bologna " rimane alle dipendenze della Divisione « Brescia " · La strada Agedabia- Gialo dovrà essere sorvegliata con elementi mobili e con l'occupazione, come punto di appoggio (a caposaldo), di el H aseiat.
3) La Divisione « Ariete " il 3 . 4, dopo lo sgombro della zona a sud -ovest di Agedabia da parte della 5.. Divisione Leggera, si sposterà da 5 a IO chilometri avanti ad Agedabia, ove si sistemerà a difesa a cavallo della strada. Fronte principale verso sud- ovest.

Il Gruppo Santamaria passerà alle dipendenze della Divisione << Ariete ". Con speciali reparti avanzati della forza di circa 2 compagnie, rinforzati da artiglieria ed armi anticarro, dovranno essere occupati Giof el Matar e Bir el Fenscia e dovranno effettuarsi giornalmente, con forti pattuglie, ricognizioni a Bir Ben Gania e Saunnu.
4) Truppe di Corpo d'Armata (I gruppo contraerei da 88 mm e 33o reparto caccia- carri) seguiranno, in zona a nord di Mel ah en Nogr a.
5) Il Comando Tattico del C.T.A. si sposterà il 3. 4 alle ore 9 in zona Agedabia.
Direttive cd ordini Intorno alle ore 12 del giorno 2 il gen. l'Alto Comando me ordinava al Gruppo Sostegno di tannico nel gio e nella tarda serata del 2 aprile.
nuare il più a lungo possibile il blocco della via di Bengasi, evitando però di farsi mergere : « Non esitare a ceder terreno, cuando eventualmente Bengasi ». Alla III
Brigata Corazzata ordinava di tenersi pronta a muovere verso leidima bassa (ai piedi del ciglione gebelico), in condizione di lire in qualunque momento il ciglione stesso per procedere verso est. Nel pomeriggio giungeva in volo a Barce il gen. W avell. formato telegraficamente che la 2• Divisione Corazzata non era in grado di bloccare la strada Agedabia Bengasi ed era costretta a piegare su Antelat (conforme all'originale piano di difesa del rale Neame), il gen. Wavell insisteva perché fosse almeno ostacolato l'accesso alla strada costiera, dando mandato alla 2a Divisione Corazzata di ritardare al massimo l'avanzata dell'avversario su Bengasi. In relazione a quest'ordine, la divisione doveva operate riunita, ritirandosi combattendo verso nord, fino a el Magrun. Se costretta a ripiegare in tale zona, il Gruppo Sostegno doveva cercare di contenere frontalmente il nemico lungo la litoranea, allo scopo di prire l'evacuazione di Bengasi, mentre il resto della divisione doveva portarsi per Sceleidima nella zona a sud di el Abiar, per coprire a sua volta il fianco destro della 9" Divisione austra liana.
Il contrasto fra queste direttive e gli ordini del gen. Neame può spiegarsi con il fatto che mentre questi aveva l'impressione di trovarsi di fronte ad un attacco di forze assolutamente preponderanti che giudicava di non poter contrastare, il gen. W avell non riteneva che Rommel fosse pronto per una grande operazione a largo raggio. Questo era, invero, anche il pensiero del Primo Ministro Churchill che lo stesso giorno 2 aveva tel egrafato:
« Sarebbe estrema mente desiderabile che l'offe nsiva tedesca contro la Cirenaica venisse stroncata. Qualunque disfatta inflitta ai tedeschi avrebbe conseguenze psicologiche dì vasta portata. Sarebbe giusto cedere terreno a scopo di manovra ma tm' eve ntuale definitiva ritirata da Bengasi sarebbe assai dolorosa. Non riesco a capire come il nemico possa essere riuscito a sviluppare una considerevole forza d'attacco al termine di questa lunga ed arida costiera, né posso credere che in questo momento il suo attacco in Cirenaica possa essere alimentato. Se questo nucleo che si è spinto innanzi contro di voi potesse essere tagliato fuori, potreste godere dì un prolungato riodo di distensione. Naturalmente, se esso riuscirà a scorrazzare

ancora in avanti distruggerà gradualmente i risultati della nostra vittoria. Avete uomini sottomano come O'Connor, o Creagh, per affrontare questo problema di frontiera? >>.
Il gen. Wavcll convocava la sera stessa il gen. O' Connor (già comandante della « Forza del Deserto Occidentale » durante la recente offensiva e presentemente elevato alla carica di Comandante Superiore delle Truppe Britanniche in E gitto) il quale lo raggiungeva immediatamente in volo, accompagnato dal brigadi ere J. F. B. Combe, già comandante dell'u o Ussari. Ma conosciuta la situazione il gen. O ' Connor condivideva il pensiero del gen. Neame, ritenendo che il nemico avrebbe dilagato per le numerose direttrici del deserto. Non sostituiva il gen. Neame nel comando delle truppe, ma gli veniva affiancato, per consiglio e sostegno.
L'ordine del gen. Wavell di ritardare al massimo l'avanzata su Bengasi, emanato alle 21 del giorno 2, non giungeva a destinazione che alle 2,25 della notte, quando ormai risultava superato dagli eventi. Il gen Gambier- Parry, comandante della 2 & Divisione Corazzata, faceva presente che le circostanze lo costringevano a ripiegare con l'intera divisione (e non soltanto con un'aliquota, come il gen. Wavell aveva ordinato) per Sceleidima in una zona a sud di el Abiar, dove avrebbe provveduto a riordinarsi, prima di procedere a qual siasi ulteriore azione. Con ciò svaniva ogni spera nz a di coprire Bengasi e al gen. Neame non rimaneva che disporre la messa in atto del piano di distruzioni predisposto in quel porto. Assegnava contemporaneamente i nuovi compiti alla 2 • Divi sione Corazzata: impedire l'accesso dell'altopiano, su ogni strada, tra Sceleidima e l'Uadi Gattara incluso; coprire i l fianco sinistro degli Australiani; assicurare la protezione dei depositi accumulati a Msus ( 1).
L a giornata del 3 aprile .
I n relazione agli ordini emanati dal generale Rommel la sera del giorno 2 la situazione subiva frattanto la seguente evoluzione:
m ovimento, Divisione « Ariete » aveva disposto per la ripresa del dando mandato a una colonna Fabri s (2) di occupare
(1) « History of the Second World War »,vol. II, pag. zr.
(2) La colonna agli ordini del ten. col. Fabris (8° rgt. bersaglieri) era così costituita: I II brg bers. motOciclisti; I / 132° art. (meno una btr.); due sez. mtr. da 20; una cp. da 47/ 32; una R.F . 3/ C; una stazione radio tedesca.

a caposaldo le posizioni di Bir el Fenscia- Giof el Matar e di compiere giornalmente puntate su Saunnu e Bir Ben Gania. La colonna partiva alle ore 12 del giorno 3;
- la D ivisione « Brescia>> aveva disposto per il trasferimento nella zona di Agedabia di tre co m pagnie anticarro da 47 f 32 che il mattino del 4 sarebbero state raggi u nte dal III gruppo di artiglieria e da una batteria c.a. da 20 mm. Aveva predisposto inoltre il movimento a scaglioni degli altri reparti, per modo che ciascuno disponesse di un nucleo servizi e di rifornimento munizioni e carburante. I reparti non motorizzati che avevano raggiunto la zona ad est di el Agheila dovevano restare in posto ed essere scavalcati da quelli tuttora trattenuti nella zona di C. Ristoro (40 chilometri ovest di el Agheila);
__, la Sa D ivisione Leggera si era a sua volta spinta innanzi, prendendo ripetutamente fuggevole contatto con elementi nemici, solleciti a sottrarsi.
Nel pomeriggio del 3 il gen. Rommel aveva trasferito il proprio comando ad Agedabia. Le sue impressioni dirette sullo sviluppo della situazione sono state fedelmente registrate (1).

<< L 'avversario continuava a ripiegare e dava l'impressione di voler sgomberare la Cirenaica. Probabilmente ci considerava molto forti ed in questo i finti carri armati ebbero una parte molto decisiva ... (2).
« Avevamo fatto prigionieri cir ca 8oo britannici. Era evidente che gli inglesi volevano evitare ad ogni costo un combattimento decisivo. Nel pomeriggio stesso decisi per questo di rimanere alle calcagne del nemico in ripiegamento e, se possibile, di prendere con un colpo di mano tutta la Cirenaica. Per realizzare questo progetto misi subito in marcia un reparto dell '« Ariete», al comando del ten. col. Fabris, su Ben Gania e diedi ordine alla s• Divisione Leggera di mandare il 3o reparto esplorante lungo la via Balbia, su Ben gasi ... ».
(1) RoMMEL: «G uerra senza odio», Garzanti, 1952, pagg. r6- 17.
(2) Il gen. Romm e l aveva fatto approntare una sezione di finti carri, destinati a ingannare l'avversario sulla forza reale del C.T.A.: « Per apparire forti il più possibile c indurre i britannici alla massima prudenza feci preparare nelle officine al quinto c hilom etro a sud di Tripoli un gran numero di sagome di carri armati ch e poterono essere montate sui nostri piccoli Volkswagen, le nostre auto utili tar ie, ed av eva no una sorprendente somigl ianza con gli originali » (RoA!MEL: « Guerra senza odio », Garzanti, 1952, pag. r6).
In questo momento aveva dunque preso corpo nella mente del gen. Rommel il proposito di passare dai piccoli atti preparatori della maggiore offensiva prevista per .fine maggio, al grandioso « colpo di mano » per la immediata riconquista dell'intera Cirenaica. L'ardito progetto trovava resistenze, se non proprio opposizione, nella cerchia stessa dei più diretti colLaboratori ai quali non sfuggiva la estrema difficoltà dell'esecuzione. A tutti il comandante del C.T.A. opponeva la propria ferrea determinazione, lo slancio irresistibile verso il raggiungimento delle mete lontane, oltre ogni limite di calcolo razionale.
Il comandante della 5" Divisione L eggera gli aveva rappresentato qualche preoccupazione per le condizioni degli automezzi. C'era inolt:e il problema dei rifornimenti per un'operazione a così lungo
raggto:
<<Verso le r8 (del giorno 3) ritornai al mio comando tattico dove venni a conoscenza che la 5• Divisione Leggera aveva segnalato che abbisognava di quattro giorni per fare il rifornimento di carburante. Ritenni la richiesta del tutto esagerata e pertanto ordinai alla divisione di scaricare immediatamente tutti gli automezzi e di inviarli al deposito divisionale di Arco dei Fileni e provvedere entro le 24 ore ai rifornimenti di carburante, viveri e munizioni necessari per l'avanzata. Ben s'intende che per 24 ore la divisione non fu più in condizio n e di muoversi. Ma in considerazione della situazione in atto presso il nemico era una crisi che si poteva rischiare.

« Nel frattempo si palesava sempre più chiaramente come il nemico sopravalutasse le nostre forze. Gli inglesi dovevano essere lasciati assolutamente in questa impressione e continuare a credere che la nostra avanzata fosse una grossa offensiva. Naturalmente io non ero in con dizione di prem ere sul nemico con la m assa delle mie forze, però mi parve opportuno mantenere, con i reparti esploranti, la pressione su di esso e far sì che continuasse il suo ripiegamento. Speravo di poter seguire i r eparti esploranti dopo 24 ore con forti aliquote di truppe. Con ciò intendevo spostare la pressione sull'ala meridionale : attaccare da B. Ben Gania i n di rezione di T mimi e qui rinchiudere in una sacca forti aliquote britanniche c distruggerle».
Lo stato d'animo del gen. Rommel è reso efficacemente in una breve annotazione del suo Diario personale, in data appunto del 3 aprile: << Dal 31 marzo attacchiamo con notevole successo. A T ripoli dovranno accorgersene, ed anche a Roma e Berlino. H o osato varie
avanzate, malgrado le direttive opposte, perché l'occasione era propizia. Esse daranno in seguito i loro frutti ».
La colon na Fabris aveva raggiunto Giof cl Matar alle ore 21. Il C.T.A. prescriveva di organizzare in quella zona una base logistica e la Divisione « Ariete » provvedeva per l'affluenza di 15 fusti di carburante, 2 giornate di viveri e 2500 litri d'acqua.
Alle 20,30 il Comando Superiore A.S. aveva segnalato al Comando della 5" Squadra Aerea l'importanza della sorveglianza degli sbocchi dal primo gradino gebelico, specialmente quelli di Antelat e Sceleidima, stabilendo che l'indomani l'attività esplora tiva dovesse essere corrisponde ntemente orientata.
Alle 23>30 si presentava al Comando della 5" Divisione Leggera un ufficiale italiano, già appartenente alla nostra Brigata Corazzata, catturato nel corso dell'offensiva britannica e trattenuto come interprete in un ospeda le di Bengasi. Presentato al gen. Rommel lo informava che i britannici avevano sgomberato la città, dopo avere operato varie distruzioni. Tutta la zona tra Bengasi e i reparti tedeschi, distanti circa 40 chilometri, era sgombera dal nemico che vi aveva lasciato soltanto qualche gruppo di senu ssiti a cavallo, armati di fucile e bombe a mano. Si supponeva che retroguardie di mezzi meccanizzati e pattuglie di carri inglesi fossero ancora prese n ti lungo le vie interne per Mechili (1).
In seguito alle notizi e fornite dall'ufficiale, che collimavano con informazioni direttamente raccolte dal geo. Rommel da altre fonti, il Comandante del C.T. A. disponeva perché l'avanzata fo sse celerm ente proseguita su Bengasi (2).
L'intervento del Co- Quasi contemporaneamente al messaggio nel mando S upremo. Azione del gen. Rommel.
quale il mattino del 2 aprile il gen. Garibaldi prospettava al Comando Supremo la opportunità di frenare con il suo autorevole intervento prevedibili nuovi slanci del gen. Romm el, giunge va a Ro m a la notizia dell'occupazione di Agedabia e Zuetina da parte di truppe italiane e tedesche.
(1) Dal Diario della Divisione cc Brescia >>
(2) RoMMEL: cc Guerra senza odio >> , Garzanti, 1952, pag. 17: cc La sera del giorno 3 mi r ecai verso il nord per vedere come fossero a ndate le cose per il 3" reparto esp lorante, in viato in direzione di Bengasi. Incontrai il reparto

Di fronte alla situazione di fatto la sera del 3 il Comando Supremo impartiva al Comandante Superiore FF. AA. A.S. le seguenti nuove direttive, a firma Mussolini:
« 783 Op. - Per Eccellenza Garibaldi . 3 aprile ore 21,25. Vostro telegramma or f 3283 mi giunse insieme notizia occupazione Agedabia et Zuetina. Poiché Vi siete recato sul posto Vi sarete reso conto della situazione et forse del pericolo che corrono reparti non sufficientemente forti, molto distanti dalle rimanenti forze et che non hanno possibilità di essere rapidamente sostenuti et facilmente riforniti. Ma se scontri avvenuti danno fondata sensazione che nemico attraversa un periodo di crisi et che numerose so no le probabilità di successo, sarebbe errore gravissimo non approfittare del mom ento favor evole per tutto osare. Dovrebbesi in tal caso sostenere azione con altre forz e rapidamente autoportate, tratte da Tripoli e dintorni. Soltanto Voi potete avere tutti elementi necessari per decidere et per regolare azione gen. Romm el ».
Pur nella doverosa cautela del Comando Supremo di fronte ad una impresa che si presentava molto rischio sa, dalla direttiva sopra riportata traspare come sostanzialmente la prospettiva di sfruttar e prontamente e a fondo l'imprevista situazione che si era manifestata di fronte alle nostre prime spinte esplorative non dispiacesse affatto a Roma: chiedeva al gen. Gariboldi di assicurarsi della rispondenza della valutazione del gen. Romme l alla realtà dei fatti e gli dava preciso mand ato, in caso affermativo, di fornire tutto l'appoggio possi bi le, con tutte le forze disponibili in Tripolitania, per la vittoriosa riuscita d ell'impresa.
Ignaro di questa direttiva di Mussolini, il gen. Gariboldi si era frattanto re cato al Quartier Generale di Rommel per esercitare personalmente qu ell'azio n e « frenante » per l a quale aveva invocato da Roma più autorevole appoggio. L'incontro avveniva al ritorno del Comandante del C.T.A. dalla sua visita al reparto esplorante dove aveva ra ccolto la notizia dello sgombero di Bengasi da parte dei brit annici. Il gen. Garibaldi, riferisce lo stesso gen. Rommel (1), poco soddisfatto delle operazioni, gli rivolgeva violenti rimproveri, sotto-
nei dintorni di Magrun e il barone von Wechmar (il comandante) mi riferì che fino a quel punto non era entrato in contatto con il nemico. Un parroco italiano ci era venuto incontro da Bengasi portando la notizia che il nemico stava già sgomberando la città. Su preghiera del barone von Wechmar feci subito marciare il reparto su Bengas i >>.
(x) RoMMEL: « Guerra senza odio», Ga rzanti, 1952, pag. 17.

lineando che era no in contrasto con le istruzioni di Roma. Il nimento delle truppe ted esche e italiane non era assicurato in misura tale da permettere la responsabilità di una cosl vasta impresa e delle possibili conseguenze. Il gen. Gariboldi chiedeva infine di dere l'avanzata e stabiliva che ulteriori movimenti dovessero nire dietro sua esplicita approvazione.
Lo stesso gen. Romm el registra la propria reazione a questa energica presa di posizione del Comandante Superiore italiano:
« Io volevo assicurarmi fin dal principio la massima libertà sibile, operativa c tattica e, del resto, non pensavo neppure mente a lasciar passare senza app rofittarne la favorevole occasione che si presentava. Così si venne a una dicussione alquanto vivace, durante la quale esposi con tutta chiarezza il mio punto di vista. Il gen. Gariboldi voleva innanzitutto ottenere il consenso dei comandi di Roma (come si è visto non era ancora a conosce nza del più ciliante atteggiamento del Comando Supremo) ma ciò poteva dere anche parecchi giorni. Non cedetti e dissi che avrei continuato a fare quello che n ella situazione esistente dovevo ritenere giusto. L a discussion e aveva raggiunto il punto culminante quando, come un angelo di salvezza, arrivò attraverso l'etere un radiotelegrarnma del Comando Supremo della Wehrmacht che mi dava piena libertà di azione. Così il vivacissimo dibattito terminò nel senso da me luto >> (r).
Si trattava evidentemente di un ordine concertato con il do Supremo italiano e di analogo contenuto: purtroppo il suo do rispetto al rapido evolversi della situazione aveva eposto il rale Gariboldi, legato alle precise direttive dei giorni precedenti, ad assumere un atteggiamento « sfasato >> che in seguito sarebbe stato costretto a sco nfessare. E' suo infatti un radiogramma inviato domani a Roma , di ritorno dalla ricognizione presso il comando del C.T.A. nel quale riconosceva che l'azione del gen. Rommel non era che la logica conseguenza del ripiegamento intrapreso dal nemico, oltre Bengasi.
L'episodio (purtroppo non isolato) tratteggia efficacemente, ad ogni modo, la natura della relazione instaur ata fin dal principio fra il Comandante del Corpo Tedesco in Africa e il Comandante periore italiano A.S. che, secondo gli accordi, avrebbe dovuto essere di piena dipe nd enza operativa e minacciava invece di essere zialmente invertita, ponendo il Comando Superiore italiano (e con

esso il Comando Supremo) a rimorchio dell'iniziativa operativa del gen. Rommel. Indipendentemente dalla palese anormalità del rapporto, tale procedimento doveva porre il Comando Superiore italiano di fronte a gravi difficoltà, talvolta insuperabili, in quanto respo nsabil e, per la parte italiana, di tutta la pesante parte logistica delle operazioni.

Considerazioni del gcn . Wavcll. Commenti di Ch u rchi ll.
Il giorno 3 aprile, afferma il gen. W aveli, fu per le forze britanniche il giorno più sfortunato di queste operazioni (1).
« Si intendeva continuare la regolare ritirata verso est, parallelamente alla strada di Bengasi, e le truppe stavano prendendo posizione vicino a Sceleidima, quando si ricev et te l'informazion e che consistenti forze corazzate nemiche si -stavano avvicinando a M sus, ove trova si il principale deposito dei carburanti e dei rifornimenti della divisione corazzata. Questa notizia generò molta confusione. Alla fine il Gruppo Sostegno continuò il proprio ripiegamento in direzione di Regima, sul fianco si nistro della 9• Divisione australiana, mentre l a III Brigata Corazzata muoveva su Msus ove constatava che il distaccamento posto a guardia del deposito, avuta notizia dell'avvicinamento del nemico, aveva incendiato tutta la benzina. Da allora in poi i movimenti d ella III Brigata Corazzata furono interamente determinati dalla mancanza di carburante » (2).
( r) Citato rapporto del gen. W aveli al Ministero della Guerra.
(2) In un rapporto in data 27 maggio T94r, il gen. Neame riferisce al riguardo:
« Il trasferimento della 2a Divisione Corazzata (meno la III Brigata Corazzata) ad ovest della linea Sceleidima- el Regima non era stato previsto né ordinato da me. Esso causò difficoltà ai trasporti m eccanizzati della divisione nel varcare l'uadi a sud di el Regima. Questo trasferimento risultò conseguente ad ordini emanati dal mio comando la sera del 2 aprile, allorché il Comandante in Capo (gen. W aveli) si era interposto, e da un altro ordine emanato, non so se in base ad istruzioni dello stesso Comandante in Capo, il mattino del 3 aprile, dal suo Capo di S.M., mentre io stavo con il Comandante in Capo. Una parte di questi ordini non era conforme alla situazione che veniv.a sviluppandosi sul posto. La III brigata si tra sferì a Msus, non avendo potuto muovere la sera precedente. Il Comandante in Capo mi trattenne lontano dal mio comando per tutta la critica mattinata del 3 aprile, mentre egli visitava in Bengasi la 9a Divisione australiana. I Ted eschi avanzavano su Ben-
Così scrive, a sua volta, Winston Churchill sulla giornata del 3:
« Il gen. Wavell si recò in volo sulla linea del &onte il giorno 3 e al suo ritorno riferì che la maggior parte della III Brigata Corazzata era stata soverchiata e scompaginata da superiori forze corazzate. Questo fatto avrebbe scoperto il fianco sinistro della 9• Divisione australiana, ad est e a nord- est di Bengasi. Il loro ripiegamento può diventare necessario. Egli affermò che, data la forza del nemico in Libia, la 7" Divisione australiana non poteva recarsi in Grecia ma doveva invece trasferirsi nel Deserto Occidentale. La 6.. Divisione britannica, ancora incompleta, doveva diventare la riserva ... e il corpo di spedizion e in Grecia, già di modeste proporzioni, veniva ulteriormente ridotto. L'occupazione di Rod i, che era un elemento essenziale dei nostri piani di guerra aerea nell'Egeo, diventava impossibile . ..
« Ven ne ordinato lo sgombero di Bengasi . . . In tal modo, con un colpo solo e quasi in un sol giorno, il fronte del deserto, dal quale erano dipese tutte le nostre decisioni, era crollato» (1).
La no tte sul 4 aprile: occupazione di Bengasi. Ripiegam ento dell e fo rze britannich e (per la toponomastica v. Schizzo n. 9).
zata a Mcchili, dove
Le punte avanzate tedesche entravano in Bengasi alle ore 3,30 del giorno 4· I britannici avevano incendiato tutte le scorte.
Nella stessa notte il gen. Neame decideva di ritirare le proprie forze dietro la linea Uadi D erna -M echil i: 9.. Divisio ne australiana sull'Dadi Derna; 2 Divisione Corazsi sarebbe riunita alla III Brigata motorizzata
gasi lungo la strada costiera senza trovare opposizione. La 9" Divisione australiana (cinqu e battaglioni} era schierata sul ciglione, a 30 miglia ad est di Bengasi ... >> .
Evidentemente, anche dalla parte britannica i rapporti fra gli alti comandi non correvano scevri di difficoltà e di attriti.
(1) CHUR CHILL: « La seconda gu erra mondial e>> , Mondadori, 1952, Parte III, vol. I, pag. 237·
Lo stesso Churchill, in una lettera in data 3 aprile così scriveva al Ministro Eden, in quel momento ad Atene: ((Lo sgombero di Bengasi è un fatto grave. Molto più importante della perdita di terreno è l'idea che non possiamo tener testa ai ted esc hi Ciò può avere ripercus sioni assai sfavorevoli in tutti i Balcani e sulla Turchia ... >> .
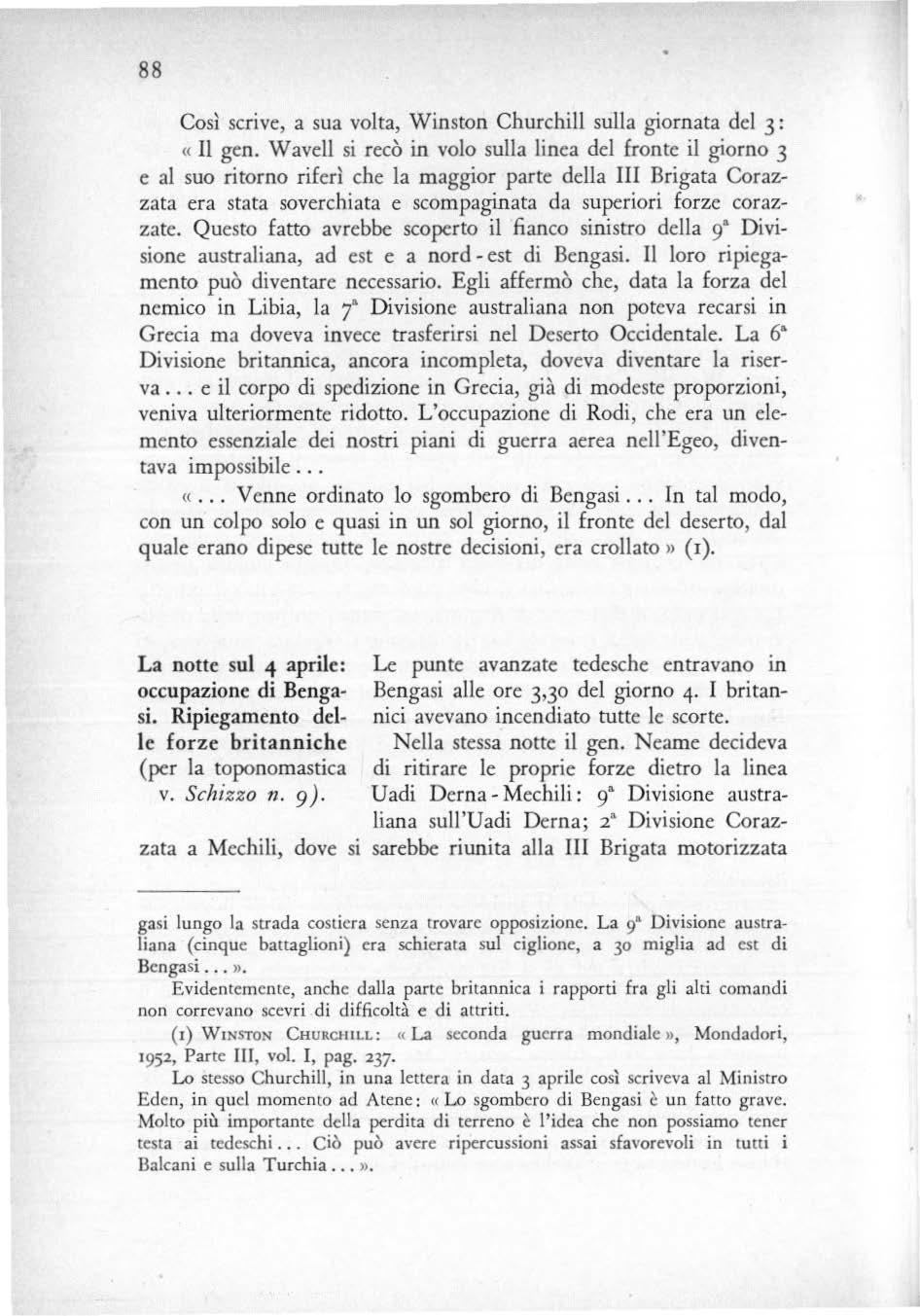
indiana che veniva tras ferita da Tobruch per la protezione di quell'i m portante nodo di comun icazione (1).
L 'ordine veniva poi attenuato prescrivendo alla 9.. Divisione australia n a di non lasciare la posizione R egima- T ocra prima della notte successiva e di ripiegare quindi sulla scarpata ad est di Barce. Analogamente, alla 2 a D ivisione Corazzata veniva prescritto di concentrarsi attorno a el Gharruba, per proteggere il fianco sinistro degli australian i, lasciando delle pattuglie nella zona di Msus. Solo se un ulteriore arretramento si fosse reso indispensabile gli australiani dovevano portarsi all'Dadi el Cuf e la 2 D ivisione Corazzata a Mechili. .
Alla III Brigata Corazzata, a Msus, quest'ordine non perveniva che nel pomeriggio del giorno 4·
Co n l'occupazione di Bengasi si può considerare ultimata la prim a fase dell'operazione, consistita sostanzialmente in un semplice movimento in avanti, quasi senza contrasto da parte del nemico.
Il Comando Supremo richiamava l'attenzione del Comando Superiore A.S. sulla necessità di organizzare la difesa co n traerea di quel porto e di assicurare l'immediato concorso di mezzi navali per il rifornimento delle truppe operanti.
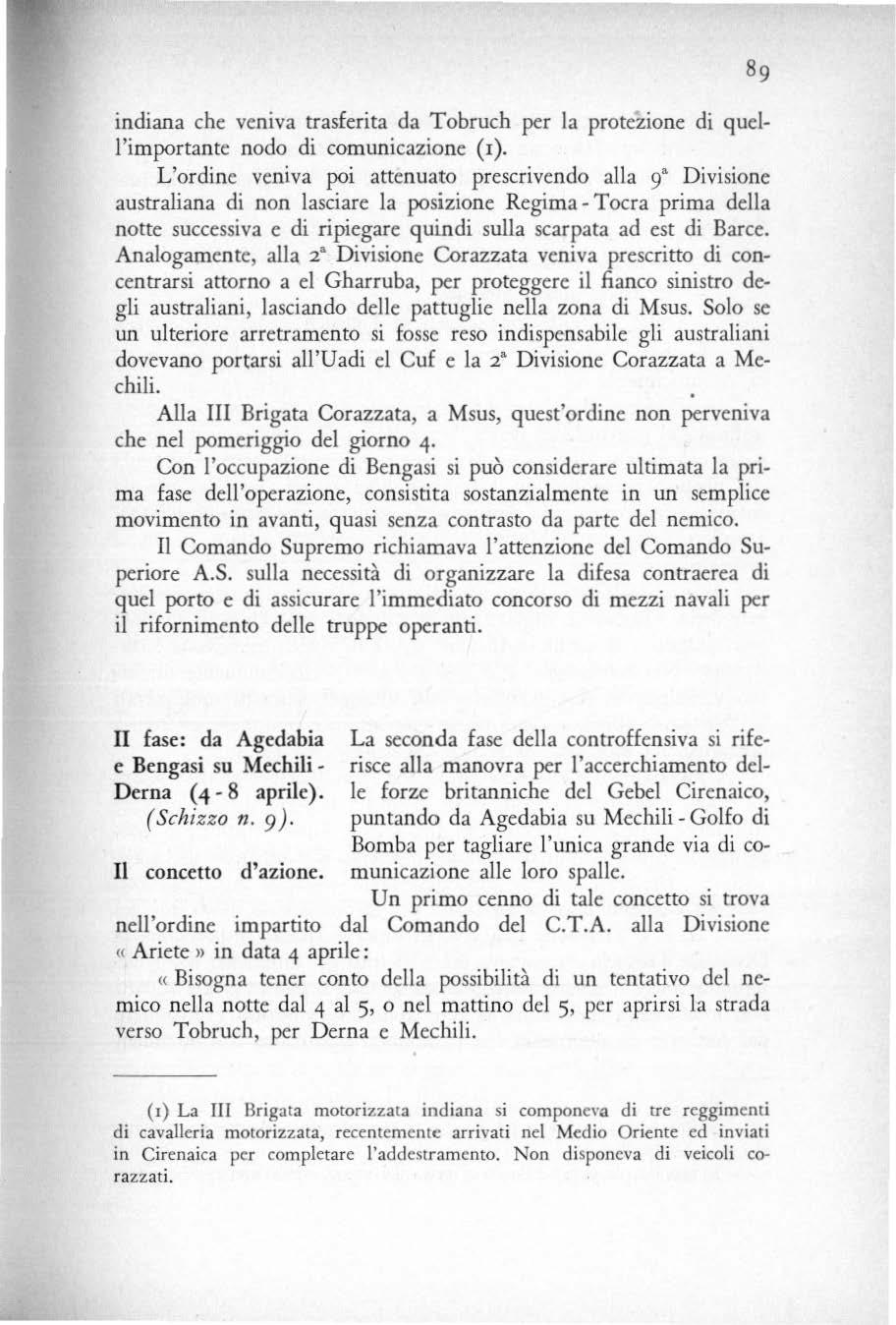
II fase: da Aged abia e Bengasi su M echiliDerna (4 -8 april e) .
(Schizzo n. 9).
L a seconda fase della controffensiva si riferisce aJla manovra per l'accerchiamento delle forze britanniche del Gebel Circnaico, puntando da Agedabia su M echi li -Golfo di Bomba per tagliare l'unica gran de via di coIl concetto d'azio ne. municazione alle loro spalle. Un primo cenno di tale concetto si trova nell'ordi ne impartito dal Comando del C.T.A. alla Divisione « Ariete» in data 4 aprile : «Bisogna tener conto della possibilità di un tentativo del nem ico n ella notte dal 4 al 5, o nel mattino del 5, per apri r si la strada verso T obruch, per D erna e Mechili.
(1) La III Brigata motorizza ta indiana si componc\·a di tre reggim enti di cavalleria motorizzata, recent emente arrivati nel Medio Oriente ed inviati in Cirenaica per completare l'addestramento. Non di sponeva di veicoli corazzati
<< Bisogna raggiungere il più presto possibile:
- il btg. Schwerin, la strada presso Tmim i,
- il btg. Fabris, il sud di Mechili, con un reparto esplorante ad ovest della località.
<< Impiego dell'aviazione nella mattinata del 5 su :
- le strad e presso Derna,
- le strade presso Mechili,
- tutte le strade convergenti su T obruch.
« Le truppe debbono tempestivamente esporre numerosi scgru di riconoscim ento »
In relazione all'ordine, il Comandante della Divi sio ne « Ari ete » ordinava al comandante dell'B o bersaglieri (col. Montemurro) di seguire celerm en te la colonna Fabris e raggiungerla con un'aliquota del proprio comando , un battaglione bersaglieri, una sezio n e da 20 mm., una compagnia anticarro da 47/32 e una batteria del 132° artiglieria. Ra ggiunto M echili i reparti dovevano sostare, in attesa di ordini.
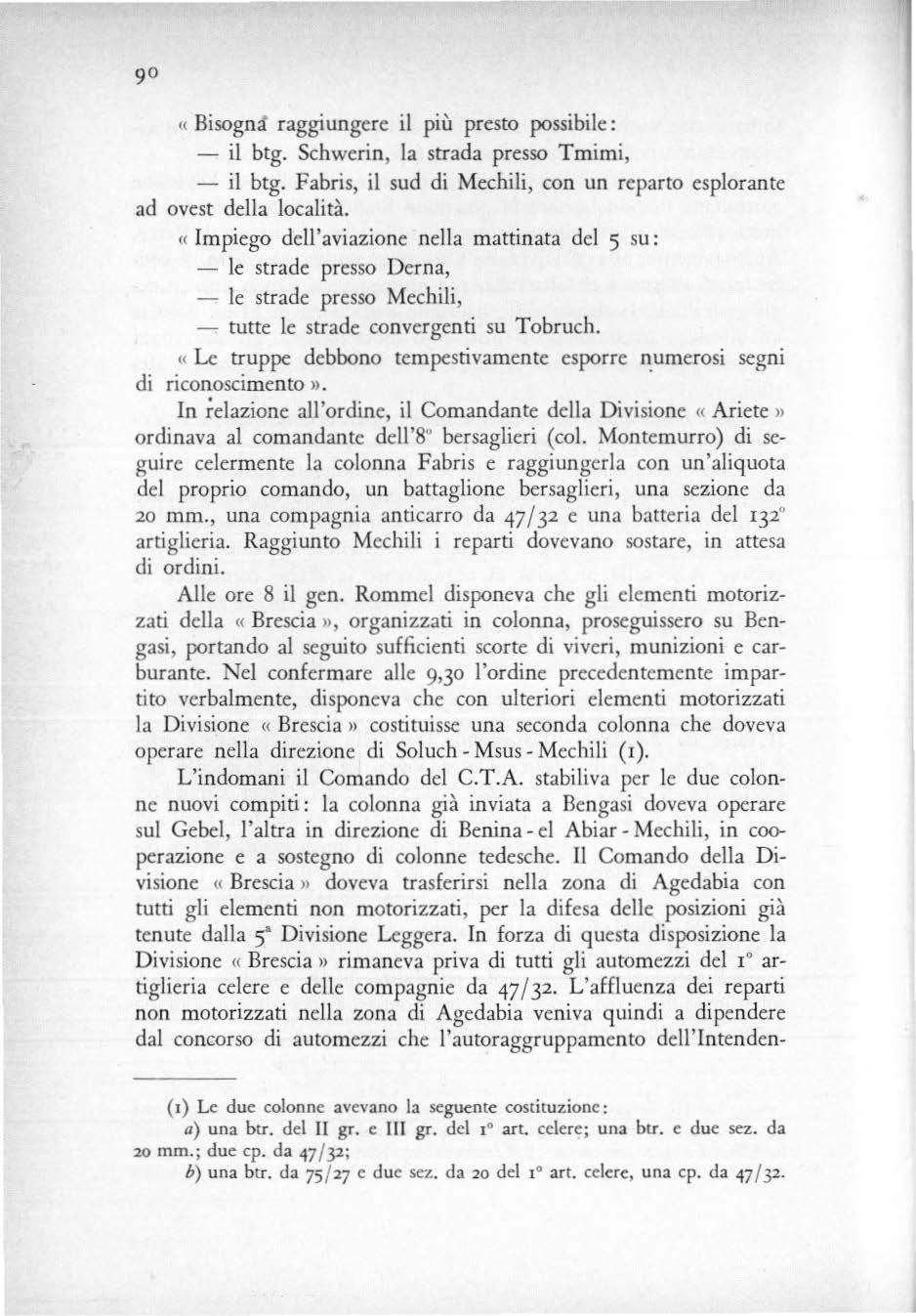
Alle ore 8 il gen. Rommcl dispo neva che gli ele menti motorizzati della << Brescia », orga ni zzati in colonna, proseguissero su Bengasi, portando al seguito sufficie nti scorte di viveri, mu n izioni e carburante. Nel confermare alle 9,30 l'ordine precedentemente impartito verbalme nte, dispon eva che co n ulteriori elementi motorizzati la Divisione « Brescia » costituisse una seconda colon na che d oveva ope rare nella direz ion e di Soluch- Msu s - Me ch ili (r).
L'indomani il Comando del C.T. A. stabiliva per le due colonn e nuovi compiti: la colon na già inviata a Bengasi doveva operare sul Gebel, l'altra in direzio ne di Benina- el Abiar- Mechili, in cooperazio ne e a sosteg no di colonne tedesche. Il Comando della D ivision e « Brescia >> dov eva trasferirsi n ella zona di Agedabia con tutti gli ele m en ti non motorizzati, per la difesa delle posizioni già tenute d alla s• D ivisione L egge ra. I n forza di qu es ta disposizione la D ivisio n e « Brescia >> rimaneva priva di tutti gli automezzi del 1 ° artiglieria celere e delle co mpa g ni e da 47 j 32. L 'affluenza dei reparti n o n motorizzati nella zona di Agedabia veniva quindi a dipender e dal co ncorso di auto m ezzi che l'autoraggruppamento dell'Intenden-
(1) Le due colonne avevano la seguente costituzione:
a) una btr. del II gr. e III gr. del 1° art. celere; una btr. e due sez. da 20 mm.; due cp. da 47 / 32;
b) una btr. da 75 / 27 c due sez. da 20 del 1° art celere, una cp. da 47 / 32
za avrebbe potuto fornire, tenuto co nto delle notevoli e pressanti esigenze del rifornim ento delle vari e colonne in movimento.
Mancano nella documentazione agli atti elementi per ricostruire nei particolari gli ordini impartiti dal gen. Rommel ai reparti tedeschi: si può comunque desumere seoz'altro che fossero intesi a lanciare con urgenza su tutte le direttrici il totale delle forze disponibili, verso gli obiettivi indica ti.
In sostanza la manovra risultava articolata su quattro colonne miste italo- tedesche, precedute da forti avanguardie:
1 ° colonna: costituita dal grosso della 5" D ivisio ne Leggera (gen. Streich) e un 'aliquota della Divisione « Ariete » (due btg. bersaglieri rinforzati con armi anticarro) preceduta dal Gruppo Schwerin e dal Gruppo Santamaria, in avanguardia. Compito: avanzare da Agcdabia su Giof el Matar- Bir Ben Gania- Bir Tengeder per poi procedere su Mechili da una parte e sul Golfo di Bomba, dall'altra.
2 " colonrJa: costituita dal 5o rcgg. carri armati e reparti mitraglieri tedeschi (col. Olbrich), più elementi corazzati della D ivisione « Ariete ». Compito: convergere da Antelat c da Soluch su Msus per attanagliarvi le forze corazzate nemiche che vi risultavano concentrate e procedere poi su Bir Belamed, tenendosi in misura di concorrere alle operazioni delle colonne laterali, sia su Mechili e Tengeder, sia verso nord.
3• colonna: costituita dal 3o reparto esplorante tedesco (maggiore Wechmar) rinforzato da elementi della Divisio ne « Brescia ». Compito: puntare da Bengasi, per R egima, su Mechili.
4" colonna: costituita da un'aliquota della Divisione « Brescia » (un btg. e un gr. artiglieria), un btg. della Divisione « Bologna» ed elementi meccanizzati tedeschi (gen. Kirchheim). Compito: avanzare da Bengasi sul Gebel e procedere per Tocra e Barce verso Derna.
Da questo schema risulta chiaro il sistema caro al gen. Rommel di ricorrere alla formazione di gruppi di co mbattimento di circostanza, basati spesso sulla scelta del comandante, a suo giudizio più particolarmente adatto all'assolvimento del particolare incarico, senza molto riguardo ai vincoli organici fra gli elementi occasionaimente riuniti. Un sistema, evide nte mente , basato piuttosto su un concetto meccanico di intercambiabilità delle componenti che su q uello della valorizzazione del prezioso fattore affiatamento e coe-
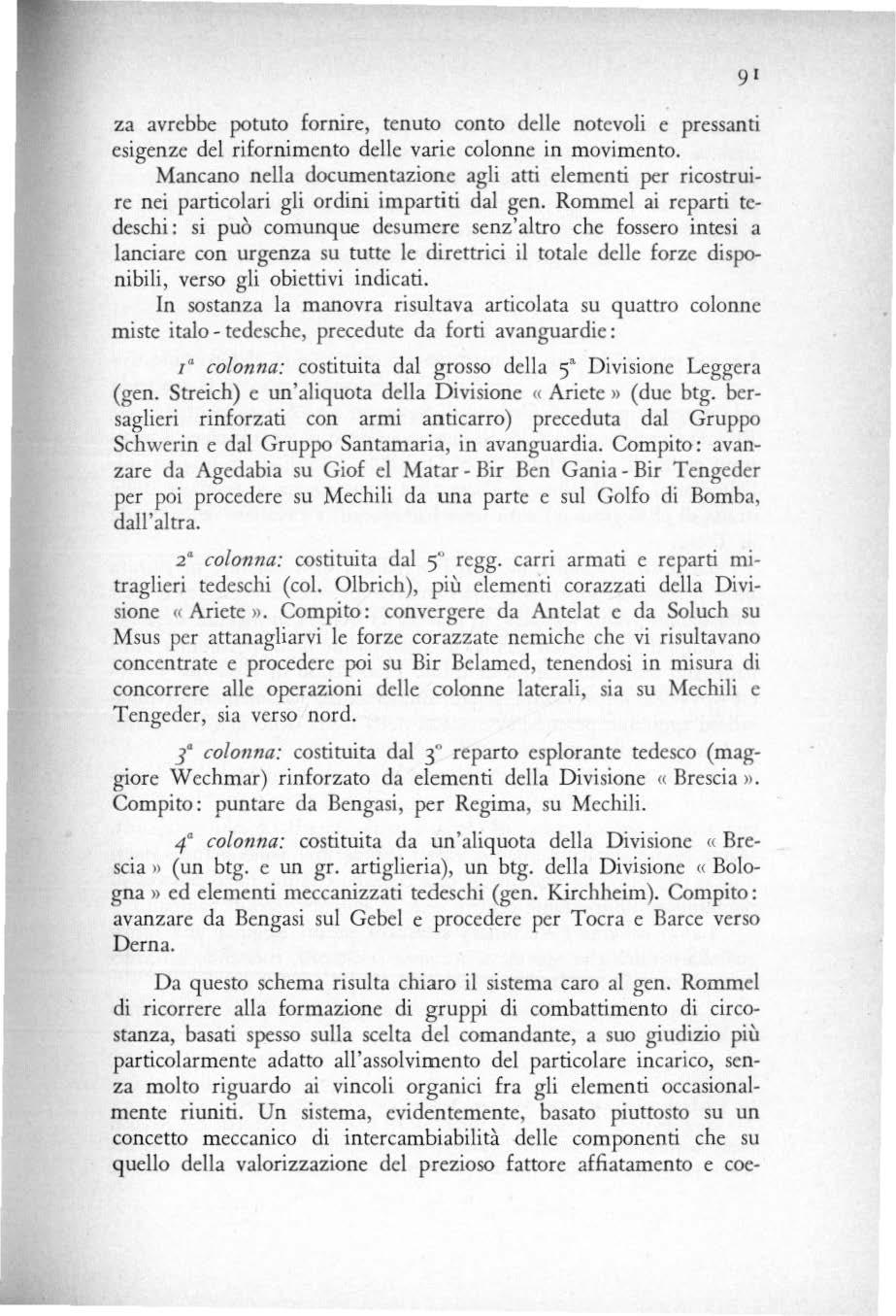
sione organica. Un sistema comunque che, rispondente forse alla natura ed al perfetto grado di addestramento del sold ato tedesco, non si potrebbe riconoscere efficace nei confronti della natura e del diverso livello di addestramento del nostro soldato, spesso costretto a improvvisare, di fronte ai problemi proposti da situazioni tattiche per le quali non era preparato e tanto meno attrezzato.
La giornata de l 4· Il mattino del giorno 4 la 2 Divisione Corazzata britannica si trovava con il comando e la maggior parte del Gruppo di Sostegno a el Abiar, mentre la III Brigata Corazzata era a Msus, incerta su dove poter co mpiere il prossimo pieno di carburante. L a 9• Divisione australia na si trovava sull'altopiano, tra Regima e Tocra, con una brigata a cavaliere della strada di el Regim a e l'altra (due battaglioni) a cavaliere della strada di Tocra.
La nostra ricognizione aerea segnalav a forti colonne in ritirata sulle strade del Gebel; M echili risultava fortemente occupato e forti autocolonne erano segnalate in marcia da Bomba su Mechili stesso.
Ra ggiunto Bir Ben Gania , le avanguardie della Ia colonna s'imbattevano nei primi campi di mine. Procedendo in direzione nordest trovavano nuovi campi min ati, numerosi ma facilmente individuabili ed aggirabili perché l'avversario, nella fretta dello sgombero, aveva trascurato di togliere i cartelli indicatori.
Le avanguardie della 2 ,. colonna avanzavano su Msus per impegnare il nemico da ovest (reparto mitraglieri tedesco) ed attaccarlo con azione aggirante da sud (reparti carri armati tedeschi e italiani). Msus, presidiata da numerosi carri, veniva due volte battuta dagli Stukas che disperd eva no altresl una colonna che dal nord cercava di raggiu ngere l'importante centro, sede di ingenti depositi campali.
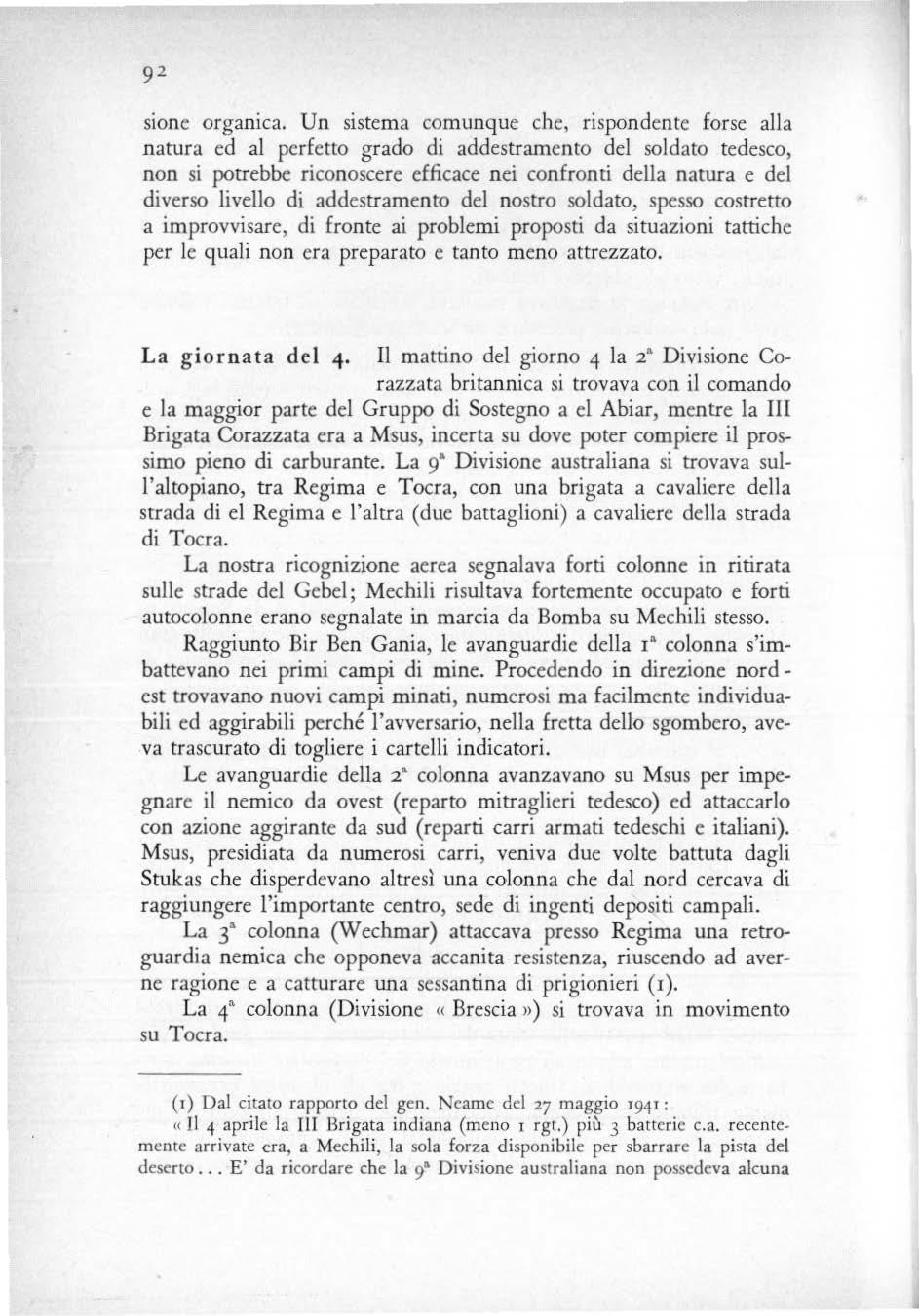
L a 3a colonna (W echmar) attaccava presso R egima una retroguardia nemica che opponeva acca nita resistenza, riuscendo ad averne ragione e a catturare una sessa ntina di prigionieri (1).
La 4" colonna (Divisione « Brescia») si trovava in movimento su Tocra.
(1) Dal citato rapp orto del gen. Neame del 27 maggio 1941 : (( Jl 4 aprile la m Brigata indiana (me no I rgt.) più 3 batterie c.a. recentement e arrivate era, a Mechili, la so la forza disponibil e per sbarrare la pista del deserto E' da ricordare che la 9• Divisione australiana non possedeva alcuna
La giornata d el 5· La realtà degli eventi trascinava ormai anche i superiori comandi sulla scia delle truppe avanzate alla riconquista della Cirenaica. Il 5 aprile appunto il gen. Guzzoni, esa minando con il gen. von Rintelen l'andamento delle operazioni in Libia, osservava che la situazione si presentava effettivamente favorevole perché gli inglesi dovevano avere ritirato molte forze, e riconosceva l'opportunità di lasciare ai comandi in posto di decidere gli ulteriori sviluppi.
Contemporaneamente, in un colloquio svoltosi ad Agedabia verso le ore 12, il gen. Rommel illustrava al gen. Gariboldi le direttive impartite per la manovra già in atto che veniva così sintetizzata:

- azione principale, con la massa d elle forze, per la direttrice Agedabia - Mechili- Derna;
- az10ne secondaria di rastrellamento lungo il litorale;
- azwne aerea sulla strada costiera e sulle zone di possibile imbarco.
Ammetteva di stare attraversando un periodo di crisi dei rifornimenti ma confidava ugualmente di poter ripr endere la Cirenaica n ei prossimi due giorni. O quanto meno di accerchiare le forze britanni che ivi dislocate, per poi annientarle nei giorni successivi. Precisava i propri intendimenti nelle seguenti direttive :
- avviare tutte le truppe già concentrate ad Agedabia (5" D ivisione Leggera e Divisione Corazzata « Ariete ») nella zona di Bomba, fra Bomba e Ain el Gazala;
- effettuar e il rastrellamento verso D erna e contemporaneamente prendere co n tatto con il nemico a T obruch;
- premere da ovest sulla Cirenaica con la Divisione « Brescia>>, la Divisione « Trento» ed alcun i reparti della 5a Divisione Leggera.
capacità di manovra, non aveva au tomezzi per il trasporto della truppa; mancava persino dei trasporti di primo scaglione e i s uoi cannon i anticarro, italiani, erano immobilizzati.
« A ca u sa della deficienza di automezzi era stato necessario far muovere due battaglioni della divisione prematuramente verso le nuove posizioni arretrate, sul costone immediatamente ad est di Barce. L'unico modo per trasportarli fu di ricorrere a parecchi viaggi che furono eseguiti la notte precedente, u sando tutti gli automezzi del primo scaglione della divisione. Per conseguenza la divisione non aveva riserve: il suo battaglione impegnato a el Regi ma aveva subito gravi perdite e perciò avevo ordinato alla divisione di ritirars i nottetempo sul ciglione di Barce »
In relazione alle particolari difficoltà che gravavano stùla Divisione « Brescia » che aveva elementi, pronti a muovere su due colonne, tra Nofilia e Driana, a oltre 450 chilometri di distanza, il gen. Garibaldi sollecitava inoltre l'Intendenza a portare rapidamente avanti le basi logistiche necessarie all'alimentazione delle operazioni, in armonia con l'avvenuto allungamento delle linee di rifornimento.
Faceva anche presente che si stavano attuando previdenze per l'utilizzazione del porto di Bengasi e metteva a disposizione del gen. Rommel l'aliquota della Divisione Motorizzata « Trento » che era già pronta a Misurata (un rgt. fanteria e un gr. artiglieria).
Le colonne continuavano ad avanzare verso gli obiettivi assegnati, ostacolate, oltre che dalle difficoltà di rifornimento, dall'imperversare del ghibli che rendeva estremamente penosi il movimento e l'osservazione
La I "' colonna procedeva verso B. Tengeder, attardata da zone minate e da azioni di contrasto di pattuglie con carri armati . A sostegno della « colonna Fabris » la Divisione << Ariete» spingeva avanti una << colonna Montemurro» (I).
In seguito alla segnalazione da parte dell'aviazione dello sgombero di Msus da parte del nemico, il gen. Rommel disponeva che il movimento venisse accelerato al massimo, per arrivare a investire Mechili prima che fosse raggiunto dalle truppe britanniche in ripiegamento da Msus. A questo scopo gli elementi più agili della colonna (Gruppo Santamaria e Gruppo Schwerin) venivano lanciati avanti, con il mandato di sbarrare le piste verso nord- ovest, ovest e sud -ovest, senza tuttavia lasciarsi impegnare a fondo.
A sera B. Tengeder era raggiunto e occupato. Il movimento veniva proseguito durante la notte, abbandonando temporaneamente gli automezzi che avevano esaurito la scorta di carburante, in attesa che fossero riforniti appena possibile . Si procedeva con gli altri, fino al limite delle rispettive disponibilità. Del Gruppo Santamaria solo quattro automezzi, con due pezzi ed altre armi, erano in condizione di continuare la marcia (2).
( r) La colonna al comando del col. Montemurro (8 ° rgt. bcrs.) era costit uita dal XII brg. bers. au toportato, una sez. mitragliere da 20, uòa cp. da 47 / 32, una btr. da 75 / 27 del 132° art.
(2) Il gen. Rommel, atterra to con un apparecchio «c icogna » presso la colonna, ordinava di travasare la nafta, concen tr andola su alcune macchine e di proceder e con qu elle, lasciando sul posto le altre.

Le forze avversarie concentrate attorno a Msus, dopo essere state bombardate dall'aviazione de ll'A sse venivano attaccate dai carri della 2 colonna e cos trette a ripi egare . L'attacco era stato portato dal 5o reggimento carri armati tedeschi, insieme al VII battaglione carri M 13 / 40 della D ivisione « Ariete». M sus veniva occupata sul far della se ra ma anche qui l'ulteriore movimento risultava ostacolato da difficoltà di rifornimento.
La 3.. colonna (Wechmar), procedendo oltre el Abiar veniva co ntrattaccata da una quarantina di carri armati ma riusciva a respi ngerli.
La 4"' colon na infine (Div isione « Brescia ») raggiungeva il bivio di T ocra , m entre di fronte a lei il nemico co n tinuava a ritirar si.
L 'aviazione otteneva notevoli risultati attaccando colonne in ritirata sulla strada D erna- T mim i, fortemente ingorgata: lungo la litoranea ri sultavano distrutti o inutilizzati un ce ntinaio tra autom ezzi e carri ar mati britannici.
Da parte avversaria, nel pomeriggio il gen . Neame, sulla base delle segnalaz ioni molto co ntr ad d i ttorie della propria ri cognizione aerea, era sul punto di ordinare la ritirata gen erale, per timore del completo accerc hi amento. Non m odifi cava tuttavia le precedenti istruzioni, intese ad opporre un a prolungata resistenza sulle posizioni di Barce (I).
La giornata del 6. Alle ore 3 de1 6 aprile perve niva al Comando della Divisione Corazzata « Ariete » l'ordine del C.T.A. di riprendere il movim ento per Sceleidima, con tutti i reparti:
CoRPo TEDEsco I N AFRI CA
Rep. la
Q. G., 6 aprile 1941

Al Co mando Divisione Co ra zzata « Ariete >>
In iziare immediatamente con tutti i r eparti il movimento via Agedabia - Ghemines- Soluch per Sceleidima. F ermarsi qui co n l a te sta, far sosta e aspettare nu ovo ordine
Il movimento verrà prevedibilmente ripreso in direzione Mechili. L'ordine per inizio movimento sarà portato probabilmente da un ufficiale in « cicogna», fra le ore 8 e le 9· Indicare terreno di atterraggio vicino a Sceleidima mediante una croce bianca. Attenzione fosso anticarro italiano e mine italiane a destra e sinistra di Sceleidima. Attenzione bottiglie- thermos lanciate sulla via Soluch- Mechili. Sono espl osive e pericolose a prendersi (1). f
Si prenda in tempo contatto con il btg. mitr . .Y (tedesco) che attacca in direzione Soluch- Sceleidima- Msus.
Si comunichi: l'inizio del movimento della «Ariete», passaggio della testa e coda da Agedabia, arrivo previsto dei primi reparti a Sceleidima.
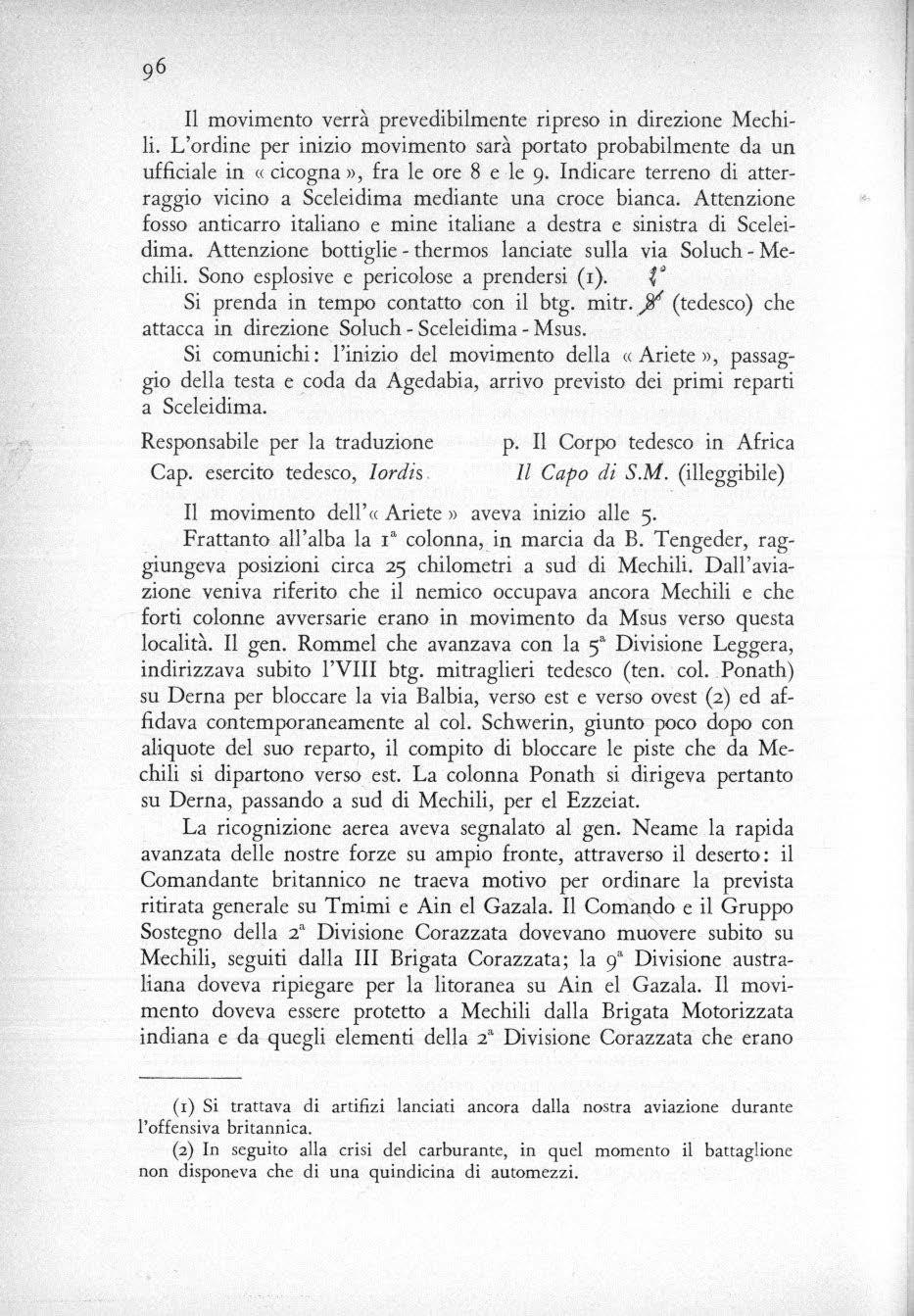
Responsabile per la traduzione p. Il Corpo tedesco in Africa
Cap. esercito tedesco, Ior dis Il Capo di S.M. (illeggibile)
Il movimento dell' « Ariete » aveva inizio alle 5· Frattanto all'alba la 1"' colonna, in marcia da B. Tengeder, raggiungeva posizioni circa 25 chilometri a sud di Mechili. Dall 'aviazione veniva riferito che il nemico occupava ancora Mechili e che forti colonne avversarie erano in movimento da Msus verso questa località. Il gen. Rommel che avanzava con la 5a Divisione Le ggera, indirizzava subito l'VIII btg. mitraglieri tedesco (ten. col. Ponath) su Derna per bloccare la via Balbia, verso est e verso ovest (2) ed affidava contemporaneamente al col. Schwerin, giunto poco dopo con aliquote del suo reparto, il compito di bloccare le piste che da Mechili si dipartono verso est. La colonna Ponath si dirigeva pertanto su Derna, passando a sud di Mechili, per el Ezzeia t. La ricognizione aerea aveva segnalato al gen. Nearne la rapida avanzata delle nostre forze su ampio fronte, attraverso il deserto: il Comandante britannico ne traeva motivo per ordinare la prevista ritirata generale su Trnimi e Ain el Gazala. Il Comando e il Gruppo Sostegno della 2" Di visione Corazzata dovevano muovere subito su Mechili, seguiti dalla III Brigata Corazzata; la 9a Divisione australiana doveva ripiegare per la litoranea su Ain el Gazala. Il movimento doveva essere protetto a Mechili dalla Brigata Motorizzata indiana e da quegli elementi della 2a Divisione Corazzata che erano
( r) Si trattava di artifìzi lanciati ancora dalla nostra aviazione durante l'offensiva britannica.
(2) In seguito alla crisi del carburante, in quel momento il battagl ione non disponeva che di una quindicina di automezzi.
riusciti ad arrivare sul posto (1). Un reggimento di artiglieria veniva pure diretto a Mechili, a rinforzo della Brigata indiana.
In relazione alle disposizioni impartite dalle due parti, nel corso della giornata a Mechili dovevano verificarsi scontri di elementi avanzati, che si svilupparono effettivamente con alterna vicenda.
Ali 'imbrunire il gen. Rommel aveva potuto riunire nella zona, all'altezza della Sebca di Baltet er Ramla, forze ritenute sufficienti all'investimento del caposaldo. Giungeva contemporaneamente la colonna Fabris che prendeva posizione sulle alture ad oriente della ridotta.
La stessa sera del 6 il Comando della 2 • Divisione Corazzata britannica, che da due giorni non era più in regolare contatto con il complesso delle forze dipendenti, raggiungeva Mechili mentre il Comandante della III Brigata Corazzata decideva (sembra in relazione alla deficienza di carburante) di dirigersi per Maraua su Derna, ove erano anche confluiti i Dragoni Guardie del Re ed il Gruppo di Sostegno (2). Ne risultavano così aumentate le già gravi difficoltà di movimento della 9.. Divisione australiana, impegnata sull'erto gradone gebelico.
Ad aumentare la generale confusione in campo britannico, accadde che i generali Neame e O' Connor, rima sti a fino alle
(1) << Durante la ritirata da Agedabia - riferisce il gen. Neame - le truppe della 2• Divisione Corazzata (Gruppo di Sostegno e III Brigata Corazzata) erano considerevolmente sparpagliate, sottraendosi al controllo del Comando di Divisione. I collegamenti furono una cont inua difficoltà perché il personale agli apparati in dotazione era stato sottratto alla d ivisione appena sbarcato in Egitto. Per conseguenza la divisione non fu mai raccolta nel modo appropriato, come io avevo ordinato , nel settore di Charruba >>
(2) Da « History of thc Second World War - Tbc Medit erranean and Middle East », Playfair I.S.O., London, 1956, Ed. H.M.S.O.: <<La III Brigata Corazzata ricevette l'ordine di muovere verso nord su el Charruba nel pomeriggio del giorno 4· Disponeva soltanto di 9 carri "I" (per fanteria) del 5" reggim ento Royal Tanks e dci carri italiani del 6" reggimento che "andavano avanti zoppicando". Percorse r5 miglia la sera stessa. Nelle prime ore del pomeriggio del 5 i carri rimasti (8 carri "I" c 14 carri leggeri) cercavano di raggiungere la zona di cl Charruba. Il 6'" Royal Tanks seguiva il movimento a distanza: con l'esaurirsi del carburante dei motori diesel i carri più efficienti erano riforniti con il carburante di quelli meno efficienti che venivano poi di strutti. Questo procedimento durò finché rimas ero soltanto due carri. La b<'n7ina per i carri brìtannìci era divenuta pure molto scarsa: malauguratamente un convoglio, ìnviato da Maraua, era stato distrutto da un attacco aereo il 4 april e; due altri lo furono il 5· La III Brigata non era più una formazione di combattimento »

ore 20, s1 dirigessero insieme, sulla stessa vettura, su Berta. Senonché, invece di prendere la pista che, verso est, portava a Tmimi, per Martuba, ne avevano imboccata un'altra che, piegando a nord, sboccava a Derna. Verso le 3, nell'oscurità, incappavano improvvisamenuna pattuglia meccanizzata tedesca e venivano presi prigiomen.
Il forte ghibli impediva l'attività aerea e ritardava la marcia delle varie colo nne. Comunque Ja 2 • colonna si spingeva fino a Bel Meléz, la 3" a el Heira el Ageba e la 4", dopo aver ripristinato il transito sulla via Balbia che era stata interrotta su l ciglione, occupava Barce e il villaggio di Maddalena.
La giornata del 7· Nella notte sul 7 la sit uazione generale, per la parte britannica, era la seguente:

-a M echili : il gen. Gambier- Parr y aveva ai propri ordini la Brigata Moto rizzata indiana (Brig. Vaughan) meno un reggimento, un'aliquota del 1° Ro yal H orse Artillery e parte del 3° reggimento anticarro australiano;
-a Tobruch: ad ovest della piazza (circa 25 km) la 9"' Divisione australiana (gen. A. F. Harding, del Comando Cirenaico Avanzato), m eno la XXIV Brigata, ma con il Gruppo di Sostegno della 2 • Divisione Corazzata, era schierata a cavallo della rotabil e, con la sinitra ad Acroma;
. nell'interno della Piazza erano assegnate, per apprestarne la difesa, la XVIII Brigata australi an a (della t Di visione) in trasferime nto via mare dall' E gitto, e la XXIV Brigata, della 9• Divisione australiana; a el Adem forze mobili, comprendenti i resti del Gruppo di Sostegno della 2 • D ivisione Corazzata, rinforzati da altri elementi, a guardia delle provenienze da sud e sudovest.
Con la giornata del 7 si avviava a conclusione la manovra di accerchiame nto iniziata nell e prime ore del giorno 4· All'alba aveva inizio il movimento della 1 • colonna per l'ultimo balzo sul punto chiave di Mechili. Il dispositivo di attacco era il seguente:
- az10 n e frontale: affidata alle colonne Fabris e Montemurro;
- doppio aggiramento: da ovest (un gr. carri su 3 cp., II btg. mitraglieri del 200° rgt., una btr. da 88 mm) e da est (reparto Schwerin).
Prima dell'attacco il gen. Rommel inviava un parlamentare per intimare la resa « di fronte ali 'intero Corpo Tedesco d'Africa che accerchiava Mechili >> : la proposta veniva respinta.
L 'attacco aveva inizio soltanto alle ore 18, dopo una nuova intimazione di resa, preceduta dal fuoco di artigli eria delle colonne italiane; il gen. Rommel aveva ritenuto opportuno attendere, per lasciare serrar sotto la massa delle forze avanzate e ricevere rifornimenti di acqua e benzina, per via aerea. Alle ultime luci del giorno i carri armati irrompevano nelle linee avversarie, se nza raggiun gere risultati risolutivi ma creando tuttavia le premesse per l'attacco, all'alba dell'indomani.

Nello stesso pomeriggio del 7 la colonna del ten. col. Ponath (VIII btg. mitraglieri) riusciva a bloccare D erna .
La 2 colonna veniva attardata da difficoltà d'ordine logistico: un'aliquota, con il col. Olbri ch poteva raggiungere Reab el Beter, mentre reparti dell' « Ariete >> erano fermi al bi vi o per Bir Belamed e sulla pista per Bir Ben Gania. In serata affluivano qui anche reparti tedeschi, agli ordini del gen. von Prittwitz (33 o reparto cacciacarri e gruppo contraerei).
L a 3a colonna (Wechmar), dopo aver superato resistenze di retroguardie, raggiungeva B. en Ngara (est di Zaviet en Neian ) e spingeva elementi su Maraua.
La 4.. colonna infine (Divisione « Brescia ») riprendeva il movimento da Maddalena. Attardata anch'essa da azioni di fuoco di retroguardie, proseguiva per l'itinerario Castellabia- Maraua- Slonta e raggiungeva il villaggio De M artino.
La ricognizione aerea segnalava forti concentramenti di automezzi e carri armati nemici attorno ad Ain el Gazala, che venivano efficacemente attaccati da formazione di Stukas e di caccia . La nostra aviazione agiva inoltre co n successo contro le colonne nemiche in ritirata lungo le strade gebeliche e ad oriente di Derna.
La giornata dell'8. Nella notte sull'8 le forze britanniche presenti a Mechili avevano ricevuto l'ordine di ripieg are su el Adem. All'alba effettuavano un tentativo di sortita e di aggiramento della colonna Fabris, subito stronca to dal rapido
intervento della nostra artiglieria e delle mitragliatrici. La colonna Montemurro, sopraggiunta, partecipava poco dopo all'attacco del fortino che veniva occupato dopo breve e violenta lotta. Alle ore 6 le prime truppe italo- tedesche entravano in Mechili, innalzando le rispettive bandiere.
Una parte del presidio britannico era costre tta a capitolare m entre riuscivano a sfuggire alla cattura il reparto del I 0 Ro yal H orse Artillery, truppe indiane che riusc iro no a forzare l'accerchiamento verso sud, nonché un gruppo del 18° rgt. cavalleria indiana e alcuni cannoni anticarro australiani. Cadevano prigionieri il gen. Gambier -
':i: Parr y, comandante della .. DivisioRe austl'ahafta (che si arrendeva a l col. Mo ntemurro con tutto il suo stato maggiore) il brigadiere Vaugham e la maggior parte della Brigata Motorizzata indiana (circa 1200 uomini).
Verso le ore 12 giungeva notizia dal ten. col. Ponath che a D erna il bottino e il numero dei prigionieri andavano d'ora in ora aumenta ndo: si andava delineando una situazione che egli difficilmente avrebbe potuto fronteggiare con i ridottissimi effettivi del proprio reparto e che rendeva necessario l'immediato invio di rinforzi. Quasi nella stessa ora la 4:. colonna, preceduta dal gen. Zambon, co mandante della Divisione « Brescia >> insieme al gen. Kirchheim, quale ufficiale di collegamento, raggiungeva la città e si schierava sul costone est dell'abitato. Tentativi nemici di forzare il passaggio da ovest, protrattisi per tutto il pomeriggio, venivano respin ti (r).
Il Co mand ante della III Brigata Corazzata e la maggior par te dei resti di questa unità venivano ca ttu rati, sulla via di Derna. Il Gruppo Sostegno britannico combatteva nei sobborghi or ienta li della città un'abile e deci sa azione: la maggior par te dei suoi effe tti vi e dei Dragoni Guardie del Re riusciva ad apr irsi la via della ritirata su Tobr uch.
Alle 19 confluivano a D erna an che le due avangu ardie Schwerin e Santamar ia che, dopo l'occupazione di Mechili, avevan o ri-
(1) Torna qui opportuno cogli ere un esempio della maniera distorta con cui sovente da parte dell'alleato sono stati esposti episodi del la cooperazione d'armi italo - tedesca. Ecco come viene riportata dal geo. Rommel l'azione della «Bresci a »: « .. . La ''Brescia ", supera ta Bengasi, era già arriva ta a Derna. Qui il generale Kirchhcim, che aveva accompagnato l'avanzata di queste truppe, era intervenuto in forze » (RoMMEL: «G uerr a senza odio», Ed. Garzanti, 1952, pag. 26). Affatto trascurabi le che quelle forze fossero della divisione i tal iana, comandate evidentemente da uffi ciali i taliani.

preso il movimento, sfruttando le ultime scorte di carburante. Anche la colonna Fabris veniva fatta convergere su Derna.
La colonna Montemurro rimaneva invece a presidio della zona di Mechili, a temporanea disposizione del C.T.A.
Mentre sulla linea avanzata si svolgevano questi avvenimenti, gli elementi delle colonne rimasti indietro per difetto di carburante, venivano man mano riforniti e potevano serrare sulla testa delle proprie colonne. Superando notevoli difficoltà, l'Intendenza provvedeva frattanto a stabilire regolari correnti di rifornimento (1).
n problema logistico costituiva sempre la maggiore preoccupazione e il maggiore impegno per il Comando Superiore italiano
A.S., per assicurare l'efficienza operativa delle truppe avanzate, lanciate senza adeguata preparazione in un'impresa dal ritmo tanto sconvolgente.
Il gen. Gariboldi ordinava che tutti gli automezzi del X e del XX Corpo d'Armata disponibili in zona arretrata venissero utilizzati per assicurare alle Divisioni « Brescia » e « Trento » e al 2 " rgt. artiglieria celere l'autonomia logistica che la situazione esigeva. Con la seguente lettera informava il gen. Rommel delle disposizioni assunte:
GovERNO GENERALE DELLA LIBIA

CoMANDo SuPERIORE FoRZE ARMATE AFRICA SETTENTRIONALE
STATO MACClORE
OI/5091 di prot. Op.
Al Generale Rommel
li 9 aprile 1941 -XIX
Comatzdante Corpo Tedesco m Africa
P. Militare
H o dato tutti automezzi d i sponibili per motorizzare il massimo dei reparti della D ivisione «Brescia», completare «Trento» et 2 "
(x) Il 7 mattina gli elementi non motorizzati della «Brescia >> ricevevano ordine dr concentrarsi a Bengasi a scaglioni, usufruendo degli automezzi che sarebbero stati messi di volta in volta a disposizione dall'Intendenza. Il grosso dell'« Ariete» si spostava lungo l'itinerario Soluch- Scelcidima- Msus- Bir Bel amed- Bir Ben Gania- Bi r Tengeder- Gadd cl Amhar verso el Adcm . Marcia lunga c logorante di circa 500 chilometri che richiedeva una complessa organizzazione logistica. Il movimento iniziato il 6 aprile si concludeva ad el Adem la sera del 13.
reggimento artiglieria celere. Ogni sforzo è compiuto per dare alle unità predette l'autonomia logistica occorrente e per alimentare le nuove basi di rifornimento.
Per ottenere questi risultati ho tolto tutti, dico tutti, gli automezzi alle unità del X e del XX Corpo d'Armata le quali, in consegtienza, non hanno più alcuna capacità di movimento.
Pertanto, .fino a quando non giungeranno automezzi di rinforzo, non sarà possibile spostare altre unità dalla Tripolitania verso la fronte.
Vivo compiaci mento per quanto avete fatto.
Il Generale D esignato d'Armata Comandante Superiore Forze Armate A.S.
Italo GaribaldiL a precisazione appare oggi come un opportuno richiamo alla realtà delle cose, nel momento stesso in cui il gen. Rommel, nell'euforia del successo, sembrava sul punto di perdere il senso delle proporzioni, se si deve dar credito di concretezza a quanto eg li stesso, forse in un abbandono di epico lirismo, aveva scritto il giorno prima in una lettera alla moglie:
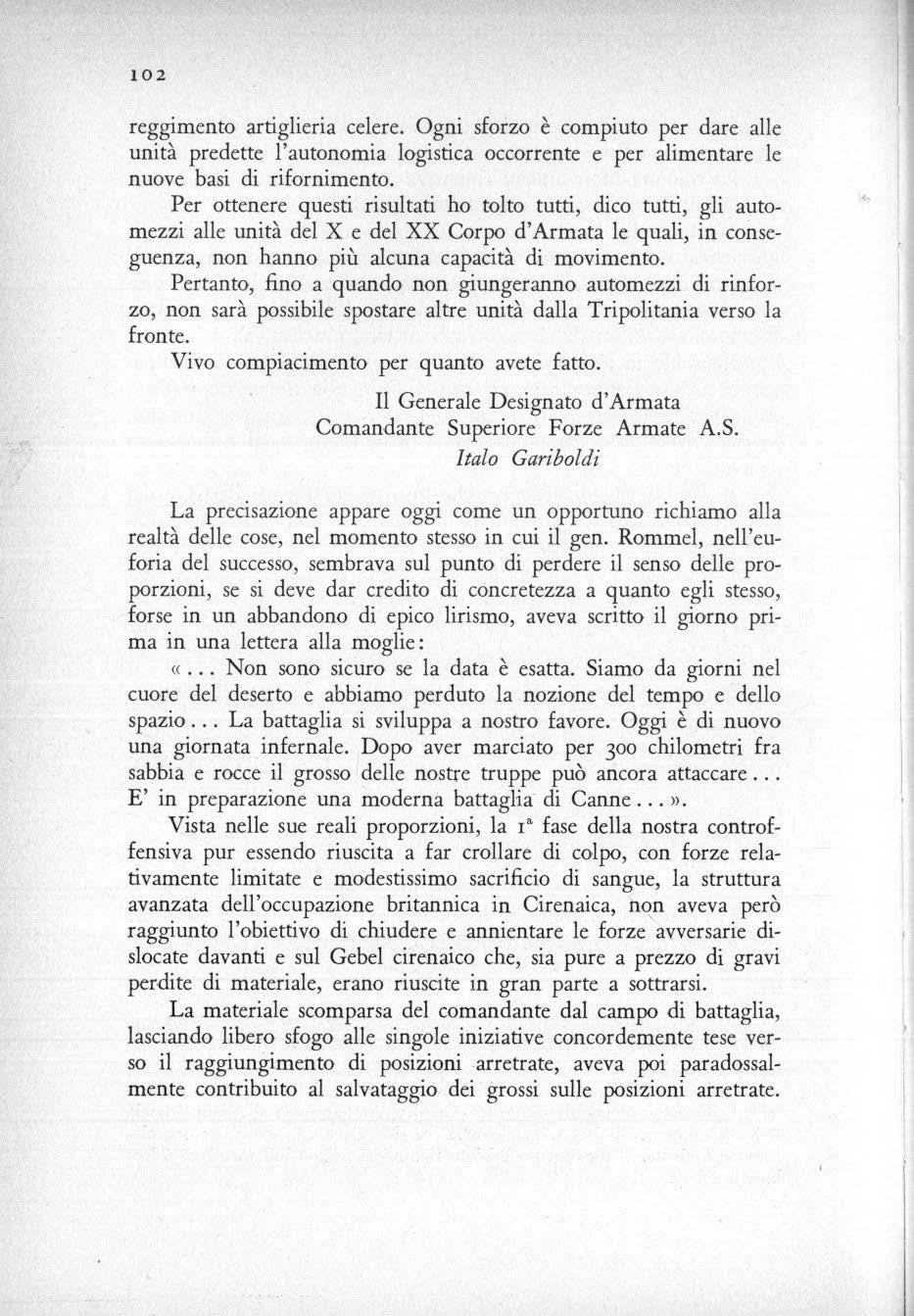
« . . . Non sono sicuro se la data è esatta. Siamo da giorni nel cuore del deserto e abbiamo perduto la nozione del tempo e dello spazio ... La battaglia si sviluppa a nostro favore . Oggi è di nuovo una giornata infernale. Dopo aver marciato per 300 chilometri fra sabbia e rocce il grosso delle nostre truppe può ancora attaccare E' in preparazione una moderna battaglia di Canne ... ».
Vista nelle sue reali proporzioni, la I & fase della nostra controffensiva pur essendo riuscita a far crollare di colpo, con forze relativamente limitate e modestissimo sacrificio di sangue, la struttura avanzata dell'occupazione britannica in Cirenaica, non aveva però raggiunto l'obiettivo di chiudere e annientare le forze avversarie dislocate davanti e sul Gebel cirenaica che, sia pure a prezzo di gravi perdite di materiale, erano riuscite in gran parte a sottrarsi.
La materiale scomparsa del comandante dal campo di battaglia, lasciando libero sfogo alle singole iniziative concordemente tese verso il raggiungimento di posizioni arretrate, aveva poi paradossalmente contribuito al salvataggio dei grossi sulle posizioni arretrate .
III fase: da DernaMechili a Bardia - Soll um (9- 13 aprile).
Inve stimento di Tobruch e presa di Bardia - Sollum. (Schizzo n. 9)·
secuzione dell'offensiva.
Gli Inglesi attr i buiv an o giustamente gra nde valore al possesso di T obruch, in relazion e alla sua importanza co me base marit ti m a e pe r i cospicui rifornimenti ammassati nella piazza. In mano britannica, Tobruch avrebbe costituito una spi n a nel fianco del futuro schieramento dell'Asse e ci avrebbe impedito di valerci di quel porto e d elle locali rise rve idriche per alimentare l'eventuale pro-
La decisione di tenere Tobruch era stata presa da Wavell nel corso di una riunione tenuta al Cairo il giorno 6, con il ministro Eden, il ge nerale d 'aeronautica Longmore e l'amm. Cunningham. Aveva conseguentemente o r di n ato che una brigata della t Divisione australian a, che si trovava in P alestina per raggiungere la Grecia, venisse imbarcata per tra sferirsi a T obruch, a ri nforzo della locale difesa Dall'Egitto inviava inoltre dei carri al distacca m ento corazzato che si trovava già nella piazza per la riparazione dei carri e che diveniva così disponibile a sostegn o della difesa stessa.
La decisione colli mava piename nte co n il pensiero del Primo Ministro che l'indomani tel egrafava da Londra:
« Vo i dovreste cer tamente essere in grado di tenere Tobruch con le sue difese perma nenti costrui te dagli italiani, almeno si nch é . . . il nemi co non porti in linea gran di forze di artiglieria. S i stenta a crede re che possa fare ciò per qua lc h e setti man a. D 'altra parte correrebbe dci grossi rischi, qualora lasciasse da parte Tobruch e continuasse l'avanzata co ntro l' Egitto, dato che noi potremmo mandare rinforzi dal mare e minacciare le sue co municazioni. T obruch sembra pertanto una piazzaforte da difend ere a oltranza, senza pensare di ritirarsi. Sarei lieto di conoscere le Vo stre intenzioni » ( 1 )
Il giorno 8 il gen . Wav ell si r ecava in volo a Tobruch, insieme al generale australiano Laverak al quale affid ava, temporaneam ente, il comando della Piazza. Il giorno 10 precisav a al Primo Mini stro:
« Propon go di tenere Tobruch , di piazzare n ella zona BardiaSollum truppe dotate d ella m assi ma mobilità possibile, per proteggere le comunicazioni a ope rare co ntro il fianco e il rovescio delle
(x) W. Cu uRCHlt.L: « La seconda guer ra mondiale li Mondadori, 1952, Parte III, vol. I, pag. 240.

forze nemiche che attaccano Tobruch e di attuare il vecchio piano difensivo nella zona di Marsa Matruh. Sarà un difficile calcolo quello di distribuire le forze in maniera tale da guadagnare tempo senza arrischiare di subire scacchi, qua e là. Le mie riserve sono limitatissime, specialmente di truppe mobili e corazzate e di armi anticarro e contraeree. Sarà una gara contro il tempo».
La risposta di Churchill gli assicurava il pieno consenso di Londra:
« Noi tutti approviamo cordialmente la vostra decisione e faremo tutto il possibile per venirvi in aiuto »
Il 9 aprile le avanguardie della 5a Divisione Leggera, seguite immediatamente da reparti bersaglieri dell' « Ariete>> (colonna Montemurro) r aggiungevano Ain el Gazala. n giorno IO il Comando del C.T.A. ordinava per la notte successiva di « stringere il cerchio>> at torno a Tobruch. Verso la mezzanotte, per saggiare la reazione del presidio, veniva svolta un'azione di fuoco sul centro della città alla quale partecipava anche la Divisione « Brescia >> con tutte le batterie avanzate. (Allegato 11. 14).
All'alba dell'II le truppe corazzate, agli o rdini del gen. von Prittwitz (com andante della 15a Divisione Corazzata non ancora giunta in Libia) procedevano all'investimento della Piazza, che aveva rifiutato la resa. L'ordine del gen. Rommel era di attaccare con le ava n guardie della sa Divisione Leggera a cavaliere della via Balbia e di avviare il 3" reparto esplo ran t e per Acroma su el Adem. Il grosso della s· Leggera doveva seg uirn e il movimento.
In un primo tempo l'azione del battaglione mitraglieri Ponath, che si era già spiegato sui lati della rotabile all'altezza del ch ilometro 31, procedeva abbastanza bene ma a circa 20 chilometri da Tob r uch veniva fermata dali' effi cace fuoco dell'arti gli eri a britannica. Alla testa degli elementi avanzati cadeva il gen. von P rittwitz.
L a zona di el Adem veniva in vece occupata dopo breve resistenza. L a s• D ivisione Leggera veniva qui sostituita dalla « Brescia » ed inviava le proprie ava n g uardie verso nord- est : respinte verso Sollum le forze m obili britanniche che tentavano di fermarle, raggiungevano la Balbi a ad es t di Tobruch, tagliando così la comun icazione con Bardia e completando l'investi m ento della Piazza.
Il giorno 12 veniva effettuato il movimento in avanti delle compag ni e anticarro e delle restanti artiglierie della Divisione l< Brescia>>. Nel pomeriggio elementi di questa D ivisione e della s· D ivisione Leggera che avevano continuato ad affluire attorno a T obruch es· rgt. carri) effettuava no ricognizioni su l fronte tenuto dal-
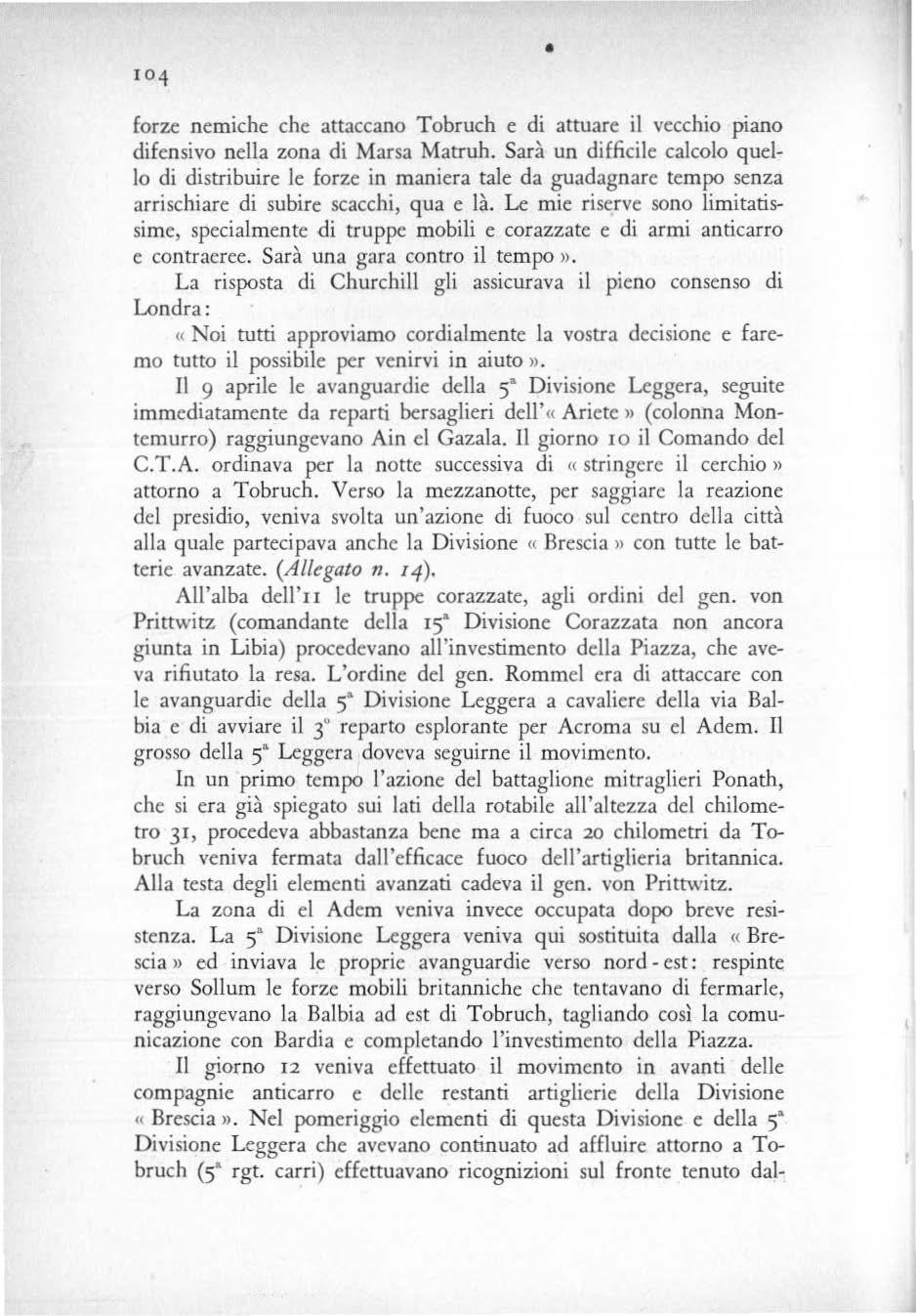
la XX Brigata australiana, ad occidente della rotabile di el Adem. Le azioni venivano bloccate, prevalentemente dal tiro di artiglieria.
I mezzi meccanici disponibili per l'immediato impiego non riuscivano a valicare il fosso anticarro, cope r to di tavole e mascherato con uno strato di sabbia e l'attacco veniva contenuto. La speranza di scoprire un punto debole nella difesa o di incontrare un nemi co m eno combatti vo era andata delusa.
Elem enti corazzati britannici cercavano di co n trattaccare, senza peraltro conseguire apprezzabile risultato.
Era chiaro or m ai che la difesa di Tobruch, effici ente e reattiva più del previsto, e l'ostacolo rappresentato dal fosso anticarro, costringevano ad attendere la disponibilità di forze più consisten ti, prima di rinnovare il tentativo di conquistare la Piazza.
Frattanto il mattino dello stesso giorno 12 il gruppo W echmar c la colonna Montemurro occupavano Bardia e ne mantenevano il possesso contro i contrattacchi di reparti corazzati avversari. Nel pomeriggio d el 13 elementi celeri di Bardia, a contatto co n pattuglie meccanizzate nemiche, si spingevano fino a Sollum Alt a e se ne impossessavano: eravamo tornati a presidiare il confine orientale della Cirenaica!
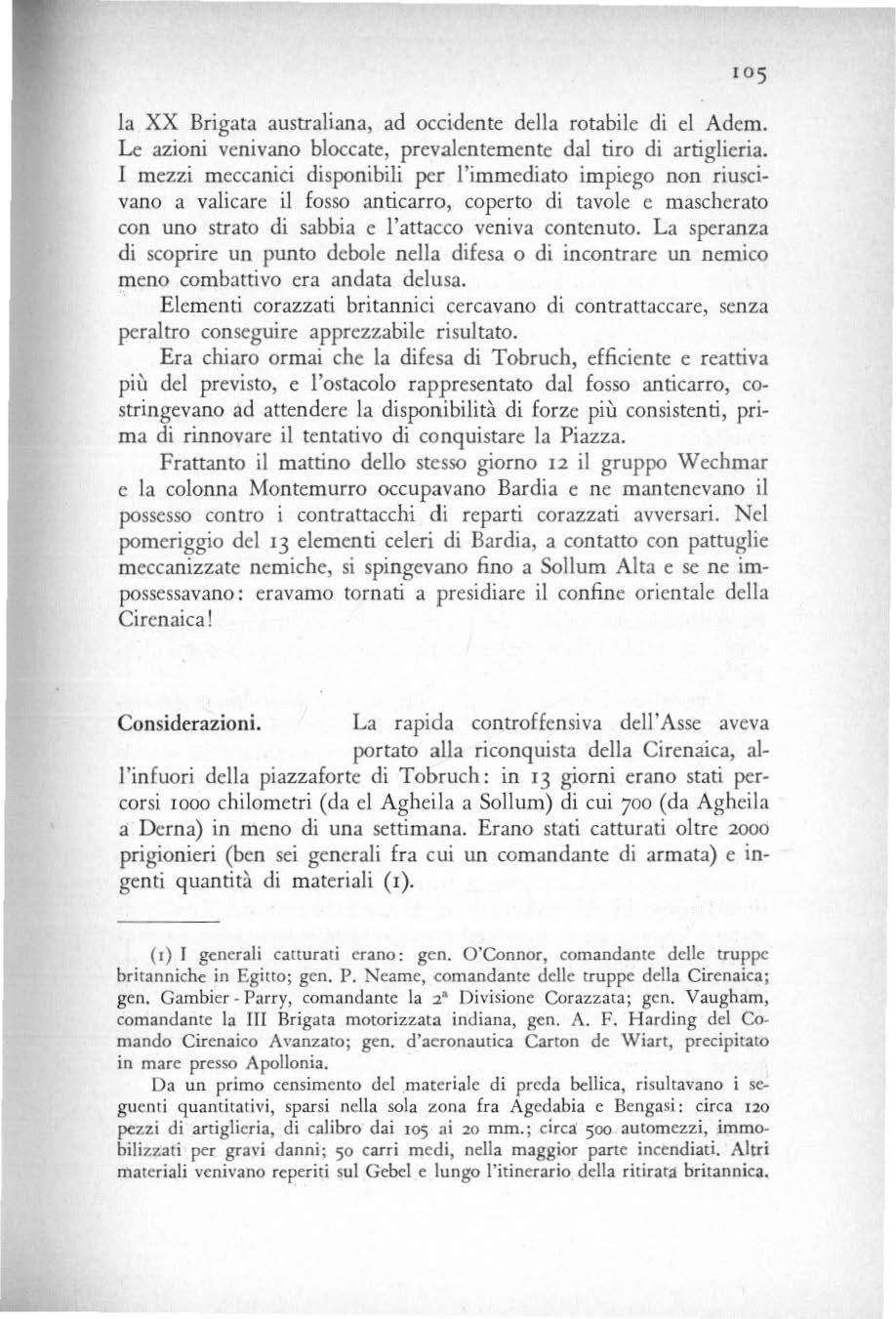
Co n sideraz ion i. La rapida controffensiva dell'Asse aveva portato alla riconquista della Cirenaica, all'infuori della piazzaforte di Tobruch: in 13 giorni erano stati percorsi 1000 chi lometri (da el Agheila a Sollum) di cui 700 (da Agheila a Derna) in meno di una settimana. Erano stati catturati oltre 2000 prigionieri (ben sei ge ne rali fra cui un comandante di armata) e ingenti quantità dì m ateriali (1).
(•) J generali catturati erano : gcn. O'Connor, comandante delle truppe britanniche in Egitto; gen. P. Neame, comandante delle truppe della Cirenaica ; gcn. Gambier- Parry, comandante la :2.• Divisione Corazzata; gen Vaugham, comandante la III Brigata motorizzata indiana, gen. A. F. Harding del Comando Circnaico A"anzato; gen. d'aeronautica Carton dc Wiart, precipitato in mare presso Apollonia.
Da un primo censimento del materiale di preda bellica, risultavano i seguenti q u antitativi, sparsi nella sola zona fra Agcdabia e Bengasi: circa 120 pezzi di artiglieria, di calibro dai 105 ai 20 mm.; circa 500 automezzi, immobili zzati per gravi danni; 50 carri m cdi, nella maggior parte incendiaci. Altri mat er iali venivano reperiti sul Gebel e lungo l'itinerario della ritirata britannica.
Le perdite erano state molto limitate: dell'ordine delle centinaia, fra morti, feriti e dispersi (1).
Analizzata l'operazione nel suo sviluppo, il ritmo irruento impresso alla « corsa in avanti » dall ' impulso personale del gen. Rommel dev e riconoscersi rispondente ai canoni dell'arte militare. L 'impresa era nata il JI mar zo come ricognizione offensiva (consenzienti i superiori comandi, italiani e tedeschi) intesa a saggiare la consistenza e la reattività della occupazione avversaria e ad assicurare, nello stesso tempo, una più valida posizione avanzata di attesa c base di partenza per la prevista grande controffensiva che avrebbe dovuto prendere il via a fine maggio.
Da quel momento è stato il contegno negativo dell'avversario a condizionare e caratterizzare gli incalzanti sviluppi dell'improvvisata operazione e deve essere ascritto a m erito del comandante l'aver saputo cogliere istantaneamente i segni del cedimento ed impartire « sul tamburo >> gli ordini conseguenti. Un risultato questo che è da ascrivere alle alte doti di comando del gen . Rommel ed alla sua costante presenza nei punti focali della zona avanzata che consentiva l'immediato adattamento degli ordini alla mutevole situazione, mentre contemporaneamente valeva a trasmettere in ciascuno degli esecutori la stessa inflessibile determinazione di superare ogni difficoltà.
I nostri comandi superiori, a Tripoli e a Roma (non diversamente dall'OKW) erano rimasti sulle prime sorpresi dall'improvviso andamento dell'operazione che temevano potesse tradursi in una rischiosa avventura, tale da com promettere le calcolate possibilità della controffensiva. Riconosciuto che, in sosta nza, la mode sta spinta iniziale della ricognizione offensiva aveva determinato il cedimento (si potrebbe dire: materiale e morale) dell'intera struttura britannica in Cirenaica, essi (e par ti colarmente il Coma nd o Superiore italiano in A.S.) avevano assi milato lo spirito del « colpo di mano >> imposto da Rommel ed avevano fornito ogni possibile concorso per agevolare il movimento della massa di manovra: si trattava di superare gravissime difficoltà logistiche, connesse all'improvvisato spostamento di forze ragguardevoli (di cui alcune motorizzate con misure di circostanza), impegnate in com battimento, su g rand i distanze.

Si vuole infine rilevare come alla riconquista della Cirenaica, indubbiamente prevalentemente determinata dalle forze motocorazzate tedesch e (in quanto particolarmente idonee allo speciale impiego) abbiano concretamente partecipato considerevoli aliquote italiane senza le quali, in sostanza, non sarebbe stato possibile raggiungere il pieno successo finale. Perfettamente giustificata risulta dunque la qualifica di impresa italo- tedesca che qui viene affermata, di fronte all'etichetta di marca esclusivame nte tedesca che spesso le è stata applicata, così nelle rappresentf}zioni dell'alleato, come in quelle dell'avversario.
Ed è giusto riconoscere in special mod o le prestazioni fornite da quei reparti che, come per le improvvisate colonn e della « Brescia», pur in una forma di motorizzazione occasionale e imperfetta, avevano volenterosamente sostenuto la parte attribuita nel piano generale dell'operazione, arrancando per sincronizzarsi con l'andatura delle « vere » unità celeri.
La ferma determinazione del gen. Romm el appare in stridente contrasto con l'atteggiame nto spirituale del gen. Neame. Il comandante delle forze britanniche in Cirenaica possedeva una limitata esperienza del particolare teatro di guerra per avere assunto da poco la carica, quando il gen. O' Connor, al termine dell'offensiva da lui brillantemente condotta, era stato promosso Comandante delle Forze Britanniche in Egitto.

Ridotte all'estre mo le forze a sua disposizione, depauperate per correre in soccorso della Grecia (ridotto al minimo, in particolare, il sostegno dell'aviazione), nella tranquillante ipotesi della impossibilità di una sollecita ripresa controffensiva italiana e all'oscuro del sopraggiungere di forze tedesche a Tripoli, il gen. Neame si trovava nelle condizioni ideali per essere colto assolutamente di sorpresa dall'annuncio della vigorosa spallata delle forz e dell'Asse contro i suoi elementi avanzati. Sorpresa che doveva subito tramutarsi, in lui e nel suo comando (anche per effetto delle direttive ri cevu te dall'alto) in una fatalistica rassegnazione alla sconfitta che si doveva ne cessariamente tradurre, negli ordini e nella mentalità dei subordinati, nel concetto di « salvare il salvabile » per correre a difendersi su posizioni arretrate, senza un serio tentativo di contrastare immediatamente l'iniziativa avversaria.
Dall'esam e dei fatti non si può certo escludere che una più attiva azione di comando, rispondente a un più vigoroso spirito combattivo, non avrebbe potuto individuare nei numerosi momenti critici della nostra improvvisata «co rsa in avanti >> l'attimo fuggente
per imporre un tempo di arresto e persino sconvolgere il temerario piano del gen. Rommel che, in fondo, si reggeva sul riconoscimento della mancata opposizione avversaria. Come in tanti altri esempi che la Storia fornisce, anche in questa circostanza il risultato è da ascrivere più alla personalità dei comandanti che all'entità delle forze e dei mezzi contrapposti.
Bisogna però riconoscere che l'atteggiamento del gen. Neame trovava piena rispondenza nella valutazione e nelle direttive dei suoi comandanti superiori. Il sorprendente successo dell'Asse, a meno di due mesi dall'annientamento della IOa Armata italiana, è stato « ufficialmente » attribuito da parte britannica in misura preponderante alle menomate condizioni materiali della III Brigata Corazzata, unica massa di manovra disponibile in Cirenaica, dopo il trasferimento in Grecia dell'altra brigata corazzata della 2 "' Divisione. Nel Medio Oriente vi era assoluta indisponibilità di carri e parti di ricambio per rimettere in efficienza la 7" Divisione Corazzata che era uscita estremamente logorata dalle generose prestazioni della recente offensiva.
La III Brigata Corazzata che, proiettata sul fianco meridionale dello schieramento britannico, avrebbe dovuto rappresentare la massa d'urto e di manovra dell'intero sistema, si era immediatamente frantumata, mentre la sola riserva disponibile, la III Brigata Motorizzata indiana, dislocata a el Adem, era sprovvista di carri e di armi anticarro.
In questa situazione il concetto d'azione britannico, al primo delinearsi della crisi, era stato di sottrarsi al combattimento e serbare la maggior parte delle forze per la resistenza in situazione più favorevole.
Scrive in proposito Winston Churchill :
« La nostra III Brigata Corazzata era un organismo improvvisato che comprendeva un reggimento di carri di crociera (si tratta dei carri denominati « Cruiser >>) in mediocre stato, un reggimento carri leggeri e un reggimento dotato di carri medi catturati agli Italiani. Dato l o stato dei nostri mezzi corazzati al termine della campagna cirenaica, tale unità rappresentava quanto di meglio Wavell poteva mettere in linea, dal momento che le rimanenti forze corazzate dovevano accompagnare le truppe che si recavano in Grecia. Tuttavia, se essa fosse stata in piena efficienza e ci fosse stato più tempo per metterla a punto come unità tattica, avrebbe potuto far fronte all'azione avversaria prevista >> (I).

Lo stesso argomento viene sviluppato più in profondità dal gen. Wavell nella sua relazione, con evidente proposito di obiettività e di severa autocritica: pur nella forma necessariamente atte nu ata della relazione ufficiale è possibile leggervi, in trasparenza, un apprezzamento dì fondo sostanzialmente non difforme da quello che qui è stato avanzato:
cc Io non venni a conoscenza sino al momento dell'attacco tedesco del pessimo stato in cui si trovavano i mezzi del reggimento carri da crociera, sul quale facevamo soprattutto assegnamento. Un certo numero di questi carri si era guastato prima di raggiungere il fronte e molti altri furono distrutti a causa di guasti di vario genere durante la prima fase del combattime nto. Lo ste sso se mbra essere accaduto all'altro reggimento carri da crociera della 2"' Divisione Corazzata che si recò in Grecia. I nostri carri leggeri erano impotenti contro i carri tedeschi, tutti armati di cannone. Il reggimento dotato di carri (catturati agli) italiani non aveva avuto il tempo necessario per impratichirsi.
cc La Divisione Corazzata aveva ricevuto istru zio ne di ritirarsi gradualmente, nel caso fosse attaccata da forze superiori, così da mantenersi in efficienza sinché le difficoltà dei rifornimenti non avessero indebolito il nemico ed offerto l'occasion e per un contrattacco. Queste erano le mie istruzioni.
c< Da come le cose sono andate (si deve dedurre che) questa è stata una tattica sbagliata. Un contrattacco immediato avrebbe per lo meno inflitto gravi perdite al n e mi co, ritardandone notevol m ente l'avanzata, o avrebbe potuto arrestarlo addirittura. Così invece la III Brigata Corazzata si liquefece, praticamente, durante la ritirata per difetti di macchine e deficienze dell'organizzazione logistica, senza molto comba ttere, mentre l'inesperto co mando della 2"' Divisione Corazzata sembrava averne perso il co ntrollo: in parte ciò era dovuto all'inesperienza del personale addetto ai collegamenti.
« Allorché visitai il fronte, dopo le operazioni del primo giorno, sentii la necessità di un comandante esperto della guerra del deserto e telegrafai a O' Connor di venire ad assistere Neame. Questi generali furono entr ambi catturati durante il ripiegamento, da una pattuglia della colonna nemica che e ntrò a Derna. Questo è in breve il disastroso episodio di cui io porto la principale responsabilità. Evidentemente, errori di manovra sono stati compiuti da parte della 2"' Divisione Corazzata durante il ripiegam ento ma le loro difficoltà erano considerevoli.
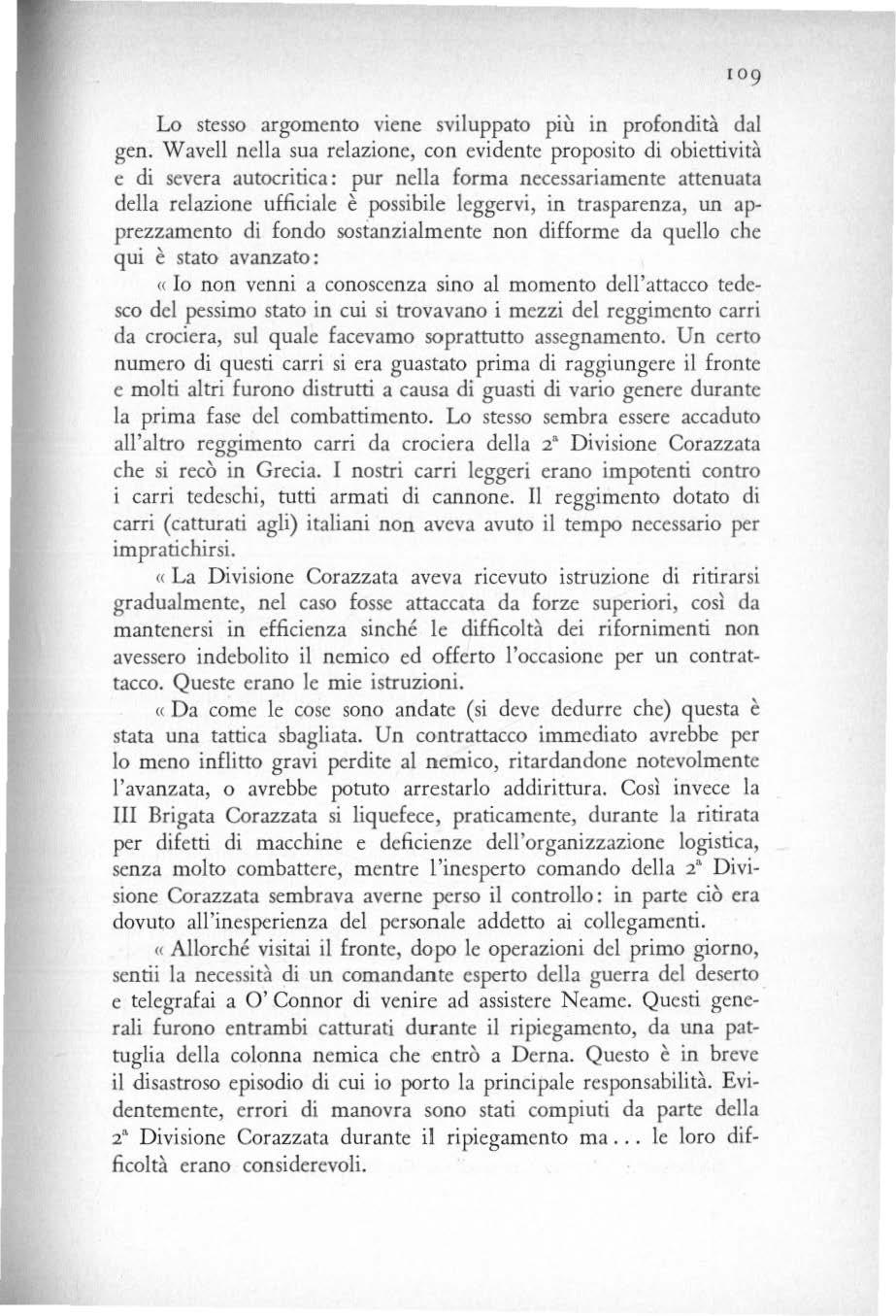
« Lo spmto combattivo delle forze sembra sia stato eccellente anche durante la ritirata e, nonostante la disorganizzazione, ci furono molti esempi di azioni fredde e decise».
Sulla base di queste considerazioni sembra di poter riconoscere nell'atteggiamento britannico l'influenza dì un altro fattore, non esplicitamente posto in evidenza nella relazione ufficiale: un certo complesso d'inferiorità, nel primo incontro con le forze tedesche, tecnicamente superiori nell'armamento (in particolare, in quel momento, nel campo dei carri armati e delle armi anticarro) e soprattutto nella pratica del « Blitzkrieg», agli antipodi della concezione della lenta « sistematicità » britannica, avvolte inoltre da quell'alone di invincibilità di cui i Britannici avevano già fatto durissima esperienza nella campagna di Francia. Non per niente Winston Churchill aveva ammonito fin dal primo giorno: « Sarebbe estremamente desiderabile che l'offensiva tedesca ... venisse stroncata. Qualunque disfatta inflitta ai tedeschi avrebbe conseguenze psicologiche di vasta portata ... >>. E scrivendo al suo Ministro degli Esteri aveva commentato: << • • • motivo più importante della perdita di terreno è l'idea che non possiamo tener testa ai Tedeschi ».
Rimane a questo punto da contrapporre alle considerazioni del gen. Wavell, quelle del vincitore, il gen. Rom mel:
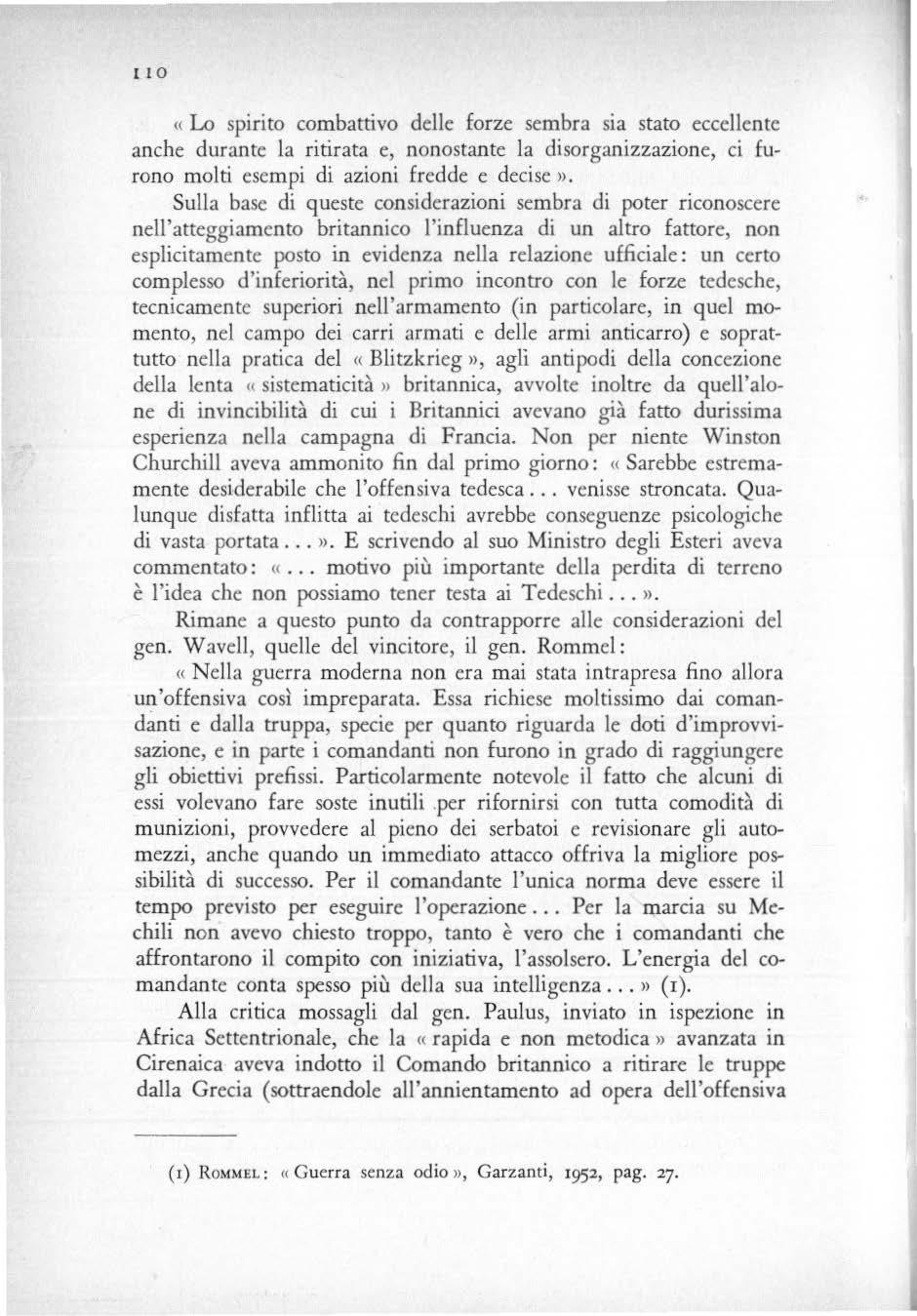
« Nella guerra moderna non era mai stata intrapresa fino allora un'offensiva cosi impreparata. Essa richiese moltissimo dai comandanti e dalla truppa, specie per quanto riguarda le doti d'improvvisazione, e in parte i comandanti non furono in grado di raggiungere gli obiettivi prefissi. Particolarmente notevole il fatto che alcuni di essi volevano fare soste inutili .per rifornirsi con tutta comodità di munizioni, provvedere al pieno dei serbatoi c revisionare gli automezzi, anche quando un immediato attacco offriva la migliore possibilità di successo. Per il comandante l'unica norma deve essere il tempo previsto per eseguire l'operazione Per la marcia su Mcchili non avevo chiesto troppo, tanto è vero che i comandanti che affrontarono il compito con iniziativa, l'assolsero. L'en ergia del comandante conta spesso più della sua intelligenza .. . >> (1).
Alla critica mossagli dal gen. P aulus, inviato in ispezione in Africa Settentrionale, che la « rapida e non metodica >> avanzata in Cirenaica aveva indotto il Comando britannico a ritirare le truppe dalla Grecia (sottraendole all'annientamento ad opera dell'offensiva
tedesca), in contrasto con le vedute dell'OKW, il gen. Rommel risponde:
<< A questo proposito c'è da osservare prima di tutto, che io nulla sapevo dei piani greci del Comando Superiore della Wehrmacht. Dubito comunque che avremmo fatto prigionieri i Britannici in Grecia se al momento dell'offensiva tedesca nel Sud- Est fossero stati colà. In generale, infatti, i Britannici erano in grado di mettere rapidamente in salvo le loro truppe via mare, qualora fosse stato necessario. Ciò è stato chiaramente dimostrato da Dunkerque e Andalsnes e, non da ultimo, dalla Grecia stessa ...
« Oltre ciò sono dell'opinione che sarebbe stato più vantaggioso lasciar stare la Grecia e creare, invece, un centro di gravità nell'Africa del Nord per cacciare i Britannici dal Mediter ran eo ... Forti unità motorizzate tedesche avrebbero allora potuto occupare nell'Africa Settentrionale l'intera costa mediterranea in possesso dei Britannici e isolare così l'Europa Sud- Orientale. La Grecia, la Ju goslavia e Creta satebbero state costrette a starsene tranquille ... >> (I).
Pur senza entrare nel m erito della visione personale del generale Rom mel in questo campo (che esorbita d'altronde dai precisi confini della presente Monografia) si ritiene di poter riconoscere alla sua osservazione una certa base di rispondenza, laddove rileva come al teatro di guerra nord- africano non fosse stato attribuito un coefficiente di primaria importanza nell'economia generale della lotta contro l'Inghilterra, per un attacco a fondo nel vitale Scacchiere Mediterraneo. Considerazione valida per l'intera campagna, così n ei riguardi della direzione politico- militare italiana che disperdeva su altri teatri per noi non essenziali le proprie forze (scarse e scarsamente rispondenti alle esigenze della guerra in atto) come lo è certamente e soprattutto nei riguardi dell'OKW che non seppe o non volle mai trovare l'opportunità di assegnarvi forze terrestri e aeree adeguate al raggiungimento di un obiettivo veramente risolutivo, nel grande quadro strategico mediterraneo. Sotto questo punto di vista possono apparire velleitarie le grandiose concezioni operative del gen. Rommel, in quanto, in ogni momento della campagna, anche nei periodi più favorevoli, la disponibilità delle forze, terrestri, aeree e navali, doveva fatalmente rendere ogni successo fine a se stesso, sterile di sviluppi veramente risolutivi nel più largo orizzonte strategico mediterraneo.
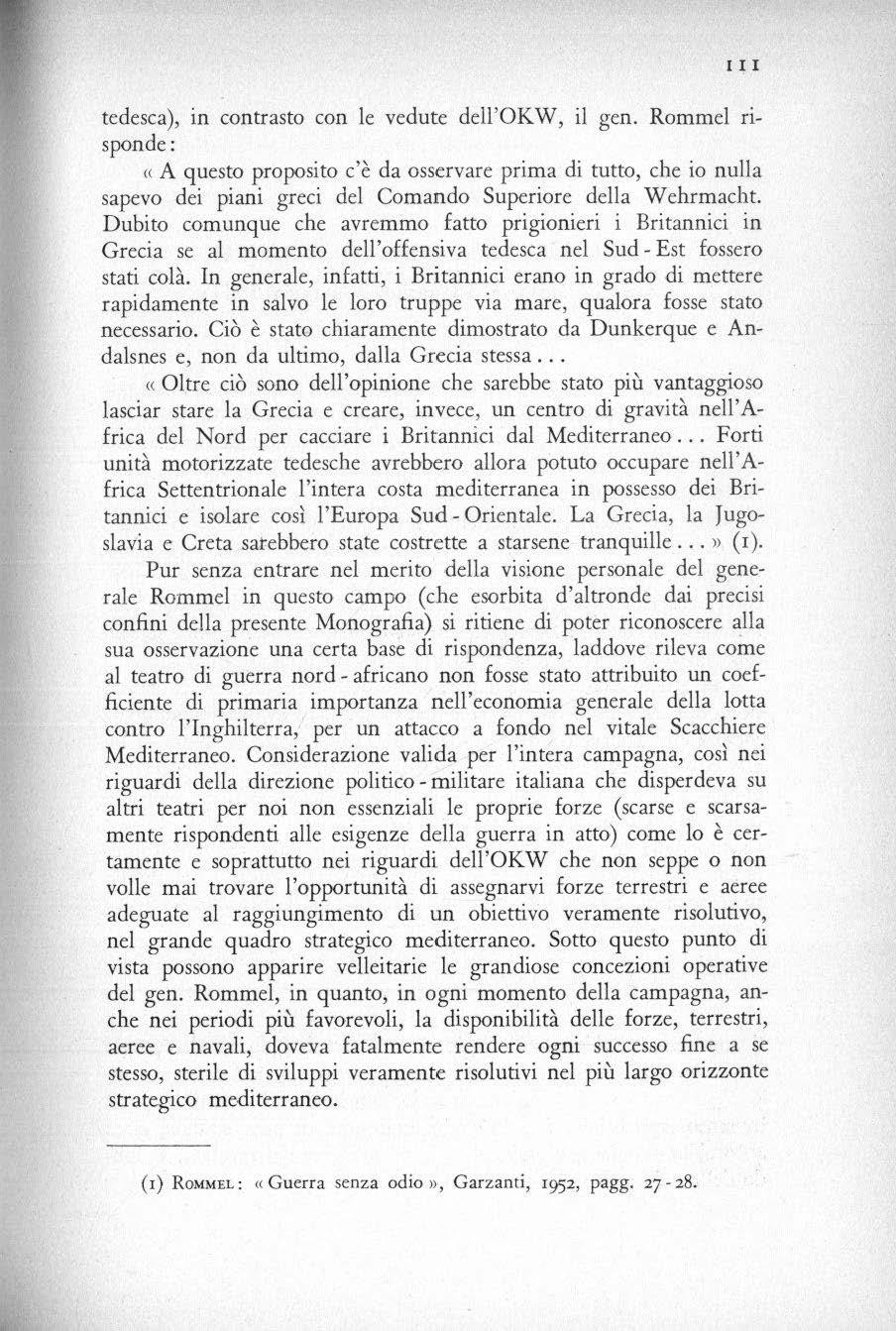
(14- 17 aprile e 30 aprile- 2 maggio 1941)
Capacità difen siva e offe nsiva de lla pi azza.
Si è già accennato all'importante vantaggio che il possesso di Tobruch assicurava ai Britannici, al valore della base marittima, alla funzione difensiva e -offensiva che la piazza avrebbe potuto assumere nelle eventuali future operazioni.
Recip rocamente, è altrettanto vero però che la no stra riconquista di tutto il territorio della Marmarica, fino al confi ne egiziano , poneva la guarnigione britannica in una posizione di notevole difficoltà: ristretta in breve spazio e completamente accerchiata sul fronte terrestre, ad oltre 150 chilometri dal grosso ritiratosi oltre il confine egiziano, esclusivamente affidata ai rifornim enti marittimi. In queste condizioni e tenuto conto dell'evidente stato di depressione dell'avversario dopo il recente scacco, si poteva ragionatamente sperare che Tobruch sarebbe facilmente caduta, sotto la spinta di un attacco con forze limitate ed è nel quadro di questa possibilità che bisogna considerare i piani del Comandante del C.T.A. e i suoi tentativi di impossessarsi della piazza prima che l'avversario si fosse riavuto dalle conseguenze morali del rovescio subito e, soprattutto, prima che potesse ripianare le perdite materiali sofferte nel rapido ripiegamento. Nel pensiero del gen. Rommel il fattore tempo aveva insomma valore prevalente su ogni altro
Il terreno (Schizzo n . 10).
La regione di T obruch fa parte dell'ampio tavolato della Marmarica, a fondo pianeggiante e sodo, con lievi ondulazioni disposte in senso equatoriale. La città (che in tempo di pace contava circa 4000 abitanti) giace, protetta dal ripido margine del tavolato, al fondo della baia omonima.
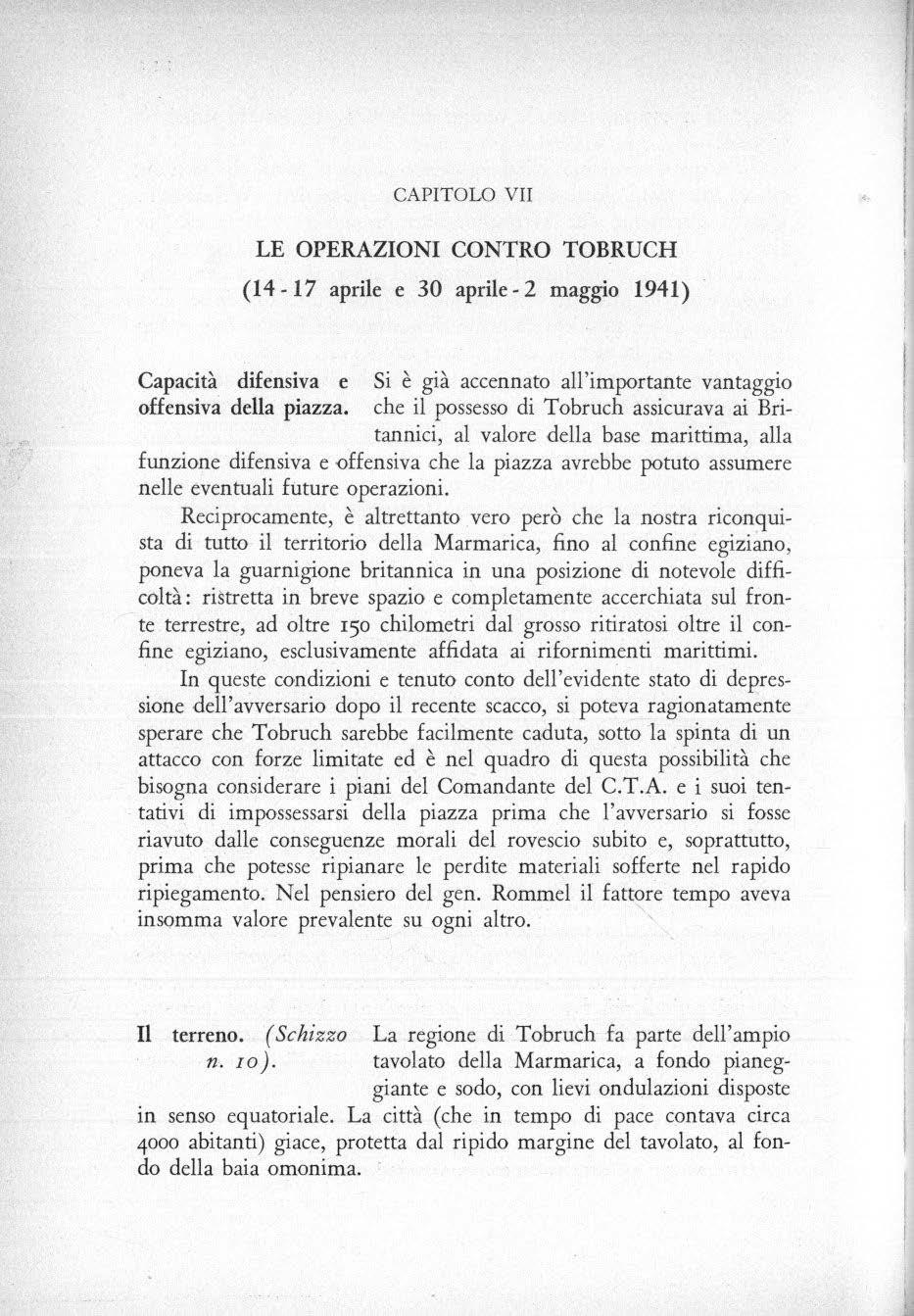
Procedendo dal mare verso l'interno si possono schematicamente distinguere i seguenti elementi caratteristici:
- fascia costiera (in verde sullo schizzo) alla quota media di so m. sul livello del mare. Sulla costa degrada più o meno ripidamente, profondamente solcata in senso perpendicolare da numerosi uadi: i più notevoli sono l'Uadi Sehel e l'Uadi Zeitun ai quali si appoggiavano appunto le ali della cinta fortificata di Tobruch. Il terreno sale dolcemente verso l'interno, fino ad una quota media di circa 8o m.
Ad occidente di Tobru ch la fascia presenta una profondità media di 6-7 km. ed è percorsa dalla via Balbia; ad oriente della città si restringe bruscamente, fino a ridursi a una sottile cimosa;
- una ristretta fascia intermedia, intorno ai 100 m. di quota (Sghifet Chargia, in giallo sullo schizzo) raccordata alla precedente da un gradino non molto ripido di circa so m. (Hagiag es Sehcl).
Ad est di Tobruch questo elemento si confonde quasi con la fascia costiera;
una fascia interna (in rosso sullo schizzo) raccordata alla precedente da un nuovo gradino (Harf el Agereb- Hagiag Chargia) che sale di altri so m., portandosi cioè ad tma quota media di ISO m.
Il terreno va poi grada tam ente elevandosi verso sud, raggiungendo le quote più elevate in corrispondenza della cinta fortificata (Ras el Medauuar, che può essere co n siderato la chiave di volta del sistema: m. 209; Sidi Cheiralla: m. 167).
Il tavolato m armari co prosegue infine verso sud, con una serie di ondulazioni più o meno marcate.
L e comunicazioni. Oltre la litoranea (via Balbia) con caratteristiche di arteria asfaltata di grand e co mun icazione, sono da prendere in co n siderazione:

- la rotabile allora in costruzione a sud della Balbia, esterna alla linea di investimento di Tobruch, disegnata sul tracciato di piste preesistenti: rimanevano da saldare i due tronconi interrotti, con un raccordo parallelo al Trigh Ca puzzo: sembrava difficile di poterla ultimare prima di tre mesi (I);
( 1) Tale raccordo venne effe nivamcnte eseguito, per consentire il trans ito verso la frontiera fuori del t iro delle artiglierie della Piazza. Una volta ultimata la strada fu battezzata « la strada dell'Asse)),
- il Trigh Capuzzo, che collegava es Sollum con el Mechili e di qui co n Bengasi, costituendo un raddoppio della litoranea, in corrispondenza di el Adem;
- l'autopista Tobruch- el Adem (in senso m eri diano) che trovava la propria prosecuzione nella pista per Bir el Gobi e Giarabub.
Il movimento nella regione di Tobruch non presentava dunque serie difficoltà e sare bbe ri sultato molto agevolato per i nostri rifornimenti, una volta ultimata la strada in costruzione a sud della ptazza.
Il terreno non offriva apprezza bili appigli alla difesa, se si eccettuano gli Uadi Sehel e Zeitun, profondamente incisi, che costituivano notevole ostacolo anticarro ed ai quali si appoggiavano le ali della cinta fortificata .
L'attacco poteva trovare nell e modeste ondulazioni del terreno un certo correttivo all'assoluta mancanza di copertura e un apprezzabile aiuto per l'osservazione del tiro, ostacolata comunque nelle ore più calde dalle deformazioni dell'effetto miraggio. Come zone di più facile e redditizia penetrazione si presentavano le fasce costiere, a cavallo dei due tronchi, occidentale e orientale, della via Balbia e la fascia a cavallo della rotabile di el Adem.
La sistemazione di fe n - L'organizzazione difensiva del fronte a tersiva preesistente. ra era stata studiata con il criterio di proteggere la baia e i relativi impian ti dall'azione dei medi calibri. L a cinta fortificata era costituita da una serie di piccoli ridotti, distribuiti a scacchiera, in modo da poter assicurare l'incrocio e la sovrapposizion e del fuoco delle armi automatic he, così in senso frontale come in senso radiale. Nella definizione delle caratteristiche tecniche delle opere si era tenuto conto della possibilità di attacco da parte di unità mcccanizzate e corazzate.
L 'ubicazio ne di ciascun ridotto era stata determinata nel concetto di trarre il massin1o vantaggio dagli appigli offerti dal terreno, particolarmente apprezzabili sui fronti est ed ovest, in cor ri spondenza dei due citati Uadi Zcitun e Sehel, mentre erano quasi insussistenti nel terreno piatto e nudo del fronte sud. Questa diversità intrinseca dei valori naturali si rifletteva sui criteri fortificatori che erano stati adottati n ei vari settori.

Si trattava in complesso di 124 opere, distribuite su un doppio ordine, della profondità di circa 400 m. La cinta esterna comprendeva 74 opere ed aveva uno sviluppo di 50 km. Tutte le opere erano a carattere semipermanente, con postazioni scoperte o in caverna e potevano essere ricondotte a due tipi fondamentali:
un tipo per terreno piano e uniforme;
- un tipo per le zone affacciate sugli uadi.
Avevano in comune le seguenti caratteristiche generali : . . . . . . .
- ncovero per uom1m e ncovero mun1z1om m ciascuna postazione;
- ricovero centrale per ogni opera;
____, nicchie per riserva d'acqua;
----= lavatoi;
- reticolato, di siepi trapezoidali fissate a gabbioni ancorati al terreno.
Sulle balze le opere erano munite inoltre di postazioni e di fosso anticarro che mancavano invece nelle opere in corrispondenza degli uadi, nelle quali di massima le singole postazioni erano state ricavate in caverna.
Esistevano infine, in alcune opere così della linea esterna come della linea interna, dei ricoveri per il riparo di personale o per gli organi dei comandi di settore o di sottosettore.
Il complesso del sistema consentiva l'impiego di 247 mitragliatrici e 99 armi anticarro. Completavano l'organizzazione difensiva postazioni allo scoperto per 21 batterie di piccolo e medio calibro
Organizzazione difensiva britannica.

su tre ordini:
In base alle notizie in possesso del S.l.M. risultava che gli Inglesi avevano rafforzato la preesistente organizzazione, sviluppandola
- perimetro esterno, corrispondente alla cinta, preesistente;
- linea intermedia, a capisaldi discontinui (del Pilastrino);
- posizioni arretrate per la difesa immediata dei vecchi forti (Marcucci, Solaro, Airente, Perrone).
Tali linee venivano contraddistinte dagli Inglesi rispettivamente con il nome di linea rossa, blu e verde. Denominazioni e distinzioni di linee e fasce rispondevano non tanto a sostanziali diversità di com-
piti e di funzione, quanto all'opportunità di contraddistinguere l'ordine di successione dei lavori di fortificazione programmati e di disciplinare conseguentemente l'impiego dei materiali di rafforzamento.
In realtà le direttive dei comandi superiori tendevano alla definizione di un'unica organizzazione difensiva, profonda una diecina di chilometri, dove tutti gli elementi della fortificazione campale si alternavano e si integravano in successione pressoché costante: campi minati, muretti, reticolati, trincee, allacciamenti, postazioni multiple per fucili di precisione, per armi automatiche, per armi anticarro, per artiglierie, sistemazioni multiple per posti di comando, osservatori, ricoveri, piccoli depositi. Nell'insieme ne era risultato un sistema fortificato robusto ed efficiente e, anche se a carattere campale, rispondente al concetto di frazionare, contenere, logorare l'attacco nemico, in attesa dell'adeguata reazione manovrata.
In ogni caso, l'attaccante che avesse superato la cinta esterna sarebbe stato fermato da resistenze successive, sulle quali l'azione della sua artiglieria sarebbe risultata poco efficace, per la difficoltà del rilevamento degli obiettivi e dell'osservazione dd tiro.
D ire t t i ve br ita n n iche per l a d ifesa di T obruch: 14 ap r ile 194 1.
Dopo la raccomandazione di Churchill di non abbandonare Tobruch, almeno per il momento, 1'8 aprile il gen. Wavell (che d'altronde era già dello stesso parere) si era recato sul posto ma aveva trovato la situazione talmente deteriorata che aveva espresso dubbi sulla possibilità di poter attuare una difesa redditizia. Dopo essersi consultato con i Capi di Stato Maggiore, il Primo Ministro aveva preparato frattanto un altro messaggio nel quale confermava seccamente: «Sembra impensabile che la piazzaforte di Tobruch debba essere abbandonata ».
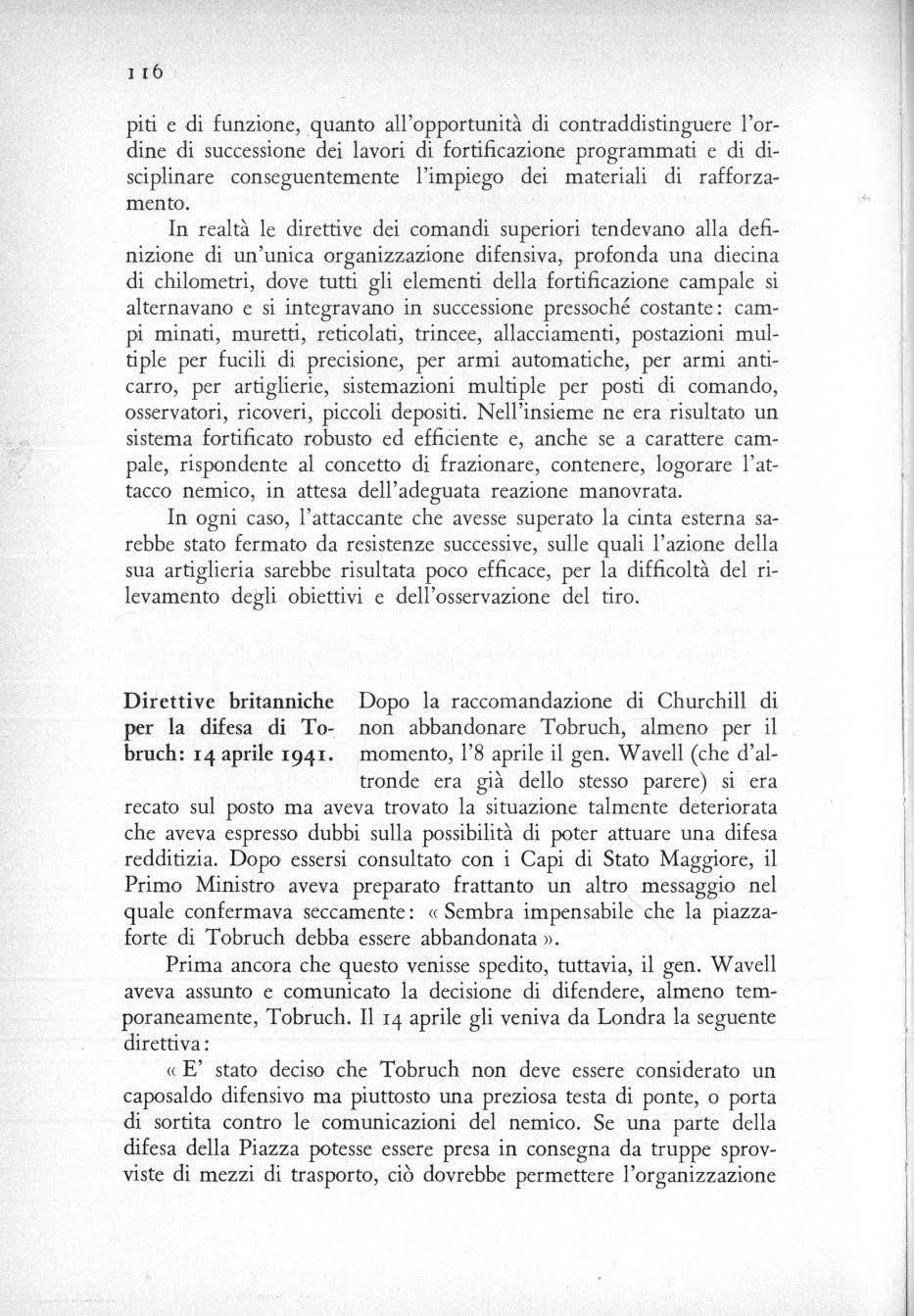
Prima ancora che questo venisse spedito, tuttavia, il gen. Wavell aveva assunto e comunicato la decisione di difendere, almeno temporaneamente, Tobruch. Il 14 aprile gli veniva da Londra la seguente direttiva:
<< E ' stato deciso che T obruch non deve essere considerato un caposaldo difensivo ma piuttosto una preziosa testa di ponte, o porta di sortita contro le comunicazioni del nemico. Se una parte della difesa della Piazza potesse essere presa i n consegna da truppe sprovviste di mezzi di trasporto, ciò dovrebbe permettere l'organizzazione
di unità motorizzate, sia come riserva della fortezza, sia come forze d'attacco contro il nemico. Sarebbe di grande vantaggio impegnare il nemico in operazioni di assedio a Tobruch e costringerlo a trasportare ed alimentare a tale scopo formazioni di artiglieria pesante >>
Primo attacco di Tobruch: 14- 17 aprile
I94I. (Schizzo 11. 10) .
Fallito il tentativo di eliminare di slancio la piazzaforte di Tobruch, il gen. Rommel valutava g iustamente il grave pericolo rappresentato dalla permanenza di quell'elemento alle nostre spalle:
« . . . Vedevo chiaramente che se non avessimo potuto dare l'assalto a T obr uch ci saremmo trovati in una situazio ne tattica e strategica molto delicata, che avrebbe avuto ripercussioni specialmente nel caso di un attacco britannico al fronte di Sollum. Il comandante britannico pensava indubbiame nte che di co n seguenza noi o ci saremmo ritirati sull'altura (probabilmente si deve leggere: all'altezza) di Tobruch, e allora egli avrebbe sempre potuto appoggiarsi nell a difesa a una solida fortezza, o ci sare mmo fermati più oltre, presso Sollum, e in tal caso saremmo stati minacciati da tutte le parti » (I).
D ecideva pertanto di ripetere l'attacco, non appena potesse dispo rre di altre artiglierie c della Divi sione Corazzata « Ariete». Intendeva impedire all'avversario di rafforzare la propria organizzazion e difensiva, All'operazione, decisa per il I 4 aprile, prendevano parte:
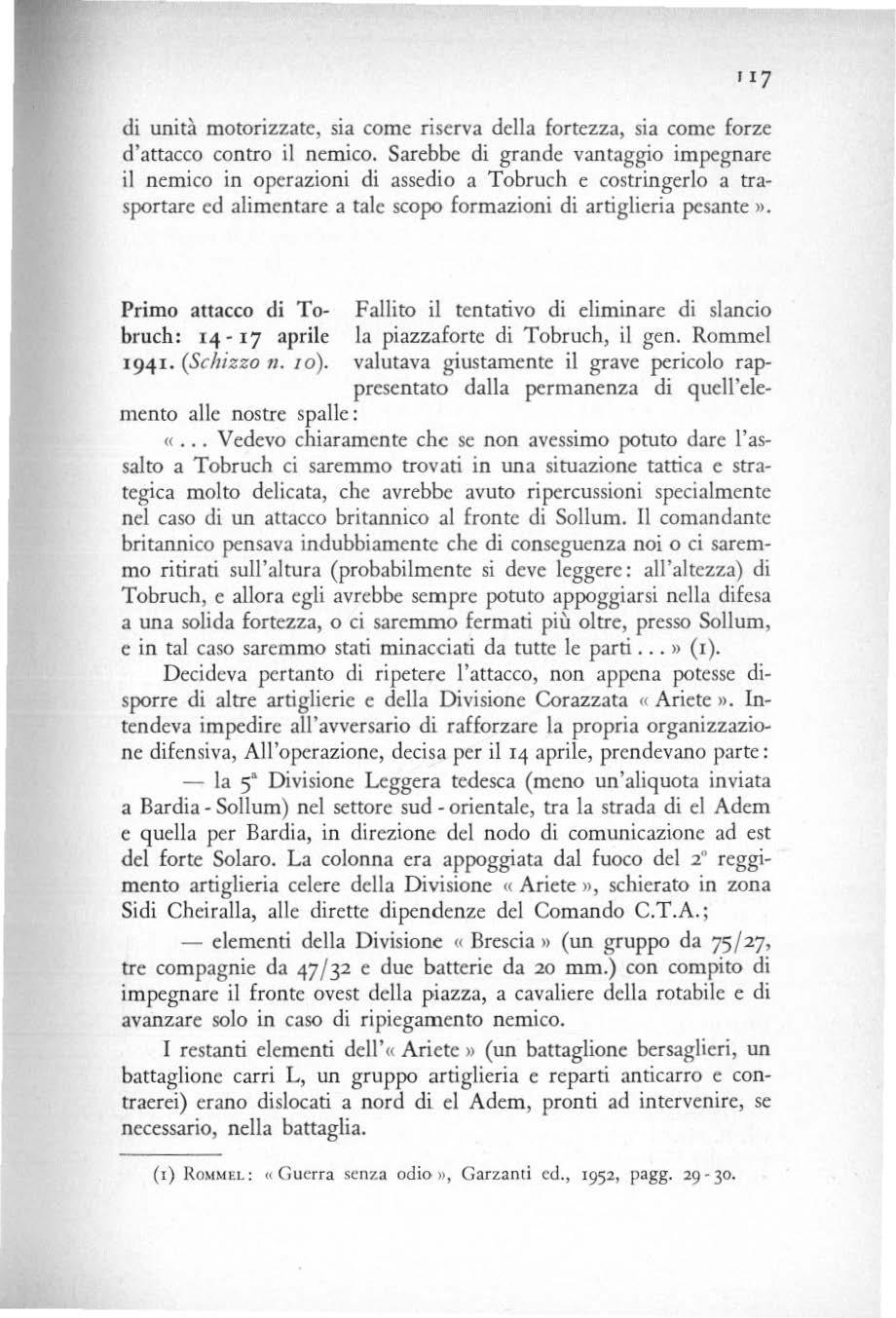
- la 5a Divisione Leggera tedesca (meno un'aliquota inviata a Bardia- Sollum) nel settore sud- orientale, tra la strad a di el Adem e quella per Bardi a, in direzione del nodo di comunicazione ad est del forte Solaro. La colonna era appoggiata dal fuoco del 2 ° reggim ento artiglieria celere della D ivisione « Ariete », schierato in zona Si di Cheiralla, alle dirette dipendenze del Comand o C.T.A.;
- eleme n ti della Divisione « Brescia » (un g ruppo da 75/27, tre compagnie da 47 / 32 e due batterie da 20 mm .) con compito di impegnare il fronte ovest della piazza, a cavaliere della rotabile e di avanzare solo in caso di ripiegamento n emi co.
I restanti elementi dell '« Ariete » (un battaglio ne bersaglieri, un batta glione carri L, un gru ppo artiglieria e reparti anticarro e contraerei) erano dislocati a nord di el Adem, pronti ad interven ire, se necessario, nella battaglia.
(r) RoMMEL: ((Guerra se nza odio », Garzanti cd ., 1952, pagg. 29 • 30.
In base alle informazioni in possesso del Co m ando Superiore A.S. la piazza di Tobruch sarebbe sta ta presidiata dal Corpo australiano: 6", 7"' e 9"' Divisione (la seco nda intatta, le altre due già provate) e truppe di Corpo d'Armata. In realtà la 6.. Divisione era stata trasferita in Grecia e la guarnigione di Tobruch era così composta:
- 9" Divisione australiana, su tre Brigate (XX, XXIV, XXVI);
- una Brigata della t Divisione (XVUI);
----,- III Brigata Corazzata, in via di rico stituzio ne (era prevista l'affluenza di materiale dall'Egitto, per un complesso di 26 carri « Cruiser », 15 carri leggeri e 4 carri « I »);
- quattro reggim enti artiglieria da campagna;
- due reggimenti anticarro;
- una brigata contraerea (16 cannoni pesanti e 59 leggeri) (x).
L'attacco era stato preceduto, il giorno 13, da un'azione preparatoria, iniziata alle ore 18, dall'VIII battaglione mitraglieri tedesco (ten. col. Pon ath) rinforzato con elementi del genio. Scopo dell'operazione era la costituzione di una testa di ponte sul fosso anticarro, nel tratto immediatamente ad ovest della strada di el Adero. Le batterie del 18° gruppo artiglieria contraerea intervenivano con tiro diretto sui nidi di resistenza avversa ri , con evidente successo. Qua e là l'artiglieria britannica eseguiva tiri di sbarramento, senza provocare gravi perdite.
L 'attacco vero e proprio seguiva il mattino del giorno 14, alle 4.30, dopo intenso tiro di preparazione. All'inizio tutto sembrava procedere favorevolm ente. Attraverso la piccola testa di ponte costituita nella notte, il 5o reggimento Panzer spingeva i carri a 4 chilom etri dalla città. All 'altezza del forte Solaro veniva però fermato, m ancandogli l'appoggio dell'artiglieria e la collaborazione della fanteria che era rimasta bloccata dal tiro nemico di sbarramen to e repressione, non neutralizzabile da parte nostra per mancanza di bocche da fuoco idonee.
Il battaglione Ponath, penetrato animosamente in profondità (ma su un fronte eccessivamente ristretto) senza conoscere la struttura delle posizioni, aveva lasciato dietro di sé, a destra e a si nistra,
(1) Notizie di fonte britannica (« Th e Mediterranean and Midd le East >>, vol. II, Playfair I.S.O ., London, 1956, ed . H.M.S.O.) che trovano riscon tro in un foglio d'informazioni su l nemico in data 3 maggio e nella situazione presunta al 15 maggio riportata nello schizzo n. 14.
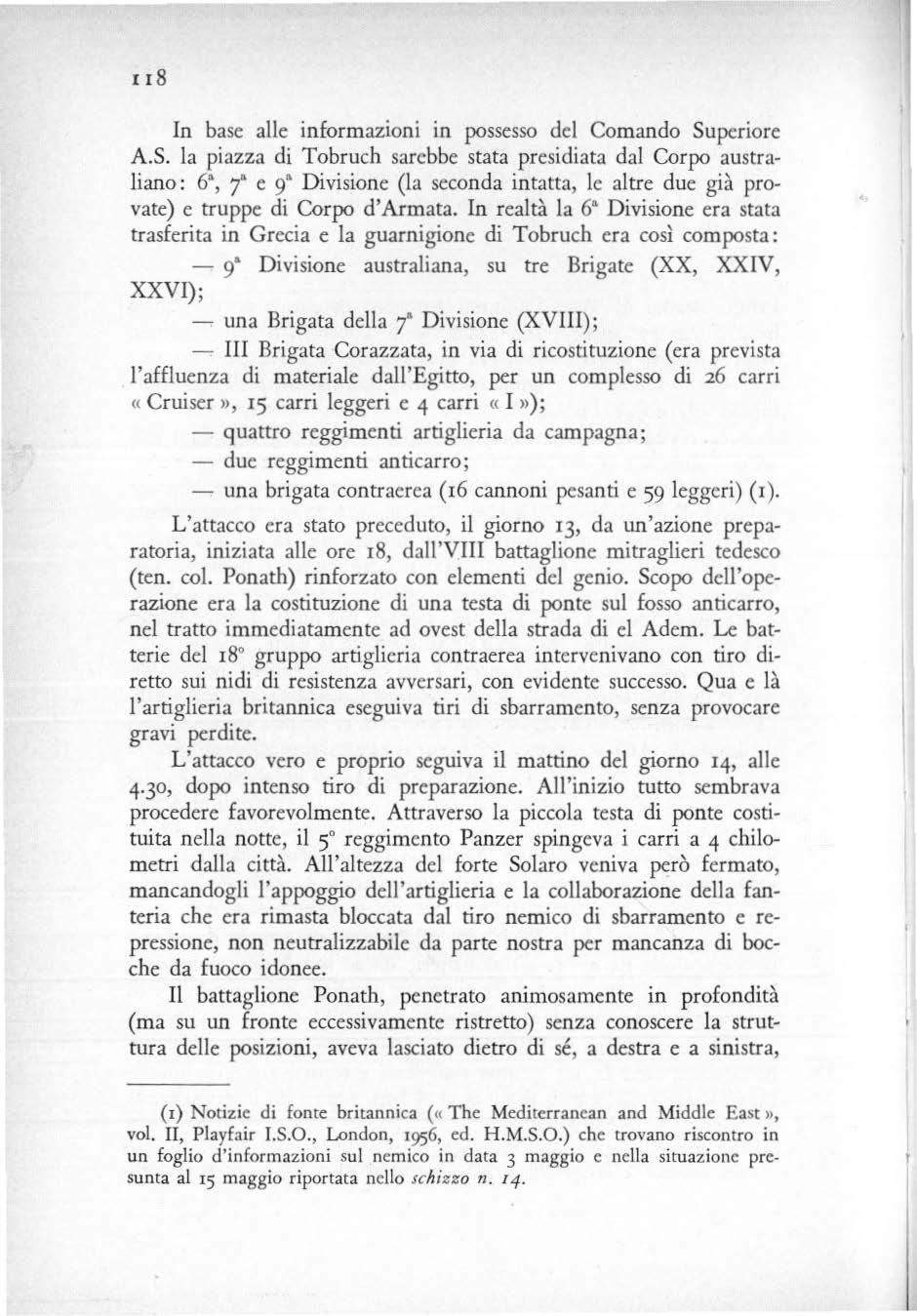
nidi di resistenza in piena efficienza e i carri tedeschi, battuti frontalmente dai pezzi anticarro e impegnati su entrambi i fianchi dal tiro di carri « Cruiser » occultati in posizioni defilate, erano costretti a tornare indietro per sfuggire aU'annientamento totale (r).
Nonostante gli sforzi del gen. Rommel di rilanciare la 5a Divisione Leggera ali' attacco e di fare intervenire anche l' « Ariete », prima di mezzogiorno l'azione risultava praticamente fallita, almeno per il momento. Non si avevano notizie del battaglione mitraglieri del ten. col. Ponath, rimasto nella posizione avversaria senza la protezione dei carri (2). La reazione dell'artiglieria britannica era stata talmente violenta da costringere ad abbandonare sul posto i prigionieri fatti nella fase iniziale dell'attacco (3).
In seguito all'ordine verbale del gen. Rommel di tenersi pronti ad attaccare Tobruch con direttrice la rotabile di el Adero, fino a H agfet Umm Haleiga- costone di Sidi Cheiralla, gli ufficiali superiori e i comandanti di compagnia carri e di batteria dell' « Ariete» si erano recati in ricognizione finché, spintisi troppo avanti, erano venuti a trovarsi sotto il fuoco delle mitragliatrici nemiche. Non rientravano che a sera inoltrata ai rispettivi reparti che nel frattempo, in base a nuovi ordini emanati alle ore 14 dal Comando del C.T.A., avevano assunto un nuovo schieram ento per l'attacco, in zona Bir Scerif, 12 km. a nord- ovest di el Adem.
Il gen. Rommel pensava di fare intervenire il giorno successivo anche la Divisione « T rento» che si trovava in via di trasferimento verso T obruch.
Un suo ufficiale di stato maggiore raggiungeva alle ore 10,30 il Comandante della Divisione lun go la pista a sud di Acroma e lo pregava di seguirlo presso il Comando della Divi sio ne « Brescia», dislocato poco a nord del costone di H agiag es Sehel, circa 19 km. ad ovest di Tobruch. Qui gli veniva esposta la situazio n e che, per qu an-

(x) Perdite: 5n Div. Lcgg. una quindicina di carri distrutti o inutilizzati, due o tre pl. mtr. mancanti; 5 ufficiali carristi morti e diversi feriti. 2° rgt. art. ce!.: II morti, 35 feriti, 3 pezzi colpiLi c 7 trattori distrutti. Div. «Brescia»: poche perdite, imprecisate.
Perctite inglesi accertate: due carr i catturati e vari altri distrutti.
(2) L'VIli btg. mtr. ebbe a subire perdite tali da farlo considerare praticamente distrutto; lo stesso comandante cadde in combattimento.
(3) Il gen. W aveli comunicava in proposito a Londra: « I due- trecento prigionieri tedeschi catturati a Tobruch nella mattinata di oggi, 14 aprile, affermano di essere stati sfavorevolmente sorpresi dal fuoco delle nostre artigli erie e di essersi trovati estremamente a corto di cibo e di acqua >>.
to riguardava la Divisione « Brescia >> (presente solo con elementi di artiglieria immediatamente ad est dell'Dadi es Sehel) si può così sintetizzare :
- una btr. da 20 m.m. e una cp. cannoni da 47/32 a nord della via Balbia;
- una btr. del 1° rgt. art. celere fra la rotabile e q. 131;
- un gruppo (su due btr.) del 1° rgt. art. celere, una btr. da 20 mm. e una cp. da 47/32 nella zona fra q. 131 e q. 142 (cisterna).
Venivano quindi comunicate al Comandante della Divisio n e c< Trento >> le direttive del gen. Rommel per un'azione che avrebbe dovuto iniziarsi alle ore 18 dello stesso giorno. Si trattava di un nuovo attacco su Tobruch, da sviluppare questa volta su tre direttrici:
......., s• Divisione Leggera, da sud- est;
- Divisione «Ariete>> da sud, con obiettivo alture di Hagiag Chargia e q . 144;

- Divisioni « Brescia>> e « Trento>> da ovest, con obiettivo quadrivio di q. r87 ( R as el Medauuar) e q. 145 (ex forte Pilastrino).
L'azione doveva essere diretta dal Comandante della « Brescia >> , in quanto co n maggiore esperienza della zona.
La Divisione « Trento >> doveva mettere a disposizione della « Brescia >> un reggimento di fanteria (61 °), due compagnie da 47/32 (104", ro6a), un gruppo da 10ojr7 (I/46•).
Al mattino del 14 aprile la Divisione « Trento >> si trovava così scaglionata :
......, Comando di divisione: a Derna;
- scaglion e col. Perugini (comandante 6r " ftr): sulla vta Balbia, a circa 42 km. da Tobruch;
......, scaglione col. De Luca (comandante 62" ftr.): circa 20 km ovest di Derna;
- scaglio n e ten. col. Scarampi (comandante quartier generale): Agedabia (r).
(t) I tre scagli oni avevano la seguente composizione:
- scaglione col. Pcrugini: 6r• ftr., I f 46° art., 96• sez. marconjsti, 104" e ro6a cp. da 47 / 32, nucleo 51 " sez. suss., x6o• scz. CC.RR.;
- scaglione col. De Luca: 62° ftr. (meno II btg. lasciato a Barce), 6r 0 btg. mtr., e ga btr. da 20 mm., 51 • sez. san ., 161• SC'.G. CC.RR.;
- scaglione tcn.col. Scarampi: quartier generale, 204" autorep., sr• sez. su ss., una sez 7" btr. da 20 mm.
In seguito ad accordi intervenuti con il Comandante della «T rento », il Comandante della Divisione « Brescia » ordinava verbalmente e confermava per iscritto:
- posizione di raccolta del 6r• rgt. ftr. : valloncello immediatamente ad ovest della q. II7 di Ha giag es Sehel;
- avvicinamento su automezzi fino all'altezza del km. 20 da Tobruch;
- azione da svolgere su due colonne: colonna n. 1 :
. obiettivo il Pilastrino,
. direzione: q. 134- q. 147- q. 152- il Pilastrino,
. composizione: un btg. del 6r • ftr., con elementi di rinforzo del reggimento e III gr del r • rgt. art. celere in appoggio specifico, colonna n. 2:

.. obie ttivo q. 187 di Ra s el Medauuar, . direzione: q. 131 di Sehel- q. 142- q. 187, composizione: un btg. del 6r " rgt ftr. rinforzato da una cp. da 47 / 32, . raggiunto l'obiettivo di q. 187 doveva puntare sul forte Pila strino, in concor so co n l'altra colonna.
Il Comandante del 61" fanteria (colonnello Perugini) era incaricato del coordinamento delle due colonne.
Alle 15,30 i primi elementi d ella divisione si mettevano in moto; verso le 17,30 veniva raggiunta la zona di sbarco e alle 18 le fante rie si attestavano nella zona di racco l ta.
Poco prima delle 18 però l'attacco era stato sospeso e rinviato al giorno successivo, a causa del man cato intervento di apparecchi da bombardamento in picchiata .
Il gen. Rommel decideva poi di sospendere l'attacco anche per il giorno 15, ma l'ordine non perveniva in tempo alla Divisione << Brescia>> la quale pertanto alle ore 15, secondo il piano prestabilito, muoveva all'attacco con il 6r " fanteria, rinforzato con una compagnia da 47 J32 per battaglione e appoggiato dal III gruppo del 1 ° artiglieria celere e dal l gruppo del 46• artiglieria.
Il IIJ6r ", superato il reticolato, raggiungeva con gli elementi avanzati un trincerone in prossimità della q. 145 dell'ex forte Pilastrino, dove veniva fatto oggetto a tiri di mitragliatri ce e di artiglieria , spezzonamento da aerei e contrattacchi di elementi mobili.
Contemporaneamente il I/61 ° occupava la q. 187 ma doveva però abbandonarla, portandosi 300 m. più ad ovest, perché sottop<r sto a violento tiro di repressione.
In mancanza del concorso delle grandi unità laterali (le quali si erano attenute al contrordine tempestivamente ricevuto dal Comando del C.T.A.) l'azione non presentava alcuna possibilità di sviluppo e all'imbrunire il Comandante della Divisione << Brescia» ordinava il ripiegamento sulla base di partenza. Il movimento si compiva nella notte, con sensibili perdite che indussero a riportare il II / 61° all'altezza di Ain el Gazala, per riordinarsi. Una compagnia mortai da 81 rimasta nei pressi delle posizioni raggiunte veniva contrattaccata nella mattinata del 16 e sopraffatta
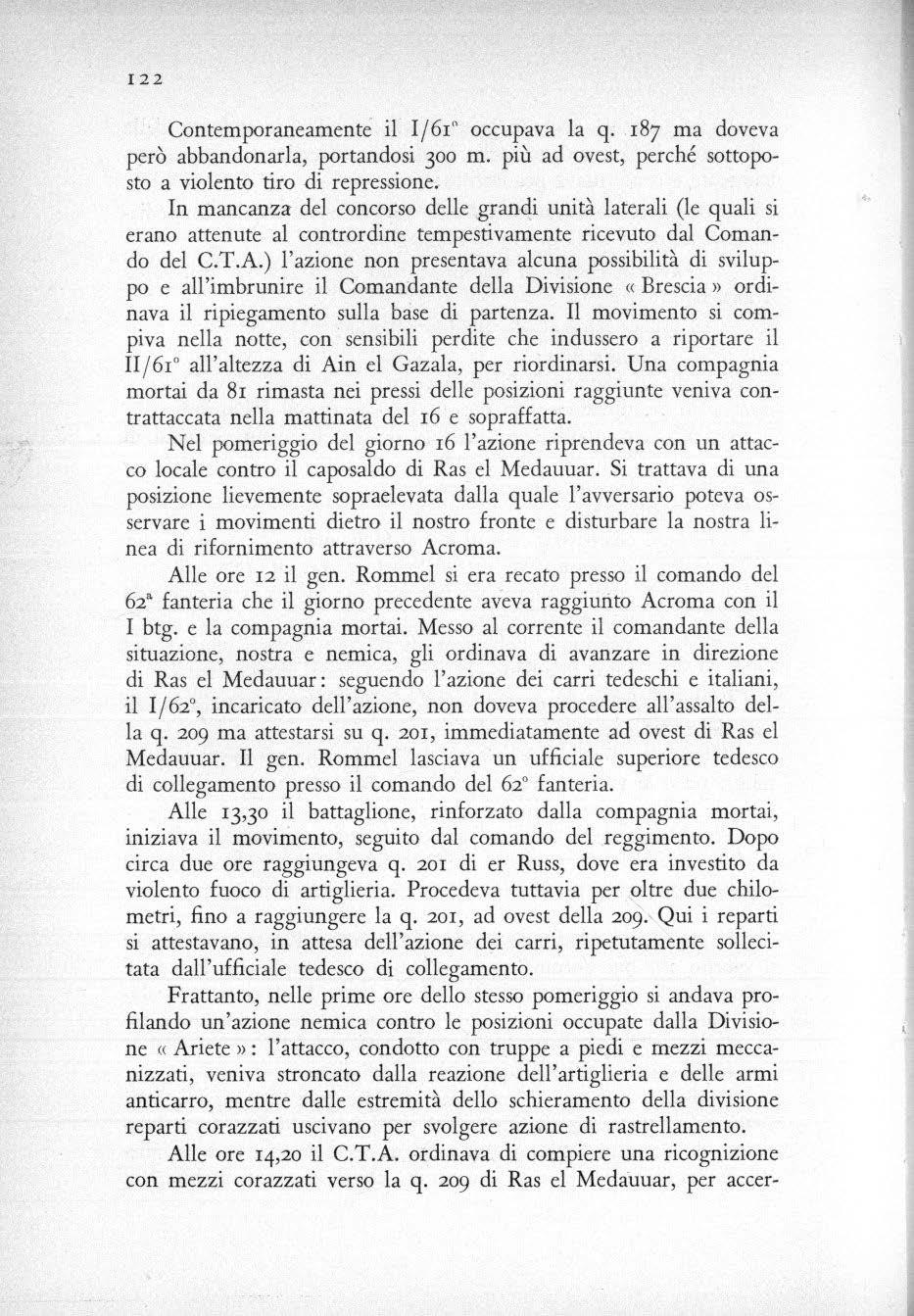
Nel pomeriggio del giorno 16 l'azione riprendeva con un attacco locale contro il caposaldo di Ras el Medauuar. Si trattava di una posizione lievemente sopraelevata dalla quale l'avversario poteva osservare i movimenti dietro il nostro fronte e disturbare la nostra linea di rifornimento attraverso Acroma.
Alle ore 12 il gen. Rommel si era recato presso il comando del 62a fanteria che il giorno precedente aveva raggiunto Acroma con il I btg. e la compagnia mortai. Messo al corrente il comandante della situazione, nostra e nemica, gli ordinava di avanzare in direzione di Ras el Medauuar: seguendo l'azione dei carri tedeschi e italiani, il I j 62°, incaricato dell'azione, non doveva procedere all'assalto della q. 209 ma attestarsi su q. 201, immediatamente ad ovest di Ras el Medauuar. Il gen. Rommel lasciava un ufficiale superiore tedesco di collegamento presso il comando del 62° fanteria .
Alle 13,30 il battaglione, rinforzato dalla compagnia mortai, iniziava il movimento, seguito dal comando del reggimento. D opo circa due ore raggiungeva q. 201 di er Russ, dove era investito da violento fuoco di artiglieria. Procedeva tuttavia per oltre due chilometri, fino a raggiungere la q. 201, ad ovest della 209. Qui i reparti si attestavano, in attesa dell'azione dei carri, ripetutamente sollecitata dall'ufficiale tedesco di collegamento.
Frattanto, nelle prime ore dello stesso pomeriggio si andava profilando un'azione nemica contro le posizioni occupate dalla Divisione <<Ariete»: l'attacco, condotto con truppe a piedi e mezzi meccanizzati, veniva stroncato dalla reazione dell'artiglieria e delle armi anticarro, mentre dalle estremità dello schieramento della divisione reparti corazzati usc ivano per svolgere azione di rastrellamento.
Alle or e 14,20 il C.T.A. ordinava di compiere una ricognizione con mezzi corazzati verso la q. 209 di Ras el Medauuar, per accer-
tare se la posizione era ancora occupata dal nemico. Il Comando dell'« Ariete » disponeva conseguentemente che un reparto di carri L, rinforzato da 7 carri M (che n el frattempo erano stati distribuiti al reggimento carri della divisione) effettuasse una puntata nella dir ezion e indicata, per raggiungere Ja q. 209.
Nel frattempo il I /62° fanteria, che non disponeva di armi anticarro, ve n iva contrattaccato con mezzi corazzati sulle posizioni raggiunte e, soverchi.ato, veniva catturato in ·gran par te (r).
Poco dopo giungevano sul luogo carri armati tedeschi e itali ani, appena in tempo per evitare che carri inglesi isolati continuassero l'attacco contro l 'autocarreggio di combattimento del I /62° che aveva seguito il movimento ed ora veniva fatto ripiegare (2).
Così anche la giornata del r6 era trascorsa senza portare alcun risultato. Un nuovo tentativo veniva compiuto il giorno 17 con una colonna tedesca, fo rte di due compagnie e un reparto carri dell' « Ariete » (6 ca rri M e 7 carr i L): i carri raggiungevano e superavano la q. 209 di Ra s el Medauuar ma poi, sottoposti a violenta reazione di armi anticarro c di artiglieria, subivano sensibili perdite ed erano costretti a ritirarsi (3).
Mentre a Tobruch la situazione rimaneva così preoccupatamente pesante, il 16 aprile i reparti esploranti spinti nella zona di Sollum si trovavano a dover fronteggiare un attacco di mezzi corazzati nem ici, sos tenu ti da unità della flotta (un incrociatore e quattro cacciatorpediniere) che continuavano ad incrociare nella baia.
Considerazioni. Il gen. Rommel attribuiva il mancato successo dell'attacco in parte all'insufficiente addestramento dei reparti tedeschi alla particolare forma di combattimento, m a soprattutto al ca ttiv o addestramento e al deficiente ar-
(t) Nelle azioni dal 15 al 16 aprile la Divisione « Trento >> aveva subito le seguenti perdite: 24 morti, t 12 feriti, 436 dispersi, in gran parte, questi ultimi, feriti non potuti recuperare.
(2) Sull' episodio si legge nella relazione del gen. N uv oloni, Comandante della Divisione « Tr ento», in data 29 aprile: « Il gen. Romrnel, parlando dell'azione con il Comandante della Divisione, ha affermato che un cumulo di disgraziate circostanze, provocando il ritardo dell'intervento dei carr i armati, aveva compromesso il buon es ito dell 'azione. Ha soggi unto che nella situazion e che si era verificata, il btg. non poteva fare di più >>.
(3) Perdite dell' « Ariete » a tutto il r8 aprile (esclusa la colonna Fabris): morti II ufficiali, 15 sottufficial i e truppa; feriti: 7 ufficiali, 53 sottufficiali c truppa; dispersi: 2 ufficiali, 17 sottufficiali c truppa.
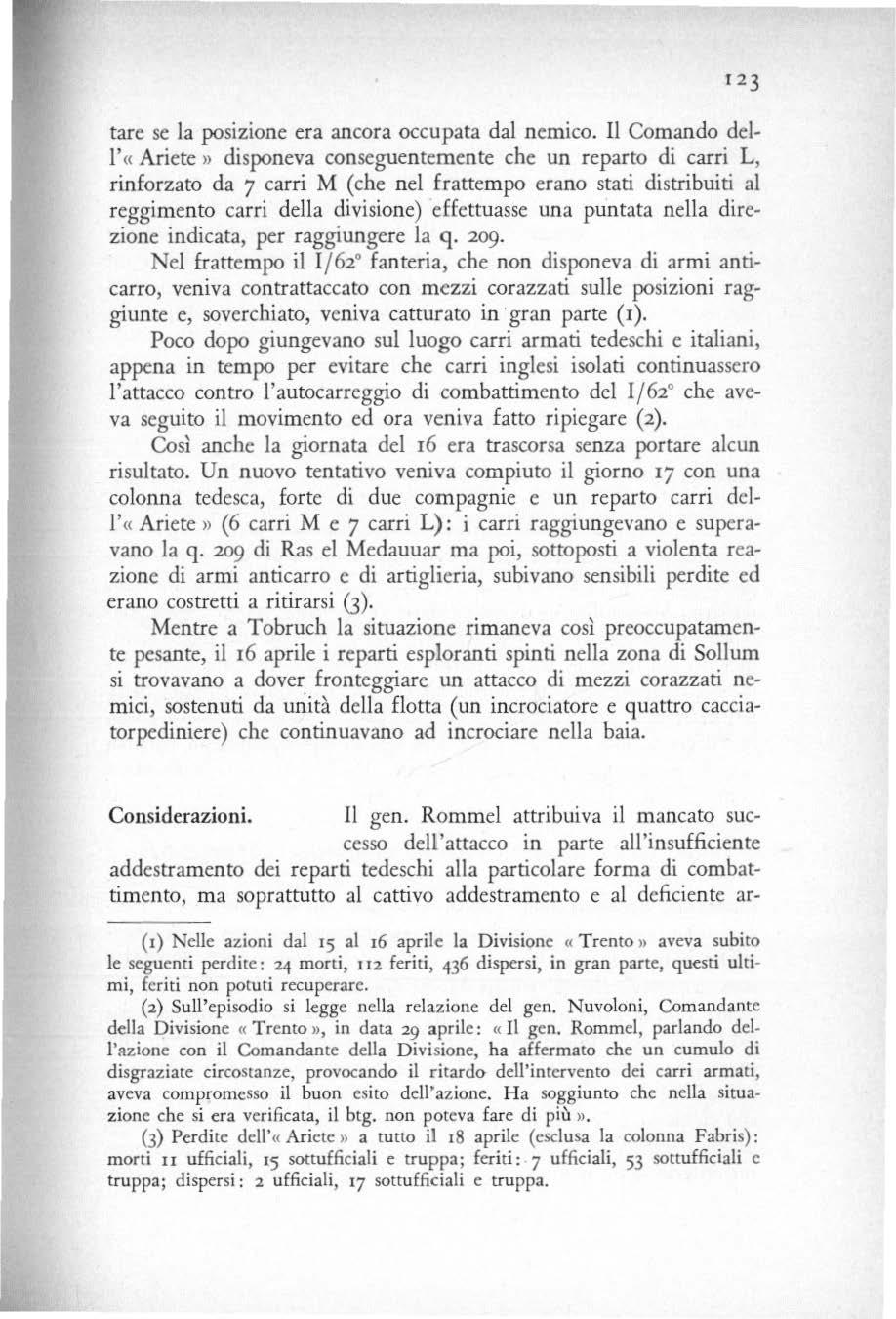
mamento dell e unità italiane: « Purtroppo, non avevo avuto occasione di i struire personalmente le mie unità prima del nostro raid poiché in tal caso , davanti a Tobruch , saremmo stati più all'altezza dei nostri compiti .. . C'era da sentirsi rizzare i capelli in testa, pensando con quale armamento il Duce mandava a combattere l e sue truppe! >> E il 17 aprile annotava nel Diario: « Abbiamo un duro lavoro; gli Inglesi tengono saldamente Tobruch e si sono piazzati bene. Non possiamo fidarci completamente dei nostri alleati in combattimento».
Un'equa valutazione degli avvenimenti deve prendere atto innanzi tutto dell'abile condotta d ella difesa da parte dell'avversario c he nell'intrinseca saldezza dell'organizzazione della piazzaforte aveva evidentemente superato la crisi di cedimento di cui aveva dato prova appena pochi giorni prima ed ora opponeva agli attacchi dell' Asse un ' azione di difesa coordinata e valorosamente sostenuta.
Da parte tedesca era mancato l'atteso concorso degli Stukas sull e batterie avv er sarie, mentre l'av iazione nemi ca aveva potuto co mpiere numerosi interventi sulle colonne d'attacco e sulle immediate retrovie. Ma sembra di dover riconoscere in primo luogo l'inadeguatezza del dispositivo frettolosamente messo insieme dal gen. Rommel per un compito tanto oneroso. C'era inoltre da tener conto del fatto che giungendo il-43 aprile ad el Adem, dopo la strenua corsa nel des erto, le unità sentivano l'estrema necessità di una breve pau sa per distendersi e riorganizzarsi. Per quello che riguarda in particolare le nostre divisioni, la « Brescia » , l '« Ariete » e la « Trento » erano al loro primo incontro con il nemico e si trovavano ad essere impiegate, specialmente la « Brescia », in condizioni e secondo procedimenti assolutamente in contrasto con la loro organizzazione e il loro addestramento. Su tutte cominciava a gravare quella denominazione di « divisione » , sproporzionata alle dimensioni della binaria che portava ad impegnarle in compiti eccessivi. Per l' <<Ariete» infine è da ricordare cke in quel momento la nostra unità corazzata non disponeva che di 7 carri M, in aggiunta a quei carri L che lo stesso Rommel pochi giorni prima aveva definito « semplicemente ridicoli ». Molto opportunamente il gen. Garibaldi il 13 marzo, alla proposta di Rommel di potenziare l'efficienza bellica dell' « Ariete>> aveva risposto, come già ricordato, che nell'impossibilità di accedere alla richiesta, il problema era quello di commisurarne i compiti alle concrete capacità. Nulla appare certamente meno rispondente a questo criterio della maniera in cui la divisione era stata impiegata fin
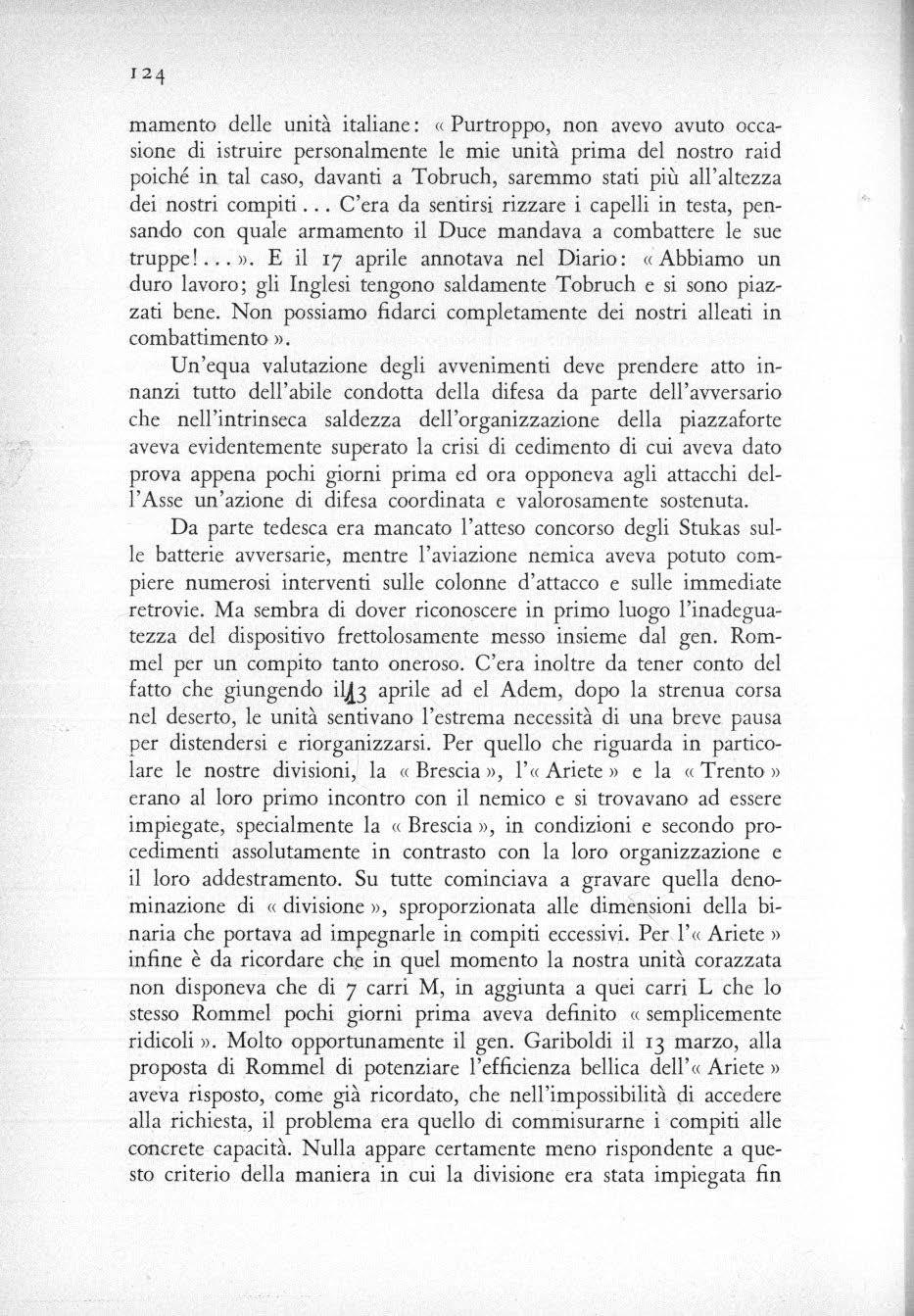
dall'inizio, smembrata in tre frazioni: Colonna F abris, Colonna Montemurro, battaglione carri assegnato al reggime nto ca rri tedesco.
Si può infine ril evare co me, pur nel riconoscimento della importanza prevalente della tempesti vità dell'attac co per prevenire il possibile consolidarsi dell'avv ersa rio, non sembra che l 'azione stessa fosse stata organizzata con la piena e coordinata utilizzazione di tutte le forze disponibili ma rivelasse piuttosto la fi sionomia di una serie d'impulsi separati e più o meno improvvisati, nella quale gli sforzi, certamente generosi da parte di tutti gli esecutori, finivano per disperdersi, piuttosto che co mporsi in un uni co effetto.
Situazione delle forze Raggiunto il 13 aprile il confine egiziano, il dell'Asse nella seco n- gen. Rom mel pensava che ormai l'avversario da quindicina d'apri- non disponesse di altre truppe di pronto imle. Necessità di una so- piego per contrastare la nostra marcia in sta operativa. Egitto e informava il Comandante Superiore italiano A S. che il C.T.A. si proponeva di continuare con le avanguardie l'avanzata verso est, per battere successivamente le riserve in glesi, man mano che fossero affluite (1). Non appena assicurati i rifornim enti, la massa delle truppe avrebbe dovuto seguire immediatamente. Il Comandante del C.T.A. indicava le seguenti misur e indispensabili e urgenti :
- tempestivi rifornimenti ai r.eparti italiani;
- afflusso accelerato al C.T.A . di tutte le forz e motorizzate italiane ancora disponibil i;
- occupazione della Cirenaica, difesa costiera e riattivazione delle principali comunicazioni co n altri reparti italiani;
- collegamento co n il Comando Superiore italiano e con le divisioni italiane e rifornimento delle avanguardie essenzialmente a mezzo di aerei;
- s1curezza delle coste, co n pieno impiego d ella Marina itali ana;
(1) L ' ufficiale di collegamento presso il C.T.A., gen. Calvi dì Bergolo, precisava che il Comando tede sco era orientato a continuare le operazioni per raggi ungere Marsa Matr uh con lo stesso ritmo tenuto fino a quel momento, nella certezza che il nemico avesse già sgomberato tutto l'Egitto, fino a'la zona del Canale.

- sorveglianza della flotta inglese da parte dell'aviazione italiana, intesa a sventare tentativi di avvicinamento e di offesa alle coste africane ad occidente del fronte di combattimento.
In pieno contrasto con questa visione, il Comando Supremo stimava invece pericoloso proseguire l'avanzata oltre Sollum senza una adeguata preparazione e pertanto lo stesso giorno 13 prospettava al Comando Superiore A.S. la necessità di interporre un tempo di arresto nelle operazioni:
DISPACCIO A MEZZO TELEAVIO Trasmesso il 13(4(41
per: Supercomando A.S.l. e per conoscenza : a: Superesercito Supermarina
8r96jOp. - Difficoltà logistiche et logoramento conseguenti vastità et rapidità operazioni che ci hanno condotto sino Bardia e forse Sollum impongono ora un tempo di sosta per riorganizzazione reparti et rifornimenti. Occorre anche per le future operazioni che le truppe operanti siano fortemente rinforzate. Non est possibile intervenire immediatamente con azioni da mare oltre quelle dei mezzi insidiosi che per quanto possibile si vedrà di rinforzare.

Il Corpo Aereo Tedesco non può per un certo periodo di tempo essere distratto da compiti suoi che mirano ad eliminare nel più breve tempo possibile difese inglesi e greche sul territorio greco. Si provvederà compensare la riduzione di velivoli del C.A.T. con invio di aerei italiani, nei limiti consentiti dall'approntamento delle basi. Come vi è noto le offese per mare e per cielo sul Canale di Sicilia per parte degli Inglesi sembrano intensificarsi e ciò richiede maggiore distrazione da altri compiti di mezzi navali ed aerei per scorte nostri convogli. In questa situazione sarebbe troppo pericoloso proseguire l'avanzata oltre Sollum prima di avere una sufficiente preparazione. Quello che intanto interessa, più che una ulteriore avanzata lungo la litoranea, è l'occupazione delle oasi di Giarabub e possibilmente di Siwa.
Mussolini
· Ad analoga conclusione era giunto il gen. Garibaldi il quale, conosciute le decisioni del Comando Supremo, impartiva conseguenti ordini al gen. Rommel, stabilendo di provvedere anzitutto a scegliere una favorevole posizione sulla quale sistemarsi, in attesa di
disporre di forze sufficienti e sufficientemente organizzate per nprendere l'avanzata e predisporre l'occupazione di Giarabub.
L'indomani del fallito tentativo di eliminare con attacco speditivo la « spina nel fianco» di Tobruch, il gen. Rommel cambiava spontaneamente il proprio orientamento. Comunicava infatti al Comando Supremo dell'Esercito tedesco di non poter prevedere il momento in cui si sarebbe potuto portare un nuovo attacco decisivo su Tobruch, in quanto subordinato all'arrivo di nuove forze e dichiarava di dovere temporaneamente rinunciare all'ulteriore avanzata in Egitto, malgrado la situazione generale eccezionalmente favorevole.
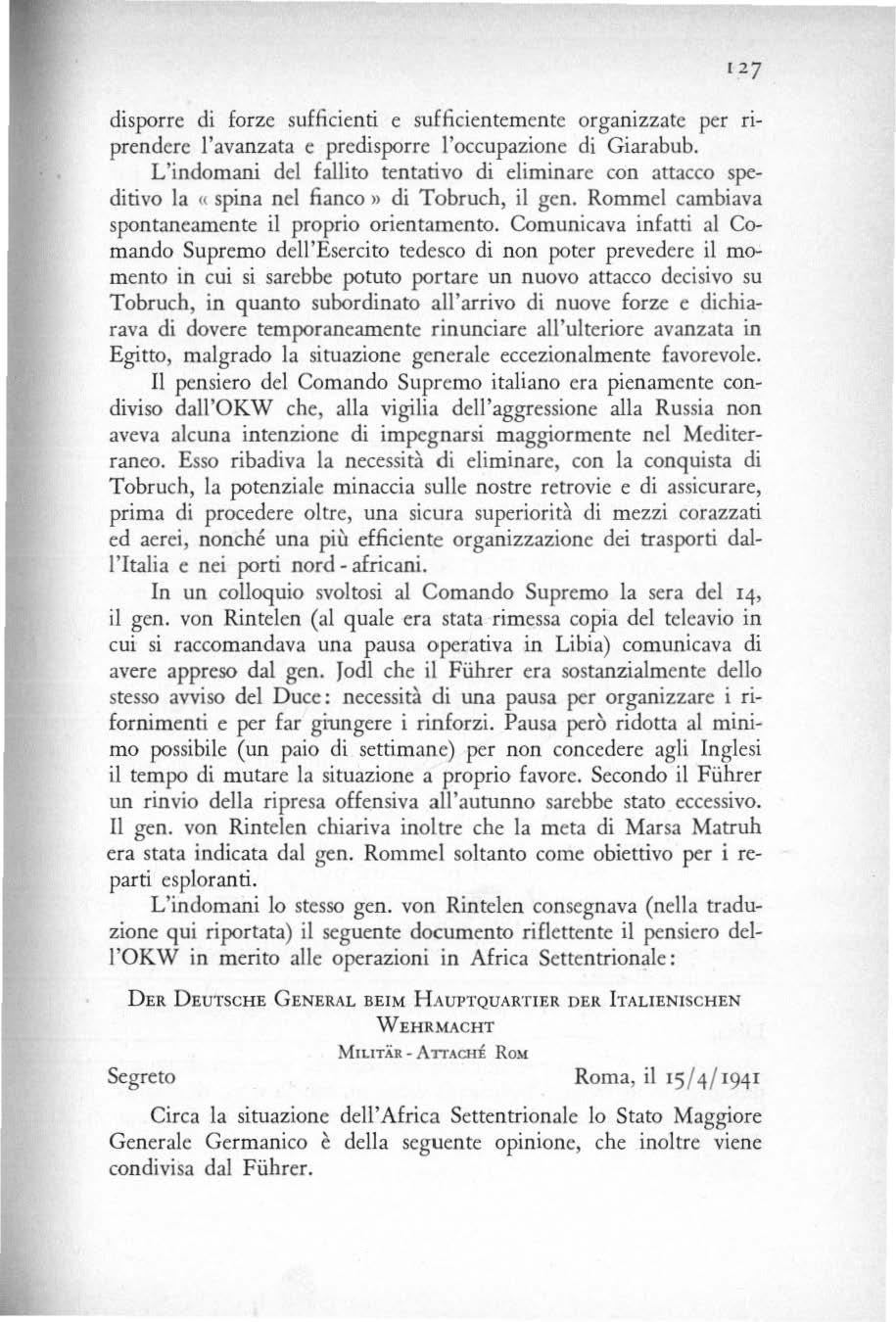
Il pensiero del Comando Supremo italiano era pienamente condiviso dall'OKW che, alla vigilia dell'aggressione alla Ru ssia non aveva alcuna intenzione di impegnarsi maggiormente nel Mediterran eo. Esso ribadiva la nec essi tà di eliminare, con la conquista di Tobruch, la potenziale minaccia sulle nostre retrovie e di assicurare, prima di procedere oltre, una sicura superiorità di mezzi corazzati ed aerei, nonché una più efficiente organizzazione dei trasporti dall 'I talia e nei porti nord - africani.
In un colloquio svoltosi al Comando Supremo la sera del 14, il gen . von Rintelen (al quale era stata rimessa copia del teleavio in cui si raccomandava una pausa operativa in Libia) comunicava di avere appreso dal gen. Jodl che il Fiihrer era sostanzialmente dello stesso avviso del Duce: necessità di una pausa per organizzare i rifornimenti e per far gi'lmgere i rinforzi. Pausa però ridotta al minimo possibile (un paio di settimane) per non concedere agli Inglesi il tempo di mutare la situazione a proprio favore. Secondo il Fuhrer un rinvio della ripresa offensiva all'autunno sarebbe stato eccessivo. Il gen. von Rintelen chiariva inoltre che la m eta di Marsa Matruh era stata indicata dal gen. Rommel soltanto come obiettivo per i reparti esploranti.
L 'indo mani lo stesso gen. von Rintelen consegnava (nella traduzione qui riportata) il seguente documento riflettente il pensiero dell'OKW in merito alle operazioni in Africa Settentrionale:
D ER DEUTSCHE GENERAL BETM HAUPTQUARTIER DER lTALIENIS CHEN
WEHRMACHT
MtLITAR-ArrACHÉ Ro.\t
Segreto Roma , il 15 / 4 / 1941
Circa la situazione dell'Africa Settentrionale lo Stato Maggiore Generale Germanico è della seguente opinione, che inoltre viene condivisa dal Filhrer.
Viene approvata l'opinione dello Stato Maggiore Generale italiano, che vista la situazione attuale delle operazioni nella Cirenaica Orientale, dev'essere intermesso un periodo di sosta, utilizzabile per la continuazione delle operazioni.
Le premesse per evitare un insuccesso di una operazione contro l'Egitto sono le seguenti :
I 0 - Rafforzamento dei reparti d'assalto. Si deve perciò aspettare l'arrivo della IS" Divisione Corazzata e di altri reparti italiani di fanteria, come pure di reparti aerei pronti per essere impiegati in combattimento, Per questo scopo il C.A.T. è di nuovo a disposizwne.
E' previsto come rinforzo:
_, I gruppo aeroplani posa- mine;
- I gruppo da caccia;
- I gruppo Stukas;
e, se necessario, I gruppo di apparecchi da trasporto.
2 " - Allargamento della base di partenza per l'operazione, da avviare con l'occupazione delle oasi di Giarabub e di Siwa, per protezione sui fianchi.
3o - Completamento di una base logistica per le truppe dell'esercito come pure l'istituzione ed il provvedimento dell'organizzazione aeronautica terrestre della Cirenaica, anche per i reparti dell' aeronautica germanica.
4o - La cosa più importante però è l'eliminazione di un intervento inglese contro le nostre retrovie:
a) mediante la presa di Tobruch;
b) mediante la protezione della litoranea e della navigazione litoranea contro attacchi nemici dal mare e dall'aria. Questa protezione deve essere fatta nel modo più efficace, per mezzo di apparecchi da combattimento e da caccia (caccia- bombardieri), di difesa contraerea e, se possibile, per mezzo di un impiego di sommergibili e di mas;

c) mediante la protezione dei trasporti nava li dall'Italia in Libia.
Il tempo di sosta previsto non esclude però avanzate di reparti da ricognizione (reparti esploranti) verso est, con lo scopo di chiarire la situazione e di ostacolare la costruzione metodica di un fronte di difesa inglese.
von RintelenLa nostra occupazione avanzata presentava, invero, una limitata estensione ed era pertanto suscettibile di aggiramento da sud, dove il nemico occupava l'oasi di Giarabub e disponeva delle altre posizioni di confine, più a nord, fino a Sidi Ornar.
L'enclave di Tobruch inoltre, mentre teneva impegnata per l'assedio una forte aliquota delle nostre truppe, rappresentava una non trascurabile minaccia alle nostre retrovie: una sortita in forze dalla piazza avrebbe infatti tagliato fuori il nostro schieramento avanzato, già esposto alla minaccia da est e da sud.
Come si è visto;il Comando del C.T.A. valutava il presidio di Tobruch a circa tre divisioni, vale a dire tutte quelle sfuggite a Mechi li ed a Derna. Alla data del 15 aprile le forze italo- tedesche disponibili, tanto per l'investimento della Piazza di Tobruch quanto per lo schieramento sulle posizioni avanzate, erano costituite soltanto dalla 5" Divi sione L eggera tedesca e da semplici aliquote delle Divisioni « Brescia», « Trento » e « Ariete ». Gli altri elementi di queste Di visio ni stavano progressivamente affluendo da Barce, Bengasi, Agedabia.

Una nostra colonna era in marcia su Gialo, che occupava il giorno z8. La z;• Divisio n e Corazzata tedesca, giunta in Italia, doveva iniziare a giorni il trasferimento in Tripolitania.
La situazio ne delle nostre forze alla data del 15 aprile è riportata nell o schizzo 11. 11 In complesso il turbinoso sviluppo degli avve nim enti aveva determinato un'inorganica distribuzione delle forze, italiane e tedesche, esposte alla momentanea superiorità dell'artiglieria e dell 'aviazione avversarie, mentre l'efficace attività delle forze navali britanniche aggravava pesantemente il problema delle comunicazioni marittime.
La deficienza fondamentale era sempre rappresentata dalla scarsa mobilità delle divisioni italiane, per insufficienza organica di automezzi, situazione re sa ancora più grave, sul mom ento, dalla necessità di provvedere all'autotrasporto dei rifornimenti che facevano capo, almeno in primo tempo, esclusivamente a Tripoli e solo in seguito an che a Bengasi.
L'interdipendenza fra i due fronti, di Sollum e di Tobruch , imponeva la direzione di un comando unico ed avrebbe voluto la disponibilità di una adeguata massa di manovra per parare prontam ente così gli eventuali tentativi di sortita dalla Piazza come le manovre di aggiramen to della posizione di co nfine. La mancanza di forze sufficienti da assegnare a questa funzione comprometteva seriamente la possibilità di far fronte alla doppia mina ccia. Nella pre-
caria situazione in cui ci si era venuti a trovare al termine dell'ardita impresa c'era seriame nte da preoccuparsi per poter mantenere i frutti della vittoria. La situazione nella valutazione degli alti comandi italiani e tedeschi .
Il 20 aprile il Capo di S. M. dell'Esercito, gen . Roatta veniva inviato dal Comando Supremo a rendersi conto esattame nte sul posto della situazione. Egli si associava alla generale opinione della ne cessità di eliminare la Piazza di Tobruch, ma riteneva difficile av er ragione del presidio, molto efficiente, con le sole forze disponibili in quel momento, m olto provate, ed anche co n i rinforzi che sarebbe stato possibile fare affluire in pochi giorni. Notevole risultava in particolare l'insufficienza delle artig lierie di medio calibro, alla quale tuttavia si sarebbe potuto ovviare, nei limiti consentiti dall e strutture esistenti, con l'impiego a massa dell'aviazione. Non c'era n epp ure da pensare alla eventualità di proseguire l'offensiva oltre confine: le forze itala- tedesche proiettate in avanti erano poche ed avevano di fronte un avversario che già si manifestava sempre più attivo.
Non diversa era la conclusione prospettata l 'indomani dallo stesso gen. Rommel in una comu nicazi one al Comando Supremo dell'Esercito tedesco:

« L e forze inglesi a Tobrucb e ai confini d ella Cirenaica sono, ora come prima, più forti di quelle tedesche. Il tempo lavora inoltre per gli Inglesi. In seguito alla grande quantità di tonnella ggio ed alla padronanza del Mediterraneo da parte della flotta inglese, come pure per le forze esistenti in Egitto, gli Inglesi sono nella situazione di inviare prontamente più truppe al fronte africano di quello che non sia possibile da parte nostra. Gli sviluppi della situazio ne in Grecia ed in A.O.I. mettono gli In glesi nella situazione di liberare, almeno in parte, nelle prossime settimane notevoli agguerrite forze che essi verosimilmente potranno e vorranno impiegare nel Nord Africa. Gli In g lesi rinforzano già i loro reparti presso Sollum e qui sono pronti a passare dalla ritirata all'attacco. L a flotta e l'arma aerea inglese so no interamente padro ne attualmente della costa e dell'aria, nella zona di Sollum e Tobruch.
« Una ripresa dell'attacco verso est prima della caduta di Tobruch è esclusa perché solo l 'investi mento dell'avversario in Tobruch richiede la massa delle forze tedesche. Un acceleramento della ca-
duta di Tobruch è desiderabile. Un normale attacco di massa non è attualmente possibile, in considerazione della proporzione delle loro forze e delle posizioni fortificate inglesi (già italiane). Un tale attacco su Tobruch sarà possibile solo quando molti reparti della 15a Divisione saranno disponibili.
« Dopo la caduta di Tobruch si potrà tendere all'occupazione di Marsa Matruh e ad avere in mano la linea di collegamento verso il sud, fino a Siwa compresa. E' dubbio che la eliminazione di Marsa Matruh possa portare veramente ad un ulteriore ritardo. In ogni caso le posizioni finora raggiunte devono essere mantenute e assicurate dalle provenienze da sud, con l'occupazione di Siwa- Giarabub.
« Una premessa principale per l'eliminazione di Tobruch e per ogni ulteriore azione verso est è un pronto rinforzo dell'arma aerea, affinché si possa interrompere l'attuale attività dei caccia, dei bombardieri e delle forze navali inglesi, completamente indisturbata. Pitt tardi la realizzazione delle operazioni in progetto sarà possibile se i rifornimenti di carburante, munizioni ed acqua potranno essere assicurati d a reparti di trasporto aereo, sufficie ntemente protetti dalla caccia. P er una ulteriore proficua offensiva, se si vuole che le operazioni non si fermino a metà strada per mancanza di forze, è necessario il completamento della s• Divisione Legg er a con una poderosa divisione corazzata e l'invio di almeno un'altra divisione motorizzata ted esca, con le corrispondenti truppe di Corpo d'Armata. Anche que sto bisogno di truppe, in relazione ai trasporti inglesi, sarà sufficiente solo se sarà condotto entro le prossime 4 o 6 settimane.

« Il fronte di Tobruch, che si sviluppa su 50 km., presenta grosse lacune che, con le forze attualmente esistenti, non possono essere colmate. E' intenzione, per il prossimo avvenire, di colmare qu este lacune con truppe che sono già in marcia verso la zona, con il sostegno di attacchi di Stukas che possono d emolire le fortificazioni di Tobruch pezzo per pezzo, con la co ntemporanea occupazione della fortezza di Bardia con truppe italiane e tenendo in scacco il nemico a est di Sollum con reparti avanzati tedeschi » .
Il 23 aprile, dopo aver conferito con il gen. Rommel, il gen. Gariboldi così precisava quanto era stato insieme concretato:
- l'attacco della Piazza , largamente appoggiato dall'aviaziozione, sarebbe stato ritentato non appena completate in sito le divisioni « Ariete », « Brescia >> e « Trento » (rinforzate con l'intero 2 ° reggimento artiglieria celere c tre gruppi da 105/28), ultimato l'af-
flusso della rs• Corazzata tede sca e costituita una sufficie nte scorta di carburante, munizioni e viveri;
- raggiunto questo traguardo si sarebbe provvedu to al riordinamento dello schieramento, facendo serrar sotto le unità della Tripolitani a (Divisione << Pavia» a Derna e D ivisione « Bologna » sul Gebel) in attesa di poter riprendere l'avanzata, dopo l'arrivo di tutte le forze necessarie;
- procedere intanto allo studio dell'operazione per l 'occupazione d elle oasi di Giarabub e di Siwa per la quale, tenuto conto delle forze avversarie, sarebbero occorsi notevoli mezzi di fuoco, rifornimenti e automezzi idonei al movimento nel deserto.
In complesso, nella seco nd a m età di aprile la situazione, inizialmente per noi alquanto critica, andava poi m an mano migliorando, con il comple tamento della Divisione « Trento» e l'arrivo della Corazzata tedesca.
In un colloquio con il ge n. Guzzoni, il gen. von Rintel en prospettava la necessità di fare di tutto per aiutare il gen. Rommel e comunicava ch e il 26 sarebbe passato da Roma il gen. Paulus, caporeparto operazioni e delegato del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che si recava in Libia « per esaminare la situazio ne insieme a Rommel c decidere che cosa fosse da inviare, anche a mezzo aerei, oltre la rs" Divisione Corazzata». Sembra però che il suo mandato riguardasse piuttosto l'accertame nto delle condizioni da realizzare per una efficace e sicura difesa, qualora si fosse stati costretti ad abbandonare Sollum. Doveva inoltre appurare i reali intendimenti di Rommel e fargli capire di non attendersi ulteriori aiuti (r).

Il gen. Paulus raggiun geva Rommel al suo posto di comando il 27 aprile e dopo esauriente esame e discussione della situazione ne approvava il piano per un nuovo attacco a Tobruch, da attuare il 30 aprile. Lo stesso piano veniva approvato l'indomani anche dal gen. Guzzoni. << Non sì parlò di Suez come obiettivo. Invero, Paulus annotò che se Tobruch fo sse caduta egli avrebbe ordinato all' Afrika Korps dì assicurare il possesso della Cirenaica tenendo la linea Si w a -
(t) Il gen. Halder, Capo di Stato Maggior e deli'Eserciw, che << aveva un'avversion e ist intiva per la tendenza di Hitl er a secondare quei militari più dinamici che, com e Rommel, non si conformavano alle tradizionali regole di condotta » dello Stato Maggiore tedesco, avrebbe dato mandaw al proprio delegato di « bloccare quest'uomo che ormai dà i numeri », come egli stesso annotava nel proprio diario. ( LIDDELL HART: « Storia militare della Seconda Guerra Mondiale », Mondadori ed., 1970, pag. 240).
Sollum. A nome dell'Alto Comando germanico egli evidentemente intendeva accuratamente evitare che il tea tro d'operazioni del deserto diventasse di nuovo fonte di difficoltà » ( r ).
La situazione britannica. (Schizzo n. 12).
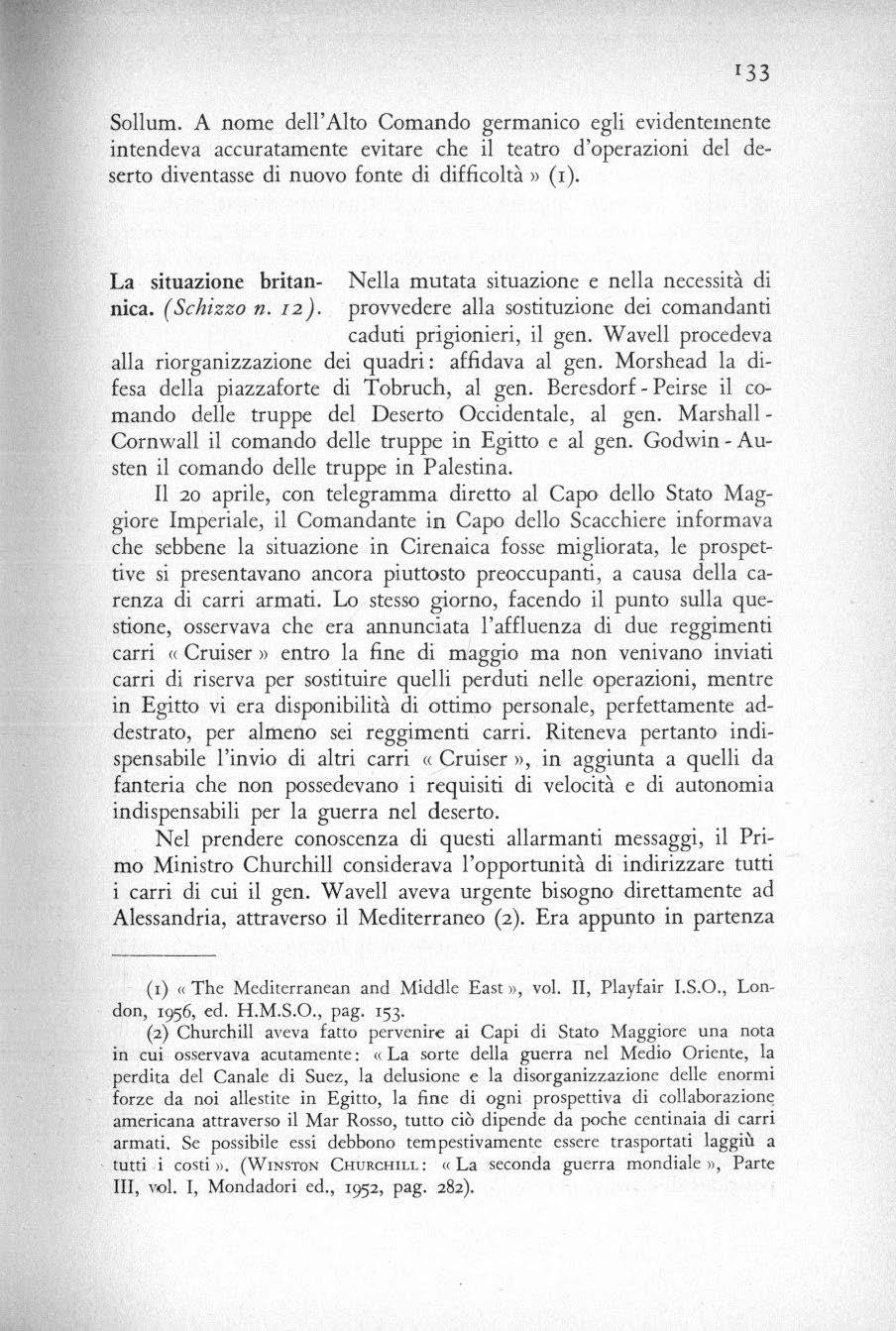
Nella mutata situazione e nella necessità di provvedere alla sostituzione dei comandanti caduti prigionieri, il gen. Wavell procedeva alla riorganizzazione dei quadri: affidava al gen. Morshead la difesa della piazzaforte di T obruch, al gen. Beresdorf- Peirse il comando delle truppe del Deserto Occidentale, al gen. MarshaliCornwall il comando delle truppe in Egitto e al gen. Godwin- Austen il comando delle truppe in Palestina.
Il 20 aprile, con telegramma diretto al Capo dello Stato Maggiore Imperial e, il Comandante in Capo dello Scacchiere informava che sebbene la situazione in Cirenaica fosse migliorata, le prospettive si presentavano ancora piuttosto preoccupanti, a causa della carenza di carri armati Lo stesso giorno, facendo il punto sulla questione, osservava che era annunciata l'affluenza di due reggimenti carri « Cruiser » entro la fine di maggio ma non venivano inviati carri di riserva per sostituire quelli perduti nelle operazioni, mentre in Egitto vi era disponibilità di ottimo personale, perfettamente addestrato, per almeno sei reggimenti carri. Riteneva pertanto indispensabile l'invio di altri carri « Cruiser», in aggiunta a quelli da fanteria che non possedevano i requisiti di velocità e di autonomia indispensabili per la guerra nel deserto.
Nel prendere conoscenza di questi allarmanti messaggi, il Primo Ministro Churchill considerava l'opportunità di indirizzare tutti i carri di cui il gen. Wavell aveva urgente bisogno direttamente acl Alessandria , attraverso il Mediterraneo (2). Era appunto in partenza
(1) << Thc Mcditcrranean and Middlc East )) ' vol. II, Playfair I.S.O., London, 1956, ed. H.M.S.O., pag. 153.
(2) Churchill aveva fatto pervenire ai Capi di Stato Maggiore una nota in cui osservava acutamente: << La sorte della guerra nel Medio Oriente, la perdita del Canale di Suez, la delusione c la disorganizzazione delle enormi forze da noi allestite in Egitto, la fine di ogni prospettiva di americana attr averso il Mar Rosso, tutto ciò dipende da poche centinaia di carri armati. Se possibile essi debbono tempestivamente essere trasportati laggiù a tutt i i costi » (WrNSTON CHURCH ILL: <<La seconda guerra mondiale », Parte III, vol. I, Mondadori ed ., 1952, pag. 282).
un convoglio per la rotta del Capo, con grandi rinforzi di carri e Churchill proponeva che le navi più veloci ne fossero dirottate su Gibilterra per seguire la via più corta, abbreviando così la durata del viaggio di circa quaranta giorni. Il Comitato di Difesa dava la propria approvazione e il giorno 22 il gen. Wavell veniva informato che 307 carri del tipo più efficiente venivano inviati attraverso il Mediterraneo, nella speranza che giungessero entro il IO maggio. Si trattava di « Cruiser >> Mark IV e Mark VI, con relative parti di ricambio, e carri tipo « I >>
Lo stesso giorno il Primo Ministro scriveva al Capo dello Stato Maggiore Imperiale: « Ci si aspetta che 25.000 uomini co n 100 cannoni ed ingenti scorte siano in grado di tenere una zona potentemente fortificata contro 4500 uomini che si trovano a dover ricevere i rifornimenti da una base distante oltre IIOO chilometri, anche se questi uomini sono tedeschi e in questo caso alcuni non lo sono Non dobbiamo ritenerci troppo inferiori all'avversario ... >>.
Il convoglio di cinque navi, denominato « Tiger >>, fortemente scortato passava Gibilterra il 6 maggio. Il giorno 8 subiva un forte attacco aereo e durante la notte due navi andavano ad urtare contro mine, mentre si avvicinavano al Canale di Sicilia: l'una (Empire Song) s'incendiava e affondava in seguito a esplosione (con essa andavano perduti 57 carri); l'altra poteva conti nu are il viaggio con il c?nvoglio che, fortemente m enoma to , raggiungeva Alessandria il gwrno 12.
Successivamente altri 50 carri « Cruiser >> e 50 tipo « I >> prendevano la via del Capo con un convoglio che giungeva a Suez il 15 luglio.
Rico g n izioni e puntate offensive nella seco nda quin dici na di aprile.
In attesa del nuovo attacco previsto per la fine del mese, si andavano sviluppando azioni minori con caratteristiche di operazioni di approccio e di sondaggio.
La nostra ricognizione offensiva incontrava dovunque notevole resistenza. Il 24 un r eparto della Divisione « Trento>> incaricato di agire in direzione di q. 187- q. 209 di Ras el Medauuar riusciva a superare i reticolati con alcuni elementi ma, preso sotto nutrito fuoco di mitragliatrici, era costretto a ritirarsi con sen sibili perdite.
D a parte inglese si rendeva manifesto il proposito di aggirare le posizioni di Bardia, ma ste ril e rimaneva il ri sultato d elle sue azioni,

anche se inizialmente era potuto sembrare promettente. Nella notte sul 20 il mezzo da sbarco Glengyle, scortato dall'incrociatore contraerei Coventry e tre cacciatorpediniere, sbarcava in quattro punti della spiaggia, alle spalle della nostra linea, un battaglione della Brigata cc Servizio Speciale » (Commandos): l'operazione finiva miser amente con la cattura di 3 ufficiali e 56 uomini di truppa. La sera del 23 si sviluppava un ' azione avvolgente da ovest e da sud contro Capuzzo, con il concorso di ben 6o carri, numerosi automezzi e artiglierie, anche di medio calibro. L'attacco veniva respinto ma l'episodio era valso a mettere in evidenza la pericolosità della situazione , talché l'indomani il Comandante del C.T.A., nel riferirne all'OKW, sottolineava che l'eventuale perdita od anche soltanto l'accerchiamento di Bardia- Sollum ci avrebbe costretto anche a desistere dall a battaglia di Tobruch, non disponendo di forze sufficienti per esercitare la difesa su due fronti. cc Un cambiamento nello stato molto critico di que sta situazione - aggiungeva il ge o. Rommel sarebbe possibile soltanto con tm rapido apporto di forze tede sche per via aer ea, con il ripianamento delle perdite della s" Divisione Leggera, con l'immediato rinforzo dell'aviaz ione (particolarmente con aeroplani da combattimento) e con l'impiego di sommergibili lungo la costa Sollum- Tobruch >> .
All'alba del 22 aprile la guarmgwne di Tobruch, dopo vivace preparazione di artiglieria, passava all'attacco sui fronti ovest e sud, con forti formazioni di carri, autoblindo e fanteria. Sul fronte sud veniva senz'altro respinto. Sul fronte ovest veniva pure ricacciato, dopo duro combattimento, dalla Divisione cc Brescia>>, schierata a cavallo della via Balbia. Riusciva tuttavia a soverchiare un reparto dell' cc Ariete))' davanti alla q. 201 di Ras el Medauuar e a penetrare nelle posizioni dell'artiglieria, spingendosi fino ad Acroma, investendo le posizioni tenute dalla colonna Fabris (r). La crisi poteva essere dominata già nel corso del mattino stesso con l'intervento di qualche caccia- carri tedesco: l'azione era costata al nemico la perdita di 9 carri e 2 autoblindo. Altre perdite subiva nel pomeriggio, ad opera dell'aviazione tedesca, durante le operazioni di sganciamento e di ripicgamento nelle proprie linee. La sera stessa infine, dopo un bombardamento aereo e di artiglieria, si manifestava un
(x) Nell'azione cadevano sul campo 2 ufficiali e 46 bersaglieri. Il col. Fabris, comandante del caposaldo, moriva due giorni dopo, in seguito a grav e ferita ripor tata all'ini z io del combartimento.
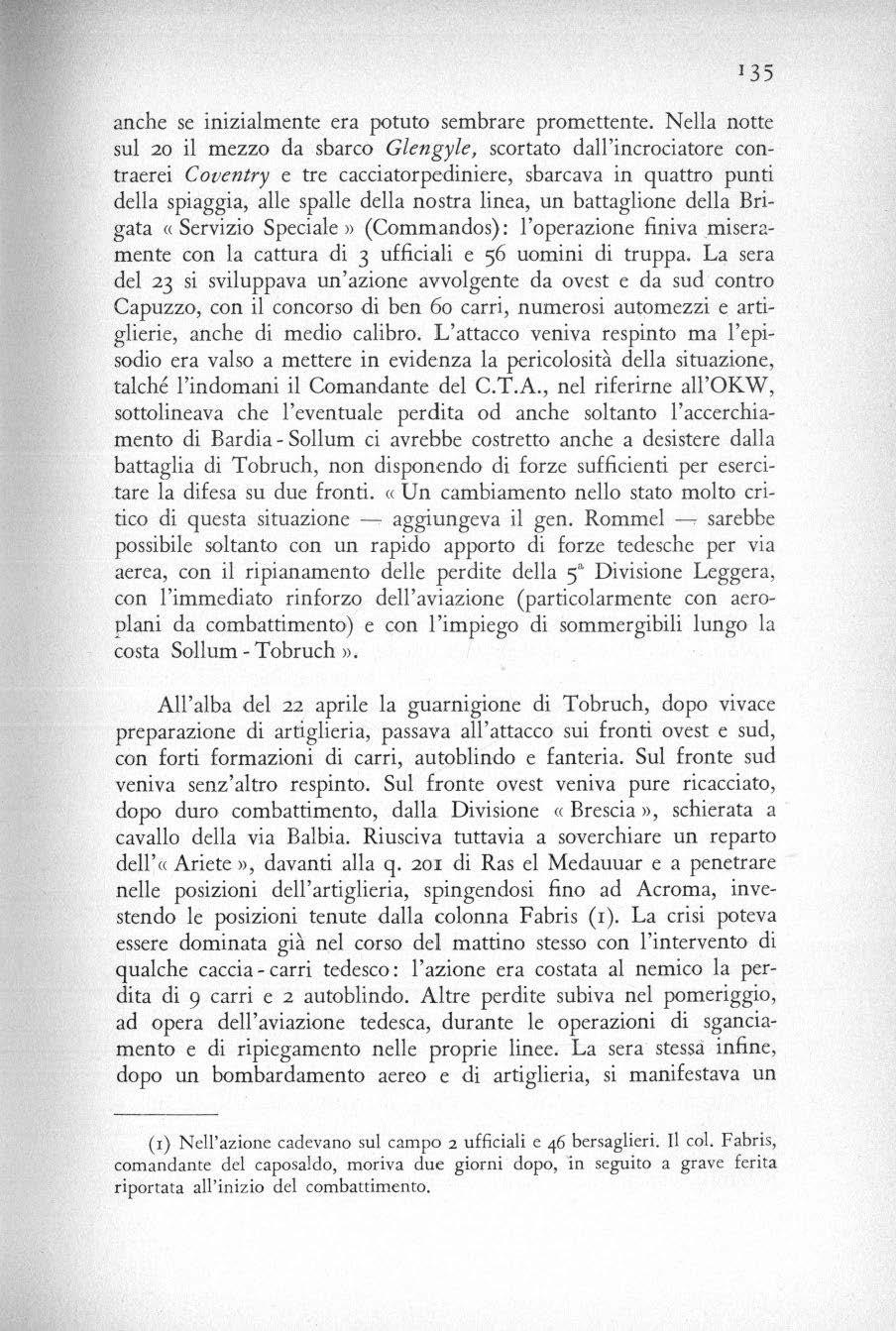
nuovo attacco, di fanteria questa volta, contro l ' ala nord della Divisione « Brescia», respinto dalla divisione stessa.
L'indomani aerei da bombardamento in picchiata italiani rf!_
Stukas bombardavano la rada di Tobruch colpendo 4 piroscafi ed affondandone uno.
Nella notte sul 24 artiglieria navale britannica sparava per la prima volta nella zona di Acroma, nodo principale delle nostre linee di comunicazione, dietro il fronte d'investimento della Piazza. Nella stessa notte nostre ricognizioni e puntate offensive tentate all'alba incontravano dovunque una consistente reazione.
Il 25, carri armati nemici tentavano più volte di raggiungere le nostre posizioni, costretti dovunque a ripiegare nelle proprie linee dal fuoco della difesa.
La notte sul 26 il nemico apriva un varco di circa 6o metri nel nostro sbarramento, ad ovest della strada Tobruch- el Adem: reparti di fanteria inviati in ricognizione verso mezzogiorno attraverso questa apertura, venivano completamente sgominati da carri armati tedeschi.
L'evidente difficoltà della situazione, messa in luce dall'inattesa ripresa britannica, l'andamento di queste azioni minori che sembrava denunciare una certa debolezza delle truppe italiane nel combattimento, avevano determinato delusione e amarezza nel gen. Rommel, inducendolo ad addossare alla parte italiana gli elementi n egativi della situazione in cui si era venuto a trovare, trascinato dal proprio impulso, al termine del brillante raid controffensivo.
Le sue annotazioni riportano in quei giorni severi apprezzamenti nei riguardi dell'armamento e dell'addetram ento delle unità italiane (giudizi, talvolta, anche poco generosi sul loro comportamento di fronte al nemico). Il 29 aprile, alla vigilia del nuovo attacco alla Piazzaforte, in un rapporto personale riservato a Hitler, lamentava « la disorganizzazione dei comandi italiani » e trasmetteva copia di un ordine del giorno da lui diramato il 25, a tedeschi e italiani, nel quale minacciava severe sanzio n i ove si fossero ripetuti « i casi spiacevoli di mancanza di disciplina in combattimento e di forza di resistenza, verificatisi presso qualche reparto italiano »

Nello stesso ordine del giorno il gen. Rommel contrapponeva il contegno della Divisione « Brescia», che veniva citata ad esempio:
<< ••• che sia possibile annullare con le armi esistenti, con resistenza decisa, <>gni puntata nemica, anche di carri armati, lo ha dimostrato il comportamento dei reparti della Divisione « Brescia » i quali han-
no respinto una ugualmente forte puntata di carri armati e fanteria nemica, avanzati .fino sulle loro posizioni di artiglieria e i quali in questa azione hanno bruciato 4 autoblindo e 2 carri armati e catturato 5 mitragliatrici leggere, come pure un certo numero di prigionieri». Nell'evidente malumore del momento, dopo aver sottolineato l'estrema importanza del fronte libico nei riguardi della futura condotta della guerra, il gen. Rommel non risparmiava le sue doglianze neppure nei riguardi del proprio superiore gerarchico, secondo la linea di comando tedesca, denunciando l'incomprensione del Comando Superiore Sud, con sede in Roma, « insabbiato nelle rive del Tevere e soffocato dall'atmosfera debilitante dell'insidiosa pnmavera romana ».
Dovendo registrare, per debito di obiettività, queste manifestazioni del severo giudizio del geo. Rommel nei riguardi del nostro soldato occorre rilevare come queste valgano piuttosto a documentare l'estrema mutabilità degli umori, e quindi delle valutazioni, del Comandante del C.T.A., di fronte al variare degli aspetti, favorevoli o sfavorevoli, della situazione sul fronte di combattimento. A soli due giorni di distanza dai riferiti giudizi negativi (non riservati d'altronde alle truppe italiane: anche per le tedesche denuncia la « mancanza di addestramento» come causa delle alte perdite subite) annotava: « Durante le mie ispezioni la truppa tedesca e italiana faceva ottima impressione ». E dopo l'attacco di Tobruch, come avremo occasione di registrare in seguito, esprimeva riconoscimento alle unità italiane alle dipendenze del C .T. A .

Superfluo riesce poi mettere in evidenza la vacuità della minaccia di severe sanzioni nei rigua rdi degli italiani che, in base agli accordi a suo tempo conclusi, nel campo amministrativo e disciplinare dipendevano integralmente ed esclusivamente dal Comando Superiore italiano.
L a sit ua z ione d elle forze alla vig ilia del secondo atta cco.
E ra stato accelerato il trasferimento in Africa Settentrionale della 15a Divisione Corazzata, trasportandone alcuni elementi per \. v1a aerea.
Ciò non ostante l'unità non era ancora completa.
Il 27 aprile si aveva il segue n te schieramento:
fronte avanzato (sulle posizioni di Bardia - Ha lfaya - Sollum):
II l 62" ftr. rinforzato da una cp. cannoni da 47 l 32 e una sezione da 20 mm. (Div. « Trento»);
. elementi della rs" Divisione Corazzata tedesca:
- investimento della Piazza di T obruch : aliquote della Divisione « Brescia » (meno un btg. dislocato ancora a Derna e il Comando di divisione, a Bengasi);
. Divisione « Trento >> (meno il 7" rgt. bers., in marcia da Bengasi e il II 162° ftr .);

. D ivisio ne « Ariete>> (meno due btg. carri rimasti indietro, fra Soluch e Agedabia e mezzo btg. carri lascia to in Sirtica);
. 5" Divisio ne Leggera tedesca;
- Sirtica:
. Divisione « Pavia >>; Divisione « Bologna >> (meno un btg. inviato avanti, a Barce);
. mezzo btg. carri dell' « Ari ete»;
Tr i politania:
. Divisione « Sabratha » (a Homs);
. Divisione « Savona >> (a Garian);
- campo trincerato di T ripoli:
. elementi della Guardia alla Frontiera (3400 u.) con 32 batterie, rinforzati con 7 btg. ftr., un btg. mitraglieri e 6 btr.
In questa situazione si organizzava la seconda operazione per la conquista di Tobruch.
Tra il 28 e il 30 reparti della Divisione « Trento >>, con il Comando del 62° rgt. ftr., in sosta a occidente di Acroma, venivano destinati alle posizioni avanzate di Bardia e Sollum, in sostituzione di elementi della rs"' Divisione Corazzata tedesca che erano chiamati a prender posto nel dispositivo di investimento della Piazza. Altri reparti della « Trento >> con il Comando della Divisione e il Comando del 6r o rgt. ftr., già in linea sul fronte ovest di Tobruch, cedevano il proprio settore a truppe tedesche e si trasferivano sul fronte orientale della cintura d'investimento dove frattanto si era schierato il 7" rgt. bers. Nella giornata del 30 il Comando del 6r o rgt. ftr. con
il I btg. rinforzato da una cp. del DLI btg. mitraglieri e una sezione da 20 rom. era stato fatto proseguire fino alla zona di Gambut, con co mpito di sorveglianza di quel campo di aviazione e di riserva, pronto a intervenire così nel settore orientale di Tobruch come in quello di Bardia - Sollum.
Parall ela mente si portava avanti con la massima intensità la preparazione logistica, sfruttando fino all'estremo limite di rendimento tutti gli automezzi disponibili per il trasporto delle necessarie dotazioni di munizioni, carburante, viveri ed acqua. Il ghibli, spesso imperversante in qu elle giornate, aumentava le difficoltà e il disagio per le truppe, ostacolando il fluido sviluppo dell'operazione che comunque, ad onta degli attacchi aerei avversari lungo l'unica via di comunicazione, alla data stabilita poteva dirsi sostanzialmente compiuta.
Lo schieramento delle forze aeree era stato inizialmente concepito in funzione del possesso di Tobruch: le attrezzature di alcuni campi arr etrati disarmati erano state trattenute a Derna, in attesa di poter disporre di campi avanzati. In relazione alla resistenza della piazzaforte si era dovuto procedere alla revisione dei piani e alla fine di aprile lo schieramento delle forze aeree italo- tedesche era il seguen te (r):

Comando 5" Squadra Aerea a Bengasi:
I75"' squadriglia da ricognizione strategica: I sezione a Berka, I sezione a Castel Benito;
- comando tattico Divisione « Pegaso » a Derna: 53o gruppo bomb. terr., a Misurata, 98o gruppo bomb. terr., a Berka, 236" squadr. bomb. terr., a Derna, 27" gruppo bomb. terr., a Derna, 2 ° gruppo caccia terr., a D erna, I8• gruppo caccia terr., a Berka (2 squadr.), Hon (r squadr.),
151 ° gruppo caccia terr., a Sorinan (2 squadr.), Mellaha (1 squadr.),
(r) Gen. di S.A. GIUSEPPE SANTORO : <<L'Aeronau tica italiana nella seconda guerra mondiale », Ed. ESSE, Milano 1957, vol. II, pag. 75·I55" gruppo caccta terr., a Derna, 274" squadr. caccia terr., a Castel Benito, 19" squadr. bomb. terr., a Castel Benito, II5n squadr. oss. aerea, ad Ain el Gazala, 129.. squadr. oss. aerea, a Castel Benito, 145" squadr. ricogn. mar., a Tri poli (idroscalo);
Flieger Fi.ihrer Afrika a Derna: 2 gruppi « Stukas », 1 squadriglia caccia- bomb. Me. uo, a Derna, I squad rigli a ricognizione Ju 88, a Derna, I squadriglia caccia Me 109, ad Ain el Gazala.
In base alle notizie in possesso del nostro servizio informazioni, alla data del 29 aprile la situazione delle forze britanniche in Cirenaica e in Egitto risultava essere la seguente:
- guarnigione di Tobruch: due divisioni, più altre forze imprecisate non indivisionate (1);
- fronte di Sollum: 2" Divisione Corazzata (2);
- Deserto Occidentale: forze equivalenti a quattro divisioni, di cui una corazzata, più i presidi di Siwa, Sitra e Baharia, valutati complessivamente a una divisione;
- zona del Delta: da 5 a 6 divisioni, delle quali m età in corso di riorganizzazione;
- zona del Canale: contingenti pari a una divisione; più forze egiziane;
(r) In data 26 aprile il S.l.M. aveva precisato che fra le truppe del presidio del campo trincerato di T obr uch vi erano la 9"' Divisione austral iana, elementi della 6.. e t· Divisione australiana e il rS • lancieri, inquadrato nella III Brigata indiana.
(2) Da un documento nemico caduto in no stro possesso risultava che a metà marzo la 2" Div. Cr. era su due brigate: la l e la If! (la I Brigata però, come si è visto, era parzialmente sbarcata in Grecia il 7 marzo).

Tra i repart i inquadrati nella 2• Div. Cr. risultavano: il 4" Queen's Own Hussars, il r• King Dragoon Guards, i reggimenti carri 3" e s•, il I btg. del rgt. Tower Hamlct Rifles, il 2° rgt. art., il 102° reparto art. c.a. e amicarro su 3 cp., la 115" btr. c.a., il 142" reparto pionieri, collegamenti e se rvizi vari.
Al termine dell'offensiva in Cirenaica la 7"' Div. Cr. era stata ritira ta nel Delta: verso la fine di aprile, data la situa zione creata dall'avanzata delle forze italo- tedesche, l'unità era in corso di affluenza nel Deserto Occidentale.
- in affluenza dalla madre patria, via Capo: 25- 30.000 uomini. Segnalati partiti da Capetown 15.000 uomi ni; da Port Suda forze pari a una divisione.
Queste cifre risulta no in generale largamente approssimate per eccesso ma rimane tuttavia che, alla vigilia del nuovo attacco, la Piazza di T o br uch si presentava più fo rte di quanto non fosse all'atto della battaglia del 13- 17 aprile. Indipendentemente dalla consistenza numerica della guarnigione, le sue difese erano state rafforzate, specie con campi minati, ed era giunto via mare un carico di carri « I » , insieme a circa 5000 tonnellate di rifornimenti.
Il seco nd o att acco d i Tob ru ch: 30 apr ile- 2 maggi o 1941.
A partire dal 28 aprile il gen. Rommel aveva ordinato l'esec uzione dì azioni dimostrati ve su larga scala, tendenti a trarre in inganno l'avversario.
Tali azioni dovevano effettuarsi:
- a Tobruch, nei settori della 5.. Divisione Leggera e della << Trento », con le forze delle rispettive divisioni;
- nella zona di Bardia- Sollum - Ca puzzo, con le forze di un « Gruppo H erff » appositamente costituito (allegato n. 1 5) (1).
Erano in particolare prescritte le seguenti misu re per ingenerare nell'avversar io l 'i m pressio ne dell'attacco : intensifìcazione del traffico delle comu nicazioni dei se ttori <<S treich >> (2) ed « H erff >>; forte sollevamento di polvere dietro il fronte, per simulare intenso movimento di automezzi; effettivi spostamenti di truppe e carreggio sulla Balbia e sulle piste parallele per Bardia e Capuzzo; oste n tato movimento di carri in punti diversi; visibili concentramenti di automezzi, intensa attività di ricognizio n e e di pattuglie; largo impiego di segnali luminosi durante la notte (ad eccezione dei razzi rossi, riservati alla segn alazione dì un reale attacco nemico); fuoco di di-
(1) Il gruppo di combattim ento agli ordini del col. Il crff era costituito dal 3° reparto esplorante tedesco rinforzato con pochi carri armati e due batteri e di artiglieria e da reparti italiani (un btg. della Div. « Tre nto li, rinforzato da una btr da 20 mm. c una cp. cannoni da 47 / 32; la <<colonna Montemurro >> s u due cp. bers., una btr. da 75 / 27, sei pezzi da 47 /3 2 e du e mitragli ere da 20 mm.; un gr. da I0) / 28) .
(2) Il gen . Streich era ii Comandante della 5" Divi sione Legge ra.
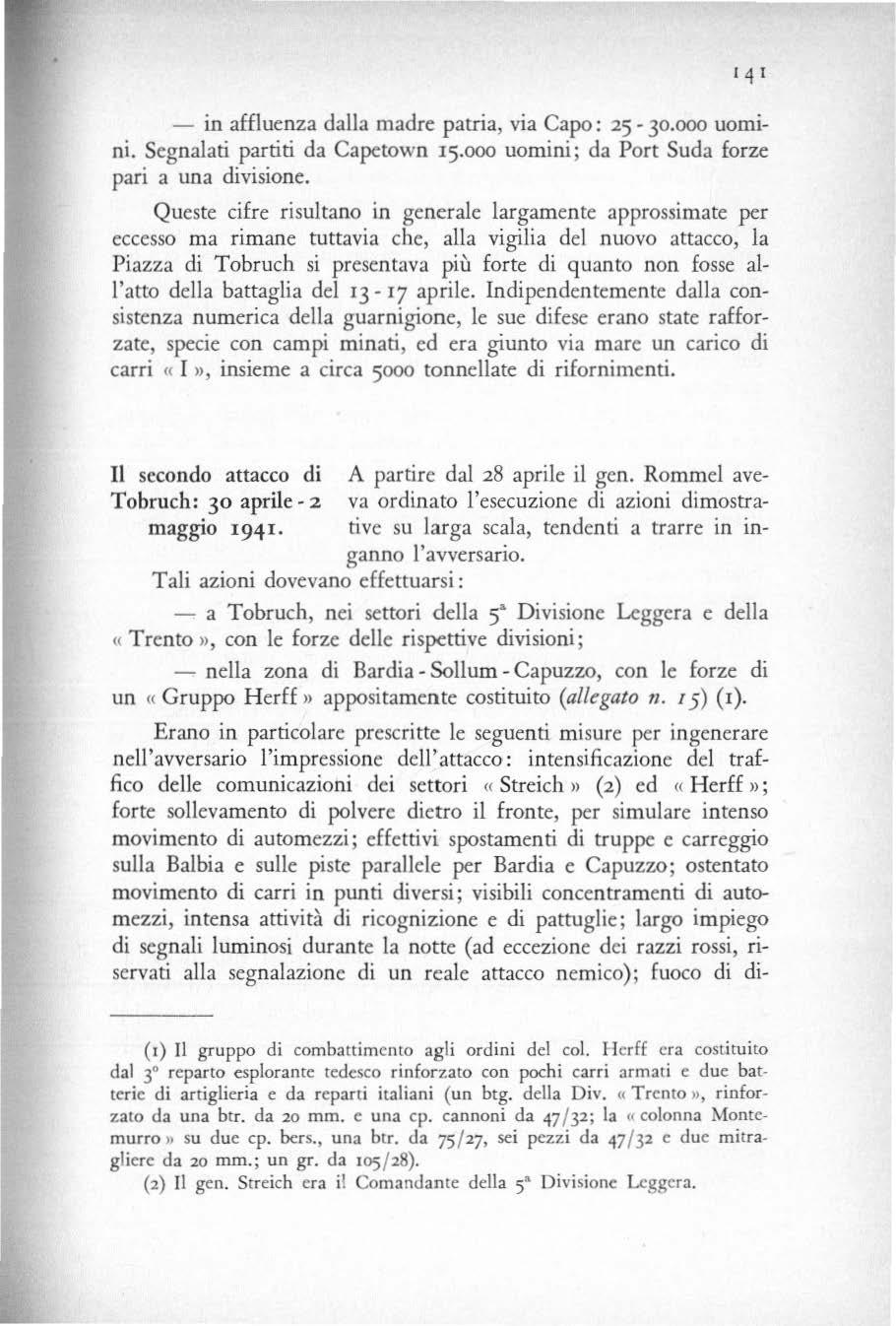
sturbo delle artiglierie; intenso movimento di atterraggio e decollo di aerei «cicogna», di recente assegnazione.
All'impiego dell'aviazione nei settori della 5• Divisione L eggera e della « Trento >> dovevano corrispondere mi sure dimostrative in grande stile, come movimento di fanteria delle prime linee, di automezzi sul rovescio delle posizioni, avanzata di carri, e così via. Sul piano esecutivo queste direttive si risolvevano in una intensa attività di pattuglie, colpi di mano notturni, azioni di fuoco d'artiglieria, vistoso movimento di automezzi, intensificazione del traffico radio e dell'attività di volo, con ritmo crescente, dal giorno 28 alla notte sul 30 aprile.
Sul fronte di Sollum si attuava no invece reali puntate offensive, co n il concoro dell'aviazione, spingendosi verso Sidi el Barrani e Sidi Suleiman, affrontando vivaci combattimenti con elementi corazzati nemici, specie nella zona a nord di Sollum. La sera del 29 l'avversario lanciava un forte contrattacco di autoblindo, sostenute da artiglieria, riuscendo ad impadronirsi di Sidi Suleiman: ne veniva ricacciato il mattino successivo da un nostro ritorno controffensivo.
L 'o rdine di operazione per l'attacco e relativo piano cronologico (schizzo n. IJ - allegati 11. 16, 17 e r8) stabilivano che l'azione avesse inizio alle ore 19,30 del 30 aprile. Obiettivo della prima giornata era lo sfondamento della cintura fortificata in corrispondenza del caposaldo di Ras el M edau uar; il mattin o successivo l'attacco avrebbe dovuto proseguire con direttrice Giaida- Pilastrino- Tobruch. L'azione di sfondamento era affidata a due gruppi di combattimento tedeschi:
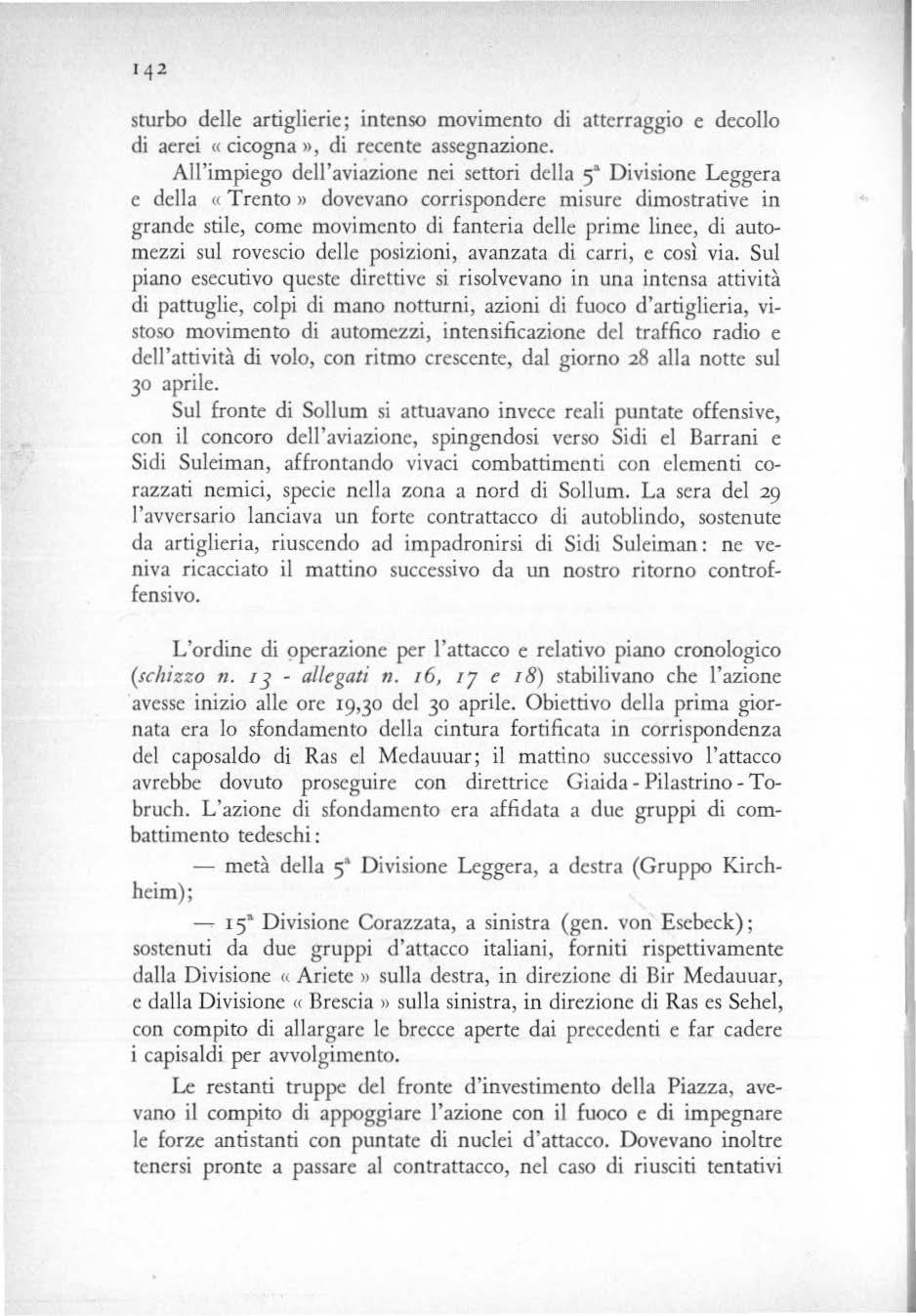
- metà d ella s• Divisione Leggera, a destra (Gruppo Kirchh eim);
-I s· D ivisione Corazzata, a sinistra (gen. von E se beck); sostenuti da due gruppi d'attacco italiani, forniti rispettivamente dalla Divisione « Ariete » sulla destra, in direzione di Bir Medauuar, e dalla Divisione « Brescia >> s ulla sinistra, in direzione di Ras es Sehel, con compito di allargare le brecce aperte dai precedenti e far cadere i capisaldi per avvolgimento.
Le restanti truppe del fronte d'investimento della Piazza, avevano il compito di appoggiare l'azione co n il fuoco e di impegnare le forze antistanti con puntate di nuclei d 'attacco. Dovevano inoltre tenersi pronte a passare al co ntrattacco, nel caso di riu sciti tentativi
di rottura da parte di forze avversarie, ovvero a partecipare allo sfruttamento del successo con forze mobili.
Alle ore 18,30 era previsto l'intervento degli Stukas sulle posizioni di Ras el Medauuar e in corrispondenza dei punti di irruzione dei gruppi d'attacco. Alle 19 doveva scatenarsi il tiro delle artiglierie, contemporaneamente allo scatto dell'operazione di rottura. Doveva quindi seguire l'allargamento delle brecce e il consolidamento delle posizioni raggiunte. Nella notte doveva poi aver luogo lo spostamento in avanti dell'artiglieria, per scaglioni, in vista della prosecuzione dell'attacco all'alba del I 0 maggio, con nuovo intervento di Stukas sulle posizioni arretrate e azione di caccia e caccia- bombardieri sulle riserve avversarie.
L'attacco partiva secondo il piano prestabilito. La cintura fortificata veniva superata per una profondità di circa 3 chilometri, la q. 209 di Ras el Medauuar occupata alle ore 2I ,30. L'avversario continuava tuttavia a difendere strenuamente i centri di resistenza, anche dopo che le opere erano state sorpassate dall ' attaccante. Durante la notte cercava anche di sviluppare dei contrattacchi di carri armati, sostenuti da vivace fuoco di artiglieria, tutti respinti. Nell'intera giornata del I 0 maggio si svolgevano accaniti combattimenti per tentare di allargare la breccia.

Alle ore 2>30 muovevano i reparti della « Brescia», nell'oscurità, con obiettivo le opere S 9 e S I I. Alle 7 avevano raggiunto la linea fra q. I52, q. 151 e q. 173, alquanto spostata sulla destra . Effettuata dai guastatori l'apertura dei varchi nel reticolato, riuscivano ad occupare l'opera S 7 e si avvicinavano alla S 9, mentre la compagnia assaltatori e i reparti di sostegno appoggiavano i Tedeschi che procedevano all'attacco delle opere S 3 ed S 5·
Attraverso la breccia aperta in direzione di Ras el Medauuar, entrava in azione nel pomeriggio un gruppo di combattimento dell' «.Ariete » e conquistava le opere R 7 ed R 9·
Nel settore orientale, la sera del 30 un gruppo d'assalto della Divisione « Trento >> aveva .cercato di penetrare nelle posizioni dell'Dadi ez Zeitun, in corrispondenza della q . IIJ, ma era stato fermato dal nutrito fuoco della difesa. All'alba del I 0 maggio un altro gruppo d'assalto, raggiunta q. 95, muoveva verso q. n4 ma veniva ugualmente fermato per l'intera giornata da violenta reazione di armi automatiche e di artiglieria sulle posizioni raggiunte.
Il nemico procedeva a numerosi contrattacchi. Il mattino del I 0 maggio aveva compiuto senza risultato delle puntate di carri ar-
ma ti; nel pomeriggio aveva organizzato un energico contrattacco sull 'intero fronte di sfondamento, con reparti di carri e fanteria, sostenuti. da fuoco di artiglieria terrestre e navale. Anche questa reaz10ne nusc1va vana.
Nel corso della giornata, resa più dura da forte sollevame nto di sabbia, la penetrazione si era potuta allargare fino ad un'ampiezza di circa 5 km. (fra Ras el Medauuar e Bir Medauuar) per 3- 4 km. di profondità. Al successo aveva portato un notevole contributo l'aviazione, attaccando per cinque volte le posizioni arretrate della difesa, con particolare ricerca delle riserve: alm eno due btg. nemici ve nivano giudicati distrutti. Nei vari combattim enti erano stati catturati complessivamente 6 ufficiali e 26g uomini di truppa.
Nella notte sul 2 si attenuavano i contrattacchi nemici, mentre si manteneva vigoroso il fuoco di artiglieria. Riconoscendo che la resistenza era da con siderare ancora efficiente, soprattutto in fatto di artiglieria, venivano diramati gli ordini per l a prosecuzione dell'attacco (allegato 11. r9) che comportavano una diversa ripartizione del fronte e stabilivano che l'azione offensiva dovesse essere sviluppata là dove si presentassero condizioni favorevoli. Il fronte di attacco doveva essere allargato dovunque il nemico desse segni di cedimento, sui due lati della breccia, in m odo da creare un sistema continuo dall' R n per q. 177 (1,5 km. sud di Giaida)- est di q. 173 (2 km. ovest di Giaida)- q. 159 (2,5 km. nord- ovest di Giaida) fino alle opere S 8- S 9· In ogni tratto di posizione occ upato le truppe dovevano interrarsi al più presto e sistemarsi a difesa, così da ridurre al minimo le perdite.
Su tutti gli altri fronti estra nei allo svolgimento dell'atta cco dovevano essere co n tinuate le mi sure dimostrative intese a trarre in inganno l'avversario. Si raccomandava particolarmente di far risultare la presenza di carri armati anche in tutti i pu n ti in cui non era previsto il loro impiego.
I nuovi ordini equivalevano in sostanza ad introdurre un tempo di arresto nello svil uppo dell'operazione offensiva, per dar tem po all 'o rga nizzazione del dispositivo rivelato si n ecessario per tacitare le difese messe in atto dal n emico sul fian co della cinta fortificata, in corrispond enza dell'Dadi Sehel e per fiaccarne ulteriormente la resistenza co n una più efficace azio ne distruttrice, da affidare prevalentemente all'ar m a aerea, sulle opere e sull'artiglieria. Si voleva attendere inoltre l'afflusso pe r via aerea di reparti tedeschi del genio, già richiesti a Berlino, particolarmente equipaggiati e addestra ti per l'espugnazione delle opere fortificate, m entre int anto si provvedeva
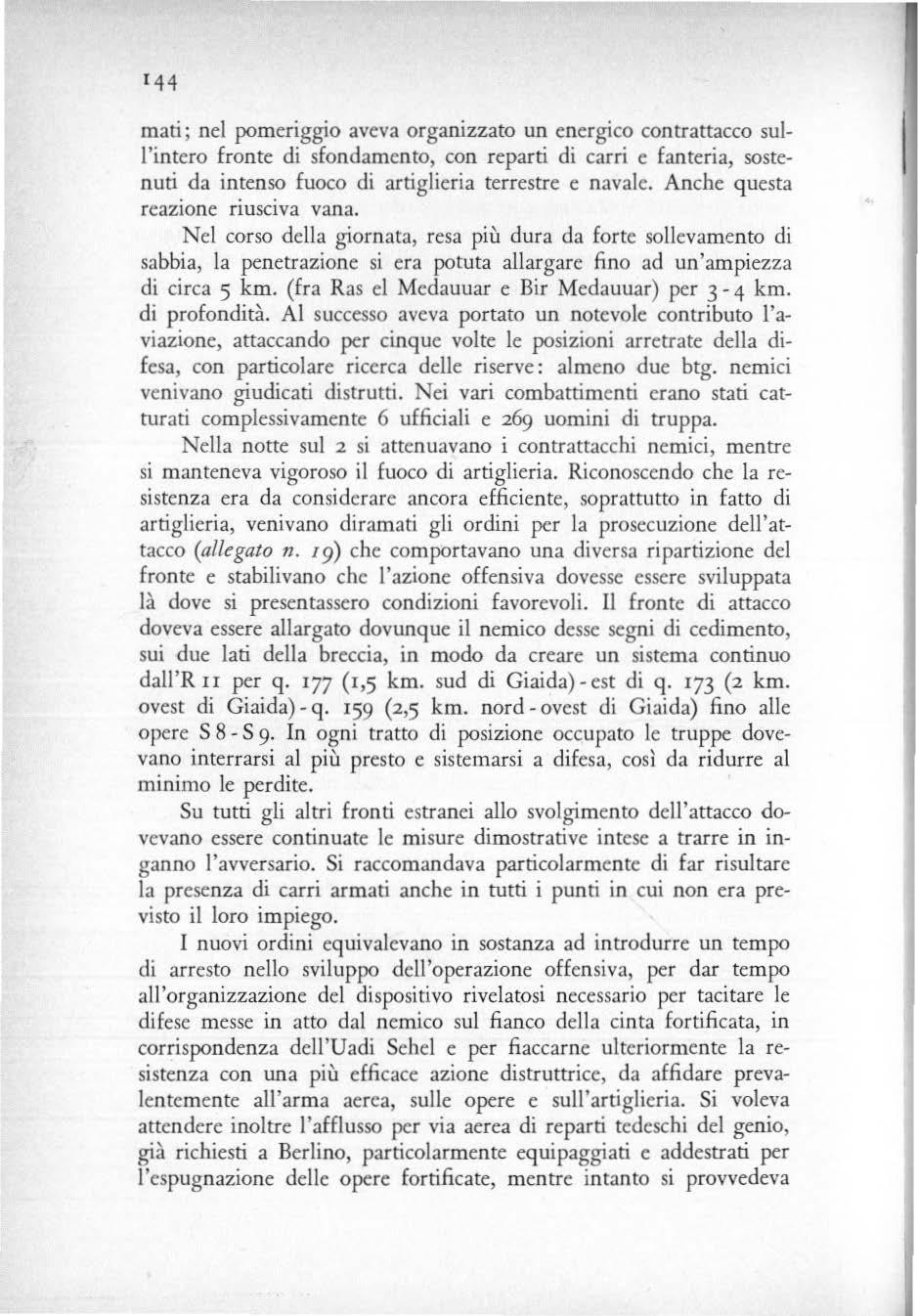
al riordinam ento delle unità (1) ed al miglioramento dei rifornimenti.

Nella realtà la sosta era destinata a protrarsi indefinitivamente e, in sos tanza , segnava la fine del secondo tentativo di conquista di Tobruch.
Contrattacchi britan- Dopo le operazioni svoltesi fra il 30 aprile nici e az io n e d i nostri grupp i d'assalto: 2-18 maggio 194 x.
e il 2 maggio, che erano riuscite appena ad intaccare la prima linea avversaria, la nostr a azione risultava limitata ad un vigile investimento della Piazza, mentre le conq uistate posizioni di Ra s el Medauuar, di scarsa profondità, restavano soggette alla continua repressione dell'artiglieria britannica.
Alla strenua resistenza della guarnigione della Piazza, sempre vigile e pronta a reagire ad ogni tentativo di forzamento, la difesa inglese aveva aggiunto continue azioni di disturbo e tentativi di aggiramento in forze contro le nostre esposte posizioni di co nfine ed incessanti offese aero- navali contro le basi di rifornimento di T ripoli e di Bengasi e sul nostro schieramento, mentre si andava sempre più inten sificando l'offesa contro le linee marittime di rifornimento dalla madrepatria.
In particolare, nel tardo pomeriggio del giorno 2 l'avversario lanciava a Tobruch numerosi co ntrattacchi di carri armati, tutti senza risultato, in corrispondenza della falla da noi aperta nella cinta fortificata. Il successivo giorno 3, alle 21, dopo vigorosa preparazione d'artiglieria anche di grosso calib ro (probabilmente canno ni navali), il nemico attaccava decisamente in corrispondenza del centro del fronte di irruzione, co n preponderanza di forze verso l'ala si ni stra della rs• Divisione Corazzata tedesca e con formazioni prevalentemente corazzate anche verso l'ala sinistra del tratto tenuto dalla Divisione « Ariete» . L'attacco riusciva a guadagnare ci rca un c hilom e-
(1) Tn seguito alle gravi perdite subite ed alla sottrazione della colonna Montemurro, la Divisione << Ariet e >l , sul fronte del Gruppo << Kir chheim u, e ra ridotta a 2 cp. bers., 3 btr. da 75/27, 50 carri L e lanciafia mm e, 15 pezzi da 37 e 8 pezzi da 47·
L:t colonna Santamaria era ridotta a 5 nuclei (armati ciascuno di 2 mtr. e 2 fuciloni ingl esi da 17 mm.), 3 pezzi da 47 e r pezzo da 20 mm., 1 btr. da 75/27 in via di riordinamen to .
tro ma gli elementi organizzati a difesa sull'ala destra resistevano valorosamente e quando all'alba giungeva sul posto un reparto guastatori tedeschi, inviato dì rinforzo, la minaccia era stata praticamente già parata (r). Prendendo lo spunto da questo combattimento, ., il 6 maggio il ge n. Rommel indirizzava il seguente proclama alle truppe (2):
C.T., il 6 maggio 1941

Sento il dovere di esprimere il m io alto riconoscimento a tutti gli appartenenti delle unità italiane alle dipendenze del C.T.A. per il loro rendimento dimostrato durante l'attacco alla linea fortificata dalla piazzaforte di Tobruch.
Voi tutti avete agito in modo straordinario, nelle ore più diffi.ci li, fianco a fianco ai vostri camerati tedeschi per i quali è onore aiutarvi nella riconquista della Cirenaica. In duri e tenaci combattimenti senza pari, su terreno difficilissimo si è riusciti a rompere la linea fortificata ed a tenere le posizioni conquistate, nonostante i quotidiani ripetutti contrattacchi degli Inglesi. Il mio particolare ringraziamento e riconoscimento ai valorosi appartenenti della Divisione «Ariete» che con un eccezionale combattimento difensivo il giorno 3 maggio hanno reso vana qualsiasi avanzata del nemico ed hanno mantenuto nelle loro mani le opere conquistate il giorno precedente.
E' onore e gioia per me di esprimere questo riconoscimento. Con m e concorderanno tutti i camerati italiani in armi, nella volon-
(r) Dal 30 aprile al 4 maggio sul fronte di Tobruch le tr uppe italo - tedesche avevano subito le seguenti perdite:
(2) Il testo viene qui riportato nella versione italiana curata dallo stesso Comando del C.T.A.
tà di non sostare nel vincere il nemico, fino alla distruzione completa. Noi vinceremo il nemico dovunque lo incontreremo.
Prego di darne conoscenza a tutti i componenti della Divisione. Rommel
Nei giorni 5 e 7 maggio l'avversario ripeteva, senza successo, l'attacco in zona Giaida ed eseguiva una puntata locale a sud della stessa località. Il mattino del 13 tentava ancora una ricognizione in forze sul fronte della Divisione « Trento», in corrispondenza della strada costiera e a nord di questa, presso Sidi Daud: la Divisione respingeva l'attacco condotto con l'appoggio di carri armati e ancora una volta il gen. Rommel era sollecito ad esprimere all'Unità italiana il proprio riconoscimento (r ) :
ORDINE DEL GroRNo DEL CoRPo N. 8

1 5-5- 1 941
« Riconoscimento. Nelle ore mattutine del 13-5 la Divisione « Trento >> respinse un forte attacco inglese, condotto con l' appoggio di carri armati, avente lo scopo di spezzare l'accerchiamento.
<< Dei 15 carri armati 6 vennero immobilizzati e parte degli equipaggi catturati.
« Esprimo alla Divisione « Trento » e specialmente agli ufficiali, sottufficiali e soldati che con eccezionale valore e sangue freddo respinsero l'attacco, il mio più pieno riconoscimento »
In data 8 e 9 maggio il gen. Rommel aveva dato ordine alle D ivisioni « Brescia», « Ariete», 15"' Corazzata e Gruppo di Combattimento Kirchheim di organizzare degli attacchi da effettuare nelle prossime notti con adeguati « gruppi d'assalto» contro opere e caposaldi nemici. L'ordine veniva eseguito nella notte sul r6, men-
(r) Non sembri eccessivo questo frequente riferimento a riconoscimenti ufficiali del contributo italiano nello sviluppo delle operazioni. Come si è accennato nella Prefazione, la presen te Monografia si propone, nel rigoroso rispetto della verità, di contribuire alla demolizione di una valutazione pressoché nulla, quando non addirittura negativa, dell'apporto italiano alla campagna nord- africana, largamente diffusa, guerra durante, dalla propaganda nemica (ed anche alleata) e successivamente ripresa un poco dovunque, in sede storiografica. Si intende inoltre contrapporre i numerosi · riconoscimenti della capacità e del valore del soldato italiano da parte del gen. Rommel alle sue non poche annotazioni di senso contrario, scritte in momenti di depressione o di cattivo umore, nell'alterna vicenda degli eventi di cui egli ebbe la ventura di essere il grande protagonista.
tre sul . fronte di Sollum la situazione si presentava piuttosto fluida, in seguito ad un attacco sferrato dall'avversario la mattina del rs.
La Divisione << Brescia » lanciava all'assalto tre gruppi, composti di guastatori e fanti, rispettivamente contro le opere Su, S I3 .. ed S IS del caposaldo di Ras es Sehel. Aperti i varchi nei reticolati, i gruppi passavano oltre, ma venivano àd incappare nell'intenso fu oco delle armi automatiche delle opere stesse, mentre elementi dislocati in profondità passavano all'immediato contrassalto. Sottoposti a dure perdite, non tutti i superstiti riuscivano a ritrovar e i varchi per ripi egare sulla base di partenza (I).
La Divisione « Ariete» a sua volta mandava all'assalto due gruppi, contro le opere R 9 del caposaldo di Bir el Medauuar e R II di Bir el Giasc . I gruppi, composti di guastatori e bersaglieri, giunti a una ventina di metri dal reticolato incappavano in una fascia di mine a strappo che, esplodendo, davano l'allarme. Mancata la sorpresa non era più possibile procedere all'apertura dei varchi e i gruppi dovevano rinunciare all'impresa.
Le azioni del Gruppo Kirchheim contro le opere R 8 e R I I e della Divisione Corazzata contro il caposaldo A 22, presso la q. 159, e contro le: opere S 8, S 9 e S Io, fruttavano soltanto l'occupazione della S IO nella quale venivano catturati una ventina di uomini, con 4 ufficiali.
L'indomani 17, il nemico reagiva, verso la mezzanotte, con un assalto nei pressi di Bir Scerif e un contrattacco condotto da un battaglione rinforzato con carri armati e batterie a nord di Ras el Medauuar, entrambi stroncati dalla reazione dell'artiglieria.

Lontano dalla zona avanzata, sul Gebel Cirenaica, nella prima quindicina di maggio la situazione generale presentava ancora aspetti di insicurezza. Era stata accertata fra gli arabi la presenza di militari nemici, fra cui qualche nucleo di una certa consistenza. Il 12 maggio un'azione di rastrellamento a sud- est di Mechili dava luogo a l:ln combattimento nel corso del quale veniva catturata una . radio trasmittente.
(1) Perdite: morti i 3 ufficiali comandanti dei gruppi di assalto; feriti 17 sottuffìciali e truppa; dispersi 63 sottufficiali e truppa (la maggior parte dei quali verosimilmente morti e fe riti, rimasti en tro le lin ce nemiche).
CONTRO LE POSIZIONI DI HALF AY A- SOLLUM- CAPUZZO
(Operazione « Brevity >>: 15 - 18 maggio 1941)

Terreno e apprestamenti difensivi. (Schizzo n. 14).
A 120 km. da Tobruch, al margine del deserto marmarico, una siepe di filo spinato ( 1) segnava il confine fra la Libi a e l'Egitto. Ancorato a nord al campo trincerato di Bardia, il reticolato si snodava in direzione sud per circa 270 km, avvolgendo la ridotta Capuzzo, Sidi Ornar, la ridotta Maddalena, B. el Garn el Grein, fino a raggiungere l'oasi di Giarabub.
Ad oriente della frontiera una scarpata di circa 200 m. corre da Sollum Alta in direzione sud -est per circa 6o km., degradando bruscamente a o ri ente su l Deserto Occidentale egiziano . A Sollum il terreno precipita bruscamente sul mare, nell'ampia baia di Sollum, ove giace il piccolo villaggio di Sollum Bassa.
L'im pervia scarpata poteva essere percorsa dagli automezzi solo in tre punti: a Sollum, al Passo Halfaya (2), e ad est di Bir Sofafi. I primi due erano attraversati da buone rotabili, nei pressi del terzo passava una discreta autopista che raggiungeva Bug Bug.
A sud e ad ovest della sca rp ata il terreno è genera lmente percorribile ad ogni specie di automezzi; tra la scarpata e il mare il movimento si presenta più difficile per gli automezz i non cingolati.
(1) Era stata costruita nel 1931, per ordine del gen. Graziani, al fine di ostacolare l'ingresso in Libia di carovane e singoli elementi che, come agenti del Senussi rifugiatisi in Egitto, tentavano di penetrare nel nostro territorio per fomentarvi la ribellion e.
(2) La denominazione di « Passo Halfaya », entrata nell'uso comune, è impropria in quanto non si trana di un colle ma di una incisione nell'orlo dell'altopiano, in corrispondenza della testata di uno degli uadi che scendono al mare.
La rotabile costiera si svi lup pav a sul ciglione, dapprima lungo speroni degradanti a l mare, quindi attrav erso la dett a incisione.
La siepe di filo spinato, strappata e insabbiata in molti punti, non aveva altro valore che quello di una materiale delimitazione di fronti era ed era quotidianamente attraversata dalle nostre autoblinde che, davanti a Sidi Suleiman e Sidi Ornar, provvedevano alla sicurezza del fronte avanzato.
La Piazza di Bar dia aveva una duplice serie dì piccole ridotte: si trattava in sostanza di un campo trincerato, costituito da opere in scavo, prive di copertura, cinto lungo il perimetro da un ordine discontinuo di reticolato e da un fosso anticarro incompleto (r).
La ridotta Capuzzo, estremo presidio italiano della fascia costiera del territorio libico, aveva le caratteristiche delle fortificazioni desertiche per guarnigioni di frontiera .
Era fronte ggiata da Sollum , in territorio egiziano, a 12 km. di distanza, di analoga consistenza ma fornita di più ampie case rme e più spaziosi depositi.
In previsione dell'eventualità che un successo ingle se contro il nostro schieramento avanzato potesse indurci ad abbandonare l'assedio di Tobruch, il Comando del C.T.A. aveva ricono sci uto una posizione arretrata che nel m ese di maggio era già in via di allestimento, con forze di lavoro messe a disposizione dal Comando Superiore italiano.
Si componeva, questa, di una linea avanzata e di una posizione principale.
La prima era individuata dai segue nti punti: 4 km. est di q. 201 (12 km . ovest di Acroma)- q. 159- q. 40- q. 22 cd aveva la funzione fondamentale di assicurare il tempo per la regolare occupazione della posizione principale.
Di fronte a un consistente attacco nemico i suoi difensori dovevano np1egare.
La posizione principale correva da q. 208 ( 19 km. sud- ovest di Ain el Gazala), per q. 183 all'uadi ad est di q. 137. Volgeva poi a nord- ovest, parallelamente alla via Balbia, lungo il ciglione, e a circa 2 km. ad est di q. II6 scendeva sulla profonda baia di Ain el Gazala.
La posizione di Ain el Gazala era stata giudicata la più facilm ente difendibile, nei confronti di altre eventualmente individuabili nella Marmarica e in base a qu esto criterio era sta ta preferita.
(x) Notizie particolareggiate su ll e caratteristiche della Piazza di Bardia si trovano, insieme a quelle sulla Piazza di Tobruch, nella Monografia dell'Ufficio Storico: cc Africa Settentrionale - La prima offensiva britannica >> .

Azioni preliminari. Nella terza decade di aprile il concorso di notizie varie indicava l'affluenza verso Marsa Matruh di notevoli e materiali dalle zone arretrate del Sudan, della Palestina e del Delta, l'avviamento al confine libico di una nuova divisione corazzata, l'arrivo in Egitto di forze aeree, ricuperate dall'A.O.I. (delle quali era già sensibile l'apporto nell'intensa attività che si andava manifestando in tutto lo scacchiere). Il complesso di tali segnalazioni induceva il nostro servizio informazioni a ritenere che il Comando Britannico in Egitto si proponesse di procedere a breve scadenza all'attacco delle nostre forze in Cirenaica (r).
I sistematici bombardamenti degli impianti portuali di Tripoli, intesi evidentemente ad ostacolare le nostre operazioni di sbarco, e l'intensificata attività offensiva nel Canale di Sicilia contro il nostro traffico marittimo con la Libia si intonavano perfettamente a questa ipotesi.
All'alba dell'8 maggio i Britannici compivano replicate puntate in forze, da est e da ovest, contro le nostre posizioni del settor e di Sollum.
Eravamo costretti ad abbandonare l'occupazione di Suleiman e Sidi Ornar, ma a sera rimanevamo padroni della linea q. 206- q. 194 (di Halfaya)- Sollum.

L'indomani i combattimenti erano ostacolati dall'imperversare del ghibli ma tuttavia il contrattacco di nostre forze mobili consentiva di rioccupare le posizioni perdute .
A mezzogiorno del IO risultava che il nemico si era ritirato con il grosso su Der el Hamra, lasciando elementi avanzati lungo la costa, a nord di q. 189 (20 km. sud- est di Sollum).
Il giorno II si sviluppava una nostra puntata offensiva, tendente all'aggiramento di reparti che risultavano in ripiegamento verso Sidi el Barrani. L'azione si spingeva fino all'altezza di Bir Habata, sul ciglione, e raggiungeva con qualche elemento anche la pianura sottostante. Risultato: un carro armato e una batteria di artiglieria catturati; distrutti due autoblinde, due pezzi semoventi e diversi automezzi.
(r) Il 26 april e il S.l.M. telegrafa da Roma al Comando Superiore I taliano
A.S.: << Ambi enti britannici Egitto confermano prossima controffensiva britannica accompagnata da sbarco rinforzi Tobruch. Secondo notizie non contro!late sarebbe in corso trasferimento Deserto Occidentale di reparti blindati, oltre alla 7n Divisione Corazzata e in viaggio, via mare, notevoli contingenti indiani, diretti Marsa Matruh aut Tobruch. Circa 500 autocarri sarebbero giunti Suez et avvia ti via Cairo verso Deserto Occidentale >>
Direttive del gen. Ro mmel e del gen. Wavell per l a condotta delle operazioni alla frontie-
Lo stesso giorno II, in occasione di un rapporto ai comandanti di divisione, così prospettava il gen . Rommel la situazio n e sul fronte di Bardia- Sollum: « L'attività avra eg iziana. versaria su questo fronte è aumentata n egli ultimi giorni ma tutti gli attacchi sono stati sempre respinti, costringendo il n emico a ripiegare per riordinarsi e rifornirsi, in conseguenza delle gravi perdite subìte. Probabi lmente gli attacchi si ripeteranno da parte dell'avversario, il quale continuerà ad agire su questo fronte per tentare con un'azione dall'esterno, da est verso ovest, di risolve re la grave situazione degli assediati di Tobruch.
« D a parte n ostra i provvedimenti necessari per rintuzzare tali attacchi sono stati già presi con l'i nv io anche di notevoli rinforzi tedeschi ed italiani.
(( Attualmente, fra Bardia e Sollum, le nostre forze ammo ntano in totale a ci rca una divisione e sono ben sistemate in posizioni favorevoli. Di co nseguenza il nemico, per affrontarle, dovrebbe disporre di almeno tre divisioni. Pertanto la situazione complessivamente può ritenersi buona, fintanto che l'avversario si mantiene nei limiti di forza suddetti e non riceve rinforzi con i quali aggirare le n ostre posizio n i.
(( Da parte nostra la condotta della guerra sarà come per il passato improntata a schi etta difensiva manovrata e cioè con puntate offe n sive dovunque e se mpre, quando possibile. In caso di attacco, l' avversario sarà fatto avanzare per poi colpirlo, specialmente in corrispondenza del fianco.
cc Per guanto riguarda l'avversario, sono da tenere presenti le difficoltà di cui esso soffre per ricevere rifornimenti attraverso la vasta zona desertica » .
F in dal primo m aggio il ge n. Wavell, a sua volta, aveva dato istruzione al nu ovo com anda n te della For za del D eserto Occidental e, gen. Sir Noel Beresdorf- Peirse, di preparare un 'operazio ne offensiva, non appena le co ndi zio ni delle sue forz e corazzate lo conse nti ssero . Con i ca rri in arrivo dalla rnadrepatria e con quelli riparati n ell e o ffi ci ne d'Egitto, egli spe rava di poter ricostituire la t Divisione Corazzata per la fine di m aggio e di essere quindi in grado ai primi di giug n o di riprendere l'iniziativa per un'azione intesa a conqu istare mom entan eamente la Cirenaica, almeno fi n o a Tobruch. Verso la metà di maggio, prima ancora che potessero essere sbarcati i rinforzi giunti ad Al essandria dal R egn o Unito, sembrava
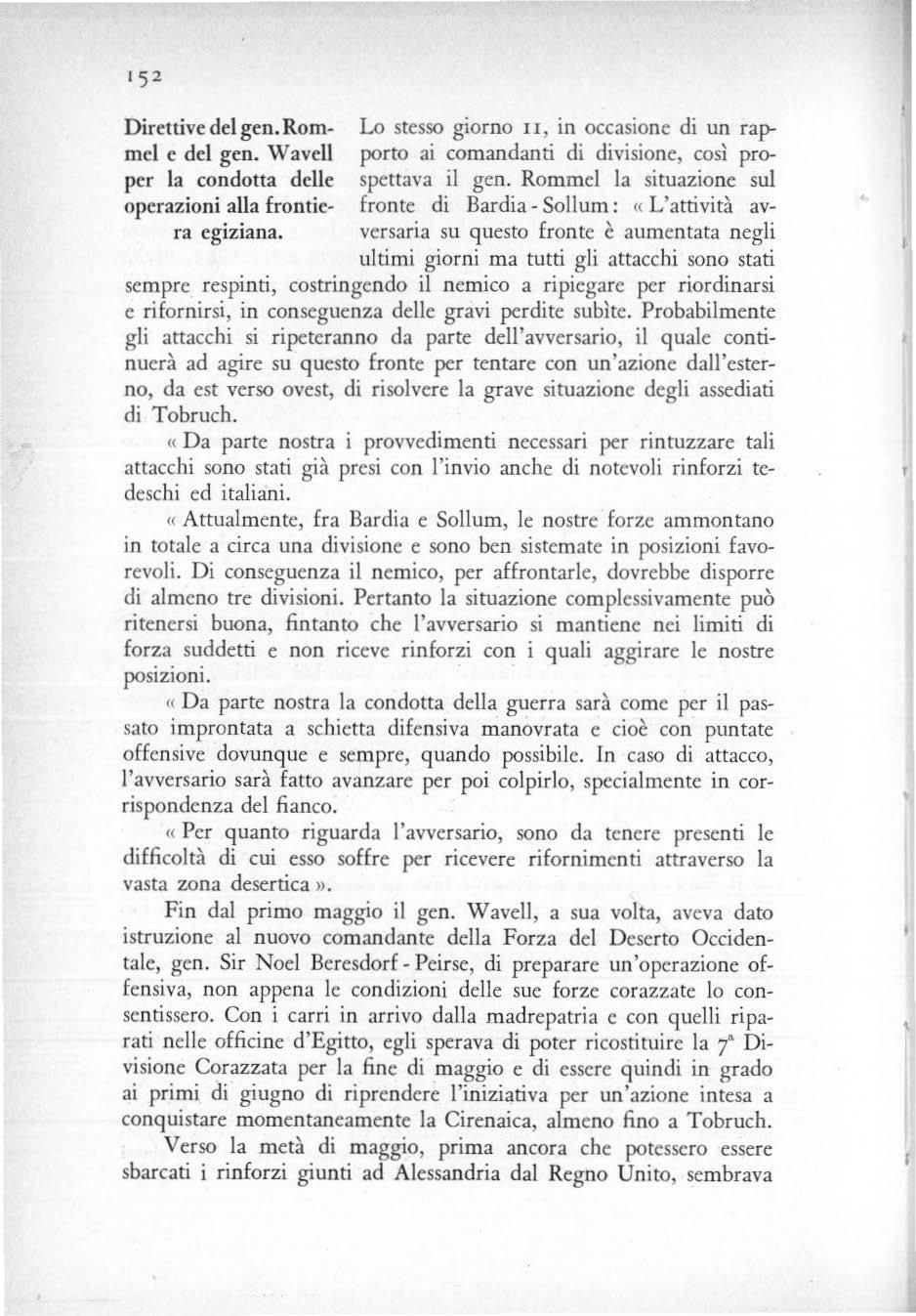
però manifestarsi una fugace opportunità di attaccare in condizioni favorevoli le nostre forze avanzate presso il confine egiziano, nella zona di Sollum: il servizio informazioni britannico aveva infatti segnalato che le nostre forze corazzate in linea in quel settore erano scarse e si trovavano in difficoltà di rifornimenti Il gen. W avell ne fu indotto a decidere di lanciare senz'altro un attacco ad obiettivo limitato, con i carri di cui disponeva (circa 30 « Cruiser » e 25 « I ») (1), per assicurarsi una buona base di partenza per una successiva operazione di maggiore portata, da iniziare non appena avrebbe potuto disporre di forze adeguate.
Il 13 maggio comunicava i propri propositi al Primo Ministro:

« Senza attendere "Tiger" (2) ho ordinato a tutti i carri armati disponibili di unirsi alle forze di Gott (3) per attaccare il nemico nella zona di Sollum. L 'azione dovrebbe aver luogo fra uno o due giorni; ritengo che Gott sia in grado di affrontare le truppe nemiche di prima linea. Nel caso che l'attacco fosse coronato da successo noi piglieremmo immediatamente in considerazione un'operazione combinata delle forze di Gott e d ella guarnigione di Tobruch, per cacciare il nemico ad ovest d ella piazzaforte. Potrà esse re ne cessari o aspettare una parte del " Tiger " per farlo. Tuttavia so no ansi oso di agire al più presto possibile, prima che il nemi co ab bia potuto ricevere rinforzi ».
L e fo r ze con tr appo ste il 15 mag g io. (Schi zzi n. 14 e n. r 5).
L'interdipendenza delle due poslztoni, per l'investimento di Tobruch e per la difesa avanzata alla frontiera egiziana era ben presente al pensiero del Comando del C.T. A. In funzione delle caratteri stiche delle forze disponibili, si trattava di affidare alle uni t à non motorizzate la r esponsabilità dell'investim ento di T obruch e il presidio degli ele m enti fortificati della posizione avanzata, dalla Piazza di Bardia alle varie ridotte di co n fine,
(1) Relazione gen. Wavcll.
(2) Come già riferito « Tiger » era la sigla attribuita al co nvoglio che attr:JV erso il Mediterraneo av eva raggiunto Alessandria il 12 maggio. Si traltava ora di addestrare gli equipaggi cui sarebbero stati distribuiti i carri: il gen. Wavell contava che sarebbero stat i pronti per l'impiego alla fine d el mese.
(3) Il gen. Gott comandava il Gruppo di Sostegno della Divisione Corazzata, riorganizzato e rinforzato, già a co ntatto con le nostr e truppe nel settore di Sollum.
per riservare alle truppe mobili la possibilità dell'intervento manovrato sull'uno e sull'altro fronte.
Alla metà di maggio, annota il gen. Rommel (1), «il nostro schieramento rispondeva assai poco a queste esigenze. Il fronte di Sollum non era occupato dalla fanter ia in tutta la sua estensione, solo alcuni leggeri gruppi di combattimento vi tenevano una specie di posto avanzato». Con attacco di sorpresa il gruppo Herff era riuscito ad impossessarsi del Passo di H alfaya.
Alla data del 15 maggio lo schieramento d elle forze itala- tedesche era il seguente:
- sulla posiziotz( di confine (settore Bardia- Sollum): gruppo Herff così composto:
.
3° gruppo esplorante tedesco, rinforzato con alcuni carri armati e due batterie di artiglieria; aliquota della Divisione « Trento » : I I6I 0 rgt. ftr. rinforzato da una cp. mtr. e Il l62" rgt. ftr. rinforzato da una cp. cann. da 47 l 32 e una sez. da 20 mm.;
. raggruppamento Montemurro su due cp. 8" rgt. bers., una btr. da 75 l 27, 6 pezzi da 47 132 e due mitragliere da 20 mm.;
. un gr. da IOSI28 del 24o rgt· art.;
- sul fronte di Ì1westimento di Tobru ch :
. Divisione « Brescia »;
15"' Divisione Corazzata tedesca;
. Divisione « Ariete » ;
.
.
5.. Division e Leggera tedesca, rinforzata dal Gruppo Santamaria;
D ivisione « Trento », con : t rgt. bers., 11 161° rgt. ftr. , due cp. da 47 l 32 e 46° rgt. art. nel settore orientale; c p. comando reggimentale, un pl. mtr. c due scz. da 20 mm. a Gambut.
-a Derna:
. D ivisione « Bologna >>;
-a Gialo:
. colonna celere Silvestri.
(t) RoMMEL: « Guerra senza odio )) , Garzanti ed., 1952, pag. 47·

La situazione e la dislocazione particolareggiata sono riportate sullo schizzo n. -q. All.
Le forze britanniche risultavano così distribuite:
- Piazza di Tobruch: 9" Divisione australiana, resti della III Brigata Corazzata e truppe di Corpo d'Armata. In totale: 14 btg. di fanteria, I btg. mtr., 4 cp. anticarro, 6 rgt. artiglieria, 20 ( ?) autoblinde, 6o ( ?) carri;
- Settore di Sollum: 3 brigate miste con un totale di 6 btg. di fanteria motorizzati, 4 cp. anticarro, r rgt. autoblinde, 3 o 4 btg. carri, I o 2 rgt. artiglieria;
- tra Marsa Matruh e Alessandria: · t Divisione Corazzata, tre divisioni di fanteria (fra cui la 4a indiana);
- Oasi di Siwa e Baharìa : forze pari a una divisione;
- Zona del Delta: forze pari a 5-6 divisioni, di cui solo la metà di pronto impiego;
- Zona del Canale: contingenti britannici ed egiziani, pari ad una divisione.
Erano inoltre segnalate in affluenza da I a 2 divisioni dall'Inghilterra, per la rotta del Capo, e forze pari a una divisione dal Sudan.
La presunta situazione delle forze britanniche è riportata nello schizzo n. I 5).
L'operazion e « Brevity >>. (Schizzo n. 16 ).
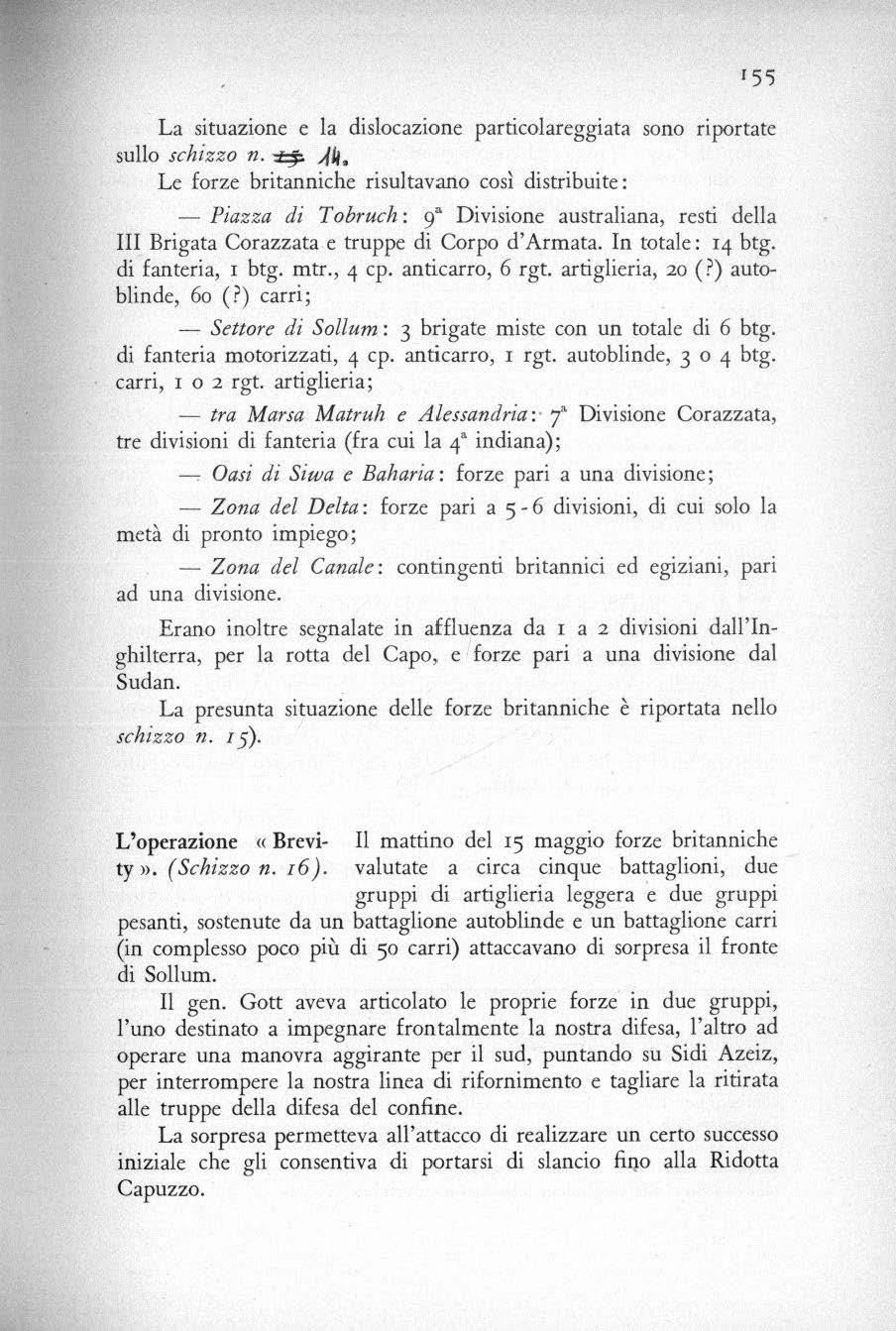
Il mattino del rs maggio forze britanniche valutate a circa cinque battaglioni, due gruppi di artiglieria leggera e due gruppi pesanti, sostenute da un battaglione autobli n de e un battaglione carri (i n complesso poco più di so carri) attaccavan o di sorpresa il fronte di Sollum.
Il gen . Gott aveva articolato le proprie forze in due gruppi, l' uno destinato a impegnare frontalmente la nostra difesa, l'altro ad operare una manovra aggirante per il sud, puntando su Sidi Azeiz, per interrompere la nostra linea di rifornimento e tagliare la ritirata alle truppe della difesa del confine.
L a sorpresa permetteva all'attacco di realizzare un certo successo i niziale che gli consentiva di portarsi di slancio fì.Qo alla Ridotta C apuzzo.
Il Raggruppamento Montemurro, schierato sulle posizioni avanzate dal Passo H alfaya al mar e, riu sciva a contenere, presso Capuzzo, due attacchi di fanteria sostenuti dai carri. La ridotta, temporaneamente perduta, veniva rioccupata alle 14 dal contrattacco di una colonna moto- corazzata tedesca, condotto da nord- ovest. I superstiti reparti del R aggruppamento Montemurro ripi egava no allora, in seguito ad ordine, in direzione di Bardia per occupare posizioni intorno a quella Piazza, allo scopo di rendere disponibili forze mobili tedesche per la difesa manovrata.
Il gen . Rommel ritirava intanto alcuni elementi dal fronte di T obruch e ordinava all 'Bo rgt. corazzato della 15.. Divisione, rinforzato da una batteria da 88, di portarsi per el Adem a Sidi AzeizCapuzzo, a sostegno del Gruppo H erff.
La lotta si protraeva nel pomeriggio con alterna vicenda. Alle 18 il nemico riusciva ad occupare Sollum, mentr e il presidio della q. r86 (ovest di Sollum) continuava a tener fermo fino al sopraggiungere dell'oscurità per forzare quindi l'accerchiamento e aprirsi una via verso il nord.
A sera l'avversario sferrava un nuovo attacco, da sud e da sudovest contro la linea Sidi Azeiz- Ridotta Capuzzo. Con duri combattimenti su tutto il fronte (presso Azeiz contro forze corazza te) la linea Bardia- Az eiz (esclusa) poteva essere mantenuta . Una compagnia tedesca rinforzata da quattro plotoni cannoni dell'B o rgt bersaglieri, accerchiata a Passo Halfaya dai carri britannici, riusciva a mantenere la posizione per tutta la g iorn ata; un altro reparto co ntinuav a a resistere presso Suleiman (1).
Il modesto successo iniziale era stato pagato dall'avversario a caro prezzo: numero si carri erano andati distrutti nel corso dei combattimenti. Il ge n. R ommel intendeva contrattaccare l'indomani in direzione di Azeiz, ed oltre questo obiettivo, allo scopo di ristabilire co m pleta mente la situazione. Nel bollettino della sera del 15 pro-
( 1) Sul valoroso comportamento delle truppe italiane nella critica giornata del 15 maggio si hanno le seguenti testimon ian ze : Ordine del giorno del Com:! ndo Gruppo col. von Herff della 15"' Divisione Corazzata: « Z.O., il 17 maggio 1941: E spr imo il mio più alto elogio ai reparti Montemurro dell'8° reggimento bersaglieri, ai miei ordini, per il valore dimostrato durante i gravi combauimenri del 15 maggio c.a. Ufficiali e truppa hanno tenuto le posizioni, impegnandosi fino all'ultimo. Il reparto preposto alla difesa della pianura di Passo Halfaya ba resistito con !conino coraggio fino all'ultimo uomo contro prcponderami forze nemiche. La maggior parte di essi si è immolata, fedele alla bandiera. Sia reso onore alla loro memoria! ... ».

spettava tuttavia come ineluttabile l'abbandono dell'assedio di Tobruch qualora il contrattacco non fosse riuscito.
L a reazione otteneva invece pieno successo: raggiunta fin dal mattino del r6 la zona a sud di Capuzzo, già alle 14 la colonna poteva rioccupare Sollum e spingersi verso sera fino a Sidi Suleiman, che era sempre rimasto in mano nostra. Era successo che il generale Gott, considerata ormai fallita l'azione del nucleo aggirante (minacciato a sua volta sul fianco dalla colonna messa tempestivamente in moto da Rommel) aveva spo ntan eamente desistito dall'attacco e si era ritirato verso il sud, lasciando deboli presidi nei punti occupati nel corso dei combattimenti del giorno precedente. L'indom ani ripiegava senz'altro sulle basi di partenza. L'operazione « Brevity » era finita.
Considerata ormai superata la crisi, il gen . Rommel provvedeva alle opportune mi sure per il consolidamento dello schieramento. Inviava pertanto nel settore avanzato tutte le forze disponibili della 15" Divisione Corazzata non assolutamente indispensabili per l'investim ento di Tobruch . Disponeva lo spos tam ento del 2 ° rgt. art. celere, con due gruppi, a Bardia mentre l'altro gruppo rimaneva a cl Adero, insiem e all'VIII btg. carri M 13, per guardare le provenienze dal T righ Capuzzo e da Bir el Gobi. Chiedeva infine al Comando Superior e italiano il sollecito invio nella zona di Tobruch dei mezzi di fuoco (artiglierie, pezzi anticarro, mitragliere da 20 mm.) della Divisione « Pavia».
Nella notte sul 17 e nel corso della giornata successiva riusciva a ristabilir e completamente e consolidare la situazione n ella zona Sollum- Capuzzo, occupando anche Sollum Bassa, mentre eleme nti esploranti manten eva no il contatto con gli elementi n em ici rimasti a Sidi Ornar, Sidi Suleiman e q. 194, ad ovest di Halfa ya che veniva raggiunta il giorno I8. n Comandante della rs" Divisione Corazzata che doveva seguire con altre forze e assumere il comando del fronte est, veniva ferito davanti a Tobruch prima ancora dì poter eseguire l'ordine (r).
(1) Le perdite delle truppe italian e e tedesche dal 13 al 16 maggio erano state le seguenti:
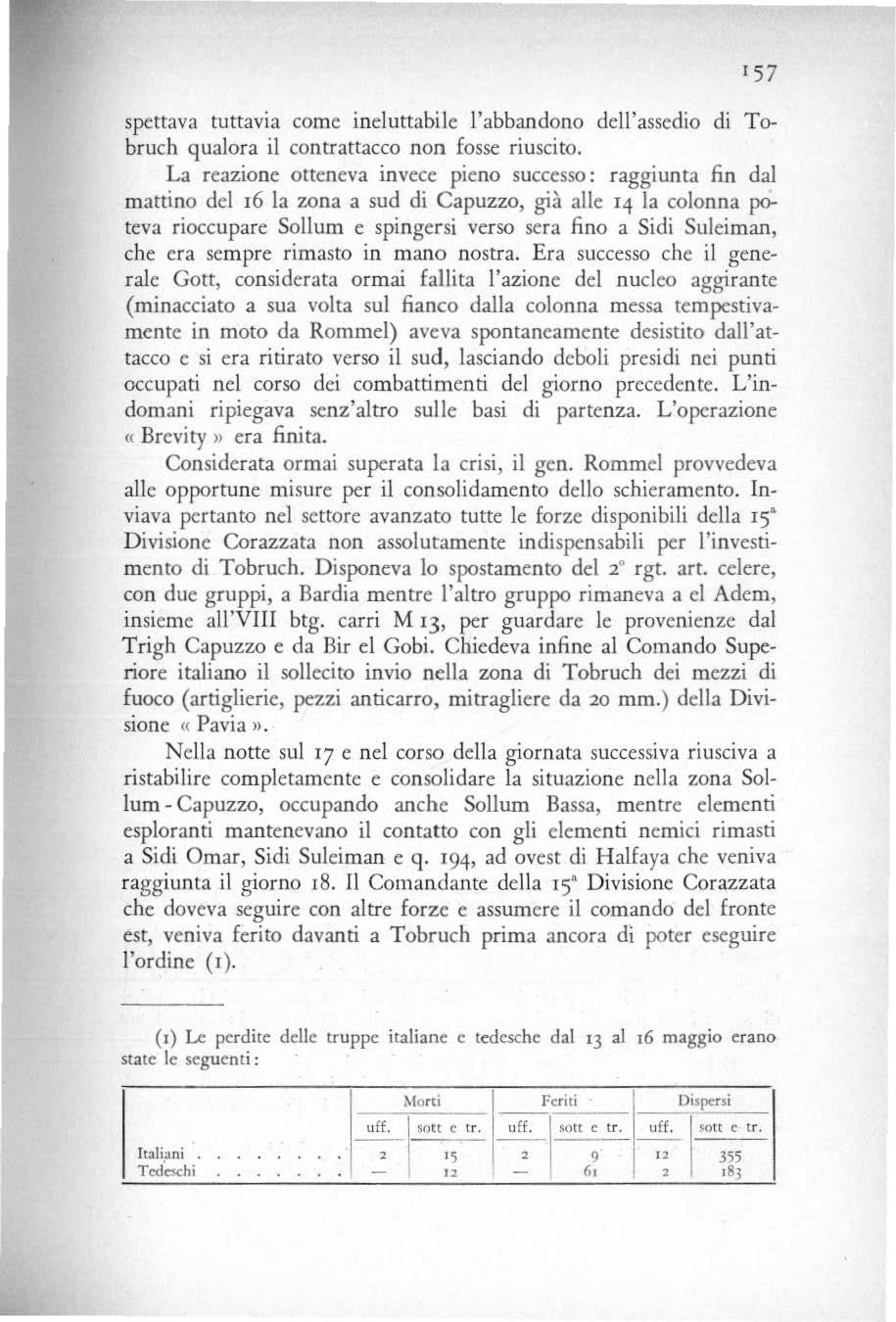
Lo stesso gwrno il gen. Wavell doveva comumcare al Primo Ministro:
« Il nemi co si è dimostrato più forte di quanto pensassimo e ci Ila costretti sulla difensiva fino a quando n on entreranno in azione i " Tigrotti ". Ciò non avverrà prima della fine del mese; sarebbe anzi meglio se essi potessero disporre di un periodo ancora maggiore per ambientarsi, ma questo dipenderà dalla situazione. Il nemico sta raccogliendo forze nelle posizioni avanzate e potrà tentare ulteriori avanzate».
Otto giorni più tardi, infatti, un'azione condotta congiuntamente da forze italiane e tedesche tendeva ad impadronirsi con manovra aggirante da sud, per Sidi Suleiman, delle posizioni dell'Halfaya, sulle quali il nemico andava fortificandosi. Il passo e l'intero Uadi Halfaya venivano in nostro possesso. L'avversario, completamente eliminato dal ciglione, si ritirava con i grossi ad oltre 40 km. da Sollum, all'altezza del meridiano di Bug Bug (r).
La posizione dell'Halfaya ci assicurava lo sbocco nella sottostante costiera del Deserto Occidentale egiziano e, mentre costituiva un prezioso eleme nto in caso di offensiva, rappresentava nello stesso tempo un serio ostacolo ad eventuali ritorni controffe nsivi dell'avversario, come si sarebbe verificato appunto nella futura battaglia di Sollum, promossa dagli Inglesi il rs giugno sotto il nome di « Battleaxe ».
Non si hanno notizie dirette delle perdite dell'avversario ma in una lettera del Primo Ministro Churchill al gen. Wavell in data 17 maggio 1941 si legge: << I risultati dell'azione ci sembrano soddisfacenti. Senza impiegare i "Tigroui" (intendeva riferirsi ai carri trasportati con il convoglio "Tiger", giunti il 1 2 maggio ad Alessandria) siete passaro all'offensiva, avete avanzato di 50 km. occupato Halfaya e Sollum, catturato 500 prigionieri tedeschi e inflitto al nemico gravi perdite in uomini e mezzi co razzati. Per tutto questo la perdita di 20 carri del tipo "I" e di 1000 o rsoo uomini non mi sembra affatto un prezzo troppo elevato »

(z) Nel corso dell'azione erano state inflitte al nemico sensibili perdite: catrurati 62 prigionieri (di cui 4 ufficiali), 9 pezzi (di cui 4 efficienti), 7 carri armati Mark Il (di cui 3 efficienti), 2 mezzi corazzati, diverse armi anticarro c numeroso altro materiale.
Nostre perdite: 4 morti (sottufficiali e truppa}; 17 feriti (2 ufficiali c 15 sottuffi ciali e truppa di cui 2 italiani); 1 ufficiale italiano disperso.
P o t enzi amento delle Il 19 maggio il gen. Cavallero rientrava deforze. finitivamente dall'Albania ed assumeva in pieno le proprie funzioni di Capo di Stato Maggiore Generale. Il 24 maggio il geo. Guzzoni veniva esonerato, a domanda, dalla carica di Sottocapo di S.M.G. (che rimaneva vacante) e da qu ella di Sottosegretario alla Guerra, nella quale veniva sostituito dal gen. Squero.

Era stato convenuto un poderoso piano di potenziamento delle forze per l'A.S., alla cui realizzazione si stava provvedendo con il m assimo impegno.
Era previ sta la presenza in A. S. di:
- I Comando Superiore, con truppe e servizi di Armata, cm veniva affidato il comando di tutte le truppe operanti in Cirenaica;
- I Comando di Armata (5•) con truppe e servizi, per le tr uppe della Tripolitania;
- 3 Comandi di Corpo d'Armata mobili (2 italiani, I tedesco), con relative truppe suppletive e servizi;
- 2 Comandi di Corpo d'Armata di occupazione, con relative truppe suppletive e servizi;
- 5 Divisioni Corazzate (3 italiane, 2 tedesche);
- 7 Divisioni Motorizzate, tipo A.S.;
- 4 Divisioni di occupazione.
I provvedimenti conseguenti a tale programma comportavano :
a) il riordinamento in A.S. di:
- truppe e servizi di armata per le forze della Cirenaica, per la s• Armata e per l'Intendenza;
- truppe e servizi per i Corpi d'Armata mobili X e XX;
- Divisione Corazzata « Ariete », Divisioni Motorizzate « Pavia », « Bologna », « Brescia » , « Savona >>, « Trento >> , Divisione di occupazione « Sabratha >>;
b) l'invio dalla madrepatria di:
- truppe, servizi e mezzi per il completamento delle citate unità;
- artiglieria per la difesa contraerea territoriale e per la difesa costiera;
c) la costituzione ne lla madrepatria e l'invio di:
- 2 Corpi d'Armata di occupazione (comandi, truppe e servizi);
___,. Divisioni Corazzate « Littorio » e « Centauro >>, Divivisioni Motorizzate « Trieste » e « Piave >> .
Complessivamente, la completa attuazione del ptano di potenziamento richiedeva l'invio in A.S. di:
100.000 UOmilll, 14.000 automezzi e carri armati, 4.000 motomezzi, 8so pezzi.
Il grado di realizzazione dei provvedimenti 10 questione alla fine di maggio era il seguente:

a) in seguito ad accordi intercorsi fra il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e il Comando Superiore A.S. il riordinamento delle unità già prese nti in Africa era già in corso. Di prossima emanazione direttive particolareggiate per il riordinametno delle artiglierie di C.A. e contraeree;
b) pronti per il trasferimento (o quanto meno ordinato l'approntamento) unità e mezzi occorrenti per il completamento di:
- truppe e servizi dell'Arm ata della Cirenaica e dell'Intendenza (compreso I autoraggruppamento pesante e 2 parchi automobilistici);
- truppe e servizi per il X Corpo d'Armata (compreso 1 autogruppo);
-Divisione Corazzata « Ariete » e Divisio ni Motorizzate << Pavia», « Bologna>>, « Trento>> e « Trieste >> .
14 batterie c . a. da 75 e da 20 mm. per la difesa c.a. territoriale;
r gruppo da I'j2 /37 per la difesa costiera.
Si trattava in complesso di 50.000 uom1ru, 5.ooo automezzi, 1.500 motomezzi e 425 pezzi;
c) restava da provvedere all'approntamento dei reparti e dei mezzi per :
__,. il completamento del XX Corpo d'Armata, delle Divisioni Motorizzate « Savona >> e « Brescia » e della Divisione di occupazione « Sabratha », tutte già presenti in Africa Settentrionale: complessivamente 5.000 uomini, 2.000 automezzi, 500 motomezzi;

- le grandi unità o reparti da inviare completi dal territori o:
-2 comandi, truppe c servizi di Corpo d'Arm ata dì occu pazwne;
__,. Divisioni Corazzate « Littorio » e « Centauro »;
- Divisione Motorizz.ata « Piave » ;
- Divisione di occupazione « Pistoia », più altre due, forse da costituire ex novo con elementi della Guardia alla Frontiera;
- 52 batterie c.a. da posizio ne da 75 e da 20 mm.
All'approntamento di queste ultime grandi unità n on veniva attr ibuito carattere d'urgenza, sia per il tempo che sarebbe comunque intercorso prima di poterle inviare in A.S., sia soprattutto per il tempo necessario a raggiungere la disponibilità degli automezzi e dell'armamento occorrenti ed a conseguire l'indispensabile grado di addestramento.
Per la « Centauro», attualmente dislocata in Albania, si trattava inoltre di ri entrare al più presto in sede, in Italia.
Per le divisioni corazzate era stato studiato un tipo di organizzazione più potente, rispondente al seguente schema:
- I reparto esplorante;
- 2 brigate, ciascuna su I rgt. carri M, I rgt. bers., I btg. anticarro e contraerei;
- 2 r gt. art.: uno su 2 gr. da 75 / r8 se moventi e 2 gr. da 105 / 28 e uno su 2 gr. misti da 90/53 e da 20 c.a.;
- SCrVlZl.
L'allestimento importava la disponibilità di numerosi nuovi mezzi co razzati c conseguentemente la trasformazione delle tre di-
visioni sarebbe avvenuta gradualmente. Frattanto avrebbero assunto una formazione transitoria su I rgt. carri M (o francesi di preda bellica), I rgt. carri L, 1 rgt. bersaglieri, I rgt. artiglieria (su 2 gr. da 75/27, I gr. da xoojr7, I btg. da 47), 1 gr. mi sto c.a., I btg. misto del genio, numerosi elementi dei servizi.
La divisione d'occupazione doveva risultare complessivamente costituita da 2 rgt. fanteria su 3 btg., I btg. mitraglieri, I btg. anticarro, I rgt. artiglieria (su 2 gr. da 75/27, 2 gr. da 100/17, I gr. c.a.), 1 btg. genio, servizi.
La divisione motorizzata tipo A.S. era ordinata su I cp. motociclisti, 2 rgt. ftr. (ciascuno su 2 btg. fuc. e I btg. armi controcarro ed accompagnamento), I rgt. art. (su I gruppo ob. roo /I7 oppure cn. 75/27, 2 gr. cn. 75/27, I btr. da 47/32, I gruppo mi sto c.a.), I btg. misto del Genio, I btg. armi controcarro ed accompagnamento divisiona le, servizi (con 387 motocicli, 6o autovetture, 739 autocarri di vario tipo, 84 autocarri speciali, 76 trattori, 20 ambulanze).
La prevista motorizzazione delle divi sio ni di fanteria incontrava però gravi difficoltà per la forte defìcii!nza di automezzi, giunta in Africa ad un punto veram ente critico, in quanto da tre mesi tutti i trasporti venivano utilizzati esclusivamente per l'affluenza delle unità tedesche. Si era pertanto disposto l'invio di un autoraggruppamento pesante di intendenza, completo, di un autogruppo di corpo d'armata e di un certo numero di automezzi (in cifra tonda, un migliaio) da assegnare alle Divisioni « P avia» e « Brescia» . Si era i no ltre stabilito l'invio di due parchi automobilistici (di cui uno già parzialmente arrivato) per sollecitare la riparazione in posto dei numerosi automezzi avariati (circa 2000) esistenti in A.S.
Il 26 maggio il gen. Cavallero chiedeva al ge n. Garibaldi una relazione, corredata del p roprio apprezzamento, sulla si tuazione davanti a Tobruch. Il giorno 29 lo informava che per l'organizzazione delle forze il Duce, in via di massima, era così orientato:

I 0 - disimpegnare le divisioni tede sche per costituirne, insieme ad altre forze italiane, un corpo completamente mobile;
2° - costituire un Corpo d'Armata italiano per l'assedio di Tobruch;
3" - costituire un Corpo Mobile interamente italiano;
4o - formare con i due Corpi Mobili , italiano e tedesco, una Armata Moto- Corazzata, al comando di Rommel, alle dirette dipe nd enze del Comando Superiore A.S.
Il programma doveva essere attuato gradualmente, in rapporto alle affluenze delle truppe e dei materiali dall'Italia, secondo l'ordine di precedenza indicato dallo stesso Comando Superiore A.S. (r).
La relazione del gen. Garibaldi reca la data del 30 maggio.
Dopo il fallito tentativo di impadronirsi di slancio deJla Piazza di T obruch, il successivo attacco in forze, di fronte alla superiorità dell'artiglieria avversaria, sostenuta anche dal mare, alla robusta struttura delle difese e alla difficoltà di individuarne esattamente gli elementi, era riuscito soltanto ad intaccare la prima linea. L'azione si limitava presentemente al vigile investimento mentre si procedeva ad estendere i lavori di rafforzamento, per consolidare la tenuta della cintura esterna di fronte alla eventualità di tentativi di sortite da parte degli assediati . Si provvedeva inoltre a logorare l'avversario con l'assidua pressione aerea. Contemporaneamente si procedeva al riordinamento dello schieramento, a cominciare dal ripristino dell'unità delle divisioni, districando il frammischiamento della primitiva, improvvisata distribuzione.
Le truppe tedesche, idonee al movimento, erano state inviate (ad eccezione di taluni reparti della 5" Divisione Leggera, specie anticarro, impiegati nell'investimento di Tobruch) al confine egiziano, per guardare le provenienze dall'est. Si provvedeva al rafforzamento dei capisaldi, sempre per raggiungere maggiore disponibilità di elementi mobili per la manovra.

La capacità di resistenza della Piazza era da considerare fortemente aumentata per l'incremeno che le perveniva dal mare, incremento che non trovava alcuna contropartita nel nostro schieramento. Nel le attuali condizioni di forze e di mezzi giudicava sconsigliabile un attacco di viva forza.
Limitati erano i rinforzi che pervenivano tanto alla parte italiana quanto a quella tedesca: occorreva fare affluire tutto quanto era stato preannunciato ed almeno un'altra divisione corazzata tedesca.
Scarsa era da considerare l'aviazione, in rapporto alle esigenze : era indispensabile aumentarla, sino a raggiungere la superiorità sull'avversario, soprattutto per contrastare le possibilità del rifornimento di Tobruch e proteggere nello stesso tempo i nostri rifornimenti e il riposo delle truppe, continuamente soggette agli attacchi notturni.
( r) Sullo scorcio del mese di maggio si era iniziato l'invio degli automezzi del 1° autoraggruppamento, inizio peraltro poco fortunato per la perd ita di due grossi trasporti: il Conte Rosso e il Foscarini.
Insufficiente era da consi derare il numero degli automezzi di cui il solo logorio normal e, escluse cioè le perdite per eventi bellici, non era compensato dal gettito delle riparazioni: urgeva promuoverne l'abbondante affluenza dalla madrepatria.
In conclusione:
« ... Fino a che le forze nemiche non subissero notevoli aumenti, la situazio n e può essere guardata con serenità . . . Se il nemico rinforzasse molto c con intenzioni aggressive, cd a noi arrivassero nessuno o mod es ti rinforzi, la situazio n e si potrebbe capovolgere, divenire pericolosa pe r noi , fino al punto di obbligarci a togliere l'investimento di T o bruch ... » ed a ritirarci nella zona di Ain el Gazala, che si stava oppo rtunamente organizzando.
In riferimento poi alle direttive del giorno 29 il gen. Garibaldi, mentre le riconosceva rispondenti al proprio orientamento e assicurava che in tal senso erano in corso, o in progetto, adeguati provvedimenti, osservava di non ritenere opportuno svincolare il gen. Rommel dall'investimento di Tobruch, prima di avere forze italiane sufficienti per sostituire gli elementi tedeschi che vi partecipavano, ed anche per fianch eggiare in linea generale l'azione del C.T.A. Bisog nava anche evitare il pericolo che alla prima occasione il ge n. Rommel « liberato da quella palla al piede» si lanciasse oltre i limiti del desiderabile.

Il gen. Gariboldi proponeva inoltre di mettere a disposizion e del gen. Rommel d elle divisioni, anziché un corpo d'armata, poiché in altre occasioni il comanda nte del C.T.A. aveva già detto di non gradire l'interposizione di altri comandi intermedi. Nel confermare le richieste già precedentemente inoltrate, il Comandante Superiore A.S. tornava infine a chia rire che queste si riferivano esclusivamente alla sicurezza dello scacchiere: si riservava di presentare il fabbisogno di forze e di m ezzi per eventuali operazioni di maggior portata, non appe na ultimati gli studi in corso.
Il problema dci rifor- La situazione dei rifornimenti era tutt'altro nimenti. che rassicurante, nel suo complesso. Per migliorarla sarebbe stato necessario arrivare a soddisfare integralmente le esigenze quotidian e della vita delle tru ppe (e della colonia in generale, largamente tributaria delle importazioni) e per il combattimento e provvedere inoltre ai trasporti diret-
tamcnte co nne ssi al pote nziam ento dello scacchiere, in vista delle progettate operazioni: eliminazione della P iazza di T obruch e successiva avanzata verso est.
Ricordiamo ancora una volta che la soluzione del problema dipendeva sos tanzialmente dalla sicurezza delle vie m arittime, dalla disponi bilità del tonnellaggio (i n particolare: naviglio veloce) e potenzi alità delle attrezzatur e nei porti di caricamento e di sca rico. L 'orga n izzazio n e in atto n el me se di maggio era suffi cie nte appena per far giungere, co n 50 viaggi- piroscafo, l'indispensabile per il rifornimento ordinario delle trup pe, italian e e tedesche, e della popolazio n e civile : non vi era m argine per l'invio di personale isol ato o di nuovi reparti e complem enti, i l cui piano di trasporto (1) richiedeva 200 viaggi- piroscafo, in più dei 30 effettivamente realizzabili.
Si impo n eva perta nto di intensificare il ritmo dei co nvogli e ridurre, possibilmente, le presenze inutili alla vita della colonia . Un sostanziale alleggerimento delle difficoltà sarebbe stato assicurato dalla libera disponibilità dei porti della T unisia.

Per i primi due provvedimenti erano stati interessati nell'ambito dell e rispettive specifiche competenze, lo Stato Ma ggiore M arina c il Ministero dell'Africa Italiana, m entr e ve nivano prese misure per aumentare la potenzia li tà di scarico nei po rti della Libia.
Per l'accesso ai porti tunisini erano state aperte conversazioni con la parte tedesca. Il 2 giugno s'incontravano al Brennero il Maresciallo Kcitel e il gen. Cavallero per un esam e ge n erale c d ettagliato della situazion e milit are dell'Asse. P er quanto riguarda lo scacchi ere nord - africano veniva app rofo ndita appunto la questione dell'utilizzazi o ne dei porti tunisini. I Francesi avevano concesso l'uso del porto di Biserta (an ziché di quello di Bon a, precedente m ente offerto dai Francesi stessi): la decisione risultava favorevole perc h é Biserta era armato, e quindi in condizione di difendersi, mentre n on si poteva escludere l'eventualità di attacchi inglesi, come già si era verifi cato a Sfax.
Si trattava di definire le m odalità e la data d'inizio dei trasporti . I F ran cesi avrebbero provveduto direttamente all e operazioni di scarico e di trasporto in territorio tuni sino, con relativa scorta. La concessione era limitata ai soli rifornimenti ordinari, con esclusione
(r) Alla data d el 24 magg io, come g i à ricordato, erano pronti per la partenza o si era disposto l'app rontam ento di unità c mezzi corrispondenti a un di 50.000 uomini, 5000 automezzi e 425 pezzi.
dunqu e di avvalersene per l'invio di rinforzi e di materiale . Si r avvisava l'opportunità di procedere co n estrema cautela, evitando di ricorrere alla maniera forte, in co n siderazione del ri schio di eventuali rappresa glie britann iche per i Francesi e a l pericolo di provocare la secession e delle inquiete colonie nord- africane dal Governo di Vichy, per aderire al movimento gaullista, che su l pos to godeva i ndubbiamente di num erosi fautori.
Era necessario tener presente c h e, venendo a m ancare qu esta possibilità di raddoppio del rifornimento allo scacchiere n ord- africano, ci si sarebbe trovati di fronte alla materiale impossibilità di far giu n gere in Lib ia quanto era stato programmato. A q uesto fine ci si proponeva di fruire della concessione per gradi, in vista di ottenere poi di m ano in m an o più di quanto sancito nelle co ndizioni di armistizio : all'inizio non si dovevan o avviare per Biser ta che viveri e vestiario . La concessione, inoltre, era stata formalmente con corda ta con la Germania e co nsegue ntemente i m ateria li italiani dovevano essere camuffati come tede sc hi.
L 'ordine di precedenza da osservare nella spedizio n e dci materiali doveva seguire il criterio di pote n ziare in primo tempo l'investimento di Tobruch (specie con artiglierie pesanti e a tiro curvo) per rendere al più presto possibile l'attacco decisivo e l'eliminazione della Piazza . A vrebbe ro poi segu ito munizioni, carburante e automezzi per m etterei in condizione di parare ad un eventuale ritorno offensivo britannico, non ché artiglierie contraeree e costiere per la protezione delle linee di comunicazione.
Soltanto in seguito si sarebbe passati a quella parte del programma ch e si riferiva alla futura g r ande offensiva ve rso il Canale. P er questa occorreva:
un a sufficiente m assa di manovra, da costi tuire con due divisioni corazza te tedesche, la Division e Corazzata « Ariete » e la Di vis ione Motorizzata « Tren to» (una volta provveduto al loro ripristino), integrate co n du e o tre divi sio ni mobil i di ri se rva (Divisioni Mo torizzate « Tri es te» e « Piave» e Divi sio n e Corazzata << Li ttorio »);

una forte aviazione, alla qual e avrebbe dovuto provvedere la parte italiana;
- num erose artiglierie;
- una sic ura cor rente di rifornimenti e un'adeguata scorta 10 loco di carburante e munizioni.
Nell'incontro veniva sottolineata la necessità di poter contare più sulla qualità delle divisioni e sulla specie e la quantità dell'armamento, che sul loro numero.
L'imponenza del programma di potenziamento dello scacchiere nord - africano m ette in evidenza il senso di realismo con cui erano state analizzate le condizioni indispensabili anzitutto per la sicurezza della nostra attuale occupazione e per conferire poi alle forze italotedesche la capacità offensiva indispensabile ad affrontare imprese di larga portata. Non altrettanto senso realistico sembra invece di poter ravvisare, dovendo escludere il sospetto di vero e proprio vell eitarismo intenzionale, nel proposito di soddisfare a questo imponente fabbisogno con un programma di potenziamento tanto ponderoso da poterlo difficilmente ragguagliare alle nostre concrete possibilità in fatto di armamento come pure all'effettiva disponibilità del concorso germanico in terra d'Africa, allo scoccare dell'ora z ero della grande avventura dell'operazione « Barbarossa » contro il colosso russo. Il dubbio è tanto più legittimo se si ristabilisce la corrispondenza cronologica con l'imminente decisione di Mussolini di partecipare anche noi, per pure ragioni di prestigio, con un corpo italiano (il C.S.I.R .) alla lotta mortale contro il comunismo. Anche sotto l'esclusivo punto di vista dei trasporti, d'altronde, il limitato e condizionato apporto della linea di rifornimento tunisina non sembra sufficiente a giustificare la fiducia nell'agibilità di un piano di così vasta portata.
Comunque, l'attività del Comando Supremo italiano era effettivamente indirizzata, in questo pe riodo , alle ponderose questioni co?nesse alla realizzazione dei trasporti verso l'Africa Settentrionale.

La cost ituzione di uno « Stato Maggiore Tedesco di Collegamento >> presso il Comando Superiore italiano in A.S.
Con l'arrivo dei primi reparti tedeschi agli ordin i d el gen. Rommel, nel mese di febbraio, era stato distaccato presso il Comando Superiore italiano in A.S., con funzioni di collegamento, un ufficiale superiore di S.M. del Comando C.T.A. Con l 'aumentare del contingente tedesco presente nello Scacchiere, allo scopo di raggiungere u n a più efficace forma di collaborazione, il 24 m aggio l'OKW aveva chiesto di i nserire nel nostro Comand o Superiore un proprio « Stato Maggiore di Collegamento>>:
la proposta era stata accolta dal Comando Supremo che ne dava comunicazione con il seguente dispaccio:
DISPACCIO IN PARTENZA A MEZZO TELEAVIO.
Diretto: Supercomando A.S.l.
N. 3ooor Op.
lì 1° giugno 1941
Oggetto: Capo di S.M. del Corpo Germanico presso Supercomando A.S.I.
Informo che il Duce, allo scopo di facilitare il collegamento e la collaborazione fra le forze armate italiane e tedesche, ha accolto la proposta dell'OKW di istituire un secondo Capo di Stato Maggiore del Corpo Germanico in Africa, da distaccare presso codesto Supercomando.
In particolare la missione del nuovo Capo di S.M. germanico è quella di presentare i desiderata e le richieste del Corpo tedesco a codesto Supercomando e di informare il Comandante del Corpo Germanico sulla situazione generale.

Il Capo di Stato Maggiore Generale
U go Cavallero
Il provvedimento rispondeva evidentemente al desiderio di poter esercitare maggiore c più diretta influenza all'interno del nostro Comando Superiore, allo scopo di ottenerne una più stretta e più rapida aderenza ai disegni operativi del Comandante del C.T.A.: non poteva pertanto riuscire gradito al Comandante Superiore che lo giudicava assolutamente non necessario ed anzi dannoso per l'esercizio della già difficile funzione di comando. In questo senso il gen. Gariboldi esponeva il proprio pensiero al Capo di Stato Maggiore Generale:
All'Eccellenza Cavallero
Capo di Stato Maggiore Generale
Credo mio dovere segnalare un fatto che può avere importanza notevole. Si è presentato il generale tedesco Gausc, incaricato di costituire uno Stato Maggiore di Collegamento tra me c il Comando Corpo Tedesco e il C.T.A. Si tratta di 42 ufficiali e 120 truppa.
La mole è significativa. Nessuno, né io né il gen. Rommel ha chiesto un simile organo ed anche il Comando tedesco attualmente
qui è rima sto per lo meno stupito . A me fa l'impressione sì voglia prep arare una sovrapposizione al Coma n do Superiore italiano.
Questa impressio n e è avvalorata d al contegno che in genere tengo no i T edeschi verso gli Arabi. Cercano cioè in ogni modo di ingraziarseli, quasi per far risaltare es$ere loro migliori e preferi bili agli Ita liani. Sono sfu mature m a se si tien e co nto che nella gra nde guerr a i Tedeschi erano già q ui (e gli Arabi se li ricordano con si mpati a) la supposizione si rafforza.
Inoltre il generale in viato come capo dcii 'Ufficio tedesco non sa una parola d'italiano.
Prospetto quanto sop ra esp rim en do il parere che qu esto Stato Maggiore di Collegamento no n è necessario e i nv ece pericoloso; ma ad og n i modo dovrebbe essere ridotto di numero a due ufficiali e che sappiano l'italiano; tanto più che, a malgrado di ogni buona V(r lontà, alla sede del Comando Superiore non avremmo la possibilità materiale di ospitare se no n il ge nerale capo missione e una o due persone del suo seguito al massimo.
D evoti saluti.
GaribaldiSappiamo oggi che l'inopinata iniziativa clcll'OKW era effettivamente dispiaciuta anche al gen . Rommel che evide nteme nte sco rgeva n el nuovo organo presso il Comando Superiore uno strum ento suscettibile di compromettere quella personale posizione di quasiindipendenza che si era assicura t a fin dai primi atti d ella sua gestione del comando operativo in terra di Afr ica . Annotava i nfatti, senza mezzi termini (r) : « U n giorno arrivò in Africa il gen . Gause che, accompagna to c.Ia un grande stato ma ggiore, doveva studiare e preparare le possibilità d ' impiego di maggiori co nting enti di truppe sul terr eno africano, con le quali si voleva intraprendere un'offensiva verso l'Egitto. Il ge neral e aveva bensì r icevu to d al Co mando Superiore d ella W ehr ma cht l'espressa istruzio ne di non mettersi ai miei ordi n i, ma lo fece quando io gl i affermai esplici tame nt e che il comando sulle trup pe tedesche in Africa era st ato conferito solo a m e. D opo alcune conversazioni co n le autorità italiane, C ause ebbe l'impressione che queste difficilm en te avrebbero approvato l'invio di alcune unità tedcsch,e nell 'A fri ca del Nord, pe rché temevano dì essere so verchiate » .
 RoMMEL : « Guerra senza odio >1 , Garzanti cd., 1952. pag. 46.
RoMMEL : « Guerra senza odio >1 , Garzanti cd., 1952. pag. 46.
La chiara presa di posizione del gen. Gariboldi aveva dato luogo a discussioni, richieste di chiarimento e precisazione che finirono per mettere in evidenza l'intenzione della parte germanica, fin dal suo primo giungere in terra africana, di assumere una parte sostanzialmente prcponderante nella condotta delle operazioni in quello Scacchiere. La composizione ed i compiti del nuovo Stato Maggiore di Collegamento (allegato 11. 20) era stato specificato nei particolari dal gen. von Rintelen solo dopo l'approvazione di principio della proposta tedesca da parte del Duce .
Si trattava effettivamente di un complesso di 43 ufficiali, 20 funzionari civili, 46 sottufficiali e uo uomini di truppa, con 57 automezzi : il peso di un tale organismo non poteva non destare sorpresa nell'Ufficio Operazioni del Comando Supremo, tanto più che lo stato maggiore del C.T.A. era invece molto leggero, costituito da un tenente colonnello e pochissimi ufficiali. Non si era tuttavia ravvisata una possibilità di opposizione, posto che la preventiva approvazione personale del Duce non importava limitazioni di personale.
In base ai chiarimenti verbali forniti a seguito della nota scritta dal gen. von Rintelen, veniva precisato che lo Stato Maggiore di Collegamento avrebbe dovuto trattare tutte le questioni logistiche e organiche, per alleggerire il gen. Rommel della parte relativa ai rifornimenti ed alla protezione delle comunicazioni c consentirgli di dedicarsi esclusivamente alla parte operativa, per la quale avrebbe dovuto continuare, come in passato, a far capo direttamente al Comando Superiore italiano in A. S. (allegato n. 21 )
I n quest'atmosfera non certo favorevole, di sospetto e di aperta avversione il gen. Gause, giungendo il IO giugno in Africa Settentrionale, prendeva i primi contatti e poneva mano alla costituzione e all'avviamento del nuovo organo di collegamento.
Secondo l'impressione riportata sul posto dal Capo di Stato M aggio r e dell'Esercito, ge n. Roatta, nelle linee ora ben definite delle sue funzioni, il nuovo ufficio non avrebbe dovuto produrre i ncon venienti.

( « Battlca xe » : 15 - 17 giugno 1941)
Primi indizi degli intcndimen ti offensivi del Comando bri tanfll CO. Forze co n trapposte.
Fin dai primi di giugno movimenti di truppe in Egitto e altri indizi raccolti da varie fonti di informazione facevano ritenere ai comandi italo- tedeschi che l'avversario si app re st asse a sferrare al più presto una nuova offensiva . Era sta to rilevato, in particolare, un più denso raggruppamento delle forze dislocate ad est di Sollum, l'arrivo di rinforzi e il raffittimento della rete radio.
La consistenza dello sc hieram ento britannico era valutata in 13q divisioni, di cui due cora z zate, alle quali si potevano contrapporre non più di 8 divisioni, di cui 3 co razzate (due tedesch e ed una italiana) ed r motorizzata (italiana). Nel no stro ca mpo soltanto 6 divisioni gravitavano nella zona avanzata, necessariamente frazionate fra l'investimento di Tobruch e la difesa diretta alla frontiera, m entre la Divi sio n e « Savo na >> , incompleta, si trovava ancora a Sirte e la « Bologna » era suddivisa in due aliquote, fra Bengasi ed Apollonia.
La situazione delle forze contrapposte alla data del 6 giugno è riportata n ello schizzo n. 17.
In relazione alle informazioni sugl i apprestamenti n emici, il 7 giugno il Comando Supremo (r) chi edeva l'opinione del Comando Superiore FF. AA. in A.S. sulla prevista offensiva. Ne riceveva l'indomani risposta assolutam ente rassicuran te, nel senso che non si aveva la sensazione che si potesse trattare di un 'azione di grande port ata.
L a sera del 9 il Comando del C.T.A. informava il Comando Superiore A.S. che non era stato rilevato u n ulteriore riordi n amento d e lle forze ne mic h e ad es t di Sollum. Precisava la co n sistenza del
(x) Il 6 giugno si era proceduto a d un riordinamento dello Stato Maggiore Generale ed alla sua trasformazione in <c Comando Supremo >> .

presunto aumento vcrificatosi recentemente in un comando di divisione, un comando di reggimento e un battaglione fucilieri e indicava come probabile lo spostamento di tutte le forze corazzate disponibili dalla fascia costiera all'altopiano.
Veniva disposto il passaggio della s• Divisione Leggera tedesca (che era stata disimpegnata dali 'investimento di Tobruch per passare a riposo ad ovest della Piazza) in riserva del C .T.A. , nella zona tra Acroma cd el Adem, con la massa dei carri in quest'ultima località. Veniva inoltre spostato ad est di Tobruch l 'VIII battaglione carri della Divisione « Ariete l> (l'unico efficiente), dietro alla Divisione << Trento».
La sera del 14 il gen. Rommcl aveva elementi per ritenere che l'offensiva nemica sarebbe stata sferrata il mattino successivo. In una comunicazione inviata all'OKW tramite l'ufficiale di collegamento a Roma annunciava: « Il nemico ha spinto innanzi altre forze sul suo fianco sud, verso la zona di Dar el Hamra. A mezzo radiogoniometria è stato accertato il trasferimento verso la stesso zona dello stato maggiore di una divisione e di una brigata corazzata. Sembrano possibili intenzioni di attacco per il 15 giugno ».
Alle ore 21 il gen. R ommel allarmava il fronte di Sollu m ed ordinava alla Divisione Leggera di serrar sotto.
L'imminente scontro ci trovava in condizioni di notevole inferiorità numerica nel campo dei carri armati, aggravata anche da una certa scarsezza di scorte di carburante.
Il nostro schieramento alla frontiera era il seguente:
- 15• D ivisione Corazzata tedesca (meno la XV Brigata ftr. mot.);
- un rgt. ftr. di formazione della Divisione « Trento»;
- clementi (imprecisati) della sa Divisione Leggera tedesca;
- 2 ° rgt. art. cel. (su un gr. da 75/27 ed uno da I00 / 17)·
Il grosso delle forze era sistemato nei capisaldi di Halfa ya, Capuzzo, Musaid, Sollum Alta, q. 206 a sud di Capuzzo e q. 208 di Bir Hafid, con elementi m obili esploranti sull'altopiano, verso Sidi Ornar , Scefersen e Sidi Suleiman.

La condotta della difesa era orientata sull'azione spiccatamente manov rat a da parte di truppe moto- corazzate, n egli intervalli fra i capisaldi. Di particolare importanza si presentava il caposaldo dell'Halfaya, vera chiave di volta dell'intera difesa.
La formazione dei presidi nei singoli capisaldi del settore Capuzzo- Halfa ya era• la seguente:
Caposaldo di Hal faya:
- It aliani:
una cp. e una squadra mortai da 45 del III62'' ;
. un p l. anticarro da 47 l 32; una cp minatori del genio;
. una btr. da 100l 17 del 2 ° rgt. art. cel.;
. Forza complessiva: circa 400 uomini.

Tedeschi:
un btg. ftr.;
una btr. da 88 (contraerea e anticarro); una cp. cannoni da 37 anticarro; quattro mitragliere da 20 mm.
Forza complessiva: circa 500 uomini.
Il caposaldo era stato rafforzato con lavori di fortificazione campale ed era protetto da un campo minato, esteso dal litorale al costone del Passo. Le singole opere erano munite di reticolato, non molto profondo.
Caposaldo di SolitmJ Alta e Bassa:
- Italiani:
. cp. comando, una cp. fucilieri e una squadra mortai del Il l 62o;
. un pl. anticarro da 47 l 32 .
. Forza complessiva: circa 200 uomini.
- Tedeschi:
. nessun reparto.
Nel caposaldo non era no ancora stati compiuti lavori di fortificazione, vi erano soltanto muri a secco e ripari di sacchi a terra.
Caposaldo di M usaid:
- Itali ani:
. u na cp. fucilieri e una squadra mortai del li i6 2n;
. un pl. anticarro da 47 l 32.
Forza compl essi va: circa 220 uom1m.
Tedeschi:
. nessun reparto.
Il caposaldo era rafforzato con lavori campali (piazzuole per armi automatiche).
Caposaldo di Capuzzo:
- Italiani:
. una cp. fucilieri del I / 6°.
. Forza complessiva: circa r8o uomini.
- Tedeschi: due p anticarro da 37;
. una mitragliera da 20 mm .
. Forza complessiva: circa 30 uomini.
Vi erano stati iniziati lavori di rafforzamento per i reparti t edeschi.
Caposaldo di q. 206: presidiato da reparti tedeschi di forza imprecisata.
Caposaldo di q. 208: presidiato da reparti italiani (di artiglieria) e tedeschi : tre mitr. contraeree da 20 mm.; due p. anticarro da 37 mm.; due btr. (8 p.) del 2 ° art. cel.; otto p. da 106 tedeschi.
La situazione particolareggiata delle forze italo- tedesche in Cirenaica al mattino del r5 giugno è riportata nello schizzo n. 18.
Il pia n o d 'attacco br i- Nella concezione di Churchill l'operazione tannic o. << Battleaxc >> si proponeva obiettivi ambiziosi: vittoria c< decisiva » nel Nord Africa e « distruzione>> delle forze di Rommel. Pur fiducioso nell'esito della battaglia, il gen. Wavell si limitava però ad esprimere la speranza di riuscire a « ricacciare il nemico ad ovest di Tobruch >>.
Le operazioni di sbarco dei carri inviati dal Regno Unito, giunti ad Alessandria il 12 maggio, erano risultate più lunghe e complicate di quanto si fosse previsto. Molti carri richiedevano una radicale revisione, oltre all'applicazione dei filtri per la sabbia e la pitturazione mimetica intonata all'ambiente del deserto. Non fu che nella prima settimana di giugno che tutti i carri risultarono disponibili ma a

questo punto lo stato di approntamento e di addestramento della 7"' Divi sione Corazzata inducevano il gen. Wavell a rinviare ancora l'attacco al giorno 15. Scrive in proposito n ella sua relazione:

« La lunghezza della linea delle comunicazioni (200 km. da Matruh al confine egiziano) attraverso deserto senza acqua limitò l 'ordine di grandezza delle forz e che sarebbe stato possibile impiegare.
« Il corso delle operazioni, a cavaliere della frontiera egiziana, era largamente condizionato dal ciglione che parte da Sollum e corre in direzione sud- est.
« Si tratta di uno scosce ndimento di circa 6o m., intransitabile ai carri armati e agli automezzi per circa Bo km., eccetto che a Sollum stesso e al Passo Halfa ya.
« Un'avanzata lungo la costa quindi avrebbe dovuto aprirsi la strada per uno di questi scoscesi passaggi, mentre un'avanzata a sud del ciglione comportava il pericolo di esporre la propria linea di comunicazioni ad un attacco aggirante ... ».
Il piano compilato dal Comandante della Forza del D eserto Occidentale, ten. gen. Beresford- P eirse, e approvato dal gen. Wavell, prevedeva l'attacco su tre colonne:
- colonna di destra (XI Brigata indiana, cavalieri dell'India Centrale, reparti carri c< I » , un r gt. art. leggera, una cp. gen io) : operare lungo la costa su Sollum, appoggiando la colonna di centro n ell'attacco per il possesso dell'Halfaya;
- colonna centrale (IV Bri gata Corazzata su due btg. carri « I », due rgt. art. leggera, una bLr. pes. camp., un rgt. anticarro, XXII Brigata « Guardie >>) : doveva attraversare la frontiera molto a sud di Sollum, risalire il ciglione evitando le nostre difese organizzate indi volgere a nord e impadronirsi di Musaid, Bir Waer e Capuzzo. Un suo distaccamento doveva impadronirsi di Halfa ya;
- colon11a di si11istra (t Divisione Corazzata (1) meno la I V Brigata): avanzare a sud del ciglione, a protezione del fianco sini-
(1) Sulla costituzione e le caraneristiche della 7a Divisione il gen. Wavell ha scritto: 11 La 7" D. Cr. era formata dall'n• Ussari (autoblinde), dalla VII Br. Cr. s u due rgr. carri "Cruisers", dalla IV Br. Cr. su due rgr. carri "I", da un Gruppo di Sostegno comprendente due rgt. art. da 25 libbre (88 mm.), un rgt. anticarro, un brg. ftr . mor. c dell'art. contraerea leggera. Ciasc una brigata corazza ta mancava quindi di un reggimento ma non sarebbe stato possibile portarle a pieni organici di tre reggimenti lino alla fine di giugno o ai primi di luglio. La velocità di crociera e il raggio d'azione delle due brigate
stro della colo nna di ce ntro, tenendosi pronta ad una battaglia d'incontro co n le forze corazzate avversarie.
Con l'attacco delle colonne di destra e d i centro co n tro le zon e organizzate a difesa (minacciate anche da tergo e n ei rifornimenti dalla colonna di si ni stra) il Comando bri tannico co ntava di provocare la reazion e d elle forze corazzate tede sch e che avrebbe dato lu ogo ad una battaglia di carri sia ad est del co nfin e, durante l 'attacco su Halfaya, sia anche più ad ovest, d opo l'eventuale conqu is ta di Ca puzzo .
Qualora la prima fase dell'offensiva si fosse c h iusa con la sconfitta delle forze itala- tedesche schierate al confine egiziano, il Com ando britannico avrebbe proseguito l'azione, spi ngendosi fino in prossimità di T obruch ed el Adem, co ntro le forze impegnate nell'investimento della P iazza, con il co ncorso di una vigorosa sortita di quella guarnigione.
Il gen. Wa vell faceva assegnamento sull 'effetto della prima apparizione d ci nu ovi carri pesanti Mark II (si trattava di una nuova edizio ne del carro « I )) ). Per l'appoggio aereo dell'offensiva il generale Wavell disponeva di sei gruppi caccia, quattro gruppi bombardieri m edi e quattro gruppi (meno q ualche distacc amento) di bombardieri pesanti notturni.
L'attacco fra Sollum e Sid i Ornar (15 -17 gi ugno . (Schizzo n. r9).

L'attacco si pronunciava alle o re 4,30 del 15 g iu g no , contemporan ea m ente da est, lungo il set tore costiero, da sud e da sud - es t, sull ' altopiano, investendo il no stro schiera-
erano così largamente diversi che sa rebbe stato ovviamente molto difficile manovrarle congiuntamente. I carr i armati "Cruiscrs" a'·evano una velocità di r5 - 20 miglia all'ora, cd un raggio d'azione di So- roo miglia mentre i carri armati 'T' avevano una velocità di non più di 5 miglia all'ora, ed un raggio d'azione di sole 10 miglia »
Scrive in proposito WIN STON CHURCH ILL nel vo lume <<La Germania punta a O rie nte>> de lla sua « La Seconda G u erra Mo ndi a le>> : « Il carro da fanter ia er:t un carro pesante, lento, fortemente corazzato, dest ina to ad accompagnare e ad appoggiare la fanteria. Il c arro "da crociera" ("Cr ui ser") era un carro vc!oce, meglio armato di quello da fanteria ma con corazza più sottile. Veniva impiegaw in combattimento come unità estremamente mobile. Il carro leggero era più veloce ancora, con corazza sottile e armato solo di mitragliatrici: veniva usato per la ricognizione '' ·
Per quanto riguarda le caratteristiche dei me-L.Zi corazz:lti italiani, tedeschi c britannici impiegati in A.S vedasi a/1(gato n. 22.
mento da Sollum a Sidi Ornar, su di un ' ampiezza, in linea d'aria, di circa 40 chilometri.
Le posizioni d ell' Halfaya, pur battute da intenso tiro di preparazione di artiglieria e da bombardamento aereo, resistevano validamente. Fin dalle prime ore del mattino l'avversario presentatosi immediatamente in forze con una im pone nte massa di m ezzi m ecca nizzati, seguiti da fanteria autoportata, subiva sensibili perdite. L 'azio ne dei carri pesanti ve niva i n breve stro ncata dal tiro preciso degli 88 tedeschi (r), con il concorso dei nostri pezzi anti carro da 47/32. L'attacco della fanteria falliva, di fronte alla reazione delle nostre armi. Verso sera l 'avversario cercava di co n solidar si sulle posizioni raggiunte.
Anch e in basso, nel settore costiero, dopo qualche modesto prog resso iniziale l'attacco veniva arrestato, in chiodato al terr eno dal fuoco di artiglieria in posizione ali ' Halfaya.
Le altre due colonn e, provenienti da sud- est e da sud, riuscivano invece a progredire verso Capuzzo, fra le posizioni di q. 206 a sud della Ridotta e di q. 208 di Bi r H afid.
Ric onosci uta l'ampiezza e l'entità dell'attacco nemico, il ge nerale Rommel dava ordine alla 5• Divisio ne Leggera (gen. Streich) riunita a sud di Gamb ut, di tenersi pronta per il contrattacco, mentre la Divi sione « Ariete>> (gen. Ba ld assar re) veniva posta in stato di allarme. Contemporaneamente si ordinava alla 15"' D ivisione Corazzata (col. Neumann- Silkow) di « te n ere il passo H alfaya e battere il nemi co». T em po ran eamente, la divisione doveva condurre il comba ttime nto difensivo da sola, ma ncando ancora la visione di quanto sarebbe avvenuto sul fronte di Tobruch , dove avrebbe potuto m anifestarsi un concorrente tentativo di sortita da parte d ella guarni gio ne assediata.

In m ancanza di elementi per for mar si un quadro preciso della si tuazion e, il ge n. R ommel era costre t to per il mome nto a trattenersi al proprio comand o tattico, ad ovest di Tobruch. Solo intorno alle ore 10 le notizie raccolte gli permettevano di intuire il piano del gen. Wav ell e individuarne l'obiettivo: la rottura dell'a ssedio di Tobruch. Ordinava co n segu enteme nte alla Divisione Leggera , rin-
( r) Il cannone campale contraereo tedesco da 88, impi egato in funzione anticarro, era il solo pezzo efficace contro la pesante corazzatura del carro per fanteria Mark H ( M atilda) La sua apparizione doveva preparare agli [nglesi, fiduc iosi nell'invulnerabilità del nuovo modello, un'amara sorpresa nel corso dell'operazion e « Banlea xe » .
forzata con l'assegnazione di un gruppo di artiglieria pesante, di attendere quale riserva lo sviluppo degli avvenimenti.
Intorno alle 12, sotto la pressione di forze preponderanti, il caposaldo di q. 206 era costretto a cedere. All e ore 14 carri armati britannici avanzavano a nord di Capuzw.
Il gen. Rommcl disponeva allora per la manov ra controffensiva da sviluppare l'indomani da parte della 15"' Divisione co n attacco da nord mentre la sa Leggera, procedendo sulla direttrice Sidi OrnarSidi Suleiman- posizioni ad est dell'Halfaya, doveva tendere all'aggiramento delle forze nemiche penetrate nella zona Capuzw- Sollum.
Il Comando Superiore italiano &attanto, preoccupato per la persistente possibilità d i un tentativo di sortita da parte della guarnigione di Tobru ch, specie nel settore orientale più strettamente interessato all'operazione in corso, m et teva a disposizione del ge n. Rommel il raggruppamento « Montemurro », comprendente quasi tutti gli elementi della Divisione « Ariete» in via di riordinamento. Si trattava precisamente di:
- un btg. bersaglieri di formazione;
- VIII btg. carri M 13;
- due cp. anticarro (22 pezzi);
- un gr. da 75 / 27; per un totale di circa 2000 uomini. Il raggruppamento doveva prendere il posto della sa Divisione Leggera, come riserva del C.T.A. , ad est di el Adem (a cavaliere del Trigh Capuzzo, fra Bir Saleh ed el Duda).

L'attacco britannico intanto, oltrepassata la Ridotta Capuzzo, si dirigeva sul caposaldo di Musaid, che veniva investito verso le ore 17 co n violento tiro di artigl ieria. Seguiva immediatamente l'attacco dei carri armati, accompagnati da un battaglione di fanteria. L 'attacco poteva essere con tenuto; i carri erano costretti a fermarsi a circa 900 m etri dalle nostre linee. Per tutto il resto della giornata il n emico si limitava a sbarrare co n i propri carri le com unicazioni con gli altri capisaldi an cora in nostro possesso. P enetrato con qualche elemento fino alla strada di Bardia, ne risultavano scontri di carri armati ma non insisteva nell'attacco in direzio n e della Piazza. Alla sera del 15 la si tu azio ne era la seguente:
- conquistati dai britannici i capisaldi di q. 2o6 e di Capuzzo;
- mantenuti d a parte no stra i capisaldi di Passo Halfa ya, q. 208, Musaid e Sollum.
Il giorno 16 la lotta si riaccendeva con maggior violenza. Alle 4,30 il caposaldo di Musaid, attaccato durante la notte, veniva sopraffatto.
Alle ore s, secondo gli ordini, la xs" Divi sione Corazzata avanzava in direzione di Capuzzo e si accendeva ben presto una vivace battaglia di carri. Molti mezzi meccanizzati e corazzati britannici venivano immobilizzati dai carri tedeschi che con abile manovra portavano avanti più volte la loro opera per ripiegare quindi sotto la protezione delle artiglierie. Molti altri mezzi venivano distrutti dalle armi anticarro che, spinte in primissima linea, a breve distanza centravano con precisione i carri avversari che, trascinati dalla foga dell'assalto, incautamente si spingevano troppo sotto.
Di fronte alla superiorità numerica del nemico l'azione della xs• Divisione non riusciva però a proseguire: dopo aver subìto sensibili perdite i suoi carri erano stati costretti a retrocedere (I).
Non riuscendo a dilagare a nord, oltre Capuzzo, il nemico si volgeva ora ad est, verso il caposaldo di Sollum Alto, tenuto da elementi della Divisione « Trento». Verso le II,30, dopo strenua resistenza risoltasi in duri combattimenti entro l'abitato, il. presidio era costretto a cedere, di fronte alla prepo nd eranza dell'avversario largamente provvisto di mezzi corazzati. I superstiti, scendendo sulla costa, riuscivano in parte a raggiungere Bardia.
Cominciava frattanto a rendersi sensibile l'effetto della manovra aggirante della Sa Divisione Leggera. Procedendo su Sidi Suleiman, per raggiungere il Passo di Halfaya, veniva ben presto ad impegnarsi con la VII Brigata Corazzata britannica. Le alterne vicende del combattimento consentivano in definitiva al gen. Streich di formare a sera, con alcuni elementi, un robusto fianco difensivo ad est di Sidi Ornar, mentre la massa della divisione poteva riprendere l'attacco su Suleiman.
« Fu questa la svolta decisiva della battaglia » - annota il general e Rommel che ordinava allora alla ISa Divisione Corazzata di lasciare a nord di Capuzzo solo le forze strettamente necessarie alla difesa e raccogliere rapidamente tutte le unità mobili disponibili per procedere insieme alla s' Leggera all'attacco di Sidi Suleiman. «So-
(r) Ro!.ntEL: << Guerra senza odio >> , Garzanti ed., 1952, pagg. 48-49: « Nonostante gli sforzi più accaniti la Divisione non poté ottenere alcun successo decisivo. Degli So carri armati messi in azione dalla 15" Divisione ne rimanevano sol tanto 30. Gli altri erano in fiamme sul campo di battaglia o dovevano essere portati nelle officine di riparazione >>.

vente si ,può decidere una battaglia con il puro spostamento del centro di gravità, che coglie di sorpresa l'avversario » - commenta compiaciuto il Comandante del C.T.A.
Durante la notte sul 17 l'artiglieria nemica continuava a battere ininterrottamente tutta la zona.
« Il nemico non parve voler cedere l'iniziativa. Concentrò il grosso dei suoi carri armati a nord di Capuzzo per attaccare alle prime ore del mattino del terzo giorno di battaglia i resti della rs"" Divisione Corazzata rima sti a nord e ottenere là lo sfondamento. Per imporre in anticipo i miei piani al nemico, ordinai alla s" Divisione Leggera e alla 15a Divisione Corazzata di riprendere l'attacco nella medesima direzione, su Sidi Suleiman, già alle 4,30 e cioè prima del verosimile inizio dell'attacco avversario. La s" Divi sione L eggera poté raggiungere verso le 6, dopo una marcia rapidiss ima, la zona di Sidi Suleiman. La 15a Divisione Corazzata fu dapprima impegnata in aspri combattimenti con i carri britannici ma raggiunse anch'essa la meta. Gran numero di carri armati britannici colpiti rimasero sul terr eno attraverso il quale erano avanzate le due divisioni.
« Evidentemente l'avversario era assai stupito di questa operazione. Esso definì la propria situazione come molto seria ... » ( r ).
In realtà la decisione di desistere dali' attacco e di ripiegare sulle posizioni di partenza era già stata- presa dal comandante britannico fin dalla sera del r6. L'idea del ri piegamento deve essere stata adottata con una certa precipitazione, di fronte al delinearsi della forte minaccia sul fianco sinistro segnalata dalla r icognizione aerea, nella zona di Sidi Ornar e Sceferzen : si spiega così come, mentre fino alle ore 14 venivano diramate istruzioni per fare avanzare i rifornimenti fin presso il reticolato di confine, dopo l'esito della ricognizione aerea delle r8 l'ordine veniva improvvisamente contromandato.
Nella giornata del 17 il ripiegamento si manifestava poi chiaramente nella sua integrità, con l'arretramento di tutti i servizi lungo la linea Zigdin - Bir H abata - Bir Sofafi . La copertura del movimento era stata affidata alla t· Divisione Corazzata, lasciando su posizioni più arretrate elementi della 4" Divisione indiana e di artiglieria.
Un'intera brigata della t Divisione Corazzata (la IV Corazzata) era dislocata attorno a Capuzzo; il Gruppo di Sostegno si trovava immediatamente a sud, fra Capuzzo e Bir Ghirba. L'altra brigata della divisione non poteva concorrere perché non era riuscita a di-

sirnpegnarsi dalla stretta della 5.. Divisione Leggera, nella zona di Sidi Ornar.
Nel settore centrale elementi della 4.. Divisione indiana venivano a trovarsi impegnati nelle posizioni d i Musaid e Sollum , senza possibilità di ricongiungersi alle forze del settore costiero, sempre immobilizz ate dal fuoco d'artiglieria del caposaldo dell'Halfaya, rifornito di munizioni per via aerea.
Attraverso il servizio d'intercettazione il g en. Rornrnel riusciva a formar si un quadro sufficien temente chiaro della situazione :
« Il Comandante della t Divisione Corazzata pregò il Comandante delle forze combattenti del deserto (evidentemente il Traduttore vuole intendere il Comandante della « Forza del Deserto Occidentale ») di recarsi al posto di comando della division e. Ques to invito era molto sospetto. Secondo l e apparenze il capo br i t anni co non si raccapezzava più in quella situazione. Vidi chiara m ente che per il momento i Britannici non avrebbero intrapreso nulla, dato che non sapeva no a qual punto si trovassero. Decisi di approfitta rne per chiudere co m pletamente la sacca fino ad H alfaya. Verso le 9 fu impartito alla 5" Divisione Leggera e alla r) Divisione Corazz ata l'ordin e di procedere all'attacco su H alfaya ma anche di impedire un'irruzione di carri armati britannic i dal nord. Speravo di po ter dare bat taglia ai Britannici, i quali avevano scarsità di benzin a e munizioni, e annientarli » (I).

Verso le ore 13 tutte le posizioni perdute nei due giorni precedenti erano state riconquistate ed erano nu ova mente presidiate da tru ppe itala - tedesche. Mezzi corazzati della 5"' Divisione Leggera, oltrepassato Sidi Suleiman, proseguivano verso l' Halfa ya m entre le sue fanterie impegnavano la massa nemica, dislocata fra G sar el Abd e Sceferze n. Carri della 15" ad Al am Abu D iak (nor d- ovest di Sidi Suleiman) contrastavano il passo al nemico c he da Capuzzo tentava di sfuggire verso sud : dopo vivaci sco ntri lo costrin g evano ad una co n version e verso est, continuan do a premerlo e a mol estarlo sul fianco, con i reparti anticarro.
Verso le ore r6, mentre le colonne tedesche si avvicinavano alle posizio ni d ell' H alfaya ch e continuava no ad oppo rre tenace resistenza, l'esito dei combatti m enti appariva ancora incerto. Così comme nta il gen. Rommel lo svolgimen to dell'operazione:
« Le due unità (la 5.. Di visione Leggera e la 15" Divisione Cor azzata) raggiun sero il P asso di H alfaya dopo le ore r 6 e attaccaro no
spalla a spalla verso nord. Questa disposizione era la più infelice possibile perché in tal modo si premeva sul nemico senza impedirgli di sfuggire. Nella grande breccia fra Sidi Ornar e il P asso H alfaya i Britannici potevano passare indisturbati. Ero straordinariamente irritato per la perdita di un'occasione così propizia. Giusto sarebbe stato affrontare il nemico subito dopo aver raggiunto la posizione di H alfaya, costringerlo a combattere e impedirgli di scappare. In tal modo avremmo potuto eliminare una gran parte delle sue forze offensive >> (I).
I n tre giorni la battaglia difensiva si era dunque conclusa a favore dell'Asse, anche se era sfuggita l'opportunità di infliggere all'avversario maggiori perdite.
L'aviazione italo- tedesca aveva partecipato attivamente alla battagl,ia, con azione di bombardamento e di mitragliamento e con la vigile ricognizione dei movimenti dell'avversario. Vi aveva concorso anche il Corpo Aereo Tedesco di Creta, intervenendo sulle colonne nemiche in movimento sulle strade che da Sidi el Barrani portavano alla linea di combattimento.
Anche dalla parte britannica l'aviazione era stata molto attiva in ogni fase dell'operazione. La sua ricognizione operava praticamente senza interruzione alle spalle del nostro schieramento per tutto l'arco della giornata solare, dalle 6 del mattino alle 19 e si doveva appunto alla sua tempestiva segnalaz,ione della rapida avanzata delle forze corazzate tedesche sul fianco sinistro della 1 Corazzata se il Comando aveva potuto sottrarsi ad una totale sorpresa (2).
(x) RoMMEL: cc Guerra senza odio», Garzanti cd., 1952, pag. 51. In realtà il grosso delle forze britanniche e ra già sfuggito verso il sud.
(2) Diverso è il parere del Primo Ministro Churchill che in una lettera indirizzata il 6 luglio al gen. Au chinleck (nuovo Comandante in Capo delle Forze del Medio Oriente) citava invece l'insufficienza del concorso dell'aviaz ione nella bauaglia di Sollum (oltre l'inattività del presidio di Tobruch) e ne criticava i criteri d'impiego: cc Quanto alla situazione aerea, ritengo che per tutte le operazioni di maggior respiro dobbiate prevedere l'impiego di tutta l'av:iazione dislocata nel Medio Oriente, tenendo naturalme nte presente che l 'aviazione deve svolgere la sua predominante funzione strategica e non essere dispersa per fornire alle truppe piccoli ombrelli di protezione, come sembra sia accaduto durante la battaglia di Sollum . . . Non si può fare a m e no di ritenere che nella battaglia di Sollum (" Battleaxe") la nostra superiorità aerea è stata sciupata e che le nostre forze di Tobruch sono rimaste inattive, m ent re tutti i carri armati nemici disponibili venivano impegnati a spezzare la no stra offensiva nel deserto » (da CHURCIIILL: cc La Seconda Guerra Mondia le », Parte III, vol. IT, Mondadori ed., 1952, pag. 35)

Le perdite britanniche venivano valutate in oltre 200 carn armati, contro soltanto 25 carri perduti dai Tedeschi (1).
La grande differenza è dovuta anche al fatto che il C.T.A., rimasto padrone del campo di battaglia, aveva potuto provvedere al ricupero delle macchine avariate, per sottoporle alla riparazione, mentre l'avversario era stato costretto ad abbandonarle sul posto.
Consi derazion i. Sull'esito dell'operazione « Battleax.e » gli Inglesi avevano riposto ambiziose speranze e il suo fallimento doveva costituire per loro un duro colpo: lo ammette esplicitamente lo stesso Churchill (2):
« ... Sebbene questa operazione possa sembrare modesta se paragonata all'ampiezza di tutte le varie campagne del Mediterraneo, il suo fallimento fu per me un duro colpo. Il successo nel deserto avrebbe significato la distruzione dell'audace esercito di Rommel; Tobruch sarebbe stata liberata e la ritirata del nemico avrebbe potuto facilmente farlo ritornare oltre Bengasi, con la stessa rapidità
( I) Una co muni caz ione del C. T.A. del 22 giugno precisava così il bilancio dell'operazione. Perdite britanniche: 3 I9 prigionieri, 237 carri fuori uso (di cui 120 Mark II) c I2 carri efficienti catturati, IO cannoni, 74 pezzi anticarro, 71 armi amoma tiche, 178 fucili, 20.000 colpi di munizioni di vario genere. Perdite tedesche: 13 mitragliatrici, 1 mortaio, 3 fucilo n i anticarro, 3 pezzi anticarro da 50 e 4 da 37, r canno ne semovente da 20 mm. ed x da 75 mrn., I obice campale da 18o mm., 5 carri II , 6 carri III, I carro IV, 55 automezzi.
Secondo il Comando Super iore I taliano le perdite umane erano state:
Dalla relazione d el geo. Wavell risulta che i carri perduti dai Britannici erano 95 : 25 « Crui sers » e 70 « I », contro 42-50 carri tedeschi distrutti
Churchill a sua volta regi str a cifre un poco diverse : cc Le nostre perdite nella battaglia durata tre giorni furono di poco superiori ai 1000 uomini, dei qua1i 150 ucci si c 250 dispersi. Andarono perduti 29 carri da crociera e 58 del tipo « I >> ••• Si sostenne che la parte migliore dei 200 carri nemici sia stata allora messa fuori combattimento; furono fatti 570 prigionieri e sepolti molti cadaveri nemici (da WrNSTON CHURCJllLL: cc La Seconda Guerra Mo odialeLa Germania punta ad Oriente >> , cd., I952, pag. 385).
(2) \-VINSTON CHURCHILL: << La Seconda Guerra Mondial e», Parte III, vol. I , Mondadori ed., I952, pag. 386.

con la quale era avanzato. Per questo supremo obiettivo erano stati affrontati tutti i pericoli d el « Tiger » ... ».
La delusione del Primo Ministro doveva chiaramente manifestarsi d'altronde nella immediata sostituzione del gen. Wavell al Coma ndo in Capo delle Forze del M edio Oriente, con il generale Auchinleck, già Comanda nt e in Capo nell'India. Anche i comandanti della Forza del Deserto Orientale c della i' Divisione Corazzata venivano sostituiti, a breve scadenza.

La battaglia era stata preparata con estrema cura in ogni dettaglio, secondo la consueta meticolosità del sistema britannico. Il riordinamento delle forze non aveva ancora potuto raggiungere quella piena disponibilità di automezzi che rappresentava il fattore primario della capacità manovriera nel deserto: erano state tuttavia attuate misure atte a seguire elasticamente con i servizi gli auspicati sviluppi delle operaZJioni. Nella zona di Sidi el Barrani a nord, e soprattutto nella zona di Bir Rabia- Bir Mella a sud, erano stati approntati dei centri mobili di rifornimento, in grado di seguire con immediata aderenza l'avanzamento delle truppe. L'asse principale dei raornimenti non seguiva la direttrice costiera, reputata troppo esposta alla osservazione e all'offesa aerea, ma l'autopista interna di Bir MellaBir Habata, sulla quale infatti nei giorni della battaglia si svolgeva intenso traffico. Probabilmente l'asse dei rifornimenti doveva svilupparsi fino a Bir Kenayis.
Nella zona di Bir Enda- Bir Mell a si trovava il 29° deposito campal e nel quale erano state co ncentrate 85.000 razioni di guerra mentre un altro deposito, il 30°, aveva ordine di tenersi pronto a scavalcare il precedente, non appena la situazione in lo richiedesse.
Solo a preparazione logistica ultimata e dopo siste m ati i collegamenti erano state fa tte arrivare dalle lo ntane retrovie le unità desti nate all'attacco, che dovevano scavalcare le truppe già in linea (le quali frattanto dovevano stri n gere il contatto co n le nostre posizioni) ( r ) .
Il piano della battaglia non offriva particolare carattere di originalità. L'ambiente nord- africano imponeva d'altronde in maniera quasi imperativa questo costante schema di manovra. su motivi di azione aggirante a raggio più o meno ampio, per il sud. Impegnata
( 1) Prigionieri del t Royal Tanks ammisero di provenire direttamente da Alessandria, con un solo giorno di sosta a Matruh.a nord la 4• Divisione indiana per l'investimento frontale delle nostre posizioni, spettava alla 7" Divisione Corazzata il compito del· l'aggiramento, per il sud, attraverso il terreno desertico. In caso di successo di questa prima fase, la manovra avrebbe poi proseguito in direzione di Tobruch, per la liberazione della Piazza assediata. Ri· spetto all'offensiva del dicembre 1940 era stata introdotta una variante: la protezione del fianco esterno della massa di manovra era stata allora affidata al Gruppo di Sostegno della divisione corazzata, cui eran o state assegnate delle autoblinde. Questa volta invece la funzione era stata assegnata alla VII Corazzata, dislocata nella zona di Sidi Ornar e più a nord. La modifica ri spondeva logi· camente alla diversa situazione, caratterizzata allora dalla quasi assenza di carri nell'Armata italiana ed ora dall'autorevole presenza della efficiente massa motocorazzata del C.T.A.
Alla base della preparazione il Comando Britannico aveva posto in primo piano il perseguimento della sorpresa. Si deve però riconoscere come, nonostante ogni precauzione, l'obiettivo non fosse stato raggiunto. Sembra di poter attribuire questo mancato risultato alle segue n ti cause principali :

---.,. eccessivo impiego dei collegamenti radio: erano state intercettate persino delle conversazioni in chiaro , atte indubbiamente a semplificare l'azione di comando, ma preziosa fonte d'informa· zio ne per l'avversario;
- rilevamento radio - gon io m etrico da parte nostra, che consentiva di seguire gli spostamenti delle stazioni radio dei maggiori comandi britannici (e quindi dei comandi stessi);
- ricognizione aerea che individuava co n continuità i movim enti e le zone di addensamento dei mezzi (e quindi delle unità) del nemico.
Il Comando Britannico si era probabilmente proposto di raggi ungere già nella prima giornata, il 15 giugno, la conquista di tutte le posizioni del nostro sistema difensivo di Capuzzo e cominciare immedi atamente a lanciare puntate esplo r ative c di disturbo verso le nostre linee di comunicazione. Conseguenza logica di questo primo ri sulta to avrebbe dovuto essere il crollo del siste m a Halfaya- Sollum, rim asto tagliato fuori dal complesso della nostra difesa. Nella stessa giornata si doveva inoltre assicurare il controllo di tutto il settore meridionale, con l'occupazio ne di Sceferzen e Si di Ornar, indispensabile premessa per l'aggiramento dell'intero schieramento .
Tutto questo non era stato realizzato. Nella prima giornata l'attaccante si era trovato impegnato in durissimi combattimenti e già nella stessa sera da qualche telegramma intercettato si poteva rilevare una prima nota d'incertezza: veniva sospeso il programmato avanzame nto dei servizi e si introducevano varianti nel raggruppamento delle forze, in vista della prosecuzione d eli' attacco per la giornata successiva.
Il mattino del 16 era sembrato che l'attacco, riuscito a far saltare la difesa nel settore Capuzzo e a compromettere seriamente quello di Halfaya, fosse sul punto di riprendere lo slancio. Dall'intercettazione si veniva a sapere di riusciti scontri con nostre colonne e della cattura di cannoni e prigionieri. Nel pomeriggio invece la situazione si invertiva a sfavore dell'attaccante, fino al punto di includo a rinunciare completamente all'operazione Nella zona di Capuzzo la IV Brigata Corazzata non era riuscita a portarsi in aiuto delle fanterie seriamente impegnate in quel settore. La XXI Brigata Guardie e i reparti indiani che operavano nel settore Halfaya- Sollum si trovavano alle prese con la tenace resistenza della no stra difesa. L a VII Brigata Corazzata infine , c ui era stata commessa la protezione meridionale dell'intero dispo sitivo britannico, si trovava in seria difficoltà, alle prese con la s• Divisione Leggera. Il Comando Britannico, trovandosi bloccato in ogni punto del proprio sforzo offensivo, ne aveva probabilmente desunto una netta inferiorità del proprio mezzo corazzato di fronte ai carri e soprattutto ai cannoni anticarro dell'avversario ed era pervenuto alla decisione di desistere da un'impresa nella quale ormai riteneva di non potere uscire che battuto.

Con il consueto impegno di obiettività il gen. Wavell cerca di individuare esattamente le ragioni fondamentali dell'insuccesso:
« Le cause principali del nostro insuccesso furono indubbiamente: la difficoltà di combinare l'azione dei carri « Cruisers » con quella dei carri « I » ; il fatto, paralizzante la manovra, di avere solo due reggim enti per ogni brigata corazzata e il deficiente addestramento della 1 Di visione Corazzata. Se gli equipaggi dei carri armati avessero avuto maggiore pratica delle armi, avrebbero distrutto un numero superiore di carri ar m ati n emici e se tutti fossero stati più esperti in materia di manutenzione ci sarebbero stati meno carri fuori uso per inconvenienti meccanici. T alché, invece di essere tanto surclassati di numero alla fine della battaglia, saremmo stati in forze sufficienti per distruggere il nemico a conclusione della battaglia >> .
Più duro è il giudizio dello storico inglese Liddell H art, esperto in materia d'impiego dell'arma corazzata, notoriamente critico estre-
mamente severo della condotta della guerra dei propri connazionali. Egli attribuisce agli 88 tedeschi il merito principale della v.ittoria (x):

« ... Si trattava di un piano che conteneva già in sé gli elementi destinati a provocare il fallimento. Assegnando a metà delle forze corazzate disponibili il compito di dare man forte alla fanteria nella prima fase (la IV Brigata Corazzata, dotata di carri « I » Matilda era stata assegnata in appoggio alla 4" Divisione indiana) esso dimezzava, a dir poco, le possibilità di annientare il reggimento corazzato tedesco (della 15a Divisione Corazzata) dislocato nella zo na avanzata, prima che arrivasse di rinforzo l'altro reggimento corazzato (della 5a Divisione Leggera) di Tobruch e riduceva quindi al minimo le possibilità di realizzare la seco nda e la terza fase del pia no inglese ..
« ... Inoltre, la possibilità che gli In glesi avevano di coglierli di sorpresa (i difensori del Passo Halfaya) fu annullata dalla decisione, presa già nella fase di stesura del piano, che i carri armati non operassero il loro attacco finché non vi fosse abbastanza luce da permettere all'artiglieria di aprire il fuoco. Questa decisione ebbe in effetti conseguenze tanto più gravi in quanto l'unica batteria assegnata all'attaccante del Passo di Halfaya si impantanò nella sabbia. Era orm ai giorno perciò, quando lo squadrone di « Matilda » che guidava l'attacco par.tì per l'ultimo balzo, ma la prima notizia che giunse via radio per bocca dello stesso comandante suonava così: «Sta nno facendo a pezzi i miei carri armati». Fu anche il suo ultimo messaggio. Dei 13 « Matilda » solo I sopravvisse alla « trappola anticarro>> dei pezzi da 88 che Rommel aveva preparato su quello che le truppe inglesi da quel momento definirono «i l Pa sso del Fuoco d'Inferno »
Alla Ridotta Capuzzo infatti, dove non c'erano gli 88, l'attacco preceduto da un reggimento di « Matilda >> riusciva abbastanza rapidamente ad affermarsi, mentre invece la brigata di carri m cdi che procedeva in testa alla colonna di sinistra andava ad incappare in altra « trappola anticarro » predisposta ad Ha.fid , subendo gravi perdite che le impedivano di proseguire nella propria missione :
« ... Al calar della notte della prima giornata gli Inglesi avevano perso, soprattutto nelle du e trappole anticarro, più di metà dei loro carri armati, mentre i Panzer tedesch i erano ancora quasi intatti ... >>.
(x) LIDDELL HART: « Storia Militare della Seconda Gu erra Mondial e n, Mondadori ed., 1970, pagg. 246 · 247.Liddell Ha rt con cl ud e con in teressanti considerazioni, ritenendo di poter individuare nelle ultime sfortunate operazioni britanniche una vera svolta n ell'orientam ento tatti co della guerra ( r):

« Fino a quel m om ento essa (la guerra) aveva visto un qu asi completo rovesciamento di quella tendenza alla supre m azia della difensiva che era prevalsa durante la prima guerra mondiale e nel precedente m ezzo secolo. A partire dal se ttembr e 1939 l'offensiva, specie quando at tuata da forze corazzate capaci di muovere ad alta velocità, aveva riportato su tutti i teatri bellici tanti e così sc hiaccianti successi che sia l'opinione pubblica sia gli ambienti militari avevano finito col convi ncersi che la difensiva fosse una tattica intrinsecamente debol e e che l'attaccante fosse dovunque destinato a prevale re. Ma « Battleaxe » dimostrò, come « Brevity » a Tobruch aveva lasciato presagire, q uanto efficace potesse essere la difensiva, anche in un ten:eno apcrto come il deserto n ord - afri cano , se condotta con abilità c basata sulla co no sce nz a delle proprietà degli strum enti mode rni. A par tire da quel mom ento, col procedere della guerra e con l'aumentare del! 'esperienza, apparve sempre più chiaro che la difensiva, concepita in una forma più mobile, aveva ri guadagnato qu ella supremazia di cui aveva goduto nella prima guerra mondiale e che per avere successo l'offensiva doveva poter contare su una grande superiorità di forze, o su un altissimo grado di abilità tattica (abilità di squilibr are l'avve r sario c di coglierlo poi in contropiede) ... ».
Il Liddell H art co ntesta anche le considerazioni del ge n. Wavell r ela tiv e alla difficoltà di coord inare l'azione dci carri m edi con i più lenti carri « I » :
« In realtà tale coordinam ento non era stato neppure tentato, né ci si era preoccupati di vagliarne la potenzialità. I due reggimenti di « Matilda » erano stati distaccati d all a divisio ne corazzata e m essi a disposizione d ella d ivisione di fanteria fin dali 'in izio e questa li aveva poi tenuti ai suoi ordini per tutta la battaglia ... Con un intelligente coordinamento i carri « I » avrebbero potuto svolgere un ruolo molto importante nella battaglia fra m ezzi corazza ti, operando come robusto perno offensivo di manovra per i carri m edi. C'era so lo una trascurabile differenza di velocità fra « Matilda >> e i carri m edi A. IO •.. Tanto in qu es ta come in successive occasioni, i T ed esc hi si dimostrarono capaci di far lavorare insieme tipi di carri ar-
mari con differenze di velocità non inferiori a quella esistente fra i carri medi più veloci inglesi e i « Matilda » (r).
I commenti del gen. R ommel si avvicinano invece, in qualche parte, all'apprezzamento del gen. Wavell:

« L'offensiva britannica era stata ideata dal gen. W aveli in modo eccellente dal punto di vista strategico ... Ma il suo grande svantaggio era la scarsa m obilità dei carri armati pesanti d ella sua fanteria che non gli cons entiva di reagire efficacemente agli attacchi dci nostri tipi di carri armati veloci. La minore velocità del grosso delle sue unità era dunque il punto che potemmo sfruttare tatticamente ...
« Per questa impresa i Britanni ci impiegarono in gra n numero i loro carri armati Mark II, la cui corazzatura era straordinariamente forte e non poteva essere perforata da una parte delle nostre armi difensive. Il cannone di questo carro aveva però una portata e un calibro troppo piccoli e, inoltre, i Britannici disponevano soltanto di proiettili pieni. Sarebbe veramente interessante sapere perché il Mark II veniva chiamato carro di fanteria se non poteva sparare granate esplosive nei combattimenti contro la fanteria nemica. Oltre a ciò questi carri, come si è già d etto, erano troppo lenti. In definitiva potevano essere impiegati solo per azioni immediate di sfondam ento, di fronte a concentramenti di materiale ...
« W avell, a causa della minore velocità dei suoi carri armati di fanteria, non aveva potuto, al momento dell'attacco tedesco proveniente dalla zona a nord di Sidi Ornar, spostare il suo centro di gravità da Capuzzo alla zona di attacco delle truppe dell'Asse. Non gli rimaneva altro che ritirar si rapidamente e ciò egli fece con minim e perdite per le forze operanti britanniche ... » (2).
Obiettivamente, l'esito vittorioso della battaglia difensiva di Sollum è da attribuire essenzialmente ai seguenti fattori d eter minanti:
- razionale schieramento delle forze italo- tedesche, in previsione dell' offcnsi va n emica;
- rispondente organizzazione difensiva campale dei si ngoli capisaldi;
- perfetto funzionamento del nostro servizio informazioni che, prevedendo con esattezza il m anifestarsi dell'attacco, aveva im-
(1) LJDDELL 1-IART: «S toria Militare della Seconda Guerra Mondiale >>, Mondadori ed ., 1970, pagg. 250- 251. (2) RoMMEL: <<G uerra senza odio>>, Garzanti ed., 1952, pagg. 52- 53-pedito all'avversario di realizzare quella sorpresa su c ui faceva asseg namento come fattore essenziale di successo; - disponibilità e tempestivo impiego di un 'adeguata massa di manovra moto - corazzata.
A questi è da aggiungere naturalmente, con massimo coefficiente, il valore delle truppe. E' il caso di specificare: di tutte le truppe, come ne fa esplicito riconoscimento il gen. Rommel il quale dopo avere riconosciuto che « la truppa italiana rendeva molto quando era guidata da un capo valente» afferma ancora (1): « Grande contributo al successo difensivo delle truppe dell'Asse diedero anche i presidi dei singoli capisaldi del fronte di Sollum, i quali in parte respinsero tutti gli attacchi britannici, in parte fecero il loro dovere fino all'ultimo respiro».

I due falliti tentativi di sbloccare Tobruch da parte nostra, le due fallite imprese offensive da parte britannica avevano valso a mettere in evidenza la posizione che si potrebbe dire di « stallo » ra ggiunta in Africa Settentrionale dai contrapposti schieramenti . Da questa situazione discendeva l'imperativa indicazione della necessità di un congruo periodo di sosta operativa da dedicare al potenziamento delle forze, con l'obiettivo di riuscire a realizzare tempestivamente una effettiva preponderanza sull'avversario, nella misura indispensabile a tornare in possesso dell'iniziativa delle operazioni.
Si stava cioè per aprire, dal l e due parti, una serrata gara contro il tempo, per tentare di prevenire l'avversario sulla m eta della netta prevalenza materiale dell e forze. Era da prevedere conseguentemente un periodo nel quale, accanto agli sforzi per raccogliere e trasportare sul teatro delle operazioni il ma ssimo di uomini e di mezzi per le armate operanti, si sarebbe esasperata all'estre mo la lotta per la sicurezza o, rispettivamente, l'interdizione delle vie di comunicazione marittime di cui entrambi i partiti erano tributari. Il centro di gravità delle operazioni si sarebbe dovuto necessariamente trasferire, almeno temporaneamente, nel campo della guer ra aero- navale, nel quale l'avversario aveva già mo strato di godere di una forte preponderanza.
( 1) « Guerra senza odio », Garzanti ed., 1952, pag. 53·DELLA SITUAZIONE POLITICO- MILITARE
PRIMA DELL'INIZIO DELLA CAMPAGNA DI R USSIA
(fine marzo- 21 giugno 1941)
Si è già acce nnato in altro capitolo ag li eve nti che nel m arzo 1941 avevano condotto la Ge rm an ia all'apertura della campagna dei Balcani, fondamentalmente allo scopo di assicurare le spalle alle armate che entro pochi m es i avrebbero dovuto in traprendere la g randiosa prova co ntro l'Armata R ossa. Si ritiene opportuno ritornare ora sugl i sviluppi che ne sono seguiti, nei Balcani e nel Medio Oriente, in quanto interessanti la situazione politico- militare della Gran Bretagna nel M editer ran eo e quindi, di riflesso, la si tu azione strategica nell'Africa Settent ri o n ale. Per lo stesso moti vo si to rn erà ad accennare all'evoluzione delle operazioni nell'Africa Orientale Italiana, in quan to alimentate con forze a disposizione del Comando in Capo del Medio Oriente .

In un quadro più generale è da tener presente che l 'allin eamento della Slovacchia, d ell'Ungheria, d ella Romania e della Bulgaria dalla parte dell'Asse aveva praticamente assicurato alle forze tedesche la libera disponibilità territorial e dal Baltico all' Egeo (schizzo n. 20).
Le operazioni in Ju- Co me già ricordato, il 27 marzo un colpo di goslavia. stato aveva abbattuto a Belgrado il Consiglio di R eggenza del principe P aolo che aveva firmato l 'adesione al Patto Tripartito ed aveva portato al potere, nel nome del giovanissimo Re Pietro, un governo di coalizione filo- britannico capeggiato da Simsovic. A qu esto punto la Germania aveva deciso di togliere di mezzo la Jugoslavia.
Il mattino del 6 aprile le armate tedesche, passavano le frontiere . Seguiva il 7 l'i n vasione italiana e l'II quella dell'Ungheria, cui era stata offerta la restituzione di territori fra la Drava, il Danubio e il Tibisco che aveva dovuto cedere al termine della prima Guerra Mondiale (1). Belgrado veniva ridotta in rovine dal bombardamento aereo; tutto i l paese era rapidamente conquistato, quasi senza incontrare resistenza. Le forze organizzate del giovane regno sl avo si polverizzavano, praticamente, sotto la pressione irresistibile di un avversario tanto preponderante. Il 10 aprile la Croazia proclamava la propria indipendenza, il 16 la resa incondiziona ta della 2" Armata di Serajevo segnava la cessazione dell'ultima forma di opposizione organizzata. Il Governo e il giovane Re Pietro riparavano in territorio greco e il g.iorno 18, Markovic, l'uomo che con la firma del Tripartito aveva creduto di garantire la salvezza del proprio Paese, firmava la capitolazione generale della Jugo slavia alle potenze dell' Asse. Le operazioni sul fro nte greco - albanese.
In Albania la controffensiva italiana del marzo 1941 non aveva fr uttato apprezzabili vantaggi territoriali, ma aveva comunque ricondotto l'in iziativa in mano nostra c logorato sensibilmente la residua capacità di r esistenza dell'esercito greco.
(1) Alla notizia del colpo di stato di Belgrado, Hitler aveva i nviato in aereo a Budapest il ministro ungherese a Berlino, latore del seguente messaggio per il Reggente, Ammiraglio Horthy: «La Jugoslavia verrà annientata perché essa ha testé ripudiato pubblicamente la politica d'intesa con l'Asse L a maggior parte delle Forze A rmat e tedesche deve passare attraverso l'Ungheria. L'attacco principale non partirà però dal settore ungherese. L'esercito magiaro dovrebbe intervenire e in camb io della sua collaborazione l'Ungheria potrà r io ccupare tutti quegli antichi terr irori che essa fu costretta, a suo tempo, a cedere alla Jugos lavia. Il problema è urgente. Si chiede una r isposta immediata e afferma tiva >>
L'ultimatum d i Hitler implicava la vio l azione del patto di amicizia esistente fra Ungheria e Jugoslavia, sottoscritto appena da poch i mesi, nel dicembre 1940, dal Presidente de l Consiglio ungherese, conte Teleki. Il Capo dello Stato Maggiore magiaro, gen. Werth, prendeva accordi diretti con l'Alto Comando germanico, all'insaputa de l propr io Governo. La sera del 2 aprile il conte T elek i, a'>'uta notizia che le truppe tedesche avevano attraversato la frontiera ungherese, si uccideva con un colpo di rivoltella (WINSTON CHuRcHILL: << La seconda Guerra Mondiale » , Par te III, vol. I: « La Ge r mania punta a Oriente », Mondadori ed., 1952, pag. 19{) R.EVICZY: « Gue rre allemande - Paix russe », pag 89)

Come si è già ricordato, il 6 aprile, contemporaneamente all'invasione della Jugoslavia, le armate tedesche erano entrate in Grecia dalla Bulgaria, non tanto o non solo per intervenire a sostegno dell'alleato italiano, quanto per prevenire gli Inglesi, di cui si sapeva imminente lo sbarco in territorio ellenico (I).
L'operazione procedeva con ritmo travolgente: il 9 era raggiunta Salonicco, con conseguente resa delle truppe della Tracia, il r8 veniva occupata L arissa, dopo aver rovesciato la difesa della forte « Linea Metaxas » nella quale la Grecia aveva riposto tutte le sue speranze e sulla quale si erano inserite le poche forze inglesi già sbarcate. La bandiera del Reich sventolava sull'Olimpo. Lo stesso giorno il Primo Ministro greco si era suicidato e gli In glesi decidevano di procedere al reimbarco.
Sul fronte albanese la nostra offensiva aveva inizio il giorno 13. Sotto l'incombente minaccia alle spalle delle avanzate colonne tedesche, l'ala destra greca cominciava il ripiegam ento che si estendeva ben presto all'intero fronte, assumendo ritmo sempre più accelerato. Entro il 21 aprile tutto il territorio albanese era in nostra mano. Praticamente non esisteva più in Grecia una forma di difesa organizzata e il Governo era costretto a chiedere la resa.

In questa sede interessa solo, ovviamente, rendersi conto dei riflessi della sfortunata impresa sulla posizione della Gran Bretagna nel M editerraneo e, conseguentemente, nell'Africa Settentrionale.
Su 53.000 uomini del corpo di spedizione le perdite ammontavano a circa r2.ooo (66oo britannici, 3000 austral iani, 2400 neozelan-
(1) Il 30 marzo Churchill aveva cosl telegrafa to a Fadden, facente fun. zione di Primo Ministro australiano:
<<Allorché un mese fa decidemmo l'invio di un esercito in Grecia, sembrava che si trattasse di un'av\"e ntura militare senza significato, dettata dal "noblesse oblige".
«Gli avvenimenti di Belgrado, di giovedì, mostrano le conseguenze di grande portata di questa cd altre nos t re decisioni sull'intera situazione balcanica. I piani tedeschi sono stati sconvolti e ora possiamo accarezzare nuovamente la speranza di costituire un fronte balcanico con la Turchia, nella quale siano impegnate una settantina di divisioni alleate appartenenti alle quattro potenze interessate. Ques to risultato non è naturalmente in alcun modo certo. Ma già ora pone il piano "Lustre" (la spedizione in Grecia) nella sua vera luce, non come atto mili tare isolato, ma come prima mossa di un più vasto disegno. Quale ne possa essere il risu l tato, l 'operazione è giustificata da tutto ciò che è accaduto dal momento in · cui la no str a decisione fu presa ... J>. (WtNSTON CH URCHILL: « La seconda Guerra Mondial e>>, Mondadori ed., 1952, Parte III, vo l. I, pag. 2oo).
desi). Le operazioni di sgombero si protraevano fino al 29 aprile: circa 26.ooo uomini venivano evacuati a Creta, circa rs.ooo in Egitto. Piccoli gruppi isolati erano riusciti a riparare nelle varie isole: 1400 uomini potevano raggiungere l'Egitto, con l'aiuto dei Greci, nei . . . mes1 successtvl.
L a valutazione britannica della situazione mediterranea dopo il rovescio subìto in Grecia è espresso in alcune direttive proposte da Churchill il r8 aprile ai Capi di Stato Maggiore e da qu esti approvate e diramate telegraficamente, nel tes to integrale, ai Comandanti del Medio Oriente:
« l Capi di Stato Maggiore ai Comandanti in Capo - r8 aprile 1 94!.
« Dal Primo Ministro e Mi ni stro della Difesa sono state impartite le seguenti direttive :
« I. - Non è possibile stabil ire successioni e precedenze precise fra interessi di cui nessuno può essere completamente ignorato, ma le seguenti istruzioni possono seguire di guida. Il salvataggio delle truppe neozelandesi, australiane e britanniche che si trovano in Grecia interessa tutto l'Impero.
« 2. - Dovrebbe essere possibile fare in modo che navi da trasporto vadano e tornino da Tobruch o prima o dopo la crisi della tenendo presente che Tobruch ha rifornimenti per due mes1.

« 3· - Voi dovete conciliare l'esigenza di proteggere la ritirata dalla Grecia con quella di alimentare la battaglia in Libia. Ma se tali esigenze fossero in contrasto, cosa che si potrebbe evitare, l'accento deve essere posto sulla vittoria in Libia.
« 4· - Per il momento non preoccupatevi dell'Iraq. Sembra che le cose vadano lisce.
« 5·- In un primo tempo Creta sarà soltanto un centro di raccolta di tutto quanto vi si potrà trasportare dalla Grecia. Una sua più completa difesa dovrà essere organizzata più tardi. Nel frattempo, tutte le forze dell'isola debbono difende rsi dai bombardamenti aerei, disperdendosi, impiegando la baionetta contro i paracadutisti o eventuali intrusi atterrati dall'aria.
« 6. - Salve le considerazioni generali sopra esposte, la vittoria in Libia ha il primo posto, l'evacvazione delle truppe dalla Grecia il secondo. L'approvvigionamento di T obruch, a meno che non sia indispensabile alla vittoria (in Libia) va effettuato secondo le oppor-
tunità. L'Iraq può essere ignorato e Creta rimessa in efficienza più tardi >> (I).
Identico criterio della preminenza assoluta da attribuire alla vittoria in Africa Settentrionale si trova espresso in un telegramma del Primo Ministro al Presidente degli Stati Uniti, R oosevelt. Questi aveva accennato in suo messaggio all'« azione ritardatrice pienamente giustificata » svolta in Grecia, aggiungendo che altri eventuali ripiegamenti, in Africa Settentrionale e nel Medio Oriente, se necessari, << avrebbero rappresentato una parte del piano che in quella fase della guerra tendeva ad accorciare le linee britanniche e ad allungare considerevolmente quelle dell'Asse >> . Churchill gli rispondeva il 4 maggio prospettandogli che l'atteggiamento della Spagna, della Francia di Vichy, della Turchia e del Giappone poteva essere condizionato dall'esito nello Scacchiere Mediterraneo: i Britannici, affermava, erano decisi a combattere sino all'ultimo sangue per l'Egitto, compresi i suoi avamposti di Tobruch e di Creta. Concludeva scongiurando il Presidente di non sottovalutare la gravità delle conseguenze che potevano derivare da un collasso nel Medio Oriente.
L e operazioni nell ' iso- Per apprezzare le difficoltà dell'operazione l a di Creta. lanciata il I9 m aggio dalla Ger man ia per la conquista aerea dell'isola di Cr eta occorre aver presente la natura estremame nte aspra di quell'ambiente geografico. L 'isola di Creta ha conformazione montagnosa (un'alta catena impervia, culminante a 2456 m. nel Monte Ida, l'attraversa in tutta la sua lunghezza) ed era allora percorsa da una sola rotabile che si snodava per circa 230 km. lungo la costa settentrionale. Tre allacciamenti, non transitabili per gli au tomezzi, congiungevano la costa settentrionale ai piccoli centri di quella meridionale, distanti tra i 56 km. e i I2 km : da H eraklion a Tymbaki, da R etimo fin presso T ymbaki, da Maleme a Selinos. Da Suda una strada risaliva la m ontagna verso sud, fino a poche miglia da Sphakia, che si poteva raggiungere per un erto se nti ero m ontano.
Gli Ing l esi avevano inviato truppe a Creta fin dal I 0 novembre 1940: un comando di brigata di fanteria con due battaglioni, un r e-
( x) CHURCHILL: « La seconda Guerra Mondial e» , Mondadori ed., 1952, Parte Hl, vol. I, pag. 262.

parto incursori- sabotatori e alcune minori unità. Si era così disimpegnata l a guarnigione greca che, verso la fine dello stesso mese, era stata trasferita altrove. Un altro battaglione inglese era stato inviato a Creta nel febbraio 1941. Più tardi era stata organizzata la difesa della baia di Suda (base di rifornimento di carburante per la Marina britannica) (r).
Alla fine di aprile, dopo l'affluenza degli scampati dal Peloponneso, i militari britannici presenti nell'isola assommavano a 28.6oo, i n parte non armati (circa 7000 uomini sgomberati inizialmente su Creta erano poi stati trasferiti in Egitto). Vi erano inoltre circa altrettanti greci (due divisioni) (2). Poco prima dell'attacco vi erano stati fatti affluire 6 carri armati « I >>, r6 carri leggeri, r8 cannoni contraerei, 17 cannoni da campagna, un battaglione di fanteria, automezzi e materiali vari.
L'attacco tedesco era previsto, come logica conseguenza della conquista della Grecia e gli agenti del servizio informazioni avevano fornito preziose notizie in proposito. Ma l'operazione di aerosbarco (di cui d'altronde non esistevano precedenti) non era stata presa in seria considerazione. Churchill rivela che il 5 maggio il generale australiano Freyberg, comandante di Creta, aveva scritto: « Non posso capire il nervosismo; non sono minimamente preoccupato per un attacco di truppe aviotrasportate ... » (3).
Churchill invece temeva un attacco « soprattutto dal cielo » e raccomandava che si inviassero ai difensori altre armi. Particolarmente grave era la carenza di forze aeree, indispensabili per affrontare g li Stukas avversari e intercettare i trasporti di truppa. Anche la difesa contraerea era assolutamente insufficiente (4).
(1) La Baia di Suda era stata forzata la notte s ul 26 marzo dai mezzi d'as salto della Marina italiana. Due cacc ia torpedin ier e partiti da Lero si erano portati fin presso l'ingresso della baia ed avevano messo in mare sei motoscafi esplosivi. I piloti attraversavano inosservati tutta la baia ( l unga 12 km.) superando tre successivi ordini di ostruzioni. Venivano colpiti l'incrociatore York, danneggiato gravemente, una nave cisterna e un piroscafo.
(2) Nell'isola erano stati concentrati 16.ooo prigionieri di guerra italiani che costituivano un onere per la difesa.
(3) WINS1'0N CHURCHILL: « La seconda Guerra Mondiale », Mondadori ed., 1952, Parte III, vol. l, pag. 317.
(4) WINSTON CHURCHILL: « La seconda Guerra Mondiale », Mondadori ed ., 1952, Parte III, vo l. L pag. 319: «G li effettivi della R.A.F. ai primi di maggio comprendevano: 12 Blenheim, 6 Hurrican e, 12 Gladiator e 6 Fulmar e Brewster dell'aviazione della flotta, di cui solo la metà poteva essere impiegata.

La difesa aveva ripartito le proprie forze in quattro gruppi, lungo la costa, per difendere soprattutto i campi di aviazione. Ad Heraklion c'erano due battaglioni britannici e tre greci; intorno a Retimo la XIX Brigata australiana (su quattro battaglioni) e sei battaglioni greci; nei pressi di Suda due battaglioni australiani, due greci e reparti di formazione di fucilieri britannici; a Maleme due brigate neozelandesi (una in prossimità dell'aeroporto e una più a oriente, in riserva). Data la conformazione dell'isola, non esisteva una riserva centrale in grado di accorrere da un settore all'altro, una volta interrotta la strada costiera.
Il piano tedesco affidava l'attacco all'XI Corpo Aereo, composto della i Divisione Aeroportata e la 5" Divisione da Montagna più la 6a Divisione da Montagna in riserva. Quasi r6.ooo uomini, in gran parte paracadutisti, dovevano essere sbarcati dall'aria, 7000 uomini dal mare. L'azione era appoggiata dall'VIII Corpo Aereo. In complesso la forza aerea disponeva di 280 bombardieri, r8o bombardieri in picchiata, r8o caccia (Me 109 e Me no), 40 ricognitori, 100 alianti, 530 Ju 52 da trasporto.

Era previsto di compiere l'aerosbarco in tre punti: Heraklion ad oriente, Suda e La Canea al centro, Maleme ad occidente. Affermato il primo successo, l'azione doveva essere poi alimentata via mare con altre truppe, armi pesanti e rifornimenti, mediante due convogli di caicchi e piccoli vapori greci, protetti dall'aviazione e da una scorta di naviglio leggero (fra cui due torpediniere italiane).
L'operazione si apriva felicemente il pomeriggio dd 19 maggio con un primo lancio di paracadutisti su Candia e Retimo e proseguiva all'alba del giorno successivo, con il sostegno di un potente bombardamento aereo: 7000 uomini atterravano nell'isola, paracadutati o trasportati su alianti. La resistenza si rivelava immediatamente fortissima ovunque, ponendo l'attaccante, in piena crisi di raccolta e riordinamento delle forze, di fronte a seri problemi di sopravvivenza. Nelle notti sul 21 e sul 22 gli scaglioni navali, intercettati dalla flotta britannica, non riuscivano a raggiungere la meta: le imbarcazioni del primo convoglio erano state in gran parte affondate e il secondo, invertita la rotta, riusciva a sottrarsi alla distru-
Essi erano dis t ribuiti tra il campo di atterraggio di Ret imo, l'aeroporto di Maleme, per soli caccia, e l'aeroporto di H eraklion, adatto a tutti i tipi di apparecchi ... Il 19 maggio, giorno precedente all 'attacco, tutti gli apparecchi superstiti vennero sgomberati in Egitto ... >> .
zione disperdendosi fra le numerose isole circostanti (r). La prosecuzione dell'attacco doveva ormai affidarsi unicamente all'aerosbarco, che continuava ininterrotto, anche in situazione di vivissimo contrasto, nei giorni successivi.
Inizialmente, e per qualche tempo, da parte britannica la situazione veniva considerata con ottimismo. Risulta che il secondo giorno Churchill informava la Camera dei Comuni che << la maggior parte» degli invasori era stata spazzata via. Per altri due giorni il Comando in Capo del Medio Oriente continuava a parlare di « rastrellamento » dei Tedeschi superstiti. Soltanto il 26 maggio, il gen. Freyberg segnalava: « Ritengo che le truppe ai miei ordini abbiano raggiunto il limite della resistenza La nostra situazione è disperata » (2) . La difesa di Creta era ormai praticamente spezzata e la notte sul 28 cominciava l'evacuazione delle truppe britanniche, conclusa entro la notte del 31 maggio (3).
(t) L'azione viene così descritta da Winston Churchill («La seco nda Guerra Mondiale >>, Mondadori ed., 1952, Parte III, vol. I, pag. 329): « Alle 23,30, a 18 miglia a nord di La Canea, il contrammiraglio Glennie con gli incrociatori Dido, Orion e Aiax e quattro cacciatorpediniere, sorprese il convoglio di trupp e tedesche composto principalmente di caicchi scortati da motosiluranti. Per due ore e mezzo le navi britanniche diedero la caccia alla preda, affondando non meno di dodici caicchi e tre piroscafi, tutti gremiti di truppe tedesche. Si stimò che quella notte annegassero circa 4000 uomini>> .
La stessa valutazione vien fatta dal Comandante della Flotta del Mediterraneo, amm. Cunningham (A. B. CuNNINGHAM: « L'odissea di un marinaio », Garzanti ed. 1952, pag. 231)

Alquanto diversi sono i dati riportati dall'amm. Bernotti («Storia della guerra nel Mediterraneo », Vito Bianco ed., Roma, 196o, pagg. 172 - 173):
«L'inseguimento delle unità del (primo) convoglio durò due ore; su 2300 uomini, gli uccisi c i dispersi furono circa 8oo ... L'abile e coraggiosa manovra (delle torpediniere italiane di scorta) riuscì a salvare la quasi totalità del (secondo) convoglio che però fu messo nell'impossibilità di giungere a Creta>>·
(2) LIDDELL HART: « Storia militare della seconda Guerra Mondiale >> , Mondadori ed., 1970, pag. x88.
(3) A completare il quadro, sia pure estremamente sintetico dell'operazione di Creta si ritiene interessante ricordare l a partecipazione del 9° rgt . ftr. italiano, di stanza nell'Egeo, rinforzato con carri armati leggeri, due cp . e artiglieria da sbarco della Marina Sbarcato il 28, sotto la protezione di nostre unità navali e aeree, nella rada di Sitia, nella parte orientale dell'isola, avanzava rapidamente verso l'interno e il 31 prendeva contatto con i ted esc hi a Hierapetra.
In merito a questa partecipazione si apprende dal Diario del gen. von Rintelen: « Fui incaricato dall'O.K .W. di trasmettere a Mussolini la pressante richiesta di Goring di far sbarcare da Rodi truppe nella parte est dell'isola c
Le perdite inglesi erano state di II.ooo uonum dell'esercito e 2000 della m arina. L e operazioni di evacuazione erano riuscite a trasferire tin Egitto q.s8o uomini, di cui 2000 greci. Sensibili le perdite delle forze navali, ad opera essenzialmente dei bombardieri tedeschi: 3 incrociatori e 6 cacciatorpediniere affondati; 13 altre uniti, fra cui 2 corazzate e l'unica portaerei a disposizione della Flotta del Mediterraneo, fortemente danneggiate (1).
Le perdite tedesche, secondo notizie di fonte ufficiale, ammontavano a 1353 morti, 1919 feriti e 2621 dispersi. Nella valutazione inglese queste cifre sarebbero largamente inferiori alla realtà.
La perdita di Creta assumeva particolare gravità, da un punto di vista psicologico, venendosi a sommare ai recenti disastri della cacciata dalla Cirenaica e dalla Grecia. In senso assoluto significava il passaggio all'avversario di una base aerea- navale di primaria importanza per il dominio del Mediterraneo ce ntro- orientale.
Nella valutazione tedesca dd la vittoria, pur celebrata per il brillante successo nella prima operazione di aviosbarco che fosse mai stata tentata nella storia, ha certamente influito l'alto prezzo che si era dovuto pagare, molto superiore a quello preventivato. E videntem ente le perdite non vanno considerate in termini assol uti ma comm isurate al prezioso, costosissimo e limitato patrimonio degli specialisti paracadutisti della Luftwaffe, praticamente più che dimezzato nella battaglia di Creta.
In sostanza l'attacco aveva subìto in partenza la sorpresa di trovare l'isola presidiata da forze inglesi almeno tripl e di quelle previste. Hitler che aveva concesso a malincuore l'autorizzazione per l'impresa, caldeggiata da Goring, ebbe poi a ripetere più volte al gen. Student, ideatore e comandante dell'operazione: « Le truppe paracadutiste han no fatto il loro tempo ... »
Nel quadro generale della situazione del Mediterraneo il valore della conquista di Creta da parte dei Tedeschi doveva comunque riman ere limitato alla installazione nell'isola di un forte e attivo Corpo Aereo, la cui infl uenza sarebbe risultata sensibile in tutto il bacino
di venire in aiuto ai repar ti gcrmanlCI tmp eg nau m duri combattimenti. Il Duce si dichiarò senz'altro pronto e non ebbe una parola sul precedente rifiuto (eviden te mente: rifiuto tedesco opposto a una precede nt e offerta italiana di cooperazione) ll.
(x) LmnELL HART : «Storia milita re della seconda Guerra Mondiale ll , Mondadori ed., 1970, pag. x88.

centro -orientale: temibile in particolare come potenziale mmace1a al libero esercizio del potere aero- navale britannico.
Impegnato a fondo nella preparazione dell'imminente campagna di Russia, l'OKW non prendeva neppure in considerazione la di sfruttare il successo « a botta calda » e fare di Creta il trampolino per nuove azioni di valore fondamentale in quel teatro di guerra, si trattasse della eliminazione di Malta o della conquista del Canale di Suez.
Le operazioni nell'Iraq.
Ricordiamo che l'Iraq, già provincia turca, era stato reso indipendente con il Trattato di Sèvres (IO agosto 1920) ed affidato alla Gran Bretagna con mandato della Società delle Nazioni. La Gran Bretagna ne aveva riconosciuto l'indipendenza con il trattato di Bagdad del 1930, entrato in vigore nel 1932, dopo l'ingresso dell'Iraq nella Società delle Nazioni.

Il giovane Stato si era impegnato fin dalla sua fondazione a prestare assistenza all'Inghilterra, in caso di guerra, ed a consentire il passaggio di truppe britanniche sul proprio territorio. La Gran Bretagna manteneva una missione militare presso l'esercito irakeno; la R.A.F. disponeva di due aeroporti: uno ad Habbaniyah, circa 6o km. ad ovest di Bagdad (con un deposito ed. una scuola di addestramento) ed uno a Shaban, presso Bassora. Per la protezione dei campi erano state arruolate localmente milizie irakene.
Le forze aeree dislocate a fine marzo 1941 nella base britannica di Habbani yah (dove si stava svolgendo un corso per circa 400 allievi piloti) venivano valutate a circa 300 aerei d'istruzione, 100 bombardieri efficienti e pochi caccia. Le forze aeree irakene erano stimate in 28 apparecchi, di cui circa la metà sprovvisti delle armi di bordo.
Allo scoppio della guerra, nel settembre 1939, il Governo irakeno aveva rotto le relazioni diplomatiche con la Germania, senza tuttavia dichiarare la guerra. Nel maggio 1940 era reggente dell'Iraq l'emiro filo- britannico Abdul Illah mentre il suo Primo Ministro, Rashid Alì el Gailani, era invece favorevole politica dell'Asse. Nessun passo era stato compiuto nei confronti dell'Italia e la nostra legazione era rimasta indisturbata a Bagdad. Forti pressioni clelia Gran Bretagna sul Governo irakeno per indurlo a rompere le relazioni dip lomatiche con l'Italia erano rimaste senza risultato.
Nel gennaio 1941, in relazione al manifestarsi di una forte tensione interna, Rashid Alì el Gailani si era dimesso per ev itare lo sco_ppio di una guerra civile, ma ai primi di marzo un colpo di stato lo aveva riportato al potere ( 1). Il 31 il Reggente lasciava Bagdad per rifugiarsi su di una nave da guerra i n glese.

Il Gove rno britannico non ricono sceva il nuovo stato di cose e dava corso ai movimenti di truppa già previ sti. Una brigata che era sul punto di partire dall'India veniva diretta a Bassora, dove sbarcava il 18 aprile, senza dar luogo a reazione. Rashid Alì rifiutava però di consentire lo sbarco di una seco nd a brigata e disponeva che forze meccanizzate nazionali si schierassero su di un'altura che dominava da occidente la sede della R.A.F.
Le truppe britanniche presenti nel settore di Habbaniyah (circa 8ooo uomini ) per la sicurezza di quella base aerea non erano sufficienti per svolgere un'azione di forza su Bagdad e venivano rinforzate con un battaglione inviato per via aerea da Bassora e con altri aerei provenienti dal Medio Oriente.
Il 7 maggio l'aviazione britannica non aveva difficoltà a m ettere fuori combattimento la m odesta aviazione irakena. Il dista ccamento m eccanizzato inviato a controllare la base di Habbaniyah, soggetto a continui bombardam enti, era costretto a ritirar si Il ro m aggio una colo nna motorizzata (IV Brigata di cavalleria, 6oo rgt. art. e I 0 rgt. Essex) dalla Palestina varcava la frontiera e il r8 raggiungeva Habbaniyah. Re spinto un contrattacco avversario, la colonna giungeva il 30 a breve distan za da Bagdad.
Ad evitare una crisi totale del Paese, non desiderata da Londra, veniva stipulato un armistizio: il 1 ° gi ug no il R egge nte con i suoi ministri, rifugiati in Tr ansgiorda n ia, riassumeva no il pote re c la Gran Bretagna tornava ad occupare l'antica posizione di predominio n el paese.
(1) In occasione di una visita Cairo, Eden aveva concluso con il Ministro degli Esteri irakeno un accordo c he abrogava di fatto ogni virtuale indipendenza dell'Iraq. Il partito nazionalista di el Gai l ani, venuto a conoscenza dei nuovi impegni, effettuava il colpo di stato, riuscendo a rovesciare il gabinetto prima che arrivasse a presentare il testo dell'accordo in Parlamento.
Il Governo di el Gailani poneva nuove condizioni per lo sbarco di uuppe anglo- indiane a Bassora: lo sbarco e il transito attraverso il territorio irakeno che il precedente Governo aveva autorizzato per so.ooo uomini , veniva autori zzato a non più di un battaglione per volta. L'esercito irakeno aveva allora un:1 forza di 6o.ooo uomini
La Germania, pure seriamente impegnata nell'impr esa di Creta, intendeva intervenire attivamente a sostegno del governo nazionalista: sono del 23 maggio le direttive di Hitler in materia, superate peraltro dal precipitare degli eventi (1).
In sostanza dunque la conclusione dell'episodio irakeno, non senza importanza nel quadro generale della situazione politico- militare mediterranea, era da ascriversi a favore della Gran Bretagna.
Le operazioni in Siria. L a Siria, posta nel 1920 sotto mandato francese, era stata fra il 1936 e il 1939 teatro di sanguino se ribellioni contro la potenza mandataria. Nel 1940, dopo il crollo della Francia, la Siria (come la Tunisia, l'Algeria, il Marocco e l'Africa Occidentale Francese) si considerava vin colata all'autorità del Governo francese di Vichy.
La Commissione Italian a d'Armistizio con la Francia (C.I.A. F.) aveva autorizzato l 'amministrazione frances e a mantenervi un certo complesso di forze, nazionali e indigene, in parte meccanizzate . In totale: 35 .000 francesi e 14.000 indigeni.
Nell'agosto si era installata in Siria una Commissione Italiana di Controllo.
Ne i primi mesi del 1941 la situazion e del paese era caratterizzata da fermenti inte rni , dovuti special m ente alle cattive co ndizioni economiche. Lo stato di insoddisfazione era mantenuto vivo dagli Inglesi che avevano interesse a provocare m ovimenti a favore della causa gaullista (2), valendosi anche della minaccia di soffocare eco-
(1) Direttiva n. 30 di Hitl er per il Medio Oriente : « Gran Quanier Generale, 23 maggio 194r. Il Movimento Arabo della Libertà rappresenta nel Medio Oriente il nostro alleato natural e contro l'Inghilte rra. A questo proposito è della massima imponan za provocare una ribellion e nell'Iraq la quale si estenderà al di là della frontiera irakena e andrà a rinforzare Je forze ostili all'Inghilterra nel Medio Oriente, interrompendo le lince di com unicazione bri tannich e e impegnando truppe e navi inglesi a spese di altri teatri di operazione. P er tali motivi ho deciso di accelerare lo sviluppo degli avvenimenti nel Medio Oriente, venendo in soccorso dell'Iraq. Se e in qual modo sarà più tardi pos. sibiJe far c rollare definitivamente le posizioni dell ' Inghilrerra tra il Mediterraneo e il Golfo Persico, in connessione con un'offensiva contro il Canale di Suez, ques to è ancora sulle ginocchia degli Dci »
(2) La pr im a istituzione politica del gen D c Gaulle come Capo delle « Forze Libere francesi >> era stata il << Consiglio d i Difesa dell'Impero Fran-

nomi camente il paese, con un severo controllo del traffico marittimo.
L'eventuale presenza di forze aeree dell ' Asse in Siria avrebbe rappresentato una seria minaccia per Cipro, per il Canale di Suez e le basi britanniche in Egitto e per le importanti raffinerie di petrolio del Golfo Persico. Reciproca mente il possesso della Siria avrebbe assicurato all' Inghilterr a la continuità territoriale fra Egitto e Turchia, rafforzandone la posizio ne dipl omatica ad Ankara.
Nella prima decade di marzo il gen. W eygand, delegato del Governo di Vichy e Co mandante delle Forze Francesi in Africa era stato convocato dal maresciallo Pé tain. Un co muni ca to uffi ciale emanato subito dopo riaffermava la decisione di difendere l'Impero Coloniale contro tutti: l 'affermazione veniva interpretata come diretta particolarmente all'Inghilterra, in rapporto alle sue note aspirazioni sulla Siria che andavano assumendo forme sempre più consistenti.
Il 7 aprile il gen . De Gaulle si incontrava al Cairo con il general e Wavell per chiedere che tutte le forze libero- francesi dislocate nel Medio Oriente fossero concentrate in Egitto e organizzate in una divisione da trasferire in Palestina per essere impiegata in Siria, a sostegno delle locali forze francesi, nel caso che queste si fossero trovate a dover far fronte a tentativi di penetrazione tedesca. Il 14 aprile la presenza del gen. De Gaulle in Palestina e il conce ntramento in quella regione dell e forze libero- fran cesi già operanti in Cirenaica e nell'Africa Orientale Italiana avvaloravano l'ipotesi di un a prossima azion e gaullista in Siria, appo ggiata dalla Gran Bretagna, se nza tener co nto della possibile re azione del Governo di Vichy.

A seg uito di un incontro di H itler con il vice- presidente Darlan (1), il Governo francese aveva conc esso l ' uso degli aeroporti si-
cese ». Dal gen. De Gaulle, residen te a Londra, dipend evano oltre il Consiglio dì Difesa : un Delegato Generale per il Levante (Libano, Siria, G ebel Druso); un Alto Commissario per l'Africa « Francia Libera » (Africa Equatoriale, Territorio del . Ciad, Camerun, Gabon, Medio Congo, Ubanghi- Sciarì); un Governatore per gli Stabilimenti Francesi dell'India (Yanaon, Mah e, Pondichery, Caricai, Chandarnagor); un Alto Commissario per il Pacifico (Tahiti, Nuo\'C Ebridi, Nuova Caledon ia, Isole dell'Amicizia, Clipperton).
( r) L'amm. Darla n, vice- presidente e ministro degli esteri del Governo di Vichy dopo i riman eggiarnenti che nel febbraio 1941 avevano portato all'allontanamento di alcuni membri decisamente conrrari a qualsiasi forma di collaborazione co n la Germa nia, era favorevole ad una effettiva co llabora zione franco- germanica, limitata peraltro al solo campo ec onomico- industriale.
riani per il transito di aerei tedeschi destinati all'Iraq e autorizzato l'invio in Sira di una missione aeronautica tedesca per l'organizzazione dei campi di aviazione.
Il Governo britannico ordinava di rimando il bombardamento delle basi siriane e annunciava di riservarsi altre misure, eventualmente imposte dagli eventi. Il 17 maggio bombardieri britannici attaccavano, senza apprezzabili danni, gli aeroporti di Palmira e Rayak e la città di Damasco.
Il gen. Dentz, Alto Commissario francese per la Siria, attenendosi agli ordini ricevuti da Vichy per la difesa ad oltranza dei territori del Mandato, aveva disposto opportuni movimenti di truppe, a sbarrame nto delle strade di accesso alla capitale.
Il 21 maggio il gen. De Gaulle sollecitava la marcia delle truppe libero- francesi verso Damasco.

In base alle istruzioni ricevute, il gen. Wavell aveva trasferito la 7" Divisione australiana (meno la brigata rimasta a Tobruch) da Marsa Matruh in Palestina e aveva inviato alla frontiera settentrionale della Transgiordania la V Brigata di fanter ia indiana della 4a Divisione, appe na giunta dal Sudan. Aveva inoltre ordinato al ge nerale Wilson, comandante le truppe di Palestina e Transgiordania, di prepararsi ad una eventuale avanzata in Siria.
Da parte dell'Asse, nel convegno tenuto al Brennero il 2 giugno, era stato deciso di mantenere una linea di larga collaborazione con la Francia, particolarmente per assicurarle mezzi e forze per la difesa della Siria.
Nelle prime ore del mattino dell'8 giugno le forz e anglo- gaulliste varcavano i confini della Siria. L'attacco si sviluppava su tre direttrici:
- a destra : per Deraa su Damasco;
- al centro.: per Marjayn su Rayak;
- a sinistra : (direttrice costiera) : da Haifa su Beirut.
Le truppe francesi del gen. Dentz rispondevano validamente al loro compito difensivo, impegnandosi in vivaci combattimenti. In condizioni di netta inferiorità erano tuttavia costrette a perdere progressivamente terreno, sulle tre direttrici dell'avanzata avversaria. I maggiori ce ntri del territorio venivano occupati l'uno dopo l'altro. Il 21 giugno cadeva la capitale, Damasco. Beirut, sede del governo siriano e del quartìer generale del gen. D entz, era seria mente minaccia ta di avvolgimento: la fin e della resistenza si presentava ormai inevitabile a breve scadenza.
Il 6 luglio il Primo Mini stro Churchill scriveva al gcn. Auchinleck (succeduto nel fratte mpo al gen. Wavell) m ette ndo perfettamente a fuoco l'interdipendenza fra la situazione siriana e i prossimi sviluppi in Africa Settentrionale:
« 1) Sono d'accordo sulla necessità di finirla in Siria; qui abbiamo se m pre pensato che il possesso della Siria è la necessa ria premessa per tenere o per ripr endere Cipro. Si spera ch e la Siria possa essere liquidata rapidam ente e che il nemico non ci preceda a Cipro. La precedenza di qu este due operazio ni rispetto all'offensiva nel Deserto O cci dentale, dopo quanto è accaduto, è pienamente ammessa;
« 2) il D eserto O cciden tale re sta tuttavia il teatro sul quale si deciderà nel prossimo autunno la difesa della valle del Nilo ... » .

L'8 luglio, divenuta ormai impossibile ogni ulteriore resistenza, il Governo di Vichy autorizzava il gen. Dentz a chiedere la sospensione delle ostilità; il 14 luglio veniva firmato l'armistizio.
Le truppe britanniche assumevano il controllo dell'intero territorio della Siria e del Libano (1). La partita, pur co ndotta con una certa lentezza, si era conclusa anche qui con il pieno successo del Regno Unito. Tale lo considerava Churchill:
« Il successo della campagna di Siria migliorò co nsiderevolmente la nostra situazione strategica nel Medio Oriente. Esso sbarrò le porte ad ogni altro tentativo di penetrazione nemica dal Mediterraneo verso est, trasportò a 400 km. più a nord la nostra linea di difesa del Canale di Suez e liberò la Turchia da ogni preoccupazione per la sua fro n tiera m eridionale».
Rip e r c u s s i o n i i n Crollata ogn i resistenza nei Balcani, cadute Turchia. in possesso dell'Asse le isole dell'Egeo, mentre il lento evolversi delle operazioni in Siria poteva lasciare ancora intravedere un risultato favorevole alla F rancia di Vichy (e quindi favorevole all'Asse) la Turchia si era venuta a trovare in un a situazione di estrema delicatezza.
( 1) Il 28 settembre si svolgeva a Damasco la cerimonia d ella decadenza formale del mandato francese sulla Siria. I n tale occasione il nuovo Presidente dello stato s iriano esprimeva al gen. Catroux, Alto Commissario della Francia Libera nel Levante, la delle popolazioni arabe e lo assicurava che la Siria avrebbe collaborato lealmente con la Francia Libera e la Gran Bretagna.
Il Governo di Ankara, preoccupato dall 'attività di minoranze turbolente da tenere a freno e dalla situazione di in sicurezza alle proprie frontiere , aspirava in sommo grado, in pieno accordo co n la nazione, a mantenersi fuori dal conflitto (r).
Il crollo fulmineo della Jugoslavia e della Grecia aveva tolto ogni valore di affidabilità alla garanzia britannica, nonostante la formale esistenza dell'alleanza con il R egn o Unito. In queste circosta nze il 17 giugno la Turchia aveva cercato di procurarsi una valida controassicurazione attraverso un patto di amicizia con la Germania (2).

L'occupazione della Siria e lo scoppio dell e ostilità contro la Ru ssia dovevano poi tranquillizzare il Governo d ' Ankara, di fronte alla possibilità di nuov e imbarazzanti pretese tedesche. D'altronde il cauto atteggiamento della Turchia non riusciva sgradito alla Germania la quale seguiva con vigile attenzione gli avvenimenti del Vicino Oriente, appunto per i riflessi che potevano avere nei riguardi di quella nazione, ma in sostanza desiderava di evita re ogni ulteriore complicazione, finché non avesse liquidato la partita con l'Unione Sovietica .
Le operazioni 1n In marzo la cam pagna stava giungendo alla A.O.I. sua fase risolutiva. Il giorno 26, un mese dopo lo sgombero di Mogadiscio, gli Inglesi occupavano Harar, l'indomani si concludeva la battagli a di Cheren, per la sorte dell'Eritrea, iniziata il 2 febbraio. Asmara e Addis Abeba , perché non fossero coinvolte nelle distruzioni della guerra, venivano abbandonate e dichiarate città aperte. L '8 aprile cessava la resi-
(r) In occasione di dichiarazioni r ese ad una riunione del gruppo parlamentare il 29 aprile, il Mini stro degli Esteri turco aveva accennato alla situazione creatasi in seguito al crollo jugoslavo e greco e all'occupazione delle isole dell'Egeo da parte della Germania. Affermava che il suo Paese aveva tenuto fede ai propri impegni aiutando, nei limiti del possibile, l'alleata Grecia e riconfermava la volontà di indipendenza del Governo. Ricordava inoltre l'ottima preparazione delle forze armate. In particolare l'aviazione turca era stata potenziata negli ultimi sci mesi: e ra aumentata di 250 apparecchi e ne attendeva 30 modernissimi dagli USA. Alle scuole di aviazione erano giunti nuovi istruttori britannici.
(2) Il Pano di Amicizia turco - tedesco era stato stipulato ad Ankara. I due Paesi si impegnavano a rispertare reciproc.amente l'integrità e l'intangibi lità dci ri spettivi territori cd a non prendere alcuna misura che si rivolgesse direttameme o indirettamente contro l'altra parte contraente.
stenza di Massaua. Con la perdita dell'Eritrea, della Somalia, dell'Hararino, dello Scioa era venuta a mancare l'unità dell'A.O.I. Le nostre forze residue si raccoglievano per l'ultima resistenza nei « ridotti » di Dessié- Amba Alagi e del Gondarino. Nei territori dei Galla e Sidamo, abbandonata la fascia di frontiera, le truppe si ritiravano sull'altipiano.
La resistenza delle forze raccolte attorno al Duca d'Aosta sull' Amba Alagi si protraeva valorosamente fino al 17 maggio; gli ultimi presidi del Galla e Sidamo non cessavano le ostilità fino al 9 luglio. Resisteva ancora soltanto i[ ridotto dell' Amhara: l'ultima battaglia, in difesa di Gondar si combatterà fra il 21 e il 28 novembre.

Per quanto interessa i riflessi della campagna in A.O.I. sulla situazione britannica nel Medio Oriente, risulta dunque che dal giugno in poi quello scacchiere aveva cessato di pesare sull'economia generale della distribuzione delle forze disponibili a favore dell'attività operativa in Africa Settentrionale.
I nizio de lla campagna Evidentemente, quest'abbozzo di panorama di Russ ia. generale sarebbe incompleto senza un accenno alle ripercussioni della prossima apertura di un nuovo fronte principale, alla frontiera russa. Per ciò che riguarda la Germania si possono brevemente sintetizzare nel totale assorbimento del potenziale bellico e dell'interessamento di quel belligerante per le esigenze che risulteranno in continuo aumento, e pur sempre insufficientemente soddisfatte, della lotta mortale impegnata i l 22 giugno contro il colosso moscovita.
Per quanto riguarda l'Italia è da registrare la distrazione di forze, particolarmente armate ed equipaggiate per la formazione di un corpo di spedizione italiano, destinato a segnare poco più che simbolicamente la nostra partecipazione alla crociata anticomunista.: modesta cosa in paragone alle colossali dimensioni dell'impresa ma pure sensibile dispendio per la limitata capacità delle nostre strutture militari, già largamente assorbite dai molti impegni assunti, all'infuori delle esigenze primordiali della « nostra» guerra in Africa Settentrionale e della difesa diretta del territorio nazionale, per l'occupazione di territori in Francia, Jugoslavia e Grecia.
Il 30 maggio Mussolini aveva fatto al gen. Cavallero un primo accenno alla costituzione di un corpo di spedizione da inviare in Russia. Il 9 giugno la questione era stata esaminata dal Comando Supre-
mo e si era prevista la partecipazione di un Corpo d'Armata, su una divisione celere e due divisioni autoportate. Il ro luglio il C.S.I.R. iniziava il trasferimento verso la zona di radunata: un complesso di quasi 6o.ooo uomini con 5.500 automezzi e un'aliquota di aviazione che, evidentemente, venivano ad essere sottratti al piano di potenziamento delle forze dell'Africa Settentrionale.
Vista dalla parte britannica, l'apertura della campagna contro l'Unione Sovietica significava la fine dell'isolameno, l'affiancamento di inesauribili risorse materiali e umane per la prosecuzione della lotta. L a vittoria finale, ancorché ancora lontana, cominciava finalmente ad assumere contorni definiti.

Il punto di vista bri- Nel Regno Unito il bilancio degli eventi qui tannico sulla situazio- molto sinteticamente ricordati veniva conne complessiva. siderato sostanzialmente positivo per gli interessi britannici, nonostante i gravi scacchi subiti in Africa Settentrionale e in Grecia.
La campagna balcanica, pur nella fulminea conclusione vittoriosa per l'Asse, aveva reso evidente la fine della minaccia d'invasione delle isole britanniche ed ora l'occupazione dei territori comportava necessariamente per l'Asse dispersione e logorio di forze.
La battaglia di Creta era stata pagata con il logorio dell'unico strumento disponibile per operazioni di aviosbarco ed ora la Germania si trovava nella pratica impossibilità di ripetere imprese del genere. Commenta Churchill (r):
« I Tedeschi impiegarono h1tti gli effettivi di cui potevano disporre. Doveva essere questa la prodigiosa impresa aerea di Goring. Tali truppe avrebbero potuto essere lanciate nel 1940 sull'Inghilterra se l'aviazione britannica fosse stata piegata ma l'attesa era andata delusa. Avrebbero potuto piombare su Malta: ma il colpo ci fu risparmiato . . . Quando la battaglia (di Creta) cominciò non sapevamo quale fosse la forza complessiva della Germania in fatto di forze paracadutiste. Solo dopo molti mesi fummo certi che l'XI Corpo era l'unica unità del genere ...
« La perdita da parte germanica di ottimi combattenti eliminò la formidabile arma delle truppe aviotrasportate e paraca-
dutiste da tutte le operazioni immediatamente successive nel Medio Oriente. A Creta Goring ottenne solo una vittoria di Pirro; le forze che vi logorò avrebbero potuto infatti conquistargli facilmente pro, l'Iraq, la Siria e forse anche la Persia. Queste truppe erano prio quelle necessarie per invadere vasti paesi titubanti dove non avrebbero incontrato alcuna seria resistenza.
«Le forze terrestri britanniche a Creta __...., dissero i Tedeschierano numericamente tre volte superiori al previsto. La zona di razioni dell'isola era stata approntata per la difesa con . la massima cura e con tutti i mezzi possibili ... Tutte le opere erano state metizzate con grande abilità ... L'errore, dovuto a mancanza formazioni, nell 'app rezzare esattamente la situazione del nemico mise in pericolo l'attacco dell'XI Corpo Aereo e fu causa di perdite eccezionalmente alte e sanguinose »
Nel Medio Oriente era stata realizzata la continuità territoriale dall'Egitto, per la Palestina e la Siria, fino alla Turchia, togliendo ogni preoccupazione di pericolose novità da quella provenienza.
Erano state soffocate le aspirazioni e le irrequietudini listiche delle popolazioni dell'Iraq, che potevano compromettere la disponibilità del petrolio di. quel Paese, indispensabile per la flotta inglese del Mediterraneo.
Tutte le forze a disposizione del Comando in Capo del Medio Oriente erano oramai disponibili per far fronte alla minaccia l'Asse contro l'Egitto. Si trattava ora essenzialmente di contrastare nel modo più energico ed efficace l'afflusso dei nostri rinforzi in Libia, estendendo la sorveglianza, senza alcun riguardo per la eia, alle acque territoriali tunisine. Contemporaneamente occorreva sollecitare e accelerare l'invio di rinforzi della madrepatria, con l'obiettivo dì raggiungere al più presto un grado di superiorità l'avversario che consentisse di riprendere ancora una volta l'iniziativa delle operazioni.
Il 27 maggio il Presidente degli Stati Uniti aveva proclamato lo « stato di emergenza nazionale illimitato >> : non si trattava ancora della decisione di aperto intervento nel conflitto ma costituiva già il materiale schieramento a fianco della Gran Bretagna.
Infine, come si è già accennato, oltre e al di sopra di ogni tore materiale della situazione, vi era il nuovo clima di fiducia generato dal grande evento della guerra del Reich contro la Russia: un evento che mutando radicalmente la prospettiva strategica della tuazione, induceva a considerare con fondata fiducia il prossimo avvemre.

Missione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito .

Il q giugno, alla vigilia della battaglia di Sollum, il gen. Roatta si recava nuovamente in Libia per studiare sul posto il problema operativo, nei suoi tre elementi:
- espugnazione della Piazza di Tobruch;
- possibilità di sbarchi inglesi in Tripolitaoia e possibili contromisure;
- operazioni offensive verso l'Egitto.
Sui singoli argomenti il gen. Roatta riferiva con tre studi distinti, condotti in concorso con il Comando Superiore italiano dell'Africa Settentrionale, dei quali vengono qui riportati gli elementi essen ziali.
I 0 - Espugnazione della Piazza di Tobruch (I):
- una fase preliminare, tendente a sgretolare progressivamente le difese e la capacità di resistenza della Piazza , con azione affidata essenzialmente all'artiglieria e all'aviazione, e ad insidiarne le vie d'alimentazione con assidua vigilanza aerea, posa di mine, attacchi aerei e agguati di naviglio leggero;
- una fase conclusiva, per l'espugnazione della Piazza mediante una o più spaliate risolutive.
(x ) La forza delia guarnigione di Tobruch alia fine di giugno era così valutata:
9a Divisione australiana (Brigate XVIII, XX, XXIV, XXVI);
un btg. mitraglieri;
un btg. motorizzato dei Northumberland Fusiliers;
XVIII btg. « Lancers » indiano ed altri elementi indiani imprecisati;
un btg. carri, probabilmente rinforzato, in piena efficienza;
un btg. pezzi anticarro;
G rgt. artiglieria, di cui 2 di medio calibro;
Forze ritenute necessarie per queste operazioni:
4 divisioni corazzate (le due tedesche già m posto, l' « Ariete» ricompletata ed una nuova divisione);

----, 5 divisioni di fanteria (le quattro italiane m posto, più una nuova);
- I divisione motorizzata (la « Trento », ricompletata);
- 47 squadriglie (I9 caccia, 16 bombardieri, 8 bombardieri in picchiata, I aerosilurante, 2 ricognizione strategica, I cacciabombardieri).
Fin dalla prima fase si richiedeva l'attivo concorso delle forze aeree italiane e tedesche dalla Sicilia e, soprattutto, da Creta e dalla Grecia.
2 ° - Difesa contro eventuali sbarchi in Tripolitania.
Era stato considerato separatamente il caso di piccoli sbarchi di disturbo, su qualunque punto della costa, e il caso di grandi sbarchi in prossimità dei porti di Tripoli e di Bengasi. Per il primo si era ritenuto necessario disporre di IO- 12 battaglioni autoportati, bene armati; per il secondo di due divisioni motorizzate e adeguate forze aeree, in grado di poter intervenire tempestivamente.
3° - Operazione offensiva contro l'Egitto.
Ne era previsto lo sviluppo im tre fasi successive, con l'impiego di 17- I9 divisioni, di cui 6 - 7 corazzate, 7- 8 motorizzate.
2 rgt. artiglieria contraerea. In totale, accertati:
15 btg. fanteria;
70 (circa) tra autoblindo, carri leggeri e medi;
40- so pezzi anticarro;
rso. r6o pezzi di artiglieria;
lmezzi organici delle formazioni
34 cannoni e 48 mitragliere contraerei di cui sopra, certamente rinforzati con altri extraorganico.
C'era i noltre da tener conto delle armi italiane che il nemico poteva aver rimesso in funzione dopo l'occupazio·ne della Piazza (artiglieria, pezzi anticarro, mitragliere)
Nella Piazza non esistevano forze aeree fisse; vi atterrava soltanto occasionalmcnte qualche apparecchio di collegamento o sanitario. Alla difesa partecipava l'aviazione dislocata nel Deserto Occidentale, compatibilmente con le esigenze del complessivo scacchiere mediterraneo.
Particolarmente efficace era il contributo della flotta ma anche questo rimaneva aleatorio, come misura e come tempestività.
Gli studi erano accompagnati da una memor ia sulla situazione e sulle possibilità del momento. Il Capo di Stato Maggio re d ell'Esercito vi esponeva anzitutto lo schieramento che quanto prima avrebbero potuto assumere le forze italo- tedesche in Cirenaica (I ) e la consistenza delle forze mobili disponibili in Libia a occidente di Tobruch (fra Ain el Gazala e Derna, nel Gebel Cirenaico, nella Sirtica e in Tripo litania) . Considerava infine le possibilità di difesa della Tripolitania e le possibilità di concorso dell'aviazione. In rappo rto alla disponibi lità de lle forze e dei mezzi in Africa Settentrion ale e alla realtà d ei tra sporti, secondo il gen. Roatta non si poteva pensare ad una offensiva contro l'Egitto se non come ad una eve ntualità molto lontana. Neppure l'espugnazione di Tobruch era concepibile a breve scadenza, essendo condizionata d alla disponibilità di forze e mezzi ben superiori a quelli presenti, assorbiti anche in misura notevole dalla difesa della posizione di frontiera. Egli si dichiarava convinto che l'avversario avr ebbe ritentato un'azione offensiva, con forze maggiori delle precedenti, prima ancora che noi si fosse in condizione di attaccare Tobruch: vari indizi (affluenza di navi, attività di artiglieria, frequenti colpi di mano, specie notturni, contro le nostre posizioni) davano a divedere che la Piazza, rafforzata nella sistemazione difensiva, rifornita dei materiali e dei mezzi che erano risultati deficienti all'atto del ripiegamento dalla Cirenaica, si avviava ormai verso una più attiva partecipazione alla lotta, nel quadro complessivo dell'atteggiamento operativo britannico nello scacchiere nord - africano. Era stato accertato che forze dell a guarnigione di Tobruch avrebbero dovuto agi re il 16 giugno in direzione di Bardia, nel piano della « Battleaxe >> e che soltanto il rapido fallimento dell'attacco alla frontiera aveva fatto sospendere l'ordine.
(r) T ale schieramento ri sul ta dal seguente prospetto:
- fronte di Sollum: a sini stra t ruppe mobili te desch e, a destra Divisione c< Savona »;
- Piazza di Bardia: repar ti delle Divisioni cc Ariete » e cc Tr ento>>;
- investimento di Tobruch: Divisioni <c Bresc ia » e c< Pavia », grosso della XV Brigata Schiitzen (fuci li er i) e un'aliquota della Divisione cc Trento»;
- riser va mobile: s a Divisione Leggera e 15a Divisione Corazzata, no gli elementi distaccati al fronte di Solium e all'investimento di Tobru ch. Un 'aliquota di battaglione carri M 13 dell' cc Ariete » nei pressi di Bardia.
<;i attendevano inoltre dei reparti tedesch i da posizione che avrebbero sostituito le truppe mobili impegnate nel settore sinistro del fronte est. La mas sa mobil e sarebbe stata allora tut ta riunita, meno il grosso della XV Brigata Schiitzen (della 21a Divisione Corazzata) che il gcn. Rommel preferiva lasciare nel de l ica to settore sud· ovest della cintura d i Tobruch (Ras Medauuar).

11 gen. Roatta giungeva alla conclusione che il problema immanente, per il momento, non era già quello dell'offesa, bensì quello della difesa che andava analizzando nei suoi cinque aspetti principali:
- difesa dei fronti avanzati ( « fronte est >l , << fronte Tobruch »);

____, difesa su posizioni arretrate (Ain el Gazala, Uadi Derna);
- difesa (o meglio: presidio) dell'interno;
- difesa della costa;
- difesa (eventuale) da attacchi provenienti dalla frontiera occidentale.
Per la difesa dei fronti avanzati occorreva poter disporre di una adeguata riserva mobile, dislocata fra Tobruch e Sollum. Urgeva inoltre potenziare concretamente i due fronti difensivi e disporre di qualche grande unità per dare il cambio in linea alle unità più provate. F intanto che queste misure non fossero perfezionate la situazione difensiva complessiva dei fronti avanzati doveva essere considerata come precaria. P er il fronte di T obruch si raccomandava di metterlo agli ordini di un unico comandante, preferibilmente- italiano.
Per il momento, e fin quando non si fosse disposto di forze eccedenti allo stre tto fabbisogno della difesa im m ediata dei fronti avanzati, appariva discutibile la convenienza di mantenere delle unità su li11ee arretrate: bisognava ev itar e il frazionamento delle forze, a rischio di risultare deboli ov unqu e.
Passando alla difesa dell'interno, il Capo di Stato Ma ggiore dell ' Esercito era dell'opinione che alla tranquillità del territorio, ad eccezione delle località m o lto lo ntan e, si potesse provvedere con maggiore efficaci a con reparti mobili, u tilizzabili eve ntualm ente anche per altri scopi, piuttosto che con i presidi fissi. Riteneva consegue ntemente vantaggioso disimpegnare la Di visione « Bologna >> dagli attuali compiti territoriali n el Gebel Cirenaica, per dislocarla più avanti, nell'ambito dello schie r amento difensivo avanzato.
La difesa costiera già in atto veniva giudicata sufficiente per parare piccòli tentativi di sbarco, nettamente insufficiente invece di fronte a te ntativi di maggio r m ole, per il possesso dei porti, o dovunque effettuati. Si ri conosceva però impossibile per il mom en to inviare dall'Italia forze idone e sufficienti a colmare qu esta lacuna .
Quanto all'ipotesi peraltro puramente teorica al momento, di un attacco dall'ovest (Tunisia), le truppe ed i mezzi della Tripolitania venivano giudicati assolutamente insufficienti.
Il gen. Roatta riconosceva la necessità di rinforzare al massimo l'aviazione: la massa in Cirenaica per la difesa dei fronti avanzati, un'aliquota a portata di Bengasi ed un'altra a portata di Tripoli per la difesa antisbarco. Il Comando della s"' Squadra Aerea riteneva di essere in condizione di poter ricevere, previa attrezzatura logistica, un rinforzo di due gruppi da caccia e sei da bombardamento.
La memoria concludeva ricordando esplicitamente come il ritmo dei trasporti, a prescindere dalle condizioni meteorologiche e dalle offese avversarie, fosse indissolubilmente legato ad elementi materiali di valore assoluto: tonnellaggio, velocità del naviglio, rotte, scorta, capacità di carico e di scarico dei porti. Dal complesso di questi elementi risultava che, pure adottando opportuni accorgimenti nella scelta delle rotte e nell'organizzazione delle operazioni di carico e scarico, non si sarebbe superata sensibilmente la media giornaliera di 6ooo tonnellate (4ooo a Tripoli, 2000 a Bengasi), esclusi i carburanti non infustati: una cifra che, una volta soddisfatto il fabbisogno della forza presente e della popolazione, lasciava minimi margini per il programma di potenziamento. Senza l'avvento di nuove condizioni, tali da mutare sostanzialmente la situazione aeronavale nel Mediterraneo (neutralizzazione della flotta britannica) o da consentire l'util izzazione di nuove linee di rifornimento più brevi e più sicure (Biserta) avremmo certamente perduto la gara sul tempo con l'avversario e, anziché raggiungere tempestivamente una concreta superiorità delle forze, ci saremmo trovati di fronte alla superiorità dell'avversario stesso.
Il r8 luglio aveva luogo fra il gen. Garibaldi e il gen. Bastico lo scambio delle funzioni di Comandante Superiore delle FF. AA. in A.S. Il Duce aveva fatto pervenire due giorni prima le seguenti direttive:

« I 0 - L'afflusso in A.S.I. delle forze e dei mezzi ormai largamente predisposti in Italia e in corso di aumento, per ripristinare l'efficienza delle nostre unità costà operanti o per inviarne di nuove, trova limitazione nelle note difficoltà dei trasporti e nel limitato rendimento dei porti di sbarco.
« 2 ° - D'altro lato le forze britanniche in E gitto appaiono in continuo aumento, allo scopo evidente di riprendere al più presto
l'azione offensiva contro di noi; tentativi di sbarco sulle coste della Libia sono anche possibili, con speciale riferimento alle zone di Tripoli e di Bengasi.
« 3o - Ciò posto, mentre è previsto che l'Asse svilupperà a buon momento una doppia contemporanea azione offensiva contro l'Egitto, dalla Cirenaica e dal Medio Oriente, tale azione deve essere rimandata ad epoca più propizia, anche in relazione allo sviluppo delle operazioni in Russia.

<< 4o - In tale attesa occorre:
a) potenziare al massimo l'assetto resistente della Cirenaica con le unità che vi si trovano, debitamente completate, avendo presente che tale completamento potrà essere attuato con gli invii, che a prezzo di grandi sforzi, saranno fatti dall'Italia durante il mese in corso e che l'afflusso di nuove forze; se pure limitato, potrà iniziarsi nell'agosto;
b) curare al massimo l'organizzazione difensiva sul fronte orientale e creare la disponibilità. di una forte riserva mobile per la manovra;
c) esaminare ed attuare le misure necessarie per prevenire possibili tentativi avversari di aggiramento da sud;
d) esaminare l'organizzazione di comando delle forze operanti sul fronte orientale ed inoltrare proposte orientate ad ottenere un più agile funzionamento dell'insieme. Tenere presente l'opportunità di costituire, appena possibile, un gruppo corazzato mobile agli ordini del gen. Rommel;
e) preparare, specie con le artiglierie e con gli altri mezzi in corso di avviamento, l'operazione per espugnare la Piazza di Tobruch. Siccome tale preparazione richiederà tempo, continuare intanto una sistematica attività, specie di artiglieria e di aviazione, per fiaccare la resistenza fisica e morale della Piazza, ostacolarne i rifornimenti via mare e impedire al presidio di concorrere attivamente all'attacco da est sul fronte di Sollum;
f) per quanto concerne la Tripolitania, tenere presente che nell'attuale situazione la minacca più grave è quella di uno sbarco: perciò orientare prevalentemente le forze ivi dislocate nel senso della difesa costiera;
g) ogni sforzo deve essere fatto per migliorare quanto più possibile la capacità di sbarco di Tripoli e di Bengasi e l'organizzazione della difesa aerea e contraerea di tali località.
<< E ' ovvia misura prudenziale continuare lo studio e l'organizzazione delle posizioni arretrate già previste da codesto Comando
Superiore, posizioni che potranno essere embrionalmente guarnite con elementi tratti dalla Tripolitania e in seguito, quando ciò sarà possibile, con unità a turno di riposo» .
Come si vede, il rigoroso senso di realismo che aveva ispirato la relazione del gen. Roatta aveva già subìto una sensibile attenuazione risalendo a livello del Comando Supremo e nelle direttive che venivano impartite sotto l'autorità della firma del Duce. Nella prima si affermava senza mezzi termini che l'espugnazione di Tobruch non era neppure concepibile « come operazione a breve scadenza >> e che l'offensiva contro l'Egitto appariva come <<una eventualità molto lontana>> , io relazione alla reale capacità dei trasporti che, salvo sostanziali mutamenti nella situazione aero- navale nel Mediterraneo, potevano a malapena sopperire alle ordinarie esigenze di alimentazione delle forze già presenti in Africa Settentrionale e risultavano impari all'esecuzione di un ponderoso piano di potenziamento. Nella direttiva di Mussolini ci si preoccupava invece di mantenere viva, sullo sfondo, l'idea dell'offensiva verso l'Egitto, nella nebulosa di una colossale operazione a tenaglia di cui l'altra branca sarebbe stata manovrata dalle forze tedesche, una volta liquidata definitivamente l'Armata Rossa. Senza nulla dire in merito ad una futura intensificazione dei rifornimenti (se si astrae da una platonica affermazione di principio) si prescrive di preparare appunto quelle operazioni che la relazione Roatta sosteneva tassativamente impossibi li senza un sostanziale aumento della corrente dei trasporti.
Il 26 luglio il gen. Bastico, dopo avere riconosciuto personalmente la situazione e preso contatto con il gen . Romme l, con i comandanti della Grandi Unità in lin ea e con le truppe, comunicava al Comando Supremo le proprie impressioni.

In relazione alla loro organizzazione e all'armamento - egli osservava - le divisioni italiane avevano scarsa efficienza e insufficiente mobilità. Si trovavano ad avere tutti gli elementi in linea e mancavano di ogni riserva e della possibilità di turni di riposo (r).
Il geo. Rommel le giudicava pertanto m eno idonee all'attacco e tendeva ad impiegarle nello snervante servizio di trincea: ne risultava
(r ) Un punto di riferimento può essere forn i to dal paragone fra il numero deg li automezzi in quel momento a disposizione delle due divisioni tedesche da una parte e delle sette divisioni italiane c tutti i servizi genera li de ll a colonia dall'altra: 7000 contro 8500 (d i cui 1500 fuori uso o in riparazione).
che erano destinate a sostenere l'urto nemico, in caso di attacco, mentre alle divisioni tedesche rimaneva riservato il compito della manovra e della riconquista degli elementi eve ntualm ente travolti.

Il gen. Rommel sosteneva che, rappresentando le divisioni corazzate tedesche l'unica riserva mobile efficiente per i due fronti di Sollum e di Tobruch, questi dovessero trovarsi alla dipendenza di un unico coma ndante . Ciò equivaleva a lasciare tutte le unità operanti contro g li Inglesi agli ordini del comandante tedesco.
In considerazione della riconosciuta tensione della situazione del fronte avanzato, n ei suoi due elementi di Tobruch e di Sollum, il gen. Bastico si proponeva di portare in Cirenaica tutto quanto risultasse sottraibile alla Tripolitani a.
Il Capo di Stato Maggiore Generale tornava a ribadire il 4 agosto che la situazio ne dell'Africa Settentrionale era funzione del problema dei trasporti: in tale campo si stava esercitando, affermava, il massimo sforzo possibile, così da parte delle autorità centrali come da quella delle autorità locali. Le perdite subìte per eventi bellici avevano inciso in importanti settori (artiglierie, munizioni, carburante) e questo faceva sì che purtroppo non si potesse considerare prossima l'espugnazione della piazzaforte di Tobruch.
Il gen. Cavallero co ncordava co n il proposito di ritirare dalla Tripolitani a tutto quanto possibile, a beneficio del fronte cirenaica n elle cui unità, ricordava, erano inquadrati solo 45.000 uomini su 120.000 nazionali e 20.000 libici presenti in Africa Settentrionale.
Il Capo di Stato Maggiore Generale richiamava l'attenzione del gen. Bastico sull' ultim o comma delle recenti direttive del Duce, relativo allo studio e l'approntamento delle posizioni arretrate già previste dal Comando Superiore, sottolineando che l' i mba stitura della posizio ne D erna- Mechili (da integrare con la salda organizzazione di Agedabia, quale punto di appoggio per forze mobili destinate a contrastare possibili tentativi di aggiramento a largo raggio, da parte di forze leggere avver sarie) era problema da portare avanti con la massi ma alacrità, per poter disporre di tale posizione in stato di efficienza nel momento in cui si pronunciasse l'attesa offensiva avversaria dal Deserto O ccide n tale.
Non si può evidentemente evitare l'impressione che questo ultimo suggerimento del gen. Cavallero contrastasse decisamente con la raccomandazione del gen. Roatta di non disperdere forze sulle posizioni arretrate, fin quando n on ne risultassero di disponibili in
eccedenza alle esigenze della difesa dei fronti avanzati (il che, seco ndo la visione del gen. Roatta, rinviava p raticam ente il provvedimento ad un futuro co mpletamente ipotetico) per non cadere nell' errore di risultare deboli ovunque, proprio per correre dietro ali 'illusione di poter parare a tutto.
Sta di fatto che la lettera del 4 agosto denuncia uno stato d'animo completamente diverso da quello che aveva ispirato le direttive del r6 luglio. Queste rispondevano all'illusione, o a lmeno alla speranza, di poter adempiere agli impegni del grande piano di potenziamento delle forze dell'Africa Settentrionale, concepito appunto in funzione di una prossima ripresa offensiva su lar ga scala; la l ettera invece (come si avrà occasione di documentare in seguito) è dettata sotto la precisa impressione del fallimento di quello stesso programma, su l piano dei trasporti. La gara a tempo per il ra ggiungimento della superiorità sull'avversario è già data per perduta e occorre far fronte alla realistica ipotesi di un pr ossimo ritorno offensivo dell'avversario. Il problema delle posizioni arretrate, appena sfiorato n elle ultime righe nelle direttive del r6 luglio, passa così al primo posto nella lettera del 4 agosto .

Caratterist i c he dello In sostanza, il Coma ndo Supremo giudicava sc hieram e nto ital otedesco a i primi di agosto.
oramai certa una prossim a ripresa offensiva da parte dell'avversario. Le forze italo- tedesche erano ali 'incirca ancora le stesse che avevano già sostenu to l ' attacco del rs- r8 giugno: si era aggiunta soltanto la D ivisione << Savona », incompleta, che era stata fatta affluire dalla Sirtica . La si tuazion e logistica permaneva molto seria.: anziché aumentare il ritmo dei trasporti , non si era realizza to neppure il modesto potenziamento previsto per il mese di luglio: fra l'altro erano andate perdu te due navi cisterna e due batterie pesanti desti nate all'assedio di T obruch.
Ai primi di agosto lo schieramento aveva le seguenti caratteristiche:
- in Tripolitania: non esisteva alcuna unità mobile in co ndizione di agire eventualmente alla frontiera tuni si na. L'unica gra nde unità pesante, la Divisione « Sabratha », era in via di ricostituzione e completamente sp rovvi sta di m ezzi di tra sporto;
.
le Divisioni « Brescia >>, « Pavia >> e « Trento >> e la XV Brigata tedesca erano im m obilizzate per l'investimento di Tobruch. La « T rento>> era su l punto di essere completata; ben poco si poteva fare per il completamento delle altre due con quanto si sarebbe riusciti a trarre dalle più che modeste disponibilità della Libia;
la Divisione « Ariete » era impegnata per la protezione delle spalle del fronte di Tobruch contro eventuali tentativi di sbarco e come riserva del fronte stesso;
la Divisi one « Savona>>, insieme ad elementi tedeschi, provvedeva al presidio del fronte est;
la 15a e 21• Divisione Corazzata tedesca (1) costituivano la riserva mobile, proiettata verso est ma legata anche alle vicende operative del fronte di Tobruch;
.
la D ivisione « Bologna>> era infi n e dislocata indietro, sul Gebel Cirenaico, tra Ain el Gazala e Bengasi.
Tale schierame nto prese ntav a in sos tanza cara tteristic he rispondenti al concetto di una temporan ea sosta ope rativa, in attesa della eli min azione di Tobruch, prima di riprendere lo slancio offensivo verso es t. Vi si possono bensì riconoscere gli clem enti fondamentali delle dir ettiv e ema nate dal Duce il 16 luglio : « potenziare il più possibile l'aspetto resistente della Cire n aica », agire sistematicamente per ammorbidire la resistenza della Piazza in vista della prossima espugnazione, procedere al l'or ganizzazione di posizioni arr etrate. Non rispondeva però ce rtamente al prudente criterio difensivo racco mand ato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, in vista di un prossimo a ttacco sul fron te est ch e si prevedeva condotto con magg iori forze, in co ncomitanza con una d ecisa sortita degli assediati ed anche, eventualmente, co n uno sba rco ad ovest della Piazza.
Elem enti nuovi si erano verificati n ella situazione generale, dopo la battaglia di Sollum, a n ostro sfavore.
L 'aper tura del fronte russo impegnava or mai totalmente la massa delle f orze tedesche, distrae nd o sempre più l'interesse dcii 'OKW (e di Hitler in particolare) dalle vicende del teatro di guerra del Mediterraneo. Per il momento n on vi era n eppure da pensare a quel

ponderoso concorso della Wehrmacbt, in vista della grande operazione a tenaglia per il Canale di Suez, di cui si andava parlando molto vagamente.
L'andamento degli avvenimenti in Siria e l'accentuarsi del movimento gaullista nel Nord Africa francese, avevano indotto il Governo di Vichy ad attenersi ad un atteggiamento più guardingo. Così le trattative per l'utilizzazione del porto di Biserta erano finite in nulla ed era ormai tramontata la prospettiva del passaggio di nostri materiali attraverso la Tunisia. Di più, la nuova situazione ci imponeva di assumere provvedimenti cautelativi verso quella frontiera.
Tutto lasciava prevedere (d'accordo con numerose informazioni) che il nemico avrebbe tentato di cogliere il momento favorevole per attaccarci al più presto in Cirenaica, potendo ragionevolmente contare anche sulla eventualità di una sollevazione a noi ostile nell'Africa Settentrionale francese. Risultava quindi completamente fuori di luogo, almeno per il momento, pensare all'espugnazione di Tobruch e tanto meno a maggiori operazioni offensive in E gitto: il problema concreto era quello di mettersi in condizione di sostenere vittoriosamente la dura battaglia difensiva che si preannunciava in Cirenaica .
Ci si attendeva che il prossimo attacco, a parte l'entità delle forze, avrebbe avuto più o meno le stesse caratteristiche fondamentali di quello del 15 giugno: investimento frontale del settore SollumHalfa ya e azione aggirante per Sidi Ornar verso nord- est, con compito di battere, o quanto meno immobilizzare le forze motocorazzate tedesche. In più si prevedeva un'operazione aggirante sussidiaria a più largo raggio che, partendo da Bir es Sceferze nMaddalena, tendesse per Bir el Gobi a cadere su el Adem, alle spalle del nostro schierame nto di Tobruch e forse anche più oltre, sul nodo di Mechili, la vera chiave di tutto il Gebel Cire nai ca .
In questa ipotesi, la Divisione << Savona >> e le due Divisioni Corazzate tedesche (meno la XV Brigata) avrebbero dovuto sopportare il peso principale dell'attacco mentre tutte le altre forze rimanevano impegnate nell'assedio di T obruch. La sola « Ari ete» sarebbe restata dis ponibile per contrastare l'accennata minaccia su Bir cl Gobi e Mechili.
L 'operazione sarebbe risultata articolata in tre episodi di stinti, seppure interdipendenti, e il successo di ciascun episodio avrebbe potuto essere determinante per l'annientamento di tutto il nostro schieramento della Marmarica, lasciando l'intera Libia in completa balia del nemico.

S tudi relativi all' cven- In base ad analoghe considerazioni, il Cotuale abbandono della mando Supremo aveva posto allo studio la Marmarica. eventuale opportunità di abbandonare volontariamente Sollum e Tobruch, per raccogliere a difesa su di una sola posizione tutte le forze disponibili.
Si era considerato non sufficientemente rispondente la posizione di Ain el Gazala, precedentemente scelta dal Comando Superiore A.S. d'accordo con il geo. Romm el. Il Comando Supremo si era orientato ora sulla posizione di Derna, con margine anteriore lungo la linea M artuba- Mechili ed elementi avanzati T mimi - Bir Tengede r, su di un'ampiezza di circa 100 chilometri. Avrebbe dovuto essere occupata a capisaldi da tutte le divi sion i attualmente distribuite sui fronti di Sollum e Tobruch o dislocati nel Gebel ( « Savona», « Pavia », « Brescia », « Bologna ») m entre le due divisioni corazzate tedesche, l' « Ariete >> e la « Trento », avrebbero dovuto costitui re una poderosa massa di manovra, in grado di agire controffensivamente contro le forze mobili avversarie. L'urto fron tale sarebbe stato sostenuto, anzi ché dalla sola Divisione «Savo na >> e dalle due divisioni corazzate tedesche, da un'intera armata di qu attro divisioni di fanteria, tre divisioni corazzate e una divisione motorizzata.

Le due divisioni che si sarebbero rese libere a Tobruch per la parte avversaria sarebbe ro state largamente compensate, da parte nostra, con il recupero della libera disponibilità di quattro divisioni. Si sarebbe inoltre raggiunto il vantaggio di costringere l'avversario ad affrontare la battaglia a maggior distanza dalle sue basi, mentre la nostra linea di comunicazione n e sarebbe risultata corrisponde ntemente raccorciata.
Non si riteneva che l'avversario potesse avventurarsi con grandi forze per la pista desertica Bir Tengede r- Bir Gania su Agedabia, lasciand osi alle spalle tutte le nostre forze raccolte sul Gebel. Comunque la n ostra ma ssa moto- corazzata avrebbe potuto operare in condizioni particolarmente favorevoli sul fianco delle colonne britanniche che si fossero eve ntu alme nte avventurate per quella direttr ice. Agedabia doveva essere comunque organizzata a caposaldo, anch e per impedire ad elementi leggeri di raggiungere la litoranea ed insidiare le nostre retrovie.
Si pensava che il coraggioso sacrificio della Marmarica avrebbe salvato la Libia, espos ta a grave e imminente pericolo di essere somme rsa.
Il ripiegamento avrebbe dovuto essere mascherato, lasciando sulle posizioni avanzate elementi di fanteria co n compito di resistenza ad oltranza e qualche grande unità corazzata incaricata di svolgere azione ritardatrice, opponendo all'avanzata dell'avversario un'accorta difesa elastica. Tenendo conto degli automezzi disponibili, il ripiegamento avrebbe dovuto compiersi per scaglio ni · successivi, sotto la protezione delle unità corazzate, dando la precedenza alle forze del fronte di Sollum, seguite da quelle di T obruch.
In un secondo studio, del 5 agosto, il Comando Supremo aveva calcolato i tempi della eventuale operazione, precisando che sarebbero state necessarie tre settimane. Si prevedeva che a un certo mom ento il nemico, si sarebbe reso conto di quanto stava accadendo e avrebbe quindi esercitato una forte pressione per coglierci in piena crisi di movimento. Il prezzo della manovra sarebbe consistito nel sacrificio degli clementi lasciati indietro in copertura c nel logorio di qualche unità coraz zata.
Con la seguente lettera il Capo di Stato Maggiore Generale dava incarico al Comandante Superiore FF. AA. A.S. di studiare nei particolari modalità e tempi di esecuzione dell'operazione, la cui riuscita doveva basarsi essenzialmente sul segreto : SUPREMO

5 ago sto 1941 -XIX
Le trattative per effettuare i trasporti per la Libia via Biserta sono per il momento arenate. Dobbiamo perciò fare assegnamento soltanto sulle vie di Tripoli e di Bengasi il cui rendimento è noto, come sono noti i rischi ai quali esse sono espos te.
All'espugnazione di Tobruch non sarà possibile pensare per un lun go periodo, tenuto anche presente che le grosse artiglierie a ciò destinate sono state affondate e che il Comando T edesco non può pe r ora sostituirle.
L'atteggiamento della Francia diventa sempre più infido cosicché dobbiamo prcoccuparci, se non subito almeno per un avvenire prossimo, del Nord Africa francese.
Così stando le cose è evidente che non si può pensare per ora ad una nostra offensiva dalla Cirenaica verso oriente, programma al quale corrisponde il nostro presente schieramento in Cirenaica.
Si impone invece di considerare prossimo un attacco avversario contro di noi.
La limitazione delle nostre cor r enti di trasporto non ci ha permesso di potenziare l'assetto resistente della Cirenaica nella misura che sarebbe stata possibile se la via di Biserta ci fosse stata aperta com e si era sperato . Come ho esposto nella mia lettera del 4 corrente n oi stiamo facendo e continuiamo a fare tutti gli sforzi che sono possibili in materia di trasporti.
Il risultato di qu esti nostri sforzi sarà certamente quello di portare la nostra Colonia ad un assetto difensivo soddisfacente. Però, m entre il problema della frontiera libica occidentale comincia ad affacciarsi e vuole essere considerato, alla fronti era orientale il nostro schieramento non appare sufficiente per affrontare un attacco nemico che fosse condotto con forze decisamente superiori a quelle del giugno.
In tal caso la massa mobile di cui disponiamo, dovendo servire di riserva tanto per il fronte di Sollum che per quello di Tobruch, non rimarrebbe disponibile per stroncare la manovra a largo raggio che il nemico non mancherebbe di tentare con forze adeguate.
Già nelle direttive del 16 luglio il Duce ha sottolineato la necessità di predispo rr e una posizione arretrata e sulla pronta imbastitura di questa ho insistito nella mia lettera del 4 corrente.

Il trasferimento della nostra resistenza su tale posizione si imporrebbe senza dubbio nell'ipotesi sopra considerata e ciò allo scopo di sottrarci all'aggiramento e trovarci in pari tempo con le forze raccolte e la massa di manovra disponibile per dare battaglia nelle condizioni più favorevoli.
Uno studio compiuto da qu esto Comando circa il mecca nismo di un tale spos tam ento ha portato a concludere che esso non potrebbe essere effettuato con successo sotto la pressione del n emico. Ne risulta la necessità che, volendolo compiere come è necess ario, esso deve effe ttuarsi in anticipo rispetto all'offensiva avversaria. E poiché, seco ndo le informazioni ormai concordi, dobbiamo attenderci que sta offensiva verso il settembre, si conclude che il movimento deve essere organizzato ed eseguito nel corso del mese di agosto.
Ciò premesso si dispone:
1 " - Codesto Comando esamini modalità c tempi dello spostame nto da eseguire, avendo presente che lo sgombero d ei pochi magazzini e degli elementi non combattenti e non strettamente necessari alle unità deve precedere il movimento delle unità medesime ed essere fatto in guisa da non dare al nemico l a sensazione di quanto si prepara.
2 ° - Poiché è previsto che il gen. Rommel conservi alla propria dipendenza tanto il fronte di Sollum quanto quello di Tobruch, il movimento deve essere studiato in pieno accordo con il generale stesso al quale, secondo le intese qui già avvenute, può essere affidata " la responsabilità dell'esecuzione.
3o - La nuova posizione, già indicata sulla linea approssimativa Derna- Mechili (più organizzazione di Agedabia) sia imbastita in anticipo con tutti gli elementi disponibili, artigli e rie comprese. Con le forze disponibili sarà possibile attuare su questa posizione un solido schieramento con scaglionamento in profondità, conservando la massa mobile per la manovra , che rappresenta il nostro scopo essenziale.
4° -A schieramento così ultimato sarà il caso di esaminare se la Divisione Motorizzata « Trieste», il cui completamento in atto è previsto per i primi di settembre, non possa esse re lasciata in Tripolitania per costituirvi il primo nucleo dello schieramento verso ovest. Questo Comando pensa che subito dopo si potrebbe provvedere al completamento ed alla motorizzazione della Divisione « Sabratha » e ciò prima di far luogo all'invio in Libia di altre grandi unità complete. Su questo punto si gradirà conoscere il pensiero di codesto Comando.
Occorre appena accennare che la buona riuscita di questo concentramento delle forze dipende essenzialmente dal segreto. Nessuno sforzo sarà superfluo per mantenere celata al nemico la nostra manovra, fino al momento nel quale avrà inizio il movimento delle unità. A questo momento assumerà speciale importanza l a massa di manovra alla quale spetterà il compito essenziale di proteggere contro l'azione nemica, compresa quella uscente da Tobruch, lo spostamento ordinato delle nostre divisioni fino allo schieramento sulla posizione prescelta.
L'intervento dell'aviazione in questa manovra sia studiato e regolato da codesto Comando tenendo presenti gli accordi in vigore con il Comando dell'Aeronautica tedesca.
 Il Capo di Stato Maggiore Generale Cavallero
Il Capo di Stato Maggiore Generale Cavallero
Come si è già avuto occasione di rilevare, a Roma ci si era ormai resi conto della materiale impossibilità di incrementare la corrente dei trasporti nella misura richiesta dall'impostazione di un programma offensivo c, andando oltre persino al realismo della relazione Roatta, ci si preoccupava soprattutto di salvaguardare il possesso della Colonia.
Diverso orientamento del Mar. Keitel. pralluogo del gen. Cavallero accompagnato dal gen. von Rintelen.
Giungeva intanto al gen. Cavallero una lettera del Maresciallo Keitel, datata 3 agosto, nella quale il Capo dell'OKW esprimeva il parere che fosse intempestivo stabilire il comtme piano di guerra delle Potenze dell' Asse contro le posizioni inglesi del Mediterraneo, prima che la campagna di Russia fosse conclusa.

Egli esponeva concetti alquanto diversi, o quanto meno alquanto sfasati, in merito alla situazione in Africa Settentrionale. A suo avviso i nostri sforzi dovevano tendere alla eliminaz ione della Piazza di Tobruch, per poter ricuperare le forze colà impegnate, a favore della difesa della frontiera egiziana . Riconosceva che il conseguimento di tale obiettivo risu l tava ostacolato dalle gravi difficoltà dei rifornimenti via mare ed ammetteva che si potesse essere costretti a dover giungere al ripiegamento dei due fronti di Sollum e di Tobruch, ma solo come soluzione estrema, nel caso che gli Inglesi attaccassero con forze preponderanti prima della conquista di Tobruch.
Tene nd o conto di questa eventualità, si prese nt ava la necessità di provvedere all'approntamento· di una posizione arretrata che il Maresciallo Keitel riteneva dovesse essere quella già scelta dal Comando Superiore A.S. all'altezza di Ain el Gazala.
Si riporta per esteso il testo della lettera, nella quale il punto di vista tedesco viene esposto nel quadro complessivo della situazione generale.
3 agosto 1941
Eccellenza
è giusto che io Vi fornisca di nuovo un quadro sintetico della situazione secondo il mio attuale giudiz io .
Nonostante la tenace resistenza ed i numerosi contrattacchi del nemico, le operazioni (sul fronte russo) si svolgono in conformità del piano prestabilito. Per quanto concerne il Gruppo Armate Sud, fondate ragioni ci permettono di prevedere l'annientamento di importanti forze avversarie già sulla riva del Dniepr. Faremo il possibile affinché il Corpo di Spedizione Italiano (C .S.I.R.) che si sta ora trasportando verso l'Ucraina e sta già avanzando, possa ancora partecipare a queste operazioni. Sarà nostra cu r a che il Cor po Ita-
liano venga impiegato riunito. Non è però escluso che si possano presentare situazioni nelle quali sarebbe contrario al senso della responsabilità rinunciare all'impiego di una o due divisioni già disponibili per il solo fatto che le dtte altre divisioni, o la terza, non si trovassero ancora sul posto. Analogamente, a suo tempo, il Corpo Tedesco in Africa lanciò immediatamente in combattimento perfino piccoli reparti, dopo il loro sbarco.
Il Fuhrer ha preso atto della magnanim a offerta del Duce di concedere, in caso di n ecessità, un secondo Corpo Italiano per il fronte Est, e ringrazia.

Il Gruppo Armate Centro ha frantumato, con le sue formazioni celeri, importanti forze avversarie nella z.ona a nord -ovest di Smolensk, frazionandole in piccoli gruppi; ha pure respinto in sanguinosi combattimenti concomitanti attacchi diversivi dei Ru ssi ad est c sud- est. La vittoriosa conclusione della battaglia al centro del fronte orientale fornirà la base per le future operazioni.
Dopo il vittorioso sfo nd amento che porta le sue formazioni celeri oltre il Luga, il Gruppo Armate Nord attende l'arrivo delle divisioni di fanteria che permetteranno di completare con attacchi l'accerchiamento di Leningrado.
Gli Inglesi hanno finora trascurato di profittare dell'inchiodamento del grosso dell'esercito tedesco e dell'aeronautica tedesca sul fronte orientale. Neppure in avvenire essi oseranno tentativi di sbarco n ei territori occidentali occupati né credo che essi riusciranno a stabilirsi saldamente nella penisola iberica.
E' tuttavia certo che gli Inglesi hanno riconosciuto qual maggiore pericolo minaccerà, al termine della campagna ad Est, le loro posizioni nel Medio Oriente. Se opereranno correttamente (come dobbiamo presupporre) essi saranno portati a ritentare, n ei prossimi mesi, l'attacco contro la Cirenaica, nel duplice intento di impossessarsi dell'Africa Settentrionale I taliana e di influire, conseguentemente, sul contegno dei Francesi dell'Africa Nord- Occidentale.
E' perciò particolarmente confortante che il grande convoglio britannico che trasportava recentemente rinforzi verso oriente, seguendo il Canale di Sicilia, sia stato così efficacemente colpito dagli attacchi italiani. Anche per l'audace e vittoriosa azione contro Malta debbo esprimerVi, Eccellenza le mi e congratulazioni.
Non è tempestivo stabilire, prima che la campagna di Russia sia conclusa, il comune piano di guerra delle potenze dell'Asse contro le posizioni inglesi del Mediterra neo.
Per quanto concerne l'Africa Settentrionale ecco il mio concetto:
! 0 - I nostri sforzi devono essere diretti alla presa di Tobruch ed al conseguente annientamento delle locali forze inglesi, allo scopo di liberare e poter quindi utilizzare alla frontiera t giziana le unità attualmente impegnate nell'accerchiamento.
2 ° - Il conseguimento di tale obiettivo è però ostacolato dalle enormi difficoltà dei rifornimenti via mare. La perdita di artiglieria pesante e di altre unità destinate all'attacco contro Tobruch, in seguito al recente affondamento, è perciò particolarmente deplorevole perché non è prontamente ri parabile.
3o - Qualora gli Inglesi dovessero attaccare con forze preponderanti prima della presa di Tobruch, sarà necessario, in caso estremo, ritirare verso ovest le forze dei fronti di Sollum e di Tobruch, preferibile in ogni caso ad una sconfitta alla frontiera eg1z1ana.
4o - Il riconoscimento di tale eventualità esige che si faccia il possibile per approntare almeno posizioni arretrate, decorrenti approssimativamente da Ain el Gazala in direzione sud- ovest, protette sui fianchi, dalla zona di el Mechili, mediante azioni difensive condotte da formazioni mobili : tanto meglio se tali posizioni non saranno utilizzate.
5° - Passando da tali concetti alla preparazione del successivo sbalzo contro il Canale di Suez, è stata prevista la partecipazione di un Comando di Gruppo Corazzato alle dipendenze del gen. Rommel che, a sua volta, è sottoposto al Vostro Comandante, gen. Bastico.
Come apprendo dal gen. von Rintelen, Voi siete d'accordo che il fronte di Tobruch rimanga, in un primo tempo, alla dipendenza del gen. Rommel: considerata l'intima connessione del tronco di Sollum con quello di Tobruch, ritengo che questa sia la soluzione migliore.

Se motivi particolari dovessero però richiedere più tardi che il fronte di Tobruch passasse alle immediate dipendenze del Comando Superiore Italiano, il Gruppo Corazzato Rommel dovrebbe potere almeno disporre, oltre che di un Corpo italiano (fronte di Sollum) possibilmente anche di ulteriori formazioni italiane.
6" - La sicurezza ed il miglioramento dei trasporti marittimi conservano la loro decisiva importanza. A tale oggetto occorre tenere presente che noi continueremo a fare assegnamento principalmente sui porti italiani di Tripoli e Bengasi.
Non appena le operazioni in oriente saranno giunte ad una temporanea conclusione apprezzerò moltissimo un incontro con Voi per fissare il piano delle ulteriori operazioni. Tale piano non verrà allora dettato dalla volontà di riposare sugli allori, bensì da quella di utilizzare l'inclusione della Russia come base di operazioni in grande stile anche nel Medio Oriente, atte a migliorare la situazione strategica dell'Italia.
Con particolare riconoscenza ho accolto la decisione del Duce di inserire nella compagine del Comando italiano gli Stati Maggiori di Collegamento germanici, per giungere ad una più stretta collaborazione con Roma. Vi prego volerVi servire anche in avvenire del gen. von Rintelen per l'ordinario scambio di vedute tra Voi ed il Comando Supremo della Wehrmacht da me dipendente.

Il Vostro desiderio recentemente trasmessomi dal gen. von Rintelen di concedere a fabbriche italiane la costruzione del carro III e IV è attualmente in esame : esso verrà per quanto possibile soddisfatto.
Con saluto di camerata rimango
Si può osservare che, a parte la ricchezza di pareri e suggerimenti e l'evidente tono di estrema cortesia, nella lettera non si ravvisa alcun cenno a qualsiasi forma di partecipazione attuale, con nuovi mezzi, alla soluzio ne, o almeno all'alleggerimento, della grave crisi che fronteggiava l e nostre forze dell'Africa Settentrionale. L a cosa può ritenersi anche naturale, nell'ora in cui lo sforzo della Germania era tutto teso all'assolvimento dell'enorme compito che essa stessa si era assunta il giorno che era partita alla conquista dello sterminato dominio sovietico.
La visione del Maresciallo Keitel collimava sostanzialmente con quella del nostro Comando Supremo, q uale risulta dalle direttive del 16 luglio, ma appariva sostanzialmente diversa dal pensiero del generale Cavallero alla data del 4 agosto. Rispondendo il 5 agosto al Capo dell'OKW, dopo aver trattato l'argomento con il gen. Rommel, il gen. Cavallero sottolineava particolarmente la concordanza di ved ute sulla pr evisione di un prossimo attacco in forze degli Inglesi, certamente consci del pericolo che avrebbe minacciato la loro posizione del Medio Oriente al termine di una campagna vittoriosa per i Tedeschi sul fronte orientale.
L 'i nd omani il Capo di Stato Maggiore Generale si recava in Libia, accompagnato dal gen. von Rintelen, per riesaminare sul posto la situazione insieme al gen. Bastico.
L a posizione di Ain el Gazala, evide ntem ente, era stata prospettata all'OKW dallo stesso gen. Rommel. Come si è accennato, sulla scelta aveva concordato a suo tempo anche il Comando Superiore italiano, talché ne erano già stati avviati i lavori di rafforzamento.
In una riunione preliminare (alla qual e partecipavano il generale Gambara, Capo di S.M. del Comando Superiore A.S., il gen. Passi, Capo Ufficio Operazioni dello stesso Comando, e il gen. Manca, Comandante Superiore di Artiglieria in A.S.), il gen. Cavallero precisava che la posizione di Aio el Gazala, giudicata dal Comando Supremo e dal Comando Superiore A.S. di limitate possibilità difensive e di appoggio, sarebbe stata ugualm ente presa i n considerazion e, per tener conto del punto di vista del generale Romrn el e armonizzare le nostre vedute con quelle dei T ed eschi, dato che questi dispone vano delle truppe più mobili ed efficienti ai fini della manovra. Conseguentemente, al concetto di una posizione arretrata ad occidente di Tobruch si doveva ora sovrapporre quello della disponibilità di una nuova massa mobile motocorazzata (Divisioni «Ariete», « Trento » e « Trieste ») (r) dislocata in posizione arretrata, in condizione di agire in tutte le direzioni e di concorrere con la manovra alla resistenza delle grandi unità staticam ente impegnate nella difesa della posizione.

In una successiva riunion e (8 agosto) alla quale partecipavano anche il geo. von Rintel en e il ten. col. Heggenreiner (uffìcale di collegam ento presso il Comando Superiore A.S.) si giungeva alle seguen ti deliberazioni, r egol armente verbalizzate (allegato n. 2 3) :
- costituzio ne di un Corpo d'Armata mobile, con le Divisioni « Trento», « Ariete » e « Trieste», agli ordini del gen. Gambara (che conservava la carica di Capo di S.M. del Comando Superiore A.S.) (2);
( r) L'afflu e nza dall' I talia della Divisione motorizzata « T rieste >> era prevista fra la fine di agosto e i primi di settembr e.
(z) La Divisione « T rento n poteva essere ritirata subito dal fronte e sostituita dalla « Bologna >> Le veniva assegnato un battaglione ca rri L, di spo nibile.
La Divis ion e « Ariete >> disponeva dei suoi tre battaglioni carri M; altri 36 carri M, ri cuperati in discrete condizioni, sarebbero serviti all'occorrenza per i r impiazzi. Il reggimenro bersaglieri (col. Monte murro) sarebbe stato ritirato dal fronte di So!J um , prcvia sostituzione.
- organizzazione d ella pos1z10ne di Ain el Gazala, st ente di una linea di sicurezza e una posizio n e di resistenza, sulla quale i lavori erano già abbastanza avanzati: ne sa rebbero sta ti cupati gli elementi principali con altre forze di sponi bili e se ne rebbe predi sposta l 'a ttr ezzatura logistica e un ' ad egua ta rete dei legamenti. L 'occ upazion e della posizione dov eva rispondere alla «i potesi di una decisione di arretramento preventivo, presa in zione alla situazion e generale e ali ' imminenza di un attacco di for ze nettam ente preval enti ... La presenza di una ri se rva mobil e riva n ecessaria anche, e più che m ai, in qu esto caso perché una linea difen siva del ge n ere non poteva essere con cepita che co m e punto di partenza per la manovra »;
- espugnazione di Tobruch non appena com p leta ta fluenza d ei mezzi rich iesti (soprattutto artiglie ria e munizi oni) e di almeno al tre due divi sio ni (una corazz ata ed una normal e) : questo obiettivo costituiva il presupposto indispensabile per l a futura presa offensiva verso l ' E gi tto;
- scioglimento del Comando dell a s• Arm ata e zione del XX Corpo d'Armata in Comando Territoriale della litania ( 1 ), allo scopo di realizzar e, attrav er so un allegger imento le strutture, il ricupero di personale e m ezzi a favore della na1ca;
-conservazione del comando unitario d ei fr onti T o bruch Sollum, alle dipendenze del gen. Rommel. Il gen. Rommel non aveva potuto parteci pare alla riunione ché trattenuto in Germania ma il 9 agosto, alla presenza del rale Bastico e del gen. von R intele n , si dichiarava perfettamente cordo con quanto era sta to convenuto. In relazione alle decisioni raggiunte si era proceduto anch e a qualch e ri man eggi am ento male d ell'o rdinam ento dei comandi.
Conclusion e. Ottenuto il comando di tutte le truppe , liane e tedesche, operanti in M ar marica, Rommel ( finora Comandante d el « Corpo Tedesco Africa») tuiva il 15 agosto il Comando del Gruppo Corazzato Africa » ( « P anzer Gru ppe Afrika ») che, in relazione alla sua giurisdizione
( z) Al Comando T erritoriale della Tripolirania veniva designato il gen. Carlo Vccchiarelli.

territoriale, assumeva anche il nominativo di « Comando della Marmarica ». Analogamente il Comando del X Corpo d'Armata assumeva le funzioni e il nominativo di << Comando della Cirenaica ».
Il grosso Stato Maggiore di Collegamento tedesco presso il Comando Superiore A.S. si trasformava nello Stato Maggiore del Gruppo Corazzato Africa: veniva così a raggiungere, oltre ai compiti puramente logistici iniziali, quella competenza operativa che in primo tempo non gli si era voluta riconoscere, per timore di ingerenze nelle prerogative del Comando Superiore A.S. La nuova decisione giustificava, almeno in parte, le diffidenze sorte al momento della presentazione del voluminoso seguito del gen. Gause, ma il Comando Supremo non riteneva di muovere obiezioni : realisticamente giudicava che maggiore autorità e maggior prestigio il nostro Comando in Libia avrebbe potuto ottenere soltanto attraverso un sostanziale potenziamento e un radicale miglioramento delle armi e dei mezzi in dotazione alle truppe e ai servizi italiani alle sue dipendenze.
Con la costituzione del Gruppo Corazzato Africa, del Corpo d'Armata Mobile (che assumeva la denominazione di << Corpo d'Armata di Manovra » = C.A.M.) e del XXI Corpo d'Armata di Tobruch, l'ordinamento delle forze itaio- tedesche veniva a rispondere allo schema di cui alla seguente pagina.

In base ai concetti ora espressi, lo schieramento in atto alla data del 15 agosto era il segue n te:
- alle dipendenze del gen. Rommel, comandante del Gruppo Corazzato Africa, con competenza territoriale nella regione ad oriente del meridiano di A in el Gaza! a:
. sul fronte di Sollum: Divisione << Savona », rinforzata da elemen ti tedeschi;
. sul fronte di Tobrt-tclz: Divisione << Brescia » , XV Brigata Corazzata tedesca, Divisione << Pavia », Divisione << Bologna», inquadrate nel XXI Corpo d'Armata (r); in riserva, fra M ars.a Luch e Bardia, il Corpo Tedesco Africa;
- alle dirette dipendmze del Comando Superiore A.S.: il Corpo d'Armata di M anovra, costituito temporanea-
( 1) La XV Brigata, della 21 a D i visione Corazzata, resterà a far parte del XXI C.d'A. fino alla metà di ottobre
(t) Il Ragg rup pamento Esplorante de l C.A.M. era così costituito:
- un btg. P.A.I. (Poli1ia Aìrica Italiana);
- un btg. carri M 13 (da formare);
- un btg. carri L (111/Jzo);
- una cp. mitragl ieri con nucleo lanciabombc (de lla disciolta colonna
- una cp. del XXXI btg. guastatori (in corso d1 affluenza);
-un raggruppamento batterie «volanti» (cannoni da 65 / 17 montati su autocarri): un gr. su tre btr., un gr. su due btr. , un btr. autonoma; una btr. da 20 mm. anticarro;
- un gruppo da 105/28 ;,u due btr. (atteso dall'Italia);
- un gruppo c.a su due bt r. da 20 mm. (attC>O dall'ltali:1);
- btr. c.a. da 88 o 90 (attesa dall'Italia);
- una cp. mista del genio (attesa dali 'Italia);
- un autoreparto misto (da formare in Libia). Al raggruppamento sarebbero stati assegnati d i volta in volta re pa rti di fanteria, in relazione ai compiti da svo lgere.
(2) Division zur bcsonderen Verwendung = per impiego speciale. La si pot rebbe definire una grande unità motocorazzata leggera. Nel di novembre assumerà la denominazione di « Divisione Tedesca Afrika » che il 27 dello stesso mese si muteril in quella di 90" Divisione leggera « Afrika "·
(3) Le Divisioni " Bologna » e "Pavia • erano destinate ad assumere la formazione motorizzata " tipo A.S. • , come la Oi\•isio ne « Trento • che era in attesa degli automez7.i previsti.
(4) La Divisione " Brescia * doveva wnscrva re le ca ratteristiche delle divisioni metropolitane.
 (ge n. Bastico)
Corpo d'Armata di Manovra C.A.M.
Gruppo CoraZ7ato Africa G.C.A. (gen Gamharl) (gen. Rommel)
D. "Ariete » Rep. C.A.M. ( l)
D. " Trento»
lCorpo Tedesco Africa C.T.A. (gen. Cru well)
I) D.Cr. lla D.Cr. D .• D.z.b.V. (2) (già 5a D. Legg.)
lXXI C.A. (gen. Navarrini}
D. " Bologna » D. « Pavia » D. " Brescia " aliquote (J) (3)
l(4) D. • Sabr:uha •
Samamaria);
(ge n. Bastico)
Corpo d'Armata di Manovra C.A.M.
Gruppo CoraZ7ato Africa G.C.A. (gen Gamharl) (gen. Rommel)
D. "Ariete » Rep. C.A.M. ( l)
D. " Trento»
lCorpo Tedesco Africa C.T.A. (gen. Cru well)
I) D.Cr. lla D.Cr. D .• D.z.b.V. (2) (già 5a D. Legg.)
lXXI C.A. (gen. Navarrini}
D. " Bologna » D. « Pavia » D. " Brescia " aliquote (J) (3)
l(4) D. • Sabr:uha •
Samamaria);
mente dalla Divisione Motorizzata « Trento » e dalla Divisione Corazzata « Ariete », dislocato fra Ain el Gazala e Martuba;
• t Comandi di Settore di Derna, Barce ed Agedabia, che presidiavano con elementi vari il restante territorio della Cirenaica;
il X Corpo d'Armata cui era affidata la Piazza di Bengasi;
. il Comando della Tripolitania, con la Division e « Sabratha », più i normali presidi della frontiera tunisina e del Sahara Libico.
Per assicurare la migliore intesa fra i comandi italiani e tedeschi erano stati costituiti due Stati Maggiori Italiani di Collegamento: l'uno presso il Gruppo Corazzato Africa (gen. Calvi di Bergolo) per conto del Comando Superiore A.S. e l ' altro presso il Corpo T ed esco Africa (col. S.M. Lovera di Maria) pe r le relazioni con le unità italiane del fronte di Sollum.
Presso il Comando Superiore A.S. (ove, come si è accennato, lo Stato Maggiore di Collegamento tede sco, si era trasformato Comando del Gruppo Corazzato Africa) era rimasto il solo ten. col. Heggenreiner che manteneva il collegamento con il Comando del Gruppo Corazzato Africa.

Per le forze aeree, in seguito ad accordi stipulati a Roma nello stesso mese d'agosto fra lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ed il generale tedesco von Pohl, Comandante tedesco dell'Aviazione (Fliegerfiihrer) in Africa, a quest'ultimo restava devoluto il compito del coordinamento delle operazioni offensive delle locali forze aeree, tedesche e italiane.
I primi elementi della Divisione « Trieste » cominciavano ad affluire alla metà di settembre. L'unità passava senz'altro a far parte del Corpo d'Armata di Manovra, dislocandosi in primo tempo sul Gebel, fra Maraua e Slonta. La di slocazione d efinitiva del C.A.M. era prevista nel triangolo Ain el Gazala - Bir Hacheim - Garet Meriem, a portata 'di Tobruch e a poco più di 150 km. da Sollum (r), in condizione cioè di poter manovrare sul fianco di una eventuale colonna aggirante avversaria operante a largo raggio per cadere sul rovescio di Tobruch.
( r) Precisamen te : r6o km. da Bir Ha ch e im, 225 da Garct Me ricm.
Il gen. Rommel avrebbe preferito una dislocazione più avanzata, all'altezza di Tobruch, forse anche perché, venendosi a trovare ad est del meridiano di Ain el Gazala, il C.A.M. sarebbe passato alle dipendenze dirette del Comandante del Gruppo Corazzato Africa. Il Comando Superiore A.S. aveva invece ritenuto che lo spostamento non avrebbe migliorato sensibilmente la tempestività dell'intervento sul fronte di Sollum mentre invece avrebbe favorito la possibilità di aggiramento del l 'intero nostro schieramento, vuoi con una felice sortita dal fronte occidentale di Tobruch, vuoi mediante l'azione di forze celeri, dalla Ridotta Maddalena, per Bab el Serir- Bir Hacheim.
Concordando con tali considerazioni cd anch e per l'opportunità di mantenere una riserva nelle mani del Comando Superiore A.S. , per metterlo in condizione di parare alla eventualità di sbarchi o di minacce dal sud della Cirenaica (nonché per evidenti motivi di prestigio) (r) il Comando Supremo aveva sanzionato la dislocazione proposta, sottolineando inoltre l'importanza della disponibilità di una grande unità nella zona di Agedabia.
Risultava infatti una inconsueta attività della ricognizione avversaria lungo le piste Giarabub- Gialo- Agedabia c Tazerba- Marada- el Agheila. La minaccia non preoccupava per l'entità delle forze eventualmente impiegabili su quelle direttrici , ma avrebbe potuto riuscire molto seria per tutto lo schieramento della Cirenaica se effettuata in co ncomitanza con uno sbarco in forze nel Bengasino. Di qui l'importanza di una salda organizzazione di Agedabia, già prevista d'altronde in base alle direttive del 4 agosto, co m e punto di appoggio per forze mobili destinate a contrastare eventuali tentativi di aggiramento a largo raggio.
Su questi punti il Comando Supremo in data 6 settembre, richiamava l'attenzione del Co man do Superiore A.S. , prospettando anche la possibilità di puntate nemiche su Marada- el Agheila, e chiedeva di fargli conoscere i provvedimenti previsti ed attuati.
11 Comando Superiore faceva presente di rimando che con i mezzi a sua disposizione non era possibile attuare una salda organizzazione difensiva di Agedabia. Era stata però studiata l'organizzazione dell'intera zona Agedabia- Gialo- Marada- el Agheila, con la costituzione di piccoli presidi locali, fissi e mobili, in grado di svolgere un sistematico pattugliamento, allo scopo di individuare tem-
(x) In una nota del l' Uffi cio Operazioni del Comando Supremo in da ta 6 settembre 1941 si legge : « Altrimenti il Comando Superiore Italiano sarebbe ridono alle so!e funzioni di Gov erno Civile della Libia » 11. 24).

pestivamente e rintuzzare eventuali puntate avversarie. Si stava apptmto esaminando la possibilità di rinforzare tali presidi, la cui entità non avrebbe comunque potuto superare la forza di due o tre compagnie, provviste di armi anticarro.
Sull'argomento riferiva d'altronde verbalmente il gen. Gambara, chiamato a Roma il 14 settembre per l'esame di que stioni varie.

(25 - 28 agosto 194 1)
L'inizio dell'operazione « Barbarossa >> contro l'Unione Sovietica, il 22 giugno, era stato giustamente apprezzato a Londra come un evento interessante direttamente l'esistenza stessa del Regno Unito. Lo aveva chiarito la sera stessa il Primo Ministro Churchill in un discorso radio alla nazione: l'attacco tedesco doveva essere considerato come il preludio ad un tentativo di invasione delle Isole Britanniche. I Tedeschi seguivano la linea tradizionale della loro strategia, di abbattere un nemico alla volta: adesso era il momento dei Russi; sarebbe poi venuta l'ora per l'attacco alla Gran Bretagna. La sorte dei due Paesi era minacciata da uno stesso pericolo e il Regno Unito avrebbe dato alla Russia tutto l'aiuto possibile.

Per la potenza dell'Empire il pericolo si presentava più immediato nel Medio Oriente, ma questo non sarebbe divenuto attuale fintanto che i Tedeschi non avessero risolto vittoriosamente la partita aperta con l'Armata Rossa. Dopo i travolgenti successi delle battaglie di frontiera le operazioni al fronte orientale stavano ora rivelando una straordinaria durezza, lasciando intravedere come la capacità di resistenza delle forze sovietiche fosse ben lungi dall'esaurimento. Tanto meno erano visibili sintomi di cedimento nella volontà di lotta dei capi sovietici.
Comunque, la potenziale minaccia era ben presente nell'Alto Comando britannico che aveva disposto opportuni provvedimenti precauzionali : si è già accennato alle misure adottate in Siria e nell'Iraq per il rafforzamento della sicurezza della Palestina e dell'Egitto. Si trattava ora di aumentare la profondità di questa fascia di protezione, includendovi il territorio dell'Iran.
La sicura disponibilità di quel Paese era anche indispensabile per garantire l'accesso alle risorse petrolifere dell'Iraq Settentrionale (pozzi di Mosul) e dell' Iran stesso (impianti di Abadan) nonché per la costituzione di basi aeree capaci di agire offensivamente contro i
territori petroliferi del Caucaso, sui quali i Tedeschi dirigevano le propne mire.
L'assimilazione dell'Iran avrebbe infine consen tito l'utilizzaz ion e della linea di comuni cazione del Golfo Persico, a co mpl eme nto di quelle del Mare Glaciale e di Vladivostock, per il trasporto dell'enorme qu a ntitativo di m ateriali anglo- americani ch e sarebbe stato fornito alla Ru ssia per l'ali m entazion e della lotta contro i T edeschi.
L a situazione politico- militare generale risultava dominata dagl i sviluppi e dai rifles si d ella ca mpagna di Ru ssia che concedeva all'Inghilterra un periodo di incontrastata libertà d'azione n el Medio Orie nte, mentre imponeva estrema cautela a questi Stati, ancora n eutrali, in attesa di un chia ro seg no sullo sviluppo degli avve nimenti all'Est per decidere l'intervento nel conflitto.
L 'u lu g lio i Capi d ello Stato Maggiore Im periale erano st ati in vitati ad esamina re l'opportunità di un'operazione nell' Ir an , in collaborazione co n i Ru ssi. Il giorno 17 il gen. Wavell (attualmente Comandante in Capo delle F orze Britanniche in Indi a, competen te giurisdizionalmente per le operazioni n ell' Iran) faceva conoscere il proprio parere al ri guardo. :

« E' indispensabile che riuniamo le nostre forze con quell e russe attraverso l' Iran; qualora il Governo attuale non si a disposto a permettercelo, si deve sostituirlo co n uno favo revole . A questo scopo si dovreb be ro esercitare immediatamente le più energiche pressioni, mentre l'esito della lotta fr a T edeschi e Ru ssi è ancora incerto ... >>
In un promemoria datato 22 luglio anche il Ministro degli E ste ri es primeva a Ch urchill il proprio punto di vista:
<< Staman e ho esaminato ulteriormente l a qu estione delle pressio ni da esercitare sull'Iran. Quanto più n e co nsidero la possibilità , tanto più mi appare chiaro che tutto dipende dalla no stra ca pacità di concentrare forze suffi cienti nell'Iraq per proteggere i cam pi petroliferi persiani. An che il se mpl ice accenno a pressio ni econo m iche sare bbe assai pericoloso sino a quando non saremo militarmente in g rado di appoggiarle, giacché lo Scià conosce perfet tamen te tutta l'importanza che i campi petrol iferi hanno pe r no i e, se si accorge dei nostri maneggi, è capacissi mo di assumere l'iniziativa.
<< Ci so no g iunti rapporti, in apparenza at tendibili, in merito a concentramenti persiani alla frontie ra russa, a quella irache n a e nella zona dei campi petroliferi. Spero che si farà ogni sforzo per potenziare le n ostre forze ne ll'Iraq, al più presto possibile. Se riu sciamo a far qu es to prima che i R ussi subiscano una g rave disfatt a sul
fronte meridionale avremo buone possibilità di riuscire ad imporre la nostra volontà ai Persiani, se nza ricorrere alla forza. Non dobbiamo però agire diplomaticamente senza disporre delle forze militari necessarie, altrimenti andremo incontro a un disastro.
<<Vi è un'altra ragione che rende impellente la necessità di solleciti rinforzi alle truppe dell 'Iraq . Nel caso che la Russia dovesse rimanere sconfitta, dovremmo esser pronti ad accupare i campi petroliferi dell'Iran giacché, in una simile circostanza, le pressioni tedesche sui Persiani per farci espellere dal Paese sarebbero senz'altro irresistibili ».
Il 25 agosto, preceduta da una richiesta a Teheran di allontanare tutti i sudditi tedeschi che in veste di tecnici e di turisti si trovavano nell'Iran, aveva inizio l'azione anglo- sovietica che, pressoché incruenta, si concludeva in tre giorni con la capi tolazion e dell'Iran.
Sul fronte irano- sovietico l'attacco (condotto con forze valutate complessivamente a tre divisioni di fanteria , una divisione motom eccanizzata, una divisione di cavalleria, reparti non indivisionati e forze di sbarco imprecisate) , muoveva dalle zone di Baku e Giulfa e dal Turkmenistan. Dalla zona di Baku:

- truppe da sbarco occupavano, lo stesso giorno 25, Bender Shah e Pahlavi, sul Mar Caspio;
- una divisione di fanteria e aliquote della divisione di cavalleria puntavano su Ardebil , che raggiungevano la sera del 26.
Dalla zona di Giulfa, forze valutate a due divisioni di fanteri a, una divisione moto- m ecca nizzata e una divisione di cavalleria, avanzavano su due col onne:
- la colonna di sinistra su T abriz, che raggiungeva il 26 e quindi su Qazvin, che occupava la sera del 30;
- la colo nna di destra, per Dilm an, su Saqqir, che raggiunge va il 29.
Dal Turkmenistan, forze imprecisate avanzavano per Kushan su Meshed , che veniva occupata il 29.
Sul fronte irano- irache no l'azione britannica (condotta con forze valutate a due divisioni di fanteria indiane, largamente motorizzate, una divisione corazzata, una brigata di cavalleria meccanizzata c forze di sbarco imprecisate) si sviluppava dalle zone di Khaniqin e di Bassora. Dalla zona di Khaniqin le due divisioni indiane il 26 agosto occupavano Gilan ed il mattino del 28 Kermanshah. Dalla zona di Basso ra il 25 agosto la brigata di cavalleria meccanizzata
occupava Abadan e la divisione corazzata la sera del 26 raggiungeva Ahwaz e la zona petrolifera di Naft i Sahid.
Il mattino del 28 veniva firmato l'armistizio. Il 17 sette mbre una brigata meccanizzata inglese ed una sovietica procedevano alla occupazione di T eheran, dopo l'abdicazione dello Scià a favore del figlio e la formazione di un nuovo governo favorevole agli Alleati. La capitale veniva poi sgomberata il 18 ottobre. Le truppe britanniche venivano impiegate n ella costruzione di apprestamenti difensivi contro un'eventuale aggressione tedesca dalla Turchia o dal Caucaso e di impianti per lo scarico e il trasporto d ei rifornimenti per la Rus sia che sarebbero affluiti nel Golfo Persico. Alcuni distaccamenti venivano lasciati a protezione delle linee di comunicazione.

L'Inghilterra si era così assicurata una salda posizione di predominio nel Medio Oriente, realizzando la materiale saldatura con l'alleato russo nell a regione del Caucaso, aveva posto al riparo da ogni minaccia i ricchi giacimenti petroliferi dell'Iraq e dell'Iran, indispensabìli per la prosecuzione della guerra, e si era messa in misura di poter influire efficacemente sul futuro atteggiamento della Turchia. Av eva infine realizzato una certa sicurezza per i rifornimenti anglo- americani destinati a raggiungere la Ru ssia dal Golfo Persico, attraverso l'Iran (1).
Questo sviluppo, mentr e in Russia le armate tedesche incontravano serie difficoltà a sboccare oltre il Dniepr, non poteva non ripercuotersi sugli orientamenti di Hitler in tema di condotta della guerra, nel senso di accantonare o gni progetto di future grandi operazioni offe n sive n ello Scacchiere Mediterraneo. L'Inghilterra per contro, raggiunto un buon grado di sicurezza nel Medio Oriente (sia pure a prezzo di qualche preoccupazione per la presenza sovietica in zone particolarmente delicate per i suoi interessi) si trovava ora in condizione di dedicarsi con maggiore impegno alla preparazione di azioni risolutive nell'Africa Settentrionale.
(1) «Grazie alla presenza di un governo amico a Teheran poté procedere all'ampliamento dci porti, allo sviluppo del traffico fluviale, alla costruzione di strade e alla ricostruzione delle ferrovie . Questo complesso di iniziative, incominciato nel settembre del 1941 e portato avanti dall'esercito britannico (e che doveva subito dopo essere ripreso e completato dagli Stati Uniti) ci permise di inviare in Russia, nello spazio di quattro anni e mezzo, ben 5 milioni di tonnellate di rifornimenti » (WINSTO:-< CHURCHILL: << La seconda Guerra Mondiale », Mondadori ed., 1952, Parte III, vol. II, pag 129.

Nuova organizzazione del Comando britannico del Medio Oriente.
Come già accennato, dopo la battaglia di Sollum il Primo Ministro e Ministro della Difesa, Churchill, aveva designato il gen. Auchinleck (in quel momento Comandante in Capo delle Forze Britanniche in India) a successore del gen. Wavell nel Comando in Capo del Medio Oriente. Il gen. Auchinleck aveva assunto il comando effettivo dello Scacchiere il giorno 2 luglio.
Poco dopo, in seguito alla conclusione della ca mpagna nell'Afri ca Orientale Italiana, le Forze Britanniche del Medio Oriente assumevano una nuova organizzazione. Venivano costituite due armate, dislocate rispettivamente in Siria- Palestina e in Egitto: il comando dell'una veniva lasciato al gen. Wilson; l'armata d'Egitto veniva posta agli ordini del gen. Cunningham, il vittorioso comandante nella campagna in Africa Orientale Italiana. Entrambe l e armate dipendevano direttamente dal gen. Auchinl eck .
La Gran Bretagna si era impegnata a fondo nello sforzo per precedere l'avversario nella gara di potenziamento delle forze dell'Africa Settentrionale, così da poter raggiungere in anticipo quella superiorità materiale che co nsiderava indispensabile per riprendere l'iniziativa delle operazioni. Partivano ininterrottamente dall'Inghilterra, dirette in Egitto per la rotta del Capo, navi cariche di truppe, carri armati, cannoni, automezzi, carburante e rifornimenti vari per le unità già in sito e per la messa a punto della costituenda armata (in settembre verrà ufficialmente classificata come 8" Armata), destinata ad assorbire compiti e funzioni della « Western Desert Force » e ad assumere proporzioni imponenti, nei confronti delle forze italo- tedesche agli ordini del gen. Rommel (1).
( 1) Solo il 31 o ttobre il servizio dd la radioint ercetta z ione captava per la prima volta nel settore d i Sollum il nominativo di un comando di armata (l'Sa) in collegamento con il XIII C.A., la cui presenza era stata a suo tempo rilevata.
Atti vità esplorativa e Il periodo che va dalla battaglia di Sollum di disturbo. alle grandi operazioni del novembre può essere considerato nel suo compl esso una fase di stasi operativa, con la sola eccezione di un modesto colpo di mano britannico sul fronte di Tobruch e di una ricognizione in forze eseguita dalla 21a Divisione Corazzata tedesca a sud di Sollum.
Dalle due parti veniva mantenuta vivace attività esplorativa e di dis tur bo, mediante saltuarie azioni di artiglieria e dell'aviazione. Quest'ultima ·veniva peraltro prevalentemente impiegata in compiti esplorativi.
Costantemente intensa risultava l'azione dell'aviazione avversaria contro le nostre basi e le retrovie. Sporadico il concorso navale d a parte del nemico.
L a notte sul 3 agosto i Britannici operavano di sorpresa un attacco locale sul fronte di Tobruch. Riuscivano ad impadronirsi del fortino S 7, presidiato da truppe tedesche. L a Divisione « Brescia » rinforzava prontamente il fianco d es tro del proprio schie ramento, verso il saliente di Ras Medauuar, impedendo l'allargarsi della breccia. L a sera dello stesso giorno truppe d'assalto tedesche rioccupavano il piccolo r idotto (1).
Attacco di s orpre sa britannico a Tobruch (3 agosto).
Ricognizione offensiva ted esca a sud di Sollum (14- r6 settembre). (Schizzo n. 21 ).
In un colloquio avvenuto il 4 settembre il gen. Gambara e il gen. Gause (capi di stato maggiore, rispettivamente, del Comando Superiore A.S. e del Comando Gruppo Corazzato Africa) era stata ve rbalmente concretata, nel le linee generali, un'azione locale da condurre di sorpresa Approvata dal gen. Bastico, l 'o peraz ione si sarebbe dovuta svolgere verso la metà del mese stesso. Doveva avere il carattere di un « colpo di mano >> eseguito da elementi corazzati ted eschi e reparti motorizzati italiani di artiglieria e fanteria, su un deposito inglese individuato nella zona di Bir el Chreigat. La ricognizione aerea aveva di
(r) Perdite: i taliane, 9 morti e 36 feriti; tedesche, 21 morti, 33 feriti, r disperso; bri tan niche: 70 mort i, num erosi feriti c 34 prigionieri.

recente rivelato che il deposito era costituito da fusti di benzina semi - interrati.
Senonché, nella settimana successiva, da varie fonti giungeva l'insistente segnalazione di una probabile offensiva britannica in Ci- • renaica. L'eventualità veniva vagliata dal S.l.M., presso il Comando Supremo, e questo giungeva il 13 settembre alla conclusione che dalle notizie in possesso del Servizio si poteva fondatamente dedurre che nell'Africa Settentrionale fosse in atto, da parte britannica, tutto un vasto complesso di provvedimenti rivolti alla preparazione di operazioni offensive di grande portata.
Come si rileva dall'ordine di operazione (allegato 11. 2 5) emanato lo stesso giorno dal Comando della « Divi sione per Impiego Speciale Africa » (pervenuto al Comando Superiore A.S. soltanto il giorno 15, vale a dire quando l'azione era già in corso dal giorno precedente) il «colpo di mano» si era tramutato nell'elaborazione degli ordini in una vera e propria azione di forza, affidata alla sola 21a Divisione Corazzata. L'obiettivo era « di ricacciare le truppe di sicurezza nemiche, avanzando su largo fronte, oltre Bir el Chreigat e di constatare se il n emico aveva fatto preparativi per un'offensiva ».
L'operazione che per vastità d'impianto e d i sviluppo esorbitava dalle dimensioni di una semplice ricognizione, doveva essere appoggiata dall'aviazione, in base ad intese dirette fra il Comando Gruppo Corazzato e il Comando del Corpo Aereo Tedesco. Era stato predisposto l'intervento di Stukas italiani e tedeschi scortati da caccia.
L'azione principale doveva essere accompagnata da un'azione dimostrativa nel settore costiero.
Nei giorni II e 12 erano stati organizzati num erosi itinerari, allo scopo di rendere più agevole e spedito il movimento delle colonne corazzate dalla zona di alloggiamento a quella di raccolta, stabilita dietro ai capisaldi avanzati del nostro schieramento.
Tutte le piste erano state contrassegnate con fusti di benzina vuoti; l'itinerario principale, da Musaid all'Halfaya, era stato illuminato durante la notte sul 14, mediante feritoie praticate nei fusti, non visibili dalla parte del nemico.
Le forze erano articolate in tre colonne, con comune obiettivo la zona di Dar el Hamra. In particolare:
- la colonna di sinistra (principale) era costituita dal 5o rgt. car ri, una cp. mitraglieri, una cp. cacciacarri, una btr., una cp. pionieri. Aveva per direttrice, in primo tempo, la pista lungo il ciglione

dell'Halfaya, fino ad Alam Battuna, e successivamente un itinerario diretto su Dar el Hamra, attraverso il deserto;
----,- la colonna di destra (aggirante) era costituita dal reparto esplorante della 15" Divisione Corazzata rinforzata da una btr. Aveva per direttrice un punto a sud di Sidi Ornar e quindi Dar el Hamra;
- la colonna centrale (di collegamento e per il ricupero del materiale di preda bellica) era costituita da tm cp. cacciacarri, una btr. e un certo numero di autocarri vuoti. Doveva procedere lungo la pista Sidi Suleiman- Dar el Hamra.
Contemporaneamente, la Divisione per Impiego Speciale Africa doveva svolgere azione dimostrativa nel settore costiero, appoggiata da intenso fuoco di due gruppi del 2 " artiglieria celere schierati sull'Halfaya.
All'alba del 13 le tre colonne erano attestate rispettivamente:
----,- a nord di Halfaya- M usai d;
- a nord di Si di Ornar;
- a nord del caposaldo di q. 207, co n una grossa colonna rifornimenti a nord della Ridotta Capuzzo.
La maggior parte dei carri armati aveva effettuato la marcia sugli appositi rimorchi.
Alle prime luci del giorno le colonne iniziavano il movimento nelle direzioni stabilite, senza incontrare inizialmente alcuna traccia del nemico né di suoi apprestamenti logistici. Solo verso le 8, in località Garet el Rueibat (sulla pista di Dar el Hamra) la colonna centrale aveva un piccolo scontro con elementi dell'n o Ussari che, dopo qualche scambio di raffiche di mitragliatrice, ripiegavano velocemente. Alle ore IO le tre colonne potevano co ngiungersi co me previsto sull'obiettivo di Dar el Hamra.
Il nemico risultava schierato con il grosso della 1 Corazzata a sud di Bir Sofafi, coperto da un sis t ema avanzato di elementi dell'n o Ussari, distribuito in tre nuclei, rispettivamente in corrispondenza di Alam el Safa, Deir Abu Gallaq e q. 209 (circa 6 km. a sud di Deir Abu Gallaq).
Allo scopo di provocarne l'ulteriore arretramento, il gen. Rommel ordinava di attaccare a fondo con la mas $a dei carri le forze dislocate sulle posizioni di Alam el Safa e di sviluppare contemporaneamente un'azione dimostrativa, accennante all'aggiramento del

nucleo avanzato di q. 209. L'azione doveva partire alle ore r5, dopo aver proceduto al riordinamento delle forze ed al rifornimento del carburante, e doveva concludersi in serata, per consentire alle colonne di rientrare alle basi con il favore della notte .

L'azione si svolgeva secondo i piani, senza però riuscire ad agganciare i nuclei avanzati avversari che avevano tempestivamente ripiegato sul grosso. Veniva tuttavia catturato un carro comando, conten ente importanti documenti.
L' azione dimostrativa nel settore costiero si era risolta in semplici scontri di pattuglie e duell i di artiglieria.
La segnalazione dei nostri movimenti verso la base di partenza era stata fornita al comando avversario dalla ricognizione aerea fino dal pomeriggio del giorno 13. Alle ore 7 del 14 il Comando del Gruppo Avanzato britannico, avuta conferma dai propri elementi esploranti dell'azione in corso, aveva diramato la parola convenzionale (« Bathchair ») per l'entrata in vigore del predisposto piano di ripiegamento. Alle ore 12,30 lo stesso Comando aveva preannunciato l'attuazione del piano « Victoria » precisando che non sarebbe entrato immediatamente in vigore. Evidentemente il nemico aveva scandito l'operazione di ripiegamento in varie fasi, da attuare progressivamente, in base all'evolversi della situazione, in seguito alla diramazione di stabilite parole convenzionali.
Alle ore 17 il grosso delle forze in ri piegamento si trovava nella zona di Bir el Thalatha, con elementi avanzati, dotati di artiglieria, a Bir Habata.
Di fronte all'azione tedesca del pomeriggio il Gruppo Avanzato britannico ripiegava ulteriormente verso oriente, lasciando alla XXII Brigata Guardie il compito di coprire la zona costiera, in corrispondenza degli sbocchi del ciglione, per fronteggiare eventuali puntate verso nord, su Bug Bug, attraverso Sofafi e Sabil. Doveva inoltre occupare i nodi stradqli c presidiare i pozzi, da distruggere in caso di ritirata.
L 'eve ntuale resistenza era prevista a sud di Matruh, dove la t Divisione Corazzata avrebbe dovuto arrestare l'attacco, m entre il Gruppo Avanzato avrebbe dovuto provvedere alla sicurezza del fianco sud.
Durante la sosta nella zona di D ar el Hamra l 'aviazione britannica, molto attiva tutta la giornata, aveva provocato sensibili perdite in uomini e materiali. Il rientro delle colonne si effettuava a scaglioni, nelle notti sul 15 e sul r6, sotto la protezione del reparto espio-
rante, seguito dall'avversario con scarsa decisione dai soli elementi esploranti. Il giorno r6 i Britannici tornavano alla primitiva dislocaz10ne.
Nell'operazione erano caduti 14 militari di truppa. l feriti erano stati 4I, di cui 3 ufficiali (I italiano) e i dispersi 39 · Erano andati perduti 6 carri, I autoblinda, 22 autocarri e IO motociclette. Completamente distrutta, dopo il co m pimento della sua missione di bombardamento su un concentramento di automezzi nella zona di Bir H abata, era stata una nostra sq uadriglia di IO Ju 87 (« Stukas >>) di cui il giorno successivo si potevano ricuperare nel deserto 5 uomini di equipaggio e 4 apparecchi ( r ).
L'operazione, personalmente condotta dal gen. Rommel, aveva sostanzialmente conseguito il risultato di riconoscere l'assenza dei preannunciati apprestame nti offensivi dell'avversario. Materialmente non aveva fruttato alcun bottino perché il nemico, tempestivamente allarmato, aveva già ripiegato i depositi predisposti che dovevano essere, in ogni caso, modesti. Un prezioso acquisto rappresentava il carro comando catturato, che doveva fornir e un interessante apporto di informazioni.
Il con sumo di carburante era stato ingentissimo, conferman do cosl ancora una volta la n ecessità di accompag nare qualsiasi piano operativo co n adeguati apprestame nti lo gistici, sufficienti a far fronte alle esigenze dell'intero sviluppo dell'azione.
Cosl sintetizzava Ro mmel il giorno r 6, in una lette ra indiri zzata al Comandante Superiore A.S., il ri sultato della ricognizione (allegato n. 26) :
« I ) le forze avversarie dislocate nella zon a ad ovest di Marsa Matruh so no più deboli di quanto finora si era presunto;
« 2) la ricognizione non ha potuto co n statare nella zo n a al di là del co nfin e alcun deposito o altri preparativi per un immine n te attacco;
« 3) l'esame d ei documenti ca tturati, m olto importanti, fornirà probabilmente utili indi cazioni per po ter conoscere lo schieramento d elle forze nemi che nel Vi cino e anche nel M ed io Oriente.
( J) Nel complesso era mancato il coordinamento fra azion e terrestre ed azione aerea e si era verificato qualche malintèso rispetto agli accordi presi con il C.A. T.
V. gen. GIUSEPPE SANTORO: « L'Aeronautica italiana nella seconda Guerra M ondiale », Ed. E sse, Milano, 1957, vol. II, pag. 9(i .

« Resta quindi confermato che le forze nemiche che attualmente sono dislocate nel D eserto Occidentale non sono su fficienti per svolgere un'offensiva >> .
Quest'ultimo apprezza mento, che conferiv a alla valutazione una colorazione sostanzialmente ottimistica, dov eva esercitare una forte influenza sui futuri orientamenti operativi del gen. Rommel, rafforzandolo n ella convinzione di essere ancora in condizione di vin ce re, sia pure di misura, la gara a tempo per il raggiungimento del pre dominio sull'avversario.
Dall 'esame d ei docum enti catturati erano ri sultati i segue nti elem enti sulla situazione avversaria.
Le forze avatJzate sc hierate in prossi m ità della frontiera cirenai ca dipendevano dalla 4• Divisione indiana ch e aveva il proprio com ando a Sidi el Barrani. Erano costituite da:
- un Gruppo Ava1zzato , comprendente il 4• rgt. autoblinde s ud- africano, la XXII Brigata Guardie rinforzata con artiglieria, uno squadro n e del « The Royal )) ' truppe di slo ca t e n ell 'altipiano, su due raggruppamenti tatti ci;
- un Gruppo delle Oasi, composto d ella VII Brigata indiana e del reggimento m ecca ni zza to « Centrai Ind ia Horse >>;
- la XI Brigata indiana.
Il Comando della « For za del Deserto Occide ntale>> disponeva inoltre delle seguenti unità:
- t Divisione Corazzata, a Marsa Matruh ;
- I a e 2 a Divisione sud- africana, tra el Daba, el Alamein e Burg el Arab;
- soa Di vision e di fanteria, in zona imprecisa ta;
- truppe e se rvi zi di co rpo d'armata a M arsa M atruh. Nel settore di Tobru ch lo schieramento aveva recentemente subito delle varianti, esse nzialmente relative alla sosti tuzion e della XVIII Brigata australiana (t D ivisione) co n una brigata polacca, l'arrivo di un nuovo b attag li one alla XX Briga ta austra li ana (9a Divisione), l'inserimento di un nuovo battaglione indiano n el settore ovest e di un battaglione pio ni eri nel settore es t (1).
(1) I n merito ai rifo rn im ent i cd ai trasferimenti d i truppe da c verso Tobru ch , scrive Churchill seconda Guerra Mondiale )) ' Mondador i ed ., 1952, Pa rte III, vol. II, pag. 55):
<< Durante l'assedio T ob ruc h fu approvvigionata dalla marina, nonostante gli incessami e crescenti a ttacchi aerei .. . ad assicurare i rifornimenti di

L'attività dell'aviazi one avversaria e le not1z1e raccolte sulla dislocazione della t Divisione Corazzata nella zona di Marsa Matruh facevano ritenere che il Comando britannico fosse tornato all'originaria concezione per la difesa del Deserto Occidentale: graduale ripicgamento delle forze terrestri, con largo sostegno di aviazione al fine di l ogorare le colonne avanzanti, fin sotto a Marsa Matruh dove era prevista la grande battaglia di arresto, condotta con forze mobili appoggiate a quel campo trincerato (1). D agli sviluppi della battaglia il Comando avrebbe poi tratto elementi per impostare un'eventuale azione controffensiva o ripiegare sul Delta, per la cui difesa sembrava venisse mantenuta e consolidata la linea Amiriya- NatrunFayam.
Modifich e allo schi cramen to ital o - tedesco Si andava frattanto consolidando la precisa sensazio n e dell'intenso sforzo condotto dalnel mese di ottobre in l'avversario per accelerare, con largo concorvi sta di un n uovo at- so di materiale americano, il ritmo del potacco a T o bruch . tenziamento delle forze del Medio Oriente. Si calcolava che dalla fine di luglio fossero giunti in Egitto dall'America oltre 2000 autocarri, 500 carri armati ed un certo numero, non precisato ma certamente rilevante, di aerei.
munizioni e viveri, si dovevano comp iere trasferimenti in mas sa di truppe da c verso la fortezza assediata alla quale si dovevano pur e portare nuove armi di varie specie, compresi carri armati. In complesso la marina trasportò a Tobruch 34·000 uomini, p. carri armati, 92 cannoni e 34.000 tonnellate di materi ale Inoltre essa evacuò un numero quasi eguale di soldat i, senza contare i feriti e i prigionieri di guerra ... >>
(t) Queste notizie sul nemico risultavano da:
- un Ordine di Operazione del 4° rgt . autoblinde sud- africano in data 23 agosto 194 I nel quale era detto che in caso di ritirata la 7'' Divisione Corazzata avrebbe dovuto prepararsi ad arrestare il nemico a sud di Marsa Matruh c che compito principale della VII Brigata di fanteria (Gruppo di Sostegno) sarebbe stato quello di contenere l'av:anzata avversaria c proteggere il fianco sud del]a divisione stessa (linea generale Bir Gellez- Khalda);
- un successivo Ordine d i Operazione dello stesso reggimento in data 10 settembre nel quale si precisav a che il Gruppo Avanzato (che aveva assunto i compiti della VU Brigata di fanteria) avrebbe dovuto contenere l'attacco dell'avversario, infliggendogli perdite ma senza lasciarsi trascinare ad importanti combattimenti.

In un prospetto dell'Ufficio Operazioni del Comando Supremo, datato 3 ottobre , le forze contrapposte nello scacchiere libico - egiziano venivano cosl valutate:
a) Terrestri.
Cirenaica (com preso T obruch) : 4 div. ftr., 2 div. mot., 3 div. cr. Tri politania : I div. ftr. , Ga F e r eparti vari.
Sahara: rep. vari (5000 u.).
Complessivamente:
7 div. ftr. (di cui 2 mot.) e 3 div. cr., per un complesso di 200 mila u. con circa 500 carri (di cui 200 leggeri).

a) Terrestri.
Tobruch: 2 div. ftr. (forze equivalenti a);
Deserto Occ : 4 div. ftr., I div. cr., rep. cr. van;
Delta: 5 div. ftr., ( + I presunta), I div. cr., rep. cr. vari.
Complessivamente:
rr o I2 di v. ftr. (con larga motorizzazione) e 3 div. cr., per un complesso di 220 mila u. con circa 1200 m ezzi corazzati (di cui IIOO dell e unità cor., IOO dei gruppi esploranti divisionali) oltre a 8oo Bren Carriers dei btg. di ftr.
b) Aeree.
570 apparecchi (120 tedeschi) di cui efficienti i 2/3 : 280 caccia (40 tedeschi), 190 bomb. (8o tedeschi),
I OO altre specialità.
b) Aeree.
IIoo apparecchi (oltre quelli delle navi 500 cacc1a, 350- 400 bomb., 200 • 250 altre specialità.
Il prospetto era corredato delle seguenti note:
« Tenuto conto della necessità del nemi co di presidiare il Delta le fanterie contrapposte si equivalgono.
« Notevole la superiorità del nemico in mezzi corazzati: il raffronto numerico va tuttavia attenuato per il fatto che i dati forniti dal S.l.M. si basano sugli « organici>> delle unità individuate che difficilmente saranno a numero e per il fatto che gran parte dei mezzi corazzati britannici è cos tituita da carri leggeri scope rti. ln sintesi: unità corazzate nostre m eno num erose, più solide; m ezzi corazzati britannici più num erosi, più mobili , più largamente distribuiti alle fanterie. In caso di offensiva avver sa ria la sua superiorità
in carri è altresì attenuata per il fatto che al maggior numero dei mezzi corazzati vien contrapposta non soltanto la contromanovra dei nostri carri ma anche la resistenza dei capisaldi e l'azione dei mezzi anticarro, di cui le nostre divisioni e que lle tedesche hanno ora una buona dotazione.
<< Indubbia la superiorità delle forze aeree nemiche, appoggiate, pare, ad una buona attrezzatura logistica e, per il momento, non vincolate da notevoli impegni nel Delta mentre invece una notevole aliquota (un terzo circa) delle nostre forze aeree è vincolata in Tripolitania per la scorta ai convogli. In sintesi, in una battaglia al fronte est sarebbero contrapposti circa 380 apparecchi nostri e 900 apparecchi nemici».
E' interessan te sottolineare la concezione schiettamente difensiva che sta alla base del documento elaborato dal Comando Supremo. Effettivamente il Comando Britannico, considerata ormai superata la minaccia all'Egitto da parte delle forze dell'A sse, andava preparando una nuova offensiva contro la Cirenaica, nel quadro di più vasti progetti da sviluppare successivamente in tutto il Nord Africa Francese.
Il gen. Weygand, Capo Civile e Militare del Nord Africa Francese, dava evidenza a] proprio atteggiamento di perfetto ]ealismo verso il Governo di Vichy ma, nonostante la vasta eco delle prime clamorose vittorie tedesche sul fronte russo, nella popolazione francese residente in quei territori e nelle trupp e nazionali e indigene che le presidiavano erano largamente diffusi sentimenti di aperta ostilità verso le potenze dell'Asse . Nello stesso tempo le forze gaulliste della Regione del L ago Ciad (1) sembravano destinate a svol-

(1) Le forze c he presidiavano l'Africa Equatoriale Francese potevano cons iderarsi suddivise in due blocchi: uno, rapprescmato dalle truppe di slocate nella Regione del Lago Ciad (valutate a una divisione rinforzata), l'altro dalle truppe dislocate nelle Regioni dell'Ubanghi - Sciari, del Camerun, del Gabon e del Medio Congo (valutate a circa sette battaglioni).
Le forze del Lago Ciad erano costituite nella quasi totalità da sencgalesi; i reparti erano disseminati, anche per esigenze logisti ch e, in località molto distanziate fra loro.
Le forze del secondo blocco avevano verosimilmente la funzione di presidiare il v.asto territorio e di add estrare c inquadrare i volontari gaullisti che affluivano da altr e zone. Kon era da escludere che un'aliquota di queste forze potesse partecipare ad una eventuale azione anglo - americana contro Dakar, in rappresentanza di « Francia Libera », analogamente a quanto si era verificato in Siria.
gere attività offensiva nel Sud Libico, in concomitanza con l'azione britannica contro la Cirenaica. Si riteneva però che l e scarse risorse delle zone da attraversare e la lunghezza del percorso av rebbero richiesto una complessa organizzazione logistica, specie nei riguardi del rifornimento idrico e dei ca rburanti.
In questa situazione che si potrebbe definire di equilibrio instabile, andava maturando il progetto di un nuovo attacco co ntro Tobruch. In tale previsione, nel mese di ottobre venivano apportate alcune variazioni nello schieramento delle forze italo- tedesche : sulle posizioni avanzate di confine, la Divisione « Savona» serrava verso sud mentre la Divisio ne tedesca « per Impiego Speciale» assumev a il presidio della linea a nord del caposaldo di q. 207 (sud di Capuzzo), sino alla Piazza di Bardi a esclusa (la Piazza era presidiata da truppe italiane). Sul fronte di Tobruch si inseriva la Divisione « Trento», assegnata al XXI Corpo d'Armata, mentre la XV Brigata tedesca rientrava alla propria Divisione (21 a Corazzata) e la Div ision e « Pavia » passava in riserva nella zona di Sidi R ezeg, per usufruire di un certo periodo di riposo e di particolare addestramento, in vista della partecipazione all'attacco di Tobruch.
Nella notte sull' n una ben riuscita operazione di sorpresa aveva spostato in avanti i capisaldi della n ostra cintura d'investimento per una media di 7 chilometri.: l'intero fronte aveva improvvisam ente avanzato, sotto la protezione dei carri armati e con gran fragore di motori e il nemico aveva opposto scarsa resistenza. Il restringimento della cintura di investimento era considerato dal gen. Rommel come operazione preliminare per l'ulteriore attacco. Le posizioni raggiunte erano state immediatamente mimetizzate, con masch eramenti portati al seguito e l'aspetto ne veniva modificato ogni notte per togliere all'avversario ogni punto di riferimento.
Le unità del Corpo d'Armata di Manovra venivano pure spostate verso est: la Di visione Corazzata « Ariete » a Bir Ha cheim e la Divisione Motorizzata « Trieste » a Gadd el Ahmar, rimanendo come riserva nelle mani del Comando Superiore A .S.
L'importanza attribuita dall'Alto Comando britannico al possesso di Tobru ch era stata efficacemente espressa dal Capo dello Stato Maggiore Imperiale, gen. Dill, in un discorso tenuto alla guarnigione della Piazza: « Come l'isola di Malta aiuta a mantenere libero per noi il M edi ter raneo, così l' "isola" di Tobruch frena la minaccia nemica verso oriente. Tobruch è l a difesa avanzata dell'Egi tto ... >> .

Il 20 ottobre il Comando Supremo itali ano chiedeva il piano di attacco di Tobruch , che doveva essere preparato dal gc n. Rommel. Il Comando Superiore A.S. ne comunicava in si ntesi le linee fondamentali, quali erano state più o m eno definite in una serie di riunioni nelle quali il generale tedesco aveva largamente trattato le varie questioni inerenti all'operazione (allegato n. 27).
Era stato abbandonato il precedente concetto d'azione che indirizzava l'attacco principale sul porto di T obruch , passando per il R as Medauuar e il Forte P ilastrino. Questa volta il gen. Rommel intendeva svolgere lo sforzo principale da sud- est, vale a dire nel settore che fino a quel momento era rimasto più calmo ; si sarebbero inoltre sviluppati attacchi diversivi da ovest e sud- ovest. Penetrato profondamente nell'organizzazione difensiva avversaria, il gruppo d'attacco principale doveva cercare di eliminare gli elementi rimasti ad oriente della falla, tendendo a raggiungere un so lid o appoggio d'ala sulla costa. Giunto all'altezza di Forte Air enti, l'attacco doveva procedere contemporaneamente su Tobruch e su R as Bel Ghemel.
L'azione doveva essere condotta dal XXI Corpo d'Armata italiano (gen. Navarrini) e dal C.T.A. (ge n Cri.iwcll), entrambi agli ordini del gen. Rommel. Ciascun C. d 'A. doveva disporre di una m assa di artigl ieria di C. d'A. e l'azio ne delle due masse di fuoco sarebbe stata coordinata dal Comandante di Artiglieria del Gruppo Corazzato Africa.
Il giorno 29 il gen. Bastico confermava la piena identità di vedute co n i l gen. R ommel sulle modalità dell'operazione, di cui rimaneva ormai solta n to da fi ssa re la data. Recatosi a Roma il 4 novembre, il gen. Rommel i nformava il ge n. Cavallero .che i preparativi sarebbero stati ultimati entro il 15 n ovembre ma che l'attacco non sarebbe avvenuto prima del 20, né d opo il 4 dicembre , per potersi g iovare del beneficio dell e notti lun ar i.
In merito alle modalità dell'operazione, il gen. R ommel precisava che la sera della vigilia avrebbe avuto luogo un'azion e preliminare da parte della D ivisione « Brescia », con impiego di molta artiglieria c di truppe d'assal to, per t rarr e in i n gan no il nemi co sulla r eale dir ezio ne prin cipale del nostro attacco. Eg li confidava che il n em ico, il quale aveva già schierato le proprie artiglierie prevalenteme n te verso sud- ovest, sarebbe stato tratto i n inganno dall'azione della « Brescia», che doveva essere proseguita anche il mattino successivo. Egli escludeva l'eventualità c he i l nemico potesse in ter venir e con una m anovra aggirante a largo r aggio alle spalle del nostro schieramento, i n quanto una colonna che si fosse impegnata in tale

impresa si sarebbe esposta ad essere tagliata fuori dalle sue basi, dall'intervento della nostra massa di manovra. Riteneva che tutt'al più il nemico potesse tentare un'azione di disturbo con poche forze, contrastabili con l'impiego dell'aviazio ne.
Sintomi di imminen- Mentre da parte nostra si andavano perfete offensiva britannica zionando gli apprestamenti per l'attacco di T obruch, altri indizi coglieva il Servizio Inform azioni della preparazio ne di una grande operazione offensiva . . tn campo nem1co.

Varie fonti, anche fiduciarie tedesche, concordavano n el segnalare come probabile un attacco da est, prima ancora dell'inizio del nostro nuovo tentativo di impadronirci di Tobruch. L'azione sarebbe stata affiancata da incursioni nel Sud Tri polino di forze gau lliste (e forze anche belghe) provenienti dalla Regione de l Lago Ciad. Le notizie apparivano tanto più attendibili in quanto risultava evidente il valore di un successo del gen. Auchinleck nel Mediterraneo, come auspicato diversivo pe r controbilanciare l'effetto dei successi co nseguiti dai T edesch i sul fronte meridionale russo.
Il Comando Supremo non mancav a di richiamare l'attenzione del Comando Superiore A.S. su tale eventualità (20- 22 ottobre) chiede ndo quali provvedimenti intendesse prendere per fronteggia rla , senza però perdere di vista la preparazione per l'attacco di Tobruch.
Il Comand o Superiore A.S. rispondeva il 27 ottobre (r) precisando che la sit ua zion e ad ovest e sud- ovest non ri sultava mol to preocc u pante e che co nsiderava co n se r eni tà la situazione ad est e sud- est, sempreché non avesse a verificarsi sul fronte di Sollum un attacco in forze contemporaneo alla no stra azion e su Tobruc h . Assicurava di avere comunque preso le opportune disposizioni (compatibilmente con le concrete possibilità delle forze a sua disposizione) per far fronte a que sta es tr ema eventualità.
(r) Il testo della lettera del Comando Superiore A.S è integralmente riportato, in allegato, nella monografia « Seconda offensiva britannica in Africa Settentrionale e ripiegamento italo- tedesco nella Sirtica Orientale >> . Considerata l'eventualità di un'azione offensiva nemica contro la Cirenaica, accompagnata da un'azione di gaullisti contro il Sud Tripolino, procedeva all'esame della situazione parùtamente per ogn i setto re operativo c riassumeva, per ciascuno, i provvedimenti adottati.
Successivamente nuove segnalazioni indicavano le grandi proporzioni raggiunte dai preparativi britannici. Il nostro Servizio Informazioni in Africa Settentrionale prospettava con sempre maggior ricchezza di particolari il livello raggiunto dalle forze avversarie, il presumibile disegno operativo e la data approssimativa dell'attacco.
L'n no vembre, in una lettera al Comando Supremo, il Comando Superiore A.S. tornava sull'argome nto per sottolineare il pericolo insito nell'eventualità della coincidenza delle due iniziative, nostra co ntro Tobruch e avversaria contro Sollum:
« Se invece l'azione avversaria sul fronte di Sollum tende sse ad obiettivi lontani e fosse condotta con forze adeguate a perseguire risultati decisivi, la contemporaneità delle due azioni ci metterebbe in una crisi tale dalla quale sarebbe forse estremamente difficile uscirne in una situazione ancora sopportabile ... »
Il Comando Superiore concludeva prospettando, per la decisione, l'opportunità di riesaminare a fondo il momento di intraprendere la divisata operazione per la conquista di Tobruch (allegato n. 28).
C'è da rilevare in proposito che la valutazione dei comandi italiani in A.S. circa l'atteggiamento delle forze avversarie non collimava con quella del Comando del Gruppo Corazzato Africa. L'Ufficio Informa zioni tedesco sosten eva il convincimento che, per il momento almeno, i Britannici non intendessero procedere ad un'azione offensiva. Per conto suo, il gen. Rommel era dell'avviso che anche nell'ipotesi che una reazione controffensiva britannica si fosse verificata, come risposta alla nostra ope razione su Tobruch, la sua pressione non avrebbe potuto esercitare un'influenza sensibile prima del terzo giorno dall'inizio dell'attacco alla piazzaforte (r).

Con lettera del 15 novembre (pervenuta a destinazione soltanto il 18 novembre) il Comando Supremo (allegato n. 29) ribadiva il
(r) La valutazione complessiva della presunta situazione avversaria veniva così formulata nel bolleaino dell'n nov embre del Comando Gruppo Corazzato Afri ca :
« Il raggruppamento delle forze nemiche sul fronte di Sollum c nella zona di Siwa- Giarabub è rimasto immurato nelle ultim e setti man e. Esso è caratterizzato da frequente avvicendamento c ùa aumentata attività di ricognizione su rutto il fronte .. . per conoscere i movim enti di truppe nella zona del fronte di Sollum- Tobruch e A in Gazala- Bir Hacheim - Bir cl Gobi che certamente non gli sono rimasti inosservati. Nella zona Marsa Matruh - el Daba le forze nemiche ... si sono probabilmente rafforzate di un'altra divisione.
« Riassum endo si può affermare che la situazione nemica sul fronte di Sollum- T obruch, come pure nel D eserto Occidenralc, non ha subito nelle ultime settimane dei cambiamenti essenziali».
concetto, unanimemente riconosciuto, che la presa di Tobruch rappresentava il solo mezzo per migliorare la nostra situazione tatticostra tegica in Libia: dalla sua tempestiva attuazione dipendeva ormai la possibilità di far fronte in condizioni favorevoli a un attacco nemico in forze. Confermava pertanto la necessità che l'azione di Tobruch fosse condotta al più presto, non appena completata la preparazione, per non essere prevenuti dall'iniziativa nemica. L asciava al Comando Superiore A.S., che aveva in materia piena responsabilità, di stabilire il momento dell'attacco, in base alla situazione generale e d'intesa con il gen. Romm el.
Lo stesso giorno la ricognizione aerea italiana e tedesca rilevava tra Marsa Matruh e Ridotta Maddalena una massa di 3150 automezzi e 4 consistenti gruppi di tende ed era fatta segno a reazione contraerea eccezio n almente intensa, di armi di medio e piccolo calibro. Era questa la prima volta che nella zona ad occidente di Marsa Matruh veniva rilevato un numero tanto importante di automezzi (1) (v. schizzo 12. 22).
Nella notte sul r8 novembre commandos inglesi, sbarcati da due sommergibili nei pressi di Beda L ittoria, effettuavano una audace incursione sul Quartier Generale dell'Intendenza tedesca che errate informazioni avevano indicato come sede del Comando Tattico del gen. Rommel, contro la cui persona era evide ntemente diretto il colpo. Rimasero uccisi quattro ufficiali di stato maggiore tedeschi m a l'obiettivo era andato ovviamente fallito.
Il mattino del giorno 18 il gen. Romm el veniva informato che sul Deserto Occidentale era stata rilevata un'alta cortina di polvere, originata da ingenti forze nemiche in movimento: pur avendo la sensazione di una prossima offensiva nemica, denunciata anche dalla crescente attività quotidiana dei bombardieri b ri tannici contro le basi di rifornimento e le retrovie italo- tedesche, il gen. Rommel rimaneva sorpreso dalla notizia (2) talché nel bollettino giornaliero del Gruppo Corazzato Africa, compilato la sera stessa si legge: « Situazione del nemico immutata. Fronte di Sollum: il nemico ha spinto avanti una ricognizione armata in direzione della 21a Divisio n e Corazzata »

(r) L 'acroricognizione del giorno precedente aveva rilevato soltanto 2090 automezzi.
(2) HAN S GERT EsEaEcK: cc Afrikanische Schicksalsjahrc » (Anni fatali ìn Afri c a).
Un messaggw operativo trasmesso alle ore 0,45 dal Comando Superiore A.S. al Comando Supremo caratterizza efficacemente il diverso atteggiamento mentale dei due stati maggiori, italiano e tedesco (logica conseguenza della diversa valutazione della situazione contingente) di fronte allo stesso elemento informativo.
« or / 19401 Op. r8 novembre ore 24,35. Fronte Sollum: stamane ore 8 avvistati automezzi nemici sud Sidi Ornar et reparti appiedati intenti rafforzarsi terreno. Pomeriggio artiglieria « Savona » habet sparato migliaio colpi contro concentramenti mezzi blindati et corazzati. Intercettazioni radio trasmesse da avversario in chiaro lasciano supporre imminente attacco nemico da sud Sidi Ornar in direzione Bir el Go bi ».

Il mattino del 19 il nemico sferrava la sua nuova offensiva. Superata l'ala destra del nostro schieramento alla frontiera, puntava con le maggiori forze sul rovescio della linea di investimento di Tobruch: era iniziata la seconda offensiva britannica in Africa Settentrionale (r). La gara a tempo per il potenziamento delle forze contrap. poste in quello Scacchiere era stata chiaramente vinta dall'avversario, grazie all'incontrastata supremazia assicuratagli dal fattore aeronavale nel campo dei trasporti marittimi ed allo sconfinato concorso degli aiuti americani.
(x) La situazione dell 'S" Arma ta britannica all ' inizio della ba ttaglia della Marmarica è riporta ta in allegato nella Monografia « Seconda offe nsiva britannica in Africa Se tten trionale e ripiegamento i taio- ted esco nella Sirtica Orientale » Per i rinforzi aer ei giunti nel Teatro del Medio Oriente dal ge nnaio all'ottobre 1941 v. alleg <Jto n. 30.
(15 febbraio -16 novembre 1941)
P erdit e subit e dalle forze italo- tedesche nel periodo compreso fra la prima e la seconda offensiva britannica (I 5 febbraio - 16 novembre 1941).

Nel corso della narrazione sono state di volta in volta indicate, per quanto possibile, le perdite riportate dai reparti italiani e tedeschi nei vari episodi della controffensiva e delle successive azioni svoltesi intorno a Tobruch o al confine egiziano. Lo specchio che segue raccoglie mensilmente le perdite sofferte in tutto il periodo qui considerato.: i dati son tratti dalle segnalazioni giornaliere registrate sul Diario del Comando Superiore A.S.
Nella prima quindicina di aprile, durante la quale si era svolta la fulminea avanzata da el Agheila alla frontiera egiziana, in questo documento ricorre spesso la voce « perdite imprecisate » e la imprecisazione permane, per le truppe tedesche, sino a fine mese. Nello specchio che seg ue sono quindi state riportate in aprile, per i Tedeschi , le perdi te indicate g lobalmen te fino al 9 maggio nella Memoria: « Anni fata li in Africa», di Hans Gert von E sebeck . Conseguentemente sono state riportate in maggio le perdite tedesche che risultano dal Diario del Comando Superiore A .S. , l imitatamente al periodo dal IO al 31 eli quel mese.
Il contributo di sangue offerto dalle due componenti delle forze dell'Asse giustifica pienamente il carattere italo -tedesco eli ogni episodio della vicenda qui analizzata, carattere che la presente Monografia ha tenuto a mettere in evidenza, sulla base di inconfutabili documenti, contro l'antistorica faziosità della versione largamente diffusa, con l'avallo an che di illustri nomi della storiografìa internazionale, di una cam pagna esclusivamente tedesca dell'Africa Settentrionale.
La proporzione delle perdite, superiore anche percentualmente per la parte italiana, risponde non solo allo sfavorevole rapporto in fatto di armamento delle nostre unità ma anche alla natura dei compiti che, in funzione appunto delle loro caratteristiche organiche, venivano prevalentemente affidati alle divisioni italiane. E infine il maggior numero di dispersi (prigionieri, per la maggior parte) risponde logicamente alla situazione di truppe pressoché prive di mobilità tattica, implicate nelle vicende di una guerra a carattere di esasperata mobilità.

(4)
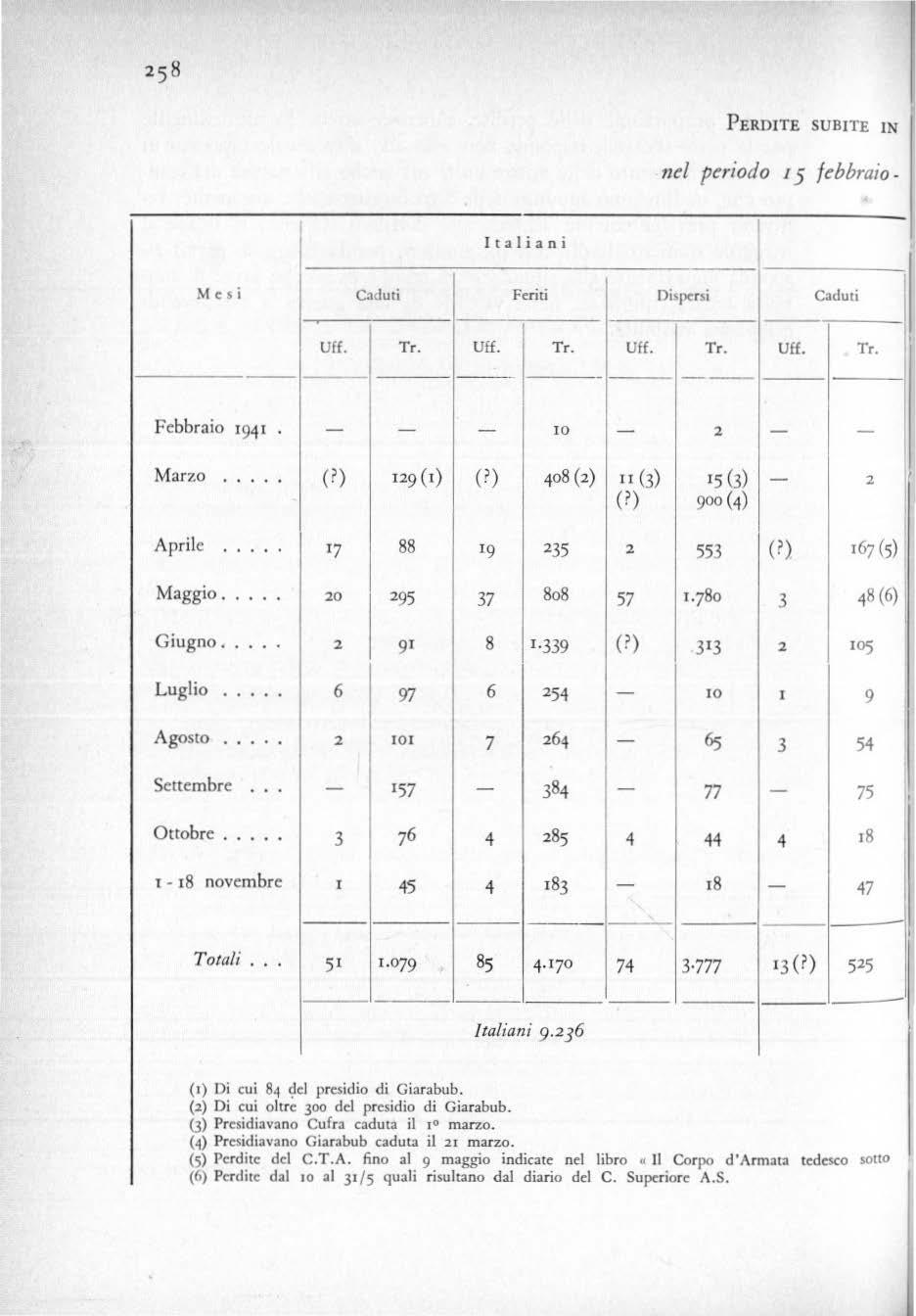
(5)
(6)

Come è sistematicamente affiorato nell'esame degli avvenimenti, e come d'altronde appare intuitivo, la situazione del teatro di guerra Nord- Africano rispecchiava in ogni momento il flusso della corrente di alimentazione dalla madrepatria alle armate contrapposte.
L'esito della campagna, nelle mutevoli fasi del suo sviluppo, era dungue in ogni momento funzione diretta della soluzione del problema dei trasporti : problema circoscritto per l'Italia all'utilizzazione delle brevi linee mediterranee, rigorosamente vigilate dalla prevalente potenza aero- navale britannica, esteso invece per l'avversario alla disponibilità delle più lunghe ma pressoché sicure rotte oceaniche.
Sembra pertanto opportuno e pertinente completare la trattazione degli avvenimenti militari nell'Africa Settentrionale con un esame sintetico, e nello stesso tempo completo, dell'andamento dei trasporti nel corso del periodo qui considerato.
A sp et t i ge n erali del p roblema d ei tras porti in A.S
Può giovare all'esatta e realistica valutazione della vastità e della complessità dell'assillante problema dei trasporti l'individuazione dei termini fondamentali della sua impostazione generale:

- affidam ento praticamente nullo sulle risorse locali della Colonia, scarsamente sufficie n ti alle esigenze degli i ndigeni;
- assenza di predisposizioni intese all'ammassamento di scorte, durante il non breve periodo di tensione internazionale che aveva preceduto la nostra entrata in guerra, profittando della completa sicurezza delle vie marittime e della maggiore disponibilità di naviglio ( r);
(r) All'atto della dichiarazione di guerra si era subita la perdita di circa 1.200.000 ton. di naviglio, pari al 35 % della disponibilità totale: unità in navi-
--.., fabbisogno corrente molto elevato per il mantenimento di circa 2oo.ooo uomini delle truppe metropolitane, 25.000 militari libici (con relativi familiari = 104.000 persone) e Io.ooo quadrupedi. A questa forza si era aggiunto nel 1941 il Corpo tedesco che alla fine di ottobre 1941 ammontava a 67-ooo uomini. Si doveva inoltre provvedere alle esigenze della popolazione civile metropolitana e di circa 35.ooo operai militarizzati;

- fabbisogno rispondente ai consu m i operativi. Per il solo carburante (automezzi, corazzati, aerei) nel periodo qui considerato il con sumo medio gio rn aliero si aggirava sulle 250 tonn., aumentabili a 350-400 nelle fasi di m aggiore attività operativa;
- eccezionale sviluppo delle linee di operazione che assorbiva gran numero di automezzi e ingente quantità di carburante per i trasporti d'intendenza, dai lontani porti di scarico alle linee avanzate.
- limitata capacità delle attrezzature dci due porti principali (Tripoli e Bengasi) che contribuiva a prolungare il termine viaggiopiroscafo;
- difficoltà di fare affluire tempestivamente nei porti metropolitani d'imbarco quantitativi di materiali adeguati alla capacità dei convogli, costretti talvo l ta a partire a carico ridotto;
- strenua lotta dell'avversario, con preponderanti m ezzi navali, subacquei e di superficie, ed aerei contro i nostri convogli, sottoposti a perdite in genti e irreparabili, non solo agli effetti dell'impoverimento del tonnellaggio disponibile ma anche della progressiva riduzio n e della nostra capacità di protezione aerea e navale ai convogl i stessi.
Capacità di scaricamento dei porti libici.
n imenti nei porti libici.
Si tratt a ovviamente di un dato fondame n tale per l'apprezzame n to teorico delle local i possibilità di ricezione dei n ostri rifor-
Il porto di Tripoli, di gran l unga i l m aggiore dell'inte ra Libia, consentiva lo scarico giorn aliero di 4500 ton nellate. E ra stato appro-
gazione fuori del Mediterraneo (fra cui alcune fra le più moderne ed efficienti) catturate, internate in porti neutrali o autoaffondate. La situazione del tonnellaggio doveva poi andarsi progressivamente inasprendo per effetto delle perdite, non compensate dalle nuove costr uzioni.
fondito prima della guerra e i lavori di dragaggio continuavano guerra durante, per consentire l'accesso alle navi di maggior tonnellaggio.
Il porto artificiale di BetJgasi consentiva lo sbarco giornaliero di 1000 tonnellate. All'inizio delle ostilità ne erano state ultimate le opere principali ma restavano da compiere importanti lavori di completamento . Poteva accogliere navi fino alle 3000 tonnellate e in numero limitato: non dunque convogli di una certa entità. Nel maggio 1941 il Comando Superiore Marina della Libia aveva espresso il parere che la potenzialità di sbarco potesse essere aumentata a 2000 tonnellate giornaliere, attraverso semplici perfezionamenti degli impianti dell'organizzazione.
Il porto di Derna non costituiva in realtà che un punto d'appoggio per il piccolo tonnellaggio, accessibile solo in condizioni meteorologiche favorevoli : la sua potenzialità giornaliera di sbarco non superava le 500 tonnellate.
Il porto di Tobru ch rappresentava l'unico buon approdo della Marmarica, dotato di efficienti strutture e buone attrezzature che consentivano lo sbarco anche di 700 tonnellate giornaliere.
Il porto di Bardia consisteva in una rada natural e, atta ad accogliere navi glio di piccolo tonnellaggio: la ristretta imboccatura risultava di difficile accesso in caso di mare grosso. La capacità giornaliera di sbarco era di circa 6oo tonnellate.
Contro l'integrità dei porti principali concentrava , ovviamente, la propria attività l'aviazione britannica, con reiterati bombardamenti diurni e notturni.
Dal 7 febbraio al 31 dicembre 1941 il porto di Tripoli subiva ben 83 incursioni, di cui 36 nelle sei settimane precedenti l'offensiva del 18 novembre.: 63 provocavano danni all'abitato e agli impianti fi ssi portuali, 20 provocavano danni agli impianti ed ai materiali militari (1). Ciò nonostante, con alacre lavoro di riparazione, si provvedeva a mantenere l'agibilità del porto a un livello soddisfacente.
Anche Bengasi era soggetta a continue azioni di bombardamento aereo: 134 nel periodo dal 7 febbraio al 31 dicembre 1941, di cui 57 nelle sei settimane precedenti l'offensiva del 18 novembr e. Di queste, II7 provocavano danni all'abitato e agli impianti fissi portuali, r7 danni agli impianti e ai materiali militari (2).
(r) Gwsi!PPE SANTORO: « L'A erona utica Italiana nella seco nda Guerra Mondiale», Ed. Esse, Milano, 1957, vol. II, pag. 134.
(2) GruSEPPE SANTORO: « L'Aeronautica Italiana nella seconda Gu erra Mondiale >l , Ed. Esse, Milano, 1957, vol. II, pag. 135.

Molte distruzioni erano state compiute sulle opere e attrezzature di Bengasi all'atto del nostro ripiegamento: poco era stato riattato dai Britannici durante la breve occupazione ed altre distruzioni aggiunsero al momento del loro abbandono della città, riducendo praticamente a zero le possibilità di utilizzazione del porto. Nei giorni immediatamente successivi alla nostra rioccupazione si poneva mano ai lavori di riattamento. Uno dei primi provvedimenti era la trasformazione del relitto di un grosso piroscafo, appoggiato sul fondo con relativa stabilità, in un pontile di circostanza, lungo r6o m. e largo m. 4,50 (r).
Scrive in proposito Churchill, con riferimento alla situazione in Libia nella terza decade di aprile:
<< ••• A noi sembrava r agione di grandissima insoddisfazione il fatto che il porto di Bengasi, di cui non eravamo riusòti a servirei utilmente, avesse già una parte tanto importante, ora che era passato in mani tedesche ... » (2).
Indubbiamente la << grandissima insoddisfazione » del Primo Ministro sarebbe cresciuta a dismisura se l'orgogliosa determinazione a non riconoscere altro degno avversario all'infuori del tedesco gli avesse permesso anche soltanto di sospettare, come poi era effettivamen te avvenuto, che assolutamente nessun tedesco aveva contribuito al ripristino del porto di Bengasi .. .
Lotta a d ol tra nza contro i c on v og li dell'Asse.
Fin dall'inizio delle ostilità la Marina britannica aveva condotto con particol are durezza la lotta con tro le n ostre comunicazioni con la sponda africana. Inizialmente la sua azione, pur imponendo ai nostri trasporti gravosi pedaggi, non aveva raggiunto l'intento di compromettere troppo seriamente il flusso dei trasporti indispen sabili per l'alimentazione delle operazioni nello Scacchiere Nord -Africano.
Il perno di manovra dell'azione aero- navale britannica contro
(r) Gen. del Genio L mcr GRosso, Comandante Superiore del Genio in Libia nel 19 40 - 41: « I porti della Libia e il Genio Militare nelle operazioni del 1941 - 42 » in Bollettino dell'Istituto Storico e di cultura dell'Arma del Genio, Roma, gennaio 1951.
(2) Dati tratti da « T h e Mcdirerranean and Middle Easr )) , PLAYFAIR I.S.O., London, 1956, ed H.M.S O., vol. II.

il nostro traffico era rappresentato da Malta ma lo Stato Maggiore Imperiale, dopo averne riconosciuto fin dal 1939 l'importanza primordiale per il dominio del Mediterraneo Centro- Occidentale, aveva trascurato la realizzazione del programma di potenziamento deliberato in relazione a tale funzione. Nella seconda metà del 1940 aveva progressivamente cercato di ovviare alle trascorse manchevolezze così che Malta andava gradatamente assumendo il ruolo che le competeva, ai danni delle nostre comunicazioni con la Libia .

Un radicale cambiamento interveniva però nel gennaio 1941, con il trasferimento del X Corpo Aereo Tedesco in Sicilia: per cinque mesi Malta veniva mantenuta sotto pesante pressione di bombardamento aereo (con l'attivo concorso della caccia italiana) e per qualche tempo il traffico nel Mediterraneo tornava a svolgersi con una certa tranquillità, così da consentire il trasporto del Corpo Tedesco d'Africa e di varie unità italiane, per ripristinare rapidamente la situazione seriamente compromessa dalla sconfitta della ro• Armata del maresciallo Graziani.
Senonché l'azione del X C.A.T. non poteva essere ulteriormente continuata con lo stesso ritmo , per l'eccessiva usura del materiale e per le perdite. La Germania, ormai impegnata a fondo nella Campagna dell'Est, non era in condizione (e comunque non era intenzionata) a devolvere altre forze a favore del teatro di guerra mediterraneo. Il centro di gravità dell'attività aerea veniva trasferito dalla Sicilia nell'isola di Creta: la pressione su Malta ne risultava conseguentemente alleggerita.
Da parte britannica erano state prese immediatamente efficaci contromisure per rendere sempre più costose le programmate incursioni sulla base di Malta: l'entità delle perdite subite dai nostri trasporti nel periodo gennaio- maggio 1941 riproduce efficacemente il fenomeno del graduale ritorno al primitivo stato di insicurezza delle nostre comunicazioni con la Libia, dopo il primo alleggerimento provocato dall'intervento del X C.A.T. (1):
Gennaio: navi affondate n. 4· per 14.537 tonnellate
Febbraio: )) )) )) 3 )) 6.027 ))
Marzo: )) ) ) )) 3 )) 10.194 ))
Aprile: )) )) )) IO )) 23·371 ))
Maggio: )) )) )) 31 )) 47·327 ))
(r) W. Crt u RCIIILL: << La sec onda Guerra Mondiale )) 1 Mondadori cd., 1952, Parte III, v<>!. I, pag. 287.L'inopinato intervento tedesco sui campi dell'Africa Settentrionale e la fulminea impresa del gen . Rommel che nel giro di due settimane aveva totalmente annullato i vantaggi raccolti dalla prima offensiva britannica, rendendo drammaticamente attuale una nuova minaccia alla frontiera del Deserto Occidentale, avevano convinto l'Alto Comando britannico che il successo o il fallimento della difesa della posizione egiziana (e, complessivamente, del Medio Oriente) sarebbe ormai dipesa in buona parte dall'efficacia delle misure intese ad impedire, o quanto meno a rallentare, il potenziamento delle forze dell'Asse, in concomitanza con i l massimo sforzo per intensificare i propri rifornimenti, così da raggiungere tempestivamente una sostanziale preponderanza sul l 'avversario, tale da consentire la riconquista del l 'iniziati va operati va.

Malta è e rimane sempre al centro di questa inasprita battaglia aeronavale contro il traffico marittimo italiano. Le direttive impartite nel maggio dal Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica britannica al gen . Hug Lloyd, nuovo comandante delle forze aeree di Malta (che erano state sostanzialmente rafforzate) erano di lotta senza quartiere contro i co n vogli dell'Asse con rotta sud: « Il vostro compito a Malta è di affondare qualunq ue nave che dall'Europa diriga in Africa >>.
Questa non era che l 'interpretazione del pensiero del Primo Ministro e Ministro della Difesa che il 14 aprile, i l giorno stesso in cui veniva respinto il nostro primo attacco contro la Piazza di Tobruch, aveva scritto:
« Se i Tedeschi potranno co n tinuare ad alimentare la loro invasion e della Cirenaica e dell'Egitto attraverso il por to di Tripoli e lungo l a strada costiera, essi potranno certamente investirei con forze corazzate superiori alle nostre, con conseguenze della massima gravità ...
« Compito principale della flotta britannica del Mediterraneo agli ordini dell'ammiraglio Cunningham div enta pertanto di arrestare tutto i l traffico m aritti mo tra l'Italia e l'Africa con l'impiego intensissimo delle unità di superficie e con l a collabo r azione, per quanto è possibile, dell'aviazione e dei somme rgib ili. Per questo obiettivo della più alta importanza ci si deve preparare, se necessario, a gravi perdi te di n avi d a battaglia, d'incrociatori e di cacciatorpediniere. Il porto di Tripoli deve essere m esso fuori uso con periodici bombardamenti e co n il blocco e la posa di mine, avendo cur a che la posa di min e n on impedisca il blocco o i bombardam enti. I conv ogli nem ici in navi gaz ione verso e di ritorno dall'Africa devono essere
attaccaci dai nostri incrociatori, cacciatorpediniere e sommergibili, con l'appoggio dell'arma aerea della flotta e della R.A.F. Ogni convoglio che riesce a passare deve essere considerato un grosso insuccesso navale. La reputazione della Marina Reale è impegnata nell'arresto di tale traffico.
« La flotta dell'ammiraglio Cunningham deve essere a tale scopo rafforzata a seconda delle necessità ... Essa dovrebbe essere in grado di costituire due squadre che potrebbero a turno bombardare periodicamente Tripoli, specialmente quando si venisse a sapere che navi o convogli si trovano nel porto ...
« 11avali sufficieuti dovrebbero la propria a Malta >> (I).
La recrudescenza dell'offe nsiva britannica coincideva con la decisione dell'Alto Comando Tedesco di trasferire a Creta il X C.T.A. (sulla quale si avrà occasione di tornare più oltre). Gli effetti si manifestavano immediatamente sensibili sul nostro traffico, come ri su lta dalla seguente tabella relativa alle perdite tra il giugno e l'ottobre
1941 (2):
Giugno: navi affondate n. 6, per r6.956 tonnellate
Luglio: )) )) )) 7 )) 28.070 ))
Agosto: )) )) )) 9 )) 35·070 ))
Settembre: )) )) )) II )) 64·954 ))
Ottobre: )) )) )) 7 )) 33·471 ))
Aggiungendo a questo passivo il naviglio minore perduto nell'intero Mediterraneo per cause varie si arriva alla cifra di oltre 470.000 tonnellate, di gran lunga superiore al gettito delle nuove costruzioni. Nonostante la severità del blocco, tra il giugno e l'ottobre la nostra Marina riusciva a trasportare sulla sponda africana 375.000 tonnellate di carichi vari e 125.000 tonnellate di carburante, con perdite di poco superiori al 15 °o del totale. Si dovevano registrare dolorosi affondamenti di grossi trasporti di truppa, particolarmente sensibili anche per le loro ripercussioni psicologiche, e perdite di torpediniere e navi ausiliarie, con grave danno per l'armonica composizione della flotta.
( 1) WINSTON CH URCHILL: « La seconda Guerra Mondial e - La G ermania punta a Oriente », Mondadori cd ., 1952, pag. 245·
(2) Da « Thc Mcdircrran can and Middlc East ))' di PLAYFAIR I.S.O., London, 1956, ed. Il.M.S.O., vol. IL

Colloq uio ital o - ted esco. La crisi dei trasporti si aggrava.
Il 16 settembre il Maresciallo del Reich Goring invitava il gen. Pricolo, Capo di Stato Maggiore della nostra Aeronautica, ad un colloquio, per esaminare la situazione nel Mediterraneo e stabilire eventualmente nuovi accordi per una maggiore efficacia della collaborazione fra le due aviazioni in quel teatro di guerra.
Il colloquio aveva luogo il 2 ottobre a R ominten e risultava praticamente poco conclusivo (1). In sostanza il Maresciallo non faceva che prospettare suggerimenti su misure già prese in considerazione dal nostro Comando Supremo e da Supermarina : intensificare gli attacchi per la neutralizzazione delle forze aeree di Malta; trasporto di truppa con sommergibili e cacciatorpediniere, riservando i piroscafi per i materiali; far capo, oltre che a Tripoli, anche a Bengasi, Derna e Bardia, valorizzando quei porti .

Il gen. Pricolo annunciava l'allestimento, in corso dì esecuzione, di una nuova base di appoggio nell'isola di Lampedusa. Nel quadro di un nebuloso riferimento alla prossima risoluzione vittoriosa della campagna di Russia, il Maresciallo lasciava sperare un possibile aumento nell'assegnazione del carburante entro il termine di qualche settimana, evitando di impegnarsi in qualsiasi promessa di altri concors1.
Molto era stato frattanto realizzato nell 'isola di Malta per attenuare l'efficacia dei bombardamenti, predisponendo aree di diradamento e numerose piste per il decentramento degli apparecchi. Ne era stata sensibilmente rafforzata la potenzialità difensiva ed offensiva, con nuove unità da caccia e da bombardamento. In ottobre era stata dislocata nel porto di L a Valletta una di visione navale, composta di due incrociatori leggeri e due cacciatorpediniere, denominata
«
Forza K >>Rilevata la presenza di questa nuova unità la nostra Marina sollecitava insistentemente la ripresa del martellamento della base aeronavale, al fine di snidare la nuova minaccia . In una riunione dei Sottocapi di Stato Maggiore delle tre Forze Armate, l'amm. Sansonetti sviscerava a fondo l'intero problema del traffico con la Libia.
(r) Il punto di vista dell'Alto Comando tedesco ri su l ta molto efficacemente espresso dal Capo di Stato Maggiore Generale, gen. Halder, che nel suo Diario anno tava sotto la data del 29 luglio: cc La garanzia della sicurezza dei trasporti diretti al Nord Afr ica spetta all ' Italia. Nell'attuale situaz ione sarebbe crimi nale assegnare ad aeroplani tedeschi questo compito>>.
L'Aeronautica della Sicilia, nell'ambito delle proprie possibilità, aumentava al massimo la pressione sull'isola, senza peraltro raggiungere vistosi risultati. C'era d'altronde in preparazione il nuovo attacco di Tobruch e l'Aeronautica doveva tener conto dell'eventualità di dover temporaneamente rinforzare la 5"' Aerosquadra, nell'Africa Settentrionale, per fornirle gli elementi da caccia, da bombardamento e da ricognizione necessari per quell'operazione.
La Marina iniziava in ottobre un nuovo ciclo di trasporti, ricorrendo ali 'imbarco diretto delle truppe sui cacciatorpediniere che, grazie all'alta velocità, riuscivano a compiere gran parte della traversata nell'arco di una notte. P er i restanti co nv ogli ricorreva alla decisione di rafforzarne la protezione, impegnando nel compito divisioni di incrociatori e persino navi da battaglia, oltre i normali mezzi di scorta, senza tuttavia raggiungere risultati adeguati, per effetto soprattutto della perdurante inferiorità tecnica in fatto di radar e di aerei notturni. Nello stesso mese la Marina tedesca provvedeva all 'impianto di una base di som mergibili a Salamina e faceva affluire nel Mediter raneo 20 unità subacquee . L'avi azione tedesca, che rappresentava indubbiamente l'arma più efficace nella particolare circostanza, non tornava a riprendere il proprio posto in Sicilia che due mesi più tardi.
In novembre la Marina britannica si accaniva con inaudita viole nz a, con tutti i mezzi di superficie, subacquei ed aerei, contro i nostri trasporti raccogliendo cospicui risultati: andavano perduti complessivamente tre cacciatorpediniere e tredici piroscafi (fra cui un intero convoglio di sette navi da carico, sorpreso e distrutto circa 35 miglia a levante di Siracusa) (1). Era questo un duro colpo, nell'imminenza della grande offensiva che 1'8• Armata britannica si apprestava a sferrare c che infatti aveva inizio dieci giorni dopo.
La situazione minacciava di divenire insostenibile, di fronte anche alle sole esigenze difensive del fronte nord- africano, per non pensare alle trascorse velleità di piani di conquista fino al Canale ed oltre .
(1) Avvistato da un ricognitore nel pomeriggio del giorno 8, il convoglio veniva attaccato di sorpresa nella none dalle navi di Malta che, grazie ai radar, potevano preparare il tiro prima di giungere a distanza visiva. Aprivano quindi improvvisamente il fuoco da breve distanza, ripartendosi i bersagli. Entro appena sette minuti tutti i piroscafi erano in fiamme ed in stato di affondamento.

Il ricorso all'aviotrasporto, an che per la limitata disponibilità di m ezzi idonei a tale im piego, come pure il ricorso ai sommergibili o al naviglio sottile no n pote vano essere considerati che un'utile integrazione d ei rifornimenti impe r ati vamente richiesti per la materiale alimentazione d elle unità e p er rinvigorire la loro capacità operativa, sul punto di trovarsi esposta ad una durissi m a prova di resistenza e di r eattivi tà.
Si imponeva pe rtanto di escogitare mezzi idon ei a modifi care sostanzialm ente lo stato di soggezio ne cui erano sottoposte le nostre vie di comunicazione con la sponda nord - african a. Si trattava in sosta nza di un fattore negativo permanente, soggett o ad assum ere valori variabili in funzione d ella situazio ne generale c che in qu esto momento minacciava di esercitare una influenza d eterminan te sul ca mpo dell'imminente battaglia fra le due armate co n trapposte.
Il problema non era certamente nuovo ed era stato cos tantem ente tenuto nel dovuto conto dal Comando Supremo. Vale la pena di fare un passo indietro e atta rd arsi nella ricapitolazione delle misure via via adottate sotto la spi nta della situazione con tingente, nell'arco di tempo interessante la presente Mono grafia.
Ricerca e organizzazio ne di nuove basi. Necessità d i disporre delle basi tunisin e
Il 14 aprile 1941 il Sottocapo di Stato M aggio re Generale, gen. Guzzoni, c ui co m pe teva la trattazione dei proble mi del traffico oltremare, aveva indetto una riunione alla qu ale avevano partecipato i capi re spo nsabili .dell e tre Forze Arm ate e del Comando Supremo (r).
Il ge n. Rommel aveva invocato mi sure per risolvere la situazione che eg li d efiniv a «c ri tica» . In effetti tutti gli automezzi disponibili erano stati impiegati per co nferire mobi lità ai reparti italiani che avevano partecipato alla fortunata «corsa in avan ti » ed ora le unit à rim aste ind ietro non erano in grado di ser r ar sotto sulle posizioni
(1) Si trattava d i:
- amm. Riccardi, Sottosegretario di Stato e Capo di Stato Maggiore della Mar ina (succed uto 1'8 dicemb re 1940 all'arnm. Cavagnari);

- gcn . di s.a. Samoro, Sotrocapo di Stato Maggiore dell'Aeronau tica;
- gen. Rossi Francesco, Sottocapo di Stato Maggiore In tendente;
- gen. Magli, Add etto al Comando Supremo (s ucceduto il 26 gennaio 1941 al gen. Arm ellini);
- gen. von Rintclen, Addetto Militare tedesco a Roma.
raggiunte. Secondo le asserzioni del gen. von Rintelen le perdite di automezzi e carri armati subite dai reparti tedeschi raggiungevano la metà circa delle dotazioni: si trattava però in genere di guasti riparabili presso le officine al seguito delle truppe.
Nel corso della discussione veniva posta in luce la possibilità di procedere all'avviamento del personale per la via aerea: il gen. von Rintelen preannunciava per il 26 dello stesso mese l'arrivo a Foggia di aerei tedeschi da trasporto. Per i materiali occorreva invece continuare con i trasporti marittimi.
Il gen. Guzzoni rappresentava la necessità di rendere più efficiente l'offesa aerea e di intensificare quella subacquea. E gli metteva in discussione anche l'eventualità di giovarsi delle navi da gue rr a per i trasporti in A.S.:
« La situazione migliorerebbe sensibilmente qualora potessimo chiudere Gibilterra ma dato che su tale argomento null a anco ra è possibile prevedere (egli accenn ava evidentemente ai vaghi piani tedeschi di procedere, con la connivenza della Spagna, alla conquista della poderosa rocca britannica all'ingresso del Mediterraneo) la situazio ne è quella che è, n on certamente rosea, e per migliorarla occorre inviare gli automezzi perché con essi i reparti possano migliorarla. Quando i reparti sono mobili, anche i tentativi di sbarco avversari sono difficili ( r) )) .

Il gen. Santoro faceva rilevare che per un effi cace incremen to della partecipazione aerea nella battaglia delle comunicazioni, mancava un'adeguata organi zzazio ne a terra.
L'amm. Ri ccardi rappresentava l'assoluta impossibilità dell'impiego di navi da guerra per il trasporto dei materiali. In se nso assoluto, l'utilizzazione dei cacciatorpedini ere (c ui si ricorse pe rtan to com e estremo rimedio, in casi di estrema crisi) conse ntiva un ben scarso volum e di carico utile. Una più larga utilizzazione di questo tipo di n aviglio, già molto ridotto per le perdite subi te , avrebbe influito sul numero delle siluranti disponibili per la scorta ai convogli e quindi in definitiva sul numero stesso dei convogli d a potersi effettuare. La Marina ave va proceduto e procedeva alla protezione delle rotte con l'organizzazione di vasti campi minati ed impegnava già tutto il naviglio sottile disponibile nei servizi di scorta. Volendo impiegare navi maggiori per l a protezione dei convogli sarebbe stato
(1) Trattative avviate per l'acquisto di autom ezzi in Tunisia av e vano dato risultati molto modesti: possibilità di acquisto di 120 autocarri e 20 rimorchi, fra Tu nisia e Algeria.
necessario proteggere a loro volta anche queste navi con altro naviglio sottile. Sarebbe desiderabile disporre di navi più veloci per la composizione dei convogli ma la loro disponibilità era invece molto limitata. Tutto questo in linea teorica, senza tener conto del maggior consumo di carburante, amministrato dalla Germania con estrema parsimonia.
Il 29 aprile, in un colloquio con il gen. von Rintelen, il gen. Guzzoni prospettava alla parte germanica, come unica via di uscita per aumentare il volume dei trasporti diretti alla sponda nord - africana, la necessità di poter disporre dei porti della Tunisia : si sarebbe abbreviato così sostanzialmente l'insidiato percorso marittimo, sia pure a spese di un maggior percorso terr estre, da realizzare però in condizioni di maggior sicurezza (1). Si è già accennato a suo tempo al pratico fallimento di questa trattativa ma può valere la pena di riprendere in questa sede l'esposizione della complessa vicenda.
Il 5 maggio il gen. von Rintelen comunicava al gen. Guzzoni che il Governo del Reich dichiarava di non poter accedere alla desiderata richiesta « perché troppo gravi sarebbero state le complicazioni che sarebbero derivate da un rifiuto francese ».

Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale ribadiva allora che l'accesso a Tunisi era assolutamente necessario per l'alimentazione del vitale scacchiere nord- africano ed occorreva assicurarselo subito, tenendo anche conto del tempo non breve occorrente per l'organizzazione del nuovo sistema di trasporti fino alla frontiera tripolina. A suo avviso neppure la conquista di Creta e l'auspicata ripresa di Tobruch avrebbero potuto migliorare sostanzialmente la situazione in quanto, per la limitata disponibilità del naviglio da carico, solo la netta riduzione del termine viaggio- piroscafo poteva apportare un reale incremento del flusso dei rifornimenti. E aggiungeva: « Vi sarebbe una diversa soluzione, che interessa il Comando tedesco: quella cioè di attaccare il Delta da est, dopo aver traversato la Turchia e occupato Cipro (l'ipotesi si intonava evidentemente ai velleitaristici piani che
( r) Già nel febbraio, prima di partire per l'Italia, il gen. Rommel aveva insistito con il Ministro degli Esteri d el Reich, von Ribbentrop, perché si trovasse una soluzione per l'utilizzazione di Tunisi e di Biserta. L'altro aveva obiettato che un ' azione in tal senso era prematura: si trattava di evitare difficoltà con i Francesi e di non fare il giuoco dell'Italia che teneva a mettere un'ipoteca su Tunisi e forse su tutto il Nord Africa: « Portare gli Italiani a Tunisi significava alienarsi tutti Francesi di buona volontà e pregiudicare la politica estera tedesca in Occidente » Nello stesso colloquio von Ribbentrop dichiarava di non ritenere importante il possesso di Malta perché, a giudizio dell'OKW, bastava neutralizzar e l'isola con l'aviazione.
in quel momento si andavano ventilando negli ambienti dell'OKW, vendendo anzitempo la pelle del coriaceo orso russo) ma anche ammettendo sufficienti 1 0 divisioni per le operazioni del Delta occorrerebbe pur sempre trasportare in Libia 5-6 divisioni, calcolando che 3-4 divisioni dovrebbero essere lasciate indietro, lungo la costa. E siccome il trasporto di qu este 5-6 divisioni non potrebbe essere effettuato per il settembre, anche in questa ipotesi occorrerebbe qualche elemento nuovo, che facilitasse la soluzione del problema dei trasporti »
Come si vede, la rude materia del problema che ci fronteggiava , italiani e tedeschi allo stesso modo, si frammi schiava nelle argomentazioni degli alti comandi e si confondeva con l'impalpabile prodotto della fantasia .
Ad un accenno del gcn . von Rintelen in merito alla possibilità di occupare Malta con mezzi italiani e tedeschi, il gcn. Guzzoni dichiarava di ritenere l'operazione molto difficile, data la ristrettezza d ell'isola, battuta dai venti (difficoltà di lancio di paracadutisti) e difesa da robuste sistemazioni in caverna. Concludeva infine con l'affermazione: « Se, comunque, si escludeva la possibilità di trattare con la Francia per avere Tunisi, bisognava tentare Malta. Diversamente bisognava rinunciare a marciare sul D elta da ovest ».
Il gen. Guzzoni convocava nuovamente il 6 maggio i Capi delle tre Forze Armate per metterli al corrente delle conversazioni avute (r).
L'amm. Riccardi faceva presente la materiale impossibilità di continuare con il ritmo di un convoglio ogni quattro giorni e la necessità di ridurlo ad uno ogni sci giorni, che è quanto dire portare un notevole ritardo al programma dei trasporti , prolungandolo fin verso la fine di ottobre.
Nonostante le opposizioni di principio presentate alla nostra proposta, la que stio ne di Tunisi veniva poi affrontata dai Tedeschi con la parte francese e nell'incontro avvenuto al Brennero il 2 giugno con il generale Cavallero il maresciallo K eitel, come si è visto, lasciava sperare che la questione fosse per avviarsi ad una soluzione concreta.

( r) Questa volta le FF.AA. erano rappresentate, oltre che dall'amm. Riccardi per la Marina, da:
- gen. s.a. Pricolo, Sottosegretario di Stato e Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- gen. Roatta, Sottocapo di Stato Maggiore dell'E sercito;
- gen. Gandin Antonio, Capo Reparto Operazioni del Comando Supremo.
Un approfondìto studio condotto dall'Ufficio Servizi del Comando Supremo sulle condizioni relative ai porti di Tunisi e di Biserta metteva in evidenza i chiari vantaggi del sec<!ndo rispetto al primo, per capacità, 1ttrezzatura e organizzazione portuale, difesa e comunicazioni. Dista una decina di miglia meno di Tunisi dai nostri porti d'imbarco (Napoli- Tunisi, 310 migli a ; NapoliBiserta, 300 miglia) e la maggior distanza dal confine della Tripolitania era compensata dall'esistenza di una ferrovia e di una strada , entrambe a grande potenzialità. Bisognava quindi insistere per l'autorizzazione ad accedere al porto di Biserta : in tal senso veniva rivolta una sollecitazione all'OKW, in data 12 giugno.
Contemporaneamente da parte germanica veniva suggerito che per l'inoltro dei rifornimenti urgenti per il C.T.A. si seguisse un diverso sistema, basato sul concetto di indirizzare esclusivamente sulla rotta più diretta di Bengasi e Derna i trasporti << periodici » (munizioni, vettovagliamento, pezzi di ricambio per i reparti di prima linea) e dirigere su Tripoli e Biserta i trasporti << occasionali » (rinforzi di truppe, artiglierie, assegnazioni di automezz i, personale di terra dell'aviazione, ecc.). Suggeriva inoltre di tener conto dell'avvenuta occupazione di Creta per organizzare una nuova linea di comunicazione dali 'Italia, via Grecia, con l'Africa Settentrionale. Giungeva infine dal Comandante in Capo della Marina tedesca, amm. Raeder, una richiesta relativa alle possibilità di tma operazione per la conquista di Malta: rispondeva Su per marina il rs luglio che, in base all'aggiornato studio del problema, la conquista dell'isola non poteva essere affrontata con i mezzi aerei e navali di cui l'Italia disponeva.

La soluzione del problema di Malta e Tunisi veniva nuovamente sollecitata il 19 luglio dal gen. Rommel in un rapporto diretto personalmente a Hitler:
<< Ritengo il problema di Malta tale da dover essere risolto subito, come è stato per Creta. In ogni caso è necessario, per i rifornimenti attraverso il Canale di Sicilia, che i convogli siano assolutamente indisturbati. La Marina italiana ha intensificato in questi ultimi mesi il sistema delle scorte ma occorre aumentare il potenziale aereo. Sono d'avviso che l'azione per Tunisi e Biserta è condizione indispensabile per l'esito dell'avanzata dell'Afrika Korps verso la Valle del Nilo. Tutta la situazione del Nord Africa è fluida e infida. Le mie informazioni e quelle di Canaris (l'ammiraglio Capo del Servizio Informazioni tedesco) concordano con quelle degli Italiani nello stimare possibile un gesto di dissidenza da parté del Nord
Africa Francese, che avrebbe enormi ripercussioni negative sulla sit uazione strategica del Mediterraneo, ponendo delle basi essenziali nelle mani del nemi co, irrigidendo ancor più la Spagna e facendo crollare la già effimera resistenza francese in Siria (x).
« Mi per metto perciò di suggerire all'OKW di prendere in conside razion e per la prossima offensiva (che , ripeto, non potrà farsi prima dell 'au tunno) una doppia manovra, verso est e verso ovest, con l'occupazione di Tunisi e di Biserta nonché, se opportuno, dell'Algeria.
« Gli Arabi sono ancora passibili di essere influenzati verso l'Asse, sia i n Algeria che i n Egitto ... ».
Strana proposta invcro che, nel riconoscimento dell'impotenza ad alimentare la « se mplice » impresa contro l'Egitto, cerca il rimedio nell 'impostazion e di una doppia impresa che avrebbe implicato, come logica premessa, un gettito più che raddoppiato dei trasporti sulla sponda nord- africana. Comunque, Hitler rispondeva il 22 lug lio che i piani contro l 'Egitto erano ormai studiati, ma rimaneva perplesso per Tunisi: riteneva preferibile che si procedesse alla sua occupazione. Il Comandante Superiore del Sud, maresciallo Ke sselring, e il gen. Student, Comandante del Corpo dei Paracadutisti ed eroe dell'impresa di Creta, avrebbero inoltre studiato insieme agli Italiani un piano per l'occupazione di Malta.
Molte parole, come si vede, molte idee, ma scarsa aderenza di realismo ai drammatici aspetti della situazione concreta di un'armata italo- tedesca schierata nel deserto , a migliaia di chilome tri dalle basi logistiche, che minacciava di essere travolta per l'in sufficienza dei rifornimenti inviatile dalla madrepatria.
Come si è già accennato nell'esporre g li avvenimenti di Siria, dopo la sfavorevole conclusion e di quella ca mpagna il Gov ern o di Vichy era divenuto ben altrimenti cauto c rifiutava ora ogni trattativa relativa all'utilizzazione della base di Biserta, per timore di complicazioni con la Gran Bretagna e con le stesse sue forze militari del Nord Afri ca, profondamente permeate ad ogni livello di spi rito ga ullista. Si è già visto attraverso le parole del Ministro degli E steri del Reich quale fosse lo spirito di Berlino nei riguardi delle pretese
« ipoteche» italiane su lle colonie francesi: non tal e ce rtamente da indurre Hitler e i suoi collaboratori a correre il ris chio di comprom ettere, per soddisfarli, i rapporti con la Francia.

Dopo mesi di inutili scambi di vedute ci si trovava insomma esattamente al punto di partenza: il problema dei trasporti rimaneva circoscritto negli stessi termini entro i quali, pertanto, occorreva cercare, se non proprio la soluzione totale invocata dalle esigenze della campagna nord- africana, almeno un alleggerimento della presente situazione di crisi.
Scelta di nuove rotte. Un'apposita Commissione aveva compiuto un approfondito esame della situazione gen erale nel bacino Mediterraneo Centrale. Nel suo rapporto in data 4 luglio metteva in evidenza la convenienza di far seguire ai convogli veloci (1) diretti a Tripoli rotte molto a levante di Malta, meno soggette all'offesa aerea nemica (allegato n. 31). Le rotte di ponente (fra Pantelleria, Lampedusa e la costa tunisina ), pur essendo ptù brevi, risultavano più pericolose per effetto della maggior vicinanz a dì Malta: la caccia di scorta non aveva sufficiente autonomia (2) e l'artiglieria contraerea delle navi, pur di notevole efficacia, non era in grado di garantire l'incolumità dei trasporti. L'esistenza di ampie zone minate, predisposte dalla nostra Marina, finiva inoltre per delimitare su un lungo tratto, a nord e sud di Pantelleria, dell e ristr ette fascie di obbligato passaggio, probabilmente perfettamente individuate dalla ricognizione britannica. L 'allungamento del percorso sulle rotte orientali co mportava è vero una perdita nello sfruttamento del tonnellaggio, ma in compenso i convogli si portavano oltre la portata dei bombardieri d i base a Malta.
In data 7 luglio gli Stati Maggiori della Marina e dell' Aeronautica emanavano direttive per la protezione dei convogli veloci sulle rotte ad oriente di Malta: sistematica sorveglianza delle forze navali avversarie in provenienza da Malta; protezione aerea dei convog li nella navigazione diurna per il maggior percorso possibile, con eventuale concorso della caccia tedesca dalle basi della Morea.
L 'efficacia dell'espediente doveva mostrarsi di breve durata. Sfuggiti al campo d'azione degli aerosiluranti provenienti da Malta, i convogli andavano ad incappare nella sfera di attività della flotta
( 1) La stessa convenienza non veniva riconosciuta pe r i convogl i lenti perché l'allungamento avrebbe importato un sensibile aumento nella durata della traversata, fuori della protezione aer ea .
(2) Raggio d'azione: 85 miglia.

di Alessandria, ormai libera da ogni altro impegno per la Siria. Nuovi provvedimenti difensivi venivano presi in considerazione in una riunione di esperti tenuta il 17 luglio presso il Comando Supremo, tradotti in ordini il successivo giorno 20: oltre al controllo della base di Malta era indispensabile tenere sotto sorveglianza i movimenti delle forze navali avversarie lungo il fascio delle probabili rotte adducenti dalla base stessa al Canale di Creta. Sino a quando non fosse stato possibile dislocare a Suda una squadriglia da ricognizione marittima, Superaereo doveva assicurare una particolare attività esplorativa per sorvegliare le provenienze da Ale ssandria, sino a 200 miglia dalla base medesima. Entro il raggio della propria autonomia, la protezione dei convogli doveva continuare ad essere assicurata dalla caccia dislocata in Grecia. Un complesso di provvedimenti teoricamente ineccepibili, ma difficilmente realizzabili nella misura necessaria a renderli veramente efficaci, con i mezzi a disposizione degli organi esecutivi.

L a neu trali zzaz ione di Si continuava insomma a cercare di girare Malta intorno alla dura concretezza del problema di Malta, ma questo continuava a dominare nella lotta a fondo per le comunicazioni marittime fra l'Italia e la Libia. Sembra interessante a questo punto individuare sommariamente i dati materiali del problema.
La piccola isola (290 kmq. di superficie, 28o.ooo abitanti nel 1940) doveva e deve la propria importanza alla posizione geografica e al vasto e sicuro porto di La V alletta. Situata a cavallo fra il bacino occidentale e quello orientale del Mediterraneo, a metà cammino fra Gibilterra e Suez, a 100 km . dalla Sicilia e 300 circa dalla costa tripolina, rappresenta veramente un nodo obbligato di tutto il traffico di questo mare. Dopo la caduta della Francia costituiva inoltre l'unica base aerea e navale inglese in condizione di esercitare una efficace e continua azione di contrasto sulle nostre comunicazioni marittime con la Libia, d'importanza veramente vitale per l'alimentazione della guerra terrestre colà impegnata. La base aerea di Malta era anche un prezioso osservatorio a disposizione della « Mediterranean Fleet » di Alessandria.
L'organizzazione difensiva dell'isola, favorita dalla natura rocciosa del terreno e dalla struttura aspra a diruta delle coste, constava
di un sistema periferico e di un sistema interno. Il primo si presentava particolarmente robusto in corrispondenza delle basi navali di La Valletta e Marsa Scirocco, l'altro provvedeva particolarmente alla protezione dei campi di aviazione ed a contrastare eventuali azioni di paracadutisti e di aviosbarco. Comprendevano vecchi forti, modernamente riattati ed armati, batterie in caverna c postazioni in barbetta, nidi di mitragliatrici, riflettori e una fitta re te di osservatori e posti di vigilanza , ostacoli, sbarramenti, sistemazioni protettive di depositi, rifugi sotterranei e in caverna, compresi i ricoveri per la popolazione civile.
Non risulta che, a parte qualche pezzo contraereo , esistessero apprestamenti difensivi di qualche entità nelle due isole minori di Gozo e Comino.
Dopo la perdita di Creta il Comando in Capo del Medio Oriente aveva considerato la possibilità di un'analoga impresa nemica per la conquista di Malta ed aveva preso corrispondenti misure per potenziarne la capacità difensiva con considerevoli rinforzi , così della guarnigione come in particolare della difesa aerea. Ai primi di maggio, senza contare la marina, la forza era di 26.ooo uomini dell'esercito e 2000 (destinati ad aumentare a 3000) dell'aviazi one. Per gli aerei il programma di potenziamento prevedeva che l'isola avrebbe dovuto servire come base per 300 apparecchi di cui un centinaio da caccia, una trentina di siluranti e il resto da bombardamento leggero e pesante.
Il Comando Aeronautica della Sicilia disponeva alla fine del 1940 di 63 apparecchi efficienti, jn maggio di 130 (40 bombardieri, 3 aerosiluranti, 87 caccia).
Come si è visto, il X Corpo Aereo tedesco (X C.A.T.) era cominciato ad affluire in Sicilia nella seconda metà di dicembre. Il suo comando era dello stesso rango del Comando Aeronautica della Sicilia, con il quale collaborava per via di intese dirette, mentre dipendeva direttamente da Superaereo. Il Corpo Aereo comprendeva reparti da bombardamento in picchiata, da bombardamento leggero e pesante, da caccia e cacciabombardieri, da ricognizione e ricognizione strategica e da trasporto. La forza media efficiente era in gennaio di 141 apparecchi, in maggio di 243 (8o }u87, 65 Ju88, 36 Henr, 30 Meno, 32 Mer09). In febbraio, in coincidenza con l'inizio dell'arrivo in Libia della s• Divisione Leggera tedesca, erano stati trasferiti alle dipendenze del << Fliegerfiihrer Afrika » (Comandante dell'aviazione in Africa) reparti di }u87 e Meno.

Sino alla fine di ma ggio 1941 al Comando Aeronautica dell a Sicilia competeva la protezione del traffico marittimo co n la Libia, la difesa aerea dell'isola e la scorta alle formazioni da bombardamento italiane e tedesche. Alle forze del C.A.T., più numerose e qualitativamente più rispondenti, erano affidati i compiti offensivi contro Malta e sul Canale di Sicilia.
I risultati iniziali del nuovo schie ramento , come si è già visto, si presentavano molto promettenti. Il ro- 11 gennaio si registrava l'affondamento di un cacciatorpediniere e gravi danni alla portaerei Illustrious di scorta ad un convoglio britannico diretto a Malta: l'II gennaio veniva colpito da Stukas (la bomba però non esplodeva) l'incrociatore Gloucester e affondato l'incrociatore Soutlzampton in navigazione da Malta verso levante. Particolarmen te grave era la temporanea indisponibilità della portaerei, l'uni ca presente nel Mediterraneo. Annotava in proposito l'amm. Cunningham, Comandante della Flotta del Mediterraneo: « Avevamo molti motivi per riflettere. In pochi minuti l'intera si tuazione era mutata. Di colpo la flotta era stata privata dei suoi aerei da caccia ed il suo dominio del Mediterraneo era mina cciato da un'arma m olto più efficiente e pericolosa di quelle contro le quali avevamo prima co mb attuto (r) >) .
Il 15 gennaio il X C.A.T. iniziava una serie di violenti attacchi contro i campi e il porto di La V alletta. L'azione veniva ripetuta il giorno r6, il 18 e il r9, la notte sul 21 e il giorno 23 con indubbi risultati. Nel porto veniva fra l'altro colpita nuovam ente la portaerei Illustrious che riusciva tuttavia a riprendere il mare e giungeva due giorni dopo ad Alessandria.
Perdurando la pressione aerea su Malta, nei mesi di febbraio e d1 marzo la minaccia al no stro traffico marittimo si attenuava così da conse ntirci di provvedere con perdite accettabili al trasporto del Corpo Tedesco d'Africa e di quanto era programmato per il ripr istino della Sa Armata in Tripolitania.
La Gran Bretagna non si era, ovviamente, limitata a registrare la nuova minaccia ma aveva immediatamente delib erato adeguate mi sure per fronteggiarla. L'Ammiragliato aveva destinato la portaerei Formidable in sostituzione dell'lllustrious: la nuova unità
(1) Amm. A. B. « L 'odissea di un marinaio », Garzanti ed., 1952, pag. 142.

raggiungeva la Flotta del Mediterraneo, per la rotta del Capo, alla m età di m arzo.
Il 28 marzo un'op erazio ne offensiva della nostra flotta contro g li inglesi dir etti in Grecia si era conclusa con il già ricordato sfavorev ole comb atti m ento di Capo Matapan. Nella notte sul r6 aprile un no stro convoglio di ci nq ue piccoli piroscafi (quattro tedeschi e uno italiano) scortato da tre cacciatorpediniere veniva attaccato al largo di Sfax da quattro cacciatorpediniere nemici, forti del con sueto vantaggio del radar : nel rapido sco ntro che ne seguiva tutti i piroscafi (per complessive 14.000 ton.) e due cacciatorpediniere andavano perduti, contro l'affondamento di un cacciatorpediniere avversario.
In un colloquio svolto il 18 apri le al Comando Supremo con il gen. von Rintelen veniv a riconosciuta la ne cessità di non dar tregua a Mal ta , per l a protezione indiretta del tra ffico. Si ri co nosceva in pari tempo l'opportunità di mo lestare in mani era continuativa l'attività avversaria sul D elta e sul Canale di Suez e di « stringere da vicino» Creta, una volta padro ni della Grecia.
In questo ordine d'idee il gen. Guzzoni, premesso che da parte no stra sareb be stata aum entata l'aviazione de li' Africa Settentrionale, m etteva in rili evo il m iglior ren dim en to d egli Stukas (di cui n oi aveva m o scarsa disponibilità) contro bersagli navali, con qu esto ad un a più lar ga pa rtecipa zio ne tede sca in tal e ca mpo, m entre n oi avremmo potuto aumentare i bo mbardi eri in Grecia. In tal senso venivan o i m partiti precisi ordini a Superaereo
Tutto questo orientamento veniva pe rò a cadere pochi giorni dopo, quand o l'OKW chied eva che l'avia zio ne italiana assumesse d a sola la responsabilità così dell'azione su Malta come délla scorta ai convogli, dato che l'aliquota del X C.A.T. ancora i n Sicilia, sarebbe stata sposta ta in Grecia, « !Per avvicinarla maggiormente alla Cirenaica e all'Egitto >> Si trattava dei prodromi della i mmin ente operazione di Creta.
La pressione su Malta continuava tuttavia ad esse re esercitata in qualche m an iera . Qualche successo frutt ava il minamento de ll 'ingresso del Gra nd H arbour : un cacciatorpediniere ri m aneva affond ato e l'incr ociatore Gloucester, danneggi ato, veniva fatto ripartire per il Le vante (r).
 ( 1) Gen. GIUSEPPE SANTORO: « L 'Aeronautica Italiana nella seconda Gu erra Mon diale))' Ed. Esse, Milan o, 1957, vol. II, pag. so.
( 1) Gen. GIUSEPPE SANTORO: « L 'Aeronautica Italiana nella seconda Gu erra Mon diale))' Ed. Esse, Milan o, 1957, vol. II, pag. so.
L'attività svolta dal X C.A.T. dal gennaio al maggio 1941 su Malta risulta compendiata nel seguente prospetto:
Può risultare a questo punto interessante conoscere il pensiero del Comandante della Flotta del Mediterraneo sul ruolo e l'efficienza di Malta nel maggio 1941 (I):

« Indubbiamente Malta era la giusta base strategica per una flotta, quantunque anche così parte della flotta sarebbe dovuta essere dislocata altrove per proteggere i convogli nell'Egeo e la linea di rifornimento dell'esercito, fra Alessandria e Tobruch: compiti che entrambi richiedevano la cooperazione aerea.
<< Tuttavia. Malta non aveva mai raggiunto il progettato grado di efficienza n ella difesa antiaerea, in fatto di cannoni e di gruppi da caccia e perciò era pericoloso che navi da guerra se ne servissero come base. Assai poche navi avevano potuto servirsi dell'isola e delle sue attrezzature di raddobbo senza restare danneggiate.
<<L'arrivo in Sicilia dei bombardieri in picchiata tedeschi (che erano perciò a sole 6o miglia di distanza) e l'accresciuta attività degli aerei che portavano torpedini avevano molto aumentato i rischi.
<< L'eventuale arrivo della Luftwaffe nella Grecia meridionale avrebbe reso precario l'u so della Baia di Suda da parte nostra e avrebbe graveme nte complicato, con bombardamenti in picchiata da parte di aerei provenienti dalla Grecia, dall'Italia, dalla Sicilia e dall'Africa Settentrionale il rifornimento di Malta da Alessandria ...
<< .. L'orizzonte si presentava tetro e prevedevo che, se non fossimo riusciti ad ovviare, e rapidamente, alle nostre deficienze nel campo aeronautico, avremmo dovuto fronteggiare alternative molto spiacevoli nel Medio Oriente
(1) A. B. Cu NNINGHAM: « L'odissea di un marinaio l> , Garzanti ed., 1952, pagg. 205-207, 224 - 225.
« ... La superiorità aerea del nemico era tanto assoluta che gli attacchi continuavano senza interruzione. Il 15 m aggio il vìceammira glio comunicò che in tre giorni erano andati perduti 7 "Burricane" con la maggior parte dei piloti. Il risultato degli attacchi fu che almeno 27 "Hurricane", 4 "Beaufighter" e 2 "Glenn Martin" erano stati gravemente danneggiati al suolo e che r "Blenheim" aveva dovuto essere distrutto. L'ammiraglio Ford disse che la gravità delle perdite era in gran parte dovuta all'inferiorità qualitativa dei nostri aerei rispetto a qu elli del nemico e che, se Malta non avesse ricevuto immediatamente modernissi mi caccia e alcuni caccia notturni si sarebbe rapidamente trovata in gravi condizioni e non avrebbe potuto proteggere il porto, la navigazion e e gli abitanti ...
« Con il pensiero fisso a Creta e la nostra quasi totale mancanza di aerei da caccia basati a terra per la protezione della flotta, mi sentivo in grande ansia per il futuro ... >>
Questa valutazion e alquanto pessimistica contrasta indubbiam ente con una relazion e inviata al Capo di Gabinetto dell'Aeronautica poco dopo la partenza del X C.A.T. dalla Sicilia (r) . La relazione proviene da « fonte attendibile))' non precisata nella copia co n servata negli archivi di Su peraereo: essa tradisce evidentemente l'amarezza di un aviatore italiano di fronte alle possibilità consentite ai camerati tedeschi dalla maggiore efficienza della Luftwaffe, ma costituisce ugualmente un'attestazione della insufficienza dell'azione aerea ai fini di una permanente liquidazione delle difese di Malta:

<l Operazioni belliche:
<< I gruppi da bombardamento hanno effettuato num erose azioni su convogli, su navi da guerra, sul porto di La Valletta, sugli aeroporti di Malta e sulle basi lontane di Alessandria, di Suez e della Grecia.
« I risultati conseguiti dicono siano da considerare non rispondenti ai numerosi mezzi impiegati ... Sul porto di La Valletta gli stessi reparti hanno effettuato numerose azioni di bombardamento, lanciando un quantitativo di bombe notevole , ma il porto conserva tuttora quell'attività ridotta alla quale era stato costretto dalle azioni degli aerei della 2" Squadra. Anche i campi di aviazione, nonostante l'elevata quantità di esplosivo su di essi lanciata, sono oggi in piena attività e dotati di un numero di apparecchi da bombardamento e
(t ) Gcn. GIUSEPPE SA:-ITORO : 11 L'Aeronautica Ita liana nella sec onda Guerra Mondiale », cd . Esse, Milano, 1957, vol. II, pagg. 23-24.da caccia che si presume superiore al complesso esistente cinque mesi or sono. Il parere dei Tedeschi sulle possibilità difensive dell'isola è mutato ed è ben diverso da quello espresso all'inizio, al loro arrivo in Sicilia. Malta, secondo la maggior parte dei G ermanici, avrebbe dovuto capitolare in pochi giorni. I Tedeschi, dopo aver assaggiata la capacità difensiva ed offensiva di Malta, hanno modificato il loro parere.: molti di loro affermano che Malta è un obiettivo duro che può essere paragonato solo a Narwick n.
Profittando del respiro concesso dall'allontanamento del X C.A.T., l'Alto Comando britannico decideva in luglio di organizzare una vera azione di forza per far giungere all'isola un ponderoso rinforzo, così da porla in condizione di poter far fronte al paventato attacco simultaneo dal mare e dall'aria (Operazione « Substance »).
Si trattava di due battaglioni di fanteria, un reggimento di artiglieria contraerei pesante ed uno leggero, 30 cannoni da campagna con relativi serventi e un certo num ero di piloti della R.A.F. (r): con questo apporto la guarnigione di Malta veniva a raggitmgere una consistenza complessiva di 13 battaglioni e 104 pezzi di vario calibro, in postazione fissa o mobili. La difesa contraerea disponeva di I 12 cannoni pesanti e u8 leggeri . Anche l'aviazione da ricognizione e la caccia, diurna e notturna, erano state sostanzialmente potenziate.
Il convoglio era scortato dalla cc Forza H », residente a Gibilterra, rafforzata da potenti navi della cc Home Fleet » inviate per l'occasione, mentre otto sommergibili vigilavano i movimenti della flotta italiana, in prossimità della costa tirrenica. All'altezza del Canale di Sicilia le grandi navi e la portaerei che le accompagnavano dovevano invertire la rotta per rientrare a Gibilterra mentre il convoglio avrebbe proseguito su Malta, sotto la scorta di una cc Forza X » costituita da tre incrociatori e otto cacciatorpediniere. La protezione aerea ne sarebbe stata assunta dalle forze di Malta mentre h Flotta del Mediterraneo avrebbe svolto evoluzioni a scopo diversivo nel Bacino Orientale.
Il giorno 22 luglio la nostra ricognizione aerea avvistava la formazione nemica, senza peraltro rilevare il convoglio che la seguiva. Il mattino del 23 un nostro attacco di bombardieri e aerosiluranti, a sud della Sardegna, riusciva a danneggiare gravemente un incrociatore e affondare un cacciatorpediniere. Nuovi attacchi nel pome-
(r) Da: « The Mediterranean and Middle East >> , PLAYFAIR I.S.O. , London , 1956, ed. H.M.S.O., vol. IL

riggio pervenivano ancora a danneggiare un altro cacciatorpediniere e a colpire un trasporto. In definitiva la manovra avversaria riusciva a svolgersi secondo i piani e, a prezzo delle perdite accennate, il 24 luglio il convoglio poteva raggiungere il porto di La Valletta.
Il giorno successivo la Marina italiana tentava allora di lanciare un ultimo attacco al convoglio, nell'interno del porto stesso. Veniva organizzata per la notte sul 26 un'ardita incursione di « mezzi speciali >> che però, individuati tempestivamente dalla difesa locale, venivano distrutti prima ancora di poter effettuare la missione loro affidata, tranne che per il crollo di un ponte di raccordo, provocato da un'esplosione.
Con questo episodio si chiude la storia dei tentativi di neutralizzare Malta da parte dell'Asse, nel 1941: il problema delle nostre comunicazioni marittime con la sponda nord- africana, l ungi dall'essere risolto , si presentava sempre più minaccioso, in funzione del maggior coefficiente di priorità attribuito in quel momento dall'avversario alla lotta contro il rifornimento delle nostre armate d'Africa ed al conseguente aggravamento delle misure per il blocco del Mediterraneo.

Po ssi bili tà di az10ne aeronavale co n tro la flotta inglese nel M editerraneo.
La linea di rifornimento delle forze britanniche del Medio Oriente (di cui la « Forza del Deserto Occidentale>>, diventata poi 8"' Armata, era parte) seguiva praticamente la lunga rotta del periplo africano, esposta soltanto alle insidie dei sommergibili tedeschi.
Fino ai primi di maggio, nel 1941 nessu n convoglio britannico aveva più attraversato il Mediterraneo. Si è già visto come il 7 maggio venisse fatta una prima eccezione alla regola, con il convoglio « Tiger », per sollecitare l'invio di carri armati alle forze del gen. Wavell, nella gravissima crisi succeduta alla precipitosa ritirata dalla Cirenaica. Un secondo convoglio era stato organizzato in luglio, anche questo in condizioni giudicate critiche, per la salvezza di Malta: si tratta di quella complessa operazione « Substance » cui è stato accennato nelle pagine precedenti.
In occasione del passaggio del primo convoglio il contrasto della sola arma aerea era risultato meno efficace di quanto sperato e la Marin a ne era indotta ad elaborare un progetto di difesa aeronavale del Canale di Sicilia, integrato con la difesa passiva, già in corso
di organizzazione con la posa di vasti campi di mine fra Capo Bon e la Sicilia.
Alla fine del mese il Comando Supremo prendeva in esame la possibilità di un'azion e aeronavale a massa contro la Flotta Inglese del Mediterraneo. I Capi di Stato Maggiore della Marina e dell'Aeronautica venivano incaricati di compiere appositi studi le cui risultanze venivano poi inserite il r4 giugno in concrete « disposizioni preventive>>.
In occasione del passaggio del secondo convoglio, il 22 luglio, l'avvistamento da parte dei nostri ricognitori era avve nuto troppo tardi per un tempestivo intervento della squadra navale prima del passaggio del Canale di Sicilia e pertanto l'azione di contrasto era rimasta ancora una volta limitata all'intervento dell'aviazione.
In agosto, in relazione a notizie relative a un probabile convoglio sco rtato che da Gibilterra doveva muover e verso est, con contemporanea uscita della Fl otta del Mediterraneo da Alessandria verso ovest, Supermarina aveva disposto per la completa vigilanza con somme rgibili e mas del Canale di Sicilia, dove era pressoché ultimato lo sbarramento di chiusura. Aveva inoltre disposto esplorazione di sommergibili e intensificazione della ricognizione aerea ad ovest della Sardegna. Una formazione di forze navali di superficie (2 na vi da battaglia - Littorio e Vittorio Veneto - 4 incrociatori pesanti e 23 cacciatorpediniere) doveva riunirsi nel Tirreno Centrale, pronta ad intervenire, alle ore 22 del 23 agosto; una divisione navale (3 incrociatori leggeri e 5 cacciatorpediniere) doveva essere pronta a manovrare da Paler mo a partire dalle ore 7 del 24·
Superaereo, per parte propria, dichiarava di essere in grado di intervenire dalla Sardegna, dalla Sicilia, dall'Africa Settentrionale e dall'Egeo complessivamente co n 38 aerosiluranti, 76 bombardieri e 152 caccia.
La notizia risultava poi priva di fondamento.
Un terzo convoglio (ultimo del 1941 ) di 9 trasporti sotto potente scorta (comprendente le corazzate Nelson, Prin ce of Wales e Rodney, la portaerei Ark Royal, 5 incrociatori e 18 cacciatorpediniere) muoveva il 24 settembre da Gibilterra, diretto a Malta.
In seguito all'avvistamento della formazion e nemica, il 26 settembre veniva messo in funzione il previsto dispositivo di contrasto. La nostra formazione navale rimaneva ad incrociare nel Tirreno Meridionale, per trovarsi il mattino successivo in mi sura a levante di Capo Carbonara, di incontrare l'avversario. A gguati erano stati predisposti nel Canale di Sicilia con sommergibili, torpediniere e

mas . Le forze n avali venivano effettivamente assai prossime al contatto ma in definitiva questo non si verificava e ancora una volta il contrasto rimaneva affidato alla sola azione aerea. Aerosiluranti colpivano la nave ammiraglia Nelsotl che tuttavia riusciva a raggiungere la meta insieme al convoglio. Un piroscafo veniva affondato.
Prote z i o n e dei convog li.
Anche in questo campo tutti i possibil i espedienti venivano posti in atto, compatibilme n te con i mezzi disponibili, per aumentar e la sicurezza dei convogli.
In primo luogo tutte indistintamente le unità navali di tipo idoneo disponibili venivano impegnate per la scorta e per la protezion e costie r a della Libia. In maniera particolare si provvedeva ad au mentare al massimo la difesa aerea, attiva e passiva, dei convogli stessi. Nota i n proposito il comandante della difesa aerea di Malta (1):
c< La prima reazione dell'Asse alle gravi perdite subite d alle sue navi fu, nel giugno 1941, l'aumento delle scorte aeree e navali. La seconda venne nell'agosto, q uando ogni nave mercantile fu armata di n umerose m itragliatrici. In conseg uen za i danni su biti dai Blenheim crebbe ro in misura allarmante: in agosto e in settembre raggiunsero il 2o "{, In settembre non vi erano meno di sei caccia monoposti italiani in torno ad ogn i convoglio, co n una scorta a distanza d1 q u attro Jun kers 88 ».

Alla fi n e di settembre ve n iva disposto che, a partire da l mese di ottobre, entrasse in linea una squadriglia di R e 2000 a grande auton o mi a che, dislocata a T rapani con base avanzata a Pantelleria, assicurava la scorta ai convogli nel tratto centrale del percorso, per ci rca 35 migli a, rimasto si n o r a privo d i protezione aerea per la limit ata autono m ia d egli apparecc h i ad ibiti al servizio di scorta.
Personale e materi al e trasportati in Libia, vi a ma re, nel 1941.
Nei seguenti specchi sono riportati i dati relativi agl i uo mi n i e al m ateria le traspor t ati mensilmente via mare dall'Italia in Libia nel corso del 194 1. Vengono premesse le cifre complessive relative al 1940 (giugno- dicembre) , per dare evidenza alla
(1) Sir H uc H LLOYD: « Briefed to a ttac k: Malta's part in African Vi ctory ''• Hodd c r and Stonghton cd., London, 1949
(1) Non giunti nel mese d i giugno.
(2) Compresi i carburanti di cui al lo specc hio segue nt e .
(3) Pe rdute nel so lo me se di d icemb re 6.98.2 tonnellate.
(4) Di cui 6.o86 appartenen ti alle forze tedesche.


radicale trasformazione verificatasi nel frattempo nel campo della sicurezza delle comunicazioni marittime nel Mediterraneo (1).
Molto eloquente è il linguaggio delle cifre: da valori praticamente insignificanti nel 1940, nel primo semestre del 1941 il livello delle perdite sale al 4% circa per il personale, al 6% per il materiale e all'8 % per il carburante e si quadruplica poi, grosso modo, nel secondo semestre, rispettivamente al 16, 26 e 36%.

Andamento parallelo segue ovviamente la statistica dd naviglio perduto nella dispendio sa impresa di assicurar e i rifornimenti ai soldati dell'Africa Settentrionale:
Comisten z a al 1 0 giu g no 1940 . .
- detrazioni:
. naviglio catturato o riparato in porti stranieri all'atto dell'entrata in guerra . . . . naviglio affondato o alienato nel 1940 . . . . .
- rtmanenza . . . . . . .
- aumenti: nuove costruzioni, rientro da porti stranieri, acquisti, incorporazioni navi stram ere
Comistenza al I 0 gennaio 1941 . .
- detrazioni : naviglio affondato o alienato nel 1941 .
- rtmanenza .
- aumenti:
. nuove costruzioni, acquisti, ncupen . . . . . . navi rientrate da porti stramen
navi straniere incorporate
Consistenza al 31 dice mbre 1941 . . . .
Modesto l'apporto del naviglio tedesco presente nel Mediterraneo: 224.820 t.s.l. al I 0 genna1o 1941, I85.305 al 31 dicembre dello stesso anno.

In settembre il Comando Supremo aveva disposto che il trasporto del personale per il potenziamcnto delle unità fosse compiuto per via aerea, al ritmo di 1500 uomini al giorno. L'onere risultava eccessivo per l'Aeronautica e, dopo un primo periodo sperimentale, il contingente veniva ridotto a soo uomini al giorno. L'operazione aveva impegnato pesantemente per circa due mesi la quasi totalità dei mezzi e dei Servizi Aerei Speciali senza offrire, in definitiva, che un modesto contributo alla soluzione del problema di fondo.
Il 15 novembre, quando l'azione nemica contro i nostri convogli era più violenta, l'Alto Comando tedesco interveniva finalmente con l'offerta di inviare in Italia il Comando della 2 • Flotta Aerea, con sede a Roma, e un comando tattico a Taormina. Ne sarebbe di peso il II C.A.T., con sede a Taormina, su 2 stormi da bombardamento, 2 da caccia, I di « Stukas >> , 1 gruppo da caccia notturna, I gruppo da ricognizione, I gruppo da trasporto, I squadriglia di soccorso e I divisione di artiglieria contraerea. Si trattava nel complesso di 52 squadriglie di impiego, con circa 30.000 uomini.
Il Comandante della 2 • Flotta Aerea (Maresciallo Kesselring) con la qualifica di Comandante in Capo Sud (Oberbefehlshaber Siid) doveva avere giurisdizione di comando, oltre che sul C.A.T. in Sicilia, anche sul X C.A.T. in Grecia e sulle aliquote dello stesso X C.A.T. distaccate in Africa Settentrionale.
Si trattava indubbiamente di un ingente apporto di forze che l'OKW aveva deliberato, convinto finalmente della vitale importanza del Mediterraneo nel grande quadro strategico nel quale si trovava ormai impegnato a fondo. Il provvedimento aveva soltanto il fondamentale difetto di giungere troppo tardi, quando ormai l'avversario, per le sicure rotte di Suez, aveva già perfezionato il proprio programma di riarmo mentre i nostri piani di potenziamento, per le contese vie del Mediterraneo, avevano potuto avere soltanto parziale attuazione: il 18 novembre come già sappiamo, 1'8n Armata britannica prendeva l'iniziativa dell'attacco.
Nelle pagine che precedono si è cercato di riprodurre esattamente, attraverso la sintetica esposizione di dati e di fatti, la dimensione d ete rminante del fattore Malta per la ma teriale alimentazione dello sforzo militare italiano (e successivamente dell'Asse) nello Scacchiere Nord- Africano. E sorbita dai limiti della presente Monografia, esattamente collocata n el tempo fra le due grandi offensive britanniche, estendere indagini e considerazioni sul problema integrale della funzione di Malta nei riguardi dell'esito della campagna. Da quanto precede si presenta n aturale un quesito: perché non si tentò, almeno, l'eliminazione di questa rocca del predominio britannico, giustamente definita dall'amm. Cunnin gham « la chiave di volta della vittoria nel Mediterraneo» e tale costantemente considerata dalla direzione politico- militare britannica?
La materia è tanto vasta, complessa e interessante da meritare una m onografia a sé. No n si tratta di q uestione esclusivamente aeronavale ma è da considerare anzi di pertinenza squisitamente interforze , nella più ampia estensione del termine in quanto, oltre alla Marina e all'Aeronautica, anche l'Esercito vi risulta ugualmente interessato, sia come eventuale protagonista n ella material e operazion e di conquista, sia come « ute nte », nell'Africa Settentrionale, del vitale servizio dei rifornim enti, mortalmente compromesso dal potenzi al e offe n sivo dell'isola.
Ci si propone di contenere in qu esta sede la trattazione entro gli stessi limiti di tempo fissati per l'esposizione degli avvenimenti, al fine essenzialmente di m ettere in evide nz a l'evoluzione del pe nsiero dell'Alto Comando Italiano, perfettamente conscio ddla necessità di una soluzione radical e che tuttavia sfuggiva (forse dopo la perduta occasion e di « un colpo di mano>> da effettuare n ella primi ssima ora del conflitto) sempre più alle conc rete possibilità delle forze e dei m ezzi a sua disposizione, mentre la questione trovava scarsa riso nanza nell'ambiente dell'Alto Comando alleato.

Il valore di Malta era stato giustamente apprezzato dallo Stato Maggiore della Marina che fin dal dicembre 1938, nel quadro di un progetto di massima per il trasporto in Libia di uomini e mezzi in caso di guerra, affermava la necessità di «prevedere l'occupazione di Malta come indispensabile premessa a qualsiasi nostra operazione in grande stile in Africa Settentrionale ... Solo l'occupazione di detta base, che non deve essere considerata impossibile, risolverebbe totalmente il problema ... »

L'impostazione era dunque ineccepibile. Alla vigilia dell'entrata in guerra, nel maggio 1940, procedendo ad un concreto piano di sbarco nell'isola, la Marina confermava i grandi vantaggi connessi al possesso di Malta, ma si rendeva anche conto delle gravi difficoltà dell'impresa, dovute alla intrinseca capacità difensiva della base britannica ed alla mancanza del dominio del mare (in quel momento l'ipotesi di guerra considerava la presenza delle flotte francoinglesi coalizzate). In queste circostanze si giudicava che l'operazione poteva eventualmente essere tentata immediatamente all'inizio delle ostilità: si poteva infatti contare su di un « temporaneo » dominio del mare, finché nell'isola si trovavano soltanto poche forze leggere britanniche, come pure forze leggere francesi a Biserta mentre la Flotta inglese del Mediterraneo era ad Alessandria e quella francese ad Orano.
L'Esercito non disponeva di reparti specializzati per operazioni di sbarco; la 2 Squadra Aerea della Sicilia non disponeva di forze adeguate, né quantitativamente né qualitativamente, per un'impresa di tanto impegno. La stessa Marina non riteneva di poter basare le probabilità di riuscita del!' operazione sulla fragile ipotesi del << temporaneo dominio » del mare (I).
Sta di fatto che più ci si addentrava nella concretezza dei particolari esecutivi e più ci si rendeva conto della estrema difficoltà di venire a capo dell'impresa con i mezzi inadeguati a disposizione. Per giudicare d'altronde dello stato d'animo dei responsabili della condotta della guerra nel secondo semestre del 1940 bisogna non dimenticare che nella valutazione comune (oggi forse troppo fac ilm ente criticata con il facile « senno del poi »), dopo il crollo francese si attendeva a breve scadenza l'invasione e il conseguente cedimento dell'Inghilterra: perché allora impegnarsi in imprese rischiose, quando i frutti della vittoria stavano per cadere maturi nel grem-
(I) UFFICIO SToRico nELLA MARINA MILITARE - MARIAKO GABRIELE: « Operazione C3: Mal ta », Roma , 1965, pagg. 35, 44- 45·bo dei «vi ncitori »? Si aggiunga che nel 1940 l'azione di Malta su lle nostre comunicazioni con la sponda africana era quasi irrilevante. Né va dimenticato infine che in agosto Berlino stava perseguendo l'impostazione di un piano («Felix») per la conquista di Gibilterra, con la partecipazione della Spagna di Franco. Il possesso della Rocca di Gibilterra avrebbe scosso a fondo, ovviamente, la posizione britanni ca in tutto il Mediterran eo, senza bisogno di mettere le mani su Malta.
Ad una precisa domanda sulla difficoltà dell'operazione, il Capo di Stato Maggiore della Marina aveva specificato il 5 giugno: « La costa si presta poco ed è fortemente difesa ». Il piano d'azione del 18 giugno veniva accompagnato dalle seguenti considerazioni:
« Date le eccezionali difficoltà di impresa e le forze che dovrebbero esservi dedicate, essa sarebbe giustificata soltanto se Malta rappresentasse un obiettivo decisivo . Ma avendo da tempo l'Inghilterra rinunciato a servirsene come base principal e di operazioni, la minaccia che da Malta può essere esercitata contro le nostre co municazioni e contro le nostre basi navali è di secondaria importanza.
« E' sufficie nte che con bombardamenti aerei, con agguati di sommergi bi li e (quando occorra) con crociere notturne di siluranti, continui ad essere impossibile la permanenza a La Valletta di importanti forze navali, ad essere insidiato il movimento di quelle poche che ci sono, ad essere impedito il rifornimento dell'isola.
« Malta cad rà nelle nostre mani come conseguenza della vittoria finale, ottenuta concentrando tutte le energie negli scacchieri contenenti obiettivi risolutivi ».
Gli aerosiluranti di base a Malta venivano d'altronde giudicati scarsamente efficaci, in relazione al modesto raggio d'azione degli apparecchi allora in dotazione (intorno ai 130 chilometri).
Sta di fatto che per tutto il secondo se mestre del 1940 il problema d e ll'occupazione di Malta, pur restando virtualmente presente, non doveva però mai avviarsi a soluzione, sia per mancanza di truppe e mezzi idonei (paracadutisti, mezzi da sbarco) sia per lo stato d'approntamento della flotta (r).
(1) Nel giugno 1940 due sole navi da battaglia (Giulio Cesare c Cavour, rimod ernate) erano pienamente efficienti . Littorio e Vittorio Veneto stavano compiendo i primi tiri nelle acque di Taran to; Duilio c Doria non eran o ancora entrate in squadra; Roma e Impero non erano ancora neppure scese in mare.

Nel frattempo si faceva esperienza dell'inadeguatezza della nostra pressione aerea per la neutralizzazione della base nemica mentre il Comando Britannico si rendeva conto a sua volta di aver sottovalutato l'importanza attuale di Malta, in un primo tempo reputata detronizzata dalla sua posizione di dominio mediterraneo, esposta com'era al martellamento delle forze aeree della vicina Sicilia. Ai primi di settembre organizzava una prima operazione per il generale potenziamento delle forze terrestri, navali e aeree del Mediterraneo e in particolare per il rafforzamento della guarnigione, delle attrezzature e delle scorte dell'isola.
Le condizioni per il facile « colpo di mano '' che sarebbe forse stato possibile all'inizio delle ostilità erano già svanite: l' << operazione Malta'' si presentava ormai come un'impresa complessa, irta di difficoltà in continuo aumento.
Seguendo le alterne vicende della lotta al traffico marittimo nel Mediterraneo durante il corso del 1941 si è rilevato come il 5 maggio il gen. Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, riconosciuto il progressivo attenuarsi dell'efficacia della pressione aerea esercitata su Malta , preso atto del fallimento delle trattative per l'utili zzazione dei porti della Tunisia, affermasse la necessità di tentare l'occupazione di Malta, a meno di rinunciare a qualsiasi idea di ulteriore offensiva in Africa Settentrionale. E' in quel momento che si può considerare nascesse la seria determinazione di andare a fondo dell'assillante problema, nonostante le note difficoltà.
La Marina riprendeva il. progetto preparato un anno prima e, in collaborazione con le altre Forze Armate, si dedicava al suo aggiornamento, per tener conto delle riscontrate variazioni nelle difese dell'isola e nella situazione generale del Mediterraneo. Il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina, amm. Riccardi, faceva risaltare in un'annotazione del 9 maggio: (( ... l'esperienza di quasi un anno di guerra aveva purtroppo dimostrato che la maggior parte dei presupposti dai quali si era partiti fossero errati : in particolare la preventivata azione aerea demolente e il blocco dell'isola, da ottenere con mezzi insidiosi erano risultati, almeno fino a quel momento, velleitari >>.
In un promemoria di Supermarina (n. 103 segreto) del 18 maggio 1941, su richiesta del Comando Supremo, si affermava: « Undici m esi di esperienza bellica hanno dimostrato l'eccessivo otti mi smo di queste conclusioni (del precedente piano del giugno 1940) non tanto nei riguardi dell'entità delle forze che l'Inghilterra è riuscita

saltuariamente a mantenere, quanto nei riguardi della minaccia da tali forze esercitata contro le nostre comunicazioni con la Libia e della capacità di Malta a funzionare da punto di appoggio per il trasferimento di forze aeree, di forze navali e di piroscafi dall'uno all'altro bacino del Mediterraneo »
Il do cumento constatava come il potenziamento delle difese di Malta av esse fatto sì che gli attacchi aerei dell'Asse avessero ottenuto «effetti distruttivi che sembra lecito giudicare decrescenti >>
L'isolamento di Malta con i mezzi insidiosi della Marina si era rivelato illusorio per lo scarso rendimento dei sommergibili e delle mine, mentre mas e siluranti potevano godere raramente di condizioni meteorologiche favorevoli all'impiego . Dato che il traffico con l'Africa Settentrionale assorbiva completamente il naviglio silurante, le comunicazioni marittime di Malta si potevano attaccare solo «i n misura ridotta con sommergibili >> . « L a sola probabilità che a Malta ci sia anche una sola squadriglia di velivoli atti a portare siluri o mine magnetiche » data la crescente pericolosità di questi ordigni, imponeva permanentemente l'effettuazione di scorte aeree e navali. La presenza a Malta di reparti navali di superficie costringeva inoltre la Marina a impiegare incrociatori in servizio di scorta e per sopperire alle esigenze di questo servizio i reparti leggeri della flotta si trovavano disseminati nei porti della Sicilia, senza possibilità di procedere a un addestramento continuo, mentre le corazzate rimanevano prive di caccia di scorta.
Ciò premesso, si concludeva: « ... La presa di Malta rappresenterebbe un miglioramento decisivo della situazione e le perdite che essa ci costerebbe in un giorno ci salverebbero da quelle ulteriori cui andremmo incon tro nei trasporti per la Libia e che, in base alla dura esperienza fatta, potrebbero a lungo andare diven tare preoccupanti, per l'impossibilità di rapida sostituzione del naviglio perduto. Nessuno più della Marina è perciò interessato all'i m presa di ritogliere Malta agli Inglesi >> .
Le difficoltà già rilevate nel precedente studio del giugno 1940 erano frattanto aumentate e ora si stimava necessario preventivare una forza di 35- 4o.ooo uomini, da sbarcare rapidamente, Ìh assenza di un permanente dominio del mare. La forza d'attacco era commisurata all'entità dei difensori che venivano valutati a rs.ooo UOinllll.
Per un'operazione del genere si consigliava l'impiego di apposite zattere, o pontoni blindati da 8 tonnellate, capaci di 40 uomini, oltre l'equipaggio, m unite di motori silenziosi co n autonomia di 25

miglia alla velocità di 7 nodi: si trattava in sostanza di una prima concezione (a scala ridotta), di quelli che saranno poi i famosi << mezzi da sbarco », protagonisti dell' « Invasione » alleata dell'Europa. Le zattere, munite di un ponte di sbarco a prua e armate con una mitragliera, dovevano portare a terra la prima ondata d'attacco, composta di 4000 uomini, mentre i l grosso sarebbe stato trasportato da una flotta di piccole unità di ogni tipo adatto allo scopo. Occorrevano per questo da r6o a r8o battelli, capaci in media di 200 uomini, e attrezzati con pontili da sbarco. Si suggeriva di chiedere alla Germania la cessione di mezzi blindati da sbarco che avrebbero potuto essere « prelevati da quelli preparati per l'invasione dell'Inghilterra e costruendone rapidamente in serie nel numero a noi necessario ».
Così presentata (e non si potrebbe contestare la fondatezza d elle considerazioni di base e la rispondenza dei provvedimenti proposti) l'operazione si presentava estremamente difficile e complessa e richiedeva un lungo periodo di preparazione, giudicato non inferior e ai sei mesi. A parte la sorte della forza d'attacco vera e propria, l'esecuzione del piano impegnava a fondo ed esponeva a grave rischio l'Aviazione e l'intera Marina. La sorpresa tattica, alla quale era affidata la realizzazione di un periodo di temporaneo dominio locale, non poteva inoltre prevedibilmente giocare oltre il primo giorno dell'operazione, essendo estremamente improbabile che sfuggisse alla ricognizione aerea avversaria la concentrazione dei mezzi necessari nei porti meridionali della Sicilia.
D i fronte a queste difficoltà, il promemoria poneva il quesito se convenisse « affrontare l'arduo problema, tenendo specialmente conto del tempo richiesto per avere buona probabi lità di risolverlo a n ostro favore ».
Il 25 maggio Supermarina indirizzava al Comando Supremo altro promemoria, per riprendere e sviluppare alcuni punti, accentu ando l'atteggiamento negativo del precedente. Passando dal teorico al concreto, dopo aver ricordato che la d ifesa di Malta non era stata smantellata e neppure sostanzialmente indebolita dall'offensiva aerea tedesca, poneva io evidenza la mancanza delle motozattere e dei relativi motori silenziosi per il trasporto del primo scaglione. Per il resto, utilizzando 30 motovelieri predisposti e non adoperati per azioni di sbarco sulle isole Jonie ed altri adibiti alla sorveglianza foranea dei porti, giungeva alla constatazione che ne mancava sempre l a metà, del fabbisogno calcolato. Concludeva confermando che non prima della fine dell'anno si sarebbe potuto dare il via all'operazione,

a patto naturalmente che si ponesse mano senza ritardo alle relative predisposizioni (I).
Veniva poi la parentesi del miraggio di un accordo con la Francia, tramite la Germania, per l'utilizzazione dei porti tunisini: il problema di Malta sembrava, ovviamente, aver perduto molta della sua importanza e venivano pertanto accantonati i progetti cui si è appena accennato, apparsi d'altronde sotto un aspetto tanto arduo da risultare praticamente irrealizzabili, con i mezzi a disposizione dell'Italia. Breve parentesi: il 5 agosto il gen . Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale, dichiarava che le trattative per l'utilizzazione della rotta di Biserta erano arenate.
La per<iita di Creta aveva i n izial m ente determinato se ri e preoccupazioni nel Comando della Flotta del Mediterraneo, proprio nei riguardi dei rifornimenti alla base di Malta. Per sua fortuna, Hitler non intendeva sviluppare il successo in qu ella direzione ed anzi il conseguente trasferimento del X C.A.T. dalla Sicilia alla Grecia veniva ad alleggerire sensibilmente non solo la pressione diretta sull'isola, m a anche l'accessibilità di Malta per le vie del Bacino Occidentale: si è visto come il Comando Britannico abbia saputo trarre vantaggio da questa opportunità per forzare il passaggio di un importante convoglio di rinforzi e rifo rnimenti provenienti da Gibilterra. Il problema di Malta aveva ormai assunto nuove, maggiori dimensioni e la sua soluzione andava impostata su nuove basi.
Il 14 ottobre il gen. Cavallero incaricava il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Roatta, dell'aggiornamento degli st udi per l'occupazione di M al ta (allegato tl. 32), mentre annotava nel suo D iario: « Data l'impossibilità di valersi di Biserta, tale azione diviene inevitabile». Ad esasperare la drammaticità della situazio ne, nel momento stesso in cui stava per scatenarsi la nuov a offensiva britannica, la Marin a, esaurite le scorte di nafta, era completamente condizionata nella propria mobilità, comprese le scorte ai co nvo gli, dalle assegnazioni di co mbu stibile che la Germania si era riservata e che effettuava co n estrema parsimonia: « In novembre manca la nafta per le unità di scor ta; l'imbarco dei materiali è paralizzato e di sorga nizzato dai bombardamenti dei porti libici, di quelli d ella Sicilia, di Napoli e di Brindi si. Talvolta occorre far partire i trasporti da un porto e la scorta da un altro, se nza possibilità di intese preliminari».
(I) Da: ((Operazione c3 - Malta », UFFICIO STORICO DELLA MARINA MILITARE - MARIANO GABRIELE, Roma, 1965, pag. 100.

L'n novembre il Comandante Superiore A.S. lamentava che i rifornimenti dalla madrepatria erano ridotti « a possibilità puramente casuali», espressione che corrisponde efficacemente alla dura realtà delle cifre per il mese di ottobre.:
Trasporti programmati
5 convogli:
Porto di Tripoli
14 piroscafi per italiani
12 piroscafi per tedeschi
3 navi cisterna
Trasporti giunti
I convoglio:
3 piroscafi per italiani
- piroscafi per tedeschi
- navi cisterna
I nave frigorifero
l3 convogli:
d B . 17 ptroscafi per ttaharu
t engast . fi d h'
4 ptrosca per te esc t
P ls convogli : orto . . . .
5 piroscafi per italiani
r piroscafo per tedeschi
L a conclusione di tutto quanto è stato qui esposto può venire sintetizzata nei seguenti punti fondamentali:
1. - Malta ha assunto gradualmente la funzione di vera e propria valvola regolatricc del traffico tra la penisola italiana e la Libia. Gli effetti se ne sono resi sensibili a partire dal 1941.
2. - L'insuccesso delle nostre armi nella prima parte della campagna non è quindi da attribuire a Malta (o alla nostra mancata occupazione de li 'isola) ma a deficien ze organiche della nostra preparazione e della condotta della guerra in Africa.
3· - Una volta identificato il valore concre to della minaccia aeronavale di Malta si è ritenuto di poterla paralizzare con la sola pressione aerea, assunta prevalentemente dall'arma aerea tedesca, risultando insufficiente l'aviazione italiana.
4· - P er l'inadeguatezza della sola pressione aerea e in conseguenza della decisione dell'OKW di trasferire in Grecia il X Corpo Aereo precedentemente inviato in Sicilia, verso la metà del 1941 la crisi dei rifornim enti per l'Afr ica Settentrionale si è manifestata in tutta la sua gravità.
5· - Si era sperato in primo tempo di poter aggirare la difficoltà aprendo, con il co nsenso della Francia, una nuova linea di comunicazione, più breve e più sicura, ai porti della Tunisia.
6. - Svanita questa possibilità è stata finalmente presa in seria considerazione la soluzione dell'occupazione dell'isola, con un'ope-

razione di forza. L'esame approfondito del problema ha rivelato come l'impresa fosse da ritenere praticamente inattuabile con i soli mezzi italiani.
7· - Al termine del periodo qui considerato, mentre sta per scatenarsi la nuova grande offensiva dell'Ba Armata britannica, il problema di Malta incombe drammaticamente sulla sopravvivenza delle forze dell'Asse in Africa Settentrionale. Si avviano nuovi studi per individuare una soluzione radicale: sappiamo già che l'attuazione non potrà essere a breve termine né potrà realizzarsi senza un sostanziale concorso, almeno di mezzi, d eli' alleato tedesco alla cui decisione, in definitiva, rimarrà condizionata la concreta esecuzione dei piani.

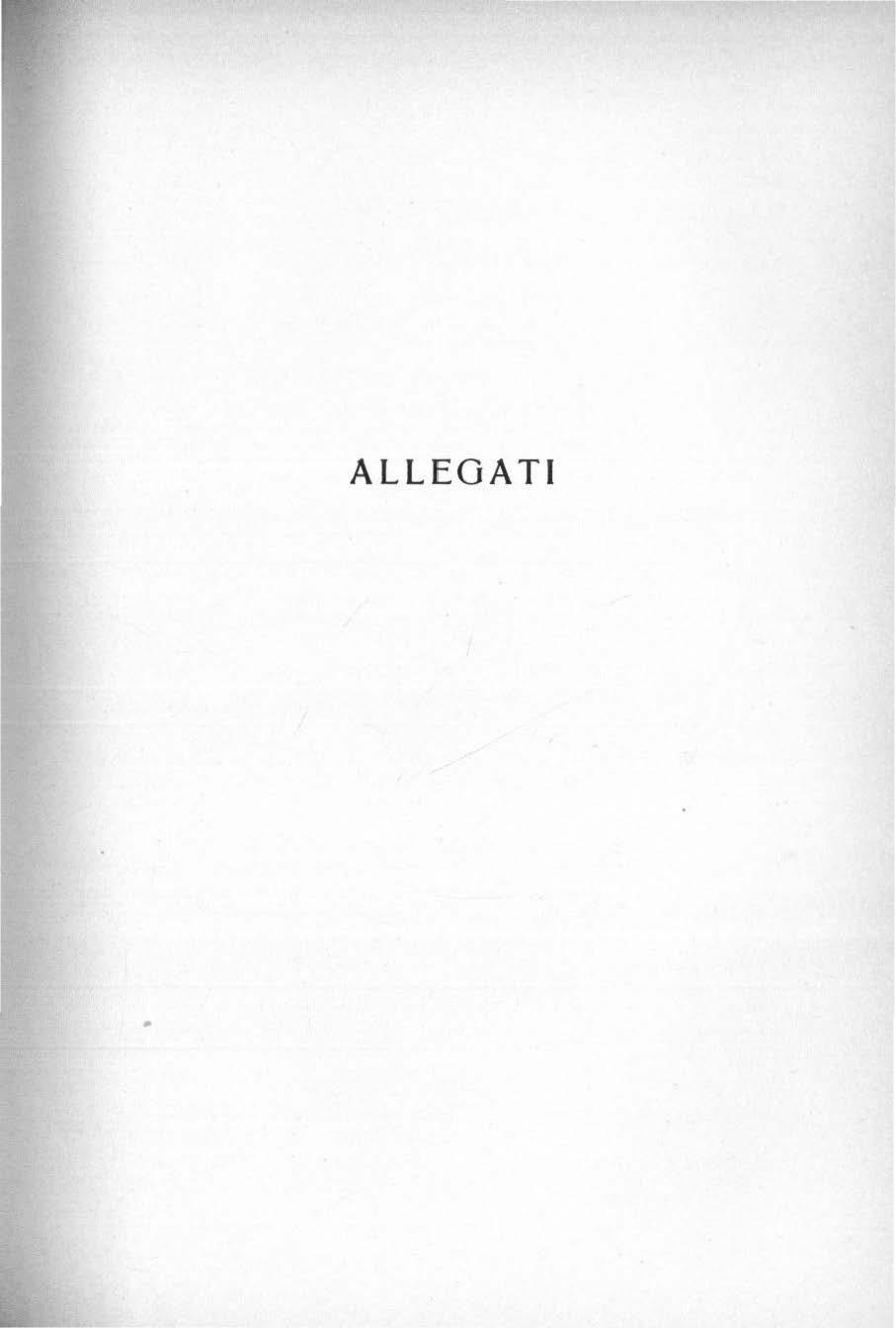

Mi riferisco al vostro 01 f 1376 Op. del 1° corrente e Vi preciso le m1e direttive di massima.
1" - La difesa della Tripolitania dovrà essere effettuata, non già attorno a Tripoli, ma avanti il più possibile, sia per tenere gli inglesi lontano dal porto ove devono sbarcare i rinforzi a Voi necessari, sia per proteggere più efficacemente le basi aeree.
Darete quindi battaglia su posizioni da Voi scel te, sufficientemente lontane da Tripoli e ta!i da costringere gli ingEesi a combattere con il deserto alle spalle.
2° - Lasciate poche truppe (essenzialmente G.a.F ed elementi poco mobili) nella piazza di Tripoli ed i n copertura alla frontiera occidentale, impiegherete le unità di fanter i a, meno mobi l i, per la difesa in posto, su dette posizioni da Voi prcscelte a sbarramento della litoranea e delle sue adiacenze.
3° - Le unità m otomeccanizzate ita l iane e tedesche dovranno essere impiegate - sin che possibi1e per intere divisioni e sempre offensivamente - in primo tempo nelle difese ritardatrici della Sirte, profittando di ogni occasione favorevole per passare alla offensiva a fondo in modo da infliggere agli inglesi quante più possibi1i perdite; in secondo tempo quale riserva di manovra della posizione da Voi scelta, per agire sul fianco e sul tergo del nemico.
4° - Tenete presente nella Sirte l'importanza delle oasi di Zella Socna, per l'azione che attraverso esse gli ing lesi potrebbero svi l uppare sul fianco c sul tergo del nostro schieramento.
5° - Non considero un'azione d i forze proveniente dalla Tunisia o da s ud perché, nonostante la situazione interna francese, ritengo improrogab i le che i degaullisti possano rivolgere grosse offese contro di Voi, e ciò specie in considerazione della pressione che Germania c Itali a sono in grado di esercitare sul suolo francese .
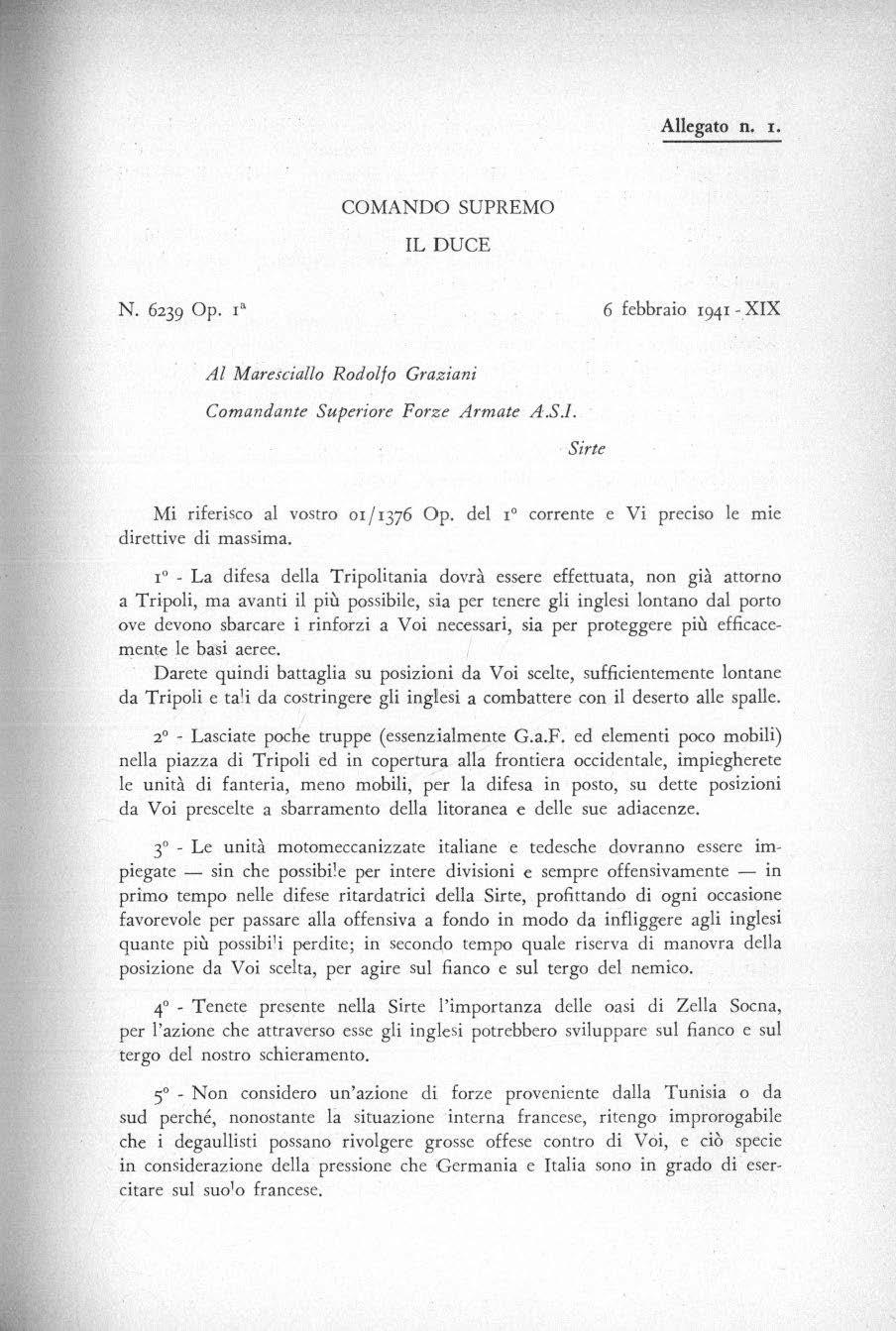 N. 6239 Op. I'
Al Maresciallo Rodolfo Gt·aziani
N. 6239 Op. I'
Al Maresciallo Rodolfo Gt·aziani
Qualora; poi, grosse offese degaulliste dovessero verificarsi e, solo in tale caso, potrete distrarre una parte delle forze meccanizzate (sempre a unirà intere) per dare reattività alle difese che predisporrete in vista di possibili piccole infiltrazioni da sud e da ovest, su Tripoli.
6° - Vi prospetto, infine, la possibilità che gli inglesi tentino sbarchi; è necessario perciò curare la sorveglianza e la difesa costiera e disporre sbarramenti di mine specie nel tratto Misurata- Homs.
7• - Le più importanti basi della Cirenaica dovranno essere battute dalla aviazione quanto più intensamente e continuamente sarà possibile. Ciò recherà un contributo efficacissimo al rallentamento dell'avanzata degli inglesi, i quali, per poter proseguire nell'offensiva verso ovest, si trovano nella imprescindibi!e necessità di utilizzare le basi di Bengasi e Derna.
go - Sono in attesa di conoscere gli ordini che impartirete per la difesa della Tripolirania sulla base delle presenti direttive.
Telegramma
N. 189172
N. 190172 Prov. da Roma
N. 19II72
M.P.A. - MM.PP.AA.
Supet-comando A.S.
Posta Militare
Arrivato 11.2.1941 - ore 18,20
Partito 1r.2.194'f- - ore 15
6330 / 0p. - II febbraio ore 13 (.) Rispondo al telegramma n. rs8o in data 9 febbraio (.) Mi rendo pienamente conto vostre difficoltà (.) Rinforzo aeronautica est in corso et ho disposto per ulteriori rinforzi (.) Ma osservo che (,) poiché possibilità d ifesa Tripolitania est subordinata affluenza previsti rin forzi

aerei (,) corazzati et motorizzati (,) dovete fare ogni sforzo per guadagnare tempo occorrente loro trasporto et spazio per schieramento reparti aerei (.) Confermo quindi mie direttive in data 6 corrente (.) Azioni ritardatrici nella sirtica dovranno possibilmente essere effettuate anche at oriente di Sirte ( ) Divisioni 53 Armata inutile rimangano attorno Tripoli (.) Insisto necessità schierare grosso delle forze disponibili il più avanti possibile (,) almeno oltre Misurata (.) Segnate ricevuta (.) MussoLINI .

Prot. 634r/Op. - Ore 21 dell'rr febbraio (.) Con riferim ento a quanto rappresentato con vostro dispaccio n. ol f 158ojOp. r.
Superaereo ba esaminato con ufficiale 5" Squadra et con ufficial e corpo tedesco possibilità intervento aviazione (.) Aeronautica riprenderà sua completa efficienza al più tardi fra dieci giorni con un complesso di circa 350 apparecchi italiani e tedeschi (.) Per intervento nella Sirtica est necessario disporre per appoggio reparti aerei almeno dei campi di Tauorga (,) Misurata (,) Tamet et Bir Dufan (.) Intervento potrà avere notevole efficacia specialmente dato impiego apparecchi tedeschi muniti di cannoncini con munizionamento speciale anticarro (.) Est però indispensabile che codesto Supercomando assicuri un minimo di protezione a terra e che nemico venga arrestato ad oriente di Sirte al meno fino alla fine del mese (.) Inoltre est necessario che codesto Supercomando agevoli tutti i trasporti marittimi occorrenti per sollecita sistemazione et per impiego reparti italiani et tedeschi et per sgombro personale superfluo et che lasci completa libertà di manovra dei trasporti aerei (.) GuzzoNr m
m Nota dell'Ufficio Storico. - Il telegramma del Maresciallo Graziani n. oxfxsSo del 9 febbraio rispondeva alle direttive del Comando Supremo in data 6 mettendo in evidenza difficoltà di mezzi e di terreno.
Allegato n. 3·S T ATO MAGG I ORE
Teleavio in partenza
Ministero G uerra - Gabinetto Roma
A)
20 febbraio 194 I - XIX
or/1917 (.) 20 febbraio ore 12 (.) At TII404 /7 8 / 2/2 (.)
FoRMAZIONE GRANDI U N ITÀ ( : )
1° - Comando Superiore Forze Armate A.S
Generale des ignato d'armata Gariboldi Italo - comandante Coma ndo su periore CC RR.
Comando superiore artigli er i a Comando super iore genio
I ntendenza A.S.
Autoraggruppamen ro del Comando Superiore
2° - X Corpo d'Armata
Generale di C.d'A. Barbieri A lber to - comandante
Divisione di fanteria «Bologna» (25a)
genera le di d i v. Maggiani P ietro - comandante
Divisione d i fan teria « P av i a>> (r7'')
generale di brigata Zaglio Pietro - com andante

Divisione corazzata « Ariete >>
genera le di d iv. Baldassarre Ettore - comandante
3° - Campo trincerato di T ripoli
Generale di d iv i.g s Spatocco Car lo - comandante
Divisione di fanteria « Brescia>> (27")
ge nera le di div C remascoli Giuseppe - comandante !l>
Divisione di fanteria « Savona>> (55a) ! 2 >
generale di div Margh inotti Mar io - comandante
(l) Rimpatriato per malattia (Nota dell'Ufficio Stori··o: verrà sos tituito dal gcn. Zamhon).
<21 In corso di ri costituz io ne.
Distaccamento divisione fanteria « Sabratha »
generale di div. Della Bona Guido . comandante
Guardia alla Frontiera
colonnello Parri Dino . comandante
Piazzaforte di Tripoli
generale di div. Quarra Edoardo - comandante
Truppe Libiche
4° . Comando Sahara Libico
Tenente colonnello A.A. L eo Michel e . comandante
5° • Presidio Giarabub
Tenente colonnello Castagna Salva tore . comandante
B) UNITÀ DISCIOLTE (:)
Comando 5a Armata
Comando Territori Sud Cirenaico
Comando Territori Sud Tripolitano
C) UNITÀ DA CONSIDERARSI DISCIOLTE (:)
Comando roa. Armata
Comando XX Corpo d'Armata
Comando XXI Corpo d'Armata
Comando XXII Corpo d'Armata
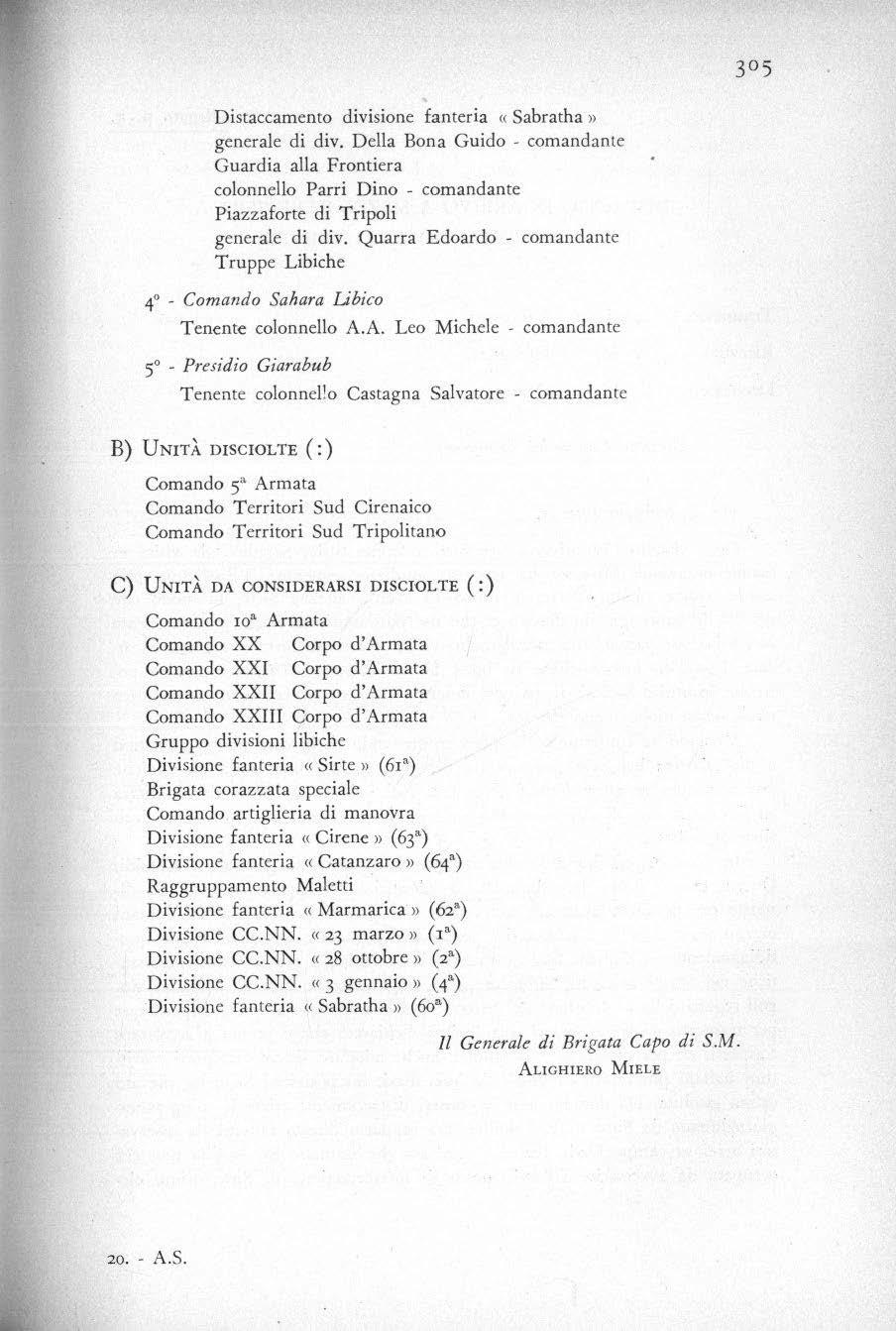
Comando XXIII Corpo d'Armata
Gruppo divisioni libiche
Divisione fanteria «$irte>> (6ra)
Brigata corazzata speciale
Comando artiglieria di manovra
Divisione fanteria (( Cirene >> (63")
Divisione fanteria «Catanzaro» (64')
Raggruppamento Maletti
Divisione fanteria (( Marmarica » (6z")
Divisione CC. NN. « 23 marzo » (1•)
Divisione CC.NN. << 28 ottobre " (2a)
Divisione CC. NN. « 3 gennaio" (4")
Divisione fanteria 1< Sabratha » (6o")
Il Generale di Brigata Capo di S.M.
ALIGH!EJ\0 MIELE
Trasmesso il 14 / 2/1941 - Ore 01,50
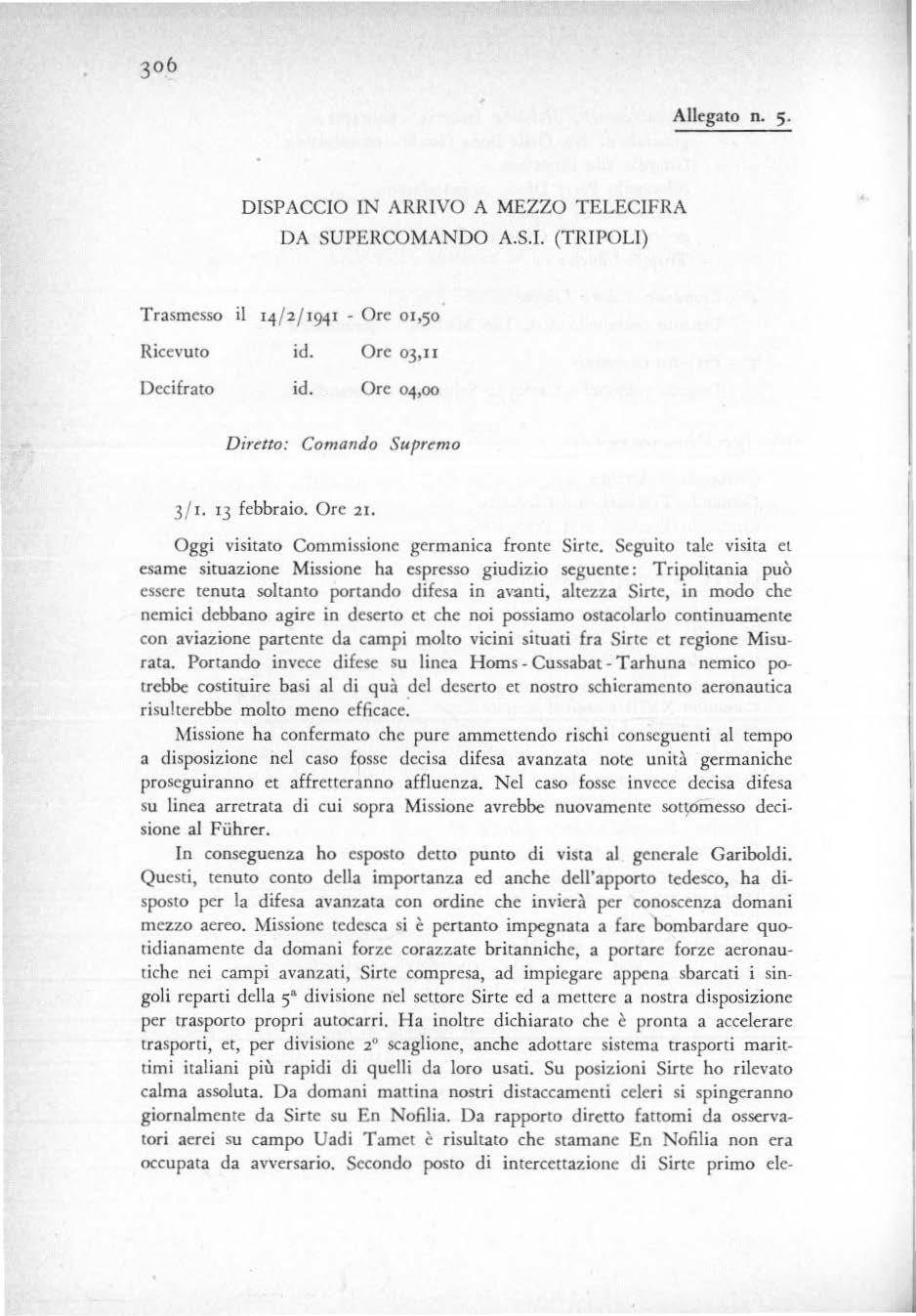
Ricevuto id.
Decifrato id.
Diretto: Comando Supremo
3/ I. 13 febbraio. Ore 21.
Oggi visitato Commissione germanica fronte Sirte. Seguito tale vtslta et esame situazione Missione ha espresso giudizio seguente: Tripolitania può essere tenuta soltanto portando difesa in avanti, altezza Sirte, in modo che nemici debbano agire in deserto et ch e noi possiamo ostacolarlo contin uamente con aviazione partente da campi molto vicini situati fra Sirte et regione Mi surata. Portando invece difese su linea Homs- Cussabat- Tarhuna nemico porrebbe costituire bas i al di quà del deserto et nostro schieramento aeronautica risulterebbe molto meno efficace.
Missione ha confermato ch e pure ammettendo rischi conseguenti al tempo a disposizione nel caso fosse decisa difesa avanzata note unità germaniche proseguiranno et affretteran no affluenza. Nel caso fosse inv ece decisa difesa su linea arretrata di cu i sopra Missione avrebbe nuovamente SOt\-l)messo decisio ne al Fiihrer.
In conseguenza ho esposto detto punto di vista al generale Gariboldi. Questi, tenuto conto della importanza ed anche dell'apporto tedesco, ha disposto per la difesa avanzata con ordine che invied per conoscenza domani mezzo aereo. Mis sione tedesca si è pertanto impegnata a fare bombardare quotidianamente da domani forze corazzate britanniche, a portare forze aeronautiche nei campi avanzati, Sirte compresa, ad impiegare appena sbarcati i singoli reparti della 5 divi sione nel settore Sirte ed a metter e a no st ra disposiz ione per trasporto propri autocarri. Ha ino ltre dichiarato che è pronta a accelerare trasporti, et, per divisione 2 ° scaglio ne, anche adot tare sistema trasporti marittimi italiani più rapidi di quelli da loro usati. Su posizioni Siete ho rilevato calma assoluta. Da domani manina nostri distaccamenti cele ri s i spingeranno giornalmente da Sirte su En Nofilia. Da rapporto diretto fattomi da osservatori aerei su campo Uadi Tamet è risultato che stamane En Nofilia non era occupata da avversario. Secondo posto di intercettazione di Sirte primo ele-
menro avversario è uno squadrone Il0 Ussari at casa Ristoro ad ovest el Agh eila. Prego interessare Stato Maggiore R.E. accelerare in accordo con rappresentant i Divisione, dandole eventualmente precedenza su nostri trasporti. RoATIA



SIT UAZIONE VIVERI, DERRATE, CARBURANTI E LU BRIFICANTI PER LE ES IGENZE MI LIT ARI IN LIB IA
ALLA DAT A DEL 20 FEBBRAIO 194 l
Grafico compi lato dal Ministero de ll 'Afri ca Italiana nel mese di marzo 1941, sulla base dell'ultima segnalazione relativa alle forze terrestri ita li ane pervenuta dal Com ando S u periore Forze Ar m ate A.S.
Quantità Periodo d i s u f f i c i.e o z a Ge n eri Quinta li fcbb. marzo aprile maggio g iugno
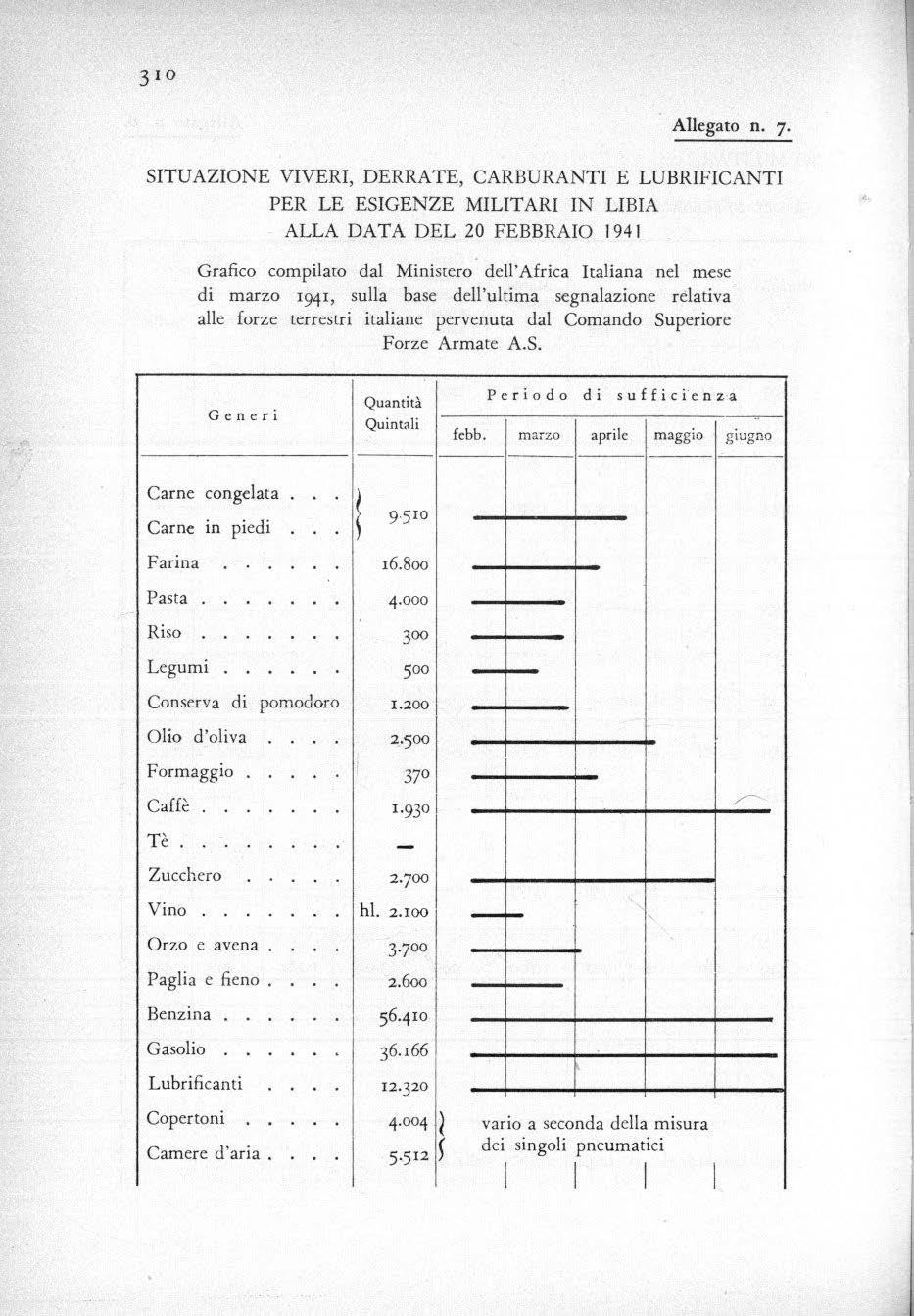
Note: Il periodo di suffic ienza è calcolato in base alla forza di:
Truppa:
Nazional i (compresi Uff. e Sott.) .
Libi ci . . . . . .
Quadrupedi:
Cava lli e muli
Cammelli
T otale
n. 113-158 )) 15.81]
n. 128.975
n. 4·658 )) 2.8o6
T otale
Automezzi:
a benzina n. 3.001 (di cui 6 13 inefficienti)

a gasolio >> 2.2li9 (di cui 6-Jx inefficient i)
Totale n. 5.270
Motomezzi: n . 1.714 (di cui 424 inefficienti)
n. ]-464
N.B. - P e riodicamente, su richi esta dell' In tendenza A.S., il Ministero della Guer ra provvedeva a reintegrare i quantitati vi d i derrate c carb uranti consumati nel mese precedente .
Come forza di rifornimento alle unità tedesche dovevano servire di base i dati seguenti :
- s· div. leggera : uomin i 16.500 - macchine 3·500;
- 15a div. corazzata : uomini r6.500 - macchine 4·500·
Allegato n. 8.
COSTI T UZ IONE ORGAN ICA
DELLA DIVISIONE CORAZZ AT A INGLESE
Brigata carri leggui:
1° Ussari (3 squadro ni e I sq uadrone comando) - s8 ca rri leggeri
5 car ri esp lorator i 41 m otoc iclette
2° Ussari (3 squadroni c I squadrone comando) - 58 carri leggeri
5 carri esploratori
41 motociclette
3° Ussari (3 sq uadioni autoblindate e I diO ne comando)
Brigata carri armati:
- 74 autoblindate
41 motociclette
I btg. carri armati (3 cp. carri e 1 cp. comando) - 50 carri medi
7 carri esploratori
II btg. carri armati (3 cp. carri e 1 cp. comando) - I6 carri medi
16 carri sostegno
7 carri esploratori
22 carri leggeri
Brigata autoportata:
I btg. K.R.R.C. (su 4 cp. fuc. e t cp. comando)
- 20 carri esploratori
16 fucili anti car ro
50 fucili mitragl.
Il btg. K.R. (su 4 cp. fucilieri e 1 cp. comando)
- 20 carri esploratori
16 fucili anti carro
50 fucili mitragl.
Artiglieria:
I 0 rg t. R.N.A. (su 4 btr.) .
2 ° rgt. art. legg. (s u 4 btr.)
Numero impredsato di btr. anticarro.
Elementi del genio e servizi (Sanità, munizioni, rifornimenti).
ToTALE
Ufficiali 410 - Truppa 9·400 (?)
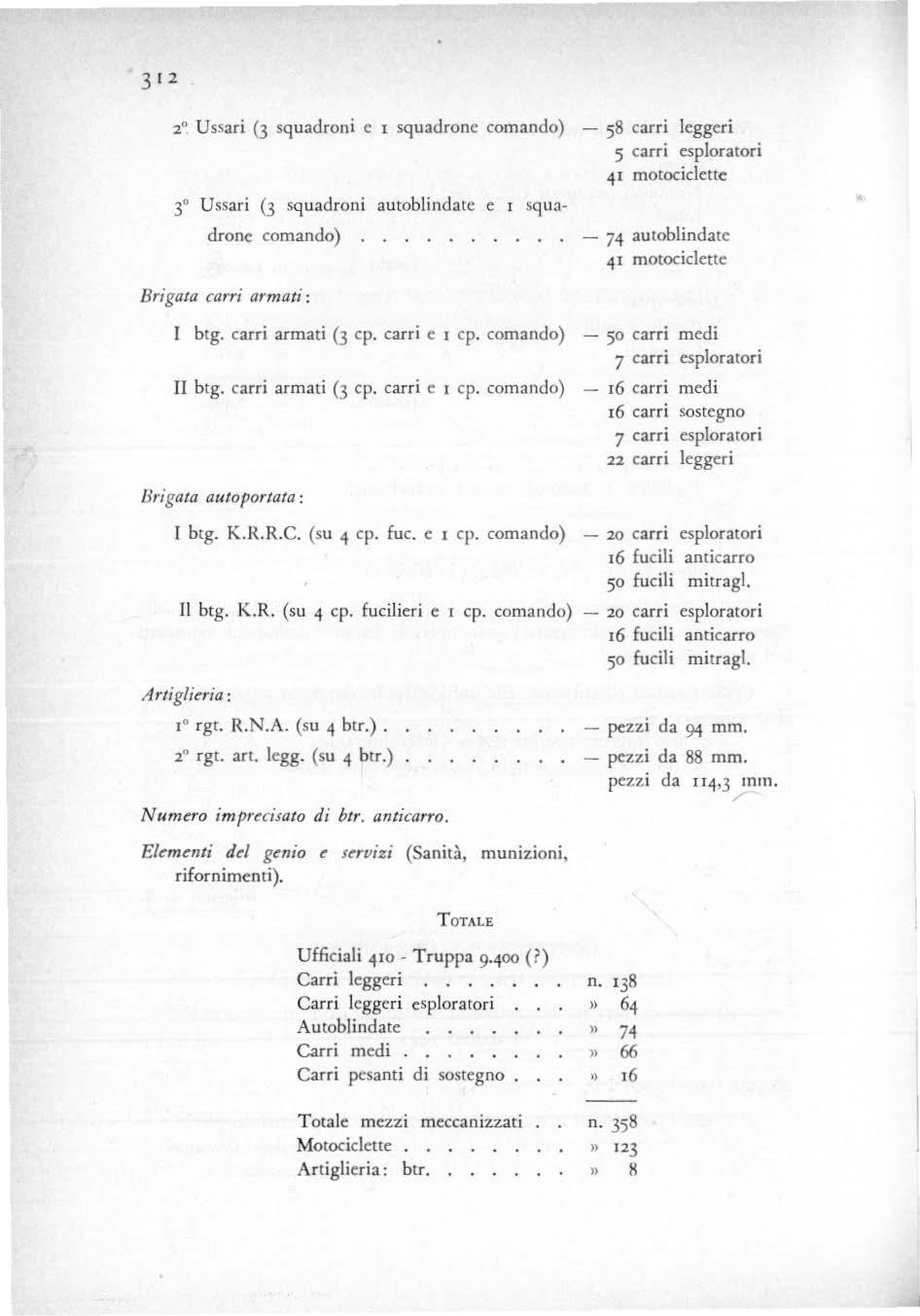
Carri leggeri
Carri leggeri esploratori
Autoblindate
Carri medi ..
Carri pesanti di sostegno
Totale mezzi meccanizzati
Mot ociclette
Artiglieria: btr.
- pezzi da 94 mm.
- pezzi da 88 mm. pezzi da u4,3 mm.
n . 138 )) 64 )) 74 )) 66 >) 16
358
UFFICIO OPERAZIONI
N. 106 l 3 - 4r
Segretissimo: 2 copie 1 2" copia
Al Comando Superiore A.S.
Qui all egato viene trasmesso per conosce nza una relazio ne del C.T.A. al Comando Supremo dell'Esercito, circa una valuta zio ne delle possibilità di una operazione di attacco nel Nord Africa.
4 allegati
per Il Corpo Tedesco in Aj1·ica
Il Capo di Stato Maggiore
V'lN DEN B oRNE
UFFICIO OPERAZIONI
Segretissima: 7 copie l 1" copia
Oggetto: Sbloccame nto di G iar abub e rico nquista di Cufra.
In preparazione de lla f u tura condotta delle operazioni, specialmen te per la sicurezza dell'ala des t ra, è attualmente esam inata la questione dell'occupazione di G ialo, con consegue nte sblocco di Giarabub, e riconqui sta di Cufra. Il C.T.A. è d 'avviso che per questo scopo come truppe d 'attacco bastano proporz ionate forze poco nu111erose, composte di reparti mi st i mobi li, di grande efficienza bell ica, i quali eventualmente potranno essere dati dai r ep arti ted eschi.
L'esecuzione di questo progetto viene in questione per i l me se di aprile.
Ol l doc ufll en ti qui ripo rtat i sono la traduzione del testo ori g ina le te desco curata dallo stesso Comando del C.T.A. e da questo inv ia to pe r co nosce nza al Comando Superiore lta· liano i n A.S. Sono sta ti pertanto riprodotti integralme n te ndl a loro forma linguis ti camen te alquanto app ross im ativa .

Premessa per una prosecuzione dello studio del progeno, è la promessa del Comando Superiore Italiano che per ognuna delle due imprese potranno essere messi a disposizione circa :1 battaglioni rinforzaù, possibilmente mobili. Essi dovrebbero inoltre servire, attraverso l'occupazione e la difesa delle oasi intermedie, ad assicurare i collegamenti nelle retrovic dei reparti di attacco nella futura avanzata; come pure dovranno intraprendere il rifornimento e la sistemazione dei campi di aviazione per l'arma aerea.
Però deve essere possibilmente evitato di trarre forze dalle divisioni stabilite come partecipanti all'atta cco principale (Trento, Pavia, Ariete e anche Bologna, Savona e Brescia).
A parere del C.T. A. potrebbero tuttavia venire in questione con vantaggio, le guarnigioni di Tagrifet, Bu Gnem, Beni Ulid c Mizda (o i n cambio di altre forze mobili) i c ui compiti attuali con lo spostamento della sicu rezza verso est e sudest (Gialo e Kufra) perdono importanza.
P e r la riunione di queste forze sarebbe opportuno tener presente Marada.
per Il Corpo Tedesco in Af,.ica
Il Capo di Stato Maggiol'e voN DEN BoRNE
UFFIC IO OPERAZIONI
N. 6o / 3 - 41
Segretissimo
Allo Stato Ma ggiore del Co m ando Supremo dell'Esercito
Ufficio Operazioni J5I6o f 4I segretissimo
6o / 41 segretissimo
Riservatissimo! solo per Ufficiali
Allo Stato Maggiore del Comando Supremo dell'Esercito
VALUTAZIONE D ELLE POSS IBI LITÀ PER UNA OPERAZTONE DI ATTACCO IN NoRD AFRI CA.
1) Situazione approssimativa nemica. La massa dell'esercito operante i nglese destinata alla difesa dell'Egitto, sta attualmente in Cirenaica (c irca 5 divisioni, comprese le corazzate). Dietro si trovano, fino al delta del Nilo incluso, circa 7 divisioni, c ancora 5 divisioni al Canale di Suez.
Un essenziale rinforzo dell'armata che è nel Nord Africa, in caso di un attacco di sorpresa tedesco, sarà appena possibile, perché le grandi forze attualmente esistenti nel Mediterr an eo orientale e nel nord est dell'Africa, special-
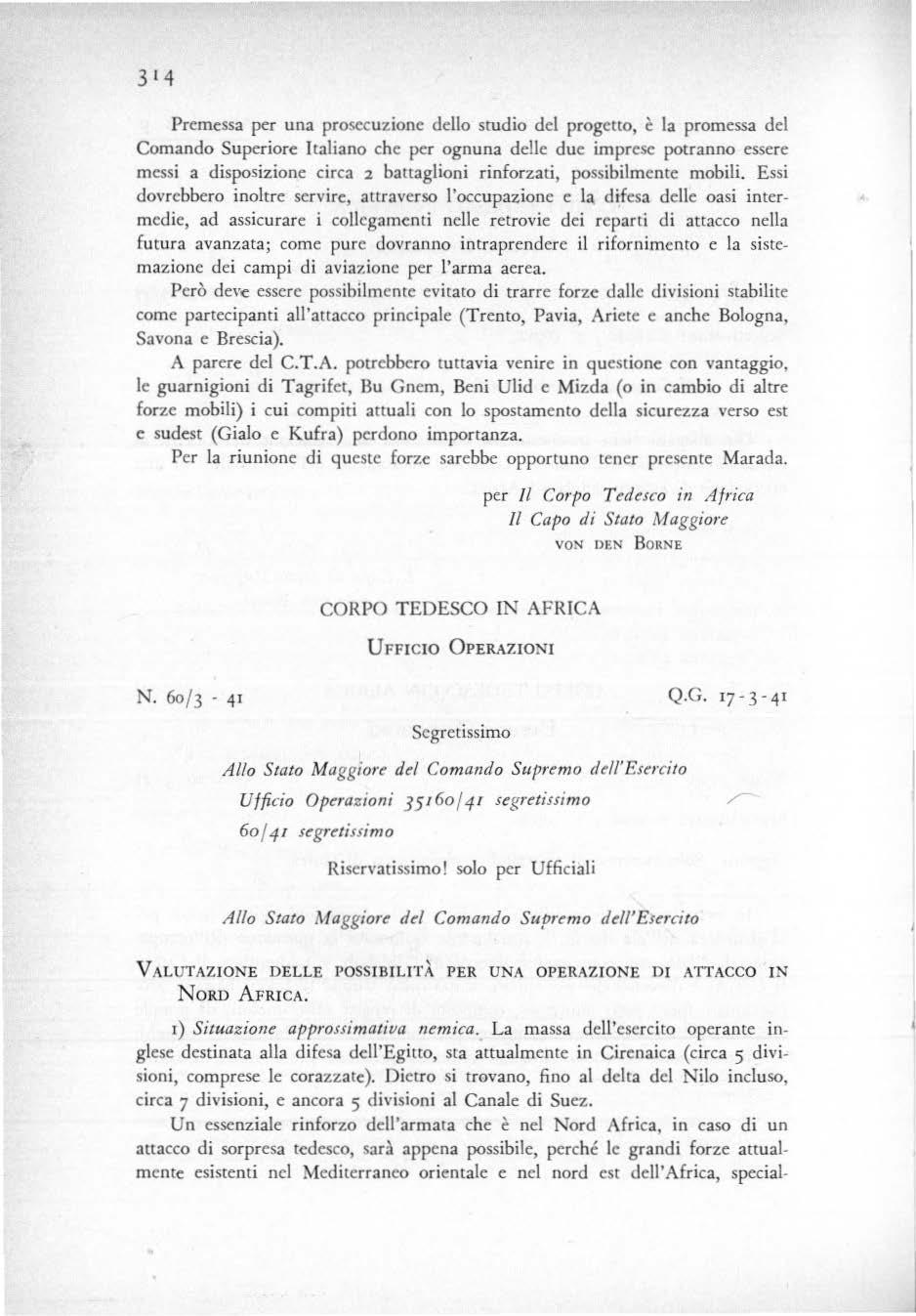
mente flotta ed aviazione, dovrebbero essere impegnate ancora per i prossum due mesi per l'az ione in Africa Orientale Italiana e pér lo schieramento che si va delineando contro la Siria. Perciò dovrebbe un tale aiuto, in seguito a un rapido successo tedesco- italiano venire troppo tardi.
Le intenzioni inglesi di un attacco comro Tripoli, sono in questa situazione provvjsoriamente inverosimili. Però gli inglesi faranno di tutto per tenere il ter r itorio conquistato in Cirenaica a protezione dell'Egitto, onde impedire la minaccia della costituzione di basi aeree i taio - tedesche. Inoltre si sforzerà di terminare presto vittoriosamente l'azione contro I'A.O.I. per l iberare per altro futuro impiego le truppe attualmente colà impegnate: forse contro Tripoli oppure per rinforzare la difesa contro un atteso attacco tedesco- italiano. Un ritardo di questo attacco può essere des iderabile per gl i i nglesi nella loro attuale situazione
Il tempo che per questo teatro di operazioni attualmente l avora per l'Italia, devia a favore degli in questo momento in cui le forze italo- tedesche. sono capaci di tener fronte ad un poss ibile per quanto inverosimi le attacco inglese.
E' anche possibi le, e corrisponderebbe alla loro menta l ità, che gli inglesi, per mancanza di altre forze, lancino le truppe di De Gaulle in una rapida puntata attraverso le regioni desertiche del sud della Libia. Il successo di una simile impresa potrebbe recare notevoli disturbi per l'attacco verso est, per quanto per l'azione su Tripoli non possa essere decisivo. Tuttavia potrebbe rendere necessario per un certo tempo, l'impiego dell'arma aerea tedesca.
Nel sud non ci sono possibilità d i operazioni per grandi forze, anche considerando l'atteggiamento non amichevole simpatizzante per De Gaulle nel sud a1gerino e nel sud l ibico.

2) Momento per ur1 attacco. L'attacco verso est deve perciò essere fatto presto al più tardi prima che vengano i grandi calori estivi Perciò per la condotta di tutte le operazioni r imane disponibile solo il mese di maggio. E' necessario quind i che ogni preparazione sia conclusa per la fine di aprile .
3) Scopo di attacco. Lo scopo di u na operazione di attacco può essere solo il cuore dell'Egitto (A lessandria Cairo - Canale di Suez). La limitazione alla riconquista della C i rena ica, significa solo riconquista di territorio.
Il pieno impiego d i tutte ie truppe che sono in L ibia e de ll e truppe italiane di rinforzo che verranno dall'Italia deve essere garantito; dal Comando Superiore Ita liano deve essere inoltre assicurato che, nello spirito di tutta la condotta di guerra, almeno le divis ion i celeri italiane, l'arma aerea italiana e l a Marina da guerra ital i ana per l a continuazione dell'offensiva verso l'Egitto vengano messe a disposizione. Sulla condotta d i tutte le operazioni di attacco verso est, al C.T.A deve essere concessa un'ampia influenza per garant i re l'unità dell'az ione.
L'intera operazione deve essere divisa in due tempi : battere l'armata inglese Cirenaica e rottura su l Ca i ro
Per la continuazione dell'operazione offensiva verso l'Egitto è premesso il rapido definitivo ahnientamento delle forze armate inglesi in Cirenaica. Perché questo scopo sia ottenuto si deve per mezzo dell'aviazione dalla Sicilia e dalla Grecia, come anche per mezzo del pieno impiego della Marina italiana, respingere la flotta inglese nel Mediterraneo Orientale così che la via mari ttima per il trasporto dei rifornimenti approntati in Italia (Napoli) a Bengasi e Tobruk sia assicurata con l'inizio delle operazioni in Cirena ica. Se come sfruttamento del primo successo, potrà essere effettuata una rapida puntata con deboli forze verso l'Egitto, risulterà dallo svi lu ppo della situazione.

4) Situazione delle forze in Libia. Forze inglesi stanno in Cirenaica con la massa stretta alla costa e appoggiate sul corso della Litoranea, in zona Agedabia- D erna il corpo corazzato in glese cd il corpo australiano. Il corpo corazzato inglese dispone d i 3 reparti corazzati, 6 reggimenti di esploratori corazzati, 2 btg. mot. e 6-9 gruppi di artiglieria. Il corpo australiano ha 3 divisioni ciasc una con 9 btg. c ciascuna con circa 6 gruppi di artiglieria.
L'efficienza bellica di queste forze, specialmente per le esigenze del dcserto, deve essere indicata come buona. Le perdite sofferte c le sostituzion i ricevute non sono precisabili. Di fronte a questo il comando tedesco dispone, data la attuale dotazione di reparti destinati all'attacco, in truppe tedesche solo la 5. divi s ione leggera e la divisione corazzata, insieme a quattro gruppi corazzati, 1 reparto esplorante corazzato, 7 btg. mot. e gruppi di artiglieria. Ciò corrisponde all'incirca delle forze del cor po corazzato inglese. Delle forze italiane sono in questione in primo luogo per la condotta mobile dell'attacco 3 divisioni mot. (di cui una divisione corazzata). Tre altre divisioni a piedi devono seguire con celerità sia per mezzo di motorizzazionc provvisoria o a marce forzate . Circa la forza dci reparti vedere all'incirca annessi I e 2
5) T e mpo della condotta dell'attacco. Il comando perciò è anche costretto a battere presto le divisioni nemiche una dopo l'altra sfruttando lo schicryncnto inglese attualmente molto esteso, in conformità delle condizioni attuali Bisogna ino1tre tenere presente che dopo l'arrivo della notizia di un attacco, è da aspettarsi l'afflusso di nuove forze dall'Egitto. I n ogni caso deve essere evitato che queste forze possano intervenire prima che l'armata della Cirenaica sia definitivamente battuta. Per colpire rapidamente in special modo nella guerra nel deserto, sono meno necessarie forze numerose che non le armi moderne, di speciale efficacia morale, ancora non conosciute nel deserto. Vicino alle forze aeree e truppe paracadutiste, promettono qui il massimo successo in prima l inea i carr i armati, gruppi di artigli eria d'assalto, lanciatori di nebbia e anche in relaz ione alla supremazia di artiglieria degli inglesi, possib ilmente numerosi calibri da 150. Inol tre per una rapida condotta del combattimento nel deserto, sono necessari speciali reparti autonomi di esploratori corazzati, posti a grandi distanze, agli ordini di scelti comandanti. La massa nel deserto è difficile da condurre e da sostenere. Al contrario è con la distribuzione delle nominate armi moderne che s i può riportare un successo anche contro forze superiori.
6) d ' urto dell'attacco. La direzione principale d' urto dell'attacco su Tobruk è attraverso lo sc hi eramento degli inglesi, come pure attraver so l'obbligo dato di mante nere nel dese rto i post i produttivi d'acqua come base per il proseguimen to di ogni combattimento. La regione di Dcrna e di Bardia è co m e quantità d'acqua, la migliore e la pi ù ricca, così ch e anch e forze ammass ate possono essere approv\·igionate. Qui ci sono an che i primi campi d'aviazione u tilizzabili per il so rvolamen to del deserto. Tobruk è oltre a ciò il principale posto di approv vigionamento c porto di ri fornimento degli inglesi.

7) Condotta atta cco. La co nd otta dell'attacco deve tener conto che i n primo luogo il ca mpo avanzaro degl i inglesi tra Agheila ed Agcdabia deve entrare in nostro possesso Inoltre è da intendere, dopo l'impiego d i su ffi. cienti forze, la conqui sta possibilmente improvvisa dei post i avanzati di sic ure-aa inglesi di Marsa Brega e quindi d i sp ingere avanti la difesa della srretta d i es Scgira.
Nel caso c he il nemico non abbia già indietreggiato, da queste posiz ioni, essen do il punto pi ù vicino, verrà eseg uito il salto co ntro le pos izioni base ing les i di Agedabia.
Con questo la prima decisiva fa se di la ba ttag lia per Agedabia, sa rà a perta. Scopo d i que s to attacco è la frantumazione del corpo corazzato inglese.
1\"el caso che il n em ico accetti l'a t t acco può essere possibile che esso schieri le sue forz e secondo il modo di com batte re finora da lui praticato; ch e esso cerc hi l'attacco fro ntale come m ezzo di co nte ner e l'urto del nemico c ce rchi di incontrarlo co n la mass a d ci suoi carri armati. E' a nch e possibile che esso intenda m ettere i s uoi ca r ri armati sol i alla difesa. Contro q uesta poss ibili tà è la estensione del deserto, per cu i si può aspenare un attacco da qual siasi direzi one. In ogni caso il ne mico dovrà dalle inte re divisioni coraz zate essere attac cato e distrutto, prima che possa pensare ad un proseguimento del combatt imento con operazioni a largo ragg io in direz ione di T obruk. Senza la prece. dente distru z ione del corpo corazzato, viene in que st ione se gli ingl es i eviteranno il combattim ento ad Ag edabia e s i ritireranno sul corpo australiano. I ndipendentemente da questo, sempre al principio dell'azione su Agedabia piccol i, ma potenti reparti, se esistenti, d i paracadutisti dovrebbero essere lanciati sulla Htoranea i n direzione di T obruk, per prendere possesso rapidamente del porto d i Tobruk, per lo sbarrame nto della li toranea nell e due direzioni e per la conquista d i impor ta n ti camp i di avia z ione (p .es. Ad em ).
La battaglia su Agcdabia deve esse re condotta con in aud i ta e nergia c celerità: I 0 - per afferrare il corpo co raz zato ingl ese; 2° - mcuere alla prova anche nel deserto, fin dal pr incipio delle operazio ni, la preponderanza della disposizione delle armi esistent i.
1\"el caso della dec isione su Agedabia, l'azione entra nella 2 • fase dello svil uppo Un urto frontale con la ma ssa delle fon:e sparse lungo la litor anea, non prome tt e nessun rapido e dec is ivo successo e può darsi che gli i ngles i fi n dal princi p io lan ci no nel combatt im ento il co r po australiano. Una rapida dcc i-
sionc in Cirenaica, può essere raggiunta solo intraprendendo una marcia di giorno e di notte attraverso il deserto a sud del gebel el Achdar, attraverso la zona di Derna, con il proposito di ostacolare la ritirata degli inglesi e con una rapida sistemazione verso ovest, annientare le forze anglo- australiane prima che possano ritirarsi verso sud- est o sui piroscafi. La copertura della marcia di fianco verso il nord di Agedabia e verso est nei riguardi delle ancora esistenti forze inglesi o di possibili contrattacchi del corpo australiano, come pure la copertura delle retrovie litoranea verso l'Egitto, deve essere garantita con reparti.
8) Aviazione. Circa le operazioni dell'arma aerea, segue uno speciale rapporto. L'opporruna, rapida sicurezza dei campi di aviazione sulla costa in zona di T obruk- Derna è, riguardo al futuro, d i decisiva importanza specialmente per gli Stuka.
9) Rifornimenti (v. annesso 3). Riguardo ai rifornimenti nel deserto, specialmente la questione dell'acqua costringono a risolvere presto. Specialmente deve essere evitato un lungo combattimento nel deserto contro un nemico che può disporre di una base di rifornimento e di speciali sicuri posti d'acqua. Il deserto, anche con forze ammassate, con una rapida violenta marcia può essere vinto; combattere si può, con tali reparti, solo nelle terre coltivate.
per Il Corpo Tedesco in Africa
Il Capo di Stato Maggiore vo,.; DEN BoRNE
Segreti ssimo
Annesso 1 al foglio del C.T.A. Ufficio Operazioni n. 6o { 41 dc!I7·3·4I /

A) Truppe per il Comando del Corpo (già r ichieste) :
3 gruppi esploratori corazzati che sono idonei a combattere isolatamente a grande distanza {dotazioni di Pionieri, batterie d'assalto, cacciatori di carri, plotoni di vetture popo 1ari (Volkswagcn) cd anche propri aeroplani di ricog nizione c corr ieri).
3 gruppi artiglieria pesante {mot.) con 1 comando di rgt.
1 reparto di nebbia artificiale.
3 btg. di pionieri -lanciafiamme su carri popolari con dotazione di fuciloni ant icarro co razzat i (come sostituzione di carri l anciafiamme).
3 plotoni autonomi di carri popolari con fuciloni corazzati e numerose mitragliatrici e pistole mitragliatrici col compito di caccia e comando speciale nel deserto.
L'assegnazione di almeno un apparecchio da collegamento (cicogne) per ciascuno è desiderato.
1 reggimento paracadutisti.
r comando superiore per il quarticr generale Libia.
B) Maggiore dotazione della 5" divisio11e leggera:
1 comando rgt. artiglieria.
I gruppo artiglieria leggera (mot.).
r gruppo artiglieria pesante (mot.).
1 battaglione motociclisti (invece di motocjcJette, autopopolari) (Volkl>wagen)
I btg. corazzato Pionieri (già in riunione).
Annmo 2 al foglio del C.T.A. Ufficio Operazioni n. 6oj41 de/J7 ·3·41
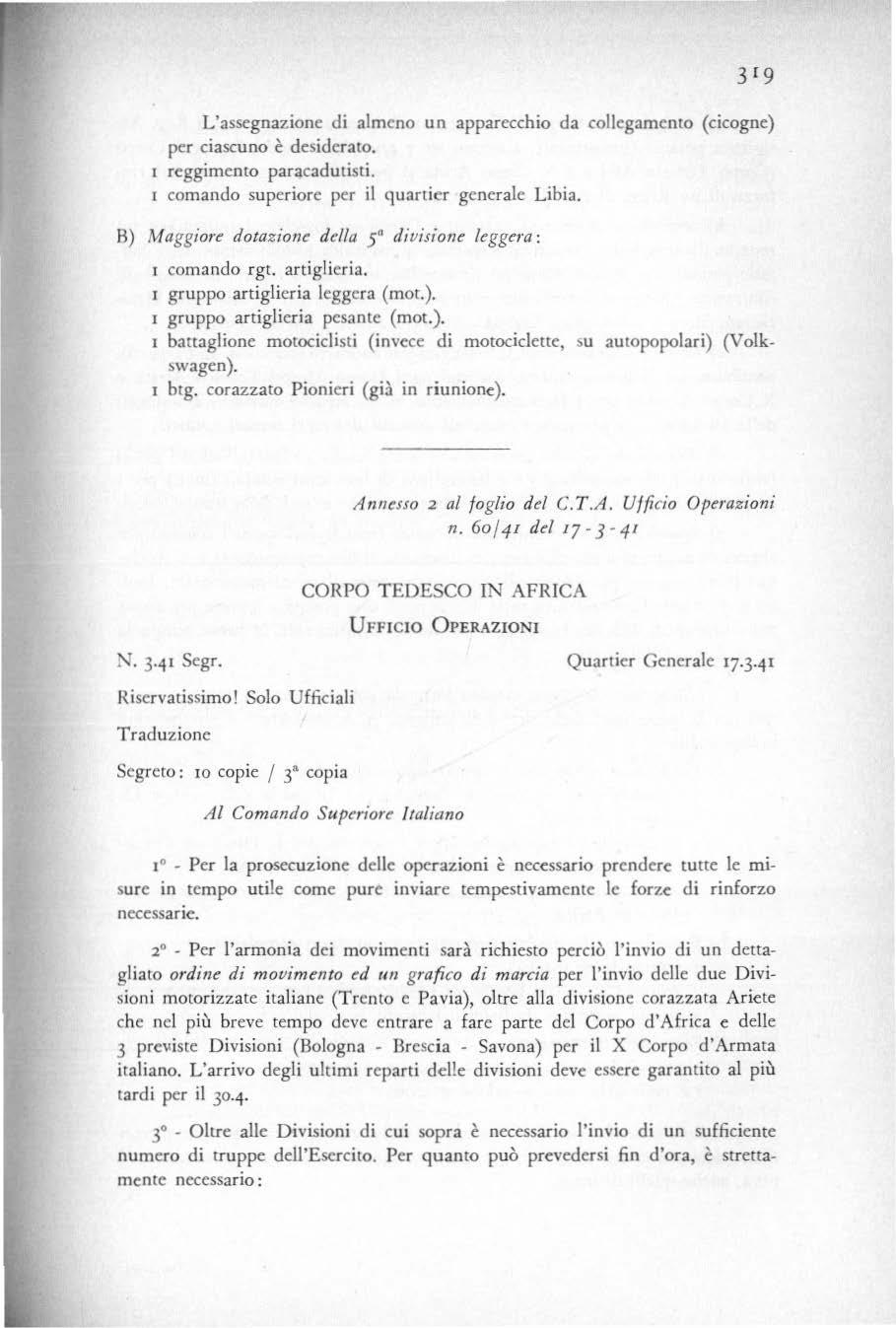
UFFI CIO OPERAZIONI
:-.:. 3.41 Segr.
Riservatissimo! Solo Ufficiali
Traduzione
Segreto : ro cop ie j 3" copia
Al Comando Superiore Italiano
Quartier Generale 17·3·41
1 ° - Per la prosecuzione delle operazioni è necessario prendere tutte le misu re in tempo utile come pure inviare tempestivamente le forze di rinforzo necessane.
2° - Per l'armonia dei movimenti sarà richiesto perciò l'invio di un dettagliato ordit1e di movimento ed un gra fico di marcia per l'invio delle due Divisioni motorizzate italiane (Trento c Pavia), oltre alla divisione cor azzata Ariete c he nel più breve tempo deve entrare a fare parte del Corpo d'Africa e delle 3 prc\liste Divisioni (Bologna - Brescia - Savona) per il X Corpo d'Armata italiano. L'arrivo degli ultimi reparti delle divisioni deve essere garantito al più tardi per il 30+
3° - Oltre alle Divisioni di cu i sopra è necessario l'invio di un sufficiente numero di truppe dell'Esercito. Per quanto può prevedersi fin d'ora, è strettamente necessario :
a) Artiglieria di Cot·po d'Armata (po55ibilmente cal. I) cm.): 2 Reg. Artiglieria pesante (motorizzati) ciascuno su 3 gruppi, in modo che ogni Corpo (Corpo Tedesco Africa e X Corpo Armata) possa fare assegnamento sul rinforzo di un Regg. di Artiglieria pesante.
b) Artiglieria contraerea: ciascuna Divisione dovrebbe comprendere un reparto di artiglieria contraerea motorizzata costituita possibilmente da 3 batterie pesanti e 2 leggere. Cosicché risulterebbe in totale 6 reparti di artiglieria contraerea. Questo rinforzo contraereo è indispensabile per le Divisioni Mo torizzate (Brescia - Bologna - Savona - Trento - Ariete - Pavia - Totale 6).
c) Reparti anticarro (mot.): 2 reggimenti anticarro (ciascuno su 3 reparti), possibilmente di grosso calibro, cosicché ogni Corpo (Corpo Tedesco Africa e X Corpo Armata) possa fare assegnamento su un reparto anticarro a sostegno delle Divisioni, ciò per parare eventuali attacchi dei carri armati nemici.
d) Truppe del Genio: prevede re in breve tempo IO battaglioni del genio (almeno in parte motorizzati) e 5 battaglioni di lavoratori stradali (mot.) per i preparativi in genera le, coll'inizio dei movimenti in avanti delle truppe celeri.
e) Squadra idrica con impianti di sonda (mot.): con speciali colonne per riserva di acqua, una per divisione, in modo che il bisogno ammonta a 6. Anche qui è più urgente provvedere all'attrezzatura delle divisioni motorizzate. Inoltre è necessaria la dotazione a tutte le truppe di una pompa a motore per acqua nella misura di una per battaglione, in modo da accelerare in breve tempo la presa d'acqua dai pozzi.
4° - L'aviazione deve essere tanto forte da poter adempiere a tutti 1 compiti per la protezione delle divisioni italiane. A questo scopo è strettamente indispensabile:
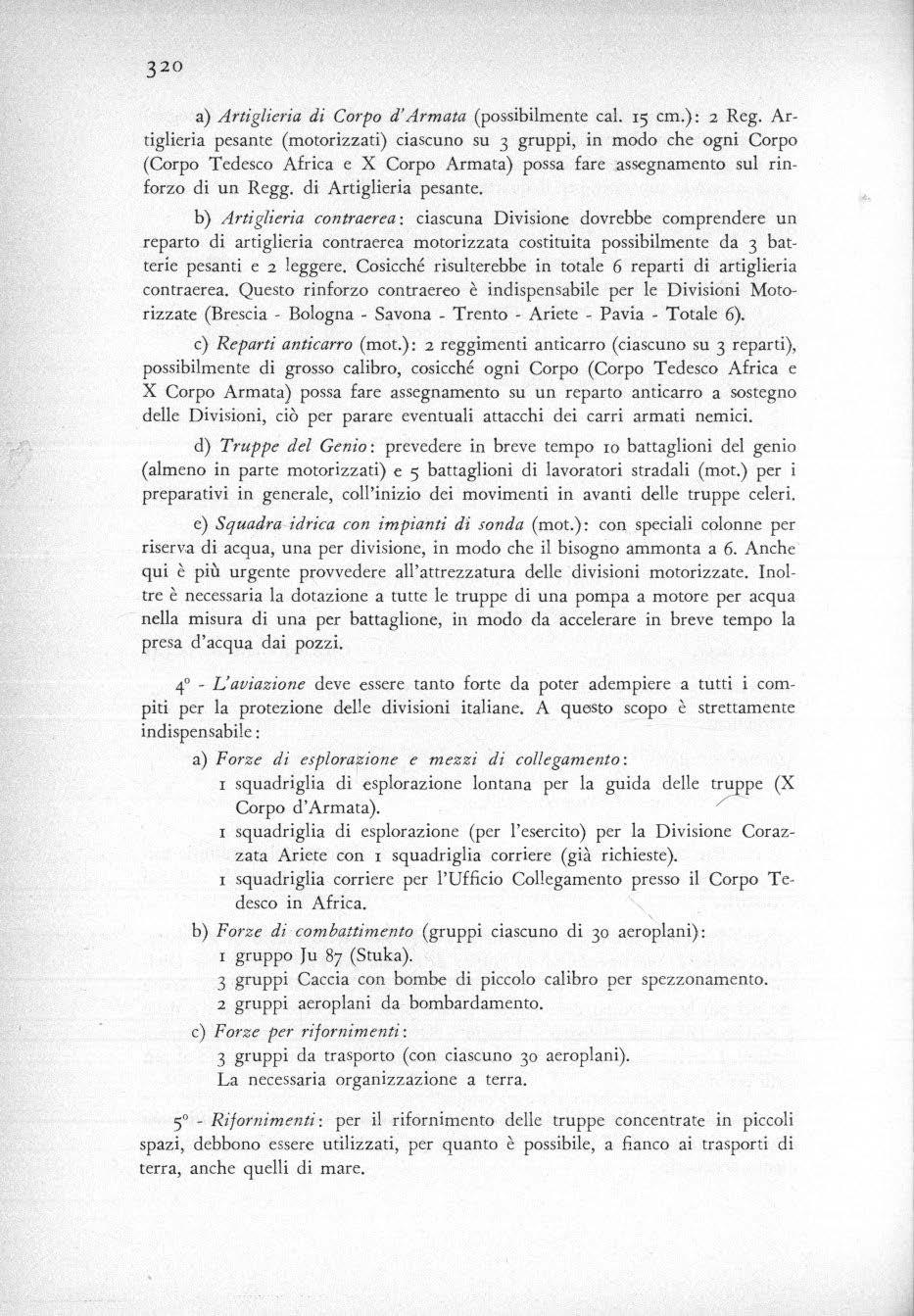
a) Forze dì esplorazione e mezzi di collegamento:
I squadriglia di esplorazione lontana per la guida delle /pe (X Corpo d'Armata).
I squadriglia di esp lorazione (per l'esercito) per la Divisione Corazzata Ariete con l squadriglia corriere (già r ichieste).
I squadriglia corriere per l'Ufficio Collegamento presso il Corpo Tedesco in Africa.
b) Fot·ze di combattimento (gruppi ciascuno di 30 aeroplani):
r gruppo Ju 87 (Stuka)
3 gruppi Caccia con bombe di piccolo calibro per spezzonamento.
2 gruppi aeroplani da bombardamento.
c) For ze per rifornimenti:
3 gruppi da trasporto (con ciascuno 30 aeroplani).
La necessaria organizzazione a terra.
5° - T?ifornimenti: per il rifornimento delle truppe concentrate in piccoli spazi, debbono essere utilizzati, per quanto è possibile, a fianco ai trasporti di terra, anche quelli di mare.
A questo scopo è strcttamcme necessario:
a) di trasporto: Approntamento di parecchi piroscafi per viaggi lungo le coste, forte aumento di tonnellaggio di piroscafi in convog'io per assicurare il tempestivo trasporto di truppe e materiale dall'[talia (e Germania), come già in corso. Come pure approntamento di tonn ellaggio navale per approvigionamento dall'inizio delle operazioni per il movimento in avanti, per alleggerire mediante trasporti mobi li via mare, le già lungh e lin ce di rifornimenti impegnate al massimo sino alla linea
b) armata navi di rifomimento mediante approntamento di un numero sufficiente di navi guardiacoste come anche approntamento di più grandi unità della R. Marina per la protezione dei convogli e per ass icurare dalle possibili offese da parte delle uni t à navali inglesi.
Per il rifomimento dd le Unità motorizzate per le probabili grandi distanze, sarebbe inoltre necessaria la previsione di trasporti via aerea (vedi anche sopra).
Per il dell'ordine 11elle per la sorveglianza e lo sgombero dei prigionieri e per l a sicurezza del mater i ale catturato è necessano l'approntamento di una congrua forza di polizia.
6° - collegamenti : per assicurare almeno un collegamento te1cfonico che possa rispondere allo scopo lungo la strada costiera, è necessario, l'approntamento per di forze per la costituzione di posti telefonic i. E' pertanto necessario ch e sia dislocato presso il Corpo Tedesco d'Africa un r eparto di trasmettitor i i taliano col compito di com unicare coi reparti delle divisioni italiane in modo chiaro e rapido. Precise proposte seguiranno dopo l'arrivo dd Comandante del Reparto del Corpo di trasmissione tedesco.
Annesso 3 al foglio dd C.T.A. Ufficio Operazioni n. 6o / 4r del q- 3-41
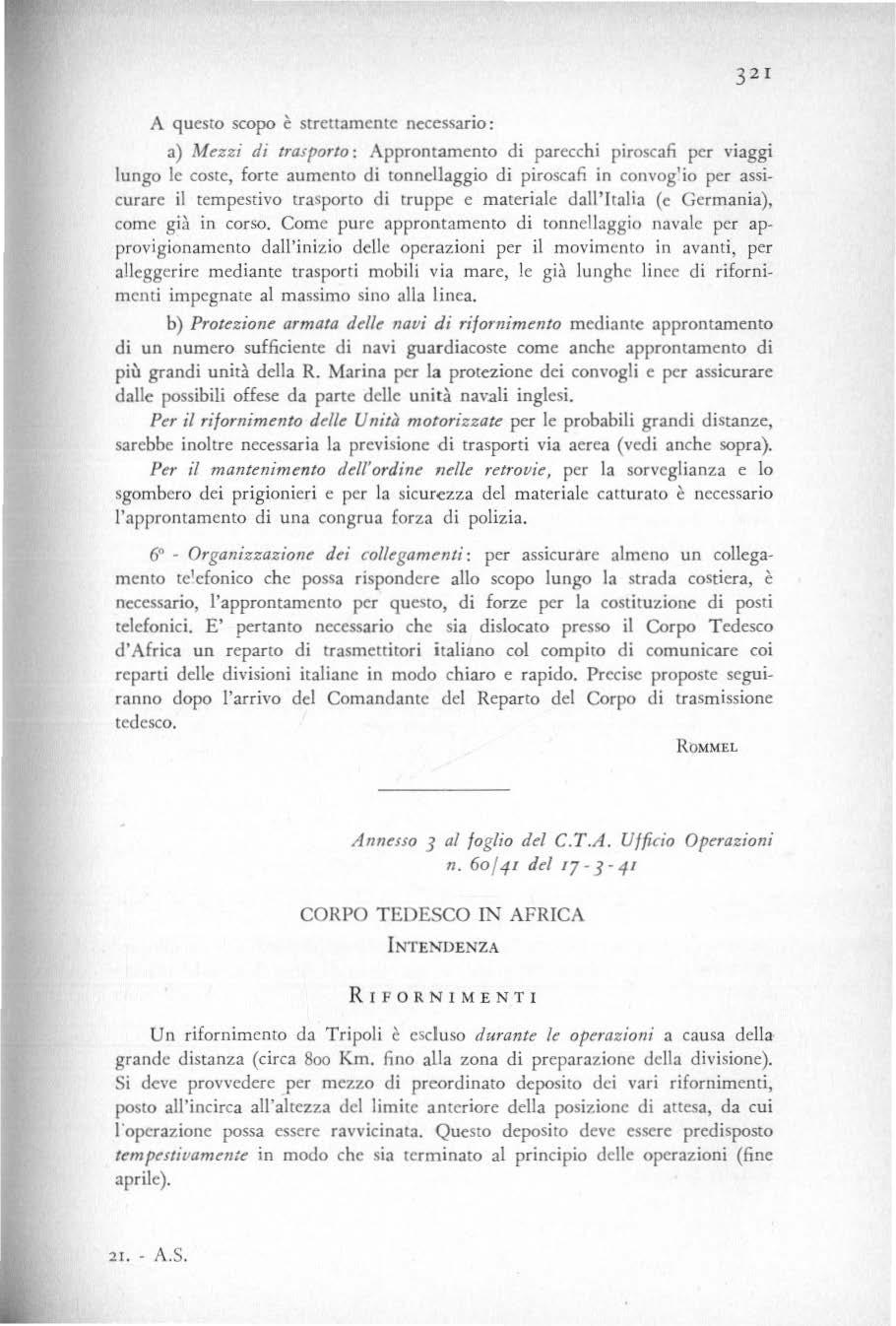
INTENDENZA
R IFORNIMENTI
Un rifornimento da Tripoli è escluso durante le operazioni a causa della grande distanza (circa 8oo Km. fino alla zona di preparazione della divisione). Si deve provvedere per mezzo di preordinato deposito dci vari rifornimenri, posto all'incirca all'altezza del limite anteriore della posizione di attesa, da cui !"operazione possa essere ravvi cinata. Questo deposito deve essere predisposto tempestivamt:nte in modo che sia terminato al principio delle operazioni (fine aprile).
La preparazione del deposito, ha importan za, prima perché attualmente non c'è un impiego di colonna di rifornimento e più tardi perché sara nno insufficienti fino a che non seguirà la intera utilizzazione della navigazione costiera. Come porti, a questo scopo sono in questione, Marsa e Aucgia e Ras el Aali; ambedue sono nella zona di preparazione. La potenzialità di sbarco è per il momento bassa, ma può esM:re aumentata fino a 100- 200 tonnellate giornaliere.
Pa la sono attualmente a disposizione in Tripoli in tutto ro navi di c irca 300 - Soo tonnellate. Si pone ora la questione se per i rifornim ent i italiani potranno essere date 5 navi, così che solo 5 navi rimangono d is ponibili
In considerazione del tragitto (II- 12 giorni compreso lo sbarco), si può considerare un lavoro mensile delle cinque navi di circa 6.ooo tonnellate. E' perciò necessario inviare dall'Italia a Tripoli ancora 10 o 15 navi costiere (piccoli piroscafi, motovelicri).
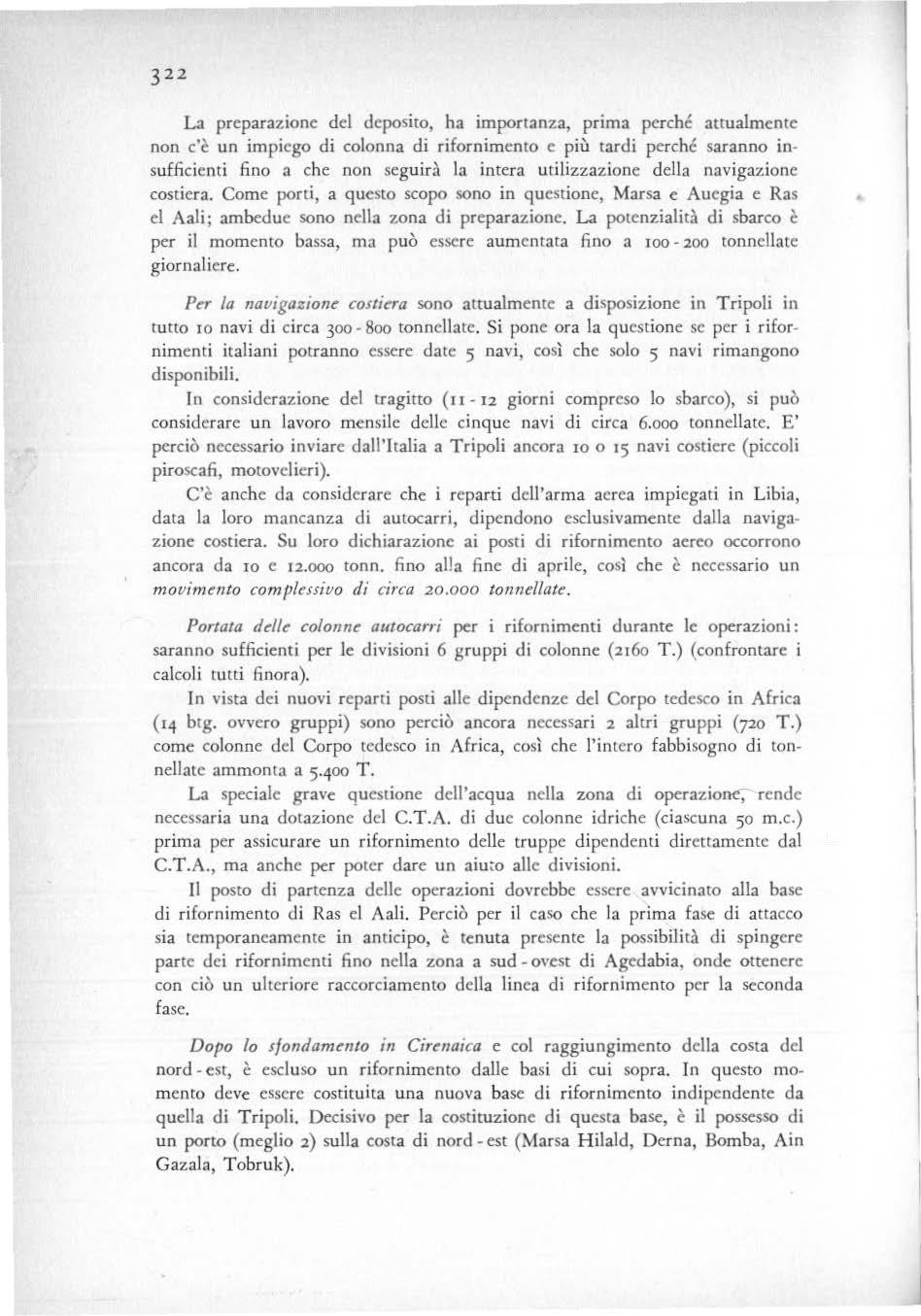
C'è anche da considerare che i reparti dell'arma aerea impiegati in Libia, data la loro mancanza di autocarri, dipendono esc lusivamente dalla navigazione costiera. Su loro dichiarazione ai posti di rifornimento aereo occorrono ancora da ro e 12.000 tonn. fino alla fine di aprile, così che è necessario un complessivo di ci,-ca 20.000 tonnellate.
Portata colonne autocan·i per i rifornimenti durante le operazioni: saranno suffic ienti per le divisioni 6 gruppi di colon ne (zr6o T.) (confrontare i calcoli rutti finora).
In vista dei nuovi r eparti posti alle dipendenze del Corpo tedesco in Africa (14 brg. ovvero gruppi) sono perciò ancora necessari 2 altri gruppi (720 T.) come co lonn e del Corpo tedesco in Africa, così che l'intero fabbi sog no di tonnellat e ammonta a 5.400 T.
La speciale grave questione d ell'acqua n ella zona di operazione, rend e necessaria una dotazione del C.T.A. di due colonne idriche (ciascuna 50 m.c.) prima per assicurare un rifornimento delle truppe dipe nd ent i direttamente dal C.T.A., ma anche per poter dare un aiu•o alle divisioni.
Il posto di partenza delle operazioni dovrebbe essere avvicinato alla base di rifornimento di Ras el Aali . Perciò per il caso che la prima fase di attacco sia temporaneamente in anticipo, è tenuta presente la possibilità di spingere parte dci rifornim enti fino nella zona a sud- ovest di Agcdabia, onde ottenere con ciò un ulteriore raccorciamento della linea di rifornimento per la seconda fase.
Dopo lo sfondamento in e col raggiungim ento della costa del nord - est, è esc luso un rifornimento dalle basi di cui sopra. In questo momento deve essere costituita una nuova base di rifornim e nto indipendente da quella di Tripoli. Decisivo per la costituz ion e di questa base, è il possesso di un porto (me glio 2) sulla costa di nord- est ( Marsa Hilald , Derna, Bomba, A in Gazala, Tobruk).
Per l'entità del deposito di questa nuova base, sarebbe da tener presente che :
a) la truppa dopo aver raggiunto la costa, è sfornita e dovrà essere rifornita;
b) un approvigionamento per altri ro giorni di azione deve essere a disposizione;
c) una perdita di circa il so % durante il tragitto per azione del nemico deve essere messa in conto;
d) anche le divisioni italiane devono essere rifornite di questo conto pacchetto di rifornimento.
Tenendo conto di questo punto, di vista, occorrono ancora:
15 serie di carburanti,
1 dotazione munizioni,
IO giornate di razioni viveri, inoltre gomme, parti di ricambio, materiale sanitario.
L'entità del rifornimento è necessariamente decisa dalle possibilità tattiche che si profileranno col raggiungere della costa: avvolgimento della Cirenaica da est verso ovest, difesa dai contrattacchi ingles i, possibilità di sfondamento verso l'Egitto.

Questo scaglione di nav.i deve essere dotato in caso di distruzione di porti, possa fare uno sbarco sulla costa libera.
L'approntamento di questi rifornimenti, sarà indipendenre dal norma le rifornimen to che attualmente ha luogo nei porti meridionali d'Italia (Napoli), poiché le merci, con l'i nizio delle operazioni (principio maggio) dovranno stare caricate sulle navi, pronte a dispos izione del C.T.A ..
Il tonnellaggio totale necessario sarà di 35- 4o.ooo T. (calcolato il so % di perd ité).
La questione della scorta deve essere chiarita prima, vale a dire l'impiego di tutta la R. Marina, e di forti repa r ti dell'arma aerea (v. relazione ufficio informazioni).
L'ulteriore rifornimento delle truppe in Cirenaica dovrebbe avvenire :
a) per mezzo dell'utilizzazione di q uello che è sul posto;
b) per mezzo di immediato rifornimento marittimo dai porti meridionali d'Italia .
La base di Tripoli sarebbe da sciogliere e le rimanenze avviate in Cirenaica.
..
ORDINE DI BATTAGLIA DELLE FF.AA. ITALIA NE IN A.S.
AL Jo APRILE 1941- XIX
Comando Superiore Forze Armate A .S.
Comando Superiore Carabinieri Reali
Comando Superiore Artiglieria
Comando Superiore Genio
In ten denza A.S.
Autoraggruppamento del Comando Superiore
Divisione corazzata <<A riete» (132..) (l)
Divisione motorizzata « Trento'' (102")
X Corpo d'Armata
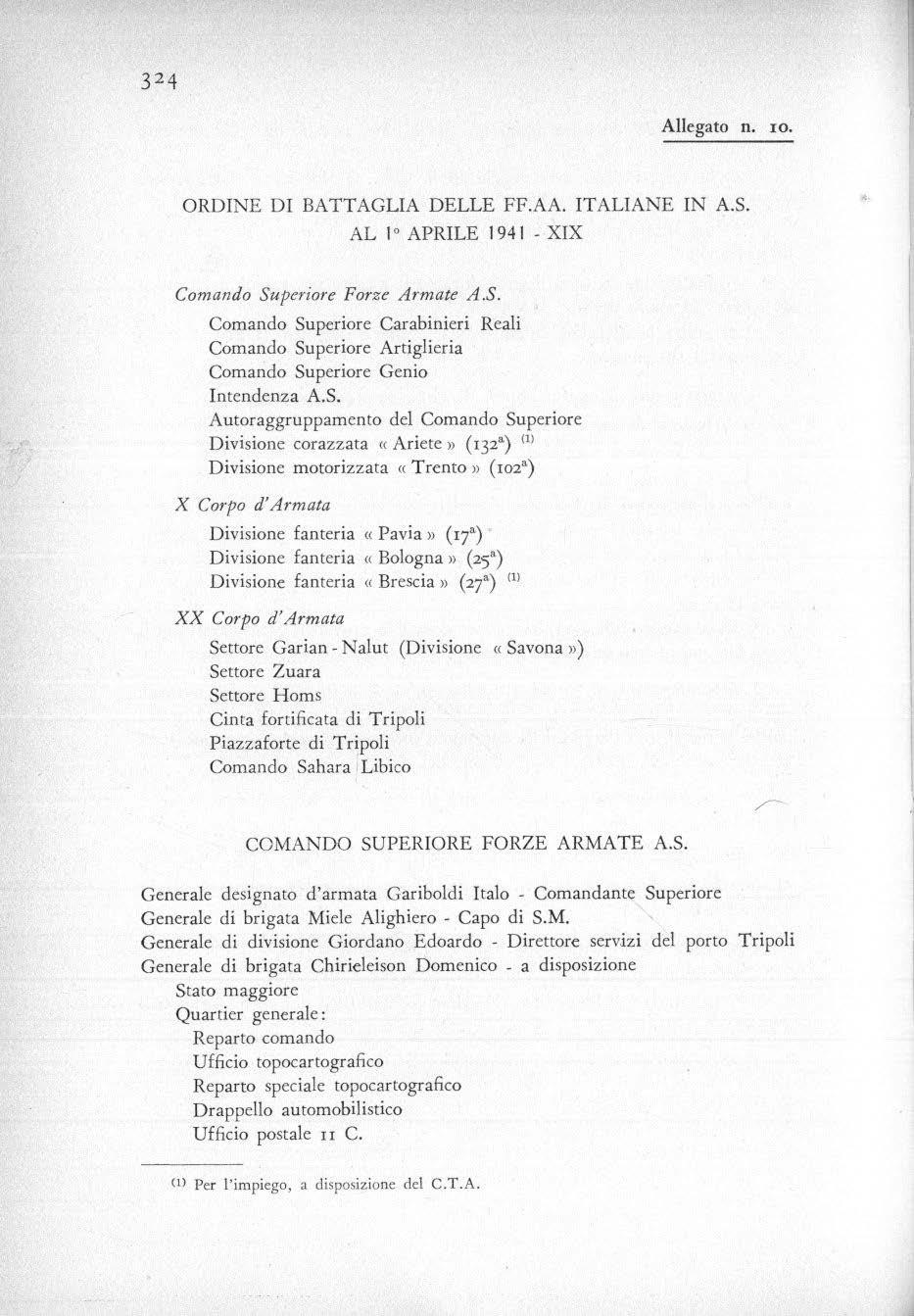
Divisione fanteria « Pavia '' (r7'')
Divisione fanteria « Bologna ll (25")
Divisione fanteria << Brescia » (27") (l)
XX Co1·po d'Armata
Settore Garian- Na lu t (Divisione « Savona ll )
Settore Zuara
Settore Homs
Cinta fortificata di Tripoli
Piazzaforte d i Tripoli
Comando Sahara Libi co
COMANDO SUPERIORE FORZE ARMATE A.S.
Generale designato d'armata Gariboldi Italo - Comandante Superiore
Generale di briga ta Miele Alighiero - Capo di S.M.
Generale di divisione Giordano Edoardo - Direttore servizi del porto Tripoli
Generale di brigata Chirieleison Domenico - a disposizione
Stato maggiore
Quartier generale :
Reparto comando
Ufficio topocartografico
Reparto speciale topocartografico
Drappello automobilistico
Ufficio postale II C.
<ll Per l'impiego, a d isposiz ione d el C.T.A.
Colonnello Castriotta Raffaele - Comandante in te; inale
266' sezione motorizzata cc.rr.
620"' sezione motorizzata cc.rr.
621" sezione motorizzata cc.rr.
66o sezione motorizzata cc.rr.
lry1.. sezione motorizzata cc.rr.
675• sezione mororizzata cc.rr.
676• sezione motorizzata cc.rr.
704• sezione motorizzata cc.rr.
Generale di Brigata Benclli Cesare - Comandan te
5° raggruppamento art. di armata
XIX gruppo da 149/35
XX gruppo da 149/35 al XX Corpo d'Armata
XXI gruppo da 149/35
XXII gruppo da 149/35
2 ° reggimento c.a. autocampale
XVIII gruppo da 88/56
XXIX gruppo da 88/56
XLIII gruppo da 75(48 Skoda
XLII gr. da 75(48 da posiz. Skoda (2 brr.;
XIV gr. autocamp. da 75(27 C.K (2 btr.:
2° reggimento artiglieria celere
I gruppo da 75 / 27- II (2 btr.)
II gruppo da 76/27- II (2 btr.)
III gruppo da 100f 17 (3 btr )
16° reggimento artiglieria
XV gruppo da 105(28
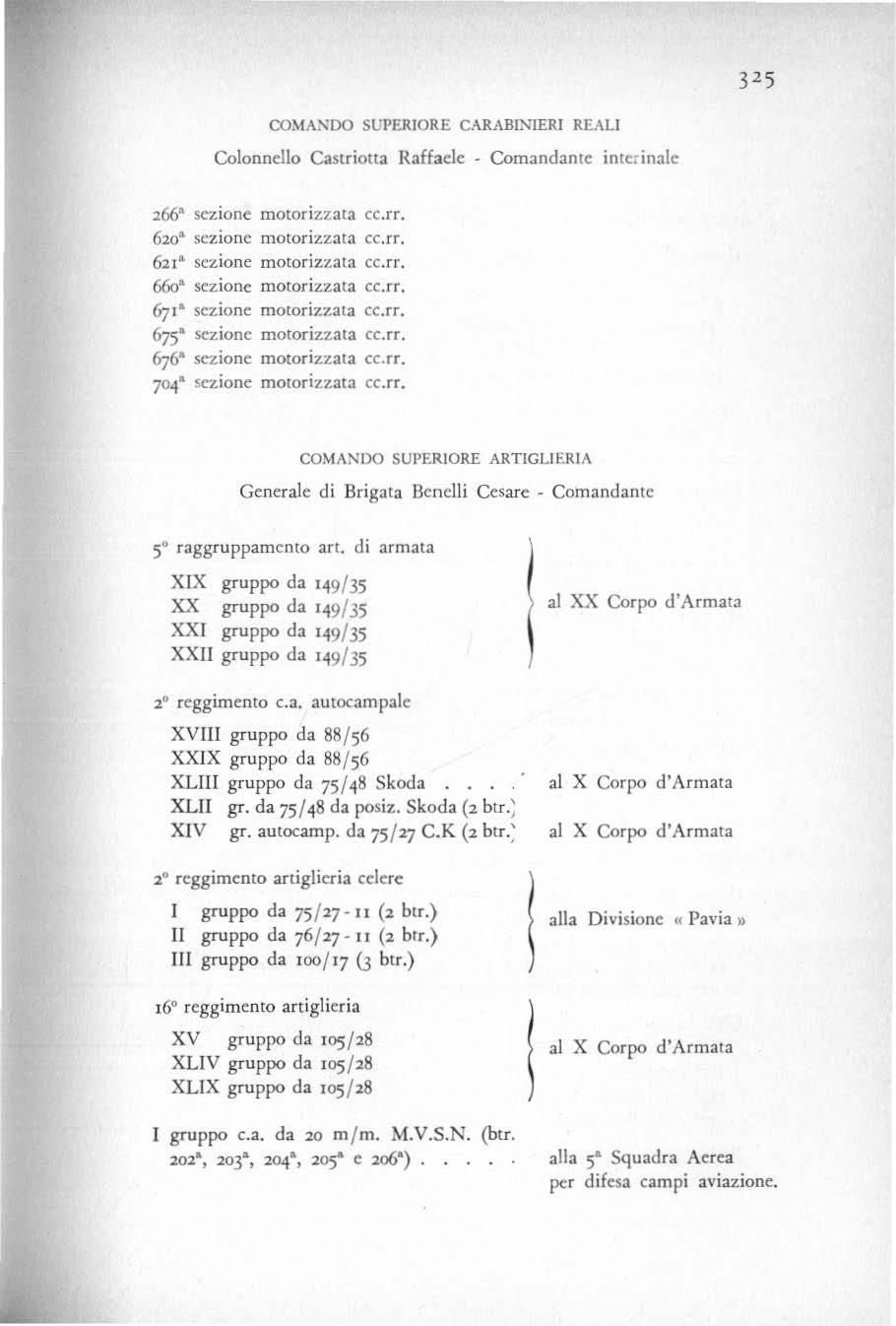
XLIV gruppo da IO'j/28
XLIX gruppo da 105 ( 28
gruppo c.a da 20 mf m. M.V.S.N. (btr. 202·, 203a, 2046 , 205" e 2o6•) . . . . .
al X Corpo d'Armata
al X Corpo d'Armata
alla Divisione << Pavia »
al X Corpo d'Armata
alla 5• Squadra Aerea per difesa cam pi aviazione.
Generale di divisione Grosso Luigi - Comandante
1° RAGG RUP PAMENTO SPECIALE GEN I O
II battaglione artier i minatori:
23"' compagnia minatori
26" compagnia minatori
x• compagnia artieri d'arresto
14• compagnia artieri d'arresto
15• compagnia artieri d'arresto
Battaglione guastator i :
3• compagnia guastatori
4"' compagnia guastatori
Battaglione idrici:
3" compagnia idrici
4"' compagnia idrici
6" compagnia idrici
10" compagnia idric i
Battaglione speciale:
3" compagnia anticendi
3• compagnia aerostieri
Compagnia fotoelettricisri
Sezione cincmatografisti

XXV II battagli one artier i :
x" compagn ia artieri
2• com pagnja artieri
2° RAGGRUPP AMENTO SPECIALE GE N I O
IV battaglione collegamenti :
119" compagnia telcgrafisti
120 compagnia telegrafisti
uo" compagnia marconisti
12• colombaia mobile
LXV battaglione collegamenti:
126" compagnia telegrafìsti
12t compagnia tclcgrafìsti
n3• compagnia marconisti
3t colombaia mobile
XI battagl ione collegamenti:
1 I t compagnia tclegrafisti
127" compagnia marconisti colleg.
134• compagnia marconisti col'eg.
VII battaglione collegamenti:
137" compagnia marconisti speciale
rsr• compagnia marconisti speciale
Battaglione collegamenti del Comando Superiore:
n8" compagnia telegrafisti
Compagnia tclegrafisti Comando Superiore
Compagnia marconisti Comando Superiore
Reparto officine mobili
25" colombaia mobile
55" comp. collegamenti P.F.T.
VI battaglione lavoratori: compagnia lavoratori
9• compagnia lavoratori
10" compagn ia lavoratori
14" compagnia lavoratori
Compagnia lavoratori fotocleuricisti
VII battaglione lavoratori:
17" compagnia lavoratOri
r8" compagnia lavoratori
25.. compagnia lavoratori
2f compagn ia la voratori
30" compagnia lavoratori
V battaglione lavoratori:
28" compagnia lavoratori
29" compagnia lav.oratori
6" compagnia lavoratori (auto noma)
Compagnia deposito (autonoma)

I battaglione la voratori:
r" compagn ia lavoratori
2" compagnia lavoratori
3• compagnia lavoratori
4" compagnia lavoratori
II battaglione lavoratori:
7'' compagnia lavoratori
ga compagnia lavoratori
T0 RAGGRUPPAMENTO COMPAGNIE LAVORATORI. 2 ° RAGGRUPPAMENTO CO MP AGNIE LAVORATORI.n " compagnia lavoratori
12" compagnia lavoratori
13• compagnia lavoratori
III battaglione lavoratori: compagnia lavoratori
16" compagnia lavoratori
19" compagnia lavoratori
20" compagnia lavoratori
21" compagnia lavoratori
IV battaglione lavoratori:
22• compagnia lavoraLOri
23• compagnia lavoratori
24• compagnia lavoratori
26" compagnia lavorato ri
AuTOGRUPPo SPECIALE GENIO.
I" compagnia autogruppo
2 " compagnia autogruppo
3" compagnia autogruppo
Reparto servizi
r:-.'TE:-.lDENZA A.S.
Generale di brigata Romano Giuseppe - Intendente f.f

Stato maggiore
Quartier generale:
104" sezione mista cc.rr.
IO)" sezione mista cc.rr.
268• sezione motorizzata cc.rr.
289a sezione motorizzata cc.rr.
1337" sezione mista cc.rr.
UFF ICi o INTENDENZA A.S . ( B uERAT)
Direzione di Sanità
Colonnello medico Forti Igino - Direttore
1 magazzino spec sanità e veter di intendenza
r frazione di magazz. di sanità
13 ospedali da campo: 103", 104", 212•, 300•, 30 1•, 302•, 303• , 327", 8r 1°, 868•, 893°, 8ss·
2 ospedali militari di riserva
2 ospedali militari s uss idiari
I nucleo chirurgico (4°)
I ambulanza radiologica (47")
I sezio ne bonifica gassata (sa)
I sezione disinfezione (Ii')
I sezione autoambulanza (27'")
Direzione di Commissariato
Colonnello Commissario Ceccarell i Vito - Direttore
I magazzino specia le viveri e avena
1 magazzino speciale F.P.L.
I maga zz ino speciale V .E. ricuperi
3 frazioni magazz ino speciale V.A.F.P.L.
I sezione panettieri con forni W eiss
I sezione panettieri senza forni Weiss (I73"')
1 sezione sus sistenza di armata (99a)
Direzione Genio
Colonnello genio Poli Pietro - Direttore
2 reparti autonomi genio intendenza A.S.
I magazzino spec iale genio intendenza A.S.
I deposi to personale specializzato per l'impiego degli aereorifornitori
Direzio11e trasporti
Ten. colonnello genio tn s. S.M. Cittadini Gius epp e - Direttore
2 autogruppi di manovra (IV e V)
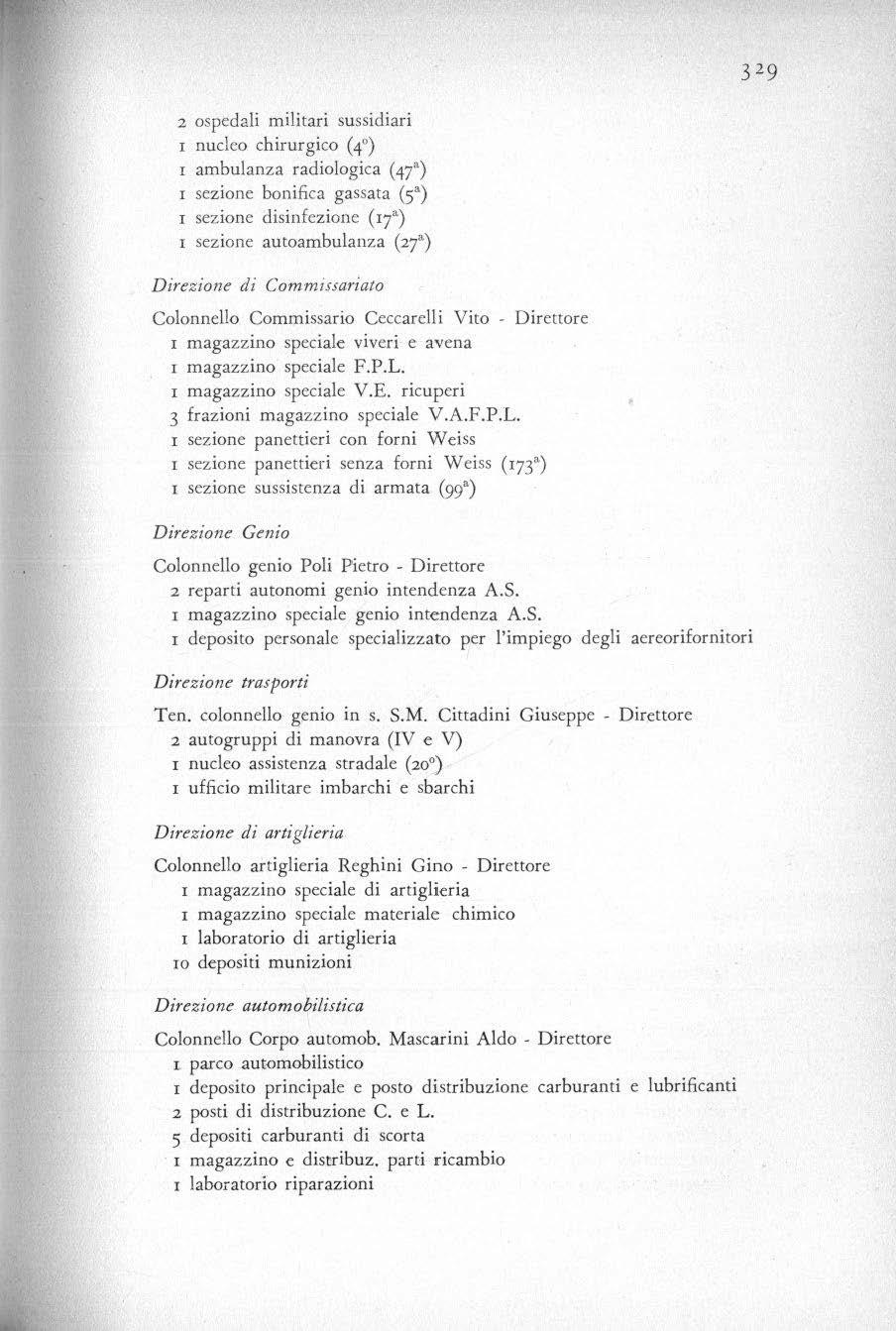
I nucleo assistenza stradale (2o0 )
I ufficio militare imbarchi e sbarchi
Direzione di artiglieria
Colonnello ar tig lieria Reghini Gino - Direttore
I magazzino speciale di artiglieria
I magazzino speciale materiale ch imico
I laboratorio di artiglieria
ro depositi munizioni
Direzione automobilistica
Colonnello Corpo automob. Mascarini Aldo - Direttore
L parco automobilistico
I d eposito principale e posto distribuzione carburami e lubri ficanti
2 posti di distribuzione C. e L.
5 depositi carburanti di scorta
I magazzino e distribuz. parti ricambio
I laboratorio riparazioni
Ten. colonnello ammfne Bagnani Umberto - Direttore
Maggiore Berardo Pietro - Direttore
6 comandi di tappa
5 centri raccolta materiale di ricupero
r campo concentramento prigionieri
Capitano De Agos tini Guglielmo - Direttore
XI concentramento
XII concentramento
14 uffici postali
Ufficio
Console Felici Guido - Capo ufficio
2 nuclei di polizia forestale
7 distaccamenti di polizia forestale ippica
Capitano i.g.s. Trotta Michele - Dtrettore
Savizio
54• reggimento T.M.
225• battaglione T.M.
226° battaglione T.M.
AUTORAGGRUPPAMENTO DEL COMANDO SUPERIORE
Colonnello Corpo automob. Nicolardi Tullio - Comandante Comando
VIII autogruppo:
24• autoreparto pesante
142° autoreparto pesante
143• autoreparto pesante
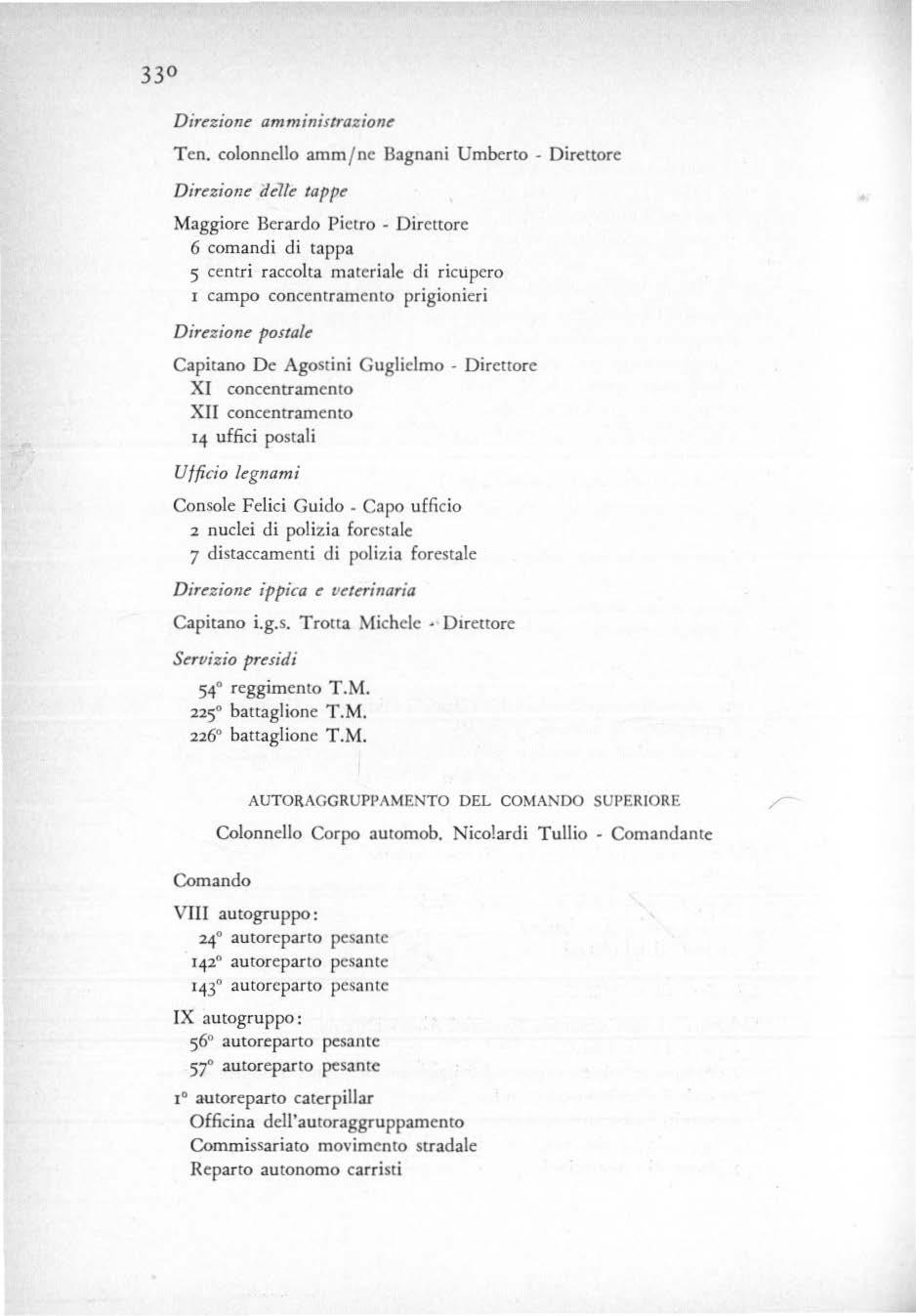
IXs6autogruppo:
· autoreparto pesante
57" autoreparto pesante
1° autoreparto caterpilJar
Officina dell'autoraggruppamento
Commissariato movim ento stradale
Reparto autonomo carr isti
Ge ne rale di divisione Baldassarre Ettore - Comandante
Stato maggiore
Quartier ge neral e : Reparto comando
70• sez ion e motor. cc.rr.
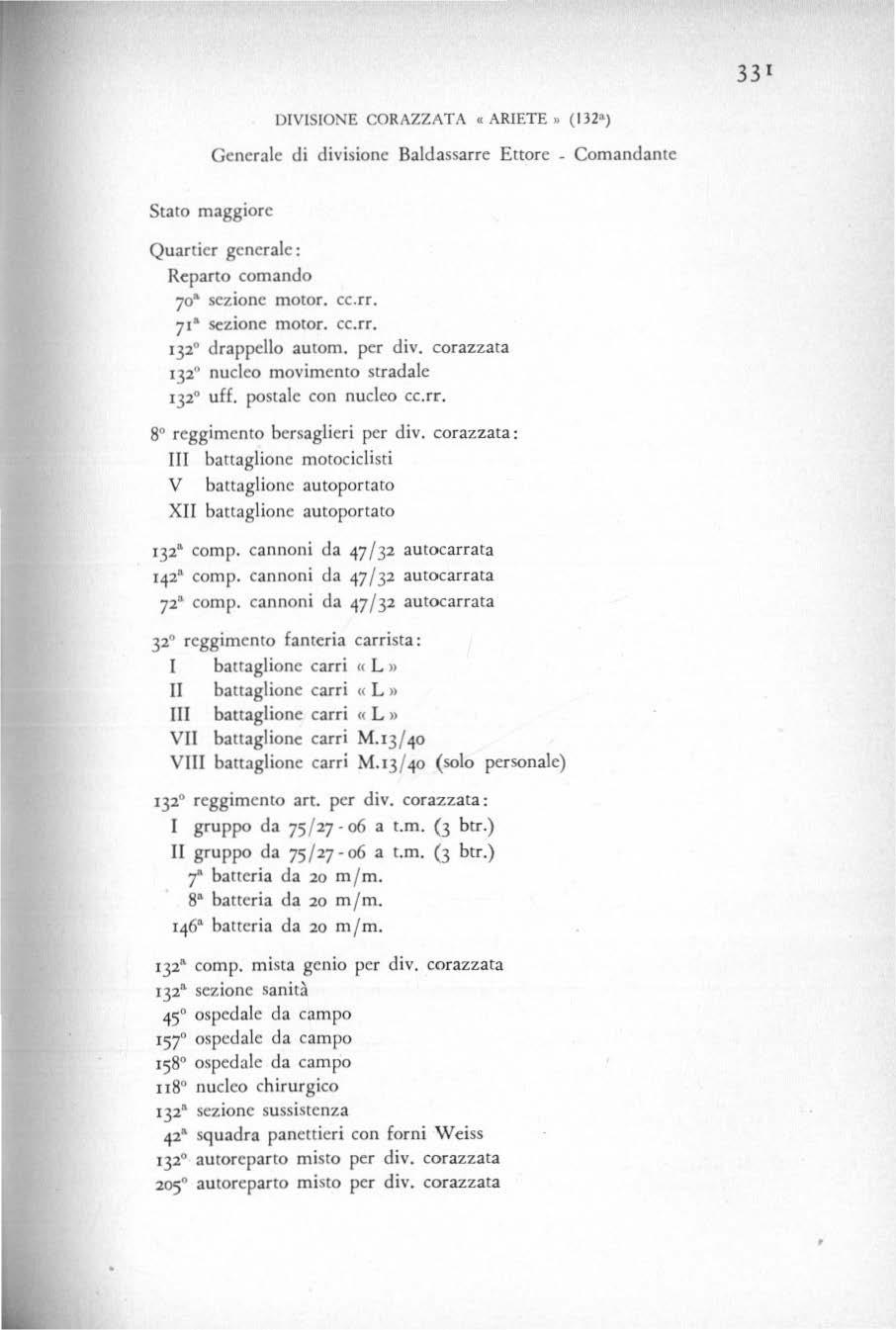
71 • sezione motor. cc.rr.
132• drapp ello autom. per div. corazzata
132n nucl eo movim e nto stradale
132• uff. postale con nucleo cc.rr
s· r eggimento bersaglieri per div . corazzata:
IIT battaglione motoc iclisti
V battaglione autoportato
XII battaglione autoportato
132" comp. cannoni da 47 /3 2 autocarrata
142" comp. cannoni da 47 /3 2 autocarrata
72" comp. c annoni da 47 {32 autocarrata
32" reggim e nto fanteria carrista:
I battaglione c arri cc L >>
Il battaglione carri cc L »
III battaglione c arri cc L >>
VII battaglione carri M. 13 / 40
VIII battaglione c arri M..r3 / 4o (solo personale)
132° reggim e nto art. pe r div. corazzata :
[ gruppo da 75 / 27 - o6 a t.m. (3 btr.)
[[ gruppo da 75 / 27 - o6 a t m. (3 btr.)
t batteria da 20 mf m.
s• batte ria da 20 mf m.
146" batteria da 20 mf m.
132" comp. mista genio per div. corazzata
132" sez ione sanità
45" ospedale da campo
157" ospeda le da campo
158" ospedale da campo
u8° nucleo chirurgico
132• se zion e suss istenza
42" squadra panettieri con forni Weiss
132" autoreparto misto per div. corazzata
205" autor e parto mi sto per div. corazzata
a) avuti da l X Corpo d'Armata:
ro pezzi da 37 l 54
I gr. da 105 l28 del 24° rgt . art. di C.d ' Ar. (3 btr.)

b) avuto dalla Divisione « Bologna » : I battaglione del 39° fanteria
Stato maggiore 1*1
Quartier gener ale 1*1 :
Reparto comando 1*1
r6o" sezione motor. cc.rr. 1*1
161" sezione motor. cc.rr. 1 * 1
109° ufficio posta le
109° ufficio postale nucl eo cc.rr.
102° drappello automobilistico per cdo dm .
102° nucleo movimento stradale
61° reggim ento fanteria motorizzato 1*1
62° reggimento fanteria motorizzato
t reggimento bersag lieri per div. motorizzata
DLI ba ttagl ione mitr. motorizzato
102" compagnia cannoni da 47 l 32 autoc. 1*1 m
104" co mpagnia cannoni da 47 l 32 autoc. 1*1
106" compagnia cannoni da 47 132 autoc. 1*1
46° regg im ento artigli eria dm.: /
I gruppo obici da 100f 17- 14 T. M. 1*1
II gruppo cannon i da 75l27- TI T.M.
III gru ppo cannoni da 75l27- II T .M.
2 batterie cannon i c.a. da 20 mlm.
LI battaglione mi sto per divisione motorizzata:
161" compagnia art. con parco autoc. compagnia telegrafisti con sez. fotoe legr. autoc.
96"' sezione marconisti per dm. 1 * 1
s6" sezione fotoel. autoc.
51" sezione san i tà per G .U. speciale: comando, perso nale di sa11ità e rep portaferiti drappello automobilistico
('itJ Elementi giunti al ro aprile.
OJ Temporaneamente assegnata alla Divisione «Brescia ».
51"' sezione sussistenza per G.U. speciale <*> • persona le di sussistenza drappello automobilistico
9° autorepar to misto pe r divisione motorizzata: comando con autofficina
ro2° nucleo socc. stradale
131"' autosezione mista
201"' autosezione leggera
202a autosezione leggera
71"' aurosez ione autocarrette
2"' sezione carburanti di autopes. ra sezione carburanti di mototricicli
E LE MENTI NON DI ASSEGNAZIONE ORGANICA.
Ospedali da campo per G.U speciali :
57" (l)
580 . •... {l)
509° .... .
9° nucleo chirurgico < 2 >

55 squadra panettieri con forni rotabili mod. W eiss
Comando
Tr u ppe c servizi di corpo d'armata
D ivisione di fante ria <<Pavia>> (r7'')
D ivisione di fanter i a « Bologna >> (25"')
D ivisione di fanteria « Brescia >> (27a)
COM ANDO DEL X CORPO D'ARMATA
Genera le d i corpo d'armata Barbieri A lber to - Comandan te
Stato maggiore
Comando artiglieria
Comando genio
Direzione san i tà
Direzio ne commissariaw
( '!!< ) Elem ent i gi unti al xo aprile
(l) Attualme n te asseg na ti alla J" Divisicne celere
(2) Attua lm e nte assegnato or ganicamen te all'Armata « Po »
68o• sez ion e motorizzata cc. rr.
681• sez ione motorizzata cc.rr.
TRUPPE E SERVIZI :
IV battaglione carri L. - alla Divisione cc Bologna >>
V battaglione carri L. - alla Divisione « Pavia >>
24" raggruppamento artiglieria:
I gr. da 105 { 28 (s u 3 b tr .) - alla Divisione cc Ariete >>
II gr. da 10) / 28 (su 3 btr.) - alla Di visione cc Pavia >>
III gr. da xoo{ 17 (su 3 btr.)

X ba ttaglione collegamenti:
89" compagnia trasmettitor i
10"' autoffi cina collegamenti
X ba ttaglio ne speci ale artieri
12 ospeda li da campo (66", 68", 6<f, 93°, 94°, 95"· 96", 221°, 529°, s8o", ll95",
ro• ambulanza radiologica
10• ambulanza odontoiatrica
2 nuclei chirurgici ( 45" e 35")
Sezione di sinfez ione (29•)
Sezione su ssistenza (74•)
Sezio ne panettieri ( x8 ") :
34a squadra panettieri
71 " squadra panet ti e ri
a) avuti dal Comando Superiore:
XXXVI battaglione libi co
XVIII battaglion e libico
b) avuto dal Comando Superiore art.:
x6" raggrupp. art. di c.d'a.:
XLIV gr. da 105/28 (3 btr.)
XLIX gr. da 105 /2 8 (3 btr.)
XV gr. da I0) /28 - alla Divisione « Bresc ia >>
c) avuto dalla Divis ione cc Savo na » :
r6• rgt. fante ria (2 btg.):
I battaglione
lfi battaglione
comp. mortai da 81
t!) avuto dal distaccamento Divisione « Sabratha >>:
I gr. da xoo/17 (3 btr.) del 10° rgt. art
e) avuti da l 2° rgt . art. c.a. :
XIV gr. da 75/48 Skoda (2 btr.)
XLIII gr. da 75 / 48 Skoda (2 btr.) - alla Divisione u Pavia >>
f) amta dal Comando superiore genio:
124" comp. marconisti
DIVISIONE FANTERIA « PAVIA , ( t7 a)
Generale di brigata Zaglio Pietro - Comandante
Stato maggiore
Quartier generale:
Sezione mista cc.rr. (74a)
Ufficio postale con nucleo cc.rr. (54")
27° reggimento fanteria Ul :
T battaglione
II battaglione (meno cp. a.a.), al XX C.d'A. (cinta fortificata)
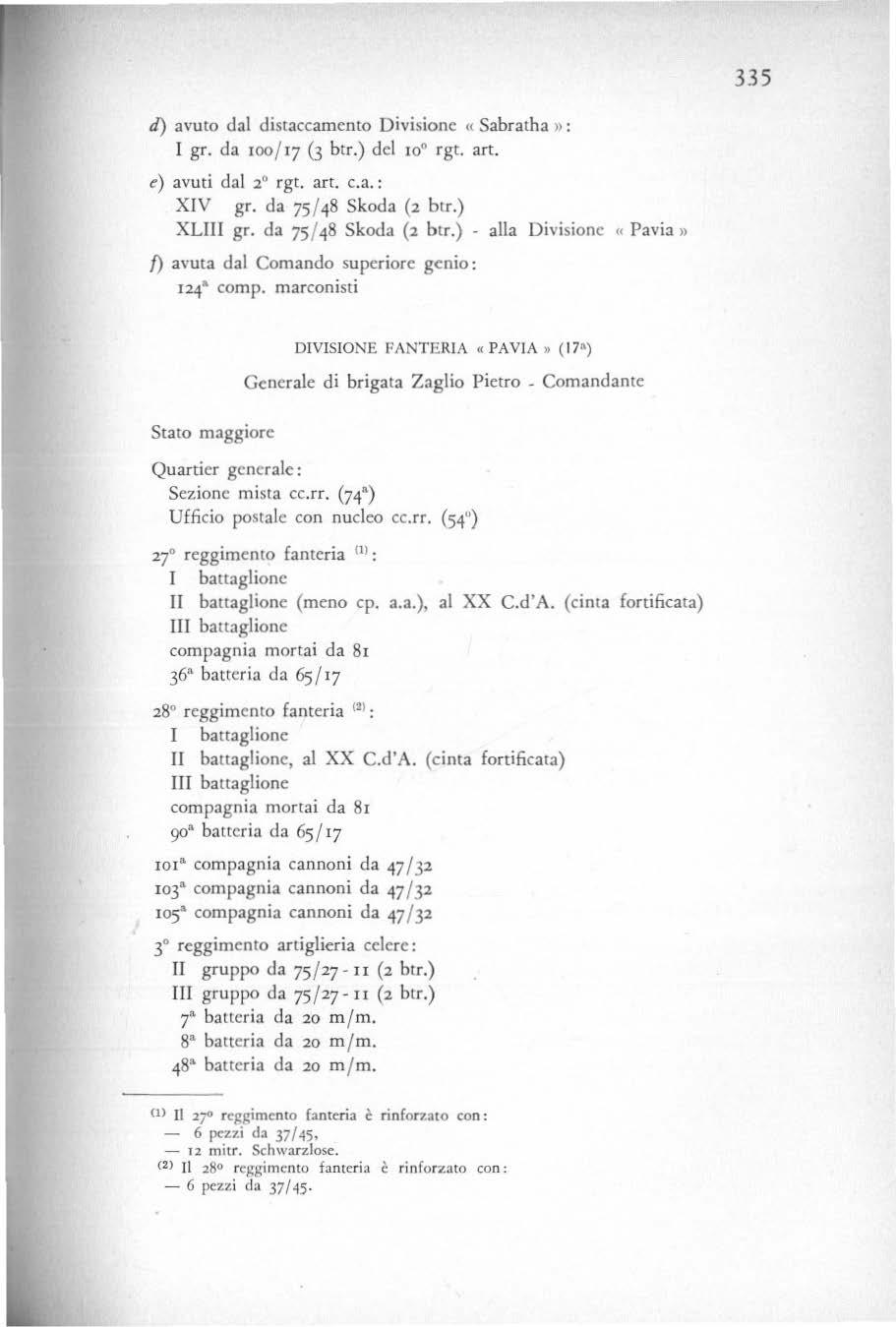
III battaglione
compagnia mortai da 8r
36" batteria da 6s / 17
28° reggim ento fanteria 12>:
I battaglione
II battaglione, al XX C. d'A. (cinta fortificata)
III battaglione
compagnia morrai da 81
90" batter ia da 65/17
ror " compagnia cannoni da 47 /32
103" compagnia cannoni da 47 (32
105'" compagnia cannoni da 47/32
3° reggimento artiglieria celere:
II gruppo da 75/27- II (2 btr.)
III gruppo da 75/27-11 (2 btr.)
i"' batteria da 20 mfm .
8"' batteria da 20 mfm.
48" batteria da 20 mfm .
Ul Il 2'1' rej!gimenro fanteria è rinfonato con:
-6 pezzi da 37/45,
- 12 mitr. Schwarzlose.
C2l Il 28o reggimento fanteria è rinfo rzato con:
- 6 pezz i da 37/45·
Battaglione complementi (XVII) - al XX C.d'A. (cinta forùfìcata)

Battaglione genio (XVII)
Sezione sanità (21 3 )
Sezione sussistenza (3")
Autosezion e mista (207")
ELEMEN TI DI RINFORZO :
a) avuti dal Comando X Corpo d'Armata:
V battaglione carri « L »
II gr. da 105/28 (3 btr ) del 24° raggr art.
XLII gr. da 75/48 Skoda (2 btr.)
b) avuto dal Comando Superiore artiglieria:
2° reggimento artiglieria celere:
I gr. da 75/27-It (2 btr.)
II gr. da 75/27- II (2 btr.)
III gr. da 10ojr7 (3 btr.)
7" btr da 20 mf m.
8• btr. da 20 mfm .
ELEMENTI DIFESA COSTIERA :
n• btr. da 75/27 da posizione
68" btr. da 75/27 da posizione (meno r sez. a Buerat)
9• comp. mitr. da posiz. (meno 1 pl. a Buerat)
DIVIS IONE DI FANTERIA « DOLOGNA » Generale di div. Marchinotti Mario - Comandante
Stato maggiore
Quartier generale:
Sezione mista cc .rr. (73")
Ufficio posta le con nucleo cc.rr. (58°)
39° reggim ento fanter ia !ll :
l battaglione, alla Divisione « Ariete >>
Il battaglione (meno cp. a.a.), al XX Corpo d'Armata (cinta fortificata)
III battaglione
Compagnia mortai da 8r
29" batteria da 6s/I7
O l Il 39o reggimento fanteria ha in rin fo rzo:
- 6 mjrragliatrici Schwarzlose,
- 8 pezzi da 37 l 45,
' 5 mitr. Hotchiss,
- 2 pezz i da 65/17.
40" reggimento fanteria 111 : battaglione (meno cp. a.a.), al XX Corpo d'Armata (cinta fortificata)

II battaglione
m battaglione
Compagnia mortai da Sr
91a batteria da 6) l 17
20" compagnia cannoni da 47 l32
44 3 compagnia can noni da 47 l 32
73a compagnia cannoni da 47 l 32
205° reggimento artiglieria:
l gruppo da 75 l 27-o6
II gruppo da 75 l 27- o6
III gruppo da 75 l 27- 11
4" batteria da 20 ml m.
17" batteria da 20 mlm.
30" batteria da 20 m l m.
Battaglione complementi (XXV), al XX Corpo d'Armata
Battaglione genio (XXV)
Sezione san ità (24•)
Sezione sussistenza ( rt)
Autosezione mista ( r35•)
a) avuto dal X Corpo d'A rma ta: IV battagl ione carri cc L »
DIVISIONE FA:>:TERIA «BRESCIA» (2 7&)
Gener ale di divisione Za m bon Bartolo - Comandante
Stato maggiore
Quartier generale:
127 sezion e mi sta cc.rr
96" uff. postale con nucleo cc.rr.
Ul Il 40" ha in rin forzo:
- 36 mitragliatrici Schwarxlosc, 8 pezzi da 37/45,
- I cannone da 4ì /3 1.
19" reggimento fanteria !Il ·
I battaglione
II battaglione
III battaglione (meno cp. a. a.), al XX Corpo d'Arma ta (cinta fortificata)

Compagnia mortai da 8r
34" btr. da 65l 17 « Livorno >>
20" reggimento fanteria Ol :
I battaglione
II battaglione (meno cp. a.a.), al XX Corpo d'Arma ta
III battaglione
Compagnia mortai da 8r
38" btr. da 65 l 17 « Ravenna >>
5" compagnia cannoni da 47/32
71 a compagnia cannoni da 47 l 32
227" com pagnia ca nnoni da 47 l3 2 (in approntamento)
1 ° reggimento artiglieria celere:
I gruppo da 75 l 27- II (2 btr.)
II gruppo da 75 l 27 - II (2 btr.)
7.. batteria da 20 m l m.
8" batteria da 20 ml m.
502" batteria da 20 m l m.
Battaglione complementi (XXVII), al XX Corpo d'Arma ta (cinta fortificata)
Sezione sanità (34")
Sezione sussistenza (34")
Autosezione mista (328")
ELEMENTI DI RINFORZO :
a) avuto dal X Corpo d'Armata:
XV gruppo da Jo5 l 28 del r6" rgt artiglieria (3 brr.)
b) temporaneamente: 102" cp. da 47 l 32 della Divisione « Trento >>
Comando Trup pe e servizi
- Settore Carian - Nalut
Divisione di ftr . « Savona >> (55")
Settore di copertura di Nalut
Settore di copertura della Chibla
O> l reggi menti di fanteria so no rinfo rza ti da:
- 3 plo toni da 37/45,
2 p lotoni mtr. Schwarzlose
XX CORPO D'ARMATAII - Settore Zuara
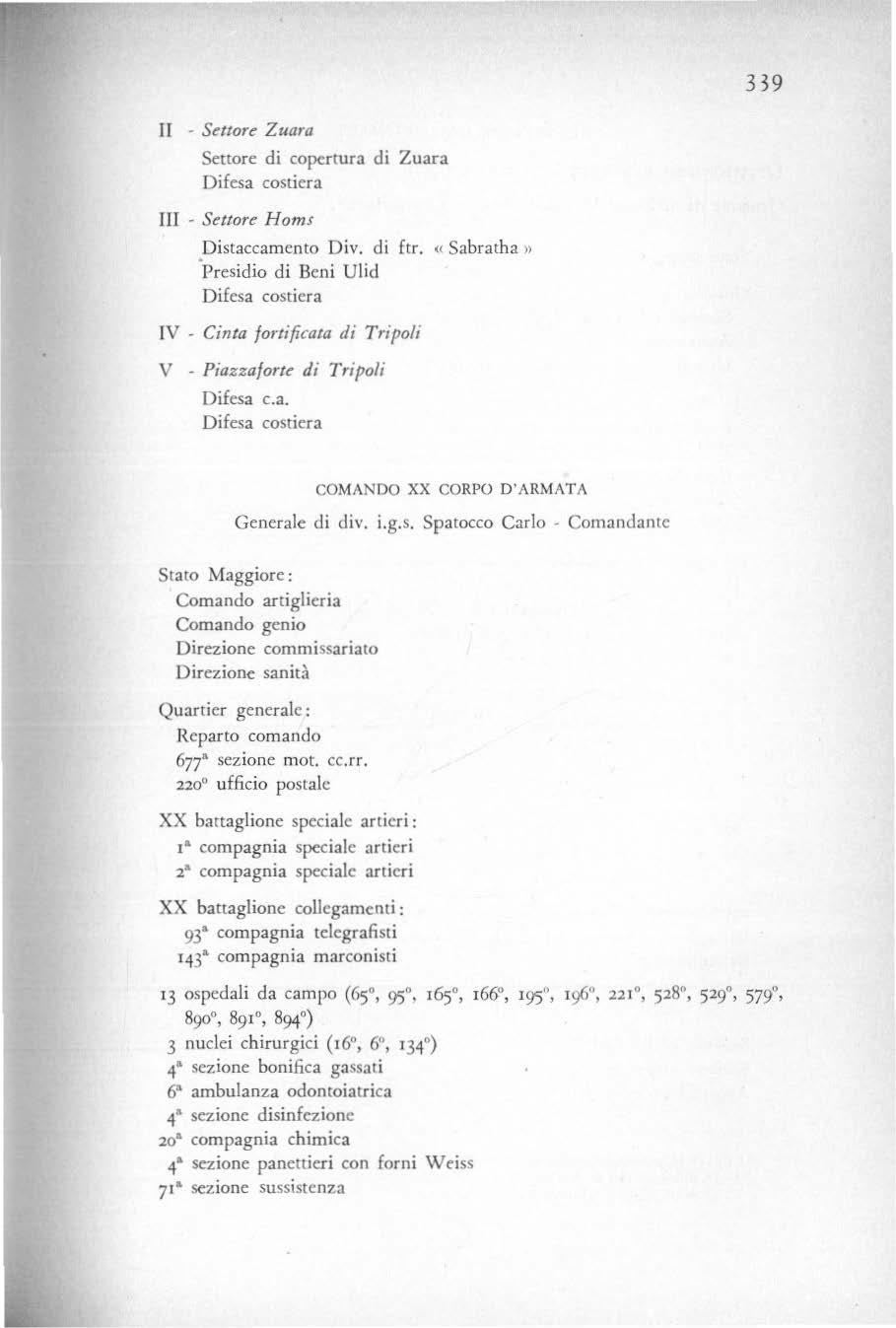
Settore di copertura di Zuara
Difesa costiera
III - Settore Homs
Distaccamento Div. di ftr. « Sabratha »
Presidio di Beni Ulid
Difesa costiera
IV - Cinta fot"tificata di Tripoli
V - Piazzaforte di Tripoli
Difesa c.a.
Di fesa costiera
Generale di div.
Stato Maggiore: Comando artiglieria Comando genio Direzione commissariato Direzione sanità
Quartier generale:
Reparto comando
677• sez ione mo t. cc rr
22o0 ufficio postale
XX ba ttaglione speciale artieri:
r• compagnia speciale artieri
2• compagnia speciale artieri
XX battaglione collegamenti :
93• compagnia tdegrafisti
143" compagnia marconisti
Comandante
13 ospedali da campo (65•, 95•. 165", 166", 195", 1g6", 221•, 528°, 529", 579•, 890•, 891", 894•)
3 nuclei chirurgici ( 16•, 6°, r34 ")
4" sezione bonifica gassati
6n ambulanza odontoiatrica
4" sezione disinfezione
20• compagnia chimica
4" sezione panettieri con forni Weiss
71" sezione sussistenza
COMANDO XX CORPO D'ARMATA i.g. s. Spatocco Carlo -D i visiONE 01 FANTERIA « SAvoNA » c55·)
Generale di divisione Maggiani Pietro - Comandante
Stato maggiore
Quartier generale:
Sezione mista cc.rr. (75•)
Autodrappello (55°)
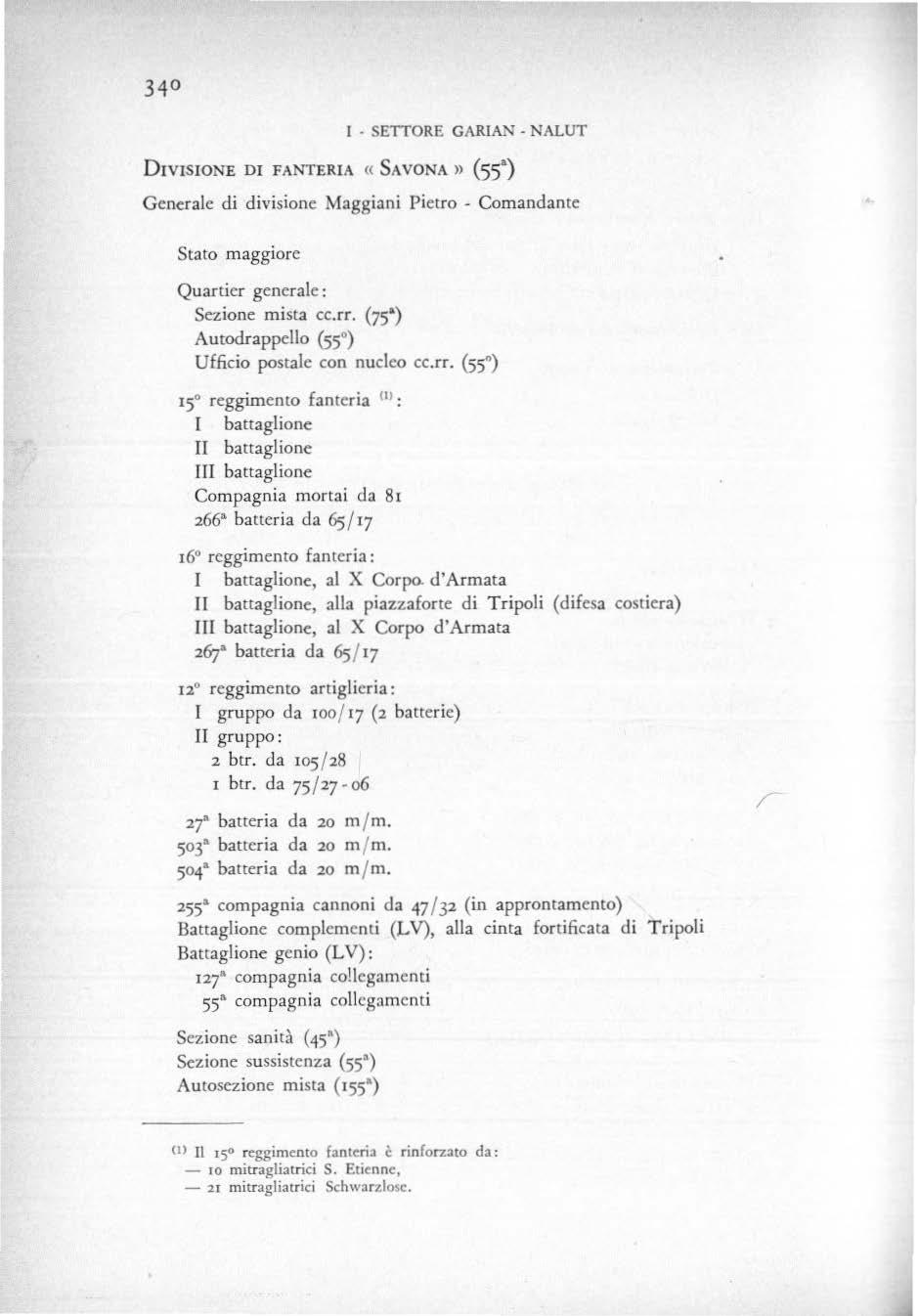
Ufficio postale con nucleo cc.rr. (55°)
15° reggimento fanteria n•:
I battaglione
II battaglione
III battaglione
Compagnia mortai da 81
266a batteria da 6s l 17
16° reggimento fanteria :
I battaglione, al X Corpo. d'Armata
II battaglione, alla piazzaforte di Tr ipoli (difesa costiera)
m battaglione, al x Corpo d'Armata
26]• batteria da 6s l 17
12.0 reggimento artiglieria:
I gruppo da roo l 17 (2 batterie)
II gruppo:
2 btr. da 105l28
I btr. da 75l27-o6
27• batteria da 20 mlm.
503• batteria da 20 m l m.
504• batteria da 20 ml m.
255• compagnia cannoni da 47/32 (in approntam ento)
Battaglione complementi (LV), alla cinta fonificata di T ripoli
Battaglione genio (LV):
12t compagnia collegamenti
55" compagnia collegamenti
Sezione sanità (45")
Sezione sussistenza (55•)
Autosezione mista ( 155•)
(l) n •5° reggimento fanteria è rinforzato da:
G.a.F. - fanteria: uomini 1.000 circa
290° raggruppam ento art.:
CCXCI gruppo da 77 / 28 (2 btr.)
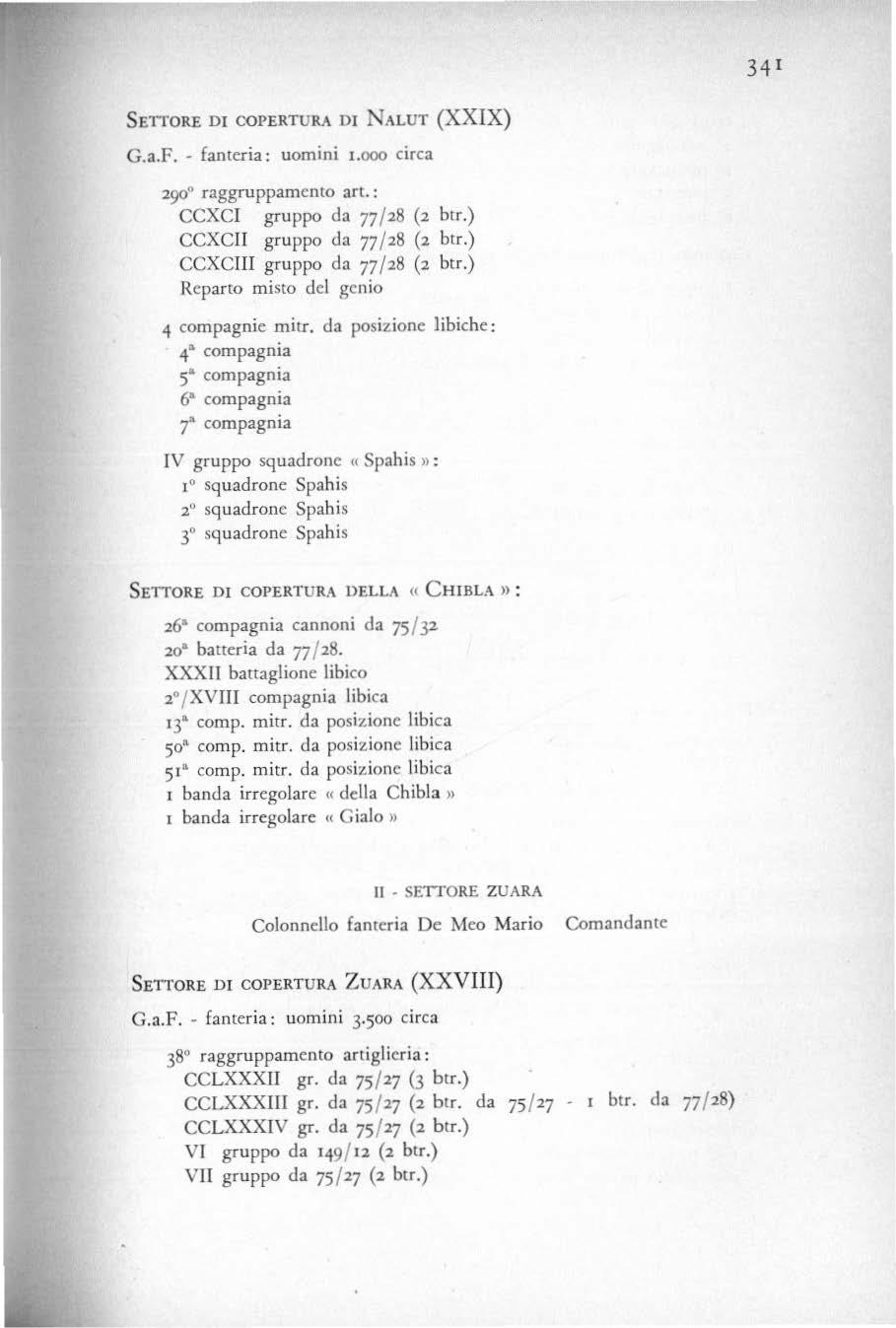
CCXCII gruppo da 77 / 28 (2 btr.)
CCXCIII gruppo da 77/28 (2 btr.)
Reparto misto del genio
4 compagnie mitr. da posizione libiche:
4.. compagnia
s · compagnia
6• compagnia
t compagnia
IV gruppo squadrone « Spahis >> :
1 ° squadrone Spahis
2 ° squadrone Spahis
3° squadrone Spahis
SETTORE DI COPERTURA DELLA (( CHIBLA )) :
26• compagnia cannoni da 75 /32
20• batteria da 77 / 28.
XXXII battaglione libi co
2°J XVIII compagnia libica
13" comp. mitr. da posizione libica
so" comp. mitr. da posizione libi ca
sr a com p. mitr. da posizione l ibica
1 banda irregolare '' della Chibla »
r banda irregolare '' G ial o »
Colonnello fanteria De Meo Mario Comandante
SETTORE m coPERTURA ZuARA (XXV III)
G.a.F. - fanter ia: uomini 3.500 circa
38° raggruppamento artiglieria:
CCLXXXII gr. da 75 / 27 (3 btr.)
CCLXXXIII gr. da 75 / 27 (2 btr. da 75 / 27 · 1 btr. da 77 / 28)
CCLXXXTV gr. da 75 / 27 (2 brr.)
VI gruppo da 149 / 12 (2 btr.)
VII gruppo da 75 / 27 (2 btr.)
4 compagnie mitr. da posizione libiche:
1" compagnia
2" compagnia
3" compagnia
8" compagn ia
Comando raggruppamento cavalleria libica
I gruppo squadroni Spahis:
1° squadrone Spahis
2° squadrone Spahis
3° squadrone Spahis, al sottosettore costiero Zavia
4° squadrone Spah is
II gruppo squadroni Savari:
1
° squadrone Savari
5° squadrone Savari
6° squadrone Savari
7° squadrone Savari
III gruppo squadroni Spahis:
1° squadrone Spahis
2° squadrone Spahis
3° sq u adrone Spahis
3" compagni a automitragliatrici
D IFESA COSTIERA.
Sottosettore costiero Zuara
XXX battaglione costiero CCLXXXI gr. da 77/28 (2 btr.)
S ottosettore costiero Zavia
II battaglione 20° fa n ter ia, avuto dalla Divisione « Bresc ia)) r compagnia prcsidiaria (de ll '86° ftr.)

I squadrone cava ll eria l ibica (3°), avuto dal Com. raggr. cav. cccxxxr gruppo da 77/28 (2 b tr .)
III - SETTORE HOMS
Generale di div . Della Bona Gu ido - Comandante
D IS TACCAMENTO DI VISIONE (( SAB RATHA))
Stato maggiore
Quartier generale :
ro6" sezione mista cc.rr.
26o0 ufficio posta le
Reggimento fanteria di formazione cc Sabratha >> :
I btg. 85• frr. e 85" cp. mortai da 8r
I btg. 86" flr. c 86' cp. mortai da 8r
257" batteria da 6; l 17
264• batteria da 6; 1'7
XV[{ battaglione mitraglieri << Pavia >>
XXV battaglione mitraglieri cc Bologna >l
LX battaglione mitraglieri << Sabratha »
200• compagnia cannoni da 47 l 32
117" compagnia cannoni da 47 l 32
Elementi ro• r eggimento bersaglieri
Elementi comp. bersaglieri mot.
Elementi 202" comp. bersaglieri mot.
Raggruppamento artiglieria
I gr. da posiz. da IOolr7 del 14° raggr. art. G.a.F. (2 btr.)
12"' btr. da 75/27 del 20° reggimento artiglieria
6"' btr. da 75/27 del Il gr. 26° art. cc Pavia >>
I gr. da roo/17 del ro• rgt. art., al X Corpo d'Arm ata
LX battaglione genio:
1263 compagnia speciale artieri
6o" compagnia collegamenti
r;t>• sez ione fotoc!ettricisti
103° ospedale da ca mpo
20" se-tione sussistenza
ro;• autose-t.ione mista

PREsiDIO nr BENI Uun
XXX V battaglione libico
1 sezione cc.rr. motorizzata
DIFESA COSTIERA.
costiero Homs
Il gr. del 26° artiglieria
4"' batteria da 75/27
5a batteria da 75l27
66" bntteria cla 77/28
r comp del V btg. cc.nn. (3")
CII gruppo arr. costiera
6t btr. da 75 l 27
63' btr. da 77 l 28
II " comp. mitr. da posiz. libica
2" comp. mitraglieri complementi
Sottouttore costiero Misurata
XXV battaglione complementi
70• compagnia presidiaria avuto dalla Divis ione cc Bologna>>
VII gr del XXXV raggrupp. art. G.a F.:
ssa batteria da 77 l 28
59.. batteria da 77 l 28
6ra batteria da 77 l28
65• batteria da 75 ' 27- o6
SETTORE COSTIERO OVEST
XXXIII settore G.a.F. (Zanzur):
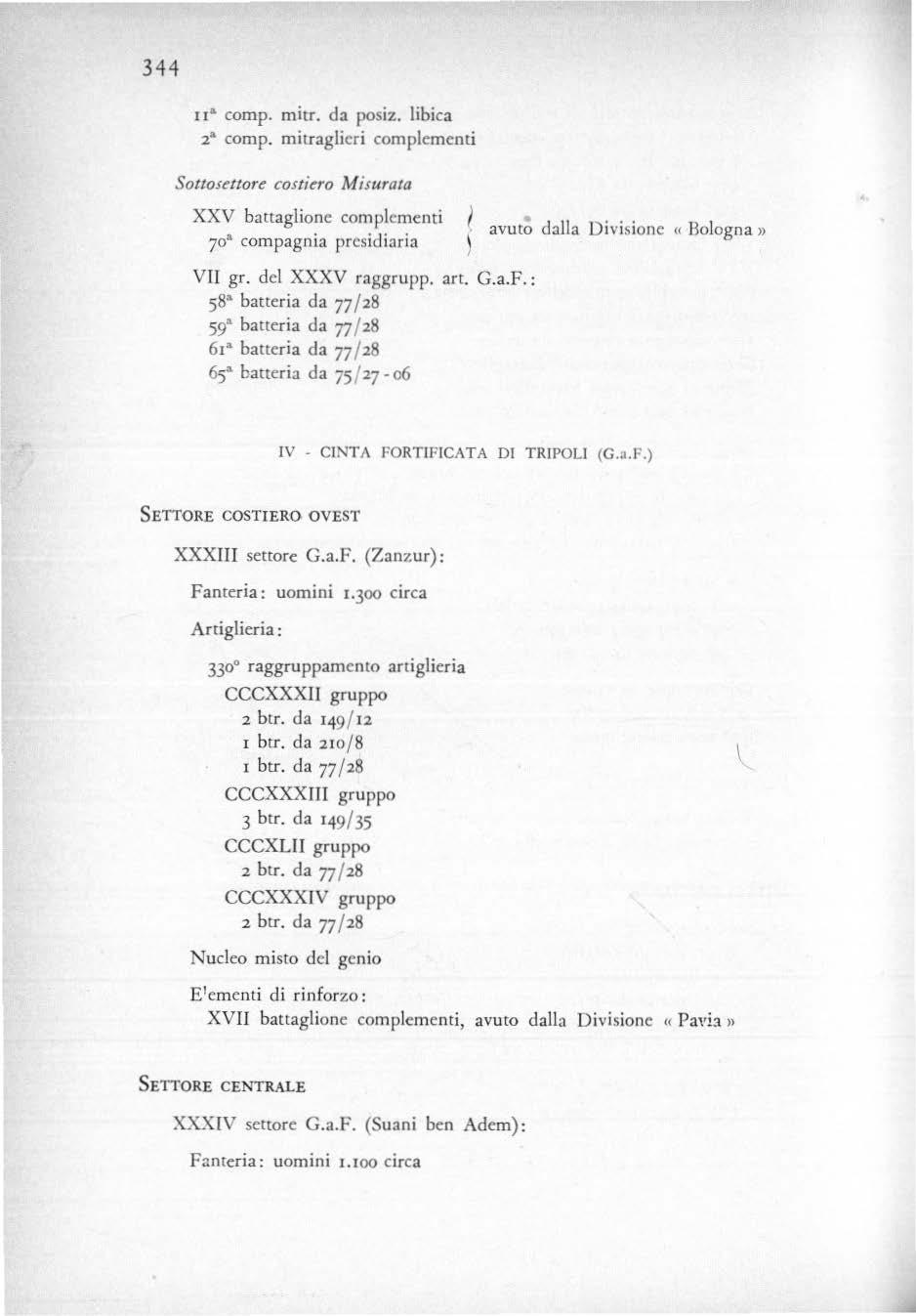
Fanteria: uomini 1.300 circa
Artjglieria:
330° raggruppamento artiglieria
CCCXXXII gruppo
2 btr. da 149/ 12
r btr. da 21ol8
r btr da 77 l28
CCCXXXIJI gruppo
3 btr. da 149135
CCCXLII gruppo
2 btr. da 77 l28
CCCXXX I V gruppo
2 btr. da 77 l 28
Nucleo misto del genio
E 1cmcnti di rinforzo:
XVII battaglione comp lementi, avuto dalla Divisione cc Pavia>>
SETTORE CENTRALE
XX..XIV settore G.a.F. (S uani ben Adem):
Fanreria: uomini I.Ioocirca
Artiglieria:
340° raggrupp. artiglieria:
CCCXXXV gruppo
3 btr. da 149l 12
CCCXLIII gruppo
2 btr. da 77 l 28
CCCXLIV gruppo
3 btr. da 77 / 28
V gruppo da 105 l 28
2 btr.
Elementi di rinforzo:
XXVII battaglione compi. - avu to dalla Division e « Bresc ia >>
II battaglione del 28° ftr. - avu to dalla Division e «Pav ia »
XXXV settore G.a.F. (Castel Be nito):

Fanteria: uomini x.ooo circa
Artigli eria:
350° raggrupp. artiglie ria
I gruppo
2 batterie da xzo l 25
1 batteria da 100l 17
CCCLI gruppo
2 batterie da 77 l 28
CCCXLI gruppo
2 batterie da 149/3 5
CCCXLV gruppo
2 batterie da 120l 25
Elementi di rinforzo :
II btg. del 27° ftr., avuto dalla Divisione << Pavia >>
LX battaglione co m plementi, avuto dalla Divds ione << Savona »
Il battaglione del 39° ftr., avuto dalla Divisione « Bologna »
III battaglione del 19° ftr., avuco dalla Divisione « Brescia »
IV gruppo squadr. mitr. «Genova»
Gruppo artiglieria di forma z ione:
2 batterie da 120 l 25
1 batteria da 149l35
! scz. della s8" btr. da 100117
I battaglione del 40° ftr , avuto dalla Divisione (( Bologna >>
VI gruppo squadr. mitr. ((Aosta» Comando 5° raggrupp artiglieria di Armata
XX gruppo
3 batterie da 149 135
XXI gruppo
3 batterie da 149l35
VII gruppo del 35° raggrupp. art. G.a.F.
2 batterie da 77l28
r batteria da 149l 12
CCCLII gruppo artiglieria G.a.F.
2 batterie da 77 j28
V • PIAZZAFORTE DI TRIPOLJ
Generale di div Quarra Sito Edoardo - Comandante
a) Difesa c.a.
30° raggruppamento art. costiera e c.a.
C gruppo costiero e c.a .:
3 btr. da 76 l 40 · c a. c costiere
I btr. da 77 l28 ·c a
CI gruppo da posizione: '\
3 btr. da 77 l 28 · c.a.
I btr. da 76 l 40 - c.a. e costiera
I gruppo c.a. da posiz. (M.V.S.N .):
2 btr. da 76l4o- c.a.
2 btr da 76 l 45 - c a.

I gruppo artiglieria (( Milmart » :
3 btr. da 102 l35 - c.a e costiere
XVII gruppo c.a . :
3 btr. da 88l56 - c.a
XXIX gruppo c.a.:
3 btr. da 88 / 56 - c.a.
b) Difesa costiera
II battaglione del 16" fanteria, avuto dalla Divisione << Savona ''
Battaglione complementi piazzaforte
I battaglione costiero cc.nn.
V battaglione ec.nn A.S.
VI battaglione cc.nn. A.S.
l battaglione cc.nn.
roa compagnia mitr. da posiz. libica
12" compagnia mirr. da posiz. l ibica
2 batterie da 190/39: (dd C gruppo)
XIX gruppo: 3 batterie da r49/35
XXII gruppo: 3 batterie da 149/35
\'1
Co!onnello ftr. Piatti dal Pozzo Umberto - Comandante
S ETTORE Ho:-:
XXXV II battaglione libico
21" com p. cannoni da 47 / 32
58" comp. mitr da posiz. libica
6r" comp. m i tr. da pos iz . l ib ica
4" comp . sa h ar iana ( i n approntamento)
5" comp. sa h ariana ( in appro n tam ento)
838" batteria da 77/28 (G.a .F .)
Reparto autonomo m i tr. da 20 mfm.
Gruppo ir regolare << Giofra >>
Compagnia mista del genio
6 apparecchi Ghibli
7 apparecchi Cr. 42
T apparecchio Ca 133
 · SAHARA LIBICO
· SAHARA LIBICO
Brak
ss· comp. mitr. da posizione libica
828• batteria da 77 / 28 (G.a.F.)
6 apparecchi S.8x
2 apparecchi Ghibli
SETTORE UBARI- SERDELES- GHAT
V bari
54• comp. mitr. da posizione libica
I plotone della x• comp meharisti
Serdeles
52' comp. da posizione libica
2' comp mehari sti << dello Sciati »
Ghat
53• comp. mitr. da posizione libica
I comp. mchari sti << del Fezzan »
1 gruppo cammellato Tua regh
SETTORE M u RZUK
;\1urzuk
57• comp. mitr. da posizione libica
2 • compagnia sahariana
829• btr. da 77 / 28 (G .a.F.)
compagnia meharisti << della Chibla »

Sebha
56 comp. mitr. da posizione libica
3• compagnia sahariana
84o• batteria da 77 / 28 (G.a.F.)
3 apparecchi Ghibli
Zelia
t • compagnia sahariana
4• comp. del XVlll btg. libico
Tagrifet
1 plotone mitr. della 59" cp.
1 batteria da 71 / 27
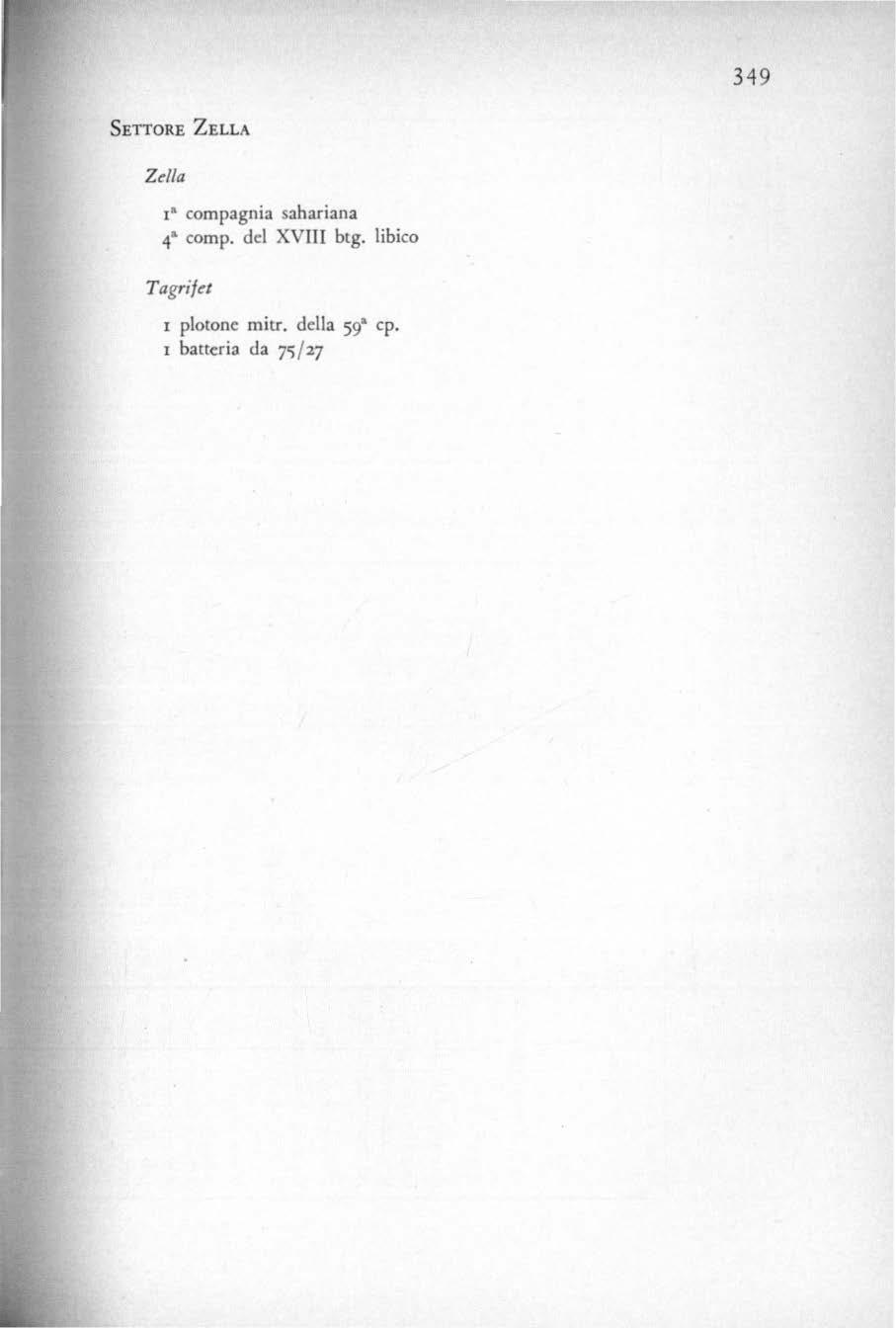
SEZ IONE OPERA Z ION I I NFORMAZION1 SERVIZI ORDINE DI BATIAGLIA DELLA DIVISIONE ALLA DATA DEL l• APR I

VII brg. carri M: 3 cp. c. M. , r cp. comando .
Br r . anticarro 37/45: 4 scz. (2 su 3 pezz i, 2 su 2 pet:zi) .
1 ]2° Reparto comando rgt.
I gr. 75/27: 3 btr. s u 4 pezzi da 75/27-1)06.
n gr. 75/27: 3 btr. su 4 pezzi da 75 / 27 -1)06 o
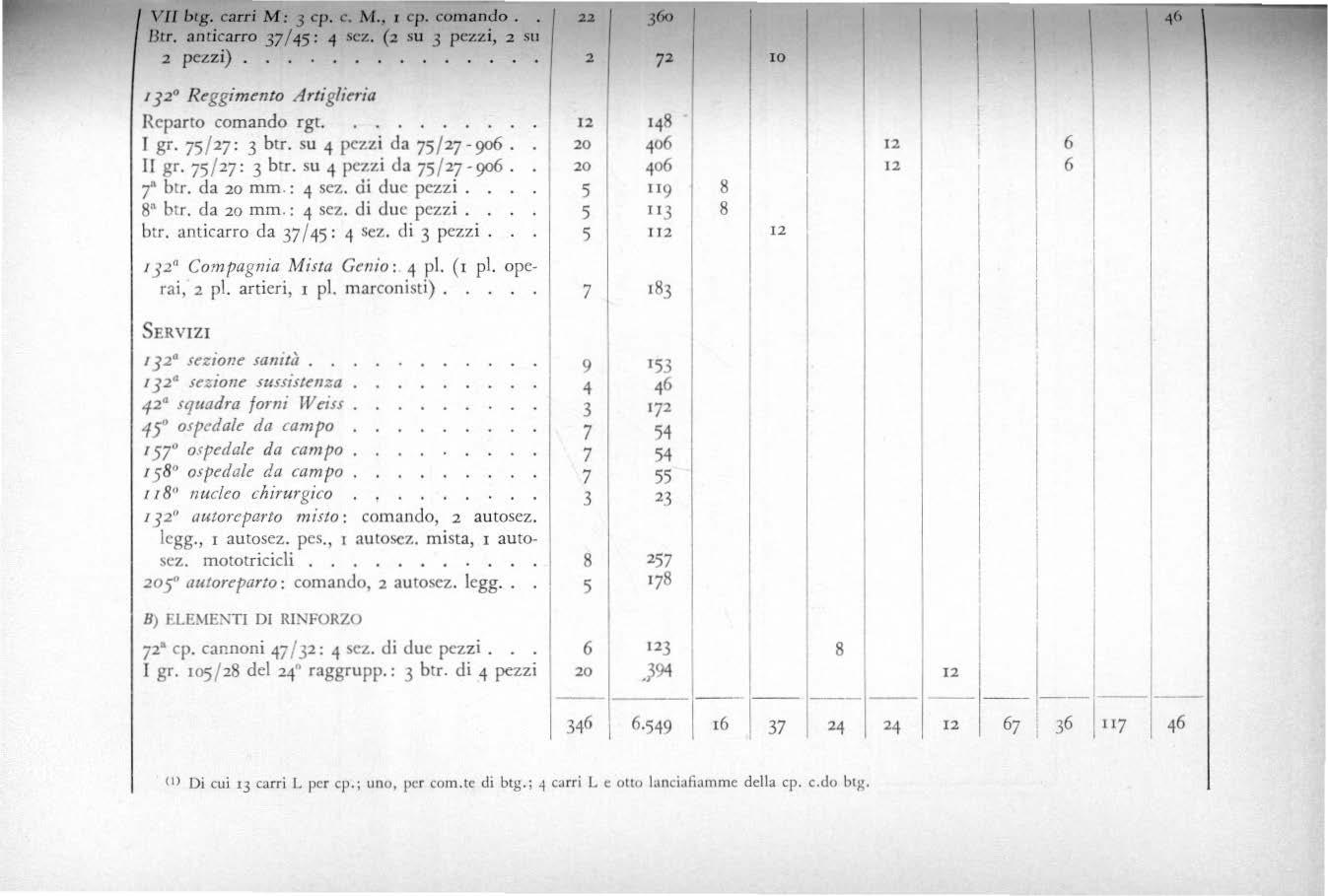
7n btr. da 20 mm.: 4 sez. òi due pezzi .
8a btr. da 20 mm.: 4 sez. di due pezzi .
btr. anticarro da 37/45 : 4 sez. di 3 pezzi .
rp" Compagnia Mista Genio : 4 pl. (r pl. operai, 2 pl. artieri, I pl. marconisti) .
SERVIZI
1 32" sanità .
13 2 4 .
42• squadra fomi IVass .
45" ospedale da campo
t 57" oJpedale da campo
158" ospedale da campo
11 8" nucleo chirurgico
1 32" autoreparto misto: comando, 2 au tosez. lcgg., I autosez. pes., 1 auto:.cz. mista, 1 a utomototricicli
205'' auioreparto: comando, 2 autosez . legg..
72• cp. cannoni 47 / 32: 4 se.l. di due pezzi .
l gr. Io5 / 28 del 24" raggrupp.: 3 btr. di 4 pezzi
Q.G. Tru ppe c servizi Comando Superiore FF. 1
m Compresa la G.a. F.
m Emi territoriali merropolitani c l ibici - gruppi CC .RR Tripo l i e Misurata • Distaccamenti
(3) Compresi organi e stabilimenti d'intendenza. Divisione corazzata « Ariete » e Divisione <•> Di cui 1.135 a\ini.
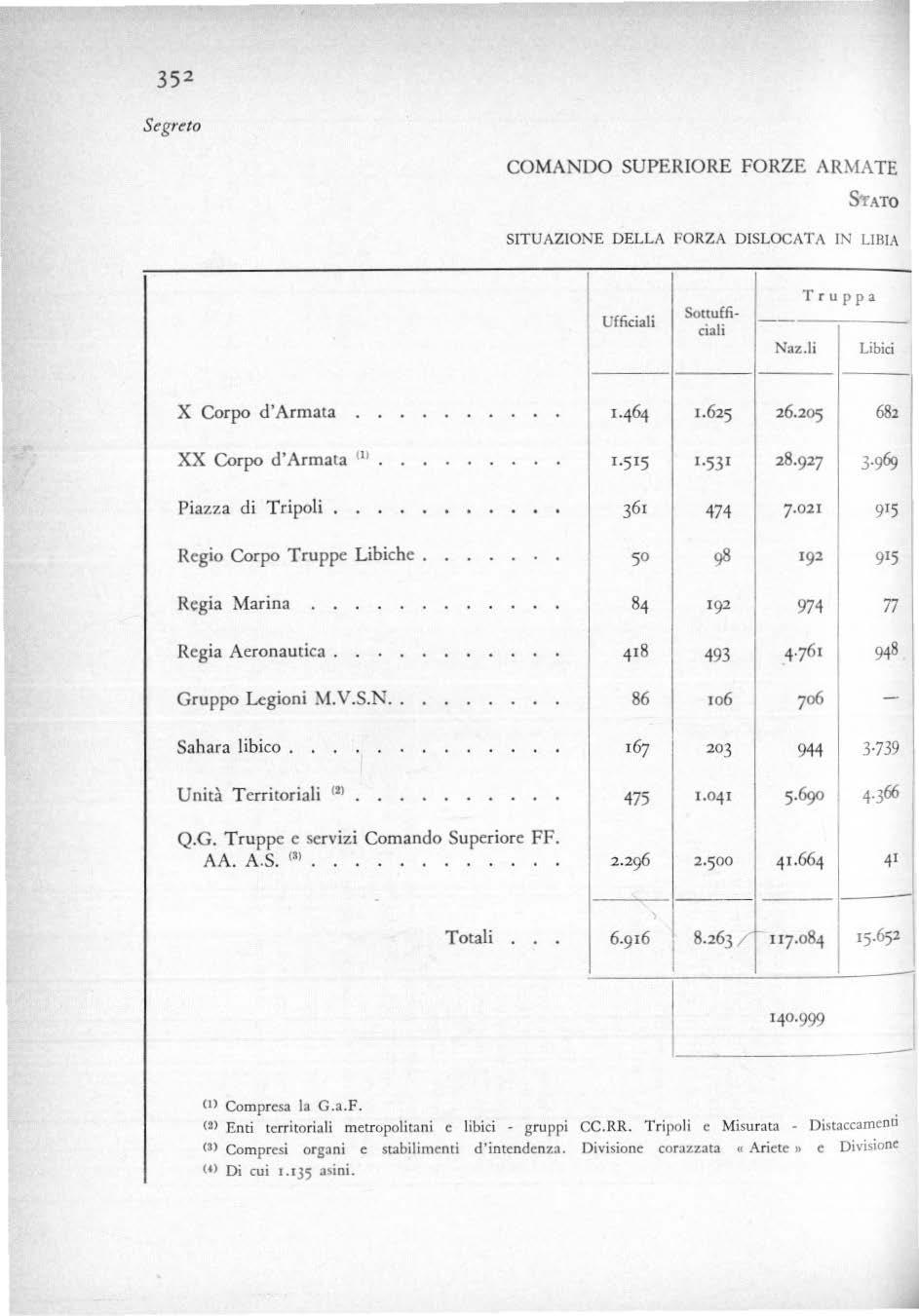


2 Sq. a Misura ta, I a Sorman
1 Sq. a Hon, 1 a Tauorga, 1 a T amet
2 Sq. a Sorman, 1 a Mel!aha
di cui : 2 cff. volo; 2 a disposiz. CAT; 2, Zuara; r, Sirte per coli. In oltre il I 0 Gr. APC ha eff volo: I Borea, 1 Ca.wo, 2 Ca.164. l12° Gr. APC, dci Ghibli 1 è sanit. c 2 Ca.133 eff. volo. Il btg . Sahar ha 1 Ca.133 efficienrc

Allegato n. 14.
la
Q .G. 10 aprile 194 1

Il cerch io di Tobruch sarà fatto ancora questa notte.
Il primo a[tacco si deve fare a mezzanotte. Per iniziare questo primo attacco c he deve servire sopratt utto per saggiare le forze e la resistenza delle truppe di Tobru ch probabilme nte verso m ezzanotte vi sarà un'azione di fuoco da tutte le parti sul centro di Tobru ch .
Questa azione di fuoco comincia solo in seguito ad ordine del comandante.
A questa azione prendono parte anche t utti i pezzi della parte avanzata della Divisione << Brescia>> Di rezione del tiro ad est solamente al nord della via Balbia.
I preparativi per svolgere questa az ione devono essere iniziati sub i to.
L'azione di fuoco deve cominciare subito dopo l'arrivo del l 'ordine.
per Il Corpo Ted esco in Africa
Il Capo di S M.
F.to illeggibile
Allegato n. 15.
N. 222 / 41 Segreto
13 co pie / IOa copia
T raduzione
U FFICIO O PERAZIONI ( Quart Gen , 26/4 / 41
Ord i ne per l 'esecuzione delle misure di finzione dimostrativ e nel periodo da l 28 / 4 al 1°/ 5/ 41.
1° - Coll' in izio della preparazione per l'attacco su Tobru ch a part ire dal 28 aprile devono essere nella misura più grande possibile delle operaz ioni d imostrative (di finzione) nel settore comp lessivo della s"' divisione leg-
gera con le forze colà presenti (compresa div. Trento) c nella zona Bardia · Sollum - Capuzzo dal Gruppo Herff. In questi settori si deve creare presto nel nemico l'impressione di un attacco. Perciò particolarmente nei giorni di preparazione e dell'esecuz ione dell'attacco su Tobruch la difesa deve essere mobile e possibi lmente offensiva con la massima attività.
2 " • In particolare per questo si dovrà eseguire :
a) forte traffico d i comunicazion i radio nel settore Streich e Herff e viceversa;
b) forte sollevamento di polvere dietro il fronte per fingere molto movimento. Movimenti partenti da settore possibilmente nell'oscurità. Molto movimento sulla Via Balbia e la pista parallela per Bardia Capuzzo. Mediante movimenti di reparti di truppe e carregg io durante il giorno in direzione delle posizioni in modo da fingere crescenti rinforzi. Le armi non mobili, come carri armati, anticarro, ecc., debbono essere imp iegate in maniera molto visibile per ingannare. Simulare possibilmente molti carri armati mediante impiego mobile in posti diversi. Automezzi sch ierati visibilmente e non interrati;

c) forte attività di ricognizione e pattuglia, particolarmente con forze tedesche. Possibilmente portare dci prigionieri. Durante la notte sparare molti razzi luminosi di tutti i color i (all'infu ori di quel li rossi, che servono soltanto nel vero caso di un attacco nemico);
d) fuoco di disturbo dell'art ig lieria sulle strade d'avvicinamento e nodi principali dietro le posizioni nemiche. Molti cambi di posizioni dell'artiglieria. Contemporaneamente fare tiri per pezzo da appostamenti diversi;
e) molte partenze ed atterraggi delle «c icogne» nuove assegnate. Nella zona di Bardia . Forte Capuzzo debbano essere effettuati dall'aviazione possibilmente numerosi atterraggi intermedi di qualche apparecchio.
3° - Le misure di finzione debbono esse re eseguite i n misura tale che il nemico noti un visibile aumento dell'attività rispettivamente dietro i settori Streich, Herff. Le misure di finzione debbono essere iniziate il giorno 28/4 c aumentate in modo da raggiungere il massimo il giorno 30 / 4· Per la notte del 30/4 · r f 5 saranno ordinate ancora imprese particolari pattuglie sul fronte complessivo di Tobruch. Per il settore HerH suddette disposizioni valgono per i l senso e per la sostanza.
4° Contrariamente a quanto sopra non vi dovrà essere sul fronte di attacco alcun segno che potesse svelare al nemico l'a ttacco. Perciò le misure det te in cifra 2 valgono nel senso inverso.
Particolarmente deve essere osservato :
a) il traffico radio deve essere ridot to al minimo;
b) movimento dietro il fronte e sollevamento di polvere durante il giorno debbono essere evitati. Tutt i i movimenti verso il fronte anche di automezzi iso lati, so l tanto nell'oscurità;
c) automezzi debbono essere i ntcrrati c messi a grandi distanze, bene mascherati e scaglionati bene i n profondità;
ti) carri armati debbono essere tolti quanto possibile alla visibilità sia dall'alto come da terra. Carri armati e cacciatori carri autotrasportaù già impiegati debbono essere ritirati dappertutto;
e) al nemico deve essere tolta ogni visibilità nelle nostre linee. Puntate di ricognizioni nemiche debbono essere lasciate avanzare ed annientate soltanto nell'ultimo momento. Durante pumate nemiche dimos trare soltanto poca reazione dell'artiglieria.
5° - Per le misure di finzione debbono essere pr e parati dai gruppi Streich e H erff, dei piani cronologici studiati fino nei particolari debbono essere mandati al C.T.A.
Dal gruppo Streich debbono essere preparati anche le misure di finzion e per la division e Trento.
Però non si deve comunicare ai comandi dipend enti che si tratta di mauo\U"a di finzione.
ROMMEL
All ega to n. 16.
N. 230 / 41 Segreto
22 copie /'t copia
Traduzione
Quart. Gen. 27 aprile 41
ORDINE PER L'ATTAcco su ToaRucH (Carta inglese delle fortificazioni di Tobruch 1 :so.ooo)
1° - Il nemico a sud di Sollum è respinto. Un se rio attacco da di questo avversario non è più da aspettarsi nei prossimi giorni. Sul fronte di T obrucb sono state respinte con successo tutte le puntate di ricognizione degli inglesi. Però deve cons id erarsi che anche per l'avv enire si verificherà molta attività nemica di ricognizione c tentativi di sbarchi, particolarmente tra i! settore est e Bardia.
2° - Il Corpo d'Africa eseguirà nella notte dal 30.4 - 1.5 al 1.5. m ediante attacco da ov es t il combattimento decisivo di Tobrucb.
3° - Primo obiettivo dell'attacco del giorno 30.4. è lo sfondamento della linea fortificata in co rri spondenza dei 2 lati di Mdauuar. Continuazione del-

l'attacco il mattino del 1.5. con direttrice Giaida - Pilastrino - Tobruch. Linea di convergenza per l'attacco (r :so.ooo): quota 209 ad ovest di Mdauuar (2o)- faro alla punta sud- ovest della penisola di Tobruch (6o).
4° - Per i particolari sull'impiego delle forze e la prevista condotta dell' attacco vedi schizzo carta I :50.000. I noltre tali particolari sono Tegola ti mediante gli ordini a parte:
- formazione delle forze impiegate, piano cronologico delle operazioni, piano di fuoco, esec uzion e dei movimenti, impiego dell 'aviazione ed esecuz ion e 'di misure di finzione.
5° - Limite di settore delle divisioni di prima linea (gruppo Kirchheim a destra, 153 Div. corazzata a sinistra): margine sud della quota 202 (er Russ) -margine nord della quota 209 (Mdauuar) limite sud del quadrilatero stradale immediatamente a sud di Pilastrino - forte Marcucci.
La div. Ariete segue con un gruppo d'assalto scaglionato indietro a destra del gruppo Kirchheim, la div. Brescia con un gruppo d'assalto scaglionato indietro a sinistra della 15.. Div. Corazzata. I gruppi di difesa delle 2 divisioni appoggiano l' attacco col loro fuoco.
6° - I gruppi d'assalto del gruppo Kirchheim e della rsa div. Corazzata, passando ai 2 lati del caposaldo di Ras el Mdauuar, entrano il g. 30.4 alle ore 20.00 nelle posizioni nemiche, sfonda no la posizione proporzionalmente all'allungamento del fuoco di artigLieria e prendono sul rovescio la posizione Mdauuar. Ciascuno gruppo di assalto delle divisioni Ariete e Brescia avanzano contemporaneamente ai gruppi d'assalto del gruppo Kirchheim e della rs" div. Cor., allargano ed assicurano la fronte di rottura verso i lati.
7° - Immediatamen te dopo riuscito lo sfondamento, la rs" div. cor. punta avanti con una forte grossa pattuglia di ricognizione fino alle posizioni ai due lati di Giaida. In caso che queste posizioni non fossero occupate dal nemico oppure soltanto debolmente presidiate, dovranno essere occupate immediatam ente dalla divisione e dal gruppo Kirchheim e difese da contrattacchi nemici. Altrim ent i si deve passare alla difensiva a sud -ovest di queste posizioni. La. Div. Ariete av,'lOlge verso destra il settore della posizione Bir ed Mdauuar, la Div. Brescia verso sinistra il settore della posizione Ras ed Sehel.
Di seguito le divisioni si sistemeranno a difesa nei settori delle posizioni occupate.
go - Dopo l'arrivo al primo obiettivo di attacco deve essere spostata in avanti la massa della divisione. L'artiglieria della divisione deve essere immediatamente portata avanti affinché all'alba possa essere impiegata a protezione della linea di difesa conquistata

Zona di preparazione per l'attacco del 1·5 vedere schizzo allegato.
9° - Nelle zone rimanenti del fronte ùi investimento, il nemico deve essere mantenuto agganciato mediante vivace attività di fuoco e di gruppi d'assalto. Le forze impiegate su questo fronte fermo debbono difendere le loro posizioni
contro ogni tentativo di rottura da parte del nemico e debbono in caso ùi bi!><>gno in seguito a riusciti tentativi di rottura di qualche reparto avvw.ario passare al contrattacco oppure all 'inseguimento con forze mobili. Per distogliere l'attenzione del nemico dal punto d'irruzione debbono essere seguiti contemporaneamente con l'irruzione presso Mdauuar delle « azioni di finzione » sui tratti di fronti rimanenti. Per i particobri vedere il piano cronologico.
5a Div. Leggera eseguisce inoltre nella notte dal 28 al 29 delle azioni di finzione di gruppi d'assalto, ciascuna appoggiata da tutti i mezzi disponibili, verso i settori de ll e posi z ioni di Sidi Da ud e Bir cd Faras, co me pure nella notte dal 29 al 30 verso il settore della posizione Bir Umm Haleiga. Il fuoco di disturbo nella none dal 28 sul 29 e dal 29 sul 30 deve essere diretto sugli stessi obiettivi, come ordinato per la none del 30 aprile.
10° - Il Comando Ta nico avan zato del Corpo d'Africa il 30.4. alle ore 18 viene spostato in zona a sud - ovest di Ras el 11dauuar.
CORPO TEDESCO IN AFRICA
UFFICIO
Segreto Traduzione
22 copie / 7" copia
Quart. Gen., 29+41
PrANO c RoNOLOGico PER L'ATTA CCO DI To anucH
RELATIVO AL 30-4- E AL ! 0 .5.1941 { (Carta inglese delle fortificazioni di Tobruch al 1 :5o.ooo)

Invio delle truppe di assa l to (con piomerJ, anticarro, dapprima senza carri armati) dietro la linea avanzata.
Deve essere provveduto:
dalla 15" Div. Cor. c gruppo Kirchheim alm eno r gruppo di assalto ciascuno, dalle Div. Brescia e Ariete 1 gruppo di as salto ciascuna, in stretto contano con i gruppi d'assalto tedeschi.
19,r5 • 20,15
19, 15 - 19,25
Attacco di « Stukas » sulle posizioni presso quota 209 (Mdauuar) come pure sui punti d'irruzione della 15a Div. Cor. e del gruppo Kirchheim. Le truppe d'assalto avanzano fin dove lo permette il riparo completo contro la visibilità. Avvicinamento dci carri armati per le truppe di assalto al coperto della vista d i terra fin dietro la prima lin ea.
Concentramento di fuoco di artiglieria sulla quota 209 e sui punti d'irruzione. Contemporaneamente preparazione di artiglieria sul resto del fronte presso le Div. Brescia, Ariete, Div. leggera e Tremo sui punti d'irruzione delle truppe d'assalto (impresa di finzione) secondo disposizioni delle divisioni.

Aumento del fuoco d'artiglieria (4 colpi al minuto per ogni cannone) c concentramento sui tratti d'irruzione ai due lati di Mdauuar.
Lancio di nebbia sulla quota 209.
Le truppe d'assalto con i carri armati assegnati si avviCInano guanto è possibile agli ostacoli. Le altre forze devono essere inviate in avanti colla testa fin alla linea di attesa (ultimo riparo).
Rottura del fronte. Per il piano di fuoco vedi carta.
Irruzione sul margine più avanzato delle posizioni nemiche sui due lati di Mdauuar. Contemporaneamente nel restante fronte presso la Brescia, Ariete, sn div. leggera e Trento av.vicinamento delle truppe d'assalto al margine anteriore alla linea di difesa nemica, qui particolarmente forte attività di fuoco con mitragliatrici, anticarro e artiglieria, anche nebbia c razzi luminosi. Tutt'al più rottura di iso late posizioni di difesa, quando il nemico cede.
19,25 - 19,35
Allargamento della irruzione in profondità della pos1z10ne su1 posti d'irruzione da ambedue i lati di Mdauuar. Accecamento ai lati possibilmente con nebbia.
19,35 - 20,15
- 20,15
Sfondamento fino alle spaPe di Mdauuar e quota 187 e allargamento dci luoghi d'irruzione in senso late rale.
Irruzion e sulle posizioni fortificate di Mdauuar dal rovescio e rottura del fronte verso destra f1n al settore di Bir cl Mdauuar incluso, e verso sinistra fin al settore di Sahel incluso.
19,30 - 20,30
20,30 - 21,30
Vivace f uoco di disturbo su tutto il fronte su obiettivi più vicini, secondo il piano di fu?Co.
Consolidamento della difesa sui settori conquistati di Bir el Mdauuar- Ras el Mda uuar- Ras el Sahcl c suJia zona a nord-
Dalle ore 5,30
est fino alle quote 180 e 173 incluse. Avvicinamento della massa delle forze sulle posizioni di attesa per il proseguimento dell'attacco, al mattino successivo in questa zona. Sicurezza dei fianchi. Avvicinamento delle forze di artiglieria. Invio di un reparto d'assalto forte e poderoso della Div. Cor. a Giaida.
Avvicinamento delle forze d'assalto delle Div. Brescia e Ariete fino ai posti di irruzione. Sicurezza dci fianc hi. Vivace fuoco di disturbo su tutto il fronte su obiettivi delle retrovie secondo il piano di fuoco.
Av,·icinamcnto dell'artiglieria di divisione. Il fuoco di difesa in profondità e verso i fianchi deve essere assicurato dall'artiglieria del Corpo c da contraerei. Fuoco di disturbo su tutto il fronte su obiettivi nelle retrovie il piano di fuoco. Contemporanei concentramenti del fuoco di disturbo alle ore J ,oo - 3·00 c 5,00.
Concentramento fuoco dell'artiglieria di Corpo d'Armata su posizioni ai 2 la ti di Giaida, per il caso che questa zona fin Il non avrebbe potuto essere ancora occupata dal gruppo d'assalto della 15 Divisione Corazzata Altrimenti riunione sulle posizioni presso Pilastrino. Contemporaneamente tiri sul fronte rimanente presso Div. Brescia, Ariete, 5• Div. Leggera e Trento sui punti d'irruzione di finzione.
Continuazione dell'attacco in direzione su Pilastrino e allargamento del varco sul fronte di posizione mediante sfondamento verso i 2 l ati delle Div. Brescia e Ariete. Contemporaneamente rinnovat è imprese di finzion e sul fronte rimanente presso la Div. Brescia, Ariete, 5" Div. leggera e Tr ento.
Dalle 7,00
Im piego di caccia c distruttor i (Zerstorer) su riserve portate in avanti nella zona arretrata. Avvicinamento dell'artiglieria di Corpo d'Armata e di parti della contraerea.
Im piego degli « Stukas » nella zona arretrata secondo carta d'impiego per l'aviazione. ROMMEL

Allegato n. 18.
N. 230l4r Segretissimo IV Abg.
22 esemplari 1 4° esemplare
Riferimento: C .T.A.II A N. 230l 41 Segretissimo del 27 141194 1
Oggetto: r) Ordine per l'attacco su Tobruch
2) Piano orario del 29l4 l 1941
In seguito a esigenze tecniche l'attacco dei Stuka del 30l4 non avrà luogo come previsto dalle r8,45 alle 19, ma circa alle 18,30. Lo sfondamento dci reparti d'assalto deve avvenire indipendentemente da questo; secondo il nuovo piano orario alle ore 19,30. Ugualmente rimangono invariati tutti gli altri orari. Il piano orario, come pure «l'o rdin e per l'attacco su T obruch >> (pag. 2 - Par. 6) sono corrispondentemente da rettificare >> .
per Il Corpo in Africa
IL Capo di Stato ELERT Maggi ore I. G.
Allegato n. 19.
CORPO T EDESCO IN AFRICA
uFFI CIO OPERAZIONI
N. 246l41 Segreto
24 copie l 7'• copia
1° - I combattimenti del giorno 30.4 e 1.5 hanno portato alla occupazione del caposaldo pi ù importante di tutto il fronte fortificato esterno di T obruk e sono finora terminati con successo con un·a irruzione di circa 5 Km. di larghezza e 2-3 Km. di profondità nella sistemazione difensiva nemica. Sono stati distrutti r6 carri armati, di cu i 2 pesanti. Sono stati fatti prigionieri 275

uomini. Tutti i tentativi del nemico di riconquistare con un contrattacco le posizioni occupate sono falliti.
2 " - La battaglia di Tobruk viene proseguita offemivamcnrc, dove si offrano delle occasioni favorevoli.
3"- Dal 2.s. si effettua la seguente nuova ripartizione della fronte :
a) Fronte sud ed est: s" div leggera (senza il gruppo Kirchheim) e divisione Trento che den: cooperare strouameme con la s• leggera. Responsabili tà per tutto il settore Generale Streich.
b) Fronte sud- ovest: Gruppo Kirchhcim e div. Ariete che deve cooperare strettamente col gruppo Kirchheim. Responsabilità per tutto il senore: Generale Kirchheim.
c) Fronte ovest: I Sa div. corazzata c div. Brescia che deve cooperare strettamente con la I Sa div. corazzata . Responsabilità per tutto il settore: Gen erale von Escbeck.
4° - For mazione delle truppe invariata con le seguenti eccezioni:
a) TI s" reggimento carri armati deve nuovamente riportarsi in 2 gruppi, J c II, senza riguardi per carri armati mobili o non mobili. Il reparto del Maggior e Hohmann rimane presso il gruppo Kirchheim aV\'icinando i suoi carri armati immobili. Il Reparto Maggiore Balbrinnker rientra alla sa Div leggera
h) Il reggimento artiglieria Grati rimane reggimento di artiglieria di Corpo d'Armata c come tale deve cooperare col gruppo Kirchhcim. Il reggimeOLo deve impiegato in modo da poter proteggere il settore del fronte sud ovest
c) Il gruppo contraerei Hec h t rim a ne alle di rette dipendenze del Corpo con g li stess i compiti finora assolti Qualche batteria è a disposizione delle divisioni per la cooperazione.

5° - Linee di separazione tra i singoli settori:
a) tra il gruppo Streich cd il gruppo Kirchh e im: Bir Sccrif - Bir ed Faras Bivio a sud di Tobruk - Abiar et Gicddaff;
b) tra gruppo Kirchheim cd il gruppo von Esebeck: ciglione nord di quota 209 - ciglione sud triangolo della strada di Pi lastrino.
6"- Compiti:
a) v.al evole per t u tt i i fro nt i : res pin ge re ogni attacco nem ico. P er fissa re il fuoco d i sbarramento il gruppo contraerei H cc h t sta a d isposizione del gruppo Kirchheim e del gruppo von Escbeck;
b) su tutti i fronti dove non si attacca debbono essere continuate in maniera più grande possibile le misure di finzione particolarmente anche per i carri armati che debbono mostrarsi in tutù i posti dove non è previsto il loro impiego. Dietro i! fronte particolarmente nei settori scoperti, debbono essere eseguiti giornalmente in ore diverse i sollevamcnti di polvere con automezzi
per fingere maggiori forze. Sorprese di fuoco ed auività di gruppi d'assalto di nott e, particolarmente sui fronti ch e altrimenti non sono protetti da forze di difesa, costituiscono l'espediente migliore per inquetare l'avversario e !asciarlo all'oscuro circa le forze che lo fronteggiano. Di particolare importanza per il Comando è la continua osservazione del fronte nemico, co me viene fatto anche con successo da parte inglese, c la rapida trasmissione dei risultati dell'osservazione. Dalle forze es iste nti debbono esse re costituiti in tutti i seuori delle riserve mobili, che essere gettate nei tratti di fronte pericolanti;
c) di attacco: il posto di irruzione deve essere allargato dovunque il nemico cede verso i due lati in modo che si formi un settore contiguo di posizione da R.n oltre 177 (1,5 Km. a sud di Giaida) - ad est 173 (2 Km. ovest Giaida)- 159 (2>5 Km. a nord- ovest di Giaida) - SS • Sg (compreso).
In ogni settore di posizione occupato le truppe debbono in terrars i al più presto possibile e sistemarsi a difesa in modo ch e c i siano possibilmente delle perdite minime.
t - La formazione delle Divisioni e gli intendimenti particolari debbono essere comunicati al Corpo Tedes co in Africa.

Allegato n. 20.
MILITAR - ATTAccHi - RoM
N. 275 Roma, den 14.6.194 t Coma11do Supremo
Ho l'onore di informan·i sui dettagli riguardanti l'istituzione del Comando di Collegamento Germani co présso il Comando Superiore in Africa Settentrionale. (Tn tedesco questo comando porta il nome « D e utsc her Verbindungsoffizier beim Tralien ischen Ober Kommanclo i n Nord -Afrika »).
1°- Ufficiale di co ll eg amento ( il capo del Com:tndo) è il generale di brigata Gause ch e è partito da Roma a Tripo!i il ro c.m. in aeroplano.
Il Comando si compon e come seg ue : 43 ufficiali - 20 funzionari . 46 sotruffì c iali - no truppa - totale 219; 45 automezzi - 1 rimorchio - 6 motocicli5 sidccar - totale 57·
Parte della truppa appartiene attualmente al Corpo Tedesco in Africa c sarà assegnata in seguito al nuO\'O co mando.
2° - I suoi compiti saranno i seguenti:
a) mantenere il contatto fra il Comando Superiore delle FF.AA. in A.S. cd il Comando Supremo dell'Esercito germanico;
b) trattare tutte le questioni del Corpo T edesco in Africa per quanto esse tocchino il Comando Superiore in A .S.;
c) sistemare il rifornimento in terra africana del Corpo Tedesco in Africa;
d) tenere stretto contano col Generale Germanico presso il Comando Supremo Italiano nelle questioni di trasporti germanici in Africa.
3° - Saranno sottoposti al Comando dell'ufficiale di collegamento presso il Comando Superiore in A.S.J.:
a) i! Comandante retrovie tedesche (generale di brigata Mi.iller- Gebhard );
b) il comandante dell'intendenza tedesca in Libia (maggiore di S.M. Schlcussuer).
4° - Tutti gli ordini del Comando Superiore dell'Esercito germanico diretti al Corpo Tedesco in Africa saranno dati tramite: Generale germanico presso il Comando Supremo italiano, Ufficiale di collegamento germanico presso il Comando Superiore in A.S. Lo stesso tramite sarà percorso in senso inverso dai rapporti del Corpo Tedesco in Africa.
Allegato n. 2.1.
U FF ICIO OPERAZION I ScACCHIERE AFR ICA
Prot. n. 3oo6c;J/Op. Giugno 1941

All'Ecc. il Ge11erale Gariboldi, Comandante Supt:riore FF.AA. A.S.I.
c, per conoscenza:
Ecc. il Generale Roatta, Capo di S.M. dell'Esercito
Oggetto: Ufficia le di collcgamcnro presso Comando Superiore FF.AA. dcll'A.S.I.
Il generale germanico presso questo Comando Supremo ha consegnato l'appunto n. 275, di cui si allega copia, in merito alla istituzione dell'ufficial e di collegamento presso codesto Comando Superiore.
VON R I NTELEN Generale di DivisioneSono chiesti verbalmente chiarimenti circa i punti a) e b) del comma 2 ' , ed il generale von Rinrelen ha dichiarato:
- che nulla è variato in merito a quanto fissato dal protocollo KeitclGuzzoni (trasmesso a codesto Comando con n. 6339 in data II febbraio u.s.);
- che il contatto fra il Comando Superiore Forze Armate in Nord Afri ca c il Comando dell'Esercito Tedesco, deve intendersi esclusivamente per quanto ha attinenza al campo organico e logistico, e mira a consentire al generale Gariboldi di esprimere eventuali suoi desideri in una materia per la quale l'Afrika- Korps dipende direnamente dal Comando dell'Esercito tedesco, come da citato protocollo;
- che è ben chiaro che in materia d'impiego il generale Rommel dipenda direttamente dal generale Gariboldi e quindi dal Comando Superiore Italiano e che la responsabilità del comando sia unica ed esclusivamente italiana.;
- ch e l'istituzione dello Stato Maggiore del generale Gause mira solo allo scopo di alleggerire il genera le Rommel di tutto quanto si riferisce ai rifornimenti c alla protezione delle comun icazioni e a consentire che egli si dedichi esclu sivamente alla parre operativa;

- che in un primo momento si era pensato di istituire un secondo Capo di Stato Maggiore del generale Gariboldi, ma si è poi scartata questa idea per timore che si potesse pensare a un'ingerenza tedesca nel campo impiego;
- che con l'invio del generale Cause si mira da pane tedesca non già a limitare ma ad aumentare le possibilità del generale Gariboldi in fatto di esercizio del comando sull'« Afrika- Korps » in ogni campo, non solo in quello operativo.
Si ritiene che sulla base di tali chiarimenti l'azione del generale Gause e del suo Stato Maggior e, possa essere da Voi, Eccellenza, bene inquadrata e definita, evitando ogni ingerenza in quanto è prerogativa di questo Comando Supremo e di codesto Comando Superiore.
11 Capo di Stato Ma ggio re Generale CAVALLEROEqui-
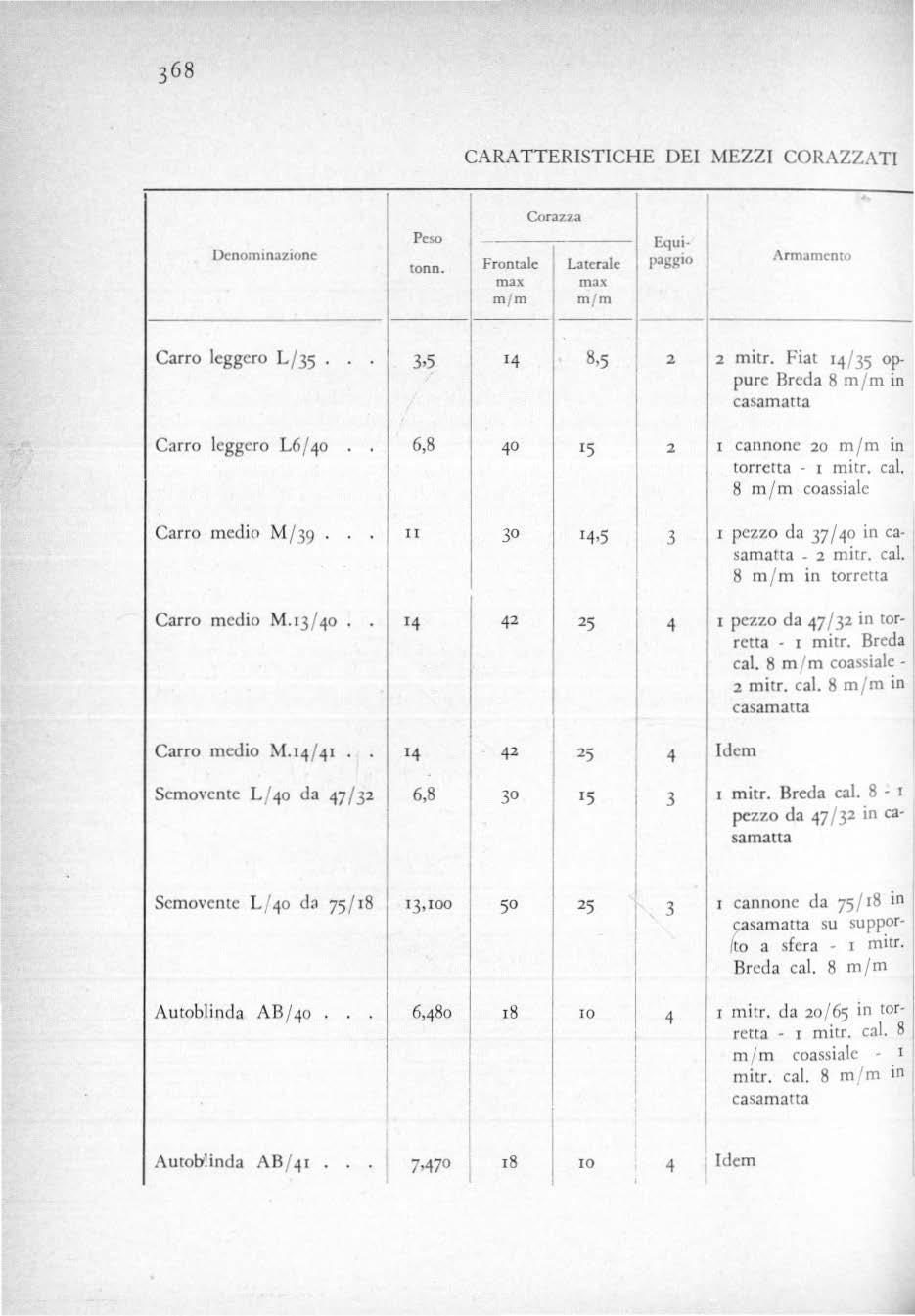
Dei due carri fu approntata anche una versione « lanciafiamme» gettaponte, recupero, semovente, radio (de ll 'L6 / 4o le versioni lanciafiamme, porta munizioni, semovente).

Fu sostituito dal carro M.r3 / 40 dopo la In offensiva ingl ese.
Questi due mezzi f urono im propriam ente definiti « Artiglierie semov e ntì >> Per i l sistema di installazione del pezzo e le limitate possibi l ità di brandeggio poterono meg lio considerar si <<carr i d'assalto », oppure « cacc iatori dì carri ».
Caratterizzata dal doppio sistema di gu ida (uno ante riore ed uno posteriore) al ternabili per il cambiamento di direzione dove non era possibi le la volta (strada limi tata da due passi lateral i, ecc.). Tal e caratte ris tica si rilevò completamente inutile nei terreni libico - egizian i, qua si ovunque pe rcor ribili in ogn i se nso.
Den om in az ion e Fromalc Late ra le Equi- Armamento ton n. paggto ma x
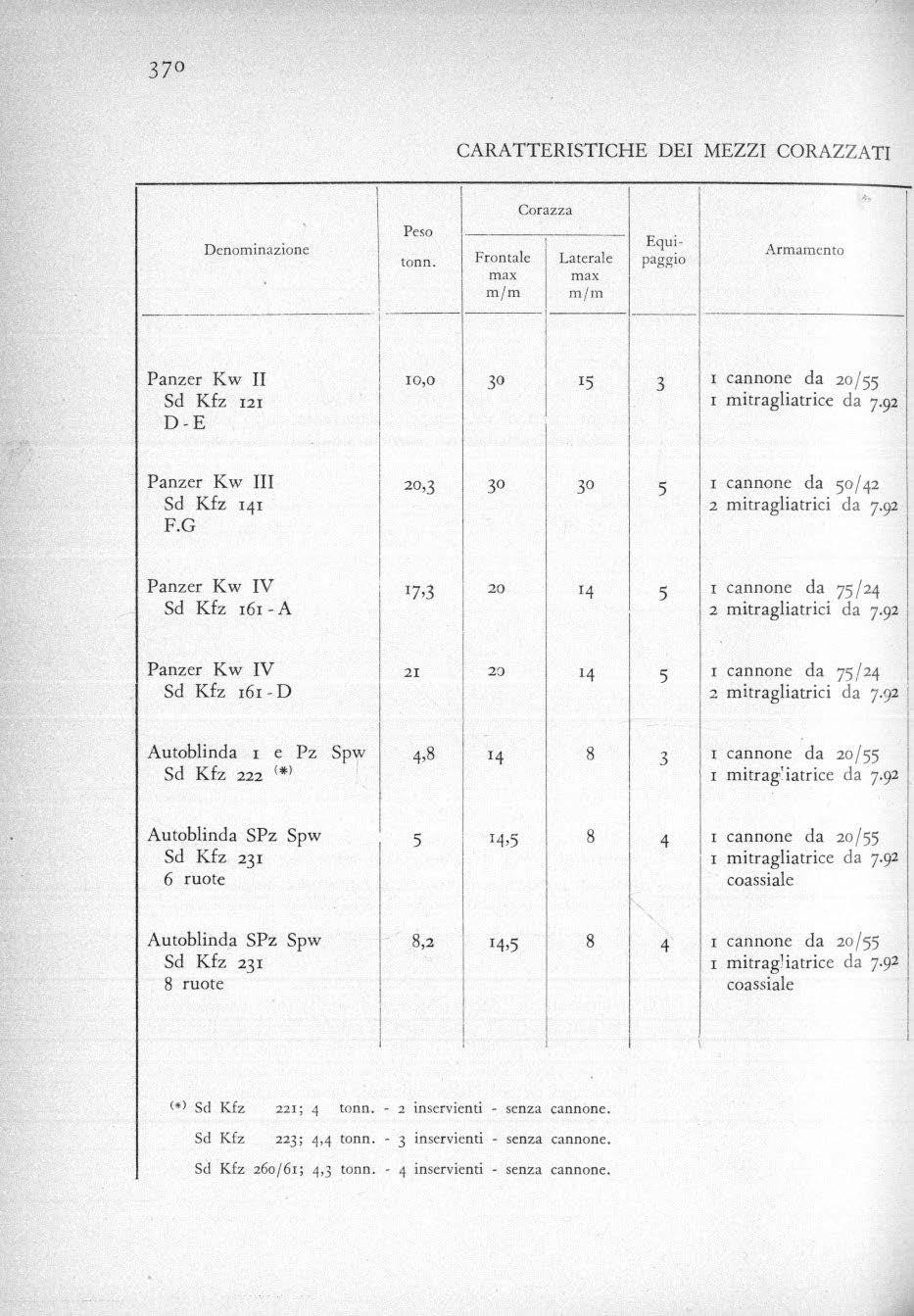
Segue: Allegato


Segue: Allegato n. 22.
Armamento
I mi tr. Wickers ca!. 12,7 oppu re
I mi tr. Wickers ca!. 7•7
Apparato motore
Velocità !Autonomia Annotazioni
209,2 In numero limitato
vennero impiegati nella t• offensiva in A.S.
I pezzo da 40/50. I mitr. Besa cal. 7,92
1 pezzo da 40/50- 2 mitr. Bcsa ca!. 7,92
l I pe:tzo da 37 / 53- 2 Browning ca!. 7,62
1 pc:tzo da 40 mf m - 1 mitr. Besa cal. 7·92
Furono i carri base delle Divisioni Corazzate
I pezzo da 40 / 50- I mitr. Besa ca!. 7,92
l pezzo da 75/3I - I mitr. contrae rei ca!. 12,7 - r mitr. cal. 7•7
l 1 pez zo da 57/52- 2 mitr. Besa cal 7,92
can none da 37 - r mitr. cal. 7,7
l pezzo da 40 /5 2 - I mitr. Besa ca!. 7,92
l pez zo da 40/52- r mitr. Besa cal. 7,92

1 m it r. cal. 7,7
l ca nnone da 40 e 2 mitr. 7.62
/ Furono impiegati la prima volta nella ( battaglia di El Alal mein (autunno 1942)
Furono impiegati solo ne1la fase finale della guerra in A.S.
Esiste anche la versione ferroviaria
AFRICA SETTENTRIONALE
STATO MAGGIORE
CoNSIDERAZIONI GENERALI
lì 8 agosto 1941
Esaminati gli attuali aspetti della situazione, si conv iene che l'attuale schieramento rappresenta la conseguenza di una rapida avanzata fatta con la visione di sollecitamente proscguirla, prosecuzione che deve per ora esse re rimandata.
Si esaminano perciò le condizion i nelle quali si svolgerebbe la nostra difesa contro il ripetersi di un attacco nemico da oriente: nell'attuale schieramento, la massa di riserva delle due divi sioni corazzate germaniche appare insuffi ciente specie se l'attacco dovesse pronunciarsi contemporaneamente da est e da Tobru ch.
Si conviene perciò che per poter dare battaglia co l presente schieramento necessario disporre di un'altra riserva mobile per poterla impiegare in azione coordina ta con la prima.
CoSTITUZIONE DELLA RISERVA MOB I LE
Si prendono in considerazione le Divisioni « Trento», « Ariete li Tri este ». La Division e « Tr ento» può essere ritirata subito dal fronte e sostituita con la « Bologna ». Accordi al riguardo sono già interven uti col Comando T edesco. Il completamento di essa in autocarri ed altri m ezz i può essere fatto sollecitamente Questa divisione ha già la formazione speciale prevista per A.S. più un reggimento bersagl ieri. Si decide d i !asci arle detto reggimento bersagl ieri e di assegnarle un battaglione carri L che è disponibil e
La Div. « Ariete» dispone dci suoi tre btg. carr i M. Il reggimento bersaglieri, al comando del col. Montemurro, trovasi sul fronte est agli ordini del Generale Rommel e verrà ritira to previa sostituzione con altri elementi. Talune deficienze tecn ich e dei carri sono in via di eliminazione. Altri 36 carri M, in discrete condizioni, sono stati rccuperati c serviranno all'occorrenza per i rimpiazzi.

n Supercomando A.S.I. sta provvedendo per organizzare il sef\'IZIO riparazioni e ricuperi al seguito della Divisione. L'addestramento sarà co mp!ctato.
La Div. « Trieste» affluirà in Libia entro i primi di settembre e sarà chiamata a fare parte di questo Corpo d'Armata di manovra.
Il Comando del Corpo d'Armata di manovra sarà assunto dall'Ecc. il Gen. Gambara, il quale conservcr!ì la sua carica di Capo di S.M. del Supercomando A.S.J.
Il Gen. Gambara comunica di avere in corso di allestimento uno squadrone di 24 camionette di preda bellica adatte a tutti i terreni, su ciascuna delle quali viene installato un cannone da fl; / 17 specialmente per il tiro anticarro ed eventualmente per altri compiti.
Sulla posizione detta di Ain cl Gazala i lavori sono già abbastanza avanti. La posizione si compone di una linea di sicurezza c di una posizione di resistenza. Questa posizione ha il vamaggio di non essere troppo lontana dalla piazza di Tobru ch (circa 50 km. di linea d'aria). Ha requisiti tattici soddisfacenti. Si decide di completarne la sistemaz ione.
E' bene inteso che l'occupazione di questa linea arretrata non potrebbe essere fatta sotto la pressione dd nemico.
La s ua utilizzazione risponde perciò all'ipotesi di una decisione di arretramento preventivo che fosse presa in relazione alla situazione generale ed alla imminenza di un attacco in forze nettamente prevalenti.
Questa interpretazione è stata confermata dal Geo. von Rintelen, il quale interpreta in questo senso il pensiero del Maresciallo Kcitd circa la funzione della linea arretrata.
La presenza di una riserva mobile sarebbe indispensabile anche e più che mai in questo caso, poiché una linea difensiva di questo genere non può essere concepita se non come punto di partenza per la mano\Ta.
n Supcrcomando A.S.I. provveded al sollecito completamento ed armamento di questa posizione.
Questo rimane l'obiettivo da perseguire come presupposto per la futura ripresa offensiva verso l'Egitto.
Per determinare l'epoca di ini zio dell'espugnazione occorre stabilire :
1 ° - tempo ancora occorrente per completare dei mezzi, soprattutto artiglierie e munizioni;

2° - tempo occorrente per l'afflusso delle forze ancora necessarie, che si precisano, sentito anche il Gen. Rommel, almeno in una divisione corazzata cd una di ripo normale.

Per quanto riguarda l'afflusso dci materiali, la determinazione dci rempi sarà fatta d'accordo fra il Supcrcomando A.S.I. ed il Comando Rommel.
Per le forze, i tempi saranno determinati dal Comando Supremo tenuto presente che, si[Uazione permettendolo ed esigendolo, l'attacco di Tobruch potrà essere condotto prelevando i rinforzi occorrenti dalla massa mobile anche se non fosse ancora completato l'afflusso delle nuove unità.
SciOGLIMENTO GmtANDI G.U. DELLA TRIPOLITANIA
Si conviene nella opportunità di addivenire allo scioglimento del Comando 5a Armata cd alla trasformazione del Comando XX C .A. in cc Comando della Tripolitania » co n attribuzioni c competenza s u tutte le truppe dislocate in T ripoli t a nia.
L'alleggerimento della struttura suddetta consentirà ulteriore rccupcro di personale e di mezzi dalla Tripolitania a favore della Cirenaica.
Le Ecc. Cavallero e Bastico concordano nella scelta dell'Ecc. Gcn. Vecchiarelli per il nuovo cc Comando della T ripolitania >• .
CoMANDO DELLO SCHIERAMENTO ToBRUCH- SoLLuM
Tenuto conto che l'unica riserva mobile attuale per il fronte TobruchSollum è ancora il gruppo di divisioni tedesche, rimane confermato che il Gcn. Rommcl continua a tenere il Comando di tutte le truppe schierare in Marmarica (da Ain Gazala ad est) cd al confi ne egiziano c ciò anche dopo la cost it uzione imminente del Comando C.A. per Tobru ch.
Il Capo di Stato Maggiore Generale
Il Comandante Superiore A.S.l.
Il Capo di Stato Maggiore dd Supercomando A.S.l.
Il di Brig. C . Fassi - Segretario
Tutto quanto è contenuto nel presente verbale ha fatto oggetto di successiva conversazione col geo. Rommel a Bardia, nel pomeriggio del giorno 9 agosto, presenri l'Ecc. Bastico e il Gcn. von Rintclcn.
Su tutto il Gcn . Rommcl si è dimostrato pienamente d'accordo.

S c ACC HIERE AFRI CA
6 settembre 1941
DISLOCAZIO:-:E CORPO D'ARMATA MOBILE
Supercoma ndo A.S.I., in risposta al telesc ri tto 30504 del Comando Supremo, com unica c he il C.A. mobile - a organizzazione ul timata - sarà dislocato nel la zo na di A ìn el Gazala - Bìr Hach eìm - Garet Merìem.
Note.
Si conco rda con Superasi circa tale di slocazion e per i l C.A. che risulta così ad imm ed ia ta portata di Tobruch, a poco più di 100 chilometri dal fronte Sollum cd in condizioni di comrom an ovrare sul fianco di una eventuale azione aggirante avversaria a largo raggio, provenieme da Ridotta Maddalena, con obiettivo i rovesci di T obru ch.
Una dislocazione più avanzata, a sud di Tobru ch, come desidererebbe il gen. Rommel, mentre non migliorerebbe sensibilmente il pronto in tervento dd C.A mobile su l fronte di Sollum, p ermetter ebbe all'avversario di aggirare tutto il nostro schieramento co n una eve ntual e feli ce sort ita sul fronte occidental e di Tobruch. An che l'azione da Ridotta per Bah es Serir - Bir Ha ch eim potrebbe porrare all'agg ir amento se non totale, almeno parziale del C.A. mobile.
I n sintesi sembra che la dislocazione scelta da Superasi sia la più indicata per una massa mobile c he abbia f un zioni di riserva generale nelle mani del Comando Superiore. Questo inoltre non deve solo provvedere a parare le e ventuali minacce del fronte Sollum- T obruc h , ma deve anche mettersi in misura di far fronte ad eventuali sbarc hi e alle mi naccie del sud Cirenaica (Vedas i promemoria « Intendimenti avv e rsa ri » data odierna).
Il Comando Superiore potrebbe anche ra lv isare l'opportunità di dislocare even tualm ente una intera G .U. nella zona di Agedabìa.
La dis locazione, proposta dal gen. Rommel, molto probabilmente è determinata dal suo desiderio dì avere ad oriente del m er idian o di A in Gazala anche il C.A. che secondo l'attuale ord iname nto è alle dipendenze del gruppo Corazzato tedesco. ·
Oltre che per le ragioni tattiche sopra esposte, pe r le stesse ragi on i dì prest igio c he hanno cons igliato la costit uzione di una riserva del Comando Superi ore, sì ritiene che non sia opport uno aderire alla proposta del Generale Rom-
mel. AlLrim enti il Comando Superiore italiano sarebbe ridono alle sole funzioni di Governo Civile della Libia.
Perché Supcrcoma nd o A.S.I. possa decidere tranquil!amente su ll e eventuali r ichieste del gen. Romtncl, si propone fargli conoscere il pens iero del Comando Supremo con l'unito telescrilto.
Telegramma per la firma del Capo di S.M. Generale.
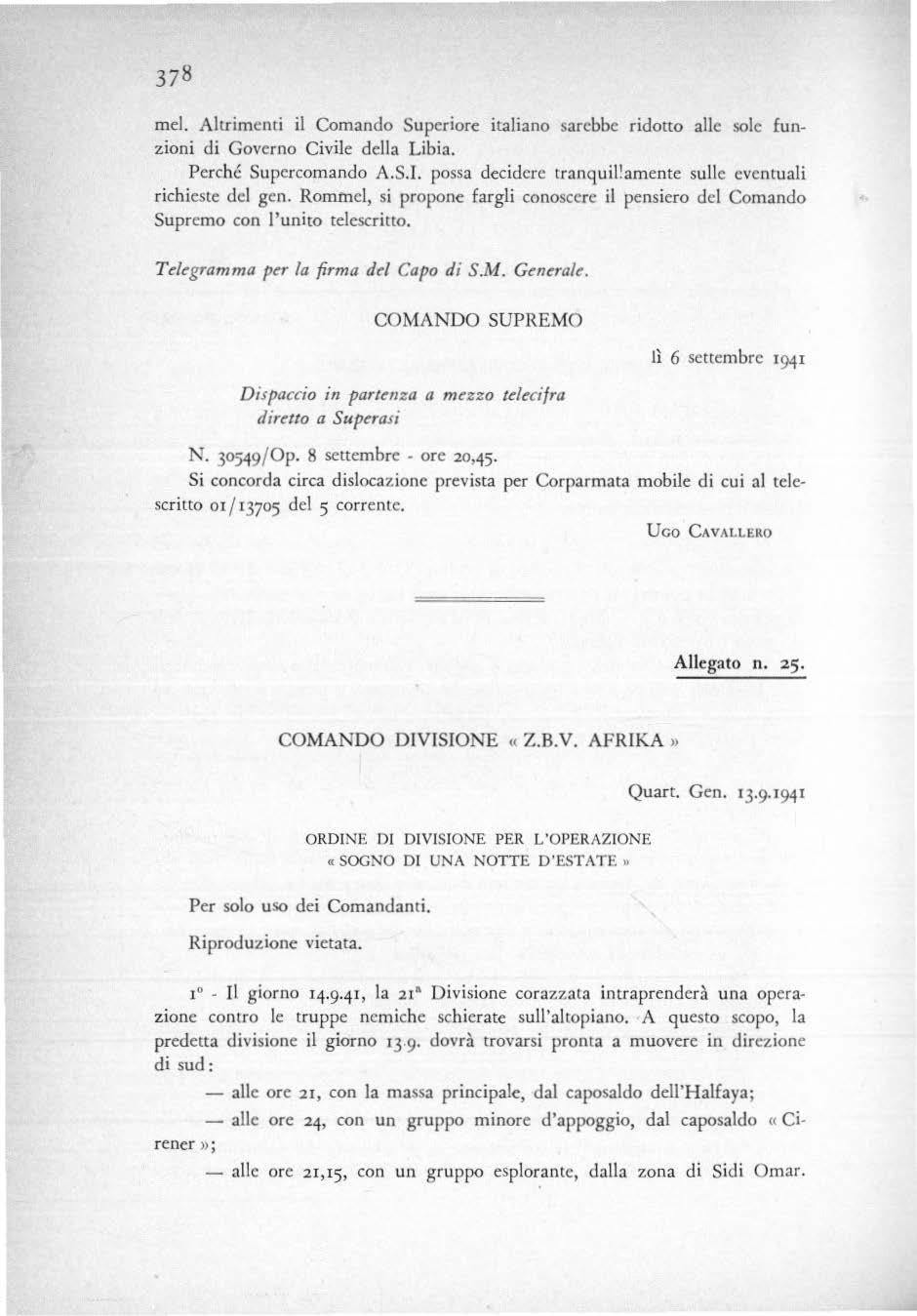
COMANDO SUPREMO
Dispaccio in partenza a mezzo telecifra diretto a Superasi
N. 30549/0p. 8 settembre -o re 20,45.
lì 6 settembre 1941
Si concorda ci rca dislocazione prevista per Corparmata mobile di cui al te lesc ri tto 01/13705 del 5 corrente.
Uco CAvALLERo
Alle gato n. 25.
COMANDO DIV ISIONE « Z.B.V. AFRIKA >>
Quart. Gen. 13·9·1941
OR DI NE DI DIVISIONE PER L'OPERAZ IONE «SOGNO DI UNA NOTTE D'ESTATE>>
Per solo uso dei Comandan ti.
Riproduzione vietata
1 ° - Il giorno 14·9·41, la 2I 6 D ivision e co ra zz:lla intrapr ende rà una operazione contro le truppe nemi che schie rate sull 'altopiano. A questo scopo, la predetta divisione il giorno IJ9· dovrà trovarsi pronta a muovere in direzione di sud :
- alle ore 21, con la ma ssa principale, dal caposaldo deii'Halfaya;
- all e ore 24, con un gruppo minore d'appoggio, dal caposaldo «Cirener >> ;
- alle ore 21,15, con un gruppo esp lora nte, dalla zo na di Sidi Ornar.
2° - Il gruppo principale inizierà il movimento nel suo settore di marcia, avanti ai capisaldi, per le ore 2.
Il gruppo d'appoggio muoverà invece alle ore 5·
3° - Al termine dell'operazione, prevedibilmente alla sera del 14·9· e nel corso della stessa notte, il grosso della 21"' divisione corazzata si ritirerà nella zona retrostante ai capisaldi, mentre aliquote parziali rimarranno fino al I5·9· a contatto del nemico per essere poi anch'esse eventualmente ritirate.
4° - L1 Divisione « Z.B.V. Afrika >>, a partire dalle ore 7 del 14·9·· asseconderà la riuscita delle operazioni sull'altopiano con attività combattiva nel settore dell'Halfaya e con l'invio di elementi esploranti nel settore costiero in conformità degli ordini verbali ricevuti.
5° - La zona di sbarramento dinanzi ai capisaldi, a partire dalle ore 19 del giorno 13.9 fino alle ore 5 del r6.9., sarà abolita ad evitare disgrazie. Rientrerà in vigore automaticamente allo scadere di tale termine.
6" - A partire dal mattino del giorno I4·9· è da attendersi una forte reazione aerea nemica anche sulle rctrovie. Dovrà perciò essere assicurata una più elevata prontezza di intervento aereo.
t - Collegamenti: come in sito.
Il silenzio radio viene tolto a partire dalle ore 7 dd giorno 14.
Il traffico orario sarà libero entro i limiti dci normali compiti informativi.
Il traffico radio fittizio dovrà essere assicurato dalle stazioni a ciò particolarmente destinate.
8° - Dovrà essere diligentemente assicurata la sorpresa circa l'inizio delle operazioni e la loro condotta.
Lo schieramento delle truppe dov·rà pertanto essere ultimato alle ore 18 del giorno 13·9·
9° - Il posto di comando avanzato della divisione sarà stabilito, a partire dalle ore 5 del giorno 14·9·• presso il II grup po artiglieria (Pardi).

Da qui saranno inviate informazioni, a partire dalle ore 5 del giorno 14·9·· ogni 3 ore anche dai settori e dal comandante del reggimento artiglieria.
Segue ordine per l'uso dei segnali luminosi e di riconoscimento.
Il Gene1·ale Comandante della Divisione SuMMERMANN
N. 95 l 41 Segreto per Comandi
2 copie l 1 3 copia
All'Eccellenza il Comandante Superiore delle FF.AA. A.S.
Q.G., x6.9.41
Ho l'onore di trasmettere qui di seguito la relazione desiderata da V. Eccellenza circa la ricognizione in forze effenuata il giorno 14 settembre 1941.

La 21a Divisione Corazzata, senza le unità fucilieri, aveva l'ordine di ricacciare le truppe di sicurezza nemiche avanzando su un vasto fronte oltre Bir el Khreigat c di constatare se il nemico aveva fano dci preparativi per una offe nsiva.
La Divisione, con una rapida puntata, è giunta alle ore 8 nella zona Dar el Hamra e dopo una sosta ha continuato, nel pomeriggio, l'inseguimento d el nemico fino a Bir Habata.
Nella notte sul 15 settembre la Divisione è ri tornata, secondo il piano prestabilito, dietro il fronte di Soll um , lasciando a contatto del nemico delle forti pattuglie.
L'azione ha dato il seguente risultato:
t 0 - Le forze avversarie dislocate nella zona ad ovest di Marsa Matruk sono più deboli di quanto finora si era presunto.
2° - La ricognizione no n ha pot u to constatare nel la zona al di là del confine alcun deposito o altri preparativi pe r un imm i nente attacco.
3° - L'esame dei doc u menti catturati, molto importanti, fornirà probabilmente delle utili indicazioni per poter conoscere lo schieramento delle forze nem ich e ne l vicino e anch e nel Medio Oriente.
Quindi resta confermato che le forze nemkhe, che attualmente sono dislocate nel deserto occ identale, non so no sufficienti per svo lgere un 'offensiva Il Comandante
Generale delle Truppe CorazzateSTATO MAGGIORE
K or/ 17550 di prot. Op.
Risposta al foglio n. 30743 Op. del 20 corrente
Carte annesse: n. I carta al 50.000 di Tobruk.
Argomento: Progetto attacco Tobruk.
Al Comando Supremo Uff. Operazioni - Smcclliue Africa
P.M.r t, lì 26 ottobre 1941
Posta Militare 21
Com'è noto a codesto Comando Supremo, l'azione per la espugnazione di T obruk è stata concretata dal Comando Panzergruppe Afrika, responsabile di tutto il settore della Marmarica.
Ad esso è devoluta la redazione del progetto d'attacco; progetto che peraltro non sembra ancora definito.
In una serie di riunioni, il Generale Rommel ha trattato ampiamente le varie questioni relative al l'azione; di volta in volta però il Generale Rommel ha ann un ciate sostanz iali varianti a quanto detto nelle riunioni precedenti, il che fa supporre che molti particolari non siano ancora ben definiti.

Il Comando del Panzergruppe sarà sollecitato a trasmenere un completo progetto scritto; per intanto si indicano qui, in sintesi, le linee maestre dd progetto quale è apparso nelle su indicate riunioni, l'ultima delle qual i è avvenuta il 20 corr ente mese.
della massa di attacco :
- 15a Divisione corazzata tedesca;
- Divisieae tedesca di formazione, parzial mente motorizzata (di cost ituzione ancora non nota);
- Divisione « Pavia », tolta dall'investimento di Tobruk c sostituita dalla « Trento », la quale ha presidiato anche il settore di Ras Mdauuar g ià tenuto da due btg. tedeschi;
- Divisione « Bologna ,, , ch e verrà parzialmente tolta dall' investimento di Tobruk << verso il 20 novembre >> c sostituita, nei soli caposaldi avanzati, con clementi tedeschi ed italiani;
- circa 500 bocche da fuoco tutte in schieramento molto avanzato.
Non ancora definita. Nella riunione del 20 ottobre il Generale Rommel ha indicato alle divisioni, come tempo disponibile per l'addestramento, «circa 4 ancora».

IIL - Conatto d'azione.
Penetrare profondamente nello schieramento avversario con direzione S.E.N.O. ed eliminare prontamente il tronco nemico che risulterà ad oriente della falla per avere un'ala appoggiata al mare; raggiunto il forte Airenti divergere l'attacco contemporaneamente su Tobruk e su Ras Bclgàmel.
l V. - Direzione d' atta,·co: fortino R.69 - crocicchio di Si di Mahmud - forte Airenù. Da forte Airenti una colonna marcerebbe su Tobruk; altra su Ras Bclgàmd.
V. - Fronte d'attacco: tra fortino R.ss (a ovest) e v1a Balbia - Sidi Daud (ad est).
VI. - Obiettivi:
a) crocicchio di Sidi Mahmud, da raggiungere per le ore 12 del giorno X;
b) Tobruk, da raggiungere per la sera del giorno X;
c) Ras Belgàmel, da raggiungere nello stesso giorno X o al mattino del giorno X + 1.
VII. -Colonne d'attacco:
-a sinistra della direzione d'anacco le Divisioni italiane;
- a destra quelle tedesche.
V III. - Azioni concomitanti:
- la «Trento>> dovrà occupare i fortini R.u- R.13 c Sidi Chciralla;
- la << Brescia >l, dopo intenso fuoco di arùglicria e annebbiamento, attaccherà per dare al nemico l'impressione che l'attacco si pronunci ad ovest
IX. - Modalità:
- nel pomeriggio del giorno X - 1 intensa azione di controbatteria e annebbiamento nel settore ovest (Divisione «Brescia ») per attirare da quella pane l'attenzione dell'avversario;
- preparazione d'artiglieria, immediatamente prima dell'attacco, della durata di 3 ore circa;
- mano a mano che l'attacco procederà, le divisioni italiane dovranno assicurare il fianco sinistro creando rapidamente caposaldi di compagnia; quelle
tedesche cercheranno di eliminare rap i damente le truppe avversane schierate ad est fino al mare;
- ciascuna divisione attaccante dovrà avere al seguito 4 gruppi art. da spostare rapidamente in avanti; altre artiglierie saranno spostate in avanti appena raggiunto l'obiettivo a);
- se, raggiunti gli obiettivi a), b), c), il nemico schierato nel settore ovest della Piazza resisterà ancora, sarà eliminato con azione da tergo e con potente azione di artigli eria;
- se non riuscirà a superare la linea dei fortini su tutto il fronte d'attacco, è previsto di incanalare tutta la massa d'attacco dove si saranno prodotte delle falle.
L'attacco sarà quindi condotto da un Corpo d'Armata italiano (il XXI) agli ordini del Generale Navarrini e da un Corpo d'Armata tedesco agli ordini del Generale Cri.iwell, entrambi agli ordini del Generale Rommel.
Ciascun C.A. avrà una massa di artiglieria agli ordini rispettivamente del Comandante art. del XXI C .A . e del Comandante artiglieria del C.T.A. L'azione delle due masse d'artiglieria sarà coordinata dal Comandante artig li eria del Panzergruppe Afrika (Generale Boetscher).

Il Genera le Rommel ha anche detto che, se dopo raggiunti gli obiettivi (24 od al massimo 48 ore), il nemico schierato nel settore ovest dovesse resistere ancora e, contemporaneamente si pronunciasse una minaccia sul fronte di Sollum, penserebbe di liquidare Tobruk col fuoco dell'artiglieria (più, si sottintende, colle divisioni italiane) e correr ebbe colle «divisioni corazzate» verso est (da questa frase si deduce ch e forse il Generale Rommel pensa di impiegare, eventualmente, sul fronte di T obruk, entrambe, le divisioni corazzate tedesc h e e non so lo la 153 ).
Intanto:
- le truppe dest ina te all'attacco svolgono intenso addestramento anche in ore notturne;
- gli ufficiali eseguono molte ricognizioni;
- i reparti in linea attendono alla rimozione dei campi minati superati nello sbalzo della notte su l giorno n c.m. cd al ricupero di materiali da rafforzamento che serviranno in seguito.
Inoltre procede alacremente la costruzione de ll e piazzole, lo schieramento delle artiglierie e quello dei servizi, la costituzione dei depositi, scorte, ecc.
A fronteggiare eventuali minacce avversarie sul fronte di Sollum contempo ranee alla nostra azione su Tobruk, è prevista per ora :
- una riserva del Panzergruppe Afrika cosutulta dalla 2ta D ivisione corazzata tedesca che si dislocherà presumibilmente a sud est di Gambut;
- una riserva del Comando Superiore costituita dal C.A. di manovra italiano che ha attualmente le divisioni dislocate: «A riete >> a Bir Hacheim; « Trieste » a Gadd el Hamar; ma che saranno spostate a tempo opportuno rispettivamente a Bir el Gobi e a Bir Hacheim.
Su Ila dislocazione definitiv-a delle ri serve c sul coord in amento della loro azione non sono stati presi ancora accordi definitivi. Saranno concretati quan to prima e ne sarà data comunicazione a codesto Comando Supremo.
d'ordine
Il Generale di C.A. Capo di Stato Maggiore
 G. GAMBARA
G. GAMBARA
STATO MAGGIORE
N. or f r886rj. Op.
Allegato n. 28.
P.M. n, lì rr nov. 1941 - A. XX
Oggetto : Azione offensiva per la presa di Tobruch.
Al Comando Supt·emo per Eccellenza Cavallero
Roma
La preparazione per l'azione su Tobru ch ha proceduto alacremente in base ai progetti a suo tempo formulati: essa può ritenersi quasi ultimata. Da parte di questo Comando Superiore ogni facilitazione ed ogni possibile concor so è stato dato affinché essa fosse sollecita e comp leta.
Coi movimen ti in corso di attuazione (cf . orjr7904 del 29 ottob re) e che saranno compiuti cmro il 15 corrente, è attuato anche il prev is to schieramento delle G.U. di manovra per fronteggiare una eventuale azione nemica s ul fronte di Sollum contemporanea alla nostra offensiva sul fronte di Tobruch.
Ta 1c eventual ità (da considerarsi per noi la più sfavorevole) indusse già a valutare nuessaria, sul teatro delle operazioni, la disponibilità di un'altra divisione corazzata la « Littorio )).
Questo Comando Superiore, perfettamente conscio della capacità dei trasporti insufficienti a soddisfare anche le normali esigenze di vita e di attività delle unità qui esistenti, non ha fatto pressione per l'invio di tale divisione; ha ritenuto invece di facilitare la so luzione del problema, ottenendo, con accordi diretti, di cedere, per l 'azione di Tobruch, una sola divisione motorizzata.
Ciò posto, conviene ora considerare su un piano concreto c reale le nostre possibilità in relazione alla presumibile reazione avversaria.
E' ovvio che la contemporaneità d elle due azioni (noma su Tobruch; avversaria sul fronte di Sollum) rappresenterebbe per no• il caso più sfavorevole e quindi, nei limiti del prevedibile da evitarsi.
Tale eventual ità è stata posta sulla bilancia, e per il caso che si manifestasse improvvisa c impreveduta, sono state adottate tutte le misure possibili.

E' facilmente va lut abilc però che tali misure sono appena sufficienti a fronteggiare un'azione nemica a raggio limitato ed avente il conten uto scopo di distrarre forze dall'attacco su Tobruch (diversiva).
Se invece l'azione avversaria su l fronte di Sollum tendesse ad obiettivi lontani c fosse condotta con forze adeguate a perseguire risultati decisivi, la contemporaneità delle due azioni ci metterebbe in una crisi tale dalla quale sarebbe forse estremamente difficile uscirne in una situazione ancora soppor· tabilc.
La preparazione dell'avversario, quale risulta da tutte le fonti informative, induce a ritenere che esso sia ormai pronto ad un'azione in grande stile e che attenda so lo l'inizio del nostro attacco su Tobruch per avere faci li tato il suo compito.
I segni della sua vasta c completa preparazione sono:
- aumento di forze nel deserto occidentale (valutate a sci divisioni di forza cd armamento assai superiore alle nostre, più sci o serre raggruppamenti esploranti);
- forti concentramenti di reparti celeri nelle oasi Siwa Giarabub;
- notevo!e aumento c intenso movimento di automezzi più che raddop· piato in breve tempo;
- costruzione di una linea ferroviaria da Marsa Matruch a Bir Abu Kilab con di ramazione da Bir Abu Tunis fino a Bir e l IIalaq c lavori in corso per prolungare verso ovest i due tronchi;
- creazione di depositi avanzati nelle direzioni Giarabub • Gialo e Giarabub- Mechili;
- attività intensa di reparti esploranti motorizzati che battono la zona delle oasi Gialo. Marada e si spingono fino sulla Balbia;
- raffittimcnto dei campi di aviazione e aumento notc\'olc dci suoi mezzi aerei (36 squadroni da caccia e circa 20 squadroni da bombardamento);
intenso traffico delle trasmissioni da noi controllate e parzialmente i ntercettatc.
Ciò a conferma di quanto è stato possibile conoscere da interrogatorio di prigionieri di recente catturati fra i quali ufficiali del S.I. inglese c delle numerose altre informazioni che pervengono frequentemente da codesto Comando Supremo e dal S.l.M.
In contrapposto, la nostra situa zio ne può così sintetizzarsi:
- efficiente sch ieramento solo sul fronte di Tobru ch e sul fronte orien-
- tale; però, assenza di riserve;
- impossibilità, di contrastare l'attività esplorante avversaria nel sud gcbclico e nella zona delle oasi;
- insufficiente difesa del quadrilatero Agedabia- Gialo- Marada - el Aghcila e impossibilità di contrastare un'avanzata nemica in tale direzione;
- parvenza di copertura costiera in cu i non è efficiente neppure la vigilanza;
- insufficienza di automezzi appena appena bastanti alla vtta dci reparti in normale attività;
- assenza di gasolio e di benzina avio;
- pochezza delle scorte in viveri, munizioni, ecc.;
- rifornimenti dalla Madrepatria ridotti a possibilità puramente casua li;
- grande penuria di mezzi per la difesa contraerea;
- grande inferiorità nell'aviazione sopra ttutto da caccia.
Data questa situazione e considerato che si presenta come molto probabile il verificarsi per noi delle due cond izioni più onerose e sfavorevo li e cioè:
- azione nemica non so lo a scopo diversivo, ma in grande sti le e con mezzi adeguati a perseguire scopi decisivi;
- contemporaneità colla nostra azione su T obruch; si prospe tta a codesto Comando Supremo - per la decisione - la opportunità di sottoporre a nuovo approfondito esame l'epoca nella quale potrà essere intrapresa l'azione per la conquista di Tobru ch.
Il Generale d'Armata
Comandante Superiore FF.AA. A.S. ErroRE BASTICO

N. 30921 Op. di prot.
15 novembre 1941 - XX
Ecc. il Generale di Armata Ettore Ba.rtico Comandante Superiore Forze Armate A.S.I.
Ri spos ta al foglio n. ox/ 1886t; dcll'n.n.I941 - XX.
Oggcno: Azione su T obruk.
Come già discusso e convenuto con voi e col generale Gambara in precedenti riunioni, la presa di Tobruk è il solo mezzo per migliorare la situazione Lattico -strategica costì c metterei, se tempestivamente attuata, nella possibilità di affrontare in buone condizion i un attacco nemico in forze.
Dal punto di vista dci rifornimenti, questo comando, presi gli ordini dal Duce, ha disposto perché tutti i mezzi e tutte le forze aeree e navali disponibili siano chiamati a contributo per assicurare alla Libia la continuità del minimo dei rifornimenti necessari.
Ciò premesso, la possibilità di attuare l'azione su Tobruk al più presto, così da non essere prevenuti dall'auacco nemico, e in modo da conservare la necessaria capacità di reazione ove questo si produca subito dopo la caduta della piazza (da ottcncrsi con uno sforzo violento e rapido che il Generale Rommcl assicura di poter fare), deve esse re ricercata con ogni mezzi, prima di pensare ad un lungo rinvio.
Pe rciò:
1 ° - completamento della preparazione con i mezzi e con quelli in corso di affluenza;
2° - decisione circa il momento di eseguire l'attacco, subordinatamente ai dati della situazione generale, demandata a codesto comando che ne ha la p iena responsabilità (d' in tesa con il Generale Rommcl).

d'ordine
Il Capo di S.M. Generale
RINFORZI AEREI BRITANNICI GIUNTI DA TUTTE LE ROTTE
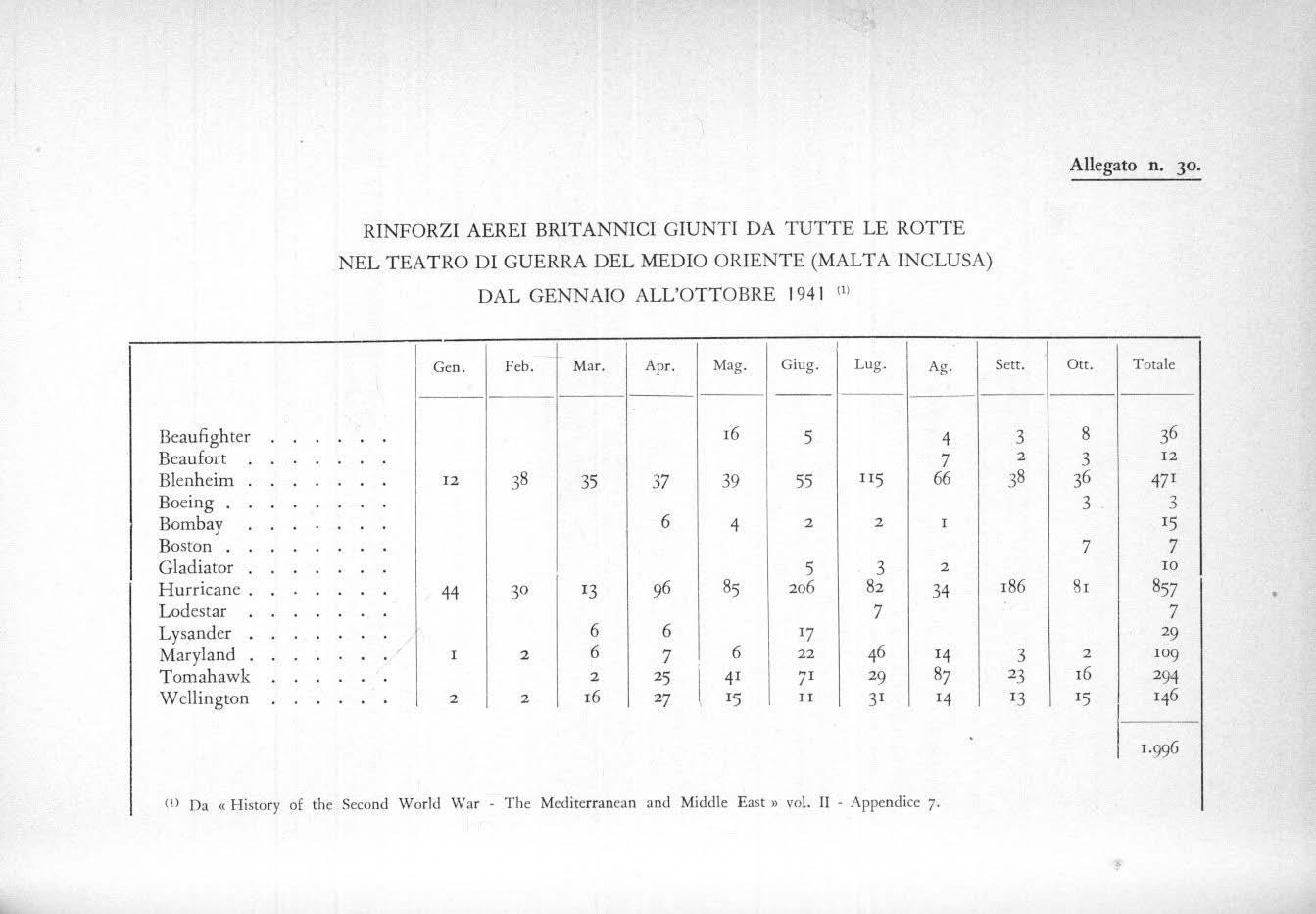
NEL TEATRO DI GUERRA DEL MEDIO ORIENTE (MALTA INCLUSA)
DAL
ALL'OTTOBRE 1941 111
Il 5 luglio 1941
PROTEZIONE AEREA AI CONVOGLI VELOCI SULLE ROTTE A LEVANTE DI MALTA
La mattina del 4 luglio, nell'Ufficio Operazioni, presieduta dal Generale Gandin si è riunita una commissione per l'esame dei seguenti argomenti:
1) rotte ad ori ente di Malta per convogli diretti a T ripoli;
2) attuali possibi1ità di scor te aeree ai convog li predetti;
3) modalità e possib ili tà di aumentare ta li scorte.
Alla riunione hanno partecipato:
il Contrammiraglio Ferreri
il Cap. di Vascello Bedeschi
il Col. A.A. r.n. Biani
il Cap. di Fregata Pucci Boncampi
il Cap. di Vascello Marcatili
per Supermarina per Supcracreo
Dall'esame dell'attuale situazione generale de l bacino del Mediterraneo centrale è emerso come le rotte per Tripoli che i convogli seguono a ponente di Mal ta, sia no per lungo tratto, a nord ed a sud di Pantelleria, obbligate entro limiti ri stretti, per la presenza delle largh e zo ne da noi minate. E' assai probab ile che i limitati specchi di mare liberi siano stati in d ividuati dalla ricogniz ione inglese che in questi ul ti mi g iorni ha seguito con particolare insistenza i convog li ch e su tali ro tte si muovevano.
Data la vicinanza di Ma lta alle rotte .Q-i ponente, queste, per quanto più brevi, sono g iu dicate più per ic olose per l'azione del bombardamento e dell'aerosiluramento, perché né la caccia (ch e d'altra parte non ha l'autonom ia necessaria per u na scor ta comp leta - raggi o di azione 85 miglia) né l'artigli er ia antiaerea, per quanto dalla loro azione si siano ottenuti risultati efficaci, consenrono di garantire in maniera sufficiente l'incolumi tà dci trasporti.
Tal i condizio ni hanno consigliato recentemente l'adozione delle rotte a levante di Malta per il convoglio veloce : il suo cari co di truppe costituiva un ele m ento particolare di valore.
Questo convoglio, partito da Taranto nell'avanzato pomeriggio (probabilm ente la presenza nel porto di Taranto era stata rivelata dalla ricognizione inglese) ha segu ito sul primo tra tto una ro tta per SSE, qu i ndi per SSW, fino all'altezza d i Misurata, indi per po nente. Tali rotte tenevano il convoglio ad u na distanza non in feriore alle 200 miglia da Mal ta, distanza ritenuta suffì.

ciente per rendere difficoltoso l'impiego degli aerosiluranti inglesi, di autonomia insufficiente. Peraltro si osserva ch e se i nuovi aerosiluranti inglesi sono del tipo Bristol- Blenheim, la loro autonomia sarà notevolmente aumentata.
Il convoglio in parola fu continuamente avvistato dalla ricognizione inglese nel secondo giorno di navigaz ion e; sul mattino del terzo giorno, lungo la rotta di atterraggio a Tripoli a breve distanza dall'arrivo, fu bombardato senza effetti.
Le rotte seguite dal convoglio consentivano la scorta aerea della caccia solo nel primo tratto (in prossimità di Taran to) e nell'ultimo tratto, quando esse intersecavano le zone di azione delle squadriglie da caccia di Misurata e Tripoli. La lungh ezza delle ro tte percorse fu di circa miglia 730, il tempo impiegato fu di ore 43 alla velocità di 17 nodi.
L'in conven iente di tale rotta è che essa lascia il convoglio fuori della portata dell'aviazione da caccia per tutta la durata diurna del secondo giorno di navigazione.

Perciò, partendo dal presupposto di poter dislocare squadriglie da caccia ad Araxos (Capo Papas) ed a Kalamata (Morea) ed a Bengasi, si sono esaminate delle altre rotte spostate ancor più verso levante che, al vantaggio di una maggiore distanza da Malta accoppiassero il vantaggio di più efficace protezione della caccia aerea, partente dai punti menzionati.
Lo svantaggio di tali rotte è un maggior percorso c cioè un maggior tempo del convoglio in mare.
Date le ore di navigazione diurna e notturna si è praticamente visto che una sq uadriglia da caccia dislocata a Bengasi non porterebbe sensibile vantaggio; si è invece rilevato che un convoglio partente da Taranto o da Brindisi alle ore 17 circa del giorno X con rotta orientata circa per S.E., a distanza di circa 40 miglia dalle isole Jonie e dalla Morea, e dall'altezza del meridiano 20° E circa per SW fino a prendere una rotta per ponente su Tripoli, potrebbe essere scortato dalla caccia aerea di L ecce dalla partenza fino al tramonto del giorno X, dalla caccia di Araxos c di Kalamata dall'alba del giorno X +I fino al limite delle possibilità (Yz giorno per la caccia italiana; fino al tramonto per la cacc ia tedesca eventualmente dislocata a Kalamata), dalla caccia di Misurata e di T ripoli dall'alba del giorno X + 2 fino all'arrivo a Tripoli, che avverrebbe alle ore 15 circa dello stesso giorno. Il percorso è di circa mg. 770; la sua durata di circa ore 46.
Tali rotte, che dovrebbero essere presso a poco segu ite anche nel viaggio di ritorno, si presentano vantaggiose purché si possano dislocare due squadriglie da caccia i tal iane, una ad Araxos e l'altra a Kalamata; oppure due squadriglie di caccia pesante (Me no) tedesche, ambedue a Kalamata (data la loro maggiore autonomia). ·
Conclusione:
- la rotra anzidetta sembra la più consigliabi le. Occorre però esaminare la possibilità di dislocare due squadrigli e da caccia, una ad Araxos, l'altra a Ka!amata;
- per quest'ultima località si potrebbe chiedere all'aviazione tedesca un gruppo od almeno una squadriglia da caccia pesante (Me uo). Sembra che tale richiesta possa essere avanzata all'aviazione tedesca in cambio della richiesta a noi fatta di una squadr iglia caccia ad Araxos (che non s'identifica con quella segnalata come necessaria) per la scorta nel golfo di Patrasso, di due squadrig!ic di caccia per la protezione di Atene e del gruppo di caccia a Candia, la cui base sarà pronta ad ottobre.
Dalla riunione è inoltre emersa la necessità di mantenere un più stretto Segreto sulle partenze dei convogli; potrebbe esse re anche st udiata la poss ibili tà di imbarco in più por ti (Taranto, Brindisi, Bari) con riunione in mare, allo scopo di dare meno nell'occ hio.
Sarebbe utile e raccomandabile la dislocazione di una squadriglia di ricognizione marittima (C.Z. 506) a Sud per l'esplorazione delle acque 11el canale di Creta onde garantire, entro i limiti del possibile, le provenienze da levante, nei giorni interessanti il transito dei convogli. A questo scopo bisognerebbe prendere accordi con il X C.A.T. a variazione di quelli esistenti, fissando bene che scopo de' la squadriglia è la protezione dei convogli ve loci, dci quali usufruiscono anche le truppe tedesche.

E' importante che, in prevjsione di convogli per la Libia, siano effettuate ricognizioni aeree su Malta allo scopo di accertare la presenza in quella base di unità da guerra. Se la loro assenza è constatata, si può contare su non intervento di una divisione in crociatori al!a sco rta e usufruire dci CC.TT. assegnati alla divisione stessa per rinforzare la scorta navale del convoglio.
In vista del rafforzamento della caccia aerea nel settore Jonico, si potrebbe ra ccomandare a Superaereo l'esa m e di un eventuale alleggerimento della caccia negli scacchieri settentrionali.
Per i convogl i lenti (materiale) la so lu zione della rotta a levante di Malta non può essere adottata perché le traversate durerebbero circa 4 giorni e per lungo tempo fuori della protezione aerea. Per tali convogli non c'è che la rotta di ponente; per rinforzare al massimo la difesa di artiglieria contraerea a bordo delle navi, e nei limi ti del possibile, le scorte navali ed aeree.
Dall'esame de1l'insieme della si tuazione sempre più si rende palese la perico losissima funzione di Malta come elemento di valido contrasto sulle nostre comunicazi"Oni vitali con la Libia. Il problema di queste comunicazioni potrà essere integralmente risolto solo con l'occupazione di Malta. Tale azione, di vastissima c assai complessa mo1e, non potrebbe essere sostenuta dai nostri soli
mezzi, navali ed aerei. Comunque appare necessario una ripresa delle azioni aeree su Malta, ora in ncna diminuzione, come dall'accluso grafico: c mli azioni dovranno essere organizzate in piena adesione al movimento dei convogli
Per il preminenre interesse dci trasporti marittimi con la Libia, che soli possono consentirci di conservare effic ienza alle forze che difendono quello è apparso asso l utamente necessa ri o ch e continu i ad essere polarizzara su tali trasport i ogni attività delle nostre forze navali c che non vengano distratte le forze aeree destinate alla loro protezione, forze ch e, anzi, dovrebbero essere aumentate.
Nora. - Da parte di Superaerco è stato ordinato un sopralluogo a Kalamata per riconoscere le possibilità del campo che risultava in approntamento.
Allegato n. 32.
COMANDO SUPREMO
1° REPARTO
UF F I CIO O PERAZION I ScACCH IERE OcciDENTALE
Prot. ro82ojOp.
Oggetto: Esigenza « C3 >>.
Mario Roatto
Capo di Stato R.E.
14 ottobre 1941 • XIX
A prescindere dall'attuale situazione in Mediterraneo, considero necessario aggiornare e comp letare gli st udi già compiuti conce rnenti l 'eventuale operazion e per l 'occupazione dell'isola di Malta, sv iluppandoli anche nella parte rela tiv a alle prcdisposizioni possibi li, con particol are riguardo all'indispensabile addestramento spec iale de ll e truppe destinare all'imp resa.
Vi prego, pertanto, di trasmetrermi uno studio esaurie nte su ll 'organ izzazione, preparazione e svil up po tecnico dell'operazione, basandovi sul presupposto che siano disponibili i mezzi navali ed aerei occorrenti.
In partico1are, lo studio dovrà contenere dati concreti circa specie e quantità delle forze, nonché dci mezzi, del R.E. previsti necessari per l'esecuzione dell'operazione.

Ai fini dell'addestramento speciale dci reparti che fossero destinati ad effettuarla, occorre siano approntati con la maggior sollecitudine uno o più campi sperimentali in sede di terre no aventi caratteristiche per quanto possibìle similari a quelle dell'isola.
E' ovvia, infine, la necessità di mantenere il più ermetico segreto in proposito, onde sono da adottare sin d'ora tutte le precauzioni atte a neutralizzare e sviare qualsiasi indiscrezione, sia eliminando rigorosamente dalle corrispondenze e dalle conver sazioni ogni specifico ri ferimento a Malta, sia presentando l'addestramento, per le comunicazioni che si rendessero indispensabili agli enti dipendenti, come corollario completiva di quello già svolto per l'approntamento all'esigenza <<Cors ica ».
Converrà anzi che, ai fini ora detti, questa nuova esigenza venga denomi. nata (( c3 )) .




CPT.l CPT.II
- Situazione dopo la prima offensiva britannica. Forze contrapposte a fine febbraio 1941
Situazione delle forze ital iane .
Concorso di forze tedesche. P r ime trattative. Affluenza del X Corpo Aereo (Tedesco) in Sicilia. Costituzione del Corpo Corazzato Rommel in A.S.
P r ime impressioni e primi rapporti del generale Rommel
Sc h ieramento delle forze ita lo- tedesche alla data del 24 febbra io 1941

Sc h ieramento c consistenza delle forze bri tanniche a fine febbraio 1941
Contrastanti i nd icaz ion i su gli ori entamenti operativi b ritannici
Variant i nella dipendenza c nello sch ieramento delle un i tà italo - tedesc h e nella prima metà di marzo. Occupazione di Marada
- Situ azio ne politico- militare nello scacch iet·e balcanico e in A O .I Sviluppo della situazione aero- navale nel Mediterraneo
Evol uzione del r appor to russo- german ico
La sit uaz ione i n Grecia
Gl i avveniment i i n Bulgaria Ripercussioni in T ur chi a
Gli avven iment i in Jugoslav ia .
Si tuazione ac ro -navale nel Mediterraneo
Le operaz io ni i n Afr ica Orientale Italiana
Valutazione b ritann ica della situazione poli t ico- mi l itare genera le
CPT.III - della Libia. gli alti comandi italiano, britannico . Pag. 39
Potenziamento della Libia .
Previsioni di offensiva parziale. Orientamento italiano e obiettivi tedeschi
Orientamento britannico nei riguar di di un "eventuale controffensiva italo- tedesca. Ordini del Comandante britannico in Cirenaica .
CPT. IV - Difesa dci presidi di Cufra Giarabub
L'Oasi di Cu(ra
Le operazioni nell'Oasi di Cufra (18 febbraio-1 ° marzo 1941) o

L'Oasi di Giarabub
Le operazioni nell'Oasi di Giarabub (x6 febbraio- 21 marzo 1941)
CPT. v
- di El del Comando Supremo Italiano del Comando Britam1ico del alla dz marzo
Occupazione di el Agheila
Direttive de l Comando Supremo italiano
Direttive del Comando britannico del Medio Oriente
CPT. VI
- La riconqu ista della Cirenaica ( 31 marz.o- 13 aprile I94l)
Fasi dell'operazione
Situazione iniziale delle forze italo - tedesche
Situazione delle forze britanniche
l Fase: da d Agheila a Bengasi (JI marzo- notte sul 4 apri Le operazioni dal 31 marzo al 2 aprile
Ordini dd gen . Rommd la sera del 2 aprile .
Direttive ed ordini dell'Alto Comando Britannico nel pomeriggio e nella tarda serata del 2 aprile
La giornata del 3 aprile
L'intervento del Comando Supremo. Azione del gen.
Considerazioni del gen. \Vavcll. Commenti di Church ill Pag.
La notte sul 4 aprile: occupazione di Bengasi. Ripiegamento delle forze britanniche n 88
Il Fase: da Agedabia e Bengasi su M echi/i- Derna ( 4-8 aprile). Il concetto d'azione >> 89
giornata del 4 aprile »
giornata del 5 aprile »
giornata del 6 aprile »
giornata del 7 aprile »
giornata dell 'S aprile » 99
[[[ Fase: da Derna- Mechili a Bardia- Sollum ( 9 - r 3 aprile). Investimento di Tobruch e presa di Bardia - Sollum »
CPT. vn - Le operazioni contro Tobruch ( 14- 17 aprile e JO aprile- 2 maggio 1941)

Capacità difensiva e offensiva della Piazza
Il terreno
Le com umcaz10nt
La sistemazione difensiva preesistente
Organizzazione difensiva britannica
Direttive britanniche per la difesa di Tobruch: 14 aprile 1941
Primo attacco di Tobruch: 14- 17 aprile 1941
Considerazioni
Situazione delle forze dell'Asse nella seconda quindicina d'apri le. Necessità di una sosta operativa .
La situazione nella va lutazione degli Alti Comand i italiani e tedeschi
La situazione britannica
Ricognizioni e puntate offensive nella seconda quindicina di ap rile
La situazione delle forze alla vigilia del secondo attacco Pag. 137
Il secondo attacco di Tobruch: 30 aprile- 2 maggio 1941 » T4I
Contrattacchi britannici c azione d i nostri gruppi d'assalto: 2 - 18 maggio 1941
CPT. VIfJ - Fallito tentativo di offensiva britannica le posizioni di Halfaya- Sollum- Capuzzo (operazione « Brezity »: 15 - I8 maggio 1941)
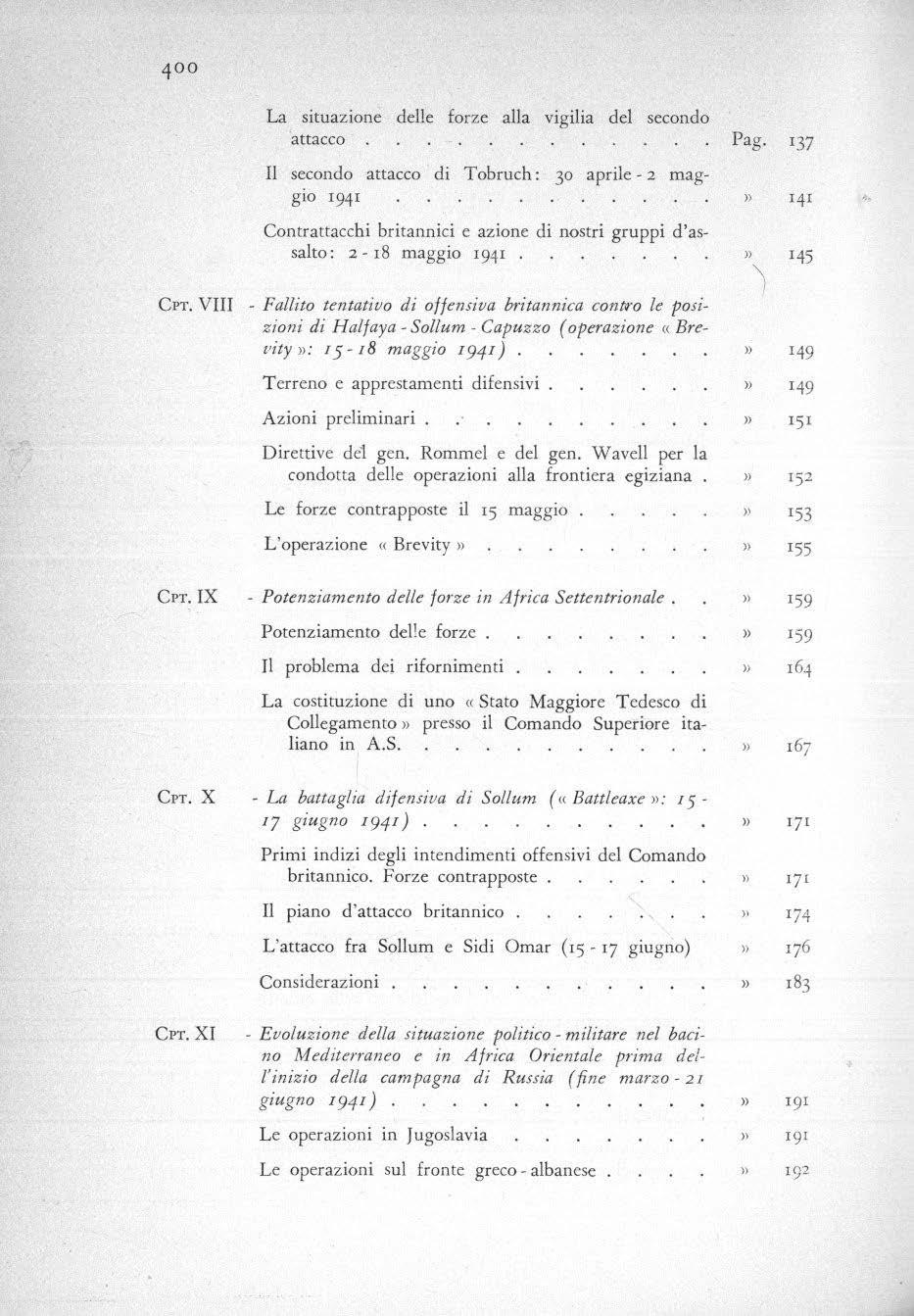
Terreno e apprestamenti difensivi
Azioni prelimina ri
Direttive de1 gen. Rommel e del geo. Wavell per la condotta delle operazioni alla frontiera egiziana
Le forze contrapposte il 15 maggio
L 'operazione « Brevity >>
CPT. IX
- Potenziamento delle forze in Africa SetterJtrÌonale .
Potenziamento forze .
n problema dci rifornimenti
La cost itu z ione dì uno «Stato Maggiore T edesco di Collegamento » presso il Comando Superiore italiano in A.S.
CPT. X
-La battaglia difensiva di Sollum (« Battleaxe »: 1517 giugno 1941)
Primi indizi degli intendimenti offensivi del Comando britannico. Forze contrapposte
CPT. XI
- Evoluzione della situazione politico- militare nel bacino Mediterraneo e m Africa Orientale prima dell'inizio della campagna di Russia (fine marzo - 21 giugno 1941)
CPT. XII - Contrasto di opinioni con il Comando tedesco sulla defini z ione della posizione difensiva
Missione del Capo di Stato Maggiore dell'Eserc ito .
Caratteris t iche dello schieramento i taio- tedesco ai primi di agosto
Studi relativi all'eventuale abbandono della Marmarica
Diverso orientamento dd Maresciallo Keitel. Saprailuogo del gen. Cavallero accompagnato dal gen. von Rintelen
Conclusione
CI'T. XIII - Occupazione anglo - russa dell'han ( 25-28 agosto 1941)
C!'T. XIV - Attività operativa tra la battaglia difensiva di Sollum e la seconda offensiva britannica
Nuova organizzazione del Comando Britannico del Medio Oriente
Attività esp1orativa e di disturbo
Attacco di sorpresa britannico a Tobruch (3 agosto)
Ricognizione offensiva tedesca a sud di Sollum (r4- 16 settembre)
Modifiche allo schieramento italo- tedesco nel mese di ottobre in vista di un nuovo attacco a Tobruch
Sintomi di imminente offensiva britannica
CI'1·. XV - Perdite subite dalle forze italo- tedesche nel periodo compreso fra la prima e la seconda offensi v a britannica ( 15 febbraio - 16 novembre r941)

Aspetù generali del problema dei trasporti in A.S
Capacità di scaricamcnto dei porti libi c i .
Lotta ad oltranza contro i convogli dell'Asse
Colloquio italo tedesco. La crisi dei trasporti si aggrava
Ricerca e organi.Gzazione di nuove basi. Necessità di disporre dcl!e basi tunisine .
Scelta di nuove rotte .
La neutraliaazionc di Malta
Possibilità di azione aeronavale contro la flotta inglese nel Mediterraneo
Protezione dci convog li
Personale e materiale trasportati 111 Libia, via mare, nel 1941
CPT. XVII - ConsidaazJoni generali sul problema di .\!alta .

A ll. 1 - Foglio n. 6239 / 0p. 1°, del 6 febbraio 1941, del Comando Supremo - il Duce, relativo a lle d irettive al Maresciallo Graziani Comandante Supe r iore Forze Armate A.S l. Pag. 301

)) 2 - Telegr amma n. 6330 / 0p. delì ' n febbra io 1941, del Comando S u periore FF. AA. Afr ica Settentr ionale a SuperComando A. S. >> 302
» 3 - Teleg r amma Gen Guzzoni 6341 dell'n febbraio 1941 in risposta a telegramma oi / I58o / Op. 1 >> 303
>> 4 - Teleav io n. or / 1917 de l 20 febbraio 1941 del Comando Superiore FF AA Africa Settentrionale - Diretto al Ministero Guerra -Gabinetto, relativo alla formazione Grandi Unità >> 304
>> 5 - Dispaccio 3/ r, del 13 febbraio Supercomando A S.I. a Comando Supremo Ita li ano, circa visita Gen . Roatta alla Comm issione germanica di Sirte >> 300
>> 6 - Situazione della fo r za dis locata in L ib ia alla data 20 febbraio 1941 . >> 308
>> 7 - Situazione viYeri - derrate - carburante - lu brificante per le es igenze mil ita r i in L ibia, alla data del 20 febbraio 1941 >> 31·)
:> 8 - Cost i tuzione o r ganica della Divisione co razzata inglese, ìn base a i dati i n possesso del SIM '' 311
>> 9 - Relazione n. 106/3-41 del 20 marzo 1941 del C.T.A. diretro per conoscenza al Comando Superi ore A.S. circa una valutaz ione delle possib i lità di una operazione di attacco nel Nord Africa >> 313
>> ro - Ordine di battaglia delle FF.AA. ital iane in Africa Settentr ionale al 1° ap ri le 1941 - XIX » 324
» II - Ord i ne di battaglia della D i visione corazzata «Ar iete >> ( 132") alla data l o aprile 1941 - XIX . » 350
>> 12 - Situazione della forz a d islocata i n Li bia alla data 1° apri- · le 1941 . >> 352
Ali. 13 - Situazione della forza della 5a Squadra aerea al 1° aprile 1941 - XIX Pag. 354

>> 14 - Comunicazione del Corpo T edesco in Africa per l'azione contro T obruch
>> 15 - Foglio n. 222/41 del 26 / 4 / 41 , d el Corpo Tedes co in Africa, circa l' ordine per l'esecuzion e di azioni dimostrative, da attuare nel periodo dal 28/4 al 1°/5/1941 per l 'attacco di T obruch
>> 16- Foglio n. 230 / 41 del 27 14 / 41 del Corpo Tedesco 111 Africa circa l'ordine per l ' attacco su Tobruch
» 17 - Piano cronologico del Corpo Tedesco in Africa per l'attacco di Tobru c h relativo ai giorni 30 aprile c 1° maggio 1941
>> r8- Fogl io n . 230/41 del Corpo T edesco in Africa relativo a rettifi che al piano orario c all'ordine d i attacco di Tobruch
>> t 9- Foglio 246/4 1 del 2 / 5/4 • del Corpo Tedesco in Afr ica contenente l'ordine per l 'ulteriore atta cco d i T obruch .
" 20- Foglio 275 d e l 14 /6/ 41 rc!ativo alla composizione ed ai compiti dello Stato Maggiore di collegamento tedesco .
•• 21 - Foglio 300&;/0p. del giugno 1941 del Comando Supremo Italiano ai gene rali Gariboldi e Roatta all'oggetto: Ufficiale di collegamento presso i l Comando Superiore FF. AA. dell' A.S. I.
>> 22 - Caratteristic he dei mezzi co razzati i ta liani , tedeschi e inglesi impiegat i in A.S. .
•• 23 - Verbal e relativo alle questioni trattate nella r i unione del1'8 agosto 1941 in Cirene .
>> 24 - Foglio del 6 sc ucmbre 1941 del Comando Supremo I taliano riguardant e la dislocazione del Corpo d'Armata mobile
u 25 - Foglio del 13 settembre 1941, d el Comando Divisione « Z.B.V. Afrika >> per l'ope razione ((Sogno di una notte d'estate>>
>> 26 - Foglio 95 / 41 de l r6 settemb re 1941 del Comando Panzergruppe Afrika c irca la ricognizione in forze nella zona di Dar el Hamra, effettuata il 14 settembre 194t
" 27 - Fogl io o r f 17550 Op. del 26 onobre 1941, del Comando Superiore FF. AA. Africa Settentrionale diretto al Comando Supre mo Italiano relat ivo al proge tto per l'atta cco di T obruch
Ali. 28 - Foglio 01/18865 Op. dell'Il novembre 1941 del Comando Superiore FF.AA. Africa Settentrionale diretto al Comando Supremo Italiano circa l'azione offensiva per la presa di Tobruch Pag. 384
>> 29 - Foglio 30921 Op. del 15 novembre 1941 del Comando Supremo Italiano diretlo al Generale Bastico riguardante l'azione su Tobru ch » 387
l> 30 - Rinforzi aerei britannici nel teatro di guerra del Medio Oriente (Malta inclusa) dal gennaio all'ottobre 1941 • » 388
n 31 - Relazione della riunione del 4 luglio 1941 tenuta nell'Ufficio operazioni del Comando Supremo sulla protezione aerea ai convogli veloci sulle rotte a levante di Malta . >> 389
>l 32 - Foglio 10820/0p. del 14 ottobre 1941 del Comando Supremo Italiano, diretto all'Ecc. Roa na circa (( c 3 >> )) 392

Schizzo n.
(in busta a fine volume)
- Nostra situazione al 24 febbraio 1941. - Dislocazione forze Sahara Libico.
» » 2 - Presunta dislocazione delle forze britanniche al 28 febbraio 1941.
>> >> 3 - Dislocazione sommaria degli elementi avanzati italo - tedeschi al 9 marzo 1941.
» » 4 - Presidio di Cufra. - Le operazioni dal 18 febbraio al I 0 marzo 1941.
>> » 5 - Presidio di Giarabub - Sistemazione difensiva al 10 febbraio 1941. - Attacchi britannici dal 16 al 21 marzo.
» » 6 - Nostra situazione al 30 marzo 1941. - Dislocazione forze Sahara Libico.
» >> 7 - Presunta situazione forze britanniche al 30 marzo 1941.
>> >> 8 · Le operazioni dal 31 marzo alla notte sul 4 aprile 1941.
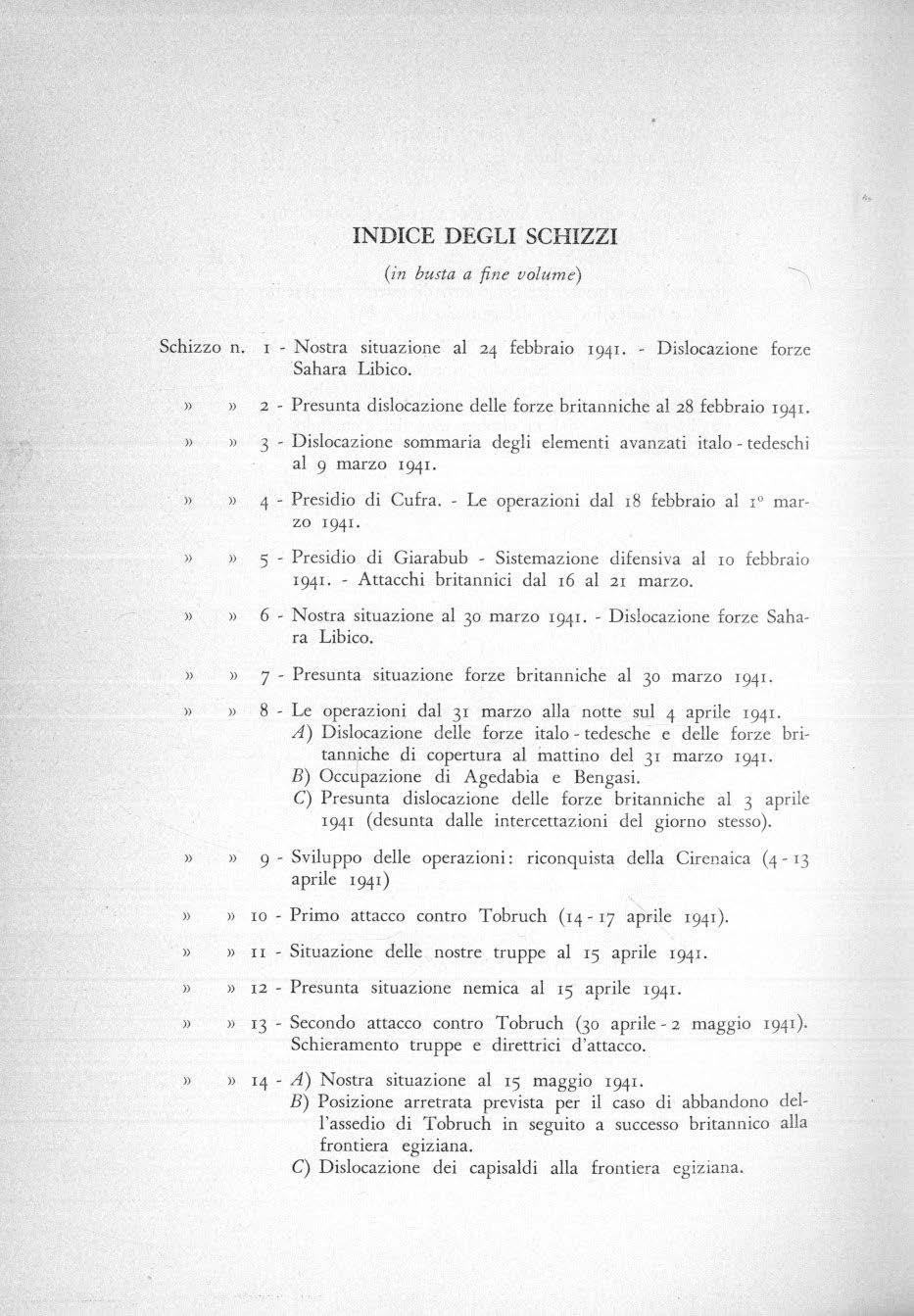
A) Dislocazione delle forze italo - tedesche e delle forze britanniche di copertura al mattino del 31 marzo 1941.
B) Occupazione di Agedabia e Bengasi.
C) Presunta dislocazione delle forze britanniche al 3 aprile 1941 (desunta dalle intercettazioni del giorno stesso).
» >> 9 - Sviluppo delle operazioni: riconquista della Cirenaica (4- 13 aprile 1941)
>> » IO- Primo attacco contro Tobruch (14-17 aprile 1941).
>> » II - Situazione delle nostre truppe al 15 aprile 1941.
>> >> 12 - Presunta situazione nemica al 15 aprile 1941.
>> >> 13 - Secondo attacco contro Tobruch (30 aprile- 2 maggio 1941). Schieramento truppe e direttrici d 'attacco.
» » 14 - A) Nostra situazione al 15 maggio 1941.
B) Posizione arretrata prevista per il caso di abbandono dell'assedio di Tobruch in seguito a successo britannico alla frontiera egiziana.
C) Dislocazione dei capisaldi alla frontiera egiziana.
Schizzo n 15 - Presunta situazione forze britanniche al 15 maggio I94I.
» >> 16 - Primo attacco britannico contro le posizioni di Halfaya - Sollum- Capuzzo (r5- r8 maggio 1941).
» » 17 - Situazione delle forze contrapposte al 6 giugno 1941.
» » r8 - Nostra situazione al mattino del 15 g iugno 1941. Dislocazione forze aeree al 15 giugno 1941. Dislocazione dei capisaldi sul fronte di Sollum.
» » 19 - Battag lia dife ns iva di Sollum (15- 17 giugno 1941).
Sit uazione alla sera del 15 g iugno. Situa zione alla sera del r6 g iugno . Situazione alla sera del 17 giugno. Sit uaz ione alla sera del 18 giugno
>> » 20 - Le operazioni nello scacchiere balcanico, nel vrcmo e medio oriente (aprile- agosto 1941).
A) Occupazione dell'isola di Cand ia (19- 28 maggio 1941).

B) Le operazioni in A.O.I. (febbraio - novembre 1941).
>> » 21 - Ricognizione in forze della 2I 3 D. cr. germanica a sud- est di Sollum (14- 15 settembre 1941)
» » 22 - Forze contrapposte a contatto il 18 nove mbre 194 1. Ricognizione aerea italiana e tedesca del giorno 15 novembre 1941.
Presunta situazione forze britanniche al 18 novem bre 1941.