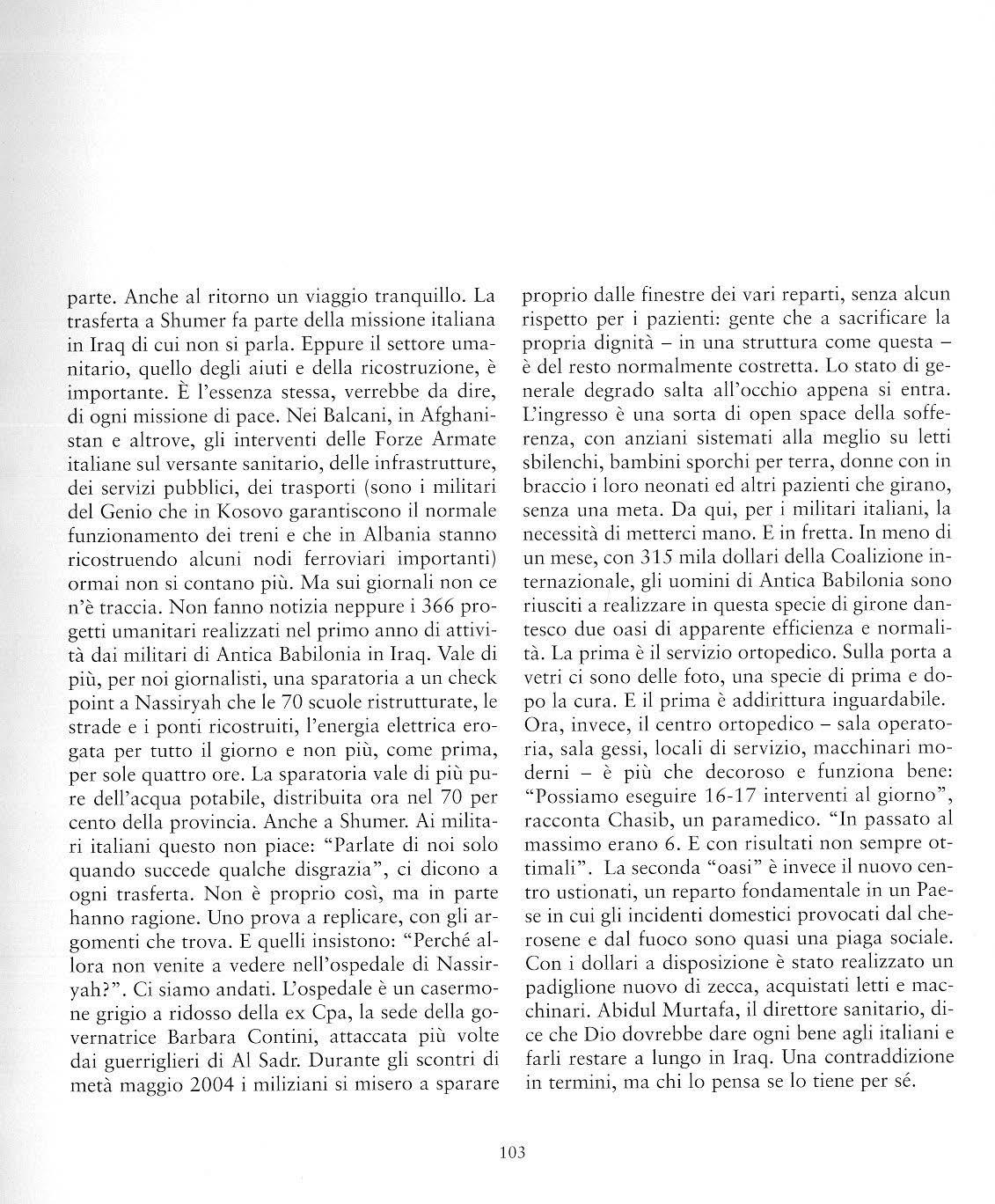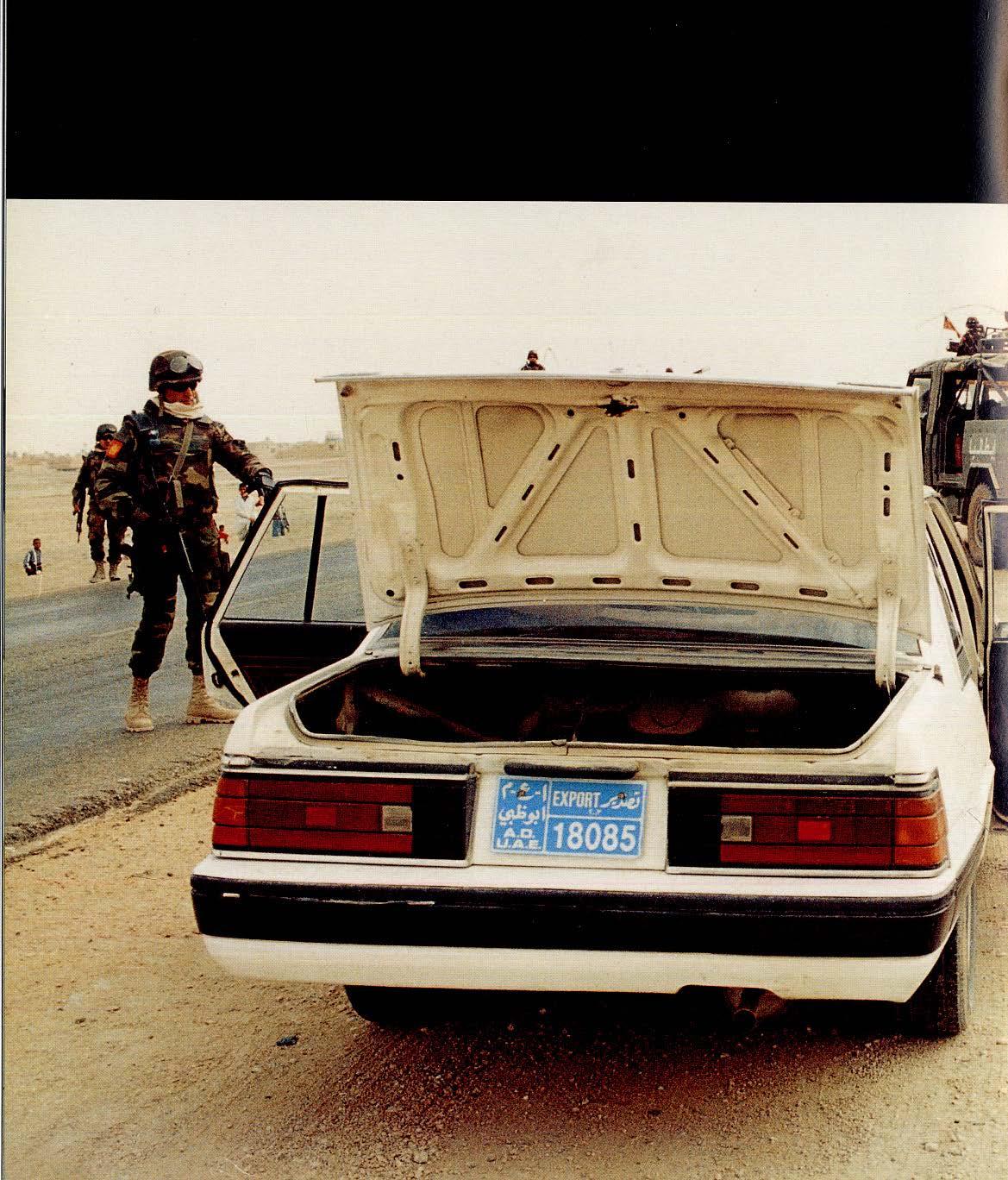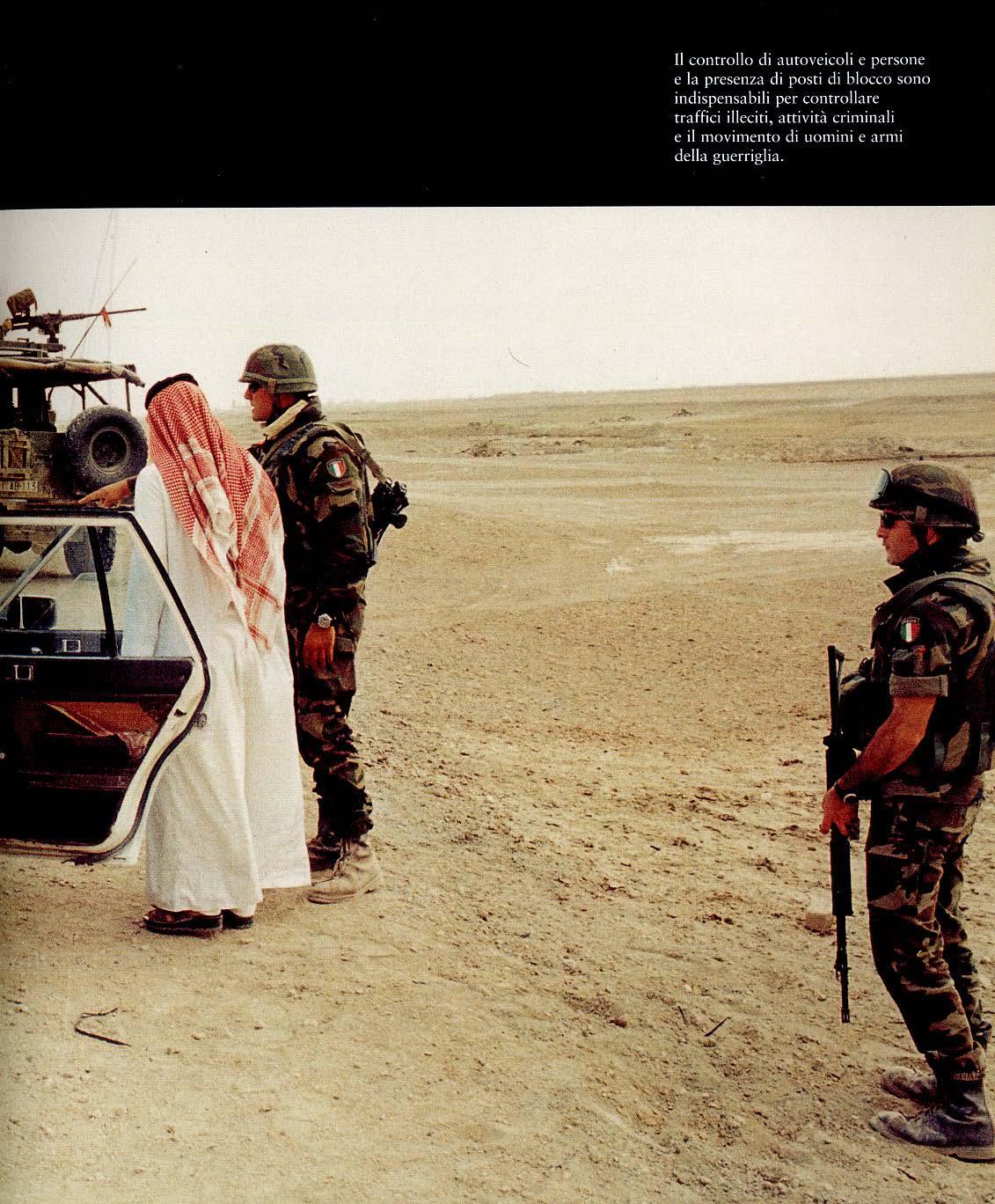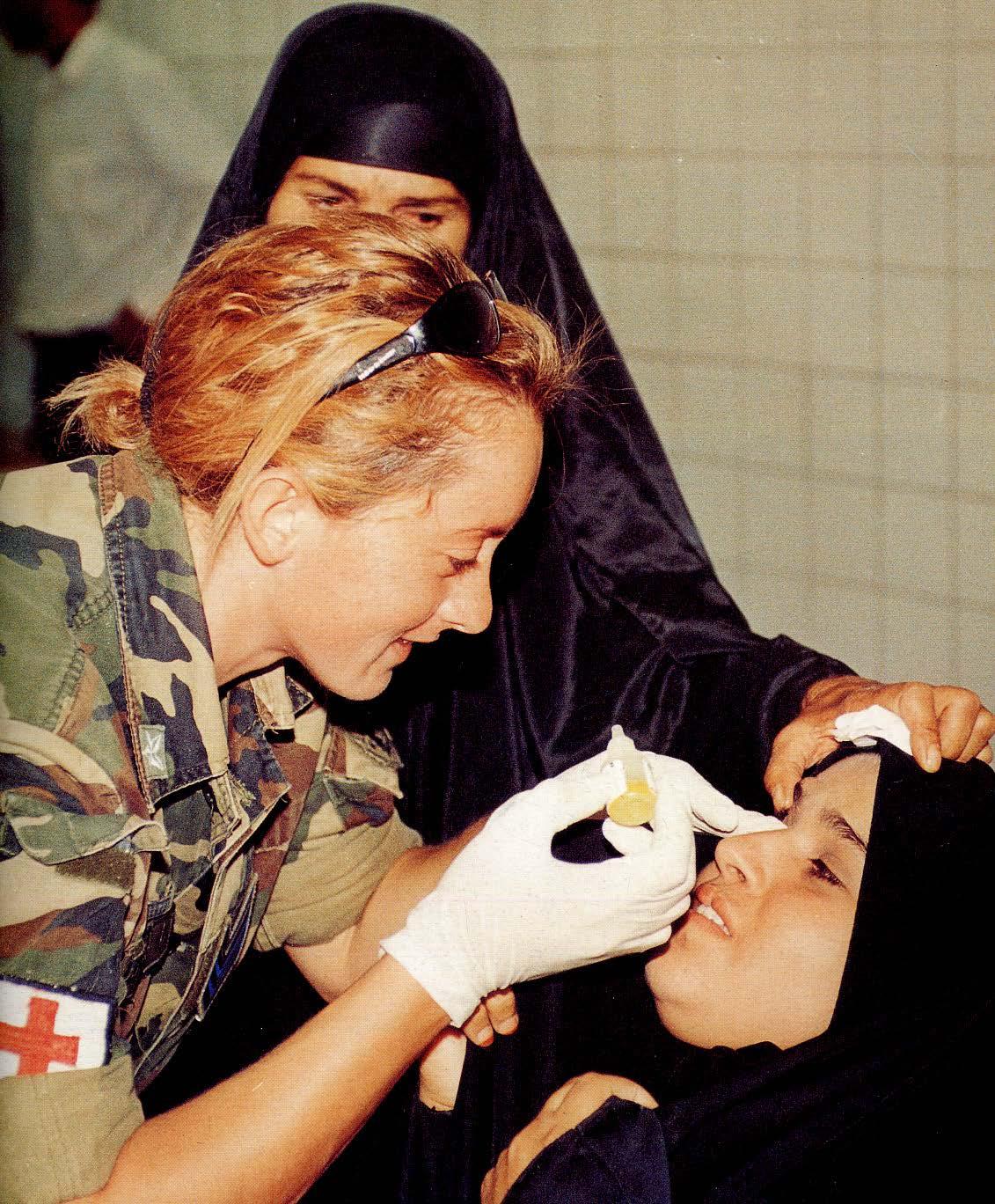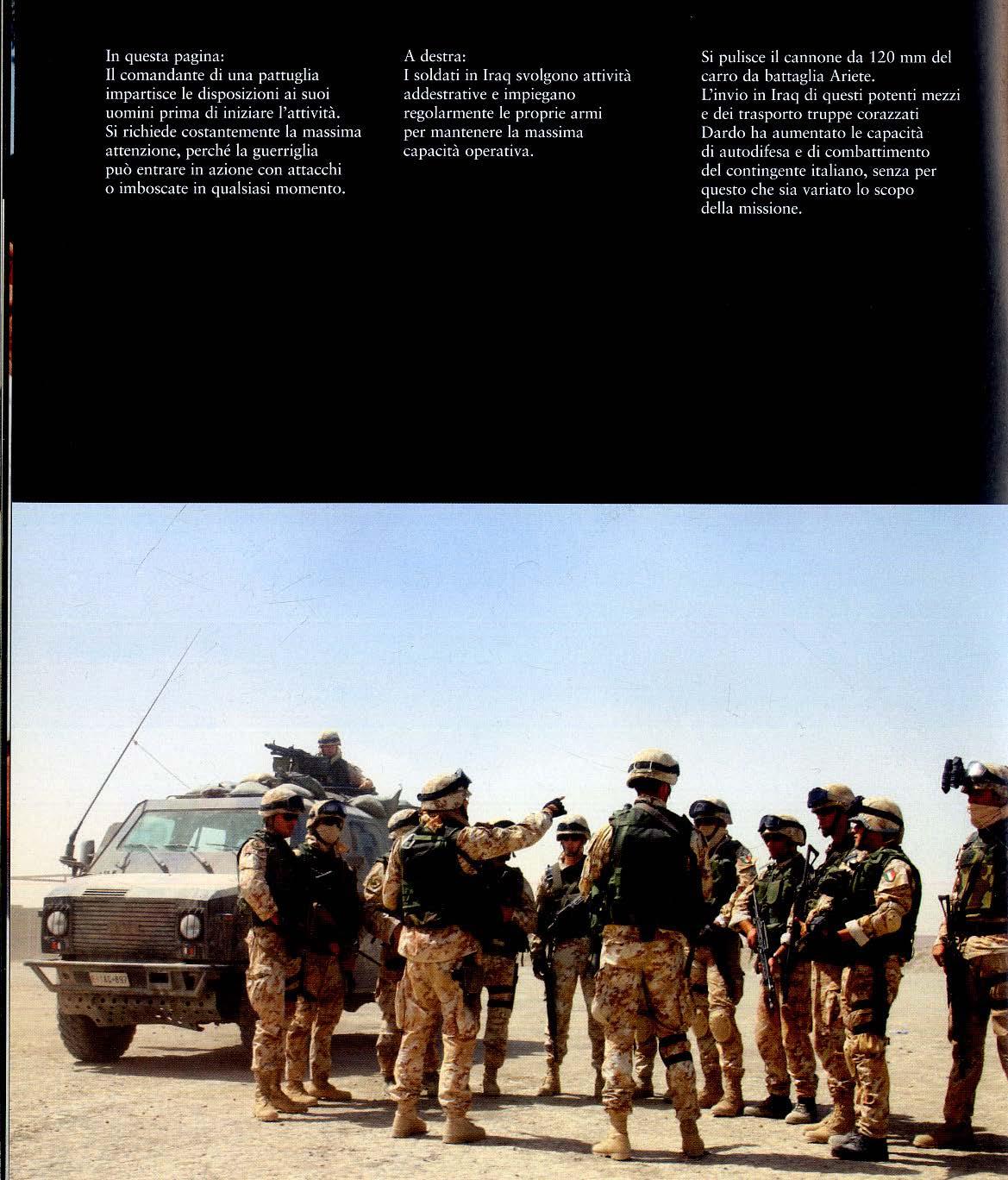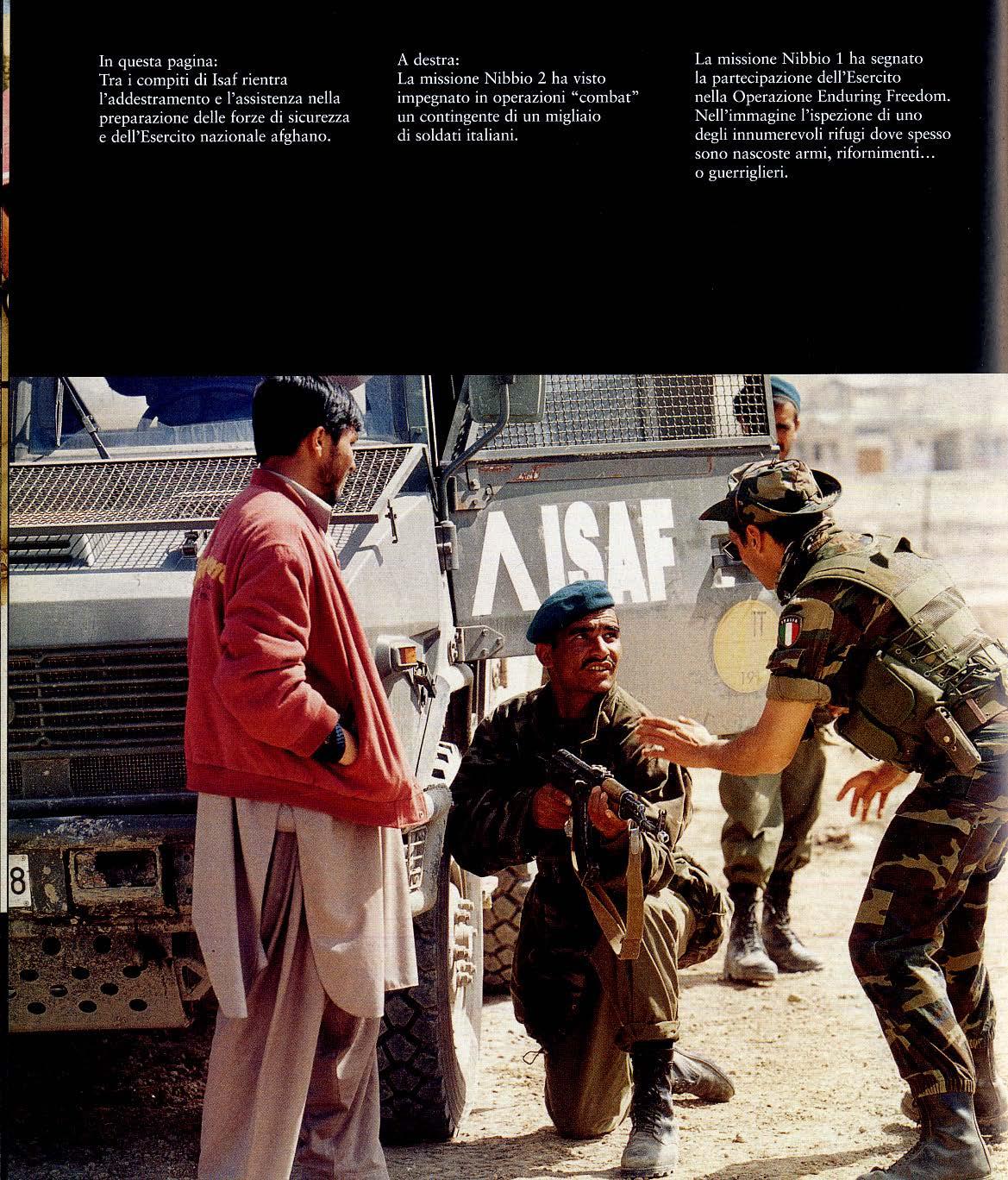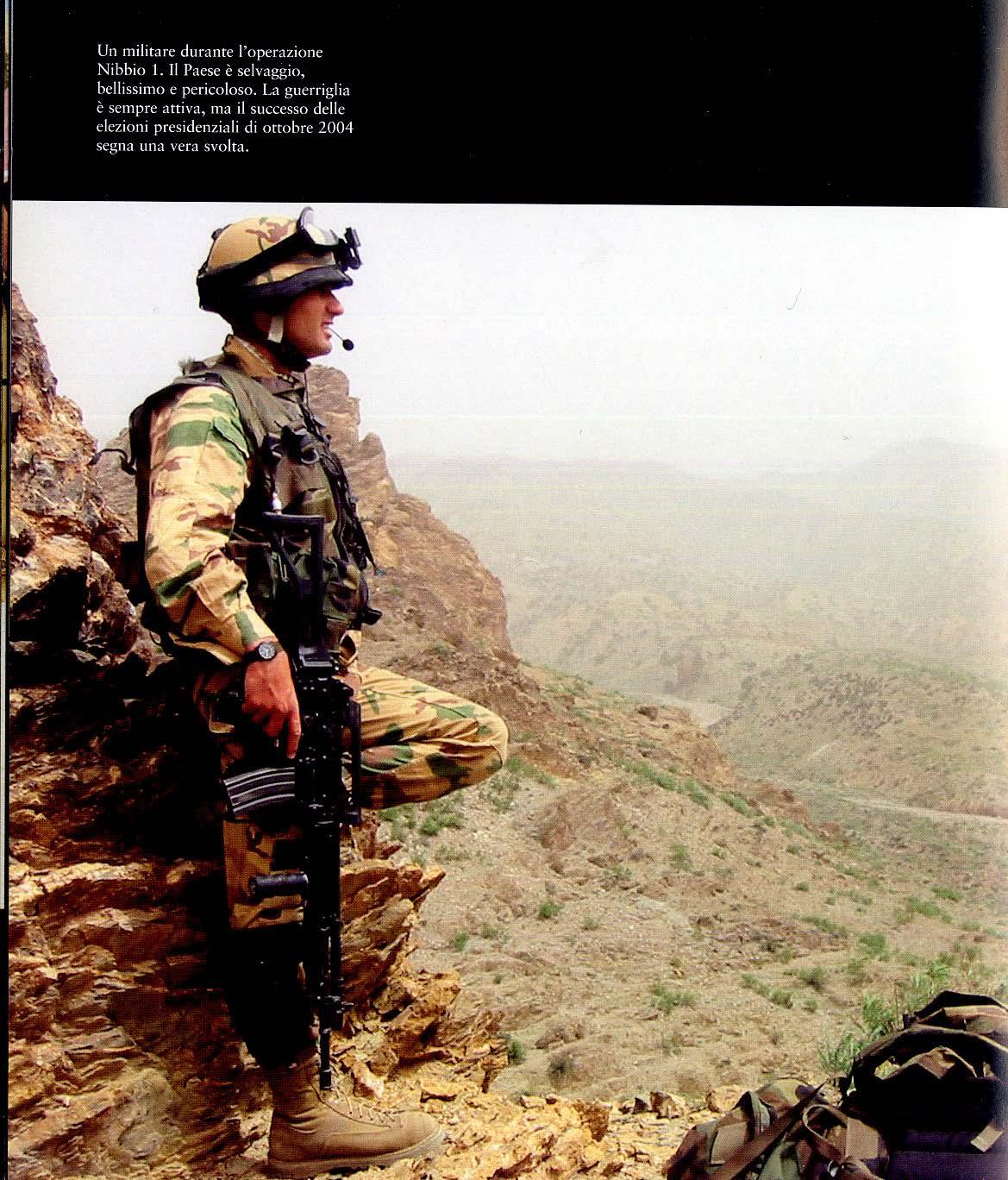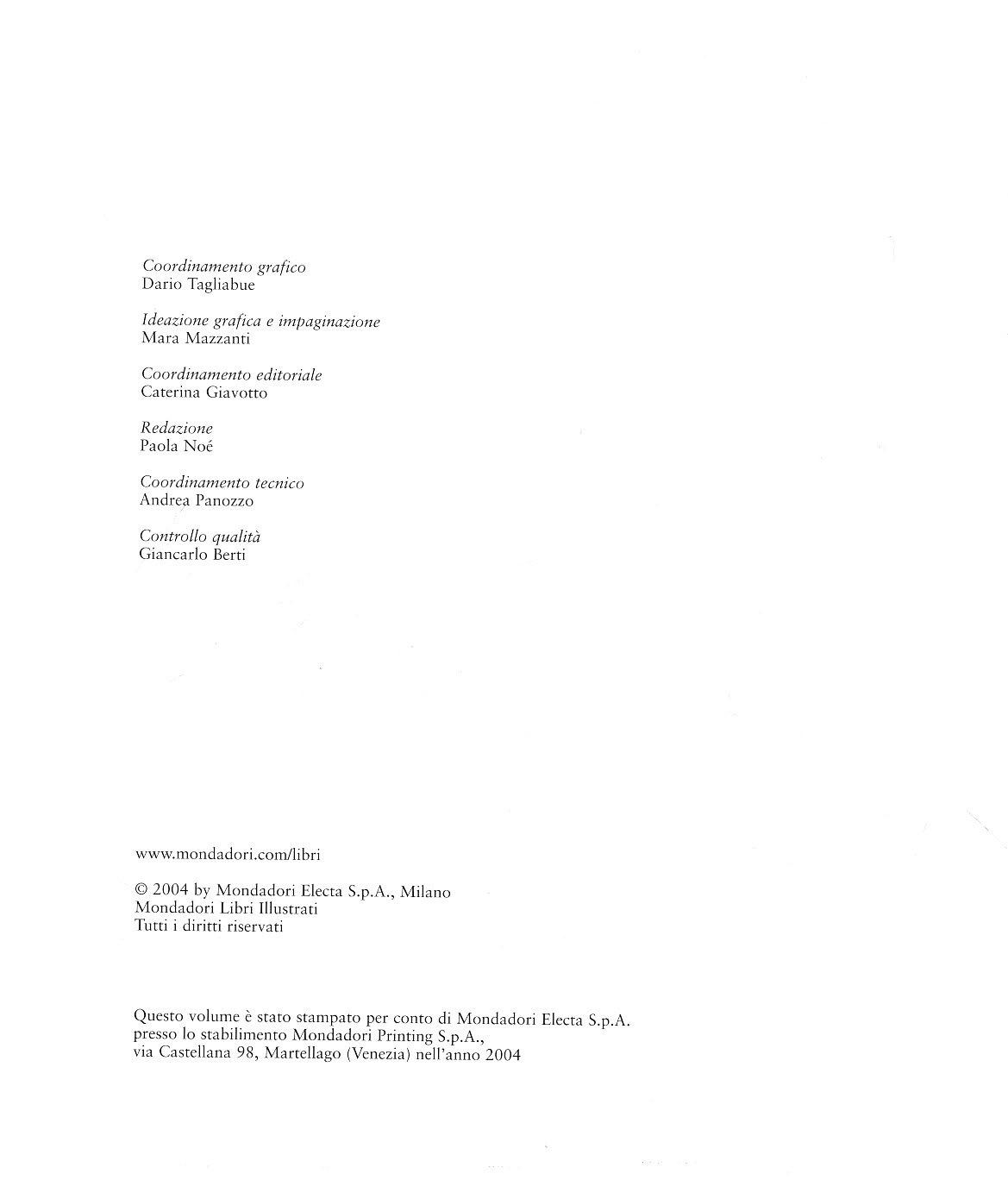Sono trascorsi quindici anni dal novembre 1989 che vide la caduta del muro di Berlino e l'inizio del processo di riavvicinamento fra l' ex mondo comunista e il mondo occidentale . La fine della guerra fredda ha avviato una straordinaria pacifica z ione in E uropa mediante l' es tensione dell'area della democrazia e della libertà.
La crisi della ex Jugoslavia ha rappresentato il momento di maggior tensione nel nostro continente dopo il 1989 e ha richiesto l'azione della comunità internazionale sotto le bandiere dell ' Onu e della Nato, per frenare le guerre interetniche e stabilizzare la pace: interventi cui l'Italia dà un contributo di primaria importanza .
In altre parti del mondo, soprattutto lungo que!l-'"arco della crisi" che si estende dall'Asia centrale al Medio Oriente, fino al Caucaso e al Corno d'Africa, la fine della contrapposizione fra Est e Ovest non ha , purtroppo, rafforz a t o le ragioni della convivenza.
In tal senso, gli specialisti di questioni strategiche sono soliti ricordare che al mondo "inge ss ato" dalle due superpotenze, capaci di controllare le crisi locali impedendone l'aggravamento, è succeduto il mondo della conflittualità diffusa, con l'esplosione di tante tensioni nazionali, etniche, religiose, spesso aggravate dalla povertà, dalla mancanza di effettive autorità statuali, dal degrado sociale e ambientale, dal fanatismo.
La comunità internazionale non è certamente spettatrice pa ss iva di queste crisi Il peacekeeping è una realtà di tutti i giorni, spesso divenuta peacenforcing nei teatri di maggiore complessità. Tutti i grandi Paesi dell' E st e dell'Ovest hanno dovuto ripensare i propri strumenti militari, chiamati a operare in scenari totalm e nte nuovi, con minacce assai diverse ris/Jetto agli anni della guerra fredda : minacce concrete e non solo potenziali, da fronteggiare attraverso missi oni mult inazionali, con una forte comfJOnente terrestre, in un quadro inusitato : la cosiddetta guerra asimmetrica.
L' Italia ha fatto e sta facendo la sua parte, con oltre novemila uomini e donne impiegati fuori dai nostri confini, due terzi dei quali appartengono all'Esercito In questi quindici anni, le Forz e Armate italiane (a parte l'intervento in Libano) hanno partecipato a missioni di grande impegno anche in aree lontane dal territorio nazionale, dall-'Iraq all'Afghanistan a T imor Est, ove sarebbe stato impensabile pochi anni addietro schierare soldati italiani . In questo stesso arco di tempo il nostro strumento militare è profondamente mutato in funzione

del quadro strategico mondiale, che è radicalmente nuovo. Non è errato affermare che, tra le Forze Armate, l'Esercito è stato maggiormente segnato dalle trasforma zioni. Per alcuni aspetti era inevitabile, considerando che Marina e Aeronautica, per loro stessa natura, già erano composte da personale pr eva lentemente volontario. Con la totale professionalizzazione del personale e la fine della leva, con l'arruo lamento delle donne, con l'ammodernam en to dei sistemi d'arma, l'Esercito ha definitivarnente consegnato alla storia la vecchia immagine del soldato italiano.
Nelle moderne missioni internazionali non c'è posto per l'improvvisazione Sono invece richieste alta professionalità, padronanza dei più moderni sistemi d'arma, integrazione multinazionale e interforze, capacità di coordinare le operazioni militari con l'azione dell'intelligence. Né il peacekeeping deve poi condurre a un'impostazione limitativa delle funzioni militari in quanto le caratteristiche "comhat" di un esercito devono comunque restare elevate, completandosi, anche grazie a un addestramento specifico , con la preparazione richiesta dalle missioni di pace. Inoltre, la combinazione di forze militari e di for ze di polizia a ca rattere militare assicura alle missioni internazionali la flessibilità derivante dalle specifiche competenze e professionalità.
È perciò davvero utile, allo studioso, al militare, al cittadino, questo tipo di libro, che riassume la storia, le ragioni , le caratteristiche , le prospettive del peacekeeping, esaminate dal punto di vista dell'Esercito, cioè d e lla Forza Armata maggiormente interessata dalle missioni internazionali. All'editore e al curatore esprimo sincero apprezzamento per aver concepito e realizzato un'opera del genere . Agli opinionisti, quasi tutti testimoni diretti dell'impegno dell 'E sercito, rivolgo un plauso sentito Lo Stato Maggiore dell' Esercito, che ha sostenuto l' iniziativa editoriale, conferma la sua tradizionale attenzione alla pubblicistica specializzata quale testimonianza , anche in una prospettiva storica, dell'impegno e della dedizione degli uomini e delle donne in armi. Auguro, dunque , al libro un pieno successo di pubblico e di critica.
 Antonio Martino Ministro della Difesa
Antonio Martino Ministro della Difesa
Parlare di peacekeeping è ormai quasi una moda e il termine è a un tempo abusato e forse inadeguato per descrivere la realtà di operaz ioni militari tanto complesse, quanto articolate, rischiose e sempre esposte alla prospettiva -rischio di cambiare in corsa la propria natura a causa dell'evoluzione dello scenario Tuttavia, quest' attività, così difficile, è diventata ormai un vero "core business" per gli eserciti di molti Paesi.
In particolare l'E sercito Ita liano vanta una professionalità e una competenz a con pochi paragoni, perché è stata sviluppata e costruita nel corso di lustri di missioni che abbracciano l'intera gamma delle possibili operazioni. Ed è senza dubbio un risultato straordinario che la Forza Armata abbia ottenuto tali risultati mentre affrontava una radicale trasformazione, con l' immissione nei suoi ranghi di un numero crescente di volontari e professionisti, mentre contemporaneamente la componente di leva, che ormai da anni non è più impegnata all'estero, si andava riducendo.
Proprio le ridotte dimensioni del pool iniz iale di personale impiegabile all'estero ha prodotto un corpo di professionisti che ha all'attivo un bagaglio di conoscenze ed esperienze con 1JOchi eguali e che vengono regolarmente trasferite e assimilate dalle nuove leve.
È proprio la preparazione e la qualità del personale la caratteristica peculiare del nostro E sercito nel confronto con gli eserciti occidentali più blasonati e in qualche caso meglio equipaggiati . Sicuro , contano anche i mezzi e le tecnologie e in questo campo l' Esercito Italiano ha compiuto progressi notevoli nel giro di pochi anni . Del resto , se non si è all'altez za degli alleati , è impossibile operare al loro fianco. Ma mentre un buon soldato riesce a cavarsela anche con equipaggiamenti standard, il non plus ultra della tecnologia può non essere decisivo se non è impiegato al meglio dal personale.
Una conferma della validità del percorso intrapreso dall'Esercito è venuta dove più conta, sul camtJo, quando si è trattato di svolgere missioni in nuovi teatri operativi, dal 2001 in Afghanistan e dal 2003 in Iraq, in un contesto nuovo e davvero difficile, prima di tutto a causa della distanza geografica dall'Italia. In Afghanistan in particolare sono state condotte le prime operaz ioni propriamente "combat", con ottimi risultati. In Iraq l'aggressività della guerriglia , impegnata a cercare di destabilizzare il processo di ricostruzione del Paese, ha con{ermato come anche la più pacifica delle missioni possa richiedere il ricorso alle armi per poter conseguire i suoi scopi .

E in entrambi i casi Le Forze Armate italiane si sono comportate in modo egregio, ottenendo significativi riconoscimenti da parte dei comandanti delle forze militari internazionali.
Con questo volume abb iamo cercato di raccontare le nuove frontiere delle operazioni di pace nelle quali sono coinvolte le nostre Forze Armate, esaminandole sotto diversi punti di vista e prospettive, partendo dall'analisi strategica e politica, evidenziando le prosp ettive future e il ruolo del nostro Paese, le nuove minacce, per arrivare alla disamina tecnico -militare e senza trascurare il reportage in "presa diretta" di chi segue, condividendone le esperienze e i rischi, le attività dei nostri soldati.
Uno sforzo corale che ha l 'ambizione di fornire una chiave di lettura per meglio comprendere un compito che richiede impegno, sacrificio, motivazione, che vede protagonisti migliaia di militari italiani, che richiede forti investimenti per poter essere svolto continuativamente agli attuali livelli senza logorare lo strumento militare e che offre straordinarie opportunità a ll'Ita lia, nella consapevolezza che solo pochi Paesi sono in grado di esprimere capacità di tale livello, per quantità e qualità, proprio nel momento in cui la comunità internazionale ne ha più bisogno .
Andrea Na ti vi


L'Esercito in azione: l'impegno, il significato, le lezioni apprese. Il nation building in contesti conflittuali
Tenente Generale Giulio Fraticelli
Capo di Stato hlaggiore dell'Esercito

Politiche di sviluppo e di sicurezza: costi e prospettive della cooperazione mediterranea
Antonio Calabrò
Il futuro dell'Afghanistan e dell'Iraq
Sergio Romano
La "nuova" guerra e le operazioni di stabilizzazione: prime lezioni
Andrea Nativi
Al Qaeda e la lotta al terrorismo internazionale
Andrea hlargelletti
Le nuove missioni e l'Italia
Alberto Negri
Il significato e i risultati politici e strategici della presenza italiana nei nuovi teatri
hlarcello Foa
Le Forze Armate italiane nelle missioni internazionali
Tenente Generale Filiberto Cecchi
Le missioni dopo 1'11 settembre 2001.
I contingenti dell'Esercito in Afghanistan e Iraq
Enrico Magnani
Come cambia l'atteggiamento degli italiani nei confronti delle Forze Armate e dell'Esercito
Oscar Giannino
Con i soldati italiani in azione
Vincenzo Sinapi
Parte fotografica
Iraq: Operazione Antica Babilonia
Afghanistan: Isai' e lhbbio
I concetti della difesa e della sicurezza colle ttiva, tempo addie t ro r iservati a una ristretta élite di addetti ai lavor i, hanno assunto negli ultimi anni una partico lare valenza e sono diventati oggetto di interesse per un numero sempre crescente di studio si ; questo volume può offrire un ulteriore contributo di pensiero sull'argomento e nuovi spunti di riflessione e approfondimento.

Il decennio appena tr ascorso, ini ziato sotto gli auspici di trn lungo periodo di pace vera dopo o ltre mezzo seco lo di guerra fredda, si è rivelato invece assai turbolento. La rottura degli equilibri che avevano dominato la scena internazionale dal la fine del secondo conflitto mondiale ha provocato, infatti, il sorgere di rivendicazioni di differente natura, che hanno dato luogo a crisi non sempre ben definite. Dall'l 1 settembre 200 ·1, poi, si è dischi usa una nuova fase, caratterizzata da un'accentuata percezione della minaccia terroristica, che ha imposto una profonda revisione del concetto stesso cli s icurezza. In tale contesto, le politiche di sicurezza sono divenute sempre più complesse, coniugando aspetti sociali ed economici di grande rilievo con capacità di interventi militari lungimiranti ed efficaci, nell'in t ento di mantenere un difficile eq uilibrio t ra la volontà di pace e l'uso rego lato della forza in a ree situate ben al di fuori dei confini n azionali. Questo mutare dello scenario politico -strategico, rapido e segnato anche da esigenze di multidimensional ità e m ultifunziona lità, è sta to affrontato, al.l'inizio, con s trumenti mi litari messi a punto per tutt'altre missioni. Un po' tutte l e Forze Armate (in misura inferiore quelle statunitensi
e britanniche) hanno dovuto esprimere una crescente capac ità di proiezione lontana, pur partendo da lo giche "stanziali", proprie della difesa terri toriale dei confini. Ciò ha impos t o ag l i strument i militari di dare avvio a una rad icale trasformazione, tesa ad adattare organizzazione e capac it à alle nuove esigenze, che abbracciano tutta l'ampia gamma de l le operazioni, da quelle cli combattimento a d alta intensità al concorso nell'assis t enza umanitaria
Oggi, anche le Forze Arma t e italiane sono impegna t e, al pari di quanto avviene presso i Paesi allea ti e amici, in quesro profondo cambiamento . In particolare, l 'Eserc ito ha già da tempo avvia t o un cammino evolutivo volto all'acqu isizione delle capacità operative necessarie; non si tratta più, come in passato, di opporsi a una so la minaccia (peraltro sufficientemen t e conosciuta nelle sue caratter istiche), ma cli approntare forze in grado di fronteggiare minacce o rischi non chiaramen t e prevedibili, estremamente variabili in quanti t à e qualità, che potrebbero concretarsi in tempi indetermina ti , con moda lità operative differenti e generalmente asimmetriche. Si è t rattato, insomma, di passare, in tempi serrati, da un asse tto "st atico" e sostanzialmente progettato per la dife sa del territorio naziona le, a un sistema di capac it à basato su forze prontamente proiettab . ili a di stanza e pienamente integrabili in ambiti interforze e multinazionali. Tu tto ciò, ovviamente, tenendo conto del con testo e de i condizionamenti in cui ci si è trova ti a muovere: l'esigenza di soddisfare le incombenze derivanti dalle iniziative assunte in ambito Nato e Unione europea; la ero-
L'Esercito in azione: l'impegno, il significato, le lezioni apprese.
nica carenza di fondi per l'esercizio (addes t ramento de l persona le, mantenimenro d ei m ezzi) e per l'ammodernamento dei sistemi d'arma e il passaggio dal s ervizio di leva a l volon t ariato . L e prime indicazioni circa la necessità di rivedere orga nizzazion e, compi ti e dottrina della Forza Armata possono esse r e fatte risalire già all e due missioni in Libano, nel 1982 e nel 1985, c h e fornirono importanti inseg n a m e nti per quanto concern eva le strutt u re di comando e controllo in operazioni. Riflessioni significative furono co ndotte all'indomani della guerra del Go lfo de l 1991, quando si dovette p rendere atto dell'incapac ità de l le Forze Arma t e nazionali di schierare in un teatro operativo lon ta n o dalla madrepatria una forza t errestre combatten t e di adeguata cons ist enz a e in grado di operare in un contesto multinazional e
G li elementi sca turiti da quel proc e sso di brain storming furono tr asforma ti in provv e di menti concreti, la cui validi t à ve nne immediatamente verificata neg li interventi del 1991 nel Kurdistan irac h eno (operazion e Pro vi d e Comfort) e del 1992 in Mozambico (o p erazione A lb atros) e in Soma li a (operazione Ibis). I succ e ss ivi impieghi n e i Balcan i sanc iron o c hiaram en t e l'esigenza di ampliare le capacità d'inte rve nro d egli s trum e nt i militari, sempre più largamente coinvo lti in at tivi t à di norma lizzazione , sta bili zzaz ione e ricos t ruzion e del t essu t o socio-istituzionale de i Paes i beneficiari dell'interve nt o militar e internazionale. Due operazioni, in particolare, evi d enziarono anche la specifica atti tud ine dell 'Esercito It a lia no alle mi ssioni proprie delle Peace s upport operat ions
(Pso) : l'operazione A lb a, in A l bania, del 1997 (al momento rimane l'unica esperienza de ll'Ita lia nel ruo lo di L ead Na ti on di un contingente multinaziona le } e l'operazione Stabilize, in Tim or Est, del 1999 .

Ma è soprattutto n elle ultim e missioni in Afghanistan e in Iraq, in aggiu nta a quelle nei Balcani, che è stata messa alla p r ova la capac it à dell'Eserc ito cli fornir e sicurezza in un contesto mu lti naz ionale " fuor i area".
È bene ricor da re che lo strumento militare terre s tr e ha effettua tO rutti questi interventi in concomitanza e al termine di un robusto proces so di riduzione (i propri organici sono dimin u i ti di oltre il 60 % nel corso d eg li ultim i 15 anni, passando da 290 .000 effett iv i de l 1990 ai circa 11 4.000 attuali).
O ggi , i l mutato contesto din amico ve d e l 'Eserc ito Ita li ano in pie no cambiamento, con riferimento a cinque d irett rici ben de lin ea t e : eia forza prevalentement e statica e " in potenza" a s t rw11ento rapidamente proiettabile e con capacità opera tive "in atto " ; da una visione prevalente di s ingola Forza Armata a compon ente integrata di uno strume nto interfo rze e multinazionale; da eserc ito di l eva a esercito profess io nale; da forza di massa a forza di quali t à, ma numericamente suffici ente, operativa mente fless ib ile e t ecno lo gicamente evoluta ; d a ese rcito in guarnigione a eserc ito nella soc ietà e della società .
Lo s trumento militare terrestre che s ta prendendo forma s i s t a dimostra ndo in grado di svolgere eff ic ace mente le mi ss ioni imposte dal nuovo scenario e d iscendenti dalla no s tra legis la zione .
Vediamole più da vicino. La difesa degli interessi v itali del Paese contro ogni possibile aggressione, compiro prio r itario d elle Forze Armate, prevede l ' imp ie go di tutte le forze a disposizione, mentre la salvaguardia degli spaz i euro -atlan tici, nel quadro degli interessi st rategici e/o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della Nato, può essere attua ta con un Comando di Corpo ci' Armata di Reazione Rapid a , quello di Solbiate Olona (Nrclc -It 1 ), e con due complessi di forze a livel lo divisione, con relativi support i tattico -logistici . Questi due pacchetti di forze sono rispettivamente assegnati al citato Comando Nrdc -It e al Comando Arrc 2 di Rheindahlen. In tale contesto, sarà possibile proiettare fuori dal territorio nazionale l'Nrclc e uno dei due complessi, un totale di circa 45.000 uomini "one shot" (periodo massimo di 6 mesi), devolvendo il rimanente complesso alla condotta di operazioni di sicurezza e difesa in Patria .
Per quanto riguarda, invece, la partecipazione a operazioni di prevenzione e ges tione d elle crisi, al fine cli garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, i l contributo massimo per l'Esercito si concretizza in una ta s k farce composta da una struttura framework di comando e controllo a livello di Corpo d'Armata o di Divisione, due Brigate e un reggimento, impiegabili anche in tre tea tri operativi distinti, fino a un m assimo d i 13.000 uo mini continuamente in operazioni . Se si assume a riferimen to la rotazione del personale "a base 4", attualmente adottata, l'es igenza complessiva ammonta a .52 . 000 uomini; se si prende a riferimento, invece, i l Nato Usa-
bility Concept-1 "a base 5" l'esigenza di v ie ne pari a 65 .000 uomini per poter consentire d i sostenere con continuità i 13.000 impiegati.
Grazie al processo di trasformazione intrapreso dall'Esercito Italiano, è stato possibile assicurare una consis t ente partecipazione di nostre unità in tut ti i maggiori interventi operati recentemente dalla comu nità internazionale in aree di crisi. Oggi l ' im pegno è costituito eia circa 7.000 soldati clell ' Eserciro sc hier ati dall'Iraq all'Afghan istan e ai Balcani. Ma il dato forse p iù significa ti vo è rappresentato d alla med ia g io rnaliera del personale impiegato fuori dai confini nazionali negli ultimi sei anni, che è di circa 8.000 unità, pari al 75-80% dell'intero dispositivo militare nazionale .
Tutto ciò senza considerare gli impegni operativi, sul t erritorio metropo.litano, ne l quadro della missione di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento cli compiti specifici in circostanze cli pubbliche calamità e in altri casi di straord inari a necess ità e urgenza . Tale compiro viene assicurato giornalmente dalla Forza Armata con l 'attività di prevenzione di atti terroristici (ope ra zione Domino) e impegna dal 2001 una media di 4.000 uomini per il presidio e la vigilanza di oltre 150 obiettivi sensibili dislocati in 88 province, per complessivi 12.000 uomini ogn i anno.
In totale, l'impegno annuo per inter venti in aree di crisi e in Patria è di circa 30.000 unità, pari a poco meno del 40% della forza operativa (85 .000 uomini).
In termini capacitivi, invece, per rispondere a queste es igenze, le forze sono sta re articolate in differenti tipologie - Brigate leggere, medie e pe-

santi, p iù la Brigata Aeromobile e le Forze per Operazion i Special i - c h e, nell' ins i eme, configurano la componente di manovra cli uno strumento armonico, bilanciato e flessibile, la cui en t ità complessiva sarà pari, a regime, a 112 000 unità. Come sempre accade, le attività svolte sul campo, non so lo dalle unità nazionali, ma anche da quelle degli altri eserci t i, h anno consentito di trarre utili ammaestramen ti. A fa tto r comune, le crisi internaz iona l i de ll'ultimo decennio (da qu elle balcaniche alle più recenti in Afghanistan e in Iraq) hanno confermato il ruolo centrale e il cara ttere risolutivo d ella componente t errestre n elle operazion i militari, ancorché in un contesto fortemente in t egrato .
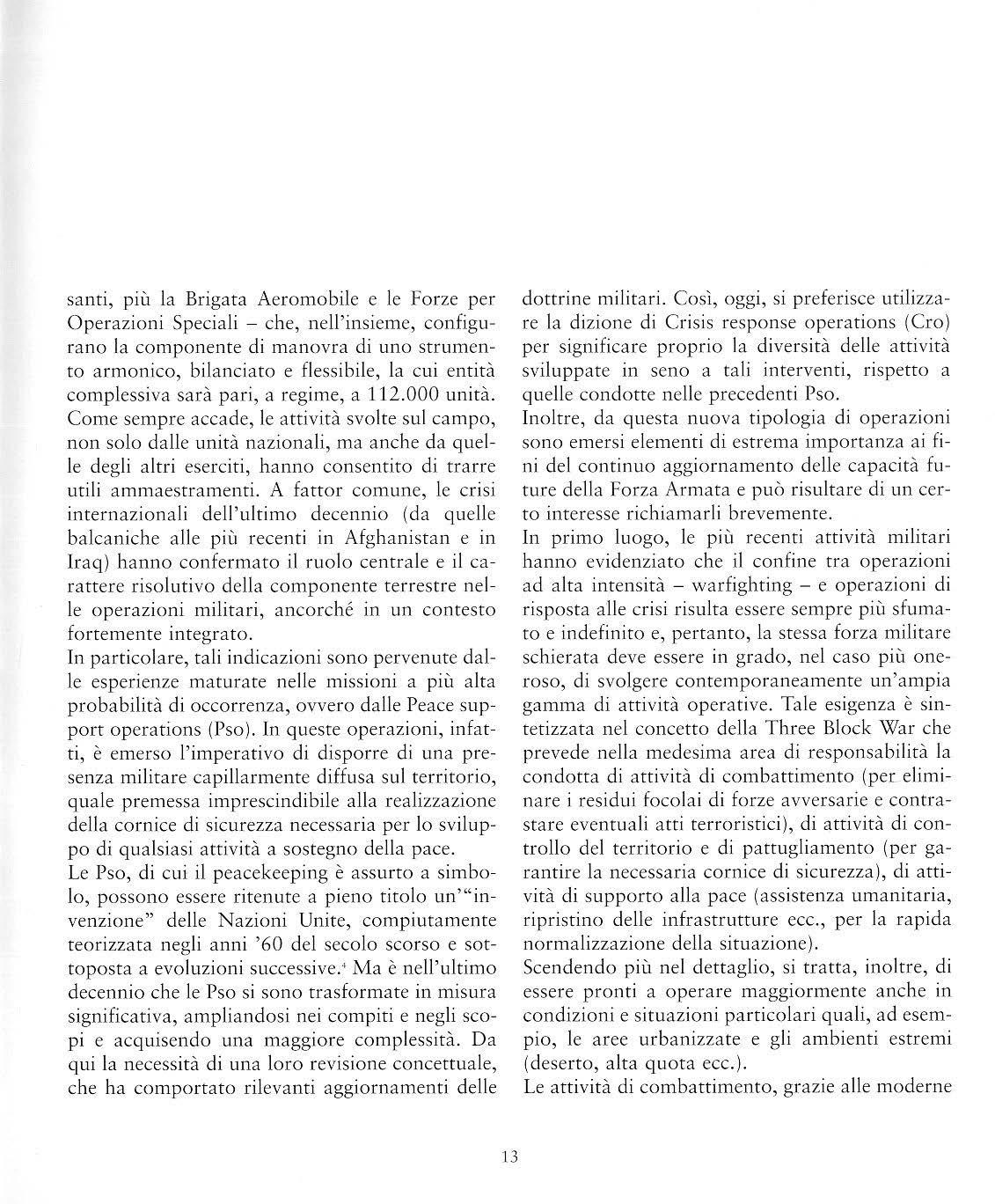
In particolare, tali indic azio ni sono pervenute dall e esperienze matu ra re nelle m ission i a più al ta probabilità di occorrenza, ovvero dalle Peace support operations (Pso). I n q u este operazioni, infatti, è emerso l'impera t ivo di disporre di una presenza militare capi llarmente diffusa sul territorio, qua le premessa impr esc ind ibi le alla rea li zzazione de l la cornice di s icurezza ne cessaria per lo s viluppo d i q u alsiasi attività a sostegno della pa ce .
Le Pso , di cui il peacekeeping è ass urto a si mbolo, possono essere riten ut e a pieno t it olo u n "'inve nzion e" delle Nazioni Un ite, compiutamente t eor izzata ne gl i anni '60 del seco lo scorso e sottoposta a evoluzioni s ucc essive . ' Ma è nell'ultimo d ecennio che le Pso s i so no t rasformate in misura significativa, amplian dosi nei compi ti e negli scopi e acquisendo una maggiore compless it à . Da qui la necessità di una loro revisione concettuale, che ha compor t ato rilevanti aggiornamenti delle
dottrine mi l ita ri . Così, oggi, s i preferisce uti lizzare la dizione di Cris is response operations ( Cro ) per significare proprio la diversità delle attività sviluppa t e in seno a ta li in terve nti , rispetro a q u elle condo tte nelle precedenti Pso .
In o ltr e, da ques t a nuova tipologia di ope razio ni so n o emersi e lementi cli estrema importanza a i fini del continuo aggiornamento delle capacità future della Forza Arm a t a e può ris u lt are di un certo interesse richiamar li brevemente .
In p rimo luogo, le più recent i a tti vità militari ha nno evidenziato che il con.fine t r a operazioni ad alta intensità - warfighting - e operaz ioni di r isposta alle crisi risulta essere sempre più sfumato e i ndefin ito e, pertanto, la s t essa forza mi litare schierata deve esse re in grado , nel caso più oneroso, di svolgere contemporaneamente un'ampia gamma cli attività operative . Ta le esigenza è sint eti zzata nel concetto della T hree Block War che prevede n e lla medesima area di responsabili t à la condotta d i a tti vi t à di combattimento (per el iminare i residu i focolai di forze avversarie e contrastare eventuali atti terroris t ici ), cli a ttiv ità di controllo d el territorio e d i pattug l iamento (per garantire la necessaria corn ice di sicurezza), cl i attivi tà di s upporto alla pace (ass iste n za umanitaria, ripris t ino dell e infrastrutture ecc ., pe r la rapida n orma lizzazio n e della situazione).
Scendendo più n el dettaglio, si tratta, inol tr e, di esse re p r onti a operare mag g iormente anche in condizioni e situazion i par t icolari qu ali, ad esempio, le aree urbanizzate e gl i ambienti es tr emi (deserto, alta quota ecc. ).
Le a tti vità cli combattimento, graz ie a lle moderne
tecno logie, all'a pplicaz ione dei concetti legati alle Network Centric Operations e all'impiego d i nuo ve me todolo gie operative, tendono a svo lgersi su un arco tempor ale assai ristre tto, trad ucendosi in un ' a ssoluta superiorità opera tiva a tutto campo s ull 'avversario che non dispone di pari capacità . Co n il trascorrere del t e mpo, è n ecessario procedere a un progressivo a lle gger im ento d eg li a sse tti combat, focalizzando gl i sforzi verso la "costruzione" e il man teniment o di una stabil ità a lungo termine, attraverso una sempre più stretta coordinazione con le agenzie/organizzazioni civi li che operano all 'interno dell'area di responsabilità È indispensabile, inoltre, da l mo mento che il Comando della forza di intervento è chiamato ad assolvere la dopp ia funzione di responsabile dell a sicurezza e cli principale "gestore" de.Ile attività di ricos t ruz ione, che il con ting e nte militare sia in grado di esprimere capacità specialistiche atte a consentire l ' avvio e i l success ivo funzioname nto del.le strutture civili .
Per questo as p e tto, in particolare, è emers o che il s ucc esso d i una Cro dipende soprattutto da un' atten ta e accurata pianificazione, fin dalle fasi iniziali, degli inter venti post co nflict poiché, per trasformare il s ucc esso m ilitare in su ccesso poliricostrategico, occorre coordinare a l meglio l e a tt iv ità milit ari tip ich e d ei boots on the ground con quelle di una adeguata organizzazione C imi c5 svo l te dallo s t esso personale. La gestione dell a fase post -co nflittua le è infatti complessa e di lunga du ra ta e deve ten d ere alla co nqui s ta "dei cuor i e d elle menti " della popolazione civile, aiutan dola a ripristinare su ffic ienti condizioni di vita, a rico-
struire le infrastrutture di primar ia importanza , a riattivare l'assistenza sanitar ia, e così via.
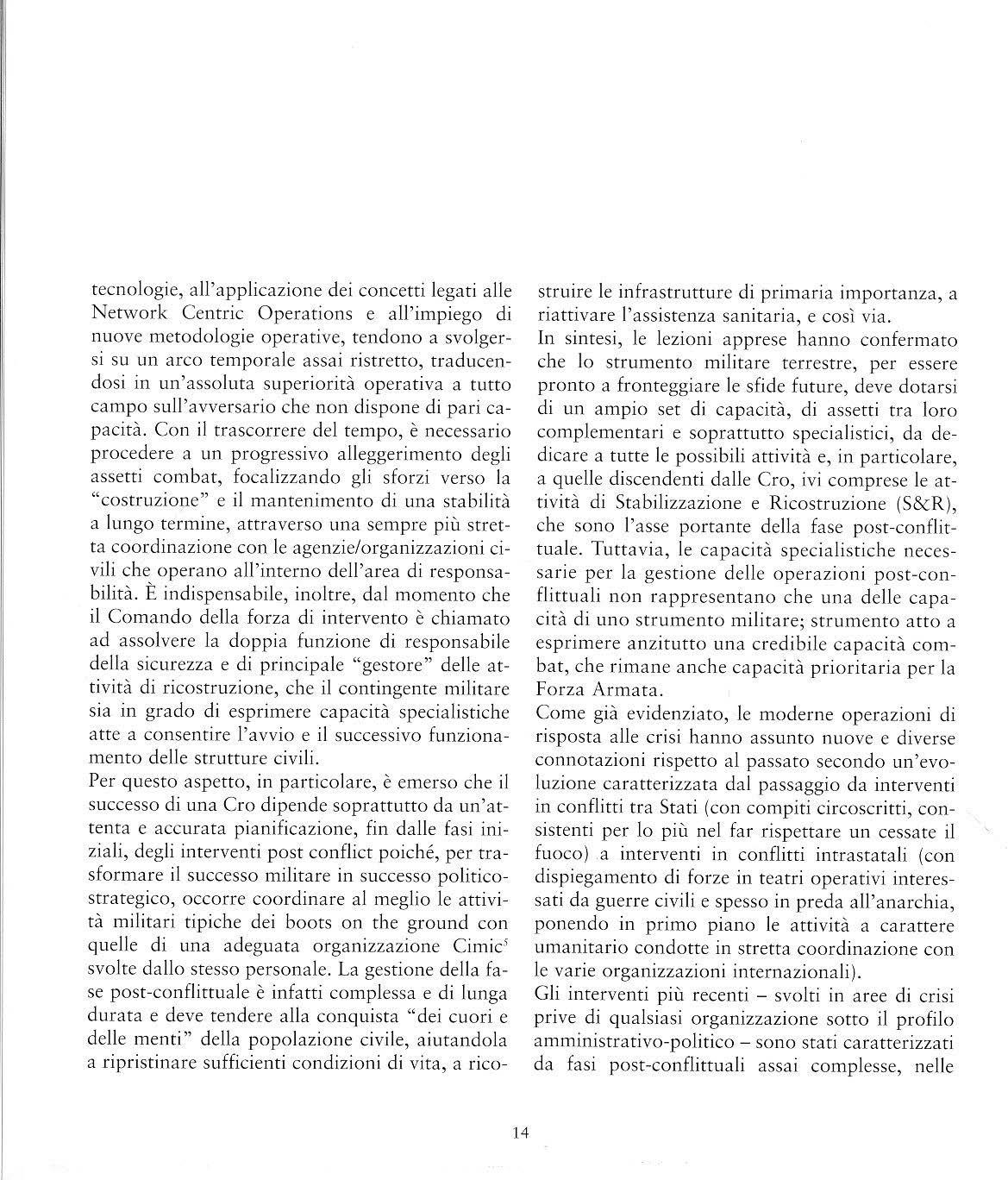
In sintesi, le lez io n i apprese hanno confermato c h e lo strumento mi l itare terres tr e, per essere pronto a frontegg iare le sfide future, d eve d otarsi di un amp io set di capacità, di assetti tra loro complementari e sopra ttutto spec ial istici, d a d ed icare a tutte le poss ibili attività e, in particolare, a quelle discendenti da lle Cro, ivi comprese le attivi tà di Stabilizzazione e Ricostru zione (S&R ), che so n o l'asse portante della fase post -conflittuale. Tu ttavia, le capacità s p ecia li s tiche necessar ie per la ges tio ne d elle operazioni post- conflittuali non r appresentano che una delle capacità d i uno strumen to militare; strumen to atto a espr imere anzi tutto una credibile capacità combat, che rimane anche capacità prioritaria per la Forza Arma ta .
Co m e già evi den ziato , le moderne operazioni di risposta alle cr isi hanno a ss unto nuove e div e rse con no t a zioni risp e tto al passa to secondo un' evol uzione caratterizzata dal passaggio da inter venti in conflitti tra Stati (co n compiti circoscr itti , consis tent i per lo più ne l far ri sp ettar e un cessate il fuoco ) .a interventi in conflitti int-rastatali (co n di s pie gamen to di forze in t eatri operativi in t eressati da guerre civili e spesso in preda all'anarchia, ponen do in primo piano le attività a carattere umanitario co n dott e in stretta coor dinazione co n l e varie organizzazioni in ternazio nali).
Gli inter vent i p i ù recenti - svol ti in aree di crisi prive d i qualsiasi organizzazione sotto il profilo ammi nis trativo-politico - sono stati caratterizza t i da fas i post-conflittuali assai complesse, nelle
quali l e attività di S&R hanno v isto ampliare la loro portata, oggi sempre più coincidente con un vero e proprio nation builcling, termine con cui si suole intendere l'in sieme di attività finalizzate alla realizzazione di un framework politico-sociale sicu ro e stabile nel post conflicr. È chiaramente un processo di grande vale nza che trova le g ittimazione negli organismi sovranazio nali della Comunità internazionale, segnatamente l'Onu, che può delegare specifiche organizzazioni regionali {la Naro, l'Osce, l 'Un ion e europea ecc.), ovvero organizzazioni o agenzie internazionali (Undp 6, Unhcr7, Iom 3 ecc.), alla risoluzione e trattazione di determinati aspetti {istituzio nali , di sicurezza, amminis trativi e altri).
In questa tipologia di interventi si possono individuare, dal punto cli vista operativo, e nel caso più impegnativo, tre diver s i momenti: una fase di immissione e schieramento delle forze, ch e talvolta può essere di per sé sufficiente a disinnescare la crisi; una fase caratterizzata da elevata con flittualità, di norma di breve durata, in cui ha preminenza l'impiego d e lla capacità combat (questa fase può essere assente, come nelle operazioni di peacekeeping); una fase post-conflitto, comprendente le at t ività S&R per l'avvio o il ritorno alla normalità .
Fermo restando che, in generale, l'esatta composizione quantitativa e qualitativa de l la task force da impiegare è in funzione d el compito da assolvere e delle caratteristiche ambientali, sempre diverse da un teatro operativo all'altro, è altrettanto evidente che ciascuna di queste tr e fa si necessita di assetti opportunamente dedicati. Pertanto ,

nella pmna fase di immissione e schieramento è imp o rtante disporre di un pacchetto di forze che, per ti pologia e capacità, s ia il più bilanciato e flessibile possibile ( forze pesanti, medie e leggere).
Tali assetti, in particolare la componente heavy, saranno ancor più necessari nell'eventuale fase comba t, nella quale le forze blindo/corazzate e meccanizzate sono particolarmente idonee per la protezione e potenza di fuoco che sono in grado di espr imere Infine, nella fase di S&R, alle citate forze cornbat sarà necessario affiancare unità specialistiche (Nbc, C imic, Psyops, Humint, genio ferrovieri, sanità e altre), a ll o scopo di garantire una maggiore tipologia d'interventi sul campo Proprio per rispondere a quest'esigenza specifica della fase S&R (na tion builcling), l'Esercito Italiano ha avviato un processo di riqualificazione, riordinamento, ovvero di creazione ex novo, cli a lcune unità specialistiche nelle seguenti aree:
- Rista - EW9;
- difesa Nbc con capacità di rivelazione, analisi e bonifica;
- Cimic con uno staff interforze e mu ltinazio n ale (Nato, Cimic Group South);
- genio, con capacità di rilevazione e bo nifica ordigni esplosivi (Eod/Ie dd 10 Mdd/Edd 11 );
- genio ferrovieri, con elevate capacità di costruzione e ripristino di linee e ponti ferroviari;
- san ità, impiegabili a nche a favore delle popolazioni ci vili;
- trasporti, in grado d i assolvere anche le incombenze relative ai rifornimenti e alla distribuzione di aiuti umanitari a favore della popolazione civile;
- sostegno psicologico .
Per quanto attiene alla presenza di forze con capacità comba t nella fase post -conflittuale, che potrebbe sembrare a prima vista non del tutto appropriata, essa risul t a in vece fondamentale poiché in tale fase si devono gestire - come già sintetizzato nel concetto della Three Block Warsituazioni diverse, io cui possono convivere emergenze umanitarie, azioni di guerriglia e/o attacc hi terroristici su larga scala, al fine di garanti re le necessarie condizioni di sicurezza in cu i far operare i reparti specializzati nel ripristino della normal it à.
In questo contesto, alle forze militari possono essere assegna ti compiti particolari da assolvere nel più ampio scena rio del nation building, del quale, di norma, non saranno responsab i li direttamente. Il mandato loro attribuibi le si traduce, infatti, nel compito di garantire una cornice di sicurezza entro la quale le autorità/organizzazioni internazionali possano muoversi e operare.
T uttavia, in casi particolari e a seguito di accordi a livello politico, le forze militari possono sostenere o svolgere direttamente specifiche attività non strettamente connesse ai compiti di sicurezza (e lezioni, distribuzione di aiuti umanitari, funzionamento dei serv izi essenziali e altre forme di concorsi) .
Tale eventualità si verifica, comunque, in casi eccezionali, allorquando la si tuazion e sul t erreno si caratterizza per par t icolare virulenza conflittuale e le condizioni di sicurezza non consigliano la presenza di organizzazioni civili: si tratta di casi limite , che devono essere circoscritti e l imi tati nel tempo, prevedendo il passaggio di responsabilità alle autori t à civili com-
petenti non appena ciò risulti possibile . Per rispondere anche a siffatte esigenze operative, che impongono alla forza d'intervento la capacità di svolgere insieme alle funzioni militar i in senso stretto anche attivi tà più ampie che investono - sia pure in forme rudimentali - il campo sociale, poli ti co, economico e quello dell'amministrazione pubblica dello Stato, sono stati creati in ambito Nato i Cimic Groups. Tali reparti dispongono di personale in possesso di specifiche conoscenze professionali in se ttori che, di norma, sono solo in parte di diretto interesse per una Forza Armata: si tratta, in part icolare, cli assicurare alla forza militare una capacità d'azione nel campo degli affari pubblici (azione di governo, affari giuridici, istruzione, affari sanitari, sicurezza, ambiente), delle infrastrutture c iv i li (comunicazioni, tr asporti, servizi d'emergenza, lavori, risorse energetiche e idriche), dell'economia e commercio (sviluppo economico, agricoltura, indu stria , commercio), del sos te g no umani tario (rifugiati e profughi, r ifornimenti essenziali, sanità, diritti umani), de gli affari culturali (monumenti storici, arti , archivi, affari religiosi, servizi linguistici). Stante l 'attuale indirizzo di riduzione quantitativa degli strumenti militari e la conseguente difficoltà di disporre permanentemente di personale con dette professionalità, è risultato assai proficuo il ricorso, per il loro reclutamento e impiego solo all'occorrenza, allo strumento della "riserva selezionata" 12 In defin itiva, l' Esercito, o ltre a svolgere attivi tà combat, se richiesto, e a concorrere in maniera significa tiva alla transizione tra le operazioni ad alta intensità e le a t tività di na rion building, esal-
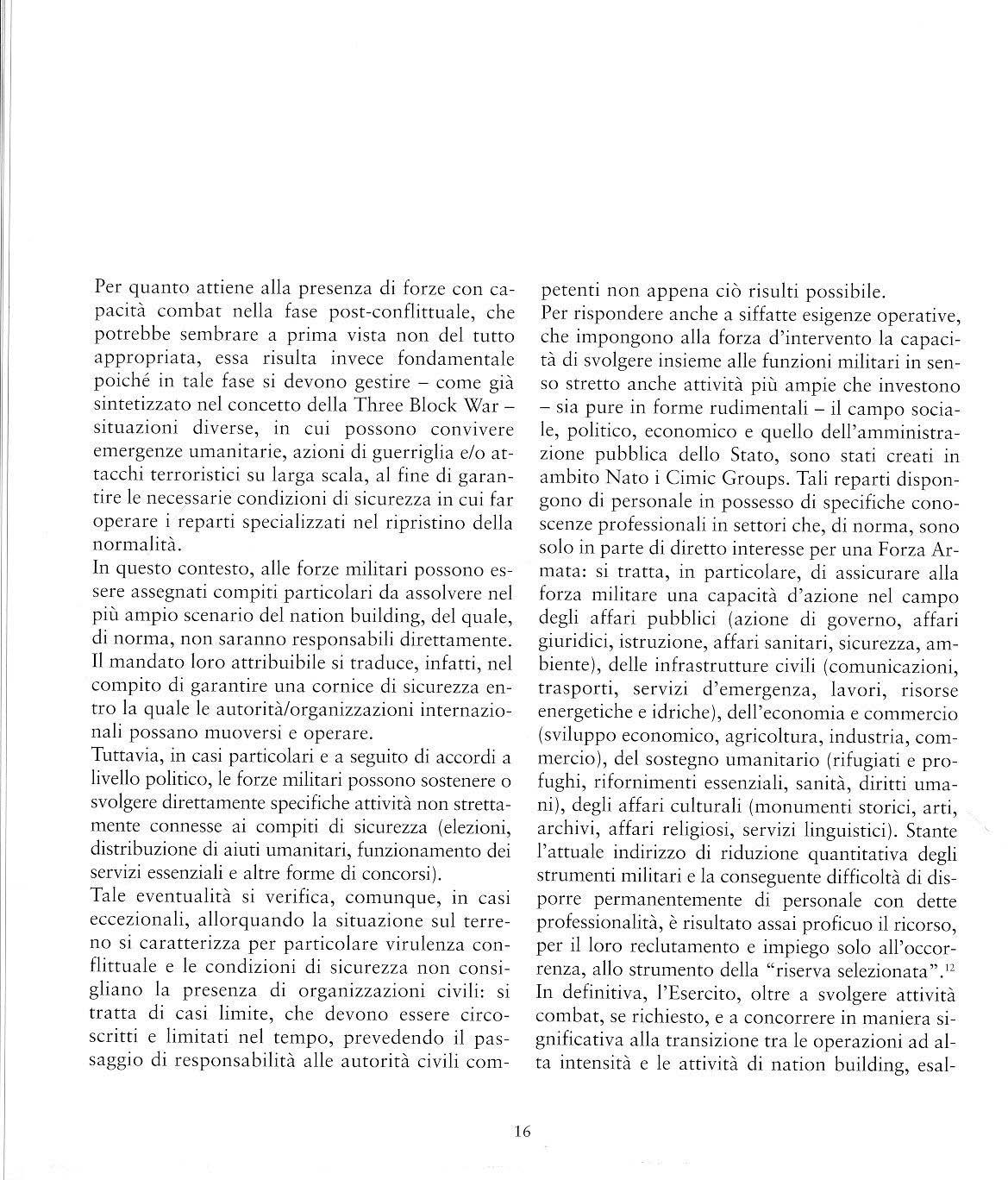
rando le po t enz ial ità delle organizzazion i civ il i e contr ibuendo in man iera sostanziale alla soluz ione politica, economica e sociale della crisi, svolge un ruolo determinante anche nella stessa fase di na t ion building. Fondamen t ale si rive la lo svi l uppo d i u n costante collegamento e interscambio cli informaz ione t ra i mi l itar i e le real t à civil i , economic h e e socia li allo scopo di crea r e meccan ismi cli integrazione e coordinamento , mig lio r ando in questo modo la conoscenza e la fiducia reciproca. Tali meccan ismi, opportunamente mantenuti e rafforzati, con t ribu iscono in man iera decisa a incremen t are l'eff icac ia degl i int erventi di na t ion bu ilding n azionali e internaz ional i, aumen t ando , di conseguenza, la vis ibilità de l la po l it ica estera del Pa ese.
Per chiudere, qualche considerazione sul consenso della società i t aliana a questo impegno dell'Eserc it o e alle scelte s t ra t egiche che lo governano in un reg i me d i scarsa d ispon i bi lit à di risorse finanzia rie .
Sul primo aspetto (consenso della pubblica opinione) va sorrolineato un crescendo favorevole, da parre sia della società nazionale sia di molti opinion lea d ers verso le sce lt e operate da l Paese i n questi u lt imi a n n i nel campo della s icurezza e de l mantenimento della pace . Queste scelte rivestono gran d e interesse per l'Italia e per i Paes i a lleati, anche in relazione alla loro centralità per l'equi librio e la stabili t à internazionali. Vi è una maggiore vivac it à e presenza del nos tr o Paese sulla scena mond ia le c h e ha rigenera to l'immagine naz iona le, ponen d o le basi per un accresciuto peso specifico e una maggiore credibilità inte rn azionale .
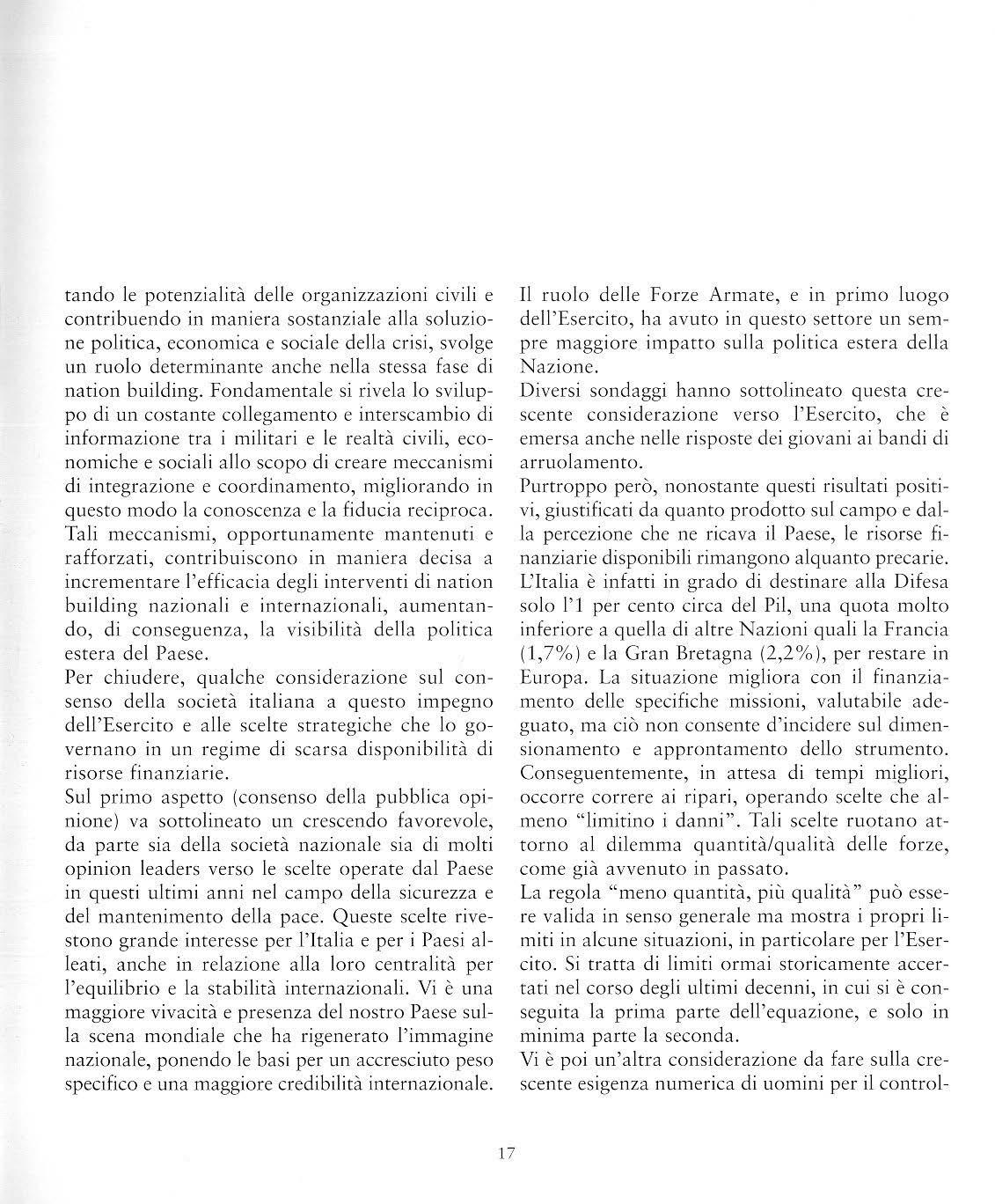
Il ruo l o delle Forze Arma t e, e in primo l uogo dell 'Ese r c ito, ha avuto i n questo se tt ore un se mp r e maggiore impatto su l la polit ica estera della Nazione.
Diversi sondaggi hanno sottolineato questa crescente considerazione verso l'Esercito, che è emersa anche nelle rispos t e dei giovani ai bandi di arruo lamento.
Purtroppo pe r ò, nonostante quest i risu ltati positivi, giustificati da quanto prodotto su l campo e dalla percezione che ne ricava il Paese, le risorse finanziarie disponibili rimangono alquanto precarie
L'Ita lia è infa tt i in grado di destinare alla Difesa solo l 'l per ce nt o circa ciel Pi i , una quota molro infe ri o r e a que lla di a ltre Nazioni quali la Franc ia (1,7%) e la Gran Bretagna (2,2%), per restare in E uropa. La situa zi one migliora con il f inan z iamento delle specifiche missioni, valutabile adeguato, ma c iò non consente d'incidere sul dimensi onamento e approntamento dello strumento . Conseguentemente, in a t tesa cli tempi miglior i, occorre correre ai ri pari , operando scelte che almeno " limitino i danni". Ta l i scelte ruota n o attorno al di lemma quantità/qualità de lle forze, come già avvenuto in passato.
La regola "meno quanti t à, più qua l ità" può essere val id a in senso generale ma mostra i propri limiti in alcune si t uazioni, in particolare per l ' Esercito S i tratta di lim iti ormai storicamen t e acce rtati ne l corso deg l i ultimi decenni, in cu i s i è cons eg uita la prima parte dell'equazione, e solo in minima parte la seconda.
Vi è poi un'a lt ra cons id erazione eia fare sulla cresce nt e esigenza numerica di uomini per il contro! -
lo del t err itor io nel le aree d i crisi, c h e si m a nifesta nono sta nte la maggiore di spo nibilità d i tecnolog ia atta a surrogarla a lmeno in parte . E questo è valido anche con riferimento agl i scenari multin azionali in cui le nostre forze ormai da tempo operano . In sintesi, a differenza forse delle al t re Forze Arma t e, l 'integraz ione multinazionale ha per l 'Esercito un valore aggiunto, non sos titut ivo ag li effe tti del d imensionamento, e ciò in rapporto alla vasti t à de l le aree di possib il e impiego. Si pensi a ll'Iraq o ai Balcani, per non parlare d el Congo, e alle lessons learned sull'idea, rivela t asi poi fallace, di po t er utilizzare a l ungo dispositivi terres t ri t roppo rido tt i, ancorché t ecnologicamente ben dotati.
D i fro nte a questo s i tratta dunque di tr ovare una formula di "sufficienza" numerica . Non occorre fare molti sforzi al riguardo. Per l a componente terres t re infatti può bastare un liv ello di ambizione corrisponden t e all'at tu ale impegno (po co meno cli 3 Briga re, con le turnazioni 11 - 12 Brigate in rotale, re ndend o le tutte il più possibile id onee a svolgere l'intera gamma di ope r azion i, dal combar alle Cro). In sostanza, un comp l esso di forze numericam en t e sufficiente (l'attua l e modello a 112.000) dotate cli eleva t a flessibilità operativa . Forze in c ui la t ecnologia si a ben presente, ma le c ui dotazioni d i sistem i d 'ar ma s iano veramen t e fasate sul caso medio d'impiego (dun que in prevalenza brigate medie) con possib i lit à di svo l gere anche compiti di più e levata intensità operativa in misura numericamente r id o tta.
Il prob lema è così quello di rendere il più poss ibile cos r- effec ti ve l'investimento pro -capi t e, ev ir an -
do di "conge lare" uomini e costosi programm i di approvvigionamento su forze impiegab il i esclusivamente in uno sce n ario di guerra t r ad izionale, oggi rela ti vamente poco probabile per un Paese come l'Ital ia, al di fuori delle Alleanze e , comunque, di un contesto legittimato dall'Onu. Vincol i c h e , almeno il primo, limitano molto l'esigenza sul piano dei fabbi sog ni (ivi compreso que l lo per la difesa ciel t erritor io) e, il secon d o, su quello della ti pologia di conflitto
A quest 'es igenza, riferibile essenzialmente alle uni r à di manovra, si uniscono quelle relative alle uni r à specializzate che, sempre cli più, vanno dimostrando la loro utilità in T eatro . Tra queste vanno evi denziate le unità di cooperazione civi lemilitare (C imi c) , nucleare biologica e chimica (Nbc), exp los ive ordnance disposal (Eod), reconnaissance, intelligence, surveillance and t arge t acquisit ion (Rista) e altre, che r isu lt ano tra le più ric hi este e apprezza t e Si tratta di se tt or i nei qua li l'Esercito vanta un know-how molto im portante, riconosciuto anc h e all' i nterno dell'Alleanza Atlantica, come ne l caso Nbc
In sintesi, s i tratta di investire mo lt o di più sulla fless i b i li t à operativa e su asse tti specialistici, privilegiando l'uomo come fa ttor e di s u ccesso .
All'uomo vengono garan titi, ol t re che un più i ntenso addestramento, anche un maggiore standard di sicurezza, va lore verso il quale, tra l'altro, la sens i b i lit à de l la società moderna è molto fo rre, e un'a lta capacità operativa a 360 gradi, a ttra verso un con venie nte investimento in t ecno logie . Quest'uomo non p u ò che essere un professionis t a, che sa coniugare le d oti miglior i e i valori in -

nat i del soldato italiano con u na pr eparaz ione p r otratta ne l tem p o . Quest'ultima r iguarde r à tutti i camp i, a l fine di creare un co m battente forte, efficace, sereno, i n gra d o d i ope rare al meglio in tutte le c ircosta n ze, ivi compresa la lotta a l terror ismo m il it arizzato, e riscuot ere anche solidariet à dalla gente
Scelte oculate in tema di fless i b ili t à, fabbisogni, tecnologia, iter addes t ra ti v i co nsentono all'Esercito la dis pon i bili t à d i solda ti idone i all'impiego in u na vas ta ga mm a di scenari ma con una forte red dit iv it à d ello strumento, finalizzato per obiett ivi conc reti e pla usi bili, p i u ttos t o che per i potesi eva n escent i o, peggio ancora, vellei t arie .
TI sistema -sol d a t o ( uomo con valori cli ri fe ri me nto molto forti orien t ato verso u n impiego con-
trollato della forza, pi ù tecno logia) sarà lo "zoccolo d uro" d ell' Eserc ito.
La confer m a d ella v a lid ità d i questa scelta v ien e d al campo, in t ut ti i settori, compreso quello d ei va lor i, come i fatt i d i Nassiryah ci ricordano.
La componente terrestre, pari oggi al 75 - 80% de l l'intero dispositivo mili t are italiano all'e s tero, svo lge un ruolo primario, insos ti tuib il e n el p r odurre sicurezza .
A differenza del passate> in cu i esso era essenzialmen t e espress io n e d i una "capacità in potenza", oggi l 'Esercit o è - come già ricordato - una "forza in a t to", in grado di fornire un contribu t o dec is ivo alla politica ita liana e alla s t abili rà interna z ionale L'auspicio è che s ia messo , sempre di più, in condiz ion i di po t e rl o fare .

' N ato R api d D ep loya b le Co rp s - Ira ly (N rd c -l c)
' Allied Rap id Rea c tion Corps
1 S i t r a t ta d e l p r i nc ip io N ato r e la t ivo a ll' imp iego e alla sosten ib i li tà del le for ze in operazion i.
' Si deve a l Se gre tario Genera l e d ell'Onu, Dag Hammarskjèild, la prima enunciazione, in un rapporto indirizzato all'Assemblea G enerale, de i pr inc ipi di b ase e delle li nce -guida per g l i i n -
terventi di p eacekeep i ng (R a pporto de l Segretario Generale A/3302 de l 1960)
5 Civil -Milira ry Coop erar ion. Pe r coop erazione ci vil e-militare si inte nde l' insieme delle r isorse e d eg li accor d i che so-
st engo n o le rel azio ni interco r renti era i Co mandami, le Autor ità naz ionali - c ivi li e m ilitari - e le popo lazion i di un 'area dove le fo rze sono impiega t e o dove è p ianificato il lo ro imp iego Tali accor -
di incl ud ono la cooperazione con le agenz ie, le organizzazion i o le a u torità non gove rnative o internazio nali

• United Narions Deve lopmenr Programme .
' Uni t ed Nations High Comm issioner for Refugees. s Internat iona l Organisacion fo r Migra t ion.
·, Reconnaissance, inre lli gence, survei ll ance, ta rge r a cquisi t ion, elec tron ic warfare
10 Exp los ivc Ordnance Dispo sal/Im prov ised Explosive D evicc D isposa l.
11 Mi ne Det ec t ion Dog/Exp los ive Det ectio n Dog.
12 Pe r " ri se rva se lez ionata" si inten d e la creaz ione d i u n ba-
cino d i persona le - uom ini e d onne - i n p ossesso di part icolari profess iona lità d i interesse, non dis ponibili n e ll 'ambito dell 'Esercito, da c ui la Forza Armata può attingere di vo lta in vol ta s u lla base de lle propr ie necess ità . A ra ie personale, tratto d irettamente d a professionis ri d el mon d o
civi le, v ien e co n fe ri ta - senza concorso e previa sottosc rizione d e ll a d isponibili tà al richiamo alle armi s ul territorio naziona le, ovvero a ll 'esterola nom in a a Uffic ia le di complemento (a i sens i de l regio dec reto 819/1932 e s uccessive mo difi che apportare da l decreto legislativo 4 90/1997).
Strane, le coincidenze. "Incidenze", avrebbe preferi t o chiamar le lo spi rito vol ra ir riano d i Leonardo Sciasc ia, per sottolinearne la rela z ione convergente, pur se formalmente in volontaria, sulla realtà . Strane appunto . E affascinanti. Perché nello stesso giorno - domenica 1 agosto del 2004in cui i quotidiani danno notizia dell'imporrante incesa sul ri lancio del la world tracie organization (Wto) , sui suss id i agrico li e su l l'abo l izione graduale del protezionismo da parte dei Paesi più ricchi, proprio a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo (vantaggio parziale e ancora quasi solamente di indirizzo politico, ma comunque importante, dopo le chiusure degli anni precedenti), nelle pagine delle cronache internazionali trova spazio significativo un'altra notizia, desti nata anch'essa ad avere eco e conseguenze di peso: l'appello sottoscritto da 309 intellettuali egiziani che domandano riforme radicali e maggior democrazia nel loro Paese La modernizzazione dell'Egitto, impostata e sos t enuta dal pres idente Hosni Mubarak, infatti , è ancora fragile . Ed è sottoposta a spinte divergenti. Da una parte c'è la gestione di Mubarak, autoritaria e ampiamente criticata per certi elementi di corruzione, ma comunque sens ibile alle relazioni di pac e e d'affari con i Paes i islamici moderati e con l'Occidente . Da l l'altra, c'è la crescita dell'integra l ismo is l amico che minaccia di portare indiet r o nel tempo l'evoluzione democratica e il pur timido sviluppo economico nel segno degli scambi, della cultura di mercaro, dell'industrializzazione legata agli investimenti i nternazionali e dell'ap ertura verso il resto del M.ed iterra n eo e del mondo .
I 309 inte ll ettual i in sistono sul rafforzamento dei processi di democrazia: fine del monopolio de ll a vecchia classe dirigente, riforme costituzionali e politiche nel sens o di maggiori libertà, scelte politich e e culturali che esa lti no l e capacità di dialogo dell'Islam . Parlano al loro Pa ese e alle stesse tecnocrazie che sorreggono s ia J'vlubarak che il suo probabi le successore, il figlio Gama l , un g iova n e leader arabo vic ino all'Occidente e i mpegnato nella modernizzazione politica, econom ic a e ci vile. Ma insistono anche perché l 'E uropa, gli Usa e Israele aprano gli occhi, collaborando attivamente ai proc essi cli pa ce in Medio Oriente e sostenendo l'evoluzione dell'opinione pubblica araba e i govern i pur solo timidamen t e democratici e comunque sensibili a i temi de l la sicurezza, della pace e d ello sviluppo equilibrato Ascoltarci e sostenerci - dicono gli intellettuali egizianiè interesse comune: arabo ma anche europeo. L'Egitto, per la stabili rà mediterranea, è un Paesecard ine: potenza economica e militar e, interlocutore non pregiudizialmente osti le di Israe le, centro di relazioni positive sull 'evoluzione di tutta l'area d el Medio Oriente, attore autonomo e credibile dell e politiche di dist ensione da sostenere, da parte degli Stati Uni ti e dell ' Europa e stimolo all'evoluzione di al t ri Paes i dell'area, a cominciare dalla Siria.
Tra le due no ti zie - le intese della Wto e l 'ap pello degli uom ini di cultura de l Ca iro - non c'è un nesso diretto . Ma il lettore attento de i quotidiani che riflette, per mestiere e passione, sulla convergenza tra i t emi d ella sicurezza e quelli della crescita economica e dello svil uppo socia le e c ivil e non

può non trovar si a sottolineare la coincidenza .
E l'incidenza Con una certa soddisfazione E un filo di speranza. Le vie del dialogo sono essenziali . E sta proprio nel gioco incrociato della politica, dell'economia, delle diplomazie e delle forze culturali la leva da usare per cercare la via di uscita dalla "stagione del terrore" cominciata forma lm ente con gli attenta t i di Al Qaeda alle Twin Towers di New York, ma carica di radici nei conflitti, nelle dispar ità socio-economiche e nelle tens ioni irrisolte lungo tutto il corso degli anni ottanta e novanta.

Processi di pace, superamento degli squilibri tra nord e sud del mondo, strategie di s icurezza globale nel lungo periodo, po litiche di ges t ione dell'immigrazione, di accoglienza e di integrazione, rafforzamento delle economie locali sostenendone le potenzialità autonome di crescita, diffusione delle democrazie e delle economie di merca to sono turti aspetti cli un'unica , grande questione che potremmo chiamare di governance della globalizzazio n e Partendo d a l Mediterraneo, area cruciale de lle tensioni internazionali. E investendo l ' Europa, gli Stati U niti e il resto del mondo . Come?
Valorizzando non certo il "mercatismo" e cioè l'ideologia salvifica del primato del libero mercato (che proprio a caval lo tr a vecchio e nuovo seco lo ha mostrato tutti i suoi limiti), ma l'insieme delle sce lte pol itiche che sostengano uno sviluppo equili brato e compatibile con diritti, culture, esigenze e interessi locali.
L'Egitto è vicino, infatti. E la lingua degli uomini di cultura del Cairo ha moi re assonanze con la nostra lingua europea. Le sponde del Maghreb
non sono altro c h e l e rive di fronte de l nostro stesso mare. E garantire ai Paesi arabi, alle aree dei Balcani e al le nazioni del Vicino Oriente prospettive di crescita economica e sociale e riforme poli ti che che ne valorizzino identità, ma anche evoluzione e libertà significa in fin dei conti s ia giocare una carta di assunzione cl i responsabilità per nuovi e migliori equ ilibri internazionali, sia rispondere ai nostri st ess i interessi nazionali ed europei : Io svi luppo arabo è l'altra faccia della nos tra sicurezza, e viceversa.
Per cap ire meg lio si può partire da alcune consideraz ioni di fondo, sulla scia delle valutazion i d i uno dei mig liori interpreti della stor ia e de l l'evoluzione dell'area de l Mediterraneo, Predrag Matvejevic . Un mare di rel az ioni e di traffici, di scambi di merci e di idee: "Lungo l e coste di questo mare passava la via della seta, s i incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli oli e dei profumi, dell' ambra e degli ornamenti, della sap ienza e della conoscenza, dell'arte e dell a scienza. Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le re ligio ni. Sul Mediterraneo è s tata concepita l'Europa".
Confronti . E conflitti: "È difficile scoprire - insiste Matvejevic - ciò che ci spinge a provare a ricompattare continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare tante vo lt e il catalogo delle s ue componenti, a verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell'una nei confronti dell'altra: l'Europa, il Maghreb e il Levante , i l giu daismo, il cristianesimo e l ' islam; il Talmud, la Bibbia e il
Corano; Gerusalemme, A t ene e Roma, A lessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l'arte e la democraz ia; il d i ritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; i l R inascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, celebri e atroci; gli Slavi del sud dell'Adriatico e molte a ltre cose ancora. Qui popoli e razze per seco li hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli a ltr i, come forse in nessun'altra regione di questo pianeta . Si esagera evidenziando le loro convergenze e somiglianze e tr ascura ndo invece i loro antagonismi e le differenze. TI Med iterraneo non è solo storia" . Anche se proprio la lezione del la s toria spinge a fare i conti con quel che resta d'attualità, con quel che il "Breviario mediterraneo" consegna oggi all'agenda della politica e delle scelte di costruzione di un migliore futuro: "In ogni periodo, sulle varie parti de ll a costa ci imbattia mo nelle contraddizioni. Da un lato la chiarezza e la forma, la geometria e l a log ica, la legge e la giustizia, la scienza e la poetica, dall 'altro tutto ciò che a ques t e particolarità si contrappone . I libri sacri della pace e dell'amore e le guerre di religione, crociate e jihad. Un ecumenismo generoso accanto a un ostrac ismo feroce. L'universalità e l'autarchia. L'agorà e il labirinto. La g ioia dionisiaca e il macigno di Sisifo. At ene e Sparta Roma e i barbari. L'impero d'Orie nte e quello d'Occ id ente. La costa se tt en trionale e quella meridionale. L'Europa e l'Africa .
Il cristianesimo e l'islam. Il cattol icesimo e l'ortodossia. La tradizione giudeocristiana e la persecuzione degli Ebrei.
Sul Mediterraneo il Rina sc im ento non è riuscito
dappertutto a superare il Medioevo" .
A guardar bene ai fatti più r ecent i della cronaca mediterranea, possiamo trovare numerosi esempi d'una raie dialettica, ancora irrisolta . Rinascimento, per esempio, è l 'ina ugurazione della nuova Bibl ioteca d i A lessandria d ' Egitto, catalogo esemp la r e di sapienze orienta l i e occidentali che si incrociano, con un profon do omaggio sia al recupero storico d'una antica abitud ine (i l dialogo a tt raverso i libri, la traduzione e la rie laborazione critica come atto creativo, gli auto ri arabi come mediatori t ra la filosofia greca e la sapienza c ris tiana ), sia alle opportunità offerte dalle nuove tecno logie in forma ti che e telematiche (la biblioteca ha robusti supporti hi - tech ed è raggiungibile e consulta bile via Internet) Rinascimento, ancora, sono gli scambi economici in corso e il crescere de g li inves ti menti europei in parecchi de i Paes i del Maghreb (con iniziative interessanti di imprend itori it al iani, come il centro di ricerche di Pininfarina in Marocco o le attivi t à industriali siderurgiche di Riva in Tunisia, tanto per fare so lo due dei tanti esempi poss ibili, o ltr e alle già note collaborazioni r ra l'Eni e gli enti petrol i fer i cli Egi tto , Libia e Algeria). Rinascimento, per continuare, so no le iniziativ e- pilota italiane, in cornice eu ropea, de ll e attivi t à cli e -government per i Paesi arab i e african i, una s pinta importante per la modernizzaz ione delle pubbliche amministrazioni e dunque dell'economia . Rina scimento, insomma, è un catalogo lungo di inizia ti ve politiche e dip lomatiche, attività culturali, interscamb i, int raprese economiche e finanziarie nel segno del potenziamento delle relazioni, in vista di quel

2010, ormai v1c1110, in cui il Mediterraneo dovre bbe essere "a rea d i libero scambio" tra i Paesi Ue e le a ltre n azioni che si affacciano sul grande mare comune.
E il Medioevo? L'aggravarsi del conflitto i n Med io Oriente, con l ' esasperazione delle contrapposizioni id enti t arie e religiose e l'in t ens i ficazione delle vio lenze ne è un esempio . I dra m m i della povertà e dei confl itti etnici che spingono migliaia di dispera ti a cercare rifugio, protezione e sa lvezza sulle sponde europee ( un popo l o di migra nti alla me rcé di mercanti di uomini, con forti complic ità politiche in alcuni porti medi t erranei e con relazioni p ericolose con centrali mafiose e cr i mina l i e gruppi t error is t ici ) ne sono u n a ltr o . E ancora : l e tragedie su danesi del Darfur, segnate dal fana t ismo is lamico e dalle complicità politiche loca li; l'emergere di nuovi e vecchi fondamentalismi; le c rescenti aree di contig uit à con i gruppi de l terrorismo internaz ionale in Paesi tradizional m ente modera t i e aper ti al dialogo con l 'Occidente e l ' Europa. E l'antisemitismo che s'espande , allarmante, per esempio, in terra di Francia, da parte d i gruppi robusti di giovani arabi provenie nti dalle periferie più povere e d ispera t e contro g li appartenen t i alle comunità ebra iche . Un antisemitismo, ancora, c he cresce e minaccia le comunità ebra iche in terra europea e a l imenta vecchie e nuove ostilità contro la stessa sopravvivenza de llo St ato di Israele (l'unica democrazia in Med io Oriente, riprova v iven t e ed esemplare d'un t entativo costante di affrontare le questioni d el la sicurezza e dello svil u ppo senza ab d icare mai ai principi della d emocraz ia e del rispetto delle libertà) .
Affron t are e combattere l'ant isemitismo e il pregiudiz io ami - Israele finisce così per essere tema pol iti co fondamentale, stre t tamente correlato a quello della t ut ela dell ' evoluzione democratica e aoti -integralisra d ei Paesi della sponda araba de l Mediterraneo Una battag lia aperta. Dall'esi t o incerto. Ma da affrontare con luc id it à poli t ica e lungim iranza d ' intenti. L'Europa è inquieta. E il Me d iterraneo, dei tan t i vo lt i c he ne hanno segnat o la storia, può ri t rova rsi a vivere i peggiori, quelli delle st ragi, de l le guerre d'interesse e di religione, de l t erro re . Ma non ci possono essere né abdicaz ioni né rassegnazione.
L'ombra d el terrorismo pesa in modo crescente sull'Europa e sugli stessi Paesi islamic i moderati. Un t errorismo di cu i valutare tutti gli aspetti. Gli e lementi antichi, seg n a ti d a un fondamenta lismo religioso pervasivo che d ell'Islam sva l u t a le cara tteristiche di confronto e tolleranza E le cara tt eristiche di " m odernità" lega t e all'idea di "r i fondar e la c ivi lt à" e costruire "l'uomo nuovo" tipica delle due ideologie c he h a nn o funestato il Nov ecento, il nazismo del ro t al it arismo della razza e il comunismo d e ll a stor ia salvifica e del t rionfo d i classe , con t ro l 'i mperfezione p rob lema t ica de ll a società aper t a d'impronta liberale e l'i ntr eccio fecondo t ra libertà indiv iduale , so l id arie t à, principio di responsabili t à .
Se questo è vero - Al Q aeda come terrore t ota lit ario "moderno" (secondo l e stimolanti analisi d i John Gray) ma a nche recupero "antico" del fondamen t al ismo e contemporaneamente parave n to ideolog ico del rifiuto delle ing ius t izie e scorciatoia verso un riba ltamen t o di poteri e interessi -

l 'Euro pa e i Paesi arabi sensibi li a un riequilibrio possibile hanno bisogno di definire meglio intese, alleanze, proge t ti politici che del connubio tra cresc it a econom ico -soc iale e sicu rezz a facciano una leva di costruzione di pace, l ibertà e benessere. Non un programma generico di buone intenzioni . Ma una vera e propria strategia politica di sviluppo, in un contesto internazionale che faccia suo i e pratichi concretamente il multiculturalismo e il multipolar ismo de l le r e lazio ni internaz iona l i. Co m e? Anzitutto rafforzan d o l'Europa. Soggetto economico di rilievo , grande mercato aperto di intelligenze, culture, ca pita li, merci, tecnologie, nel corso d el tempo la Ue s'è rivelata sogge tt o politico fragile e inc erto, forma lmente in t eressata a una poli ti ca estera di cresc it a e sicurezza ma sosta nzi al mente incapace di svolgere un proprio ruo lo autonomo e incisivo (l'assenza di una vera e propria politica euro pea durante i l d ecennio d elle crisi nei Balcan i ne è evi d ente riprova).
Si so no mossi alcuni Paesi della U e, in ambito Nato e ne l concerto delle iniziative d e ll'Onu (co n man i festazioni d'imp egno e di effic ienza a mmirevo li nei processi di peacekeeping in cui le Forze Armate italiane hanno t estimoniato capacità tecnica e int ell igenza " politica") . Ma l'E urop a come tale no . Un limi t e . E un' ip oteca negativa sui futuri e quilibri in ternaz ionali .
La nuova cost ituz ione europea consente di fare dei passi avanti, su ll a strada d i una Ue come "superpotenza pl u ra le" oltre che come "potenza civile" (secondo le d efinizioni usate da un attento studioso dei problemi della politica estera europea come Marco Cleme nti ). E l o sc h ema d ella
stra t eg ia pu ò essere individu ato nel ra p porto firmato da Javier Solana ("m is t er Pese" e cioè Alto Rappresentante per la po l itica estera comune) e in titolato A secure Europe in a better world. L'Europa , secondo Solana, dovrà da r e tre ri sposte alle sfide della globalizzazione e delle necessità di una sua governance : contribuire alla stab i lità e a l buon governo dell'immediato vic ina t o; rafforzare l 'ord in e internaziona le trami t e le is titu zioni universal i e reg io n al i; ris pond ere alle minacce "prim a c h e si ve ri fichi u n a crisi". Affe rm azioni importanti. Ma anche dest inate a restare buone intenzioni se non seguite da scelte po l itiche conseg u enti . D i obiettivi. E di strumentazione per l'intervento .
P reso atto della fine della s ta g ione dell'" unila t er a Iismo" americano rispet t o alle gran di sce lte pol itiche internazionali , torna a ll a riba lt a la questione del ruolo, del peso e, dunque, del r afforzamento e della riforma dell'Onu. L'E uropa non ha ancora una linea comune e i suoi gran d i Paesi si muovono in ordine sparso, per que l che riguarda ad esempio le funzioni e la par t ec ipazi one al Cons igl io di Sicurezza . Una discussione sincera e aperta in sede Ue, con un forte contributo dello stesso Parl amento di Strasburgo, sarebbe indis pensa b i le . Allargan do il confronto sulle ipotesi di riforma delle altre grandi istituzioni internazionali, dalla Banca Mondiale al Fondo Monetario Int erna zion a le e c io è agli strumen t i car d ine per la cos t ruzione di mo dern e strategie di crescita e di svi luppo e per il supe ra mento dei tradiz iona li squilibri nor d -su d. Un nuovo ordine economico mondia le è necessario e adesso anc he più

possibile che nel recente passato. Le intese in sede Wto sul tenta t ivo di superamento dei protezionismi e dei sussidi agricoli ne sono una pur timida conferma . Altre iniziative dovranno seguire, tenendo sempre presenti i nessi tra svi luppo e sicurezza , tra l'espansione delle libertà culturali (legate al miglioramento delle condizioni economiche, ma anche presupposti per la crescita economica stessa) e la diminuzione dei conflitti .
Le riforme, naturalmente, non possono non r iguardare anzitutto l'Europa, l'intera area della Ue, i Paes i di p iù antica e so l ida tradiz ione comunitaria A cominciare dalla riforma del settore che assorbe la quota maggiore delle risorse di Bruxelles: l'agricoltura. Sulla Pac (la politica agricola, appunto) sono stati fatti passi avanti Ma restano ancora parecchi vinco l i pro t ezionisti . Giustificati alcuni (quelli realmente legati alla qualità e alla tu t ela dei p r odotti agricoli e agroindustriali "tipici"). Ingiustificati altri (quelli che più o meno direttamente finiscono per essere sostegni assistenziali per categorie agricole prote t te). Il guaio è che il protezionismo Ue taglia fuori dai mercati europei proprio i prodott i che vengono da i Paesi della sponda araba del Mediterraneo . E dunque finisce per ral lentarne la crescita economica, l'ap e rtura alla cultura di mercato, l'evoluzione liberale e democratica. Il nesso tra sviluppo e sicurezza sta proprio qui: l'Europa che protegge con m iopia recid it i e sicurezza economica d i una parte dei suoi abitanti, non consente l'evoluzione di Paesi in bi l ico tra innovazione e fondamentalismo, tra d ia logo e identità rivendicazionista, tra apertura verso l'Occidente e ostilità fondamentalista. L'Eu -
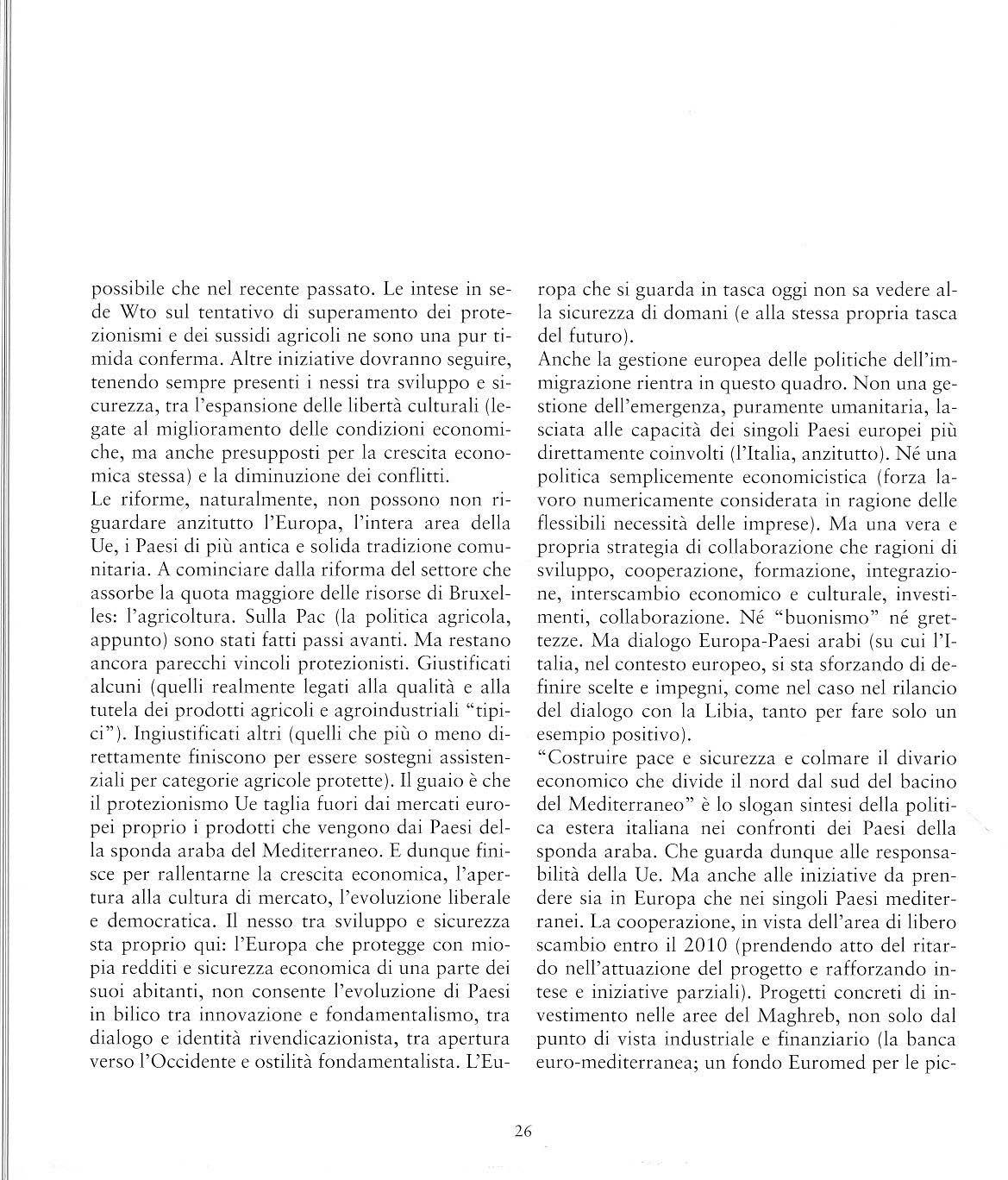
ropa che si guarda in tasca oggi non sa vedere alla sicurezza di domani (e alla s tessa propria tasca del futuro).
Anche la ges t ione europea delle politiche dell'immigrazione rientra in questo quadro. Non una gestione dell'emergenza, puramente umanitaria, lascia t a alle capacità dei singoli Paesi europei più direttamente coinvolti (l'Italia, anzitutto). Né una po l iti.ca semplicemente economicistica ( forza lavoro numericamente considerata i n r agione delle flessibili necessità delle imprese ). Ma una vera e propria sera regia di collaborazione che ragioni di sviluppo, cooperazione, formazione, integrazione, interscambio economico e culturale, inves t imenti, collaborazione. Né "buonismo" né grette z ze. Ma dialogo Europa - Paesi arabi (su cui l'Italia, nel contes t o europeo, si sta sforzando di definire scelte e impegni, come nel caso nel rilancio del dialogo con la Libia, tanto per fare solo un esempio positivo).
"Costruire pace e sicurezza e co lmare il divario economico che divide il nord da l sud del bacino del Mediterraneo" è lo slogan sintes i della politica estera italiana ne i confronti dei Paesi della sponda araba Che guarda dunque alle responsabilità della Ue. Ma anche alle iniziative da prendere sia io Europa che nei singoli Paesi mediterranei. La cooperazione, in vista dell'area di l ibero scambio entro il 2010 (prendendo atto del ritardo nell'attuazione del progetto e rafforzando intese e inizia t ive parziali). Progetti concreti di investimento nelle aree del Maghreb, non solo dal pun t o d i vista industriale e finanziario (la banca euro - mediterranea; un fondo Euromed per le pie-
co le e medie imprese interessate a creare JOmt ven tur es in Marocco, Algeria, Libia, Tunisia, Egitto e Turch ia ) ma anche da quello della cu ltura e del l 'istruzione, facendo delle università italiane centri d ' eccellenza per la formazione tecnica e culturale delle nuove classi dirigent i arabe, in collaborazione-c ompeti zi one con le migliori università degli altri Paesi europei Programmi di assistenza tecnica e t ecno logica .

Un vero e proprio lungimirante "pacchetto Nledit erraneo", raccordato con gli "obiettivi di Lisbona" (investimenti in infrastrutture d 'ava nguardia e hi-tech, per potenziare la competitività internazionale d ell'E uropa )
Il resto , seguirà. Sta proprio nelle pol iti che di collabora zione, insomma, il cardine delle strategie cli sicurezza . "Svuotando l'acqua in cui nuotano i pesci del terrorismo". Rafforzando le istituzioni dei Paesi d ell'Is lam moderato .
E attenuando le dispari t à econom iche, le condizio ni di povertà, le marginalità economiche e sociali che alimentano g li sp i rit i di rivalsa , i radicalismi fondamentalisti in cui le organ izzazioni terroristiche tro vano paraventi e giustificazioni ideologiche. L'Europa, più d'ogni altra area del mondo , ha un ruolo centrale . Cui non abdicare . Pena l a crisi della s icurezza g lobale. E dell o svi luppo
Dall'1 l settembre del 2001 .l'Afghanistan e l'Iraq
vengono spesso evocati e discussi come manifestazioni geografiche di un eguale pericolo. Le due guerre sono state g iustificate con uno stesso argomento : la minaccia del t errorismo islamico . E gli sco pi della p oli tica americana dopo la fine delle operazioni militari vengono spesso d escri tti negli stessi termini: la creazione di un sistema democratico I due Paesi avevano , secondo \Vashington, regimi politici diversi, ma erano divenuti pedine di una stessa strategia. Il primo ospitava Osama bin Lad en e numerosi cam pi di addestramento per i militanti della sua organizzazione.
Il seco ndo collaborava con Al Qaeda e si apprestava a fornirle le armi micid iali che Saddam Hussein sta va progettando e costruendo nei laboratori del suo Paese. Non vi sarebbero sta t e quindi due guerre, ma due fasi di una stessa guerra. E i due dopo g uerra continueranno a essere affrontati, a parte qualche ada ttamento alle circostanze locali, con una stessa strategia politica. Terno che questa rappresentazione sia sbagliata e che l'errore rischi di rendere ancora più difficile la soluzione dei du e problemi.
Esiste a prima vista un dato comune. Ciascuno dei due Paesi è composto da un pot-pourri di gruppi etnici o confessioni religiose: in Afghanistan pashtun, tagichi , hazari, uzbechi, kirghisi: in Iraq sunniti, sciiti , curdi, turco manni, assiri, caldei . Ma vi è una fondamentale differenza. L'Afghanistan è un vecchio Paese orientale, cronicamente afflitto dalla mancanza di uno Stato moderno. Ma esiste da l 1747, a Kandahar o a Kabul, un uomo che ha nelle sue mani le red in i del pote-
re Può essere, a seconda delle circostanze storiche, un emiro, un khan, uno scià, un re oppure, come negli anni tumultuosi dopo la rivoluzione del 1978, un segretario di partito, mullah o presidente. Può essere forte o debole, sperico lato o prudente. Ma è la personificazione dello Stato, nel senso che la parola ha avuto in Asia . Ed esiste accanto a lui un'istituzione che rappresenta, sia pure in modo imperfetto, la struttura tribale della società afghana. È la Loya Jirga, versione asiatica delle cortes, dei fueros, delle diete e dei parlamenti che esistevano nell'Europa f eudale. Il sov rano (quale che sia il nome della sua funzione ) e la Loya Jirga rappresentano l 'identità e la continuità storica del Paese. Qu ando firmano un trattato di amicizia con A bdal i Ahmed Khan o soccombono a continue imboscate durante una hmga marcia verso le frontiera orientale nel gennaio 1842, gli inglesi sanno chi sono i loro interlocutori e i loro nemici . Quando la Russi a bolscevica firma con il governo di Kabul uno dei suoi primi trattati di amicizia (28 febbraio 1921), Lenin dimostra di non ignorare l'importanza di uno Stato che i suoi predecessori hanno inutilmente cercato di conquistare o di asservire.
L'Iraq invece è un Paese recente e artificiale, costruito poco più di ottant'anni fa dagli interessi mediorienta li di una grande potenza. E presenta la paradossale caratteristica di avere avuto per alcuni decenni, a dispetto della sua fragile id entità, uno Stato forte e , per molti aspetti, moderno . Per comprendere l'origine di que s ta chimera (un volto di leone, un corpo di capra) occorre tornare alla fine della Gran de Guerra. Nel 1918 la parola

Iraq è so l tanto il nome antico di una regione bagnata da due fiumi, il Tigr i e l'Eufrate, fra Baghdad e il Golfo Persico . Nei 437 . 000 chilome t ri quadrati di cui si compone oggi lo Stato iracheno esistevano allora soltanto i tre villayet ottomani di Baghdad, Bassora e Mosul. Qu an do Francia e Gran Bretagna decisero di spartirsi le terre arabe del Sul t ano fra il Mediterraneo e il Golfo, Londra chiese e o t tenne un mandato internazionale sui due territori che le t ruppe britanniche avevano conquistato durante i l confl itto e che erano allora chiamati, con termini sto rici, Pa les tina e Mesopotamia. Le ragioni, anche se l'Ammi r agliato bri t annico era consapevole dell'import anza del petro lio per le esigenze della flotta, erano principalmente geopoli t iche. Afflitta , come tutti gli imperi, da bulimia terri t or ia le, la Gran Bretagna voleva il Canale d i Suez per controllare la via delle Indie, l'Egitto e la Palestina per megl io co n trollare il Canale e il Mar Rosso, la Mesopotamia per meglio salvaguardare i suoi possedimenti medior ienta l i e per disporre, con Aden, di altre "stazioni " lungo le vie che scendono dal Golfo verso il mare Arab ico e l'Oceano Indiano: un grande domino territoriale che Londra aveva costruito giustificando ogni nuova conquista con la necessità d i meglio garantire quella precedente . D ietro il domino si profila va l'ombra del Raj indiano, perla della corona, vertice dell ' impero , simbolo di potenza imper ia le e, al tempo stesso, giustificazione della s t raordinaria accumulazione territoriale con cu i la Gran Bretagna aveva progressivamente riempito la spazio tra Gibilterra e Bombay
11a quando ottenne i l suo mandaro su lla .tvlesopotamia alla conferenza di San Remo d e l 1920 , Londra non aveva ancora deciso quale forma dare al suo nuovo possedimento. Avrebbe potuto adottare la formu la del governo diretto, come fece in Palestina, o affidare le responsabilità amministrative a un gruppo di notabili sotto l'occhio vigi le di un Al t o Commissar io, come aveva fatto in numerose colonie dell' i mpero. Ma non esistevano malauguratame nte in !vlesopotamia i maharaja e i su ltani di cui il governo britann ico, con qualche generoso vitalizio, si era servito per governare l'India e la Ma lesia In attesa di una decisione i l gab inetto di Lloyd George aveva m andato a Baghdad una sorta di legato con po t eri non diversi da quelli che Herbe r t Samuel esercitò a Gerusalemm e dal 1920 al 1925 . M.a era nel fra ttempo fortemente preoccupato da due esigenze diffic il mente conci l iabili. Doveva tagliare drasticamente le spese militari, divenut e durante la guerra esorbitanti . Ed era costret t o a mantenere una forte presenza mi l itare, per ragioni diverse, in Irlanda, sul Reno, a Costantinopo l i, nel Mar Nero, in Egi t to, nella Russia nordocc identale, in Iran e nel Ca u caso . Il dilemma divenne drammat ico quan d o la rivo lta di un villaggio del v i layet di Mosul nel maggio 1920 si estese come l'incend io d'una prater ia ad altre zone del Paes e e mise a dura prova le fo rze d'occupazione. Le sommosse furono represse con bo m bardamenti aerei, gas tossici e la distru zi one dei v illaggi coinvo lti nella ribellione. Ma era ormai necessario fare una sce lta che perme tt esse alla Gran Bretagna di sottrarsi a l sangumoso logorio degli scontri quotidiani, ri -

durre le truppe sul terreno e mantenere al tempo stesso il contro l lo d el Paese .
Come racconta Christopher Catherwood in un libro apparso nell'esta t e del 2004 (Churchill's folly. How Winston Churchill created modern Iraq, Carro] ] and Graf Publishers, New York), la scelta fu fatta da Churchill, allora ministro delle Colonie. Fu deciso di c reare un regno e d i affidare la corona a Feisal, figlio cli Hussein, sceriffo hascemita della Mecca. feisa l non era iracheno. Aveva diretto con T.E. Lawrence la rivolta araba contro gli ottomani durante la guerra e sarebbe dovuto diventare re della Siria . Ma era stato cacc iato da Damasco, attribuita alla Francia, e aspetta va da due anni che gli inglesi pagassero il debito. Nacque così nel 1921 il r egno dell'Iraq: uno Stato multie tnico e multireligioso governato da un re straniero (g li hascemiti provenivano dalla regione di Hejaz, nella p en isola araba) e sorvegliaro a vista dalla Gran Bretagna . Esisteva appena da un anno quando i curdi, costretti a far parte del regno, si ribellarono. Il lettore avrà già nota t o, a questo punto, quante analogie corrano t ra le vicende del primo dopoguerra e la situazione attuale.

La monarchia sopravvisse fino al 1958 e finì in un bag n o di sangue . La storia dell'Iraq, prima e dopo, è una lunga successione di rivol t e etniche, congiure di pa lazzo, colpi di sta t o e massacri . Di tutti i problemi che affliggono il Paese i maggior i sono la m inoranza curda e il rapporto di forze tra le due grandi famig l ie religiose dell'islamismo.
Mentre i curdi (sunn iti, ma non arabi) sono circa quattro milioni, i sunniti e gli sciiti costituiscono r ispettivamente il 32-37 e il 60 -65% di una po -
polazione che conta circa 16 milioni di persone . Mentre i curdi sono concentrati nel nord de l Paese e aspirano all'autonomia, se non addiri t tura all ' indipendenza, gl i sc i iti sono preva lentemente nelle province sud occidentali e i sunn iti in un grande tria ngolo attorno a Baghdad All'e poca del l'Impero ottoma n o curdi, sunniti e sciiti vivevano più o meno saggiamente separati nei tre vi llayet di Mosul, Baghdad e Bassora. Ma nello Stato iracheno, dal giorno della sua creazione, vivono insieme e sono sempre, ma t eria lmente o psicolog icamente, sul piede di guerra . È difficile immaginare che le regole della democrazia possano essere app lica t e a un Paese in cui i vinc oli tribali, etn ici o confessionali sono più impor tan t i del rapporto che dovr e bbe instaurarsi fra i l cittad i no e lo Stato . I sunniti sanno che p erde rebbero le elezioni e hanno qualche buon motivo per temere che le perderebbero una volta per tut t e. E i curdi non intendono ri n unciare alla sostanziale indipendenza cli cui hanno god ut o dopo l a guerra del Golfo. In queste condizioni non è assurdo pensare che la strada de l la democrazia sarà molto più lunga de l ca lendario fissato a Wash ington nei primi me si de l 2004.
Quale può essere in ques t e circostanze il ruolo dell'Occidente? Il presidente americano (Bush o Kerry, poco importa) avrà bisogno, per restare in Iraq, di un forte avallo internazionale Ma è improbab ile che intenda rinunciare , per o ttene rlo, alla guida dell'opera zi one e permettere che il comando venga assunto, come in Somalia nel 1993, dal generale di un altro Paese. Gl i americani vogliono la Nato a Baghdad perché il comandante
supremo, a Mons, è un generale degli Stati Un iti. Possono gli alleati europei accettare una tale situazione? L'accetterebbero di buon grado, certamente, i Paesi che hanno già una presenza militare in Iraq, come l'Ita l ia, e che sarebbero lie ti di con ferirle in tal modo una maggiore legi tt im ità internazionale. Ma qua le sarà l'atteggiamento di coloro che si sono pubblicamente opposti alla guerra irachena? Al di là degli interessi degli uni e degli altri, resta comunque un punto di fondamenta le importanza: se sia utile lasciare che la Na t o venga visibilmente e tangibilmente coinvolta nella vicenda irachena Anche in questo caso è utile fa.re un passo indietro . Prima dell'inizio della guerra afghana il Consig li o atlantico dichiarò che la minaccia terroristica giustificava l'applicazione dell'art. 5. Chiedendo al regime talebano cli cacciare Osama da l suo t erritorio l'America reagiva a un'aggressione e aveva diritto al sostegno di tutti i suo i am ici. Grazie al "giuramento dei moschettieri" (tutti per uno, u no per tutti) ogni membro dell'Alleanza fu da quel momento in guerra con il governo di Kabul. Ma gli Sta ti Uniti, dopo aver incassato il sostegno morale della Nato, prefer irono servirsi di una forza anglofona (america ni , br itannici , canadesi) e degli irregolari dell'Alleanza del nord, fieramente ostili al regime ta l ebano. Non volevano ripetere l'esperienza ciel Kosovo quando ogni nuova ondata cli bombardamenti veniva sottoposta ogni mattina al vagl io e all'approvazione di un comitato del)' Alleanza. Dopo essere stata invocata solennemente alla vigilia delle operazioni, la Nato tornò nelle quinte e dovette limitarsi a osservare

dalla p latea il d r amma de ll a guerra . Ritornò in scena più tardi quando gl i american i, dopo aver liquidato lo Stato islamico dell'Afghanistan e ormai d esiderosi cli aprire al più presto la questione irachena, dimostrarono cli non avere altro interesse fuor che quello di eliminare i nuclei della resis t enza t alebana e catturare Osama bin Laden. Toccò all'A ll eanza allora, e in particolare ai suoi membri europei, ga r ant ir e l'ordine in vista delle prime elezioni politiche dopo l ' inizio della presidenza Karzai . Ma i 6.500 uomini de)J' Alleanza possono mantenere l'ordine, tutt'al più a Kabul, e nelle zone circostanti. Per pacificare un Paese diviso fra signori della guerra, talebani, parrigiani d i Osama e mercanti della droga sarebbe necessario un corpo di sped izione ben più consis t ente e, soprattutto, una ragionevole prospettiva di successo. L'unico motivo di speranza è l'esistenz a, per due secoli e mezzo cli uno Stato . Hamid Karzai ha più legittimi t à di quanta ne abbia un qualsias i uomo politico iracheno .
Ne] caso dell'Iraq la Nato ha recitato grosso modo la stessa parte. Come in Afghanistan gli Stati Uniti preferivano agire da soli, alla testa di una coalizione fondamentalmente anglo-americana . Ma cercarono cli ottenere dalla Nato l ' avallo formale che non avevano potuto ottenere nelle settimane precedenti dall'Onu e chiesero al Consiglio Atlantico un impegno a proteggere la Turchia dalle minacce irachene Quali minacce? L'Iraq avrebbe minacciato la Turchia, verosimilmente, soltanto se gli american i, come era allora nelle intenzioni di Washington, si fossero se r viti del territorio tu rco per attaccare il regime di Bagdad .
E si sarebbe trattato, in tale caso, di legittima difesa. La F r ancia si oppose e l'impegno, in mancanza d i meglio, fu assicuraro da l Comitato mi l itare, vale a dire da un organismo de ll'Alleanza in cu i il governo francese non è rappresentato . Poco tempo dopo , quando il parlamento di Ankara negò alle forze americane il passaggio a ttr averso la Turchia, l' i mpegno p erde tt e comu n que qualsias i importanza .
Co me in Afghanis tan la N ato è stata rich iamata alle armi in Iraq allo rc h é l'America si è accorta d i averne bisogno. Sollecitata da Bush in un momento in c ui il presidente era in campagna elettora le (e ogni ri fi uto sarebbe parso una manifestazione di s impatia per il suo avversar io), l'Alleanza ha f inito per impegnars i ge neric amente ad addestrare le Forze Armate de l n uovo Stato iracheno . Ma i tempi e i modi dell 'impegno dipendono in ultima anal isi d al corso delle cose . Se gli americani e il nuo vo governo di Baghdad riusciranno a spegnere la rivolta e a controllare il territorio, tutti i membri d ell'A ll ea nza (anche quelli contrari a l conflitto) saranno probabi l mente fe lici di lasciarsi coinvolgere e d i acquistare in ta l mo d o un titolo di b e n e me renza . Se la situazione, come appare oggi più probabile, sfuggirà al controllo america no, l'Alleanza ev iterà di la sc iarsi im prig ionare in una via senza uscita. Saranno probabi lmente costretti a restare in I r aq , finché gli Stati Uniti non avranno cambiato politica, i Paes i che hanno acce tt ato di assecondare la polit ica
amer icana. E l 'U n io ne europea, in ta l caso, cont inuerà a essere priva di una comune po l itica irachena.
In ulti ma ana l isi la risposta a tutti questi in t errogativ i è a Washington. Ma il problema, a dispe tto di certe impressioni degli scorsi mes i, non è rappresentato né dalla persona che occ u perà nei prossimi ann i la Casa Bianca né dai collaboratori d i cui vorrà c i rcondarsi. C hiunque s ia presidente e quali che siano le persone da cui si farà consigliare, gl i Stati U niti sono condannati, per il momento , a restare in Iraq .
Se lasciassero i l Paese ora diverrebbero responsab i li di tutto ciò che accadrà nella regione dopo la loro partenza e d arebbero alla loro immagine nel mondo u n colpo irrepara bile Usciranno dall'Iraq, se non riusciranno a pacificarlo, so ltant o quando il tempo, i t entat ivi falli ti , i sen ti menti della pubblica opinione, le ripercussioni della guerra sul bilancio dello Stato e un radicale camb io della guardia al vert ic e de l Paese avranno creato le condizioni che perm isero a Nixon e a Kissinger d i chiudere la part ita vietnamita D i qui ad allora l'America può so ltanto s tringer e i denti , e vivere alla giornata .
Res t a soltan t o, se è permesso fantas t icare, una dom an d a Saremmo a questo punto se l 'Unione fosse sta ta capace di con trap por re alla poli ti ca ir achena e mediorientale de gl i Stati Uniti un disegno e u ropeo? Se l 'America ha agito nel vuoto, chi, se non noi, ne è responsabile?

Parlare di "nuova" guerra è probabilmente improprio, anche perché, p er quanto si faccia un g ran discutere di gu err a al terrorismo, le operazioni su va sta scala che hanno coinvolto, a partire da ottobre 2001, le Forze Armate statunitensi e quelle dei Pa es i allea ti non erano rivolte direttamente contro organ izzazioni terroristiche, b e nsì contro avversari tradizionali, stati e governi. Le az ioni antiterrorismo ci sono eccome, ma hanno meno pubblicità e co involgono protagonist i che non hanno interesse a ottenere tito l i d a prima pagina sui media . Si tratta, per quanto riguarda la dimensione militare, di formazioni operative dei servizi di sicurezza, civili e militari, nonché di unità delle forze speciali delle Forze Arma re. E su ques to versante occorre svolgere qualche rifle s s ione Sia l'Iraq sia Afghanistan, per non par lare delle operazioni coperte, hanno ev id enz iato le enormi potenziali t à a l ivello strategico e operativo delle forze spec iali, che rappresentano anz i una vera fissazione per il Segretario alla Difesa Rumsfeld (al punto da richiamare dal servizio un generale dei Berretti Verdi, Pe t er Schoomaker, per fargli assumere l'incarico di Capo di Stato .tv1aggiore dell'Esercito). Questi reparti, proprio p e rché di élite, hanno consisten za numerica l imitata e vanno utilizzati ne l modo più pagante. Per intenderci, fargli fare la "scorta Vip" rappresenta uno spreco intoller abile. Possono ottenere grandi risulta ti sia lavorando a favore dei com andi "convenzionali", s ia, forse soprattutto, agendo s ul territorio con forze e gruppi locali. Pensiamo a quanto hanno ottenuto le forze s p eciali collaborando con le forze dell'alleanza del nord in Af-

ghanistan o con le formazioni curde nel nord dell'Iraq o ancora a l lavoro che stanno svolg e ndo nella lotta contro la guerrig li a in questi due t eatri e in alti punti caldi lontan i dai rifle tt or i (Corno d' Afri ca, ad esempio). Possono poi fornire i "musco li " in operazioni coperte o dec isamente clandestine che costituiscono la no r ma nella lotta ai gruppi terroristic i e nell a controproliferazione dei missil i balistici/da crociera e delle armi per la distruz io ne di massa Non sono però onnipo t enti e i l lo ro impi ego aggressivo comporta rischi po li tici e mi litari considerevol i.
Ma questa digressione s ulle forze specia l i non ci deve distog l iere dalla considerazione essenziale : Iraq e Afghanistan ci hanno ricordato che la parola fine alle op e ra zioni militari e il vero successo, la vittoria, sono conseguiti quando si è realizzato l 'obiet ti vo politico che ha originato l'az ione militare. La sconfi t ta delle fo r ze nemich e in battaglia è un t raguardo intennedio, non il fine ultimo. Quindi mentre è sicuramente importante o tten ere la supremazia militare nel più breve t em po possibile, impi egando magari un numero di uomini e mezzi limitato, il lavoro non è terminato fino a quando non si è rag g iunta la piena stabilità e quello specifico nuovo stato d i pace che ci si era prefissa ti. Come abbiamo o r mai capito perfettamente, per realiz za re tutto questo nei due Paesi citati occorrerà a lmeno ancora un lustro.
Lo ha d etto anche il generale Tommy Franks, comandante delle forze Usa ìn Enduring Freedom e Iraqi Freedom
Del re s to, basta guardare ai v ic ini Balcani per ricordarsi che le truppe Nato e presto queste ciel-
l'Unione europea, entra re i n Bosnia nel 1995 e in Kosovo nel 1999 sono destinate a rimanervi ancora per lunghi anni, anche se la fase bellica propriamen t e de t ta è stata iniziata e conclusa nel volgere di poche settimane o, al massimo, in poco più di due mesi e mezzo.
I conflitti recenti insegnano che l 'intervento in combattimento dire t to delle forze pesanti convenzionali t errestri può non essere politicamente né necessario né opportuno, in determina re circostanze e contro specifici avversari . Le forze aereemissil ist iche sono davvero in grado di o t tenere una vittoria militare abbastanza ve locemente, subendo perdite contenute e lim it ando sia lo spargimento di sangue, sia le distruzioni irreparabili di infras t rutture-chiave. Anche quando si devono impegnare forze terrestri convenzionali in misura significativa, come è accaduto in Iraq, il ruolo della componente aerea è decisivo . Basta leggere in proposito le analisi del generale Wes l ey Clark, ex comandante delle forze Nato nel 1999, ufficia le dell'Eserc it o e fautore d i un'"opzione terrestre" ai t emp i dell'attacco alla Jugoslavia di Milosevic, durante la crisi del Kosovo.

Tutto questo non d eve creare crisi di identi t à o di "disoccupazione", sia perché ormai si ragiona in un'ottica interforze, s ia perché in mo ire altre occasioni la situazione potrebbe cambiare: pensiamo alla lotta alla guerriglia in Iraq o al ven t ilato (e speriamo ipotetico) intervento internazionale in Sudan per scongiurare un genocidio nella reg ione del Dafur.
Quanto è avvenuto in Iraq è significativo in questo senso: in tre settimane la guerra vera e propria
era praticamente conclusa, compresa la presa della capitale e la distruzione delle forze regolari nem iche. Ma sono fermamente convinto che la strategia "light", volta a impegnar e un numero mi n imo di soldati e di marines, ripudiando la trad izionale dottrina statunitense (sostenuta, tra gli altri, dall'allora Capo di Stato Maggiore della Difesa Col in Powell) volta all'impiego d i una forza assolutamente preponderante anche quando non strettamente necessario, abbia fatto correre rischi eccessivi, prolungando più del necessario i comba t t imenti e probabilmente provocando perdi t e che si po t evano evitare. Quando poi si è trattato di occupare il Paese, esse ndo mancata sia la sperata sollevazione della componente sciita e la sua collaborazione con le forze st atunite nsi , sia la possibilità di impiegare immediatamente una larga parte delle forze dell'Esercito iracheno regolare non compromesse con il regime, l'intestardirsi ne ll a strategia "light" ha portato all'impossibilità di ottenere davvero il controllo del Paese, facilitando la diffusione e il radicamento di fenomeni di guerriglia. La cosa del resto non de ve stupire: quando la Nato entrò in Kosovo nel 1999, a guerra f inita, , inviò un Corpo d'Armata con oltre 50 000 solda t i in una regione vasta come il Molise e con una popolazione di un paio di milioni di abitanti. L'Iraq ha una superficie di 345 .000 chilome t ri quadrati, sia pure in buona misura occupata da deserti, e una popolaz ione di 24 milioni di abitanti, ma le truppe della coa lizione contano circa 160.000 effetti vi . È uti le ricordare che a provvedere alla sicurezza interna italiana ci sono oltre 300 . 000 tutori dell'ordine .
Il vero problema in Iraq è costituito dall'insufficienza di soldati sul terreno . Aveva r agione il generale Eric Shinseki, ex Capo di Stato Maggiore dell'Esercito U sa , che ipotizzava la necess ità di schierare almeno 250.000 soldati in Iraq. Il vertic e politico del Pentagono invece ha sos t enuto che sarebbero bastati 50.000 uomini per pochi mesi. Le cose però sono andate in modo diverso. C'è di più . Proprio perché la coalizione non controlla davvero il t erritorio (come può pericolosamen t e verificare chi percorra la strada tra Bassora e Bagdad), la guerriglia riesce a muoversi, a co lp ire, a nascondersi con relativa impunità. Se c i fossero più soldati d ella coalizione in circo l azione e nei centri abitati, anche se aumente r ebbero i pot enziali "bersagli", in rea ltà le diverse anime della guerriglia incontrerebbero serie difficoltà e, verosimilmente, a n che il numero di attacchi e di v ittime, mi l itari e civili, diminuirebbe.
In atte sa che le forze loca l i ( Esercito, Guardie di frontiera, Polizia, Guardia naz iona le ecc ) abbiano la consistenza, la capacità, l'esperienza p er ass um ere ruo li sempre più significativi non c'è quindi alcuna poss ibilità di ridurre i contingenti attuali, anzi, il picco di attività os ti li regi strato in concom it anza con il trasferimento di poteri al n uovo governo iracheno ha fatto predisporre piani per far affluire truppe d i rinfor z o, mentre si continua a giocare su lla "sovrapposizione" tra reparti smon t an ti al termine del periodo di servizio e unità appena arrivate in t eatro per ottenere un incremen t o temporaneo della forza.
La via di uscita, che richiederà t empo, fatica e quattrini, prevede comunque un"'i r achizzazione"
gradua le delle opera zi oni di stabilizzazione e di controguerriglia, senza ripetere però gli errori della "vietnamizzazione" de l confli t to ne l sud -est asiatico dei primi anni settanta. Si può fare, purché l'azione militare s ia coordinata a quella po litica, economica, socia le .
Un ragionamento analogo vale anche per l'Afghanistan, do ve il disarmo degli eserciti pr iva ti dei var i "signori della guerra" procede molto lent;:11nente. Non a caso il presidente Hamid Karzai chiede insistentemente alla comunità internazionale e alla Nato di manda r e a ltre tr upp e . E l'impegno dell'Alleanza Atlantica a incr eme ntare da poco più di 6.500 a oltre 10.000 unità la consiste112a della forza di stabilizzazione Isaf, c he allargherà la competenza su buona parte del territorio pur non partecipando attivamente alle operazioni di controgue r rigl ia che gli americani conducono con gli alleati (con circa 10.000 solda ti complessiv i ), costituisce una risposta significativa. Il governo afghano non è in grado di garant ire que lla sicurezza che cos titui sce l'esige nza più sent ita dall a popolazione ed è una cond itio sine qua non solo per lo svolgimento di elezioni ma per creare una "norma lità" che il travagliato Paese forse non ha mai conosc iuto
Tu tto questo ci dice che anche nell'era del networkcentric warfare, della guerra tecnologica e delle arm i di precisione non c'è a lt erna ti va a l soldato quando si deve occupare fisicamente e controllare un territorio.
Ed è bene evitare ogni faci le retor ica, si d e ve trattare di un solda t o con un bagaglio di conoscenze, capaci t à, mezzi e sistemi d ' arma su 360 gradi;

non esiste un "solda t o di pace" alternativo al soldato tout court , anche perché la natura iniziale e g l i obiettivi di una missione non necessariamente coincidono con la situazione che si può t rovare sul terreno, soggetta ai r i schi del mission creeping, ovvero una rapidissima trasformazione, come è accad u to, ad esempio, in Somalia. E d una missione d i s t abilizzazione, come doveva essere in t eoria quella irachena, può portare a operazioni di combattimento su vasta scala. Del resto, proprio nel 2004, si è rischiato qualcosa ciel genere nei Balcani, in Kosovo, a causa della preannunc iata crisi di M ir rov ica
Attenzione quind i a pensa r e che le operazioni di stabilizzazione e nation building, a eccezione del peacekeeping puro, possano essere affidate a soldati di serie B o a militari specializzati per questo ruo lo. Anzi, se si acce tt a la provocazione, visto che la guerra vera e propria è ques ti one che si svo lge e conclude in fre tt a e con contenuto spargimento di sangue, le operazio n i più difficili, sanguinose, estenuanti e a rischio sono proprio quelle che in iz iano quando arriva il cessa r e i l fuoco u fficiale.

T al i evi d enze d ovrebbero avere l'effe tt o di una salvifica d occia fredda negli Usa per i fautori della guerra rapida, condotta da formazioni leggere imbottite di costosissimi ritrovati tecno logici. Il Pentagono, infatti, è corso a rastrellare uomini ove possibi le, da un t ea t ro a risch io come q u ello coreano fino agli uffic i di \Vas h ing ro n e ai comandi in madrepa t ria, ne i quali molt i pos t i inutili sono stati soppressi e diversi ruoli sono stati trasferiti al personale civile, chiarendo che il mestiere cli mili -
tare si svo lge sul ca m po, non dietro una scrivania. Per non dover abiurare al credo proposto con tanta intensità, si è escogitato qualche sotterfugio pur di r iuscire a incrementare gli effe t tivi della componente di manovra e opera t iva dell'Esercito , che in pratica si trova ogg i ad avere una forza effettiva superiore di c irca il 10% r ispetto a quella organica . Il can di da t o democratico alla presidenza, John Kerry, ha .invece detto senza patemi che lo US Army d ovrà vedere i suoi organici potenziati, così co m e le forze speciali. Esattamente il contrar io di quanto è staro proposto in quest i an ni , sostenendo che le nuove t ecno logie giustificavano e più che compensavano una riduzione del persona le. lnrend iamoci, i l rinnovamento tecnologico è irr inunc iabile ed è indispensabi le mantenere un margine sostanziale di superior ità ne i confront i dei potenzia li avversar i, me nt re è giun t a l'ora di consentire anche a l singolo combattente di beneficiare dei progress i già disponibili su altri "sistemi d'arma", quali navi, aerei, elicotteri e mezzi corazzat i. La miniaturizzazione de ll 'elettro ni ca e i nuovi materiali lo consen t ono.
T uttavia, non è necessario cont in ua r e a correre su questa s t rada , sacr ificando rutto alla tecnologia fine a se stessa Intanto perché, se guardiamo per un is t a nte quello di cui dispongono g li avversari probab i li, convenzionali o asimmetr ici, ci si ren d e conto che non è certo la sofis ti cazione d e i mezzi a preoccupare, casomai il mo d o in cu i so n o utilizzati. La Cina res t a ancora molto lontana dagli standard occ identali , la Russia non ha i soldi per rinnovare la sua tecnologia militare che continua a invecchiare , le potenze emerge nt i s i acco ntentano .
In secondo luogo forse st ia mo fornendo ai combatrenti la tecnologia sbag l iata: i vantaggi del ne rworkcentric warfare sono indubbi, ma ai soldati americani che cadono quotidianamente in Iraq servirebbero di più sistemi per neutralizzare mine anticarro e ordigni esplosivi impro vvisati, nonché banali e obsoleti lanciarazzi controcarro o magari p er scoprire a dist anza di sicurezza la presenza cli esplos ivi a bordo di autoveico l i in rapido sposta men to, o per verificare se ci sono uomini armati all'interno di un edificio e in un assembramento. Ci si è anche resi conto che g l ielicotteri sono tanto indi spensa bili quanto vulne r abili. Qualcosa si sta facendo, rispondendo all'emergenza, ma non è facile trovare le giuste rispos t e in fretta.
Altre lezioni salutari sono venute dalla "riscoperta" della guerriglia, anche in ambiente urbano, mentre c'è un ri pensamento sull'uti l izzo di mezzi blinda t i ruotati in sostituzione dei mezzi corazza t i. In Israe le, dove la protezione della vita dei propri combattenti ha la massima priorità, si sono sdegnosamente rifiutati i mezzi blindati Stryker proposti dagli americani e si continua a fare affidamento su mezzi pesanti, cingo lat i, ben corazzati, che consentono agl i equipaggi cli vedere cosa accade intorno a loro, e a utilizzare con precisione le armi senza doversi esporre . Lo stesso Us Army, che aveva rimpatriato con troppa fretta carri eia battaglia Abrams e mezzi da combattimento per la fanteria Bradley, li ha poi dovu t i riportare in linea. E, per ora, la tecnologia non riesce a coniugare la potenza, protezione, mobilità d i un carro armato su un mezzo che pesi il 60% in meno.
Questi sono naturalmente solo esempi, perché i l fall -out delle operazioni in corso è continuo e abbraccia ogni se ttore.
È imporr ante che le sorprese spiacevoli emerse in queste campagne siano ben individuate, studiate e forniscano indicazioni appropriare per la futura evoluzione d eg li eserc iti occidentali, perché se è vero che ogni evento bellico è in buona misura a sé stante e non è saggio genera l izzare, sarebbe comunque miope proseguire sulla via de ll a trasformazione networkcentrica a passo di carica come se nulla fosse accaduto.

È significativo che quando la Gran Bretagna ha deciso, la scorsa es tate, dove e in che modo apportare i cagli imposti da l tesoro allo strumento militare, si sia acceso un vero dibattito. Ed erano in molti a contestare la scelta di seguire passivamente gli Usa in uno sviluppo di t ecnolog ie esasperate che comporta una netta sforbiciata degli organici. In ogni caso a Londra s i è deciso cli difendere, per quanto possibi le, proprio la consistenza del British Army, sac rific ando altri settori. Ecco, non è un caso se, proprio parlando di tagli, passo ora a esaminare la realtà e le prospettive dell'Esercito ltaliano, perché, tanto per cambiare, proprio in questi mesi si sta discut endo l'ennesima riduzione d ella consistenza dell e Forze Armat e nazionali, mentre l'eterna emergenza economica chiede pesanti sacrifici proprio a l la Difesa.
L'Esercito Italiano è staro ed è massicciamente coinvolto nelle operazioni in corso in Iraq e in Afghanistan (senza dimenticare i Balcani) e sta procedendo a metabolizzare " in corsa" le esperienze compiute con gli opportuni aggiustamenti tattici,
operat1 v1, organ iz zat1v1, traendo insegnamenti importanti che influenz eranno le sce lte strategiche a medio e lungo termine .
I due teatri hanno visto i soldati italiani impegnati in missioni ch e, pur essendo ufficialmente "da dopo guerra", hanno richiesto e richiedono lo svolgimento dell'intero spettro dei ruoli previsti per un esercito moderno. Compreso quello "combat " : per la pr i ma volta dalla conclusione del conflitto mondiale, con le due mission i Nibbio in Afghanistan, i nos tri soldati sono stati coinvolti in operazioni dichiara t amente di combattimento.
È andato tutto bene, non ci sono state perdite, anche se gli scontri a fuoco e gli incidenti contro i ta lebani e i guer r iglieri non sono mancati . È arriva to il plauso sincero dei comanda nti americani alla guida delle forze della coalizione nel teatro Si spara e si comba tt e anche in Ira q, quantunque la missione abbia diversa natura, ma sono le forze della gu err iglia a volere gl i scontri, che, come detto, restano una possibilità concreta in ogni op erazione che veda coinvolte truppe e non Ong.
Purtroppo ci sono state perdite dolorose, sia a causa degli attenta ti terroristici dello scorso novembre a Nassiryah, sia nei vari episodi di combattimento.
I media non hanno sprecato molto spazio per analizzare gl i esiti e la dinamica di questi even ti, né la Difesa aveva e ha interesse a raccontare più cli tanto, per ragioni di opportunità politica, ma questo non toglie che, pur tra i natura li prob lemi, difficoltà, carenze in vari settori, i nostri soldati si siano comportati più che bene: truppa , quadri, comandanti sono usciti a res ta al t a da quello che
è il ve r o discrimen per qualsiasi esercito, la prova del fuoco, facendo svanire la nomea d el so ldato ita liano bravo , capace, ma solo quando non c'è da sparare.
TI personale non ha certo sfigurato nel confronto con i professionisti più blasonati e anche se i mezzi non erano magari u ltimo modello e se qualche e lemento dell'equipaggiamento la sciava a d esiderare, i risulta t i sono stati eccellenti, come ci è stato riconosciuto da partner e alleati. Che questo avvenga mentre l'Esercito è impegnato nel passaggio a un sistema di reclutamento basato esc lusivamen t e su volontari e professionisti, vista l'ormai imminente sospens ione del servizio mi l itare obbligatorio, merita un apprezzamento. I problem i da affrontare sono enormi, compresa la scommessa costituita dal reclutamento di durata ann ual e di giovani che in realtà aspirano a una carriera in altri corpi a r mati e organizzazioni statali e che sono costretti a un noviziato con le Forze Armate. Ma la sfida costituisce anche un'oppo r tuni tà , perché l 'Esercito, il più colpito dall a tra nsizione al modello professionale in quanto l 'elemento cardine del suo potenziale è espresso dal singolo comba tten te, è costret to ad affrontare una riforma radicale e potrebbe quindi adattars i alle nuove es igenze più velocemente e senza le abituali resistenze presenti in qualsiasi organizzazione, massime se militare .
Non va certo sottovalutato il fattore economico : recepire i nuovi dogmi e passare ser iamente al professionale comporta inves timenti massicc i e costanti, che in Italia non saranno realizzabili, né ora né in un ipotetico quanto remoto roseo futu -

ro. Le priorità del Paese sono diverse, inutile negarlo, e i famosi progetti di accresce re gli sta n z iamenti per la funzione difesa propriamente detta fino all' 1,5 % del Pil, anche ricorrendo a misure straordinarie, sono stati, more solito, accantonati. La realtà impone quindi misure draconiane e in particolare la ricerca di un difficile equilibrio tra quantità e livello tecnologico. Si profi lano all ' orizzonte anche tagli numerici alla consistenza degli organici, che attualmente sono fissati in 190.000 unità complessive, delle quali 112.000 per l 'Eserc ito Italiano. Tenendo conto della scarsa propensione dei governi nazionali a impegnar e le Forze Armate in ve re e proprie missioni di guerra, preferendo casomai un più massiccio e prolungato contributo nella fase post- bellica (ancorché questa sia una scelta strategicamente e politicamente con uno sfavorevole rapporto costo/benefici) sarebbe logico che l'E serciro subisse proporzionalmente la min i ma contrazione. L'impatto effettivo di questi tagli potrà essere contenuto se si saprà procedere parallelamente a render e più efficienti e snelle l e strutture, a pprofittando appieno delle s inergi e che possono essere trovate in ambito interforze .
Inutile farsi illusioni: scendendo nei numeri ci s i avvicina alla soglia di minima produttività, perché determinate funzioni e capacità di supporto sono insopprimibili quale che sia la consistenza delle forze operativ e . Anche queste ultime saranno quindi colpite e in Italia non esiste, a parziale compensazione, una forza di riservisti consistente richiamabile e impiegabile per periodi prolungati, mentre qualità e quantità del persona le civile del-
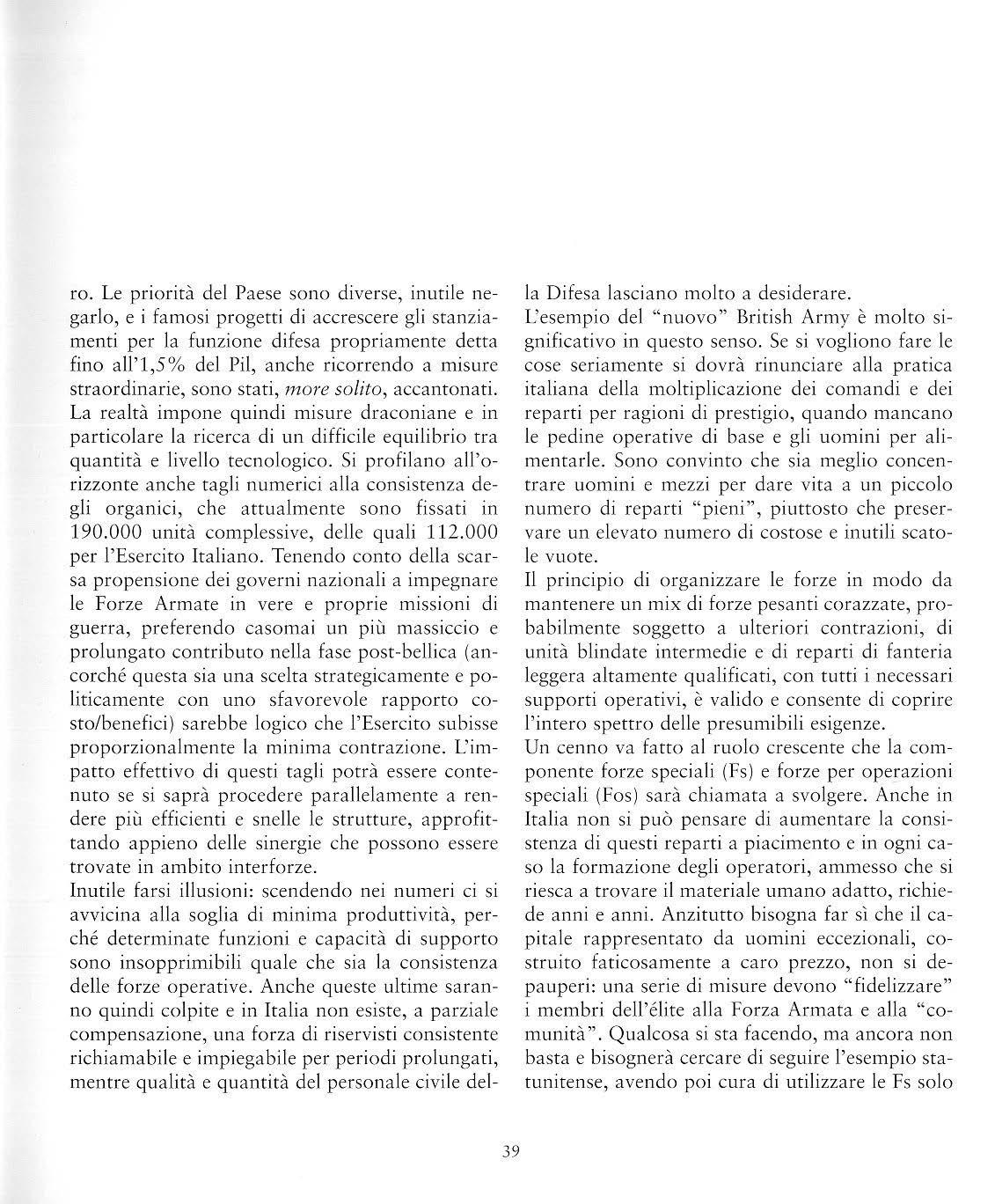
la Difesa lasciano molto a desiderare.
L'esempio del "nuovo" British Army è molto significativo in questo senso. Se si vogliono fare le cose seriamente s i dovrà rinunciare alla pratica italiana della moltiplicazione dei comand i e dei reparti per ragioni cli prestigio, quando mancano le pedine operative di base e g li uomini per alimentarle. Sono convinto che sia meglio concentrare uomini e mezzi per dare vita a un piccolo numero cli reparti "pieni", piuttosto che preservare un elevato numero di costose e inutili scatole vuote.
Il principio cli organizzare le forze in modo da mantenere un mix di forze pesanti corazzate, probabilmente soggetto a ulteriori. contrazioni, di unità blindate intermedie e di reparti di fanteria leggera altamente qualificati, con tutti i necessari supporti opera t ivi, è valido e consente cli co prir e l'intero s pettro delle pres umibili esigenze.
U n cenno va fatto al ruolo crescente che la componente forze speciali (Fs) e forze per operazioni speciali (Fos) sarà chiamata a svo lge re. Anche in Italia non si può pensare di a u mentare la consiste11Za cli questi reparti a piacimento e in ogni caso la formazione degli operar.ori, ammesso che si riesca a trovare il materiale umano adatto, richiede anni e anni Anzitutto bisogna far sì che il capitale rappresentato da uomini eccezionali, costruito faticosa mente a caro prezzo, non si depauperi: una ser ie di mi sure devono "fidelizzare" i membri dell'élite alla Forza Armata e alla "comunità". Qualcosa si sta facendo, ma ancora non basta e bisognerà cercare di seguire l'esempio s tatuni t ense, avendo poi cura di utilizzare le Fs so lo
per i compiti istituziona l i e con turni opera ti v i ragionevoli. La crescita de ll e Fos, più fac ile da r eali zzare e già in a tt o, co nsentirà una magg io r e flessibi lità. Un potenziamento è comunque possibil e, anche sul versante dei mezzi e dei vettori aere i (velivoli ad ala fissa ed elicotteri) e n avali e sarà ancora più significativo se, contemporaneamente, decollerà realmen t e il costituendo comando interfor ze per o p erazioni specia l i, nel quale l 'Ese r cito sarà il "socio" di maggioranza. Possiamo esse r certi che un po o l di Fs e Fos cons ist ente costituirà un asse tto strateg ico preg iato molto ricercato in ogni contesto, Nato, e uropeo o di coalizione , purché ci s ia la disponibilità p ol itica a impiegare davvero questi reparti senza troppe prucler ie, come raramente è avvenuto in questi anni. Sia mo sicuri che se gli Usa potessero chiedere a proprio piac iment o u n contributo a un partner non sceglierebbero una Bri gata corazzata in p iù , ma un battaglione di fo r ze speciali. Se la tecnologia è importante anche in qu esto campo, quello che conta veramente è la qu a lità degli uomini e l ' It al ia no n ha nulla eia invidiare ai miglior i a livello mon d ia le Si dovrebbe anche approfo n dire la cooperaz ion e
istituzionale tra servizi cli sicurez za, cronicamen t e a corro d i unità paramil it ari dopo alc u ne sciagura t e decisioni prese negl i anni novanta, e le Forze Speciali come avviene, ad esemp io, negli Usa e in Gran Bretagna, an d an do al cli là dei timi di passi compiuti in questi ultimi mesi .
È chiaro che ~in Paese con un picco lo Esercito, p er quanto effic iente e profess ion ale, do vrà abd icare a certe velleità di grandez za sulla scena intern azionale. Nla, come dicono negli Us a, "non esistono pasti gra ti s". Bisognerà anche r in unciare a certe ca ttiv e ab itudini, come quel la d i impiegare i so ldat i come "ausiliari" del le Fo r ze di Po lizi a per qu anto concerne la sic ur ezza interna. No, un Esercito con 100.000 effettivi o giù cli li non può destinare migli aia di pro fess ionisti pagat i e addestrati a caro prezzo per fare da mu t e s entinelle davanti a edi fici e palazzi Se propr io si deve, almeno non si neghi la qualifica di agente di PS . Inoltre non è che al nos tro Paese manchino i tut o ri d ell' or din e e po i, di c iamolo, è bizzarro che l' Esercito utilizzi i suoi soldati per sos titu ire in Italia membri d e ll'Arm a ch e invece vanno in missione di pace all'estero. N o n si potrebbe far sì che ciascuno faccia ciò che gli r ie sce m egli o?

Vi sono pochi dubbi che, nei prossimi anni, una delle principali ragioni d'instabilità a livello globale sarà cos t ituita da l t errorismo a ma tr ice relig iosa L'irredentismo e il desiderio d i r ival sa da parte di chi si sente esc luso od oppresso hanno sempre fatto parte dello scenario internazionale . Dagli anarchici russi, al "file rouge" dell'eversione post 1968, il terrorismo del vent esimo secolo è stato vissuto più come una minaccia proveniente dall'interno , piuttosto che come uno scontro m ilitare con un nemico prove ni ente dall'esterno. G l i s t essi problemi della sicurezza de ri vanti dall 'a rea mediorientale in passato sono stati tradizionalmente legati a un contesto pal estinese, sovente laico e, in alcuni casi, di matrice l eninista. Pertanto, la scoperta di un "revanscismo" re ligioso non solo violento, ma costitu ito da una classe decisionale con lunga esperienza di contatti con il mondo occidentale è stata per molti non tanto inaspetta t a, ma anche improvvisa.
Al Qaeda può rappresentare, secondo una concezione politica d i "ancien rég ime", un'avanguard ia r ivoluzionar ia de l mov i me n to dei " di seredati"
Al Qaeda è, nel contempo, a n tic hi ssima (g li Shaeed - martiri - di bin Laden sono gli odierni "assassini" degli Ismaeli t i) e decisam e nte moderna . La s t rategia mediatica, la globa lizzazione organ izzativa e la v io lenza dei suoi a t tacchi la rendono u n a rea lt à un ica ne l suo genere .
La sua peculiarità è definita da l la capac it à d i rinnovarsi e adeguarsi a seconda dei contesti strategici e sociali nei quali è coinvolta. In questo , "la base" si differenzia da altri movimenti eversivi che hanno nella rivend icazione t erritoriale l a pro -

pria ragion d ' essere. Al Qaeda non ha bandiere o confini e i propri uomini sono piuttosto d elle "isole" sparse ov u nque
Il risultato a cu i la s t ru t tura di Osama bin Laden mi r a è quello della creazione di un cal i ffato internazionale: una sfida che appa r e a l lo stesso tempo irrealizzabile, ma terribi lmente appetibile per coloro ch e ne hanno fatto lo scopo principale della propria esis t enza. La struttura originaria cli Al Qaeda si forma nella prima metà degli anni ottanta . Essa trae le s ue origin i da l ruo lo s volro da Osama b in Mohammad b in Laden a supporto dei movimenti radicali islamic i in Med io Oriente e, in particolare, in Afghanistan
Nel 1979, le Forze Armate sovietiche invadono l'A fghanistan. Osama bin Laden inizia a sostenere la lotta annata dei Mujahedin afgani, creando una struttura mil itare parallela . Quest'ultima nasce dall'incon t ro con i l gruppo de l MAK (Mak t ab al Khidamat - "ufficio dei servizi" o anche "casa dei partigiani") guidata dallo sc eicco Abdallah Azzam, pa lestinese di origine giordana, legato a lla nasc it a del mov i mento di Hamas nella seconda metà deg li anni ottanta.
La stru ttura creata da bin Laden e d a Azzarn svo lge una funzione di propaganda e informazione in tutto il mondo arabo, per "arruolare" i giovani musu lmani e uti lizzarli nella lotta d ei Mujahedin in Afghanistan. Ne nascono veri e propri "uffici di reclutame nt o", persino negli Stati Uniti e in Europa. In quel contesto , bin Laden fornisce i finanziamenti per il trasporto e la logistica, utilizzando a tale scopo gran parte del suo pa tr imonio, valutabile attorno ai 300 milioni di euro
Il contingente mili t are, che in breve tempo viene formato, cos t ituisce solo una delle di verse fazioni armate operanti in Afghanistan. T uttavia, i gruppi di volontar i che Osama bin Laden e il MAK riescono a organizzare hanno svolto un ruolo sos t anziale nella guerriglia am i- sovietica . Essi provengono da diversi Paesi islamici, ma soprattutto dall'Egitto e dall'A lger ia (circa 5 .000 el ementi), nonché dal Pakistan, Sudan, Yemen e Arabia Saudi t a
Durame il conflitto afghano lo stesso bin Laden partecipa direttamente alle operazioni be lli che, stabilendo le sue basi logistiche e opera t ive a Pesha va r e Khost, in Pakis t an e in iz iando a intessere una fitta rete di rapporti con il servizio di sicurezza e intelligence pakistano (Isi) , che si rivelerà d'importanza stra t egica negli anni novanta.
In Afghanistan, la rete di combattenti asso ldati da bin Laden e Azzam ha l ' opportuni t à di svilupparsi e rafforzarsi, acquistando, dal pun t o cli vista militare, consistenza numer ica (si stima attorno alle 10.000 uni t à il n umero d i volontari provenienti dall'es t ero) e un buon live llo di preparazione, soprattutto pe r quanto riguarda l e tattiche d i guerr iglia e sabotaggio .
Con il ritiro delle arma t e dell'Unione Sovietica dall'Afghanistan, la magg ior parte dei combattenti is lamici fa ritorno nei propri Paesi d'origine.
Lì, tuttav ia, essi trovano spesso un ambiente os t ile, che non ne facilita il reinserimento nella soc ietà; anzi, in molti casi, i guerrig lier i vengono anche perseguitati dall e au t ori t à e, comunque, ostracizzati. Da questo punto di vista, va ev idenziato che i governi di mo lt i Paes i is l amici avevano visto con fa -
vore la partecipazione di gruppi di loro cittadini in attività di guerriglia e terrorismo all'estero C iò consentiva, infatti , cli liberarsi di una presenza molto scomoda e perico l osa dal punto di vista d ella sicurezza interna.

Anche a causa dell'atteggiamento d i ostilità e chiusura che sperimentano in patria, i cosiddetti "vet erani dell'Afghanistan" entrano in clandestinità, ingrossando le fila di varie organizzazio ni terroristiche, soprattutto in Nord Africa. Su questo presupposto, Osama bin Laden e i suoi seguaci hanno creato una struttura d i base (Al Qaeda infarti significa " la bas e") nella quale i reduci della guerra in Afghanis t an tro van o "ospitalità".
Questo fenomeno si è inserito e concatenato nel processo cli mutamento dell e relaz ioni cli potere che si è ver i ficato in Nord Africa e in Medio Oriente ne l corso degli anni ottanta.
In que l periodo, i governi de i Paesi islamici o a maggioranza musulmana dovevano fronteggiare una c r escente opposizione interna, che spingeva per la presa de l potere e verso un radicale cambiamento delle leadership .
Questi sogge t ti cercavano gli strumenti per affermare le proprie posizioni e rovesciare i rapporti di forza . Essi hanno iniziato così a indirizzare i loro sforzi in un'opera d i propaganda contro le classi dirigenti, pol itiche ed economiche de i loro Paesi, denunciandone la corruzione e la dipendenza dall'esterno e raffigurandole come un nemico da combattere .
In maniera mo lto larvata, seppur crescente, ess i puntavano a far emergere una vi a alternativa, ma pratica bi le, alla d iarchia culturale e ideolog ica
che dalla fine dell'Ottocento ba interessato gran parte del mondo nordafricano e mediorienta le: quella tra il colonia lismo/capitalismo occidentale e il panarabismo socia lista, che vide nel leader egiziano Nasser il suo più importan t e promotore, su cui molti gruppi di potere hanno basa t o la propria affermazione politica ed economica, a discapito del resto della società.
Questa via alternativa trova nel "foro" religioso la propria ragion d'essere e la s u a giustificazione. Essa è rappresen t a t a dal ritorno alle origini de ll'Islam, a l la Ummah dei fede l i voluta dal profeta Maometto e basata su l Co r ano e sulla Sharia, la legge islamica. L'idea di una restaurazione islam ica, religiosa e anche politica, trova il proprio radicamento ideolog ico nella dottrina wahabita e in quella salafita, entrambe incentrate sulla ricerca della purezza del credo re ligioso e su l recupero dell'ortodossia di p r at iche e cos t umi
La rivoluzione islamica in Iran e la successiva invasione sovietica dell'Afghanistan producono un potente shock nell'opinione pubblica del mondo musulmano dell'epoca, coinvolgendo in ciò non solo le class i più povere e meno abbien t i della società, ma sop r attutto i ceti medi e professionali, quella borghesia produttiva ed economicamente trainante, di fatto troppo spesso esclusa dalla gestione rea le ciel potere . Nella maggior parte dei Paesi nordafricani e mediorientali infatti le élite al potere no n hanno con t r i buito alla produzione "reale" di r icchezza dei loro Paesi, limi t andosi a sfruttare il grande potenziale in t ermini finanziari proveniente dalle risorse petro lifere ed energetiche in generale.
Il caso dell'Arabia Saudita è l'esempio più evidente . La casa regnante deg li al Saud ha potuto governare incontrastata g r azie al suo controllo delle rendite petrolifere, di fatto escludendo da ogni posizione di potere quelle componenti socioeconomiche del Paese - come ad esempio la famiglia cli Osama bin Laden - che invece hanno costituito la struttura portante dell'economia produttiva.
Ortodossia religiosa ed esclus ione da ll a ges t ione diretta del potere sono due e lementi che descrivono la figura di Osama bin Laden e che ne rendono comprensibili le scelte e l'operato.
Allo stesso tempo, si è fatta sempre più strada l'idea che la presenza straniera e, in particolar modo, quella occidentale rappresentino la vera forza dei regimi politici in No r d Afr ica e in Medio Oriente e la principale fonte dalla quale essi traevano la propria legittimità e autorità. Soprattutto la po litica sta t unitense in Medio Oriente è stata pe r cep it a come particolarmente "invasiva" dai nuovi seguaci radical i. La presenza s t arunitensc nei Paesi arabi e islamici d ivenne così una sorta di "feticcio", l'immagine de l nem ico da combattere, attorno alla quale coalizzarsi, seppure nelle reciproche differenze confessionali e dottrinali.

Al Qaeda nasce proprio da questo : da l ma lessere d i un Islam un tempo amico, alleato e, in alcuni casi, suddito dell'Occidente, che si diffonde anche tra le c lassi abbienti
Agli occhi di personaggi come Osama bin Laden, si aprono così gl i spazi per una "crociata musu lmana", nella quale Afghan is t an , Corno d'Africa, Balcani, Penisola Arabica e Sud-Est asiatico rap-
presentano gli avamp ost i dai qua li parme per p ropa gandare un " Is lam possi b ile" .
Già dal 1988, Osama bin Laden costituisce la sua o rganiz zaz ione: Al Q aeda . Scopo dichiarato della " base " è quello cli po r tare la gu e rr a sa nt a a ll ' interno del " D ar a l I slam", ossia nel cuore del mondo musulmano e, in particolare, in quei Paes i i cui govern i h a nno abbandonato la strada dell'ortodoss ia islamica e ceduto alle lusinghe politiche e a l sos t egno eco n omico dell'occidente, Stari U n iti in tes t a .
Obiettivo principale è quello di ricreare un "ca liffato" ossia una struttura cli controllo pol itico sul mondo r e ligi o s o is lamico, così come era avve nuto a i tempi del profeta Maometto e, più r ece ntemente, con l'impero ottomano.
La possib ili t à di a ttingere a un bac ino cli com ba ttenti addes tr ati e p re parati alla guerrigli a offre all'organizzazione di Osama bin Laden la possibilit à di costitu ir e ce l lule t erro risti che in di verse reg ioni d e l mo nd o.

li primo nucleo di Al Q aeda è pertanto formato da di versi gruppi e unit à che rappresentano una "ga lassia" s tre ttame nte legata alla lea der ship centrale facente capo a O sama bin L aden
La rete di A l Qa eda comprende n umeros e organizzazioni terrori s tic h e, qua li: il Grup po Is la mico e I' A l Jihad egiz iani, l' H arakat ul Muja id in pakistano, il gruppo islamico Armato ( Gi a) alger ino, il mov im ento is lamico in U zbekis tan (Mi u ), il gruppo Abu Sayyaf nelle Filipp ine, l'al lttihad a l Islarniyyah in Somalia, e varie a ltr e organiz zaz ion i di r es is t enza occu lt e .
" La base" evolve po i nel corso deg l i a nni in un
gruppo il c ui nu c leo centra le è formato d a a ppartenenti a ll' estr em ismo rel igioso egiz iano. Esso rappresenta l'avanguardia della "diaspora" dei m emb ri dell a Jihad islam ic a egiz iana, f uggit a a lla dur a oper a cli rep ressio n e da parr e del governo di Ho sni Mubarak, seguita all'attentato che uc cise Anwar Sadat . Allo stesso tempo , pers onaggi come Ay m an a l Za wahiri, Muhammed Atef e Muhammed Atta appartengono a quell'élite socio-economica egiziana a l la qua le è negata og ni forma d i partecip azio ne e gestio ne d e l po t ere politico, non appartenendo essa alla cerc hi a del presidente.
I l primo confl it to de l Golfo, con il s ucc ess o d e ll' int ervento milit are internaziona le contro l'invas ione irachena del Kuw ait, rafforza la presenza occidentale in Medio O rie nte , m a a l t e m po s tesso co ntribui sc e ad acc resce re il rad ica lismo di determinati gruppi come quelli legati ad Al Qaeda I n partico lar modo, la p resen za di continge nti milit ar i statuni t ens i ne ll ' ar ea del Go l fo P ersico, soprattutto in Arabia Saudita, viene viss ut a da bin La den e dai suoi se gu aci no n so lo come un e lemento di d is t urbo e min acc ia, ma a nch e co me un fa ttor e da sfruttare in chiave di propaganda antioccid entale e come un o strume n to di pr ess ione s u i gov e rni is lam ici, in par tico la r modo la casa reale saudi ta.
Durante g li anni novant a, Al Q aed a accre sc e la s ua ret e di con ta tti co n il terror ism o di ma t rice is lami ca e pianifica una s trateg ia c he prevede la penetraz ione delle varie cell ul e te rrori stic he all' interno dei contesti soc ia li in cu i si vuo le operare. L a stru ttur a di O sama bin L aden non si li-
mita al finanziamento di attentati ad hoc, ma crea la base per lo s vi luppo di un network di gruppi e cellule pronte a colpire a l segnale proveniente dall'alto e, allo stesso tempo, capaci di organizzarsi autonomamente in modo da restare celate e "dormient i " per lungo tempo.
L'att enta to del 1993 a l World 1rade Center di New York è un classico esempio di questo duplice piano operativo e mette in evidenza, contemporaneamente, l 'e m e rgere di una leadership all'interno della s truttura guidata dallo sce icco saudi ta, che ne affianca e supporta l'opera a livello internazionale. È questo, ad esempio , il caso di Ramzi Yousef, ideatore dell 'a tt entato che, prima di portare a termine la sua az ione, ha vissuto per diver so t empo negli Stati Un iti.
Nella metà degli anni novanta, Osama bin Laden viene bandito dall'Arabia Saudita e disconosciuto d alla sua famigl ia Si rifugia i n Sudan, dove , ol t re a sviluppare e conso l idare le sue numerose attiv ità economiche, approfondisce la conoscenza d i Hassan al Turabi, ideologo del fondamentalismo islamico s udanese e propugnatore di un'all eanza tra mondo sunnita e mondo sciita nella lotta per l 'affermazione dell'Islam.
Dal Sudan Osama bin Laden continua la sua a ttività di proselitismo nei confronti dei combatt enti islamici e di finanziamento ai gruppi islamici radicali
Nel frattempo si afferma in Afgha ni s tan il regime dei taleba ni. In Afghanistan Al Qaeda affianca il governo dei taleba ni e, in pratica, ne influenza e indirizza gran parte delle scelte politiche, attraverso una rete di stretti r appor ti personali (si pen -
si anche a l legarne familia re tra Osama bin Laden e il Mullah Omar ).
In ques t o modo l'organizzazione di Osama b in La den assume la forma di una vera e propria realtà statuale Dal 1996 fino alla caduta del regime dei taleban i, l 'Afghanistan diventa quindi la ba se di partenza per il sostegno economico e militare della g u errig li a is la mica in varie regioni, dai Balcani al Caucaso, all'Africa orientale.
Nel febbraio del 1998, Osama bin Laden annunc ia la creazione di un'orga ni zzaz ion e chiamata Al -Jabhah a l- Islamiyyah a l-Alamiyya h li-Q ita l alYahud wal - Sal ibi yyin, il fronte islamico mondiale per la lotta contro g l i ebrei e i crociati È l'ennesima conferma della continuazione del proge tto de l califfato e d ell'intenzione di colpire gli "infedeli " per minarn e il sostegno e il s uppo rto ai governi islamic i loro alleati.

Nello stesso anno gli atti terrorist ici si susseguono con par tico la r e vio lenza ed efferatezza, mirando sem pr e più a colpire la presen za politica e mili tare occidentale nel Go lfo Persico e nell'area de l Corno d 'Afr ica.
Nel mese di agos t o du e attentat i contro l e ambasciate statunitens i di Nairobi, in Kenya e Dar es Salaam, in T anzania, manifestano a li vello mond ia le la capacità della re t e di Al Qa eda di colpire i propri obiettivi ovunque e con effetti devastanti
A llo stesso tempo si intensifica l 'a ttività "nava le" dell'organizzazione, che vede in Abdul Rah i m Mohamrned Hussein al Nashir i, il principale coordinatore e s tratega . La strategia di Al Qaeda ha un duplice obiet t ivo: colpire le nav i da guerra statunitensi nell'area del Golfo P ersico e del Medio
Oriente , e m in acc iare i traspo r ti petrol i feri. Nel primo caso vanno ricordati gli attacchi a ll 'incrociatore s t atunitense C o le de ll 'otto br e 2000 e il fallito attentato alla Uss Sullivan s del genna io dello stesso a n no; nel sec o nd o c aso l'att acco dell 'o tt obr e 2002 contr o la petroliera francese L im b urg, ancorata n e l porco yemen ita di al Dhab bah. A seguito di qu es t 'atte nt ato vi e ne ca tturato a l Nashiri in Yeme n , durante un'operazione congiunta d e i serv izi d i sicu r ezza di San a' a e dell a Cia.
In questa fase , Al Qaed a m os t ra d i es ser e un a struttura con un el eva to gra d o di co m pa tt ezz a e di pote r con ta r e su una forre cent r alizzaz io n e, con una diretta responsabilità della lea d ership su lla pia ni ficaz io ne e, in a lcuni casi, su ll' ese cuzio ne stessa de gl i atti ter roristici.
In conc l usione , prima d e ll' 'l 1 settembre 20 01 , l'o rgani zzazione di Osama bi n L ade n p uò a ncora esse r e considerata un gruppo terroristico "t radi zi onal e", s tru tt u rato su b ase piramidale , con un s ist ema di comando e contro llo effi ca ce e nuc lei opera t ivi dec e ntr ati a rid otta autonom ia d ec isionale.

Gli att e ntati dcl l ' l 1 se t te mbr e rappresentano un punto di svolta fond a me ntal e nell e attivi t à d i Al Q ae da. E ssi m os tr ano il pot e nzi a le distruttivo d e lle sue azioni terroris ti c h e e i l fatto ch e anc he la a zio ne più p otente al m o nd o, dal punto di vista m ilita re e d e l la s icur ez za , non s ia stata in grado di p revederne le mosse e qu in di di di fe nd ers i. Ino ltr e, 1'11 settembre conferma che la mi naccia terrori s tica non proviene s olo da s perduti a vamp os ti mediorientali, ma h a le propr ie basi operati ve anc he a ll ' intern o de l mondo o ccid e ntal e, co -
me mostrano l a pro venienza eur o pe a di a lcu ni membri dei commando s uicidi, nonch é la lunga pr e p araz ione d e i lor o pil o ti negli Sta ti Uniti . È q ui ndi evidente a g li oc c hi d el m on do intero ch e la minaccia di Al Q aed a è concre t a e che, dal punto di vista dell a s tr a tegi a comp lessi va , l'or ga ni zzaz ion e di Osama bin Laden è realmente in g rad o di a tti vare le propri e cellule pe r co lp ire i reg i mi "a posta ti " e i loro g ov e rnan t i, attrav e rso i lo ro a ll eati, g l i "i nfede li " nemici dell' Islam . Dall ' l l sette m bre i n poi , non è piC1 possib il e attribuire la responsab i lità d ire rra degli atte ntat i te rrori s tici di Al Q ae d a es clus iva me nte al nu cl eo d ecisio nal e nascosto n ei monti d e l l'Afg ha nis tan.
A l Q aeda h a ini zia t o a voler s i pro porre come l'avangu a rdia di un fe nom e no, q u e.l lo d e l radicalismo is lami co che, attr a verso la guida e il successo de lle a zio ni di Al Qaeda, h a a cquista to f iduci a e consa pevo le zza n ei pr opr i mezzi e n ell a ca pacit à di in flu ire di re ttamente sulle di na mi c he interne ai Pa es i d 'o rigin e e a liv e llo r eg ion a le. Sono qu indi va ri gru pp i in Medio Oriente, in Afric a , ne l Caucaso e n e l Sud -E st as iatico che s i fanno carico di proseguire la lott a armata e conseg u en tem e nte veng ono a crea r s i le figure di "p roc o ns oli" d i bin Laden in divers e ar ee del
mondo
L'es p e rie n za di c o -g es tione d e l pote r e in Afg ha nistan ha permesso a Osama bin Lad en e ai suoi seg uaci di ra f fo r za re la s t rutt ur a d i Al Qae da. li "rifugio" offer t o dai co nfini afgha ni ha consentiro a i me mbri d e ll 'organizzazione di mig l ior a re la pr ep a r azione dei co mb a ttenti e d i pr es erv a rn e le cap aci tà opera ti ve, a l ri paro dalle operaz io ni di
controterrorismo statunitensi e int ernaz ionali. Tutt avia, l'Afghanistan rapprese nta un obiett ivo reale e ben definito ve rso il quale g l i Stat i Uniti e i lo ro alleati possono in d irizza re la prop r ia azione di contrasto e repressione al terrorismo e ai cosiddetti "rogue states" .
A seguito d ell 'o p eraz ion e Enduring Freedom in Afghanistan e nelle Filippine, Al Qaeda scopre quindi i limiti e le vulnerabi l ità insite nel controllo d ire tto d i u n Paese. Ne llo spec i fico, la leaders hi p di bin Laden e i ta lebani pagano l'errore di aver affrontato l e forze statunitensi e i M uj ahedin con una strat eg ia mili tar e convenzionale, m irante allo sco ntro fro n ta le con "gli invasori" .

Il s ucce sso dell'intervento militar e s tatunit ense in Afg han istan e la rapi d a quan to inaspettata disfa tta delle Forze Armate ta leb ane e delle mi l izie di Al Q aeda hanno d imostrato l'estrema vulnerabilità di un simile approccio e hanno costretto bin Laden e l'ormai r idotta leadership d i Al Qa eda a cambiare st ra t egia, tornando a l passato . La caduta dei talebani ha così messo fine a ll ' esperienza di Al Q aeda come elemento statua le Da quel momento "la base" non ha pi ù influenzato direttament e le sorti di un Paese .
Al Q aeda subisce quindi un nuovo cam bia mento, divenendo s empre più una struttura multinaziona le e spostando il suo princ ipale asse d'interesse d a ll 'area del Golfo a l supporto all' Islam in d iverse parti del m o ndo .
I sopravv is suti all'intervento mi li tare in Afgfhanistan si rifugiano n el vicino Pakistan, sfruttando l' esis t en za d i stre tti legam i risalemi a i tempi d ella g u errig li a ami -sovietica tr a alcuni membri d i Al
Qaecla e importan t i figur e dell'Isi, che aveva co ntribuit o a ll a creazione del reg im e tal ebano in Afghan ista n.
Si assiste così a u n rit orno alla str ategia della guerriglia. Contestualmente vengon o rafforzati i gruppi r eg ionali, meno legati alt' Afghanistan, che rimane, tuttavia , la base/r ifu gio di bin Laden e dei suo i seguaci.
Pu r avendo perso gran parte dei suoi "santuari " e nono sta nte la mor te e la cattura d ei suoi pr in cipali leader e i l blocco di buona parte d elle sue principali fonti di finanziamento, Al Qaeda dimostra di poter continuare a svolgere comunque la sua attività di coordinamento .
Nello s pec ific o, Al Qaeda ha dovuto far fronte a tre fattori che ne hanno ostacolato le attività e m inacciato la stessa esistenza: dopo 1'1 1 settembre 2001, la li b ertà d i movimento e comunicazione dei membri di Al Q ae d a viene praticamente ridotta a z ero, mentre la capac it à finan ziari a d ell 'organizzazion e s ubi sce una ser ie di l imi t azion i dovute al rafforzamento dei s iste mi di poliz ia e sicurezza in ternaziona l i e a ll ' aumento dei con trolli sui traffici finanzi a ri. Allo st esso tempo, v iene fortemente ridimensionata la capacità di comunicazione tra il vertice e l e va rie cellule o galassie s parse a liv ello internazionale. Per quanto attiene alla s t ruttura, gran parte dell'originaria leadership di Al Qaecla è stata debellata: Muhammed Atef, capo militare dell'organizzazione, è stato ucc iso mentre i l pa le sti nese Abu Zub aclyah, capo della logistica di Al Q aeda, Khal ed Sheikh Mohammed (soprannominato Mokh ta r, il "cervello" ) e Ramzi bin al Shi b h , presunti organizzatori
deg li attentati del settembre 2001, sono stati imprigionati.
La ri presa d e ll e attività terr oris ti c he - in dras ti co aumento - rivendicare dall 'organizza zione dell o s ceicco saudita è l a confer ma che Al Qaed a non è sconfitta e c he essa s i è trasformata da "gruppo" a "movimento" In particolare era l'a pri le e il nove mbr e 200 2 va nn o ev id enz iaci:

- l'accentato in T unisia alla sinagoga di Djerba, dov e res t ano uccisi 3 tuni sini e 13 turis ti e uropei.
Il d op pio atte ntat o a lle di sco t ech e di Ba l i, Ind ones ia, dov e muoiono oltre 200 persone, tra le quali molti c ittadin i a ustr a liani e occid e ntali 111 vacanza;
- gli att acchi in Kenya, a ll ' H ote l Par ad ise d i Mombasa e a l vol o della com pa g ni a aer ea isra eliana Arkia Airl incs con a bordo 261 passeggeri diretti a Tel Aviv.
Gli o biettivi di qu es ti atte ntati r ap pres enta no il nuovo v olto operativo cli Al Q aeda . Essi fanno capo a una stra t eg ia precisa e b en de lin eata .
L' obi e ttiv o di colp ir e c itt ad i ni s t ran ieri n e l mondo islamico era s tat o già sperimentato in p assa t o a ope ra della leadership egi zi a na di Al Q aeda Nel nov e mbre 1997, un comman d o ap parten e nte al gruppo Al Gama'at Al l slamiyya aveva ape rto il fuo co co ntr o una co miti va di tur isti st ra n ier i presso il tempio di Hashep su t a Luxor : vennero ucci se 58 persone e fe rite a ltr e 26. A esser e co lpiti furono cittadini eu rop ei, asia ti ci e s ud amer ic ani. L a Al Gama'at Al Tslamiyya è lo stesso gruppo c h e nel 1 99 2 av eva cer ca to d i rove sc iare il governo egiz iano organizzando l' assass inio, poi fall it o, del preside nte Hosni Mubarak; il s u o lea d er
spirituale, lo sceicco cieco Omar Abdel al R ahman , è staro condannato negl i Sta ri Uniti per il suo coi n volgi men to nell'atten t ato co ntr o il World T racie Center, dell 'o ttobre 1993.
Col pe ndo nuovame nte il tu ris mo in ternaz ion a le Al Qaeda punta a indebolire le st ruttur e economich e di P aesi mu s ulmani o a m agg ioran za is lamica , come la Tu ni s ia e l ' Indone s ia, o di Paesi ritenuti s tr ategicamente imporranti, come il Kenya, tllt ti forte me nte se n sibi li agli intro iti derivanti dal tur ismo .
Il calo dell e entrate finanziarie e il clim a di costante a ll erta e in s ic ur ezza per la poss ibi lità di nuov i a ttentati hanno contribuito a d accr escere il malcontento in t erno della popo lazio ne, fome nt ando le proteste e, soprattutto, cont rib uend o a ll a radicalizzazione delle istanze sociali, attraverso lo s tru me nto relig ioso del fo ndam e nta lism o islamico. I govern i di qu esti, ma a nche di altr i Paesi, s i sono così tr ova ti di fronte a un 'alte rnativ a : la r epress ione d e ll e attiv ità dei g ruppi ra dicali e dei l oro memb ri o la cooptazione degli stess i all'interno del pro cesso decisionale po litico, a l fine di allargarn e la b ase di conse nso.
In ent rambi i casi, la strategia di Al Q aeda è destinata ad ave re successo: da un lato, l'op era di r epress ione comporta s pesso fo rti li mi tazi on i a ll e libertà personali dei cit t adini e, comunque, l' utili zzo di misu re illib era li ch e ve ngo no perc ep it e con g r ande sfavore dall a popo lazione. Inoltre, i govern i han no optato p e r far ricorso al sos t egno fi nanziari o e mili ta re o cc idental e, in p a rticolar e s tatun itense, per por t are avanti cale opera e sviluppare la propria sic ure zza inte rna . D all 'a ltro, i g overn i
in questione, nel cercare di coinvolgere democraticamente i gruppi radica l i e di allargare il proprio consenso interno, non hanno fatto altro che l egitt imarne la posizione e, conseguentemente, giustificare le attività terroristiche della stessa A l Qaeda Inoltre, Al Qaeda ha potuto verificare quali sono le reazioni poli t iche e militari deg li Stati colpiti e soprattut t o quelle dell 'op inione pubbl ica a seguito delle azioni terrorist iche.
Il successo di quella che è stata d efin ita la strategia della "rivoluzione silenziosa", ha fa t to sì che A l Qaeda abbia contribuito ad accrescere il peso politico dei gruppi radica li is lamic i in alcu ni Paesi. In particolare, ciò comporta che venga mitigata ag li occh i dell'opinione pubblica interna e internaziona le l 'immagine negativa di tali gruppi. Pertanto, le loro attività non vengono più percepi t e come esclusivamenre terroristiche o nemiche d ella pace e della sicurezza internaziona l i, bensì come una legittima opposizione a i nemici dell'Islam, così come suggerito dall'applicazione più o rt odossa dei dettami coranici . Con l'attenzione internazionale rivolta soprattutto ag li sviluppi del conflitto israelo -palestinese e de l confl itto in Iraq, procede l 'o pera di Al Qaeda di sostegno ai vari mov imen ti radica li islamici e, contestualmente, s i rafforza n o le nuove figure di leadership del movimento all'interno dei singoli cont es ti reg io n ali e nazionali .
Elemento di grande innovazione in questa fase è l'approdo del terrorismo in Europa: con gl i attentati a Istanbul del novembre 2003 e la strage di Madrid dell'1 l marzo 200 4, si apre infatti la fase di a tta cco di A l Q aeda
In questo con t esto si assiste a ll a realizzazione dello stadio attuale della strategia della rete di Osama bin Laden. Entrambi questi episo di mos t rano il camb iamento di prospettiva nell'azione t erroris ti ca di Al Qa eda .
Qu ella attua l e potrebbe essere definita una fase di metamorfosi in un"'en tità sovrannaz ionale", che cerca di sfruttare l'elemento mediatico per accrescere la propr ia capacità di inserirsi in contesti cli friz ione all'interno delle singole realtà politiche mediorientali.
In particolare, A l Qaecla persegue g l i obiet ti vi d i aumentare l'autonomia e preparaz ione de i gruppi regionali e locali, ricercare nuove font i di finanziamento alterna t ive al s istema dell'Hawala, come ad esemp io, nel caso dello sfruttamento dei traffici ill eciti di risorse naturali in Africa occid entale, aumentare la visibi lità med iatica dell'organizzazione e migliorare, nel contempo, le capacità comunicative a tt raverso gl i strumenti tecnologici e rappresentare sempre di più un "ombrello" ideologico all'interno del quale si riconoscono i va ri gruppi terroristici islamici per at ti ngere a ll a strategia globale di lotta ai governi moderati islamici e ai Paesi che ne garantiscono il potere e l'autorità .
Questa strategia è indirizzata sempre più ve rso obiettivi "politici", p r oponendo Al Qaeda come un soggetto con amp io potere negoziale e autorevo le nei confronti della comunità interna zionale Da questo punto di vista, gli a ttentati di Madrid hanno come conseguenza diretta il cambio del governo in Spagna e il ritiro dall'Iraq del contingente m ili ta re spag nolo, mentre in Turchia vengono

chiaramente pres i di mira gl i int e ress i occ ide ntal i e le velleità euro p e iste e laich e di una certa leadership politi co-econ o mica del Paese

Anc h e gli avven ime n t i me d iori e nt a li d es ta no pr eoc cupazi o ne : mentre la Giord a nia riman e sotto cos tant e minaccia terroristica a ca usa dei rapp o rti tra i l governo di re Abdallah e g li Stati Un iti , in A r ab ia Sa udit a i co ntinui attacc h i a ll e infrastru ttu re petrol ifer e co l p iscono le s truttu re economiche ed è minacciata la sicurezza del personal e s t ran iero p e r l imi t arne la pres enza n el P aese .
C iò comporta un danno d i amp ie propor1.ioni laddove n on esis te una classe professionale a ucocrona in grado di ma ntenere le in frastrutture, sopra ttu tto que lle en e rge tich e . Le con se g ue n ze economiche h a nno un forte i mp at to sugli equ il ibr i po litic i intern i , favoren do ulteriormente l ' ind ebolime nt o della lead e rship p o litica e amp l iando le s pa ccat u re intern e a ll a cas a regna nt e. Il con fli tt o iracheno h a coi nciso co n quest ' i mportante fa se dell'evoluzione di Al Qaeda, in pa rte contribuendo allo stadio d i met a morfosi turcora in atto .
L'int e r ve nto militar e della co alizio ne internazionale guidata dagli Stat i Uniti in Iraq e i l conseguente a bb at time nt o d e l reg ime d i Sa dd am Hussein hann o offe rt o d iverse op portuni t à a ll a re t e guidata d allo sce icco saud ita .
Una dell e principali conseg uen ze p er qu anto rigu a rd a il mondo isl am ic o è stata q u e ll a di accrescere i l m alc o nten t o d e l la popola z ione mu su lmana in Occid en t e . Ciò ha permesso ai gruppi e alle cellule t error is tiche, presenti soprattutto in Europa, d i meglio ca mu ffar si a ll ' int e rn o d ell e com u n i -
tà isla mich e se mpre più critiche e di ffi d ent i ne i confronti delle autorità e dei governi dei Paesi che li os pitano.
A ll o s t esso mo d o va inqua d ra t a la q u es t io n e deg l i os tagg i, em blemati ca per c ompren dere la nuova s trategia di Al Q aeda .
Se bbe n e il fe no meno de ll a cattura deg li os tagg i abbia avuto or igine spontanea e a narchica, lega ta a ll 'alca instabi lità d e l periodo di transizione postbell ic a, esso si è ben presto tr asfo rmato in una mi c idia le arma ne ll e mani dei gruppi t erro r is tici e in part ico lare de ll a rete irac h en a di Ahmad Fai ! al Kh a lailam , a lias Abu iusab al Zarqaw i .
Attraverso una gest ione organi zza ta e graz ie al for t e imp atto d egli stru men ti t e lev is iv i e m ed iat ici, g li osta gg i sono diventa t i un o strumento di pressione per in fluir e direttamente e in maniera s p ess o deci s iva s ull e d ec isio n i d ei go verni d ei Paes i s tra ni e ri prese nti con i propri con tin genti m i lit a ri in Iraq.
Ne è chiaro ese mp io la decisione da parte de l governo dell e F ilippine d i r itirare le propri e t r up p e in r isp o s t a a ll e m ina cce di esec u z ione di un cit tadino filippino t e nur o in ostaggio da fond ame ntalisti islamici.
I n q u es t o contes t o , il terro ri smo d i matric e is lam ica, per la pr im a volta, h a potuto metters i su ll o stesso piano de l ne mico, negoziando a p ert amente e ve dendo spess o ac co lte le propri e richieste.
I no ltr e , oss e r van do il r is ultato otten uto d a l punt o di vista d e ll'impatt o emotiv o s ulle m asse islamiche e del loro sentimento di rivalsa socia le, esso e quiva le in sostan za a una vittoria di tipo mili tare, ladd ove ne ss u n Ese rcito r eg o la re d i u n Pae -
se islamico dal secon do dopoguerra in poi, con esclusione degl i Hizballah contro Israele, è riuscito a piegare le Forze Armate di stati occidentali e, in questo modo, influenzarne le scelte po litiche. La strategia di destabilizzazione dell'Iraq di Al Q aeda ha inoltre percorso due binari paralleli . Da un lato colpire le istituzioni locali e internazionali, per limitarne l'opera di ricostruzione del Paese . È il caso dell'attentato contro il quartier generale dell'Onu, costato la vita al rappresentante speciale Sergio Vieira de Mello, di que llo contro la sede d ella Croce Rossa intern azio nale, nonché dei con t inui attacchi al le autor ità di polizia e sicurezza irachene.
Dall'altro, i grupp i che fanno capo ad al Zarqawi hanno colpito i partiti islamici, come lo Sciri e Al Dawa. In questo contesto l'obiet tivo è staro quello di impedire l'instaurazione di conta tti continuati tra i rappresentan ti delle leadership politiche islamiche e le Istituzioni irachene e internazionali Infatti, l'esistenza di tali forme d i dialogo minaccia l 'app r occio intransigente e radicale dei gruppi t erroristi, volto a colpire i governi "aposta ti " e i loro alleati "infedeli" .
Vi è, infine, un altro aspe tt o importan t e da tenere in considerazione per quanto riguarda la presenza di Al Qaeda in Iraq : sotto la guida di al Zarqaw i, l'organizzazione di Osama bin Laclen cerca di utilizzare l ' instabilità in Iraq, così come nei var i scenari d i conflitto nel resto de l mondo, per addestrare una nuova generazione di combatten ti e leader da utilizzare nei con t esti internazionali, ponendo le basi per future minacce alla sicurezza internazionale. I recenti avvenimenti han-
no mostrato come la minaccia del terrorismo di matrice islamica sia sempre più pericolosamente rivo lt a verso l'Europa e riguardi direttamente anche l'Italia.
Dall'l l settembre 2001 il nostro Paese ha continuato a giocare un ruolo importante ne lla lotta al t errorismo internaz ionale di matrice islamica e ad Al Qaeda in particolare .

Il contributo italiano ha riguardato nume ros e atti v ità in diversi settori: politico, militar e e d'intelligence.
Dal punto di vista politico, l'Italia ha s upportato gli Stati Uniti nell'applicazione estensiva dell'art. 5 del trattato della Nato ai fini di un p iù ampio e diretto coinvolgimento dell 'Al leanza Atlantica per contrastare i l fenomeno del terrorismo. Ciò ha permesso di utilizzare, in maniera flessibile, uno strumento mi litare in grado così di ada t tarsi alla trasformazione in corso dal pun t o di vista della sicurezza internazionale.
Sul piano europeo, inoltre, il governo italiano ha sostenuto l 'istituzione della figura di "coordinatore contro il terrorismo", integrato nell 'ambito del segretariato del consig lio dell'Ue, con il compito di coordinare le diversi misure di lotta al terrorismo assunte all'interno dei Paesi del l 'Unione euro p ea .
Dal punto di vista operativo, l'Ita l ia è stata presente nei principali teatri di lotta ad Al Qaeda e al la sua organizzazione, sin dalla guerra al regime talebano in Afghanistan .
In questo contesto, sono sta ti importanti i contributi ita liani forni ti attraverso la missione internazionale Isaf (lnrerna ti onal Security and Assistan -
ce Force) e nell'ambito dell'operazione Enduring Freedom, con la partecipazione di unità navali e con le task forces Nibbio I e II .
In particolare, l 'attività della Marina Militare italiana, attraverso l 'u tilizzo di un gruppo nava l e di altura g uid ato dalla portaerei Garibaldi, è stata incentrata in operazioni di interdiz ion e e contrasto navale, controllo del traffico marittimo e scorta di unità e convogli. Con la fine del conflitto in Afghanistan, quest'attività si è inserita nel più ampio contesto di lotta al terrorismo nel Mar Arabico e nelle acque antistanti i l Corno d'Africa, all 'intern o dell ' operazione Resolute Behaviour. In Afghanistan, la componente dell'Esercito ha invec e contribuito alle attività di controllo del territorio e di interdizione con l'obiettivo di neutralizzare e distruggere le basi logistiche di Al Qaeda in territorio afghano e creare i presupposti per una ricostruzione de l Paese .
In particolare le due task forces Nibbio hanno operato sulla fascia di confine tra Afghanistan e Pakistan, lavorando per contrastare i traffici illegali di droga e armi e l'infiltrazione di gruppi armati e cellule terroris tiche. L'operazione Nibbio è stata caratterizzata da un alto grado di complessità sia per quanro riguarda il s upporto logistico (l'Afghanistan si trova a circa 6 . 000 chilometri dall'Italia), sia per quanto concerne la pericolosità delle attiv ità svolte .
Le task forces Nibb io, composte da circa 1.000 uomini, hanno visto l'impiego, tra le varie unirà, di forze speciali del 9° reggimento Co l Moschin e del gruppo operativo incursor i della Marina, nonché di un plotone del reggimento Carabinieri
paracadutisti Tuscania e di circa 200 mezzi, preva lenteme nte di tipo tattic o.
Con la fine del confl itto iracheno , l'Italia ha potuto contribuire alla delicata fase di ricos tru z io ne post- bellica del Paese. Anche all'interno di questo contesto, un ruolo preponderante è staro assunto dalla lo tta al terrorismo. Attraverso l'operazione

Antica Babilonia l e Forze Armate it aliane sono state utilizzate per diverse a ttività ineremi l 'area meridionale del Paese e in particolar modo la provinc ia di Dih Qar.
In Iraq la componente dell'Esercito ha condotto la gestione delle attivi tà principali, non solo attra verso le sue unità specializzate (genio, nucleo Nbc, Cimic) ma anche grazie all'apporto di tutti i reparti presenti, inclusi gli elementi di polizia militare e un'unità Multinational Specialised U nit (Msu) forniti dall'arma dei Carabinieri .
L'opera di contrasto alla minaccia terroristica in
I raq è stara svolta anche pagando un prezzo elevato in t er min i di vite umane a seguito sia clell'atren tato cli An Nassiryah del novembre 2003, sia dei fatti relativi alla caserma Libeccio ciel m aggio scorso.
Un se n sibile e prezioso contributo è stato fornito dall'opera clell'intelligence militare itali ana .
Il successo nella liberazione degli ostaggi italiani è stato uno dei più evidenti contributi clell'intelligence italiana in Iraq, alla quale va aggiunta l'opera cli coordinamento e cooperazione tra il Servizio Infor mazioni e Sicurezza Militare (Sismi) e i Paesi arabi moderati in Nord Africa .
In conclusione, anche nel l 'ipotesi che Osama bin
Lade n e il suo principale stratega, Ayman al Za-
wahiri, fossero già sta t i uc cisi o ven iss ero pres t o cattura t i, la minaccia terrori s t ica internazional e non diminuirebbe Da questo punto di vis t a , è poco probab i le che la distruzione tota le di Al Q aeda com porti la cess azione delle attività terroristiche legate al fenomeno d el radicalismo islamico In quest'ottica, la missione di A l Qa eda sembra aver avuto s ucc esso . Il movimento di bin Laden si è affermato come avanguardia de l radica l ismo islamico Al Q ae d a h a ottenuto lo scopo di gettare le basi per l'afferma zione del Ca l iffato, ossia di una rivoluzione non solo religiosa e culturale,
ma sopra ttutto poli ti ca e quindi economica . Sebbene questa s t rateg ia si a p rincipa l mente orientata ve r so il mondo mediorienta le e nordafricano , es sa ha allargato enormemente i suoi confini, coinvolgendo l'intera comunità internaz ional e Allo s t ess o tempo, Al Qaeda s i è rrasfo rma ta in un sogge tto po l itico che, n o nostant e non venga riconosciuto da ne ssu na autor it à le gi ttima internazionale, riesce, attraverso la minaccia d e l le sue attività, a negoziare con gli stati sovrani e a mfluenzarne le scelte pol it iche.

Dove s iam o andati ? Perché ci s iamo andati? Perché c i restiamo? Sono queste tre domande che il pubblico italiano, anch e quello meno a tt e nto e id eo logico, s i pone a quasi du e a nni dall ' ini zio dell e ope r azioni militari in Iraq e a oltre un anno e mezzo dall o schie ram ento delle nostre truppe. Nessu no d egli ultimi due interro ga tivi ha ancora ottenuto una risposta co nvinc ente e puntu a le e, soprattutto, la situazione su l campo impedisce di dare risposte chiare.
In primo luo go nel t eatro iracheno le oper azioni milit ar i continuano nonos tant e il pr es id e nte Bu sh avesse dichiarato la fine della g u erra nel maggio 2003 In secondo luogo l 'i nstabilit à irachena non so lo non è stara circoscr itta, ma ap pare se mpr e più co lle gata a quella internazionale, all'imperversare del terr o rismo integra l ista in diverse parti d el Medio Oriente, del! ' Asia centra le e anche dell'Eu ro pa .

Nell'a nali si di una situaz ione così co m p lessa e confusa ci si deve servire dei dati di fatto ma per le previsioni, co llegate a eve n tuali dec isioni politi co- militari, s i può pro ce dere più per intui z ioni che pe r certez ze Certamente uno Stato, un a nazione, per elaborare la sua politi ca es t era non si può basare solta nto sulle in tui zioni: deve fare riferime nto a linee -guida e pr inc ipi c h e do vrebbe ro in qualche modo costituire un quadro di riferimento preesistente . P er questo, come sempre, la decisione di impegnar e un Pa ese fuori da i propri confini s i confronta con la sua s it uazione int erna, sia per quanto riguarda le sue condizioni materi ali e morali, s ia per i princip i a cui fa riferimento il s uo ordin e is tituzio n a le Qu es to ordin e nel
nost r o caso è fr utt o de ll e vicende dell'Ital ia repubblicana e di una storia che ha vis to passare il Pa ese, dall a mo narch ia alla dittatura, in tutte le g u er re mond ia li e in u n lunga sequenza di avventure co loniali delle qua l i una parte import ante si sono svolte nel mondo a rabo -mu sulma no. Si deve poi tenere conto, oltre che dell a sto ria , d e l la posizi one geopol itica dell 'Ita lia, col locata in mezzo a l Mediterraneo e quindi pro t agonista attiv a e passi va di moltepl ici interazioni con g li altri Paesi europe i e d e l.l a s pond a su d. Siam o un Paese fondatore dell a Com unit à e uropea, ma per la nostra posizione geogra fica e ovvie ragioni econom iche e soc iali , dal petroli o all'emigrazione, l'Ita lia è so prattutto un Pa ese medit erraneo, con pro bl ematic he ben diverse dall e nazioni atlantiche e continentali Se quindi s i vogliono fare p arag oni e confron ti su ll a politica es t era, i parallel i più evid ent i sono co n le d ec is ion i e i comportamenti adott ati da altri Paesi m e diterranei. Senza naturalmente saltare a conclusioni affrettate e ovvie : Spagna, Greci a e Turchia, per fare un es em p io, sono fuori d a ll ' impr esa ir ache n a, mentr e partecipano a quella in Afghanistan Ma con decisioni prese e motiv ate con ragioni e t empi ben div e rsi l ' un a dall'altra.
li pro blema è un altr o : in que sto s pazio med iterran eo di 450 milion i d i a bitanti, dove si affacciano po t enze eco nomich e e militari di un certo ris p et to, n on si è anco ra definito uno spazi o ge opolitico comune; esso costi tui sce ancora un'area di forte instabi lità . Con uno sguardo alla ca rta geografica e un a ltro ai nos tri interessi n azio nali n on è difficil e ca pire d ove sono le nos tr e prior ità
di poli t ica estera per avere confini s icuri, per mare e per terra, e rapport i pol iti c i, economici e culturali funzionali al nostro sv il uppo e a quello dell'intera regione. Qualunque governo ita liano deve t en er conto di questo quadro nel programmare le azioni di poli t ica es t era e la politica di difesa, sia da l punto di vista delle risorse militari che tecnologiche. E sicco me le r isorse umane e finanziarie sono comunque lim itate , bisogna investire in primo luogo soddisfacendo le nostre necess ità e priorità .

È in base a queste considerazioni, anche un po' banali, che dovrebbero essere prese in futuro le decisioni riguardanti il nostro impegno militare in Iraq e pure in Afghanistan . Le decisioni possono essere drastiche o gradua li , ma comunque commisurate a quello che è già il forre impegno internazionale dell'Italia nel campo delle mi ssioni a ll'estero, in particolare nei Balcani, un'area che s icuramente ricade per destinazione nel nostro spazio geopoli ti co .
Ma torniamo a quello che s ucced e in Iraq per rispondere alla prima domanda: dove s iamo andati? E proviamo a dare uno sguardo al passato recente e a come si presentava la s ituaz ione nell'autunno del 2002, quando cominciava l'escalation verso la guerra al regime di Saddam Hussein . Un dici mi li oni cli iracheni nell'ottobre di quel l'a nno andavano alle urn e, sospin ti da una propaganda che non amme tt eva defezioni, p er il referendum presidenziale in un Paese dove il 50% della popolazione è sotto i vent'anni e non aveva conosciuto altro che il regime del Baath e l e sanzi oni internazionali, una generazione int era sigillata dentro i confini di uno Stato che non
consentiva né informazione né libertà .
Eppure Saddam Hussein non era il diavolo né un extraterrestre . Era il prodotto di una società e di una s toria, quella irachena, c h e ha il privilegio non invidiabile di racch i udere contraddizioni laceranti. Alcuni di quest i problemi, come le tensioni etniche e confessionali, non so n o estranei anche alle vicende europee, come hanno dimostrato dieci anni di guerre balcaniche. In un certo senso l'Iraq di Sadclam, dove il 54% della popolazione, c ioè la netta maggioranza, è costitui ta da arab i sc i iti, mentre curdi e arabi sunniti pesano ciascuno per il 22 - 24%, aveva qualche somiglianza con il mosa ico de l la Jugos lav ia di T ito, in una versione più crudele e arricchita dal petrolio. Il pericolo cli una disgregazione del Paese era stato , fino a quel momento, il motivo principale, fuori e dentro l'Iraq, che aveva tenuto in sella i l R aìs Lo sapevano bene gl i Stati Uniti che ne l 1.991, dopo la l iberazione del Kuwai t , ferma ron o il generale Schwarzkopf quando era arr ivato ormai a poche ore di marcia d a Bagdad . Lo stesso Bush senior rivolse un appello per incitare curdi e sci it i alla rivolta con t ro il Raìs , ma sul terreno non fu mosso un dito per aiutarli, nel timor e che a Nord reagisse la T urchia, diffidente ieri come oggi dell'irredentismo curdo, mentre a sud po t esse approfittarne la Repubblica islamica sci ita dell'ran che a Na jaf e Kerba la, cioè in territorio ir acheno, ha le città più sacre e importanti della sua tradizione religiosa. Frenare g li sc i iti e le spinte del fondamentalismo islamico è s t ata la missione che a Saddam affidarono per un decennio le monarc hi e arabe petrolifere e gli Stati Uniti.
vero che 1'11 settembre e la lotta a l terrorismo multinazionale di A l Qa eda avevano cambiato tutto per l 'America . Ma sull'Iraq persisteva un eq uivoco di fondo : cosa fare di qu esto Pa ese e ciel Raìs, nominato allora sul campo, a i tem pi della guerra contro l'Iran degli ayarollah, "gendarme de l Golfo " contro l'integralismo rivoluzionario?
" l'Iraq è un rompicapo geopolitico e il dopo Sa ddam un 'incognita", si scriveva allora sulle colonne del "Sole 24 Ore" con qualche buona ragione

L'avventura co loniale eur opea ha avu to una parte fondamentale nella storia dell'Iraq e nei conflitti recenti. L'Occidente qui si proponeva co me po rtator e di una mission e civili:aatrice che in realtà na scon dev a a mal apena gli appe titi della Gran Bretagna, interessata al petrolio, ma anche a co nt rollare la via verso le Indi e ln quel per iodo, dop o la prima guerra mondi ale, l 'America non era come oggi un nemico, ma la s peranza deg li arabi. Dopo il c rollo d e ll 'Impero ottomano, la Socie t à d e lle Nazioni aveva a ttribuito un mandato alla Gran Bretagna in nome dei l 4 punti sull'e mancipazione de i popoli elabora ti dal pres id e nte am e ricano Thomas Woodrow Wilson. Ma questi principi furono disattesi dalla Gran Bretag na che, nonostante le ribellioni, indiceva referend um a favore deg li in g les i con metodi non diversi da quelli che ved iam o oggi a Bagdacl. Saddam avev a sfruttaro abilmente ques to passato per presenta rsi, dopo i r egimi di Ka sse m e dei fratel li Aref, come l'uomo che sapeva difendere l'indipendenza del Paese. Lo ha fatto afferrando il potere n e l 1968 in ta ndem con H assa n al Bakr e un golpe anim ato dal parti to Baath, fondato in Si-
ria dal cris tiano Miche! Aflaq e tra sfo rmaro q ui in vess illo del na ziona l ismo panarabo e socialista quando ormai la stella dell'egiziano Nasser tramontava dopo la sco nfitta del 196 7 contro Is raele. C ome era ri masto in sella il Raìs? Non solo con la forza e l'ideologia laica del parriro Baatah, ma utilizzando clan, g ruppi tribali e familiari che occupavano posizioni s tra tegiche nel l 'Eserc ito e nell'economia. Negli anni seguici all'invasione del Kuwa i t e alla sco nfitta ne l 1991 da parte di un'ampia coa li zione intern az ional e, a clan e tribù era stato affidato il compito di ri empire i vuo ti, anche nell'ordine pubblico, lasciati da un o Stato impoverito e in efficie nte. Sacldam era il ca po di un sistema dove si fondevano elementi moderni e tradizionali utilizzati per controllare le strutture di potere e le ma sse turbol e nte di una società mu ltietnica e divisa tra sunniti, sc iiti e cur di. "Questa m iscela - scrivevo in quell'autunno del 2002 - ha costituito il pr ope llen te della sua durata ma è anc he il tallone d'Achille di un reg ime che senza il leader è destinato a disintegrarsi".
Era un a previsione un po ' ottimista: non era so lo il regim e destin ato a disintegrarsi, ma l'intero Paese. Anzi, in Iraq si è verificato un fen omeno quasi paradossal e : i resti del regim e, rappr ese ntati da strutture c lan destin e de ll 'Eserc ito e dei serviz i segreti, sono sopravvissuti al crollo e a una sco nfitta militare c lamoro sa e costituiscono a ncora oggi una parte im portante della gue rriglia e del terrorismo che s i oppongono al governo ad interim e alle forze internazionali .
Proviamo anc h e un par a ll elo con l'Afghanistan
La caduca ciel regime integralista dei tal ebani è
stato seguito dal ritorno al potere dei "signori della guerra" le cui lotte sanguinose avevano costituito la principale ragione dell'ascesa al potere degli studenti islamic i sos t en uti dal Pakistan . E oggi una qualunque evo luzione politica del Paese, in senso posi t ivo o ne ga t ivo, non può comunque fare a meno di tenerne conto. Nonostante gli sforzi della comunità internazionale e di una Nato sempre più coinvolta su l campo, in Afghanistan c'è soltanto un embrione istituzionale e organizzativo dello Stato . L'Afghanistan è ancora in quell'area grigia dove si collocano g li Stati "falliti" a i qua l i non è succeduta alcuna forma istituzionale affidabile: s i tratta di una situazione che perdura da un quarto di secolo, passando dalla caduta della monarchia all'invasione sov ie t ica del 1979 alla guerra dei mujaheclclin contro l'Impero rosso .
T utto questo non significa che l 'Afghanista n debba essere abbandonato a l suo destino: nessuno, pera ltro, sostie ne una posizione di questo genere È i mportante però che si abbia ben presente che in Afghanistan non si è sostituito un regime con un altro, ma si t enta un diffici le passaggio non solo alla democrazia, che è una forma di governo, ma sopra ttutto alla costituzione di un nuovo Stato che non es is te più da decenni e quando esisteva appariva comunque fragile e dal tessuto molto labile. Non ha senso quindi, se si esaminano i fatti della storia e del presente, parlare di ricostruzione dell'Afghanistan, ma cli una vera e propria costruzione cli una nuova compagine s t atuale .
Questo vale in buona parte anche per l' Iraq . Crollato il vecchio Iraq, che s i id entificava nella dit tatura feroce di Saddam Hussein e nel regime
del partito Baath, quello nuovo non esis t e ancora: si tratta di uno St aro fallito sulle cui macerie non è staro cos truit o in questo anno e mezzo quasi nulla di so lido . Il governo non ha né l'autorità né la forza per garant ire la s icure zza dei cittadini: la Po li zia è inesistente, l'Esercito versa in uno stato embrionale. 11 contingente militare capeggiato dagli Stati Uniti è perc e pito come una forza d'occupazione illegittima o inutil e . Neppure l ' Iraq del petrolio si salva da attentati e sabotaggi. L'operazione di ricostruzione, come orma i s i riconosce da mo lt e part i, anche nel le cifre fornite dalla Casa Bianca, è un fiasco.
L'unica giustificazione concreta e ineludibile per mantenere le trupp e insabbiate nello Shatt e lArab è che andarsene significa amme t tere la sconfi t ta clamorosa di un'impresa mi litare nell'area s t rategica de l Golfo dove s i trova il 65 per cento delle ri serve petrolifere mondia li e da dove ogni giorno parte il 40 per cento delle esporta zioni destinate ai mercati cli consumo.
Questo è lo s tato delle cose: in Iraq è in corso una guerra che s i muove almeno su tre piani Un confli tto tra gruppi di guerrig l ia e terrorismo contro le forze occupanti, uno scontro di potere, a volte palese, a vo l te sotterraneo, t r a c lan, fazioni, tribù ed etnie, una situazione di desta bilizzazione in cui si infiltrano forze esterne, da quelle della Jihacl, la guerra santa, ai servizi segreti di molte nazioni confinanti e non che approfittano dell'assoluta permeabili t à delle frontiere per affermare la lo r o i nfluenza . Questo deve essere un punto ben chiaro: a un anno e mezzo dall'inizio delle operazioni mi l itari amer icane i confin i ira -

cheni so n o tota lment e fuori controllo. Pu ò es is ter e uno Stato in queste cond izioni ? Evide ntem ente no, o a lm e no non anc ora. L'Ira q oltre a essere uno Stato fa ll ito e non ricostruito, è un a g r an d e "a rea grigi a" di centina ia di migl ia ia di chi lometri quadrati precipitata nell'anarchia do ve l e strad e son o imp e rcorribili o molto in s icure e il controllo de l t erritorio ine sistente Ne l disastro seg uito al cro llo del r egime sono in parre a ffo ndate persino le is titu zioni in forma li: cl a n, tribù, g ruppi di pr ess ion e, c he in qu a lche modo costituivano nel te mpo , a l di là d ei regimi dittatoriali e autocra ti ci, il debole tessuto connetti vo della società
Più c he una li baniz za zione o una b a lcanizzazione, l'Ir a q ha subìro una d er iva alla "so mala " . R es istono le strutture e le gerarc hie religiose, ma fino a un certo punto. Anche l'a cco rdo di t ajaf tra l'ay a tollah Alì Sistani e Muqtada a l-Sadr è ad a lto ri sch io, come dimo s trano gli sco n tr i t ra i due nel recente passato e g l i ar r c ntati mortal i con s tragi di leader e di fede li sci iti. De l r esto la carta della lea dership re l igiosa p e r stabi lizzare l'Iraq era stara scartata s in dall'in iz io d agli a meric ani c he durante l'a nn o del proconsole Paul Bre mer avevan o sis t ematicamen t e rifiutato CLJtte le proposte ch e ve nivano da Sistani.
M a ch i sono le v ittime di questo confli tto? In prim o luogo g li iracheni - in un anno e mezzo più di 10-15 mila p ers one ucci se - che n ella lista quotidi a na di una contabi lit à mortal e non app a iono mai con nome e cognome, non hanno di gnità di stampa e scompaiono come una nota a piè di pagina nei te leg iorn ali. Purtroppo r icor dano a ltre
vittime anonime, com e i 120mila a lgerini massacrati nella guerra tra gene r ali e integ r alisti du r ante g li anni no va nta e oggi velocemente dim e nticati. Ce rto gli ir ac heni non sono i "nos tri" morti, quindi suscitano meno co mmoz ione e pietà : fo rse però sareb be ora di abbandonare a lmeno per un p o' il filo d ell a retoric a e quell'ign o ranza, semp re a braccetto co n l'arro ga nza, ch e impediscono di solleva re il ve lo sulla r ealtà d e ll ' Iraq .
11 fondo d e ll a ques t ione non è la religione, ma il na z ionalism o iracheno, che non ba avuto alcu n modo in qu est i mesi di oc cupa z ione militar e per rinascere e rigenerarsi .
Un ese mpi o è s raro lo sc iita Muqtada Sad r c he, prima ancora di ess ere un r e li g ioso ch e s trumenta liz za il linguag g io del Corano , è un nazionalista . P erché i laici qui non riescono a emergere e fatic ano ad agi tare il vessillo della ca usa naziona le? La risposta è sempl ice mente nella sco ri a del Medio Ori ente di qu es ti decenn i do ve i regimi seco laris ti sono passati d a una sconfitta militare all'altra e hanno dimo st rato di esse re incapaci di a ffrontare, nonostant e il petroli o, le sfide dello sv iluppo.

O ccupando l'Iraq gli americ ani - e noi con loronon hanno ab battuto so ltanto un regim e , ma h anno ereditatO tutti i pro blemi naz ional i iracheni irrisolti da più d i ottant'anni, anc he quelli legati al fallimento d ei modelli p o litici importati, compresi il soc ialismo e l ' economia dirigist a .
Per questo la p a rtita è co mples sa, forse dr am maticamente in so lubile nel g iro di poch i anni, destinata in ogni caso a pesare com e un macig no sul n ostro futuro
Un tempo l'Unione Sovietica, oggi la minaccia del fondamentalismo islamico. Ieri Stalin, oggi Saddam. Di mezzo, come sempre, l'America : imperialista per alcuni, fonte di libertà e democrazia per altri. L'Italia ama appassionarsi e dividersi . A ogni crisi il copione s i ripete: c i acca loriamo per le grandi cause, i pr in cìpi. Più as t ra t ti sono, più intensa è la nostra partecipazione. Poi , improvvisamente, il Paese si quieta. E all'emozione non subentra mai la raziona lità, mai la riflessione . Da noi nessuno ch iederà mai, come invece succede neg li St a ti Uni t i, qua l i s iano gli in t eressi de l Paese in una determinata crisi e quale s ia il modo m ig liore pe r d i fenderl i. Né domanderà conto al governo "di come vengano spesi i so l di dei contribuenti", frase che risuona sovente nel Parlamento americano e negli editoria li dei giornali ogni qualvo lt a la D ifesa deve inv iare solda t i all'es t ero. Gli americani sono concreti, talvo lta fin t roppo, e sarebbe sc iocco pre t ende re dal nos t ro Paese, che ha tradizioni c iviche molto diverse, un comportamento analogo a quello statunitense . Ma un po' più di senso pratico e di capacità analitica non farebbe ma le all'Italia. Anche perché aiuterebbe a scopr ire realtà insospe tt a t e. Noi it aliani adoriamo parlar male de l nostro Paese e con t in ui amo a essere co n v in ti di contar poco sul gran d e palcoscenico della politica internaziona le . Nonostante la nostra presenza nel G8 e nel drappello dei quattro Paesi principali d ell'Unione europea (assieme a Gran Bretagna, Francia e Germania) res ti amo persuas i che l ' It alia non abbia un profilo in t ernaz ionale e leva to e dunque che non s ia capace di elaborare né d i portare a co m p ime nt o una
propria strategia Davvero continuiamo a essere dei semplici gregari? Non siamo diventati certo un colosso politico (e come potremmo a l confronto cl i Sta t i U niti , Russia, Cina, India?), né abbiamo le pretese , in gran parte anacronist iche, d i Gran Bretagna e Francia che, memori del loro passato coloniale, continuano a considerarsi delle potenze, ma negli ultimi 10 -15 anni l'Ita l ia ha saputo ritagliarsi un ruolo non banale sulla scena internaziona le. E non solo per le quali t à umane e professiona l i dimostrate dai nos tr i militari nelle operaz io n i di peacekeeping e d i ricostruzione e che hanno contr i bu ito a migl iorare la reputazione de l l'Ita l ia Siamo cresciut i anche ne l le relazioni internazionali. Ci siamo fatti una reputazione. Siamo, come sempre, buoni equi libristi, ma credibili, affidabili e capaci cli costruire percorsi e alleanze origina li, talvo lta persino preveggent i. È l'italian way (la via ita l iana) alla diplomaz ia, cos t ru ita da i govern i degli ultim i 10 ann i, d i ogn i colore politico, e che ci ha guidati nelle difficil i scelte successive ag li attentati dell'l 1 settembre 2001, come in Afghanistan e in Iraq.
Una p oli ti ca es t era cara tr erizza t a dall ' intrecciarsi di t re grandi filoni :
- i nos t ri rapporti con g l i Stati Uni t i;
-i nostr i interessi in Medio Oriente, ne l nord Africa e in generale con il mondo musulmano;
- l e re lazioni con i part n er de ll 'Unione europea e con la Russia .
Autunno 2001.. L'Amer ica d ecide di inva d ere
l'Afghanistan . Primavera 2002 . L'America vince e chiede aiuto agli alleat i per stabil izzare un Paese instabile e pericoloso . L'Italia deve salvaguardare

posizioni particolari a Kabul? No. Eppure decidiamo d'intervenire al fianco degli Stati Uniti. Primavera 2003. L'America decide di in vadere l ' Iraq di Saddam Hussein, poi, come in Afghan istan, chiede al mondo un aiuto per ricostruire uno Stato mar tor iato dalla guerra e dalla stor ia. L'Italia è chiamata a difendere inter essi impe l lenti e supremi? No . Eppure decidiamo d'inviare a Nassiryah i nostri solda ti. Posta in ques t i termini la questione potrebbe essere facilmente risolta: l'Italia ha semplicemente assecondato i desideri della Casa Bianca . E per una parte imporrante d ell'opinione pubblica italiana - pacifista e di sinistra - il nos tro comportamento a Kabul e a sud di Bagclad rappresenta la prova che l' Itali a è, né più né meno, asservita agli Stati Unir.i Si sbagliano: non s iamo così banali. Nessuno può negare che i rapporti rra Rom a e Washington siano strettissimi e con un rapporto cli forza no n paritetico: loro sono la superpotenza mondia le, no i uno degli alleati e urope i, ma è sbagliato pensare che il nostro Paese sia sottomesso e, sopra ttutto, che tra i due Stati gli interessi siano totalmente corrispondenti . Se l e accuse di una certa parte dell'opinione pubblica it aliana fossero vere, la nostra politica estera dovrebbe ricalcare in t utto quella americana. E in vece non è così . Perché l'Italia persegue nei confronti del mondo arabo e più in generale di quello islamico una politica autonoma, molto differente rispetto a quella americana . Come sempre in quest'area del mondo le questioni politiche sono strettamente correlate a quelle energetic he. Il Medio Oriente è cruciale negli equilibri geostrategici mondi ali per una ra-
gione fondamentale : il petrolio . Da oltre trent'anni la politica statunitense ruota a tto rno a un sillogismo . L'economia americana dipende fortemente dal greggio, ma i giacimenti statun itensi non sono suffic ienti a coprire il fabbisogno naz ion ale; dunque l'America ha bisogno di contare su approvv igionamenti dall'estero stabi li e duraturi. Questo obiettivo è stato raggiunto stringendo un'alleanza ferrea con il Paese che ha le più grand i riserve di greggio al mondo: l'Arabia Saudita. Parallelamente Washington ha coltivato rapporti privilegiati con altri Paesi del Go lfo ricchi cli petrolio: il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti. Fino al febbraio 2003 tre dei primi cinque Paesi più importanti al mondo per estensione dei giacimenti perroliferi erano alleati degli Stati Uniti. Dopo la caduta di Saddam Hussein il computo è salito a quattro. Nella r egione un solo Stato, l ' Ir an, è al di fuori dalla sfera d'influenza america n a . Anche in a ltre zone del mon do l'America h a avuto rapporti non facili con Paesi ricchi di "oro nero": come la Libia di Gheddafi, che fino alla fine del 2003 è rimasta nella lista nera dei Paesi fiancheggiatori terroristi e per questo so ttoposta a un duro embargo. O la Russia di Putin, di cui l'amministrazione Climon prima e quella Bush junior dopo, hanno diffidato a lungo, per ragioni politiche e per l ' influenza, rivendicata da entrambi i Paesi, sui Paesi asiatici ex sovietici, ricchi di risorse naturali, tra cui, ancora una volta, il greggio e cruciali per il passaggio dei nuovi oleodotti Washington da sempre trascura il Nord Africa e in particolare non si fida del!' Algeria, primo Paese m us u l ma no a subire il terrori smo di ma-

tric e i n t egralista, con cu i non ha mai stret t o relazioni p arti co lari, che invece sono, s roricament e, una pr eroga t iva della Francia .
E l'Ita lia quali rapporti intrattiene con i Paesi produttori di greggio? La do man d a è cruciale per tutti, ma in part ico lare per il nos tro P aese che, contrariamente ag li Sta ti Uniti - i quali possono c ontar e s u ampi giacimenti n aziona l i di petrolio e su un'import ante produzione di energ ia nuclear edipend e in modo preponderante dall'estero : importiamo 1'8 4,3 % d el fab bisogno naziona le di energia, percentuale che sa le al 94 % p er quel che co ncerne i. l petrolio Se davv ero i l nos tro Paese fosse app iattito sug li Sta ti Uniti avr emmo ogni convenienza a d accodarci con g li americani . L'Arabia Saudita, ad esemp io, do vreb be essere, di gran lun ga , il no s t ro pri mo fornitore, seguita dagli a ltri Paesi del Golfo. So lu zione che sarebbe facile e tutto sommaro sic ura: far coincidere i propri interessi energeti ci con quelli dell'unica s up erpotenza mon di ale offrirebbe s olide gar anzi e, se s i p re sum e - correttamente - c h e la question e petrolio s arà prioritaria alla Casa Bianca - e nel mondo - per molti anni a venire E invece la s ituazione è ben diversa . L'Arabia Saudita è u n Paese importante con il qua le intratteniam o buoni rapport i commercia li - e dove, naturalm en t e, opera il nostro unico colosso petro lifero , l 'Enima che non è prioritario per il nostro fabbisogno energetico. Non è un caso che le rel az ioni con Riad siano co rd iali, ma tu tto sommato di basso profilo. Così come qu elle con il Bahra in, gli E mira ti Arabi Uniti, il Kuwa it, che ci vendono una man cia t a di ba rili cli greggio all'anno . In ez ie . Nel -
la lis ta dei Paes i che esportano greggio i n Italia, qu elli "amici" deg li a m er icani non sono ai primi. posti, mentre svettano que lli "nemici" o perlomen o , a lungo no n vicini ag li Usa . Secono le s tati s tiche del M inist ero italiano d elle att iv it à produttive, pe r il pe t rolio il nostro p rimo fornitore è la Libia di Gheddafi (25%), seguita a ruota dalla Russia e a l tri. Paesi ex sov ietici (22 % ), po i l'Iran (13%). L'Arabia Saudi t a è so lo quarta (11 %). Al quinto posto un altro Paese su lla lista nera degl i Usa, la Siria (7% ). Per que l che concerne il gas, sul q ual e il no s t ro Pa ese ha puntato m o lro, il forn itor e più importan t e continua ad esse re di gran lunga l'Alge r ia, seg uita dalla Ru ssia Le sempl ificaz io n i, dunque, possono essere fuorvianti. R ig uardo il tema - crucia le - dell 'energia l' I ta l ia è tutt 'a ltro che asservita ag li Stati Uniti . Anzi, vis t a da lon tano sembrerebbe ad dirittura un Pa ese de side roso di smarcarsi d all ' influe n za sta tunitense . In r eal t à Roma è riuscita a gesti r e con abili t à una situazione d i potenziale imbarazzo. Pur s tringendo accordi. con la Libia e con l'I ran, i l nos tro governo h a me sso in chi a ro con Washington che il rapporto di alleanza e fedeltà non sarebbe mai stato rimesso in discussione. Al contempo ha dimostrato a i regimi is lam ic i os ti l i ag li Stati Uni ti , che l'Ital ia non è vinco lata agli Sta ti U niti ed è a p erta al dialogo e alla comprensione Con il passare d eg li anni. il ruolo di ponte d el nostro Paese tra gli Stati Uniti e g l i Sta ti "nemici" si è svi luppato con esiti inaspettat i. A cavallo tr a il 2003 e il 2004 l a Libi a è stata ri ammessa ne lla comunità internazionale : una svo l ta che sar ebbe stata più diffic i le senza il discreto, ma t enace dialogo con -

dotto per a nni dall'Ita l ia e di cui hanno in seg uito beneficiato Wa s hington e Londra, e che ha v isto un'accelerazione proprio dopo l'arrivo di Berlusconi a Palazzo Chigi . I rapporti ufficiali tra Iran e Stati Uniti r es tano t es i, ma dietro l e qu inte i con tatti indiretti sono stati intensi negli ultimi sei anni, con risultati talvolta impor tanti (vedi l'acco do seg reto de ll a primavera 2003 tr a Te heran e il Dipartimento di Stato che ha garantito la benevola neutralità dell ' I ran durame la guerra co ntro Sad d am Hussein). Anch e in questo caso scopriamo un'Ita lia "apripista". Nel gennaio
1997 l'allora premier Lamberto Dini riatti vò le relaz ion i co mm e r cia li con l ' Iran. L'Ame ri ca dapprima non gradì, ma poi cam biò idea e incoraggiò il dialogo tra Roma e Teheran (vedi le dic hi arazion i nel marzo 1998 dell'allora segretario d i stato Made la i ne A lb right} : grazie ai contatti ital iani Washingcon poteva sondare con discr ezione la leadershi p sciita . Il di alogo tra l' Ira n e g li Stati Uniti ora è n uovame n te interrotto, ma n on quello tra Roma e Teheran, che si è consolidato negli anni con i premier dell ' Uli vo e con Berluscon i. Un comportamento, quello italiano, c h e in parte ritroviamo anche nel conflitto israeliano- palestinese . D opo l ' l l sette mbr e Washington si è schierata con co nvin zione al fianco di Sharo n e ha deciso di non riconoscere più la leadership del presidente dell'Autorità Naziona le Palest ine se (A np ) Yasser Arafat . Altri Paesi eu rop ei, co me la F r anc ia, hanno continuato a sostener e Arafat, non risparmiando pesanti cr iti che a Sharon. E l'Italia?

Ha ribad ito la g r ande ami ciz ia pe r lo Stat o ebra ico, ma al contempo ha dimostrato particola re
se n s i bilità per le sofferenz e pa lest in esi . Ber luscon i, che è senza dubbio il premier ita liano più filoisraeliano degli ultimi trent'anni, ha lanciaco l'idea - orig in a le e aud ace - di un piano Mars h a ll pe r la Pa lest in a, guadagna nd osi così la si mpatia degli stessi palestinesi e in genere dell'opinione pubblica ara ba. Che cosa c'entra tutto questo con il nostro intervento in Afghanistan e in Iraq?
E, soprattutto, quali sono gli interessi politici e st rategici del n ostro Pa ese in qu esti due t eatri di crisi ? Per que l che co nc erne la no st ra mi ssione a Kabul, il quadro è tutto sommato ch iaro. L' Afgha nistan è un Paese diffi ci le e impervio da cui, s toricam e nte è megl io t ene rsi lont a no. Non h a risorse naturali e non è strategico, se non per il transito degli oleodotti che trasportano il greg gio da i g ia c ime nti d e ll 'e x Urss ve rso Occ ident e . La guerra in Afgh anistan è stata lanciata da Bush in risposta agli attentati dell'l 1 settembre 2001 a llo sco po di estirpare il regime de i talebani e le bas i di A l Qaeda. A conclusione della guerra l'Italia, come molti alni P aesi europei, ha deciso di invia r e un co ntin ge nte di pea cek eepi ng sulla base d i due valu tazi oni: un impeg n o morale - la solidarietà agli Stati Uniti, nostri amici di sempre - e un inter esse con creto : combattere un'organ izzaz ione terro risti ca c h e ha d ichiarato g u erra non solo all'America, ma a tutto l'Occidente, Europa com p resa (co m e g l i a tt entati dell ' l 1 mar zo 20 04 a Madrid hanno poi tra gica me nte co n fermato) .
Ino ltr e Roma era consapevo le di non ri schiare riperc u ssion i dip loma tic he. Il regime del Mullah
O mar non b enef ic iava de ll' appogg io di ness un Paese arabo e p i ù in generale islamico, che anzi
vedevano nei talebani e in Osama bin Laden dei po t enziali destabilizzatori. Nessuno si è rammaricate per la loro sconfitta, nemmeno l'Iran - che confina con l'Afghanistan - e che ha sempre osteggiato quel regime fondamentalista sunnita .
La scelta italiana in questo caso era scontata e vincente su tutta la linea. Infatti, il nostro intervento:

- ha consolidaro l'alleanza con g li Usa;
- è srato moralmente doveroso e gratificante;
- non ha incrinato i rapporti con il mondo is lamico . Più complessa è la valutazione de l nostro i mpegno in Iraq.
Come noto, l'intervento è stato deciso unilateralmente dagli Stati Uniti adducendo ragioni che dall'autunno 2002, quando si è concretizzata la prospettiva di una seconda guerra del Golfo, sono apparse a molti governi non convincenti e sono state osteggiate dalla quasi totalità dell'opinione pubblica araba e da un'ampia maggioranza di quella europea. E allora perché l'Italia ha deciso dapprima di sos t enere politicamente l'in t ervento mi l itare ang lo -americano e poi di partecipare alla missione d i peacekeeping a Nassiryah? Retrospettivamente si possono ind iv iduare i seguenti mot1v1:
1. L'amicizia con gli Stati Uniti, consolidata non solo dai rapporti storicamente buoni tra i due Paesi, ma rafforzati dall'amicizia personale e strategica tra il presidente George Bush e il nostro primo ministro Silvio Ber lusconi. Per la prima volta nella storia recente, gli Stati Uniti si sono trovati isolati e hanno chiesto la so l idarietà a1 Paesi che reputavano davv e ro amici, come la
Gran Bretagna e la Spagna cli Aznar. L'Italia poteva tirarsi indietro? No, tanto più ch e Bush è stato il sos t enirore più importante cli Berlusconi, dopo la vi ttoria elettorale della primavera 2001. E questo ci conduce alla seconda ragione, che riguarda l'Europa .
2. La necessità di smarcarsi da una Ue poco amica. L'Unione europea non ha mai amato Berlusconi e, anzi, sin dalle prime battute (ve di la di ffidenza con cui fu accolto al vertice europeo di Gi>teborg del giugno 2001), ha giudicato il prem ier ita liano come un fas t idioso populista da emarginare o sottomettere Es is t evano le premesse per una replica di quanto accaduto nel 1994, anno del primo gov erno Berlusconi: allora, però, l ' isolamento era totale, perché sull'altra sponda dell'Atlantico il presidente era Clinton, il qual e, da democratico, privilegiava ovviamente le alleanze con a ltr i inte rl ocurori europei di sinistra nel tentativo di costruire una terza v ia laburis t a, il cosiddetto "Ulivo mondiale". Il Cavaliere era isolato e non fu difficile, per i suoi avversari, disarcionarlo. Sette anni dopo, nel 2001, la vittoria de l leader di Forza Italia è giunta pochi mesi dopo quella di Bush alle presidenziali degli Stati Uniti. Tra conserva t ori l'intesa è spon t anea e quando è cementata da reciproc i benefici diventa incrollabile. Il presidente repubb l icano ha trovato in Berlusconi un interlocutore affidabi le in un mondo - e in particolare in un'Europa - che lo ba acco lto con grande diffidenza 11 premier italiano ha individuato in Bush un alleato così forte e importante da consentirgli di sottrarsi ai condizionamenti e alle inimicizie dei partner europei, in -
ducendolo ben presto a concentrare le proprie energie diplomatiche sul dialogo non con le canceller ie Ue, ma con le grandi potenze. Ad esempio con la Russia cli Putin . Contrariamente a Bush, che all'inizio della presidenza diffida va del giovane capo ciel Cremlino, Be rlusconi e Blair hanno creduto subito nel successore cli E ltsin. E d è stata la loro discre ta, ma tenace mediazione a favorire lo spettacolare riavvicinamento tra Mosca e Washington, iniziato al G8 di Genova e suggellato dopo l'l l s ettem bre. Con il passare del t empo si rafforza l' asse delle tre B: Bush- Blair-Berlusconi, con l'aggiunta dello spagnolo Aznar. Quando, nell'autunno 2002, l'Europa è chiamata a prendere posizione sulla guerra in Iraq, il Cavaliere, benché person almen te non del tutto persuaso della necessità di un intervento militare, è chiamato a una scelta : affidare il proprio fato a Schroed er, cancelliere della declinante G erm ania, e a Chirac, presidente della claudicante Francia, che da t empo bramano per ridimensionare l'Italia, o continuare al fianco di Bush, amico e garante, leader dell'unica superpotenza mondiale . Una scelta tormentata, ma inevi tabile. Per continuare a contare.

3 La nostra politica energetica. Decidendo cli partecipare alla missione in Iraq l'Italia rischiava di compromettere i rapporti con i Paesi fornitori di petrolio e di gas? La risposta è no. Con la Libia le relazioni sono addirittura migliora t e, perché il colonnello Gheddafi ha deciso cli riconciliarsi con Stati Uniti e Gran Bretagna, proprio dopo la caduta di Saddam Huss ein: t emeva di fare la stessa fine. E oggi Tripoli è un partner commerciale molto più affidabile di guanto fosse ne l
gennaio 2003. L'Algeria è retta da un regime militare e la guerra in Iraq è stata ininfluente all'interno di un Paese che combatte il t errorismo islamico da oltre dieci anni. Con la Russia i rapporti sono rimasti eccellenti, benché Putin fosse contrario all'intervento militare L'unica incognita era rappresentata dall ' Iran. Ma anche in quesro caso l'Italia ha saputo cautelarsi mantenendo aperti tutti i canali di dialogo con Teheran prima, durante e dopo la guerra, nella cons apevolezza che l'estromissione di Saddam non era sgradita alle autorità iraniane. Un clima di cooperazione che nemmeno l'ondata di attentat i terror istici in Iraq, alcuni dei quali di matr ic e sciita, ha incrinato. Non a caso nel giugno 2004 il governo britannico ha ottenuto la liberaz ione d egli o tt o marinai inglesi catturati nel Go l fo dagli iraniani, grazie alla mediazion e di Pa la zzo Chigi. Le nostre truppe operan o a Nassiryah, nel sud dell'Iraq a maggioranza sciita. Eppure i rapporti tra Roma e Teheran non sono peggiorati. Anzi, forse sono persino migliorati. Indizio tangibi le che il governo iraniano non ritiene l' Italia asservita al Grande Satana americano . Roma sembra aver superato le ripercussioni della guerra in Iraq, mantenendo la propria capacità di d ialogo con i Paesi arabi e p i i:1 in genera le con il mondo islamico. Ha addirit t ura posto le p r emesse per migliorar e la propria situazione energetica. Chi beneficerà ciel petrolio iracheno? Gli americani? Certo. Ma dopo di loro, gli alleati che hanno im pegnaro le proprie truppe in Iraq potranno vantare un diritto di prelazione. E le falde irachene ospitano le più grandi riser ve mondiali di greggio dopo l'Arabia Saudita. Come ha evidenziato
uno dei più autorevoli esperti mondiali di energia, Leonardo Maugeri, diretrore delle strategie Eni, in un artico lo pubb licato nel luglio 200 4 su l settimanale "Newsweek ", è "una terra vergine", "fulcro di quals iasi futuro equi librio nel mercato petro l ifero mondiale" e capace di eguagliare la produzione saudita . E in un mondo che ha sempre più sete di petrolio, nel lungo periodo l'Italia sarà più che lie t a di vantare rapporti privilegia ti con i l nuovo Iraq (ammesso beninteso che la violenza cessi e che tale questo Paese diventi). In conclusione: la decisione italiana di schierarsi a l fianco degli Stati Uniti risponde a precise logiche strategiche ed economiche. Non è, sia chiaro, priva di rischi .
A cominc iare da quell i terror istici, che sono addirittura aumentati, sia sul nostro territorio (al Qaeda li ha minacciati), sia contro il contingente a Nassiryah (come già accaduto), per finire con quelli politici: i falchi neoconservatori dell'amministrazione Bush hanno commesso gravi error i d i va lutazione, al pu nt o che non si può ancora escludere un fallimento sti le V ietnam, benché l'ipotes i sia remota Ed è legittimo chiedersi - rileggendo Sun Tzu - se l'obiettivo di un nuovo Iraq non potesse essere raggiunto con maggior sagacia. Ma questa è una riflessione che riguarda il passato ed esula da l tema di questo capito lo. Ora coma so lo il presente . E il futuro, che l'Ita l ia è chiamata ad affronta re con coe renza e dignità.

L'Italia sostiene gli sforzi d i pace della comunità internazionale in modo efficace, anche attraverso il concorso attivo e re sp onsabile del nostro strumento mil itare, a difesa cli un sistema di va lori in cui crediamo e in cui s i riconoscono il nostro popolo e la nostra costituzione : democra z ia, lib ertà, g iust izia , primato del diritto, rispetto d e i diritti umani, pace, sicurezza, stabili rà e legalità internazionale.
Il nostro impegno, con oltre 9.000 militari risch ierati all'estero, in numerose missioni di pace, in t ant e parti d el mondo, ne è manifesta zione eloquente .
Quale contributo alla pace, alla sicurezza, alla l egalità internazionale e al soccorso umanitario, da tempo ormai, le Forze Armare italiane sono attivamente impegna re all'estero e ta l i impegni sono via via cresciut i neg l i ultimi decenni e, più in particolar e , in questi u ltimi anni.
La sicurezza del nostro Paese, secondo un ' ormai consolidata accezione comune, è collocata nel sistema di s icur ezza internazionale, alla qual e l e Forze Armate italiane contribuiscono nell'ambito dei seguenti principali contesti istituzional i:

- l e Nazioni Unire, per missioni di peacekeeping;
- l'Alleanza Atlantica, per compiti di difesa collettiva e di risposta alle crisi;
- l'em ergente dimensione di sicurezza e difesa dell'Unione europea, per lo svolg imento delle cosiddette missioni di Pete rsberg 1 •
Lo strumento militare italiano è inoltre aperto all'integrazione verso cooperazioni militari a carattere multinazionale non compres e nei contesti istituzionali precedentemente cita ti, soprattutto ladd ove i nuovi scenari, conness i alla lotta contro
il t errorismo, hanno comportato la necessità di ric e rcare la maggiore adesione internazionale possibile L'assolvimento cli una così vas ta e diversificata gamma cli missioni op erati ve , non può ovv iamente prescindere dalla disponibilità di forze altamente professionali, proi ettabili anche in teatri lontani con tempi di preavviso contenuti e in grado di operare in ambiente interforze, ove le componenti di singola For za Armata (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) sono ch iamate a intera gire strettamente t ra di loro, e nei contesti multinazionali, fianco a fianco co n i contingenti forniti da altr i Paesi .
il comando e controllo dello Strumento M i litare Nello scenario sopra eviden z iato, un moderno St rumento Militare deve essere innanzitutto configurato per esprimere capacità di comando, controllo e comunicazioni con valenza interforze. Tale capacità, di centrale importanza, s i concretizza nell'esercizio dell'autorità che attribuisce :
- al Comandan t e che esercita il comando opera tivo (Opcom), la responsabilità di asseg nar e ai Comandanti subordinati missioni e compiti, schierare unirà e riassegnare forze;
- al Comandante delegato a esercitare il controllo opera tiv o (Opcon), la responsabili t à di impiegare le forze assegnategli per l'assolvimento di compiti o missioni che sono normalmente lim itati ne l tempo e nello spazio;
- ai Comandanti delle unità opera tiv e in campo il controllo tattico (Tacon), ovvero la responsabilità di guidare le forze nella condotta delle attività operative sul t erreno.
Nelle operazioni multinazionali l ' Opcom è sempre mantenuto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa (Cincdifesa). Conseguentemente, il Cinc, con la direttiva strategica, definisce la missione (discendente dalle decisioni a l ivello politico), le risorse che ciascuna Forza Armata deve mettere a disposizione per la condotta di un'operazione multinazionale, la linea funzion ale, l'indicazione degli enti responsabili, ai va ri livelli, della pianificazione, predisposizione e direzion e delle attività. Per la condotta delle operazioni multinazionali, a guida nazionale o mul t ina ziona le, le Forze messe a disposizione vengono poste sotto l 'a utorità del Comandante d esignato e vengono quindi "cedut e" p er l'impiego. Con il trasferime nto dell'au torità (Transfer of Authoricy, Toa), il Cinc stabilisce, tra l'altro, il livello di autorità che il Comandante designato può esercitare sulle forze nazionali ( Opcon o inferio re livello di comando) e fissa eventua li limitazioni dettat e da prioritarie esigenze di carattere nazionale. Per garantire il corretto impiego delle unità nazionali , cedute ad un Comandante multinazionale attraverso i l Toa, il Cinc:
- nomina un Itali an Senior Represenrative (lt-Snr) con il compito principale di verificare, con faco ltà di veto, che le direttive d ell ' Auto ri t à multinazional e siano compatibili con l'amp iezza di delega concessa;
- delega l'Opcon a l Comandante d el Coi, il quale può a sua volta esercitarlo tra mite un Na tion al Contingent Commander (Ncc), su tutt e le componenti nazionali, rischierate in Area di Operazioni, che non trans itano sotto l'autorità di un
Comandante multin aziona le (assetti per le telecomunicazioni, aliquota di Polizia Militare, di forze speciali, centri amministrativi, e lem enti logistici, elementi di supporto nazionale, ecc . ).

La pianificazione, la predisposiz ione e la dire z ione delle operazioni
All'insorgere di una specifica esigenza operativa e ricevute l e indispensabili direttive a livello politico, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel suo ruolo di Cinc , di spone l'avv io della pianificazione intesa a definire gli elementi di base della missione. Per tale incombenza, eg li s i avvale del Comando Operativo di vertic e Interforze (Coi), costituito nel 1998 quale vero e proprio "braccio operativo" del Cinc, competente per .la pianificazione, la predisposizione e la direzio ne delle operazion i e dell e eser citazio ni interforze sul territorio nazionale e "fuori area". Cabina di regia delle missioni interforze, il C oi dispone di un complesso sistema di comando e controllo che consente il collegamento in tempo reale con tutti i Comandanti dei vari contingenti sparsi nelle diverse aree di crisi e il costante monitoraggio del quadro di situazio ne di ogni teatro operativo . Le comunicazioni, in partico lare, utilizza no in prevalenza il sistema sa t ellitare italiano Satellite Italiano Comunicazioni Riservate e Allarmi (Sicral), ma anche altri satelliti, militari e civili, nazionali ed esteri, in modo da garantire la continuità delle connessioni radio, telefo ni c h e, i nformatich e e in videoconferenza . Tale architettura è ovviamente integrata con quelle in uso presso i comandi alleati, per assicurare lo scambio infor-
mativo indispensabile nel caso di operazioni multinazional i. L'attività del Coi si esplica di norma in quattro passi successivi .
Il primo è quello della pianificazione, proc esso att r averso il quale vengono definiti gli elementi essen ziali dell'operazione. Tra questi i compi t i, l'area di responsabi l ità, la struttura di comando e controllo, la composizione dell e forze, la valutazione del rischio, le esigenze di supporto logistico e di trasporto, l'analisi dei costi, gli aspetti giurid ici, l'approntamento delle regole di ingaggio (Rules of Engagement, Roe).
Su quest'ul t ime è il caso di soffermarsi perché costituiscono oggetto di forte curiosità, ta lvolta di difformi interpretazioni, da parre deg li organi di informazione e dei "non addetti ai lavori " .

Le Roe vengono definite, a ragione, come uno strumento di controllo dell'autorità politica sull'impiego della forza da parte dello strumento militare. Sulla base della normativa Nato vigente, il catalogo de l le Roe per la condotta di una specifica operazione è soggetto all'approvazione dell'autorità politica, mentre l'autorizzazione ad applicarle, in toto o in parte, è devo luta al Comandant e strategico ( nel caso specifico il Cinc). L'implementazione de l le singole regole è, infine, responsabi l ità del Comandante in teatro operativo. In termin i generali, nessuna regola può limitare il diritto natural e all'autodifesa e l 'us o della forza, ancorché conforme alle Roe, deve essere sempre improntato ai principi di forza minima necessaria al conseguimento della missione e di proporzionalità all'entità della minaccia. Entro i vincoli inderogabili sopra evidenziati, il sistema è impron -
taro comunque a un elevato grado di fl essibilità, indispensabile ai Coma nda nti sul terreno per adattare i comportamenti d elle proprie unità e de i singoli alle mutevoli e imprevedibili situazioni operative contingenti.
Come già detto , altro aspetro essenziale di pianificazione è la composizione delJe unità da impiegare sul campo. Si tratta di individuar e le formazioni p iù idonee allo scopo, quasi mai blocch i monolitici e omogenei, ma in genere complessi d i forze accuratamente attagliati alla missione da compi ere (Jtf, joint task forces}, cos ti tuit i mediante l'attento dosaggio d elle componenti terrestre, marittima, aerea e dei carabinier i, fornite dalle diverse Forze Arma t e, cui permane l a piena responsabilit à dell'addestramento e della preparazione delle proprie uni t à in previsione d ell'i mpiego .
La seconda fase è rappresenta t a dallo schieramento del contingente nel t eatro delle op erazioni Un'a tt iv i tà complessa e delicata, soprattutto quando le missioni si svo lgono molto lontano dal territorio nazionale, in luoghi impervi e d ifficilmente accessibili, com'è il caso dell'Afghanistan. Un particolare o rganismo del Coi (Joint Movemem Coordination Centre, Jmcc} si occupa della pianificazione e della gestione di tutti i tra spo rti da e per i teatri operativi, che vengono effe t tuati con sistemi di t rasporto diversi e per più missioni contemporaneamente. Oltre a uti lizzare gl i aerei e le na vi militari, vengono sovente noleggiati vettori civili e, quando possibile, si ricorre ad asset t i messi a disposizione dagli alleati.
Nella terza fase, l'impegno del Coi si materializza nelle gestion e dell 'o perazione. È già sta t o precisa-
to che nelle missioni multinazionali il controllo operativo delle un ità nazionali viene ceduto al Comandante in teat ro (n on necessariamente italiano), che lo esercita attraverso il proprio staff.
L'attività del Coi è in questo caso focalizzata sul supporto logistico -amministrativo (responsabilità di ciascun Paese contributore ) e su l costante monitoraggio delle attivi t à ciel nostro cont in gen t e . Quest'ultima è una funzione cli primaria importanza perché consente a ll 'Autorità politica e militare nazionale di essere costantemente aggiornata sull'attivi t à delle nostre unità e di intervenire, attraverso l'Italian Senior National Representative (ltsnr ), per evitare che esse siano impie gate al di fuori delle regole che la Nazione ha posto nella fase degli accordi e delle intese preliminari.
Ben diverso risulterebbe l'impegno qualora l'Italia venisse i nvestita dall'Organismo soprannazionale preposto (Onu, Nato, Ue, Coa l izione di Stati ecc.) della "leaders hip " cli una missio ne. In tale eventualità, l'intera re sponsab ilità della direzione strategica e operativa r icadrebbe sul Capo di Stato Maggiore della Difesa, che la eserciterebbe tramite il Coi. È rutta via necessario precisare che in questo caso lo staff del Co i sarebbe opportunamente r inforzato da persona le nazionale e da "augmentees" provenienti da tutt i i Paesi partecipanti alla missio ne.
In termi ni di impeg no sul terreno, i contingenti nazionali sono mediamente avvicendati nei teatri operativi ogni quattro me s i e poi trascorrono almeno otto mesi in patria, i n un ciclo a tre fas i - approntamen to , impiego e r icondizionamentoconsiderato abbastanza soddisfacen te, anche se
un percorso di preparazione su quattro fasi consentirebbe di conferire maggiore impu lso all 'a ddestram en to proprio cli ciascuna arma e specialit à, che rimane presupposro ineludibile della capacità operativa a livello individuale e di reparto .
Ta le obiettivo potrà essere pienamente consegu ito allo rquando il mod ello profess ionale dell e Forze Armate sarà a regime, al ter mine del processo di trasformazione t uttora in itinere .
L'ultima fase è successiva alla conclusione della missione e consiste ne l l'ana li si dei var i sta di dell'operazione e dei prob lemi incontrati per trarne ammaestramenti ed eventua lm en t e apportare correttivi alla pianifica zi one delle missioni correnti e di quelle successive.

I principali teatri di operazione
Le Forze Armate ital iane sono attualmente impegnate in numerose missio ni sia di controllo della confl it tualità, s ia di contrasto diretto delle minacce asimmetric he. Oltre 9 000 uomin i sono schierati all'estero nell'ambito cli missioni in t ernazionali poste sotto l 'egida/controllo delle Nazioni Un ir e, dell'Alleanza Atlantica, di Comandi multinazionali, oppure ne ll'ambito di missioni tecniche e di assis t enza nate da accor di bilaterali. Vo lendo citare i teatri operativi più significativi, tale impegno si rea lizza in particolare:
- nei Balcani con le operazioni Joint Forge in Bosnia -Erzegov ina, Joint Guardian in Kosovo e con la missione mil it are in Albania;
- nel Mediterraneo con l'operazione Ac ri ve Endeavour;
- in Afghanistan con le operazioni Enduring Free -
dom e lnternational Security Assistance Force (lsaf);
- in Iraq con l'operazione Antica Babilonia; - nell'Oceano Indiano, con il gruppo navale Euromarfor, inserito nella task force 150 per lo svolgimento dell ' operazione Resolute Behaviour, nel quadro più ampio dell'operazione Enduring Freedom.
Sulla base della risoluzione Onu 1031, dal dicembre 1995, la Nato è impegnata in Bosnia -Erzegovina con una forza di stabilizzazione (Sfor), alfine di garantire la cornice di s icurezza indispensabile a favorire la normalizzazione politica e sociale del Paese.
Della Sfor, alle origini composta da 35.000 uomini e gradualmente ridotta agli attuali 8 .500, fa parte un contingente italiano di 1.200 militari, che si colloca tra i più consistenti tra quelli schierati nel teatro operativo TI contingente nazionale comprende, oltre a un reggimento d ell'Esercito, una Multinational Specialized Unit (Msu), composta da militari dell'Arma dei Carabinieri, cui si è aggiunto personale di Estonia, Francia, Romania, Slovenia e Ungheria, che fornisce al comando Sfor un determinante contributo nel settore della Pubblica Sicurezza e de l contrasto alla criminalità
A seguito della Risoluzione Onu 1244 del giugno
1999, la Kosovo Force (Kfor) a guida Nato è stata schierata in territorio kosovaro, consistente ini zialmente in circa 36.000 uomini, .ridotta gra-
dualmente a 18 .000 un ità, con il compito di garantire un ambiente sicuro per il raggiungimento di una soluzione pacifica della crisi ciel Kosovo e favorire la ricostruzione della Provincia . L'Italia ha fornito sin dall'origine un contributo significativo a Kfo.r, oggi consistente in 2.800 unità, secondo contingente militare dopo quello tedesco . De l contingente, incentrato su una Brigata dell'Esercito, fanno parte un'Unità Msu dei Carabinieri e un reparto operativo autonomo (Roa) del1' Aeronautica Militare, che gestisce l'aeroporto di Dakovica .
La missione militare italiana in Albania
La presenza militare italiana in Albania, mai cessata dal primo massiccio intervento umanitario degli anni 1991 - 1993, e oggi consistente in 450 unità, si colloca nell'ambito:

- ciel Nato Headquarter Tirana (Nhqt), costituito ne l 2002 per coordinare gli aiuti dei Paesi contributori;
- della delegazione italiana di esperti (Die), che svolge un ruo lo importante nella ricostruzione delle Forze Armate albanesi;
- del gruppo navale 28 che, operando dai porti e lungo le coste albanesi, in concorso con le autorità locali, assicura con efficacia il controllo dei traffici illeciti e dell'immigrazione clandestina verso le coste italiane.
In conseguenza dell'atto terroristico negli Stati Uniti dell'l 1 settembre 2001, la Nato ha approvato il dispiegamento di una forza navale (task for -
ce Endeavour), composta dalla St anavformed (Standing Naval Force for Me d iterranean), in alternanza con l'al t ra forza di inte r vento rapido della Na t o , la Stanavforlant (Standing Naval Force for At lantic), con compi t i cli controllo e sorvegl ianza marittima, quale importante contributo alla ]o rta al terrorismo internaz iona le. La Marina Militare vi partecipa dal settembre 2001 con una fregata/cacciatorpediniere. Di recente, l'area de ll 'operazione è stata estesa fino allo stretto di Gibil t erra.
Nel quadro de ll a campagna contro il terrorismo internazionale decisa a seguito deg li eventi dell'11 settembre 2001, gli Usa hanno dato l'avvio all'operazione Enduring Freedom, su una vasta regione comprendente l'Afghanistan, il Mar arabico settentrionale e il Corno cl' Africa. L'Italia h a immediatamente offerto il propr io contributo, costitu ito in izialmente da un consistente gruppo navale e in un momento successivo (febbraio -settembre 2003) da un reggimento di fanter ia (alp ini/paracadutisti) dis locato nel la zona orientale dell'Afghanistan (operazione Nibbio) . Dall'iniz io del 2004 , la partecipazione i t aliana consiste ne l l' impegno di due unità naval i (una fregata e una nave appoggio) operanti nel mare del Corno d'Africa ne l l'ambito cli Euromarfor, formazione navale europea c h e comprende unità francesi, ita liane, spagnole e portoghesi .
A seguito degli sviluppi della situazione po liticomilitare in Afg h a ni stan, il Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite ha approvato in data 20 dicembre 2001 la Risoluzione 1386 con la qua le ha autorizzato il disp iegamento nella città cli Kabul cli una Forza multinazio n ale d enom i nata International Security Assistance Fo r ce (Isa f ), con il compito di ass is t ere le istituzioni pol it ic h e provv isor ie afgane, nel quadro degli obiettiv i fissa t i dagli accordi di Bonn .
La forza, inizialmente compos t a da unità fornite da una Coalizione di Stati, a partire dall 'agosto cie l 2003 è stata posta sot t o la guida della Nato, che ha iniziato un processo d i espansione dell'area d i responsabilità di Isaf, comprenden t e oggi l'area di Kabu l e una vasta porz ione de l terr it orio settentr io n ale clell' Afghanistan.
Il contributo it aliano a Isaf consiste in una task force terrestre d i 500 unità dislocata in Kabul. Vanno, tutta via, conside r a t i parte integrante del contingente i 70 militari del l'Aeronautica componen ti il reparto operati v o autono m o, dis locato ad Abu D h a bi (Eau), che con i propri velivol i da trasporto C 1 30] garantisce un sostegno costante e aderente sia a l le un it à ita liane di Isaf, sia al contingente italiano schiera t o a Nassiryah, nel teatro opera t ivo iracheno .
L'operazione post- Iraq war Antica Babilonia Completa t e le operazioni belliche che hanno portato all'abbattime n to del regime di Sadd am Hussein, dal maggio 2003 è s t ata avviata la fase "pos t conflitto" (IV fase d ell'operazione Iraq Freedom), che si p on e come ob ie tti vo la creazione de ll e condizioni indispensabil i allo sviluppo pol i tico, soc ia le ed economico de ll 'Iraq

Su decisione del Parlamento e del Governo, un contingente italiano di circa 3 . 000 unità veniva ridisloc ato, a partire dal g iugno 2003, nell'area cli Nassiryah, provincia di Dhi Qar, nell'Iraq meridionale per concorrere, con g li altri Paesi della coa lizi one, a garantire le condizioni di sicurezza e stabilità necessarie alla ricostruzione del Paese.

Il contingente nazionale, inquadrato nella Di v isione Mu ltinazionale a gu ida britannica, consiste in una task force interforze comprendente una componente dell'Eserciro a livello Brigata, un reggimento .tvlsu d e i Carabinieri, un reparto operativo autonomo cieli' Aeronautica Militare. La Marina
.Mi li tare ha partecipato alla missione inizialmente con la nave da sbarco San Giusto, due unità cacciamine e, successivamente, con una compagnia di fanti di marina del regg imento San Marco.
Del contingente italia no fanno parte unità della Romania e del Portogallo.
Significativa anche la presenza di personale italiano presso i comandi della coalizione . Tra questi, di pa r ticolare risalto, il Vice Co mand ante del Corpo d'Armata in Bagclad e il Vice Comandante della Divisione a Bassora .
Numerose le missioni dell'Onu cui partecipa l'Ita li a con personale mili tar e :
- dal 1979 nell'Unifil (Uniteci Nations Interim Force in Lebanon), con 51 uomini e 4 elicotteri AB-205 dell'Aviazione dell 'Esercito, per la sorveg lianza d ella fa sc ia meridionale del Libano;
- dal 195 8 nell'Untso (United Nations Truce Supervision Organization), con 6 osservatori per il
controllo d e.Ila tregua stipu lat a tra Israele ed Egitto, Libano, Giordania e Siria;
- da l 1951 nell 'Unmo g ip (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan), con 7 osservatori dislocati in Kashmir sul confine tra l'India e il Pakistan;
- dal 1991 nella Minurso (Un iteci Na tio ns Mission for the Referendum in Western Sahara), con 5 osservatori per controllare il processo referendario di autodeterminazione che dovrebbe porcare alla definizione dello stato di sovran ità nel Sahara occidentale;
- dal 1999 nell'Unmik (Uniteci Nations Mission in Kosovo), con 59 uni t à cli cui 1 ufficiale di co llegamento in Kosovo, per il monitoraggio dell'attuazione del "cessate il fuoco" e l 'effettuazione delle indagini in caso di violazione;
- dal 2000 nell'Unmee (Uniteci Nations Mission in Ethiopia and Eritrea) . Attualmente sono presenti 50 carabinieri e 3 osservator i per supportare le operazioni di p eacekeeping, conseguenti ai recenti accordi di pace sig lati da Etiopia ed Eritrea per la cessazione de l le ostilità, originate da lla disputa sui confini tra i due Pa esi ;
- da gennaio 2004, in Sudan e Ken ia sono presenti 2 ufficiali, sotto egida Onu, per monito rare le operazioni di cessate il fuoco nella zona di Moun tain Nu ba e nella regione del Darfur. Nell'ambito delle operazioni multinazionali, personale italiano è presente nei seguenti organismi:
- Mfo (Multina ti onal Force ancl Observers) dove opera un gruppo navale, con il compito di tutelare i l diritto di transito nello Stretto di Tiran che unisce il Golfo di Aqaba al Mar Rosso;
- Eumm (European U nion Monitoring M iss ion) nei Balcani per monitor izzare gli aspett i po litici, militari, econ o mici e umanitari nell'area, con par ti colare attenzione a l lo sv i luppo della fase di ritorno dei dispersi e dei rifugiati;
- Tiph2 (Temporary lnternational Presence in Hebro n) in Palestina, allo scopo di facili t are la cooperazione tra forze israeliane e pa lestinesi;
- Eu p m (European Union Po l ice Miss ion) in Bosnia, con lo scopo di addestrare la po l izia locale . In fin e, su base bilaterale, o ltr e alle citate m iss ion i in Albania, l'Italia ma ntiene su l territorio di Malta una delegazione di assistenz a t ecnico-militare (Miatm) composta da 50 mi l itari delle diverse Forze Armate .
Contributo al sistema di Difesa e Sicurezza Europea
Nel dicembre 1999, in Helsink i, il Consiglio Europeo ha con fermato l 'intendimento di svi l uppare capacità decisionali autonome e idonei strumenti militari per condurre operazioni in risposta a crisi internazionali, in caso di non interve nto della Nato. P er quest'es igenza, l'Italia ha reso

disponibile, o lt re a u n cosp icuo pacchetto di assetti e di forze tratti dall e quat t ro Forze Armate, un operation Headquarter (Euo hq) a liv ello strat egico, per la direzione e la condotta d elle operazioni svolte in a d erenza ai "comp iti di Pet ersberg" e che comprendono una vasta gamma di opzion i, dagli intervent i umanitari a que ll i per l'imposizione della pace. D i conseguenza, è stato recentemente realizzato un nuovo Comando strategico, multinazionale e interforze, dislocato nella sede del Coi, separato dal quart ier generale nazionale, in grado d i gestire, appu nto, le future operazioni a guida europea. La parte infrastrutturale e l'architettura di comando e controllo sono or m ai comp letati, mentre la mul tinaziona li zzazione de ll o staff è in via di d e fin izione con i partner europei Si t ratta di un progetto indubbiamente rilevante, soprattutto in termini di risorse uman e, la cui realizzazione pone il no stro Paese a l pari livello di altre nazioni europee che hanno forte rilevanza ne l campo politico, d iplomatico, economico e militare e che comporta sicuri ritorni sulla credibilità de ll o s trumento mi litar e it aliano su ll a scena e uropea e mondial e .
' Le missioni da compiere son o le cos idd ette missioni d i Pet ersherg, integrate nel titolo
V del trattato su ll' Unione europea, e che tra ducono adeguatamente la vo lontà deg li s ta ti membri di garantire la s i-
curezza attraverso m iss io ni :
- u manirarie o di evacuaz ione di pe rsone;
- di mantenimento della pace;
- di gestione del le c ri s i, ivi compres e operaz ion i d i r ip ris t ino della pace.
Premessa
el quadro della Global \Xfar on Terrorism lanciata dalla Casa Bianca, una coalizione angloamericana e che vedeva la p r esenza di contingenti militari australiani, polacchi e danesi, ha dato avvio ne l mese cli marzo 2003 all'operazione Iraqi Freeclom (Oif) per il rovesciamento del regime d i Saddam Hussein . Il 1 ° maggio 2003, terminate le operazioni militari cli maggiore importanza, è iniziata la fase "post confl itto ", con l'obiettivo di costituire le condizioni indispensabili allo sviluppo politico, sociale ed economico del Paese .
In t ale contesto, il Consiglio di Sicurezza delle Nazion i Unite, con la Risoluzione n. 1483 de l 22 maggio 2003, sotto il Ca pitolo VII della Carta dell'Onu, vo t ata all 'unanimità dai suoi 15 m e mbri sollecitava la comuni t à inte rnazionale a contribuire alla stabilità e sicu r ezza dell'Iraq e ad assistere il popolo iracheno nello sforzo per l'opera riforma t rice del Paese, prendendo atto della situazione creatasi in Iraq dopo la caduta del regime di Saddam Hussein e, su indicazioni del Consig li o di Sicurezza, il Segre t ario Genera le delle Nazioni Unite nominava un Rappresentante Speciale p er l'Iraq. Molte nazioni, tra cui l ' Italia, hanno offerto un contributo militare a protezione delle attività di ricostruzione, altre solo un a ppoggio finanziario

Successivamente, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu con la Risoluzione 1511 riaffermava l'invito agli Stati membri a contr ibuire, anche con uni r à militari, al processo di stabilizzazione e ricos tru-
zione econom ic a e socia le d ell'Iraq e, dopo un lungo negoziato diplomatico, con la Risoluzione 1546 clell'8 giugno 2004, le Nazioni Uni t e auspicavano l'inizio di una nuova fase del processo di transizione iracheno attraverso la nascita di un governo democraticamente eletto nonché la fine dell'occupazione con l'assunzione della piena res ponsabili tà e autori tà da parte dell'Interim Government dell ' Iraq, dal 30 giugno 2004 e il conseguente scioglimento della Coalition Provisional Authority {Cpa), l'entità amministrativa provvisoria, costituita nelle ultime fasi delle operazioni militar i a guida anglo -ame ricana, incaricata di gestire l'ammin istrazione dell ' Iraq.
Terminare le operazioni militari, il territorio iracheno è s tato suddiviso in se i aree di responsabilità (Aor, Area of responsibili t y), al cui presidio è stata assegnata una grande unità.
Il compito della presenza internazionale è quello di concorrere a garantire le condizioni di sicurezza e stabilità necessarie a consentire l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari e contribuire al ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni irachene .
Nell'ambito dell'int ervento italiano in Iraq, il governo ha costituito una componente militare, nel contesto dell'operazione denominata Antica Babilonia, che a sua volta rappresenta i l con tributo n aziona le alla IV fase dell'operazione Iraqi Freedom. Al contingente italiano, posto sotto il Controllo Operativo del Comandante della Divisione
Multinazionale a guida britannica (i l Transfer of Authority, Toa , dalle forze inglesi a quelle italiane è stato effettuato il 15 luglio 2003 ), è stata affidata l'area di responsabilità della Provincia cli Dhi Qar, con capoluogo Nass iryah. I compiti assegnati al contingente italiano sono : creazione e mantenimento cli un ambiente sicuro; concorso all'ordine pubblico e polizia militare; supporto alle attività di sminamento; rilevazioni biologiche e chimiche; assistenza sanitaria; gestione aeroportuale; supporto alle attività di assistenza umanitaria.
La struttura multinazionale
Nel mese di maggio 2003, t erminate le operaz ioni mi l itar i, al vertice della presenza militare internazionale è stato costituito un Comando di Teatro di livello Corpo d'Armata con sede a Bagclad, il combined joint task force-7 (Cj t f- 7), articolato su 3 cli visioni statunitensi (opera nt i rispetti varnen t e nelle aree nord, nord -ovest dell'Iraq, e nell'area urba n a di Bagdad ); 1 Brigata Multinazionale a comando s t atunitense a presidio del Kurdistan iracheno. Le forze statunitensi presenti in Iraq nel luglio 2004 assommano a circa 130.000 unità. Sono inoltre schierate in una Divisione Multinazionale a comando polacco (Mnd -Sc), operante nell ' area centro - meridionale e una Divisione Mul t inazionale a comando inglese operante nell'area sudorientale (Mnd -Se).
All'interno della area d i responsabilità della Mnd - Se, che comprende quattro province, all'Italia è stata assegnata la responsabili t à della provincia di Dhi Qhar, con capoluogo Nassiryah, dal 15 l uglio 2003 e la missione del contingente ita -
liano è quella cli concorrere, con gli altri Paesi de l la coa l izione, a garantire le condizioni di sicurezza e stabilità nece ssar ie a consentire l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari e contribuire, con capacità specif iche, agli interventi più urgenti per il ripristino delle infrastru ttur e e dei servizi essenziali .
li 15 maggio 2004, dopo una consultazione basata sull'analisi dei risulta t i e dell'evoluzione d ella situazione politico-militare e sul t erreno, il Cjtf-7 è stato so ppr esso e sostituito da due entità, la Mnf-1 e il Mnc-1, entram bi a comando statunitense.

La prima è responsabile del le attività opera t iv e a livello congiunto dell e forze della coalizione (escluse le uni r à statunitensi) e dovrà enucleare la forza mu lt inaziona le che in futuro do vreb b e operare in Iraq sotto la bandiera (o il mandato) dell'Onu; il Multi Nationa l Corps -Iraq (Mnc -1), con comperenze essenzialmente operative, ovvero di gestione delle operazioni di contrasto a ll e formaz ioni armate irregolari ed esercizio de l controllo sulle forze militari irachene, che saranno soggette solamente sotto il profilo amministrativo, all'autorità del Ministero della Difesa e dello Staro .Maggiore delle Forze Armate irachen e, in via di progr essi va costituzione.
Infine, per completare il panorama dell'intervento internazionale in Iraq, nella prima metà di agosto 2004 è giunto a Bagdad il primo nucleo della missione Nato, la Ntim -1 (Nato Training lmplementat ion .Mission-lraq) incaricata di preparare e porre in essere un piano complessivo e coordinato delle diverse iniziative, che mol t e nazioni che hanno forze nel Pa ese mediorientale hanno avvia -
to, destinate a ll 'ad dest rame nto e formazione de lle Forze Armare e di Poli zia irachene.
L a missio n e Nato, che n e l mese di ortob r e h a raggiunt o la forz a di u n centinaio di Ufficia l i e So tt ufficia li di div ersi P aesi dell'Allean za (tra cui l' Italia), si integra inoltre co n i molti programmi che a ltri Paesi e uropei e mediorientali ha nno sv il upp a to , anch e os pitando s u l loro t er r itorio a lli evi de ll e For ze Arma t e e di Polizi a ir achene, ne l quadro sino ad allora gesti to dall'apposito com a nd o, Multi na tional (sec urity tr ans ition) comma n cl - lraq .
La struttura nazionale
11 Comando ope ra ti vo (Op com) del le Forze italian e è manten uto da l Capo di Stato Ma gg iore della Difesa , mentre il Controllo opera ti vo (Opcon ) è s tato del egato al Co mand ante dell a Divisione Multi Naz ionale ing lese a Bass o r a (m ent re per le componenti navali questo riferiscono a l Comanda nte di Usnavcenc/5 'h Us fleet (Forze Navali Usa centrali/5 • Flotta Usa) .

Il Coman d ante de l Co id ifes a (Comando op e r a tivo inte rfor ze) è responsabile per le forze che permangono sotto l'Autorità nazionale . Il meccanismo di comando e cont ro llo int erforze pr eve de un M aggior Ge n e rale d e ll 'Esercito It a l iano (E .T. ) in qua lità di I ra l ian Senior Repres en t a tive (c h e risiede a Camp Vic t ory, Bagda d ) e un al tro Maggior Ge neral e dell'Esercito in q u alità di Nat iona l Co nr ige nt Commander, dislocato a Bassora ne i press i de l Comando della Mnd -Se (collo cato presso l'ae roport o) unitamente a l suo staff. D all' Iralian Senior R ep resemat ive dipend e il Nati o na l
Cont ingenr Com mand er, che comanda la joinr ta sk force Iraq (a livello Brigata ), la task force C (Coma ndo, Co ntrollo , Com unicazioni, Comput er), il P ub l ic informari on office e il Co mand o aer oportuale i nte r forze per circa 70 unità . Al l'Ttal ia sono state inoltre assegnare le posizioni di Vice Comandant e e a lcune di s taff (15 unità) n ell'a mbit o del Comando dell a Mnd -Se.
In o ltre, p r esso la sede dell'Ambasciata Italiana in Bagdad ha operato il nucleo militare presso la D elega zion e D ip lomati ca Speciale Italiana composta d a 12 unità ( 10 E. I.+ 2 M.M.) con il compito di fornire consulenza al personale diplomatico italiano de ll a missione di cooperazione con la C p a c hi uso i l 30 g iugno 2 00 4 con il passaggio dei pot er i al Gov e rno ad interim iracheno . Ino lt r e, nell'ambito della Mnf-I opera, dal 15 maggio 2004, un Brigadiere Generale d e ll 'E.l. Infin e A ll'inte rno d e l Mnc -I, il Dcpu t y Comma n der della s t ruttura, dall'ultima d eca de d el mese di giugno 2004, è ugualmente un Generale dell'E .l. 11 co ntin gen te si com pone co mpl essiva m ente di c ir ca 3.000 u ni tà ed è formato da una co mponent e dell'Esercito, numericament e preponderante, della Marina, dell 'Aero nauti ca e dei Carabi nie ri. Antica Ba bilonia, a nche se è a carattere in terfor ze, per la pr i ma volt a è stata affidata all'Esercito qua le leading -componenr e qu es ta è una novità che si in serisce in un collaudato schema opera ti vo, arricchito d alla vas t issim a esperienza che le F.A . h anno accumulato in o ltr e vent'anni.
L' Eserc ito schie r a circa 1.900 uomini che compongono un Coma nd o di Brigata (Jrf Ira q) co n s u pporti, in g rado di gestire unit à a nche di a ltre
nazioni; un'unità di manovra a li vell o di reggimento , con unità di supporto logistico a livello reggimentale; uno squadrone d ell 'Av ia z ione dell 'Esercito con elicotteri con funzioni di trasporto; un'unità del gen io, a livello di battaglione, con capacità di interventi su l la v iabi lit à , di sminamento e di supporto generale; una compagnia d i difesa Nbc, con capacità di verifica della presenza di aggressivi chimici e d ei liv elli di radioattività, delimitazione di aeree contaminate e analisi di agenti contaminanti o ltr e a controlli chimici e radioattivi su pe rsone, mezzi e materiali e decontaminazione e bonifica di emergenza; assetti di cooperazione civile e militare.
Attua lmente è schierata in teatro una Brigata costruita sul telaio della Brigata Friuli:
Comando Brigata Friu li (Brig Gen. Enzo St efanini), 6 settembre 2004- lO gennaio 2005, schierato con il 66° Reggimento Fanter ia Aeromobile Forlì e con tutte l e usuali component i operat ive, comprendenti unità blindate, delle forze speciali, forze per operazioni speciali, genio, difesa Nbc, guerra e lettronica, Cimic, Aviazion e d e ll'Es erc ito nonché i supporti tattici e logistici tratti anche da diversi reparti dell'E.l.
Hanno operato in Iraq
Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli (Brig. Gen. Corrado Dalzini), 23 maggio-6 settembre 2004, schierata con Reggimento Lagunari Serenissima e Reggimento Genova Cavalleria e con le abituali altre pedine operative t ra tte anche da altri reparti, nonché con i supporti tattico e logistici .
Brigata Corazzata Ariete (Brig. Gen Gian Marco
Chiarini), 30 gennaio 2004-22 maggio 2004, sch ierata con 1'1 1° Reggimento Bersaglieri, con abituali pedine operative tratte anche da altri reparti, nonché con i supporti tattic i e logist ic i.
Brigata Meccanizzata Sassari (Brig. Gen Bruno Stano), 8 ottobre 2003 -29 gennaio 2004 , schierat a con 1'151 ° Reggimento Fanteria Sassari, con abitual i pedine operative tr a tt e anche da altri reparti, nonché con i supporti t a tt ici e logistici.
Brigata Bersaglieri Garibaldi (Br ig . Gen. Vincenzo Lops), 15 luglio - 8 ottobre 2003, schierata con 1'18° Reggimento Bersaglieri, con abitua li pedine opera tiv e tratte anche da altri reparti, nonché con i s upporti tattici e logis tic i
Altri contingenti
All'interno del Contingente Italiano è stato inserito un battaglione di fanteria motorizzato rumeno su veico li ruotati Btr (40 4 unità) e nella città di Nassiryah opera, anche se separato d al contingente ital iano, una formazione sudcoreana della forza di un battaglione (600 unità circa), che include un elemento di protez ione e sicurezza e reparti logistici, del genio e san it à che operano a favore della popolazione civile.
Il contributo militare italiano

alla ricostruzione dell ' Iraq
Un'operazione così complessa, come il ripor tare nell'ambito della comunità internazionale un Paese di antiche tradizioni e differenti religioni, etnie e culture, che emergeva da una brutale dittatura e da avventure militari che ne avevano prostrato l'economia e minato la coesione socia le, rappre -
senta una sf ida col ossale . Il 1 ° maggio 200 3 è iniziat a la fase "p ost con flit t:o" (IV fase dell'operazione Ir aqi F reedom), che si pone come obiett i vo la c reaz io ne d ell e co ndiz ion i indi s pensabili allo svi luppo p o litico, soc iale ed ec onomico d e ll ' Iraq . Le at ti vità di coop e raz io ne civile mi l itare so no state svo lt e dalla J rf Iraq co n i fon di del Co mm a nder em e r g enc y respon se progr am della coa lizione . Al l'interno di ques t o programma sono stari attivati circa 26 6 pro ge tti p er un o s tanzi amento tota le di 3 . 788 m ili o n i di do ll ar i. Da l 1° lu g lio 2004 sono sta ti m ess i a di sposi zion e altri 3 milioni d i euro a favo re dell'att iv it à Cimic svolte da lla Jtf Iraq e t a li ri sorse finan zia rie sar a nno d estinate a sos titui re i fond i d el Cornmander's Emergency
R esponse Programme ( Cerp ) che h ann o costi tu it o l ' esclusiva fon t e d i fi n an~ia m en ro p er lo s volgime nto d ell e attivit à umanitarie e di ricostruzione s ino al termine del mandato della Cpa i l 30 giugno scors o.
Le altre Forze Armate in I raq
P e r la Ma rina Milit ar e la par t ec ip azi one all 'o pera z ione Antica Babi lon ia è iniz iata il 29 m agg io 2003, con la p art enza d e l P attugliaro re Ciga la Ful gos i e d e i Cacciami n e C hioggi a e Viar egg io d a l porto di Al M anam ah in Bahrain.
D a l 5 giugno 2003, co n la partenza da Brin disi di n ave Sa n Gi usto, il co ntributo dell a Marina è s tato p otenzi ato Il Cigala Ful gos i e i C hioggia e Viareggio hanno operato nell e acque se ttentrionali d el Golfo Persico d al 3 giugno 200 3 con il compito d i gar a nt ir e la bonifica da eventua li min e, ordi g ni bell ic i e instrada re il tr a ff ico navale s u rotte
e a ncora gg i contro ll ati e s ic uri, p er r ie ntrar e in Itali a il 22 agos to 2003. N ave San Giu sto, d opo aver rilev ato il Cigala Fulgosi, ri entrato a La Spezi a il 19 luglio, è ri mas t a in zona op e raz ioni fino a l 25 nove mbr e 2003, quando è inizia to il rien tro in It alia . l i contributo d ella Marina Militare a ll 'o per azio ne A ntica Bab ilonia è continuato nel p e riodo gi ug n o 20 03-ma ggio 20 04 con il R eg gim e nto San Marco c he ha alterna t o circa 600 uomin i.
li 29 m agg io scors o ha avuto luogo il rientr o defini ti vo d e lla parte p iù co ns is t ent e del Re gg ime nto . Attualmente la presenza della Marina Milirare s u l suo lo ira che no continua con una squadra d e l Regg i111ento San Mar co che garantisce i l funziona m ento di comunicazioni satellitari presso la ba se d e i Carabinieri d el la M s u a Nassir ya h, e un'a li qu o ta d ell e forze spec ia li d e l ComsubinGoi ( Comando s ubacqu e i inc ursori - Gruppo o perativo incursori)
Pe r l 'Aerona uri ca Mi li tar e (circa 2 00 unir à} la partecipazione all'operazi o ne Anti ca Babilonia si conc re ti zza nel 6° R e part o O p era ti vo A uton om o, una formaz io n e ad hoc, e int erforze, col loc a t o nella b ase a ere a cli Tallii (una d elle install az ioni areee di maggior e import a nza delle forz e aeree d el regim e di Sadd a m Husse in) , s em pre n ell a prov incia di D i Qar.
Il 6° R oa è un r epar to volo composto attu a lment e da eli co tter i HH - 3F d e l l'Ae ron a utica Mi litare, C H-4 7 e AB -4 12 dell'Esercito It ali a no. Il rep a rto, cos tit uito ne l lug lio 200 3 ha come co mpiti quelli di assicurare alla tas k for ce italiana in I raq il s e rvizio di Medevac (Medica i Ev acu at ion - evac uazi one m edica), Qr f (Qui ck Reaction Forces - For-

ze di reazione rapida), pattugliamento delle principali linee elettriche e petrol ifere, trasporto truppe, scorta convogli e ricogniz ione aerea per le truppe a terra, con capacità di ges ti one e supporto di operazioni aeroportuali. Il 6° Roa dalla sua costituzione, ha effetruaro oltre 3.000 ore di vo lo a favore delle Brigate che si avvicendano nel corso della miss ione. Gli e licotteri ed equ ipaggi del1' Aeronautica Militare provengono dal 15° Stormo cli Pratica di Mare, mentre il contributo dell' E.I. si articola med iamente su 3 CH-47 e 4 AB412 (107 unità ) dell'Aves schierati dal 17 d icembre 2003 . Infine l'Aeronautica .Militare assicura anche le capacità di trasporto aereo in t eatro a tutte le altre componenti della missione e a favore di altri contingen t i nazionali, impiegando C130], C - 130) - 30 e B-707 TT. Per l'Arma dei Carabinieri (circa 350 uni tà ), la partecipazione si artico la principalmente con il Reggimento M.su (Tallii), che svo lge le seguenti mansion i: controllo del territorio - attività d i raccolta del le informazioni in mater i a di ordine e sicurezza pubblica; a tti vità di contrasto alla cr im inalità organizza t a e ami-terrorismo; pattugliamento mirato; assistenza e consulenza alla locale po l izia. Il Regg i mento Msu è un'entità multinazionale in quanto comprende una compagnia de l la Guardia Nazionale Repubblicana portoghese (1 40 unità } e una compagnia della Polizia Militare dell'Esercito Romeno (120 un it à). Il Reggimento è in grado di ges ti re eventuali contributi di altri Paesi e ha la possibili t à cli int erven ire, su esplicita richiesta, in tutto il settore divisionale britannico.
Accanto alla Msu, l 'Arma ha schierato un nucleo
(26 unità ) con funzioni di polizia militare presso la Brigata Italiana (Tallìl), un nucleo cli protez ione ali' Ambasciata d'Italia (25 unità) e un reparto Carabinieri (circa 30 uni t à) per assicurare la sicurezza in terna d ell'ospedale da campo della Croce Rossa Italiana a Bagdad .
Infine vi è una dozzina di mi l itari dell'Arma impegnata in diverse funzioni: pro t ezione Vip dell'Ita l ian Senior Representative presso la Cpa, collegamento presso il comando di Nassiryah; Cai (Centro Amministra ti vo Interforze) cli Kuwait City e Comando del la Divisione M.u lti Nazionale a comando ingl ese a Bassora . La Croce Rossa Itali ana (Cri) co ncorre con un import ante contributo in t ermini di personale e attrezzature spec ia li stiche al fine di assicurare il sostegno sanitario al Contingente nazional e schierato e alla popo lazione locale, con tutte le sue componenti, militari e civili. In particolare il Corpo Mi litare della Cr i ha schierato un Nucleo Chirurgico e un Posto Medico Avanzato con 63 unità (14 medici, 31 t ra paramedici e personale logistico, 18 infermiere volontarie) . La componente civile della Croce Rossa, infine, ges tisce un ospedale da campo nella città di Bagdad, in aiuto dirett o alla popolazione civile e coopera con la autorità locali nella r ipresa d elle attività di uno dei più importanti ospedali civili della capitale irachena.
Il 12 novembre 2003, alle ore 10.40 loca li, è stato effettuato un attentato mediante un'autobomba nella base Camera cli Commercio (denominata dai CC Maestrale) a Nassiryah dove era ubica-
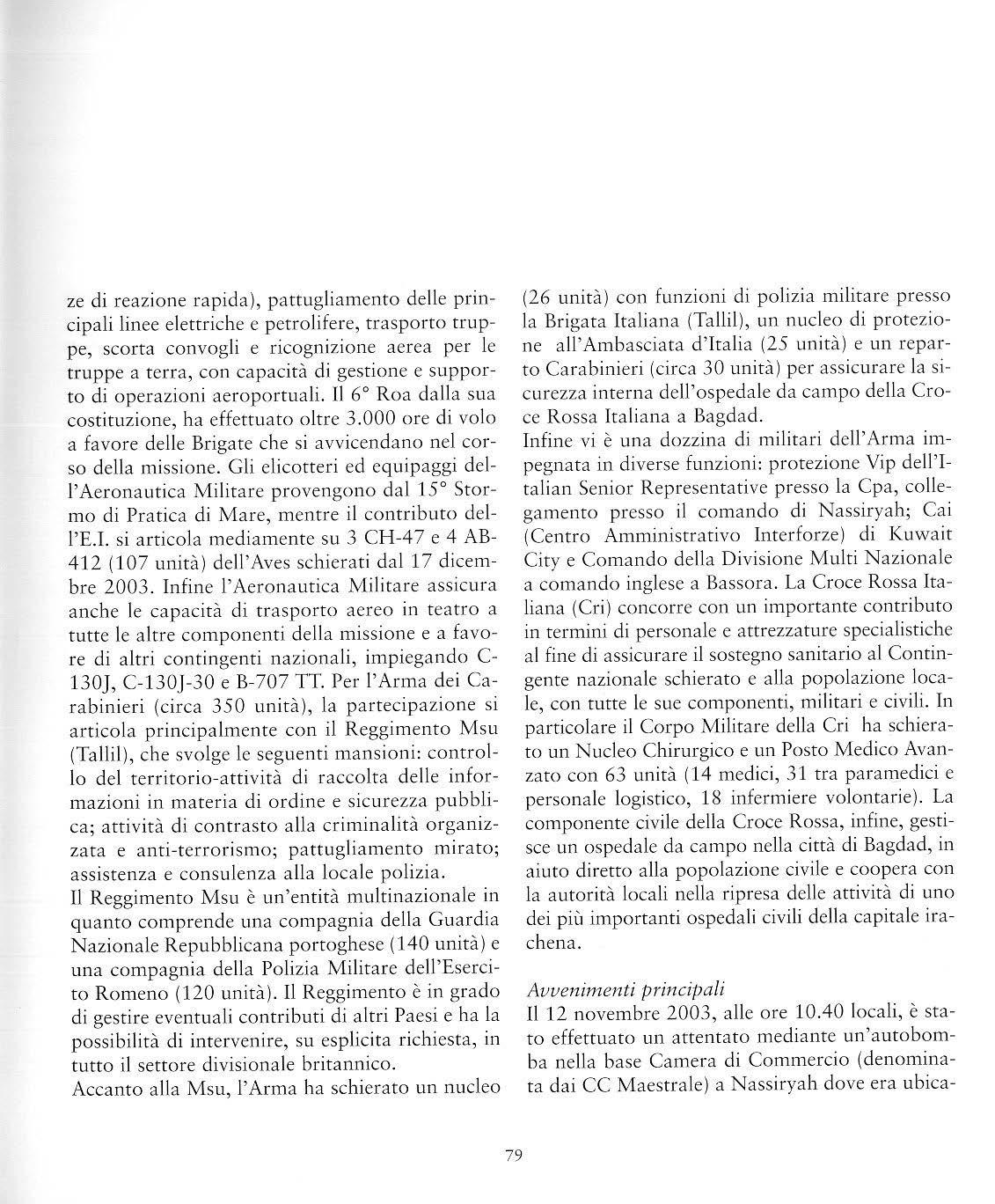
t a un 'al iquot a d e lla M s u. L'esplosione ha di s trutt o pa rte d ella pa la zzina ce ntr ale, del corpo di guardia e d ella s truttur a difensi va Im me diatam e nte dopo è d ivamp ato un vasto incend io che h a coinvol t o la r is ervetta muniz ion i e i veicoli parcheggiati A segui to dell'esplosione 12 carabinieri, 5 militari d e ll 'E .l., 2 c iv il i italiani e 8 c iv il i iracheni so no d ec e duti mentr e so no ri mas t i feriti 20 mil itari it aliani e 25 ci v ili irac heni.
A seguiro della crescente tensione sul terr eno, per megl io prot egge re la sicurezza del c ontingente , i l Comando d e lla Jtf Iraq s i è ridis locat o, d a l ·15 marzo 2004, da Ca mp Whire H orse a Carnp M ittic a (precedenteme nte denomi n a t o Ca mp Family
Qu a rters) in s i e me a l G sa (G rupp o Supporto A der em.a), a l r eggi mento genio, all 'Ms u, al R epar t o Coman do e Supporti T attici, al nucleo Cimice alle unità d elle fo r ze specia li e acquisizione obiettivi, las ciando a Ca mp W hi te H ors e, presso la citt à di Nassir yah, la comp one nte opera tiva , con le T f italia na e rome na.
D all'a prile 200 4 il continge nt e ita l ia no è co ncentra to qui nd i in tr e in s talla z i oni , includ e ndo anche la ba se aerea d i T a llii.
Il 3 apri le 2004, dall e ore 19 . 30 locali, a seguito d ell' arr es t o, da pa rte d e ll e forze Usa, del port av oce d e l par tit o di Moqt ada Al Sadr, Mus ta fà a l Yaqub i, si è ve ri fica ta una ser ie d i incident i e scontri a fuoco tr a manifestant i e mi lit ari del Contingent e it a li a no ch e h ann o coi n vo lto 3 ca rabinieri d e lla Msu e alcun i mili t ari p o rtogh esi in du e di sti n t i attentati a Nassiryah e Suq Ash Shuyukh . I mi litari it ali ani ri po rtavan o feri re legge r e . Il 6 apri le 20 04, la Jt f a ll o s copo di riacqui s ir e il cont ro llo
d ei pont i s ul fiume Eufrat e in Nass ir yah, v irali per garantire la libera circolazione nella città, lanciava un'operaz io ne con le forz e de ll a Tf E leven (tr a tta dall' l 'I O Reggim e n to Bersa g lieri) , rin fo r zat a da una compag nia del la M s u , dalla Tf Pegasus (R eggimento Savoia Cavalle ri a 3°) e da un Do d e ll e Forze Specia li .
D opo viol enti sc o n tri, durante i qual i sono rimasti fer iti 12 militari ita lian i, la Jtf riconqu istava il possesso dei ponci; il 16 maggio, la Jcf interveniva a difesa d e l com pl esso dove è d is locata la se de d e ll a C pa di Nass iryah co n il Govern at o r e de ll a P rovincia di Ohi Q ar.
A seg uito degli sc ontr i a fuoco contro elem enti irr ego lar i app arte nen ti a ll e mi li z ie fede li a Moqcacl a A l Sadr rim anevano co involti a lcuni mi l ita ri del reggim ento lagunari: uno di loro veniva gravemente f erito da schegge cli m ortaio .
Ri co ver ato press o l'o speda le d a ca mpo it a lian o, d ecedeva il ma ttino seguente per le g ra v i ferire r iportare . In una breve ma significativa cerimonia , il de legato d e ll a Cpa, l ' italia na Ba rbara Co ntini , c ed ev a il 27 g iugno la g iurisdizion e amm inist rativa de ll a pr ov in cia di Dhi Qar a ll e a utorit à provvisorie irachene Nella pr ima settima n a d i agos t o, di fr onte a un a nuov a ond a ta di viole nte pr otes t e d el mov im ento sciita cli Moq tada A l Sadr, le tru ppe italiane in gaggiavano scontri con le mil izie armate d el partito, che dopo av e r inutilm e nte tentato di pr e nd e re il contro llo d e i ponti su l l' E ufr ate, per t ag li are le lin ee di ri fo rnimento e dividere in due l ' I raq , lasciavano la c itt à di Nassi r yah, a seguito di neg ozia ti con le a ut orità rel ig iose e ammin ist r ative lo ca li .

Operazioni
Sin dalle prime fas i, il contingente italiano ha svolto un'intensa attività, i nd irizza t a a contribuire alla sicurezza delle popolaz ion i loca l i, coinvolgendo in misura crescente le nuove istituzioni. Accanto alle operazioni di spiccato profilo militare, si vuole so tt olineare l 'imparante ruolo svolto dalle F.A it alia n e e dall'E.I , in ogni settore dell'assi s tenza alle popolaz ioni e alle nuove istituzioni locali, cont ri buendo alla r inascita de l Paese.
2. Afghanistan Jlsaf-Oefj (in corso dal 30 dicembre 2001)
Premessa
L'intervento italiano in Afghanis t an e nell'operazione Enduring Free dom, in co rso dal d icembre 2001, è articolato su diverse iniziati ve, la prima delle qua li rientra nel quadro delle attività internaziona li sancite dal Consig lio di Sicurezza dell'Onu e vo lte a deporre un governo, quello talebano, che ospitava ne l suo territor io i ns t allazioni e centri di addestramento per terroristi collegati alla rete Al Qaeda . Parallelamente veniva cost itui t a, sempre su mandato Onu , una forza di int erven t o multinazionale, l ' lsaf (lnternational Security Assistance Force) con il compi t o cli garantire u n amb iente sicuro a t utela cieli' Au t orità a fghana, forza che si è insed iata a Kabul il 22 d icembre 2001.

L'Italia partecipa a entrambe con formazioni attag lia t e ai differenti profi li operati vi anche se è in discussione a l p iù alto livello politico-militare, tra le nazioni partec ipant i all' l saf e all'Oef, l'unifica -
zione dell e missioni, ridefinendo il quadro giuridico e operativo della presenza internazionale con una nuova risoluzione del Consiglio cli Sicurezza del l'Onu . Proprio il successo delle elezioni afghane , che tra l'ottobre 2004 e la primavera 2005 dovrebbero vede re, in diverse tornate elettora li, l'elezione del presidente della repubb l ica, del parlamento nazionale e delle assemblee locali, rappresen t erebbe il punto di svo lta della norma lizzaz ione de ll a situazione a fghana, con l'accelerazione de l p rocesso cli unificazione delle due forze multinazionali migl iorandone l'e fficacia e razionalizzandone la presenza su l ter ri torio .
La Oef si artico la intorno alla Cjtf 180 che ne è l'e lemen t o di terra e che ne l corso del 2002 ha raggiunto una forza d i quasi 8 000 uomini e donne di 17 nazioni sch ierati accanto alle forze Usa (circa 10 -15.000 unità) e a que ll e afghane rego lari (Ana). Ques t' operazione è diretta da Tampa, in Flor ida, sede ciel Cemcom, il comando interforze sta tu ni t ense che ha giurisdizione sul Medio Oriente, Golfo Arabo Persico, Asia Centra le e Corno d'Africa
A Tampa opera un coman d o mu lti nazionale con centinaia di militari di una ventina di nazioni che coordina le attivita di terra, mare e ar ia in quel la regione.
Il Parlamento Ita li ano ha autorizzato, a partire dal 7 novembre 2001 e in più occasioni rinnovato, la partecipazione di con tingen ti militari italia -
ni alle operazioni condotte dalla coalizione sia in Afghanistan che nelle acque del Golfo Persico e del Mare Arabico nel quadro dell'Operazione Enduring Freedom (Oef), autorizzata da numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e in particolar modo con la 1368 del 12 settembre 2001 e la ] 373 del 28 settembre 2001. Il contributo italiano alla Oef si concretizza in una componente navale in navigazione nell'Oceano Indiano (task force 150), che svolge operazioni di interdizione e contrasto navale, in particolar e nei confronti della leadership di A l Qaecla; scorta di unità della coalizione; con t rollo del t raffico marittimo.
At tualmente il contributo della Marina Militare consiste nella presenza media di una fregata, mentre nelle fasi inziali ha preso parte alla componente nava le d ell a forza multi naziona le anche un gruppo da combattimento incentrato attorno alla portaerei Gariba ld i.
Per l'Aeronautica Militare la partecipa zione all'operazione Enduring Freedom s i è concretizzata nel 5° Reparto Operativo Autonomo, una formazione ad hoc, collocaro nel la base aerea di Manas, in Kirgyzstan, che forte di 2 ve livo l i C - 130] (c irca 70 u.) ha il compito di effettuare trasporto aereo tat tico a favore sia dei contingenti italiani sia della coalizione. Dall ' inizio di maggio fino a metà ottobre 2002 è sta t a ri sch ierata un ' unità ci el genio dell'Aeronautica Militare (circa 50 unità) per concorrere all'effettuazione di la vori nella base aerea cli Bagram. Infine, vi è un nucleo di collegamento interforze presso l'Us Centcom a Tampa (Florida).
L'Oef è al momento nella sua quarta fa se che prevede l'impiego delle unità di terra al fine di creare un ambiente stabile e sicuro per prevenire il riemergere di focolai di terrorismo , supportare le operazioni umanitarie e addestrare l'Esercito afghano .
Ques t a fase dell'operazione è caratterizzata da un più sp iccato orientamento umani tario volto a conquistare il favore della popo lazione locale e preparare le condizioni cli sicu re zza per un tranquillo svo lgim ento d elle elezioni politiche generali, effettuate in ottobre, sotto il controllo dell'Onu e per le quali l'Italia ha già effettuato un rafforzamento della sua presenza nel Paese centroasiatico raddoppiando la consistenza del contingente sch ierato a Kabul nel quadro dell' Isaf.
Ne l quadro dell ' avvicendamen t o dei reparti terrestri, nell'es tate del 2002, gli Stati Uniti chiedevano all 'Icalia cli rendere clispon ibile una task force a li vello reggimento, da integrare nel dispositivo della Coa lizione.
Il 2 ottobre 2002, il Parlamento It al iano autorizzava la partecipazione, a par t ire dal 15 marzo 2003 e con manda t o di 6 mesi , scadente il ] 5 settembre 2003, di un contingente dell'Esercito Italiano di 1.000 so ld ati. Prende va così l'avvio la missione della t ask force Nibbio, inizialmente cos t itu ita sulla base del 9° Reggimen t o A lpini della Brigata Taurin e nse, avvicenda to il 15 giugno 2003 dal 187° Reggimento Paracadutisti della Brigata Fo lgore, che il 15 settembre 2003 cedeva la responsab i lità della propria area al 1 ° battaglione dell'87° R egg imento d ella 10'' Divisione da Mon t agna dell'Us Arm)'.

Al Contingente Nibbio è stata assegnata la missi one di concorrere, con le altre forze della Coalizion e, al raggiungimento d egli obiettivi strategici prefissati per la terza e quarta fase dell'Oef (stabilizzazione del Paese asiatico e contributo alla ripresa economica -sociale) In par ti colare, il contingente na z ionale aveva ricevuto il compiro di condurre attività di controllo del territorio e di interdizione della propria Area di Responsabilità e di concorrere alla neutralizzazione di sacche di resis t enza, basi logis ti che e di centri di reclutamento delle formazioni di Al Qaeda e dei talebani . Mentre il grosso del contingente N ib bio veniva dislocato nella loca.lità di Kho st (provincia di Paktia), confinante con il Pakistan , presso la base operativa avanzata (Fob) statunitense Salerno, un'aliquota di circa 200 u. veniva mantenuta, con compi ti di s upporto logistico, nella base aerea di Bagram, sede del Comando della Coalizione in Afghanistan. In tale contesto, il Contingente italiano ha condotto un'attività operativa spiccatamente dinamica, sviluppando una diffusa presenza sul t e rritorio mediant e pattuglie e complessi di forze itineranti t endenti, da un lato, a raccogliere informazioni e a ostacolare la libertà cli movimento dei gruppi armati, dall'altro, a intensificare il contatto con la popolazione locale, anche attraverso la distribuzione di aiuti umanitar i e interventi cli ricostruzione e di sostegno alle istituzioni locali. La Tf è stata, inoltr e, imp egna ta in frequenti operazioni di più ampia portata, pianificate autonomamente o disposte dal Comando della Coalizione, intese a interdire vaste zone do-
ve fonti intelligence d ella Coalizione o nazionali indicavano la presenza di gruppi ostili o di depositi illeg ali di armi e munizioni .
Comando e controllo della struttura nazionale Il Comando Operativo (Opcom) delle Fo r ze Nazionali impegnate nell'operazione è stato eserc itaCO dal Capo di Stato Maggiore della Difesa (Cincclifesa), che lo esercita a tt raverso il Coi, mentre il Controllo Operativo (Opcon) delle unità nazionali schierate in area d i operazione è delegato al Ncc (National Cont ingent Commander), con giurisdizione su tutte le forze italiane sch ierate in Afghanistan, inclus e quelle della Isaf. Il Controllo Operativo della Tf Nibbio sul terreno è stato delegato al Comandante Usa in Afghanistan (che è anche il Comandante della Cjtf 180) che lo ha delegato al Comandante della Tf Devii, di st anza a Kanclahar. Sulla base di una prassi orma i sperimentata con successo in altri teatri operativ i, al comandante della Coalizione è stato affiancato un Generale italia no, nella ves ce di Rappresentante M.ilitare Ita l iano (lt -Snr), per verificare che l'impiego del nostro contingente fosse mantenuto nell'ambito delle deleghe conferite dall'Autorità nazionale .

In tale scenario operativo, i reparti italiani hanno fermato e identificato 4.170 persone sospet t e, controllato 1.055 veicoli, sequestrato 1.288 armi di vario genere; scoperto e distrutto 5 .200 kg di munizioni ed esplosivi di vario tipo; effettuato 450 pattuglie a breve, medio e lungo raggio
(62.000 km percorsi); condotto auronomamente, o in concorso con altre unità della coalizione, 40 operazioni. La missione ha registrato solo 4 feriti l eggeri, anche se le installazioni del contingente hanno regis trato una ventina di attacch i da parte di formazioni ostili.
La task force Nibbio e r a costituita da contingente interforze (Esercito, Marina e Carabinieri) a l ivello reggimento composto da circa 1.000 mili tari e circa 200 veicoli ed era articolata su: un Comando di Reggimento con un battaglione di fant eria, rinforzato con mo lt e a ltre pedine e componenti operative e un supporto tattico e logistico idoneo a sostenere il reparto in un teatro tant o disagiato e isolato.Il supporto elicotteris ti co, per ragioni di standardizzazione e semplificazione operativa e logis t ica, è stato fornito dal Comando Usa, che ha rischierato sulla base Salerno di Khowst 2 elicott eri d'attacco AH - 64 Apache e 2 UH -60 Bl ack Hawk dedica t i a ll a Medevac e alle operazioni eli po.rtate e che ha assicurato il regolare flusso di rifornimenti via aerea da Bagrarn. Neg li ultimi quattro mesi, anche velivoli C -130.J dell'A. M. sono stati messi in condizione di operare sulla pista semipreparata d ella Fob Salerno, a diretto sostegno dell'uni tà italiana. L'Us Army ha inoltre reso disponibile su ll a base Salerno un Field Surgical Team (Fst).

Task force Nibbio I (Col. C laudio Berto) dal 15 marzo 2003 al 15 giugno 2003 Costituita intorno al 9° Reggimento Alpini, r inforzato con tutte le abitual i pedine operative e con un adeguato supporto tattico e logistico.
Task force Nibbio II (Co l. Federico d'Apuzzo) da l 15 g iu gno al 15 settembre 2003. Costituita intorno a l fulcro rappresentato dal 187° Reggimento Paracadutisti Folgore, rinforzato con tutte le abituali ped in e operative e con un adeguato suppo rto tattico e logistico .
L'operazione Nibbio può essere considerata una delle più comp lesse e rischiose missioni compiute dalle Forze Armate Itali ane dalla seconda guerra mondiale .
La difficoltà deriva anzitutto dalla notevole distanza del teatro operativo dalla Madrepatria (circa 6.000 km), che ha imposto un massiccio piano di trasporti via aerea (96 voli militari e 3 7 civ ili ), per garantire il dispiegamento, il rientro e il regolare flusso cli r ifo rnimenti del contingente. Complessa, inoltre, per la necessità di realizzare lo stretto coordinamento e la forte interazione a l ivello operativo e tattico con le forze statunitensi, indispensabile per ga r antire l'efficacia della missione. Le caratteristiche morfologiche del terri tor io, difficilissimo, e il contesto socio-economico e gl i instabili equilibri politico -etnico - tribali hanno reso estremamente impegnativo l'assolvimento della missione, me ntre la diffusa presenza nel t erritorio di formazioni armate ha mantenuto cos tan temen te eleva to il livello di minaccia incombente sul nostro personale . Le nostre unit à hanno fornito prova di grande professionalità ed efficienza, affidab ilit à ed umanità, confer m ando come le operazioni di Pso abbraccino una vasta gamma di miss ioni che varia dall'invio di osser-
vatori disarmati fino allo schieramento di forze consistenti e reattive a causa di situazioni talmente difficili e degradate dove solo la de t errenza e credibilità di contingenti militari possono rappresentare un e lemento di stab ilit à.

Premessa
In Afghanistan è in corso anche una seconda operazione multinazionale: è quel la dell'Tsaf (International Security Assistance Force) autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 'Unite con le risoluzioni 1386 del 20 dicembre 2001 (e seguenti) che ha il compito di assistere le autorità afgane nel mantenimenro della sicurezza a Kabul e nelle zone circostanti e l'Ita lia vi contribuisce con un contingente terrest re dell'Esercito e con personale dell'Arma dei Carabinieri. L'lsaf, che opera sulla base di un Military Technical Agreement (Mta) siglato dalle autorità provvisorie afgane, era inizialmente a gu ida inglese, ha visto la Turchia (dal gi u gno 2002), Olanda e Germania (co n g iuntamente dal febbraio 2003) svolgere il ruolo di leading nat ion si no a ll'agosto 2003, quando è stata posta sotto il comando della Nato
La missione dell'Isaf è quella di assistere le istituzioni poli ti che provvisorie afgane a mantenere un ambiente s icuro nella città di Kabul e aree limitr ofe nel quadro degli Accordi di Bonn. In pra tica, i principali compiti sono: proteggere i convogli sulla Loc (Line of Communication) Bagram-
Kabul; supportare i proget t i di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie; sostenere le operazioni di assistenza uman ita ria; fornire assistenza e aiuto alla riorganizzazione delle strutture di sicurezza delle autorità provvisorie afgane e formare e addestrare l'Esercito e le forze di poJizia locali.
La struttura multinazionale
L'Tsa f è una forza Nato a tutti gli effetti e la sua composizione richiama gli aspett i schematic i delle forze multinazionali che operano nei Balcan i, dove, accanto a contingenti dei Paesi alleati, vi sono presenze più o meno ampie di altri Paesi che aderiscono ai meccanismi di cooperazione conn l'Alleanza Atlantica.
Nel g iu gno 2004, l'Tsaf contava c irca 6.500 unità (è in corso un rafforzamento che porte r à il totale ad oltre 10.000), provenienti da tutti i Paesi de ll'Alleanza (ora 26), 9 nazioni partner e 2 paesi non -Nato/non-Eapc.
L'lsaf dipende direttamente dallo Shape (Supreme Headquarters Allied Povve r in Europe), il vertice militare al leato, mentre Afnorth, il Comando Alleato pe r l'Europa settentr ionale (con sede a Brunssum, in Olanda), è responsab ile della condotta operativa della missione.
L'lsaf si articola in diverse component i. Il comando vero e proprio della missione è responsabile della pianificazione delle operazioni dell'intera forza multinazionale. Inoltre il comando dell'Tsaf ha contatti opera ti vi con la forza multinazionale a guida statun itense che opera fuori della capitale afgana, l a Oef!Cjtf 180. Mantiene i contatti
con la mission e Onu in loco, l'Unama e con le numerose organizzazioni intern azionali e non governative che operano nel Paese centroasiarico . La principale componente operativa dell'Isaf è la Brigata Multinazionale di Kabul (Kmnb, Kabu l Multi Na rion a l Brigade) che assicura la sicurezza della capitale afghana e d ell e sue immediate adiacenze . La Brigata si articola su coman do e reparto comando (e ntrambi mul ti nazionali), un r e parto sicurezza (assegnato a ll'Ita l ia sin dalla istituz ione clell'Isaf, a protezione delle installaz ioni di comando e controllo di tutta la pr esenza alleata a Kabul), 3 gruppi tattici di fanteria (Turchia, Germania , Canada ); 1 squadrone ricognizione (Francia); un reparto ciel genio, uno logistico, medico, elicotter i, supporto aereo e po l izia militare (tu t ti multinaziona li)
La seconda componente dell'lsaf è il Kabul Afghan lntern a tio nal Airport suppor t uni r, una formazione multinazionale, che assiste le autorità dell'aviazione civile afghana in t utte le attività conness e al funzionamento dell'aeroporto della capitale sino a quando s trutture e personale locale non saranno in condizione di poterlo gestire autonomamente . Il terzo elemento dell'Isaf sono i Prt (Provinc ia! reconstruc t ion teams), organismi composti da personale civile e militare dislocati sul territorio afghano e che assisrono le autorità locali nella ripresa delle attività economiche e sociali, protette da un nucleo di sicurezza (generalmente una compagnia di fanteria) .
Questi nuclei che comprendono anche personale civile, rispondono a un progetto iniziato a gennaio de] 2004 e che vede il passaggio di queste

formazioni (16, disperse su tutto il territorio afghano), poste sotro l'egida della Oef all'lsaf. Il primo di questi Prt (Kunduz) è a guida t edesca e gli altri sono stati trasferiti dalla Oef/Cjtf all'Isaf, quali Mazari Sharif e Meymana (Gb) , Feyzabad (Ger) e Baghlan (01). Insieme al la Fob vicino a Mazari Sharif e alla presenza a Sar-e -Pol, Samangan, Sherberghan, I saf sarà in condizione di accrescere la sicurezza in 9 province settentriona li de Il' Afghanistan.
L'Italia, unitamente alle altre nazioni alleate che hanno dispiegaro forze maggiori in Afghanistan, sta negoziando in ambito Nato per vedersi assegnaro un Prt, negozia to che ragione v olmente dovrebbe concludersi nel 2004.
Infine, rispondendo positivamente all'appel lo de] Segretario Generale dell ' Onu di rafforzare la presenza mili t are internazionale in Afghanistan, è stato rinforzato a settembre 2004, sia pure temporaneamente, il contingente nazionale in Isaf, con lo schieramento di un gruppo tattico a livello di battaglione basato sul 3° Reggimento Alpini in concomitanza con l 'a ppuntamento e letto rale .
La struttura nazionale
11 Contingente Italiano, il cui nucleo avanzato è giunto a Kabul il 30 dicembre 2001 (guidato da ll 'allora Colonnello Giorg io Battisti), provvede alla sicurezza del Comando della Missione oltre alle attività di bonifica da ordigni esplosiv i e chimica. Attualmente la task force lsaf, al comando del Colonnello Maurizio Collavoli, è costituita da un forza comp lessiva pari a circa 500 militari, tra cui 25 donne è organizzata sul telaio tratto da l 5°
Regg imento Artiglieria Terrestre Superga dal quale è tratto anche il Gruppo Supporto d i Aderenza e l a compagnia per la Sicurezza de l Comando Isaf (Force Protection Coy) Vi sono poi tutte le abituali pedine operative e una robusta componente cli supporto tattico e lo -
gistico.In passato ha fatto parte della miss ione lsaf anche un nucleo ae roportual e interforze (Nai), ora 7° Roa, con 2 ve livo l i da traspo rto C130] dell'Aeronautica Militare di s lo cati sull'aeroporto militare d i AI-Bateen, negl i Emirati Arab i U niti.

Un a pa tria ritr ov ata , o m ill e patri e se nza n az ione? Le so lenni esequ ie di St a t o de ll e vi tti me di Nass i ry ah, in u n a s s olato m e zz o nove mbr e 2003 pr ess o la ba s ilica r om a n a d i San P a o lo , confe rmava n o la prima , co nforta nte le t tura c he media e osservatori tentarono, di q ue i giorni di lutto, per così tanti vers i senz a pr ece d e nti. Ma in qu e ll a patri a ri t rovata s' imponev a una cir c o sta nza, p os it iva, ma a n oma la . A parlare senza eq ui voc i, con composta fermezza in una secca e chiara omelia, er a i l c ardin ale Ca rnill o Ruini, la g u id a de ll a Co nferenz a episco p a le it a li ana . Fu Rui n i a r ag li are la testa a l toro de i se e dei ma e, a ll e giuste parole evangeliche, seppe agg iunge r e quel " n on fu gg ir emo dav an ti ai te rrori s ti, a n z i li fronteg gerem o co n tutt o il cora ggio, l ' en e rg ia e la d e t e r m inazi one di c u i siamo capaci", d estinato i n evitabi lmente a esser ri mbec cato dal l 'onorevole Be r tino tti e d al pacifis mo no gl o b a l. E anc h e, su Rait re , dal s e n a tore A ndr ea M a n ze lla , a llin ea to a Ma rio Pi ra n i e " R epubblica" che q u el g iorno spiegavano come il "g iorno di tr eg ua " m a i po t e ss e esse r scam bia to per il sì a "p o litic he av ve nturiste " . M a no n è di pol emic he po liti c h e c h e qui me tt e conto p arl are. In quella occasione furo n o anz i , tu tto s ommaro, cont e nute . Co me fo rse n o n e r a n e ppur lecito in precede n za spera re, consid e r a to q u anto l' intervento m i l ita r e ita liano nella s t abi lizzazione irachena e in que lla afghana ab bi a verticalm e nte spa cca to la p o litica itali a n a . Pol e mi c h e conte nute, qu e l giorn o, non so lo d a lla com pos tezza c h e il sac ri ficio di ta nte vite uma n e impon e . Ma s o p r attut t o d a un a ltr o fa tt or e, p rioritario. Poi.irica e is tit u zion i trattenn e ro il fiato pe r
g iorni . A fr ena rli era l'ince rt ezza, i l dubb io d i come sarebbe stara vissuta dagli italiani la sconvolgente no vità d i ranto nu m e ro s i m il ita ri e civ ili ital ian i caduti in I r aq a ca u sa di un a t te ntato s u ic ida È s t a t a l' incert ezza, anzi tutt o, a d aver facto misurare le parole a governo e opposizione, quell a "sens azi o n e d i fredd o e di paur a" c he sol o Ruini e bb e la s ap ie nza e insie me il cora g g io civ i le di evocare . Ri uscen d o egli - autorevo le figura sp i rituale e più alta espressione is t it uz ionale d el cle r o n a'.lio n a le -a t ro v ar e le parol e di fe rmez za c oere n t i a l se ntir e profond o de g li ita liani, q u e ll e parole che po litica e istirnzio n i c ivi li esi t avano a pronunc i are È d a questo to pos, per ta nt i vers i se nza pr ece d e nt i ne ll a s tori a un it a ri a , che o cco rre pa rt ir e pe r un somma r io b ilancio d i come s ia mutata l 'opin ione d eg li ita lia n i n ei c o nfr o nt i delle Fo r ze Arm a t e a seguito delle m iss ioni lsaf in Afghani s tan, e Antica Bab il oni a a ass iry ah e ne ll a pr ovincia di Di Q h a r. L e class i di r igenri d el P aese ne i giorn i s u ccessiv i a qu el 1 2 no vem bre h a n no g u a rdat o a lungo e a dis ra nw a ch e cos a a v ve ni va press o uno dei lu og hi più desu eti de l culto patrio Fur ono le lun g h issime o r e trasco r se in asso lu to si lenz io a R oma da ce n t in a ia cli mi g li aia di pers one n e l le n ti ssim o tragitt o dal F o r o di Cesa r e a lla s a l a d e lle b and ie re d el Vitt oriano, s filan do mu ti e asso rt i mentre i parenti dell e vitt im e vegl iavano le sa lme, a da re un a prima ri sp osta all ' interrogativ o se fos se una o ness una , la pa tria r it rova ta in quel du ro fr a ngente . l a convenzio n e p r evale nte era, ce n o, que lla cle ll 'a ut oconfo rto n azio nale, d ì un nuo vo possibil e - p er alcuni insp era to, d a altri m a lsoppor -

tato - mito unificante celebrato intorno ai nostri "soldati buoni" . Fa tto sta che come la tumulazione del milite ignoto era suggello a Vittorio Veneto, così ora per la prima vo lt a dopo cinquant'anni erano delle masse e vo lontariamente, non una casta militare e politica, a risugge llare il valore civile e patrio del Vittoriano. Sia pure in omaggio al cardine che tiene insieme oggi la strag ran de maggioranza degli italiani, cioè a quell'articolo 11 de lla Costituzione so lennemen t e posto a discrimine di ogni possibile ricorso alle Forze Armate. Ma posto in maniera contraddittoria, tanto che finisce per essere invocato da fronti contrapposti e per significare, legitt imare o delegittimare cose diverse. Eppure, era ne l vincolo unificante di que l controverso articolo 11 che gli italiani quel giorno e quella notte, in fila nel prestare omaggio ai caduti , hanno celebrato il rito del loro "patriottismo della Costituzione". Che istituzioni e politica trattene ssero il fiato era del tutto comprensibile, consapevol i di quanta machiavelleria vi fosse stata da parte loro nel far dire all'articolo 1 1 o ciò che non afferma - il d iv ieto tassati vo all'util izzo delle Forze Armare tranne che su mandato dell'Onu - oppure ciò che non avrebbe mai potuto di re ai suoi tempi - l ' assenso a m iss ioni di peace enforcing e na ti on building, che all'epoca del costituente nella realtà del diritto e della poli ti ca internazionale ancora non esist evano. Così, che la Chiesa riuscisse a trovare parole più adeguate delle istituzioni politiche, fu ins ieme una fortuna ma anche una conseguenza obbligata. Non era affatto scontato, che gli ita l iani riconoscessero come "propri" martiri i caduti d i un Paese che uf-
ficialmente aveva dichiarato di bandire la guerra, foss'anch e quella per rovesciare un regime tirannico e sanguinario, ingaggiata nel grande scontro mondiale contro il terro ri smo che ha finito però per spaccare l'Occidente.
Eppure, nelle lunghe ore notturne di coda ordinata e muta sul la scalea del Vittoriano, mentre neppure alle 3 di notte quasi nessuno desi steva pur essendo molti gl i a n ziani, l'impressione era diversa . Solo chi conosce "dal di dentro" la comunità militare italiana - il che oggi raglia fuori mo lti ssimi colleghi giornalis ti , purtroppo, avvezzi in l arga parte, a giudizio almeno di chi qui si firma, a giudizi poco professionalmente basati su scarsa conoscenza diretta di uomini e cose in divisapoteva avere occhi per capire, che cosa davvero stesse accadendo quella notte . L'omaggio era reso a un "Paese a parte", rispetto a quello che su.i media a nnunciava compiaciuto il nuovo mito di concord ia naziona le in via di formazione . U n "Paese a parte" formato da diverse decine di migliaia di italian i, co loro che personalmente hanno fatto la scelta dell'Esercito non più di leva, ma professionale e volontariamen t e servono in armi all'estero, e dai loro fa milia ri. È stata questa, per l ' Italia, la novità senza precedenti. Non si è trattato più dell'equipaggio di un velivolo abba ttuto per sventura ne i Balcani, come avvenuto nel 1992 a nord di Z agabr ia e in Bosnia, o delle tre v ittime di un agguato delle milizie di Aid id in Somalia come avvenne nel lugl io 1993, o dei quattro militari periti nella caduta di un AB -205 dell 'Un ifil in L ibano, nell'agosto 1997 . .Nla di un intero reparto di vo lontari colpito dal nuovo nemico interna -

zionale d ell'l l settembre, in una m1ss10ne che molti negano sia davvero quella per cui chi la compie ed è caduto sente di essere andato là . Qualcosa di diverso e di ben peggiore della strage condotta contro i 13 avieri italiani "umanitari" a K indu, nel 1961. A essere precisi, ne l novembre del 2003 non si tr attava solo di una novità nella recente storia ital iana. Era a tutti gl i effetti una novità euro pea, il costo del sangue sparso in così grande numero da parte cli chi ha deciso vo lontariamente di metterlo in conto . Un attonito turista francese, in fila anch'egli al Vittoriano, a chi scrive ammetteva sommessamente quella notte che il suo pur nazionalistissimo Paese sareb be andato probabilmente in crisi, di fronte alla sce l ta di do ve rende re g li onori funebri a così tanti militari caduti non in una guerra tradi zionale, ma contro terrorist i islamisti. Nel cortile d egli lnvalides bruttato dalla memoria dreyfusarda? Al napo leonico Pantheon così poco pacifista? Nelle piazze d'arme delle grandi Éco l e Militaire? Pensateci. I parenti dei caduti tante volte, in quei giorni, si sono schermiti davanti alle domande dei giornalis ti. Non era solo il pudore del dolore. Per chi conosce quel "Paese a parte " che è il mondo militare come in questi anni si è venuto riformando in Italia, si avvertiva netta la distan za tra i loro valori, e chi li interrogava puntando all'aspe tto "privato" dell'eroismo quotidiano del marito o del padre caduto, per tacere della sempre riemergente solfa del giovane meridionale arruolatosi solo per sfuggire alla sordida presa di disoccupazione e camorra. Era spesso un silenz io opposto
in nome cli un'incomprensione etica . Quella di chi nella propria famiglia ha dovuto fare i conti con la scelta di un congiunto che ha abbracciato la vita militare, in un Paese che a questa scelta st oricamente riserva zero status sociale e va ste e sroriche inc omprensioni e pregiudizi, sapendo che in essa vibra qualcosa che certo non evoca nostalgie di vecchie fanfare, rese impossibili dalla tragedia italiana de l fascismo. Ma nien t e ha al contempo a che vedere con chi confonde questo Esercito e queste Forze Arma te con un'armata di panettieri e vo len terosi assis t enti soc iali. È un "Paese a parte", che ha accettato in chiave moderna che gerarchia e disciplina siano la maniera funzionale per affermare valo r i di libertà e democrazia, e che solo obbedendo ci si può sentire responsabili degli uomin i che si hanno al proprio fianco: in combattimento come nella vita. Questo mondo resta incompreso a moltissimi di coloro che in quei giorni hanno creduto di celebrare una nuova riscoperta della patria, la patria dell'articolo 11. È un mondo che conosce bene, invece, chi in quei giorni ha avuto il merito di instradare quel nuovo rito civile su un binario cli dignità e composte zz a. Cioè l'Arma dei carabinieri, cui apparteneva la maggioranza dei caduti . Che molti di loro venissero dai reparti territoria l i dell' Arma, invece che dai battaglioni mobi l i o dei parà, parlava una lingua che g li italiani conoscono bene. Non quella dei carabinieri di Pinocchio: ma di chi ha scelto di ser vire in armi. E va a onore di codesto "Paese a parte", il fatto che il più in alto in grado a cadere, il capitano Ficuciello, fosse il figlio di uno dei più alti vertici della classe dirigen -

te mil itare. Era ed è un esempio frequente, il sacrificio estremo e personale, nel re s t o della classe dirigente italiana? QuantO contraddice la retorica massmediologica dell 'a rmata dei panettieri, il caporale dei lagunari Matteo Vanzan che cadrà vittima cli in un colpo cli mortaio a Nassiryah negli scontri cli metà maggio 2004, lui che figlio di infermieri aveva servito prima come vigile del fuoco, per po i abbracciare con convinzione la carriera delle arm i e salutare gl.i amici afferma ndo che "per capire e aiutare l'Iraq bisogna essere lì "? Un "Paese a parte", quello che ha celebrato composto il suo rito . Una classe dirigente seria si porrebbe il problema di non perdere il conta tto con questa minoranza di c ittadi ni preparati, concre t i, solidi e inclispensa bili . Per la patria ritrovata, c'è una lingua ciel dovere da riscoprire, spesso o sempre sconosciuta sulle bocche dei predicatori di diritti. Purtroppo, il bilancio da trarre è che poli ti ca e med ia ci hanno messo del bello e ciel buono, dopo 1 ' 11 settembre, per disperdere a lm eno in parre lo spirito di concordia nazionale che da vent'anni a questa parte si stava lentamente creando in Ita l ia intorno alla scelta di partecipare in armi a un numero crescente di missioni internazionali, ben 23 nel so lo 2004 con oltre 9mila uomini impegnati. Nel capitolo che Gian Enrico Rusconi dedica a Guerra e intervento umanitario, a conclusione ciel diciottesimo volume degli Annali della Storia d'Italia, Einaudi, dedicato appunto a "Guerra e Pac e", lo studioso avanza considerazioni non diverse da quelle che saranno più recentemente svi luppat e da walter Barberis nel suo Voglia di Patria . La natura stessa delle Ootw (Operations

Other Than War), in cui si articola o dich ia ra di articolarsi la maggior parte degli interventi "umanitari" di peacemaking , peacekeeping, peaceenfo rcin g e peacebuilding, ha subito in questi anni una torsio ne inevi ta bile, imposta d all'11 settembre . È a quel quadrilatero, però, che il Capo dello Stato ha vincolato in ques ti anni, anche attraverso delibere formali de l Consiglio Supremo di Difes a fatte proprie da l governo Berlusconi, la possibili t à dell' int ervento in armi italia n o, e sempre dietro manda t o mu ltil aterale, Onu o quanto meno Nato Ma qu esti stess i mandati hanno conosciuto, a propria volta, torsioni sempre più marcate, subito dopo l'l l settembre e la dottrina di difesa preventiva emanata da George Bush. L'iniziativa americana contro l ' Afghanistan santuario qaedista era ancora in grado di s u scitare un ampio consenso, moti vo per il quale la Na to è in Afghanistan, Germania e Francia comprese. Non così quella contro Saddam Hussein, il "fronte del no" ha considerato privo di mandato Iraq i Freedom - malgrado le "gravi conseguenze" esplicitame nte add itate dall'Onu al regim e di Bagdad se no n si dec id eva infine a interrompere 12 anni di persistenti violazioni delle risoluzioni del Palazzo di Ve tro - e senza che per questo l'Onu si ritraesse po i dal riconoscere forma lmente all'autor it à provvisoria della coalizione e alle sue Forze Armate occ upa nti l 'Iraq lo status di "strumento necessario e riconosciuto", per realizzare, entro t empi stabi l iti e rapidi, la transi z ione verso il pieno autogoverno del Paese.
La crescente p olarizzazione della vita politica ira -
liana ha aggiunto di suo a ll e d iff icolt à d e l quadro internazionale di fronte al la d ete rminazione americana e della "coa lir io n of th e will ing " . Per conseg u en za s i è ven ut o purtropp o a infran ge re quel progressivo processo di co n vergenza biparrisan c he negli a nn i novanta si era sper im entato, in ordine a lle missioni internazionali in cui s i impeg n avano a rmi ita liane. E c he aveva conosciuto la sua ve tta più a lta n ell' atti vazi one del Co nsi g lio Atlantico per l'a tta cc o all a Ser bia, nell' aut unnoin verno 1 99 8-1 999, e nella successiva m a rtell a nte c a mpa gn a aerea co ntr o gli obiettivi ser bi che porrò alla caduta d e l regime di Slobodan Milo sevi c. Una guerr a s enz a N azio ni Unire, v isto ch e la risoluzione del 23 settemb re 1998 de l C onsi g lio di Sic urez za si limita va ad affe rma re che, in caso le su e rac comandazioni volte a far ce ssar e l e violenz e in Kossovo fo ssero s tat e disattese da lle autor ità serbe, sarebbero s ta t e prese "m is ure a gg iunti ve" : una formula a ssa i più blanda e vaga di q u ella us ata ne ll 'ultim a risolu:lion e contro Saddam, in b ase alla qu ale Stati Uniti e alleaci misero in atto Iraqi Freedom. Come scrive Rusconi e la m ag gior parte dell a pubblici sti ca più eq uanime in m a teri a, la circosta nza che il gov e rno itali a no fosse nel 1999 g uid a to d a un leader die ss ino come l 'o no revole Ma ss imo D'Ale ma rese impen sabile il tirarsi indietro, sar e bbe s ta t o co m e un p e rcorrere a ritroso la lunga v ia ci e l pieno e leale riconosc im e nto della Nato, che la for za pr evalente della s ini str a it a lian a av eva ini z iat o a imboc ca re lentamente 20 anni prima . Di consegu e nza, in que l co nfl itto pur per tanti ver si controverso -e che es ce let teralmente "demo li ro" in rec e n ti r ico -
srruzio ni e bil a nci p ol iti co-m ilitari - le forze aeree itali ane co operarono dir e ttam ente a colpire gli obiettivi serbi , se nz a sottrarsi a lle stesse m is sion i di b o mbardamento. E senza che n e l Paese si produc ess er o dissensi, se n on dell a sinis tra es tren1a e dell' a la più militant e del pacifismo no glo bal. L'allontaname nto tra ma ggior a nza e opposizione non è avvenuto in quest i anni in un so lo colpo, ma ha conosciuto un andam e nto a ltalenant e, in c ui inevit a bilm e nte gl i svi lup pi int ernazio nali , le reazioni dell'opin ione pubbli ca ita l iana, il tono e gli argome nti del di ba ttit o svoltosi sui me di a e la dial e ttic a interna al ce ntro-sini s tra hanno gio ca to ciascuno un ruolo distinto e concorrente Non sempre n e lla stessa direzione: que s to va ri conosciuto . Ed è an zi di qui che un a classe diri ge nte responsabi le do vrà ripar t ir e, per torn a re au s pic a bilmente a realizzare po liti c he d ell a di fe sa e dell a sicur ez za naz ionale non incrinate dal lo scontro mur o cont ro muro, il cui ris c hio è di appannare conse nso e sos tegno d eg l i italiani verso le F o rz e Armate, e di indebolire il Paese nella su a co es ione a ll e minacc e, nell e su e a lleanze e sce lte di fondo. Nei dibatti ti pa rl a ment a ri del n o vembre 2001, rel ativ i a lla partecipazione d a lle operazioni in Afghanis t an, la co n vergen za riu scì ancora, sia pur e s u mozioni separate, ma con il vo to di un dispositivo comune verso il qu a le si app untav a no gli stra li solo di po co pi ù di 20 parl amenta ri dell'estrema s inistra e di orga ni co m e "Il Manifes to " . Nell'ottobre 2002, la pressione c resc e nte dell a compon e nte pac i fi s ta otte n eva l' e ffetto di far dividere i partiti dell 'U li vo, sull'invio degl i alp ini in Afghanis t an, in b e n quattro mozioni, al le

quali si aggiungeva anche que lla di Rifonda zione comunis t a . Con J\tlargherita, Sd i e Udeur, favorevo li all'invio degli alpini, e i Ds contrari, perché l 'utilizzo dei so ld ati italiani veniva giudicato nell 'ambito di Endur ing Freedom e non della miss ione l saf sotto l'egida dell'Onu . Era u n voto che avveniva dopo la manifestazione di piazza San Giovanni: quella dei cosiddetti girotond i, in cui veniva espresso un forte richiamo al centro -sinistra a riservare l 'opposizione più decisa possibi le al governo Berlusconi, ri lanciando con il pieno sostegno della Cgi l un pacifismo senza aggettivi né confini. A dettare l'evoluzione seguente fu la preoccupazione dei Ds, e con il crescere della pressione americana in vista di Iraqi Freedom anche di settori via via più estesi della Margherita, di non perdere i contatti con quella piazza . Nel febbraio 2003, mentre si consumavano gli u lti mi sforzi alle Nazion i Un it e per una nuova risoluz ione p er confermare la piena legi tt imità delle intimazioni a Saddam Hussein già comprese nelle 12 precedenti, l 'Ul ivo trovò una travag l ia ti ssima unità ne l no a qua lunque coinvolgimento ita l iano, compreso il divieto di sorvolo e a prestare basi allo sforzo alleato . E il 19 marzo , quando ormai si era alla vigilia delle operazioni militari in Iraq, il Capo dello Stato volle assumere l'iniziativa di un Consiglio Supremo di Difesa d es t inato a porre palett i invalicabili. "Nessun soldato italiano è andato in Iraq, e ne ss uno ci andrà" - dichiarerà allora Ciampi, con parole destinate a essergl i in seguito rimproverate dalla parte pacifista - il nos tro è un Pa ese "non bel l igerante, anche se - come ha osservato il ministro degli es t eri Franco
Frattini due giorni fa in Parlamento - non per questo si può considerare neutrale" . I "paletti " indicati dal Consigl io Supremo di Difesa ne l dare ufficialità a una controversa le ttu ra dell'articolo 11 della Costituzione, in assenza di una nuova de l ibera Onu che era però mancata ai t empi delle az ioni contro la Serbia, prevedevano " l'e sclusione della fornitura e della messa a disposizione di armamenti e mezzi militari di qualsiasi t ipo", e dell'uso di strutture m i litari "quali basi di attacco dire tto a obiettivi iracheni " Le basi andavano utilizzate solo "per le esigenze di transito, di riforn imento e di manutenzione d ei mezzi". Ma intanto da Vicenza partiva la 173a aerobrigata americana, e c'era da chiedersi quanta coerenza ci fosse, tra il dire e il fare .
Dall'estate 2003 in avanti, di fronte all'impegno italia no nella missione Antica Babilonia ne l quadro dichiarato del sostegno umanitario alla ricostruzione e t ransizione irachena che nel tempo troverà la conferma di ripetute r iso luzioni dell'Onu, il centro -sinistra confermerà il suo giudizio negativo attestan dosi sulla s ucc essiva ricerca di necessarie "svolte" , prima di un più im mediato coinvo lgimento delle Nazion i Unite e dell'ind icaz ione di una data precisa e immediata della consegna dell'autorità civile dalla Cpa a un governo iracheno e del passaggio dalle forze alleate a un contingente dell'Onu della stabilizzazione militare, e via via che le riso l uzioni dell'Onu accoglievano l'accelerazione della transi zione po l itica voluta in primìs da Washington - ma senza per questo adottare lo schema di una forza militare d i caschi blu - sli t tando di vo lt a in volta alla ricerca di

sempre più ava nzar e "svo lte", sino all'invocazione di una non meglio precis ata "iniziativa eu ropea" nell'est ate 20 04 .
11 di ssenso su lraqi Freed o m aveva assumo nel fratt em po il carattere di un discrimine politico mondiale n ei confronti de ll' amministrazione
Bu sh A m aggior r ag ion e di fronte all ' incrudiment o degli a ttacchi terrori s tici in Iraq a lle forz e dell a coalizio ne, a co min cia re dall'aprile 2004, quando il calendario della transizione er a venuto a pr ec isarsi e la Cpa guidata d a Paul Breme r avrebbe in poche se ttiman e lasci aro la mano al governo All a wi e al processo destin at o a sfoc iar e in un triplo passaggio elettora l e entro du e anni Ciò ha defini t ivamente impedito il recup ero di ogni prospettiva bip a rtisan s ull' impiego del conting ente ita l iano in Antica Babilo nia . Ma, da un altro punto di vista , sarebbe un grave errore sottovalut a re le reazioni prodottesi nell'ambito di quali fica ti se rrori dell'opposizione a seguito d e i più grav i epis odi ch e hanno caratte rizzato l'azione mil itar e ita lian a. All'indomani de lla strage di Nassiryah, l 'o norevo le M ass imo D ' Alem a fu il prim o - se g u ito d a F rancesco Rut e ll i, Romano Prod i, e Piero Fassi no - a riconoscere che "non era il momento di chie der e il ritiro " , di fronte all'att acco terr oris tic o contro trupp e italian e le cui rego le d ' ing agg io erano stare ferreamente mantenute co erenti al la minima reazione necessaria per respin g ere minacce, e che avevano a nche opposto dini eg hi a interv enti so llecitati dall e forze sta tunitensi. Posiz ioni assunte a costo di app rofondire l e diver ge nze n e ll'opp os izion e rispetto alle parei più es treme, ma rese megl io possibili nel frattempo
dal "rientr o" dell a minacc ia es erc itata nell'anno prec ede nte d a l l'ini ziat iva di p iazza assuma da girotondini e Cgi l. Margherita e D s, le forze maggioritarie d el centro-sinistra, son o g iunt e a contrattare una sos t an z ia le as se nza d a lle pia zze nell e man i festazioni pa cifis te, che hanno co ntr assegnato la campagna ele ttoral e amminis t rativ a dell a prim ave ra 200 4, comando s ul fatto di non aver e più co nvenie nza alla replica di episo di precedenti, che erano culminati n ell '"es pul s ionc " del segret a rio D s da un co rt eo pacifista monopolizzato da p os izioni più estreme .
Analoga m ode raz ione da par t e della leadership dell' o pposi zio ne e frattura intern a nei con fronti dell e frang e più radica li e an tago niste si è verificata a nche in occa s ione d eg li episo di di più ri levante imp egno b e lli co delle forze italiane, quando fatt e segno di attacchi o qu an do c hiamat e a ripristina re le condizioni di controllo delle aree assegnat e Come in occasio n e della cosiddett a " battag lia dei du e po nti " de l 6 aprile 2004 a Nassryah. In que ll'o ccasione so lo le frange più es treme hann o espress o e manifestato esplicita condanna d e ll'op erato de ll e forze itali a ne, e sca rsissimo segu ito hanno ottenuto iniziative come que ll a d ell'espos to in seguito presen tato da alcuni parlam ent ari e gi uristi "democratici" al Procurat o re d ell a Repubb lic a presso il Tribunale Penale Militare di R oma , p er viola i io n e da parte del conti ngente italiano dell a IV Co nvenzione di Ginevra del 12 agosto 1949. A maggior r ag ione il fenomeno s i è dete rminato di fronte all e vi tt im e civili italian e del t errorismo iracheno, F abri zio Quattrocc hi ed Enzo Baldo ni. In occasion e di qu est' ulti ma vicenda, per i l profi -

lo personale fortemente "uma nitario" del g iorn alista freelance sequestrato e ucciso, destinato fatalmente a colpire magg iormente i mmaginario e pubb licistica dell'opposiz ione o a essa v icin a, non hanno mancato di tornare a levarsi voc i significative nel "fron te del no", affermando esplicitamente che la presenza italiana anela va ormai considerata come ut ile e positiva nell'ambito di una trans izione irachena ormai avviata, e volta a impedire che il Paese cada sotto il controllo di minoranze nostalgiche baathiste o di fanatismi rel igiosi "tagliatori di test e ". Da Gianfranco Pasquino a Riccardo Barenghi del "Manifesto" , fino a Piero F assino sia pur sotto la formula più prudente di una "globalizzazio ne dei diritti" di fronte alla violenza t erroris tica. In ogni caso, la parte maggioritaria dell'oppos izion e ha evi tato con sempre maggior accorte z za g iudi zi negativi nei confronti delle fo rze militari italiane . Neppure di fronte all'app ello e al sostegno diretto r icercato e ottenuto eia parte del governo francese ne i confronti di organizzazioni come Hamas, Hezbollah e di esponenti della lotta armata irachena come Moqtada Sadr, in occasione del sequestro di due giornalisti tra nsalp ini, la leadership de ll'opposizion e italiana ha rimproverato alle autorità naz ionali politiche e mili t ari di non aver assunto iniz iative cons i mili, a segui t o dei sequestri di ostaggi italiani. In ogni caso, anche la più equanime disamina del l ' intervento militare italiano in Afghan istan e Iraq ci lascia i n eredità almeno cinque seri problemi irrisolti.
Il primo è che la "guerra al t errorismo" non ha retto alla prova d el già di suo troppo parossistico
confronto civile e po litico del la recente fase della vita pubblica ital iana E ciò r appresenterà inevitabilmente un problema p er la perce z ione che gli italiani hanno e avranno d elle For ze Armate .
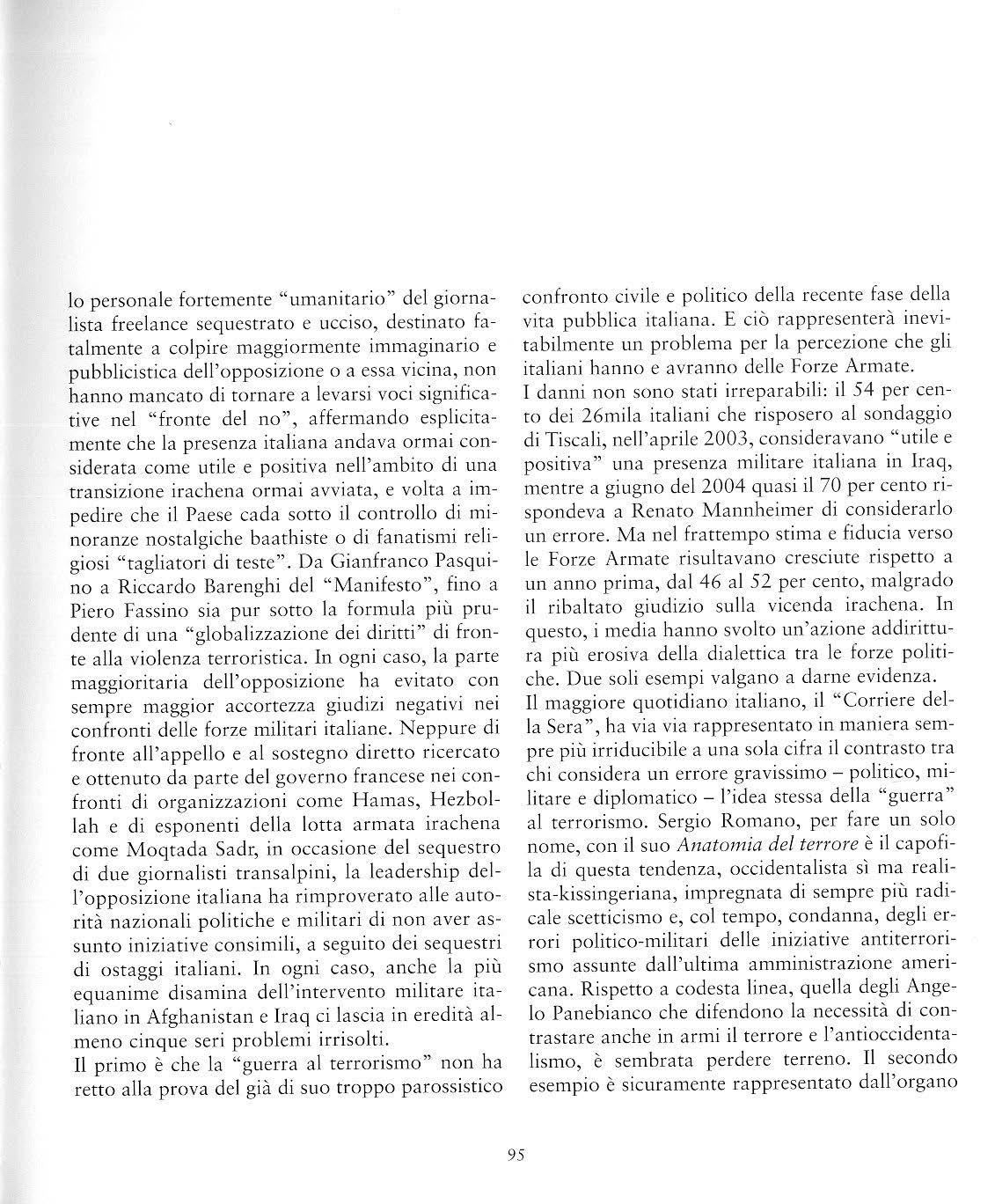
I danni non sono stati irreparabil i: il 54 per cento dei 26mila ita liani che risposero al sondaggio di Tiscali, nell'apri le 2003, consid erav ano "utile e positiva " una presenza militare italiana in Ir a q, men tre a giugno del 2004 quasi il 70 per cento rispondeva a Renato Mannheimer di considerarlo un errore . Ma nel frattempo stima e fiduc ia verso le For ze Armate risu ltavano c re sciute rispetto a un anno prima, dal 46 al 52 per cento, malgrado il ribaltato g iudizio sulla vicenda ira chena. In questo, i med ia hanno svo lto un'a zi one addi rittura p iù erosi va della dialettica tra le forze poli tiche. Due soli esempi valgano a darne evidenza .
Il maggiore quotidiano italiano, il "Corriere della Sera", ha via via rappresentato in maniera sempre più irriducibile a una sola cifra il contrasto tra chi considera un errore gravissimo - politico, militare e diploma ti co - l' idea stessa della "guerra" al te rro rismo. Sergio Romano, per fare un solo nome, con il suo Anatomia del terrore è il capofila di questa tendenza, occidentalis ta sì ma realista - kissingeriana, impregnata di sempre più radicale scetticismo e, col tempo, condanna, degli errori politico- militari delle ini ziat ive antiterrorismo assunte dall'ultima amministrazione americana. Rispetto a codesta linea, quella degli A ngelo Panebianco che difendono la necessità di contrastare anche in arm i il terrore e l' antioccidental ismo, è sembrata perd ere terreno. Il secondo esempio è s icuramente rappresentato dall ' organo
d ' informazione leader, nell'orientamento delle opinioni della sinistra italiana. "Repubblica", più attraverso i ricorrenti interventi del suo fondatore Eugenio Sca l fari che del suo attuale direttore, si è assunta il ruolo cli richiamare sistematicamente il centro -sinistra a posizioni più estreme, quanto a contrarietà dell'uso dello strumento militare, non di rado po lemizzando con la stessa leadership più moderata della sinistra. Ogniqualvolta Scalfari ha chiesto a un Giuliano Amato di turno, dubbioso dell'utilità di continuare a chiedere il ritiro italiano dall'Iraq, se fosse "disposto a seguire l 'America anche all'inferno", ha picchiato eforo e ha lascia to il segno . Il secondo problema è che le necessità della politica - "esserc i sui teatri operativi ma rischiando i l meno possibile" - hanno inevitabilmente esposto Esercito e Forze Armate italiane a direttive di comunicazione pubblica subottimali. I nostri media per conseguenza non hanno coperto in modo minimamente soddisfacente le operazioni militari italiane di bonifica condotte in aree afghane molto a rischio e operativamente impeg native al confine afghano - pachistano. E guanto alla già citata "battaglia dei due ponti" a Nassryah, le prime ricostruzioni degli ufficial i italiani - comprensibilmente improntate a mani festa soddisfazione per la prova eccellente fornita dai propri uomini, in condizioni d'impegno estreme e senza l 'ap poggio di mezzi pesanti e di proprio Cas (Close Airsupporr) aeroterrestre - risultano essere s tate immediat amente "silenziate", al fine di evitare ripercussioni negative di sta mpa. Con quanta frustrazione e conseguenti interrogativi nella testa dei
militari italiani impegnati, è appena i l caso di chiederselo .
Il te rzo problema è che inevitabilmente da tutto ciò discenderanno conseguenze tang ibili per il futuro stesso dello strumento mi li.tare nazionale. Chi conosce la realtà vera della pianificazione politico-militare italiana sa che a oggi non esistono realmente come identificate, reperite e imp egna te le risorse necessarie a rendere operativo l'adottato modello di difesa b asato su 190mila professioni sti. In teoria tale modello ipoti zza, ma sarebbe meglio dire ipotizzava, in 18mila unità l'aliquota mili tare italiana proiettabile in concomitanti missioni internazionali. Il doppio delle forze attuali, quei 9mila uomi ni che hanno comportato oltre un miliardo cli euro di spesa nel 2003, e il logorio oltre mis ura di equipaggiamenti e dotazioni già a volte giunti al limite e privi di rimpiazzo È una prospettiva irrealistica, così non si può continuare .
Il quarto problema è la carenza storica di una sensibilità e cultura specifica, nella comprensione e comunicazione del "military affair" italiano . Si comprende bene che ogni Paese è figlio d ella propria storia, noi non abbiamo grandi e affermati storici specialisti di dottrine e questioni militari come i John Keegan, i Victor Davicl Hanson o i Michael O'Han lon, chiamati dai direttori dei quotidiani anglosassoni ad aprire serissimi dibattiti a ogni Spending Review della Di fesa, ma forse è giunto il momento che sia la stessa Di fesa italiana, a volere e a do vere contribuire a una più seria preparazione di chi sui media è incaricaro di affrontare tali argomenti .
Il quinto problema, infine, affonda le sue radici

nell'idea stessa di Occidente. Quando Annie Vieira De Mello, la vedova de] capomisisone dell'Onu ucciso in un attentato dinamitardo a Bagdad, ha detto dei caduti di Nassiryah "so che i ragazzi it aliani uccisi erano tutti volontari, sono cer t a che i loro cari sapessero quan t o loro stessi volevano partecipare a una ca usa per la libertà"; quando Jud ee e Ruth Pearl, i genitori del giornalista americano ucciso dai fondamentalisti, hanno dichiaratO "rendiamo onore ai militari italiani per non essersi piegati al ricatto dei terroristi"; in Italia non hanno avuto eco.
Può essere che l'Am erica cambi direzione e che
l' Europa continui a stenta re a lungo nel trovarne una sua , ma ormai chi porta la divisa per un bel po' di ann i non avrà il sostegno che si merita se non si faranno i conti con quanto afferma il rabbino Shalom Hartman di Gerusalemme. L'Occidente è chiamato a capire, a spiega re etalora anche a imporre che Dio parla l'arabo il venerdì, l 'ebraico il sabato, il latino la domenica, la babele delle lingue tutti gli altri giorni; ma non c'è tota l itarismo etno -religioso che tenga se pensa che tagliare le gole a casa propria sia un diritto più sacro dell ' uso dell'arma atomica ieri, e degli arsena li di distruzione di massa oggi .

La missione militare ita l iana in Iraq ha gli occhi azz urri di Silvia, l a lagunare . Sorridono qu ando un bambino per strada le chiede dell'acqua, "wat er, please, water". Scrutano l 'a utomobile c he si affianca lentamen t e al suo mezzo blindato, ma po i lo sorpassa . Si bagnano di lacrime quando qualcuno le chiede del suo mig liore amico, Ma tte o Vanzan, ucciso mentre difendeva la base Libeccio . Ecco : la vog l ia di dare una mano a un popo lo che ha bisogno di tutto, la determinazione nell'affrontare una minaccia sempre stri sciante, il ricor d o commosso di qu elli che ci ha nn o rimesso la pe l le, "perché se noi stiamo qui lo facciamo anche per loro " . Tutto questo dicono gli occhi azzurri di Sil via , l a lagunare, in pattuglia nelle strade polverose di Nassiryah . E gli altri? Gl i altri t remila? Genera li zzare, lo dicono tutti, è sempre rischioso, e se anche le u niformi so n o le stesse, d entro ci sono persone ogn u na con una sua storia, proprie idee , sensibi l ità diverse Ma se ti capita di viverci gomito a go m ito per un mese - condi videndo tende, mensa e missioni - alla fine l'idea che ti fa i è che questo modo di sentire e d i pensare - quello di Silvia - sia comunque diffuso nel contingente . E non solo in Iraq, ma in A fgha nistan e ne i Balca ni e nel Sinai e dovunque nel mondo sono ogni gio rno in azione quasi d iecimila militari italiani. La circos t a nza non deve stupire . "Se l o faccio è perché sono convinto", c i spiegava qualche tempo fa un u ffici ale di Mari na, a bordo di una nave nel Mar A r abi c o . E una buona indennità di mi ssione, probabilmente, da sola non spiega la ragio ne per cu i siano sempre tanti i vo lo ntari che si candidano a partecipare alle varie
missioni. Soprattutto quelle in cui non è a ffatto scontato tornare a casa senza u n graffio. C'è dell'a lt ro, dunque. Che cosa? Alcune storie dai var i " t eatri" d'operazione possono aiutare a scop rirl o . Una di queste è una storia di cani. Di cani e di mine. Alla fine d el marzo 2003 ho viaggiato con Ge in, Baks, Mapi e Megan su un C - 130 dell'Aeronautica Militare diretto in Afg hanistan Poco più di un anno dopo li ho incontrat i di nuovo in Iraq. I cani antim ine e antiesp lo sivo, una novità dell'Esercito, sperimenta t i in Koso vo, hanno avuto il battesimo d el fuoco proprio a Khost, in Afgha ni stan : un Paese d ove g li ordigni inesplosi sparsi dovunque sono 7 m i lioni, forse di più U n militare ci mostra il manualetto in dotazione a tutti i so ldat i italiani in Afghanistan: ci sono 31 fo to a colori con i più frequenti tipi di mine che potrebbero insidiare la loro mi ssione . Min e anticarro e ant iuomo, quest'ulti m e tarat e quasi sempre per esp lo dere anche sotto il peso leggero di u n ragazzino Mine a frammentazione, mine a trazione, a pressione, a impulso elettrico, d i tutte le forme e le dimensioni . E poi le trappole esplosive, ancora più insidiose perc h é frutto della fantasia di chi le proge t ta e poi le rea lizza . Il repertorio è cinico e vario : dalle scato le di scarpe alle bambole esp lo sive. Certo, per gli sminatori del contingente italiano e i loro cani il lavoro non è mancato . E si sono sempre fatti valere. Lo stesso sta succedendo in Iraq .
"Qui il caldo è il loro vero nemi co", ci spiega uno de g l i is tru t to r i, il maresciallo Andrea Lombardi, un rise rv ista . " L'unico stru mento ch e i ca ni hanno è l ' olfatto. Dunque: naso aperto e bocca chiusa.

Ma sopra i 40 gradi (quando in estate a Nassiryah la massima supera i 60 - ndr) è impossibile lav orare in apnea Per questo escono solo di sera, o la ma t tina di buon'ora" . E infatti so no da poco passate le 8 di una torri d a giornata di luglio quando Bali, uno stupendo pastore tedesco, setaccia un campo infestato da cluster bombs - bombe a frammentazione, una delle quali solo tre giorni prima ha dilaniato una ragazzina - risalenti alla prima guerra del Go lfo. Alla fine, graz ie anche a Bali, l'area viene completamente bonifica t a. "Un cane di tre anni, con questo livello di addestramentospiega Lombar di - vale sul mercato 40.000 doll ari circa. Le organizzazioni non governative che si occupano di bonifica umanitaria lo acqu isterebbero anc h e domani, e g li frut t erebbe 15.000 dollari al mese . Ma anche i conduttori dei cani, come del resto tutti gli sminatori, sono merce pregiata" . Insomma, se proprio si decide di andare in giro a togliere mine, ci sono modi mo lto remunerativi per farlo . E i genieri ita liani qu es to lo sanno, anch e se si os ti nano a indossare la loro m imetica . Un'a ltra storia istrutt iva è quella dei carri armati di Nassiryah. Gli Ariete alla fine hanno raggiunto l' Iraq dopo aver lasciato in Italia una scia di pol em iche , "perché la pace non si fa con i cannoni da 120 millimetri". Ma i "guerrieri" che pilo t ano questi mostri da 53 tonnellate - sorprende scopri rl o - sono i pr i mi a sperare che non vengano usati .
A Camp Mittica, i l quartier generale ita l iano, i carristi saltano all'occhio per la tuta ver de ignifuga che indossano al posto d ella normale uniforme . E perché t rascorrono l ' intera giornata, in un
settore defilato d ell'accam p amento, amoreggiando - non saranno certo loro a obiettare sul verbo - con i loro " te rr ibili" carri armati Li tirano a lucido, c i gi r ano intorno, ci salgono su e li mettono in moto, oppure se mp l icemente li guardano . Non se ne sono mai separati, viaggian do semp re con loro: dal porto di Monfalcone, dove sono stati imbarca ti per il Kuwait, a Nassiryah. È la prima volta che gli Arie t e escono dall'Italia per una missione e l'onere è toccato al 32" Reggimento cli Tauriano (Udi ne ), 3 ° battag lione, 1° compagnia . Si chiama "Leoni di Bard ia", in memoria della battaglia in Africa settentrionale in cui 13 carri, e i l oro equi paggi, furono annientati durante l a seconda guerra mondiale. Li comandava il tenente Cas t ellano e uno degli Ariete cli Nassiryah porta que l nome. Un a lt ro t en ente, Lorenzo Nlangia, 26 anni, di Lecce, ha la responsabi l ità de l plotone spedito in Iraq. Non è, non se mbr a , un guerrafondaio Come tutti certo è attaccato al suo mezzo, ne descrive entusiasta le qua lità come se fosse la macchina che ha appena comprato (e infatti lo definisce " la Ferrari dei carri armati") e si ve d e che av rebbe voglia a n che adesso cli mettersi ai comandi e fare u n giretto. "Ma la mia sp era nzadice - è che non ci sia mai la necessità d'impi egare l ' Ariete e che tutto vada avan ti cosi', in modo tranquillo. Anche perché ques t o vorrebbe dir e che l'obiettivo della nostra m issione, che è una mission e cli pa ce, si sta rea lizz ando" E allora perché portarli fin qui? "L'Ariete è enorme e incute paura . Spesso basta questo per far scappare i ca tt ivi", ipotizza il t enente . Morale della storia : i soldati it al iani non vanno dov e si spara perc hé sma-

niosi di fare a ltrett anto. Non i Leoni di Bardia. Epp ure con i " cattivi", come li chiama il carrista, prima o poi i conti bisogna farli . E non è mai detto che la partita sia chiusa una volta per tutte . Lo dimostra quello che è successo in Kosovo, una regione secondo molti "pacificata", dove l'odio etnico è riesploso all'improvviso dopo che la guerra era finita da 5 anni , la sciando sul terr eno decine d i morti e feriti. L'ord ine è stato riportato soprattutto grazie ai militari italiani della K-for, che da qu ei giorni, anche loro, dormono sonni meno tranquilli. E tranquilli non lo sono mai stati per gli alpini e i parà che si sono avvicendati a Khost, in Afghan ist an: "La missione più p ericolosa dal dopoguerra", ha sempre detto il ministro della Difesa, Ant onio Martino . E infat t i gli agguati alle pattuglie e i tiri di mortaio contro la base Sal erno sono stati un incubo quotidiano Solo qualche feri t o, per fortuna. Niente rispetto al drammatico bilancio di Nassiryah. Qu esti i discorsi che facevamo con Devis, sergente della task force "Serenissima", quando i l Vcc dell'Esercito si blocca impro vv isamente proprio a due passi da Animai Hous e, il rudere della base dei carabinieri distrutta nella strag e d el 12 novembre . "Non è niente, so lo un con tro llo", tranquillizza Devis, il caposquadra. E infatti la pattuglia poco dopo riparte. N on sono giorn i facili a Nassiryah. L'uccisione di Vanzan è un ricordo recente e in città vengono ancora segnalate possibili sacc he di miliziani. È stata una settimana di fuoco con attacchi ai convogli umanitari, esplosioni di autobomba, spari contro gli elicotteri del contingente. Tutto questo mentre gli organismi cli intelligence ri -

lanciano allarmi di tutti i tipi: dal kamikaze telecomandato ai guerriglieri provenienti da fuori, addirittura dalla Cecenia, proprio per colpire i soldati italiani . In questo clima, alla pattuglia dei lagunari tocca oggi ripercorrere le strade della battaglia di metà maggio. Era lo stesso mezzo, lo stesso equipaggio. "Sentivamo le pallotto le sopra la testa che facevano "ding", rimbalzando su l Vcc", ricorda Devis, il sergente. "Abbiano sparato migliaia cli colpi e non c'era tempo nemmeno a ricaricare le armi. Era il primo giorno, eravamo appena arrivati, e siamo andati avanti cosi', senza fermarci, per ore. E poi il giorno dopo, lo stesso. Mi sono chiesto se ero capitato all ' inferno". Il fuciliere che gli sta accan to sembra non ascoltare. Di tanto in t anto pulisce dalla polvere - o forse accarezza - il Beretta 70/90 che tiene appoggiato sui sacchetti di sabbia sistemati intorno al mezz o blindato. In piedi sopra un sedile controlla la situazione.
"Vede i fori su quella parete? Sono i colpi che abbiamo sparato", dice Devis, improvvisato cicerone su l terreno della battaglia . Ma oggi il clima è "dec isamente d iverso" : neppure un sasso contro gli italiani, e i bambini fanno cia o con la mano. Ma non tutt e le facce che si girano allo sferragliare dei cingolati sono amichevoli.
C'è una regione, come il Kosovo, dove la fede relig iosa è anche radice di un'identi t à naziona le e la distruzione dei monasteri serbi o delle moschee albanesi diventa essa stessa espressione d i un odio etnico ancora feroce. C'è un Paese, come l'Iraq, dove i resti d ell 'antichissima civiltà sumerica e mesopo tami ca con tinuano a essere saccheggiati
da bande di predoni manovrati da traffica nt i int ernazionali o, forse, dalla guerriglia. In entrambi i casi i militari italiani sono intervenuti, e ancora oggi lo fanno, p er cercare di contrastare un crimine - la distruzione delle opere d'arte - che offende non so lo g li abitanti di quelle terre, ma tutta l 'umani tà.
In Kosovo, vic ino a Pec, il monastero di Decani è sopravvissuto alla guerra e all e tensioni che anche di rec ente sono riemerse solo grazie alle costante protezione dell'Esercito Italiano. Qu ello di Decani non è solo un momumento di enorme pregio storico e artistico, costruito nel 1327, con degli affresch i che "in alcun e loro parti - ha detto Vittorio Sgarbi - ricordano Giotto" . È anche un simbolo religioso, perché dal Xlll secolo è la sede dell'ortodossia serba in una provi n cia oggi a stragrande maggioranza a lbanese . Da parte dei monaci, dunque, è un continuo appello agli italiani a non lasc iarli indifesi: "Non anda re via. Se ve ne andrete ci ammazzeranno e distruggeranno tutte le nostre chiese", ripete padr e Sava J anic . Il timore è che la riduzione delle forze della Nato nei Balcani possa lasciare sguarnito questo e a ltri s iti ortodossi, come il patriarcato di Pec, fin dal 1999 presidiati dalle blindo italiane. "Siete soldati per la pace e per l'arte", ha detto di recente l'ex presidente della Repubbl ica, Fran cesco Cossiga, che li è andati a trovare. Soldati che in più occasioni hanno rischiato la pelle per sottrarre alla furia etnica questi p ezzi di Storia. Uno che lo fa volentier i - perché la storia dell'arte è una sua grande passione - è il capitano Marco Briganti: pilota di elicottero dell'Esercito ha " la fortuna" (sono pa-
role su e) di essere uno di quelli, insieme a i colleghi cieli' Aeronautica, che si occupano delle non sempre tranquille mission i aeree di ricognizione sui circa 800 siti di interesse archeologico dell a prov incia irachena affidata al controllo degli italiani, la terra di Abramo e di Ur dei Caldei. L'archeologo pres taro all'Esercito, che ha la tenda pi ena di libri sulla sroria e l'art e della Mesopotamia, sorvola oggi il si to di Tel Yukhan, a nord , uno dei più importan ti. Come era facile prevedere, c'è folla. Alla vista dell'elicottero u na trentina di person e si danno alla fuga su tre pick up . Ci sono anche donn e e bambini: sono piccoli, e si infilano meglio nei buchi.
Compito dei soldati italiani (che per quest 'attività si sono guadagnati anche un ampio servizio sulle prestigiose pagine del "New York Times") è cli dare una mano al le poche e disarmate guardie archeologiche local i affinch é non proprio tutto vada saccheggiato e perduto. Trasportati dagli elicotteri, i carabinieri del comando Tutela pa trimonio culturale e quelli del Reggimento Tuscania hanno già ar re stato una cinquantina di tombaroli: per lo più poveracci, che p er quattro soldi devastano le necropo li , con l'aiuto di mogli e figli. Ma quello che è più importante è che proprio da ques ti fermi, e da una complessa attiv ità inv estigativa e di intelligence, i militari cieli ' Arma sono forse arrivati a individuare alcuni dei veri boss del traffico, le menti, i mandanti P ers one "influenti", in contatto con s t ranieri attivi in alcuni Paesi confinanti, incaricati di vendere la merce al migliore acquirente, soprattutto su Internet. È in questo modo che moltissimi beni di grande valo -

re hanno già raggiunto gl i Sta r i Unit i e vari Paesi europei, Italia compresa. A casa di uno di questi archeo-boss, ad Al Fa jir, i carabinieri hanno fatto irruzione. Lui non c'era, ma hanno recuperato un vero tesoro: statuette d'epoca sumerica, tavolette con scri t ture cuneiformi, monete, monili d'oro. Una gran quantità di materia le cli "nestimabile valore storico e artistico", ma che sul mercato clandestino dell'arte ha quotazioni ben definite e sempre alti,ssime . È un business milionario, che suscita molti appe t iti . "Anche alcuni gruppi politici estremisti sfruttano il traffico di reperti archeologici per finanziare le loro attivi tà", ci dice Hussen Karim, giornalista del quotidiano "A l Meda". Per gli investigatori italiani altra materia su cui indagare. Ancora in Iraq, a Shumer, un villa ggio a 120 chilometri a nord di Nassiryah. In un fosso le vacche fanno quello che devono e poco più a valle le donne attingono l'acqua . Tra la gente del posto, soprattutto i bambini, sono in aumento i cas i di dissenteria e le patologie, anche gravi, dovute proprio all'inquinamento di quella che è la loro unica riserva idrica. I mi li tari italiani decidono di intervenire. Una decisione non facile, quella di portare un potabilizzatore a Shumer. Il villaggio si trova a ridosso del confine settentriona le dell a provincia di Dhi Qar e per raggiungerlo la strada attraversa l 'area più turbolenta del la regione, dove proprio in quei giorni la guerriglia ha rialzato la resta . Il convoglio è pesantemente scor tato. A metà strada si ferma . I giornalis ti , come sempre insofferenti ai giubbet ti antiproie tti le, che questa volta sono però costretti a ind ossare, chiedono cosa è successo . "C'è una
nostra pattuglia che sta arrivando proprio dalla zona dove siamo diretti. Dobbiamo aspettarla", risponde tranquillizzante il tenente colonnello Danilo Pres ri a, un paracadutista-veterinario che è responsabile d ella Cooperazione civi le- militare (la cellula Cimic) del contingente. D iamo la risposta per buona, ma in t anto passano quasi due ore e d a lì non ci spostiamo .
Quella strada è diventata all'improvviso troppo pericolosa, pensiamo tutti Ma finalmen te la pattuglia di c ui parlava Prestia si materializza . Un breve conciliabo lo tra i responsab ili dei due convogli e s i riparte . "Tutto ok, aneliamo avanti": siamo tropp o stanchi e troppo acca ldati per indagare che cosa è realmente successo. Sta di fatto che l'unico vero incidente che si è sfiorato è s tato quello, "diplomatico", con il capovillaggio, che ci aspettava per l'ora di pranzo. Lo sceicco Melik h a infatti preparato per gli italiani un sontuoso - per gli standard del luogo - banchetto Dopo aver concesso ai soldati di entrare con gli stivalettigrande gesto di cortesia - invita gli ospiti in una sala comune dove, dall'agnello al cocomero, viene servito di tutto . Na tu ra l mente niente posate e tutti seduti a t erra, mentre gli iracheni, come tradizione vuole, non partecipano al pranzo (ma guardano divertiti) Intanto, sotto il sole, i giovani militari responsabili di montare i l potabilizzatore hanno ormai finito la loro opera. Con grande capacità e a tempo cli record hanno messo in azione un macchinario che preleva le acque melmose del fosso e le restituisce bianche e potabi li. Lo sceicco guarda incuriosi to, si fa spiegare dai ragazzi come funziona, ri ngrazia. Il convogl io italiano ri -

parte. Anche al ritorno un viaggio tranquillo. La trasferta a Shumer fa parte della missione ita liana in Iraq di cui non si parla. Eppure il settore umanitario, quello d eg li aiuti e della ricostruzione, è importante . È l' essenza stessa, verrebbe da dire, di ogni missione di pace. Nei Balcani, in Afghanistan e altrove, gli interventi delle Forze Armate italiane sul versante sanitario, delle infrastrutture, dei servizi pubblici, dei trasporti (so no i militari del Genio che in Kosovo garantiscono il normal e funzionamento dei treni e che in Albania stanno ricostruendo alcuni nodi ferroviari importanti) orma i non si contano più . Ma sui giornali non ce n'è tracc ia. Non fanno notizia neppure i 366 progetti umanitari realizzati nel primo anno di attività dai militari d i An t ica Babilonia in Iraq. Vale di più, per noi giornalis ti , una sparatoria a un check point a Nassiryah che le 70 scuole ristrutturate, le strade e i ponti ricostruiti, l'energia elettrica erogata per rutto il giorno e non più, come prima, per sole quattro ore. La sparatoria vale di più pure dell'acqua potabile, distribuita ora nel 70 per cento d ella prov in cia . Anche a Shumer. Ai militari italiani questo non piace: "Parlate di noi solo quando succede qualche disgrazia", ci dicono a ogni trasferta. Non è proprio così, ma in parte hanno ragione. Uno prova a replicar e , con g l i argomenti che trova. E quelli in sistono : "Perché allora non veni t e a vedere nell'ospedale di Nass iryah? ". Ci siamo andati. L'ospedale è un casermone grigio a ridosso della ex Cpa, la sede della governa tri ce Barbara Contini, attaccata più volte dai guerriglieri d i A l Sadr. Durante gli scontri di metà maggio 2004 i mi li ziani si misero a sparare
proprio dalle finestre dei vari reparti, senza alcun rispetto per i pazienti: gente che a sacrificare la propria dignità - in una struttura come questaè del resto norma l mente costretta. Lo stato di generale d egrado salta all'occhio appena si entra . L'ingresso è una sorta di open space d ella sofferenza, con anziani sistemati alla meglio su letti sbilenchi, bambini sporchi per t erra, donn e con in braccio i loro neonati ed altri pazienti che girano, senza un a meta Da qui, per i militari italiani, la necessità di metterci mano. E in fretta. In meno di un m ese, con 315 mila dollari della Coalizione internazionale , gli uomini di Antica Babilonia sono r ius citi a realizzare in questa specie di girone dantesco due oasi di appare nte efficienza e normalità . La prima è il servizio ortopedico. Sulla po r ta a vetri ci sono delle foto, una specie di prima e dopo la cura. E il prima è addirittura inguardabile. Ora, invece, il centro ortopedico - sala operatoria, sala gessi, locai i di servizio , macchinari moderni - è più che decoroso e funziona bene: "Possiamo eseguire 16-17 interventi a l g iorno", racconta Chasib, un paramedico. "In passato al massimo erano 6. E con risultati non sempre ottimal i" . La seconda "oasi" è invece il nuovo centro ustionati, un reparto fondamentale in un Paese in cui gli incidenti domestici provocati dal cherosene e dal fuoco sono quasi una piaga sociale. Con i dollari a disposizione è stato realizza t o un padiglione nuovo di zecca, acquistati letti e macchinari. Ab idul Murtafa, il direttore sanitario, dice che Dio dovrebbe dare ogni bene agli italiani e farli restare a lungo in Iraq . Una contraddizione in termini, ma chi lo pensa se lo tiene per sé.