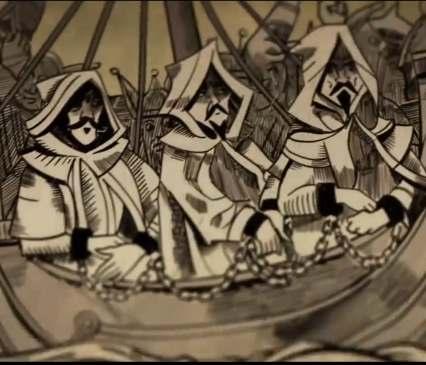
6 minute read
Una fucina di giovani killer
from ViaLibera n. 3
by LiceoRummo
di Gaetano Maio, Francesco Maio Vincenzo Leucio Rossi, Giorgio Barbato
Intesa come organizzazione criminale che ha vasto controllo sulle attività di un determinato territorio, la mafia ha un impatto grave sul benessere della popolazione che le vive accanto. In queste zone la mortalità infantile può essere più comune rispetto a quella che troviamo in zone libere dalla mafia, perché spesso i servizi sanitari non sono completamente accessibili, molti bambini non riescono ad ottenere le cure necessarie e sono costretti a spostarsi per una sanità che dovrebbe essere al primo posto tra le priorità dello Stato, ma che spesso viene lasciata in mano alle mafie, che corrompono medici e operatori sanitari, talvolta aggredendoli o uccidendoli addirittura.
Advertisement
Lasanitàcorrottanonècertol'unicoobiettivodellemafie:illoromaggiorericavoprovienedalledroghe, che mettono in serio rischio i bambini, in quanto spesso sono proprio loro a commerciarla o consumarla. A volte, però, sono i genitori dei medesimi che ne fanno uso o la smerciano, mettendo inpericoloiproprifiglichesiritrovanoconigenitoriincarcereopeggioancoramortidioverdose. Un dei più recenti ed allarmanti fenomeni legati alla mafia è sicuramente quello delle baby gang, che seminano panico tra le piazze delle città disturbando comuni cittadini; protagonisti di queste gangsonoragazzinispessoassoldatidallemafie.
La mafia e le baby gang sono collegati in quanto entrambi rappresentano forme di devianza giovanile e di criminalità organizzata. I bambini che crescono in famiglie coinvolte nelle attività criminali delle mafie possono essere esposti a un maggior rischio di violenza che può portare anche alla morte. Tuttavia, non esistono dati specifici sulla mortalità dei bambini appartenenti alle famiglie mafiose, poiché le mafie non sono organizzazioni che operano in modo trasparente o che forniscono informazioni affidabili sulle loro attività. Inoltre, i bambini che vivono in questi contesti spesso sono sottoposti a un forte controllo da parte della famiglia e sono raramente inclusi in statistiche, rendendodifficilequantificarel'evento.
Il termine "baby gang" si riferisce ad un fenomeno criminale in cui gruppi di giovani, spesso minorenni, si organizzano per commettere atti di violenza e vandalismo nelle strade delle città. Questi gruppi possono essere motivati da diversi fattori, tra cui la mancanza di opportunità, la povertà, la ricerca di identità e il desiderio di appartenenza ad un gruppo. La prevenzione di questo fenomeno richiede una combinazione di interventi a livello sociale, educativo e di sicurezza pubblica, che possano fornire ai giovani alternative positive e ridurre l'attrattività del crimine. I giovani possono essereespostiallacultura mafiosa fin dall'infanzia ecrescerein ambientiin cui laviolenza eladelinquenza sono considerate normalità. In questi contesti può essere più facile per loro cadere nel giro ed essere reclutati dalle organizzazioni criminali più grandi. Dunque la povertà, la mancanza di opportunità e la presenza pervasiva della criminalità organizzata spesso conducono i giovani a sceglierelaviadelcriminecomeunicapossibilitàdisopravvivenza. Ma la loro è una vita sacrificata. Il loro è un destino già scritto. Vi è solo sangue ad attenderli. E la morte precoce non è rara tra le fila malavitose, sia perché abbracciando una condotta di vita eslege si è esposti a pericoli di conflitti armati, sia per la semplice appartenenza a famiglie malavitose: non è infrequente, infatti, che, pur non avendo scelto di essere un mafioso, il giovane non vada incontro alla morte per regolamenti di conti o vendette familiari. La cronaca recente riporta i casi di bambini torturatieuccisisenzapudoredascagnozzidellemafie,colpevolisolodiesserefiglidiqualcunoche abbiaoperatoqualchesgarroafamigliepiùpotenti.
Sopra tutti c'è sicuramente forse il caso più noto di rapimento, tortura e infine morte da parte della mafia ai danni di Giuseppe Di Matteo, un bravo ragazzo, diligente a scuola, praticava equitazione e voleva bene ai suoi genitori, che purtroppo saranno la sua condanna. DopolastragediCapaci,delmaggio1992,incuiperselavitailgiudice Falcone, sua moglie e la sua scorta, numerosi mafiosi furono dichiarati collaboratori di giustizia, tra cui Santino Di Matteo, padre del piccoloGiuseppe;fuluilavittimasacrificaleperscoraggiarelacomparsa di altri collaboratori: a sceglierlo furono alcuni uomini famosi tra le cerchie mafiose, tra i quali troviamo l'ex superlatitante Matteo Messina Denaro. In un giorno di novembre il piccolo Giuseppe fu rapito daalcuniuominitravestitidaagentidellaDIA(DirezioneInvestigativa Antimafia) e con la promessa di fargli vedere il padre, a cui Giuseppe era molto legato, riuscirono ad adescarlo: quella fu l'ultima volta che Giuseppe si sentì libero; la sua libertà infatti sarà poi usata come merce di scambio per arrivare al silenzio del padre, che però, dopo vari tentativi di ricerca con la speranza di trovare suo figlio, collaborerà ancora con la giustizia arrivando a far condannare all'ergastolo Giovanni Brusca (l'uomo per cui lavorava Santino Di Matteo). Giuseppe era tenuto in pessime condizioni, cambiato spesso di posizione per evitare che venisse trovato e alla fine strangolato e sciolto nell'acido nitrico. I suoi assassini, come racconta Vincenzo Chiodo (uno degli assassini), andrannoadormirepocodopo,comesenullafossesuccesso.
La mafia, che spesso è vita e boccata d'aria per ragazzini sommersi da crisi e povertà, che non hanno paura né del carcere né di morire, in realtà è soltanto morte: di adulti che si lasciano coinvolgere, ma anche di bambiniinnocenti,chedovrebberogiocarefelicitralestradeeipalazzi.
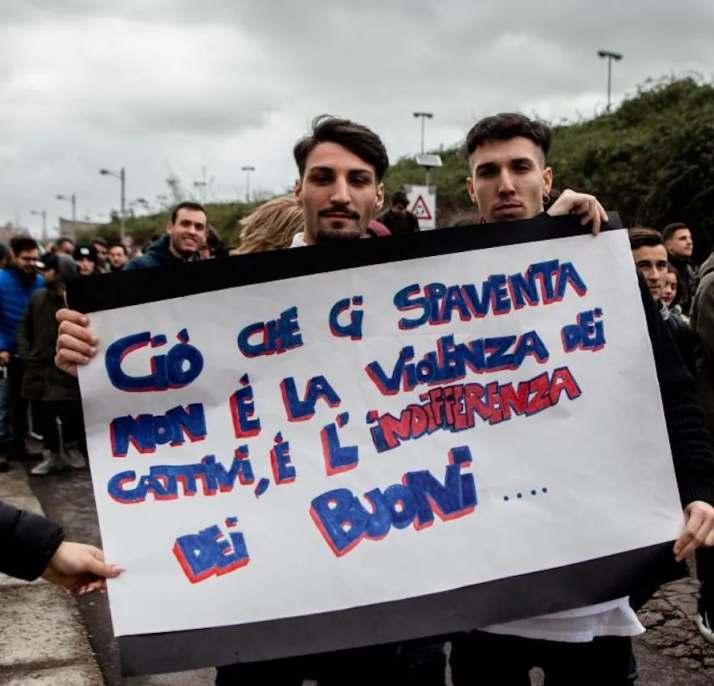
Sorvegliare e punire! di Simone Vetrone
Per far sì che uno Stato funzioni, c'è bisogno di diversi fattori, ma quello più importante è che ogni membro si impegni non soltanto per il suo tornaconto, ma anche per il bene comune. Questo però non accade: ci sono e ci saranno sempre delle persone che andranno a ledere la collettività per il proprio interesse, per questo tutti i tipi di società hanno concepito delle contromisure a questa problematica, la più comune delle quali, almeno al giorno d'oggi, è sicuramente il carcere. Ma a cosa serve e quanto è efficace ad adempiere al suo scopo?
Prima di rispondere a questa domanda, però, c'è bisogno di capire una cosa: perché le persone commettono dei reati?
Nella maggior parte dei casi le persone sono portate, o talvolta costrette, a commettere dei crimini, o per via del tessuto sociale che le porta a delinquere, o per la loro situazione economica. Queste condizioni sono molto più comuni di quello che può sembrare: ragazzi che crescono in famiglie di criminali sono portati, se non proprio obbligati, a seguire quella strada. Per non parlare dei problemi legati al denaro: basti pensare che l'under 30 medio guadagna circa 830 euro al mese, e questo porta molti a cercare di incrementare i suoi introiti ricorrendo ad attività illecite, come lo spaccio o il furto. Il problema realeècheigiovanivengonoportatiacommetteredeireatisoprattutto quando ancora non hanno sviluppato un pensiero critico e la loro mente è malleabile, per questo è importante intervenire soprattutto in questa età. Ma poiché questo fattore spesso non viene considerato, se accade che dei ragazzi vengono colti in flagranza di reato, essi sono messi in carcere come se fossero criminali qualunque, andando ad interromperelaloroformazione.Edunque:acosaserveilcarcere? Ilcarcereidealedovrebbeportareatermine4obiettivi:lapunizionedel condannato, la difesa della collettività, il monito verso il popolo e la rieducazione del condannato. In Italia questa è una descrizione puramente teorica; ma analizziamo i punti uno per volta, partendo dal monitoversoilpopolo.L'ideaallabasediquestopuntoèchelepersone vengono scoraggiate a commettere un determinato crimine, per paura della punizione, il che non è un metodo efficace per evitare che le persone commettano reati, infatti appena il controllo della legge viene meno, le persone riprendono a fare ciò che vogliono. A dimostrare ciò è l'enorme numero di luoghi in cui la legge non arriva o che ha difficolta a raggiungere, luoghi nei quali i crimini sono all'ordine del giorno, incluse associazioni criminali mafiose: è in questi posti che i ragazzi abbandonatidallaleggevengonointrodottiallavitacriminale. Quanto alla rieducazione del condannato, in Italia abbiamo un tasso altissimo di recidiva, pari al 70%, dovuto al fatto che nelle carceri non ci sono i mezzi necessari per rieducare i prigionieri, non perché non ci siano i fondi, ma perché questi vengono spesi male, anche perché alle persone di ciò che succede all'interno di un carcere non interessa minimamente. Il pensiero comune è che «siccome stanno lì, non meritano attenzioni» e questo porta a delle condizioni di vita pessime, celle fatiscenti piene di crepe e muffa, un sovrappopolamento elevatissimo: tutto ciò fa in modo che si crei un ambiente poco adatto anche solo alla vitadeicarcerati,figuriamociallalororiabilitazione.
Il secondo obiettivo è la difesa della collettività: la maggior parte delle persone che entra in carcere, soprattutto le più giovani, non fanno parte del mondo criminale o di quello malavitoso, ma ci finiscono per crimini leggeri; il problema è che poi lì dentro molti incontreranno gente che è a tutti gli effetti criminale, pronta ad avviarli verso un percorso malavitoso rapido ed efficace. Così, nel migliore dei casi, un ragazzo che è stato in prigione sembra doppiamente condannato: prima dalla legge a diventare un detenuto, poi dalla società ad essere un reietto, perché separato dalla società, in cui non riuscirà mai più ad integrarsi. Questo sistema sembra alimentare la creazione di criminali, che non solo vedono nello Stato un nemico che ha tolto loro tutto, ma che hanno imparato come essere più “efficienti”, operando, una volta fuori dalle carceri, in un'organizzazione da cui si sentiranno accolti e protetti.

In definitiva l'unico scopo che il carcere sembra raggiungere è quello di punire il condannato, ma questo non migliora né la sua condizione di vita né quella di chi sta fuori. Con questo non si intende affermare che bisognerebbe abolire il carcere, perché è chiaro che ci sono dei membri dellasocietàchenonpossonoesserelasciatiliberidifareciòchevogliono, dato che causerebbero solo problemi, ma che in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di ragazzi, il carcere non fa altro che peggiorare la situazione e non porta ad alcun giovamento per la collettività. Per questo bisognerebbe o essere più comprensivi, o usare metodi alternativi, intensificando i servizi sociali o potenziando i domiciliari: basti pensare che quando vengono utilizzati questi ultimi provvedimenti il tasso di recidivacalaal20%.
La cosa più importante non è punire il soggetto che ha commesso il crimine,maresponsabilizzarloattraversometodicomeillavoroelarieducazione, per far sì che lo strappo che si era creato fra lui e la società si possaricucire.










