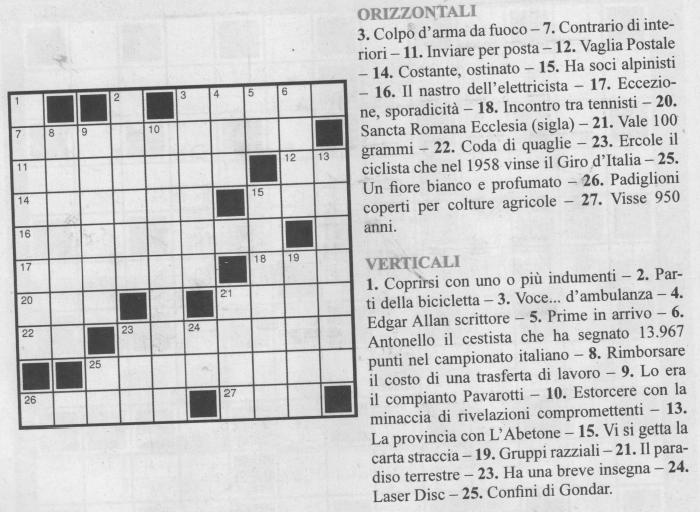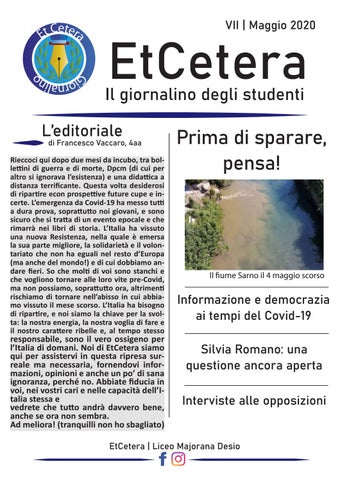4 minute read
Su paralleli opposti
Attualità
3
Advertisement
Giacomo Longoni, 4bb
Su paralleli opposti
Care majorane, cari majorani Eccoci qui. Ci siamo lasciati il 22 febbraio scorso. Chi poteva pensare che quel sabato sarebbe stata l’ultima volta che i nostri amici di quinta avrebbero messo piede al Majo prima della “matura”? Chi avrebbe predetto un distacco così prolungato, un’emergenza sanitaria così forte, una crisi socio-economica così grave? Sono passati quasi tre mesi. A dir la verità nessuno può dirlo con certezza. Come possiamo essere certi che sono solo tre mesi? Già, quanto tempo è passato? In qualche modo ci poniamo quella stessa domanda che si pose prima di noi Agostino nelle Confessioni a proposito del tempo: “Misuro il tempo, lo so; ma non misuro il futuro che non esiste ancora; non misuro il presente che non ha estensione, non misuro il passato che ormai non esiste più. Che cosa misuro dunque?”. Come misuriamo noi questo periodo? Anzi, cosa misuriamo? Una leggenda metropolitana che vaga nelle nostre città e che intasa i commenti dei buonisti su Facebook, Twitter e Instagram attribuisce la misura del tempo ad uno strumento del tutto particolare: la bontà. “Diventeremo più buoni”, e ancora, “Ne usciremo migliori” - scrivono - come se il raggiungimento della bontà decretasse l’avvenuto passaggio dal coma alla nuova vita. Se abbassiamo lo sguardo sullo schermo si notano decine e decine di altri commenti che sono una risposta forte, brutale e irriverente alla leggenda sopracitata. Pare evidente ai miei occhi che usciremo diversi da come ne siamo entrati. Ma non migliori. Non più buoni. Dopo il sogno infranto pare normale cercare il colpevole. Chi è costui che ha il potere di sottrarmi la terra promessa della bontà? Chi il maledetto che mi deruba della bontà meritata? La risposta non ce l’ho e potrei finire qui l’articolo. Saluti e statemi bene! Poi rifletto. No, dai, non posso fare scena muta; una risposta la devo dare. Ripercorro in quattro nanosecondi il periodo della quarantena. Non riesco a trovare un colpevole. Deluso della mia ignoranza sblocco il cellulare e mi rifugio nel porto sicuro, nell’evergreen in cui imbattersi quando non si hanno alternative migliori: Instagram. Mi compaiono un po’ di meme, un video di indiani che fanno cose, la notifica dell’hacker che
4 Attualità
mi ha taggato per la trecentesima volta in 24 ore e… tanti commenti. Ce n’è per tutti i gusti! C’è chi chiede al governo di non portare in Italia il 5G, c’è l’eco nomista laureato presso la prestigiosis sima Università della Vita che parla di Mes, c’è il virologo con dottorato pres so il Centro Nazionale Sollevamento Polemiche e Complotti che profetizza sui tempi del vaccino. I più temerari che, non contenti, scorrono più in bas so possono trovare i terrapiattisti che urlano al complotto per presunte ne gligenze da parte del Fbi e, ultimo ma non meno importante, il classico: “Con i soldi dello stipendio di Conte, Matta rella & Co. l’Italia ripartirebbe in due settimane”. Forse aveva ragione il grande Umberto Eco quando diceva che “i social danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggia re la collettività.” Eco aveva fiutato il problema già cin que anni fa. Generalmente questo afo risma è servito con l’immancabile “E questi hanno pure il diritto di voto!”. Ed è qui che nascono idee preoccupan ti e oscure come quella della democra zia elitaria. I più estremisti addirittura propongono un “test della democra zia”: se si risponde correttamente al 60% dei quesiti di cultura generale che vengono posti, allora si ha diritto alla tessera elettorale altrimenti si è out. Curioso, no? No, assolutamente no. E anche poco divertente. La risposta al problema sta tutta qui: tutti quei commenti che vi ho ripor tato sono scritti da persone che non hanno avuto la possibilità di istruirsi su determinati temi e che non hanno as similato delle competenze che gli per mettano di trattare con “scienza e co scienza” i grandi problemi che toccano questo deplorevole 2020. La colpa non è loro. Il dito va puntato contro coloro che non sono stati in grado di trasmet tere a questi gli strumenti essenziali per poter solamente avere un pensiero fondato su fatti reali, non strampalato. Questa è la vexata quaestio. Questo il dilemma. Allora, nella mia smania di trovare un colpevole, mi domando di nuovo: “Di chi è la colpa?” La colpa è di chi dovrebbe occuparsi della loro informazione, di chi dovreb be trasmettere in modo chiaro, conciso ed efficace gli strumenti necessari per permettere di affrontare in modo serio e realistico il problema. La colpa è dei mezzi d’informazione. Solo loro. Anzi, per correttezza, solo nostra. Ci voleva davvero una pandemia, una
5 Attualità
crisi, una situazione estrema per farci capire l’importanza di fonti vere, certe, sicure, affidabili da cui informarsi? Ci voleva davvero l’emergenza Coronavirus per capire l’importanza dell’informazione (e dell’istruzione)? La corretta informazione è quella cosa che rende il cittadino capace di affrontare in termini generali ogni discorso. È quel bene di prima necessità che non può essere accantonato in una democrazia. Ecco, tutti questi commenti decretano in modo tangibile la sconfitta della corretta informazione quindi, la sconfitta della democrazia. Dovremo ripartire da qui. Anzi, continuare da qui. Loro, la Democrazia e la Corretta Informazione non si sono mai fermate. Hanno vissuto in questi mesi su paralleli opposti rispetto a noi, ma non si sono fermate. Noi sì e stiamo pagando un prezzo altissimo. Ad majora!