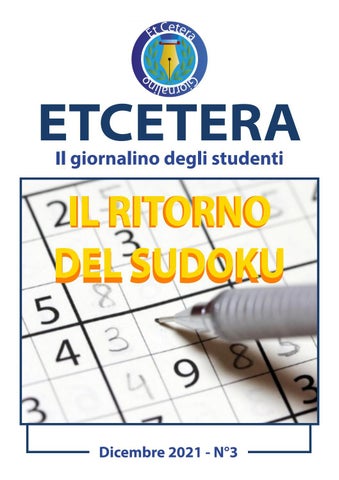9 minute read
Squid Game: bello, e
GIULIA RADICE, 5aa
Il “fenomeno Squid Game” è sulla bocca di tutti ancora adesso. La serie, distribuita dalla celebre piattaforma streaming di Netflix e divenuta Cult nel giro di pochissimo, ha ricevuto un’accoglienza molto positiva, grazie al suo carattere tagliente e innovativo, che ha stuzzicato tutte le fasce d’età, in particolar modo quelle più giovani. Squid Game, serializzata in 9 episodi, ha come suo perno tematiche che spaziano dalla denuncia sociale a quella morale, e che non riguardano unicamente la Corea del Sud, come dirò in seguito, ma che sono da intendere su un piano universale. Tuttavia, nonostante il grande successo della serie, tanti, anche se non abbastanza da sovrastare l’applauso generale, sono stati i fischi e le polemiche che hanno messo in discussione la legittimità e l’integrità dell’opera. Tali critiche vengono fatte circolare sul Web con articoli, video, forum che fomentano le diatribe tra parti – non a caso, per informarmi meglio sulla questione, anch’io ho ricorso a trafiletti pescati qua e là da Internet -. Indagando appunto diversi siti, ho notato che molti di questi avevano basato le loro critiche su questioni similari e mi sono decisa a stilare una scaletta delle “critiche più comuni contro Squid Game”, non trattenendomi dall’esporre le mie confutazioni e opinioni a riguardo. Questo articolo, pertanto, conterrà spoiler.
Advertisement
TRAMA EFFICACE E PERSONAGGI SPONTANEI
La maggior parte degli utenti insorti contro la nuova serie firmata Netflix, dichiara di aver individuato buchi di trama, mai in seguito chiariti, o addirittura contraddizioni nella narrazione. In questo, la critica si giustifica ampiamente e con argomentazioni valide, le quali tuttavia, non mi hanno convinta. Particolare attenzione è spesso dedicata ai Pink Soldiers, i soldati mascherati in tute rosse che vediamo agire in quasi ogni puntata della serie, i quali sembrerebbero, a detta di molti, inverosimilmente impassibili e spietati nei confronti dei giocatori,
nonostante siano anch’essi uomini come loro. Inutile dire che un’eventuale spiegazione a questo verrà meglio esplicitata nella seconda stagione della serie – ancora in cantiere, ma della quale è già disponibile un teaser -. Dunque per ora, non avendo abbastanza informazioni, proverò a dare una mia interpretazione. Ritengo che, in questo caso, si sia deciso di ricorrere al patto di sospensione dell’incredulità, tecnica narrativa che vedrebbe spiegato qualcosa che, nella realtà dei fatti, non avrebbe ragion d’essere: ecco che i Pink Soldiers diventano per definizione soldati disumani e dalla mano ferma, che non temono né di uccidere né di essere uccisi, cosa che, a rigor di logica, non dovrebbe poter accadere senza una giustificazione plausibile. Certi altri lamentavano il fatto che fossero presenti troppe comparse, pressoché inutili allo snodo narrativo. Tuttavia, credo che l’intenzione della serie fosse proprio quella di far trovare allo spettatore il modo di “immedesimarsi” anche nei personaggi di sfondo e non solo in quelli chiave, dal momento che ognuno degli altri giocatori si porta dietro una storia e un motivo precisi per trovarsi lì. Dopotutto, trattandosi di un’opera corale, è giustificata la comparsa di numerosi “personaggi fantasma”. Inoltre, la compresenza di tante mentalità diverse sulla scena, lasciate agire in uno spazio relativamente ridotto, che cambia solo in qualche scenario – come durante i giochi -, fa in modo che lo spettatore non si ritrovi mai da solo, focalizzando la sua attenzione sugli stati d’animo o sui pensieri di un unico soggetto, bensì che gli suggerisca una visione di insieme, che lo guidi ora nella testa dell’uno ora nella testa dell’altro personaggio. Sarà il pubblico, poi, a costruire da sé un suo filone di pensieri senza che glielo inculchi forzatamente il film.
TRADUZIONI BEN CALATE NEL CONTESTO
L’ennesima critica riguarda i dialoghi e l’adattamento in traduzione di questi ultimi, materia sulla quale spenderò poche parole. Non so se sia trattato di un problema specifico degli USA, però io non ho notato incoerenze tra la traduzione italiana e il contesto in cui vengono sviluppati i dialoghi. Non sapendo il coreano, d’altra parte, non posso sbilanciarmi troppo sulla questione. In ogni caso, ho apprezzato i discorsi proposti nelle scene e li ho trovati sempre molto centrati sull’argomento e anche decisamente trascinanti.
I CINEFILI (NON) CAPIRANNO
Numerosissimi video-analisi o di commentario – tipologie di critica massmediale che di questi tempi vanno per la maggiore – si sono trovati a dibattere, in particolare, sulla direzione artistica della serie. Thumbnail accattivanti e titoli clickbait appaiono in massa e rendono noti errori di regia o dettagli trascurati dagli spettatori meno attenti, a volte complimentando e altre criticando il lavoro di produzione. Essendo io, come molti, poco esperta in merito, devo dire che sono comunque riuscita a godermi i nove episodi a cui ammonta la serie senza particolare
difficoltà. Con questo non dico che non ci fossero sbavature, ma che nel complesso queste non hanno intaccato la genuinità dell’opera. Concludendo, i falli in regia non sono da ritenersi un valore aggiunto alla disapprovazione generale che l’opera ha suscitato.
IL FINALE DAL RETROGUSTO AMARO E INASPETTATO
Tanti i commenti negativi sul finale della serie. L’anziano, giocatore numero 1, che sin dalla prima scena ha destato tenerezza e compassione in molti, si rivela essere il cattivo di turno. Sono d’accordo con l’opinione di alcuni, che criticano le motivazioni che hanno spinto Oh Il-nam, questo il nome del vecchio, a mettere in piedi l’organizzazione dietro ai giochi, ritenendole piatte e banali. Al contrario, apprezzo il colpo di scena, che nulla toglie alla consistenza del personaggio. Nell’episodio intitolato “Gganbu”, infatti, Il-nam esce di scena, facendo credere a tutti a malincuore che di lui non si parlerà mai più. Solo in seguito, nella puntata finale, il vero colpo al cuore. Come a dire, anche i migliori hanno bisogno di perdono. Unica cosa che mi ha lasciata un po’ delusa è stato il palesamento dell’identità del Frontman. Avevo già dato per scontato che fosse il fratello del poliziotto infiltrato, sotto trama che, tra l’altro, ho gradito – insieme anche a quella del traffico di organi illegale – e che ho trovato ben arrangiata ai ritmi della storia principale. NETFLIX, BRUTTA BESTIA
Un’altra critica è stata avanzata, questa volta, nei confronti di Netflix stessa, piattaforma di dominio mondiale, che da una ventina d’anni a questa parte detiene il monopolio dello streaming. La sua notorietà l’ha portata sia a crescere come azienda sia ad aumentare il numero d’ascolti per l’incredibile scelta ludica che offre, tanto da aver quasi superato la ormai leggenda della televisione a colori. Squid Game è stata una delle recentissime serie che ha contribuito al nome di Netflix, e che veicola un messaggio per certi aspetti anti-capitalista. Il biasimo di alcuni, infatti, è stato rivolto all’ipocrisia dell’azienda, la quale avrebbe finanziato e promosso un progetto che si schiera contro le ingiustizie del sistema capitalistico, al contempo agendo essa stessa in maniera capitalista. Di fatto, la grandezza della piattaforma americana deve il proprio merito all’aver saputo sfruttare produzioni cinematografiche di basso o alto livello e di aver investito e lucrato su queste, facendo rientrare le proprie strategie in quello che è a tutti gli effetti uno schema capitalistico. Oggi come oggi, in un’era digitalizzata dove ogni cosa è un pretesto per trarre profitto, è fondamentale che una qualsiasi azienda debba inserirsi nel sistema di mercato capitalista, mercato che ha ormai in mano le redini della compravendita mondiale. Quella di Netflix, a mio parere, non è stata una mossa ipocrita ma, anzi, molto intelligente, perché, consapevole del successo che Squid Game avrebbe riscosso, è ricorsa ad ogni mezzo possibile per vedersi fruttare qualcosa. E,
dopotutto, l’”ipocrisia” di Netflix ha portato alla luce una serie che racchiude in sé un messaggio assai positivo, che denuncia l’abuso che ne è dell’uomo in un sistema capitalistico radicato.
TUTTA QUESTIONE DI MARKETING
I Pink Soldiers, di cui ho già precedentemente parlato, sono ormai diventati riconoscibili da tutti, dal momento che sono presenti in gran parte dei frame e inoltre indossano un vestiario – rosso e con una maschera che nasconde per intero il volto – facilmente riconducibile ai costumi scenici dei rapinatori ne La casa di carta. Ancora, nella serie ci viene detto che il grado dei soldati è stabilito in base al simbolo – triangolo, quadrato o cerchio – che portano sulla maschera. Ebbene, la scelta di queste tre figure geometriche, come molti fanno notare, non è affatto banale. Ricordano, infatti, i tasti di selezione di un joystick, periferica di una console – come quella prodotta dall’azienda Sony, la PlayStation® – che permette all’utente di muoversi all’interno di un videogame o di qualsiasi altro programma. La mostruosità, in senso buono, di Squid Game sta proprio nell’attenzione ai dettagli e nella consapevolezza dell’impatto che questi avrebbero avuto sul pubblico. Le seguenti sono solo teorie personali, senza alcuna base scientifica, ma che spiegherebbero quanto devastante sia stata l'influenza della nuova serie Cult sul mercato: infatti, recentemente uno spot della Playstation 5® rivela come il prossimo joystick potrà essere scelto in tinta rossa, oltre che bianca: Sony dimostra ancora una volta di non avere peli sulla lingua. Allo stesso modo la Pavesi, marchio di produzione italiano, ha lanciato una collaborazione tra Ringo e PlayStation®, motivo per cui da adesso i famosi biscotti presenteranno sui due dorsi delle forme geometriche, già note ai videogiocatori ma anche al pubblico di Netflix: quadrato, triangolo, cerchio e “x”.
MANIFESTO DI DENUNCIA UNIVERSALE
Squid Game è, per certi aspetti, un manifesto di denuncia sociale come tanti altri. Ma, contrariamente a quanto si possa pensare, è una serie che non tratta della Corea. Tratta dell’essere umano. Certo, il fulcro della storia ruota intorno alla Corea del Sud, territorio asiatico che tuttora prevede un indebitamento del tot%, che ha mandato in crisi l’economia del Paese, mettendo a rischio il sostentamento di intere famiglie. Ma, sebbene la serie sia stata effettivamente ambientata in Corea, ritengo che il modo migliore di leggere l’opera sia quello di espandere la visuale e considerarla su un piano più universale: cosa potrebbe mai spingere un uomo a rischiare la propria vita pur di vedersela risparmiata? I soldi? La fame? L’onore? Be’, tutto questo in realtà. Squid Game vuole dimostrare, su un piano psicologico, a cosa l’uomo è capace e consapevole di farsi incontro, pur di sopravvivere in un mondo che gli ha già innalzato la lapide. I personaggi sono dei disperati,
e in condizioni del genere, quando ormai si è con un piede nella fossa, sommersi di debiti, di disonori e di critiche, viene naturale e necessario sopravvivere, facendo vanto di tutto il proprio egoismo. Non è questione di mentalità, poiché anche la persona più buona e onesta, come Gihun, può perdere la sua umanità – come ci viene mostrato di fatto nell’episodio delle biglie -. Squid Game narra la storia del mondo e della società, non prettamente coreana bensì mondiale. Non ha l’obiettivo di essere una serie sovvertitrice, ma di smuovere l’opinione pubblica e la coscienza di molti che, tutt’oggi, sono o troppo legati ai beni materiali, o vittime dei soprusi della società. Parla dell’uomo e della sua finitezza, come parla anche della sua libertà di scelta e del suo ruolo nel mondo.
Infine, Squid Game è una serie dalla trama contorta e suggestiva e che, come poche altre, ha lasciato e lascerà un segno nella storia dello streaming. Sia i contenuti veicolati sia il modo in cui questi sono stati gestiti, la rendono un ottimo prodotto, non certamente adatto ai più deboli di stomaco ma, per chi è affascinato dal dramma, dal gore e dallo psicologico, assolutamente irrinunciabile. Attenti però a non farla vedere ai vostri figli, fratellini o sorelline più piccoli! Potrebbero rimanerne sconvolti...