

Inquadra il QRCODE e unisciti anche tu al canale Telegram dell’ACP
Editoriale
193 Relazione della presidente 2025 Stefania Manetti
195 Promuovere senza proteggere: un equivoco dannoso per l’allattamento Sergio Conti Nibali
Infogenitori
197 Parliamo di sesso (senza tabù)
Antonella Brunelli, Stefania Manetti, Antonella Salvati, Paola Menga
Ricerca
197 Studio della Griffonia Simplicifolia per il miglioramento del sonno nei bambini con disturbo dello spettro autistico: risultati preliminari
Gaia Di Fiore, Giuditta Bargiacchi, Marco Carotenuto
199 Le competenze digitali dei bambini: sostenere il benessere dei bambini e un uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali
Mattia Messena, Marina Everri
202 Allattamento: comprendere il vissuto per sostenere le scelte delle madri
Giulia Bagnacani, Sara Lo Scocco, Linda Debbi, Laura Bonvicini, Costantino Panza, Luca Ghirotto, Paolo Giorgi Rossi
Osservatorio internazionale
207 Pietas o cinismo? L’Europa e l’eutanasia nel bambino
Mario Renato Rossi, Patrizia Elli, Francesco Morandi
Il caso che insegna
209 La rachicentesi che risolve i sintomi: riflessioni su due casi di meningite asettica Giulia Pederzani, Francesco Accomando, Enrico Valletta
Imparare con i giovani
212 Una porpora, tante sfumature: approccio alla vasculite da immunoglobuline A (IgAV)
Claudia Brusadelli, Anna Cogliardi, Leonardina De Santis, Daniela Zanta, Alessandra Tozzo
Il punto su
219 Affido dei figli e alienazione parentale: le conseguenze sul benessere dei bambini
Maria Grazia Apollonio, Mariachiara Feresin, Michela Nacca, Patrizia Romito
Ambiente e salute
222 Mestruazioni sostenibili e dintorni
Federica Bartolini, Francesca Lucchi, Paola Menga, Antonella Brunelli
Esperienze
226 La pediatria tutta intera: l’esperienza della Repubblica di San Marino
Elisabetta Muccioli
Il pediatra e le sfide educative
228 Mio figlio è capriccioso
Chiara Borgia
Narrative e dintorni
231 Il peso del sentire. L’esperienza emotiva e relazionale del bambino e del ragazzo in cure palliative pediatriche
Anna Santini
Epiquaderni
234 Dalla rivista Epidemiologia & Prevenzione, un invito alla lettura per i pediatri ACP Giacomo Toffol
Libri
235 Mario De Curtis, Silvio Garattini, La salute dei bambini. Migliorarla si può
235 Ginevra Bompiani, Sarantis Thanopulos, Il pensiero affettivo
235 Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita
Lettere
237 Osservazioni in merito alla progetto policy aziendale per l’allattamento
237 Per una formazione in loco, indipendente e a costi contenuti, per l’allattamento
238 Risposta alle lettere sul progetto PAA
Congressi in controluce
240 Pediatria e neurosviluppo. Innovazione clinica e telemedicina per la diagnosi precoce del disturbo dello spettro autistico
Noemi Buo, Paola Colombo, Massimo Molteni
rivista bimestrale dell’associazione culturale pediatri
Norme redazionali per gli autori
I testi vanno inviati alla redazione via e-mail (redazione@quaderniacp.it) unitamente alla dichiarazione che il lavoro non è stato inviato contemporaneamente ad altra rivista.
Per il testo, utilizzare carta non intestata e carattere Times New Roman corpo 12 senza corsivi; il grassetto va usato solo per i titoli. Le pagine vanno numerate. Il titolo (in italiano e inglese) deve essere coerente rispetto al contenuto del testo, informativo e sintetico. Può essere modificato dalla redazione. Vanno indicati l’istituto/ente di appartenenza e un indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza. Gli articoli vanno corredati da un riassunto (abstract) in italiano e in inglese, ciascuno di non più di 1000 caratteri (spazi inclusi). La traduzione di titolo e abstract può essere fatta, su richiesta, dalla redazione. Non occorre indicare parole chiave.
Negli articoli di ricerca, testo e riassunto vanno strutturati in “Obiettivi”, “Metodi”, “Risultati”, “Conclusioni”.
I casi clinici per la rubrica Il caso che insegna vanno strutturati in: “La storia”, “Il percorso diagnostico”, “La diagnosi”, “Il decorso”, “Commento”, “Cosa abbiamo imparato”.
Tabelle e figure vanno poste in pagine separate, una per pagina. Ciascun elemento deve presentare una didascalia numerata progressivamente; i richiami nel testo vanno inseriti in parentesi quadre, secondo l’ordine di citazione.
Casi clinici ed esperienze non devono superare i 12.000 caratteri (spazi inclusi), riassunti compresi, tabelle e figure escluse. Gli altri contributi non devono superare i 18.000 caratteri (spazi inclusi), compresi abstract e bibliografia (casi particolari vanno discussi con la redazione). Le lettere non devono superare i 2500 caratteri (spazi inclusi); se di lunghezza superiore, possono essere ridotte d’ufficio dalla redazione.
Le voci bibliografiche non devono superare il numero di 12, vanno indicate nel testo fra parentesi quadre e numerate seguendo l’ordine di citazione. Negli articoli della FAD la bibliografia va elencata in ordine alfabetico, senza numerazione. Esempio: Corchia C, Scarpelli G. La mortalità infantile nel 1997. Quaderni acp 2000;5:10-4. Nel caso di un numero di autori superiore a tre, dopo il terzo va inserita la dicitura “et al.” Per i libri vanno citati gli autori (secondo l’indicazione di cui sopra), il titolo, l’editore e l’anno di pubblicazione.
Gli articoli vengono sottoposti in maniera anonima alla valutazione di due o più revisori. La redazione trasmetterà agli autori il risultato della valutazione. In caso di non accettazione del parere dei revisori, gli autori possono controdedurre.
È obbligatorio dichiarare la presenza di un conflitto d’interesse. La sua eventuale esistenza non comporta necessariamente il rifiuto alla pubblicazione dell’articolo.
direttore
Michele Gangemi
direttore responsabile
Franco Dessì
presidente acp
Stefania Manetti
comitato editoriale
Melodie O. Aricò, Antonella Brunelli, Sergio Conti Nibali, Daniele De Brasi, Luciano de Seta, Martina Fornaro, Stefania Manetti, Luigi Memo, Laura Reali, Paolo Siani, Maria Francesca Siracusano, Maria Luisa Tortorella, Enrico Valletta, Federica Zanetto comitato editoriale pagine elettroniche Giacomo Toffol (coordinatore), Laura Brusadin, Claudia Mandato, Maddalena Marchesi, Laura Reali, Patrizia Rogari, Chiara Roncarà collaboratori
Fabio Capello, Rosario Cavallo, Francesco Ciotti, Antonio Clavenna, Massimo Farneti, Claudio Mangialavori, Italo Spada, Angelo Spataro, Augusta Tognoni progetto grafico ed editing Oltrepagina s.r.l., Verona programmazione web Gianni Piras stampa
Cierre Grafica, Caselle di Sommacampagna (VR), www.cierrenet.it
Quaderni acp aderisce agli obiettivi di diffusione gratuita online della letteratura medica ed è disponibile integralmente all’indirizzo www.quaderniacp.it
Pubblicazione iscritta nel registro nazionale della stampa n. 8949 © Associazione Culturale Pediatri ACP
Edizioni No Profit
redazione redazione@quaderniacp.it
amministrazione segreteria@acp.it
direzione direttore@quaderniacp.it
Quaderni acp è stampato su carta Lenza Top 100% riciclata. L’etichetta FSC® su questo prodotto garantisce un uso responsabile delle risorse forestali del mondo.
ufficio soci ufficiosoci@acp.it
Relazione della presidente 2025
Stefania Manetti presidente ACP
«it’s a long and winding road...»
Il 2024 si è chiuso con la mia rielezione alla presidenza ACP. Nel tracciare il percorso di questo ultimo anno vorrei sottolineare la ricchezza culturale che caratterizza l’Associazione Culturale Pediatri, ricchezza che deriva dai percorsi tracciati nel 1974, che hanno segnato la nostra strada, fisiologicamente tortuosa e ricca di nuovi sentieri che si sono sempre ricongiunti alla strada maestra. La coerenza culturale e scientifica ci ha sempre accompagnato e credo che questo sia il mandato principale a cui tutte e tutti noi siamo chiamati a rispondere. Lo abbiamo dimostrato fin da allora e ancora oggi, grazie ai contributi di tutte e tutti, forse oggi con maggiore fatica data la complessità che caratterizza il nostro tempo. L’impegno profuso è stato importante, ha richiesto tempo, dedizione e presenza non solo della sottoscritta, ma di tutti coloro che hanno collaborato a tracciare e consolidare percorsi, squadre diverse, per età ed esperienze, senza le quali l’ACP non avrebbe vita.
Nello scrivere questo editoriale non posso non evidenziare e di nuovo mettere in luce con i “fari” a disposizione, la situazione delle bambine e dei bambini di Gaza, dell’Ucraina, e di tutte e tutti – che sono tanti (648 milioni) – che vivono in situazioni di guerra e conflitti. È di pochi giorni la richiesta di Jeffrey Goldenhaghen presidente dell’International Society for Social Pediatrics and Child Health (ISSOP), di diffondere la loro position paper e inviare una nostra dichiarazione di sostegno con il logo ACP: “Sebbene ISSOP abbia rilasciato dichiarazioni su Gaza in passato, non ci siamo sentiti a nostro agio nell’utilizzare il termine ‘genocidio’ … negli ultimi mesi la situazione è cambiata notevolmente ed è chiaro che ciò che Israele sta perpetrando, con il sostegno di molti dei Paesi in cui viviamo, soddisfa la definizione di genocidio data dall’ONU.” Il position statement di ISSOP e la risposta di ACP con un proprio documento, saranno a breve messi sul sito. Questa riflessione apparentemente potrebbe sembrare “fuori contesto”, ma è invece la testimonianza di come la nostra Associazione abbia e continui ad avere una prospettiva giusta e ampia sul concetto di salute (molti ci avete scritto in merito) e sulla necessità di sollecitare chi può operare concretamente in questo senso. La speranza è che una posizione più forte possa mobilitare le capacità di lobbying legislativo.
Collaborazioni e progetti
Importanti riflessioni che negli ultimi anni sono spesso emerse ci hanno portato (presidente e direttivo) alla proposta di una collaborazione tra ACP e SIP a partire da alcuni gruppi di lavoro comuni. Con il nuovo presidente SIP, Rino Agostiniani, dopo una serie di incontri online e di riflessioni comuni, il 15 febbraio si è stipulato un protocollo d’intesa focalizzato prioritariamente ai seguenti ambiti di attività: ambiente e salute dell’età evolutiva; dolore e cure palliative pediatriche; pediatria di genere; formazione nelle scuole di specialità. Questa collaborazione sta già dando i suoi frutti: è stata prodotta una survey inviata alle socie e soci ACP e SIP, con il dipartimento di epidemiologia del SSR della Regione Lazio,
sulla dieta sana e sostenibile per il clima, e a oggi abbiamo ricevuto 800 risposte. Tutti i gruppi di lavoro stanno collaborando sia sulla produzione di webinar comuni sia su altri percorsi sui quali sarete costantemente aggiornati. Nel corso dell’ultimo congresso SIP a fine maggio 2025, ACP è stata presente con Michele Gangemi in una sessione focalizzata sulla riorganizzazione delle cure primarie pediatriche, avendo come punto di partenza il libro Pediatria di Famiglia , una scrittura corale dove la sezione dedicata alla riorganizzazione delle cure pediatriche è stata molto ben delineata e approfondita da Claudio Mangialavori, responsabile del gruppo di lavoro ACP sulla riorganizzazione delle cure primarie pediatriche. Il 27 maggio 2025 è stata istituita la Commissione Cure Primarie SIP e il Consiglio Direttivo SIP ha deliberato di nominare Michele Gangemi come componente della commissione. La formazione nelle scuole di specialità e la possibilità di contribuire al biennio di cure primarie pediatriche è stato un tema che abbiamo molto approfondito negli ultimi anni, grazie al contributo di molti di voi, in particolare ai colleghi del Direttivo che precede quello attuale: Antonella Lavagetto, Claudio Mangialavori; ad Alberto Ferrando, Laura Reali, che ringrazio per aver aperto un ulteriore percorso che sta dando molti frutti. Al momento siamo collegati a diverse Scuole di Specialità a partire dalla Università di Salerno, l’Università Federico II di Napoli, l’Università Cattolica di Roma, l’Università di Pisa, l’Università di Verona, l’Università Bicocca di Milano, in alcune il percorso è già iniziato da alcuni anni, in altre sta nascendo, in altre ancora è in fase di costruzione, con l’obiettivo concreto di uniformare i percorsi e lavorare sulla formazione dei tutor. Durante il congresso di Jesolo dello scorso anno abbiamo descritto e avuto occasione di approfondire alcuni progetti in corso in collaborazione con l’ISS e altre associazioni, come quello sulla “Nurturing Care” e la formazione di pediatri formatori, tutti ACP, che stanno collaborando nella formazione a cascata, insieme al team dell’ISS e delle altre associazioni partecipanti.
Il progetto “4e-Parent” con l’obiettivo della prevenzione primaria della violenza con un’attenzione sulle modifiche delle norme sociali e dei comportamenti al fine di promuovere una mascolinità accudente attraverso il coinvolgimento concreto dei papà fin dalla gravidanza ha e continua ad avere una notevole risonanza attraverso una costante azione di advocacy e anche di lobbying.
La Joint Action (JA) sulla implementazione di una Baby Friendly Community & Health Services (BFC&HS), un progetto europeo presentato dall’Istituto norvegese di sanità pubblica (Breastfeeding Unit), con l’obiettivo a livello europeo della riduzione dell’impatto delle Non-Communicable Diseases, affrontando i fattori di rischio a livello sia individuale sia sociale. Anche questo è un progetto di cui l’ACP è partner in collaborazione con ISS, COIRAG, UNICEF e altre associazioni e società scientifiche. Una task della JA è implementare la buona pratica BFC&HS e condurre un’azione pilota in nuovi contesti, come contributo alla riduzione dell’incidenza di cancro e altre NCD nella fase successiva della vita, a partire dai primi mille giorni, con un focus sulle disuguaglianze sociali e sanitarie. Come territorio di intervento è stata individuata, per il nostro Paese, la Regione Calabria dove è già partito il progetto nel territorio cosentino con un kick off meeting a marzo 2025. Il prossimo settembre inizierà nello stesso territorio la formazione al fine di realizzare una Baby Friendly Community. Una bella opportunità che potrà essere poi esportabile in altri contesti del nostro Paese.
Una nuova collaborazione è nata con la SIMRI per la realizzazione di un progetto che ha come obiettivo quello di adottare dei valori di riferimento italiani sulla spirometria in età pediatrica, progetto in corso.
In tema di collaborazioni ricordo la più antica, quella con il CSB. Vi menziono la partecipazione di ACP alla conferenza di EURead dove ho avuto l’occasione di parlare di Nati per Leggere e dell’importanza del coinvolgimento del settore sanitario, non sempre scontata a livello europeo.
Il direttivo ACP
È stato di valido aiuto e punto di riferimento per condividere proposte e prendere decisione attraverso un lavoro produttivo di squadra. Ricordo che l’organizzazione del congresso è frutto di tanti incontri fatti con il direttivo, tutti online, quasi sempre serali, a volte a digiuno fino a tarda sera, dopo una giornata di lavoro. Tutto questo non è scontato ma frutto di una dedizione all’ACP che ogni anno si presenta nella sua interezza. A tutte e tutti va un grande ringraziamento!
I gruppi di lavoro ACP
In questo ultimo anno, dopo alcune riorganizzazioni i gruppi di lavoro continuano a essere molto attivi, produttivi e appassionati. Sono aperti a tutte e tutti coloro che hanno voglia di partecipare e contribuire. Il gruppo di lavoro sulla salute mentale (responsabile Federica Zanetto) insieme al gruppo di lavoro sull’adolescenza (responsabile Franco Mazzini) si sono uniti nella realizzazione del Congresso del prossimo 25 ottobre a Bologna, un incontro che ha ripreso le fila del congresso di Neuropsichiatria quotidiana per il Pediatra. Il gruppo Salute Mentale ha proposto e sta lavorando alla realizzazione di “Pillole di Neurospichiatria”, una nuova modalità di comunicare sotto forma di “pillole” di breve durata e online su alcuni aspetti del neurosviluppo, quadri clinici neuropsichiatrici nell’ambulatorio del pediatra delle cure primarie e percorsi dedicati. A parte il ringraziamento a tutto il gruppo di lavoro, un grazie speciale va a una nuova componente del gruppo, Stefania Millepiedi, neuropsichiatra appassionata e di grande competenza. Il gruppo dei PUMP continua nel suo incessante lavoro, nel percorso insieme al gruppo Nutrizione alle pagine elettroniche di Quaderni acp. Argomenti attuali sull’impatto dell’ambiente sulla salute delle bambine e dei bambini, come i PFAS, le creme solari, i cambiamenti climatici, tutti argomenti in collaborazione con diverse società scientifiche italiane e europee. Il passaggio di testimone del gruppo Cure Palliative e Dolore da Michele Gangemi a Francesco Morandi è avvenuto nel corso dell’anno 2024, il gruppo è molto attivo su vari fronti attraverso incontri online e in presenza, ora anche in collaborazione con il corrispondente gruppo SIP.
Il gruppo di lavoro su Abuso e Maltrattamento è attivissimo sempre sia nella partecipazione ai nostri ultimi congressi, sia nella realizzazione di diversi webinar e articoli su Quaderni acp Il gruppo Pediatria di Genere è anch’esso molto attivo nella realizzazione di webinar e nella collaborazione con il corrispondente gruppo SIP sui diritti delle bambine e dei bambini. Il gruppo sulla riorganizzazione delle cure pediatriche primarie è attivo negli ultimi anni riguardo a un percorso oggettivamente tortuoso, dato l’argomento, che è stato approfondito da
Webinar realizzati o programmati nel 2024-2025
Organizzatore
Acp e IRCCS “Mario Negri”
Quaderni acp e E&P
Gruppo acp “Nutrizione”
Claudio Mangialavori durante il nostro congresso di Napoli e, successivamente, con la produzione di un documento che ha come obiettivo quello di contribuire alla realizzazione di un’organizzazione delle cure primarie centrata sulle famiglie e sui piccoli pazienti. Questo gruppo di lavoro il cui responsabile per le cure primarie è Claudio Mangialavori, ha lavorato su un documento che è stata in gran parte la base di una parte del libro Pediatria di Famiglia . Un particolare grazie a tutti coloro che hanno contribuito, in particolare a Claudio che si è avventurato in percorsi resi tortuosi da documenti politici e dal PNRR producendo un documento di notevole interesse e utilità che attualmente è oggetto di un’ulteriore sintesi.
I referenti regionali
Una risorsa importante un “sentire” dei territori, che potremmo ascoltare durante il congresso attraverso le voci di alcuni referenti sulle attività in corso. Per favorire ulteriormente un avvicinamento è stata nominata Federica Zanetto come coordinatrice dei referenti, quindi abbiamo un eccellente “collante”, di grande esperienza, che ci porterà la voce dei vari gruppi regionali e locali, che ringrazio per avere accettato.
La redazione di Quaderni acp e la formazione
Solo un ringraziamento a Michele Gangemi come direttore della rivista e a tutta la redazione per il grande lavoro svolto con dedizione e grande passione. Un ringraziamento va a tutti i revisori interni ed esterni, ma su questo lascerò la parola a Michele che approfondirà questo tema durante l’assemblea di Jesolo. Nel momento in cui questo editoriale si avvia alla stampa una bella notizia per i soci, amici e simpatizzanti dell’Associazione Culturale Pediatri, l’ACP apre un nuovo canale di comunicazione su Telegram per dare maggiore visibilità ai contributi scientifici delle sue riviste – Quaderni acp e Pagine Elettroniche di Quaderni – e per diffondere notizie, commenti e aggiornamenti su temi di attualità d’interesse pediatrico e sulle iniziative culturali e scientifiche dell’ACP. Potete aderire e avere accesso al canale semplicemente inquadrando il QR Code che vedete qui. Iscrivetevi numerosi e passate parola a chi pensate possa essere interessato a un aggiornamento pediatrico multiprofessionale, tempestivo e di qualità. Ci rivediamo su Telegram! Nonostante i miei tentativi di sintesi, l’elenco dei nostri risultati è sempre lungo. E ogni anno, negli ultimi quattro, mi chiedo come renderlo più breve senza perdere nulla. La risposta è sempre la stessa: non si può. Perché questo elenco non è una semplice lista, ma il segno tangibile della straordinaria vitalità e ricchezza culturale della nostra Associazione Culturale Pediatri (ACP).

E in ultimo un grazie al motore dell’ACP, alla benzina o forse, in termini ecologici, alla elettricità che lo alimenta, Gianni Piras che oramai ci accompagna da un ventennio e passa, con sempre maggiori competenze, passione e dedizione!
Ancora grazie!
Titolo Data Stato
Dopo i primi tre anni la crescita assume altre dimensioni: la Coorte Nascita
01/03/2025 Realizzato
Pediatria ed epidemiologia: come misurare gli effetti della crisi del SSN 09/04/2024 Realizzato
Alimentazione complementare: lo stato dell’arte 25/05/2024 Realizzato
Gruppo acp “Maltrattamento all’infanzia” Le tante facce della violenza (Parte II)
Gruppo acp “Pediatria di genere” Pediatria di genere
Gruppo acp “Salute mentale” Pillole di Neuropsichiatria
Gruppo acp “Pump” e Francesco Tonucci Campagna “Io vado a giocare”
15/11/2025 In programma
22/11/2025 In programma
27/11/2025 In programma
12/12/2025 In programma
Promuovere senza proteggere: un equivoco dannoso per l’allattamento
Sergio Conti Nibali
A nome del gruppo ACP “Nutrizione”
Nel 2014, dalle pagine di Quaderni ACP, lanciavamo un appello chiaro: i pediatri italiani decidano se vogliono proteggere l’allattamento [1] e siamo tornati a farlo 2023 [2]. Lo facevamo con la consapevolezza, già allora ben documentata, che promuovere l’allattamento senza proteggerlo è una strategia inefficace; che ogni azione per sostenere l’allattamento va accompagnata da una rigorosa applicazione del Codice Internazionale OMS e dalla denuncia dei conflitti di interesse, specie quelli che legano l’industria dei sostituti del latte materno a società scientifiche, formazione professionale, ricerca e informazione. A distanza di dieci anni, possiamo chiederci: cosa è cambiato? Sul piano culturale, qualcosa si è mosso: è cresciuto l’impegno di singoli operatori, équipe e singoli amministratori; ma a livello istituzionale, la protezione dell’allattamento resta ancora largamente disattesa, mentre si moltiplicano iniziative che, pur dichiarandosi a favore dell’allattamento, ne minano i fondamenti etici e metodologici. Il caso più emblematico è il progetto Policy Aziendale Allattamento (PAA), promosso dalla Commissione Allattamento della Società Italiana di Neonatologia (SIN), con l’adesione di numerose sigle professionali, presentato nel suo recente contributo [3] da Riccardo Davanzo. A una prima lettura, si presenta come una “alternativa semplificata” alla Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI), rivolta ai reparti di ostetricia e neonatologia italiani. Ma, come già osservavamo nei precedenti editoriali, una politica che promuove l’allattamento senza proteggerlo è destinata a produrre risultati modesti, se non fuorvianti. E i dati presentati da Davanzo lo dimostrano, come sottolinea Cattaneo nella rubrica Lettere di questo numero di Quaderni acp: nel rapporto 3 del progetto PAA [4], l’allattamento esclusivo è aumentato di appena 1,7 punti percentuali (dal 69,2% al 70,9%), senza alcuna riduzione dell’uso di formula artificiale. L’apparente “successo” è il frutto di una lieve flessione dell’allattamento predominante, non di un’effettiva sostituzione della formula con latte materno; dunque un miglioramento statisticamente significativo, ma clinicamente irrilevante. Il tutto in un contesto che – come riconosce lo stesso Davanzo – non prevede alcuna valutazione esterna, non impone il rispetto del Codice, non esclude il finanziamento da parte dell’industria, e che ammette che ogni professionista debba “gestire il dilemma del Codice a livello personale”. Questa ambiguità metodologica riflette un’ambiguità più ampia e radicata: quella culturale e politica. In Italia, dopo 25 anni dalla sua introduzione, la BFHI resta una nicchia affidata al lavoro volontario di operatori motivati e all’impegno di Unicef Italia, senza alcun reale supporto da parte delle istituzioni sanitarie centrali. Esempi virtuosi non mancano di certo, neppure troppo rari, di amministratori e operatori sanitari che hanno deciso con consapevolezza di intraprendere percorsi virtuosi, applicando protocolli basati su pratiche validate dalla letteratura scientifica, e ampiamente applicati in molti parti del mondo [5]. Eppure né il Ministero della Salute né le principali società scientifiche pediatriche hanno mai assunto un ruolo attivo nel superare gli ostacoli ben noti all’attuazione della BFHI: carenza di formazione indipendente, turn-over del personale, assenza di vincoli normativi, collusione
sistemica con l’industria. L’esempio di Paesi come Slovenia, Croazia, Regno Unito dimostra che questi ostacoli non sono insormontabili; basta volerli affrontare, come sottolinea Cattaneo nella lettera. La domanda è: perché in Italia non si è voluto? Le società aderenti al progetto PAA, pur pronunciandosi regolarmente a favore dell’allattamento, non hanno mai fatto pressione concreta per la rimozione degli ostacoli sistemici alla BFHI. Al contrario, hanno continuato a beneficiare del sostegno economico dell’industria delle formule: sponsor di eventi, congressi, corsi, pubblicazioni. Ciò che più colpisce, oggi come dieci anni fa, è la mancanza di coerenza: si dichiara un impegno per l’allattamento, ma lo si colloca dentro cornici operative che ne contraddicono i principi fondanti, a partire dalla necessaria protezione dall’influenza commerciale. La Lancet Breastfeeding Series 2023 ha dimostrato che le pratiche di marketing dei sostituti del latte costituiscono una minaccia globale alla salute pubblica [6]. Le multinazionali del settore influenzano operatori sanitari e decisori politici attraverso sponsorizzazioni, finanziamenti e co-produzione di linee guida [6,7]. Il risultato è un sistema sanitario esposto a conflitti di interesse che ostacolano politiche efficaci di protezione, promozione e sostegno dell’allattamento. Non si tratta di puntare il dito contro questo o quel progetto, ma di tornare a chiedere una scelta di campo chiara. Le prove di efficacia esistono. I modelli funzionanti esistono. Le raccomandazioni internazionali sono pubbliche e accessibili. Quello che manca è la volontà politica e istituzionale di attuarle. Anzi, a volte si ha l’impressione che si preferisca sostituire politiche efficaci ma impegnative, come la BFHI, con iniziative più compatibili con gli interessi dell’industria, più accettabili dai decisori politici, meno vincolanti per i reparti. Nel nostro contesto, la scarsa diffusione della BFHI non dipende da limiti strutturali, bensì dalla mancanza di volontà politica e culturale. Le iniziative volontarie, pur meritorie, non sono sufficienti a generare un cambiamento sistemico. Senza una regia pubblica, l’adozione della BFHI resta confinata all’impegno di singoli operatori e all’attività dell’Unicef Italia. La promozione dell’allattamento, se disgiunta dalla protezione, non è solo inefficace: è fuorviante. Serve una strategia integrata che preveda valutazioni indipendenti, formazione libera da interessi commerciali, e standard vincolanti. Occorre inoltre un impegno chiaro per recidere i legami economici con l’industria e ristabilire la credibilità delle società scientifiche. L’auspicio è che almeno l’esperienza del PAA serva da stimolo per l’adozione di percorsi BFHI in nuove strutture. Ma ciò sarà possibile solo se le organizzazioni promotrici decideranno di sostenere con coerenza le strategie OMS/Unicef, anche a costo di rivedere i propri rapporti con gli sponsor. Diversamente, ogni sforzo resterà inefficace, e l’allattamento continuerà a essere promosso a parole, ma indebolito nei fatti.
Bibliografia
1. Conti Nibali S. I pediatri italiani decidano se vogliono proteggere l’allattamento. Quaderni ACP. 2014;21:99.
2. Conti Nibali S. A che punto siamo con la protezione dell’allattamento. Quaderni ACP. 2023;30:99.
3. Davanzo R. Allattamento: l’epoca della consapevolezza. Quaderni ACP 2025;32:174-176.
4. Progetto PAA. Rapporto 3, 2025.
5. Pedrotti A, Ruscitti G, Mariotti G, et al. L’iniziativa Baby Friendly in Provincia di Trento: l’esperienza della certificazione dei punti nascita e della comunità. Quaderni ACP. 2023;30:112-116.
6. Rollins N, Piwoz E, Baker P, et al. Marketing of commercial milk formula: a system to capture parents, communities and science. Lancet. 2023 Feb 11;401(10375):486-502.
7. WHO. Scope and impact of digital marketing strategies for promoting breast-milk substitutes. Geneva, 2022. https://apps.who.int/ iris/handle/10665/354094:
8. WHO. Marketing of breast-milk substitutes: National implementation of the International Code. Geneva, 2022. https://www.who.int/ publications/i/item/9789240046085 serconti@glauco.it

Parliamo di sesso (senza tabù)

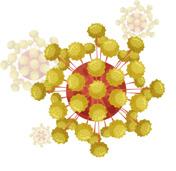




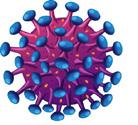
Lo sai? Dal 1988 il 1 dicembre è la giornata mondiale contro l’AIDS.
Papilloma virus
Clamidia HIV
Gonorrea
Studio della Griffonia
Simplicifolia
per il miglioramento del sonno nei bambini con disturbo dello spettro autistico: risultati preliminari
Gaia Di Fiore, Giuditta Bargiacchi, Marco Carotenuto
UO di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Obiettivi . I disturbi del sonno interessano oltre l’80% dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico (ASD) con effetti negativi su comportamento, umore e capacità cognitive. Scopo dello studio pilota è valutare l’efficacia della Griffonia Simplicifolia nei disturbi del sonno nei pazienti con ASD.
Metodi . A 42 bambini in età prepubere con diagnosi di ASD livello 3, secondo i criteri del DSM-5, e disturbo da insonnia cronica, secondo i criteri ICSD3, è stata somministrata Griffonia Simplicifolia (2-5 mg/kg) per 30 giorni consecutivi, 30 minuti prima di dormire.
Risultati Lo studio ha evidenziato che la somministrazione di 5-Idrossitriptofano (5-HTP) è efficace nel ridurre i risvegli notturni in circa il 75% dei soggetti a cui è stato somministrato in assenza di effetti collaterali rilevanti. Conclusioni . I dati dello studio dimostrano un’efficacia promettente della Griffonia Simplicifolia sul mantenimento del sonno nei bambini con ASD.
Objectives . Sleep disturbances affect more than 80% of children with Autism Spectrum Disorder (ASD), with negative consequences on behavior, mood, and cognitive functioning. This pilot study aimed to assess the efficacy of Griffonia simplicifolia in managing sleep disorders among children with ASD.
Methods The study included 42 prepubescent children diagnosed with Autism Spectrum Disorder Level 3, according to DSM-5 criteria, and Chronic Insomnia Disorder, as defined by ICSD-3 criteria. Participants received Griffonia simplicifolia at a dosage of 2–5 mg/kg for 30 consecutive days, administered 30 minutes before bedtime.
Results . Treatment with Griffonia simplicifolia led to a reduction in nocturnal awakenings in approximately 75% of participants, with no clinically significant side effects reported.
Conclusions . These findings suggest that Griffonia simplicifolia may represent a promising therapeutic option for improving sleep maintenance in children with ASD.
Introduzione
I disturbi dello spettro dell’autismo (ASD) rappresentano un disturbo del neurosviluppo a eziopatogenesi multifattoriale [1] con stime di prevalenza in Italia pari a 1,15% [2]. I criteri del DSM-5-TR evidenziano la compromissione in due principali aree: (A) difficoltà di comunicazione e interazione sociale, (B) pattern di comportamento, interessi ristretti e ripetitivi e attività sensoriali insolite verso stimoli ambientali. Il livello di gravità è valutato in base al tipo di compromissione e alla quantità e tipologia di supporto riabilitativo necessario [3]. Numerosi studi hanno dimostrato che il 50-80% dei bambini con ASD manifestano disturbi del sonno rispetto all’11-47% di probabilità dei soggetti non autistici [4]. Inoltre, a differenza dei bambini con sviluppo tipico (TDC) in cui i disturbi del sonno tendono a risolversi spontaneamente con la crescita, nei bambini con ASD queste alterazioni possono persistere anche dopo l’età scolare [5]. Nonostante l’elevata prevalenza di disturbi del sonno, pochi sono gli studi polisonnografici (PSG) con risultati contrastanti riguardo la durata maggiore o inferiore del sonno a onde lente (SWS, stadio N3) o la riduzione della fase REM oppure l’assenza di variazioni rispetto ai controlli neurotipici [6]. Del resto, la National Sleep Foundation (NSF) ha identificato i bambini autistici come una delle popolazioni pediatriche più a rischio per disturbi del sonno, sottolineando l’urgenza di approfondire la ricerca [7].
In ambito clinico, i caregiver tendono a preferire approcci farmacologici definiti “naturali”, come nutraceutici e fitoterapici rispetto ai farmaci tradizionali. Tra questi, l’utilizzo della melatonina e di 5-Idrossitriptofano (5-HTP) nei disturbi del sonno sono i più diffusi.
Nei bambini con ASD, la melatonina è efficace nel migliorare la latenza del sonno (SOL) e il tempo di sonno totale (TST), ma lo risulterebbe meno nella frammentazione del sonno da risvegli multipli [8]. Ruolo chiave nella regolazione neurochimica del sonno è svolto dall’amminoacido essenziale 5-HTP, precursore della serotonina, capace di modulare anche l’appetito, l’umore, le capacità visuospaziali, la memoria a lungo termine e il metabolismo delle kirunenine [9,10]. Uno studio basato sulla somministrazione di latte in formula ad alto contenuto di 5-HTP si è mostrato più efficace di quelli a dosaggio standard nel migliorare la latenza del sonno e il numero di risvegli notturni [11].
La Griffonia Simplicifolia è una pianta di origini africane, fonte naturale di 5-HTP e largamente utilizzata nella medicina popolare per cefalea, turbe dell’umore, insonnia. Negli ultimi anni, si è riscontrato un crescente interesse nei suoi confronti, grazie ai numerosi effetti benefici [12].
Le evidenze sull’utilizzo della Griffonia Simplicifolia nei bambini con alterazioni della qualità del sonno sono, però, ancora poche e ancora meno nei bambini con ASD.
Obiettivi
Considerata l’elevata incidenza e l’impatto negativo che i disturbi del sonno hanno sulle condotte dei pazienti autistici, lo scopo del presente studio è valutare gli effetti della Griffonia Simplicifolia sul sonno nei pazienti con ASD utilizzandone l’estratto titolato al 25% in 5-HTP.
Metodi
Il campione è costituito da 42 bambini prepuberi (24 maschi e 18 femmine) di età compresa tra 3 e 11 anni (età media 3,57± 0,7) con ASD di livello 3 e con diagnosi di insonnia cronica secondo i criteri dell’ICSD-3 (≥ 3 risvegli per notte per 3 volte a settimana per almeno 3 mesi), reclutati presso la UOSD di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Sono stati esclusi soggetti con concomitanti epilessia, malattie neuromuscolari, obesità, sindromi neurogenetiche.
Per lo studio è stata utilizzata una soluzione a base di Griffonia Simplicifolia titolata al 25% in 5-HTP al dosaggio di 2-5 mg/kg/die (media 5,92 ± 1,47) dove 1 ml di prodotto corrisponde a 40 mg di Griffonia Simplicifolia a sua volta pari a 10 mg di 5-HTP. La soluzione è stata somministrata per 30 giorni circa 30 minuti prima di andare a letto. Per 30 giorni, quindi, è stato compilato dai caregiver un diario del sonno strutturato e successivamente i pazienti sono stati rivalutati clinicamente. Si specifica che il disegno dello studio è open-label e no profit in quanto non sponsorizzato.
Analisi statistica
L’elaborazione dei dati è stata effettuata mediante il software IBM® SPSS Statistics Versione 29.0.2.0. L’analisi si è avvalsa della statistica descrittiva dove le variabili categoriali sono state espresse come numero dei soggetti e percentuali, quelle continue sono state espresse come media e deviazione standard. Valore di p è stato ritenuto statisticamente significativo se <0,05.
Risultati
Il punteggio medio alla scala ADOS-2 era 14,74 ± 2,05, a conferma del livello di severità clinica.
Prima del trattamento i bambini presentavano una frequenza media di risvegli intrasonno (WASO) di 3,83 risvegli, con un massimo di 10 risvegli per notte.
Dall’analisi statistica effettuata è emerso un miglioramento nella qualità del sonno nei pazienti affetti da ASD. In particolare, in 15/42 casi (37%) si è riscontrata una riduzione dei risvegli compresa tra il 50% e il 100%, mentre la riduzione del 50% dei risvegli è stata rilevata in 15/42 casi (37%). Nessuna variazione è stata riscontrata in 11/42 casi (26%) [Grafico 1]. Inoltre, è stato rilevato un aumento della durata media del sonno notturno da 4 a 6,5 ore con riduzione numerica dei risvegli notturni [Grafico 2].
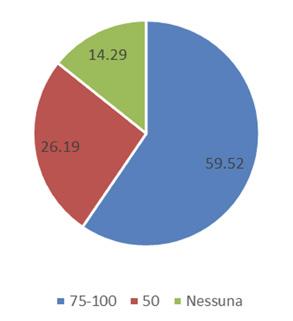
Grafico 1. Efficacia della riduzione dei risvegli intrasonno post-somministrazione.
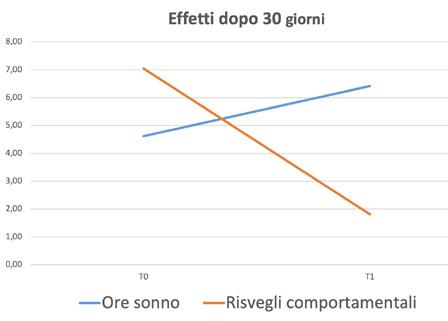
2. Effetti dopo 30 giorni di somministrazione.
Conclusioni
I disturbi del sonno sono particolarmente frequenti nei disturbi del neurosviluppo e in particolare nei bambini con ASD. La qualità del sonno può influire negativamente, sia nel breve sia nel lungo termine, sul comportamento, sulle stereotipie, sull’umore e sul funzionamento cognitivo di questi pazienti [6] e sulla qualità di vita dei caregiver. I risultati promettenti ottenuti nel presente studio suggeriscono che la Griffonia Simplicifolia potrebbe contribuire a migliorare la qualità del sonno nei bambini autistici, soprattutto nella fase di mantenimento del sonno, e pertanto può essere considerata in prospettiva futura una valida alternativa terapeutica nel breve termine. Oltre all’efficacia dimostrata, rilevante è risultata essere anche l’assenza di effetti avversi rilevanti e l’ottima compliance genitoriale.
Tuttavia lo studio presenta alcune limitazioni, tra cui l’assenza del placebo, il disegno in open label e la mancanza di un follow-up a lungo termine.
In prospettiva futura sarebbe auspicabile condurre uno studio in doppio cieco con introduzione del placebo, prevedendo un follow-up nel lungo termine e un ampliamento del campione di ricerca.
Bibliografia
1. Fallea A, Vetri L, L’Episcopo S, et al. Oral Health and Quality of Life in People with Autism Spectrum Disorder. J Clin Med. 2024 Aug 31;13(17):5179.
2. Narzisi A, Posada M, Barbieri F, et al. Prevalence of Autism Spectrum Disorder in a large Italian catchment area: a school-based population study within the ASDEU project. Epidemiol Psychiatr Sci. 2018 Sep 6:29:e5.
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TR, Fifth edition, 2022.
4. Bruni O, Biggio G, Malorgio E, Nobili L. Insomnia in children affected by autism spectrum disorder: The role of melatonin in treatment. Sleep Med. 2024 Jul:119:511-517.
5. Humphreys JS, Gringras P, Blair PS, et al. Sleep patterns in children with autistic spectrum disorders: a prospective cohort study. Arch Dis Child. 2014 Feb;99(2):114-118.
6. Kawai M, Buck C, Chick CF, et al. Sleep architecture is associated with core symptom severity in autism spectrum disorder. Sleep. 2023 Mar 9;46(3):zsac273.
7. Sleep Foundation. Autism and Sleep Issues. https://www.sleepfoundation.org/physical-health/autism-and-sleep (consultato: 11 maggio 2025).
8. Salanitro M, Wrigley T, Ghabra H, et al. Efficacy on sleep parameters and tolerability of melatonin in individuals with sleep or mental disorders: A systematic review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2022 Aug:139:104723.
9. Sejbuk M, Siebieszuk A, Witkowska AM. The Role of Gut Microbiome in Sleep Quality and Health: Dietary Strategies for Microbiota Support. Nutrients. 2024 Jul 13;16(14):2259.
10. Savino R, Carotenuto M, Polito AN, et al. Analyzing the Potential Biological Determinants of Autism Spectrum Disorder: From Neuroinflammation to the Kynurenine Pathway. Brain Sci. 2020 Sep 11;10(9):631.
11. Sánchez CL, Cubero J, Sánchez J, et al. The possible role of human milk nucleotides as sleep inducers. Nutr Neurosci. 2009 Feb;12(1):2-8.
12. Esposito M, Precenzano F, Sorrentino M, et al. A Medical Food Formulation of Griffonia simplicifolia/Magnesium for Childhood Periodic Syndrome Therapy: An Open-Label Study on Motion Sickness. J Med Food. 2015 Aug;18(8):916-20.
Grafico
Le competenze digitali dei bambini: sostenere il benessere dei bambini e un uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali
Mattia Messena, Marina Everri
School of Medicine, University College Dublin, Irlanda
Introduzione
Nella pratica pediatrica odierna le preoccupazioni che i genitori portano ai professionisti vanno oltre aspetti strettamente medici come influenza, mal di pancia, arrossamenti cutanei, ma possono riguardare aspetti comportamentali che in qualche modo si collegano all’uso di tecnologie digitali. Alcuni esempi possono essere preoccupazioni legate alle abitudini di sonno, sedentarietà, fino ad aspetti più espliciti di dipendenza da gioco online [1]. Questo perché l’ambiente virtuale non è più un aspetto periferico dell’infanzia e adolescenza, ma è diventato a tutti gli effetti un contesto di sviluppo tanto quanto l’ambiente fisico. A tal proposito, nell’ambito della psicologia dello sviluppo, i tradizionali modelli ecologici di sviluppo sono stati aggiornati per includere i contesti digitali che i bambini e gli adolescenti frequentano, in cui incontrano i pari, giocano e imparano [2]. Il ruolo delle tecnologie digitali nei processi di sviluppo e, soprattutto, nel benessere dei bambini è diventato un fattore centrale per ricercatori e professionisti della salute. La promozione di un uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali è diventata prioritaria al fine di tutelare il benessere dei bambini. Al fine di far luce sugli aspetti più importanti legati a queste tematiche, l’articolo presenta i principali risultati di un progetto di ricerca durato quattro anni [3,4] che si è svolto in due Paesi europei: Italia e Irlanda. La ricerca ha coinvolto bambini frequentanti le scuole elementari (10-12 anni) nei due Paesi, con l’obiettivo di chiarire in che modo l’uso delle tecnologie digitali si connette al loro benessere e quali sono le competenze digitali più rilevanti per poter utilizzare le tecnologie in modo sicuro e positivo.
Il progetto di ricerca è stato condotto presso la Universitty College Dublin e finanziato dall’Irish Research Council in partnership con CyberSafeKids, un’organizzazione irlandese no profit che si occupa di programmi educativi sulla sicurezza online per bambini.
In questo articolo verranno innanzitutto presentati modelli complessi dello sviluppo a cui il progetto si è riferito per contestualizzare le tecnologie digitali nei processi evolutivi. In seguito, verrà presentata una panoramica sugli aspetti metodologici, seguita dalla presentazione dei risultati principali. Infine, si discuteranno le implicazioni per l’intervento clinico.
Tecnologie digitali e sviluppo
Le prime ricerche sul ruolo delle tecnologie nello sviluppo dei bambini sono state fortemente influenzate dall’approccio li-
neare della tradizione dell’effetto dei media [5] e hanno studiato sperimentalmente l’impatto diretto delle tecnologie su varie dimensioni di sviluppo quali funzioni cognitive, emozioni, funzioni esecutive e processi di socializzazione [6-9]. Tuttavia questi studi sono stati fortemente criticati per importanti aspetti metodologici che hanno portato gli studiosi a constatare che i difetti nel rigore e nella validità di questa tradizione di ricerca hanno prodotto risultati poco significativi dal punto di vista clinico sul rapporto di causalità tra tecnologie e benessere dei bambini [10].
Un’altra importante critica a questa tradizione di ricerca riguarda le premesse teoriche, in particolare rispetto al ruolo del bambino. Assumendo infatti una relazione causa-effetto diretta tra tecnologie e benessere, il ruolo del bambino è relegato a mero soggetto che passivamente riceve input dai dispositivi, negandone pertanto l’agentività, ossia la sua partecipazione attiva nel dare forma a diverse modalità di adozione e uso delle tecnologie e di conseguenza diverse traiettorie di appropriazione e autonomia nell’utilizzo [11,12].
Questa visione semplicistica che non riconosce il ruolo attivo del bambino nel suo sviluppo è stata superata dalla tradizione ecologica. Il modello di sviluppo teorizzato da Bronfenbrenoner e colleghi [13,14] ha posto il bambino al centro di una complessa serie di sistemi concentrici che interagiscono tra loro e ne influenzano lo sviluppo [15]. Allo stesso tempo, però, il bambino influenza e contribuisce a dare forma a questi ambienti [16]. Questi sistemi sono costituiti dagli ambienti in cui il bambino è direttamente inserito, come la famiglia e la scuola, gli spazi di interazione tra questi ambienti, i contesti che si collegano indirettamente al bambino, come il luogo di lavoro dei genitori e, a livello più ampio, il contesto culturale [17]. La progressiva importanza assunta dalle tecnologie nell’offrire nuovi spazi di crescita per i bambini ha portato gli studiosi ad aggiornare questo modello, aggiungendo gli ambienti virtuali come ambienti in cui i bambini a tutti gli effetti si esprimono, imparano e socializzano [2].
La tradizione ecologica ha ispirato modelli che si sono focalizzati sull’uso delle tecnologie digitali da parte dei bambini e il loro benessere. Per esempio, i modelli elaborati da Livingstosne e colleghi [18,19] e Smahel e colleghi [20] hanno tentato di sistematizzare i fattori coinvolti nel determinare le attività online dei bambini e la loro influenza sul benessere. Complessivamente, le variabili incluse in questi modelli attengono a diversi livelli: a un livello individuale troviamo età, genere, tratti di personalità, compiti di sviluppo come la costruzione dell’identità e sessualità, accesso alle tecnologie, pratiche online, opportunità, rischi e competenze; a un livello sociale ci sono variabili familiari, legate ai contesti educativi e dei pari; a un livello nazionale/culturale sono comprese le variabili che riguardano digitalizzazione e regolamentazione delle tecnologie. Se da un lato questi modelli hanno il pregio di rendere conto dell’estrema complessità delle variabili in gioco quando si tratta di comprendere l’utilizzo delle tecnologie da parte dei bambini e come esse possano determinare il loro benessere, dall’altro lato offrono una limitata concettualizzazione delle attività online [20]. In tal senso, l’Activity Theory [21] viene in aiuto in quanto offre un modello comprensivo che definisce le componenti dell’attività. L’aspetto che rende particolarmente utile questo modello nell’ambito dell’uso della tecnologia è che pone l’accento sulla natura mediata dell’attività umana: l’attività, definita dal suo oggetto (ossia il motivo, le azioni e le operazioni svolte), è mediata dagli artefatti, oggetti o strumenti che il soggetto utilizza. È quindi chiaro che i dispositivi tecnologici supportano diverse attività definite da vari scopi e svolte mettendo in campo diverse competenze. Il modello però non si limita a questo livello individuale. L’attività è contestualizzata all’interno di una comunità i cui membri a vario titolo si coordinano e stabiliscono delle regole che ne cir-
coscrivono il campo. Questo modello ha guidato il nostro lavoro di ricerca [Figura 1].
Si può concludere quindi che gli studi hanno evidenziato come un approccio complesso e multidimensionale sia necessario per comprendere il ruolo delle tecnologie digitali nello sviluppo dei bambini e nel loro benessere.
Il progetto di ricerca
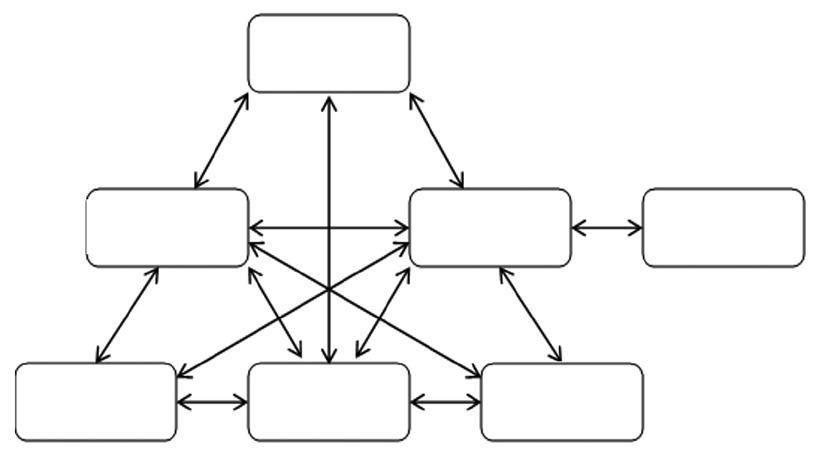
Soggetto/bambino
Il progetto è stato svolto tra il 2020 e il 2024 sul finire della pandemia di Covid-19, si è basato sulla integrazione di metodi di raccolta e analisi dati misti (combinando studi qualitativi e quantitativi) e ha attinto da diversi settori disciplinari, quali psicologia, sociologia e educazione. In totale sono stati coinvolti 606 preadolescenti in 7 scuole del nord Italia e 260 preadolescenti in 8 scuole del sud-est dell’Irlanda. I partecipanti avevano un’età compresa tra i 10 e i 12 anni. La scelta di coinvolgere bambini preadolescenti è dovuta al fatto che questa fase dello sviluppo è emersa particolarmente critica, in quanto dai più recenti report [23,24] emerge che i bambini tra 10 e 12 anni diventano progressivamente più autonomi nell’utilizzo delle tecnologie digitali e per la prima volta entrano in possesso di dispositivi personali, nello specifico smartphone.
Strumenti/ Tecnologie digitali
Attività (online/offline)
Regole Comunità Coordinamento agenzie sociali/ educative
Figura 1. Adattamento del modello dell’Activity Theory [22].
Esito/uso delle tecnologie
Per ragioni di spazio, in questo articolo presenteremo una sintesi dei risultati che rispondono alle seguenti domande:
1. qual è il rapporto tra utilizzo delle tecnologie digitali e benessere dei bambini?
2. quali sono le competenze necessarie per supportare un uso positivo delle tecnologie digitali da parte dei bambini e tutelare il loro benessere? [per maggiori dettagli cfr. 3,25].
Uso delle tecnologie digitali e benessere dei bambini
Studi condotti sulla relazione tra tecnologie digitali e benessere hanno evidenziato come il concetto di “uso” delle tecnologie digitali non fosse chiaro. Con l’obiettivo di chiarire questo concetto e quale sia il rapporto con il benessere dei bambini, è stata condotta una rassegna della letteratura [25] che ha incluso 129 studi. I criteri di inclusione sono stati:
1. coinvolgimento di bambini in età scolare (6-19 anni);
2. focus sull’uso negativo delle tecnologie digitali in relazione al benessere.
In merito alla concettualizzazione dell’uso, sono stati identificati due approcci. Uno focalizzato sul tipo di tecnologia utilizzata, per esempio internet o smartphone, e basato sul concetto di dipendenza; il secondo riferito a ciò che avviene online, ossia la qualità dell’esperienza, facendo riferimento per esempio a sexting o bullismo. Alla luce di ciò, due principali osservazioni possono essere fatte. Innanzitutto, se si applica il modello dell’Activity Theory [26], i due approcci non si escludono l’un l’altro, ma anzi devono essere entrambi considerati per apprendere a fondo l’esperienza dei bambini con le tecnologie digitali. In altre parole, non conta solo in che modo il dispositivo digitale viene usato in termini di tempo e frequenza, ma è fondamentale considerare che cosa viene svolto con il dispositivo e quali motivazioni guidano l’uso. Inoltre, la rassegna ha evidenziato un preponderante utilizzo del concetto di dipendenza, che però è stato ampiamente criticato in letteratura [27]. Per quanto riguarda il rapporto tra uso delle tecnologie e benessere, gli studi passati in rassegna hanno mostrato evidenze sia del fatto che l’uso può impattare sul benessere, sia che lo
stato di benessere può in qualche modo determinare il tipo di uso che i bambini fanno delle tecnologie digitali. Questo evidenzia un rapporto complesso di reciproca causalità più che di linearità. Per chiarire ulteriormente quale sia l’impatto dell’uso delle tecnologie digitali per il benessere dei bambini, abbiamo condotto due focus group con i bambini che hanno partecipato al progetto sia in Irlanda sia in Italia. Ciò che è emerso pone l’attenzione principalmente su aspetti relazionali e di contenuto. Infatti i partecipanti hanno evidenziato come l’uso delle tecnologie digitali può impattare sul loro benessere sia in modo positivo sia in modo negativo. In particolare hanno sottolineato come le innumerevoli opportunità che le tecnologie offrono, in particolar modo legate alla connettività con gli amici e all’apprendimento, supportano un umore positivo e fiducia in sé stessi. Dall’altro lato, contenuti inappropriati o problemi legati alle interazioni con gli altri possono suscitare frustrazione o rabbia. Degno di nota è il fatto che tra bambini italiani e irlandesi non emergevano discrepanze; tuttavia, i bambini italiani hanno maggiormente sottolineato il tema dei rischi e della necessità di regolare l’accesso ai dispositivi.
Competenze digitali e uso positivo
Recentemente, gli esperti hanno messo in luce l’importanza delle competenze digitali come quel set di competenze che i bambini dovrebbero acquisire per massimizzare i benefici delle tecnologie e minimizzare potenziali danni [28]. Anche in questo caso però, in ricerca le competenze digitali sono state concettualizzate e misurate in modi diversi, talvolta in senso molto ampio e talvolta in modo molto specifico [29]. Inoltre, le conseguenze delle competenze digitali in termini di supportare l’uso positivo delle tecnologie e il benessere dei bambini non è chiaro: gli studi hanno riportato risultati non sempre univoci, suggerendo che dimensioni specifiche di competenze digitali potrebbero portare a conseguenze diverse [30]. Per far chiarezza su questo aspetto, è stato condotto uno studio [31] che innanzitutto ha fornito una definizione di uso positivo delle tecnologie e poi, riferendosi a un recente modello teorico di competenze digitali [32], ha indagato l’impatto di diverse dimensioni di competenze sull’uso positivo delle tecnologie digitali durante attività di intrattenimento come giocare e guardare video online. L’uso delle tecnologie si caratterizza come sicuro e positivo quando ha un impatto positivo sul benessere. Come è già stato detto in precedenza però, assumere un rapporto causale diretto tra uso e benessere può essere fuorviante e semplicistico, sia perché ci sono molte variabili in gioco a livello individuale, sociale e culturale, sia perché tra uso e benessere ci può essere un rapporto di duplice causalità. Per superare queste proble-
maticità, recenti modelli hanno proposto che le attività online influenzano il benessere nella misura in cui si associano a opportunità e rischi online [10]. Inoltre, aspetti legati alle strategie di gestione dell’utilizzo dei dispositivi, e al fatto di avere un adulto di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità, sono ulteriori fattori per far sì che l’uso possa essere definito sicuro e positivo. Quattro diverse dimensioni di competenze digitali (tecniche, creazione di contenuti, comunicazione e interazione, ricerca e analisi di informazioni) sono state considerate in funzione di tutti gli aspetti che sono stati descritti come costituenti un uso sicuro e positivo delle tecnologie. I risultati dello studio hanno evidenziato che le competenze digitali come costrutto unitario erano associate in modo positivo a un uso sicuro e positivo delle tecnologie. Quando però le dimensioni erano considerate singolarmente, esse contribuivano in modo diverso al risultato. Infatti, competenze digitali comunicative e interattive e competenze di ricerca e analisi dell’informazione erano le uniche a promuovere un uso sicuro e positivo delle tecnologie per i preadolescenti. Al contrario, competenze di creazione di contenuti erano negativamente associate all’uso positivo, mentre competenze tecniche non avevano riportato alcun significativo impatto. In questo senso, al fine di favorire un uso positivo e protetto delle tecnologie digitali è necessario favorire e sostenere lo sviluppo di competenze che consentono ai preadolescenti di sapere comunicare efficacemente online e criticamente analizzare il tipo di interazioni che avvengono e il tipo di informazioni e contenuti che si trovano online.
Implicazioni per l’intervento I risultati del progetto di ricerca presentati in questo articolo suggeriscono interessanti elementi da tenere in considerazione per l’intervento. Innanzitutto, l’importanza di approcciare le tecnologie come strumenti che offrono l’accesso a modi virtuali (online) che possono diventare importanti contesti di sviluppo per i bambini in continuità con i contesti fisici (offline). Pertanto, è fondamentale contestualizzare l’uso delle tecnologie per capire come rischi e opportunità si bilanciano, a quali esigenze e motivazioni del bambino si lega e qual è il ruolo degli adulti, in particolare dei genitori, in termini di mediazione dell’utilizzo.
Inoltre, la promozione dello sviluppo di competenze, perlopiù critiche, legate alle interazioni online e alla ricerca di informazioni è centrale per sostenere un uso sicuro e positivo delle tecnologie e, di conseguenza, tutelare il benessere dei bambini. Tuttavia, questo non è sufficiente. I risultati infatti hanno anche evidenziato come la capacità di gestire e regolare l’emotività negativa può essere un importante fattore protettivo.
Bibliografia
3. Riva G, Mancini T. Psicologia dei media digitali. Il mulino, 2023.
4. Navarr J.L, Tudge JR. Technologizing Bronfenbrenner: neo-ecological theory. Curr Psychol. 2022 Jan 21:1-17.
5. Messena M. Fostering Children’s Digital Skills Development for Safer and Positive Use of Digital Technologies and Social-Emotional Wellbeing Through the Application of Innovative Educational Technologies. In: School of Medicine 2025, University College Dublin, 2025:235.
6. Messena M, Everri M, O’Brien V, Cooney, A. Children’s Digital Skills. Safe and Positive use of Digital Technologies in Ireland and Italy/Competenze Digitali dei Bambini: Uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali in Irlanda e Italia. CyberSafeKids, 2024.
7. Valkenburg PM, Peter J, Walther JB. Media effects: Theory and research. Annu Rev Psychol. 2016:67:315-338.
8. Krcmar M, Cingel DP. Parent-child joint reading in traditional and electronic formats. Media Psychology. 2014;17:262-281.
9. Lillard AS, Peterson J. The immediate impact of different types of television on young children’s executive function. Pediatrics. 2011 Oct;128(4):644-649.
10. Mares ML, Acosta EE. Be kind to three-legged dogs: Children’s literal interpretations of TV’s moral lessons. Media Psychology. 2008;11:377-399.
11. Mares ML, Woodard E. Positive effects of television on children’s social interactions: A meta-analysis. Media Psychology. 2005;7:301322.
12. Büchi M. Digital well-being theory and research. New Media & Society. 2024;26: 172-189.
13. Livingstone S, Sefton-Green J. The class: Living and learning in the digital age. New York University Press, 2016.
14. Livingstone S, Haddon L. Children, risk and safety on the internet: Research and policy challenges in comparative perspective. Policy Press, 2012.
15. Bronfenbrenner U. The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press, 1979.
16. Bronfenbrenner U, Morris PA. The ecology of developmental processes, in Handbook of child psychology: Theoretical models of human development, Damon W and Lerner RM Editors. John Wiley & Sons Inc., 1998:993-1028.
17. Quickfall A. “Down Here, It’s Our Time”: Bronfenbrenner’s Ecological Systems and The Goonies, in Unlocking Social Theory with Popular Culture: Remixing Theoretical Influencers, Barnes N and Bedford A Editors. Springer International Publishing, 2021:83-99.
18. Tudge JR, Mokrova I, Hatfield BE, Karnik RB. Uses and misuses of Bronfenbrenner’s bioecological theory of human development. Journal of family theory & review. 2009;1:198-210.
19. Bronfenbrenner U, Morris PA. The Bioecological Model of Human Development, in Handbook of child psychology: Theoretical models of human development, Damon W and Lerner RM Editors. John Wiley & Sons Inc., 2006.
20. Livingstone S, Mascheroni G, Staksrud E. Developing a framework for researching children’s online risks and opportunities in Europe. 2015.
21. Livingstone S, Mascheroni G, Staksrud E. European research on children’s internet use: Assessing the past and anticipating the future. New media & society. 2018;20:1103-1122.
22. Smahel D, Gulec H, Lokajova A, et al. The integrative model of ICT effects on Adolescents’ well-being (iMEW): The synthesis of theories from developmental psychology, media and communications, and health. European Journal of Developmental Psychology. 2023;20:944-61.
23. Vygotsky L. Thought and language. MIT press Cambridge, MA, 1962.
24. Bakhurst D. Reflections on activity theory. Educational review. 2009;61:197-210.
25. Beresford O, Cooney A, Keogh A, et al. Keeping Kids Safer Online. Online Safety Matters. Trends and Usage Report Academic Year 2022/2023. CyberSafeKids, 2023.
26. Smahel D, Machackova H, Mascheroni G, et al. EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. 2020.
27. Messena M, Everri M. Unpacking the relation between children’s use of digital technologies and children’s well-being: A scoping review. Clin Child Psychol Psychiatry. 2023 Jan;28(1):161-198.
28. Bertelsen OW, Bødker S. Activity Theory, in HCI models, theories, and frameworks: Toward a multidisciplinary science. 2003.
29. Ryding FC, Kaye LK. “Internet addiction”: a Conceptual Minefield. Int J Ment Health Addict. 2018;16(1):225-232.
30. ITU. Measuring the Information Society Report. International Telecommunication Union, 2017.
31. Haddon L, Cino D, Livingstone S, Doyle M-A. Children’s and young people’s digital skills: a systematic evidence review. ySKILLS-Youth Skills. 2020(A):1-152.
32. Livingstone S, Mascheroni G, Stoilova M. The outcomes of gaining digital skills for young people’s lives and wellbeing: A systematic evidence review. New media & society. 2023;25:1176-202.
33. Messena M, Everri M, O’Brien V, Gerosa T. The role of digital skills for safe and positive entertainment activities online. A cross-sectional study with pre-adolescents. 2025. To be submitted.
34. Helsper EJ, Scheider LS, van Deursen AJ, van Laar E. The youth Digital Skills Indicator: Report on the conceptualisation and development of the ySKILLS digital skills measure. Katholieke Universiteit Leuven, 2020.
Allattamento: comprendere il vissuto per sostenere le scelte delle madri
Giulia Bagnacani1 , Sara Lo Scocco2 , Linda Debbi3 , Laura Bonvicini2 , Costantino Panza4 , Luca Ghirotto5 , Paolo Giorgi Rossi2
1 Consultorio Salute Donna, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia; 2 Servizio di Epidemiologia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia; 3 Tirocinante corso di Laurea in Ostetricia, Università di Modena e Reggio Emilia; 4 Pediatra di Libera Scelta Dipartimento Cure Primarie, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia; 5 Direzione Scientifica, Unità di Ricerca Qualitativa, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia
mothers) through semi-structured interviews. Recurring themes emerged from analyzing their narratives, forming an explanatory model.
Results . Mothers’ accounts revealed a crucial point: the perception of a “positive” or “negative” experience doesn’t depend on whether they breastfed, but on the overall quality of the lived experience.
Conclusions The study suggests considering the “breastfeeding/non-breastfeeding experience” in its full complexity, including women’s self-determination and their broader context. The healthcare professional’s role is crucial in balancing biological, psychological, relational, and cultural aspects to offer adequate and personalized support.
Introduzione e obiettivi
Date le attuali conoscenze scientifiche sui vantaggi dell’allattamento per la salute psicofisica del bambino, della mamma e del pianeta e sui rischi dell’alimentazione formulata [1-3], gran parte della ricerca si concentra sui modi per favorirlo il più a lungo possibile – secondo le raccomandazioni dell’OMS [9] – individuando i fattori facilitanti e i fattori che invece possono giocare un ruolo nella decisione di non allattare delle donne (che siano essi di tipo biologico, sanitario, istituzionale, familiare, culturale o sociale).
Disclaimer
Nel corso dell’articolo, i soggetti verranno indicati utilizzando talvolta la terza persona singolare o plurale maschile (i clinici, i professionisti, i bambini, il neonato). Questa scelta ha lo scopo di rappresentare e includere tutte le soggettività partecipanti allo studio, indipendentemente dall’identità di genere. L’uso del maschile, condizionato dalle convenzioni della lingua italiana, è da intendersi in senso neutro e inclusivo. Sarà utilizzato il femminile quando si discuterà delle questioni di genere applicabili alle donne.
Obiettivi Comprendere l’esperienza reale di allattamento/ non allattamento delle madri, esplorando il loro “vissuto” per capire cosa lo renda positivo o negativo, al di là del mero successo nell’allattare.
Metodo. Abbiamo condotto una ricerca qualitativa usando la Grounded Theory. Questo approccio genera teorie direttamente dai dati, senza ipotesi predefinite. Abbiamo raccolto le storie di 36 donne (nonne e madri) tramite interviste semi-strutturate. Dall’analisi dei loro racconti, sono emersi temi ricorrenti che formano un modello esplicativo.
Risultati . Dalle testimonianze delle madri è emerso che la percezione di un’esperienza “positiva” o “negativa” non dipende dal fatto di aver allattato, ma dalla qualità complessiva del vissuto.
Conclusioni Lo studio invita a considerare l’esperienza di “allattamento/non allattamento” nella sua complessità, includendo l’autodeterminazione della donna e il suo contesto. Il ruolo del professionista sanitario è cruciale nel bilanciare aspetti biologici, psicologici, relazionali e culturali per offrire un sostegno adeguato e personalizzato.
Objectives . To understand mothers’ real breastfeeding/nonbreastfeeding experience, exploring their “lived experience” to determine what makes it positive or negative, beyond mere breastfeeding success.
Method . We conducted qualitative research using Grounded Theory. This approach generates theories directly from data, without predefined hypotheses. We collected stories from 36 women (grandmothers and
Il corpo sempre crescente delle conoscenze scientifiche riguardo i benefici dell’allattamento ha però forse portato lo sguardo dei professionisti lontano dall’esperienza reale delle donne che allattano o che non allattano, catalizzando tutta l’attenzione sull’esito (allattamento/non allattamento) e non sul processo (qual è l’esperienza della donna che allatta/non allatta?).
Mentre conducevamo una ricerca qualitativa che indagasse il ruolo che l’esperienza di allattamento o non allattamento delle nonne esercita sull’allattamento delle figlie o nuore [5-10], abbiamo avuto modo di raccogliere i racconti anche delle madri rispetto alla loro esperienza di allattamento, scoprendo come il concetto di “positivo” e “negativo” quando si parla di allattamento per le donne non riguarda il fatto di aver allattato o meno, bensì il tipo di esperienza fatta con l’allattamento o il non allattamento.
Di seguito quindi condivideremo una parte dei risultati di uno studio più ampio (“Dai Nonne! Gli effetti intergenerazionali dell’allattamento” in fase di traduzione in inglese per pubblicazione), focalizzandoci sulla parte riguardante le madri e la loro esperienza di allattamento e non allattamento.
Metodo: una ricerca che ascolta le persone
Quando si studiano temi così intimi come l’allattamento e le relazioni fra generazioni, i numeri da soli non bastano. Servono le storie, le emozioni, i significati che le persone attribuiscono a ciò che vivono. Per questo abbiamo scelto un metodo qualitativo: invece di contare quante nonne sostengono o scoraggiano l’allattamento, ci siamo chiesti come lo fanno, perché e con quali conseguenze nelle dinamiche familiari. È un approccio scientifico a tutti gli effetti, ma la “materia prima” non sono tabelle statistiche: sono le parole e i racconti dei partecipanti, raccolti con procedure rigorose di registrazione, trascrizione e analisi.
Grounded Theory: la teoria che nasce dal basso
Fra i vari metodi qualitativi abbiamo scelto la Grounded Theory, letteralmente “teoria fondata sui dati” [11,12]. In pratica funziona così:
1. Si parte senza ipotesi da confermare.
2. Si ascoltano le persone con domande aperte.
3. Dalle loro risposte emergono temi ricorrenti che, passo dopo passo, vengono intrecciati fra loro fino a formare un modello esplicativo del fenomeno.
L’immagine è quella di un puzzle: ogni intervista fornisce pezzi nuovi; noi li avviciniamo, vediamo quali combaciano, torniamo a chiedere se ne mancano altri, finché non appare una figura comprensibile.
La versione che adottiamo è quella costruttivista (K. Charemaz): riconosce che la conoscenza è co-costruita fra ricercatoari e partecipanti. Non si tratta di scoprire “la verità assoluta”, ma di costruire una spiegazione condivisa e utile nel contesto in cui le storie nascono.
Raccogliere le storie: 36 interviste, due generazioni
Abbiamo ascoltato 36 donne:
• 19 nonne (madri o suocere delle puerpere);
• 17 madri di neonati.
Le interviste erano semi-strutturate: una traccia di domande per non perdere i temi chiave, ma abbastanza flessibile da lasciare spazio a ciò che ogni donna riteneva importante raccontare. Ogni conversazione è stata audio-registrata, trascritta parola per parola e anonimizzata.
Dare ordine ai racconti: tre livelli di codifica Nell’approccio della Grounded Theory, l’analisi delle interviste si sviluppa attraverso un processo sistematico in più fasi, che permette di passare dai racconti individuali a una comprensione più generale e strutturata del fenomeno studiato. I tre passaggi principali di questo percorso analitico sono: la codifica aperta, la codifica focalizzata e la codifica teorica [Tabella 1]. Non aspettiamo di finire le interviste per analizzarle. Applichiamo subito i tre passaggi a ogni nuovo testo; ciò che scopriamo orienta le domande successive, così approfondiamo gli aspetti che emergono come cruciali.
Questione di etica: la sicurezza prima di tutto Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Area Vasta Emilia Nord (prot. n. 2023/0044308, 6 aprile 2023) e segue i principi della Dichiarazione di Helsinki, standard internazionale per la tutela dei partecipanti.
• Ogni donna ha letto e firmato un consenso informato scritto.
• La partecipazione era volontaria; chiunque poteva ritirarsi in qualsiasi momento senza ripercussioni.
• I dati sono trattati in forma riservata e anonima.
Questo percorso – ascolto, etichettatura, raggruppamento, modellizzazione – ci permette di trasformare racconti individuali in una spiegazione condivisa del ruolo che le nonne giocano nell’allattamento. Il risultato non è una legge universale, ma uno strumento utile per professionisti sanitari e policymakers che vogliano progettare interventi più sensibili alle dinamiche familiari multigenerazionali.
Risultati
In questa sede vorremmo offrire una panoramica delle categorie concettuali emerse nell’esperienza di allattamento/non allattamento delle mamme, rimandando all’articolo completo (in fase di traduzione in lingua inglese per futura pubblicazio-
ne) per uno sguardo allargato sugli elementi ricorsivi e comuni alle esperienze di allattamento di mamme e nonne. Un primo aspetto interessante emerso riguarda la definizione di ciò che può essere considerato positivo o negativo rispetto all’esperienza di allattamento/non allattamento vissuta. Il gruppo di ricerca partiva dall’aspettativa iniziale di considerare positive le esperienze in cui l’allattamento vada a buon fine e negative quelle in cui ciò non avvenga. Procedendo con la lettura e la codifica delle interviste, si è meglio compreso come non sia l’allattamento tout court a essere individuato come desiderabile dalle donne, bensì una positiva esperienza di allattamento o di non allattamento, che è un concetto più ampio, poiché non tutte le donne che hanno allattato con successo hanno avuto un’esperienza positiva, mentre non tutte le donne che non hanno allattato hanno avuto un’esperienza negativa. Ciò che concorre a produrre una narrazione di un tipo o di un altro sembra abbia a che vedere con fattori di vario genere di tipo personale, fisico, familiare, sociale e culturale. Si tratta di fattori da noi raggruppati in due macro-categorie. Da un lato quelli che abbiamo chiamato i “fattori favorenti/ sfavorenti” l’allattamento: conoscenze e informazioni sull’allattamento, aspetti emotivi nel post-parto, aspetti caratteriali e motivazione, difficoltà “tecniche” nell’avvio dell’allattamento, fattori bio-psico-sociali, supporto pratico ed emotivo nel post-parto, fiducia nel processo. Dall’altro quella che abbiamo definito “l’esperienza di allattamento/non allattamento” vera e propria che, naturalmente, è influenzata dai suddetti fattori che possono aver favorito o sfavorito l’allattamento tout court. Una predominanza di fattori che possono aver favorito l’allattamento è un’ottima premessa a che l’esperienza di allattamento sia vissuta positivamente, laddove invece una predominanza di fattori che hanno intralciato l’allattamento può essere alla base di un’esperienza negativa sia di allattamento sia di non allattamento.
Ciò che può moderare l’impatto dei fattori sfavorenti, oltre al ruolo della nonna che, ricordiamo, è discusso nell’articolo completo, sono gli elementi dell’esperienza di allattamento/ non allattamento che abbiamo così categorizzato: l’immagine della donna che allatta, l’idea di bambino, le teorie e le conoscenze sull’allattamento e il tipo di relazione instaurata con i professionisti sanitari.
Di seguito approfondiremo le singole categorie emerse.
Fattori favorenti e fattori sfavorenti l’allattamento
Sono queste una serie di variabili connesse alla madre di tipo fisico, emotivo, personale, familiare e sociale, che sono state raggruppate in due macro-categorie concettuali: fattori favorenti l’allattamento e fattori sfavorenti l’allattamento di seguito descritti brevemente.
Conoscenze e informazioni sull’allattamento
Le conoscenze e le informazioni corrette sull’allattamento o una chiara idea di dove reperire tali informazioni, sono elementi che concorrono a sostenere l’allattamento, mentre la
Fase Che cosa facciamo Esempio pratico
1. Codifica aperta Etichettiamo frasi o episodi significativi. “Ho avuto la sfortuna di non avere latte” → etichetta: allattamento percepito come questione di fortuna.
2. Codifica focalizzata Raggruppiamo etichette simili in categorie più generali.
3. Codifica teorica Colleghiamo le categorie fra loro e costruiamo un modello che spiega il fenomeno.
Le etichette sull’idea di “fortuna/sfortuna” confluiscono nella categoria: visione passiva dell’allattamento.
Il modello mostra, per esempio, che la visione “passiva” delle nonne influenza il modo in cui giudicano o consigliano le figlie.
Tabella 1. Le tre fasi della codifica delle interviste
mancanza di informazioni o conoscenze imprecise o scorrette vanno nella direzione opposta.
Aspetti emotivi nel post-parto
Gli aspetti emotivi nel post-parto giocano un ruolo importante nel favorire o meno l’allattamento laddove una situazione di carico emotivo negativo rappresenta un ostacolo, mentre un benessere psicologico rappresenta un fattore protettivo.
Aspetti caratteriali e motivazione
Un altro elemento emerso come particolarmente favorente la riuscita dell’allattamento è un “carattere” molto determinato unito a una forte motivazione ad allattare, laddove caratteri più “arrendevoli” rappresentavano un elemento sfavorente, specialmente a fronte di altre complessità.
Difficoltà “tecniche” nell’avvio dell’allattamento
In questo senso il far esperienza di “difficoltà tecniche” nell’avvio dell’allattamento (come ragadi, ingorghi, mastiti, difficoltà nell’attacco, esperienza di parto molto medicalizzata ecc.) aveva un ruolo nello sfavorire l’allattamento, mentre un allattamento avviato con “facilità” favoriva il proseguimento dello stesso.
Fattori bio-psico-sociali
Allo stesso modo situazioni di difficoltà fisiche, logistiche, sociali o psicologiche (lutti, malattie, ricoveri ospedalieri, separazioni, problematiche economiche ecc.) non deponevano a favore di una buona riuscita dell’allattamento, mentre situazioni di relativa stabilità creavano un contesto più incentivante.
Supporto pratico ed emotivo nel post-parto
La presenza di un supporto pratico ed emotivo a opera del partner, della famiglia d’origine o della rete amicale aveva un impatto positivo sull’esito dell’allattamento, mentre al contrario l’isolamento, la solitudine o la mancanza di supporto emotivo andavano in direzione contraria.
Fiducia nel processo
Infine una variabile psicologica emersa come favorente l’allattamento aveva a che fare con la “fiducia nel processo” dell’allattamento, evitando cioè di focalizzarsi sui singoli eventi ma confidando nella bontà delle risorse di madre e bambino e nella naturale predisposizione dei bambini ad essere allattati e delle madri ad allattare.
Esperienza di allattamento/non allattamento delle madri
Immagine della donna che allatta
Una categoria concettuale emersa nelle madri intervistate riguarda l’immagine sociale e il vissuto psicologico percepiti rispetto alla donna allattante, dalla donna stessa. In particolare, sono emerse due tipologie di immagine: da un lato l’allattare il bambino come elemento costrittivo e di dipendenza che riduce la donna al suo seno e alla sua funzione nutritiva, impedendole di realizzare la propria identità e le proprie potenzialità in altri ambiti (lavorativo, personale, relazionale e di coppia). Questo tipo di lettura e di vissuto sostiene un non allattamento, un allattamento di breve durata o un’esperienza non positiva di allattamento.
M7: “ho vissuto tanto la fatica di non essere sostituibile in questa cosa e… mio marito è un papà che fa il papà veramente, quindi è un papà presente, che anche con la vita che facciamo, comunque, cioè abbiamo la fortuna di… cioè lui ha poche ore fuori di casa di lavoro, perché fa giusto un part-time e… e quindi insomma, io ho vissuto tanto il fatto che lui era sostituibile a me in tutto tranne che quello”.
M7: “questo è stato comunque un passaggio molto grosso a livello identitario anche, perché… cioè lasciare il lavoro… qua le cose erano appunto in cambiamento, però non c’era ancora una struttura solida come adesso e quindi io ho fatto molta fatica con A., cioè ho passato dei mesi in cui facevo solo la mamma, che va benissimo, però io… cioè nel senso, non sono fatta così, quindi io ho fatto molta fatica”.
M3: “siccome potevo darglielo solo io in quel preciso momento, ne sentivo la responsabilità, quindi anche il fatto che io, essendo in partita IVA, una libera professionista, dovevo tornare a lavorare e tutto, questa cosa un po’, poi nel tempo, l’ho vissuta sempre meno come quell’atto romantico bellissimo tra me e mia figlia, ma più un ‘oddio devo pensarci solo io’… iniziava a essere un peso”.
Contrariamente, altre donne (o le stesse donne in fasi diverse dell’allattamento) hanno riconosciuto l’allattamento come fattore sia di praticità nella gestione, sia potenziante il proprio senso di efficacia e di soddisfazione, includendo anzi l’esclusività materna rispetto a questa pratica e la conseguente dipendenza del bambino per i primi tempi dalla madre, tra gli elementi vissuti positivamente, sebbene con fatica.
M5: “[l’allattamento] era nella mia mente la cosa più comoda. La tetta ce l’ho sempre, il latte è sempre con me, sempre pronto, temperatura giusta, possiamo andare ovunque.”
M5: “i primi mesi sono stati difficili [ricovero in TIN per prematurità] però ne è valsa la pena. Allattare era l’unica cosa che potevo fare io per la mia bimba mentre era ricoverata. Io non avevo lei tra le braccia, però io posso nutrirla e nessun altro lo può fare, questo mi ha motivato per tanti mesi.”
M3: “a livello di società intorno a me non ho mai avuto quelle cose, quelle paure tipo, non so se ero a fare un aperitivo fuori con degli amici e Gaia aveva bisogno di essere allattata, non ho mai sentito quella paura o vergogna di allattarla in pubblico, assolutamente.”
Idea di bambino
Questa categoria riguarda il tipo di idea che la nonna ha dei bambini in generale e della loro fisiologia.
Da un lato è presente un’idea di bambino come portatore prevalentemente di bisogni fisici e fisiologici (fame, sete, sonno, evacuazione): in questa lettura i segnali di disagio che il bambino manda sono tradotti e compresi prevalentemente in questa chiave. Il pianto del neonato, per esempio, viene interpretato primariamente come fame e ciò può portare a pensare che, se dopo una poppata il bambino piange o ricerca il seno, ciò significhi che non abbia mangiato a sufficienza e che dunque la produzione di latte della madre non sia adeguata alle esigenze del bambino. Questo tipo di lettura impedisce di considerare il bambino come portatore anche di intenzioni e bisogni emotivi (bisogno di comunicazione, di connessione, di contenimento e così via) e di interpretare il pianto anche in un’altra possibile chiave, rispondendo adeguatamente. In questo senso un’idea di bambino di questo tipo non favorisce una positiva esperienza di allattamento, in quanto potrebbe confondere la madre sul tipo di bisogno del bambino e sulla propria adeguatezza a rispondervi, preferendo adottare un metodo di alimentazione che possa essere più facilmente controllabile nelle quantità (così da assicurarsi appunto che il bambino mangi a sufficienza).
M4: “piangeva molto, tantissimo e non ce lo spiegavamo, dopo mia suocera diceva: ‘Ma non è che ha fame?’ poi me la metteva come pulce anche mio papà, quindi insomma tutto il contorno familiare, mio papà medico, quindi ho detto ‘vabbè mi fido’.” Diversamente, un’idea di bambino come portatore di bisogni anche emotivi, aumenta le possibilità interpretative della madre circa i segnali del bambino, ampliando e differenziando le possibili risposte al disagio non solo ricondotto a bisogni fisici. Questa lettura permette alle madri di riporre una maggiore
fiducia nelle proprie capacità accuditive e in quelle adattative del bambino, spostando il focus dall’allattamento come alimentazione tout court, all’allattamento come modalità per rispondere anche ad altri bisogni e introducendo differenti strategie per rispondere al bambino senza necessariamente ricorrere alla formula. Sostenendo la fiducia nelle proprie capacità di madre, questo tipo di lettura porta a vivere l’esperienza di allattamento in termini positivi.
M11: “il bambino piangeva, però non sai davvero perché piange, io collegavo il pianto alla fame, però è un bambino e non sai davvero perché sta piangendo. Potrebbe essere quello o no.”
M9: “tanto secondo me ha fatto il fatto di essere molto impreparata, perché molti dei primi segnali di difficoltà sono stati male interpretati.”
Teorie e conoscenze sull’allattamento
Avere informazioni corrette e scientificamente aggiornate sulla fisiologia dell’allattamento, sulle possibili difficoltà e su come affrontarle, oltre ad avere chiaro chi siano le professioniste qualificate per offrire consulenza sull’allattamento, è un fattore che favorisce un’esperienza positiva e di empoweroment della mamma sull’allattamento.
In particolare sono emerse due categorie di credenze e teorie sull’allattamento che sembrerebbero contribuire al tipo di esperienza vissuta dalle donne.
Le teorie da noi denominate “attive” riguardano l’idea che l’avvio e il successo dell’allattamento dipendano da fattori prevalentemente sotto il diretto controllo della donna o su cui sia comunque possibile intervenire. Spesso questo tipo di teorie sono sostenute anche da aggiornate conoscenze scientifiche sull’argomento o da esperienza di allattamento pregressa. M11: “mia mamma era sorpresa del fatto che io sia riuscita ad allattare, che la produzione di latte si potesse aumentare. Questa convinzione è arrivata dalle mie conoscenze, le mie letture.”
M9: “[con il secondo figlio] nel momento in cui mi sono arrivati dei nuovi feedback esterni ‘ah non hai latte, no, ma lascia stare, smetti di allattare’ [ho detto] no, non è così. Il latte c’è, è a richiesta, il seno va solo… bisogna dare il tempo e allora quello ha fatto la differenza. Quando ho avuto questi tipi di interventi anziché accettarli [come avevo fatto con il primo figlio] [ho avuto] l’apertura di capirli e capire se erano veritieri o meno.”
D’altro lato il vuoto informativo può lasciare spazio a teorie e credenze sull’allattamento che abbiamo definito “passive”, ovvero che vedono la donna in un ruolo passivo rispetto all’allattamento, vissuto come qualcosa che è fuori dal loro diretto controllo, legato quindi a variabili come la fortuna o la genetica. Questo tipo di teorie non predispone la donna verso un atteggiamento di risoluzione dei problemi, ma di accettazione passiva di uno stato di fatto, che nel caso in cui sia di fatica nell’avvio dell’allattamento, aumenterà le probabilità di fallimento e di vissuto negativo al riguardo.
M10: “Penso che non avevo latte perché è una cosa del mio fisico, non tutte hanno il latte, avendo avuto due figlie con lo stesso problema credo sia un problema del mio fisico.”
Tipo di relazione con il personale sanitario
Il tipo di relazione che intercorre tra la donna e il personale sanitario di riferimento, rappresenta un elemento che può giocare un ruolo nella percezione di empowerment o meno della donna rispetto all’allattamento/non allattamento (e alle sue competenze genitoriali in generale). Da un lato l’instaurarsi di un rapporto di tipo collaborativo, nel quale viene riconosciuto il ruolo professionale, ma che al contempo restituisce alle donne competenze nella relazione e nelle scelte per il proprio figlio e il proprio corpo, sostiene un’esperienza di nutrizione vissuta positivamente.
M1: “sì, quando le ho comunicato [alla pediatra] che intendevo smettere [di allattare] a 10 mesi, lei, insomma, ha detto ‘va bene’, comunque il bimbo era sano, per cui sicuramente lei spinge, ma nel modo giusto, a me fa piacere anche che una pediatra abbia avuto l’attenzione anche sulla mamma, perché è importante.”
Dall’altro lato una modalità di intendere il rapporto con il personale sanitario che vede la donna in un atteggiamento passivo e di delega al professionista, il quale di contro assume un ruolo di prescrizione dei comportamenti e delle strategie di nutrizione e accudimento (a volte vissuto come giudicante), depaupera la donna stessa della fiducia nelle capacità proprie, del proprio corpo e del proprio bambino, aumentando la possibilità di vivere l’esperienza in maniera non soddisfacente.
M4: “e infatti adesso mi chiedo se io avessi aspettato i 6 mesi anche con F. anziché fargli assaggiare mentre era a tavola con noi, però anche la pediatra mi aveva detto ‘se vedi che è curioso, chiaro che vede i fratelli, si sporge lungo la tavola, e vuole provare nulla in contrario’ quindi mi dico che forse gli ho fatto assaggiare troppo presto qualche alimento che poi magari l’ha incuriosito, avvicinato a tutto il resto e ha detto beh posso fare a meno del latte materno me lo sono posta come domanda, non so se ho sbagliato pure lì.”
M4: “sono andata più volte da [servizio pubblico di supporto all’allattamento] e sono sincera, mi sono sentita una mamma non capace quando uscivo da lì.”
M14: “ogni volta c’era un’ostetrica diversa, una volta ho trovato una che non mi piaceva, non ci andavo d’accordo, le ho risposto male e lei mi ha consigliato di andare dalla psicologa. Per me è un approccio sbagliato, non puoi consigliare una psicologa a una mamma che è presa male, l’ho presa come ‘sta isterica vatti a far vedere’.”
Laddove una madre possa contare su una predominanza di fattori favorenti l’allattamento è probabile che allatti e che la sua esperienza sia positiva anche in caso di non allattamento. Diversamente una predominanza di fattori sfavorenti potrebbe sostenere un non allattamento e un’esperienza negativa dello stesso o un allattamento vissuto non positivamente. In questa dinamica sembrerebbe giocare un ruolo anche il tipo di modalità comunicativa e di supporto messa in atto dalle nonne, ma per un approfondimento su questo aspetto si rimanda all’articolo completo.
Conclusioni
Oltre alle implicazioni pratiche che possono derivare da quanto emerge in termini di influenza delle nonne sull’esperienza di allattamento delle figlie/nuore (discusso nell’articolo completo in fase di traduzione in vista di una pubblicazione), questo studio ci offre uno spunto per iniziare a ragionare in termini di “esperienza di allattamento/non allattamento” e non solo di allattamento come ultimo e unico obiettivo desiderabile, includendo, oltre agli aspetti biologici, una visione della donna più ampia che comprenda necessariamente la sua autodeterminazione e il contesto familiare, sociale e culturale in cui si muove. Il ruolo del/della professionista sanitario, nella promozione e nel sostegno all’allattamento, appare oltremodo cruciale considerato l’intreccio di aspetti non solo biologici, ma anche psicologici, relazionali, sociali e culturali che il fenomeno allattamento racchiude. Tenerli in considerazione e saperli bilanciare nell’incontro con la donna è capacità non banale. La consapevolezza delle potenzialità, ma anche dei limiti del nostro ruolo professionale, ci appare strategica. Se, da un canto, “l’immagine della donna che allatta” non appare un fattore direttamente modificabile nella nostra pratica clinica, “il tipo di relazione con il personale sanitario”, “l’idea di bambino” e “le teorie e conoscenze sull’allattamento” delle quali ogni donna è portatrice, possono essere più facilmente modellate dal nostro intervento professionale. Agire consape-
volmente rispetto alla complessità assistenziale che hanno di fronte permetterà ai/alle professionisti/e di averne una visione completa offrendo alle donne un sostegno adeguato e, per loro stessi, maggiormente appagante.
Di seguito riportiamo un pezzo di un’intervista che riassume molti degli aspetti visti fino a qui e in cui il ruolo delle professioniste giuste, esperte di allattamento, ha giocato un ruolo cruciale nella buona riuscita dell’allattamento e dell’esperienza successiva.
M11: “io ero una persona molto motivata ad allattare, sana, forse avrei dovuto leggere di più al riguardo, ma pensavo sarebbe stata una cosa più naturale. Questa assunzione non mi ha aiutata. Poi io pensavo che c’era la chance che non avrei potuto allattare perché mia mamma non aveva allattato, non avevo letto abbastanza. Quindi mi sentivo dire ‘se tua mamma non ha allattato, forse anche tu’. Però io sono testarda e ho fatto del mio meglio, quello che era in mio potere. Quindi abbiamo continuato a provare, un po’ di latte usciva e quando siamo tornati a casa abbiamo letto altre cose e poi abbiamo scoperto la Leche League. [...] Il mio problema è stato che in ospedale non sono stati molto di supporto, io ero un po’ a digiuno di allattamento al seno, non preparata, avevo fatto i corsi, ma nessuno parla diffusamente di allattamento, nessuno nomina la Leche League, che è fantastica. Nessuno mi aveva consigliato di usare il tiralatte, mi hanno subito dato la formula, anche in ospedale. E non lo sapevamo, ora se avessimo un altro figlio sapremmo cosa fare. Abbiamo avuto un po’ di supporto dalle ostetriche ma non così tanto. [...] La Leche mi diceva ‘abbi fiducia nel tuo seno’, ce la fai, va tutto bene. Mentalmente ci ho messo un po’ ad accettare questo approccio perché pensavo sempre ‘oh mio Dio, lo sto affamando?’ perché non puoi misurarlo. [...] Il bambino piangeva, però non sai davvero perché piange, io collegavo il pianto alla fame, però è un bambino e non sai davvero perché sta piangendo. Potrebbe essere quello o no. Poi noi volevamo passare subito dalla formula al latte materno, ma anche alla Leche ci hanno detto no devi farlo gradualmente, quindi ci hanno aiutati in questo.”
Bibliografia
1. Stuebe AM, Schwarz EB. The risks and benefits of infant feeding practices for women and their children. J Perinatol. 2010 Mar;30(3):155-162.
2. Ip S, Chung M, Raman G, et al. Breastfeeding and maternal and inefant health outcomes in developed countries. Evid Rep Technol Asisess (Full Rep). 2007 Apr:(153):1-186.
3. Robinson S, Fall C. Infant nutrition and later health: a review of curlrent evidence. Nutrients. 2012 Aug;4(8):859-874.
4. World Health Organization. Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. World Health Organization, 2017.
5. De Brito Angelo BH, Pontes CM, Pedrosa Leal L. Knowledge, attitudes and practices of grandmothers related to breastfeeding: a meta-synthesis. Rev Lat Am Enfermagem. 2020 Feb 14:28:e3214.
6. Emmott EH, Mace R. Practical Support from Fathers and Grandmothers Is Associated with Lower Levels of Breastfeeding in the UK Millennium Cohort Study. PLoS One. 2015 Jul 20;10(7):e0133547.
7. Ferreira T, Piccioni L, Breno Queiroz P, et al. Influence of grandmothers on exclusive breastfeeding: cross-sectional study. Einstein (Sao Paulo). 2018 Nov 8;16(4):eAO4293.
8. Gharaei T, Amiri-Farahani L, Haghani S, Hasanpoor-Azghady SB. The effect of breastfeeding education with grandmothers' attendance on breastfeeding self-efficacy and infant feeding pattern in Iranian primiparous women: a quasi-experimental pilot study. Int Breastfeed J. 2020 Oct 12;15(1):84.
9. Grassley JS, Eschiti V. Grandmother breastfeeding support: what do mothers need and want? Birth. 2008 Dec;35(4):329-335
10. Negin J, Coffman J, Vizintin P, Raynes-Greenow C. The influence of grandmothers on breastfeeding rates: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth. 2016 Apr 27:16:91.
11. Charmaz, K. Constructing Grounded Theory (2nd ed.). SAGE, 2014.
12. Glaser BG, Strauss AL. La scoperta della Grounded Theory. Strategie per la ricerca qualitativa. Armando, 2009
giulia.bagnacani@ausl.re.it
Pietas o cinismo?
L’Europa e l’eutanasia nel bambino
Mario Renato Rossi, Patrizia Elli, Francesco Morandi
Pediatri e membri del GdL ACP “Dolore e cure palliative pediatriche”
In Olanda e Belgio sono vigenti leggi che permettono l’eutanasia nei pazienti minori in particolari condizioni. In altri Paesi l’eutanasia è permessa solo negli adulti e sempre a condizioni che vedono al centro la volontà dichiarata del paziente non sempre possibile nel minore. La maggioranza degli altri Paesi europei, tra cui l’Italia, rifiutano l’idea dell’eutanasia sia nel minore sia nell’adulto, considerata un reato punibile penalmente. Il “migliore interesse del bambino” è il fulcro intorno al quale si svolge il dibattito unitamente alla “definizione di sofferenza intollerabile e intrattabile”. Questo articolo non vuole dare opinioni, indicazioni o giudizi etici in merito all’eutanasia nel minore. Solo pone il problema alla discussione e al confronto su un tema tanto spesso evitato.
In the Netherlands and Belgium there are laws that allow euthanasia in children in certain conditions. In other countries, euthanasia is only allowed in adults and always under conditions that place the declared will of the patient at the center, this is not always possible in minors. Most other European countries, including Italy, reject the idea of euthanasia in both minors and adults and it is considered a crime punishable by law. The “best interest of the child” is the fulcrum around which the debate takes place together with the “definition of intolerable and intractable suffering”. This article does not intend to give opinions, indications or ethical judgments regarding euthanasia in minors, it only raises the issue for discussion and comparison on a topic so often avoided.
Nel nostro Paese parlare di eutanasia nel minore, anzi nel bambino, provoca subito una reazione di fastidio, di rifiuto dell’argomento. L’idea stessa di indurre la morte in un bambino cozza contro il viscerale rifiuto di un simile atto anche a fronte di motivazioni che, ragionevolmente, appaiono valide. Storia personale, etica personale, credenze religiose, contesti lavorativi e individuali ecc. portano alla necessità di forzare il nostro pensiero a considerare un’eventualità del genere. Altri Paesi con una storia diversa, con diverso peso della religione, con etiche diversamente elaborate hanno invece affrontato il problema, anche se con difficoltà e sofferenza, arrivando, in alcuni casi, a definire una legislazione, non sempre lineare e totalmente condivisa, sul tema.
Il fastidio suscitato dall’argomento e la difficoltà insita nell’affrontarlo non ci possono esimere dalla necessità di farlo a fronte di un dibattito aperto e vivace sul fine vita, sull’accanimento terapeutico, sul rispetto delle volontà dichiarate, sulla sedazione profonda, soprattutto su cosa consista il maggiore interesse del bambino. Ormai nel paziente adulto tutto questo ha trovato una sua definizione e un’accettazione in buona parte condivisa anche se non del tutto compiuta [1].
I bambini sono orfani di questa pietà come se le loro sofferenze fossero diverse, minori o più tollerabili perché la legge non riconosce loro competenza, volontà, capacità di intendere e
volere delegando a chi li ama lo straziante compito di chiedere, decidere e agire e, come disse un giudice inglese del caso Indi Gregory, queste persone sono spesso intellettualmente capaci, ma emotivamente incapaci.
Un modo per iniziare a parlare di questo tema è vedere come chi l’ha fatto in Europa ha prodotto una normativa che dovrebbe aiutare genitori, medici e giudici ad affrontare una simile decisione.
In Olanda fin dal 1985 l’eutanasia è permessa a determinate condizioni per i maggiori di 16 anni. Nel 2005 col protocollo di Groningen [2] si è aperta, sempre in Olanda, la possibilità di estenderla a neonati e bambini fino a 1 anno di vita e dal 2020 la “Commissione federale di valutazione e controllo eutanasia” ha ammesso l’eutanasia nei bambini tra 1 e 12 anni secondo strette condizioni e col consenso genitoriale aprendo un dibattito non ancora concluso; in tutti i casi, dopo l’eutanasia, la procedura viene segnalata alle autorità competenti per una verifica legale, per assicurarsi che siano stati rispettati tutti i requisiti legali e che il consenso sia stato ottenuto correttamente. Guardando il peso dei casi di minori sul totale, l’RTE (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie) nel suo report del 2023 riporta solo due casi di eutanasia in minori su un totale di 9068 notificati [3]; non viene riportata la casistica relativa all’applicazione del Protocollo di Groningen nei minori 0-1 anno.
In Belgio dal 2014 (legge C-2014/09093 del 28 febbraio 2014) è possibile praticare l’eutanasia ai minori, con l’assenso di entrambi i genitori e a determinate condizioni che prevedono che i minori debbano essere coscienti e dimostrare capacità di discernimento, capacità valutata da uno psicologo o uno psichiatra infantile, oltre al sussistere di una condizione di “costante e insopportabile sofferenza fisica” o che causi la morte a breve termine. In sintesi, in Olanda e Belgio l’eutanasia è permessa col consenso dei genitori a partire dai 12 anni fino a 16, tra i 16 e i 18 il consenso genitoriale non sempre è richiesto [4] mentre, nei neonati ed entro il primo anno di vita, col Protocollo di Groningen è permessa in casi di malattie gravi incurabili e con sofferenze insopportabili, col consenso genitoriale e il parere di due medici di cui uno non coinvolto nel caso; per i bambini tra 1 e 12 anni è richiesto il consenso dei genitori e il parere di almeno due medici. In altri Paesi, come Spagna e Lussemburgo e, in modo più complesso, in Svizzera, è ammessa l’eutanasia a certe condizioni e solo per i maggiorenni. In Francia è in corso l’approvazione parlamentare di una legge che permette il suicidio assistito e, in alcuni casi, l’eutanasia, ma non nel minore [5].
Tutto ruota intorno all’obbligo di perseguire “il migliore interesse del bambino”, affermazione che rappresenta un principio etico e operativo centrale che dovrebbe guidare ogni decisione medica attiva. Questo principio dovrebbe riguardare anche l’eutanasia e stare alla base della valutazione prioritaria del benessere fisico, emotivo e della dignità del minore in situazioni di malattia terminale o sofferenza intrattabile. Dovrebbe, inoltre, guidare le decisioni mediche e legali, bilanciando l’autodeterminazione del minore (se capace di discernimento) con la tutela dei suoi diritti fondamentali. Vi sono aspetti chiave sull’applicazione del principio del miglior interesse nell’ambito dell’eutanasia che sono stati diversamente affrontati dai Paesi che hanno fattivamente trattato il problema:
1. Capacità di discernimento: per esempio, il Belgio non impone limiti d’età, ma richiede una valutazione psicologica e psichiatrica per accertare la maturità del minore nel comprendere le conseguenze della scelta. I Paesi Bassi consentono l’eutanasia dai 12 anni, con il consenso genitoriale obbligatorio sotto i 16 anni.
2. Sofferenza insopportabile: deve essere accertata l’impossibilità di alleviare dolore e sofferenza con cure palliative,
limitando l’eutanasia ai casi di malattie fisiche incurabili (sono escluse quelle psichiche). Il Protocollo di Groningen (Olanda) include criteri come il giudizio dei genitori e dei medici sulla qualità della vita, sebbene questo possa sollevare dubbi sull’oggettività della valutazione.
3. Ruolo dei genitori e dei medici: il consenso di entrambi i genitori (o del tutore) è obbligatorio, ma la volontà del minore, se ritenuta autonoma, prevale nel processo decisionale. I medici devono garantire un’alleanza terapeutica, coinvolgendo il minore nelle scelte quando possibile, come previsto dalla legge belga del 2014.
4. Tutela della dignità: l’eutanasia è vista come un mezzo per evitare una morte “terribile”, preservando l’integrità del paziente. Il principio automaticamente esclude l’accanimento terapeutico, privilegiando una morte “dignitosa” rispetto al prolungamento artificiale della vita.
La “sofferenza intrattabile” è il punto cardine su cui si articolano le considerazioni che portano alla sedazione profonda o all’eutanasia. È una condizione in cui il bambino sperimenta sintomi fisici, psicologici, sociali o spirituali che non possono essere adeguatamente alleviati, nonostante interventi ritenuti appropriati, e questi sintomi risultano intollerabili per il paziente, richiedendo un approccio globale e la presa in considerazione di interventi come la sedazione palliativa profonda o l’eutanasia, come abbiamo visto in alcuni Paesi, affermando così che il miglior interesse del bambino è l’incoscienza totale o la morte. È una definizione difficile, complessa, che impatta con sensibilità diverse e che per questo sottolinea la necessità di una valutazione accurata e multidisciplinare, che tenga conto sia dei sintomi fisici sia del vissuto globale del bambino e della sua famiglia ma con strumenti che difficilmente si possono definire come definitivamente efficaci e oggettivi [5].
Ed è per questo che appare indispensabile che “tra l’équipe curante, il bambino malato e la sua famiglia si instauri una relazione comunicativa, contrassegnata dal continuo dialogo e dall’aperto confronto e che grazie a questa alleanza si realizzi il migliore interesse del minore e, nei limiti del possibile, il rispetto della sua volontà” [6,7].
In sintesi, la sofferenza intrattabile si può così rappresentare:
• multidimensionalità della sofferenza: il dolore e la sofferenza nei bambini non sono solo fisici, ma includono aspetti psicologici, sociali ed esistenziali, secondo il concetto di “dolore totale” introdotto da Cicely Saunders [8];
• refrattarietà del sintomo: un sintomo si può definire refrattario se non è controllato in modo adeguato nonostante sforzi tesi a effettuare trattamenti tollerabili, efficaci e appropriati, sia farmacologici sia non farmacologici, da parte di personale esperto;
• intollerabilità per il paziente: la sofferenza è intollerabile quando così è percepita dal bambino (o, nei casi in cui il bambino non può esprimersi, dedotto dai segni osservabili e dal confronto con i genitori e caregiver), e nessuna opzione terapeutica può assicurare un sollievo accettabile in tempi ragionevoli.
Ma quanto è possibile e quanto validi sono gli strumenti che abbiamo per valutare la sofferenza di un bambino spesso non in grado di esprimere con chiarezza a chi lo cura il suo dolore? Il tentativo di oggettivare e standardizzare il dolore con le scale di valutazione, pur utile, spesso non è sufficiente e può scontrarsi con la soggettività del bambino perché il dolore è individuale e come tale diversamente sentito e manifestato; come già detto, la sofferenza è intollerabile perché così è percepita dal bambino e la soglia di intollerabilità non è la stessa in tutti i bambini. Esperienza, ascolto del bambino e dei genitori, osservazione, conoscenza del vissuto, valutazione dei presidi analgesici ecc: tutto questo può aiutare a capire la percezione d’intrattabilità del “dolore totale” e a proporre e prendere decisioni per il suo maggiore interesse.
Arrivati a questo punto viene da chiedersi come la sedazione profonda continua e l’eutanasia possano rispondere al bisogno di interrompere la sofferenza intollerabile.
La sedazione profonda è un atto medico praticato in una malattia inguaribile, quando il paziente presenta sintomi refrattari, dolori o sofferenze fisiche/psichiche che non possono essere controllate in altro modo e la morte avviene di conseguenza senza interventi ad hoc [6].
L’eutanasia consiste nella somministrazione intenzionale di farmaci con lo scopo di provocare la morte del paziente su sua richiesta e col suo consenso, se ottenibile, o con la decisione di genitori ed esperti (medici, giudici) se la legge del Paese lo permette.
Quindi la differenza sta nell’intenzionalità e negli strumenti farmacologici utilizzati mentre la morte rimane la conclusione comune.
Sono riportati in vari documenti lavori che mostrano come la sedazione profonda non riduca la sopravvivenza del paziente rispetto alle attese [9]; quindi, sopravvivenza, non vita intesa come partecipazione, relazione, affettività ecc. Nella preponderante maggioranza dei casi la morte è l’esito che ci si attende da una sedazione profonda terminale in tempi più o meno lunghi. Anche la sofferenza e lo strazio di genitori e di chi assiste il bambino sedato si prolunga nell’attesa dell’evento finale. Chi è favorevole all’eutanasia si chiede se questo prolungarsi della sopravvivenza sia pietà a fronte di un esito previsto. L’invito è quello di non sottrarsi al confronto, di evitare preconcetti su base ideologica e religiosa, di aprire un dibattito nell’ACP per affrontare la complessità di un tema in grado di mettere in discussione convinzioni e coscienze.
Bibliografia
1. Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/01/2018.
2. Verhagen E, Sauer PJJ. The Groningen Protocol - Euthanasia in severe ill newborns. N Engl J Med. 2005;352:959-962.
3. RTE (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie) Annual Report 2023:17.
4. Service Public Federal Justice [C − 2014/09093] 28 FEVRIER 2014. Loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs.
5. Petrini V. Fine vita, la lezione che viene da Parigi. La Stampa. 30 maggio 2025.
6. Comitato Nazionale per la Bioetica “Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte”. 26 gennaio 2016:11-13.
7. Regione Toscana Commissione Regionale di Bioetica “Il dolore in età pediatrica: ascoltarlo, misurarlo, curarlo”. Parere CRB, 2020.
8. S. Du Boulay, Cicely Saunders. L’assistenza ai malati “incurabili”. Jaca Book, 2004.
9. Sykes N, Thorns A. The use of opioids and sedatives at the end of life. Lancet Oncol. 2003 May;4(5):312-318.
La rachicentesi che risolve i sintomi: riflessioni su due casi di meningite asettica
Giulia
Pederzani1,2 , Francesco Accomando1 ,
Enrico Valletta1
1 UO Pediatria, Ospedale G.B. Morgagni – L. Pierantoni, AUSL della Romagna, Forlì
2 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Bologna
La meningite asettica è definita come un’infiammazione delle meningi in assenza di microrganismi rilevabili nel liquido cerebrospinale. La sua eziologia può essere infettiva – più comunemente virale – o non infettiva, rendendosi una diagnosi di esclusione. Presentiamo due casi di meningite asettica in età pediatrica in cui si è osservato un immediato miglioramento clinico dei sintomi neurologici dopo puntura lombare, suggerendo un aumento della pressione intracranica come possibile meccanismo patogenetico. Questo fenomeno, denominato Elevated Lumbar Puncture Opening Pressure (ELPOP), può essere utilizzato come ulteriore indicatore diagnostico nella meningite asettica. Queste osservazioni evidenziano il potenziale beneficio terapeutico, oltre che diagnostico, della puntura lombare nel ridurre l’ipertensione intracranica in corso di meningite asettica.
Aseptic meningitis is defined as inflammation of the meninges without detection of any microorganism in cerebrospinal fluid. Its etiology can be infectious - most commonly viral - or non-infectious, making it a diagnosis of exclusion. This paper describes two pediatric cases of aseptic meningitis with immediate clinical improvement of neurological symptoms after lumbar puncture, suggesting increased intracranial pressure as a possible pathogenetic mechanism. This phenomenon, referred to as “elevated lumbar puncture opening pressure” (ELPOP), may be an additional diagnostic indicator in aseptic meningitis. These observations highlight the potential therapeutic, as well as diagnostic, benefit of lumbar puncture in relieving elevated intracranial pressure in aseptic meningitis.
La meningite asettica (MA) è una sindrome benigna, generalmente di breve durata (si risolve entro 5-14 giorni), caratterizzata da un’infiammazione delle meningi non attribuibile ai comuni agenti eziologici batterici [1,2]. I due casi di MA che descriviamo, e che hanno mostrato un rapido miglioramento clinico a seguito della rachicentesi, ci consentono di ripercorrere i principali meccanismi eziologici e patogenetici della malattia e di confermare come la rachicentesi possa avere un significato terapeutico, oltre che diagnostico, in questi pazienti.
Il primo caso
Un lattante di 7 mesi è stato ricoverato per irritabilità, vomito ricorrente e febbricola (37,5 °C) in presenza di una fontanella anteriore (FA) lievemente bombata. Nove giorni prima era stato dimesso dal nostro reparto con diagnosi di disidratazione in corso di gastroenterite acuta.
Gli esami ematici mostrano una leucocitosi neutrofila con contestuale linfo-monocitosi [GB 20380/mmc (v.n. 600017000), N 13930/mmc (v.n. 1500-8500), L 3880/mmc (v.n. 1300-3500), M 2490/mmc (v.n. 200-1300), PLT 590.000/ mmc (v.n. 14.0000-400.000)], PCR 0,9 mg/L (v.n. <5,0).
In seguito al peggioramento dello stato neurologico (il piccolo appariva scarsamente reattivo, irritabile alla visita con una FA persistentemente bombata), si è proceduti alla rachicentesi, previa esecuzione di tomografia assiale computerizzata (TC) per escludere controindicazioni alla manovra.
L’esame chimico-fisico del liquor cefalorachidiano (LCR) mostra un quadro di meningite asettica (aspetto limpido, incolore dopo centrifugazione, proteine: 0,32 g/L (v.n. 0,20-0,40), glucosio: 50 mg/dl, cellule nucleate totali: 97 x 10^6/L, GB: 94 × 10^6/L, PMN: 2 x 10^6/L, mononucleati: 92 x 10^6/L, GR: negativi). Durante la procedura si osserva una fuoriuscita accelerata del LCR senza, tuttavia, la disponibilità della misura manometrica della pressione di apertura.
Il paziente inizia un trattamento empirico con Ceftriaxone e Acyclovir, poi sospeso non appena pervenuta la negatività delle indagini microbiologiche sul liquor. Nel corso degli accertamenti, emerge la positività fecale per norovirus GII. Risultano negative le sierologie sieriche per toxoplasma, CMV, EBV, enterovirus e herpes simplex 1 e 2. Il decorso clinico è stato favorevole, con risoluzione dei sintomi neurologici immediatamente dopo la rachicentesi. A completamento, l’elettroencefalogramma (EEG) è risultato negativo per anomalie parossistiche e la risonanza magnetica nucleare (RMN) dell’encefalo non ha evidenziato alcuna alterazione parenchimale né aumento della captazione del contrasto da parte delle meningi.
Il secondo caso
Un bambino di 5 anni è stato ricoverato per accertamenti in corso di cefalea frontale, febbricola (37,6 °C), irritabilità e un singolo episodio di vomito. Gli esami ematici hanno evidenziato una modesta neutrofilia senza incremento degli indici di flogosi [GB 13960/mmc (v.n. 6000-17000), N 9720/mmc (v.n. 1300-3500), L 2640/mmc (v.n. 1300-3500), PLT 322.000/ mmc (v.n. 140.000-400.000), PCR 2,6 mg/L (v.n. <5,0)].
Esclusa, inizialmente, un’ipertensione endocranica all’esame del fundus oculi, è stata successivamente richiesta una TC dell’encefalo e del massiccio facciale che non ha mostrato anomalie del sistema nervoso centrale (SNC) e solo minimi segni di sinusopatia a carico dello sfenoide e dei seni mascellari.
Per la persistenza di cefalea intensa con episodi di vomito a digiuno, si effettua la rachicentesi. L’esame chimico fisico del LCR ha evidenziato un quadro di meningite asettica con liquor limpido e incolore [proteine: 0,64 g/L (v.n. 0,20-0,40), glucosio: 48 mg/dl, cellule nucleate totali: 174 x 10^6/L, GB: 170 x 10^6/L, PMN: 4 x 10^6/L, mononucleati: 166 x 10^6/L, GR: negativi]. Negativi l’esame batterioscopico e il colturale su LCR. Negative anche le ricerche su LCR, tramite PCR, degli acidi nucleici dei principali patogeni causa di meningiti/ encefaliti nonché gli accertamenti sierologici e la PCR su feci. Si segnala una positività per rhinovirus nell’aspirato nasofaringeo. È stata inizialmente avviata terapia antibiotica e antivirale empirica con Ceftriaxone e Acyclovir, sospesa alla negatività delle indagini microbiologiche. Il decorso clinico è stato anche in questo caso favorevole, con un miglioramento pressoché immediato della sintomatologia dopo la rachicentesi e senza più riscontro né di cefalea né di ulteriori episodi di vomito. A completamento, l’EEG è risultato privo di anomalie mentre la RMN encefalo, eseguita alla dimissione, ha evidenziato impregnazione contrastografica a carico delle leptomeningi confermandone l’interessamento infiammatorio.
Tabella 1. Eziologie infettive di meningite asettica
Virus Batteri Funghi Parassiti
– Enterovirus
– Arbovirus
– Adenovirus
– Virus influenzali
– Rhinovirus
– Virus della parotite
– HIV
– Virus della coriomeningite linfocitaria
– Mycoplasma pneumoniae
– Mycobacterium tubercolosis
– Treponema pallidum
– Leptospira spp.
– Meningiti parzialmente trattate
– Infezioni parameningee
– Endocardite
Tabella 2. Eziologie non infettive di meningite asettica
– Candida spp.
– Criptococcus neoformans
– Coccidioides immitis
– Blastomyces dermatitidis
Malattie sistemiche Farmaci Neoplasie
– Sarcoidosi
– Malattia di Behçet
– Sindrome di Sjögren
– Lupus eritematoso sistemico
– Granulomatosi con poliangioite
Discussione
– FANS
– Antibiotici (sulfamidici, penicilline)
– Immunoglobuline per via endovenosa (IVIG)
– Anticorpi monoclonali
La MA è un processo infiammatorio a carico delle meningi, caratterizzato da segni e sintomi acuti di irritazione meningea in assenza di microrganismi evidenziabili tramite le più comuni indagini batteriologiche. L’eziologia può essere infettiva o non infettiva [Tabelle 1-2]. La meningite asettica è nella maggior parte dei casi a eziologia virale (fino al 90% attribuibile a enterovirus e arbovirus); queste forme sono generalmente autolimitanti e con una buona prognosi [3].
È importante sottolineare che i termini meningite asettica e meningite virale non sono intercambiabili, poiché la meningite asettica può avere un’ampia gamma di cause potenziali, anche di natura non infettiva e non virale e una causa specifica è identificabile solo nel 30-65% dei casi [Tabella 2] [2,4]. Alcune MA, per esempio, sono sostenute da microrganismi che non crescono sui comuni terreni di coltura (es.: T. pallidum nella sifilide o B. burgdoferi nella malattia di Lyme), da farmaci o da malattie infiammatorie [3].
La diagnosi di MA si basa principalmente sull’esame del LCR che mostra una pleiocitosi con una presenza di leucociti superiore a 5 cellule/mmc2 . L’imaging può essere di supporto per confermare il sospetto clinico, escludere altri processi intracranici, valutare le possibili complicanze, escludere un’ipertensione endocranica prima di effettuare la puntura lombare o, infine, per monitorare lesioni già note. I pattern radiologici come la localizzazione, l’estensione dell’edema e il tipo di enhancement, possono in alcuni casi suggerire il tipo di infezione sottostante e tuttavia la diagnosi definitiva di meningite verrà dai riscontri clinici e di laboratorio [5].
Il primo caso descritto inquadra una forma di MA associata a gastroenterite da norovirus GII, una delle principali cause di diarrea infettiva nei bambini insieme al rotavirus [6]. Sebbene l’infezione da norovirus sia tipicamente autolimitante e localizzata al tratto gastrointestinale, può talora associarsi a manifestazioni extraintestinali come febbre, mialgia, cefalea, malessere generale e, in rari casi, anche complicanze neurologiche [5-7]. Sono riportati in letteratura alcuni casi di encefalopatia e MA associati a infezione da norovirus, nei quali si è ipotizzato un meccanismo patogenetico diretto con replicazione del virus nel SNC, o indiretto, legato alla risposta infiammatoria sistemica e alla conseguente iperproduzione di citochine [6,9-11].
Il secondo caso è esordito con un quadro neurologico acuto. Nonostante i test di laboratorio non avessero rilevato la pre-
– Toxoplasma gondii
– Taenia solium (neurocisticercosi)
– Trichinella spp.
– Hartmannella spp.
– Metastasi di tumori solidi
– Linfomi
– Leucemie
senza di microrganismi specifici, a eccezione della positività per rhinovirus nell’aspirato naso-faringeo, la risonanza magnetica ha confermato la reazione infiammatoria delle meningi. La RMN è metodica più sensibile della TC nella rilevazione delle infezioni del SNC e l’impiego del mezzo di contrasto a base di gadolinio consente di evidenziare (contrast enhancetment) precocemente le alterazioni della barriera emato-encefalica e l’aumentata vascolarizzazione associata ai processi infiammatori [12].
In entrambi i casi, la sintomatologia neurologica è completamente regredita dopo la rachicentesi diagnostica, suggerendo la possibilità di un incremento della pressione intracranica alla base della sintomatologia clinica, così come avviene nel corso di una meningite acuta batterica [13]. Purtroppo la pressione di apertura al momento della procedura non è stata misurata con un manometro e questo ci ha impedito di quantificare l’eventuale grado di incremento pressorio.
Un recente lavoro ha posto l’attenzione su un fenomeno poco studiato nella MA: l’Elevated Lumbar Puncture Ppening Pressure (ELPOP) ovvero l’elevata pressione di apertura alla puntura lombare, definita nel paziente adulto come una pressione superiore a 25 cmH2O [14,15]. Secondo gli autori, l’ELPOP è stata riscontrata nel 13,8% dei 116 pazienti valutati, ma resta comunque un aspetto della MA poco caratterizzato. Lo studio sottolinea l’importanza di includere l’esame del fundus oculi e la misurazione della pressione di apertura alla puntura lombare come parte integrante della valutazione in tutti i pazienti con sospetta meningite, poiché potrebbero fornire ulteriori indicazioni per orientare l’iter diagnostico e le decisioni terapeutiche [14].
Alcune ricerche condotte con protocolli standardizzati suggeriscono che le pressioni di apertura nei bambini non siano inferiori a quelle degli adulti e che non vi sia una stretta correlazione con età o l’indice di massa corporea. Tuttavia stabilire intervalli di riferimento affidabili nei pazienti pediatrici è complesso: l’iperventilazione dovuta al timore indotto dalla manovra può transitoriamente ridurre la pressione intracranica, portando a una sottostima; d’altra parte, in condizioni di sedazione o anestesia, la pressione intracranica può risultare più elevata, introducendo elementi di variabilità nelle misurazioni. La selezione dei pazienti, inoltre, rappresenta un ulteriore limite: il prelievo del LCR viene eseguito, ragionevolmente, in soggetti con sospetta o accertata malattia neurologica, rendendo difficile la raccolta di dati negli individui sani [16-17].
In letteratura si segnala un effetto terapeutico della puntura lombare in alcune forme di meningite e, tuttavia, le evidenze variano a seconda dell’eziologia e per quanto riguarda la MA sono piuttosto limitate [18-19]. Uno studio del 1989 su 48 bambini ha osservato un miglioramento significativo dei sintomi (irritabilità, cefalea e febbre) dopo la puntura lombare nei pazienti con meningite virale, mentre non si è riscontrato nessun cambiamento nel gruppo di controllo con infezioni non meningee. Tuttavia, anche in questa casistica, peraltro poco numerosa, non erano disponibili dati sulla pressione di apertura della puntura lombare e l’osservazione risultava in definitiva poco interpretabile [20]. Il miglioramento clinico immediato dopo rachicentesi nei pazienti con meningite virale ha trovato ulteriore conferma nel lavoro di Schlager et al . [21] condotto nel corso di un’epidemia di MA. Gli autori descrivono il cosiddetto “segno dell’hamburger”, riferendosi al comportamento di bambini che, entro trenta minuti dalla puntura lombare, mostravano un miglioramento sorprendente dei sintomi, tra cui la comparsa di appetito improvviso (talora chiedendo di potere mangiare un hamburger) con ripresa delle normali attività motorie e ludiche. Su 14 bambini con MA confermata, 10 presentarono un rapido miglioramento dopo rachicentesi, in assenza di terapia antibiotica, suggerendo che questo potesse costituire un elemento discriminante tra meningite virale e batterica e giustificando così un approccio più conservativo nella gestione terapeutica in alcuni casi di MA [21].
Conclusioni
La diagnosi di MA è, in definitiva, una diagnosi di esclusione. L’osservazione di un rapido miglioramento delle condizioni cliniche successivo alla puntura lombare può costituire un ulteriore elemento di riflessione e di indicazione diagnosticoterapeutica, rafforzando la decisione di sospendere la terapia antibiotica o antivirale eventualmente intrapresa, non appena acquisita la negatività degli accertamenti microbiologici sul liquor.
Bibliografia
1. Ellison D, Love S, Chimelli L, et al. 12. Acute viral infections. In: Ellison D, Love S, Chimelli L, et al. (eds.). Neuropathology (Third Edition). Mosby, 2013:305-326.
2. Kaur H, Betances EM, Perera TB. Aseptic Meningitis. In: StatPearls. StatPearls Publishing, 2025. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK557412.
3. Huppler AR. 52. Fever. In: Kliegman RM, Toth H, Bordini BJ, Basel D (eds.). Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnosis: Common Diseases and Their Mimics (Second Edition). Elsevier, 2023:965992.e2.
4. Jarrin I, Sellier P, Lopes A, et al. Etiologies and Management of Aseptic Meningitis in Patients Admitted to an Internal Medicine Department. Medicine (Baltimore). 2016 Jan;95(2):e2372.
5. Wong J, Quint DJ. Imaging of central nervous system infections. Seminars in Roentgenology. 1999;34:123-143.
6. Obinata K, Okumura A, Nakazawa T, et al. Norovirus encephalopathy in a previously healthy child. Pediatr Infect Dis J. 2010;29:10571059.
7. Arias C, Sala MR, Domínguez A, et al. Epidemiological and clinical features of norovirus gastroenteritis in outbreaks: a population-based study. Clin Microbiol Infect. 2010 Jan;16(1):39-44.
8. Shima T, Okumura A, Kurahashi H, et al. A nationwide survey of norovirus-associated encephalitis/encephalopathy in Japan. Brain Dev. 2019 Mar;41(3):263-270.
9. Sánchez-Fauquier A, González-Galán V, Arroyo S, et al. Norovirus-associated encephalitis in a previously healthy 2-year-old girl. Pediatr Infect Dis J. 2015 Feb;34(2):222-223.
10. Ito S, Takeshita S, Nezu A, et al. Norovirus-associated encephalopathy. Pediatr Infect Dis J. 2006;25:651-652.
11. Medici MC, Abelli LA, Dodi I, et al. Norovirus RNA in the blood of a child with gastroenteritis and convulsions – A case report. J Clin Virol. 2010 Jun;48(2):147-149.
12. Vaswani AK, Nizamani WM, Ali M, et al. Diagnostic Accuracy of Contrast-Enhanced FLAIR Magnetic Resonance Imaging in Diagnosis of Meningitis Correlated with CSF Analysis. ISRN Radiol. 2014 Mar 20:2014:578986.
13. El-Hajj VG, Pettersson I, Gharios M, et al. Detection and Management of Elevated Intracranial Pressure in the Treatment of Acute Community-Acquired Bacterial Meningitis: A Systematic Review. Neurocrit Care. 2024 Aug;41(1):228-243.
14. Ben-Dov M, Fellner A, Keret O, et al. Elevated lumbar puncture opening pressure in aseptic meningitis. J Clin Neurosci. 2022 Dec:106:55-60.
15. Friedman DI, Liu GT, Digre KB. Revised diagnostic criteria for the pseudotumor cerebri syndrome in adults and children. Neurology. 2013 Sep 24;81(13):1159-1165.
16. Lee MW, Vedanarayanan VV. Cerebrospinal Fluid Opening Pressure in Children: Experience in a Controlled Setting. Pediatr Neurol. 2011 Oct;45(4):238-240.
17. Avery RA, Shah SS, Licht DJ, et al. Reference range for cerebrospinal fluid opening pressure in children. N Engl J Med. 2010 Aug 26;363(9):891-893.
18. Glimåker M, Johansson B, Halldorsdottir H, et al. Neuro-Intensive Treatment Targeting Intracranial Hypertension Improves Outcome in Severe Bacterial Meningitis: An Intervention-Control Study. PLoS One. 2014 Mar 25;9(3):e91976.
19. Rolfes MA, Hullsiek KH, Rhein J, et al. The effect of therapeutic lumbar punctures on acute mortality from cryptococcal meningitis. Clin Infect Dis. 2014 Dec 1;59(11):1607-1614.
20. Jaffe M, Srugo I, Tirosh E, et al. The ameliorating effect of lumbar puncture in viral meningitis. Am J Dis Child. 1989 Jun;143(6):682685.
21. Schlager TA, Harris-Evans C, Hendley JO. “Hamburger sign” in aseptic meningitis. Pediatr Infect Dis J. 1997 May;16(5):540. francesco.accomando@auslromagna.it
Una porpora, tante sfumature: approccio alla vasculite da immunoglobuline A (IgAV)
Claudia Brusadelli1 , Anna Cogliardi1,2 , Leonardina De Santis2 , Daniela Zanta2 , Alessandra Tozzo3
1 Dipartimento di Pediatria, Ospedale San Leopoldo Mandic, ASST Lecco, Merate
2 Dipartimento di Pediatria, Ospedale Alessandro Manzoni, ASST Lecco, Lecco
3 Dipartimento Materno-Infantile di Pediatria, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
La vasculite da immunoglobuline A (IgAV), precedentemente nota come porpora di Schonlein Henoch, è la più frequente vasculite sistemica pediatrica. La diagnosi è essenzialmente clinica, ma le manifestazioni eterogenee e la possibile assenza del tipico rash all’esordio, mandatorio per la diagnosi, possono rappresentare una sfida per il clinico. La malattia è autolimitante nella maggior parte dei casi, tuttavia una piccola percentuale di pazienti può presentare un decorso complicato dal coinvolgimento gastrointestinale e renale. La revisione si pone l’obiettivo di definire le indicazioni al trattamento di prima e seconda linea e al ricovero per i pazienti affetti.
Immunoglobulin A vasculitis (IgAV), formerly known as Henoch Schonlein Purpura, is the most common systemic vasculitis of childhood. The diagnosis is made clinically, but the heterogeneous manifestations and the absence of the typical rash at the onset, necessary for diagnosis, can represent a challenge for the clinician. The disease is self-limiting in most cases, however a few patients can have a severe course because of gastrointestinal and renal involvement. This review aims to define first and second line treatment indications and hospital admission criteria for patients affected with IgAV.
Matilde, 3 anni
Matilde, bambina di 3 anni con anamnesi non significativa, viene condotta in pronto soccorso (PS) per dolore agli arti inferiori e rifiuto della deambulazione in apiressia. L’obiettività evidenzia un’artrite del ginocchio sinistro e gli esami ematochimici mostrano solo un lieve rialzo degli indici di flogosi (GB 8400/mmc, PCR 1,97 mg/dl v.n. <0,5). La bambina viene ricoverata, viene avviata terapia antinfiammatoria con ibuprofene per os e vengono eseguiti accertamenti nell’ipotesi di un’artrite reattiva: sierologie infettive (EBV, CMV, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae) risultate negative per infezioni in atto, TAS 1973 UI/ml (v.n. <100), VES 44 mm/h (v.n. <15), C3 e C4 nei limiti di norma, ferritina nella norma, tampone faringeo per streptococco negativo, ANA positivo 1:160 fine speckled (AC-4) , ECG ed ecocardiogramma nella norma. L’elevazione del TAS e il quadro di artrite
monoarticolare in assenza di coinvolgimento cardiaco fanno propendere per un’artrite post streptococcica. Stante il miglioramento della sintomatologia dolorosa con la terapia antinfiammatoria, la bambina viene dimessa con follow-up reumatologico per l’avvio della profilassi con penicillina. A domicilio compaiono lesioni purpuriche agli arti inferiori per cui la bambina viene ricondotta in PS dopo cinque giorni dalla dimissione. Gli esami ematochimici confermano il lieve rialzo degli indici di flogosi (GB 9700/mmc, PCR 1,26 mg/dl), l’emocromo esclude una trombocitopenia, la coagulazione è nella norma, lo stick delle urine nella norma. Matilde viene nuovamente ricoverata nel sospetto di IgAV. Durante la degenza compare dolore addominale e la bambina presenta episodi di vomito con striature ematiche e rettorragia. L’ecografia addome esclude l’invaginazione intestinale o l’ispessimento delle pareti intestinali. In considerazione del coinvolgimento addominale con numerosi episodi emetici si decide di avviare terapia steroidea endovenosa con metilprednisolone 1 mg/kg/ die per 3 giorni, poi modificata con terapia orale con prednisone 1 mg/kg/die per il miglioramento delle condizioni generali. La bambina viene pertanto dimessa prevedendo un lento scalo della terapia con prednisone. Tuttavia, dopo circa 6 settimane dall’esordio, in corso di scalo della terapia steroidea, si assiste a una riacutizzazione della sintomatologia dolorosa addominale con proctorragia e ricomparsa delle lesioni purpuriche per cui la bambina viene ricondotta in PS e ricoverata. In considerazione dell’abbondante proctorragia Matilde viene sottoposta a colonscopia in narcosi con evidenza di un quadro di flogosi a livello dell’ileo terminale e petecchie nel colon discendente, sigma e retto. L’esame istologico conferma il quadro macroscopico mostrando marcata iperplasia del tessuto linfoide a livello del piccolo intestino e modesta flogosi acuta e cronica, senza evidenza di granulomi. Il severo coinvolgimento intestinale e la steroido-dipendenza inducono ad avviare una terapia di secondo livello con immunoglobuline endovena 2 g/kg in 5 giorni e metilprednisolone endovena 2 mg/kg/die per 3 giorni. La terapia steroidea viene successivamente proseguita per os con prednisone 2 mg/kg/die a cui viene associato micofenolato mofetile. Nel corso del ricovero vengono inoltre estesi e ripetuti gli accertamenti ematochimici che risultano nella norma/negativi (in particolare ANCA negativi, ANA ripetuti e in questa occasione negativi, immunoglobuline nei limiti per età). L’esame urine e i valori pressori si mantengono nella norma. Il miglioramento delle condizioni generali della bambina consente la dimissione con follow-up reumatologico. Per successiva comparsa di proteinuria persistente seppur lieve (rapporto proteine urinarie/creatinina urinaria su campione estemporaneo 0,4-0,6) associata a ematuria, anche alla luce dell’insorgenza in corso di terapia, Matilde viene sottoposta a biopsia renale che mostra un quadro di nefrite lieve caratterizzato da proliferazione mesangiale. La paziente è attualmente in buon controllo di malattia in corso di terapia immunosoppressiva con micofenolato in follow-up nefrologico e reumatologico presso un centro di riferimento di nefrologia pediatrica.
Introduzione ed epidemiologia
La IgAV, precedentemente nota come porpora di Schonlein Henoch, con una incidenza di 3-27 casi per 100.000 bambini, è la vasculite sistemica più comune dell’età pediatrica. Può presentarsi a qualsiasi età, anche adulta, ma il 90% dei casi esordisce prima dei 10 anni con un picco nei bambini tra i 4 e i 6 anni. Gli adolescenti affetti presentano caratteristiche più simili alla forma dell’adulto con maggiore coinvolgimento articolare e renale e tendenza alla cronicizzazione [1]. La distribuzione stagionale della IgAV, prevalente nei mesi invernali e primaverili, supporta l’ipotesi patogenetica del ruolo di trigger infettivi delle vie respiratorie superiori in soggetti gene-
ticamente predisposti. Nel 50% dei pazienti, infatti, è possibile rilevare in anamnesi una recente infezione delle vie respiratorie, soprattutto streptococco beta-emolitico di gruppo a (SBEGA), ma anche parvovirus, adenovirus e virus di Epstein Barr (EBV) [2]. Sebbene alcuni case report abbiano riportato la correlazione tra vaccinazioni e IgAV, non esistono studi a supporto di tale associazione [3,4]. L’incidenza della IgAV è maggiore nei soggetti affetti da febbre mediterranea familiare, in cui prevale il coinvolgimento addominale [2].
Eziopatogenesi e istopatologia
La IgAV è una vasculite dei piccoli vasi dall’eziopatogenesi ancora non completamente chiarita. È noto che si tratta di una malattia mediata da immunocomplessi a IgA che si depositano a livello dei vasi verosimilmente in seguito a stimoli infettivi. Esiste una predisposizione genetica alla malattia associata ad alcuni geni HLA (Human Leucocyte Antigen), a polimorfismi genici coinvolti nella anomala glicosilazione di un sottotipo di IgA (IgA1), nella risposta agli insulti del sistema vascolare (e-NOS, Endothelial Nitric Oxide Synthase; ACE, Angiotensin-Converting Enzyme; MCP, Monocyte Chemoatetractant Protein e TGF, Transforming Growth Factor) e cortrelati a citochine pro-infiammatorie (interleuchina 18) [1,2]. È evidente quindi che la IgAV non sia determinata da una singola mutazione genica, ma piuttosto dalla combinazione di più fattori di suscettibilità individuale che contribuiscono all’insorgenza e alla severità del quadro clinico, associati a fattori ambientali [1]. Il reperto istologico è caratterizzato da una vasculite leucocitoclasica a prevalenza polimorfonucleare dei piccoli vasi (arteriole, capillari, venule e glomeruli) associata a depositi di immunocomplessi del sottotipo 1 delle IgA, localizzata a livello cutaneo, intestinale e glomerulare [5].
Clinica e diagnosi
La diagnosi di IgAV è clinica, non essendoci test diagnostici laboratoristici. Negli anni sono stati formulati diversi criteri di definizione e classificazione della patologia. Stando alle raccomandazioni europee SHARE (Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe) del 2019 i criteri classificativi da utilizzare sono quelli EULAR/PRINTO/Paediatric Rheumatology European Society del 2008 riportati in Tabella 1 [6].
Tabella 1. Criteri classificativi EULAR/PRINTO/PReS 2008 per la diagnosi di IgAV [1]
Criterio Definizione
Porpora (criterio mandatorio) Porpora palpabile o petecchie, prevalenti agli arti inferiori, e non correlati a trombocitopenia
Più almeno 1 dei seguenti 4 criteri
Dolore addominale Colico, acuto, diffuso; possibile sanguinamento intestinale o invaginazione
Istologia Vasculite leucocitoclastica con prevalenti depositi di IgA oppure glomerulonefrite proliferativa con prevalenti depositi di IgA
Artralgie/artrite Dolore articolare acuto, con tumefazione e limitazione al movimento (artrite) oppure isolato (artralgia)
Interessamento renale Ematuria
Proteinuria (>0,3 g/24 h)
• Cute. Nel 75% dei casi la IgAV esordisce con un rash simmetrico eritemato-maculare, a volte orticarioide, che evolve in petecchiale/purpurico, in assenza di trombocitopenia o coagulopatia, a partenza dalle aree gravitazionali come arti inferiori e glutei, oppure volto e tronco nei bambini non deambulanti. La porpora è generalmente palpabile con lesioni che possono essere pruriginose ma mai dolorose. L’eruzione cutanea può non essere presente all’esordio (25% dei pazienti), complicando la diagnosi, ma compare sempre nel corso della malattia ed è mandatoria per la diagnosi [1].
• Artrite/artralgia. L’interessamento articolare è la seconda manifestazione clinica in frequenza, poiché si riscontra fino all’84% dei pazienti. Può raramente precedere l’eruzione cutanea, solitamente di 1-2 giorni. È caratteristico della malattia l’interessamento oligoarticolare (fino a 4 articolazioni) migratorio e non deformante delle articolazioni degli arti inferiori. La tumefazione articolare è spesso prominente seppure non si riscontrino rubor o calor né abbondante versamento sieroso [7,8].
• Sintomi gastrointestinali. Le manifestazioni gastrointestinali, variabili in intensità da lievi (nausea, vomito, ileo paralitico transitorio) a gravi (emorragia gastrointestinale, ischemia, intussuscezione e perforazione), interessano circa la metà dei pazienti. Solitamente esordiscono entro 8 giorni dalla comparsa del rash, ma sono descritte anche tempistiche più lunghe (settimane o addirittura mesi). Il quadro gastrointestinale può anche precedere la comparsa del rash, rendendo difficile la diagnosi. L’invaginazione interessa tipicamente solo il piccolo intestino, a differenza della forma idiopatica che è più frequentemente ileo-colica. Il riscontro di sangue occulto fecale positivo fino al 56% dei pazienti affetti, pur in assenza di sintomi specifici, supporta l’ipotesi di un interessamento gastrointestinale spesso subclinico [1,9]. Gli esami endoscopici gastrointestinali vengono raramente eseguiti, solitamente in caso di sintomi severi, per la diagnosi differenziale con forme infettive/infiammatorie o nel sospetto di IgAV in assenza di coinvolgimento cutaneo, cioè in caso di dolore addominale difficilmente interpretabile mediante imaging tradizionale o poco responsivo alla terapia, specialmente se associato a edema sottocutaneo di mani e piedi [10,11]. Il quadro endoscopico mostra erosioni, ulcerazioni, eritema e petecchie soprattutto a livello del piccolo intestino; l’esame istologico evidenzia flogosi con stravaso di globuli rossi, edema ed essudati di fibrina, vasculite leucocitoclasica e capillarite [12].
• Nefropatia da IgA. Il coinvolgimento renale riguarda il 2054% dei pazienti, soprattutto adolescenti, ed è determinante per l’outcome a lungo termine della malattia. La manifestazione più comune è la microematuria associata e proteinuria lieve. La presenza di proteinuria in range nefrosico, ipertensione arteriosa e incremento della creatinina, di più raro riscontro, sono associati a un outcome più severo e al rischio di insufficienza renale cronica. Il coinvolgimento renale è spesso asintomatico e deve pertanto essere attivamente ricercato, anche fino a un anno dall’esordio della malattia, poiché può manifestarsi anche a distanza di tempo [1,6].
• Altre manifestazioni. L’interessamento testicolare riguarda il 4-13% dei pazienti e può raramente precedere le manifestazioni cutanee. I reperti clinici possono mimare una torsione testicolare. La diagnosi differenziale necessita di esame eco-doppler. Nella IgAV con coinvolgimento testicolare è frequente il riscontro di aumento della vascolarizzazione al Doppler in un quadro di orchite/epididimite; la torsione testicolare è una complicanza rara. Raro è inoltre il coinvolgimento neurologico con cefalea, convulsioni, encefalopatia, emorragia cerebrale, neuropatia centrale e periferica [1].
Tabella 2. Esami di I e II livello e relative indicazioni per la diagnosi di IgaV (mod. da [1,6])
Esami diagnostici
Emocromo, PCR, PT, a PTT, fibrinogeno
Esame chimico fisico urine/stick urine, creatinina, azotemia, elettroliti sierici, albumina e proteine totali
Ecografia addome
Ecografia scrotale
VES, C3, C4, TAS, IgA
Tampone faringeo SBEGA
ANA, ANCA, dsDNA
Biopsia cutanea
Biopsia renale
Indicazioni
Esami di I livello
Da richiedere sempre per la diagnosi.
Da richiedere sempre per la diagnosi di coinvolgimento renale.
Da richiedere in caso di dolore addominale per diagnosi di complicanze come invaginazione intestinale.
N.B. Nella IgAV è frequente il riscontro di ispessimento delle anse intestinali.
Da richiedere in caso di dolore e tumefazione scrotale per diagnosi di complicanze come torsione testicolare.
Esami di II livello
Inquadramento diagnostico: possibile il riscontro di VES elevata, IgA spesso elevate, solo in rari casi riduzione di C3 e C4 transitoria.
Se quadro clinico compatibile con infezione streptococcica, poiché la IgAV si associa a infezione da SBEGA nel 30% dei casi. In caso di positività prevedere adeguata terapia antibiotica.
Per diagnosi differenziale con altre vasculiti e artriti, solitamente negativi.
Da eseguire in caso di rash atipico per diagnosi differenziale.
Da eseguire in caso di proteinuria severa (Pr U/crea U>250 mg/mmol spot su urine del mattino per almeno 4 settimane), proteinuria moderata persistente (100-250 mg/mmol), riduzione della funzione renale, rapida insorgenza di insufficienza renale acuta, sindrome nefritica o nefrosica.
N.B. La proteinuria severa è indicazione relativa all’esecuzione della biopsia renale anche se di durata inferiore a 4 settimane.
La proteinuria moderata/lieve persistente con normale funzione renale è indicazione discussa all’esecuzione della biopsia renale.
PCR, proteina C reattiva; PT, tempo di protrombina; a PTT, tempo di tromboplastina parziale attivata; VES, velocità di eritrosedimentazione; TAS, titolo anti-streptolisinico; IgA, immunoglobuline A; SBEGA, Streptococco Beta Emolitico gruppo A; ANA, anticorpi anti-nucleo; ANCA, anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili; ds-DNA, anticorpi anti-DNA a doppio filamento; Pr U/crea U, rapporto proteinuria su creatininuria su campione estemporaneo.
È descritto inoltre un quadro di interstiziopatia polmonare con alterazione della capacità di diffusione osservato raramente in adolescenti e adulti [2].
Esami diagnostici
Sebbene la diagnosi di IgAV sia essenzialmente clinica, la necessità di escludere altre diagnosi impone l’esecuzione di accertamenti ematochimici e urinari di primo livello in pronto soccorso. L’imaging non è necessario di routine, ma è indicato in caso di sospetto coinvolgimento intestinale o testicolare. In Tabella 2 sono indicati gli esami da richiedere nell’approccio e nell’inquadramento diagnostico del bambino con sospetta IgAV e le indicazioni all’esecuzione della biopsia renale. In Tabella 3 sono riportate le definizioni di severità della proteinuria.
Diagnosi differenziale
La diagnosi differenziale della IgAV è ampia e può essere complicata in caso di mancanza del tipico rash cutaneo all’esordio. In Tabella 4 sono indicate alcune delle patologie da prendere in considerazione nella diagnosi differenziale. Nei pazienti con presentazioni incomplete o inusuali l’esame istologico di un organo interessato consente la diagnosi definitiva di vasculite leucocitoclasica con deposizione di IgA all’esame in immunofluorescenza. L’assenza di depositi di IgA alla biopsia, tuttavia, non esclude la diagnosi di IgAV, ma la rende meno probabile [6].
Trattamento e gestione
La gestione del bambino con IgAV in pronto soccorso dipende dalle manifestazioni cliniche, dalle condizioni generali del paziente e dall’intensità della sintomatologia dolorosa nonché dalla compliance familiare. In considerazione della benignità del quadro e della tendenza alla risoluzione spontanea con terapia di supporto, la maggior parte dei pazienti può essere gestita a domicilio con adeguato follow-up ambulatoriale (ospedaliero o presso il curante). Il ricovero è solitamente indicato in caso di incapacità di assumere adeguata idratazione orale, dolore addominale severo o sanguinamento intestinale significativo, nefropatia (ipertensione arteriosa, sindrome nefrosica, insufficienza renale), dolore articolare con rifiuto della de-
Tabella 3. Definizioni di proteinuria persistente in base alla severità
PrU/creaU (mg/mmol) PrU/creaU (mg/mg) Stick urine
>250 mg/mmol per 4 settimane >2,5 mg/mg >2+/3+
>100 mg/mmol per 3 mesi >1 mg/mg >2+/3+
>50 mg/mmol per 6 mesi >0,5 mg/mg >1+
In caso di utilizzo di differenti unità di misura si ricordi che PrU/creaU 100 mg/mmol equivale a circa 1g/die su raccolta delle 24 h e a 150 mg/dl (2+) su stick urine [6].
Tabella 4. Diagnosi differenziale della IgAV (mod. da [1,6])
Patologia
Piastrinopenia autoimmune, sindrome emolitico uremica, leucemia, coagulopatie, coagulazione intravascolare disseminata
Sepsi
Edema emorragico acuto dell’infanzia (malattia di Finkelstein o Seidlmayer)
Glomerulonefrite post-streptococcica (GNPS)
Vasculiti sistemiche e secondarie a connettivopatie (es. lupus eritematoso sistemico)
Vasculite da ipersensibilità
Artriti
Panarterite Nodosa (PAN)
Appendicite acuta, pancreatite, altre cause chirurgiche di addome acuto
Rx, radiografia; TC, tomografia computerizzata.
Diagnosi differenziale
Nella IgAV emocromo e coagulazione normali, la porpora è palpabile
Nella IgAV indici di flogosi solo lievemente alterati e possibile febbricola, esami colturali negativi
Interessa bambini di età <2 anni con un quadro clinico esclusivamente cutaneo e solo raramente viscerale [17 ]
Nella glomerulonefrite post-streptococcica assenti il coinvolgimento cutaneo e addominale caratteristici della IgAV. Il consumo del complemento è costante nella GNPS, raro nella IgAV
Nella IgAV l’autoimmunità è solitamente negativa, l’esame istologico evidenzia depositi di IgA
Nella vasculite da ipersensibilità è solitamente possibile individuare un trigger (farmaci o infezioni), il rash è prevalentemente orticarioide e l’interessamento renale è assente
Assenza del tipico rash. Nell’artrite settica il coinvolgimento è solitamente monoarticolare e i segni locali di flogosi sono più marcati. Nelle patologie reumatologiche l’autoimmunità è spesso positiva
La PAN interessa bambini più grandi (picco di incidenza 9 anni), l’esame istologico mostra un quadro di vasculite necrotizzante dei vasi di piccolo-medio calibro [18]
Esami di laboratorio (indici di flogosi e funzione pancreatica) e imaging (ecografia addome, Rx addome, TC addome) possono essere di aiuto in caso di assenza di manifestazioni cutanee
ambulazione, orchite, sintomi neurologici o respiratori [13]. Il paziente con quadro clinico esclusivamente cutaneo e articolare può essere dimesso con adeguata terapia antidolorifica e follow-up clinico e della funzione renale. In caso di coinvolgimento addominale severo o testicolare sono indicati accertamenti radiologici mirati e ricovero. L’interessamento renale, esclusa la microematuria e/o proteinuria lieve isolata con fun-
zione renale e pressione arteriosa nella norma che non richiedono terapia ma follow-up seriato, necessita invece di ricovero e valutazione nefrologica. In Figura 1 è mostrato uno schema di gestione del bambino affetto da IgAV in pronto soccorso. Il trattamento è essenzialmente di supporto con adeguata idratazione orale e terapia antidolorifica con paracetamolo, da utilizzare in caso di sanguinamento gastrointestinale at-
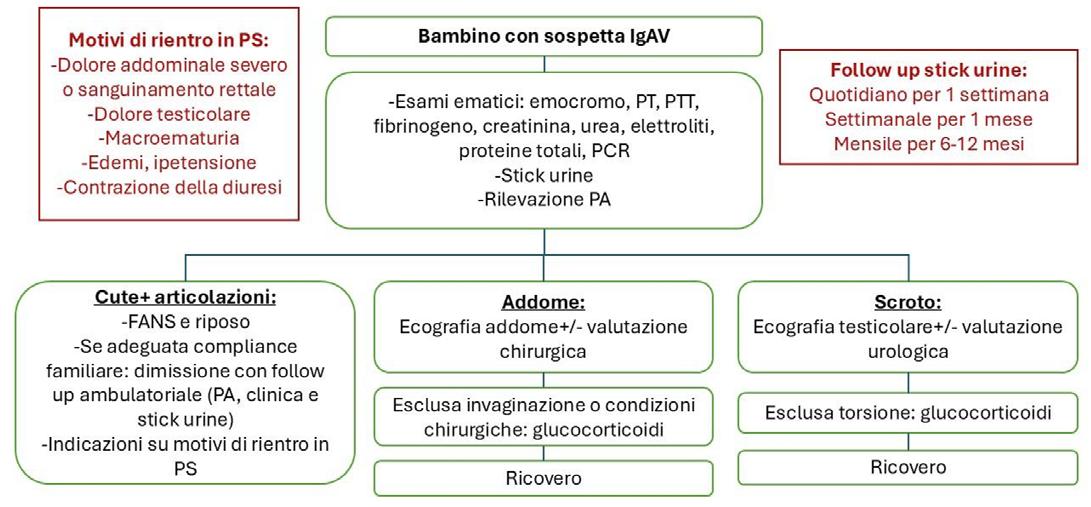
1. Algoritmo di gestione del paziente affetto da IgAV in pronto soccorso (PS). FANS, farmaci antinfiammatori non steoroidei; PA, pressione arteriosa. Vedi testo per dosaggio farmaci.
Figura
Figura 2: Algoritmo per la gestione e il trattamento della nefropatia da IgAV. PDN, prednisone; MPDN, metilprednisolone; ACE, Angiotensin-Converting Enzyme. Mod. da [6].
tivo o nefropatia, o farmaci antinfiammatori non steroidei (es. ibuprofene 10 mg/ kg/dose ogni 8 h), da prediligere in caso di dolore articolare. I glucocorticoidi, come prednisone o prednisolone per os al dosaggio di 1-2 mg/ kg/die per circa 2 settimane con successivo scalo, sono indicati in caso di orchite, vasculite cerebrale, emorragia polmonare, dolore addominale severo e/o sanguinamento rettale massivo (una volta esclusa l’invaginazione). In caso di impossibilità ad assumere terapia per os o severo coinvolgimento d’organo, è possibile somministrare boli di metilprednisolone (10-30 mg/kg/die, massimo 1 g per 3 giorni consecutivi). È noto che la terapia steroidea non prevenga lo sviluppo di nefrite. La gestione della nefropatia da IgA con proteinuria severa o persistente o declino della funzione renale è di pertinenza specialistica e prevede i glucocorticoidi come terapia di prima linea (da soli o in associazione a terapie di seconda linea a seconda della severità del quadro) e, in seconda battuta, azatioprina, micofenolato mofetile o ciclofosfamide. La terapia con ACE inibitori è indicata in caso di proteinuria persistente [6]. In Figura 2 è mostrato lo schema di gestione della nefropatia da IgA. Non esistono linee guida per la gestione del coinvolgimento intestinale severo e refrattario alla terapia steroidea. Alcuni lavori supportano l’utilizzo di micofenolato mofetile e immunoglobuline ev [14-16].
Prognosi
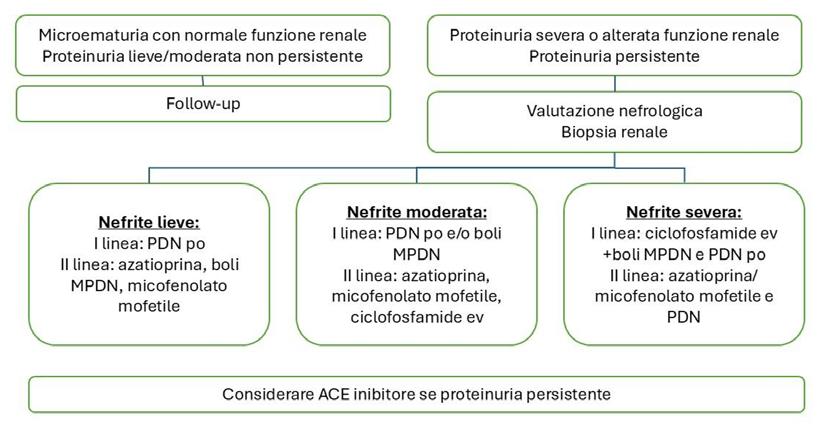
vasculitis-the SHARE initiative. Rheumatology (Oxford). 2019 Sep 1;58(9):1607-1616.
7. Trapani S, Micheli A, Grisolia F, et al. Henoch Schonlein purpura in childhood: epidemiological and clinical analysis of 150 cases over a 5-year period and review of literature. Semin Arthritis Rheum. 2005 Dec;35(3):143-153.
8. Calviño MC, Llorca J, García-Porrúa C, et al. Henoch-Schönlein purpura in children from northwestern Spain: a 20-year epidemiologic and clinical study. Medicine (Baltimore). 2001 Sep;80(5):279-290.
9. Chang WL, Yang YH, Lin YT, Chiang BL. Gastrointestinal manifestations in Henoch-Schönlein purpura: a review of 261 patients. Acta Paediatr. 2004 Nov;93(11):1427-1431.
10. Ozturk K, Cakan M. Initial manifestations and short term follow-up results of Henoch-Schönlein purpura in children: A report from two centers. North Clin Istanb. 2020 Jun 1;7(4):341-347.
11. Rubino C, Monacelli C, Marrani E, et al. Gastrointestinal involvement in IgA vasculitis: a single-center 11-year study on a cohort of 118 children. Clin Rheumatol. 2021 Dec;40(12):5041-5046.
12. Han Y, Jin SY, Kim DW, et al. Endoscopic and microscopic findings of gastrointestinal tract in Henoch-Schönlein purpura: Single institute experience with review of literature. Medicine (Baltimore). 2019 May;98(20):e15643.
La maggior parte della IgAV si risolve spontaneamente senza sequele entro 4-6 settimane. Un terzo dei pazienti sperimenta recidive entro un anno dall’esordio. La prognosi della malattia è determinata dal coinvolgimento renale: sindrome nefrosica/ nefritica o compromissione della funzione renale all’esordio sono indicatori di peggiore outcome renale [1]. Le linee guida SHARE raccomandano il monitoraggio della funzione renale con stick urine e della pressione arteriosa per 6-12 mesi nel paziente con IgAV, anche in assenza di interessamento renale all’esordio, poiché la nefropatia può comparire anche a un anno di distanza [6].
Bibliografia
1. Oni L, Sampath S. Childhood IgA vasculitis (Henoch Schonlein Purpura)-advances and knowledge gaps. Front Pediatr. 2019 Jun 27:7:257.
2. Parums DV. A Review of IgA Vasculitis (Henoch-Schönlein Purpura) Past, Present, and Future. Med Sci Monit. 2024 Jan 28:30:e943912.
3. Bonetto C, Trotta F, Felicetti P, et al. Vasculitis as an adverse event following immunization - Systematic literature review. Vaccine. 2016 Dec 12;34(51):6641-6651.
4. Piram M, Gonzalez Chiappe S, Madhi F, et al. Vaccination and Risk of Childhood IgA Vasculitis. Pediatrics. 2018 Nov;142(5):e20180841.
5. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum. 2013 Jan;65(1):1-11.
6. Ozen S, Marks SD, Brogan P, et al. European consensus-based recommendations for diagnosis and treatment of immunoglobulin A
13. Masarweh K, Horovitz Y, Avital A, Spiegel R. Establishing hospital admission criteria of pediatric Henoch–Schönlein purpura. Rheumatol Int. 2014 Nov;34(11):1497-1503.
14. Morotti F, Bracciolini G, Caorsi R, et al. Intravenous immunoglobulin for corticosteroid-resistant intestinal Henoch-Schönlein purpura: worth a controlled trial against corticosteroids? Rheumatology (Oxford). 2021 Aug 2;60(8):3868-3871.
15. Wang H, Zhang B, Li S, et al. Clinical outcome in pediatric refractory gastrointestinal Henoch-Schönlein purpura treated with mycophenolate mofetil. Eur J Pediatr. 2020 Sep;179(9):1361-1366.
16. Martin S, Cramer CH, Heikenen J, Gitomer JJ. Gastrointestinal symptoms of Henoch-Schönlein purpura treated with mycophenolate mofetil. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006 Aug;43(2):245-247.
17. Saraclar Y, Tinaztepe K, Adalioğlu G, Tuncer A. Acute hemorrhagic edema of infancy (AHEI) - a variant of Henoch-Schönlein purpura or a distinct clinical entity? J Allergy Clin Immunol. 1990 Oct;86(4 Pt 1):473-483.
18. Braungart S, Campbell A, Besarovic S. Atypical Henoch-Schonlein purpura? Consider polyarteritis nodosa! BMJ Case Rep. 2014 Mar 7:2014:bcr2013201764.
Si riportano altre due schede dell’app Firstline
CELLULITE PERIORBITALE (PRE-SETTALE)
DEFINIZIONE
Infezione dei tessuti palpebrali sottocutanei anteriori al setto orbitale (il globo oculare e i tessuti all'interno dell'orbita ossea non sono coinvolti)
Importante: La maggior parte dei casi (cellulite pre-settale) deriva da infezioni adiacenti (es. infezione della palpebra, sacco lacrimale, seni periorbitali, infezioni dentali) o a seguito di morsi o traumi palpebrali. La cellulite orbitaria post-settale, più grave, può svilupparsi per diffusione da una pre-settale o, più spesso, come diffusione per contiguità da sinusite complicata.
DIAGNOSI
Manifestazione clinica
– In genere segni unilaterali di flogosi perioculare (es. palpebra arrossata, gonfia, calda e dolente) senza movimento oculare limitato o doloroso +/- febbre (≥38 °C).
– La vista è normale.
Importante:
– Di solito è una patologia lieve, le complicanze sono rare.
– È importante la diagnosi differenziale con cellulite orbitale post-settale (movimenti oculari limitati, protrusione dell'occhio e diminuzione della vista).
Test microbiologici
–
Di solito non necessari.
– Le colture sono difficili da ottenere e le emoculture, quando eseguite, sono di solito negative.
Altri test di laboratorio
Di solito non necessari.
Imaging
Considerare una TAC delle orbite e dei seni per valutare coinvolgimento orbitale e possibili complicanze (es. ascesso) se esoftalmo, oftalmoplegia, riduzione dell’acuità visiva, edema bilaterale, mancato miglioramento/peggioramento clinico dopo 24 h di terapia, febbre persistente.
MICROBIOLOGIA
Agenti patogeni più probabili
– Batteri:
- Staphylococcus aureus (compreso MRSA)
- Streptococcus pneumoniae
- Haemophilus influenzae
- Moraxella catarralis
- Anaerobi: sospettati se vi è anamnesi di morso animale o umano o se è presente necrosi
– Virus:
Considerare un virus con successiva impetiginizzazione se è presente un'eruzione cutanea vescicolare, es.:
- Virus dell'herpes simplex
- Virus varicella-zoster
L’AIFA ha reso disponibile una app – sulla piattaforma Firstline – che ingloba e rielabora le raccomandazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book sulla gestione delle infezioni più comuni nei bambini e negli adulti, di cui AIFA ha realizzato l’edizione italiana. Il lavoro sulle 10 schede su 10 malattie infettive è stato realizzato dall’AIFA con il contributo sostanziale di tutti gli organismi di indirizzo pediatrici (SIP, SITIP, FIMP, ACP). Queste schede sono disponibili online ed è possibile scaricarne l’app al seguente link: https://firstline.org/aifa. Le modifiche apportate nelle schede, rispetto alle indicazioni dell’OMS del manuale AWaRe, e alcune note clinico-terapeutiche aggiuntive sono riportate in: “Maggiori Informazioni. Nota introduttiva AIFA”. Rendiamo disponibile la versione in formato stampa delle singole schede, al fine di favorire la loro più larga conoscenza e applicabilità nella pratica clinica.
CONSIDERAZIONI CLINICHE
La maggior parte dei casi può essere gestita in regime ambulatoriale con antibiotici orali, specialmente nei bambini >1 anno senza segni di infezione grave.
TRATTAMENTO ANTIBIOTICO
Nota: tutti i dosaggi si intendono per una funzionalità renale normale.
Gli antibiotici sono elencati in ordine alfabetico e devono essere tutti considerati come pari opzioni di trattamento se non diversamente indicato.
Trattare per 10-14 giorni (a seconda della gravità)
– Amoxicillina + acido clavulanico 80-90 mg/kg/die in 3 dosi ORALE
OPPURE
– Cefalexina 50-100 mg/kg/die in 2-3 dosi ORALE
OPPURE
– Flucloxacillina 50-100 mg/kg/die in 4 dosi ORALE
Nei casi con manifestazioni gravi o con scarsa compliance alla terapia orale .
– Amoxicillina + acido clavulanico EV
Prima settimana di vita: 100 mg/kg/die di componente amoxicillina in 2 dosi.
Oltre la prima settimana di vita: 75-100 mg/kg/die in 3 dosi.
OPPURE
– Flucloxacillina o oxacillina 100-200 mg/kg/die in 4 dosi EV
La flucloxacillina (o oxacillina) ha uno spettro più ristretto di attività antibatterica rispetto all’amoxicillina+acido clavulanico e alla cefalexina con una copertura limitata di batteri gram-negativi del tratto respiratorio superiore che possono causare cellulite periorbitale. Pertanto, quando si sospetta questa infezione, amoxicillina + acido clavulanico o cefalexina sono le opzioni preferite.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Nota introdotta da AIFA
– È stata caratterizzata la cellulite nella forma presettale rispetto alla cellulite orbitaria (post-settale).
– Sono state riportate le indicazioni per l’esecuzione della TAC delle orbite e dei seni.
– In caso di necessità di utilizzo della terapia EV una alternativa all'amoxicillina+acido clavulanico è l'ampicillina+sulbactam (150 mg/kg/die in 3-4 dosi).
– La cloxacillina è stata sostituita con la flucloxacillina (o oxacillina) sulla base della disponibilità del farmaco sul territorio.
– I dosaggi della terapia antibiotica sono stati riportati in mg/kg e non per fasce di età.
IMPETIGINE – ERISIPERLA – CELLULITE
Questo documento non tratta le infezioni cutanee causate da agenti patogeni virali, fungini o parassiti; fascite necrotizzante; piomiosite; infezioni gravi con sepsi e infezioni del sito chirurgico. La cellulite orbitaria ha gravità e trattamento differenti non trattati nella presente scheda.
DEFINIZIONE
Infezioni batteriche superficiali della cute, che non interessano gli strati tissutali più profondi.
DIAGNOSI
Manifestazione clinica
Impetigine: insorgenza acuta di lesioni cutanee superficiali di solito senza sintomi sistemici associati.
– Maggioranza dei casi: le papule progrediscono a vescicole e pustole che si rompono fino a formare croste (forma non bollosa).
– Minoranza di casi: le vescicole si sviluppano formando bolle più grandi (forma bollosa).
Erisipela: insorgenza acuta di una lesione cutanea arrossata con margini induriti ben definiti, di solito sul viso o sulle gambe.
– Possono essere presenti bolle o svilupparsi nei primi giorni.
– Possono essere presenti febbre (>38,0 °C) e altri segni di infezione sistemica.
Cellulite: insorgenza acuta di una lesione cutanea che presenta una combinazione di arrossamento, gonfiore e indurimento, calore al tatto e dolenzia della zona interessata.
– Aree più comunemente interessate: gambe e viso.
– Possono essere presenti febbre (>38 °C) e altri segni di infezione sistemica.
– L’arrossamento da solo può non indicare infezione.
– La diagnosi differenziale tra cellulite ed erisipela è spesso difficile.
Test microbiologici
Non necessari nella maggior parte dei casi lievi.
– Le colture da tampone tissutale devono essere evitate, soprattutto in caso di cute integra.
Altri test di laboratorio
Non necessari nella maggior parte dei casi lievi.
Imaging
Non necessario nei casi lievi.
– Si può considerare l’ecografia se si sospetta un ascesso o un coinvolgimento subdermico.
MICROBIOLOGIA
Agenti patogeni più probabili.
– Batteri (nella maggior parte dei casi).
– Streptococcus pyogenes (Streptococcus di gruppo A), specialmente in caso di erisipela.
– Staphylococcus aureus (compreso MRSA).
L’AIFA ha reso disponibile una app – sulla piattaforma Firstline – che ingloba e rielabora le raccomandazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book sulla gestione delle infezioni più comuni nei bambini e negli adulti, di cui AIFA ha realizzato l’edizione italiana. Il lavoro sulle 10 schede su 10 malattie infettive è stato realizzato dall’AIFA con il contributo sostanziale di tutti gli organismi di indirizzo pediatrici (SIP, SITIP, FIMP, ACP). Queste schede sono disponibili online ed è possibile scaricarne l’app al seguente link: https://firstline.org/aifa . Le modifiche apportate nelle schede, rispetto alle indicazioni dell’OMS del manuale AWaRe, e alcune note clinico-terapeutiche aggiuntive sono riportate in: “Maggiori Informazioni. Nota introduttiva AIFA”. Rendiamo disponibile la versione in formato stampa delle singole schede, al fine di favorire la loro più larga conoscenza e applicabilità nella pratica clinica.
CONSIDERAZIONI CLINICHE
– Le opzioni antibiotiche empiriche devono avere una buona attività contro Streptococcus pyogenes di gruppo A e Staphylococcus aureus .
– Trattamento empirico contro MRSA acquisito in comunità: considerare in casi specifici in base a fattori di rischio individuali, colonizzazione nota e prevalenza locale.
– Infezioni lievi: il trattamento orale è adeguato.
– Antibiotici per via endovenosa: possono essere necessari se l'infezione si diffonde rapidamente e non risponde agli antibiotici orali.
TRATTAMENTO
Topico
Trattare per 5 giorni . Trattamento per durata maggiore necessario in assenza di miglioramento clinico o con patologia sottostante. Impetigine non bollosa localizzata: il trattamento topico è preferito rispetto a un antibiotico orale, quando possibile. Per esempio, un ciclo di 5 giorni con un unguento di mupirocina 2% o acido fusidico crema 2%.
Antibiotico
Note: tutti i dosaggi si intendono per una funzionalità renale normale.
Gli antibiotici sono elencati in ordine alfabetico e devono essere tutti considerati come pari opzioni di trattamento se non diversamente indicato.
Trattare per 5 giorni . Trattamento per durata maggiore necessario in assenza di miglioramento clinico o con patologia sottostante.
– Amoxicillina + acido clavulanico 80-90 mg/kg/die in 3 dosi ORALE . OPPURE
– Cefalexina 50-100 mg/kg/die in 2-3 dosi ORALE . OPPURE –
Flucloxacillina 50-100 mg/kg/die in 4 dosi ORALE .
Flucloxacillina e cefalexina hanno uno spettro più ristretto di attività antibatterica rispetto ad amoxicillina+acido clavulanico con buona efficacia nelle infezioni lievi della cute e dei tessuti molli. Dal punto di vista della stewardship antibiotica, queste sono laddove possibile le opzioni preferite.
MAGGIORI INFORMAZIONI - Nota introdotta da AIFA
– La cloxacillina è stata sostituita con flucloxacillina sulla base della disponibilità del farmaco sul territorio.
– Nei suggerimenti di terapia topica è stato incluso anche l’acido fusidico crema.
– I dosaggi della terapia antibiotica sono stati riportati in mg/kg e non per fasce di età.
– Il trattamento empirico contro lo Staphylococcus aureus (SA)-meticillinoresistente acquisito in comunità (CA-MRSA) o, comunque, contro lo SA produttore di leucocidina di Panton-Valentine può essere considerato in alcuni casi sulla base di fattori di rischio individuali (es. colonizzazione nota di MRSA o infezioni cutanee recidivanti nel paziente e/o conviventi) oppure se la prevalenza locale di infezioni da MRSA è >10%. In questi casi, la letteratura suggerisce l’uso di clindamicina o sulfametossazolo + trimetoprim.
Affido dei figli e alienazione parentale: le conseguenze sul benessere dei bambini
Maria Grazia Apollonio1 , Mariachiara Feresin2 , Michela Nacca3 , Patrizia Romito4
1 Psicologa, psicoterapeuta, Centro Antiviolenza GOAP Trieste, gruppo Maltrattamento all’infanzia ACP; 2 Assegnatista di ricerca, Dipartimento di studi umanistici, Università di Trieste; 3 Avvocata dello S.C.V. e del Foro italiano, Presidente dell’Associazione “Maison Antigone”, Roma; 4 Senior scholar e titolare del corso “Violenza di genere”, Università di Trieste
Obiettivi . Valutare se l’accusa di alienazione parentale (AP) fatta a donne vittime di violenza domestica incida sull’affidamento dei figli minorenni.
Metodi Questionario compilato da 137 madri accusate di AP e vittime di violenza domestica.
Risultati . I padri accusati di violenza domestica e di violenza contro i figli, anche qualora condannati in sede penale, ottengono l’affidamento condiviso nel 71% dei casi. Dopo l’accusa di AP diminuiscono i casi di affido condiviso (dal 71% al 53%), aumentano i casi di affido esclusivo paterno (dal 4% al 14%) e di affido ad “altri” (dal 3% al 18%). Questa situazione incide negativamente sul benessere di madri e bambini.
Conclusioni . La violenza domestica e la violenza diretta o indiretta contro i bambini non vengono considerate nella determinazione dei rapporti genitoriali; l’accusa di alienazione parentale fatta alle madri incide sull’affidamento, con grave danno per la tutela e il benessere di donne e bambini.
Introduzione
Il concetto di sindrome di alienazione parentale (SAP) è stato introdotto nel 1985 negli USA da Richard Gardner, uno psichiatra forense attivo nella difesa dei padri accusati di incesto, e si basa sul presupposto che il rifiuto di un bambino nei confronti di un genitore – più spesso il padre – non sia determinato dai comportamenti inadeguati o violenti agiti dallo stesso, ma dalla manipolazione del genitore affidatario e collocatorio, in genere la madre [1]. Dopo numerose critiche da parte della comunità scientifica e di enti internazionali a causa dell’assenza di criteri empirici [2-5], e dopo che l’OMS ne ha escluso l’inserimento dai principali manuali diagnostici, la SAP è stata rinominata alienazione parentale (AP), senza però modificarne i concetti alla base. Rimane, ancora oggi, un concetto frequentemente usato per spiegare il rifiuto di un genitore, negando le possibili violenze agite dallo stesso e negando credibilità alle paure espresse dai bambini. Come conseguenza, spesso nelle cause per la determinazione dei rapporti genitoriali dopo una separazione, le madri che segnalano violenze nei loro confronti e nei confronti dei figli e chiedono la loro tutela vengono considerate mentitrici e alienanti; i bambini vengono obbligati a frequentare il padre che dicono di temere, affidati in forma condivisa a entrambi i genitori, o addirittura in forma esclusiva al padre rifiutato, previo, a volte, inserimento presso comunità o case-famiglia al fine di “decondizionarli e riallinearli” [6-9]. Viene di fatto applicata
quella che Gardner chiamava “terapia della minaccia”, ovvero obbligare il bambino a frequentare il genitore rifiutato, collocandolo presso lo stesso e allontanandolo e inibendo ogni contatto con il genitore “alienante” [1]. Questi “trattamenti”, imposti ai bambini contro la loro volontà sono stati dichiarati non etici e una palese violazione dei diritti civili fondamentali [10]. Ricerche hanno dimostrato i danni sulla salute psicofisica dei bambini: vissuti di impotenza, ansia, depressione, dissociazione, disturbi somatici, fughe, autolesionismo, tentativi di suicidio e suicidio [11-15], nonché, nella quasi totalità dei casi, la prosecuzione dei maltrattamenti [16]. A volte queste decisioni hanno esiti fatali: ricordiamo il caso di Federico Barakat, ucciso nel 2009 a 8 anni dal padre durante una visita che avrebbe dovuto svolgersi in modalità protetta. La madre aveva cercato disperatamente di evitare i contatti padre-figlio ma, accusata di alienazione parentale, era stata costretta ad accettare che si incontrassero (https://www. federiconelcuore.com/).
L’alienazione parentale risulta, in sintesi, un potente strumento di negazione delle violenze, di difesa dei maltrattanti e un grave rischio di prosecuzione dei maltrattamenti ai danni dei bambini e delle loro mamme.
La ricerca
La ricerca presentata in questo articolo è parte di uno studio che ha coinvolto 13 Paesi (Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Israele, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Belgio, Francia, Spagna, Italia) dal titolo “Alienazione parentale e violenza domestica: una collaborazione internazionale per delle strategie innovative”; finanziato dal Social Science and Humanities Research Council of Canada e coordinato dal prof. Simon Lapierre dell’Università di Ottawa.
Gli obiettivi sono di analizzare l’utilizzo dell’alienazione parentale o di concetti affini nelle decisioni relative all’affido dei figli in contesto di violenza domestica post separazione e di esplorare il vissuto delle donne e dei bambini coinvolti.
Metodo
La partecipazione alla ricerca è stata proposta a donne che frequentavano un centro antiviolenza o un’associazione specializzata su queste tematiche, purché soddisfacessero i seguenti criteri: essere maggiorenni; avere almeno un figlio di età inferiore ai 18 anni; aver subito violenza domestica – fisica, sessuale, economica, abusi verbali o psicologici, comportamenti di controllo coercitivo – dal padre del bambino; esser state coinvolte in un procedimento di tutela o di affidamento del minore, che includesse o meno un procedimento giudiziario; esser state considerate un genitore “alienante”, che il termine “alienazione” fosse stato esplicitamente menzionato o meno. Le donne che hanno accettato di partecipare hanno risposto a dei questionari anonimi online. Le domande riguardavano: le violenze subite da madri e figli; quali professionisti erano stati informati delle violenze; le eventuali condanne; l’accusa di AP; l’affido dei figli prima e dopo l’accusa; le conseguenze sulla salute e sul vissuto di madri e bambini. Hanno risposto al questionario 137 donne; le analisi qui presentate riguardano le 132 donne che hanno risposto ad almeno il 60% delle domande del questionario. L’analisi dei dati è stata svolta con il programma in libero accesso Jamovi.
Chi sono le donne che hanno partecipato alla ricerca Il 60% delle intervistate ha un solo figlio e il 28% ne ha due; le altre hanno tre o più figli. Se più bambini sono stati coinvolti nell’accusa di AP, si chiede di descrivere l’esperienza del bambino più grande: l’età media di questi bambini è di 9 anni; un po’ più della metà sono femmine. Il 48% delle donne ha tra 36 e 45 anni; il 39% è più grande e il 13% è più giovane. Il livello di istruzione è elevato: la metà è laureata, le altre quasi tutte diplomate.
Risultati
La violenza e il suo impatto nell’affidamento dei figli
Tutte le donne hanno subito violenze dal partner o ex partner; quasi tutte ne hanno parlato con almeno un professionista implicato nei procedimenti di tutela e/o con le forze dell’ordine. Anche i bambini hanno spesso parlato della violenza subita dalla madre con gli operatori. Nel 20% dei casi (27 uomini su 132) l’uomo è stato condannato in un procedimento penale.
Applicando la definizione CISMAI [17] e la Convenzione di Istanbul [18], tutti i bambini coinvolti nella ricerca sono vittime di violenza assistita.
Secondo le madri, il 33% dei bambini ha subito violenze fisiche dirette da parte del padre e il 18% abuso sessuale. Nella quasi totalità dei casi sia le mamme sia i bambini ne hanno parlato con professionisti e/o con le forze dell’ordine. Due padri erano già stati condannati per maltrattamenti fisici e uno per le violenze sessuali, mentre altri procedimenti erano in corso.
Le condizioni dell’affido e l’alienazione parentale
Prima che le madri fossero accusate di AP, nella maggioranza dei casi (71%) l’affido era condiviso tra i due genitori; nel 16% dei casi la madre aveva l’affido esclusivo e questa era la situazione per il 4% dei padri; 3% dei bambini era affidato a terzi; il 6% delle madri preferiva non rispondere.
Alcune mamme riferivano di subire pesanti pressioni da parte degli operatori dei servizi sociosanitari e giudiziari affinché accettassero l’affidamento condiviso, anche in situazioni in cui il padre era stato condannato per le violenze, spesso con la minaccia di togliere loro il collocamento dei figli.
Tutte le madri intervistate sono state accusate di essere alienanti: nella metà dei casi, utilizzando il concetto di AP, nell’altra metà usando definizioni dall’utilizzo analogo come simbiotiche, ostative, manipolatrici, fusionali. In seguito all’accusa, l’affido dei figli è stato modificato nel 57% dei casi: diminuiscono i casi di affido esclusivo materno (dal 16% al 12% del campione) e i casi di affido condiviso (dal 71% al 53%); aumentano invece i casi di affido esclusivo paterno (dal 4% al 14%) e i casi di affido ad “altri” (dal 3% al 18%).
Sia prima sia dopo l’accusa di AP, la condanna del padre per violenza domestica o le accuse nei suoi confronti di violenze fisiche o sessuali sui bambini non incidono sul fatto che gli siano affidati i figli in modalità condivisa o addirittura esclusiva.
Quando il padre ottiene l’affido esclusivo dopo l’accusa di AP, il tempo che madre e figlio passano insieme si riduce drastica-
mente: nel 39% dei casi i bambini non hanno più nessun contatto con la mamma e in un altro 39% la vedono per non più di 5 ore alla settimana.
L’impatto sul benessere psico-fisico dei bambini e delle mamme
Secondo le mamme, la vicenda giudiziaria influisce negativamente sulla salute psicologica, fisica e sul rendimento scolastico dei bambini. L’obbligo di frequentare un padre temuto lede il loro senso di sicurezza. Quasi tutte le donne coinvolte riportano gravi conseguenze sulla loro stessa salute fisica e psicologica, sul rendimento lavorativo e sulla situazione economica, nonché sul senso di sicurezza e sulla fiducia nella giustizia; circa la metà riporta conseguenze negative nel rapporto con la famiglia allargata e con il bambino. Più della metà delle donne ritiene che la loro reputazione nella comunità sia stata intaccata dalle accuse e dalle vicende giudiziarie [Tabella 1].
Discussione e conclusioni
I risultati di questo studio su un campione di donne vittime di violenza domestica e accusate di essere delle madri alienanti indicano che, già prima che l’alienazione parentale fosse menzionata, segnalazioni o denunce di violenza sulla donna e sui bambini o relative condanne non influivano sull’affidamento dei figli, che restava condiviso nella maggioranza dei casi. Dopo l’accusa di AP si assiste a un cambiamento drammatico: diminuiscono i casi di affido esclusivo materno e di affido condiviso, mentre aumentano di più di tre volte i casi di affido esclusivo paterno, che passano dal 4% al 14% del campione.
Nella maggior parte di questi casi, i contatti madri-figli sono brutalmente interrotti, secondo le indicazioni della “terapia della minaccia” di Gardner.
I risultati evidenziano come la violenza domestica, la violenza assistita da parte dei bambini e delle bambine e la violenza da loro direttamente subita non vengano considerate ai fini dell’affidamento e quanto, invece, il concetto di AP sia lesivo. A questi bambini viene imposto il rapporto con un genitore che temono e rifiutano e del quale riferiscono le violenze e viene, invece, limitato o addirittura inibito, il rapporto con la mamma, colpevole di aver cercato di proteggere i figli. Viene disconosciuto l’impatto sui bambini della violenza alla quale hanno assistito o subito, i loro timori e i loro vissuti rimangono inascoltati; la violenza post separativa e l’uso dei figli come strumento per continuare a perpetrare sopraffazione e controllo vengono ignorati, esponendo i bambini alla prose-
Tabella 1. Conseguenze sul benessere del/lla bambino/a e della mamma della situazione di affido e dell’accusa di alienazione parentale (valori espressi in percentuale)
Moltissimo o molto
Poco o nulla Non sa, non risponde
Abbastanza
Totale
COSA PUÒ FARE IL PEDIATRA
I pediatri hanno grande responsabilità nella tutela dei bambini e delle bambine, sia nel lavoro sui singoli casi sia nella promozione culturale di conoscenza, di buone pratiche operative e di buone linee guida politiche. Per garantire ciò, è importante:
– Conoscere e riconoscere gli esiti lesivi della violenza assistita, considerata un trauma a tutti gli effetti con le stesse conseguenze di una violenza direttamente subita.
– Saper rilevare e riconoscere le situazioni di violenza domestica, distinguendole dalle situazioni di conflitto familiare.
– Offrire supporto alle vittime di violenza, adottando un approccio empatico e accogliente e mai giudicante, indicando e attivando servizi specialistici di supporto (es. centri antiviolenza e centri specialistici per il maltrattamento e l’abuso all’infanzia) e la rete territoriale, segnalando quando opportuno all’autorità giudiziaria.
– Conoscere la violenza post separativa: spesso in fase di separazione i maltrattamenti si acuiscono; i bambini diventano strumento per continuare a esercitare potere, controllo e vendetta verso la ex partner; femminicidi e infanticidi vengono spesso commessi in questa fase.
– Conoscere le norme, i documenti e le linee guida relativi alla determinazione dei rapporti genitoriali nei casi di violenza domestica (si veda bibliografia citata nell’articolo), che escludono l’affidamento condiviso e il collocamento paritetico dei figli.
– Conoscere le norme, i documenti e le linee guida che indicano l’alienazione parentale e i concetti analoghi come a-scientifici e a-giuridici e i danni arrecati ai bambini e alle bambine da trattamenti forzosi e coercitivi.
– Rappresentare nel lavoro di rete queste conoscenze e il diritto dei bambini all’ascolto e al rispetto dei loro bisogni e dei loro vissuti.
– Agire come categoria professionale affinché sia proibito l’uso di concetti non riconosciuti dalla comunità scientifica e dannosi per il benessere dei bambini.
– Agire come categoria professionale affinché nelle situazioni di violenza domestica venga riconosciuto il diritto dei bambini a venir tutelati, a vivere liberi dal maltrattamento (anche indiretto e anche post separativo), diritti che si traducono nella pratica con l’affidamento esclusivo al genitore tutelante e l’ablazione della responsabilità genitoriale del genitore maltrattante.
cuzione del maltrattamento e a gravi danni per il benessere psico-fisico [19]. Infatti, la ricerca rileva le ripercussioni sulla salute e sul benessere psicologico dei bambini e delle loro mamme, le conseguenze sociali ed economiche e la perdita di fiducia nella giustizia, nonché il danno al rapporto mamma-bambino derivante dallo stress anche legato ai provvedimenti giudiziari.
I limiti della ricerca sono rappresentati dalla numerosità del campione e dalla soggettività delle risposte delle donne; i risultati, tuttavia, coincidono con quelli di studi internazionali condotti su ampi campioni e integrati da documenti giudiziari [20] e con quanto evidenziato in Italia dalla commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (2022).
La ricerca indica il mancato rispetto di precise norme e raccomandazioni nazionali e internazionali: a partire dalla Convenzione di Istanbul [18], che vincola a tenere conto della violenza domestica per la determinazione dei rapporti genitoriali, alle raccomandazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità [21] che vieta ogni forma di vittimizzazione secondaria e definisce l’alienazione parentale e le formule analoghe a-giuridiche e a-scientifiche, fino a numerose ordinanze della Corte di Cassazione che più volte si è pronunciata in modo critico su questo concetto (ordinanze n. 7041/2013, n. 13274/2019, n. 13217/2021 e n. 9691/2022, n. 3576/2024, n. 4595/2025).
Anche l’ONU [22] sottolinea quanto la priorità data alla bigenitorialità, in presenza di violenza domestica, violi il principio dell’interesse superiore del bambino e raccomanda che “Gli Stati legiferino per proibire l’invocazione dell’Alienazione parentale o di pseudo-concetti simili nei casi di diritto di famiglia”.
In conclusione, appare fondamentale agire affinché concetti lesivi per la tutela e il benessere dei bambini non possano più venir applicati e affinché i professionisti della salute e dell’area giudiziaria ricevano adeguata formazione in tema di violenza di genere.
Le autrici ringraziano le madri vittime di violenza e le operatrici dei centri antiviolenza e delle associazioni che hanno partecipato alla ricerca, il gruppo di ricerca dell’Università di Ottawa e Camila Costa Cardeal, per il supporto nell’elaborazione dei dati.
La bibliografia di questo articolo è consultabile online.
psico@mgapollonio.it
Mestruazioni sostenibili e dintorni
Federica Bartolini1 , Francesca Lucchi2 , Paola Menga1 , Antonella Brunelli1
1 UO Pediatria e Consultorio Familiare Cesena, AUSL Romagna
2 Assessorato Sostenibilità ambientale, Comune di Cesena
Premessa
Nell’ambito delle azioni che ciascuno di noi può mettere in atto per ridurre l’impatto ambientale, nel tentativo di salvare la salute di tutti e non solo del pianeta (One Health), si inserisce anche quella che riguarda l’utilizzo di presidi per le mestruazioni. Ci siamo chieste le dimensioni del fenomeno, in termini sia di consumo sia di costi, ossia quale impatto sui rifiuti abbiano i diversi sistemi utilizzati e se ci sono soluzioni che possono ridurre tutti questi parametri. Parliamo di un argomento che coinvolge tutte le donne per circa una volta al mese per un tempo che si aggira intorno ai quarant’anni di fertilità. Abbiamo consultato alcune fonti qualificate e da alcune di queste, in particolare da National Geografic e Senato ragazzi, abbiamo riportato importanti informazioni. In ultimo, abbiamo aggiunto un piccolo paragrafo su un argomento altrettanto trascurato, cioè l’uso dei profilattici e il loro corretto smaltimento.
Lo abbiamo detto: ciascuno di noi, in mille modi, può dare il proprio contributo.
Un po’ di storia
La storia sulla gestione delle mestruazioni, che risale all’origine stessa dell’umanità, è ardua da ricostruire a causa della limitata disponibilità di informazioni. In epoche antiche la documentazione, i graffiti, le sculture e le prime scritture erano prevalentemente opera degli uomini, riducendo così l’interesse dedicato a questa esperienza esclusivamente femminile e coloro che si sono interessati a questo argomento hanno spesso offerto interpretazioni personali. Nel corso della storia, il ciclo mestruale ha attraversato diverse fasi sociali e di approcci alla sua gestione. Nell’antichità, le donne si impegnavano principalmente a nascondere il proprio flusso per motivi soprattutto di comodità. Per questo, venivano creati prototipi di assorbenti utilizzando materiali come cortecce morbide di alberi, foglie e pelli di animali; nell’antico Egitto si impiegavano fogli di papiro per questo scopo. Durante il medioevo, le superstizioni associarono al ciclo mestruale poteri legati alla stregoneria e all’inauspicio, cosa che portò le donne a nascondere tempestivamente il ciclo mestruale per preservare la propria sicurezza e a temere il periodo fertile. Nel corso dei secoli, i dispositivi utilizzati per l’assorbimento del flusso mestruale hanno subito significative modifiche sia nella forma sia nei materiali impiegati, spesso frutto – appunto – di un’idea maschile che cercava di interpretare il pensiero delle donne e finendo, come spesso è successo, per condizionarne il vissuto. Quello che riportiamo di seguito è un brano tratto da un articolo pubblicato da National Geographic che rappresenta bene questa storia: “All’inizio del ventesimo secolo, molti individui, medici e uomini, erano ‘preoccupati’ dall’idea che le donne, soprattutto le più giovani, potessero provare imbarazzo nel toccare direttamente i propri genitali durante l’applicazione di un tampone. Questa preoccupazione ha portato gli innovatori a cercare un modo più discreto e igienico,
dando origine all’idea di un tampone con applicatore. Il primo brevetto registrato per un tampone negli Stati Uniti nel 1929 comprendeva un applicatore costituito da un tubicino telescopico di cartone. Altri, invece, considerarono l’acciaio inossidabile o persino il vetro come materiali per l’applicatore. A partire dagli anni Settanta, le plastiche potevano essere modellate in forme lisce, sottili, flessibili e arrotondate, caratteristiche ritenute perfette da alcuni progettisti per gli applicatori dei tamponi. Ma non solo l’applicatore del tampone è fatto di questo materiale: diversi incorporano pezzi di plastica nella stessa parte assorbente. Uno strato sottile che spesso aiuta a tenere insieme il cotone pressato. In alcuni casi il cordino è di poliestere o di polipropilene.
A partire dalla metà del secolo scorso, le principali società americane hanno offerto un numero crescente di opzioni ai propri clienti per l’acquisto e l’utilizzo discreto di prodotti, insieme a varie soluzioni per lo smaltimento degli assorbenti usati. Questa ossessione per la riservatezza ha radici profonde. Negli anni ’20, Johnson & Johnson inserì degli annunci discreti nei propri cataloghi per i ‘Modess’, i propri assorbenti, permettendo alle donne di ritagliare l’immagine e consegnarla in farmacia senza pronunciare una parola, ottenendo in cambio una scatola praticamente anonima. In seguito, l’approccio al packaging si è orientato verso l’imballaggio individuale per consentire alle persone durante il ciclo mestruale di trasportare i prodotti senza sporcarli, sia dal desk ai servizi igienici che successivamente al cestino.
Questa modifica ha portato all’uso diffuso di confezioni in plastica per ogni articolo. Nel 2013, si è registrato un punto culminante quando Kotex ha lanciato il tampone con un involucro ‘più morbido e discreto per garantire la riservatezza’, progettato per essere aperto in modo silenzioso”.
Oggi e domani
La maggior parte di assorbenti e salvaslip contiene un’importante presenza di plastica, che va dalla base impermeabile alle sostanze sintetiche assorbenti, fino all’imballaggio; i tamponi sono confezionati in plastica, dotati di applicatori in plastica e corde di plastica che fuoriescono da un’estremità; talvolta presentano persino uno strato sottile di plastica nella parte assorbente, anche se negli ultimi anni le aziende produttrici si sono sensibilizzate all’argomento cercando di ridurre il quantitativo di plastica utilizzato per la produzione.
Il futuro della plastica potrebbe non essere inevitabile: in Europa, la maggioranza dei tamponi è venduta senza applicatore. Negli Stati Uniti, sta emergendo un crescente interesse per alternative sostenibili: un recente sondaggio ha evidenziato che quasi il 60% delle donne intervistate sta considerando l’adozione di prodotti riutilizzabili, con circa il 20% che li utilizza già. “Vi è un evidente cambiamento nell’approccio delle donne alla gestione del ciclo mestruale,” afferma Susannah Enkema, ricercatrice presso lo Shelton Group, società statunitense che si occupa di relazioni pubbliche e strategiche [1]. Tra le soluzioni più attuali vi è l’adozione di assorbenti riutilizzabili, una reinterpretazione contemporanea di un metodo antico. Alcune imprese hanno commercializzato biancheria intima progettata per assorbire direttamente il flusso mestruale, che può essere lavata e riutilizzata. Al contrario, alcune donne preferiscono utilizzare le coppette mestruali, un’opzione tradizionale che ha recentemente riscosso un aumento di interesse. Altre persone preferiscono sanguinare liberamente, respingendo il tabù sociale associato a una delle funzioni biologiche più fondamentali. Superare il divario legato alle mestruazioni è cruciale per avanzare verso una società più consapevole del futuro sociale e ambientale. A tale scopo è importante mantenere un approccio che consideri l’argomento da prospettive antropologiche, di inclusività ed equità.
È anche attraverso scelte politiche di sostegno, come la riduzione dell’iva dal 22% al 5% su assorbenti e tamponi biodegradabili e compostabili, che si promuove un cambiamento nell’uso e quindi culturale. Numerosi Comuni, tra cui Cesena, promuovono l’uso delle coppette mestruali: l’Assessorato Sostenibilità ambientale, in sinergia con i servizi sanitari territoriali dedicati alla salute femminile e infantile, organizza campagne di distribuzione gratuita all’interno dello Spazio Giovani. Parallelamente, ai genitori residenti dei neonati disponibili, nel corso delle sedute vaccinali viene donato un kit di 6 pannolini lavabili e riutilizzabili.
Alternative comode e sostenibili
Come in precedenza descritto, esistono varie alternative ai convenzionali assorbenti e tamponi, non solo più comode ma anche decisamente più sostenibili.
• La coppetta mestruale è un piccolo contenitore morbido in silicone medicale, progettato per raccogliere il sangue mestruale. Simile a un comune assorbente interno, viene inserita e successivamente svuotata quando piena. Dopo il lavaggio, può essere riutilizzata molte volte e ha una durata fino a 10 anni; al termine del suo ciclo d’uso deve essere smaltita tra i rifiuti indifferenziati.
• Gli slip assorbenti lavabili, provvisti di un tassello assorbente composto da 4 strati sovrapposti composti da cotone 100% nello strato interno a contatto con la pelle, di poliammide e poliestere, poliestere e poliuretano negli strati intermedi e di cotone con elastan nello strato esterno. Sono resistenti all’acqua, si asciugano velocemente, sono antibatterici e neutralizzano gli odori. Lo strato traspirante assorbe fino a 40 ml di liquido, mentre la loro forma a mutandina garantisce la massima aderenza al corpo anche durante la notte.
• Gli assorbenti e i salvaslip lavabili, sono realizzati con un tipo di cotone biologico, ogni tipologia ha uno strato finale impermeabile in poliuretano, per evitare le perdite e si chiude con un bottoncino cucito sulle due ali. Sono molto freschi, comodi in estate e nella prima e ultima fase del ciclo.
• Gli assorbenti e i tamponi usa e getta, ecologici biodegradabili e compostabili (per essere definiti compostabili devono riportare il certificato del CIC, Consorzio Italiano Compostatori e il certificato ICEA, Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) sono privi di residui, di pesticidi ed erbicidi e non contengono profumi. Inoltre, non vengono sbiancati chimicamente. Queste caratteristiche li rendono idonei per ridurre il rischio di irritazioni, essendo prodotti anallergici. Attualmente, questi dispositivi, biodegradabili, con imballaggi compostabili certificati, sono commercialmente difficili da reperire.
• La spugna mestruale è un prodotto costituito da una spugna, tipicamente di origine naturale marina, morbida e disponibile in varie dimensioni in base alle esigenze e all’intensità del flusso mestruale. In genere, può essere utilizzata per un periodo che va dai 3 ai 4 mesi. Tuttavia, poiché deriva da risorse ambientali, potrebbe comportare rischi di esaurimento delle risorse e impatti negativi legati alla sua estrazione e raccolta. Sorgono inoltre preoccupazioni, da confutare con studi scientifici di qualità, riguardo alla possibile presenza di batteri difficili da eliminare, che includono non solo quelli naturalmente presenti nella vagina, ma anche quelli eventualmente presenti nella spugna stessa [Figura 1].
I rifiuti prodotti da assorbenti interni, esterni e salvaslip Determinare l’origine dei rifiuti di plastica derivanti dai prodotti destinati all’igiene femminile risulta complesso, in parte a causa della classificazione di tali rifiuti come sanitari, che non richiede tracciabilità, e in parte a causa della limitata ricerca condotta in merito. Le stime attuali sono tanto approssimative quanto allarmanti: solo nel 2018, gli statunitensi hanno acquistato ben 5,8 miliardi di tamponi [1]. Nel corso della vita, ogni individuo soggetto al ciclo mestruale utilizza tra 5000 e 15.000 tamponi e assorbenti, la maggior parte dei quali finisce poi in discarica. La mestruazione dura dai 2 agli 8 giorni. Di solito comincia con qualche avvisaglia: le prime perdite aumentano velocemente per uno o due giorni e sono seguite da un altro giorno o due di flusso abbondante, che va poi a scemare. La quantità generalmente sta all’interno di un bicchiere, ma non è facile da quantificare: se lo chiedete a una donna, le sembrerà sempre di perdere molto di più. Nella maggior parte dei casi, le donne sperimentano il ciclo mestruale per circa 40 anni, con una durata media di sanguinamento di circa 5 giorni al mese, totalizzando circa 2400 giorni nel corso della vita. Questo equivale a circa 6/7 anni, in media, durante i quali il fluido mestruale viene comunemente assorbito da tamponi o assorbenti. Tuttavia, dopo questo breve periodo di utilizzo, tali prodotti solitamente finiscono smaltiti come rifiuti: in Italia il 3% dei rifiuti totali è attribuibile a prodotti assorbenti per la cura della persona. Questo dato equivale a circa 900 mila tonnellate all’anno su un totale di rifiuti non recuperabili pari a 32 milioni di tonnellate [2]. Lo smaltimento corretto degli assorbenti interni, esterni e salvaslip, rappresenta un aspetto di vitale importanza. Di norma, gli assorbenti igienici vanno eliminati tra i rifiuti solidi non riciclabili, insieme ad altri materiali non riciclabili come gomma, stracci sporchi, carta oleata, materiali plastificati, prodotti chimici, scontrini, cartoni per la pizza sporchi, posate e stoviglie di plastica usate, pannolini e simili. Gettare gli assorbenti nel water è fortemente sconsigliato poiché, oltre a danneggiare l’ambiente a causa del loro lungo tempo di degradazione, potrebbero causare ostruzioni nelle tubature, dal momento che i sistemi di trattamento delle acque reflue non sono progettati per smaltire materiali diversi dai rifiuti umani e dalla carta igienica.
Gli assorbenti realizzati in cotone biologico per ragioni igieniche devono essere smaltiti nei rifiuti solidi non riciclabili, evitando il compostaggio. Gli assorbenti, anche se puliti e non utilizzati senza una data di scadenza, devono essere eliminati nei rifiuti solidi non riciclabili. Nei luoghi pubblici come scuole, uffici, bar, ristoranti e discoteche, è fondamentale gettare

Figura 1. Confronto dei prodotti mestruali in base al loro impatto ambientale.
gli assorbenti nei cestini appositi per i rifiuti igienici, che verranno successivamente smaltiti come rifiuti solidi non riciclabili.
In Italia, non tutti i siti di compostaggio sono idonei per il trattamento degli assorbenti, e alcune Regioni non dispongono delle infrastrutture necessarie. La carenza di adeguate strutture di compostaggio può portare alla dispersione di sostanze inquinanti nell’atmosfera e alla produzione di cattive emissioni di odori, con conseguenti impatti negativi sulla qualità della vita. Durante il processo di fermentazione, che richiede un’umidità compresa tra il 55 e il 70%, si genera un percolato acido o alcalino ricco di nutrienti che potrebbe contaminare le risorse idriche.
Il costo economico
Un acuto intervento di Senato ragazzi, nel quale ci si chiede se le mestruazioni siano un bene di lusso, riporta alcuni dati di consumo e di spesa, anche relativa al tipo di tassazione a cui sono sottoposti questi presidi: “Durante il periodo fertile, una donna consuma in media tra 10.000 e 14.000 assorbenti, con un costo approssimativo di 5000 euro. Si stima che una donna spenda mediamente 126 euro all’anno per gli assorbenti, considerando che una confezione di 14 pezzi ha un prezzo di circa 4-5 euro e che solitamente sono necessarie almeno due confezioni; di questi 126, circa 22,88 euro sono costituiti dall’iva.
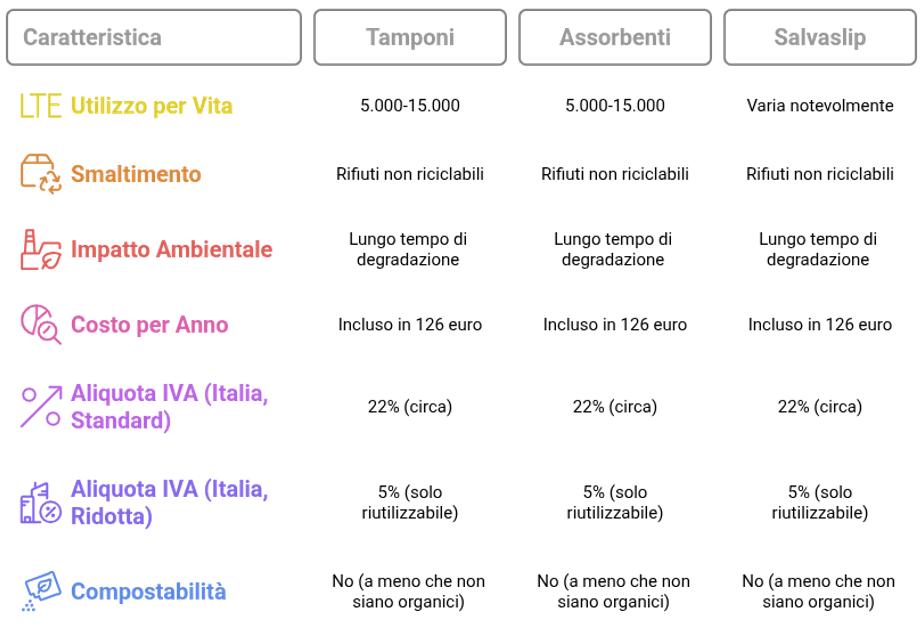
Non contenendo ormoni, i profilattici sono un’opzione adatta per coloro che non possono o preferiscono non usare contraccettivi ormonali a causa di condizioni mediche o effetti collaterali.
In Italia, a partire dal 2020, l’aliquota iva è stata ridotta al 5% esclusivamente per gli assorbenti riutilizzabili in tessuto, le coppette mestruali e gli assorbenti biodegradabili e compostabili. Questo settore costituisce lo 0,4% del mercato complessivo.
Un’indagine condotta dall’Istat sulle persone senza dimora nel 2011, con un successivo follow-up nel 2014 in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha rivelato che in Italia le donne costituiscono il 14,3% delle persone senza dimora. Questo gruppo risulta essere particolarmente vulnerabile alla ‘period poverty’, poiché spesso non hanno a disposizione le risorse economiche necessarie per procurarsi prodotti igienici durante il ciclo mestruale. Il concetto di ‘period poverty’ si riferisce alla situazione in cui individui si trovano nell’impossibilità economica di garantire un’igiene adeguata durante il ciclo mestruale, a causa della mancanza di accesso a dispositivi sanitari specifici come assorbenti, tamponi o coppette, e a strutture adeguate come bagni puliti e attrezzati”. [Figura 2].
Profilattici & Co.
I profilattici, anticoncezionali di barriera, sono strumenti contraccettivi essenziali per prevenire gravidanze indesiderate e infezioni a trasmissione sessuale; presentano il vantaggio di essere facili da utilizzare, ampiamente disponibili e di avere pochi effetti collaterali. Per essere più precisi, è opportuno soffermarsi sulla descrizione su quanto affermato sopra.
Vantaggi: prevenzione delle gravidanze indesiderate. I profilattici agiscono come una barriera fisica che impedisce allo sperma di raggiungere l’ovulo, prevenendo così il concepimento. Se usati correttamente e in modo coerente, hanno un tasso di fallimento molto basso [3].
Prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale (ITS): questa è una delle caratteristiche più importanti e uniche dei profilattici. Agiscono come una barriera che riduce significativamente il rischio di trasmissione di molte ITS, tra cui HIV, clamidia, gonorrea, sifilide ed herpes genitale [4].
Inoltre i profilattici sono relativamente semplici da usare, non richiedono una prescrizione medica e sono facilmente reperibili in farmacie, supermercati e anche online. Questa ampia disponibilità li rende accessibili a un vasto pubblico. Rispetto ad altri metodi contraccettivi, i profilattici sono generalmente economici. Controllo condiviso: l’uso del profilattico può essere una responsabilità condivisa tra i partner, promuovendo una maggiore consapevolezza e comunicazione sulla salute sessuale. Tra i limitati svantaggi segnaliamo che, sebbene raro, alcune persone possono essere allergiche al lattice, il materiale più comune con cui sono fatti i profilattici. I sintomi possono includere prurito, eruzioni cutanee, gonfiore o, in casi gravi, anafilassi. Per queste persone sono disponibili profilattici in materiali anallergici come il poliuretano o il polyisoprene [Fonte: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). 2023. Latex Allergy. Retrieved from https://www. niaid.nih.gov/diseases-conditions/latex-allergy]. Anche se radri, i preservativi possono rompersi o sfilarsi anche con un uso corretto. Questo aumenta il rischio di gravidanze indesiderate e la trasmissione di ITS. La rottura può essere dovuta a un uso improprio (es. taglia sbagliata, conservazione inadeguata, utilizzo di lubrificanti a base oleosa con profilattici in lattice) o a difetti di fabbricazione. Alcune persone riferiscono tra gli svantaggi il dover interrompere il flusso del rapporto sessuale. Con la pratica, però, questo aspetto può essere gestito con maggiore fluidità, oppure riferiscono una leggera riduzione della sensibilità durante il rapporto sessuale con l’uso del profilattico. Tuttavia, questo è soggettivo e per molti il beneficio della protezione supera questo inconveniente. In sintesi, i profilattici rimangono uno strumento fondamentale per la salute sessuale pubblica grazie ai loro molteplici benefici nella prevenzione di gravidanze e ITS, con un profilo di effetti collaterali generalmente molto favorevole.
Nonostante l’introduzione di alternative più sostenibili, è cruciale sottolineare che, a oggi, i preservativi usati – inclusi quelli vegani – non sono compostabili e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. L’impatto ambientale dei preservativi è significativo. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), ogni anno vengono fabbricati circa 10 miliardi di preservativi in lattice, la maggior parte dei quali finisce nelle discariche. Questo è dovuto principalmente al fat-
Figura 2. Confronto dei prodotti per l’igiene mestruale.
to che molti preservativi sono realizzati con lattice sintetico e contengono additivi e sostanze chimiche che li rendono non riciclabili [Fonte: UNFPA]. È fondamentale che i consumatori prestino attenzione alle certificazioni dei prodotti. Anche se alcuni materiali possono essere definiti “biodegradabili”, questo non implica automaticamente che siano compostabili. Spesso questi materiali devono comunque essere smaltiti nei rifiuti solidi indifferenziati, anche se non sono stati utilizzati, a meno che non sia specificamente indicato che sono compostabili e certificati per tale scopo.
Questi materiali impiegano circa 30 anni per degradarsi e costituiscono una minaccia rilevante per gli animali, specialmente per i pesci che potrebbero ingerirli o rimanere intrappolati.
Aspetto da non sottovalutare, l’involucro di alluminio o i materiali compositi utilizzati per il packaging dei preservativi rappresentano delle sfide significative in termini di inquinamento e sostenibilità ambientale; l’alluminio, sebbene sia un materiale altamente riciclabile, ha un impatto ambientale considerevole; la produzione di alluminio vergine (primario) dalla bauxite è un processo estremamente energivoro. Richiede grandi quantità di energia, spesso derivante da combustibili fossili, contribuendo così alle emissioni di gas serra. L’estrazione della bauxite, il minerale da cui si ricava l’alluminio, avviene spesso in aree ricche di foreste tropicali. Questo porta a deforestazione su vasta scala e alla distruzione di ecosistemi vitali, con conseguente perdita di biodiversità. Il processo di estrazione e raffinazione della bauxite produce anche un residuo tossico chiamato “fango rosso”, che può inquinare fiumi e terreni agricoli se non gestito correttamente. Sebbene l’alluminio sia riciclabile all’infinito con un risparmio energetico del 95% rispetto alla produzione primaria, l’involucro singolo dei preservativi è molto piccolo e leggero. Questo rende la raccolta differenziata e il riciclo effettivo più complessi a causa delle dimensioni ridotte e del rischio di contaminazione con altri rifiuti. Spesso questi piccoli imballaggi finiscono nell’indifferenziata, vanificando la loro riciclabilità teorica. In sintesi, mentre l’alluminio è teoricamente riciclabile, la sua produzione ha un impatto ambientale elevato e la piccola dimensione degli imballaggi dei preservativi ne complica il riciclo effettivo. I materiali compositi, d’altra parte, sono intrinsecamente difficili da riciclare a causa della loro struttura multistrato.
Queste problematiche spingono verso la ricerca di soluzioni di packaging più sostenibili per i preservativi, come l’uso di materiali compostabili o monomateriali più facilmente riciclabili, pur mantenendo i rigorosi requisiti di sicurezza e igiene.
Consigli utili
Di qualunque presidio si tratti, è comunque sempre opportuno leggere attentamente le indicazioni riportate sulla confezione di ogni prodotto prima di procedere allo smaltimento. In caso di dubbi è bene informarsi sulle disposizioni del proprio Comune di appartenenza in materia di raccolta dei rifiuti.
Bibliografia
1. Borunda, A. Tamponi e assorbenti: ecco perché non sono sostenibili. National Geographic. Sez. Ambiente. 4 marzo 2020.
2. Studi e comunicazioni di Fater SpA.
3. Trussell J. Contraceptive efficacy. In: RA Hatcher et al. Contraceptive Technology (20th ed.). Physicians for Reproductive Health, 2011:779-763.
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2024. Condom Effectiveness. Retrieved from https://www.cdc.gov/std/prevention/ condomuse.htm
Sitografia
y https://www.alea-ambiente.it/wp-content/uploads/2021/12/dizionario-rifiuti-Alea-2022-def.pdf
y https://www.senatoragazzi.it/media/uploads/tampon-tax-approfondimento-nel-merito-della-materia-tratta.pdf
Articoli scientifici
y Mann S, Byrne SK. Period Poverty from a Public Health and Legislative Perspective. Int J Environ Res Public Health. 2023 Nov 28;20(23):7118.
y Babbar K, Garikipati S. What socio-demographic factors support disposable vs. sustainable menstrual choices? Evidence from India’s National Family Health Survey-5. PLoS One. 2023 Aug 17;18(8):e0290350.
y Mohd Tohi NF, Haque M. Breaking the Cycle: Addressing Period Poverty as a Critical Public Health Challenge and Its Relation to Sustainable Development Goals. Cureus. 2024 Jun 16;16(6):e62499.
federica.bartolini@auslromagna.it
La pediatria tutta intera: l’esperienza della Repubblica di San Marino
Elisabetta Muccioli
Responsabile pediatra dell’Ambulatorio di Pediatria Preventiva e Sociale, UOC Pediatria, ISS, Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino
La pediatria nella Repubblica di San Marino è caratterizzata da unitarietà e continuità nell’assistenza, innovazione e miglioramento dei servizi in risposta ai bisogni emergenti, integrazione con servizi sanitari e educativi, enti e associazioni sul territorio [1].
La mission della pediatria sammarinese è garantire la migliore assistenza possibile in ambito sanitario e sociosanitario ai bambini/e e un adeguato sostegno alle loro famiglie, impegnandosi anche nella prevenzione o diagnosi precoce delle malattie attraverso la promozione di adeguati stili di vita e la realizzazione di coerenti progetti sul territorio. In altri termini, l’impegno che i professionisti, nei loro diversi ruoli, assumono nei confronti dell’utenza è quello di offrire un approccio globale alla cura dei bambini e delle loro famiglie (care) necessario a un armonico percorso di crescita. Afferiscono alla UOC Pediatria [2]:
• reparto di degenza pediatrica (ricoveri e day hospital, I livello);
• osservazione breve intensiva in fase di strutturazione;
• ambulatorio pediatrico di continuità assistenziale;
• ambulatorio di pediatria preventiva e sociale;
• ambulatori specialistici per neuropsichiatria infantile, gastroenterologia pediatrica, endocrinologia pediatrica, disturbi alimentari, allergologia pediatrica, ecografia delle anche;
• assistenza al neonato in sala parto, sala operatoria e degenza rooming-in.
Non vi è distinzione tra pediatria ospedaliera e territoriale, tra pediatri dedicati a un unico settore o generali. Anche gli ambienti stessi in cui si svolgono le attività non sono differenziati ma si svolgono tutti, dagli ambulatori al reparto degenza e al punto nascita, all’interno dell’Ospedale di Stato. Nella strutturazione dei servizi e nel successivo rimodellamento in base ai bisogni emergenti, si è mantenuta l’unità dell’équipe pediatrica nella garanzia della continuità di assistenza e dell’integrazione tra servizi [3].
La stessa équipe pediatrica in base alla turnistica si dedica ai bilanci di salute dei propri assistiti, alle visite pediatriche nell’ambulatorio di continuità assistenziale o alle consulenze presso il pronto soccorso generale, all’assistenza al neonato in sala parto o in sala operatoria, durante la degenza in roomingin e nei controlli post dimissione, garantisce la guardia attiva all’interno dell’ospedale con orario diurno e notturno anche per le valutazioni dei bambini ricoverati in degenza pediatria. La presenza degli ambulatori all’interno dell’ospedale permette al professionista che visita il bambino di prescrivere indagini diagnostiche quali radiografie, prelievo ematico, esame urine ecc. In questo modo lo stesso pediatra, che ha preso in carico il bambino, è in grado di concludere la diagnosi con continuità e può fornire in tempi brevi le indicazioni alla fami-
glia, senza dover ricorrere a professionisti o strutture esterne (pronto soccorso pediatrico, centro prelievi ecc.) evitando di sottoporre il bambino e la sua famiglia a spostamenti e a lunghe attese. Inoltre lo staff infermieristico agisce in modo integrato e coerente con le attività del medico nell’ambulatorio pediatrico di continuità assistenziale, svolge triage telefonico e risposte mail in modo autonomo e professionale, esegue prelievi ematici, tamponi rapidi, esame urine, ECG e rilevazione di parametri, colloqui con le famiglie nell’ambito dell’educazione sanitaria e attività di cura genitoriale nelle principali patologie pediatriche. Tale integrazione di ruoli e professionalità, permette a tutti gli operatori di svolgere al meglio i propri compiti, rendendo l’attività più efficace ed efficiente, riduce i tempi di attesa e permette un migliore accompagnamento della famiglia in un ambito di malattia acuta, aumentandone la compliance e la fiducia. Per quanto riguarda le cure primarie, gli assistiti vengono affidati a un pediatra di riferimento, all’interno dell’équipe, a cui si riferiscono per i bilanci di salute, le visite pediatriche programmabili, i colloqui personalizzati, i contatti via mail e telefonici. Le valutazioni non differibili a lungo termine sono affidate all’ambulatorio pediatrico di continuità assistenziale che provvede a garantire la visita pediatrica anche in assenza del pediatra di riferimento del bambino, avvalendosi dei colleghi della stessa équipe. Durante gli orari di chiusura del suddetto ambulatorio (sabato pomeriggio, notte e festivi), la famiglia può mettersi in contatto con il servizio telefonando al cellulare del pediatra di guardia per consigli e triage telefonico o invito a visita in ospedale. Lo stesso medico presente all’interno della struttura in guardia attiva risponde a ogni necessità inerente l’ambito pediatrico ospedaliero e alle emergenze attinenti con eventuale supporto del personale del pronto soccorso e dell’anestesista.
In questo modo lo stesso gruppo di pediatri svolge assistenza ospedaliera e territoriale integrando le attività al servizio del bambino e della sua famiglia, dalla nascita al compimento dei 14 anni (in casi particolari anche oltre questa età), garantendo accessibilità al servizio 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
Con la ferma convinzione che “se cambiamo l’inizio della storia, cambiamo tutta la storia” [4] da anni sono stati potenziati e poi continuamente implementati i servizi di promozione alla salute e al neurosviluppo, sostegno alla genitorialità responsiva, attività di prevenzione primaria e secondaria, educazione sanitaria e informazione alle famiglie mediante visite dedicate, incontri, guide anticipatorie e colloqui fino a strutturare l’ambulatorio di pediatria preventiva e sociale (APPS). Bilanci a valutazione infermieristica all’età di 7 e 18 mesi di età vengono eseguiti in autonomia da professionisti formati, dedicando un’ora di tempo al colloquio con la famiglia, alla valutazione della crescita (peso, altezza, circonferenza cranica), alla visione diretta del comportamento del bambino in area gioco e a tappeto, all’interazione con il caregiver, alla compilazione di scheda dedicata e ad attività di educazione sanitaria su argomenti adeguati alle diverse età. L’ideazione, la strutturazione, applicazione, mantenimento e miglioramento di questo servizio hanno portato all’inserimento di questa attività all’interno del “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale delle persone con disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo” (PDTA) con ottimi risultati. Un ulteriore “PDTA del paziente con malattia celiaca”, frutto di una storica attenzione della pediatria sammarinese allo screening per celiachia, trova collocazione nell’attività infermieristica a supporto del pediatra con il bilancio a valutazione infermieristica previsto all’età di 6 anni che comprende l’esecuzione di prelievo ematico di screening e parametri (peso, altezza, pressione arteriosa), valutazione acuità visiva e rachide, colloquio sull’alimentazione, stili di vita, utilizzo dei media device e salute orale. Queste valutazioni si integrano con l’attività del pediatra nei
bilanci di salute dei propri assistiti che sono previsti all’età di 1, 3, 5, 9, 12 mesi e a 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13 anni. Nella solida convinzione che la rete tra servizi possa migliorare l’accoglienza, la professionalità e la presa in carico del bambino e della sua famiglia, l’ambulatorio di pediatria preventiva e sociale collabora con altre UOC all’interno dell’ospedale e con enti, istituti, università, società scientifiche italiane e internazionali. Il pediatra referente dell’APPS partecipa al tavolo multidisciplinare e intersettoriale per la programmazione e il coordinamento degli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole e ha continui confronti con l’authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, sociosanitari e socioeducativi della Repubblica di San Marino. È promotore dell’iniziativa “Leggere, che sorpresa” con i lettori volontari dell’associazione “Lettori con la Valigia” presso le sale d’attesa degli ambulatori pediatrici e del progetto musicale di sostegno alla genitorialità “Noi… In Crescendo” con l’Istituto Musicale Sammarinese, Dipartimento Musicagiocando [1,5]. Esegue un incontro con le famiglie durante il corso di accompagnamento alla nascita sui temi del nurturing care, genitorialità responsiva, buone pratiche, salute e prevenzione nei primi mille giorni, argomenti che vengono poi nuovamente ripresentati nelle guide anticipatorie inviate periodicamente via mail (newsletter baby) e negli incontri di sostegno alla genitorialità responsiva con le famiglie nel primo anno di vita del bambino. Il modello organizzativo sammarinese, declinato nelle diverse funzioni ma unito nella stessa UOC e nell’unica équipe pediatrica, fornisce spunti di riflessione e stimoli al confronto e alla condivisione. Tale modello organizzativo potrebbe essere replicato e proposto in altre realtà esterne, anche italiane, applicandone i principi e mettendo a frutto quanto già sperimentato e realizzato. Quello che è possibile nella nostra piccola realtà territoriale mostra le potenzialità e i risvolti positivi che può assicurare un servizio unitario e integrato, dedicato al bambino e alla sua famiglia.
Nel documento del National Scientific Council on the Developing Child dell’Harvard University [6] si dichiara che “il futuro di qualsiasi società dipende dalla sua capacità di promuovere la salute e il benessere della prossima generazione”. La pediatria nella Repubblica di San Marino, consapevole di questa grande opportunità e responsabilità professionale, etica e sociale, si sta impegnando per questo grande obiettivo a supporto del singolo, della famiglia e di tutta la comunità presente e futura.
Bibliografia
1. Tamburlini G, Muccioli E. Integrazione e continuità tra servizi attorno alle famiglie con bambini: l’esperienza della Repubblica di San Marino. Medico e Bambino. 2025;44:180-182.
2. Carta dei servizi. https://www.iss.sm/on-line/home/dedicato-a/articolo49000309.html.
3. Centro per la Salute del Bambino, Associazione Culturale Pediatri. Senza confini. Come ridisegnare le cure per l’infanzia e l’adolescenza, integrando i servizi, promuovendo l’equità, diffondendo le eccellenze, 2020.
4. World Health Organization, United Nations Children’s Fund, World Bank Group. Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. 2018. Versione italiana disponibile in www.csbonlus. org.
5. Muccioli E, Farinelli M, Felici E, et al. La musica come fattore di sviluppo “Noi... In Crescendo” progetto musicale di sostegno alla genitorialità nella Repubblica di San Marino Pediatria Preventiva e Sociale. SIPPS. 2024;3.
6. The Science of Early Childhood Development National Scientific Council on the Developing Child – Center on the Developing Child, Harvard University, 2007.
elisabetta.muccioli@iss.sm
Mio figlio è capriccioso
Chiara Borgia Pedagogista
“Dottoressa, mio figlio è ingestibile”. “Si butta a terra se gli dico di no, non obbedisce, mi dice bugie”. “Non ascolta, mi prende a calci, urla, io non so più che fare”. “Dottore dove abbiamo sbagliato?”
Durante le giornate di ambulatorio i pediatri ascoltano spesso dai genitori frasi simili accompagnate da sguardi e toni carichi di frustrazione, preoccupazione, a volte senso di colpa. Tutto ciò può disorientare: “Abbiamo poco tempo, già abbiamo parlato di alimentazione, di sonno, di vaccini e adesso anche i capricci?!”
Questo genere di comunicazioni e richieste devono interessare i pediatri, perché riguardano un concetto ampio di salute, che si costruisce in larga misura attraverso la qualità delle relazioni che accompagnano i bambini nella crescita.
Un’opportunità anche per il pediatra
Quando il pediatra intercetta la fatica di un genitore, può scegliere di chiudere rapidamente la questione o aprire uno spazio al dialogo e alla riflessione. Non serve molto tempo: in alcune situazioni ci sarà bisogno di un colloquio in più, senza la presenza del bambino, in altre basterà una frase, uno spunto, in altre ancora, si potrà offrire ai genitori (per esempio durante i bilanci di salute) elementi sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei figli, aiutandoli così a leggere certi comportamenti come espressione di bisogni evolutivi.
Il lavoro quotidiano del pediatra offre già molti strumenti utili per rispondere alle domande sui “capricci”. La prima chiave per affrontare i momenti difficili risiede infatti nel possedere, nei confronti dei più piccoli, uno sguardo che va oltre un affrettato giudizio su ciò che il bambino fa, e prova a osservare e comprendere ciò che accade e le motivazioni che possono essere alla base di quel comportamento. Allora si capisce subito quanto si può fare in ogni visita, anche parlando di crescita o raffreddore, per sostenere, allenare, stimolare nei genitori questo genere di osservazione.
I pediatri che lavorano così sanno bene come tutto ciò abbia un ritorno importante sulla costruzione ed espressione delle competenze genitoriali, sulla crescita dei bambini e anche sul lavoro ambulatoriale: un genitore che comprende meglio ciò che accade al proprio figlio si sente meno solo, meno in colpa, meno in allarme, più capace di stare nelle fatiche della crescita. E chiama meno anche il pediatra.
Alcuni presupposti da cui partire
“Si butta a terra se gli dico di no. Che devo fare?” La tentazione di rispondere subito è forte. Ma prima di suggerire strategie la pediatra può offrire un cambio di prospettiva, attraverso alcuni presupposti da usare come “occhiali” per osservare le dinamiche tra grandi e piccoli.
Primo presupposto: i capricci si fanno in due ll capriccio non è un tratto caratteriale del bambino, ma un fenomeno che riguarda la relazione tra lui e l’adulto. Nei cosiddetti capricci è sempre presente uno “scontro” tra volontà: i bambini vogliono fare/ottenere qualcosa che secondo i genitori non va bene o non vogliono fare ciò che loro vorrebbero facessero, manifestando le loro emozioni con modalità che
spesso appaiono esagerate. Al di là dell’oggetto specifico del capriccio (voglio il gelato, non voglio vestirmi…), c’è in ballo qualcosa che riguarda anche la relazione tra adulto e bambino. Poiché non solo ogni bambino è unico, ma è unica anche ogni relazione tra adulto e bambino, possiamo dire ai genitori che non esiste un metodo uguale per tutti per fermare i capricci. Un altro spunto interessante è che la relazione tra genitore e figlio non nasce certo nel momento del capriccio. Possiamo ricordare con i genitori quante emozioni e trasformazioni hanno già vissuto (quando non sapevamo come affrontare il suo pianto, quando non ne voleva sapere di mangiare, quando ha imparato a camminare così in fretta e la nostra casa non era pronta, quando…). Ciò serve a riconoscere che il modo di stare insieme può sempre evolversi e, anche nel caso dei capricci, una delle possibili “cose da fare” è proprio sperimentare modalità diverse nella relazione con i bambini, immaginando piccoli o grandi cambiamenti.
Se i capricci sono un fenomeno relazionale, è evidente che ci si debba occupare non solo delle emozioni dei bambini, ma anche di quelle dei genitori. Genitori attenti e accoglienti rispetto alle proprie emozioni lo saranno anche verso quelle dei figli e ciò che può fare il pediatra nell’ambito del proprio ruolo è provare ad attivare la loro consapevolezza nei confronti delle proprie emozioni: “Come vi sentite quando Giulia fa la sua ‘scenata’? Immagino che sia faticoso mantenere la calma in quella situazione”.
Infine, una domanda interessante da poter rivolgere a mamme e papà è se, nelle loro vite, siano accaduti o stiano accadendo eventi particolarmente significativi. Aspetti che riguardano la vita personale, familiare, lavorativa, di coppia, possono avere una ricaduta sui bambini e sulla relazione genitori-figli, anche se a volte non ce ne si rende conto.
Secondo presupposto: il motivo del capriccio non è quasi mai evidente
La caratteristica dei “capricci” è il fatto che i comportamenti di bambine e bambini sembrano essere insensati, esagerati o compiuti solo per irritare i genitori. “Com’è possibile che abbia fatto tante storie solo perché il biscotto che le ho dato era rotto?” Possiamo tranquillizzare un po’ i genitori condividendo che certamente sarebbe più facile se i bambini potessero dire: “Mamma (papà), ho bisogno che tu mi dica più volte di no, altrimenti senza limiti mi sento persa”; “sono preoccupato perché vedo che sei stanco e nervoso, vorrei che mi dimostrassi ancora una volta il tuo amore”; “ti sfido in continuazione perché sono in una fase di crescita in cui ho l’esigenza di affermare la mia volontà”. Ma non è possibile! Una metafora che spesso propongo ai genitori è quella dell’iceberg. Possiamo immaginare i capricci come un iceberg: la parte immediatamente visibile è il comportamento del bambino, che riguarda solitamente cose (desideri, oggetti, eventi, azioni) dall’adulto considerate sciocche e associate a reazioni fuori misura, mentre per il piccolo sono questioni “di vita o di morte”. Sotto il livello del mare, si trova la parte più grande e importante della montagna di ghiaccio: i bisogni del bambino. Per crescere, i bambini hanno bisogno di soddisfare dei bisogni profondi: di sentirsi sicuri, di contatto, di protezione, di essere guidati, di sentirsi amati, di essere riconosciuti nella propria crescita, di essere accolti e valorizzati nel rispetto delle proprie caratteristiche, di appartenenza e di autorealizzazione. Ci sono momenti, durante lo sviluppo, in cui alcuni di questi emergono, naturalmente, in modo più evidente. Altre volte possono essere maggiormente legati a circostanze particolari, eventi familiari, approcci educativi non corretti, cambiamenti significativi nella relazione con gli adulti.
La maggior parte delle volte, durante un capriccio, ci si ferma alla punta dell’iceberg. Per questo, che si decida di assecondare la richiesta o meno, spesso sia gli adulti sia i bambini rimangono con un senso di frustrazione e rabbia.
Capire “cosa c’è sotto” non è certo semplice ma è anche vero che bambine e bambini, come Pollicino, lasciano in giro mollichine a indicare il percorso, segnali che sguardi allenati riescono a cogliere. Pediatre e pediatri hanno la responsabilità di sostenere e stimolare, quando serve, questa competenza genitoriale, in tutte le occasioni dei loro incontri.
Terzo presupposto: i bambini hanno bisogno di tempo e vicinanza per imparare ad autoregolarsi
Le pediatre e i pediatri conoscono bene come funziona lo sviluppo delle “capacità di autoregolazione e di autocontrollo” nei bambini; è importante che ne parlino con i genitori, fornendogli informazioni e chiavi di lettura del comportamento del bambino. Il primo messaggio chiave da trasmettere è che uno dei compiti più difficili per un bambino è quello di riuscire a gestire i propri stati fisici, le proprie emozioni, controllare e regolare il proprio comportamento. Il pediatra può fare degli esempi molto concreti per far comprendere questo faticoso lavoro di crescita: che sia giocare con altri, costruire una torre, rispondere alle richieste di un adulto o arrampicarsi su un albero, i piccoli hanno bisogno di imparare a padroneggiare gli impulsi, le emozioni, le sensazioni corporee e quelle che sentono agitarsi dentro di sé come spinte interne (devo rimanere ferma anche se mi viene da muovere le gambe; devo riuscire a concentrarmi su questo foglio per scrivere; devo aspettare il mio turno per giocare; come faccio quando il cuore mi batte così forte e non riesco a calmarmi?). Resistere alle tentazioni, fare cose quando non se ne ha voglia, imparare a consolarsi, vivere sensazioni ed emozioni frustranti e spiacevoli senza esserne travolti, ma anche ritrovare la calma dopo l’eccitazione, collaborare e condividere, riconoscere cosa accade dentro e fuori di sé, poter avere un controllo sempre più consapevole e intenzionale sulle proprie esperienze… Se mettiamo tutto questo in relazione con i capricci ci rendiamo conto che quelle che agli occhi di un adulto possono sembrare reazioni esagerate o comportamenti difficili da comprendere, hanno a che fare con una certa immaturità fisiologica dei bambini, i quali non hanno ancora conquistato del tutto le competenze di autoregolazione e autocontrollo.
Pediatri e pediatre avranno poi tantissime occasioni per sottolineare l’importanza delle funzioni di co-regolazione dei genitori, valorizzando i momenti in cui gli adulti si sintonizzano con i bambini (“Guardi come si è calmato adesso che l’ha preso in braccio”) e sostenendoli nei momenti di rottura e riparazione.
Valorizzare la funzione guida dell’adulto non vuole dire proporre a papà e mamme dei modelli irreali: sappiamo che alcuni comportamenti dei bambini possono mettere gli adulti anche duramente alla prova, allo stesso tempo non spaventiamoci di affermare che i piccoli hanno bisogno di avere un solido timone che li guidi e che non si faccia trascinare dalla tempesta emotiva che talvolta li attraversa. Diciamo ai genitori che i bambini impareranno. Con il passare del tempo, con la vicinanza e la fiducia dei genitori diventeranno sempre più capaci di regolare i propri stati emotivi, impareranno a comunicare anche verbalmente i loro bisogni, a prendere in considerazione le necessità degli altri e a trovare autonomamente le soluzioni per affrontare le situazioni difficili che possono presentarsi.
Qualche strategia per affrontare i momenti più difficili Per i genitori è importante comprendere il fenomeno dei capricci nella sua globalità, ma anche capire come rispondere in maniera appropriata nel momento in cui il capriccio si è scatenato. Quando i genitori chiedono “Cosa devo fare?», può essere utile rilanciare con una domanda: “Voi cosa fate, in quei momenti?” Questo attiva il pensiero del genitore e gli consente di partire, senza sentirsi giudicato, dalla sua esperienza concreta.
A volte punizioni. A volte urla. A volte minacce. A volte il tentativo di spiegare, con calma, ma senza successo. I genitori raccontano e spesso sono loro stessi a concludere: “Non funziona”. “Funziona solo per poco”. “Poi devo alzare la voce sempre di più”. In quel momento si apre uno spazio per proporre strategie diverse.
Prima È possibile prevenire i capricci? Non del tutto, ma possiamo provare a evitare che assumano un’intensità troppo forte, difficile da gestire. Per far questo invitiamo i genitori a osservare. Spesso, prima di arrivare all’apice della crisi ci sono dei segnali “premonitori”: i bambini si lamentano, sono irritabili, non collaborano o “sfidano” volutamente gli adulti, oppure sono particolarmente eccitati, hanno difficoltà a concentrarsi o a rilassarsi. Anche il contesto può disturbare i bambini influenzando la regolazione emotiva (stanchezza, fame, malattia, i luoghi e le persone presenti, l’ora del giorno…). Quando papà e mamme si accorgono di determinati segnali “di allarme”, possono cercare di aiutare i bambini a ritrovare un equilibrio: proponendogli un diversivo, dandogli spazio per il riposo, cambiando contesto quando possibile, avvicinandosi con un abbraccio, proponendogli un gioco.
Man mano che i bambini imparano a comprendere e a utilizzare il linguaggio verbale, i genitori possono utilizzare più spesso il dialogo per aiutarli a regolarsi. In alcune occasioni potrà essere utile impiegare il ragionamento, prima di fare una richiesta a cui il bambino o la bambina potrebbe opporre resistenza: “È arrivato il momento di riordinare, così potrai trovare i giochi quando li cerchi. Se vuoi posso aiutarti”. Anche le strategie basate sul gioco, possono aiutare, anche se non sempre, a risolvere con più leggerezza alcune situazioni senza che ciò mini l’autorevolezza del genitore.
“Serena, quante volte te lo devo dire, smettila di saltare sul letto, così lo rovini!”
“Non posso, mamma, sono Spiderman!”
“Ah, capisco… Ma sai che ho sentito dire che è arrivato un cattivo da sconfiggere? Vieni sul tappeto per allenare meglio le tue ragnatele!”
Durante
È necessario avere bene in mente che, nonostante il piccolo o la piccola comunichi in modo inadeguato, sta chiedendo un sostegno, per trovare la via d’uscita e stare meglio. Non c’è un’unica modalità che vada bene per tutti, ma alcune accortezze possono aiutare a migliorare la gestione dei momenti di “crisi”.
• Fare un bel respiro per cercare di abbassare la tensione e mantenere il più possibile la calma. Se i genitori sentono di essere troppo nervosi possono allontanarsi per un momento o “darsi il cambio”.
• Non mettersi al livello dei bambini. Non è un conflitto tra pari. I genitori dovrebbero mostrare di saper gestire le proprie emozioni senza mancare di rispetto o essere distruttivi, i piccoli li guarderanno e imiteranno.
• Rispondere senza tirarla per le lunghe. La prima risposta data al capriccio deve essere semplice, chiara, breve (spesso basta un “sì” o un “no”). È necessario essere fermi, senza timore di provocare reazioni negative. Le indecisioni, così come le paternali o le trattative infinite, potrebbero confondere i bambini e inasprire la situazione. Si possono utilizzare fermezza e coerenza senza aggiungere rimproveri, anzi cercando di avere un atteggiamento comprensivo: “so che volevi vedere un altro cartone, è vero, sono bellissimi, ma non è possibile. Se ne vedono due al giorno”.
• Gestire la crisi e, quando serve, fermare l’esplosione Per aiutare i bambini ad affrontare le emozioni intense, i genitori possono provare a tradurre queste emozioni in parole. Per
farlo, vanno usate frasi semplici e brevi, ricordando che non possiamo mai sapere con certezza di cosa si tratta (“vedo che ti agiti, forse sei arrabbiato?”; “adesso mi sembri triste”).
Significa porsi in un atteggiamento che non giudica ma accoglie le emozioni, qualunque esse siano. Se invece si pronunciamo frasi come “non devi gridare così”, “non ti devi preoccupare”, “non dovresti essere geloso di tua sorella”, non saremo di grande aiuto al bambino o bambina nel comprendere e governare ciò che prova.
Un’altra accortezza è non lasciare soli i bambini, soprattutto nel momento in cui la crisi emotiva è nella sua fase più acuta. Un’abitudine diffusa è invitare un bambino o una bambina a calmarsi autonomamente dicendo, per esempio: “Vai nella tua stanza e rimani lì fino a quando non hai finito di piangere”. I bambini, però, specie se sotto i 6 anni di età, non hanno ancora le competenze necessarie per far fronte da soli a ciò che li sta emotivamente “travolgendo”. Tra l’altro, se – come abbiamo più volte affermato – sotto la superficie si sta “giocando” sempre qualcosa che riguarda la relazione tra bambino e adulto, il piccolo o la piccola vorrà proprio la presenza di quest’ultimo e potrebbe arrabbiarsi ancora di più se “abbandoniamo il campo”: ha bisogno di capire come reagisce il genitore, cosa succede se, vuole avere risposte rispetto all’appropriatezza o meno dei suoi comportamenti.
Se l’adulto ha bisogno di prendere un attimo di respiro dalla situazione, va comunicato chiaramente: “Adesso sono molto arrabbiato, non riesco a parlare con te, ho bisogno di allontanarmi un attimo e poi torno”. In questi momenti, anche se è difficile, è molto importante provare a mantenere la calma: gridare, minacciare, cercare di reprimere i comportamenti in modo aggressivo, non farà ottenere altro risultato se non quello di gettare benzina sul fuoco. Anche tentare di far ragionare il bambino usando la logica non sarà di grande aiuto al culmine del capriccio. Cosa fare allora? Per aiutare un bambino a calmarsi si può provare ad avvicinarsi tentando il contatto e il contenimento fisico, con delicatezza, ma non è detto che sia la strada migliore per tutti i bambini: alcuni trovano giovamento nell’essere abbracciati, magari dopo qualche minuto di agitazione fisica, altri non tollerano di essere toccati. In quest’ultimo caso i genitori possono mostrare la propria vicinanza attraverso lo sguardo, l’espressione del viso, l’utilizzo di parole rasserenanti (“Ora sei molto arrabbiato, adesso pian piano ti puoi calmare, io sono qui se hai bisogno”), sempre evitando l’eccesso di parole e interventi. Certe volte, rimanere in contatto diretto può rendere più difficile il raggiungimento di uno stato di calma, e allora sarà più utile stare in silenzio. Altre volte, soprattutto se la crisi si prolunga, si può lanciare un input, facendo sentire al piccolo o alla piccola che stiamo prendendo in mano la situazione: “adesso basta, fermati”, “stop, prova a fare un bel respiro. Vuoi un po’ d’acqua?”
Se i genitori osservano che il bambino sta provando in qualche modo ad autoregolarsi, frenando autonomamente un com-
portamento che sa essere sbagliato, è meglio non intervenire direttamente. Se invece il piccolo, durante la crisi, assume comportamenti che possono far male a sé o agli altri, bisogna intervenire e fermarlo, contenendolo fisicamente con fermezza e delicatezza insieme, nonostante le possibili proteste. Il messaggio importante da trasmettere ai bambini tramite i gesti e le parole che usiamo è che gli adulti accolgono tutte le loro emozioni (che hanno sempre ragion d’essere, anche se provarle può far stare male), mentre non tutti i comportamenti sono accettabili.
Una volta che l’ondata emotiva sarà scemata, ci sarà bisogno di un momento di riconciliazione e conforto. I bambini possono spaventarsi per la potenza delle emozioni che provano, unita alla sensazione di non avere il controllo su di esse. Allo stesso tempo, hanno bisogno di sentire che gli adulti ci sono ancora per loro, che la tempesta che hanno scatenato non li ha allontanati né distrutti e che non smettono di amarli anche se si sono “comportati male”.
Questo atteggiamento da parte dei genitori fa sì che il bambino o la bambina si senta compreso/a e sostenuto/a nel regolare le sue emozioni e i suoi comportamenti. L’adulto non cede alle richieste, non perde autorevolezza, al contrario ne guadagna se invece di tenere il broncio o umiliare il bambino per il comportamento avuto durante il capriccio si offre a lui come un porto sicuro.
Dopo. Non dimenticare la parte nascosta dell’iceberg Oltre a “risolvere” l’episodio del momento, i genitori dovrebbero cercare di comprenderne le ragioni profonde e dare delle risposte adeguate. Potrebbero per esempio percepire che il bambino ha un bisogno particolare di sentirsi rassicurato o amato e trovare il modo di trascorrere del tempo speciale con lui o magari provare a non proporre troppi cambiamenti. Potrebbero pensare a un bisogno di maggiore autonomia; o, ancora, accorgersi che il piccolo ha necessità di essere maggiormente guidato e così via.
Per concludere
I capricci, o meglio, tutti quei comportamenti dei bambini difficili da comprendere e affrontare, possono diventare occasione di dialogo e sostegno alla genitorialità e quindi un investimento per la salute globale di bambine e bambini. Il pediatra non deve diventare un pedagogista, ma può certamente contribuire a seminare buone pratiche e riflessioni educative, creando un’alleanza di intenti e interventi integrati con professionisti dell’educazione ove necessario.
chiara@uppa.it
Il peso del sentire
L’esperienza emotiva e relazionale del bambino e del ragazzo in cure palliative pediatriche
Anna Santini
Psicologa e psicoterapeuta, Centro Regionale Veneto di Cure
Palliative e Terapia Antalgica Pediatrica, Hospice Pediatrico, Azienda Ospedale Università di Padova
Questo contributo è stato scritto nell’ambito dell’attività del gruppo di lavoro Dolore e CPP di ACP
Le cure palliative pediatriche (CPP) non si limitano al trattamento clinico, ma abbracciano anche la dimensione emotiva e relazionale del bambino e ragazzo malato. Spesso, il paziente sviluppa una responsabilità emotiva verso la propria famiglia, cercando di proteggerla dal proprio dolore e sperimentando sensi di colpa. Inoltre, il vissuto del bambino e ragazzo è profondamente influenzato dalle dinamiche familiari e dalla qualità della comunicazione con i caregiver. L’ascolto attivo e una comunicazione aperta aiutano il paziente pediatrico a costruire una narrazione personale della malattia, favorendo il suo benessere psicologico. Anche per i professionisti sanitari, il coinvolgimento emotivo può diventare un peso significativo: trovare strategie di gestione del carico emotivo è essenziale per garantire un accompagnamento efficace e sostenibile. Attraverso l’esperienza di Teo, emergono le complessità del “peso del sentire” e l’importanza di costruire un percorso di cura basato su autenticità, ascolto e supporto condiviso.
Pediatric Palliative Care (PPC) goes beyond clinical treatment, addressing the emotional and relational dimensions of the child or adolescent patient. Often, the patient develops a sense of emotional responsibility toward their family, seeking to protect them from suffering and experiencing guilt. Additionally, the child’s experience is deeply influenced by family dynamics and the quality of communication with caregivers. Active listening and open dialogue help the child construct a personal narrative of illness, supporting their psychological well-being. For healthcare professionals, emotional involvement can become a significant burden, making emotional management strategies essential for effective and sustainable care. Through Teo’s experience, the complexities of the “burden of feeling” emerge, highlighting the importance of building a care pathway based on authenticity, listening, and shared support.
Introduzione
Le cure palliative pediatriche (CPP) rappresentano un approccio multidimensionale volto a garantire il benessere fisico, psicologico e spirituale del bambino e della sua famiglia [1]. La salute, infatti, non riguarda solo il benessere fisico, ma include anche aspetti psicologici e relazionali, fondamentali nel contesto delle CPP [2]. In questo senso, è necessario preoccuparsi degli aspetti emotivi che caratterizzano l’esperienza di malattia del paziente pediatrico. Tuttavia, la sfera emotiva e relazionale del bambino e del ragazzo in CPP viene spesso valutata un ambito squisitamente riservato agli psicologi, mentre invece tutti i professionisti che
si prendono cura di lui e lo accompagnano nel suo percorso di crescita dovrebbero esserne parte attiva.
Alcuni preconcetti sulle CPP portano a proteggere il bambino e il ragazzo dalla consapevolezza della sua prognosi, ritenendo che ciò sia essenziale per preservare la speranza. Tuttavia, l’ascolto attivo permette di costruire un percorso di cura più autentico e personalizzato. La comunicazione empatica è essenziale per comprendere i reali bisogni del bambino e del ragazzo, superando preconcetti e schemi mentali che possono ostacolare un percorso di cura personalizzato.
Questo contributo esplora il mondo emotivo del bambino e del ragazzo nelle CPP, evidenziando l’importanza dell’ascolto e del coinvolgimento attivo per il suo benessere.
Il peso emotivo della malattia inguaribile: vissuti, linguaggio e condivisione
La percezione della propria malattia da parte del bambino e del ragazzo in CPP è un processo dinamico che dipende molto dall’età del paziente ma anche dalle modalità di comunicazione con lui [3-5].
Oltre ai sintomi fisici, il paziente affronta un peso emotivo legato alle limitazioni e alla consapevolezza della perdita di alcune funzioni. Anche i bambini e i ragazzi devono avere lo spazio per vivere il proprio dolore della perdita di una competenza o di una funzione. Questi pensieri spesso sfociano nella domanda “perché proprio a me?” che tende a spiazzare chiunque la senta e che è apice della ricerca di senso dentro la sofferenza. Da qui si apre la necessità di costruire un significato alla propria esperienza. Ogni bambino, ragazzo e famiglia vivono la diagnosi di inguaribilità in modo unico, e la costruzione di una narrazione personale della malattia diventa un processo fondamentale per comprendere il proprio vissuto [6]. Questo processo è influenzato dalla disponibilità degli adulti a rispondere alle sue domande e dal grado di apertura alla sua esperienza soggettiva. Costruire una narrazione della malattia aiuta il bambino e il ragazzo a mantenere continuità con la sua identità e a gestire le emozioni.
Spesso il processo di normalizzazione avviene attraverso un uso particolare del linguaggio che diventa ricorsivo. Così per un bambino la sua carrozzina è la “caregheta” mentre per un altro l’hospice pediatrico è la “casetta”, oppure il personale sanitario sono gli “zii” e le “zie dell’ospedale”, la pompa enterale è “il bussolotto del latte”, mentre per una bambina la gastrostomia è diventata “Greta”. Questi possono sembrare dettagli, solo spiegazioni riduzionistiche e edulcorate per essere adattate a un interlocutore giovane, invece sono modalità di narrare una quotidianità che diventa priva di paura, timore o rabbia perché acquisisce un senso di familiarità e naturalezza. Con il processo di socializzazione secondario, le realtà di vita del bambino e del ragazzo si moltiplicano e si rende necessario il confronto sociale che attiva la necessità di una spiegazione. A volte, questa richiesta di approfondimento è data dal contesto stesso, altre volte è il paziente che desidera spontaneamente condividere la propria storia per rafforzare il senso di appartenenza ed evitare pregiudizi o incomprensioni. Un sostegno emotivo e una comunicazione chiara aiutano il bambino e il ragazzo a esprimersi e a migliorare il proprio benessere. Diventa quanto mai importante capire che ruolo attivo possono svolgere i bambini e i ragazzi in questo processo di condivisione della propria storia di malattia [7,4,8].
Questo coinvolgimento attivo non solo favorisce una maggiore consapevolezza personale, ma aiuta anche chi sta intorno al paziente a comprendere meglio la sua realtà, riducendo il rischio di isolamento sociale e favorendo un’integrazione positiva. L’obiettivo è quello di contenere pensieri ed emozioni dentro una matrice di senso che possa dare spazio alla delusione, all’amarezza, alla tristezza e al disappunto ma non si esaurisca in esse servendosi del potere generativo della condivisione.
Box 1. La spiegazione di Teo della propria situazione clinica: “Le mie palline nella schiena”
Teo ha 16 anni, è affetto da neurofibromatosi di tipo 2 da quando ne ha 8, attualmente utilizza la carrozzina manuale, è diventato cieco ed è ipoacusico nell’ultimo anno e mezzo. In uno dei colloqui psicologici dove si ripercorre la sua storia di malattia, il ragazzo esordisce con questa frase: “Sai che sono malato da metà della mia vita?” All’interno del percorso co-costruito di narrazione della sua biografia, mi racconta come ha saputo che non sarebbe mai guarito: “Eravamo al mare, l’estate prima di andare in carrozzina. Mi hanno detto che avevo quest’altra pallina intrusa, che non si poteva togliere e me lo hanno detto i miei genitori perché sono bravi a parlare. Dirlo al mare che sono più rilassato ed è una situazione più tranquilla mi ha aiutato rispetto all’ambulatorio. Ogni tanto mi dà fastidio che mi tengano nascoste delle cose anche se ogni tanto è anche meglio per evitare che uno resti col pensiero, come che magari mi dicono che un domani morirò, vabbè ma tanto lo faranno tutti. Che cambia? Quindi ho capito che le palline sono ancora presenti. Noi abbiamo scelto di non fare altri esami perché se anche avessi altre palline non potrei farci niente e a questo punto sono più tranquillo così. Non mi fa piacere avere le palline nella schiena ma va bene anche così perché posso comunque fare le cose”.
Le parole di Teo trasmettono tranquillità, mostrando come l’ambiente sereno abbia influenzato la sua accettazione della malattia.
La responsabilità emotiva: tra protezione e senso di colpa Il bambino e il ragazzo in CPP vivono la malattia all’interno di un sistema-famiglia con dinamiche relazionali che influenzano profondamente il vissuto emotivo. La malattia non è un evento esclusivamente individuale: coinvolge necessariamente tutto il nucleo familiare, modificandone equilibri, ruoli e modalità di comunicazione [6].
Il giovane paziente tende a proteggere le persone care minimizzando la propria sofferenza e nascondendo il dolore. In molte famiglie, la narrazione della malattia è filtrata e adattata per tutelare il bambino e il ragazzo dalla realtà difficile, ma, paradossalmente, questo atteggiamento può portarlo ad assumere un ruolo di protezione inversa: sentirsi responsabile del benessere emotivo dei genitori e degli altri membri della famiglia, anche a discapito della propria autenticità emotiva [9]. In una famiglia dove uno dei figli è malato si evita spesso l’espressione delle emozioni negative, mettendo in scena copioni impossibili che comportano dei giudizi interni su cosa è più giusto sentire.
Il bambino e il ragazzo possono sentirsi un peso per la famiglia provando frustrazione, autocolpevolizzazione e senso di colpa. Molto spesso queste emozioni generano narrazioni che il bambino e il ragazzo tengono per sé e che contribuiscono a creare un senso di solitudine e isolamento.
In una visione sistemica, il bambino e il ragazzo non sono solo pazienti, ma membri di un sistema-famiglia con modalità specifiche di funzionamento che devono essere prese in considerazione quando si opera nel contesto della sua cura. La qualità della comunicazione familiare determina il modo in cui regola il proprio vissuto emotivo: nelle famiglie più aperte al confronto, il bambino e il ragazzo possono trovare uno spazio per esprimere la propria esperienza; nelle famiglie evitanti, invece, il dolore può essere nascosto o minimizzato, generando strategie di adattamento emotivo che spingono a mascherare le vere emozioni. Tuttavia, sostenere l’espressione delle differenze tra i membri della famiglia può favorire una ricostruzione delle relazioni, consentendo ai membri di riconoscersi e di affrontare insieme il percorso di cura.
Box 2. Teo e la percezione di essere un peso
In un altro colloquio, Teo porta il tema di sentirsi un peso per la sua famiglia. Mi dice: “Ho bisogno di mettere in ordine i pensieri perché sia io che la mamma siamo emotivamente coinvolti e se le parlassi ora non riuscirei a fare un discorso chiaro e sensato. Molte volte mi sento in difficoltà, mi sembra di generare tristezza. Sono preoccupato perché ultimamente i genitori sono sempre più spesso tristi e insoddisfatti. Sento che cercano tutti i modi per fare delle attività di famiglia, ma è difficile trovare qualcosa che vada bene alle mie esigenze. Mi sento un peso per tutti e genero infelicità”.
Ne parliamo a lungo, pensando a quanto possa essere utile per lui condividere questi pensieri con i suoi genitori, mi scrive qualche giorno dopo: “Alla fine dopo aver affidato a te le mie emozioni e parole sono stato meglio, ho vissuto con più serenità il fatto che la mia famiglia si fosse divisa. Mia mamma con mio fratello sono andati a un evento al parco mentre io sono rimasto a casa con mio padre. Quando sono tornati a casa erano emozionati ed entusiasti e io mi sono sentito alleggerito. Mi sento rincuorato ricordandomi che le cose spesso si sistemano e la maggior parte delle volte le nuvole sono solo di passaggio”.
Teo riconosce le sue emozioni, le sa nominare e capisce da cosa derivano. Le indirizza al suo psicologo dedicato, mostrando di saper utilizzare dei meccanismi di coping funzionali.
Il ruolo dei professionisti della salute: garantire una presenza autentica e centrata sul paziente
Nel contesto delle CPP, il bambino e il ragazzo sono delle persone con una storia, desideri e bisogni emotivi che devono essere accolti con rispetto e autenticità. Il ruolo degli operatori sanitari diventa centrale [10]. Ogni bambino e ragazzo vive la propria esperienza in modo unico e soggettivo: solo ascoltandolo si può realmente costruire un percorso di cura personalizzato e significativo. La comunicazione deve essere adatta all’età e alle capacità del paziente, senza cadere nella semplificazione eccessiva o nella minimizzazione delle difficoltà che porta. Parlare in modo chiaro, accessibile e rispettoso contribuisce a creare fiducia, riducendo la sensazione di impotenza e favorendo la partecipazione attiva nelle decisioni che lo riguardano [11]. Quando è presente, gli operatori devono rivolgersi al paziente direttamente e chiarire che verranno coinvolti anche i suoi familiari. Fingere che non ci sia o parlare di lui senza includerlo nella conversazione può generare un senso di estraneità e perdita di controllo sulla propria situazione [12]. È necessario anche approfondire la realtà della sua famiglia, raccogliendo informazioni su quali valori guidano le loro scelte e come affrontano i conflitti. Il bambino e il ragazzo non sono individui isolati, ma parte di un sistema relazionale che incide profondamente sul vissuto emotivo. Capire le dinamiche familiari permette di supportare non solo il paziente, ma anche il nucleo che lo circonda [10].
Per i professionisti della salute, trovare un equilibrio tra empatia e gestione emotiva è essenziale. Il coinvolgimento nel vissuto del bambino e del ragazzo può diventare molto intenso, e il rischio di burnout è concreto. Creare uno spazio di confronto all’interno dell’équipe consente di affrontare le difficoltà senza sentirsi sopraffatti, migliorando la qualità dell’intervento e garantendo una presenza autentica e sostenibile nel tempo [12].
Box 3. Come Teo ha creato un legame con i suoi curanti
Teo ha sempre di più preso parte al suo progetto di vita, contribuendo a prendere le decisioni insieme ai suoi curanti e decidendo insieme cosa fosse importante per lui. In particolare ha sviluppato un rapporto molto personalizzato con il servizio di CPP e il suo pediatra. Inizialmente non sapeva come interagire, lasciava soprattutto che fossero i suoi genitori a interfacciarsi con tutti gli interlocutori. Teo ha accettato subito un sostegno psicologico da parte delle CPP e ha potuto focalizzare in che modo diventare attivo nel suo percorso di cura. Ha iniziato quindi a partecipare sempre più attivamente ai colloqui durante le visite o i ricovero; durante alcuni periodi critici ha chiamato in prima persona il medico e l’infermiere. Ha chiesto spiegazioni precise riguardo alla terapia farmacologica, al funzionamento dei farmaci, alla sua modulazione nei dosaggi. Questo gli ha permesso di comprendere e condividere le decisioni cliniche. Ha messo dei paletti su alcuni momenti dell’anno in cui non era disponibile a ricoveri di follow-up perché voleva dare priorità a impegni scolastici e personali. Ha richiesto di poter svolgere un’attività sportiva in sostituzione della riabilitazione fisioterapica e ha accettato di mantenere attivo un monitoraggio. Ha continuato a girare il mondo con la sua famiglia, chiedendo aiuto nell’organizzazione dei viaggi e nella gestione di tutto quello che potesse servirgli.
Conclusione
Nel cuore delle CPP, il bambino e il ragazzo non sono solo pazienti, ma vita che pulsa tra dolore e speranza. Il loro sentire attraversa relazioni, sfiorando il coraggio silenzioso di chi gli sta accanto. Accanto a loro, il professionista sanitario diventa guida e presenza autentica, ascoltando senza fuggire. E forse, è il giovane paziente a insegnarci che ogni istante vissuto con autenticità ha un valore che nessuna diagnosi può cancellare.
Bibliografia
1. Le cure palliative pediatriche. Un approccio multidimensionale. OMS, 2020.
2. Benini F, Ferrante A, Facchin P. Cure palliative pediatriche. Epidemiologia e sfide assistenziali. Rivista Italiana di Pediatria. 2007;33:87-94.
3. Toro-Pérez D, Camprodon-Rosanas E, Navarro Vilarrubí S, et al. Assessing well-being in pediatric palliative care. A pilot study about views of children, parents and health professionals. Palliat Support Care. 2024 Oct;22(5):1000-1008.
4. Walsh F. La resilienza familiare. Raffaello Cortina Editore, 2008.
5. Scarponi D. Cure palliative pediatriche: Aspetti psicosociali. ASMEPA, 2014.
6. De Tommasi V, Minetto M. La morte del bambino e la gestione del lutto: problemi sommersi che mettono in crisi. Area Pediatrica. 2016:17:117-121.
7. Hain R, Goldman A, Rapoport A, Meiring M. Oxford Textbook of Palliative Care for Children (3rd ed.). Oxford University Press, 2021.
8. Bowen M. Dalla famiglia all’individuo. La differenziazione del sé nel sistema familiare. Astrolabio, 2021.
9. Hrdlickova K, Polakova K., Loucka M. Innovative communication approaches for initializing pediatric palliative care: perspectives of family caregivers and treating specialists. BMC Palliat Care. 2023 Oct 10;22(1):152.
10. Mosconi G, Zaninelli FL. Quando un bambino si ammala. Accompagnare i genitori nell’esperienza della malattia. RIEF. 2022;20, 143-154.
11. D’Ulivo B. La comunicazione: parlare con il bambino e con la famiglia. Istituto G. Gaslini, 2025.
12. Bobbo N. Educazione al limite, di fronte al dolore ed alla morte dei bambini. IRIS Catalogo Ricerca UNIPD, 2004.
anna.santini@aopd.veneto.it
Dalla rivista
Epidemiologia
& Prevenzione, un invito alla lettura per i pediatri ACP
Numero 3-2024
Giacomo Toffol
Coordinatore Pagine elettroniche di Quaderni acp
Continua su questo numero di Quaderni acp la segnalazione degli highlight dell’ultimo numero della rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia Epidemiologia & Prevenzione, frutto di un accordo tra l’Associazione italiana di epidemiologia e l’ACP che prevede uno scambio di segnalazioni per evidenziare e promuovere reciprocamente i temi di maggior interesse delle due riviste. Abbiamo letto per voi il numero 3 -2024 della rivista, ricco di spunti di sicuro interesse per i nostri lettori.
Uno degli editoriali ci riporta agli inizi della pandemia da Covid-19, al periodo in cui la comunità medica riteneva che le principali vie di trasmissione del virus fossero il contatto diretto con superfici contaminate e le goccioline respiratorie (droplet) emesse durante tosse e starnuti che, sulla base di un dogma della fine dell’Ottocento, sarebbero dovute cadere rapidamente a terra, limitando la loro portata di diffusione alla prossimità (1-2 metri). L’articolo, ricostruendo la tortuosa storia che ha permesso di modificare queste convinzioni errate, pone l’attenzione sulla necessità di ulteriori sforzi da parte della collettività scientifica mondiale per affrontare e risolvere la questione della qualità dell’aria negli ambienti indoor. Il rischio connesso alle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e in particolare il disastro ambientale causato dalla contaminazione da queste sostanze in Veneto costituiscono un tema rilevante di sicuro interesse anche per i pediatri. I PFAS, di cui abbiamo parlato anche nell’ultimo numero di Quaderni, sono collegati a vari problemi di salute, tra cui cancro, basso peso alla nascita, alterazioni del fegato e del metabolismo, nonché problemi immunitari. Questo tema è trattato da uno studio di A. Biggeri che ha valutato, anche se solo sulla popolazione adulta, il rischio legato all’assunzione di sostanze per- e polifluoroalchiliche per via alimentare da parte della popolazione veneta residente nella zona con contaminazione delle acque. Ma si parla di PFAS anche in un’intervista, rilasciata dall’autore dello studio succitato, e in un editoriale che riprende, partendo dal caso dei PFAS, il tema della “citizen science”, ovvero della ricerca epidemiologica cui collaborano non solo gli scienziati, i ricercatori, ma anche i cittadini comuni, quelli che potrebbero essere definiti “scienziati di comunità”. Il termine sottolinea come questi cittadini siano portatori di conoscenza specifica sui fenomeni indagati, anche se non espressa per mezzo del linguaggio tecnico della disciplina scientifica. Forse solo la loro partecipazione, suggeriscono i testi, permette di ricostruire una cornice di senso alle ricerche, iniziando dalla definizione dei quesiti e arrivando alle implicazioni di sanità pubblica. Forse solo con l’apporto di que-
ste conoscenze espresse dalle comunità degli esposti si può fare davvero una consequential epidemiology, ovvero un’epidemiologia che si prende cura delle conseguenze sociali, che non si limita allo studio delle cause delle malattie, ma agisce per prevenirle. E questo è sicuramente un tema caro ai nostri lettori.
Tra gli altri temi trattati nella rivista segnaliamo gli effetti dell’esposizione ambientale e professionale agli insetticidi e in particolare agli organofosfati sulla concentrazione spermatica, ben evidenziati da una recente revisione sistematica della letteratura; il rischio di ipospadia connesso all’inquinamento ambientale di un sito di interesse nazionale, quello di Gela, caratterizzato fino al 2014 dalla presenza di un polo petrolchimico; i rischi connessi all’uso di talco commerciale analizzati da una nuova metanalisi.
Nella rubrica “Epigenetica e ambiente” si parla del “costo nascosto” della violenza psicologica domestica che, sebbene non lasci lividi o cicatrici evidenti, può essere altrettanto dannosa e più subdola di quella fisica. Questo tipo di violenza domestica, che a volte noi pediatri possiamo sospettare osservando i comportamenti dei genitori dei nostri pazienti, lascia spesso segni indelebili nella psiche delle madri, che si ripercuotono ovviamente sullo sviluppo psicorelazionale dei figli. Le madri vittime di questa violenza spesso sono affette da disturbi emotivi e psicologici, difficoltà nelle relazioni interpersonali, senso di colpa e vergogna, paura costante. Tutte condizioni che minano la loro stabilità emotiva e rendono difficile istituire un adeguato rapporto relazionale con i figli, i quali, crescendo in ambienti violenti, spesso imparano che la violenza è un modo accettabile per risolvere i conflitti o per ottenere ciò che vogliono, perpetuando così il ciclo della violenza. Uno studio pilota, condotto dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, ha identificato alcuni marcatori epigenetici associati ai sintomi di depressione, ansia e disturbo da stress post-traumatico nelle donne che sono sopravvissute alla violenza in ambito relazionale e/o sessuale. Un ulteriore esempio di come l’ambiente può influenzare il nostro epigenoma.
Infine nella rubrica “La prevenzione di domani” segnaliamo un articolo sugli effetti delle arti sulla salute. Un recente rapporto che presenta i risultati di una dozzina di studi di coorte realizzati negli Stati Uniti e nel Regno Unito conferma che in bambini e adolescenti la partecipazione ad attività culturali e artistiche riduce i problemi di iperattività, le difficoltà di concentrazione e i comportamenti antisociali e violenti; aumenta/migliora i comportamenti pro-sociali, quali empatia e altruismo; diminuisce la probabilità di fumare sigarette e assumere sostanze alcoliche e stupefacenti. Ancora una conferma della bontà dei nostri Nati per Leggere e Nati per la Musica. Ricordando che la rivista è integralmente leggibile per gli abbonati dal sito https://epiprev.it/ vi auguriamo una buona letptura.
Libri
Occasioni per una buona lettura
Rubrica a cura di Maria Francesca Siracusano
La salute dei bambini. Migliorarla si può di Mario De Curtis, Silvio Garattini Baldini & Castoldi, 2025, pp. 304, € 19
La salute dei bambini. Migliorarla si può di Mario De Curtis e Silvio Garattini, edito da Baldini & Castoldi, è un volume che unisce rigore scientifico, umanità e indicazioni concrete. Se ci fosse bisogno di avere un’analisi accurata e affidabile di cosa è necessario fare in Italia per migliorare la salute dei bambini, basterebbe leggere attentamente questo libro. Il testo, oltre a rappresentare una fotografia accurata della condizione dell’infanzia nel nostro Paese, costituisce anche una cornice di riferimento essenziale e uno strumento prezioso per la pratica pediatrica quotidiana di chi si occupa di salute dei bambini nel loro contesto di vita reale. Gli autori, rispettivamente un eminente pediatra e neonatologo, e un farmacologo di rilievo internazionale, illustrano con chiarezza e metodo come le politiche sociosanitarie possono e devono sostenere la salute dei minori, focalizzandosi soprattutto sui primi mille giorni di vita. Questa fase specifica viene esaminata nel quadro delle disuguaglianze e delle politiche sanitarie come base scientifica e operativa per indirizzare interventi specifici volti al miglioramento della salute infantile in Italia. Le disuguaglianze costituiscono il filo conduttore attraverso cui gli autori analizzano nel primo capitolo la specificità pediatrica del servizio sanitario nazionale, suggerendo indicazioni concrete per la sua necessaria riforma. I capitoli successivi, con lo stesso filo conduttore, sono dedicati ai bambini con malattie inguaribili o rare, in cure palliative, figli di genitori stranieri o appartenenti a famiglie omogenitoriali, minori abbandonati, adottati, in affido o ospiti di case-famiglia, nonché bambini affetti da patologie legate a uso di sostanze, fumo e alcol durante la gravidanza. In ogni capitolo vengono presentati dati statistici aggiornati, criticità rilevanti e soluzioni potenziali evidence-based. Un quadro completo e accurato della situazione dell’infanzia in Italia. Molto interessante il concetto di salute, pilastro fondamentate del benessere, come diritto ma anche dovere. Con questo si apre l’ultimo capitolo, quello sulla prevenzione. La salute è un impegno per le istituzioni oltre che per l’individuo e gli autori chiudono condividendo l’approccio one health promosso dall’OMS, come risultato di un equilibrio armonico tra uomo natura e ambiente. Approccio che non può che essere globale. Una conclusione che suona ancora più forte in un momento storico così complesso come quello che stiamo attraversando.
Il pensiero affettivo
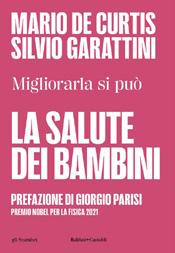
Laura Reali
di Ginevra Bompiani, Sarantis Thanopulos Feltrinelli, 2024, pp. 128, € 16,15
L’affetto è una forma del pensiero? Questa è la base da cui parte l’idea di uno scambio epistolare, che va da maggio 2021 a ot-
tobre 2022, tra Ginevra Bompiani e Sarantis Thanopulos. La prima, scrittrice, saggista e traduttrice, figlia dell’editore Valentino Bompiani, ha insegnato letteratura inglese all’Università di Siena e nel 2002 ha fondato, insieme a Roberta Einaudi, la casa editrice Nottetempo, che ha diretto fino al 2016. È stata sposata col filosofo Giorgio Agamben. Il secondo, psicoanalista a Napoli, presidente della Società Psicoanalitica Italiana fino all’anno scorso, è autore di numerosi volumi e collabora col quotidiano il manifesto. È sposato con una magistrata. Essendo uno scambio epistolare, che quindi si anima nel confronto, ci si aspetterebbe una sequenza cronologica delle lettere. Modalità secondo cui ho fatto, ovviamente, la prima lettura. Gli autori invece hanno deciso di mettere in sequenza prima tutte le lettere di Bompiani e poi quelle di Thanopulos, in modo da mostrare come ciascuno segua il proprio discorso, ispirato dall’altro ma distinto e parallelo. Scelta vincente perché in questo modo appaiono evidenti le diverse impostazioni degli amici. Emergono i punti di contatto e gli accordi che sottendono i disaccordi, in una dimensione non speculativa ma relazionale della verità. Ginevra fluttua tra un’infinità di saperi filosofico-letterari, mentre Sarantis si mantiene per lo più sullo zoccolo duro della psicoanalisi. Bompiani parte dall’etimologia. Affetto, dal latino ad ficere, significa “fare qualcosa per”. Pensare, dal latino pensum, significa “pesare” (la lana grezza, che poi va trattata). E noein (nome arcaico per pensiero) significa “annusare, percepire col naso”, e quindi avrebbe un’origine fisica, nell’odorato, nel respiro. “Il respiro, del resto, è il nostro primo scambio col mondo”. Ancora Bompiani. La realtà è tutto ciò che ti resiste e ti limita. Se il pensiero nasce dall’affetto, cioè da Eros, è saggio proteggerlo da lui (Freud docet). Poiché se l’affetto è natura ardente, “va tenuto manso nel suo recinto. Certo, infuoca e ingentilisce la vita, ma, come un bambino fra gli adulti, bisogna insegnargli a giocare da solo senza disturbare”. Quindi “l’affetto (passione, desiderio) è una forma del pensiero, anzi, è il modo del pensiero in azione. Ma anche l’affetto è alla radice del pensiero. Entrambi, intrecciati, producono conoscenza, la quale o è affettiva, o è still life, natura morta”. Ragione ed eros (passione e raziocinio) rappresentano l’accavallarsi reciproco del limite e del suo scavalcamento. Thanopulos. In psicoanalisi all’inizio della vita affetto e pensiero coincidono, e questa coincidenza persiste in tutta la vita, è il nucleo profondo, essenziale, della nostra concezione della realtà. L’affetto contiene la spinta, e la spinta è il desiderio che lo abita. Il nostro primo altro è la madre. “Il silenzio che precede la parola, il senso senza significanti, è fondato su un’esperienza condivisa, su due respiri che si incontrano, si sincronizzano, dialogano, si intendono”. Le parole sono strumento di comunicazione, ma la comunicazione nel suo fondo è relazione silenziosa (ancora il respiro). In mancanza di affetto non c’è attività mentale. La lettura del testo richiama costantemente la relazione precoce madre-bambino dove affetto e pensiero sono inevitabilmente legati nella costruzione della sintonizzazione. Rimane il leitmotiv della vita, l’impronta o l’ombra dell’oggetto.
Il Maestro e Margherita
di Michail Bulgakov
Feltrinelli, 2014, pp. 552, € 11,40
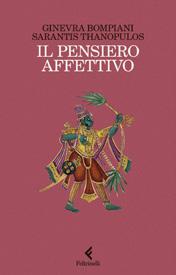
Claudio Chiamenti
Ci sono tanti libri che rileggiamo, soprattutto se in epoche lontane della nostra vita li abbiamo letti e ci sono sembrati i libri
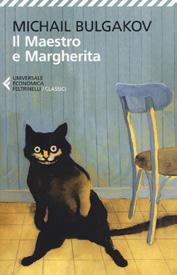
della vita, anche se a mente fredda ci chiediamo cosa abbiamo capito, cosa ci è rimasto di questa lettura precoce. Per Il Maestro è Margherita, l’occasione di rilettura mi è stata data dall’uscita nelle sale, a giugno, del film diretto da Michail Lokšin, uscito con un grande battage pubblicitario e coda di polemiche sul ritorno del diavolo nella Mosca putiniana. Così ho ripreso tra le mani il vecchio libro, edizione De Donato editore, 1967 (verosimilmente io non l’avrò letto in quell’anno, perché nel ‘67 avevo 9 anni) e di cui ricordo ancora la fascinazione su me adolescente, per quanto abituata alla lettura dei libri classici probabilmente poco adeguati all’età. Definito da subito un capolavoro, magico e affascinante. In sintesi, Bulgakov divide Il Maestro e Margherita in due libri. Nel primo, narra l’arrivo nella Mosca degli anni ’30 di Satana nei panni di Woland, un misterioso professore straniero, esperto di magia nera, attorniato da una cricca di personaggi alquanto particolari. Il gruppo prende di mira i membri di un’importante associazione letteraria sovietica, che ha sede presso la Casa Griboedov, luogo di convegno dell’alta società moscovita. In seguito al loro arrivo alcuni dei membri vengono uccisi, alcuni finiscono esiliati o al manicomio. All’interno di questa narrazione vengono rievocati gli avvenimenti accaduti a Gerusalemme durante il periodo pasquale al tempo del prefetto romano Ponzio Pilato. Woland racconta di essere stato presente al processo al “mite predicatore” Jeshua Ha-Nozri (Gesù), e così il lettore viene anche a conoscenza che questi fatti erano contenuti in alcune pagine del perduto romanzo del
Maestro in cui si narrava ciò che accadde a Pilato durante il processo e nei giorni successivi alla morte di Ha-Nozri. Nella seconda parte viene raccontata la storia d’amore del Maestro e di Margherita; benché la loro storia sia finita, lei è convinta che si ritroveranno; per questo accetta l’invito del Diavolo e la sua seduzione. Per riassumere e descrivere un romanzo così complicato, meglio usare le parole di Eugenio Montale: “Il Diavolo è il più appariscente personaggio del grande romanzo postumo di Bulgakov. Appare un mattino dinanzi a due cittadini, uno dei quali sta enumerando le prove dell’inesistenza di Dio. Il neovenuto non è di questo parere... Ma c’è ben altro: era anche presente al secondo interrogatorio di Gesù da parte di Ponzio Pilato e ne dà ampia relazione in un capitolo che è forse il più stupefacente del libro... Poco dopo, il demonio si esibisce al Teatro di varietà di fronte a un pubblico enorme. I fatti che accadono sono cosi fenomenali che alcuni spettatori devono essere ricoverati in una clinica psichiatrica... Un romanzo-poema o, se volete, uno show in cui intervengono numerosissimi personaggi, un libro in cui un realismo quasi crudele si fonde o si mescola col più alto dei possibili temi: quello della Passione... È qui che Bulgakov si congiunge con la più profonda tradizione letteraria della sua terra: la vena messianica, quella che troviamo in certe figure di Gogol’ e Dostoevskij e in quel pazzo di Dio che è il quasi immancabile comprimario di ogni grande melodramma russo”. Alla lettrice che sono stata sono rimaste scolpite in modo indelebile l’incipit del secondo libro (“Seguimi lettore! Sia recisa la lingua infame al mentitore che ha negato l’esistenza di un amore autentico, fedele ed eterno sulla terra”) e il momento in cui Margherita spalma con la punta delle dita sul corpo la crema del vasetto dorato che la renderà bella, eternamente giovane e dannata. Maria Francesca Siracusano
Nomine del Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni (NITAG)
L’Associazione Culturale Pediatri (ACP) esprime forte disappunto e chiede al Ministero della Salute la revoca di due componenti
Pisa, 11 agosto 2025. L’Associazione Culturale Pediatri (ACP) esprime il proprio forte disappunto e la più viva preoccupazione per la recente nomina dei nuovi componenti del Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni (NITAG, National immunization technical advisory group) da parte del Ministero della Salute.
Il NITAG è un comitato tecnico che dovrebbe operare in modo indipendente, con il compito di consigliare il Ministero in materia vaccinale secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e basandosi su un approccio di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment).
L’ACP chiede al Ministro Orazio Schillaci di chiarire in base a quali presupposti scientifici e a quali curricula siano stati inclusi nel NITAG il dottor Eugenio Serravalle e il dottor Paolo Bellavite. Entrambi sono noti per aver pubblicamente espresso posizioni che contraddicono il solido consenso scientifico sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini, strumenti fondamentali per la sanità pubblica.
Il loro inserimento in un organismo deputato ad analizzare le evidenze scientifiche rischia di compromettere la fiducia pubblica nella medicina e nelle politiche di prevenzione, legittimando una narrativa pseudoscientifica. Per queste ragioni, l’ACP si unisce alla richiesta di altre società scientifiche e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) di rivedere la composizione del NITAG, revocando la nomina di Serravalle e Bellavite ed esprime la propria solidarietà a vicinanza alla dottoressa Francesca Russo dirigente del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto per essersi dimessa dal NITAG in segno di disaccordo per le scelte ministeriali.
L’ACP invita inoltre il Ministro a considerare con attenzione il problema del conflitto di interessi. È stato rilevato che alcuni dei professionisti nominati hanno svolto o svolgono attività di consulenza per l’industria farmaceutica del settore. Sebbene ciò non precluda necessariamente un contributo scientifico valido, la loro presenza in un organismo consultivo su un tema così sensibile come le vaccinazioni rischia di alimentare i sospetti di quei movimenti che già mettono in discussione la credibilità delle scelte vaccinali, minando ulteriormente la fiducia dei cittadini.
L’Associazione Culturale Pediatri ritiene indispensabile che un organismo cruciale come il NITAG sia composto da esperti di comprovata integrità e indipendenza, la cui competenza scientifica sia inequivocabilmente allineata con i principi della medicina basata sulle evidenze.
Lettere
Pubblichiamo la lettera di Adriano Cattaneo e quella di Maria Antonietta Grimaldi in riferimento all’articolo di Riccardo Davanzo pubblicato su Quaderni acp 4/2025. L’argomento è sicuramente di notevole interesse con importanti ricadute sui bambini, le bambine e le loro famiglie.
Ripensando a Carlo Corchia (componente storico della redazione di Quaderni), mi auguro che il confronto fra le diverse opinioni e i punti di vista possa avvenire nel rispetto di tutti i protagonisti.
Invito le nostre lettrici e i nostri lettori a intervenire in questo dibattito che ci vede tutti coinvolti.
Michele Gangemi, direttore di Quaderni acp
Osservazioni in merito alla progetto policy aziendale per l’allattamento
Nel suo articolo [Quaderni acp 2025;32(4):174-176], Davanzo elenca alcuni ostacoli, ben noti da anni agli addetti ai lavori [J Hum Lact 2012;28:317-334], alla realizzazione della BFHI in Italia. Omette, però, di dire che questi e altri ostacoli sono stati superati con successo in Paesi limitrofi come Slovenia e Croazia, o con sistemi sanitari simili al nostro come la Gran Bretagna. La BFHI, un intervento con solide prove di efficacia [Women and Birth 2025;38:e101881], alla costruzione delle quali Davanzo ha dato un importante contributo [BMJ 2001;323:1358-1362], è attiva in Italia da 25 anni. Nei suoi 12 anni di esistenza, Davanzo presidente, il TAS, che ha generato e poi abortito il progetto PAA [www.salute.gov.it/new/sigtes/default/files/imported/C_17_pubblicazioni_3261_allegato.pdf ], ha pubblicato decine di documenti, ma nessuno sulnla BFHI. Che io sappia, il TAS non ha nemmeno mai perorato la causa della BFHI presso il Ministero che lo ha istituito. Neppure la SIN, della cui commissione allattamento Davanzo è presidente, la SIP e le altre associazioni professionali che hanno ereditato dal TAS il progetto PAA, pur pronunciandosi sempre a favore dell’allattamento, e a volte anche della BFHI, hanno mai fatto pressione sulle autorità sanitarie perché gli ostacoli di cui sopra fossero affrontati. Il progetto PAA non ha prove di efficacia. I risultati millantati da Davanzo sono ingannevoli. Se si va alla fonte dei dati presentati, al rapporto n. 3 del progetto PAA [www.sin-neonatologia.it/wp-content/ uploads/2025/05/R3-2025_PAA_-Red.pdf ], si vede che a no2vembre 2023 il 28,7% dei neonati (24,4% con alimentazione mista e 4,3% alimentati con formula) assumeva formula; lo stesso 28,7% (23,8% + 4,9%) di febbraio 2025. L’aumento statisticamente significativo (ma basta aumentare il campione per rendere significativo anche l’aumento di un punto decimale) di 1,7% dell’allattamento esclusivo (da 69,2% a 70,9%) è attribuibile solo alla diminuzione dell’allattamento predominante (da 2% a 0,3%), non quindi all’aumento dell’uso di latte mater-
no a scapito della formula. In pratica, il progetto PAA è riuscito a diminuire l’uso di liquidi non nutritivi, un risultato di cui è difficile andare fieri. Un risultato che però soddisfa le ditte produttrici di formula, che finanziano gli eventi e le attività di SIN, SIP et al. Io mi auguro, sinceramente, che il progetto PAA stimoli più ospedali a intraprendere il percorso BFHI, ma ne dubito. Bisognerebbe che SIN, SIP et al. tradissero i loro finanziatori e facessero la giusta pressione sulle autorità sanitarie per la BFHI. Finché questa sarà a carico solo di Unicef Italia e di personale sanitario di buona volontà, sarà arduo superare gli ostacoli.
PS Precisazione: “A ritenere la promozione dell’allattamento imprescindibile dal pieno rispetto del Codice” non sono gli attivisti dell’allattamento, ma OMS e Unicef.
Adriano Cattaneo, epidemiologo, Trieste
Per una formazione in loco, indipendente e a costi contenuti, per l’allattamento Nell’articolo Update sul progetto Policy aziendale per l’allattamento pubblicato su Quaderni acp 2025;32(4) ho letto che i motivi per cui facciamo poco per l’allattamento sarebbero dovuti a scarso interesse da parte del personale sanitario e alla presenza di conflitti di interesse (CdI).
Anche io nutrivo scarso interesse per l’allattamento. Durante il mio percorso di studi non ricevetti alcuna preparazione in merito. Dopo avere frequentato un corso OMS/Unicef sull’allattamento, la mia attitudine professionale cambiò, specificamente nel modo di rapportarmi con madre e bambino e nella valorizzazione delle loro straordinarie competenze. Non ebbi bisogno di nessuna incentivazione economica perché il mio lavoro era diventato più appassionante. Inoltre, credo che incentivare economicamente chi promuove l’allattamento sarebbe come erogare un premio economico a un medico che prescrive correttamente le terapie.
Riguardo ai CdI, in occasione della realizzazione di un progetto di formazione a cascata sull’allattamento per la Regione Sardegna negli anni precedenti l’epidemia da Covid e che prevedeva innanzitutto la formazione di formatori locali, avevo potuto constatare quanto è possibile risparmiare se si producono competenze in loco, se sono i formatori a recarsi verso i poli sanitari più importanti per raggiungere i discenti che lì operano, e se si lavora il più possibile in orario di servizio. Dopo cinque corsi OMS/Unicef di 80 ore, 26 edizioni del corso di 40 ore, e due edizioni del corso di 20 ore erano stati formati 63 nuovi formatori e 520 operatori sanitari con costi inferiori a quanto assegnato dal Piano Regionale di Prevenzione, e di molto inferiori al costo di un pacchetto pronto con formatori esterni. Non avrei potuto accettare contributi dall’industria farmaceutica. Sarebbe stato come fare due faticosi passi avanti a favore dell’allattamento e due indietro. Inoltre, avrei avuto il timore che per ogni pranzo o viaggio che l’industria ci avesse rimborsato, una quota di recupero spese avrebbe gravato su chi acquista i sostituti del latte materno, con maggiore incidenza sulle famiglie meno abbienti. Peraltro, sappiamo che favorire l’allattamento porta a notevoli risparmi per il Servizio Sanitario, con possibilità di investimento in corsi di formazione indipendenti.
Maria Antonietta Grimaldi, pediatra di Consultorio in pensione
Risposta alle lettere sul progetto PAA
Mi ha fatto piacere l’interesse destato sul progetto PAA, che rappresenta – si voglia o no – una indiretta conferma della sua rilevanza e riapre un dibattito antico e irrisolto sulle sponsorizzazioni da parte dell’industria produttrice di alimenti per l’infanzia. Cerco, brevemente, di rispondere alle lettere ricevute.
Riccardo Davanzo
Risposta al dott. Cattaneo su “Osservazioni in merito alla progetto policy aziendale per l’allattamento”
Avendo fatto parte negli anni 2009-2012 del Comitato nazionale multisettoriale per l’allattamento al seno che ha preceduto il TAS, Cattaneo dovrebbe ricordare le difficoltà incontrate nel portare avanti concretamente la BFHI nel contesto nazionale. Bisogna ammettere che né quel Comitato Multisettoriale (2009-2012), né il successivo TAS (2012-2024) potevano fare di più.
Per quanto riguarda il ruolo che il TAS ha avuto nel generare il progetto PAA, ricordo che il primum movens è stato un invito giunto proprio dall’OMS di Ginevra, che auspicava un più diffuso impegno da parte degli ospedali italiani almeno su alcuni dei 10 passi della BFHI. Come risposta a tale richiesta, in seno al TAS si era delineato un progetto, chiamato 3P (cioè dei 3 passi), che aveva ottenuto l’adesione di società scientifiche e ordini professionali, ma che era stato alla fine archiviato per mancanza di consenso sul fatto che vi dovesse essere incluso o meno il richiamo alla piena osservanza del “Codice”, indiscusso riferimento etico, ma notoriamente divisivo. L’Unicef e le ong per l’allattamento si erano alla fine dichiarati contrari. Fortunatamente quel progetto 3P non è abortito, ma al contrario si è sviluppato al di fuori del Ministero della Salute, in seno alle società scientifiche e alle associazioni professionali, che ne hanno apprezzato il pragmatismo, il basso costo (se non proprio la gratuità), lo stile di gestione collegiale e l’assenza di un’impostazione colpevolizzante. Ne è venuto fuori il progetto PAA, che rifuggendo i dogmatismi ha ottenuto l’adesione di molte aziende sanitarie e ha sollevato/riattivato entusiasmi sull’allattamento fra il personale sanitario ospedaliero. Risultano aver aderito al progetto PAA sia centri che necessitavano semplicemente di rinforzare percorsi ben avviati, sia centri che richiedevano la creazione di un percorso ex novo, ottenendo indicazioni sulle modalità operative e i materiali per poterlo iniziare e sostenere. Il progetto PAA rappresenta una realtà, ma Cattaneo tenta ora di sminuirne il valore. L’efficacia del progetto PAA va però misurata non solo sull’indicatore principale dell’allattamento esclusivo, ma anche sulla variazione positiva degli indicatori secondari: la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc, la definizione di una policy, la diffusione delle pratiche postnatali facilitanti la relazione madre-bambino, la copertura formativa e l’applicazione di protocolli aziendali sull’allattamento. Ci si dovrebbe rallegrare che il progetto PAA abbia avuto una diffusione così ampia, che potrebbe far da battistrada al BFHI.
In assenza di un impegno governativo concreto, non c’è da attendersi che attualmente siano le società scientifiche a promuove questo upgrading , rinunciando alle sponsorizzazioni dell’industria. Il progetto PAA ha riacceso in più di 100 maternità italiane la cultura dell’allattamento, ma la spinta verso la BFHI dovrà essere locale, sfruttando, ove presenti, la motivazione di chi dirige l’ospedale e di chi vi lavora. Una volta fatte le enunciazioni identitarie imposte da “testa e pancia”, i detrattori del progetto PAA dovrebbero piuttosto cogliere l’assist fornito e calarsi nella complessa quotidianità operativa dei nostri ospedali, rinunciando alle ideologie e mirando piuttosto al vero obiettivo da perseguire: garantire a tutte le famiglie in ogni punto nascita italiano un valido (non si pretende perfetto!) sostegno all’allattamento e alla relazione madre-bambino, con o senza il cappello del Codice. Vedremo se avranno il coraggio e la capacità per farlo.
Risposta alla dott.ssa Grimaldi su “Per una formazione in loco, indipendente e a costi contenuti, per l’allattamento”
Rispetto la posizione e la preziosa esperienza della Grimaldi e mi congratulo per l’impegno. La formazione del personale sanitario comunque è molto più composita di quella, pur importante, dell’allattamento a cui si fa riferimento nella lettera. Non sempre è possibile formarsi sui temi del proprio ambito professionale restando nella propria sede perché non tutte le aziende hanno il dinamismo e l’autorevolezza per confezionare in sede momenti formativi di valore.
Una volta scartati i molti eventi pseudo-scientifici, a preminente finalità turistica o quelli meramente celebrativi dell’organizzatore di turno o quelli in stile me too, resta la necessità di una formazione professionale continua, seria e selezionata per obiettivi, qualità della docenza, temi.
Questa oggigiorno ha un costo significativo, anche quando è improntata a uno stile sobrio. La gran parte delle amministrazioni ospedaliere non hanno o non intendono utilizzare fondi per missioni fuori sede per la formazione dei propri dipendenti. Altro problema irrisolto è che, ove ci siano dei fondi, i criteri seguiti dal direttore clinico per selezionare i pochi dipendenti da inviare in missione sono spesso mal definiti o poco trasparenti, talora arbitrari.
Anche se molte delle conoscenze mediche possono oggigiorno essere acquisite online, resta quindi il bisogno di viaggiare per partecipare a convegni. Ma con quali risorse? Non va dato per scontato che il singolo sia pronto a pagarsi la formazione. Finché non si trovano i fondi necessari, non si può proporre a medici, infermiere e ostetriche di sobbarcarsi le spese per la missione di studio, rilevanti sia in termini assoluti, sia, ancor più, relativamente al salario attualmente percepito. Inoltre, appare penalizzante che il medico o il professionista che si occupa di allattamento risulti l’unico nel panorama delle professioni sanitarie a doversi sobbarcare l’onere della propria formazione (anche su temi diversi dall’allattamento) sulla base di un pregiudiziale conflitto di interesse.
Il comunicato ACP che segue, inviato a International Pediatric Association (IPA) e International Society for Social Pe)diatrics and Child Health (ISSOP), si aggiunge a un ulteriore appello che le organizzazioni pediatriche internazionali il 30 luglio hanno condiviso e diffuso per fermare il genocidio di Gaza.
«Non rimanete in silenzio. Fate sentire la vostra voce. Agite. Boicottate. Ogni voce conta, e il silenzio è complicità.»
Serena Awad
NON POSSIAMO RIMANERE IN SILENZIO perché i bambini non sono nemici e gli aiuti umanitari non dovrebbero essere usati come arma.
Prima dell’ottobre 2023, Serena Awad si dedicava a programmi di sviluppo a lungo termine per i giovani a Gaza, concentrandosi sulla creazione di opportunità sostenibili per i giovani. A seguito dell’escalation del conflitto, il suo ruolo è passato alla risposta umanitaria di emergenza.
Il lavoro e la testimonianza di Serena Awad sono stati condivisi durante un recente webinar organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità italiano.
In questa nuova veste, Serena ha svolto un ruolo fondamentale nel coordinare la distribuzione degli aiuti, fornendo un sostegno cruciale alle famiglie sfollate all’interno del Paese e conducendo rapide valutazioni dei bisogni nelle zone più colpite. Questa transizione è avvenuta in condizioni di estrema difficoltà, con i doveri professionali che spesso si sovrapponevano alla sopravvivenza personale. Nonostante sia stata sfollata più volte e abbia continuato il suo lavoro sotto i bombardamenti, Serena ha dimostrato un impegno incrollabile.
Nei rifugi di emergenza e nelle zone non sicure, ha organizzato la distribuzione di beni di prima necessità, tra cui cibo, acqua e prodotti per l’igiene. Uno degli obiettivi principali del suo lavoro è stato quello di garantire la protezione delle popolazioni vulnerabili, in particolare delle donne e dei bambini. Secondo Awad, le donne di Gaza non sono semplici sopravvissute passive, ma stanno attivamente tenendo insieme la società. Esse costituiscono la “spina dorsale silenziosa” della resilienza della comunità, fornendo assistenza ai feriti, guidando gli sforzi di risposta locale e offrendo sostegno psicologico alle loro comunità. Ciò evidenzia il ruolo fondamentale e multiforme delle donne nella crisi umanitaria in corso e negli sforzi di ricostruzione.
Dobbiamo esprimere la nostra indignazione come esseri umani e come pediatri che si prendono cura dei bambini, delle loro famiglie e delle generazioni future.
In qualità di membri dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP), siamo costretti a esprimere la nostra profonda preoccupazione come pediatri. Il grave stress a cui i bambini sono stati esposti dall’ottobre 2023 avrà inevitabilmente effetti profondi e a lungo termine sul loro benessere fisico e psicologico. I bambini che sopravvivranno a questo conflitto, così come i loro figli e nipoti, saranno profondamente colpiti dal grave stress tossico che stanno attualmente subendo. Questa situazione richiede l’attenzione immediata della comunità internazionale e delle organizzazioni scientifiche. Dobbiamo affrontare non solo i bisogni immediati, ma anche le conseguenze durature per le generazioni future. Ribadiamo con forza l’enorme gravità di questa situazione e speriamo che il nostro appello, insieme a quello di altre istituzioni e associazioni, venga accolto, affinché la negazione dei diritti umani e la totale assenza di protezione dei bambini abbiano fine il prima possibile. Il silenzio delle associazioni mediche risuona in questo momento come un urlo che deve essere soffocato. Noi siamo la voce che deve prevalere su questo silenzio, dobbiamo parlare e denunciare il genocidio che sta avvenendo, dobbiamo essere la voce competente, etica e morale che si eleva sopra le altre. Questo appello, insieme a quelli di altre organizzazioni, mira a difendere i diritti umani fondamentali e a garantire che i principi umanitari siano rispettati senza eccezioni. Non possiamo e non vogliamo essere complici e rimanere in silenzio.
3 agosto 2025 Stefania Manetti presidente Associazione Culturale Pediatri presidente@acp.it doc.manetti@gmail.com
Pediatria e neurosviluppo
Innovazione clinica e telemedicina per la diagnosi precoce del disturbo dello spettro autistico
Noemi Buo, Paola Colombo, Massimo Molteni
Medea SmartLab, IRCCS E. Medea, Associazione La Nostra Famiglia
Webinar IRCCS E. Medea, 21 giugno 2025
Il 21 giugno 2025 si è svolto un webinar organizzato dall’IRCCS E. Medea, Associazione La Nostra Famiglia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri (ACP), nell’ambito del progetto regionale AUTINCA (DGR n. XII/277/2023). L’evento, rivolto ai pediatri di Regione Lombardia, ha rappresentato un momento di aggiornamento sull’utilizzo della piattaforma WIN4ASD e dei relativi strumenti di screening, con un focus sul questionario Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), recentemente integrato nel sistema. Il dott. Massimo Molteni, responsabile scientifico, ha aperto i lavori richiamando la duplice vocazione del progetto: clinica e di ricerca. La Lombardia è oggi una delle realtà più avanzate in Italia nell’approccio sistemico e proattivo ai bisogni legati ai disturbi del neurosviluppo, grazie a un modello strutturato che unisce osservazione precoce, strumenti digitali e formazione dei professionisti.
Il primo intervento è stato quello della dott.ssa Valentina Riva, psicologa e ricercatrice presso l’IRCCS E. Medea, referente per l’attività di ricerca del centro PIVOT NIDA. Il punto di partenza dell’intervento sono stati i numeri dell’autismo: nel mondo si stimano almeno 78 milioni di persone nello spettro autistico e, in Italia, circa un bambino su 77 riceve una diagnosi, con una maggiore prevalenza nei maschi (rapporto 4:1). Il contributo è proseguito offrendo un approfondimento sulla complessità dell’autismo e ponendo l’accento sull’importanza della diagnosi precoce e sul lavoro del network NIDA, rete nazionale coordinata dall’ISS. Nell’introdurre il discorso sugli strumenti di screening, è stato illustrato il nuovo strumento TeleNIDA, basato sull’analisi di videoregistrazioni domestiche per il rilevamento precoce di segnali di rischio autismo tra i 18 e i 36 mesi. Riva sottolinea che lo screening rappresenta solo il punto di partenza di un percorso che può portare a un supporto mirato per il bambino. Una diagnosi tempestiva non è un’etichetta, ma una porta aperta verso un aiuto concreto e personalizzato.
Il dott. Michele Gangemi, pediatra e direttore di Quaderni acp, ha definito l’esperienza Win4ASD una vera e propria “misura architettonica” a sostegno della sorveglianza del neurosviluppo: nel contesto dei bilanci di salute, Win4ASD si inse-
risce con strumenti operativi che consentono un’osservazione continua e flessibile dello sviluppo del bambino, valorizzando il ruolo attivo dei genitori. Nel contesto delle attività di sorveglianza attiva, sono state presentate le schede di osservazione del neurosviluppo, sviluppate in collaborazione con l’ISS e articolate in tre principali domini: motorio, linguistico e sociocomunicativo. Queste consentono un’osservazione continuativa e flessibile del bambino durante i bilanci di salute, offrendo al contempo indicazioni operative utili al pediatra anche in un’ottica di promozione delle competenze genitoriali. È stato evidenziato come i bilanci di salute siano non solo occasione clinica, ma anche fonte potenziale di dati epidemiologici utili per politiche sanitarie. Si è sottolineata inoltre l’importanza della formazione dei pediatri e il valore di iniziative come Nati per Leggere, Nati per la Musica e Custodi Digitali, in ottica di promozione universale dello sviluppo.
La dott.ssa Paola Colombo, psicologa e coordinatrice delle attività del Medea SmartLAB, ha approfondito il ruolo dell’innovazione digitale nella sorveglianza dello sviluppo e nella costruzione della rete curante. Ha presentato la piattaforma Win4ASD, sviluppata nel 2016 e oggi pienamente integrata nel sistema sanitario lombardo. Utilizzata dal 77% dei pediatri della regione, con oltre 84.000 screening effettuati dal 2022. Lo strumento si distingue per l’interfaccia intuitiva, lo scoring automatizzato, la restituzione immediata dell’esito e la capacità di connettere cure primarie e nuclei funzionali autismo secondo la configurazione territoriale. La raccolta sistematica dei dati consente un monitoraggio efficace e un’evoluzione continua della piattaforma. Tra le ultime novità: l’inserimento del questionario SDQ (novembre 2024) per lo screening fino ai 36 mesi e l’aggiornamento dei criteri di invio (aprile 2025) per migliorarne l’appropriatezza, riducendo i falsi positivi. È stata infine presentata la piattaforma digitale “Genitori in Corso” (www.genitorincorso.it) promossa da Medea SmartLab con il contributo di Fondazione Cariplo. Lo strumento, pensato anche per le famiglie con bambini in condizioni di fragilità evolutiva, offre contenuti psicoeducativi e la possibilità di confronto con uno psicoterapeuta. Il tema chiave riguarda la regolazione, declinato in tre aspetti fondamentali: regolazione della relazione genitore-bambino, regolazione emotiva e regolazione dell’uso del digitale nella prima infanzia.
Ha concluso l’incontro la dott.ssa Noemi Buo, con un approfondimento tecnico-clinico sul questionario SDQ. A partire dai risultati di un sondaggio, che ha evidenziato il bisogno di chiarimenti in merito al significato clinico di alcune domande del questionario, l’intervento si è focalizzato su sette item ritenuti particolarmente critici. Per ciascuno di questi item sono state delineate tre aree di analisi: la funzione psicologica sottostante, esempi osservabili del comportamento in bambini a sviluppo tipico e indicazioni su come codificare correttamente le risposte.
L’evento webinar si è concluso con una tavola rotonda molto partecipata, in cui tutti i relatori, moderati dal dott. Molteni, hanno risposto alle numerose domande, a dimostrazione del grande interesse per l’argomento da parte degli oltre 300 pediatri che lo hanno seguito in diretta. L’evento ha ribadito l’importanza di un approccio integrato e il valore della piattaforma Win4ASD come strumento efficace per promuovere il neurosviluppo e favorire l’accesso precoce alla diagnosi, rafforzando la rete tra pediatri e servizi specialistici.


DIAGNOSI E TERAPIA DELLE
PATOLOGIE NELL’AREA PEDIATRICA IN AMBITO TERRITORIALE E OSPEDALIERO
XIII EDIZIONE
MODULO 1: 14 MARZO 2025 - 20 DICEMBRE 2025 È ABUSO SESSUALE?
I DUBBI NELL'AMBULATORIO PEDIATRICO
Maria Grazia Apollonio, Alessandra Paglino
MODULO 2: 1 LUGLIO 2025 - 20 DICEMBRE 2025 IL PEDIATRA E IL DERMATOLOGO IN AMBULATORIO: UNA COLLABORAZIONE UTILE PER LA SALUTE DEL BAMBINO
May El Hachem
MODULO 3: 1 NOVEMBRE 2025 - 20 DICEMBRE 2025
LO STROKE IN ETÀ PEDIATRICA: È DAVVERO UN EVENTO RARO? CAUSE, SINTOMI, ESITI
Elena Laghi
Fad Asincrona


Quote di iscrizione
€ 25 per singoli moduli (SOCI ACP)
€. 60 per intero corso (SOCI ACP)
€. 30 per singoli moduli (NON SOCI)
€ 80 per intero corso (NON SOCI)
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN: IT56P0344017211000035017181
Banca: Banco DESIO
Intestazione: Associazione Culturale Pediatri - via Montiferru, 6 - 09070 Narbolia (OR)
Causale: QUADERNI ACP 2025 + NOME E COGNOME
Inviare distinta di bonifico


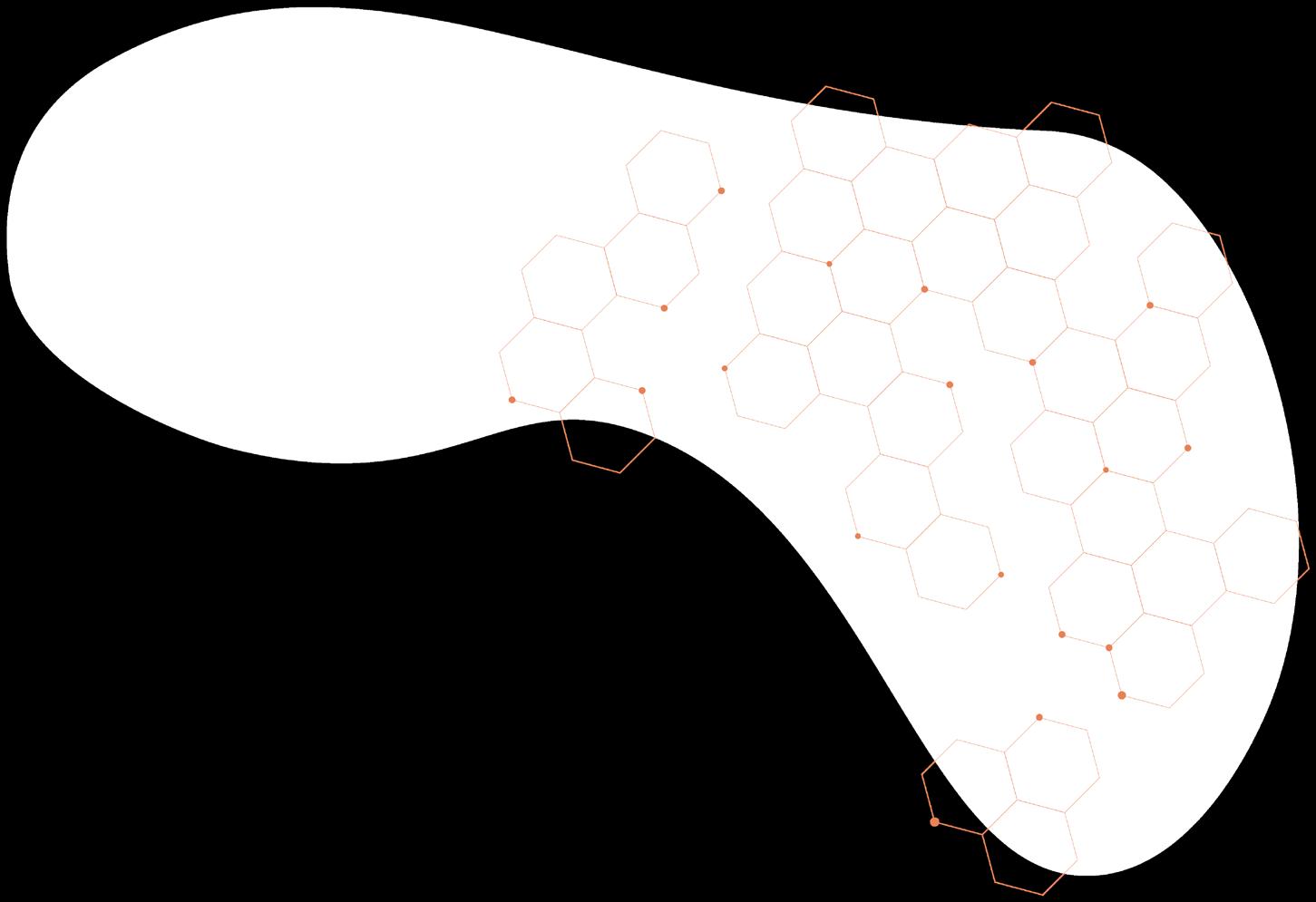
Bimonthly magazine of Associazione Culturale Pediatri xxxii, 5, September-October 2025 redazione@quaderniacp.it
Editorial
193 President’s report 2025
Stefania Manetti
195 Promoting without protecting: a harmful misconception about breastfeeding
Sergio Conti Nibali
Info parents
197 Let’s talk about sex (without taboos)
Antonella Brunelli, Stefania Manetti, Antonella Salvati, Paola Menga
Research
197 Investigating Griffonia Simplicifolia for Sleep Improvement in Children with ASD: Preliminary Findings
Gaia Di Fiore, Giuditta Bargiacchi, Marco Carotenuto
199 Children’s digital skills: supporting children’s well-being and a safe and good use of digital technologies
Mattia Messena, Marina Everri
202 Breastfeeding: understanding the experience to support mothers’ choices
Giulia Bagnacani, Sara Lo Scocco, Linda Debbi, Laura Bonvicini, Costantino Panza, LucaGhirotto, Paolo Giorgi Rossi
A window on the world
207 Pietas or cynism? Europe and euthanasie in children
Mario Renato Rossi, Patrizia Elli, Francesco Morandi
Learning from a case
209 Lumbar puncture and symptoms disappearance: considerations on two cases of aseptic meningitis
Giulia Pederzani, Francesco Accomando, Enrico Valletta
Learning with young people
212 One purpura, lots of shades: approach to Immunoglobulin A vasculitis (IgAV)
Claudia Brusadelli, Anna Cogliardi, Leonardina De Santis, Daniela Zanta, Alessandra Tozzo

Via Filippo Garavetti 12 07100 Sassari (SS) www.acp.it
Appraisals
219 Child custody and parental alienation: the consequences on children’s well-being
Maria Grazia Apollonio, Mariachiara Feresin, Michela Nacca, Patrizia Romito
Environment and health
222 Sustainable menstruation and related issues
Federica Bartolini, Francesca Lucchi, Paola Menga, Antonella Brunelli
Personal accounts
226 The entire field of paediatrics: the experience of the republic of San Marino Elisabetta Muccioli
The paediatrician and the educational challenges
228 My child is temperamental Chiara Borgia
Around narration
231 The burden of feeling: the emotional and relational experience of children and adolescents in pediatric palliative care Anna Santini
Epiquaderni
234 From the Journal Epidemiologia & Prevenzione, an invitation to read for ACP paediatricians
Giacomo Toffol
235 Books
237 Letters
240 Meeting synopsis
Come iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’ACP
La quota d’iscrizione per l’anno 2025 è di 130 euro per i medici, 30 euro per gli specializzandi, 30 euro per il personale sanitario non medico e per i non sanitari. Il versamento può essere effettuato attraverso una delle modalità indicate sul sito www.acp.it alla pagina «Come iscriversi». Se ci si iscrive per la prima volta occorre compilare il modulo per la richiesta di adesione e seguire le istruzioni in esso contenute, oltre a effettuare il versamento della quota come sopra indicato. Gli iscritti all’ACP hanno diritto a ricevere la rivista bimestrale Quaderni acp, le pagine elettroniche di Quaderni acp e la newsletter mensile Appunti di viaggio. Hanno anche diritto a uno sconto sull’iscrizione alla FAD di Quaderni acp; a uno sconto sulla quota di abbonamento a Medico e Bambino; a uno sconto del 50% per l’abbonamento alla rivista Epidemiologia & Prevenzione; a uno sconto sull’abbonamento a Uppa (se il pagamento viene effettuato contestualmente all’iscrizione all’ACP); a uno sconto sulla quota di iscrizione al Congresso nazionale ACP. Gli iscritti possono usufruire di iniziative di aggiornamento e formazione a quota agevolata. Potranno anche partecipare ai gruppi di lavoro dell’Associazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.acp.it.
