
In questo numero:


In questo numero:
Obesità e rischi per la salute: in età pediatrica un’inversione di rotta è possibile
Documenti pag. d.1 Newsletter pediatrica pag. n. 1
La malattia e la cardite reumatica secondo l’OMS, con uno sguardo rivolto all’ AHA
Ambiente & Salute pag. a&s.1
Ambiente e Salute News (n. 32, marzo - aprile 2025)
L’ articolo del mese pag. am.1
Bronchiectasie: quando il sospetto precoce può migliorarne il decorso
Nutrizione pag. nu.1
Nutrizione News (n.13, aprile - maggio 2025)

“Sinfonia in verde” Concorso fotografico “Noi siamo la Natura”, 2024 (particolare)
Newsletter pediatrica ACP
n.1 Obesità e rischi per la salute: in età pediatrica un’invern.1 sione di rotta è possibile
n.2 Cochrane Database of Systematic Review: revisioni
n.1 nuove o aggiornate (Marzo-Aprile 2025)
Documenti
d.1 La malattia e la cardite reumatica secondo l’ OMS, con n.1 uno sguardo rivolto all’ AHA
n.1 Commento a cura di Martina Fornaro
d.2 L’impatto dell’ esposizione al piombo su bambini e n.1 adolescenti: aggiornamenti attuali
n.1 Commento a cura di Angela Pasinato ed Elena Uga
Ambiente & Salute
a&s.1 Ambiente e salute news (n. 32, mar. - apr. 2025)
.1
L’ Articolo del Mese
am.1 Bronchiectasie: quando il sospetto precoce può
am.1 migliorarne il decorso
am.1 A cura di Francesco Accomando
Nutrizione
nu.1 Nutrizione news (n. 13, aprile - maggio 2025)
Direttore
Michele Gangemi
Coordinatore
Giacomo Toffol
Comitato editoriale
Laura Brusadin
Claudia Mandato
Maddalena Marchesi
Laura Martelli
Patrizia Rogari
Annamaria Sapuppo
Giacomo Toffol
Collaboratori
Gruppo PuMP ACP
Gruppo Nutrizione ACP
Gruppi di lettura della
Newsletter Pediatrica
Redazione di Quaderni acp
Presidente ACP
Stefania Manetti
Progetto grafico ed editing
Programmazione web
Gianni Piras
Internet
La rivista aderisce agli obiettivi di diffusione gratuita della letteratura medica ed è disponibile integralmente all’ indirizzo: www.acp.it/pagine-elettroni che
Redazione redazione@quaderniacp.it
Electronic pages Quaderni ACP index (number 3, 2025)
ACP Paediatric Newsletter
n.1 Obesity and health risks: in paediatric age a turnaround is possible
n.2 Cochrane Database of Systematic Review: new and updated revisions March-April 2025
Documents
d.1 Rheumatic disease and rheumatic carditis according to WHO, with a look at the AHA
Comment by Martina Fornaro
d.2 The Impact of Lead Exposure on Children and Adolescents: Current Updates
Comment by Angela Pasinato and Elena Uga
Environment & Health
a&s.1 Environment and health news
Article of the month
am.1 Pediatric bronchiectasis: how early suspicion can influence
ni.1 disease outcome
ni.1 By Francesco Accomando
Nutrition
nu.1 Nutrition news

Putri
RR, Danielsson P, Ekström N, et al.
JAMA Pediatr. Published online January 21, 2025. doi:10.1001/jamapediatrics.2024.5552
Lo studio ha analizzato una coorte prospettica di bambini e adolescenti con obesità registrati nel Registro Svedese per il Trattamento dell'Obesità Infantile (BORIS), confrontandoli con la popolazione generale. I dati di base sono stati raccolti tra il 1996 e il 2019, mentre le analisi sono state condotte nel 2023. Gli esiti sono stati valutati tra i 18 e i 30 anni (2005-2020). I partecipanti erano bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni sottoposti ad almeno un anno di trattamento per l'obesità. La risposta al trattamento è stata valutata sulla base del cambiamento dell'indice di massa corporea (BMI) standardizzato, e classificata in: scarsa/ intermedia/ buona/ remissione. Lo studio ha incluso 6.713 individui con un’ età media di inizio trattamento di 12.1 anni e una durata media del trattamento di 3 anni. Rispetto a una scarsa risposta, la remissione dell'obesità o una buona risposta erano associate a una riduzione del rischio di mortalità (HR: 0.12; IC 95%: 0.03-0.46). Una buona risposta era anche associata a un rischio inferiore di diabete di tipo 2 (HR: 0.42), dislipidemia (HR: 0.31) e chirurgia bariatrica (HR: 0.42). La remissione dell'obesità mostrava riduzioni simili, ma anche un rischio minore di ipertensione (HR: 0.40). Non è stata trovata un'associazione tra la risposta al trattamento e il rischio di depressione o ansia. Una buona risposta al trattamento dell'obesità infantile comporta benefici duraturi per la salute, riducendo significativamente il rischio di malattie e mortalità in età adulta. Sebbene non sia descritto in dettaglio il tipo di trattamento offerto, principalmente basato sulla modifica comportamentale degli stili di vita e non erogato con le stesse modalità nel tempo in tutti i centri, è evidente che l’ offerta di terapie efficaci già in età pediatrica dovrebbe essere tra gli obiettivi prioritari dei nostri servizi sanitari.
Obesity and health risks: in paediatric age a turnaround is possible
The study analysed a prospective cohort of children and adolescents with obesity registered in the Swedish Childhood Obesity Treatment Register (BORIS), comparing them to the general population. Baseline data were collected between 1996 and 2019, with analyses conducted in 2023. Outcomes were assessed between the ages of 18 and 30 (2005-2020). Participants were children and adolescents aged 6-17 who underwent at least one year of obesity treatment. Treatment response was evaluated based on changes in standardized body mass index (BMI) and classified as poor/intermediate/ good remission. The study included 6.713 individuals with a mean treatment initiation age of 12.1 years and an average treatment duration of 3 years. Compared to a poor response, obesity remission or a good response was associated with a reduced risk of mortality (HR: 0.12; 95% CI: 0.03-0.46). A good response was also associated with a lower risk of type 2 diabetes (HR: 0.42), dyslipidaemia (HR: 0.31), and bariatric surgery (HR: 0.42). Obesity remission showed similar reductions and a lower risk of hypertension (HR: 0.40). No
association was found between treatment response and the risk of depression or anxiety. A good response to childhood obesity treatment leads to lasting health benefits, significantly reducing the risk of diseases and mortality in adulthood. Although the specific types of treatment offered were not detailed - primarily based on behavioural lifestyle modifications and not uniformly administered over time across all centres - it is evident that providing effective therapies during childhood should be among the primary objectives of our health services.
Obiettivo (con tipo studio)
Studio prospettico di coorte effettuato per valutare l’impatto della risposta al trattamento dell’ obesità pediatrica sugli esiti di salute e sulla mortalità nei giovani adulti.
Bambini e adolescenti con obesità secondo l'International Obesity Task Force, di età compresa tra 6 e 17 anni all'inizio del trattamento, che hanno ricevuto almeno 1 anno (335 giorni) di trattamento per l'obesità prima dei 18 anni e sono stati registrati in BORIS (Swedish Childhood Obesity Treatment Register). Sono stati esclusi gli individui con sindromi genetiche, gli emigranti, coloro che sono stati sottoposti a chirurgia bariatrica o deceduti prima dell’inizio del follow-up. Inoltre, è stato incluso un gruppo di confronto della popolazione generale, comparato a livello individuale con un rapporto di 1:5 su sesso, anno di nascita e area geografica di residenza. Gli individui nella coorte BORIS non erano eleggibili come comparatori di popolazione.
L’ efficacia del trattamento è stata ricavata da BORIS e si è basata sulla variazione del punteggio di deviazione standard (SDS) dell’indice di massa corporea (BMI) tra la prima e l’ultima visita effettuate durante il trattamento. L’ efficacia del trattamento è stata classificata arbitrariamente in risposta:
- scarsa (quando il BMI SDS è aumentato di 0.25 unità o più);
- intermedia (variazione del BMI SDS compresa tra una diminuzione di 0.24 e un aumento di 0.24 unità);
- buona (diminuzione del BMI SDS di 0.25 unità o più);
- remissione dell’ obesità (quando il soggetto non era più considerato obeso secondo i criteri dell’ International Obesity Task Force).

Outcome/Esiti
Gli esiti erano diabete tipo 2, ipertensione, dislipidemia, depressione o ansia, chirurgia bariatrica e mortalità. Inoltre, sono state considerate le fratture per valutare le differenze tra i gruppi nella richiesta di assistenza sanitaria necessaria.
Gli esiti sono stati valutati dalla data in cui gli individui hanno compiuto 18 anni fino al verificarsi dell’esito della malattia, chirurgia bariatrica, morte, emigrazione, età di 30 anni o 31 dicembre 2020, a seconda di quale evento si sia verificato per primo. Tutti i dati sono stati ottenuti dai registri nazionali di prescrizione dei farmaci, dal registro di diagnosi e interventi chirurgici di cure specialistiche ospedaliere e ambulatoriali e dal registro delle cause e date di morte. Sono stati applicati criteri di esclusione specifici per outcome (es. soggetti con diabete tipo 1 sono stati esclusi nella valutazione dell’ outcome diabete tipo 2).
Tempo
I dati riguardanti l’arruolamento e il periodo del trattamento sono stati raccolti tra il 1996 e il 2019 mentre quelli del follow-up dal 2005 al 2020. L’ analisi è stata condotta nel 2023.
Risultati principali
Sono stati inclusi nello studio 6.713 individui (56.3% maschi e 43.7% femmine), l’ età mediana all’inizio del trattamento era di 12.1 anni, il BMI SDS mediano era di 2.82, la durata mediana del trattamento era di 3,0 anni. Le categorie di risposta al trattamento includevano risposta scarsa (n=1.224), risposta intermedia (n=2.913), risposta buona (n=1.070) e remissione dell’ obesità (n=1.506). Nella coorte BORIS si sono verificate 21 morti, a un’età mediana (Q1; Q3) di 23.6 (19.8; 25.0) anni. Rispetto alla scarsa risposta, la remissione dell’ obesità o una buona risposta al trattamento erano associate ad un ridotto rischio di mortalità (rapporto di rischio aggiustato [HR], 0.12; IC 95%, 0.03-0.46). Una buona risposta era anche associata a rischio inferiore di diabete tipo 2 (HR 0.42; IC 95% 0.23-0.77), dislipidemia (HR, 0.31; IC 95% 0.13-0.75) e chirurgia bariatrica (HR 0.42; IC 95% 0.300.58). La remissione dell’ obesità oltre a questi esiti ha mostrato una riduzione anche del rischio di ipertensione (HR 0.40; IC 95% 0.24-0.65). La risposta al trattamento non è stata associata a depressione o ansia. Tutti gli esiti, ad eccezione della mortalità e delle fratture, sono risultati più bassi nella popolazione generale.
Conclusioni
In questo studio la buona risposta al trattamento dell’ obesità pediatrica ha prodotto benefici duraturi per la salute, riducendo notevolmente i rischi futuri di morbilità e mortalità nei giovani adulti.
Altri studi sull’argomento
L'obesità in età pediatrica è associata all'insorgenza di diabete di tipo II, malattie cardiovascolari e a mortalità precoce in età giovane-adulta [1]. In particolare, il valore di BMI in adolescenza correla con il rischio di patologia cardiovascolare (stroke, ipertensione, coronaropatia) nell'adulto [2]. Dalla revisione del 2018 di Ells et al. una riduzione di 0.2 in BMI-Z score è associata a un decremento di tale rischio [3]. Anche lo sviluppo di diabete
di tipo II è associato a un BMI elevato in adolescenza (HR 2.76; IC 95% 2.11- 3.58). Tale rischio viene azzerato se si raggiunge un BMI normale in età adulta (HR 1.01; IC 95%, 0.75-1.37) [4] La probabilità di successo nel trattamento dell'obesità infantile è maggiore più precoce è l'intervento. Nella Cochrane review del 2020 vengono presi in considerazione 153 RCT. Le evidenze di efficacia di un intervento combinato su dieta e attività fisica sono maggiori nella fascia di età 0-5 anni con una riduzione media di BMI pari a -0.07 kg/m2 (IC 95% da -0.14 a -0.01 kg/m2) rispetto ai controlli. Nelle età successive, 6-12 anni e 13-18 anni, l'impatto maggiore è determinato dal cambiamento nell'attività fisica, in associazione o meno al regime alimentare, mentre non vi sono evidenze dell'efficacia della sola dieta. La problematica che si evidenzia in tutte le età è mantenere il risultato dell'intervento nel tempo. Come nello studio considerato, nella review la risposta al trattamento non è stata associata ad ansia o depressione [5]
Che cosa aggiunge questo studio
Il trattamento inefficace in età pediatrica dell’ obesità ha conseguenze sulla salute in età adulta, in termini di malattia cardiometabolica, chirurgia bariatrica e mortalità. È necessario valutare l’ efficacia clinica dei trattamenti e concentrare le risorse sulla realizzazione di progetti di dimostrata efficacia.
Commento
Validità interna
Disegno dello studio: lo studio è stato condotto in un contesto reale, ha riguardato un alto numero di pazienti e il periodo di follow-up era molto lungo. Inoltre, il collegamento tra i registri ha consentito di seguire gli individui dall’infanzia all’ età adulta con perdite minime nel follow-up, data la partecipazione obbligatoria ai registri nazionali svedesi, determinando una buona validità interna e una generalizzazione nazionale dei risultati. Da rilevare che il tipo di trattamento offerto, principalmente basato sulla modifica comportamentale degli stili di vita, non era descritto in dettaglio e non era erogato con le stesse modalità in tutti i centri, condizionando l’ efficacia. Per valutare un eventuale bias di selezione è stato calcolato il tasso d’incidenza di fratture nei vari gruppi di risposta senza che risultassero delle differenze significative. Data la difficoltà di trattamento dell’ obesità in adolescenza, sono state effettuate analisi di sottogruppo per gli individui che all’inizio del trattamento avevano un’ età compresa tra i 12 e i 17 anni (3434/6713): questi dati, pubblicati nel supplemento e non commentati, hanno confermato una scarsa risposta al trattamento più frequente rispetto al gruppo di età < 12 anni: 21.6% vs 14.7%.
Esiti: Sebbene gli esiti valutati siano ben definiti e significativi, è possibile che i tassi d’incidenza riportati siano sottostimati in quanto molte delle condizioni considerate possono essere affrontate con modifiche dello stile di vita senza l’utilizzo di farmaci, inoltre i dati relativi all’assistenza primaria non specializzata non affluiscono al Registro Nazionale dei Pazienti.
Trasferibilità
Popolazione studiata: le caratteristiche della popolazione all’inizio del percorso terapeutico sono probabilmente sovrapponibili a quelle dei ragazzi italiani con obesità.

Tipo di intervento: il trattamento dell’ obesità in Svezia si basa sulle raccomandazioni della Società pediatrica svedese ed è organizzato a livello locale; quindi, può essere erogato con modalità differenti per numero di visite, tipo di esami, approccio individuale e/o di gruppo; sono raccomandate visite annuali, indipendentemente dal successo o meno del trattamento, e l’inclusione nel registro per il trattamento e follow-up dell'obesità infantile, BORIS. Sebbene i centri di trattamento stiano creando team multidisciplinari con pediatri, infermieri pediatrici, dietisti e fisioterapisti, spesso è l'infermiere pediatrico a fornire la maggior parte del supporto comportamentale [6]. In Italia non c’è un registro nazionale e la gestione nella gran parte dei casi è affidata all’iniziativa dei singoli pediatri e reparti ospedalieri in assenza di protocolli condivisi. Un modello virtuoso, peraltro inserito dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità tra le buone pratiche europee per il contrasto all’ obesità infantile, è quello dell’Emilia-Romagna, deliberato nel 2013, che ha dato indicazioni alle Aziende sanitarie per la realizzazione di una rete integrata di servizi per la prevenzione, diagnosi e la terapia dell’obesità infantile fondato sulla rete sanitaria già esistente. Partendo da una formazione ad hoc dedicata ai pediatri di famiglia e agli altri professionisti coinvolti nella presa in carico, è stato attivato uno specifico Percorso Preventivo Diagnostico, Terapeutico, Assistenziale (PPDTA) caratterizzato da tre livelli d’intervento:
- LIVELLO 1: pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, focalizzato sull’intervento motivazionale.
- LIVELLO 2: equipe multidisciplinari territoriali per la presa in carico e l’ educazione terapeutica del bambino obeso e del nucleo familiare. Il team multidisciplinare è costituito da medici (medico dello sport e/o pediatra e/o medico SIAN), dietista, biologo nutrizionista, assistente sanitaria, psicologo dell’ età evolutiva, chinesiologo, tutti adeguatamente formati nella gestione dell’ obesità pediatrica.
- LIVELLO 3: pediatra ospedaliero.
L’ efficacia del progetto, che per i primi 2 livelli si richiama alle indicazioni delle linee guida dell’ Accademia Americana di Pediatria [7], è documentata, oltre che dalle valutazioni locali, anche dai dati del sistema di sorveglianza OKkio alla salute (anno 2023) con riduzione della prevalenza di bambini con sovrappeso dal 20.5% nel 2008 al 18.6% nel 2023, e dell’obesità dall’ 8.6% nel 2008 al 7.1% nel 2023. Le linee guida americane indicano, con evidenza di grado B, di offrire agli adolescenti dai 12 anni con obesità una terapia farmacologica per il calo ponderale, secondo indicazione medica, valutando rischi e benefici, in aggiunta al trattamento sullo stile di vita. In Italia sia la liraglutide (Saxenda) che la semaglutide (Wegovy) sono autorizzate per il trattamento dell'obesità negli adolescenti a partire dai 12 anni di età. Entrambi i farmaci sono a carico dei pazienti e possono essere prescritti esclusivamente da centri specializzati di terzo livello, in casi specifici: 1) Adolescenti dai 12 anni in su con obesità grave o con complicanze correlate all'obesità 2) Pazienti che non hanno risposto adeguatamente a interventi sullo stile di vita, come dieta ed esercizio fisico. Non abbiamo trovato dati sull’utilizzo di questi farmaci in età adolescenziale nel nostro Paese. Nonostante la frequenza e gli alti costi psicosociali e sanitari della patologia obesità siamo lontani da una gestione omogenea sul territorio nazionale che garantisca a tutti i pazienti l’accesso a cure di qualità.
Conflitto di interessi: questo studio è stato sponsorizzato da
Novo Nordisk A/S che è stato parzialmente coinvolto nella progettazione dello studio e nell'interpretazione dei dati. Lo sponsor non è stato coinvolto nella raccolta o nell'analisi dei dati.
1 Marcus C, Danielsson P, Hagman E. Pediatric obesity-Long-term consequences and effect of weight loss. J Intern Med. 2022 Dec;292(6):870891. doi: 10.1111/joim.13547.
2. Baker JL, Olsen LW, Sørensen TI. Childhood body-mass index and the risk of coronary heart disease in adulthood. N Engl J Med. 2007 Dec 6;357(23):2329-37. doi: 10.1056/NEJMoa072515.
3. Ells LJ, Rees K, Brown T,et al. Interventions for treating children and adolescents with overweight and obesity: an overview of Cochrane reviews. Int J Obes (Lond). 2018 Nov;42(11):1823-1833. doi: 10.1038/ s41366-018-0230-y.
4. Tirosh A, Shai I, Afek A, et al. Adolescent BMI trajectory and risk of diabetes versus coronary disease. N Engl J Med. 2011 Apr 7;364(14):1315-25. doi: 10.1056/NEJMoa1006992.
5. Brown T, Moore TH, Hooper L, et al. Interventions for preventing obesity in children. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jul 23;7(7):CD001871. doi: 10.1002/14651858.CD001871.pub4.
6. Hagman E, Danielsson P, LindbergL, et al; BORIS Steering Committee. Paediatric obesity treatment during 14 years in Sweden: lessons from the Swedish Childhood Obesity Treatment Register-BORIS. Pediatr Obes. 2020;15(7):e12626. doi:10.1111/ijpo.12626
7. Hampl SE, Hassink SG, Skinner AC, et al. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity. Pediatrics. 2023;151(2): e2022060640
Scheda redatta dal gruppo di lettura di Monza e Brianza: Elena Arosio, Claudia Brusadelli, Riccardo Cazzaniga, Lucia Di Maio, Ines L’Erario, Ambrogina Pirola, Giulia Ramponi, Ferdinando Ragazzon, Patrizia Rogari, Federica Zanetto.

Il CDSR è il database della Cochrane Library che contiene le revisioni sistematiche (RS) originali prodotte dalla Cochrane Collaboration. L’ accesso a questa banca dati è a pagamento per il full text, gratuito per gli abstracts (con motore di ricerca). L’ elenco completo delle nuove RS e di quelle aggiornate è disponibile su internet. Di seguito è riportato l’ elenco delle nuove revisioni di area pediatrica di Marzo – Aprile 2025. La selezione è stata realizzata dalla redazione della newsletter pediatrica. Cliccando sul titolo si viene indirizzati all’abstract completo disponibile in MEDLINE, la banca dati governativa americana, o presso la Cochrane Library. Di alcune revisioni vi offriamo la traduzione italiana delle conclusioni degli autori.
Revisioni sistematiche nuove o aggiornate di area pediatrica Marzo – Aprile 2025 (Issue 3-4, 2025)
1. Mucolytics for children with chronic suppurative lung disease
2. Antibiotic treatment for non‐tuberculous mycobacteria lung infection in people with cystic fibrosis
3. Safety and efficacy of proton pump inhibitors in preterm infants with gastroesophageal reflux disease
4. Antidepressants for low back pain and spine‐related leg pain
5. Models of care for managing non‐specific low back pain
6. Non‐pharmacological and non‐surgical treatments for low back pain in adults: an overview of Cochrane reviews
7. Lutein and zeaxanthin for reducing morbidity and mortality in preterm infants
8. Interventions for preventing diarrhoea‐associated haemolytic uraemic syndrome
9. Acupuncture for procedural pain in newborn infants
10. Psychological interventions for treatment of inflammatory bowel disease
11. Interventions for smokeless tobacco use cessation
12. Drug treatment for myotonia
13. Digital tracking, provider decision support systems, and targeted client communication via mobile devices to improve primary health care
14. Clinical rating scales for assessing pain in newborn infants
15. Gonadotropins for ovulation induction in women with polycystic ovary syndrome
16. Factors that influence caregivers and adolescents views and practices regarding human papillomavirus (HPV) vaccination for adolescents: a qualitative evidence synthesis
Prevenzione della sindrome uremico emolitica associata a diarrea, nessuna novità
Imdad A et al
Interventions for preventing diarrhoea-associated haemolytic uraemic syndrome
Cochrane Database of Systematic Reviews 2025
Si tratta di un aggiornamento della precedente revisione Cochrane del 2021 il cui scopo è quello di valutare rischi e benefici degli interventi di prevenzione secondaria per la Sindrome Uremico Emolitica (SEU) e le sue complicanze, in pazienti con diarrea, sapendo che l’infezione da Escherichia coli produttori di Shiga tossina (STEC) è il fattore di rischio principale per SEU. L’ aggiornamento al 2025 non ha individuato alcun nuovo studio e gli autori ripropongono gli stessi risultati e conclusioni. La revisione precedente aveva individuato 4 studi per un totale di 536 soggetti in età pediatrica ed adulta affetti da diarrea ad alto rischio per SEU e condotti in 3 paesi (Argentina, Canada e Germania). Negli studi venivano valutati 4 diversi tipi di intervento: antibiotico (trimetoprim-sulfametoxazolo), colostro bovino contenete anticorpi anti tossina Shiga (Stx), un sorbente sintetico della Stx (Synsorb-PK) e un anticorpo monoclonale contro la Stx (urtoxazumab). Per quanto riguarda il trattamento con trimetoprim-sulfametoxazolo comparato al placebo (47 soggetti: RR 0.57, 95% CI 0.11 - 2.81) vi è evidenza di bassa certezza che possa ridurre l’incidenza di SEU. Nei soggetti trattati con colostro bovino e nel corrispondente gruppo di controllo non si è sviluppato alcun caso di SEU, ma allo stesso tempo non è chiaro se tale trattamento presenti eventi avversi con più frequenza. Bassa certezza vi è anche per il Synsorb Pk nel ridurre l’incidenza di SEU comparato con placebo (353 soggetti: RR 0.93, 95% CI 0.39 - 2.22). Il quarto studio compara due diverse dosi di urtoxazumab (3.0 mg/kg e 1.0 mg/kg) verso placebo ed i risultati sono di bassa certezza sulla capacità di ridurre l’incidenza di SEU (3.0 mg/kg urtoxazumab: 71 soggetti: RR 0.34, 95% CI 0.01 - 8.14; 1.0 mg/kg urtoxazumab - 74 soggetti: RR 0.95, 95% CI 0.06 - 14.59).
Gli studi sono pochi e con basso numero di partecipanti, presentano diversi bias, spesso dati sulle complicanze ed effetti avversi non sono riportati, tutto ciò non permette alcuna conclusione su questi interventi di prevenzione secondaria per la SEU.
Agopuntura per il controllo del dolore procedurale nei neonati
Cabano R et al
Acupuncture for procedural pain in newborn infants
Cochrane Database of Systematic Reviews 2025
L’ agopuntura sta cominciando a essere considerata una potenziale alternativa per il controllo del dolore procedurale nei neonati e la revisione ha lo scopo di definirne rischi e benefici. Sono stati individuati 11 RCT, pubblicati all’ agosto 2023, per un totale

di 852 bambini, e 4 studi erano in corso al momento della ricerca. Gli studi selezionati utilizzano scale validate per il dolore (PIPP, NIPS o N-PASS). Cinque studi confrontano l’ agopuntura con nessun trattamento o un placebo e dai risultati sembra che possa ridurre il dolore da (SMD −0.56, 95% CI −0.75 - −0.37; 5 studi, 471 neonati) però con evidenza di bassa certezza. Per quanto riguarda I rischi non si registra nessuna differenza (RR 0.35, 95% CI 0.01 to 8.31; 2 studies, 138 neonati, evidenza di bassa certezza). Quattro studi comparano l’ agopuntura con un trattamento non farmacologico quale una soluzione zuccherata. L’evidenza dei risultati in questi studi è molto incerta (SMD 0.29, 95% CI 0.04 - 0.54; 4 studi, 267 neonati), nessuna differenza per quanto riguarda i rischi. Due studi comparano l’ agopuntura con altri tipi di manovre quali il massaggio e la riflessologia e l’ evidenza è molto incerta (SMD 0.05, 95% CI −0.26 - 0.36; 2 studi, 163 neonati).
Dai risultati della revisione non sono per il momento chiari i benefici ed i rischi dell’ agopuntura.
Interventi psicologici per il trattamento della malattia infiammatoria cronica intestinale
Tiles-Sar S et al
Psychological interventions for treatment of inflammatory bowel disease
Cochrane Database of Systematic Reviews 2025
Le persone affette da malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI) hanno un aumentato rischio di soffrire di problemi psicologici, associazione che agisce in modo bidirezionale. Trattamenti di tipo psicologico possono migliorare la qualità di vita (QoL), la condizione psicologica e possono anche incidere sull’ attività della malattia. Molti studi hanno valutato diversi tipi di approcci psicoterapici, ma i singoli risultati appaiono inconsistenti. Lo scopo di questa revisione è quello di definire l’efficacia dei vari interventi sulla QoL, lo stato emozionale e l’ attività della patologia in soggetti di ogni età affetti da MICI. Sono stati individuati 68 studi pubblicati entro maggio 2023 e di questi, 48 hanno informazioni sufficienti da permettere una metanalisi. Gli studi riguardano 6.111 adulti e 294 bambini e adolescenti. La maggior parte degli studi usa un approccio multimodale e il problema più frequentemente riscontrato è quello della mancanza di cecità sia del paziente che dell’ operatore. Per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti la psicoterapia multimodale migliora, con moderata certezza, la QoL (SMD 0.54, 95% CI 0.06 to 1.02; I2 = 19%; 3 studi, 91 soggetti), mentre i risultati non sono conclusivi per lo stato d’ ansia. L’ attività della malattia non è stata presa in considerazione. Gli interventi educativi, valutati in uno studio, sembrerebbero avere un ruolo positivo sulla QoL (MD 7.1, 95% CI 2.18 to 12.02; 40 soggetti, evidenza di bassa certezza), ma non sulla depressione. Ansia ed attività della malattia non vengono considerate tra gli esiti. Gli studi che utilizzano tecniche di rilassamento non sono risultati conclusivi per bambini ed adolescenti. Risultati più significativi ci sono per gli adulti dove gli interventi psicologici migliorano leggermente la QoL, l’ ansia e la depressione. Gli autori concludono sulla necessità di continuare questa revisione focalizzando l’ analisi sui singoli vari tipi di interventi utilizzati.
Fattori che influenzano l’adesione alla vaccinazione contro il papillomavirus (HPV) da parte degli adolescenti: sintesi di evidenze qualitative
Cooper S et al
Factors that influence caregivers and adolescents views and practices regarding human papillomavirus (HPV) vaccination for adolescents: a qualitative evidence synthesis Cochrane Database of Systematic Reviews 2025
La vaccinazione anti papillomavirus (HPV) è ormai stata introdotta in molti paesi, ma ancora molti adolescenti non la ricevono per ragioni diverse che tale sintesi qualitativa intende individuare. Si tratta dell’integrazione di una precedente revisione Cochrane del gennaio 2020 riguardante i fattori che possono migliorare il tasso di adesione a tutte le vaccinazioni da parte degli adolescenti. La revisione aveva individuato alcuni interventi quali l’ educazione sanitaria, l’incentivo economico, l’ obbligatorietà e la vaccinazione in ambito scolastico, ma le evidenze erano basse e gli autori indicavano la necessita di questa sintesi qualitativa. Sono stati individuati 206 studi, pubblicati al 2023, che utilizzavano metodi qualitativi per la raccolta e analisi dei dati, e centrati su visione, pratica, accettazione, esitazione verso l’HPV da parte sia degli adolescenti di età 9-19 anni che degli adulti coinvolti (genitori, operatori sanitari…), nei paesi dove tale vaccino è disponibile. La sintesi riguarda 71 degli studi selezionati, condotti in tutte e 6 le zone dell’ OMS in contesti sia urbani che rurali e di diverso reddito (35 in paesi ad alto reddito, 26 in paesi a medio reddito, 8 in paesi a basso reddito, 2 in contesti vari). Diversi e complessi fattori sono stati individuati e possono essere sintetizzati in 8 gruppi: 1. mancanza di conoscenza medica; 2. convinzione personale sul rapporto rischio e beneficio dell’ HPV; 3. visione ed esperienza delle altre vaccinazioni; 4. ruolo delle dinamiche nel nucleo familiare ai fini decisionali; 5. ruolo di altri membri della famiglia o del contesto sociale e dei media; 6. convinzioni socio-culturali e relative pratiche circa l’ adolescenza, la sessualità, il genere, la genitorialità e la salute; 7. fiducia o sfiducia nelle istituzioni, sistemi e personale coinvolti nelle vaccinazioni (insegnanti e scuola, industria farmaceutica, governo, scienza e medicina ,sanitari); 8. accesso ai programmi e servizi per l’HPV, in termini di costo e barriera linguistica, vaccini offerti alle ragazze e distribuzione in ambito scolastico. Da questa sintesi emerge quindi che ciò che influenza la decisione per l’HPV non è solo la conoscenza medica e la percezione dei rischi e benefici, ma una complessità di fattori. Sarebbero infatti in gioco fattori sociali, politici, economici, strutturali e morali da cui partire per una miglior conoscenza del fenomeno.

Questa rubrica propone Documenti sanitari, linee guida, linee di indirizzo o di intenti di interesse pediatrico commentati a cura dell’ Associazione Culturale Pediatri. Potete inviare le vostre osservazioni ai documenti scrivendo a: redazione@quaderniacp.it. Le vostre lettere verranno pubblicate sul primo numero utile.
U.O.C. Pediatria e Neonatologia, AST di Macerata, Macerata
Le Linee Guida dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicate nel 2024 sulla prevenzione e diagnosi della febbre reumatica (FR) e della cardiopatia reumatica (CR) rappresentano un aggiornamento molto interessante nell’ ambito della sanità pubblica internazionale, con un target di elezione per i paesi a basso e medio reddito, dove la malattia mantiene un impatto epidemiologico significativo. Secondo dati del 2021, globalmente nel mondo ne sarebbero affette 55 milioni di persone, causando 360.000 morti/anno, prevalentemente nell’ Africa sub-sahariana, Medio-oriente, Asia centrale e meridionale, regioni tropicali dell’ America latina e Sud Pacifico. In queste regioni del mondo, la FR rappresenta un problema di salute endemico con un alto rischio di sviluppare una CR. Al contrario, in Europa e Nord-America queste patologie hanno registrato, negli anni, una progressiva riduzione. Tuttavia, viste le recenti recrudescenze di epidemie da streptococco beta-emolitico di gruppo A (SBEGA), può essere utile una riflessione sulle indicazioni dell’ OMS e un confronto con le linee guida pediatriche dell’American Heart Association (AHA) del 2015.
L’ impostazione dell’OMS
Le linee guida dell’ OMS e quelle dell’ AHA del 2015, utilizzano la stessa stratificazione del rischio di FR/CR in basso e medio-elevato (endemico), in base a considerazione geografiche e di popolazione.
Atteso il target a cui sono principalmente rivolte - le zone endemiche per FR/CR e i possibili setting di cura (per esempio health center rurali) - nelle linee guida dell’OMS troviamo un approccio molto pragmatico e senza distinzioni né stratificazioni per età, giustificato dalle risorse limitate spesso carenti di strumenti diagnostici adeguati e volto essenzialmente a prevenire il più possibile lo sviluppo di malattia reumatica (MR) e l’ evoluzione verso la CR e le sue complicanze.
I punti di forza delle raccomandazioni OMS sono da ricercare nei metodi di sviluppo della linea guida, secondo criteri rigorosi di alta qualità, e l’estrema schematizzazione nel dichiarare gli obiettivi e le strategie di prevenzione. Quest’ultime sono articolate in quattro livelli: prevenzione delle infezioni da SBEGA attraverso il miglioramento delle condizioni sociosanitarie; prevenzione primaria mediante il trattamento efficace delle infezioni da SBEGA; prevenzione secondaria delle recidive di FR e dello sviluppo di CR utilizzando la profilassi antibiotica con penicillina; prevenzione terziaria grazie al trattamento delle complicanze della CR. Vengono poi dichiarati due principi guida a cui si fa sempre riferimento nel testo, soprattutto nelle sezioni riguardanti le strategie di implementazione sanitaria. Anzitutto, il richiamo al miglioramento delle condizioni sociosanitarie (a esempio, l’ accesso
ad acqua pulita) come prerequisito per ridurre i rischi infettivi. In secondo luogo, la necessità di garantire equità di accesso alle cure (screening e terapia) a tutta la popolazione, soprattutto nelle regioni del mondo a maggiore fragilità.
Le linee guida OMS pongono un forte accento sugli interventi di educazione sanitaria, riconosciuti come strumento fondamentale per la prevenzione. Vengono quindi proposte diverse tipologie di approccio che possano determinare un miglioramento della comunicazione dei rischi alla popolazione, coinvolgendo a diversi livelli gli operatori sanitari e della comunità per sviluppare consapevolezza, modificare comportamenti e migliorare l’adesione delle persone ai piani sanitari.
La diagnosi di malattia reumatica: OMS vs. AHA
Per la diagnosi di faringite da SBEGA nei pazienti con sintomi sospetti, l’OMS non raccomanda l’utilizzo di score clinici, ritenuti poco accurati e troppo variabili nei risultati, mentre si confermano come gold-standard i test microbiologici, compresi quelli point of care (POC), considerati alternativi ai classici ma validi. L’ accesso a test di laboratorio nei paesi a medio-alto rischio di MR/CR può essere difficile e, quindi, l’ OMS raccomanda di trattare comunque tutti i bambini, adolescenti e adulti con sintomi compatibili con infezione da SBEGA, pur in assenza di conferma di laboratorio, valorizzando alcuni elementi clinici come la presenza di febbre e l’ essudato tonsillare. Nei pazienti con test positivo o con diagnosi clinica, il trattamento di prima linea indicato è quello con penicillina, intramuscolo o orale (profilassi primaria della MR). È evidente che la strategia scelta sia la più inclusiva possibile (treat-all strategy) accettando, nel bilancio rischio-beneficio, la possibilità di overdiagnosis e overtreatment. Gli autori stessi riconoscono, inoltre, il rischio di antibiotico resistenza per cui viene sottolineata l’importanza di un sistema di sorveglianza nazionale delle resistenze antimicrobiche. Questo approccio risulterebbe, al contrario, del tutto ingiustificato in altri contesti sanitari come quello italiano, nel quale la combinazione di test di laboratorio disponibili - più o meno sostenuti da score clinici validati per l’ età pediatrica (ad esempio, Centor o McIsaac) - e la corretta selezione dei pazienti (per età e sintomi) dovrebbero ridurre l’uso inappropriato dell’ antibiotico (amoxicillina, come prima linea). Proprio l’ accessibilità agli antibiotici è un altro elemento considerato indispensabile al contenimento della MR da parte dell’OMS, tanto da farne un punto di richiamo per le strutture governative alle quali la linea guida si rivolge.
L’ OMS raccomanda che la diagnosi di FR sia effettuata secondo la linea guida del 2015 dell’ AHA che ha ridefinito i criteri di Jones, introducendo il criterio epidemiologico che distingue zone geografiche ad alto e a basso rischio. Sono considerate ad

alto rischio le zone con incidenza di MR superiore a 2 casi ogni 100.000 bambini in età scolare tra 5 e 14 anni. L’ obiettivo, per entrambe le linee guida è, da una parte, di ridurre la sensibilità e migliorare la specificità della diagnosi con criteri più restrittivi nelle popolazioni a basso rischio, dall’ altra di aumentare la sensibilità dei criteri diagnostici, con maglie più “permissive”, nelle popolazioni a moderato-alto rischio, per evitare sotto-diagnosi e complicanze gravi, implementando inoltre la formazione degli operatori sanitari sull’ applicazione dei criteri di Jones.
E la cardite?
Nella stessa direzione vanno anche le raccomandazioni relative all’utilizzo dell’ecocardiografia per la diagnosi precoce di CR, soprattutto in fase subclinica. Già nel 2001 l’OMS aveva suggerito l’utilizzo dell’ecocardiografia in tutti i casi confermati di MR, pur in assenza di sospetto coinvolgimento cardiaco. Nelle linee guida AHA del 2015 è stato quindi attribuito alla cardite silente il ruolo di criterio maggiore per la diagnosi di MR, equiparandola alla cardite clinica, visto il rischio di cronicizzazione a cui possono andare incontro le lesioni cardiache o come conseguenza di un primo episodio di MR oppure come effetto di infezioni recidivanti di SBEGA. Rispetto alle linee guida dell’ AHA, che individuano nell’ecocardiografia con doppler lo strumento diagnostico gold-standard per la CR, l’ OMS ammette - nei paesi a risorse limitate e soprattutto in setting rurali o periferici - anche l’impiego dell’ ecocardiografia portatile (HHE), in particolare nei bambini, negli adolescenti e nelle donne in gravidanza, pur riconoscendo per l’HHE un livello inferiore di accuratezza diagnostica (74% sensibilità e 86% di specificità). L’HHE, inoltre, è raccomandata nel follow-up successivo nei soggetti con precedenti di malattia reumatica. Sono poi fornite indicazioni per sviluppare programmi di screening che tengano conto delle caratteristiche dei diversi contesti territoriali. È riconosciuta la necessità di formazione per gli health-workers, sia nell’utilizzo dell’HHE come primo livello diagnostico, sia per cardiologi specialisti che sappiano utilizzare l’ ecocardiografia standard per la conferma della diagnosi e per un corretto follow-up. In questo senso, potrebbero trovare spazio utile anche progetti di telemedicina. Inoltre, le linee guida dell’OMS sottolineano l’importanza di programmi di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle comunità per aumentare la consapevolezza del problema e implementare strategie proattive.
Il confronto continua con i farmaci
Una sostanziale differenza nel documento dell’ OMS riguarda l’assenza di raccomandazione all’utilizzo di farmaci ad attività antinfiammatoria (FANS, immunoglobuline endovena, corticosteroidi) come misura di prevenzione della CR nei pazienti con MR. È noto, in realtà, che questi farmaci trovano comune indicazione pediatrica, con variabile modulazione per tipo di farmaco, dosaggio e durata della terapia, in relazione all’ entità del coinvolgimento cardiaco e/o alla presenza di artrite o corea.
Nell’ambito della profilassi secondaria, l’ OMS conferma l’indicazione alla somministrazione di penicillina G benzatina per via intramuscolare, ogni quattro settimane, nei soggetti con precedente episodio di FR o CR e che rispondano a criteri minimi necessari per la diagnosi. La profilassi secondaria è indicata anche nei soggetti con cardiopatia avanzata. Viene suggerita la possibilità di utilizzare formulazioni di penicilline orali, come strategia profilattica alternativa, nei pazienti adulti a basso rischio di recidiva di malattia o nei setting in cui le formulazioni iniet-
tabili possono non essere disponibili. Prima di intraprendere la profilassi non ci sono indicazioni a eseguire test allergologici, se non nei casi di storia nota di reazioni allergiche alla penicillina. Interessanti, al fine di migliorare l’adesione alla profilassi, sono le indicazioni alla prevenzione del dolore, associando anestetici locali alle formulazioni antibiotiche per via iniettiva, e alla previsione di programmi di supporto ai pazienti, anche dal punto di vista educativo. A differenza delle linee guida AHA, che stabiliscono con maggiore precisione la durata della profilassi in funzione dell’ età e della presenza di cardite residua, le linee guida dell’ OMS non contengono criteri temporali precisi ma viene utilizzata la definizione generica di trattamento a “lungo termine”. I dati internazionali, sia storici che contemporanei, forniscono ormai prove inequivocabili che la prevenzione secondaria migliori gli esiti cardiaci della MR. Mantenere un’ elevata aderenza alla profilassi con penicillina rimane una sfida globale ed è necessario elaborare nuove strategie per esplorare e consentire una migliore somministrazione, aggiornamento e aderenza alla profilassi. Il dolore delle iniezioni, la difficoltà nel mantenere la cadenza degli appuntamenti, eventuali difficoltà finanziarie rappresentano possibili ostacoli alla somministrazione della profilassi. D’ altra parte, il costruire una solida relazione paziente-infermiere e lo strutturare percorsi con personale dedicato anche all’ educazione del paziente per stimolarne il senso di responsabilità individuale, possono rappresentare fattori favorenti. Anche in questo senso, lo sviluppo di progetti di telemedicina potrebbe trovare spazio nell’ incentivare l’ aderenza alla profilassi secondaria.
1. World Health Organization. WHO guideline on the prevention and diagnosis of rheumatic fever and rheumatic heart disease. Geneva: World Health Organization; 2024
2. Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al. Revision of the Jones Criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015;131(20):1806–1818.
3. Kumar RK, Antunes MJ, Beaton A, et al. Contemporary Diagnosis and Management of Rheumatic Heart Disease: Implications for Closing the Gap: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2020;142(20): e337-e357.

Questa rubrica propone Documenti sanitari, linee guida, linee di indirizzo o di intenti di interesse pediatrico commentati a cura dell’ Associazione Culturale Pediatri. Potete inviare le vostre osservazioni ai documenti scrivendo a: redazione@quaderniacp.it. Le vostre lettere verranno pubblicate sul primo numero utile.
Commento a cura di Angela Pasinato e Elena Uga Pediatri per Un Mondo Possibile (PUMP)
A ottobre 2024 è stato pubblicato da “Pediatrics” un numero monografico sul piombo. Il documento discute le tendenze emergenti negli USA, e non solo, riguardo alla prevenzione dell’esposizione al piombo nei bambini, evidenziando, fra le altre, nuove fonti di esposizione legate alle armi da fuoco, alle catene di approvvigionamento alimentare e alle strategie di marketing dei prodotti.
Il piombo è un metallo naturale, onnipresente nell’ ambiente, di cui sono ampiamente riconosciute le proprietà neurotossiche e i potenziali effetti nocivi per gli esseri umani, ma in particolare per i bambini sotto i cinque anni, età in cui si verificano danni neurologici evolutivi e comportamentali. L’ esposizione cronica anche a basse dosi può essere correlata a insorgenza di iperattività o deficit di attenzione. La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che nessun livello di esposizione al piombo è privo di conseguenze sulla salute o sul comportamento, infatti non è ad oggi stato identificato alcun livello sicuro di esposizione al piombo, e i laboratori non sono in grado di dosare bassissimi livelli. Il Centers for Disease Control and Prevention americano (CDC) ha apportato, nel 2021, una modificazione al livello consentito arrivando a 3.5 µg/dL, ma diverse fonti sottolineano come questa soglia potrebbe non essere sicura. Ad esempio uno studio effettuato in North Carolina evidenzia come l’ esposizione a bassi livelli di piombo nelle prime fasi della vita vada a influenzare il comportamento scolastico, associandosi a un comportamento peggiore e a più giorni di sospensione, anche quando i livelli sono inferiori agli attuali limiti di sicurezza. Nella monografia è inoltre riportata una scoping review sugli effetti di livelli di piombo nel sangue <10 µg/dL nei bambini e negli adolescenti in età scolare, da cui emerge l’ evidenza di un’ associazione fra gli esiti sul QI e sulle diagnosi di disturbi comportamentali o di ADHD, confermando che anche bassi livelli di piombo (Blood Lead Levels, BLL) nei bambini e negli adolescenti in età scolare possono essere associati a un outcome negativo per la salute. In merito alla necessità di trovare strategie per ridurre il più possibile l’ esposizione al piombo, nell’ ambito dello screening nel 2022, il CDC ha condotto un’indagine su 62 programmi statunitensi raccogliendo informazioni sulle leggi e le linee guida relative all’avvelenamento da piombo nell’infanzia, sulle strategie di sorveglianza e prevenzione e sui servizi offerti dai vari programmi evidenziando come negli USA quasi tutti gli stati abbiano programmi di screening che prevedono l’ obbligo di segnalazione dei BLL e circa due terzi dei programmi ha aggiornato i valori soglia di BLL che determinano un’ azione di sanità pubblica. In un altro articolo si riflette sul proporre un dosaggio universale della piombemia in gravidanza. Teoricamente, proporre il test universale del piombo in gravidanza negli USA potrebbe ridurre
le risorse disponibili per il test e la gestione del piombo nel sangue dei bambini; d’ altro canto questo rischio sarebbe compensato dai benefici derivanti da una più precoce identificazione e trattamento dell’ esposizione al piombo, in quanto la gravidanza rappresenta un periodo di maggior rischio a causa del ricambio osseo e dello sviluppo di un feto neurologicamente vulnerabile. Oltre all’ attenzione allo screening dei valori di piombemia alcuni stati degli USA hanno messo in atto programmi di controllo dell’ esposizione nelle scuole. Ad esempio nel 2023 in Colorado è stata approvata una legge sui test per la piombemia che obbliga tutte le strutture di assistenza all’infanzia autorizzate e le scuole elementari pubbliche a testare tutte le postazioni di acqua potabile per verificare la presenza di piombo, riscontrando come il 7% degli impianti testati presentasse livelli di piombo nell’acqua al di sopra della soglia considerata a rischio. Grazie a questo programma, quasi 600.000 bambini sono stati protetti dalla potenziale esposizione al piombo nell’ acqua potabile. Inoltre, il livello di tossicità e danno può variare non solo in base alla via o alla dose di esposizione, ma anche in base alla fisiologia, all’ età, allo stato di salute e all’ adeguatezza nutrizionale del bambino. La sanità pubblica dei paesi ad alto e medio reddito ha bandito, dagli inizi di questo secolo, il piombo dalla benzina e dalle vernici, che all’ epoca rappresentavano le fonti principali di avvelenamento, ma il problema permane.
Ad oggi sono segnalate tre fonti emergenti di esposizione e disseminazione di piombo nell’ ambiente:
1. La proliferazione delle armi da fuoco: l’uso di armi e munizioni può portare a esposizione al piombo attraverso la polvere di piombo su vestiti o carne contaminata.
2. La complessità delle catene di approvvigionamento alimentare globali (materie prime importate da paesi frequentemente a basso reddito, come nel caso della contaminazione, in USA, della purea di mele alla cannella, dove la fonte era la cannella, alimento dedicato proprio ai bambini). Particolare attenzione deve essere posta agli alimenti importati da paesi in cui i controlli non siano effettuati secondo le direttive condivise per quanto riguarda i livelli degli inquinanti presi in considerazione (in questo caso il piombo).
3. Le strategie di marketing dei prodotti di consumo per bambini. Prodotti non alimentari come giocattoli e utensili da cucina possono contenere piombo, specialmente quelli venduti online da venditori terzi.
Dopo l’ eliminazione del piombo dalle vernici e dalla benzina, i livelli ematici del piombo nei bambini di età fra 1 e 5 anni erano in notevole diminuzione. Infatti, dal 1976-80 al 2017-20 i valori

medi riscontrati nei monitoraggi negli USA sono scesi dai 15.2 microgrammi/dl ai 0.6 microgrammi/dl, con diminuzione pari al 96%.
Oggi però la situazione è cambiata e il rischio di esposizione a nuove fonti concreto. Inoltre sono sempre più evidenti le differenti esposizioni legate alle differenze sociali. Ad esempio da uno studio effettuato in Pensylvania emerge come i bianchi non ispanici e i bambini con disturbi dello sviluppo, comportamentali ed emotivi avessero percentuali relativamente basse di follow-up appropriati. Questi dati sottolineano come negli USA l’avvelenamento da piombo nell’ infanzia sia un onere sanitario ed economico significativo, soprattutto tra i bambini con difficoltà socio economiche e senza copertura assicurativa. Sempre nell’ ottica di disuguaglianza sociale un lavoro pubblicato nella monografia ha valutato la possibile associazione tra anemia falciforme (SDC), patologia più frequente nella popolazione di etnia africana, e l’avvelenamento da piombo nell’infanzia analizzando i dati del registro del piombo di New York per i bambini con livelli di piombo nel sangue (BLL) ≥15 mcg/dL nel periodo 2005-2019. I risultati hanno evidenziato una potenziale associazione tra SCD e avvelenamento da piombo nell’infanzia e la pica è emersa come un fattore di rischio potenzialmente importante.
Quindi in alcune situazioni, soprattutto là dove vi sia svantaggio sociale, si dovrà effettuare, proprio in virtù delle tre fonti emergenti identificate, un attento monitoraggio attraverso:
- Strumenti Educativi: è necessario lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione sui rischi legati all’ esposizione al piombo, ad esempio tramite strumenti come video educativi.
- Monitoraggio attraverso campagne di screening con misurazione della piombemia: è necessaria la collaborazione tra agenzie per sviluppare un sistema di test del piombo nel sangue più sensibile e capillare.
- Aggiornamento delle Politiche Nazionali: sono necessari programmi nazionali per sostituire tubature e vernici contenenti piombo, con un focus su comunità a basso reddito e marginalizzate.
Nel volume vengono infine riportati due case report, uno su un grave avvelenamento in due fratelli nati da una madre con comportamenti di pica, che evidenzia l’ importanza di gestire in modo appropriato le donne in gravidanza con elevati livelli di piombo nel sangue e la necessità di redigere e implementare linee guida o protocolli per la chelazione dei neonati. Il secondo case report descrive un caso di avvelenamento da piombo in un bambino di 1 anno che ha ingerito un medaglione metallico contenente piombo proveniente dall’India, evidenziando la natura ubiquitaria del piombo nel nostro ambiente globale e il rischio di esposizione a nuove fonti, soprattutto per i bambini. In un altro articolo vengono esaminate le segnalazioni di ritiro di prodotti per bambini contaminati da piombo (in particolare giocattoli provenienti dalla Cina) evidenziando come negli USA la protezione dei bambini dai rischi del piombo nei prodotti di consumo potrebbe essere migliorata notificando tempestivamente ai CDC i ritiri di prodotti in modo che possano diffondere ampiamente le informazioni attraverso i loro canali per ridurre l’ esposizione al piombo.
In conclusione, la monografia, che si concentra principalmente su problematiche e realtà statunitense, sottolinea la necessità di un approccio olistico alla prevenzione dell’ esposizione al
piombo, tenendo conto dei determinanti sociali della salute e dei principi di equità sanitaria. In Italia non vi sono studi recenti che facciano vedere una controtendenza come quella evidenziata in questa monografia. Certo risulta preoccupante pensare che ancora oggi il piombo possa essere una causa di iperattività e/o deficit di attenzione, visto la grande prevalenza attuale di questa patologia nella nostra popolazione. Si potrebbe ipotizzare uno studio pilota sui bambini italiani affetti da iperattività in epoca prescolare per valutare, insieme agli altri fattori determinanti la patologia, anche il dosaggio del piombo.
Il problema attuale della ricerca negli Stati Uniti
Il 22 gennaio, l’amministrazione Trump ha dato istruzioni alle agenzie federali sanitarie e scientifiche, tra cui i National Institutes of Health (NIH), la National Science Foundation (NSF) e i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), di interrompere le comunicazioni esterne, le riunioni e i viaggi. Ha inoltre ordinato il congelamento delle sovvenzioni federali e ha annullato le revisioni dei grant che consentono di distribuire i fondi governativi per la ricerca agli scienziati in tutto il Paese, impedendo l’ avvio di nuove ricerche. Due settimane dopo, ma ha revocato alcuni di questi blocchi, l’amministrazione ha annunciato ulteriori tagli ai finanziamenti, questa volta limitando i “costi indiretti” applicabili nei progetti finanziati al 15% del totale delle sovvenzioni, cifra ritenuta dalle agenzie non adeguata a coprire i costi di esercizio. Si corre il rischio di vedere bloccata la ricerca a tutti i livelli, comprese le attività di monitoraggio e rilevazione dell’inquinamento da piombo di cui si parla in questo capitolo.
Nella nostra rivista e sul nostro sito, si è parlato in più occasioni del problema della tossicità da piombo:
- Primavera G., “La tossicità da Piombo nei bambini, un problema dimenticato”, Pagine Elettroniche di Quaderni ACP 2017; 24(2):as.2
- Vincenza Briscioli “Tossicità del piombo nell’infanzia. Quanto è importante smaltire correttamente le pile?”

La salute pediatrica non può più essere considerata separata dalla crisi climatica. Come sottolinea Friederike Otto in Ingiustizia climatica, il cambiamento climatico non è un destino ineluttabile, ma una costruzione sociale profondamente iniqua: chi ha contribuito meno all’inquinamento globale – come i bambini nei paesi a basso reddito o nelle comunità vulnerabili – ne paga il prezzo più alto [1]. Questa disuguaglianza si riflette ormai in una vasta mole di dati scientifici: l’esposizione a inquinanti come PM2.5, PFAS, metalli pesanti e interferenti endocrini può alterare lo sviluppo neurocognitivo, immunitario, endocrino e metabolico già nelle prime fasi della vita, contribuendo anche a condizioni gravi come disturbi dello sviluppo, patologie respiratorie, disfunzioni tiroidee e, in alcune popolazioni, aumentato rischio oncologico. Le prime finestre dello sviluppo – dalla gravidanza all’ infanzia – sono particolarmente vulnerabili, e ogni grado in più di riscaldamento globale intensifica il peso di queste esposizioni ambientali. In questo contesto, i pediatri diventano sentinelle ambientali e promotori di giustizia climatica, sono chiamati a integrare l’ anamnesi ambientale nella pratica quotidiana, contribuire alla sorveglianza di esiti pediatrici sensibili al clima e farsi portavoce di una nuova medicina territoriale che agisca anche sui determinanti ambientali. Anche in questo numero numerosi sono gli articoli che pongono l'accento sull' importanza dell' anamnesi ambientale e del ruolo dei determinanti di salute su equità e adattamento climatico. In questa rivista continuiamo a riassumere sinteticamente i principali articoli pubblicati nelle riviste monitorate, tutti gli articoli e gli editoriali ritenuti degni di attenzione vengono elencati divisi per argomento, con un sintetico commento. Questo numero si basa sul controllo sistematico delle pubblicazioni di marzo e aprile 2025.
Child health can no longer be considered separately from the climate crisis. In her book Climate Injustice, Friederike Otto argues that climate change is not an inescapable fate, but a profoundly unjust social construction. Those who have contributed least to global pollution – such as children in low-income countries or vulnerable communities – pay the highest price [1]. This injustice is well documented by a growing body of scientific evidence: cognitive development may be affect-ed by pollutants like PM2.5, PFAS, heavy metals, and endocrine disruptors during the earliest stages of life. Such exposures are also linked to serious health conditions including developmental and respiratory diseases, thyroid dysfunction, and in some populations increased cancer risk. The first windows of human development, from pregnancy to early childhood, are especially vulnerable, and each additional degree of global warming increases this burden. In this context, paediatricians must act as environmental sentinels and advocates for climate justice. They are called to integrate environmental history into routine care, monitor climate-related paediatric outcomes, and speak out for a new model of primary care that addresses social and environmental determinants of health. Additionally, the articles featured in this issue highlight the critical importance of environmental history and health determinants in cimate adaptation and equity. We continue to summarize the main articles published in the monitored journals, all articles and editorials deemed worthy of attention are listed divided by topic, with a brief commentary. This issue is based on the systematic monitoring of publications in March and April 2025.
1. Friederike Otto: Ingiustizia climatica. Einaudi

:: Cambiamento climatico
1. Un futuro di eventi climatici estremi: sempre più persone esposte lungo tutta la vita
2. Cambiamento climatico e benessere infantile: una revisione sistematica delle evidenze e delle lacune
:: Inquinamento atmosferico
1. Inquinamento dell’ aria, temperature estreme e distacco di placenta: nuove evidenze da un registro nascite in Cina
2. Inquinamento atmosferico e sistema immunitario dei bambini: una revisione sistematica delle evidenze disponibili
3. Esposizione a lungo termine a PM2.5 e noduli tiroidei in bambini e adolescenti in età scolare: uno studio trasversale nella Cina orientale
4. ▶ Esposizione perinatale all' inquinamento atmosferico da polveri sottili e rischio di sarcoma di Ewing infantile in uno studio caso-controllo
5. ▶ Esposizione all'inquinamento atmosferico residenziale e sviluppo della connettività funzionale delle reti cerebrali fino all'adolescenza
:: Inquinamento da sostanze chimiche non atmosferiche
1. Esposizione ad interferenti endocrini presenti nell'aria e asma nei bambini e negli adolescenti: una revisione sistematica con meta-analisi
2. Co-esposizione a metaboliti di ftalati e bisfenoli e rischio di difetti del tubo neurale
3. ▶ Esposizione a pesticidi e morte improvvisa infantile: una revisione sistematica delle evidenze disponibili
4. Sostanze perfluoroalchiliche e infezioni comuni nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 7 anni: Il caso di una elevata esposizione prenatale a PFAS provenienti da acqua potabile contaminata in Svezia
5. Impatto dell'esposizione prenatale alle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sui ritardi dello sviluppo nei bambini di 4 anni: studio giapponese sull'ambiente e l'infanzia
6. ▶ Effetti dei “nuovi” PFAS acido perfluoroesanesolfonico ramificato (PFHxS) e acido perfluoroeptanoico (PFHpA)sul microbiota intestinale e sulla funzione metabolica nei bambini
7. Esposizione materna alle sostanze per e polifluoroalchiliche e risposta ai vaccini contro morbillo e rosolia
8. Esposizione prenatale ai metalli pesanti e malattie atopiche dell'infanzia
:: Ambienti naturali
1. Effetti delle passeggiate all'aria aperta e del “portare i piccoli” sugli outcomes comportamentali e adrenocorticali nelle madri e nei neonati
:: Psicologia ambientale
1. Tutto è connesso: richiami al senso di connessione con la natura e con gli altri rafforzano le attitudini ambientali
Riviste monitorate
American Journal of Public Health
.. American Journal of Respiratory and Critical Care medicine
American Journal of Epidemiology
Archives of Diseases in Childhood
Brain & Development
British Medical Journal
Child: Care, Health and Development
Environmental and Health
Environmental Health Perspectives
Environmental International
Environmental Pollution
Environmental Research
Environmental Sciences Europe
European Journal of Epidemiology
International Journal of Environmental Research and Public
Health
International Journal of Epidemiology
JAMA (Journal of American Medical Association)
JAMA Pediatrics
Journal of Environmental Psychology
Journal of Epidemiology and Community Health
Journal of Pediatrics
NeuroToxicology
Neurotoxicology and Teratology
New England Journal of Medicine
Pediatrics
The Lancet
Revisione delle riviste e testi a cura di:
Vincenza Briscioli, Laura Brusadin, Sabrina Bulgarelli, Federico Marolla, Angela Pasinato, Laura Reali, Laura Rocca, Annamaria Sapuppo, Vittorio Scoppola, Rita Straquadaino, Laura Todesco, Mara Tommasi, Giacomo Toffol, Elena Uga.
Pediatri per Un Mondo Possibile
Gruppo di studio sulle patologie correlate all’ inquinamento ambientale dell’ Associazione Culturale Pediatri (ACP) mail: pump@acp.it

Cosa aggiungono questi studi: indicazioni pratiche
• È essenziale promuovere una sorveglianza attiva delle patologie ambiente-correlate, incorporare l’ anamnesi ambientale nella valutazione del rischio, e sviluppare strategie di prevenzione che tengano conto delle disuguaglianze socio-ambientali. Particolare attenzione va posta all’ inquinamento atmosferico, che rappresenta una minaccia crescente e multisistemica per la salute dei bambini, agendo fin dalle prime fasi della vita e influenzando il rischio di patologie immunitarie, neurologiche, endocrine e oncologiche. Studi recenti documentano come l’ esposizione precoce a PM2.5 sia associata a disfunzioni immunitarie e a una minore risposta ai vaccini, alterazioni persistenti della connettività cerebrale, sviluppo di noduli tiroidei in età scolare e, in popolazioni vulnerabili come i bambini ispanici, a un aumento del rischio di sarcoma di Ewing. In gravidanza, l’ esposizione materna a inquinanti atmosferici – in particolare al biossido di azoto (NO₂) – è correlata a eventi avversi come il distacco di placenta.
• Ricordiamo che l’ ecologia della salute inizia nel grembo materno. Integrare l’ anamnesi ambientale nelle valutazioni pediatriche e promuovere strategie di riduzione dell’ esposizione prenatale e infantile può rappresentare un passo concreto per ridurre il carico delle malattie atopiche nei bambini e ridurre il rischio di alterazioni sullo sviluppo neuro-motorio, comunicativo, metabolico e immunitario. Sempre più studi indicano che l’ esposizione prenatale a metalli tossici può aumentare il rischio di asma, eczema e altre forme di atopia nei primi anni di vita. Non si tratta di un rischio uniforme: le risposte variano in base al sesso del bambino e alla storia familiare di allergie, suggerendo una complessa interazione tra ambiente, genetica e sviluppo immunitario. Emerge inoltre un ruolo dei contaminanti chimici indoor, come ftalati, bisfenoli, metalli e ritardanti di fiamma, nel contribuire all’ insorgenza e all’esacerbazione dell’ asma pediatrico. Sempre più studi inoltre mostrano che le esposizioni prenatali e infantili ai PFAS, inclusi i composti “di nuova generazione” come PFHxS e PFHpA, sono un rischio concreto per la salute pediatrica, con effetti documentati sullo sviluppo neuro-motorio, comunicativo, metabolico e immunitario.
• Serve integrare la giustizia climatica nella prevenzione, nella formazione sanitaria, nella progettazione urbana e nelle politiche educative, coinvolgendo bambini e adolescenti nei processi decisionali. Con l’aggravarsi della crisi climatica, proteggere il benessere infantile non può limitarsi alla salute fisica, ma deve abbracciare una visione ampia, sistemica e intergenerazionale. Le nuove generazioni vivranno un’esposizione senza precedenti a eventi climatici estremi nel corso della loro vita – ondate di calore, siccità, inondazioni – con rischi amplificati dalle disuguaglianze socioeconomiche. Difendere la salute delle nuove generazioni significa agire oggi su più fronti, con consapevolezza, ascolto e impegno verso un futuro sostenibile ed equo.
• È necessario integrare sistematicamente l’anamnesi ambientale e la raccolta di dati sull’esposizione domestica e professionale anche nelle indagini post-mortem. Le evidenze oggi disponibili suggeriscono un possibile ruolo dell’esposizione a pesticidi, in particolare quelli con azione neurotossica, nei casi di SIDS. Sebbene le prove non siano ancora conclusive, ignorarle sarebbe un errore.
Cambiamento climatico
1. Un futuro di eventi climatici estremi: sempre più persone esposte lungo tutta la vita
Il lavoro evidenzia un’ accelerazione intergenerazionale del rischio climatico, aggravata da forti disuguaglianze socioeconomiche. I risultati rappresentano un monito quantitativo e politico sulla necessità di rafforzare le strategie di mitigazione e adattamento, soprattutto a tutela delle popolazioni più vulnerabili. Gli eventi climatici estremi si stanno intensificando a causa dei cambiamenti climatici antropogenici, tuttavia, non è ancora chiaro come questa esposizione cumulativa e senza precedenti
possa impattare sulla salute nel corso della vita di una persona. Gli autori di questo lavoro hanno utilizzato modelli climatici, modelli di impatto e dati demografici per calcolare il numero di futuri nascituri che sperimenteranno, nel corso della loro vita, un' esposizione cumulativa agli eventi climatici estremi superiore al 99.99° percentile rispetto all’ esposizione prevista in un clima preindustriale. Secondo queste proiezioni, il numero di nascituri che affronterà questa esposizione senza precedenti ad ondate di calore, scarsità di raccolti, inondazioni fluviali, siccità, incendi e cicloni tropicali raddoppierà, considerando un riscaldamento globale che raggiunga i 2.7 °C al di sopra delle temperature preindustriali, entro il 2100. Con un aumento di 1.5 °C, il 52% delle persone nate nel 2020 sperimenterà un'esposizione alle ondate di calore senza precedenti nel corso della vita. Se il riscaldamento globale raggiungerà i 3.5 °C entro il 2100, questa percentuale salirà al 92% per le ondate di calore, al 29% per la scarsità dei raccolti e al 14% per le inondazioni. La possibilità di affrontare un'esposizione senza precedenti alle ondate di calore nel corso della vita sarà sostanzialmente maggiore tra i gruppi di popolazione caratterizzati da un'elevata vulnerabilità socioeconomica. Questi risultati sottolineano la necessità urgente di una riduzione profonda e sostenuta delle emissioni di gas serra per ridurre il peso del cambiamento climatico sulle attuali giovani generazioni.
° Grant, L., et al. Global emergence of unprecedented lifetime exposure to climate extremes.Nature 641, 374–379 (2025).
2. Cambiamento climatico e benessere infantile: una revisione sistematica delle evidenze e delle lacune
In questa revisione sistematica, gli autori mappano in modo estensivo lo stato delle conoscenze su come i cambiamenti climatici e le relative strategie di mitigazione e adattamento influenzano il benessere globale dei bambini e degli adolescenti (0–18 anni). Sono state incluse 1.127 revisioni (sistematiche, scoping e ricerche originali) pubblicate da gennaio 2014 a dicembre 2024, che coinvolgono bambini e studi sull'impatto, la mitigazione o l'adattamento ai cambiamenti climatici. La maggior parte delle ricerche ha esaminato gli impatti diretti e indiretti del cambiamento climatico sulla salute dei bambini, sull'istruzione, sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione. In particolare la salute è stata l'area di maggiore ricerca (84%), seguita dall'istruzione (15%), dalla sicurezza alimentare e dalla nutrizione (14%). La ricerca sull'azione e la resilienza dei bambini, lo sfollamento, il disagio socioeconomico e la sicurezza ha ricevuto meno attenzione. Le lacune della ricerca sanitaria erano rappresentate dal basso numero di studi sulle malattie trasmesse da vettori, sulla salute mentale dei bambini (oltre il disturbo da stress post-traumatico) e sui risultati di salute per i bambini di età 5-18 anni. La ricerca sulla mitigazione e l'adattamento si è concentrata in gran parte sui cambiamenti educativi (45%) e comportamentali (31%), con lacune nella valutazione dei finanziamenti, delle infrastrutture, della tecnologia, dell'energia pulita e delle azioni politiche. La partecipazione di giovani volontari del comitato consultivo “Children in All Policies 2030” ha rafforzato il messaggio centrale: la protezione del benessere infantile in un contesto climatico in rapido mutamento non può prescindere dal coinvolgimento diretto delle nuove generazioni nelle agende di ricerca e azione. Lo studio segnala con forza l’urgenza di riequilibrare la ricerca, ampliando le prospettive finora trascurate e integrando la voce
e Salute
dei giovani nei processi decisionali a tutti i livelli e dimostra che con l'intensificarsi dei cambiamenti climatici, la ricerca sul potenziale delle azioni di mitigazione e di adattamento per salvaguardare il benessere dei bambini diventa sempre più cruciale; i lavori futuri dovrebbero garantire che i giovani e i bambini siano coinvolti nella definizione delle priorità della ricerca e dell'azione.
° Mohamed, Malak et al.Climate change and child wellbeing: a systematic evidence and gap map on impacts, mitigation, and adaptation. The Lancet Planetary Health, 2025, 9.4: e337-e346.
1. Inquinamento dell’aria, temperature estreme e distacco di placenta: nuove evidenze da un registro nascite in Cina Lo studio fornisce nuove evidenze sul legame tra esposizione a NO₂ e distacco di placenta, basandosi su un registro nascite in Cina e su stime ambientali ad alta risoluzione. L’ analisi suggerisce che l’ esposizione a NO₂ durante la gravidanza – ma non prima del concepimento – così come temperature estreme nel terzo trimestre, possano contribuire in modo rilevante ad eventi avversi in gravidanza. Il distacco di placenta è una rara patologia di eziologia poco chiara e mancano prove solide che ne illustrino la relazione con l’ esposizione all’inquinamento atmosferico e alla temperatura. Questo studio ha cercato di indagare l’associazione tra l’ esposizione agli inquinanti ambientali e alle temperature e il rischio di distacco di placenta, identificando le finestre temporali e i sottogruppi di popolazione più suscettibili. È stato condotto uno studio caso-controllo utilizzando il database dei nati vivi della municipalità di Chongqing (la più grande città cinese), relativo al periodo 2018–2022. Ogni caso di distacco di placenta è stato abbinato a quattro controlli per età materna al parto, settimana gestazionale, numero di gravidanze, numero di parti e data del parto. Sono stati stimati, mediante algoritmi di apprendimento automatico, i livelli di sei inquinanti atmosferici [PM2.5, PM10, NO₂, CO, O₃, e SO₂] e della temperatura ambientale. Le associazioni tra l’ esposizione agli inquinanti e al calore sono state analizzate attraverso l'analisi statistica che tiene conto dell’ abbinamento tra casi e controlli in cinque finestre temporali: pre-gravidanza, l'intera gravidanza e ciascuno dei tre trimestri. Sono state inoltre condotte analisi stratificate per valutare l’ effetto di fattori che possono modificare l’associazione osservata, come il numero di gravidanze, i parti, l’area di residenza (urbana o rurale), l’ esperienza pandemica e la stagione del parto. Dopo il controllo qualità dei dati, sono stati identificati 798 casi e 3.192 controlli. È emersa un’ associazione tra l’ esposizione al biossido di azoto (NO₂) durante la gravidanza e l’aumento del rischio di distacco di placenta (p < 0.001). Rispetto al primo quartile di esposizione a NO₂, gli odds ratio (OR) per il secondo, terzo e quarto quartile sono risultati rispettivamente di 1.42 (IC 95%: 1.03–1.96), 1.90 (IC 95%: 1.30–2.76) e 2.27 (IC 95%: 1.39–3.71). L’ associazione era presente durante tutti e tre i trimestri, ma non nel periodo pre-gravidanza. Inoltre, l’ esposizione a temperature estremamente basse (sotto il 5° percentile) nel terzo trimestre era associata a un aumento significativo del rischio di distacco di placenta (OR = 3.68; IC 95%: 1.67–8.08), rispetto a temperature moderate (tra 25° e 75° percentile). Le analisi stratificate

non hanno mostrato differenze statisticamente significative tra i sottogruppi. Basandosi su un ampio database di nascite, questo studio suggerisce che l’ esposizione durante la gravidanza ad alcuni inquinanti atmosferici, in particolare al NO₂, possa rappresentare un importante fattore di rischio per il distacco di placenta. Lo studio si distingue per la numerosità del campione, il disegno metodologico solido e l’uso di modelli avanzati per stimare l’ esposizione ambientale. Tuttavia, la natura osservazionale, l’assenza di dati individuali diretti e il controllo limitato dei fattori confondenti ne riducono la capacità di supportare inferenze causali.
° Wang, T., et al. Association of Ambient Air Pollution and Temperature Exposure with Placental Abruption: A Nested Case–Control Study Based on Live Birth Registrations. Environmental Health Perspectives, 2025;133(3), 037001.
2. Inquinamento atmosferico e sistema immunitario dei bambini: una revisione sistematica delle evidenze disponibili Con l’ obiettivo di capire quanto possa essere compromesso il sistema immunitario di bambini e ragazzi sollecitato dagli inquinanti è stata effettuata una revisione sistematica delle evidenze epidemiologiche disponibili sugli effetti dell’ esposizione all’inquinamento atmosferico, sia indoor che outdoor, sui biomarcatori immunitari sistemici nella prima e seconda infanzia (dalla nascita ai 18 anni). Seguendo le linee guida PRISMA, gli AA hanno selezionato 96 articoli su oltre 4.000. Tutti gli studi vengono riportati in una lunga tabella e nei risultati vengono elencati, per ogni singolo inquinante atmosferico, i parametri immunitari studiati. Solo 12 studi hanno riguardato l’inquinamento indoor. Gli AA concludono che esistono prove limitate di una associazione causale tra esposizione prenatale a PM2.5 e riduzione dei linfociti T (sottoclassi CD3 e CD8) e tra esposizione postnatale sempre a PM2.5 e aumento delle IgE specifiche e della sensibilizzazione allergica agli pneumoallergeni nelle età successive. Tutte le altre associazioni riscontrate nei vari studi non sono state poi confermate o sono state giudicate troppo deboli. Questa revisione sistematica mette in luce l’insufficienza e la frammentazione delle evidenze attuali sul rapporto tra inquinamento atmosferico ed equilibrio immunitario nei bambini e negli adolescenti. Gli studi futuri dovrebbero essere condotti su coorti prospettiche ben caratterizzate, con misure standardizzate di biomarcatori immunologici e strategie di valutazione dell’ esposizione più precise, includendo anche l’inquinamento indoor, spesso trascurato. È fondamentale approfondire i meccanismi biologici alla base della disregolazione immunitaria, considerando le finestre critiche dello sviluppo e integrando approcci interdisciplinari. Inoltre, la ricerca dovrebbe garantire equità nella selezione dei partecipanti, includendo popolazioni vulnerabili e geograficamente diversificate; è prioritario comprendere l’impatto precoce dell’inquinamento sull’immunità e promuovere strategie efficaci di prevenzione lungo tutto l’arco della vita.
° Carvajal V et al:Air pollution and systemic immune biomarkers in early life: A systematic review. Environ Res. 2025 Mar 15;269:120838. doi: 10.1016/j.envres.2025.120838. Epub 2025 Jan 18. PMID: 39832545.

3. Esposizione a lungo termine a PM2.5 e noduli tiroidei in bambini e adolescenti in età scolare: uno studio trasversale nella Cina orientale
L'esposizione a lungo termine al particolato PM2.5 è correlata alla formazione di noduli tiroidei negli adulti, ma a oggi mancano evidenze per quanto riguarda bambini e adolescenti. Questo studio mira a esplorare l'associazione tra l'esposizione a lungo termine al PM2.5 e la prevalenza di noduli tiroidei nei bambini e negli adolescenti in età scolare. Lo studio ha preso in considerazione 10.739 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nella provincia di Jiangsu, in Cina, nel 2021. La stima delle concentrazioni annuali di PM2.5 è stata ottenuta utilizzando il dataset China High Air Pollutants 2019-2020, mentre le concentrazioni di esposizione individuali sono state assegnate in base agli indirizzi scolastici dei partecipanti. Per rilevare la presenza di noduli tiroidei è stata utilizzata un’indagine ecografica ad alta risoluzione. I risultati hanno evidenziato una correlazione positiva non lineare tra la concentrazione media di esposizione a due anni di PM2.5 e l'aumento della prevalenza di noduli tiroidei. Non sono state riscontrate le associazioni specifiche per sesso riscontrate tra gli adulti. Sulla base dei risultati sopra riportati, sono necessari ulteriori studi di coorte longitudinali per confermare l'associazione causale tra PM2.5 e noduli tiroidei.
° Liu M. et al. Association between long-term exposure to PM2.5 and thyroid nodules in school-aged children and adolescents: a cross-sectional study in Eastern China. Environmental Health, 2025, 24.1: 18.
4. ▶ Esposizione perinatale all'inquinamento atmosferico da polveri sottili e rischio di sarcoma di Ewing infantile in uno studio caso-controllo
Questo studio caso-controllo svolto in California ha voluto esaminare l’associazione tra l'esposizione al particolato fine ambientale perinatale (PM2.5) e il rischio di sarcoma di Ewing infantile (la cui incidenza è in aumento). Lo studio ha arruolato 388 bambini nati in California tra il 1982 e il 2015 e a cui è stato diagnosticato il sarcoma di Ewing tra 0 e 19 anni, e 19.341 controlli sani. Le concentrazioni ambientali di PM2.5 presso la residenza materna sono state valutate in due periodi, l’ epoca gestazionale e il primo anno di vita. I risultati, aggiustati per sesso, anno di nascita, razza, etnia, peso alla nascita e istruzione materna e stratificati per le diverse etnie, hanno evidenziato che l'esposizione ambientale perinatale a PM2.5 non è associata a un aumentato rischio di sarcoma di Ewing nella popolazione generale, considerando l'esposizione durante la gestazione o nel primo anno di vita. Se però si considerano solo i bambini ispanici, che hanno subito una maggiore esposizione all'inquinamento atmosferico rispetto ai bambini non ispanici, livelli più elevati di PM2.5 durante la gravidanza si associano ad una maggiore probabilità di sarcoma di Ewing. I bambini ispanici hanno inoltre presentato un rischio più elevato anche in relazione all'esposizione durante il primo anno di nascita. Questi risultati forniscono prove suggestive che il PM2.5 ambientale possa contribuire al rischio di sarcoma di Ewing, sebbene questi risultati non siano stati statisticamente significativi e siano specifici dei bambini ispanici.
° Clark CJ. et al. Perinatal exposure to ambient fine particle air pollution and risk of childhood ewing sarcoma in a population-based case-control study in California (1988–2015). Environmental Health, 2025, 24.1: 6.
5. ▶ Esposizione all'inquinamento atmosferico residenziale e sviluppo della connettività funzionale delle reti cerebrali fino all'adolescenza
Gli autori di questo studio hanno valutato l'associazione tra l'esposizione all'inquinamento atmosferico dalla nascita ai 3 anni e un anno prima del primo imaging proposto e lo sviluppo della connettività funzionale delle reti neurali durante l'adolescenza. Sono stati reclutati 3.626 bambini del Generation R Study (Paesi Bassi) stimando l'esposizione residenziale a PM10, PM2.5, NOX e NO2 nei primi tre anni di vita con modelli di regressione dell'uso del suolo. La connettività funzionale tra reti neurali è stata valutata con imaging (rs-fMRI) calcolando la connettività funzionale per 13 reti corticali e per l'amigdala, l'ippocampo e il nucleo caudato in due tempi (8.6-12.0 e 12.6-17.1 anni), ottenendo 4.628 scansioni (2.511 per la valutazione 1 e 2.117 per la valutazione 2). I dati sono stati aggiustati per lo stile di vita e le variabili socioeconomiche. I risultati hanno mostrato come una maggiore esposizione al PM2.5 dalla nascita a 3 anni risultasse associata allo sviluppo di una minore connettività tra l'amigdala e le reti ventrali di attenzione, somatomotoria della mano e uditiva per tutta l'adolescenza (ad esempio, - 0.027 connettività funzionale [95 % CI – 0.040; - 0.013] amigdala - rete di attenzione ventrale per 5 μg/m3). Una maggiore esposizione al PM10 un anno prima della prima valutazione di imaging è stata associata a una connettività funzionale persistentemente più bassa tra la rete della salienza e la rete mediale-parietale per tutta l'adolescenza. In conclusione, i dati mostrano come l'esposizione all'inquinamento atmosferico nelle prime fasi della vita sia associata ad alterazioni persistenti della connettività neurale fino all’adolescenza.
° Kusters MSW, et al. Exposure to residential air pollution and the development of functional connectivity of brain networks throughout adolescence. Environment International, 2025, 196: 109245.
Inquinamento da sostanze chimiche non atmosferiche
1. Esposizione ad interferenti endocrini presenti nell'aria e asma nei bambini e negli adolescenti: una revisione sistematica con meta-analisi Lo studio conferma che esiste un’ associazione statisticamente significativa tra l’ esposizione a interferenti endocrini presenti nell’aria (come ftalati e bisfenoli) e la comparsa di asma nei bambini e negli adolescenti. In particolare, i risultati della meta-analisi mostrano che l’ esposizione a determinati composti chimici, soprattutto in ambienti indoor, può aumentare il rischio di sviluppare sintomi asmatici o asma conclamata. Vari studi hanno valutato l'associazione tra l'esposizione ad interferenti endocrini (EDC) e la salute respiratoria di bambini e adolescenti, mostrando potenziali effetti a lungo termine e collegamenti con l'asma. Questa revisione sistematica esplora l'associazione tra l'esposizione a sette gruppi EDC durante l'età scolare e l'adolescenza e l'insorgenza o l'esacerbazione dell'asma, evidenziando i composti predominanti alla base di queste potenziali associazioni. La ricerca è stata effettuata nei database PubMed, Web of Science, Scopus e Cochrane Library senza limiti di tempo ricercando studi su parabeni, ftalati, metalli, ritardanti di fiamma, alchilfenoli, fenossifenoli, triclorosan, bisfenolo, idrocarburi policiclici

aromatici. Il rischio di bias e l'eterogeneità tra gli studi inclusi sono stati valutati utilizzando rispettivamente la scala Newcastle Ottawa e il test I2. Gli odds ratio aggregati (OR) e i loro intervalli di confidenza (CI) al 95% sono stati calcolati utilizzando il modello a effetti casuali e la qualità delle prove per ciascun risultato è stata misurata utilizzando l'approccio GRADE. La revisione ha incluso 64.851 bambini e adolescenti provenienti da 61 studi osservazionali, la maggior parte con un basso rischio di bias nei domini studiati. L'OR aggregato per l'insorgenza dell'asma era significativo per gli ftalati nei campioni di polvere (OR:1.21, CI:1.02; 1.44). A causa del numero limitato di studi, gli effetti complessivi aggregati per gli altri gruppi di sostanze non sono stati calcolati. I singoli composti che hanno dimostrato associazioni significative con l'insorgenza dell'asma includevano nichel (OR:1.10, CI:1.03; 1.18), zinco (OR:1.13, CI:1.11; 1.15), bisfenolo S urinario (OR:1.40, CI:1.13; 1.73), bisfenolo A (OR:1.57, CI:1.02; 2.40), arsenico (OR:2.08, CI:1.33; 3.26), DiBP (diisobutilftalato) (OR:1.41, CI:1.08; 1.82), DEHP(di-2-etilexilftalato )(OR:1.89, CI:1.00; 3.57), e TBOEP (tris(2-butossietil)fosfato) (OR:2.61, CI:1.08; 6.30) nella polvere. I singoli composti con associazioni significative con maggiori probabilità di esacerbazione dell'asma comprendevano nichel (OR:1.08, CI:1.01; 1.16) e zinco (OR:1.09, CI:1.01; 1.17) e MEHHP (mono(2-etil-5-idrossiesil)ftalato) urinario (OR:1.24, CI:1.02; 1.51), MECPP (2-C-metil-d-eritritolo-2.4-ciclopirofosfato) (OR:1.30, CI:1.07; 1.57), MEOHP (mono(2 –etil-5-ossoesil)ftalato) (OR:1.30, CI:1.09; 1.55) 0, CI:1.09; 1.55) e MCOP (mono-carbossi-isooftilftalato) (OR:1.32, CI:1.11; 1.57). L'esposizione agli EDC è stata significativamente associata all'insorgenza e all'esacerbazione dell'asma nei bambini e negli adolescenti, in particolare per gli ftalati, i bisfenoli A e S, l'arsenico, il nichel e lo zinco. Lo studio si distingue per l’ approccio sistematico e quantitativo con cui indaga l’ associazione tra esposizione a interferenti endocrini presenti nell’aria (come ftalati e bisfenoli) e l’asma in età pediatrica, offrendo una sintesi aggiornata e rilevante per la salute pubblica. Tuttavia, l’ elevata eterogeneità tra gli studi inclusi, la prevalenza di dati trasversali e la scarsità di informazioni provenienti da paesi a basso reddito ne limitano la capacità di trarre conclusioni sul legame tra esposizione e asma. Gli autori raccomandano di approfondire la ricerca per concentrarsi sull'impatto della sinergia e della co-esposizione ad altri inquinanti dell'aria indoor.
° Georges Hatem et al: Association between exposure to airborne endocrine disrupting chemicals and asthma in children or adolescents: A systematic review and meta-analysis,.Environmental Pollution, Volume 369, 2025, 125830, ISSN 0269-7491.
2. Co-esposizione a metaboliti di ftalati e bisfenoli e rischio di difetti del tubo neurale
Lo studio suggerisce che l’ esposizione ai metaboliti di ftalati e bisfenoli durante la gravidanza possa aumentare il rischio di difetti del tubo neurale (NTDs). Servono quindi norme più rigorose per limitare l’ esposizione a ftalati e bisfenoli nell’ ambiente, al fine di proteggere la salute fetale. Gli NTDs sono tra le malformazioni congenite più comuni. I ftalati e i bisfenoli sono sostanze chimiche onnipresenti con attività di interferenti endocrini (EDCs), capaci di alterare il sistema endocrino modificando i livelli ormonali. Tuttavia, non esistono studi sulle associazioni tra la co-esposizione ai metaboliti degli ftalati e ai bisfenoli e il rischio di NTDs fetali. I ftalati, in particolare il MEHP, posso-
no contribuire ai difetti del tubo neurale attraverso meccanismi multipli: stress ossidativo, alterazioni epigenetiche, interferenza con segnali molecolari dello sviluppo neurale, disregolazione ormonale, infiammazione placentare e disfunzione mitocondriale; questi effetti compromettono i processi cellulari embrionali. Tra il 2005 e il 2016 è stato condotto uno studio caso-controllo su 286 campioni di placenta raccolti al termine della gravidanza, di cui 77 provenienti da gravidanze complicate da difetti del tubo neurale (NTD) e 209 da gravidanze senza anomalie congenite (controlli). I livelli di 25 EDCs misurati in questi campioni sono stati rilevati tramite cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem. Sono stati utilizzati modelli di regressione logistica e modelli multi-inquinante per valutare gli effetti, sia della singola esposizione che della co-esposizione agli EDCs, sul rischio di NTD, includendo come covariate: età materna, settimane gestazionali al momento del prelievo placentare, indice di massa corporea pre-gravidico, storia di difetti congeniti, supplementazione di folati in gravidanza e fumo. Lo studio ha inoltre valutato se l’esposizione gestazionale al mono-(2-etilesil) ftalato (MEHP) in cavie gravide inducesse NTDs nella prole. L’ esposizione individuale a livelli elevati di MEHP, mono-octil ftalato e mono-cicloesil ftalato è risultata associata a un aumento del rischio di NTD [odds ratio (OR) = 2.89; intervallo di confidenza (IC) al 95%: 1.13–7.43; OR = 3.00; IC 95%: 1.15–7.85; OR = 2.78; IC 95%: 1.08–7.18]. I modelli multi-inquinante hanno mostrato una correlazione positiva tra i livelli della miscela di EDCs e il rischio di NTD, con MEHP e bisfenolo Z come inquinati con maggior impatto. Negli esperimenti su animali, i tassi di NTD aumentavano con il dosaggio di MEHP, mostrando una tendenza statisticamente significativa. Questo è il primo studio a valutare gli effetti, sia della singola esposizione che della co-esposizione ai metaboliti dei ftalati durante la gravidanza, sul rischio di NTD. Lo studio è pionieristico e apre la strada a ulteriori ricerche, ma non può da solo stabilire un nesso causale definitivo; presenta alcuni bias, tra cui la limitata validità esterna del campione, il possibile sfasamento temporale tra esposizione misurata e fase critica dello sviluppo neurale, il rischio di fattori confondenti non controllati e le difficoltà metodologiche nell’analisi della co-esposizione; pur offrendo indicazioni importanti, i risultati richiedono conferma con studi prospettici più ampi.
° Li, S. et al: Associations of prenatal co-exposure to phthalate metabolites and bisphenols with neural tube defects. Environ Sci Eur 37, 58 (2025).
3. ▶ Esposizione a pesticidi e morte improvvisa infantile: una revisione sistematica delle evidenze disponibili
Per morte improvvisa e inaspettata nell'infanzia (SUDI) si intende la morte inaspettata di un neonato nel primo anno di vita, compresa la morte spiegata e inspiegabile (SIDS). Sono noti i fattori di rischio di questa condizione, come la posizione del sonno e il fumo passivo, ma pochi studi hanno affrontato la possibile influenza sulla SUDI dell'esposizione a sostanze chimiche ambientali. Sappiamo inoltre come i pesticidi siano onnipresenti, ma poco del loro impatto sulla mortalità infantile. Gli autori hanno quindi condotto una revisione sistematica degli studi sulle SUDI e sull'esposizione ai pesticidi presenti nel database MEDLINE nel marzo 2024, includendo studi epidemiologici e tossicologici sull'uomo. Sono stati selezionati 92 studi in totale, 17 dei quali inclusi nell'analisi. Gli studi epidemiologici analizzati han-

no riportato risultati diversi: tre studi riportano un'associazione tra SIDS ed esposizione professionale dei genitori a pesticidi. Per quanto riguarda l 'esposizione domestica sono emersi risultati contrastanti: la metà degli studi non ha evidenziato alcuna associazione, mentre un’ esposizione massiccia accidentale ad insetticidi è stata associata a un aumento della mortalità infantile. Diversi studi hanno rilevato la presenza di pesticidi in campioni di cervello di casi di SIDS, dimostrando la diffusa esposizione ambientale dei bambini a organoclorurati e organofosfati e il passaggio attraverso la barriera emato-encefalica. Molti di questi studi sono piuttosto datati e potrebbero quindi non essere rappresentativi dei livelli di esposizione attuali. Questa revisione sottolinea la necessità di rafforzare le indagini post-mortem sulle SUDI e SIDS, integrando dati sistematici sull’ esposizione ambientale, domestica e professionale. La distinzione tra SUDI e SIDS, più concettuale che clinica, è cruciale per orientare correttamente la ricerca sulle possibili eziologie ambientali. Data la scarsità di studi sull’ associazione tra SUDI/SIDS ed esposizione a pesticidi, le evidenze attuali non consentono conclusioni definitive per la variabilità metodologica, l’ età degli studi e i potenziali bias. È però urgente condurre ricerche tossicologiche ed epidemiologiche più ampie, basate su dati aggiornati e su metodi di valutazione dell’ esposizione più accurati; in particolare, andrebbero approfonditi i pesticidi con potenziale neurotossico, come quelli che interferiscono con l’ acetilcolinesterasi, attivano i recettori nicotinici o inducono stress ossidativo. Poiché le cause delle SUDI sono eterogenee, la ricerca ambientale dovrebbe focalizzarsi sui casi inspiegati (SIDS), dove è più probabile il coinvolgimento di fattori ambientali, genetici o metabolici non rilevabili nei decessi spiegati.
° Bourdet E et al: Sudden deaths in infancy and pesticide exposure: A systematic review. Environ Res. 2025 Mar 1;268:120741. doi: 10.1016/j. envres.2024.120741
4. Sostanze perfluoroalchiliche e infezioni comuni nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 7 anni: il caso di una elevata esposizione prenatale a PFAS provenienti da acqua potabile contaminata in Svezia Si ipotizza che i PFAS compromettano la funzione immunitaria nei bambini. In questo studio è stata analizzata l'associazione tra l'esposizione prenatale a PFAS da acqua potabile contaminata e infezioni comuni nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 7 anni a Ronneby, in Svezia. Nel 2013 si è scoperto che l'acqua distribuita da uno dei due impianti di trattamento delle acque nel comune di Ronneby, nella contea di Blekinge, in Svezia, era fortemente contaminata da PFAS. La fonte della contaminazione era un sito di esercitazione antincendio militare che utilizzava schiume antincendio da circa 30 anni. Quando la contaminazione è stata scoperta, Ronneby aveva 28.000 abitanti e l'impianto di trattamento delle acque contaminate aveva rifornito un terzo delle famiglie. L'acqua contaminata presentava livelli estremamente elevati di due PFAS. La coorte studiata comprendeva 17.051 bambini, nati tra il 2003 e il 2013, da madri residenti nella contea di Blekinge per almeno un anno nei cinque anni precedenti il parto. Le diagnosi di infezioni agli occhi, alle orecchie, alle vie respiratorie e alle vie urinarie sono state recuperate dal Blekinge Healthcare Register. I dati sulla residenza delle madri sono stati utilizzati come riferimento per l'esposizione prenatale: molto alto ( madre residente in zona con acqua contaminata per 5 anni
e Salute prima del parto), alto ( madre residente per 1-4 anni nella zona contaminata nei 5 anni anni prima del parto), intermedio(la madre aveva un indirizzo di residenza a Ronneby nella zona non contaminata da uno a cinque anni, durante i cinque anni prima del parto) e di fondo (madre con indirizzo di residenza a Ronneby, ma che non viveva a Ronneby nei 5 anni prima del parto). Sono stati poi stimati gli hazard ratio (HR) aggiustati per i fattori confondenti (fumo materno, livello di istruzione materna, età materna, reddito). È stato osservato un aumento del rischio di infezioni dell'orecchio (HR 1.28; IC 95% 1.03-1.58) nei bambini con esposizione prenatale molto elevata a PFAS, nonché associazioni suggestive ma non significative con infezioni oculari e del tratto urinario. I bambini con esposizione prenatale intermedia avevano un rischio ridotto di infezioni oculari (HR 0.86; IC 95% 0.77-0.95). Non è stato osservato alcun aumento del rischio di infezioni del tratto respiratorio in nessuna delle categorie di esposizione. Questo studio, il primo a indagare l’associazione tra alti livelli prenatali di PFAS e infezioni comuni diagnosticate in ambito di cure primarie, contribuisce alle crescenti evidenze sulla potenziale immunotossicità dell’ esposizione precoce a queste sostanze. L’ aumento del rischio di otiti e, in modo suggestivo, di infezioni oculari e urinarie, indica che l’ esposizione in utero ai PFAS può tradursi in manifestazioni cliniche, non solo subcliniche. Il lavoro si distingue per l’esposizione ambientale ben documentata, il solido disegno di coorte e l’uso di registri sanitari nazionali affidabili. Tra i limiti, l’assenza di misurazioni individuali dei PFAS, potenziali fattori confondenti e la limitata precisione nella classificazione delle infezioni.
° Ebel M et al: Common infections in children aged 6 months to 7 years after high prenatal exposure to perfluoroalkyl substances from contaminated drinking water in Ronneby, Sweden. Environ Res. 2025 Mar 1;268:120787. doi: 10.1016/j.envres.2025.120787. Epub 2025 Jan 7. PMID: 39788443.
5. Impatto dell'esposizione prenatale alle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sui ritardi dello sviluppo nei bambini di 4 anni: studio giapponese sull'ambiente e l'infanzia L’ esposizione materna a singole sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e alle loro miscele durante la gravidanza può contribuire a ritardi dello sviluppo nei bambini. Questo è stato evidenziato da uno studio di coorte giapponese che ha studiato le correlazioni tra l’ esposizione prenatale a PFAS e cinque domini dello sviluppo nei bambini di 4 anni (comunicazione, motricità grossolana, motricità fine, problem solving, competenze personali-sociali). Il JECS (Japan Environment and Children’s Study) è un’ ampia coorte nazionale giapponese che ha arruolato oltre 100.000 donne in gravidanza tra il 2011 e il 2014. In un sottogruppo di circa 25.000 madri, sono state misurate tramite cromatografia liquida-tandem spettrometria di massa le concentrazioni sieriche di sette PFAS (tra cui PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFDA). Lo sviluppo neuro-motorio-cognitivo dei bambini è stato valutato con il questionario Ages and Stages (ASQ-3) somministrato dai 4 anni di età; il ritardo è stato definito da punteggi inferiori alle soglie standardizzate in uno o più domini. Per le analisi statistiche, sono stati applicati modelli di regressione logistica per le singole PFAS e due tecniche per le miscele: il Weighted Quantile Sum (WQS) e il Bayesian Kernel Machine Regression (BKMR), aggiustando per età materna, livello di istruzione, reddito familiare, abitudine al fumo, età gestazionale alla

nascita, sesso del bambino e altri potenziali confondenti. Questi i principali risultati: Nelle analisi individuali: concentrazioni più elevate di PFNA e PFOS sono risultate associate a una maggiore probabilità di ritardo nei domini comunicazione e motricità fine (OR per raddoppio di PFNA ≈ 1.20; IC 95%: 1.05–1.37; PFOS OR ≈ 1.15; IC 95%: 1.02–1.30). Altre PFAS (PFOA, PFHxS) hanno mostrato effetti meno coerenti. Nelle analisi delle miscele: l’indice di esposizione misto alle PFAS è risultato significativamente correlato a incrementi del rischio di ritardo in comunicazione e problem solving. Nel modello WQS, le sostanze con peso maggiore nell’effetto combinato sono state PFNA e PFDA. Questo studio, basato su un’ampia coorte prospettica, fornisce evidenza che sia l’esposizione materna individuale sia le miscele di PFAS durante la gravidanza possono contribuire a ritardi dello sviluppo nei bambini a 4 anni. Dato il carattere ubiquo e persistente delle PFAS, i risultati sottolineano la necessità di strategie di riduzione dell’esposizione prenatale – ad esempio interventi sui sistemi di approvvigionamento idrico e sui prodotti di consumo – nonché di ulteriori ricerche sui meccanismi tossicologici e sull’effetto di miscele complesse di contaminanti ambientali.
° Itoh M. et al. Impact of prenatal exposure to per-and polyfluoroalkyl substances on developmental delays in 4-year-old children: The Japan Environment and Children’s study. Environment International, 2025, 198: 109434.
6. ▶ Effetti dei “nuovi” PFAS Acido perfluoroesanesolfonico ramificato (PFHxS) e acido perfluoroeptanoico (PFHpA)sul microbiota intestinale e sulla funzione metabolica nei bambini
Recentemente, essendo stato bandito l’utilizzo di alcuni PFAS in considerazione della loro nota tossicità, si è diffuso l’utilizzo di composti alternativi come l'acido perfluoroesanesolfonico (PFHxS) e l'acido perfluoroeptanoico (PFHpA); si tratta di PFAS a catena corta, i cui dati di sicurezza sono scarsi. Questi composti sono stati riscontrati come contaminanti dominanti nei suoli residenziali cinesi e la loro potenziale tossicità è osservata in modelli animali. La sicurezza di queste alternative è ovviamente dubbia, soprattutto sui bambini. Gli autori di questo studio hanno esaminato gli effetti di questi due composti sul microbiota intestinale e sulla funzione metabolica in bambini cinesi di 6-9 anni. Sono stati arruolati 336 bambini che hanno fornito campioni plasmatici e fecali. La composizione del microbiota intestinale è stata valutata attraverso il sequenziamento del gene 16S rRNA, mentre i metaboliti fecali e gli acidi grassi a catena corta (SCFA) sono stati analizzati utilizzando rispettivamente la profilazione metabolomica mirata e la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC). I PFAS nei campioni di plasma sono stati rilevati con la cromatografia liquida ad alte prestazioni e la spettrometria di massa in tandem (UPLC-MS/MS). I risultati hanno rivelato come l'esposizione ai PFHpA abbia ridotto significativamente la diversità e la ricchezza microbica nel microbiota intestinale. Specifici ceppi batterici sono stati associati positivamente o negativamente alle esposizioni a PFHxS e PFHpA ramificati (β = -0.008-0.009, P_fdr = <0.001-0.048); la presenza di Parabacteroides è risultata positivamente correlata con l’ esposizione a PFHxS ramificati e quella di Lachnospiraceae FCS020 negativamente con PFHpA. L'analisi metabolomica ha mostrato che l’ esposizione a PFHxS e PFHpA ramificati è associata a cambiamenti distinti nei profili dei metaboliti fecali dei bambini esposti (β =
-0.182-0.177 P_fdr = 0.015-0.172), in particolare si è evidenziata una riduzione degli acidi grassi e degli aminoacidi. Inoltre, una maggiore esposizione al PFHpA è stata collegata a una riduzione dei profili di metaboliti fecali, come l'acido valerico (β = -0.691 - -0.341, P =0.011-0.030). Questo studio offre nuovi spunti di riflessione sui potenziali effetti avversi dei PFAS utilizzati come alternativi, in particolare dei PFHxS e PFHpA ramificati, sul microbioma intestinale e sulla salute metabolica dei bambini.
° Hong Z, et al. Branched perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) and perfluoroheptanoic acid (PFHpA):’Safer’per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs) alternatives for their effects on gut microbiota and metabolic function in children. Environment International, 2025, 198: 109380.
7. Esposizione materna alle sostanze per e polifluoroalchiliche e risposta ai vaccini contro morbillo e rosolia Alcuni studi hanno evidenziato che le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) possono avere un ruolo immunosoppressivo; tuttavia, la ricerca sull'impatto dell'esposizione ai PFAS sulle risposte anticorpali al vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MPR) è limitata e incoerente. Questo report ha incluso 748 coppie madre-figlio della Boston Birth Cohort: nelle madri sono stati dosati subito dopo il parto 8 composti PFAS, nei bambini è stata valutata la reattività delle IgG a Morbillo (M) e Rosolia (R) tramite prelievi del sangue cordonale e prelievi ematici durante la prima infanzia. Sono poi state valutate le relazioni tra esposizione materna a PFAS e reattività delle IgG per M e R nei bambini. I risultati hanno evidenziato che gli 8 composti PFAS venivano rilevati nel sangue materno tra il 90% e il 100% dei casi. Per quanto riguarda la correlazione tra esposizione a PFAS e reattività anticorpale a Morbillo questo studio ha evidenziato una minor risposta anticorpale in associazione all’ esposizione complessiva a PFAS (ma non per i singoli composti PFAS). In 348 bambini è stata riscontrata una correlazione significativa tra minor risposta anticorpale al vaccino e esposizione materna a 3 composti PFAS (Me-PFOSAAcOH, PFHpS e PFHxS). Queste associazioni sono risultate più evidenti nei bambini di razza nera e nei pretermine. Non sono invece state riscontrate associazioni per quanto riguarda la risposta anticorpale alla Rosolia. In conclusione questo studio prospettico fornisce prove suggestive che l'esposizione materna a PFAS sia associata a una ridotta risposta immunitaria al vaccino contro il Morbillo, in particolare tra i bambini di razza nera e nei pretermine.
° Hong X, et al. Maternal exposure to per-and polyfluoroalkyl substances and epitope level antibody response to vaccines against measles and rubella in children from the Boston birth cohort. Environment international, 2025, 198: 109433
8. Esposizione prenatale ai metalli pesanti e malattie atopiche dell'infanzia
Questo studio, condotto all’interno della coorte francese ELFE, esplora la relazione tra l'esposizione prenatale a undici metalli pesanti e lo sviluppo di malattie atopiche (come asma, eczema, rinite allergica e allergie alimentari) nei bambini fino ai 5 anni di età. Lo studio parte dall’ipotesi che l’ esposizione prenatale a metalli pesanti – alcuni dei quali noti per la loro tossicità immunitaria – possa influenzare il rischio di sviluppare queste condizioni. L’ obiettivo dello studio è infatti quello di valutare l'associazione

tra i livelli di metalli pesanti rilevati alla nascita (in urina materna, capelli materni o sangue del cordone ombelicale) e i modelli di malattie atopiche nei bambini. Sono stati analizzati campioni di urina, capelli e sangue del cordone ombelicale di oltre 3.000 madri e neonati. I dati sulle malattie atopiche dei bambini sono stati raccolti tramite interviste telefoniche periodiche ai genitori. I ricercatori hanno classificato i bambini in cinque “cluster” di multimorbidità atopica, come “asintomatici”, “respiro sibiliante precoce senza asma” “solo asma”, “solo allergie” o “multimorbidità”. Si è evidenziato che il cobalto (Co) è associato a un rischio minore di multimorbidità atopica, in particolare nei maschi. Il cesio (Cs) e lo stagno (Sn) sono correlati a una minore incidenza di asma precoce e multimorbidità nei maschi. Il cromo (Cr) ed il mercurio (Hg) mostrano tendenze protettive, ma meno evidenti. Il cadmio (Cd) e l’ antimonio (Sb) al contrario, sono associati a un rischio maggiore di rinite ed eczema, soprattutto nelle femmine o nei bambini con familiarità per allergie. Curiosamente, l’ esposizione a metalli noti come tossici, come piombo (Pb), arsenico (As), nichel (Ni) e vanadio (V), non ha mostrato associazioni significative con lo sviluppo delle patologie atopiche. In conclusione, i risultati suggeriscono che non tutti i metalli hanno lo stesso impatto sul sistema immunitario fetale e che il sesso del bambino potrebbe giocare un ruolo chiave. L’ esposizione prenatale a determinati metalli può influenzare lo sviluppo di malattie atopiche nell’infanzia, ma gli effetti variano in base al sesso e alla storia familiare di allergie. Queste scoperte aprono la strada a nuove ricerche per prevenire le malattie allergiche fin dalla vita intrauterina. Tra i punti di forza: misurazioni biologiche precise, disegno prospettico e analisi multivariata solida. I principali limiti riguardano la non rappresentatività del campione, la possibile misclassificazione degli esiti riferiti dai genitori e la dimensione relativamente ridotta per analisi stratificate. Le associazioni osservate sono deboli e non conclusive, ma suggeriscono la necessità di ulteriori studi.
° Dow C et al: Prenatal exposure to heavy metals and childhood atopic disease. Environ Res. 2025 Apr 1;270:121062. doi: 10.1016/j.envres.2025.121062. Epub 2025 Feb 6. PMID: 39920965.
Ambienti naturali
1. Effetti delle passeggiate all'aria aperta e del “portare i piccoli” sugli outcomes comportamentali e adrenocorticali nelle madri e nei neonati
Lo studio evidenzia i potenziali benefici della camminata all'aria aperta in un ambiente verde naturale e del trasporto dei neonati con fasce o marsupi sui livelli di stress e sul sonno dei neonati, nonché sui livelli di stress e sull’ energia delle madri. Le ricerche condotte ad oggi su bambini in età scolare dimostrano gli effetti positivi delle passeggiate all'aria aperta sull'autoregolazione comportamentale. Inoltre, diversi studi riportano una riduzione dello stress sui neonati e sulle madri che stanno a contatto. Ad oggi però nessuno studio ha valutato i possibili effetti benefici per mamme e neonati di una passeggiata all'aria aperta portando i piccoli (con fasce o marsupi). Questo studio ha valutato gli effetti di una passeggiata di 30 minuti in un ambiente verde all'aperto (rispetto alla permanenza in casa) e del contatto portando i piccoli con fasce o marsupi (rispetto all'uso di una carrozzina)
su 101 neonati (N = 101, 0-5 mesi) e sulle loro madri. Sono stati esaminati gli effetti sul cortisolo e sul sonno del neonato, sul cortisolo e sull'umore materno e sulla sincronia adrenocorticale madre-neonato. Le diadi madre-neonato sono state randomizzate a una delle quattro condizioni: camminare in un ambiente verde all'aperto con il bambino in una carrozzina o in un marsupio, oppure stare in casa con il bambino in una carrozzina o in un marsupio. Le madri hanno descritto il sonno del bambino e l'umore materno nei minuti successivi alle condizioni analizzate attraverso la “Global Vigor and Affect Scale” (GVAS) (uno strumento psicometrico che misura lo stato d’animo e il livello di energia percepiti in un dato momento, utilizzando scale analogiche visive da 0 a 100). I livelli di cortisolo della madre e del bambino sono stati determinati attraverso cinque campioni di saliva prelevati durante l'esperimento. I risultati hanno evidenziato come i neonati portati all'aperto in un marsupio o in una carrozzina abbiano dormito più a lungo di quelli che sono rimasti in casa in una carrozzina. Al contrario, le madri che rimanevano in casa mostravano una maggiore diminuzione delle concentrazioni di cortisolo rispetto alle madri che camminavano all'aperto. Rispetto alle madri che tenevano il bambino in carrozzina, le madri che portavano il bambino (anche in braccio) hanno mostrato una maggiore diminuzione delle concentrazioni di cortisolo. Non è emersa invece alcuna differenza nella sincronia adrenocorticale madre-neonato tra le condizioni analizzate. In sintesi il trasporto in fascia o marsupio riduce lo stress (in base ai valori di cortisolo) sia nei neonati che nelle madri. La camminata all'aperto è benefica per il sonno dei neonati e per mantenere alta l’ energia nelle madri. Studi futuri potrebbero valutare i potenziali effetti di portare a spasso i bambini in ambienti naturali rispetto a quelli urbani, di utilizzare carrozzine o marsupi che offrono una maggiore visibilità e di portare a spasso i bambini con regolarità per un periodo di tempo più lungo. Ciò potrebbe contribuire a motivare i caregiver a implementare le passeggiate all'aperto nella loro routine quotidiana. Questi risultati forniscono inoltre importanti indicazioni per la progettazione di politiche di salute pubblica che possano facilitare la possibilità di trascorrere tempo all'aperto per le famiglie e i bambini (come il prolungamento dei congedi materni post-partum, e l’inserimento della pratica del “portare” nei protocolli post nascita). Lo studio si distingue per il disegno sperimentale rigoroso e per l’uso di misure oggettive (cortisolo salivare) che rafforzano la validità dei risultati. L’ approccio integrato, che include anche sonno e umore materno, offre indicazioni utili per promuovere pratiche quotidiane benefiche nel post-partum. Tuttavia, il protocollo di stress non ha suscitato un aumento significativo del cortisolo nei neonati, inoltre il campione è poco eterogeneo, la breve durata dell’intervento e la misura soggettiva del sonno rappresentano ulteriori limiti alla generalizzabilità e solidità delle conclusioni.
° Nicole Rheinheimer et al: Effects of outdoor walking and infant carrying on behavioral and adrenocortical outcomes in mothers and infants, Journal of Environmental Psychology, Volume 102, 2025, 102527, ISSN 0272-4944.

1. Tutto è connesso: richiami al senso di connessione con la natura e con gli altri rafforzano le attitudini ambientali Lo studio suggerisce che le campagne educative e comunicative che attivano un senso di appartenenza a un tutto interconnesso possono rafforzare le norme morali pro-ambientali, soprattutto in soggetti inizialmente meno sensibili. Gli autori hanno indagato l’ efficacia di brevi richiami testuali alla connessione ambientale e sociale nel rafforzare gli atteggiamenti pro ambiente. In due studi sperimentali su larga scala (N = 774; N = 854), integrati da due studi pilota, i partecipanti (reclutati online tramite la piattaforma Prolific) sono stati esposti a vignette che evocavano l’interconnessione tra esseri viventi (condizione ambientale), tra esseri umani (condizione sociale) o testi neutri (descrizione di edifici o di sistemi meccanici). Le attitudini ambientali sono state valutate tramite le scale di Environmental Concern e Awareness of Consequences, articolate in dimensioni biosferiche, sociali ed egoistiche, in accordo con il modello Value-Belief-Norm. Environmental Concern (Scala della Preoccupazione Ambientale) e Awareness of Consequences (scala della Consapevolezza delle Conseguenze Ambientali) sono strumenti psicometrici consolidati per misurare le attitudini ambientali, sviluppati nell’ambito del modello Value-Belief-Norm (VBN) (Modello dei Valori, delle Credenze e delle Norme personali). La scala della preoccupazione ambientale misura il grado di preoccupazione che una persona prova per i problemi ambientali, in funzione del tipo di oggetto di valore minacciato: che può essere una preoccupazione per piante, animali o ecosistemi (preoccupazione per la biosfera) o per l’impatto sulle comunità e le generazioni future (preoccupazione sociale altruistica) o sulla propria salute e sul proprio stile di vita (preoccupazione egoistica). La scala della consapevolezza delle conseguenze ambientali misura la consapevolezza dell’individuo circa le conseguenze ambientali negative delle azioni umane sull’ambiente naturale (consapevolezza della biosfera), sulle conseguenze per le persone in generale (consapevolezza sociale) e sulle conseguenze su sé stessi o la propria famiglia (consapevolezza egoistica). I risultati mostrano che l’ effetto dei richiami è maggiore tra coloro che normalmente non si sentono connessi alla natura o agli altri. L’effetto è stato più marcato per la preoccupazione biosferica, ma si estende anche alla consapevolezza delle conseguenze sociali e all’interesse egoistico. Il meccanismo proposto è che il richiamo attiva una consapevolezza nuova del fatto che le proprie azioni hanno conseguenze sugli altri esseri umani e sugli ecosistemi. Questa nuova consapevolezza attiva norme morali personali e rafforza le attitudini pro-ambientali, secondo il modello Value-Belief-Norm (VBN). Nessun effetto è stato rilevato tra i soggetti con alti livelli preesistenti di connessione, suggerendo che tali interventi hanno maggiore impatto su chi parte da una condizione di disconnessione. Lo studio fornisce evidenza sperimentale del potenziale trasformativo di semplici interventi testuali nel promuovere l’impegno ambientale, evidenziando il ruolo sinergico della connettività ambientale e sociale ovvero il sentirsi parte della natura e della comunità umana. I risultati suggeriscono che le campagne educative e comunicative che attivano un senso di appartenenza a un tutto interconnesso possono rafforzare le norme morali pro-ambientali, soprattutto in soggetti inizialmente meno sensibili. Lo studio presenta una solida base teorica ed un design sperimentale robusto, ma pre-
senta il limite della non rappresentatività del campione e del fatto che le misure sono auto-riferite, inoltre lo studio non ha testato l’ efficacia dell’ intervento nel promuovere il cambiamento reale, e non solo nelle intenzioni; infine non indaga eventuali differenze di genere nelle attitudini ambientali o nella risposta ai richiami alla connessione. Questo rappresenta un aspetto potenzialmente rilevante da approfondire in ricerche future.
° Marianna Drosinou et al: Everything is connected: Reminders of environmental and social connectedness strengthen environmental attitudes,Journal of Environmental Psychology,Volume 102,2025,102549,ISSN 0272-4944.

Faverio P, Franco G, Landoni V, et al.
Diagnostic management of pediatric bronchiectasis: a literature review and clinical examples
Respiration. Published online April 24, 2025. doi:10.1159/000546030
Le bronchiectasie rappresentano una condizione cronica infiammatoria delle vie aeree, caratterizzate dalla dilatazione irreversibile delle pareti bronchiali e infezioni respiratorie ricorrenti. In età pediatrica, costituiscono un’ entità ancora sottostimata, con diagnosi spesso tardive e approcci gestionali eterogenei e non uniformi. Riportiamo una recente revisione della letteratura, arricchita da alcuni casi clinici rappresentativi, che offre un aggiornamento completo e dettagliato sul percorso diagnostico, sulle comorbidità e sulle attuali strategie di gestione delle bronchiectasie in età pediatrica.
Pediatric bronchiectasis: how early suspicion can influence disease outcome
Bronchiectasis is a chronic inflammatory airway condition characterized by irreversible bronchial wall dilatation and recurrent respiratory infections. In the pediatric population, it remains an underestimated entity, often associated with delayed diagnosis and heterogeneous, non-standardized management approaches. We report a recent literature review, enriched by representative clinical cases, which provides a comprehensive and detailed update on the diagnostic pathway, associated comorbidities and current management strategies of pediatric bronchiectasis.
Le bronchiectasie rappresentano una condizione polmonare cronica, caratterizzate da dilatazione bronchiale, un’ eccessiva produzione di muco e da frequenti esacerbazioni di natura infettiva. Si tratta di una patologia sottostimata, tutt’ altro che rara, con recenti dati epidemiologici che ne sottolineano l’ aumento di prevalenza nei paesi sviluppati, con il relativo aumento della spesa sanitaria, anche come conseguenza del miglioramento delle tecniche diagnostiche e dell’ aumento della sopravvivenza dei bambini con patologie croniche predisponenti. Soprattutto nei casi non correlati alla fibrosi cistica, la patologia resta largamente sottostimata, sia per l’ eterogeneità clinica che per la tendenza a trattare i sintomi persistenti, soprattutto la tosse cronica, con approcci sintomatici e terapie antibiotiche, spesso trascurando gli adeguati approfondimenti diagnostici [1-3]
Dal sospetto clinico alla diagnosi
Il lavoro di Faverio et al.[4] offre un interessante spunto di riflessione sull’importanza di riconoscere i sintomi cardine e i segnali di allarme che devono porre il sospetto di bronchiectasie e avviare così un adeguato iter diagnostico. In presenza di tosse cronica produttiva (durata > 4 settimane), tosse che non risponde a 4
Rubrica L’ articolodelmese
Commento di Francesco Accomando U.O. Pediatria, Ospedale G.B. Morgagni – L. Pierantoni
AUSL Romagna, Forlì
settimane di antibiotici orali o una bronchite batterica protratta ricorrente (>3 episodi/anno) è essenziale una valutazione approfondita. L’ eterogeneità clinica è tale che solo in alcuni casi, in presenza di patologia avanzata, si possano manifestare segni come emottisi, ippocratismo digitale, polmoniti ricorrenti, dolore toracico, dispnea e alterazioni nella crescita. Nel sospetto di bronchiectasie, è indispensabile una valutazione radiologica: il gold standard per la diagnosi è la TC ad alta risoluzione del torace (HRCT). Secondo le linee guida della ERS (European Respiratory Society) [5], nei bambini e adolescenti dovrebbe essere eseguita una TC multidetettore (MDCT) ad alta risoluzione (HRCT), anziché la sola HRCT convenzionale. La MDCT consente di acquisire più sezioni contemporaneamente grazie all’utilizzo di un sistema di acquisizione più avanzato rispetto alle tecniche CT tradizionali. L’utilizzo di questa metodica permette di ottenere immagini di qualità migliore con una sensibilità più alta nella individuazione delle bronchiectasie. La caratteristica principale delle bronchiectasie alla TC è l’aumento del rapporto bronco-arterioso (BAR), definito come il rapporto tra il diametro interno della via aerea e il diametro esterno dell’ arteria adiacente, con un rapporto diagnostico che nel bambino è superiore a 0,8. Gli altri segni alla TC includono ispessimento delle pareti bronchiali, assenza di assottigliamento bronchiale (dalla zona centrale alla periferia) con il tipico aspetto a “binario”, presenza di strutture bronchiali evidenti nelle porzioni polmonari più distali, ostruzione da muco e perfusione a mosaico che riflette l’intrappolamento dell’aria.
Dalla diagnosi eziologica alla valutazione delle comorbilità Le cause di bronchiectasie nei bambini sono molto eterogenee e comprendono principalmente condizioni post-infettive (es.: H. influenzae, B. pertussis, morbillo, adenovirus, M. pneumoniae, tubercolosi e micobatteri), ostruzione bronchiale (es. inalazione di corpi estranei), immunodeficienze, condizioni associate a compromissione della clearance mucociliare (es. fibrosi cistica, discinesia ciliare primitiva) e malformazioni congenite delle vie aeree (es. tracheomalacia o broncomalacia). Una condizione da considerare con attenzione è quella dei bambini con grave patologia neurologica (es.: paralisi cerebrale infantile), nei quali l’inefficacia della tosse e la ridotta clearance delle secrezioni possono favorire la recidivanza di episodi infettivi e l’ eventuale danno da inalazione alimentare. Le linee guida ERS [5] e quelle australiane (Thoracic Society of Australia and New Zealand) [6] raccomandano un pannello minimo di esami per la diagnosi, la ricerca eziologica, la valutazione della gravità e la necessità di trattamento delle bronchiectasie (Figura 1). Sono indicate: le

Figura 1. Principali test diagnostici per bambini e adolescenti con bronchiectasie, mod. Faverio et al. [4]
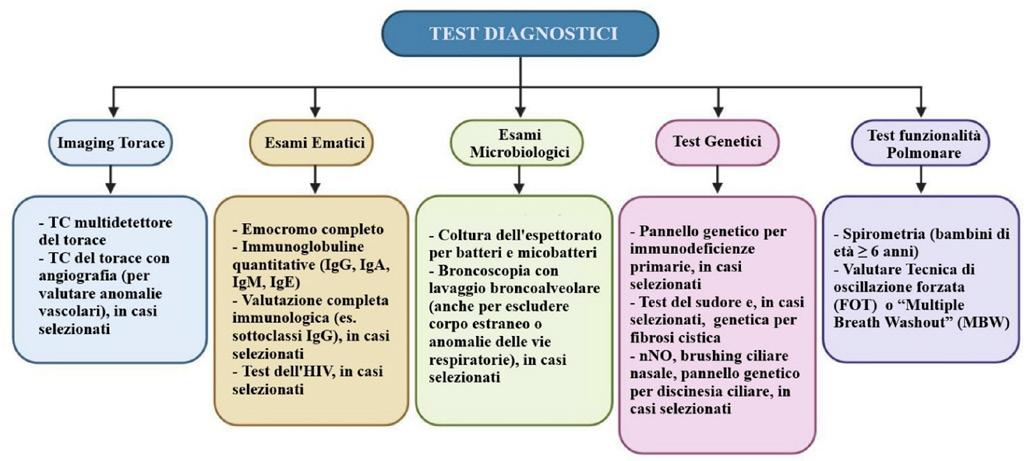
prove di funzionalità respiratoria (spesso si osserva un quadro ostruttivo), la valutazione dell’ assetto immunologico, test del sudore e indagini genetiche per la fibrosi cistica, le indagini funzionali e strutturali per la discinesia ciliare e gli accertamenti nel sospetto di una malattia da reflusso gastroesofageo. Già all’inizio del percorso diagnostico, è importante ottenere un campione di secrezione delle vie aeree inferiori (espettorato), soprattutto nei pazienti con frequenti riacutizzazioni, con l’ obiettivo di guidare la terapia antibiotica e di identificare micobatteriosi non tubercolare o la colonizzazione da P. aeruginosa. La broncoscopia è utile nel sospetto di una pneumopatia localizzata, di alterazioni strutturali delle vie aeree, di inalazione di corpo estraneo o in presenza di una insoddisfacente risposta alla terapia antibiotica. Il liquido di lavaggio broncoalveolare servirà per la citologia e i test microbiologici, fondamentali soprattutto nei soggetti immunocompromessi. Nella Figura 2 sono riportate le più frequenti situazioni cliniche che possono sottendere o essere associate a quadri di bronchiectasie.
Commento
L’ articolo rappresenta un aggiornamento dettagliato e completo sull’ iter diagnostico e sul follow-up delle bronchiectasie in età pediatrica. Il lavoro si inserisce in un contesto in cui le recenti linee guida internazionali (ERS 2021 e TSANZ 2023) cercano di standardizzare la presa in carico e la qualità delle cure di questi pazienti che richiedono un approccio specialistico e multidisciplinare. È di fondamentale importanza mantenere alto il sospetto clinico per la diagnosi precoce, con l’ obiettivo di avviare tempestivamente le strategie diagnostiche e terapeutiche più efficaci, soprattutto nei soggetti a maggiore rischio e nei pazienti che presentano tosse cronica produttiva. Un percorso diagnostico completo, insieme a interventi mirati a favorire la clearance delle vie aeree, ovvero l’uso tempestivo di antibiotici durante le riacutizzazioni e la correzione delle anomalie congenite delle vie respiratorie, possono prevenire l’ aggravamento della malattia e, di conseguenza, il peggioramento della qualità di vita del paziente. Un altro aspetto importante, evidenziato in questo lavoro, riguarda la prevenzione e la possibile “reversibilità” delle bronchiectasie, in particolare se trattate precocemente. Questa evenienza entrerebbe in contrasto con la definizione stessa di bronchiectasia (dilatazione irreversibile di un tratto delle vie aeree) ma secondo recenti studi, come quello di Mills et al. [7], citato nel manoscritto, i quadri meno gravi di bronchiectasie possono risolversi con un adeguato trattamento, soprattutto nei bambini più piccoli e in assenza di colonizzazione da pseudomonas. In tutti i casi,
Figura 2. Maggiori comorbidità di bambini e adolescenti con bronchiectasie, mod. Faverio et al. [4]. ORL: otorinolaringoiatrica; MRGE: malattia da reflusso gastro-esofageo
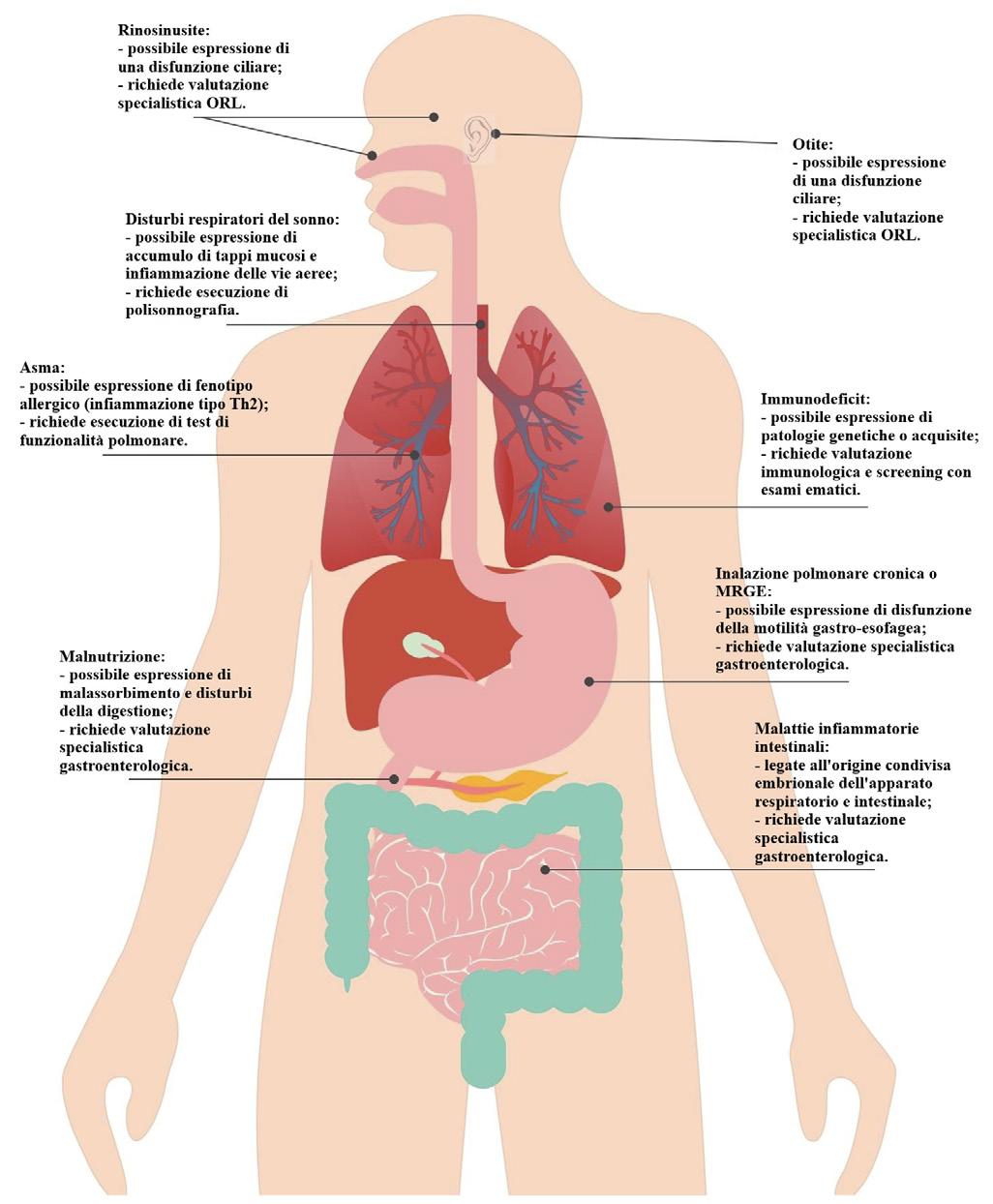
mantengono la loro validità le raccomandazioni di prevenzione (allattamento al seno, vaccinazioni, riduzione dell’ esposizione ad inquinanti e al fumo di tabacco) e di trattamento efficace delle polmoniti, delle bronchiti batteriche croniche ricorrenti e dei disordini primitivi dell’ immunità.
1. Chang AB, Bush A, Grimwood K. Bronchiectasis in children: diagnosis and treatment. The Lancet, Volume 392, Issue 10150, 866 – 879. doi:10.1016/S0140-6736(18)31554-X.
2. Roberts JM, Goyal V, Kularatna S, et al. The Economic Burden of Bronchiectasis: A Systematic Review. Chest. 2023;164(6):1396-1421. doi:10.1016/j.chest.2023.06.040.
3. Nigro M, Laska IF, Traversi L, et al. Epidemiology of bronchiectasis. Eur Respir Rev. 2024;33(174):240091. Published 2024 Oct 9. doi:10.1183/16000617.0091-2024.
4. Faverio P, Franco G, Landoni V, et al. Diagnostic management of pediatric bronchiectasis: a literature review and clinical examples. Respiration. Published online April 24, 2025. doi:10.1159/000546030.
5. Chang AB, Fortescue R, Grimwood K, et al. European Respiratory Society guidelines for the management of children and adolescents with bronchiectasis. Eur Respir J. 2021;58(2):2002990. Published 2021 Aug 26. doi:10.1183/13993003.02990-2020.
6. Chang AB, Bell SC, Byrnes CA, et al. Thoracic Society of Australia and New Zealand (TSANZ) position statement on chronic suppurative lung disease and bronchiectasis in children, adolescents and adults in Australia and New Zealand. Respirology. 2023;28(4):339-349. doi:10.1111/ resp.14479.
7. Mills DR, Masters IB, Yerkovich ST, et al. Radiographic Outcomes in Pediatric Bronchiectasis and Factors Associated with Reversibility. Am J Respir Crit Care Med. 2024;210(1):97-107. doi:10.1164/rccm.202402-0411OC.

A cura di Sergio Conti Nibali Gruppo ACP "Nutrizione"
Prosegue in questo numero la rubrica sulla nutrizione pediatrica curata del gruppo nutrizione dell’ Associazione Culturale Pediatri. Il gruppo sorveglia 37 riviste scientifiche internazionali tra le più qualificate in base a criteri EBM, per diffondere i risultati degli articoli più rilevanti in materia di nutrizione infantile. Su queste pagine verranno riassunti sinteticamente i principali articoli pubblicati nelle riviste monitorate. Tutti gli articoli e gli editoriali pubblicati e ritenuti degni di attenzione vengono elencati divisi per argomento, con un sintetico commento. Questo numero si basa sul controllo sistematico delle pubblicazioni di aprile e maggio 2025. La gran parte degli articoli selezionati in questo numero richiama, ancora una volta, l’attenzione di noi pediatri sull’importanza che riveste la nutrizione nella prevenzione di numerose malattie non trasmissibili e ci sollecita a intraprendere iniziative di advocacy per difendere i nostri bambini e le loro famiglie dai rischi di un’alimentazione inadeguata. Speriamo che il servizio che possa risultare utile ai lettori di Quaderni acp.
The section on pediatric nutrition edited by the Nutrition Group of the Associazione Culturale Pediatri continues in this issue. The group monitors 37 of the most highly qualified international scientific journals based on EBM criteria to disseminate the results of the most relevant articles on pediatric nutrition. On these pages, the main articles published in the monitored journals will be summarized briefly. All articles and editorials published and deemed worthy of attention are listed divided by topic, with a brief commentary. This issue is based on the systematic monitoring of publications for April and May 2025. The majority of the articles selected in this issue once again call the attention of us pediatricians to the importance of nutrition in the prevention of many noncommunicable diseases and urge us to undertake advocacy initiatives to defend our children and their families from the risks of inadequate nutrition. We hope that the service that may be useful to the readers of Quaderni acp.

:: Allattamento
1. Allattamento nei paesi dell’Africa sub-Sahariana
2. Supporto all’allattamento fornito dai consulenti per l’allattamento: una revisione sistematica e meta-analisi
3. Implicazioni delle variazioni nella concentrazione del latte umano durante i primi sei mesi di vita?
4. Associazione del consumo materno di alimenti ultra-processati con le pratiche alimentari e la malnutrizione nei bambini allattati: uno studio trasversale
5. Allattamento e sovrappeso: modelli di crescita e rischi associati, uno studio di coorte
:: Prematurità
1. Confronto dell'effetto dell'odore del latte materno, del tucking* facilitato e della suzione non nutritiva applicati ai neonati prematuri durante l'iniezione al tallone sul dolore e sui parametri fisiologici: uno studio randomizzato controllato
2. Effetto della posizione e del tipo di alimentazione sulla salute digestiva: uno studio retrospettivo randomizzato controllato sulle coliche nei neonati pretermine
3. Associazioni tra crescita e composizione corporea infantile in bambini very preterm, late preterm e a termine
:: Obesità
1. Associazione tra oligosaccaridi del latte umano e il recupero precoce dell'adiposità nei bambini: uno studio caso-controllo del Tohoku Medical Megabank Project Birth e Three-Generation Cohort Study
2. Le esperienze genitoriali nella gestione dell'obesità dei figli presso l'ospedale pediatrico di Reunion Island
3. Obesità e sovrappeso infantili sono associati a un maggior rischio di stress percepito e scarsa qualità del sonno: uno studio trasversale su bambini di età compresa tra 6 e 9 anni
:: Modelli alimentari
1. Seminare i semi del gusto? Un nuovo approccio per investigare l'impatto dell'esposizione precoce al dolce sui modelli alimentari gustativi dei bambini da 12 a 36 mesi
2. Esplorare la fattibilità dell'uso dei dati sugli acquisti alimentari scolastici come metodo per valutare l'assunzione alimentare negli studenti delle scuole secondarie
3. Dieta, abitudini alimentari e fattori legati allo stile di vita associati ad un’adeguata durata del sonno in bambini e adolescenti residenti in 5 Paesi del Mediterraneo: il progetto DELICIOUS
4. Il consumo precoce di bevande a base di latte e cereali, correla con il rapido aumento del peso e adiposità precoce, ma non con il sovrappeso e l’obesità nelle età successive
5. Consumo di frutta e verdura tra gli studenti delle scuole secondarie adolescenti a Boukombe e Natitingou, Nord Benin
6. Il ruolo dei pasti in famiglia e del comportamento alimentare sociale in relazione all’evitamento esperienziali negli adolescenti spagnoli
:: Marketing
1. Gran Bretagna: esposizione al marketing della formula e credenze tra donne in gravidanza e madri
2. Messico: sviluppo e implementazione di un’applicazione per monitorare le violazioni del Codice Internazionale
3. Hong Kong: analisi delle strategie di marketing digitale da parte delle ditte di formula
4. L'impatto della pubblicità di marca sulle preferenze alimentari e sulle intenzioni comportamentali dei bambini: uno studio sperimentale
5. Pubblicità di cibi e bevande lungo i percorsi di trasporto scolastici dei bambini a Victoria, Australia e implicazioni politiche
6. Gran Bretagna: valutazione di un programma scolastico per aumentare le
competenze nutrizionali e le abilità culinarie degli alunni
7. Determinanti commerciali della salute: un’analisi degli ambienti alimentari negli ospedali pubblici per bambini e giovani nei paesi ad alto reddito: dobbiamo riorganizzare le Priorità della Salute
8. Aziende di formule artificiali ed allergologi in India
:: Miscellanea
1. Prevalenza globale dei disturbi alimentari nei bambini: una revisione sistematica e meta-analisi completa
2. Efficacia di un intervento basato sulla teoria cognitivo-sociale e sulla teoria dei sistemi familiari nel migliorare i comportamenti alimentari nei bambini in età prescolare
3. I latticini a basso contenuto di grassi sono una raccomandazione appropriata per i bambini?
4. Australia e Nuova Zelanda: nasce un’alleanza per l’alimentazione dei bambini
5. Saltare la colazione e rendimento scolastico tra gli 8 e i 16 anni: uno studio di popolazione nell’Australia Meridionale
6. Assunzione di iodio in un campione di coppie madre/lattante a 6-12 mesi dalla nascita
7. Lezioni basate sull'evidenza da due decenni di ricerca sull'implementazione di programmi di alimentazione complementare
8. Un punteggio dietetico infantile basato sulla documentazione sanitaria è associato all'IMC: (Indice di Massa Corporea): uno studio di coorte madre-bambino a livello nazionale in Islanda (ICE-MCH)
9. Le associazioni tra tratti della personalità, auto efficacia e comportamento nell’alimentazione complementare tra i caregivers di lattanti nella Cina rurale occidentale
10. Vie infiammatorie intestino–cervello nel disturbo da deficit di attenzione/ iperattività: ruolo e potenziale terapeutico della dieta
11. Introiti di sodio e potassio: una revisione sistematica della letteratura
12. Profili nutrizionali in una popolazione di bambini australiani: uno studio di coorte longitudinale

Riviste monitorate
Acta Paediatrica
American Journal of Clinical Nutrition
.. Archives of Diseases in Childhood
Birth
Breastfeeding Medicine
Early Human Development
European Journal of Clinical Nutrition
.. European Journal of Nutrition
European Journal of Epidemiology
Food Policy
Frontiers in Nutrition
International Breastfeeding Journal
.. International Journal of Environmental Research and Public Health
International Journal of Epidemiology
The Italian Journal of Paeditrics
JAMA
JAMA Pediatrics
Journal of Epidemiology and Community Health
Journal of Pediatrics
Journal of Perinatology
Journal of Human Lactation
Journal of Nutrition
Journal of Public Health
Maternal and Child Health Journal
Maternal and Child Nutrition
Metabolites
New England Journal of Medicine
Nutrients Pediatrics
Plos Medicine
PLOS One
Public Health Nutrition
The Lancet
Revisione delle riviste e testi a cura di:
Roberta Bosi, Ivana Bringheli, Giovanni Cacciaguerra, Natalia Camarda, Adriano Cattaneo, Angela Cazzuffi, Margherita Cendon, Nicoletta Cresta, Samuel Dallarovere, Giulia D'Arrigo, Cristina Di Berardino, Monica Ghezzi, Antonella Lavagetto, Stella Lonardi, Alice Marzatico, Samantha Mazzilli, Lorenzo Mottola, Maria Napoleone, Angela Pasinato, Ilaria Polenzani, Giuseppina Ragni, Gherardo Rapisardi, Annamaria Sapuppo, Vittorio Scoppola, Silvia Triarico, Alessandra Turconi, Rosanna Vit.
Allattamento
1. Allattamento nei paesi dell’Africa sub-Sahariana Molti sono portati a pensare che nei paesi a basso reddito, e in particolare in quelli dell’ Africa sub-Sahariana, tassi e durata dell’allattamento siano superiori alla media globale, in ragione del fatto che una popolazione prevalentemente rurale non sarebbe ancora stata raggiunta dalle pratiche commerciali dei paesi ad alto reddito. Si tratta di una supposizione errata, come dimostrano i risultati di una meta-analisi sui dati di 6 coorti, per un totale di quasi 12mila bambini seguiti dalla nascita per almeno un anno, studiate in Etiopia, Malawi, Uganda e Zambia in anni che vanno dal 2000 al 2021. Quasi tutti questi bambini sono stati allattati, ma l’inizio precoce (entro un’ora) va dal 63% al 67%, l’allattamento esclusivo per 6 mesi varia tra 40% e 67%, mentre quello continuato a 12 mesi di età o più va dal 65% dello Zambia al 99% del Malawi. Molto interessante l’analisi per livello socioeconomico: né il grado di istruzione materna (nessuna, primaria,
secondaria, terziaria) né il reddito della famiglia (basso, medio, alto) sembrano associati a differenze significative nei vari indicatori studiati (qualsiasi allattamento, inizio precoce, allattamento esclusivo a 4-6 mesi e continuato a 12 mesi o più) anche dopo aggiustamento per diversi potenziali fattori di confusione. Se in questi paesi, o meglio nelle coorti dello studio, esiste una cultura dell’allattamento, questa sembra essere uniformemente distribuita tra classi sociali e in differenti contesti urbani e rurali, contrariamente alle evidenti differenze per livello di istruzione materna e classe sociale che si osservano nei paesi ad alto reddito come il nostro. Risultati simili, se non peggiori, sono riportati da una revisione sistematica con meta-analisi di dati dai paesi anglofoni e francofono dell’ Africa occidentale. Il valore medio dell’inizio precoce dell’ allattamento era del 51.7% nei primi e del 45.5% nei secondi. Per l’ allattamento esclusivo nei primi 6 mesi, le prevalenze erano del 41.2% e 30.1%, rispettivamente.
° Mohammed S et al. Socioeconomic pattern of breastfeeding in sub-Saharan Africa: an individual participant data meta-analysis of six longitudinal cohorts. BMJ Public Health 2025;3:e001298
° Lewis‐Koku MO et al. Early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding in anglophone and francophone West African countries: systematic review and meta‐analysis of prevalence. Matern Child Nutr 2025;21:e13792
2. Supporto all’ allattamento fornito dai consulenti per l’allattamento: una revisione sistematica e meta-analisi In questa revisione sistematica e meta-analisi di 40 studi clinici randomizzati per valutare l'effetto degli interventi dei consulenti per l’allattamento (LC) sull’allattamento, sull’autoefficacia materna nell’allattamento e sulla crescita del neonato rispetto alla cura abituale. Sono stati consultati il Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, Embase, CINAHL, Scopus, Web of Science e la letteratura grigia per articoli pubblicati tra gennaio 1985 e luglio 2024. La ricerca è stata effettuata il 10 luglio 2024 e l’analisi dei dati è stata condotta tra luglio e agosto 2024. Sono stati inclusi studi clinici randomizzati sugli interventi di consulenti per l’ allattamento svolti in paesi ad alto reddito, pubblicati in qualsiasi lingua. Sono stati identificati 6.476 articoli, di cui 40 studi inclusi con un totale di 8.582 partecipanti. Gli studi sono stati pubblicati tra il 1992 e il 2024, con la maggior parte (n = 22) condotti negli Stati Uniti. Rispetto alla cura abituale, gli interventi dei consulenti per l’allattamento hanno ridotto il rischio di interruzione dell'allattamento esclusivo e di qualsiasi tipo di allattamento rispettivamente del 4% e dell'8% e hanno aumentato la durata di qualsiasi allattamento di 3.63 settimane. Vi erano prove deboli che tali interventi aumentassero la durata dell’ allattamento esclusivo (differenza media [MD], 1.44 settimane; IC 95%, −2.73 a 5.60), l’ autoefficacia materna (MD, 2.83; IC 95%, −1.23 a 6.90), o il rischio di sovrappeso e obesità infantile (RR, 1.52; IC 95%, 0.94-2.46). La meta-regressione ha mostrato che gli interventi dei consulenti erano più efficaci nel ridurre il rischio di interruzione dell’ allattamento esclusivo (P = .01) e di qualsiasi allattamento (P < .001) se misurati più precocemente nel periodo post-partum. Gli interventi con maggiore intensità (cioè un numero maggiore di visite del consulente) erano più efficaci nel ridurre il rischio di interruzione di qualsiasi allattamento (P = .04). Secondo questa revisione sistematica e meta-analisi, gli interventi dei consulenti per l’ allattamento rappresentano un

approccio promettente per migliorare l’ allattamento esclusivo e qualsiasi tipo di allattamento nei paesi ad alto reddito.
° D’Hollander CJ, et al. Breastfeeding Support Provided by Lactation Consultants: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Pediatr. 2025;179(5):508–520. doi:10.1001/jamapediatrics.2024.6810
3. Implicazioni delle variazioni nella concentrazione del latte umano durante i primi sei mesi di vita?
L’ articolo esplora le variazioni nella concentrazione delle principali proteine del latte umano durante i primi sei mesi di allattamento e il loro impatto sulla crescita infantile. Lo studio ha coinvolto 105 madri e i loro bambini a termine in Cina, con campioni di latte raccolti a 1–5 giorni, 8–14 giorni, 1 mese e 6 mesi dopo il parto. Le concentrazioni di proteine come α-lattalbumina, lattoferrina, osteopontina, caseina totale e frazioni di caseina (β-caseina, αs-1 caseina, κ-caseina) sono state misurate utilizzando tecniche avanzate di cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa. I risultati hanno mostrato una diminuzione significativa delle concentrazioni di tutte le proteine misurate nel latte durante i primi sei mesi di allattamento (p-trend < 0.001). Fattori materni come età, livello di istruzione, reddito e modalità di parto hanno influenzato queste variazioni longitudinali (p-interazione < 0.05). In particolare, le concentrazioni di αs-1 caseina nel latte sono risultate inversamente correlate con i punteggi Z del peso per età dei bambini sia a 1 mese (r = −0.29, p = 0.038) che a 6 mesi (r = −0.33, p = 0.020). In sintesi, lo studio evidenzia che la composizione proteica del latte umano cambia dinamicamente nei primi sei mesi di allattamento e che questi cambiamenti possono influenzare la crescita dei bambini. I fattori materni giocano un ruolo importante in queste variazioni, suggerendo che interventi mirati potrebbero ottimizzare la composizione del latte per supportare meglio la crescita infantile.
° M F Young. Implications of Changes in Human Milk Concentration across the First 6 Months of Life? The Journal of Nutrition, Volume 155, Issue 4, aprile 2025
4. Associazione del consumo materno di alimenti ultra-processati con le pratiche alimentari e la malnutrizione nei bambini allattati: uno studio trasversale Sebbene gli effetti negativi sulla salute legati al consumo di cibi ultra-processati (CUP) siano ben documentati, esistono evidenze limitate sul loro impatto durante l'allattamento. Questo studio ha esaminato l'associazione tra il consumo materno di CUP, le pratiche alimentari e la malnutrizione nei neonati allattati. È stata condotta un'analisi trasversale su 111 coppie madre-bambino fino a 150 giorni dopo il parto. Le pratiche alimentari infantili sono state valutate utilizzando gli indicatori dell'OMS e la malnutrizione è stata valutata in base alla lunghezza e al BMI per età. L'assunzione dietetica materna è stata valutata con due interviste al giorno, e il consumo di CUP è stato classificato secondo la classificazione Nova. Le coppie sono state raggruppate in base al quartile di consumo di CUP più elevato, ed è stata applicata la regressione logistica binaria aggiustata. Gli CUP rappresentavano in media il 26% della dieta materna. Sebbene il 71.2% dei neonati fosse allattato esclusivamente al seno, un terzo era in sovrappeso e l'11.7% era sottopeso. Il consumo elevato di CUP da parte della madre (>32% dell'apporto energetico) era associato
a un aumento delle probabilità di malnutrizione in base al BMI per età (sottopeso o sovrappeso) (OR 3.38; IC 95%: 1.29–8.83) e a scarsa crescita (OR 3.89; IC 95%: 1.04–14.58). Questi risultati evidenziano che il consumo di alimenti ultra-processati da parte della madre, nella popolazione esaminata, è associato a una probabilità di malnutrizione nei neonati allattati, sottolineando la necessità di indicazioni dietetiche durante l'allattamento per migliorare i risultati di salute dei bambini.
° Juliana Morais de Sousa et al. Association of maternal consumption of ultra-processed foods with feeding practices and malnutrition in breastfed infants: a cross-sectional study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2025, 22, 608
5. Allattamento e sovrappeso: modelli di crescita e rischi associati, uno studio di coorte Questo studio longitudinale di coorte condotto su 7.074 neonati in Danimarca ha esaminato l'associazione tra la durata dell'allattamento al seno esclusivo, i modelli di crescita infantile e il rischio di sovrappeso tra i 5 e i 9 anni. Sono stati identificati tre modelli di crescita infantile: media (51%), accelerata (8%) e decelerata (41%). La durata dell'allattamento esclusivo è stata raggruppata in mai, <4 mesi e >4 mesi. Una maggiore durata dell'allattamento esclusivo è stata associata a un minor rischio di sovrappeso infantile. Un ritmo di crescita accelerata è stato associato a un rischio aumentato di sovrappeso infantile, mentre un modello di crescita decelerata è risultata protettiva o non associata a rischio. Nell'analisi combinata, i bambini con crescita accelerata che non sono mai stati allattati presentavano il rischio più elevato di sovrappeso. Tuttavia, la crescita accelerata non mostrava evidenza di essere associata a sovrappeso se i neonati erano stati allattati esclusivamente al seno per più di 4 mesi. I bambini con crescita decelerata non hanno mostrato rischio aumentato di sviluppare sovrappeso, indipendentemente dalla durata dell'allattamento esclusivo. Una maggiore durata dell'allattamento esclusivo è stata associata a un minor rischio di sovrappeso in tutti i gruppi di crescita infantile. In conclusione un modello di accrescimento rapido dovuto a forme di alimentazione diverse dall'allattamento esclusivo (come per esempio la formula artificiale) potrebbe comportare un rischio aumentato di sviluppare sovrappeso, mentre un modello di accrescimento rapido in presenza di allattamento al seno esclusivo non sembra portare con sè questo rischio.
° Leth-Møller M et al. Breastfeeding and infant growth in relation to childhood overweight - a longitudinal cohort study. Am J Clin Nutr. 2025 Apr;121(4):835-842. doi: 10.1016/j.ajcnut.2025.01.020. Epub 2025 Jan 23. PMID: 39863115.
1. Confronto dell'effetto dell'odore del latte materno, del tucking* facilitato e della suzione non nutritiva applicati ai neonati prematuri durante l'iniezione al tallone sul dolore e sui parametri fisiologici: uno studio randomizzato controllato
I neonati prematuri ricoverati in terapia intensiva neonatale (UTIN) vengono spesso sottoposti a procedure dolorose, che

possono portare a complicazioni sia a breve che a lungo termine, inclusa la potenziale mortalità. In questo contesto, una gestione efficace del dolore è fondamentale. Sebbene numerosi studi abbiano esplorato metodi non farmacologici per il sollievo dal dolore nei neonati prematuri, nessuna ricerca ha confrontato simultaneamente gli effetti dell'odore d2. e del latte materno, del tucking facilitato e della suzione non nutritiva. Con uno studio clinico randomizzato controllato in una TIN di terzo livello con 144 neonati pretermine (età gestazionale 31-36 settimane) che necessitavano di puntura del tallone e assegnati in modo casuale a quattro gruppi: controllo, suzione non nutritiva, tucking facilitato e odore del latte materno. Il dolore e i parametri fisiologici sono stati valutati tramite registrazioni video delle procedure e valutati a intervalli di 1 minuto utilizzando il Premature Infant Pain Profile and Data Evaluation Form. Tutti gli interventi hanno dimostrato efficacia nel mantenere la stabilità fisiologica e nell'alleviare il dolore. Tuttavia, l'intervento identificato come più efficace nel ridurre il dolore è stato il gruppo con tucking facilitato.
* Il tucking facilitato è una tecnica non farmacologica di gestione del dolore utilizzata nei neonati, in particolare durante procedure come il prelievo del tallone o l'aspirazione endotracheale. Consiste nel tenere delicatamente le estremità del neonato in flessione (piegamento) per riportare il corpo sulla linea mediana, creando un senso di contenimento e sicurezza. Questa posizione può contribuire a ridurre il dolore e ad aumentare il comfort durante le procedure.
° Negarin Akbari et al. Comparison of the Effect of Maternal Breast Milk Odor, Facilitated Tucking, and Nonnutritive Sucking Applied to Preterm Neonates During Heel Stick on Pain and Physiological Parameters: A Randomized Controlled Trial Breastfeeding Medicine 2025 vol. 20 n.4
2. Effetto della posizione e del tipo di alimentazione sulla salute digestiva: uno studio retrospettivo randomizzato controllato sulle coliche nei neonati pretermine Ancora oggi vi è una mancanza di misure efficaci per alleviare le coliche nei neonati pretermine, essendo la patogenesi di queste ultime ancora poco chiarita. Questo studio si pone l’ obiettivo di valutare quale tipo di posizione e quale tipo di alimentazione possa essere più utile nella gestione delle coliche nei neonati pretermine. Presso l’ Ospedale Affiliato dell'Università di Nantong (febbraio 2021-dicembre 2022), sono stati arruolati 313 neonati pretermine con un quadro clinico compatibile con coliche del lattante: 125 sono stati trattati sottoponendoli a diversi tipi di posizione, mentre 188 a diversi tipi di alimentazione. Il follow-up è durato 4 settimane. I risultati dello studio hanno mostrato che il grado di coliche in posizione supina è elevato, 3/4 dei neonati pretermine in posizione laterale presentavano coliche da moderate a gravi e il 90% dei casi posti in posizione flessa e prona ha sperimentato coliche da moderate a gravi. Per contro, l’uso della posizione a marsupio ha determinato una gestione significativamente migliore delle coliche, migliorando anche la qualità delle feci (p<0.05). Lo studio sulla tipologia di alimentazione ha mostrato una differenza significativa sulla manifestazione del grado di coliche e del tipo di feci tra i gruppi sottoposti a differenti modalità di alimentazione, dove il latte materno risulta essere la scelta meglio tollerata e legata a una migliore gestione della sintomatologia dolorosa.
° Xing Y et al.. Effect of positional management and milk type on digestive health: a retrospective randomised controlled study on colic in preterm infants. BMJ Paediatr Open. 2025 Apr 9;9(1):e002951. doi: 10.1136/bmjpo-2024-002951
3. Associazioni tra crescita e composizione corporea infantile in bambini very preterm, late preterm e a termine Lo scopo di questo studio è di determinare come l'età gestazionale alla nascita e la crescita postnatale siano correlate alla composizione corporea nell'infanzia. È stata calcolata la crescita (nascita-2 anni, 2 anni-6 anni) e misurato la composizione corporea a 2 e 6 anni utilizzando la bioimpedenziometria in coorti di bambini neozelandesi nati molto pretermine (VPT; 23-31 settimane), pretermine tardivi (LPT; 35-<37 settimane) e a termine (≥37 settimane). Sono state esplorate le relazioni tra la crescita e l'indice di massa grassa (FM) e l'indice di massa magra (FFM) a 6 anni utilizzando la regressione lineare multipla. Dei 1.125 bambini (51% maschi), 202 erano VPT, 114 LPT e 809 a termine. Rispetto ai bambini a termine, i VPT ma non i LPT erano più magri e più bassi a 2 e 6 anni e avevano un indice di FM e FFM più basso. L'associazione tra la crescita del peso da 2 a 6 anni e sia l'indice di FM che l'indice di FFM a 6 anni era più forte rispetto alla crescita del peso dalla nascita a 2 anni o alla crescita in altezza in qualsiasi periodo in tutti i gruppi di età gestazionale. Le dimensioni e la composizione corporea a 2 e 6 anni sono diverse tra i neonati nati VPT, ma non LPT, e a termine. La crescita del peso successiva è più fortemente associata alla composizione corporea dell'infanzia rispetto alla crescita precedente.
° David A. Nyakotey et al. Associations between growth and childhood body composition in very preterm, late preterm and term children. Acta Paediatrica Volume 114, Issue 5 p. 1030-1042
Obesità
1. Associazione tra oligosaccaridi del latte umano e il recupero precoce dell'adiposità nei bambini: uno studio caso-controllo del Tohoku Medical Megabank Project Birth e Three-Generation Cohort Study
In questo studio viene esaminata la relazione tra la composizione degli oligosaccaridi del latte umano (HMOs) e l'insorgenza precoce del "adiposity rebound" (AR) nei bambini. L'AR è il momento in cui l'indice di massa corporea (BMI) inizia a salire nuovamente durante l'infanzia, e un AR precoce è associato a un rischio maggiore di obesità e disturbi metabolici in età adulta. Lo studio caso-controllo ha coinvolto 184 coppie madre-bambino provenienti dallo studio di coorte Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation (TMM BirThree). I campioni di latte materno sono stati raccolti un mese dopo il parto, e sono stati analizzati 15 HMOs per determinare la loro concentrazione e la diversità alfa (indice di Simpson inverso). I risultati hanno mostrato che, nelle madri "secretrici" (in grado di produrre fucosiltransferasi), una maggiore diversità degli HMOs e concentrazioni più elevate di HMOs legati all'acido sialico, come il 3'-sialyllattosio (3'SL), erano inversamente associati all'insorgenza precoce dell'AR nei bambini. Inoltre, è stata osservata una tendenza all'interazione tra il Lacto-N-tetraosio sialilato (LSTa) e lo stato di secrezione materna nell'insorgenza dell'AR. Questi

risultati suggeriscono che la composizione degli HMOs nel latte materno, in particolare la diversità e la presenza di HMOs legati all'acido sialico, può influenzare l'insorgenza dell'AR nei bambini, con differenze legate allo stato genetico della madre. Tali scoperte offrono nuove prospettive sul legame tra l'allattamento e lo sviluppo dell'adiposità infantile, con implicazioni per la prevenzione dell'obesità e dei disturbi metabolici in età adulta.
° K. Sawane et al. Association Between Human Milk Oligosaccharides and Early Adiposity Rebound in Children: A Case–Control Study of the Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study. The Journal of Nutrition, Issue 155, Volume 5, Maggio 2025
2. Le esperienze genitoriali nella gestione dell'obesità dei figli presso l'ospedale pediatrico di Reunion Island
Le prospettive dei genitori sulla gestione dell'obesità del loro bambino (BMI >30) sono essenziali per garantire risultati positivi. Questo studio ha esplorato le esperienze dei genitori nella gestione dell'obesità dei loro figli e ha investigato i fattori socioculturali e ambientali che influenzano tale gestione a Reunion Island, un dipartimento d'oltremare francese nell'Oceano Indiano. Questo studio qualitativo ha utilizzato un approccio di analisi induttiva generale. Sono state condotte interviste telefoniche semi-strutturate dalla Francia, tra gennaio e aprile 2019, con nove genitori di bambini trattati nell'Unità di Obesità Infantile dell'Ospedale Pediatrico. Le interviste sono state analizzate utilizzando un'analisi tematica fino a saturazione dei dati. Quattro temi principali sono emersi durante il trattamento: storia di vita con sentimenti di giustificazione e colpa, accettazione, coinvolgimento e attivismo. Le tradizioni culturali alimentari erano un ostacolo all'implementazione di abitudini più sane. Il supporto e i consigli forniti dai servizi sanitari hanno alleviato i sentimenti di isolamento e motivato i genitori a essere più proattivi nella gestione dell'obesità dei propri figli. Il coinvolgimento dei genitori ha motivato i loro figli e migliorato le relazioni familiari. In conclusione, il coinvolgimento dei genitori è essenziale nella gestione dell'obesità infantile. Per massimizzare i risultati del trattamento, sono fondamentali interventi personalizzati che affrontino le dinamiche familiari e le prospettive socioculturali dei genitori.
° Mary Lebleu et al. Parents' experiences of their children's obesity management at the children's hospital on Reunion Island. Acta Paediatrica Volume 114, Issue 5 p. 838-845
3. Obesità e sovrappeso infantili sono associati a un maggior rischio di stress percepito e scarsa qualità del sonno: uno studio trasversale su bambini di età compresa tra 6 e 9 anni Negli ultimi anni, il sovrappeso e l’obesità infantili sono diventati un serio problema di salute pubblica, anche in Grecia. Questo studio, condotto su oltre 4300 bambini greci di età compresa tra i 6 e i 9 anni, ha esaminato i legami tra obesità infantile, stress percepito e qualità del sonno. Le informazioni sono state raccolte attraverso questionari compilati dalle madri, che includevano dati sulla salute e lo stile di vita dei figli, così come valutazioni sul loro livello di stress e sonno. I risultati sono chiari: i bambini in sovrappeso o obesi presentano un rischio significativamente maggiore di soffrire di stress percepito e di avere una qualità del sonno compromessa. Anche dopo aver tenuto conto di altri
fattori, come il sesso, la condizione economica della famiglia, il tipo di parto e le abitudini alimentari e motorie, l’associazione tra obesità, stress e sonno disturbato è rimasta significativa. In particolare, il rischio di stress percepito era oltre tre volte più alto nei bambini obesi rispetto a quelli con peso normale, mentre il rischio di sonno inadeguato era più che raddoppiato. Inoltre, altri fattori legati all’ aumento del rischio di obesità includevano: essere femmine, vivere in famiglie con basso reddito, essere nati da parto cesareo, non essere stati allattati esclusivamente al seno e avere livelli bassi di attività fisica. Questo studio mette in evidenza che obesità, stress e disturbi del sonno sono strettamente connessi già nei primi anni della vita. Gli autori sottolineano l’importanza di adottare strategie di prevenzione precoci e multidimensionali, che coinvolgano scuole, famiglie e operatori sanitari, al fine di promuovere una crescita sana e uno stile di vita equilibrato fin dall’infanzia. Infine, gli autori raccomandano ulteriori studi longitudinali per indagare meglio le relazioni causali tra questi fattori, contribuendo così a creare politiche sanitarie più efficaci nella prevenzione dell’obesità infantile e dei suoi effetti collaterali.
° Mentzelou, M. et al. Childhood Obesity and Overweight Are Associated with Higher Risk of Perceived Stress and Poor Sleep Quality: A Cross-Sectional Study in Children Aged 6–9 Years. Metabolites 2025, 15, 345
Modelli alimentari
1. Seminare i semi del gusto? Un nuovo approccio per investigare l'impatto dell'esposizione precoce al dolce sui modelli alimentari gustativi dei bambini da 12 a 36 mesi
Gli autori dello studio valutano se l'esposizione precoce al gusto dolce durante l'introduzione dei cibi complementari influenzi i modelli gustativi e le preferenze alimentari dei bambini tra i 12 e i 36 mesi. Lo studio ha coinvolto 246 bambini olandesi, suddivisi in due gruppi: uno esposto a purè di frutta e verdura dolci e l'altro a purè di verdura dal gusto neutro, per un periodo di 15 giorni all'inizio dello svezzamento. Successivamente, è stata valutata l'assunzione alimentare dei bambini a 12, 18, 24 e 36 mesi tramite tre giornate di 24 ore di recall alimentare. I dati raccolti sono stati analizzati utilizzando un database di intensità gustativa per identificare cinque cluster di alimenti: "sour-sweet", "sweet-fatty", "fatty-salty", "fatty" e "neutral". I risultati hanno mostrato che, indipendentemente dal gruppo di esposizione, la dieta dei bambini è diventata più variegata e intensa nel gusto nel corso del tempo. In particolare, l'assunzione di energia e peso da alimenti dal gusto neutro è diminuita, mentre è aumentata quella da alimenti dolci-grassi, grassi-salati e grassi. Tuttavia, non sono emerse differenze significative tra i due gruppi in termini di evoluzione dei modelli gustativi. In conclusione, lo studio suggerisce che l'introduzione precoce di alimenti dolci non ha un impatto duraturo sulle preferenze per il gusto dolce o sull'assunzione di alimenti dolci nei bambini. Piuttosto, i modelli alimentari dei bambini sembrano evolversi in modo naturale verso una maggiore varietà e intensità di gusti, influenzati probabilmente da fattori ambientali e familiari.
° C Mueller et al. Sowing the Seeds of Taste? A Novel Approach to Inve-

stigate the Impact of Early Sweet Exposure on Children’s Dietary Taste Patterns from 12 to 36 Months. The Journal of Nutrition, Issue 155, volume 5, Maggio 2025
2. Esplorare la fattibilità dell'uso dei dati sugli acquisti alimentari scolastici come metodo per valutare l'assunzione alimentare negli studenti delle scuole secondarie Gli autori dello studio indagano la possibilità di utilizzare i dati sugli acquisti alimentari scolastici come metodo per valutare le abitudini alimentari degli studenti delle scuole secondarie. Tradizionalmente, la raccolta di dati sulle abitudini alimentari degli studenti si basa su metodi di autosegnalazione, che possono essere soggetti a errori di reporting. L'uso dei dati sugli acquisti alimentari scolastici potrebbe offrire un'alternativa più oggettiva per valutare le abitudini alimentari degli studenti. Lo studio ha coinvolto cinque scuole secondarie nel Regno Unito, raccogliendo dati sugli acquisti alimentari di 3466 studenti durante un periodo di quattro settimane. I dati raccolti includono informazioni su orari, date, articoli alimentari e bevande acquistati, quantità, costi e stato di idoneità al programma di pasti scolastici gratuiti. I risultati hanno mostrato che il 92% degli articoli alimentari e delle bevande acquistati (338 su 367) poteva essere assegnato a un gruppo alimentare, rappresentando l'82% degli acquisti totali. Di questi, il 60% (258 articoli) conteneva informazioni sufficienti per assegnare un codice nutrizionale. Tuttavia, l'8% degli articoli (29 su 367) non aveva informazioni sufficienti per essere classificato in un gruppo alimentare o assegnato a un codice nutrizionale. Lo studio conclude che l'uso dei dati sugli acquisti alimentari scolastici è un metodo fattibile per ottenere dati oggettivi sulle abitudini alimentari degli studenti su larga scala. Questo approccio consente di raccogliere dati su oltre 3.000 studenti in un breve periodo di tempo, cosa che sarebbe difficile ottenere utilizzando metodi tradizionali di valutazione alimentare. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confrontare questi dati con quelli ottenuti tramite metodi di autosegnalazione validati, al fine di valutare l'accuratezza e l'affidabilità di questo nuovo metodo di raccolta dati.
° Exploring the feasibility of using school food purchase data as a method to assess dietary intakes in secondary school-aged pupils. Bradley J et al. Public Health Nutr 2025; DOI 10.1017/S1368980025000527, Aprile 2025
3. Dieta, abitudini alimentari e fattori legati allo stile di vita associati a un’ adeguata durata del sonno in bambini e adolescenti residenti in 5 Paesi del Mediterraneo: il progetto DELICIOUS
I genitori dei bambini e degli adolescenti che hanno partecipato al progetto DELICIOUS sono stati intervistati per valutare le abitudini alimentari dei loro figli (ad es. routine dei pasti), così come altri comportamenti legati allo stile di vita (ad es. livello di attività fisica, tempo trascorso davanti agli schermi, ecc.) potenzialmente associati a una durata del sonno adeguata (definita tra 8 e 10 ore secondo la National Sleep Foundation). La qualità della dieta è stata valutata attraverso lo Youth Healthy Eating Index (Y-HEI), un questionario che misura quanto le abitudini alimentari siano aderenti rispetto alle linee guida raccomandate. 2011 individui hanno partecipato all’indagine; i bambini e gli adolescenti con genitori più giovani hanno riportato una mag-
giore probabilità di avere una durata inadeguata del sonno. Tra i comportamenti alimentari, fare colazione (OR = 2.23; IC 95%: 1.62–3.08) e mangiare a scuola (OR = 1.33; IC 95%: 1.01–1.74) sono risultati associati a una durata del sonno adeguata. Al contrario, mangiare da soli, l’ eccessivo uso di schermi e mangiare fuori casa erano associati a una minore probabilità di avere una durata del sonno adeguata. Una migliore qualità della dieta (OR = 1.63; IC 95%: 1.24–2.16), che include un maggiore consumo di frutta, carne, pesce e cereali integrali, è risultata associata a una durata adeguata del sonno. Pertanto, la durata adeguata del sonno sembra essere fortemente influenzata da fattori legati allo stile di vita individuale, alle abitudini alimentari familiari e scolastiche, così come alla qualità complessiva della dieta.
° Godos, J. et al. Diet, Eating Habits, and Lifestyle Factors Associated with Adequate Sleep Duration in Children and Adolescents Living in 5 Mediterranean Countries: The DELICIOUS Project. Nutrients 2025, 17, 1242
4. Il consumo precoce di bevande a base di latte e cereali, correla con il rapido aumento del peso e adiposità precoce, ma non con il sovrappeso e l’obesità nelle età successive Far bere a bambini molto piccoli bevande a base di latte e di cereali potrà causare un rapido aumento di peso nell’ immediato, ma non incide sull’ indice di massa corporea o sul rapporto circonferenza addominale / altezza nelle età successive. Questo è emerso da una o studio longitudinale eseguito su tre diverse comunità nella Svezia Occidentale. Ben 1.333 bambini hanno costituito la corte combinata e i dati sono stati ottenuti retrospettivamente dal Registro Nazionale delle Nascite, dai centri di salute infantile e dai servizi sanitari scolastici. I dati antropometrici e le abitudini alimentari riferite dai genitori sono stati raccolti nell'indagine di base IDEFICS 2007-2008 e i dati di follow-up di 656 bambini sono stati raccolti nell'indagine Family 2013-2014, per la valutazione statistica sono state utilizzate regressioni lineari e logistiche. Ben 820 (62%) dei 658 ragazzi e 675 ragazze (età mediana 6.0 anni, intervallo interquartile 4.0-7.5 anni), consumavano bevande a base di latte e cereali e 229 (18%) hanno mostrato un incremento di peso (RWG) precoce, ma questo senza effetti sul BMI o sul WHtR successivi 6 anni dopo. L’ incremento ponderate precoce si è dimostrato predittivo di parametri antropometrici più elevati nella successiva infanzia, in particolare per l’ adiposità addominale, ma non è causa di obesitá a lungo termine.
° A. Lindholm et al. Early milk cereal drink consumption correlated with rapid weight gain but not with subsequent adiposity. Acta Paediatrica, Volume 114; 5:964
5. Consumo di frutta e verdura tra gli studenti delle scuole secondarie adolescenti a Boukombe e Natitingou, Nord Benin La frutta e le verdure (F&V) sono raccomandate per una vita sana. L'adolescenza è un periodo critico per l' insorgenza di disturbi alimentari e per la salute futura. Il consumo di F&V tra gli adolescenti è globalmente basso, rendendo questo gruppo un target chiave per gli interventi legati alla dieta/nutrizione. Questo studio trasversale mirava a valutare il consumo di F&V tra gli studenti delle scuole secondarie nelle comuni a insicurezza alimentare di Boukombe (rurale) e Natitingou (urbano), in Benin. Utilizzando un campionamento casuale probabilistico, 303

studenti hanno completato questionari sulla frequenza di assunzione di F&V e resoconti dietetici di 24 ore nei giorni scolastici e non scolastici. I modelli di Poisson hanno identificato fattori associati al consumo di F&V. I risultati hanno mostrato che solo l'8.8% (Boukombe) e l'11% (Natitingou) degli studenti consumavano frutta almeno due volte al giorno, e oltre l'80% degli studenti non aveva mangiato frutta nelle 24 ore precedenti; il 9.9% e l'11.4%, rispettivamente, consumavano verdure almeno due volte al giorno. In media, il 45.5% degli studenti a Boukombe e il 68% a Natitingou consumavano almeno tre tipi di verdure nei giorni di scuola. La frutta più comunemente consumata erano le arance a Boukombe e i limoni a Natitingou. I fattori che influenzavano il consumo di frutta includevano il sesso (p = 0.005), l'età (p = 0.04) e la professione delle madri (p = 0.03), nei giorni di scuola e non scolastici, mentre il comune (p = 0.00017) e il gruppo etnico influenzavano il consumo di verdure. Un consumo così basso di frutta e verdura tra gli studenti intervistati rappresenta una questione di salute pubblica, poiché è probabile che influisca sulla loro salute, in termini di carenza di micronutrienti, e sulle prestazioni intellettive. Questi risultati dovrebbero incentivare i ricercatori in nutrizione, i manager di progetto, i funzionari della salute pubblica e i responsabili politici a (ri)progettare e implementare misure più ampie mirate alle pratiche alimentari degli studenti delle scuole superiori per aumentare il loro consumo di frutta e verdura.
° Melina Maureen Houndolo et al. Fruit and Vegetable Consumption Among Adolescent Secondary School Students in Boukombe and Natitingou, North Benin. Int. J. Environ. Res. Public Health 2025, 22, 767
6. Il ruolo dei pasti in famiglia e del comportamento alimentare sociale in relazione all’ evitamento esperienziali negli adolescenti spagnoli Lo studio, parte del più ampio studio EHDLA (Eating Habits and Daily Life Activities study), ha avuto l'obiettivo di analizzare le associazioni tra i pasti in famiglia, il comportamento alimentare sociale (SEB) e l'evitamento esperienziale (EA) in 617 adolescenti spagnoli di età compresa tra 12 e 17 anni. L'evitamento esperienziale è definito come la riluttanza a entrare in contatto con esperienze interne avverse (come sensazioni corporee, pensieri, ricordi) e lo sforzo di evitarle o modificarle. È stato misurato utilizzando l'Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II), dove punteggi più alti indicano maggiore EA. I risultati hanno rivelato una relazione significativa ed inversa tra il SEB e l'EA. Per ogni ulteriore punto nella scala SEB, è stata osservata una media marginale stimata inferiore dell'AAQ-II (-0.86 punti). Gli adolescenti con uno stato SEB elevato presentavano punteggi AAQ-II significativamente inferiori rispetto a quelli con stato SEB medio o basso. Questo suggerisce che un SEB elevato può comportare una maggiore capacità di affrontare le esperienze interne sgradevoli. Al contrario, lo studio non ha riscontrato una relazione significativa tra la frequenza dei pasti in famiglia e l'EA. In conclusione, la ricerca suggerisce che promuovere ambienti sociali positivi legati al cibo e un SEB sano potrebbe contribuire a mitigare l' EA negli adolescenti e le sue potenziali conseguenze negative. Sebbene la frequenza dei pasti in famiglia non abbia mostrato una relazione significativa con l' EA in questo studio, è un fattore che altri studi hanno associato al benessere psicosociale. Lo studio evidenzia con forza il ruolo positivo delle interazioni sociali piacevoli durante i pasti.
° José Adrián Montenegro-Espinosa et al. What is the role of family meals and social eating behaviour in relation to experiential avoidance in adolescents among Spanish adolescents? the EHDLA study: BMJ Nutrition, Prevention & Health 2025;:bmjnph-2024-001072
1. Gran Bretagna: esposizione al marketing della formula e credenze tra donne in gravidanza e madri Come ben sappiamo, esistono codici, leggi e regolamenti che pongono dei limiti al marketing dei vari tipi di formula. Sappiamo altresì che le ditte escogitano in continuazione strategie commerciali miranti ad aggirare queste norme. Succede in Italia e succede in Gran Bretagna. In questo studio è stata analizzata l’ esposizione a questo marketing in un campione di oltre 1.000 donne in gravidanza e madri di bambini fino a 8 mesi di età, e le conseguenze sulle loro credenze e attitudini. Le partecipanti sono state intervistate tra febbraio 2020 e febbraio 2021 e sono state assegnate a un “punteggio di marketing” in base al numero di volte in cui avevano visto pubblicità, erano entrate in contatto con le ditte e avevano ricevuto messaggi promozionali. Anche le loro risposte positive al marketing sono state trasformate in un punteggio, in base al livello di accordo o disaccordo su 17 affermazioni. Da notare innanzitutto che tutte le donne intervistate hanno riportato un qualche tipo di esposizione al marketing mediante molteplici canali, spesso digitali. Questa esposizione non sembra variare in base alla classe sociale delle donne. Tuttavia, donne in gravidanza e madri appartenenti a classi sociali più basse hanno mostrato punteggi di risposta positiva al marketing più elevati rispetto a quelle di classe sociale più elevata. Per esempio, sono più propense a rispondere positivamente all’ affermazione “latte materno e formula hanno gli stessi benefici per la salute del bambino”. In conclusione, il marketing influenza negativamente le credenze e le attitudini delle donne, in gravidanza e in allattamento, e dovrebbe perciò essere regolato in maniera più rigorosa. Non è una novità, né in Gran Bretagna né in Italia.
° Athanasiadou M et al. Cross‐sectional associations between exposure to commercial milk formula marketing, beliefs about its use, and socioeconomic position among pregnant women and mothers in the UK. Matern Child Nutr 2025;e70022
2. Messico: sviluppo e implementazione di un’ applicazione per monitorare le violazioni del Codice Internazionale Non c’ è paese al mondo in cui non si violi il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno. In molti paesi vi è un monitoraggio di queste violazioni, al fine di riportarle alle autorità competenti affinché prendano misure per prevenirle e/o punirle secondo la legge. I sistemi nazionali di monitoraggio, ispirati dalle raccomandazioni di IBFAN (International Baby Food Action Network) sono solitamente su base cartacea con successiva immissione online via email e/o social media. In alcuni paesi si stanno sperimentando apposite applicazioni che permettono di velocizzare questo processo. È il caso del Messico, come descritto in quest’ articolo. Dopo una fase di studio qualitativo (interviste semi-strutturate a genitori, ricercatori e operatori, focus group e interviste a persone-chiave), sono state identificate 4 categorie utili per lo sviluppo di un’applicazione:

1. conoscenze e prospettive sul Codice, 2. attitudini a riportare le violazioni, 3. prospettive sul monitoraggio da parte dei portatori di interessi, e 4. prospettive per l’uso dell’ applicazione. Quest’ultima è stata finalmente sviluppata, con l’ ausilio dell’ intelligenza artificiale, e associata a un sito internet. Gli ideatori dell’iniziativa sperano che l’applicazione sia ampiamente scaricata e usata con successo, possibilmente contribuendo ad aumentare la responsabilità sociale. Gli organismi governativi di controllo potranno usare le notificazioni di presunte violazioni del Codice Internazionale per infliggere sanzioni e per valutare l’adeguatezza delle misure di legge al fine di aumentarne il rispetto o di renderle più rigorose.
° Unar‐Munguía M et al. Formative research for the development and implementation of a smartphone application to report breaches to the International Code of Marketing of Breast‐Milk Substitutes in Mexico. Matern Child Nutr 2025;e70014
3. Hong Kong: analisi delle strategie di marketing digitale da parte delle ditte di formula Ormai è assodato: il marketing digitale sta scalzando quello convenzionale. E succede di più e più in fretta in Cina e dintorni, sia perché il digitale è più diffuso per qualsiasi aspetto della vita, sia perché è più grande il mercato della formula (tra qualche anno, probabilmente, succederà anche in India). Alcune ricercatrici di Hong Kong hanno voluto analizzare questo marketing digitale confrontando con le leggi vigenti i contenuti delle promozioni commerciali di formula sui social media, da parte di influencers, e sui siti internet delle 5 maggiori ditte presenti sul mercato locale. Come ci si poteva facilmente immaginare, le violazioni sia della legge sia del Codice Internazionale sono molto numerose. Su oltre 1.000 materiali di influencers raccolti e su oltre 500 materiali delle ditte, tutti (nel caso delle influencers) e il 95% (nel caso delle ditte) violavano almeno due articoli del Codice. La ripetizione dei messaggi digitali e la “cross promotion” (promuovere un prodotto per promuoverne altri dello stesso marchio) erano frequentissimi, così come la condivisione tra genitori sui social media, le immagini di bimbi e famiglie felici, e la sponsorizzazione da parte di celebrità. Le autrici concludono che i governi dovrebbero rivedere le leggi per renderle più severe, ponendo dei limiti, o addirittura un bando totale, al marketing digitale.
° Ng WC et al. A content analysis of digital marketing strategies of formula companies and influencers to promote commercial milk formula in Hong Kong. Matern Child Nutr 2025;e70007
4. L'impatto della pubblicità di marca sulle preferenze alimentari e sulle intenzioni comportamentali dei bambini: uno studio sperimentale
Gli autori dello studio esaminano come la pubblicità di marchi alimentari influenzi le preferenze alimentari e le intenzioni comportamentali dei bambini. Lo studio è stato condotto in un ambiente controllato, con un campione di bambini esposti a pubblicità di prodotti alimentari e successivamente osservati per valutare le loro scelte alimentari e intenzioni. Gli autori hanno evidenziato diversi risultati rispetto a preferenze alimentari modificate, intenzioni comportamentali influenzate e differenze individuali. Preferenze alimentari modificate: i bambini esposti alla pubblicità di marchi alimentari hanno mostrato una mag-
giore preferenza per i prodotti pubblicizzati rispetto a quelli non pubblicizzati. Intenzioni comportamentali influenzate: l'esposizione alla pubblicità ha anche modificato le intenzioni comportamentali dei bambini, spingendoli a scegliere più frequentemente i prodotti pubblicizzati. Differenze individuali: l'effetto della pubblicità variava in base a fattori individuali come l'età, il sesso e la familiarità con il marchio. Lo studio suggerisce che la pubblicità di marchi alimentari ha un impatto significativo sulle preferenze alimentari e sulle intenzioni comportamentali dei bambini. Questi risultati evidenziano la necessità di regolamentare la pubblicità rivolta ai bambini per promuovere scelte alimentari più sane e prevenire comportamenti alimentari dannosi. In sintesi, l'articolo sottolinea l'importanza di considerare l'influenza della pubblicità di marchi alimentari sulle scelte alimentari dei bambini e la necessità di politiche efficaci per mitigare i suoi effetti negativi
° Mulligan C et al. The impact of brand advertising on children’s food preferences and behavioral intentions: an experimental study. Public Health Nutr 2025; DOI 10.1017/S1368980025000369, Maggio 2025
5. Pubblicità di cibi e bevande lungo i percorsi di trasporto scolastici dei bambini a Victoria, Australia e implicazioni politiche
Il marketing tende a trasferirsi sul digitale, ma se ne può trovare ancora per strada e sui mezzi di trasporto (treni, autobus, metro, stazioni, fermate, etc). Gli autori di questo articolo hanno analizzato le pubblicità di alimenti e bevande non alcoliche trovati sui mezzi di trasporto e le infrastrutture stradali a febbraio 2023 nelle rotte più frequentate da alunni delle scuole primarie e secondarie per recarsi a scuola nello stato di Victoria, in Australia. I prodotti pubblicizzati sono stati classificati come salutari e non, in base alle linee guida governative. Su 888 messaggi pubblicitari, 156 riguardavano gli alimenti e le bevande di interesse; tra questi, il 58% erano non salutari. Il marketing di questi prodotti puntava su sapore (31%), convenienza (28%) ed emozioni (9%).
La maggior parte di questi messaggi pubblicitari, il 91%, si trovava in un raggio di 500 metri dalle scuole. Gli autori fanno notare la contraddizione tra le linee guida governative e il marketing. La soluzione proposta sembra la più logica: bandire la pubblicità di cibi e bevande non salutari, per lo meno nelle vicinanze delle scuole.
° Li SX et al. Food and drink advertising along school children’s transport routes in Victoria, Australia and policy implications. Public Health Nutr 2025; DOI 10.1017/S1368980025000345
6. Gran Bretagna: valutazione di un programma scolastico per aumentare le competenze nutrizionali e le abilità culinarie degli alunni
Da molti anni e in più di 80 paesi è attiva un’iniziativa, rivolta alle scuole per bambini tra 3 e 12 anni di età, mirante a promuovere diete bilanciate e stili di vita salutari. Si chiama Nestlé for Healthier Kids e se volete saperne di più potete consultare il sito. Il programma sembra essere attivo anche in Italia. In particolare, vi si promuove il Nutripiatto, anche in collaborazione con un’associazione di pediatri. Alcuni ricercatori inglesi, con un trial controllato a cluster finanziato da Nestlé, hanno voluto valutare l’ efficacia dell’iniziativa. L’ intervento, denominato Phun-

ky Foods (credo sia un neologismo, forse un misto tra punky, delinquenziale, e funky, bizzarro, stravagante), era un modulo didattico sulla buona alimentazione, sull’imparare a cucinare, e sull’importanza di mangiare frutta e verdura. Lo si è applicato tra aprile e luglio 2022 in 13 scuole primarie dell’Inghilterra del nord, dopo apposita formazione dei docenti. In altre 13 scuole, il gruppo di controllo, non è stata modificata la didattica rispetto ai normali programmi. Sono stati raccolti dati prima dell’intervento e 12 mesi dopo. In totale, hanno risposto ai questionari iniziali 631 bambini tra 6 e 9 anni di età, 307 nel gruppo di intervento e 324 in quello di controllo; a quelli finali 275 e 277 alunni, rispettivamente. I questionari, per chi fosse interessato/a, sono disponibili come supplementi all’articolo. I risultati non hanno mostrato alcuna differenza statisticamente significativa tra i due gruppi. Da notare che Phunky Foods è attivo da oltre 20 anni in moltissime scuole britanniche. Evidentemente serve a qualcos’altro.
° Vaughan KL et al. Evaluation of the school-based “PhunkyFoods” intervention on food literacy and cooking skills; a cluster randomized controlled trial in the UK. DOI 10.1017/S1368980025000552
7. Determinanti commerciali della salute: un’ analisi degli ambienti alimentari negli ospedali pubblici per bambini e giovani nei paesi ad alto reddito: dobbiamo riorganizzare le priorità della salute Ci sono prove crescenti che gli ospedali pubblici nei paesi ad alto reddito, particolarmente nei paesi anglosassoni neoliberali (USA, Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda e Australia), stiano collaborando con i rivenditori di alimenti per attrarre capitali privati e massimizzare i loro redditi nel tentativo di ridurre i costi. Inoltre, il cibo negli ospedali pubblici può avere un'influenza sostanziale sulla salute dei bambini e dei giovani. Tuttavia, c'è ancora relativamente poca ricerca sul cibo per i più giovani negli ambienti sanitari. Questo è preoccupante, poiché un'assunzione alimentare adeguata è vitale non solo per la prevenzione e il recupero da malattie, ma anche per la crescita fisica e lo sviluppo psicologico dei giovani. Questa revisione ha esaminato le prove disponibili sulla fornitura, le pratiche e gli ambienti alimentari negli ospedali, così come le esperienze dei bambini durante la degenza in paesi ad alto reddito, attingendo ad articoli peer-reviewed e alla letteratura grigia. La lente analitica per questa revisione sono stati i Determinanti Commerciali della Salute (CDOH), un framework che richiede un esame critico delle influenze commerciali sulle pratiche individuali, istituzionali e politiche rilevanti per la salute. I risultati illustrano i meccanismi attraverso i quali i CDOH fungono da barriera a cibi e abitudini alimentari salutari per i bambini. In primo luogo, gli ambienti alimentari ospedalieri possono essere considerati obesogenici. In secondo luogo, vi è una mancanza di cibi culturalmente inclusivi e appropriati offerti nelle strutture sanitarie e un'abbondanza di cibi processati e pronti. Infine, l'alimentazione individualizzata è incoraggiata nelle strutture sanitarie a scapito dei comportamenti alimentari comuni che tendono a essere associati a una dieta più sana. Gli ospedali pubblici stanno affrontando sempre più pressioni commerciali. È estremamente importante resistere a queste pressioni e proteggere i pazienti, specialmente i bambini e gli adolescenti, dal marketing e dalla vendita di alimenti che si sono dimostrati essere additivi e dannosi.
on the Food Environments of Public Hospitals for Children and Young People. Int. J. Environ. Res. Public Health 2025, 22, 601
8. Aziende di formule artificiali ed allergologi in India
In India vive un quarto dei bambini del mondo! Il governo ha effettuato molti sforzi, con successo, per sostenere l'allattamento esclusivo per 6 mesi e la prosecuzione dell’ allattamento per 2 anni, in una realtà culturale in cui è già presente una buona sensibilità all'allattamento. Attualmente il 70% dei bambini indiani sono allattati fino ai 2 anni e le vendite dei sostituti del latte materno sono rimaste invariate dal 2008 al 2020. I vantaggi del latte materno sono stati tramandati dalle antiche scritture indiane, ove il seno è descritto come una “brocca piena di nettare”. Le problematiche legate all'allergia, un tempo poco comuni in India, stanno aumentando, anche per le maggiori opportunità diagnostiche e questo potrebbe creare i presupposti per la vendita di formule “ipoallergeniche”, sulla scia di ciò che è successo nei paesi ad alto reddito. In un paese in via di sviluppo come l'India ne conseguirebbe un aumento di morbilità e mortalità infantile. Nel 2020 l'Accademia Indiana di Pediatria e la Società Indiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica, hanno stilato le prime linee-guida per la diagnosi e cura dell'allergia al latte, prendendo spunto dalle linee-guida nei paesi ad alto reddito. A causa della ancora limitata disponibilità di mezzi diagnostici, le linee-guida non raccomandano l'esecuzione di IgE specifiche, ma suggeriscono le prove di evitamento/reintroduzione del latte, anche con sintomi di non univoca interpretazione, aprendo così la possibilità di un eccesso di diagnosi e di un inutile impiego di formule speciali. Viene consigliato l'allattamento per almeno 6 mesi in un paese dove viene comunemente proseguito per almeno 2-3 anni, così come viene consigliato l'uso di una formula parzialmente idrolisata in caso di alimentazione con formula, come prevenzione dell'allergia al latte, se presente una storia di allergia in entrambi i genitori. Inoltre viene suggerita dieta materna senza latticini sia come diagnosi ex adiuvantibus, sia come terapia dell'allergia al latte per una costellazione di sintomi gastrointestinali anche di origine funzionale. Le linee-guida appaiono in netto contrasto con la politica nutrizionale infantile indiana. La consensus Delphi del 2022 sulla diagnosi e terapia dell'allergia al latte ha messo in chiaro che l'eliminazione dei latticini dalla dieta materna è sconsigliata sia a livello diagnostico sia terapeutico, poiché le reazioni allergiche attraverso il latte materno sono improbabili e questo provvedimento può avere un effetto scoraggiante la prosecuzione dell'allattamento. Viene lasciata aperta questa possibilità solo in casi molto particolari di sintomi cronici, con scarsa crescita ed enteropatia protidodisperdente. Non vengono consigliati latti speciali per la prevenzione delle allergie e qui mi sembra importante ricordare la storia degli idrolisati, con lo studio, poi rivelatosi fraudolente, di Chandra del 1989, che proponeva la dieta materna e l'uso di idrolisati per prevenire la dermatite atopica in soggetti con anamnesi familiare suggestiva. Gli autori suggeriscono con forza la necessità di vigilare su questa possibile deriva in tema di scelte nutrizionali, che riguarda la corretta alimentazione di un quarto dei bambini del mondo e che esporrebbe i bambini indiani ad un aumentato rischio in termini di morbilità e mortalità.
° Allen H et al Formula milk companies and allergy healthcare professionals in India Clin Exp Allergy 2023:53:697-710

1. Prevalenza globale dei disturbi alimentari nei bambini: una revisione sistematica e meta-analisi completa Il presente articolo analizza la diffusione globale dei disturbi alimentari (EDs) nei bambini attraverso una revisione sistematica e una meta-analisi. Gli autori sottolineano come i disturbi alimentari, tradizionalmente associati agli adolescenti e agli adulti, stiano emergendo anche nella popolazione infantile, con potenziali effetti negativi sulla crescita fisica e mentale. Per stimare la prevalenza globale, sono stati analizzati studi raccolti da database principali fino a luglio 2024, usando rigorosi criteri di inclusione ed esclusione. Dopo la selezione, 19 studi sono stati considerati idonei per l'analisi finale, coinvolgendo circa 448.000 bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. La prevalenza globale dei disturbi alimentari nei bambini è dell'1% (con un intervallo di confidenza del 95% tra 0.6% e 1.6%). Tra i singoli disturbi il pica è il più comune (2.1%); il disturbo da alimentazione incontrollata ha una prevalenza dell'1%; l’anoressia nervosa e bulimia nervosa sono meno frequenti (0.6% e 0.1% rispettivamente). A livello geografico, la prevalenza più alta è stata registrata in Australia (5.2%, ma basata su un solo studio), seguita dall'Europa (2%) e dal Nord America (1%). L'Asia ha mostrato la prevalenza più bassa (0.6%). Gli autori sottolineano che l'alta eterogeneità tra gli studi può essere spiegata da differenze nei metodi di ricerca, campioni, strumenti diagnostici e definizioni di "età infantile". Viene anche evidenziato come la prevalenza dei disturbi alimentari sembri diminuire negli studi più recenti e aumentare con la riduzione della dimensione campionaria. In conclusione, vista la rilevanza dei disturbi alimentari nella salute infantile, è fondamentale che operatori sanitari e genitori siano sensibilizzati per favorire diagnosi precoci e prevenire complicazioni future. Gli autori raccomandano inoltre di condurre ulteriori ricerche soprattutto in aree geografiche meno rappresentate (come l'Africa) e di approfondire le conseguenze a lungo termine di questi disturbi.
° Salari, N., et al. Global prevalence of eating disorders in children: a comprehensive systematic review and meta-analysis. Ital J Pediatr 51, 107 (2025)
2. Efficacia di un intervento basato sulla teoria cognitivo-sociale e sulla teoria dei sistemi familiari nel migliorare i comportamenti alimentari nei bambini in età prescolare Il presente articolo si concentra sull’importanza di intervenire precocemente per migliorare i comportamenti alimentari nei bambini piccoli, con l'obiettivo di prevenire l'obesità infantile e i problemi di salute a lungo termine. Il periodo prescolare rappresenta una fase cruciale per instaurare abitudini alimentari corrette. In questa fase, infatti, si formano preferenze e comportamenti che possono durare tutta la vita. Tuttavia, modificare le abitudini una volta consolidate può diventare molto difficile. Per questo motivo, gli autori hanno voluto verificare se un intervento educativo rivolto ai genitori, basato su due approcci teorici – la Social Cognitive Theory (SCT) e la Family System Theory (FST) – potesse effettivamente incidere sui comportamenti alimentari dei bambini. Lo studio è stato condotto a Behbahan, in Iran, coinvolgendo 120 bambini tra i 4 e i 6 anni e le loro madri. Il gruppo sperimentale ha partecipato a sei incontri educativi incentrati su tecniche di parenting positivo, strategie di gestione emotiva,
rinforzo dei comportamenti desiderati e comunicazione efficace, mentre il gruppo di controllo ha ricevuto solo informazioni nutrizionali generiche. Gli effetti dell’intervento sono stati misurati con il Child Eating Behavior Questionnaire (CEBQ), compilato prima dell’intervento, e poi dopo tre e sei mesi. I risultati sono stati incoraggianti. Nei bambini le cui madri avevano seguito il percorso formativo si è osservato un miglioramento nella capacità di riconoscere il senso di sazietà (Satiety Responsiveness) e una maggiore lentezza nel mangiare (Slowness in Eating). Allo stesso tempo, si è registrata una diminuzione nel desiderio di bere bevande dolci (Desire to Drink), nell’ alimentazione emotiva (Emotional Over-Eating), nel piacere eccessivo legato al cibo (Enjoyment of Food) e nella reattività agli stimoli alimentari esterni (Food Responsiveness). Tra tutti i comportamenti osservati, i miglioramenti più significativi hanno riguardato la capacità di percepire la sazietà, il desiderio di bere e la reattività al cibo, suggerendo che un approccio educativo che coinvolge direttamente i genitori può avere un impatto positivo duraturo. Gli autori sottolineano come il coinvolgimento della famiglia, e in particolare delle madri, sia fondamentale per favorire un ambiente domestico che promuova abitudini alimentari sane. Nonostante ciò, il lavoro riconosce anche alcuni limiti: l’assenza del coinvolgimento paterno, il campione ristretto e l’area geografica limitata potrebbero ridurre la generalizzabilità dei risultati. In conclusione, questo studio dimostra che educare i genitori attraverso un approccio strutturato e basato su teorie consolidate può rappresentare una strategia efficace e sostenibile per migliorare i comportamenti alimentari dei bambini e prevenire l’ obesità infantile. I risultati offrono spunti utili anche per politiche sanitarie future, suggerendo l’importanza di pogrammi educativi rivolti alle famiglie fin dalla prima infanzia.
° Shakerinejad, G., et al. Effectiveness of a social cognitive theory and family system theory-based intervention in improving eating behaviors in preschool children. Ital J Pediatr 51, 125 (2025)
3. I latticini a basso contenuto di grassi sono una raccomandazione appropriata per i bambini?
Molte linee guida dietetiche dei vari Paesi raccomandano un'assunzione quotidiana di prodotti lattiero-caseari ricchi di nutrienti sotto forma di latte, yogurt o formaggio, solitamente derivati dal latte vaccino (“latticini”). Dai 2 ai 18 anni, ai bambini viene consigliato di consumare 2–3 porzioni di latticini al giorno e di passare dal consumo di latticini interi a quelli a basso contenuto di grassi per prevenire obesità e malattie cardiovascolari (CVD); tale raccomandazione è contenuta nelle Dietary Guidelines for Americans (DGA) e in quelle del Regno Unito, dell’ Australia e dell’Europa. Storicamente, le linee guida alimentari, basate maggiormente su studi osservazionali, hanno promosso il consumo di latticini a basso contenuto di grassi per controllare l’apporto energetico e prevenire l’ obesità infantile. Tuttavia, studi pediatrici d’intervento e di coorte non hanno riscontrato associazioni tra consumo di latticini interi e aumento di peso o adiposità. Al contrario, alcuni studi indicano che i latticini a basso contenuto di grassi sono positivamente associati all’adiposità, mentre i latticini interi mostrano un’associazione inversa. Una meta-analisi ha riscontrato che i bambini che consumavano latte intero avevano una probabilità inferiore del 39% di essere in sovrappeso o obesi rispetto a chi consumava latte scremato o parzialmente scremato. Allo stesso modo, il comitato consultivo scientifico delle DGA

2025 ha concluso che nei bambini più piccoli, il consumo di latte intero rispetto a quello scremato potrebbe essere associato a una crescita e composizione corporea favorevoli e a un rischio inferiore di obesità, anche se le evidenze sono giudicate limitate. Nella maggior parte degli studi, l’assunzione media di latticini era di circa 2 porzioni al giorno, in linea con le raccomandazioni DGA. Gli effetti sazianti dei latticini interi potrebbero prevenire la sostituzione con alimenti meno salutari, come quelli ad alto indice glicemico (IG) o bevande zuccherate. Le interazioni tra i grassi e altri nutrienti presenti nel latte possono stimolare il rilascio di ormoni intestinali che inducono sazietà e rallentare lo svuotamento gastrico. I bambini piccoli regolano naturalmente l’assunzione energetica sostituendo le calorie risparmiate da un alimento con altre fonti. I consumatori sono anche incoraggiati a scegliere latticini a basso contenuto di grassi per ridurre l’assunzione di grassi saturi e il rischio cardiovascolare. Tuttavia, negli studi pediatrici sul legame tra grassi lattiero-caseari e rischio CVD non sono emerse differenze significative nell’adiposità o nei fattori di rischio cardiometabolico (pressione sanguigna, lipidi sierici, glucosio, emoglobina A1c e proteina C reattiva). Le evidenze attuali, seppur limitate, suggeriscono che il consumo di latticini a basso contenuto di grassi non riduce il rischio di sovrappeso, obesità o CVD nei bambini. Invece di focalizzarsi sul contenuto di grassi, sarebbe meglio porre maggiore attenzione sulla scelta di latticini non zuccherati per soddisfare il fabbisogno giornaliero.
° Ng NX, Gross SM. Is Low-Fat Dairy an Appropriate Recommendation for Children? JAMA Pediatr. 2025;179(4):363–364.doi:10.1001/jamapediatrics.2024.7105
4. Australia e Nuova Zelanda: nasce un’ alleanza per l’ alimentazione dei bambini
I primi tre anni di vita rappresentano un periodo critico per le buone pratiche di alimentazione, e quindi di salute, dei bambini; gli effetti, positivi o negativi che siano, si ripercuoteranno su tutti gli anni a venire. Questo articolo presenta la creazione di un’ alleanza multidisciplinare tra accademici, ricercatori ed operatori al fine di influenzare le ricerche e le pratiche, comprese l’ advocacy, la protezione e la promozione, in questo ambito. Le prime riunioni dei membri dell’alleanza sono servite per identificare tre priorità e tre temi trasversali, successivamente analizzati in dettaglio da gruppi di lavoro specifici. Le tre priorità sono: il marketing e la commercializzazione di alimenti e bevande per bambini fino a tre anni, il sistema sanitario e l’ ambiente di cura, e il sostegno per genitori e accudenti. I tre temi trasversali sono: la costruzione di un solido corpo di prove scientifiche indipendenti da interessi commerciali, la traduzione di queste prove scientifiche in raccomandazioni pratiche, e l’ advocacy per leggi e regolamenti che favoriscano tutto ciò. Questa nuova alleanza si impegna a rispettare integralmente il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e tutte le successive e pertinenti Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale per la Salute.
° Chung A et al. Driving Research and Advocacy for Healthy Infant and Toddler Diets: The Infant and Toddler Foods Research Alliance. Matern Child Nutr 2025;e70013
5. Saltare la colazione e rendimento scolastico tra gli 8 e i 16 anni: uno studio di popolazione nell’ Australia Meridionale In questo studio viene esplorata la relazione tra il salto del pasto della colazione e il rendimento accademico degli studenti australiani di età compresa tra 8 e 16 anni. Lo studio ha coinvolto 28.651 studenti delle scuole pubbliche del Sud Australia, analizzando le loro abitudini alimentari e i risultati ottenuti in cinque test standardizzati di alfabetizzazione e matematica (NAPLAN). I risultati hanno evidenziato che gli studenti che saltavano la colazione, sia occasionalmente che quotidianamente, mostravano un rischio significativamente maggiore di ottenere punteggi bassi in tutti i test analizzati. In particolare, il rischio era più elevato per la numeracy (1.78 volte) e la lettura (1.63 volte) tra gli studenti che saltavano sempre la colazione. Anche gli studenti che saltavano occasionalmente la colazione presentavano un rischio aumentato di rendimento accademico scarso, sebbene inferiore a quello degli studenti che la saltavano quotidianamente. Lo studio suggerisce che il consumo regolare della colazione svolge un ruolo importante nel successo accademico degli studenti. Pertanto, promuovere abitudini alimentari sane, come la colazione quotidiana, potrebbe essere una strategia efficace per migliorare il rendimento scolastico e ridurre le disuguaglianze educative legate a fattori socio-economici. In sintesi, i dati raccolti indicano che saltare la colazione è associato a un rischio maggiore di ottenere risultati accademici inferiori, sottolineando l'importanza di politiche educative che favoriscano l'accesso a pasti sani e regolari per tutti gli studenti.
° Sincovich A et al. Breakfast skipping and academic achievement at 8–16 years: a population study in South Australia. Public Health Nutr 2025;28:e28, Aprile 2025
6. Assunzione di iodio in un campione di coppie madre/lattante a 6-12 mesi dalla nascita
Si tratta di uno studio osservazionale trasversale. Un campione auto-selezionato di 99 madri inglesi (età media 33 anni ±4) con figli tra 6 e 12 mesi di età (media 8.4 mesi; il 55% ancora allattati) hanno compilato questionari sull’assunzione di cibo nelle ultime 24 ore. Con un software specifico, sono state estratte da questi dati le quantità di iodio assunte. La mediana di assunzione di iodio è stata di 140 μg/die, cioè la quantità raccomandata dalle linee guida britanniche. Quelle dell’ OMS, però, raccomandano 250 μg/die, mentre quelle dell’ associazione dei dietisti britannici parlano di 200 μg/die. La distribuzione dei valori individuali di assunzione mostra quindi che il 50% delle madri di questo campione non arriva alla quantità raccomandata dal ministero britannico. Il 50% sopra la mediana di 140 μg/die mangiava più pesce, uova, latte e latticini rispetto al 50% sotto la mediana. L’ assunzione di iodio da parte dei figli era proporzionale a quella delle madri. Questi risultati mostrano che l’ assunzione di iodio in un’ alta percentuale di madri britanniche, e anche dei loro figli, potrebbe essere insufficiente; la situazione potrebbe essere molto peggiore se al posto dei livelli raccomandati in Gran Bretagna si usassero quelli dell’ OMS. Se così fosse, sarebbero necessari interventi efficaci per migliorare la dieta (in gravidanza, dopo il parto e durante l’ allattamento) o addirittura programmi per la fortificazione con iodio di alcuni cibi, a cominciare dal sale per finire con le bevande derivate da vegetali, apparentemente molto popolari tra le donne inglesi.

° Pearce J et al. Intake of iodine in a sample of UK mother–infant pairs, 6–12 months after birth: a cross-sectional study. Public Health Nutr 2025;28:e61
7. Lezioni basate sull'evidenza da due decenni di ricerca sull'implementazione di programmi di alimentazione complementare Raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile e ridurre la malnutrizione, il deperimento e l’ obesità infantile dipendono dal miglioramento dell’ alimentazione complementare (OMS 2023). L'alimentazione infantile ha serie implicazioni a lungo termine sullo sviluppo. Sono urgentemente necessari quadri e modelli basati sull'evidenza per ridurre su larga scala le carenze alimentari nei neonati e nei bambini piccoli. Il presente articolo esamina 32 pubblicazioni e cinque valutazioni d'impatto di programmi in Bangladesh, Etiopia, Nepal, Nigeria e Vietnam per identificare cosa ha funzionato e perché; la qualità delle evidenze, la diversità dei paesi e gli interventi multilivello su larga scala sono stati i criteri di selezione. Le lezioni chiave sono: la necessità di sensibilizzazione per dare priorità all'alimentazione complementare, il coinvolgimento di più operatori per raggiungere la scala nazionale e affrontare diversi fattori come l'accesso al cibo, il marketing dannoso di alimenti e bevande non salutari, le lacune conoscitive, le norme sociali e l'autoefficacia materna (ossia la capacità percepita dalle madri di mettere in atto un determinato comportamento). L'applicazione di una prospettiva comportamentale, il monitoraggio della copertura degli interventi, la riduzione delle disuguaglianze, il coinvolgimento dei leader comunitari, la motivazione degli operatori in prima linea e l'utilizzo dei mass media per raggiungere un pubblico diversificato hanno lavorato in sinergia per produrre impatti su larga scala. Nonostante i diversi contesti e i diversi livelli di diversità alimentare di base, valutazioni rigorose hanno documentato miglioramenti sostanziali attribuibili agli interventi in tutti e cinque i Paesi. Le spese sostenute variavano a seconda della complessità del programma e hanno dimostrato di essere gestibili se gli interventi si concentrano su questioni prioritarie, sono ottimizzati per adattarsi alle piattaforme esistenti e raggiungono ampie popolazioni. Grazie all'evidenza dell'impatto in contesti diversi, a un quadro concettuale e a strumenti per l'implementazione basati sull'evidenza, a spunti su come adattarsi ai contesti nazionali e alla conoscenza di cosa includere nel budget, i responsabili politici possono investire con fiducia nel miglioramento dei programmi di alimentazione complementare.
° Sanghvi T.G. et al. Evidence-Based Lessons From Two Decades of Implementation Research on Complementary Feeding Programmes. Matern Child Nutrition, 2025; e 13811
8. Un punteggio dietetico infantile basato sulla documentazione sanitaria è associato all'IMC: (Indice di Massa Corporea): uno studio di coorte madre-bambino a livello nazionale in Islanda (ICE-MCH)
La documentazione sanitaria nazionale offre opportunità di ricerca innovative. Studi hanno ripetutamente riportato l’ associazione tra dieta nei bambini piccoli, crescita e sovrappeso/obesità, ma diversi di questi si sono focalizzati sull’ associazione tra obesità e un singolo gruppo di alimenti; tuttavia, sarebbe più efficace ricorrere a valutazione di modelli alimentari e alla creazione di “punteggi dietetici” in grado di valutare l’allineamento o meno
con le raccomandazioni nutrizionali. Gli Autori osservano come la correlazione tra un indice dietetico infantile e l’indice di massa corporea (IMC), come pure fattori riguardanti le modalità di nascita e sociodemografici, non fossero stati esplorati a livello nazionale; di lì l’ obiettivo degli stessi Autori di creare una misurazione della qualità della dieta infantile attraverso un indice dietetico infantile IDS (Infant Diet Score) basato sulle raccomandazioni dietetiche nell’infanzia riportate dalle Linee Guida. Lo scopo era pertanto di descrivere l'alimentazione infantile nel primo anno di vita tra tutti i lattanti in Islanda nati da gennaio 2009 a giugno 2015 (N = 30.623), esplorare la fattibilità di creazione di un punteggio composito dietetico infantile IDS nella fascia di età 0-12 mesi in un sottogruppo di lattanti con dati sanitari registrati derivanti dal monitoraggio del tipo di nutrizione di routine (n = 12.848) ed esaminare le sue associazioni con lo z-score dell'IMC (Indice di Massa Corporea) per età a 12 e 18 mesi, le caratteristiche materne e alla nascita. Le variabili dietetiche registrate includevano l’ allattamento al seno (> 90% a 2-3 settimane), allattamento al seno esclusivo (13% a 6 mesi); introduzione del latte vaccino (26% a 12 mesi); introduzione di pappe, frutta/ verdura, carne e pesce (> 50% ne ha ricevuto ≥ uno a 5 mesi); Integratori di vitamina D (95% a 12 mesi). Il nuovo indice di crescita individuale (IDS) comprendeva: durata dell'allattamento al seno (i) esclusivo e (ii) qualsiasi tipo di allattamento; età dell'introduzione di (iii) latte vaccino e (iv) alimenti semisolidi/ solidi; (v) una stima della varietà alimentare; (vi) utilizzo di integratori di vitamina D. È stata utilizzata una regressione lineare multipla e logistica, aggiustata per fattori rilevanti, per esaminare le associazioni tra allattamento al seno, parto e fattori materni, e BMI > =+2 (standard di crescita OMS, indicativi di sovrappeso/ obesità). Rispetto al quintile 5 dell' IDS (in linea con le raccomandazioni nutrizionali), i quintili 1 e 2 dell' IDS presentavano maggiori probabilità di sovrappeso/obesità a 12 mesi e a 18 mesi. Questo IDS messo a punto dagli Autori è stato associato a caratteristiche materne e alla nascita, a supporto del suo valore come misura della qualità della nutrizione infantile.
° Jonsdottir et al. An Infant Diet Score based on health records is associated with BMI: a nationwide mother-child cohort study in Iceland (ICE-MCH). Maternal and Child Nutrition,2025;e 70010
9. Le associazioni tra tratti della personalità, auto efficacia e comportamento nell’ alimentazione complementare tra i caregivers di lattanti nella Cina rurale occidentale
L’ alimentazione complementare dei bambini piccoli nelle famiglie è correlata al comportamento del caregiver. Al pari di altri comportamenti genitoriali, fattori psico-sociali, includendo tra questi la “autoefficacia” (ossia la capacità percepita dal caregiver di mettere in atto un determinato comportamento) possono essere fattori determinanti un’ alimentazione complementare appropriata o meno. Gli effetti dei fattori psicologici sul modo di affrontare l’ alimentazione complementare sono stati ampiamente descritti, tuttavia i meccanismi alla base delle complesse relazioni tra tratti di personalità, autoefficacia e comportamento nell’alimentazione complementare rimangono poco chiari. Questo studio trasversale è stato condotto utilizzando un processo di campionamento a cluster multistadio per selezionare diadi caregiver-bambino nella Cina rurale occidentale. Sono stati valutati rispettivamente i tratti di personalità, l'autoefficacia e il comportamento nell’alimentazione complementare. Per esplo-

rare queste associazioni sono stati utilizzati sia la regressione logistica multipla che la struttura a rete bayesiana (BN). Sono state arruolate in totale 787 diadi caregiver-bambino. I risultati hanno indicato che i caregiver con livelli di estroversione media (ossia capacità del caregiver di essere estroversi o socievoli) o alti così come quelli con un'elevata autoefficacia rispetto all’alimentazione complementare, aumentavano significativamente la probabilità di soddisfare i criteri per dell'Indice di Alimentazione del Bambino (ICFI INFANT AND CHILD FEEDING INDEX, un sistema di valutazione che assegna un punteggio per pratiche di alimentazione positive come allattamento al seno o dieta diversificata) Inoltre, sono stati impiegati i BN per chiarire i parametri di influenza, rivelando un'associazione diretta tra il livello di estroversione del caregiver, il livello di autoefficacia e l'ICFI. Infine, l'analisi ha mostrato che l'apertura di un caregiver aveva un effetto indiretto sull'ICFI attraverso la sua influenza sull'autoefficacia riguardo all'alimentazione complementare. Questo è uno dei pochi studi che esplorano le associazioni tra tratti di personalità, autoefficacia e comportamento nell’alimentazione complementare. Lo studio sottolinea l'importanza di comprendere le differenze individuali nell'assistenza e suggerisce che gli interventi dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento dell'autoefficacia del caregiver, anziché concentrarsi esclusivamente sui tratti della personalità.
° Zhou X. et al. Associations between personality traits, self-efficacy and complementary feeding behavior among infant caregivers in Western rural China. Maternal and Child Nutrition, 2025;e 70021
10. Vie infiammatorie intestino-cervello nel disturbo da deficit di attenzione/iperattività: ruolo e potenziale terapeutico della dieta Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) è una condizione neuroevolutiva che insorge nell’infanzia ma può perdurare anche in età adulta, con effetti importanti sulla qualità della vita: problemi scolastici, relazionali, emotivi e rischio aumentato di disturbi psichiatrici, incidenti e persino autolesionismo. Le cause sono complesse: componenti genetiche, fattori ambientali, alterazioni dei neurotrasmettitori e, come sempre più studi suggeriscono, anche squilibri nel microbiota intestinale e infiammazione cronica. Questo articolo di revisione esplora il legame tra alimentazione, intestino, infiammazione e ADHD, proponendo che la dieta possa rappresentare non solo una causa aggravante, ma anche una potenziale risorsa terapeutica. Il microbiota intestinale – l’insieme dei batteri che popolano il nostro apparato digerente – è oggi riconosciuto come attore fondamentale nella comunicazione tra intestino e cervello. Nei soggetti con ADHD si osservano frequentemente alterazioni della flora batterica (disbiosi), associate a permeabilità intestinale, infiammazione sistemica e neuroinfiammazione. L’ alimentazione, che regola la composizione del microbiota, è spesso di scarsa qualità nei bambini e adolescenti con ADHD: ricca di zuccheri, grassi saturi e additivi, e povera di fibre, omega-3 e micronutrienti essenziali. Diversi approcci nutrizionali sono stati analizzati: Omega-3 (EPA e DHA): fondamentali per lo sviluppo cerebrale e con proprietà antinfiammatorie. Alcuni studi mostrano benefici modesti nei sintomi di ADHD, specialmente nei soggetti con livelli iniziali bassi di omega-3, ma la letteratura rimane disomogenea. Micronutrienti: carenze di ferro, magnesio, zinco, vitamina D e vitamine del gruppo B sono comuni in chi ha ADHD. Supple-
mentazioni mirate mostrano talvolta miglioramenti, ma i risultati sono ancora inconcludenti per molte sostanze. Diete di eliminazione: escludere additivi artificiali o alimenti a cui si è sensibili può dare benefici in alcuni casi, ma sono diete difficili da seguire a lungo termine e non adatte a tutti. La dieta mediterranea – ricca di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio extravergine di oliva – si è dimostrata efficace nel ridurre l’infiammazione, migliorare la diversità del microbiota e proteggere la funzione cognitiva. Tuttavia, è sorprendentemente poco studiata in relazione all’ ADHD, nonostante il suo potenziale come intervento semplice, sostenibile e sicuro. In conclusione quindi, pur non essendoci ancora prove definitive, la dieta rappresenta una promettente leva terapeutica per l’ ADHD, da integrare agli approcci farmacologici e psicologici. In particolare, la dieta mediterranea, per i suoi effetti positivi su infiammazione, microbiota e neurotrasmettitori, merita maggiore attenzione nella ricerca e nella pratica clinica.
° Lewis, N. et al. Gut–Brain Inflammatory Pathways in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: The Role and Therapeutic Potential of Diet. Metabolites 2025, 15, 335
11. Introiti di sodio e potassio: una revisione sistematica della letteratura
Lo studio è una revisione sistematica della letteratura con metanalisi che ha esaminato le tendenze globali e temporali dell'assunzione di sodio (Na) e potassio (K) in bambini e adolescenti (0-18 anni) dal 1990 al 2021. Analizzando 259 studi, la metanalisi mirava a stimare gli apporti di Na e K a livello mondiale, regionale e nazionale. I risultati aggregati mostravano un'assunzione media di Na di 2.5 g/die e di K di 2.0 g/die. Standardizzata per l'energia, l'assunzione di Na era di 2.7 g/d/2.000 kcal e di K di 2.3 g/d/2.000 kcal. Il 73% dei bambini aveva un'assunzione elevata di Na (≥2 g/d/2.000 kcal) mentre l'89% aveva un'assunzione insufficiente di K (<3.5 g/d/2.000 kcal). L'assunzione di Na era più bassa nell'Africa subsahariana e più alta nel Nord Africa e Medio Oriente. L'assunzione di K era più bassa in Asia meridionale e più alta nell'Europa centro-orientale e Asia centrale. Dal 1990 al 2021, le assunzioni di Na e K hanno mostrato una leggera diminuzione lineare. Le assunzioni di Na e K sembrerebbero aumentare con l'età, con maggiori incrementi soprattutto nei primi anni di vita. In conclusione, lo studio suggerisce che l'assunzione di Na è globalmente troppo alta e quella di K troppo bassa nei bambini e adolescenti in tutto il mondo. Sarebbero necessari interventi di tipo nutrizionale per ridurre l'assunzione di Na e aumentare quella di K fin dalla prima infanzia.
° Magali Rios-Leyvraz et al. Worldwide and time trends in sodium and potassium intakes in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. BMJ Nutrition, Prevention & Health 2025;0. doi:10.1136/ bmjnph-2024-001016
12. Profili nutrizionali in una popolazione di bambini australiani: uno studio di coorte longitudinale
Lo studio ORIGINS ha esaminato il profilo nutrizionale di 779 bambini all’anno di età in Australia Occidentale. Questa coorte presentava un elevato stato socio-economico e di livello di istruzione materno. Al compimento del primo anno, il 41.5% dei bambini era ancora allattato e il 58% riceveva invece formula artificiale. Nella maggior parte (99.7%) erano stati introdotti i cibi

solidi. Per quanto riguarda i macronutrienti, l'apporto proteico medio superava significativamente i fabbisogni nutrizionali consigliati, mentre il consumo medio di grassi totali e fibre risultava insufficiente, i carboidrati totali invece venivano consumati in eccesso rispetto alle dosi consigliate. I bambini non allattati tendevano a superare i livelli di energia, proteine e carboidrati consigliati. La coorte ha soddisfatto invece i valori nutrizionali di riferimento per la maggior parte dei micronutrienti. L’ apporto di iodio era inferiore ai valori desiderati nel gruppo allattato, mentre l’apporto di sodio ha superato le raccomandazioni in entrambi i gruppi. In sintesi, in entrambi i gruppi la qualità complessiva della dieta non ha soddisfatto le raccomandazioni consigliate; in particolare si evidenziava un eccessivo consumo di frutta e alimenti discrezionali e un insufficiente consumo di verdura e cereali, suggerendo possibili aree di potenziale miglioramento: riduzione degli alimenti discrezionali e aumento del consumo di verdura e alimenti a base di cereali. I limiti dello studio potrebbero includere il metodo di valutazione della dieta e la potenziale inaccuratezza nel riportare i diversi apporti.
° Whalan S et al. ORIGINS: Nutritional Profile of Children Aged One Year in a Longitudinal Birth Cohort. Nutrients. 2025 May 1;17(9):1566. doi: 10.3390/nu17091566