La stampa è al servizio di chi è governato, non di chi governa.
Da 300 numeri siamo sempre resilienti passando da Sapri alle Termopili, sempre via Vicenza






La stampa è al servizio di chi è governato, non di chi governa.
Da 300 numeri siamo sempre resilienti passando da Sapri alle Termopili, sempre via Vicenza





Sembrava ieri, comincerebbe a scrivere un qualunque editore, fondatore e poi anche direttore di una testata senza lacci e tantomeno lacciuoli. Ma arrivati al n. 300 di VicenzaPiù e a quasi 20 anni di esistenza (resilienza?) è bello pensare che siamo ancora qui, a farci leggere da voi, che ci raggiungete in edicola, sui taxi locali o da abbonati digitali. Sulla testata web consorella, Vipiu.it, vi proponiamo quella cronaca un po’ ragionata che interessa la comunità per risvolti più ampi e illuminati del tipico “dagli allo straniero!”, “se le cose vanno male è colpa di chi governava prima”, “vorrei ma non posso… aiutare i più deboli”…. Di sicuro è una piccola parte del noioso quotidiano: aggettivo sostantivato che sta per “ripetitivo vivere giornaliero” non, per carità, per il quotidiano locale per antonomasia
Trecento numeri di resilienza aspettando il 301°
Ma quella parte di cronaca quotidiana, che ci tiene in contatto h24 ogni giorno e già più portata a far riflettere la massa dei nostri lettori/utenti (siamo la testata web con la più alta Domain Authority tra quelle indipendenti in Veneto), è quella che alimenta il nostro e vostro mensile cartaceo, VicenzaPiù
Viva, anche il n. 300 nelle vostre adorate mani, dandogli spunti o continuandone lo sviluppo per gli approfondimenti e le riflessioni di una Vicenza, che prova a guardare di nuovo verso il mondo. Più…
Viva, appunto, nonostante venti anni di barbarie, sì di barbarie, che hanno segnato la città e il suo territorio a causa di una fetta, grossa ma per fortuna non totale, di (im)prenditori, politici, dirigenti pubblici ed anche ecclesiastici, spesso inconsapevoli, giurano, ma non per questo meno responsabili, di quello che avveniva intorno a loro (dobbiamo ricordare l’immagine delle tre scimmie?).
Ecco da quasi venti anni e, ora che siamo nelle vostre mani, da 300 numeri proviamo, con le nostre forze e risorse limitate, a scrivere liberamente. Nonostante le censure pubblicitarie: non investono su di noi quelli che contano, appena sotto al primo livello, che ci leggono e, forse, ci rispettano ma obbediscono alla “cupola dei poteri”, più di quanto questa, forse, vorrebbe sempre più ridotta com’è, da se stessa, a un soffitto di paglia, anche se ancora tenuta nascosta fra due sottili strati di cemento per perpetuare il controllo secolare dei vicentini storicamente fin troppo ossequiosi. E nonostante le mille “tensioni” giudiziarie subite: mai per i fatti da noi riportati ma perché pare che li raccontiamo, un appiglio leguleo, con un linguaggio crudo e non “cremoso”. Ecco perché in copertina abbiamo parlato di resilienza e perché

abbiamo citato la frase con cui la Corte Suprema Usa decretò la libertà della stampa (quella che oggi, non a caso Trump attacca di nuovo come fece Nixon all’epoca) e del Washington Post e del New York Times, in particolare, rei di aver pubblicato le verità ignominiose della guerra in Vietnam: “La stampa è alservizio di chi è governato, non di chi governa”. Abbiamo anche ricordato, giocando col 300 (come facciamo all’interno per alcune coincidenze con questo numero), che siamo resilienti subendo le “restrizioni” economiche e gli attacchi legali (a Sapri “Eran 300, eran giovani e forti e sono morti”) ma lottando anche come i 300 Spartani di Leonida contro i Persiani. I 300 persero la battaglia ma posero le basi per la vittoria a Salamina. Per noi di VicenzaPiù Viva e di ViPiu.it, resilienti “per Vicenza” la vittoria è darvi l’arrivederci al n. 301 e poi al 302 e al... Grazie, lettori. Siete voi, i “governati”, e la vostra fiducia la nostra forza da utilizzare, informandovi senza se e ma, per farci governare, sì, ma meglio.
Così vorrebbero anche le vittime, ben più di noi, dei conflitti attuali, scatenati da interessi contro cui anche il Papa ha urlato. A loro anche diamo ampio spazio in queste pagine di lotta e di speranza.
Giovanni Coviello
Femminismo e ambientalismo potrebbero farvi risparmiare 300 miliardi di Eleonora Boin
La sofferenza è un valore? di padre Gino Alberto Faccioli
Spese militari: la guerra delle cifre ruota intorno a 300 miliardi di Salvatore Borghese
La giornalista iraniana Hana Namdari di Fulvio Cavallari
La testimonianza dell’ucraina Marina Sorina di Hana Namdari
Ucraina, resistenza e verità di Fulvio Cavallari
Israele, Gaza e Iran di Hana Namdari
Tareq Wahba, il tenore palestinese di Betlemme e Vicenza di Hana Namdari 32
Victoria Karam: cittadina del mondo e italiana (era ora), vicentina d’adozione e un futuro radioso di Federica Zanini 36
Andrea Pellizzari, un nuovo Cavaliere ad Arzignano di Martino Montagna
VicenzaPiù Viva Fondato il 25 febbraio 2006 come supplemento di La Cronaca di Vicenza
Autorizzazione Tribunale di Vicenza n. 1183 del 29 agosto 2008
Responsabile direzione ed edizione Giovanni Coviello - direttore@vicenzapiu.com
Redazione tel. 0444.1497863 - redazione@vicenzapiu.com
Sede Viale Verona 41, 36100 Vicenza tel. 0444.1444959 - info@vicenzapiu.com
40 Italia-America Friendship Festival, Vicenza agli americani: di Emilio Franzina
42
44
Italia-America Frienship Festival, “Un festival non per dividere, ma per raccontare” di Giovanni Coviello
Storie dimenticate dello scandalo Mose, L’unico che restituì 7 milioni di tangenti di Renzo Mazzaro
60
Impaginazione Aurea Italy
Concessionaria della pubblicità
Editoriale Elas - Editorale L'Altra stampa srl elas@editoriale-elas.org
Questo teatro non ha più pareti… di Federica Zanini
Operetta che passione di Giulia Matteazzi
Lina Buffolente di Marika Andreoli
Uova e asparagi? Si, ma in un rotolo goloso e non solo a primavera di Federica Zanini
Rondinella del nord-est, Turbiana e Pinot grigio di Michele Lucivero
Il B.A.R., ma con i puntini di Marco Ferrero
Demoni a Vicenza - Amicizia oltre il tempo di Giulia Matteazzi
Sede centrale Via XX Settembre 118, 00187 Roma tel. 06.86358980 - elas@editoriale-elas.org
Stampa CTO / Vicenza via Corbetta 9, 36100 Vicenza
Lettere dei lettori cittadini@vicenzapiu.com
Distributore Chiminelli Spa, Silea (TV)

Abbonamenti digitali e postali https://www.vipiu.it/vicenzapiu-freedom-club info telefoniche 06.86358980
Impaginazione chiusa il 20 luglio 2025
Associato n. 5967

300 è un numero carico di simboli, che ricorda storie di coraggio, battaglie epiche e piccoli gruppi che sfidano potenze sproporzionate. Che poi diciamocelo, è quello che ViPiù e VicenzaPiù provano a fare da anni.

di Eleonora Boin
In occasione del numero 300 di VicenzaPiùViva, riporto questo numero per parlare di qualcosa di un po’ meno epico e molto più concreto. Perché, se con le cifre si può raccontare il mondo, 300 è anche la misura di due enormi costi che, come società, continuiamo ad ignorare. Infatti, ammonta a 300 miliardi di euro, il prezzo della violenza di genere che l’Unione europea affronta ogni anno. Come è sempre 300 miliardi di euro il costo, il costo causato ogni anno dalla siccità e dal degrado ambientale a livello globale. Quindi 600 miliardi, solo per queste due voci. Ogni anno. In perdita secca. Eppure, sono ancora numerosissime le persone che ritengono la causa femminista e quella climatica appannaggio di una sinistra radicale ed elitaria. Questo articolo è per loro, perché se non basta l’etica a convincerli forse possiamo provarci sostenendo che siano lotte anche economicamente intelligenti.
I conti nascosti della violenza
La violenza maschile contro le donne è una dei fenomeni più evidenti del nostro presente, con 51 femminicidi registrati dall’osservatorio di Non una di meno dall’inizio del 2025 (e 33 tentati femminicidi). Un’emergenza sociale e culturale gravissima, che però nasconde

Manifestazione di NUDM a Roma nel settembre2022-fotoDinamopress
anche degli importanti costi economici. Secondo le stime portate a febbraio dalla commissaria europea per la parità, la preparazione e la gestione delle crisi Hadja Lahbib, il costo complessivo della violenza sulle donne in Unione europea è di circa 300 miliardi di euro all’anno, un dato proveniente da uno studio pubblicato nel 2021 dall’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE), l’agenzia ufficiale dell’Ue incaricata di monitorare e analizzare le politiche in materia di parità. Lo studio, “The Costs of Gender-based Violence in the European Union” (trad. il costo della violenza di genere in Unione europea), ha analizzato tre ambiti principali di costi.
Il primo riguarda la perdita di produzione economica e quindi tutte le ricadute legate alla riduzione della produttività delle vittime, spesso costrette ad assentarsi dal lavoro, a ridurre l’orario o addirittura ad abbandonare del tutto l’attività professionale. Il secondo ambito sono i costi a carico dei servizi pubblici, come il sistema sanitario e il sistema giudiziario. Rientrano in questa categoria anche le spese per il sostegno abitativo, la protezione dei minori e l’accesso a servizi specializzati come i centri antiviolenza. Infine, lo studio considera l’impatto fisico ed emotivo subito dalle vittime, un aspetto che, pur difficile da quantificare con precisione, comporta una sensibile riduzione della qualità della vita, spesso
con effetti a lungo termine sulla salute mentale e sul benessere complessivo.
In Italia, la violenza di genere colpisce ogni anno centinaia di migliaia di donne, e solo una minima parte trova sostegno adeguato. Per darvi un’idea con dei numeri, secondo l’Istat, “il 31,5% delle 1670enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila)”. In questo contesto, i centri antiviolenza sopravvivono con fondi insufficienti e incerti, erogati spesso in ritardo, e l’educazione al rispetto, all’affettività, all’uguaglianza di genere non solo resta marginale nelle scuole, ma viene demonizzata da alcuni politici come il più grande nemico del nostro tempo.
Il paradosso è lampante: prevenire potrebbe costare meno che curare. Investire in cultura, servizi e protezione delle vittime è un risparmio sociale, oltre che, soprattutto, ci tengo a ricordarlo un dovere etico. Eppure, la retorica pubblica tende ancora a considerare il femminismo come un fastidio ideologico, piuttosto che una soluzione.
Il prezzo del clima che cambia Il secondo “300” arriva da un altro fronte caldo, letteralmente. Infatti, il grido d’allarme lanciato dalla COP16 ONU a dicembre 2024 parla di 300 miliardi di euro spesi globalmente in desertificazione, siccità e degrado del suolo. Costi che non consonsiderano solo le perdite agricole immediate, ma “hanno conseguenze su intere catene di approvvigionamento, riducono il prodotto interno lordo (PIL), incidono sui mezzi di sussistenza e causano problemi a lungo termine, come fame, disoccupazione, migrazione” come sottolineato da Kaveh Madani, autore del rapporto e direttore dell’Istituto universitario delle Nazioni Unite per l’acqua, l’ambiente e la salute.
Senza considerare poi che il cambiamento climatico non è più solo un rischio: è un dato attuale. In Italia lo abbiamo visto con le alluvioni in Emilia Romagna e Toscana, che hanno devastato campi, abitazioni e strutture commerciali, e lo stiamo vedendo in questo periodo con gli incendi che devastano le aree più calde come la Sardegna. Ma anche nel caldo atroce che sta tenendo il nostro Paese nella sua morsa in questa estate cocente, e che ha già fatto più di qualche morto. Eppure, anche qui, gli investimenti strutturali sono modesti, frammentati e spesso tardivi. Si finanzia il contenimento, la ricostruzione, ma si fa ben poco per la prevenzione.
Anche in questo caso, la soluzione c’è e si chiama transizione ecologica: include la protezione del suolo, l’efficientamento energetico, l’adattamento climatico, la riforestazione e l’agricoltura intensiva riformata. Il rapporto della Cop16 evidenzia proprio come le soluzioni basate sulla natura, come la riforestazione o la gestione dei pascoli, siano in grado di ridurre le perdite agricole e, allo stesso tempo, aumentarne i rendimenti, garantendo sia benefici climatici che economici. Un approccio condiviso anche da uno studio del 2020 della rivista scientifica Global Change Biology, secondo il quale “gli investimenti basati sulla natura spesso si dimostrano altrettanto efficaci, se non di più (59% dei casi) di altri interventi per combattere le conseguenze del cambiamento climatico”. Anche in questo caso, però, il cambiamento viene vissuto come un lusso, un rallentamento, un costo, quando in realtà è la sola forma di risparmio sostenibile che abbiamo.
300,

Manifestazione NUDM
l’8 marzo 2023 a Pisa
Due battaglie, un solo modello alternativo
Se sommiamo queste due voci - violenza di genere e degrado ambientale - otteniamo 600 miliardi all’anno di costi evitabili. E sono solo due sintomi di un modello insostenibile, che continua a riprodurre diseguaglianze sistemiche: tra i generi, tra esseri umani e natura, tra pro-
fitti e futuro. Due cause che si basano su un principio semplice: non sfruttare ciò che è vulnerabile solo perché puoi farlo. Non costruire la tua forza sulla debolezza altrui. È un principio valido nei rapporti tra generi. Ma anche tra Stati ed ecosistemi, tra produzione e risorse.
600 miliardi ogni anno - bruciati in violenza e siccità - non sono solo un dato
contabile. Sono soprattutto un fallimento collettivo. Ma sono anche la dimostrazione che i valori su cui si fondano femminismo e ambientalismo non sono utopie, ma razionalità applicata. Sono scelte che fanno bene alle persone, che riducono i danni sistemici, che liberano risorse per crescere in modo equo.
Un investimento intelligente
Forse allora dovremmo cambiare prospettiva. Non chiedere più quanto costa garantire diritti e futuro, ma quanto costa non farlo. Non chiederci se possiamo “permetterci” il femminismo o l’ambientalismo, ma se possiamo davvero permetterci di ignorarli. La risposta, ogni anno, è la stessa: 600 miliardi di euro buttati. Un sistema che si rifiuta di cambiare e preferisce pagare il prezzo dell’ingiustizia.
Alla prossima emergenza climatica e alla prossima donna lasciata senza protezione. Vogliamo ancora far finta di non sapere?
Il nord Italia continua ad essere gravementecolpitodallasiccitàimmaginedalsatelliteCopernicusdella Commissioneeuropea
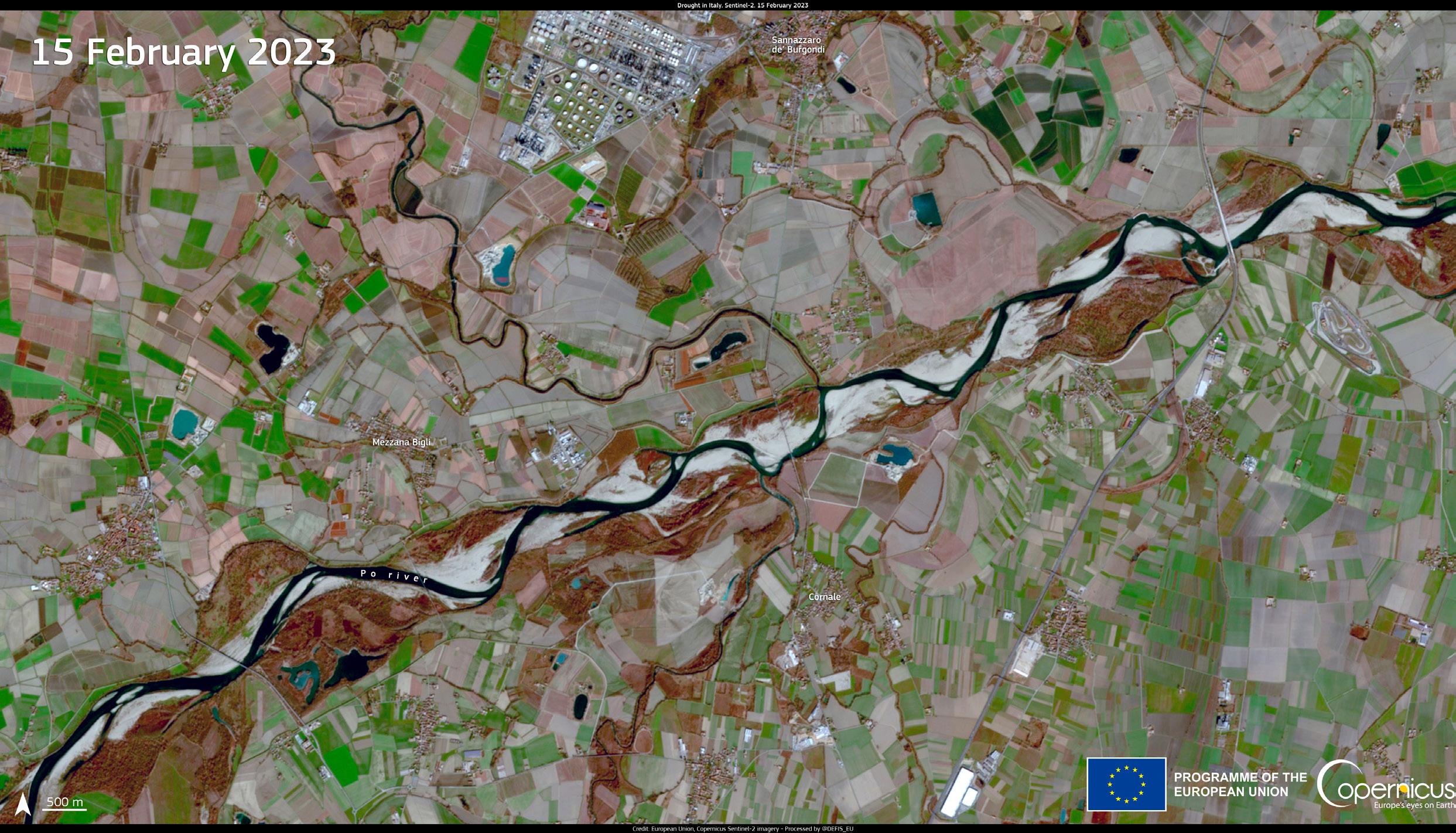
In base ai nuovi impegni sottoscritti con la NATO, l’Italia dovrà aumentare significativamente le proprie spese destinate alla difesa. Un’idea che agli italiani piace sempre meno…
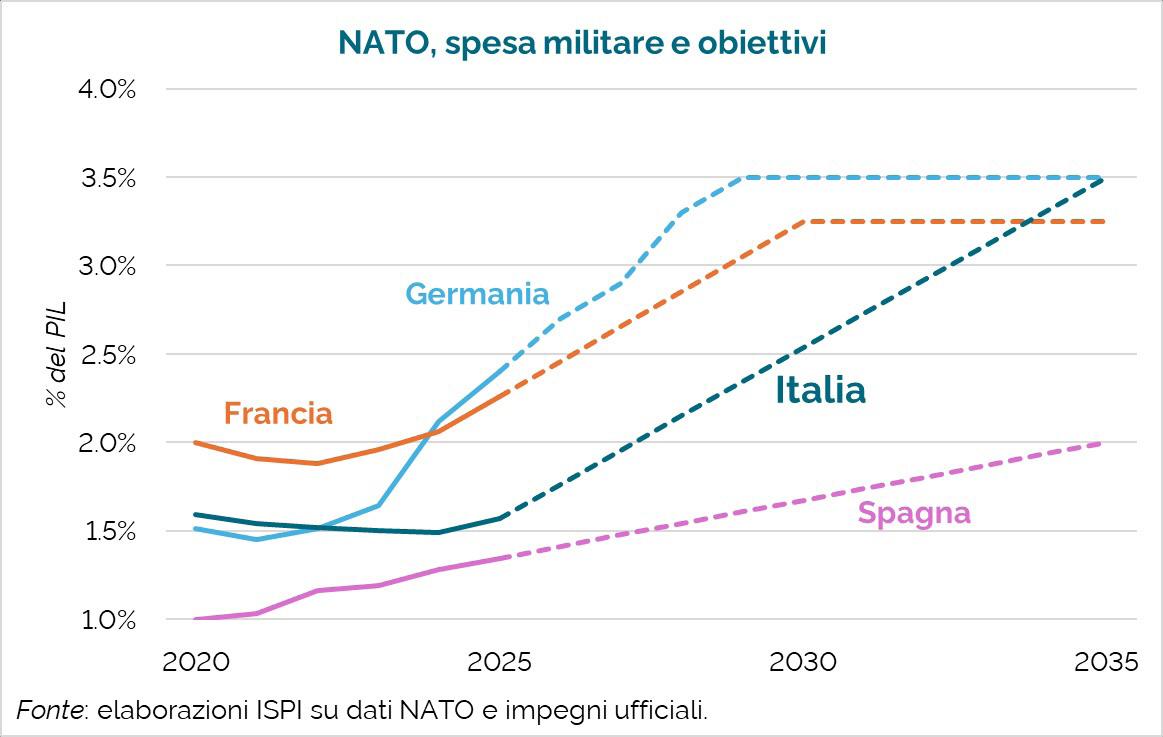
Lespesemilitaridialcunipaesieuropeiegliimpegni presiconlaNATO(Fonte:ISPI)
di Salvatore Borghese
Trecento è un numero che sarebbe apparso perfettamente a suo agio in mezzo alle cifre (tante) di cui si è sentito parlare ultimamente nel dibattito politico italiano. Intesi, ovviamente, come “trecento miliardi”: sarebbero in realtà persino molti più di così (finanche più di 400) gli euro che lo stato italiano dovrebbe sborsare nei prossimi anni per onorare gli impegni presi nell’ultimo vertice NATO, stando ad alcune dichiarazioni di esponenti dell’opposizione. Lo scorso 25 giugno a L’Aja, infatti, i paesi membri dell’alleanza atlantica si sono impegnati ad aumentare le proprie spese per la difesa fino al 3,5% del PIL, a cui si aggiunge un ulteriore 1,5% in spese definite “dual use” (ovvero legate alla sicurezza e alla resilienza delle infrastrutture
civili) entro il 2035. In totale, la spesa militare complessiva salirebbe così fino al 5% del PIL, proprio come auspicato dal presidente USA Donald Trump. A partire da questo dato di fatto è partito – immancabile – il balletto delle cifre e delle accuse incrociate.
Ma quanto spenderemo davvero?
La realtà, come spesso accade, è un po’ più sobria – e decisamente meno sensazionale. Innanzitutto, perché il nuovo obiettivo della NATO è da intendersi come una soglia di riferimento, non come un obbligo immediato. L’Italia, attualmente, spende circa l’1,5% del PIL per la difesa (dato recentemente “aggiustato” in modo da farlo arrivare al 2%). Un aumento pluriennale verso il 3,5% (più le spese “dual use”) non comporterebbe quindi
uno sbilanciamento improvviso, ma un incremento graduale (di circa 3-5 miliardi ogni anno), come spiegato da un recente articolo del Post.
Inoltre, l’Italia potrebbe utilizzare la clausola sul “dual use” per includere spese già previste in ambito infrastrutturale e di protezione civile, riducendo così l’impatto complessivo dell’aumento. In altre parole, le spese previste non saranno tutte nuove, ma andranno a coprire investimenti già programmati ma che verranno opportunamente “riclassificati”. Del resto, visti i limiti e i vincoli derivanti dalla struttura della spesa pubblica in Italia, non potrebbe che essere così. Secondo l’analista ISPI Matteo Villa, l’Italia non arriverà mai a rispettare un impegno così macroscopico come quello di portare la spesa militare al 3,5% del PIL, a meno di usare artifici contabili (come già fatto quest’anno per farla salire dall’1,5% al 2%). Insomma, questo obiettivo, pur formalmente dichiarato, verosimilmente non si tradurrà certo in una rivoluzione.
Perché allora si parla di cifre enormi?
Nonostante queste puntualizzazioni, alcuni esponenti politici continuano a parlare di stime di centinaia di miliardi di spesa ulteriore. Una possibile spiegazione è di tipo “strategico”: alimentare la percezione di un aumento massiccio della spesa militare può servire a compattare l’opinione pubblica contro il governo in carica che (a differenza di quello spagnolo, unico tra i paesi NATO) ha sottoscritto tali impegni.
Ma c’è anche un altro fattore, più strutturale: l’opinione pubblica italiana è storicamente fredda – se non apertamente ostile – rispetto
all’idea di aumentare le spese militari. E cavalcare questo sentimento è, semplicemente, politicamente conveniente.
Cosa ne pensano gli italiani?
Un sondaggio Ipsos per l’ISPI pubblicato ad aprile mostrava che solo il 10% degli italiani è favorevole ad aumentare la spesa militare. Il 43% è per mantenerla ai livelli attuali, mentre quasi un italiano su quattro vorrebbe addirittura ridurla. Tutto questo, nonostante la crescente incertezza internazionale e la minore disponibilità degli Stati Uniti a farsi carico della sicurezza europea.
Già a marzo, un’indagine condotta da Euromedia aveva evidenziato un orientamento simile: anche allora, i favorevoli a un aumento delle spese militari – “vista la nuova situazione internazionale” – erano circa un terzo, contro una maggioranza assoluta (intorno al 55%) di contrari. Un dato particolarmente significativo era che i favorevoli risultavano maggioritari solo tra gli elettori di PD, Forza Italia, Azione e Italia Viva – partiti che, insieme, ad oggi rappresentano circa il 35% dell’elettorato.
Alcuni dati, inoltre, sembrerebbero dimostrare che più il tema viene discusso, più

IlsondaggioIpsos/ISPI(aprile2025)
aumentano i contrari: un sondaggio dell’istituto Ixè condotto a fine giugno ha rilevato che oltre il 70% degli italiani è contrario ad aumentare la spesa pubblica in difesa e armamenti. Un’opposizione trasversale, che attraversa tutte le principali fasce demografiche e gli elettorati – con l’unica eccezione di chi si auto-colloca al centro, dove i favorevoli sono leggermente prevalenti (53%). Lo stesso sondaggio ha segnalato anche un raffreddamento nei confronti dell’idea di un esercito europeo: oggi, il 52% degli italiani si dice contrario, in netto contrasto con il favore espresso in precedenti rilevazioni negli scorsi anni.




Favorevoliecontrariall’aumentodellespese militari(fonte:sondaggioIxè)
In questo scenario, l’Italia rappresenta un’eccezione rilevante. Secondo una recente ricerca dello European Council on Foreign Relations (ECFR), l’Italia è l’unico tra i grandi paesi europei in cui il numero dei contrari all’aumento della spesa militare (57%) supera nettamente quello dei favorevoli (17%). In Germania, Francia, Spagna e Regno Unito i ruoli sono invertiti: i cittadini favorevoli all’aumento sono la maggioranza, talvolta con percentuali molto nette (come in Polonia, paese confinante con la Russia).
Questa posizione peculiare si spiega, in parte, con una tradizione culturale che ha sempre privilegiato il welfare rispetto alla spesa militare; ma anche con una diffidenza di lungo corso verso le logiche della deterrenza. In un paese in cui vi è un diffuso scetticismo (non del tutto ingiustificato) su come vengono investite le risorse pubbliche in scuola e sanità
e con una pressione fiscale così elevata, ogni euro in più alla difesa viene percepito come un euro in meno destinato ad altri scopi ritenuti prioritari.
Una strategia rischiosa
La strategia del governo italiano (mantenere l’impegno formale con la NATO, senza generare un impatto immediato sul bilancio né un forte contraccolpo nell’opinione pubblica) potrebbe rivelarsi fragile nel lungo periodo. La pressione dei partner – e in particolare degli Stati Uniti guidati da Trump – affinché l’Europa si faccia carico della propria sicurezza è enormemente aumentata rispetto al passato. Se lo scenario globale dovesse deteriorarsi ulteriormente, la richiesta di impegni più concreti potrebbe diventare difficile da eludere. In quel caso, l’Italia dovrà scegliere: accettare un aumento netto (ed effettivo) delle spese militari, assumendosene anche il costo politico interno; oppure difendere la propria specificità, rischiando un progressivo isolamento nel contesto euro-atlantico.
La vera posta in gioco non è solo contabile, ma culturale. Riguarda l’idea di sicurezza che ogni paese coltiva, e la disponibilità – o meno – a investire in essa. Per ora, almeno in Italia, quella disponibilità sembra rimanere molto limitata.
Link alle fonti:




(Fonte:indagineECFR,maggio2025)

di padre Gino Alberto Faccioli
La sofferenza è un’esperienza umana, che da sempre accompagna l’uomo e per questo la si può considerare come fondamentale. Essa interpella l’uomo ai vari piani della conoscenza: psicologico, filosofico, religioso.
de gruppo in cui è incorporato e dell’umanità.
Alcune volte la sofferenza è un’esperienza negativa accidentale nella vita di una persona o di una collettività. Altre volte si stabilizza come sensazione prevalente di un’intera esistenza o della storia in vari settori.
ma al tempo stesso quel mondo è in lui come una entità finita e irripetibile. Di pari passo con ciò, va, tuttavia, la dimensione interumana e sociale. Il mondo della sofferenza possiede quasi una sua propria compattezza» (Salvifici doloris, 8) Molte e varie sono le cause e le manifestazioni della sofferenza: il clima, la fame e la povertà, le malattie, la morte; contrasti con caratteri difficili; offese e disprezzo: da parte di nemici o di persone indifferenti, come pure ingratitudine, sfrontatezza, perfidia, persecuzioni, calunnie; pene spirituali: tentazioni, scrupoli, persecuzioni del demonio, incomprensioni, aridità spirituali. A queste sofferenze che si possono definire comuni, che possono, cioè, capitare a chiunque, si devono aggiungere quelle derivanti dal proprio stato di vita, ad esempio il matrimonio, lo stato religioso o la convivenza con persone che soffrono di queste stesse pene: amici, familiari o dipendenti. Oltre a tutte queste cause elencate, esiste la paura di soffrire nel futuro, che moltiplica e aggrava in modo indefinito il dolore dell’uomo, e questo in ogni momento.
La sofferenza è per l’uomo, in primo luogo, un’esperienza forte e diretta, prima che un tema o un problema interessante. Molteplici sono le forme e i gradi di questa esperienza e si presentano numerosi e vari a tutti i livelli: spirituale, psichico, somatico. E ognuna di queste forme si moltiplica, se teniamo conto che il soggetto soffre, oltre alle sue proprie pene, quelle delle altre persone che gli sono care o vicine e i patimenti del piccolo o gran-
«La sofferenza umana, scrive san Giovanni Paolo II nella Salvifici doloris, costituisce in se stessa quasi uno specifico mondo che esiste insieme all’uomo, che appare in lui e passa, e a volte non passa, ma in lui si convalida e approfondisce. Questo mondo della sofferenza, diviso in molti, in numerosissimi soggetti, esiste quasi nella dispersione. Ogni uomo, mediante la sua personale sofferenza, costituisce non solo una piccola parte del mondo,
La sofferenza implica: il sentimento di un dolore, il danno o male che apporta al soggetto, la ripugnanza della volontà e la sua possibile accettazione, l’interpretazione positiva o negativa della stessa, la reazione con cui la si evita o la si integra.
Gesù Cristo
Da sempre il “problema” sofferenza ha spinto l’uomo a darsi delle risposte, anche l’autore del libro della Genesi si è posto la domanda del perché della sofNella Passione Cristo

ferenza, del dolore, dove questa ha origine. La risposta che si è dato è che la sofferenza, che non era parte del disegno originario di Dio, ha origine con il peccato delle origini, dove la prima umanità (Adamo ed Eva) ha dato ascolto alle parole del demonio e non a quelle di Dio. Peccato, dunque, come causa della sofferenza, e questo era un comune modo di pensare, che tuttavia Gesù non accetta, soprattutto quando la sofferenza va a toccare “l’innocente”: «I suoi discepoli lo interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio”» (Gv 9,2-3). La sofferenza offre a Dio, afferma Gesù, un’occasione per manifestare la sua misericordia operando la redenzione per suo mezzo, premiando sempre colui che soffre, liberandolo qualche volta. Meglio ancora con le parole, Gesù illustra il mistero della sofferenza con l’esempio della sua vita.
Senso cristiano
Cristo non elimina la sofferenza ma la porta al massimo del suo realismo umano e divino allo stesso tempo. Nella passione di Gesù si incontrano e si contrastano nel modo più intimo il piano salvifico di Dio e la libertà malvagia degli uomini così Cristo non sopprime il dolore, ma lo spoglia del suo carattere punitivo, quale pura conseguenza del peccato. Come la passione di Gesù redime, ma non elimina il dolore, così il
senso cristiano redime il non senso, ma non elimina il problema della sofferenza umana.
Oggi la sofferenza è guardata con timore anche dai cristiani. Le origini di questa deviazione sono: 1. la perdita del sentimento del peccato e delle sue cattive conseguenze permanenti nell’uomo; 2. l’ottimismo esagerato e la fiducia della natura umana, fondata sui progressi della scienza ogni giorno maggiori; 3. la scoperta dell’importanza della risurrezione di Cristo nel mistero del cristiano che in generale fa dimenticare o trascendere gli altri aspetti altrettanto importanti del ministero.
L’elemento formale della sofferenza è la volontà umana, che reagisce accettando o rifiutando. L’elemento cristiano è, oltre la volontà rassegnata, la visione di fede che riesce a inquadrare la sofferenza nel mistero della redenzione. La distinzione tra volontario-involontario riferito alla sofferenza prende un duplice aspetto. Volontario, infatti, può significare un dolore deliberatamente cercato, per esempio quello della contrizione della mortificazione veramente scelto appunto; involontario: in questo caso significa un dolore che sopravviene indipendentemente dalla nostra volontà, come le malattie. Volontaria è anche la sofferenza nel caso in cui si accetti liberamente un dolore che sopravviene, si è cercato da noi, si è aggiunto da sé.
L’accettazione del dolore fisico o morale comporta un obbligo per la vita cristiana nella misura in cui esso è necessario per compiere i propri impegni cristiani vocazionali. Chi trova il dolore sulla propria strada, deve saperlo assumere e integrarlo nella fede, nell’amore e nella speranza ognuno di questi atteggiamenti

fondamentali imprime un senso speciale un impulso originale nell’esperienza della sofferenza umana. Il dolore di cui si occupa la spiritualità è lo stesso che analizzano e cercano di curare la medicina e la psicologia, la psichiatria. Il fatto di dare un senso al dolore va accompagnato dal legittimo desiderio e dallo sforzo per porvi rimedio.
Tolta quindi la falsa speranza di eliminare la sofferenza coi mezzi tecnici della nostra civiltà, la chiesa affronta con apertura da decenni i progressi morali connessi con l’analgesia. È stata la carità cristiana la forza più viva nella storia nella lotta contro la sofferenza allo stesso punto che predicava allo stesso tempo la speranza.
La sofferenza è diventata una componente inseparabile della condizione della vita dell’uomo, del cristiano. Anche qui vale il principio teologico teologale: comprendere nella fede, accogliere nell’amore, agire nella speranza. L’utilità della sofferenza si dimostra in tante forme e occasioni, come fattore di crescita, particolarmente in due momenti: all’inizio del cammino verso Dio come elemento di conversione di purificazione, e nelle fasi più avanzate in cui diventa decisiva nel rendere più profonda l’intimità divina.
Quanto più la volontà interviene per accettare la sofferenza, tantomeno si soffre, perché il dolore è ciò che contraddice le nostre tendenze e, se la volontà vi si adatta, esso contraddice soltanto le tendenze inferiori. Al contrario, quanto maggiore sarà la volontà, tanto maggiori saranno i meriti e migliori gli effetti, perché essi dipendono dalla sottomissione della volontà alla grazia. Arriviamo quasi alla relazione inversa: trattandosi di una sofferenza concreta, essa è tanto più meritoria è valida quanto più soave e tollerabile, cioè meno dolorosa. L’importante è, dunque, non quanto si soffre, ma come si soffre: con pazienza, con generosità, con allegria. Non è desiderio di soffrire per soffrire, che sarebbe una un’aberrazione psichica, ma la convinzione e, forse, l’esperienza che eleva Dio e attua le relazioni di carità con lui.
Vive a Verona, lavora per Independent Persian ed è una giornalista
freelance: “a Teheran rischio arresto e impiccagione”

Hana Namdari: “Finché la base del potere rimane religiosa e assoluta, nessun cambiamento sarà reale. Le libertà si possono simulare, ma non vivere. E gli iraniani lo sanno fin troppo bene, chi prova a ribellarsi viene eliminato in silenzio.”
Hana Namdari, giornalista con origini curde nata a Teheran, è in Italia dal 2010 e da quattro anni lavora a Verona, -dove vive dal 2018 e dove si è sposataper l’Indipendent Persian, media indipendente con cui denuncia quella che definisce la “sistematica azione di repressione” della Repubblica Islamica. Hana Namdari, volto noto anche sulle tv nazionali (a TgCom 24 ha recentemente dichiarato “Io sono scappata dal mio Paese e non posso più tornare a casa: se solo mi avvicino all’aeroporto di Teheran vengo arrestata e impiccata, immediatamente. Per quale colpa? Per essere un’attivista che dice la verità e che denuncia la dittatura e i soprusi che da 47 anni continuano nel Paese? La guerra è uno choc ma forse così cambierà qualcosa, in tanti oggi lo sperano anche se non tutti hanno il coraggio di parlare”), è da sempre in prima linea sul fronte dei diritti umani, strenua oppositrice del regime teocratico iraniano e ha concesso per Guerre da dentro un’intervista a ViPiu.it per rilanciare la sua testimonianza, in un momento particolarmente difficile per il suo paese colpito dagli attacchi di Israele e Stati Uniti prima di scriverne alcune che vi proponiamo in queste pagine (con una sola regola valida per tutte: riportare il “sentiment” di chi viene intervistato senza entrare, chi scrive, in valutazioni e considerazioni che si possono fare altrove)
Il regime iraniano condiziona la diffusione delle notizie? E se sì in che modo? Assolutamente sì. In Iran, l’informazione con l’attuale regime non è mai stata libera. Esiste un sistema di censura capillare, gestito diret-
tamente dallo Stato, che controlla tutto ciò che viene pubblicato o trasmesso. Ogni giornale, ogni programma televisivo, ogni sito internet attivo nel Paese deve ottenere l’autorizzazione preventiva delle autorità e firmare un impegno formale di fedeltà alla Costituzione della Repubblica Islamica.
Qualsiasi contenuto che anche solo vagamente metta in discussione i valori del regime, il ruolo del Leader Supremo o le leggi religiose viene bloccato, censurato o punito. Le redazioni vivono sotto costante minaccia: basta un titolo considerato “sospetto” per far chiudere una testata o far arrestare un giornalista.

lavorando in televisione, la censura la sentivo addosso in modo ancora più pesante. Ogni frase che pronunciavamo in onda doveva essere autorizzata, ogni intervista passava al vaglio, ogni argomento veniva filtrato secondo i criteri imposti dal regime.
Io stessa ne ho fatto esperienza indirettamente: mio padre è stato arrestato più volte per articoli che avevano osato toccare verità scomode. Non serviva molto: bastava una parola fuori posto, una foto fuori contesto, una frase interpretata male.
Ma non si tratta solo di censura. Il regime pratica anche una strategia attiva di disinformazione sistematica: manipola immagini, riutilizza fotografie del passato, diffonde versioni distorte degli eventi. In questi giorni, ad esempio, hanno fatto circolare immagini vecchie spacciandole per attuali, nel tentativo di controllare la percezione pubblica e internazionale.
Anche i media internazionali non sono liberi di operare in Iran. Devono firmare gli stessi impegni di lealtà al regime, sono sottoposti a controlli severi, seguiti dai servizi e non possono partecipare liberamente a manifestazioni o eventi pubblici. Chi tenta di raccontare il vero rischia grosso. Il caso della giornalista italiana Cecilia Sala, arrestata appena arrivata nel Paese, ne è un esempio chiaro: per il regime, la verità è pericolosa, soprattutto se raccontata da occhi stranieri.
In Iran, la verità non è solo nascosta: viene attivamente sostituita. Questo è il dramma più profondo per chi, come noi, ha scelto di raccontare ciò che succede davvero.
Quindi lei si sentiva condizionata? Ovvio che mi sentivo condizionata, ogni giorno, in ogni parola. E non solo come cittadina, ma soprattutto come professionista:
Non esisteva libertà editoriale, né libertà di opinione. Dovevamo ripetere frasi imposte, evitare nomi proibiti, seguire linee guida ideologiche rigide. Anche l’abbigliamento era una forma di censura visiva: io stessa potevo apparire solo se completamente coperta, con il velo ben sistemato, senza un filo di trucco in più, senza poter esprimere nulla del mio stile, della mia identità.
In quelle condizioni, è difficile sentirsi liberi. E ancora più difficile è creare qualcosa di autentico, quando sai che ogni parola può costarti il lavoro, la libertà o anche peggio.
Come maturò la scelta di lasciare il suo paese?
Avevo solo sei anni quando fui costretta a indossare un’uniforme nera che mi copriva dalla testa ai piedi. Iniziai così la scuola elementare sotto la Repubblica Islamica. Ogni mattina cominciava con la lettura obbligatoria del Corano e proseguiva con slogan gridati in coro: “Morte all’America”, “Morte al regime sionista”. Un’educazione ideologica imposta fin dall’infanzia, senza spazio per il pensiero critico o per la libertà.
Nonostante tutto, riuscii a entrare all’Università di Teheran e poi a lavorare in televisione. Per motivi professionali, mi trasferii a Sanandaj, la mia città d’origine, dove conducevo un programma rivolto ai giovani. Ma fu proprio allora che capii, fino in fondo, quanto fosse impossibile per me continuare a vivere e lavorare in Iran.
L’atmosfera era soffocante. Ogni parola do-
veva essere approvata dalla censura. Non potevo andare in onda senza essere completamente coperta; ogni intervista, ogni battuta, ogni testo era controllato. La libertà di espressione non esisteva. Non potevi dire, scrivere o perfino pensare liberamente.
Per una donna, per una giornalista e per giunta una curda, non c’era futuro. Era chiaro: dovevo cercare un’altra strada, un’altra casa, un’altra vita.
È stata una consapevolezza che ho maturato giorno dopo giorno. Paradossalmente, cercavamo di ricreare piccoli spazi di libertà nelle nostre case: feste private, balli, conversazioni intime, letture proibite, un bicchiere di vino, la possibilità di stare senza velo, di sentirci semplicemente umani. Era il nostro modo per sopravvivere, per respirare.
Ma la paura era sempre presente. Alcuni cittadini, molto religiosi e fedeli al regime, facevano da spie. Bastava una telefonata alla polizia “In quella casa c’è una festa, uomini e donne insieme” e la tua vita poteva cambiare in un attimo.
È importante ricordare che prima del 1979, durante il periodo dello Shah, in Iran si viveva in un modo completamente diverso: non c’erano obblighi religiosi nell’abbigliamento, uomini e donne potevano frequentarsi liberamente, si andava a concerti, in discoteca, al mare. Una quotidianità simile a quella di molti Paesi europei. Gli anni ’60 e ’70, per chi li ha vissuti, restano ancora oggi un simbolo di libertà.
Io non ce la facevo più. Non riuscivo ad accettare che, dopo una serata passata tra affetti, risate e musica, la mattina dovessi rientrare in un mondo buio, cupo, dominato dalla paura e dalla repressione. Quel contrasto è diventato insostenibile. Non volevo più sopravvivere: volevo vivere.
Com’era la situazione in Iran sul fronte dei diritti umani e delle libertà delle donne?
La condizione delle donne in Iran, sotto la Repubblica Islamica, è una delle più discriminatorie al mondo. I diritti fondamentali sono gravemente limitati da leggi religiose e patriarcali che trattano le donne come cittadine di seconda classe.
A livello legale, la testimonianza di una donna vale la metà di quella di un uomo in tribunale. In caso di divorzio, la custodia dei figli viene assegnata automaticamente al padre o alla famiglia paterna. Se una donna commette adulterio, rischia ancora oggi la pena di morte per impiccagione — e fino a pochi anni fa, la lapidazione era praticata ufficialmente.
Una donna non può sposarsi né viaggiare all’estero senza il permesso del padre (se nubile) o del marito (se sposata). E sempre il marito ha il potere legale di impedirle di lavorare o di lasciare il paese.
Sul piano della vita quotidiana, le donne devono rispettare un rigido codice di abbigliamento: il velo è obbligatorio in ogni luogo pubblico, e il corpo deve essere completamente coperto. Anche andare al mare o in piscina è una questione di controllo e separazione: le spiagge sono divise per genere, e in molti casi alle donne è vietato fare il bagno in pubblico, se non coperte.
Cantare in pubblico è proibito per una donna. Così come fumare in pubblico è considerato “immorale”. Le restrizioni colpiscono anche la libertà di movimento, di espressione, di arte, di scelta personale. In breve, le donne iraniane vivono sotto un sistema che legalizza la discriminazione e nega ogni autonomia, anche sui più semplici aspetti della vita. Chi osa sfidare queste regole, rischia carcere, frustate, o peggio.
Un altro aspetto poco noto riguarda le restrizioni matrimoniali imposte alle donne iraniane.
Secondo la legge della Repubblica Islamica, una donna musulmana non può sposare legalmente un uomo non musulmano. Se lo fa, il matrimonio non viene riconosciuto dallo Stato. Questo vale anche fuori dall’Iran, nei consolati e nelle ambasciate.
Molte donne iraniane residenti all’estero, anche in Paesi liberi e laici come l’Italia, si trovano in situazioni assurde e discriminatorie. Per ottenere il nulla osta al matrimonio da parte delle autorità iraniane, è spesso richiesto che il futuro marito – se non musulmano – si converta formalmente all’Islam. Senza questa conversione, la donna non può sposarsi civilmente, né registrare legalmente il matrimonio in Iran.
È una pratica che viola il principio di libertà religiosa, oltre a ledere i diritti fondamentali della persona. Ed è sorprendente – e anche doloroso – vedere che Paesi democratici come l’Italia tollerino che, sul loro territorio, uno Stato straniero imponga condizioni così medievali e sessiste alle proprie cittadine.
Queste sono le contraddizioni che molte donne iraniane affrontano ogni giorno, anche dopo essere fuggite dal proprio Paese. La libertà, per noi, non è mai stata un diritto acquisito: è una conquista continua.
Oggi secondo lei non è cambiato nulla? Purtroppo, no. Non è cambiato nulla di sostanziale. La Repubblica Islamica si fonda su una costituzione religiosa, ispirata direttamente alla sharia e al Corano, considerato parola divina e dunque intoccabile. Questo significa che chi protesta contro le leggi o contro il sistema, viene immediatamente accusato di essere contro Dio stesso e per questo può essere arrestato, torturato, persino giustiziato.
Non bisogna farsi ingannare da alcune immagini diffuse sui social o dai media di regime, che mostrano giovani donne sorridenti, senza velo, come se l’Iran fosse improvvisamente diventato un paese libero.
È una propaganda studiata, pensata per manipolare l’opinione pubblica internazionale e soprattutto per ingannare l’Occidente, mostrando una “normalità” che non esiste.
La verità è che la repressione è ancora durissima, e anzi, negli ultimi anni si è fatta ancora più feroce. Le telecamere controllano le strade, le università, i mezzi pubblici. Le donne vengono identificate con l’intelligenza artificiale e punite, anche solo per un velo messo “male”. Le prigioni sono piene di attivisti, studenti, artisti, giornalisti, semplici cittadini che hanno osato esprimersi.
Finché la base del potere rimane religiosa e assoluta, nessun cambiamento sarà reale. Le libertà si possono simulare, ma non vivere. E gli iraniani lo sanno fin troppo bene.
I suoi familiari vivono ancora in Iran? Per fortuna, tre dei miei fratelli sono riusciti a lasciare l’Iran negli anni scorsi. Ognuno di noi ha seguito una strada diversa, ma
con un unico obiettivo: cercare libertà e dignità fuori da quella gabbia.
Mia madre, invece, vive ancora lì, da sola. È una delle tante donne forti che sono rimaste, spesso per necessità più che per scelta. In questo momento, per fortuna, si trova qui con noi, in Italia, per ricevere le cure mediche di cui ha bisogno. Ma il pensiero che debba un giorno tornare in un Paese dove la sanità è sotto il controllo del regime e dove i diritti più basilari mancano mi fa molta paura.
E poi ci sono gli amici, le persone care, quei legami profondi che restano anche a distanza. Ogni telefonata, ogni silenzio improvviso, porta con sé l’ansia di sapere se stanno bene, se non sono stati arrestati, se non sono finiti nel mirino del regime.
Quello che ci hanno tolto, oltre alla libertà, è anche la possibilità di vivere insieme ai nostri affetti, nella nostra terra.
È ben noto l’attacco israeliano e di recente quello statunitense al suo paese, come vengono vissuti dal popolo iraniano ?
Per molte persone in Iran, questi attacchi non sono vissuti come una minaccia, ma come un segnale di speranza.
Dopo 47 anni di dittatura religiosa, dopo decenni di repressione, povertà, torture, esecuzioni pubbliche e censura, la gente è stanca. Stanca di essere sola, di gridare libertà senza che il mondo ascolti.
Negli ultimi tre anni, soprattutto con il movimento Donna, Vita, Libertà, milioni di iraniani sono scesi in piazza, hanno rischiato tutto – molti hanno perso la vita – ma nessuna vera potenza internazionale è intervenuta a sostegno. Siamo stati dimenticati.
E mentre il regime continuava a minacciare Israele e l’Occidente, nelle scuole, negli uffici pubblici, perfino agli ingressi degli edifici statali, venivamo costretti a calpestare le bandiere di Israele e degli Stati Uniti. Era obbligatorio. Dovevi farlo per entrare. Dovevi gridare “Morte all’America”, “Morte a Israele”, anche se non ci credevi. Altrimenti rischiavi l’espulsione, o peggio.
A Teheran, c’è ancora un grande tabellone elettronico, ora danneggiato da un’incursione israeliana, che ogni giorno “conta” quanto manca, secondo loro, alla fine del cosiddetto regime sionista “fissata” al 2040.

È tutta una propaganda continua, ossessiva, costruita per odiare. Per distrarre dalla realtà: una società impoverita, devastata ecologicamente, piena di giovani che fuggono, di donne oppresse, di carceri piene di innocenti.
In questo contesto, alcuni vedono l’intervento esterno come un’operazione chirurgica necessaria.
Perché il popolo, da solo, non ce la fa più. La repressione è troppo forte. Chi prova a ribellarsi viene eliminato in silenzio.
Non è questione di sostenere una guerra o un’occupazione, ma di capire che senza un aiuto concreto, il popolo iraniano rischia di rimanere per sempre schiacciato sotto un regime disumano.
Anche perché, una volta eliminato questo regime, potrebbe davvero tornare la pace in Medio Oriente.
La Repubblica Islamica dell’Iran, fin dalla sua nascita nel 1979, ha esportato instabilità e conflitto.
Non è un’opinione: è un fatto documentato. Ha finanziato milizie estremiste in Palestina, Libano, Siria, Iraq, Yemen, e ha alimentato l’odio verso Israele e l’Occidente per decenni. È la radice di gran parte delle tensioni nell’area.
Finché questo regime resterà in piedi, nessun popolo nella regione potrà davvero respirare in pace, né il popolo iraniano, né quelli vicini.
Solo con la fine della teocrazia di Teheran si potrà aprire uno spazio nuovo per la stabilità, il dialogo e la riconciliazione.
Il popolo iraniano non vuole più guerra, non vuole più essere usato come arma ideologica. Vuole vivere, costruire, rialzarsi. E per farlo, ha bisogno che il mondo riconosca una verità semplice: il cuore del problema, purtroppo, è a Teheran.
Ha notizie di vittime fra i civili nelle incursioni che hanno avuto come principali obiettivi i siti per la produzione di energia nucleare?
Finora, alla notte del 24 giugno, si registrano circa 819 morti in Iran a seguito degli attacchi, di cui circa 180 sono civili. Gli attacchi hanno colpito sia siti per la produzione di energia nucleare sia altre infrastrutture
Che lei sappia l’Iran stava preparando l’atomica?
Non solo io, ma anche l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha confermato che l’Iran ha accumulato uranio arricchito in quantità tale da poter potenzialmente costruire una bomba atomica. Sebbene il governo iraniano abbia sempre dichiarato che il suo programma nucleare è a scopi civili, molte autorità internazionali temono che ci siano intenti militari dietro a questo accumulo.
I capi del regime sono in fuga o nascosti da qualche parte?
I vertici del regime iraniano non sono in fuga apertamente, ma molti vivono sotto stretta protezione e in condizioni di massima sicurezza, consapevoli delle crescenti minacce interne ed esterne. Alcuni membri importanti cercano di mantenere un basso profilo per evitare di essere bersaglio di attacchi o arresti.
Tuttavia, alcune fonti sostengono che alcuni esponenti di spicco potrebbero già essersi rifugiati in paesi come Russia o Venezuela,
anche se queste informazioni non sono state confermate ufficialmente.
È ipotizzabile un ribaltone degli Ayatollah?
Certamente, è ipotizzabile e lo speriamo con tutto il cuore. Un ribaltone degli Ayatollah rappresenterebbe non solo una liberazione per il popolo iraniano, oppresso da decenni di dittatura religiosa, ma sarebbe anche un grande regalo per tutto il mondo, poiché potrebbe portare a una maggiore stabilità e pace in Medio Oriente.
Inoltre, per il regime è stato duro subire gli attacchi da parte di Israele, che hanno messo in evidenza le fragilità e aperto crepe tra i suoi vertici, alimentando tensioni interne che potrebbero favorire un cambiamento.
Ora cosa faranno Cina e Russia?
La Russia aveva affermato che avrebbero fornito testate nucleari all’Iran, ma questa notizia non è mai stata ufficialmente confermata. Successivamente hanno smentito, sottolineando che, a differenza di Israele, la Russia è membro del Trattato di Non Proliferazione Nucleare.
Attualmente, la Russia condanna ufficialmente contro Israele e gli USA ma cerca di evitare un’escalation del conflitto, non volendo entrare in ulteriori tensioni.
La Cina, invece, ha chiesto a tutte le parti coinvolte di evitare escalation e di impedire che la guerra si allarghi ad altre regioni.
La Cina ha sottolineato in modo particolare che lo Stretto di Hormuz, attraverso cui transito molto del greggio e del gas anche verso quel paese, e il Golfo Persico devono essere protetti dalle conseguenze del conflitto, evitando che vengano coinvolti nelle tensioni e nelle ripercussioni della guerra.
La repubblica islamica sperava in un sostegno più deciso da parte di Cina e Russia, ma finora così non è stato. In questo momento in cui Trump parla di tregua e pace, bisogna aspettare e vedere come si evolveranno gli eventi. Spesso queste dichiarazioni aprono spazi di speranza, ma la situazione resta molto complessa e delicata. Sarà fondamentale osservare le mosse dei vari attori coinvolti per capire se davvero ci sarà un cambiamento concreto.
ripassate la storia, paghiamo un prezzo alto per la libertà e sovranità di tutta l’Europa “
L’unica presenza tangibile dell’Iran in Ucraina sono gli Shahed (droni). Iran non esporta più bei tappeti o deliziosi pistacchi, ma i droni-kamikaze che la gente ormai ha imparato a riconoscere quando si avvicinano alle case per poi esplodere

di Hana Namdari
Marina Sorina, nata a Kharkiv (Ucraina) nel 1973, dal 1995 vive in Italia, dove si è laureata nel 2004 in Lingue e letterature straniere presso l’Università di Verona. Nel 2009 ha conseguito un dottorato di ricerca in letterature comparate presso lo stesso Ateneo. Dal 2008 abita nel quartiere di Veronetta (sarà un caso che i colori di Verona siano quelli della bandiera ucraina, cioè giallo e azzurro?) che considera “casa mia e al quale ho dedicato il mio secondo libro. Dal 2012, dopo aver passato un esame impegnativo, lavoro come guida turistica. Dal 2014 al 2022 facevo parte del direttivo di “Malve di Ucraina” APS, l’associazione che riunisce la comunità ucraina veronese presso Centro per le donne migranti “Casa di Ramia”. Ero impegnata negli aiuti umanitari all’Ucraina, nei progetti rivolti alla diaspora ucraina in Italia, assistenza ai profughi, traduzioni letterarie, organizzazione delle manifestazioni, eventi culturali. Fra il 2022 e 2024 sono stata candidata alle elezioni municipali, politiche ed europee con Più Europa.
Sono autrice di diversi racconti pubblicati nelle miscellanee di scrittori migranti e di due libri di narrativa (Voglio un marito italiano, Punto d’incontro ed., 2006; Storie dal pianeta Veronetta, Tra le righe ed., 2018). Negli ultimi anni mi sono dedicata alla traduzione letteraria dall’ucraino, pubblicando due volumi: le poesie di Oksana Stomina (Lettere non spedite, Gilgamesh Ed.,2023) e le prose brevi di Illia Iliukha (Le mie donne, Mezzelane ed., 2024)”.
Marina, la guerra come ha cambiato la tua vita quotidiana?
Il primo cambiamento è avvenuto a fine autunno del 2013, quando sono andata a Kyiv per partecipare alla protesta di massa in piazza d’indipendenza, descritta magistralmente nel libro di Marcy Shore “La notte ucraina”, tradotto di recente dalla prof. Olivia Guaraldo (Castelvecchi ed., 2025). Quella manifestazione pacifica e popolare, durata mesi, ha determinato un cambiamento epocale nella politica ucraina, da un lato lanciandola verso l’integrazione europea, ma a prezzo di veder invase due delle regioni più importanti: Donbas e Crimea. Dopo quella esperienza mi sono avvicinata alle donne ucraine che frequentavano il centro culturale “Casa di Ramia”, e ho cominciato a collaborare con loro per la promozione della identità ucraina.
Dopo l’inizio della invasione russa su larga scala, a fine febbraio del 2022, la mia vita è cambiata completamente. Non avevo tempo per le faccende quotidiane o per la mia salute. C’era una emergenza umanitaria alla quale dovevamo rispondere. Certi giorni non mangiavo nemmeno, e questo stato di massima mobilitazione era comune alla maggior parte delle mie amiche. La notte mi svegliavo prima dell’alba, all’ora in cui cominciavano a bombardare la mia città, come se fossi sintonizzata. La prima cosa la mattina era vedere quali città fossero cadute, quali resistessero. Ma c’era anche un lato positivo: sono… dimagrita di colpo, ho conosciuto tante persone meravigliose e ho cominciato a parlare spesso l’ucraino, per rispetto dei profughi con i quali avevo a che fare. È cambiata radicalmente anche la mia vita lavorativa: ho cominciato a lavorare anche in lingua ucraina, oltre che in italiano ed inglese. Con il passare del tempo è tor-

nata maggiore calma, anche se l’abitudine di svegliarsi presto e controllare subito il notiziario è rimasta.
C’è qualcosa che ti manca particolarmente della tua vita “prima”?
Mi manca la fiducia nell’umanità. La guerra ha tolto il velo di illusioni, facendo vedere cosa valgono le persone alla prova dei fatti. Prima pensavo che la nostra società europea fosse basata su leggi giuste, scritte o non scritte, ispirate ai principi di solidarietà, giustizia, libertà.
Ora, visto come reagiscono i governi e i semplici cittadini alle sfide lanciate da tante dittature, mi viene il dubbio che questi valori siano veramente compresi dagli europei. Il segnale d’allarme suona chiaro e forte, il sangue scorre a poca distanza da noi, e la gente continua a dormire, ovvero vivere la propria vita senza rendersi conto del pericolo incombente.
Mi aspettavo maggiore attenzione da parte degli ambienti preposti a sensibilizzare la società, ad esempio, dalle femministe. Stranamente, non si sono mobiliate più di tanto per la guerra in Ucraina, dove le donne subiscono violenza sistematica da parte dei militari russi, ma ricoprono anche ruoli importanti all’interno dell’esercito.
Un’altra cosa che mi manca, e che spero di poter ritrovare dopo la vittoria, è la possibilità di viaggiare liberamente in Ucraina. È il paese più grande d’Europa, ricco di meraviglie storiche e naturali e di città-gioielli come Odessa e Lviv, per non parlare di Kyiv, la capitale plurimillenaria. Erano e restano, nonostante le ferite evidenti, città affascinanti e con ricca offerta culturale. Mi dispiace tanto di non aver dato abbastanza attenzione alle città meno note ma importanti, come Mariupol, mutilata in modo da essere ora irriconoscibile nei primi mesi della invasione e ormai irraggiungibile.
È molto forte la nostalgia della Crimea, dove passavo le vacanze estive con la famiglia negli anni nell’infanzia. Per me era un luogo dell’anima, che non potrò rivedere finché non tornerà sotto l’ala ucraina.
Hai familiari o amici ancora in Ucraina? Come stanno affrontando tutto

questo?
I miei genitori vivono sempre a Kharkiv, a distanza di 20 secondi di volo per i missili russi. Hanno avuto varie occasioni per poter andar via, ma non hanno mai voluto fare. Non è questione di eroismo, piuttosto di fatalismo: se deve succedere qualcosa di brutto, succederà. Non vogliono lasciare la propria casa, gli affetti e le abitudini di una vita. Guardano gli eventi bellici con rassegnata serenità. Entrambi conoscono bene la storia e sanno che la pace è solo una breve parentesi fra le guerre. Se capita di trovarsi in guerra, bisogna continuare a vivere e restare umani, anche se la tua vita è in costante pericolo.
Anche i miei amici, per la maggior parte non hanno voluto espatriare. Alcuni l’hanno fatto nei primi mesi e poi sono tornati a casa. Per molti di loro conta di più essere a casa che in sicurezza. È una questione esistenziale: cedere alla prepotenza o affrontarla a testa alta? Fuggire per proteggersi o rischiare la vita ma restare coerenti con le proprie idee? Ciascuno fa la scelta in accordo con le proprie idee e forze.
Anche solo restare a vivere in Ucraina, contribuendo all’economia, mantenendo viva l’economia e la cultura, a mio avviso, è un atto eroico. Fra i miei amici rimasti in Ucraina molti si sono dedicati al volontariato, a sostegno dell’esercito e dei ceti vulnerabili. Ma c’è anche chi ha fatto un passo più deciso e si è arruolato nell’esercito, lasciando in sospeso carriera e famiglia. Alcuni di loro sono stati gravemente feriti e sono tornati a casa; altri non torneranno mai perché sono stati uccisi.
Secondo te, come si sente oggi il popolo ucraino? È più arrabbiato, più unito, più stanco…? Non posso parlare per tutto il popolo, posso però riassumere gli umori dei miei amici, cioè della parte attiva e patriottica della società ucraina. L’aspirazione alla vittoria e alla giustizia rimane forte, come anche l’idea del destino comune, dell’unità del popolo (inteso sempre non in senso meramente etnico, ma come comunità residente su un certo territorio). Nessuno vuole arrendersi, cedere territori ecc. I russi credono che i loro attacchi potranno scoraggiare
e opprimere i civili, ma in realtà ottengono l’effetto contrario e aumentano la repulsione e la volontà di rivalsa. La rabbia nei confronti dei nemici è tanta, ma non meno diffusa è l’amarezza nei confronti di chi fra i nostri alleati avrebbe potuto risolvere la situazione tempo fa, fornendo aiuti adeguati, sia militari che diplomatici ed economici, ma ha preferito temporeggiare, protraendo la guerra e dissanguando l’Ucraina.
Il cosiddetto “mondo occidentale”, fortemente idealizzato dagli ucraini, non ha mantenuto né gli obblighi legali del Memorandum di Budapest, né gli impegni presi in questi ultimi anni. Ora, in questi giorni con la minacciata defezione degli USA, se verrà confermata, l’Ucraina sarà privata anche delle armi difensive promesse, arrivate fino in Polonia. Questa decisione di Trump lascia il paese esposto alla crudeltà dell’esercito russo, che non ha tardato ad intensificare gli attacchi.
Che cosa si dice tra la gente comune sulla situazione attuale? C’è fiducia nel governo?
C’è fiducia nel governo fra quelli che lo hanno sostenuto fin dall’inizio, ovvero il 75% degli elettori; c’è, come sempre, lo scetticismo da parte dell’opposizione. Ciò che unisce entrambi gli schieramenti è, però, il desiderio di resistere all’invasore. Il governo non è il punto nodale della situazione: si fa e si disfa. Quel che conta è che i cittadini, a prescindere dalla propria etnia, fede o lingua madre, vogliono difendere la propria terra dalla barbarie russa. Sappiamo, per esperienza storica e per le testimonianze recenti dai territori occupati, che agli sconfitti sarà riservato il trattamento di cancellazione fisica e identitaria, più amaro della morte. Per questo la gente vuole ancora combattere, nonostante la stanchezza e il dolore.
I media ucraini danno un’immagine realistica della guerra o senti che qualcosa viene nascosto?
In Ucraina la verità è difficile da nascondere, perché le notizie sulla situazione reale ti arrivano direttamente dagli amici che combattono sul fronte o vivono nelle città colpite. La guerra impone tempi brevi sia
di diffusione che di fruizione delle notizie, questo fa passare in secondo piano i giornali e la TV, che hanno subito una sorta di “aggregazione forzata”.
Per agevolare e sintonizzare il lavoro di singole stazioni, nel 2022 è stata imposta dal governo la “maratona televisiva”, giustamente criticata per mancanza di libertà d’espressione. I singoli canali smettevano la propria programmazione indipendente e contribuivano invece a turni al palinsesto unico. L’intenzione era buona: la realtà della guerra è tragica, rivedere sullo schermo gli orrori che hai già visto dalla propria finestra creerebbe un trauma che danneggia l’animo più fragile, soprattutto quello dei minori. Per questo il governo ha cercato di offrire un mix di notizie in cui i fatti difficili possano essere bilanciati dalle notizie rassicuranti.
Ma in fondo non ha grande importanza. Gli adulti traggono informazioni dai canali social e dagli amici. Se a Kharkiv sarà colpito un palazzo, lo saprò nel giro di mezzora, pur stando in Italia, perché da un lato ne scriveranno i testimoni oculari, dall’altro la notizia sarà confermata dai canali municipali, dei servizi di emergenza che rifletteranno l’accaduto, mentre per l’analisi più approfondita arriverà il commento di un esperto di mia fiducia sul canale YouTube qualche ora dopo.
Com’è cambiata la vita nelle città ucraine che non sono in prima linea?

Va detto che non esistono in tutta l’Ucraina zona sicure: l’assenza di difese antiaeree espone tutto il paese alla furia omicida dei vicini. Eppure, essendo il paese più grande d’Europa, l’Ucraina è così estesa, che nella maggior parte delle regioni la vita può proseguire in modo normale nelle zone non occupate e lontane dal fronte. Ci sono poi alcune isole felici difficili da colpite perché troppo vicine al confine con i paesi NATO o nascoste nelle valli montane.
Eppure, anche laddove la vita scorre in apparenza tranquilla, con bambini che giocano, studenti che vanno a scuola, caffè pieni di gente, la guerra si palesa in più modi. A livello di architettura, si trovano inevitabilmente finestre spaccate dai raid aerei e ricoperte con il compensato. A livello umano, la guerra ha portato in molte città nuovi abitanti, fuggiti dai territori occupati, che cercano di ricostruire faticosamente la propria esistenza. La loro presenza significa nuova manodopera qualificata e grande richiesta di alloggi nuovi, quindi, uno stimolo per l’economia. Un secondo gruppo, invece, è sottratto alla normalità: si tratta di militari in licenza o di reduci. Rispetto ai tempi di pace, si vedono molto più spesso uomini in uniforme, di tutte le età.
Tu come vedi il futuro dell’Ucraina?
L’Ucraina deve uscire vittoriosa da questa guerra, ripristinare la propria integrità territoriale, entrare nella comunità Europea e dedicarsi a ciò che meglio sa fare: sviluppo economico, creativo, culturale. Ci vorranno decenni per guarire le ferite di guerra: sminare i campi e i boschi, riparare i danni al patrimonio architettonico ed industriale, stabilizzare l’economia, compensare le lacune demografiche causate dalla morte dei giovani e dal calo di natalità. È essenziale anche processare i criminali di guerra russi, in un processo internazionale che faccia giustizia sia per vertici che per i singoli esecutori, e il tribunale istituito di recente è il primo passo verso quel processo.
C’è ancora speranza, o prevale la paura?
La paura non è mai stata un sentimento prevalente in Ucraina in questi anni, tanto meno la provo io che vivo nella sicurezza dell’Italia. Non ci mancano le emozioni negative: il dolore, la stanchezza,
l’offesa, il disgusto, l’incredulità di fronte al tradimento di chi si dichiarava “fratello maggiore” e poi ha invaso per depredare, violentare e uccidere. Dopo le notti insonni aumenta sempre il tasso di rabbia verso gli esseri disumani che bombardano le città inermi, che si trasforma in energia positiva che ci spinge a donare, a sostenere l’esercito e l’economia ucraina, a fare ciò che possiamo, ciascuno nel proprio ambito. Ma la fiducia nella vittoria della giustizia rimane il sentimento dominante, rafforzata dal rifiuto totale e profondo del “mondo russo”.
Se potessi decidere tu, che tipo di Ucraina sogneresti dopo la guerra?
L’Ucraina già prima dell’invasione era molto vicina al mio ideale. Era un paese giovane, ricco di risorse umane e naturali, molto ambizioso, indipendente, multietnico, tollerante, lanciato verso l’integrazione europea. Tornando a trovare i miei, ogni estate la trovavo migliorata: nuovi quartieri residenziali, nuovi centri commerciali, le stazioni ferroviarie e i vecchi parchi rinnovati. Molti servizi erano digitalizzati e in molti ambiti l’Ucraina era più moderna ed accessibile dell’Italia.
L’Ucraina voleva scrollarsi velocemente di dosso secoli di colonialismo, il grigiore sovietico, la corruzione dei primi anni dell’indipendenza. Ciò che mancava negli anni di forte crescita economica era un po’ di pragmatismo. Pochi si rendevano conto del pericolo incombente, si sperava di riuscire a restare in bilico fra la civiltà europea e la dittatura russa. Alcuni politici insistevano sul potenziamento dell’esercito e sull’indipendenza energetica dalla Russia, cercavano di recuperare la memoria storica e rafforzare l’identità nazionale, ma non venivano ascoltati dalla maggioranza. Il risveglio è stato brutale e doloroso per tutti, anche per quelli che avevano promosso la smilitarizzazione o sminuivano l’importanza dell’uso della lingua ucraina in ambito ufficiale. I missili non badano molto alle idee della gente, quando colpiscono un condominio, facendolo crollare addosso agli abitanti.
Cosa pensi che il mondo (in particolare l’Europa) dovrebbe fare di più
per aiutare l’Ucraina?
Basterebbe essere sinceri e realistici, ed agire di conseguenza, lasciando da parte profitti economici e mancanza di coraggio.
L’Ucraina è lo scudo della democrazia europea, sta pagando un prezzo altissimo anche per la libertà e sovranità dell’Italia e di tutta l’Europa. Se cadrà, nessuno potrà più fermare l’espansione della Federazione Russia che si mangerà con gran piacere i paesi Baltici, la Moldova ecc., imponendo ovunque la propria influenza ideologica e politica. Permettere alla Russia di invadere un paese sovrano e rimanere impunita creerà un precedente capace di sovvertire l’ordine mondiale, cancellando l’Europa dalla mappa delle potenze mondiali e lasciando il gioco ai tre paesi più grandi. Se il “mondo” vuole mantenere la propria esistenza benestante e sicura, deve svegliarsi e sostenere l’Ucraina, con azioni concrete e non solo con parole altisonanti. È un favore che farebbe a se stesso, e non solo agli ucraini.
Che cosa diresti oggi a chi vive lontano dalla guerra e magari non capisce davvero cosa succede lì?
La prima cosa che pregherei di fare è: ripassate la storia, per favore! Andate a vedere a cosa ha portato il compromesso di “appeasement”, scelto dai diplomatici europei dopo l’annessione dei Sudeti dalla dittatura tedesca. Leggete ancora degli orrori della guerra che si svolgeva proprio dove ora vivete in pace, garantita dall’Alleanza Atlantica. Senza quella, l’esercito italiano non sarà in grado di difendervi. Quando leggete delle proteste contro il riarmo, ricordatevi che anche le città italiane erano bombardate. Possono ancora esserlo, se si lascia il paese senza difese e se si cerca di saziare il drago di una dittatura in espansione, facendogli “inghiottire” altri territori, soprattutto i pezzi ghiotti come l’Ucraina.
Per uscire dalla catastrofe in passato c’è voluto l’intervento militare, e poi economico, degli americani. Ora, quando il loro governo ha subito un’involuzione e dichiara di non interessarsi più alla difesa del vecchio continente, chi ci penserà, nel caso di bisogno?
La seconda cosa è ancora più semplice: informatevi dalle fonti primarie. Parlate con gli ucraini se volete sapere come vanno le cose davvero. Leggete le ricerche degli ucrainisti italiani, i giornali internazionali, ascoltate i canali ucraini, che spesso hanno la traduzione in inglese. Non fidatevi dei finti specialisti che nascono come funghi dopo ogni emergenza. Non lasciate distogliere la vostra attenzione dal conflitto più sanguinario e duraturo in corso sul nostro continente. È quello che ci tocca da vicino.
Come reagisce la diaspora ucraina in Italia alla guerra?
Gli ucraini sono la quinta comunità straniera più numerosa in Italia, dopo i romeni, gli albanesi, i marocchini e i cinesi. In tre decenni di presenza, la diaspora si era organizzata tramite parrocchie, scuole ed associazioni locali, che si occupavano soprattutto della comunità già presente nel territorio. Feste, concerti, eventi culturali e la raccolta degli aiuti umanitari erano gli ambiti prevalenti.
Dopo il febbraio 2022 sono nate numerosi nuovi gruppi ed è cambiato il vettore di aiuti. La priorità erano l’accoglienza dei profughi e il sostegno all’Ucraina. Le associazioni ucraine si sono date da fare, ciascuna nella propria città, a supplire alle esigenze che non copriva lo stato italiano o quello ucraino. Ad esempio, l’integrazione dei nuovi arrivati, che nei primi mesi avevano bisogno di tutto, a partire dall’alloggio e dai documenti, che aprivano la strada verso il lavoro, la sanità e la scuola. Anche un semplice abbraccio in stazione, una bottiglia d’acqua, un pernottamento al sicuro potevano fare la differenza nello stato psicofisico di chi fuggiva dalla guerra.
Un altro tema molto sentito è quello del contrasto alla propaganda russa tramite eventi culturali ed informazione corretta e la denuncia dei casi più eclatanti di manipolazione dei fatti da parte dei sostenitori italici del paese terrorista. Da quest’anno una ventina di associazioni del Nord-Est e del Sud si sono unite in una rete, la Network Associazioni pro-Ucraina, salendo così di livello per poter organizzare insieme più eventi di informazio-
ne e beneficenza. È importante avere una voce rappresentativa, che possa aiutare la società civile italiana a capirci meglio.
Secondo te, la guerra ha rafforzato o cambiato il senso di identità nazionale?
Direi che la guerra ha amplificato il segnale, ma il senso è rimasto lo stesso di prima. L’Ucraina è la terra di donne e uomini liberi, indipendenti, creativi, attaccati alla propria casa, alla propria terra, pacifici ma pronti a difenderla ad ogni costo. Siamo stati oppressi per secoli ma siamo riusciti a mantenere la nostra propria identità tramite la cultura e l’arte, tramite i contatti diretti con l’Europa. Va specificato, che l’identità ucraina è multietnica e al giorno d’oggi include con orgoglio la presenza tartara, ebraica, armena, greca ecc. Solo per fare due esempi: nel governo attuale, il presidente è un ebreo che perso parenti nella Shoa, mentre il ministro della difesa è tartaro di Crimea, nato in Uzbekistan dove il governo sovietico aveva deportato i suoi genitori.
Ciò che è cambiato con l’invasione russa è il risveglio delle coscienze delle persone comuni, che una volta preferivano badare solo al proprio orticello senza porsi domande esistenziali. Ora non è più possibile.
Ci sono poesie, canzoni e simboli che oggi per gli ucraini hanno un significato ancora più forte? Ci sono ovviamente anche poesie e canzoni, ma sono così tante che ci vorrebbero pagine e pagine per spiegarle, al pubblico generale mancano i riferimenti culturali per capire velocemente di cosa si tratta.
Ci sono anche tanti simboli, barzellette, meme, personaggi della cultura di massa legati alla guerra, ma appunto dovrebbe essere un lungo articolo solo su questo, illustrato da tante immagini.
Il primo, e il più evidente simbolo, comunque, è quello dei colori della bandiera nazionale: giallo e azzurro. Molti ucraini scelgono questi colori come segno distintivo. Un fiocco sulla borsa, un braccialetto sul polso, un adesivo sul telefono, una collanina ti aiutano a identifi-
carti come appartente al popolo ucraino.
Un altro elemento importante è l’abbigliamento, e non si tratta solo di magliette o felpe con stampe patriottiche, di cui abbiamo di solito una collezione. Il capo più prezioso è la vyshyvanka, ovvero la camicia tradizionale ricamata, di solito a punto croce, preferibilmente a mano. Questa camicia, maschile o femminile, estiva o invernale, spesso passa in dono dai padri ai figli. Chi non ha questa fortuna se la compra nei negozi specializzati o al mercato dalle artigiane ricamatrici.
C’è anche una festa dedicata alla vyshyvanka che cade il 21 maggio. Quel giorno la indossano tutti: per strada, negli uffici, nelle scuole. Ciascuno può scegliere i colori e i decori che più piacciono. L’infinita varietà dei disegni da ricamare fa sì che non sia mai noiosa. La tradizione lascia spazio alla creatività dei designer. In questi ultimi anni indossare la vyshyvanka per gli eventi solenni o familiari è ormai la regola.
Molti in Europa vedono l’Iran come complice dell’aggressione russa per via dei droni. In Ucraina, la gente vede con favore l’indebolimento dell’Iran, oppure c’è preoccupazione per l’allargamento del conflitto in Medio Oriente?
Il vettore di sviluppo dell’Ucraina moderna è diametralmente opposto all’ideologia dello stato islamico. Purtroppo, l’attualità oscura la millenaria cultura dell’Iran, cancella il fascino delle sue città storiche e della sua natura. I rapporti erano tesi già dal 8 gennaio 2020, quando l’Iran ha abbattuto un aereo civile ucraino, causando la morte di 176 persone. E sono ancora più tesi ora, quando l’unica presenza tangibile dell’Iran in Ucraina sono gli Shahed (droni). Iran non esporta più bei tappeti o deliziosi pistacchi, ma i droni-kamikaze che la gente ormai ha imparato a riconoscere dal caratteristico rumore che fanno quando si avvicinano alle case per poi esplodere. Il regime autoritario che attualmente governa l’Iran è amico del regime russo, e quindi per forza nemico degli ucraini.
Come stai tu davvero, essendo una donna ucraina e soprattutto come

La prima “Processione della vyšyvanka” di Zaporoghi alla celebrazione del 500º anniversario dei cosacchi di Zaporižžja nel 1990
attivista? Perché spesso dietro la forza c’è molto dolore nascosto. Credo questa domanda sia troppo personale, per rispondere dovrei menzionare tutte le parti della mai identità, ti do comunque una risposta generale, perché è sbagliato partire con una nota negativa e/o autocelebrativa.
Sto bene perché la mia coscienza è a posto. So che ho sostenuto la causa giusta
e che ho fatto del mio meglio, in modo concreto, per aiutare la gente che aveva bisogno d’aiuto in quel momento. Nello stesso tempo, c’è una certa amarezza. Il volontariato non può risolvere i problemi globali, può solo tappare i buchi in attesa che intervengano le strutture ufficiali che hanno il potere reale nel nostro mondo. Se dopo anni vedi che lo stato non fa ancora ciò che ci si aspettava che facesse, subentra la delusione. Ci aspet-
tavamo una risposta più duratura e seria anche da parte della società civile, da parte dei mass media, ma poi ci siamo resi conto che se non ci pensiamo noi stessi con i nostri amici, non ci penserà nessuno. Questo riguarda sia la difesa degli interessi del nostro paese d’origine in senso più ampio che il benessere degli ucraini immigrati in Italia.
E magari anche del mondo libero…

LagiornalistaUcrainaMariannaSoronevych
di Fulvio Cavallari
Marianna Soronevych, giornalista ucraina e direttrice di Gazzeta Ukrainska, il principale giornale in lingua ucraina per la diaspora in Italia, dal 2006, Marianna è un punto di riferimento per la comunità ucraina residente nel nostro Paese. In questa conversazione a cuore aperto, ci parla del ruolo dell’informazione in tempo di guerra, della resistenza del popolo ucraino, del peso della propaganda russa, del sostegno dell’Unione Europea e delle prospettive per una pace giusta e duratura.
Un’intervista che non si limita all’analisi geopolitica, ma che ci restituisce anche il volto umano, se così lo si può definire, della guerra, visto attraverso gli occhi di una giornalista che, da Roma, continua a difendere la verità sul suo Paese.
Grazie Marianna per aver accettato l’invito di ViPiu.it per questa intervista. Dove vive e che lavoro fa? Vivo in Italia da oltre vent’anni. Mi sono trasferita a Roma e, con il tempo, posso dire di sentirmi un po’ ucraina e un po’ romana. Dal 2006 dirigo “Gazzeta Ukrainska”, il giornale dedicato alla comunità ucraina in Italia. All’inizio era
un’edizione cartacea: in quegli anni, quando Internet non era ancora diffuso, rappresentava l’unica possibilità per gli immigrati ucraini di ricevere notizie aggiornate e informazioni utili – in lingua ucraina – sulla legislazione in materia di immigrazione e sul diritto del lavoro italiano.
Oggi la testata si concentra sull’edizione online. Creo contenuti per il nostro sito http://www.gazetaukrainska.com/ e gestisco attivamente i canali social. “Gazzeta Ukrainska” continua a essere una fonte autorevole d’informazione per la comunità ucraina residente in Italia.
Può spiegare ai nostri lettori l’origine storica del conflitto Russo Ucraino? È una domanda difficile da spiegare in poche righe. La Moscovia (Granducato o Gran Principato di Mosca) è nata secoli dopo la Rus’ di Kiev (sorta verso la fine del IX secolo in parte del territorio delle odierne Ucraina, Russia europea, Bielorussia, Moldavia, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia orientali e considerata il più antico Stato organizzato slavo-orientale, del quale Kiev fu la capitale), eppure ancora oggi tenta di appropriarsi della storia e della cultura ucraina. Nel corso dei secoli, la Russia ha occupato l’Ucraina in diverse fasi storiche e, ancora oggi, pretende che quei territori le appartengano di diritto.
La propaganda russa, per giustificare l’invasione in corso, diffonde teorie pseudo-storiche, arrivando persino a sostenere che l’Ucraina, come Stato indipendente, non sia mai realmente esistita. A mio avviso, l’unica radice storica di questa guerra è la natura imperialista della Russia. Tuttavia, nel diritto internazionale non contano le ricostruzioni storiche di parte,
ma le costituzioni e gli accordi ufficiali. Nel 1994, la Russia – insieme a Stati Uniti e Regno Unito – ha firmato il Memorandum di Budapest, impegnandosi a garantire la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Ucraina, in cambio della sua adesione al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.
Invece, ha violato quell’impegno, dando inizio a una guerra su larga scala contro l’Ucraina.
Ricorda i primi momenti dell’invasione? Come avvenne?
La Russia ha dato inizio all’invasione nel cuore della notte del 22 febbraio 2022, alle tre. La sera prima avevo sentito i telegiornali italiani annunciare lo stato di guerra. Ho subito chiamato amici e parenti in Ucraina, e abbiamo parlato a lungo della possibilità di un conflitto. Non tutti credevano che potesse davvero accadere.
Nonostante l’annessione illegale della Crimea e la guerra nel Donbas avviata nel 2014, molti ucraini non immaginavano che il conflitto si sarebbe esteso a tutto il Paese… Finché le bombe non hanno iniziato a esplodere.
Come reagì il suo paese?
Le persone hanno mostrato fin da subito una resilienza incredibile. Mentre le ma-
dri cercavano di mettere al sicuro i propri figli rifugiandosi nella metropolitana o spostandosi verso l’ovest del Paese, molti si sono presentati ai centri di arruolamento per impugnare le armi e difendersi dall’invasore, oppure hanno formato le Forze di Difesa Civile per sorvegliare le proprie città e quartieri.
L’esercito ucraino su quanti uomini poteva contare?
Esistono diverse stime sulla consistenza dell’esercito ucraino all’inizio della guerra, ma il sito ufficiale delle Forze Armate ucraine non pubblica dati ufficiali. Durante lo stato di guerra, queste informazioni non sono disponibili. In ogni caso, il numero dei soldati ucraini era, ed è, nettamente inferiore rispetto a quello dell’esercito russo.
Grazie alla stretta collaborazione tra militari e civili, è stato possibile evitare l’occupazione di Kyiv e delle altre città, che avrebbe significato la resa del Paese.
Eravate dotati di supporto aereo o solamente di droni?
All’inizio della guerra, e ancora oggi, la difesa aerea rappresentava il punto debole dell’Ucraina. La flotta aerea non era

in grado di proteggere l’intero territorio nazionale, nemmeno ora, nonostante gli aerei militari forniti dai Paesi partner.
L’uso dei droni è cresciuto notevolmente negli ultimi due anni di guerra su larga scala. L’Ucraina è diventata leader nell’impiego esteso di questi dispositivi, sempre più progettati e costruiti da noi, rivoluzionando radicalmente la strategia militare. Attualmente, i droni vengono utilizzati non solo per la ricognizione, ma anche per la correzione del fuoco e il rilascio preciso di munizioni in aree difficili da raggiungere. Sono impiegati anche per colpire obiettivi strategici sul territorio russo, come fabbriche di armi o raffinerie.
I droni hanno dimostrato la loro efficacia sul campo di battaglia, diventando uno strumento essenziale per rispondere rapidamente alle esigenze del fronte.
Ricorda i momenti più importanti o salienti di questa guerra?
Non vorrei parlare soltanto della guerra su larga scala. Per l’Ucraina, il conflitto è iniziato nel 2014 con l’annessione della Crimea. I momenti cruciali successivi sono stati l’occupazione di alcune zone delle regioni di Luhansk e Donetsk, la difesa dell’aeroporto di Donetsk e le sanguinose battaglie di Ilovaisk, seguite dalla liberazione delle città di Sloviansk, Kramatorsk e altre ancora.
Dopo l’inizio della guerra la difesa di Kyiv è stata epica e molto doloroso e tragico l’assediamento di Mariupol con oltre 20.000 vittime civili e la città rasa al suolo.
Vorrei inoltre citare la controffensiva di Kharkiv e la liberazione di Kherson, capoluogo regionale, quando le Forze Armate dell’Ucraina sono riuscite a liberare numerosi territori occupati dalle truppe russe.
Secondo il Ministero per la Reintegrazione, tra il 2022 e il 2023 l’esercito ucraino ha de-occupato circa 2.800 insediamenti in oltre 160 comunità territoriali, distribuite nelle regioni di Donetsk, Luhansk,
Zhytomyr, Zaporizhzhia, Kyiv, Mykolaiv, Kharkiv, Kherson, Chernihiv, Sumy e Odesa.
Attualmente quante parti del territorio Ucraino sono occupate?
A inizio 2025, la superficie esatta delle aree occupate in Ucraina resta oggetto di stime, poiché la situazione sul fronte è molto dinamica.
Sintetizzando i dati disponibili, la Russia occupa circa 112.000 km² del territorio ucraino, pari al 18% del Paese.
La valutazione precisa dell’estensione dei territori occupati è complicata dalle intense operazioni militari in corso. Diverse fonti utilizzano immagini satellitari e dati di intelligence, ma anche questi forniscono soltanto cifre approssimative.
Quante parti del territorio russo occupa l’esercito ucraino?
L’operazione delle Forze Armate ucraine nella regione di Kursk è iniziata a marzo 2024, con l’obiettivo di costringere le truppe russe a ridislocarsi, alleggerendo così la pressione su altri punti critici del
fronte, in particolare nelle direzioni di Pokrovsk, Kharkiv e Sumy.
Durante l’operazione, le Forze Armate ucraine sono riuscite a prendere il controllo di circa 1.130 chilometri quadrati di territorio russo. Per contrastare l’avanzata ucraina, oltre alle proprie forze regolari, la Russia ha impiegato anche militari della Corea del Nord.
Attualmente, però, l’Ucraina si è ritirata dalla maggior parte di quel territorio: a metà marzo 2025, le truppe ucraine controllavano ancora circa 205 km² della regione di Kursk.
Come già accennato in precedenza, la valutazione precisa dell’estensione dei territori sotto controllo rimane complessa, a causa dell’intensa attività militare e della continua evoluzione della situazione sul campo.
Cosa pensa di Zelenski?
Credo che Zelensky sia un ottimo comunicatore: sa trasmettere al mondo il dolore dell’Ucraina in questa guerra e riesce a trovare gli alleati giusti per resistere.
In verde la mappa della Rus’ di Kiev nel 1054, alla morte di Jaroslav I

Cosa pensa di Trump?
Purtroppo, Donald Trump non si è dimostrato coerente nella sua politica nei confronti dell’Ucraina. Ha espresso opinioni e adottato posizioni spesso contraddittorie. In campagna elettorale ha promesso di porre fine alla guerra in un solo giorno, ma non è riuscito nemmeno a ottenere un cessate il fuoco fino ad oggi.
Ci sono stati momenti in cui sembrava illudersi di poter convincere Putin alla pace, ma ora, riconoscendo che tutti i tentativi diplomatici sono falliti. ha dichiarato l’intenzione di continuare il sostegno militare all’Ucraina, sia pure addebitandone i costi alla NATO.
L’unico risultato positivo concreto finora è stato lo scambio di prigionieri tra i due Paesi.
Che rapporti avete con L’Unione Europea?
L’Unione Europea è il principale alleato dell’Ucraina in questo conflitto. Ha reagito in modo rapido e deciso all’aggressione russa, adottando misure restrittive.
Ha fornito oltre 88 miliardi di euro in aiuti economici, militari e umanitari, rafforzando il sostegno alla resistenza ucraina.
Sono state imposte sanzioni mirate a persone, aziende e organizzazioni legate al regime russo. Queste misure puntano a indebolire la base economica della Russia, privandola di tecnologie e mercati strategici, e a ridurre drasticamente la sua capacità di sostenere l’aggressione militare.
L’UE è impegnata anche nel contrasto alla disinformazione russa e ha istituito un Fondo di Sostegno all’Ucraina per garantire un aiuto finanziario stabile nei prossimi anni. Ha inoltre istituito un Fondo di Sostegno all’Ucraina da 50 miliardi di euro per il periodo 20242027, per garantire un aiuto stabile e duraturo.
Saranno in grado questi leader di guidare le parti ad un tavolo di pace? Spero di sì. Perché l’obiettivo dell’U-
craina è una pace giusta e duratura. Noi ucraini sogniamo un cielo sereno sopra le nostre case e il ritorno dei nostri soldati dal fronte, sani e salvi.
Purtroppo, come vediamo nella realtà, la Russia comprende solo il linguaggio della forza: quello militare e quello delle sanzioni, sia economiche che personali, contro i leader del regime.
Attualmente, il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato che l’Unione Europea, su iniziativa della Francia e in coordinamento con i senatori statunitensi, sta preparando un nuovo pacchetto di sanzioni – il più severo dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina.
Spero che queste misure producano l’effetto desiderato.
Cosa sono le terre rare?
I metalli delle terre rare sono elementi appartenenti al gruppo dei lantanidi, come cerio, olmio, neodimio, erbio e altri. Sono fondamentali in diversi settori: medicina, industria militare e tecnologia avanzata.
Ad esempio, l’olmio è impiegato nella produzione di barre per reattori nucleari, il cerio è utilizzato nell’industria automobilistica e nella raffinazione del petrolio, il neodimio nei dischi rigidi e l’erbio nelle apparecchiature per la chirurgia laser.
Secondo Forbes (2023), il valore totale delle risorse minerarie in Ucraina è stimato in circa 15.000 miliardi di dollari, oltre il 70% dei quali si concentra nelle regioni di Donetsk, Dnipro e Luhan-


sk, attualmente interessate da pesanti combattimenti e non sotto il controllo dell’Ucraina.
Secondo lei hanno un ruolo queste terre rare nel conflitto?
Si è parlato molto delle terre rare in relazione alla guerra, ma non credo che siano la causa principale dell’invasione russa. L’Ucraina, pur avendo individuato alcuni giacimenti, non ha mai avviato l’estrazione su larga scala. L’estrazione di terre rare è molto complessa: si tratta di metalli presenti in basse concentrazioni, che richiedono tecnologie avanzate, reagenti specifici e comportano seri impatti ambientali.
Lo sviluppo di questi giacimenti richiede investimenti ingenti e competenze altamente specializzate. In questo senso, è importante ricordare che l’Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo strategico per istituire un Fondo di investimento per la ricostruzione e per promuovere una partnership sui minerali critici.
Spero che questo accordo contribuisca concretamente alla rinascita economica e industriale dell’Ucraina nel dopoguerra.
Attualmente qual è la situazione e quante parti del paese sono divenute inabitabili?
Tantissime città ucraine sono state ridotte a polvere. Alla fine del 2024, il numero di abitazioni e infrastrutture distrutte dalla guerra russa in Ucraina ha raggiunto le 330.000 unità. Intere città si sono trasformate in deserti di pietra, proprio come molti altri centri urbani finiti nell’epicentro dell’aggressione russa.
Nell’Ucraina orientale esistono ormai decine di insediamenti simili, devastati dalle truppe russe. Secondo gli esperti, il livello di distruzione in molti di questi centri abitati varia dal 60% al 90%.
Questa strategia è stata definita da alcuni analisti come una forma estrema di “urbanicidio”: la distruzione sistematica e deliberata delle città.
Toretsk, Chasiv Yar, Vovchansk, Bakhmut, Soledar, Avdiivka, Maryinka, Sievierodonetsk, Lysychansk e Mariupol un tempo erano importanti città industriali. Oggi, da una vista a volo d’uccello appaiono come città gemelle, ridotte a cimiteri a cielo aperto.
Avete un conteggio delle vittime sia civili che militari?
La risposta a questa domanda avremo alla fine della guerra. Speriamo tutti che arrivi presto. Come non condividere questa speranza?
giornalista iraniana Hana Namdari intervista Angelica Edna Calò
Livne, nata a Roma e dal 1975

AngelicaEdnaCalòLivne,animatricedipace
di Hana Namdari
Angelica Edna Calò Livne è nata a Roma il 27 agosto 1955 e dal 1975 vive in Israele nel Kibbuz Sasa, in Galilea sulla frontiera del Libano. Angelica Edna Calò Livne è un’educatrice, scrittrice e regista, fondatrice col marito e direttrice della Fondazione Beresheet LaShalom in Alta Galilea (Israele), impegnata nel dialogo interculturale. Per il suo operato ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui una candidatura al Nobel per la Pace nel 2005.
La Fondazione Beresheet LaShalom nasce nel 2001 con il Teatro Multiculturale
Umanante “Arcobaleno” per avvicinare differenti etnie, religioni, tradizioni ed educare al dialogo attraverso le arti. Dall’esperienza di Angelica Edna Calò Livne, che parte dal Dottorato interdisciplinare conseguito in Pedagogia e Teatro, è nato un modello educativo per lo “Sviluppo del pensiero umanistico attraverso le arti performative” che lei stessa insegna all’Università di Tel Hai e presenta in tutto il mondo con laboratori per il miglioramento della società. Dalla tragedia del 7 Ottobre continua la sua opera di educatrice al dialogo perché la Speranza è l’unica risorsa possibile in questa terra martoriata.
Come hai vissuto i giorni del conflitto? Hai avuto paura per te o la tua famiglia? Cosa ricordi del primo giorno in cui l’Iran ha lanciato un attacco?
Dove ti trovavi hai dovuto trasferirti o rifugiarti in un bunker?
L’attacco massivo lanciato dall’Iran è avvenuto dopo 17 mesi in cui stavamo vivendo la guerra. Una guerra lunga, dolorosa iniziata il 7 ottobre con il pogrom perpetrato da Hamas. Il 2023 sembrava un anno decisivo, magico per la realizzazione di pace. Si stavano stipulando i Patti di Abramo, decine di progetti tra Israele e i Paesi circostanti. Israele non era più dentro Gaza ma si adoperava per costruirvi impianti di desalinizzazione, impianti di recupero e riciclaggio, ogni giorno entravano operai a lavorare in Israele, i membri dei Kibbuzim di confine organizzavano turni per trasportare donne incinte, malati e bambini nei nostri ospedali. Il sogno è svanito, esploso in poche ore quel 7 ottobre e da quel momento non c’e’ stato un attimo di tregua. Io vivo in un kibbuz di confine sul bordo del Libano. In poche ore il kibbuz è stato evacuato- 450 persone- e siamo rimasti in 40 a proteggere le nostre case, sotto i missili di Hezbollah e poi degli Houti e, quindi, dell’Iran. Dall’8 di ottobre ci siamo trasferiti nella stanza blindata. Purtroppo i miei figli e i nipotini vivono al centro di Israele e la preoccupazione è grande e viscerale. Come spiegare ai bambini le sirene? Le esplosioni assordanti? Il pericolo? L’asilo vuoto e il dover rimanere chiusi in casa per ore e ore? Come raccontare cosa succede senza destare preoccupazione, rancore, paura? L’attacco dell’Iran è iniziato mentre ero all’aeroporto di Ben Gurion. Avevo già in mano la carta d’imbarco per raggiungere Helsinky, in Finlandia, dove
avrei dovuto presentare la mia ricerca di Educazione al dialogo attraverso le Performing Arts in un congresso di Psicologia positiva. Sono tornata a casa sotto la pioggia di missili col cuore che scoppiava… non per la paura ma per la rabbia verso chi impiega le sue risorse per distruggere, per fomentare l’odio, per dominare.
Hai perso qualcuno o conosci persone coinvolte direttamente? Come sono cambiate le tue abitudini durante e dopo l’attacco? Pensi che la reazione israeliana sia stata giusta o sproporzionata? Credi che il programma nucleare iraniano costituisse una minaccia reale?
Quasi ogni famiglia in Israele ha avuto un lutto. Siamo un Paese piccolo, come una grande famiglia che ancora vive il trauma profondo delle violenze perpetrate nel Festival Nova, nei kibbuzim e nelle città al confine con Gaza. Molti di noi non dormono più di due ore a notte per la preoccupazione, per i missili, per i dolori in tutto il corpo a causa dello stress, per affrontare il disagio e i timori. Il corpo mobilita i suoi sistemi per sopravvivere, secreta ormoni e altre sostanze che aiutano a sopportare la tensione insostenibile in cui ci troviamo.
Possono essere sostanze anestetizzanti, che attenuano l’ansia, l’impotenza, la sofferenza e il dolore, oppure sostanze stimolanti e attivanti che ci aiutano a funzionare durante un periodo in cui non si riesce davvero a dormire o riposare. La minaccia iraniana era reale, costante, durava da anni. Nella Piazza


AngelicaEdnaCalòLivne,un’esibizione
Palestina, la piazza principale di Teheran c’era un display che contava alla rovescia la distruzione di Israele prevista per il 2040. Si può vivere cosi? Si puo vivere con questa spada di Damocle sul capo che di tanto in tanto si stacca e ti ferisce nel corso di 75 anni durante la prima intifada, poi la seconda, poi i missili dal nord e dal sud, tutto organizzato, premeditato, programmato e finanziato dall’Iran. Come si può vivere cosi? Quanto si può continuare a pensare secondo la cultura occidentale con i suoi valori umani, l’amore e il culto della vita, il rispetto per le donne e i bambini, la negoziazione, la mediazione di fronte a una cultura dell’odio, del terrore, dell’annullamento totale dell’altro?
Cosa pensi dell’accordo di cessate il fuoco? Ti senti più sicura oggi? Cosa ne pensi del ruolo degli Stati Uniti nel conflitto? Ritieni che il governo Netanyahu abbia gestito bene la crisi? Ecco il cessate il fuoco: si torna al lavoro, i bambini che sono rimasti quasi due settimane a casa, senza una routine, in una sorta di vacanza apocalittica, si svegliano, si preparano per andare a scuola. Ieri ci preoccupavamo che si allontanassero troppo da casa e dal rifu-
gio, e ora tornano in classi da 35 bambini. Un momento siamo tutti in un terrore estremo, temendo centinaia di tonnellate di esplosivo che piovono dal cielo e perfino un orrore nucleare – e il momento dopo la minaccia svanisce. Il cessate il fuoco ci fa sentire più sicuri ma molti di noi sono frastornati, la testa martella: ci stavamo riabituando al ritorno nelle proprie case dopo mesi dopo l’evacuazione e all’improvviso lo scoppio di una nuova guerra nella guerra, ancora più letale, ancora più spietata, una guerra terribile che forse eviterà la nostra distruzione. Gli Stati uniti sono venuti in nostro aiuto… ma abbiamo ancora 50 ostaggi rinchiusi nei tunnel di Gaza e Israele è addolorata.
Secondo te è possibile, in futuro, costruire un dialogo con l’Iran? Cosa dovrebbe succedere perché israeliani e iraniani non siano più “nemici”?
Io non mi sento nemica dell’Iran, al contrario, ho una profonda stima per il coraggio di chi combatte per la sua libertà di espressione e determinazione, per la sua cultura millenaria, per la sua storia appassionante. Sento che abbiamo molto in comune e soffro per lo stato di oppressione in cui vive la popo-

AngelicaEdnaCalòLivne,unaperformancenell’ambito delsuoprogettodiPsicologiapositiva
lazione. Potremmo vivere splendidamente gli uni accanto agli altri. Condividere la ricerca scientifica, medica, biologica. Potremmo trasformare insieme il Medio oriente in un Visitor Center per chi ama la cultura, la bellezza e la speranza in un destino che può cambiare e trasformarsi in benessere per tutti. Ma tutto ciò può accadere solo sconfiggendo il terrorismo, l’oscurità mentale, il dispotismo e la tirannia.
Cosa diresti a un cittadino iraniano se potessi parlargli direttamente?
Gli direi: continua a lottare per te e per la tua discendenza, non ti arrendere mai, unisciti a noi per risvegliare il diritto alla propria femminilità, la libertà di pensiero e di scelta per riportare la luce sul tuo Paese!
Che ruolo hanno i media nel modo in cui percepiamo “il nemico”?
Purtroppo i media e i social fomentano l’odio, si schierano e giudicano senza conoscere la storia. Quando c’è un conflitto, se veramente credi nella pace, devi ascoltare i due contendenti, devi trovare la via per avvicinarli, per la riconciliazione, chi si schiera divide e risveglia la violenza e l’ingiustizia.
Ti senti rappresentata dalla politica estera del tuo Paese?
Di natura non sono estremista, sono sempre pronta ad ascoltare e, se anche non sono d’accordo con tutto, trovo il modo di conciliare. Mi è difficile accettare l’estremismo di alcuni politici del mio governo. Credo negli accordi, nel dialogo, nello sforzo di vedere l’altro.
Qual è stata l’emozione più forte che hai provato durante il conflitto?
Mentre ero nel rifugio con i miei nipotini durante uno degli attacchi più massivi e assordanti abbiamo cantato insieme “Ani noladti la Shalom – Sono nato per la Pace…”: era una canzone che cantavo con i loro genitori, quando erano bambini. Una canzone che fino ad oggi si canta in Israele in tutte le feste di bambini. Ho pregato che si avverasse… finalmente!
Se potessi inviare un messaggio al mondo, cosa vorresti che capissero del popolo israeliano in questo momento?
Che non abbiamo mai voluto nessuna delle guerre in cui siamo stati trascinati. Che porgiamo la nostra mano, il nostro aiuto, le nostre ricerche, i nostri progetti per migliorare il mondo e la vita. Che abbiamo bisogno di “teste e cuori pensanti” come
scriveva Etti Hillesum, che capiscano da che parte sta il male, che capiscano che stiamo combattendo per la nostra sopravvivenza. Che abbiamo diritto alla vita.
Hai partecipato a proteste o manifestazioni legate alla guerra o alla pace? Certo, nel corso di tutta la guerra.
Hai paura che questo conflitto possa riesplodere? Come immagini Israele tra dieci anni, dopo quello che è successo?
Il mondo, l’Europa, l’ONU tutti coloro che hanno potere e influenza devono trasmettere un messaggio chiaro, al di la degli interessi politici ed economici, un messaggio contro il terrorismo e la violenza di Stato.
Voglio immaginare un Israele circondato da Paesi alleati con i quali ci sono scambi culturali, artistici, economici e accademici. Un’area di esempio per le altre Nazioni dove i diritti, i valori e i rapporti umani sono un simbolo per tutto il mondo!
Possiamo farcela!
Parola di Angelica Calo Livne… E per voi?
Tra Palestina, Israele e Italia, la storia del cantante lirico e pianista che punta sulla bellezza come risposta alla guerra. Da Gerusalemme a Vicenza, passando per Messina e Tel Aviv, il suo canto unisce mondi divisi: «Senza amore, speranza e arte, il dialogo muore»

TareqWhabaalpianoforte
Artista palestinese che ha trasformato la musica in un ponte tra mondi diversi, nato a Betlemme e cresciuto tra le note del pianoforte e del canto, il suo percorso lo ha portato da Gerusalemme a Messina, da Catania fino all’Italia di oggi. Con delicatezza e forza, Tareq Wahba, di Hana Namdari
pianista e cantante lirico, ci racconta cosa significa vivere tra due culture, due realtà, e due identità: quella di musicista e quella di testimone di una terra ferita, ma piena di speranza.
La biografia
Nato 46 ani fa a Betlemme, sotto l’Autorità Palestinese, ha iniziato fin da gio-
vane a dedicarsi alla musica. A soli 18 anni ha vinto un concorso di pianoforte, grazie al quale ha potuto trasferirsi a Messina per proseguire gli studi. In Italia ha studiato e lavorato per più di dieci anni tra Messina e Catania, perfezionandosi nel pianoforte e nel canto lirico.
Successivamente è stato chiamato a Gerusalemme per insegnare presso la scuola “Magnificat” della Custodia di Terra Santa, dove ha lavorato per dieci anni. Lì ha anche completato gli studi in canto lirico, grazie alla collaborazione con il Conservatorio “Pedrollo” di Vicenza.
Ha partecipato a numerose produzioni d’opera e concerti, collaborando con artisti israeliani, palestinesi e internazionali. Dopo l’escalation di violenza iniziata il 7 ottobre 2023, è rimasto in Italia, a Vicenza, dove oggi insegna privatamente, canta, scrive musica e continua a credere nel potere dell’arte come strumento di dialogo, verità e riconciliazione anche se le sue risposte, spesso molto brevi e secche, testimoniano una tristezza di fondo.

TareqWhabasiesibiscealConcertospecialeconilcorodi PiazzolasulBrenta.(Ellagiammaim’amò)ilsantonome
L’intervista
Cosa ti ha portato a trasferirti da Betlemme a Gerusalemme a 22 anni?
In Palestina (autorità palestinese) Betlemme e Gerusalemme sono un paese unico, sono molto vicine 10 minuti in macchina, ho lavorato come insegnante di pianoforte e canto a Betlemme e Gerusalemme. All’età di 18 ho vinto un concorso di pianoforte per studiare a Messina e lavorare dopo la laurea. Dall’età di 18 fino l’età di 30 ho studiato e lavorato a Messina e Catania. Poi mi ha chiamato da Gerusalemme una Scuola della custodia di Terra Santa, il Magnificat, dove ho insegnato 10 anni. Durante il lavoro ho studiato canto lirico nella stessa scuola e, grazie al gemellaggio con il Magnificat, per tre anni al conservatorio di musica di Pedrollo Vicenza.
Quando e perché hai deciso di venire in Italia?
Dopo il 7 ottobre 2023 mi hanno detto che avevano bombardato Gaza e mi hanno consigliato di rimanere in Italia
dove sono stato aiutato a fare i documenti pur rimanendo sempre preoccupato perché la mia mamma vive lì.
Da quel giorno, è cambiato qualcosa nel tuo modo di vedere la situazione?
Dal mio punto di vista niente è cambiato. I palestinesi sono stati sotto il controllo (occupazione) 80 anni, ma questa è la più lunga e la più tragica mentre il mio lavoro andava benissimo con il Magnificat e l’Opera di Israele. Tutti i giovani palestinesi lavorano in Israele e guadagnano molto bene. Israele è un paese ricco in confronto con la Palestina (Cisgiordania).
Tu credi ancora nella possibilità di una convivenza pacifica?
La pace è sempre possibile senza un governo dei matti e religiosi. L’amore è possibile (il possibile è impossibile).
Hai avuto e hai esperienze dirette di collaborazione o amicizia con israeliani?
Sono miei amici israeliani musicisti e cantanti e la scuola Magnificat è piena
di insegnanti ebrei che adorano la pace così come di docenti cristiani, musulmani e atei che studiano la musica e suonano in una orchestra insieme. La mia amica e la mia accompagnatrice di pianoforte vive in Israele (è un’araba di Israele) e siamo un duetto di canto e pianoforte con una pagina su Facebook (The opera Mosaic) Ho vinto un concorso di canto all’opera di Gerusalemme (Concorso lirico di Gerusalemme), ho fatto tanti ruoli d’opera con l’Opera di Gerusalemme e Tel Aviv…
Hai ancora contatti con la tua famiglia? Dove vivono ora?
Assolutamente sì, a Nablus e Betlemme.
Come stanno vivendo i tuoi cari questa nuova ondata di tensioni e violenza?
Con pazienza e preghiera ma tutto sta cambiando verso il peggio.
Come credi che la società palestinese stia reagendo agli ultimi sviluppi?
Il popolo palestinese è senza niente, crescono, la violenza i ladri…
C’è ancora spazio per il dialogo? O sta prevalendo la rabbia e la sfiducia? Non lo so.
Come ti trovi in Italia?
Canto e suono il pianoforte a Vicenza e insegnò privatamente in presenza e online .
È stato facile ambientarti? È il mio secondo paese, amo l’Italia.
Hai trovato accoglienza o hai vissuto episodi di diffidenza o razzismo?
Sempre massima accoglienza. Tra i sacerdoti (ce lo ha presentato padre Gino Alberto Faccioli, direttore del periodico della Madonna di Monte Berico e nostra firma, ndr), nei monasteri ho tantissimi amici Niente razzismo.
Tu che canti con i cori e come solista e scrivi musica, pensi che la cultura e l’arte possano aiutare a costruire ponti tra i popoli?
La musica aiuta perfettamente. Ci sono tre cose che aiutano: l’amore, la speranza e l’arte.
Ti vedi ancora in Italia nei prossimi anni o speri di tornare nella tua terra?
No, il mio mondo è in Europa come musicista.


Cosa vorresti dire ai giovani – sia palestinesi che israeliani – che crescono dentro questo conflitto? Non credete completamente a tutto quello che appare sui media, sulle TV, alle radio, confrontate le versioni. Il dialogo è importantissimo. La verità, cercatela anche con contatti diretti e anceh in questo caso confrontate “le verità” di ognuno.
Se potessi mandare un messaggio direttamente a un giovane israeliano della tua età, cosa gli diresti? lo direi in inglese: stay safe and God bless you .
Giusto: Stai al sicuro e Dio ti benedica.


Un impegno: conservare il sorriso “incazzato” ma sincero di oggi anche quando sarà protagonista, non solo su queste pagine che raccontano la ventinovenne fondatrice di @Volti.italiani.storie

VictoriaKaram, l’assistenteeuroparlamentareallavoro
Chissà se, al momento di andare in stampa, le collettive danze della pioggia avranno sortito qualche effetto… quando però ho in agenda questa intervista si boccheggia ancora. Eppure, lei, la protagonista di questo mese, arriva all’appuntamento impeccabile, bella carica, fresca. E in effetti quella che porta a Vicenza, in giro per l’Italia e anche a Bruxelles è decisamente una ventata
fresca e sorridente.
Vicentina d’adozione, nata in Italia da genitori brasiliani ma riconosciuta italiana solo a 22 anni, oggi fa la pendolare tra la sua città e Bruxelles, dove è assistente europarlamentare. Abbiamo incontrato la giovane e “incazzata”, ma con stile, attivista per la revisione della legge sulla cittadinanza, fondatrice della pagina Instagram @Volti.italiani.storie e già con tante altre qualifiche che ne fanno presagire un futuro da protagonista. di Federica Zanini

VictoriaeGiacomoPossamaifesteggianol’elezionein piazzadeiSignori-fotodiGiovanniCoviello
Victoria Karam, assistente prima di Alessandra Moretti e ora di Annalisa Corrado all’Europarlamento, è giovane (29 anni) ma ha già molto da raccontare, soprattutto a partire dalla propria esperienza personale. Come sempre, i nostri ritratti non possono prescindere dal curriculum, ma nel caso di Victoria più che mai sono biografia e vissuto a interessarci e ad averci attratti è in particolare la grinta garbata ma inscalfibile con cui è scesa in campo per difendere il diritto alla cittadinanza (in particolare a un iter burocratico più rapido e snello) per chi è nato in Italia da genitori stranieri.
Elegante, mai fuori dalle righe, amabile ma determinata, è un’attivista di quelle che non hanno bisogno di striscioni e megafoni, slogan urlati, parate a rischio di infiltrazioni facinorose, uscite sguaiate a effetto. Nulla di tutto questo le appartiene: lei non ha scelto di provocare, ma di insinuare… un nuovo punto di vista nonché il dubbio nelle teste di chi oggi è artefice (o anche solo complice) della non-cultura che, ahinoi, ancora distingue il nostro Paese rispetto ad argomenti di estrema attualità e importanza. Ecco perché noi l’abbiamo avvicinata non solo come giovane protagonista della scena (anche) vicentina, ma soprattutto come fondatrice
di Volti Italiani. Ma andiamo a conoscerla.
Victoria, qui sedute nel salotto buono di Vicenza, circondate da parlate straniere ma soprattutto da cadenze e terminologie dialettali, la più italiana di tutti sembreresti proprio tu. Perché questo dovrebbe, ancora, stupirci?
Perché io, complice anche il mio cognome “esotico” Karam, rappresento esattamente quel caso tipo che in Italia di solito suscita curiosità (ndr: magari anche allarme?) nel pubblico pensare e non suscita un bel niente in termini di risposte nelle pubbliche istituzioni. Sono nata in Italia, ho studiato e poi lavorato in Italia ma sono stata riconosciuta italiana dalla legge soltanto a 22 anni. Si, perché per fare richiesta devi aspettare di aver compiuto 18 anni, ma devi farlo entro 365 giorni e io non lo sapevo… Così è slittata di un anno una procedura che poi ne ha richiesti altri 3 per andare a buon fine.
Spiegaci meglio, perché l’immaginario collettivo a volte è deviato, nel meno peggiore dei casi ignorante, e lo scenario è confuso tra immigrazione clandestina e richiesta di cittadinanza. I miei genitori sono entrambi brasiliani, di San Paolo. Mio padre, Alan Feres Karam,
in quanto hockeista su pista, a 16 anni, nel 1990, viene ingaggiato dal Thiene e si trasferisce. Le parentesi italiane di una carriera intensa in giro per il mondo lo portano in lungo e in largo per lo Stivale, fino a Salerno, dove lo raggiunge mamma, Ana Lucia Alarcon, e dove, nel 1996, nasco io (ndr: un bel mix di sangue brasiliano e “sentiment” campano nel DNA che, quindi, ne spiega il grande sorriso). Quando ho 6 anni e papà è con il Bassano 54, i miei si separano e io resto con mamma. Nel 2006 ci trasferiamo dalla città del Grappa a Vicenza, dove io frequento sia medie che liceo, prima di iscrivermi a Scienze Politiche all’Alma Mater di Bologna, l’Università più antica del mondo. Mi laureo nell’atmosfera surreale del periodo Covid e decido di trasferirmi per un anno a Berlino, per poi rientrare a Vicenza e cominciare a lavorare qui (ndr: ha tra l’altro collaborato attivamente e appassionatamente, come in ogni cosa che fa, alla campagna elettorale per Giacomo Possamai sindaco, con cui la ritrae una foto scattata dal nostro direttore durante i festeggiamenti con gli amici in piazza dei Signori dopo la sua elezione). Un perfetto percorso italiano, da italiana no? Peccato che per la legge io lo sia soltanto da quando ho compiuto 22 anni!
Chissà quante persone si sono trovate o si trovano nella tua stessa situazione… Una volta gli immigrati eravamo noi e ora il popol(in)o distratto ed esasperato da ben altri flussi migratori, irregolari, male o per nulla gestiti, sembra aver dimenticato sia la nostra stessa storia, sia la responsabilità morale di approfondire e distinguere.
È stata proprio la consapevolezza dell’esistenza di una realtà diffusa, e ignorata, insieme all’avvicinarsi di un appuntamento importante come il referendum dell’8 e 9 giugno scorsi, a stimolarmi a scendere in campo. È


Ilgiornodellalaureainscienze politicheerelazioniinternazionali
così che lo scorso aprile è nata @Volti.italiani.storie, la mia pagina Instagram che raccoglie le testimonianze di italiani e italiane con background migratorio e ne mostra appunto volti e risvolti. Un modo per dare loro voce, per combattere le fake news, per scollegare il tema cittadinanza ai figli di stranieri dal tema dell’immigrazione clandestina e soprattutto per fare rete. E anche un modo per tradurre positivamente l’incazzatura che ho dentro. In un’Italia che ha il peggior tasso di natalità nel mondo dopo il Brasile e i cui giovani fuggono sempre più all’estero, l’iter attuale non è solo ingiusto, ma stupido. Le testimonianze raccolte, già una quarantina ma in continuo aumento, raccontano non solo il disagio morale di sentirsi italiani e non esserlo davanti alla legge, ma anche i tanti, inaccettabili limiti a condurre una vita normale: dall’impossibilità di votare alla carta d’identità che non è valida per l’espatrio, dal veto a partecipare a concorsi pubblici alla difficoltà nell’ottenere un contratto di lavoro o di affitto e così via… Sebbene con i ritmi del Parlamento Europeo mi ci debba dedicare nel poco tempo libero,

quella di Volti Italiani è un’esperienza bellissima, carica di varia umanità a conferma di un’unica verità: la legge sulla cittadinanza italiana, ferma dal 1992, così com’è non è più accettabile. Per questo creo eventi di sensibilizzazione in giro per l’Italia.
A proposito di referendum, tasto dolente, sappiamo tutti come è andata. Tu come l’hai vissuto?
Ho puntato tanto sulla consultazione di inizio giugno perché era un’occasione unica, ma non mi sono mai illusa che potesse andare diversamente. Il problema oggi, ancor prima di quello della non-cultura contro cui stiamo combattendo, è la piaga dell’astensionismo e mantenere il quorum al 50% è sicuramente anacronistico. Detto questo, è inutile girarci intorno, l’affluenza al 30% è stata una sconfitta come anche una percentuale consistente di votanti per il “no” a questo che considero un diritto, ma personalmente dagli insuccessi prendo nuovi stimoli a fare di più e a fare meglio. Senza contare che, comunque, il referendum e tutto il rumore attorno a esso hanno smosso, se non le coscienze, almeno le acque: oggi abbiamo molti più attivisti e quasi 10 milioni di italiani che hanno votato SI. È proprio adesso il momento di mettercela tutta.
genitori italiani, tra compagni e compagne con cui hanno condiviso tutto. Ma non sono cittadini. Non ancora. E soprattutto, chissà quando lo saranno… La cittadinanza non è un premio né una concessione. È un riconoscimento. Un atto civile, e civico, che dà voce a una realtà già esistente. Non riguarda l’immigrazione irregolare, non ha nulla a che fare con la retorica dell’emergenza. Riguarda ragazze e ragazzi che vivono, parlano, pensano e sognano in italiano.
Tu di lingue ne parli addirittura cinque, vivi nel cuore istituzionale dell’Unione Europea, fai la spola tra Bruxelles e Strasburgo e hai girato il mondo. Che rapporto hai con Vicenza e soprattutto che cosa ne pensi di quel certo provincialismo di cui ancora troppo spesso viene tacciata?

Avanti tutta, quindi. Ma ti sembra che dei progressi siano davvero possibili? La strada è ancora lunga, ma di recente qualcosina si è mosso. Antonio Tajani – vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia – ha dichiarato pubblicamente che il suo partito è pronto a presentare una proposta di ius scholae, che prevede la cittadinanza per chi ha completato almeno dieci anni di studi in Italia con profitto, e a discuterla con tutti. Stiamo a vedere, la politica estiva è sempre a rischio evaporazione… (ndr: e non a caso, poco dopo questa intervista, Pier Silvio Berlusconi è entrato a gamba tesa sul leader del partito del padre). Sta di fatto che sono circa 900.000 gli studenti con cittadinanza non italiana che frequentano le nostre scuole, circa il 12% del totale degli alunni. Bambini e ragazzi che sono cresciuti tra gli stessi banchi dei coetanei con
In realtà trovo personalmente che oggi la scuota un bel fermento. Credo che a livello internazionale abbia tutto il potenziale per essere sempre più attrattiva. Proprio perché sono andata parecchio in giro, riesco a vederne la bellezza, la storia, la cultura. In ogni caso, Vicenza è la città che mi ha accolta, che mi ha cresciuta. Quando ci torno, il più spesso possibile perché tutti i miei affetti sono qui, mi sento a casa. Anche a livello di dimensione, la trovo perfetta: ti offre tutti i vantaggi di una città non troppo piccola, senza i disagi delle grandi metropoli. Il lavoro mi ha portata all’estero, ma mi sento molto legata (e collegata) a Vicenza.
Non abbiamo parlato con Victoria, tutta immersa nel suo impegno civile dopo un’esperienza giovanile non tutta rose e fiori, dei suoi progetti più strettamente personali, ma a 29 anni una ragazza che ama la città in cui vive può legittimamente aspettarsi di trovarvi, oltre a tutti gli affetti attuali, anche quelli futuri. Magari con gli umani e, perciò, emozionanti alti e bassi ma rimanendo sinceramente sorridente anche se pronta a incazzarsi. È il nostro migliore augurio a questa “italiana dentro”. VictoriaemammaAnaLucia, l’annoscorsoinvacanza,

Intervista a una figura di riferimento, da promessa letteraria a manager di successo tra impresa, cultura e impegno civile

di Martino Montagna
La sua nomina è arrivata il 2 giugno 2025, nel giorno della Festa della Repubblica. La spillatura, come da tradizione, si è tenuta qualche settimana dopo: il 21 giugno, con una cerimonia riservata ma significativa nella sede del Club dell’Associazione Industriali di Vicenza. Accerchiato dagli affetti famigliari e dalle persone più significative per lui, Andrea Pellizzari è ufficialmente diventato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, un titolo
che premia cittadini italiani e stranieri che si sono distinti nei settori delle lettere, dell’arte, dell’economia, della pubblica amministrazione, del volontariato e delle attività civili o militari. Una carriera intensa, la sua, costruita tra managerialità, impegno politico, volontariato, scrittura e cultura. E soprattutto, vissuta sempre con una visione chiara: contribuire al bene pubblico, promuovendo l’innovazione e tutelando i diritti fondamentali. In questa intervista, ripercorriamo le tappe più significative della sua storia personale e professionale.

1985.allenamentoUSGarciaMorenoArzignanoconun giovanissimoRobertoBaggio,arrivatoinbusegiàcedutoalla Fiorentina-Pellizzariilquintodasinistratragliaccosciati
Andrea Pellizzari nasce il 22 gennaio 1972 ad Arzignano, città dove oggi è tornato a vivere dopo un periodo di 8 anni a Vicenza; lì si è trovato bene ma vi ha vissuto con un pensiero nostalgico costante che lo ha spinto a tornare al luogo natio.
“Arzignano è sempre rimasta nel mio cuore e l’idea di tornare a viverci c’è sempre stata”, dice sorridendo. Dopo la maturità scientifica conseguita al Liceo Da Vinci, si laurea in Giurisprudenza all’Università di Ferrara, con una tesi in Diritto Processuale Civile. La sua formazione continua poi con numerosi master e percorsi post-universitari, l’ultimo dei quali – in Intelligenza Artificiale e responsabilità – appena conseguito all’Università di Brescia, il 18 luglio. Sin dai primi anni Duemila, la sua carriera si muove su più fronti. Nel settore privato, è amministratore delegato, consulente strategico e componente di organismi di vigilanza. In parallelo, non abbandona l’impegno pubblico: assessore provinciale a Vicenza dal 2007 al 2012, con deleghe centrali come Innovazione, Politiche giovanili e Servizi legali.
“La politica, a livello locale, è stata per me – ci dice il Cavaliere Andrea Pellizzari - un acceleratore, ma anche un freno. Quando amministri c’è sempre la possibilità di fare molto per il prossimo ma, allo stesso tempo, c’è anche il rischio di non piacere a tutti. Resta comunque una passione intesa come servizio verso i cittadini”.
Manager, consulente, innovatore ma anche scrittore e volontario. Attualmente, Pellizzari è direttore di HD Consulting Srl del gruppo Belluscio e of counsel dello studio Gitti & Partners, presente a Milano, Roma, Brescia e da gennaio anche a Vicenza, e collabora con numerose società nei settori energia, ICT, AI, finanza, assicurazioni, fondi di private equity e servizi pubblici. Ma il suo sguardo è stato sempre rivolto anche oltreconfine. Nel 2010, ad esempio, fu designato rappresentante dell’Italia presso il Consiglio d’Europa, all’epoca del ministro dell’Interno Maroni. “In quella sede si discuteva di tutela delle minoranze e dei diritti fondamentali. Ricordo bene anche le tensioni legate alle prime sanzioni alla Russia per l’invasione del Donbass. È stata una delle esperienze istituzionali più formative della mia vita”. Dietro la figura del manager si cela però un mondo ricco di interessi personali. Andrea Pellizzari è da sempre appassionato di scrittura, una passione coltivata fin dalla giovane età con risultati assolutamente lusinghieri, tanto da prefigurare un brillante futuro nel mondo letterario. È stato finalista nel 1991 del Premio Campiello Scuola, presieduto da Dacia Maraini. “Il mio racconto era una storia di fantascienza ambientata sulla Luna, in cui si contrapponevano il lato chiaro e il lato scuro. In realtà era una metafora del conflitto israelo-palestinese. Un tema, purtroppo, ancora oggi drammaticamente attuale”. Un talento coltivato anche negli anni successivi: già finalista e vincitore di concorsi nazionali, anche promossi dalla Commissio-
ne Europea, ed è stato componente tecnico di giuria in diverse edizioni di premi letterari regionali. Oggi continua a leggere molto e a collaborare con testate locali, curando rubriche su innovazione, giovani e trasformazione digitale. Ma alla passione per la cultura si affianca anche un forte impegno nel volontariato iniziato dal servizio civile svolto presso l’Auto Mutuo Aiuto di Montecchio Maggiore, dove guidava perfino il pullmino, fino agli anni passati al centro diurno “Duca d’Aosta” per fragilità psicologiche, dove ha dato il suo supporto agli utenti. È stato membro del CdA dell’IPAB “Scalabrin” di Arzignano. Ma anche l’arte ha rappresentato una sua rilevante fonte di interesse partecipando attivamente al lavoro del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio Palladio, contribuendo all’organizzazione della mostra per i 500 anni dalla nascita del celebre architetto, ed una decennale adesione al Fondo Ambiente Italiano.
Vita privata.
“Mi sono sposato il 30 agosto 2020, un giorno che segna un capitolo fondamentale della mia vita. Da quel momento, insieme a mia moglie Adriana, abbiamo intrapreso un cammino che ci ha portato a vivere una nuova fase di serenità e cambiamento. Molto ha influito la decisione di tornare a vivere ad Arzignano, un luogo che mi è rimasto nel cuore e che ora con Adriana e le sue, e nostre, figlie, Alice e Anna, consideriamo casa. Arzignano, seppur una piccola cittadina, rappresenta per me una radice profonda, un legame affettivo che non si è mai spezzato. Nonostante gli anni passati lontano, il richiamo di questa terra, con la sua comunità e le sue tradizioni, è stato più forte di ogni altra cosa. I miei genitori, papà Flavio, che è stato dirigente d’azienda e mi ha insegnato l’impegno e l’amore per la cultura d’impresa, e mamma Grazia sono ancora una presenza costante e fondamentale nella mia vita. La loro esperienza e il loro amore sono per me una fonte di ispirazione quotidiana. Ho un fratello, Alessandro e ben tre meravigliosi nipotini: Leonardo, Chiara e Maria”.


2giugno2025-Consegnadiploma
Cavalierato OMRI con Sindaci Valchiampo
Un altro punto di riferimento importante per Andrea Pellizzari è stato Monsignor Antonio Mistrorigo, vescovo di Treviso e suo prozio. Tra l’altro, un legame che si fa ancora più forte visto che fu lui a diventare, nel 1975, Cavaliere Grand’Ufficiale, un traguardo che segnò non solo il suo percorso, ma anche quello della famiglia.
“50 anni prima di me - commenta il neo Cavaliere - Monsignor Mistrorigo ha saputo combinare fede e dedizione in una vita di servizio. La sua figura, seppur lontana nel tempo, continua ad ispirarmi. La sua determinazione e il suo amore per il prossimo sono una luce che mi guida nel cammino della vita. Oggi, guardando indietro, mi rendo conto di quanto questi legami, queste radici familiari, e anche l’eredità di figure come quella di Monsignor Antonio, abbiano contribuito a plasmare chi sono oggi. La famiglia, nel suo senso più ampio e profondo, è sempre stata il punto di partenza e di arrivo, il luogo dove tutto ha senso e dove ogni sfida si affronta con il cuore”.
I riconoscimenti e il significato del Cavalierato
Nel corso degli anni, Pellizzari ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti che testimoniano il suo impegno professionale e civico. Tra questi, spiccano il Premio Nazionale “E-Gov”, il Premio “Handimatica” per l’inclusione digitale, il Premio speciale della giuria “Fabbrica dell’Innovazione” e diverse Menzioni per Best Practice dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Formez.
Ma qual è il significato di questi premi e che cosa rappresentano questi riconoscimenti?
“Ogni premio ricevuto è una conferma che il lavoro svolto nel campo della pubblica amministrazione, dell’innovazione e dell’inclusione digitale è stato apprezzato e ha avuto un impatto positivo. Il Premio ‘E-Gov’ per esempio, premia le best practice nel digitale per la pub-

21giugno2025CavalieratoOMRI consegnatargadaPresid.RotaryViNord
blica amministrazione, un settore in cui la digitalizzazione è fondamentale per migliorare i servizi offerti ai cittadini”, afferma Pellizzari.
“Il Premio ‘Handimatica’ per l’inclusione digitale, conferito da FORUM PA e dalla Fondazione ASPHI, è uno dei più significativi per me. Riconosce l’impegno per rendere la tecnologia accessibile a chi ha difficoltà, in particolare alle persone con disabilità. È un tema che mi sta molto a cuore e che credo debba essere una priorità in ogni progetto di innovazione”, aggiunge Pellizzari.
Un altro traguardo importante è il Premio speciale della giuria “Fabbrica dell’Innovazione”. Come è stato accolto questo riconoscimento?
“Il premio ‘Fabbrica dell’Innovazione’, conferito durante l’evento EuroPA, ha celebrato il mio impegno nell’innovazione e nella trasformazione digitale delle istituzioni pubbliche. In questo settore, dove l’efficienza e la trasparenza sono essenziali, lavorare per rendere i servizi pubblici più accessibili e moderni è una sfida che accetto con passione”.
Adesso è arrivato questo riconoscimento che ha segnato una tappa fondamentale nella sua carriera. Come ha reagito alla notizia della nomina a Cavaliere?
“L’onorificenza rappresenta un onore che non mi aspettavo. Quando ho appreso della nomina, mi sono sentito travolto da una grande emozione, ma anche da un senso di responsabilità. Questo riconoscimento è una testimonianza del lavoro svolto, ma è anche un invito a continuare a impegnarmi per il bene comune; non è un riconoscimento solo per me, ma per tutti coloro che, come me, si impegnano ogni giorno, in silenzio, per migliorare il nostro Paese”.
Per lui, la nomina a Cavaliere, il cui primo passo è stata la trasmissione alla Prefettura del suo Curriculum Vitae da parte di Pierantonio Zanettin, senatore vicentino di Forza Italia, partito in cui ha avuto un ruolo atti-
vo, non è solo un riconoscimento personale, ma un simbolo di un impegno collettivo: «Dedico questo premio a chi crede nel lavoro serio, nel servizio e nell’importanza di ogni piccolo passo che, nel tempo, può cambiare in meglio la società. È un impegno che non finisce mai e che continua ogni giorno”.
Con l’assegnazione del Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) ad Andrea Pellizzari, Arzignano si arricchisce di un nome che si aggiunge a una lunga e illustre lista di cittadini che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento: Bepi De Marzi, uno dei più celebri maestri della musica folk italiana, autore della memorabile “Signore delle cime”; Padre Giovanni Gentilin, un missionario che ha dedicato la sua vita all’aiuto delle popolazioni più bisognose; Mirco Balsemin, imprenditore conciario che ha contribuito allo sviluppo e all’innovazione del settore della concia, presidente del settore a livello Confindustriale; Cristian Greco, l’egittologo nato all’ospedale di Arzignano, direttore del Museo Egizio di Torino.
Andrea Pellizzari si inserisce ora accanto a queste figure importanti, rappresentando una continuità con una tradizione di cittadinanza attiva che Arzignano vanta.
E se glielo chiedessero, tornerebbe in politica?
Noto per il suo impegno nel mondo dell’innovazione e della pubblica amministrazione, ha anche alle spalle una significativa carriera politica che lo ha visto ricoprire il ruolo di consigliere comunale e assessore provinciale. Alla fine di un’intervista che ripercorre la sua carriera e le sue esperienze professionali, una domanda appare inevitabile: “Tornerebbe in politica?”.
La sua risposta, pur non chiudendo definitivamente la porta, lascia trasparire un sperimentato senso di realismo: “Per me la politica è sempre stata passione, intesa come servizio. Mai dire mai. Ma oggi, con tutti gli impegni professionali che ho, sarebbe davvero difficile trovare il tempo. Credo però che ciascuno di noi debba continuare a contribuire alla vita pubblica, anche fuori dalle istituzioni perché la politica non è solo una questione di incarichi o poltrone, ma un impegno continuo che può trovare spazio in ogni angolo della vita quotidiana”.
“Dov’è finito il sindaco che avevamo votato? Di che amicizia con gli USA si va cianciando?”

Emilio Franzina
di Emilio Franzina
“La potenzialità rappresentata dalla presenza della comunità Usa a Vicenza – secondo il sindaco, Giacomo Possamai (da “Bulgarini d’Elci nominato consigliere esterno dal sindaco”, 7 luglio 2023, Comunicato stampa del Comune di Vicenza, ndd) – [sarebbe] un ambito in larga parte inesplorato, rispetto al quale ho
chiesto a Jacopo Bulgarini d’Elci di supportarmi, considerate le sue significative relazioni con la base americana. Lo sviluppo del brand Vicenza è l’altro tema a cui, alla luce della sua esperienza, gli ho chiesto di lavorare al mio fianco, sempre a titolo gratuito e senza alcun incarico di tipo politico. Con questa nomina introduciamo la figura del “consigliere esterno” che utilizzeremo anche con altre persone
che ci hanno accompagnato durante la campagna elettorale e che possono aiutarci a dare sostanza alla nostra visione di un’amministrazione plurale che coinvolge e valorizza le energie positive”.
Dov’è finito il sindaco per cui, assieme alla gran massa dei suoi coetanei, anche non pochi di noi, vicentini più vecchi o comunque anziani, avevamo votato due anni fa pur essendo al corrente delle sue posizioni assai moderate in seno al PD? Per quale motivo ha ritenuto di poter capovolgere principi e concetti condivisibili che non più tardi dell’ultimo 25 aprile lui stesso aveva esposto contro la guerra? Lo aveva fatto, si ricorderà, assieme a Walter Veltroni, in una Piazza dei Signori partecipe e gremita, mentre ora si arrampica da solo o appena con l’aiuto di qualche scudiero (o meglio di qualche scherano travestito da “consigliere esterno”) sugli specchi di una penosa apologia della settantennale “presenza” americana in città (9 su 10 una presenza armata!) attraverso il più farlocco dei festival in suo onore (Italia-America Friendship Festival) camuffato da iniziativa culturale e imposto a Vicenza, “città di pace” espropriata del suo aeroporto civile e stravolta nella propria viabilità, ma divenuta infine sede di ben due basi yankees entrambe poco gradite e sentite come estranee dalla popolazione locale.
Sessantasette anni dopo gli Americani a Vicenza di Parise è forse giunto il momento di occuparsi finalmente di Vicenza agli americani? Probabilmente sì, ma sempre ricordando che le basi americane
di Vicenza al pari di tutte le altre, non escluse quelle dotate di armi nucleari ancora esistenti in Italia, esercitano, dalla fine del Secondo conflitto mondiale, una funzione non già di difesa o di deterrenza, quanto di controllo politico militare (a sue ovvero nostre spese) di chi le “ospita” in Europa. Parlare o meglio straparlare vaneggiando di “amicizia” tra Vicenza e USA in un tale contesto, anche al di là delle recenti performances belliche del leader cotonato e inquietante che ora siede alla Casa Bianca e davanti a cui si genuflettono pressoché tutti i sovranisti di paglia europei, e farlo con la scusa puerile delle relazioni culturali non è dunque lecito e costituisce, semmai, un gesto vile e servile di cui chi lo compie dovrà prima o poi rispondere e rendere conto al proprio paese. Il monumento di gratitudine, ma in realtà di subordinazione agli Stati Uniti ora anche trumpiani (e non già all’”America” che è qualcosa di ben più ampio e di assai diverso) ovvero il fatuo coacervo di spettacolini, di esposizioni, di conferenze ecc. che a Vicenza si vorrebbero far svolgere, a spese del Comune, dalle istituzioni culturali o associative cittadine, spesso prive di specifica competenza in materia, costituisce quindi, prima di tutto, un oltraggio ai suoi abitanti e, in subordine,

L’alloravicesindacoJacopoBulgarinid’Elcipresentesenzafasciaenon partecipaaltagliodelnastroall’inaugurazionedellasecondabaseUSA
un vergognoso tentativo di affossare la memoria di sette anni di lotte popolari contro la seconda base chiamata provocatoriamente nel 2013 Del Din e invisa a una intera generazione di vicentini non tutti andati in quiescenza (o in aceto).
Di che amicizia tra Vicenza e USA si va cianciando? Che cosa c’entrano le bombe e i depositi di missili a stelle e a strisce, i paracadutisti e i soldati stranieri accasermati a casa nostra con la cultura e con la
storia dei rapporti artistici, musicali, letterari ecc. intercorsi, massime in passato, fra due diverse parti del mondo? E allora si sappia che quel grottesco monumento, se mai si farà, porterà per sempre il nome di Possamai e di altri penosi maggiordomi di Washington i quali, ottusi e in mala fede, ne rivendicano la pretesa liceità, ma si consegnano sin d’ora alla triste storia della cortigianeria italiota come campioni provinciali e periferici d’ineguagliabile arroganza e stupidità.

così l’Avatar di Giacomo Possamai risponde a Franzina e al centrosinistra che critica il sindaco di Vicenza
Questo testo è stato generato da un’intelligenza artificiale in forma di avatar AI ispirato al “nostro sindaco”. Gli avevamo chiesto subito, mercoledì 8 luglio notte, il giorno stesso della pubblicazione su ViPiu.it delle osservazioni di Emilio Franzina, riportate nelle pagine precedenti, “una risposta a tutti spiegando l’iniziativa, senza polemizzare” conoscendo il carattere ecumenico di Possamai. Dopo pochi minuti, ci messaggiava “Ok, domattina ci sentiamo”. Preso, non è ironia, dai suoi impegni, mi messaggiava pochi minuti dopo la mezzanotte di giovedì 9 “Tra l’altro oggi grazie a te ho fatto una bella chiacchierata con Franzina. L’articolo mi ha dato lo stimolo per sentirlo dopo tanto tempo. Domattina sono in viaggio dalle 7 alle 11, quando posso chiamarti?”. Alla mia immediata risposta “Quando vuoi” è seguito il silenzio assoluto, abitudine democristiana, buona o
di Giovanni Coviello
Negli ultimi giorni, e in particolare dopo la pubblicazione della lettera aperta del professor Emilio Franzina su ViPiu.it, ho letto con attenzione una serie di riflessioni, critiche, persino inviti a tornare sui miei passi. Lo dico con rispetto e senza polemiche:
cattiva ce lo potrebbe dire il Maestro Achille Variati. Abbiamo, quindi, pensato, noi che non abbiamo alcun incarico, interno od esterno, di aiutare il sindaco e abbiamo chiesto al nostro programma preferito GPT (Generative Pretrained Transformer) di scrivere, sotto il nostro check di corrispondenza al vero, quello che avrebbe scritto Giacomo Possamai: lo stile, i contenuti e il punto di vista riflettono una simulazione realizzata sulla base di fonti pubbliche in base alle istruzioni fornite. Si tratta, quindi, di una rappresentazione artificiale e non di una dichiarazione autentica o ufficiale della persona citata. Ma, al 99%, da essere dotato di normale AI (Autonoma Intelligenza) mi sembra più che realistica. Se vorrà, il buon Giacomo Possamai, quello vero, potrà sempre… repicare. Il direttore
non condivido queste letture e sento la necessità di spiegare, nel merito e nel metodo, perché ho scelto di sostenere l’Italia–America Friendship Festival.
Non è un mistero che su questa iniziativa si siano divise non solo le forze politiche in Consiglio comunale, ma

anche quelle della mia stessa maggioranza. Lo considero legittimo, e persino utile se il dissenso nasce da una volontà di dialogo. Ma vorrei che si sgombrasse il campo da un equivoco di fondo: questo Festival non è una parata militare, né un’operazione propagandistica. È invece un evento culturale, pensato per valorizzare Vicenza come ponte tra due mondi, tra due storie, tra due popoli che da decenni convivono, a volte faticosamente, in questa città.

Italia-AmericaFriendshipFestival(dasxJacopoBulgarinid’Elci,ideatoree direttoredelprogetto,ilConsoleperlaStampaelaCultura,Consolato GeneraledegliStatiUnitiaMilanoYoonNam,SindacoPossamai,ilPresidente dell’associazioneVicentininelmondoFerruccioZecchin,eilSegretario Generale della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza Pier Giacomo Cirella (loscattoèdellaconferenzastampadiannunciodelFestival)
Mi si chiede: “Ma che tipo di amicizia celebriamo, con chi, e perché proprio ora?”. La risposta è semplice: non celebriamo l’America delle guerre, dei muri e dei bombardamenti, ma quella della cultura, delle università, della comunità americana che vive a Vicenza e contribuisce, anche economicamente, alla nostra città. Non ho mai nascosto, nemmeno in campagna elettorale, di voler rilanciare una politica di relazioni inter-
nazionali che valorizzi Vicenza oltre i confini del suo perimetro storico. Il brand Vicenza, come città di cultura e di dialogo, ha bisogno di strumenti nuovi, e tra questi c’è anche una diplomazia culturale che sappia parlare lingue diverse senza smarrire la propria.
Il Festival – che si svolgerà dal 12 al 14 settembre – ospiterà concerti, dialoghi tra università italiane e statunitensi, incontri con scrittori e in-
tellettuali. A organizzarlo con visione e cura è Jacopo Bulgarini d’Elci, che ho scelto come mio consigliere per la valorizzazione culturale della città, convinto com’ero (e come sono) che la sua esperienza possa servire a Vicenza. A chi, come Franzina, mi rimprovera un certo stile “corporate”, quasi pubblicitario, rispondo che non c’è nulla di sbagliato nel voler comunicare bene ciò che si fa, se dietro c’è sostanza. E la sostanza, in questo caso, è una proposta culturale che abbraccia molte sfaccettature: storiche, artistiche, perfino gastronomiche.
È vero: su questa iniziativa ho trovato il sostegno anche dell’opposizione di centrodestra. Ma non è una scelta “contro” qualcuno. Non lo è contro la sinistra con cui governiamo, né contro chi teme che questo Festival normalizzi la presenza della base americana. Su questo punto, voglio essere chiaro: non ho mai smesso di interrogarmi sul ruolo di quella presenza, e resto convinto che il confronto con le forze civili e pacifiste sia sempre necessario. Allo stesso tempo, però, penso che non sia contraddittorio cercare spazi di dialogo anche con chi oggi è nostro ospite e sarà nostro vicino ancora a lungo.
Concludo con una nota personale. Mi ha colpito che il professor Franzina mi chieda “dov’è finito il sindaco che avevamo votato?”. Sono qui, e sono lo stesso. Solo che oggi ho anche la responsabilità di un’intera città, delle sue sensibilità plurali, delle sue esigenze concrete, delle sue aspirazioni più alte. Cerco di fare il mio mestiere con equilibrio e serietà. So che non tutti saranno d’accordo, e accetto volentieri il confronto. Ma non accetto l’idea che la cultura debba sempre stare nel recinto delle identità politiche. Se vogliamo davvero essere europei, se vogliamo essere città del futuro, allora dovremo anche imparare a parlare linguaggi che sappiano unire, non solo distinguere.
Devis Rizzo, presidente del Coveco, oggi Kostruttiva, ruppe il fronte delle aziende che resistevano all’inchiesta della magistratura.
Dieci anni dopo un libro racconta come le cooperative rosse si sono guadagnate un ruolo egemone nei lavori della grande opera

DevisRizzo,presidenteLegacoopVeneto
di Renzo Mazzaro
La storia del Mose raccontata dall’interno, da una delle aziende protagoniste dello scandalo. Cos’è successo ai dirigenti e alle maestranze quando il malaffare apparve in tutta la sua enor-
mità, un miliardo di euro su cinque rapinato all’erario con sovrafatturazioni, tangenti, sprechi, perfino lavori pagati e mai eseguiti. Era il «fabbisogno sistemico» come lo chiamava l’ingegner Piergiorgio Baita, un andazzo che andava avanti da dieci anni. Se dividete un
miliardo per dieci anni, saltano fuori 280.000 euro al giorno. Ogni mattina che si alzava il sole 280.000 euro delle tasse prendevano il volo verso altre destinazioni. Finché il 4 giugno 2014 la procura di Venezia ha fatto saltare il banco.
Qualche settimana dopo, Devis Rizzo viene catapultato dalla scrivania di un ufficio alla plancia di comando del Coveco (Consorzio veneto cooperativo), il consorzio delle cooperative rosse che lavorano per il Mose e che rischia di chiudere. Deve salvarlo senza avere nessuna esperienza imprenditoriale, imparando tutto sul campo, a sue spese. Comincia una vita spericolata, anni di tensione continua che lo portano all’infarto, dal quale si salva per il rotto della cuffia. Nel 2014 quando prende in mano il Coveco, le cooperative avevano il 2,5% dei lavori del Mose, oggi il Coveco ribattezzato Kostruttiva è il pilastro delle aziende del Mose. Devis è l’unico che ha restituito spontaneamente il denaro delle sovrafatturazioni, 7 milioni di euro, cosa che nessuna delle grandi imprese del Mose si sognava di fare. Tutte hanno resistito in processo. Rizzo ha rotto il fronte e l’ha fatto contro il parere di chi l’aveva messo a capo del consorzio, convinto che si sarebbe limitato a fare da prestanome.
Dieci anni dopo, questa avventura
umana e professionale è raccontata in un libro, “L’Avana Marghera sola andata”, uscito lo scorso dicembre. Un libro basato sui fatti, molti dei quali inediti anche se riguardano una vicenda sulla quale sono stati scritti quintali di pagine. Con un ulteriore pregio: parla del Mose da un punto di vista sempre snobbato, quello delle maestranze, dagli ingegneri agli operai che alla grande opera hanno lavorato giorno dopo giorno e non sono mai andati sotto i riflettori. In tv arrivavano solo i grandi capi.
Il 4 giugno 2014 Rizzo è a L’Avana con una delegazione della Lega delle cooperative. In Italia sono le 7 di mattina, Cuba è 6 ore indietro di fuso orario. Una telefonata da Marghera lo butta giù dal letto. È un suo collega: «Hai saputo? Hanno arrestato tutti». «Tutti chi?». «Tutti, i loro, i nostri, tutti». Al rientro in Italia trova gli uffici sottosopra. La situazione è fuori controllo, da Roma i dirigenti della Lega hanno fatto sapere: voi avete combinato il disastro, voi ve lo gestite.
Tagliare i ponti, troncare i collegamenti: è la reazione che accomunò tutti i centri di potere coinvolti. Tutti spartivano i proventi del Mose, ma tutti prendono il largo quando l’imbroglio viene alla luce. Lo scandalo ha dimensioni nazionali, coinvolge politici, magistrati, poliziotti, alti burocrati, professionisti di grido, perfino il comandante in seconda della Guardia di Finanza in Italia. L’ossatura della classe dirigente del Paese, quelli che ci dicono di rispettare le leggi i primi a farsene beffe. Per salvare il sistema bisognava retrocederlo a scandalo veneto, anzi veneziano. È la linea che, ognuno per sé, tutti perseguono.
Il 27 giugno 2014 Rizzo è in ferie in Puglia e gli arriva un’altra telefonata: la dirigenza del Coveco è stata azzerata, servono nomi nuovi e per la presidenza hanno pensato a lui. Ventiquattro ore per decidere. Più che una poltrona è una graticola, Rizzo se ne rende conto, ma è tentato dalla sfida. Accetta ad una condizione, la garanzia del posto di lavoro in caso di fallimento. Ovvio che sì, gli rispondono. Menzogna: quando vorrà tornare gli sbatteranno la porta in faccia.

La sfida si rivela molto più dura del previsto. I dipendenti del Coveco si vedono arrivare uno sconosciuto, digiuno di tutto, a tirarli fuori dai guai. Figurarsi, i migliori pensano di andarsene, Rizzo deve sudare sette camicie per trattenerli. Le banche allarmate dall’inchiesta revocano i fidi: su 15 che lavorano con il Coveco solo 2
mantengono aperti i rubinetti del credito. Gli ex dirigenti del Coveco chiedono al nuovo presidente di limitarsi a firmare le carte e lasciare il timone a chi ne sa più di lui. Gli fanno pressione, gli scatenano contro le cooperative consorziate.
Qui Rizzo si impunta: non solo si dissocia dalla gestione precedente ma fa causa agli ex amministratori del Coveco, sostenuto dall’avvocato veneziano Alfredo Zabeo, l’unico che gli è vicino e gli traccia la rotta. Su consiglio di quest’ultimo concorda con i commissari del Mose la restituzione di 7 milioni di euro, illegalmente incassati dal Consorzio Venezia Nuova. Un ravvedimento operoso, che gli vale l’uscita dal processo. Cambiano i rapporti con la magistratura e con i commissari del Mose, ma non la situazione pericolante del Coveco: il governo non sblocca i fondi, non girano quattrini, Rizzo si arrabatta con gli ultimi cantieri rimasti in portafoglio, cambia il nome di Coveco in Kostruttiva, vende la sede per fare cassa, è ridotto a licenziare parte del personale. Finché nel 2018 è costretto a chiedere il concordato preventivo al tribunale: Kostruttiva è sull’orlo del fallimento.
Alla fine di quell’anno, l’acqua alta invade Venezia provocando danni milionari. È uno scossone per il governo che sblocca i fondi per il Mose. Nessuno ci sperava più: Kostruttiva riceve dai commissari incarichi di lavoro per 170 milioni di euro. È la fine della traversata del deserto per Rizzo. Kostruttiva si rimette in piedi, ma lui no: un infarto lo colpisce a tradimento, è solo in casa, non riesce a muoversi, la figlia piccola lo salva chiamando il 118.
Il 3 ottobre 2020 di nuovo l’acqua alta minaccia Venezia. La marea è ai livelli del 1966 quando piazza San Marco andò sotto 175 centimetri sul medio mare. Invece le paratoie del Mose si alzano ed evitano un altro disastro. È lo sdoganamento del Mose, il sistema funziona. Rizzo riceve telefonate da mezzo mondo. Da allora tutto va in discesa:
l’intervento per proteggere la Basilica di San Marco, il progetto per isolare la piazza dall’acqua che non arriva dal bacino ma cresce dal basso, da sotto i masegni. E i lavori di compensazione ambientale per salvaguardare la laguna, lasciati colpevolmente per ultimi. Con una nuova sfida da intraprendere: la manutenzione delle paratoie, futuro tutto da inventare.
Tra i bilanci che il libro traccia a fine corsa, c’è la disillusione di Rizzo alla “scoperta” che le cooperative rosse erano dentro al patto consociativo, incassavano sovrafatturazioni e pagavano tangenti come le altre imprese del Mose. La presunta superiorità morale vantata dalla sinistra non è mai esistita. O meglio, Rizzo è convinto che esistesse nel ’92 all’epoca di Mani Pulite, per il forte legame che c’era allora tra le cooperative e il partito. Vent’anni dopo, con il tramonto delle ideologie tutti i gatti sono diventati bigi. La dimostrazione, a suo dire, è che a suo tempo l’inchiesta Mani Pulite lasciò praticamente indenne il Pci. Ma resterebbero da spiegare vicende come quella di Primo Greganti, il “compagno G” cassiere del partito e titolare del conto “Gabbietta” dove finivano le tangenti del gruppo Ferruzzi, da lui sempre negate. Negare tutto, sempre, anche l’evidenza: questa era la diversità.

messo e riconsegnato il maltolto. Un coraggio, ribadisce, che gli viene proprio da quella militanza politica. I contribuenti italiani dovrebbero essergli grati in ogni caso.


Ma è acqua passata. Oggi Devis Rizzo ha senz’altro una diversità morale da poter vantare: il coraggio di aver am-


il comunale di lonigo, oggi l’unico teatro storico dell’ottocento nella provincia di vicenza:
La rassegna estiva è un grande palcoscenico diffuso delle bellezze artistiche e storiche leonicene e anche delle attrattive dei Berici vicentini e dell’Est veronese

IlComunalediLonigoèl’unicoteatrostorico dell’Ottocento della Provincia di Vicenza
Tanta, bellissima storia e un presente unico, che nei mesi estivi esce persino dalla sala con un Festival – chiamato per l’appunto PostoUnico – per trasformare i luoghi più belli del territorio in cornici d’eccezione per spettacoli e concerti itineranti. Quella che, praticamente senza sosta, va in scena dentro e fuori dal prestigioso Teatro Comunale di Lonigo è una magia senza tempo. Non appena calato il sipario sulla stagione 2024/2025 si è infatti
subito cominciato a lavorare alla locandina 2025/2026, su cui si accenderanno i riflettori dal prossimo novembre. Nel frattempo era già ovviamente pronta l’attesissima rassegna estiva per quello che la direzione artistica del teatro negli anni ha trasformato in un grande palcoscenico diffuso, inizialmente coinvolgendo e valorizzando le bellezze artistiche e storiche leonicene e poi allargandosi anche alle attrattive dei Berici vicentini e dell’Est veronese. Costruita su progetto di Giovanni Carraro in sostituzione del settecente-
sco Teatro dei Concordi per dare alla città di Lonigo «un luogo accessibile al ceto impiegatizio, operaio e contadino» e inaugurata sull’ultimo strappo di XIX secolo (per la precisione, il 23 ottobre 1892), la sala-gioiello è oggi l’unico teatro storico dell’Ottocento nella Provincia di Vicenza. Intitolato a Giuseppe Verdi, il Comunale dalle origini e fino al 1977 non ha mai interrotto, nemmeno in tempo di guerra, la sua fervida e prestigiosa attività di palcoscenico per la grande lirica e la musica classica. Poi la chiusura per l’impegnativo restauro – conservativo e innovativo – ormai improrogabile, protrattosi fino al 1993. Ne è valsa decisamente la pena perché non solo ha restituito all’antico splendore l’armonica convivenza di art déco, pittura e vetri veneziani, ma ha dotato la sala di tecnologie moderne e le ha affiancato una nuova ala con ampi spazi a disposizione di artisti e maestranze. Ad accogliere il pubblico sono invece ancora, più eleganti che mai, il foyer di ispirazione liberty in legno rosa, le decorazioni pittoriche del veneziano Giuseppe Dolcetta, i fregi dei tre ordini di palchi e del boccascena, con i due grifoni che reggono l’orologio, e i lampadari dei maestri vetrai di Murano… Dalla riapertura nel 1993, la programmazione del Comunale continua a dare ampio spazio alla musica, ma si è aperta anche a prosa e danza contemporanea, con l’alto gradimento di un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo e con la partecipazione dei

La locandina del Comunale abbracciatutteleartisceniche(Foto:LucaArmellini).
grandi protagonisti della scena culturale italiana. Tra i tanti, Giorgio Albertazzi, Alida Valli, Franca Rame, Ottavia Piccolo, Ugo Pagliai, Luigi de Filippo, Valeria Valeri, Milena Vukotic, Lella Costa, Marco Paolini, Enrico Bertolino e Andrea Pennacchi, solo per la prosa. Per quanto riguarda la musica, si è spaziato da Uto Ughi a Fiorella Mannoia, da Paolo Conte a Edoardo Bennato, da Branduardi a Cocciante e tanti altri. Per la danza, dal Balletto di Mosca ai Mummenschanz. Dopo il re-opening, il cui trentennale è stato degnamente e ampiamente festeggiato nel 2023, indipendenza, qualità, ricerca, apertura a tutte le arti sceniche, nuovi talenti accanto a nomi noti, anteprime e riprese di successo caratterizzano la linea artistica del Comunale, la cui direzione è attualmente affidata allo stesso Alessandro Anderloni che firma anche le stagioni del Mattarello di Arzignano. E che anche qui infonde tutto il suo impegno verso le nuove generazioni, con numerose iniziative dedicate alle scuole e ai giovani in genere. Trasversale anche il pubblico cui è dedicato il Festival della musica, del teatro e della danza nei luoghi dell’arte PostoUnico, altro fiore all’occhiello del Comunale, che da dieci anni ogni estate, tra giugno e agosto, porta cultura e spettacolo in ville, palazzi, chiese, castelli, parchi e giardini del territorio che va da Lonigo ai colli Berici e all’Est veronese.
Info: Teatro Comunale, piazza Matteotti, 1 Lonigo Tel. 0444 835010 www.teatrodilonigo.it info@teatrodilonigo.it

Dopo il successo delle rappresentazioni di febbraio e
marzo a Vicenza il prossimo anno tocca a Vedova allegra e Orfeo all’inferno

SuccessoperleoperettepropostealComunale diVicenza.QuiSilviaFelisettieAlessandroBrachettiinBalloalSavoy
di Giulia Matteazzi
Operetta a Vicenza, garanzia di successo: il teatro Comunale di Vicenza propone stagioni di spettacoli sempre decisamente interessanti, sia nella prosa, sia nella danza, sia nella musica, e ogni anno mette in calendario almeno un paio di operette che regolarmente riempiono tutti e novecento i posti della Sala Maggiore. Anche per la prossima stagione teatrale sono in calendario due spettacoli, la celeberrima Vedova Allegra l’8 marzo 2026 e l’Orfeo all’inferno (quello del can-can) il 3 maggio 2026. Perché l’operetta all’ombra dei Berici (ma credo sia così in tutta Italia) piace così tanto? Bè, c’è da dire che chi la va a vedere normalmente non è proprio giovanissimo, e l’opera lirica è stata la prima forma di in-
trattenimento popolare. Certo, a teatro nei palchi andavano le famiglie abbienti, quelle con prestigio da ostentare, ma a riempire il resto dei posti c’erano le persone normali. E la passione ha attraversato almeno un paio di generazioni.
E se l’opera lirica era l’equivalente di un film drammatico, l’operetta è a buon diritto la controparte teatrale dei film musicali. Più spensierata della “sorella maggiore”, con più parti recitate e con sequenze danzate di una certa consistenza, richiede comunque ottime voci, brillantezza e una capacità di cambiare registro, passando dal dramma alla commedia e viceversa, non scontata. L’operetta è in un certo senso l’antenata del musical, e forse in Italia faremmo bene a continuare a proporla, perché riempie sempre i teatri e, nel novanta
per cento dei casi, i testi o sono nati in italiano o sono adattamenti talmente consolidati da non suonare forzati come capita a volte nelle versioni italiane dei Musical di Broadway.
In più l’Operetta a Vicenza è programmata di domenica pomeriggio. Scelta perfetta. Intanto pensando all’età media del pubblico, dato che una persona non giovanissima fa fatica ad uscire dopo le otto di sera, anche in considerazione del fatto che sono spettacoli che raramente durano meno di due ore e mezza. Poi perché andando a teatro di pomeriggio poi si può finire la serata cenando fuori senza fare troppo tardi. E poi perché si combatte la malinconia da sera del dì di festa.
In attesa di apprezzare le rappresentazioni del 2026, torniamo con la memoria a quello che abbiamo visto nel 2025. Quest’anno i due titoli proposti dal Comunale sono stati Ballo al Savoy e La Principessa della Czarda. Entrambi portati in scena dalla Compagnia Teatro Musica Novecento (come i posti del teatro… forse un segno di buon auspicio?), trentennale Compagnia di Reggio Emilia che in tema di operette è tra le migliori d’Italia e che infatti sarà protagonista anche delle due operette in programma la prossima primavera. Ballo al Savoy, su musica di Paul Abraham e libretto di Alfred Grünwald e Fritz Löhner-Beda, è un classico per gli appassionati del genere. La trama, ambientata nel lussuoso albergo Savoy dove sta per avere luogo un gran ballo, racconta le peripezie di Aristide (interpretato da Antonio Colamorea) un ex rubacuori, che per via di uno strano testamento dovrebbe tradire la moglie Maddalena (Renata Campanella) per non perdere una cospicua eredità e che si trova a interagire con una soubrette di varietà, Daisy Darlington (Silvia Felisetti) che è anche – in incognito – l’autrice delle

musiche più in voga del momento. A reggere le fila dei vari sotterfugi ed equivoci – con amici e servitori più o meno premurosi che cercano di risolvere la situazione (interpretati da Fulvio Massa, Marco Falsetti e Alessandro Garuti) – è il pittoresco Mustafà, ospite del Savoy con tutto il suo seguito di mogli, interpretato dal capo comico e regista dello spettacolo Alessandro Brachetti. La trama non è particolarmente profonda e il lieto fine si vede all’orizzonte sin dalla prima battuta, ma l’operetta è così, e siamo grati agli autori di non aver cambiato il copione per adattarlo alla mentalità odierna. Anche perché non ce n’è bisogno, ci sarà forse qualche battuta che oggi definiamo sessista, ma nel Ballo al Savoy emergono ben due figure femminili all’avanguardia, la moglie dell’ex rubacuori, innamorata e dolce ma anche ben decisa a far valere i suoi diritti di legittima consorte, e la soubrette Daisy Darlington, che sa comporre musica e per far sì che i suoi lavori vengano accettati dai produttori e dal pubblico finge di essere un uomo. Lo spettacolo scivola via veloce, coinvolgente e divertente, tanto che quando cala il sipario, sembra quasi impossibile che siano passate oltre due ore. Anche la principessa della Czarda, musica di Emmerik Kalman e libretto di Leo Stein e Bèla Jenbak, andata in scena a fine marzo, è un titolo celebre per gli appassionati. Anche qui la trama, esile ma articolata quanto basta per catturare l’attenzione del pubblico, è il pretesto per gag divertenti, cori, duetti e assoli trascinanti e piacevoli numeri d’ensemble di danza e canto. La storia parla ancora una volta di amori contrastati, e stavolta il problema è la differenza di ceto. Il giovane principe Edvino (ancora il bravo
L’ALTRA VICENZA V
Colamorea) è innamorato di Sylvia Varescu, la principessa del titolo, che però realtà è principessa solo di nome… d’arte, in quanto è una bravissima artista ma senza sangue blu (le dà volto e voce, splendida, ancora Renata Campanella). Un amore impossibile dunque, perché Edvino è di discendenza nobile di un casato dal nome impronunciabile pure per coloro che vi appartengono. Con le intrusioni del conte Boni (Brachetti) e della contessina Stasi (la brillante Felisetti), unica a saper pronunciare correttamente il nome del casato di Edvino, e le trovate del Marchese Feri, del generale Rushdorf e del Principe Leopoldo (Fulvio Massa, Francesco Mei e Marco Falsetti) anche qui l’amore trionferà, non senza sotterfugi, finzioni, anelli inghiottiti per sbaglio e tanto divertimento.
La compagnia Novecento sa il fatto suo, l’orchestra dal vivo Cantieri d’Arte diretta dal maestro Stefano Giaroli è un valore aggiunto (dipendesse da me, renderei obbligatorio suonare dal vivo in tutti gli spettacoli dove c’è accompagnamento musicale) e c’è pure un corpo di ballo stabile che fa da contorno, e anche questo è un segnale di serietà professionale, perché non sono molte le compagnie che si impegnano a tenere attivo anche il corpo di ballo. Il regista e capocomico Alessandro Brachetti è una garanzia, il ritmo è sempre vivace e in entrambe le rappresentazioni, al calare del sipario, il pubblico vicentino è rimasto ad applaudire e a salutare gli attori fino in fondo. Che per un pubblico che normalmente a fine spettacolo si esibisce in scatti verso l’uscita da fare invidia a Bolt, significa davvero che il gradimento è stato tanto.
È vicentina la “signora del fumetto” d’Italia che si confrontò anche con le “posizioni” del fascismo prima e dell’americanismo dopo
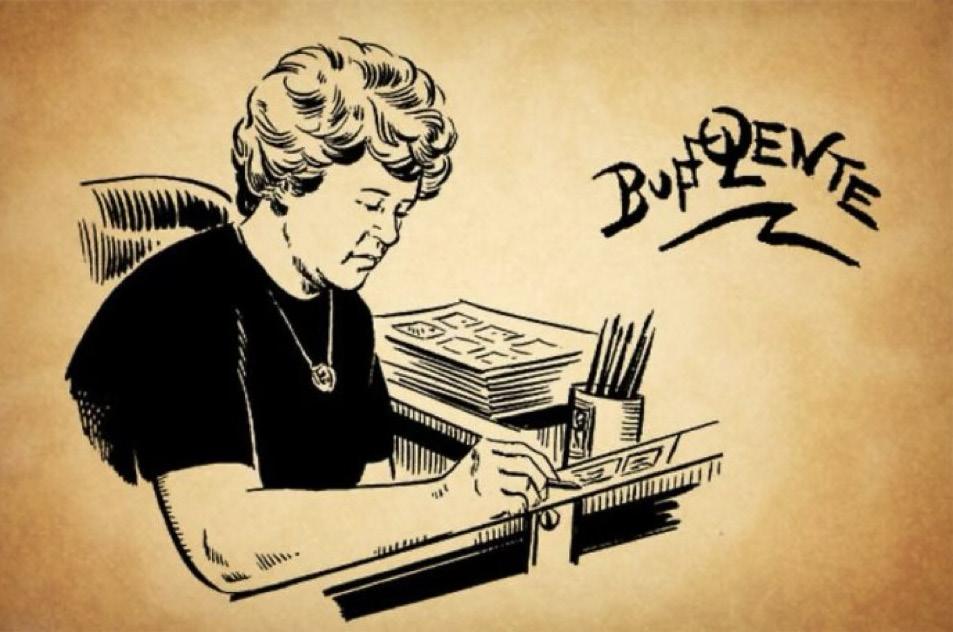
LinaBuffolente;credits:sitoSergioBonelli
di Marika Andreoli
Lina Buffolente nasce a Vicenza il 27 ottobre 1924 ed è la prima donna a occuparsi di fumetti in Italia. Per la sua lunga e prolifica carriera Lina è meglio conosciuta come “la Signora del fumetto” che ha attraversato, armata di un tratto sicuro ed espressivo e di una versatilità appassionata, tutta la storia del fumetto italiano.
La “signora del fumetto” si è infatti con-
frontata inizialmente con le rigide posizioni della cultura fascista che imponevano ad editori e autori la necessità di “sorvegliare” la produzione sia riguardo agli argomenti che alle immagini e addirittura ai tipi somatici e, nel periodo della guerra, le sue restrizioni e la crisi conseguente.
Ancora, ha vissuto il periodo di “americanizzazione” e delle censure degli anni cinquanta fino alla rivalutazione del fumetto negli anni sessanta grazie a in-
tellettuali ed avanguardie e quello degli anni settanta che vedono la consacrazione del fumetto come forma espressiva di indiscussa dignità e spessore, trend che prosegue ancor oggi con una sempre più puntuale attenzione contrappuntata da mostre, dibattiti, convegni.
La passione e il precoce talento non furono però l’unico motivo che portò ad accendere i riflettori sulla sua figura. I soggetti che disegnava “la signora dei fumetti” non erano infatti per il pub-
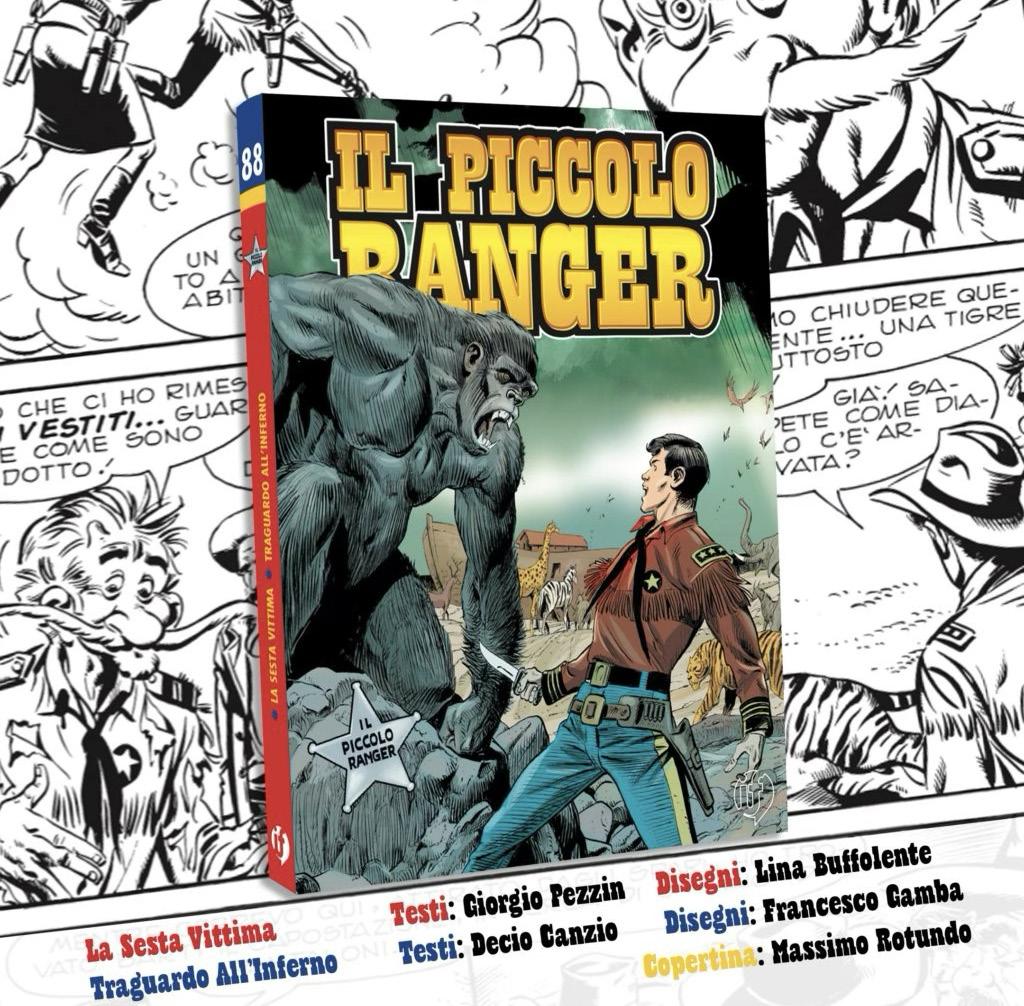
FumettiillustratidaLinaBuffolente;credits:Twitter
blico consoni alla penna di una dama: scazzottate, sparatorie, cow-boy nobili e coraggiosi.
Dopo essersi diplomata all’Accademia di Brera a Milano, Lina debutta appena diciassettenne, nel 1941, come assistente di Giuseppe Cappadonia per l’editrice Edital con storie avventurose senza personaggi fissi per la collana di Albi Mundus. Poco dopo guadagna una collaborazione avuta con Edizioni Alpe di Giuseppe Caregaro che la porta a dar vita ai suoi primi personaggi: cow-boy e avventurieri come Frisco Jim, Colorado Kid e la donna pistolero Calamity Jane. Per Edizioni Alpe realizza anche le avventure western umoristiche di Petto di pollo
Nel 1945 diventa autrice di testi e disegni per Lupo, primo fumetto italiano a tema fantascientifico; nel secondo dopoguerra inizia ad occuparsi di rivisitazioni a fumetti di grandi classici letterari (come I Miserabili e i Tre Moschettieri). Talento e fama crescenti le fanno guadagnare diverse collaborazioni con editori esteri, in particolare per il mercato tedesco e francese (per i quali pubblicherà la famosissima serie Sciuscià, ispirata a temi neorealisti). Nel 1956 Lina diventa la disegnatrice ufficiale della popolare serie a fumetti Forza John. Filo rosso della sua carriera è il tema dell’avventu-
ra e del western che la porta a essere illustratrice di serie famose come Piccolo Ranger e Il Comandante Mark per l’editore Sergio Bonelli. Nel 1992 collabora con il celebre periodico per ragazzi L’Intrepido, per La settimana enigmistica disegnandone i rebus e con Bis, trasmissione condotta da Mike Bongiorno. Di alto livello nelle illustrazioni per l’infanzia, ama tuttavia sempre il fumetto d’avventura, la forma espressiva che considera a lei più congeniale.
Nel 1984 riceve l’Ambrogino d’oro, riconoscimento della Città di Milano e nel 2001 la collana Quaderni d’Autore le dedica il primo numero, presentandolo alla fiera annuale del fumetto, Cartoomics.
La Signora del Fumetto Lina Buffolente si è spenta a Milano il 6 marzo del 2007 dopo una carriera artistica ricchissima che l’ha resa, ad oggi, la più importante fumettista italiana. Per suo desiderio, le sue ceneri riposano a Campagnola (Reggio Emilia, Italia) nella tomba di famiglia accanto al marito Fausto Fava, originario di quella località.
Nel 2017 la città di Milano ha inscritto il suo nome nel Famedio del Cimitero Monumentale

Ha fatto una primavera che pareva estate? E io ora vi propongo una ricetta di primavera che in realtà non ha stagioni. Anche voi, in vista di Pasqua e Pasquetta, avete esagerato nell’acquisto delle uova? No, non parlo di quelle di cioccolato, per le quali tra l’altro ormai tocca accendere un mutuo. Parlo delle semplici, care mai banali uova di gallina… E infatti, lo faccio presente a mio (e vostro) discapito, in quel periodo - quando è nata questa ricetta, ripetibile comunque sempre grazie agli asparagi surgelati - nel re-
parto uova dei supermercati, assieme alle solite confezioni da 2, 4, 6 o 10 ecco comparire i plateau famiglia, quelli che usano cuochi e pasticceri, per intenderci, quelli che quando ero ragazza, una volta svuotati, salvavano le stesse famiglie dalle performance di improvvisate e discutibili garage-band, andando a insonorizzare in qualche modo le pareti.
Tornando a oggi e all’acquisto compulsivo di uova in vista dei baccanali post-quaresima, ti arrovelli, ti concentri sul menu con largo anticipo, forse troppo anticipo, e le idee si accavallano, gli ospiti aumentano, senza
contare che il pranzo di domenica non esonera dal pic-nic di lunedì.
Che fare? La ricetta della nonna, quella origliata sull’autobus, quella di quel video sui social, quell’antipasto che è andato a ruba dai vicini l’anno scorso? Plagi e voli pindarici pur concessi, la tradizione va comunque rispettata. Non c’è scampo. Due tagliatelline all’uovo condite con i piselli freschi. La torta pasqualina che più siamo, più aumentano le uova intere nella sua culla di ricotta e spinaci. Le immancabili uova sode, che quelle colorate e decorate a mano sono troppo belle come centrotavola nel loro canestro (oppure servono per la caccia dei bambini in giardino) e allora tocca farne bollire altrettante per mangiarle. Per non parlare di almeno una a testa da destinare al piatto da portata con gli asparagi. E, per i più arditi, non può mancare la ciotola di cremosa maionese fatta in casa. E poi ancora la frittata di primavera, la torta al formaggio da abbinare ai salumi, la fugassa pasquale (altro che colomba comprata!) e via così. Come ti giri, ti giri, in cucina a Pasqua non fai che inciampare, ops, incappare nelle uova. Quindi, mai farsi trovare senza.
Si, ma dopo? Smaltite le abbuffate (diciamocelo: quest’anno tra Pasqua, 25 aprile e primo maggio una bella sfida!), ripristinati i livelli di colesterolo e ritrovato l’appetito, eccole lì, ancora loro: le uova che, nonostante tutto, non abbiamo utilizzato. Non scadono subito, è vero, ma in qualche modo mi chiamano. Sbircio in frigorifero in cerca di un’ispirazione fresca, colorata.
Ed eccola: rotolo di primavera. In una ciotola sbattere bene le uova intere (io ne ho usate 14, perché avevo ospiti, ma potete dimezzare la dose di tutto) con sale, pepe e una manciata di farina


bianca a pioggia. Aggiungere grana grattugiato ed erba cipollina fresca. Eliminare qualsiasi grumo e rovesciare nella placca del forno (che intanto abbiamo pre-riscaldato) ben rivestita di carta antiaderente. Infornare a 180° per una ventina di minuti. Nessun problema se la frittata si gonfierà, anche tanto. Toglierla dal forno quando è ben dorata e lasciarla raffreddare dopo aver bucato con una forchetta i rigonfiamenti d’aria. Sempre in nome del riciclo, io avevo avanzato la salsa del tonnato (voi potete frullare una scatoletta di tonno, aggiungendo eventualmente i vostri sottaceti preferiti) e l’ho allungata con abbondante robiola fresca (quella a cubetto). Nel frattempo ho cotto a vapore degli asparagi, qui verdi ma ancora meglio
Anchedell’asparagononsibutta via nulla. Niente parti filose sotto i denti e un bel bottino in freezer? Io li taglio sempre tutti della stessa lunghezza, così da utilizzare solo la parte tenera. Gliscartilisbucciosenzapietà, salvando solo il cuore dei gambi, che faccio a pezzetti, lavo, asciugoesurgeloinunascatola che mi permetta di aggiungerne ogni volta che cucino asparagi.Dopounpo’holamateria prima per sughi, zuppe, contorni misti. Lo stesso vale per la polpa delle foglie esterne dei carciofi(dalessareprima).

(sempre meglio, da vicentina) andranno quelli bianchi. In questo caso, per un tocco di colore, aggiungere alla crema dei pomodorini sminuzzati e privati del liquido. Una volta raffreddata bene la base, coprirla con la farcitura e adagiare su questa gli asparagi ben asciugati con carta casa (lasciando solo una striscia di circa due dita da un lato). Arrotolare delicatamente ma fermamente, partendo dal lato con gli asparagi e verso l’estremità lasciata libera. Usare gli sbaffi di salsa che vi avranno seguito per sigillare il tutto, quindi fare le fette dello spessore preferito. Un consiglio: se il ripieno è un po’ liquido, potete stringere il rotolo in carta forno e lasciarlo qualche ora in frigo prima di tagliarlo e servirlo.


di Michele Lucivero
Intorno al 1863 si diffuse in tutto il mondo una infestazione da fillossera, un insetto che intaccò irrimediabilmente molte viti, determinando la quasi totale scomparsa dei vitigni autoctoni. Dopo quella catastrofe, la Francia nel 1869 fu la prima a trovare una soluzione per superare l’epidemia, innestando la vite europea su quella americana, per cui furono i vitigni francesi per primi ad essere diffusi in tutta Europa e non solo. È per questo che quei vitigni oggi vengono definiti “internazionali” e consentono di ottenere, ovunque, degli ottimi vini. Tuttavia, il lavoro combinato dei viticultori e degli enologi oggigiorno è incentrato sulla valorizzazione di tanti piccoli areali destinati alla produzione di antichi vitigni autoctoni, sopravvissuti alla devastazione che quella pandemia causò ai vitigni di tutto il mondo. Nel solco di questa tradizione, che unisce alla competenza la tenacia e la ricerca della peculiarità enologica, va inserito Le Fornaci, un vino rosé veneto della cantina Tommasi, una delle più rinomate e famose case vitivinicole della Valpolicella, sicuramente nota per il suo prodotto di punta, cioè l’Amarone. Ad ogni modo, questo rosé da 12,5% vol. di grado alcolico si caratterizza per un interessante blend di uve Turbiana (90%) a bacca bianca e uve Rondinella (10%) a bacca nera, appunto due vitigni autoctoni allevati con maestria e tanta cura dalla cantina nella zona del Lago di Garda tra Sirmione e Peschiera del Garda.
Dal colore provenzale senza unghia, risulta brillante e trasparente, all’olfatto fruttato con fragolina di bosco, mora e agrumato, mentre nel floreale si avverte una nota molto leggera di lillà. Un leg-
gero vegetale di erba tagliata anticipa i sentori di timo tra le erbe aromatiche e poi nel minerale si avverte una nota leggera di gesso, per lasciare, infine, la sensazione di un vino di intensità semplice, ma di una complessità interessante. Al primo sorso lo avvertiamo secco, caldo, avvolgente nelle morbidezze, fresco, ma anche salato e con corpo esile. Le prospettive di consumo sono di un vino pronto, come molti rosé beverini del nostro nord-est.
Al contrario, invece, con Dessimis, e con la denominazione Isonzo DOC, questo prestigioso produttore friulano, Vie di Romans, ha deciso di valorizzare un nobile vitigno internazionale, cioè il Pinot grigio, dopo essersi specializzato, con lodevoli risultati, anche nella coltivazione di altri vitigni internazionali sul terreno del Friuli Venezia-Giulia. Prima di cimentarci nell’analisi gustativa, va detto che siamo al cospetto di uno dei più interessanti vitigni in circolazione, la cui produzione ci consente di apprezzare alcuni tra i vini più eleganti del mondo, e non solo in Francia! Alla vista questo vino da ben 14 % vol. di grado alcolico si presenta con una bellissima nuance ramata senza riflesso, assolutamente limpida e brillante. Appena si avvicina il bicchiere al naso, la prima sensazione è di stupore assoluto per il ricco bouquet che sprigiona: un fruttato con sensazione di ananas, pera e litchi. Nelle fragranze del floreale la prima cosa che colpisce è il sentore di rosa, per poi percepire la peonia e il profumo dell’ortensia. Si avvertono, inoltre, un tra le erbe aromatiche sentori di lemon grass, timo e zafferano, con una lieve nota di rosmarino. È straripante la mineralità di questo vino, che s’impone al naso con profumi di gesso, che diventano presto talco e cipria, così

come si percepiscono con una forte intensità le tostature di vaniglia, la cannella, la curcuma e la radice di liquirizia, note che elevano il vino ad una nobiltà e complessità unica. Infine, tra le note balsamiche si percepisce quella freschezza tipica dell’eucalipto, che lascia il posto, tra le sensazioni eteree, a note di erbe medicali. Inutile dire che si tratta di un vino meraviglioso, che raccoglie in sé un’ampiezza olfattiva e un turbinio di profumi così vasto che è difficile da trovare nei vini bianchi, al punto che addirittura la salivazione è in trepidante attesa in preparazione al sorseggio. E, in effetti, il vino non delude al gusto: secco e al tempo stesso caldo, la sua avvolgente morbidezza lo fa quasi percepire come dolce con una punta citrina, che tende a venir fuori verso la fine del sorso. Questo vino, con la sua sapidità, che aiuta il sorso, si presenta come un vino di corpo, una concezione estrema per un vino bianco, che si ritrova generalmente come accezione dei vini rossi, ma il suo equilibrio, la sua lunghezza gustativa, che resta in bocca per molto tempo dopo l’assaggio, ne fanno un prodotto di qualità definita.
Abbinamenti
Sempre per non disdegnare l’elemento territoriale nell’accostamento dei vini ai cibi, ma anche per invitare alla scoperta dei prodotti regionali italiani, al di là dei classici e scontati abbinamenti, consigliamo di degustare le Fornaci, questo rosé elegante e leggero, a prodotti sapidi veneti, ad esempio salumi, ma anche formaggi mediamente stagionati, per antipasti veloci, oppure per aperitivi rinforzati a base di prodotti panificati, ma, proprio perché crediamo sia arrivato il momento di osare, consigliamo il rosé soprattutto con la pizza, anche perché non bisogna dimenticare che nel 2024 al terzo posto tra le pizze più buone d’Italia vi è quella de I Tigli a San Bonifacio (VR). Per certi versi, invece, è molto più facile trovare un abbinamento al Pinot Grigio Dessimis, non solo perché si tratta di un vino che anche in sola degustazione regala emozioni compatibili con un prodotto da meditazione, ma soprattutto perché le sue caratteristiche trasversali ne fanno un vino che può essere abbinato quasi a tutto per gusto, ma anche per colore.


Ifratellicalò,GiuseppeeMarianna,titolaridelB.A.R.
di Marco Ferreo
A Vicenza, in contra S. Caterina, c’è un bar con i puntini. Quando Giuseppe Calò, titolare del locale insieme alla sorella Marianna si recò alla Camera di Commercio per la registrazione della nuova attività non aveva pensato ancora al nome da assegnare. Diretto com’è, Giuseppe pensò di chiamarlo semplicemente “Bar”. Si tratta tuttavia di una categoria generica e questo nome non può essere utilizzato e così, su due piedi, decise semplicemente di aggiungere i puntini tra una lettera e l’altra… E così nacque il B.A.R., aggirando in questo modo una farraginosa burocrazia. Da allora sono passati molti anni, per la precisione 18, e il locale nel frattempo ha mutato più volte pelle, sempre nel solco dell’idea originale, ovvero quella di un luogo semplice, ma all’interno del quale si sta bene, si può ridere e si può scherzare, si può bere un calice di vino, una birra, un miscelato. Dal punto
di vista commerciale la posizione è assolutamente strategica, non lontano dal tribunale, con due scuole di fronte e, da qualche anno ormai punto di riferimento anche per gli studenti dell’Università che si trova a poche centinaia di metri e che nel corso degli ultimi anni si è ingrandita, passando celermente da 1000 a oltre 5000 studenti.
Il B.A.R., tuttavia, non è soltanto un punto di riferimento per gli universitari, ma si configura come una sorta di hub verso il quale convergono tipologie di clienti tra di loro spesso assai diversi e legati in modo particolare ai diversi momenti della giornata.
Il mattino vede alternarsi studenti universitari, persone che si recano sul posto di lavoro e si fermano per una rapida colazione e, particolarmente interessante, genitori dei ragazzi che frequentano le scuole antistanti e che provvedono a ordinare il pranzo che i loro figli consumeranno all’uscita della scuola. E qui possiamo aggiungere sicuramente uno degli aspetti che contraddistinguono il B.A.R.; ponendo una grande attenzione ai più giovani, i titolari hanno un occhio di riguardo non soltanto per quanto riguarda la preparazione dei piatti o dei panini, ma anche e soprattutto alla tutela degli alunni che frequentano le scuole. Sappiamo come la sicurezza non sia un dato scontato nella quotidianità e così, qualora persone sconosciute si aggirino nei paraggi, è cura dei titolari porre loro una certa attenzione, il cui significato è ovviamente quello della tutela dei ragazzi. Il secondo momento della giornata è invece quello che vede presenti molti


appartenenti agli studi professionali dei dintorni, essendo contrà S. Caterina. Particolarmente apprezzato da avvocati, commercialisti e notai che in quella zona tranquilla, adiacente al centro storico, ma nello stesso tempo a libera circolazione, hanno i loro studi.
A partire dalla tarda mattinata iniziano le tre ore più impegnative della giornata caratterizzate appunto dalla costante presenza di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, dalla secondaria di primo grado fino all’università, mettendo a dura prova l’organizzazione logistica del locale. Si assiste progressivamente ad un cambio di utenza; si passa infatti al passaggio di quanti, avvicinandosi la fine della giornata lavorativa, si concedono un attimo di pausa per uno spritz o per una birra; il momento raggiunge sostanzialmente il clou a partire dalle 18, ora che tradizionalmente e per consuetudine è dedicato all’aperitivo serale che chiude la giornata. Anche in questo caso è tuttavia possibile fermarsi per mangiare una bruschetta o una piadina nello spazio esterno che, durante i periodi più caldi dell’anno, diventa un vero e proprio centro di aggregazione e di ritrovo tanto che chi desidera fare quattro chiacchere dopo una giornata lavorativa può facilmente trovare qualcuno con cui scambiarle al di là della reciproca conoscenza o di una eventuale amicizia.
Da qualche anno inoltre il B.A.R.
si è arricchito di un ulteriore momento di relax settimanale; una volta alla settimana, inizialmente di mercoledì, ma ormai stabilmente di venerdì, sia durante il periodo estivo e dunque all’esterno sia durante quello invernale, e dunque all’interno, il locale offre a gruppi di musicisti di ogni età di suonare e di trovare l’occasione per farsi conoscere. Ci sono gruppi che, in maniera quasi professionistica si dedicano alla musica da anni, altri che invece la praticano semplicemente come un’arte da accompagnare allo svolgimento dei lavori quotidiani e nel tempo la qualità di questi gruppi sicuramente è cresciuta.
Non resta dunque che provare a fermarsi una sera e anche se non conoscete nessuno non ci vorrà molto perché le chiacchere in compagnia fluiscono rapidamente e rapidamente facciano sparire le fatiche della giornata.

Il secondo libro di Parolin è un viaggio nel mistero, tra Vicenza, Praga e i salti nel tempo

PonteCarloaPraga
di Giulia Matteazzi
L’autore Massimo Parolin lo aveva anticipato in sede di presentazione: il libro “Quella strada per il lago 1980-2023” avrebbe avuto un seguito. Ha mantenuto la promessa con questo “Demoni a Vicenza – Amicizia oltre il tempo”. Il libro comincia dove si era concluso il precedente, con un gruppo di amici che è riuscito a fare chiarezza sulla misteriosa scomparsa di Damiana, la ragazza di cui l’io narrante, Massimo, era innamorato. Damiana era stata uccisa per mano umana aizzata da un demone, ed è contro il demone che Massimo e i suoi amici hanno lottato, riuscendo a vincere. Una vittoria amara, perché la fanciulla non è tornata tra i vivi, ma che ha finalmente messo l’animo in pace al protagonista, il quale ha potuto così andare avanti con la sua vita.
La narrazione riparte da qui. Dalla vita
che continua tra impegni quotidiani, ricordi, pensieri e serate tra amici, con la cornice di una Vicenza che cambia nel tempo, ma in fondo rimane uguale a sé stessa. I primi capitoli sono fatti di descrizioni accurate, dialoghi vivaci, battute in dialetto veneto, scorci della città che prendono vita e soprattutto un’appassionata disquisizione sull’amicizia, tema centrale di questo libro quanto l’amore lo era del precedente. Sarà la sparizione di uno degli amici, Fabrizio, appassionato di fantascienza e di viaggi nel tempo, a dare il là alla seconda avventura.
Il tono della narrazione cambia completamente. Se nei capitoli iniziali lo stile era leggero, a volte persino comico, coinvolgente ma anche rilassante, ora la scrittura diventa incalzante, frenetica, cupa. Nel giro di poche righe si passa dall’atmosfera goliardica di una cena estiva a quella tetra di una casa vuota
con segni inquietanti che non fanno presagire nulla di buono riguardo la sorte di chi ci viveva. Come i moschettieri di Dumas, Massimo e i suoi amici sono tutti per uno, e decidono di unire le forze per riuscire a ritrovare e a salvare Fabrizio.
La missione di salvataggio si rivelerà assai complessa: un viaggio a Praga, un esperimento scientifico, addirittura un salto nel tempo e uno strano processo per tradimento in cui i “nostri” si troveranno coinvolti, lottando invano contro un’amministrazione della giustizia decisamente poco equa. E poi di nuovo il demone, che si ripresenta a Massimo prendendosi gioco dei suoi ricordi e dei suoi sentimenti. Insomma, un’avventura che metterà alla prova coraggio e lealtà, e che confermerà una volta di più che contro il male l’arma più potente sono i sentimenti positivi.
Oltre ad apprezzare lo stile sempre gradevole della scrittura di Parolin, quello che colpisce in “Demoni a Vicenza”, e che lo differenzia dal libro precedente, è il fatto che qui il soprannaturale non è suggerito, ipotizzato e immaginato per buona parte del racconto, per diventare concreto solo nei capitoli finali. Qui i protagonisti si immergono totalmente nel mistero, affrontando situazioni non solo pericolose ma anche contrarie ad ogni logica. Una scelta coraggiosa sia per lealtà verso l’amico scomparso sia perché, una volta accettato che nel mondo c’è spazio anche per il “non spiegato”, la curiosità diventa più forte della paura. Non stiamo a dire come si conclude il libro, se non per anticipare che “Demoni a Vicenza” è il secondo di una trilogia e che siamo curiosi di scoprire come il terzo volume chiuderà il cerchio di un’avventura intrigante.
144 pagine | € 12,00 Acquistabile da aprile in libreria, nelle edicole e on line su Amazon e sullo shop di Vipiu.it





