TRIMESTRALE DI UNIONE ENERGIE PER LA MOBILITÀ - ANNO 2023 N.2 - WWW.UNEM.IT


ENERGIE E TECNOLOGIE PER IL FUTURO
UN APPROCCIO DINAMICO AL TRILEMMA ENERGIA di Guido Bortoni





UN APPROCCIO DINAMICO AL TRILEMMA ENERGIA di Guido Bortoni



Le nuove strategie globali riusciranno a governare la complessità della transizione?

QUALCHE IDEA PER LA RETE CARBURANTI CHE VERRÀ di Claudio Spinaci
I dati dicono che la nostra rete è ridondante e frammentata. La speranza è che il tavolo aperto dal Governo consenta di affrontare questo scenario in modo sistematico e pragmatico e di superare questa situazione di inefficienza che caratterizza la nostra rete distribuzione carburanti ormai da decenni e che impedisce una sua evoluzione, ormai improcrastinabile
LA VARIABILE DEMOGRAFICA DIMENTICATA
DALLA POLITICA INTERNAZIONALE intervista a Massimo Livi Bacci
La geodemografia del Mondo sta vivendo un cambiamento strabiliante. La popolazione del pianeta potrebbe stabilizzarsi in mezzo secolo sfiorando i dieci miliardi e mezzo. Due miliardi e mezzo in più di persone che dovranno nutrirsi, vestirsi, trovare alloggio, consumare energia per riscaldarsi, cucinare, lavorare e produrre, senza cadere in povertà
I NUOVI PARADIGMI DELLA “ECONOMIA DELLA FIDUCIA” di Rosario Cerra e Francesco Crespi
SUPPORTARE LA CRESCITA E PROTEGGERE DAI RISCHI DEI MERCATI ENERGETICI intervista a Paolo Arrigoni

SULLE QUESTIONI STRATEGICHE NON PUÒ DECIDERE SOLO IL MERCATO intervista a Nicola Procaccini

LE DINAMICHE DEI PREZZI DEL PETROLIO: ORIGINI ED EVOLUZONI di Salvatore Carollo


ANNO
MUOVERSI
Nel suo rapporto di aprile il Fondo monetario internazionale sottolinea che si sta entrando in “una fase pericolosa” in cui i “rischi finanziari sono aumentati” a fronte di una crescita economica che “rimane bassa rispetto agli standard storici”. L’iniziale ottimismo ha lasciato spazio ad una diffusa preoccupazione per gli effetti delle politiche monetarie restrittive adottate dalle Banche centrali per raffreddare l’economia e frenare dunque la corsa dell’inflazione che, sempre a detta del Fondo, non avrebbe ancora raggiunto il suo picco. Un’inflazione che si è rivelata molto più “vischiosa” del previsto, con impatti sui redditi reali e sul sistema finanziario che ha mostrato alcune crepe. Le cause, secondo il Fondo, sono molteplici e su tutte la maggiore frammentazione geoeconomica che porta a crescenti tensioni commerciali, minori investimenti diretti e ritmi di innovazione più lenti, anch’essi frammentati in “blocchi”. È difficile che un mondo frammentato porti a progressi per tutti o ci consenta di affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte, come il cambiamento climatico o la gestione dei numerosi conflitti in corso in aree strategiche per gli equilibri mondiali. Ma quali sono le strategie di politica economica, energetica e industriale adottate nei diversi contesti globali? Ma soprattutto, riusciranno a governare la complessità della transizione?
Il processo di globalizzazione avvenuto negli ultimi decenni ha accresciuto enormemente il grado di interdipendenza sistemica dei vari paesi, facendo emergere squilibri economici, finanziari, sociali, ambientali e geopolitici di vasta portata. Dall’altro lato, ha fatto però emergere forti dipendenze strutturali soprattutto in ambito energetico. In tutto il mondo sono andati in crisi quei percorsi di sviluppo, crescita e progresso basati sul concetto di mercato che tanto a lungo sono stati motori di dinamismo economico e sociale, che tutti riconoscevano come ciò che permetteva di muoversi in avanti. Oggi stiamo assistendo ad un cambio di paradigma che vede nell’intervento statale la risposta alle crisi di diversa natura emerse in questi ultimi anni. In questa direzione va l’Inflation Reduction Act, ma anche il Green Deal Industrial Plan europeo o la National Security Strategy del Giappone. Insomma, che si tratti di ambiente o di benessere, di industria o di sostenibilità, di mobilità o crescita, l’intervento pubblico è ormai visto come elemento imprescindibile e risolutivo. Per questo abbiamo deciso di dedicare questo numero all’approfondimento delle prospettive di crescita e di cambiamento positivo, e come queste possono determinare un nuovo per quanto difficile equilibrio che risponda in modo efficace alla crescente domanda di energia e benessere. In questo tentativo ci hanno aiutato autorevoli accademici e studiosi, a partire da Massimo Livi Bacci, tra i massimi demografi italiani, che nell’intervista di apertura della cover story si mostra pessimista sulla possibilità di governare fenomeni come le migrazioni di massa indotte dai cambiamenti in atto, “un mare in tempesta per i contrasti di interessi tra Paesi la debolezza delle Istituzioni internazionali”. Parliamo poi di scenari macroeconomici e questioni energetiche con Carlo Andrea Bollino dell’Università di Perugia, di “economia della fiducia” con Rosario Cerra e Francesco Crespi del CED, di Stato e mercato con David Chiaroni del Politecnico di Milano, di IRA con Stillwater Associates, di Green Deal Industrial Plan con Alessandro Lanza della Luiss. Ma anche di piani di adattamento e mitigazione con Filomena Pietropertosa e Monica Salvia, due ricercatrici del CNR che ci illustrano un nuovo metodo di valutazione, nonché dei fattori ESG con Monica Billio dell’Università Ca’ Foscari, che ci spiega come non possono diventare strumenti guidati dal dogmatismo.


In questi ultimi mesi si è parlato molto di rete carburanti e di cosa servirebbe per renderla più efficiente e in linea con gli standard europei da cui siamo molto lontani.
L’innesco lo ha dato il cosiddetto “DL trasparenza prezzi” emanato a metà gennaio dal Governo per cercare di tamponare le polemiche seguite al ritorno all’accisa piena sui carburanti dal 1° gennaio. Un provvedimento che ha spinto le Organizzazioni dei gestori a proclamare uno sciopero a cui il Governo ha risposto, sperando di poterlo evitare, offrendo l’apertura di un tavolo di confronto, presieduto dal Ministro Urso, per discutere sulle criticità del settore.
Lo sciopero c’è comunque stato, anche se limitato ad un solo giorno rispetto ai due annunciati, ma i contenuti del decreto-legge, convertito in legge a metà marzo, non sono stati sostanzialmente cambiati nonostante le ripetute sollecitazioni arrivate praticamente da tutti gli attori della filiera – e anche dall’Antitrust – sulle molte criticità di un provvedimento che nulla aggiunge in materia di trasparenza dei prezzi, se non nuovi adempimenti e costi per i titolari e i gestori degli impianti.
Il tavolo, che dovrebbe dare risposta alle preoccupazioni del comparto, è stato avviato a febbraio individuando i temi da affrontare che si possono riassumere in quattro macroaree: razionalizzazione della rete ordinaria; razionalizzazione della rete autostradale; contrattualistica tra titolari e gestori degli impianti di carburanti;
utilizzo degli strumenti di pagamento. Temi oggetto anche delle due distinte risoluzioni presentate recentemente alla Camera su cui i proponenti, del PD e del M5S, chiedono un impegno al Governo e su cui è in corso un ciclo di audizioni, a cui abbiamo partecipato. E proprio da qui vorrei partire per lanciare qualche idea per la rete che verrà.
Come ho avuto modo di dire durante l’audizione, per capire come e dove intervenire bisogna anzitutto partire dai dati. E questi ci dicono che la nostra rete di distribuzione è oggettivamente ridondante visto che a parità di litri distribuiti abbiamo circa il doppio degli impianti della Spagna, nonché
della Francia e del Regno Unito (in questo caso sono ben più del doppio) che però hanno volumi complessivi di vendita di molto superiori (tra il 40 e il 50%). Per non parlare della Germania che ha volumi quasi doppi dei nostri ma con due terzi degli impianti.
Va poi tenuta in debito conto l’estrema polverizzazione degli operatori che non c’è negli altri Paesi europei, in particolare in Francia, Germania e Regno Unito dove i titolari di meno di 30 punti vendita sono tra i 350 e i 600 rispetto agli oltre 5.000 presenti in Italia. Una polverizzazione che ha generato una inefficienza complessiva del sistema e messo sotto pressione, nel decennio scorso, i tradizionali sistemi di controllo basati sui documenti cartacei, lasciando spazio ad una diffusa illegalità: se prima gli obblighi in termini di Iva e accise gravavano su pochi soggetti di grandi dimensioni, relativamente facili da controllare, oggi tali soggetti sono talmente tanti, spesso di piccolissime dimensioni, che i con-
Si sta parlando molto di rete carburanti e di cosa servirebbe per renderla più efficiente e in linea con gli standard europei: per capire come e dove intervenire bisogna partire dai dati, che ci dicono che la nostra rete è oggettivamente ridondante e frammentata


Confido che il tavolo aperto dal Governo consenta di affrontarli i vari e complessi temi in modo sistematico e pragmatico e di superare questa situazione di inefficienza che caratterizza la nostra rete distribuzione carburanti ormai da decenni e che impedisce una sua evoluzione, ormai improcrastinabile

trolli tradizionali non bastano più. Da questo punto di vista va però detto che molto è stato fatto a partire dal 2016, con una serie di misure che hanno spinto sulla progressiva e completa digitalizzazione della filiera, utile a consentire una tracciatura completa di tutte le transazioni, sia fisiche che finanziarie, a monte e a valle. In questa direzione vanno interventi come la revisione della disciplina dei destinatari registrati, nuovi criteri per autorizzare i depositi fiscali, la trasmissione telematica dei corrispettivi, la fatturazione elettronica – che abbiamo anticipato nella sua adozione sin dal 2018 – l’eliminazione della lettera d’intenti, l’e-das, l’Infoil per i depositi - che però andrebbe esteso anche a quelli inferiori ai 3.000 mc. Interventi che in qualche modo hanno permesso di limitare il fenomeno delle frodi che stimiamo intorno al 5-10% dei volumi, pari a 2-4 miliardi di euro. Siamo in una fase di miglioramento ma non bisogna arretrare: l’automazione dei controlli va completata rapidamente, va favorita la interoperabilità tra le diverse banche dati per intervenire sulle fattispecie di frodi emergenti (ad esempio, sul rispetto degli obblighi sui biocarburanti sempre più significativi). Un discorso a parte lo merita la rete autostradale, dove la situazione è molto compromessa ed ha ormai assunto caratteristiche strutturali. Le cause sono note e sono legate al progressivo e costante calo dei consumi data la crescente autonomia degli autoveicoli che hanno sempre meno bisogno di una sosta per il rifornimento (in autostrada in media c’è un’area di servizio ogni 30 km), ma anche agli alti costi di gestione dovuti alla necessità di assicurare rigide condizioni operative che comportano maggiori oneri rispetto alla rete ordinaria (apertura 24 su 24 ore, 7 giorni su 7, presenza servito, royalties da corrispondere al concessionario). È evidente che andrebbero chiusi il 20-30% dei punti vendita se vogliamo dare una prospettiva di sostenibilità alla distribuzione autostradale garantendo comunque un servizio capillare e qualificato. A tal
fine servirebbe aggiornare il Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015 che invece prevedeva la chiusura di pochi impianti a cui andrebbe poi dato seguito con un efficace piano ad hoc ben più profondo di razionalizzazione e riconversione
Una significativa modernizzazione e razionalizzazione anche della rete ordinaria è ineludibile, soprattutto nella prospettiva dello sviluppo di carburanti alternativi, che non sono solo ricariche elettriche ma anche tutta quella gamma di prodotti (carburanti low carbon liquidi e gassosi: e-fuels, biocarburanti, recycled carbon fuels, idrogeno, biogas naturale) di cui avremo bisogno per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione.
Dal mio punto di vista, sarebbe opportuno partire da quello che già c’è. Anzitutto dalle incompatibilità, assicurando l’applicazione di norme che ci sono dal 2017, scarsamente rispettate e su cui molti Comuni sono in ritardo. Inoltre, si dovrebbe, anche in questo caso, spingere con l’interoperabilità delle banche dati (Osservaprezzi, Anagrafe Carburanti, Agenzia delle Dogane) per un’efficace attività di monitoraggio e controllo utile ad elaborare una programmazione per bacini. Pensare poi a misure di incentivazione per aggregazioni tra operatori, a un Fondo pubblico per la chiusura e smantellamento degli impianti non idonei alla modernizzazione, nonché a procedure di smantellamento e bonifica degli impianti chiare e certe nei tempi. Un’ultima riflessione riguarda il tema della contrattualistica che ricorre spesso nel dibattito pubblico. Un argomento su cui va fatta chiarezza. Oggi, in base alle norme vigenti, l’impianto può essere gestito in forma “diretta”, ossia dal titolare dell’impianto oppure affidato ad un “terzo” a cui il titolare dell’impianto dà in uso gratuito tutte le attrezzature (c.d. “comodato d’uso petrolifero”), assicurando l’approvvigionamento dei prodotti con un contratto di fornitura in esclusiva. Nel primo caso, il titolare dell’autorizzazione dell’impianto, nonché titolare della licenza fiscale d’esercizio, opera con l’ausilio di proprio personale e non ha altri vincoli se non quelli previsti dalle attuali norme civilistiche anche in termini di trattamento economico. Nel secondo caso, i rapporti economici sono invece regolati secondo modalità e termini definiti dalla disciplina di settore con accordi aziendali, cioè tra singola azienda titolare e Associazioni rappresentative dei gestori, nel rispetto degli indirizzi comunitari. Oltre al “comodato e fornitura”, previsto dalla legge, sono altresì consentite altre tipologie contrattuali purché “tipizzate”.
Un esempio in tal senso è il “contratto di commissione” sottoscritto nel 2018 da unem (allora Unione Petrolifera) e le Associazioni dei gestori. Uno step ulteriore potrebbe la “tipizzazione” anche del contratto base di comodato con fornitura in esclusiva per adattarlo alle nuove esigenze operative. In questo contesto, nel caso di affidamento a “terzi” è necessario, per evitare dannosi e iniqui fenomeni di dumping contrattuale, che l’applicazione dei contratti “tipizzati” e la contrattazione collettiva venga rispettata da tutti gli operatori a prescindere dalla loro dimensione, in quanto la dimensione ridotta di alcune aziende titolari di impianti non può rappresentare un ostacolo al rispetto della disciplina di settore. Una soluzione potrebbe essere quella di arrivare ad accordi collettivi su base regionale per operatori con un numero limitato di impianti.
Ciò che non è assolutamente condivisibile, è l’introduzione per legge di trattamenti minimi delle gestioni che negherebbe il principio della negoziazione tra le parti, trattandosi di un rapporto commerciale e non di lavoro subordinato. Introduzione, peraltro, di difficile applicazione vista la pluralità di fattori che dovrebbero incidere sulla definizione di tali minimi.
I temi sono tanti e complessi. Confido che il tavolo aperto dal Ministro Urso e coordinato dal Sottosegretario Bitonci consenta, con il supporto di tutti gli altri Ministeri coinvolti e del Parlamento, di affrontarli in modo sistematico e pragmatico e di superare questa situazione di inefficienza che caratterizza la nostra rete distribuzione carburanti ormai da decenni e che impedisce una sua evoluzione, ormai improcrastinabile.

Si sono generati “strappi” ovunque al tessuto economico-sociale europeo sia sul fronte della decarbonizzazione (es. ritorno della produzione elettrica a carbone), sia su quello della sicurezza la cui tenuta è stata più volte messa in discussione
Nessuno ha previsto né poteva prevedere lo scatenarsi e gli effetti delle tre crisi che hanno inciso sul sistema europeo dal 2020 ad oggi. Ricordiamo in breve ciò che è avvenuto nell’energia:

a) la profonda depressione della domanda causata dai lock-down asincroni ‘20-‘21 in diverse parti del mondo,
b) la ripartenza (invece) sincronizzata della domanda post-Covid nell’ultima parte del ‘21 con rialzo spaventoso dei prezzi gas-elettricità e c) le tensioni geopolitiche introdotte dall’invasione russa in Ucraina che hanno prodotto
decarbonizzazione
la cosiddetta weaponization dell’energia contro l’Europa. Crisi energetiche inèdite che ci hanno colto impotenti o, quanto meno, con poche ricette in mano per una loro soluzione efficace. Il trilemma europeo della sostenibilità ambientale-economica-sociale dell’energia, vale a dire decarbonizzazione accelerata, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività (o affordability) dei prezzi, è stato scosso alle fondamenta e, con esso, la prima vittima illustre è stata proprio la credibilità della pianificazione o programmazione pubblica dell’energia-clima in Europa. Si sono generati “strappi” ovunque al tessuto economico-sociale europeo sia sul fronte della decarbonizzazione (es. ritorno della produzione elettrica a carbone), sia su quello della sicurezza la cui tenuta è stata più volte messa in discussione, per non far menzione dei poderosi multipli ai profili dei prezzi rispetto alla normalità 2019. Non si contano le vistose deviazioni rispetto alle traiettorie previste nei Piani Nazionali Integrati Energia Clima (Pniec) approvati nel 2020 dai vari Stati Membri, le quali ne squalificano – come detto – la credibilità e l’utilità complessiva.
competitività dei prezzi
sicurezza energetica
Come dunque programmare il futuro del sistema energia in una maniera adeguata al nuovo contesto? Non possiamo di certo immaginare di attrezzarci oggi per prevedere la natura e l’intensità delle perturbazioni (se non proprio crisi) a venire, visto che possono essere unprecedented, né possiamo fare ipotesi apodittiche (ed altrettanto ingenue) che la realtà futu-
ra segua pedissequamente ciò che noi vogliamo che sia o che non sia. Non ci resta altro che far sì che il sistema energia sia in grado di “ri-salire” (ovvero rialzarsi, il vero significato di re-salio da cui resilienza) dagli stati problematici o semplicemente imprevisti in cui si andrà a trovare. E così la sua pianificazione.
Non potendo prevedere con precisione cosa servirà per far fronte alle deviazioni da un’unica traiettoria primaria o first-best auspicata per la soluzione del nostro trilemma energia, occorre predisporre un numero adeguato di risorse “alternative” e gestirle in maniera dinamica in ragione delle evenienze (opportunità/ostacoli) che occorreranno negli anni futuri. In altri termini, andranno previste delle traiettorie second-best, third-best, etc. con attivazione delle risorse alternative in modo che ci sia sempre almeno un percorso che ci faccia raggiungere gli obiettivi (es. quelli della tappa intermedia al 2030) e sia compatibile con gli svariati e numerosi vincoli posti dal contesto.
Una pianificazione siffatta, con tante chances alternative al percorso primario, condurrà ad avere una transizione energetica più costosa rispetto alla pianificazione semplice mono-traiettoria? È quasi certo che lo sia, beninteso. Infatti, con quest’approccio, non stiamo facendo altro che stipulare una serie di polizze assicurative con garanzie reali (investendo in risorse alternative) per la transizione del nostro sistema energia che normalmente hanno un onere aggiuntivo da sopportare. Ma sono altresì convinto che questa pianificazione possa costare assai meno per la collettività rispetto al caso in cui il trilemma non venga conseguito in termini di risultati-obiettivo. Si pensi solo al caso della sicurezza di approvvigionamento ed agli sforzi cui siamo ora sottoposti per garantirla in termini di dispiegamento di nuove infrastrutture in emergenza
Per far fronte alle deviazioni da un’unica traiettoria primaria o first-best auspicata per la soluzione del nostro trilemma energia, occorre predisporre un numero adeguato di risorse
“alternative” e gestirle in maniera dinamica in ragione delle evenienze (opportunità/ ostacoli) che occorreranno negli anni futuri
ossia in maniera poco programmata. Ma vi è di più nella mia proposta di nuova pianificazione: dobbiamo essere in grado di dispiegare un approccio dinamico nella scelta della traiettoria alternativa necessitata nell’arco di piano. Mi aiuta in questo senso il ricorso ad una metafora ben conosciuta da tutti: i navigatori di ultima generazione che pianificano i percorsi nei moderni sistemi di trasporto. Data la località di partenza ed il punto di arrivo, i navigatori moderni sono in grado di suggerire il percorso primario sulla base di criteri e vincoli definiti a priori (lunghezza del percorso, onerosità del medesimo, tempo di percorrenza, etc.) ma, al contempo, anche un “albero” di traiettorie alternative e disponibili che si aggiorna dinamicamente ed in tempo quasi reale in funzione di evenienze di ogni sorta durante il percorso (es. situazione traffico, ostacoli, soluzione di congestioni, etc.).
Così potrebbe funzionare la pianificazione avanzata nell’energia. L’attivazione dinamica delle traiettorie alternative consentirebbe in ogni momento del percorso di scegliere da un albero aggiornato delle possibilità un percorso già programmato di attivazioni di risorse che ci consenta, ceteris paribus, di raggiungere gli obiettivi senza derogare ai vincoli. E di ripetere questo esercizio in maniera ricorrente
sino all’anno orizzonte.
Un esempio è a questo punto d’obbligo, per recare di rendere la pragmaticità dell’approccio proposto. È noto come vi siano dei mezzi nella transizione assai preziosi per l’avvicinamento agli obiettivi di decarbonizzazione: le fonti rinnovabili elettriche, cioè quelle che hanno a priori il minimo impatto sulle nuove emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Tuttavia, confidare in maniera esclusiva e totalizzante in tale mezzo espone l’intera transizione energetica a rischio di insuccesso qualora eventuali nodi nella disponibilità di risorse dovessero inceppare il percorso primario o anche solo produrre stop&go nelle catene del valore. Ciò si applica all’elettrificazione spinta dei consumi abbinata ad un ampio deployment delle fonti rinnovabili elettriche senza prevedere alternative basate su vettori molecolari in via di decarbonizzazione anche attraverso la cattura delle emissioni di CO2 così come alla mobilità leggera completamente BEV (Battery-based Electric Vehicle) senza ricorrere ad alimentazioni alternative e decarbonizzate quali HVO o celle combustibili ad idrogeno.
Difficile applicare il nuovo tipo di pianificazione? Certo, ma anche utile se non addirittura necessario nel contesto attuale di elevata complessità ed imprevedibilità nei sistemi energia.

L’eventualità che i biocarburanti possano essere equiparati agli e-fuels per alimentare le auto e i furgoni nuovi a motore endotermico oltre il 2035 è per ora esclusa dalla Commissione europea. Dopo l’accordo raggiunto dal Consiglio Energia a fine marzo, faticosamente raggiunto dopo settimane di negoziato diretto fra Bruxelles e Berlino per evitare il blocco del regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 100%, un’intervista della Commissaria Kadri Simson a RaiNews24 aveva fatto sperare al Governo e ai produttori italiani di biocarburanti che la partita non fosse chiusa. La Commissaria estone aveva infatti detto che “i biocarburanti sono un argomento che verrà trattato: noi sosteniamo le iniziative al riguardo, è mia responsabilità sostenere i produttori, il sostegno (della Commissione) c’è ed è forte”. Parole chiare, tuttavia non riferite specificatamente al regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni. Che si sia trattato di un equivoco è evidente, indotto dall’esigenza italiana di gestire una sconfitta negoziale a Bruxelles, non poi controverso. Sta di fatto che Bruxelles ha successivamente e pubblicamente chiarito che la Commissaria Simson nell’intervista televisiva “si riferiva alla più ampia questione del mix energetico e non al settore dei trasporti, non avendo mai affermato che i biocarburanti avranno un ruolo nella futura attuazione di quelle norme, ma solo che saranno una parte importante di vari dossier legislativi UE”. dal canto suo, il portavoce comunitario Tim McPhie aveva rafforzato questa posizione affermando che “il tema dei bio-

carburanti è delicato in termini di sostenibilità ed emissioni zero di gas a effetto serra perché c’è un impatto sull’uso dei terreni”. In ogni caso attualmente la Commissione “non è in grado di dire quali potranno essere le alternative per il post 2035, molto dipenderà dalle tecnologie disponibili in quel momento”. Abbiamo detto: per ora e attualmente. In sostanza, lo spazio per continuare a investire sui biocarburanti nella UE ci sarà (basti pensare al trasporto aereo e marittimo), ma per ora non si prevede di equipararli agli e-fuels per alimentare auto e furgoni nuovi dal 2035. D’altra parte, questo quadro era già chiaro dall’inizio dell’ultimo negoziato condotto dalla Commissione europea per superare l’opposizione di Italia, Polonia e Bulgaria (la quale in realtà aveva dichiarato l’astensione), abilmente sfruttata dalla Germania con il solo obiettivo di assicurarsi la deroga per gli e-fuels: nelle discussioni Bruxelles-Berlino il tema dei biocarburanti non è mai entrato. E chiaro è il risultato della trattativa condensato nella dichiarazione con la quale la Commissione europea ha definito il modo in cui procederà nei prossimi mesi. Tutto si gioca sul “Considerando 11” del regolamento che costituisce il punto di partenza delle iniziative legislative future (il “Considerando” è una integrazione del testo di legge per spiegare le ragioni di una disposizione e non contiene enunciati di carattere normativo). Intanto Bruxelles presenterà un regolamento di esecuzione per l’omologazione dei veicoli con una procedura “a prova di evasione per i veicoli alimentati esclusivamente, e in modo perma-

nente, con carburanti rinnovabili di origine non biologica”. Poi, dopo la consultazione dei portatori di interessi (innanzitutto i settori produttivi, ma non solo), la Commissione proporra un atto delegato per specificare in che modo “i veicoli che utilizzano esclusivamente elettrocarburanti potrebbero contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2”. L’esclusione dei biocarburanti non avrebbe potuto essere più netta. Non si può non notare come la dichiarazione interpretativa comunitaria, che ha permesso l’adozione definitiva del regolamento, abbia una intensità prescrittiva superiore al “Considerando 11”. Quest’ultimo, infatti, si limita a indicare che la Commissione “presentera una proposta relativa all›immatricolazione posteriore al 2035 di veicoli che funzionano esclusivamente con combustibili neutri in termini di emissioni di CO2 in conformita al diritto dell’Unione, al di fuori dei livelli di prestazione in materia di emissione del parco veicoli, e conformemente all’obiettivo della neutralita climatica dell'Unione”. In sostanza, attualmente i biocarburanti non vengono considerati dalla UE “neutri” dal punto di vista dell’impatto ambientale,
Attualmente lo spazio per continuare a investire sui biocarburanti nella UE ci sarà (basti pensare al trasporto aereo e marittimo), ma per ora non si prevede di equipararli agli e-fuels per alimentare auto e furgoni nuovi dal 2035
ma la partita per dimostrarlo in futuro, sulla base del “Considerando” resta aperta. La dichiarazione aggiuntiva della Commissione, limitando l’interpretazione ai soli e-fuels, segnala che tale spazio sarebbe ora ristretto, almeno sulla carta. Segnale importante, dal momento che proprio sul principio della neutralità tecnologica aveva fatto leva il tentativo italiano di difendere il più possibile la filiera della produzione auto a motore endotermico. In ogni caso si può dire che la partita non è chiusa. Tuttavia, è un fatto che l’industria automobilistica europea, comprese quelle case tedesche che hanno puntato i piedi in difesa degli e-fuels, ha confermato finora la scelta strategica dell’elettrico nonostante l’accumularsi di incertezze e difficoltà, che vanno dalla disponibilità delle materie prime e per produrre batterie, al dispiegamento delle infrastrutture on the road per la ricarica al costo per i consumatori. Volkswagen, Stellantis e Renault, per esempio, si sono impegnate a passare all’80% o anche al 100% alla produzione di veicoli elettrici entro il 2030, ben cinque anni prima dello stop UE (con deroga per gli e-fuels). Il regolamento UE contiene una clausola di revisione: nel 2026 (quando ci sarà già un nuovo Parlamento europeo e quindi una nuova Commissione che potrebbe rovesciare le carte in tavola visto che le elezioni si terranno nella primavera del 2024) la Commissione dovrà valutare “in modo approfondito i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del 100% all’orizzonte 2035 e l’eventuale necessità di rivederli” tenendo conto “degli sviluppi tecnologici — anche per
quanto riguarda le tecnologie ibride plug-in — e dell’importanza di una transizione sostenibile e socialmente equa verso l’azzeramento delle emissioni”. Di conseguenza, dovrà essere valutata “la necessità di rivedere gli obiettivi”. Per il Governo italiano, che alla fine si è astenuto nella votazione in Consiglio dopo aver originariamente dichiarato il voto contrario, ci sarebbe lo spazio per anticipare un confronto sul merito dell’impatto pro-clima dei biocarburanti in relazione al loro utilizzo per auto e furgoni nuovi dal 2035. Spazio che però a Bruxelles, attualmente, non viene riconosciuto. Tanto è vero che dopo l’accordo di fine marzo e l’intervista della commissaria Simson, male interpretata in Italia, la Commissione ha spiegato che rispetto agli e-fuels “i biocarburanti presentano maggiori sfide dal punto di vista della neutralità climatica avendo una maggiore impronta da uso del suolo con un impatto indiretto anche sull’agricoltura”. In teoria, poi, c’è l’esportazione extra-UE: il regolamento europeo, infatti, riguarda l’immissione sul mercato dell’Unione delle auto e dei furgoni “puliti”; tuttavia, non è su questo che puntano i produttori auto in assenza di novità tecnologiche sul fronte dei carburanti “puliti”, come ha recentemente sintetizzato Carlo Tavares, AD di Stellantis: “la traiettoria del settore non cambierà significativamente, siamo sulla buona strada per fornire l’elettrificazione attesa dall’Unione europea”. Da notare che Tavares già diversi anni fa aveva accusato la UE di mancanza di realismo nella transizione forzata e accelerata all’elettrico, ma adesso prevale la difesa degli investimenti strategici già avviati dalla metà dello
Segnale importante, dal momento che proprio sul principio della neutralità tecnologica aveva fatto leva il tentativo italiano di difendere il più possibile la filiera della produzione auto a motore endotermico
scorso decennio. Tutto lo sforzo, questo il messaggio dell’industria automobilistica europea, è volto a ottenere la realizzazione degli obiettivi stabiliti senza ulteriori aggravi per i produttori (le norme Euro 7). Questa la valutazione dell’AD Acea, Sigrid de Vries (l’Acea rappresenta i produttori auto europei): “la rotta è ora ufficialmente impostata per eliminare gradualmente la vendita di automobili con motori a combustione interna tradizionali. Il nostro settore accoglie con favore la certezza della pianificazione, crediamo fermamente che un approccio tecnologicamente neutrale, con al centro un’elettrificazione diffusa, sia il modo migliore per raggiungere gli obiettivi climatici”. Adesso occorre fare in modo che le auto elettriche “siano convenienti e possano essere ricaricate” e che “l’industria abbia un accesso competitivo alle materie prime essenziali e all’energia per mantenere un futuro sostenibile in Europa”. Secondo le analisi Acea, nel 2022 un’auto ogni cinque vendute nella UE aveva una “spina”; entro il 2030 ce ne saranno tre ogni cinque. Sarà veramente così? La risposta potrà arrivare solo dai consumatori.

In che misura la guerra in Ucraina ha modificato il commercio internazionale di gas naturale, di petrolio e di carbone? La risposta dipende da ciò che si guarda: la materia prima sulla quale si fa zoom, i suoi flussi, il suo prezzo o il nolo che si paga per far giungere quella merce a destino. Certamente, il pandemonio innescato da Putin non solo ha favorito un parziale ritorno al carbone, ma ne ha anche mandato ben all’insù il prezzo. Tanto è vero che nell’ottobre scorso per la prima volta le quotazioni di quanto estratto nell’Appalachia centrale hanno superato la soglia di 200 dollari/tonnellata. Invece, non sono cresciuti i noli pagati per far viaggiare via mare tale fossile. Eppure, l’Europa ha cercato di tamponare il taglio dato da Mosca alle sue forniture carbonifere attingendo in Sudafrica, in Australia e in Indonesia, facendo così crescere del 4% la lunghezza media delle tratte battute dallo steam coal e dal carbon coke. Come mai? La risposta è semplice: i noli trattati sullo spot market (vale a dire sul mercato ove si svolgono le negoziazioni inerenti un singolo viaggio) dipendono dal rapporto intercorrente tra la richiesta e l’offerta di scafi. E la bulkcarrier fleet (il naviglio utilizzato per il trasferimento del carbone, dei cereali, della bauxite, ecc.) al momento esprime un’offerta di stiva ben più abbondante della domanda. Tanto più abbondante che, nel caso di questo tonnellaggio durante il 2022, quanto finisce in tasca all’armatore dopo aver dedotto dal nolo la spesa per il combustibile e per l’utilizzo di porti e canali – il cosiddetto timechar-
ter equivalent – ha registrato un trend discendente.
Che insegna il caso del carbone? Che ogni materia prima energetica è una realtà a sé. D’altronde, il gas naturale e il petrolio sono sì entrambi degli idrocarburi, ma - industrialmente parlando - sono beni alquanto diversi. Intanto, il petrolio viene imbarcato pressoché come estratto, mentre quella miscela
Quando Putin ha limato, o addirittura negato, l’export di natural gas ai suoi tradizionali clienti, quest’ultimi hanno dovuto rivolgersi a fornitori ubicati molto più lontano della Russia, ma tenendo conto che la richiesta addizionale di naviglio che stavano generando trovava un tetto nelle poche LNG carrier svincolate da impegni a lungo termine

di metano, etano, propano, etc., usualmente indicata come natural gas, va depurata e soprattutto intensamente raffreddata per farla divenire liquida e volumetricamente ridimensionata in misura gestibile. Diversamente, il liquefied natural gas (LNG) non potrebbe essere immagazzinato a costi accettabili e caricato in navi speciali - le cosiddette metaniere – per attuarne trasporti intercontinentali. Vi è, però, una seconda – e importante - differenza tra il natural gas e l’oro nero. Riguarda i loro contratti di compravendita. Infatti, quelli relativi al natural gas sono
in prevalenza delle intese a lunga durata e poco flessibili sia in termini di prezzo che di volume. E tanta rigidità produce quantomeno due effetti. Innanzitutto, fa sì che ben poco natural gas finisca per essere negoziato nelle Borse mondiali. Così, quando Mosca ha preso a frenare le sue forniture all’Europa, i più grandi operatori e trader di settore si sono scatenati su queste Borse (in particolare su quella olandese) per cercare del natural gas alternativo a quello russo. In buona misura sono riusciti nell’intento, ma comprando anche a quotazioni pressoché stratosferiche. Tanto è vero che nel 2022, stando alle stime, é più che triplicato l’onere per le importazioni di LNG. La rigidità caratterizzante il business del gas naturale comporta, però, anche dell’altro: una quota rilevantissima del traffico marittimo di LNG si svolge tramite metaniere unicamente dedite a servire per lungo tempo una specifica tratta. Di conseguenza, sono pochi gli armatori che corrono l’alea dello spot market. Così, quando Putin ha limato, o addirittura negato, l’export di natural gas ai suoi tradizionali clienti, quest’ultimi hanno dovuto rivolgersi a fornitori ubicati molto più lontano della Russia, ma tenendo conto che la richiesta addizionale di naviglio che stavano generando trovava un tetto nelle poche LNG carrier svincolate da impegni a lungo termine. Quindi, il fabbisogno di metaniere non ha avuto un vero e proprio boom; rispetto all’anno precedente è salito solo del 50% il timecharter equivalent mediamente percepito dalle LNG carrier da 160.000 metri cubi.

Ovvero, dalle metaniere costituenti il benchmark delle spedizioni di dimensione consistente svolte su rotte di lunghezza significativa. Le cose sono andate in tal modo anche nel caso dell’oro nero? No, per il barile, giacché il suo prezzo non ha certo toccato le vette raggiunte dal natural gas; molto meglio per le tanker, sebbene - da quando il nolo incide poco sul costo del barile a destino - le major e i trader trovino conveniente trattare sullo spot market la stragrande maggioranza del traffico
In conclusione, gli armatori di cisterne si trovano nella posizione inversa di quel generale di Luigi XIV che giustificò una propria sconfitta dicendo d’essersi trovato sul campo di battaglia con pas des amis et trop des ennemis.
internazionale via mare. Ad ogni modo, da quando si combatte in Ucraina di noli elevati hanno goduto tanto le petroliere trasportanti crude oil, quanto quelle movimentanti oil product. È andata così per il combinarsi di quattro motivi. Il primo: il consumo petrolifero mondiale è pressoché tornato ai livelli pre-pandemia e c’è meno crude oil stoccato sulle navi. Pertanto, oggi si trasporta via mare un po’ più petrolio di quanto si facesse quando Putin attaccò l’Ucraina. Il secondo: la Russia ha finora riversato nel mercato mondiale grosso modo la stessa quantità d’olio minerale greggio che tradizionalmente esportava, ma si sono rarefatte le sue consegne all’Europa, la quale in parte ha dovuto rivoluzionare il suo import via mare, mentre è esploso l’export di Mosca verso Cina e India. Il che vuol dire che le vendite russe, anziché comportare mediamente un viaggio di 10 giorni (se non meno), oggi
sono divenute spedizioni includenti viaggi che durano anche dai 30 ai 50 giorni. In più, un allungamento delle percorrenze vi è stato nell’ambito degli oil product, poiché è ben vero che ultimamente i russi hanno dovuto ridimensionare le loro esportazioni globali di benzina, di gasolio e via dicendo, ma è anche vero che Rosneft e le altre compagnie che hanno in mano l’export petrolifero russo hanno spedito ben di più oil product di quanto facessero tradizionalmente in territori quali il Medio Oriente, la Turchia, l’Asia e l’Africa. Così come è pure vero che le maggiori importazioni indiane e cinesi di greggio russo in buona misura si trasformano in oil product destinati a mercati piuttosto lontani dalle raffinerie che li hanno lavorati. Ed ecco il terzo motivo: il calo della produttività delle tanker. Dipende dal diffondersi del dark trade: l’interscambio fatto in barba alle sanzioni. Infatti, quest’ultimo – facendo il caso del crude oil russo disponibile in Mar Nero – si svolge in tal modo: una cisterna imbarca a Novorossiysk del greggio sul quale grava l’embargo e poi, anziché recarsi al porto di destino del carico, va a un meeting point al largo del Peloponneso oppure in Nordatlantico e lì trasborda il proprio greggio su una tanker di maggior capacità, la quale – solo dopo essere stata ulteriormente alimentata da una seconda (e magari anche una terza) petrolierainizia il viaggio verso il terminal d’approdo finale. E siamo al quarto motivo: la crescita al rallentatore della flotta cisterniera. Perché quest’ultima non si dilata, ancorché i noli siano elevati? Un po’ perché le tanker sono molto care e nessuno sa se valga la pena d’investire in newbuilding, non conoscendo quanto a lungo possa durare l’attuale bonanza Un po’ perché non si sa bene quale piega potranno prendere le cose. Un po’ perché gli shipbuilder si trovano nell’impossibilità di stimolare le ordinazioni calando il prezzo. Infatti, la fabbricazione delle tanker (come quello delle altre navi) oggi ha un costo pressoché incomprimibile, vuoi perché le quotazioni dell’acciaio sono alquanto elevate, vuoi perché va messo in conto che l’inflazione prima o poi manderà all’insù – e di parecchio – la spesa necessaria per il pagamento della manodopera. In conclusione, gli armatori di cisterne si trovano nella posizione inversa di quel generale di Luigi XIV che giustificò una propria sconfitta dicendo d’essersi trovato sul campo di battaglia con pas des amis et trop des ennemis. Così i possessori di tanker oggi finiscono per essere degli emuli di zio Paperone, giacché - come detto - di amici ne possiedono quattro e di nemici non ne hanno alcuno.

Il 2022 è stato caratterizzato da uno straordinario shock dell’offerta energetica a livello globale, i cui sintomi si erano già manifestati a fine 2021. Anche il petrolio ne ha subito le conseguenze, sebbene in misura diversa rispetto al gas. Per soddisfare la domanda energetica italiana, che stimiamo in calo sul 3%, le diverse fonti energetiche hanno rilevato variazioni inattese rispetto ai trend consolidati. Oltre all’emergenza geopolitica, che ha spinto a mutare profondamente i flussi di approvvigionamento, e alle politiche di sostituzione fra fonti messe in atto per tamponarne le conseguenze, vi è stata anche l’emergenza legata alla siccità che ha fatto crollare la produzione idroelettrica di quasi il 38% e pertanto il supporto della nostra principale fonte rinnovabile. Nelle variazioni del nostro bilancio energetico spicca la forte riduzione del gas, di circa il 10%, seguita da quella delle fonti rinnovabili, superiore all’8%. Questi eccezionali cali sono stati controbilanciati soprattutto dal carbone, che nella produzione termoelettrica ha rilevato un aumento di oltre il 60% e che a livello di energia primaria è risultato in crescita del 35%.
In un contesto di improvvisi e profondi mutamenti il petrolio, grazie alla sua maggiore flessibilità, ha affrontato le sfide del 2022 riorientando i propri flussi, contenendo gli aumenti dei costi e garantendo la sicurezza energetica al Paese, oltre alla mobilità. Passando dal 33% a circa il 36%, il suo peso nel soddisfacimento della domanda energetica italiana si è rafforzato nel 2022, confermandosi la seconda fonte di energia. Sotto il profilo economico, il conflitto russo ucraino ha provocato un esborso


netto dall’estero per le fonti energetiche, la cosiddetta «fattura energetica», superiore ai 114 miliardi di euro, un record nella storia italiana, con un peso arrivato al 6% del nostro Pil. L’aumento di circa 65 miliardi della fattura energetica è stato determinato per il 73% da gas ed elettricità, il cui esborso è quasi triplicato rispetto al 2021. Il petrolio ha rilevato, per contro, la variazione più contenuta fra le diverse fonti (+68%) con un peso sul Pil pari all’1,7%. La produzione nazionale di petrolio e gas, pari a 7 milioni di Tep, ci ha tuttavia consentito un risparmio di oltre 6 miliardi di euro. Nello specifico dei consumi petroliferi, l’anno si è chiuso a 58,2 milioni/tonnellate, 2,8 milioni in più rispetto al 2021 ma inferiori di 1,9 rispetto al 2019. Alcuni prodotti petroliferi ne hanno frenato, in misura più o meno ampia, il ritorno ai livelli pre-pandemici (carboturbo, petrolchimica, gasoli per riscaldamento agricolo, ecc.), mentre altri, come i carburanti, hanno rilevato un aumento congiunturale legato ad effetti eccezionali. La petrolchimica, fra i pochi prodotti che non avevano subito effetti negativi della pandemia, anzi in costante crescita nel triennio 2019-2021, ha invece chiuso
Sotto il profilo economico, il conflitto russo ucraino ha provocato un esborso netto dall’estero per le fonti energetiche, la cosiddetta «fattura energetica», superiore ai 114 miliardi di euro, un record nella storia italiana, con un peso arrivato al 6% del nostro Pil
l’anno con volumi del 26% più bassi, con una situazione di particolare criticità che si è evidenziata da maggio in poi. I carburanti, benzina e gasolio, invece non solo hanno sostenuto il recupero dei volumi petroliferi complessivi persi con la pandemia, ma li hanno addirittura superati di mezzo milione di tonnellate. Valutandoli separatamente, si nota che è stata sostanzialmente la benzina ad essere responsabile di tale risultato, in particolare da agosto in poi. Nel complesso la benzina è cresciuta dell’11,6% (+818.000 tonnellate), arrivando a 7,9 milioni di tonnellate, mentre il gasolio ha rilevato un incremento del 2,7% (+630.000 tonnellate).
Carburanti stradali e driver di crescita
Sappiamo che il parco circolante italiano è sempre più vecchio e stenta a rinnovarsi. Nello specifico del parco auto (quello più numeroso fra le tipologie di circolante), nel 2022 con un 1,3 milioni di unità ha toccato un livello di immatricolazioni tra i più bassi della storia e con radiazioni pari a poco più di 1 milione di auto. Tuttavia, già da qualche tempo questo parco e i suoi consumi stanno subendo delle profonde modifiche strutturali che sono sempre più evidenti, quali l’ibridizzazione dei motori e lo switch da gasolio a benzina.
A questi importanti driver strutturali, nel corso del 2022 se ne sono aggiunti altri due, quantitativamente meno rilevanti, ma peculiari del contesto, determinati dalla diversa economicità fra carburanti alternativi (metano auto e GNL) e fra Paesi limitrofi.
La costante riduzione delle forniture
di gas dalla Russia ha acutizzato le carenze di offerta di tale fonte e anche le quotazioni dei carburanti gassosi hanno subito dei trend in forte ascesa, già da fine 2021. Tale fenomeno, inusuale per questi prodotti che storicamente erano sempre stabili con prezzi al consumo inferiori ai carburanti liquidi, ha spiazzato i consumatori, spingendo ad utilizzare la benzina nei mezzi a metano bifuel. E anche l’utilizzo e l’acquisto dei veicoli merci a GNL ha subito una brusca frenata. Altro fenomeno congiunturale riguarda la disparità di interventi per tamponare gli effetti del «caro energia» che alcuni Paesi limitrofi non hanno adottato nella primavera del 2022, come invece fatto da Italia e altri. Austria e Svizzera, ad esempio, non sono mai intervenute sui prezzi e ciò ha favorito il pieno oltre frontiera e ridotto i loro consumi tra il 2 e il 5%. In particolare, in Italia nel periodo estivo in media i prezzi dei carburanti sono risultati più bassi di quasi 42 centesimi euro/litro per la benzina e di oltre 61 per il gasolio rispetto a quelli praticati in Svizzera.
Cresce l’apporto della raffinazione Nel 2022 le lavorazioni delle raffinerie italiane sono aumentate di circa il 7%, trainate dall’incremento dei consumi interni (+5%), e dalle esportazioni (+4%). In particolare, le esportazioni di prodotti petroliferi hanno contribuito alla bilancia commerciale con oltre 25 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al 2021, grazie a maggiori quantità esportate (oltre 28 milioni di tonnellate) e alla maggiore valorizzazione dei prodotti. Anche le esportazioni di biocarburanti hanno dato un contributo positivo, passando da 1,1 a 2,4 miliardi di euro. Quanto alle fonti di approvvigionamento di greggio, il contesto determinatosi dopo il 24 febbraio 2022 ha prodotto un solco profondo nelle provenienze, considerato che a seguito dell’entrata in vigore dell’embargo al petrolio russo quasi tutte le compagnie hanno dovuto dirigersi verso altri mercati.
Nel complesso abbiamo importato 62,5 milioni di tonnellate di petrolio (+9,6%) da 28 Paesi diversi (rispetto ai 22 del 2021) per 82 qualità differenti (rispetto alle 73 del 2021). In una situazione di improvvisa complessità, quale quella conseguente al venir meno dei flussi russi di greggi (pari a oltre il 10% dei greggi importati), la raffinazione ha saputo riorientare i suoi flussi di approvvigionamento, pur con notevoli difficoltà finanziarie, dati dagli alti costi energetici.
Per quanto riguarda i prezzi internazionali, in media il Brent nel 2022 si è attestato a 99 dollari/barile, più del doppio rispetto alla media del 2020.
Il progressivo allontanamento dei Paesi occidentali dal mercato russo ha innescato un crollo delle quotazioni del
Altro fenomeno congiunturale riguarda la disparità di interventi per tamponare gli effetti del «caro energia» che alcuni Paesi limitrofi non hanno adottato nella primavera del 2022, come invece fatto da altri Paesi, Italia compresa. Austria e Svizzera, ad esempio, non sono mai intervenute sui prezzi e ciò ha favorito il pieno oltre frontiera
greggio Ural a favore di greggi alternativi e un rialzo delle quotazioni del Brent, che nella prima settimana di marzo ha segnato il primo picco di 128 dollari/barile, corrispondenti a 118 euro/barile, un record storico.
Il rilascio delle scorte strategiche e le misure restrittive per nuova ondata pandemica in Cina hanno rallentato temporaneamente le tensioni sui mercati. Dopo quelle di Stati Uniti e Regno Unito nel primo trimestre, il 3 giugno la pubblicazione del sesto pacchetto di sanzioni con il blocco alle importazioni di greggio e di prodotti petroliferi russi ha determinato un nuovo rialzo delle quotazioni, con il Brent arrivato l’8 giugno a 124 dollari/barile.
Nel secondo semestre hanno invece prevalso le spinte ribassiste per la possibile recessione dell’economia mondiale, data l’inflazione elevata e le politiche restrittive delle banche centrali sui tassi di interesse e per il rallentamento della Cina, che hanno frenato le quotazioni. I corsi del petrolio hanno così progressivamente ripiegato fino agli 80 dollari/barile di fine anno. Anche per le quotazioni il 2022 ha registrato delle peculiarità, anzitutto l’elevata volatilità. Storicamente il delta giornaliero variava fra il mezzo dollaro e 1-2 al massimo in casi eccezionali. Nel 2022 la forchetta si è amplificata, con differenze dai 7-9 a oltre 10 dollari da un giorno all’altro, riflettendo la maggiore incertezza dei mercati.
Altra caratteristica è stato il progressivo indebolimento del cambio euro-dollaro, che aveva iniziato a 1,13-1,14, poi sempre più vicino alla parità da aprile, e infine sotto la parità ad agosto-settembre, per chiudere l’anno intorno a 1,06, con un effetto penalizzante sulle quotazioni del barile in euro che il 2 marzo 2022 per la prima volta nella storia hanno superato quota 100. Altro aspetto peculiare riguarda le quotazioni dei prodotti. Storicamente le quotazioni di benzina e gasolio hanno sempre rilevato un delta compreso in 2-3 dollari/tonnellata dovuto a motivi stagionali (la benzina generalmente in estate, il gasolio in inverno), mentre nell’anno la paura di minore disponibilità di gasolio per il venir meno delle esportazioni russe verso l’Europa ha fatto lievitare in misura record le sue quotazioni. Per la prima volta nel 2022 abbiamo infatti assistito ad impennate particolarmente significative che han-
no provocato una inversione nei livelli dei prezzi.
Le quotazioni del gasolio hanno infatti risentito delle criticità sul mercato europeo per:
• la carenza strutturale distillati medi in Europa, che era sempre compensata dalle importazioni di prodotto russo (pari al 35% delle importazioni europee);
• il venir meno dei greggi sour Urals, pari al 20% del grezzo lavorato nelle raffinerie OCSE, utilizzati proprio per produrre distillati medi;
• la capacità di raffinazione che si è ridotta nell’ultimo decennio, si è rivelata scarsa rispetto alla domanda in Europa e USA;
• una accelerazione nella riduzione delle scorte di distillati medi che già alla fine del 2021 erano ai minimi dal 2017.
L’apparente stabilità delle quotazioni del greggio, con oscillazioni marginali e una media nel primo trimestre attorno agli 82 dollari/barile rispetto agli oltre 97 del 2022, nasconde la spinta di forze contrapposte: da un lato, la domanda della Cina che è prevista salire molto, dando un forte impulso alla domanda petrolifera, dall’altro, la domanda delle economie occidentali che invece sta frenando per effetto della stretta monetaria avviata dalle Banche centrali e di tassi di inflazione elevati. Per quanto riguarda il lato offerta, agli ulteriori possibili sviluppi negativi di natura geopolitica, si sono aggiunte ad inizio aprile 2023 le dichiarazioni a sorpresa di un ulteriore taglio delle forniture di greggio da parte dei Paesi Opec Plus che al target di 2 milioni barili/giorno deciso nell’ottobre scorso, ha aggiunto una nuova riduzione dei volumi disponibili nel mercato di 1,6 milioni barili/giorno. Con quale sentiment?
In chiave rialzista, visto che subito dopo l’annuncio il Brent è salito di 5 dollari/barile, o piuttosto in misura precauzionale ritenendo che la crescita della domanda dell’anno sarà molto meno ampia?
Per il momento le quotazioni sembrano aver scelto quest’ultima ipotesi e, secondo ad alcuni analisti, la mossa dell’Opec Plus sarebbe dettata più da motivi politici, come un messaggio diretto agli Stati Uniti sul fatto che gli equilibri stanno cambiando. In questo solco si inserisce anche un altro fattore eccezionale che si sta già delineando, ossia l’avvento di un processo che è stato definito di “de-dollarizzazione” del petrolio. L’abbandono del dollaro nelle transizioni per le altre “valute chiave” mondiali, quali lo Yuan, non solo ridimensiona il ruolo della finanza statunitense nei mercati internazionali, ma apre a scenari del tutto inediti anche sul fronte di equilibri geopolitici mondiali già instabili.

Gli andamenti demografici sono una delle varianti che impattano sul futuro del pianeta anche da un punto di vista dei consumi energetici e dei cambiamenti climatici. A Massimo Livi Bacci, apprezzatissimo studioso italiano di demografia, abbiamo chiesto di illustrare quali sono le tendenze che dobbiamo attenderci.
L’Onu dice che siamo ormai 8 miliardi sula terra: cresceremo ancora e in che misura?
All’incirca due secoli fa, all’inizio della Rivoluzione Industriale, la popolazione del mondo toccò il miliardo di abitanti, che divennero due dopo la Prima Guerra Mondiale, quattro negli anni degli sbarchi sulla luna, e otto alla fine dello scorso anno. Per fortuna la corsa è andata rallentando, un nuovo raddoppio non è alle viste e, secondo le ultime proiezioni delle Nazioni Unite, la popolazione del pianeta potrebbe stabilizzarsi negli ultimi tre decenni del secolo sfiorando i dieci miliardi e mezzo. Due miliardi e mezzo in più rispetto a oggi – quanto la crescita accumulata nell’ultimo trentennio - che nel prossimo mezzo secolo dovranno nutrirsi, vestirsi, trovare alloggio, consumare energia per riscaldarsi, cucinare, lavorare e produrre, senza cadere in povertà.
La velocità della crescita della popolazione mondiale aveva raggiunto il culmine del 2% negli anni ’60 del secolo scorso, per scendere gradualmente sotto l’1% negli ultimi anni. Tuttavia, i paesi e le regioni del Mondo non
viaggiano allo stesso passo, per cui il tasso di crescita attuale è una media di situazioni molto diverse e dipende dalla fase del processo di transizione demografica nel quale essi si trovano. Per comprendere meglio consideriamo i 6 paesi più popolosi del mondo (che insieme valgono il 40% della popolazione del pianeta) e osserviamo i loro tassi di crescita attuali (2022) secondo le valutazioni delle Nazioni Unite: nell’ordine: 0% per la Cina, 0,5% per gli Stati Uniti, 0,6% per l’Indonesia, 0,7% per l’India, 2% per il Pakistan e 2,4% per la Nigeria e – per confronto – 0,9% per il Mondo intero. Si va dunque dalla stazionarietà della Cina, all’alta velocità della Nigeria, la cui popolazione, se non rallentasse il passo, si troverebbe raddoppiata in meno di trent’anni.
La crescita della popolazione nel corso del tempo è stata particolarmente ineguale nei diversi strati sociali e nelle diverse aree del mondo. Quale fenomeno sta avvenendo ora e come può incidere sui futuri equilibri socio-economici?

La geodemografia del Mondo è profondamente cambiata nel corso del tempo e continuerà a cambiare rapidamente nei prossimi decenni. Tra il 1950 e il 2050 - possiamo considerare assai attendibili le proiezioni fino alla metà del secolo – il cambiamento è strabiliante. Nel 1950 due abitanti su tre vivevano nei paesi che le Nazioni Unite definiscono “in via di sviluppo”, nel 2050 saranno sette su otto;
Si va dunque dalla stazionarietà della Cina, all’alta velocità della Nigeria, la cui popolazione, se non rallentasse il passo, si troverebbe raddoppiata in meno di trent’anni
nel 1950 l’Europa conteneva il 22% della popolazione mondiale, l’Africa sub-sahariana il 7%, nel 2050 le proporzioni saranno invertite, 7% l’Europa e 22% l’Africa sub-sahariana. Guardando alle prospettive del prossimo (abbondante) quarto di secolo (20232050), va messa in rilievo la dinamica dei grandi “competitori” mondiali. Per gli Stati Uniti si prospetta ancora un periodo di crescita sostenuta fino alla metà del secolo (+11%), per la Russia un declino (-8%). Si tratta di variazioni importanti, ma non rivoluzionarie, anche se incideranno sui processi d’invecchiamento, sulla produttività e su altri aspetti sociali. Tuttavia, la Russia vive una sorta di duplice affanno demografico: il primo, è dovuto alla grave usura della guerra in Ucraina e agli estesi reclutamenti (2022 e 2023) richiesti da una guerra di attrito; il secondo, che risale all’epoca di Pietro il Grande, riguarda la necessità di popolare e presidiare il suo amplissimo territorio. Il divario riguarda anche i due grandi serbatoi umani, Cina e India: la prima su un binario discendente (-8%), la seconda ancora in robusta ascesa (+18%).
Fino a che punto e in che modo queste tendenze possono influenzare i flussi migratori?
Va premesso che alle dinamiche dei flussi concorrono una pluralità di fattori, di natura oltre che demografica anche politica ed economica, per le disuguaglianze tra paesi e l’incidenza della povertà. Si consideri la fascia della popolazione giovane-adulta, che è il motore dello sviluppo di ogni società, per la più alta produttività, la capacità di innovazione, la maggiore mobilità; età nelle quali si mette su famiglia e si fanno figli, si prendono le decisioni di vita; età dalle quali proviene la grande maggioranza dei migranti. Per fare un esempio vicino a noi: nei paesi dell’Europa meridionale e mediterranea i giovani-adulti diminuiranno di un quarto tra oggi e la metà del secolo, mentre nei paesi del Nord Africa aumenteranno del 46%. Nessuno può dire in che misura questo sbilancio potrà essere attenuato dalla migrazione sud-nord, ma sicuramente la pressione continuerà ad essere elevata.
Crescita e decrescita convivono nel mondo. Per l’Europa e il Nord America (e per l’Italia la tendenza è ancora maggiore) il dato più rilevante è quello dell’invecchiamento. Reggeranno e quanto i meccanismi di welfare che conosciamo oggi?
Tra oggi e la metà del secolo e ovunque nel mondo, la quota di persone molto in là con gli anni avrà una ulteriore forte crescita, in conseguenza dei progressi della sopravvivenza e della minore natalità. Nel nord del Mondo, ma anche in Cina, Corea e Giappone, i sistemi di welfare sono sotto crescente stress e devono definire nuove regole – l’aumento dell’età pensionabile non è il solo rimedio. Occorrono azioni e investimenti che rendano progressivamente più capace, in salute, autonoma e produttiva la popolazione anziana. Con l’ausilio di domotica, robotica, digitalizzazione, pianificazione urbana, mobilità agevole si può ottenere che la popolazione molto anziana e fragile possa essere ben sostenuta, e che la popolazione “in là con gli anni” possa essere attiva e, se possibile, produttiva.
Analizzando le diverse componenti che hanno prodotto nel tempo quell’impronta carbonica che è all’origine dei mutamenti climatici, quanto incide la componente demografica? Quali possono essere politiche di mitigazione e adattamento in grado di dare un contributo?

Essenzialmente in due modi: più popo-
lazione significa, evidentemente, più consumi (per nutrirsi, vestirsi, alloggiare, riscaldarsi, lavorare, muoversi), più produzione, maggiori emissioni di gas serra. È stato stimato dall’IPCC che la crescita demografica (al netto di altri fattori) ha contribuito a generare una quota di circa un terzo dell’aumento dei gas serra negli ultimi decenni. La crescita demografica, inoltre, si determina quasi esclusivamente in paesi poveri: l’uscita dalla povertà implica un forte consumo di energia e di materie prime non rinnovabili, e quindi contribuisce fortemente alla generazione di gas serra. Se guadagno un dollaro in più, e sono povero, lo utilizzo per comprare più cibo per nutrirmi, o più carburante per muovermi, o più utensili per lavorare. Se sono ricco, col dollaro (metaforico) in più posso comprare musica, un taglio di capelli, il biglietto per un museo....tutte attività poco inquinanti.
Nei paesi dell’Europa meridionale e mediterranea i giovani-adulti diminuiranno di un quarto tra oggi e la metà del secolo, mentre nei paesi del Nord Africa aumenteranno del 46%. Nessuno può dire in che misura questo sbilancio potrà essere attenuato dalla migrazione sud-nord
Per quanto riguarda le politiche di mitigazione, è dagli scienziati che attendiamo soluzioni. Per quelle di adattamento, c’è una pluralità diversissima di azioni possibili: un cambiamento dei modelli di consumo (mangiare meno carne, ad esempio), una diversa urbanizzazione (evitare che le grandi città siano voraci consumatrici di energia e produttrici di rifiuti), una mobilità più razionale (più trasporto pubblico), per citarne alcune.
L’uomo nel corso della sua storia sulla Terra ha saputo adattarsi a tutte le condizioni, anche le più difficili. Ne sarebbe ancora capace?
La mia risposta è sì. Ma io sono un ottimista, anche se il mio ottimismo è messo a dura prova.
Perché?
Sicuramente adeguate politiche sociali potrebbero sostenere la riduzione della natalità e della crescita nel continente subsahariano, come già è avvenuto in Asia o in America Latina. Sono invece pessimista per quanto riguarda la possibilità di governare le migrazioni, un mare in tempesta per i contrasti d’interesse tra Paesi e la debolezza delle Istituzioni internazionali. E per la crescente massa di persone vittime di migrazioni forzate indotte da guerre, conflitti, persecuzioni e discriminazioni. Solo la Grande Politica Internazionale può mettere ordine. Ma questa, dov’è?

Perché gli scenari macroeconomici si intrecciano con la questione energetica? Non è facile dare una risposta a questa domanda, perché l'interconnessione fra macroeconomia ed energia è talmente complessa, i fili sono talmente intrecciati, che qualsiasi analisi rischia di diventare incompleta o parziale.
Vorrei partire dall'identità di Kaya che dice che il tasso di crescita delle emissioni di CO2 dipende da 4 fattori: il tasso di crescita della popolazione, il tasso di crescita del PIL pro-capite, il tasso di crescita dell'intensità energetica e il tasso di crescita dell'intensità carbonica. Come è noto, i primi due
termini sono positivi per la crescita del benessere e i secondi due dovrebbero essere negativi per controbilanciare la crescita delle emissioni.
Assumendo una continuazione dello sviluppo storico dell’ultimo mezzo secolo, risulterebbe una crescita del PIL del 2% medio annuo tra il 2019 e il 2050, in confronto a 3,2% nel periodo 1965-2019. Le previsioni dell'ONU indicano che popolazione mondiale arriverà a 9,7 miliardi 2050 e quindi con un tasso di crescita dell'1%, il che significa che il PIL pro-capite crescerà anch’esso di almeno l'1%. Occorrerebbe dunque almeno l’1% di miglioramento tecnologico dell'intensità energetica
e un'addizionale 1% di miglioramento dell'intensità carbonica per poter stabilizzare il tasso di crescita delle emissioni. Ma per l’obiettivo di emissioni zero al 2050 occorre di più: secondo la raccomandazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) sarebbe necessario aumentare il tasso di miglioramento dell'intensità energetica al 4% annuo per ottenere 1/3 dell'obiettivo di emissioni nette al 2050.
Per quanto riguarda l’ultimo fattore, l’intensità carbonica, il pacchetto europeo “Fit for 55” prevede il raggiungimento della riduzione del 55% delle emissioni, con un livello obiettivo nel settore elettrico di circa 110 gCO2/ KWh contro i 275 del 2021. Ma l’Europa rappresenta meno del 10% delle emissioni mondiali.

Sempre secondo la AIE, l’obiettivo di decarbonizzazione al 2050 si dovrebbe ottenere con la riduzione dei consumi
Occorrerebbe dunque almeno l’1% di miglioramento tecnologico dell'intensità energetica e un'addizionale 1% di miglioramento dell'intensità carbonica per poter stabilizzare il tasso di crescita delle emissioni

di fossili dall’80 al 20% del fabbisogno mondiale, con la penetrazione all’80% dei veicoli elettrici e la quintuplicazione del livello di investimenti in fotovoltaico ed eolico fino al 2040.
Non sembra inappropriato commentare che siamo ancora lontani e che questo scenario ha necessità di un'analisi SWOT (streght-weakness-opportunity-threat), cioè: forza, debolezza, minacce, opportunità.
I punti di forza delle politiche europee sono quelli di tracciare un segnale di avvertimento, di forte consapevolezza e di esempio di avanguardia nel mondo. I punti di debolezza sono rappresentati, dall’opportunismo nelle negoziazioni. Ad esempio, se un paese alla COP dice che raggiungerà gli obiettivi nel 2060 invece che nel 2050, si crea un vantaggio competitivo indebito. Niente di nuovo sotto il sole, come ben noto alla macroeconomia internazionale, con il classico caso della svalutazione competitiva delle politiche “beggar-thy-neighbor”: svaluto il mio tasso di cambio per rendere più competitive le mie esportazioni. Con il linguaggio di oggi: continuo l’utilizzo di energia più inquinante perché meno costosa e rendo le mie esportazioni più competitive, a spese dell’ambiente.
Le minacce sono date dallo sfasamento fra l'orizzonte politico di breve termine di chi vuole essere rieletto e le necessità di sacrifici di lungo periodo da imporre alla popolazione.
Le opportunità sono quelle delle invenzioni e dei miglioramenti tecnologici che i nostri laboratori di ricerca, le nostre università e le nostre aziende portano avanti ogni giorno.
Di queste quattro punte del dilemma SWOT, a mio modesto avviso, il problema del velato protezionismo che sta risorgendo a livello mondiale è quello più importante.
L'inizio strisciante di questo fenomeno lo possiamo far risalire al rischio, del quale si è tanto parlato dopo il lockdown del 2020, della mancanza di forniture nella filiera globale della catena del valore. Sono state di fatto ripensate le strategie di offshoring, portando alla ribalta questa nuova idea del reshoring. Ma, ovviamente, si sta parlando di visioni di velato protezionismo, perché se mi produco tutto in casa, ho ricominciato a fare una politica di implicito protezionismo dell'industria nazionale. Ora le politiche del rafforzamento dell'industria nazionale, tipo “Picking in the winner”, già le avevano proposte i francesi negli anni ‘70, subito dopo la rottura del sistema di Bretton Woods. Quindi, potremmo assistere a un nuovo corso e ricorso della storia, con un aumento del nazionalismo industriale, tipo Buy American, come risposta alle incertezze del sistema monetario e di commercio internazionale?
In questo contesto, sebbene la risposta maestra sia quella del dialogo del multilateralismo, come è noto, una regionalizzazione dei problemi sia di conflitti, ahimè, militari come quelli che sta vivendo l'Europa ma anche l'Asia, potrebbe comportare una nuova regionalizzazione delle politiche commerciali?

Sarebbe pernicioso che ricominciassimo con mercati dell'energia regionalizzati, magari in nome del concetto di sicurezza energetica.
Ad esempio, un segnale a mio avviso
non positivo si è avuto recentemente nel mercato petrolifero. Alcuni commentatori vicini alla finanza internazionale newyorkese hanno offerto l'interpretazione di una Arabia Saudita che si allontana dalla tradizionale amicizia con gli Stati Uniti, con l’aggressiva politica di riduzione delle quote in sede OPEC che mina la ripresa internazionale. Ma c'è un'altra verità, che hanno offerto i sauditi, e cioè che le vendite allo scoperto, preparate proprio dalla finanza internazionale anglosassone, stavano speculando al ribasso sul prezzo del petrolio e il taglio delle quote OPEC è stata una risposta per combattere la speculazione.
Da europeo mi auguro sinceramente di sbagliare, ma con il 60% del petrolio saudita esportato a Cina, Giappone, Korea e India, cioè quella parte del mondo che prevede una crescita del PIL del 4-5% al 2050, l’agenda mondiale dell’energia sarà dettata sempre più dall’Asia.
Le minacce sono date dallo sfasamento fra l'orizzonte politico di breve termine di chi vuole essere rieletto e le necessità di sacrifici di lungo periodo da imporre alla popolazione.
Le opportunità sono quelle delle invenzioni e dei miglioramenti tecnologici che i nostri laboratori di ricerca, le nostre università e le nostre aziende portano avanti ogni giorno
È l’esordio di una nuova era industriale: l'era della produzione di “tecnologie energetiche pulite” che hanno l’ambizione di condurre ad un mondo a zero emissioni.
I Paesi di tutto il mondo stanno intensificando gli sforzi per espandere la produzione di “tecnologie pulite” con l’intento di far progredire le transizioni net-zero, rafforzare la sicurezza energetica e competere, ognuno con punti di partenza e forza diversa, nella nuova economia energetica globale.
I punti di partenza: ognuno ha il suo e ognuno a modo suo.
Il passaggio a sistemi energetici sostenibili è una sfida globale che coinvolge una moltitudine di decisioni prese a livello nazionale e locale. Non tutti i Paesi partono dalla stessa posizione e non tutti i Paesi possono o vogliono cercare le stesse soluzioni.
Ciò dipende dalla struttura della propria economia, dal proprio mix energetico,
La concentrazione, in qualsiasi punto lungo una catena di approvvigionamento sia presente, rende l'intera catena vulnerabile agli incidenti, siano essi legati alle scelte politiche di un singolo Paese, ai disastri naturali, ai guasti tecnici o alle decisioni aziendali
dalla propria struttura di governance e da fattori come il clima e la geografia. Ogni Paese ha un punto di partenza diverso e punti di forza differenti. Le strategie, quindi, non possono che essere specifiche per ogni singolo Paese. L'UE, ad esempio, coltiva le sue ambizioni di produzione di energia pulita ma si scontra con la dipendenza dalle importazioni di materiali critici. Basta pensare che l'Europa è responsabile di oltre un quarto della produzione globale di veicoli elettrici ma ospita pochissimi dei materiali che li alimentano.
Come si posiziona l’Europa in questo nuovo scacchiere internazionale? Quali sono le nuove alleanze commerciali? Quali le opportunità da cogliere e i rischi da mitigare?

La supply chain della green energy, sia per quanto riguarda la produzione delle tecnologie che per i materiali su cui si basa, è una catena fortemente concentrata: la Cina domina nella produzione e nel commercio della maggior parte delle tecnologie e delle materie prime. Per le tecnologie prodotte in serie come eolico, batterie, elettrolizzatori, pannelli solari e pompe di calore, i tre principali Paesi produttori rappresentano almeno il 70% della capacità produttiva globale per ciascuna tecnologia, con la Cina dominante in tutti.
La distribuzione geografica dell'estrazione di minerali critici è strettamente connessa alle dotazioni di risorse che ciascun Paese ha (o non ha) e gran
parte di essa è molto concentrata. Ad esempio, la Repubblica Democratica del Congo da sola produce il 70% del cobalto mondiale e solo tre Paesi rappresentano oltre il 90% della produzione globale di litio.
La concentrazione, in qualsiasi punto lungo una catena di approvvigionamento sia presente, rende l'intera catena vulnerabile agli incidenti, siano essi legati alle scelte politiche di un singolo Paese, ai disastri naturali, ai guasti tecnici o alle decisioni aziendali. Oggi il mondo sta già vedendo i rischi di catene di approvvigionamento strette: gli effetti della guerra russo-ucraina si sono fatti sentire acutamente per il ruolo che il gas russo ha nella fornitura di energia.
E cosa fare se anche la catena di approvvigionamento per la transizione all’energia pulita pone l’Occidente e l’Europa in particolare in una posizione di estrema vulnerabilità?
Le principali economie stanno agendo per combinare in maniera efficiente le loro politiche climatiche, di sicurezza energetica e industriali.
L'Inflation Reduction Act (IRA) negli Stati Uniti è un chiaro passo in questa direzione. Difatti l’IRA, approvato nell’agosto 2022 dal Presidente Biden, diversamente da ciò che il nome del disegno di legge farebbe pensare, riguarda l’inflazione solo fino ad un certo punto. Si tratta più propriamente di una scommessa strategica e finanziaria

sulla centralità del sistema manifatturiero americano nella transizione verso le energie pulite. Una possente leva statale volta a sostenere le imprese statunitensi nella sfida energetica e attirare investimenti in suolo americano: quasi 400 miliardi di dollari di investimenti, ripartiti tra (250,6) energy, (47,7) manufacturing, (46,4) environment, (23,4) transportation and electric vehicles, (20,9) agriculture e (4,7) water. La manovra mira a ricostruire un apparato industriale che possa fronteggiare le sfide di questa fase storica: una singola risposta che ottemperi alle esigenze congiunte di produzione nazionale, sicurezza energetica e continuità degli approvvigionamenti.
In Europa, le misure decise dal governo di Washington hanno provocato forti preoccupazioni: il timore è che gli incentivi spiazzino l’industria europea, dirottando investimenti destinati all’Europa oltre oceano.
Difatti, gran parte dei crediti di imposta sono vincolati all’utilizzo di materiali statunitensi o di Paesi che hanno un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, nonché all’apertura di stabilimenti sul suolo americano. A titolo di esempio, si potrebbe pensare allo sconto di 7.500 dollari per l’acquisto di automobili elettriche, concesso solo se una certa percentuale dei materiali critici utilizzati per le batterie e il loro assemblaggio arrivano dall’America o paese aderente all’Accordo di libero scambio (Canada e Messico). L’IRA va letto assieme ad altre due misure intro-
Anche se i Paesi costruiscono le loro capacità interne e rafforzano i loro posti nella nuova economia energetica globale, rimangono enormi guadagni da ottenere dalla cooperazione internazionale come parte degli sforzi per costruire una base resiliente per le industrie di domani
dotte a partire dal 2021: la Bipartisan Infrastructure Law (BIL), che promuovere investimenti per modernizzare il sistema infrastrutturale statunitense e, in secondo luogo, il Chips&Science Act, finalizzato ad aumentare il peso americano nella delicata e senz’altro strategica catena dei semiconduttori. Queste misure potrebbero essere contestate dall’Europa per violazione delle norme sull’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Accordo SCM) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ma l’Europa, ad oggi, non ha perseguito questa strada. Sul piano normativo, una prima reazione europea all’Inflation Reduction Act ha portato alla presentazione da parte della Commissione, nel gennaio 2023, della proposta del Green Deal Industrial Plan. Il piano si fonda su quattro pilastri: la creazione di un contesto normativo prevedibile e semplificato, un accesso più rapido ai finanziamenti, il miglioramento delle competenze e la creazione di un commercio aperto per catene di approvvigionamento resilienti. Seguendo gli stessi principi, la Commissione europea ha annunciato il Net-Zero Industry Act, il Critical Raw Materials Act e la Electricity Market Design Reform
La normativa sull'industria a zero emissioni nette stabilisce un quadro europeo chiaro per ridurre la dipendenza dell'UE da importazioni altamente concentrate: le tecnologie strategiche a zero emissioni nette riceveranno un sostegno particolare e sono soggette al criterio del 40 % di produzione interna.
Il Critical Raw Materials Act punta a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche per l'industria europea e a ridurre notevolmente la dipendenza dell'UE dalle importazioni da singoli paesi fornitori. La normativa individua un elenco di materie prime critiche e un elenco di materie prime strategiche essenziali per le tecnologie per la transizione verde e digitale, nonché per la difesa e lo spazio. Stabilisce inoltre parametri
di riferimento per le capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento strategica delle materie prime da raggiungere entro il 2030:
• almeno il 10% del consumo annuo dell'UE con l'estrazione;
• almeno il 40 % del consumo annuo dell'UE con la trasformazione;
• almeno il 15 % del consumo annuo dell'UE con il riciclaggio;
• un massimo del 65 % del consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della trasformazione può provenire da un unico paese terzo.

Gli Stati membri dovranno inoltre sviluppare programmi nazionali per l'esplorazione delle risorse geologiche. Al fine di garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento la normativa prevede il monitoraggio delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e il coordinamento delle scorte di materie prime strategiche tra gli Stati membri. Alcune grandi imprese dovranno effettuare un audit delle loro catene di approvvigionamento di materie prime strategiche.
La Commissione, con l’Electricity Market Design Reform, infine propone di riformare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE per dare una spinta alle rinnovabili (la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili - prevalentemente solare ed eolica - dovrebbe crescere dal 37% nel 2020 a oltre il 60% entro il 2030), rafforzare la tutela dei consumatori e promuovere la competitività industriale. La riforma proposta prevede misure tese ad incentivare i contratti a più lungo termine con produttori di energia non fossile e ad apportare al sistema soluzioni flessibili più pulite in concorrenza col gas, come la gestione della domanda e lo stoccaggio. La proposta prevede anche la revisione delle norme sulla condivisione delle energie rinnovabili: i consumatori potranno investire in parchi eolici o solari e vendere ai vicini – e non solo ai fornitori – l'elettricità in eccesso generata da impianti solari su tetto.
Anche se i Paesi costruiscono le loro capacità interne e rafforzano i loro posti nella nuova economia energetica globale, rimangono enormi guadagni da ottenere dalla cooperazione internazionale come parte degli sforzi per costruire una base resiliente per le industrie di domani.
Il commercio internazionale è vitale per la transizione energetica ma l’Europa deve aumentare la diversità dei fornitori.

La Transizione Energetica è la sfida globale più importante per il futuro di ciascuno di noi. È il più grande cambio di paradigma tecnologico dai tempi della rivoluzione industriale e richiede di cambiare il modo in cui produciamo, trasportiamo, stocchiamo e consumiamo l’energia, tutti i giorni, nel quotidiano delle nostre vite, come nelle nostre imprese e organizzazioni. Vincere questa sfida significa concretamente avere una chance di contrastare il cambiamento climatico e proporre un modello di funzionamento del sistema economico più sostenibile. Una sfida così complessa non può, a mio parere, essere lasciata esclusivamente al “mercato” e per almeno

quattro ragioni, che ne riflettono altrettanti limiti. Innanzitutto, la transizione ha natura ecosistemica, coinvolgendo una varietà di attori con interessi talora contrastanti, e soffre spesso del cosiddetto chicken-egg problem. Pensiamo al caso delle installazioni di impianti a rinnovabili di grande taglia che richiedono, oltre alla disponibilità dei luoghi, infrastrutture di rete che siano in grado di “seguire” o meglio “anticipare” i fabbisogni di connessione, ma che sono in capo a soggetti diversi rispetto a quelli che sviluppano gli impianti stesi sul territorio. Vi è poi la necessità per alcune soluzioni tecnologiche di tenere conto esplicitamente del
Pensiamo al caso delle auto elettriche, rispetto alle quali, se si vuole rapidamente sostituire i motori endotermici, bisogna “spingere” le immatricolazioni ad un tasso superiore a quello che normalmente il mercato esprimerebbe, in buona sostanza convincendo i proprietari ad anticipare il ricambio delle proprie auto

maggior costo rispetto all’alternativa “fossile” e quindi di intervenire con un sistema di incentivazione che renda la soluzione appetibile (non lo sarebbe altrimenti) sul mercato. Un caso su tutti è quello dell’idrogeno “verde” (ossia con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’elettrolisi che consente di produrlo dall’acqua) che sconta oggi un divario di costo di almeno tre volte rispetto a quello ottenuto ad esempio dal gas naturale o, addirittura, dal carbone.
In altre circostanze ancora, gli incentivi sono necessari (se si condivide l’obiettivo finale) per accelerare un mercato che altrimenti non sarebbe in grado di raggiungere i livelli necessari. Pensiamo al caso delle auto elettriche, rispetto alle quali, se si vuole rapidamente sostituire i motori endotermici, bisogna “spingere” le immatricolazioni ad un tasso superiore a quello che normalmente il mercato esprimereb-
be, in buona sostanza convincendo i proprietari ad anticipare il ricambio delle proprie auto.

Infine, vi sono le situazioni, pensiamo all’adozione di pratiche di economia circolare che valorizzino le risorse disponibili connettendo diverse filiere produttive (in logica di end-of-waste), dove la transizione passa per la “rottura di equilibri” e deve tenere conto della ridistribuzione del valore che avviene tra i diversi soggetti; ed in quanto tale, come ricordava magistralmente Macchiavelli, trovando “l’inimicizia di coloro i quali hanno profitto a preservare l’antico e soltanto tiepidi sostenitori in coloro che sarebbero avvantaggiati dal nuovo”.
In tutti questi casi, che però sono estremamente pervasivi nell’ambito della transizione energetica, il mercato incontra dei limiti, senza risolvere i quali non è possibile immaginare che si raggiunga l’obiettivo. Ed è proprio qui che il ruolo dello Stato, o se si vuole della Politica (con la P maiuscola), diviene fondamentale.
È compito, a mio parere, dello Stato definire innanzitutto gli obiettivi di decarbonizzazione e, tenendo conto delle specificità che indubbiamente esistono, distribuire questi obiettivi tra i diversi macro-settori (trasporti, produzione di energia, mondo del costruito, etc.) e – cosa che ora purtrop-
po non si fa più – tra le diverse Regioni ed aree geografiche. È compito dello Stato stabilire, assumendo chiaramente una condizione di inizio e di fine ed una modulazione economica nel mezzo (anche questo molto difficilmente riscontrabile nel nostro Paese), i sistemi di incentivazione, siano essi mirati alla sostenibilità economica o
Ed è ovviamente troppo facile per il mercato addossare la colpa alla politica, e talvolta viceversa, quando questi equilibri non si trovano. La soluzione però è e resta quella del ritrovare costantemente questo equilibrio di mix tra Stato e Mercato
blighi ed imposizioni – gli investimenti del mercato, accompagnandolo verso il risultato atteso.
Si tratta, indubbiamente, di un gioco di equilibri complesso e non privo di rischi. Accelerazioni troppo forti –come recentemente accaduto con il super ecobonus e prima ancora (ma ne abbiamo forse perso memoria) con il famoso emendamento “salva Alcoa” del 2010 che avviò l’effimero exploit delle rinnovabili – non consentono all’offerta di mercato di adeguarsi, con il conseguente effetto rialzo sui prezzi e successiva brusca “frenata” degli investimenti. Allo stesso tempo, attese troppo lunghe, come quella che riguarda l’avvio del meccanismo delle “comunità energetiche rinnovabili”, in ritardo di almeno un biennio, non fanno altro che trattenere un mercato ed un sistema di operatori industriali che invece avrebbe tutte le potenzialità per esprimersi.
alla accelerazione delle dinamiche di mercato. È compito dello Stato, infine, “prendersi cura” degli attori delle filiere per i quali la transizione genera un displacement (e che troppo spesso sottacciamo) e che vanno accompagnati o verso la riconfigurazione o verso l’uscita dal sistema. È compito, in buona sostanza, dello Stato il definire le regole del gioco ed indirizzare – talvolta bilanciando gli incentivi con ob-
Ed è ovviamente troppo facile per il mercato addossare la colpa alla politica, e talvolta viceversa, quando questi equilibri non si trovano. La soluzione però è e resta quella del ritrovare costantemente questo equilibrio di mix tra Stato e Mercato, costruendo il più possibile regole, da un lato, e filiere, dall’altro, in grado di adattarsi rapidamente ai mutati cambiamenti di contesto.

Globalizzazione e digitalizzazione, unite alla disponibilità di manodopera, capitale e materie prime a basso costo, hanno garantito negli ultimi decenni la stabilità dei prezzi in un contesto di elevata crescita mondiale. Oggi assistiamo a un cambio di paradigma nell’economia mondiale il cui segnale più evidente è rappresentato dal ritorno dell’inflazione.
Il processo di globalizzazione avvenuto negli ultimi decenni ha, infatti, accresciuto enormemente il grado di interdipendenza sistemica dei vari Paesi favorendo, attraverso gli scambi e la specializzazione produttiva, la crescita dell’economia mondiale, ma anche innescando squilibri economici, finanziari, sociali, ambientali e geopolitici di grande portata.
La globalizzazione ha anche stimolato l’emergere di forti dipendenze strut-
Il processo di costruzione di una “Economia della Fiducia” non avverrà tuttavia a costo zero. Le imprese non potranno più organizzare la propria produzione considerando semplicemente dove i costi sono più bassi, ma le proprie scelte saranno vincolate da elementi geopolitici che definiranno il nuovo perimetro in cui potersi muovere
turali, di cui quella relativa alla produzione di energia si è manifestata di recente come la più evidente. Più in generale, l’accresciuta interdipendenza delle economie ha generato le tensioni strutturali sui prezzi che oggi osserviamo sotto forma di ele-
vata inflazione, aggravata dagli effetti dell’aggressione militare della Russia all’Ucraina.
Nell’attuale fase, la fine del gas russo a basso costo, la spinta globale verso la sostenibilità ambientale, l’accorciamento delle catene del valore e l’avvio di processi di re-industrializzazione dell’Occidente ci stanno portando verso un Mondo che potrebbe essere strutturalmente più inflazionistico, almeno nel breve (ma, a quanto pare, non brevissimo) termine.
Allungando lo sguardo, è ancora troppo presto per dire come andrà a finire, ma si possono già vedere segnali di cambiamento nell’ordine mondiale e di riconversione delle economie dei sistemi occidentali verso un modello che possiamo definire di “Economia della Fiducia”.

La prima fase di questa transizione è

Prendendo atto che l’accelerazione nella diffusione delle energie rinnovabili solleva enormi problemi dal punto di vista delle dipendenze da Paesi terzi, viene adottata una strategia “make” invece che una strategia “buy”, anche al costo di rinunciare ai vantaggi della libera concorrenza internazionale in termini di maggiore efficienza e minori costi
rappresentata dal passaggio dalla dipendenza alla diversificazione nelle forniture. Ne abbiamo avuto un esempio chiaro negli sforzi realizzati dai Governi italiani per stringere accordi per sostituire la fornitura di gas dalla Russia. In realtà, è un processo avviato già prima del conflitto da molte imprese che, appresa la lezione della pandemia, puntano a ridurre la dipendenza da catene di approvvigionamento globali di tipo lineare e ad aumentare la diversificazione dei fornitori.
Il passaggio successivo consisterà in una prevedibile maggiore frammentazione dell’economia a livello globale, a cui corrisponderà una crescente integrazione a livello regionale. Non si tratta della fine della globalizzazione, ma di una radicale modifica della sua architettura, in cui gruppi fortemente integrati di paesi che condividono uno stesso sistema di valori e/o interessi, competono tra loro per l’egemonia economica, politica e culturale.
Il processo di costruzione di una “Economia della Fiducia” non avverrà tuttavia a costo zero. Le imprese non potranno più organizzare la propria produzione considerando semplicemente dove i costi sono più bassi, ma le proprie scelte saranno vincolate da elementi geopolitici che definiranno il nuovo perimetro in cui potersi muovere. Significa quindi che i criteri di efficienza saranno in parte sostituiti da quelli di fiducia, con la conseguenza che i costi legati a una ristrutturazione dell’offerta su base “regionale” e “fiduciaria” saranno significativi.

In questo contesto un secondo cambio di paradigma si sta realizzando. Siamo infatti di fronte al ritorno della politica industriale, ovvero l’abbandono della strategia non interventista dei governi nazionali che si erano affidati negli ultimi decenni all’azione autonoma delle forze di mercato su scala globale.
I 369 miliardi di dollari di incentivi previsti dall’Inflation Reduction Act approvato negli Stati Uniti, destinati ad investimenti verdi e alla sicurezza
energetica del Paese, sono solo l’ultimo esempio in questa direzione. Si tratta del più grande piano contro il cambiamento climatico mai realizzato negli USA, perdipiù caratterizzato da una chiara impronta protezionistica.
In un colpo solo gli Stati Uniti hanno messo in chiaro due punti fondamentali: 1) l’importanza strategica della transizione energetica e 2) la scelta di perseguire il raggiungimento degli obiettivi ambientali sviluppando adeguate capacità tecnologiche e produttive internamente.
In altre parole, prendendo atto che l’accelerazione nella diffusione delle energie rinnovabili solleva enormi problemi dal punto di vista delle dipendenze da Paesi terzi, viene adottata una strategia “make” invece che una strategia “buy”, anche al costo di rinunciare ai vantaggi della libera concorrenza internazionale in termini di maggiore efficienza e minori costi. La risposta dell’Unione europea all’IRA non è sembrata del tutto soddisfacente. Si prevede infatti una riorganizzazione del quadro normativo sugli Aiuti di Stato, un più efficace e indirizzato utilizzo dei fondi già disponibili e, in prospettiva, il varo di un Fondo di Sovranità europeo ancora tutto da definire. Non molto, in verità, in un contesto in cui USA e Cina già stanno investendo centinaia di miliardi per sostenere la propria competitività
tecnologica e produttiva.
In questa fase storica caratterizzata da incertezza, in cui il tema della sicurezza del sistema energetico è sempre più centrale è, invece, necessario adottare politiche più incisive da parte dei Paesi dell’Unione europea e delle Istituzioni comunitarie. Occorre, in particolare, confermare e rilanciare gli sforzi sugli obiettivi di decarbonizzazione, adottando un approccio tecnologicamente neutro in grado di combinare diverse soluzioni e valorizzare tutte le tecnologie di decarbonizzazione sulla base dell’efficacia e dell’efficienza del contributo che possono offrire, garantendo la stabilità e la sicurezza del sistema energetico nel processo di transizione. In questo scenario sarà quindi fondamentale porre in essere uno sforzo collettivo, in Italia e in Europa, per garantire la sostenibilità e la sicurezza del sistema energetico attraverso un processo di profonda trasformazione tecnologica e industriale, avendo ben presente l’obiettivo di evitare di passare da una dipendenza all’altra. Obiettivo che potrà essere realizzato attraverso il potenziamento delle capacità tecnologiche e produttive italiane ed europee, puntando su un ampio portafoglio di tecnologie ed evitando di fare affidamento nelle catene di fornitura su un numero troppo ristretto di paesi.


È da notare che la legge è stata approvata con una strettissima maggioranza al Senato, 5150 e con il voto decisivo del vicepresidente Kamala Harris, ricorrendo alla procedura della “Reconciliation” del bilancio, uno strumento legislativo che non lascia spazio all’ostruzionismo e limita le possibilità di emendare il testo della legge
L’approvazione dell’Inflation Reduction Act (IRA) da parte dell’amministrazione Biden ha scosso non solo l’Europa per il sostegno pubblico concesso agli investimenti nel settore dei combustibili rinnovabili e per i possibili vantaggi competitivi di cui ora potranno godere gli operatori americani. L’articolo che segue si concentra sugli aspetti dell’IRA relativi ai combustibili a basse emissioni di carbonio (LCF), analizzando dettagliatamente gli incentivi disponibili per i vari tipi di biocarburanti e combustibili rinnovabili. L’IRA è molto più di un semplice strumento regolatorio per la promozione dei clean fuels. Si tratta di un più ampio e ambizioso strumento di riequilibrio del bilancio federale che introduce una serie di nuove ed aggiuntive entrate fiscali, nonché nuovi crediti o nuovi impieghi del gettito fiscale. Pertanto, la disponibilità di crediti d’imposta per i carburanti a basse emissioni di carbonio rappresenta solo una piccola parte dei cambiamenti introdotti dall’IRA al bilancio federale. È da notare che la legge è stata approvata con una strettissima maggioranza al Senato, 51-50 e
con il voto decisivo del vicepresidente Kamala Harris, ricorrendo alla procedura della “Reconciliation” del bilancio, uno strumento legislativo che non lascia spazio all’ostruzionismo e limita le possibilità di emendare il testo della legge. Secondo le regole del Senato degli Stati Uniti, infatti, i disegni di legge di “riconciliazione” possono includere solo disposizioni che riguardano direttamente il bilancio federale ed essere approvati dal Senato con un voto a maggioranza semplice anziché qualificata di 60 voti. Per questo motivo l’IRA è stato il risultato di molti compromessi politici su disposizioni che hanno un impatto diretto sul bilan-
cio federale, tra cui i crediti d’imposta. In base al requisito che il disegno di legge contenga solo disposizioni che riguardano il bilancio federale, l’IRA non include regolamenti come obblighi per i combustibili rinnovabili o, ad esempio, modifiche al Renewable Fuels Standard (RFS) federale. Come in una direttiva dell’Unione europea, in cui gli atti delegati e i regolamenti di attuazione sono affidati alla Commissione, l’IRA fornisce uno schema generale che le Agenzie federali devono poi integrare con la regolamentazione di dettaglio.Di seguito una breve descrizione delle principali misure relative ai LCF.
SEZ. 13104 SEZ. 13201 SEZ. 13202 SEZ. 13203
Cattura e sequestro del carbonio (45Q)
Proroga dell'attuale BTC fino al 2024 (40A)
Proroga del credito per i biocarburanti cellulosici fino al 2024
Nuovo credito SAF fino al 2024 (40B)
SEZ. 13204 SEZ. 13404 SEZ. 13704 SEZ. 22003
Credito d'imposta per l'idrogeno pulito (45V)
Credito di proprietà per il rifornimento di carburante alternativo (30C)
Credito per la produzione di carburante pulito (45Z)
Sovvenzioni per l'infrastruttura biocarburanti
Cattura e sequestro del carbonio Questa disposizione modifica la sezione 45Q del codice fiscale e prevede un credito di 85 dollari/tonnellata che scende a 60 dollari se l’attività di cattura del carbonio gode di un altro beneficio finanziario (come il recupero avanzato del petrolio o l’uso come materia prima chimica). La costruzione dell’impianto di cattura e sequestro deve iniziare entro gennaio 2033 e il volume minimo è di 12.500 tonnellate di CO2 all’anno, con crediti per 12 anni. Per il settore dei carburanti, le applicazioni principali sono probabilmente l’idrogeno blu e l’etanolo, ma andrebbe precisato che questo credito non è cumulabile con i crediti per l’idrogeno pulito (45V) o i carburanti puliti (45Z). Si prevede che gli operatori prenderanno in considerazione i vari crediti disponibili per un determinato progetto e sceglieranno quello che offre il valore maggiore.
Credito d’imposta per l’idrogeno verde Questa misura crea una nuova sezione (45V) del codice fiscale, che prevede un credito per 10 anni dall’avvio degli impianti, con una scala graduale di crediti a seconda delle emissioni del ciclo di vita dell’idrogeno secondo il modello GREET elaborato dal centro studi Argonne:
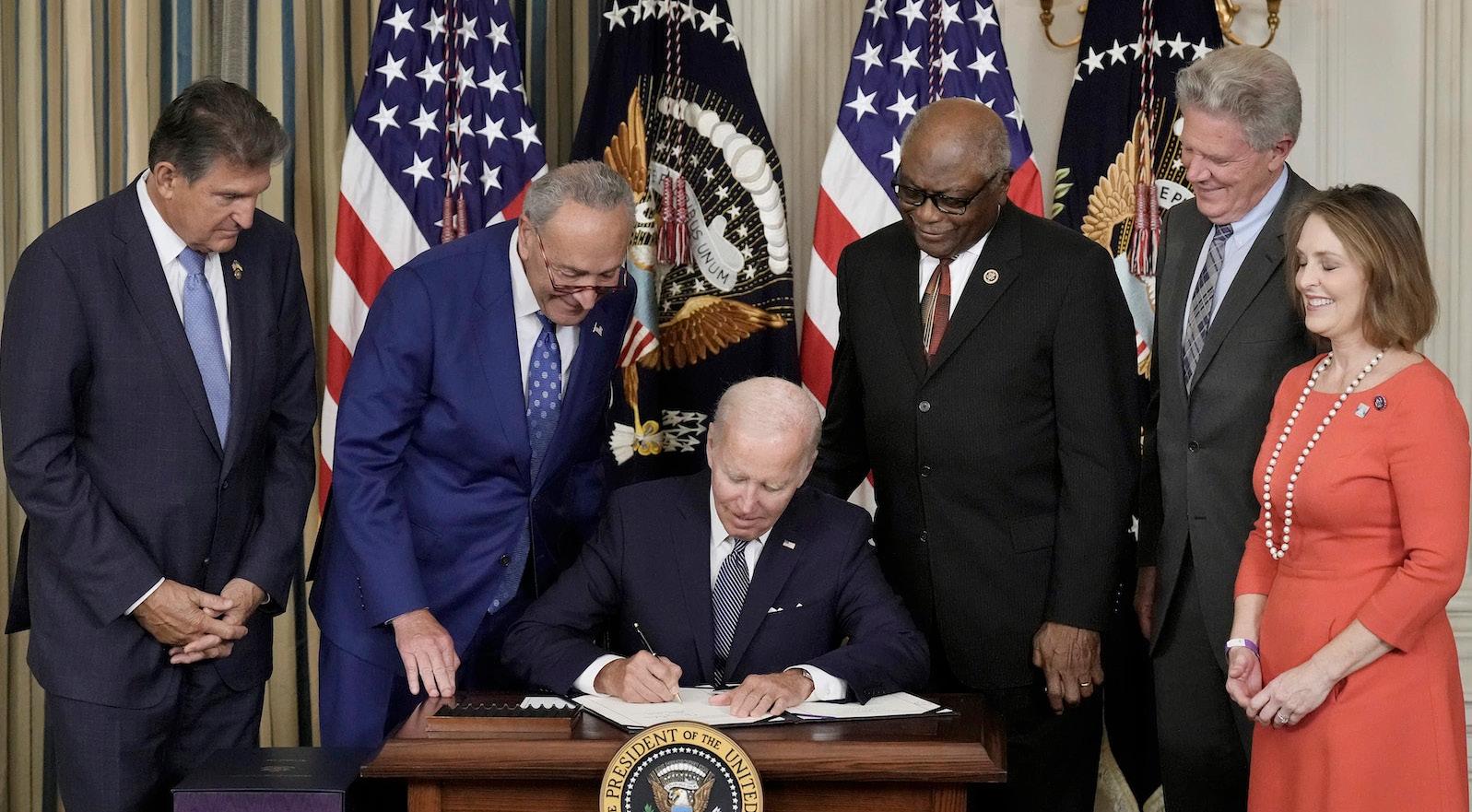
Il valore del credito aumenta notevolmente per l’idrogeno con un IC inferiore a 0,45 kg CO2e/kg H2. È strutturato in modo da incentivare la produzione di idrogeno verde con energia rinnovabile (ad esempio, eolica o solare). Per accedere al credito, l’idrogeno deve essere prodotto negli Stati Uniti (o nei loro possedimenti).
Proroga dei crediti BTC e Cellulosici Si tratta semplicemente di una continuazione di strumenti previsti da politiche precedenti. Il credito d’imposta per il gasolio biomass-based (BTC), pari a 1 dollaro/gallone, è disponibile in modo sporadico dal 2004 a chi miscela “diesel a base di biomassa” (BBD), che include sia il diesel a base di FAME che di HVO e quello sostenibile per l’aviazione (SAF). La miscelazione deve avvenire negli Stati Uniti, anche se il prodotto finito può essere esportata a condizione che il BBD non sia stato precedentemente importato. Il credito può essere utilizzato in modo flessibile per compensare le accise o l’imposta sul reddito. Le cosiddette “pass-through entities”, ossia le società non soggette alla tipica imposta sul reddito delle imprese come, ad esempio, quelle a responsabilità limitata (LLC, Limited Liability Companies), possono trasferire il credito agli azionisti invece soggetti a tassazione. Questa dovrebbe essere l’ultima proroga del BTC, poiché dal 1° gennaio 2025 tale previsione sarà definitivamente sostituita dal nuovo sistema di crediti denominato Clean Fuels Production Tax Credit (CFPC) (vedi più avanti). Allo stesso modo, il credito per i produttori di biocarburanti di “seconda generazione” viene prorogato senza modifiche fino
alla fine del 2024. Il credito pari a 1,01 dollari è concesso a condizione che le materie prime utilizzate siano cellulosiche o emicellulosiche, alghe coltivate, cianobatteri o lemna.
Si tratta di un cambiamento significativo rispetto all’attuale BTC, con la creazione di un credito separato per la miscelazione di SAF (nella nuova sezione 40B) che ha un valore più elevato rispetto al BTC ed è soggetto a una scala mobile dell’intensità di carbonio. I SAF che raggiungono la soglia di riduzione delle emissioni di gas serra (GHG savings) del 50% riceveranno 1,25 dollari/gallone. Questo valore sarà aumentato di 0,01 dollari per ogni 1% di GHG savings serra fino a 1,75 dollari/gallone per il 100%. Anche in questo caso, il SAF deve essere prodotto negli Stati Uniti e destinato ad un aereo negli Stati Uniti. Sono esclusi il co-trattamento dei lipidi nelle raffinerie e i distillati di acidi grassi derivati dalla palma (PFAD). Come il BTC per il diesel, questo credito per i miscelatori cessa dal 1° gennaio 2025 per essere sostituito dal CFPC.
Credito per la produzione di carburante pulito (CFPC)
Questo è probabilmente l’elemento di maggior impatto dell’IRA per quanto attiene ai biocarburanti, sia per le implicazioni sulla monetizzazione dell’intensità di carbonio, sia per il segnale positivo a più lungo termine dato agli investitori statunitensi. Dal 1° gennaio 2025 i crediti BTC e SAF saranno infatti sostituiti dal CFPC che definisce una scala progressiva di tassi di emissione a partire da 50 kg di
CO2e/mmBTU (equivalenti a 47,4 gCO2e/MJ) fino al “livello base” di 1,75 dollari/gallone per il SAF e 1 dollaro/ gallone per gli altri biocarburanti quando l’intensità di carbonio raggiunge lo zero. L’IC sarà arrotondato a 5 kg/mmBTU più vicino. È importante sottolineare che scala progessiva continua anche per i biocarburanti con IC negativo. Ad esempio, il SAF con un IC di -5 kg/mmBTU beneficerà di un credito di 1,75+0,175 dollari. Anche questi livelli di credito saranno indicizzati all’inflazione a partire dal 2024. L’IRS (Internal Revenue Service) pubblicherà annualmente una tabella dei tassi di emissione applicabile ad ogni carburante. Come per il credito SAF, sono esclusi il co-trattamento e il PFAD. Il passaggio dal credito BTC e SAF alla CFPC nel 2025 presenta una serie di aspetti significativi:
1) Il beneficio di questo credito si trasferisce al produttore anziché al primo miscelatore
2) Il carburante deve essere stato prodotto negli Stati Uniti (ma le materie prime possono essere importate e il prodotto esportato).
3) Il credito si applica a tutti i biocarburanti, non solo al diesel a base biologica e al SAF.
4) I biocarburanti con un IC di 50 kg/ mmBTU (circa il 50% di GHG savings rispetto ai valori di riferimento dell’analogo prodotto fossile) vedranno il loro credito scendere a zero da 1 dollaro per i BBD e 1,25 dollari per i SAF. Ciò è particolarmente rilevante per i prodotti a base di soia, per i quali non si prevede un GHG savings significativamente superiore al 50-60%.
5) Per il SAF, il valore dell’1% di GHG
savings è più che triplicato, in quanto l’incremento dal (circa) 50% al 100% di risparmio è ora da zero a 1,75 dollaro/gallone, anziché da 1,25 a 1,75. Si tratta di un motivo importante per cercare di migliorare continuamente l’intensità di carbonio in ogni aspetto della catena di fornitura SAF.
6) Sebbene la CFPC sia ufficialmente in vigore solo fino dalla fine del 2027, la maggior parte degli osservatori si attende che venga estesa a lungo termine per fornire agli investitori il tanto atteso segnale di prezzo stabile, un cambiamento ben visto rispetto alla storia altalenante del BTC diesel.
Impianti di rifornimento / Infrastrutture
Infine, sono disponibili crediti e sovvenzioni per gli investimenti nella logistica e nella distribuzione per facilitare la diffusione degli LCF, ad esempio con colonnine dedicate all’erogazione di LCF nei punti vendita. Si prevede che tali risorse saranno utilizzate principalmente per sostenere i distributori e i rivenditori indipendenti più piccoli, piuttosto che le grandi società Oil&Gas.
In conclusione, con l’IRA l’amministrazione Biden ha cercato di fornire una serie chiara e affidabile di meccanismi di sostegno fiscale per la produzione di clean fuels negli Stati Uniti. Questi crediti continueranno a lavorare insieme all’RFS (Renewable Fuels Standards) e alle normative statali (come l’LCFS della California) come parte della “struttura” di incentivi finanziari per lo sviluppo di LCF. Le reali implicazioni di questi cambiamenti sul mercato statunitense sono tuttora da verificare e si
Al di fuori degli Stati Uniti le conseguenze stanno iniziando a farsi sentire, in quanto aziende e investitori stanno rivalutando la loro posizione competitiva rispetto ai produttori americani
manifesteranno nel corso dei prossimi anni. Alcune domande chiave sono legate al vero impatto sull’accelerazione degli investimenti e al ruolo dell’idrogeno verde nei trasporti o se anche al fatto se il SAF sia sufficientemente incentivato per competere con il diesel rinnovabile negli impianti che producono HVO. Al di fuori degli Stati Uniti le conseguenze stanno iniziando a farsi sentire, in quanto aziende e investitori stanno rivalutando la loro posizione competitiva rispetto ai produttori americani. La canadese Parkland Corp. ha già annunciato di avere cancellato il progetto per impianto di diesel rinnovabili presso la sua raffineria di Burnaby, vicino a Vancouver, adducendo tra i motivi proprio che “avvantaggia i produttori statunitensi”. Gli operatori di mercato multinazionali, come le major del settore Oil&Gas, avendo un certo grado di scelta sulla localizzazione degli investimenti, potrebbero invece guardare con più favore agli Stati Uniti rispetto al passato, mentre le aziende impegnate nella produzione in Europa continueranno senza dubbio ad aspettarsi - e a richiedere - una serie di incentivi commisurati da parte dei responsabili politici europei.

il trimestrale italiano sui problemi dell’energia e dell’ambiente
Per i nuovi abbonati c’è uno sconto del 20% ! scopri come su
4 numeri - 40 articoli - 400 pagine seguici su




Il 20 marzo scorso gli studiosi che fanno parte del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) hanno presentato un Rapporto di sintesi con le conclusioni del sesto ciclo di valutazione scientifica sul cambiamento climatico che contiene un forte invito ai policy makers a fare di più per evitare perdite irreversibili in termini di ecosistemi e popolazioni.
Il 2023 è un anno importante per il pianeta, in quanto è l’anno della prima revisione degli obiettivi stabiliti nell’Accordo di Parigi, il cosiddetto “Global Stocktake”, cioè un processo mediante il quale le Nazioni sono chiamate a monitorare le azioni per il clima per valutare se sono, collettivamente, sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo dell'Accordo di Parigi. Alla COP28, che si svolgerà nel mese di dicembre a Dubai, tutti gli Stati membri dell’ONU forniranno la valutazione delle proprie politiche in tema sia di mitigazione che
Valutare i progressi relativi alle azioni di adattamento non è altrettanto immediato poiché l’efficacia di tali misure può manifestarsi solo dopo un certo periodo di tempo. Pertanto, ad oggi non c'è accordo sulla valutazione dello stato attuale dell'adattamento, su cosa significhi "progresso" e su come valutarlo
di adattamento.
Tuttavia, mentre per la mitigazione la contabilizzazione delle emissioni di gas serra è basata su sistemi concordati e consolidati (inventario delle emissioni), valutare i progressi relativi alle azioni di adattamento non è altrettanto immediato poiché l’efficacia di tali misure può manifestarsi solo dopo un certo periodo di tempo. Pertanto, ad oggi non c'è accordo sulla valutazione dello stato attuale dell'adattamento, su cosa significhi "progresso" e su come valutarlo.
Il nostro recente studio, “Quality of urban climate adaptation plans over time”, pubblicato su Nature npj Urban Sustainability, intende supportare tale processo fornendo un sistema di valutazione della qualità dei piani di adattamento in grado di valutarne i progressi rispetto agli obiettivi previsti.

L’indice ADAQA (ADAptation plan Quality Assessment index) si basa
su sei principi di qualità dei piani ampiamente riconosciuti dalla letteratura scientifica:
1) Stato degli impatti e dei rischi del territorio;
2) Obiettivi di adattamento;
3) Misure previste;
4) Attuazione delle misure;
5) Monitoraggio e valutazione;

6) Coinvolgimento e partecipazione. Viene, inoltre, introdotto un aspetto relativamente nuovo nella pianificazione climatica, che consiste nel valutare la "coerenza" dei piani, ovvero l’allineamento tra impatti/rischi, obiettivi, misure, monitoraggio e partecipazione pubblica. Ad esempio, se una città identifica la propria vulnerabilità all'aumento delle ondate di calore, che mettono a rischio soprattutto gli anziani, un buon piano progetta e attua anche misure specifiche per contrastarne gli impatti concentrandosi sugli anziani, con meccanismi in grado

In assenza di indicatori comparabili e disponibili a livello globale sull'adattamento e sui suoi risultati, l’indice ADAQA rappresenta un valido indicatore per la valutazione della qualità dei Piani sviluppati dalle città per fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici
ta significativamente negli ultimi 15 anni anche in termini di coerenza tra obiettivi e azioni intraprese. I piani più recenti sono generalmente più attenti ai potenziali impatti del cambiamento climatico sui gruppi vulnerabili, ma tali gruppi sono ancora raramente coinvolti nei processi di partecipazione.
Un’altra limitazione comune a molti piani è l’assenza di strategie di monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle misure previste per affrontare le loro esigenze specifiche.
di valutare se tale rischio si è ridotto o meno dopo l'attuazione. Tale lavoro è partito dal censimento dei piani di adattamento adottati, tra il 2005 e il 2020, in un campione di 327 città europee omogeneamente distribuite nei 27 Paesi europei più la Gran Bretagna. La raccolta e l’analisi dei contenuti dei piani, che si è svolta tra il 2019 e il primo semestre del 2020, ha evidenziato che solo la metà delle città analizzate (167) si è dotato di un piano di adattamento, con una maggioranza di piani concentrati in Gran Bretagna, Polonia, Francia e Germania.

I risultati hanno mostrato che, in generale, la qualità dei Piani è migliora-
I piani di adattamento della capitale bulgara Sofia e delle città irlandesi di Galway e Dublino sono quelli che hanno ottenuto i punteggi più alti con l’applicazione dell’indice ADAQA. In particolare, il piano di Sofia include dettagli sugli impatti e sui rischi passati, presenti e futuri, considera gli impatti climatici in diversi settori e presta particolare attenzione ai gruppi sociali vulnerabili, mentre le città irlandesi sono tenute a seguire le linee guida dettate dal governo irlandese che, ad esempio, includono una valutazione dei rischi climatici per l'area urbana. L’Italia risulta abbastanza indietro, sia in termini di numero di Piani urbani sviluppati, sia in termini di qualità: Tra le 32 città italiane incluse nel campione, risulta che solo due città - Bologna
e Ancona - avevano nella prima metà del 2020 un Piano di adattamento. Se Bologna risulta posizionata abbastanza in alto nella classifica della qualità, all’undicesimo posto, Ancona rimane a metà classifica, piazzandosi all’84° posto. Tale situazione, probabilmente, risente dell’assenza di un quadro di riferimento nazionale in grado di supportare la definizione di strategie e piani locali e regionali: occorre ricordare, infatti, che il Piano nazionale di adattamento è ancora in fase di adozione.
In assenza di indicatori comparabili e disponibili a livello globale sull'adattamento e sui suoi risultati, l’indice ADAQA rappresenta un valido indicatore per la valutazione della qualità dei Piani sviluppati dalle città per fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici. Uno strumento fruibile gratuitamente online attraverso il ”Climate Change Adaptation Scoring tool”. Tale studio è stato reso possibile grazie allo sforzo congiunto di circa 40 studiosi di tutta Europa che collaborano costantemente per valutare e monitorare lo stato della pianificazione climatica a scala locale nell’ambito della EURO-LCP Initiative, coordinata dalla professoressa Diana Reckien dell’Università di Twente (Olanda).
Davide Tabarelli

Nello scontro, a volte battaglia, con gli ambientalisti, quello dei sussidi ai fossili è uno dei campi dove gli economisti vincono facile, perché le assunzioni alla base dei calcoli sono molto deboli. Tuttavia, i contabili devono stare attenti, perché di sussidi ai fossili parlano le grandi Istituzioni internazionali, il Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l’OCSE, la Banca Mondiale, tutti organi potenti della politica internazionale, rigorosamente guidati da economisti, non da architetti o filosofi come accade per le associazioni degli ambientalisti. Il sussidio ai fossili nasce proprio nel contesto internazionale, dagli studi riferiti ai Paesi produttori di petrolio, quelli che navigano letteralmente nel petrolio e che da sempre fanno prezzi dei derivati del barile estremamente bassi, a volte vicino allo zero. Il Venezuela spicca fra tutti, perché è quello con le riserve più grandi al mondo, ma è anche quello dove più fallimentare è stato lo sfruttamento del petrolio, con prezzi alla pompa della benzina di po-
chi centesimi al litro, cosa che serve a poco per un paese con milioni di abitanti che fanno la fame.
Prezzi più alti sono quelli dei paesi del Golfo Persico, oppure quelli in Africa, ma sempre a livelli di molto inferiori a quelli dei paesi industrializzati. Il ragionamento della filosofia del sussidio è che il prezzo internazionale del petrolio, quello a cui esportano i Paesi produttori, giustificherebbe prezzi interni della benzina di molto più alti. Ad esempio, ad inizio 2023, con il petrolio

poco sopra gli 80 dollari/barile e con un prezzo spot della benzina a 850 dollari/tonnellata, il prezzo alla pompa avrebbe dovuto essere almeno di 70 centesimi di euro/litro, per altro senza alcuna forma di tassazione. Siccome molti Paesi produttori decidono che il prezzo delle loro risorse, in questo caso la benzina, può essere più basso, vicino ai costi di produzione, allora gli organismi internazionali tacciano la differenza come sussidio agli sporchi fossili. Sotto il profilo strettamente
Nello scontro, a volte battaglia, con gli ambientalisti, quello dei sussidi ai fossili è uno dei campi dove gli economisti vincono facile, perché le assunzioni alla base dei calcoli sono molto deboli

etico, che non è mai questione marginale per l’economia, ogni Paese, in particolare se non particolarmente ricco, decide da solo cosa farne delle proprie risorse e come fissarne il prezzo nei suoi confini. Certo, vedere che la benzina praticamente non viene fatta pagare in Venezuela è follia, ma, allo stesso modo, è esagerato considerare sbagliato il fatto che l’Iran o l’Egitto, che hanno molti problemi, applichino prezzi bassi rispetto a quelli internazionali. È forse il mercato internazionale, dove si forma la quotazione del petrolio, il giudice supremo del giusto prezzo? È giusto il prezzo attuale di 85 dollari, oppure era giusto quello del gennaio 2016 di 28, o quello di 140 del luglio 2008?
Nel tempo questo ragionamento dai Paesi produttori è stato esteso ai consumatori, con il sussidio, però, non stimato in base al prezzo internazionale, ma prendendo a riferimento la tassazione più alta praticata nel singolo Paese. L’Italia è un ottimo esempio, in quanto il sussidio più importante, da circa 4 miliardi di euro all’anno, è lo “sconto" praticato sul gasolio autotrazione rispetto alla tassazione della benzina. La differenza di accisa e di IVA, di tasse, sui due prodotti, è di circa 14 centesimi di euro/litro, che moltiplicata per gli enormi volumi di gasolio autotrazione consumato in Italia di circa 28 miliardi di litri comporta un valore di 4 miliardi di euro. È una mancata tassazione sul gasolio che diventa, nella logica ambientalista, un sussidio al fossile. A questo si aggiungono gli sconti di accisa su una lunga serie di prodotti, con i più importanti che sono il gasolio pesca e il gasolio agricolo, ma anche la benzina per le autoambulanze, o il cherosene per gli aerei.
È qui che è facile trovare un elemento di debolezza nella logica di queste stime, quello relativo al fatto che i fossili contribuiscono, appunto con la tassazione, a volte certamente un po’ agevolata, ad un enorme flusso di risorse per le casse dello Stato. L’Italia,
di nuovo è uno dei casi più eclatanti, con entrate ogni anno da tassazione dei derivati del petrolio, la fetta più importante, dell’ordine dei 40 miliardi di euro. Se quelli degli “sconti” sono chiamati sussidi dannosi, allora la tassazione dovrebbe quantomeno ricevere una definizione più positiva, una sorta di riconoscimento come contributo a frenare i consumi, e le emissioni di CO2 e altri inquinanti, e pertanto un aiuto al miglioramento dell’ambiente. Ciò non accade e si preferisce guar-

dare solo alla riduzione rispetto alla massima tassazione che, essendo la più alta, è considerata anche quella giusta a cui dovrebbero tendere tutte le tassazioni di quel paese.
Dei fossili tutti vorremmo fare a meno, fosse facile, e forse un giorno ce la faremo, ma non certo attraverso queste effimere contabilità che servono per facili proclami e per distogliere l’attenzione dei problemi veri, a cominciare delle gigantesche difficoltà a trovarne dei sostituti.
Dei fossili tutti vorremmo fare a meno, fosse facile, e forse un giorno ce la faremo, ma non certo attraverso queste effimere contabilità che servono per facili proclami e per distogliere l’attenzione dei problemi veri, a cominciare delle gigantesche difficoltà a trovarne dei sostituti
L’acronimo ESG sintetizza le tre dimensioni della sostenibilità: quella ambientale, sociale e di buon governo, in inglese Environmental, Social e Governance. È ora sempre più noto, anche al di fuori del mondo della finanza, per verificare, misurare, controllare e sostenere (con acquisto di prodotti o con scelte di investimento) l’impegno in termini di sostenibilità di una impresa ma anche di una Organizzazione. Il come misurare e verificare chiede non solo l’individuazione dei fattori rilevanti per le tre dimensioni, ma soprattutto chiede la valutazione della loro materialità, cioè dell’impatto sull’attività aziendale (business), sulle performance finanziarie e sulla valutazione da parte degli stakeholders (aspetti reputazionali). Questo passaggio è fondamentale per comprendere come i fattori ESG influenzino le scelte di investimento e quindi possano indirizzare fondi e capitali. La definizione degli standard di va-


Il come misurare e verificare chiede non solo l’individuazione dei fattori rilevanti per le tre dimensioni, ma soprattutto chiede la valutazione della loro materialità, cioè dell’impatto sull’attività aziendale (business), sulle performance finanziarie e sulla valutazione da parte degli stakeholders (aspetti reputazionali)
lutazione è ancora in corso e bisogna accelerare, ma le scelte normative e regolamentari, quali la tassonomia verde e le richieste dei regolatori di mercato, danno già indicazioni che si traducono in valutazioni degli impatti di materialità. Entrando più nello specifico, ad esempio della dimensione ambientale, dove norme e indicazioni regolamentari già ci sono, possiamo comprenderne la materialità distinguendo tra rischio fisico e rischio transizione, dove il primo rappresenta l’esposizione a rischi ambientali che possono andare aggravandosi a causa del cambiamento climatico, mentre il secondo è connesso alle modalità di passaggio
verso un’economia a basse emissioni di carbonio, che dipende dal progresso tecnologico ma anche dalla definizione di politiche attive da parte dei Governi, quindi da scelte politiche (oltre che dalle scelte dei consumatori). Entrambi sono legati a indicatori quali le emissioni di gas climalteranti, che costituiscono infatti i principali KPI del pillar E, ma il rischio transizione ha una componente rilevante legata alle scelte politiche e di consumo le cui dinamiche possono non sempre essere ben allineate alle soluzioni migliori di riduzione delle emissioni. Il rischio di transizione, inoltre, può avere un orizzonte più breve del rischio fisico (o dell’accresciuto rischio fisico) che

può renderlo quindi prevalente nelle scelte della finanza e degli investitori. Entrando ancor più nel merito della questione, ci sono alcune situazioni emblematiche legate al rischio transizione. Oggi scelte politiche spingono per l’elettrificazione dei veicoli in presenza di una tecnologia non ancora vincente in tutte le sue forme, con conseguenze che possono addirittura portare a valorizzare soluzioni non vantaggiose per l’ambiente. Nell’uso sulle lunghe distanze, ad esempio concreto, l’impiego di un’auto con sistema ibrido plug-in a benzina risulta essere più impattante di quello di un’auto alimentata con motore a gasolio. Da una inchiesta che stiamo svolgendo sulle flotte di alcune multinazionali che hanno cambiato le vetture a gasolio con quelle plug-in a benzina, sta infatti emergendo che il 70% degli utilizzatori si lamenta di un consumo di carburante sensibilmente più elevato e di conseguenza con maggiori emissioni. Questo tema sta emergendo solo ora, sollevando anche la questione greenwashing e di adeguata trasparenza, ed evidenzia come vi sia necessità di un approccio più attento, che consideri lo stato dell’arte attuale e in divenire, sia nel breve che nel medio periodo, per non favorire soluzioni non ottimali. Altri esempi si possono trovare per gli investimenti nel gas, nel petrolio e nel nucleare in quanto ci vuole molto più tempo di quello che erroneamente si pensa per la conversione e questo costituisce un problema. Le ultime stime disponibili da parte
sia dell’IPCC (Panel Intergovernativo per il Cambiamento Climatico) sia da nostri studi del Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari, come quelli di McKinsey, indicano che gli investimenti necessari per la transizione climatica non saranno inferiori ai 3.000 miliardi di dollari annui con orizzonte al 2050. L’impegno del finanziamento pubblico potrà arrivare forse ad un terzo e c’è quindi un gap annuo di oltre 2.000 miliardi di dollari che necessariamente chiama a una mobilitazione importante di capitale privato verso investimenti sostenibili. E per questo avere metriche ESG ben congeniate permetterebbe a tutti di ridurre il rischio e valorizzare gli investimenti. La corretta valutazione del rischio transizione è strettamente legata anche alla necessità di una transizione ordinata, che chiede un bilanciamento tra l’implementazione di attività a bassa emissione e il rallentamento di quelle ad alta emissione, possibil-
La corretta valutazione del rischio transizione è strettamente legata anche alla necessità di una transizione ordinata, che chiede un bilanciamento tra l’implementazione di attività a bassa emissione e il rallentamento di quelle ad alta emissione, possibilmente prevedendo misure di resilienza e ridondanza adeguate per evitare problemi di sicurezza energetica

mente prevedendo misure di resilienza e ridondanza adeguate per evitare problemi di sicurezza energetica così come di ordine sociale (concetto di transizione giusta per le implicazioni su lavoratori e territori maggiormente coinvolti/colpiti dalla transizione climatica). Questa valutazione non deve quindi basarsi sulla situazione attuale, che implicherebbe uno screening negativo (e quindi nessun investimento nelle attività ad alta emissione), ma deve avere capacità forward looking, valutando il potenziale e la volontà di transizione verso tecnologie e processi a minori emissioni. Gli indicatori da includersi quindi nella valutazione non devono fotografare solo lo status quo, ma prendere in carico anche informazioni e valutazioni che guardino avanti e che dovrebbero essere incluse nei piani di transizione, per permettere agli investitori di allocare capitali nelle direzioni utili. Non bisogna poi sottovalutare l’aspetto geopolitico, perché in questo ultimo ventennio con la crescita esponenziale della Cina e quella prossima dell’India, il tema delle risorse disponibili per tutti come le abbiamo conosciute fino ad ora sarà ancora più rilevante. Concludendo, dei passi importanti sono stati fatti e si stanno facendo ma altrettanti ne mancano. Ci vuole da parte di tutti una visione più attenta ma anche meno dogmatica a prescindere.
Con il contributo di Marco Marelli, journalist expert in mobility, sustainability and economics.
Confindustria Energia ha avviato negli ultimi anni una serie di studi finalizzati ad approfondire lo sviluppo delle infrastrutture energetiche in Italia e nei Paesi dell’area del Mediterraneo attraverso previsioni di investimenti e proposte di modifiche normative che consentano di traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione. Con il contributo delle Associazioni rappresentate (Assogasliquidi, Assorisorse, Elettricità Futura, Proxigas, unem), H2IT, Snam e Terna e con il supporto analitico di PwC Strategy&, Confindustria Energia ha concluso nel dicembre 2022 i lavori della terza edizione dello Studio sulle “Infrastrutture energetiche per una transizione sicura e sostenibile” le cui analisi, avviate nella cornice della ripresa post-Covid e della pubblicazione del “Fit for 55”, hanno avuto come priorità la ricerca di una convergenza tra sicurezza energetica, obietti-


Confindustria Energia ha concluso nel dicembre 2022 i lavori della terza edizione dello
Studio sulle “Infrastrutture energetiche per una transizione sicura e sostenibile” le cui analisi, hanno avuto come priorità la ricerca di una convergenza tra sicurezza energetica, obiettivi ambientali e crescita economica, in un quadro di sostenibilità sociale
vi ambientali e crescita economica, in un quadro di sostenibilità sociale. Le complicazioni delle condizioni di contesto, che si sono susseguite nel corso del 2022, hanno delineato una nuova situazione geopolitica, ponendo in risalto i temi della sicurezza energetica e della necessità di un’ulteriore spinta verso la transizione ecologica, considerati elementi di indirizzo per lo Studio. Le analisi hanno condotto all’elaborazione di due scenari, denominati “Fit for 55” e “Sostenibilità integrata”, attraverso cui sono stati individuati due piani integrati per gli investimenti fino al 2030, periodo in cui l’Italia, con altri Paesi europei, dovrà far fronte alle criticità del proprio sistema energetico fortemente dipendente dalle importazioni. Lo scenario “Fit for 55” ha avuto
come focus quello della sostenibilità ambientale del settore energetico; il piano di sviluppo che tiene conto dei criteri di “Sostenibilità integrata”, nelle sue dimensioni ambientale, economica e sociale, consente di raggiungere gli obiettivi climatici 2030 previsti dal “Fit for 55” e garantisce contemporaneamente la sicurezza e la competitività delle forniture energetiche in linea con gli indirizzi del RePowerEU. Per le scelte strategiche che il Paese dovrà compiere in questo settore, questo scenario coglie al meglio le potenzialità del settore energetico nazionale e valuta in 182 miliari di euro gli investimenti previsti nel periodo 2022-2030, che si traducono in un valore aggiunto totale di 320 miliardi, nell'impiego di 380.000 Unità Lavorative Annue ed in una riduzione delle emissioni pari a 127 Mton CO2/anno nel 2030, facendo leva

su una visione strategica che supera l’attuale situazione emergenziale e mantiene la focalizzazione sugli obiettivi di transizione energetica nel medio-lungo termine, tenendo presente gli effetti sui livelli occupazionali delle filiere tradizionali e di quelle innovative. Dal piano emergono diverse leve sinergiche tra loro, a partire dalla leadership in Europa nella produzione di biocarburanti e di importanti eccellenze nei processi di economia circolare. In particolare, i nuovi biocarburanti e i low carbon fuels risultano necessari e complementari alla mobilità elettrica ed è importante che continuino il loro processo di sviluppo per il ruolo significativo che potranno giocare per la decarbonizzazione dei trasporti e per la sicurezza degli approvvigionamenti. In questo quadro l’analisi proposta dallo Studio anche della dimensione sociale della transizione energetica nel nostro Paese pone una seria riflessione sul bando del motore a combustione interna al 2035 e dei suoi impatti e criticità sulle filiere e sul patrimonio di competenze e know-how nazionale. Il piano tiene conto delle ulteriori leve complementari dovute alla posizione geografica ottimale del nostro Paese per l'ulteriore crescita di fonti rinnovabili e per la diversificazione delle rotte di importazioni energetiche, alle sue riserve di gas naturale non utilizzate, alle capacità di stoccaggio ed accumulo incrementabili e dalle reti di trasporto e trasmissione efficienti e diffuse nel territorio. Il gas manterrà in Italia un ruolo indispensabile nel medio termine, anche per supportare lo sviluppo previsto per le fonti rinnovabili elettriche, e non sarà completamente sostituibile dal biometano e dall’idrogeno. Sarà quindi necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio e di utilizzo della CO2 per accelerare i processi di decarbonizzazione in alcuni settori industriali. Lo Studio dedica altresì una sezione
all’economia circolare da cui emergono le significative prospettive di sviluppo per il nostro Paese in termini di valorizzazione delle filiere produttive nazionali e di risparmio e di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, garantendo la sostenibilità sociale ed il rapporto con il territorio. Questo approccio contribuisce alla sicurezza energetica anche attraverso la riduzione della dipendenza dai Paesi extra-UE nell’approvvigionamento dei materiali critici. La condivisione, inoltre, con le comunità locali delle priorità strategiche, dei criteri progettuali adottati e la definizione ex ante delle ricadute economiche e occupazionali, unitamente a uno stretto coordinamento tra enti autorizzativi nazionali e regionali, sono i presupposti necessari per la “messa a terra” nei tempi previsti delle iniziative proposte. Si ritiene che i risultati e le proposte

di questo Studio possano costituire un utile contributo per la definizione del nuovo PNIEC a livello nazionale e per la negoziazione degli atti delegati del “Fit for 55” e del RePowerEU a livello europeo nel quadro di una visione strategica e geopolitica per il nostro Paese, di maggiore collaborazione con i Paesi del Mediterraneo, area di tradizionale presenza degli operatori italiani, al fine diversificare gli approvvigionamenti energetici e di incentivare modelli di sviluppo infrastrutturale sostenibili e integrabili. Programmi coordinati per la realizzazione delle infrastrutture energetiche individuate possono costituire un valido riferimento per le decisioni di investimento nel medio-lungo periodo, purché sia assicurata la definizione di un quadro articolato di «fattori abilitanti» di carattere normativo, autorizzativo e finanziario.
Dal piano emergono diverse leve sinergiche tra loro, a partire dalla leadership in Europa nella produzione di biocarburanti e di importanti eccellenze nei processi di economia circolare. In particolare, i nuovi biocarburanti e i low carbon fuels risultano necessari e complementari alla mobilità elettrica

Presidente come vede il suo nuovo ruolo e quali sono le sue priorità?
Presiedere il Consiglio di Amministrazione del GSE è sicuramente un onore, anche in virtù del fatto che nella mia esperienza come parlamentare sono stato sempre attento al ruolo che questa azienda ha nel panorama energetico nazionale e nel supportare aziende, privati e pubblica amministrazione. Proprio in tale direzione stiamo lavorando, insieme all’amministratore delegato l’Avv. Vinicio Vigilante, per migliorare il dialogo con associazioni di categoria, operatori del settore ed enti pubblici. Tenere in considerazione le loro istanze è fondamentale per rendere la transizione energetica ed ecologica del Paese un fulcro della crescita economica.
Al GSE è demandato il compito di promuovere lo sviluppo sostenibile. Cosa dobbiamo intendere con sostenibile?
Il paradigma dello sviluppo sostenibile, come dichiarato dall’ONU con gli obiettivi dell’Agenda al 2030, si fonda sul concetto di uno sviluppo che sappia coniugare la sostenibilità ambien-
Il ruolo del GSE è fondamentale per l’Italia considerando che, con la sua attività, solo nel 2021, ad esempio, ha contribuito ad attivare 2,3 miliardi di euro di nuovi investimenti e la creazione di almeno 53 mila posti di lavoro

tale con quella economica e sociale. Dunque, la sola pragmatica interpretazione possibile è quella di un modello di sviluppo che sia in grado di garantire la salvaguardia del pianeta, dell’individuo e dell’economia. In questi termini il ruolo del GSE è fondamentale per l’Italia considerando che, con la sua attività, solo nel 2021, ad esempio, ha contribuito ad attivare 2,3 miliardi di euro di nuovi investimenti e la creazione di almeno 53 mila posti di lavoro.

Il GSE è un’interfaccia importante sia per il Governo che per gli operatori della filiera energetica. Come si pos-
sono coniugare le diverse esigenze?
Il GSE svolge il ruolo di braccio operativo del Governo e dunque deve rendere le norme elaborate il più possibili efficaci e tempestive. Il raggiungimento di questo obiettivo può essere facilitato proprio prendendo in considerazione i punti di vista di coloro che operano nel settore. In virtù di questo principio, la nuova governance del GSE, accogliendo le proposte delle associazioni di categoria e degli operatori, ha già attivato una campagna di semplificazione delle procedure che renderà più snelli i processi, riducendo le difficoltà degli operatori e le
Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, inoltre, questi stimoli dovranno essere orientati anche alla creazione di una solida rete di protezione che sia in grado di ridurre l’impatto delle fluttuazioni del mercato energetico su famiglie e imprese
tempistiche. Il primo aggiornamento, pubblicato ad aprile e orientato a garantire una sempre maggior efficienza del parco di generazione elettrica fotovoltaica, ha visto lo snellimento delle procedure relative alla gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti in Conto energia.
Sulle piattaforme che in qualche modo fanno capo al GSE ci sono anche quelle relative ai biocarburanti, al centro di una discussione a livello europeo dopo il voto sullo stop alle auto endotermiche dal 2035. Che ruolo possono avere secondo lei?
Partiamo dal presupposto che il nemico da contrastare responsabile dei cambiamenti climatici è la CO2, non l’auto con motore a combustione interna. È dunque fondamentale che per perseguire la neutralità climatica, assicurando il principio della neutralità tecnologica e dunque anche tutelando le nostre filiere nazionali, debba proseguire il sostegno ai carburanti low carbon come i biocarburanti, tra cui il biometano, che, come alternativa ai carburanti fossili, rappresentano già oggi una risposta efficace per la mobilità sostenibile. Il loro ruolo sarà decisivo per la decarbonizzazione dei trasporti. Mi auguro pertanto che, come i carburanti sintetici (e-fuel), possano essere impiegati anche dopo il 2035.
GSE svolge un ruolo rilevante anche nella programmazione energetica del Paese. Quali sono le priorità su cui lavorare secondo lei?
Il ruolo di decisore spetta al Governo. Tuttavia, il GSE, che fa parte sia del Sistema Statistico Nazionale ed è responsabile della produzione dei dati statistici nazionali sugli impieghi di fonti rinnovabili, fornisce al Governo tutte le informazioni ed i dati necessari per costruire un quadro chiaro della situazione energetica del Paese. Inoltre, assicuriamo il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi intermedi e al 2030 del PNIEC, elaboriamo scenari, studi economici e modelli previsionali nel campo energetico e

ambientale.
Detto questo, l’ambito energetico, in piena fase di transizione, è orientato verso un paradigma differente da quello a cui siamo stati abituati. La spinta della “RED II” sull’autoconsumo e sulla condivisione dell’energia, ad esempio, vedrà lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili che, autosostenendo i propri consumi, alleggeriranno la dipendenza energetica italiana dalle fonti fossili e dai fornitori esteri.
L’attuazione del PNRR passa anche dal GSE. A che punto siamo?
Il GSE svolge un ruolo di primo piano nel PNRR, in quanto è stato designato come soggetto attuatore delegato per diverse misure finalizzate ad accelerare la transizione energetica e a garantire una corretta allocazione delle risorse stanziate. In primis, per lo sviluppo del teleriscaldamento, il cui bando ha messo a disposizione 200 milioni di euro. Durante la fase di gestione, abbiamo ricevuto domande per un risparmio equivalente previsto di circa 73.000 Tep/anno. Il GSE è soggetto attuatore anche della misura “Parco Agrisolare” con uno stanziamento complessivo di 1,5 miliardi di euro. Abbiamo poi la misura dedicata allo sviluppo del biometano di cui è in corso il primo bando. L’obiettivo della
misura, sostenuta con 1,73 miliardi di euro, è quello di raggiungere, entro il 31 dicembre 2023, una produzione aggiuntiva di biometano pari ad almeno 0,6 miliardi di metri cubi e, entro il 30 giugno 2026, a 2,3 miliardi di metri cubi. E siamo pronti per gestire le misure dedicate allo sviluppo delle comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo, sostenute con 2,2 miliardi di euro e quella dell’agrivoltaico finanziata con 1,1 miliardi di euro.
Che ruolo immagina per il GSE dei prossimi anni?
Decisamente quello di continuare a supportare il Governo nella crescita economica del Paese. L’obiettivo, oltre a favorire la decarbonizzazione e l’elettrificazione dei consumi, è quello di collaborare sempre più attivamente nel rafforzare l’economia nazionale attraverso stimoli volti alla crescita del settore energetico e ai nascenti settori ad esso collegati. Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, inoltre, questi stimoli dovranno essere orientati anche alla creazione di una solida rete di protezione che sia in grado di ridurre l’impatto delle fluttuazioni del mercato energetico su famiglie e imprese. Un rischio, quello di indebolire le attività del tessuto produttivo italiano a causa del costo dell’energia, che dobbiamo impegnarci a ridurre.
Gli ultimi due anni sono stati un banco di prova per la tenuta energetica dell’Europa. Come giudica quanto fatto sinora?
Il tema energia è un punto centrale per lo sviluppo e la stabilità dell’Europa e quindi su di esso si è misurata la tenuta dell’intero sistema della UE che ha rischiato di vacillare sotto i colpi delle vicende di questi ultimi mesi. È chiaro che la sfida di realizzare una autonomia energetica oggi più che mai è il presupposto per una autonomia politica, soprattutto rispetto ad autocrazie come la Cina o agli Stati autoritari di Africa e Medio Oriente. L’Europa avrebbe potuto e dovuto agire prima e meglio ed ha dimostrato poca capacità reattiva e decisionale su temi come gli acquisti congiunti di gas o sul price cap.
E sul PNRR?
È positivo che la Commissione abbia finalmente aperto alla modifica del PNRR e alla possibilità di poter attingere a tali fondi per aumentare la produzione energetica nazionale così come chiesto dal Governo italiano.
Partiamo dal presupposto che noi non abbiamo mai messo in discussione l'obiettivo finale della decarbonizzazione. Sosteniamo, però, che gli obiettivi dettati dalla UE debbano essere perseguiti attraverso una transizione sostenibile sia economicamente che socialmente
Non si può non tenere conto della crisi geopolitica ed energetica in cui l’Europa è piombata rispetto al momento in cui è stato formulato.
Sui temi ambientali l’Europa in questi ultimi anni ha prodotto un coacervo di norme non sempre coerenti ed utili allo scopo. Anzi, spesso hanno avuto ricadute negative sulla nostra industria in termini di perdita di competitività rispetto alle altre economie del mondo. Secondo lei è un processo irreversibile o si può fare qualcosa per invertire questa tendenza?

Partiamo dal presupposto che noi non abbiamo mai messo in discussione l'obiettivo finale della decarbonizzazione. Sosteniamo, però, che gli obiettivi dettati dalla UE debbano essere perseguiti attraverso una transizione sostenibile sia economicamente che socialmente. L’intero pacchetto del Green Deal è invece ispirato a misure di impronta ideologica, fatto senza guardare alle conseguenze reali sulla vita dei cittadini. Deve essere lasciata la libertà agli Stati di percorrere la via che reputano più efficace e sostenibile. C’è il tempo e lo spazio per evitare tutto questo, programmando una transizione energetica più ragionata e condivisa, investendo di più in ricerca ad esempio.
Dall’Europa è arrivato il via libera finale allo stop alla vendita di veicoli a benzina o diesel dal 2035 ma solo dopo che la Germania ha ottenuto quello che chiedeva sugli efuel.
Dall’accordo sono rimasti fuori i biocarburanti che invece chiedeva l’Italia. Alcuni hanno parlato di sconfitta per l’Italia. Che idea si è fatto in proposito?
Chi parla di una sconfitta, forse non ha seguito bene questo caso. Parlerei, invece, di importante e opportuno lavoro da parte del Governo italiano che, come ho avuto modo di affermare, ha aperto gli occhi all’Europa sulle pesanti conseguenze dello stop. A differenza di quanto avvenuto quasi sempre in questi anni, la UE non ha potuto far finta di nulla davanti a preoccupazioni che hanno fornito l’opportunità per una discussione più approfondita e un’analisi più completa delle questioni coinvolte. Soltanto a seguito di ciò la Germania ha ottenuto quello che chiedeva sugli e-fuels.

Ora la Commissione è chiamata a dare seguito all’impegno preso con la Germania. Il Governo italiano ha già detto che si adopererà affinché anche i biocarburanti possano rientrare nella categoria dei combustibili carbon neutral. Come pensate di riuscire a convincere la Commissione a farlo visto come sono andate le cose sinora?
Sono convinto che la partita non sia ancora definitivamente chiusa. È vero che c’è stata una votazione, ma è altrettanto vero che c’è uno step intermedio di revisione dei parametri al 2026. Sono certo che si possono riaprire le porte alla proposta italiana di inserire i biocarburanti. È anche una questione di buon senso. Non dimen-
tichiamo che tra poco più di un anno ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e molti equilibri potrebbero cambiare. Posso garantire che Fratelli d’Italia e il gruppo dei Conservatori a Bruxelles continueranno a battersi per cambiare contenuti, tempi e modalità di attuazione di questo provvedimento. Su argomenti tangibili e concreti dobbiamo avviare una trattativa per modificare la linea imposta dalla Commissione europea.

Nel presentare a febbraio il Green Deal Industrial Plan, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che è un’opportunità unica per guidare la rivoluzione delle tecnologie pulite e garantire la leadership industriale dell'UE nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette. Molti l’hanno letta come una risposta all’Inflation Reduction Act americano che sta già attraendo molti investitori. Quali conseguenze vede?
Se questo Piano rappresenti la risposta europea all’Inflation Reduction Act non credo sia un punto centrale. Ci interessa molto di più capire modalità di attuazione e conseguenze pratiche. Il punto d’interesse è che sono previsti investimenti di carattere strategico, con l’identificazione di obiettivi per ogni settore. Occorrerà esaminare in dettaglio che tipi di investimenti saranno finanziati. Tutto questo, sottolineo ancora, non deve però avvenire con il paraocchi ideologico ma garantire concretamente che i passi neces-
sari siano fatti in modo equilibrato, senza disastrosi sconvolgimenti sul piano economico e sociale.
In questa fase storica stiamo assistendo ad un attivismo sempre più spinto dei Governi. È perché il mercato ha smesso di funzionare ed ha fatto il suo tempo oppure sui temi energetici e ambientali serve una diversa governance a livello globale? La continua e accelerata evoluzione dei sistemi economici e la complessità del quadro geopolitico stanno inevitabilmente creando ripercussioni nei rapporti tra livello governativo e produttivo. Ritengo che nella guida e gestione delle filiere strategiche e degli asset fondamentali di una nazione sia importante una pianificazione strategica complessiva in carico ai Governi. Considerando poi livelli di governance che vanno oltre il singolo Stato, la stessa Europa, in alcuni settori fondamentali come l’energia e la sostenibilità, è chiamata a definire politiche comuni, ma deve sempre farlo nel rispetto delle esigenze e peculiarità delle nazioni che la compongono. La tematica investe questioni complesse di carattere geopolitico di cui i Governi devono tenere conto per evitare che sia solo il mercato a decidere su questioni strategiche che hanno ripercussioni fondamentali sulla vita dei cittadini.
Nel 2024 ci saranno le elezioni europee. Cosa si aspetta?
Abbiamo l'ambizioso progetto di di-
Un progetto che ci porta a condividere anche con il Ppe una visione della Ue maggiormente rappresentativa, specie su alcuni temi di fondo. Un'Europa confederale, in sostanza, con obiettivi comuni in politica estera, cultura, difesa, ma che non violi la sovranità delle Nazioni che la compongono
segnare una nuova governance della UE, che veda alla guida un asse diverso rispetto all’attuale maggioranza del Parlamento europeo. In questo senso l’Italia e il governo Meloni rappresenta un riferimento, direi un apripista. Non solo per quanto sta avvenendo a livello politico in Stati come Svezia e Finlandia, ma anche rispetto a quanto potrà accadere nei prossimi mesi negli appuntamenti elettorali in Spagna e Polonia. Il nostro percorso come partito dei Conservatori europei (ECR) è di apertura ad alleanze con chiunque condivida i principi fondativi dell'Ue, principi che maggioranze troppo schiacciate a sinistra hanno via via deformato. Un progetto che ci porta a condividere anche con il Ppe una visione della Ue maggiormente rappresentativa, specie su alcuni temi di fondo. Un'Europa confederale, in sostanza, con obiettivi comuni in politica estera, cultura, difesa, ma che non violi la sovranità delle Nazioni che la compongono. Questa è l’Europa che vogliamo costruire oggi e soprattutto con il 2024.
In questa seconda puntata de “L’energia spiegata”, Salvatore Carollo ripercorre la storia della formazione dei prezzi del petrolio che sono passati per diverse fasi. Prima sotto il controllo dei Paesi produttori, poi della finanza e ora della geopolitica. Un mercato che in realtà è meno libero di quello che appare.
Immaginiamo una nave che trasporta un milione di barili di petrolio dal Golfo Persico verso gli Stati Uniti e volessimo sapere quale prezzo è stato pagato al produttore, verrebbe quasi spontaneo prendere una rivista specializzata (Platts, Argus, ecc.,) e leggere il valore del Brent pubblicato per quel giorno. Assumiamo di leggere un valore del Brent Dated di 80 dollari/barile. Possiamo dire che quello è il prezzo del nostro carico? Per chiarire questo concetto vale la pena di ricordare la formula di base con cui si calcola il prezzo di ogni singolo tipo di petrolio commercializzato nel mondo:
P (singolo carico) = P (Benchmark) +/- Δ (Differenziale di qualità)
Ovvero, il prezzo di un carico deriva dalla somma algebrica del valore del cosiddetto benchmark e di un differenziale commerciale che stima l’effetto dovuto alla diversa qualità di ogni singolo greggio rispetto a quello usato come benchmark. Questo differenziale può assumere valori importanti, perché in esso spesso incorpora i risultati di negoziati commerciali collaterali. La sua esistenza fa impazzire gli studiosi di econometria, che non riescono ad elaborare modelli di previsione del prezzo del petrolio visto che i modelli econometrici, pur essendo strumenti importanti nella
Da allora, nessuno seppe come fissare il prezzo dei carichi in vendita o in acquisto: senza un benchmark, la formula del prezzo scritta nei contratti non aveva più alcun valore legale. Occorreva una soluzione urgente, ma senza Arabia Saudita non c’era modo di averla
formulazione delle politiche economiche, scontano limiti intrinseci. Ricordo che nel corso di una tavola rotonda, all’interno di una Conferenza organizzata dal Ministero dell’Energia norvegese, mi trovai a discutere con il capo dell’ufficio studi della Banca d’Inghilterra e con un emerito professore di econometria dell’Università di Chicago. Erano furiosi perché Compagnie e Paesi produttori non si mettevano d’accordo su un unico valore giornaliero del prezzo del petrolio, azzerando il differenziale di qualità, da loro ritenuto un inutile disturbo per i loro modelli. Nella formula del prezzo la variabile fondamentale è quella del valore del benchmark, ovvero dell’entità che viene presa come riferimento da tutti i soggetti coinvolti nel processo di commercializzazione del petrolio a livello mondiale. Oggi, questo valore, salvo alcune eccezioni, è costituito dal cosiddetto Brent Dated, che sarebbe, teoricamente, il prezzo giornaliero di un carico fisico di greggio Brent prodotto nel Mare del Nord. Non è stato sempre così. Fino all’agosto del 1985 il benchmark del mercato petrolifero universalmente accettato era l’Arabian light, greggio saudita la cui produzione era di circa 5 milioni barili/giorno. Il suo prezzo veniva pubblicato congiuntamente dai paesi OPEC durante la loro Conferenza annuale e rimaneva fisso per l’anno in corso. I vari paesi OPEC e non-OPEC produttori di altri greggi potevano soltanto definire, in accordo con l’andamento dei mercati, il valore del differenziale di qualità dei loro singoli greggi.
Il processo che porterà all’abbandono dell’Arabian light e alla scelta del Brent Dated come benchmark si avvia nel 1982, quando la guerra Iran-Iraq sembrava ridimensionata a semplice conflitto regionale senza alcun effetto sulle esportazioni dal Golfo Persico. Inizia in quel momento l’operazione

di riduzione del gigantesco volume di scorte petrolifere che erano state accumulate dall’inizio del conflitto, che si tradusse nella decisione dell’Opec di ridurre la produzione, almeno per un anno. Nonostante gli accordi raggiunti per ripartire tale diminuzione fra i vari Paesi membri, alla fine il peso reale del taglio di produzione finì col gravare soltanto sull’Arabia Saudita, costretta a farlo per difendere il valore del benchmark sui 34 dollari/barile. Dal 1982 al 1985 la produzione dell’Arabia Saudita scese da 11 a 2,6 milioni di barili/giorno. Raggiunto il valore minimo al di sotto del quale non era possibile nemmeno garantire la continuità tecnica della produzione, il ministro Yamani, a fine agosto 1985, fece la dichiarazione che creò uno shock nel mondo intero: l’Arabia Saudita non avrebbe più pubblicato il prezzo dell’Arabian light (che quindi non sarebbe stato più il benchmark mondiale del petrolio) e non avrebbe più svolto il ruolo di “swing producer” per difendere il livello dei prezzi.
La fine di un’epoca
Da allora, nessuno seppe come fissare il prezzo dei carichi in vendita o in acquisto: senza un benchmark, la formula del prezzo scritta nei contratti non aveva più alcun valore legale. Occorreva una soluzione urgente, ma senza Arabia Saudita non c’era modo di averla. Un passo avanti fu fatto nei primi giorni di settembre, quando Yamani, durante una conferenza stampa ad Oxford, spiegò che per i greggi arabici il nuovo prezzo si sarebbe basato sul meccanismo del “net-back”. Ovvero, un prezzo fissato su un calcolo a ritroso a partire dai ricavi finali dei raffinatori e la garanzia di un margine di raffinazione garantito. Nel giro di qualche mese, l’Arabia Saudita riprese il suo livello di produzione intorno ai 6 milioni di barili/giorno. Non tutti realizzarono subito quanto era accaduto. L’Arabia Saudita aveva
risposto alla sfida dei paesi del Mare del Nord mettendo in opera le condizioni del “libero mercato petrolifero” tanto voluto da Mrs. Thatcher: fu il primo vero scontro geopolitico per il controllo del mercato petrolifero mondiale. Nel tentativo di trovare un rimedio alternativo al disordine innescato da Yamani, nel luglio del 1986, la Shell UK lanciò il contratto forward del Brent (15 days Brent), che creava un mercato dove ogni carico “fisico” previsto in produzione nei sei mesi successivi poteva essere comprato e venduto sulla base di un contratto standard. In pratica, nasceva un mercato in cui ogni carico (fisico, reale) di Brent passava di mano migliaia di volte al giorno, creando una liquidità “equivalente” (in termini di transazioni complessive) di circa 40 milioni di barili/giorno, superiore alla produzione complessiva dei paesi Opec. Il passaggio al Brent come il nuovobenchmark del petrolio. Non fu però immediato. Senza avere più uno swing producer e con l’accelerazione impressa dal meccanismo del net-back pricing, il mercato fu presto inondato sia di prodotti finiti che di greggi e nei primi mesi del 1987 il prezzo crollò a 11 dollari/barile. Fu un disastro sia per tutti i produttori offshore, inclusi quelli del Mare del Nord, sia per i produttori marginali americani (strippers), obbligati a fermare i loro pozzi. Il crollo avvenne proprio a distanza di pochi mesi dall’avvio del nuovo mercato forward del Brent, con il risultato che traders che avevano acquistano carichi per i mesi successivi a prezzi superiori a 30 dollari/barile si trovarono obbligati a ritirare al terminale un carico fisico di 500.000 barili a 11 dollari/barile. Centinaia di traders chiusero la loro attività e sparirono da Londra senza onorare i loro impegni finanziari. Fu chiamato il “Blood Bath” del “Black Monday”. La vittoria di Yamani era totale. L’arroganza dei produttori non-Opec del Mare del Nord era stata punita. Come pure la furbizia dei Paesi Opec che, sottobanco, continuavano a produrre più greggio delle quote stabilite, scaricando solo sull’Arabia Saudita il peso della difesa del benchmark. Il Mondo si mobilitò per chiedere all’Opec di tornare al prezzo fisso con l’Arabian light, cosa che accadde nel 1988. Mentre il mondo petrolifero si stava nuovamente stabilizzando, la City di Londra lanciò una nuova sfida nella battaglia per il controllo del mercato petrolifero mondiale. A luglio del 1988, l’IPE (International Petroleum Exchange) lanciò il “Brent Future”, un contratto puramente finanziario che
scimmiottava quello del WTI americano, ma con una differenza: creava un mercato petrolifero senza petrolio. Si voleva in questo modo eliminare totalmente il rischio che i traders coinvolti nel sistema delle transazioni “paper”
La maggior parte dei traders che giocano con i future non sono in grado di gestire un carico fisico. Fu allora necessario creare un mercato “a futuri” completamente staccato da quello forward fisico, facendo però finta che i due mercati coincidessero e rispondessero alle stesse dinamiche
Brent crollò a 9 dollari/barile. L’eccesso potenziale di offerta era troppo grande per stabilizzare i prezzi. Lo sviluppo degli scenari geopolitici nell’area del Golfo evitò la nuova guerra dei prezzi. L’evoluzione dei prezzi fu, infatti, legata alla sequenza degli eventi drammatici che si susseguirono e che determinarono il taglio di importanti quote di produzione. Prima l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq e poi le sanzioni all’Iraq, che andarono avanti per tutti gli anni ’90, crearono il supporto al prezzo del petrolio che si stabilizzò sopra il 20 dollari/barile. A partire dal 2000, la spinta al rialzo del prezzo venne dall’introduzione di norme ambientali che fecero ridurre pesantemente l’offerta della nuova benzina riformulata.
potessero restare intrappolati nella gestione di un carico fisico di Brent, come era avvenuto nella crisi del 1987. Nasceva un mercato virtuale dove si parlava di barili e di Brent senza mai materializzarli. Ma quali sono le differenze tra il mercato futures del Brent e quello del WTI? Nel NYMEX, borsa petrolifera di New York, si comprano “a futuri” slot di 1.000 barili di greggio WTI per consegna fisica a Cushing (Oklahoma) nei dodici mesi successivi. Se il trader non intende ritirare i barili fisici, li può vendere al prezzo del giorno di consegna al gestore del sistema di stoccaggio di Cushing. Con il Brent questo non è possibile. La consegna del greggio fisico avviene come carico da 500-600.000 barili al terminale di Sullom Voe, nelle Shetland Island. La maggior parte dei traders che giocano con i future non sono in grado di gestire un carico fisico. Fu allora necessario creare un mercato “a futuri” completamente staccato da quello forward fisico, facendo però finta che i due mercati coincidessero e rispondessero alle stesse dinamiche. Una finzione che ancora oggi appanna la vista di molti economisti e giornalisti, che parlano indistintamente di Brent senza distinguere fra i vari mercati. L’Opec reagì pesantemente alla nascita di questo mercato e, nel dicembre 1988, prese la storica decisione di abbandonare definitivamente l’Arabian light come benchmark, sostituendolo con il Brent. Era la risposta alla nuova sfida della City e del Mare del Nord ed avrebbe dovuto aprire una nuova guerra dei prezzi. Senza un accordo con e dentro l’Opec, ognuno si ritenne libero di produrre quello che voleva, “come in un libero mercato”. In poche settimane, il prezzo del
La nascita dell’IPE futures Brent (sviluppatosi poi nel più globalizzato ICE Brent) determinò un cambiamento strutturale del mercato petrolifero internazionale, modificando in modo radicale soggetti e meccanismi di formazione del prezzo del petrolio. Fu una vera rivoluzione. Paesi produttori e compagnie petrolifere divennero soggetti marginali del mercato, le cui leve stavano in mano quasi esclusivamente alle grandi Istituzioni finanziarie del mondo. In pochi anni il cosiddetto mercato petrolifero finanziario raggiunse livelli di liquidità stratosferici, dell’ordine di 2-3 mila miliardi di dollari/giorno, più del Pil di alcuni paesi industrializzati. Era diventato possibile spostare centinaia di miliardi di dollari dal “petrolio” ad altre commodities e viceversa in meno di un’ora, determinando variazioni importanti nei prezzi di questi beni. Vedere il prezzo del petrolio salire e scendere di 5-10 dollari/barile nel corso di una giornata senza che nulla fosse cambiato nel rapporto domanda/offerta di greggio fisico, era ormai la nuova normalità. Dal 1988, non c’è stata più la ricerca di soluzioni alternative. L’Opec praticamente scomparve dalla scena, almeno fino ai giorni nostri, quando ha assunto una nuova centralità dando vita all’Opec Plus. Forse il grafico seguente può dare un’idea visiva della nuova dimensione del mercato petrolifero internazionale e delle dinamiche che muovono i prezzi del petrolio. In questo nuovo contesto globalizzato e finanziarizzato, l’equilibrio domanda-offerta di greggio fisico diventa una variabile secondaria del sistema complessivo del mercato.
Solo per fare un esempio, il crollo di 110 dollari/barile del prezzo del petrolio nel 2008 avvenne mentre il bilancio domanda-offerta non aveva subìto nemmeno la variazione di un barile fisico. Come pure le grandi manovre speculative in occasione della crisi libica e delle sanzioni europee all’Iran, avvenute in contro tendenza rispetto
impianti di raffinazione perpetuando la crisi fino a farla diventare dirompente. La nascita dell’Opec Plus, in questo nuovo quadro, sta determinando, più che diverse dinamiche sull’andamento del prezzo del petrolio, aggiustamenti negli equilibri geopolitici fra le varie aree del Mondo. Su base diversa, sembra una ripresa della guerra di Yama-
ICE -> Datato)
Produttori “Petrolio” Prezzo
Istituti Finanziari
Altre merci o investimenti
Mercato del petrolio greggio

Margine raffineria
Prezzi prodotti Consumatori Prodotti mercato Sistema di Raffinazione
alla logica dei fondamentali. Per oltre vent’anni, le dinamiche del mercato petrolifero sono state dettate dalle logiche dei mercati finanziari che ruotavano intorno alla mono-variabile del Brent “paper” e non più alle dinamiche più complessive dei mercati fisici. La prima grande vittima di questo mutamento è stata l’industria della raffinazione. Lo sviluppo dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei margini di raffinazione erano assolutamente al di fuori del perimetro di interesse (salvo qualche gioco su alcuni derivati specifici secondari) degli operatori finanziari.
Vince la geopolitica
Oggi cominciamo a renderci conto che il castello che abbiamo costruito e che abbiamo chiamato “libero mercato del petrolio” in realtà non è libero e si è sviluppato calpestando, spesso, le leggi fondamentali dell’economia. Ci accorgiamo di non essere più in grado di trasformare “tutta” la produzione di materia prima nei prodotti finiti di cui abbiamo bisogno e soprattutto non siamo in grado di garantire la qualità che le esigenze ambientali ci richiedono. Il sistema è talmente fuori controllo da non essere in grado di mettere in moto i meccanismi di feedback naturali dei sistemi economici del libero mercato. Nonostante le tensioni sui mercati dei prodotti finiti, non si investe più negli
ni, in termini nuovi e contemporanei, per il controllo dei mercati energetici. Come Paese stiamo vivendo questa fase storica da puri spettatori, spesso nemmeno consapevoli. Abbiamo vissuto quasi con indifferenza la crisi del prezzo del gas, accettando in modo rassegnato un rialzo strutturale del prezzo con tutte le conseguenze sul costo dell’energia nazionale. Ci siamo poi inventati un piano Mattei per l’Africa, che nessuno ha ancora
riempito di contenuti e di cui nessuno ha descritto i futuri benefici per il paese. Mattei determinò in modo concreto e misurabile il rifornimento di energia a basso costo, che divenne il motore del boom economico del dopo guerra. Il tutto era incentrato sul ruolo della raffinazione nazionale e sul sistema di imprese italiane di progettazione, ingegneria ed impiantistica. Il piano odierno è ancora un oggetto misterioso. Forse occorrerebbe rivisitare il progetto “Interdipendenza Euro Araba” che l’Eni di Marcello Colitti, insieme all’allora Professore di Bologna Romano Prodi, elaborarono insieme ai paesi del Golfo sul tema della cooperazione energetica ed economica. Purtroppo, il livello culturale della nostra classe dirigente non permise di comprendere le potenzialità del progetto e lo fece morire prima di nascere. Oggi sembra di essere nella stessa situazione.
Oggi cominciamo a renderci conto che il castello che abbiamo costruito e che abbiamo chiamato “libero mercato del petrolio” in realtà non è libero e si è sviluppato calpestando, spesso, le leggi fondamentali dell’economia. Ci accorgiamo di non essere più in grado di trasformare “tutta” la produzione di materia prima nei prodotti finiti di cui abbiamo bisogno e soprattutto non siamo in grado di garantire la qualità che le esigenze ambientali ci richiedono
I tre mercati del petrolio
800+ milioni b/g 2000 miliardi USD/giorno
50 milioni b/g
25 milioni b/g
Eni lancia HVOlution sulle prime 50 stazioni di servizio
Dallo scorso mese di febbraio su 50 stazioni di servizio a marchio Eni è in vendita il biocarburante HVOlution, il primo diesel di Eni Sustainable Mobility prodotto con 100% di materie prime rinnovabili. L’obiettivo è di arrivare a marzo 2023 a 150 punti vendita. HVOlution, si legge in una nota, è un biocarburante che viene prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, e da olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare. La tecnologia proprietaria Ecofining™ consente, infatti, di trattare materie prime vegetali di scarto e olii non edibili per produrre biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) di cui Eni Sustainable Mobility è il secondo produttore in Europa.
Eni e Saipem, accordo sui biocarburanti
Eni Sistainable Mobility e Saipem hanno firmato un accordo con l’obiettivo di utilizzare carburanti di natura biogenica sui mezzi navali di perforazione e costruzione di Saipem. In base all’accordo, Eni metterà a disposizione le proprie conoscenze per fornire soluzioni per la riduzione delle emissioni di carbonio e Saipem aumenterà l’uso di carburanti alternativi sui propri mezzi, confermando così l’impegno di entrambe le società nella diversificazione delle fonti energetiche e nella riduzione dell’impronta carbonica all’interno delle operazioni offshore.
Iplom aderisce all'iniziativa Italia Loves Sicurezza
La struttura HSE della Raffineria Iplom di Busalla ha aderito all'iniziativa Italia Loves Sicurezza organizzando un ciclo di cinque eventi con l'Istituto Comprensivo Primo Levi, che contribuisce a far nascere la sensibilità sui temi di sicurezza, ambiente, e sostenibilità nei giovani di oggi.
Itelyum: accordo preliminare con Petrokan per acquisizione Secomar e Ambiente Mare
Itelyum, leader nazionale e player internazionale nella gestione, riciclo e valorizzazione dei rifiuti, ha concluso un accordo preliminare per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza di Secomar S.p.A. e di Ambiente Mare S.p.A. Con questa operazione, informa una nota, Itelyum intende rafforzare la propria posizione nel settore dei rifiuti e della gestione ambientale nell’ambito portuale. Itelyum, già protagonista di questo comparto nel porto di Trieste, estende la presenza al porto di Ravenna dove operano Secomar e Ambiente Mare, consolidandosi così nei servizi portuali e marittimi nell’Adriatico. Nello specifico, Secomar svolge attività di prevenzione, pulizia e bonifica dell'acque marine, oltre che raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti liquidi prodotti dalle navi; Ambiente Mare possiede e gestisce un impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali, oli e fanghi, pericolosi e non pericolosi. L’acquisizione delle società target si perfezionerà con il closing nei prossimi mesi.
Per offrire al mercato soluzioni a basse emissioni di carbonio, NextChem e la sua controllata MyRechemical (Gruppo Maire Tecnimont) hanno firmato un accordo con l'olandese Dimeta per esplorare nuove opportunità di sviluppo di impianti per la produzione di dimetiletere (DME) di carbonio rinnovabile e riciclato dai rifiuti. Questo prodotto, si legge in una nota, grazie alle sue proprietà simili al GPL, può essere miscelato con il GPL convenzionale, contribuendo così a ridurre l'impronta di carbonio senza modificare le apparecchiature o le infrastrutture tipiche del GPL. Dimeta è una joint venture olandese tra SHV Energy e UGI International ed è stata fondata per sviluppare la produzione e l'uso di DME rinnovabile e riciclato ed accelerare la transizione dell'industria del GPL verso il Net Zero. L'organizzazione ha l'ambizioso obiettivo di produrre 300.000 tonnellate di DME rinnovabile e riciclato entro la fine del 2027, creando impianti nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.
Neste e Ryanair ampliano la collaborazione per decarbonizzare il trasporto aereo
Neste e Ryanair hanno annunciato una partnership per alimentare circa un terzo dei voli sull’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS) con il 40% di miscela SAF. Questa miscela, informa una nota, ridurrà le emissioni di gas serra di oltre il 60%, supportando gli obiettivi di decarbonizzazione di Ryanair Pathway to Net Zero by 2050. Neste, principale produttore mondiale di carburante sostenibile per l'aviazione, sta attualmente aumentando la sua capacità produttiva annuale SAF a 1,5 milioni di tonnellate all'anno entro la fine del 2023 con investimenti in corso nelle sue raffinerie di Singapore e Rotterdam.
Neste e
Grazie a una cooperazione strategica tra Q8 e Neste, gli operatori del settore dei trasporti pesanti potranno acquistare Neste MY Renewable Diesel™ presso nove stazioni Q8 in Danimarca. L'obiettivo della collaborazione tra Q8 e Neste è consentire al settore dei trasporti pesanti in tutta la Danimarca di ridurre le emissioni.
Sarlux ha portato la propria testimonianza al seminario “Behavior-Based Safety (B-BS): la sicurezza sul lavoro basata sui comportamenti. Metodologie per la prevenzione del rischio-infortuni sul lavoro”. L’iniziativa, che ha visto una numerosa partecipazione delle imprese dell’hinterland cagliaritano, fa parte di un Piano Territoriale di più ampio respiro, proposto da Confindustria Meridionale a istituzioni, enti, associazioni e imprese, che prevede una serie di azioni congiunte per lo sviluppo del territorio.
Sonatrach Raffineria Italiana e Sasol Italy hanno presentato il Progetto Hybla, un impianto innovativo per la produzione di idrogeno e syngas low carbon in grado anche di catturare e riutilizzare la CO2 e contribuire al processo di decarbonizzazione dei due siti (con una riduzione di emissioni di CO2 pari a circa 120 mila tonnellate all'anno). Il Progetto Hybla, spiega una nota, può rappresentare un passo di estrema rilevanza per accelerare la creazione di una Valle dell’Idrogeno nella Regione Siciliana, con la potenzialità di essere fra le più grandi presenti in Italia. Un territorio che si distingue, da un lato, per il suo grande potenziale in materia di fonti rinnovabili e, dall’altro, per la sua posizione strategica.
TotalEnergies, primo pieno di biocarburante a una nave nel Mediterraneo
TotalEnergies Marine Fuels e Corsica Sardinia Ferries hanno reso noto di aver completato con successo la prima operazione di bunkeraggio di biocarburante nel Mediterraneo dal porto francese di Tolone. Una nota informa che 100 tonnellate di biocarburante composto da gasolio (Mgo) e da un 30% di biomolecole (Fame – estere metilico di acidi grassi di seconda generazione) prodotte da oli da cucina esausti e certificate Iscc, sono state consegnate via camion alla nave ro-ro Mega Express Two. Secondo una stima well-to-wake, questo biocarburante offre una riduzione di circa il 20% delle emissioni di gas serra rispetto al carburante marino convenzionale.


Il presidente dell'Unione energie per la mobilità, Claudio Spinaci, assicura che l'embargo ai prodotti russi non causerà un aumento dei prezzi dei carburanti. «L'Italia da questo punto di vista è il paese meno esposto, e già da luglio 2022 ha praticamente ridotto a zero gli arrivi dalla Russia. Questo perché abbiamo un'industria dalla raffinazione in grado di soddisfare ampiamente la domanda interna e minimizzare gli impatti sui prezzi». Non è un caso, specifica, se abbiamo i prezzi industriali (al netto delle tasse) tra i più bassi d'Europa (sulla benzina siamo al 19° posto, sul gasolio al 23°). Una posizione avvantaggiata rispetto al resto dell'Europa, per cui le compagnie petrolifere tornano a ragionare sul «lungo termine», immaginando una lunga vita per il petrolio proprio nel momento in cui l'invasione dell'Ucraina sembra avere messo in crisi tutto.
Mentre l'incertezza legata all'Ucraina continua, da un punto di vista reputazionale le raffinerie riguadagnano terreno. Gli asset, che sembravano ormai avviati alla chiusura o alla conversione in tutta Europa, hanno ricominciato a essere attraenti per il mercato, e non solo in un'ottica geopolitica, visto che sono piccoli presidi internazionali nei paesi in cui operano. Come il mercato, anche il governo Meloni ha ricominciato a vedere come strategici questi impianti. Una situazione che Spinaci testimonia in prima persona per la categoria: «Abbiamo già avuto modo di confrontarci e devo dire che ho trovato interlocutori attenti e interessati». Quello che conta, conclude, «è salvaguardare l'integrità industriale di un settore strategico».
Quello che sta succedendo in Europa ha dell'incredibile. Si continua perseverare nell'errore di confondere gli obiettivi con gli strumenti», attacca Claudio Spinaci, presidente di Unem molto critico con lo stop ai motori diesel e benzina deciso dall'Unione europea per il 2035. «È solo una scelta ideologica, che oltre alla filiera dell'auto produrrà un impatto occupazionale molto forte anche sul nostro settore, che tra addetti diretti e indiretti occupa 150 mila persone», spiega. A suo parere, infatti, «decarbonizzare non significa necessariamente elettrificare tutti i trasporti. In questo modo non ci avviciniamo all'obiettivo, ce ne allontaniamo, tra l'altro con impatti economici e sociali devastanti. Sono anni che avvertiamo sui rischi di questa escalation dirigistica che punta a vietare ogni modalità di trasporto che non sia elettrica. Si è cominciato con le auto, ora tocca ai camion e poi sarà la volta di aerei e navi. Mi stupisce il fatto che solo ora qualcuno cominci a rendersene conto. Spero non sia troppo tardi e che il Governo italiano possa opporsi in qualche modo».
Secondo voi come andrebbe affrontata la questione della decarbonizzazione, che comunque visti i disastri meteo-climatici resta un obiettivo irrinunciabile...
«Che sia irrinunciabile siamo perfettamente d'accordo. Quello che abbiamo sempre contestato è l'approccio dirigistico e unilaterale che ha scelto l'Europa. Eppure, ci sarebbero strade più sicure ed efficaci per arrivare allo stesso risultato, come i carburanti a basso o nullo contenuto di carbonio (LCF). Se l'obiettivo è decarbonizzare i trasporti, allora perché rinunciare a priori a tecnologie in grado di dare un contributo concreto”.
Una richiesta che avanza l'Italia è proprio quella di puntare sulla neutralità tecnologica. Quella dei biocarburanti è una strada praticabile di qui al2035?
«Certo. Recentemente abbiamo presentato uno studio che dimostra come l'obiettivo si possa raggiungere, in modo più sostenibile economicamente e socialmente, con una più realistica penetrazione del vettore elettrico e una valorizzazione dei Low Carbon Fuels (LCF), di cui fanno parte i biocarburanti, oggi esclusi dai piani europei. Carburanti "neutri" in quanto non aggiungono emissioni in atmosfera perché in fase di impiego emettono quanto assorbito in fase di produzione, che è poi l'obiettivo degli accordi di Parigi che puntano ad "emissioni zero nette".
Che vantaggi avremmo?
«Sarebbero significativi ed immediati perché sono prodotti impiegabili nel parco auto in circolazione: prodotti in grado di abbattere fino al 100% le emissioni di CO2 dei trasporti se calcolate sull'intero ciclo di vita. Anzi, in alcuni casi, il saldo diventa addirittura negativo. Oggi in Europa circolano circa 300 milioni di auto di cui il 98,6% sono dotate di un motore a combustione interna e solo l’1,4% sono elettriche pure, concentrate perlopiù in alcuni paesi ad alto reddito del Nord e Centro Europa, e pensare di ribaltare questo rapporto nel giro di poco più di dieci anni è irrealistico».
L'Italia, i governi precedenti, potevano essere più determinati nel difendere l'interesse nazionale, l'occupazione in particolare? «Avrebbero dovuto fare di più per cercare di arginare la deriva ideologica della Commissione».
Biocarburanti; una delle strade della decarbonizzazione. Eppure la decisione europea di bandire i motori a combustione dal 2035, ora rimandata a data da definirsi, rischia di avere un impatto anche su questo settore dalle ampie prospettive di crescita. Secondo le previsioni dell’International Energy Agency la domanda globale di biocarburanti crescerà del 20% al 2027. Ma l'incertezza non aiuta gli investimenti. Per il presidente di Unem, Claudio Spinaci, «è evidente che tutto ciò rappresenta un freno e non certo uno stimolo per nuovi investimenti e la recente proposta della Commissione europea sul trasporto pesante rappresenta un ulteriore ostacolo. Limitare l'impiego di questi prodotti solo ai settori hard to abate non permetterà di creare le necessarie economie di scala che consentiranno di abbattere i costi e dunque i prezzi. Non si è valutato sino in fondo, o non si è voluto farlo, il fondato rischio di determinare la delocalizzazione della raffinazione europea che avrebbe invece tutte le competenze e le risorse per favorire uno sviluppo ottimale delle diverse tecnologie di produzione dei low carbon fuels (Lcf)».
«L'Europa, così come previsto dal regolamento sulla C02, che solo ora sta facendo emergere dubbi in alcuni Paesi a partire dall'Italia, dovrà definire entro il 2025 un sistema di calcolo delle emissioni climalteranti basato sull'intero ciclo di vita e valutare entro il 2026 i progressi delle singole tecnologie per introdurre eventuali modifiche all'attuale disciplina. Speriamo solo che non sia troppo tardi», condude Spinaci. Idrogeno a parte, mettendo infila esempi di progetti che interessano lo sviluppo dei carburanti rinnovabili, si toccano almeno i 9 miliardi di euro. Per impianti di co-processing e co-feeding, da realizzare nelle raffinerie per carburanti destinati a un utilizzo in miscelazione, sono necessari 2.3 miliardi di euro. Per il biometano avanzato l'obiettivo è arrivare a 6 miliardi di metri cubi. È previsto un progressivo aumento della produzione di bio-Gnl soprattutto per il trasporto pesante e marittimo; servono 45 impianti da 200 mila tonnellate annue con un investimento di oltre 1,5 miliardi. Per quanto riguarda i recycled carbon fuels, carburanti liquidi e gassosi prodotti in particolare da rifiuti non riutilizzabili, ci si aspetta prossimamente una produzione di circa 800 mila tonnellate all'anno grazie a nuovi impianti e a investimenti programmati sempre al 2030 di circa 1,5 miliardi di euro. Altri 1,5 miliardi di euro andranno nella realizzazione di impianti di produzione di bio-Gpl e 2,4 in quelli di Dimetil-Etere rinnovabile (Dme), tramite processamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani destinati a trasporti e riscaldamento.
I prezzi dei carburanti continuano a scendere e non si discostano dalle medie europee. Secondo l'ultimo bollettino del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, questa settimana la benzina è scesa in media di altri 0,4 centesimi rispetto alla precedente e il gasolio di 1,3 centesimi. Al lordo delle imposte, entrambi i carburanti si aggirano attorno agli 1,8 euro al litro, col diesel che è tornato sotto la benzina. Anche nel confronto col resto d'Europa tutto va come deve: fare il pieno in Italia costa mediamente un po' più della media Ue, ma questo dipende essenzialmente dalla componente tributaria (tradizionalmente più alta) mentre al netto delle tasse siamo sotto di duetre centesimi. Nulla da segnalare, quindi? In realtà, c'è molto da segnalare: proprio l'assenza di sorprese costituisce una notizia, visto che abbiamo speso settimane, all'inizio dell'anno, a discutere della scelta del governo Meloni di non rinnovare lo sconto sulle accise (decisione fortemente criticata dalle opposizioni) e della polemica assurda sulla speculazione dei benzinai. L'andamento dei prezzi, che si sono tenuti ben lontani dalla soglia psicologica dei due euro se non in qualche distributore isolato, conferma che Palazzo Chigi ha fatto bene a tenere duro e a privilegiare la stabilità dei conti pubblici al populismo fiscale. Ma diventa ancora più evidente quanto sia stato ingenuo l'esecutivo a prestarsi alla guerra contro i gestori degli impianti, introducendo norme (come quelle sull'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale) utili solo a scatenare le giuste proteste della categoria.
Ci sono alcune cose sulla transizione ecologica che, ogni tanto, andrebbero prese in considerazione. Prima tra tutte il fatto che la riduzione dell'anidride carbonica nell'aria è una priorità assoluta, naturalmente, ma che non dovrebbe avere nulla di ideologico. II partito del gas, quello del petrolio, quello dell'idrogeno, ora quello dell'e-fuel, non hanno prodotto i risultati attesi. Meglio sarebbe adottare un metodo nel quale la scelta sia il risultato della ricerca, delle opzioni rese possibili dalla tecnologia. Quando è scoppiata la guerra d'invasione della Russia in Ucraina, tutti ci siamo accorti di che cosa volesse dire un'Europa dipendente dal gas di Mosca per il 40%. Avere una fonte di approvvigionamento quasi esclusiva, insieme al petrolio, per il riscaldamento delle case, per l'alimentazione delle centrali e per tutti gli altri usi industriali e civili, si è rivelata una grande fragilità economica e strategica. E siamo corsi ai ripari accelerando sulla diversificazione energetica. Certo, ci è voluto un conflitto e il fatto che il prezzo del gas al metro cubo fosse esploso da 9 dollari a quasi 300 dollari. Un livello insostenibile. Una lezione che andrebbe tenuta presente anche su un altro fronte, quello della mobilità. La ricerca in Italia è molto avanti e il governo ha insistito con l'Unione europea perché non si adottasse soltanto l'opzione dell'e-fuel fortemente voluta dalla Germania, un carburante sintetico che parte dalla scissione dell'acqua e dalla ricombinazione dell'idrogeno. Come ha sottolineato ieri il ministro Adolfo Urso «solo grazie all'Italia il dialogo è stato riaperto». Qualcosa si è mosso ma, al momento, per le auto questa sarebbe l'unica alternativa al motore elettrico. Qui vale la pena ricordare che i primi veicoli elettrici non sono, come molti immaginano, le Tesla, ma risalgono all'Esposizione Universale di Parigi del 1867. Nella competizione tecnologica e produttiva, però vinse il motore a scoppio. Fu un bene per l'industria e per la mobilità, non per il Pianeta, certo. Ecco, probabilmente la via maestra sarebbe quella di lasciare più spazio alla competizione tra le tecnologie, dal momento che ormai appare evidente a tutti che bisognerà avere come priorità assoluta la riduzione di CO
2. L'Europa parla di «tecnologia neutra» ma probabilmente si dovrà lavorare ancora per renderla davvero tale.

L'Europa, è vero, ha aperto all'ipotesi di lasciare sul mercato i motori a combustione anche dopo il 2035. ma le incognite sul piatto restano molte. Per questo al momento l'approccio delle aziende della componentistica auto italiana resta molto cauto. Come sarà "normato" il tema degli e-fuel nell'allegato al Regolamento che dovrebbe arrivare in autunno? E soprattutto, si farà strada l'ipotesi di contingentare le immatricolazioni dei veicoli a motore? «Se l'Europa dovesse decidere ad esempio di limitare ad una percentuale molto bassa le auto alimentate a motore a partire dal 2035 - dice il direttore Gianmarco Giorda – allora per le imprese della filiera che si occupano di componenti per i motori a combustione il problema resterebbe irrisolto perché avremmo di fronte volumi di produzione molto limitati».
«La scelta europea sull'elettrico è ideologica. Non diciamo no, è l'autostrada per il futuro, ma diamo spazio ai motori endotermici con carburanti adeguati». Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, è intervenuto in apertura al Business Talk di Res Academy e Corriere della Sera dedicato alla transizione energetica. Il ministro ha sottolineato come l'Italia stia investendo «3,6 miliardi sull'idrogeno da cui derivano gli e-fuel» rimarcando però come la produzione di biocarburanti sia all'avanguardia nel Paese. La sfida è quindi dimostrare all'Europa che esiste un «bilanciamento» possibile sulle emissioni dei biocarburanti oltre all'accelerazione necessaria sulle rinnovabili.



L’obiettivo della Formula 1 è di arrivare alla carbon neutrality nel 2030. Intanto si parte dalle categorie minori come la Formula 2 e la Formula 3 che per la prima volta sono scese in pista con un pieno composto per il 55% da low carbon fuels.
Nel mese di marzo, il Bahrein International Circuit ha visto per la prima volta le case automobilistiche che partecipano alla Formula 2 dotare per uso competitivo i propri mezzi con l’Advanced Sustainable Fuel, come richiesto dalla Direttiva europea sulle energie rinnovabili e secondo i parametri della specifica stabilita dalla Federazione Internazionale dell’Automobile. L’obiettivo è raggiungere la totalità dell’utilizzo dei carburanti sostenibili avanzati entro il 2027, partendo da un impiego del 55% in Formula 2 e Formula 3 nel 2023, con un aumento graduale di stagione in stagione, così da pervenire al compimento della strategia di sostenibilità promossa dalla Formula 1 di diventare Net Zero Carbon entro il 2030. Alla soddisfazione di Bruno Michel, CEO di FIA Formula 2 e FIA Formula 3, per la straordinaria svolta nel motorsport segnata dall’introduzione di tali carburanti in queste categorie, si aggiunge l’entusiasmo del Presidente e CEO di Formula 1 Stefano Domenicali per il quale “lo sviluppo degli Advanced Sustainable Fuels, insieme al nostro partner globale Aramco, è un enorme passo che vedrà lo sport e l'industria automobilistica in generale muoversi verso un futuro più sostenibile”


Dello stesso avviso il CTO di Aramco
Ahmad Al-Khowaiter, che amplia l’orizzonte guardando a soluzioni pratiche che possano consentire la decarbonizzazione del settore dei trasporti nella sua totalità: dai carburanti a basse emissioni di carbonio e motori più efficienti, ai materiali all'avanguardia e alla tecnologia di cattura del carbonio.
“L'introduzione dei carburanti sostenibili avanzati approvati dal World Motor Sport Council nella FIA Formula 2 e Formula 3 è una pietra miliare significativa nel viaggio del nostro sport verso la neutralità del carbonio ed è
un elemento chiave dei nostri progressi verso l'implementazione di carburanti sostenibili al 100% in Formula 1”, ha sottolineato il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, per il quale “il nostro sport è all'avanguardia nell'offrire soluzioni innovative e proattive che hanno un enorme potenziale per il futuro di tutti i trasporti”
La Formula 1 adotterà i carburanti sostenibili avanzati a partire dalla stagione 2026, coerentemente con l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality nel 2030.
Un recente studio coordinato dal MIT di Boston ha dimostrato come sia possibile ridurre l’impronta carbonica del cemento catturando la CO2 nel cemento stesso, dando origine a quello che è stato definito “calcestruzzo multifunzionale”. Ma non è la sola sperimentazione in questo senso.
Riduzione delle emissioni di CO e immagazzinamento o utilizzo di quote di CO2 già emesse sono due aspetti dello stesso processo di contenimento dell’impatto inquinante e climalterante di tante attività e filiere. Uno degli ambiti più coinvolti è quello delle costruzioni, con specifico riferimento al cemento, che è uno dei materiali più usati al mondo e con più impatto sulle emissioni. Un gruppo di ricercatori - coordinato da Admir Masic e Franz-Josef Ulm del MIT di Boston - ha pubblicato sulla rivista statunitense PNAS Nexus i risultati di uno studio su nuovi modi di gestire la carbonatazione, un processo chimico già noto che permette di assorbire la CO2 nel cemento, legandola chimicamente, anche se finora con il rischio di indebolire la qualità del prodotto finale. Inserendo nella miscelazione che serve a produrre il cemento anche un quantitativo di bicarbonato i ricercatori hanno invece verificato che la tenuta finale del cemento non viene modificata. Entrando un po’ più nel tecnico, la produzione di cemento comporta il rilancio di grandi quantità di carbonio, sia come effetto delle quantità di energia necessarie (cosa gestibile incrementando l’uso di fonti energetiche non fossili) sia come impatto delle lavorazioni chimiche: la miscelazione ad altissime temperature di carbonato di calcio e argilla produce infatti silicati di calcio e anidride carbonica dispersi in atmosfera. Quando si arriva poi, per arrivare alla produzione di calcestruzzo, all’aggiunta di acqua, sabbia e ghiaia - vista la caratteristica fortemente alcalina di questa miscela - è possibile catturare CO2 nel prodotto finale. Ma fino ad oggi, come già ricordato, non erano state superate le controindicazioni relative alla qualità e resistenza del materiale. Ecco perché i risultati della ricerca del MIT - al netto della necessità di verificare gli impatti nel lungo termine - aprono prospettive nuove molto promettenti, con stime di abbattere fino al 15% delle emissioni di CO2 grazie a quello che uno dei ricercatori, Masic, ha definito "calcestruzzo multifunzionale”
Un’altra sperimentazione è quella della start up californiana Heirloom Carbon Technologies, che riscalda ad alte temperature il calcare macinato per far sì che si rompa e rilasci anidride carbonica pura, facilmente catturabile, producendo minerali ossidi altamente reattivi, che si legano facilmente alla CO2 e che vengono esposti all’aria proprio per assorbirla, agendo come delle spugne, per poi trasformarsi in carbonato di calcio, il componente principale del calcare. E così il processo ricomincia, con nuova rottura del calcare, cattura della CO2 e così via, fino circa 10 ripetizioni. La CO2 così immagazzinata viene poi invita ad una azienda canadese, la CarbonCure Technologies, che la trasforma in un materiale che rafforza il
calcestruzzo, riducendo la necessità di cemento (che serve proprio a rendere il calcestruzzo più solido). C’è infine anche un progetto italiano (Cleanker - Clean clinKer production by calcium looping process), in corso di sviluppo grazie ai fondi del programma Horizon 2020, nell'ambito dell’impianto di produzione del cemento di Vernasca del gruppo Buzzi Unicem. Il processo punta a catturare fino al 90% della CO2 prodotta durante la realizzazione di cemento, utilizzando componenti e materiali già presenti nelle lavorazioni dei cementifici, permettendo di trasformare il calore necessario in energia elettrica e potendo arrivare ad un sistema di emissioni nette negative grazie all’uso di low carbon fuels.

Il Premio di Studio intitolato a Pasquale De Vita, giunto alla IV edizione, questa volta è stato assegnato a Federico Orsini, ricercatore presso l’Università degli Studi di Padova, per la tesi di dottorato «Conflict-based approach for road safety analysis”. Un lavoro che affronta in modo nuovo il tema della sicurezza stradale ricorrendo all’intelligenza artificiale per sviluppare un modello predittivo in tempo reale. A seguire, le principali conclusioni a cura del vincitore, al quale vanno i nostri complimenti.

L’approccio convenzionale alle valutazioni di sicurezza stradale si basa sull’analisi di dati di incidentalità. Sebbene, in generale, tale approccio sia adeguato, ci sono molti contesti in cui esso non può essere applicato o non è in grado di fornire valutazioni attendibili.
I dati di incidentalità, infatti, possono essere affetti da diverse problematiche. La fonte originaria di molti dei database sugli incidenti sono i rapporti della polizia stradale, che possono contenere imprecisioni, sia dal punto di vista della localizzazione spazio/ temporale, sia della classificazione tipologica dell’incidente e delle sue conseguenze; inoltre, una percentuale molto rilevante di incidenti non viene denunciata, specialmente nel caso di collisioni con danni di scarsa entità, a causa della struttura dei premi assicurativi. L’aspetto però più rilevante è che, fortunatamente, gli incidenti sono eventi sostanzialmente rari: di conseguenza, per raccogliere una sufficiente quantità di dati necessari allo svolgimento di solide analisi di tipo statistico, è necessario lavorare su lunghi periodi di osservazioni e/o aggregando dati su aree di studio molto ampie. Se oggi si costruisce una nuova infrastruttura stradale, si dovrà attendere mesi o anni prima di avere dati di incidentalità suf-

ficienti per valutarne la sicurezza. E si tratta, peraltro, di un approccio di tipo reattivo: serve osservare incidenti, magari con conseguenza drammatiche, prima di poter intervenire, e questo è un problema anche di tipo etico.
Esiste tuttavia un approccio alternativo, che si basa sulla teoria dei conflitti di traffico, i quali si possono tradurre, intuitivamente, come “quasi-incidenti”, ovvero situazioni osservabili in cui due o più utenti della strada si avvicinano tra di loro a tal punto che esiste un rischio di collisione se il loro movimento dovesse rimanere inalterato. Essi sono, per definizione (pensiamo alla “piramide della sicurezza”), eventi molto più frequenti degli incidenti stradali, e questo li rende particolarmente attraenti, perché la raccolta dei dati può avvenire in maniera molto più rapida (giorni/settimane invece che mesi/anni), permettendo un approccio proattivo, in cui si riconoscono le criticità e si può intervenire ancora prima che si manifestino incidenti stradali.
Tale approccio non è nuovo; anzi, si iniziò a ragionare su questo sin dagli anni ’70-‘80. Ciò che ne ha ostacolato la diffusione a livello pratico sono stati: 1) la difficoltà ed il costo associato alla raccolta sul campo dei dati necessari
per identificare i conflitti; 2) trovare un modo per mettere in relazione in maniera solida il numero di conflitti osservati ed il reale rischio di incidente.
I recenti sviluppi tecnologici e di intelligenza artificiale stanno permettendo di superare le difficoltà associate al primo punto. Ad esempio, esistono software per il tracciamento delle traiettorie che permettono di estrarre da registrazioni video in maniera automatica (o quasi), i dati necessari per l’identificazione dei conflitti.
Quanto al secondo punto, mentre in passato si è cercato di trovare, con scarsi risultati, dei fattori di conversione fissi per trasformare il numero di conflitti osservati in incidenti stimati, recentemente sta emergendo un punto di vista alternativo, di tipo probabilistico. Sostanzialmente, si assume che conflitti ed incidenti siano lo stesso tipo di evento, caratterizzato da un livello di severità diverso; in altre parole, si possono considerare gli incidenti come degli eventi “estremi” di conflitto, in cui il conflitto è talmente ravvicinato da sfociare in una collisione. L’idea, dunque, è quella di osservare sul campo i “quasi-incidenti”, utilizzarli per fittare una distribuzione probabilistica, e utilizzare questa distribuzione per estrarre la probabilità che avvengano eventi ancora più estremi, ovvero gli incidenti (Fig. 1). In questo modo si può stimare un rischio di incidente pur non avendone potenzialmente osservato alcuno. Questo approccio probabilistico è quello della “Teoria dei Valori Estremi” ed è utilizzato in diversi ambiti ingegneristici, ad esempio in idrologia per stimare il tempo di ritorno di precipitazioni atmosferiche estreme, dato fondamentale per la progettazione di dighe o opere fluviali.
L’applicazione della “Teoria dei Valori Estremi” nell’ambito della sicurezza stradale è ancora agli albori. Nel corso degli studi svolti nel mio dottorato di ricerca, ho contribuito in questo cam-
po, validando l’approccio sia con degli studi proof-of-concept al simulatore di guida , sia utilizzando dati reali raccolti in diverse sezioni di un’autostrada italiana . I metodi che ho testato sono in grado di fornire non solo una stima degli incidenti annui che possono avvenire in un determinato segmento autostradale, ma anche un relativo intervallo di confidenza, che permette di tenere in considerazione l’incertezza previsionale. Nel caso di studio analizzato, le previsioni sono state confrontate con il reale numero di incidenti annuo: in circa il 90% delle sezioni studiate, il numero di incidenti osservato ricadeva all’interno dell’intervallo di confidenza del modello previsionale (Fig. 2).


Un ulteriore contributo della mia tesi di dottorato è stato l’utilizzo dei conflitti di traffico per la stima di modelli previsionali in tempo reale , ovvero di modelli in grado di prevedere il rischio che avvenga un incidente nell’immediato futuro (ad esempio entro una finestra di 5-10 minuti), sulla base delle attuali condizioni di traffico e di meteo. Tali modelli, che si basano su algoritmi di machine learning, sono addestrati solitamente utilizzando dati storici di incidentalità, associati alle relative
condizioni di traffico/meteo immediatamente precedenti. L’utilizzo di conflitti di traffico (identificati per mezzo di soglie definite con l’ausilio della “Teoria dei Valori Estremi”) al posto di dei dati di incidentalità, ha permesso di ottenere un’affidabilità previsionale significativamente più alta: confrontando i due metodi nello stesso contesto autostradale, quello addestrato con i conflitti di traffico è stato in grado di prevedere l’avvenimento di incidenti nei successivi 5 minuti con un’accuratezza del 14%
più elevata rispetto a quello addestrato con i dati storici di incidentalità. La mia attuale attività di ricerca sta ora puntando sullo sviluppo di protocolli per l’analisi di dati di conflitti di traffico che siano i più semplici e pratici possibili, pur mantenendo un adeguato livello di rigore e attendibilità, al fine di essere utilizzati non solo nell’ambito della ricerca, ma anche a livello operativo da professionisti impegnati in valutazioni di sicurezza stradale, sia a lungo termine che in tempo reale.

• Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2023) Contiene semplificazioni e chiarimenti rispetto al Decreto del 2020, tra cui l’esclusione dalle misurazioni per le radiazioni di origine naturale degli impianti di trattamento acque di falda nelle messe in sicurezza d’emergenza dei punti vendita carburanti.
• Legge n. 6/2023 recante “Misure urgenti di sostegno al settore energetico e di finanza pubblica” (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2023)
In sede di conversione del c.d. “Aiuti-quater”, il Governo ha posto la fiducia e, pertanto, non sono state apportate modifiche.
• Legge n. 10/2023 recante “Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici” (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2023)
In sede di conversione del Decreto-legge n.187/2022 non sono state apportate modifiche agli articoli di interesse per il settore.
• Decreto-legge n. 13/2023 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023)

Si evidenziano, in particolare, i seguenti articoli:
• Art. 6 – Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR;
• Art. 7 – Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC;
• Art. 8 – Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori;
• Art. 9 – Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;
• Art. 13 – Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
• Art. 19 – Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale;
• Art. 38 – Disposizioni in materia di crisi di impresa;
• Art. 41 – Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile;
• Art. 47 – Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
• Art. 48 - contiene la delega al governo per la revisione della disciplina delle terre rocce da scavo, per la razionalizzazione e la semplificazione della modalità di utilizzo delle stesse;
• Art. 49 – Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici.
• Legge n. 14/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023)
In sede di conversione del c.d. “Milleproroghe” non sono state apportate modifiche sostanziali agli articoli di maggiore interesse per il settore. Si segnalano tuttavia i seguenti articoli, approvati in prima lettura dal Senato:
• Art. 9, commi 4-ter e 5-ter – Proroga dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni;
• Art. 10-quater – Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.
• Decreto del Ministero dell’Interno 16 febbraio 2023 “Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto” (G.U. n. 52 del 2 marzo 2023)
Costituisce regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione.
• Legge n. 17/2023 recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale” (G.U. n. 55 del 6 marzo 2023)
In sede di conversione del Decreto-legge n. 2/2023 è stata approvata una modifica emendativa con la quale è stato inserito il seguente articolo:
• Art. 1-bis – Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa.
• DPCM 3 febbraio 2023 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023” (G.U. n. 59 del 10 marzo 2023)
Contiene i nuovi modelli per Ia presentazione del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) il cui termine è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento (entro l'8 luglio 2023).
• Legge n. 23/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico” (G.U. n. 63 del 15 marzo 2023)
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5/2023 (c.d. “Decreto Trasparenza prezzi carburanti”), approvato con modifiche, annovera diverse misure che interessano il settore:
• Art. 1 – Stabilisce un obbligo di comunicazione da parte dei gestori a Osservaprezzi per ogni variazione dei prezzi praticati, anche in caso di riduzione e comunque con frequenza settimanale in caso di mancanza di variazioni. Inoltre, prevede che Osservaprezzi elabori quotidianamente un “prezzo medio di riferimento” (regionale per la viabilità ordinaria e nazionale in autostrada) quale media dei prezzi comunicati dai gestori, che devono poi pubblicizzarlo sugli impianti attraverso apposita cartellonistica;
• Art. 3 – Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi. La norma prevede l’emanazione di un decreto ministeriale attuativo.
• Decreto-legge n. 34/2023 recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (G.U. n. 76 del 30 marzo 2023)
Si evidenziano, in particolare, i seguenti articoli:
• Art. 2 – Riduzione dell’IVA al 5% e degli oneri generali per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nel secondo trimestre 2023;
• Art. 4 – Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta pari al 20% o 10% a seconda delle casistiche, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
• Art. 5 – Rideterminazione della base imponibile per il calcolo del contributo di solidarietà straordinario;
• Art. 6 – Calcolo della tassazione agroenergia per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Pensare il futuro è un compito decisivo per tutti, per il quale è utile farsi ispirare da studiosi, esperti, narratori: per immaginare come sarà il pianeta nel quale vivranno le prossime generazioni, saper prevedere come cambieranno le abitudini delle persone e individuare modelli di crescita pienamente sostenibili e rispettosi dell’ambiente.
La maggior parte dei costi associati agli attuali disastri climatici sono dovuti alla variabilità climatica naturale, non ai cambiamenti climatici, e sono determinati dallo sviluppo economico e dalla resilienza della società, non dall'intensità del rischio climatico. Per questi motivi, la formula di base per l'adattamento ai cambiamenti climatici è la stessa che ha permesso al mondo di ridurre radicalmente i costi umani dei disastri legati al clima nell'ultimo secolo: più ricchezza, infrastrutture e tecnologia. […] Nonostante le prove schiaccianti che l'umanità è diventata molto più resiliente agli estremi climatici - e sa come aumentare ulteriormente la sua resilienza - gli sforzi internazionali per affrontare il cambiamento climatico hanno ampiamente ignorato questi fatti. Invece di concentrarsi sullo sviluppo economico e infrastrutturale per aumentare la resilienza, i responsabili politici, gli esperti e gli attivisti si sono concentrati solo su una serie molto più piccola di misure di adattamento che non sarebbero in conflitto con il loro sforzo risoluto per mitigare le emissioni di carbonio. […] Fermare il riscaldamento globale richiederà che il mondo smetta completamente di bruciare combustibili fossili a un certo punto. Ma un mondo più ricco, più resiliente e più equo avrà più tempo e più risorse per farlo. La storia straordinaria e in gran parte non raccontata dell'adattamento agli estremi climatici da parte dello sviluppo mostra come.
[The Obvious Climate Strategy Nobody Will Talk About, Foreign Policy, 6 novembre 2022]
a questo numero
Monica Billio, Carlo Andrea Bollino, Guido Bortoni, Salvatore
Carollo, Rosario Cerra, Davide Chiaroni, Modestino Colarusso, Francesco Crespi, Alessandro Lanza, Marco Macciò, Olivier Macé, Federico Orsini, Filomena Pietrapertosa, Rita Pistacchio, Antonio Pollio Salimbeni, Monica Salvia, Adam Schubert, Claudio
Spinaci, Davide Tabarelli
Hanno contributo alla rivista
Alessandro Aresu, Luca Aterini, Marco Baldi, Alessandro
Bartelloni, Simona Benedettini, Monica Billio, Carlo Andrea
Bollino, Carlo Bonomi, Guido Bortoni, Giogio Carlevaro, Arianna Cappelli, Carlo Carminucci, Salvatore Carollo, Nadia Cerone, Rosario Cerra, Giorgio Chiantella, Davide Chiaroni, Stefano Cingolani, Paolo Cintia, Francesco Clementi, Alessandro Clerici, Alberto Clô, Modestino Colarusso, Emanuela Colombo e Diana Shendrikova, Francesco Crespi, Marco D’Aloisi, Stefano Da Empoli, Giuseppe D’Arrigo, Vittorio D’Ermo, Bruno Dalla Chiara, Franco Del Manso, Pier Luigi Del Viscovo, Paola De Micheli, Pierroberto Folgiero, Alessandro Fontana, Benedetto Forlani,
Marco Frittella, Giuseppina Fusco, Vannia Gava, Massimiliano Giannocco, Romano Giglioli, Jacopo Giliberto, Gianni Girotto, Maria Cecilia Guerra, Icao, Innovhub, Alessandro Lanza, Pietro Lanzini, Stefano Laporta, Antonio Lazzarinetti, Marco Macciò, Olivier Macé, Marco Mannocchi, Marco Marcatili, Enrico Mariutti, Benedetta Marmiroli, Michele Masulli, Paolo Mellone, Marco Mocchetti, Enrico Morando, Martina Nardi, Lisa Orlandi, Federico Orsini, Azzurra Pacces, Gilberto Pichetto Fratin, Linda Piedimonte, Filomena Pietrapertosa, Marilena Pisani, Rita Pistacchio, Politecnico di Milano, Antonio Pollio Salimbeni, Cristiana Pulcinelli, Ilaria Querci, Paolo Raimondi, Francesco Ramella, Filippo Redaelli, Aurelio Regina, Francesco Ricotta, Giacomo Rispoli, Piero Salatino, Monica Salvia, Tommaso Santarelli, Francesco Sassi, Francesco Ciro Scotto, Adam Schubert, Antonio Sileo, Guido Silvestri, Claudio Spinaci, Carlo Stagnaro, Angelo Sticchi Damiani, Davide Tabarelli, Luca Tabasso, Antonio Tajani, Giuseppe Tannoia, Chicco Testa, Antonio Tintori, Stefania Tomasini, Roberto Ulivieri, Maria Rita Valentinetti, Claudio Velardi, Angela Zanoni, Giovanni Battista Zorzoli
Unione Energie per la Mobilità
Piazzale Luigi Sturzo, 31 00144 Roma info@unem.it www.unem.it tw: @unem_it in: /company/unem
Per proporre contributi o per richieste pubblicitarie: muoversi@unem.it
Le opinioni espresse impegnano unicamente gli autori e sono indipendenti da opinioni e politiche dell’Editore. Registrazione Tribunale di Roma n. 121 del 19 settembre 2019
Itelyum ti aspetta
al Fuorisalone 2023
dal 17 al 26 Aprile 2023 presso








l’Università degli Studi di Milano





