
6 minute read
CONTENUTI DIGITALI FLASHCARD: I tipi di frazione
Quando impariamo, prendiamo un concetto, un’idea, un movimento, una storia e li facciamo nostri; integriamo nuove informazioni con quello che già sappiamo per ottenere qualcosa di nuovo, diverso, aggiornato. Queste nuove conoscenze e capacità sono a nostra disposizione quando abbiamo bisogno di loro; è in quel momento che mostriamo di aver appreso. L’evoluzione ha selezionato la capacità di apprendere come risposta flessibile alle sfide che l’ambiente in cui viviamo ci pone. Nel corso dei millenni abbiamo progressivamente riunito le nostre conoscenze pratiche e le tradizioni all’interno della cultura, la quale viene trasmessa di generazione in generazione attraverso l’educazione. Imparare ci permette sia di integrarci nel nostro ambiente culturale, sia di affrontare nuovi problemi e sfide della nostra generazione. Questo è particolarmente vero se consideriamo l’apprendimento matematico. Se imparare è così importante, allora è altrettanto importante capire quando impariamo meglio1. Il coinvolgimento attivo favorisce l’apprendimento. Se volete insegnare ai vostri figli/figlie o alunni/e come preparare una torta di mele, è bene che vi sporchiate le mani in cucina piuttosto che usare delle slides per presentare la ricetta. Minimizzare le distrazioni sostiene l’apprendimento. Facciamo in modo che l’attenzione sia sul contenuto da apprendere e non vi siano interferenze esterne. Come fare per suscitare attenzione e interesse? Una buona strategia è contestualizzare il materiale d’apprendimento, così che diventi rilevante per l’alunno/a. Spazio, velocità e tempo, per esempio, suonano più interessanti se applicati per calcolare l’itinerario della gita scolastica. Infine, apprendiamo meglio quando lo facciamo in interazione sociale: quando ci confrontiamo con altre persone costruiamo insieme la nostra conoscenza. Un ottimo modo per imparare e verificare il proprio apprendimento è insegnare ad altri. Nel creare le attività di questi libri abbiamo cercato di rispettare questi principi di apprendimento, in modo da massimizzare l’esperienza educativa.
La negoziazione sui significati mediata dalla narrazione
Ogni unità viene introdotta da un piccolo accenno alla storia della Matematica, per attirare l’interesse dei bambini e delle bambine rispetto alla storia di questa disciplina, ma anche per sottolineare la natura pratica di una materia scolastica che spesso viene associata soprattutto a regole astratte da imparare a memoria. “Il metodo che consiste nel proporre e riproporre una negoziazione sui significati con la mediazione dell’interpretazione narrativa costituisce a mio avviso uno dei grandi risultati dello sviluppo umano in senso ontogenetico, culturale e filogenetico”. Questo è quanto scriveva Jerome Bruner (1915-2016) in un libro apparso in Italia nell’ormai lontano 19922, una delle opere più significative tra le numerose che descrivono “il compito” fondamentale della scuola, sovraordinato e sovraordinante rispetto ai campi specifici del sapere che si stanno trattando e che, è bene ricordare, sono “una parte” di quell’unicum che descrive, accompagna ed è un “prodotto” dell’evolvere della storia dell’essere umano. Questo vale a maggior ragione per la Matematica, sebbene sia improprio definirla “parte” del sapere. Per anticipare ciò che si dirà in seguito, “Matematica” vuol dire “imparare”, dal greco m¿qhma (máthema) = scienza, conoscenza, che, a sua volta, deriva dal verbo manq¿nw (manthano) = io imparo. Il μaqhmatikfiŁ (mathematikós), dunque, è “colui che è incline a sapere” 3 .
1 Hirsh-Pasek, K., Zosh, J.M., Golinkoff, R.M., Gray, J.H., Robb, M.B., & Kaufman, J. (2015), Putting Education in “Educational” Apps: Lessons From the Science of Learning. Psychological Science in the Public Interest, 16(1), 3–34. https://doi. org/10.1177/1529100615569721 2 Bruner, J.,1992, La ricerca del significato, Bollati Boringhieri, Torino 3 Cortelazzo, M., Zolli, P., 1983, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna
Sorridoimparo
Da più tempo, della Matematica si ha una considerazione almeno “diversa”, se non più alta di quanto non s’abbia delle altre scienze, dunque (per estensione) degli altri saperi. In Dante (1265-1321), per esempio, si legge: “E lo cielo del Sole si può comparare a l’Arismetrica […] ché del suo lume tutte s’illuminano le scienze […]”4 . In ogni caso, quale che sia l’idea che se ne abbia, è ineludibile (e, crediamo, condivisibile) l’idea che una negoziazione continua sui significati delle “sue” parole mediata dalla narrazione sia il tratto primo e distintivo di ogni sua didattica “ben fatta”. Per altro, è assunto scientifico ormai consolidato quello che afferma che “senza parole non si pensa”. E, in Matematica, quando non la si voglia trasformare in puro e semplice “addestramento al calcolo”, il pensiero è l’animatore e il direttore d’orchestra di ogni processo, a partire dall’emozionale-affettivo che genera dal racconto. Gianni Rodari, che se intendeva, scrive: “Le fiabe servono alla Matematica come la Matematica alle fiabe”5 . Di esempi ne correrebbero a iosa. Per ovvie ragioni ne esamineremo solo uno, cominciando a lavorare – come già si è appena fatto – dagli etimi e sugli etimi. La piccola narrazione che faremo sullo “zero” riguarda (almeno) l’opera di Leonardo Pisano, detto Fibonacci (~1170 - ~1250). Recatosi adolescente in Algeria con suo padre, studiò la sapienza araba, da cui derivò quel che scrisse nel suo libro più importante, il Liber Abbaci: «Le nove figure degli indiani sono queste: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con queste nove cifre, assieme al simbolo “0” (che gli arabi chiamano zephir) è possibile scrivere qualunque numero, come si vedrà più avanti»6 . Nel brano, la parola (che gli arabi chiamano) zephir, “zefiro”, è in realtà la traduzione dell’arabo sifr che, “ufficialmente”, vale sia “cifra” sia “zero”; e, oltre al personaggio mitologico Zefiro, il vento quasi “nullo”, “lo zero” rappresenta il nucleo più importante del calcolo e della Matematica, senza il quale, almeno quella occidentale, sarebbe rimasta ancora a lungo lontana dalla “potenza” dei sistemi di numerazione posizionali. Quando Fibonacci venne a contatto con la sapienza araba e la sua Matematica, in realtà gli Indi avevano già superato il pensiero greco (in particolare quello di Aristotele) che negava l’esistere dell’insieme “vuoto” e, perciò, del numero che ne “contasse” gli elementi, provvedendo a rappresentare con un simbolo – “0” – “il contenuto” di quell’insieme e, quindi, a mettere a punto la prima forma “rudimentale” – ma quanto già rivoluzionaria – di notazione posizionale. Questo è ciò di cui Fibonacci era venuto a conoscenza durante i suoi studi e i suoi viaggi. In particolare, questo è ciò che aveva imparato studiando l’al-jabr – da cui la parola italiana “algebra” – del matematico persiano Al-Khwaˉ rizmıˉ (~780 - ~850) – da cui la parola italiana “algoritmo”. Per questo, infine, Fibonacci attribuì correttamente agli Indi quelli che ancor oggi noi chiamiamo “numeri indo-arabi”. In realtà, sia Al-Khwaˉ rizmıˉ sia Fibonacci non sapevano che i loro “colleghi” indiani erano andati già ben oltre il “simbolo 0”, assegnandogli invece il valore di “numero vero e proprio”, cosa che, come scrive Umberto Bottazzini (1947), fu “un’idea che ha cambiato il corso della Storia”7, completando definitivamente una delle più importanti rivoluzioni di tutta la storia della Matematica. È grazie allo zero, la cifra per eccellenza, che i calcoli sono “automaticamente” più veloci e meno impegnativi, consentendo invece lo sviluppo del pensiero legato a essi, cosa che ha altro e ben più importante valore. Probabilmente Fibonacci non fu il primo europeo in assoluto ad aver conosciuto “lo zero” e la sua rivoluzionaria funzione. Alcuni studiosi sostengono che già il monaco Gerberto di Aurillac, vissuto tra il 950 e il 1003, sapesse della sua esistenza e di ciò che allo zero era legato. Gerberto, però, aveva conservato ciò che sapeva nel suo convento, mentre il grandissimo merito di Fibonacci sta nell’averlo divulgato, fatto conoscere e, quindi, diventare patrimonio di tutti e tutte. Termina qui il racconto, ma non la certezza che condividere con i nostri bambini e bambine i racconti della Storia del mondo e dell’essere umano, mentre si cerca il senso del tutto, attraverso i numerosi
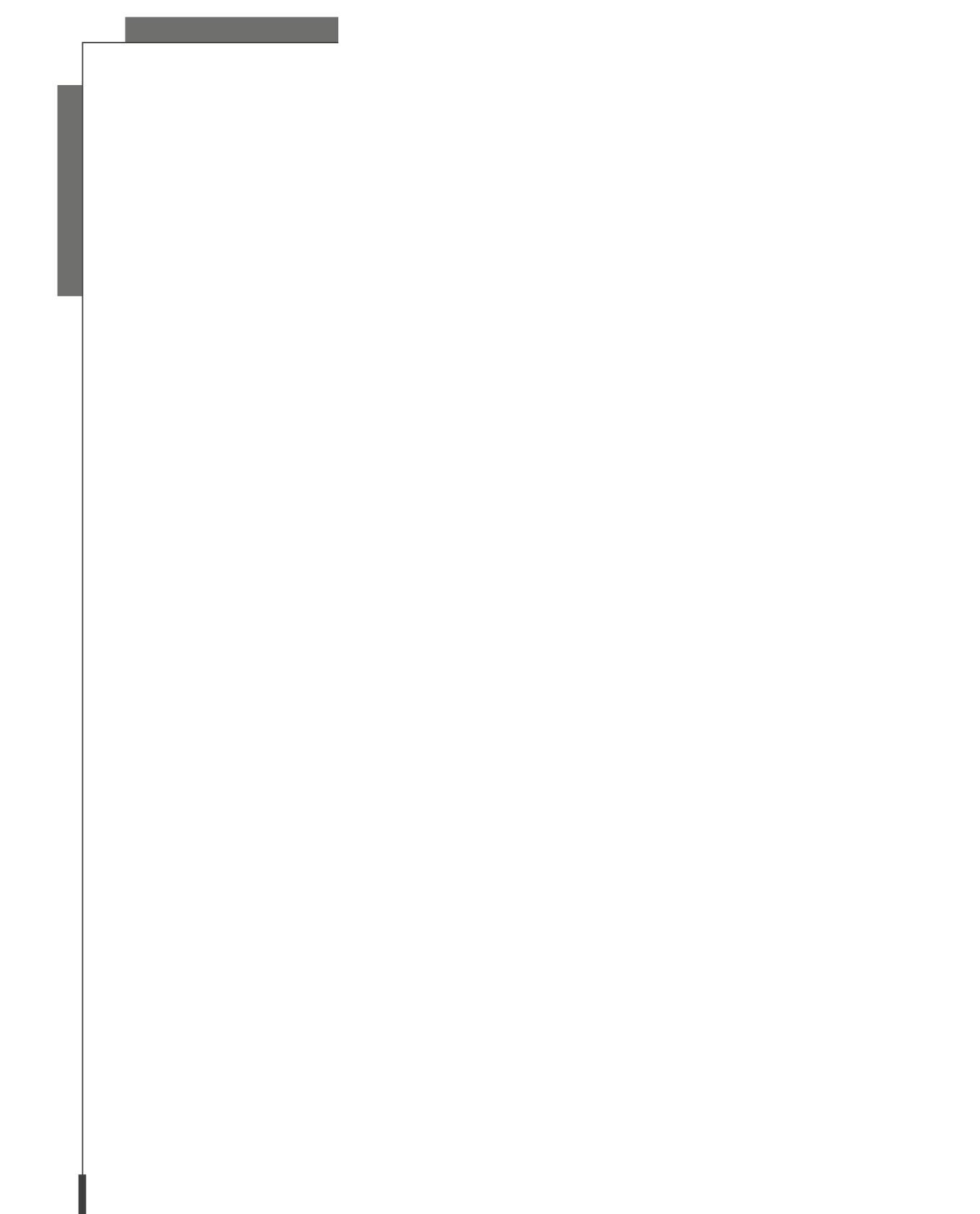
4 Dante, Convivio, Trattato II, Cap. XIII, 15-16 5 Rodari, G., 1973, Grammatica della fantasia, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 6 Boncompagni, B., 1857, (a cura di), Scritti di Leonardo Pisano, Vol. I, Roma 7 Bottazzini, U., 2019, Istanti fatali, Laterza, Bari-Roma









