
66 minute read
l'opera di Giovanni Gersdorf
sangue ne,rwstoro, nelle ferite de1lo stomaco e dell'intestino, se ~)l'Ovocano siparg1mento di materie a11imentad e fr,cali ed in quelle della .. vescica, se sono causa di e)Jlissione di urina .
([ Pa~ 1 ft 03 iw bti: infh:umcnt /vii bas oyenetmec ob1 en l'ff 03 bau bt /l:>aii fnnjl l:>amcbc1obcr l>ittbttt. t>acumb b; es nit l>:e<yte glcyct, bat ralst>3 ned)ft m flrnmet l)rc voi v~r 3eyd}nct,l'.>nl> bycn ~t au<b/mann t>ie
Advertisement
t,rr11f d>AI jngcfd)la gen ifl/oas man f;e 111it bivi tnftrnmèt wit>ec vff f d)rnnb.
J<'ig. 42 - U na trapanazione del cranio co'n trapano a tre piedi. (Dall'opera di Giovanni di Gersdorf). ,
L'opera del Gcrs<lorf, al contrario di Yperiman, . più che con dissertazioni teoriche, ,si es,plica praticamente sul camrpo di battaglia BStraendo frammenti di freccie (:fig. 39), cauterizza1ndo le feiritc con strumenti g, rossolani (fig. 40), praticando amputazioni degli · arti (fig. 41) ed anche trUJpa,nazioni del cranio con trapano a
tre piedi di sua invenzione ~fig. 42), ·per lo .più senza aiuti e con mezzi disponibili assai linnitati. Lo studio dell'estrazione dei proiettili è trattato con buone conoscenze ari.atomiche e con esatta descrizione ,degli strumenti.
RicOl'deremo infine ·Giovanni Langi (1485~1565), di cui il vero nome era Langius di Lemberg, nativo di Lowenberg nella Slesia, ma naturaJlizzato italia,no per la lunga dimora in· Pisa. Fu medico di ,quattro elettori palatini: Luigi-Federico II, Ottone, Enrico e Federico IIIJ e lasciò 11 di&;0rsi intorno alla ch1rurgia << Themata a.liqu,ot chirurgica», f,ra cui uno dedicato alle ferite d'arma da fuoco, nel qua.le, oltre a.d .affermare la necessità del ritorno allo studio dei classici testi greci, sostiene l'uso delle sosta.n7,c topiche nella cura delle lesioni e consiglia ~'acqua di rose.
Per quanto riguar<la l'assistenza sanitairia negli eserciti in questo pel'iotlo, a(Xenneremo che ~otto il l'egno di Uai1Lo VII, il quale aveva un semplice brurbicre 1per chirurgo addetto alla su:1 persona, Hon trovia.ino alc1mH, traccia di organizzazione di medici milita1ri; e solfanto un c01'po speciale di 220 uomini « i sergenti verga )) dello OhMelet a, Parigi, i quali, del resto non 80stenèvano altre lotte cruente che contro i debitori insolvibi1Ii, aveva ottenuto nel 1495 il privilegio di disporre di << un esercito per la cura di lor ferite, ipiaghe o lacerazioni )).
Ca,rlo il Temerario, duca, di B011gogna, prende per il primo l'iniziativa di istitui1re un servizio sanitario in guerra, e a ciascuna compagnia di 100 lande assegna un chirurgo. Poichè ogni lancia, era formata da otto combattenti, si veniva a disporre di un chirurgo ogni 800. uomini. L'esercito di Borgogna aveva una forza di 22000 soldati, e ·perciò per l'assistenza in campagna poteva valersi dell'opera di 27. chtrurghi, senza contare i sanita,ri addetti al],a· persona stessa del re e dei grandi vas-saJlli.
Nel 1337 Filitppo di Valois, avendo dichiarato guerra a:ll'Ing-hilterra, fece allestire nel porto di Genova 40 galere ed assegnò a.ila nave .ammiraglia un maestro di chirurgia coHa paga di 10 fiorini al mese ed a tutti gli aJlt,ri. vascelli un chirurgo barbiere ed un allievo chirurgo (barbierotto).
Ma la ipènuria dei medici milita1·i presso le trmppe oipcranti fu quasi. sempre la regola, e quando Enrico V, re d'Inghilterra,

13
mosse nel J.413 con un esercito formidabile contro la Francia, non ;_~veva a disposizione che un solo chirll!rgo, Tomma"'o Morstèdc, che si era aggregato una dozzina di assistenti. Ji:d in urH1 seconda spedizione, per·dnrando l'assoluta deficienza cli pPrsonale sanitario, fu costretto ad ordina,re allo stesso Morstède di imha,rcare manii m-ilitari tutti i chi1rurghi, di cui ritenesse opportuno vailersi ed anche un certo numero <li artieri e meccanici ,per fabbricare apparecchi e skumenti.
Cominciano invece nei massimi centri, special.mente in Italia, ad erigersi stabili luoghi cli cura, per il ,ricovero, non solo dei pelleg,l'ini infonni, ma anche dei .<mildati del presi<lio e di quelli in gran numero reduci dalle Crociate o dalle guerre nel ter~ritorio che si susseguono ininterrottamente.
Già fin dall'a,nno 1J 13 a Pisa fu fondato 1l'ospeda,le di S. Sc!};>Olcro e di S. G·iovanni per cura dei Cavalieri del Sov,rano MiJitarc Ordine di Malta, che accoglieva anche i soldati ma.Iati e fprjti. Nel 112·2 fu istilu.ito un n,ltro nosocmnio ad Altopascio: ivi nna campa,na,, battezzata la, sma.J',rita, sumutva verso il t·ramonto ;per indicare la via ai numerosi pellegrini che dovevano traversa,re un bosco 1picno di insidie, così, come oggi a,ncora, a- due ore di notte, suona, una campana- della tone di S. ·~fa,ria l\ifaggiore in Ronm per munifico lla.scito di una gentildonna, smiu,r·ita,si secoli addietro nel 'deserto Esq uilino, la qua.te, gui<lata. -ffai rintocchi dei hron.zi della hHsilica,, :-.tvcva potuto ritrovare ht strada.
Nell'a,nno 1177 ·fu edifica,to un altro ospedale a, Ferrara; nel 1204 il ·papa, Innocenzo TTT ordinò la, costruzione dell'ospedale di S. S:pirito in Sassia a Roma e qua,si contemporanea/lllente il principe CAllonna, fondò l'ospedale del Sa1lvatore a, S. Giovanni in Laterano.
Nel 1214 sorge l'ospedale <lel Ceppo a Pistoia; nel 1224 l'ospedale maggiore a Vercelli; nel 1288 :F'olco Portinari istituisce a Firenze, ehe .già, possedeva l'ostpcdaJc di S. Giova,nni, eretto fra il Battistero ed il Voochio Duomo di S. Reparata fin dalil'epoca di Cacciaguida, il nuovo ospedaJe di S. Maria Nuòva e fra le prime ad essere ricove,rate fu momia, 'l'essa, sua anoella, che aveva nei giorni antecedenti generosa.mente ospitata nel suo avito pala,zzo. Verso la fine del 1400 cominciano .già a, funziona,re dei grandiosi' ospedali per il ,ricovero e cura, oltre che tlei forçsticri e dei pel1egrini, anche dei soldati, ed i rno,ggiori artefici del tempo, a,rchitetti,. rpittori e scultori, concol'rono in nobile gara a fare di

questi luoghi di cura dei ver·i e 1propri ea,JJolavori d 'a,rte. C{isì il grande Qspe<lale Maggiore a Milano, l'Ospeda]e degli Innocenti ht Firenze, l'Ospedale di S. Ma1·ia. della 8cala a Siena e 1più tardi I 'Ospeda.Je dei SS. Giova.nni P- Paolo di Venezia,, l 'Ospc'{lal<~ della Vita a Bo1Iog1m, quello degli Incura,bili a N3tpoli ecc.
Così i più rinomati a,rchitetti, quali il Bramante ed il Bruuelleschi a Milano e a :F'irenze, i più g•randi artisti del p<mnello e dello scalpello, quali Domenico di Bartolo a Siena, il Pollajuolo P i~ Ghirlandaio a, 1!'ir,enze, ,Giovanni Della Robbia a Pistoia, prolligano i loro tesori ne]1]a deccwazionc delle sale ospedaliere con 1'.:tffigurazioni di assistenza ai malati, pre11.iosc iconogra,fie per la ;.,,f.oria della medicina, colla rapp,res,entazione dei santi taumaturg-hi e, ispeciahnente, dei Santi Cosma, e Da,miano, che erano ve11enLti fin da, ternipi remoti come i patroni della medicina.
Finalmente con l'invenzione del1a stampa, avvenut~L suil fi11 ire de] '400, le sciem,;c modiche riccvette,ro nn efficace impulso e 1·.isveglio, poichè, come ben nota, il Caistiglioni, i va1·i testi antichi ,•ù i classici trattati, che iprima era.no co1piati in Jimitaitissimo nn111ero da arrmnuensi di :sca,rsa, cultura, ehbe,r-o con tale scoperta, più larga -diffusione e più gran numero di consultatori, i quali pe'1' la maggfor quantità di copie disponibili potevano p,rcnde1~ne visione e studiarli anche se si trovavano lontano -cJa,i maggiori ccnlri scien-

(itjd.

CA.Pì'J'OLO rv.
LA MEDICINA MILITARE NEL CINQUECENTO.


I
l. - LA CHIRURGIA l\HLITAilE DlllL CINQUl<.CEN'l'O IN l 'rAJ,IA.
Le armi da fuoco a piccolo e gn>sso calibro 11<. ·l ;periodo della Rinasceuza, col dP.terminare un decadimento della cavalleria, co. mindano a,d avere una IJ.)a-rte preponderant,e nell'a,rte della, guerra, e di conseguenz::i, anche lo studi.o delle ferite e delle le.'3ioni <la esse p,rodotte viene a ricevere nuovo f\ vivace im1pulso, <:on indirizzo soprattutto sperimentale.
Nel cinquecento in Italia 11a chirurgia, come ben si esiprime iJ Giorda .. no, (( che a. guisa dell'a,ntico marIUo g1·eco mutiila,to - la vittoria, di Sn,motrn.cia - aveva serbato intatte le a.li stille rovin~ i.rnponenti della SUIJ)•erstiziouc, sorg·e liurandosi <xm volo indomito >>. Anche la c;hirurgia 1militare si emancipa dalle :vecchie p·astoie, assm·gendo a uiaggior dignità, ,e il t1·attamento delle ferite e l'emostasi, che ne costituiscono la base, trovano fra noi la prima loro origiJiaJe· applicazione, mentre le antiche teorie della vclenosità e ,dell'ustione delle lesioni d'a·rnna da fuoco ,ricevono un gran colpo e vanno gradatamente declinando :fino· alla comp1lèta abolizione. 'Nel _] 552 un· sommo chirurgo italiano si leva per primo a comb'attere aid oltranza, questi due e,rrori, e ne ottiene dopo non pochi wnt1·asti comJ>lcb:i vittoria. E: questi Bartolomeo 1Muggi (1516-1562), bo.Jognese, lettore h1 quell'a.ntichis-simo Studio, ehe ben a ragione rpossia.mo ritenere il fondatore ~lella, chirurgla militare italiana. : egli, contempora.neairnente ad Ambrogio Pareo, e forse senza. sapere l'lÌno dell'altro, dimosLrò 1Iuminosa,menLc che le ferite d'arma da, fuoco non sono avvelenate, n~ uste, m.a soltanto contuse. La sua. opera ha per titolo: « Dc vu.lnermi1, sclovetorum et bombardarum mtratione tracta,tu . .'I », la quale fu p11hhlicata dopo la sua mo1·te pP-r la 1prima volta in Bologna nel Hi65 e fece parte ùi una Enciclop~lia chirurgic,L dèl secolo XVI, che vide 1:a J nce in Svizz~ra, ed intitolata : « De chin.wgia soriptores optirni quique 1;eteres et recentiores >>. ·

Uiù sin dalla fine del secolo antecedente Marcello Oumano, d1fa·urgo òe]l'armata dei Veneziani, che aveva potuto assistere ad una delle guerre più micidiali ed osservare di persona gli effetti. prodotti dalle novissime armi, dopo la battaglia. di Fornovo de'l 14H5 aveva date notizie delle lesioni da arma da fuoco nelle rnc an~otazioni alla chirurgia di Pietro d' Argelnta, i;ion riguardan dole come avvelenate e consigliando per calmare il ,dolore una miscela, di assa fetida e di galbano sciolta in olio di ,rose, ,e Berengario da Caripi nel 1508 ipure aveva emesso qualche· dubbio sulla natura spedfica di· tali ferite. Aiprh~mo una breve parentesi per rammentare che Jacopo Berengario nacque a, Carpi nel 1470 da paòr~ medico, e trascor.se i primi anni nella natia città alla corte di Alberto Pio; poi fu a Bologna presso Aldo iManuzio ed a Ferrara presso il duca d'Este. Sommo anatomico e des,c,rittore 1per· il .primo della glandola pineale, del timpano e deill'ruppendicc vermiforme, san in gran fama per l'a1p[.>licazione dell'unguento mercuriale nelila cura della sifilide; fu .lettore per vent'anni nel1lo ~tndio hologrw~e dal 1 @2 al 1522, e scrisse anche un lihro: ne fractitra calvariae, s. cro,nii. Esercitò largamente in grandi città e morì a Ferrara nel 1529. s~ondo il Falloppfa, col suo famoso unguento riuscì. ad a~sicurairsi una ragguardevole posizione economica << Lucratus C8t plu,s quam quinquaginta mili,a ducatorum . aureorum ~).
Ma il · merno di avere risolto veramente l'importante questione della non velenosità delle ,ferite da a,rma da fuoco sipett11 a Bartolomeo Maggi.
Questi era stato chiamato a curare Giovanni .. Battista Del Monte, comandante l'esercito della Chiesa sotto il pontificato di Giuilio ITJ, di una lesione di arma, da. fuoco a.Ila coschL, riportata ncll·'agro modenese. Gjà un:altra volta lo stesso cwpitano lo aveva fatto venire a -presta,r soceorsio ai feriti durante l'assedio delJa · Mirandola. Giunto colà, t•rovò che . medici e soldati medicavano secondo l'uso invalso: « Animadverti 1nagni nomin/48' medicos, qui in eo erwnt emercitu ad m,ilnera bombarda.rum ictibu,s . acoepta sananda) . eam, curationc admovisse) ao si ab ignito cadentique telo cxccpta f'i~·issent .... >). Ma egli non volle seguire tale oonsuetudine e soggiunge : << Verurn qivnm huc anini.it,m 1:ntendù;scm atque animadvcrsiunem et d'i,ligentiam excita8sem, multa a militibus, sit· scitando et gua,erendo) atq1,ie rem ham ad rationem) oonjectJuramerrasse viay deprchendL .. )).
Tornato a Bologna col il'iooo corredo delle osserva:,,ioni ra('.-

<·olte, e foi·te della esperienza acquistata direttamente sul ca,mpo dl bat tag1ia, si indusse, dietro [e istanze dei suoi discepoli, a, ipubbJicare il suo libro, che de,dicò al. ea,pitano pontificio suddetto. rngli comincia a pone 1a ques~ione capitale: e< Nttmquid huiusmocli vulnera cauterio aut veneno 'infecta sint? >> Discute l'ar,go111ento con mirabile a('.ume ed equilibrato raziocinio e dimostra che j a li ferite non sono nè avvelenate nè abbruciatc, concludendo che << /julnera h1.//iwsniodi nec ew pulvere neo aliunde 1:;enenata esse .... nt adusta vulnera Qi1,1,t aliqiw modo ad igne ajjecta non esse 01,1,l'anda) sed tanq,uam a,h atterente re et contundente /acta) medivcirula .... >~.
P,rescrive come topico il semplice albume d'uovo, o il .. miele 1·osato, l'altea, ed altri pochi lenitivi, sconsigliando l'introduzione di fhlaccie; e non tralascia di dare ra,zionali pre<)etti intorno ~l 1uodo di esaminare le ferite, e di esbrarre i corpi ,estranei, al qualle :-:f'opo ideò e ci lasciò disegnati degli ingegnosi strumenti.
Ma la verità non ,riesce a trionfare dei pregiudizi e degli cr· . .-ori radicati da lungo tempo senza aspre lottù, e le dott,rine del d 1i,rurgo bolog1rnse furono impugnate dai seg·uaci <li Alfonso Fer,ri (1515-1595), chirurgo del pontefice Paolo III, il quale, nei suoi tre llhri ;pubblicati un anno p~·ima (n~l Hi51) cOil titolo: e< De sclopet,u,rum si1;e archihuson1,1n vulnerib'us: »7 aveva scritto: « m,1,inws 8Clopeto sive archibuso factu,m, mu,lMplew est rnorbi genus) multiplexque continui solutio) ·non care1isi veneno. Multiplex niorbi ,<Jenus esse propterea dicitur) quod in eo vulnere adustio) ·contusio) nctritio, fractura venenum ost )).
In quest'opera dedica uno speciale capitolo all'estrazione dei proiettili, p!i:·e,~,entando uno strumento di sua invenzione, e.descrive in modo perfetto [e lesioni e gli accidenti :prodotti dallo .scoppio delle armi da, fuoco. Propone inoltre una pinza a tre branche [)er l'estrazione dei calcoli vescicali, bandisce il forro rovente dalle amputazioni e f.rena le emorragie o con una miscela caustica, ò colla lt'gatm:·a mediata del vaso per mezzo della sutura. Scrive infine (< in ,nodo beJilo et interessante)) sull'iscuria.
Le idee del F,erri sul trattamento delle ferjte d'arma da fuoco, che èollimano con quelle di G. Ba,ttista Vigo, caddero e risorsero molte volte, e per·molti anni, ;prima di essere abbandonate completa.mente.
Bairtolomeo, Maggi descrive con molta esattezza e minuziosi pa,rtico1lari conie in qnell 'eipoca si eseguivano J.e amputa .. zioni, ipcr le quali indicava due tempi, uno iper l'cmosfasi, l'altro per la muti-

l:w,ioue : e vale la ipena di darne,qui un cenno, trattandosi di un c;i 0 pi.tolo poco noto di. storia della chirurgia milita.re ,italiana. e< Quando non ti rimarrà altro scampo, scrive egli nell'opera sopraeitata, ti sairà forza tagUare il membro fraca,c.;sa,to dalle pallP. ed allora opera h1 questa guisa : Loco a.liqito priw; membrum supra. corruptam partem diligabis arctissime) ita id; a,liquo modo obstu,pescat) novacitla, deinde infectam, p(J,rtem a sana, separabis undeq'u<iqite) ad ossa usque; post hoc serra optirQ,(1 falJricata quwrn citissim,e proecide.s) illa · ca;ro condenti propterea vena arl&riaqiie secta et • ferro adurenrla ). primo a,ctissimum senvicor-r·upta erit falcatidn in8tr11.1,mentwn) deinde alio i1istrumento 1Jel gladii fornuim habente) vel aliam formam) u,t sa,ngitinem compritnas -uti poteris) vel si videbitur membrum illiul a quo pittrefacta illa pars abscissa f1,writ ad .so,nam 1.tsqu,e partem in simplex oleitin fervens) (tilt cum sulphure colliquato a,dmiwtiim,) irmnerges )):
L'a,mputazione di un membro in quei tempi· era un 'operazione taJe da for tremare le vene e.ct i polsi ai chirurghi, non meno che ai pazienti. L'emorragia soprattutto incuteva loro spavent<), poichè la. !legatura delle aiterie, sebbené già nota a Celso, era caduta in ohiìo nella barbarie dei temipi medioevali e <loveva, toccare, con1e vedremo, a.a Ambrogio Parèo, Ja gloria·di il.'ichiarna1·la, in ·nso. Crudeli ·perciò e malsicuri i mezzi di cui disrponevano per dominare questo terribile accidente. Taglia•r:e sulle pwrti mortificate il più lontano che fosse possibile dal tronco, passare. aghi infilati dentro [e ca,rni ,per stringère il lacerto in cui scorre l'arteria e legare strettamente con un laccio drcola,re tutto l'airto, bruciare quindi 1e estremità delle arterie recise: ecco i solli ,l.llcz.z.i emostatici che a.Jlora si conoscevano.
Le amputa.zioni fatte so11n·a, il gomito, .e specia1l4ente quelle p1·aticate sopra il ginO<lChio, erano ritenute pericolosissime: << Praesertim :supra geni,,rn) nisi coa,ct11,s) sect1:onem, fa,cere non a,uderes )) - scriv;e il Map;gi - e la ragione di ciò, ,h1t1.a. ILnatomica, è facile a comprendersi. Ta.gliate neri modo descritto le 1parti molli con un coltello falcato fino aJl'osso,' e dopo di averlo segato, · e bruciata · la parte cruenta con una sipada a·rroventata., ,Ri a,spergeva il moncone con um1 miscela di gomma ,e di polvere di <'-al.eante, detta d::i,gli arabi colcotar, alJo scopo di seda1 re il dolore e mettersi sempre meglio al sicuro cont•ro !l'emorragia dei piccoli vasi, mentre per quelli di maggior calibro si ricorreva al bottone infocato. Indi si applicava 1m ompia,stro fatto c~n peli_ di leipre, albume d'uovo, bolo ::irrneno

cfl alo~, si metteva intorno uno strato di stoppa e finalmente fa.Hciavasi l'arto, dandogli una posizione dc.,>clive vorso il tronco.
Bartolomeo Ma,ggi, edotto dall'esperienza di molti anni, aveva introdotto un'utile modificazione a questo processo o[)eratorio; egli pr·aticava l'emÒ'stasi prima di segare il'osso, che veniva amputato qnanto più [)OS1si1Jile v.icino alle carni; 1n·eo<:<:11pa,to inoltre di evi1 ,awe la ,sporgenza e <li <Poter in qualche modo rko1prire h1 vastu, fer·il;a, faceva dai suoi assistenti stirare indietro fortemente la pelle e le carni al diSO[ll'a del taglio, aJfinchè queste, ricadendo, potes:-;1:1·0 in qualche modo costituire un adatto lembo. Egli aveva apweso tale tecnica ùai libri di Celso, ma più ancora, dagli es·ecutori !li giustizia della Re[)ubblica. di Vc:mezia, ('veneti lù;tures, collie 1\µ;li. li chiama), i ,quali, dovendo ta,glfar la mano a qualche delinquente, usavano stirare in su fortemente la 1pclle, poi abbandonarla ;1 sè dopo avore fatto il taglio ed applicarvi sopra i ventriglli di 1111a gallina -<la poco :sacrificata. In tal modo si comprimevano Je :1,d;nie ,e -si _formavano lembi che coprivano il moncone.,
Presentiva, iperù nella mente altri miglioramenti da, intr-od1wsi 11clla tecnica, operatoria, pe1.X'Jhè conchiude dicenòo: « dabo opera, rUis voientìbus) 11,t pr.opedinmn et mo,ioro, et 1.1,tiliora, intelligcis )).
M,a !Per meglio mettere in giusta evidenza; [a chirurgia militare <lel tempo e l'assistenza, sanitaria in guerra, ci si::L permesso di riesumare una delle più fulgide glorie italiane. Giiovanni delle Bande NeN\ celebrato condottiero da, Forlì, della illust.re famiglia Medici, frorentina, figlio· di Caterina Sforza, che per il suo valore fu chia111ato 3'« invincibile)). Parente (li Leone X, ebbe da questi l'incarico di [)Orre alla ragione pa,re<.'.,chi tiranneHi della Marca di Ancona e fu in tale nfficio che egli istituì la ' << cavalleria leggera>> <'>Il introduRse la milizia., che si chiamò poi delle << lande spezzate )> •. Più yasto teatro deJle sue gesta, fu la guerra di Lombmrdia, mossa, {fa Leone X, alileàto con Carlo V, contro l!'rancesco I. In premio deUa sua perizia militare e degli atti di valore compiuti, ebbe il comando di un corpo di 6000 fonti, che, iu seguito, sotto il titolo di Bande Nere, rese celebre e g1lorioso il nome dell~ armi italiane. Nell'anno 1523 sconfisse cd inseguì l'esercito inviato da Francc~o I per il'iconquistare la Lombardia,. cl 1526 tredicimila fanti tedeschi, fatta testa a Bolzano, cala.vano in Italia in soccorso degli imperiali, e per Rocca cl' Anfo e

Uastiglione si spinsero nel territorio mantovano : li guidava Giorgio Frundsber·g, capitano di molto grido. Il 19 novembre gli mosse incontro il dum d'Urbino, il quale aveva al seguito Giova.uni de Medid, e disponeva di un esercito di 600 uomini d'armi, 1000 cavalli e 8000 fanti, essendosi p['oiposto il compito di impedire il vettovag1liamento del nemico.· I tedeschi, presa la via di Borgoforte, . si rifugiwrono a Governolo in posizione fortissima, perchlè difesi dal Po e da un argine assai elevato: Li inseguì Giovanni de' iMe, dici, molestandoli abi1mente nei reparti e in quattro giorni, combattendo quasi semp,re di continuo, tanto li sgomentò che essi lo chi.rumavano riel loro idioma il cc gran diavolo )). Rinnovato l'as-
Rll,lto il 25 novembre, dopo aver combattuto tutto il giorno, l'animoso condottiero, essendo l'ora tarda, stava per, ritirairsi, quando, i nemici sparando a caso cd in arcata colle artigilierie che aveva mandato in soccorso il duca di Ferrara, fu colpito da, una tpalla alla, gamba destra, nel suo ~er1,o superiore, determinante ,la frattura comminuta della tibia. GiaJ1 Girolamo Rm;l,;i, 8110 biografo, ci (fa sarper·e che egli stette 20 ore senza ipoter 'avere qualsia.si soccorso, 1u1,sc-0sto nel suo attendamento rper non ishigottire i soldati, in una stagione fredda e nevosa. :Essendo rimasto fel'ito sul tar·di, passò tutta 1a notte in questo stato, e :finalmente con grandissimo disagio fu di necessità portato a spalli~ in lettiga :fino a Mantova e ricove1mto nel pala,zw del marchese Luigi Gonzaga,, ove fu jpreso da fobb1'C e da vomito. Il giorno seguente, essendosi aeggrava,te le condizioni della ferita, fu decisa l'amputazione dell'arto. Fu dato a Pietro Aretino, suo inti1mo amico, che aveva voluto seguirlo nella spedizione, il pietoso incarico di. annunziare tale risoluzione dei medici a,l1l'illm,tre infermo, ed ég1i così gli tparlò : << lo farei ingiuria al vostro animo, se con iparol e dipinte volessi persuaidervi che la morte sia la curatrioe dei mali, e più paurosa che grave; ma perchè è somma-felicità, il far ogni cosa liberamente, la,sciatevi tòr via il gurusto dell'artelleria, et in otto giorni pokete far reina
Italia, che è ser·va; e sia, il zoippo con cui rima•rrete, invece dell'o,r,éline: di S. Michele, di cui v/ insignl nel ] 525 il re F,rancesco e che mai vo]est_c portaire al c-0110, la distinzionè di gloria; porcbè le ferite e la perdita dei membri sono le collane e le medaglie dei famiglialT'i di. Marte>>. -<< Faicciasi tosto, )) rispose eg1Ii. In questo en- . tra,rono i medici, et esalta.udo la fort,ezza dP.lla, liberation sua, termina,r rper' fa sP.ra l'ufficio che dovevano; e fattogli piglia,r meòicina a,ndaii·ono a ordinare strumento per ciò )).

Sa(Ppiamo il nome dell'o(Peratore, .che fu un ebreo, chiarnato 111:i,estro Abrauno. Approssimandosi l'ora dell'intervento (la sera, del 28 novembre), giunsero i chirurghi cogli strllimenti e gli a,p1parecchi necessari e si distribuirono le ,varie incombenze. Ma Jll'ima ordinarono si facessero venire ottQ o dodici' persone per imillObilizzare l'infermo. << Neanche venti, disse Giovanni de' Medici Ho1Tidendo, mi terrebbe.ro se io non volessi ». E con fermissima, vvlontà e calma a,mmirevole, presa la candela in mano, fece lume 11, maestro Abramo, che, scamiciato sino ai gomiti, comiI1ciò la incisione circolrure della gamba col suo coltello falcat,o. Gli stol'id ci fa,nno sapere che egli tagliò le carni rasente la ferita e che poscia gli diede il fuoco : dail che si .può desumere come egli abbia amputato sotto il ginocchio e non si sia scostato dalle re~ole allora universalmente adottate.
Lo stesso Aretino ci riferiS<:e ohe, essendosi aggravato il male, il ma,ttino successivo aJll'ol[)erazione Giovanni fece testamento: << neJl quale dispensò molte migliaia di scudi in contanti et in ,robe ft·a quegli che l'avevano ,seguito)). Il documento ci fu conservato ,~ vorta, la data deU'« anno Dmwini, li Nativitate eju,8dem, millesimo qningentesimo 1;igesimo searto, indutione q'ttartodecirna, die J ovis, ·1;i.'Je8imo nono novembris )). Da, fedele amico, ·Pietro Aretino lo asN i:,tette fino agli ultimi istanti, e così ne descrive l'a,gonia: « Afla liue dormito ch'ebbe un quarto d'ora, destossi dicendo: Io sog-nava di testare, e son ,guwrito, nè mi sento 1()iù niente e se io vado migliorando così, insegnerò ai todeschi come si comba,tte e come io so vendicarmi. Ciò detto, il lume intrigandogli le [ud cedeva alle tenebre perpetue, onde da sè stesso chiese l'est•rema nnzione. E ricevuto cotal sacramento, òisse: Io non voglio morire in questo letto. Onde fu ae~:ioncio un letto da campo et jyi po~to: 111entre ,egli dormiva, fu co~to dalla morte >>.
Così· si spegneva Giovanni dc' Medici, nel mattino del · 30 novembre 1526, verso le 4 antimeridiane,,: la violenta commozione causata dail tiraumatismo, i lunghi disagi del trasporto, e l'opera½ ione doloròsissima, eseguita tardiva!llente, ne aff.retta,rono la fine.
Degli storici del tem!Po, Gian Girolamo Rossi rpensa che (< la IO.orte 1procedesse dal non aver avuto medici a tempo e dall'ignoranza dell'ebreo, il quale, avendo a segare quella gamba, vi lasciò. del percosso tanto che il riimanente si putrefasse ». E Giovanni Rattista T,edaJdi ritiene che « la cura non riuscì peirchè fatta troppo tardi >>. Corse anche vooe, narra ì1 Guerrazzi n ell'A ssedio (li J!'irenzey che Clemente VII cono~1pesse il c,e,rusico giudeo, e

4[ uesti segasse fa gamba con ferri avvelenati, ma tali sospetti <·addero ben presto, come :pure è da ritenersi che alla. corte dèi Gonzaga,, ove a-flluirono sommi artisti e lettenLti, quali iii. J!Jatina, iI Guarino, Lcon Battista, Albeirti, Giu1io Romano ecc., in un periodo in cui le Università di Pa<lova, Bologrn1 e Pavia erà:no nel massimo splendore, imprimendo il maggior incremento alle discipline medico'.chirurgiche, non mancasse1·0 sanitari di valoire: e quincli è da· mettere in l'iserbo anche ]a taccia di ignorante data al cerusico ebieo mantovano, il quale piuttosto non fu ahha8tanza fol'tunato pcir salvare la, vita, aWillnstre condottiero.
Nel dnq uecento fa chirurgia. di guer·ra fa sensi.bili iProgressi in Italia,, soprattutto per il fatto che i chirurghi. dell'epoca sono a-rnJ1e incarica.ti dell 'insegnanwnto dell'anatornfrL, la quale era tenuta allora in gr·an p•regio ed aveva dato un impulso not(woJissimo aHo sviJup!J?O d·elle discipline chirurgiche.
Fra, le glorie italianr., ricorderemo in rprimo luogo Giov. Battista dri Vigo (14f>O-Hi25), oI"iundo, di Ra1pallo, ma soprannominato lo genoghese) il quale passò la giovinezza a.lla, Corte del 1\fard1esc Luigi. di Saluzzo e quindi a Genova ove studiò medicina e. prestò i;;ervizio all'ospedale Pammntone. In ·seguito ritomù a, Srtluzzo p·resso il marchese, ma essendo questi stato spoglia.to dei suoi beni nel 1487 dail duca, di Savoia, il da Vigo fu co,stretto a, ,ripa.rare tt Ravoua, ove conobbe il ca,rdinaile della, Rovere, che si era, colà 1·ifugiato per· sa]Ya,rsi dalle persecuzìoni di Alessandro VI r· del nipote, il dncn Valentino Borgia. Più tardi seguì il cardinale suo protettore a Roma, e quando questi fu creato pontefice col nome di Giulio II, ne divenne a·rchiatra e lo a(X'.Ompagnò nelle sue numerose imprese bellliche, non cesRando di fare il suo dovere di chirurgo, osser·vando e curando di persona le molteplici ferite d'arma da fuooo e da taglio, fra cui queila di un « todesco, molto famigliare del papa, forito di un hmcione alla veocica )).
Nel 1:i14 Vigo pubblicò il famoso trat,t.ato claRsico, daJl titolo << Practica copiosa ·in a,rte chiru1rg'ica, )), che fu 1presto tn~dotto in firancese, in inglese, in italiano, in spagnuoilo od in te,d,esco, ed ebbe la, fortuna di quaranta edhàoni. Jn esso sono raccolte tutte 1~ ricerche ed i. risultati dell'esperienza di guerra: << La prognosi i~ in rappo1·to, egli scrive, con la ~·cgjone ferita, con la, forma e dimensioni dell'agente vulnerante e con l'assenza o rprcsem,a di

<·OI1)i estranei )). Le lesioni prodotte dalle · armi da fuooo . sono q nelle iproprie deiHe ferite contuse. « L'estrazione tmmedia.ta dei 1·orpi estra,nei, ·OS•scrva inO'ltre, deve pI'eferirsi a quella, ta1'tliva, poichè, se (p1esti in genr.re p0,ssono migrare impunemente nei I essuti, la loro permanenza talora è · acoòlllJPagnata da fenom,eni g· ,1·a,vi )). E proSjpetta gift l'idea della legatura dei vasi col filo a 111pzzo dell'a,go !p'er frenare le emorragie : « i r,itromittenclo acttm s·ub ocna desuver filuJrn stringendo )>. ' Opera il da,' Vigo « con ingegno e prontcM,a .)) gli a.se.essi epa,tid 1·tl interviene abitfancnte neJle lesioni del cranio e della colonna n•t·tcbralc. con un tra,pàno di sua, invenzione e consiglia di (( tag-linre e steripare con tutte le sue vene e ,ra,did )) il canc-ro della 111:1.mmella,. Non a1pp1'0va invece l'estirpazione del gozzo, « vergo~·ua. dei medici e danno dei ipazienti >>, ma interviene nell'a,bla · ilionè dcHc glandule oervicali in .soggetti scrofolot:ii; desc-rive annm.t minutamente la, tecnica cle1l'erniotomia, e si serve di cannule speda.li per l'int,rodmdonc di sali d'argento nèll'uÌ:etra. F~ da dtaire inoltre Maria,no Santo (1488), da .Barletta (Jig. 4~), all.ievo di Giovanni drL Vigo, il quale fu uno <lei più grandi litotomi del suo tempo ed è celebre. per il suo metodo rnàriano o apparntus mag_ nus) appreso d~1l suo mae,~tro Giov'anni Dc Romanis, per ]'estra z. ione dei calcoli vescicalli a mezzo della cistotomia perineale col t:1glio late,ra1e, che egli descrive nel Libelltl8 aitretis cle lapide a vcsica, per incisionern extrahencla) pubblicato in Roma, nel 1522. ()nesto metodo fu hyrgaiillcnte adottato anche all'e~tcro ed Ambr,ogio 1 >ar,èo nO'n disdegnò di e,s,porlo nella, sua, opera monumentale, senza <·itarne ,però la fonte. Til .Santo è allJChe autore del famoso compendiurn in chiritrgùi) edito a, Roma, netl 1516 ed a, Lione nel 1521. Fu r7dto apparecchio maggiore iper distinguerlo da, quello cefaiano. detto m,inore) che 1:·ichieùcva pochissimi s.trumenti per praticarlo (coltello l'd uncino), mentre per il ma1·iano ocoorrevano uno scioringone, uno :-calil)ello, un dilatatore ed una tenaglia per l'estrazione della pietra.
Mariano ,f?anto presP. parte come chfrm·go mitlitare a1la spedi;,. ione di Carlo V contro il sultano Solimano, u,lla quale partecipa1·0110 trupipe italiane e spagnuole: durante questa, camipagna conl.1·asse amicizia col capitano Guiqo Rangoni_ , al ,quale dedicò la, sua opera De lapide reniirn, e potè trattenersi qualche teimpo nei princi1p111.i dannbian.i a Belg: r-ado e a Buda, apprendendo la tecnica ope·ra1 oda dei. chirurghi turchi in raipiporto speci'almente aJ sa.:lasso.
Menzioner,emo anoora Miclielang-elo Biondo (1597-1665), da Ve11~zia, allievo di Alfonsp Ferri, già ,ricordato, n quallc èscrcitò la

modkina a Na,poli e fu fervido sostenitore della curà delle contusioni e delle ferite d'arma da fuoco a mezzo della .$emiplice a,pplicazione deill'acqna, fredda, trattamento che egli riteneva a<ldirittnra (< disce.<;o dai!. cielo)), mentire bandiya l'uso delle s:ostanzc mr:dicarnentose, le quali ritardavano la cicatrizzazione.
}.'ig. 43 - Mariano Santo, da Ilarletta. (*)

Altri rinomati chi,rurghi furono: Fra,ncesco Rota, nato a nofogna eù insegnante chirurgia. in quell'antichissimo tStndio: è autore di un trattato << De tormentariòntm 1Ju,lneruini no,tu,ro, et ciiratione liber ,), puibblicato nel 1555, in cui si dimostra partigianq del ferro rovente nel trattaimento deille ferite : << Ustis ex7wditissim;it1n est CliumiT!i1.tm )) ; Giambattista-Camrno, da, Ferrara, inventore di -un tiraipelle per il'es:trazione dei proiettili da,l torace e dall'addome.
Nè devesi dimenticare . Giovanni Andrea dalla Croce, nato nel 1509 a Venezia, che a soli 24 anni fu nominato membro, poi priore di quel Collegio medico:chirurgico. quindi fu << con .honòrevole sti, pendio pubblicamente salariato da11a magnifica et QPulenta città di Feltre )), ove soggiol'nò a lungo e sali in gran fama come chirurgo per
(•) Sono grato all'amico prof. P. CAPPARONr della gentile concessione della riprodu21ione dei dtrl\tti di alenni medici italiani dei secoli XV-XVIII.
,l'opera prestata negli .eserciti durante le continue guerre che fune,.;Larono quella regio.µe, opèrando fra l'altro un soldato ferito gravemente ad un rene. Egli era solito affermare che << quello che vuol 1•ssere buon chirurgo li fa bisogno seguitaire li eserciti et luoghi dove si fanno guerre,· et praticar con chirurghi vecchi e di lunga l'Sperienza )).
Secondo il Hoheraavc, (Pare che abbia rprestato servizio anche i:ome chirurg1,is classarius. Infatti il òalla Croce sorive che « si vede bene -spesso nei marittimi conflitti e altrove varie ferite iperf o1·anti cor·pi umani')); ma tutta,vh1 non si schiera fra coloro (( che 1 :-:eguono gli· eserciti e vanno con l'armate da mare molto esercì. l~tti nella pi'atica di Oirurgia, i quali. affermano :t;arc volte aver veduto . usdre gli intestini ·crassi»- Il dalla Croce ha fasciato 1111'0tpera monumentale la << Oirurgio, unfoe1-sale et perfetta di tutte le parti portin~nti al ottimo chirurgo) nella q1,iale si cont'iefU}( la fh eoriea et praltiea di ciò che p11,ò essere nella oir11,rgia nccessa,,rio) pubblicato nel 15n, che ebbe l'onore di pa,recchie traduzioni in l'ran<'R-Se, in tedè,CO e in latino.
Nel lihro VII de~crive nell'(( Ofi)cina, della ciru1·gia )) mi copiosissimo armaimenta.rio per gli interventi sulle varie regioni, con molti strumenti di sua invenzione. Per gli atti orperativi sul collo raccomanda, per non ledere il fascio vascolo-nervòso, di sc,pwrare le fihre col dito o con un colte1lo di ·legno; :per le lesifJni ca.'rrli:,che ~i limita. a 1·ictrnoscerP- che « ferito il cuorP-, muore l'uomo»- li'u inoltre. un abile chirurgo nella cura deliFem[)iema e dell'ernia, e per l'op<0,razione della ,pietra fu uno dei primi a lateralizzare il taglio c~l'3iano verso fa na.tica sinistra. Infine consiglia che << bisog11a fa.r taglio)) per correggere la iposizione vizia,ta ~foi frammenti nelle fratture del1Ia clavi.cola e descrive minutamente a,pparf>.(',ehi ingegnosi e strumenti torcolareschi 1per il tl'attamento delle << sconciatul'e ovver fenestratu·re delle giunture)). J:,J sono da ricorda,re a suo -onore gli inte1·venti nelle lesioni del cra.liio, pràticati · ardita,mente con trapano e scal[}ello di sua invérndonc (fi.g· _ 44); il trattrumento delle ferite del torace, diretto di massima ad una cuta aspettante, saJlvo ad aspirare il sangue iil caso di sintomi allarma,nti od a dM esito ai liquidi media,nte drenaggio o a,d eseguire irrigazioni con soluzioni aromatiche, in caso di sopraggiunta infezione; e fìnalrnénte 1à cura dei feriti · addominali, pei quali consiglia la posizione seduta,, perchè i liquidi << se ne va,nno alle anguinaglic come a.1 proprio emuntorio)) e possono essere eliminati con una, piocola incisione. Nè a lui era .. rncora sco-

nosciuta la p•roprietà emostatica dei sangui eterogenei, qua[i ad esempio quello delle toirtore e dei piccioni S<?pra Je membrane e la sostanza cerebrale lese. I~ altresì da ,rievoCT1rc G~1ido Guidi, da Firenz-e, che, :0ltwe insigne anatomico,. scopritore dèlla mancanza di ipori nel setto cardiaco,. fu anche chirurgo di grande valore. Per l'inte!essamento di Luigi Corte di Alamanni, che era tenuto in g1randc oonsiderazione Francia, fu chiamato nel 154-2 a Parigi come medico alla pri· vato del Re e fu nominato professore di chirurgia del Collegio di
Fig. 44 - Tmpana,zione del cranio : dalla Cit"1irgia Uni:vcrsalc di Giovanni Anflrea dalla Croce.

Francia. Perfetto conoscitore della lingua gieca,, dalla quale t•radnsse la iparte chiirurgica d~Ì Corznis hippocraticurn) ana.tomico insigne ed intelligentissimo d'airte, pubblicò, nel 1!544 a Padgi, coi tipi di Pietro d'Antier, un'op,ora: « Chirurgia e Graeco in Latinu,m conversa cum cornentariis », che ebbe 1parecchie traduziòni in f1ranccse ed ha il pregio di essere ado1·na di numerose ed artistiche incisioni, inspil'ate a,ll'arte romanica, rigua,rdanti specialmente la riduzione delle fratture e deliJ.e lussazioni (fig. 45), che taluni non rsitano aò attribuire al Prfa:naticeio. Des<'.·rissc per il primo il nervo ed il canale Gnidiano, che da lui iprese,ro il nome ed ai <fnali legò la sua · fama. Nel J574 fu ~·ichiWlilll,to 1n patria da Cosimo. I, e tenne con grande onore la cattedra di chirurgia nello studio ipisano.
Ricorderemo ancora Giulio Cesare A,rizza.ra, da Pisa, chi1·urgo di Ferdinando, Princi1pe di Toscana,, che in una traduzione deil Cauliaco aggiungeva queste sue note personali: « Gli uomini gTandi nella chirurgja sono quelli che seguitano e mc<lkano-nelle hattaglie, vantandosi talvolta aver fatto, come cssi dicono: ta.nte
Fig. 45 - Riùuziono della Jnasazione dell'omero destro: Chirurgia di Guido Gnidi ·- Pubblica,ta. a Parigi nel 1544.

e tante campagne in ,qualità, di (•.hirui:go. Circa a questo punto, parmi potere, anzi ò.overe p·rimieramente stabilfre, che quegli che esercita, la chiorurgia nell'armi, va, o chirurgo già provetto, buon teorico e pratico, per servizio di Re o sim.il gran persona,ggio, che Reguiti la milizia, ovvero è destinato chiru.rgo ministro di esso. 11c-r il pubblico servjzio del caimJPO.
« ,Se è nel primo modo, concedo, che i gran ,principi per se,i·yizio della pro1pria jpersona, possono condurre uomini grandi, ma in quanto agli altri, dico essere imrpossibile, che i gra~di' uomini si espongano ai porieoli della guerra e che gli altri di oondizione inforio,re possano rendersi grandi. Parmi (tralasciando molte ragioni, che sopra questo potrei esporre) che a chi dice, che tali uomini ponno .con franchezza grande mostrare il modo di curare
Fig. 46 - Gabrielo Falloppia, da Modena..

le fe1·ite, si possa rispondere che nemmeno nel campo militare si può ben e'sercitarc nena curJ1 delle fe'l'ite, non che app•rendere la buona, chirurgia, per ragiorìi già addotte )).
E finisce col concludere che l'ammaestramento dei giovani chirurghi1 si doveva fare nei luoghi ove buoni e dotti maestri si trovano, cioè nei sacri iuoghi od archio~'lpcdaH, che sono veramente studia sapientitm.
Due secoli do1PO, Paffermazione delP .A rizzari:1, d1e i grandi chirurghi non si es1pongono ai pericoli della guerra,, riceveva una
solenne smentjta dai sommi scienziati che seguirono le armate napoleoniche : Larrey, Percy, Assaijjni ecc.
Ai. fasti della chirurgia italliana del Rinascimento è legato il nome di Gabriele Palloippia (1523.-1563), da Modena (fig. 46), il •ttmìe. fu anche uno dei ipÌÙ grandi e geniali a,natomici del 500. Rinunciato ad un canonkato in IJ)atria., studiò dappdma a, Per rara, poi a Pisa e quindi fu chiamato dalla Re1pùbblica di Venezia ad insegnare anatomia e chirurgia nello Studio di PaJova : l 'Haliler lo chiruma indefes,su:s ma,gnus inventor. La sua opera più importante è costituita da,lle Osservazioni anatomiche pubblicate a, Venezia nel JG6J . Egli scoprì le trombe uterine, che portano ancora il suo nome, i nervi trigemino, acustico e glosso-faringeo, il seno sfenoidale, la corda, del timpano ,ed i canali semkh·colari. 'l'entò di ottérn~re la guarigione delle ferite colle semplici medi,cazioni. « mo1li candide e pure, trrL quali si coi;na.nda molto il bombace pe1· Ja sua mollitia,, biandrnzza, copia>>. E diede 1p,ratici insegnamenti sulla ridmdone (folle f.rattnre e lussazioni; suJJla, lcg-a,tura dei va,-;i) rtLOComandando di non comprende1~e nel faccio i rn~rvi viciniori, <li isolare l'artel'ia ,coll'unghia,, e c< con sehL intorfa, e (lll1Plica.ta .. >> ,stringerla moderatamente; suill'intcrvento nelle ferite craniche, consigliando larga.mente l'uso dcii. t,rapa.no: sulla, rinopla,sti<·a,; snll'f1bla.zione del cancro. della, mamrnel1a; 'lu l ta,glio jipoga.strko nella cistotomia; sullrh curatfone dell'c-rnh intestina.ile, ris1parmiando il testicolo; suJla tecnic~ dell'empi emn, e delle sutu1;e intestinali e infine sulla, particolare curMione della ,dilatazione uretm1e con candelette vP,getali.
Per il tifo ·e~a;nlematico già intravede un nesso per la, s1rn, propagazione con la, carestia e con la guerra,, e getta, le prime basi del .concetto- della, contagi-0sità, nell'attJrihni•re i morbi infettivi a con- . ta.minazione dell'aria. Si oocupu, anche del!la peste e ne studia il modo di diffusione, la quale IJ)HÒ a,vvenire anche dopo cessata l'epidemia per l'uso delle cose infette. Dedica infine la sua attività allo ~tuclio della-~ifilide 1proponendo come cura profilattica,. un unguento da spàlmar·e l'asta ed ostruire il mea.to nrinairio ed nrrn, tela finissima unta dcilla stessa sostanza d~1 ricoprire il glande durante il coito.
Falloppia. morì nel 1563 a Padova, e fu SC.lf.Jollto ncJla chiesa del Santo : sul suo seipolcro fu inciso questo epitafio :

FallOJJ'i hic tunnào solus non conderis : una liJst variter tecum, nostra sevpiilta, domus.
Citeremo anoora Filippo Palazzi, da '1'1·evi, allievo c1i F a,lloppia, 1,trenuo sostenitore del trattamc,nto delle ferite <li guerra, coll'acqua di fonte ,e( rimBdio comune a tutti e di ninn costo)). Ciò che feee escla.Jna;re a1l suo contempora,neo Brambilla,: « Oh che felicità 1per le n.rma,te se tutto dò che dice fosse vero! )). E lo designò ~a,rcasticamente col nome di chiru.rgo rwqu,11.iolo.
Leonairdo Botallo, nato nel 1530 in A,'sti, altro sc-olaro di Falloppià, trascorse ]a, maggiDr pa,rte della, sua vita a, .Parigi, ove fu medico di Carlo IX, d,el duca d'Alenç,on e di Enrico III. ~ella, sua opera Do <Ju.ranclis Vulncri1n1,s Sclopctorttrn~ pubblicata a Lione nel 1560, combatte J'oipinione, fino allO'ra prevalsa, della velenosità delle ferite <la arma ·<fa fuoco e del conseguente trattamento col cauterio ed espone interessanti osscirvarL.ioni personali sulla tra1panazione del c1·anio e sulla cu1•a clel1lc lesioni di guerra, sostenendo l'uso dei mezzi più semplici sul campo di battaglia: << In corpore MLno :saepe twlo b1ctyro quoa<l caro oontus<i separar-i irwiJ)it, ,xmtenti snmus )).
Alt,ro chirurgo fra i ipiù rinomati del Rinascimento è Gerolamo Fahrizi ,d' Ac~11rn1pendent-c (1537-1619), pme aillievo di Falloppia. InNigne anatomico si a,ffer-mù :s-opr-aUntto per le sue diligenti oRservazioni sull'utero e Rnl feto e per la sco[)erta delle valvole delle vene, fatta nel 1574 e fu precursore del Bo-relli nella :fìsioilogia, dei movimenti. Fu lettore di chirurgia a Padova nel lf>fi!'i e di anatomia nel 1571, cd ebbe Ia,rgo stuolo di discepoli ac,,corsi fin dalla, Spagna, dàlla Danima,rca, da11la Svezia e dal Belgio. Per le girandi sue be· nemerenze ottenne la, cittadinanza onoraria e dal Senato della Repubblica Veneta venne creato Cavaliere <li S. Miarco. Dopo otto luski di insegnamento, ebbe il privilegio di nominare nel 1609 il suo successore in persona di Giulio Casserio, inserviente a-natomioo, celebre per i suoi studi sugli organi {lella voce e <lell'u,cÌito. Morì nel 1619, ad 82 anni, iasdando una cospkna eredità di olke 200.000 ducati, frutto della lar,ghiRsima clientela acquistatasi fra le· più cos,picue ipersonalitù. del tempo.
Nella sua opera ch.irurgica Pentrde1,cco espone utilissimi ammaestramenti sulla ,riunione immediata delle ferite con empiastri agglutinativi con la sutura superficiale e p,rofon<la,, sostenendo la necessità dell'emostasia, a mezzo <lella legatura <lei vasi (LVI . C. 2), della nettezza e riposo della paùe 1lesa, nonchè. della ~emplicità della medkazione. E .s:i trntUene ancon1 con profondt1 1lottrina ~ulla tracheotomia « nè difficile nè .,peri,eoilosa, >), sulla toracotomia,

s11lla toracentesi od nretrotomia, sulla cura ddle ernie, delle :fi.111.osi e dei 1r·estringimcnti uretrali.. Si può anche ritenere un prei· 1wsore dell'ortopedia:, rper avere ideato ingegnosi appn.1·,et.cld. e 111acchine per il trattamento delle deviazioni ossee.
Non meno famoso nel campo della chi,rurgia ip;lastica è Gasipare Tagliaoo':llzi (lf>46-1599), da Boilogna, (fig. 47). Laureatosi a, :.!4 a,nni in quel famosQ Studio, vi insegnò più tardi anatomia e chi-
Fig. 47 - Gaap:n·e Tagliaoozzi, da. Bologna.

rur,gia, con lo stipendio di 200 ducati por la prima materia e cospicuo assegno II)Cor Ja seconda. Fu il iprimo a praticare con indirizzo veramente scientifico e su basi anatomiche, la rinoplastica, già familiare ai . chirurghi siciliani e calabresi (famiglie Vianoo e Foiano), :prelevando il t lembo <'!ella.cute <Jal braccio e :fissandolo al naso con a,pparecchio inamovibile, fino a completo attecchimento. Qu est-0 metodo fu esposto nella sua opera « De ciirtorum ohiriirgia 7)er insitionem >> . Il Collegio dei medici di Bologna gli eresse nel teatro a.'Tlatomico dcliJ' A,rchiginnasio una statua, ehc lo ,raffigul'a ~tl'ingente f,ra le dita un naso reciso.
Introdusse infine una meravigliosa tecnica nelle p[a,st.icbe del naso, deHe oreochie e delle labbra, in quell'eipoca deturpate dalla sifilide, ottenendo irisu]tati sorprendenti.
Ricorderemo altresì Giusepipe Plazzoni, professore all 'Università di Padova, che pubblicò nel 1570 in Perugia un libro « Dc veris methodo quibuscumque vulnerfbus rnedcndo )), in cui si fa sostenitore dell'uso dell'acqua semplice nella mediicatura delJ.e ferite e nel 1603 un trattato teorico « De 1;11lneribus salopetor,uni )). Ed ancora Francesco Muratori, da Bud,rio (Hi69-1630), aùtore di interes'. santi memorie sulle ferite d'a,rma da fuoco, letto·re di chirurgia nell'Archiginnasio di Boilogna e [Jrim~rio dell'ospedale .La Vita.
B da menzionai1·e altresì un precursore dell'educa,,;ionc fisica, Girolamo Mercuriale (1530-1606), il quale insegnò jper 7 anni a Roma e per 17 a Padova, quindi fu 1J..ettore, dP-lJe Uni.versità di Bologna e di Pisa. La, sua opera più importante è quella dal titolo << Dc wrte gymnastica )), in G lib,ri, della quale si hanno 5 edizioni.
Attenendosi ai principi di Galeno, il l\forcuriafo suddivide la g·innastica medica in boll'iua) leg'itùna sive medica et 1;itioso, 8CU athletica,, distinguendo in tal modo la ginnastica. che ha, lo s,copo di· addestrare j giovani alla, guerra, dalla ginnastica :fisiologica, che consiste nell'ei:;ercfah, moderato del sistema muscola1·e e nm·voso e daJla ginnastica atletica e profe~sionale, che svi:111:ppa, eccessivamente i muscoli, a danno di altri organL L'opera è illustrata da numerose indsioni deil Ligol'io, che riproducono specip.,lmcnte i giuochi ginnici .greco-romani, ,e si può ritenere uno dei più importanti favori che sia stato scritto sull'a,rgomento.
Come si vede, agli Italiani spetta un posto eminente nelila chirurgfa del Il.inasdmento ed il' l'!lerito di avere spianato fa, via al progresso f1cl1a. tr·a,11rnat-Ologia, di guerra. Soùo infatti gli Italiani che introducono per primi la narcosi negli int~rventi, soHeva,ndo il pftziente da indicibili sofferenze e rendendo più ca.Ima e tranquilJa l'operazione; sono essi che applicano per primi nel trattamento delle ferite una semplice medicazione con fasciatura occlusiva; sono essi i primi a b~inq.ire il f.r,,rro rrovente nell'emostasi ed a :praticare la 1Iegatura, dei vasi, sanguinanti; sono essi infine i pri~1i a suggerire mezzi pratici e raziona.Ii per la rLduzione àcllc frattu1·c e delle lussazioni. E questo nostro primato, oltre che ai [)rog,r,essi notevolissumi nel campo anatomico fatti in qncl tempo, si ·deve ascriv,ere anche alla conoscenza :perfetta dei classici trattati, al perfezionamento della tecnica ed a.Jla quotidinrm ossrrva-

11ionc del malato, che contribuirono validamente a portare le di~cipline chirurgjchc e la medidna operatoria, ad altezze mai ())rima ,,·aggiunte.
II. - LA CHIRURGIA MILI'l'AltM DML CINQUECEN'l'O IN PRANCIA. ,
Dato così il meritato ,posto d'onore alla chirurgia, italiana, ci occuperemo ora, della chirurgia militare presso le altre nazioni.
I J

Fig. 48 - Ambrogio Parèo, a 72 anni (con la firma autografa).
L'astro maggiore sorto in Francb in questo periodo, e saJutato come il padre della, ,chirurgia fra,ncese, <~ Arn b1·ogio Parèo (fig. 48), figlio di t~n negO½bnte di bauli, ugonotto. Nacque nel 1517 :~ ~ourg-Hcrsent preR,RO Savane. :Fu apprendista, nella sua giovinezza., in una bottega di ba,rbiere ed ebbe una grandissima, prre-
dilcidone fino da questa età per gli studi anatomici. Si na.r,ra in p1·oa)osito che, essend-ogli stato offerto il cadavere di un giustiziato, l'avesse irmba1samato e se lo fosse rportato con sè per oltre 25 anni per poterlo studiare in ogni circostam,a. Dopo quattro armi di assiduo studi.o all'Hotel-Dieu, ove aveva. potuto ese,rcitarsi in numerose (lissezioni a,natomiche ed arpprofondirsi nena pratica coll'esame quotidiano di un gran numero di maJlati ivi ricoverati, salì ben presto in gran fama, per avere preso subito posizion·e in una lotta tenace e fierissima ingaggiata contro la facoltà parigina, che aveva ordinato la distruzione dei siioi manoscritti, nei qua.,li combatteva efficacemente tutte le 1p,resorizioni de]fa medicin,'1., scoIa,stica di quei tempi.
Ancor giova,ne, a soli 19 anni, Pa,rièo seguì in Piemonte il maresciallo di Francia Rena,to. di MontejeaJ1, comanda-nte deTia fanteria francese durante la cainpagna d'Italia, che durò dail 1536 al 1545; cd anche ·egli, in principio, si attenne al metodo della « therapia, cru(lel·is >> e<l a.Ha ùornmetudinc di curare le ferite di a,1•chibugio con oUo bolilente, w11d1e :se Io•sf,el'O in pro~-simità, di nervi e di applica,rvi l'unguento ,egiziano, se,conclo la, formula d'Avicenna. Ma ben presto negò la velenosità ,di queste ferite, e limitò l'uso dell~ sonde, deg11i stuelli e dei setoni e di tutto ciò che poteva, disturbare iil processo <li c.katrizzazione della, lesione; s~rap:pò gli amputati e gli operati di ogni sp,ecie aUa, tortura del feri'o m,roventato e dell'olio hoillente, usato fino allora come mezzo emostatico e ritornò al semrplice balsamo costituito da una miscela di giallo d'uovo, miele rosato ,e trementina, col quale dovevasi ottenere la cicatrizzazfone delle ferite·<< senza infiaD}n.tazione o gonfiore )). '
Tale è l'importanza di.questa, rivoluzione llf\] trattamento delile IeRioni di guerra da arma da fuoco . che nrnrita l'avvenimento di essere ,ricordato con le ,parole stesse di Ambrogio Parèo: (( L'anno 1536, jl grande Franceseo II inviava le sue trup1pe in Piemonte per assediare Torino e ,riprendere le città e castella,, cd io fui ben lieto ,di segui,re l'esercito, per1Chè anco,ra non. avevo potùto osservare il trattamento d·elle ferite d'archibugio, quantunque avessi giù, ],etto m~l 1priano ca1pitolo di Giovanni da Vigo sulle ferite in generale (cap. VIII) che le lesioni prodotte da arma, da fuoco sono velenose in causa ,della polvf're e che perciò dovevano essere trattate per mezzo della, cauterizzazione coll'olio di sambuco, mesc,ola,to con un poco d.i tedaiea. E per non sba,gliare, si sconsigliava di usare 9lio bollente, ,che rprocnraNa, atroci sofferenze a,i feriti. Da princi-

pio volili anch'io aipplicare quest'olio bollente al massimo grado; poi, non avendone più disponihi1le, fui costretto ad applicrwe un semplice digestivo fatto ai gia,llo ò'ovo, miele rosa.lo e trcmenta. i\1[a alla notte non ipotei chiudere occhio, preoccupato dal pensiero i:he, non avendo potuto trattare i feriti coll'olio bollente, li avrei dtrova,ti a,l mattino seguente morti avvelenati. ,~Ia rprnle non fu la 111ia, sorpresa quaindo, ailzqtomi òi buona, ora, potei constatare personahnente che i feriti medicaiti col digestivo aNevano potuto riiposn,re tranquillamente per tutta la notte, presentando inoltre nna diminuzione ·aell'in fia1mna,zione attorno alla piaga, mentre gli altri pa:,;ienti trattati coll'olio bollente P-rano febbricitanti, molto soff~renti ed avevimo una zona attorno aJlla lesione arrossata e<l i nfiamma,ta. Da questo momento venne la risoluzione di non brndare p~r l'avvenire le ferite (lei poveri ,soldati colpiti da archibugio )). -vale ancora la pena •di riesumare un cnrioso ti-attarnento, orma,i obliato, delle ferite d'arma da fuoco di quej ternipi. Il Pa,rèo, avendo · appreso che un mDdico torinese era, salito in gran fama per la cura delle ferite d'archibu,gio oon uno s1pedale unguento da I ni iii rato, prima, di far ritorno in F,randa, voille conoscere il R<:greto di qu,el medicamento. Ed il medico ben volentieri lo svelò.
« ·Mi tmandò a cercare, sùrive a questo riguardo Pa1rèo, due piecoli ca1ii, una, Iil1bra. di vermi di terra, due libbre d'olio di lino, sci once di tcrebcnthina di Vene7,ia ed un'oncia ò'aùqnavite, ed in mia p,resenza 'immerse ancor vivi i cani nel suddetto olio e li fece bollire a lungo, fino a che la carne si~fosse staccata completamente dalile ossa; poi vi aggiunse i vermi che aveva fatto m:orke nel vino bianco e gli altri ingredienti. E chiamò Dio a testimonio che .questo era il suo famoso rimedio, pregandomi di non divul~arlo )).
Questo balsamo iper la cura delle ferite d'arma da, fuoco fu nsato per molto teill!)o dalilo stesso Pa,rèo e dai chirurghi militari del XVI s~olo. Ed è da presm:~ere che la prolungata ebolilizione · riuscisRe a rendere strrile la miscela così preparata, che si manteneva tale coll'aggiunta dell'acquavite. Ma l'uso di topici « SUIPIPUrativi )), come egli. era solito chiamarli, determinava quasi sempre ]o i;;;viluippo di un'infezione purulenta,. Le forite, anche ile più lievi, davano luogo a :supp\1razione, e nelle battaglie di Hesdin e Rouen il numero clei colpiti da infezione, con esito letale, fu'. enorme. Allora, Pa,rèo attribuì quelle suppura,zioni all' « a.ria 1maligna, e cqr1·otta )); ed, in luogo dei sµppurativi, ricorse agli ung·uenti Pgiziaco,

,n.ercuriaJle, canforato ed altri simili, sciolti nel vino ed iniettati nella ferita mediante setoni o sonde.
Nella Sufi, opera Dc 1;ulneribus sclopetorum) riferisce di alcune curiose esperienze rpersona,li fatte imme,rgendo le pane d'archibugio in una miscela di succhi <li rododendr-0, di napello e di ranuncolo, e constatò che iil peso della. miscela,, dopo l'immersione delle palle aumentava, mentre avr,ebbe duvuto diminuire se il piombo, come si riteneva allora, dalla maggioranza, iper la sua permeabilità facilitasse l'assorbimento dei succhi velenosi anche in piccola dose. Aii:nlinetteva inoltre che i1l risca,ldamento dei p:roiettili per effotLo dello spairo avrebbe contribuito a distruggere in gran parte i vapori <lei veleni, che 'eventualmente vi, fossero penetrati.
Il Grevin invece affermava, l'esistenza di veleni volatili che, cos1>a!I'si sulle staffe anche in minima quantità, avevano il 1POtere di csse1·e assorbiti dal for:ro delle staffe stes~e e dalla suol.a, dei calzari, raggiungendo così gradatamente [a ipianta del piede del cavaliere e p1'ovocando rapidamente manifesti sintomi d'avvelenamento.
Nè meno scalpore suscitò la sua 01pera << JJf éthode de traioter le8 pla,jes fa,ictes par harq1.wbuses )), per aver osato lui « cornpagnon bairbier )> di espone in lingua francese i risultati della sna esperienza in materia di traumatologia di guerra. Egli nega, la velenosità delle ferite, cd alla polvere pfrica penetrata nel canale deJla lesione ascrive soltanto un'azione infìammato1·ia: perciò la dilatazione di detto tragitto con lo sca,lipello e la introduzione snceessiva di olio bollente non.fa.ccv.ano altro che sciogliere detta polvere ed evitare la cancirena.
Nellle amputazioni il moncone non è ipiù cauterizzato, ma ricoperto oon lombi formati da parti molli sui quali viene praticata l'emosta:sia e dopo sono 1n·otetti con vescica umida ùi animale. Lo studio dell'estrazione dei proiettili è trattata, con buone eono.~,cenze anatomiche e con esatta descrizione dei cauteri e deg1i strumenti · (fig. 49), fra cui un tira palle a tJ,c punte, un cava,.f.reccie, ed un apparecchio per ridu;r,ionc delle lussazioni, da, lui id,eati.
Ambrogio Pa,r.èo :fu uno ·dei primi a praticare l'estensione continua neJ fa·a,ttamento delle frattnl'e ed a segnailare il sintomo importantissimo nelle f.ratture dellle coste dell'enfis,erna sottocutaneo. << Qua,ndo, egli. osserva, si comiprime con la mano 1,1ulla parte, si sente l'aria che se ne va con un rpiooolo s,cricchiolio e vi resta, l'impressione del dito come negli edemi)). Amunette ancora, la possi-

lii Lità dell'incistamento dei proiettili nei tessuti e della lung~1 tolleranza,, e dà preziose jndicazioni per la loro estrazione: << Occor,re, egli consiglia, mettere il paziente nella posizione approssi111::Ltiva in cui trovavasi qua,ndo fu ferito, perchè i muscoli ed altre parti del corpo, diversamente situati, possono ottura,re ed irnpe<lire la, via. E per trovare bene le pa,lile, è necessario cercal'le col dito, piuttosto che con altri strumenti, « le sens du tact étant plus eertain que nullle sonde on a,ntre chose insensible )). E nel I 1536 p·l'ati,ca la prima diswrticolazionc del gomito per cancrena gasosa,.
Fig. 49 - Strumenti chÌrnrgici e cauteri dell'epoca di Ambrogio Pa,rèo.

Ma SO[lrattutto è la Iegatm·a dei vasi alla surperficie · di sezione ileHc amputazioni, già nota agli antichi, ma poi dimenticata, come 1·iferimmo precedentemente paJ'lando di Giovanni da Ca,samicciofa, il magg·ior t'itorlo di_ gloria di Par<',o, che cg·li rese di pubblica rag-ione in una memoria pubblicata in francese nel 1552. Un giorno, in cui discuteva coi chirurrghi Stefano de Larivière e Francesco R.a,sse, del Collegio òei santi Cosma e Dantia.no, sull'atpplicazione del ca,uterio per frena.re le emorragie, avanzò l'idea chP., dal momento che 8i pra,ticava la legatura delle arterie e delle vene nel1e ferite ,1·eccnti, essa, poteva essere egùa,lmente estesa anche in caso di am-
putazionc. Ed infatti, durante l':u;sedio · di Danniliers, su un gentiluomo del duca di Rohan, òJ.'imasto gravemente, ferito da un co~po di colubrina . alila gamQa destra con frattura comminuta, Parèo praticò l'rumputazione dell'arto, senza ricorrere al ferro rovente, ma limitando1si al.La legatura dei vasi beanti nel tronco d'amputazione (fig. 50).
Fig. 50 - Ambrogio Parèo pratica la legatura 'delle arterie sn un ferito a1l' assedio di Dannilliers. - (Quadro di Chartran, alla Sorbona-Parigi).

Per la fama nniv,ersalmente acqui~tata P:mi>o fu nominato nel 1554 membro del Collegi-O dei S;S. Cosma, e Damiano a Parigi, non senza però vivacP, opip·mdzione per parte dei m<tgùdri della Sorbona, i,gnorando egli fa, lingua, latina,. In una memoria pubblicata nel 1582 impegnò una strenua battaglia contro la tera,pia, delle ferite a base di polvere di mumia, e di unieo1·n-0 allora genenilmente in uso e per la quale ebbe a sostenere [Polemiche violentissime.
Parèo enumera diverse ,quail.ità, di m~,.dicamcnti nena cura delle lesioni da a;rma da fuoco: repellenti, attraentì, rìsolventi., suppuranti, emollienti, detergenti, sarooLici, €ì_Pul:otici, glutilianti, pirotici e anodini. Il nome stesso indica le proprietà, te1·apeutiche e l'azione specifica di ciascuno di p,.ssi.
Parèo fu inolfa·e uno dei p1'imi ad usare i trapani a corona 11(:lla craniotomia, a riesumare l'operHzione di pla:stica del labbro lc•porino, ad applicare i cinti JPer ila contenzione delle ernie ed a p ,·atica,re il maissaggio nel trattamento de11e fratture. Fra gli scolar-i di Ambrogio Parèo sono da ri-c.ordare A<lriarw e Giacomo Amboise, Bartolomeo Cabro! e ·Pict,ro J,--,ranco, Prove1rnaJe.
A Pa,rèo non dobbiamo inoltre dh;conoscere il merito di aver l,,1·ascorso quasi tutta la vita sui campi di' battaglia pa,rtecipa,ndo n ben 45 campagne, sotto i regni di Enrico II, Fntnccsco II, Carlo lX ed Enrico III, e di aver dedicata tutta la sua attività alla e m·a di un numero straordinario di feriti. « Dio sa, egli seri ve 11~Ha prefazione delle sue 01pe,r,e, quanto n giudizio di un uomo si rperfe:doni in questo es,ercir.io, ove, il vantaggio essendo remoto, i I solo onore ci vienè e ] 'amicizia di tanti valorosi soldati, ai quali si salva la vita, come, dopo Dio, posso va,nta1rmi d'aver fatto a 11 nmero infinito)). F.,d è di P31rèo l'osservazione che i semplici solda,ti siano meglio cnmti dei gra,n<li capitani : « 8e fosse stato p,r·incipe, cg.Ii nota, non ,si sarebbe salvato, a cagione che non av,r,ebhe voluto soffrire ciò che l'arte comanda cd i. chirurghi. sì ard ita,nrnnte non :wrehhe,ro fatto 1 'ohlJlligo loro)).
Nel 1543 fu al seguito del duca di Rohan nella battaglia di I 'e1,pi,gnano e si distinse per avere estrt:ttto con prontezza ed a.bilità rm proiettile daJla s,pa]la destra del maresciallo duca, di OosseH<rissu,c. Ogni compagnia di soldati disponeva allora di caissoni <·ontenenti i medicinaJli e gli oggetti di medicatura, ma in quantità CJ uasi sempre insufficiente. E Parèo descrive le sofferenze dei feriti e quelle dei IP'l'igionieri, di cui aveva diviso la sode, per la. Je:ficienza <li personale e <li materiale sanitario _ e, per quanto zelo adoperasse nell'alleviare le sofferenze aìtrni, le sue forze erano impari allo straordinario numero -degli abbisognevoli di cura.
Nel ~545 fu 1prcsente aJll'assedio di Boulogne condotto· da Enwico VIII, re d'InghHtel'l'a, durante il quale Francesco di Lorena, <lnca, _ di Guisa, dmase ferito alla faccia da un colJPO di lancia al <li sotto d:eWocchio dèstro, in conseguenza del (Jnale residuò una cicatrice detuI'!Pantc, donde il soprannome di sfrer;ia,to. Paroo praticò l'estraz;ione del frammento di lancia, !ricorrendo alle tenag1lic (li un manisca,lco, e per esercitare tutta la forza necessaria, non esitò di punhH'C un piede sulla faccia, dell'illustre persom:bggio, dopo averne ottenuto relativ,a licenza.
Francesco <li Lorena, con geniale ·iniziativa, fece requisire in

questa circostanza un gran numero di barbieri chirurghi, anticipando lo,ro denaro per l'acquisto dei medicinali e dell materiale di medicazione necessari e curò l'impianto di osipedali da campo per le proprie trup!Pe ed altri ,per i ·prigionieri di guerra,. l\la, soprattutto l'am·ivo di Parèo oontribuì a s()lllevare il mùl'ale delle trvppe, ed, a quanto riferisce il Malga..igne, il duca, che sapeva. colpi-re l'immaginazione dei suoi solòati, lo prese11tò egli st,esso nel 1552 all'assedio di M,etz, fatto da Oa.rlo V, sulla hrr.ccia a tutti i
Fig. 51 - Ambrogio Parèo nel 1552 all'assedio <li Mctz, acclamato rlai corub;1tteuti.

princi!Pi, signol'i e capitani, ·che lo abbracciarono· ed accla,:rnarono come un salvato·re (fig. 51). B Parèo, per ordine del Re, Enrico II, attraversò imipavido le file <lei soldH.ti per incoraggia,re gli assediati e 1po1·tare loro il soccorso dell'a,rte:
L'assedio di l\Ietz durò da,l 20 ottobre al 26 dicembre 1582 ed in quef!t,0 periodo il se,rvizio s:mitario nelìa piazza fu sufficientemente organizzato: i malati e feriti vennero prontamente ricoverati neg.li osped.aJi e i contagiosi fm·ono isolati in repa,rti speciali . . Al personaJle sanitario furono concessi i fondi necessari p,er il manteni.mento e l'assistem,a degli jnfermi; n9nchè per assicnrrure l'igiene e la pulizia della città.
Gli assedia:nti invooe ebbero a. soffrire gravissimi disagi per il freddo è per la mapcanza, di allimenti, fattori che contribuirono enormemente alla diffusione delle malattie castr·ensi, q mdi la dii:;f:enteria, lo scorbuto e il tifo e.santerr1atico, che caust~rono una perdita di ci11Ca 20.000 uomini: e moiltissimi feriti rimasero senza soccorso e molti caidavcri ,rimasero insepolti.
Fatto òe•gno di essere messo w ,rilievo che durante l'a:Rseclio <li M,etz <~ominciano a jprevalere sentimenti umanitari verso i p,rigfonieri di guerra, che vengono trattati con un certo riguardo. come i combattenti-di ,part(; propria, precor,rendo così di tre secoli i principi di rispetto e ,di ·prot.ezione cl1e saranno sanciti n:ffi.cialmente nella convenzione di. Ginevra. · Nel 1550 Ambrogio Pa,rèo scR,se in Italia, coll'armata di Entico Il alla guer,ra di Modena,, ove forse ebbe occasione di inMntra,rsi con Bartolomeo -Maggi, inviato a, cur·al'fdl nipote di Paolo III.
Anche nel J 553 'in Picctwdia, all'attacco di HesdiJ1, egli fu inviato a p1·e.sta.re l'opera sua, che fu quanto mai ardua e difficile per la mancanzà di viveri, di mezzi di ,ricovero, di biancheria e di ogni più elementa,re mezzo di soccorso: e fu, anche in questa circosta,nza, altamente api[)rez.:ilata e ricompensata dal Re, che lo nominò 0onsiglieÌ'e e :primo chirurg{?.
Nel 1556 lo. troviamo ancora. alla battaglia di St. Quentin ove· ebbe occasione di cura,re il Connestabile per uha ferita di !Pistola a.i dorso e nel 1557 fu a Dourlan, assediata dag1li Spàgnoli; nel 1562 pa,rtecipò àll'attacco di Rouen, nel 1563 alll'as,sedio rlell'H.av1:e e infine nel 1568 prese parte al111 spedizione in :Fiandra.
Parèo, àvendo guarito con la, semplice applicazione di terebenthina Carlo IX di 1ma ferita al ne,rvo· mediàno, provocata inavvertita.mente du•rant~ un .salasso, ne fu largamente ricomtpensato, poichè nella tragica notte òi S. Ba,rtolomeo, in cui vennero maiSsacrati circa 30.000 ugoi1otti, ebbe salva la vita dallo stes..-;o 1·e, che 110 nascose nella ,sua alcova. Pareo era uno dei· pil'J. ferventi ugonotti, ed· avendolo' il ·morn}rca invitato a convertirsi alla religi,one cattolica, egli •ricoròava. con fermezza la promessa che lo stesso sovl'ano· gli aveva fatto di chiedergli tutto, tranne t]uesti quatt>ro favori : .di rientra,r.e. nel seno di sua maidre; di astenersi daJ partecipare ad una battaglia o combattimento; òi abbandonare i1 servizìo a Corte; e di ascoltare la .meRsa. rimàse incrolla-hile nella sua fede protestante. '

15
I * * *
Aceanto alla costellazione maggiore di Ambrogio Pairèo, ritenuto giustamente come il pa<lr,e della chirnrgia francese e il primo autore òi un trattato di chirurgia milH,are scrittò nella lingua natia, bri(l.la,no astri ·ai seconda g_ randezza, che meritano di essere segnalati.
Fra qnesti, Nicola Goddin: fu uno dei 1primi a pratkare la comipressione <ligi tale sulle ferite dei grossi vasi. Il suo trattato òi chirurgia militare fu tradotto <lal latino •jn francese da (Hacomo Blon<lel di LUla nel 1553, ed i11 esso si afferma anoora la velenosità <lelle forite d'arma da fuooo e se ne eSi.Pone un sintoma particolare << Ceux qui soccombent rendent souvent· un ou deux jom·s ~1Vant la mort du sa,ng pa,r lcs na.rines, la, IJouche ou le fondement. Ce sang provient dc la maHgnitè de la pou<lre qui l'a, infecté, corrompu )). ·
Doublet, cl1ieurgo dd d11,~a ,li Nemours, tr aR~ dalla, penl,ka di guerra il metodo di cma delle ferite con abluzioni di acqua 1rnm e fa,<sciatura con bia.nche1·ia, pulita, non senza escludere le par-0le ma,giche e gli cso,rcismi, ai 1quali lo spirito superstizioso dei temipi n,ttribuiva esdnsivamente la gua,ri.gione, così c-0mc Teodol'ico Borgognoni, vescovo di Cervia, di cui già pa•rlammo, era, solito benedire l'acqua limpida, che doveva se,rvire a medicare le lesioni.
Le raulmier, di Caen, medico di Cado IX, ci ha lasciato un « 'l'raité de la, nature et oiwation des playes, de pistole,s , arqne1rnuses et autres ba8tons à, feu, >>. (Jontra.rkmente aJle idee allora dominanti, egli nega in questi suoi scritti.la velenosità de11e palle e !della polvere pirica,, combatte l'uso dei setoni e dei suppurativi, che p1·ovoca,rono nei feriti dell'assedio di Rouen e delle batta.glie di Breux e St. Denis i:r1fezioni puruilentc, con IPCl'dite sen,;ibilissime. Tratta inoltre dei traumatismi senza lesioni app~t·enti, prodotte dal « vento dei proietti >>, della peÌ'manenza delle palle nei tessuti e loro com1portament..o e delle cure postume da usarsi ai feriti. ' Lorenzo Joubert, medico del Re e suo lettore· di medicina, chi>rurgia e farmacia; nrllo studio òi Montpeillicr, ebbe occasione durante le .prime guerre civili del Reame di visitare i feriti che a.ffiuiv;mo in gran numero da ogni regione. In base alle sue osservazioni ipeisoiiali, scrisse neil 1570 un cc 'l'ra,ité des arqu,e1nusa,<.les )) e nel 157~ un « Epitorne de la, therape1J.:tiq1ie et des arqiieb1,isades )), in cui descrive i medicinali, il materiale di medicatura e gli strn-
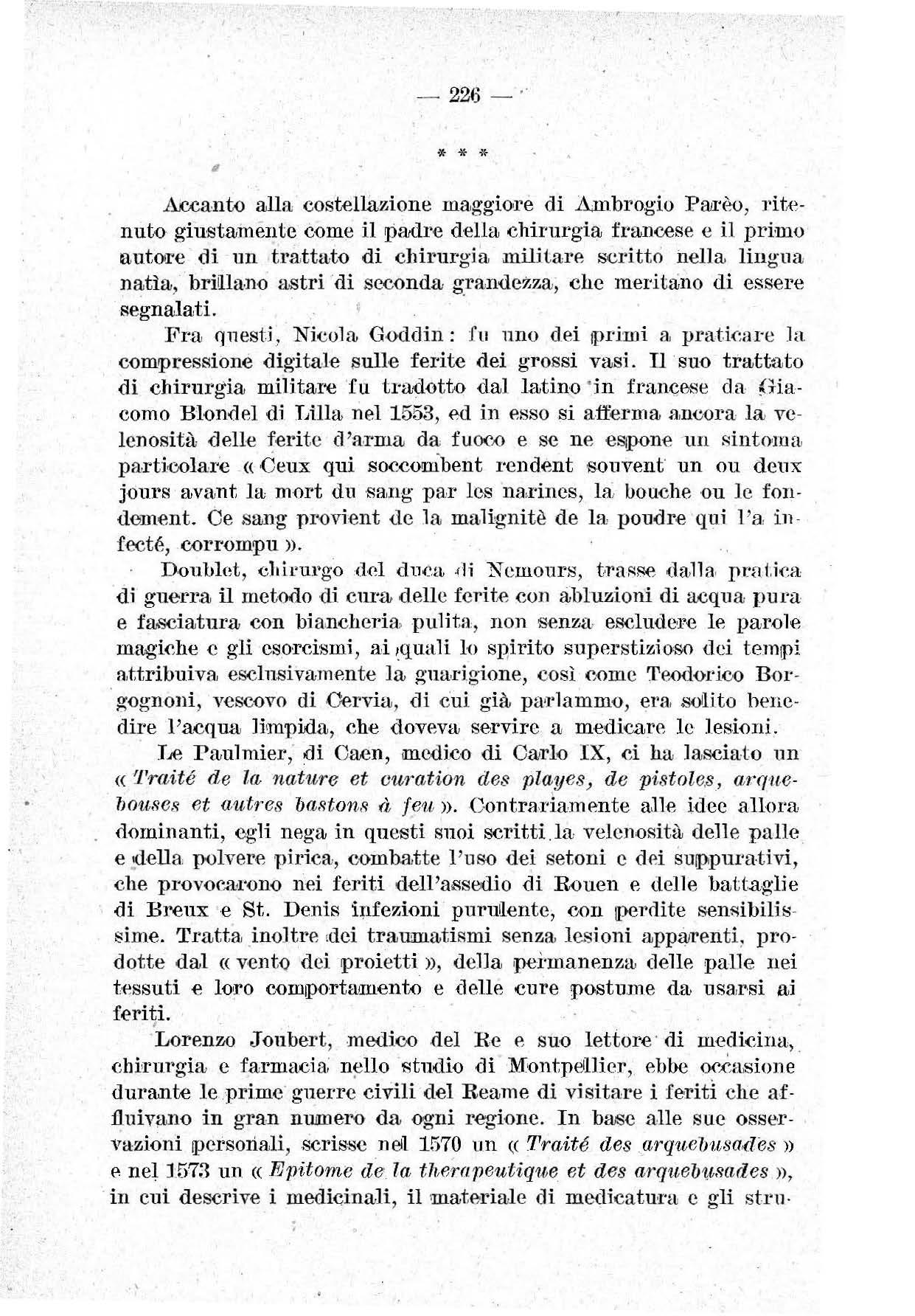
menti chjnngici, di cui si deve provvedere ·n medico milita.re in c.,"1impagna. E vale qui. ]a. [)ena di riportarne l'elçmco: acqua, vino~ nceto, emostatfoi, -eome il bolo d'Armenia ed il pelo di lepre, polv-eri astringenti, co'tone filato, stoppacci, piumaccioli, cauteri (trementina. e pece, vetriolo anche ,polverizza,to), ventose, sanguisughe; e nelfo st,rrnmentario la sega, ed in un astuccio sonde, pinze, col. telli. Egli fu scetlto inoltre arbitro nella djbattuta questione fra . Prurèo, 1p:1irtigiano dei suppurativi e Martel, chirurgo di Enrico III e ,poi di Enrico IV, che lo seguì nelle guerre del Dellfinato <li Savoia, di Linguadoca _ e di Normandia, RORtenitore dell'a,c,qua tpura nelle ferite da a.rchibugio, ,dichiarandosi per quest'ultimo. _
Ricorderemo a,ncora, faaia, Le Lièvre, autol'e nel 158.3 di un trattato (< Officine et jardin dc chirurgie militai'f:e 1 )), nel quale 1·aceomanda 1a (tna...<isima, cura neM'estrazione òei corpi estranei, non ç.imenticando i frammenti {li stoffa t,rascinati dal [)roiettile nel cana,le della ferita. Pa.l'i,menti Verduc ci fornisce preziose indica'lfoni i:m 1 modo ,i:'li asportare le pa.1lc . dai tessuti, a.fferm'ando che le dita :rappresentano sempre lo strumento ideale, più adatto :1110 scoipo.
E citeremo infine Duchesne, detto anche Quercetanus, il quaJe pubbllic_ a, nel 1576 a Lione un << Trnilé de la citre générale et pairticnlièrc .des arq1wb1tsadas )), in cui in~org·c contro l'abuso delle amputazioni jn g1rnrra. Veyrafl e Gnilhemet nel} 1581 danno infine a,lla luce un « 'Fraité de chirurgie contenanf; le vrage méthode de guérir pla,ye8 d'a.rqitebwiade )), nel quale illustrano le dottrine e il tratta1mento delle lesioni di guerra, in quell'e[)oc.a.

III. - LA MMDICINA F, CIIJRUHGIA M:ILI'.rAnID Dl!JL CINQUF,CffiN'ro. NffiLLl<l AL'l'lÙD NAZIONI.
Anche in Germania nel cinquecento la. chirurgia ha degnissimi cultori. Fra i chil'urghi milita,d ,tedeschi rievocheremo anzitutto Enrico von _Pfonspeundt, che fu uno dei primi chirurghi d'esercito Si oécu1pò dellle ferite d'arma, da fuoco e diede fin ·da.I 1460 le noil'me peil' l'estrazione dei IProicttiJi. e della polvere da, sparo che si supponeva fosse con essa penetrata.: la pallottola doveva essere sOilleva.ta con lo spt>;Cillo e la polvere rimossa a me,r,7..0 di iniezioni cli iatte <li ca1pra o ,di donna., mescolato a~ olio ed a, succhi di pia,nte. Nel 1469 pubblicò una memoria: (( Sul modo di fare un nuovo naso ad uno cui siasi staccato del tutto o lo abbia, avuto mangialo dai cani)). Citeremo inoltre Guglielmo Fabbry (1560-1634), più conosciuto
sotto il nome di Fabrizio Hildano. Nàto a Hildsen, presso Diisseldorf, studiò j,n Svizzera, in Francia ed ÌIJ ltaJlia. Nel 1606 pubblicò
a Basilea un'opera importante : « Observution <Js ,,nedico-ahirurgi· cae », in cui afferma il principio che i chirurghi~ oiltre ad essere abili opera,tori, debbono possede,re colll(pleta conoscenza dell'anatomia e della medicina,. In un aJtro libro: « De ,reota curundarum vulnerum ratione >> dedica qualche capitolo a11e ferite di guerra.
Troppo noto, per intrattenerci !Più a lungo, è il nome di Andrea Vesalio (1512-H>G4), di famigli,a, tedesca oriunda di Wesen su[l Reno, nato a Bruxelles. Fece i suoi primi studi in quella dttà, poi si tra.sfori a Montpc1lie1· e a Padgi ove ebbe a maestiro il celebre chkm·go italiano Guido .Guidi, già. ricordato. In seguito, nel 1537, a soli 25 anni, fu nominato lettore di anatomia nell'Università di Pa,<lova-ove ebbe a sostenere aspre batt.aglic per essersi da solo messo oontro le teorie di GaJeno.
Ma più cl1e anatomico iilm:tre, è qui il luog<). di ,rievoca,rtlo com.e chi.rm1go milita,1·e. che prffie 1parte a!llc spedizioni di Oa,rlo V di Filip!(lo II, dei quali fu anche mooi.co privato alle _ corti di Bruxelles e di. Madrid. Lo stesso Filippo II lo inviò !Presso Enrico II per cm•arlo di una ferita riportata in combattimento. Nel celebre suo· trattato della << Gramdc Chirurgia.)) ,dedica poche pagine alle ferite di guerra. .
In Inghilterra Tomaso Ga.le, chirul'.go di Enrico VHI, e .quindi della regina. Elisabetta, dopo iaver preso parte con . Parèo alle campagne di Mont,1•euil e di Saint-Qmmtin, dà alle stampe « An

exceUent treati8e of wo11,nd8 rruicle 1,oith gu,n,8 hol >> ed un manuaJle di chi.rurgia, i,n cui tratta delle ferite d'wrma da fuoco.
In Ispagn::i, Arccus pnl,ùlicn, 1ml 1601 un << .Recopilac(W da Oi-
ritrgia, di1Jidas mi oirwo lrcrtuclo.Sj )) in cui combatte· l'uso del tam!POnamento e della sutura nel trattamento delle ferite.. .
Fra i chimrghi mi~ita,ri oriundi della Svizzera è da menzionare Felice Wurtz. (1518-1575), nnto a Zurigo, che nella sua.opera<< J>ractica der Wunilar.rnwi », pubh1lkata a, Basilea, nel 1574 sulle ferite, fratture e luss:azioni, e~mba,tte ern:frgica,mente l'uso del cauterio e dègli empiast1·i nelfa cÙra. delle lesioni ,per a,rm[11 da fuoco, pur non dimostra,ndosi grande operatore nè perfetto conoscitore dell'anatomia, e desorive per il primo 11e fratture longitudinali delle ossia.
Nè dobbiwmo dimenticare uno dei ,più irruenti i'iformatori del teinip:0 nel campo delfa medicin:1 : Filippo Teofrasto Bom bast-0 Paracelso, nato: il 16 dicemb1·e J49~ a Eìnnsi-eldcn. Tntta fa. sna vit:1,
fu tma continua !Peregrinazione per l'Euro1pa, convinto che la scienza non si vede in un so1o uorm_o n~ in un sol ]uogo, così" come tutte le costellazioni e tutte le stelle non si !Possono vedere dall'orizzonte del ·villaggio natio. Così egli peregrinò in molte città; studiò a Basilea, si laureò a, Fe,rra,1·a e quindi dimorò a, Wiir7'"burg, SchwtLrtz, Montpf}llier, Bolo"gna, Padova ed ancora a Ferrara,, poi passò a;
Fig. 52 - Chirurgo militare che medica presso fa tenda un soldato ferito alla testa. (Dall' << Opus chirurgicum >> di Paracelso - Francofol"tc, 1535).

Lil"lhona e Rll('.CessivH.mente in Inghiltena e nei Pae;,ii Bassi. {.ìuivi si ar1~uolò ,come chirurgo militare neltl'esercito e prese parte a, diversi combàttimen~i, p,resfando soccorso a feriti danesi e svedesi. Pitl tardi segui gli eserciti, vm.·sà,ndo nella, più sq nallidu miseria., sia in Austria, in Boernia, Mora.via, che in Polonia, Lituania; poi si ridu·sse a ' ,Mosca e a Costantinopoli, e finailmente si trasfed·a Fiume ed a Venezia. Qnivi si arruolò una, S(>,COild,a volta come chirurgo milita,re durante la gue,r,ra, tra, :Francesco I e Carlo V che si trascinò per circa tre anni e successivamente emigrò a F,ribùrgo,
:L Zurigo ed a. Basil(>a, ove nel .1527 fu nomiuaito lettore in queilla Università, catteclra che dovette presto lascia,re rper il suo sipirito iri·uento, in lott::t continua contro le antiche teorie. Egli insegnò in lingua volgal't', il che. gli procurò moltissime O!J)iposizioni e IJ)rcse per ba,se della pt·opria, scienza. l'esperien7la. Fu uno dei primi a riconose.ere che il cloruro di sodio .è indispensabile ailla vita e ìiel 1535 rpubblicò a FraJ1coforte un'importante « Opits chin.trgfoum, >> (fig. 52), in cui r::wcomanda nella cura delle ferite di guerra uu sèrnplice trattamento con acqua ~alata, cosi come oggi nella pratica chirurgica <~ la1·gamente apiplicata, la soluzione fisiologica al 0.75%0.
Fra le sue 01pcrc più famose ,rièordererno ,H1cl1e il« Pa:nwi,irum, >> ed il « l'wragra,nuni )). La concezione che rgli a.:veva della, medicina, è essen7lialmente organicH, e chimi,ca, ed introdusse ·per primo nella terapia le sostanze chimiche.
Exp~rÙrientnrn ac ratio .. fu il motto· della sua attività1 ~i011tifica, ed al letto degli infermi, con l ;OAAerva.zionc diretta più che sui lilwi, sviluppò la sua profoJHla, dottrina, 1·iformatrkc d1~ costituisce uno dei capisaldi deill'cvoluzione delle disd1pUnc medkhe del. Rinascimento. Morì a Ralisbrnr~o nel 1:>41 , Yiltima <l el proprio ca.rattc1~e. ·

.lV. - L'AS8JSTillN½A SANl'l'AHJA Ol<}GLI .ESEilCl'.rI NJ.IJL CINQUJ<~CIDNTO.
La medicina milita1·c, che g'ià. verso la :fine dd 400 cominciava ad affc1~marsi lentàmcnte, ebbe più tardi un principio di organizzazione vera e propriai, Il Re di Francia àveva 12 chirurghi addl'tti alla sua persona, ma in maggior consi<lerazio1ie erano tenuti quei sanitari. che accon1pa1grmvano gli e~erciti in guerra e che venivano reclutati all'inizio di ogni campa,gnn. l<M :inehe per il ricovero d<.'i feriti e malati si raggiunse un sensibile prog1·esso con la f01·mazionP dclJlc compagnie di ordinanze di 100 lande (GOO uomini) e dei fra,nchf arciel'i. Ca.rio VJI in Francia, e Mas~irnilia.n-0 I in Germania, con l'istitnzione degli eserdti permanenti, ·riorganiz?l,U'ono anche i1l scl'vizio sanita,l'ÌQ. Più tar<li F1·a1iecsco J istituisce· le legfoni ·iprovinciali, <lelfa forza tli 6000 uomini dascnna, divise in ~ei bande e •provvède a<l una più ra7liona1e assistenza <'lei malati e feriti. Con ]a sistemazione delle monrurchie, gli eserciti si organizza,no sem~re più e diventano strumenti l'fi Stato. An(·.he in ,Spagna le milizie si 1·iordinano: l'unità della: fantel'ia è il tol'cio, composto di 2000-3000 nomini, <li cui <lne terzi armati di al'chibugi e il ·rima11e11te (li picchP.
l'a,rimenti il.piccolo stato svizzero 1prcpara un esercito in masse di baLta.glioni, con picchieri, alaba,rdieri, spa,doni, e balestderi, così ben Òliganizzato da esi;,ere riccrca.to e pagato anche dalle nazioni straniere, dopo la splendida prova, fatta ne1la. guerra d'indi,pentlerrna contro i Francesi.
In 1talia,, pe,r qpcra dei duchi di Sa-yoia, e i;.oiprattutto di Eman nele l!__,iliberto, le millizic si l'iorganizzano : la fanterh1 si di vi de in colonneJllati di ,sci compagnie e la cavalleria si ordina in compagnie eun una· guanlia ducale. Lo ,stesso imp·eratote .Massimilia,no istituisce una gerarchia sanitaria militare con l'istituzi onc degli Oberstfeildarzt, addetti al servizio press:o i v.a1·i coepi e repiwti.
Le gne-rre cli Francia contro l'Inghilterra,, la Ger1na,nia e l'Ita, lia (1500-1590), la canqmgna, di l•'iand,ra contro la Sipagna, iper l'intlipendemm, dei Paesi Ilassi :(1G67-JG09), fa, spedizione dei Turchi <·ontro gli ,stati da,nubi:aini (15Hl-l571) sono gli avvenimenti bollici più importanti del secolo XVI.
Abbiamo ancora notizia che in Jnghilte,rra., durante la caimpugna che Edoa.edo IV mos.:è nel 1475 ,contro Luigi XI, venne.ro ~rnscgnaN alle tru1ppe un medico capo éon due aissisicnti od un chirurgo con 13 aiuti-ha.rhieri. Ed alla battaglia di Saint Quentin del 1537 l'esercito inglese disponeva d{'J seguente personale sanitfwio; due chinwglii. addetti a,lla ,persona del comandante su1premo ed uno per ogni tenente gcnc,rale, rnaresdallo, generaJlc f'li cavalleria e di fanteria, in tutto 57 chirurghi con lo sti1pendio giornaliero di uno scellino.
Di altri medici. militari sii ha, notizie: di. Ga,briele· Miron, che p,rc,;c parte ~ll'ai;.sedio di Nwpoli nel 1424, con !l'ei;.ercito di ·car~ lo VII, d.i Symphorien Cham:11pier, che sotto Fnmcesco I partecipò nel 1!"i1G alla, batta,glja di Marigna,no e di Luigi Dc.-;bourgesi, che ~u presente alla hattagl1a, di P~1via nc11 1525. ·
Fin dal ~ooolo XIV sappiamo cli e i rned ici <'d i. chi-rurglii .uccompagna,yano gli eserciti s,pa,gnoli in guerra e nella; S[)agna dei Mauri trovimmo già impiantati da <1neill'epoca ospedali sul t~po di quelJi a,rabi, owi gl'infermi venivano •ricoverati. e distrihuiti secondo il sesso e la natura della maia.ttia.
In Spagna ad ogni reggimento di fanteria era, assegnato in guerra un medioo ed un chirurgo con lo stipendio mensile ris,pettiYamente di 15 e 12· scudi : un ospedale militare peumanente venne ('relto a Pamplona dal generale Gonza,ga.-Colonna.
Dobbiamo alla regina JRa'beliJ.a., la Oatt9lica, le più radicali. in-
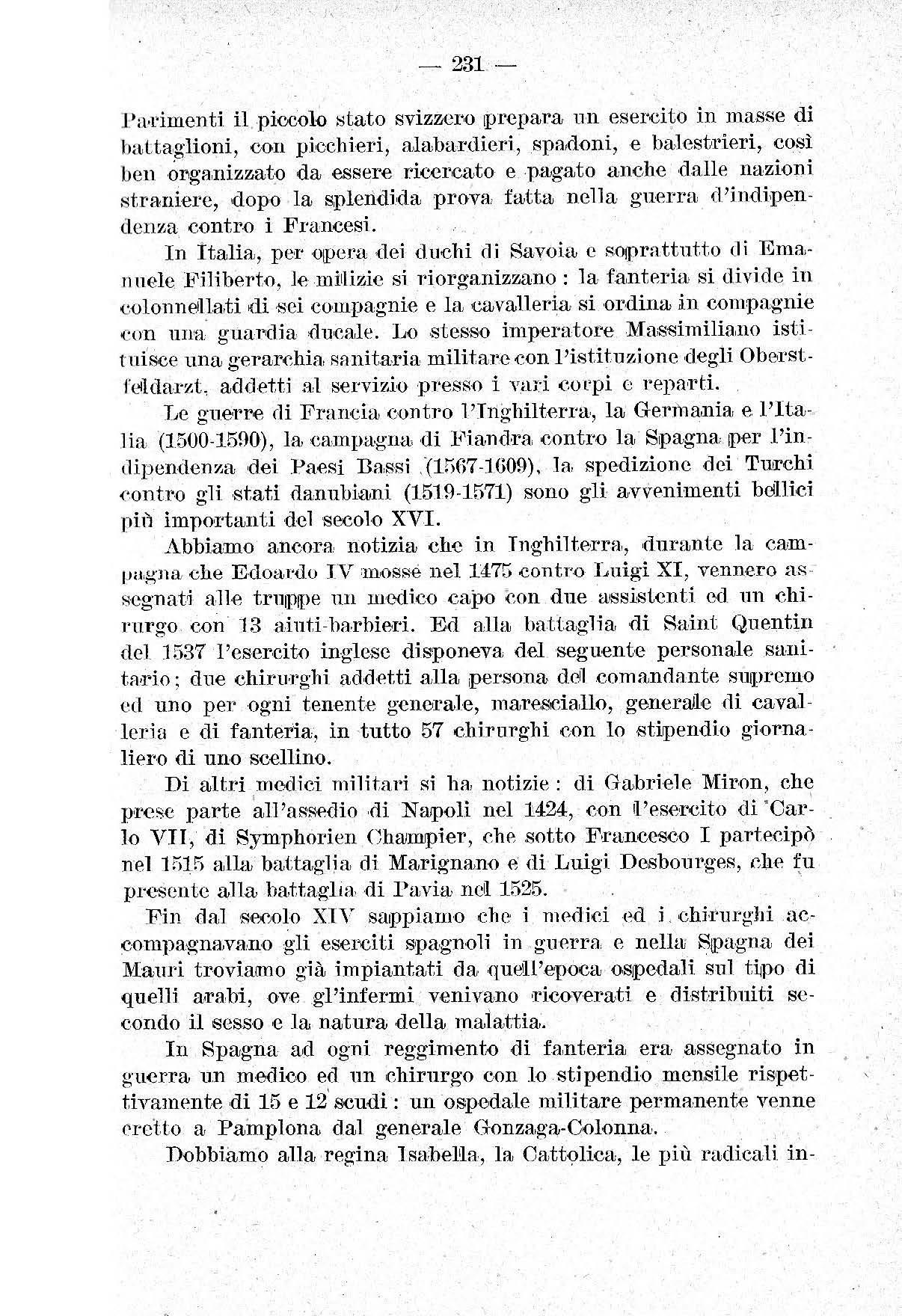
11ovazioni nel serv1z10 sanitario in campagna con Ja istituzione dei primi ostpedali da campo e delle rumbulanze negli eserciti. Di1ra.nt.e l'assedio di Alora del 1484, furono infatti impiantate sei grandi ten9-e :per ricovero dei malaiti e feriti ed altre quattro furono ·a,llcstite nelil'assedìo p.i Baza ,del 1489. Questo fatto· segiia un passo notevole nell'organizzazione- sanitaria di guerra e riteniamo opportuno metterlo in giusta luce con la,,.scorta. delle fonti storiche.
Così nella relazione compilafa da :F'crclina.ndo del Pulgwr sull'assedio di .Allo,ra si legge; fra l'altro : · (( E' para curar los foridos é fos dolientes, la reyna ernbiaha ~iem;pre a los reales seis tiendas grandes) è las carnas- dc ropa necessarios para ~o!s feridos -y iiifermos; y embh1ba fisioos é cirujanos é medicina~ é hombres qne los serviesen, é mandaba que no llevasen p•recio alguno, porque ella lo mandaba pagar. Y estas tiendas con toùo este a,parejo se Jilarnadan en los ,reales el hoaj_)ital de la Reyna, )).
Il giorno 11 nov,embrc 1487 f;i tenne in Roma un concistoro alla presenza del Pa,pa, ed iil vose-0vo Valentiniano Pietro Rosea nella sua orazione così si es(n·bi1e. parlando dell'attacco di Ba.za : « Sequunt1.1;r ,itf)m, ewercitum religiosù1simum) ne illi q1ticquid dc·esse poss~t) QUADRJOIDNTI FERME CURRUS, operti 1,1,mbraculis qiiod ho8pitale reginac appcllam.t / in, qnilms impensa regia ef; sumptit amplissi1no) q11,ioguià cwra,ndi8 aegrotis) sive ex acie 1J1,1,lneratis arte meclica vel cyrurgica necessariwrn esse potest invenitur ). honestissimii? et pro-batissimi,'I matronis huic mitneri servientib1,1,s a,dministruntibus. Nulla scorta) 1iulli lenones) n11,lla periuria) nulli deniqu,e .c:;ortù1,rnliuli in . emercitu admittiintur) ne 01liq11,e pessime cm,t 7Jerperam (tgendi occasio dari valeat )).
Ed anche in una Jettérll, di Pietro ,Martire diretta all'arcivescovo di MiJa,no, .riferendo sull 'assP.ilio ilella, stessa città, si t,rova questo brano : (( Hospitcilia, post haec 'l'lDNTORTA QUA'l'TO,Tm INGIDNTIA) vrovidiim:
Reginae pieta,tis irwenfom,, est operae · praetiu,m 1;idere) ad rem,ediU1n haec et medelam non sauciorum modo) sed q11,01;is morbo laborantium ereota. ]l,[eclicontrn) pharmacopolorwm) c11/irurgorumque et reliqum:wrn ad mini.'!teria addictorum) is est n1tmerus) is' est ordo) ea dil'igentia rerum) e.o, copia) ut neqiw subm:bano vestro ffancto Spiri tu,, neqiw vasto ,im tiw M edfola,nen.'liiirn cedant hospi~ ta,lib1.1;s. Regia impensci q1iicq1,1,id lang11,oris) quif quid acC'identis emergit) hi status c1tique a natitra dies assit absconditiir )).

Si ha inolti·e notizia, che nell'a,ttaooo di Otrera (1477-1478) fu- . tono introdotti dei cani speciali tl_:wovvisti di lettighe per il traspo1;to dei soldati infermi; e nella presa, di MaJàg~ del 19 agosto 1487 se ne contavàno fino a 400.
La regina lsa,belfa a,veva la consuetudine di visitare i soldati fe-. riti snl campo stesoo di ba\tagilia, ed ai grandi della sua casa, chele fa<>,e,;ano osservare costitnirè ciò una trasg,ressi,onè all'etichetta castigliana, ,rispondc,,a semplicemente : « Lasciatemi sola in mezzo a qucsti1comhattenti, pcrd1è qui non l1anno altra madre per confortairli ed addolcire le loro sofferenze. La pres,enza, derlla sov,ra.na sul campo è l'unica consolazione di q11esti derelitti : ' e se anche 'ciò non 1può ridonare la salute, ne ~·ialza _sempre il morale e li sipinge,a soippoll'tarc con maggio,r rassegna,zione _ p doilore )).
Al questa benefica regina, osserva, H Withington, si può quindi bene adattare il titolo di mater ca.<?trormn) giù aipp[icnfo alle donne iPietose inooronatè dell'antica Grecia e d.i Roma, che prestavano impavide socéorso ai feriti sul campo di battaglia. Durante il regno ili Ca,rlo V, continuano ad impiantarsi in campagna osrpedali sotto lende, con personale di medici, assistenti od infermiere, le quali facevano vita comune coi soldati, come del resto le mogli ed i .figli elci comba,ttenti che seg·uivano l'esercito in guerra : i ma/lati e-i feriti più gravi venivano inveoe invin,ti agli ospedali perma,nenti delle città viciniori. Durante l'azione, i medici militarj si trovavanoa,lla, retroguardia ed avevano l'incarico di . s-occorrere e sgomberare prnntamente dalla prima linea, i caduti, i quali continuavano a percepire la.paga per tutta Ja durata dell'infermità.

Come a,pipendice, ,riportiamo quailche docu!}lcnto g,raftco· dell'epoca. Per l'icoiiografia della storia della medicina militare del teI111Po è intere,ssfl,nte un'incisione in legno di Nicola Meldemann, pittore di lettere a Nor _imber,ga presso il ponte lungo, che riproduce mi chiirurgo·da ca.Ill/Po con il su-0 aiutante '(fig. 53). -In aJlto, ai sinistra, è riportato in versi un auto elogio, in cui il chirurgo esalta le virtù dei suoi medicinali e dei suoi unguenti per la cura delle ferite, srperimentati .a lungo sul campo di batta.glia, .con un accenno anche ::iJ suo vivo interessamento nel soccorrere i caduti, anche se non facoltosi, essend9 la ,sua prestazione gratuita, iper,chè egli troyasi a ] ~Oll:do della bandiera.

