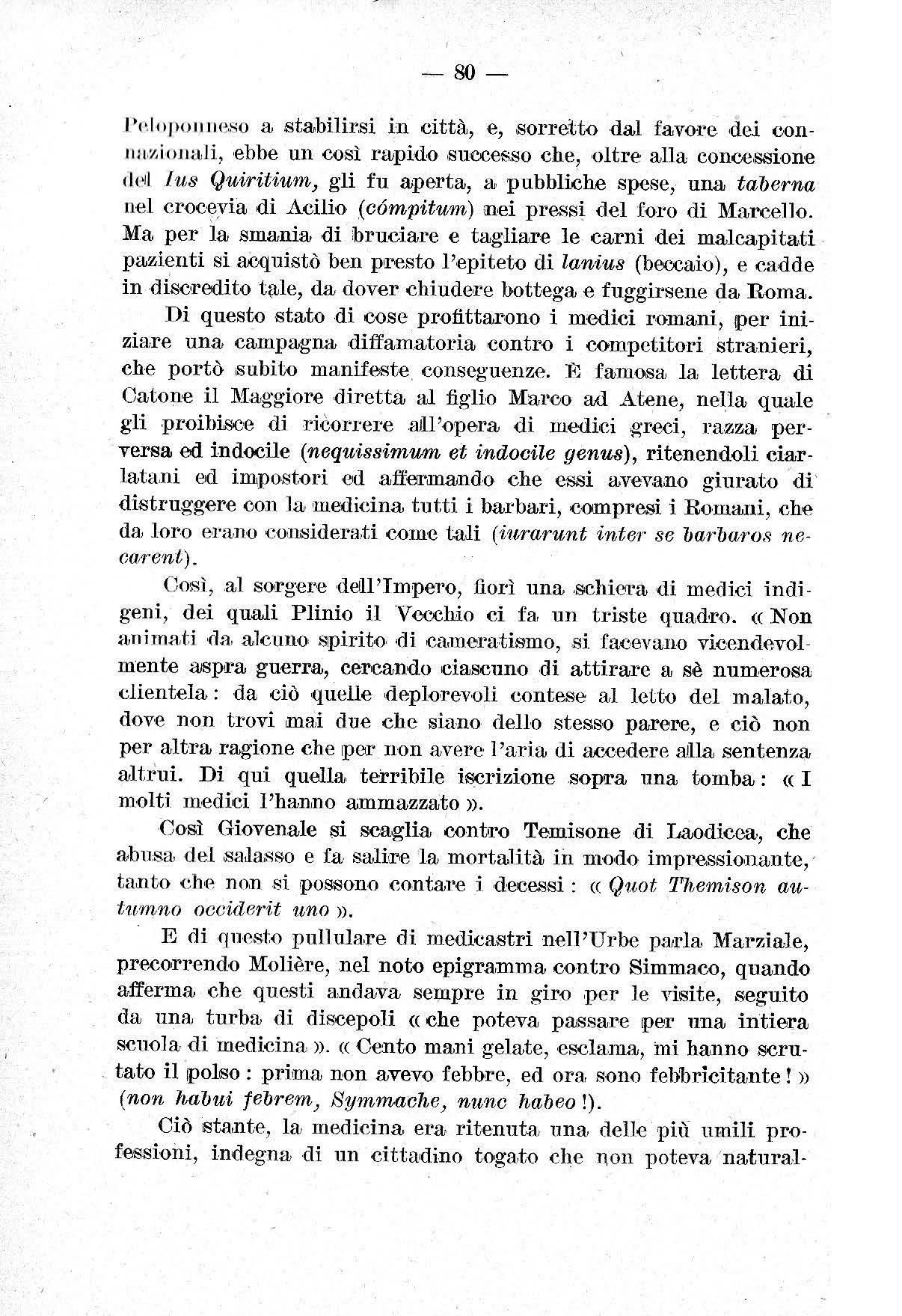11 minute read
11 maresciallo <li Sassonia si fa trasr)()rtnre sul cu:rnpo cli bat
' I
I. - L 'ARTE SALU'l 'ARE PRESSO 'i R OiYIA:'H. '
Advertisement
Data una rapiUa, scorsa. alla ·rndimentaria, organizzazione dei stwvizi sa,nita.ri militari nei tempi preistorici ddla Babilonia,, dd1 · 1~gitlo, della Uina., deU' ln(lia,, della Persia, e della, G11~cia, passen:mo ora ad iut,rnttenerci s ulla medicina militare dell'antica Roma.
Invero a.i Romani, a questo popolo di c,onquistatori, spetta i.I nwto di avere svil nippafo dalle 1·egole igieniche degli antichi I :a,hifonesi ed Rgizia,ni, da.I le pre,...,x;ri:r.io.ni (lei G1·eci e da,lla Lradi·1,ione di altri popoli orientaJi una legislazione ·l'.'la,nitarìa così completa nella, ~ma, ,g1r,rn<limm. COIH:,e?.ione, da, costituii-e anche oggi, a, dis tanza di 2000 anni, il tipo della più grande perfezione.
La primitiva Roma qua<l·ra-ta del Palatino, fa,tta, di. ca.panne <· (li casupole d'argilla, a.veva, ceduto il posto a, quella, più l'Ìe<.:a, r·:t(,-chinsa nelle mum, Servi:me, dotata. di mera,vigliooc opere di fognatura e splendida di templi costruiti al modo etrusco. Dopo l'incendio dei Galli (387 .a. C.) .si rifabbricò rapidamente la. nuova. d ttà ,rcpuhMica;na, che scompa1•ve· a, sua volta quasi del tutto nel 1 ,eriodo imperiale.
Gli incendi f.requenti, e soprattutto quello n<~roniano òell'a,nno 64, fecero sì che intc,re contrade ven~ro più volte ricostruite. N eronc, seplJ)nre 11()11 fece egli stesP<O· appiccare il fuoco, ne profittò per attuai·c i suoi progetti di abbellim<-!nto della, città, facendo allin~a·re ,regola.rmente le nuove fabbriche. La città imperiale a1 tempo ,cli Cootantino conta;va, 27 biblioteche pubblliche, 11 te-rmc, nelle quali potev::l!no ba.gna1rsi contf>mporaneamentc 62000 persone, 856 ha.gni a paga,mento, 1352 fontane ,pubbliche, 8 campi da giuoco, r, naumachie, 11 fori ,g,ran~i, 15 ninfei, 1 O basiliche maggiori, 19 a,oquedott:i., di cui soltanto quello dell'acqua ,M~rda costò 160 milioni di St>.Sterzi, pari a 66 milioni <li nostre 1Ure ante guel'l'a, che

p!t'ovvedevarn..> a(;(lna 1pu1·issima a, ciascun abitante in ru,gione del quintulJ.)Jo del fabbisog11Q, che oggi è il massimo ,richiesto dalle norme jgieniche, 36 archi di t·rionfo, (i alloggiamenti milita1·i, 8 ponti ~ml 'fcv,ere, 7 ca~enne òei vigiJU, grandi teatri.
Già ;per 111 legge deille 1:J tavole si procedeva al controllo degli alimenti colle iSipezioni ai meTca,ti, alla sorveglianza dei cana1i o delle cloache oon a.pipositi curatori (c'uratores alvei), alla disciplim~ deHc cremazioni e delle inumazioni, all'approvvigionamento dell'acqua potabile, alla bonifica dei tene11i paludosi, all'assi, stenza gratuita ai ipoveri, e si erano istituite speciali lill:l,gistrature pe,r la rigorosa, esecuzione di tali dii.posizioni.
E dobbia,mo alla, mera,vigHo.sa legislazione ròma.ru1 se il medico fu liberato òa.ltla sua posfaione avvilente e preca,ria e innalzato ai più alti gi-adi socia.li col commettergli la, cura. e la responsabilità suprema della salute del civis romanus) senza la. quale, non è pos..~ihille concepir~ fa potenza, e la ,grandezza deUa l)atria,. Salus 7wpu,li S'ttprmna lem esto !
Ma, puJ·troppo, come lo studio della, storia della, medicina neil periodo roma.no non ha avuto quella pro.fonda, tni,ttazione e quel completo sviluppo che troviamo ir~ a.Jt1·e epoclw ~1,ntrce<lenti ·e susseguenti, così non meno incel'te e · f.I-rummenta.rìe sono le notizie sulla. medicina milita1·c del tempo, desunte in gran ipairte da investigazioni storiche di ordine gene1·ale. Sicchè ~a su<',einta esposizi011e di questo capitolo, l:3€117..a avere l~ . pretesa, di portare nuove documentazioni al vasti..<sSimo tema, non ha. aliio scopo che di •riàs. smnere a la.rghi trntti quel poco che i da$sid antol'i la,tini e greci e gli scarsi monumenti òelPepoca, ci banno tramand}1to dei nostri reJUoti prodec·essori.

* * *
E possiamo chiederci, aa1zitutto, se Roma non a,hhia, avnto medici p '.rima del TI secolo a. C. e [Per oH.re sri soooli, fino ::i,lla na8ei.ia di Cicerone, come aiferita Plinio il Vecchio, e se un popollo continuamente in gut>na. come i Homn.ni, che tenevano quasi sempre schiuse le porte (lel tempio di Giano, non abbia ma.i fatto tf>,..;;01'0 dell 'esperienz:.i, lasciata dai O.ceci; circa, :i sO<'.eorsi da· ipre~tarsi ai ma1a,tj e feriti s ui c..'1lÙlpi di ba.ttaglia.
Smppiamo, invrer, che tìn dal tempo cli Silla la, riledicina greca, si era già affc1·mata nell'Alma città a, mezzo di uomini liberi,· i
q 111n li ies(~~cita.vano l'arte sa-nitaria, recandosi daJl'una. ~1,]ll'altra 11f'g-i<Jue o di. schiavi, che erano chiamati dornestici se•u j"arniliari '111 1:i/,iC'i. E1ssi erano al servizio delle famiglie patrizie, che li. istrUJi1•11110 ma.ggiornnente nelle uozioui di medicina domestica per rivend1·1'1i, come riferisce Platone, a p1·ezzi più elevati; cd a,bbirur.no 110Lizi.e di ,pene severe emanate contro i mestieranti poco onest i., d1c dalla /Professione traevano scandaloso lucro. T medici fami1liad servivano i loro ,pad,roni come domestici e li aocompaignavano 11ni viaggi e nelle spedizioni belJiche: avevano inolbre l'incarico d i e ura,re la numerosa sGrvitù, (1 i prepa,rare le bevande JH··edilette 1·d i veleni e di aiprire le vene ai ;prigionieri di guer,ra, per farli 111 orire dissanguati.
Ed è presumibile che g·li Etruschi, dai quali i Romani ~redi1 iu·OJlO la •religione, l'airte e ile scien,,.c, che da Eschilo sono ricono1:1ci uti oome « un poipofo che produce medicina. >> e cbe i rf',,mmti i-H:iwi delle numerose necroipoli -cli Tairquinfa e di Civita. Castellana ci hanno rivelato molto esrpe1·ti anche nelkt, cura ,d,ei morbi, e p,erli no nella probesi dentaria, a,hhiano non poco contribuito al1a diffuisioJte di quell'insieme di cognizioni e .. li formuile empiriche, legat-c i 11 gr.an pwrte an~-., supe,r1-1tizione, che costituLscono la mooidna. popolare dell'epoca. Nè dobbi-amo dimentka,re che la vicin;i,nza del l'eg-no d'Alba e della Magna Grecia, ove ci risulta che l'arte sa11i taria era, professata, fin dai remoti tempi, non 1può non avere :wnto influenza sull'occor,re·re dei medici in Roma. Come pm·e i popoli finitimi: I Pelasgi, i Marsi, i Sa.bini ed i Sannit, dalil'idioma dei quali fu tratta la radice di molti termini di mcdichrn .. , devono ne<·eRsa,rirumente, in continuo sca,mbfo coi Quiriti, aver porta.to la, lo,rD matura esperienza a:nche in questo campo.
E fin da,ll'etp-oea dei re si. parla dell'esistenza di un CoHegio medico, che continuò più. ta~di nelle sue funzioni a.nche al tempo il ella, Repubblica e dell'Impero.
Fonti più attendibili Rulla ipresenza dei medici in Roma, fin ,falle IJ)ÌÙ remote origini, possiamo de1-1umere dagli storici. Dfonisi,o d 'AJica,rna,sso ci riferisce clie nelil'a.nno 282 dalla fonda,zione dell'Urbe, consoli Lucio P,ina,rio e Publio Furio, scoppiò nella città, 1m'epidemfa << che non riHpa,rmiò n~ età,, nè ,sesso, nè forti, nè deboli, e cont<ro · la quale · rjuscì inefficaée la scienza dei medici)). J,o stesso Rtorico nel libr? X pair]a -cli una, pestilenza m:mifo-,tala.si nell'anno 301, a, combattei·e Ja quale fu vano ogni soccorso,
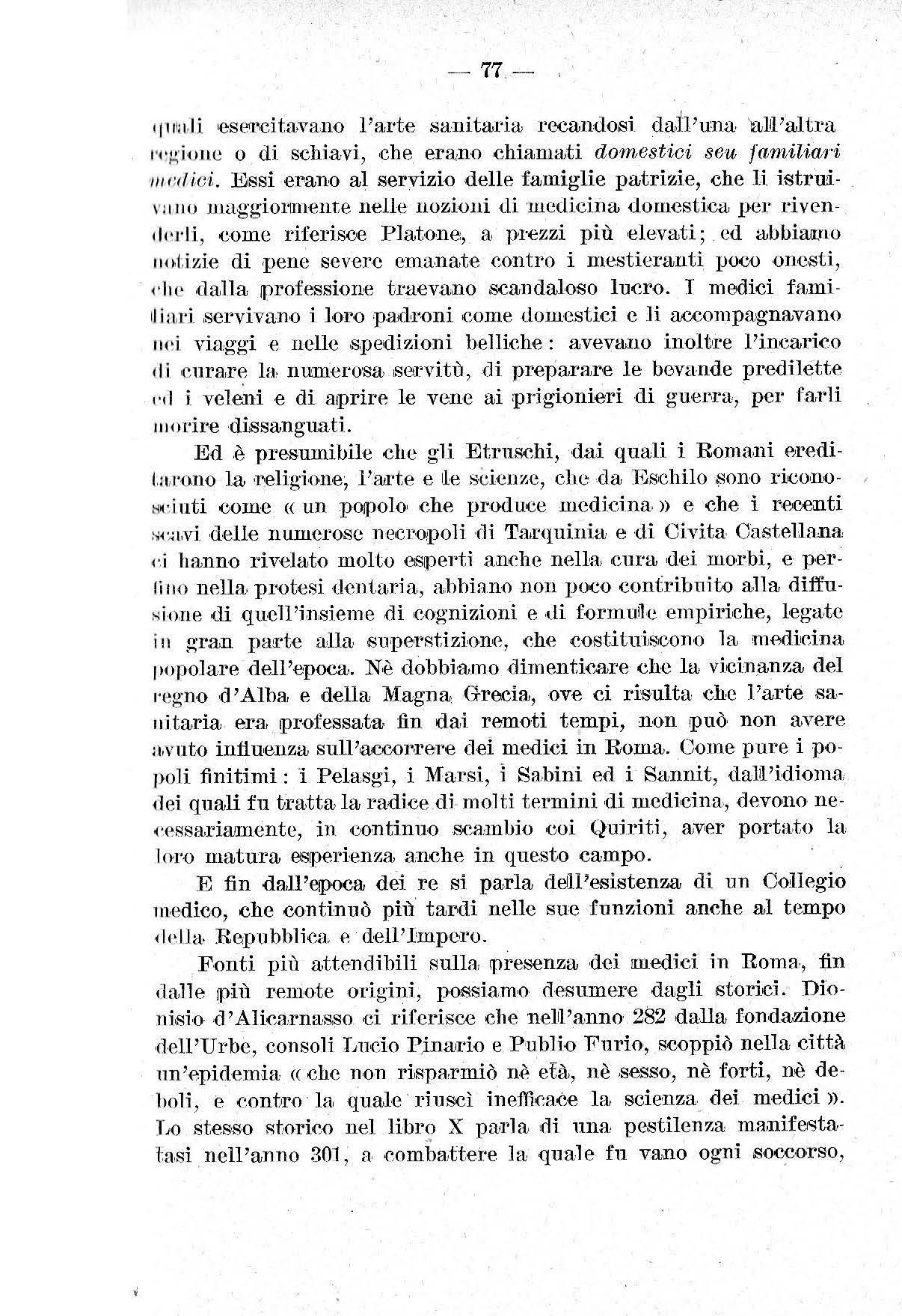
c,-;seudo i1l numero dei medici troppo esigno rper Fingente <piani i f.:ì, di malati e per il panico generale della popolazione, per cui i cadaveri gia,cevano insepolti o venivano gettati nel Teve,re o
IH~lle cloache. Uli esei'Citi ·romani, ra<X:olti nelle regioni circostanti a combattere contro gli Equi, ,contribuirono sensibilmente a. diffon(lere questa infezione.
Così la legge Aquilia,, ,che fu promulgata, nel IV sooolo a. C. rendeva res1p<mi:;t1,bile il chiirurgo della, morte deJJo schhwo quando fo~se stata, accertata a, carico suo negligenza ed imperizia, nell'intervento operativo : il che fa pensare all'ssjstenza di ipratkanti l 'a,r te sa.11i ta;eia in q ut'.st 'epoca.
Analogamente la, legge Cornelia, puniva con la confisca dei beni, con la, deportazione e talora· anche· con la !Pena di mort<~ l'omicidio colposo per parte del chirurgo. ·
Anche nel 7i82, a, detta del medesimo Dionisio (Libro IX); sotto il conso1Jato di Sesto Quintilio e PuoJio, Ora.zio, l'Urbe fu colpita cla una malattia. ,oontaigfo,sa ancor più ten·ibile delle 1p,rocedentL che m,~nò s-frage rra gli schiavi e gra,n parte dei. cittadini « sicchè non v'erano abbastanza medici per cm'al'li )). Diodo,ro Sicnlo, infine, ,ci attesta che nella prima guerrrL punica, (lurante la fazione comba,ttuta in Sicilia, si s-viluppò 1m'e1pid.emia negli accampanienti dei Cairtagine.si, di tale veemenza. e ,rapidità nel decorso, che j mPdici noi1 furono sufficienti a presta.1·e assistenza ai ~mldati colpiti, e la loro opera riuscì inefficace.
Nessun dubbio 1pe1'<;iò sulll'esistenza, dei medid in Roma, 'fin dai primi te,mpi. Plinio, che fu à1l coma,ndo dell'a,rmafa, di Miseno, nel libro XXIX della sua Historia Natiiralis) d dà notizie ancora più intm·essanti su ll'csercizio dell'arte sa-lufare nella città. eterna-. Nei primi secoli della repubblica medici schiavi e liberi erano soiliti di a:ppre:.<stnre le lorcl cm·e se.(',olldo 1·icctte stereotipate e formule va;gh,~ lHHl n,yenti alcun l'U[Yporto con l'e~.me diretto deil malato.
Allcwcht\ dopo ~?'orollo della, libertà politica della Greda, ]a. coiltura: g1recH, inéominciò a penetrare lentamente in Roma, la medicina fu forse tra le prime arti, con Je quali i Greci vinti conquistarono i vincitori.
R.oma, era ,g·ià, 1mo ·stato militarmente :forte e saldai:nente costituito pei' la sagg,ezza delle sue leggi e la vktù politica dei suoi citt::ulini, qmrnélo ancoir·a nc1l'escrdzio dell'arte me<iica non si riscontrava, a:lcun ,p.rogrèsso, dai tempi nei quali i p,rimi abitatori de1I

Ln1,i,o avevano portato nella città le loro divinità I} le loro super· "' i,doni. Vjg·eva ancora, ed era in gran fiorire, il culto di Apol!lo 111etljc,o, di .:Minerva, di Escnlapio, di Igea e <li tutte le inmumer·pvoJi divinità, che avevano templi e saef>rdoti in Roma e nelle q11ali i Romani singofarmcntè· idcnti:ficav~no le cause delae varie 111alattie; gli infermi dormivano nei templi per attendere il sogno 111h;tico che doveva a(Pportairc loro la guaiigione. E Pluta.rco nar;ra i·he press() gli antichi Romani si usava, espor,re sulla pubblica via. i rualati, affinchè ,coloro che passavano, sia perchè altra volta afflitti dal mede.silmo morbo, ~fa iperchè srupe..~isero i mezzi con· cui i-i poth~se por•gere soccorso, ne de,sse1·0 comunicazionfl ai soffo,n·nti.
Allorch:è giunsero in Roma medici gr~i, le condizioni della IIH..'llidna. non erano gra,n che differenti da quelllc che si possono l':wilmc.ntc immaginare ancol' oggi in un po:polo primitivo; così d1e, quando :i,ppa1rvero uomini dott,i nell'arte, e ciò che :mcor forse rnaggiormente s'imponeva alla pubblica opinione, esperti nel vantare la loro abilità e nello spiegare con l'ison:anti parole e con radle eloquenza, i vantaggi che il malato doveva a,ttendere daUe loro cure, il ,successo fu ra!J)ido e g,randf\. Non valse aid impedire questa pcnctra'.6ionc della m<?;dicina greca, in Roma fa difosa degli 11intichi costumi fatta da nomini come Catone (234-149 a. 0.), gelmm cut-:1iode della tradizione 1·oma.im.
Quando i Roma,ni im!pa1ra,rono a, conoscer le scuole mediche g,reche e la loro org·:wizzazione, e le norme secondo le <1uali si richiedeva. dai medici uno studio regolare, e ooloro che ·volevano esorcitare l'a,rte doveva.no prestare giuramento nelle mani dei maestri, fu chia,ro quale di.ITerenza C',Si,steRse fra questi medici e qnel1li ai quali fino allora, era stata a:Ìii.da,ta la cura ùegli a.mnu1: lati; fu evidente oome .ROìlt:.mto i Greci potessero f'sse.re veramente considerati medici degni di tal nome e della, :fiducia, dei cittadini. E per quanto i primi seguaci di Esculrupio che giunsero a Roma fossero, a . quanto sembra, tutt'altro cli e uomini tali da saper segni re i dettami di Ippocrate e meÌ·itevoli di 1e&'lerne considerati discepoli, pure assai. ,p,resto essi· conquistarono il favore del pubblico.
Infatti nell'anno 535 dalla fon<lazionP di Roma, sotto il conRolato di _ Lucio Rmi:lio e L. Giulio, quando Arnniha,le era già seeso in ItaJia, ùn chiil'nrgo g.reco Arcagato, figlio di Lisania,, venne dal
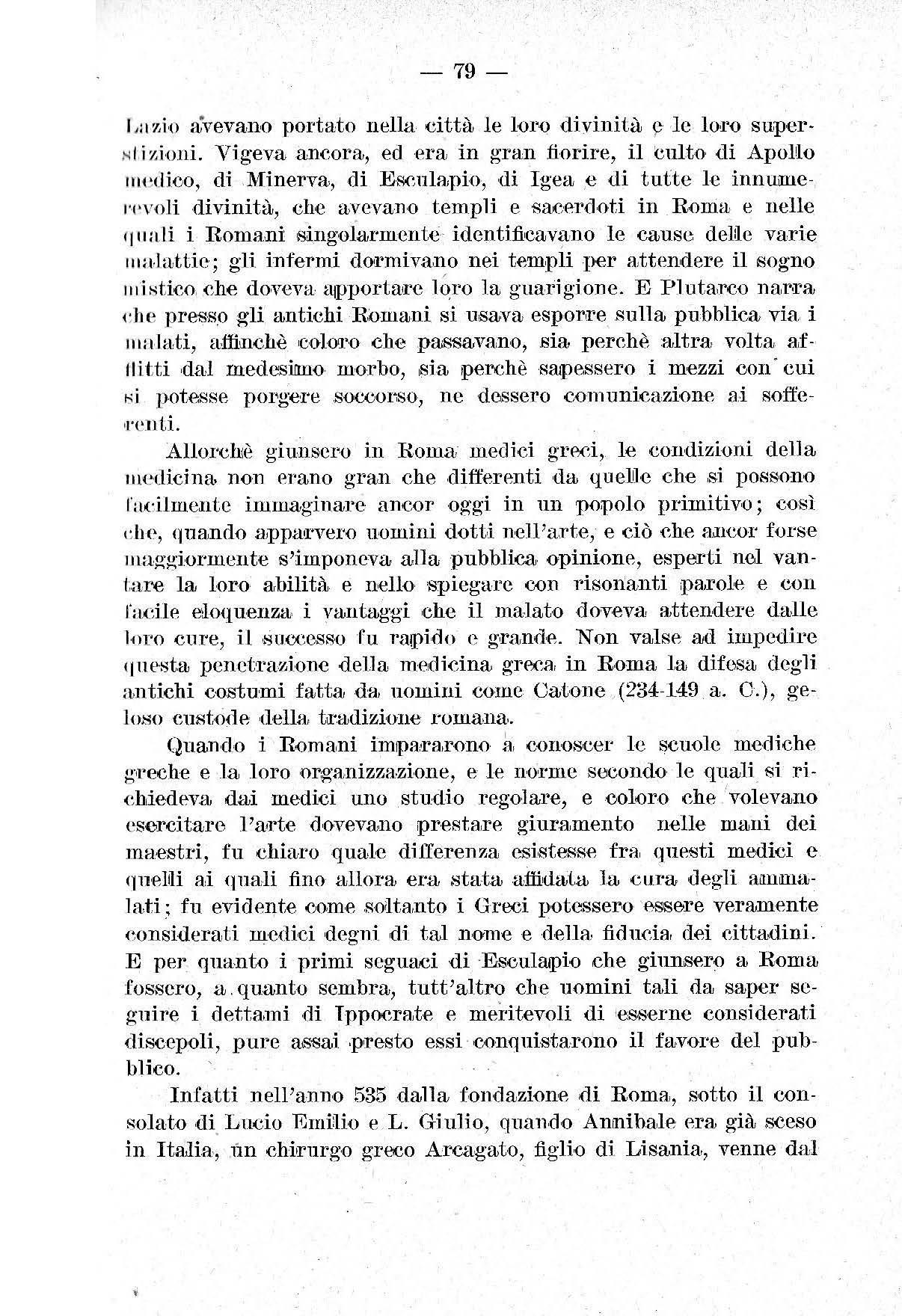
l'1·.l11po t111e.-;o a stabilirsi in città, e, sorretto dal favore ,del oon1111,1/.Ìo JJa li, ebbe un così rapido ,successo che, oltre alla conoessione d,~I l u s Quiritium) gli fu aperta, a pubbliche spese, una taberna nel croce,vfa di Acilio .(compitum) ìllei pr(>A<ssi del for o di Marcello.
Ma per Ìa smania di bruciare e tagliare le carni dei malcapitati pazienti si acquistò ben presto l'epiteto di lanius (beccaio), e cadde in disc,redito t{l,le, da dover chiudere bottega e fuggirsene da Roma. Di questo stato di cose profittarono i medici romani, ll_)er iniziare una campaigna diffamatoria contro i competitori stranieri, che portò subito manif.este. conseguenze. l~ famosa la lettera di
Catone il 1\1.aggiore diretta al figlio Maroo ad Atene, nella, quale gli proibisee di rièorrere aJll'opera di medici ~·reci, razza perversa ed indocile (nequissimum, et indocile genus), ritenendoli ciarlatani ed iD1ipostori od affermando che essi avevano giura,to di' distruggere oon la medicina tutti i barbari, compresi i Romani, che da loro e,1·:1ino c0u1sidera,ti <-'-Ome tali (ùtrarunt inter se barbaros necarent). Così., al sorge1'e de1ll'Jmpe1·0, fiorì una ,schiera di medici indigeni, dei quali Plinio il Vcc,chio ci fa un triste qua,d,ro. << Non anirn.ati ffa, alcuno ijpirito di ca.meratismo, .si facevano vicend~volmente aisp,ra guerra, cercando ciascuno di attirare a sè numerosa clientela : da ciò quelle deplorevoli conteA<se al letto del malato, dove non trovi mai due che siano dello stesso parere, e ciò non per altra ragione che rper non avere l'aria ùi accedere a!lla sentenza a,ltrui. Di qui quella terribile iscrizione sopra una tomba : « I molti medici l'hanno ammazzato>>. Così Giovenale si scaglia contro Temisone di Laodicea, che abusa del saJa,,;;so e fa. saliil'e la mortalità iii modo imp1·essiommte, · tanto eh~· non si. ,possono conta1·e i decessi: « Q1.wt 1'hemison autivmno occiderit 11,no >>. E di ·()nesto pullula.re di me<.licastri nell'Urbe pa,rla Ma1·ziale, prf'.correndo Molière, nel noto epigramma oontro Simmaco, quando a,fferma che questi andava se~pre in giro ,per le visitf•, seguito da una turba di discepoli « che poteva pMsare IJ)er una intiera scuola di medicina>> . e< Cento mani gelate, ,escfama, 1ni hanno scru. tato il ipolso : prima non avevo febbre, ed ora sono febbricitante ! » (non habui febrem ) Symmache) nunc habco !). Ciò stante, la medicina era, ritenuta una dell€ piu umili professioni, indegna di un cittadino togato che non poteva 'natural-