
40 minute read
Pittura murale ,pompeiana, ora al Museo nazionale di Napoli Il chirurgo lapis tenta di ·estrarre con una pinza la frecei;i.
Altr::i, 1rapip,resentazionc gra,fica della ci,rconcisione trovasi neil tempio di Khons in Kairnak, e risale all'epoca della XIX di.nastia di R.amsete II, corrispon?ente circa alil'anno 1392 a. O.
Fig. 1 - Graffito della necropoli tli Saklrnrah con scene cli circoncisione (1800 anni a. C.).
Advertisement
E che questa pratica fos,se generalmente diffusa lo attestano i numerosi monumenti :figurativi dell'epoca, nei quaJi gli organi genitali· maschi!li sono tutti I'U!PlH'ese.ntn.ti ,-;en'.ba prepuzio. Così Eliot Smith, ,nelle sue irruportaJ1ti esplo!èazioni della necwopoli di Nagaa,d-dlèr, che ;risale a, 5000 aJmi a . . c., ha potuto accertare ché intutti i cada.veri di sesso mascolino era stata praticata la circoncisione.
l,uw1·ey, uclle sue memorie, osserva che le pitture mu,raJi, i g rn,llll.i cd j bassorilievi, di cui erano adorni i templi egiziani, il'app,··eHenta,vano Un utilissimo atlante, in CUi era, meHSa in evidenza .la tecnica chirurgica, sop.:rattutto negl'interventi sull'apparato genito: urinario e nella cirooncisionè.
Ed abbiamo· pure notizia di altri atti· operatori che 1praticavano con st,rumenti di bronzo (coltelli, lancette, pinzette, bacchette per cal'.1stici e tenaglie), i quali nel Museo di Berlino formano un'interc>ssante raccolta, e di numerosi appairecchi per fratture e di p, rotesi dentaria, che si sono ritrovati nelle mummie. ,Gl'istrumenti ,rinvenuti a.ppa,rtengono gencraJme:nte aill'età .del bronzo; ma Plate II, nel grande .rulbum di Lepsio, rapprre.senta le lame dellle spade, .Le I.a.ne.e e le frecco con la punm, di colore bleu; il che fa supporre che fin da quell'epoca fosse conosciuta la tempera.
Così lo ste,s,so EJiot Smith soop,rì nel rnos la mummia di una donna, che p1•ef;entava fra,ttura dell'avambraccio sinistro, con completo aip,parcccbio <li <',0nte,J11;ione f01,nN1to da Jisterelle di legno, fissa.te da fasde.
Anche k~ mnmmic scavate ne!Jla. Nubia, 1w.l ]907, p,rima deJl'innondazione dell' Assuan°Da.m, ,ci ,rivelano l'esistenza di fratture ben consoli(late, con scarso aroorciaimento e contenute con stecche di legno e bende di falsa palma.
Altre mummie presontano tracce manifeste di affezioni sifilitiche, c.ancerig1ie, di carie denta,rie, necrosi ossee, art,riti ,reumatiche, sponòiliti defonnainti, gotta., a,teroma.Ria ec.c.
Per aver infine un'idea del barbaro trattamento cb,e gli Egiziani usavano ai 1iemici, basti ricorda,re nna, poco nota inscrfaione del gran R~ Pepi I Miriri, che suona press'a poco così : << Questo eserdto andò in paoe: entTò come gli pia1cquc nel [)a.ese degli Iliruslraitu. Questo eserdto andò in paoe: disfece il paese degli Hirushaitu. Questo esercito andò in pace: tagliò tutte le Joro ficaie e ile vigne. Questo esercito andò in pace: ,dette fuoco a tutte le foro .case. Questo esercito andò in pace : massacrò a migliaia i loro soldati. Questo esercito a,ndò in pace : portò via i loro uomini; le òonne .e i bambini in gran numero. E di questo, più di ogni altra cosa, si rallegrò Osiride >>.

IV. - LA MEDICINA MILITARE l?R1!1SSO IL POPOLO lllilRAICO.
La medicina degli Ebrei, che possiamo far risalire approssimativamente a 1500 anmi a .. C., è stata, a noi tramandata dagli :intichi testi della, Bibbia e delle Sacre Scdtture. Si caratterizza " si differenzia, dalle altre svilu1ppatesi presso i II)opoli della, ipiù remota antichità, perchè attribuisce unicamente aJla divinità la ca.usa della guarigione e l'origine delle .malattie, ile quali colpis,no,no l'uomo per punizione dei suoi peccati. (< Io solo, il Signore, sono il tuo medico)): così tuona, il verbo Divino.
Infatti ,nel Libro IV dell'F,sodo, è lddio che fa diffondere e . scompa,rh:e la, lebbra; ne] Libro XII è Iddio che semina la strage tra i primogeniti d'Egitto; nel Libro I dei Re è il'angelo del Signore, messo di Dio, che fa sopprimere collla peste in una sola notte 185000 .AJssiTi. È Iddio infine che punisce Davide, il quaJe ::i,wwa ba,ndito, <U suai iniziativa,, il c.R.nfiimento, trasgrooe:ndo alle leggi supreme e scatena fra gli Ebrei, la pestilenza che fa 70000 vittime.
Ammessa pertanto una fonte unica. della sailute e del male nella
Divinità, cadono di conseguenza, tutte le pratiche mediche superstiziose che abbiamo osservato presso i popoli Babilonesi:, Cinesi ed Egiziani, e l'arte sanitaria, affidata esclusivamente ai ~erdoti, vi,ene ad a.ssumere un ca,rattere sommMDent.e religioso, mentre una severa, ma giusta legislazione sanitaria. governa indistintamente tutto il popolo ebraiço. Ed ecco l'imipero della J.egge sorgere per fa, prima volta in difes:a della saJu,te di tutti. ·
I mèdici sono ,rarmmentati in molti passi della .sacra Scrittui'a: .JorlliIIl, ferito in combattimento, si rifugia a lesraièl rper farsi curare dai medici; Giobbe, acceso dall'i,ra., inveisce contro i sanitari che non erano riusciti a guarirlo.
Se consideriamo i nlllIIlerosi precetti igienici sommàùnente i,mporta.nti in un rpaiese tropica.le, povero d'aoqua e presso un ,popolo poco curamte della pulizia,, e le cognizioni mediche, quali ad es,empio i segni più evidenti per riconoscere la. lebbra ed i mezzi per curarla, cbe sono contenuti nel capitolo, XII del Levitico, non possiamo a meno di rioonoscel'e che, non ~lo ]a meòicina aveva già fatto qualche progresso fin da quelle epoche remotissime facendosi strada fra i miti e le supersti7,ioni più fantastiche, ma che

d1,,·<·:-;:,;1•1·0 L1·Qv,11t·1:ù <ld sanitari alla dipeudenza ùcl prof.eta ed aJ Ht\r·viiio .(.] elle sue schiere nei combattimenti. l Jiuei sood magnifiC3illo -le virtù tempeutiche degli aromi e degU umguenti nella cura d~lle ferite di guerra, e le norme igie11iche scver·amente prescritte a tutela della. salute degli eserci.tL E David coi tocchi armoniosi deJlla sua cetrà -I'Ìfflce. a calmare sotto la tenda le o~sioni epilettiche di Saulle.
Questi libri ci hrun.n:o trrumandato le leggi sanit.u,I'ie che prDSCrivono l'osservazione più -rigorosa di tutte le regole -riguarda.o.ti la pulizia individua.ile, con abbondai1ti a,hluzioni .prima dei pasti e con bagni rituali p,e1· la ipurific.a,zione del wr,po 1pri1JT1a di entra;re ,nel tempio, la proibizione assoluta di certi ·alimenti, l'obbligo della matta.zione degli animali, l'imposizione dei!Ja cfrconcisione e del riposo settima,nale dCll saiha,to.
E gi:1 comi.nciano n, òeHnearsi i primi provvedimenti sanitari adottati presso gli eserrciti in difesa dalile mala,ttie ca,st,rcnsi.
Cos'ì ne.1Jo ste&-io. Dent.<wono.rnio ~nno JfW.(',-:('.ritte 111iJ':l t!'l'e profilattiche molto rigorose riguardanti i1 modo col (lUa,fo i i:;ol<lati negli H-0campn.menti ò-0wanno ,provvedere p,er eliminare ogni pe1ricolo di infezione mediante le deiezioni, ricopl'enclole abhonda.ntementc di terra: cc Habebis locurn extra, castraJ ad quem egreàieris ad 1·eq1uùFita naturaeJ et habebis paa:illum oum armis tuis, 01.,,mque sederis per circuitum et egesta operies quo revelatus es : Dett8 enini a1r1,bulat in medio castrorurn )). ·
Ne] libro XIX dei Re è descritta, la pestilenza che <leei:mò ·p~r volere di Dio 1 'escrcito di S,cru-.l(;heriho llccidendo oltre 13000 soldatj, e si attT•ihuisce al topo una pai1·te prepondel'ante nella 1pro, ipa.gazione <leil morbo. A lt,:ra epideònia di veste, .secon<l.o na1~l'a Samuele, fu quella che colpì le truppe dèi Fil.istei per punizione di avere a.spo.rt:1fo, il'arca santa, e nawosta ,nel tiempio di n~.g-.one. Pc,r placare l'ira divina, oltre alla restituzione della ,reli<p1ia preziosa., furono offerti in espiazione 5 t,()Jpi d'oro e cinque huhboni.
Grande fonporta.n7,.'l, nella diffusione delle m~1,l::i,ttie epidemicooonfagiose negl\ eserciti venne pure assegnn,fa, ·a,Uc m~<;,che ed aJle zanza,re, e .si adottarono ,severi. provved:Lmen U. per i sold.a..ti colipiti da blenorl'ea, i quali dovevano abbandonare l'aiec31mpamento, mentre si con.."liò,eravano htfetti le iJ.oro vesti e il gi:-id~lio e chiunque aJVesse avut-0 contatto coi tnodcsimi ..
Ed abbiamo aJ1coi·a notizie del trattamento del!le ferite e delle

fratture in guerra dal profeta, Isaia, che scrive : « Le tue piaghe non sono state asciugate n:è fasciate, nè unte çon olio)) e fa esclamare u,I Dio d'Israele: « Ho rotto il hraccio di Faraone Re d'Bgitto ed c·gli non è stato curato applicandovi dei medicina.li o ponendo delle fa,i,;cie per fasda,rlo e fortificatl']o )).
Come interessante docnmf'nt,1 di psicoilogia di guerra di questo popolo sernrpre in armi, non sa1rà inutile rioordare che, quando e,ra i rnminent,e la battaglia, i srucer,rloti arringavano i combattenti: <t .Non si turbi il vostro cnore, non ternetc, non dat,e indiétro, non uùbiate paura .... Iddio è con voi)). Ed i capitani sog.giungevano: « Vi è f,ra, di voi chi abbia fabbricato casa e non l'abbia rinnov.al;,a? Chi abbia piailltato mm vigna da meno di tre anni·? Chi abl1ia, fatto spo,n.saili e non a-bbia, condotto a, cJ-.1.<,a, la, sua donna? ',['ornino alla loro diimora tutti oostoro >).
Lo ,stesso Mosè dava, ordini di cJirninare iprima del comk1tti1111•11to i solda,ti pa,vidi e vili : << Qnis est honw formidolosits et corde 1)(1/nido ? -V adat et revertatnr in domum suam) ne pavere f aciat <Jordci frcitnun 8UOrum s'iciit ip8e timore porterritit.8 est» (Deut., \X. 8).
Anche la legge mosaica, non è improntata, a più la1rghi sensi 11 i rnmrnità ver,s:o il nemico : << Occhio iper occhio, dente per dente )> : 1io:a;ì il IJ)rofeta ordina, nell'Esodo. « Tu divorerai tutti i popoli, i 11 nali dal Sig"nore, Dio tuo, saranno dati in I uo potere. Non i:;i im 1pietosisca sop,ra di essi il tuo occhio)>: così è sancito nel Deuteronomio.
Per puni•re i Madianiti) le cui. donne a,vevamo fornicato con gli Ebrei, Mosè costituì un còrpo di 12.000 uomini che mosse guerra. :-,enza, qruuticre in .nome di. Sa,haoth, il Dio dogli eserdti. Il nemico 1'11 vinto; i nutSchi furono tutti trucidati, le città, i borghi e le c.a:-, I c•lla furono date aille fiamme·: solo le donne furono ri~par.rniate.
Ma .Mosè a.ndò iill oolLe:m contro i ca.pi deJl'esercito pc,rohè avevni11 0 sa,lvatc le <lonne: << Sia.no scannate quel1le che conobbero uomo, lmsciate le fanciuIJine e le donne vergini! )). E oosì fu! Qualche l. <·1111po dopo egili orrlina ai solid:ati dclJc tribù di Ruben, di Gad, e e I i M~ _ ,,nasse, avainguaooia, generraJ.e : <e Passate il Giordwno, entJ·ate 11•·1 Jt, terre di Oha.na,a,n : sterminate tutti gli abita,nti <li f1Uel paese: 1'11,li \ n, ,pezzi gli aJtari, riducete in polvere le statue, devast.ate tutti i I 110,g'lli eocelsi. Se voi non vo-Nete uccidere tutti g-Ji abitatori de!l pn,c \r..:·c, quelli che resteranno saranno q1.w~"1i clavae in oculis et lan-

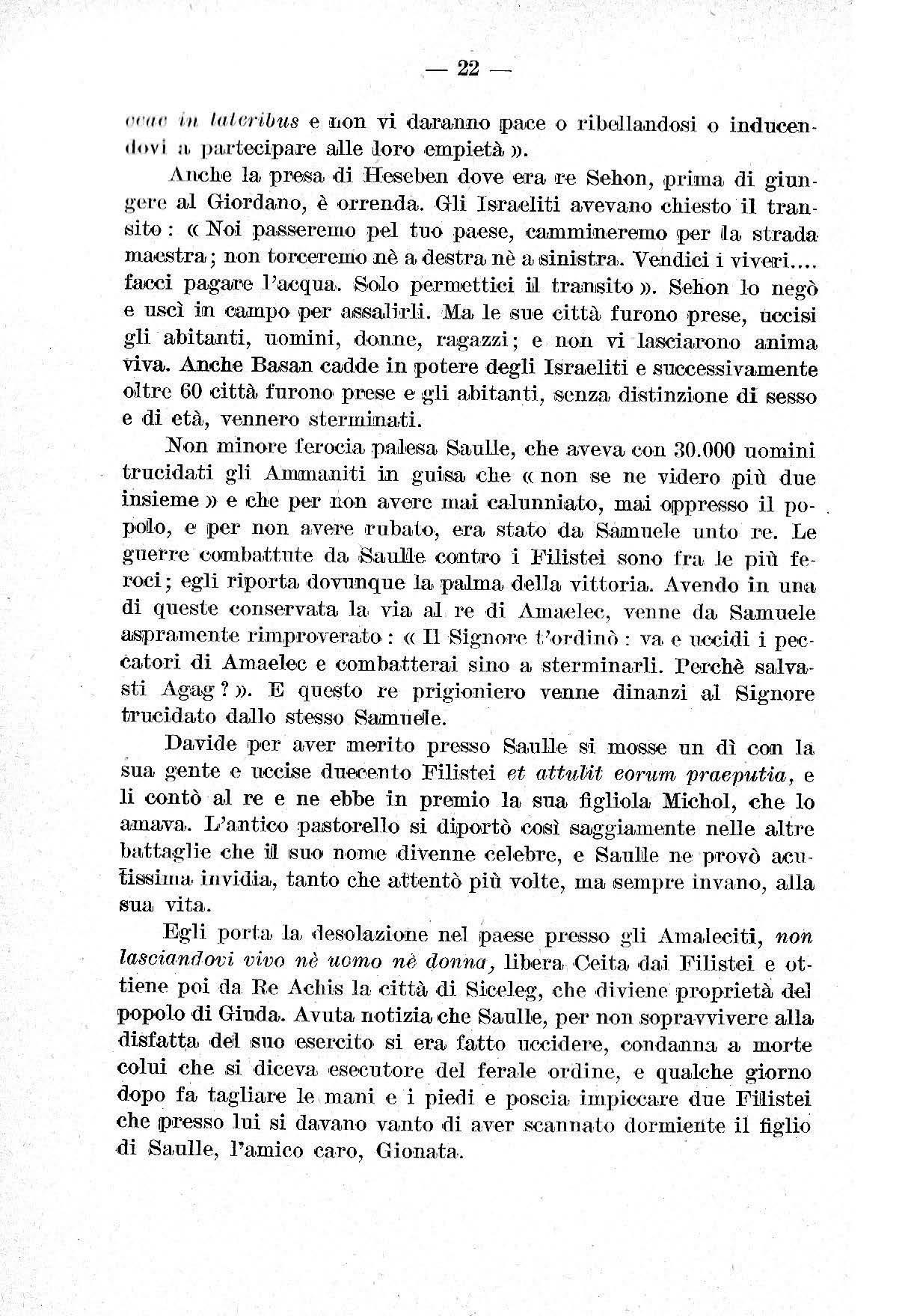
•111i i,11 ta.l eriuits e 110n vi daranno ipace o ribollandosi o inducendovi 11, p:_1,L·tecipare alle J.oro empietà)).
Auche la prosa di Heiseben dove era 1J.'e Sehon, prima di giungel'c al Giordano, è orrenda. Gli Israieliti avevano chiesto il tran~ito : « Noi :passeremo pel tuo paese, cammiineremo per !la strada ma,estra; non t-Orceremo nè a destra nè a sini1stra. V endici i viveri. ... facci paga,re l'acqua,. Solo permettici hl transito)). Sehon lo negò e uscì in ca.mpo per assalkli. Ma le sue città. furono prese, uccisi gli abitanti, nomini, donne, ragazzi; e non vi lasciarono anima viva. Anche Basan cadde in potere degli Israeliti e successivamente oltre 60 città furono prieise e :gli a,hitanti, senza, distinzione di sesso e di età, vennero sterminati.
Non minore ferocia pmlesa Saulle, che aveva con 30.000 uomini trucidati gli Am,rna.niti in guisa che « non se ne videro ,più due insieme>> e che per -11on avorc ma.i calunniato, mai oippresso il popollo, e iper non avei1-e ,rubato, era stato da Saannele unto re. Le gnet're co:mha,ttute da ,Sau]l:e oont;ro i ]filistei sono fra, Je più foroci; egli riporta dovunque Ja paJma del.Ja vittoria. Avendo in umt di queste conservata la, via al re di Amaelec, venne da Samuele aspramente rim;provera,to: << Il Rigno,r~ t'onlinò: va e nocidi i peccatori di Amaelec e combatterai sino a. sterminarli. Pe,rchè salvasti Ag:ag? )). E questo 1·e prigioniero venne dinanzi al Signore trucidato dallo stesso Saimuelle.
Davide per aver merito presso Sanlle· si mosse un dì con la sua gente e uccise duec,ento Filist,ei et attulit eorum praep1,1,tia, e li contò al re e ne ebbe in premio la sua :figliola Michol, ehe lo ama.va. L'a;ntioo pastorello si di;portò così saggiamente nelle altre hatta,glfo cl1e i!l suo nome divenne celebre, e Sanlile ne p•rovò acutissima, invidia, tanto che att,entò più volte, ma sempre invano, alla sua vit.a.
Egli porta, la desola,½ione ne] paese p.r,esso gli Amaleciti, non lasciandovi vfoo nè uomo n è, donna; libera,. Ceita ,cla.i. Filistei e ottiene poi da Re Achis la città di Siceleg, che ,éliviene proprietà deJ popolo di Giuda. Avuta notizia che Saul1e, per non sopravvivere alla disfat~a deil suo ,esercito si era fatto uccidel'e, co,nda.nn3, a morte colui che .si diceva, ,esecutore del ferale ordine, e qualche giorno dopo fa tagliare Je,mani e i piedi e poscia impiccare due Fi11istei che ip,resso lui si davano vanto di aver scannato dormiente il figlio di Saulle, l'amico ca,ro, Gio-nata.
Anche Giosuè muove guerra 3JCC3,nita contro le p-opoilazioni al di là del .Giordano e dn~e d'assedio Gabaoh. Dopo una marcia notturnà sor[H'®dc Ja città e niercè l'aiuto divino che [a pio:vere su!I. nemico un nembo -di saissi ed rurrestaire il sole nel suo oorso, la !l·a,de al suolo: i r,e sono fatti prigioi1ieri, i grandi condottieri calcano barbammente iil loro collo con i piedi e quindi. sono fatti ruppie.care tutti alle forche.
Giosuè devasta quindi tutto il paese montuoso e la pianura e non vi lascia reliquia, ma uccide tutto quello che respira come gli · aveva ordinato il Signore, da Gadeshrurne sino a Ga7,a, e tutta la terra di ('~sen sino a Giaibaoh.
Nè il sesso g·entile si dimostra 1più olemente verso i vinti: la sacerdotessa Debora, in un giorrno di vittoria inneggia a Ja,hel, la quale al generaJe nemico SiRa,rà fuggente che chiedeva dell'acqua so,mministrò del latte e del burro e l'ospitò in casa, ma, durante il sonno, prese un chiodo colla ·sinistra e ,con la destra un mMte.llo e trapanò le temrpia, del!. ncmioo-.
Questi uomini degli anLichi terupi, .sanguigni, corpulenti, dal :pelo folto, ;rapinatori d'a:r,menti e di donne, stermina,tori di nemici, ben meritevoli di e,ssere chiamati, come Enea t>roiano, massacratot·i di nomini, che dopo a:ver trascinato per i piedi l'ucciso rivaJe s'inebhriavano con tazze rfooJme di vino e si cibava,:no di carne cruda,, n\ale insofferenti. deJila legge, come li vediaimo descritti nel Mahabharuta e nell'Iliade, nel poema, di Izdubar e nel libro della gue,rira di ,J ahoè, se non fossr-..ro stati t,errol'izzati daJ castigo degli Dei, sa•rebbero stati ancora più feroci e crudeli. In tempi, in cui per un occhio si chiedeva la t,esta, per un dito un braccio e per una vita cento vite, la legge del tagJione che si limitava a redla,nia.rc solo occhio ipcr o _ cchio ed esistenza per esistenza ra,ppresentava già una segnalata. vittoria della umanità. Anche fra gli antichi Gla1li <lelle foreste dl'nidiche par,e sia esistita un'assistenza sanitaria negli eserciti, assai b:arba,ra. I sacerdoti addetti a queste mansioni erano soliti ricm;rere a · piante sacre, colle . quali. innalzavano una specie di rogo tper sacrificare i prigionieri -di guerira, se prima non ·erano ipassa.ti a :fil di spada, q1mndo volevano guarire i malati _e feriti in r,0mbattiiroento.

V. - I SERVIZI SANr!'ARI MILYl'ARl Nl!JLL~ ANTICA. INDIA.
~e ora volgiamo le indagini all'India, che, oome è noto, fu uHa, delle culle più antiche della medicina, noi possiamo, scorrendo i poemi sacri, trova,re qnaJ.che traccia di assistenza, .sanitaria in guerra.
L'Ayur-Veda, ossfa, 1-ibro della vita, di Susruta, figlio di Visvamitra, che dal fon<lo-della foresta di Bena,res fu dettaito da, Dhavantare semidio, è un poema oostituito, come i libri di Ippocrate, daHa- fnRione ùi pa,recchie opere. È la rpiù 1mporta.nte raic.cOllta oomiposta 2000 anni ,circa a.. C. da medici antichissimi clell' India e porta il titolo<< Sns' rutas Ayur Véda.s, ossia. si~tern,a, rli ffif'i(licina ciel veneml,ile Dhavoota.re dimostr.ato e daJ ,suo (Usccpolo Sus',rut.a composfo )). Era costituita origim~ria11111,nte dn. crnt.omila v~r:.si, divisi in mille ca.pitoli cd in seguito Svayamhs, saceròote di B1·ahama, la, riunì in otto libri: che poi ùuJ Dhavantare fu1·ono 1-;uddiyjsi in 5 ip:u·t'i :
La, p1··ima ;pa1-te (Sutrast~hàna,) comprende le cognizioni prelimina,ri ed afferma il dogma che meclicina e chinwgia, devono sempre agke co.nternporancamente, di comune accordo: chi vofosse <' ,oltiva.re Roltanto una di queste branche potl·cbbe par::iigonarsi ad uu uooeUo che intende&--e volare con un'ala, soltanto. A titolo di curiosità., ricordiamo che ncl ,capitolo X ,si parla· già òell'ago-puntura, nel XVI della ,rinoplastica, nel XVIII si descrivono 14 maniere diverse di fascia.ture .e nel XXXIV si aooenna all'istituzione deill'a-rcbia,tra del Re, che dov,eva, segni<rlo, quando muovevasi in guerra, coll'esercito, e custodirne la salute : egli aveva il posto d'onor~ nclfo, tenda del principe e vestiva abiti regali.
Nella, s~ouòa, parte (N idàna8tJhàna,) è tratta,ta la patologia delle varie a:ffeiioni, fra cui. la, tuhPrcolosi <'letta « rnaJ la,ttia ,rc.>0,le )), le genito-m·ir1n,rfo, le veneree, 1e cufauee, con specia,le riferimeinto al vaiuolo, .a,]],a, Jehb11:t, di cui si •Pnumerano va,1·ie ·Sp<'cic e se ne rioonosce il carrattere conta,giooo, come si ip11ò desumere da quest-0 passo tradotto nel 1844 d.all'Haesler òa,l Ranscrito in lati.no: << OopulationeJ corporis contactuJ adspirationeJ con1JictuJ c01nmuni c11,bitn et sed e~ 1;estis et serf; i fiore·i iniwtiono, lepr o , f ebris, taòes, li ppi tttdo, daemonfooiquc morbi ab hornine a<l hominem transgrediuntur )).

Nella terza parte (Sarirasd'hàna) .sono esposte le co.gmz1oni _ anatomiche, e si ricorda come gli Indiani si valevano dei cadaveri, oonvenientemente prepa,rati, iper lo studio del corpò umano: « Jllortitum abluendo simitl visibilis .e.st membror11,m ratio. Ante ooitlos enim quod vi.mm est et qu,od doctrina) id imo verbo magùi seienl'iam a,uget >> . I cada,veri veinivano rinchiusi in una gabbia, ed immersi pm· 7 giol'ni nel finme e successivamente, senza, l'aiuto di coltelJi, si i-it;roifinava,no fortemente le parti molli fino a mettere ano oooperto gli ,organi interni.
La ·qna,Tta parte (Olvikitsistast)hàna) è dedicata all1a terapeut:ica, essenzialmente medica, e chirurgica, e si pairla già del sala~so, della tonsillotomia, della litotomia, della paracentesi, delle orper·;i, ~foni di cataratta e di fistola anaJle, nonchè ,dei vari metodi di l'id azione delle fratture e hissazion_i.
Dei mc~icamenti sono già l'iconosdute le virtù ter:1,peutiche del -mercurio, che già sin da quell'epoca remotissima era, tem1t,o in g1·an p,regio. << Il medico che conosce le virtù delle erbe e delle ra,.,1 ici, è detto, è un uomo; ,quello che sa le virtù dell'-a,e.qua è un il•f',mone; ma colui che conosce le virtù del mercurio ,è un Dio )). Nf'lla quinta, nnahncnte (Kltlpast'hàna) si accenna all'azione ,h·ll,e ,i;;ostanzc velenose, ai ·sintomi e cura. D _ a que,-ito poema HIJ)prl'.ndiamo inoltre che, quando un ,rajah pawte per la guerra, deve essere accompagnato da un medico provetto che lo .a..~ista in ogni evenienza e vigili ,scrupolosa-mente i:,ugli alimenti e bevande èhe servono aUa sua mensa, da UJl sooerdote, pct·chè l,e sue p,reghiere possano essere più -efficacemf'.nte ascoltate 1·d esaudite p,e1:· iJ conseguimento della vittoria., e òa un astrologo die interpreti i presagi ed alllontani aJ momento opportuno con 111, 'offerta ipropizia,trice alla, Divinità i pericoJi che possono derim re da una m.alaugurata. cOJ1giunzione òi .ast;·i. Rilevia;mo altresì dir, •Juesta racoolta che negli accampamenti la, t•P ,nda d<>J medico ora di stinta da un segno convenzionp.Jc ben visibi[e a distanza, in modo, d111• i feriti e tutti gli abbisog-n-evoli di pronto soccorso potessero H1rl,ito ,rkonosceda l'-O csservì portati al più presto cd adagiati su 1111 l,etto di foglie. Qoivi era frenata l'emorn·ag·ia, e sulla ferita erano versati oli , ·lii' l~nivano il dolore e succhi di piante di grande efficacia -te1·11 ,p(•11tica. E si trovano inter,essanti particolari sulla tecnica opc-

ll'atoria degli as<;essi, sugli strumenti chirurgici in uso (dei quaJi gli ottu~i (Yantra) ragigiungevaì10 la, cifra di .LOl, prima, ifra tutti Ja, mano e 20 tiipi di strumenti taglienti (80,stra)) sul ~etto di ferro operatorio, sulla posizione del pa.ziente è dell'operatore. Le fratture e le lussazioni e1'llil10 curate in ,comune con 1'a estensione e controestensione, ricorrendo a macchine (rotae u.su), a stecche ece. Le ferite del crani.o, .della, fa<:'.cia e del colllo erano ~uturate; l'emorragia era frenata ool freddo, coill'olio caJdo, colla, cenere o con una solida fasciatura. E si parla inoltre di a.mputazioni della mano, per la grave pe1xlita di sangue che detemninano. le ferite di ,questa r,egi(me, di 1la,p.arotomie, di ,suture int<>,.sti:Qa.li, di litotomie, erniotomie e di operazioni di cataratta e di rinoplaistica, utilizzando la cute delle :guancie, ,essendo molto frequenti in India le condanne al tag11io del rul!SO per adulterio, secondo le leggi di Manù.
Si de~~crivono anoora, altri interventi operatori, parecchi st,rumenti chirurgici, e numerose fasciatnr,e; si tra.tta dei segni che distingu0110 tle ferite facili a curarsi da, quelle di difficile guarigione ed anche dell'estrazione dei coripi estranei, della tecnica, per arrestare l'emo,i~ra,gia e delila cura deHc fratture~ e delle lussazioni.
Accenneremo anco,ra ad un altro poema, india.no, il Ramayana, in cui è fatto il nome del medioo Sushena, che assist-eva i feriti e ipraticava medicature sul campo di battaglia : egli riuscì a guarire Laxshamano, ferito ,gravemente al torace da una freocia che gli altri sanitm·i, chiamati d'urgenza, non e1·ano stati capaci di estra,rrc. Ricorderemo infine che i medici milita,1.·i erano in quelle epoche remote tenuti in partico1Jare consi.derazione fra, gli Indiani. Dopo l'aocanita lo.tta, che costò all'esercito di Rama perdite gravissime, i d1ii-urghi Vibishana e Ranoumat 1pe1·correvano in lungo e in Ja,1·go il campo di battaglia per p1rodigare i primi. soccorsi ai feriti, quando scorsero il vrechio eroe Dyambarat, confnso fra i caduti, che non dava più segno di vita. Gli spruzzarono l'acqua sul volto, gli eccitarono la r~ipirazione facendogli annusaire ,essenza di loto e di nelumbo, ed a poco a ipooo il vegliardo rinvenne, senza però poter riconoscere chi lo assisteva. B la ;prima domanda che [oro rivolse fu di chieòere se Hanouma,t era iriomasto incolume : « Se vive, egli a,ggiungeva, l'a,rmata, potrà anèora essere salva,ta e saremo certi di poter ricnlJ)era,re ]a, ~alute, anche se avessimo esalato· l'ultimo ,respiro! )). ·

Il povolo indiano diede lan:go impulso alJlo sviluppo degli ordinamenti militari ed alla riorga,nizzaq;ione dell'esercito, ma non 11,vondo traffieo diretto coll'Europa, visse in una specie di isolamento, sicchè tutto quanto è a noi pervenuto più che su dati .storici ineccepibili appartiene al.ila leggel}da.
Per quanto riguarda l'igiene delle tru,ppe, furono impall'tite NeveriStSime ,norme ·riguaiJ.'danti s.pedaamente la pulizia perso,na]e prescrivendo l'uso frequente di bagni alle estremità infedo1·i, la, prulfaia dei denti che si praticava, a mez~o di fuscelli di certe piante e quella d-egli occhi fatta con col!liri e po.mate. Si ordinò i,J1oltre nn'.altme.ntazione esclusiva.mente vegetaJe, ·a haise s01pra,tLntto di frumento e di legumi, e si proscrisse infine ùgni bevanda alcoolica, punendo i colipevoli col marchio sulla fronte.
Venuta poi la, conquista degli Arabi e la sostitrndone dell'isla11tismo all'antica coltura, l'arte chirurgica di gue~ra decadde nel1 ' .India, soprattutto per il fa,ta.Jismo dei .seguaci d,eU'lslam e per l'oiN·m·e che loro incutevano gli atti operativi cruenti.
VI. - L'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MILITARE IN PIDHSIA.
Dalla presa <li Troia alla nascita di Ippocrate interoorrono ben oi.to secoli, ed in questo lungo rperiodo non troviamo alcuna nol;"izia o documento che pos,sa, gettare un po' di luce :lira le tenebre della storia ed illuminarci alquanto sui servizi sanitari degli eserciti e sultle ferite di guel'lra di qneUe evoche remote. Sappiamo t-.oltanto, da, un passo delle ('JJ)istole di Ip,poor.ate, aJllorchè Alcihi a,de prepa.rò una spedizione eontro la, Sicilia, che l'assemblea popol::tre discusse, f,ra l'altro, sull'opportunità, di aggregare dei me1 I id all'es,ereito, ed I1ppocrate stesso pl'omise di la.sciar iparti,re Nùo figilfo, medico rinollll.to, al seguifo delle truppe.
E si fa ancora menzione di Otcsia, originario di fonia, e pa-. nrnte di Ippocrate, il quale nel 416 a,. C. si sarebbe recato in PCII'Aia, e fu accolto oome archiatra alla corte di Artasersc I. R noto che q nesti mosse guerra aJ fratello Ciro, e nella batta.glia di Cunassa i 11 "Rabilonia fu ferito da Ciro stesso oon un colpo di giavellotto 11 I torace e soccorso da Otesia 1che lo guarì. Ciro, jnvece, nel momento l II cni colpiva il fratello, venne a sua volta ferito da una freccia 11.l la, 1·egione orbitaria sinistra, che produsse notevole emorragia, , .. 11<1rtigine tenebrosa. Fu sollevato, e, mentre si avviava col capo

l'('<·li 11 :tlo sulla spaJlla, fu ferito per la seconda volta, al calcaigno, p,,,. ~·,ii stramazzò al suolo, battendo vjolentemente il capo su di 1111 111.1.cig,no e ,rimase morto a.ll'ista.nte. Narr,asi che questo re non hevesse che aéqua, prreedcntemente bolaita, in apposite anfore di ;1rge.nto.
L'esercito di Ciro sconfitto si di~persc disordinatamente, e diecimila O.reci, al servizio del re, avendo rifiutate le conòizioni imposte d:::il vincitore, inizia,rono attraver-so l'Asia Minore la famosa ritfrafa,, così magistraJmente descritta da Senofonte, che ne fu testimone oc11la!l'e e seguì, si·pliò dire, g~orn-0 iper giorno, le va,ric vice1ide. E neil momento in cui l'esercito risale il 'l'igri, lo storico ci m1.rra che otto medici emno .a.l seguito òeHc truppe e si dovettero .fa,re pa.r,ecchie soste nei villaggi per •ricovera,rvi i nume1•osi fc1;iti eél hwa1Jiùi. Dopo avere valicato le montagne dei Ca,rdm,'Ci, du,mnte il pa.~saggio delle pianure dell' Annenia, ocddcnta,le, l'esercito fu bloc<:a,to <laJla neve cd ebbe a. subire gravissime oftalmie. Si cbber-0 jnoJtre a deiplora,r,r m1merosi.~tmi casi di HtS8i<forarnento, !J)Ol· oon1battc1·e i qua[i si vietò alle truppe Pa.diacdo sulila neve. Senofonte ci uru.·ra infine che turbe ,èJj donne di malaffare, pe1· lo J)iù 1}H·ovenienti da.J.lc colonie g1,cd w della lonia o di origine circa&"la, seguiva.no ostina.ta.mentc le truppe diffondendo mallattie veneree_
Dal libro ITI {lclla Ci,ropedia., e- pr~isamente dal capitolo 2°, a,p,prendi,amo ailtrosi che a,l seguito de!l t'e, in campa,gna., si trovarn.no i medici, gli a•rUtSpici ed i suonatori <li flauto, cioè i componenti il servizio sanitario, religi.oso e la ruus.ica.. Ciro stesso nel libro I si ,r:~pl'inic in questo modo: « no sentito dire ed ho veduto che, cornc k dLtù, d,c vogliono mantcnc,rsi in buona salute si soelgo11<> dei nwdiei, cosi i gen c1·ali in campa1gna, reca110 al seguito dei modici p<'l' la, t,n1rppa, )).
Così vediamo Filippo oon<lun,e rrnlla sua RfWùizione il ,proprio medico C,l'itolmk>, che gli fu di prezioso aiuto, alforchè rima.i,c ferito a.U'.occhjo ilcsl.rn (la un a.rcierc, il ~1naJe ~li aveva la,nciato un da,rdo con appesa questa curio..'>a. etichetta: nll'occhio destro di Filippo! Do,p-0 .iwerc~ <·~tratto la frecd~L, 01·itoho.lo applicò dPi. eataplasmi che H cortjgiano Olisophoo, per mel'o atto aervile, non esitò a siend<?re s11i pr01pri occhi sani, ,por imita:re il sovrano. Anche il' figlio Alessandro eblJe al suo seguito numerosi. medici

militari aJ!la dipendenza d,el eelebre l1 'ilippo ' di Aca,rna,nia, quali OaJJistene d'Olinto, Glaucia., Alessippo, A:ndrocide ecc.
Merita anche di es:se;1,e segnalafa· la, sentenza, di Ca,mbise, · che leggiamo nella Cirop-edia : (< I mcdfo~ sono come i rattoppatori di abiti, perchè i1l lorn Javoi·o si riferisce semplicemente a càrpi indisl[)osti o mutilati; pt·ovvederai me.glio per l 'a,rmata, se cerchem i di prevenire od impedire la diffusione dcl~c malattie fra le truppe )).
Inoltre nel capitolo XIII della Lacedmnoniae Respublica si Jeggc che, dopo una battaglia, contro gli A1ssi.ri, sono oondotti innan7,i al re Ciro moltissimi prigionieri feriti, ed egli oon sentimento umanita,rio ordina di scioglier-e le catene e manda a chiamare i medici per ipl'esta;r loro le cure necesswrie.
Ed abbiamo ancora notizie interessanti sul tirasporto dei feriti i11 guerra che veniva effettuato per i;r1ezzo di porta-feriti, i quali •~l'a,no <lispensati dal po1·ta,re l'armatura. Lo ~udo è il primo rudimento di ba1·ella irnprovvisa.ta, per lo sgombero dei caduti. Senofonte ci naJÌ.Ta di un -~oldato, che era rima.sto stritolato nella ;.::amba ,destra da.ne pietre lanciate ,òall'a-lto e che fu Roocorso da 11:nrHoquo d'krcadia, e trasiportato sul proprio scudo, in modo cla poter , raggiungere il suo rep.arto comhttttente. E 0011 qu~to mezzo Dario, vinto e ferito, fu ,p-ortato alla presenza di re Alessandro ..
Lo stesso Alessandro, ferito da una freccia che gli aUraversò 1:L corazza e penetrò nella l'egione ma.llllllÌllare destra, seoondo ci 11a,rra Quinto Curzio, stremato di forze, si lasciò cadere sul proiprio ~endo (clypeo fatigatum corp11,sì emcepit); ed k riano ci dice al ,,·jgua,1~do che i Macedoni tra,spo-rta,rono il r e su questo scudo alla tenda in ,co,sì grave stato che non s:a,peva,no se fosse ancora vivo. I >fll resto è pa.ssato al1]a, storia l 'imperioso motto deUe donne sparl.:Htc : « o oon questJ o su questo! )).
Si 3Jlllmette tuLlavja, che, oltire agli scudi, si iu:.uprovvisasseiro h:1 ,1·elle anche con !'ami d'albero J•ega.ti rudimentalmente ed esi1-1 1.PR~el'o delle lettighe (lecticae militares)~ destinate al trasporto il.li ,malati e feriti, che i fanti avevano il privilegio di traina[·e : i I 11 tcdesimo Alessa,ndro, ferito aJ.la coscia sinistra in un nuovo H i:ontro, sarebbe stato coricato su uno di questi carri e trasportato 11, l.11rno dai fanti e da,i cava,lif>ri, che si <lisputa,vano tale onore.
Ma, delle forité di re Alessandro, merita che ci intratteniamo

alquanto per da,re un'idea del trattamento delle lesioni di guerra in quelle epoche r-emote.
Il moofoo Oritodemo, dopo aver largrumente sbrigliata la ferita del re, estrae il dardo, che si era incuneato nello spazio interco- , stale soJPra la mammella. Pilutarco èi dà ulli1 descrizione molto m'inuziosa ed esatta di questa, lesione. Il ferro, dopo aver att,ra- · versato la. pelle e gli strati molli sottosta,nti, ha dovuto scivolare sulla quarta ·costola e pemitrare neJJa cavità toracica attraverso il terzo spa.zio inrt,ercostale, mentre l'aria sfuggiva coil sangue dalla ferita. È *stafo rifeirito l'aneddoto cbe, in attesa, del medico Cll'itodemo, re Alessandro, colpito alla coscia da una freccia, fu trasportato in lettig·a dai suoi soldati per ben quattro giorni di mruvcia. Egli, ,secondo alcuni stOTici, avrebbe dato ordine ad un s,oma,tofilax, gua1•dia addetta, aHa sua :persona, di aprire senz'altro la, forita coilla spada, per estra,rne la freccia. Ma, IJ)er poco che si (jonsiù,e,1·i l'C(;C(lziMrnle coltura. di Alessandro, discepolo di Aristotele, speciaJmente versato nell'arte sanitairia, che più volte aveva potuto nipplicare pratica.mente le sue cog11fai.oni per socco:r,rere ed assistere i suoi amici, feriti o malati, non si può non tacciare di inverosimiglianza questo episodio.
Il Rollet ritiene invece più giustaimente che il chkurgo non si sia areinto aJ1l'estra-zi-One del dardo se non dopo aw~r preparato delle bende e tutto quanto era, necessario por comprimere i vasi bea,nti e tamponare lo spazio intercostale. Appena il ferro fu rimosso dalla, ferita, 1si rip!l·odussc l'emorra,gia, mtL questa con mezzi opportuni fu arrestata,, ,e la, lesione dopo sette giorni era già cicatrizzata,. La conva1escemr.a, fu invP,ce piuttm~to lnnga,, P.d Alessa,ndro ,dovette alla sua costitu,r,ione IJ)articolarmente robusta la piena e completa guarigione.
Il ,procedimento d·elll'estrazione dei dardi dalle ferite non era tuttavia scevro ,ai pericoli. Ricordiamo che Epf1minonda alla, battaiglia di. Mantinea,, colpito al petto da un giavellotto, volle attendere che la vittoria fosse conformata prjma di sottoporsi all'interwmto chirurgico, e morì pochi momenti dopo l'operazione. fAn. che H console Erminio ed il ;re di Siparta Agi, f,eriti al torace da un eolpo di lancia,, doVfittero soccombere dnrante l'atto operativo.
DaJlle notfafo fornitt>..ci da Senofonte h1 va,ri passi della Ciropedia, si· rileva che l'a1rmata persiana aveva al seguito dei me-
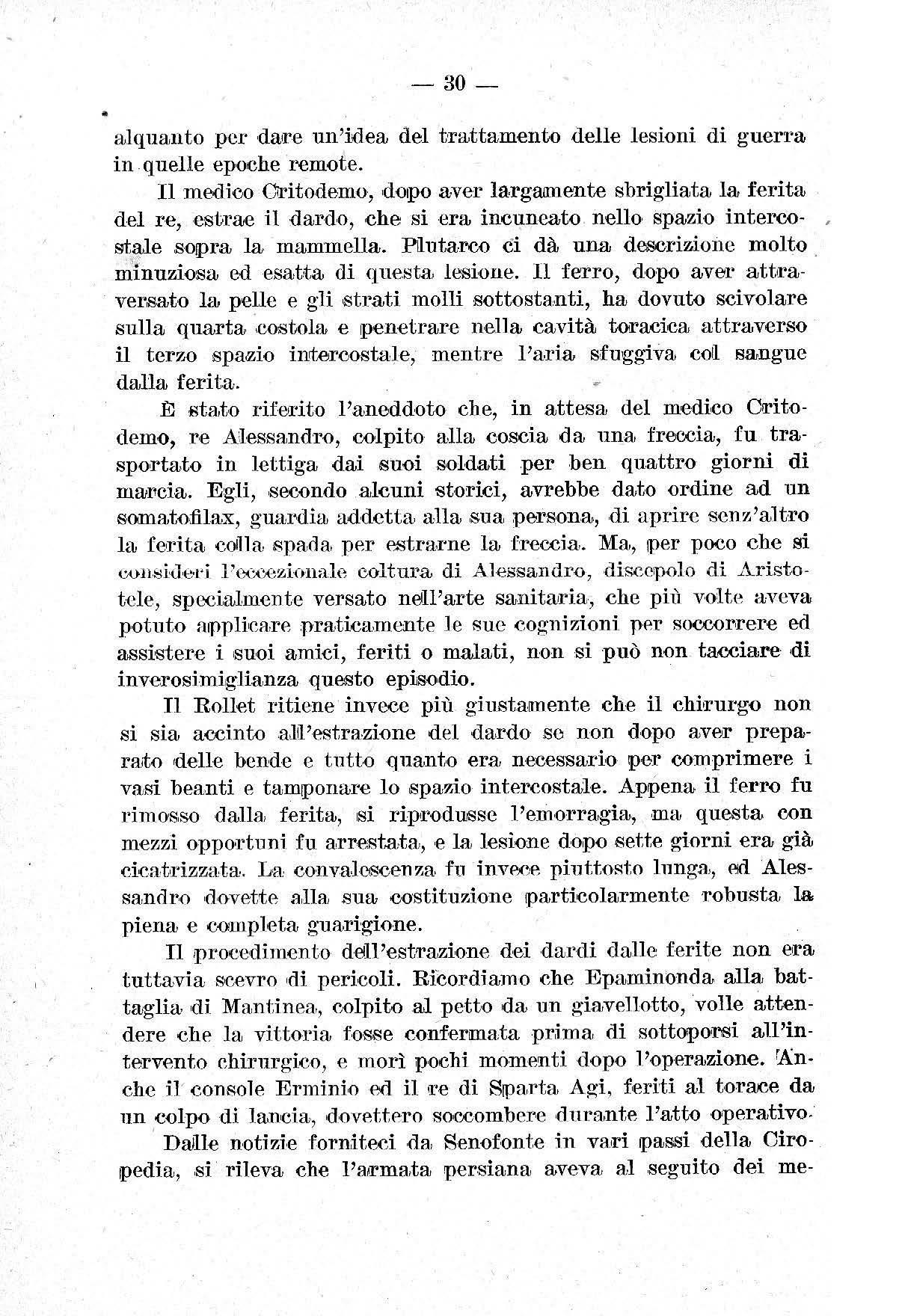
dici militari, i quali avevano l'obbligo di àssistere e cura,re anche · i 1pdgionieri f.eriti. Il che ci dimostita come molti secoli prima che i I Cristianesimo predicaib'ISe il gran principio di perdonare le offese tid a;mare ,gli stessi nemici, questi umanitari sentimenti fossero già :t,!JJJlicati in Oriente. Inoltre Serse aveva particolari iriguardi per i reriti èd era· solito disporre che gli intrasiportabili venissero ri1-·o·verati nelle città, per le quali egli passava durante la ritirata, e ,raecomandwti alle cure dei magistl'ati. Tanto era, l'interessa111.ento per i malati e feriti di guerra., che non solo i medici pensanrno di prodigar loro i soccorsi necessacI·i e di farli traiSportare in luogo sicuro, ma ta1ora, si rita,rdavano espressamente le ma,rcie per non fasciarli indìetro, ovvero venivano ,ricoveraiti nelle città :d)eate. E le ambulanze private istituite nelle città greche, come ci a,ssicura Senofonte, 1raccogHevano e curavano anche i feriti di ·11:wte ~wversa,rfa.
Ric~r<le1·emo infine che l'assistenza dei medici milita,ri in que. ..:t'epoca: preist(n·ica ,si e.stendeva a-nclw ni morti: la sepoltura. era cosa, sacra agli. occhi loro. Ar,rivando in un luogo ove era avvenuto 1111 violento combattimento, ,non mancavano di p,rocooel'e 't1.ll'innr11azione dei cadav.eri, che venivano lavati e fasciati prima di essprc- sctpollti affinchì'> S<len<lPssc1·0 d<.,'Centemente n <"lla tomba.
Nella Scuola di Alessa,ndl'ia .Ja, medicina Ipl[locratica ricevette 11n notevole impulso da,llo studio dell'anatomia, per cni si resero < icle bri Erasistrato ed' Erofifo i quali, liberandosi da ogni dottrina dogmatica, posero per base dei loro studi l'esperimento: il primo rn un precursore delJa scoperta della circolazione del sangue; il smondò prooonizzò le ricerche sull'ana,tomia del sistema. nervoso ,. !slllle va,rfa-7,ioni del poilso. "ffi la chirurgia militare se ne avvant.aggiò nelle ,guerre. comba,ttute da Fllippo il Ma!Cedone e da Aless:1,ndro Magno, i quali, oome vedemmo. avevano chi.rurghi propri d,,~ li scguiva:no.

I
VII ,
- LA MEDICINA MILITAREl NELL"' ANTICA GRECIA ti) NlllI POIDMI OMERICI.
Nella G rocia àntica è nooessrurio trasco'I'rano 800 anni dopo 1 ' ,\ccidio di 'I\roia ed airrivare fino ad Lprpo,c:,rate (460-355 a. C.), pcr:chè la medidna e· 1a chirurgia assumano forme scientifiche. f,~ veramente nel secolo di Pericle, nell'età. delil'oro, in cui la scienza gwP<ia si illustra dei nomi di Pitagora, di Aristotele e di Platone,
l'or~~toda di Eschine e di Iseo, maestro di Demostene, in cui il Pa,rtenone aveva consacrata.la gloria di Fidia e di Zeusi e si raprp,re.sentavf1no le ·tragedie di ,Sofocle, di Aristofane, e '.fuddide scriveva, la storia della peste di Atene, era tempo che f1llche per la medicina, sorgesse un uomo di genio, il quale, str'.appa,ndofa al cieco empirismo, la, pon~se ,sulla, retta via del progresso scientifico.
Ippocrate, nato rn'lll'isola di Cos, :è considerato nei tempi medioevaJi come il pa.dre ,é;iella. m1?dioina. e ci ha la.'>Ciato un grandissimo numero di ·scritti costituenti il Corpus Hippooratioum) che pu,r rappresentando mu1 raccolta ùi epoche e scuole diverse, per 17 libri si può comiiderai:·e ooo:ne opera su.a,. N~l libro De uloeribus co:nsigilia di lavare 1c ferite col vino e di ungerle coll'olio dopo aver purgat.o la piaga. coll'aip.plieazione · òi eata,plasmi. Favorisce quindi ]a ooesione dei marigini con foglie di rubits canino e di nasturzio e da ultimo ne facilita la ci.catrizzazione.
Nella scuola ,di Oos la medicina e la, chirurg·ia, formnvaJJo una ~dern1tt, solu,, fomlata sull'o&<rerva.zione diretta cd inspirata al conc<>tto d~Ua natura rnedioatrim) dominata da. quelJo ~pirito acuto di os•serrva~donc, ,per cui le ope1,e di lppo0ra,te destano anche. oggi, dopo 24 secoli, la più .gfa,nde ammiira,zione. La dottrina, dellè lesioni .esterne e speciahnente delle fratture e delle [ussazioni rp,rogrx....l(]ì molto in quel tempo, Il('J quale dava,si grande importanza, aJla heJ1lez11;a, delle forme, e rimase indietro la .pr.atica, de:Il,e antiche operazioni, .poiclÌè i Greci si ,çlavano la ttnorte,, 1phJttosfo .che rimanere mutÌilati.
Nell'a,r·mame,nfario chirurgico sono des,critti con gra,nde esattezza Ile sonde, i coltelli, i bistori, i raspatoi, i cauteri, i trrupani e le tena,glie per l'estrazione dei denti (odontagra). Sipech!Je caipitoJo è d,e,dica.to al trattamento delle fratture e (k>ille lussazioni, con e._<:;,a,tte clcsorizioni delle ossa e d!:'Jlle .articolazioni e minute esposhioni della, fisiologia dei movimenti e ,d,elle manualità pe,r la. riduzione, l'imrnobilfazazione e le fasciature. '
Si ha.rmo notizie à,bbastanza precise degli ordinamenti sa,nitari milita,ri che aveva la Grecia ai tempi i:ppooratici, i quali, se erano progrediti.. nel ,periodo a,rcàic9 della, civiltà ~(reca, ta.nto 1più dovevano essere perfezionat i in un periodo più evoluto) in cui il popolo ellenico, avendo 1per culto l'alTilorc, per ideale ]a beillez,r,a,, doveva tenere in gra:n· pregio la vita ed assicura.1·e eon ogni mezzo. il mantenimento della salute. ·

Nella raccolta ippocratica, si ileggono seritti interessanti della irtedicina Ìnilitare., che sorg<1 indipendente daJla medicina sacerdotale, ed è detto che un medico per perfeziona,r·si nelila chirurgia deve accompagnarB gli eserciti in guerra.
Ed infatti in ,quei tempi vi erano chfrurghi militari che segui-· vano le milizie, provvisti di strumenti e del materiale di medicazione necesi,iario, i quali avevano il loro posto accanto alla tenda 1·eaJe.
Tempo fa nell'isola. di Cipro fu scorper·ta una sorittura, la qna,le si riferisce ad un contratto della città di Ida,lion con Onasiloi-1 fig11io di Onasikipros e coi congiunti òi es,so per prestare l'assistenza sa,nitaria durante la guerra, dietro ,ricompensa in denari . cd anche in pos.,qedimenti terreni.
A,ristotele (384-322 a. C.), il graintrc :filosofo, e biologo, parla, ,ldla, grande importanza che ha la ipurczza dell'acqua per la rpubhlica .salute: « Le sorg<>nti ,d'ac{ina pura,, in quamti.tà sufficiente, Llcvuuo esoo1·e in vicinaJ1za, della dttà; se questo non ,è il caso, si (levono fa,re numerosi eò ampi ,serha.toi per la, raocoltai dell'acqua piova,na, a..ffinchè in <>alRo di gn~rra o di as.,,;;('.dio l'acqua non venga ;1, rna.nca1re )).

* * *
Sappiamo che, ool p;rogriedi-re dei ternipi, le arti furono trasportn.te ,dall'Egitto nella Grecia: e fra queste certamente anche la medi ...:ina. :m ormru accertato infatti che FJSculwpio, da cui diseendono ~li Asclepiadi,. era di origi.né egiziana. Gosì molti fifosofi greci, attn1,tti dal.la ,rinomanza dei medici dell'Egitto, si recavano presso 1 I i l01·0 a iierfezionarsi nell'a,rte : e nel1Ie prime emig,razioni dalJe rive del Nilo nell'Elfa,de è molto iproha,hile che la, medicim1 sia s.f atn, introòotta, c-0n le altre s,P,ienze.
Si è arriv.ati perfino ad ammettere che Ome1·0, durante un v i:i,ggfo in Rgitto, a,hhia, sottra.tto dal tP.Jnpio di Vnlca,no a, Menfi, ml la -complicità. di un amanuense, i poemi composti cla Phanf.n,sia, che deooriveva;no, sotto il velo dell'a,llegoria,, a.vvenimenti ~voHi,,;;i amtica1mente neUa terra dei Faraoni, e che egli, per megllio
o,
·1·11ltarc il ,pla,gio, abbia trasportato la scena nella T,roade, tira,, v,1•,,d. <mdo i suoi eroi a:lla, greca,. Altri sostengono, in bas.e a quanto .-i 11;1, Lra.rrianda,to Er(}doto, che Omero, viaggiando in Egitto, ~t,bbfa 111pp1·11.-;a dalla viva voce ,dei sacerdoti la istoria della, guerra di '1'1·1,ia, che il sno genio rpoi ,plasmò ncg1H imm01·ta,li. poemi.
Il
I ca11ti omer1c1 sono inve1·0 ,l'eco pi.ù remota deHe rpm antidi<~ tra,<li~;ioni, ed in essi possiamo ,rintracciare le fonti delila storia dell~ medicina ell+>1lica in genere e quella dei s-ervi11.i sanitm·i negli eserciti in ispecie.
Questi. 'poemi, cormparsi agli alboTi della ,storia gr,eca e rapida,mente diffusi. i.n tutta Ja penisola, contribu1rono a mantenere 1 salò a l'unità nazionale, così come avvf'nne · dopo tanti soooli per la Divipa Commedia, nell'Italia, straniera, e divi.sa, E qnf'Bt'opera di fusione fu tanto pi1ì efficace e durevorle quanto più largamente intellig·ibili era,no quei canti a,l popolo tutto,· che vi sentiva, palpitare la prop,ria anima. e tutta. la vita, ra!J)Ìda e violenta, ricca . di vicende incalzantisi senza tregue in qnelLa terra fatale, che, come l'Itaiia, << pa.rve angusta ai suoi figli )).
Ma.i creazione d'arte nutrì infatti tanto di s _ è stessa, un po1polo c-0me i poemi omerici Oa, nazione greca,: recita:,ti nelJe corti, nelle ca.se e nelle pia,zze, ripetuti rh gaira nelle tenzoni poetìcbe, impairati a, memoria nelle . scuole fin ifaHa prima giovinezza, come monumento <ll stile, d.i sapi,enza, di e,roismo, furono essi uno dei primi e più spirituali vineioli di na,ziona,lità..
Mai l'umanità potè deliziarsi di più semplice\ nobile e forte poesia, di questi poemi, nei quali l'eroe è così umano, anche compiendo im'P'rese sovrumane, ed è 1·wppresenta,to con tanto verismo neJ1la sua impulsività, nella ra.pida vicenda di opposti sentimenti, che lo avvicina, aJ fanciullo nell'audacia, e nei repentjni timori, nella sfida agli. dei e nella rive1,cnza verso ,di essi, nell'odio implacabile e nella g,ene1·osità cavalleresca., ove ila nairrazione conquii;;ta ooll 'evidf'nza del ver•o, mentre 1 'obbiettività del p,oeta, che mai non -si smenti.-:ce e diet1·0 c11i. ,;i cela, non impedisce di intuire l'anima sua,, sempre partecipe e ipresentc. P,e,rò l'IJiuJde e 1l'Odissea non sono sorti solit31ri ,e gigantj, co _ me la Divina Commedia, ma dimostrano un lungo pcdodo di prCIJ)arazione nella fra,seologia.,, nei personaggi eroici, nelle a1lusioni e ri- · vela.no una lunga, i.radi½ione <li canti ruccoltisi attorno al nucleo primitivo e non -sviluppati di getto dalla, mente di un solo p-0eta.
L'Iliade, che esa,lta, le ultime vkende delb !Spedizione di Troia, e il'Odissea, che canta, il ritorno di Ulisse in Ttaca, dç.,po venti anni di dolorose traversie e di tra,gici avvenimenti, sono le ultime espres' sioni della, civiltà egea, e ra.pp,resenta.no i due monumenti di insuperabile bellezza, e più imperituri, cleWepopea omerica, di;t,i quali

tra,sseiro in seguito ispirazione tutti i poeti, da Eschilo, a Sofocle, ad Euripide e tutti gli artisti da, ~'jdia, Zeusi, Prassitele, Mirone, a Policleto, Lisippo, Soopa.
L'Iliade è !'ltata ùefinita un feroce poema di guerra con intonazione sono,ra, che si svolge fra, lo strepito d eille battaglie, il fragore delle armi, i lamenti dei fcf'iti, le grida dei vincitori, e celebira le eroiche gesta di Diomede, di Sarpedontc, di Agamennone, di Menelao, dei due Aiaci e -sopra,ttutto di Achille e di Ettore.
Per contrò l'Odissea è un mera.viglfoso romanzo di avventure, improntato ad ·una calma idilliaca, dm esalta la vita ag,reste, il -sereno lavòro dei .campi e ['intima gioia familiare dopo una- vita tira.scorsa fra i pericoli e i iSacri:fici, P- nel quale, fra la descrizione dei viaiggi, degli usi e costumi, emerge maestosa una sola figura : quella di Ulis,se che tutte riunisce le virtù più elette degli eroi.
Undici città si diSiputano di a.vere da.to i natàti ad Omero (.fìg. 2), talmente le notizie biografichf' .sono incerte e oontra,dittorie. Secondo l'Inama, Omero sarebbe di origine pelopo.nne~iaro, e vissuto nelila penisola greca, :prima dell'occupazione dei Tessa-li dei Dori; secondo il Sergi, invece, sa,i·ebbe òi stirpe mediterramea.
Mentre gli antichi attribuiirono umwirncmente al 1poeta, famto l'Ilia,cle quanto l'Odissea, nell'epoca alessandrina i grammatici Ellenk.-0 ,e Zenone ne sostennero la diversa paternità, e molti seooli dopo, nél 17!)5, Federico Augusto Wolf nei suoi famosi Prolegomena ad Homeritm riprese la questione, già intuita dal nostro Giovambattista, Vico. Partendo dall'osservazione che nei tempi omerici non esisteva ancora la, scrittur·a, egli affermò che un solo poeta non poteva a,yer composto i due ipoemi, i quali dovevano es:,;er,e opert1 <li vari cantol'i ,e,;rranti (rapsodi), di cui Omero forse 1,ra _ uno dei più famosi, ~he li tramanda,va,no a, memoria di stirpe in stirpe, e che furono poi raccolti e cÒI1legati al tempo di Pisistrato nel 550 a,. C. Per il Wolf a.dunque Omero non _ è un geni.o i.ndivid ualc, ma, un poeta collettivo dei popoli ionici; non inventore, ma xn.piente rifadtore e comipila,tore di canti eroici.
Anche il Lachma,nn volle dimostrare che l'Uiwde non ,era che 11n centone di sva.riate canzoni., laddove il Nitzchz fu uno strenuo difensore dell'unità dei due poerni. Oggigiorno, in base alle più moderne vedute, si è indotti a ritenere che· l'Iliade sia opera di Omero e che l'Odissea appartenga, ad altro poeta, e che i due poemi, originairiamente di piccola mole, siano andati col succe·

<lersi dei ternpi ampliandosi ed a,nicchendosi di nuove leggende e i·a n:1,011 i. 8econdo il Km11.a, Omero deve _ essere stato profondo c~nosd tore di medicina. Anche Rondelet ammette che sia stato realmente nn medico ed abbia partecipato di 1persona alle numerose
Fig. 2 - Omero · Scultura antica · Museo Naziona,le Ili Na,1lo.li.

batta.glie descritte con tanta evidenza e p1·ecisio11c cli pairticola,rì : invero, acea:11to all'esatta òescrfaione aJ1ato 111ka e fisiopa,tologica. delle varie lesioni ili g1.H~·ra, indica sern[Pre, qnantun<1ue· in modo primitivo, il trattamento tma,peutico. Pinahnente l<',rùlich non esita a l'itencrlo un vern e proprio rn<X!ico milit..u·e. 01ùo1·0 dirnost-ra, infatti nei f.iuoi. poemi uu corredo di cogni- · iioni :uia,tomiche assai complesso e-<1 esatto, :;:alvo quakhe inevi-
tahile errore. Anzi, a ·questo p,roposito, il Darem berg non esita di para,gona,rc Ila scienza anatomica del poeta, a, quella del sommo Ippocrate, ipoichè è riuscito a, distinguere quasi tutte le parti del èorpo umano, interne cd esterne, ed a delhnitarne con una certa pirecisione la sede.
Il Ooa.kley Lettson, nel ,riconoscere ad Oruero questa meravigliosa, erudizione i.n ma.teria anatomica, avanza l'ipotesi che egli fosse un saceridotc o un sacrificatore e che tali. conoscenlie fossero in gl'an pa.rte dovute alla lunga. 1pra,tica acqujsita dal eontinuo squarta.re ed immoJa.r,e vittime a,lla divinità.
Per contI·o H Jfouclier non è moìlto entusiasta delle cognizioni a,natomiche e chi,rurgiche ,del poeta,, che gli sembrano assai primitive e molto snp,erficia.li. l1d anche il Mollet, nel ribattere un'osservazione del Daremherg circa la precisione colfa quale il poeta descrivé le ferii e della,· ;regione to,radè::1, a,mmette chif\, se il ipoeta fa caidere quasi sempre i suoi eroi colpiti, in pieno pet1o, sceglie :precis:uneni:e questa 1r,egione pN e.Ra lta,re HmgJ:>;i01·rnente le loro p;esta ed inupr-iII1c1·c un ca,ra.ttere ,più elevato all'epopea,, ciò che non avrebbe :potuto raggiungere se avesse posto i eomba,ttenti ad avventa.T'.Si fra loro, a,11 ,esempio con col1pi di la,ncia perforanti }e braocia o le gambe. 'rutfavia la figura di Omero assurge gigante~a. nell'a,ntichità . greea., e si può ormai con~idera1·e un osservatore profondo ed uno psicologo geniale. Scorrendo i ca.nti epici dell'Iliade e dell'Odissea, il }..,roHch ha, trovato ben 147 .osservazioni di ferite della forma e sede più ,svariate, p~11"eechie delle qua.ili complica.te, sicehè i poemi <>merici da al,cuni sono sta.ti paragonati ad un ve,110 e proprio trattato di chirurgia dj guerra,. Di ,queste, 106 sono dovute a 00J1pi di lancia~ 17 ti eolpi di ,spaòa,, 12 :1, freccia e 12 a lancio di ipietra.
Invero rie· t1,emende 1'esioni prodotte dalle anni pesa,nti di quell'epoca sono descritte dal poeta in modo meraiviglioso, con un'esattezza 9uasi comp1Ieta dal punto di vista anatomfoo e :fisiologico, non<:l1è <lelh sede della ferita e dell'im1portanza, risipetto agli organi <·o..lpiti e con V{'Jrità, :impressionante. Sono e.,-.;;,poste inoltre cognizioni fli. fisiologia, forse nn po' va.ghe. ma chc.conferma,no tutfavia, il pos~csso d.i nozioni rea,li e considerazioni anatomo-chirurgichc molto g-i n~'liziose : ed è tra.ttata anche c,on molto criterio l]a, cura delle fe,. i f r di guer,ra,. l'•~ <la, ri1le,arsi inoltre che queste nozioni di medicina e di chi-

1•111·gi,1, rirna,ngono pr-cssochè invariàte per circa quattro secoli e hiHog-11a, l'isalirc a<l Ippocrate iper irintracciare i primo1·<li di un l'i1iascimento dcll'a,rte sanita,ria.
Senza arrivare quindi all'opinione d~l Frolich, che intravede in Omero un remoto nostro antecessore, non si p,ossono a meno di 1riconooocre nel poeta uelle cognizioni di medidna molto fondate, e si può ,oondividere il giudizio òi 1~fo.ilgaigne ,e Da,reruberg quando affermano che « il linguaggio poetico d'Omero è 1ri.masto il linguaggio tecnico dei medici, e per qU3into non entrino nella concezione di un poema epico i particolari <'li mod.icina e chirurgia che si possono spigohu·e nell'Iliade ,e nell'Od~sea, bastan<J a, dimostrare a qual punto fosse giunta jn quei tempi quasi favolosi la terapia ,delle ferite e lesioni :p,er armi da guerra>).
* * *
Le fe,ritc, che si osservano più comunemente nei combattenti dei ,poemi omerici. ~ono quelle proòotte dal I~, ~paila, (falla lanciR, daUa f,reccia e dal giavelJotto, superficiali o penetranti, e quelle contuse prodotte dai co1pi di fmsso, i;;cagliati a ma.no o colla fionda, a seconda d<:}le dimensioni. Ciuca la sode delle ferite, quel1e alla firontc, alle tempie, alle regioni audcol:wi cd or·bitarie sono considera.te gravissime e qua,si semiprc moirtali. Delle ferite del collo è fatta menzione una sola volta nell'Odissea, e. riguarda un caso di lussazione delfo pirimc vertebre cervicali in seguito a caduta, mentre :figurano cinque volte nell'llia,de . .Sono inoltre d~-c1·itte le lesioni della clavicola., <'..Ollle conseguenti emorragie ed <e i.ntormentamento del polso>>.
Di particolare gravità sono, per i.I poeta, le ferite del cuore e speci.almente .quelle d>1:ll'addome. Rgli indica (< il basso vcntre fra l'ombeilico e gli organi geni.tali ,come ]a sed,e su cni i oolpi <li 1\fa1·te sono più pcl'icolosi pc-r i poveri mortaJi )). Non g-li sfngge anconli il ~atto cl1e nelle lesioni aòdomina,li il ferito l1n, Ja 1·espfrazione affannosa e che quaJche volta la massa intestin:i,1,e può fuoruscire daJle pareti de.ll'aiddome. Le ferite òel fog-ato, sf':(',ondo Omero, lf)01' quanto presentino una iprognosi 1·iserv}Lta, 110n portano ~emp,re aò_ esito ~etale. B ci <.hì, pe1·S'mo notfaia di nna, k•sionc interna con ;recisione dell'arteria no1·ta, a<l<lomi,nalc, det<>rmina .. 11te la morte istoot.ainea per dis.<:iangnam<:>11to. E rpa,rhL a,neo,1·a (li d.ue ~ .~i' d.i lesione della vescica, <li tre ferite a,ella, oo.<ida., delle fratture ùomplicatc











