AMMINISTRAZIONE > PAG 05 Auguri di Natale
AMMINISTRAZIONE > PAG 06
Il nuovo monumento in ricordo dell’alluvione del 8 novembre 1951
RADICI > PAG 18 Il “mangiar contadino” negli anni ‘50
REALTÀ DEL TERRITORIO > PAG 25 La Nuova Chiesa, 25 anni fa…

AMMINISTRAZIONE > PAG 05 Auguri di Natale
AMMINISTRAZIONE > PAG 06
Il nuovo monumento in ricordo dell’alluvione del 8 novembre 1951
RADICI > PAG 18 Il “mangiar contadino” negli anni ‘50
REALTÀ DEL TERRITORIO > PAG 25 La Nuova Chiesa, 25 anni fa…
Da quando i mezzi di lettura digitale hanno raggiunto una diffusione su scala globale, arrivando ad affiancare – e, talvolta, a sostituire – il libro cartaceo tradizionale, la questione relativa a quale sia il supporto migliore per un leggere completo e autentico si è fatta strada oltre il mondo specialistico degli studi scientifici, entrando a far parte della rosa degli argomenti che animano la conversazione quotidiana. Prendere parte alla diatriba diventa quasi una questione di principio, cosicché il pubblico lettore si ritrova spaccato in due: da un lato ci sono gli estimatori della pagina scritta, che amano fare della lettura un’attività fisica e multisensoriale, dall’altro invece si pongono i patrocinanti dell’ebook reader, per i quali un libro dovrebbe essere caratterizzato da una virtualità che lo rende più comodo, fruibile, economico e meno ingombrante. Al di là delle preferenze personali, questa tematica inizia ad assumere un ruolo di rilievo, in particolar modo in ambito educativo e
pedagogico, nella misura in cui si ha a che fare, per la prima volta, con la crescita e la formazione di generazioni nate nel pieno dell’era digitale, per le quali l’utilizzo dei dispositivi elettronici non è frutto di una scelta più o meno consapevole, ma parte di una realtà data, da cui non possono prescindere. Il passaggio dalla pagina stampata a quella virtuale è di portata talmente rivoluzionaria, da essere paragonabile alla transizione culturale che portò all’abbandono della tradizione orale, in favore della scrittura, ma con una differenza importante: oggi abbiamo la consapevolezza, le conoscenze e gli strumenti necessari per poter individuare in che termini questa evoluzione artificiale del modo di comunicare possa impattare sulla vita e la crescita individuale e sociale, così da poterne monitorare l’andamento e, nel caso, correggerlo.
Nel recente scritto “Lettore, vieni a casa”, la neuroscienziata cognitivista americana Maryanne Wolf ha espresso le proprie riserve a proposito della scelta di affidare la formazione del cervello che legge ad
REALTÀ DEL TERRITORIO > PAG 28 Un nuovo inizio
REALTÀ DEL TERRITORIO > PAG 38 Il pane
un’esperienza principalmente di tipo digitale, tendenza che potrebbe portare a dei cambiamenti di una certa importanza da un punto di vista cognitivo. La sua preoccupazione nasce da un dato di fatto: noi non siamo nati per leggere. Questo significa che il nostro cervello non possiede delle aree geneticamente predisposte allo sviluppo della capacità di lettura – infatti, normalmente il bambino approccia da sé la lingua parlata per imitazione di chi gli sta intorno, mentre per iniziare a leggere e scrivere deve andare a scuola – e quindi se le deve creare in un secondo momento: la plasticità che caratterizza le connessioni neuronali, infatti, consente la riorganizzazione della struttura cerebrale, in modo che si possano acquisire competenze di tipo culturale – che esulano, cioè, da una programmazione su base genetica – come, appunto, l’alfabetizzazione, al cui sviluppo contribuiscono tutta una serie di fattori interni ed esterni, compreso lo strumento utilizzato per apprenderle e accrescerle.

(continua a pagina 4)
Periodico distribuito gratuitamente - Anno X - n. 21 - Dicembre 2022
Pagg. 1, 4 Fame di libri
Pag. 2 Sommario
Pag. 3 Editoriale
Pag. 5 Auguri di Natale
Pag. 6 Il nuovo monumento in ricordo dell’alluvione del 8 novembre 1951
Pag. 18 Il “mangiar contadino” negli anni ‘50
Ricette
Pag. 20 Trattoria “La Pesa”
Pag. 21 Equazione di Dirac
Pag. 22 La fermata del “Gnocchetto”
Pag. 23 Ciao Fabio
Pag. 24 Don Paolo Busato nuovo Parroco della Comunità Pastorale di Tavernerio, Solzago e Ponzate


Pag. 8 Il cibo è cultura… anche al cinema
Pag. 10 Castagna, coltura e cultura millenaria
Pag. 11 Considerazioni sconsiderate sul cibo
Pag. 11 La cultura del cibo
Pag. 12 Fondazione Rosa dei Venti onlus: i nostri primi 25 anni di accoglienza, cura e attenzione verso l’altro…
Pag. 13 Sala da pranzo di Villa Fogazzaro-Roy
Pag. 14 Per crescere un bambino ci vuole un villaggio


Pag. 25 La Nuova Chiesa, 25 anni fa…

Pag. 26 Quando si dice cibo…
Pag. 27 Villa Santa Maria e il valore del cibo
Pag. 28 Un nuovo inizio
Pag. 29 Notizie in breve dalla scuola Pag. 30 Vivenda
Pag. 32 Chi è Slow Food e Slow Food Como
La Comunità del cibo di Slow food Como
Pag. 33 Dalla colazione alla cena all’insegna dell’inclusione
Pag. 36 Cibo & Cinema
Pag. 38 Il Pane
“Se vuoi conoscere un paese, visita i suoi mercati, mangia nelle sue case e, soprattutto, prova il suo pane”
“Il pane è l’alimento nel quale si concentra la cultura gastronomica di un luogo”
Pag. 40 I desideri: manna della vita Pag. 41 Delizioso borscht ucraino
Pag. 41 Cibo genuino e anche no…
Pag. 42 Dendrofobia
Pag. 44 Numeri utili Il Paese
Notiziario di Tavernerio Anno X – Numero 21 Dicembre 2022
Direttore responsabile: Sabrina Mantegazza Segretaria di redazione: Angelica Maesani
Comitato di Redazione: Paola Ganzetti Ugo Angelo Magri
Collaboratori esterni: Chiara Mascetti Silvia Romanò Sabrina Manicardi
Sul sito internet del Comune è disponibile la versione in digitale. www.comune.tavernerio.co.it Chiuso in redazione il 22/11/2022
Sede: Comune di Tavernerio Registrato al Tribunale di Como con n.6/2012
Pag. 15 Ritrovarsi per orientarsi: l’associazione “Séstante”
Pag. 16 Il Mantello di San Martino
Pag. 17 ProMeteo
Pag. 34 “Se accanto alla biblioteca avrai l’orto, non ti mancherà nulla”
Pag. 34 Il mio piatto del cuore
Pag. 35 Calorie... della Magia del Natale
Stampa: GRAFFIETTI STAMPATI S.n.c. S.S. Umbro Casentinese Km 4,500 - S.S. 71 01027 Montefiascone (Viterbo) - Italy
Distribuito gratuitamente in n. 3.200 copie. In caso di mancato recapito segnalare al seguente indirizzo di posta elettronica: redazione.ilpaese@comune.tavernerio.co.it
Carissimi, ci ritroviamo su queste pagine per il nostro appuntamento invernale. Il tema scelto per questo numero è “Cibo”, parola evocativa di profumi, sapori, ricordi d’infanzia, convivialità, ricette passate di generazione in generazione, tradizioni, famiglia, casa. C’è chi lo prepara per passione e magari della passione ne ha fatto un mestiere, chi lo gusta, chi ne protegge l’origine e la genuinità, chi ha pensato di renderlo protagonista di eventi televisivi e di competizioni. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: il cibo che diventa fonte di ossessione e disagio, oppure il cibo che manca o non basta per tutti a causa della povertà, della guerra, delle malattie, degli eventi climatici. Se a Natale ben mangiamo, cerchiamo di non eccedere in inutile abbondanza che poi si tramuta in spreco, doniamo invece a chi nulla si può permettere. “Mann ist was Mann isst”, “l’uomo è ciò che mangia” ricordava Feuerbach. Questo dato non riguarda solo il cibo materiale, ma anche, e forse soprattutto, il nutrimento spirituale. Come scrive Enzo Bianchi del monastero di Bose: “Non è necessario ricorrere al biblico ‘Non di solo pane vive l’uomo’ per rendersi conto che ci nutriamo non solo degli alimenti che introduciamo nel nostro corpo, ma anche delle ‘parole’, dei pensieri, della cultura che assimiliamo tramite le letture, le relazioni personali, le interpretazioni degli eventi della nostra vita quotidiana”. E a questo elenco aggiungerei “che assimiliamo anche attraverso teatro, cinema, musica, musei, mostre, conferenze...”
Le informazioni che ci arrivano sono tante e dalle fonti più disparate, internet e social compresi. Cerchiamo di giudicarle con discernimento, affinando il nostro senso critico e basandolo su solidi principi e valori.
Un grande augurio di Serene Feste a tutti da parte mia, da parte del comitato di redazione e da parte dei nostri collaboratori.
È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.
Il Direttore Sabrina MantegazzaNoi non ci facciamo caso e pensiamo che il processo cerebrale che permette di leggere e comprendere un messaggio, un e-book o un romanzo cartaceo sia lo stesso, in realtà è stato dimostrato che il modo in cui il cervello si attiva durante la lettura su schermo è profondamente diverso rispetto a quando si legge un libro stampato: la pagina virtuale, infatti, predispone a un’esperienza caratterizzata da «skimming (lettura superficiale), skipping (salto di parti di testo) e browsing (scorrimento veloce)», oltreché da una percezione difettiva e confusa delle informazioni dovuta «all’intrinseca mancanza […] della dimensione spaziale concreta del libro, che ci dice dove si trovano le cose», influendo notevolmente sulla «capacità di mettere in sequenza le informazioni» e sulla «memoria per i dettagli». Il problema è che «più leggiamo su schermi digitali, più i nostri circuiti cerebrali rifletteranno le caratteristiche di quei particolari mezzi» e più difficilmente il nostro pensiero riuscirà a distaccarsi dalla virtualità e dalla frammentaria superficialità che da essa deriva. In questo senso, ciò che spaventa la Wolf è il destino delle nuove generazioni, per le quali questa problematica non è declinata nei termini di una “perdita” –come per gli adulti – ma di una vera e propria “mancanza”: in virtù del fatto che «ciascun mezzo di comunicazione avvantaggia determinati processi cognitivi a scapito di altri», il rischio è che i nuovi lettori, iniziati fin da piccoli al mondo digitale, non siano in grado di formare adeguatamente quei «processi cognitivi che […] sono alimentati dai media stampati […], quali il pensiero critico, la riflessione personale, l’immaginazione e l’empatia».

La società contemporanea, con la sua mitraglia di stimoli, ci sottopone quotidianamente, tramite i dispositivi elettronici, a un quantitativo esorbitante di informazioni frammentate e istantanee – notifiche, messaggi, banner pubblicitari, link consigliati – riducendo la qualità della nostra attenzione, della memoria e della nostra capacità di interiorizzare contenuti nuovi, costringendoci in una condizione di distrazione cronica che si perpetua anche quando non siamo online: «stiamo creando dei bambini con deficit dell’attenzione indotti dall’ambiente», dei giovani eccessivamente dipendenti da «fonti esterne di conoscenza» –troppe e troppo frammentate per essere interiorizzate e rielaborate – delle generazioni di menti evanescenti e volubili nelle quali nulla fa più presa, dei lettori che non sono più in grado di cogliere la profondità delle pagine della grande letteratura, perché scritte in un linguaggio cognitivamente inadatto. Questo non significa voler condannare a priori lo sviluppo delle tecnologie digitali, in nome di un certo sentimentalismo nostalgico che pretende di resuscitare i morti, ma tentare di proporre un punto di vista differente, che si smarchi da una concezione unidirezionale del progresso, inteso come perpetuo
«Fra pochi anni i ragazzini di terza media potrebbero essere classificati […] come analfabeti funzionali. Sapranno leggere, ma non saranno in grado di farlo in maniera competente, né di pensare e provare sufficienti emozioni a proposito di ciò che leggono».
Maryanne Wolf, “Lettore, vieni a casa”
e violento superamento del passato, facendo emergere i rischi di una visione così radicale. È indubbio, infatti, che gli stimoli prodotti dalla lettura digitale consentano lo sviluppo di altri processi cognitivi, come per esempio la gestione di multiple fonti d’informazione e la programmazione, cha a sua volta rafforza le «abilità deduttive, induttive e analogiche». Dall’altra parte, però, non bisogna dimenticare che c’è un lato imprescindibile della crescita dell’individuo che può essere nutrito solo ed esclusivamente attraverso la «lettura profonda» di un libro cartaceo, l’unica che, educando alla lentezza, alla consistenza materiale, alla riflessione, alla rielaborazione, alla creatività e all’attenzione verso i dettagli e le piccole cose, può permettere lo sviluppo di quella pazienza cognitiva necessaria per un vivere denso e consapevole. Secondo Maryanne Wolf, la “terza via” che permette di salvare capra e cavoli sta nel favorire nel lettore neofita la maturazione di un cervello bialfabetizzato: esattamente come una persona bilingue sa padroneggiare perfettamente due diversi idiomi, adattando liberamente il proprio pensiero all’uno e all’altro, a seconda delle circostanze, così le nuove generazioni dell’era digitale dovrebbero imparare
«fin dall’inizio che ciascun mezzo […] ha le proprie regole e caratteristiche utili, con le proprie finalità», che giustificano la preferenza nell’utilizzarne uno, piuttosto che un altro in un determinato momento. In fondo, è una questione di “alimentazione cerebrale”: il cervello si plasma e si raffina in base alla qualità e alla quantità di nutrimento che riceve, e, quanto più la sua “dieta” – in termini cognitivi – è varia ed equilibrata, tanto più questo potrà rispondere in modo adeguato e puntuale agli stimoli della nostra società, coniugando l’agilità fresca e rapida della digitalizzazione, alla verticalità di senso propria della lettura profonda.
Lo scritto di Maryanne Wolf interpella in prima persona ciascun lettore e chiede di prendere posizione riguardo a una questione che tocca tutti noi, più o meno direttamente. Siamo interessati a conoscere i vostri pensieri ed esperienze in proposito.
Chi lo desidera può scrivere a redazione.ilpaese@comune. tavernerio.co.it
Le osservazioni che ci perverranno saranno pubblicate sul prossimo numero de “Il Paese” (uscita prevista giugno 2023).
Cari Concittadini, si avvicinano le festività natalizie, saluteremo l’anno che sta per chiudersi e accoglieremo il nuovo. Questo periodo rappresenta un momento di riflessione, di bilanci, di speranze ed aspettative verso un futuro più sereno. Gli ultimi anni hanno messo a dura prova le nostre certezze. In campo sanitario, ma anche rispetto ad un equilibrio politico che pensavamo ormai consolidato nel nostro continente. Davanti ai nostri occhi scorrono le immagini di una guerra non lontana dai nostri confini. Situazioni impensabili fino a qualche anno fa che hanno ricadute sociali ed economiche molto significative sui nostri territori.
La nostra comunità sta dimostrando di essere unita, partecipe alla vita del paese e capace di affrontare le difficoltà. Questo mi fa sentire orgoglioso di esserne parte.
Un sincero grazie in particolare a chi ogni giorno si impegna per il prossimo e per il bene della comunità, a chi costruisce ponti per avvicinare le persone e farle sentire meno sole.
Che possa essere per tutti un Sereno Natale ed un Sereno Anno Nuovo.
 Il Sindaco Mirko Paulon
Il Sindaco Mirko Paulon
Il giorno 8 novembre 1951 una terribile frana fece straripare il torrente Cosia e sedici persone persero la vita mentre tre rimasero ferite. I corpi di due bambini non furono mai ritrovati. Gli altri furono trovati nel letto del torrente, altri addirittura nel lago di Como.
Il 15 maggio del 1952 la Commissione di Assistenza agli alluvionati, formata dal Sindaco Domenico Meroni e dai rappresentanti comunali, affidò allo scultore Pietro Clerici la costruzione del monumento alla memoria dei caduti in quel tragico evento. Un bronzo raffigurante il Cristo risorto fu posto al centro dei sedici tumuli eretti sulle tombe nel Cimitero di TavernerioSolzago come simbolo di memoria collettiva.

A 70 anni da quel tragico evento, i sedici tumuli realizzati in marmo verde erano ormai degradati e anche il bronzo raffigurante il Cristo risorto necessitava di manutenzione straordinaria. Ciò rendeva poco decorosa tutta l’area dedicata al ricordo dei caduti.
Nel 2021, in occasione del 70° anniversario dell’alluvione, l’amministrazione comunale decise di creare un nuovo monumento in memoria delle vittime che potesse anche conservarne le spoglie. Nello stesso tempo si sarebbe anche riqualificata l’area del cimitero di Tavernerio-Solzago in modo da destinare un degno spazio al ricordo di un evento che è rimasto indelebile nell’animo della nostra Comunità. L’idea concettuale del monumento è stata donata dall’artista Fabio Rossini che aveva realizzato anche un bozzetto disegnato e un modello in piccola scala. A fine 2021 sono iniziati i lavori per il nuovo monumento a partire dalle
opere di esumazione delle spoglie delle vittime e dalla dismissione dei vecchi tumuli. Alla realizzazione del monumento hanno partecipato aziende e artigiani locali con il coordinamento dell’ufficio tecnico del comune, del consigliere Umberto Cattaneo e di Roberto Anghileri. Nell’ottobre 2022 il monumento è stato completato.
Il monumento presenta una serie di sedici canne verticali, tante quante furono le vittime dell’alluvione, che salgono dal piano del pavimento, a imitazione di un organo. L’organo nell’immaginario
collettivo risveglia l’idea di melodie serene, di musica, di pace e di preghiera. Davanti al monumento viene posto in posizione verticale, leggermente obliquo, uno dei vecchi coperchi tombali. La sua collocazione quasi verticale allude all’idea che la tomba sia stata scoperchiata dall’organo che sta emergendo dalla terra e stia salendo verso il cielo. Così le vecchie tombe vengono simbolicamente riutilizzate e reimpiegate nel rivestimento del nuovo monumento, per proseguire fisicamente in ricordo dei vecchi monumenti, per dire che il dolore ha lasciato posto alla resurrezione.
Il colore delle canne è blu come il cielo ma diventa sempre più chiaro a mano a mano che si raggiunge la cima, fino a diventare bianco, come più chiari sono i germogli delle piante sulla loro punta.
Il monumento eretto a seguito della tragedia è stato riparato e lucidato e riposto nella posizione originale.
Il 29 ottobre 2022, in presenza di alcuni parenti delle vittime, di Don Paolo, di una rappresentanza degli Alpini di Albese con Cassano e Tavernerio, del gruppo di Protezione Civile e di molti cittadini, si è proceduto alla tumulazione delle spoglie. Per Pierantonio e Giulio Meroni, i due fratellini i cui corpi non furono mai ritrovati, sono state inserite due rose bianche nelle celle dell’ossario a loro destinate.
Nell’ossario riposano anche Meroni Francesco, marito di Lucia Sertori e papà di Pierantonio e Giulio, e sua figlia Maria Graziella Meroni, che, per loro desiderio, si sono congiunti ai loro cari.
L’8 novembre si è svolta la presentazione del nuovo monumento alla cittadinanza. Don Paolo e Don Alfonso, parroco di Lipomo e Rovascio, hanno benedetto il nuovo monumento. Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco di Albese con Cassano, Carlo Ballabio, l’assessore di Albavilla Angela Bartesaghi, il gruppo Alpini e la protezione civile di Albese con Cassano e Tavernerio, la protezione civile di Albavilla, il comandante della stazione dei carabinieri di Albate Mario Iappelli, il comandante del comando di Polizia di Albavilla, Albese con Cassano e Tavernerio, Pasquale Caputo e l’artista Fabio Rossini. Inoltre, ha partecipato una rappresentanza di alunni e docenti dell’I.C. Don Milani
8 novembre 1951
Data di tristissimi ricordi. Una frana staccatasi dalla Cascina Poè (dovuta a molti fattori di incuria e certamente alle infiltrazioni di acqua dovuta alle piogge torrenziali che duravano da un mese) ha formato, nel letto del Cosia sottostante una diga instabile che, imbrigliando per alcuni istanti le acque del torrente, in quel momento abbondantissime, causò un vero lago di 50 metri d’altezza. La forza dell’acqua sfondando improvvisamente la barriera si precipitò violenta ed inesorabile sulle case costeggianti il letto del Cosia distruggendo uomini e cose. Tutto ciò avveniva senza che alcuno potesse accorgersi nel tempo brevissimo di qualche minuto. Erano le 18.18
(da uno scritto di Don Benzoni)
e del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi che hanno letto un testo commemorativo.
A seguire, la direttrice della scuola comunale di teatro Erika Renai ha letto dei testi dell’epoca che descrivono il tragico evento e il conseguente cambiamento del paese.
La cerimonia si è chiusa con l’inno nazionale cantato da tutti i presenti.


Il nuovo monumento in ricordo delle 16 vittime dell’alluvione del 8 novembre 1951 è stato un progetto complesso.

È un’opera d’arte e quindi è stato necessario rispettare
l’idea dell’artista ma anche i vincoli strutturali e funzionali di un monumento funebre che accoglie le spoglie dei defunti. È forte anche il senso di responsabilità per un’opera che deve ricordare una tragedia ancora vivissima nell’animo della nostra comunità. Crediamo di aver raggiunto il risultato sperato.
Colgo l’occasione per ringraziare chi ha collaborato alla realizzazione del monumento per aver risolto tutti i piccoli e grandi problemi occorsi nella fase di realizzazione.
Potrete trovare alcune testimonianze fotografiche dell’epoca collegandovi al sito del Comune di Tavernerio tramite il seguente link: hiip://www.comune.tavernerio. co.it/c013222/zf/index.php/galleriafotografica/index/album/album/1

Il legame tra italiani e mondo del cibo è forte, un rapporto che matura nella vita quotidiana, nel succedersi delle stagioni, ma che ha un’influenza importante e inevitabile
Il cibo è convivialità, storia, cultura. identità del viaggiatore.
anche nelle diverse espressioni della cultura: arte, letteratura, teatro e, come vorrei raccontare in questo spazio, cinema. Il cibo è convivialità, storia, cultura. È una parte
fondamentale della nostra vita, ne accompagna e scandisce i diversi momenti. È inevitabile, quindi, che acquisisca un posto di rilievo anche nei film del grande schermo.
Alimentazione e cinema ricoprono entrambi un ruolo importante nella vita dell’uomo: il cibo è un bisogno fisiologico, mentre il cinema fin dalla sua nascita soddisfa la necessità di sfuggire per un attimo dalla realtà sognando ad occhi aperti.
Il cibo, non a caso, diventa subito protagonista dello schermo a partire dalle prime pellicole fino ai giorni nostri ricoprendo le più svariate simbologie: storiche, sociali, culturali, erotiche, nevrotiche e spirituali. Tutto ebbe inizio nel 1895, in uno dei primi lavori dei fratelli Lumière intitolato Le
répas de bébé, dove venne ripresa una delle scene di vita familiare più intime: un bambino imboccato dai genitori. D’altra parte, nel cinema, come nel cibo, proiettiamo i nostri desideri e le nostre paure; cinema e cibo sono pietre miliari della comunicazione sociale e dello sviluppo relazionale.
Così, il cinema ha raccontato la fame, la convivialità, ha messo a fuoco la storica arte di arrangiarsi del popolo italiano e la nostra cultura, nella quale la cucina esprime più che altrove il luogo degli affetti, del gusto, dei desideri, dell’opulenza e della povertà, degli anni difficili e di quelli facili. La cucina intesa come tecnica e piacere del far da mangiare
è al centro del racconto, mentre la cucina intesa come spazio dentro l’abitazione ne è un set fondamentale. Sia esso un ristorante o un semplice fornello di casa.
Ma la cucina è anche lo spazio nel quale mettere in risalto, talvolta in ridicolo, l’evoluzione culturale di un Paese. In tal senso, sono indimenticabili le scene con protagonisti Ugo Tognazzi e Vittorio De Sica ne I nuovi mostri, pellicola diretta da Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola.
Un altro vero classico è Il pranzo di Babette, film danese del 1987 che vinse l’Oscar come miglior film straniero. Qui il mondo del cibo si collega a quello religioso protestante. Da non perdere anche Julie & Julia, film che valse a Meryl Streep una nomination all’Oscar e un Golden Globe e che celebra la figura della cuoca

e scrittrice americana Julia Child, la quale ha insegnato alle casalinghe americane a cucinare.

Per chi invece volesse intrattenere i propri figli con un film d’animazione le scelte non mancano! C’è Ratatouille targato Disney Pixar, un omaggio al mondo della cucina e al valore profondo che il


cibo ha nella nostra vita, attraverso le avventure del topo Remy, aspirante chef. E ci sono le opere del maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki, in primis La città incantata, ma anche Il castello errante di Howl e Il mio vicino Totoro Dulcis in fundo, La fabbrica di cioccolato, sia nella versione originale di Mel Stuart del 1971, sia nell’ultima di Tim
Burton del 2005. In entrambi i casi si tratta di capolavori capaci di far sognare, dentro quella fabbrica di cioccolato, grandi e piccini.
Come possiamo vedere, ancora prima che il cibo diventasse una piccola ossessione televisiva, dai talent show ai documentari, dai cooking show alla cucina in diretta nei programmi
dell’ora di pranzo, il cinema aveva già considerato la rappresentazione degli alimenti come qualcosa di molto attraente e ricco di significato. Le scelte possibili sono tante, e questi sono solo alcuni esempi.
Non mi resta che augurarVi buona visione, ma soprattutto buon appetito.
Durante la seduta del Consiglio comunale del 27/09/2022
è stato approvato il nuovo regolamento per la definizione dei criteri per l’attribuzione del premio di studio.
La novità riguarda sostanzialmente l’introduzione del premio anche per gli studenti che ottengono ottimi risultati all’esame di maturità e di laurea, aumentando quindi
il contributo economico che l’Amministrazione mette a disposizione, che è più che raddoppiato rispetto al passato.
“Come Amministrazione comunale abbiamo voluto ampliare la platea dei ragazzi che potranno avere accesso a questo premio, allargando il riconoscimento ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado e ai laureati.
Si tratta di una decisione che ci è sembrato giusto assumere in questo momento, perché pensiamo che possa
essere uno stimolo per i nostri giovani ad impegnarsi ancora di più negli studi
e sentirsi maggiormente parte integrante della nostra comunità, per la quale loro rappresentano una grande risorsa.
Sono particolarmente soddisfatta anche della possibilità di offrire come premio un ingresso o abbonamento al cinema in alternativa ai buoni libro, perché va nella direzione di sostenere le sale del territorio e un settore che è stato tra i più duramente colpiti dagli effetti negativi della pandemia”.

allargando il riconoscimento ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado e ai laureati.
Come ogni anno con l’arrivo dell’autunno molti di noi riscoprono la passione per un’attività antica, ma sempre appagante e spesso legata ai ricordi dell’infanzia, la raccolta delle castagne. Ed ecco che i boschi alle spalle del paese, ma anche quelli che dal Montorfano degradano fino alla brughiera, si popolano di allegre comitive famigliari. Un rito allegro e festoso che ci permetterà di gustare questi doni dell’autunno nei modi più ghiotti quali fumanti caldarroste, golose marmellate e deliziosi dolci. Ai più però sfugge il fatto che questo tipo di attività è strettamente dipendente dalla capacità dell’uomo di prendersi cura dei propri boschi. Possiamo dire che l’arte della coltivazione del castagno affonda le sue radici nella storia, sebbene i paleo botanici non siano concordi sull’originale distribuzione di questa pianta nel continente euroasiatico, tutti concordano sul fatto che i romani fecero della coltura del castagno uno dei principali segni della propria espansione territoriale. Il castagno, infatti, ha sempre garantito ottimo legname in grado di resistere per lunghissimo tempo all’immersione e alle intemperie, grazie all’alta concentrazione di tannini. Offre ottimi frutti in grado di conservarsi per moltissimo tempo dopo l’essicazione e in grado di produrre una farina particolarmente nutriente, e genera una grande quantità di fogliame, ottimo come lettiera per gli animali domestici. Inoltre, per la sua spiccata tendenza a formare polloni dopo il taglio dei tronchi principali, il castagno è utilissimo per la produzione della paleria di campo degli eserciti e per la produzione di legna da ardere. Se vi capiterà di verificarlo, vi accorgerete che gran parte dei tetti degli
edifici più antichi dei nostri territori (chiese, ville, conventi) sono fatti con travi di castagno. Possiamo quindi affermare che quella della castagna non solo è una coltura millenaria, ma è un’attività forestale che ha portato con sé una rivoluzione tecnologica e d’uso del territorio che possiamo tranquillamente definire cultura e che accomuna l’intero bacino mediterraneo.
Ma, tornando a noi, il patrimonio boschivo del nostro Comune è molto ampio, circa 940 ettari del territorio comunale (l’80,9 %) sono infatti costituiti da boschi e tra questi quelli prevalenti sono certamente i boschi cedui (il 90% dei boschi) la cui specie principale è rappresentata proprio dal castagno. La ceduazione è l’antica pratica silvicola di taglio di alberi singoli con la costituzione di ceppaie in grado di produrre in brevi cicli grandi quantità di polloni.
Eppure fino agli anni ’50 dello scorso secolo, se vogliamo definire una data storica, fino all’alluvione del 1951, la principale attività produttiva del nostro Comune era proprio quella agricola famigliare con la presenza di numerosi insediamenti rurali inseriti proprio nel contesto dei boschi: le cascine pedemontane (Poè, Meriggetto, Costantina, Burdiga, Nisiate, Fontana sotto, Gilasca), la cascina S. Bartolomeo, le frazioni di Casina, Ponzate, Urago e Rovascio, l‘enorme complesso rurale della Cà Franca.
foglie, frutti, pali e polloni per la creazione di ceste e strumenti di lavoro, indispensabili per l’antica cultura contadina dei nostri nonni.
Proprio nell’ottica di una riqualificazione complessiva del paesaggio boschivo ed una valorizzazione di un bene legato alla produzione di biomassa, utile a far fronte alle esigenze energetiche di questi ultimi anni, l’Amministrazione, attraverso la Redazione del nuovo Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Triangolo Lariano, vuole arrivare a produrre uno strumento il più possibile utile e conforme alle esigenze specifiche del proprio territorio comunale. Il PIF è uno strumento programmatorio che consente l’analisi e fornisce gli indirizzi per la gestione del territorio forestale ed in generale per la pianificazione territoriale.
Più rari sono gli esempi di selve castanili, ancora conservate, dedicate alla sola produzione di castagne e al pascolo del bestiame, qualche esempio in valle di Ponzate e attorno alle cascine di Solzago. Non sono però rari i casi di grandi castagni secolari, ormai circondati totalmente da bosco, ma un tempo inseriti in un contesto di prato pascolo costantemente brucato e/o sfalciato.

Nella nostra realtà comunale, la quasi totalità dei boschi è di proprietà privata ed è altamente parcellizzata con presenza di numerosissimi piccoli appezzamenti, a volte difficilmente identificabili. Purtroppo, ad eccezione di pochi illuminati contesti, l’abbandono ed il degrado sono la costante. A questa condizione, certamente legata alle modifiche socioeconomiche del territorio, si accompagna la scomparsa dei sentieri e delle strade forestali un tempo mantenute per poter raggiungere ed attingere le risorse forestali rappresentate da legna da ardere e da opera,
Il PIF è a tutti gli effetti un piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento e, come tale, abbraccia tutto il territorio, indipendentemente dalla proprietà, rientrando nel novero di “piani forestali sovraaziendale”, distinguendosi dal piano di assestamento, che ha invece come oggetto la singola proprietà o, raramente, più proprietà gestite in maniera collettiva. Più in generale possiamo dire che iI PIF permette di tutelare i boschi anche dove non sono presenti aree protette.
Nei prossimi mesi vorremmo approfondire attraverso incontri e serate a tema il valore del patrimonio boschivo del nostro comune nella certezza di poter mantenere viva la cultura legata ai boschi di castagno e con lei il valore ambientale e sociale del nostro splendido territorio.
“Alla sera al rientro in baracca accucciate nei letti a castello, si incominciava a parlare di minestre e pietanze, di tante minestre da sentirne il profumo e di tante pietanze da sentirne il sapore e parlando si scrivevano ricette sui ritagli bianchi dei giornali”…
Così scrivevano le sorelle Maria Camilla e Maria Alessandra Pallavicino nel 1944-45 durante la loro prigionia nel campo di concentramento di Ravensbruck, sottocampo di Rechlin, 90 km a nord di Berlino, dal quale furono poi liberate dall’armata rossa. Provavano a dimenticare la fame che le lacerava, parlando di “meravigliose pietanze” e discutendone l’esecuzione fino a “litigare per le divergenze di come avrebbero dovuto essere preparate”.
Non so perché, ma questo episodio, che è solo uno dei tanti raccontati da prigionieri scampati alla shoah, richiama le innumerevoli odierne trasmissioni televisive di cucina, alcune diventate storiche occasioni per costruirvi intorno uno spettacolo. Che legame ci può essere tra queste due esperienze così diverse, la prima tragica, la seconda amabile intrattenimento?
Dietro i discorsi dei prigionieri è facile pensare che ci fosse il tentativo di dimenticare la fame, ma è probabile che
inconsciamente vi fosse anche il desiderio di allontanare lo spettro della tragedia che incombeva sulle loro teste.
E dietro le trasmissioni culinarie della televisione? Non credo ci sia il tentativo di dimenticare la fame. Ma si può pensare che dietro vi sia l’inconscio desiderio collettivo di allontanare un disagio che ci coinvolge tutti in quanto cittadini dell’occidente?
Tutti avvertiamo che la nostra civiltà ha lasciato cadere i valori sui quali si basava la vita dei nostri nonni e in parte anche dei nostri padri. Ora le nostre divinità sono la scienza e la tecnica e, nonostante il grande benessere che esse ci hanno portato, avvertiamo confusamente di aver smarrito la strada. Alcuni dicono che l’occidente stia realizzando il significato del suo nome: tramontare. Ecco, la collettività sente inconsciamente questo disagio e si consola col BMW (chi può) o con le crociere o con altre attività più simpatiche e meno costose, come la cucina... Ma forse sono solo considerazioni sconsiderate suggerite dal tema del cibo.
Molto spesso ci scordiamo dell’importanza che ricopre il cibo nelle nostre vite. Mangiare non significa solamente riempirsi lo stomaco, ma indica un modo di vivere, dove mi trovo, chi sono. Chi non ha mai sentito l’espressione: “dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”. Sembra di facile interpretazione tale aforisma, ma le interpretazioni che questa può assumere sono svariate; a me, ad esempio, piace intenderla in chiave culturale.
Ogni popolo ha dei piatti che lo caratterizzano, che lo contraddistinguono dagli altri, prelibatezze che sono motivo di orgoglio perché parte integrante della loro identità. Tutti noi cresciamo con i frutti che la nostra terra nativa ci offre e questo ci connette indissolubilmente con il luogo in cui cresciamo e viviamo. Un rapporto di amore tra uomo e natura. Ma non ci limitiamo, anzi è doveroso non limitarsi ai piatti della propria tradizione, è bene scoprire, assaporare e degustare le leccornie che possono offrirci i nostri vicini.
la pancia ha memoria, una gran buona, memoria.
La scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova stella.
Anthelme Brillat-Savarin diceva: “la scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova stella”. La stella ci guida, ma è il piatto che ci illumina. Conoscere un piatto di una data zona ci permette di creare un legame con quel luogo, con quelle persone e sentire un po’ più nostro anche quel posto perché
Ma se da un lato le squisitezze che adornano le nostre tavole sono diverse a seconda del posto in cui ci troviamo, la convivialità è uguale per tutti e in qualsiasi regione. Il modo migliore per dimostrare ad una persona l’importanza che gli diamo, il bene che gli vogliamo, è invitarlo alla nostra tavola e facciamo il possibile per offrirgli il meglio che abbiamo e che sappiamo fare; è così per tutti, in qualsiasi angolo del pianeta. Non importa in quale paese del mondo ci troviamo, la pancia parla la stessa lingua. Mi ritrovo molto nelle belle parole espresse dal nostro chef Antonino Cannavacciuolo quando dice: “a tavola ci si incontra, si chiacchiera, ci si rilassa, si ride… talvolta ci si punzecchia, ma il buon cibo fa da paciere. È capace di restituire il buonumore persino al termine di una giornata faticosa”. Questo per dire che la tavola è il posto in cui ci si riunisce con gli altri, amici e parenti, in cui si creano nuovi legami, dove ci si ritrova con persone che non si vedono più da tempo… dove germoglia l’amore. Per concludere, il cibo è vita.
Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei.
Il 2023 sarà per Fondazione
Rosa dei Venti onlus un anno importante perché si celebreranno i primi 25 anni di attività nel campo della ricerca e soprattutto nel campo della cura delle fragilità psichiche nei giovani adolescenti minori. Correva l’anno 1997 quando infatti il dottor Luca Mingarelli e la dottoressa Monica Luisa Cavicchioli posero le basi per la costituzione di un’associazione prima, e di una fondazione poi, che diventò operativa proprio nel 1998, considerati da sempre punto di partenza della grande avventura.
Un’avventura, ma anche una grande sfida che ha visto nascere e crescere la prima comunità terapeutica del privato sociale a livello nazionale, dapprima con sede a Erba e successivamente a Casnate con Bernate. Dal 2014 la Fondazione ha rilevato la ex fabbrica di imbottigliamento dell’acqua Plinia del Tisone, situata in un meraviglioso bosco a Solzago, piccola frazione di Tavernerio (CO), e dal 2017 ha fissato in questo luogo la sua sede operativa, ingrandendosi, ampliando e diversificando la proposta dei servizi a tutto il territorio nazionale. Oggi la Fondazione è costituita da due Comunità Terapeutiche con i rispettivi Centri Diurni a Casnate con Bernate e a Tavernerio, due strutture di Residenzialità Leggera in entrambe le sedi, l’Ambulatorio Plinio con focus sulla salute mentale aperto al pubblico e una fitta rete di servizi territoriali e rivolti alle scuole.
Il 2017, anno di trasferimento nella nuova sede, è stato anche l’inizio di un nuovo capitolo sul fronte delle attività
complementari a quelle specificamente di cura poiché è stato costituito l’ufficio Comunicazione Progetti Eventi e Fundraising che ha permesso alla Fondazione di crescere ulteriormente e diventare punto di riferimento sul territorio per attività creative e ricreative aperte al pubblico a tema natura, arte e benessere fisico e interiore. Tutte le attività della Fondazione sono naturalmente a supporto delle attività di cura legate ai minori, quindi alle comunità, ai centri diurni e a tutti i servizi da essa gestiti.
L’ampliamento dei servizi della Fondazione è nato soprattutto dall’esigenza di far fronte alle nuove, e sempre crescenti richieste del territorio, determinate dall’aumento delle fragilità psichiche e delle criticità determinate da diversi fattori come la recente pandemia, ma anche di uso e abuso della tecnologia e il conseguente ritiro sociale.
Il 2023 sarà dunque un anno di festa con diversi appuntamenti, almeno 6 tra gennaio e dicembre, legati al progetto formativoeducativo e terapeutico della Trattoria Sociale sviluppato in collaborazione con ristoranti e chef del territorio e volto a insegnare un mestiere ai ragazzi ospiti delle comunità e dei servizi della Fondazione, ma anche pensato per creare un ponte verso l’esterno sul tema delle relazioni e delle attività della nostra organizzazione. Valeria Margherita Mosca, esperta di foraging, Davide Caranchini del ristorante Materia di Cernobbio, Mauro Elli del ristorante Il Cantuccio di Albavilla e Marco Rossi del ristorante Al Rustico di

Lambrugo, per fare solo alcuni esempi, guideranno i nostri giovani ospiti nella creazione di pietanze a chilometro zero. Il cibo sarà al centro della rassegna inteso come elemento da ideare, creare e condividere. Le Trattorie Sociali sono aperte al pubblico e rappresentano la base delle attività di raccolta fondi della Fondazione.
Nel calendario degli eventi aperti a tutta la popolazione saranno due i momenti importanti: a maggio la IV Festa dei Rododendri, pensata per valorizzare il parco di Villa Plinia e la sua esplosiva e colorata fioritura primaverile e a settembre la ormai tradizionale Festa dell’Acqua Sorgiva, arrivata alla sua VII edizione e considerata appuntamento fisso per chi ama trascorrere una giornata all’insegna del benessere fisico e interiore in armonia con la natura.
Trattandosi di un anno di celebrazioni, nel mese di marzo presso la Fondazione si terrà un convegno scientifico sulla salute mentale con ospiti e personalità di rilievo provenienti da tutto il territorio nazionale e, a data ancora da definire, una minirassegna cinematografica (4 appuntamenti) di sensibilizzazione sul disagio psichico in età adolescenziale rivolta per lo più alle scuole, ma aperta alla popolazione tutta.
Nel corso di tutto il 2023 sono previste delle azioni di valorizzazione del percorso artistico presente nel parco di Villa Plinia, prima tra tutte quella volta a far rientrare l’opera Specchio D’Acqua di Enrico Cazzaniga, omaggio al simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, nei
circuiti turistici del triangolo lariano. Un’opera dall’alto valore metaforico in stretta connessione con i principi sui quali si basa l’operato della nostra Fondazione (come ad esempio cura, trasformazione del sé…) e che riteniamo importante condividere con il territorio. L’opera oggi è visitabile negli orari di apertura del parco.
Proprio grazie alle relazioni attive sul territorio è stato inoltre possibile avviare il progetto Geek in – Geek out, di cui la cooperativa sociale “Questa Generazione” è il capofila. In virtuosa collaborazione con il Comune di Tavernerio, Fondazione Rosa dei Venti per tutto il 2023 e sino al mese di settembre offrirà al territorio uno sportello di supporto psicologico gratuito ai giovani della fascia di età 15-34 anni che si trovano alle prese con tutti i problemi postpandemici e, grazie al bellissimo parco di Villa Plinia, offrirà al territorio laboratori artistici e percorsi in natura guidati da esperti del mestiere.
Fondazione Rosa dei Venti onlus sarà lieta di condividere i suoi spazi e le sue iniziative in sinergia con tutte le istituzioni del territorio, nonché con associazione e aziende che ne condividono mission e valori.
Per maggiori informazioni: www.rosadeiventi.org comunicazione@rosadeiventi.org

Una tavola imbandita, perfetta, quando l’eleganza chiama la condivisione, quando la vista arriva prima del gusto.
Non tutte le tavole sono così sontuose, ma anche su quelle più modeste il cibo è elemento di incontro, di aggregazione sociale e condivisione allegra.
L’Associazione, essendo ricreativa e culturale, pone sempre molta attenzione nel mettere in comunicazione le persone anche attraverso il cibo, creando così un ponte ideale tra noi e gli altri.
La storia del cibo è la storia dell’umanità, il cibo non è soltanto sostentamento, è un gesto d’amore, è anche poesia e serve a nutrire l’anima.
L’11 dicembre presso l’Auditorium di Tavernerio ritorna la Tombola Natalizia, aperta a TUTTI, organizzata dall’Associazione. Tutti i premi in palio sono prodotti alimentari, come anche quelli destinati ai vincitori delle gare di Burraco. Ecco, una gioiosa condivisione del cibo.



E dopo aver apprezzato tutte queste bontà, rimettiamoci in forma con i nostri numerosi corsi di attività motoria.
L’Associazione augura un sereno Natale ed un prosperoso anno nuovo.
— Il direttivo di Magolibero —
Siamo i ragazzi del MAGOLIBERO, siamo tre mamme e un papà che, come tutti i genitori, vorrebbero vedere i propri piccoli riempirsi di bellezza e gioire delle piccole cose che rendono le persone grandi, sensibili e attente al mondo.
È quasi passato un anno da quando abbiamo ereditato questa Associazione genitori, direttamente dai fondatori, i quali possiamo dire, ci hanno fatto un grande regalo, poiché mese dopo mese, l’abbiamo sentita sempre più nostra!
Così l’abbiamo ridipinta a nostro piacimento, partendo dal nome che ci è piaciuto così tanto, rispecchiando il nostro bisogno di Magia e Libertà.
Abbiamo pensato alle esperienze che avrebbero reso felici i nostri figli e insieme a loro tutti i bimbi del paese, col desiderio profondo di creare una “comunità di bambini “ purtroppo spaesati da oltre due anni di COVID e per questo ancora più incuriositi (soprattutto i più piccoli) nel fare aggregazione, nel creare legami di appartenenza al paese e ai suoi contesti.
In una società sempre più disgregante e individualista, vorremmo tornare a vedere i bambini che si ritrovano come una volta nei cortili.
Dopo una grande Festa di Presentazione a tutti, realizzata nel mese di maggio, con un gran sole, tantissimi bimbi e uno spettacolo teatrale; siamo partiti con le Domeniche artistiche!

Quasi tutti i progetti saranno finanziati grazie al Bando di Regione Lombardia rivolto ai minori!
Siamo partiti col cercare uno spazio, dove incontrarsi, nel quale identificarsi e stare bene: il nostro Centro civico Livatino! Ci trovavamo inizialmente il lunedì dopo scuola, per una merenda e due chiacchiere, poi abbiamo pensato a una proposta domenicale una volta al mese, ogni volta nuova e che sviluppi immaginazione, socialità e spensieratezza, quelle caratteristiche di cui gli adulti possono nutrirsi dai bambini.
I nostri eventi sono pensati per bambini della materna e delle elementari accompagnati dai loro genitori.
*proverbio africano citato da Papa Francesco nel maggio 2020.
Sino ad ora, nel mese di ottobre, abbiamo sperimentato la “ Spin-art” attraverso un laboratorio di CIRCOLARTE con due fantastiche professioniste, oltre alla nostra spaventosa festa di Halloween dove abbiamo coinvolto tutta la famiglia. A novembre invece la narrazione della splendida Carla Giovannone, che ha raccontato le sue bellissime storie. A dicembre sperimentiamo “i millefogli di Celine” per immergerci nella magia natalizia attraverso tecniche artistiche manuali.



Dal mese di Ottobre, è anche partito il nostro corso di Teatro improvvisato e Danza creativa, in collaborazione con l’Associazione “È arte, formazione, cura”, tutti i lunedì pomeriggio; un’occasione per scoprire che la danza è per tutti, nasciamo danza, per liberare gesti innati che appartengono a ciascuno in base alle proprie caratteristiche, senza parole o gesti a memoria, tipici del teatro classico, si crea il proprio movimento unico al mondo, che insieme alle mille diversità degli
Stiamo collaborando magnificamente con le altre Associazioni del paese, come con la Cooperativa Nuova Umanità, la Proloco, gli Amici di Seba, Nati per Leggere, perché insieme è più bello e più semplice!
Vogliamo in particolare modo ringraziare tutte le famiglie che hanno partecipato e che parteciperanno ai nostri eventi, credendo che per crescere... servano gli altri, non si diventa grandi da soli, è necessario farlo insieme!
Chiunque volesse darci una mano, proporci delle idee o avesse solo bisogno di Magia e di Libertà, lo aspettiamo a braccia aperte e può contattarci all’indirizzo info@magolibero.it
Vorremmo tornare a vedere i bambini che si ritrovano come una volta nei cortili.
La vita è come il mare: a volte serena e tranquilla, a volte agitata e tempestosa, tanto da diventare pericolosa come quando arriva quell’onda anomala che non ti aspetti, che ti travolge, che ti fa sentire disorientato e che se ti trascina sott’acqua richiede tanta energia e forza per riemergere e tornare a respirare, così da rimettersi a navigare.
L’associazione di promozione sociale “Séstante”, che prende il nome appunto dal congegno nautico, si è da poco costituita per dare sostegno alle persone affette da Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) e alle loro famiglie, per aiutarle a ritrovare la rotta. Ma cosa sono i DNA?
I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), o Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), sono psicopatologie caratterizzate da alterazione delle abitudini alimentari ed eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo, e tra queste si possono citare l’Anoressia Nervosa, la Bulimia Nervosa e il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (in inglese Binge Eating Disorder). Queste psicopatologie comportano delle gravi conseguenze a
livello individuale, con uno sconvolgimento reale della propria vita: un ritiro sociale e scolastico, un’ossessione sul conteggio delle calorie e sul proprio aspetto fisico, una diminuzione delle relazioni sociali, un peso molto al di sotto della norma, che può portare fino alla situazione più infausta, ovvero la morte.
Questi disturbi colpiscono prevalentemente il sesso femminile, nonostante negli ultimi anni siano in aumento anche nei maschi. Queste patologie insorgono maggiormente negli anni dell’adolescenza. L’età di esordio è, perlopiù, tra i 10 e i 30 anni con due picchi intorno a 14 e 18 anni. La fascia d’età di prevalenza del Binge Eating Disorders (BED) si estende invece fino ai 65 anni.
È importante mettere l’accento sul periodo dell’adolescenza in quanto, proprio in questa fascia d’età, la compresenza con altri aspetti psicopatologici è elevata, in particolare con i disturbi della personalità, le condotte autolesionistiche, il rischio suicidario, i disturbi ossessivocompulsivi, i disturbi depressivi e i disturbi d’ansia, condotte devianti e uso di sostanze e in alcuni casi le psicosi.
Negli ultimi anni si è purtroppo registrato un progressivo abbassamento dell’età di esordio, con manifestazioni già in bambini/e delle scuole elementari e medie. Questo si rivela molto preoccupante in quanto le risorse cognitive, emotive e psicologiche a disposizione sono diverse da quelle di un/a ragazzo/a con età maggiore.
Il disturbo alimentare è solo ciò che più prepotentemente appare, ma, nel profondo, c’è una grande difficoltà a riconoscere la propria identità
di fronte ad un mondo esterno sempre più esigente, complesso, ed un mondo interno fatto di emozioni che non si riescono a gestire e a canalizzare. Ecco che allora agire e controllare, in modo disfunzionale e distorto, il proprio regime alimentare attraverso le privazioni o gli eccessi, diviene illusoriamente l’unico modo “di avere un potere” di fronte agli eventi interni ed esterni della propria esistenza. Giusy racconta: “La mia paura è sempre stata quella di riuscire ad esprimere veramente me stessa e le mie emozioni. Mi sembrava che nessuno ascoltasse la mia voce, nessuno mi vedesse. Allora ho trovato il modo di attirare l’attenzione degli altri su di me: il peso sempre più basso”.
Nella recentissima attualità, la prevalenza dei DNA ha subito un importante aumento come espressione della crisi associata alla pandemia del COVID-19. Tra il febbraio 2020 e lo stesso mese del 2021 l’ADI (Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica) ha segnalato un incremento medio del 30% dei casi di disturbi alimentari.
Le persone affette da DNA presentano un quadro clinico complesso, caratterizzato sia da problematiche psichiatriche che somatiche, che rende necessari interventi di tipo multidisciplinare, specifici, precoci e fra loro integrati, per ridurre il rischio di ricadute frequenti e di cronicità.
Quando in famiglia ci si accorge di avere una persona affetta da DNA, si scatena il dramma: un’onda di sensi di colpa, di vergogna, di inadeguatezza, di impotenza, tutti ne sono travolti. Un vero e proprio tsunami. È un fenomeno difficile da comprendere e la famiglia si sente sola, abbandonata e non sa che direzione prendere, quando, invece, potrebbe essere
essa stessa una vera e propria risorsa per aiutare i figli nel loro percorso riabilitativo. Ecco, quindi, l’importanza di avere un’associazione che faccia da punto di riferimento per aiutare le famiglie a fronteggiare la situazione e a confrontare le proprie esperienze con quelle di altre famiglie che hanno avuto o hanno la stessa problematica. L’associazione “Séstante” ha come obiettivi: divulgare e informare sui DNA, formare i propri volontari per consentire interventi di supporto appropriati e adeguati, e in ultimo, ma non per importanza, supportare progetti e percorsi terapeutici e riabilitativi, anche in collaborazione con altre associazioni e/o le strutture del Servizio Pubblico. L’associazione è formata da chi è direttamente interessato, da familiari di pazienti che soffrono di un DNA, da psicologi e psicoterapeuti, da operatori ed ex-operatori con esperienza nell’ambito del servizio sanitario e da quanti aderiscono in qualità di volontari all’ideazione e realizzazione delle attività dell’associazione.
È attivo uno sportello informativo e orientativo gratuito a cui si accede tramite contatto telefonico (3387414546) o tramite mail sestante@ sestanteaps.it e dal quale è possibile avere sostegno, supporto e informazioni sull’associazione stessa e sui vari servizi, dislocati sul territorio, attinenti ai DNA.
Si ringraziano per la collaborazione: il presidente di “Séstante” - Vito Gasparro - La vice-presidente di “Séstante” - Giusy Zanetti

del mese di novembre, prende spunto proprio dalla leggenda che racconta come, improvvisamente, dopo questo gesto, il cielo si schiarì e la temperatura si fece più mite e piacevole. Si narra, infine, che, durante la notte, Gesù, rivestito della metà del mantello di Martino e con le sembianze del povero assistito, apparve in sogno al giovane soldato invitandolo alla conversione.
Il “Mantello di San Martino” continua ad essere una bellissima realtà del nostro territorio.
Il Progetto è nato nel 2018 grazie alla collaborazione tra l’amministrazione Comunale, le Parrocchie di Tavernerio, Solzago e Ponzate e il Banco di Solidarietà di Como.
Le braccia di questo servizio, ormai conosciuto e ben avviato, appartengono a oltre venti persone che, settimana dopo settimana, mese dopo mese, continuano con generosità ed impegno a offrire il loro tempo. L’idea di creare un servizio in risposta ai bisogni dei cittadini in difficoltà nacque sulla scrivania della giunta guidata da Rossella Radice e la sua denominazione richiama, non a caso, il gesto del vescovo Martino di Tours, a cui la chiesa parrocchiale di Tavernerio è dedicata.
Secondo la tradizione, Martino, allora giovane soldato pagano arruolato nell’esercito romano, fu sorpreso da un violento temporale mentre viaggiava a cavallo attraverso la Gallia; cercando riparo notò sul ciglio della strada un mendicante che, semi nudo e completamente fradicio, pativa il freddo. Non avendo altro da offrire, Martino tagliò in due il suo mantello e ne offrì una parte in dono al pover’uomo.
Il fenomeno conosciuto come estate di S. Martino, ovvero il ritorno a condizioni climatiche più miti nel periodo centrale
Il gesto di generosità di Martino viene letto, quindi, come la spinta profonda e radicale al cambiamento e un grande invito ad occuparsi sempre dei più bisognosi.
Questa vicenda, al di là dei contenuti magari un poco romanzati per chi non è credente, di fatto però comprende due elementi che “vestono” perfettamente il senso del Progetto: il concetto del dono, dell’offerta incondizionata e gratuita e il senso del calore e dell’accoglienza che traspare dal gesto.
In quest’ottica, l’attività che i volontari svolgono di fatto parte proprio dal “dono” che i cittadini fanno durante le collette. Nel corso del 2022 sono state organizzate due collette, nei giorni 5/6 marzo e 15/16 ottobre, e sono state inoltre incrementate attività in rete con la Cri, sezione di Lipomo, e con lo staff dell’ufficio Servizi Sociali del Comune, entrambi partners fondamentali nel continuo rifornimento di generi in carenza.
Il lavoro di gestione del magazzino e l’organizzazione delle consegne è un processo articolato e in continua evoluzione: da gennaio a dicembre sono state effettuate oltre 270 consegne di pacchi in favore di oltre 30 famiglie, ciascuno confezionato tenendo conto delle esigenze di ogni nucleo, delle priorità e, quando possibile, anche dei gusti. Complessivamente, nel corso
dell’anno sono stati distribuiti oltre 900 kg di pasta, 350 kg di riso, 250 kg di farina, 160kg di tonno, 300lt di olio, 380 kg di legumi, 300kg di biscotti, 250 di zucchero, oltre 400 kg di cioccolato, marmellate e miele. In occasione delle festività del S. Natale, dell’Epifania e di Pasqua le consegne vengono “arricchite” da prodotti tipici sia per gli adulti che per i bambini, come panettoni, pandori, uova di cioccolata o dolcetti vari, mentre, nel mese di settembre, viene consegnata anche una buona fornitura di materiale scolastico ad alto consumo: quaderni, penne, gomme, pennarelli, album da disegno.
Entrare mensilmente nelle case delle famiglie, incontrarsi e confrontarsi in modo cordiale e mai invasivo ha consentito negli anni la costruzione di rapporti di fiducia tra le famiglie e i volontari.
Oltre alle famiglie già seguite, dal mese di marzo il bisogno si è significativamente ampliato con l’arrivo di 5 nuclei di nazionalità ucraina che, in seguito alla situazione drammatica generata dalla guerra, hanno trovato ospitalità ed accoglienza nel nostro Comune.
Nella prima colletta la risposta da parte della cittadinanza è stata davvero straordinaria: ci sono voluti giorni per sistemare in
magazzino quanto raccolto e per diversi mesi abbiamo avuto gli scaffali pieni!
Entrare mensilmente nelle case delle famiglie, incontrarsi e confrontarsi in modo cordiale e mai invasivo ha consentito negli anni la costruzione di rapporti di fiducia tra le famiglie e i volontari.
Spesso la condivisone di bisogni o di necessità immediate, anche diverse da quelle alimentari, ha generato processi relazionali significativi con soluzioni concrete ed efficaci: la ricerca di una lavatrice funzionante, un letto singolo per il bambino ormai cresciuto, una bicicletta per andare a fare la spesa più velocemente, la ricerca di un lavoro... tutte situazioni a cui i volontari, con la semplice condivisone e il coinvolgimento di altre realtà vicine, sono riusciti a trovare risposta. Il mantello è l’immagine della cura e della generosità verso chi soffre. San Martino, che con il suo mantello avvolge le persone, ha un forte valore simbolico: il nostro Mantello vuole continuare ad essere l’immagine della cura e dell’accoglienza incondizionata.
Grazie a:
• alla Parrocchia di Tavernerio che mette a disposizione uno spazio adeguato a immagazzinare tutti i prodotti e per il confezionamento dei pacchi, oltre ad ospitare gli incontri periodici e le riunioni organizzative dei volontari;
• a Don Paolo per aver garantito la continuità nel comodato d’uso dei locali e per la disponibilità al continuo via vai dei volontari;
• al Comitato CRI, sezione di Lipomo in particolare ad Anna Martinelli e a Livilla Drago;

• all’assessora Elisa Frigerio, all’Assistente sociale e alla preziosa Nadia per il supporto e il sostegno operativo;
• alle ditte Vivenda, Fumagalli e Cantaluppi per i generosi contributi;
• a tutta la popolazione per la costante presenza e per il continuo supporto, ad ogni singolo cittadino il più sentito GRAZIE!
stato questo il titolo della serata organizzata giovedì 27 ottobre presso l’auditorium comunale di Tavernerio, da AIB Tavernerio, Gruppo volontari antincendio di Tavernerio odv, Gruppo di Protezione Civile, in collaborazione con NaturalMeteo, gruppo di appassionati di meteorologia; la serata è stata moderata da Andrea Citeroni, volontario AIB Tavernerio,
Una serata che ha avuto il patrocinio dei comuni di Tavernerio e di Albese con Cassano, nonché il supporto della Commissione Cultura di Tavernerio e l’aiuto pratico ed organizzativo, della Consulta Giovani di Tavernerio.
L’idea dell’evento nasce in seno al gruppo volontari AIB Tavernerio e trova subito l’approvazione del Presidente Marco Longhi che si mette a disposizione nell’agevolare i volontari incaricati della realizzazione.
Comunicare in modo semplice e facilmente comprensibile, tutte le problematiche che si innescano a seguito degli innegabili cambiamenti climatici in atto.

Di fondamentale importanza l’immediata disponibilità di Stefano Casartelli DOS
(direttore operazioni di spegnimento) della Comunità Montana Triangolo Lariano, di Fabio Fioramonti e Simone Mura, divulgatori e membri di NaturalMeteo e del Dott. Giacomo Tettamanti, naturalista e funzionario del comune di Tavernerio.
Gli obbiettivi che ci siamo posti nel pensare e organizzare l’evento sono stati il desiderio di condividere, comunicando in modo semplice e facilmente comprensibile, tutte le problematiche che si innescano a seguito degli innegabili cambiamenti climatici in atto.
Siamo partiti da lontano,
raccontando brevemente la storia della meteorologia e della Protezione Civile italiana, per ascoltare poi Fabio e Simone che ci hanno condotto nell’affascinante mondo dello studio del clima, da come nascono le previsioni meteorologiche a quali sono le cause di eventi meteorologici sempre più anomali, quali violenti nubifragi alternati a lunghi periodi di siccità.
Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo con l’analisi, magistralmente e dettagliatamente spiegataci dal Dott. Giacomo Tettamanti, dell’alluvione che nella sera del 8 novembre del 1951
ha interessato il centro di Tavernerio.
La frana ha prima ostruito il corso del torrente Cosia, poi il cedimento della barriera formatasi, ha prodotto un’ondata di piena che ha strappato la vita di 16 persone e arrecato ingenti danni all’abitato del centro paese.
Stefano Casartelli ci ha intrattenuto, dapprima spiegandoci come interpretare le allerte meteo di Protezione Civile, differenti in funzione del loro colore che ne stabilisce l’importanza, per poi raccontarci l’evoluzione del grave incendio sviluppatosi nell’ottobre del 2017 nei boschi sopra Tavernerio. Questo evento ha coinvolto diversi Gruppi AIB della Comunità Montana Triangolo Lariano nelle operazioni di spegnimento e successivamente di bonifica, operazioni nelle quali il nostro Gruppo si è distinto in tutte le fasi, forte della grande conoscenza del territorio e delle indubbie specifiche competenze.
L’importanza della previsione (non solo meteorologica) e prevenzione è stata fortemente rimarcata in tutti gli interventi fatti; il lavoro che con programmazione e costanza svolgiamo come Gruppo volontari di Protezione Civile è quanto di meglio si possa fare per tutelare e scongiurare che eventi atmosferici sempre più anomali, ma con una drammatica frequenza, si trasformino in eventi tragici per le persone e dannosi per il territorio.
Numeroso il pubblico che ha partecipato e apprezzato la serata, conclusasi alle 23.00 con un lungo applauso e con le congratulazioni rivolte ai relatori per le loro competenze e la loro disponibilità.
Negli anni ‘50, per le famiglie contadine, buona parte di quanto prodotto era destinato all’autoconsumo.
Quanto restava era venduto o al mercato, o a qualche negozio, o a qualche abitante del paese che lavorava nelle fabbriche cittadine.
Attraverso i ricordi di Ermanno, facciamo un viaggio nel passato per capire quali erano i prodotti che si avevano a disposizione per cucinare e per mangiare nella Ponzate di allora …Nella stalla dimoravano le mucche. Il latte era munto due volte al giorno, mattino e sera, mantenendo fissi gli orari. Si procedeva alla mungitura di 5 o 6 litri di latte da ogni mucca. Alla fine, il latte veniva colato per trattenere le impurità finite nel secchio ed era poi in parte venduto ed in parte conservato per il consumo familiare; quest’ultimo era scremato più volte per fare il burro con la zangola (la penàgia) a mano. L’attrezzo era tutto in legno, di forma cilindrica, con uno stantuffo scorrevole e con un lungo manico, che veniva continuamente alzato ed abbassato fino a che il grasso del latte si compattava sul fondo formando il burro (bütéer).
Altro prodotto del latte era un formaggio acidulo ottenuto dalla fermentazione del caglio in teli appesi al fresco della cantina
(zincarlin). Quotidianamente venivano accuditi anche i maiali, i conigli (cunìli), i porcellini d’India (tuìsc), i polli e raccolte le uova. Tutti questi animali erano preziosi, in quanto rappresentavano, per la famiglia, riserve di cibo e denaro! Dopo una semplice colazione a base di latte e polentina (la pult) o di latte e pane (la paniscia) o di minestra avanzata dalla sera precedente, per gli uomini cominciava la giornata nei campi, mentre le donne si occupavano, secondo le usanze, dei lavori “meno faticosi” come allora si diceva, anche se in realtà non era
Grande protagonista della tavola era il pane. Diversamente dai paesi vicini (Solzago, Camnago, Civiglio, Tavernerio), Ponzate non ha mai avuto panettieri. Il paese aveva, in un edificio pubblico contiguo al lavatoio, un forno a legna. In questo forno

avveniva la cottura del pane casereccio fatto con farina di granoturco e di frumento (ul pan de meji; pane fatto anticamente con farina di miglio, poi con una miscela di farina di granoturco ¾ e di frumento 1/4). Erano pani rotondi di circa un chilo di
proprio così: erano le faccende domestiche, la preparazione dei pasti, la cura dell’orto e l’accudimento di bambini, malati e anziani.
Il tempo era marcato dai rintocchi dell’orologio del campanile, giorno e notte, ogni ora, oltre che dai rintocchi delle campane il mattino, mezzodì e sera. Le campane segnavano la vita del paese e comunicavano eventi a tutta la popolazione. Suonavano con suoni e ritmi caratteristici a seconda dei vari avvenimenti.
A mezzogiorno un frugale pasto a base di pane casereccio
peso e dal diametro di circa 25 cm.
Una o più volte la settimana, le famiglie che dovevano panificare si organizzavano: portavano la legna, pulivano e preparavano il forno, accendevano il fuoco e curavano il giusto riscaldamento per la cottura dei pani già preparati a casa e lasciati lievitare nelle apposite madie (la marna del pan). Nelle varie cotture
cotto nel forno comunale o di polenta (la pulenta) con qualche intingolo (la pucia) insieme a patate, fagioli o insalata o altre verdure dell’orto secondo la stagione, il tutto accompagnato da un po’ di vino nostrano (ul noostranell). Poi si ritornava alle proprie occupazioni fino a sera. Il piatto principale della cena era la minestra di riso o di pasta, arricchita sempre con le verdure di stagione che forniva l’orto e condita con il lardo ricavato dalla macellazione del maiale. Completavano il pasto il pane casereccio (fatto con farina di granoturco e farina di grano coltivati nei campi e macinate nel mulino di Camnago), qualche fetta di polenta del mezzodì abbrustolita sulla brace o pancetta o cotechino di maiale o frittata con uova dal pollaio e verdure sempre dell’orto, il tutto veramente a chilometro zero! Qualche volta si consumava minestra a base di latte oppure “pancotto”, per utilizzare il pane raffermo.
E poi fuori dalla porta c’erano gli amici di casa… gatti e cane che aspettavano la loro porzione di avanzi, le crocchette non esistevano! Non si buttava nulla! I piatti che avevano come ingrediente principale la carne, erano un lusso per la domenica e per le grandi occasioni di festa. La cottura di tutti i cibi avveniva sul fuoco del camino o sulla stufa economica a legna.
(l’infornada del pan) non mancava mai un pane speciale (ul büscell) preparato con l’aggiunta di uvetta o noci o infiorescenza di sambuco, secondo le stagioni. Appena pronte, le pagnotte (20/25), erano spostate dal forno al pavimento con una paletta dal lungo manico. A quel punto, il profumo caratteristico del pane appena sfornato si diffondeva tutt’intorno nell’aria…
Antenata della polenta. Può essere preparata anche con sfarinata di cereali minori mischiati insieme.

Farina di mais con aggiunta di farina bianca. Può essere consumata come la polenta con latte o con pucie varie.

INGREDIENTI:
Farina di mais 300 gr Farina di frumento 100 gr Latte 800 ml Acqua 2000 ml Sale q.b. Latte per condire
PROCEDIMENTO:
Mischiare le farine in una scodella. Mettere in una casseruola sul fuoco l’acqua con il latte e, all’ebollizione, salarla e versare la farina, mescolare con forchetta di legno.
Lasciare bollire fino a una certa consistenza (tre quarti d’ora).
Versare nelle scodelle e aggiungere latte freddo (se gradito aggiungere nel piatto del burro o fettine di formaggio fresco).
Con gli avanzi del pane giallo casereccio di farina di mais cotto nel forno comunale…
INGREDIENTI:
Pane giallo raffermo 500 gr Latte intero 500 ml Uova 3 Mela 1 Pera 1 Noci 40 gr Fichi secchi 50 gr Farina bianca 1 cucchiaio Zucchero 50 gr Grappa un bicchierino

PROCEDIMENTO:
Tagliare il pane a fettine e ammollarlo con latte per circa 2 ore. Lavorare il pane ammollato con un cucchiaio.
Aggiungere uova, noci tritate, fichi secchi spezzettati, la mela e la pera tagliate a fettine, lo zucchero e la grappa.
Lavorare l’impasto con un cucchiaio e metterlo in una tortiera imburrata e infarinata.
Spolverare l’impasto con zucchero e mettere qualche fiocchetto di burro. Cuocere in forno a 200 gradi per 25 minuti.
Servire freddo.
(Veniva preparata in particolare per bambini, ammalati e anziani…)
INGREDIENTI:
Riso 200 gr Latte fresco 1200 ml Acqua 500 ml Zucchero un cucchiaio Burro 30 gr Sale Una spolverata di cannella (se piace)
PROCEDIMENTO: Mischiare in una casseruola il latte con l’acqua.
Aggiungere burro, zucchero e poco sale e portare a ebollizione.
Aggiungere il riso e cuocere su fuoco vivace, mescolare spesso, aggiungendo altro liquido (3/4 di latte e ¼ di acqua) se necessario.
Quando il riso è cotto togliere dal fuoco e lasciare riposare qualche minuto. Servire tiepido… con la cannella in polvere (se piace).
Dalle pagine di questo notiziario (num.18 del Dicembre 2020), in un articolo di Romano Meroni, già vi abbiamo parlato del nostro concittadino Elia Molteni, chiamato confidenzialmente “il Lia”, e della sua passione per il legno, l’intaglio e il presepe.
La sua attività lavorativa principale era però legata al cibo, in quanto gestore della trattoria “La Pesa” situata in centro paese. Nel 1963, grazie all’amicizia con la famiglia Frangi allora proprietaria della trattoria, il Lia, insieme alla moglie Lina, riuscì ad averne la gestione. A cucinare aveva imparato dal padre Carlo, che, a sua volta, aveva gestito l’osteria detta “CARLÖO” in centro a Solzago. Curiosa è la circostanza in cui il Lia riuscì ad affinare le sue conoscenze culinarie e il suo metodo di lavoro, dopo l’esperienza con il padre. Nel 1943, durante la Seconda guerra mondiale, Elia era stato ricoverato nell’ospedale militare di Bari in quanto giunto ferito dall’Albania. Una volta guarito riuscì ad entrare come cuoco al circolo degli ufficiali statunitensi che erano di stanza proprio a Bari, dove



conobbe anche la ragazza che poi diventò sua moglie e, alla fine della guerra, tornarono insieme a Tavernerio.
La gestione della “Pesa” era completamente famigliare: Elia in cucina con la figlia Loredana, l’altra figlia Angela indirizzata alla cura della clientela, la figlia Gianna aiuto saltuario perché decise poi di lavorare in altro ambito, la moglie Lina coordinatrice del lavoro di tutti. Durante la settimana il luogo era frequentato soprattutto a pranzo dai lavoratori della zona, mentre nel fine settimana c’erano famiglie intere o grandi tavolate di amici e tutti apprezzavano molto i piatti della cucina tradizionale
lombarda preparati da Elia con l’aiuto della figlia.
La scelta era ampia: dagli antipasti che comprendevano agoni, lavarelli o trote di lago in carpione, funghi sott’olio (i famosi “ciuditt” raccolti in autunno da Elia nei boschi delle montagne di Tavernerio) nervetti e sottaceti fatti in casa, ai famosi risotti (ai funghi oppure con ossibuchi o quaglie) alla trippa, al brasato con polenta, alla “cassoeula” (piatto invernale particolarmente apprezzato fatto con verze e verdure stufate accompagnate da cotenne, costine e salamini di maiale) al pollo o coniglio alla cacciatora, allo stinco di maiale al forno. E naturalmente non potevano mancare i dolci,
tra i quali la “cutizza” (specie di crepe fritta tipica della cucina lariana accompagnata con marmellate o frutta di stagione) e i tortelli che venivano sempre preparati nella settimana della festa di San Giuseppe.
La sala principale della trattoria era dominata da un grande camino che ne era l’emblema e che era raffigurato anche sulle bottiglie di vino del “Barbera della Pesa”. L’attività proseguì florida per molti anni a fronte anche di un grande impegno: non esisteva il giorno di riposo settimanale e nemmeno chiusure per le festività. Tradizionalmente, il giorno dell’Epifania, la famiglia Molteni era solita invitare a pranzo gratuitamente i bambini ospiti dell’Istituto “Villa Santa Maria” con i relativi accompagnatori, per festeggiare tutti insieme. Nel 1994 il Lia morì, lasciando l’attività alla moglie e alle figlie, che proseguirono fino al 2005 circa e poi chiusero definitivamente per sopraggiunti limiti d’età di Lina e per i problemi di salute di Loredana, lasciando, nel ricordo degli avventori, i profumi e i sapori dei piatti de “La Pesa” che avevano potuto gustare per quasi quarant’anni.
Si ringrazia per la collaborazione Luciano Molteni
Tutti apprezzavano molto i piatti della cucina tradizionale lombarda preparati da Elia con l’aiuto della figlia.
Era l’estate del 1982 e faceva un caldo diverso, quello che ricordiamo noi che iniziavamo la scuola il primo ottobre, quello con le lucciole di sera, per capirci.
Il motorino, tanti amici sempre tutti insieme sciamando controvento, rigorosamente senza casco perché quelle poche preoccupazioni volassero via.
Era l’estate dei mondiali in Spagna, quelli con i militari in TV dentro il campo di calcio – e non ci trovavo niente di strano, mi viene il dubbio che l’aria nei capelli funzionasse veramente.
Il rito era un luogo geografico, potevamo avventurarci anche fino a Erba – mai allontanarsi troppo – ma alla fine eravamo sempre tutti lì, al Bar Trattoria “La Pesa”. Pranzo di lavoro a mezzogiorno, non “pausa pranzo”. Cena per gruppi
numerosi con cazzuola e polenta e poi c’eravamo noi, adolescenti poco avvezzi a spendere lire che circolavano con parsimonia.
La data esatta è domenica 11 luglio 1982, la finale dei mondiali.

La data esatta è domenica 11 luglio 1982, la finale dei mondiali. Vai a sapere che sarebbe finita come è finita, sarei stato più attento, avrei mandato a memoria gli attimi e i dettagli, magari preso appunti. Non l’ho fatto e ancora oggi non capisco come, in quella giornata di riposo – la trattoria stava chiusa la domenica – le serrande fossero alzate e noi tutti invitati e fastidiosamente
presenti. Niente maxischermi, la mania sarebbe arrivata anni dopo, niente incassi aggiuntivi, solo la semplice voglia di condividere e il legittimo sospetto che anni dopo, tanti anni dopo, avrebbe contato ricordare dove eravamo.
Quando le distanze si dilatano tutto il bello diventa più bello, il tempo genera una sorta di effetto lifting e il ricordo vale ora, al presente; non ha nulla di nostalgico e non ha valore retroattivo.
Quando le distanze si dilatano tutto il bello diventa più bello, il tempo genera una sorta di effetto lifting e il ricordo vale ora, al presente; non ha nulla di nostalgico e non ha valore retroattivo. Io sono felice ora di aver condiviso gioie con tante persone, sono felice ora di averlo vissuto e di averlo vissuto in quel luogo.
Esistono luoghi che fanno la storia di una comunità, esistono momenti che uniscono e non sono necessariamente legati a situazioni che lasciano traccia indelebile. La coppa del mondo del 1982 è onestamente un avvenimento epocale, ma io ho il dolce ricordo liftato anche dei cento giorni prima e dei cento giorni dopo. Credo conti volerci essere, voler essere parte di un insieme e poi, come dimostra Dirac, che stupido non era, con la sua equazione, lo saremo per sempre.
La tranvia Como-ErbaLecco, inaugurata nel 1912, era una linea tranviaria interurbana a trazione elettrica, che inizialmente collegava Como a Erba, prolungata fino a Lecco nel 1928. Dal bivio di San Martino a Como, il binario impegnava la strada comunale detta “della Rienza” fino a superare Camnago Volta, lungo la viabilità poi denominata strada provinciale 37; con un tratto in sede propria erano dunque serviti gli abitati di Solzago e Tavernerio. La linea era a binario singolo e il tram in andata si incrociava con quello in ritorno proprio in via 1° Maggio nelle vicinanze della locanda con alloggio “Gnocchetto”.


Il nome derivava da “Gnuchett”, soprannome col quale era conosciuto l’allora proprietario Brunati, in quanto gestore anche di una gastronomia in via Rienza che abitualmente preparava gli gnocchi al giovedì.
Il
nome
aiutare il marito Alfredo che si occupava degli avventori e dell’organizzazione del locale, mise il grembiule da cuoca e cominciò a lavorare in cucina. Nelle camere alloggiavano spesso i convalescenti, ormai guariti, che erano stati al sanatorio – la “Villa dei Pini”, situata in frazione Urago, ora sede dei Missionari Saveriani.
La struttura era stata, tra il 1930 e il 1945 circa, un centro di cure per malattie respiratorie (vedasi articolo di Rita Pellegrini su notiziario “Il Paese” num.17 Giugno 2020) – tra di loro c’era Leda, una cuoca di origini toscoemiliane che, anche per passare il tempo, insegnò a Elide i segreti della pasta fatta a mano: tortellini, cannelloni, tagliatelle, lasagne.

Introdurre questi piatti nel menù fu un vero successo.
sua acqua era molto rinomata per le sue qualità e la sua purezza) indusse la famiglia Sozzi a dare un nuovo nome al “Gnocchetto”: ristorante “Terme”. Le terme non furono mai costruite, ma l’attività del ristorante continuò ugualmente, grazie al grande impegno della famiglia Sozzi e alla fortunata posizione vicina allo scambio dei tram: si poteva mangiare a pranzo e cena, ma era presente anche un bar dove si vendevano i biglietti del tram e i giornali. Gli avventori si fermavano per un bicchiere di vino, un caffè o per chiacchierare, o per fare una partita a biliardo.
manutenzione degli impianti tranviari sempre più elevati, portarono la società di gestione dei trasporti a sostituire gradualmente le tranvie con nuove linee automobilistiche, considerate più confortevoli e di più economica gestione: il 5 settembre 1955 il collegamento tranviario tra Como ed Erba venne definitivamente dismesso. Un bel guaio per il ristorante che non era più in una posizione di passaggio privilegiata… Togliendo l’uso delle camere, l’attività seppe però reinventarsi. Si fecero delle grandi sale per banchetti: matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, pranzi aziendali divennero l’attività principale del ristorante per circa trent’anni.
Il posto fu acquistato dalle famiglie Sozzi-Guarisco nel 1926 e, ancor oggi, gli eredi di questa famiglia ne sono proprietari e gestori. Elide era sarta, ma ben presto, per

La mattina, alle cinque, una squadra di donne del paese arrivava per aiutare nella preparazione di centinaia di tortellini, serviti a tavola per pranzo e/o cena.
La vicinanza alla “Fonte Plinia del Tisone” (a quei tempi la
Arrivò la Seconda guerra mondiale. Il ristorante resistette: molti sfollati, fuggiti dalle grandi città bombardate come Milano, trovarono sistemazioni provvisorie in quel di Tavernerio o presso le camere annesse al ristorante e volentieri, quando potevano, mangiavano lì.
Una decina d’anni più tardi, dopo la fine della guerra, l’obsolescenza e i costi di
Poi la moda cambiò e la gente cominciò a preferire, per gli avvenimenti, location più d’effetto, con scenari panoramici e ampi giardini in ville d’epoca, due elementi che il ristorante “Terme –Gnocchetto” non aveva. Ma anche questa volta il ristorante seppe di nuovo “cambiare rotta”. Rinnovò le sale creando un ambiente funzionale, spazioso e moderno. Ai piatti tradizionali della cucina lombarda, quali trippa, cazzuola, brasato con polenta, si affiancarono piatti della cucina piemontese quali agnolotti, bolliti con salsa verde, vitello tonnato, grazie all’arrivo del cuoco Ugo Pataccia.
In fondo alla cartoleria, sul lato sinistro del locale, c’è una scrivania bianca a forma di U rovesciata, un computer e uno schermo luminoso, dove vengono segnalati i numeri del Gioco del Lotto che cambiano tre volte alla settimana. Ci sono anche Gratta&Vinci, accessori per la scuola, una fotocopiatrice e una stampante, carte veline e cartoncini di tutti i colori, sigarette e penne. Come ogni giorno, anche stamattina in cartoleria c’è fermento: chi entra per chiedere una stampa di un documento, chi vuole cambiare la vincita di un Gratta&Vinci con banconote e chi ha bisogno del biglietto dell’autobus. Chi entra e chi
esce, chi si ferma per fare due chiacchiere e chi perde una marea di tempo per scegliere il colore del biglietto di auguri da regalare a suo figlio.
Dietro la scrivania, seduto e con lo sguardo rivolto verso lo schermo del computer, c’è Fabio. Fabio ha appena toccato i quarant’anni, tuttavia, guardandolo dall’entrata della cartoleria, sembra un giovane studente. Ha i capelli corti color castano scuro, gli occhi sono così marroni che sembrano due castagne quando vengono colte nella loro massima maturazione. Indossa una polo bianca e un pullover blu notte, jeans chiari e sneakers.
Ciao Fabio, mi dai due pacchetti di Muratti e un Gratta&Vinci da 5 euro?”
Chiedo io, dopo essermi avvicinata alla scrivania a forma di U rovesciata;
“Ciao! Sì, subito. Hai preferenze sul Gratta&Vinci?” Mi risponde lui sorridendomi;
“No, nessuna preferenza. Scegli tu!”;
“Ottimo. Ecco a te!”
“Grazie Fabio”; “Grazie a te, buona giornata.
Èdavvero gentile Fabio. Ogni volta che ci salutiamo, mi augura sempre di trascorrere una piacevole giornata.” Ripeto tra me e me mentre esco dalla cartoleria e mi dirigo verso la macchina.
Il giorno successivo Fabio, insieme ad un suo amico, si è immerso nelle acque del Moregallo: guardare il mondo da laggiù, infatti, è sempre stata una delle sue maggiori passioni. Quella domenica piovigginava: gli asfalti delle strade erano bagnati; le foglie degli alberi, una volta cadute, si attaccavano ai marciapiedi; il vento, da nord, soffiava forte in tutte le direzioni.
In quella domenica di autunno inoltrato, durante uno dei suoi momenti preferiti, Fabio ci ha lasciato. Ha lasciato la sua famiglia e i suoi amici, la sua Croce Rossa, per la quale dedicava tempo ed energie, e la sua attività da subacqueo, il suo calcio e la sua cartoleria. Le acque profonde del lago sono state le sue ultime immagini: un luogo infinito, pieno di insidie e
profonde incertezze; ma anche un luogo immaginario e onirico dove i limiti spazio-temporali si azzerano. Il Suo luogo, forse il Suo luogo perfetto, l’ha cullato e dolcemente l’ha portato via. E con sé si è portato via la sua discrezione e la sua capacità naturale di ascolto e di accondiscendenza; la sua bontà d’animo e la sua gentilezza nell’accogliere e nel condividere con gli Altri le esperienze di vita; la sua vitalità e attitudine ad aiutare l’Altro porgendo la propria mano, senza mai chiedere niente in cambio.
E io che resto qui, sola e con le sue fotografie tra le mani, mi rimane vivo e inossidabile il ricordo in tutta la sua unicità: la sua voce, le sue calde mani, la sua camminata e le sue gestualità.
Ora, quando entro in cartoleria, Fabio non c’è più. Ma io la sua presenza la sento ugualmente: nei fogli che si piegano, nel rumore del cassetto della cassa che si apre e si chiude, nelle voci e nei dialoghi tra il suo papà Marco e la sua mamma Tiziana, negli spifferi di vento che si sentono quando un passante entra e quando un altro esce.
Ti voglio bene, Fabio. Più di quanto avresti mai potuto immaginare. Francesca
Il giorno 22 Maggio 2022, a nome della Comunità, la giovane Beatrice ha dato il benvenuto a don Paolo, sottolineando in più punti del suo intervento la necessità e il desiderio di avere una guida salda con cui condividere tutti insieme un percorso non facile, ma certamente stimolante e che, come auspicato dalle parole del Sindaco, “continui a non lasciare indietro nessuno”.
Lo stesso Sindaco ha ringraziato don Giorgio per il servizio prestato negli anni di presenza nel territorio di Tavernerio, ricordando la preziosa collaborazione instauratasi con l’Amministrazione, che dovrà trovare spazio anche in futuro.
Prima dell’ingresso in Chiesa, il Vescovo di Como, Mons. Oscar Cantoni, ha simbolicamente consegnato a don Paolo le
chiavi delle tre parrocchie. Esse dovranno servire non per “rinchiudere Cristo e i cristiani dentro angusti confini parrocchiali”, ma essere un mezzo di “apertura al vasto mondo che ci circonda”.
È poi seguito il corteo dei presbiteri verso l’altare. Il Vicario Foraneo, don Alfonso Rossi, ha proclamato il decreto di nomina del Vescovo, sottoscritto per presa visione da due rappresentanti per ognuna delle parrocchie, da don Paolo e infine dal Vescovo.
Mons. Cantoni si è rivolto a don Paolo evidenziando come l’aver scelto lui per questo nuovo incarico non sia stato facile. Sulle ragioni umane, sono prevalse quella della fede, confermando che l’“obbedienza è ancora una virtù”. Cambiare significa anche saper cogliere nuovi stimoli

per affrontare e superare nuove sfide. Ha ribadito la convinzione di aver trovato la persona adatta per guidare questa Comunità Pastorale, in collaborazione con gli altri sacerdoti e con tutti i laici che sapranno offrire la loro disponibilità.

Don Paolo ha confermato l’accettazione dell’incarico attraverso i riti propri della liturgia. Come previsto dal protocollo, il Vescovo ha abbandonato l’assemblea e ha affidato la celebrazione della S. Messa al nuovo parroco.
Nel pronunciare l’omelia, don Paolo ha affermato come l’obbedienza gli sia costata, come solitamente costa quasi a tutti, ma che la gioia di essere qui oggi l’ha aiutato. Forte il richiamo alla condivisione di un cammino da percorrere insieme, ognuno nel proprio ruolo,
verso la certezza di una meta comune.
Fra i presbiteri intervenuti e concelebranti, era presente anche don Aldo Maesani. Originario di Tavernerio, quest’anno ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio. Era sua intenzione condividere la gioia di questa ricorrenza anche con la Comunità che lo ha visto crescere. Purtroppo, non ci è riuscito. Il 4 ottobre scorso, ci ha lasciato, a seguito di un improvviso malore.
Alla cerimonia, hanno partecipato numerosi parrocchiani di Tavernerio, Solzago e Ponzate e un nutrito gruppo di fedeli giunti da Tirano e dalle altre comunità di cui don Paolo è stato pastore.


Al termine del rito religioso, presso l’oratorio, si è tenuto un gioioso momento conviviale.

del tempo e va oltre il tempo: simbolo della resurrezione del Cristo.
“Dove eravamo rimasti?” La domanda è risuonata in Chiesa il 26 ottobre scorso come esordio dell’omelia.
“Ti è stato annunciato, o uomo, ciò che è bene e ciò che Dio cerca da te: nient’altro che praticare la giustizia, amare con tenerezza, camminare umilmente con il tuo Dio.”
Dodici anni dopo aver lasciato la parrocchia di Tavernerio, don Silvio ha ripreso e commentato le parole del profeta Michea, fulcro del suo messaggio di saluto di allora.
Forte richiamo per la comunità parrocchiale di Tavernerio che numerosa ha partecipato alla S. Messa, in occasione della ricorrenza del venticinquennale della consacrazione della Chiesa dell’Eucaristia.
Al termine della celebrazione, don Silvio ha ripercorso i passaggi che portarono alla realizzazione del progetto.
La prima spinta arrivò da Mons. Ferraroni, Vescovo di Como, che, con grande lungimiranza, già negli anni Ottanta del secolo scorso, considerò la costruzione di questa Chiesa come futuro polo di riferimento della Comunità Pastorale di Tavernerio, Solzago e Ponzate, oggi divenuta solida realtà.
Le difficoltà erano molteplici. Don Silvio accolse l’invito del Vescovo e si mise subito al
lavoro, affiancato dai membri della Commissione Parrocchiale Affari Economici.
Furono incaricati di sviluppare l’idea gli architetti Beppe Reynaud e Alberto Ostinelli, due professionisti della nostra Comunità. E vennero coinvolti prevalentemente artigiani ed imprese del paese. Don Silvio ha raccontato qualche aneddoto verificatosi nel corso dei lavori, citando anche il nome di alcuni protagonisti. Non ha mancato di esprimere riconoscenza verso tutti coloro che hanno collaborato.
Ha poi offerto una descrizione di alcuni particolari e significati dell’edificio.
Fu consultato un architetto, sacerdote della Diocesi di Milano, in quegli anni impegnato nel seguire la costruzione di nuove chiese. Egli suggerì la forma tonda, superando la paura che potesse generare pericoli per l’ascolto, e, soprattutto, perché avrebbe valorizzato la rappresentazione dell’accoglienza unitamente alla bellezza del tempio.

Nel frattempo, a Mons. Ferraroni succedette Mons. Maggiolini. La pressione crebbe. Per il Vescovo, era la prima nuova Chiesa e fin da subito la sentì sua. Volle porre al centro dell’abside un altare ‘potente’: un chiaro invito a mettersi a tavola per i fedeli che sarebbero entrati in Chiesa.
Desiderò ‘un ambone imponente’, per evidenziare l’importanza della Parola di Dio e il tabernacolo in posizione centrale per esaltare la presenza del Santissimo, in coerenza con la dedicazione della Chiesa alla Eucaristia, da lui stesso decisa.

Il portico esterno rappresenta il primo approccio all’accoglienza che poi si manifesta meglio nella forma tonda dell’edificio, assecondata dalle trame del pavimento tutte orientate verso l’altare.
I fedeli che entrano nel tempio vengono coinvolti in una esperienza di purificazione. Accolti dall’abbraccio materno della Madonna, percorrono l’esperienza della Via Crucis, transitano davanti al Battistero e siedono di fronte all’altare. Anche il sacerdote, uscendo dalla sacrestia, prima di salire all’altare per la celebrazione, passa davanti al Battistero. “Chi potrà salire al monte del Signore?”, recita il salmo. E la risposta segue: “Chi ha mani innocenti e cuore puro...”
Mons. Maggiolini, quando vide la prima volta i quadri della Via Crucis li giudicò troppo laici. Gli sfuggì un particolare dell’ultimo quadro, la XIV stazione, la deposizione del Cristo morto. Quando si accorse, cambiò idea e fu entusiasta di quanto rappresentato. Gli autori hanno dipinto una mano, la mano di Dio, che rompe la clessidra
Don Silvio ha descritto il ciclo pittorico posto nel tondo dell’aula ecclesiale, opera del pittore Alcide Gallani. Dalla Genesi si giunge all’istituzione dell’Eucaristia, passando attraverso le Tavole della Legge, il ritorno degli ebrei a Gerusalemme, la natività di Gesù e la parabola del buon seminatore: resta da realizzare il quadro del Battesimo di Gesù.
Ha concluso con un accenno agli affreschi, appesi nella Cappella Feriale, che descrivono i tre momenti fondamentali della vita della Madonna, realizzati dal nostro compaesano Giampiero Carcano.
Una bella “Chiesa di mattoni” pronta per essere “Chiesa di persone”.
E con questo auspicio, don Silvio si è congedato e ha ripreso il suo cammino.
Una bella “Chiesa di mattoni” pronta per essere “Chiesa di persone”.
Don Silvio torna a Tavernerio per l’anniversario.
In uno dei miei viaggi, un giorno ho visto una scena che, come uno schiaffo in pieno viso, mi ha sconvolto e mi ha aperto gli occhi. Mi trovavo nella periferia della Città di Guatemala e c’era una frotta di ragazzini che giocavano ai bordi di una grande discarica, ma che, si vedeva, attendevano qualcosa. All’arrivo di un camion dell’immondizia, tutti insieme gli corsero dietro e mentre quello scaricava la sua massa maleodorante, i ragazzini, insieme a uno stormo di uccelli bianchi, si slanciarono su quel carico “prezioso”. In men che non si dica, setacciarono il mucchio di roba, alla ricerca di quello che poteva servire loro. Che cosa cercavano? I rifiuti commestibili della popolazione della Città, dei ristoranti e delle case, i resti di ciò che noi chiamiamo cibo, ma che a quel punto era materia avariata e anche in putrefazione. Era il loro cibo quotidiano per sfamarsi e sfamare anche i loro genitori e fratelli.
Questo cibo è ciò che cercavano affannosamente quei ragazzi di Guatemala nei rifiuti delle case della Città, per portarlo a casa loro, dove i genitori li attendevano per metter insieme un pasto per la famiglia. Quella scena mi mise a disagio, soprattutto perché sapevo che qui da noi ogni giorno si gettano tonnellate di avanzi che sarebbero ancora commestibili, mentre nel mondo ci sono milioni di uomini, donne e bambini che soffrono la fame. Non potevo e non posso far finta di niente. Meno male che in tanti luoghi oggi si raccoglie ciò che avanza e lo si ricicla per i poveri (il banco alimentare).
produzione in tutti i modi possibili per metterla a disposizione di tutti i viventi: nessuno, infatti, ha il diritto di accaparrarsi ciò che non è necessario per vivere, non ha senso accumulare se non per condividere, perché tutti siamo fratelli, figli dello stesso Padre creatore.
ci sentiremmo soli, isolati, e perderemmo la voglia di vivere.
“Cibo”, secondo il dizionario Treccani, significa “genericamente, tutto ciò che si mangia. In senso più ristretto, cibo può indicare anche semplicemente l’insieme degli alimenti che si assumono durante un pasto”.
Quando ero bambino e mi cadeva per terra un pezzo di pane, il babbo me lo faceva raccogliere e me lo faceva baciare: mi diceva che era un dono di Dio, il segno dell’amore di Dio che ci dona il pane quotidiano. “Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente”, si legge nella Bibbia. Dio ha creato per noi il sole, l’aria, l’acqua e la terra fertile che insieme ci offrono il frumento, la vite e l’uva, l’olivo e l’olio, l’erba e i frutti del campo perché tutti possiamo mangiare e vivere felici.

È compito di ciascuno allora cercare di incrementare la
Nel Vocabolario Treccani cibo ha anche un altro significato: “In senso figurato, la parola cibo indica tutto ciò che costituisce un arricchimento dal punto di vista intellettuale o spirituale (si dice: i buoni libri sono un buon cibo per la mente; la preghiera è il cibo dello spirito) o, per analogia con l’assoluta necessità del cibo per la sopravvivenza, anche ciò che per una persona rappresenta un motivo di interesse talmente importante da costituire la sua ragione di vita (la filosofia è il suo cibo, si dice)”. In questo senso figurato, un tipo di nutrimento necessario per la nostra vita sono anche le relazioni che ci permettono, come e meglio del cibo materiale, di vivere pienamente. Stare insieme, collaborare, condividere con gli altri gioie e sofferenze ci sostiene e ci offre energia e forza per continuare a vivere. Infatti, se non avessimo più nessuno con cui parlare e condividere il nostro vissuto,
Guardiamoci attorno: quanta solitudine, quanta fame di relazioni vere sentiamo intorno a noi! Questa è fame come quella di chi non ha nulla da mangiare, una fame che è cresciuta oltre misura negli anni della pandemia. A questa fame dobbiamo dare attenzione, come a quella materiale dobbiamo dare una risposta.
Ma c’è ancora un cibo che viene dal Cielo, cioè, dono di Dio, per saziare la fame del nostro cuore e darci una vita piena. È Gesù stesso, la sua Parola e il suo Corpo: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo”. E continua: “Chi mangia di questo pane non avrà più fame”, sarà saziato, si sentirà bene, potrà camminare speditamente e gioiosamente nel cammino della vita. Sì, perché nella vita vengono i momenti e i tempi in cui ci sentiamo soli e stanchi, come in un deserto, anche se in mezzo alla folla, senza più energie per proseguire. Allora sarà saggio cercare quel Pane che può saziarci e darci la forza per continuare. Sappiamo Chi è e dove si trova.
“Cibo”, secondo il dizionario Treccani, significa “genericamente, tutto ciò che si mangia.
In senso figurato, la parola cibo indica tutto ciò che costituisce un arricchimento dal punto di vista intellettuale o spirituale.
Non solo equilibrio tra i nutrienti, qualità degli ingredienti e cura dell’apporto vitaminico.
Quando si parla di cibo e alimentazione in realtà c’è molto di più.
Che si tratti di un pasto consumato in famiglia o del pranzo che viene servito a scuola, del panino mangiato con i colleghi di lavoro al bar o dell’uscita a cena con gli amici, nel cibo c’è infatti un richiamo diretto all’affettività, alla relazione con il prossimo e all’educazione. Una serie di aspetti che valgono a prescindere dall’età, ma che diventano ancora più rilevanti quando questi riguardano i bambini.
Fin dalla nascita l’alimentazione rappresenta per il bambino non il semplice soddisfacimento della fame, ma il modo in cui instaura una relazione con il prossimo, a partire dalla mamma. Allo stesso modo, la fase dello svezzamento non è solo un momento di cambio di alimentazione, ma è anche
un momento di distacco dalla madre, sia dal punto di vista fisico, sia da punto di vista psicologico.
I bambini osservano cosa mangiano gli altri e come lo fanno. E, attraverso questa fase di osservazione, attraverso la manipolazione del cibo e attraverso un rapporto ludico con gli alimenti, imparano a relazionarsi anche con la realtà e le persone che li circondano.
Il fatto che in questo caso ci riferiamo alla prima infanzia non tragga in inganno: l’alimentazione, la scansione dei pasti e la relazione con il cibo sono aspetti cruciali per tutto l’arco delle nostre vite. Partendo da questi presupposti, è evidente che l’educazione di un bambino alla corretta alimentazione rappresenta un passaggio a cui prestare grande attenzione. Tanto più in un paese come l’Italia, nel quale la socializzazione avviene spesso intorno a una tavola imbandita e nel quale la cura e il trattamento delle materie prime sono un patrimonio collettivo che si tramanda da una generazione all’altra con
una serie di rituali che danno valore e senso alle relazioni.
È per tutti questi motivi, oltre che per gli aspetti legati alla salute degli oltre 200 bambini e ragazzi che quotidianamente consumano i propri pasti all’interno della struttura, che Villa Santa Maria presta la massima attenzione alla qualità del cibo, alla sua presentazione e al modo in cui questo viene somministrato a pazienti che in certi casi hanno esigenze molto particolari. La cucina interna, che ogni giorno prepara i pasti per i pazienti e il personale, garantisce piatti preparati freschi, menù definiti in collaborazione con la nutrizionista del Centro, preparazioni ad hoc che tengono conto di regimi alimentari particolari per intolleranze, allergie, scelte delle famiglie e motivi religiosi.
Il personale di Villa Santa Maria addetto alla somministrazione dei pasti prevede un organico di una quarantina di operatori specializzati, in grado di rendere non solo più fruibile la somministrazione anche nei casi più delicati, ma anche di

eseguire nel modo migliore tutti quei trattamenti educativi e riabilitativi che si svolgono durante il pasto e che sono di grande utilità per i bambini. Oltre al gusto e agli aspetti nutrizionali, viene curata la relazione con gli alimenti, in continuità con quanto fanno le famiglie, e la socialità tra i bambini e i ragazzi.
Il tutto con la consapevolezza che una corretta educazione alimentare fin da piccoli riesce non solo a fare prevenzione rispetto a una serie di disturbi alimentari, ma rappresenta anche un patrimonio culturale prezioso per i bambini di oggi e per gli adulti di domani.
I bambini osservano cosa mangiano gli altri e come lo fanno.— Dino Bondavalli — Responsabile Comunicazione Villa Santa Maria

Dopo due anni, condizionati pesantemente dall’emergenza pandemica, l’anno scolastico si è aperto all’insegna di un ritorno quasi totale alla normalità.
Questo significa riprendere il filo di un discorso educativo e didattico più ricco ed articolato, su due fronti.
Il primo, di immediata evidenza, è la possibilità di arricchire ed ampliare l’offerta formativa, con progetti didattici mirati e il ritorno alle uscite sul territorio ed alle visite guidate. Ogni ordine di scuola (infanzia, primaria e secondaria) ha definito il proprio programma da inserire all’interno del P.O.F. annuale.
Il secondo fronte, altrettanto importante, è quello degli apprendimenti.
Due anni di pandemia hanno lasciato cicatrici profonde.
Gli alunni ne hanno risentito, in primis, sul piano delle relazioni. Educare è un’attività
per sua natura relazionale, tra alunni e docenti e tra compagni di classe. La Didattica a Distanza (DAD) che pure è stato l’unico strumento disponibile, nella fase acuta della pandemia, per mantenere un rapporto con la scuola, certamente non può sostituirsi alla relazione interpersonale diretta.
Gli alunni ne hanno risentito sul piano degli apprendimenti. Non solo nelle nostre classi, ma a tutti i livelli dell’istruzione, comprese le scuole superiori, ci si è resi conti che sono mancati parti importanti non tanto del cosiddetto “programma” di studi (che per precisione non esiste più da tempo), ma nell’acquisizione delle competenze e dei contenuti.
A ciò si unisce un fenomeno altrettanto negativo, da tempo oggetto di numerosi studi a livello scientifico: l’influenza dell’uso distorto dei nuovi mezzi di comunicazione (Social, Internet, smartphone).
I bambini (già in età precoce) e i ragazzi leggono poco, si distraggono facilmente, hanno difficoltà a concentrarsi e a
mantenere l’attenzione, sono spesso impulsivi. Quanti errori nelle loro prove di verifica derivano dalla fretta e da una scorretta comprensione della consegna!
A ciò si aggiunge la crescente complessità delle classi, per il sempre crescente aumento di alunni ed alunne con bisogni educativi speciali.

Il corpo docente è ben cosciente di queste difficoltà e mette in campo tutte le risorse per affrontarle.
Per completare il panorama sullo stato dell’arte dell’Istituto Comprensivo è doveroso dare qualche altra informazione.
La pandemia ha solo rallentato ma non fermato il continuo sforzo di innovazione e aggiornamento a livello strutturale e strumentale.
La Scuola ha partecipato con successo a numerosi bandi PON ottenendo i relativi fondi. Sono in corso le procedure per perfezionare gli impegni di spesa e gli acquisti.
DIGITAL BOARD: 56.908,11 Euro di finanziamento che sono stati impiegati per sostituire le vecchie LIM con i nuovi Monitor Touch da 75 e 65 pollici, dotando così le aule di una tecnologia d’avanguardia.
EDUGREEN: 25.000 Euro di finanziamento che sono stati impiegati per acquistare due serre da interni, casette, kit ed attrezzi per la semina, orto rialzato, kit per energie rinnovabili.
STEM: 16,000 Euro di finanziamento per l’acquisto di un Banco Making mobile Scientifico tipo Sciencebus Modular completo di esperimenti in ambito STEM (Scienze – Robotica – set programmabili – kit sensori modulari), kit realtà virtuale e piattaforma contenuti didattici
CABLAGGIO: in corso per potenziare la rete interna in sinergia con i fondi messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico finalizzato a dotare le scuole di una connettività a banda ultra larga (Piano Scuole Connesse).


I video dei lavori realizzati dalle classi della scuola secondaria nell’anno scolastico scorso in occasione dell’anniversario della frana di Tavernerio sono stati pubblicati nei canali social della scuola.
Il 26 ottobre si è svolto una interessante giornata di formazione condotta da specialisti della APPLE.
La sessione formativa del mattino ha interessato la classe 2 A della scuola secondaria (individuata tramite sorteggio). Gli alunni sono stati guidati alla scoperta del “Viaggio di Ulisse” attraverso il coding e il pensiero computazionale: una attività didattica trasversale che utilizza iPad e la robotica educativa, con riferimento sia all’ambito umanistico (Italiano, Storia, Geografia, Arte) sia a quello scientifico (Coding, Matematica, Scienze, Tecnologia). Nel pomeriggio ha avuto luogo la sessione riservata ai docenti.
Anche in questo anno scolastico su iniziativa dei docenti di Italiano, l’Istituto Comprensivo ha aderito all’iniziativa #ioleggoperchè che si è svolta dal 5 al 12 Novembre.
Come al solito, i libri acquistati in questo periodo presso le librerie indicate andranno a incrementare la biblioteca scolastica del nostro istituto e al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale.

Il tema scelto per l’iniziativa di quest’anno è “LEGGERE PER COSTRUIRE UN MONDO PIÙ INCLUSIVO”.
Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito: hiips://www.ioleggoperche.it
Prodotti di alta qualità, preparazioni sane e genuine, grande attenzione ai flussi produttivi e alle diete speciali, percorsi di educazione alimentare per favorire la condivisione, compartecipazione e socializzazione durante il pranzo. Si presenta così il servizio mensa per i bimbi delle scuole comunali di Tavernerio curato dalla Vivenda Spa. Fondata nel 2004, l’azienda specializzata nella ristorazione collettiva e nel global service è parte integrante del Gruppo La Cascina Cooperativa, la cui storia inizia molto tempo prima, più precisamente nel 1978, quando, su suggerimento di Don Giacomo Tantardini, alcuni studenti universitari romani e fuorisede decisero di aprire una mensa per i propri colleghi.





Da allora, La Cascina Cooperativa è cresciuta costantemente fino a divenire oggi una delle principali realtà manageriali, con diecimila dipendenti e più di 36 milioni di pasti preparati ogni anno.
Le accresciute dimensioni e la vocazione di Gruppo nazionale non hanno mutato nel tempo le peculiarità dell’azienda, da sempre radicata su tutto il territorio e attenta all’occupazione delle fasce più deboli del mercato del lavoro.
“Una macchina può fare il lavoro di cinquanta uomini ordinari, ma nessuna macchina può fare il lavoro di un uomo straordinario”. È anche nel pensiero del filosofo statunitense Elbert Green Hubbard che si rivela l’essenza di quello che, nei suoi 44 anni di vita, è divenuto il motore fondante di tutto il Gruppo: sviluppo tecnologico e innovazione sì, ma la persona sempre al centro. Perché, se da una parte il management si mostra particolarmente sensibile alle novità del mercato anche in ottica di sostenibilità ambientale, dall’altra gli investimenti principali sono rivolti al personale, che, con manualità ed esperienza, rende quel servizio, quell’attività, quel lavoro unici e straordinari.
Nell’erogazione del servizio,
la Vivenda Spa garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in modo conforme alle linee guida per la ristorazione scolastica nazionali, quelle per la ristorazione collettiva scolastica della Regione Lombardia, agli standard stabiliti dal capitolato
Ogni giorno la Vivenda Spa seleziona prodotti bio, dop, igp e a Km 0, servendosi di fornitori certificati e affidabili. Il servizio di ristorazione tiene conto anche delle differenti esigenze alimentari legate a fattori allergici, a particolari patologie e a diversi credo religiosi. Così, nella composizione dei menù, si privilegiano le produzioni derivate da agricoltura biologica, filiera corta e Km 0. I vantaggi dei prodotti a Km 0 si evidenziano non solo nella riduzione di fattori legati all’inquinamento e riscaldamento globale (riduzione di trasporto e imballaggi), ma anche nella possibilità di acquistare prodotti locali più freschi e di stagione che non abbiano perso le proprietà organolettiche. È una scelta più sostenibile per l’ambiente, più economica e in grado di valorizzare le realtà locali.

speciale e in piena attuazione del manuale di autocontrollo aziendale.
Per migliorare la vita durante la pausa pranzo e offrire ai piccoli commensali ambienti confortevoli, sicuri e accoglienti, la società del Gruppo La Cascina Cooperativa si occuperà del

Ogni giorno la Vivenda Spa seleziona prodotti bio, dop, igp e a Km 0, servendosi di fornitori certificati e affidabili.
rifacimento dei refettori; il luogo in cui i bambini mangiano, oltre che sicuro e funzionale, deve puntare a essere bello, socializzante e allegro, per contribuire ad associare le sane abitudini alimentari a emozioni positive: insomma, un vero e proprio “Ristorante dei Bambini”.
Il piano di educazione alimentare che Vivenda propone nasce dall’esperienza di esperti maturata nel corso degli anni
ed è finalizzato a favorire maggiormente il consumo della frutta e verdura da parte dei bambini, informandoli circa i principi e i valori di una corretta e sana alimentazione, educandoli alla cultura della sostenibilità, salute e consumo consapevole. Partendo da tale presupposto, l’educazione alimentare a scuola può essere, quindi, un’importante parte del processo pedagogicoeducativo al quale Vivenda Spa intende contribuire attraverso la
costruzione di itinerari didattici e multidisciplinari sul tema dell’alimentazione.
Diversi gli obiettivi che la Vivenda Spa si propone: incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini; l’apprendimento e l’atteggiamento positivo verso l’esplorazione e curiosità; realizzare un più stretto rapporto tra il produttorefornitore e il consumatore, indirizzando i criteri di scelta
e le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi produce” e “chi consuma”; offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e verificare concretamente prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, stagionalità, per potersi orientare con più consapevolezza in una scelta sostenibile sia sotto il profilo nutrizionale che di impatto ambientale.
— Sabrina Manicardi —
La Commissione Mensa dell’Istituto Comprensivo di Tavernerio è stata istituita nel 2007.
È formata da genitori i cui figli usufruiscono del servizio mensa – possibilmente in numero di due rappresentanti per ogni grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) – da rappresentanti della Scuola e della Società che gestisce il Servizio. Ha un Presidente e un Segretario ed un proprio regolamento che definisce funzioni e scopi. La Commissione ha decadenza biennale.
La Commissione Mensa svolge un compito di controllo, con un ruolo propositivo per il miglioramento del servizio. Essa raccoglie le segnalazioni delle famiglie e si pone come tramite verso il Comune ed il gestore del servizio. È presente nella vita scolastica tramite ispezioni periodiche per “toccare con mano” (e forchetta) quello che anche i nostri figli mangiano in mensa.
Durante le ispezioni, la Commissione rileva gradimento e criticità dei menù giornalieri, verificando la qualità e la quantità dei pasti, la coerenza tra i menù previsti e quelli effettivamente serviti. Per ogni ispezione vengono compilate la scheda di valutazione ed il verbale, che vengono diffusi ai membri della Commissione ed alle famiglie (tramite i rappresentanti di Classe). Sulla base delle ispezioni, delle segnalazioni delle famiglie e gli incontri regolari con i gestori del Servizio, vengono proposte alternative o modifiche al menù. Ogni modifica deve essere sottoposta all’ATS di Como per approvazione prima di essere attuata.
Le ispezioni effettuate NON sono concordate con il gestore del servizio, per dare maggior veridicità a quanto rilevato.
Per contattare la Commissione Mensa è attiva l’e-mail commissionemensa.tavernerio@gmail.com
Scrivete a questo indirizzo per:
• ricevere informazioni sull’operato dalla Commissione Mensa;
• trasmettere comunicazioni di interesse della Commissione;
• comunicare modifiche di indirizzo e-mail al fine di ricevere i verbali delle ispezioni;
• indicare il proprio nominativo per effettuare un’ispezione.
Ricordiamo infatti che qualsiasi genitore può chiedere di partecipare ad un’ispezione mensa, accompagnato da un membro della Commissione. È un’opportunità importante per valutare in prima persona i menù proposti e l’organizzazione del servizio.
Per partecipare è sufficiente fare richiesta all’indirizzo e-mail indicato sopra.
All’inizio dell’Anno Scolastico 2022/2023 si è reso necessario il rinnovo della componente Genitori (causa passaggio dei figli ad altro grado scolastico e per sopraggiunti impegni).
commissionemensa.tavernerio@gmail.com
Se hai voglia (e un pochino di tempo) da dedicare a questa importante iniziativa, scrivi a
 — Antonio Moglia —
— Antonio Moglia —
Piacere, siamo Slow Food Como, il movimento del “mangiare lento”, ed il nostro principale interesse, in sintesi e citando il nostro slogan, è il «cibo buono, pulito e giusto».


Carissimi cittadini di Tavernerio, permetteteci di sfruttare questo piccolo spazio cartaceo che fa capolino in tutti i vostri salotti e tra le vostre letture per presentarci. A noi i convenevoli, dunque. Piacere, siamo Slow Food Como, il movimento del “mangiare lento”, ed il nostro principale interesse, in sintesi e citando il nostro slogan, è il «cibo buono, pulito e giusto»; ossia quel cibo che è buono non solo perché appetitoso, ma anche perché frutto di una catena produttiva etica e locale, rispettosa dell’ambiente e promotrice di procedure zootecniche e lavorative virtuose, che non ricorrono all’ uso di sostanze chimiche e che hanno riguardo del benessere e della salute delle persone, degli animali e della società. Siamo infatti convinti che l’unico modo per aspirare ad un mondo migliore sia agire in direzione di un cibo “migliore”.
Fondata nel 1986 a Bra (Cn) dal gastronomo Carlo Petrini, Slow Food conta oggi più di un milione di soci volontari, uniti in difesa del «cibo buono, pulito e giusto», diffusi in più di 169 paesi del mondo e raccolti nelle ramificazioni locali dell’associazione; tra cui, quella di Como.
Da anni, la Condotta di Como opera nel territorio provinciale con l’obbiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone organizzando, ad esempio, dei momenti conviviali di scambio culturale ed incontro gastronomico come cene tematiche, visite ai produttori, dibattiti sui temi alimentari, momenti formativi di degustazione e lezioni frontali negli istituti di scuola superiore. Inoltre, promuovendo iniziative editoriali locali e nazionali, coinvolgendo la ristorazione locale in progetti ed iniziative o incentivando la cultura dell’orto e la realizzazione di orti urbani.
Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci sui nostri social oppure www.slowfoodcomo.it slowfoodcomo@gmail.com


Aseguito del Congresso internazionale di Slow Food che si è tenuto a Chengdu (Cina) nel 2017, la creazione di «Comunità del cibo» ha assunto un’importanza centrale nell’attività della nostra associazione.
Le «Comunità del cibo» sono modelli concreti di “Food policy” che hanno il compito di riunire sul territorio i molteplici soggetti socio-economici che lo popolano, quali i referenti istituzionali, le organizzazioni d’impresa, gli operatori ed esperti del settore, i produttori e, naturalmente, i consumatori. Lo scopo è quello di tutelare
e promuovere un sistema agroalimentare locale, corretto da un punto di vista ambientale, economico e sociale. Sulla base di esperienze analoghe in altri territori d’Italia e del mondo, nei primi mesi del 2022, la Condotta di Como ha gettato le prime fondamenta per la creazione di una rete locale di persone, competenze e valori, che prenda la forma di una «Comunità del Cibo». Questa prima esperienza di rete locale, nata con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le tradizioni alimentari del territorio, è stata resa possibile dal lavoro congiunto di un gruppo di produttori locali, con quello dei giovani studenti dell’Istituto agrario “San Vincenzo” e del Comune di Albese con Cassano.
Ed ha richiamato fin da subito l’entusiasmo dei partecipanti, uniti dal comune interesse per un progetto volto a sviluppare conoscenza e formazione, a promuovere relazioni e a tutelare non solo la biodiversità del cibo locale, ma anche la sua tradizione.
Il Mercato della Terra di Albese con Cassano: il primo progetto importante della Comunità del cibo lariano.
A partire da giugno si è avviato in via Don Sturzo, a cadenza mensile (ogni ultimo sabato del mese), il Mercato di Albese con Cassano. Il Mercato, che aderisce ai principi seguiti da Slow Food, presenta un’ampia e diversificata offerta di prodotti
di filiera corta (il raggio massimo è di 40 km, secondo le regole!): dal ricco paniere di prodotti lattiero-caseari, ai banchi della carne e degli insaccati, e poi frutta e verdura, farine, pane e lievitati, olio, confetture e conserve, miele, vino, birra e bevande.
Al mercato ogni prodotto diventa occasione di conoscenza per accrescere la propria sensibilità alimentare, sia attraverso le degustazioni guidate, i laboratori ed i corsi brevi organizzati nei giorni di fiera, sia attraverso il semplice dialogo coi produttori, pronti a raccontare le storie delle loro aziende, o con gli esperti.
Il Civico si caratterizza dal 2018 per essere un ambiente accogliente, inclusivo, aperto a tutta la popolazione locale all’interno del quale si può gustare del buon cibo, dalla mattina alla sera, sia nella quotidianità della settimana che per eventi extra, organizzati insieme ad associazioni del paese e ad amici e clienti che vogliono condividere con noi spazi, idee e valori.
Come Cooperativa Sociale il Gelso abbiamo intrapreso questo cammino, investendo nella ristorazione per creare opportunità lavorative a ragazzi con disabilità e personale svantaggiato, creando uno
spazio sociale dove il cibo è protagonista e, attraverso di esso, si vivono relazioni positive e proficue e si creano momenti di convivialità in un mix di naturalezza, spontaneità e semplicità.
Dal mattino si possono gustare colazioni con la nostra Cinzia e con Sabrina, per poi trascorrere delle pause pranzo serene e tranquille nella saletta sul retro con il nostro Davide che ha sempre un sorriso e una battuta pronta per tutti e serve i piatti preparati da Antonio e Cinzia.
Nel pomeriggio, le famiglie, i ragazzi delle scuole, gli anziani, gli studenti universitari possono
fare un break, una merenda, insieme a tutto il nostro staff.
Dalle 18 in poi ci sono gli aperitivi e, in occasioni speciali, il Civico si trasforma al servizio dei propri amici, andando incontro alle esigenze dei ragazzi del progetto Vivicivico, preparando ad esempio delle cene ad hoc il venerdì sera per i giovani e, quando veniamo chiamati in causa, siamo pronti ad offrire cene sociali, cene di Natale e cene culturali.
Durante tutto il periodo estivo si organizzano apericene e cene con musica, oltre a preparare i pranzi per il Grest organizzato dagli amici dell’oratorio.
Il nostro Civico utilizza il cibo in un modo nobile, cercando di non sprecare nulla e ha uno scopo sociale: dare l’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro a chi nella società avrebbe maggiori difficoltà.
Grazie ai nostri amici e clienti che ci vengono a trovare e ci scelgono quotidianamente per il nostro cibo, continueremo ad andare avanti con i nostri progetti, all’insegna dell’inclusione e della socializzazione intergenerazionale.
Tratto da “Il cibo come cultura” di Massimo Mantovani.
L’idea di Cibo si collega volentieri a quella di Natura, ma il nesso è ambiguo e fondamentalmente improprio. Nell’esperienza umana, infatti, i valori portanti del sistema alimentare non si definiscono in termini di “naturalità” bensì come esito e rappresentazione di processi culturali che prevedono l’addomesticamento,
la trasformazione, la reinterpretazione della Natura.
Res non naturalis definirono il cibo i medici e i filosofi antichi, a cominciare da Ippocrate, includendolo fra i fattori della vita che non appartengono all’ordine “naturale” bensì a quello “artificiale” delle cose. Ovvero, alla cultura che l’uomo costruisce e gestisce.
Tale connotazione accompagna il cibo lungo tutto il percorso che lo conduce alla bocca dell’uomo. Il cibo è cultura

quando si produce, perché l’uomo non utilizza solo ciò che trova in natura (come fanno tutte le altre specie animali) ma ambisce anche a creare il proprio cibo, sovrapponendo l’attività di produzione a quella di predazione.
Il cibo è cultura quando si prepara, perché, una volta acquisiti i prodotti-base della sua alimentazione, l’uomo li trasforma mediante l’uso del fuoco e un’elaborata tecnologia che si esprime nelle pratiche di cucina.
Il cibo è cultura quando si consuma, perché l’uomo, pur potendo mangiare di tutto, o forse proprio per questo, in realtà non mangia di tutto bensì sceglie il proprio cibo, con criteri legati sia alle dimensioni economica e nutrizionale del gesto, sia ai valori simbolici di cui il cibo stesso è investito.
Attraverso tali percorsi il cibo si configura come elemento decisivo dell’identità umana e come uno dei più efficaci strumenti per comunicarla. ….
Ricordo che la mia mamma, per il mezzogiorno o per la cena, anche quando c’erano degli ospiti, cucinava il “melemen”. Un piatto facile e veloce, tipico della cucina turca. Bastavano dei pomodori, che lei andava a prendere nel nostro orto. A casa avevamo un orto e pure un giardino con alberi di mele bianche e rosse.
Allora, la mamma affettava i pomodori, aggiungeva la cipolla, un peperoncino verde piccante, aglio, olio, sale e pepe e un po’ d’acqua e uno o più uova. La fiamma cuoceva il tutto e la pietanza era bella pronta da mangiare con il pane morbido. A me il piccante piaceva
anche da bambino e mi piace ancora adesso.
Poi tutta la famiglia si sedeva a tavola.
Li rivedo tutti: il mio papà Halis, la mamma Servinaz, i miei fratelli Ferhat e Mahmut, mia sorella maggiore Selda, e poi c’ero io, Tunay e la sorella minore Gul, che in italiano vuole dire Rosa.
Il “melemen” lo mangiavamo tutto l’anno perché i pomodori, bene o male, li avevamo sempre. È il mio piatto del ricordo, il piatto del mio cuore. Anche se la cucina turca è varia e ha tante ricette anche di dolci, io preferisco il salato e il “melemen” qualche volta me lo cucino anche qui, a Solzago, dove vivo e lavoro da 11 anni.
In questi giorni di Avvento mi sono scontrata con una riflessione che scaturisce dall’avere tre figli di età molto diverse.
Il grande è davvero grande e Babbo Natale inizia a suscitare più perplessità che felicità; insomma, lo lascia a digiuno. Stesso discorso per questo Gesù Bambino che porta l’ultima versione della Nintendo Switch, che per mamma e papà è veramente troppo costosa.
Ehm...
Non pensavo di tramandare questo spirito del Natale e mi rattristo un po’. Anche perché io non ho mai sfruttato per mio interesse questa magia, ma i tempi cambiano.
Il Natale è ricordare la nascita di Gesù, di quel Gesù che si dona a noi, che ci sazia per sempre chiedendoci di essere a “sua immagine e somiglianza”.
Ecco Chiara, grazie, così muore tutta la magia… Delle lucine scintillanti, delle renne e del “Ho ho ho” che giunge dalla fredda Lapponia, di quegli elfi dispettosi e invadenti che l’anno scorso sono saltati fuori dai calendari dell’Avvento.
Ehm...
La sorella è nella magia più totale. Si addormenta con speranza, si sveglia con il soggiorno pieno di pacchetti. Sai, quella pienezza da merendina Kinder, che stai per vomitare e dopo due minuti hai fame ancora.
A beh, capirai… una perdita immensa.
Mi piacerebbe invece che ci si accorgesse che è proprio quando tutto ciò scompare che il Natale si riempie di quella magia indispensabile per grandi e piccini.

Magia di un regalo che arriva da chi non ti aspetti e che ha pensato a te. Grazie... ne avrò cura.
Magia di donare del tempo pensando a qualcun altro. Toc Toc, permesso… cosa ti rende felice?
Magia di poter esprimere un desiderio senza aspettarsi l’eccesso. Scusami… lo vorrei tanto.
Ehm...
La piccola non capisce ancora un granché, ma durante le pubblicità urla “mioooo”… poi strappa carta, dice “WOW” e mette da parte. Insomma, mangia ciò che trova, basta che sia commestibile.
Cosa ci rimane di un Natale così? Forse non l’ennesima bambola di Elsa, ma sicuramente la certezza di essere amati da Dio e dal prossimo. E ancora di più? L’occasione di dimostrare questo Amore agli altri. Scusate se è poco… riempie più dell’intero pranzo di Natale!
E se invece di un “Ho ho ho”! (cos’HAI?!) concludessimo con tre Oh! di stupore e gratitudine?
Chissà poi perché ti arrabbi mamma quando cade per terra... Mica l’hai pagata tu… o sì? Mi stai dicendo la verità?
Mamma, perché devo comprare un regalo al mio compagno di classe, ci pensa Babbo Natale!
Cibo e cinema hanno da sempre un legame molto forte. Il cibo è convivialità, storia, cultura. È una parte fondamentale della nostra vita, che ne accompagna e scandisce i diversi momenti ed era inevitabile quindi che acquisisse un posto di rilievo anche nei film del grande schermo. A volte è parte imprescindibile della vicenda raccontata, altre volte diventa protagonista di una scena o addirittura di una sola battuta. Alcuni film raccontano le ricette e l’amore con il quale eseguirle.
Marco Ferreri (1973). Questo film è un cult del cinema gastronomico. I protagonisti sono quattro uomini benestanti che si riuniscono per un “seminario gastronomico” in una villa nei dintorni di Parigi.
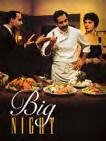

Pileggi. I due non riescono ad andare d’accordo sulla gestione del loro ristorante: Primo, lo chef, non vuole cedere a compromessi in cucina, mentre Secondo, maître, è più accondiscendente e incline ad assecondare i gusti della
già le vicissitudini di Rémy, topino molto dotato che sogna di diventare chef. Il cibo è qui raccontato dal punto di vista di chi ne è totalmente innamorato, esaltandolo sotto ogni aspetto, edonistico in particolare. Indimenticabile è la scena del commovente assaggio della Ratatouille da parte di Anton Ego critico gastronomico.
Gabriel Axel (1987). È uno dei capisaldi tra i film di cucina, un vero classico dove il mondo del cibo si collega a quello religioso. Tratto dall’omonimo racconto di Karen Blixen, è ambientato in un piccolo villaggio della Scandinavia.

Nelle vicende di Vianne, che apre una cioccolateria in un piccolo paese francese di stampo cattolico in periodo di Quaresima, il cioccolato è onnipresente in ogni sua forma. Rappresenta per gli abitanti la tentazione a cui si sono sempre opposti, ma è anche l’elemento che li porterà ad aprirsi alla novità, aiutandoli a lasciarsi andare verso un cambiamento nelle loro vite.
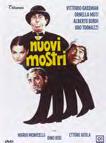
clientela statunitense. Big Night racconta molto bene questo aspetto fondamentale del mondo della ristorazione e del rapporto tra cliente e ristoratore e mostra quanto una cucina possa significare in termini di appartenenza culturale. Passano ore in cucina per confezionare una cena degna di un re, confezionando una miriade di piatti, tra cui il timpano di maccheroni ripieno di polpette, uova, salame, ragù e ricoperto di sfoglia: un’impresa davvero eccezionale che fa venire l’acquolina in bocca a tutti gli spettatori.

Di fatto, insoddisfatti delle loro vite, decidono di suicidarsi con un’abbuffata di cibo e sesso. In questo caso i bisogni primari e i piaceri della vita, in un delirio d’inappagabile ingordigia, diventano un modo paradossale per suicidarsi, ma anche una critica alla società dei consumi. Il cibo diviene metafora di decadenza, mancanza di valori e morte.
Stanley Tucci e Campbell Scott (1996). È la storia di due fratelli italoamericani, Primo e Secondo
Brad Bird e Jan Pinkava (2007). L’imperdibile lungometraggio di animazione è forse uno dei film sul cibo più visti e apprezzati di sempre. È molto probabile che la maggior parte di voi conosca
Qui Babette, cuoca parigina in fuga dalla repressione della Comune di Parigi, è accolta da due anziane sorelle Martina e Philippa, figlie di un pastore luterano deceduto. Durante un sontuoso banchetto preparato da Babette, la bontà del cibo conquista i commensali appagandoli nel corpo e nello spirito e riattivando un sentimento comunitario ormai perduto.

Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola (1977). All’interno del film Scola si occupò del racconto comico “Hostaria!” in cui, attraverso una grande parodia, i titolari di un’attività, cuoco e cameriere, impersonati da Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, hanno una violenta lite di gelosia durante il lavoro, utilizzando così il cibo come elemento di difesa e offesa. Nonostanteciò le pietanze sono servite ai clienti che le trovano buonissime.
Lasse Hallström (2000). Grande classico imperdibile, soprattutto se siete amanti del cioccolato.
Una grande caricatura, insomma non solo della vita dei ristoratori, ma anche di fatti e misfatti che possono avvenire all’insaputa degli avventori.
Steno (1954). Alberto Sordi, uno degli attori che ha fatto la storia del cinema italiano, con spirito e leggerezza cerca di immedesimarsi in una figura che molti italiani sognavano nel dopoguerra: l’americano. Un mito e stile di vita che molti conoscevano solamente attraverso il cinema e le riviste. Sordi si veste come crede facciano gli americani e cerca di assumere le loro abitudini e modi di fare, incluse le loro
abitudini gastronomiche. Parlando da solo sostiene che gli americani si nutrono di pane, marmellata, mostarda, yogurt e latte e si prepara una pietanza bizzarra, scartando un piatto di maccheroni perché «io sono americano, io non magno maccheroni». Dopo un morso schifato all’intingolo americano, scambia i piatti e cita la frase poi diventata celebre: «Maccarone mi hai provocato e ora io ti distruggo, mo te magno».
e nù pucurille ‘e zucchero».
QUEI BRAVI RAGAZZI
Martin Scorsese (1990). Nel film ‘mafioso’ diretto da Martin Scorsese il cibo svolge un ruolo fondamentale. Quasi tutte le scene in cui accade un omicidio avvengono appena prima o appena dopo un pasto, uno strumento utilizzato per dimostrare la crudeltà dei personaggi, la cui fame non è minimamente sciupata dopo aver commesso un reato.
La scena più importante del film legata al cibo si svolge in carcere, quando alcuni dei membri della gang si ritrovano insieme dietro le sbarre a scontare la pena. In carcere non c’è molto da fare, quindi si dedicano alla preparazione meticolosa di pasti sontuosi dagli ingredienti difficilmente reperibili in prigione, come gli spaghetti con le polpette.
italiani della storia, e questa scena è il risultato di un’improvvisazione tutta sua.
dell’amministratore e quella del medico. Il pover’uomo si trova allora a dover organizzare un pranzo di Ferragosto per le simpatiche vecchiette, cercando di barcamenarsi tra battibecchi, manie, diete e quant’altro.

Francis Ford Coppola (1972). I film italoamericani di mafia contengono moltissime scene legate al cibo, in particolare alla fase di preparazione delle varie pietanze e al momento di consumo, rappresentando così scene di convivialità e dell’importanza della famiglia.
Anche in questo caso Scorsese utilizza il cibo come strumento, qui per dimostrare come il loro potere permetta di vivere una vita comoda e senza sacrifici, anche in carcere.

Mario Monicelli (1958). Nel capolavoro di Monicelli, la banda di rapinatori falliti si consola con la pasta e ceci trovata nella cucina che dovevano scassinare: non tutto è perduto, la pancia, almeno, è piena.
Il menù: la pasta al forno che una di queste divora nonostante i divieti del figlio medico e il pesce pescato nel Tevere. E allora il cibo diventa il mezzo per unire più generazioni e per abbattere le distanze.
E.B. Clucher (1970). Una delle scene iconiche è quella in cui Terence Hill entra in una locanda del Vecchio West e si abbuffa di una padella di fagioli in pochissimi secondi, come se non avesse mangiato da giorni.

Nel primo film della trilogia di Francis Ford Coppola si vede un giovane Al Pacino che impara e osserva mentre Clemenza - uno dei caporegime della famiglia Corleone - confeziona il ragù con «un poco d’olio, ci friggi uno spicchio d’aglio poi ci aggiungi tomato e anche un poco di conserva.

Friggi e attento che non si attacca; quando tutto bolle ci cali dentro salsicce e pulpetta, poi ci metti uno schizzo di vino
Mario Mattoli (1954). Una delle scene più celebri in cui è raffigurato il cibo in una pellicola italiana è quando Totò in euforia totale assieme alla compagnia per la ricezione di un pasto sontuoso - inizia a mangiare gli spaghetti, saltando sul tavolo e afferrandoli direttamente con le mani.
A causa della fame sofferta (e per il timore di soffrire ancora) prosegue nel riempirsi le tasche di spaghetti, che penzolano fuori in modo comico. Totò è stato uno dei comici più famosi
Chi non ricorda la celebre scena del film, quando i ladri più iellati e simpatici del cinema italiano, scavando un cunicolo sotterraneo, invece di arrivare al tesoro del Monte di Pietà, sbucano in una cucina qualunque dove, per il colpo mancato, si consolano con la pasta e ceci e gli involtini al sugo? Una curiosità: il copione prevedeva pasta e fagioli, fu Mastroianni, uno dei ‘ladri’, a chiedere che fosse sostituita con la pasta e ceci, che, sul set, mangiò poi in piena naturalezza, con Vittorio Gassman, Tiberio Murgia e Capannelle.


Gianni di Gregorio (2008). Il film narra la deliziosa storia di un figlio alle prese con la madre, una nobildonna decaduta e leggermente caratteriale, cui vanno ad aggiungersi la mamma
Proprio l’attore, anni fa, durante la presentazione della versione home video di un suo film raccontò un curioso aneddoto: “Per girare quella scena io ho digiunato per 36 ore, sono arrivato molto affamato, quella padella me la sono mangiata tutta.”
Questo è il risultato di una passione verso il cinema e di una ricerca, sebbene parziale, sul web con la speranza di sollecitare curiosità in chi ha fin qui letto.
Il pane è un alimento sostanziale di tutte le cucine del mondo ed è universalmente riconosciuto come simbolo di benessere. Occupa un posto fondamentale nella tradizione mediterranea come componente primario dell’alimentazione, al punto che il termine stesso può diventare sinonimo di “nutrimento” nella sua accezione più generale.
Nella cucina più antica si usava il termine cumpanaticum per indicare ogni preparazione che poteva accompagnarsi al pane, sottolineando il suo ruolo fondamentale.
Su tutte le tavole imbandite di ogni Paese e continente assume forme, colori e profumazioni differenti in correlazione sia al tipo di cottura che agli ingredienti primari utilizzati.
Volendo attenersi ad una definizione precisa, il pane è un “prodotto alimentare ottenuto dalla cottura di un impasto lievitato a base di farina –normale o integrale – di cereali,
acqua, generalmente con aggiunta di sale”.
Ma nella storia dell’umanità rappresenta molto di più.
Quella del pane è una storia che ha radici antichissime: già l’uomo primitivo ne faceva uso come integratore sottoforma di impasto crudo per accompagnare la carne.
I primi veri panettieri della storia furono però gli Egizi, che intuirono l’utilizzo dei chicchi di frumento nella produzione di una grezza “polvere” che, miscelata ad acqua, produceva un impasto che veniva poi cotto su pietre roventi.
I Greci, successivamente, cominciarono ad aggiungere all’impasto altre materie prime come olio, latte ed erbe, in alcuni casi anche miele e spezie e, per primi, iniziarono a produrlo di notte per poterlo distribuire fresco e fragrante ogni mattino.
In Italia, il pane diventa alimento d’uso quotidiano solo attorno al 160 a.C., più o meno in coincidenza della fine della repubblica romana: proprio a Roma sorsero, infatti, le prime botteghe per la produzione e la vendita ed iniziarono a definirsi le categorie dei fornai e dei panettieri.
Alla Francia, infine, si deve l’invenzione dei mulini: a Quinto Candido Benigno va il merito della realizzazione di un sistema di macine mosse da forti getti d’acqua, che garantivano la produzione di grandi quantitativi di macinati ottenuti da cereali diversi.
E, da quel momento, la diffusione del pane e dei prodotti da forno in generale, dolci o salati, non si è mai più arrestata.
Il pane, ad oggi, costituisce la base dell’alimentazione per la maggior parte dei Paesi del mondo, ad eccezione di quelle popolazioni che non possono dedicarsi all’agricoltura, come per esempio gli Esquimesi, oppure alcune tribù africane, che sono dedite esclusivamente all’allevamento del bestiame.

Il pane simbolo della Francia è la baguette, tanto che la figura tipica del cittadino d’oltralpe è rappresentata da un soggetto con l’affusolato filone dorato portato sotto al braccio.
Una curiosità: in un piccolo paese del Massiccio centrale di sud est, gli abitanti hanno una secolare tradizione legata alla panificazione, una volta all’anno tutti insieme partecipano all’evento radunando prima la legna per alimentare l’unico forno presente nel paese, poi ogni famiglia vi si reca per cuocere la razione di pane predisposta per soddisfare il fabbisogno di un anno intero.
In Giappone, invece, il consumo del pane è stato introdotto dagli americani durante l’occupazione della Seconda guerra mondiale.
Tutti i pasti in Cina sono accompagnati da abbondanti
“Se vuoi conoscere un paese, visita i suoi mercati, mangia nelle sue case e, soprattutto, prova il suo pane”
Nella cucina più antica si usava il termine cumpanaticum per indicare ogni preparazione che poteva accompagnarsi al pane
porzioni di riso e solo in occasioni speciali viene preparato il Bao, un pane bianco latte dalla consistenza morbida ed elastica.
Molti Paesi mediorientali utilizzano il pane come strumento con cui prendere il cibo, senza ausili di altre posate, ingerendo poi tutto il boccone completo.
In India il pane si chiama Chapati ed è una sfoglia lievitata dalla forma tonda e
piatta, di consistenza simile alla nostra piadina, che viene cotto nei tradizionali forni tandoor in argilla.
Un’analisi di mercato promossa da AIBI evidenzia che “ […] il pane, alimento simbolo della dieta mediterranea e della cultura alimentare italiana, non perde la sua centralità nella vita quotidiana degli italiani e si conferma alimento-
rifugio anche nei momenti di crisi, prima con la pandemia e ora con la drammatica situazione Ucraina […] anche se è evidente un significativo calo nei consumi, soprattutto in riferimento al prodotto di provenienza industriale”.
Il consumo pro capite di pane in Italia si colloca su un quantitativo nettamente inferiore rispetto ad altri Paesi europei, con una stima di 41 kg annui, equivalenti a 110 gr al giorno, contro gli 88 kg della
Romania, 80 della Germania, 57 in Olanda, 52 in Polonia, 47 in Spagna, 44 in Francia, 43 Regno Unito. Questa contrazione trova una possibile spiegazione nella crescente attitudine verso regimi alimentari ipocalorici che tendono a diminuire la componente di cereali, proprio a partire dal pane, in favore di regimi dietetici e salutistici.
Tortilla serve da accompagnamento a qualunque cibo ed è la base di alcune specialità come le enchiladas, i tacos e i totopos. Si tratta di un disco di pasta fina fatto con farina di mais (più raramente di grano).
Pão de queijo sfera di pane la cui ricetta include uova, formaggio, latte, olio e farina di yucca dolce. Si serve caldo con un ricciolo di burro.
Lechuguino un tipo di Pan candeal di Valladolid, ovvero pane di grano duro con una spessa crosta dorata, brillante e incisa con piccoli tagli. Dentro, l’impasto è morbido e molto compatto.
Pumpernickel pane di segale di massa madre con un processo di fermentazione lento. Si cuoce al vapore o a bassa temperatura, è piuttosto compatto, acidulo, scuro come il cioccolato e molto aromatico. Il sapore della Mitteleuropa è probabilmente un pezzetto di questo pane con un po’ di burro.
Injera pane finissimo, simile a una crêpe, con cui si accompagnano le pietanze più saporite e condite; più spugnoso e soffice del pane arabo, è fatto con il teff, un cereale simile al miglio e poi condito con spezie varie.
Naan pane basso fatto con farina di grano, lievito, latte o più spesso yogurt, zucchero e acqua. L’impasto, anche in
questo caso, è liquido e si cuoce nel tradizionale forno Tandoor.
Damper o Bush bread, pane a base di farina, bicarbonato di sodio, olio e latte. È un pane schiacciato, che si cuoce in una padella sulle braci calde, in onore alla ricetta originale degli aborigeni australiani.
Pane di segale, più scuro e denso di quello di grano duro è molto comune e utilizzato in tanti paesi del Nord Europa, in Germania, Polonia, Finlandia e Olanda.
Bagel sono nati in Europa e precisamente in Polonia anche se oggi i Bagel si mangiano in
tante parti del mondo. A New York, in particolare, potrete mangiarne di buonissimi, così come a Montreal dove sono cotti con il miele e ricoperti di sesa.
Pita tipo di pane azzimo, diffuso in tutto il Medio Oriente, ma assimilabile anche alla cucina greca e Balcanica. Di solito aperto e farcito all’interno per fare i kebab oppure la versione greca con pezzetti di carne arrosto e verdure.
— Federica Trombetta —
“Il pane è l’alimento nel quale si concentra la cultura gastronomica di un luogo”
Un giovincello avanza verso le Alpi, tremante di dolore, il volto livido, gli occhi strabuzzati, porta con sé la Domanda. Nel suo stanco peregrinare non ha ancora trovato risposta, anima inquieta nel grande oceano della vita. Passo dopo passo, incespicando, intorpidito dal freddo, si posa per un momento ai piedi di una grande grotta.
Dimmi, anima figlia del nulla.
Ne esce una voce, profonda, sovrumana, un suono roccioso, come se la lingua di chi parla stesse battendo ininterrottamente in una bocca di marmo. È la voce della Montagna: “Cosa domandi, anima inquieta precaria nel mondo, breve di vita, a me, che sono eterna prolusione della Natura, immutabile e senza tempo custode del mondo? Dimmi, anima figlia del nulla.” Il giovane, trasalendo, risponde: “Montagna, figlia della natura, parte del Tutto, ho a lungo peregrinato domandando a chiunque sul mio cammino quale fosse il motore della vita, ciò che ci permette di esistere e ci convince a continuare a farlo, ma non ho trovato risposta alcuna; ora domando a te, infinita essenza, di rispondere al mio quesito.” E la Montagna al giovincello: “Il motore della tua vita sta nel desiderare la risposta alla domanda che ti percuote lo stomaco. È la domanda stessa la risposta ad essa. Il tuo desiderio di scoprire il senso della vita è la manna della tua esistenza. Tu sei un disperso, anima fuggiasca, in un deserto infinito, al quale nessuno può sfuggire, non c’è speranza
in questo, allora ti illudi, ti domandi, cerchi di capire ciò che ti angoscia. Non è il male, né la malattia, né la morte, bensì la noia, la non esistenza. Così, cerchi di sfuggire alla non esistenza domandandoti qual è il motore della vita, cosa ha senso per esistere e cosa no. Ma non trovi risposta. Non la trovi perché non esiste. Se la trovassi, tu finiresti di interrogarti e quindi spenderesti inutilmente gli anni a venire. La risposta non esiste. Esiste la domanda. Esiste il desiderio. Questo è il motore della vita, il vero cibo, chi non desidera non può esistere, chi vuole estinguere tutti i propri desideri non può farlo, perché al soddisfarsi di uno se ne presenterà un altro.
Questo è il senso della vita: continuare a peregrinare e a domandarsi, senza avere mai risposta alla domanda. Quindi
ora sono io a chiederti: qual è il motore della tua vita?”
Il giovincello è terrorizzato, bianco come il cielo che si gonfia d’inverno di candida neve, spaesato dalla risposta della Montagna, che incombe, titanica, su di lui. Poi chiude gli occhi, inspira lentamente l’aria muschiata e così risponde: “Ora so qual è il motore della

mia vita, o meglio qual era: è stato per tutto questo tempo domandarmi quale fosse, ignorando nella domanda la risposta al quesito. È stato illudermi di poter trovare una risposta a una domanda senza risposta. Sono stato ingannato dalla vita per lungo tempo e anche ora, con quest’ultima risposta la vita mi ha ingannato; ha posto fine per sempre al motore della mia esistenza, ha annullato la domanda, ha annullato il desiderio. Nulla è più ciò che era. Questa risposta non avrei mai voluto averla, mi ha reso per sempre cosa del mondo, senza essere nel mondo, mi ha subissato in uno stato di noia. Neanche la morte è cosa dolce, perché non so a cosa mi porterebbe di fronte: al niente? Questo è sicuro, e se anche nel niente io avessi domande? E se anche nel niente ricevessi risposte? Certo non è possibile che io muoia due volte, perciò rimarrò inerme davanti al Tutto e mi farò servo del Niente? Forse è nel non sapere che la vita è più dolce, forse è nel non domandare che la vita è più facile; ma forse anche questo non è noioso, anche questo non è desiderare? Ecco un’altra domanda, ma ora preferirei non averne risposta da te, Montagna, preferirei tenerla come nuovo motore della vita. Perché, sì, tu mi hai dato una risposta, hai soddisfatto un mio desiderio, ma non potrai mai sanare le infinite mie domande. Questo è il motore della vita, la vera manna è l’infinitezza di domande che permettono di esistere all’uomo, a fronte di una finitezza di risposte che non potranno mai annullarne l’essere. Ora ricomincio il mio peregrinare, anima incerta nel lungo viaggio della vita, ora finalmente sono certo di una sola risposta, ma affamato di mille altre.”
Senza più parole il giovincello si allontana, tremula luce nella notte, fiammella di vita nel mondo.
Esiste il desiderio. Questo è il motore della vita, il vero cibo...
 — Iryna Volosheniuk —
— Iryna Volosheniuk —
Iryna Volosheniuk, ucraina di Chernivtsi, arrivò a Tavenerio a fine marzo insieme a sua sorella e ai suoi due figli, Polina e Bogdan.
Nei mesi seguenti ha frequentato con impegno la nostra scuola di Italiano per stranieri allacciando relazioni
importanti con noi.
A fine agosto ha deciso di tornare in patria ricongiungendosi al marito e riprendendo una vita apparentemente normale. La sua città è lontana dalle zone più interessate dalla guerra, ma ultimamente racconta che gli allarmi
aerei si susseguono con sempre maggiore frequenza anche da loro.
Mantiene forte il legame con Tavernerio e, invitata a mandarci una ricetta tipica, ha inviato prontamente questa, che lei ha titolato “delizioso borscht ucraino”.
Preparare il brodo di carne, condito con alloro e spezie a piacere.
Pre-bollire i fagioli.
Sbucciare le barbabietole crude, tagliarle a listarelle. Friggere in padella in olio o strutto, condire con il succo di una fetta di limone e lo zucchero. Questo riequilibrerà l’acidità e la dolcezza del gusto.
Mi piace cominciare a parlare di cibo partendo dai miei nonni. Il pasto era molto frugale, non mancavano mai il minestrone, il caffè con la moka, caffè e latte e pane e marmellata.
Raramente erano presenti nel menù piatti a base di carne, pece di mare mai, mentre era sempre presente la polenta, polenta e latte, la “rustisciada”, pietanza a base di dadini di polenta con patate e cipolle rosolate a fuoco vivo e poi, ancora polenta accompagnata a sughi, di questo piatto ne ero veramente ghiotta!
Noi bambini, io e mio fratello, eravamo golosi di fette di polenta alla piastra spalmate di marmellata, non ho ricordi invece di biscotti, fette biscottate, ma solo pane eppure, i nonni avevano un ristorante a Como, proprio di fronte ai portici Plinio.
PER 5 PORZIONI DI BORSCHT:
• 1 l di brodo
• 2 patate di taglia media
• 1 carota
• 1 cipolla
• 1 barbabietola
• 100-120 gr di manzo
• 75 gr di cavolo
• 60 gr di fagioli
• 120 gr concentrato di pomodoro
• 1 cucchiaio di zucchero
• 1 foglia di alloro
• olio di semi di girasole o strutto per friggere
• 1 fetta di limone
• pepe nero macinato, sale qb
• panna acida per servire
Tagliare la cipolla a cubetti, la carota a striscioline sottili. Friggere in padella con l’aggiunta di concentrato di pomodoro. Puoi usare olio o strutto per la frittura. Scegliendo diversi ingredienti, puoi bilanciare il contenuto di grassi del piatto.
Tritare il cavolo cappuccio e metterlo nel brodo bollente.
Tagliare le patate a cubetti e aggiungerle al cavolo cappuccio. Portare a ebollizione le verdure e mettere in una padella le barbabietole e le cipolle fritte con le carote. Mescolare.
Cuocere per 15-20 minuti. Aggiungere i fagioli pronti e guarnire con panna acida.
A proposito, a tutti gli Ucraini all’estero manca davvero il borscht!
A casa nostra, mia e di mio fratello, c’era una golosità dietro l’altra; mamma emiliana, ed ho detto tutto, zii della stessa terra e l’arte di cucinare era innata in ognuno di loro.
Nel menù, tutto rigorosamente fatto in casa, erano sempre presenti i cappelletti, le lasagne, l’arrosto e lo zampone.
Per Natale io, mio fratello, mamma e zie, tutti insieme intorno al tavolo a piegare cappelletti fino a tarda sera.
Ai nostri giorni, volendo, si trova tutto pronto e precotto, persino il brodo lo trovi nel cartone, come il latte.
Le scelte del cibo ora sono legate all’attenzione dei prodotti che acquisti, tutti sono attenti alla linea e le diete sono il nostro incubo, ma io continuo a fare dolci seguendo le ricette, gelosamente custodite, di nonna e mamma. In cucina, considerate le mie origini, io non potevo che essere una “piccola chef”.
Arrivederci alla prossima golosità, io ci sarò, immagino l’abbiate capito che sono una gran golosa!!
Prof. Massimiliano Noseda, medico specialista in igiene e medicina preventiva, docente universitario, curatore scientifico del sito di promozione della salute www.educazione-salute.it hiips://www.facebook.com massimiliano.noseda.5 massimiliano.noseda@tin.it
La nostra comunità ha una ricchezza che molti ci invidiano, ma non tutti apprezzano veramente. È, infatti, immersa in una splendida cornice verde fatta di boschi naturali, giardini privati e piccoli orti, grazie ai quali ognuno di noi può sperimentare ogni giorno il contatto diretto con la natura e i benefici che ne derivano. Proprio per tale motivo, è bene sensibilizzare costantemente la collettività alla tutela di tale patrimonio naturale che dovrebbe essere non solo maggiormente valorizzato, ma anche tutelato da ignoranza, superficialità, interessi personali ed economici. In un contesto globale dove i temi ecologici rivestono sempre maggiore importanza, approfondiamo insieme una tematica psicologica poco nota e detta dendrofobia. Si tratta di una paura immotivata che può causare seri danni



irreversibili a tale patrimonio collettivo se non conosciuta e gestita nel modo corretto.
La paura è un istinto naturale comune al genere umano e presente anche nel mondo animale, volto a fronteggiare una situazione identificata come pericolosa e in grado di causare un danno concreto o perfino mettere a rischio la vita stessa. Ha, quindi, una finalità primitiva di tipo protettivo e, pertanto, la sua corretta percezione è assolutamente voluta e positiva. Tuttavia, può comportare reazioni molto diverse e talvolta contrastanti tra loro. Infatti, una paura di grado modesto può attivare il corpo umano e stimolare alcune capacità intellettive, come l’attenzione, o fisiche, come la fuga mentre una sua percezione eccessiva può bloccare l’individuo, sia da un punto di vista cognitivo con vuoti di memoria, sia motorio fino alla completa paralisi. Inoltre, la paura può indurre in alcuni casi alla ricerca di aiuto, in altri al ricorso alla bugia e in altri ancora ad una manifestazione alla rabbia.
Con il termine fobia si intende, invece, una reazione disfunzionale rispetto a un animale, un oggetto, un luogo, una situazione o una sensazione che, pur non rappresentando oggettivamente un reale pericolo, attiva la medesima cascata di reazioni. Si tratta, pertanto, di una paura irrazionale ed immotivata e come tale la sua presenza assume sempre una connotazione negativa. Infatti, a seconda della tipologia e della gravità può associarsi ad una variegata sintomatologia che può includere vertigine, disequilibrio, tachicardia, palpitazioni, sudorazione, vampate, formicolii, tremore, difficoltà a parlare o respirare, farfalle nello stomaco o oppressione al petto, reazione di fuga o svenimento. Può, quindi, limitare fortemente non solo la libertà dell’individuo, ma anche la sua socialità.
Con il termine dendrofobia si è soliti indicare una paura tra le meno note, ma descritta da tempo in letteratura medica, che consiste nel timore immotivato della caduta degli
alberi, legato all’inesistente preoccupazione di provocare ingenti danni a persone o cose nelle zone limitrofi.
Praticamente si manifesta con una richiesta continua e spesso petulante, ma non supportata da un reale pericolo, di eseguire interventi anche molto invasivi, consistenti in drastiche mutilazioni o addirittura tagli definitivi alla base di alberi ad alto fusto, che tuttavia sono perfettamente sani e stabili.
È, invece, preferibile parlare di pseudodendrofobia quanto il soggetto usa tale argomentazione, più o meno consapevolmente, allo scopo di spaventare terzi soggetti e raggiungere indirettamente altri obbiettivi di proprio interesse personale come, ad esempio, disboscare intere aree in quanto l’habitat naturale non gli è gradito, osservare meglio il panorama circostante aumentando così il valore di un immobile in caso di vendita oppure sostituire il verde con piante ornamentali non autoctone in quanto più confacenti al proprio giudizio estetico del bello, molto discutibile in quanto distorto a monte e non rispettoso delle aree boschive.
Quando la paura è irrazionale e diventa disfunzionale
I soggetti con dendrofobia sono quasi sempre individui tendenzialmente sedentari e poco dediti alle attività sportive, che spesso non amano gli animali e non ne possiedono nel proprio contesto famigliare. Tali consuetudini possono non essere tutte simultaneamente osservabili nella stessa persona, ma la loro presenza rende più evidente l’espressione a monte di un rapporto disarmonico con l’ambiente naturale. Tipicamente, poi, gli individui con dendrofobia risultano del tutto privi di adeguati titoli professionali o accademici, indispensabili per valutare il reale pericolo di caduta, che è in questi casi sempre insignificante o palesemente assente. Nei casi più gravi la condizione tende ad assumere i tratti patologici del disturbo ossessivo compulsivo. Questo avviene quando il tema della caduta degli alberi tende a diventare prevalente in ogni discorso pubblico del soggetto che può anche manifestare aggressività verbale nei confronti di chiunque non condivida tale pensiero arrivando fino all’incrinatura definitiva dei rapporti interpersonali con parenti, amici e conoscenti. Non è, poi, rara la mania associata di raccogliere frequentemente le foglie appena cadono senza considerare che si tratta di un processo naturale, assolutamente fisiologico e ciclico, evidente soprattutto in alcuni periodi dell’anno come la fine dell’estate e l’intero autunno. La paura aggiunta è in questo caso quella di poter scivolare e farsi male seriamente, ma spesso l’avversione è solo dovuta all’associazione mentale delle foglie con il disordine e lo sporco che suscita disturbo, disgusto e repulsione. Oltre a ciò, altri sintomi principali, comuni però a tutte le fobie estreme, possono essere gli attacchi di panico acuti, la difficoltà a respirare o a parlare, la sudorazione eccessiva, le palpitazioni e la tachicardia, la vertigine e il disequilibrio, la nausea e il vomito.
La terapia consiste naturalmente nell’affrontare i propri timori e soprattutto la loro componente irrazionale. Nessuno, però, potrà mai risolvere un problema se non accetta di averlo e, pertanto, diffondere una corretta informazione sociale sulla dendrofobia risulta essere il primo passo per approcciare correttamente una paura irrazionale in grado di causare seri danni non solo al singolo, ma di riflesso anche alla collettività. Far notare, quindi, al soggetto che i suoi discorsi sono monotematici e invitarlo a parlare d’altro è una buona strategia per stimolare l’autocontrollo, qualora sia ancora presente. Coinvolgerlo in attività di gruppo che facilitino il contatto con la natura come l’orienteering, il birdwatching e il plogging può essere, poi, un primo passo per riequilibrare il rapporto tra sé e l’ambiente, ma nei casi più radicati il soggetto tenderà a rifiutare per principio tali proposte. Al fine di ritrovare una serenità interiore, possono essere utili discipline come lo yoga e la meditazione, meglio se associate ad una revisione globale dei propri stili di vita come un’alimentazione più sana ed equilibrata, una giusta quantità e qualità di movimento quotidiano e un buon riposo notturno. L’intervento di uno psicologo o di uno psichiatra esperto è, invece, sempre da valutare in tutti i casi in cui la paura assume i tratti del disturbo ossessivo compulsivo diventando prevalente e monotono fino alla paranoia in ogni discorso pubblico del soggetto. Inoltre, la perizia di un arboricoltore professionista, in grado di discernere tra una sana e fondata paura o un caso di dendrofobia, è dirimente. Questo anche al fine di quantificare la spesa economica e limitare l’intervento, se davvero necessario, al solo albero malato e non a vaste aree perfettamente sane. Nella maggior parte dei casi si scoprirà che la potatura non è necessaria, che costituisce una spesa inutile ed evitabile e che un errato o eccessivo intervento di questo tipo può essere futura causa di
morte per l’albero. Non bisogna, inoltre, mai cadere nel tranello del giardiniere non qualificato ed opportunista, che effettua interventi demolitivi su ampie zone, nascondendo palesemente solo interessi economici personali dietro alla “foglia di fico” di una prevenzione non necessaria, né tanto meno nel grave errore di assecondare il soggetto affetto per amicizia o vicinato ricadendo, poi, nella più pericolosa dendrofobia da contagio collettivo. La corretta gestione di questa fobia parte, infatti, sempre da un secco “no condiviso”, senza indugi, senza se e senza ma, nell’interesse del patrimonio naturale, oggi ingiustamente maltrattato da ignoranza, mancanza di rispetto e competenze, prevalenza di interessi economici e personali. Nei contesti condominiali o comunque collettivi, al fine di coltivare e mantenere una convivenza armonica, è bene non coinvolgere mai il soggetto con dendrofobia direttamente nelle attività di scelta degli operatori, richiesta di preventivi a più aziende, supervisione dei lavori durante la loro effettuazione e altre attività extra da concordare con i giardinieri in quanto la sua visione distorta ed interessata del problema farà ovviamente prevalere le proprie idee e i propri interessi rispetto a quello collettivo e al volere di altri soggetti aventi potere decisionale, che spesso tendono a non essere volutamente interpellati al solo scopo di garantirsi la massima liberà di azione. Per lo stesso motivo, è sempre errato indire riunioni in assenza di una perizia tecnica già redatta da un esperto del settore o ancor peggio iniziare i lavori senza un chiaro preventivo condiviso da tutti gli aventi voce in capitolo che, a monte, non solo specifichi i costi ma che elenchi chiaramente sia gli interventi da effettuare sia quelli da non svolgere. La segnalazione all’amministratore di condominio, o a chi ne fa le veci, è sempre necessaria non appena la situazione deraglia dall’ordinario mentre la corretta informazione degli altri condomini è fondamentale per fare la scelta giusta in sede

decisionale. Invece, iniziative individuali non autorizzate sul patrimonio naturale vanno sempre segnalate per dovere civico al Comune di appartenenza e alla Guardia Forestale.
Impariamo a vedere la poesia che l’ambiente naturale trasmette in ogni stagione come propone il poeta Trilussa nel suo componimento “Foglie gialle”, non a caso incluso in molti libri della scuola elementare degli anni Ottanta.
Ma dove ve ne andate, povere foglie gialle, come tante farfalle spensierate? Venite da lontano o da vicino? Da un bosco o da un giardino? E non sentite la malinconia del vento stesso che vi porta via?
Gli uffici comunali, a causa dell’emergenza sanitaria, sono aperti solo su appuntamento
Chiamare il numero 031.421223 e scegliere l’interno desiderato:
Anagrafe > int. 1
Segreteria, URP e Protocollo > int. 2 Ragioneria > int. 6
Tributi > int. 5
Area Sociale > int. 7
Manutentiva Lavori Pubblici > int. 4 Urbanistica Edilizia Privata > int. 3 Protezione Civile > int. 4
Biblioteca 031.428168
Polizia Locale c/o sede Polizia Locale di Albavilla, Piazza Roma, 1 Si riceve su appuntamento 031.3354345
Mercoledì 14:00/18:30
Venerdì 9:00/13:00 Pronto Intervento 031.3354340 - 335.59340
Punto Prelievi
Mercoledì e venerdì 7.30/9.00
Prenotazione obbligatoria al numero Verde Regione Lombardia 800.638.638 oppure sul portale Prenota Salute della Regione Lombardia hiips://www.prenota salute.regione.lombardia.it
Nella prenotazione specificare ambulatorio di Tavernerio
Dott. Gatti
Riceve solo su appuntamento: telefonare preferibilmente entro le ore 10:00 o in orario di ambulatorio Cell. 334.1643117
Lunedì dalle ore 8.00
Martedì dalle ore 14:30
Mercoledì dalle ore 8:00
Giovedì dalle ore 14:30
Venerdì dalle ore 8:00
Dott. Incerrano
Riceve solo su appuntamento: telefonare da lunedì a venerdì 8:00 /10:30 Cell. 371.4321127
doc.incerrano@gmail.com per richieste ricette elettroniche o appuntamenti
Lunedì amb. di Albese 15:00/17:00
Martedì amb. di Tavernerio 9:00/11:00
Mercoledì amb. di Ponzate 15:00/17:00
Giovedì amb. di Albese 9:00/11:00

Venerdì amb. di Ponzate 9:00/11:00
Dott.ssa Benzi
Riceve solo su appuntamento: telefonare da lunedì a venerdì 8:30/9:30 Cell. 334.2746304
Lunedì 14:00 /17:00 Martedì 10:00 /13:00 Mercoledì 14:00/17:00 Giovedì 10:00 /13:00 Venerdì 10:00/13:00
Dott.ssa Faletti Riceve solo su appuntamento: telefonare da lunedì a venerdì 9:00/11:00 (risponde la segretaria) Cell. 324.7929432 - Solo ambulatorio ad Albese Lunedì 15:30/ 18:30 Martedì 10:00/13:00 Mercoledì 15:30/18:30 Giovedì 10:00/13:00 Venerdì 9:00 /12:00
Dott. Micieli Riceve solo su appuntamento: telefonare da lunedì a venerdì 8:00/10:00 Cell. 335.5344517 Lunedì dalle ore 15:00 Martedì dalle ore 8:00 Mercoledì dalle ore 15:00 Giovedì dalle ore 15:00 Venerdì dalle ore 8:00
Dott.ssa Spagnoli Riceve solo su appuntamento: telefonare da lunedì a venerdì 8:00 /10:00 Cell. 329.3293630 - Solo ambulatorio di Albese Lunedì 9:30 /12:30 Martedì 14:30/19:00 Mercoledì 9:30/12:30 Giovedì 15.00 /19:00 Venerdì 9:30 /12:30
Dott.ssa Cristini Riceve solo su appuntamento: telefonare da lunedì a venerdì 8:00/9:00 Cell. 338.6529401 Ambulatorio in via Risorgimento, 2a Tavernerio Lunedì 10:00/13:00 Martedì 10:00/13:00 Mercoledì 17:00/19:00 Giovedì 10:00/13:00 Venerdì 14:00 /17:00
Tavernerio
Sabato 17.30Domenica 8.30 – 10.30 – 17.30 Solzago Sabato 18.00 Domenica 11.00 Ponzate Sabato 17.00 Domenica 10.00 Urago Padri Saveriani Domenica 7.30 – 9.00