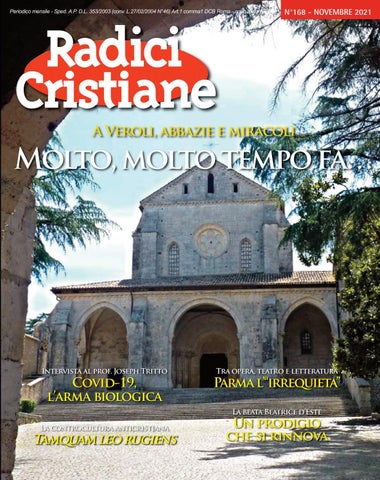11 minute read
Quell’”arlìa” leggera di Stefano Torelli
by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale



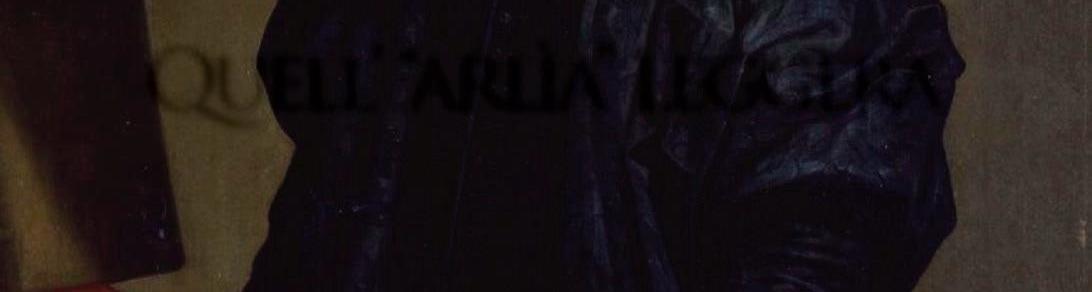

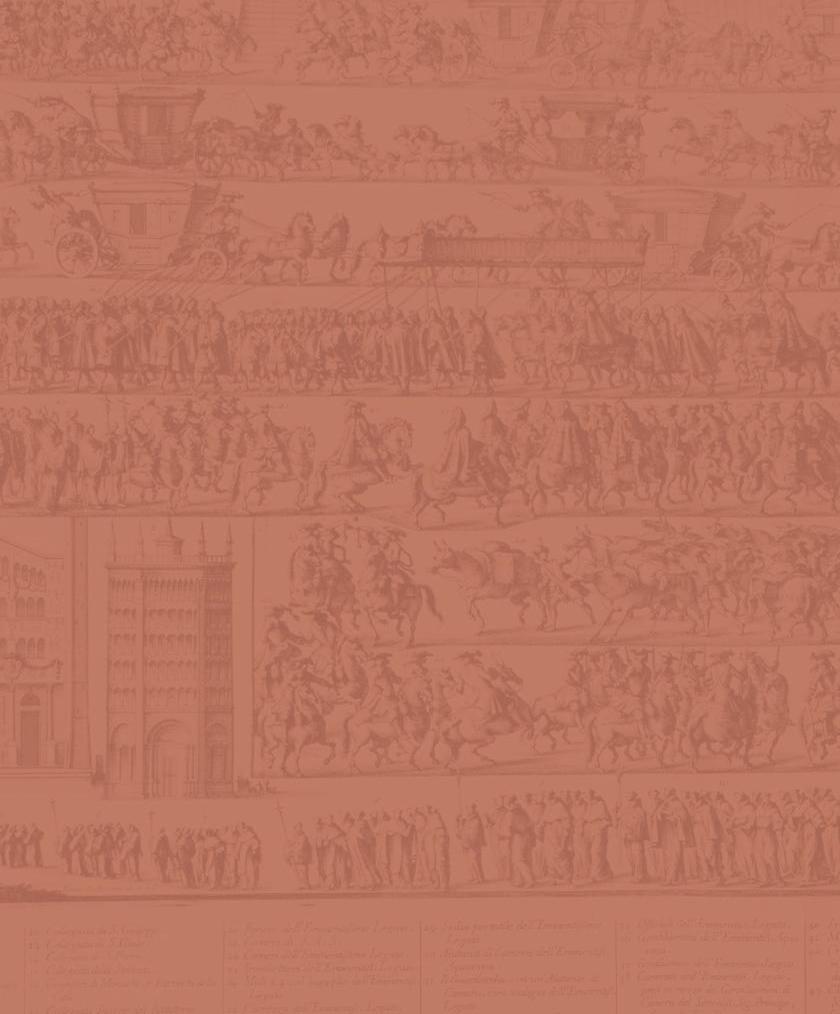
Pare che il testo più antico reperibile in dialetto sicuramente parmigiano sia quello annotato alla fine del Cinquecento dal conte Pomponio Torelli (nella foto), apprezzato tragediografo in lingua italiana, latinista, precettore del duca Ranuccio Farnese.

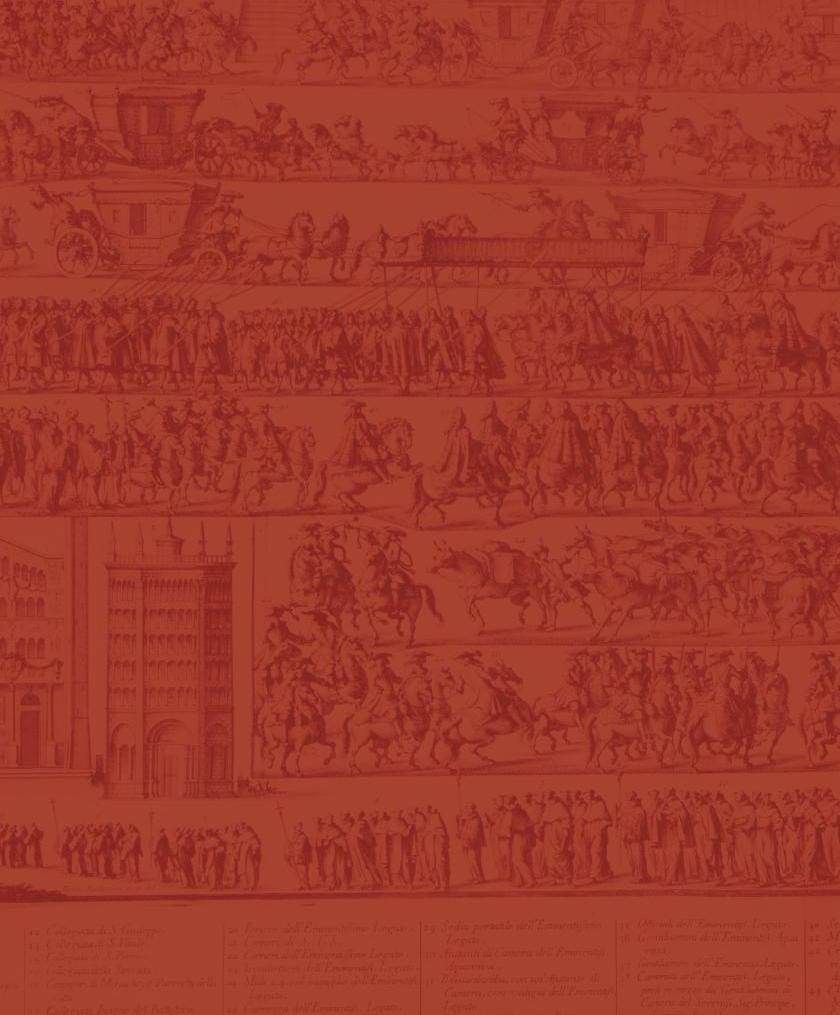
Quell’’ “arlìa” leggera
Nessun forestiero si aspetta che esista una “letteratura dialettale parmigiana”. E invece c’è. Complessa, compresa da pochi, tuttavia razionale e coerente. È ricca di bozzetti, paesaggi, quadretti di costume, dialoghi familiari, strofette e proverbi. Con una decisa prevalenza di quella che si chiama “arlìa”, un’ironia leggera, un modo di prender le cose sdrammatizzante, una presa in giro arguta e alla buona.
Stefano Torelli
Come scrivere il dialetto? È una parlata gallo-italica, piena di nessi consonantici impossibili, vocali nasali, enclitiche ed elisioni; per secoli si è tentato di metter su carta questi suoni bisbetici come si riusciva, al punto che dei documenti più lontani nel tempo non riusciamo a capire se si tratti davvero di parmigiano.
Né “Parma”, né “Pèrma”, ma “Pärma”
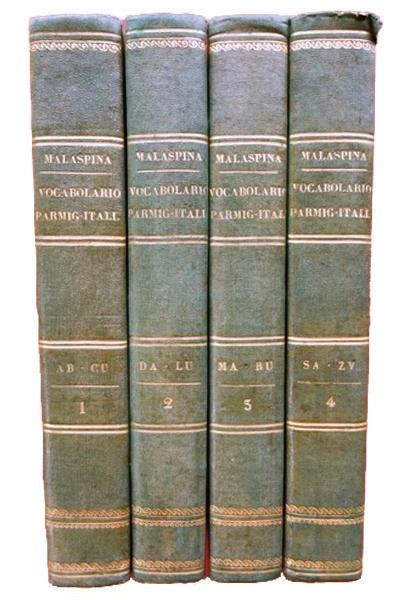

Malaspina, nel grande dizionario ottocentesco che tentò per la prima volta di registrare seriamente il lessico, non seppe che pesci pigliare e si arrabattò come poté. In particolare, sembra che nessuno sapesse bene come trascrivere il suono della “a” tonica palatalizzata, che compare, tra l’altro, nel nome indigeno della città. È sostanzialmente il suono misto tra A ed E che troviamo nell’inglese “cat”: né “Parma” né “Pèrma”. Dopo la II guerra mondiale, lo studioso della letteratura vernacolare Jacopo Bocchialini normalizzò la grafia in un sistema grosso modo rispettato tuttora, ispirato all’ortografia tedesca (ora il suono in questione si scrive “ä”). Il risultato è un sistema ortografico razionale e coerente, ma una pagina tanto piena di segni diacritici da sconcertare perfino il madrelingua, visto che chi usa il dialetto non è abituato a “vederlo”. Non parliamo poi di correggere delle bozze...come si dice da quelle parti, “gh’è da caväros j òc”- c’è da cavarsi gli occhi.
Recentemente il compianto glottologo cittadino Michelini ha proposto un sistema grafico alternativo, si vedrà. Tanta fatica, alla fine, per scrivere in una lingua tribale, che capiscono in poche migliaia? Sì, questo è l’altro grande limite della produzione letteraria in parmigiano: troppo pochi la comprendono. Ecco dunque l’occasione per render nota qualche curiosità storica e per dar omaggio a qualche bravo autore.
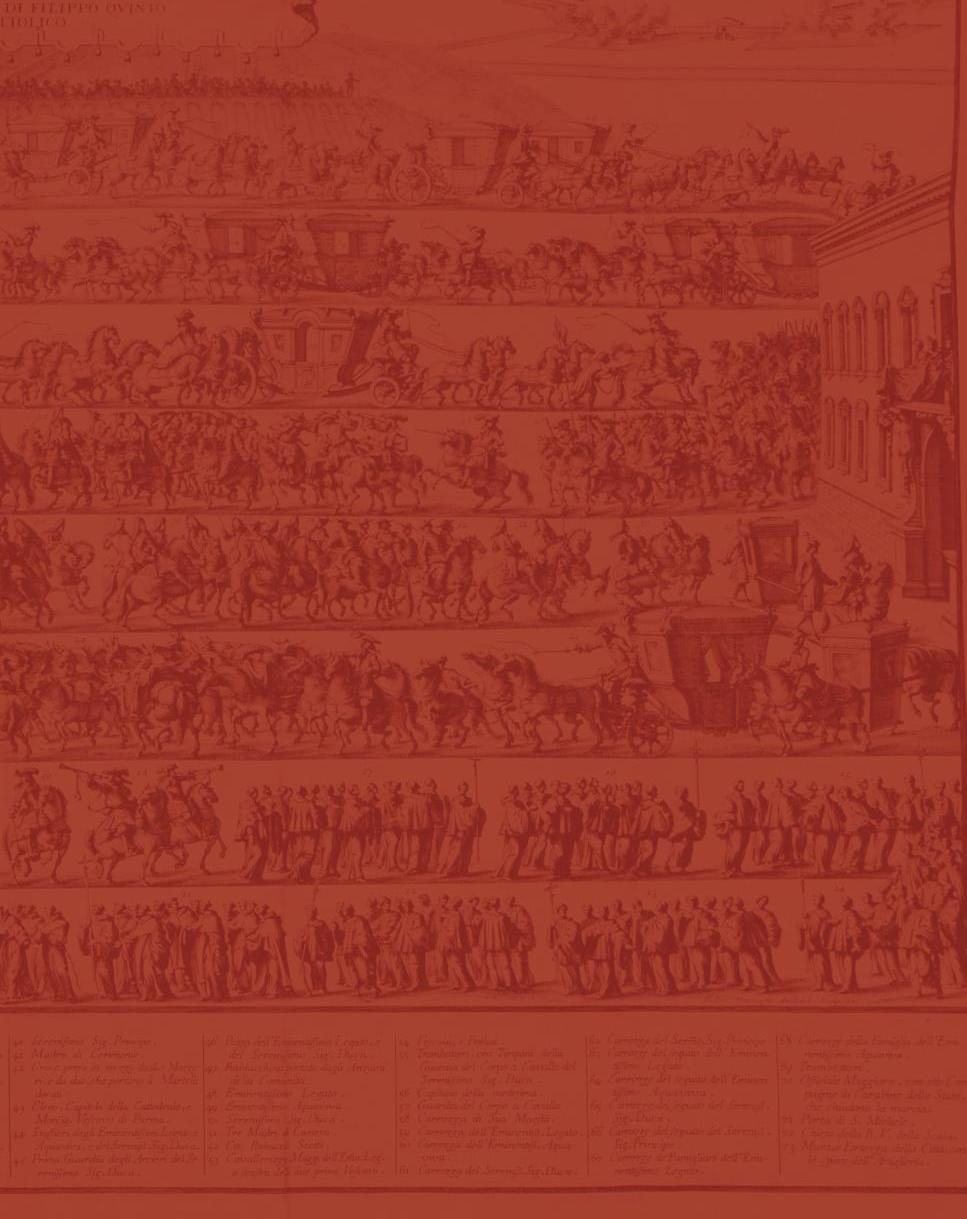
Il conte Torelli
A differenza di tante letterature, questa non inizia né con poesia religiosa, né con traduzioni. Anche nel seguito del suo sviluppo, non coltiva molto questi due filoni, potenzialmente fertili. E nemmeno tanti altri, almeno fino al Novecento inoltrato: in parmigiano non si scrive prosa; niente relazioni di viaggi, libri di ricette, favole o racconti. Nella poesia, a lungo mancano l’epica, la vera lirica d’ amore; nel teatro, manca la tragedia. Che cosa abbonda invece? Bozzetti, paesaggi, quadretti di costume,dialoghi familiari, lunario colmi di strofette e proverbi. I parmigiani dei secoli scorsi si rivolsero dunque spontaneamente alla lingua nazionale per i temi “alti”, rifluendo nel dialetto per argomenti più vicini, quotidiani, semplici. Con una decisa prevalenza di quello che chiamano “arlìa”, un’ironia leggera, un modo di prender le cose sdrammatizzante, una presa in giro arguta e alla buona.
Pare che il testo più antico reperibile in dialetto sicuramente parmigiano sia quello annotato alla fine del Cinquecento dal conte Pomponio Torelli, apprezzato tragediografo in lingua italiana, latinista, precettore del duca Ranuccio Farnese. Sembra scrivere quasi per scherzo o per scommessa, per dimostrare che si riesce a mettere per iscritto anche una fonetica tanto strana: V cherdiv al me signor Cont, Ch’anca mi dl volt s’a vliss Componer il lingua parmsana ch’an saiss... (Lo credete, signor conte? Che anch’io alle volte se volessi saprei scrivere in lingua parmigiana...).
Il primo poeta, Gaspare Bandini
Bisogna però aspettare il Settecento per avere i primi lunari in versi parmigiani e il primo vero poeta, Gaspare Bandini.
Come lingue divenute oggi ufficiali e nazionali (finnico, ceco), il parmigiano conosce il momento di gloria
Malaspina, nel grande dizionario ottocentesco che tentò per la prima volta di registrare seriamente il lessico parmigiano (nella foto), si arrabattò come poté, in particolare per la trascrizione della “a” tonica palatalizzata con un suono misto tra A ed E.



La duchessa Maria Luigia (nella foto, ritratta da Giovan Battista Borghesi, 18371839), pur austriaca e poi imperatrice di Francia, si è presa la briga d’imparare a parlare come i suoi sudditi e addirittura a scrivere un componimento semplice ma grazioso in rima, dedicato all’amicizia.

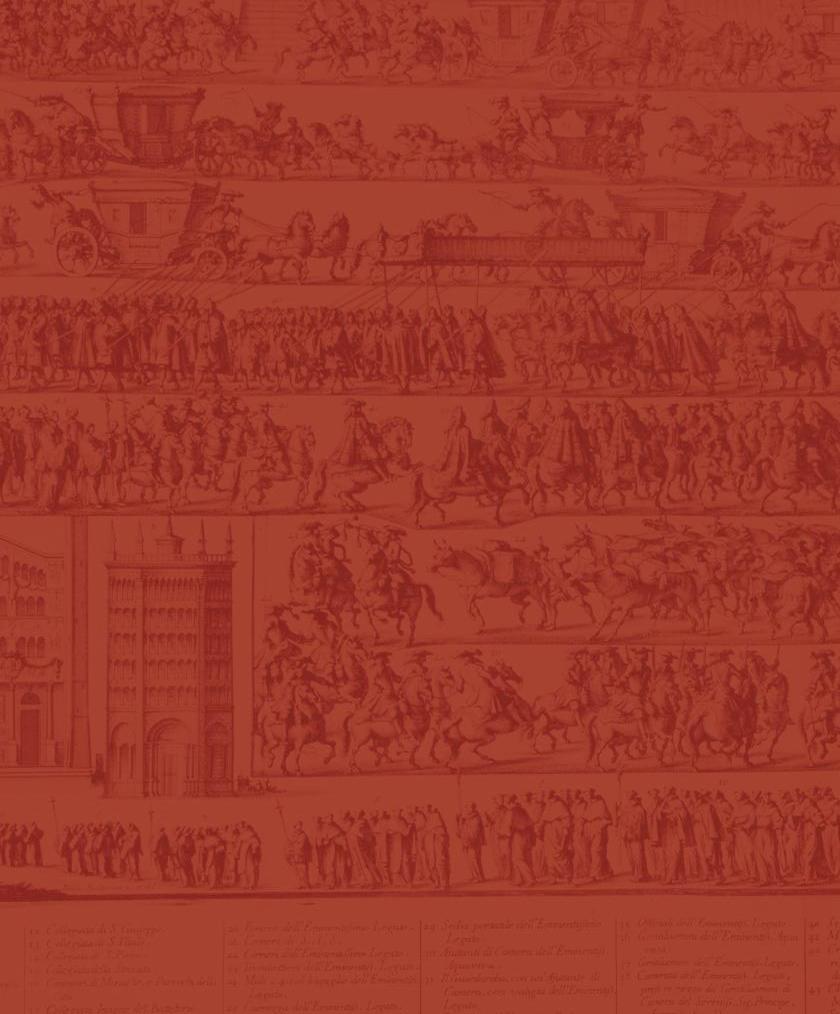

nell’Ottocento, dopo che il romanticismo ha innescato la voglia di valorizzare “l’anima dei popoli”. È l’epoca appunto del primo grande dizionario, il Malaspina, l’epoca in cui si scrive in parmigiano per il teatro dei burattini, per rime burlesche e sonetti satirici. Si cimentano col dialetto storici, bibliotecari, nobili. Sorpresa! L’amatissima duchessa Maria Luigia, pur austriaca e poi imperatrice di Francia, nel suo glorioso regno (1816-1847) si prende la briga d’imparare a parlare come i suoi sudditi e addirittura a scrivere un componimento semplice ma grazioso in rima, dedicato all’amicizia, che così inizia: L’amiçizia, don del Sgnór
La n’ consola in tel dolor:
L’ un guadagn del vint per çent
Quand’ a ghem äl coeur content (...)
Contemporaneo della duchessa è Giuseppe Callegari, che scrive rime satiriche molto spinte, oggi diremmo border line, al limite dell’accettabile nel suo contesto sociale.
La pugnata di sold
Quando arriva una traduzione di testi famosi, non si tratta di versione fedele. L’archivista di Stato, come la duchessa morto nel 1847, il coltissimo Tommaso Gasparotti, trasporta l’Aulularia di Plauto alla Parma dei suoi giorni, intitolandola La pugnata di sold. Per la prima volta si vede la volontà di scrivere veramente come parlava la gente comune, a parte le citate approssimazioni fonetiche: -Cosa val sti gamber? - Des sold. - Corpo! Sti prezzi? I n’en per mi. Stema a ved’r al marluzz. -Quatordez sold - A ne s peul viver!
Una generazione dopo, Francesco Scaramuzza (1803-1886), pittore famoso su temi della Divina Commedia, volle mettere in versi una parafrasi dell’episodio del conte Ugolino, ricalcando un suo quadro di grande successo. Un estratto, in grafia modernizzata:
J’erom za in pè e l’ora s’avzinäva
Ch’J eron solit a där’s còl po’ d’ magnär,
Mo pr’al insònni scadagnón pinsäva
Mäl. Tutt in t’ na volta a s’ sintì sarär
Ch’ l’uss maladètt, zo in t’al torión da bas...

Batistén Panäda
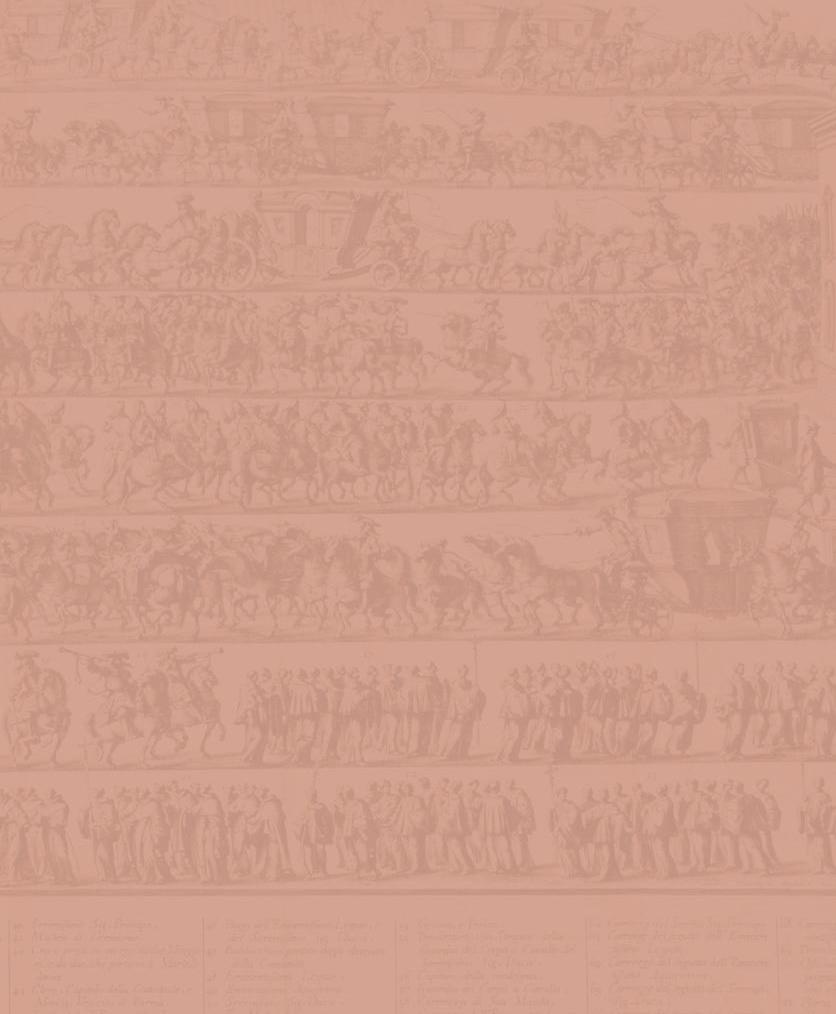
Il maggior poeta in parmigiano nel XIX secolo è Domenico Galaverna, dalla lunga vita protratta fino al 1903. Inventore del “parmigiano tipo” Batistén Panäda, fa vivere al suo personaggio varie situazioni trattate con bonaria ironia, che forniscono una dettagliata visione della società parmense di allora. Da una sua raccolta di altre rime edita nel 1870, con la grafia approssimativa di allora:
Desgrazia è nasser goeub o tartajón
O con l’istint d’andar in tì bagord,
‘na gran desgrazia è essr un’ imbrojón
O essr’ o tropp avar o tropp ingord:
Ma la pu gran desgrazia ch’poeul toccar
A un pover diavel ch’nassa a stè mond chi l’è colla d’invisciars e po sposar
‘na donna caprizioeusa in tì vestì, amanta dal teatr’ e conversar....
Dopo aristocratici, pittori, archivisti, si cimentarono col dialetto anche un grande orientalista cittadino, Italo Pizzi, uno stimato chirurgo, il prof. Monguidi, il medico Gambara, continuatore di traduzioni dantesche, lo scienziato e docente Pizzetti, il missionario in Cina, Padre Bertogalli. Insomma, non è il popolo che scrive nella propria lingua: coltivare il dialetto è soprattutto un lodevole passatempo poetico degl’intellettuali.
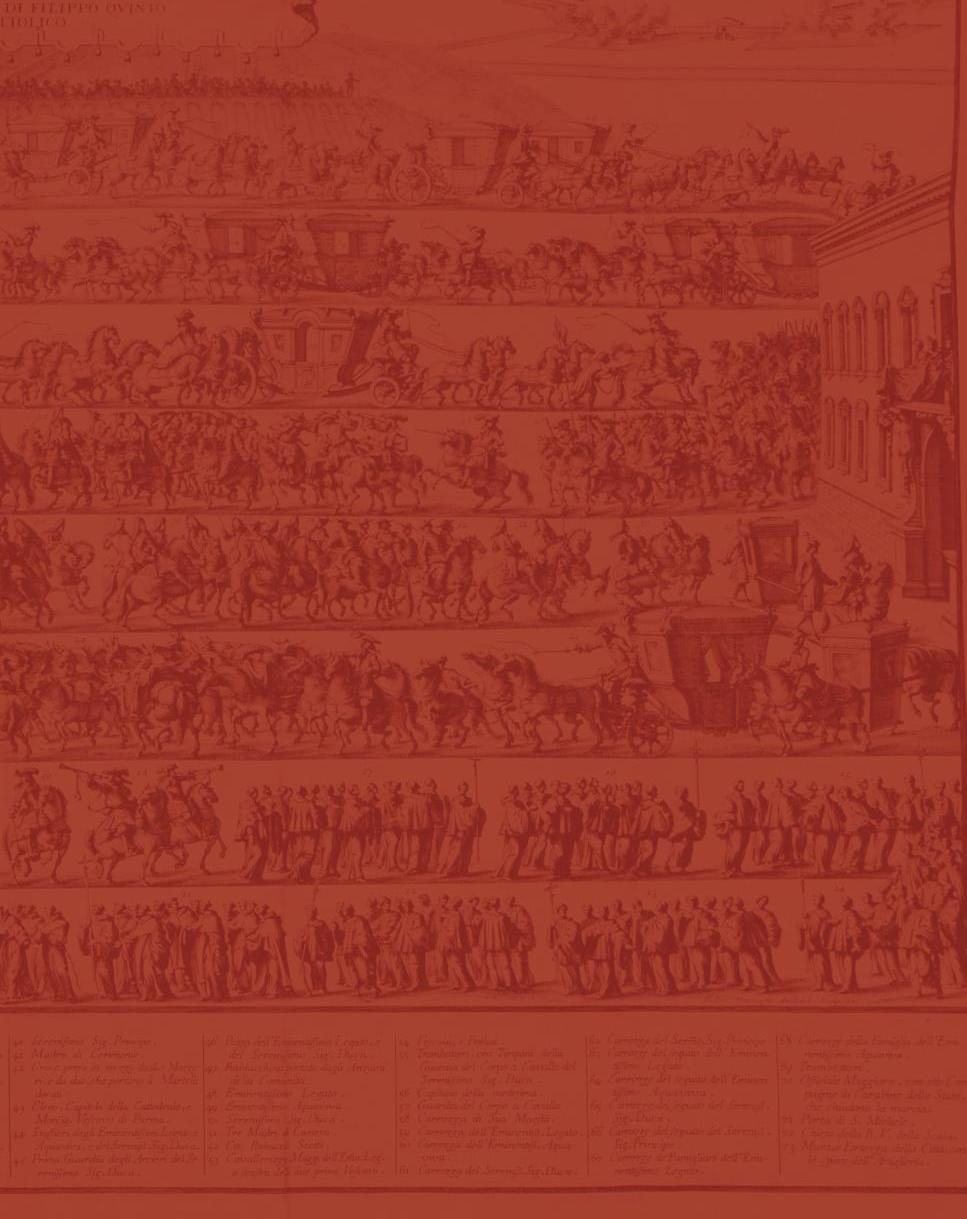
Ferrari, burattinaio e poeta
Però c’è sempre l’eccezione: non viene dalle classi “colte” il famosissimo burattinaio Italo Ferrari (1877-1961) - Parma è sede di un importante museo dedicato ai burattini. Non scrisse solo testi per i suoi personaggi, ma anche poesie di ampio respiro. Ecco versi tratti dal suo Avtón, l’autunno: E pian pianén a fnissa anca l’avtón,
E ‘l föji an lôr i van pian pian al vent,
E la téra l’è straca e con ragión,
Mo i la rugän ancora e l’è un torment.
Adess j’àn inventè anca i motor,
E a pär ch’i vöjen fin cavär al cör
Si accosta finalmente alla poesia seria, non solo giocosa, Giovanni
Casalini (1878-1969), nome significativo a livello cittadino:
La tera e ‘l cel j en griz. In-t-al me cör
A gh’è soltant na gran malinconia
Pärchè ‘t si andäda via,
Speransa dla me vitta, ultim amor....
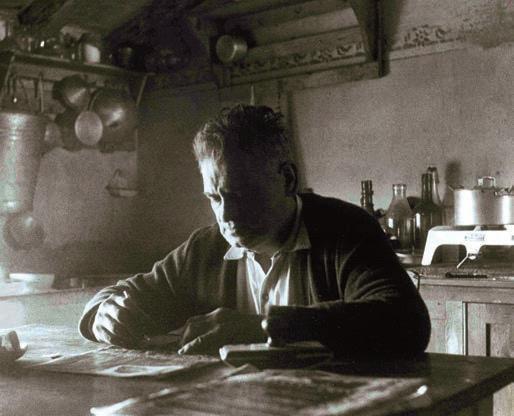

Il maggior poeta in parmigiano nel XIX secolo è Domenico Galaverna (nella foto, su licenza Creative Commons, la targa nel centro di Collecchio). Inventore del “parmigiano tipo” Batistén Panäda, fa vivere al suo personaggio varie situazioni trattate con bonaria ironia.
Alfredo Zerbini (nella foto), bibliotecario in Palatina, si è cimentato in un’opera dalle dimensioni ambiziose per il dialetto locale, un poema storico, che racconta di quando il duca Ranuccio Farnese fece fuori la migliore aristocrazia del ducato, accusandola di cospirazioni forse da lui stesso inventate.



Giorgio Torelli (nella foto) scrive in prosa parmigiana. Dopo aver introdotto larghi brani in dialetto nel romanzo storico La Parma voladora, nel 2018 ha pubblicato (vera traduzione integrale, non adattamento, né parafrasi) il Vangelo secondo Marco.

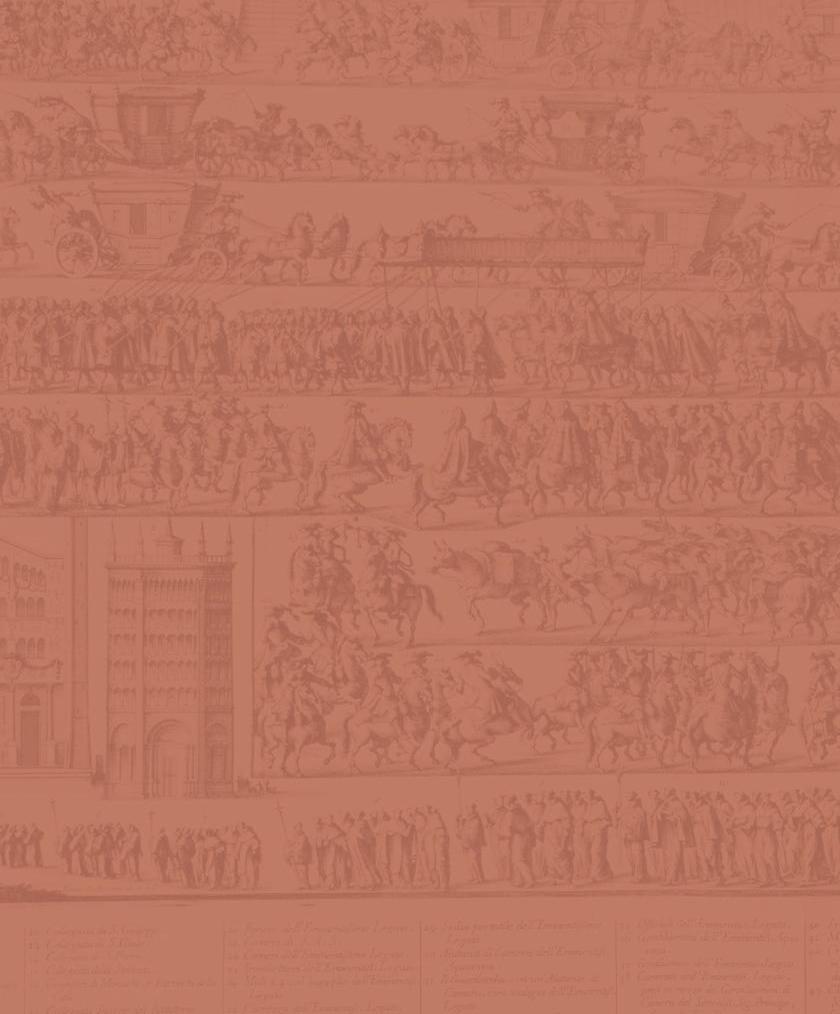

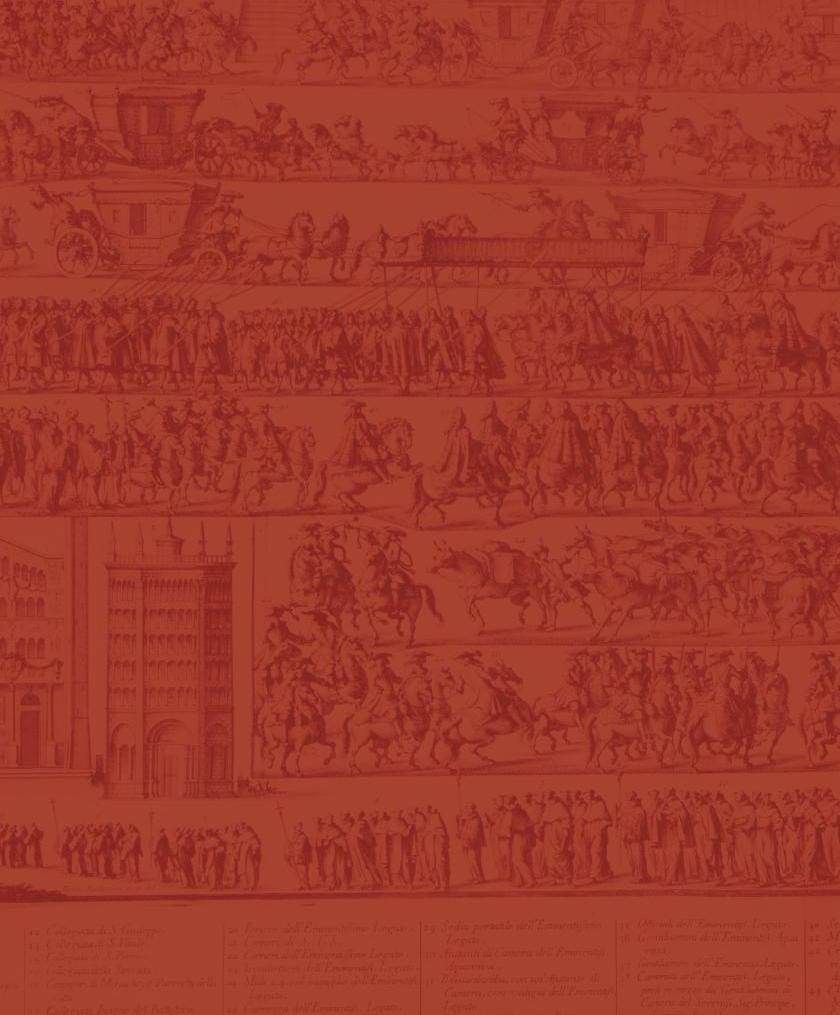
Il primo poema storico
Alfredo Zerbini (1895-1955), bibliotecario in Palatina, è figura di riferimento a metà del secolo. Si cimenta in un’opera dalle dimensioni ambiziose come mai prima per il dialetto locale, un poema storico, che racconta di quando il duca Ranuccio Farnese fece fuori la migliore aristocrazia del ducato, accusandola di cospirazioni forse da lui stesso inventate ad hoc: La congiura di Fevdatäri. È assai vasta e diversificata la produzione zerbiniana, in parte innovativa: componimenti drammatici, malinconici, pensierosi (molto ricordata a Parma è per esempio la lunga scena dialogica La nona a l’ospedalén), accanto peraltro a versi che proseguono nel modo più felice la consuetudine bozzettistica ed ironica così tipica: ad esempio La gòssa (tutta una scena di suspence, per capire se cada o meno una gocca di muco dal naso!) o La bugäda, ottave che riproducono l’inarrestabile e quasi autorigenerante pettegolezzo di una lavandaia, che, facendo il bucato, sparla di mezzo mondo, finendo ogni strofa con l’esilarante L’è méj ch’ a täza (È meglio che taccia). In Zerbini si ha una quadratura del cerchio, la capacità di coniugare dialetto vivissimo d’Oltretorrente, realistico, colmo di frasi idiomatiche colte dal vivo ogni giorno, con una tecnica scaltrissima del verso.
Il grande poeta delle piccole cose
Per universale consenso, la poesia in parmigiano raggiunge l’apice con Renzo Pezzani (1898-1951), noto anche come autore in italiano. Le sue raccolte di componimenti dialettali s’intitolano Bornisi e Tarabacli (rimasugli di cenere e cianfrusaglie). Titoli che indicano la vena intimista, da poeta delle piccole cose, quasi un nuovo Pascoli - anche per l’abilità formale, che nulla ha da invidiare al contemporaneo Zerbini. Una maniera di poetare, che esercita un influsso ancora non cessato su chi scrive versi in dialetto, come mostrano poesie saltuariamente ospitate sulla gloriosa Gazzetta di Parma (in edicola dal 1756). La generazione educata sotto il fascismo viene costretta a vedere il dialetto come lingua dei poveri, da non sfoggiare “in società”: dal dopoguerra, fenomeno certo non solo emiliano, l’uso vivo ha una regressione mai verificatasi nel millennio precedente. Encomiabili compagnie filodrammatiche aiutano la lingua degli antenati a “tener duro”, fan sì che i giovani abbiano almeno nell’orecchio una competenza passiva: commedie come Al fjól d’la serva o A la bersagliera devono averle prima o poi viste tutti, in città e dintorni. Manca spazio per citare le iniziative oggi in corso per insegnare, scrivere, valorizzare il parmigiano: non più solo dal vivo o sulla stampa, ma anche sui nuovi media, da Internet a Youtube. Novità recente della letteratura locale: in contrasto con quanto viene prima, Giorgio Torelli (1928) scrive in prosa. Dopo aver introdotto larghi brani in dialetto nel romanzo storico La Parma voladora, nel 2018 ha pubblicato (vera traduzione integrale, non adattamento, né parafrasi) il Vangelo secondo Marco, incredibilmente il primo libro della Bibbia nella storia letteraria parmigiana. La quale, iniziata forse per celia con un Torelli, arriva così, per ora, a chiudere il cerchio con un altro Torelli.