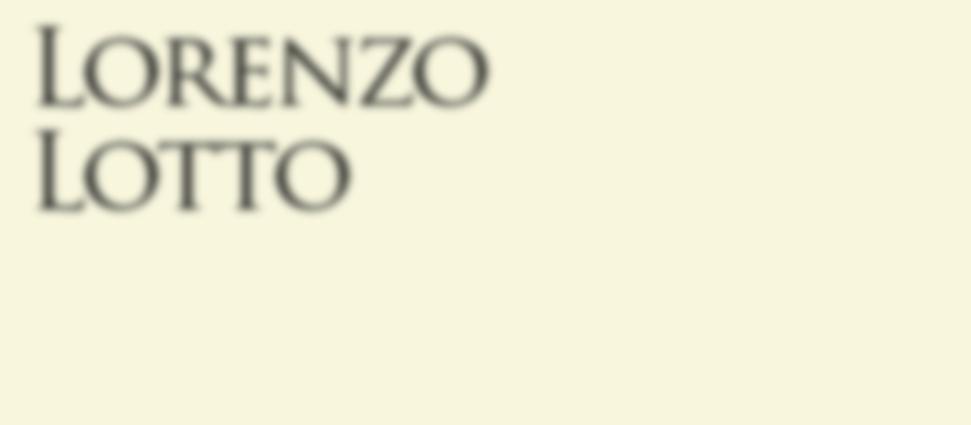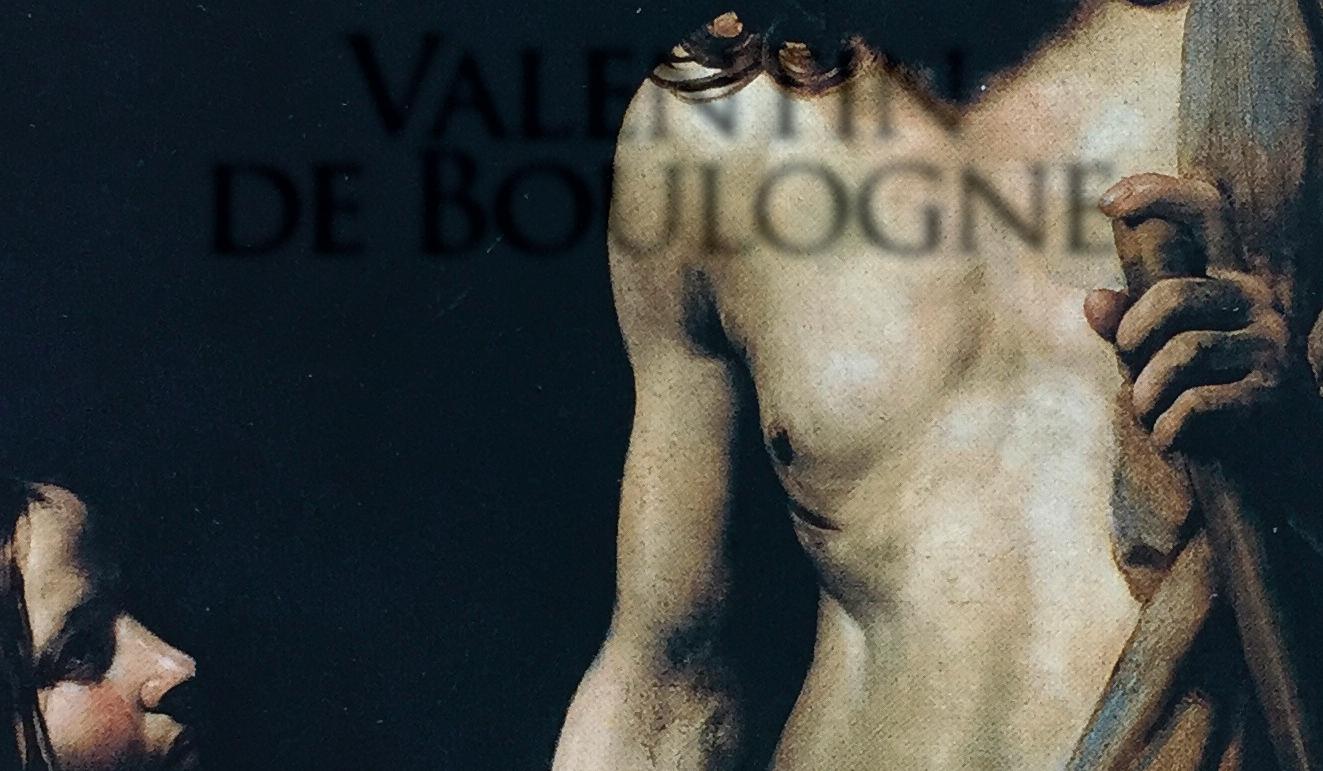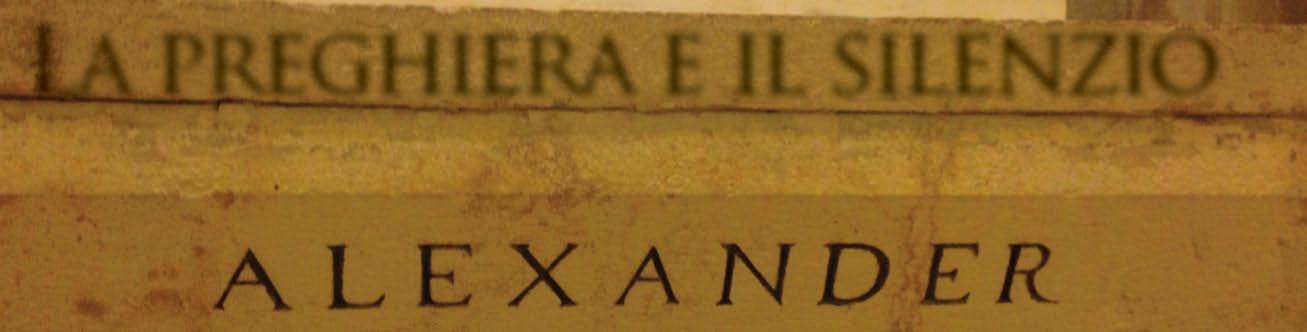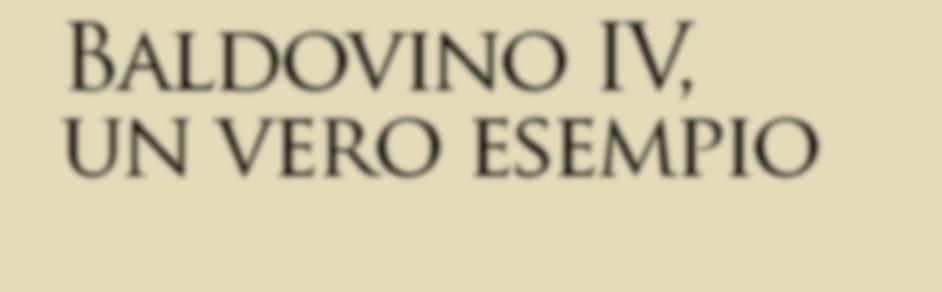5 minute read
Letture consigliate a cura di Gianandrea de Antonellis
by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale



Francesca Alexander La storia di Ida
Solfanelli, Chieti 2011, p. 96, € 8
Francesca Alexander Storie molto antiche
Solfanelli, Chieti 2014, p. 96, € 8
Francesca Alexander (1837-1917), artista americana naturalizzata italiana, si trasferì nel 1853 con la famiglia da Boston a Firenze. Studiosa di tradizioni popolari, raccolse i canti della Toscana e si dedicò alla poesia religiosa.
La casa editrice Solfanelli ne propone un romanzo breve, Storia di Ida, ed una raccolta di racconti. Nella narrazione degli ultimi anni di vita della cattolicissima Ida, la Alexander dimostra un’originale maestria stilistica unita a un profondo richiamo per quelle luci spirituali ravvisabili anche nella più cruda quotidianità. L’azione è lo specchio di quella stessa vasta opera di carità effettivamente svolta dalla scrittrice a favore dei poveri e degli umili.
L’altro volume, un’antologia tratta dalla raccolta I servi nascosti e altre storie molto antiche (1901), propone i racconti Il crocifisso della Providenza, La vecchia cantastorie, I lupini e Suora Marianna, notevoli per il perfetto equilibrio tra narrazione e poesia. Chiude l’antologia il racconto, La Sorellaccia – mai edito in volume nemmeno in America – il miglior scritto di Francesca Alexander assieme alla Storia di Ida, in cui il realismo dello stile si fa ancora più ardito, per il cambio di scena, senza soluzione di continuità, tra la dimensione terrena e quella celeste.
Nicola Bux Con i sacramenti non si scherza
Cantagalli, Siena 2016, p. 224, € 17
La Chiesa pare voler dissolvere i contorni netti della fede in una sorta di brodo indeterminato e rimescolato dal “secondo me” di certi sacerdoti. Ebbene, della Fede, i Sacramenti sono l’espressione, il frutto, il dono più alto e prezioso. Don Nicola Bux affronta il tema con la passione consueta e per ognuno dei sette Sacramenti chiarisce l’oggetto, il significato, la storia. Poi mette in guardia dalle moderne deformazioni, dagli equivoci dell’interpretazione contemporanea. In una parola, mette in guardia dalla «svolta antropocentrica che ha portato nella Chiesa molta presenza dell’uomo, ma poca presenza di Dio», una Chiesa in cui la sociologia ha sostituito la teologia, l’orizzontale ha eliminato il verticale, la profanità ha scacciato la sacralità. Lo stessa autore ricorda: la liturgia odierna è, di fatto, “di spalle a Dio”.
Ma è un errore molto grave, come ha scritto anche Benedetto XVI: «Se la liturgia appare anzitutto come il cantiere del nostro operare, allora vuol dire che si è dimenticata la cosa essenziale: Dio. Poiché nella liturgia non si tratta di noi, ma di Dio. La dimenticanza di Dio è il pericolo più imminente del nostro tempo. A questa tendenza la liturgia dovrebbe opporre la presenza di Dio. Ma che cosa accade se la dimenticanza di Dio entra persino nella liturgia, se nella liturgia pensiamo solo a noi stessi? In ogni riforma liturgica e in ogni celebrazione liturgica, il primato di Dio dovrebbe sempre occupare il primissimo posto». Dio e il suo Sacrificio salvifico, non certo la predica del celebrante…
Antonio Casera Servo di Dio Padre Rocco Ferroni. Un umile ed esemplare figlio di San Camillo
Editrice Velar, Gorle 2016, p. 48, € 4
Vi sono figure poco note eppure esemplari di sacerdoti, che han saputo vivere santamente il proprio ministero: una di queste è Padre Rocco Ferroni, della cui vita parla in un’agile pubblicazione un suo Confratello, il camilliano Padre Antonio Casera.
Padre Rocco Ferroni nacque a Marzana, a pochi chilometri da Verona, il 30 ottobre 1856. Sin da piccolo rivelò una docilità non comune, profonda devozione nella preghiera ed una spiccata inclinazione alla pietà.
All’età di dieci anni fu affidato per i corsi ginnasiali ai Camilliani di Santa Maria del Paradiso, qui giunti dopo la legge di soppressione di tutti gli Ordini religiosi. Il 29 novembre 1869 entrò come aspirante nella loro casa. Compiuti gli studi, venne ordinato sacerdote a Mantova il primo maggio 1879: «Padre Rocco vivrà la prima Santa Messa come l’ultima: semplice, raccolto, umile, tutto di Dio, senza turbarsi. Capiva che l’Altare è un calvario, la Messa un sacrificio e il sacerdozio un’immolazione».
Nominato assistente dei giovani postulanti, li invitò a praticare la virtù del silenzio: «Si parla troppo e a voce alta, gran difetto. Chi più parla con gli uomini, meno parla con Dio». Da maestro dei novizi e dei chierici professi, fu d’esempio prima di tutto con la pratica assidua delle virtù: chiese loro amore alla preghiera ed alla meditazione. Dal 1888 al 1928 fu superiore in diverse comunità camilliane veronesi ed a Cremona. Migliaia di fedeli lo videro passare innumerevoli volte nell’umile servizio di condurre i defunti all’ultima loro dimora, quella eterna, pregando poi e compiendo sacrifici di suffragio per le anime del Purgatorio: «Èsolo dinanzi al pensiero della morte che si impara a far le cose per bene», era solito dire.
Il sereno trapasso giunse per lui nel mese mariano per eccellenza, il 13 maggio 1939. Tra tutti rifulse la semplicità esemplare della sua vita santa, tanto da esser definito «un Vangelo vivente». (Mauro Faverzani)


Giovanni Battista Pighi La preghiera romana
Victrix, Forlì 2012, p. 130, € 15

Il filologo Giovanni Battista Pighi (1898-1978), vice-rettore dell’Università di Bologna e uno dei massimi latinisti del Novecento, ha affrontato la religiosità del mondo antico in vari suoi studi. In questo saggio ci fa conoscere la religiosità romana attraverso le “parole sacre” con cui i Quiriti si rivolgevano agli dei.
Tutta la vita del Romano, dalla nascita alla morte, si svolgeva in continuo contatto con il trascendente e prevedeva atti di pietas, offerte e, soprattutto, preghiere. Plinio distingueva la preghiera di richiesta – proteggere da malattie e pestilenze, rendere fertile la terra o feconda la sposa – da quella di proposta, come nella pratica della devotio tipica della stirpe dei Decii (l’offerta di se stessi in battaglia per impetrare la vittoria). Fondamentale, però, è il rispetto della ritualità: per evitare che la preghiera sia inefficace o addirittura empia, bisogna recitarla certis verbis, seguendone con scrupolosità il testo e pronunciando le parole a bassa voce o solo mentalmente. L’omissione di un termine o di un errore di pronunzia rendevano nullo il sacrificio, determinando la necessità della sua ripetizione, fino alla sua perfezione rituale. Inoltre, agli dèi ci si poteva rivolgere solo in condizione di purità dell’animo e del corpo. Insomma, è un elemento della religiosità romana che è entrato in quella cristiana: silenzio durante le cerimonie, purezza per ricevere i Sacramenti e non sminuirli come un semplice atto formale. I Romani seguivano con attenzione tutte queste regole, come le ha seguite anche la celebrazione eucaristica fino all’introduzione del novus ordo, che ha permesso ai celebranti di venire incontro ai “gusti del pubblico” e di banalizzare, in certi casi, la celebrazione.