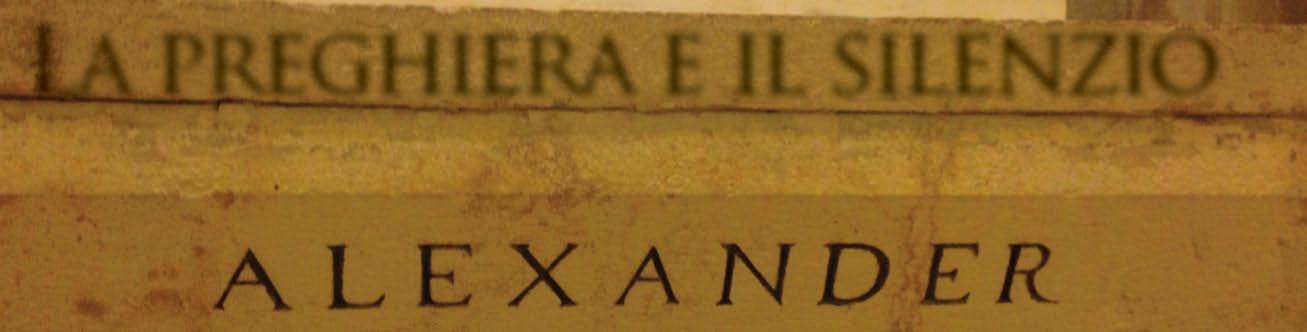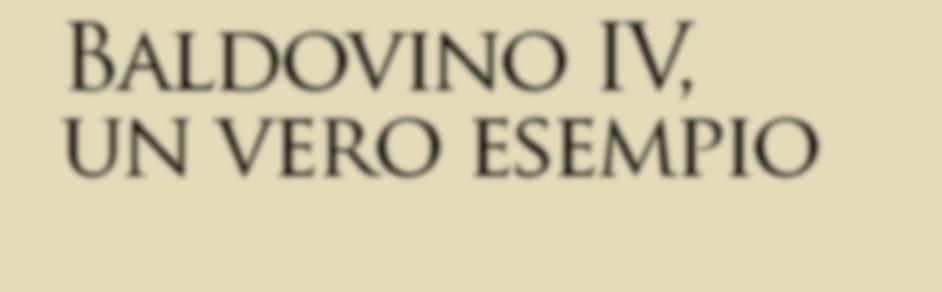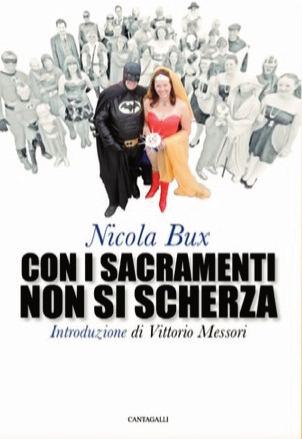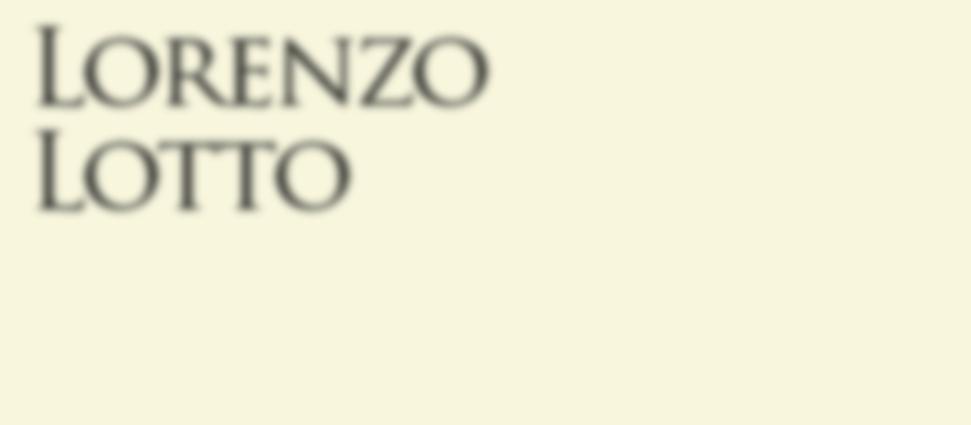6 minute read
Valentin de Boulogne di Michela Gianfranceschi
by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale
Valentin de Boulogne
Il 7 ottobre a New York si è aperta la prima mostra monografica mai realizzata sul pittore francese Valentin de Boulogne, annoverato tra i seguaci di Caravaggio, attivo a Roma fino ai primi anni Trenta del Seicento.
di Michela Gianfranceschi

Valentin de Boulogne, Cristo risorto e Maria di Magdala, 1620 circa, Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria. Artista di altissimo valore, di potente espressività, tanto da poter essere iscritto in quel gruppo ristretto di aderenti alla maniera caravaggesca, non epigoni ma continuatori di una visione estetica, Valentin de Boulogne (Coulommiers-en-Brie 1594 – Roma 1632) deve la scarsa conoscenza del suo nome presso il grande pubblico alla breve carriera artistica – essendo morto a soli 38 anni – ed al conseguente esiguo numero di opere del suo corpus. Sono solo 60 i dipinti a lui riferibili, gran parte dei quali oggi esposti negli spazi del

Valentin de Boulogne, Cristo e l'adultera, 1620-1622, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum.

Angelo, affresco navata centrale, particolare. Metropolitan Museum di New York a partire dai primi di ottobre fino al 16 gennaio 2017, nella prima rassegna monografica a lui dedicata.
La mostra, realizzata dal museo newyorkese in associazione con il Musée du Louvre, si sposterà dal 20 febbraio al 22 maggio 2017 nella capitale francese, offrendo la possibilità anche al pubblico europeo di approfondire la conoscenza del grande pittore. I curatori Keith Christiansen, Presidente del Dipartimento di pittura europea John Pope-Hennessy al Met, e Annick Lemoine, studiosa francese, autrice di una monografia su Nicolas Regnier, pittore contemporaneo di Valentin, si sono riallacciati, proseguendone il discorso, alla storica esibizione tenutasi nel 1973 presso l’Accademia di Francia a Roma e al Grand Palais di Parigi, esibizione che aveva riportato alla luce alcuni tra i più interessanti seguaci francesi del Caravaggio, tra cui appunto il nostro Valentin. In quel caso la sua figura di artista, analizzata dalle abili penne dei curatori della mostra, Arnauld Brejon de Lavergnée e Jean-Pierre Cuzin, prendeva vita grazie a un compendio della sua biografia e ad esempi eccellenti delle opere del suo catalogo.
«La vera naturalezza»
L’atto di morte di Valentin fu ritrovato da Roberto Longhi nel 1935 ossia tre secoli dopo il decesso del pittore: «Mensis Augusti 1632: Anno et mense ut supra die vero 20 sepultus fuit in nostra ecclesia Monsu Valentinus gallus e Bolognia ex provincia brie, Pictor famosus etatis sue an-
norum 38 habuit omnia sacramenta habitavat in via Margutta». Il pittore trascorse quasi tutta l’esistenza a Roma, ove giunse dalla Francia giovanissimo nel 1613, secondo quanto ci racconta l’artista e biografo tedesco Joachim von Sandrart, che sembra fosse anche suo amico. Eppure di questi primi anni si ha una documentazione solo proveniente dagli Stati delle Anime ossia i registri parrocchiali, documentazione che illumina parzialmente sulle vicende biografiche ma non sull’attività artistica, non essendo il pittore menzionato nel celebre scritto (1617-1621) del colto archiatra pontificio Giulio Mancini o nella corrispondenza del mecenate delle arti, il marchese Vincenzo Giustiniani, profondo estimatore di pittura caravaggesca. Valentin alla pari di artisti quali Bartolomeo Manfredi, Carlo Saraceni, Jusepe Ribera, Gerrit van Hontorst, Simon Vouet, è riscoperto negli scritti biografici di Giovanni Baglione (1642), Giovan Pietro Bellori (1672), Filippo Baldinucci (1681) e del citato Sandrart (1675-1679).
Fu un pittore dal tocco estremamente caratterizzato, forte nell’espressione e al tempo stesso di solida struttura disegnativa: il naturalismo nelle sue opere è un concetto elaborato e compreso, che emerge chiaro nelle belle figure delineate dal maestro, grazie all’uso di un colore caldo e pastoso, in grado di descrivere ispirate scene sacre, così come i vari soggetti legati alla vita popolare. A proposito della pittura del Valentin, Sandrart usa i seguenti termini efficacissimi: «la vera
Valentin de Boulogne, Cacciata dei mercanti dal Tempio, 1618, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini.

Valentin de Boulogne, Martirio dei santi Processo e Martiniano, 1629, Citta del Vaticano, Musei Vaticani. naturalezza, la forza, il risalto del colorito, l’armonia dei colori».

Illustri estimatori
Nell’Urbe sono noti i rapporti del francese con il suo più importante mecenate, il card. Francesco Barberini, nipote di papa Urbano VIII, il quale negli anni Venti del Seicento, in un momento in cui il caravaggismo stava già perdendo mordente, gli commissionò numerose opere. Tuttavia il linguaggio di Valentin si fa apprezzare anche nel pieno della fioritura classicista e barocca, grazie a un’impareggiabile armonia delle forme e al ricercato equilibrio compositivo delle scene raffigurate. La sensibilità dimostrata dall’artista nei confronti della cultura classica definisce chiaramente la sua pittura, di cui si segnala una piacevolissima alternanza tra naturalismo e rimandi all’antico. Le sue opere furono ammirate dai contemporanei del pittore, così come dai grandi collezionisti e amatori d’arte del XVIII secolo. Tra i suoi più illustri estimatori ricordiamo il principe di Carignano, il coltissimo collezionista Crozat, il duca d’Orléans e perfino Luigi XV, il quale acquistò per le reali collezioni i quadri del Valentin, garantendo per sempre alla sua opera un posto nel pantheon dell’arte francese.
Intorno agli anni Venti il pittore abitava nella zona di S. Maria del Popolo, tra i numerosi artisti fiamminghi, tedeschi e francesi che popolavano la zona; questi contatti umani e professionali, insieme alla vicinanza con il caravaggesco Bartolomeo Manfredi, fra tutti, produssero l’interesse di Valentin per alcune iconografie profane con raf-

figurazioni di momenti tratti dalla vita quotidiana, ad esempio scene di taverna con personaggi tipici intenti a giocare a carte o a brindare. Tuttavia la cultura classica e romana dell’artista compare anche all’interno di tali composizioni – che a prima vista sembrerebbero solo votate al realismo – con il frequente inserimento di are e sarcofagi istoriati, oltre ai numerosi simboli, fatti per dilettare gli intelletti più eruditi.
Magistrale arte sacra
Ma è nel catalogo delle opere sacre che Valentin tocca i più alti livelli qualitativi: la magistrale Cacciata dei mercanti dal tempio (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini), del 1618, in cui il gesto potente di Cristo si contrappone con grande pathos all’espressione dolente del volto, mentre condanna la decadenza dei costumi, o il Cristo e l’adultera (Los Angeles, The J. Paul Getty Museum) del 1620-1622, ove la descrizione delle emozioni dei protagonisti raggiunge livelli di alta poesia, con un’illuminazione teatrale e fortemente drammatica.
Il Martirio dei santi Processo e Martiniano (Città del Vaticano, Musei Vaticani, Pinacoteca), realizzato nel 1629 fu commissionato come pendant del Martirio di sant’Erasmo dipinto da Nicolas Poussin l’anno precedente, anch’esso conservato in Vaticano; qui Valentin dimostra tutta l’eccellenza del suo pennello, nel taglio compositivo e nella resa naturalistica e degli stati d’animo, offrendo un appassionato saggio di pittura caravaggesca, tra l’angelo in volo e gli spietati aguzzini al lavoro, bagnati da una luce fredda. Nella compostezza del volto dei martiri e dei dolenti ed in particolare dell’uomo barbuto che piange silenziosamente la morte del figlio, traspare una potente dichiarazione di fede cristiana.
Valentin de Boulogne, Il baro, 1615-1617, Dresda, Staatliche Kunstsammlungen Gemaldegalerie Alte Meister.