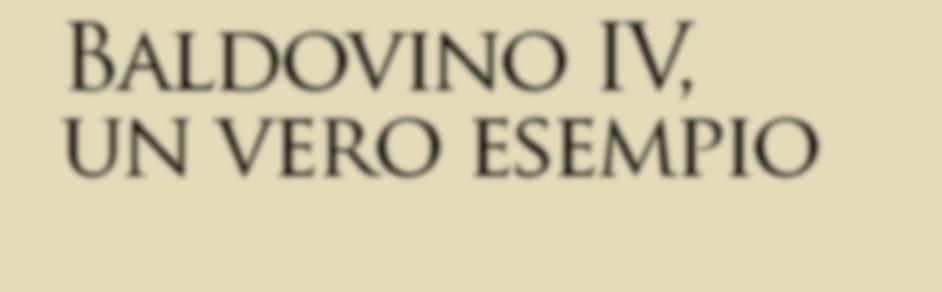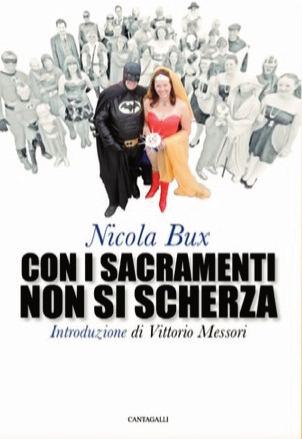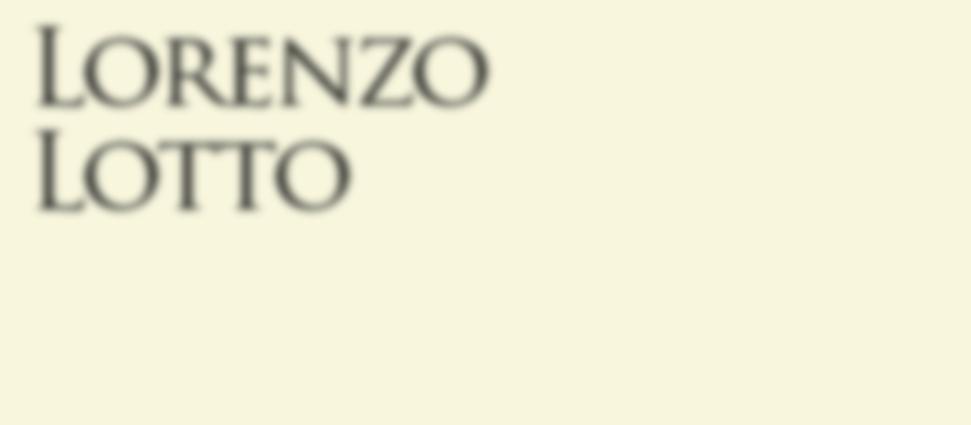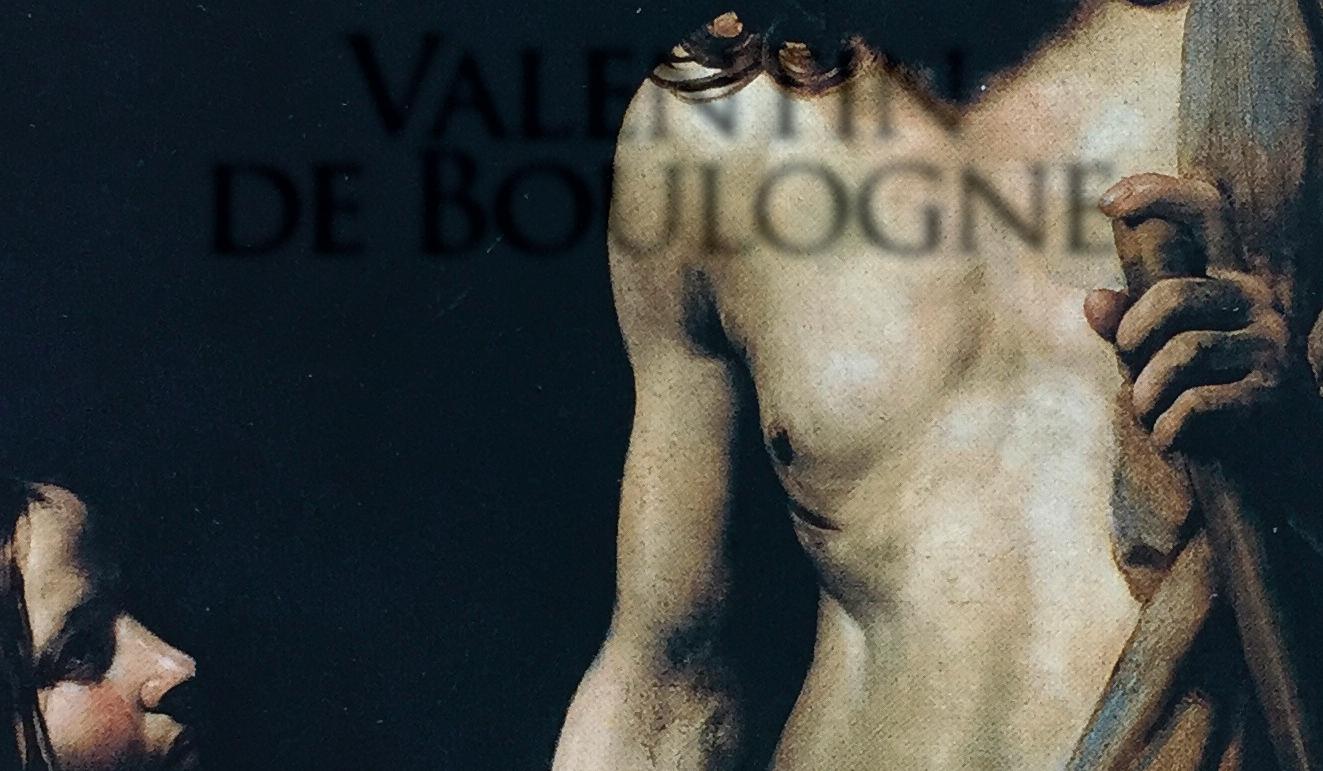3 minute read
La preghiera e il silenzio di Antonio Lambertini
by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale
La preghiera e il silenzio
Scendere nella cripta di una chiesa dà sempre una sensazione di ritorno al passato, ai secoli addietro della Cristianità; se poi si tratta di un mausoleo sepolcrale, riaffiora e si fonde a questa percezione l’idea della precarietà dell’esistenza, che ci invita a riflettere sul dono della Vita; se, infine, il sepolcreto custodisce le spoglie dei duchi di Parma e Piacenza, il fascino della storia apre le sue porte e ci spinge ad immergerci nella contemplazione dei valori antichi e sempre veri.

di Antonio Lambertini
Costruita nel 1823 per volere di Maria Luigia, affinché riunisse i resti di tutti i duchi della città, il silenzio e la povertà della minuta cripta contrasta con la ricchezza e lo sfarzo della Basilica sovrastante: il luogo invita alla meditazione, alla preghiera, al raccoglimento interiore di fronte ai grandi della Storia, che dormono il sonno eterno in piccolissimi loculi. «Pulvis es et in pulverem reverteris» è il memento, che affida questo luogo al visitatore attento: la brevità della vita e le glorie mondane poco valgono rispetto all’esistenza celeste, in cui la grandezza sulla Terra non equivale necessariamente alla Beatitudine nel Cielo, come dimostra l’angustia del sepolcreto celato.
Il sarcofago del Duca
Solo un sarcofago si erge immenso: custodisce Alessandro Farnese, terzo duca e grandissimo condottiero cinquecentesco, colui che ridisegnò il volto geopolitico europeo e combatté in difesa della Cristianità. Nel 1571 partecipò alla Battaglia di Lepanto e, impavido, per primo si lanciò all’arrembaggio delle ammiraglie turche, facendo strage di nemici ed incitando i suoi allo scontro. Nel 1577 riuscì, grazie alle sue doti militari ed al suo equilibrato governo, ad impedire che i protestanti prendessero il controllo dei Paesi Bassi e nel 1588 tentò di dissuadere Filippo II di Spagna dall’invadere l’Inghilterra anglicana, senza successo: questo fu l’unica sua sconfitta, che si
Nella foto, il sarcofago di Alessandro Farnese, terzo duca e grandissimo condottiero cinquecentesco: all’interno, il corpo del grande miles Christi è vestito di un umile saio. Sopra, si notano l’elmo e la spada indossati nella battaglia di Lepanto.


Nella cripta spicca un semplice altare, che sostiene un intarsiato reliquiario a croce, contenente una spina della Corona, un legno della Vera Croce e qualche granello di sabbia del Calvario, donato da Pio VII a Maria Teresa di Savoia in occasione delle nozze col duca Carlo II nel 1820. Nella foto a sinistra, la Croce donata dal Pontefice.
L’Imperatrice Zita di BorboneParma, consorte del beato Carlo d’Asburgo, beneficiò la città di numerosi cimeli, tra cui la camicia indossata da Luigi XVI sul patibolo (nella foto a destra), oggi esposta nel Museo costantiniano assieme alla bozza dell’ordine di condanna a morte. risolse nell’ecatombe spagnola.
Sopra il sarcofago, l’elmo e la spada indossati a Lepanto, la grande vittoria di Roma sugli Infedeli; all’interno, il corpo del grande miles Christi vestito di un umile saio.
Fra il candore della cripta spicca un semplice altare che sostiene un intarsiato reliquiario a croce, contenente una spina della Corona, un legno della Vera Croce e qualche granello di sabbia del Calvario, donato da papa Pio VII a Maria Teresa di Savoia in occasione delle nozze col duca Carlo II nel 1820: da loro discenderà Zita di Borbone-Parma, consorte dell’ultimo Imperatore d’Austria e proclamata Serva di Dio per la sua opera in favore della pace europea durante la Grande Guerra. L’Imperatrice beneficiò la città di numerosi cimeli, tra cui la camicia indossata da Luigi XVI sul patibolo, oggi esposta nel Museo costantiniano assieme alla bozza dell’ordine di condanna a morte.
La missione cristiana
In superficie, l’estasi davanti alla Bellezza cede il posto oramai alla meditazione più intima, segno di come questa chiesa – elevata a basilica minore da Benedetto XVI nel 2008 – permetta al visitatore di assaporare un ideale percorso di riflessione, adorazione e conversione.
Lo splendore della Steccata, che trae origine da un atto spontaneo di preghiera alla Madonna allattante il Bambino, immagine di amore materno nel contempo semplice e familiare, altro non è che il riflesso della fede dei parmigiani e il loro cuore non ha tradito la missione cristiana dei suoi fondatori, perpetuata dai cavalieri costantiniani, che continuano a portare aiuto a poveri, vedove, ragazzi, senza distinzioni né élitarismi.