PSICOLOGO O PSICHIATRA? NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE
Abbattere
Leggere, scrivere, esistere. L’essenza di Chiara Gamberale



Abbattere
Leggere, scrivere, esistere. L’essenza di Chiara Gamberale


Una possibile definizione di “stig ma” in psichiatria può essere: l’in sieme degli atteggiamenti negativi e di rifiuto che si risvegliano nelle persone di fronte ad una diagnosi di malattia mentale ed ai comportamenti che la accom pagnano pur senza avere una conoscenza chiara del problema. Le persone con proble mi psichici sono oggetto di pregiudizi nega tivi, a causa del loro disturbo, che genera ri fiuto, discriminazione ed esclusione. Ci sono pazienti che rifiutano la discriminazione e protestano nei confronti dell’atteggiamento di esclusione sociale. Altri che interiorizzano lo stigma, quasi lo condividessero e vivono la propria condizione con vergogna e senso di colpa.
Il 50% dei problemi di salute mentale inizia a 14 anni ed il suicidio è la seconda causa di morte negli under 25. La metà di tutte le malattie mentali inizia dunque all’età di 14 anni, ma nella maggior parte dei casi non viene rilevata o viene sottovalutata e non trattata.
Un ruolo fortemente negativo, in queste situazioni, viene giocato proprio dallo “stig ma” della malattia mentale. I genitori non ri escono a prendere neppure in considerazio ne che quel malessere che vedono addosso ai propri figli possa essere depressione o qual
che altra malattia della mente. Sarebbe trop po doloroso per loro pensare che un proprio figlio sia vittima di una condizione così ter ribile. I ragazzi più grandi vivono un misto tra la vergogna e la paura di poter avere un disturbo della mente e riconducono tutto ad altre motivazioni e ad altre cause. I più giovani non prendono l’ipotesi neppure in considerazione: non rientra nel novero delle evenienze possibili di cui hanno coscienza.
Così questa condizione aggiunge alla sofferenza della malattia anche il dolore di essere affetti da un morbo di cui vergognarsi e nascondersi.
È una storia che noi tutti conosciamo. La malattia mentale, i farmaci che la curano, gli psichiatri, gli psicologi (anche se in minor misura rispetto al passato) fanno scattare ancora un campanello di allarme e di paura in chi vede o ascolta storie di malattie della mente.
In presenza di qualsiasi malattia ognuno di noi cerca di prendere le distanze e così se un amico ha una malattia polmonare chie diamo subito se sia stato un accanito fuma tore e prendiamo così le distanze perché non fumiamo. Se ha una malattia del fegato chie diamo se abbia bevuto troppo alcol affran candoci perché noi non beviamo e così via.
Quando ci dicono che qualcuno che co

nosciamo ha un disturbo mentale ed è in terapia con psicofarmaci si scatena imme diatamente in noi la ricerca nella memoria di comportamenti anomali, bizzarri, incom prensibili di quella persona. Anche in que sto caso cerchiamo di allontanare da noi la malattia dandoci la rassicurazione, anche in maniera inconsapevole, che noi quelle cose non le abbiamo mai fatte. A differenza degli altri malanni però i disturbi mentali hanno il peso aggiuntivo di essere appannaggio del cervello; un organo oscuro, complicato, che richiede cure difficili, spesso inefficaci, con effetti collaterali e con un esito incerto. Negli ultimi anni la fiducia nella medicina è notevolmente aumentata tra la gente. A volte, anzi, esiste la convinzione, che on cor risponde a realtà, che qualsiasi malattia sia curabile e guaribile. Il malato di mente non rientra in queste categorie. Ha una sorte di versa. La medicina non può fare quello che riesce a fare in altre malattie. Queste persone hanno, nell’immaginario collettivo, un desti no segnato più infausto e sfortunato. Le cure daranno un aiuto parziale e la terapia sarà per tutta la vita. Ad aggravare il quadro e ad aumentare le distanze c’è poi una sorta di timore oscuro riguardo il comportamento del paziente con disturbi mentali. Può essere pericoloso, diventare cattivo, perdere il con trollo, fare del male. Nessun’altra malattia ha questo ulteriore carico di negatività.

Un aiuto aggiuntivo a sostenere queste paure lo danno le tante storie che la stam pa ed i media ci descrivono. La prima cosa che viene detta se c’è un assassinio che non rientra nei canoni consueti dei comporta menti criminali, è che quella persona aveva delle turbe psichiche o peggio ancora la “de pressione”. Poveri pazienti depressi! Perso ne che a volte non hanno neppure la forza di alzarsi dal letto e nella stragrande mag gioranza dei casi, e per fortuna, non hanno neppure la forza di porre fine ai loro giorni come epilogo di una malattia che nelle forme gravi genera il desiderio di morire.
Le cose però non stanno affatto come il fantasma dello stigma ci vuole far credere.
Le conoscenze delle malattie psichia triche sono diventate molto più profonde
e raffinate rispetto anche a pochi anni fa. I farmaci che vengono impiegati sono perfe zionati ed efficaci e riescono a dare grandi miglioramenti a questi pazienti che, in tan tissimi casi, migliora fino alla possibilità di vivere una vita normale.
Molti pazienti che hanno attraversato pe riodi di crisi escono spesso più forti e con una maggiore consapevolezza di se stessi rispetto a quando si sono ammalati. Spesso mostrano una maggiore maturità e grande tolleranza verso gli altri. La sofferenza è per tanti una grande scuola.
Lo stigma, con la sua struttura rozza e oscura resta, rigido e immutevole una spi na nel fianco di chi si ammala. È come un grezzo strumento preistorico che trova la sua ragion d’essere nella paura, nella diffidenza e nel sospetto. È probabilmente questo il mo tivo per cui nonostante la diffusione sui me dia di campagne di informazione, battaglie, promozioni resti ancora lì. Radicato nelle nostre menti. Verrebbe da dire parafrasando un detto popolare che “la paura è l’ultima a morire”. Ma non dobbiamo arrenderci ed un piccolo passo alla volta dobbiamo cercare di sradicare quello che è soltanto un fanta sma: quello della nostra paura.



20
Cervello piccolo, artigli e gobba: l’uomo tra mille anni di Alessio Righi

#PARLIAMONE
Così la fondazione BRF sfida i tabu con le vignette di Chiara Andreotti
CONTRIBUTO
24
Nascita della Neuroetica (sesta parte) di Alberto Carrara
L’arte di combinare farmaci e psicoterapia di Antonio Tundo
50
Un “cervello” per tornare a camminare dopo un trauma di Alessia Vincenti
Così l’acido folico diminuisce il rischio di suicidi di Francesco Carta
L’APPROFONDIMENTO
Le demenze, come riconoscerle e come comportarsi di Valentina Formica
NEUROSCIENZE
Tumori cerebrali, ecco la terapia che aumenta l’aspettativa di vita dei bambini di Antonio Acerbis
50
30 36 43 46 30
Il ritorno di Wanna Marchi. Fra truffe, manipolazione mentale e la certezza di essere nel giusto di Flavia Piccinni
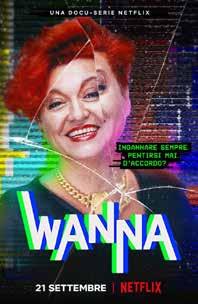
LIBRI
53
IL PERSONAGGIO Chiara Gamberale: “Leggere, scrivere ed esistere per me sono la stessa cosa” di Flavia Piccinni 40
56
Una riunione di vecchi amici diventa un gioco al massacro di Flavia Piccinni
TITOLI DI CODA Bad or Mad? L’antica questione nella scienza di Pietro Pietrini




Negli ultimi anni si parla più liberamente di salute mentale, ma lo stigma le gato al disagio psicologico fatica a scomparire. Molti continuano ad avere pregiudizi e comportamenti discriminatori verso chi soffre di una patologia mentale, o verso quelli che intraprendono un percorso di psico terapia o un una cura psicofarmaco logica. La colpa è spesso legata a una rappresentazione stereotipata dei di sturbi mentali, con conseguenze mol to serie.
I dati epidemiologici mostrano che circa il 40% degli individui pre senta una qualche forma di disturbo mentale nel corso della sua esistenza. A fronte di questo dato, i Paesi a più alto reddito spendono nel campo del la salute psichica solo il 5% del loro budget per la sanità. Inoltre, l’ambito di cura della salute mentale deve fare i conti con un fardello significativo e molto doloroso: quello relativo allo stigma sociale.

I disturbi mentali sono curabili, tuttavia la ricerca di aiuto è spesso ritardata o del tutto assente per una questione culturale. Non a caso, lo stigma legato ai disturbi psichici e ai servizi di salute mentale è considerata una delle ragioni principali dell’insuf ficiente ricerca di aiuto da parte dei pazienti. Purtroppo, però, Iil ritar do o l’evitamento delle cure hanno conseguenze dannose, influenzando tanto il destino dei pazienti quanto la possibilità di guarigione.
La parola stigma ha origine greca e significa marchio, segno distintivo, e si può definire come un processo che coinvolge l’etichettare, il discriminare e l’interiorizzare stereotipi e pregiudi zi a danno dei membri di un gruppo sociale. Sono stati identificati diversi tipi di stigma: personale, percepito,
Secondo la lette ratura, lo stigma legato al tratta mento influenza negativamente l’intenzione di cercare supporto terapeutico. È sor prendente come ancora al giorno d’oggi ci sia un elevato numero di persone convinto che chi richiede sostegno psicologi co/psichiatrico sia pericoloso.
auto-stigma. Vi è poi lo stigma legato al trattamento, ovvero quell’insieme di credenze negative che un indivi duo ha nei confronti della cura e dei professionisti che operano nell’ambi to della salute mentale.
Secondo la letteratura, lo stigma legato al trattamento influenza nega tivamente l’intenzione di cercare sup porto terapeutico. È sorprendente come ancora al giorno d’oggi ci sia un elevato numero di persone convinto che chi richiede sostegno psicologi co/psichiatrico sia pericoloso, oppure che una persona che si reca in terapia sia debole e che potrebbe facilmente guarire se solo ci mettesse un po’ di buona volontà.
A causa di questo diffuso modo di pensare, recarsi da un terapeuta o assumere psicofarmaci è visto da mol ti con sospetto e chi lo fa è indotto a vergognarsi della propria situazione. Di conseguenza, accade frequente mente che le persone a cui vengono prescritti psicofarmaci interrompano il trattamento troppo presto per ot tenere miglioramenti duraturi. Uno studio del 2016, ha mostrato che tra il 10 e il 60% dei pazienti a cui erano stati prescritti farmaci antidepressivi non li assumeva con regolarità. Spes so in chi si reca da un professionista della salute mentale si innesca il ti more del giudizio altrui, la paura di essere etichettato come pazzo. È im portante decostruire questa immagi ne per arrivare a comprendere come l’adesione ad una terapia rappresenti un gesto di cura verso se stessi, una presa in carico a fine migliorativo del la propria salute emotiva, psicologica e relazionale.
Falsi miti sulla figura dello psicologo Lo psicologo è solo un ciarlatano! Perché devi raccontare i fatti tuoi ad un estraneo? Non sei mica pazzo! Ti rati su le maniche da solo/a, ce l’hai
fatta in passato perché non dovresti farcela adesso?
Queste sono le domande e le obie zioni che spesso vengono poste a chi decide di intraprendere un percorso psicoterapico. Frasi superficiali che, anche se pronunciate di sovente con fine bonario, mostrano una profonda ignoranza. Riconoscere disagi e limiti personali è infatti un grande atto di forza, per niente indice di debolezza.
Ancora oggi sono numerose le persone convinte che lo psicologo legga nella mente e che potrebbe manipolarli. Niente di meno reali stico. Lo psicologo per deontologia professionale è chiamato a rispettare l’autonomia e le credenze dei suoi pa zienti e si astiene dall’imporre il suo sistema di valori, inoltre non è dotato di poteri paranormali e quindi non è in grado di capire qualcuno al primo sguardo. È comune l’idea che la psi coterapia non abbia un fondamento scientifico e che sia impossibile risol vere problemi concreti parlandone, oppure che se si ha bisogno di farlo sia sufficiente rivolgersi ad un buon amico. La possibilità di avere accan to, in un momento di difficoltà, amici e familiari è una risorsa preziosa; tut tavia, lo psicologo non fornisce buoni consigli, ma applica conoscenze sulla mente apprese dopo un lungo percor so di studi. A oggi sono ormai molte le evidenze scientifiche relative all’ef ficacia della psicoterapia, in partico lare cognitivo-comportamentale, per il trattamento di un vasto numero di disturbi.
Lo psicologo è dunque uno stru mento che, in un determinato perio do della nostra vita, ci può aiutare a ritrovare l’equilibrio e raggiungere i nostri obiettivi. Una figura professio nale caratterizzata da una forte etica e formata dopo un percorso di studi universitari che può fornire un im portante sostegno.
Perché abbiamo pregiudizi sugli psicofarmaci?
La diffidenza si basa su una cono scenza poco approfondita e su infor mazioni confuse e antiquate relative agli effetti di tali sostanze sulle facoltà mentali delle persone, con la radicata convinzione che conducano ad assue fazione e scarsa lucidità.
Molti credono che gli psicofar maci possano alterare la coscienza di se stessi, nonché produrre cam biamenti radicali e permanenti nella propria personalità. Sono invece al cuni disturbi psichiatrici ad alterarla. Il trattamento psicofarmacologico mira, infatti, a ristabilire il senso di consapevolezza perduto, aiutando a controllare gli stati emotivi e cognitivi aberranti.

A causa dei significativi effetti col laterali provocati dalla prime catego rie di farmaci approvati per l’utilizzo in psichiatria e l’utilizzo improprio di alcune sostanze nei decenni passati ad oggi esistono ancora molti precon cetti sull’utilizzo di farmaci per af frontare le problematiche psichiche. Un esempio è quello legato all’uso eccessivo di terapie con benzodiaze pine, che inducono tolleranza e di pendenza e non andrebbero utilizzate
in modo continuativo, poiché possie dono un effetto sintomatologico, ma non rappresentano un vero e proprio trattamento curativo.
La cattiva o approssimativa ge stione nel passato di alcune molecole ha provocato un rifiuto a priori di te rapie utili ed efficaci, nonché l’accet tazione del trattamento farmacologi co come ultima spiaggia, ovvero solo nel momento in cui la situazione si è ormai fortemente aggravata.
Come tutti i farmaci, gli psicofar maci possono avere effetti indesidera ti, ma se si seguono le indicazioni del proprio specialista non sono rischiosi e aiutano la persona a recuperare il proprio equilibrio.
Cosa fare contro il tabù della malattia mentale?
Per ridurre lo stigma intorno a noi è importante parlare apertamente di salute mentale, normalizzando con versazioni che ancora avvengono di rado e che spesso si svolgono a livello superficiale. Conoscere e abbattere i pregiudizi è il primo passo per ini ziare a prendersi cura della propria mente e far sì che i disturbi psichici e i professionisti della salute mentale facciano sempre meno paura.
Per ridurre lo stig ma intorno a noi è importante parlare apertamente di salute mentale, normalizzando conversazioni che ancora avvengono di rado e che spesso si svolgono a livello superfi ciale.
Così si possono abbattere i tabu sul disagio mentale Intervista a Valerio Rosso, psichiatra e comunicatore
di Martina GaudinoNel mondo sono 450 mi lioni le donne e gli uomi ni affetti da un disturbo mentale. Nel nostro Pa ese ne soffre una persona su tre per un totale di 17 milioni di italiani. Di questi, quasi 3 milioni hanno sintomi depressivi, e ben 2 milioni sono don ne, mentre 1 milione e 300 mila per sone ha una diagnosi di depressione maggiore. Numeri tutt’altro che pic coli e che lasciano ben capire si tratti di qualcosa di invisibile ma vicino ad ognuno di noi. Abbattere muri e barriere, accogliere per prevenire, di vulgare per cancellare la paura. Sono questi gli obiettivi di chi, giorno dopo giorno, si impegna per far conoscere le malattie mentali affinché queste possano essere qualcosa di diverso da un tabu. Parliamo di Valerio Ros so, noto psichiatra, psicoterapeuta e comunicatore che grazie alla potenza
divulgativa sta avvicinando migliaia di persone a un mondo ritenuto da sempre ed erroneamente chiuso e di cui vergognarsi o che deve far paura. Lo specialista, divenuto nel tempo anche Youtuber e podcaster, raccon ta a Brain in che direzione dobbiamo andare, insieme, per smantellare l’au ra nera che aleggia sulle patologie del la mente umana.
Come possiamo abbattere i tabu legati alla malattia della mente?
In psichiatria tendiamo a sosti tuire la parola tabu con stigma nel senso che, relativamente alla malattia mentale, abbiamo dei segni distintivi, dei segnali di riconoscimento che si attribuiscono a chi ha una sofferenza mentale e che alla fine si traduce in una disapprovazione sociale di que ste persone. Parlando di fatti recenti, mi viene da pensare alle esternazio ni di alcuni politici che con l’antico
Valerio Rosso.
concetto antropologico e sociologico di devianza hanno causato un po’ di confusione sul tema. Per indagare le cause del tabu in psichiatria, si deve andare alla radice e chiamarlo stigma. Lo stigma non è solo una sorgente di sofferenza aggiuntiva ma è, media mente, anche responsabile di diffi denza, di diagnosi ritardate, di scarsa consapevolezza della malattia che poi causa ricadute.

Quando nasce lo stigma?
Lo stigma si costruisce e ha spesso radice antiche. Nasce e si consolida nel tempo. In particolare, in psichia tria si è consolidato in tutti quei lun ghi millenni in cui le malattie mentali non avevano cure e venivano attribu iti banalmente a devianze e fragilità morali quando i pazienti psichiatrici (affetti ad esempio da bipolarità, di pendenze gravi, depressione grave), venivano additati come persone con
disagio sociale. Un disagio grave nelle classi meno abbienti ma che diventa va ancor più pesante nella classe alta, dirigente. Pensiamo, ad esempio, alla “follia di Re Giorgio III di Hanno ver” che alla fine del ‘700 ha avuto una crisi psicotica finita per essere declassata ad un “casino pazzesco”. Il parlamento non doveva sapere che era malato, non si poteva dire che il Re era malato peggiorando, di fatto, le sue condizioni.
Succede ancora oggi?
Assolutamente sì! Succede in am bito politico, nelle forze dell’ordine, persino in ambito medico è ancora presente ancora il tabu della malat tia mentale. E’ difficilissimo curare un collega medico. Questo fa capire come lo stigma sia ancora radicato. Un altro problema è che in altre pato logie c’è il concetto della testimonian za, del paziente che racconta, nell’am
Lo stigma si costruisce e ha spesso radice antiche. Nasce e si consolida nel tempo. In partico lare, in psichiatria si è consolidato in tutti quei lunghi millenni in cui le malattie mentali non avevano cure
C’è una corren te di pensiero antipsichiatrica recente che ha a che vedere con Scientology e che porta una prospet tiva molto dura e inquisitoria sulla malattia mentale e sugli psichiatri.
bito delle malattie mentali questo non c’è. Chi ha avuto il problema tenderà a nascondere il tutto una volta curato e non volentieri farà “outing”.
In che modo viene vista dall’esterno la malattia mentale?
C’è una corrente di pensiero an tipsichiatrica recente che ha a che vedere con Scientology e che porta una prospettiva molto dura e inqui sitoria sulla malattia mentale e sugli psichiatri. Questo ha portato gravi conseguenze sulle persone affette da patologie perché tendono a stare lon tani dall’ambiente esterno facendo sì che a nascere sia una retorica molto sbagliata. Un po’ come accaduto per i complottismi sui vaccini nell’era Co vid e non solo. La psichiatria come medicina ha avuto liaison criminali con le aziende farmaceutiche, lo sap
piamo tutti. Ma sappiamo anche che c’è il politico criminale e il politico che lavora bene, non si può genera lizzare, sarebbe sbagliato. Questo at teggiamento di condanna ha portato molte persone a stigmatizzare la pa tologia e soprattutto gli psicofarmaci, criminalizzati rispetto ad altri farma ci. Per questa ragione mi dedico alla divulgazione, voglio fare chiarezza in maniera costatante, voglio metterci la faccia, essere rassicurante.
Cosa è rassicurante, ad esempio?
Ritengo che il nodo centrale sia uno è cioè, quando una patologia è in una area stigmatizzata, lo stigma non si può superare con interventi puntiformi e mini congressini. Lo stigma, il muro, si abbatte e si de costruisce con un percorso che deve coinvolgere più figure professionali di tipo educativo e sociale. È triste vedere, ad esempio, come in occa sione delle ultime elezioni non ci sia stato un contributo alla medicina psichiatrica di alcun tipo.

Cosa dovrebbe fare la politica?
La politica deve coinvolgere chi fa questo di lavoro, evitare di basarsi sul le opinioni personali, utilizzare medi ci con caratteristiche da influencer. La strumentalizzazione che c’è stata delle parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni non mi è pia ciuta. Lei ha sbagliato ad esprimersi, ma non è giusto che la si attacchi per ciò che ha detto senza poi contestua lizzare e spiegare il suo scivolone. Se si vuole puntare il dito contro di lei allori si trovi anche il tempo e il modo di spiegare cosa è una devianza e cosa significa. Nessuno oggi in po litica porta veramente avanti dei pro grammi contro lo stigma della salute mentale. Non si può pensare di anda
re avanti a slogan, a campagne di in formazione, io propongo qualcosa di continuativo, di persuasivo per fare in modo che sempre più persone entri no a contatto con questa realtà ancora così segreta e sconosciuta.
Quanto pensa di essere riuscito a incidere in questo senso con il suo lavoro?

Oggi una persona su tre ha a che fare con patologie mentali, una per sona su tre significa che un nostro amico, un nostro parente ha un di sturbo di questo tipo. Personalmente ho avuto una enorme soddisfazione e la ritengo una grande crescita perso nale aver capito che c’è un pubblico interessato a capire. Da quando ho iniziato a parlare di questi argomen ti ho compreso che se una persona scende dal piedistallo e parla in ma niera trasversale è davvero incredibile e piacevole comprendere quanta gen te vuole sapere. Ci sono tantissime persone interessate a capire davvero, ma le cose vanno spiegate e racconta te, illustrate in parole che siano alla portata di tutti.
Un esempio pratico?
Sulla terapia elettroconvulsivan te non si sa nulla, nella nostra intera vita siamo portati a vederla solo come il famoso e terribile elettroshock da film dell’orrore. Questo perché in Ita lia è una terapia da sempre criminaliz zata e non utilizzata con la stessa fre quenza del resto del mondo proprio a causa dello stigma. Gli stessi medici che non sono psichiatri non sanno cosa sia davvero la terapia elettro convulsivante. Io invece, facendo un video social, ho capito che chi ascolta è disposto a cambiare idea, a capire cosa è davvero e dunque a coglierne i benefici con una giusta e corretta
applicazione. In parole povere, non servono grandi virologi in televisione, serve un rapporto autentico con chi è dall’altra parte e ci sta ascoltando. Quale ruolo può avere la stampa in questo senso?
È importante che medici e giorna listi collaborino insieme. Questo per ché non tutti i medici hanno il dono della comunicazione e quindi sarebbe bene se si affidassero a chi ha l’arte della parola per far arrivare messag gi chiari, diretti, onesti e competen ti. Ritengo che la collaborazione e la costruzione di gruppi di lavoro credo sia il futuro del progresso sanitario in Italia. Si può prevenire parlando, esiste la prevenzione anche nel cam po delle malattie mentali, un rapido accesso alla diagnostica cambierebbe tutto, drasticamente.
Oggi una persona su tre ha a che fare con patologie mentali, una persona su tre significa che un nostro amico, un nostro parente ha un disturbo di questo tipo.

Le esternazioni dei vip hanno fatto sentire tante persone meno sole. Ma occhio a non esagerare
di Carmine GazzanniQuanto spesso è capitato di guardare una foto su Instagram o Facebook e pensare: “Allora non suc cede solo a me!”
Questo è il potere dei social.
Dei social di oggi viene da pen sare, perché fino a poco tempo fa quello che emergeva da queste piat taforme era molto diverso.
Le vite degli altri sembravano uscite da una rivista di moda pati nata, perfette in ogni singolo detta glio: dalla casa alle vacanze, dall’a spetto alla salute.
In questo universo di perfezione però hanno iniziato ad affiorare a fatica alcune realtà che sono salta te subito all’occhio per la diversità: quella diversità che somiglia tanto alla vita reale.
Oggi un corpo in sovrappeso, domani un viso coperto dall’acne. È iniziata così la rivoluzione dei social: lenta, silenziosa ma irrefre nabile.

Sempre di più oggi le vite che vediamo sui social somigliano un po’ alle nostre.
Una volta sdoganata questa perfezione fittizia, sono tra i più disparati gli argomenti che stanno subendo questa rinascita necessaria: dall’aspetto fisico al lavoro, alla sa lute.
Ed è proprio la salute, in parti colare quella mentale, che sta rea gendo a questa svolta senza prece denti.
Le prime timide dichiarazioni sul bisogno di parlare di salute men tale hanno lasciato spazio a vere e proprie grida di battaglia.
Lo ha fatto l’attore Tom Holland che, dopo gli ultimi successi al cine ma, ha deciso di chiudere per qual che tempo le sue piattaforme per tutelarsi, ha detto: “Sono troppo stimolanti e soffocanti. Sono troppo
Dei social di oggi viene da pensare, perché fino a poco tempo fa quello che emergeva da queste piattaforme era molto diverso.
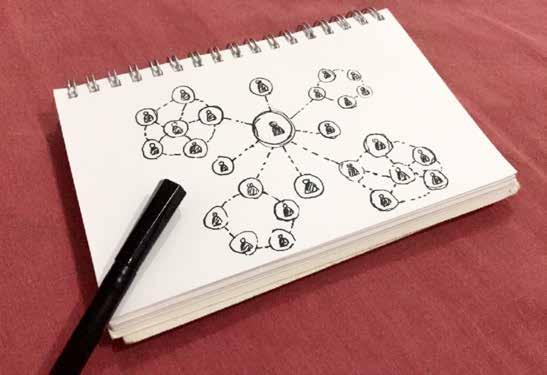
Le vite degli altri sembravano uscite da una rivista di moda patinata, perfette in ogni singolo dettaglio: dalla casa alle va canze, dall’aspetto alla salute.
coinvolto quando leggo cose che mi riguardano”.
Come lui anche l’attrice Zoe Kravitz ha deciso di abbandonare se pur temporaneamente i social.
Ma a volte chiudere i social non è sufficiente e sono tante le perso nalità che si sono esposte sui social per abbattere quel tabù che ormai sembra radicato quando si parla di salute mentale.
Bella Hadid, una delle modelle più richieste degli ultimi anni, ha strappato il velo di perfezione che avvolge i suoi social con foto che la ritraggono in lacrime, dichiarando di soffrire di depressione.
Anche in Italia ci sono state di chiarazioni importanti sul fronte della salute mentale.
Come dimenticare l’emozionan te esibizione al festival di Sanremo di Fedez e Francesca Michielin, che hanno cantato arrivando in finale
“Chiamami per nome”: con la voce sicura ma bocca tremante Fedez ha poi dichiarato di aver sofferto di un forte attacco di ansia pre-show che lo ha costretto a mettersi in contat to con il suo terapeuta, sdoganando una volta per tutte la normalità di seguire un percorso di psicoterapia.
E ancora Ed Sheeran, Matilde de Angelis, Lady Gaga, Michael Phelps, Justin Bieber, Bebe Vio.
Sembra che per una volta i so cial non debbano essere demoniz zati ma possano diventare un valido strumento per aiutare ad abbattere il muro che si è creato intorno alla salute mentale.
Le fragilità oggi esposte o per meglio dire postate con così tan ta facilità hanno aperto la strada a tutte quelle persone che si sentono sole, che hanno paura, che provano vergogna a convivere con un pro blema.
Tra mille anni l’essere umano sarà gob bo, avrà mani come artigli, un collo basso e spesso, tre palpebre per oc chio e anche un cervello più piccolo. Inoltre avrà dimensioni inferiori e probabil mente sarà anche meno “prestante” dal punto di vista intellettivo. L’uomo andrà incontro a una trasformazione, condizionata e veicolata dall’uso della tecnologia nelle nostre vite.
Sarebbe questo l’aspetto dell’uomo tra mil le anni secondo la ricerca commissionata dalla compagnia telefonica Toll Free Forwarding. Dall’elaborazione 3D è venuta fuori “Mindy”, la donna del 3000, che dovrebbe mostrare la rappresentazione degli effetti della tecnologia sull’evoluzione, o per molti aspetti involuzio ne, del corpo umano.
Postura e gestualità ripetitive sono soltan to due degli elementi condizionati dalla tec nologia che in un lontano futuro potrebbero rendere l’uomo diverso da come è oggi. Gli adattamenti vantaggiosi per la vita digitale che emergono casualmente, infatti, potrebbero “fissarsi” nelle popolazioni e dunque essere tramandati di generazione in generazione.
In un articolo per Health Matters, il dot tor K. Daniel Riew del New York-Presbyterian Orch Spine Hospital, ha spiegato esattamente cos’è: «Quando lavori al computer o guardi il telefono dall’alto in basso, i muscoli della nuca devono contrarsi per tenere la testa alta. Più guardi in basso, più i muscoli devono lavora
re per mantenere la testa alta. Questi muscoli possono diventare eccessivamente stanchi e doloranti guardando i nostri smartphone e tablet o trascorrendo la maggior parte della nostra giornata lavorativa al computer».
Gli effetti della tecnologia sull’uomo non riguarderanno soltanto la postura ma arrive rebbero a modificare anche le nostre funzioni cerebrali. Con una serie di studi a lungo termi ne che cercano di stabilirne l’impatto comple to, nel 2011 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato le radiazioni degli smar tphone come possibilmente cancerogene per l’uomo.
Gli effetti potrebbero essere più rilevanti in particolarmente sui bambini, in quanto i loro crani meno sviluppati sono più sottili e assor bono fino a tre volte più radiazioni rispetto ai cervelli adulti. Per questo il cranio dell’essere umano del 3000 potrebbe essere leggermente più spesso, così da proteggere il cervello, che però nel frattempo potrebbe rimpicciolirsi.
Secondo quanto emerso da un recente studio internazionale del Dartmouth Colle ge di Hannover, il cervello del genere Homo sarebbe di dimensioni più ridotte rispetto a circa 3mila anni fa e in futuro potrebbe diven tare ancora più piccolo a causa dello sviluppo, è l’ipotesi, della cosiddetta “intelligenza col lettiva”, veicolata attraverso la comunità e la tempesta di informazioni ricevute tramite gli smartphone.

Intervista all’illustratrice Sara “Cazzsara”: “Parlare di salute mentale non significa essere pazzi”
Sono le vignette, i pensieri e le tante parole che contraddistin guono la pagina Instagram di Sara, che sui social si fa chia mare Cazzsara, nome che spiega esse re nato durante la pandemia, quando da sola e con tanto tempo libero ha ideato la pagina.
“Avevo la necessità di parlare e sfogarmi in un momento in cui non potevamo farlo con nessuno” raccon ta Sara.
Tu e Cazzsara siete la stessa persona?
Il nome Cazzsara è dovuto al fatto che nella vita sono molto scherzosa e racconto un sacco di storie diverten ti, a volte inventate. Io e lei siamo la stessa persona ma lei rappresenta me glio il mio lato estroverso, cosa che nella vita di tutti i giorni non sono, anzi, sono molto timida.
Come è nata la tua passione per l’illustrazione?
Da piccola. Mio padre è sempre
stato il mio genitore “artistico” e lo imitavo cercando di disegnare come lui. Ho abbandonato per un po’ il disegno alle superiori, ma nel 2020 la voglia di disegnare e tradurre in carta quello che sentivo si è fatta più viva che mai. Ora seguo qualche corso di illustrazione mentre proseguo la mia carriera scientifica all’università. Sono due passioni che devo dire si conciliano bene.
Qual è il tuo rapporto con i so cial?
Ho un buon rapporto con i social e diciamo che il mio spazio è abba stanza tranquillo, ho un seguito mol to empatico e composto da persone gentili.
E con i tuoi followers?
Cerco sempre di instaurare un rapporto abbastanza comprensivo con tutti, ci sono alcune persone che mi scrivono spesso ed è come avere un sacco di amici virtuali. Alcuni mi hanno riconosciuta per strada e ne
sono rimasta molto colpita.
Senti mai il bisogno di staccare dai social?
Ogni tanto si, ci sono giornate “no” in cui non mi viene voglia di condividere con nessuno il mio sta to d’animo. Altre volte sono felice e voglio tenermi quella felicità privata e solo per me. Sono pur sempre una persona introversa.

“Scendi con me?” è il tuo primo libro. Da cosa è partito questo viaggio?
Diciamo che la trama vera e pro pria l’ho pensata quando sono partita per le vacanze. Il tema lo avevo pensa to subito ma c’è stato un momento in cui sono salita su un ascensore, come la protagonista della storia e allora mi sono detta “Questa sarà la location
del mio fumetto”.

Quali sono le emozioni che ti ispirano maggiormente? Ti senti stimolata anche da quelle che comunemente sono ritenute emozioni negative?
Tutte le emozioni mi ispirano ma riesco a tradurre meglio quelle nega tive. Forse perché è un modo per sfo gare uno stato d’animo che mi appe santisce e sia perché riesco a ritrovare le stesse emozioni negli altri. Quando mi dicono “pensavo di essere l’unic* a provare questa cosa” mi ritrovo a pensare a quanto siamo tutti simili e proviamo esattamente le stesse cose e mi libera: mi sento capita dagli altri e gli altri si sentono capiti da me.
Qual è il tuo rapporto con la salu te mentale?
“Il nome Cazzsara è dovuto al fatto che nella vita sono molto scherzosa e racconto un sacco di storie divertenti, a volte inventate”.
Così la campagna #Parliamone della Fondazione BRF acquista un nuovo motto: “Parlare ti fa volare”.

Visita il sito della Fondazione BRF (www.fondazio nebrf.org) per saperne di più.
Il mio rapporto con la salute men tale è stato travagliato durante gli anni del liceo e della triennale in uni versità. Ora penso di aver raggiunto un equilibrio ma devo ancora lavora re un po’ su alcuni aspetti. Penso sia importante capire che parlare di salu te mentale non significa essere pazzi, ma ammettere che anche la gestione delle emozioni conta. Come quando vai dal medico quando ti fa male la testa, perché non dovresti andare da uno psicoterapeuta per guarire se qualcosa ti fa stare male?
Cosa pensi riguardo ad un percorso di terapia?
In generale penso che tutti avreb bero bisogno di frequentare uno psi coterapeuta prima o poi. Come dice vo, è molto importante anche gestire
quell’aspetto e non penso ci sia nulla di più saggio che chiedere aiuto se ne sentiamo il bisogno. Molto spesso questo percorso è demonizzato ma non è assolutamente nulla di cui ver gognarsi.

In che modo la salute mentale influisce sul tuo lavoro?
Ho illustrato spesso situazioni che andavano a toccare molti aspetti della mia salute mentale e penso che succederà in futuro molte altre volte. La verità è che non siamo automi, non possiamo pensare di continuare a lavorare in modo eccellente se stia mo male mentalmente. Un po’ tutto è influenzato dalla salute mentale ed è giusto parlarne e buttare fuori quel lo che ci emoziona anche, in questo caso, negativamente.
Sulla tua pagina Instagram parli spesso del rapporto con se stessi e se vogliamo anche di salute mentale. Pensi che i social possano dare una mano?
Oramai tutti hanno un social. Da lì si prende ispirazione per out fit, trucchi, si ride ma ci può benis simo anche essere uno spazio per la salute mentale. In generale se anche una persona vedendo un mio post si chiede “forse ho bisogno di parlare con qualcuno”, è un successo. Sen sibilizzare su questo argomento è un successo, l’importante è essere diret ti e semplici mentre si trasmette un messaggio. Parlare diventa quindi un imperativo quando ci si riferisce alla salute mentale e, come Sara traduce con le sue immagini, ci trasporta in un mondo diverso. La consapevo lezza che può portare la terapia è in grado di trasformare il nostro mondo ormai grigio in un mondo in techni color. (C. A.)
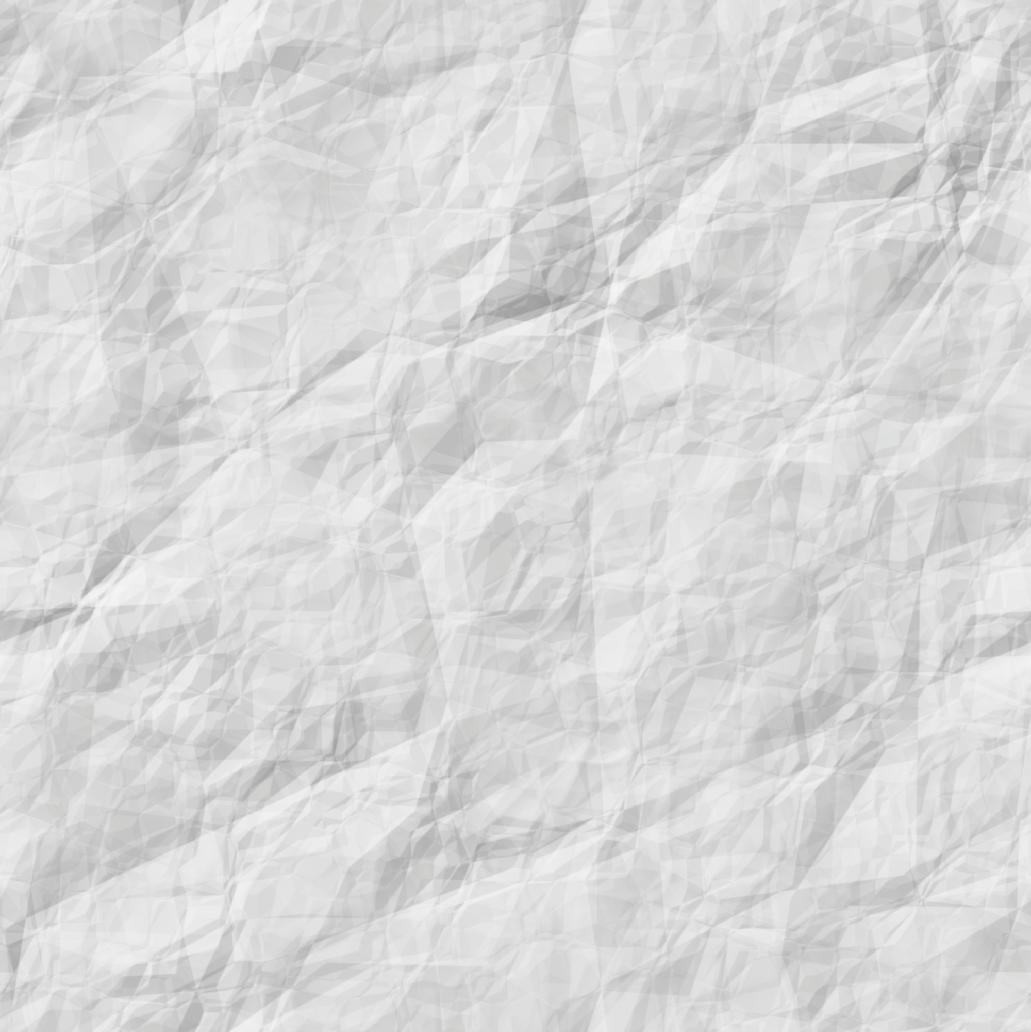




Direttore del Gruppo di Neurobioetica (GdN) dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Do cente di Neuroetica presso la Facoltà di Psicolofia dell’Università Europea di Roma, Membro della Pontificia Accademia per la Vita, Fellow dell’UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights e Presidente dell’Istituto Internazionale di Neurobioetica.
Il neologismo “neuro-etica” fa la sua comparsa nella letteratura scientifica nello stesso periodo in cui l’oncologo Potter ren deva popolare quello di “bioetica”. Nel 1973 la neuropsichiatra An neliese Alma Pontius (1921-2018) pubblicava l’articolo Neuro-ethics of “walking” in the newborn nel quale discuteva, in antitesi alla pras si comportamentista di stimolazione motoria dei neonati in voga in quegli anni negli Stati Uniti, di un «nuovo e trascurato settore di preoccupazio ne etica - la neuro-etica» (p. 244). Il ragionamento seguito dalla Pontius risulta oggi emblematico al fine di ca ratterizzare questo emergente settore di riflessione che è la neuroetica. Del la Pontius abbiamo scritto su questa rivista nel mese di dicembre 2021 (p. 36) una scheda monografica. Ora ne
consideriamo il pensiero neuroetico comparandolo e contrastandolo con un altro clinico ed esperto di stati alterati di coscienza: Ronald Eugene Cranford (1940-2006).
La prima caratteristica che identi fica l’approccio della neuropsichiatra Pontius è che ella parte dai fatti: una sorta di potenziamento motorio che si voleva ottenere in neonati iper-sti molandoli allo scopo di accelerare la naturale tendenza a muoversi in po sizione eretta. Questo era il contesto dell’originario articolo del 1973. Tale prassi venne sottoposta al vaglio delle evidenze relative allo sviluppo, strut tura e funzioni del sistema nervoso in quel momento note. Emersero nume rose criticità, visto e considerato che si stava sollecitando un sistema nervoso non ancora maturo e perciò non atto a supportare determinate funzioni.
Questo specifico tentativo di potenzia mento motorio risultava pertanto non etico e violava il cosiddetto “principio neuroetico”: non prendendo in consi derazione le conoscenze neuroscienti fiche riguardanti lo sviluppo del siste ma nervoso ed agendo di fatto contro tali evidenze, si metteva a rischio, di conseguenza, l’integrità e la dignità del soggetto vulnerabile (il neonato) a cui veniva imposta tale pratica.
In secondo luogo, il ragionamento della Pontius, criticando la corrente psicologica del comportamentismo (Behaviourism) da cui originava tale prassi, enfatizzava l’aspetto delle in terpretazioni delle neuroscienze: vi sono comprensioni sulla natura del cervello che risultano dannose per la salute, il benessere e l’integrità fisica, psichica e spirituale dell’essere uma no proprio per il fatto di non corri spondere alla realtà biologica. Sono le spiegazioni relative alla natura, strut tura e funzione del sistema nervoso e del cervello che ricalcano spesso l’epoca tecnologica in cui lo scienzia to viveva e nella quale si formava. Il filosofo padovano Giacomo Mario Gava, analizzando le concezioni della scienza contemporanea e i suoi rap porti con l’arte e la creatività tecno logica, mise in luce il ruolo e i limiti dei modelli avanzati nel tempo per la precomprensione della natura e strut tura del cervello umano. Orologi, au tomi e calcolatori sarebbero alcune invenzioni e produzioni umane che determinarono veri e propri modelli del cervello: modello meccanicistico, funzionalistico, connessionistico, ec cetera (G. Gava, Cervello e dintor ni. Saggi di Filosofia della Scienza, Cleup, Padova 2008, 115-141).
La Pontius approfondì in diverse
pubblicazioni degli anni Settanta il nucleo del “principio neuroetico”: l’importanza di approcci sperimentali e sociali informati e guidati dalle co noscenze relative allo sviluppo, strut tura e funzioni del sistema nervoso. Per la neuropsichiatra americana la neuroetica è quella riflessione che mira a valutare i benefici e/o le poten ziali conseguenze negative a breve e lungo termine di concrete sperimen tazioni o approcci all’essere umano attraverso il confronto informato con le evidenze neuroscientifiche (si pos sono leggere tra glia altri i seguenti scritti: A. A. Pontius, «Neuro-ethics: on the child’s neuro-environment», in H. Knoetig (ed.), Proceedings, Inter national Meeting on Human Ecology in 1975, Georgi Publ., Vienna 1976, 545-548. A. A. Pontius, «Neuro-envi ronment and neuro-ethics, based on
La prima caratteri stica che identifica l’approccio della neuropsichiatra Pontius è che ella parte dai fatti: una sorta di potenziamento motorio che si voleva ottenere in neonati iper-stimo landoli allo scopo di accelerare la naturale tendenza a muoversi in posizione eretta.

Nel novembre del 1989 il neurologo Ronald Eugene Cranford (19402006), esperto in stati alterati di coscienza (stati vegetativi, SV e stati di minima coscienza, SMC), utilizzò il concetto di neuroetica nel contesto etico-cli nico riguardante le decisioni sul fine vita.
new model of subject-object determi nation, toward a new system, integra ting concepts from Kant, philosophy of science and neuro-development», in H. Knoetig (ed.), Proceedings of the Second Vienna International Me eting on Human Ecology in 1977, Ar chivum Oecologiae Hominis, Vienna 1978, 145-154.).
Nel novembre del 1989 il neu rologo Ronald Eugene Cranford (1940-2006), esperto in stati altera ti di coscienza (stati vegetativi, SV e stati di minima coscienza, SMC), utilizzò il concetto di neuroetica nel contesto etico-clinico riguardante le
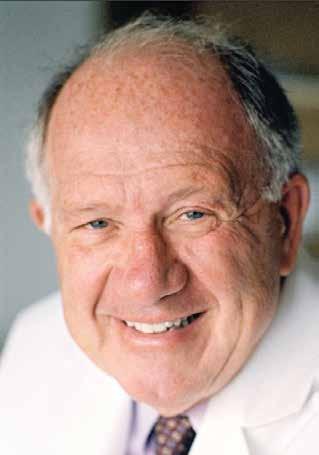
decisioni sul fine vita. Sulla rivista Neurologic Clinics titolò The Neu rologist as Ethics Consultant and as a Member of the Institutional Ethics Committee. The Neuroethicist utiliz zando per la prima volta l’accezione professionalizzante di “neuroetici sta”: il neurologo competente quale consulente all’interno dei comitati di bioetica. Cranford sostenne che, dato l’aumento delle problematiche etiche concernenti la pratica neuro logica, in particolare quella relativa alla possibilità tecnica di prolungare la vita umana, la presenza di neurolo gi esperti all’interno dei comitati etici ospedalieri faciliterebbe l’adeguata soluzione delle tematiche più spinose.
Ora, sebbene Pontius e Cranford fossero entrambi dei clinici, cioè dei medici, e perciò partendo da una for mazione organicista, le loro visioni sull’essere umano dalla prospettiva delle neuroscienze risultano antiteti che. In che senso?
Mentre Anneliese Pontius parte dal corpo per arrivare agli effetti neu ronali di alterazioni che riguardano il movimento e la cognizione, Cranford parte da danni a livello cerebrale per inferire la situazione globale-olistica dell’individuo malato. Il primo, quel lo della Pontius, è un modello cor po-centrico, mentre quello di Cran ford è un sistema cerebro-centrico.
Inoltre, significativa risulta l’inter pretazione sul rapporto mente-cer vello-corpo che i due clinici adotta no. Analizzando il modello cerebrale proposto dalla cosiddetta intelligenza artificiale, la Pontius nel 1993 sotto lineò come un’interpretazione del cervello e della mente secondo l’ana logia computazionale dell’hardware/ software risultasse disumanizzante e
pericolosa per le conseguenze nega tive sui bambini, giovani ed adulti di oggi e delle future generazioni per il “fatto neuroetico” di non prendere in considerazione le evidenze e peculia rità neurofisiologiche e neuropsicolo giche del sistema cerebrale altamente integrato e interagente con tutto il resto della corporeità (A. A. Pontius, «Neuro-ethics vs. Neurophysiologi cally and neuropsychologically unin formed influence in child rearing, education, emerging hunter-gathe rers, and artificial intelligence models of the brain», Psychological Reports 72 (1993), 451-458).

Cranford, all’opposto, all’inter pretare le condizioni di alterazione dell’autocoscienza nei pazienti in stato vegetativo, adotta una visione funzio nalistica-computazionale riguardante la relazione mente-cervello-corpo: a seguito di danni cerebrali, al venir meno di certe condizioni organiche che impediscono all’autocoscienza di manifestarsi ci troveremmo dinnanzi ad un corpo umano sì vivo, ma che non costituisce più una persona uma na. Karen Ann Quinlan, Nancy Cru zan, Terri Schiavo, Eluana Englaro e tanti altri noti casi di stato vegetativo sarebbero stati corpi vivi, ma non più le persone che erano prima del danno cerebrale corrispondente.
Questa forma mentis neurocentri ca contrasta con il paradigma neuro etico proposto dalla Pontius almeno per due ragioni: (1) ha alla base la falsa disgiuntiva tra essere umano e persona umana tipica della modernità ed attribuita allo sviluppo filosofico di John Locke (1632-1704) che vede una sintesi nell’esperimento mentale dell’ “anima” del principe nel corpo di un ciabattino (Saggio sull’intelletto
umano del 1690); (2) prevede un ap proccio funzionalistico simile a quello sotteso al comportamentismo.
Oggigiorno l’approccio medi co-clinico integrale ed integrato promosso dalla Pontius, in sintonia con gli sviluppi della Embodied ed Embedded Neurology permette di domandarsi: non è forse la mente in conscia che si manifesta e sostiene le funzionalità vitali basiche dei pazienti in stato vegetativo? Inoltre, questo “briciolo” mentale non è forse la si lente espressione della presenza per sonale di quel paziente?
Sebbene Pontius e Cranford fossero entrambi dei clini ci, cioè dei medici, e perciò partendo da una formazione organicista, le loro visioni sull’essere umano dalla prospettiva delle neuroscienze risul tano antitetiche.
Le nuove tecniche di integrazioni dei trattamenti a scopo curativo che associano la risposta di mente e corpo
di Antonio Tundo Direttore Istituto di PsicopatologiaDa qualche anno si è aperta una nuova frontiera per il trattamento dei disturbi psichiatrici, l’integrazione tra farmaci e psicoterapia. Si tratta di un grande passo in avanti perché storicamente le due modalità di cura, soprattutto per motivi ideologici, era no considerate contrapposte ed era frequente sentire affermazioni come “la psicoterapia non ha una validazio ne scientifica”, “seguire un percorso psicoterapeutico ritarda il ricorso alle cure mediche” oppure “i farmaci bloccano il lavoro psicologico e medi calizzano il disagio emotivo”.
Caduta la barriera dei pregiudi zi, rimane però ancora un problema pratico da affrontare: i due strumenti terapeutici sono spesso combinati su base empirica, seguendo l’idea che “due è meglio di uno” o che la com binazione è “utile sempre e per tutti i disturbi”. Ma le evidenze scientifiche e l’esperienza di chi utilizza questa combinazione da decenni ci dicono che non è affatto così: associare far
maci e psicoterapia, al pari di qualsiasi trattamento in psichiatria come in me dicina, ha specifici indicazioni e limiti di cui occorre tenere conto.
Come e perché combinare farmaci e psicoterapia
Bisogna attentamente valutare in quali condizioni può essere utile segui re un trattamento combinato, quale è il momento giusto per ricorrervi e con quali obiettivi.
Ci sono dei disturbi, come le for me lievi di depressione, di disturbo di panico, di disturbo ossessivo com pulsivo e di ansia sociale, che possono rispondere bene alla psicoterapia e, se la persona lo sceglie, l’intervento psi cologico è consigliato. In questi casi si associa una terapia farmacologica successivamente e solo in chi, dopo un tempo ragionevole, non ha ottenuto un risultato soddisfacente. Obiettivo della combinazione è ridurre la sinto matologia che la psicoterapia da sola non è riuscita a contenere.
Per le forme medie e gravi di de
pressione, disturbo di panico e di di sturbo ossessivo compulsivo è la te rapia farmacologica è la prima scelta. La psicoterapia verrà proposta in un secondo momento in quel 10-30% di casi in cui i farmaci, pur essendo stati correttamente prescritti e assunti, han no dato risultati parziali. Scopo della combinazione è sia la risoluzione dei sintomi residui, sia limitare il rischio di future ricadute.
Anche nel disturbo bipolare e nel le psicosi la terapia farmacologica è la prima e indispensabile scelta per rag giungere il pieno controllo, o il miglio re controllo possibile, della sintomato logia. Solo dopo aver ottenuto questo risultato si affiancherà una psicotera pia per aiutare la persona a migliorare la conoscenza della malattia, a essere più consapevole dell’importanza di as sumere regolarmente le cure, a modi ficare gli stili di vita che aumentano il rischio di ricadute, a recuperare l’auto stima, tornare al proprio ruolo in fami glia, al lavoro e nelle relazioni sociali. Farmaci e psicoterapia si associano simultaneamente quando le due tera pie insieme hanno maggiori probabili tà di successo di ciascuna singolarmen te, come nel caso della contemporanea presenza di più disturbi (per esempio disturbo bipolare e disturbo ossessi vo compulsivo), quando il disturbo psichiatrico è complicato da abuso di alcol o sostanze e quando il quadro clinico è complicato da problematiche psicologiche ed esistenziali.
Le psicoterapie non sono tutte uguali e non hanno tutte le stesse indi cazioni. Esistono infatti numerosi indi rizzi psicoterapeutici profondamente differenti tra loro per principi a cui si ispirano, tecniche utilizzate, obiettivi che si propongono, durata del tratta mento ecc.
Ancora una volta la scelta dovreb
be essere guidata dalle evidenze scien tifiche perché negli ultimi anni alcune forme di psicoterapia, soprattutto quelle definite “brevi” e mirate a spe cifici obiettivi, sono state sottoposte a prove sperimentali rigorose che ne hanno dimostrato la validità.
È il caso della terapia cogniti vo-comportamentale che è efficace nei disturbi d’ansia (disturbo di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, ansia sociale), nella depressione e nei distur bi della condotta alimentare. Oppure della terapia interpersonale, utile nella depressione e nel disturbo bipolare.
Per le patologie più gravi (distur bo bipolare, psicosi) non è tanto im portante il tipo di psicoterapia ma la conoscenza anche degli aspetti clinici di queste condizioni da parte del te rapeuta e la sua capacità di adattare con elasticità l’intervento al singolo paziente. Per chi soffre di psicosi, di sturbo bipolare o di disturbo ossessi vo compulsivo, e per i loro familiari, è molto utile la psicoeducazione, un intervento con un numero prestabi lito e limitato di incontri che aiuta a conoscere a fondo il disturbo e a ca pire come affrontarlo per aumentare le possibilità di efficacia delle cure e ridurre il rischio di ricadute.
In conclusione, la combinazione di farmaci e psicoterapia è un importante passo avanti nel trattamento dei distur bi psichiatrici che consente di raggiun gere risultati più completi sia sul piano del controllo dei sintomi, sia su quello del recupero funzionale. Come tutte le terapie, deve essere utilizzata seguendo i suggerimenti della ricerca scientifica per evitare di sprecare risorse, in termi ni economici e di tempo, e di esporre la persona a un fallimento terapeutico a causa del quale non sarà più disposta a ripetere l’esperienza (“ho già seguito una psicoterapia ma non mi è servita a niente”, “ho preso i farmaci ma sono stato solo peggio”).
Le psicotera pie non sono tutte uguali e non hanno tutte le stesse indicazioni. Esistono infatti numerosi indirizzi psicoterapeutici profondamente differenti tra loro per principi a cui si ispirano, tecniche utilizzate, obiettivi che si propon gono, durata del trattamento ecc.

Con il termine generico «de menza» si identificano oltre cento diversi tipi di malat tie che si manifestano con disturbi di funzioni cerebrali quali il pensiero, l’orientamento, la memoria e il linguaggio.
Un mondo complicato, dunque, anche solo per comprenderlo. Ma partiamo col dire che la demenza è una malattia neurodegenerativa che determina una riduzione graduale e irreversibile delle facoltà cognitive. Il principale fattore di rischio per la demenza è l’età. Al di sotto dei 60 anni, il rischio di sviluppare una forma di demenza è estremamente basso, mentre si stima che tra il 4 e il 6% delle persone con più di sessan tacinque anni sia affetto da demenza. Nelle persone con più di ottant’anni di età, si ammala circa un soggetto su cinque. In Italia, le persone affette da demenza sono circa un milione. Si stima che negli anni a venire, con l’au mento della popolazione anziana, il numero dei malati sia destinato a cre scere. A causa del rapido invecchia mento della popolazione mondiale, la demenza è diventata un problema in tutto il mondo; la malattia comporta un notevole onere per gli individui e le loro famiglie, nonché per il sistema sanitario.
Esistono diverse tipologie di de menza, come detto, tra cui la demen za vascolare, il morbo di Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy. Il morbo di Alzheimer è la forma di demenza più nota e più frequente, giacché in teressa il 50% dei casi. La malattia porta il nome del suo scopritore, lo psichiatra Alois Alzheimer, che nel

Esistono diverse tipologie di demenza. Il morbo di Alzheimer è la forma di demenza più nota e più frequente, giacché interessa il 50% dei casi. La malattia porta il nome del suo scopritore, lo psichiatra Alois Alzheimer, che nel 1906 descrisse per la prima volta la progressiva dege nerazione delle cellule nervose nel cervello.

1906 descrisse per la prima volta la progressiva degenerazione delle cel lule nervose nel cervello tipica, ap punto, dell’Alzheimer. Le cause di questi cambiamenti patologici sono, ad oggi, ancora sconosciute.
Quando raggiunge uno stadio avanzato la demenza può causare una perdita pressoché totale delle capacità cognitive, caratterizzata da incapacità nel riconoscere i propri cari, difficoltà di deglutizione, perdita della capacità di orientamento, etc. Attualmente, è ritenuta una patologia irreversibile, per cui non esiste alcuna cura efficace riconosciuta, ma solo terapie che con tribuiscono ad alleviare i sintomi.
I sintomi
Inizialmente, le manifestazioni ti piche della malattia comprendono:
- mancanza d’iniziativa e/o ten denza alla passività;
- lievi o impercettibili difficoltà di calcolo, linguaggio, comprensione e ragionamento;
- oscillazioni dell’umore;
- disturbi mnemonici di lieve enti tà (dimenticanza di eventi attuali o di nuove informazioni);
- ridotta capacità di orientamento temporale e spaziale.
Durante lo stadio intermedio si aggiungono:
- maggiore instabilità emotiva;
- difficoltà a sbrigare attività banali; - confusione e disorientamento spazio-temporale;
- problemi visivi (difficoltà nel quantificare le distanze e/o nel rico noscere i colori);
- evidenti difficoltà di linguaggio; - problemi con la memoria a breve e a lungo termine;
- perdita delle abilità cognitive, dalla capacità di apprendimento a quella di giudizio.
L’ultima fase della malattia, la de menza grave, è contraddistinta dalla massiccia compromissione delle fa coltà intellettuali, dalla perdita del linguaggio, dall’incapacità di ricono scere le persone care e dalla riduzione della mobilità. La persona ha assoluto bisogno di assistenza. In alcuni casi, infine, il soggetto può manifestare sintomi quali urla e aggressività, agi tazione, inquietudine, insonnia.
La diagnosi di demenza può es sere difficile a causa del suo esordio insidioso, dei sintomi che assomiglia no a una perdita di memoria “norma le per l’età” e di una varietà di altri
sintomi di presentazione, come ad esempio la difficoltà a trovare alcune parole o a prendere decisioni. Si deve anche considerare la capacità di un individuo di compensare o addirittu ra negare i propri sintomi nelle prime fasi. La famiglia è molto importante, perché può aver notato difficoltà di comunicazione, di memoria e cam biamenti di personalità o di umore, che il paziente nega.
I medici di base svolgono un ruo lo fondamentale nella diagnosi tem pestiva della demenza, le diagnosi differenziali includono il deteriora mento cognitivo dovuto al normale invecchiamento e la depressione. Fondamentale per una diagnosi tem pestiva è la percezione da parte del
medico di base dei segnali di allarme. Se i pazienti, i familiari o il medico di base notano segni di una possibile demenza, è necessario avviare una va lutazione neuropsicologica approfon dita. L’anamnesi raccolta dal paziente e dai familiari e l’esame fisico, inte grati da una valutazione neuropsico logica tramite una batteria di test ad hoc costituiscono la base di un primo accertamento. Se si sospetta una de menza, dovrebbe essere poi integrato un esame di laboratorio, ovvero una risonanza magnetica o una TAC, pri ma che il paziente, se appropriato, avvii terapie farmacologiche (inibitori dell’acetilcolinesterasi) e non farma cologiche (stimolazione cognitiva), che aiutano a ritardare il deteriora mento cognitivo e a migliorare la qua lità della vita del paziente.
Come abbiamo già detto, con l’a vanzare dell’età, aumenta il rischio di sviluppare una forma di demenza. Tut tavia, su alcuni fattori di rischio è pos sibile influire. Un’alimentazione sana e corretta, molto movimento e parteci pazione attiva alla vita sociale aiutano a ridurre il rischio di ammalarsi.
Quali sono i rimedi Praticare sport regolarmente ridu ce il rischio di insorgenza del morbo di Alzheimer o di una diversa forma di demenza. L’attività fisica, infatti, ha effetti positivi sulla pressione ar teriosa e sul peso. Fare movimento, inoltre, riduce il rischio di diabete, e le persone affette da diabete sono più propense a sviluppare un qual che tipo di demenza. È importante, dunque, ritagliare tempo per fare re golarmente attività fisica, da soli, in compagnia di amici o con la famiglia. Un’alimentazione sana ed equili
Quando raggiunge uno stadio avan zato la demenza può causare una perdita presso ché totale delle capacità cognitive, caratterizzata da incapacità nel ri conoscere i propri cari, difficoltà di deglutizione, per dita della capacità di orientamento, etc.

I medici di base svolgono un ruolo fondamentale nella diagno si tempestiva della demenza, le diagnosi differen ziali includono il deterioramento cognitivo dovuto al normale invec chiamento e la depressione.
brata è importante tanto quanto una regolare attività fisica. Certi alimenti hanno effetti positivi sull’organismo: frutta, verdura, acidi grassi insaturi derivati da oli vegetali (olio di colza o olio di oliva), pesce, carboidrati da farinacei, pane integrale e riso, ad esempio. Meno sani, invece, sono i piatti pronti, la carne rossa, gli acidi grassi saturi (derivati da carne, salu mi o prodotti lattiero-caseari molto grassi quali formaggio, panna e bur ro) e quantità eccessive di sale e zuc chero. Facendo attenzione alla vostra alimentazione contribuite a ridurre il rischio di sviluppare una forma di demenza. È ormai noto come eserci zio fisico e alimentazione controllata possano aumentare l’espressione di fattori neurotrofici (es. BDNF) agen do così su neuroplasticità e neuroge nesi. La corsa, per esempio, può sti molare la proliferazione delle cellule staminali nel giro dentato dell’ippo campo e migliorare la comunicazione tra queste nuove cellule e la regione cerebrale critica per l’apprendimento spaziale e la memoria.
Il cervello ha abilità eccezionali. Va, però, tenuto in esercizio: un al lenamento mirato aiuta a mantenere il cervello in forma. Imparare una nuova lingua straniera, giocare a car te, suonare uno strumento musicale o imparare una poesia a memoria sono tutti esercizi ideali per la mente e con tribuiscono a prevenire la demenza.
Anche i contatti sociali possono dare un valido contributo alla ridu zione del rischio di demenza. Trova tevi con amici e famigliari, parlate e ascoltate, mantenete una vita sociale attiva e dedicate tempo alle persone a
voi care. Con la giusta combinazione di attività fisica, allenamento mentale e rapporti sociali resterete giovani nel corpo, nello spirito e nella mente.
Campanelli d’allarme È opportuno sapere che quando si supera la mezza età, tra i 60 e i 65 anni, il cervello umano va incontro a un naturale processo di involuzione: diventa più piccolo di volume, per de alcuni neuroni e non è più effica ce come un tempo nel trasmettere i segnali nervosi. Tutto ciò, però, non significa soffrire di demenza, anche se alcuni disturbi potrebbero farlo pensare. Quando, però, dimenticare cessa di essere un fatto normale e si converte in un sintomo di demenza? Perché si possa sospettare l’insorgere della malattia, devono essere presenti più segnali d’allarme e tutti devono denotare un cambiamento rispetto al passato.
I sintomi della demenza senile su biscono un peggioramento graduale, che è strettamente dipendente dalla progressiva morte delle cellule nervo se cerebrali.
In genere, l’evoluzione sintomato logica della demenza senile è un per corso a tre stadi: iniziale, intermedio e avanzato. I sintomi più caratteristici della demenza senile allo stadio ini ziale sono: vuoti di memoria che pesano sulla vita quotidiana. Le persone af fette da un’incipiente demenza hanno problemi di memoria a breve termine. Possono, ad esempio, dimenticare un accordo preso il giorno prima, o non ricordare dove hanno messo questo o quello. Può succedere che cerchino di mascherare la propria smemora tezza. i sentono spaventate da questi
cambiamenti di cui non capiscono la ragione e in parte si vergognano della propria smemoratezza; disorientamento spaziale e temporale. Le persone affette da de menza hanno problemi via via cre scenti a orientarsi. Ecco allora che non sanno più arrivare in un dato luo go sebbene conoscano bene la zona. In genere, manifestano difficoltà a guidare l’auto o a orientarsi in posti nuovi. Anche la dimensione tempora le è fonte di confusione; difficoltà a compiere azioni quotidiane e attività note. Spesso, le persone affette da demenza hanno difficoltà a utilizzare oggetti che ma neggiavano quotidianamente, quali il telecomando della televisione, la lavatrice, il computer o il distributo re automatico di biglietti. Oppure, smettono di eseguire i pagamenti con regolarità e puntualità perché im provvisamente trovano la procedura troppo difficile. Occorre più tempo per svolgere compiti familiari e gli er rori si verificano con più frequenza; difficoltà ad organizzarsi o a risolvere i problemi. Le persone che soffrono di Alzheimer o di un’altra forma di demenza fanno via via più fatica a organizzare e programmare le attività quotidiane. I passi per prepa rare un pasto (fare la spesa, cucinare, servire in tavola) o organizzare una gita (consultare gli orari dei mezzi, comprare i biglietti, ecc.) creano d’un tratto difficoltà enormi; problemi di linguaggio. Tra i sintomi della fase iniziale del morbo di Alzheimer o di una forma diversa di demenza vi sono anche le difficoltà di linguaggio: la persona è incapace di esprimersi con chiarezza e in modo fluido. Dimentica parole comuni o
non riesce a terminare le frasi. Nel corso della malattia diventa sempre più taciturna e tende a evitare la con versazione; cambiamenti della persona lità e comportamenti inadeguati. È normale che con l’età e nel corso di tutta l’esistenza, anche il nostro modo di comportarci cambi e si evolva. La demenza, tuttavia, provoca cambia menti particolarmente profondi ed evidenti. Ad esempio, rende la per sona irrequieta o apatica. Alla base di trasformazioni del genere può esserci la consapevolezza di stare perdendo il controllo sulla propria vita. Le perso ne affette da demenza tendono a mo strare, inoltre, comportamenti insoliti o inadeguati. È il caso, ad esempio, del nonno che, anziché la solita tavo letta di cioccolato, mette nelle mani del nipotino una banconota da cento; svogliatezza e riduzione dei rapporti sociali (umore a volte basso e principio di depressione). Il lavoro in giardino, che prima dava tanta gioia, viene abbandonato, la partita serale a carte viene disdetta e la passeggiata con il cane si fa sempre più rara. Di fronte alle crescenti sfide che la vita quotidiana comporta, le persone af fette da demenza perdono la motiva zione e la voglia di dedicarsi ai propri hobby. Trascurano i rapporti sociali e per vergogna si chiudono sempre più in sé stesse; problemi di logica e di calcolo; difficoltà nel comprendere nuovi concetti.
Riconoscere da subito i sintomi iniziali e rivolgersi tempestivamente a uno specialista è fondamentale per poter diagnosticare in tempi brevi la patologia e stopparne o rallentarne il decorso.
Riconoscere da subito i sintomi iniziali e rivolgersi tempestivamente a uno specialista è fondamentale per poter diagnostica re in tempi brevi la patologia e stop parne o rallentar ne il decorso.

Caratterizzazione genetica molecolare e farmaci mirati alla base della cura persona lizzata. I risultati dello stu dio dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede pubblicati su Therapeu tic Advances in Medical Oncology.

Una terapia sperimentale accre sce l’aspettativa di vita dei bambini affetti da un tumore cerebrale molto aggressivo e inoperabile: il glioma diffuso della linea mediana. La so pravvivenza media di questi piccoli pazienti passa da meno di 12 mesi dalla diagnosi a circa 24. Il risultato arriva da uno studio clinico dell’O spedale Pediatrico Bambino Gesù, tra i primi Centri a livello internazio nale ad aver sperimentato una cura basata sulla caratterizzazione geneti ca molecolare del tumore di ciascun paziente coinvolto nella ricerca e sull’uso di farmaci ‘target’, cioè mi rati. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Therapeutic Advances in Medical Oncology.
I gliomi diffusi della linea me diana sono tumori tipici dell’età pediatrica caratterizzati, per oltre il 90%, da mutazioni della proteina H3K27M. A questa si associano al tre anomalie genetiche che possono variare da caso a caso. Si sviluppano nelle strutture mediane del cervel lo, tra le quali il ponte, la parte del tronco encefalico che regola funzioni vitali come il respiro e l’attività car diaca. Questi tumori sono molto ag gressivi, tendono a diffondersi rapi damente e a infiltrarsi in profondità. A causa della loro sede, non possono essere asportati chirurgicamente.
In Italia vengono diagnosticati
Lo studio per il trattamento sperimentale dei “gliomi del ponte” è stato condotto dal team multidisciplinare di Neuro-Oncologia (clinici, chirurghi, patologi, biologi) del Bambino Gesù. La ricerca è durata 4 anni e ha coin volto 25 pazienti di età compresa tra i 5 e i 14 anni.
circa 20-25 casi pediatrici all’anno di gliomi localizzati nel ponte, con un picco d’incidenza tra i 5 e i 10 anni di età. La sopravvivenza media è molto bassa (9 -12 mesi) e meno del 2% dei bambini sopravvive a 5 anni dal la diagnosi, nonostante i trattamenti radio e chemioterapici che costitu iscono la terapia standard. Contro questo genere di tumori, purtroppo, non è stata ancora individuata una cura efficace.
La terapia sperimentale personalizzata Lo studio per il trattamento spe rimentale dei “gliomi del ponte” è stato condotto dal team multidisci plinare di Neuro-Oncologia (clini ci, chirurghi, patologi, biologi) del Bambino Gesù. La ricerca è durata 4 anni e ha coinvolto 25 pazienti di età compresa tra i 5 e i 14 anni.
La terapia sperimentale si è ba sata sullo studio delle caratteristiche genetiche del tumore di ogni singolo paziente incluso nella ricerca: por zioni di tessuto tumorale ottenute tramite biopsia sono state analizza te alla ricerca di anomalie genetiche che potessero essere il bersaglio di farmaci già disponibili. Questa fase di indagine genetica sui tumori è stata possibile grazie a tecnologie di Next Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi molecolare avanzata, disponibili nei Laboratori di Dia gnostica dell’Ospedale.
In base ai risultati di laboratorio, oltre alla terapia standard, a 9 bam bini su 25 è stato possibile sommini strare in un secondo momento anche farmaci ‘target’, cioè diretti contro le specifiche mutazioni individuate nel loro tumore. Nei pazienti trattati con la terapia personalizzata non sono
stati rilevati effetti collaterali gravi e la sopravvivenza media è passata da meno di 12 mesi dalla diagnosi a cir ca 24 mesi.
«La combinazione di terapia standard e farmaci mirati ha porta to a risultati mai ottenuti prima nel trattamento di questa terribile forma di cancro» spiega la dott.ssa Ange la Mastronuzzi, coordinatrice dello studio e responsabile di Neuro-On cologia, struttura del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellu lare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico diretto dal prof. Fran co Locatelli. «Per i gliomi H3K27M alterati oggi non esiste una cura - prosegue Mastronuzzi - ma questi tumori possono esprimere altre ano malie genetiche contro cui abbiamo delle armi. Consentire ai bambini malati di vivere più a lungo signifi ca dare loro una chance in più per beneficiare di nuovi trattamenti via via disponibili o di trial clinici nei quali aggiungere già in prima linea le medicine target. Tutto questo è stato possibile grazie alla stretta collabo razione del team multidisciplinare di Neuro-Oncologia e in particolare del dott. Andrea Carai, neurochirur go e della dott.ssa Sabrina Rossi ana tomo-patologa, che hanno permesso di ottimizzare il percorso di questi pazienti».
e prospettive dello studio
Lo studio del team di medici e ri cercatori del Bambino Gesù, sebbe ne condotto su un piccolo gruppo di bambini, ha dimostrato che le cellule tumorali di gran parte dei gliomi dif fusi della linea mediana esprimono diverse alterazioni genetiche. Contro alcune di queste mutazioni sono già
disponibili farmaci mirati. I risulta ti della ricerca evidenziano quindi l’importanza di procedere con biop sia e caratterizzazione molecolare del tumore per disegnare un piano terapeutico che dia maggiori chance di sopravvivenza ai pazienti rispetto alla somministrazione della sola tera pia standard.
Lo studio è stato sostenuto dall’Associazione “Il coraggio dei Bambini” e, per la sua rilevanza scientifica, nel mese di ottobre 2022
è stato premiato come migliore pre sentazione orale al Congresso Nazio nale AIEOP - Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica.

La ricerca scientifica verso una cura efficace intanto prosegue su più fronti: all’Ospedale Pediatrico della Santa Sede è in fase di autorizzazione da parte degli enti regolatori un nuo vo trattamento dei tumori cerebrali con cellule CAR-T geneticamente modificate coordinato dal professor Franco Locatelli.
Lo studio del team di medici e ricercatori del Bambino Gesù ha dimostrato che le cellule tumorali di gran parte dei gliomi diffusi della linea mediana esprimono diverse alterazioni gene tiche.
Lo sappiamo bene ed esiste dalla notte dei tempi: la rela zione genitore-bambino è una com-ponente fondamentale per lo sviluppo di quest’ultimo in quan to costituisce il suo mondo affet-tivo e sociale, determina la struttura delle sue difese e porta alla formazione di rappresenta-zioni riguardanti le aspet tative rivolte alle relazioni con gli altri. La famiglia si presenta come nucleo all’interno della quale si intrecciano fattori di rischio e fattori protettivi che influenzano lo sviluppo dell’infante e risulta quindi di primaria importanza analizzare le molteplici situazioni che si pongono come l’origine di numerosi disturbi, tra cui la depressione.
In tale analisi è importante consi derare diverse dinamiche che determi nano la molteplicità di situazioni che il bambino si trova a vivere, dinamiche che sono presenti ancor prima che il
bambino arrivi nel nucleo familiare, come il vissuto della genitorialità.
La genitorialità non coincide con la nascita di un figlio, ma anzi è il risul tato di un lungo pro-cesso di elabora zione e riorganizzazione delle proprie esperienze di vita e dei propri vissuti.
Diventare genitori comporta an che un processo definito il “lavoro del lutto” che implica la ri-nuncia al ruolo di bambino che si ricopriva con i propri genitori e il doversi identifica re con questi ultimi per poter svolgere la funzione genitoriale. Al bambino, il genitore delega una par-te dei suoi desideri e bisogni infantili attraverso meccanismi di identificazione proiet tiva, non necessariamente patologici, ma che, anzi, solitamente permettono lo stabilirsi dell’empatia e favoriscono lo sviluppo psichico del bambino.
Il “lutto dello sviluppo” implicato nella genitorialità reca in sé la possi
bilità, quindi, di generare depressivi tà, determinando lo sviluppo di una conflittualità genitoriale che dipende dall’elaborazione dei lutti della pro pria infanzia, cioè quelli riguardanti un oggetto realmente perduto e quelli che implicano invece un oggetto fan tasmatico.
I vissuti legati alla genitorialità sono molto complessi e possono por tare all’insorgere di diverse problema tiche, infatti, Palacio Espasa descrive quattro tipi di dinamiche genitoriali, tra cui si evidenziano in particolare due tipologie patologiche: la genito rialità masochistica e la genito-rialità narcisistico-dissociata.
La genitorialità masochistica è ca ratterizzata da lutti basati sul senso di colpa e prevede due tipologie di casi: nel primo caso i neogenitori hanno
avuto a loro volta dei genitori con forti tendenze depressive e sono stati vis suti come figli “difficili”; nel secondo caso i genitori hanno vissuto i propri genitori come indegni, abbandonici e tendono ad essere molto protettivi nei confronti del proprio figlio. Allo stes so tempo si identificano con il genitore indegno, a cui han-no rivolto le pro prie accuse in passato, sottometten dosi al bambino, all’aggressività che proiettano su di lui, mossi dal bisogno di espiazione masochistica. Tali geni tori possono favo-rire l’insorgere, nel proprio figlio, di alcuni fenomeni pa tologici come disturbi dell’autostima, causati dall’atteggiamento sottomesso che assumono nei confronti dei geni tori, determinando una trasmissione intergenerazionale della depressivi tà. Inizialmente il bambino presenta vis-suti di grandiosità veicolati dalle identificazioni proiettive del genitore,
I vissuti legati alla genitorialità sono molto complessi e possono portare all’insorgere di diverse proble matiche, infatti, Palacio Espasa descrive quattro tipi di dinamiche genitoriali, tra cui si evidenziano in particolare due tipologie patologi che: la genitoria lità masochistica e la genito-rialità narcisistico-disso ciata.

L’attaccamento è un sistema motivazionale innato e biolo-gica mente adattivo, caratterizzato da tre elementi fondamentali: la ricerca di vicinanza al ca-regiver, l’effetto “base sicura” (il legame che permette al bambino di sentirsi capace di esplo-ra re l’ambiente e di trovare conforto nei momenti di ansia) e la protesta per la separazione.
portando a comporta-menti molto difficili e tirannici, ma tale grandiosità lascia poi spazio alle immagini svalo rizzanti che si rafforzano negli scambi con i genitori “vittime”.
Le identificazioni proiettive su cui si basano i conflitti della genitorialità narcisistica-dissociata sono unidirezio nali e deformanti rispetto all’immagi ne del bambino e sono caratterizzate dalla proiezione di immagini negative di se stessi, che assumono per il bam bino il carattere di per-secutorietà. La conflittualità genitoriale viene negata e coperta da immagini parentali posi tive, non conflittuali, assumendo così un narcisismo di base di tipo distrut tivo e generando nel bambino disturbi dell’attaccamento. Tali genitori, con le loro identificazioni proiettive pato logi-che, deformano l’immagine del figlio e lo sommergono di immagini negative del loro passato. L’interazio ne tra madre e figlio, in particolare, diventa molto problematica a causa dell’atteggiamento materno rifiutante e distanziante, generando vissuti di frustrazione e peri-colo nel bambino, che tenderà a difendersi da ciò tramite meccanismi tipici dell’Io narcisistico primario. Il bambino si identificherà con l’immagine di rifiuto, trasmessa dalla madre, e tale immagine diventa il nucleo fondante della sua struttura psichica, generando profonde diffi col-tà nell’attaccamento tra madre e bambino. Inevitabilmente gli scambi fisici tra madre e bam-bino, fonda mentali per lo sviluppo emotivo, non riescono ad essere piacevoli e a dare il via a tutte le funzioni fondamentali per un corretto funzionamento psichico, determinando l’insorgenza dei distur bi dell’umore (Palacio Espasa, 2004).
Il punto vero della questione è che l’attaccamento è un sistema mo tivazionale innato e biolo-gicamente adattivo, caratterizzato da tre elementi fondamentali: la ricerca di vicinanza al ca-regiver, l’effetto “base sicura” (il legame che permette al bambino di sentirsi capace di esplo-rare l’ambien te e di trovare conforto nei momenti di ansia) e la protesta per la separazione.
Il sistema di attaccamento, da un punto di vista evoluzionistico, per mettendo di mantenere e sollecitare la prossimità alla figura di riferimento, aumenta le probabilità di sopravviven za del bambino, data la sua scarsa au tonomia e le sue capacità limitate.
Il sistema di attaccamento del bam bino, tuttavia, si intreccia con quello del genitore, predi-sponendo quest’ul timo a determinate risposte e dinami che nell’accudimento; la qualità di tali risposte determinerà la formazione nel bambino di quelli che Bowlby chiama “Modelli Operati-vi Interni”. Questi ultimi sono delle mappe rappresenta zionali che si costruiscono attraverso le interazioni tra bambino e caregivers; in base alle risposte di questi ultimi, si creeranno nel bambino una serie di aspettative, immagini di sé e assunti che guideranno le relazioni. Il bambi no, in questo modo, diviene capace di usare questo sistema rappresentaziona le per predire il proprio e altrui com portamento e quindi gli stili di intera zione e regolazione degli af-fetti che si consolidano nel corso dello sviluppo; saranno dei prototipi per i successivi processi di mediazione che consenti ranno di instaurare relazioni sociali e di mantenere un senso di si-curezza nelle situazioni stressanti.
La tecnologia usata in 5 centri riabilitativi (e uno è in Italia)
Un vero e proprio «cervello» per tor nare a camminare e che rende le persone protagoniste della propria riabilitazione, gestendo la comunica zione tra sistema nervoso centrale e periferico. La tecnologia è stata messa a punto da una start up innovativa al Point di Dalmine - utilizzata in cinque importanti centri riabilitativi lombardi, tra cui la Domus Salutis di Brescia - ed è stato presentato al World Forum for Medicine 2022 che si è tenuto dal 14 novembre a Düsseldorf.
Il dottor Viktor Terekhov (inventore del la tecnologia) e l’ingegner Guido Gabbrielli hanno sviluppato il progetto della macchina in collaborazione con i clinici. Gabbrielli spiega al Giornale di Brescia: «Volevamo creare una tecnologia che migliorasse la qualità della vita di persone che, per diverse ragioni, hanno subìto una paresi. Abbiamo per questo svilup pato un metodo in grado di dialogare con il Si stema nervoso centrale attraverso l’erogazione di stimoli funzionali neuromuscolari mescolati al movimento attivo. In questo contesto - con tinua Gabbrielli - il paziente recita un ruolo at tivo, fondamentale nel percorso riabilitativo».
Esistono molte apparecchiature utilizzare nella neuroriabilitazione e che si basano sulla stimolazione elettrica funzionale. «La differen za del nostro metodo è proprio data dal fatto che il paziente è una componente attiva dell’e sercizio terapeutico e questo è finalizzato ad innescare meccanismo di neuroplasticità».
L’ingegner Gabbrielli parla con cognizio
ne di causa. Qualche anno fa, come lui stesso racconta al Giornale di Brescia, ha subìto una lesione spinale a seguito di un incidente in moto. Danno fisico che, ad oggi, gli impedisce di muoversi in modo completamente autono mo. La macchina di nome VIK-16 è unica nel suo genere perché con la stimolazione neurale porta il paziente a muovere col tempo gli arti in maniera autonoma, ovviamente nei casi in cui la ripresa è possibile e non irreversibile.
La Domus è uno dei centri in cui viene uti lizzata la macchina VIK-16. Ne parla al Gior nale di Brescia Luciano Bissolotti, direttore del Dipartimento di recupero e rieducazione fun zionale di Fondazione Teresa Camplani- Casa di cura Domus Salutis: «Le più recenti metodiche di elettrostimolazione applicate al settore della neuroriabilitazione sfruttano la combinazione di correnti in grado di stimolare e assecondare la residua e spontanea capacità del paziente di effettuare un gesto in modo ripetuto più volte. Il moderno dispositivo di elettrostimolazione multicanale VIK-16 viene utilizzato quotidiana mente nella nostra Casa di cura durante sessioni di trattamento degli arti inferiore e superiore in pazienti affetti da disabilità neurologica».
Quali le caratteristiche del dispositivo VIK16? «La possibilità di impostare programmi di trattamento in grado di coinvolgere sino a sedici muscoli in modo coordinato permette di impo stare simultaneamente il trattamento in modali tà unilaterale e bilaterale, dell’arto superiore e di quello inferiore». (A. V.)
Lo studio che dimostra i benefici sul cervello di Francesco Carta
acido folico, detto comu nemente anche vitamina B9 o folacina, ha tanti benefici, alcuni scoperti recentemente insospettabili. La rac comandazione di assumere questa vitamina all’inizio della gravidanza o, meglio, cominciando qualche mese prima del concepimento, è in corso da svariati decenni. Si è visto, infatti, che le donne abituate a integrare l’alimen tazione con acido folico o che ne con sumano adeguate quantità seguendo un’alimentazione ricca di verdure a foglia verde, riducono notevolmente il rischio di partorire un figlio con spina bifida o con anencefalia, cioè i cosid detti difetti del tubo neurale.
Uno studio dei Centers for Dise ase Control and Prevention (Cdc) ha rilevato che negli Usa, dopo la dispo sizione chiesta dalla Food and Drug
Administration di arricchire i cereali con acido folico, in 16 anni, i tassi dei difetti del tubo neurale sono scesi del 35%. Si calcola che i bimbi nati con queste patologie siano stati 1.300 in meno all’anno.
Ma ora un ampio studio ci mostra anche che l’assunzione di acido folico è associata a una riduzione del 44% di suicidi, pertanto, può fornire un approccio sicuro ed efficace per ri durre le idee suicidarie.
In psichiatria, il ruolo del folato, la forma naturale non ossidata della vitamina B9, è riconosciuto da più di un decennio. Può aumentare gli effetti degli antidepressivi, e la caren za di folati può predire una risposta più scarsa agli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI).
Sebbene ricerche precedenti ab biano mostrato un legame tra acido fo
lico, cioè la forma ossidata del folato, e comportamenti suicidari, i risultati, finora, erano poco conclusivi dato che provenivano da studi generalmente a basso impatto statistico o da piccoli studi osservazionali e casi clinici.
I ricercatori hanno preso in esame una coorte di 866.586 adulti (81,3% donne; 10,4% di età pari o superio re a 60 anni) che hanno ricevuto una prescrizione di acido folico tra il 2012 e il 2017.
I partecipanti sono stati seguiti per 24 mesi. L’analisi ha confronta to i tentativi di suicidio o gli eventi di autolesionismo risultanti in una visita ambulatoriale o in un ricovero ospedaliero durante i periodi di trat tamento con acido folico rispetto ai periodi senza trattamento.
Durante il periodo di studio, il tasso complessivo di eventi è stato di 133 per 100.000 abitanti, che è circa un quarto del tasso riportato nella po polazione generale dal National Insti tutes of Health di (600 per 100.000 abitanti).
L’analisi di sensibilità ha mostrato che ogni mese di trattamento era asso ciato a una riduzione del 5% del tasso di eventi suicidi. Ciò significa che più a lungo prendi l’acido folico, maggio re è il beneficio, indice, secondo i ri cercatori, di una reale associazione tra trattamento e risultato osservato.
I ricercatori hanno anche valuta to un gruppo di controllo negativo di 236.610 individui che utilizzavano cianocobalamina durante il periodo di studio. La cianocobalamina è una forma di vitamina B12 essenziale per il metabolismo, la sintesi delle cellule del sangue e il sistema nervoso. Non contiene acido folico ed è comune mente usato per curare l’anemia. I
risultati non hanno mostrato alcuna associazione tra cianocobalamina e comportamento suicidario.

«La riduzione del 44% dei tentati vi di suicidio potrebbe essere in realtà una sottostima», ha affermato Robert D. Gibbons, professore di biostatisti ca all’Università di Chicago e primo autore dello studio, in quanto analiz za solo persone che hanno ricevuto una prescrizione medica, ma l’acido folico può essere assunto tranquil lamente tramite prodotti da banco senza necessitare di una indicazione specialistica. «L’acido folico è sicuro, poco costoso e generalmente dispo nibile, e se futuri studi randomizzati controllati con placebo confermas sero una causalità di questa associa zione, avremmo un nuovo strumento terapeutico. Avere uno strumento del genere sarebbe estremamente impor tante dato che il suicidio è una crisi di salute pubblica globale», ha concluso Gibbons.
Uno studio dei Centers for Dise ase Control and Prevention (Cdc) ha rilevato che negli Usa, dopo la disposizione chie sta dalla Food and Drug Administra tion di arricchire i cereali con acido folico, in 16 anni, i tassi dei difetti del tubo neurale sono scesi del 35%. Si calcola che i bimbi nati con queste patologie siano stati 1.300 in meno all’anno.
Incontro con la scrittrice romana fra romanzi, podcast film e la perpetua ricerca di emozioni forti
di Flavia PiccinniSono appena terminate le ripre se di “10 Minuti” il nuovo film di Maria Sole Tognazzi tratto dal suo omonimo libro, pub blicato da Feltrinelli. Il suo podcast “Gli Slegati” - disponibile gratuita mente su Spotify - è una bussola, e un conforto, per chi cerca di orientarsi nelle relazioni contemporanee. Il suo ultimo libro “Il grembo paterno”sempre pubblicato da Feltrinelli - ha incantato decine di migliaia di lettori, che hanno seguito la storia di Adele e di Nicola, rispecchiandosi nella sinfo nia di amore e sofferenza che è la loro storia. Chiara Gamberale - i cui libri sono stati tradotti in venti Paesi nel mondo - mi racconta così del suo ro
manzo: “Si impara a chiedere e dare amore anche attraverso i padri. L’in fanzia, o il Laggiù per dirla con Mi chele Mari, devono necessariamente attraversare anche il grembo paterno per restituire a chi l’ha vissuta una visione intera del proprio passato. Erano anni che sentivo la necessità di scrivere questa storia, ma mancava sempre la protagonista giusta”. Poi è arrivata Adele che, come tutti i per sonaggi di Chiara Gamberale ha una storia forte e unica, in cui la storia au tobiografica danza con quella creata dalla fantasia. “Adele - prosegue leiera uno dei personaggi del romanzo che stavo scrivendo prima dello scop pio della pandemia, ma più passava il
tempo più mi rendevo conto che lei era l’unica di cui mi interessava cono scere la storia. E così ci siamo scelte, non poteva essere altrimenti”. Come con l’incontro con Ade le c’è sempre un momento in cui le cose prendono forma. C’è sempre un momento in cui ci si rivela qualcosa che ci riguarda… Quando è capitato a lei?
Credo che esista sempre un mo mento nella vita di ognuno di noi dove possiamo rischiare di essere la persona che siamo. Di sicuro tra quelli che definisco “i miei momenti” - ovvero quelli che hanno determina to tutta la mia vita - c’è proprio l’in contro con quella che è stata la mia passione, che poi ho avuto la fortuna divenisse la mia professione. Io non vengo da una famiglia di letterati per ché mio papà è ingegnere e mia mam ma ha sempre lavorato in banca, ma fin da piccolissima ero una bambina che oggi definirebbero ipersensibile. Mia madre mi dice ancora oggi “tu eri

un segreto, non una figlia”. Una volta da piccola mi trovò davanti a un tra monto in lacrime e le dissi “Mamma, non è struggente questo tramonto?”. Quello che a me riusciva a dare una specie di pace era ascoltare le storie. Che ricordi ha legati a questa scoperta?
All’inizio c’era mia nonna, che mi raccontava come aveva conosciuto il nonno. Poi ho iniziato a leggere, e ho cominciato a conoscere da sola le storie. Ricordo ancora un capitolo di “Piccole donne”, quello su Jo che decide di tagliarsi i capelli per reperi re qualche quattrino… Da quel mo mento la scrittura, e la lettura, sono diventati il mio rifugio. Non era però un rifugio dal mondo. Anzi. È dove quello che mi capita riesco a capirlo meglio, o perfino a volte accettare di non capirlo. Per me leggere, scrivere ed esistere sono la stessa cosa. Tant’è che tra i libri che scrivo e la mia vita c’è una connessione molto profonda. Ho cominciato a scrivere in seconda
“Io non vengo da una famiglia di let terati perché mio papà è ingegnere e mia mamma ha sempre lavorato in banca, ma fin da piccolissima ero una bambina che oggi definirebbero ipersensibile”.

elementare il mio primo romanzo che mia mamma conserva ancora. Sopra c’è scritto “Editore Chiara Gambe rale, anni 7 e mezzo”. Si chiamava “Clara Enrichi”, seguito poi da “Cla ra Enrichi cresce”, “I figli di Clara Enrichi” e da lì sempre la mia vita di bambina, adolescente, donna, oggi madre è sempre stata accompagnata dalle storie. Io per capire il mondo leggo i romanzi anziché i giornali.
Quale libro vorrebbe leggere sul nostro tempo?
Sono molto rammaricata della scomparsa di Phil Roth, che era uno dei miei scrittori contemporanei pre feriti, perché avrei voluto leggere un suo romanzo ambientato nel lock down per capire cosa ci è successo in questi anni. A essere sincera, ancora mi sfugge. Di sicuro questa mia osti nazione a credere che la fantasia sia l’unica chiave possibile, che abbiamo per capirci qualcosa della realtà, è quello che mi permette ogni giorno di
avere più voglia che paura di vivere.
Con “Il grembo paterno” affronta diversi temi, dall’amore alla fame d’affetto. È molto difficile farne una sintesi, ma il cuore pulsante pare legato alle ossessioni.
Questo è il mio tredicesimo ro manzo, ma è come se fosse la summa di tutti quello che ho scritto fino a questo momento. Tornano delle os sessioni a me care, sembra un ossi moro, e credo che mai come in queste pagine io sia andata loro vicino, fino in fondo.
In che senso?
Adele la protagonista ha fame. Forse fame è più di una parola in questo romanzo. La fame è una pro tagonista del romanzo, quasi quanto Adele stessa. Lei viene da una fami glia in cui sono più abituati ad avere fame che a mangiare: lei ha fame di tutto, ma è come se non sia in grado di nutrirsi di niente. È più abituata ad essere affamata. Affamata dagli uomi ni, dalle situazioni, da se stessa, dalla famiglia, da suo padre che è insieme a lei il grande protagonista di questo romanzo.
Qual è l’ossessione secondo lei predominante?
Di sicuro l’ossessione principale è questa: l’ossessione tra il vuoto e il pieno, il troppo e il niente, il trovare questo equilibrio che sembra impos sibile… Questo mancato equilibrio, Adele se lo gioca attraverso l’osses sione con il cibo e con le parole. Lei viene da una famiglia dove sono più importanti le parole che non si dico no piuttosto di quelle che si riescono a pronunciare. Non a caso Adele è logorroica, vomita parole, si fida di quelle degli altri più che dei silenzi. Questo non riuscire a dosare voglia
e bisogno, naturalmente, può essere una strada ingannevole… Per tutta la sua vita Adele, fino alla nascita di sua figlia, ha avuto bisogno di quell’emo zione… Lei cerca più emozioni forti che relazioni profonde perché ne ha paura. Perché la relazione profonda da cui viene con il padre è stata tal mente faticosa per la formazione del suo io che è come se rifuggisse dalla possibilità di una relazione. La sua vita è una continua ricerca di emozio ni forti che la terrorizzano appena si concretizzano. Almeno fino alla na scita di questa figlia che arriva un po’ per caso, quasi per gioco, e che però la trova misteriosamente pronta ad accogliere finalmente un legame.
Un tema centrale per Brain è il rapporto tra la creatività e la follia. Tu che rapporto hai con questo misterioso equilibrio?
Credo di essere partita malissimo: fin da piccola se piangevo, mi dispe ravo, se ridevo, mi veniva l’asma… Era faticoso per me credere che la se renità e la pace fossero un valore. Ci si abitua ad emozioni forti, e credo che la mia vita, se si potesse riassumere in una frase, sia stata un percorso verso la fiducia nell’equilibrio. A questo proposito è stato fondamentale riu scire a trasformare quello che mi face va soffrire in un vantaggio. C’è questo saggio dello psicoterapeuta austriaco Rolf Sellin, che si chiama “Le persone sensibili hanno una marcia in più”, nel quale racconta di persone nate con questo dono. Tutta la mia vita è un tentativo di riuscire a non essere vittima dell’esigenza di emozioni for ti, di riuscire a divenirne ed esserne padrona.
Quali sono stati gli strumenti che ha messo in pratica?
Tanta terapia, tanto lavoro, gli altri. Ho intitolato un mio romanzo “La zona cieca”: è quello che gli altri percepiscono di noi, ma a noi sfugge. Fidarmi di certe persone, dello sguar do di certe persone e di certi incontri per me è stato determinante. Oggi mia figlia è, senza tutta la retorica sul la maternità, la mia maestra d’amore. Ovviamente le persone che hanno un problema con l’equilibrio fanno fatica a passare dall’innamoramento all’amore, mentre il rapporto con mia figlia mi sta facendo capire quanto ci si può innamorare continuamente.
“Il grembo paterno”
Chiara Gamberale Feltrinelli 224 pagine 18 euro
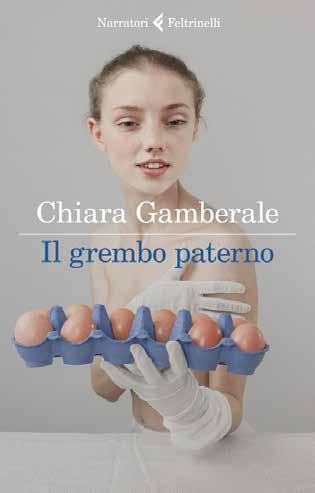
di Flavia Piccinni
Che cosa distingue una persona di successo da una persona degna di essere stimata? Esi ste ancora - in questo nostro tempo in cui si sfiora l’Olimpo per video in cui ci si umilia, e si diventa miliona ri vendendo i propri peti in barattoloun valore che travalichi l’egocentrismo e la spettacolarizzazione della propria esistenza oltre la mera idiozia? E, so prattutto, in quale momento ci siamo ritrovati ad adorare eroi senza qualità e a barattare la nostra attenzione in cambio - nel migliore dei casi - di una risata?
Non risponde ovviamente a questo la straordinaria docu-serie in quattro puntate dedicata a Wanna Marchi appe na diffusa su Netflix, ideata e firmata da Alessandro Garramone con la collabo razione di Davide Bandiera per la regia di Nicola Prosatore. Dentro infatti c’è molto, moltissimo, altro, ma in qualche modo si intravede l’inizio del baratro dentro cui ci è dato oggi sguazzare.
Nella serie la riflessione viene lasciata
al telespettatore che si ritrova catapulta to fra reperti catodici e interviste inedite in un universo costruito dai reucci delle televendite, come Roberto da Crema e Valter Carbone, e popolato da nonne/ mamme con i bigodini in testa davanti alla televisione, tutte rapite dalle televen dite di pentole, coltelli, materassi, co smetici e rossetti. Ma, soprattutto, sogni.
Frame dopo frame, lo sguardo im pietoso sul nostro Paese viene filtrato attraverso l’epopea della più celebre teleimbonitrice italiana - che qui viene raccontata dai tempi in cui era una ca salinga squattrinata che si arrangiava andando a truccare i morti. Un’esistenza in cui sopravvive qualcosa di epico e di deprimente, di contemporaneo e di pop, di disperato e di gioiosamente sfidante, se non del tutto finale.
Minuto dopo minuto, ci si ritrova invischiati - senza possibilità di fermarsi dalla visione compulsiva - in quel siero colloidale che è la miseria e lo squallo re proprio di uno show esistenziale che
presto si trasforma in una serialità da B-movie. Ecco la vita di Wanna Marchi: dallo scioglipancia (venduto ancora pri ma di essere ideato e prodotto), passan do per creme miracolose, fino ai numeri del lotto e al trucco del sale. Perché uno che sa vendere può farsi acquistare qual siasi cosa. Anche la fortuna.
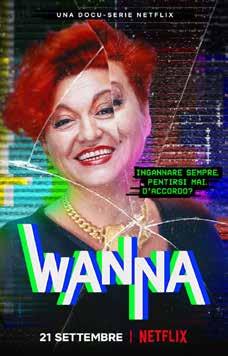
Lo racconta la stessa Wanna Mar chi, fresca di parrucchiere, imbiancata, il rossetto vermiglio e il viso capace di attraversare il tempo pressoché in modo indenne. In lei si fa forma la certezzasperiamo più promessa che interiorizza ta - di non aver fatto niente di male. C’è la completa assuefazione a quella legge della giungla in cui basta essere in grado di sopraffare gli altri, per avere il diritto di violarli. Come riporta un ex-collabo ratore in uno spezzone di Striscia la No tizia, la celebre trasmissione di Antonio Ricci che pose all’attenzione pubblica il caso: “Tutte le mattine Wanna Marchi entrava in studio e diceva sempre che ogni giorno per una Wanna Marchi si dovevano svegliare trenta coglioni da truffare”.
Scoprendo l’epopea di questa don na, si rimane impassibili davanti ai suoi primi decenni di vita - la povertà, il marito fedifrago e violento, le sfortunepoiché niente rende perdonabile per lo spettatore il male generato con strafot tenza e arroganza.
Non sono d’aiuto per seminare un briciolo di umanità né l’infanzia in una famiglia di contadini, né gli studi che si fermano alla quinta elementare, né l’os sessione di un riscatto sociale ed econo mico che passa attraverso la convinzione - mai esplicitata, ma chiaro sottotesto di ogni frame - che tutto le sia dovuto. Perché per Wanna Marchi basta essere in grado di prendere qualcosa, per me ritare di possederla. Perché “siamo tutti
deboli e abbiamo bisogno di illusioni”. Perché se riesci a ingannare “sei un truf fatore tu o un coglione lui?”.
Pare quasi che Wanna e ancora di più la figlia Stefania - evidentemente os sessionata dal compiacere la madre sfrut tando i medesimi schemi e cavalcando le stesse ambizioni - considerino grinta quella che molti specialisti indicherebbe ro come una totale e patologica assenza di empatia.
L’egoi smo nella personale scala di valo ri delle due è eviden temente ai primi posti, così come la necessità di cotonare lo smisurato ego a suon di dirette TV e di acquisti compulsivi.
La sicu rezza però spesso pro duce passi falsi. Un esempio?
La scelta di preferire al rito abbreviato un processo a porte aperte, che comprensibilmente generò un’arena catodica. Il motivo lo spiega la stessa protagonista: “Perché dovevamo ammettere delle cose che non avevamo fatto?”.
In fondo, la percezione della realtàammoniva Goethe - produce angoscia, solo con l’empiria la quotidianità si rivela tollerabile. Lezione per pochi, evidente mente non acquisita dalle due donne.
Più che a Icaro e alle sue smisurate ambizioni, Wanna appare così come un Erostrato con temporaneo: un criminale che, pur di far tramandare il suo nome, distrus se con un incendio una delle sette me raviglie del mondo antico, il tempio di Artemide. Ed è in questa ambizione di popolarità e ricchezza che forse si annida la nostra ossessione per lei.
Nella serie al processo viene dedica to un giusto spazio. Memorabili restano le espressioni delle due quando parlano le vittime - perché, come sintetizza il giornalista Stefano Zurlo, “per loro le vittime erano sempre colpevoli” - e il suggerimento, rivelato dall’avvocato del la parte civile Marzo Marzani, di Liborio Cataliotti alla sua cliente, mentre questa si avviava alla sbarra: “Miraccomando Wanna piangi”.
Più che a Icaro e alle sue smisurate ambizioni, Wanna appare così come un Erostrato contemporaneo: un cri minale che, pur di far tramandare il suo nome, distrusse con un incendio una delle sette meraviglie del mondo antico, il tempio di Artemide. Ed è in questa ambizione di popolarità e ric chezza che forse si annida la nostra ossessione per lei. Per questa donna che è un simulacro, e non conosce né empatia né pentimento, la cui aggres sività smisurata - nei modi di fare, di vestire, di portare i capelli e di fissare l’obiettivo, anche oggi a ottant’anninon tradisce una naïveté reale, ma il camaleontismo di chi non solo ha sa puto strumentalizzare le fragilità altrui fin dagli esordi, ma anche alimentare il proprio mito generandone una su perfetazione in salsa emiliana squal lor-pop. Tutto sommato, Wanna sareb be un personaggio straordinariamente amabile - così tragicamente sfrontata, così desiderosa di riconoscimento e di fama, così disperata nel tentare di non soccombere al mondo e al tempo - se non mostrasse una deplorevole uma nità con sua figlia. Un momento di commozione naturale che ci svela, nel confronto, quanto siano artefatti tutti gli altri suoi comportamenti.
A margine andrebbe poi notato come Wanna Marchi abbia trionfalmen
te indossato per oltre trent’anni in modo deliberato i panni mediatici del guru, riuscendo a manipolare le sue vittime nel profondo, arrivando a spingerle a dilapidare patrimoni personali e fami gliari, finanche a prostituirsi pur di con segnarle dei soldi. Se nel nostro Paese gli strumenti per tutelare le vittime non fos sero stati soppressi - e mai più restaurati, anche con una lettura più contempora nea - probabilmente la condanna in via definitiva 9 anni e 6 mesi sarebbe stata esponenzialmente più alta. E, magari, sarebbe stata agita prima.
A fine visione, il pregio della do cu-serie è non solo quello di aver coin volto tutti i protagonisti della vicenda - compreso il Maestro do Nascimento (un tempo cameriere scalzo) scovato in Brasile - ma anche di aver creato con ac cordi dissonanti una narrazione affatto scontata, meticolosa e provocatoria, nel la quale il materiale d’archivio si scontra con un’attitudine punk ai nostri desideri di rassicurazione. Il crash diventa quindi intrinseco alla visione e scorre parallelo all’idea che chiunque sbagli (soprattutto se consapevolmente) debba pentirsi. È evidente - come si esplicita nel corso del le puntate - che Wanna Marchi e sua fi glia non abbiano minimamente provato rimorso alcuno, e che abbiano elaborato una contro-narrazione in cui loro sono abili giustiziere in grado di farla pagare a tutti gli idioti del mondo grazie alla stra ordinaria, genetica furbizia.
Dunque no, Wanna Manchi non si è pentita. No, Wanna Marchi non chiede scusa. Sì, Wanna Marchi è stata in car cere e ha scontato la sua pena, forse ha un tesoretto seminato chissà dove, non crede di avere sbagliato e continua a ur lare nella sua testa quello che ripete sul piccolo schermo da trent’anni. È lei, e solo lei, ad avere ragione.
Lo scrittore toscano Simone Innocenti in una storia da fine dell’anno
C’è sempre un momento in cui la vita presenta il conto. Può essere un appuntamento con il proprio passato, con una persona cara o - più semplicemente - con se stessi. Nel romanzo di Simone Innocenti - toscano di Montelupo Fiorentino, classe 1974, noto giornalista del «Corriere Fiorentino», dor so regionale del «Corriere della Sera», e collaboratore de «La Lettura» - appena uscito per l’editore romano Atlantide, c’è tutto questo. E, forse, qualcosa in più.
Il romanzo si intitola non a caso “L’Anno Capo volto” (pp. 192, € 16.50) e mette in fila in un susseguir si di colpi di scena, trattati con il senso chirurgico del narratore di razza, la storia di un gruppo d’amici che si incontrano nuovamente per desiderio, e si scoprono forse mai veramente cam biati. L’ambientazione del romanzo - che si prestereb be molto bene per una narrazione televisi va o cinematografica, e che richiama in più passaggi l’amato “Compagni di scuola” di Carlo Verdone - è una stupenda villa in To scana, dove il benestante Giulio (“i soldi fanno l’euforia, non la felicità”) accoglie
“L’anno capovolto” Simone Innocenti Atlantide
gli amici di sempre con la moglie France sca (bellissima, affascinante, magra e anche un po’ cinica). Gli invitati sono una foto grafia di una certa buona società in declino - c’è un notaio e una modella, un maestro di tennis e un’assicuratrice, un poliziotto e un gioielliere, un rappresentante di lampa dine e la proprietaria dello stabilimento balneare in cui tutti loro si sono conosciuti. Una società che da Innocen ti viene smembrata e narrata con una lingua volutamente sporca, e poi viene messa alla berlina, ridicolizzata e santificata.
Dentro scorrono - più o meno sotterranei, esplicitati in urla e in silenzi - un mosai co di umanità che passa fra l’amore e l’affetto, la gelosia e la rabbia, l’invidia, i soldi, la povertà, il desiderio di ri scatto e la certezza che tutto è come sembra. Soprattutto perché non è mai così.
181 pagine, 16,50 euro
Il talento di Innocenti di venta allora quello di dipin gere un piccolo universo contemporaneo che conduce tutti i protagonisti - nessuno escluso - a fare i conti con le proprie segre te miserie. Quelle che tutti possediamo. E tutti, faticosamente, cerchiamo di tenere nascoste. (F. P.)
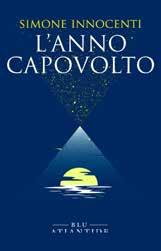
 di Pietro Pietrini
Professore Ordinario, Direttore Scuola IMT Alti Studi Lucca
di Pietro Pietrini
Professore Ordinario, Direttore Scuola IMT Alti Studi Lucca
Come ogni estate, anche quella appena trascorsa ha visto rimbal zare sulle cronache dei media no tizie nelle quali la realtà supera la fantasia. Accadimenti che non sembra no concepibili neppure alla più perversa e malvagia immaginazione. Al cospetto di eventi del genere, l’opinione pubblica inesorabilmente si divide tra coloro che invocano il ripristino della pena di morte o, qual più clemente alternativa, che ven ga “buttata via la chiave” e coloro che so stengono per contro che “solo una persona malata può fare una cosa del genere”.
Questa dicotomia nel sentire comune è ben espressa dalla letteratura anglosassone con un gioco di parole, Bad or Mad. Fino a che punto l’autore di un reato tanto gra ve e incomprensibile - come l’uccisione di un figlio da parte della madre - è bad, vale a dire consapevolmente e deliberatamente malvagio, e quanto è invece mad, ovvero incapace di comprendere la natura e le conseguenze delle sue azioni e di agire di versamente se solo lo volesse? L’umanità si confronta con questo dilemma fin dagli al bori del pensiero umano, dapprima attra verso la letteratura e la filosofia e, in tempi più vicini a noi, con i metodi della scienza.
I progressi delle neuroscienze cognitive e della genetica comportamentale stanno portando ad una sempre più fine cono
scenza dei complessi meccanismi che rego lano il comportamento umano così come degli intricati rapporti che modulano l’in terazione tra fattori biologici ed elementi esterni. Alla luce delle recenti acquisizio ni, le nette contrapposizioni tra natura e ambiente che, con alterna fortuna, si sono susseguite nel corso dei decenni, appaio no oggi prive di qualsivoglia fondamento. Nature e nurture - prendendo ancora una volta in prestito i termini della letteratura anglosassone - sono tutt’altro che entità di stinte e indipendenti.
Al contrario, gli effetti della modula zione reciproca dell’una sull’altra sono profondi e continui, tanto che, potremmo dire, natura e ambiente costituiscono lo jing e jang di quello che è ciascuno di noi.
Sono passati due secoli e mezzo da quando Platone scriveva “Perché malvagio nessuno è di sua volontà, ma il malvagio diviene malvagio per qualche sua prava di sposizione del corpo e per un allevamento senza educazione, e queste cose sono odio se a ciascuno e gli capitano contro sua vo glia (Timeo, 86e).
Sarà solo con un approccio multidisci plinare e integrato, scevro da pregiudizi e arroccamenti ideologici, che potremo arri vare a comprendere quegli aspetti dell’a nimo umano che il nostro animo non può comprendere.



