LOST GENERATION
I NEET, giovani che non studiano non lavorano, non...

Quando gli affidi creano problemi psicologici
Se il peso della performance a scuola porta al suicidio
Long-Covid
I risultati dello studio di BRF

I NEET, giovani che non studiano non lavorano, non...

Quando gli affidi creano problemi psicologici
Se il peso della performance a scuola porta al suicidio
Long-Covid
I risultati dello studio di BRF
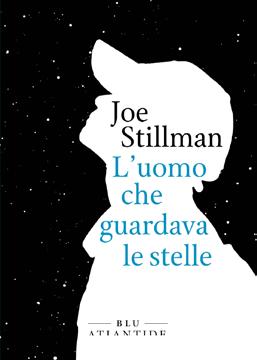
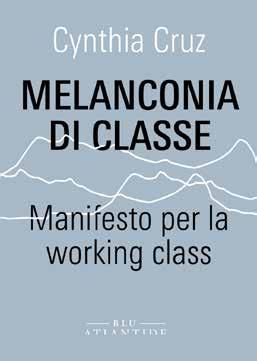
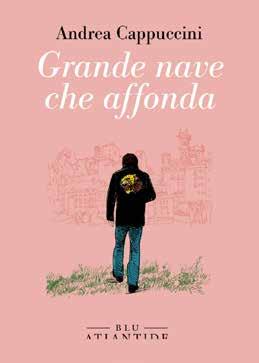
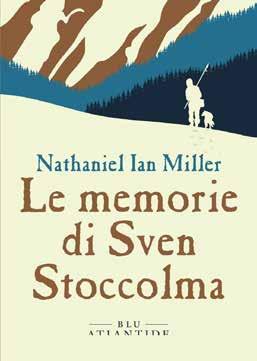
Questo numero è dedicato ad i giovani ed in particolare ad una delle fasce più fragili, numerose ed allo stesso tempo fonte di grande preoccupazione per la società, dei nostri giorni: I NEET la quota di giovani che non studiano, non lavorano e neppure si addestrano a compiere una qualsiasi attività.
Sono giovani tra i 15 ed i 35 anni e sono in Italia, come descritto nell’articolo sui NEET che trovate in questo numero di Brain, una schiera incredibilmente elevata. Sono giovani fermi e improduttivi, hanno i motori spenti. Molti di loro non li hanno mai accesi. L’Italia ha il record negativo dell’ultimo posto tra i 27 Paesi della Ue: nella fascia d’età 15-34 anni la numerosità ha superato quota 3 milioni, (3.047.000 per la precisione). Secondo la fotografia del 2020 scattata dal governo e pubblicata all’interno del decreto del Ministero Politiche Giovanili-Lavoro, per l’adozione del piano “Neet Working”, gli oltre 3 milioni di ragazzi Neet rappresentano il 25,1% dei giovani italiani tra i 15 e i 34 anni, praticamente 1 giovane su 4.
Sono questi i giovani che il presidente Mario Draghi definì durante il suo mandato di presidente del consiglio la “lost generation”.
Per cercare di comprendere le cause che

sono alla base del fenomeno è possibile fare una serie di tentativi per dissezionare il campione in sottogruppi in cui si tenga conto delle cause del loro stato, del perché sono così e del motivo per cui non cambiano.
Se provassimo a percorrere questa strada ci troveremmo di fronte a tutte quelle motivazioni che descrivono il disagio giovanile come: ambiente sociale di provenienza, grado di istruzione, le esperienze di vita, utilizzo di sostanze, le situazioni familiari, differenze nord-sud, condizione del mondo del lavoro, momento storico-economico del nostro paese, conseguenze della pandemia da Covid, conseguenze dirette ed indirette del conflitto russo-ucraino.
Nel corso della mia pratica clinica come psichiatra incontro di frequente giovani che appartengono alla categoria dei NEET. Sono, tra gli altri, giovani afflitti da disturbi della salute mentale, da problemi di dipendenza o da entrambi. La condizione di inattività di questi è giustificata dall’incapacità di applicarsi, di mantenere un impegno, di sostenere una relazione. Questi ragazzi, quando riescono ad affrancarsi dalla malattia o dalle sostanze, vivono spesso la ripresa con il desiderio di applicarsi e “di fare”, sembrano assetati di “vita reale”.
Altri giovani, vivono in famiglie in cui svol-
gono un quieto ruolo di caregiver di familiari con problemi di salute mentale. Altri ancora, e sono forse questi il sottotipo più indecifrabile sono incistati nelle loro case, inattivi, senza programmi, senza desideri e senza sogni da realizzare. Vivono il loro stato senza l’dea di doverlo modificare. Non hanno un’attività propria e non la cercano. Ciondolano tutto il giorno e riescono a restare per anni in questa sorta di limbo. I genitori che li accompagnano al consulto espongono la loro condizione ed esprimono tutta la loro preoccupazione per lo stato dei figli. Loro appartengono alla generazione precedente. Hanno lavorato, formato una famiglia e raggiunto quella condizione economica che consente ai loro figli, paradossalmente, di vivere senza avere nessun impegno produttivo.
Ma cosa determina questa condizione?
Quali sono gli elementi che la sostengono nel tempo? Le possibili risposte alla prima domanda le abbiamo accennate più sopra, prima tra tutte la scarsa disponibilità delle occasioni di lavoro che innescano la partenza della condizione provvisoria di inoccupato che si cronicizzerà col tempo.
La risposta alla seconda domanda sta nell’emergere ed affermarsi di un fenomeno che è forse il più potente uniformatore del comportamento umano: l’abitudine. L’abitudine è la tendenza a compiere ripetutamente una determinata azione ed a riproporre una determinata esperienza in maniera ripetitiva.
La nostra vita è regolata dalle abitudini. I NEET al di là delle motivazioni che li hanno portati nella loro condizione, si trovano lentamente incistati nel loro stato. Lo perpetrano nel tempo e molte volte sembrano quasi non accorgersi più della loro condizione. L’abitudine li ha resi schiavi ed adattati.
In neurofisiologia l’abitudine sensoriale è un fenomeno che consiste nell’abolizione della risposta a uno stimolo dovuta al suo ripetersi. E’ il fenomeno dell’adattamento recettoriale. Un esempio pratico banale è l’etichetta della camicia che ci dà fastidio sulla pelle del collo e che dopo un po’ smettiamo di avvertire. I recettori cutanei, quando lo stimolo si ripete, smettono di comunicare al cervello la presenza dell’etichetta. Si sono abituati. Hanno cioè subito il
fenomeno dell’adattamento.
Una volta che l’abitudine all’inattività si è instaurata, questi giovani sono in grado di passare anni sempre nella stessa condizione. L’adattamento alla situazione riduce la consapevolezza del loro stato che col passare del tempo diventa la loro “normalità”.
Qualsiasi attività che preveda il recupero di questi giovani deve tenere conto dell’abitudine un nemico oscuro e silenzioso. Pensare al loro reinserimento nella rete sociale, dell’istruzione, del mondo del lavoro senza pensare anche a come battere questo nemico invisibile è un peccato di ingenuità. L’idea che chi ha vissuto una condizione di inattività per anni si accenda al primo colpo e riparta spedito è un’illusione. E tanto più è datata la condizione di inerzia, tanto più lento e faticoso sarà il cambiamento di un comportamento che è diventato la prassi.
L’argomento che riguarda le soluzioni è complesso ed anche la minima proposta per affrontarlo risulta complicato. Di certo lasciare dei ragazzi inattivi li predispone al peggio. L’età giovanile è l’età dell’energia, dell’entusiasmo, dei grandi progetti. Una possibile ricetta per aiutare questi ragazzi è dargli la possibilità di tenere accesi questi fuochi stimolandoli precocemente e finché la fiamma resta accesa.
Corsi, apprendimenti pratici, stage di lavoro nelle aziende, scambi internazionali, coinvolgimento nel mondo del lavoro a tutto campo, affiancamenti e tutto quanto possa togliere dalla casa dei genitori questa generazione sfortunata è quello che dobbiamo poter fare.
Il rispetto di regole, orari, relazioni sociali, sono alla base della convivenza civile. L’impegno ed il cimento alla base della motivazione personale e della volontà di progredire e migliorarsi. Abituare i giovani a vivere in attività, ognuno secondo le proprie tendenze, facendogli scoprire l’esercizio e la pratica del lavoro li porterà all’abitudine virtuosa dell’attività, della dedizione e dell’entusiasmo. Prima che si inneschino le cattive abitudini.
Certo cambiare un’abitudine negativa non è facile. Lo sapeva anche Svetonio che nella vita di Vespasiano ammoniva: “la volpe perde il pelo ma non il vizio”. Speriamo che i nostri giovani siano più fortunati.




La vaccinazione contro il papilloma virus
è raccomandata e gratuita per le ragazze e i ragazzi a partire dagli 11 anni di età.

I NEET, l’abitudine, i vizi e la volpe di Armando Piccinni
PRIMO PIANO
Essere Neet oggi: ecco cause e conseguenze psicologiche di Valentina Formica


Dispersione scolastica: un problema italiano di Martina Gaudino


Anno IV | N. 3 | Marzo 2023
Testata registrata al n. 6/2019 del Tribunale di Lucca
Diffusione: www.fondazionebrf.org
Direttore responsabile: Armando Piccinni
Organo della Fondazione BRF Onlus via Berlinghieri, 15 55100 - Lucca
NEUROSCIENZE

Effetto
Perché
Antidepressivi:




I ragazzi che non studiano e non lavorano in Italia sono oltre 3 milioni
di Valentina Formica

La transizione dall’istruzione al lavoro è una pietra miliare del passaggio all’età adulta che circa un giovane su sette nei Paesi economicamente sviluppati fatica a raggiungere, rientrando nella categoria dei NEET. La preoccupazione per questi giovani è in aumento in tutto il mondo, in quanto i giovani NEET sono considerati vulnerabili, a rischio di disoccupazione a lungo termine, svantaggio economico ed esclusione sociale. Inoltre, sono vari i paper scientifici che mostrano una relazione tra l’essere NEET e il soffrire di disturbi della sfera psicologica.
Il fenomeno dei Neet in Italia presenta dimensioni preoccupanti e riguarda un insieme di giovani ampio e composito. Il termine “NEET”, acronimo di Not in Education, Employment or Training, si è diffuso nel Regno Unito negli anni Duemila e viene utilizzato per indicare i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che non sono parte attiva nel mondo del lavoro e non seguono alcun corso di formazione o istruzione. I NEET in Italia sono complessivamente più di 3 milioni con una prevalenza femminile pari a 1,7 milioni. Secondo le statistiche Eurostat del 2020, dopo la Turchia, il Montenegro e la Macedonia, l’Italia è il paese con la percentuale più alta di NEET nell’area europea, infatti circa ¼ (25,1%) dei giovani italiani rientra nella categoria, mentre negli altri paesi europei i NEET rappresentano in media il 13,3% dei cittadini di questa età. Negli ultimi anni, numerosi studi hanno tentato di identificare specifici cluster di giovani NEET, al fine di studiarne meglio le peculiarità e proporre di conseguenza interventi efficaci. Questi studi sono parti-

Il termine “NEET”, acronimo di Not in Education, Employment or Training, si è diffuso nel Regno Unito negli anni Duemila e viene utilizzato per indicare i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che non sono parte attiva nel mondo del lavoro e non seguono alcun corso di formazione o istruzione.
ti dall’evidenza secondo la quale i NEET non sono un gruppo omogeneo; al contrario, le caratteristiche all’origine di tale fenomeno possono essere molto diverse tra di loro. Spielhofer e colleghi hanno distinto tre cluster di NEET: i NEET sustained, ovvero quei giovani passivi e disimpegnati, che non intendono investire nella pianificazione della loro carriera perché supportati economicamente dalla famiglia e quindi scarsamente motivati ad attivarsi per il proprio futuro; i NEET aperti all’apprendimento, ma spaventati da uno scenario del mercato del lavoro fortemente instabile; i NEET indecisi, ovvero coloro che sono passivi perché non riescono a identificare specifici obiettivi professionali.
Negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento nel numero di ragazzi che dopo aver adempiuto all’obbligo di istruzione scolastica scelgono di non intraprendere un percorso di studi o lo interrompono precocemente. Il riferimento è a qualsiasi tipo di educazione scolastica o universitaria e a qualsiasi genere di processo formativo: corsi professionali regionali o di altro tipo (tirocini, stage ecc.), attività educative quali lezioni private, corsi di lingua, informatica ecc.
Nel Sud Italia registriamo la più alta presenza di giovani che non studiano, non lavorano e non si formano, costituiscono il 39% rispetto al 23% è del Centro Italia, al 20% del Nord-Ovest e al 18% del Nord-Est. Ai primi posti troviamo tutte le regioni del Sud, con quote molto alte per Sicilia (40,1%), Calabria (39,9%) e Campania (38,1%). Per il Centro Italia, il Lazio ha la più alta incidenza, mentre la prima regione del Nord è la Liguria (21,1%), a seguire il Pie-
monte (20,5%) e la Valle d’Aosta (19,6%). Uno dei punti principali che rendono questo fenomeno difficile da interrompere è il frequente disinteresse dei soggetti alla ricerca di un’attività. Secondo diversi studi a influenzare l’abbandono scolastico e/o l’inattività seguente non sono solo le caratteristiche individuali dei ragazzi. L’ingresso e la permanenza nella condizione di NEET è un evento complesso, dovuto a diversi fattori. Non bisogna quindi criminalizzare chi si trova in questa condizione, ma è necessario capire le cause profonde, i fattori che si legano all’insorgere di certe dinamiche e intervenire affinché la scuola e il mondo del lavoro siano capaci di includere davvero tutti.
In particolare, la ricerca psico-sociale ha centrato l’attenzione su caratteristiche quali il background familiare dei NEET, il capitale culturale, inteso come livello di istruzione e professione dei genitori, che influenzano le scelte formative e professionali ma anche le strategie con cui i giovani affrontano la costruzione della propria carriera, e la presenza o meno di precedenti esperienze fallimentari nella formazione e/o nel mondo del lavoro che possano aver inciso sulla rappresentazione di sé e della propria carriera in un’ottica di disinvestimento. Nel complesso, gli scarsi risultati scolastici e la provenienza da un contesto socioeconomico svantaggiato sembrano essere evidenziati in letteratura come fortemente associati allo status di NEET. Crescere in quartieri abitativi caratterizzati dalla povertà e dalla mancanza di buone scuole rappresenta un fattore di rischio significativo. Inoltre, uno studio condotto in Italia ha mostrato che i genitori con un basso livello d’istruzione hanno una minore competenza nel consigliare
i figli sulle scelte educative, guidandoli così più spesso verso strade sbagliate e inefficaci. Allo stesso modo, il livello di istruzione dei genitori può essere considerato un indicatore dello status socioeconomico della famiglia. L’istruzione, soprattutto quella universitaria, richiede un grande investimento. Questo implica che, soprattutto nei Paesi senza politiche attive del mercato del lavoro, i giovani che non possono contare sull’aiuto dei genitori per continuare gli studi, tendono ad abbandonare prematuramente la scuola con un rischio maggiore di rimanere intrappolati in lavori temporanei e poco remunerativi che, una volta terminati, portano alla condizione di NEET.
Dal punto di vista psicologico alcuni studi hanno evidenziato che i NEET sono meno dotati di alcune skill utili nel mondo del lavoro, quali la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di prendere decisioni e adottano stili comunicativi meno efficaci. Il tratto di sfiducia è spesso ricorrente tra questi giovani spesso caratterizzati, oltre che dagli elementi sopracitati, da un Sé fragile e da una ridotta percezione di self-efficacy. La letteratura psicologica mostra come comportamenti di sfiducia, di disinvestimento e/o di passività nei confronti del mercato del lavoro siano spesso connessi a un patrimonio di risorse psico-sociali impoverito che rende difficile uscire da una condizione di stallo attraverso strategie di coping adeguate. Il rapporto del fenomeno dei NEET con la salute mentale è stato messo in risalto da molti paper scientifici e la condizione di NEET è stata spesso associata a problemi di salute mentale e di uso di sostanze. Sono crescenti le preoccupazioni riguardo l’intersezione
tra queste due condizioni. Infatti, da bambini, spesso i NEET sono transitati nei servizi di neuropsichiatria infantile, ricevendo diagnosi soprattutto di Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, Disturbo della Condotta, Ansia, Depressione e forme di disadattamento sociale o scolastico.

I risultati degli studi finora condotti sul tema sono discordanti e variano a seconda del tipo di disagio indagato. In ogni caso, l’essere NEET è stato associato ad almeno un problema di salute mentale o di uso di sostanze nel 75% degli studi presenti in letteratura. Uno studio del King’s College di Londra ha evidenziato che il 60% dei NEET aveva già sofferto di disturbi mentali da bambino e in adolescenza. In definitiva potremmo affermare che i problemi di salute mentale e di uso di sostanze possono contribuire a ridurre lo slancio e l’energia necessari per entrare nel mondo del lavoro o continuare l’istruzione/formazione, aumentando il rischio di diventare NEET.
Dal punto di vista psicologico alcuni studi hanno evidenziato che i NEET sono meno dotati di alcune skill utili nel mondo del lavoro, quali la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di prendere decisioni e adottano stili comunicativi meno efficaci.
Igiovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente il sistema di istruzione nel nostro Paese sono il 12,7%, un dato importante se comparato al tasso medio di dispersione scolastica in Europa che si attesa al 9,7%. Sono questi i dati emersi dall’ultimo Rapporto Censis del dicembre scorso che evidenzia, inoltre, come il problema sia maggiormente radicato al Sud. Nel Mezzogiorno, infatti, la percentuale arriva fino al 16%. Nei Paesi dell’Unione europea la quota di 25-34enni con il diploma è pari all’85,2%, in Italia al 76,8% e scende al 71,2% nel Mezzogiorno. È inoltre inferiore alla media europea anche la percentuale di 30-34enni laureati o in possesso di un titolo di studio terziario: il 26,8% in Italia e il 20,7% al Sud, contro una media Ue del 41,6%.
La dispersione scolastica, al di là della sua rappresentazione numerica, «è un fenomeno complesso che coinvolge diverse dimensioni della vita sociale della persona di minore età e della comunità in cui vive: dai servizi per la prima infanzia alla formazione professionale, dalle politiche sociali a quelle abitative e del lavoro». A spiegarlo è il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Garlatti nell’ultima analisi multifattoriale sulla dispersione. «I fattori connessi – chiarisce Garlatti - possono dipendere dalla disoccupazione, dalle situazioni di esclusione sociale e di povertà, ma non si possono escludere nemmeno quelle motivazioni riconducibili a disagi personali e/o familiari, difficoltà nell’apprendimento e, più in generale, il modo in cui il singolo studente reagisce al sistema scolastico». Non solo, secondo l’Autorità garante «altre cause, da non sottovalutare, sono da attribuire a
motivazioni individuali che possono spingere verso l’abbandono precoce degli studi e, fra queste, un peso notevole è attribuito ai disturbi d’ansia. Questi studenti non sono disinteressati alla cultura e all’istruzione che, anzi, cercano di completare poi come autodidatti o iscrivendosi ai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti), ma semplicemente non ce la fanno a sostenere gli alti livelli di stress correlati all’ambiente scolastico».
Secondo un’analisi realizzata nel 2021 dall’Istat, il fenomeno dell’abbandono scolastico è da considerarsi
come una conseguenza di una serie di fattori tra cui c’è lo stato psicologico del nucleo familiare e anche il background formativo della famiglia stessa. Spesso ad abbandonare, infatti, sono giovani i cui genitori non hanno affrontato con successo il percorso di studi, non garantiscono un clima sereno in casa (anche a causa del disagio economico), non riescono a seguire adeguatamente il percorso scolastico dei figli.
Il totale abbandono della scuola o dell’università non è, però, l’unico caso possibile di dispersione in quanto esiste una forma implicita del fenomeno. Si tratta di quei giovani che pur continuando a fre -
La dispersione scolastica, «è un fenomeno complesso che coinvolge diverse dimensioni della vita sociale della persona di minore età e della comunità in cui vive: dai servizi per la prima infanzia alla formazione professionale, dalle politiche sociali a quelle abitative e del lavoro».

Il benessere psicologico dei giovani è ovviamente interesse del governo. Gli interventi per la salute mentale si rivolgono ai cittadini in generale sebbene vi sia stata una strategia ad hoc per la promozione bambini, adolescenti e giovani, adottata con un’Intesa tra il Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione nel 2014.
quentare la scuola, imparano poco, oppure imparano male o in modo irregolare. Questi giovani non appartengono ad alcuna statistica per cui è difficile, se non impossibile, stimarne il numero. Anche quando riescono a ottenere un titolo di studio, infatti, questi giovani si trovano ad affrontare la vita adulta senza avere le competenze minime necessarie per esercitare la cittadinanza attiva, proseguire gli studi o intraprendere un percorso professionale.
Il benessere psicologico dei giovani è ovviamente interesse del governo. Gli interventi per la salute mentale si rivolgono ai cittadini in generale sebbene vi sia stata una strategia ad hoc per la promozione bambini, adolescenti e giovani, adottata con un’Intesa tra il Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione nel 2014. Le azioni del PNP 2014 sono state riproposte in quello 20202025. Il Piano, spiega il ministero della Salute, sottolinea la necessità di elaborare un intervento specifico per l’area infanzia e adolescenza che richiede una differenziazione dei percorsi di assistenza rispetto all’età adulta, individuando otto obiettivi specifici che vanno dalla creazione di una rete regionale integrata e completa di servizi per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione dei disturbi neuropsichici dell’età evolutiva fino a percorsi di transizione verso i servizi per l’età adulta.
Secondo i dati Istat, nelle regioni del Mezzogiorno c’è un ulteriore dato che salta all’occhio ed è quello relativo alla percentuale di adolescenti che dichiara di avere parenti,

amici o vicini su cui poter contare, un numero in detta diminuzione: si è passati dall’86% al 78%) mentre il calo più significativo (dal 78,4% al 74,8%) si è avuto soprattutto nella possibilità di contare sugli amici.
Secondo quanto dichiarato da Giuseppe Lavenia, psicologo psicoterapeuta, presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo
“Di.Te”, l’autolesionismo in adolescenza è molto presente. «Le ricerche ci dicono che 20 ragazzi su 100 lo praticano e quella della cicatrice francese è una nuova variante», ha spiegato lo specialista secondo cui «nella scuola per poter fare prevenzione bisogna stare al passo con i tempi e usare e parlare degli argomenti che interessano ai giovani con un linguaggio che loro comprendono meglio come ad esempio dei brevi video o progetti esperienziali».
Ad oggi l’Italia è il solo Paese
europeo a non essere dotato della figura professionale dello psicologo scolastico, un vuoto importante cui si sta cerando di porre rimedio. Le scuole, infatti, possono avvalersi del servizio solo mediante accordi con le aziende sanitarie locali o con gli uffici scolastici regionali. La presenza di una figura specializzata nel sostegno delle categorie “fragili” potrebbe certamente avere risvolti positivi anche in termini di abbandono, dispersione, recupero e reinserimento dei Neet.
Ad oggi l’Italia è il solo Paese europeo a non essere dotato della figura professionale dello psicologo scolastico, un vuoto importante cui si sta cerando di porre rimedio.

Se la questione dei Neet ha una rilevanza globale, nel Sud Italia i suoi effetti sono certamente più marcati.
Sia per un’economia di fondo molto più povera rispetto ad altre aree del Paese e quindi a un tasso di disoccupazione reale più evidente, sia per altre ragioni che investono aspetti sociologici più complessi.
Il tasso di abbandono scolastico nel Meridione è ancora elevato ma regge contemporaneamente l’adesione a un percorso formativo primario che termina con il diploma di scuola media superiore.
Nel passato, tanto per fare un esempio più articolato, molti ragazzi del settentrione più opulento abbandonavano la scuola dopo la fase dell’obbligo per immettersi subito nel mondo del lavoro, mentre nel Meridione si compivano regolarmente gli studi pre-universitari.
Questo per garantire almeno l’accesso al pubblico impiego che rimaneva la fonte essenziale di occupazione.
Oggi i Neet meridionali sono lo specchio di una sorta di restanza residuale.
Nonostante ottime università, la gran parte dei giovani emigra ed a farlo sono i figli della borghesia destinati, peraltro, a non ritornare.
Gli istituti professionali che erano una buona risorsa, sia per la formazione nelle PMI che nel terziario, registrano forti cali mentre permane l’aderenza ai percorsi liceali propedeutica all’emigrazione successiva.
Il rischio concreto è che il saldo tra emigrazione intellettuale e carenza strutturale, in assenza di una politica industriale adeguata, siano proprio i Neet.
Negare che questa letargia sia stata favorita dal reddito di cittadinanza sarebbe ipocrita. E del resto, il punto debole del RDC sta proprio nella individuazione di un sostegno a categorie di persone che per età dovrebbero, invece, entrare nel mondo del lavoro.
Le statistiche sui Neet meridionali sono inevitabilmente dopate dal
lavoro nero che rimane presente più che in altre realtà geografiche. Sono ancora tanti i giovani che lavorano senza garanzie e sono altrettanti quelli parcheggiati nei call center con tipologie contrattuali a volte atipiche che non fanno emergere un’occupazione reale.
L’altro rischio di fondo è la paralisi della generazione della restanza. Iniziative seppure meritorie come “Resto al Sud” non hanno prodotto risultati rilevanti. Le regioni ad alto tasso di industrializzazione come la Puglia hanno vissuto una forte crisi. E fatica ad emergere un possibile modello di autonomia gestionale dedicato al turismo e alla cultura che rimangono due possibili opzioni lavorative poco esplorate.
Le grandi ondate di emigrazione di manodopera del dopoguerra sono
frenate dalle mutazioni del nostro sistema industriale.
Oggi si emigra per andare a studiare, laddove è possibile, anche senza un motivo valido, avendo ottime facoltà in loco.

Il disagio dei Neet meridionali riflette quello di una popolazione più vasta che nei decenni passati affidava gran parte delle sue aspettative occupazionali allo Stato.
L’agricoltura, che potrebbe essere un altro segmento chiave, è prevalentemente affidata alle vecchie aristocrazie.
C’è da fare un lavoro culturale ed economico che assegni nuovi obiettivi a generazioni potenzialmente brillanti. Che faticano a diventare parte attiva e che allontanano tristemente ipotesi di ricambio della classe dirigente.
Il tasso di abbandono scolastico nel Meridione è ancora elevato ma regge contemporaneamente l’adesione a un percorso formativo primario che termina con il diploma di scuola media superiore.

Non sempre l’interesse verso il minore sembra prioritario
Lo testimonia il resoconto di una Commissione parlamentare d’inchiesta di Carmine Gazzanni
Secondo gli ultimi dati disponibili diffusi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a fine 2019 risulta la presenza sul territorio nazionale di 27.608 minori collocati fuori famiglia (al netto dei minori stranieri non accompagnati), di cui 13.555 bambini e ragazzi di minore età in affidamento familiare e 14.053 bambini accolti in servizi residenziali per minorenni (cosiddette “comunità”).
I bambini in affidamento familiare sono l’1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Lo stesso report, tuttavia, mostra come invece sia aumentato il numero dei minori collocati in comunità: 14.053 al 31 dicembre 2019 contro i 12.892 al 31 dicembre 2017. Complessivamente, dunque, si registra un aumento dei minori in comunità pari a 1.161 unità in due anni.
Che tale fenomeno abbia negli anni meritato una forte attenzione politica è testimoniato, tra le altre cose, dal fatto che nella scorsa legislatura sono state attivate due commissioni d’inchiesta parlamentari: la “Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»” (Legge n. 21 dell’8 marzo 2019) e la “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia” (Legge n.107 del 29 luglio 2020). Soprattutto quest’ultima è stata fondamentale dato che ha messo in luce, grazie alle tante audizioni svolte e alle relazioni, due aspetti critici su tutti: la mancanza di dati certi e aggiornati sui minori collocati fuori famiglia, visto che non esiste, a oggi, un registro dei minori allontanati; e la mancanza di dati sulla durata del collocamento extrafamiliare che - come emerso dalla stessa inchiesta

I bambini in affidamento familiare sono l’1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Lo stesso report, tuttavia, mostra come invece sia aumentato il numero dei minori collocati in comunità: 14.053 al 31 dicembre 2019 contro i 12.892 al 31 dicembre 2017. Complessivamente, dunque, si registra un aumento dei minori in comunità pari a 1.161 unità in due anni.

parlamentare - supera in molti casi i due anni previsti dalla legge.
Al di là dei ragionamenti che emergono sull’eventuale business che ruota attorno al fenomeno, ciò che è emerso dal lavoro parlamentare è che non sempre (o, quantomeno, non sempre con la dovuta attenzione) l’interesse verso il minore sembra prioritario.
Eppure, le norme a riguardo sono piuttosto chiare. In particolare, la legge 4 maggio 1983, n. 184, ha sancito definitivamente il «diritto del minore alla propria famiglia», portando a compimento il delicato processo di chiusura e di trasformazione dei vecchi orfanotrofi, con la previsione delle cosiddette «comunità familiari», atte a garantire al minore la convivenza in un ambiente il più possibile simile a quello della famiglia propriamente detta, pur continuando a riconoscere un ampio sistema di misure di tutela dell’interesse primario del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare.
La sottrazione del minore alla sua famiglia, dopo l’attivazione delle misure di tutela temporanee previste dalla legge, è, in tal senso, considerata una soluzione «limite», che sancisce l’insuperabilità delle difficoltà della famiglia di origine ad assicurare al minore un ambiente familiare idoneo.
In questo contesto si inserisce il quadro normativo secondo cui «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia», tanto che «le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia».
Bisogna allora chiedersi in quali situazioni è richiesta la collocazione del minore fuori famiglia. Tra le più fre-
quenti troviamo: la malattia di un genitore, la sua carcerazione, la fragilità psicologica o anche la psicopatologia di un genitore.
Dal lavoro svolto dalla già citata Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, emerge come possa essere fondato il dubbio che ci sia un “abuso” di collocamenti in comunità rispetto agli affidamenti familiari (gli ultimi dati disponibili, per quanto lacunosi, ci dicono che «i provvedimenti emessi hanno comportato un numero cospicuo di collocamenti in struttura residenziale (2.738), a fronte di un numero piuttosto esiguo di collocamenti in affido familiare (353), il che sembra confermare un trend di ormai lungo periodo»).
Al di là di ogni ragionamento politico, ciò che in questa sede preme sottolineare è l’urgenza che venga svolta una ricerca sui reali benefici che può trarre un minore dall’allontanamento. Vari studi si sono occupati di indagare il fenomeno dei minori fuori fa-
miglia. Se però tanto è stato fatto all’estero, nessuna ricerca così sistematica è stata mai compiuta in Italia.
Dalla revisione della letteratura ad opera dei ricercatori della Fondazione BRF è emerso che l’allontanamento dal nucleo familiare di origine ha un’influenza negativa, in varia misura e a seconda dei casi, sul benessere psicologico dei minori, influenzando il loro percorso di vita.
Da alcune ricerche, tanto per dire, è emerso che la salute mentale dei minori in affidamento è peggiore di quella dei minori della popolazione generale. Uno studio condotto negli Usa ha messo a confronto la salute mentale dei bambini in affidamento e quella dei bambini in famiglie adottive o appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate. La ricerca ha mostrato che i bambini in affidamento hanno una salute mentale e fisica peggiore rispetto ai bambini appartenenti alla popolazione generale e a quelli appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate. La ricerca, nel dettaglio, mostra che i minori in affidamento sperimentano con maggiore proba-
bilità sintomi di depressione, ansia, disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e problemi comportamentali/di condotta rispetto ai bambini che vivono con due genitori biologici o con madri biologiche mai sposate.
Ma c’è di più: i minori in affido avrebbero anche maggiori difficoltà scolastiche e più problemi a trovare lavoro. Le capacità cognitive e i risultati scolastici dei minori in affidamento sono spesso peggiori rispetto a quelle dei minori appartenenti alla popolazione generale. Inoltre, si riscontra una maggiore difficoltà a trovare lavoro e una maggiore tendenza all’abuso di droghe e alcol durante l’adolescenza, come emerge da vari studi scientifici. Ciò è aggravato anche dal rischio di rapporti disfunzionali: i minori collocati in comunità vengono allontanati dai loro genitori biologici per un tempo che a volte può superare anche i due anni. Questo intacca lo sviluppo dei legami di attaccamento proprio quando ai minori viene richiesto di formare nuove relazioni con gli affidatari, col pericolo che si creino legami disfunzionali, come d’altronde testimoniato da vari casi di cronaca.
Basta questo per comprendere che ogni discussione politica - che pure c’è stata negli ultimi anni, in alcune circostanze anche accesa e oltre ogni limite - debba partire dall’approfondimento scientifico che in questo periodo non c’è stato. Per comprendere realmente quanto (e se) l’istituto degli affidi funziona, bisognerebbe capire e analizzare il benessere psicologico dei minori, con un monitoraggio puntuale. Un invito alle istituzioni, che vedremo se sarà o meno colto.
Da alcune ricerche, tanto per dire, è emerso che la salute mentale dei minori in affidamento è peggiore di quella dei minori della popolazione generale. Uno studio condotto negli Usa ha messo a confronto la salute mentale dei bambini in affidamento e quella dei bambini in famiglie adottive o appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate.


Le ragioni di un dramma di cui le istituzioni continuano a non occuparsi
di Valentina Formica
Iprimi giorni di Università sono segnati da un mix di emozioni: c’è l’eccitazione per l’inizio di un nuovo percorso che si va costruendo giorno per giorno e c’è l’aspettativa per la vita che verrà. C’è anche però quel pizzico di paura di fallire perché in fondo è arrivato il momento di confrontarsi con una realtà sconosciuta.
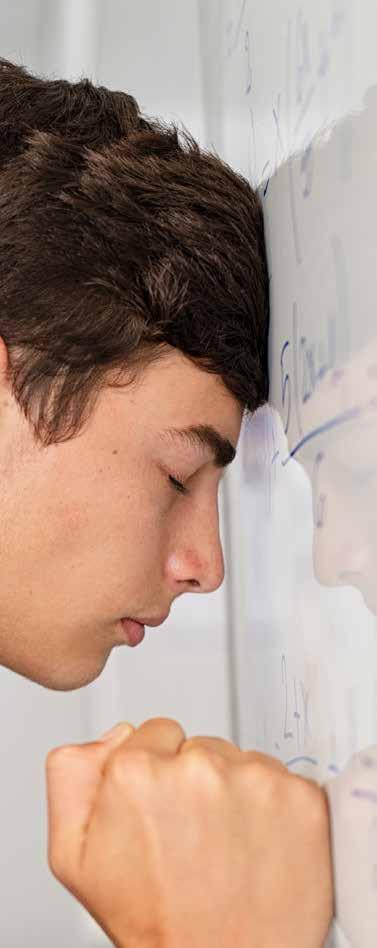
Ci sono momenti, tuttavia, in cui la paura del fallimento diventa talmente potente da silenziare tutto il resto ed è così che inizia a governare la mente.
È quello che è successo alla ragazza di soli 20 anni che si è tolta la vita nei bagni dell’Università IULM che frequentava a Milano.
L’unica cosa che rimane di lei è un biglietto di addio per la famiglia e gli amici, dove descrive la sua vita come un fallimento, appunto.
Non è l’unico caso: durante lo scorso ottobre a Bologna è stato trovato nel fiume il cadavere di un ragazzo di 23 anni. Dopo le dovute identificazioni sono risaliti ad uno studente fuorisede che aveva annunciato alla famiglia la data della laurea ma erano ancora molti gli esami che mancavano per il suo raggiungimento.
E, ancora, guardando a ritroso, nel 2019 a Napoli un ragazzo si è ucciso nelle aule della Facoltà di Lettere e una ragazza si è gettata dal terrazzo dell’Università Federico II mentre la famiglia l’aspettava nell’aula magna per la discussione della tesi.
Sono tante, troppe, le testimonianze di un fenomeno che va sempre crescendo e che sta sconvolgendo il nostro paese. Gli studenti si sono trovati di fronte ad una realtà che non riescono proprio ad accettare: «A 20 anni non si può morire chiedendo scusa per i propri fallimenti», commentano oggi i ragazzi del collettivo “Cambiare Rotta”.
Ci sono momenti, tuttavia, in cui la paura del fallimento diventa talmente potente da silenziare tutto il resto ed è così che inizia a governare la mente.
La pressione sociale che grava sugli studenti universitari è amplificata dall’ideale di perfezione che sembra aleggiare nel sistema e che talvolta le notizie tendono a celebrare.
Impossibile dimenticare la storia risalente allo scorso ottobre dell’influencer neolaureata in medicina con il massimo dei voti e in anticipo: quella che si è scatenata è stata una vera e propria bufera intorno alla notizia che in qualche modo ha alzato l’asticella del successo per gli universitari.
«Tanta determinazione e poche ore di sonno», aveva dichiarato la neolaureata riferendosi al suo metodo per eccellere. Una dichiarazione che però ha indispettito i più proprio per la poca attenzione alla salute mentale.
L’università dovrebbe essere un luogo di conoscenza, apprendimento, aggregazione, cultura e non la tomba
della speranza come accade per alcuni. Il suicidio giovanile sta crescendo in maniera esponenziale negli ultimi anni, come dimostra anche l’Osservatorio suicidi permanente istituito dalla Fondazione BRF Onlus per monitorare attraverso le notizie di cronaca tutti gli atti suicidari e i tentati suicidi.
Da inizio anno si sono verificati 145 suicidi che significa più di due suicidi al giorno: un numero che mette in allarme e che dovrebbe essere sotto l’attenzione di tutti.
C’è bisogno, infatti, di tutti per intervenire e prevenire queste tragedie: la divulgazione per capire l’importanza di parlare di salute mentale, il dialogo e l’ascolto nelle famiglie, nelle scuole e nei luoghi di lavoro e l’intervento della politica attraverso aiuti concreti così da non dover più leggere strazianti lettere di addio.




Visita la pagina
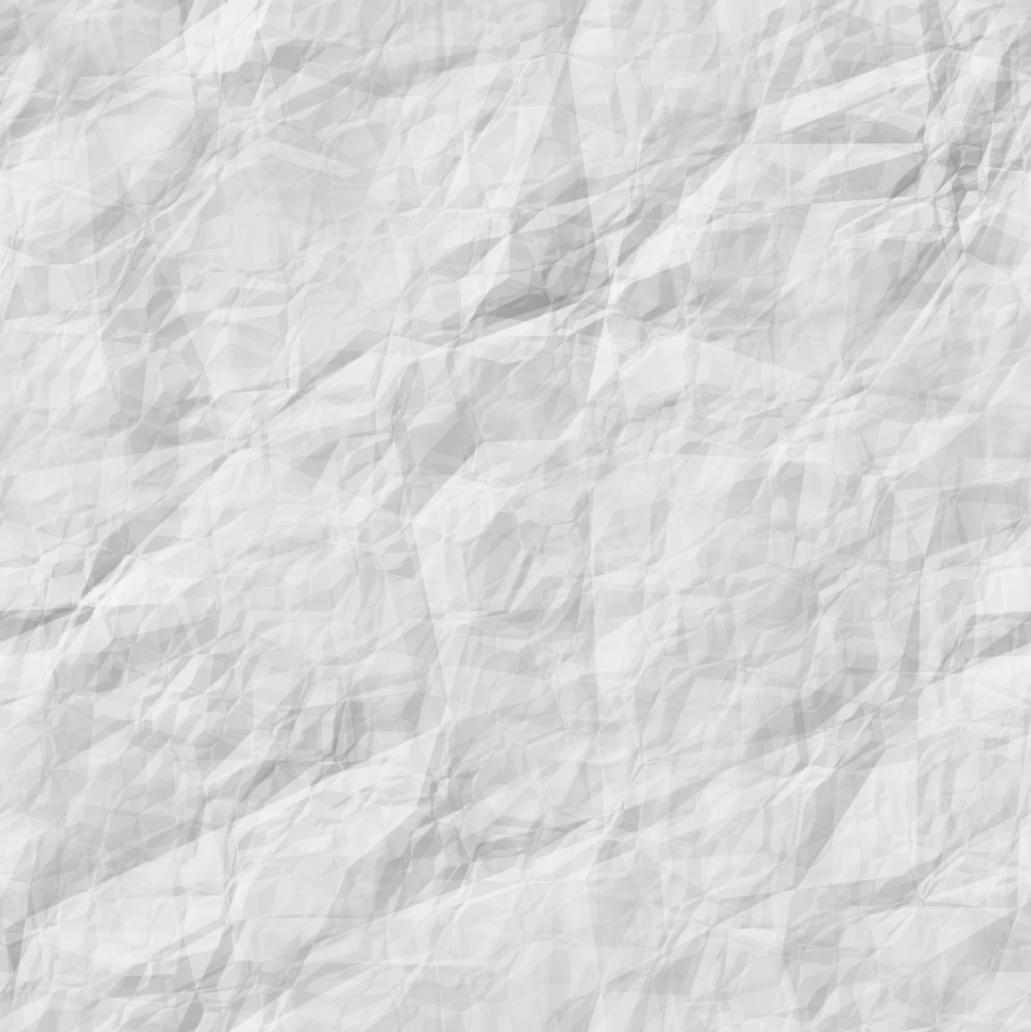
#Parliamone sul sito www.fondazionebrf.org per acquistare i gadget della campagna e sostenere la ricerca

Michael S. Gazzaniga (1939-) è un neuroscienziato statunitense, psicologo e fisiologo delle funzioni cerebrali, ha fornito imprescindibili contributi all’avanzamento delle neuroscienze, scoprendo insieme al Premio Nobel Roger W. Sperry (1913-1994) la lateralizzazione delle funzioni cerebrali e, su un piano più filosofico, sollevando il problema della natura dell’individualità e della coscienza.
Gazzaniga è noto in quest’ultimo settore per la caratterizzazione di un’area cerebrale da lui denominata “l’interprete”, interpretata quale locus privilegiato del costruire la nostra storia narrativa degli eventi.
Noto quale “padre” delle neuroscienze cognitive, Gazzaniga, già nella prefazione del suo volume
The Ethical Brain del 2005– tradot -
to ambiguamente in italiano da Codice edizione con La mente etica –, dopo aver qualificato la definizione classica di neuroetica sulla scia di quella del politologo del New York Time William Safire come campo di riflessione filosofica applicata agli sviluppi delle neuroscienze e pertanto parte speciale della bioetica, fornisce una sua definizione di neuroetica: «ogni volta che una questione bioetica riguarda il cervello o il sistema nervoso centrale, la neuroetica dovrebbe dire la sua» (M. S. Gazzaniga, La mente etica, Codice, Torino 2006, p. xiv).
Gazzaniga specifica qualcosa di interessante: «Tuttavia, la neuroetica non è una semplice bioetica del cervello. Sviluppandosi questo campo, dobbiamo ampliarne la portata e la missione. Finora, buona parte dei dibattiti neuroetici sono avvenuti, una volta di più, tra persone
Gazzaniga
“Non si tratta di una semplice bioetica del cervello”
che scienziati non sono: è tempo che i neuroscienziati si buttino nella mischia. Io definirei neuroetica l’analisi del modo in cui vogliamo porci verso le questioni sociali della malattia, della normalità, della mortalità, dello stile di vita e della filosofia di vita, arricchiti dalla conoscenza dei meccanismi cerebrali che ne sono a monte. Essa non è una disciplina che ricerca risorse terapeutiche, ma che colloca piuttosto la responsabilità personale entro un contesto biologico e sociale più ampio. Essa è, o dovrebbe essere, lo sforzo per produrre una filosofia della vita fondata sul cervello» (La mente etica, p. xv).
Una filosofia di vita radicata
sulle conoscenze neuroscientifiche: questo è in estrema sintesi l’approccio e il modello sociale di neuroetica proposto da Gazzaniga.

Potremmo pertanto definire l’approccio specifico alla neuroetica del “padre” della neuropsicologia contemporanea come di una “neuroetica del contesto”, un vero e proprio modello sociale. A più riprese lo specifica e lo afferma in modo categorico: «In neuroetica il contesto è tutto» (La mente etica, p. 18).
Ciò che si intende per neuroetica è molto più di un settore specialistico della bioetica, bensì è da considerarsi una vera e propria riflessione filosofica sistematica e informata sulle neuroscienze.
Io definirei neuroetica l’analisi del modo in cui vogliamo porci verso le questioni sociali della malattia, della normalità, della mortalità, dello stile di vita e della filosofia di vita, arricchiti dalla conoscenza dei meccanismi cerebrali che ne sono a monte.
Se scorrendo Instagram vi siete trovati davanti illustrazioni dai colori allegri, i tratti rotondi e le vignette ironiche e divertenti, probabilmente avete fatto la conoscenza con Sofia Biagini. La sua pagina “Disegni Cinici” raccoglie ormai una community davvero ampia, dove tutti coloro che sentono la necessità di sdrammatizzare i momenti critici della vita possono trovare un rifugio perfetto.
Un rifugio come quello che Sofia ha trovato nell’illustrazione:
«Fin da piccola ho sempre amato disegnare, ma non ho mai frequentato una scuola o un corso che mi permettesse di affinare la tecnicaracconta Sofia - Il disegno rappresentava unicamente una valvola di sfogo, un modo per rilassarsi nei momenti di particolare stress».
Quando hai capito che sarebbe
diventato il tuo lavoro?
A due anni dal debutto sui social di Disegni Cinici, faccio ancora fatica a vederlo come un vero e proprio lavoro; è il mio modo di esprimermi, la mia “creatura”. Ho capito però che stava diventando qualcosa di serio pochi mesi dopo l’apertura della pagina, quando alcune aziende ed altre realtà hanno iniziato a contattarmi e a voler collaborare con me.
Disegni Cinici. Come è nato?
Disegni Cinici è nato a novembre del 2020, in un periodo nel quale tutti noi eravamo costretti a trascorrere molto tempo a casa a causa delle restrizioni. La noia e il desiderio di poter esprimere tutti quei pensieri che troppo spesso mi tenevo dentro hanno dato vita ai primi disegni. Il riscontro immediato da parte del popolo di Instagram mi ha fatto subito capire che, eviden -

Parla la fumettista: “Cinismo e sensibilità si tengono a bada l’un l’altro. Così ho imparato ad ascoltarmi e ad accettarmi”
di Chiara Andreotti
temente, ciò che passava nella mia mente era anche - spesso - il pensiero delle altre persone.
Quanto è cinica Sofia?
Credo di avere un buon equilibrio tra cinismo e sensibilità, ognuno dei due aspetti tiene a bada l’altro.
Che rapporto hai con i tuoi followers?
Vorrei poter avere un rapporto più stretto con i miei follower, ma il lavoro e gli impegni quotidiani me lo impediscono. Con la maggior
parte di essi, però, sento di condividere lo stesso modo di pensare e di guardare alla vita; questo ci rende comunque vicini.
Quanto ti senti influenzata da loro e da quello che vedi sui social?
Moltissimo. Ogni volta che realizzo un’illustrazione cerco di dare voce a quelli che sono i sentimenti e le tendenze del momento. Per questo cerco sempre di rimanere aggiornata sui “temi caldi” che passano sui social.


Ti capita di provare la necessità
Disegni Cinici è nato a novembre del 2020, in un periodo nel quale tutti noi eravamo costretti a trascorrere molto tempo a casa a causa delle restrizioni.
“Ho avuto la fortuna di affrontare la pandemia in modo molto sereno, circondata dai miei affetti più importanti, in un ambiente sicuro.
I tanti anni di terapia - psicologica e farmacologica - alle spalle mi hanno poi protetta da tutte le eventuali conseguenze negative sulla mia salute mentale”.
di staccare?
A volte sì, come tutti penso. E se ne sento la necessità lo faccio tranquillamente, perché penso che le persone si accorgerebbero di un lavoro fatto tanto per fare.
Quanto aiuto possono dare i social per imparare a parlare di salute mentale senza stigma?

Credo che, al giorno d’oggi, i social rappresentino lo strumento principale per poter parlare di salute mentale. Permettono di entrare in comunicazione con tantissime persone nello stesso momento e, di conseguenza, di osservare come quelli che crediamo essere dei nostri “problemi” siano in realtà condivisi da tanti. Il filtro dello schermo, poi, rappresenta per molti utenti un elemento di sicurezza

che permette di esprimersi con più tranquillità e sincerità. Certo, questa a volte può essere anche un’arma a doppio taglio.
Come hai affrontato la pandemia e il lockdown?
Ho avuto la fortuna di affrontare la pandemia in modo molto sereno, circondata dai miei affetti più importanti, in un ambiente sicuro. I tanti anni di terapia - psicologica e farmacologica - alle spalle mi hanno poi protetta da tutte le eventuali conseguenze negative sulla mia salute mentale.
Qual è il tuo rapporto con la salute mentale?
Adesso molto buono. Ho imparato, anche grazie all’aiuto di professionisti, ad ascoltarmi e soprattutto ad accettarmi. Quando ebbi i
primi attacchi di panico (nel 2002), invece, quello della salute mentale era ancora un discorso poco affrontato e questo mi portava a sentirmi profondamente diversa e sbagliata. Rappresenti l’ansia quasi come un parassita. È così che la percepisci?
Più che un parassita la considero una presenza ingombrante che bisogna imparare a gestire e ad accettare, che non significa sottostare alle sue regole ma scendere a patti col fatto che fa parte di noi. Ho dedicato molte illustrazioni all’ansia nonché un intero capitolo del mio libro (Se son rose appassiranno, edito da DeAgostini) intitolato “Livin’ la vida in ansia”.

Pensi che la terapia possa aiutare?
Credo che la terapia sia l’unico modo per iniziare un discorso costruttivo con noi stessi ed elaborare traumi e pensieri che troppo spesso lasciamo chiusi in un cassetto. La consiglierei a tutti, anche a chi non soffre di disturbi particolari.
In che modo la salute mentale influisce sul tuo lavoro?
La salute mentale influisce in tutto quello che faccio perché fa parte di me, quindi condiziona - in modo positivo e negativo - le mie scelte lavorative, le modalità con le quali mi approccio a nuovi progetti.
Progetti in cantiere? Come vedi il futuro prossimo?
Non mi piace fare progetti eccessivamente a lungo termine, soprattutto quando si tratta di lavoro, perché le cose migliori che mi siano capitate negli ultimi due anni sono nate “semplicemente” da opportunità afferrate al volo. Sicuramente spero che Disegni Cinici continui a crescere e a travalicare sempre di più il confine dei social network.
Le parole di Sofia sono importanti per tutti coloro che si sentono abbandonati e soli, sopraffatti dalla malattia. La campagna #Parliamone, che oggi si arricchisce dell’ironia sottile di Disegni Cinici, è nata proprio per abbattere lo stigma che pesa sulle patologie legate alla mente e sostenere chi ne soffre.

Visita il sito della Fondazione BRF (www.fondazionebrf.org) per saperne di più.
Visita il sito della Fondazione BRF (www.fondazionebrf.org) per saperne di più.
Credo che la terapia sia l’unico modo per iniziare un discorso costruttivo con noi stessi ed elaborare traumi e pensieri che troppo spesso lasciamo chiusi in un cassetto.
L’analisi dei sintomi persistenti post-Covid con follow-up fino a 36 mesi
di Valentina Formica

Tra le varie attività che porta avanti attualmente la fondazione BRF, spiccano le importanti ricerche legate all’infezione da Covid-19.
In particolare, la Fondazione sta conducendo da ormai oltre 2 anni uno studio nazionale e multicentrico che indaga i sintomi persistenti post-Covid-19, analizzandone la progressione nel tempo somministrando ai soggetti reclutati questionari sviluppati ad hoc per la valutazione di sintomi sensoriali, somatici, respiratori, gastrointestinali, cardiovascolari e psicologici con tempi di follow-up fino a 36 mesi. Il progetto della Fondazione BRF mira a valutare l’epidemiologia degli effetti a lungo termine di Covid-19, a comprenderne l’impatto sulla qualità della vita e sulla salute mentale dei partecipanti e a evidenziare relazioni significative tra la persistenza dei sintomi e lo stato premorboso e le abitudini di vita dei soggetti del campione.
Il long-covid è una malattia multisistemica (ad oggi sono stati identificati più di 200 sintomi), che si verifica in almeno il 10% delle infezioni da coronavirus e che ha quindi già colpito milioni di persone in tutto il mondo. L’incidenza di questa condizione è stimata al 10-30% dei casi non ospedalizzati e al 50-70% dei casi ospedalizzati, le sfide per la ricerca sono molte e molte sono le domande aperte.
Sulla base di oltre due anni di ricerca sul fenomeno e su decenni di studio su condizioni simili si ipotizza che una percentuale significativa di individui affetti da long-Covid potrebbero riportare problematiche permanenti se non vengono messi in campo interventi efficaci.

I sintomi neurologici e cognitivi sono una delle caratteristiche principali di questa condizione, tra cui sintomi sensomotori, perdita di memoria, deterioramento cognitivo, parestesie, vertigini, aumentata sensibilità alla luce e al rumore, perdita dell’olfatto e/o del gusto, che spesso influiscono sulle attività quotidiane.
Le opzioni terapeutiche sono attualmente insufficienti anche a causa della non completa conoscenza della progressione dei sintomi, delle loro cause e dei fattori di rischio ad essi connessi. Secondo la letteratura le cause del long-Covid sono probabilmente molteplici e potenzialmente sovrapposte, mentre i fattori di rischio includono potenzialmente: il sesso femminile, il diabete di tipo 2, i disturbi del tessuto connettivo, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l’orticaria cronica e la rinite allergica, anche se un terzo delle persone con long-covid non sembra presentare condizioni preesistenti.
I sintomi neurologici e cognitivi sono una delle caratteristiche principali di questa condizione, tra cui sintomi sensomotori, perdita di memoria, deterioramento cognitivo, parestesie, vertigini, aumentata sensibilità alla luce e al rumore, perdita dell’olfatto e/o del gusto, che spesso influiscono sulle attività quotidiane. Un rapporto su oltre 1,3 milioni di persone guarite dall’infezione da Covid-19 ha mostrato che i sintomi legati alla salute mentale, come ansia e depressione, sono rientrati nel corso del tempo, ma che è aumentato il rischio di deterioramento cognitivo.
Le analisi preliminari ad oggi condotte sui dati raccolti dalla Fondazione BRF mostrano risultati in linea con quanto al momento presente in letteratura. Il long-Covid sembra essere più presente nella popolazione femminile, che in media riporta anche un numero più alto di sintomi, mentre non risultano differenze significative per quanto riguarda l’età dei soggetti. Il 65% dei soggetti del campione riporta almeno uno dei sintomi indagati dai questionari, questi tendono a
ridursi dopo 6 mesi dall’infezione, eccezion fatta per i disturbi legati alla sfera mnesica. I sintomi più frequentemente riportati nel nostro campione includono: difficoltà di concentrazione, sensazione di minore efficienza mentale, mal di testa, problemi legati al sonno, riduzione della memoria e aumento della sintomatologia ansiosa e dell’irritabilità.
Ma l’attività della Fondazione va anche oltre. Rimanendo nell’ambito Covid-19, il nostro team di ricerca è anche al momento impegnato nella conduzione di un progetto europeo in partenariato con altri Stati dell’Unione che mira a sostenere gli operatori sanitari nell’ottenimento di maggiori capacità e competenze per gestire le possibili future emergenze sanitarie. Il progetto comprende tra i diversi risultati attesi lo sviluppo di una piattaforma online di formazione per i professionisti della salute che si basi sulla letteratura recente e sulla raccolta delle conoscenze, delle esperienze e delle migliori pratiche identificate a livello europeo sul tema delle emergenze sanitarie.
Hai avuto il Covid e vuoi partecipare allo studio sul Long-Covid?
Inquadra il QR CODE:

Il microchip è il modo migliore per ritrovare il tuo amico a quattrozampe in caso di smarrimento.
Se il tuo cane o il tuo gatto non lo hanno ancora, recati dal tuo veterinario o al servizio veterinario pubblico competente per territorio, per identificarlo e iscriverlo in anagrafe degli animali d’affezione!
● Il microchip, obbligatorio per legge per il cane e presto anche per il gatto, è un piccolo dispositivo elettronico che identifica il tuo amico a quattrozampe e lo lega a te in maniera unica. L’identificazione con microchip di cani, gatti e furetti è inoltre obbligatoria per poter acquisire il passaporto europeo, per recarsi all’estero.

● Non temere per la sua salute: l’inserimento del microchip è sicuro e indolore!
● Il certificato di iscrizione nell’anagrafe degli animali d’affezione è la sua “carta d’identità”. Ricordati di portarlo sempre con te!
È un’iniziativa del Ministero della Salute in collaborazione con LAV
La ricerca di un team australiano sull’attività fisica

L’attività fisica è una preziosissima alleata contro la depressione, l’ansia e il disagio psicologico in generale, mostrando un’efficacia contro i sintomi – perlomeno nelle condizioni lievi e moderate – ben 1,5 volte superiore a quella garantita dai farmaci e dal counseling, un supporto rivolto a persone con problemi di diverso tipo (relazionali, sul lavoro, con i figli etc etc).
Diversi studi avevano già mostrato in precedenza la forte associazione positiva tra il praticare sport e i benefici per la salute mentale; tali vantaggi, fra l’altro, si manifestano sin dalla tenera età, come dimostrato da una ricerca della Norwegian University of Science and Technology (NTNU), nella quale è stato osservato un ridotto rischio di sintomi depressivi nei bambini impegnati nelle attività sportive. Non serve nemmeno “impegnarsi” troppo, visto che basterebbe appena un’ora di sport a settimana per contrastare la depressione, come emerso da un altro studio del Black Dog Institute pubblicato sull’American Journal of Psychiatry.
A determinare che l’attività fisica ha un’efficacia contro depressione e ansia superiore di 1,5 volte ai medicinali è stato un team di ricerca guidato da scienziati dell’Allied Health & Human Performance dell’Università dell’Australia del Sud (UniSA), che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi dell’Health and Use of Time (HUT) Group. I ricercatori, coordinati dal professor Ben Singh, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver condotto un peculiare studio chiamato “a ombrello” (umbrella review), nel quale hanno analizzato statisticamente i risultati di molteplici revisioni sistematiche e meta-analisi di studi randomizzati

A determinare che l’attività fisica ha un’efficacia contro depressione e ansia superiore di 1,5 volte ai medicinali è stato un team di ricerca guidato da scienziati dell’Allied Health & Human Performance dell’Università dell’Australia del Sud.
e controllati, tutti dedicati alla relazione tra l’esercizio fisico e la salute mentale. Nello specifico, hanno coinvolto nell’indagine poco meno di cento articoli scientifici, per un totale di oltre 1.000 trial e quasi 130mila partecipanti. Come indicato nell’abstract dello studio, le popolazioni coinvolte erano composte da adulti sani, con disturbi mentali e con diverse comorbilità (patologie sottostanti di natura cronica).
Dall’analisi statistica sono emersi i significativi benefici offerti dall’attività fisica contro depressio -
ne, ansia e disagio psicologico in generale. Il professor Singh e colleghi hanno osservato che tali vantaggi risultavano particolarmente efficaci quando i programmi di esercizio abbracciavano un arco temporale di 3 mesi (12 settimane) o meno; quelli troppo lunghi avevano un impatto ridotto. Inoltre l’attività fisica ad alta intensità – da valutare sempre assieme al proprio medico curante – era associata ai migliori risultati. Sebbene l’attività fisica offrisse benefici praticamente a chiunque, alcune categorie ne erano più avvantaggiate. Fra esse i pazienti affetti da depressione, infezioni da virus dell’HIV e malattie renali, così come le donne incinte, le neo mamme e i soggetti sani, come spiegato nello studio.
I ricercatori hanno anche scoperto che non tutti gli esercizi hanno la stessa efficacia. Lo yoga e altre attività che coinvolgono anche la mente, ad esempio, sembrano più efficaci contro l’ansia, mentre quelli più di resistenza come corsa, bicicletta e affini offrono i migliori risultati contro la depressione. È bene però ricordare che, sebbene evidentemente l’attività fisica garantisca enormi benefici, non può sostituirsi a una cura o a una terapia nel caso in cui un paziente abbia sintomi rilevanti che richiedono l’intervento di uno specialista.

Ècertamente un percorso difficile, quello che sta affrontando Fedez, che riguarda l’assunzione di farmaci antidepressivi. A raccontarlo è il rapper stesso su Instagram: «Da gennaio – racconta nelle sue Stories – mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino a darmi dei tic nervosi alla bocca, e non permettendomi di parlare in modo libero. Avendo questo farmaco dato degli effetti collaterali molto forti ho dovuto sospenderlo senza scalarlo. Mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound».
Al di là della questione in sé, la vicenda del rapper permette e ha permesso di ragionare sul cosiddetto “effetto rebound”. In medicina, con tale termine (noto anche come effetto di rimbalzo) si indicano i sintomi di astinenza e di depressione che possono manifestarsi subito dopo l’interruzione improvvisa di uno psicofarmaco. Tecnicamente si tratta dell’inasprimento di una malattia dopo la sospensione del principio attivo contenuto in un farmaco o la riduzione del suo dosaggio. Una situazione di malessere patita da Fedez, che raccontato di aver avuto a lun -
go «un senso di annebbiamento a livello cognitivo e forti spasmi alle gambe che gli hanno impedito per molti giorni di camminare»; una crisi fisica e mentale che lo ha portato a «perdere 5 kg in 4 giorni».
Quali sono i sintomi e le cure? Iniziamo da primi: attacchi di panico, ansia e insonnia. Di solito questi sintomi compaiono 36-96 ore dopo aver ridotto o sospeso la terapia. L’effetto rimbalzo determina nel paziente i sintomi di astinenza (come il «craving») e di una depressione anche più grave di quella per cui all’inizio ha assunto il farmaco. In molti casi l’effetto rebound provoca quindi una patologia o condizione che ha sintomi spesso peggiori rispetto a quelli determinati dalla patologia o condizione che il farmaco ha curato.
La maggior parte delle reazioni di interruzione degli antidepressivi sono di breve durata e si risolvono spontaneamente tra 1 giorno e 3 settimane dopo l’insorgenza, la media è di 5 giorni. L’effetto rebound provoca quindi conseguenze temporanee ma i sintomi possono durare fino a 6 settimane. Si tratta di sintomi reversibili, quindi non ci sono danni permanenti per le persone. La sofferenza del paziente più essere alleviata con opportuni interventi farmacologici o psicoterapici.

C’è veleno nell’aria di città, e lo sappiamo. L’inquinamento provoca malattie, e non solo fisiche. Provocherebbe infatti anche ansia o depressione. E non solo in soggetti predisposti, che hanno sofferto di questi disturbi già in passato. C’è una serie importante di “nuovi malati” di ansia e depressione causati dall’inquinamento cittadino. Uno studio di proporzioni notevoli, lungo parecchi anni (sedici) e che ha coinvolto centinaia di migliaia di cittadini, è stato effettuato in Gran Bretagna, su un campione scelto in base all’età non più giovane, e a nessun trascorso di ansia e depressione nel passato.
Partiamo da una conclusione se si vuole apparentemente scontata: chi vive in una grande città inquinata ha più possibilità di ammalarsi di ansia o depressione. Dietro però ci sono numeri e dati sorprendenti. La
ricerca, condotta sui cittadini britannici che vivono in città, è basata su numeri insolitamente elevati: quasi 400mila cittadini coinvolti (per l’esattezza, 389.185), e già essi stessi “selezionati”. Sono stati infatti non conteggiati i soggetti che già soffrivano o avevano sofferto in passato di ansia e depressione. Gli esiti di questo grande studio sono stati pubblicati all’inizio di febbraio da Jama Psychiatry, rivista mensile dell’American Medical Association, che si occupa di salute mentale e scienze comportamentali.
Sotto accusa è il particolato, inquinante tipico delle città e degli ambienti industriali, che è composto da sostanze solide o liquide sospese nell’aria. compresi metalli, fumo, particelle carboniose. Il particolato è considerato dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) can-
cerogeno, quindi c’è già abbastanza per considerarlo pericoloso. Ma può comportare, in alternativa o insieme all’insorgenza di un tumore, altri danni. Un altro dato della ricerca è la durata dell’operazione, che copre un arco di quasi vent’anni. Infatti i partecipanti sono stati individuati in un arco di tempo che va dal 13 marzo 2006 al primo ottobre 2010. Alla fine dello studio, a 13.131 persone è stata diagnosticata la depressione e a 15.835 l’ansia. L’esposizione al particolato corrisponde a una maggiore probabilità e gravità di ansia e depressione. Più colpiti i maschi che le femmine. Qualora l’esposizione
agli inquinanti venisse stemperata, anche ansia e depressione potevano regredire.
I ricercatori, a margine del loro studio, hanno sottolineato come i risultati dello studio non siano lineari, con pendenze più ripide a concentrazioni più basse e tendenze di plateau a esposizioni più elevate. Secondo gli autori dello studio, le “associazioni non lineari” possono essere molto utili per definire le politiche di controllo dell’inquinamento atmosferico. Vedremo se qualche Stato recepirà anche questa ricerca nel contrasto all’inquinamento.
Sotto accusa è il particolato, inquinante tipico delle città e degli ambienti industriali, che è composto da sostanze solide o liquide sospese nell’aria. compresi metalli, fumo, particelle carboniose.

La tendenza a rinviare ciò che prima o poi si sa di dover fare non solo rende difficile raggiungere i propri obiettivi, ma può avere anche un effetto negativo sulla salute mentale. Impossibile? Niente affatto. È esattamente quanto emerge da una ricerca realizzata su una coorte di studenti universitari svedesi da parte di ricercatori guidati da Fred Johansson del Department of Health Promotion Science della Sophiahemmet University di Stoccolma. La ricerca ha mostrato come gli studenti che hanno una spiccata tendenza a procrastinare i propri impegni soffrono più frequentemente di ansia, depressione e sintomi da stress, dormono peggio durante la notte e soffrono di dolori ricorrenti, oltre a sperimentare maggiori livelli di solitudine ed essere più esposti al rischio a lungo termine di andare incontro a problemi economici. «La procrastinazione può essere definita come la tendenza a rinviare volontaria-
mente una serie di azioni che dovrebbero essere compiute, anche quando si ha già la percezione che il rinvio darà effetti negativi. È un fenomeno che si presenta soprattutto tra le persone più giovani» dicono gli autori della ricerca, pubblicata sulla rivista Jama Network Open e ripresa dal Corriere della Sera. Si legge nell’articolo: «Viene stimato che circa la metà degli studenti universitari incappi in comportamenti di procrastinazione problematici e di un certo rilievo, come ad esempio posporre lo studio ai fini di un esame o la scrittura di relazioni dovute. La procrastinazione può anche essere descritta come una forma di fallimento del comportamento di autoregolazione ed è correlabile a tratti di personalità come l’impulsività, la distraibilità e il basso livello di coscienziosità. «La tendenza di un individuo a ricorrere alla procrastinazione resta relativamente stabile nel tempo, anche se specifici comportamenti di procrastinazione
sono influenzati da fattori di contesto, come il livello di avversione nei confronti del compito che si dovrebbe affrontare. In effetti, per alcuni studenti la procrastinazione può anche essere un comportamento occasionale, che si presenta in relazione a specifici compiti accademici, mentre in altri individui rappresenta una disposizione più stabile di personalità e in questo caso è più probabile che finisca per influire sia sui risultati scolastici sia sullo stato di salute».
Il problema, però, è che si cade in una specie di circolo vizioso: il manifestarsi di questo tipo di problemi finisce per generare ulteriori difficoltà che provocano nuovi comportamenti di rinvio. Il fatto che la procrastinazione si rilevi soprattutto fra gli studenti universitari è verosimilmente dovuto all’organizzazione di questi studi, di solito poco strutturati e che quindi richiedono un elevato livello di autoregolazione.
C’è tuttavia la possibilità di interrompere il circolo vizioso. Uno dei motivi per i quali si rinvia un compito è che, prima ancora di provare ad affrontarlo, lo si percepisce come impegnativo e scoraggiante. In questo caso può essere utile tentare di immaginarlo non più come un compito unico, una singola montagna da scalare, ma come una serie di impegni spezzettati, ciascuno dei quali può così apparire più a portata di mano. E se si riesce in tal modo a raggiungere un primo obiettivo, e poi un secondo, e così via, ciò che resta da fare viene progressivamente percepito come sempre meno impegnativo. Utile anche una riorganizzazione del proprio tempo, ad esempio facendo ricorso a una programmazione settimanale in un’agenda sulla quale sono annotate attività sia di lavoro sia di svago. Infine, se proprio non si riesce da soli a smettere di rinviare, si può chiedere a qualcuno con cui si convive di svolgere
il ruolo di controllore delle attività. Ma è forse un diretto lavoro cognitivo sui pensieri lo stratagemma che può risultare più utile. Chi procrastina spesso ha una precognizione negativa sull’esito del proprio impegno, si convince dell’inutilità dello sforzo dal momento che comunque alla fine quel compito non sarà realizzato a dovere. Il principio del cambiamento cognitivo sta proprio in questo: riuscire a individuare questi pensieri negativi e a riconoscerli come non scontati, per poter avviare un processo di cambiamento interno.
Il fatto che la procrastinazione si rilevi soprattutto fra gli studenti universitari è verosimilmente dovuto all’organizzazione di questi studi, di solito poco strutturati e che quindi richiedono un elevato livello di autoregolazione.

Negli ultimi 10 anni, il consumo di farmaci antidepressivi nel nostro Paese è aumentato del 10%. Nel 2022 gli italiani hanno speso 288 milioni di euro per acquistarli. Sono state vendute 1 miliardo e 55 milioni di dosi, rispetto ai 960 milioni del 2018. I fondi stanziati per il bonus psicologo sono bastati ad accogliere appena il 10% delle 400 mila domande presentate. Basterebbero questi dati evidenziare la necessità di un intervento strutturale che affronti il problema della salute mentale nel nostro Paese. Ma se si aggiunge che l’Italia è solo 21esima nel mondo per la spesa in quest’ambito: il 3% del costo della sanità – contro il 14% della Francia, l’11% della Germania e il 10% del Regno Unito – il quadro diventa chiaro.
Per questo le ragioni stanno intervenendo laddove lo Stato arranca:
l’istituzione di uno psicologo di base gratuito. Un professionista che in collaborazione con medico di famiglia e pediatra offre un primo livello di assistenza per poter intercettare i problemi sul nascere e indirizzare i pazienti verso professionisti adeguati. Nel frattempo, al Sole 24 Ore il ministro della Salute Orazio Schillaci fa sapere che il governo pensa a uno psicologo di base su scala nazionale, ma per il 2023 stanzia 5 milioni di euro per il bonus psicologo, un quinto rispetto al 2022. Nel 2024 dovrebbero salire a 8, nonostante la misura sia diventata strutturale.
La prima regione, come racconta in un interessante articolo Open, ad aver creato la figura è stata la Campania, con la legge del 35 del 3 agosto 2020, impugnata dal governo ma considerata legittima dalla Corte costituzionale nel 2021. Così la Campania ora stanzia 600 mila euro l’anno per avere psicologi di base nei distretti sanitari delle Asl. Sono liberi professionisti in
convenzione che aiutano i pazienti a fare fronte alle difficoltà psicologiche esasperate dalla pandemia. Poco lontano, l’Abruzzo ha approvato una legge simile a ottobre dello scorso anno, mentre il Piemonte, a giugno, ha deliberato per l’introduzione di 55 psicologi che si occupino dei casi più critici prima che degenerino. Lo stanziamento è considerevole: 1,8 milioni di euro. Psicologo di base anche in Toscana, dove i fondi, però si fermano a 350 mila euro. La Lombardia ha messo in cantiere un provvedimento simile, ma al momento mancano i fondi, anche se il rieletto governatore Attilio Fontana ha garantito, a dicembre, che verranno trovati. La Liguria sta valutando la fattibilità della cosa, mentre in Sicilia la legge è all’esame dell’assemblea regionale. La legge pugliese è stata fermata dalla Corte costituzionale perché non le avrebbe consentito di rientrare dal deficit sanitario, ma tornerà presto in esame. Infine, in Emilia-Romagna lo
ha inserito nel progetto per le case di comunità. Presidi sanitari locali già attivi dal 2021.
Nel 2022 un minore su 4 presenta sintomi depressivi. Uno su 5 ha disturbi d’ansia. Il consumo di farmaci per il sistema nervoso centrale è cresciuto del 6% nel 2021 rispetto all’anno precedente. E già nel 2020 aveva visto una salita del 3% rispetto al 2019. Il 6,6% dei giovani tra i 15 e i 19 anni ha fatto uso di farmaci antidepressivi nell’ultimo anno, Il 4% negli ultimi 30 giorni. L’1% lo fa 10 volte al mese. Percentuali che possono sembrare piccole ma che sono in costante aumento. Proprio per affrontare questo problema Diverse regioni si sono mosse per affiancare il bonus psicologo nazionale con contributi ad hoc. Per i giovani li hanno previsti Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Veneto, Puglia, Piemonte, Liguria e Calabria.
Nel 2022 un minore su 4 presenta sintomi depressivi. Uno su 5 ha disturbi d’ansia. Il consumo di farmaci per il sistema nervoso centrale è cresciuto del 6% nel 2021 rispetto all’anno precedente.

Esistono sulla terra quei luoghi dove il tempo sembra sospeso, la vita scorre sempre uguale e la realtà non viene intaccata da quello che accade intorno: è esattamente quello che succede sull’isola fittizia immaginata da Martin McDonagh nella sua ultima pellicola “Gli spiriti dell’isola”.
Avvolta dalle nubi grigie e delimitata dalle coste frastagliate, l’isola di Inisherin ospita un paese annoiato e lontano dalla guerra civile che sta devastando l’Irlanda.
Qui vive Pádraic: un uomo pacifico che potremmo definire semplice nel modo di percepire il mondo, ma questa sua semplicità racchiude tutto quello che necessita di essere percepito: amore e gentilezza.
La sua vita, che scorre monotona, viene improvvisamente sconvolta dall’annuncio di Colm: quello che per
lui era l’amico di una vita d’un tratto smette di esserlo.
Colm, riluttante, ammette di essersi annoiato di Pádraic e di voler trascorrere gli ultimi anni senza sprecare tempo in chiacchiere che non lo arricchiscono, dedicandosi alla scrittura della sua musica, vietando addirittura all’amico di un tempo di rivolgergli la parola, pena l’automutilazione delle proprie mani con le quali suona il suo amato violino.
L’irrazionalità della decisione porta Pádraic ad interrogarsi su se stesso, sulla percezione che gli altri hanno di lui e sull’importanza di essere gentili, fino a sfiorare la follia.
Colm, da parte sua, si trova a dover affrontare le conseguenze della sua ostinazione, fronteggiando quella che tutti chiamano una “disperazione” ma è chiaramente una depressione di cui possiamo solo ipotizzare la
Il tempo sembra sospeso mentre la guerra civile devasta l’Irlanda
di Chiara Andreotti
causa.
Così l’apatica cittadina viene sconvolta da questa guerra tra i suoi abitanti più di quanto stia facendo la guerra civile che si combatte oltre la costa.
Martin McDonagh racconta una storia delicata e commovente, con una punta di comicità quasi involontaria. Una storia che scorre lenta come la vita su Inisherin, dove le voci degli spiriti, quelle banshee del titolo originale, non sono più folklore ma camminano indisturbate tra la gente, sussurrando presagi di morte che forse, alla fine, diventeranno realtà.

I silenzi, gli sguardi, i gesti sono di una potenza disarmante, in netto contrasto con il blaterare dei personaggi, che si incastrano tutti perfettamente nel quadro dipinto da McDonagh.
Candidato a nove premi Oscar, “Gli spiriti dell’Isola” regala un’esperienza totalizzante.
Colin Farrell porta sullo schermo un’interpretazione magistrale, forse la più potente mai vista e che potrebbe regalargli il primo premio Oscar della sua carriera: il suo Pádraic è gentile, pacato, solitario, con una sofferenza e una malinconia che sembrano scol-
pite sul suo viso e si leggono chiaramente nel suo sguardo, come per ribadire che condurre una vita solitaria non vuol dire essere estraniato, che essere semplice nel modo di pensare non rende immune al dolore ma porta a sentire le emozioni e la sofferenza esattamente come chiunque altro.
Nature or nurture? L’antico dilemma non risparmia neppure l’intelligenza. Quanto contano nel formare la nostra intelligenza i geni che riceviamo dai genitori e quanto invece l’ambiente in cui veniamo allevati?
L’ostilità nei confronti degli studi biologici sull’intelligenza che ha animato la seconda metà del secolo scorso ha avuto l’indubbio merito di innalzare il livello della qualità delle ricerche. Gli studi su gemelli e figli adottivi, che rappresentano lo strumento privilegiato per stimare il peso relativo della biologia e dell’ambiente, concordano su un 50% di peso della componente genetica. Ma quali sono, tra i circa ventiduemila geni che compongono il nostro genoma, quelli che hanno effetti ai fini dell’intelligenza? Qui le cose si complicano. Perché l’intelligenza è un tratto complesso e occorrono numeri da capogiro per ottenere una sufficiente potenza statistica. Non sorprende, quindi, che tutti gli studi genetici condotti dai primi anni ‘90 abbiano prodotto solo risultati contrastanti. Abbiamo dovuto aspettare gli studi di associazione cosiddetti genome-wide che, analizzando centinaia di migliaia di individui, consentono di ef-
fettuare correlazioni tra l’intero genoma e determinati tratti fenotipici. Una recente metanalisi su oltre un milione di soggetti - è lo studio più vasto mai fatto finora relativamente a un tratto comportamentale - ha identificato un profilo genetico composto da oltre mille loci genetici, che è predittivo del 10% della varianza dell’intelligenza. Questa capacità predittiva è paragonabile a quella fornita dal livello d’istruzione dei genitori sull’intelligenza dei figli, pari a circa il 9%. I genetisti stimano di poter arrivare a spiegare con le differenze genetiche all’incirca il 25% dell’ereditabilità dell’intelligenza. Come si spiega quindi il restante 25% per arrivare al 50% dell’ereditabilità indicato dagli studi sui gemelli? Con la cosiddetta missing heritability, un’ereditabilità influenzata da fattori genetici non individuabili con gli studi genome-wide, che solo studi di sequenziamento massivo del genoma su milioni e milioni di individui potranno un giorno trovare. Chissà. Nel frattempo, chi vuol essere sicuro di essere intelligente, scelga con cura i genitori e l’ambiente in cui vivere. Senza dimenticare, però, che, come per ogni tratto complesso, non esiste certezza.


Con il tuo 5x1000 aiuterai la Fondazione BRF Onlus a portare avanti i progetti di ricerca, come l'Osservatorio sulla Salute Mentale.
Il tuo aiuto è prezioso: potrai contribuire a migliorare molti destini.
Scegli la Fondazione BRF Onlus sulla tua dichiarazione dei redditi.
Ti basta il nostro codice fiscale
