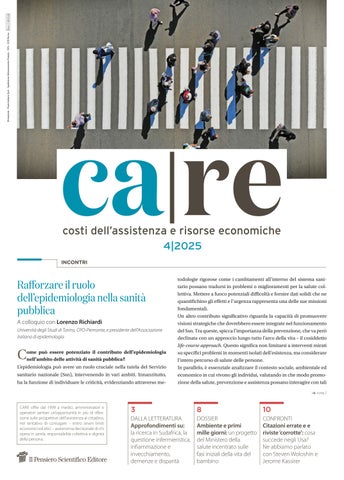ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche
4|2025
INCONTRI
Rafforzare il ruolo
dell’epidemiologia nella sanità pubblica
A colloquio con Lorenzo Richiardi
Università degli Studi di Torino, CPO-Piemonte, e presidente dell’Associazione italiana di epidemologia
C
ome può essere potenziato il contributo dell’epidemiologia nell’ambito delle attività di sanità pubblica?
L’epidemiologia può avere un ruolo cruciale nella tutela del Servizio sanitario nazionale (Ssn), intervenendo in vari ambiti. Innanzitutto, ha la funzione di individuare le criticità, evidenziando attraverso me-
CARE offre dal 1999 a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
3
todologie rigorose come i cambiamenti all’interno del sistema sanitario possano tradursi in problemi o miglioramenti per la salute collettiva. Mettere a fuoco potenziali difficoltà e fornire dati solidi che ne quantifichino gli effetti e l’urgenza rappresenta una delle sue missioni fondamentali.
Un altro contributo significativo riguarda la capacità di promuovere visioni strategiche che dovrebbero essere integrate nel funzionamento del Ssn. Tra queste, spicca l’importanza della prevenzione, che va però declinata con un approccio lungo tutto l’arco della vita – il cosiddetto life-course approach. Questo significa non limitarsi a interventi mirati su specifici problemi in momenti isolati dell’esistenza, ma considerare l’intero percorso di salute delle persone.
In parallelo, è essenziale analizzare il contesto sociale, ambientale ed economico in cui vivono gli individui, valutando in che modo promozione della salute, prevenzione e assistenza possano interagire con tali
DALLA LETTERATURA
Approfondimenti su: la ricerca in Sudafrica, la questione infermieristica, infiammazione e invecchiamento, demenze e disparità
8 DOSSIER
Ambiente e primi mille giorni: un progetto del Ministero della salute incentrato sulle fasi iniziali della vita del bambino
10
CONFRONTI
Citazioni errate e e riviste ‘corrotte’: cosa succede negli Usa? Ne abbiamo parlato con Steven Woloshin e Jerome Kassirer
01 Incontri RAFFORZARE IL RUOLO DELL’EPIDEMIOLOGIA
NELLA SANITÀ PUBBLICA
A colloquio con Lorenzo Richiardi
13 Dalla letteratura internazionale
18 Dossier
CONOSCERE PER AGIRE: POLITICHE SANITARIE EFFICACI NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA
10 Confronti
CATTIVE CITAZIONI
PORTANO A CATTIVE POLITICHE
A colloquio con Steven Woloshin
UNA MASTER CLASS SUL “VIVERE DA EDITOR” DI UNA RIVISTA SCIENTIFICA
A colloquio con Jerome P Kassirer
LA ‘QUESTIONE INFERMIERISTICA’
Di Barbara M angiacavalli
Tutti gli articoli e le interviste sono disponibili su www.careonline.it
CARE Costi dell’assistenza e risorse economiche
Direttore responsabile
Giovanni Luca De Fiore
Comitato editoriale
Giancarlo Bausano, Cristina Cenci
Guendalina Graffigna, PierLuigi Lopalco Walter Ricciardi, Eugenio Santoro Federico Spandonaro
Redazione
Andrea Calignano, Federica Ciavoni, Norina Di Blasio, David Frati, Mara Losi
Stampa
Lion Brand srl - Roma
Progetto grafico ed impaginazione
Doppiosegno snc - Roma
Fotografie
©2025 ThinkstockPhotos.it
Registrazione del Tribunale di Roma n. 00472/99 del 19 ottobre 1999
Abbonamenti 2025
Individuale: euro 90,00
Istituzionale: euro 120,00
Periodicità bimestrale
Finito di stampare agosto 2025
Il Pensiero Scientifico Editore
Via San Giovanni Valdarno 8 - 00138 Roma
E-mail: info@careonline.it
Internet://www.careonline.it
Con il patrocinio di


Lorenzo Richiardi si è laureato in medicina all’Università di Torino e ha conseguito un dottorato in Epidemiologia presso il Karolinska Institutet di Stoccolma. Attualmente è professore ordinario di Statistica medica presso il Dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Torino, direttore della Struttura di epidemiologia dei tumori della Aou Città della salute e della scienza di Torino e coordina il Cpo-Piemonte, il Centro di riferimento per l’epidemiologia e la prevenzione oncologica della regione. È responsabile e collaboratore in numerosi progetti e consorzi di ricerca a livello nazionale, europeo e internazionale, che abbracciano diversi ambiti dell’epidemiologia.
In Italia coordina il progetto Ninfea, una coorte di nascita che mira a studiare come i fattori legati alla gravidanza, al periodo perinatale e all’infanzia influenzino la salute lungo l’intero arco della vita.
Da aprile 2025 è presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia.
fattori. Non si tratta solo di rafforzare la prevenzione, ma anche di comprendere come l’intera attività assistenziale del Ssn – oggi in evidente difficoltà –possa essere sostenuta e migliorata.
L’epidemiologia ha un punto di forza metodologico: la prospettiva longitudinale. È cioè in grado di seguire i percorsi delle persone prima e dopo l’insorgenza delle malattie, identificando i momenti critici, le interruzioni nei percorsi di cura, le aree problematiche e le possibili azioni correttive.
Ritiene che le istituzioni abbiano oggi una maggiore consapevolezza del ruolo dell’epidemiologia rispetto al passato?
È difficile rispondere a questa domanda perché le realtà sono molto diversificate in ambito nazionale o, volendo estendere, a livello europeo. Ci sono iniziative istituzionali regionali e locali che cercano il contributo e il supporto dell’epidemiologia; ci sono invece altre realtà in cui il ruolo dell’epidemiologia è poco riconosciuto o addirittura osteggiato. Alcune regioni hanno visto un miglioramento rispetto al passato, altre hanno vissuto negli anni recenti una chiusura importante, avvenuta in parallelo con restrizioni nell’accesso ai dati sanitari e amministrativi. È quindi fondamentale una comunicazione aperta e attiva tra le diverse realtà locali per portare avanti istanze comuni e determinare livelli standard di attività epidemiologica a supporto del Ssn sia a livello territoriale e di comunità sia in ambito ospedaliero. In questo contesto, le associazioni scientifiche come la nostra possono svolgere un ruolo importante.
Un articolo pubblicato su The Lancet nel 1998*, richiamato da Benedetto Saraceno durante l’ultimo convegno dell’Associazione italiana di epidemiologia a Salerno, si domandava se l’epidemio-
*Rothman KJ, Adami HO, Trichopoulos D. Should the mission of epidemiology include the eradication of poverty? Lancet 1998; 352: 810-3.
logia dovesse anche farsi carico dell’eradicazione della povertà. A distanza di anni, come risponderebbe oggi?
Sicuramente l’epidemiologia deve studiare tutti i determinanti di rischio, andando ben oltre gli stili di vita individuali in età adulta o le fasi finali del ciclo vitale che conducono alla malattia. È essenziale considerare l’intero esposoma, cioè l’insieme delle esposizioni ambientali e socioeconomiche cui una persona è soggetta dalla nascita (o ancor prima, dal suo concepimento) fino alla fine della vita. Non voglio evitare la domanda, ma ritengo prioritario sottolineare quanto sia fondamentale acquisire e analizzare questi dati. Solo a partire dallo studio di questi dati possiamo chiederci in che misura i risultati delle nostre ricerche possano influenzare cultura, politiche e decisioni sanitarie. Trovare una risposta a questa domanda è più complesso.
A mio modo di vedere, fino ad alcuni anni fa il singolo ricercatore aveva l’opzione di scelta. Poteva cioè decidere di limitarsi a pubblicare i propri risultati, lasciando ad altri il compito di tradurli in cambiamenti concreti. Oggi è sempre più condivisa e accettata l’idea che la ricerca debba produrre un impatto sociale. E sta diventando quasi, io direi per fortuna, un obbligo ritenere che il compito del ricercatore sia anche quello di tradurre in impatto sociale ciò che studia.
Da questa prospettiva, la risposta è sì: se ne ha la possibilità, l’epidemiologo deve anche porsi l’obiettivo di contribuire alla riduzione – se non all’eradicazione – della povertà, attraverso l’evidenza scientifica. Forse non potrà intervenire direttamente, ma può senz’altro orientare politiche e interventi nella direzione giusta.
Forse da questo punto di vista, rispetto ai singoli ricercatori, le associazioni professionali hanno una maggiore capacità di incidere sul dibattito pubblico. Possono mettere in rete competenze diverse e rendere più efficace la traduzione dei risultati scientifici in azioni concrete. Per questo, uno dei compiti fondamentali di un’associazione scientifica come la nostra è proprio facilitare questo passaggio: far sì che la conoscenza prodotta diventi motore di cambiamento.
“L’epidemiologia... è in grado di seguire i percorsi delle persone prima e dopo l’insorgenza delle malattie, identificando i momenti critici, le interruzioni nei percorsi di cura, le aree problematiche e le possibili azioni correttive.”
Lei è da poco diventato presidente dell’Aie. Quali sono le sfide più importanti che dovrete affrontare come associazione e gli obiettivi prioritari del suo mandato?
Più che parlare di ‘sfide’, preferisco ragionare in termini di esigenze fondamentali che l’associazione è chiamata ad affrontare nei prossimi anni. Tra le priorità, sicuramente rientrano la difesa e il rafforzamento del servizio sanitario pubblico, la promozione della salute globale in un mondo segnato dalla crisi climatica, e il contrasto attivo alle disuguaglianze sanitarie e ambientali.
Un altro fronte rilevante riguarda la crescente complessità dei bisogni di salute legati all’invecchiamento della popolazione e alla multi-morbilità, così come l’urgenza di integrare in modo critico e responsabile le nuove tecnologie, in particolare l’intelligenza artificiale, nella ricerca e nella pratica epidemiologica. In questo contesto, sarà essenziale ristabilire un equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati personali e l’interesse collettivo alla salute. Un ruolo importante spetterà anche all’epidemiologia nel contribuire alla comprensione e alla risposta
I DOMINI DELL’ESPOSOMA
a fenomeni globali come le migrazioni e i conflitti armati, che pongono nuove sfide sia sanitarie che etiche.
A mio avviso, due parole chiave possono guidarci in questa fase: apertura e impatto. Aprirsi vuol dire confrontarsi dentro l’associazione, valorizzando le diverse anime disciplinari che la compongono, ma anche cercare un dialogo più strutturato con altre realtà, sia italiane sia internazionali. Penso, ad esempio, a un rafforzamento delle collaborazioni con le associazioni epidemiologiche europee e alla possibilità di coinvolgere attivamente ricercatori italiani che lavorano all’estero, favorendo un approccio più transnazionale ai temi della salute. L’obiettivo, nei prossimi anni, sarà far sì che l’Aie non sia soltanto la somma delle singole competenze, ma un organismo capace di orientarsi con decisione sulle questioni prioritarie, continuando a presidiare anche gli ambiti di ricerca consolidati, che restano fondamentali per la sanità pubblica. n
Intervista a cura di Norina di Blasio e Mara Losi
Insieme dei fattori ambientali ai quali la persona è esposta durante l’intero arco della vita.
AMBIENTE
ESTERNO SPECIFICO
Esposizione dell’individuo ad agenti esterni speci ci
AMBIENTE INTERNO
Risposte di adattamento dell’organismo, che coinvolgono processi ormonali, in ammatori e molecolari
AMBIENTE
ESTERNO GENERALE
In uenze socioeconomiche, ambientali, psicosociali
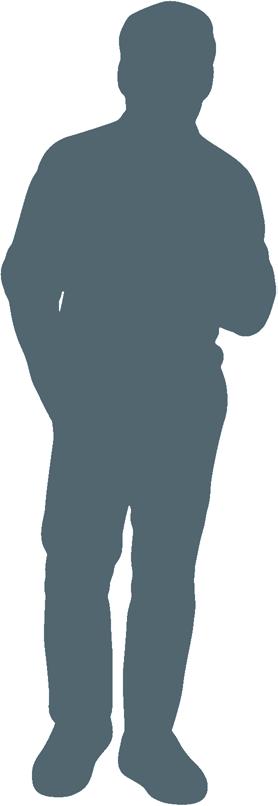

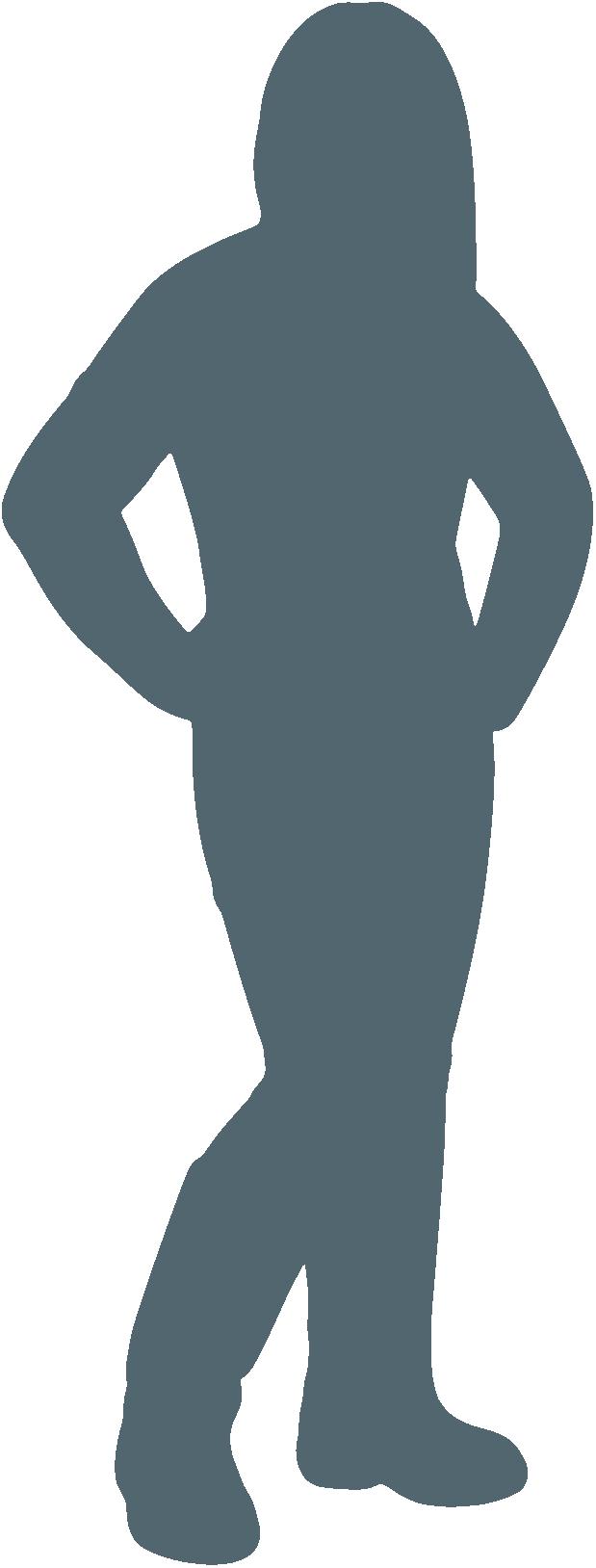
La professione infermieristica e gli appelli per la difesa del Ssn
Saiani L, De Marinis MG
Gli infermieri negli appelli a sostegno del Servizio sanitario nazionale
Assist Inferm Ric 2025; 44(2): 41-44
Negli ultimi anni il Servizio sanitario nazionale è stato sottoposto a una pressione crescente, determinata da una combinazione di politiche restrittive, sottofinanziamento, mancata programmazione e trasformazioni demografiche e sociali. La pandemia da Covid-19 ha infine accelerato e reso evidente una crisi strutturale già in atto, attirando su di sé l’attenzione della società civile e di molte componenti del mondo scientifico e sanitario. In questo contesto, tra il 2024 e il 2025, sono stati pubblicati diversi appelli pubblici volti a sollecitare un ripensamento profondo del Ssn, a riaffermarne i principi fondanti e a chiedere un intervento urgente per garantirne la sostenibilità. Un contributo pubblicato su Assistenza Infermieristica e Ricerca analizza questi appelli focalizzandosi su un aspetto spesso trascurato: la visibilità della professione infermieristica e le proposte per affrontare la carenza di personale.
CINQUE APPELLI, UN MESSAGGIO COMUNE
I documenti analizzati sono cinque, differenti per impostazione e composizione dei promotori, ma accomunati da un messaggio forte: senza un investimento reale e mirato sul personale sanitario – e in particolare sugli infermieri – non è possibile immaginare alcun rilancio efficace del Ssn.
1. “Non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico” (aprile 2024), promosso da un gruppo trasversale di professionisti di sanità, scienza, economia e comunicazione. Strutturato attorno a dieci domande chiave, evidenzia criticità e richiama l’urgenza di tutelare operatori e strutture.
2. “Manifesto per la difesa e il rilancio della salute pubblica” (novembre 2024), elaborato da gruppi civici attivi nel contesto bolognese. Organizzato in otto tavoli tematici, è quello che più approfonditamente analizza il nodo della carenza di personale, suggerendo misure puntuali di riforma.
3. “Principi per una riforma del Servizio sanitario nazionale” (gennaio 2025), una roadmap valoriale promossa da 40 studiosi italiani coordinati dal Cergas, che propone direttrici di cambiamento fondate su universalità, equità e sostenibilità.
4. “La crisi dei servizi sanitari universalistici” (marzo 2025), sintesi di un convegno dell’Accademia dei Lincei che denuncia la crisi sistemica dei servizi sanitari pubblici nei Paesi avanzati.
5. “Non possiamo restare in silenzio” (aprile 2025), appello sottoscritto da oltre 130 associazioni riunitesi a Firenze per rilanciare un fronte comune a favore della sanità pubblica.
Pur nella varietà dei contenuti, tutti i documenti convergono su alcuni snodi critici: il depauperamento del capitale umano del Ssn, l’urgenza di rendere attrattive le carriere sanitarie, la necessità di un adeguamento salariale e di migliori condizioni organizzative e di vita per il personale.
LA QUESTIONE INFERMIERISTICA: VISIBILITÀ E PROPOSTE
Un primo elemento emerso è che, sebbene non sempre gli infermieri siano esplicitamente nominati, la loro condizione è implicitamente compresa nella più ampia crisi del personale sanitario. Tuttavia, la mancanza di una citazione esplicita delle professioni più colpite – come quella infermieristica – rischia di tradursi in proposte troppo generiche. In controtendenza, alcuni appelli – in particolare quello bolognese e quello intitolato “Non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico” – mettono in luce il ruolo cruciale degli infermieri, soprattutto nelle aree di cronicità, anziani e cure domiciliari, e indicano specifiche leve di intervento.
Tra le proposte più ricorrenti:
l miglioramento delle condizioni lavorative, riducendo il carico di lavoro, il numero di turni notturni e i rischi professionali;
l formazione continua e gratuita, finalizzata al potenziamento delle competenze e alla valorizzazione del ruolo;
l riconoscimento retributivo: attualmente la retribuzione di un infermiere italiano è pari al salario medio nazionale, a fronte di un 20% in più nei paesi Ocse. Questa forbice retributiva penalizza l’Italia nella competizione internazionale per il reclutamento dei professionisti sanitari;
l introduzione di nuove figure professionali e aggiornamento dell’organizzazione del lavoro per superare l’ospedalo-centrismo e rafforzare l’assistenza territoriale;
l misure di welfare: attenzione al ruolo di cura extra-professionale, con interventi a sostegno della genitorialità (asili nido, flessibilità, conciliazione).
UNA CRISI CHE È POLITICA E MORALE
La crisi che colpisce oggi il personale infermieristico – e più in generale chi lavora nella sanità pubblica – è descritta non solo come una difficoltà organizzativa, ma come una vera e propria questione politica e morale. Tutti gli appelli esprimono l’urgenza di affrontarla con visione, lungimiranza e coraggio, recuperando una progettualità sistemica che metta al centro le persone – professionisti e cittadini. Le proposte avanzate non sono rimaste lettera morta. Molti dei contenuti degli appelli sono stati recepiti dalla Conferenza delle Regioni nel documento del 17 aprile 2025, che analizza le priorità in tema di personale del Ssn e avanza proposte di intervento.
COSTRUIRE UN FUTURO PER IL SSN
(E PER CHI CI LAVORA)
Il futuro del Ssn si gioca anche sulla capacità di riconoscere il ruolo essenziale degli infermieri come pilastro della sanità pubblica. La valorizzazione di questa professione, sotto il profilo economico, formativo, organizzativo e simbolico, è una condizione necessaria per garantire equità di accesso, qualità delle cure e tenuta dei servizi. Gli appelli analizzati sono un chiaro segnale che la società civile e scientifica non intende restare indifferente. Ora tocca alla politica trasformare queste istanze in atti concreti e coerenti. n
Mara Losi
Infiammazione e invecchiamento: dipende dalla società in cui viviamo
Franck M, Tanner KT, Tennyson RL et al. Nonuniversality of inflammaging across human populations
Nat Aging 2025, June 30. https://doi.org/10.1038/s43587025-00888-0
Una nuova ricerca pubblicata su Nature Aging e commentata dal New York Times1 rimette in discussione una delle ipotesi più consolidate in gerontologia: l’idea che l’inflammaging – ovvero l’aumento cronico di processi infiammatori associato all’età – sia un tratto universale del progressivo invecchiamento. Secondo i nuovi dati, potrebbe trattarsi invece di un effetto collaterale dello stile di vita industrializzato, il che indurrebbe a ripensare la categoria stessa di inflammaging.
I DATI
Lo studio, coordinato da un team internazionale guidato da Alan Cohen (Columbia University, New York), ha analizzato i profili infiammatori di oltre 2.800 persone, tra i 18 e i 95 anni, appartenenti a quattro popolazioni molto diverse per contesto ambientale e socioeconomico: soggetti anziani della regione del Chianti in Italia, i partecipanti allo studio longitudinale sull’invecchiamento di Singapore, e due gruppi indigeni non industrializzati, gli Tsimane dell’Amazzonia boliviana e gli Orang Asli della Malesia peninsulare.
Nei due contesti industrializzati (Italia e Singapore), i ricercatori hanno riscontrato una chiara associazione tra età avanzata e aumento di specifici marcatori infiammatori, confermando il profilo classico dell’inflammaging. Ma la sorpresa è arrivata dalle popolazioni indigene: gli Tsimane e gli Orang Asli mostrano una risposta infiammatoria molto diversa, più legata a infezioni acute che non a patologie croniche, e soprattutto priva di una correlazione sistematica con l’età.
I COMMENTI
“La nostra comprensione dell’invecchiamento si basa quasi esclusivamente su studi condotti in paesi industrializzati”, spiega Cohen. “Questo studio dimostra che esistono traiettorie biologiche dell’invecchiamento profondamente diverse”. In altre parole, ciò che consideravamo ‘naturale’ potrebbe essere invece il risultato di fattori ambientali: dieta, inquinamento, sedentarietà, stress, esposizione a sostanze tossiche.
Secondo Thomas McDade, antropologo biologico alla Northwestern University di Chicago, “nelle società non industrializzate, l’infiammazione è attivata in modo molto diverso, spesso da una maggiore esposizione precoce a fattori ambientali che modulano il sistema immunitario in senso protettivo”. Il paradosso è che questi gruppi, pur presentando infiammazioni legate a infezioni, non sembrano sviluppare con la stessa frequenza patologie croniche tipiche delle società occidentali, come diabete o cardiopatie.
Gli autori dello studio sono cauti nel trarre conclusioni definitive. I dati sono osservazionali e non permettono confronti perfettamente omogenei tra popolazioni così diverse. Inoltre, la vita media più breve nelle comunità indigene potrebbe mascherare l’emergere di processi

infiammatori a lungo termine. Tuttavia, il dato centrale resta: l’inflammaging non è una costante biologica, ma una variabile ambientale. “Una sorta di effetto collaterale del nostro modo di vivere”, lo definisce Cohen.
UN PARADIGMA DA RIPENSARE
Se confermati, questi risultati potrebbero ridimensionare l’entusiasmo per integratori e farmaci anti-infiammatori promossi nelle società del benessere per rallentare l’invecchiamento. Si darebbe piuttosto una ragione rilevante in più per intervenire su alimentazione, attività fisica e riduzione dell’inquinamento. “È possibile che esistano infiammazioni ‘buone’ e ‘cattive’ – suggerisce Cohen – e non è detto che ridurre a tutti i costi la risposta infiammatoria sia sempre la scelta migliore.
Lo studio di Nature Aging si propone quindi come una provocazione scientifica che potrebbe aprire la porta alla possibilità di un invecchiamento più sostenibile – e meno medicalizzato – fondato non tanto sul controllo dei sintomi, quanto sulla trasformazione dell’ambiente, fin troppo antropizzato, in cui invecchiamo. La verità ce la ricorda una volta di più Michael Marmot in una conferenza della WIRED Health, appena ripreso da Mun-Keat Looi sul BMJ: “Ce n’è abbastanza al mondo per farci disperare. Però, sappiamo cosa deve essere fatto: non ci resta che farlo”2 n
Luciano De Fiore
BIBLIOGRAFIA
1. Ravindranath M. A common assumption about aging may be wrong, study suggests. The New York Times, 30 June 2025.
2. Looi M-K. “There’s enough in the world to make one despair. But we know what must be done - we just have to do it”. BMJ 2025; 390. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.r990.
Demenze e disparità: un’emergenza economica da
affrontare
Mudrazija S, Aranda MP, Gaskin DJ, et al.
Economic burden of Alzheimer disease and related dementias by race and ethnicity, 2020 to 2060
JAMA Netw Open 2025; 8(6): e2513931
L’Alzheimer e le demenze correlate (ADRD) rappresentano una delle sfide più gravi della sanità pubblica mondiale. Lo studio condotto da Stipica Mudrazija e colleghi, pubblicato su JAMA Network Open, rilancia il dibattito sull’impatto economico di queste patologie con un’attenzione particolare alle disuguaglianze etniche e sociali. Utilizzando un modello econometrico basato su fonti rappresentative come la Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), il National Study of Caregiving (NSOC), e il Panel Study of Income Dynamics (PSID), insieme ai dati ufficiali di istituzioni come il Census Bureau e l’IRS, gli autori stimano che nel solo 2020 l’onere economico complessivo di queste patologie abbia raggiunto, solo negli Stati Uniti, i 344 miliardi di dollari. Una cifra che potrebbe superare i 3.000 miliardi entro il 2060. Oltre all’impatto macroeconomico, il dato che desta maggiore preoccupazione riguarda la distribuzione diseguale di questo carico: già oggi il 33% dell’onere ricade su famiglie afroamericane e latinoamericane, che si troveranno nel 2060 a sostenere un impatto economico superiore a quello delle famiglie bianche. Da 113 miliardi nel 2020 a 1.700 miliardi nel 2060. Queste cifre superano quelle relative alla popolazione bianca, la cui quota economica dovrebbe aumentare da 231 a 1.400 miliardi nello stesso periodo.
IL PESO DEL CAREGIVING NON RETRIBUITO
La componente più gravosa dell’impatto economico delle ADRD riguarda l’assistenza non retribuita prestata dai familiari. Nel 2020, il valore di questo tipo di cura è stato stimato in 62 miliardi di dollari per le comunità afroamericana e latinoamericana, ma è destinato a salire a 842 miliardi di dollari entro il 2060. Queste cifre superano di gran lunga quelle relative alla popolazione bianca, la cui quota economica dovrebbe aumentare dai 76 miliardi di dollari del 2020 ai 382 miliardi di dollari del 2060.
Questa valutazione comprende tutti i costi indiretti che impattano sulla figura del caregiver: salari non percepiti, ridotta partecipazione al mercato del lavoro, perdita di produttività e riduzione dei contributi fiscali versati, voce questa che peserà anche sul bilancio federale degli Stati Uniti. La combinazione di questi fattori penalizza le famiglie coinvolte, che si ritrovano spesso a sacrificare stabilità economica e la possibilità di trasmettere benessere alle generazioni successive.
DONNE, LAVORO E CAREGIVING: IL TRIANGOLO DELL’INVISIBILITÀ
Una caratteristica strutturale sottolineata dallo studio riguarda il genere: sono le donne le principali protagoniste dell’assistenza familiare, subendo una tripla penalizzazione. Spesso già svantaggiate sul piano retributivo e contrattuale, le donne caregiver si trovano spesso costrette a ridurre o abbandonare il lavoro, accumulano meno contributi pensionistici e sono esposte a maggiore stress psico-fisico.
Questa dinamica, già nota, viene ora quantificata e proiettata nel futuro: nel 2060, la perdita di reddito per i caregiver latinoamericani rappresenterà quasi il 18% del reddito familiare medio, contro il 12% per gli afroamericani e il 9% per i caregiver bianchi.
PIÙ DISUGUAGLIANZE OGGI, PIÙ VULNERABILITÀ DOMANI
Il quadro delineato da Mudrazija et al. non si limita a fotografare il presente. Il loro studio evidenzia come il cumulo di svantaggi – basso reddito, minore accesso a cure specialistiche, minore disponibilità di medici della stessa origine etnica e quindi culturalmente affini – possa determinare nel lungo periodo un trasferimento intergenerazionale della povertà.
Le famiglie coinvolte nella cura di persone con ADRD avranno infatti meno risparmi, più debiti e maggiore probabilità di dipendere da programmi pubblici. In assenza di politiche di contrasto adeguate, il rischio è quello di un ampliamento delle disuguaglianze strutturali, con effetti negativi su salute, istruzione e mobilità sociale.
QUALI POLITICHE SERVONO ORA
La conclusione degli autori è chiara: occorrono interventi mirati e strutturali. Alcune strade sono già tracciate: estensione dei congedi familiari retribuiti, sostegno economico diretto ai caregiver, potenziamento dell’assistenza domiciliare e della formazione per operatori socio-sanitari con background culturali diversi.
Programmi come il RAISE Family Caregivers Act e il National Family Caregiver Support Program rappresentano un primo passo, ma restano insufficienti per platea e risorse. L’urgenza segnalata dallo studio di JAMA invoca un deciso cambio di passo, necessario per garantire equità alle fasce più fragili della popolazione.
L’EUROPA
È PRONTA AD AFFRONTARE UNA SFIDA SIMILE?
Sebbene lo studio sia focalizzato sugli Stati Uniti, molte delle sue implicazioni riguardano da vicino anche l’Europa. Secondo dati recenti, oltre 500.000 migranti europei convivono con una demenza e circa 650.000 mostrano un deterioramento cognitivo lieve1. Le dinamiche di disuguaglianza, barriere linguistiche, fragilità socioeconomica e marginalizzazione culturale si ritrovano anche nei nostri contesti. Il progetto Immidem, coordinato in Italia dall’Istituto Superiore di Sanità, ha iniziato a esplorare questi aspetti, ma molto resta da fare per prevenire che i costi delle demenze diventino anche in Europa un acceleratore di ingiustizie sociali2 n
Mara Losi
BIBLIOGRAFIA
1. Canevelli M, Cova I, Remoli G et al. A nationwide survey of Italian centers for cognitive disorders and dementia on the provision of care for international migrants. Eur J Neurol 2022; 29(7): 1892-1902.
2. https://immidem.it/
Ricerca medica sotto attacco: i tagli USA demoliscono il sistema scientifico sudafricano
Khan G
South Africa built a medical research powerhouse. Trump cuts have demolished it
The New York Times, 17 giugno 2025
Un lungo articolo del New York Times illustra una delle ripercussioni ‘locali’ delle scelte dell’amministrazione statunitense, decisa a ridimensionare sostanzialmente i finanziamenti alla sanità. Il taglio delle sovvenzioni degli USA al Sudafrica compromette decenni di progressi nella lotta contro Hiv, Tbc e pandemie. Un esempio lampante di miopia politica e disinvestimento dalla sanità globale che rende evidente come le scelte, quelle sì locali, di Washington, causino disastri globali. Già al recente ASCO di Chicago la comunità oncologica aveva espresso tutta la propria preoccupazione per gli sconsiderati tagli del 40% al budget del National Cancer Institute (Nci) e dei National Institutes of Health (Nih).
Cape Town, Johannesburg, Durban: non sono solo nomi di città, ma snodi di un sistema scientifico d’eccellenza che ha fatto del Sudafrica un attore centrale nella ricerca medica internazionale. Un attore che ora rischia di essere annientato.
CHI È DAVVERO COLPITO DAI TAGLI DI TRUMP
Com’è noto ai nostri lettori, un’ondata di tagli drastici decisi dall’amministrazione Trump ha interrotto i finanziamenti federali statunitensi, distruggendo in pochi mesi un ecosistema di ricerca costruito in decenni.
Oltre 260 milioni di dollari dal Nih e centinaia di milioni dai Centers for disease control and prevention (Cdc) e USAID (l’agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale) sono evaporati, lasciando dietro di sé studi clinici cancellati, laboratori deserti, ricercatori licenziati e migliaia di pazienti – tra cui bambini e donne incinte – privati di moni-

toraggio e cure. A essere colpita non è una periferia scientifica, diciamo così, ma un fulcro globale della sanità pubblica, che ha contribuito in modo determinante a sviluppare e testare vaccini contro l’Hiv, il Covid, l’Rsv e molte altre patologie. Non è un caso che proprio in Sudafrica siano state individuate e sequenziate per prime le varianti Beta e Omicron del SARS-CoV-2, fornendo ai produttori di vaccini – Pfizer e Moderna in primis – le basi per aggiornare le immunizzazioni.
“Tagliare questi fondi significa interrompere collaborazioni scientifiche vitali e privare il mondo – inclusi gli Stati Uniti – di dati fondamentali per lo sviluppo di vaccini e farmaci”, ha dichiarato al Times il premio Nobel Harold Varmus.
IL RUOLO CRUCIALE DEL SUDAFRICA NELLA RICERCA
In Sudafrica è possibile arruolare in poche settimane migliaia di pazienti in studi clinici – in condizioni che rispettano pienamente gli standard Fda ed Ema – a costi fino a cinque volte inferiori rispetto agli Stati Uniti. Non solo: la lunga esperienza nella ricerca su popolazioni fragili, spesso escluse altrove, ha prodotto dati cruciali sulla sicurezza di nuovi farmaci in gravidanza, nell’infanzia e tra le persone immunocompromesse. Cancellare questo patrimonio di sapere e collaborazione significa rendere più lenti, più costosi e meno inclusivi gli sviluppi della medicina globale. È, come ha scritto un ricercatore coinvolto nei progetti sospesi, una forma di autolesionismo sanitario su scala planetaria.
LE CONSEGUENZE DI UNA POLITICA ISOLAZIONISTA
Ma la scelta dell’amministrazione Trump, fondata su un misto di isolazionismo ideologico, retorica e ostilità specifica verso il Sudafrica, è solo la punta dell’iceberg. Denuncia quella tendenza strutturale degli Stati Uniti a disinvestire nella sanità globale, anche quando questa è direttamente connessa alla propria sicurezza sanitaria nazionale. L’equivoco è stato ben messo in luce da Lynn Morris dell’Università di Witwatersrand, quando osserva che le politiche solidali non costituiscono affatto “beneficenza: sono investimenti che producono salute, conoscenza e innovazione. E che tornano indietro, anche in termini economici”. A oggi, le grandi aziende farmaceutiche pubblicamente preferiscono tacere, ma dietro le quinte riorientano i loro investimenti, spaventate dal clima politico. La Gates Foundation e il Wellcome Trust tentano di contenere l’emorragia, ma i fondi filantropici non possono sostituire la scala e la continuità delle risorse pubbliche.
Intanto, il danno più silenzioso ma irreparabile rischia di essere la perdita di una generazione di giovani scienziati africani, costretti a emigrare o a lasciare la ricerca. In un mondo segnato da crisi sanitarie sempre più interconnesse – pandemie, antibioticoresistenza, cambiamento climatico – indebolire una delle piattaforme di ricerca più robuste e collaborative del pianeta appare una mossa tanto miope quanto pericolosa, colpendo oltretutto il continente più bisognoso e sprovvisto di infrastrutture.
Se ce ne occupiamo, è perché il caso sudafricano è un segnale d’allarme che riguarda tutti: la salute globale non può essere ostaggio di cicli politici nazionali. O si sostiene in modo continuativo e cooperativo, oppure si pagano prezzi molto alti, ovunque.
La stessa ASCO ha lanciato l’allarme: i tagli al bilancio Nih e Nci mettono a rischio anche il futuro della ricerca oncologica negli Stati Uniti. n
Luciano De Fiore
Conoscere per agire: politiche sanitarie efficaci nei primi 1000 giorni di vita
I primi 1000 giorni di vita rappresentano una fase cruciale per lo sviluppo del bambino, durante la quale le esposizioni ambientali possono avere conseguenze a lungo termine sulla salute. In questo contesto, il progetto Ambiente e primi 1000 giorni. Conoscere per agire (Valutazione dell’esposoma nei primi 1000 giorni in coorti di nati in aree a elevata antropizzazione e attuazione di interventi per la riduzione del rischio), realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della salute – PNC e coordinato dall’Irccs materno infantile Burlo Garofolo, ha l’obiettivo di tradurre le evidenze scientifiche sugli effetti delle esposizioni ambientali precoci in azioni concrete, per influenzare positivamente le politiche sanitarie.
MILLEGIORNI.INFO: UNA PIATTAFORMA PER LA CONOSCENZA E L’AZIONE
Uno strumento chiave del progetto è il sito millegiorni.info che raccoglie dati, ricerche e materiali informativi destinati a decisori politici, operatori sa-
nitari e cittadini, e rappresenta un elemento chiave per la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle raccomandazioni sanitarie.
L’obiettivo è duplice: fornire una base scientifica per le decisioni politiche e aumentare la consapevolezza dei genitori sui rischi ambientali e sulle strategie per mitigarli. La sezione ‘Tematiche’ offre approfondimenti e materiali pratici per comprendere meglio l’impatto delle esposizioni ambientali precoci e le strategie per mitigarne i rischi. La sezione ‘Per i genitori’ è pensata per supportare le famiglie con informazioni chiare e consigli utili su come proteggere i bambini sin dal concepimento. Dalla qualità dell’aria in casa agli effetti dell’inquinamento urbano e industriale, il sito fornisce approfondimenti, schede informative, video divulgativi e suggerimenti pratici per adottare scelte consapevoli nella vita quotidiana. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento accessibile per aiutare i genitori a ridurre le esposizioni ambientali e migliorare la salute dei loro bambini con piccoli, ma significativi cambiamenti.

AMBIENTE E PRIMI 1000 GIORNI CONOSCERE PER AGIRE
Nuovi temi per conoscere meglio le relazioni tra ambiente e salute, per mettere in atto interventi di prevenzione e riduzione del rischio di esposizione a inquinanti ambientali per donne in gravidanza e bambini nei primi 1000 giorni di vita.
Progetto “Valutazione dell’esposoma nei primi 1000 giorni in coorti di nati in aree ad elevata antropizzazione e attuazione di interventi per la riduzione del rischio”, Finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito del Piano Nazionale
Complementare “Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima”.

Unità operative
IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, Trieste Università degli Studi di Torino, CPO-Piemonte
AOU Meyer, Ospedale pediatrico, Firenze
Dipartimento di Epidemiologia del SSR, ASL Roma 1, Regione Lazio
Istituto Superiore di Sanità
Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Roma
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia (ARPA ), Palermo
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Palermo
CNR, Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica, Palermo
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “GF Ingrassia”
Società scientifiche e associazioni
Associazione Culturale Pediatri
Società Italiana di Pediatria
“Il progetto Conoscere per agire si inserisce come strumento in un processo di ripensamento delle politiche sanitarie, riportando la salute infantile al centro dell’agenda politica.”
UN NUOVO APPROCCIO ALLA TUTELA DELLA SALUTE INFANTILE
L’iniziativa, in continuità con il progetto Ambiente e primi 1000 giorni, amplia l’analisi focalizzandosi sull’esposizione precoce a inquinanti indoor, outdoor e a fattori legati ai cambiamenti climatici, con un focus sulle aree contaminate che presentano rischi per la salute e l’ambiente, a causa della presenza di diversi fattori di stress ambientale. La necessità di monitorare queste esposizioni precoci è fondamentale per sviluppare strategie di prevenzione e tutela della salute pubblica, anche a partire dalle azioni promosse nel documento di consenso Inquinamento atmosferico e salute. Le proposte delle società scientifiche pediatriche e del gruppo di lavoro ‘Ambiente e primi 1000 giorni’ per migliorare la salute dei bambini e delle famiglie (https://millegiorni.info/per-i-decisori/documento-di-consenso/), sottoscritto nel 2021 dalle principali società scientifiche pediatriche italiane.
QUALI SONO LE IMPLICAZIONI
PER LE POLITICHE SANITARIE?
Il documento di consenso, elaborato dalle società scientifiche pediatriche e dal gruppo di lavoro Ambiente e primi 1000 giorni a margine del progetto esecutivo del bando CCM 2017, sottolinea l’importanza di quantificare il carico di malattia attribuibile alle esposizioni ambientali. Questo documento fornisce raccomandazioni chiave per i decisori politici, tra cui:
IL RUOLO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
L’integrazione delle conoscenze acquisite nelle strategie sanitarie nazionali è essenziale per garantire un approccio preventivo efficace. Le politiche sanitarie dovrebbero focalizzarsi su: l monitoraggio dell’esposizione ambientale: valutare l’esposizione nelle fasce più vulnerabili della popolazione;
l azioni di prevenzione primaria: promuovere ambienti più sani nelle scuole e nelle abitazioni; l formazione degli operatori sanitari: fornire strumenti e conoscenze per informare adeguatamente genitori e cittadini.
UNA RETE DI COMPETENZE
Per saperne di più, scansiona il QRcode con il tuo dispositivo e guarda le interviste a Luca Ronfani (IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, Trieste) e Lorenzo Richiardi (Università degli Studi di Torino, CPO-Piemonte)
Luca Ronfani
Lorenzo Richiardi
l riduzione delle emissioni: implementare politiche volte a diminuire le emissioni di inquinanti atmosferici attraverso regolamentazioni più severe e promozione di tecnologie pulite; l monitoraggio ambientale: potenziare le reti di monitoraggio per una valutazione accurata della qualità dell’aria, identificando le aree a maggior rischio e intervenendo tempestivamente; l educazione e sensibilizzazione: promuovere campagne informative rivolte a cittadini e professionisti della salute sull’impatto delle esposizioni ambientali e sulle misure preventive da adottare. l Esposizioni ambientali e salute: un’emergenza sanitaria?
Le evidenze scientifiche dimostrano che l’interazione precoce con inquinanti atmosferici e fattori ambientali, come traffico, aree industriali e condizioni climatiche estreme, può influenzare lo sviluppo del bambino, aumentando il rischio di malattie. Questo richiede un ripensamento delle strategie di prevenzione e un rafforzamento delle politiche sanitarie ambientali.
Il progetto ha messo in rete diverse competenze per diffondere conoscenze sull’esposizione a inquinanti ambientali. Le Unità operative coinvolte includono ospedali pediatrici, centri di epidemiologia, istituti di ricerca, università, laboratori, agenzie ambientali ed esperti di comunicazione per garantire un approccio multidisciplinare. Le competenze spaziano dalla prevenzione primaria alla comunicazione con i genitori; dall’analisi molecolare, alla gestione di banche biologiche e al monitoraggio ambientale. La creazione di una rete di coorti di nascita è stata la prima azione del progetto. I diversi studi di coorte di nati raccolgono dati su esposizioni ambientali e campioni biologici dal periodo pre-concezionale fino ai primi anni di vita, per valutare i rischi per la salute e promuovere interventi per ridurre l’esposizione delle donne e dei bambini.
VERSO UN NUOVO MODELLO DI PREVENZIONE
Il progetto Conoscere per agire si inserisce come strumento in un processo di ripensamento delle politiche sanitarie, riportando la salute infantile al centro dell’agenda politica. L’integrazione tra ricerca scientifica, politiche sanitarie e consapevolezza dei cittadini è fondamentale per costruire un futuro in cui ogni bambino possa crescere in un ambiente sano e sicuro. L’impegno delle istituzioni e dei decisori sarà cruciale per tradurre queste conoscenze in azioni concrete, trasformando i risultati della scienza in politiche efficaci e sostenibili per le nuove generazioni. n
Norina Di Blasio

Cattive citazioni portano a cattive politiche
A colloquio con Steven Woloshin
Steven Woloshin, professore di Medicine and community e Family medicine alla Dartmouth Geisel School of Medicine, e Richard L Kravitz, professore presso il Dipartimento di Medicina Interna dell’Università della California, Davis, sono coautori di un opinion piece* uscito su STAT News sugli errori contenuti nel recente rapporto Make America Healthy Again che ha citato in modo errato la loro ricerca. “È un lavoro approssimativo che compromette la credibilità dell’intero rapporto. Un rapporto governativo destinato a influenzare la vita di milioni di americani dovrebbe essere accuratamente verificato e basato sulle fonti più affidabili”, hanno scritto Woloshin e Kravitz. Abbiamo intervistato Steven Woloshin per andare a fondo della questione.
Dottor Woloshin, il suo nome è apparso nelle citazioni del rapporto MAHA promosso dall’amministrazione di Robert F Kennedy Jr. Cominciamo con l’ovvio: è rimasto sorpreso?
Sorpreso è un eufemismo. Nel mondo accademico, essere citati è solitamente una cosa positiva: significa che qualcuno ha trovato il tuo lavoro utile, forse persino degno di essere approfondito. Ma questa era una citazione di tipo diverso.
Entriamo nel dettaglio. Il rapporto ha citato uno dei suoi articoli, ma a quanto pare in modo errato. Cosa è successo?
Il rapporto MAHA sosteneva di citare un mio articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine, relativo alla pubblicità dei farmaci in televisione. Sembra prestigioso, vero? Solo che l’articolo non era uscito sul NEJM, ma su un’altra rivista, buona, ma non proprio il NEJM. E non parlava nemmeno di pubblicità televisiva. Si concentrava sulle campagne di sensibilizzazione sulle malattie nella stampa giornalistica. Quindi sì, rivista sbagliata, anno sbagliato, argomento sbagliato.
Richard Kravitz ha avuto un’esperienza simile. La sua citazione si è rivelata un riferimento a un articolo inesistente. Come può succedere in un documento governativo?
Questa è una domanda da un milione di dollari. I giornalisti che hanno approfondito le citazioni hanno scoperto uno schema: alcune citazioni non esistevano, altre rimandavano ad articoli non correlati e alcune avevano autori attribuiti in modo del tutto errato. Una possibilità, anche se non confermata, è che gli autori del MAHA si siano affidati all’intelligenza artificiale per generare le citazioni. Il che potrebbe spiegare la creatività.
Il portavoce della Casa Bianca ha liquidato la questione come “problemi di formattazione”. Come risponde a questa affermazione?
Senta, l’assenza del corsivo nel titolo di una rivista è un problema di formattazione. Citare articoli fantasma o travisare completamente degli studi? Non è un problema di formattazione, è disinformazione. Quando le politiche pubbliche sono influenzate da una scienza distorta, le persone possono subire danni. Non è solo negligenza, è pericoloso.
Il suo articolo con Kravitz ha un tono umoristico, ma sembra esasperato. È un meccanismo di difesa o fa parte del vostro messaggio?
Forse un po’ entrambe le cose. Siamo medici e ricercatori, e le prove le prendiamo sul serio. Ma quando qualcuno distorce o usa in modo improprio il tuo lavoro per promuovere un’agenda, a volte l’unico modo per far valere le proprie ragioni è conservare un po’ di ironia. Se avessero citato erroneamente PT Barnum, forse sarebbe stato diverso. Ma travisare studi sottoposti a peer review in un rapporto sulla politica sanitaria nazionale? Questo merita più di una nota a piè di pagina.
Il rapporto MAHA ha lo scopo di orientare la politica sanitaria rivolta all’infanzia. Qual è la vostra principale preoccupazione, sulla base di come sono state trattate le prove?
*Woloshin S, Kravitz RL. The MAHA children’s health report miscited our research. That’s sloppy and worrying. The errors in the report reinforce serious concerns about RFK Jr.’s HHS. StatNews, June 20, 2025.
La negligenza e la mancanza di verifica. Le citazioni false e quelle che non supportano le affermazioni per cui sono state utilizzate mi fanno dubitare
Steven Woloshin
“La politica sanitaria deve basarsi su prove rigorose e trasparenti. Altrimenti rischiamo di minare sia la scienza che la fiducia del pubblico.”
che gli autori abbiano letto attentamente il rapporto. Se le basi sono errate, se le citazioni sono inaccurate o fittizie, allora qualsiasi conclusione basata su di esse poggia su basi inaffidabili. La politica sanitaria deve basarsi su prove rigorose e trasparenti. Altrimenti rischiamo di minare sia la scienza che la fiducia del pubblico.
Passando a un argomento più generale: in Europa c’è una notevole preoccupazione per il futuro della politica sanitaria negli Stati Uniti. La decisione di alcuni ricercatori accademici di assumere posizioni di rilievo in importanti agenzie sanitarie, nonostante le opinioni discutibili e talvolta antiscientifiche del segretario alla Salute e ai servizi smani, ha causato una certa confusione. Qual è la sua opinione al riguardo?
Anche qui c’è molta preoccupazione. Immagino che quei ricercatori potrebbero dire che dall’interno dell’amministrazione possono avere un impatto maggiore. Non lo so. Spero solo che mettano al primo posto la salute pubblica. E per farlo hanno bisogno di un impegno davvero forte nei confronti della scienza. È come il vecchio detto: non si deve
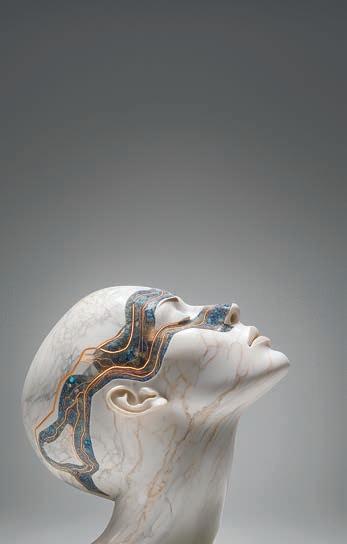
Guida facile all’intelligenza artificiale in medicina
La rivoluzione degli LLM, dei digital twin e degli agenti intelligenti
Alberto E. Tozzi Diana Ferro
Presentazioni di Alessandro Vespignani e Anthony Chang
Guida
facile all’intelligenza artificiale in medicina
La rivoluzione degli LLM, dei digital twin e degli agenti intelligenti
Di Alberto E. Tozzi e Diana Ferro Presentazioni di Alessandro Vespignani e Anthony Chang
Se pensate che questo sia un manuale pieno di equazioni e informazioni tecniche siete fuori strada. Il libro nasce dalla convinzione che l’intelligenza artificiale diventerà un’alleata per chiunque si dedichi alla cura del paziente. Questo potrà però avvenire solo a condizione che il professionista della salute comprenda i meccanismi di base di questa incredibile tecnologia.
A chi è curioso, scettico o incerto riguardo al futuro dell’intelligenza artificiale in medicina il libro si propone di raccontare le ambizioni più alte, le cose che già oggi si possono fare con questi strumenti e, soprattutto, come il compito del professionista sanitario rimanga centrale.
sparare prima e fare domande dopo. Le politiche devono basarsi su prove concrete, non il contrario. Ci sono molte preoccupazioni ragionevoli, ad esempio sulla necessità di migliorare l’alimentazione, affrontare gli inquinanti ambientali, contrastare l’eccesso di medicalizzazione. Ma hanno anche preso posizioni, in particolare sulla politica dei vaccini, che minano la salute pubblica e possono causare gravi danni. Spero solo che questo nuovo gruppo di leader ricordi chi serve: non l’amministrazione, ma il pubblico.
Le numerose referenze bibliografiche contenute nel rapporto MAHA includono anche voci, articoli o libri corretti di studiosi autorevoli che, negli ultimi decenni, hanno esplorato le “relazioni pericolose” tra la medicina accademica e l’industria: ritiene che l’establishment sanitario abbia una qualche responsabilità nella creazione di questo clima di “caccia alle streghe” che sta portando al licenziamento di centinaia di dipendenti delle agenzie federali e alla cancellazione dei finanziamenti alla ricerca?
C’è molto margine di miglioramento nei nostri sistemi sanitari e di salute pubblica. E ci sono molti intrecci malsani tra industria e mondo accademico, medici e payor, responsabili politici e regolatori e, naturalmente, comunicatori, comprese le riviste mediche e i media tradizionali e social. Ma la risposta non è quella di prendere a colpi di fucile il sistema, con licenziamenti fatti a caso e indiscriminati di esperti, chiusura di agenzie, cancellazione di sovvenzioni e indebolimento delle autorità regolatorie.
Lei conclude il suo commento con uno scambio che ha avuto con l’intelligenza artificiale. Può dirci qualcosa in proposito?
Certo. Abbiamo chiesto a un agente di intelligenza artificiale: “Quali sono alcuni principi di base per citare la ricerca in un rapporto sulla salute?” La risposta è stata davvero ottima: chiara, strutturata e persino un po’ spiritosa. Il che l’ha resa ancora più triste. Se gli autori del MAHA avessero posto la stessa domanda, forse non saremmo qui a parlarne.
Ultima domanda. Cosa direbbe agli autori del rapporto MAHA, se la stessero ascoltando?
Leggete prima di citare. Ricontrollate le vostre fonti. E se avete intenzione di utilizzare l’intelligenza artificiale, fatelo con cautela. O meglio ancora, chiedete a un bibliotecario. Oh, e correggete la mia citazione, è ancora sbagliata. n
Intervista a cura di Luca De Fiore
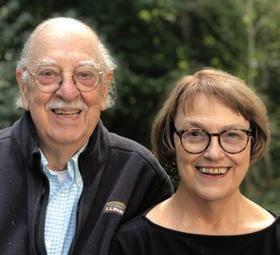
Una master class sul “vivere da editor” di una rivista scientifica
A colloquio con Jerome P Kassirer
Il giudizio del segretario alla salute del governo statunitense – Robert F. Kennedy Jr – su JAMA, Lancet e New England Journal of Medicine (“they are all corrupt”) ha suscitato sorpresa e dissenso. Le reazioni più sdegnate sono giunte da chi è più informato dei fatti: personalità della medicina americana che hanno svolto per anni il ruolo di editor-inchief di alcune di queste riviste. Ci è sembrato il caso di approfondire almeno alcune delle questioni che attraversano lo science publishing: dalla peer review ai conflitti d’interesse e all’indipendenza del lavoro editoriale. Lo abbiamo fatto con Jerome Kassirer, che ha diretto il NEJM dal 1991 al 1999.
Dottor Kassirer, pochi giorni fa, in un momento in cui le riviste mediche erano accusate di essere ‘corrotte’ da Robert F. Kennedy Jr, segretario alla salute degli Stati Uniti, lei si è offerto di fornire il suo punto di vista sul ruolo e sull’importanza degli editor medici. Credo che lei sia particolarmente qualificato per farlo, avendo ricoperto per quasi un decennio l’incarico di editor-in-chief del New England Journal of Medicine, probabilmente una delle riviste cliniche più prestigiose al mondo.
Sì, c’è molto da discutere, comprese le numerose idee sbagliate sul processo editoriale, sulla peer review e sull’influenza dell’industria sull’integrità degli articoli scientifici. Forse è meglio partire dal cuore della questione ed esaminare il contributo che un bravo editor può dare nel percorso che porta un manoscritto, inviato da un autore, alla pubblicazione su una rivista medica.
Ho notato che ha parlato di ‘bravo’ editor. Cosa intende esattamente?
È un punto fondamentale. Un bravo editor è, prima di tutto, un eccellente ricercatore, preparato in ambito statistico e in epidemiologia, e anche una persona molto capace a scrivere. Deve essere aggiornato sulle tematiche cliniche di maggiore attualità e saper valutare quando un nuovo articolo richiede una corsia preferenziale per arrivare tempestivamente ai lettori e al pubblico. Esperienza clinica,
competenza ed esperienza a lungo termine sono qualità indispensabili. Un buon editor non deve avere conflitti di interesse finanziari, non deve dipendere dal successo economico della rivista, deve essere aperto a nuove idee e metodi, e la sua obiettività non deve mai essere messa in discussione. Poiché gli editor medici condividono la responsabilità dell’affidabilità della ricerca pubblicata e, in ultima analisi, della salute pubblica, devono essere degni di fiducia: i lettori devono credere che prenderanno decisioni corrette ed equilibrate, che saranno aperti a diversi punti di vista e che selezioneranno (o rifiuteranno) i materiali esclusivamente sulla base del merito. Ho avuto il privilegio di lavorare con decine di grandi editor al NEJM nel corso degli anni.
È possibile mantenere una qualità editoriale eccellente con pochi editor e costi contenuti?
Una rivista medica può anche funzionare con un input editoriale minimo, pubblicando online la quasi totalità dei manoscritti ricevuti e lasciando che i lettori li commentino, per poi pubblicare il tutto su una versione print. Non conosco riviste di alto livello che adottino questo metodo, e non è un approccio che condivido, ma vale la pena citarlo. Personalmente preferisco il metodo classico, in cui uno o più editor si assumono la responsabilità del processo dalla sottomissione alla pubblicazione.
Il processo editoriale approfondito, ancora in uso presso riviste come NEJM, JAMA, Annals of Internal Medicine e The Lancet, conferisce una grande autorità – e responsabilità – all’editor, giusto? Esatto. Le funzioni svolte dagli editor, come l’analisi dei difetti metodologici, la selezione dei revisori e l’editing riga per riga per migliorarne la chiarezza, sono compiti intellettualmente onerosi e molto impegnativi. Tutto questo costituisce il valore aggiunto di avere un editor: migliorare, insieme all’autore, la qualità scientifica e la leggibilità di un manoscritto. Anche se talvolta gli autori si lamentano della durata del processo, delle numerose revisioni richieste o dei cambiamenti nel focus dell’articolo, nella mia esperienza la grande maggioranza ammette che il contributo editoriale migliora il lavoro.
Jerome P Kassirer e la moglie
Se i trattamenti per l’ipertensione, l’emicrania, le malattie immunologiche e alcuni tipi di tumore sono così migliorati, perché la veridicità delle riviste che hanno pubblicato questi risultati nuovi e incoraggianti è così messa in discussione?
Assumere i migliori editor deve rappresentare uno degli aspetti più costosi della gestione di una rivista medica…
È vero. Qualcuno deve pagare gli stipendi degli editor, senza contare quelli del personale di supporto, degli editor dei manoscritti e dei correttori di bozze. Qualcuno paga anche per il tempo dei revisori. Tranne che per i revisori (che in genere lavorano gratuitamente), è la rivista stessa a sostenere i costi del lavoro editoriale.
A proposito di peer review, cosa possiamo aspettarci da questo processo?
È un punto cruciale. La revisione tra pari, nel migliore dei casi, consiste nel raccogliere opinioni esperte e imparziali sull’idoneità alla pubblicazione, facendo affidamento su studiosi qualificati. Ma si tratta di un processo umano, soggetto a giudizi soggettivi, quindi impreciso e talvolta fallace. Gli editor possono scegliere revisori non imparziali; i pareri possono essere discordanti; contenuti con dei difetti o addirittura fraudolenti possono sfuggire. La mia valutazione preferita? “La peer review può eliminare studi mal concepiti, mal condotti, banali o illeggibili; migliora la qualità dei manoscritti, orienta la pubblicazione e aiuta chi non è esperto a capire in cosa riporre fiducia.”1. Tuttavia, non può eliminare le frodi, risolvere dispute tra autori o offrire certezze. Resta comunque uno strumento essenziale per aiutare gli editor a decidere.
Ci sono vantaggi anche per i revisori?
Sì, e non dovremmo trascurarli. Il processo contribuisce alla diffusione delle ultime evidenze scientifiche nella comunità, stimola la collaborazione tra scienziati e offre un’opportunità formativa per gli specializzandi, che spesso eseguono valutazioni preliminari sotto la guida dei loro mentori. È un’esperienza molto educativa.
Sebbene le riviste scientifiche siano state accusate di collusione con l’industria, sono anche state in prima linea nella promozione della pratica clinica basata sulle evidenze per decenni: dove abbiamo sbagliato, noi editori di riviste mediche, se dopo decenni di impegno, molti ancora non si fidano delle riviste mediche?
Non lo so con certezza, ma ci sono segnali che possiamo interpretare. Uno è il calo della fiducia in tutte le istituzioni: medici, polizia, industria, magistratura, persino la Corte Suprema. È sconcertante: proprio mentre sia l’efficacia sia il rapporto rischio-beneficio delle terapie sono migliorati, le riviste che ne hanno pubblicato i risultati vengono
accusate di essere inaffidabili. Se i trattamenti per l’ipertensione, l’emicrania, le malattie immunologiche e alcuni tipi di tumore sono così migliorati, perché la veridicità delle riviste che hanno pubblicato questi risultati nuovi e incoraggianti è così messa in discussione? Una ragione può essere la percezione che i risultati pubblicati siano stati condizionati da conflitti economici, tema su cui ho scritto molto. Ma ci sono altri fattori di cui si parla raramente, ovvero le critiche unilaterali di un piccolo gruppo di autori insoddisfatti che attaccano periodicamente e spudoratamente le riviste più importanti accusandole di scorrettezze, talvolta richiamando eventi di cinquant’anni fa, come la controversia su Vioxx che coinvolse il NEJM e altre riviste. Per dimostrare che le riviste più prestigiose sono corrotte, questi critici citano il fatto che il loro “miglior lavoro” non sia stato accettato; che un editor abbia rifiutato il loro articolo nonostante alcune revisioni positive; che si siano sentiti vittime di un editor con un pregiudizio personale nei loro confronti; che gli editor abbiano cambiato singole parole nei loro manoscritti; che il loro lavoro sia stato respinto perché minacciava lo status quo; che i costi di pubblicazione siano stati troppo elevati; che le entrate pubblicitarie influenzino ciò che le riviste decidono di pubblicare; che editor e proprietari delle riviste si rifiutino di rendere pubblici i loro bilanci. In breve, presunte offese personali ricevute dagli editor vengono talvolta interpretate come esempi di corruzione della rivista. Senza conoscere l’altra versione dei fatti, è ovviamente impossibile valutare la validità di queste critiche.
Dagli editor è arrivata una risposta a queste critiche?
Curiosamente, alcuni sono diventati i critici più convinti delle loro stesse riviste. Due importanti direttori di riviste scientifiche britanniche, negli ultimi anni, hanno scritto in editoriali che le riviste erano diventate semplicemente operazioni di riciclaggio di informazioni o bracci di marketing dell’industria farmaceutica. Mi sono sempre chiesto come potessero continuare a ricoprire il ruolo di editor-in-chief se avevano una visione così distorta della realtà. Se ritenevano di lavorare indirettamente per l’industria, perché continuare a fare da promotori nell’ombra? Nella mia esperienza personale nel contrastare il possibile sfruttamento della reputazione del NEJM negli anni ’90, fui licenziato dal ruolo di editor-in-chief dopo essermi rifiutato di smettere di ostacolare gli sforzi commerciali del proprietario della rivista.
Ma non è stata solo questa la causa del licenziamento, giusto?
“Quando l’editoria scientifica è fatta bene, è costosa. Il solo processo editoriale, se svolto con rigore, richiede medici altamente competenti e personale editoriale qualificato”
Probabilmente no. Anche le critiche aperte, espresse in diversi editoriali, nei confronti di quelle che consideravo pratiche poco professionali della medicina organizzata (in particolare dell’American Medical Association) negli Stati Uniti hanno probabilmente avuto un ruolo significativo.
Ricordo che lei sosteneva che un editor avesse la responsabilità di intervenire anche su questioni politiche, se rilevanti. Oggi in Italia arrivano alle riviste articoli con evidenti finalità politiche. Che consiglio darebbe a un editor?
Sono un po’ riluttante ad “aggiungere la mia opinione” a questo dibattito, ma farei una chiara distinzione tra un direttore che usa la propria posizione di rilievo per commentare qualcosa di catastrofico, come il nuovo regime antiscientifico e autoritario introdotto nel nostro paese dal segretario alla Salute e ai servizi umani (cosa che, a mio avviso, è accettabile), e l’invio casuale di articoli politici a una rivista medica, senza che ci sia attinenza con i temi discussi dalla rivista stessa (cosa per me non accettabile). In effetti, fu proprio un editoriale, a mio parere debole, del NEJM, critico verso le nuove politiche di RFK Jr, che spinse me e Robert Steinbrook a criticare duramente il direttore della rivista sulle pagine del Boston Globe2 per non aver usato il peso e la credibilità della sua posizione per condannare con forza i piani del segretario.
Kennedy aveva dichiarato: “Probabilmente smetteremo di pubblicare su The Lancet, sul New England Journal of Medicine, su JAMA e su quelle altre riviste, perché sono tutte corrotte.” A sostegno di questa affermazione, RFK citava “persone come Marcia Angell, autrice di un libro importante, simile al tuo – On the Take – entrambi dedicati al pericoloso rapporto tra la medicina accademica e le industrie farmaceutica, dei dispositivi medici e alimentare.”
Dunque, mi conferma che a suo parere Kennedy ha torto?
Si sbagliava nel presumere che le riviste da lui citate siano corrotte; in realtà, i loro direttori rispondono in gran parte ai criteri dei buoni editori che ho delineato in precedenza. Le ho viste dall’interno e non credo affatto che siano corrotte. Kennedy aveva ragione, invece, sul potenziale e pervasivo influsso distorsivo dell’industria farmaceutica, che è il tema centrale del mio libro (On the Take). Tuttavia, ha ignorato – o forse non era a conoscenza –delle numerose misure di protezione che avevamo introdotto al NEJM per mitigare i conflitti di interesse finanziari.
E, basandosi sull’editoriale del 2000 di Marcia Angell sul NEJM, intitolato ‘The pharmaceutical indu-
stry – To whom is it accountable’3, si sbaglia anche sulla critica di Marcia all’industria. In quell’editoriale, infatti, lei esprime lo stesso concetto che Steven Woloshin, della Dartmouth University, ha formulato recentemente: secondo lui, un’alternativa ragionevole sarebbe stata finanziare in modo più generoso la ricerca indipendente, così da renderla realmente tale e meno influenzata dall’industria.
L’attacco di Kennedy sembra in realtà mirato all’intero sistema della ricerca, non solo statunitense ma internazionale. E la sua ‘soluzione’ – creare riviste vicine al governo, senza peer review – appare pericolosa. La cura è peggio della malattia?
Assolutamente. In risposta a questo annuncio, Marcia Angell, Robert Steinbrook e io abbiamo scritto su STAT News il 30 giugno 20254 che un sistema in cui solo autori ‘selezionati’ possono pubblicare, e dove ogni articolo viene pubblicato indipendentemente dalla qualità della revisione, è la ricetta per una scienza scadente e di parte.
Esistono proposte migliori per riformare la peer review e l’editoria scientifica?
Alcuni critici hanno proposto di trasferire questi compiti essenziali alle istituzioni accademiche, facendo notare che alcune funzioni – in particolare la revisione tra pari – sono già in gran parte svolte dal personale accademico. Ma hanno perso di vista una caratteristica fondamentale dell’editoria scientifica: quando è fatta bene, è costosa. Il solo processo editoriale, se svolto con rigore, richiede medici altamente competenti e personale editoriale qualificato.
Anche se fossero le università a farsi carico della pubblicazione delle riviste, gli aspetti essenziali e i costi di questa ‘impresa’ resterebbero elevati, se si volesse mantenere la qualità. Le università – almeno quelle degli Stati Uniti – stanno già affrontando difficoltà finanziarie sotto un regime nazionale che cerca di limitarle; è quindi altamente improbabile che siano disposte ad assumersi un sistema che persino gli editori commerciali giudicano troppo oneroso.
Le confesso che sono un po’ deluso… Speravo che in 25 anni avesse trovato una soluzione migliore. Ahah! Mi lusinga, ma penso che un sistema perfetto non esista. Alcune proposte, come affidare il sistema ai National institutes of health o alle università, sono destinate al fallimento, in parte per timori legati al fatto che la proprietà potrebbe incentivare interferenze editoriali e che i costi
legittimi del lavoro editoriale verrebbero tagliati, compromettendo la qualità. Molti ex direttori, me compreso, stanno osservando con interesse un approccio introdotto dal nuovo direttore del Journal of the American College of Cardiology, Harlan Krumholz, il quale prevede di velocizzare il processo di peer review, coinvolgere giovani scienziati, pubblicare i lavori online prima dell’edizione cartacea, raccogliere e valutare le critiche, e infine pubblicare su carta. Spostare gran parte del lavoro editoriale online sembra un’idea il cui momento è arrivato, ma resta da vedere quanti dei difetti e delle criticità del sistema attuale potranno davvero essere risolti con questo approccio.
Cosa consiglia agli autori di studi potenzialmente innovativi?
Devono capire che non tutte le riviste hanno lo stesso livello editoriale. Evitino quelle commerciali nate da poco o quelle che garantiscono una facile pubblicazione.
Una dichiarazione da parte di una rivista secondo cui essa pratica la revisione tra pari, o il fatto che abbia un alto impact factor, non costituisce una garanzia di qualità – anche se questi criteri non andrebbero nemmeno del tutto ignorati.
Tra i ricercatori esiste già una gerarchia informale sulla qualità delle riviste. Gli autori dovrebbero confrontarsi con i propri colleghi per individuare riviste considerate rigorose ma corrette, imparziali e libere da interessi commerciali. n
Intervista a cura di Luca De Fiore
BIBLIOGRAFIA
1. Bailar JC, Patterson K. Journal Peer Review. The Need for a Research Agenda. N Engl J Med 1985; 312: 654-657.
2. K assirer JP, Steinbrook R. Medical journals need to fight back against Trump attacks. Boston Globe, Updated May 3, 2025.
3. Angell M. The pharmaceutical industry--to whom is it accountable? N Engl J Med 2000; Jun 22; 342 (25): 1902-4.
4. Angell M, K assirer JP, Steinbrook R. RFK Jr. says medical journals are ‘corrupt.’ As former NEJM editors, we know he’s wrong. STATNews, June 30, 2025.
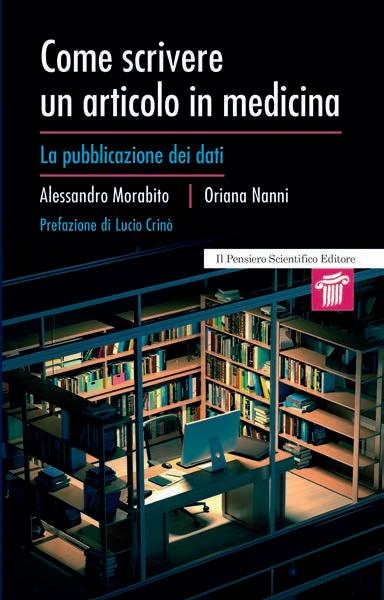
Come scrivere un articolo in medicina
La pubblicazione dei dati
Alessandro Morabito e Oriana Nanni
Prefazione di Lucio Crinò
Quali sono le caratteristiche di un “buon” articolo? Quali lineeguida possono garantire una comunicazione completa e chiara dei risultati di una ricerca? Quali i criteri per il riconoscimento dell’authorship? Come strutturare correttamente le diverse sezioni di un articolo scientifico originale? Quali sono le criticità più frequenti nella sua stesura e come possono essere efficacemente evitate?
Un manuale utile non solo per coloro che si apprestano a scrivere un lavoro scientifico, ma anche per tutti i professionisti della salute che desiderano dotarsi di strumenti efficaci per un’interpretazione più consapevole e informata della letteratura scientifica pubblicata. Un libro dedicato a medici, ma anche a biologi, biotecnologi, farmacisti, statistici, infermieri, study coordinator e data manager.
“Disporre di evidenze scientifiche come quelle raccolte dall’articolo di AIR è importante per orientare le scelte e rappresenta un cambio di passo decisivo: gli infermieri non chiedono privilegi, ma il riconoscimento del loro contributo basato su dati concreti e risultati misurabili.”
La ‘questione infermieristica’
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il commento di Barbara Mangiacavalli, Presidente della FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche, all’articolo pubblicato da Assistenza Infermieristica e Ricerca e ripreso anche da Care a pag 4 di questo numero, sul ruolo ricoperto dagli infermieri negli appelli pubblici volti a sollecitare un ripensamento profondo del nostro servizio sanitario.
La ‘questione infermieristica’ non riguarda solo una professione. Non riguarda nemmeno solo l’ambito del nostro sistema salute. Nel paese più anziano d’Europa è un tema che coinvolge tutta la società e tutti i livelli di decisione. È quindi molto rilevante per la FNOPI – la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche – il lavoro di analisi e sintesi portato avanti dalla rivista Assistenza Infermieristica e Ricerca, ripreso anche da CARE, sui documenti che in questi mesi si sono interrogati sul futuro del nostro Servizio sanitario nazionale, e sul ruolo che gli infermieri hanno, e possono avere, per tutelare questo bene prezioso e la salute di noi cittadini e pazienti.
Questo perché, seppur in un quadro complesso, noi siamo quelli che i problemi tendono a risolverli e non a crearli. Lo facciamo ogni giorno nei reparti e sul territorio e siamo determinati a dare il nostro contributo anche su questo piano.
Molte delle proposte enucleate negli appelli ripresi nell’articolo pubblicato su AIR ci vedono impegnati in prima linea.
È indubbio, come è emerso anche dalla recente pubblicazione del primo Rapporto sulle professioni infermieristiche, realizzato dalla Federazione in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che la soluzione della ‘questione infermieristica’ passi dalla valorizzazione delle competenze, del ruolo e delle prospettive di carriera degli infermieri, tanto quanto il riconoscimento retributivo. Quest’ultimo emerge come questione di equità e competitività internazionale: attualmente la retribuzione dell’infermiere italiano è pari al salario medio nazionale, mentre nei paesi Ocse è superiore del 20%. Questa disparità penalizza gravemente l’Italia nella competizione globale per il reclutamento dei professionisti sanitari.
Infermieri pienamente coinvolti nei processi decisionali, impegnati in modo strutturato sul territorio e con un orizzonte professionale in crescita, sono



Il rapporto è disponibile sul sito fnopi.it
una risorsa per tutto il sistema e sono riconosciuti dai cittadini come una chiave per un valido coinvolgimento nei processi di cura. Parallelamente, bisogna promuovere la formazione finalizzata al potenziamento delle competenze e alla valorizzazione del ruolo professionale, partendo dalle lauree magistrali specialistiche che costituiranno la base per la futura prescrizione infermieristica di ausili e presìdi. L’introduzione di nuove figure professionali e l’aggiornamento dell’organizzazione del lavoro devono accompagnare il superamento dell’ospedale-centrismo per rafforzare l’assistenza territoriale, dove il nostro ruolo spesso si misura con una maggiore soddisfazione professionale e un grande riscontro da parte dei pazienti.
Le misure di welfare, con particolare attenzione al sostegno della genitorialità attraverso asili nido, flessibilità e conciliazione, completano un quadro di interventi che si collega alla necessità di aumentare i ruoli dirigenziali, soprattutto nelle future case di comunità.
Disporre di evidenze scientifiche come quelle raccolte dall’articolo di AIR è importante per orientare le scelte e rappresenta un cambio di passo decisivo: gli infermieri non chiedono privilegi, ma il riconoscimento del loro contributo basato su dati concreti e risultati misurabili. n
Barbara Mangiacavalli
Presidente della FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
Prima edizione
RAPPORTO PROFESSIONI INFERMIERISTICHE