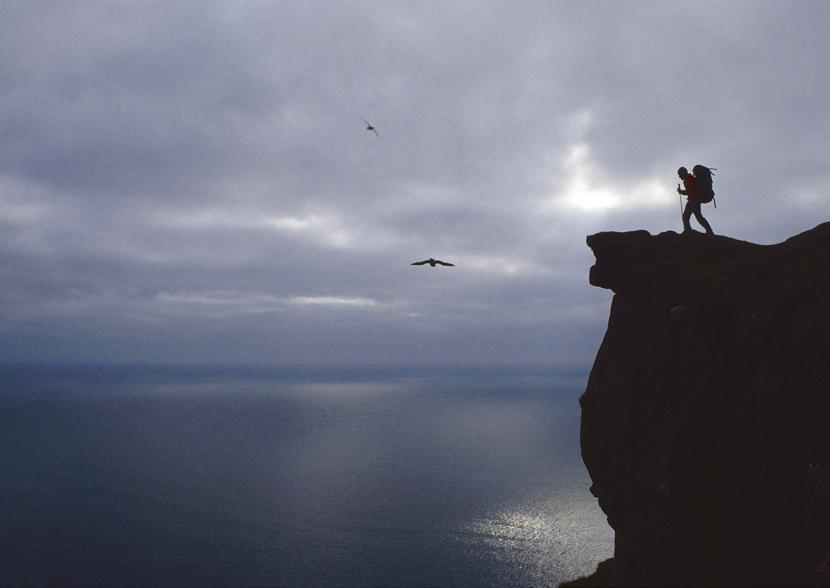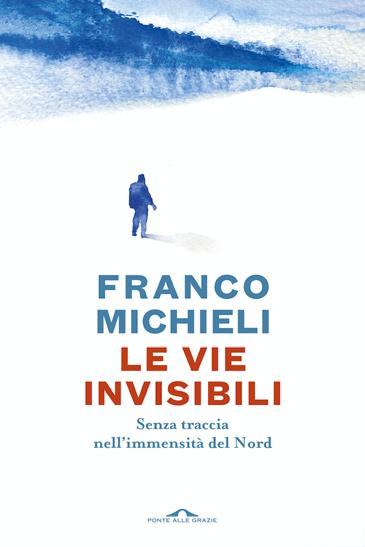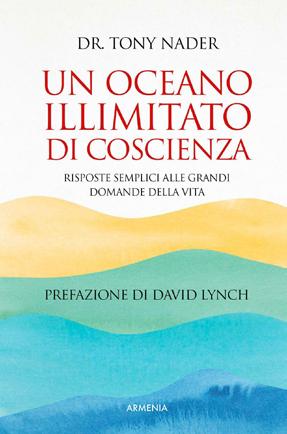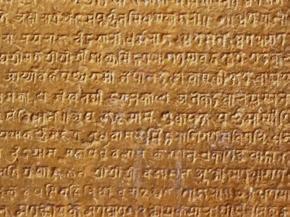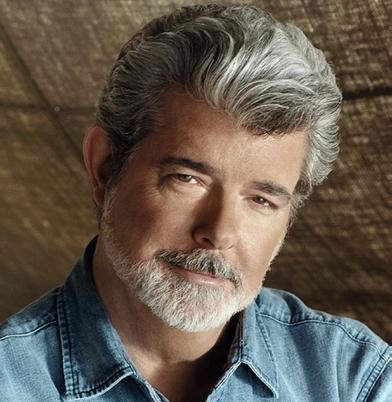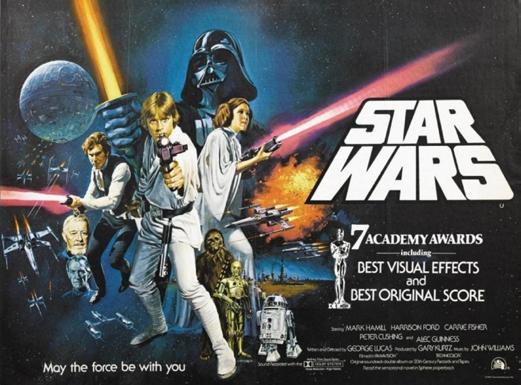Dove si parla di utopia concreta, fatta di terra e libertà, di musica indipendente e cinema megalomane, della lotta contro gli allevamenti intensivi, di Grande Nord esplorato col gusto di perdersi, di poesia ed eros popolare, di Coscienza N 17 | MAGGIO-GIUGNO 2024
Cannes 77
Giulia Innocenzi
Franco Michieli Tony Nader
Paolo Spaccamonti
Maurice Sendak
Terra di Ilizia
REDness
è passione, arte, impresa, comunicazione. È il "rossore" provocato dalle emozioni forti. Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.
La redness
è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina. È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi. Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità... Va bene tutto, purché sia fatto con redness.
In copertina: Franco Michieli alle Fær Øer nel 1996
Foto di: Franco Michieli (servizio a pag. 42)
Direttore: Fabrizio Tassi
Progetto grafco: Marta Carraro
Redazione: MondoRed
Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano
Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore
2 MESE 2022
4
EDITORIALE
4 La felicità è rivoluzionaria
6
INCONTRI
6 Terra di Ilizia: cambiare vita per cambiare il mondo
22 Food for Proft: Giulia Innocenzi ci racconta il suo flm-inchiesta
32 Paolo Spaccamonti: un musicista cinematico che pesca "nel torbido"
42
LUOGHI
42 Franco Michieli: nelle terre del Nord per riscoprirci natura
48 La bellezza travolgente delle "vie invisibili"
50
TERRE DI CONFINE
50 Luigi Balocchi: il sesso del popolo, libero e feroce. In dialetto e poesia
54
IDEE
54 Tony Nader: tutto è Coscienza, lo dicevano i Veda, lo dirà la scienza
62
EVENTI
62 Cannes 77: un mega-festival mondialista che celebra i sognatori
70 George Lucas: l'avanguardista che inventò una mitologia fanta-pop
74
COMMIATO
74 Maurice Sendak: "Nel mondo là fuori"
3 MAGGIO 2024
OMMARIO
S
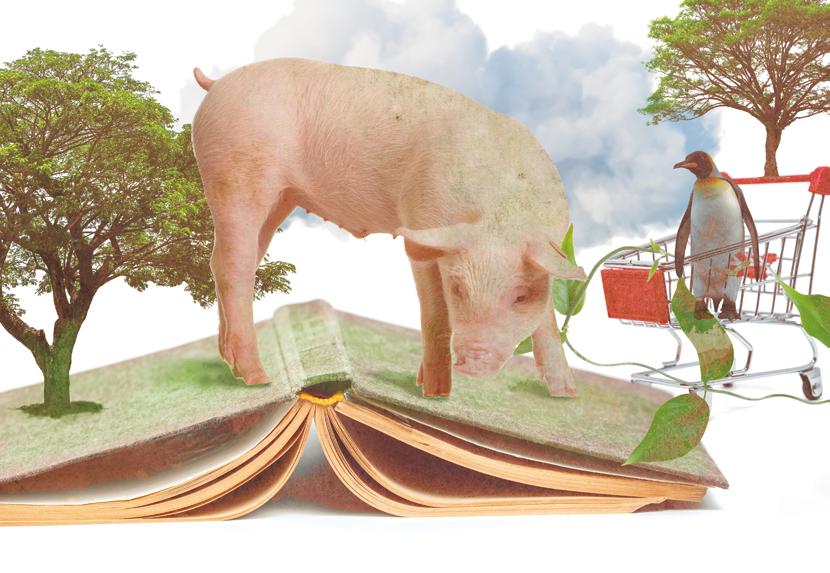
La felicità è rivoluzionaria
Qual è il compito della scuola? Formare degli esseri umani felici. La pensava così Alexander Neill, che ha messo in pratica la sua "pedagogia libertaria", profondamente anti-autoritaria, più o meno un secolo fa, a Summerhill. «Il bambino deve vivere la sua vita, non quella che i suoi ansiosi genitori pensano che dovrebbe vivere, e nemmeno una vita che segue i precetti di un educatore che pensa di sapere dove stia il suo bene»
La pensano così anche a Ubuntu, una libera scuola che ha trovato casa nella campagna lombarda, in Terra di Ilizia, dove si pratica la permacultura (cura delle persone e della terra, distribuzione equa delle risorse), si coltiva la terra con l'agroforestazione (assecondando la natura) e si incentiva la biodiversità. Perché la felicità passa anche attraverso lo stile di vita, il rapporto con gli altri e con l'ambiente in cui vivi, il modo in cui decidi di nutrirti, il lavoro che scegli, a costo di mollare tutto e provare a rifarti una vita. Loro, in Terra di Ilizia, hanno fatto così: un'intera famiglia ha abbandonato le vecchie certezze e rivoluzionato la propria esistenza, per provare anche a cambiare il mondo. Ecco perché abbiamo deciso di aprire Redness con
questa storia, che ne evoca tante altre, più o meno simili, sparse in giro per l'Italia, fatte di passione e un pizzico di follia, ma anche di conoscenza, consapevolezza, studio approfondito. Non parliamo di comunità alternative o tardo-hippy, di realtà pittoresche che propongono una fuga dal mondo, per motivi politici, ideali, religiosi (sì, ci sono anche quelle, ma come una sorta di retroguardia attardata in passate utopie). Parliamo di persone che studiano nuovi modi di fare agricoltura, che adottano metodi didattici ed educativi non convenzionali, che sperimentano modalità diverse di produzione e consumo - scoprendo spesso che la tradizione ha molto da ofrire all'innovazione - e che cercano di rivoluzionare il sistema dall'interno, dimostrando che "si può fare", che un pezzo alla volta di può davvero cambiare. Senza mai dimenticare che la libertà è strettamente legata alla responsabilità. Alexander Neill non proponeva di crescere bambini anarchici, egoisti, maleducati, ma persone che imparano, vivendo, l'importanza della comunità, il diritto di tutti a cercare la propria via alla felicità (se non ami te stesso e ciò che fai, se non credi nelle tue capacità, nel tuo essere fondamentalmente buono, come puoi amare gli altri?).
4 MAGGIO 2024
E DITORIALE
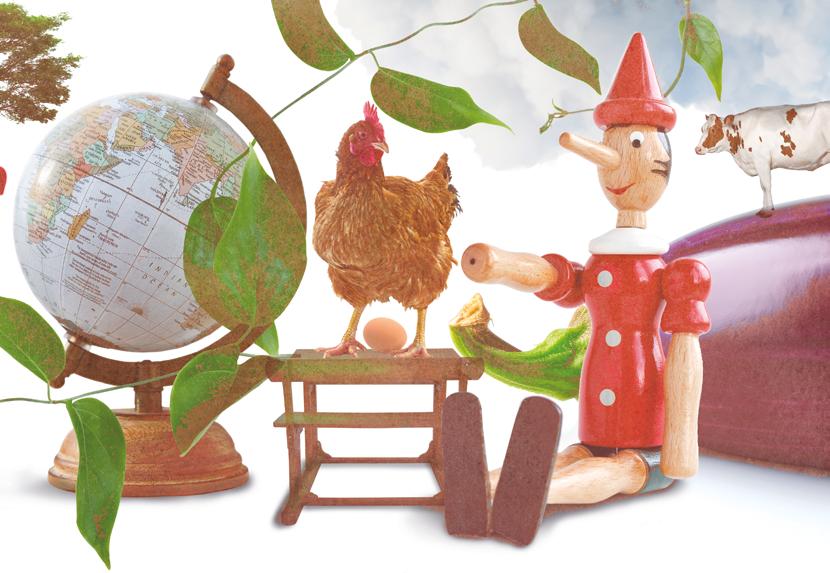
«Il bambino plasmato, condizionato, represso, disciplinato − "il suo nome è Legione" − vive in ogni angolo del mondo. Siede nel banco noioso di una scuola noiosa; più tardi sarà seduto davanti alla scrivania ancor più noiosa di un ufcio, o starà al banco di un'ofcina. È docile, fedele all'autorità, timoroso delle critiche e fanatico nel desiderio di essere normale, convenzionale e corretto. Accetta senza porsi domande quel che gli viene insegnato e trasmetterà tutti i suoi complessi, le sue paure e le sue frustrazioni ai fgli»
A proposito di cambiamenti necessari, questo mese abbiamo intervistato Giulia Innocenzi per farci raccontare la sua battaglia contro gli allevamenti intensivi, e i soldi dell'Europa (i nostri) spesi male, diventata un flm realizzato insieme a Pablo D'Ambrosi: Food for Proft. Lo hanno autoprodotto, perché nessuno era disposto a correre il rischio di problemi legali (che sono arrivati). Il successo clamoroso del flm, proiettato ovunque grazie al passaparola, è un sintomo eloquente. Il cinema può essere anche questo: un'occasione per ritrovarsi, confrontarsi, indignarsi, per poi uscire dalla sala e decidere che non dobbiamo più acquistare certi prodotti, smettendola di alimentare inconsapevolmente un sistema malato.
Il cinema è anche Cannes, un festival che in superfcie è la fera della vanità (anche intellettuale), ma che ha un'anima sempre
curiosa e un corpo multiforme, dentro cui andremo a cercare visioni "altre" e bellezza da condividere.
Siamo felici, questo mese, di ritrovare anche Franco Michieli, che abbiamo già incontrato un anno e mezzo fa, e che fnalmente è tornato a viaggiare nel Grande Nord, come piace a lui (e a noi), senza mappe e gps, confrontandosi con il limite e con il mistero, seguendo i segni della natura, continuando a perdersi per ritrovarsi (per farsi trovare dalla via).
E che dire della poesia di Luigi Balocchi, ormai una presenza quasi fssa, che usa il dialetto con una forza e una verità dirompenti, celebrando l'eros del popolo, la sua gioia tormentata e irresistibile? Sempre per citare Neill, «essere a favore della vita vuol dire divertimento, gioco, amore, lavoro interessante, risate, musica, ballo, considerazione per gli altri, fducia nell'uomo (...) lo scopo della vita è la felicità».
Lo diceva anche Maharishi Mahesh Yogi, che citiamo di nuovo, raccontando una possibile via di congiunzione tra ricerca scientifca e spiritualità, con il neuroscienziato Tony Nader (suo successore), convinto che alla radice di tutto ci sia un "campo di pura Coscienza". Bella questa idea di una realtà in cui tutto è collegato a tutto, e ogni suo aspetto è solo uno degli infniti modi possibili in cui l'universo può guardare se stesso e avere coscienza di sé. (f.t.)
5 MAGGIO 2024
mab2024

Terra di Ilizia
La rivoluzione della felicità: cambiare vita per cambiare il mondo Agricoltura d'avanguardia, educazione libertaria e la natura maestra
di Fabrizio Tassi
I NCONTRI

«Cos'è la permacultura?
Cura delle persone, cura della terra, distribuzione equa delle risorse. Si può fare!»
Si chiama Terra di Ilizia, nome ispirato alla dea greca della fertilità e dell'abbondanza. E in effetti, qui, tutto è (ri)nascita e foritura, campi, alberi, ma anche voci di bambini e ragazzi che giocano, studiano, fanno esperienza diretta della natura. Siamo a Ozzero, provincia sud-ovest di Milano, tra i navigli e il fume Ticino. Cascina Santa Maria Elisabetta, un gruppo di edifci che emerge in cima a un dosso, e che al visitatore appare come un mondo a parte, in aperta campagna, anche se in realtà è comodamente raggiungibile dalla vecchia Vigevanese.
La cosa diffcile, all'inizio, è gestire questa libertà. La nostra vita in genere è tutta incasellata nel "fai questo, fai quello".
Qui cerchiamo semplicemente di avere dei ritmi legati alla natura
In un territorio del genere è facile imbattersi in centri commerciali accanto a capannoni abbandonati, circondati da coltivazioni industriali, terreni che a inizio primavera sembrano aridi deserti, fatti di pietra e sabbia, votati alla monocoltura, alimentata dalla chimica. Nulla è più lontano da questo modo di intendere l'agricoltura e l'economia - ma anche la scuola, la cultura, l'umanità in generale – della Terra di Ilizia. Qui si praticano l'agroforestazione e la permacultura, si coltiva biologico, unen-
do tradizione e avanguardia (nel senso che si sperimentano nuovi modi di coltivare, assecondando la natura), e allo stesso tempo si crescono le nuove generazioni con “l'educazione libertaria”, seguendo le orme di Alexander Neill, secondo cui lo scopo della scuola dovrebbe essere quello di generare persone felici.
Forse la parola chiave è proprio generazione (e ri-generazione). La dea Ilizia era rappresentata spesso con una torcia in mano, intenta ad accompagnare i bimbi verso la luce, fuori dall'oscurità del ventre materno. Era una divinità invocata per proteggere i parti (toccava a lei avviare le doglie), onorata soprattutto a Creta, ma le tracce del suo culto risalgono fno all'epoca neolitica, dentro un tempo in cui la storia non era ancora cominciata, ma lo spirito umano generava già idee immaginifche e mitologie iniziatiche.
In Terra di Ilizia crescono piante, frutti, ortaggi ed esseri umani. Ci si rigenera. In quattro anni, oltre a una scuola e un'azienda agricola, sono già nati anche un ristorante, i cui prodotti seguono l'andamento delle stagioni (l'acqua è di fonte, quindi gratuita), e un servizio di vendita diretta (per ora il sabato dalle 9.30 alle 12.30), che oltre a frutta e verdura ofre pane fresco (con poco glutine), pasta, torte e conserve biologiche artigianali.
Ma c'è già anche un progetto per il futuro, che tra le altre cose prevede un parco solare, una biopiscina, spazi per chi vuole campeggiare o soggiornare, flari di vite e lavanda, dentro un'area ecologica protetta dagli alberi, in cui fgurerà anche un labirinto unicursale fatto di erbe aromatiche, in cui la gente entrerà non per perdersi, ma per ritrovarsi.


Sotto un portico ci sono dei ragazzi che parlano in inglese, con un'insegnante madrelingua, che arriva da New York (“dal Bronx”, precisa qualcuno, per far capire che è una persona tosta). Anche se “insegnante” - lo scopriremo fra poco – è un termine riduttivo, in un luogo del genere. Preferiscono “accompagnatore”, visto che si tratta di un educatore chiamato a formare i ragazzi da tutti i punti di vista, per prepararli alla vita. Poco più in là, passiamo davanti a un laboratorio di falegnameria, dove gli studenti si cimentano con la manualità, come dimostra la casetta per gli insetti che hanno costruito lì vicino. In un campo, dietro un flare di alberi, ci sono dei bambini più piccoli, impegnati nell'educazione ambientale, fondata sul fare esperienza delle cose. Altri piccoli gruppi sono sparpagliati nelle aule, per le lezioni di matematica o italiano. La scuola si chiama Ubuntu, parola proveniente dalla lingua bantu (cultura zulu), entrata da tempo nel vocabolario di chi cerca un'alternativa a un sistema basato sulla competizione e la soprafazione. Secondo questa flosofa, si può capire e praticare «il senso profondo dell'essere umani solo attraverso l'umanità degli altri» (parole di Nelson Mandela). Al centro c'è l'etica del-
la benevolenza, l'idea per cui “io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo”, e quindi è fondamentale coltivare il rispetto, la condivisione, il sentimento di un legame con tutta l'umanità.
Partita dieci anni fa, con un solo bambino, oggi l'associazione Ubuntu conta trentacinque allievi, dalle materne alle superiori, e ha accolto studenti laureandi e tirocinanti dell'Università Bicocca di Milano, contribuendo all'ingresso della pedagogia libertaria negli studi accademici. L'ha fondata Francesca Soresi, che non amava ciò che vedeva nella scuola tradizionale - che lei chiama “convenzionale” - e che ha cercato a lungo un'alternativa anche per i suoi fgli.
Questa infatti è una storia di famiglia. Una di quelle famiglie che decidono di voltare pagina, cambiare stile di vita e provare a realizzare i propri sogni. Lo ha fatto lei, ideando una versione italiana di Summerhill, la “scuola non repressiva” più famosa del mondo, fondata nel 1921 a Leiston, in Inghilterra. Lo ha fatto suo marito, Giuseppe Barone, ingegnere edile, che ha smesso di progettare edifci per dedicarsi alla terra. Lo hanno fatto i tre fgli, cresciuti libertariamente, già impegnati a tempo pieno nell'azienda-scuola-comunità.
Terra di Ilizia
9 MAGGIO 2024

Non una fuga, ma una specie di chiamata. Un progetto che, dieci anni fa, li aveva portati a fantasticare su quella cascina in vendita a una cifra impossibile, a Ozzero, per cui fecero un'oferta molto più bassa, rifutata. Si misero il cuore in pace e si dedicarono a un'altra casa, ristrutturandola completamente, per quattro anni. «Un giorno – racconta Giuseppe – mentre stavamo aprendo l'ultimo scatolone da sistemare, ci arriva una telefonata dalla cascina: avevano accettato la nostra oferta. Ma noi quell'oferta l'avevamo fatta quattro anni prima!». Disse di no, perché forse non ci credeva più. Ma Francesca ci credeva tantissimo e lanciò una sfda: «Proviamo a mettere in vendita la nuova casa e vediamo cosa succede». Tempo un giorno e arrivò l'oferta. Dopo una settimana avevano frmato il compromesso. «A quel punto ho pensato che l'universo avesse deciso per noi»
In tutta questa storia c'entrano, probabilmente, anche gli antenati anarchici e creativi, raccontati da Valentina Ghiglione, madre di Francesca, in un libro autobiogra-
fco: E poi arrivarono i Rolling Stones (Porto Seguro Editore). Lei e suo marito Gianni Soresi (che non c'è più) hanno sempre scritto e disegnato, pubblicando vari testi e cimentandosi anche nella satira politica. Perché qui tutti sono consapevoli che il problema sta nel “sistema”, l'idolatria del denaro e del successo, il consumismo come stile di vita.
L'alternativa? Pacifsmo, democrazia vera (fondata sul metodo del consenso), un diverso rapporto con la natura e con gli altri, economia circolare... Con la consapevolezza che non si tratta di ritirarsi dal mondo per vivere la propria egoistica felicità, ma di cambiare il sistema dall'interno, con la forza delle proprie pratiche, anche con la loro efcacia economica e sociale. Non è una comunità tardo-hippy, di quelle che vorrebbero tornare indietro nel tempo, scappando dalla modernità, ma una realtà proiettata nel futuro, più contemporanea di quelli che si ostinano a investire nel cemento, l'agricoltura industriale e la scuola organizzata su premi e punizioni.
10 MAGGIO 2024
Mollo tutto e scappo in campagna. Quanti lo hanno detto o pensato almeno una volta?
Oggi il “cambio vita” è diventato quasi un genere letterario. Ci sono giornali che hanno una rubrica fssa sul tema. Per non parlare delle innumerevoli pagine web, i libri, i flm. «È diventata una moda» dice Giuseppe, mentre ci accompagna a visitare l'azienda agricola. Come ogni moda, però, è il sintomo di qualcosa. «Di un malessere, certamente. Ci sono sempre più persone che vorrebbero cambiare. Ci capita di incontrarle, il sabato e la domenica. Ci chiamano, perché noi “ce l'abbiamo fatta”, per chiederci cosa devono fare per tornare alla campagna. Su internet trovano solo consigli strampalati».
In rete, generalmente, non si parla del lavoro, della fatica che bisogna fare. «Ma la difcoltà non è tanto la parte fsica, quanto entrare nel mood giusto, avere la mentalità per cui fare quella cosa ti piace e quindi riesci a cogliere sempre gli aspetti positivi. Chi lavora in un
ufcio non sa cosa signifca alzarsi molto presto, uscire quando fa caldo o fa freddo, mettersi l'impermeabile e stare sotto la pioggia... Non è così “pesante” come dicono, perché impari ad apprezzare ogni cosa»
In genere si lavora per guadagnarsi il tempo libero. Qui invece la libertà coincide con il lavoro scelto, che è la vita. «La cosa difcile all'inizio è gestire questa libertà. Qui non c'è nessuno che ti dice cosa devi fare. Vale per i campi come per la scuola libertaria. Anche i ragazzi devono imparare ad autogestirsi. La nostra vita in genere è tutta incasellata nel "fai questo e fai quello". Qui invece cerchiamo semplicemente di avere dei ritmi legati alla natura»
Chi non è abituato a questo genere di agricoltura, ed è cresciuto tra campi brulli a perdita d'occhio, può rimanere interdetto di fronte alle fle di alberi e cespugli apparentemente disordinate, dentro un campo senza una forma precisa, in pendenza, dove le coltivazioni sono mescolate a erbe spontanee, ma anche a piante scelte con cura in base alla loro funzione sinergica.

Terra di Ilizia
11 MAGGIO 2024
Un caos creativo. Il cui scopo è arrivare a un'agricoltura che non abbia quasi bisogno dell'intervento dell'uomo, riproducendo le dinamiche di un bosco, ma con le piante utili alla coltivazione. «L'agroforestazione è un'imitazione della natura» ci spiega Giuseppe, mostrandoci una pianta tropicale che cresce a vista d'occhio e nel giro di una stagione sarà alta dieci metri, con foglie grandi che faranno ombra al sottobosco. Per ora là sotto c'è solo la bacca dei cinque sapori, che è “cattiva”, e quindi resiste alle erbacce, ma presto arriveranno fragoline, more e mirtilli. «Nel bosco c'è qualcuno che va ad arare o concimare? No, ma sono rigogliosi, perché la natura fa da sé. Chi ha studiato per primo l'agroforestazione ha detto: perché non proviamo a imitare ciò che avviene in una foresta?
Ma dobbiamo anche creare qualcosa di comodo e adat-
I sistemi di agricoltura intensiva in realtà non stanno in piedi economicamente, per questo hanno bisogno dei sussidi. I cambiamenti climatici li stanno mettendo a dura prova. Noi facciamo un'agricoltura futuristica, d'avanguardia. L'agroforestazione è un'imitazione della natura

to alla raccolta. Noi ad esempio abbiamo organizzato il campo a strisce. Ovviamente non aspettiamo i tempi lunghi della natura, ma cerchiamo di accelerare il processo»
Oltre alle paulownie, che assorbono una quantità spropositata di CO2, producendo tantissimo ossigeno, ci sono pioppi e flari di meli. Ci sono anche coltivazioni in tunnel, in fle ordinate, circondate da un telo in mater-bi, quindi biodegradabile, per evitare che le erbacce sofochino le piante più delicate, quelle che chiamano scherzosamente “fghette”, perché hanno bisogno di essere protette e coccolate.
«Facciamo un'agricoltura futuristica, d'avanguardia, per cui ci sono pochi esempi. Studiamo, continuiamo a leggere libri su libri, ma non esiste una formula magica. Non ci sono procedure standard valide per ogni tipo di terreno. Questo campo è diverso da quell'altro a cento metri da qui. Abbiamo girato tanti posti in Italia dove fanno agricoltura innovativa, ma con condizioni assolutamente diverse dalla nostra. Ci sono quelli che coltivano senza pacciamatura, ma questo lo puoi fare a 1500 metri di altezza, dove non cresce un flo d'erba. Sono cose che impari osservandole e vivendole»
Di sicuro è impressionante la diferenza tra questo campo, ricco di verde, piante, cespugli, e quelli dei vicini, da una parte e dell'altra, che utilizzano la classica aratura, contribuendo a impoverire il terreno. «Il nostro non è il tipico campo “bel net” (bello pulito, ndr) come si dice da queste parti. Quei campi, appena arati, in due-tre giorni diventeranno sabbia. Al terreno vengono tolte delle risorse, e a quel punto ci vorranno dei concimi chimici per nutrirlo. Non fanno un danno solo al loro terreno, ma a tutto il pianeta Terra. Moltiplica questa cosa per un miliardo di terreni e capisci perché l'agricoltura “moderna” contribuisce in negativo ai cambiamenti climatici. Stiamo vivendo una vera e propria tropicalizzazione. Quei terreni sono stati “scoperchiati”, non sono più in grado di immagazzinare acqua, perché non hanno più la sostanza organica necessaria a trattenerla. Quando piove, nel mio terreno rimangono ettolitri d'acqua e quindi non devo irrigare più di tanto. Nel terreno arato invece l'acqua va giù direttamente in falda, fnisce nei fossi, nei fumi e poi nel mare. Non c'è più una riserva idrica in pianura. Quindi serve anche più acqua per irrigare. Inoltre c'è meno evaporazione e diminuiscono le precipitazioni».
12 MAGGIO 2024

La fglia Marina, che ha 21 anni e lo aiuta nel lavoro, ci spiega la struttura del loro campo: «Le fle non sono fatte a caso. La forma strana e il dislivello fanno sì che l'acqua scenda lungo il terreno. Tutto è studiato perché ogni fla riceva una certa quantità di acqua». Giuseppe infla una mano nel terreno, una specie di aiuola che in teoria non riceve acqua da un po' di giorni, ma la terra è umida e ricca di organismi viventi. Marina ci spiega che chi coltiva il mais potrebbe trovare delle soluzioni per mantenere il verde, ad esempio con i trifogli, ma non lo fanno. «Noi usiamo anche il cippato per migliorare il terreno», dando quel nutrimento che nei boschi è garantito naturalmente dal ciclo vitale degli alberi. In questo modo, assecondando la natura e diversifcando le coltivazioni, è più facile anche far fronte alle emergenze. Due anni fa sono stati buttati interi raccolti di mais, per colpa della siccità. Qui, invece, in un anno di caldo intenso, in cui le melanzane non sono cresciute, le zucche hanno raddoppiato la produzione. Si trova sempre il modo di compensare o risolvere l'emergenza.
Facciamo una domanda provocatoria, da avvocati del
diavolo: se io ho una piccola azienda agricola, con una famiglia da sfamare, so che devo produrre una certa quantità di mais per avere un reddito minimo. L'agroforestazione, in quel contesto, sembra un'utopia, bella ma poco redditizia. «Questa domanda nasce da un errore di fondo – dice Giuseppe: - il fatto che lui sta coltivando del mais per venderlo. È il sistema che non ha senso, che lo obbliga a vendere a qualcuno il suo prodotto. Negli ultimi anni i cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova questo sistema consolidato. Capita che il gasolio da mettere nella mietitrebbia costi più di ciò che guadagneresti vendendo il mais. I sistemi di agricoltura intensiva in realtà non stanno in piedi economicamente, per questo servono i sussidi. Non è un sistema resiliente, basta che ci sia meno acqua e non riesci più a fare nulla. Al contrario, ci sono sempre più studi sull'efcacia dell'agricoltura rigenerativa, che è come un diesel, ci mette un po' di più a partire, ma poi rende di più. In alcuni casi avrai forse meno prodotto, ma non spenderai nulla per ottenerlo, non userai fertilizzanti, non avrai bisogno di fare prevenzione contro le malattie delle piante...»
Terra di Ilizia
13 MAGGIO 2024
(foto Marco Minniti)

Sembra tutto facile, in un certo senso lo è, ma perché c'è una profonda conoscenza di base e la passione che consente di trasformare un lavoro in una ragione di vita, dentro una flosofa orientata verso la libertà e il rispetto della natura e degli altri.
Si chiama permacultura: «Si basa su tre principi base. Il primo è la cura della persona: se non stai bene nel posto dove sei, non va bene. Ci deve essere un equilibrio energetico, all'interno del nucleo famigliare e poi, allargandoti, nell'azienda, nel gruppo di persone che frequenti, ecc. Il secondo è la cura della terra, sia quella che coltivi che il pianeta Terra. Terzo principio: distribuzione equa delle risorse». Queste idee vengono poi applicate in tanti campi diversi, attraverso varie tecniche (anche quelle per il benessere spirituale delle persone, come la meditazione). «Abbraccia numerose discipline, dall'agricoltura alla costruzione degli edifci, unendo tradizione e innovazione. Penso agli arabi che costruivano case fresche, in ambienti con temperature esterne caldissime, senza bisogno di condizionatori». Ogni luogo, ogni situazione, è completamente diversa, quindi il primo principio è quello dell'osservazione, per poi sapersi adattare alle circostanze.
Qui, ad esempio, a metà strada fra Milano e Vigevano, si fanno i conti con l'erba che cresce continuamente, anche le infestanti, e si impara a sfruttare le piante spontanee, che sono molto più saporite e nutrienti di quelle coltivate. Da Ilizia si organizzano corsi per riconoscerle e raccoglierle. Come si organizzano giornate dedicate alla permacultura o all'agroforestazione. Perché questa non è un'utopia astratta, ma un progetto concreto per un nuovo modo di intendere l'agricoltura, che diventerà sempre più efcace, man mano che cresceranno le aziende che lo adottano.
«Noi non andiamo contro il sistema, ma gli giriamo intorno. Non abbiamo la forza per combattere le multinazionali, che stanno rovinando il pianeta. L'economia mondiale dovrebbe investire nelle coltivazioni su piccola scala e l'economia circolare. Le multinazionali invece fanno esattamente il contrario, vanno a cercare in giro per il mondo le condizioni più favorevoli per sviluppare il loro business, le leggi più permissive, le condizioni di lavoro peggiori, fregandosene delle persone e dell'ambiente. Il sogno è cambiare il sistema dall'interno, un passo alla volta.
14 MAGGIO 2024
Vogliamo fare divulgazione e creare delle micro-comunità che girano intorno al progetto. Vogliamo far vedere che funziona! La gente viene da noi e vede gli alberi carichi di susine, cinque cassette per ogni albero. Cosa abbiamo messo nel terreno per ottenere quel risultato? Niente! Quindi lo puoi fare anche tu! È semplice». Non si fnisce mai di sperimentare. I cipressi piantati ai limiti della proprietà (anche per difendere il campo dalla chimica dei vicini di casa) probabilmente verranno sostituiti da alberi che crescono più in fretta. I giunchi invece crescono bene e presto torneranno utili per costruire ceste e cappelli, o fare dei laboratori artigianali. Vediamo una fla di insalate accanto a pioppi e salici: «Anche qui abbiamo fatto qualcosa di innovativo. Gli agronomi mi dicevano: sei pazzo, così porti via terreno alle orticole! In realtà ci sono un sacco di piante a cui piace l'ombra. Abbiamo scoperto che le insalate vicino alle piante crescono molto meglio. Sono anche più buone»
Particolarmente ambiziosa è l'idea di creare un “orto rialzato sinergico su vasta scala”. «Di solito l'orto sinergico è piccolo, noi vogliamo svilupparlo su mezzo ettaro. Parlo di un orto che diventa permanente, in cui non ho più lavorazioni da fare (e diesel da mettere nel trattore), a parte arieggiare il terreno in partenza con la vangatrice. La base è un'aiuola fatta di terre, ramaglie e cippato. Tutto attorno ci metto le liliacee, scalogno, cipolla, aglio, che tengono lontani gli insetti. Subito sopra ci sono le insalate e i fori per l'impollinazione. In alto la coltura principale, ad esempio le melanzane». Si sperimenta e si impara. Con le piante, le tecniche, i modi di lavorare, ma anche le relazioni. Ad esempio con la “fattoria sociale”, la collaborazione con realtà del territorio che mandano a Ilizia persone che hanno bisognose di lavorare. «Arrivano qui diverse tipologie di soggetti fragili con cui avviamo progetti di inserimento lavorativo.
Terra di Ilizia

Capita anche che qualcuno si trovi particolarmente bene da noi e venga assunto. Perché questo posto per certe persone non è solo un lavoro, è molto di più».
Passiamo davanti a un fco, protetto da un cespuglio con le foglie velenose, che tiene lontani gli insetti. «Si chiama gilda, una collaborazione tra piante. L'abbiamo trovata venendo qui. I vecchi conoscevano queste tecniche. Dovremmo imparare ad ascoltarli di più, non sono cose che trovi su internet». La produzione di fchi è pazzesca, da giugno si raccolgono anche tre o quattro cassette ogni due giorni, anche di una speciale qualità antica, che viene scambiata con altre aziende bio della zona, o che fnisce nella marmellata di Ilizia.
Parliamo di un progetto che ha lo scopo di «preservare la biodiversità esistente, implementando il piano di riforestazione già avviato. Qui arrivano gli uccelli
migratori, abbiamo diverse specie autoctone e alcune protette: la volpe, il tasso e la civetta, l'assiolo e il rondone, la raganella, l'upupa, il rospo smeraldino, l'airone cenerino... Ci sono molte specie che non abbiamo ancora individuato. Alcuni di questi animali erano già qui quando siamo arrivati, altri si stanno avvicinando grazie al piano di riforestazione. Molti di questi animali sono anche utili in agricoltura e contribuiscono a creare un equilibrio funzionale a tutti. Ad esempio la volpe tiene sotto controllo le colonie di minilepri. L'upupa si ciba della terribile popillia japonica».
Nella nostra scuola non si utilizzano mezzi coericitivi. Non ci sono premi e punizioni. Accompagniamo il ragazzo nel suo percorso di crescita, senza dividere didattica ed educazione. Insegniamo la vita
Domanda personale: come è possibile che un ingegnere rinunci al suo lavoro, che immaginiamo redditizio, per dedicarsi a un'impresa del genere? «Ho fatto l'ingegnere per 23 anni, cementifcando mezza Lombardia. Amavo il mio lavoro: “far stare su le cose”. Soprattutto negli anni in cui aiutavo le persone, costruendo capannoni, con un occhio all'innovazione. Poi negli ultimi anni, prima del Covid, l'unica cosa che mi chiedevano era la logistica (guarda caso...). La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato l'arrivo delle commesse per la guerra in Ucraina. A quel punto ho detto basta». Una “pazzia” condivisa da tutta la famiglia. Una realtà del genere riesce a vivere perché non si limita a coltivare un prodotto per venderlo alla grande distribuzione, come fanno tutti.


I prodotti della terra vengono venduti direttamente al pubblico, ma in gran parte sono utilizzati per il ristorante e la mensa scolastica, o per realizzare prodotti artigianali con il marchio “Terra di Ilizia”. Gli studenti mangiano rigorosamente biologico, e mangiano anche bene. Lo abbiamo sperimentato in prima persona. Vegetariani e vegani qui si sentono a casa.
Nel pomeriggio Francesca Soresi ci racconta il sogno di Ubuntu diventato realtà. Lei è l'anima di questo luogo anche un po' magico, «che conserva un'energia antica, una memoria storica che probabilmente non è ancora stata svelata». Chi può dirlo meglio di lei, che pratica quotidianamente meditazione e yoga, studia reiki e ha una particolare sensibilità per "l'energia" dei luoghi e delle persone?
«Il giorno in cui sono arrivata qui la prima volta, per visitare la cascina, ho sentito subito che questo posto mi stava chiamando. Non sapevo perché, era qualcosa più grande di me»
Ora in Ubuntu ci sono trentacinque iscritti, ma continuano ad arrivare richieste e facilmente si passerà a quaranta. Non si andrà oltre i cinquanta, per riuscire a mantenere classi piccole, in cui si può portare avanti
un lavoro individuale con ciascuno bambino e ragazzo. Si lavora sul “metodo esperienziale”: «Alterniamo lezioni teoriche e pratiche. I ragazzi prima vedono, toccano, sperimentano, poi interiorizzano e mettono su carta». Ma soprattutto si applica l'approccio ideato da Alexander Neill, su cui si fonda l'educazione libertaria: «Noi non utilizziamo metodi coercitivi. Non usiamo premi e punizioni, non diamo voti, quindi dobbiamo entrare in sintonia con il bambino e il ragazzo. Non dividiamo la didattica dall'educazione. Accompagniamo il ragazzo nel suo percorso di crescita. L'insegnante è anche educatore e psicologo, è una vera e propria guida, perché qui si impara a vivere. La cosa fondamentale per un accompagnatore libertario è la relazione. Deve rendere la sua proposta didattica interessante, perché i ragazzi possono anche scegliere di non partecipare alla lezione. Quando partecipano è perché sono davvero interessati. Non essendoci il voto, il ragazzo studia per se stesso, per rendere il percorso di apprendimento una cosa importante per lui». Ma alla fne di ogni anno bisogna passare un esame per essere ammessi a quello successivo. E naturalmente, al termine di ogni ciclo, bisogna anche superare l'esame di Stato, cosa fatta abitualmente senza problemi.
Terra di Ilizia
17 MAGGIO 2024


Di fronte a una proposta del genere, la reazione di chi è abituato a una didattica più tradizionale può essere di perplessità e scetticismo. La domanda ovvia è questa: come farà un ragazzo formato secondo questi principi ad afermarsi in una società fondata sulla competizione e sull'efcienza? La risposta di Neill a domande del genere era: «Io spero che siano i ragazzi che escono da questa scuola a cambiare la società». È evidente a tutti, ormai, che questa società non funziona come dovrebbe, generando persone infelici, stressate, egoiste. Federico, che aiuta sua madre nella conduzione del-
la scuola, ci spiega che, in realtà, i ragazzi formati in modo libertario, sono molto più attrezzati ad afrontare la vita e i suoi problemi. Con uno spirito diverso. «L'accompagnatore ofre ad ogni ragazzo le competenze necessarie a diventare ciò che desidera. Anche quelle necessarie a vivere nella società. L'inglese lo impari meglio da noi, parlandolo ogni giorno. Chi vuole diventare medico, meccanico, ingegnere, artista, avrà le conoscenze necessarie per farlo, perché l'accompagnatore cercherà di formare una persona partendo dal suo obiettivo». Il problema nasce dall'equivoco sulla parola libertà, come ci spiega Francesca: «Libertà non signifca: faccio quello che voglio. Libertà vuol dire: io sono libero se nella comunità in cui vivo ogni persona ha la possibilità di esprimere la propria libertà. La nostra non è una “bolla”. Qui i ragazzi imparano un'autonomia che non imparerebbero in una scuola convenzionale. Insegniamo la vita. Da noi un ragazzo viene invitato a prendersi la responsabilità delle proprie azioni. Le decisioni vengono prese in assemblea. I confitti sono gestiti dai ragazzi. L'accompagnatore si limita a guidarli nella risoluzione del problema. Per questo imparano davvero a vivere»
In una scuola del genere non si impara per paura della punizione, secondo i principi del comportamentismo, «anche perché – spiega Federico – se uno impara secondo quel sistema, quando poi esce dalla scuola può accadere qualsiasi cosa, perché la paura della punizione svanisce nel tempo. Da noi, invece, il ragazzo impara a credere in ciò che gli è stato insegnato e che ha liberamente accettato».
18 MAGGIO 2024

Nasce anche una forma matura di rispetto, legata alla dinamica assembleare. Ce lo racconta Francesca: «Utilizziamo una forma di democrazia applicata. Ci sediamo in cerchio e decidiamo le regole della comunità. La comunità libertaria cambia con gli individui al suo interno. L'accompagnatore rispetta ogni ragazzo, ma il ragazzo lo deve rispettare a sua volta. Uscendo da qui si ha un concetto di rispetto interiorizzato molto più forte. Esempio: qualcuno rompe qualcosa. In una scuola convenzionale ci sarebbe una sospensione. Noi invece risolviamo la questione con un'assemblea, e la comunità chiede di far rimborsare il danno. Si condanna il comportamento, non la persona. Tutto questo porta a una maggiore consapevolezza. Ti facciamo rifettere sul fatto che la tua azione è stata sbagliata per la comunità». Aggiungiamo il fatto che qui si vive una multiculturalità di fatto, con vari bambini nati da coppie miste, chi è di origini olandesi o russe, polacche o sudamericane, giapponesi o francesi, culture diverse, religioni diverse (c'è il cattolico, il buddhista, l'ateo).
La comunità a volte decide di introdurre l'insegnamento di una lingua nuova, proprio sulla base di questi nuovi apporti culturali. Così come sceglie di
approfondire un certo sport o di praticare meditazione e yoga, come si è fatto per anni. Si dà spazio anche ai dibattiti flosofci, si suona uno strumento (chitarra o pianoforte) e ci si esercita nel canto. A fne anno viene messo in scena uno spettacolo teatrale: i ragazzi stanno preparando un musical, ispirato all'Iliade; c'è chi ha scritto i copioni, chi sta scrivendo le musiche, si lavora tutti insieme, in libertà. L'obiettivo è la felicità, concentrandosi sul potenziale di ogni ragazzo, sui suoi talenti e le sue aspirazioni. Facile intuire perché questa possibilità afascini tanti genitori. E abbia catturato anche l'attenzione di un'università come la Bicocca. Perché in Italia le scuole si chiamano libertarie e non “democratiche” come l'istituto anglosassone di Neill? Per il diverso signifcato assunto dalla parola nel nostro Paese. «Noi, a diferenza di ciò che accade nelle altre scuole all'estero, in assemblea non utilizziamo la regola della maggioranza democratica, ma usiamo il metodo del consenso: fno a che non sono tutti d'accordo, si va avanti a parlare, cercando la soluzione. Per aggiungere o togliere una regola a volte ci mettiamo anche un anno intero. Ma di solito prendere una decisione in questo modo è più veloce del normale.
Terra di Ilizia
19 MAGGIO 2024

Abbiamo pianifcato da qui a vent'anni quello che ci piacerebbe fare. È un altro principio della permacultura. Fai delle cose che possano portare benefci per almeno sette generazioni. Se io pianto una quercia, saranno i miei pronipoti a goderne i maggiori benefci

Trovare una soluzione, signifca far sì che venga mantenuto un equilibrio nella comunità, il che è nell'interesse di tutti, quindi alla fne si smussano gli angoli e si trova la soluzione insieme. Un esercizio di vita molto forte»
Non pensate a pedagogie come quella steineriana o montessoriana. «Quelle sono pedagogie ben precise, che hanno una certa struttura e solo quella. La scuola libertaria non è un metodo, ma un approccio. Che al suo interno prende in considerazione anche principi e metodi montessoriani, steineriani, modalità della scuola del bosco... Le adattiamo a ogni bambino, applicando un approccio misto. Dipende dai ragazzi che fanno parte della comunità in quel momento»
Soprattutto non confondetela con le cosiddette “scuole parentali”: «Da un punto di vista legale siamo "educazione parentale" perché in Italia il nostro approccio non viene riconosciuto. La pedagogia libertaria però ha una storia culturale antichissima, che attinge da grandi pensatori come Madeleine Vernet, Francisco Ferrer, Paulo Freire, William Godwin, Charles Fourier, Louise Michel, Lev Tolstoj, John Dewey, Célestin Freinet, Mario Lodi, Maria Montessori, Alexander Neill... In molte parti del mondo viene applicata e riconosciuta anche dalle istituzioni»
Alla fne ci ritroviamo davanti alla piantina di un progetto, una specie di cittadella dell'ecologia, della permacultura, dell'educazione libertaria. «Abbiamo pianifcato da qui e vent'anni quello che ci piacerebbe fare – dice Giuseppe. - Questo è un altro dei principi della permacultura: fai delle azioni sul tuo terreno che possano avere due o tre utilità diverse, perché tutto dovrebbe essere polifunzionale; ma soprattutto fai cose che possano portare benefci per almeno sette generazioni. Se io pianto una quercia, saranno i miei pronipoti a goderne i maggiori benefci». Ne godrà anche chi vive intorno a quel terreno, ci guadagna tutto un territorio (tutta la Terra). «Pensa in che mondo vivremmo se chi è al potere ragionasse in questo modo!»
Sulla cartina vediamo il parco che funzionerà con l'energia del sole: cucina solare, forno solare, un pirografo per far giocare i bambini, una torre per la produzione di energia elettrica tramite celle di Peltier. Ma anche qualche impiantino idroelettrico e magari una pala eolica. L'idea è «creare un centro dove far venire le persone e dire: si può fare!».
20 MAGGIO 2024
Nascerà anche una serra fotovoltaica. Poi la biopiscina, in cui la depurazione non è afdata alla chimica, ma alle piante, attraverso un sistema di vasche comunicanti. Verrà piantata la vite, come accadeva in questa zona tanto tempo fa.
Ci saranno delle casette prefabbricate, per poter accogliere le persone e fare divulgazione. Al centro, un labirinto unicursale, «quello che si usava prima dell'era minoica. Un tempo il labirinto era un cammino, una meditazione. Invece di perderti, ti ritrovi»
Ritrovarsi, ecco un'altra cosa su cui vale la pena esercitarsi. Anche solo seguendo un corso per imparare a trovare e cucinare le erbe spontanee, frequentando le lezioni di reiki, yoga, arteterapia, biodanza, iscrivendosi ai seminari dedicati all'agroforestazione, partecipan-
do ai campus estivi per bambini e ragazzi, in inglese, in cui si fanno sport e laboratori creativi, stando a contatto con la natura. Come scrivono sul sito (terradilizia.it): «Terra di Ilizia nasce dal sogno di una famiglia, la nostra. Abbiamo deciso di fare questo cambiamento drastico di vita perché desideriamo vivere in un posto felice e più naturale. Non si tratta però solo di una nuova casa per noi, ma di un posto dove tutti possono imparare cose nuove ed essere più connessi con la terra»

Terra di Ilizia
21 MAGGIO 2024
Food for Proft
Giulia Innocenzi ci racconta il flm-inchiesta realizzato con Pablo
D'Ambrosi,
contro gli allevamenti intensivi e l'(ab)uso dei sussidi europei
Polesine, Italia. Allevamento di polli. Un carnaio invivibile. Qualcuno dice che il pavimento viene pulito solo una volta all'anno. Un operaio prende a bastonate gli “scarti”, li sbatte per terra o su un ferro, per ucciderli: i polli che non pesano abbastanza non vengono pagati, quindi meglio liberarsene. L'azienda agricola – perché di questo si tratta – riceve in un anno 120 mila euro di sussidi dall'Unione Europea.
Berlino sud, Germania. 500 mucche rinchiuse in spazi insalubri. Ci sono animali con il corpo ferito, deformato, ammalati di mastite. Vengono fatte iniezioni di antibiotico in quantità. «Tutto deve essere a basso costo, veloce, squallido». 500 mila euro di sussidi l'anno. Murcia, Spagna. Più di due milioni di maiali chiusi in enormi capannoni, che producono quattro milioni di metri cubi di liquami ogni anno (1500 piscine olimpioniche, più o meno). Smaltirli è quasi impossibile. Vediamo i liquami lasciati in vasche all'aria aperta, destinate inevitabilmente a inquinare il terreno e le falde con i loro nitrati.
Come dice il flosofo Peter Singer, uno degli esperti chiamati a esprimersi sulla follia degli allevamenti intensivi, qui gli animali «sono ridotti a cose»: siamo convinti che «gli animali siano a completa disposizio-
ne dell'uomo. Li riteniamo inferiori e da loro vogliamo ottenere prodotti al più basso prezzo possibile». Salvo poi manifestare il nostro amore per cani e gatti, che invece vengono trattati come individui, in maniera ipocrita e paradossale.
Food for Proft colpisce duro, come è giusto che sia. Perché nessuno, ormai, può dire “non so”, “non mi interessa”. A chi non interessa la propria salute e quella del pianeta? Chi può rimanere indiferente di fronte al maltrattamento degli animali? Anche perché i soldi dell'Europa, i nostri soldi, attraverso il PAC (Politica Agricola Comune) vengono assegnati anche ad aziende che alimentano la piaga degli allevamenti intensivi. Siamo cittadini e siamo consumatori, una doppia responsabilità. È arrivato il tempo che tutti sappiano cosa si nasconde dentro le innocenti vaschette di polistirolo, ricoperte di cellophane, che vediamo sui banchi dei supermercati.
«387 miliardi di motivi per cui non vogliono che tu veda questo flm». Recita così il sottotitolo, alla Michael Moore, di questo documentario che non si fa problemi a dire da che parte sta. I miliardi sono quelli dei sussidi garantiti dal PAC in sette anni (55 l'anno).
22 MAGGIO 2024
I NCONTRI


23 MAGGIO 2024
Non c'è da meravigliarsi, vista la quantità di soldi in ballo, se l'industria agroalimentare sia così potente e infuente, e se gran parte dei 25 mila lobbisti che lavorano a Bruxelles siano impegnati proprio in questo settore. Un argomento sensibilissimo in tempi come questi, caratterizzati dalle proteste degli agricoltori: è assurda la tirannia esercitata dalla grande distribuzione nei confronti dei produttori, costretti a vendere i propri prodotti a prezzi insostenibili; ma è insostenibile anche il sistema alimentato dai sussidi, di cui tanti allevatori approfttano fregandosene della sbandierata “sostenibilità”.
Tutti noi abbiamo una forchetta in mano, il nostro strumento più potente, il parlamento quotidiano, e possiamo decidere se fnanziare il sistema, oppure rifutarci di consumare certi prodotti
Tutti conosciamo Giulia Innocenzi per il suo lavoro in tv: con Santoro in Rai, su La7 per Announo fno ad arrivare a Le Iene. Dall'anno scorso le sue inchieste vengono ospitate da Report, su RaiTre, e hanno colpito anche marchi importanti dell'industria agroalimentare italiana. Il suo libro Tritacarne (Rizzoli) già nel 2017 aveva indagato sugli allevamenti e i macelli italiani, chiedendosi se «è veramente sicuro ciò che mangiamo». Nasce da quella presa di coscienza il percorso che porta al flm, grazie all'incontro con Pablo D'Ambrosi, autore di documentari celebri come This World, di lavori per la BBC, ma anche per star della musica come Paul McCartney e i Rolling Stones. Si trattava di un azzardo, perché nessuno ha accettato di produrlo, temendo le possibili cause legali. Ma loro hanno deciso di rischiare in prima persona, e oggi si ritrovano sommersi dalle richieste di proiettarlo ovunque, in giro per l'Italia. “Non vogliono che tu veda questo flm”, ma evidentemente il pubblico ha una gran voglia di disobbedire. Da qui la sorpresa di ritrovare un documentario indipendente nella classifca dei flm più visti nelle sale italiane.

24 MAGGIO 2024

«L'obiettivo è che l'economia, la produzione e il consumo, siano in connessione con il Pianeta e al servizio dei cittadini». Diceva così Ursula von der Leyen, celebrando il Green Deal, la “rivoluzione verde” dell'Unione europea, fondata sulla riduzione delle emissioni, l'innovazione tecnologica, l'economia circolare, la biodiversità. Parole che aprono il flm e che fniscono per stridere drammaticamente con le immagini che vediamo. Perché Food for Proft è un “documentario d'inchiesta”, basato anche su immagini girate con telecamere nascoste, sia negli allevamenti (grazie alla collaborazione degli attivisti della LAV), sia nei corridoi e gli ufci dell'Unione Europea, dove Lorenzo Mineo ha fnto di essere un lobbista. Al centro del flm c'è proprio la PAC, o meglio, la facilità con cui l'industria della carne riesce a fare pressioni sulla politica per ottenere ciò che vuole. Si rimane basiti quando parlamentari europei, scienziati (pagati dalle aziende) e comunicatori prendono sul serio la bufala dei maiali a sei zampe, dichiarandosi interessati a questo ulteriore sviluppo della produttività, proposto dal fnto lobbista. D'altra parte l'editing genetico è il futuro dell'allevamento, oltre che dell'agricoltura, come dimostra la creazione di una razza di mucca con un doppio strato di muscoli (e vitelli così grossi che è necessario farli nascere con un parto cesareo).
Gli allevamenti intensivi sono l'esatto contrario di ciò che ci si aspetta dal Green Deal, che promette di raggiungere la “neutralità climatica” nel 2050. Come ci
ricorda Jonathan Safran Foer, «il 99% degli animali consumati in America e circa il 90% in Europa vengono dagli allevamenti intensivi e il loro impatto sull'ambiente è devastante. Secondo le Nazioni Unite gli allevamenti sono una delle cause principali del cambiamento climatico».
L'altro problema è quello dello sfruttamento dei lavoratori nelle aziende agricole e nei macelli, costretti in condizioni estreme, con paghe da fame. Non c'è rispetto per nessuno, quando si tratta di inseguire un proftto sempre più grande. Figuriamoci per gli animali, che vivono in condizioni igieniche precarie negli allevamenti intensivi: vedi ad esempio i polli ingrassati così tanto che non si reggono sulle zampe o i tacchini gettati letteralmente nei camion, anche quelli feriti e moribondi, per essere trasportati di notte. Giulia e la sua troupe sono stati minacciati e inseguiti, quando si sono presentati a fare domande, in un'azienda a cento chilometri da Roma. Lo stile è quello del servizio televisivo, in prima persona, la struttura è quella del documentario d'inchiesta, con anni di lavoro alle spalle, da riassumere in 90 minuti. Un flm costruito per convincere, denunciare, risvegliare le coscienze. Un grido. Perché qui non c'è spazio per le vie di mezzo o le sfumature. Ne abbiamo parlato con Giulia Innocenzi, che ci ha raccontato anche le scelte personali da cui è nato questo lavoro, i tentativi di censurarlo prima della sua uscita, la fatica e i rischi dell'autoproduzione, ma anche la soddisfazione di vedere migliaia di persone in sala, inaspettatamente.
Food for Proft
25 MAGGIO 2024
Ci racconti come è nata l'idea? Cosa ti ha spinto a fare una ricerca sugli allevamenti intensivi e l'industria della carne?
Per quanto mi riguarda, tutto è cominciato dieci anni fa quando ho letto il libro di Jonathan Safran Foer: Se niente importa. Mi sono messa a fare delle indagini, a investigare su questo tema. Poi ho deciso di realizzare un documentario che parlasse di tutte le criticità degli allevamenti intensivi a livello europeo, compresa quella che per me è la contraddizione più grande, il fatto che stiamo fnanziando questo sistema con i soldi dei contribuenti.
Noi cittadini siamo anche inevitabilmente consumatori, che possono orientare la produzione in una certa direzione.
Le persone che vengono a vedere il flm alla fne chiedono sempre: cosa posso fare io? C'è un piano politico, e quindi la necessità di fare pressione sul sistema afnché cambi, votando alle elezioni, partecipando a iniziative
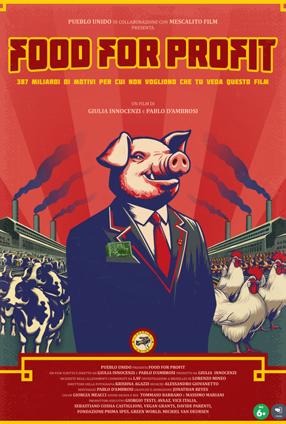
e manifestazioni. Poi c'è il piano individuale: tutti noi abbiamo una forchetta in mano, il nostro strumento più potente, il parlamento quotidiano, e possiamo decidere se fnanziare il sistema, mangiando latte e formaggi prodotti in questo modo, oppure se vogliamo dire no. Se tutti ci rifutassimo di consumare certi prodotti, questo sistema non esisterebbe più.
A volte anche chi lotta per l'ambiente e ha una sensibilità ecologica sembra dimenticare che l'industria della carne e gli allevamenti intensivi sono un problema enorme. Si fa fatica a trasformare l'idea in stile di vita, perché questa scelta richiede anche dei sacrifci, bisogna rinunciare a qualche piacere e comodità.
Richiede una scelta. Io non mi sento di fare una vita sacrifcata. A casa sono vegana e in giro vegetariana, per semplifcarmi un po' la vita, ma oggi la vita non è assolutamente difcile per chi non vuole mangiare carne. Dobbiamo essere noi ad aiutare il mercato a cambiare. Se i consumatori continuano a comprare certi prodotti, il sistema non cambierà mai.
Quanti anni ci sono voluti per realizzare il flm? Immagino che ci sia un'ampia aneddotica sui rifuti ricevuti dai produttori.
Ci ho messo più di cinque anni, proprio perché nessuno voleva aiutarci. Abbiamo dovuto produrlo io e Pablo da soli, e inizialmente anche distribuirlo. Alla fne chi ci ha aiutato più di tutti sono stati i cittadini. Abbiamo chiesto aiuto a loro, che hanno risposto in una maniera incredibile. È solo grazie a loro se abbiamo potuto organizzare proiezioni in giro per l'Italia. Hanno fatto mail-bombing alle sale per chiedere che venisse proiettato.
I produttori cosa dicevano? Tema scomodo? Genere che non tira?
Il problema più grande era la paura di beghe legali, che in efetti sono arrivate. Per ora siamo a quattro difde, vediamo cosa succederà. Io e Pablo abbiamo fatto un calcolo dei rischi e abbiamo deciso che era troppo importate uscire con questa denuncia pubblica.
26 MAGGIO 2024

Food for Proft

27 MAGGIO 2024

Abbiamo già ricevuto quattro diffde.
Nei momenti di sconforto ti viene da pensare che alla fne vincono sempre loro. Ma in realtà sono convinta che sono loro, come modello produttivo, ad avere le ore contate. La storia ci darà ragione
È stata una grande sorpresa leggere gli incassi e scoprire che Food for Proft era tra i flm più visti in Italia, insieme a kolossal come Dune. Chi è lo spettatore di questo documentario? Un vegano-vegetariano attivista? Un cittadino arrabbiato e anti-sistema? Lo spettatore di Report e Le iene? O magari una nicchia di pubblico che solitamente sfugge ai radar della distribuzione?
Ogni tanto facciamo anche alzare la mano, alla fne delle proiezioni, perché vogliamo capire che tipo di persone vengono a vedere il flm. E devo dire che la maggior parte degli spettatori sono onnivori. Questa per me è un'ottima notizia, vuol dire che siamo usciti dalla “bolla”, non ci sono solo vegani e vegetariani, che comunque ci stanno aiutando tantissimo. Ci sono anche molte persone che mangiano carne ma vogliono capire cosa c'è nel loro piatto.
Dopo aver visto il flm gli spettatori sono arrabbiati, indignati, ci chiedono se qualcuno sta facendo qualcosa, se c'è un partito che è intervenuto in qualche modo. Chiedono cosa possono fare. Sono dibattiti di una cittadinanza attiva. Io dico sempre che dobbiamo diventare cittadini responsabili, a partire dalle elezioni europee, premiare i candidati che si esprimono su questi temi, anche perché
saranno quelli che voteranno per la nuova Politica Agricola Comune nella prossima legislatura.
Qualcuno comunque vi sta aiutando, avete anche proiettato il flm al Parlamento Europeo.
Molte persone ci stanno aiutando. Per il Parlamento Europeo è stato innanzitutto Ignazio Corrao, per quello italiano Eleonora Evi. Poi, nella Regione Sicilia, Ismaele La Vardera. Al Consiglio regionale della Lombardia abbiamo proiettato il flm grazie ai Cinquestelle. In Emilia Romagna ci ha aiutato Silvia Zamboni dei Verdi. Ci sono politici e movimenti che ci stanno dando una mano. Poi, naturalmente, ce ne sono molti altri che ci stanno mettendo i bastoni tra le ruote.
Abbiamo letto le dichiarazioni di un consigliere della Lega emiliana che criticava il flm perché rischia di colpevolizzazione un intero settore. Sosteneva che in Italia non esistono allevamenti intensivi, che così si criminalizzano gli allevatori.
Si chiama Fabio Rainieri, è vicepresidente del Consiglio Regionale, e guarda caso è un allevatore. C'era anche lui alla proiezione e mi fa piacere che sia rimasto tutto il tempo a guardare il flm e a seguire il dibattito. Magari sveglieremo anche la coscienza di qualche persona che al momento la pensa al contrario.
Al Parlamento Europeo che reazioni hai ricevuto? Il flm nasce anche da un'indagine sotto copertura a Bruxelles, hai raccontato cose che magari qualcuno non voleva che si sapessero.
Al Parlamento, dopo la proiezione, ho avuto risposte positive.
28 MAGGIO 2024
Ma c'erano anche due persone che usavano il cellulare compulsivamente per flmare. Guarda caso erano due lobbisti della carne. Sono stati intercettati dall'inviato delle Iene, che ha chiesto cosa ne pensavano del flm; loro hanno risposto che “sono flm utili perché li aiutano a migliorare”. Dicono così davanti alle telecamere, poi dietro partono solo delle grandi difde.
Il greenwashing passa anche dal riuscire a recepire la sensibilità che cambia, vendendosi meglio al consumatore.
Esatto.
Eppure il Green Deal è una grande idea, una proposta importante, sulla carta.
Il problema è che a causa delle lobbies è stato smontato pezzo per pezzo. Se fosse stato applicato il Green Deal in quanto tale, sarebbe stata un'ottima notizia. Ma tante misure, dal no agli animali tenuti in gabbia all'utilizzo dei pesticidi, sono state spazzate via.
Perché hai scelto la forma cinematografca? In
fondo tu sei conosciuta soprattutto per i tuoi servizi d'inchiesta televisivi.
Un flm ha tutto un altro potere e lo stiamo vedendo con la difusione di Food for Proft. Ha la capacità di imporsi e di scatenare un dibattito, più di quanto possa fare un servizio televisivo. E poi volevo mettere tutto insieme in un'opera che diventasse una specie di compendio di ciò che non va negli allevamenti intensivi, di come li stiamo fnanziando e supportando. Volevo fare un prodotto internazionale, quindi potevo riuscirci solo con un flm: adesso l'obiettivo è farlo vedere in tutta Europa.
La produzione è frmata Pueblo Unido, nome suggestivo. Credi davvero che ci sia un popolo che non ha voce e che potrebbe avere la forza, la consapevolezza, la rabbia necessaria a cambiare il sistema? Che non viene intercettato dalla politica, le istituzioni, i tradizionali mediatori sociali?
Io credo che su un tema come quello degli allevamenti intensivi la maggior parte della popolazione sia contraria, però le minoranze organizzate riescono a condizionare la politica e a portare avanti questo modello.
Food for Proft

29 MAGGIO 2024
Solo ofrendo gli strumenti necessari all'opinione pubblica si può far partire un movimento dal basso e costringere chi sta in alto, i politici, a intervenire e cambiare. Quindi sì, ci credo tantissimo.
Ci sono spesso discussioni molto vivaci tra i sostenitori dei diritti sociali e quelli più sensibili ai problemi dell'ambiente, gli animalisti, gli ecologisti. Come se fossero due realtà contrapposte, che obbligano a decidere dove indirizzare le risorse economiche e le battaglie politiche. Anche qui c'è un grande lavoro da fare, dal punto di vista dell'informazione e della conoscenza. Perché le due cose, in realtà, sono strettamente collegate.
Alla fne Food for Proft è una critica al capitalismo. Si chiama così perché al centro ci sono gli allevamenti, ma avremmo potuto chiamarlo Pharm for Proft, se avessimo analizzato il settore sanitario. Ci sono tante declinazioni possibili. È proprio il sistema capitalistico che sta mostrando tutte le sue criticità. Di sicuro non può essere questo sistema a portarci fuori dalla crisi climatica. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo e di pensare a nuove soluzioni.
Hai già ricevuto quattro difde. Per non parlare dei personaggi poco raccomandabili con cui sei entrata in contatto durante l'inchiesta. Come ge-
stisci la paura? Lo stress? Certo, sei consapevole delle scelte che fai, è un lavoro che è una specie di missione, ma ti viene mai il dubbio che ne valga davvero la pena?
Mi faccio anch'io questa domanda nei momenti più critici. Ad esempio quando, prima di uscire con il flm, è arrivata la prima difda, da una delle aziende investigate, che fattura qualche miliardo di euro. Ho pensato: ma che senso ha stare a sbattermi in questo modo quando alla fne vincono sempre loro? Però succede solo nei momenti di sconforto, in realtà penso esattamente il contrario: sono loro, come modello produttivo, che hanno le ore contate. La storia ci darà ragione. Spero che un giorno guarderanno al 2024 e diranno: pensa che le persone tenevano gli animali in quel modo indegno solo per cibarsene e fare del proftto.
Ripetiamo la domanda più importante: cosa fare?
L'informazione e la consapevolezza sono il primo passo indispensabile, quindi bisogna aiutare il flm a continuare a girare (sul sito foodforproft.com è spiegato come). Poi c'è la proposta, che è politica, sociale, civile. E parte dalla richiesta di fermare i sussidi pubblici garantiti a questi luoghi di morte: «Purtroppo la maggior parte dei sussidi va agli allevamenti intensivi. Dobbiamo pretendere che i nostri soldi vadano a un'agricoltura verde, a favore degli animali e della nostra salute»

30 MAGGIO 2024

Si rilancia anche la moratoria su questo tipo di allevamenti, portata avanti da tante associazioni animaliste ed ecologiste. Infne si chiama a raccolta l'opinione pubblica: «Chiediamo la riforma della Politica Agricola Comune. Per dire la nostra vogliamo organizzare la prima Assemblea dei Cittadini sul tema. Per farlo occorre chiamare un campione rappresentativo della popolazione europea, che potrà discutere con esperti e rappresentanti del settore sulle potenziali riforme della Politica Agricola Comune, con un focus soprattutto sui
sussidi agli allevamenti intensivi e per una transizione verso modelli di agricoltura più sostenibili» Senza dimenticare che noi abbiamo in mano un'arma potentissima, quella dei nostri consumi. Non è indispensabile che tutti diventino vegani o vegetariani. Lo è però il fatto che siano tutti consapevoli di come viene prodotta la carne che decidono di mangiare, opponendosi a un sistema che trasforma gli animali in cose, mette in pericolo la salute delle persone e contribuisce all'inquinamento e al riscaldamento globale.
Food for Proft

31 MAGGIO 2024
 (foto Francesca Togni)
(foto Francesca Togni)
Paolo Spaccamonti
Nel torbido è il nuovo (bellissimo) album di un musicista "cinematico" che amiamo da sempre. Idee, esperienze, ispirazioni
Ti ricordi a quando risale il tuo primo incontro con la musica? Un disco, un concerto, uno strumento musicale. È stata una folgorazione o un innamoramento lento?
Una folgorazione. Da piccolissimo rimanevo incantato ogni volta che partiva la sigla di inizio trasmissioni Rai. Poi il mangiadischi di casa che mandavo in loop e che dovevano letteralmente strapparmi di mano con le forze. Per arrivare al primo concerto con i miei genitori, in uno di quei punti verdi di cui erano colme le città d’estate. Ricordo come fosse ieri quella sera: Ivan Graziani che ironizzava col pubblico, le donne che danzavano, i volumi altissimi. Mi sentivo al sicuro.
Sei stato anche un giovane metallaro. Si racconta però che eri terrorizzato dal palcoscenico. Arrabbiato ma non abbastanza…
Sì, da adolescente ho rastrellato tutto o quasi il metal, dall’hard rock al death/black. Ma l’idea del palco mi paralizzava, e ho abbandonato diverse band per quello. Fino a quando mi sono costretto a reagire, con i Chomski, nel 2005. Ricordo che per paura che succedesse qualcosa alla strumentazione mi portai dietro due cose di tutto: due amplificatori, due chitarre, due distorsori… E si ruppe la chitarra all’altro chitarrista. L’ansia a volte è lungimirante.
Parli spesso di te come di un autodidatta, che ama la “musica semplice”, ma questa tua semplicità suona complessa, raffinata, anche alternativa, soprattutto in un Paese come il nostro, in cui non c'è una grande cultura della musica strumentale. Si producono tante cose diverse e interessanti, piccole nicchie indipendenti, ma il mercato è dominato da ciò che passano radio e tv.
Per musica semplice intendo senza fronzoli o inutili virtuosismi, che non vuol dire banale. Sulla questione della nicchia non credo sia un problema solo italiano.
33 MAGGIO 2024
I NCONTRI
In America c’è gente come Jeff Parker che per sbarcare il lunario consegna pizze. La musica strumentale è sì musica per pochi, ma se promossa adeguatamente potrebbe arrivare a molti. Il problema sta a monte.
Trovo assurdo che alcune produzioni cinematografiche o teatri non investano sui compositori, preferendo affidarsi a tecnici o altro. Abbiamo dei musicisti in Italia che fanno spavento. Pensa solo ad Enrico Gabrielli con il collettivo 19'40'' o a Stefano Pilia, per dirne due. Dovrebbero stare in prima serata su Rai3 a spiegare la musica, supportati dalle istituzioni, come patrimonio nazionale da tutelare.
Invece per comporre musica da film spesso chiamano il divo di turno, sperando in un ritorno di immagine. E nei teatri è ancora peggio: si tende a tagliare sulla parte musicale buttando poi soldi in boiate come scenografie discutibili che neanche Ed Wood, pensando che la musica sia l’ultimo dei dettagli. È avvilente, e perdono tutti.
Fare musica in Italia rimane un lusso per pochi. Si naviga a vista. Gli spazi scarseggiano e non c'è nessun tipo di supporto. Ma non mi verrebbe mai in mente di fare altro
Come si è trasformato il tuo rapporto con la musica? È più importante il bisogno di esprimersi, di dare forma a qualcosa che senti e che sei, o quello di comunicare un messaggio o un'idea del mondo? È un gioco, musica per la musica, una specie di terapia, o un'occasione di condivisione? Per dirla in altri termini: conta di più la ricerca artistica, espressiva, o l'esperienza finale, collettiva?
Direi entrambe le cose. Se tutto si risolvesse nel pubblicare dischi sarebbe sicuramente bello ma mancherebbe un tassello, che è quello della condivisione dal vivo. Comporre è una terapia, non saprei farne a meno. Non ho la presunzione di fare musica per migliorare il mondo, sarebbe stupido pensarlo, ma per migliorare me sì. Sto meglio quando la faccio e immagino che questo influisca su chi mi sta vicino, creando una reazione a catena. Se tutti facessimo ciò che ci fa star bene, il clima generale sarebbe decisamente più disteso.
Tu hai l'abitudine di suonare anche in centri sociali, in luoghi di resistenza e ribellione. Quanto è importante questo aspetto del tuo essere musicista?
A volte accade che persone affini mi invitino a suonare da loro e ci vado volentieri. I luoghi di “resistenza e ribellione” spesso sono tra i pochi che promuovono determinate proposte, prendendosene i rischi, e non è casuale. Se dall’alto delle istituzioni la tendenza è di supportare contenuti vuoti e innocui, il contraltare non può che essere di ricerca e bellezza. Da ragazzino ricordo che per ascoltare musica "altra" bisognava passare per forza dai posti occupati, cioè svincolati da regole imposte. E ne ho grandi ricordi, di vicinanza e di rete.
Si riesce a vivere in Italia di musica indipendente, strumentale, magari anche di ricerca? Non viene ogni tanto la tentazione di cedere a qualche compromesso, per provare a rincorrere il gusto del “grande pubblico” (una sorta di entità mitologica, oggi blandita dagli algoritmi)? Oppure, molto semplicemente, ognuno è la musica che fa, non c'è possibilità di scelta.
34 MAGGIO 2024

Più che di vita parlerei di sopravvivenza. Gli spazi scarseggiano e, come dicevo prima, non c’è nessun tipo di supporto. Quello che mi ha aiutato negli anni è stato il diversificare, quindi non concentrarmi solo sul percorso solista ma aprirmi anche ad altre realtà come quelle del teatro, della danza, o dei cine-concerti. Mondi diversi in cui proporre la mia visione di suono e approccio all’arte, e alla vita. Detto questo, fare musica in Italia rimane un lusso per pochi, a meno che non si abbiano le spalle coperte. Si naviga a vista. Ma non mi verrebbe mai in mente di suonare altro o provare a rincorrere chissà quale pubblico. Non mi interessa e non saprei da dove iniziare.
Molto importante per te è stato l'incontro con il cinema, le sonorizzazioni dei film, a partire da Rotaie di Camerini nel 2010, fino ad arrivare ad esperienze straordinarie come quella dedicata a Dziga Vertov. Si dice spesso che la tua musica evoca il cinema, nel senso che genera immagini in movimento, sembra la colonna sonora di film mai realizzati. Da qui, forse, l'incontro fatale. Come si lavora su un capolavoro del cinema, evitando che la musica sia solo un commento?
L’approccio varia di volta in volta, in base al film e ai musicisti coinvolti. Nel caso di Vampyr, ad esempio, con il trombettista Ramon Moro si è deciso di scrivere tutto, andando a sottolineare gli aspetti cupi e deliranti. Con L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov (insieme a Stefano Pilia) abbiamo affrontato la pellicola in maniera completamente libera, improvvisando quasi tutto.
Paolo Spaccamonti
35 MAGGIO 2024
(foto Franco Rodi)

Ci sono flm a cui torno ciclicamente, come Ghost Dog, Quei bravi ragazzi, Io e Annie... Nella musica ascolto sin da ragazzo i Black Sabbath e i Boards of Canada, ma passo senza problemi da Paolo Conte agli Autechre, ascolto il rap americano e venero Mica Levi
In quel caso sul palco ci interessa restituire l’idea della ciclicità del film, che percorre l’arco di un’intera giornata. Nel farlo ci posizioniamo di fronte allo schermo, esattamente come il pubblico. L’impianto di sala diventa così il “nostro” strumento e anche noi ‒ dopo il cine-occhio, il cine-operatore, la macchina da presa e la città ‒ diventiamo parte del film. In generale direi che bisogna stare attenti a non suonare troppo didascalici, ma nello stesso tempo a non fuorviare quello che il regista voleva comunicare. È un equilibrio delicato.
Quali sono i film che ami di più, quelli in cui ti rifugi o in cui ti rispecchi in qualche modo?
Tantissimi. Ci sono film a cui torno ciclicamente come Ghost Dog, Quei bravi ragazzi, La mosca, The Funeral, Io e Annie… o il grande cinema italiano di Scola, Petri, Ferreri.
Tutti film a cui mi sono avvicinato da ragazzo. Negli ultimi anni mi sono invaghito del cinema greco: film come Miserere di Babis Makridis, Attenberg di Athina Tsangari o Suntan di Argyris Papadimitropoulos, mi hanno fatto impazzire.
36 MAGGIO 2024
Oppure il cinema di Aki Kaurismaki, con i suoi personaggi al limite, che non ridono mai. Gli unici film che patisco sono quelli in costume, non chiedermi perché. Ho fatto uno strappo solo per La favorita di Yorgos Lanthimos, padre di tutti i registi greci di cui sopra. Al cinema ultimamente ho amato Palazzina Laf di Michele Riondino e La zona di interesse
E la musica che ti fa bene? Quella di ieri e quella di oggi.
Come per il cinema, anche nella musica ho dischi che mi trascino sin da ragazzo, dai Black Sabbath ai Talk Talk o ai Boards of Canada. Dipende dal momento. Passo da Paolo Conte agli Autechre senza problemi. In generale mi sembra che veterani come Kim Gordon, Pj Harvey o Einstürzende Neubauten continuino a sfornare ottimi lavori. E poi direi il rap americano, da Westside Gunn a Pusha T. Il disco che ho ascoltato di più l’anno scorso è Travis Scott, per dire. C’è tanta freschezza in quella musica e mi rilassa. Per finire non posso non citare la compositrice Mica Levi, per cui nutro un’autentica venerazione.
Tu componi colonne sonore, crei musica per installazioni, oltre che sonorizzazioni, collabori con vari artisti, anche molto diversi tra loro, poi realizzi i tuoi dischi solisti e ti concedi anche qualche concerto in solitaria o con pochi intimi collaboratori. Qual è il “mondo” in cui ti senti più a tuo agio? Ce ne sono altri che vorresti cominciare a esplorare?
Non c’è un mondo in cui mi sento più a mio agio di altri. Ho un bisogno vitale di variare per rigenerarmi, e ogni contesto ha i suoi lati rassicuranti. Mi piacerebbe esplorare di più il mondo del cinema, delle colonne sonore, ma mi sembra un ambiente parecchio chiuso.
Paolo Spaccamonti

(foto Gianluca Camporesi)
L'immagine che abbiamo di te è quella di un musicista solitario, introverso, piegato sulla sua chitarra e i suoi pedali. Chi ti ascolta è chiamato a entrare nel tuo mondo. E però, allo stesso tempo, sembra anche di ascoltare un'orchestra intera, per la forza del suono e la ricchezza espressiva di certi arrangiamenti. È tutto semplice, minimal, ma è anche potente e visionario. Come hai trovato questa tua cifra? O è qualcosa che c'è sempre stato, che hai semplicemente assecondato? I tuoi mondi sonori hanno sempre qualcosa di estremamente evocativo, aprono porte, fanno viaggiare l'immaginazione. Sembrano il frutto di una lunga ricerca.
Ho un rapporto complicato con le defnizioni.
Quando mi chiedono che musica faccio, non so mai cosa dire. Da qualche tempo rispondo "musica cinematica", visto che mi occupo di sonorizzazioni. Spero solo che il mio tocco sia riconoscibile
È nato per caso. Anni fa la band con cui suonavo si è sciolta e ho iniziato a comporre per i fatti miei. Ci ho preso gusto, e una volta assemblati un tot di brani ho deciso di farne un disco (Undici pezzi facili) nel 2009. Da lì non mi sono più fermato. Direi che l’incontro determinante è stato quello con la violoncellista Julia Kent. Vederla sul palco, da sola, generare quelle musiche, mi ha estasiato. A quel punto ho deciso di provarci anch’io, ed è bellissimo averla poi ritrovata come collega e amica. Anche nel mio ultimo disco c’è un suo intervento, e quando arriva mi emoziono sempre.
Ti hanno infilato spesso nel calderone del post-rock. Qualcuno parla di “avanguardia”. Altri hanno evocato la “musica da film”, come fosse una categoria dello spirito (più che un genere), un certo modo di intendere i suoni e creare atmosfere evocative. Non è facile definire la tua opera. Eppure, dopo tanti anni, forse sarebbe ora di dire che esiste la “musica di Paolo Spaccamonti”, che è un insieme di tante cose, come capita spesso alla musica, ma è anche solamente tua.

38 MAGGIO 2024
Alena Ettea
Vampyr

La si riconosce al primo ascolto. Ha una sua anima, che va al di là delle scelte tecniche ricorrenti, e quindi suona in quel modo unico. Che rapporto hai con le definizioni? Cosa rispondi quando ti chiedono che tipo di musica fai?
Un rapporto complicato! Davvero, non so mai cosa dire. Da qualche tempo rispondo “musica cinematica”, ma solo perché mi occupo di sonorizzazioni. Per fare prima. Il miglior complimento è quello di aver generato un mio suono, quindi una precisa cifra stilistica, e ti ringrazio. Non mi è mai interessata la tecnica, né imitare gli altri. Quello che spero è che il mio tocco sia prima di tutto riconoscibile, nel bene e nel male.
Nel torbido dà l'impressione di essere un album molto personale, intimo, particolarmente sentito. Ci sono suoni e melodie che sembrano arrivare da molto lontano, un luogo interiore segreto, ricordi, sensazioni impalpabili. È qualcosa che evidentemente ha a che fare con la tua vita e il tuo modo di intendere la musica. O almeno così arriva a chi lo ascolta. Ci dici se è nato in circostanze particolari? Da quale idea o ispirazione?
È stato il primo lavoro ad essere ispirato da altri lavori, nello specifico lavori teatrali. Normalmente parto da zero quando compongo, lasciandomi andare alla fantasia. In questo caso quasi tutti i pezzi sono nati mentre lavoravo a testi teatrali e/o di video-arte. Quando ho iniziato a pensare al nuovo disco mi sono ritrovato tra le mani alcune bozze ispirate a quei lavori, quindi ho deciso di svilupparle e renderle autonome.
Perché Nel torbido? È come ti senti? È dove siamo tutti? Cos'è che non vediamo chiaramente?
Nel torbido arriva da una battuta di Tony Curtis (“Nel torbido si pesca meglio”) da Operazione Sottoveste, film del 1959 diretto da Blake Edwards.
Paolo Spaccamonti
39 MAGGIO 2024
(foto Rosi Dennetta)

Nel 2020 la Film Commission di Torino mi ha contattato per fare un concerto streaming nel Museo del Risorgimento di Torino, completamente deserto per via del lockdown. C’è anche un video su YouTube.
Il titolo è ispirato a una battuta di Tony Curtis da Operazione Sottoveste. L'ho sentita usare nel 2020, in pieno lockdown, per sdrammatizzare. Tony Curtis era uno dei soprannomi di mio papà, a cui è dedicato il disco
Con Paolo Manera - direttore del FCTP - si parlava di come eventi anche estremamente drammatici come la pandemia potessero aprire strade a iniziative normalmente non perseguibili, come quella appunto di suonare all’interno della Camera dei deputati del Parlamento Subalpino, luogo normalmente inaccessibile. Per giunta con la mia musica.
Quindi ha citato la fatidica frase, "nel torbido si pesca meglio", per sdrammatizzare. Eravamo tutti esausti. In effetti per me è stato davvero così: nel 2020 ho iniziato a collaborare in maniera continuativa con il teatro, tanto da licenziarmi dal mio lavoro storico. Mi si sono aperte tante occasioni lavorative, proprio nel momento più buio. Ovviamente avrei preferito succedesse diversamente, ma così è stato. Mi è sembrato quindi un ottimo titolo per il disco, ancor di più da quando ho realizzato che Tony Curtis era uno dei soprannomi da giovane di mio papà, a cui l'album è dedicato.
A volte sembra di percepire una malinconia dolorosa, quasi straziante, in altri momenti dell'album invece c'è una misteriosa felicità, molto delicata. Il finale ha qualcosa di magico, di mistico. Ci sono anche brani che sfiorano l'astrazione, come Salina, all'inizio dell'album, o quel pezzo incredibile che è I sogni non servono.
40 MAGGIO 2024
Ce ne sono altri più diretti, eloquenti. E c'è Nel torbido, la conflagrazione delle due anime, che genera qualcosa di esplosivo. In alcuni momenti lo spazio e il tempo si dilatano, ma si ha anche l'impressione che tu abbia cercato di togliere, condensare la materia, per andare all’essenziale.
Esattamente. Non mi andava di perseguire strade già battute in altri lavori, e ho optato quindi per l’astrazione, scolpendo i vari brani per farne risaltare l’essenza, buttando via il resto. Questo non sarebbe stato possibile senza l’apporto di Gup Alcaro, sound designer con cui collaboro da dieci anni. È stato lui a introdurmi e accompagnarmi a un approccio completamente diverso nella composizione e in studio di registrazione (e quindi anche nelle performance live). Ovviamente il tocco è sempre il mio, ma con lui diventa (anche) altro, e questo se inizialmente mi spaventava ora mi esalta.
Un album diverso da tutti gli altri (anche se si riconoscono i tuoi suoni e certe evocazioni). L'album migliore, forse. Sicuramente l'ultimo, o magari il primo. Come lo collochi nella tua produzione? Quali porte apre?
Quando esce un nuovo album non ho mai la lucidità per valutarlo. Ci ho passato troppo tempo dentro e devo prenderne le distanze. Spero sia un nuovo inizio del mio percorso.
Non mi andava di perseguire strade giù battute in altri lavori, e ho optato quindi per l'astrazione, scolpendo i vari brani per farne risaltare l'essenza, buttando via il resto.

Paolo Spaccamonti
(foto Francesca Togni)
Nelle terre del Nord per riscoprire che siamo natura (e mistero)
Un nuovo libro dell'esploratore che viaggia senza mappe e gps, e che ci racconta il suo ritorno in Norvegia
di Franco Michieli
Le vie invisibili (Ponte alle Grazie) è una narrazione di viaggio che ho portato
Abbiamo già incontrato Franco Michieli, sulle pagine di Redness (novembre 2022). Ci ha afascinato il suo modo unico di viaggiare ed esplorare, senza bussole e mappe, confrontandosi apertamente con il limite, il mistero, l'imprevisto. L'avventura e l'esplorazione come stile di vita, anche flosofco, dentro una logica per certi versi anti-moderna, lontana anni luce dall'efcienza arida e banale del viaggio minuziosamente organizzato. Non per niente ha scritto anche un libro su La vocazione di perdersi (Ediciclo) e sulla necessità di “farsi trovare dalla via”. Per ritrovarti devi prima perderti (sempre Ediciclo) è un altro titolo che vale come esortazione quasi spirituale, un suggerimento esistenziale. Franco Michieli è un divulgatore straordinario, per certi versi controcorrente, che insegna ad ascoltare il mondo e la natura (con empatia!). Ogni suo nuovo libro, per noi, è un evento. Accogliamo quindi con gioia Le vie invisibili, edito da Ponte alle Grazie, che racconta le sue avventure “nell'immensità del Nord”. E lo facciamo presentare da lui in persona. (f.t.)
dentro di me per decenni, mentre negli anni si sommavano le esperienze selvagge vissute nelle

terre del Nord. Luoghi a cui mi sono legato come a una seconda patria. Norvegia e Terra dei Sami, Islanda, Scozia, Fær Øer, Shetland, Groenlandia: vastità che in me, come nel racconto, non stanno sullo sfondo. Sono protagoniste. I loro eventi, la loro bellezza, il mistero dell’immenso, conducono l’andare di noi piccoli esseri umani e gli danno signifcato.
Non volevo che il libro uscisse senza aver ripreso contatto con la vera materia che lo ispira. Da quattro anni non tornavo nel Nord: la pandemia, lutti, dolori alle ginocchia.
42 MAGGIO 2024
L UOGHI
Prima di presentarlo in una serie di appuntamenti, di parlare in pubblico di cosa rappresenta questo racconto, sentivo il bisogno di riattingere a quegli orizzonti, così adatti a perdersi, lontano dai prodotti virtuali della mente umana che irretiscono il mondo. Sono tornato in Norvegia nel mese di marzo, con sci e slitta, in compagnia di Davide Ferro, che troverete con me anche in tre dei viaggi raccontati nel libro.
Un viaggio pensato nell’essenzialità: il grande altopiano innevato Hardangervidda, vasto circa 10.000 chilometri quadrati; un sito abitato da cui partire e dove tornare dopo due settimane in autonomia e isolamento; tre montagne ben riconoscibili in caso di buona visibilità all’interno dell’al-

Sopra, la traversata delle Shetland nel 2019
topiano, tra centinaia non identifcabili; la partenza senza possedere mappe, bussola, orologio, gps, cellulare; il proposito di compiere un anello in senso orario, libero, pernottando in tenda, sul percorso che sarebbe nato giorno dopo giorno. Un esercizio di meraviglia, di silenzio di informazioni, di dubbio e di fducia, un po’ anche di resistenza.
Ho, abbiamo, ritrovato quel senso
In basso, il viaggio compiuto nel marzo di quest'anno sull'Hardangervidda in Norvegia (foto Michieli)
di collaborazione tra noi e gli eventi naturali selvatici che ridà speranza alla vita; che fa pensare che perdendo la pretesa di controllo, sicurezza e programmazione del percorso umano, ma sostituendolo con attenzione e ascolto, si andrebbe per vie che rasserenano anziché impaurire.

Sono bastati un paio di giorni per farci ritrovare nell’ignoto, dentro vastità bianche e velate di brume che si succedevano senza interruzioni. Immensi falsopiani da cui si ergevano monti come grandi gobbe sovrapposte, ridondanti di neve, simili a nuvole nei vapori. Il sole appariva e svaniva, spesso era un fantasma dietro il nevischio, e ci faceva da bussola intermittente. Di incerta valutazione, perché per molte ore pareva sempre alla stessa altezza sull’orizzonte, e l’individuazione del Sud era molto approssimativa.
Andavamo verso il cuore dell’altopiano, prima a sud, poi a ovest, più avanti a nord, perdendo sempre più la cognizione di dove fossimo realmente, ma sapendo che con pazienza saremmo comunque sbu-
cati da qualche parte: una strada o un fordo.
«CI VOGLIONO ESSERI VIVENTI CHE CERCANO LA LORO VIA, TRA MILLE DESIDERI, EMOZIONI, OSTACOLI, PERCHÉ
L'INTELLIGENZA NASCA»
La luce, il vapore e l’aria posati sulla neve sono divenuti i compagni perenni dell’andare. Compagni multiformi e capaci di metamorfosi continue rispetto alla loro percezione comune. Gli efetti del whiteout, il fondersi del biancore della neve e dell’aria che fanno
sparire le dimensioni e le forme del terreno, si presentavano e sparivano tra continue variazioni. Ma il colloquio silenzioso più indecifrabile avveniva con le visioni della vastità che spesso si aprivano davanti a noi fno a orizzonti intermedi, tra i nostri piedi e nubi che nascondevano l’orizzonte ultimo. Ci pareva di afacciarci dall’alto su pianori ribassati che conducevano a monti sprofondati molto più in basso del nostro punto di vista. Eppure, avvicinandoli, questa perdita di quota non avveniva mai. Le gambe che avanzavano sugli sci sentivano sempre la fatica di aprirsi la traccia sulla neve in piano o in leggera salita, senza mai scendere. E quando, ore dopo, si arrivava alle remote montagne, s’innalzavano alte e ripide e occorreva aggirarle.

44 MAGGIO 2024
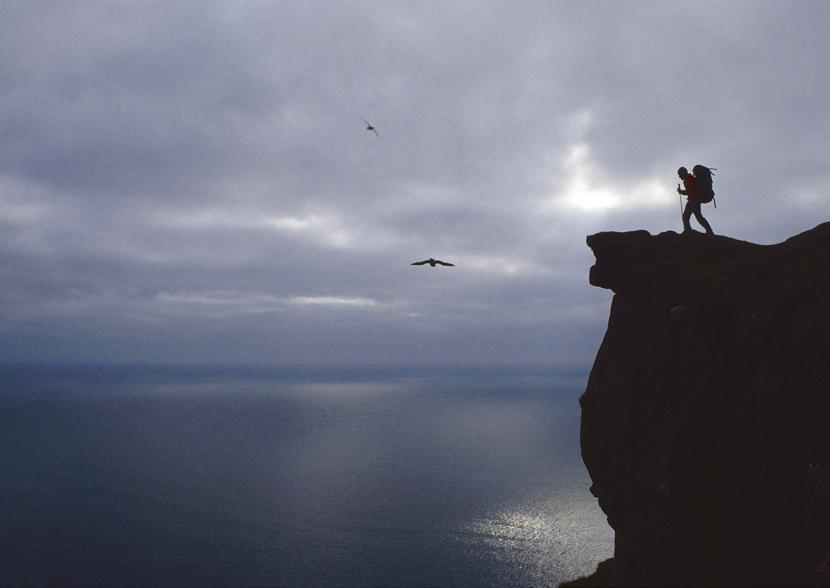
Un giorno ci trovammo di fronte a un bassopiano in evidente discesa; alle nostre spalle vedevamo la conca salire. Un grosso torrente, che a causa delle temperature ormai meno fredde che in passato scorreva per un tratto in una lunga apertura della neve, giungeva dal bassopiano, e lo vedevamo con certezza fuire in salita dietro di noi. Per quanto guardassimo, la vista confermava l’impressione. Era trascinante quel sentire di aver abbandonato non solo gli strumenti tecnologici, ma anche parte delle
abituali indicazioni dei sensi. Io ero meno stupito di Davide perché, come racconto in un capitolo del libro, avevo vissuto un simile miraggio sul ghiacciaio Vatnajökull, durante la traversata dell’Islanda. La ragione spiega che questi miraggi sono dovuti al sovrapporsi di strati di aria a diversa temperatura e densità, che rifrangono i raggi di luce mutando la loro direzione. L’alto può diventare basso e viceversa. Ma non è questo che conta. È che là, nella solitudine fsica, le nostre
Sopra, una visione magica alle Fær Øer nel 1996
Nell'altra pagina, l'esplorazione del Langjokull in Islanda nel 2018 (foto Michieli)
impressioni erano continuamente sottoposte alla verifca del corpo. Bastava mettersi in marcia e sentire con le gambe il reale andamento della superfcie per cambiare l’interpretazione dell’apparenza. Ne abbiamo parlato spesso, in viaggio, dell’inganno della mente pura, della cosiddetta intelligenza artifciale. In contrapposizione a ciò che stavamo vivendo.
45 MAGGIO 2024

Sopra, la traversata del Lyngsalpen in Norvegia nel 1999. In basso, un momento del viaggio in Islanda nel 1991 (foto Michieli)
Perché l’intelligenza appartiene alla vita, a tutta la vita, ed esiste solo come espressione e funzione di corpi viventi. Non si può tirare fuori dalla vita la capacità di calcolo, combinazione e analisi matematica e chiamarla ancora intelligenza. Ci vogliono esseri viventi che cercano la loro via tra mille desideri, emozioni, ostacoli, perché l’intelligenza nasca. Perciò andavamo avanti nell’incertezza, e le motivazioni che mi avevano ispirato a scrivere erano confermate.
Solo una sera, per un breve momento, abbiamo scorto a grande distanza le tre montagne note che potevano farci da riferimento. Una in particolare è sparita per sempre e non ci siamo capacitati di dove fosse fnita. Tanto che dopo nove giorni i dubbi su dove fossimo erano pressanti. Siamo entrati in una sorta di porta fra due alture dirupate che si è rivelata una gola
sinuosa incisa tra pareti. Non fniva più e ho capito che aveva un chiaro signifcato geologico: l’acqua incide così la roccia solo se appena oltre c’è un forte dislivello verso il basso. Forse eravamo ai confni dell’altopiano, dove per
lunghe distanze precipita nei fordi, più bassi di oltre 1000 metri. Ma dove su questi confni? Temendo precipizi, siamo tornati indietro e ripartiti accanto alle alture.
Tra me e me mi sono rivolto

46 MAGGIO 2024
al cielo, perché trovassimo un indizio. Poco dopo, oltrepassando un crinale brumoso, è apparsa una valle che sprofondava tra i monti: lontano c’erano boschetti di betulle e sagome di edifci; più a monte, la linea di una strada, dell’unica strada. In un solo sguardo tutto si era chiarito: sapevamo dove eravamo, sulla buona via per compiere l’ultima parte dell’anello verso il punto di partenza. Ci siamo arrivati con puntualità, attraverso tormente e whiteout, il quattordicesimo giorno.
Per gran parte dell’andare abbiamo incrociato orme di animali sulla neve: renne selvatiche, alci, volpi, lepri, topolini, pernici bianche e forse altri. Solo gli alci, le pernici e un topolino si sono fatti vedere. Esperienze come queste ci avvicinano agli animali; la povertà di mezzi stimola l’empatia.
Prima e dopo il viaggio mi ha accompagnato una piccola esperienza con un animale per nulla nordico. Ero a casa, alla fne di febbraio, e una mosca che si era

risvegliata in anticipo a causa delle alte temperature vagava stanca sul pavimento. La raccolsi e posai sul tavolo; immaginai che avesse sete, così deposi davanti a lei con un dito una goccia d’acqua. Subito si avvicinò e bevve con la sua minuscola proboscide. Allora pensai di mettere vicino anche una piccola goccia di marmellata, doveva avere fame. Assorbì anche un po’ di quella sostanza, ma senza esagerare, e poi si sofermò a strofnarsi le zampette e il muso. Mi venne un pensiero ispirato dalla cronaca:
che la bacheca della Gioconda, al Louvre, poteva essere coperta di minestra tutte le volte che si voleva. Anzi, che per me la Gioconda stessa poteva sparire nel nulla, se in cambio continuerà a esserci una mosca d’inverno che viene a bere alla mia goccia d’acqua.
Leonardo lo sapeva: di Gioconde poteva dipingerne quante voleva, ma creare una mosca vivente, chi poteva farlo?
Sopra, la traversata della Norvegia nel 1985. In basso, il viaggio in Groenlandia del 1994 (foto Michieli)

La bellezza travolgente di una terra smisurata
"Le vie invisibili": il puro piacere del racconto e le intuizioni inefabili
Sembra quasi di sentirlo, il profumo dei pini silvestri che investì Franco Michieli, quando la nave su cui viaggiava entrò in un ampio fordo, procedendo verso Kristiansand in Norvegia. Comincia così Le vie invisibili (Ponte alle Grazie), con il suo primo viaggio nel profondo Nord, nel 1983, insieme a un amico, quando aveva solo 21 anni. Comincia dalle sensazioni travolgenti suscitate da quella brezza profumata, quasi avesse scoperto «una sorgente remota della vita»
L'abbiamo provata tutti quella sensazione, almeno una volta. Ma Franco Michieli ha continuato ad alimentarla, ad attingere a quel mistero profondo a cui va incontro in ogni sua avventura. Un
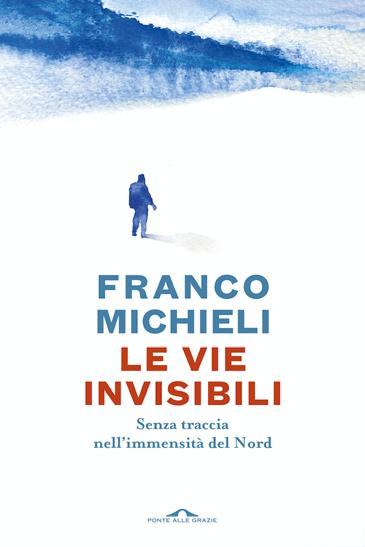
esploratore come lui, che ama confrontarsi con l'imprevedibile, non poteva che innamorarsi di quelle terre sconfnate, in Norvegia come in Islanda, in Groenlandia o nelle Shetland. Un'immensità smisurata, senza limiti, che Franco Michieli ci fa conoscere attraverso i suoi ricordi.
Dieci capitoli per dieci viaggi diversi. Partendo da un preludio che è una “rivoluzione”, ricordando il bambino che passava ore sugli atlanti, in beata contemplazione, sognando di “salvare la natura”, destinato a diventare un geografo che predilige l'esperienza alla teoria, e poi (dopo il 1998) un esploratore che rifuta le semplifcazioni tecnologiche, afdandosi ai propri strumenti sensoriali e cognitivi (quelli usati da sempre dall'uomo), alle mappe mentali. Non per inseguire chissà quale record o impresa: «La “limitazione” dei mezzi tecnici ha lo scopo di salvare la conoscenza di alcune dimensioni primarie del vivere, già perdute nel quotidiano, e la loro ineguagliabile bellezza, ed è una necessità che ci riguarda tutti». Come ci riguarda l'accettazione della nostra impermanenza, e la consapevolezza che lo sviluppo tecnologico debba rimanere «entro limiti non autodistruttivi»
È un ritorno alla natura, al corpo, ma anche all'interiorità e alla coscienza umana. Perché viaggiando in questo modo si ritrova quella condizione fondamentale in cui «il visibile e l’invisibile vengono percepiti di prima mano, senza mediazioni, in intimità. E tutto partecipa alla nostra storia. È questo il tesoro nascosto tra gli orizzonti».
L UOGHI
Michieli è anche uno scrittore, un ottimo narratore. Questo libro, più di altri, si può leggere come una raccolta d'avventure, con il suo altrove da scoprire, i luoghi mitici e le scoperte metaforiche. Non è un caso che, all'inizio del libro, compaiano citazioni che omaggiano Omero e Melville (l'Odissea e Moby Dick, naturalmente). In efetti è bello perdersi dentro queste storie-diari, fatte di cose piccole, quotidiane, dettagli di viaggio, suggerimenti per aspiranti esploratori, ma anche di incontri indimenticabili e intuizioni inefabili.
Domina il puro piacere del racconto, che non ha bisogno di troppe spiegazioni e commenti, che invita il lettore a perdersi, con semplicità, tra alte cime e vaste pianure innevate, boschi, brughiere e ghiacciai, tempeste e nebbie impenetrabili. Salvo ritrovarsi, più di una volta, letteralmente travolti

dalla bellezza delle cose, magari «in quella segreta condizione in cui l'afaticamento accumulato non ottenebra i sensi, ma li libera dalle pretese della mente, li rende trasparenti alla luce irradiata dai linguaggi non umani delle infnite creature». Come quando, alle Shetland, si ritrovò a passeggiare sul ciglio di una falesia, tra rocce che ospitavano migliaia di sule, grandi uccelli bianchi dal capo giallo, sopra l'oceano che ribolliva
schiumando, e i gabbiani in volo, quasi «galleggiando su cavalloni d'aria», tra il blu del cielo e il turchese del mare. Tornato nella tenda si limitò ad annotare poche parole: «Visione travolgente, bellezza inspiegabile, e assoluta miseria dell'uomo che presume di valere più di tutto questo»

49 MAGGIO 2024
Altre due immagini del viaggio in Norvegia nel marzo 2024 (foto Michieli)
Il sesso del popolo, libero e feroce Poesie di carne e gioia disperata
IL DIALETTO È MUSICA E RIVELAZIONE, NEL LIBRO STRAORDINARIO DI BALOCCHI
CHE CANTA L'EROS LOMBARDO, TRA VITALISMO BLASFEMO E MAGIA SACRA
«Tì, femina granda, gemu ta saveva che vorevi tornà / lì, in del venter, giù in del bus, a cà. / Per tuscòss, giboll, fam, desmentegà».
Non bisogna per forza essere lombardi e milanesi – o meglio ancora, “biagrassin” (abbiatensi) – per apprezzare la musica e la forza evocativa di queste parole. Non è solo poesia, è un'invocazione, immaginazione viva, pedestre e sacra come la terra, che ci porta dentro un altro mondo (interiore, prima di tutto).
La traduzione italiana non rende l'idea: «Tu, femmina adulta, / già sapevi che volevo tornar / lì, nel ventre, giù nel buco, a casa. / Per tutto, lividi, fame, dimenticare». L'italiano banalizza, appiattisce, tradisce la forza delle parole in dialetto. Sono letteralmente due modi diversi di vivere e pensare la realtà.
Luigi Balocchi lo dice da sempre. Lo scrive e lo pratica tutti i giorni. Poeta e romanziere, provocatore profetico, vive il dialetto come fosse uno spazio e un tempo a parte, anzi l'unico davvero importante, con le sue cose (la roba e la natura) che esistono solo in quella lingua, i sapori e gli odori dimenticati, le persone rimaste ai margini della modernità globalizzata, mercatista e consumista.
"Fà l'amour, fà l'eterna" (fare l'amore, fare l'eterno). Il sesso come via di redenzione, citando anche Edgar Lee Masters e Querelle de Brest
Nella sua poesia il sesso non è mai mancato, così come il cibo, la fame, il sangue, la carne del mondo, nuda e cruda, la realtà più “bassa” e “sporca” (parole che in italiano suonano negative, a cui il dialetto restituisce dignità e vitalità). Ma nel suo ultimo libro, Barlicch Barlòcch – Poesie dell'eros lombardo (edito da Manni), il sesso è protagonista assoluto, è ossessione e ispirazione, è feroce, spudorato, esplicito, con sprazzi di improvvisa tenerezza, è esperienza che dà un senso al corpo e insieme lo trascende, dentro la disperazione quotidiana. Parliamo di qualcosa che da tempo ormai (in italiano), è ridotto a chiacchiera sterilizzata e un po' isterica, a battuta di spirito, a banale psicologia o facile sociologia. Qui invece, grazie al dialetto, alla sapienza popolare, si torna alla carne senza fronzoli, al desiderio puro, si attraversa una dimensione quasi magica (glorie e miserie) e si approda alla provocazione di un vangelo della carne, una celebrazione anche blasfema, che ribalta il sopra e il sotto, sublima il “diabolico” del sesso (una certa tradizione cristiana del peccato e i pericoli della carne), lo eleva riportandolo alla sua bassezza terrena, lo sacralizza.
50 MAGGIO 2024
T ERRE DI CONFINE

«Al sess a l’é ona straa de redensiòn» (“il sesso è una via di redenzione”), scrive Balocchi, che si dona alla sua Ròbi, omaggia Edgar Lee Masters e Sarah Brown («l’é travers al mè còrp, come on cadò a tì donaa, che som rivaa al mè spirit», “è attraverso il mio corpo, a te donato, che ho raggiunto lo spirito”), evoca Querelle de Brest, («che ’l rusa ben, sto nòster amour grev. / Che l’é de laver, de bigul, de ciapp», “che dentro ben spinga, questo nostro fondo amore. / Fatto di labbra, di cazzo, di culo”), fa rivivere un antico incantamento d'amore della valle del Ticino («Con bas e cadènn, ta tegni / sicur, ta strengi, ta sgagni, ta casci / via al scur», “Con baci e catene, ti tengo / al sicuro, ti stringo, ti mordo, ti scaccio / l’oscuro”).
Un conto è dire, rozzamente, “for di cazzi” e “luccichio di chiappe”, un altro è cantare «Spunten fur de bigul in doe ta passa / tì, al tu sbarlusc de ciapp, a somenà / sti nòster terr, bej che succ» ("sbocciano for di cazzi dove tu passi, / il tuo luccichio di chiappe a seminare / queste nostre sterili terre"). Come scrive nell'introduzione Fabio Pusterla, grande poeta contemporaneo e vero intenditore, «questa è una poesia che non può che nascere in dialetto, dentro la densità materica del dialetto e del mondo che il dialetto rappresenta». Lo dice sulla scorta di ciò che insegnava il linguista Angelo Stella, secondo cui è assolutamente inutile scrivere in dialetto ciò che potremmo scrivere anche in italiano, usandolo come fosse un vezzo nostalgico o un artifcio retorico.
Come scrive Fabio Pusterla «questa è una poesia che non può che nascere in dialetto, dentro la densità materica del dialetto e del mondo che rappresenta. Slancio vitale e sessuale e senso di morte si stringono costantemente in un abbraccio»
Nel dialetto di Balocchi si respira «la fangosa pastosità della terra, il vitalismo di chi sopra o dentro questa terra vive, sopravvive e poi muore ricadendo nell’oblio; ma insieme al vitalismo si avverte subito una disperazione profonda, dentro la quale slancio vitale e sessuale e senso di morte si stringono costantemente in un abbraccio». Mai dimenticare, infatti, la lucida consapevolezza del poeta – o la sua allucinazione lirica, la possessione luciferina, a seconda dei punti di vista – che vede il vuoto intorno, un mondo decadente, una realtà malata, sprofondata nella dimenticanza di sé, nel tradimento delle sue tradizioni, nella svendita dell'anima al miglior oferente.
51 MAGGIO 2024

«Gioia e autodistruzione», come scrive Pusterla, desiderio di precipitare nel gorgo (il gulgher) inghiottito per sempre nel bus (anzi “i buchi”, elencati con furore pantagruelico dentro un omaggio a Carlo Porta). Una voglia che si rifette nella fame insaziabile, nel cibo, «un rosario di luganighe, burro, cassoeula, polenta, confetti, biscotti, mortadella di Bologna, sanguinacci, in una sarabanda di nuovo ossessiva che potrebbe ricordare il credo di Margutte o certi versi folenghiani, e che afonda le sue radici in quella che Pasolini chiamava la lunga età del pane, dei bisogni primari». Chi legge Redness ha imparato ad apprezzare il modo in cui Balocchi racconta gli “irregolari”, i letterati borderline, i profeti inascoltati, da Bruno Brancher a Lucio Mastronardi. Il suo mondo è quello lì. E lo trovate dispiegato anche qui. Trovate il fume (il Ticino), il Naviglio, la campagna, gli sconftti tanto amati, le radici che nutrono, il vagabondaggio senza meta, la celebrazione della vita insieme alla paura di perderla. Al Vangel del Barlicch – parola che oltre a indicare il diavolo, veniva usata come avverbio, un intercalare che indica un fatto inevitabile - è anche una sfda plateale al “politicamente (linguisticamente) corretto”, provoca, cerca lo scandalo, ma in modo quasi fanciullesco. A volte la poesia diventa flastrocca, gioco di parole: «A strus per i streccioeu, ch’hin / bagnaa da la broeuda d’ona brugna / che la berbella» ("a zonzo per i vicoli, che sono / bagnati dalla broda di una fga / che tremola di piacere"); «Al tu bel cuu l’é taccaa al ciel, lì ch’el spetta / che ’n bigul de vent la faga sgorattà; / quel ciel ciar, ciara niula de ciapp» ("il tuo bel culo è appeso al cielo, lì in attesa / che un refolo di vento lo faccia svolazzare; / quel cielo chiaro, chiara nuvola di chiappe").
«La più concreta carnalità come unica strada per affrontare l'ostilità del mondo; questa è forse la scintilla di verità che si sprigiona in questo libro, in cui l'autore dissimula la sua cultura e il suo pensiero, e si traveste da giullare, in nome dell'amore, vertigine ultima»
Ma capita che la poesia si elevi a canto sacro, e oltre la terra si spalanchi il cielo - «Fà l’amour, fà l’eterna» ("far l’amore, far l’eterno") – celebrando la gioia matta del disgraziato felice, anche solo per un attimo, che vale l'eternità. Si tratta pur sempre di poesie d'amore. «L’amore – scrive Pusterla - inteso nella sua più concreta carnalità, come unica strada da trovare e percorrere per afrontare l’ostilità del mondo; questa è forse la scintilla di verità che si sprigiona in questo libro, in cui l’autore dissimula la sua cultura e il suo pensiero, si traveste da giullare, in nome di quell’amore/pane da spezzare, nevrosi e speranza, vertigine ultima».
52 MAGGIO 2024
Come si diceva al Tirinnanzi un paio d'anni fa, ai tempi del Coer Scorbatt – Balocchi nel 2022 ha vinto il premio italiano più importante dedicato alla poesia dialettale – siamo pur sempre alla fne di un mondo, un disastro compiuto: «Disastro: assenza cioè di astri, di orizzonti superiori e metafsici, di magnifche sorti; è questo il luogo di fango, sangue, memoria e concretezza a cui Coeur scorbatt caparbiamente torna, come per cercare un radicamento senza consolazione in una terra devastata».
Ma anche stavolta, anzi di più, tra uno sberlefo sulfureo e una nostalgia che dilania, si apre la possibilità di un riscatto befardo, lirico e ludico, un'illuminazione maleducata, un godimento che ha una sua qualità salvifca. D'altra parte, come dice l'Ezra Pound dei Cantos, citato in apertura: «Da tutta questa bellezza qualcosa deve uscire».
Barlicch barlòcch
E ta savree che i idei, che la bucca na bordéghen, barlicch barlòcch, debòn varen on’ostia; che l’etaa de quella terra chì la va giù, giù in fund, fna al dì che la crèpa, num tucc a brascett con lee. Per quest, mì barlicch, ta disi vegna! vegna chichinscì, a suscià quel mel che, di bròcch de la rura granda, dura la rura e ch’el dura, ab eterno, al suta a sguttà. Stòppom la trista buccascia, sfondemel denter. Scolta, là, a la fn, al sgarì di qj milla scigal.
(E saprai che le idee, che ci sporcano la bocca, barlicch / barlòcch, / valgon nulla per davvero; che l’età di questa terra / declina, fno al giorno della morte, noi / tutti a braccetto con lei. Per questo, io demonietto, ti dico / vieni! Vieni qui, a succhiare quel miele che, dai rami / della grande quercia, dura la quercia e che duri, ab eterno, / continua a gocciolare. Tappami la triste boccaccia; sprofondamelo / dentro. Ascolta, là, alla fne, l’urlo lontano delle mille cicale)

Tuto è Coscienza: lo dicevano i Veda, lo dirà anche la scienza
L'AFFASCINANTE
TEORIA DI TONY NADER, CHE NASCE DALLO STUDIO
DELLA MENTE E DALL'ESPERIENZA DELLA MEDITAZIONE (TRASCENDENTALE)
Ese alla base di tutto ci fosse la Coscienza? Scritta con la lettera maiuscola, per non confonderla con quell'altra, di cui tutti facciamo esperienza in ogni momento, ma che abbiamo ridotto a un efetto casuale dell'evoluzione, un ulteriore elemento di separazione (io e gli altri).
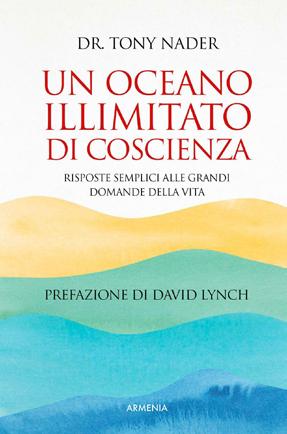
In realtà le due cose corrispondono, pur su due piani diversi (individuale e universale). Motivo per cui questa intuizione – che come vedremo non è solo un'idea, un'astrazione flosofca, ma il frutto di un'esperienza – risulta decisiva per rispondere alle grandi domande della vita.
Ipotizziamo che la Coscienza sia «tutto ciò che è». Per la precisione «un unico campo di Coscienza che è completamente non-fsico e immateriale», ma che «allo stesso tempo è tutte le cose, e queste cose sono prospettive all'interno della Coscienza che guarda il suo Sé da punti di vista infnitamente diferenti».
Si presenta così l'afascinante teoria del neuroscienziato Tony Nader, certamente rivoluzionaria, ma perfettamente in linea con lo sviluppo del pensiero contemporaneo: la scienza, dopo aver compreso che la materia in realtà non è altro che energia, andando alla ricerca di una teoria che possa unifcare le “leggi fondamentali”, è arrivata a ipotizzare, a livello quantistico, l'esistenza di un “unico campo unifcato”. Qual è il costituente fondamentale di questo livello della realtà, in cui sembrano dominare la casualità, l'incertezza, la non-località? L'ipotesi è che abbiano ragione i Veda, i testi sacri dell'India, quando parlano di un “campo di Coscienza” all'origine di tutte le manifestazioni della realtà.
L'intuizione nasce da un incontro, quello tra il medico libanese Tony Nader e un fsico indiano, diventato monaco sull'Himalaya e poi maestro e punto di riferimento per milioni di persone, grazie alla Meditazione Trascendentale: Maharishi Mahesh Yogi.
I DEE 54 MAGGIO 2024

Un incontro folgorante, paradossale, visto che Nader, nel bel mezzo di una guerra civile, alla prese ogni giorno con il dolore delle persone che incontrava nel pronto soccorso in cui lavorava, vide quest'uomo in tv che diceva: «Lo scopo della vita è l'espansione della felicità. La vita è beatitudine e la soferenza non è necessaria». Quasi una provocazione. Chi conosce la storia della MT (Meditazione Trascendentale) sa quanto siano state fatali quelle parole ascoltate da uno schermo televisivo. La scoperta che l'esperienza di pienezza, beatitudine, pace imperturbabile di cui parlano cercatori spirituali, maestri, santi, non fosse per forza il frutto di un'ascesi mortifcante, di una fuga dal mondo, ma «un diritto di nascita per tutti». Attraverso la meditazione, spiegava Maharishi, si può fare esperienza della “pura Coscienza” in modo semplice e naturale, andando in profondità nel proprio sé interiore, trascendendo l'attività della mente. Nader racconta così la sua prima esperienza meditativa, ripetuta poi innumerevoli volte: «Ho sperimentato che la mia mente si assestava in un luogo che non avrei mai immaginato possibile. Nessun pensiero, nessuna immagine, nessuna paura, nessun confne, nessuna preoccupazione – solo puro essere, puro profondo silenzio
interiore, pace interiore, ma con una vigilanza illimitata, un risveglio senza limiti (…) Mentre futtuavo in quella serenità, tutto svaniva, ma allo stesso tempo non mancava nulla»
I benefci che la meditazione apportò nella sua esperienza quotidiana furono così profondi che decise di dedicare tutta la propria vita a questa scoperta, mentre si formava ad Harvard e al Massachusetts Institute of Technology, fno a collaborare direttamente con Maharishi e ad essere scelto come suo successore. Uno scienziato si è così ritrovato alla guida del movimento nato per portare la Meditazione Trascendentale in ogni angolo del mondo.
Una visione della realtà scaturita dall'incontro tra il medico libanese, poi diventato neuroscienziato, e il maestro indiano Maharishi Mahesh Yogi, che era anche un fsico. Nader oggi è alla guida del movimento mondiale della MT
55 MAGGIO 2024
Tony Nader

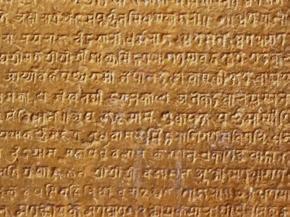
Il libro Un oceano illimitato di coscienza (edito in Italia da Armenia, pubblicato per la prima volta nel 2021) è il frutto di tanti anni di meditazione e di ricerca scientifca, di studio della mente umana e dei Veda. Un intreccio intrigante e illuminante – con una sua logica, una ragionevole plausibilità, ma anche la capacità di far appello a un altro tipo di conoscenza –che ambisce a proporre un vero e proprio cambio di paradigma. Partendo dalla convinzione che l'approccio riduzionista di tanti scienziati ormai abbia fatto il suo tempo: l'idea della coscienza come un prodotto della fsiologia, una proprietà emergente, è solo il frutto degli «“occhiali” che indossiamo», il dogma per cui «il campo fsico o materiale è ciò che è reale»
Nader attraversa la storia della flosofa e della scienza per raccontare come siamo arrivati alla possibilità di formulare una “teoria del tutto”, che riesca a includere anche la gravità dentro la “grande unifcazione”, in cui sono comprese l'elettromagnetismo (magnetismo ed elettricità) e le forze nucleari (debole e forte). L'universo materiale è stato defnitivamente decostruito

Unire ricerca scientifca e spiritualità, tradizione religiosa e innovazione tecnologica, abbattendo le barriere che separano le varie discipline e aree del sapere umano. Ecco uno degli obiettivi portati avanti da Tony Nader (immagini dal video "Know your Self to be everything", dal sito www.drtonynader.com)
dalla ricerca scientifca, anche se questo straordinario sconvolgimento fatica a entrare nella percezione del senso comune (e, all'opposto, rischia di diventare un gingillo new age). Come diceva il fsico e matematico James Jeans già nel 1934, «in generale l'universo mi sembra più vicino a un grande pensiero che a una grande macchina. Potrebbe benissimo essere che ogni coscienza individuale debba essere paragonata a una cellula cerebrale in una mente universale».
Non viviamo più nel mondo meccanico che aveva ipotizzato la scienza ottocentesca, per questo dovremmo anche abbandonare i nostri vecchi modelli che legano la coscienza alla materialità del cervello. Per dirla con il biologo premio Nobel George Wald: «La mente, invece di emergere come un'escrescenza tardiva nell'evoluzione della vita, è sempre esistita come matrice, sorgente e condizione della realtà fsica». Forse il concetto di “campo” non è così immediato per tutti, ma è fondamentale per capire la direzione in cui si sta orientando la nostra conoscenza. Dovremmo smetterla di pensare a una realtà fatta di particelle, per quanto sempre più piccole. «Gli elettroni non sono che eccitazioni di un campo sottostante», come scrive il premio Nobel Franz Wilczek.
56 MAGGIO 2024
Tutto dipende da cosa e come guardi, a quale livello della realtà presti attenzione: c'è la nostra esperienza sensoriale, che vede oggetti solidi e cose materiali; ci sono gli elementi di cui è fatta la materia, le particelle che si combinano tra di loro; e poi ci sono i campi quantistici, che è impossibile vedere per noi che viviamo «solo nella diversità, il campo “relativo”». L'idea base di Nader è che esista «un campo unifcato, una singolarità» che è un «puro campo di Coscienza», di cui peraltro si può fare esperienza nella meditazione. In questa prospettiva torna ad essere di attualità l'antica tradizione vedica, con le sue «tecnologie pratiche per lo studio, la comprensione e l'applicazione della Coscienza». Anche perché, come abbiamo ormai capito, grazie ai paradossi della fsica quantistica, l'osservatore in realtà modifca la realtà osservata, tanto che John Wheeler propone di chiamarlo “partecipante”, dentro un «universo partecipativo»
Come spiega, con una battuta, lo psicologo di Harvard Steven Pinker, «le domande che una volta erano confnate alle speculazioni teologiche e alle discussioni fra amici a tarda notte, sono ora all'avanguardia delle neuroscienze cognitive». D'altra parte nessuno, fno ad oggi, è mai riuscito a spiegare neppure lontanamente
come una fascio di neuroni «sia in grado di eseguire i milioni di calcoli che danno origine all'esperienza soggettiva di un individuo», così come alla Nona Sinfonia di Beethoven, l'Amleto di Shakespeare o il Large Hadron Collider.
Chi è impegnato in una ricerca interiore o porta avanti una pratica meditativa quotidiana, probabilmente ha fatto esperienza di quello che, a partire dagli anni '70, viene chiamato “quarto stato di coscienza”, proprio grazie alle ricerche scientifche promosse dalla MT. I primi tre sono quelli che tutti conoscono: veglia, sogno, sonno profondo. Il quarto è lo stato di turiya, per usare un termine della tradizione yogica, la combinazione paradossale tra una dimensione di grande riposo fsiologico (più profondo del sonno) e una tranquilla vigilanza, una consapevolezza espansa. È ciò che la MT defnisce trascendenza, o coscienza trascendentale. La coscienza che sperimenta se stessa. La verità ultima dell'Essere, che si può chiamare Sé (con la maiuscola). Se vogliamo darne un signifcato religioso, si può chiamare anche “comunione con il divino”. La biblica “pace che supera ogni comprensione”.

57 MAGGIO 2024

Maharishi Mahesh Yogi (in un'immagine presa dal sito www.drtonynader.com)
Nell'altra pagina, un gruppo di meditanti italiani che ha partecipato all'Assemblea per la Pace in India, praticando tutto il giorno per settimane (vedi Redness di marzo 2024)
«Ho sperimentato che la mia mente si assestava in un luogo che mai avrei immaginato possibile. Nessun pensiero, nessuna immagine, nessuna paura. Solo puro essere, pace interiore, un risveglio senza limiti»
È partendo da questa esperienza che Tony Nader – e non solo lui – propone di ribaltare i termini della questione, per dire che forse il cervello è solamente un «trasduttore di Coscienza», visto che la Coscienza «nella sua natura essenziale è oltre il cervello e oltre l'individualità. È il puro Essere illimitato, il Sé di tutto e di tutti, il campo unifcato». E se è vero che la Coscienza è tutto ciò che è, pensieri, alberi, pianeti, universi, si spiegherebbe anche perché hanno così successo certi modelli della realtà prodotti dalla nostra mente. «La matematica rifette l'universo perché la complessità delle nostre menti, delle nostre fsiologie e dell'universo sono tutte all'interno dell'unica Coscienza. Ogni ramo delle scienze, delle arti e delle scienze umane rifette la dinamica delle leggi della natura» Una visione estremamente suggestiva, che ha la virtù di andare oltre il dualismo che caratterizza tutto il
nostro sapere, superando anche la tradizionale separazione tra lo spirituale e il materiale.
In questo senso acquista un signifcato più chiaro l'idea (orientale) della realtà come un gioco, una manifestazione dell'unica Coscienza. Nader ricorda quanto, in un tempo ormai lontano, fosse controintuitivo considerare la Terra in movimento intorno al Sole, visto che chiaramente, per i nostri sensi, era il Sole a muoversi intorno a noi. Le apparenze ingannano. Da una parte c'è il non-manifestato, la «Coscienza primordiale, una realtà immateriale, non-fsica, che esiste interamente in se stessa, autosufciente, assoluta» e dall'altra ci sono «tutti gli aspetti fsici e materiali dell'universo manifesto che sono modalità di Coscienza».
Arrivati alla constatazione di certi efetti quantistici apparentemente assurdi, o a principi come quello dell'entanglement - il misterioso legame che permane tra particelle correlate anche se si trovano in luoghi diversi («tutto è collegato e infuenza tutto») - siamo forse pronti a fare l'ultimo balzo verso l'idea del campo unifcato come Coscienza, dentro cui sta anche la concezione degli universi paralleli («come le bolle dell'acqua frizzante, gli universi possono emergere da una realtà quantistica senza tempo»).
Partendo da queste premesse, il libro di Nader ci sprofonda in una rifessione che forse a qualche lettore potrà apparire fn troppo complessa, ma che farà la felicità di chi è allenato alla rifessione flosofca, scientifca e forse anche teologica.
Per parlare di coscienza bisogna che ci siano un osservatore, un osservato e l'atto dell'osservare. Questa struttura tre-in-uno, «inerente alla natura della coscienza», in realtà «è la stessa Coscienza vista in tre prospettive diverse», e permette di rispondere a molte domande decisive (o perlomeno a provarci): la questione delle origini dell'universo, il concetto di nulla, il rapporto tra l'uno e i molti, la nascita dello spazio e del tempo, la generazione dell'identità individuale separata... Il ribaltamento è davvero totale, un capovolgimento copernicano, perché «ciò che quasi tutti chiamano esistente e reale, cioè gli oggetti “concreti” della vita quotidiana, sono concetti virtuali (se considerati come oggetti indipendenti senza un osservatore): non hanno una realtà indipendente. Sono concetti nella Coscienza», l'unica realtà assoluta.
58 MAGGIO 2024

Il processo per cui io vedo un fore, deriva dall'incontro tra me, l'atto del vedere e il fore. Io e il fore siamo «solo due degli infniti modi in cui la Coscienza guarda se stessa». Ciò che nell'immanifesto accade istantaneamente, a velocità infnita, nella nostra realtà manifestata si organizza secondo la dimensione del tempo, separando i «valori uguali ma opposti», generando innumerevoli «frammenti e modalità elementari di Coscienza, che si assemblano per formare pacchetti e modelli di coscienza più complessi e più sofsticati». Di là c'è l'eterno presente di cui parlano i mistici, un campo infnito di possibilità, di qua si creano “cose” separate, sé individuali, storie manifeste.
Nader non fa della metafsica. Il suo ragionamento ha un obiettivo ben preciso, quello di chiarire il senso del nostro stare al mondo. Noi abbiamo la nostra porzione di libertà, dentro i limiti stabiliti dalle leggi della natura e dal nostro pacchetto di qualità personali. Ma esiste anche la possibilità di «crescere nella coscienza» e quindi avere «una libertà sempre maggiore»: «abbiamo la
possibilità di infuenzare il nostro sviluppo, e quindi la nostra felicità e utilità per gli altri, scegliendo a quali possibilità prestiamo attenzione, quali potenzialità scegliamo di concretizzare». Qui si apre il capitolo sugli stati superiori di coscienza. Di "illuminazione" si parla da sempre, in tutte le tradizioni, in ogni epoca (satori, nirvana, moksha, liberazione, realizzazione del Sé...) così come si parla modernamente di “esperienze di picco” o “stati di fusso”. Nella scienza vedica, così come l'ha divulgata Maharishi, si evocano addirittura sette stati. Oltre allo stato della trascendenza, il quarto (che permette di sperimentare la pura Coscienza), c'è la “coscienza cosmica” (a cui corrisponde un alto grado di coerenza cerebrale, un'esperienza di «illimitatezza, silenzio, beatitudine» di cui parlano anche grandi artisti, musicisti, scienziati, visionari), che può diventare “coscienza di Dio” (aprendo anche alla «percezione dei livelli sottili della natura», suscitando un amore travolgente), per approdare infne alla “coscienza di unità”, in cui «l'individuo percepisce tutto in termini di totalità. Tutto è veramente un oceano illimitato di Coscienza in movimento».
59 MAGGIO 2024

Sopra, "The Vedic River", rappresentazione della tradizione vedica secondo la MT. In basso, un altro gruppo di meditanti al raduno indiano
Notevoli le pagine in cui Nader cerca di spiegare le sue intuizioni sulla generazione della molteplicità, la piramide metaforica della Coscienza dispiegata, con le sue innumerevoli prospettive, che non sono illusorie, perché sono comunque “entità di Coscienza”, che strutturano il nostro universo e tutti gli universi reali o immaginari. «Sono gli atomi, le molecole, le montagne, gli alberi, gli animali e gli uomini, così come le idee, le fnzioni, le fgure mitologiche, le macchine, gli aerei e tutto ciò che può essere o sarà mai creato o immaginato. Ognuno di questi può avere una propria prospettiva, una propria capacità di percepire o sentire o sperimentare. Un elettrone percepisce il campo elettromagnetico. Una mela cade a terra come reazione alla gravità. Un albero allunga le radici come reazione al suolo. Un cane sente l'odore del cibo. I bambini corrono dai genitori. Tutti questi sono strati, livelli, sfumature e colori della Coscienza. La Coscienza non è più solo un oceano piatto e senza limiti, ma è anche le onde viste come se fossero separate dall'oceano, con ogni onda che ha la sua prospettiva»
Alla fne capiamo che l'entanglement non riguarda solo le particelle quantistiche, ma «è generalizzato a tutto il campo della manifestazione». Lo possiamo anche chiamare interconnessione, come fa il buddhismo.

60 MAGGIO 2024

Capiamo che la libertà è strettamente legata al grado di consapevolezza (l'elettrone può solo ruotare in su e in giù) e che ogni azione ha una reazione uguale e contraria, anche se distribuita nello spazio e nel tempo (il campo insondabile del karma).
Andare verso la pienezza signifca procedere verso una sempre maggiore autoconsapevolezza e autorealizzazione: «Il sentimento di felicità deriva dalla sensazione che il sé si espande». Lo possiamo fare usando l'intelletto discriminante, ma anche ricordandoci che «il sentimento dell'amore genera le forze di sintesi più forti. L'amore è il collante dell'universo».
Ciò che chiamiamo male è ciò che dissocia e separa, è parte integrante della manifestazione, anche se «il processo distruttivo in sé non è necessariamente malvagio». Di sicuro però «la non violenza e gli approcci non distruttivi, anche di fronte al male, sono più evolutivi».
Fondamentale è la pratica della meditazione, che porta alla trascendenza, ovvero «l'esperienza più
appagante e più evolutiva», dentro una realtà in cui la libertà di scegliere tra il bene e il male è strettamente legata alla possibilità che ci sia una manifestazione della Coscienza. «Possiamo allinearci con la sorgente di tutto ciò che esiste», come dicono maestri, profeti e mistici di ogni tempo. «Questo signifca cedere il nostro piccolo ego all'Assoluto». «Una pietra miliare», così scrive nella prefazione David Lynch (praticante della MT da sempre) parlando di questo libro che unisce scienza e spiritualità, vita e coscienza, visione cosmica e realtà quotidiana. Tony Nader apre prospettive letteralmente infnite, a partire dall'esperienza diretta che “tutto è uno”, dal «risveglio nel proprio essere più profondo». Non c'è spazio per il fatalismo, in questa prospettiva: «La visione del mondo presentata in questo libro evidenzia la piena responsabilità e la capacità umana di creare signifcato. Man mano che la Coscienza si eleva, possiamo creare, fare e disfare il nostro universo. Possiamo diventare padroni del nostro destino».
61 MAGGIO 2024
Megalopolis, basta la parola. In efetti basta un titolo, a volte, per trasformare un festival in un evento imperdibile. Come se Cannes ne avesse bisogno, potendo schierare Cronenberg e Lanthimos, Jia Zhang-ke, Schrader e Sorrentino.
Si dà il caso però che il flm di Francis Ford Coppola sia il più atteso del decennio (per stare stretti). Un progetto coltivato da una vita, un kolossal d'autore girato in totale autonomia, probabilmente visionario, possibilmente indimenticabile (nel bene e nel male), completamente auto-fnanziato (centoventi milioni di dollari), realizzato dal regista di Apocalypse Now (a proposito di cinema fuori scala), che decide di cimentarsi in Concorso, alla veneranda età di 85 anni. Basta questo ad alimentare l'attesa per Cannes 2024. Se non fosse che di motivi ce ne sono molti altri, evocati dal solito splendido manifesto, stavolta ispirato ad Akira Kurosawa (Rapsodia in agosto).
Uno di questi si chiama America, il cinema di cui si temeva l'assenza in questa edizione, visto lo sciopero andato in scena per mesi, con

tante uscite rinviate al 2025. Ma a Cannes arriveranno personaggi mitici come George Lucas, Palma d'oro d'onore, e Kevin Costner, che presenterà fuori concorso la prima parte della sua saga western in quattro capitoli, Horizon, ambientata tra la metà dell'800 e la guerra civile: cowboys e indiani,
pionieri, diligenze, vaste pianure a perdita d'occhio, il mito della frontiera, ma visto con lo sguardo tutt'altro che banale di chi ha realizzato un flm come Balla coi lupi e con la libertà di chi ha scelto di auto-prodursi (anche un po' obbligato, visto lo scetticismo generale).
Un
mondialista che celebra i grandi sognatori
62 MESE 2022
CANNES 77 NEL SEGNO DI COPPOLA, LUCAS E STUDIO GHIBLI. TANTA AMERICA INDIE, AUTORI DOC, FILM DA TUTTO IL PIANETA E VENTI
mega-festival
A proposito di spettacolo, grazie all'ottimo rapporto tra Cannes e la Warner, questa sarà anche l'occasione di godersi la nuova puntata di Mad Max, Furiosa, che fa venire l'acquolina in bocca pensando a quel prodigio – puramente estetico, cinematografco - che è stato Fury Road. Non c'è più Charlize Theron, gravissima mancanza, ma trattandosi di un prequel, George Miller non voleva saperne di ringiovanimenti digitali, e così è stata scelta Anya Taylor-Joy. Aggiungete, a questo già ricco
menu, la nuova puntata del felice sodalizio tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos (Kind ok Kindness, che promette un altissimo tasso di eccentrico pop-essai), il ritorno di Richard Gere insieme a Uma Thurman (!) nel nuovo flm di Paul Schrader (Oh, Canada, «commedia funebre ma non triste», secondo la felice defnizione di Frémaux), e avrete un banchetto ideale. Da completare con Nicolas Cage in versione surfer per l'australiano Lorcan Finnegan, Cate Blanchett in Rumors di Guy
Maddin (commedia politica ironica ambientata in un G7), e qualche produzione Usa indipendente: The Substance di Coralie Fargeat, presentato come un horror gore; The Apprentice di Ali Abbasi, regista iraniana che vive in Svezia e che ha deciso di raccontare le “prodezze” di un giovane Donald Trump (polemiche assicurate); ma anche Sean Baker, rappresentante della cosiddetta “new wave americana”, in Concorso con Anora, che segue le peripezie di una lavoratrice del sesso tra New York e Las Vegas.

63 MAGGIO 2024

Insomma Thierry Frémaux, “delegato generale” del Festival di Cannes, regista sapiente e poco accondiscendente di questo spettacolo planetario, ha fatto quasi il pieno. Fedele allo stile di una kermesse esclusiva ma attenta al popolare (con una certa indulgenza snob), che guarda prima di tutto all'arte del cinema, all'impegno, ai grandi nomi che piacciono alla critica, ma non ha mai perso il gusto dell'evento e dell'intrattenimento.
Seguendo però le sue regole, a cui il mondo si deve adattare, vedi ad esempio la scelta di non inserire in Concorso flm destinati alle piat-
AL CENTRO
di Cannes è “flm nelle sale”. Anche un “flm su piattaforma” è un flm. Ma se non esce in sala è diverso e noi lo trattiamo diversamente per ciò che concerne il Concorso. Anche stare Fuori Concorso è un modo altrettanto spettacolare per essere a Cannes»
In
DELL'ATTENZIONE CI SARÀ MEGALOPOLIS, IL FILM CHE COPPOLA PROGETTA DA UNA VITA,
AUTOPRODOTTO
taforme (e quindi la diatriba con Netfix), come ha ribadito Frémaux in una recente intervista concessa a Variety: «Noi favoriamo i flm che escono in sala, perché la Francia deve rimanere un grande paese di exploitation che valorizza le sale cinematografche. Il Festival

Altro aspetto fondamentale, per questo festival, è la vocazione “mondialista”, l'ambizione di offrire un panorama credibile e il più completo possibile dello stato della produzione globale. Operazione facilitata quest'anno dal numero ridotto di opere americane arrivate alla meta. Tanto che è possibile trovare in Concorso un flm indiano della documentarista Payal Kapadia (All We Imagine As Light, che promette benissimo), oltre a un Certain Regard - «cinema giovane, di ricerca, radicale, sperimentale» - pieno zeppo di scelte esotiche, tra cui un flm dall'Arabia Saudita (Norah), il vietnamita Viet And Nam (di Truong, che già conosciamo), due flm indiani (The Shameless e Santosh) e il somalo The Village Next to Paradise.
Immancabile l'Oriente, anche se in misura minore rispetto alla media festivaliera, rappresentato soprattutto da quel maestro straordinario che è il cinese Jia Zhang-ke, con Caught by the Tides: un flm-epopea che attraversa venticinque anni di storia del suo Paese, inseguendo la consueta eroina (Zhao Tao) che va alla ricerca del suo innamorato, scomparso nei primi anni 2000 per cercare fortuna in un'altra provincia. Sul fronte spettacolare, ecco She's Got No Name di Chan Peter Ho-Sun, la produzione cinese più ambiziosa e costosa dell'anno.
Greta Gerwig guiderà la Giuria (@Ben Rainer)
alto, Thierry Frémaux (@AFP)

Ma ci sono anche i flm di genere, come Twilight of The Warrior Walled In, opera di Hong-Kong frmata Soi Cheang.
Sul fronte del cinema d'autore, invece, si segnala il cinese Black Dog di Guan Hu, storia di un uomo incaricato di far sparire tutti i cani randagi di Pechino prima delle Olimpiadi. E anche Hiroshi Okuyama (My Sunshine) che Frémaux ha salutato come un “nuovo Kore-eda” (complimento assai impegnativo).
Non mancano mai anche le opere che intrecciano impegno, storia, messaggio politico e sociale, nella convinzione che il cinema abbia anche il compito di ampliare gli orizzonti. Mentre tutto il mondo parla di Gaza per tutt'altri motivi, a Cannes arriva in proiezione speciale un flm di Yolande Zauberman, La belle de Gaza: transessuali palestinesi che raggiungono Tel Aviv per provare a vivere una nuova vita. Sul fronte ucraino, invece, si segna-
la la nuova opera di Sergei Loznitsa, autore sempre interessante e spesso geniale, che in L'invasion racconta le conseguenze dell'invasione russa in Ucraina. Rithy Panh è un altro di quei registi che realizzano solo flm potenti (per pochi, purtroppo), in questo caso raccontando la storia della sua Cambogia: parlando di Rendez-vous avec Pol
Veniamo però ai pezzi grossi, quelli che fanno sperare in un'altra edizione importante, dopo quella eccezionale del 2023, in cui c'erano Glazer e Triet, Kaurismaki e Kore'eda, Wenders, Ceylan e Scorsese.

65 MAGGIO 2024
Pot, Frémaux ha evocato il sommo Lanzmann di Shoah
Megalopolis di Francis Ford Coppola è il flm più atteso. In basso, Horizon di Kevin Costner

C'erano anche tre italiani in Concorso: Moretti, Bellocchio e Rohrwacher. Stavolta ne approda in Croisette solo uno, Paolo Sorrentino, con un flm girato a/su/ con Napoli, protagonista assoluta di Parthenope, flm corale, fatto di tante storie, della città bene e di quella più popolare, raccontando una donna troppo bella, che vorrebbe essere apprezzata anche per altre qualità. Segnaliamo però al
Certain Regard anche Roberto Minervini, solitamente una certezza, con l'incognita del passaggio dal documentario alla fction, visto che Les Damnés è un flm di guerra, o meglio dedicato al “quotidiano” della guerra, ai tempi della Secessione, conservando l'immediatezza del suo cinema.
C'è tanta attesa per David Cronenberg e il suo The Shrouds, tra fantascienza e paranormale, costruito
intorno a una macchina che può mettere i vivi in contatto con i morti. Si parla di un flm intimo, inevitabilmente legato alla scomparsa della moglie del regista. Vincent Cassel è l'uomo rimasto vedovo che inventa il marchingegno per comunicare con l'al di là. Nel cast ci sono anche Diane Kruger e Léa Seydoux. Tra gli imperdibili, oltre a Schrader e Lanthimos, anche la commedia musicale sui cartelli della droga messicani (!?) di Jacques Audiard, con Zoe Saldana e Selena Gomez (titolo: Emilia Perez); il flm su Mastroianni di Christophe Honoré (Marcello Mio, con la fglia Chiara e Catherine Deneuve); il Limonov di Serebrennikov; il cinema rigoroso di Miguel Gomes (Grand Tour, che immaginiamo potente come sempre); il ritorno di Andrea Arnold alle amate-odiate periferie inglesi (Bird).

66 MAGGIO 2024
Kind of Kindness di Yorgos Lanthimos, ancora con Emma Stone
Senza dimenticare il flm d'apertura, quel Le Deuxième Acte di Quentin Dupieux che promette la consueta dose di follia, con un super-cast francese ideale per la prima montée de marches (la mitica scalinata con tappeto rosso che porta al cinema Grand Lumière).
Ma ci sono tante altre cose da tenere d'occhio. Claire Simon non è mai banale, e non la sarà certamente nel suo documentario dedicato al mondo della scuola, e degli insegnanti in particolare: Apprendre. Daniel Auteuil presenterà un polar (Le fl), Alain Guiraudie il consueto flm sulla «circolazione del desiderio, dei corpi, degli sguardi, specialmente tra gli uomini» (parole di Frémaux), Leos Carax un “essai” autobiografco, «brillante e folgorante»: C'est pas moi. Poi ci sono gli innesti dell'ultimo momento. A partire dal flm d'animazione di Michel Hazanavicius,

che in La plus précieuses des marchandises racconta di un bambino lanciato da un treno in viaggio verso Auschwitz e del taglialegna che lo trova. L'immancabile (sempre bravo) Arnaud Desplechin con Spectateurs. Il regista iraniano
dissidente Mohammes Rasoulouf e quello rumeno Emanuel Pârvu. Ma anche l'ennesimo film di Oliver Stone dedicato a uno dei grandi personaggi che ama raccontare (celebrare), in questo caso Lula, il presidente brasiliano.
Parthenope di Paolo Sorrentino. In alto, Mad Max: Furiosa

67 MAGGIO 2024
Èquasi inutile però dire che tutti i rifettori saranno puntati su Megalopolis. Soprattutto dopo le prime due segretissime proiezioni, che a quanto pare hanno suscitato grande entusiasmo tra gli addetti ai lavori, ma hanno lasciato perplessi i distributori: chi si vuole accollare il rischio di un gigantesco flm d'autore che potrebbe essere un fop dal punto di vista degli incassi? Sembra incredibile, pensando al nome e alla carriera di un regista che ha segnato la storia del cinema. Ma forse il problema è proprio la storia, la sua carriera fatta di alti (altissimi) e bassi (economicamente sanguinosi). Coppola, dopo l'epica e l'epopea produttiva di Apocalypse Now e il fop di Un sogno lungo un giorno, a diferenza di altri "registi maledetti" come Michael Cimino (che non
riuscì più a risollevarsi dopo la catastrofe de I cancelli del cielo), ha saputo reinventarsi dentro un cinema diverso, a volte anche più piccolo, libero, indipendente, con risultati alterni. Anche se rimarrà sempre il regista de Il Padrino, La conversazione e di un capolavoro apocalittico tra i più importanti di tutta la storia del cinema, non vanno dimenticati Dracula e Peggy Sue, fno ad arrivare a esperimenti come Un'altra giovinezza e Segreti di famiglia
IN APERTURA SI CELEBRA ANCHE IL NAPOLÉON DI GANCE.
ATTESA PER SCHRADER, CRONENBERG, JIA
Megalopolis è il flm di tutta una vita, a cui ha cominciato a lavorare fn dagli anni Ottanta. Uno di
quei progetti di cui in tanti hanno parlato, nel corso dei decenni, sospettando che non sarebbe mai venuto alla luce, come è capitato ad altre idee troppo ambiziose rimaste irrealizzate. E invece, eccoci qui a parlare di un autofnanziamento a suo modo folle, e di un cast che comprende Adam Driver e Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf e Dustin Hofman, Giancarlo Esposito, John Voight e Lawrence Fishburne.
Parliamo di fantascienza distopica. C'è da ricostruire la città di New York, dopo una catastrofe, e per farlo si sfdano le idee progressiste di un architetto estroso di nome
Cesar e quelle di un sindaco conservatore chiamato Cicero. Siamo dalle parti della “Congiura di Catilina”, riletta in chiave contemporanea.

68 MAGGIO 2024

Siamo però anche dentro una produzione che ha vissuto di polemiche, addii, collaboratori cambiati in corsa... Il sogno di una vita che diventa realtà tra mille difcoltà. E che, secondo i primi critici che l'hanno visto, promette di riempire gli occhi e la mente.
D'altra parte questa edizione del festival di Cannes sarà aperta, sul fronte dei classici, dal Napoléon di Abel Gance, a proposito di flm mitici, immortali, smisurati. Sulla Croisette verrà presentato, in anteprima mondiale, il restauro di questo capolavoro del 1927. «La ricostruzione titanica di un flm della durata di 7 ore», con bobine ritrovate in vari luoghi e lo studio delle note di montaggio di Abel Gance. Coppola ama molto questo flm (e non solo lui). A Cannes verrà presentata la prima parte, della durata di 3 ore e 40.
Altro evento importante per chi ama il cinema: la Palma d'Oro riservata allo Studio Ghibli. Un omaggio buono e giusto all'arte di Hayao Miyazaki, Iseo Takahata, Toshio Suzuki. Per la prima volta, un riconoscimento a un'istituzione, una realtà creativa collettiva,
invece che a un singolo autore, per sottolineare la grandezza e la singolarità del lavoro portato avanti dallo studio giapponese. Per il resto, c'è solo da sperare che Cannes, come (quasi) sempre, abbia scoperto nuove voci del panorama cinematografco internazionale. Dice Frémaux: «Ciò che guida la selezione non è “mi piace, non mi piace”, oppure “è un buon flm, non lo è”. Ciò che ci guida è:
“Questo flm deve essere a Cannes?”, “La sua presentazione a Cannes gli sarà d'aiuto?”, oppure: “La selezione di questo flm cosa dice dello stato del cinema mondiale”?».
Anche noi di Redness saremo a Cannes per raccontarvi lo "stato del cinema mondiale". Ma soprattutto vi racconteremo i (grandi) flm, i protagonisti, le emozioni, le idee. La bellezza, ecco cosa ci interessa davvero.

69 MAGGIO 2024
All We Imagine As Light di Payal Kapadia. Nell'altra pagina, il flm d'animazione di Hazanavicius
Lucas, l'autore avanguardista che creò una mitologia fanta-pop
CANNES CELEBRA IL CREATORE DI STAR WARS, CHE SI FECE CONOSCERE PROPRIO SULLA CROISETTE CON UN FILM "POLITICO": THX 1138
Quanti possono dire di aver creato una mitologia?
Un mondo, anzi tanti mondi, con la loro geografa intergalattica, i popoli diversi, le lingue, le culture, i valori di riferimento, destinati ad entrare in collisione. Il
Bene contro il Male, naturalmente. Ma non così semplicemente. Una storia che scorre come un fume
attraverso i secoli (i decenni, per lo spettatore), con i suoi afuenti, le pianure attraversate, le digressione ludiche, le avventure che non fniscono mai. E soprattutto la Forza, l'elemento magico, quasi mistico, che evoca tante cose diverse, presenti in ogni tradizione sapienziale, come potere supremo che tenta o che salva, come traguardo spiri-
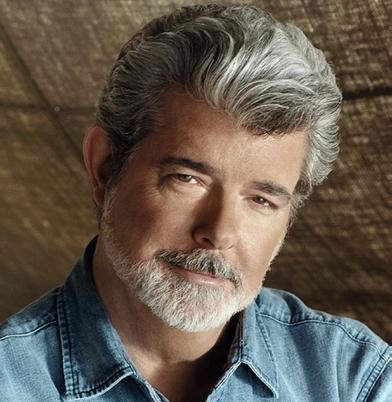
tuale di una disciplina del corpo e della mente.
George Lucas merita gloria imperitura anche solo per aver immaginato Star Wars. No, non è Omero, forse non è neppure Tolkien, ma la sua invenzione ha creato un universo immaginifco che va molto oltre l'intrattenimento. Uno dei fenomeni pop-cinematografci più straordinari di sempre.
Anche solo per questo è più che giusta la Palma d'oro d'onore di Cannes, festival che peraltro ha omaggiato Lucas già nel lontano 1971, quando sulla Croisette venne proiettato il suo flm d'esordio, THX 1138, nato grazie alla complicità di Francis Ford Coppola (a proposito di intrecci mitici, che verranno celebrati in questa edizione).
Si trattava di “fantascienza d'autore”, contro la società della sorveglianza e il dispotismo, contro un mondo che vuole ridurci all'uniformità, giocando sull'ambiguità dei concetti di bene e male, quando vengono utilizzati dal potere. Insomma, tutti temi che ritroveremo, in qualche modo, anche in Star Wars
E VENTI 70 MAGGIO 2024

THX 1138 (L'uomo che fuggì dal futuro) è il flm che lo rivelò a Cannes nel 1971. In basso, un poster del primo Star Wars, che gli diede gloria imperitura. Nell'altra pagina, George Lucas (@Jaks Procutions)
Lucas è anche il regista di American Grafti, che tra le altre cose ha rivelato Harrison Ford, è un pioniere dell'industria degli efetti speciali (l'Industrial Light & Magic è una sua creazione), è all'origine dello studio d'animazione Pixar, ed è un produttore di opere fondamentali per la storia del cinema, come Kagemusha di Akira Kurosawa, oltre che di flm entrati nell'immaginario popolare come la saga di Indiana Jones. Lucas ha raccontato spesso la sua formazione da aspirante artista –vocazione malvista dal padre – ma anche il lavoro in un garage, da ragazzo, come meccanico. Gli sono sempre piaciute le macchine – lo si nota benissimo nei quattro episodi della saga stellare realizzati in pri-
ma persona – ma anche le culture indigene, che hanno un rapporto diretto con la natura, gli alberi, le stelle. Approdato alla fotografa, all'Università della California Meridionale, e poi all'animazione, ha
sempre continuato a coltivare la passione per l'antropologia, destinata a sfociare nel suo universo fanta-mitologico.
Ma all'inizio le sue opere erano pura avanguardia e astrazione.
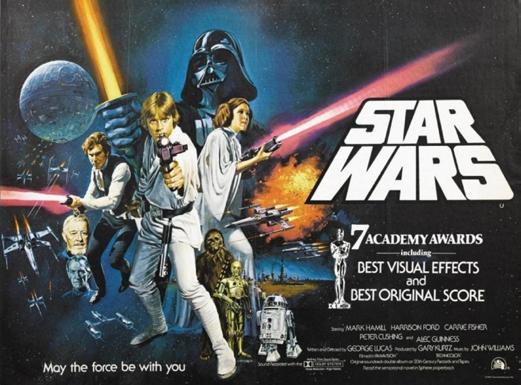


TXH 1138 fu il suo approdo in quella che lui chiamava “fanta-sociologia”: «Volevo mostrare che il potere è diventato così forte, così vasto, così burocratico, che non si può localizzarlo. È come un corpo gigantesco senza testa, che tuttavia agisce» (lo raccontava cinquant'anni fa in una celebre intervista a Positif che citeremo più di una volta).
Chi meglio di Lucas può sintetizzare il senso e la sostanza del cinema di Lucas? «THX è la mia testa, American Grafti, il mio secondo flm, è il mio cuore, è una risposta a tutti quelli che dicevano che ero freddo, bizzarro, cerebrale. Star Wars è una combinazione dei due».
È sempre afascinante ripercorrere la nascita di Guerre Stellari, con i
suoi quattro anni di lavoro e le quattro versioni diverse. La nascita di una mitologia, appunto. «Nella prima versione Luke non c'era ne-
anche. C'erano invece elementi “samurai” e “zen” che si ritrovano in Kenobi, ma avevano un ruolo più importante.

72 MAGGIO 2024
Il vecchio guerriero si aggrappava ad una tradizione che era andata perduta. Era molto più intellettuale, più dialogato, vi si parlava della forza, della religione»
Un po' riusciamo a immaginarla, questa versione più “autoriale” e pensosa, quasi esoterica, che esplorava la dimensione spirituale del racconto, ma anche quella più politica. Così come l'altra possibilità, «l'idea di un flm d'azione pieno di avventure straordinarie»
Noi spettatori, però, siamo felici che abbia prevalso un intreccio fra le due dimensioni: «Ho combinato le due cose. Dalle cinquecento pagine della prima stesura, sono arrivato a centoventi. Ma è stato difcile perché volevo tenere tutto, come un bambino in una pasticceria»
A volte il cinema funziona così, da
una parte ci sono le ragioni dell'industria, dall'altra quelle dell'arte, e il prodotto fnale è una terza cosa che riesce ad essere popolare e non banale, colonizzando l'immaginario del pubblico. «Io volevo questo aspetto di faba mitologica che mi piaceva da bambino e che ho ritrovato nei western. In antropologia avevo studiato i rapporti tra le società e la mitologia dei racconti popolari. Una delle idee base era l'esistenza, all'orizzonte, di un mondo esotico che sarà esplorato e afrontato da un giovane guerriero. È la storia di Ulisse, dei Cavalieri della Tavola Rotonda, dell'Isola
del Tesoro, di Gunga Din. E negli Stati Uniti sono stati i western. (…) L'ultimo mito, l'unica nuova frontiera, è ora lo spazio. Ma quello che mi infastidisce è che questa frontiera sia tecnologica, cerebrale, priva di romanticismo. Allora ho voluto uno spazio immaginario, come quello dei nostri sogni, dove si combattono i mostri, dove si salvano gli esseri in pericolo, dove tutto è possibile, dove si ritrovano la lealtà e l'amicizia. Ho voluto creare un immaginario che sembrasse vero». In efetto è vero, e lo sarà per sempre. Cinema mitico. Mitologico.
«THX è la mia testa. American Grafti è il mio cuore. Star Wars è una combinazione tra i due»

73 MAGGIO 2024
George Lucas sul set di American Graffti
Lo sguardo inquieto di chi conosce le paure dei bambini
Adelphi sta ripubblicando le opere di Maurice Sendak: solitudine, rabbia, ribellione, ma anche gioco e magia
C'è chi pensa all'infanzia come un tempo fatato, il regno dell'innocenza e dell'incanto, dove tutto è gioia e giocosa fantasia. E poi c'è Maurice Sendak. Basta sfogliare Nel mondo là fuori per notare, già nella prima pagina, quell'essere incappucciato, senza volto, che se ne sta seduto sotto i girasoli, mentre una ragazzina gioca col fratellino piccolo. Lo sguardo inquieto (inquietante) che la ragazza lancia verso il lettore, è tutto un programma. Lo stile del disegno contribuisce all'efetto perturbante, così pittorico e retrò, i colori pastello, il realismo magico.
D'altra parte parliamo dell'autore di quel capolavoro che è Nel paese dei mostri selvaggi, trasformato anche in un flm (inquieto, inquietante) da Spike Jonze. Un viaggio nell'interiorità di un ragazzino disubbidiente, che ha allarmato censori ed educatori, come è capitato più di una volta a Sendak.
Adelphi sta pubblicando le sue opere nella collana “i cavoli a merenda”, un'ottima occasione per rileggere l'autore newyorchese, fglio di ebrei emigrati dalla Polonia, cresciuto in un quartiere povero di Brooklyn, con gravi problemi di salute in giovane età. Insomma, non un'infanzia facile, trascorsa per lunghi tratti a osservare gli altri bambini dalla fnestra. Non sorprende, quindi, il suo sguardo originale verso questa età della vita, la capacità di raccontare, in forma più o meno fa-

besca e avventurosa, le paure, se non proprio le angosce, dei più piccoli, la solitudine, la rabbia, il senso di abbandono, in modo spesso anticonvenzionale.
Ma un autore come Sendak lo si può apprezzare anche solo per la bellezza dei suoi albi illustrati, la varietà di stili e tecniche utilizzate, così come la capacità di assimilare altre forme di espressione nel suo lavoro.
Non per niente viene considerato l'inventore del picturebook così come è inteso da alcuni decenni. Da quel lontano 1963 in cui uscì Where the Wild Things Are, l'opera più celebre di una trilogia che prosegue con In the Knight Kitchen (Luca, la Luna e il Latte) e Outside Over There.
Ma ci sono anche le bellissime illustrazioni delle fabe dei fratelli Grimm, le Storie di Orsacchiotto, il divertente-pauroso pop-up Mommy? Grazie ad Adelphi potete ritrovare anche i Gusci di noce, il Sendak più giocoso, tra un abbecedario e una flastrocca dei mesi, oltre a Bombo-Lardo e il Signor Coniglio
Ma soprattutto, ritroviamo i suoi bambini irriverenti, capricciosi, pronti a mettersi a testa in giù, sempre in pericolo, eppure capaci di capovolgere la realtà e trovare il modo di salvarsi.
Spiegava Sendak: «Troppi genitori e troppi scrittori di libri per l'infanzia non rispettano il fatto che i bambini conoscono e sofrono molto. I miei bambini mostrano un sacco di divertimento e piacere, ma spesso sembrano anche indifesi. Essere indifesi è il primo elemento dell'infanzia. Cerco di disegnare il modo in cui i bambini si sentono. Il modo in cui io mi sentivo quando ero bambino»
È certamente indifeso il bimbo rapito dai goblin, Nel mondo là fuori. E il fantoccio di ghiaccio lasciato al suo posto è spaventoso. Ma la sorella, suonatrice di corno, vola in sua difesa. Una magia ammaliante.
74 MAGGIO 2024


«Mentre il papà era per mare e la mamma in giardino, Ida ninnava la sorellina suonando il corno magico, ma senza guardarla. Fu così che i goblin s'intrufolarono nella stanza e rapirono il bebè, lasciando al suo posto un fantoccio di ghiaccio...»
(Maurice Sendak)
76 MESE 2023 www.mondored.it DIGITAL AGENCY MONDO La nostra missione è il tuo successo

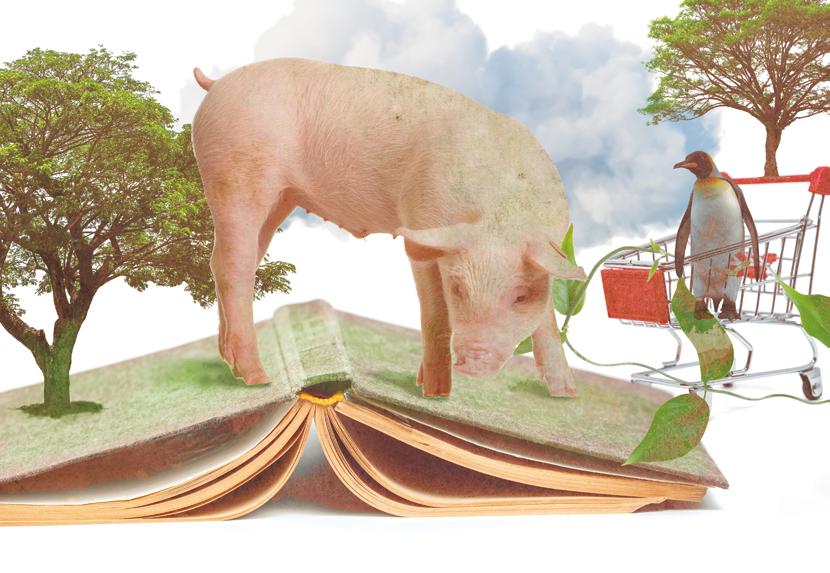

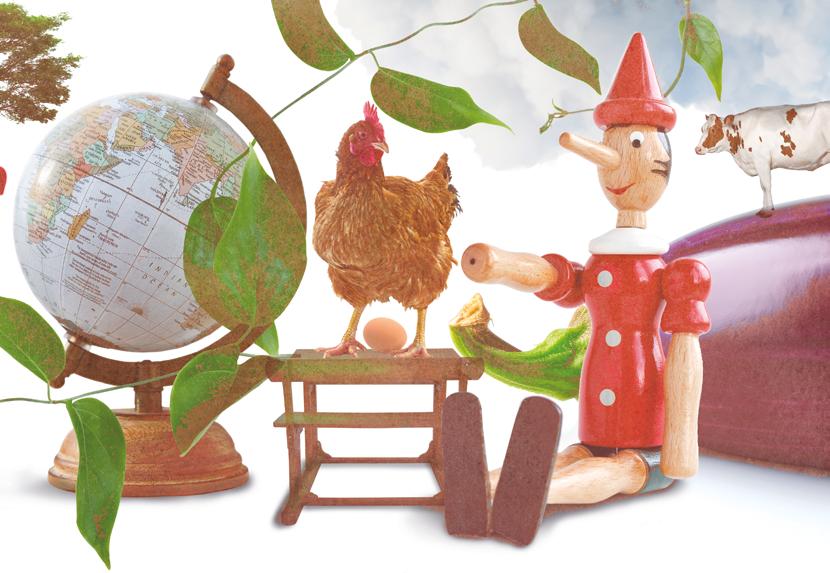






















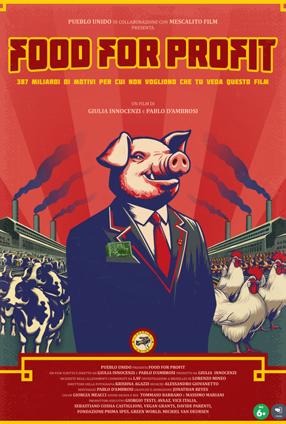







 (foto Francesca Togni)
(foto Francesca Togni)