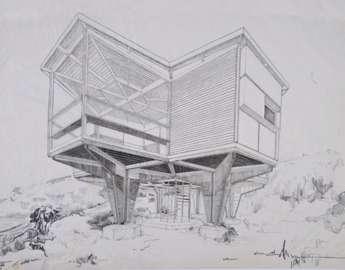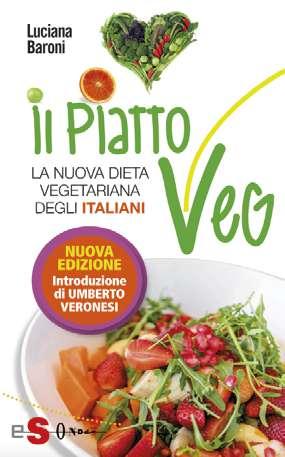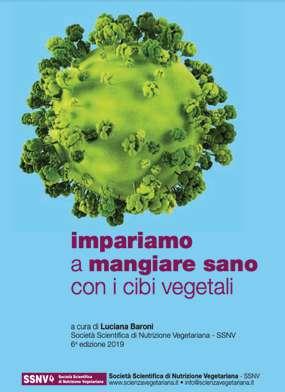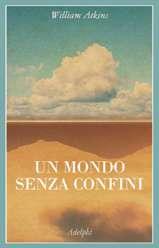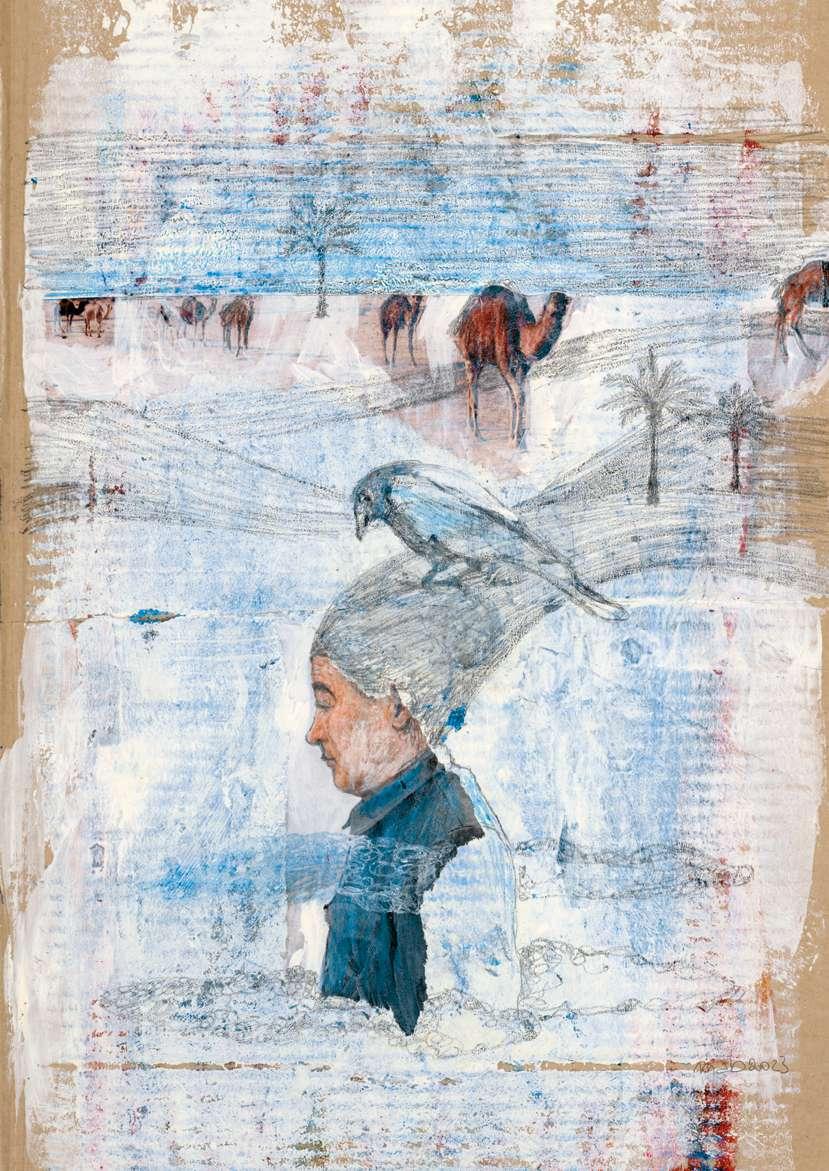Dove si parla di uomini e animali, così simili e così diversi, di deserti e foreste, di meditazione (vera o presunta) e arte della danza, del genio di Oppenheimer (e quello di Nolan), del nostro futuro vegetariano, di vacanze da abitare N 12 | AGOSTO 2023

William Atkins
Luciana Baroni
Adriano Ercolani
Anna Kolesarova
Oppenheimer
Fabrizio Rondolino
"Siamo Foresta"
REDness
è passione, arte, impresa, comunicazione.
È il "rossore" provocato dalle emozioni forti.
Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.
La redness
è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina.
È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi. Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità...
Va bene tutto, purché sia fatto con redness.
In copertina: Anna Kolesarova
Foto: Thomas Darlis
(servizio a pag. 18)
Direttore: Fabrizio Tassi
Progetto grafico: Marta Carraro
Redazione: MondoRed
Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano
Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore
2 MESE 2022
S OMMARIO
4
EDITORIALE
4 Senza confini
6
INCONTRI
6 Fabrizio Rondolino: "ritornare a casa", tra cani e gatti
18 Anna Kolesarova: l'arte della danza, qui e ora
30 Adriano Ercolani: la meditazione spiegata da un praticante del caos
42
EVENTI
42 "Siamo Foresta": arte e natura alla Triennale di Milano
50
LUOGHI
50 La vacanza è un luogo da abitare: Liguria, Toscana, Sardegna
54
IDEE
54 Luciana Baroni: pochi dubbi, il futuro è vegetariano
60
MEDITAZIONI
60 Oppenheimer: sporgersi per guardare l'abisso
66
STORIE D’IMPRESA
66 Villa Giovanelli Fogaccia: tra principi, soldati e fantasmi
70 La Maison: conoscere per vendere
74
COMMIATO
74 William Atkins: “Un mondo senza confini”
3 AGOSTO 2023
Senza confini
Gli Anangu sono un popolo indigeno australiano. Una delle culture viventi più antiche del mondo. Anangu significa "essere umano", "popolo". La loro vita è fondata sul rapporto con gli Antenati, le piante, gli animali. Non hanno una parola per dire "natura", come fosse qualcosa di separato dall'uomo. Non hanno il mito della Caduta, del legame spezzato, l'esilio da espiare nel dolore, come fosse una prova da superare. Ne parla William Atkins nel suo magnifico libro sui deserti, Un mondo senza confini (il nostro Commiato di questo mese). Sarebbe complicato spiegare a un Anangu i problemi che sta vivendo la civiltà occidentale, nel suo rapporto con la natura. D'altra parte, potrebbe osservare qualcuno, la nostra civiltà è nata proprio da questa separazione, sia da un punto di vista filosofico, ideale, che da quello tecnico, materiale. E quindi dallo sfruttamento delle risorse a disposizione. Suona quasi paradossale il fatto che oggi si torni a guardare (anche) alle culture indigene per ritrovare il bandolo della matassa, troppo intricata ormai, e ipotizzare un modo diverso di abitare il
mondo, di concepire l'uomo e il suo rapporto con gli altri esseri viventi, di ragionare in termini di unità nella differenza. Per gli Anangu «la terra è come i figli». Una pozza d'acqua non va preservata per una questione di utilità (anche se, ovviamente, è utilissima, anzi indispensabile). È qualcosa di sacro. Un dovere morale. «Distruggere la terra non significa privare qualcuno di una proprietà. È distruggere la trama del loro essere». Significa rompere il legame religioso con lo spirito creativo.

Questa idea di sacro, questa concezione organicista e non meccanicista dell'universo, questo senso di interconnessione fra le cose, è davvero così impossibile da re-imparare, con gli opportuni (anche scientifici) adattamenti concettuali?
Un mondo senza confini evoca una prospettiva del genere, guardando al deserto come realtà fisica, sociale e metaforica. Le condizioni estreme spazzano via il superfluo. Rimangono gli esseri umani, nelle loro necessità fondamentali e nelle loro aspirazioni ideali, così simili in ogni angolo del globo.
4 AGOSTO 2023
E DITORIALE
Rimane il bisogno di trovare un equilibrio con l'ambiente circostante. E non è certo un caso che si parli anche di donne e uomini che provano a superare un confine, in cerca di una nuova vita, o che si ritagliano uno spazio comunitario fuori da ogni confine. Una concezione simile la troviamo in Siamo Foresta, la mostra ospitata alla Triennale di Milano, dove il luogo senza confini è fatto di alberi, e popoli indigeni, e animali, e spiriti evocati da sciamani. Sciamanica è anche l'arte, che esalta la resistenza contro l'inciviltà del potere e dello sfruttamento, ritrovando il senso profondo di antiche culture dimenticate (compresa la nostra). Artisti indigeni e non, che vivono la foresta come luogo di libertà, bellezza, conoscenza. Citando Claude Levy Strauss: «Si è cominciato a separare l'uomo dalla natura, e con il costituirlo a regno sovrano; si è così creduto di cancellare il suo carattere più inconfutabile, ovverosia che egli è in primo luogo un essere vivente».
Questa filosofia della convivenza tra diversi, la convinzione che «siamo tutti compagni di viaggio dentro questo mondo», è quella che Fabrizio Rondolino vive ogni giorno insieme al suo "branco", fatto di cani e gatti. Gli animali «non sono fratelli, non sono sottoposti: sono altri popoli, catturati insieme a noi dalla rete della vita e del tempo». Con i loro limiti, ma a modo loro perfetti (esattamente come noi) Dopo una vita spesa a battagliare tra gli uomini, Rondolino si è ritirato in campagna, scoprendo che cani e gatti

conoscono il segreto dei segreti, la capacità di vivere nel presente. Il qui è ora è anche la scoperta decisiva per Anna Kolesarova, ballerina, coreografa, insegnante di danza, partita dalla Slovacchia e approdata alla Scala, per poi cimentarsi in tante avventure, stili, esperienze diverse. L'equilibrio (a partire da quello tra corpo, mente e anima) lo si trova "in movimento". Non è uno stato definitivo, un luogo, un'idea, ma un modo di essere.
La meditazione è lo strumento più efficace per radicarsi nel presente, per trovare il proprio centro (spirituale), per provare ad andare oltre l'ego e i suoi condizionamenti. Ne parliamo con Adriano Ercolani, uno che nel caos ci sguazza, con irriverente frenesia, mischiando sacro e profano, mentre insegue l'Uno. Lui la meditazione la pratica da tanti anni e, giustamente, mal sopporta le banalizzazioni e gli equivoci sorti intorno a questa pratica multiforme. A proposito di rapporto tra uomo e natura. La dott.ssa Luciana Baroni ci spiega perché la dieta vegetariana è il presente e il futuro dell'uomo. E il Festival di Architettura ci indica le nuove frontiere del turismo, nel segno dell'abitare (la vacanza), invece di sfruttare e consumare. L'uomo ha un potere creativo immenso. Ma anche distruttivo. È arrivato il momento di scegliere. Ce lo dice Christopher Nolan nel suo Oppenheimer, un film che è un'esperienza fisica e filosofica, un'immersione nei segreti della materia (e della mente) oltre che nella brutalità demenziale della politica. (f.t.)
5 AGOSTO 2023
Fabrizio Rondolino
"Ritornare a casa", dopo una vita "in guerra" nell'agone politico
Tra cani e gatti, esseri misteriosi, «persone di un altro pianeta»

I NCONTRI
di Fabrizio Tassi

(foto Gianmarco Chieregato)
«Siamo tutti perfetti, ciascuno nel proprio modo. Siamo simili, e siamo diversi»
Il riposo del guerriero. Dove la “guerra” è la vita, a prescindere. Meglio ancora (o peggio) se combattuta al centro dell'agorà, nell'arena della comunicazione politica, tra gladiatori e peones, abili retori e opinionisti compulsivi. Dove il “riposo” non è la fuga in un luogo esotico, un pensionamento dorato, un ritiro spirituale in beata solitudine, ma una vita “in branco”, nella campagna sabina, circondato da cani e gatti. La suggestione è omerica e ce la offre Fabrizio Rondolino, nel suo Compagni di viaggio, edito da Rizzoli. Un libro che è diario (intimo) e saggio (etologico), riflessione personale, anche poetica e filosofica (mai
Non ho nessuna nostalgia di ciò che ho lasciato. Non guardo la televisione, non ho twitter, sui social pubblico solo foto di cani.
Non ho nessun rimpianto. Hai presente "My Way"? Il testo è pazzesco. L'ho riascoltata di recente, è una bella filosofia: ho provato a fare le cose a modo mio
indulgente), e manuale animalista, con tanti suggerimenti pratici. Lo stile è limpido, immediato, la trama appassionante come quella di un romanzo, con i suoi personaggi (cani e gatti, appunto) che entrano ed escono dalla storia, rivelando complessità inaspettate. Un libro sorprendente. Così come la spietata sincerità e la semplicità zen con cui Rondolino dice che «per affermare noi stessi non possiamo non fare del male», che la “guerra” è piena di «urti, delusioni, meschinità», che la contesa della vita porta ad essere «arroganti o servili, ipocriti e sleali», ma poi arriva il momento in cui si diventa grandi per davvero ed «è ora di tornare a casa». Accade nell'Iliade e nell'Odissea. Accade in tante vite, forse quasi tutte, certamente nella sua, che oggi è completamente dedicata a questi esseri misteriosi, «così lontani eppure così vicini, trasparenti ma inafferrabili», che sembrano «persone di un altro pianeta»
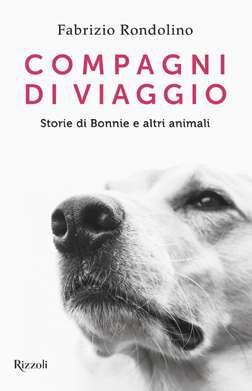
Rondolino ha combattuto per decenni, armato fino ai denti (di parole, che come tutti sanno possono fare malissimo). Arguto, poco diplomatico, odiato dai “nemici”, temuto dagli “amici”, sempre intelligente, spesso controcorrente, con una storia partita dal Pci, l'Unità, D'Alema e arrivata fino a Renzi, di cui appoggiò la battaglia referendaria e il tentativo di dare una svolta riformista e liberale alla sinistra italiana. Scelte che gli hanno procurato attacchi in quantità, a cui ha risposto a tono.
Ma nella sua vita, oltre al giornalismo, la politica, i dibattiti televisivi, ci sono anche racconti, romanzi, programmi tv. E c'è soprattutto una sensibilità che ha poco a che vedere con la durezza del dibattito politico nostrano. La sua bacheca Facebook fino a qualche anno fa era un campo di battaglia, con post polemici che scatenavano commenti anche violenti. Oggi trovate solo orizzonti verdi e blu, colline presidiate da magnifici maremmani, gatti che giocano, scene di vita quotidiana che parlano di un altro tempo (più lento) e spazio (più vasto), vissuto secondo regole naturali, dove uomini e animali convivono nel rispetto delle reciproche diversità.
Perché poi la questione è tutta lì. Per dirla con Henry Beston, citato in esergo: «L’uomo non è la misura degli animali. Essi si muovono perfetti e completi in un mondo più antico e più completo del nostro, dotati di sensi che noi abbiamo perso o che non abbiamo mai avuto, vivendo di voci che non potremo mai udire.
8 AGOSTO 2023
Non sono fratelli, non sono sottoposti: sono altri popoli, catturati insieme a noi dalla rete della vita e del tempo, compagni di viaggio nello splendore e nel dolore della Terra».
Come dice Rondolino (che ai cani dedica anche ore di volontariato): è arrivato il momento di uscire definitivamente dalla logica degli animali come “creature inferiori”, ma questo non significa trattarli come pupazzi da coccolare, umanizzandoli, imponendo loro abitudini innaturali.
Sono compagni di viaggio. Che si chiamano Bob, Claire e Shylock (un cane lupo cecoslovacco, un doloroso “fallimento”), Stella e Jefferson, la gatta Lola (che chiede a Fabrizio di seguirla, perché vuole partorire insieme a lui) oppure Valentino (che ama la musica classica), ognuno con la sua personalità e la sua storia. Che magari si ritrovano a convivere in un pezzo di terra magica, davanti al monte Soratte, «l’isolotto di roccia nella campagna romana che il dio Apollo – così
riferisce Virgilio nell’Eneide – protegge fin dall’origine dei tempi».
Rondolino parla delle differenze tra cani e gatti (che ama allo stesso modo), dell'educare un animale come «“portare alla luce” la sua natura e il suo carattere», del lettone “sancta sanctorum” (con la buffa processione dei devoti quadrupedi, seguendo la gerarchia del branco), del dolore «violento, immedicabile» che procura la loro scomparsa, del «piacere ogni volta irripetibile» di avere un gatto che ti dorme addosso, di esseri che conoscono il segreto del vivere nel qui e ora.
L'intervista capita in uno di quei giorni in cui è necessario correre dal veterinario. Uno dei maremmani ha avuto un incontro troppo ravvicinato con un temibile “forasacco”. «Una scena splatter, l'ha inghiottito e gli è uscito da un fianco. Gli hanno fatto un'ecografia, il veterinario ci ha tranquillizzato»
Perché i cani sono persone di famiglia. Con tutte le gioie e le preoccupazioni del caso.

9 AGOSTO 2023
Fabrizio Rondolino Otto, Bonnie e Valentino
La scelta di vivere in campagna è definitiva.
Vado a Roma solo in casi di estrema necessità. Nel weekend, poi, arrivano amici e famigliari. Ma la mia vita ormai è qua, in bassa Sabina.
Spazi sterminati, orizzonti lontani.
Il punto forte di questa casa è proprio l'orizzonte, la vista. In realtà è un classico casale di campagna, niente di più. Ma si trova su una mezza collina, con vista spettacolare sul monte Soratte.
Un luogo scelto o ritrovato?
Non ero mai stato qua. Una quindicina di anni fa ho deciso di comprare una casa in campagna, fondamentalmente per i weekend, un buen retiro. L'abbiamo trovata per puro caso. Cercavamo un posto vicino a Roma
(un'oretta di macchina, non di più), con l'idea magari di fare i pendolari. I romani vanno tutti in Maremma o in Umbria, in Sabina non c'è nessuno. Ci sono inglesi, olandesi, adesso stanno arrivando gli americani, poi ci sono i sabini, i locali. A me piace proprio per questo: è glocal, come si direbbe oggi. Mia figlia veniva qui a fare le escursioni con gli scout, ma nessuno di noi conosceva questi posti. Ci siamo innamorati, perché è campagna vera. Non ci sono i “vip”, non è Capalbio, dove hai quasi degli obblighi sociali (una grossa rottura di scatole). Te lo dico per esperienza, perché c'è stato un periodo in cui ho frequentato luoghi del genere.
Però tu la campagna ce l'avevi nel dna. Nel libro parli delle vacanze in Monferrato coi nonni.
Sì, sono per metà monferrino. Quando ero molto piccolo ho vissuto le mie estati in campagna, fino all'adolescenza, quindi immagino ci sia una specie di imprinting.

10 AGOSTO 2023
Una nostalgia che ti porti dentro, una sorta di memoria fisica di quella “libertà assoluta”.
È possibile. A me la campagna piace. Per molti è una noia mortale, io invece vivrei sempre in campagna. Mi piace così tanto che 4-5 anni fa mi sono trasferito qui.
Molto efficace la metafora omerica, l'idea della vita divisa tra “guerra” e “ritorno a casa”. Non ti manca mai il campo di battaglia?
No, per nulla. Non ho nessuna nostalgia di ciò che ho lasciato. In realtà potrei riprendere in qualsiasi momento, ma no, proprio no. Non voglio sputare nel piatto in cui ho mangiato per tanti anni, ma sono disgustato dal dibattito pubblico italiano, in tutte le sue forme, dalla qualità della classe politica, del ceto giornalistico, dell'informazione televisiva. Mi ritengo molto lontano, ormai. Non guardo la televisione, non seguo i siti, non ho twitter, sui social pubblico solo foto di cani. Ogni tanto, una volta al mese, mi affaccio sulle notizie e mi accorgo che sono le stesse di cinque anni fa. Non riusciamo a spendere i fondi europei: ah, davvero? Facciamo il presidenzialismo: sì, come quindici anni fa… Sono aggiornatissimo senza sapere nulla perché, essendo una massa di mediocri, non fanno altro che ripetere le sciocchezze che hanno sempre ascoltato. Anche se poi, in realtà, nel nostro circo politico-mediatico non succede mai niente.
Una volta l'anno scrivo un libro e faccio il giro dei talk show, ringraziando i miei amici conduttori che ancora mi invitano, e me ne torno a casa sempre più sconvolto. Non voglio offendere nessuno, perché sono tutti amici miei, lo dico con sereno distacco, non con cattiveria.

La distanza si sente, nelle cose che scrivi. La serenità.
Il tempo serve anche a quello, a cancellare le asperità.
Nel libro si intuisce anche una specie di pentimento. Tra le righe escono i sentimenti. Rimpianti?
Non ci sono. Hai presente My Way? “Ho qualche rimpianto, ma sono talmente pochi che non vale la pena parlarne”. Il testo di My Way (scritto da Paul Anka) è
pazzesco. Tra le mie passioni c'è anche Frank Sinatra. L'ho risentita di recente ed è una bella filosofia: io ho provato a fare le cose a modo mio.
Prova a spiegare, a chi non ti conosce, qual era la tua guerra, il tuo campo di battaglia.
La politica. Una passione costruita, maturata, esplosa fin da giovanissimo. Gli anni Settanta vengono ricordati come gli anni di piombo, in realtà sono stati anni di straordinaria creatività e partecipazione. La politica era quello. Decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia di persone che si organizzavano e facevano. La fisicità della politica. Se dovessi riassumere la mia battaglia, tra virgolette, è stata la modernizzazione della sinistra. Una sinistra riformista, liberale. Su questo punto il fallimento è totale, definitivo. In Italia non c'è una sola persona che si possa definire liberale riformista. Ed è una cosa abbastanza impressionante, se pensi alla storia della sinistra, anche prima della scissione di Livorno, il dialogo tra l'ala massimalista e quella riformista.
11 AGOSTO 2023
Fabrizio Rondolino
Jefferson e Laura
Qualche volta hanno vinto i riformisti, qualche volta i radicali. Ora invece una cultura riformista non c'è più. Forse solo, a tratti, nelle parole di Renzi e Calenda, che però sono piuttosto marginali.
Il paradosso è che alcune delle cose più interessanti che capita di leggere sulla storia del Pci le scrivi proprio tu, un “nemico della vera sinistra”, un “liberale” che “voleva distruggere la Costituzione”.
Penso al tuo libro su Berlinguer, che in realtà non era un politico d'apparato, ma un uomo libero, il cui pensiero era tutt'altro che ortodosso.
Sono contento che tu lo dica perché anch'io la penso così. Ma siamo pochi. Berlinguer è diventato un'icona di Ca-
saleggio, di Rifondazione Comunista, il suo destino post mortem è particolarmente infelice. Lui faceva parte di un mondo che non c'è più, quella dimensione della politica di cui ti parlavo, che era partecipazione. Sparita quella, vince sempre la demagogia, il populismo. Diventa solo una questione di brainwashing, di manipolazione degli ignoranti, che è un gioco da ragazzi. Una volta c'era quell'intercapedine che si chiamava intermediazione sociale: sindacati, parrocchie, partiti o bocciofile, qualunque cosa capace di mettere insieme fisicamente le persone, per far crescere una comunità. Se la comunicazione è diretta, se il discorso pubblico è disintermediato, allora vincono per forza i demagoghi e i populisti. Quindi siamo spacciati. Jefferson, mio punto di riferimento, mio grande amore, insisteva molto su questa cosa: l'obbligatorietà del voto, il suffragio universale, portava con sé l'istruzione obbligatoria, perché per votare consapevolmente bisogna aver studiato almeno due cose. In America era quasi un'eresia già allora. Se hai studiato e se hai un minimo di indipendenza economica, la tua scelta è davvero libera. Oggi quasi nessuno di noi è libero, gran parte della nostra vita è manipolata, condizionata da vizi, luoghi comuni, abitudini. Che ne è della nostra libertà di scelta?
Jefferson, nel tuo libro, è anche una sorta di mediatore culturale tra il mondo umano e quello animale.
Sì, quando affronto il tema del diritto alla felicità.
Felicità come soddisfazione di essere ciò che sei, fare ciò per cui sei venuto al mondo. A prescindere dalla specie di appartenenza. In realtà il tuo libro è anche una riflessione filosofica e sociale. Non sei diventato un eremita, uno che si è tirato fuori dal mondo.
No, però un pochino sì. In realtà ho tanti amici politici e giornalisti, mi arrivano le informazioni, mi piace parlare di queste cose, non vivo in cima a una montagna, ma non è più il centro della mia vita. Sono molto distaccato. Mi piace semmai ripercorrere pezzi di storia, Berlinguer, il Pci. La distanza ti permette di guardare le cose in modo diverso. Ma non voglio essere un nostalgico, uno di quelli che dicono “ai miei tempi” (anche se forse l'ho già detto tre o quattro volte).

12 AGOSTO 2023
Lola e Sandro bevono il latte una accanto all'altro
Cani e gatti sono "buddhisti", vivono nel presente, non coltivano rancori e aspettative. Loro ci riescono naturalmente, come i bambini. Per noi adulti, invece, ci vuole tutta una vita.
In realtà penso che ogni generazione abbia il diritto di fare le sue scelte, che il mondo non finisce mai, che non c'è mai nulla di definitivo, che c'è sempre un altro punto di vista... Una posizione di fondo non apocalittica. Diciamo però che non fa più per me, non mi ci ritrovo.
Più che un nostalgico, da questo libro viene fuori un praticante zen, radicato nel presente. Un po' come i cani e i gatti. C'è un capitolo in cui parli della “coscienza del tempo”. Noi esseri umani «siamo gli unici – almeno per quanto ne sappiamo finora – ad avere il concetto del passato e del futuro: e questo doppio concetto, come ben sappiamo, può essere un motore potente per le nostre attività oppure, al contrario, una causa decisiva della nostra infelicità».
Cani e gatti sono “buddhisti”, vivono nel presente, non coltivano rancori e aspettative. Loro ci riescono naturalmente, come i bambini. Per noi adulti, invece, ci vuole tutta una vita a tornare come loro e spesso non basta.

Recuperare quel saper essere e stare interamente in ciò che fai... Se tutti lo facessero, ci guadagne-
rebbe anche la collettività, non solo il benessere individuale.
In un certo senso il massimo dell'egoismo lo considero il massimo dell'altruismo. Se stai bene, sei felice, sei liberato, non puoi che fare del bene agli altri, e anche la gente intorno a te sta bene.
Il libro si apre con una bella citazione di Beston.
Lui è stato uno dei primi a vivere da solo nella natura, nella wilderness, a scrivere di queste cose. Parole di grande verità.
Come dice Beston, c'è anche qualcosa di mistico nella contemplazione di questo mondo completo in sé. Tu non sei affatto religioso, ma c'è del sacro in questa prospettiva.
Io direi “misticismo scientifico”. È la nostra scienza che è arrivata in ritardo nella considerazione del mondo animale.
Prima c'era questa ideologia degli animali considerati come strumenti, oggetti, invece abbiamo scoperto la ric-
13 AGOSTO 2023
(foto Marco Minniti) Fabrizio Rondolino
Bonnie, Sandro e Valentino al tramonto
chezza di quella realtà, l'interconnessione. Ti concedo l'aspetto mistico, ma fondato su solide basi scientifiche.
La tua formazione, in fondo, è filosofica. Ti sei laureato in filosofia teoretica.
Una grandissima passione, che in qualche modo è rimasta.
Si vede ad esempio nell'immagine finale del libro, particolarmente poetica: la Terra che rotola senza sosta in un universo inanimato, e noi che siamo aggrappati a questa “madre” che «ci protegge, ci avvolge e ci coccola, e così protetti ci conduce a spasso per il cosmo».
Si prova una certa vertigine pensando a certe cose. Lì siamo davvero al confine col mistico.
Che rapporto hai con l'ambientalismo e l'animalismo più radicale?
Non è my cup of tea. Ci vedo una sorta di irrazionalismo estremo. Ma soprattutto c'è una visione capovolta e altrettanto malata della natura: noi l'abbiamo usata nei secoli come una sorta di cava da cui prendere tutto ciò di cui avevamo bisogno; loro invece la pensano, all'opposto, come un museo intoccabile, anzi talmente intoccabile che noi possiamo anche scomparire. Una concezione che non ha nulla di scientifico e che reifica la natura, allo stesso modo dell'atteggiamento di chi la vuole sfruttare. Ultra-conservazionista, concettualmente sbagliata e anche nevrotica, legata all'ossessione per la cura del corpo. Poi, per carità, meglio un ambientalista radicale che un cementificatore folle. Anche se hanno una concezione molto simile.

14 AGOSTO 2023
Sergio osserva i cani
L'idea principale che emerge dal libro è quella della necessità di accettare cani e gatti come “un mondo completo” accanto al nostro, che va rispettato in quanto tale.

Rispetto forse è la parola giusta. Ognuno è perfetto nel proprio ambito. Dal punto di vista scientifico è esattamente così. Lo dice l'evoluzione. Una cosa che non abbiamo ancora totalmente digerito, perché continuiamo a considerarci come separati dalla natura.
Parli anche degli animali come “persone”. Anche se “aliene”. Qui il dibattito si fa complesso.
Perché il concetto di persona evoca un significato religioso. Io sono profondamente convinto che gli animali
abbiano una loro personalità, un carattere, emozioni, pensieri. Mentre è ancora diffusa questa idea pre-darwiniana della superiorità dell'essere umano, la concezione dell'uomo come unico essere vivente capace di usare degli utensili e quindi di sviluppare una cultura. In realtà abbiamo scoperto che anche gli scimpanzé costruiscono strumenti e trasmettono una cultura. Sappiamo addirittura che specie diverse di scimpanzé hanno comportamenti diversi, e quindi culture diverse. Certo non è come dire “gli Egizi e i Sumeri”, ma non c'è nessuna differenza rintracciabile, scientificamente dimostrabile, tra l'homo sapiens e le altre specie di animali. Bisogna accettare, interiorizzare un'impostazione del genere. Siamo tutti compagni di viaggio dentro questo mondo. Ignoriamo le origini e il senso della natura, ma siamo tutti qua, insieme.
15 AGOSTO 2023
Fabrizio Rondolino
Compagni di viaggio è anche una sorta di manuale, pieno di consigli pratici. Ed è un romanzo corale, con tanti protagonisti (cani e gatti), ognuno con la sua personalità.

Col tempo si approfondiscono i rapporti, esattamente come con gli umani. Più li frequenti più ti accorgi del loro carattere, che diventa inconfondibile.
Parlaci della tua idea di “educazione montessoriana”. Che forse hai scoperto nel corso degli anni. Avevi animali anche quando vivevi in città?
Ho vissuto con dei gatti, fin da quando sono andato via di casa da ragazzo. I cani sono arrivati soltanto in tempi più recenti. Bob, il primo cane adottato, è arrivato sedici-diciassette anni fa e ora non c'è più. Racconto anche questo. Il tema dell'educazione è molto complesso, ci sono persone molto più qualificate di me per affrontarlo. Diciamo che tra gli educatori cinofili ci sono anche pensieri radicalmente diversi.
Abbiamo usato la natura come una sorta di cava da cui prendere tutto ciò di cui avevamo bisogno. Ma nell'ambientalismo più radicale vedo una visione altrettano malata, anche se capovolta, che reifica la natura e la trasforma in un museo
Ma la scuola ampiamente prevalente ormai è quella del rinforzo positivo, che condivido anch'io, cioè premiare i comportamenti corretti (evitando invece le punizioni quando sbagliano). Io non uso bocconcini, lo trovo sbagliato perché “umano”, uso la carezza, un “bravo” detto con un tono dolce, basta per renderli felici. Anche in questo gli animali sono straordinari, come i bambini.
Poi capita di entrare in un negozio per animali e vedere, orrore!, una “colomba per cani”. Mi hanno detto che ne vendono tante. Vendono anche panettoni.
Quelli sono trastulli per noi umani.
Sì, ma ti rendi conto, il fraintendimento radicale?
Come puoi immaginare che all'animale possa interessare una cosa del genere? Il punto è farli essere pienamente animali, non trasformarli in umani. Se li voglio rendere felici, vado dal macellaio, che sottobanco mi dà un ginocchio di bue. Per un cane è il massimo. Perché dovrei comprare una cosa chimica, con una forma strana, che diverte me, ma non certo lui? Il cane, negli ultimi ventimila anni, non ha mai incontrato un panettone, mentre invece ha incontrato molte ossa. A me comunque interessa l'atteggiamento di fondo. L'ani-
male deve certamente imparare delle cose, ma la lezione principale è la trasparenza dei sentimenti, la fiducia e il rispetto reciproci.
Oggi quanti animali ci sono nel tuo branco?

Ci sono sempre i tre maremmani abruzzesi, due di razza quasi pura, mentre Valentino è un pochino più piccolo. Tutti adottati. E poi ci sono sei gatti.
Uno in più, rispetto al libro.
Sì, è arrivato dopo, si chiama Charles, lo puoi vedere su Facebook: un micetto bianco che ho trovato vicino a casa un paio di mesi fa.
Si è già integrato?
No, non si è integrato, è diventato il padrone della casa! Il gatto più spavaldo, arrogante e incosciente che io abbia mai incontrato. Fa quello che vuole.
Quindi è il tuo preferito.
In questo momento sì, lo ammetto.
17 AGOSTO 2023
Fabrizio Rondolino
 (foto Thomas Darlis)
(foto Thomas Darlis)
Anna Kolesarova
Forse l'avete vista alla Scala o alla Fenice, quando il suo mondo era quello (esclusivo, severo, rigoroso) della danza classica. Oppure all'Out Off di Milano o al Martinitt, legata a un filo rosso (Il filo rosso del destino), quando il corpo si è sciolto nei movimenti liberi e fluidi della danza contemporanea. Può darsi che l'abbiate vista indossare dei jeans Benetton su un cartellone pubblicitario, o ballare dentro uno spot Breil o Campari. Scatenata, in tv, tra le ballerine di Zelig o di Crozza. Sognante e appassionata, su un palcoscenico teatrale, quando ha interpretato il musical Fame. Ha fatto “volare l'anima” di Elisa, in un poetico videoclip, ha danzato con Luciana Savignano e Raffaele Paganini, ha creato spettacoli in cui i corpi dialogano con le luci laser. Ballerina, coreografa, modella, insegnante di danza, Anna Kolesarova è tante cose insieme, tutte diverse, unite dal filo della consapevolezza, dal bisogno di mettersi alla prova per conoscersi meglio, dall'arte di stare in equilibrio (in movimento) mentre tutto intorno cambia velocemente. In punta di piedi, pronta a spiccare il volo, ma radicata nella terra. Eterea, elegante, ma anche sensuale quando serve. Dolce e severa (con se stessa, per lo più).
Coi suoi 38 anni che sembrano 25 al massimo, la voce sottile, il viso di una ragazzina, ma l'energia e l'esperienza di chi ne ha già viste tante, e tantissime ne ha sperimentate, dall'élite della danza all'hip-hop, dalla tv commerciale al teatro di ricerca. Ecco soprattutto cosa ci affascina di questa artista nata in Slovacchia e cresciuta in Italia: la sua capacità di cambiare, rimanendo se stessa. Dentro un percorso di vita che ha dovuto attraversare anche la prova (durissima) della malattia. Alimentato da una “visione olistica” della realtà, dove l'olismo però non è solo una parola ad effetto, ma un modo di guardare le cose e di vivere la danza, senza inseguire l'iper-specializzazione diffusa o la ricerca della performance spettacolare (attira-like). In cui la ricerca interiore è importante quanto l'allenamento atletico del corpo, e l'empatia, la costruzione di una relazione profonda con l'altro (l'allievo, ad esempio), è fondamentale quanto la conoscenza della tecnica.
Incontriamo Anna Kolesarova al termine di un seminario di danza contemporanea dedicato al “floorwork”. Un lavoro sulla forza di gravità e i movimenti a terra, dove si cerca di fare emergere le emozioni più profonde, ritrovando l'unità tra corpo, mente e spirito. Due giorni di workshop, organizzati dal Teatro dei Navigli (realtà importante della provincia milanese), all'ex-convento dell'Annunciata di Abbiategrasso. Ed è proprio qui, in questa cornice magica, che ci diamo appuntamento. Lei è giustamente sfinita, ma sorridente. Lo sarà per tutta l'intervista. Con uno sguardo che ascolta, pieno di gratitudine, che accoglie ogni domanda come un'occasione per riflettere su di sé e sul proprio lavoro.
19 AGOSTO 2023
I NCONTRI
I sacrifici, il sogno (realizzato), il coraggio di cambiare. L'arte della danza, sul palcoscenico e nella vita, "qui e ora"
Mentre camminiamo mi racconta della sua scelta di vivere a Lecco, fuori dal caos di Milano, in un luogo un po' più a misura d'essere umano. Mi avvisa anche che sarà lenta a rispondermi, perché vuole cercare le parole giuste. Al bando la fretta, viva la lentezza, la sincerità, gli incontri veri.
Alla fine ci sediamo davanti a un castello (visconteo), in mezzo al vociare della gente di passaggio, chiacchierando d'arte e di vita. Anche se quelle di Anna, in realtà, non sono solo parole, c'è spesso un gesto che accompagna il suono, un movimento del corpo, delle braccia, per illustrare un concetto che magari in astratto non rende l'idea, ma una volta incarnato diventa chiarissimo. Parole danzate.
Ci racconti da dove è cominciato tutto? Come hai scoperto la vocazione per la danza?
In realtà è un talento che gli altri hanno visto in me. Lo hanno riconosciuto quando ero bambina. Fu la maestra a dirlo ai miei genitori. Per questo sottolineo spesso il ruolo delle scuole di provincia, la loro importanza nel far emergere i talenti e nell'indirizzare i bambini. Avevo 9 anni, abitavo in Slovacchia. Mia madre mi disse: vuoi provare a ballare? Ero la classica bambina che sogna di essere una principessa, con la sua coroncina, e che vorrebbe stare su un palco, ignara di tutti i sacrifici necessari per arrivarci. Sono andata a fare un provino, in Conservatorio, e sono arrivata prima.
Ma tu amavi ballare, non è stata un'illuminazione improvvisa.
Sì, mi piaceva ballare e mi piaceva essere al centro dell'attenzione. Ma fino a quel momento non avevo mai visto una ballerina. Forse solo una, che però non mi aveva colpito in modo particolare. La mia era soprattutto un'esigenza di esprimermi. Cosa che potevo fare attraverso la danza. Io sono figlia d'arte, la mamma e il papà (il mio padre naturale) sono musicisti. Mia madre insegna musica ed è direttrice di un coro, mio padre è anche compositore. Sono nata in un mondo pieno di musica. La danza era il modo più tangibile, fisico, di vivere quella realtà.
Quindi i tuoi genitori ti hanno incoraggiata.

20 AGOSTO 2023
A 9 anni ho dovuto trasferirmi a Bratislava, da sola, in un collegio, per studiare danza.
A 13 anni sono stata ammessa alla Scala.
È stata dura, ma avevo un grande sogno
(foto Fulvio Francone)
Diciamo che mi hanno dato l'opportunità di seguire questa vocazione, nonostante sapessero quanto possa essere difficile la vita d'artista. Sono stati bravi. Ci sono genitori che vietano ai figli di seguire un percorso del genere. La vita d'artista è faticosa, con poche tutele, priva di stabilità. Io ho avuto la libertà di scegliere. È stato un dono dei miei genitori. Hanno dovuto fare tanti sacrifici (anche economici) perché io potessi arrivare alla Scala.
Un bel salto, dalla scuola pubblica di una città di provincia al Conservatorio.
Sì, anche perché a 9 anni ho dovuto trasferirmi da sola a Bratislava. Vivevo in un collegio della capitale. Ovviamente c'erano delle istruttrici che si prendevano cura di noi, ma noi bambini eravamo comunque da soli nelle nostre camerette. Ho pianto tanto. Mia madre non lo sapeva. Dopo un anno, però, lei e mia sorella si sono trasferite a Bratislava, per seguirmi meglio.
Era più forte la tristezza, la sofferenza per il distacco dagli affetti, o la voglia di fare, creare?
Avevo un grande sogno. E quando da piccola sono stata scelta per il ruolo di Clara, come protagonista dello Schiaccianoci, al Teatro nazionale, il sogno è diventato realtà. È stata una soddisfazione talmente grande, che ne volevo ancora, di più.
Il piacere di dare corpo a un personaggio.
Hai detto la cosa giusta: dare il corpo. Le maestre dicevano di essere rimaste colpite dalla mia espressività, da come riuscivo a trasmettere la storia. A 10 anni, quando mi dissero che dovevo interpretare Clara, mi sono vista tre diversi film: volevo fare l'analisi psicologica di quella bambina, capire come si sente, “rubare” anche alcune cose a livello espressivo. Studiai molto, curando i dettagli.

21 AGOSTO 2023
(foto di Ivana Noto) Anna Kolesarova
Quindi era un lavoro anche intellettuale, non era solo tecnica e istinto.
Era il bisogno di trasmettere qualcosa, un certo tipo di emozioni. Il piacere di raccontare una storia nel miglior modo possibile.
A che età sei venuta in Italia?
A 13 anni, dopo quattro anni di Conservatorio. Ho fatto l'esame di ammissione alla Scala, mi hanno presa e ho avuto la possibilità di continuare il mio percorso
Il trasferimento a Milano è stato traumatico?
Sì, perché avevo 14 anni, in piena adolescenza, quando avresti bisogno di formare la tua cerchia sociale. Non sono stata accolta per niente bene dai miei compagni di corso. Lo dico senza problemi. I ragazzi a 14 anni sono cattivi, è una fase che si attraversa. Quando sono venuta in Italia, non erano passati tanti anni dalla caduta del Muro, non c'era stata ancora l'apertura verso l'Europa. Io avevo il mio modo di vestirmi, tipico del mio paese. Mi ricordo un giorno in cui ho sorpreso le compagne di stanza che si erano messe addosso i miei vestiti per prendermi in giro. In quegli anni ho dovuto tirare fuori tutta la forza che avevo. Alla fine mi sono diplomata con un ottimo voto, mi sono presa la mia rivincita. Ho anche cominciato a lavorare nel mondo della moda.
Quando si parla di sacrifici... Non hai vissuto fino in fondo la tua infanzia, l'età del gioco, e neppure l'adolescenza. Ma è più grande la soddisfazione per aver trovato la tua strada o il rimorso per ciò che hai perso?
Sì, ho perso qualcosa. Anche perché quando ho iniziato a lavorare, ho pensato solo alla mia carriera. Ho perso alcune persone per strada, perché in quel momento per me era più importante prendermi delle soddisfazioni nel mio campo. Ma la danza per me è sempre stata anche un gioco. Il mio modo di apprendere e di insegnare è quello. Da bambina, quando interpretavo lo Schiaccianoci, mi immaginavo quel mondo e giocavo. Ho sempre giocato con ciò che volevo esprimere e scoprire attraverso la danza. E lo stesso faccio oggi nell'insegnamento: non bisogna imporre nulla, le cose vanno scoperte giocando.

22 AGOSTO 2023
Noi profani vediamo nella danza classica un mondo apollineo, in cui la tecnica viene portata all'estremo, attraverso gesti ripetuti, in cui il ballerino deve trovare la sua espressività personale in modi per noi misteriosi. Altra cosa è la danza moderna e contemporanea, dove si arriva anche ad estremi di libertà anarchica. Immagino che tu avessi in mente una carriera da ballerina classica. Come è avvenuto il passaggio?
Anche quello non è arrivato da dentro, ma da fuori. Alla Scala, sotto la direzione didattica di Anna Maria Prina, hanno aperto una sezione di danza contemporanea e mi hanno selezionato. Io non volevo. Piangevo. Ma la danza contemporanea ti aiuta a migliorare alcune cose della classica, a superare certe rigidità. Ti ancora al pavimento, ti dà stabilità. Io avevo delle difficoltà tecniche, e la contemporanea secondo i miei docenti era la strada per aiutarmi. Anche se non volevo, ho seguito i loro consigli e quella è stata la mia salvezza. Grazie alla mia maestra Emanuela Tagliavia ho scoperto un mondo.
(Per spiegarsi meglio, le braccia disegnano un cerchio, che poi si trasforma, ndr) Quando spiego ai miei allievi la danza contemporanea, prendo la forma della prima posizione, il cerchio. E dico: in danza classica la posizione è questa, questa è la rigidità, puoi attraversare solo due o tre posizioni. Invece in danza contemporanea tu con questo cerchio puoi farci qualsiasi cosa: schiacciarlo, romperlo, alzarlo, ruotarlo, aprirlo. Hai tanta libertà. Ma sei comunque in una gabbia, dentro un cerchio, perché tutti abbiamo bisogno di binari su cui procedere, dobbiamo essere contenuti in qualche modo. La differenza è che in questo caso hai molte più possibilità di esplorare, di esprimerti.

Anna Kolesarova (foto Fulvio Francone)
Forse è anche una cosa legata alla personalità. C'è chi ha bisogno di stare dentro quella rigidità e chi sente l'esigenza di rompere le catene.
Io sono rigida di mio, quindi avevo bisogno di qualcosa che mi sciogliesse, che mi liberasse. Sono sempre stata molto severa con me stessa. La danza classica è così. Avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a fluire. La danza contemporanea permette di esprimere tutte le emozioni. Quindi si fluisce come l'acqua, ma c'è anche l'aggressività, il fuoco, c'è la terra, il contatto con il suolo. Ognuno, in una certa fase della propria vita, va a cercare l'elemento utile a ritrovarsi, a esprimersi, a riempirsi di qualcosa. Forse per questo ho esplorato tanti stili diversi.
Bisogna anche avere il coraggio di farlo. Tu hai fatto televisione, trasmissioni anche importanti, hai fatto hip-hop, musical, ma anche cose molto sperimentali. Alla faccia della rigidità. Immagino che siano parti diverse di te.
Sì, lo sono. È come un puzzle. E ogni esperienza è un piccolo pezzo.
Probabilmente la ballerina della Scala troverebbe un po' troppo pop, forse anche volgare, la scelta di far parte di un corpo di ballo in tv. Invece hai scoperto qualcosa anche lì.


Ma cosa vuoi trasmettermi? Quale emozione?
Io sono curiosa. E ciò che mi spinge a fare esperienze sempre nuove è proprio la mia curiosità, una cosa che mi nutre, che mi permette di rinnovarmi continuamente.
24 AGOSTO 2023
Alena Ettea
Oggi si rischia di perdere ciò che è davvero la danza. Con la complicità dei social, che esaltano la performance.
C'è l'idea di cercare sempre il massimo, stare sempre al top, spingere sempre.
A me incuriosiva molto il mondo della televisione, capire come funzionano quelle camere, sperimentare altri stili di danza. Oltre al fatto che nel mondo della televisione ti pagano meglio. Quindi sperimenti anche quella “pace interiore” per qualche anno.
Giusto. Perché c'è anche quel problema: bisogna mettere insieme uno stipendio.
E non è mai facile.
Nella danza, come nella musica, c'è sempre la questione del rapporto tra la tecnica, che rischia di diventare virtuosismo e maniera, e la libertà espressiva, che però deve avere una sua coerenza esecutiva. Come si esce dalla prigione della tecnica per trovare un proprio linguaggio?
Balanchine ha posto il focus sulla fisionomia dei danzatori, esaltando la lunghezza delle gambe e delle linee, perfezionando l'esecuzione dinamica dei passi e sottolineando la bravura tecnica. Nasce in quegli anni la modern dance americana. Ora viviamo in un mondo "contaminato" in cui non esiste uno stile definito, anzi si fondono le varie discipline (per esempio ginnastica e danza). Questi fattori hanno alzato ancora di più il livello, portando il focus sull'esecuzione e sui virtuosismi.
Il problema è che non bisogna mai perdere di vista la cosa fondamentale, ovvero l'espressività. Una ballerina non può competere, dal punto di vista atletico, con chi ha fatto per anni ginnastica ritmica o artistica. Così però si rischia di perdere ciò che è davvero la danza. Con la complicità dei social, che esaltano la performance, e ti fanno vedere quella cosa che magari riesce solo una volta, però è talmente “wow”! C'è l'idea di cercare sempre il massimo, stare sempre al top, spingere sempre.
Ma cosa c'è dietro? Cosa vuoi trasmettermi? Quale emozione? Oggi questo viene a mancare. Con il rischio di una disumanizzazione dell'artista. Sono sincera, io tecnicamente non ero forte, la mia forza era l'espressività, quindi forse anche per questo mi sento più vicina al filone che sottolinea l'importanza dell'emozione. Anche qui però ci vuole equilibrio. Un ballerino completo deve saper bilanciare bene questi due aspetti: esecuzione ed emozione.

25 AGOSTO 2023
Anna Kolesarova
(foto Sham Hinchey)
(foto Fulvio Francone)
Lo spingere sempre di più, alla ricerca del like, fa parte di un mondo sempre più digitale, virtuale, che sembra muoversi verso la smaterializzazione della realtà. Stiamo perdendo la connessione con il corpo, con le emozioni. Troppo proiettati verso l'astrazione del gesto eclatante.
Siamo proiettati verso il fuori. L'evasione. Il metaverso. Quando io insegno ai non professionisti, la mia soddisfazione più grande è riuscire a riportarli nella consapevolezza del qui e ora. Questa è anche una forma di meditazione. Dal workshop che abbiamo fatto in questi giorni ho visto i ragazzi uscire con lo sguardo aperto, trasformati, presenti, vigili su quello che accade. Questa è la cosa più importante al giorno d'oggi. La tecnologia è fondamentale, ma l'uomo, oltre a possedere gli strumenti per fare, deve anche avere la consapevolezza.
Tu non hai certo paura della tecnologia, visto il lavoro che porti avanti sull'interazione tra danza e laser.
L'arte ha bisogno di rinascere, perché ormai tutto è già stato creato. E le nuove tecnologie possono essere utili come strumento di inclusione. Perché non unire la tradizione a qualcosa di innovativo che aiuti a ricreare e raccontare un'atmosfera in modo diverso?
A me le ispirazioni arrivano attraversano le immagini, che mi aiutano a costruire un mondo. Io evado, ma per poi costruire qualcosa nel concreto, perché diventi tangibile. Ecco perché mi piace lavorare con le luci laser. Già da piccola mi ricordo che a casa, al tramonto, giocavo con la mia ombra sulla parete, mi immaginavo le cose. Come in Inception: crei un mondo che diventa reale. A contatto con la parte creativa, femminile, dell'universo.
Hai praticato anche yoga e reiki.
E sono stata in India, con il mio maestro di yoga e due carissimi amici. Ma già la danza classica è rigida di per sé, anche lo yoga a volte rischia di esserlo, quindi ho avuto bisogno di praticare discipline più morbide. Per questo ho iniziato a sperimentare il Transformational Breath. Lavoro sul respiro, su come le emozioni e il corpo sono connessi. Ogni parte del nostro corpo, in qualche modo, rispecchia la persona. Questo mi aiuta tantissimo nella didattica. Io guardo l'allievo e vedo già le sue rigidità, i problemi, se non è ancorato, se ha la testa per aria... Lo vedo da come si muove. E allora, usando la gentilezza, accompagnandolo, lo aiuto a smussare, ad accogliere quel limite per superarlo.
Quando hai scoperto la vocazione educativa?
Ho sempre insegnato, fin da quando ho 19 anni. È un dono. Riuscire a vedere, a capire le persone. Rispettare l'allievo, i suoi limiti, aiutandolo a dare il massimo del proprio potenziale. Molti maestri non rispettano l'allievo. Per me invece ogni individuo è unico, speciale, e in base a quell'unicità, lo porto a esplorare se stesso, a dare il meglio.
Oggi chi sei, o meglio, cosa senti di essere? Ballerina? Coreografa? Insegnante?


Posso non rispondere? (ride) Diciamo che oggi ho una scuola di danza, aperta da un anno. Insegno soprattutto la danza classica ai bambini.

26 AGOSTO 2023
(foto Giorgia Zamboni)
Ma qui, ad esempio, ho fatto un'altra cosa, un seminario floorwork. Sono una trasformista. Tiro fuori ciò che gli altri vedono in me. Ma la cosa a cui tengo di più in questo momento è la scuola che porto avanti in Valsassina, dove ci sono bambini che, altrimenti, per fare danza dovrebbero andare lontano. Mi piace dare l'opportunità ai giovani di studiare la danza in un certo modo.
E la ballerina? La coreografa?
Non rinuncio a nulla. Ma la mia vita va a flussi. Ora c'è la scuola, domani non lo so. Diciamo che le cose sono cambiate quattro anni fa, per colpa di una brutta malattia. Non me la sento di parlarne, per ora, prima o poi farò outing. La malattia ha bloccato completamente il mio corpo. Non lo riconoscevo più, non riuscivo più a muovermi come prima. Ho dovuto rimodulare tutto, acquisire una nuova fiducia in me stessa e un nuovo modus operandi. Ma grazie a quell'esperienza sono nate anche nuove cose, come la scuola di danza, il lavoro sull'introspezione, il bisogno di approfondire il contenuto oltre la forma. Ho deciso di rallentare alcune cose. Lavoro ancora come coreografa, ma le energie sono quelle e bisogna amministrarle. Adesso sono in una fase in cui mi dico: ok, ho raccolto tante esperienze, ora diamoci dei limiti, ma senza smettere di cercare.
Hai una filosofia di insegnamento particolare?
Non insegno solo la danza, ma anche i valori: il valore di avere pazienza nel raggiungere un obiettivo; il valore del rimanere nel presente; del superare i propri limiti, ma rispettandoli, perché se non li rispetti ti fai male; il valore del tempo: non bisogna volere tutto subito, il bambino non deve essere frustrato perché non riesce a fare due piroette, perché si tratta di un percorso. Sono valori che rispecchiano il mio modo di vedere la danza. Alcune cose che insegno adesso le ho scoperte nel corso degli anni. Osservandomi, ho capito che in ogni fase della vita, ma anche in ogni fase emotiva attraversata, il mio modo di ballare cambia.

27 AGOSTO 2023
Anna Kolesarova (foto Thomas Darlis)
(foto Andrea Ciccalè)
Ho capito quanto le cose sono interconnesse e quanto ballare ti può aiutare nell'attraversare quella fase. È un viaggio, una scoperta sempre nuova.
Anche una forma di terapia.
Sì, certamente!
Si esprimono emozioni che altrimenti sarebbe difficile verbalizzare.
Per me un bravo artista, un bravo coreografo, è colui che riesce a comunicare i vari strati. Invece adesso è il momento della super-specializzazione, in cui ci si rivolge a quella particolare nicchia, dentro quel brand. Se sei bravo comunichi a tutti i livelli, attraverso tutti gli strati, da quello più superficiale a quello più profondo, fino all'ultimo pixel di quella particolare fotografia.
Ci rimettiamo in cammino e continuiamo a parlare. Scopro che Anna è una di quelle persone che amano starsene a letto, pigramente. Il che però non è in contraddizione con il bisogno di chiedere sempre molto a se stessa. Lei la chiama “pigrizia creativa”: «Mi capita spesso di trovare la soluzione a un problema, in quel modo. Me ne sto a letto e trovo l'idea per realizzare l'obiettivo con meno sforzo»
Parliamo anche della danza come benessere. «Mi interessa la bellezza pura. Le emozioni trasmesse che fanno bene. Più cresco e meno mi interessa l'aspetto tecnico della danza. Ciò che importa è lo star bene. La dimensione olistica».

28 AGOSTO 2023
Siamo proiettati verso il fuori. L'evasione.
Il metaverso. Quando insegno ai non professionisti, la soddisfazione più grande è riuscire a riportarli nella consapevolezza del qui e ora. È anche una forma di meditazione
(foto Fulvio Francone)
E visto che alla curiosità non si può comandare, eccola alle prese con una nuova esperienza: «Ho iniziato a studiare latino-americano. Non a livello professionale, così, per provare. Non posso farci niente. Mi incuriosisce tutto».
Ad un certo punto, mentre camminiamo per strada, si mette quasi a danzare, per illustrarmi la sua teoria sull'equilibrio. «L'equilibrio non è stare fermi tra due poli. Il vero equilibrio è avere la maturità e la consapevolezza del fluire, in base al contesto. Io so stare in questa situazione, ma se il contesto cambia, devo sapere stare in quell'altra. Come su una barca. Uno stare in equilibrio anche in due poli opposti. Posso essere dolcissima o rigidissima a seconda del contesto. Si tratta di saper prendere la posizione che ti fa stare in equilibrio in quella situazione. Tutti hanno degli opposti in sé, viviamo in un mondo dualista. È attraverso la consapevolezza che troviamo l'equilibrio». Sembra facile, ma non lo è. Si tratta di imparare a uscire da un'idea rigida di sé. Chi l'ha detto che io devo essere così? «Io ci sto ancora lavorando. Ma quando ho scoperto questa cosa ho svoltato». Parliamo anche di giovani e di social, di come l'unica salvezza possibile sia «l'avere una grande passione. Che è poi ciò che ha salvato anche me». Avere un scopo, un ideale, ma anche semplicemente una cosa (creativa) che ami fare. «Deve essere anche un piacere»
A proposito: qual è lo scopo di Anna Kolesarova? Qual è la sua redness, ciò che la fa alzare la mattina? «La mia redness è la fame, perché per vivere hai bisogno di lavorare, e la sete, di conoscere, di arrivare, di raggiungere l'obiettivo. E ciò che mi disseta e mi sfama, anche in quelle giornate in cui non avrei proprio voglia di alzarmi dal letto, è la bellezza. Trovare il bello anche nelle piccole cose. Ma anche la soddisfazione di riuscire a trasmettere e raccontare la mia esperienza ad altre persone».

(f.t.) Anna Kolesarova
Adriano Ercolani
Devoto e irriverente, mistico e mercuriale, ironico ed enciclopedico.
Paz, Socrate, Chesterton, lo yoga e l'Advaita Vedanta, Dante, Umberto Eco e Michael Jordan, o meglio la sua aura sacra e sovrannaturale, Massimo Palma e Zerocalcare, “Pico della Mirandola e la spiritualità”, “Come andare al di là del Tempo, da Eraclito a Stranger Things”, Pinocchio, Cristina Campo, il Kali Yuga, il rapporto tra fantascienza ed esoterismo, ma anche cinema, cucina e fumetti in quantità, senza mai dimenticare l'amata Lazio e l'amatissima carbonara. Ecco un breve elenco, un riassunto, dei temi affrontati negli ultimi mesi da Adriano Ercolani, tra articoli, incontri e conferenze. A chi non lo conosce potrebbero sembrare tanti, troppi, tutti diversi. “Alto” e “basso” mischiati senza pudore, in modo apparentemente schizofrenico. In realtà i suoi temi, vari e innumerevoli, sono come gli eccentrici ingredienti gettati dentro il calderone delle streghe, nel tentativo di ottenere pozioni magiche da bere tutte d'un fiato, confidando nell'efficacia dell'incantesimo. Anche se forse, in questo caso, sarebbe meglio citare il calderone dell'alchimista, che vuole fabbricare l'Oro del risveglio (suona impegnativo, e lo è), la conoscenza che illumina e trasforma. Non prima però di aver bruciato le scorie del piccolo ego e dei suoi attaccamenti, attraverso un'opportuna ascesi, con l'aiuto del Mercurio (lo citeremo più di una volta in questa intervista), principio primo dell'Opera, che può trasformare ma anche dissolvere.
Tutti concetti che a uno come Adriano Ercolani sono familiari quanto gli ingredienti della carbonara (con guanciale e pecorino romano, mi raccomando) o le gesta sportive di Giorgio Chinaglia (eroe dello scudetto
laziale del '74, con 24 gol all'attivo). Nulla è più lontano da lui della posa seriosa assunta di solito da chi affronta argomenti che hanno a che vedere con la ricerca interiore, le tradizioni spirituali, il misticismo, l'esoterismo. Anche se poi, leggendo la sua Introduzione alla meditazione, scritta per Tlon insieme all'amico Francesco D'Isa, trovi scritto chiaramente che la meta è «l'esperienza dell'unità, al di là dei limiti illusori del proprio Io»
Ed ecco il grande paradosso con cui gioca quotidianamente, il caos della curiosità culturale, tipicamente occidentale, ludica, (post)modernissima, proiettato però verso il traguardo vertiginoso dell'Uno, così lontano dalla sensibilità dell'uomo contemporaneo (ancora peggio se si tratta di un intellettuale). Adriano Ercolani, che guarda all'Oriente per ritrovare l'anima dell'Occidente, non si limita a “parlare di”, ma pratica e sperimenta con devoto furore.
Tutto questo si riflette nello stile barocco di un autore, studioso, giornalista (scrive tra gli altri per Repubblica XL e Il Fatto Quotidiano online) che si autodefinisce «logorroico delirante», con un'autoironia che potrebbe anche essere una forma di depistaggio creativo (viene in mente l'umorismo sulfureo adottato da certi ermetisti moderni, da Kremmerz in giù). Ma essendo un comunicatore, Ercolani sa perfettamente quando la scrittura deve diventare semplice, e i ragionamenti alla portata di tutti. Come accade in questo libro, scritto a quattro mani su un tema che conosce benissimo (pratica la meditazione da vent'anni), in un momento storico in cui c'è un gran bisogno di divulgatori consapevoli.
30 AGOSTO 2023
I NCONTRI
La meditazione spiegata da un praticante del caos che aspira all'Uno
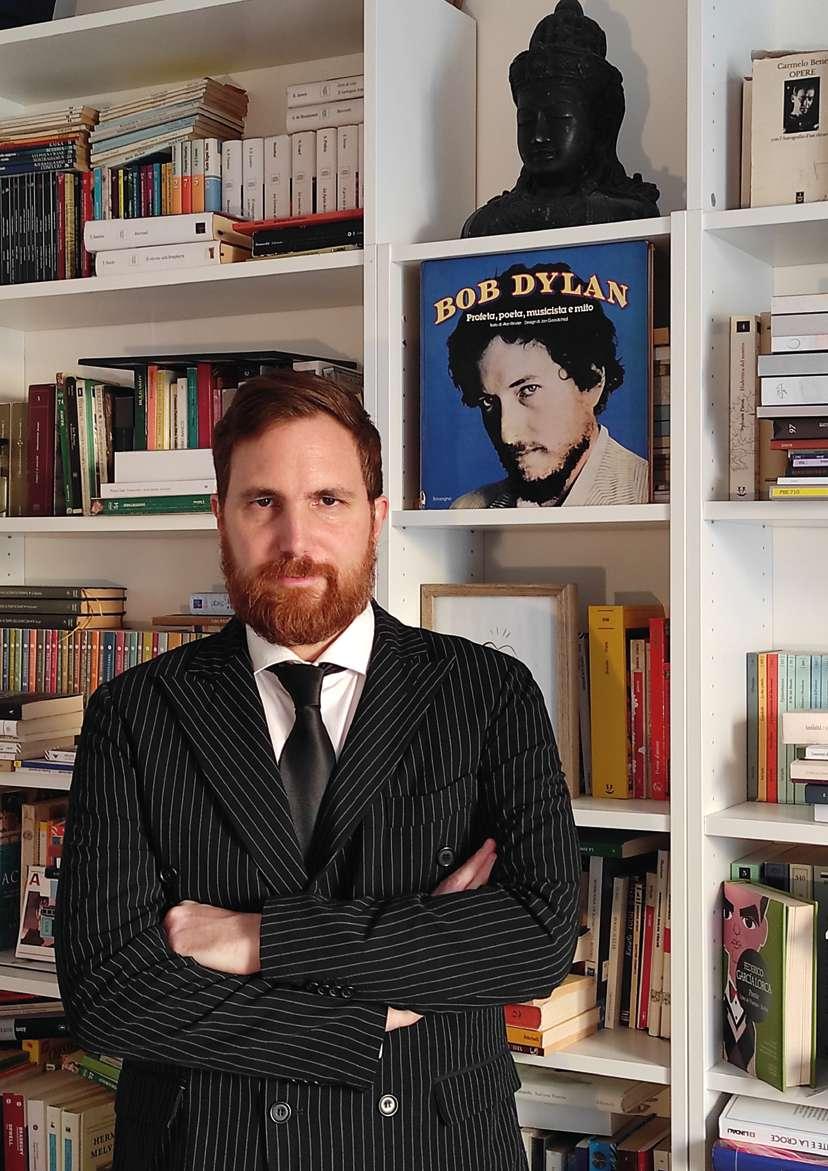
«La diffusione di una pratica è inversamente proporzionale al suo approfondimento, mentre è commisurata al propagarsi di equivoci e luoghi comuni che ne snaturano l’esperienza e ne deformano il significato».
L'Introduzione alla meditazione scritta insieme a D'Isa è fedele al titolo, didascalico e senza fronzoli (ricordando che il didáskalos in greco era il maestro), in cui si dice chiaramente che quando «qualcosa di avvicinabile all’idea di “eterno” e “assoluto” diventa improvvisamente di moda, quando una via iniziatica per l’elevazione spirituale viene utilizzata come strumento di benessere e rilassamento, è forse giunto il momento di fare chiarezza». Ecco allora alcuni concetti fondamentali per capire i contesti culturali, la terminologia, l'humus spirituale da cui sono scaturite le varie tecniche di meditazione. Un'esperienza che «se vissuta profondamente conduce a stati di coscienza diversi da quello, comune, di veglia. Come ciascun autore mistico ricorda nelle proprie testimonianze, qualsiasi tentativo di descrizione razionale di questo stato rappresenta una sfida all’ineffabile».
Nel libro si parla di yoga e vedanta, buddhismo, sufismo e qabballah, ma anche di discipline cristiane (l'esicasmo), di Pitagora, Plotino e stoicismo, ovvero la pratica della filosofia prima che diventasse puro esercizio di pensiero astratto. Ma al centro c'è l'esperienza personale dei due autori. Perché, come dice Adriano Ercolani, per parlarne con cognizione di causa, bisogna aver sperimentato quello «stato di quiete interiore, di consapevolezza senza pensieri, in cui la mente è immersa in un silenzio colmo di grazia». Non una fuga dal mondo, ma una “roccaforte silenziosa” che permette di vedere e vivere meglio la realtà.
Un libro utile e serio, quindi. Di cui però Adriano ama parlare nel suo modo giocoso, irriverente, poco ortodosso, tra citazioni colte in quantità e incisi platealmente romaneschi, non facendo mai mancare la sua risata fragorosa.
Ti piace l'aggettivo “eclettico”?
Certo che sì! Se non puoi dare a me dell'eclettico, puoi pure cancellare l'aggettivo dal dizionario. Mi piace eclettico e mi piace molto anche “mercuriale”. So che l'astrologia in ambito intellettuale viene considerata poco più che un passatempo superstizioso, ma la trovo molto interessante come studio simbolico degli archetipi. Io sono Gemelli. Anzi sono la pubblicità ambulante dell'essere Gemelli.
Ma questa curiosità insaziabile è qualcosa che hai scoperto lungo la via o sei sempre stato così?
Diciamo che ho un'estroversione abbastanza pronunciata, quindi più che altro se ne sono accorti gli altri.
Però vedendo i tuoi interessi mistici e spirituali, verrebbe da pensare, in origine, a un ragazzo introverso, tutto preso dal suo mondo interiore.
Lo so che sembra un paradosso, ma il mio temperamento tende a nutrirsi di caos. Probabilmente sono cosi attratto dall'Uno proprio perché, altrimenti, vivrei un dualismo prossimo alla schizofrenia. Tra le varie cose che ho scritto, e di cui vado assolutamente fiero, c'è anche un saggio sul sentimento del tragico in Lino Banfi per una fanzine online significativamente chiamata DROGA.

32 AGOSTO 2023
(foto di Luca Brunetti)
Ho avuto un'infanzia molto particolare, potremmo definirla magica, immersa in una dimensione quasi paranormale. Oggi mi piace mischiare il sacro e il profano
Per me Vieni avanti cretino è il più compiuto esercizio applicativo del Viaggio dell'Eroe individuato nella teoria del monomito di Joseph Campbell, con tutte le sue tappe iniziatiche. A me piace moltissimo mischiare il sacro e il profano. Diciamo che “la mia religione” si fonda su questa mescolanza.
Assorbi il caos per poi trasformarlo in unità.
Forse il più bel complimento che abbia mai ricevuto, grazie. Come dice la mia stella polare, Bob Dylan, artista “gemellino” per definizione: "Io accetto il caos, ma non sono sicuro che il caos accetti me". Una frase che riecheggia la ricerca junghiana.
Immagino che da ragazzo passassi tante ore tra le bancarelle di libri.
Ho trascorso l'adolescenza squattrinatissimo ma compulsivamente vorace di libri. Avevo anche la fortuna di avere due amici fraterni, con la stessa passione – coi quali, tra parentesi, mi vedo ancora quotidianamente: uno i libri me li prestava, l'altro più rocambolescamente me li rubava. Tra l'altro tutti libri dal potente significato. Mi ricordo che una volta mi aveva rubato Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij, il che mi sembrava un omaggio corretto al protagonista. Quando fui riformato, per sfregio, con i soldi della diaria mi comprai il Trattato del Ribelle di Jünger.
Le prime cose che ti hanno aperto la mente? Quelle che ti hanno fatto venire il sospetto che il mondo fosse più complesso e misterioso di come te lo raccontavano a scuola?
Stavo alle medie, me lo ricordo ancora, avevo da poco 11 anni, ero all'ospedale per un'operazione. L'inconsapevole veicolo della mia follia mistica fu mio zio, per me un secondo padre, persona assolutamente antitetica allo stereotipo dell'intellettuale di sinistra. Andò a comprarmi qualcosa da leggere, chiedendo consigli all'edicolante, dicendogli che suo nipote leggeva cose da grandi. Era il luglio 1989,18 anni dalla morte di Jim Morrison. Mio zio comprò Ciao2001, con Jim Morrison in copertina, e un albo di Dylan Dog, La clessidra di pietra. Per coincidenza, in entrambe le testate si parlava di poeti
mistici e visionari: Blake, Baudelaire e Dylan. Hai presente Elevazione di Baudelaire? Le ultime due strofe agirono come un comandamento: “Fuggi lontano da questi miasmi ammorbanti, e nell’aria superiore vola a purificarti e bevi come un liquido divino e puro il fuoco che colma, chiaro, le regioni limpide...”. Mi ricordo che a 11 anni leggevo I fiori del male chiuso nello sgabuzzino. So che può sembrare megalomane, ma sentivo una profonda risonanza con il modo in cui percepivo la realtà. Se ti sembra eccessivo, ti basti sapere che ho avuto un'infanzia molto particolare, potremmo definirla magica, immersa in una dimensione quasi paranormale, dunque avevo una percezione già di per sé alterata della realtà quotidiana. Prima Baudelaire e Rimbaud, poi l'incontro con Dylan, mi hanno schiuso le porte della ricerca.
Però la tua formazione è stata soprattutto di tipo letterario.
Al liceo sono cresciuto con questi due amici straordinari: uno è Daniele Capuano che ha appena pubblicato con Edizioni Tlon Introduzione all'esicasmo, mente dalla cultura sterminata (è come essere amico di Marsilio Ficino), l'altro è Lorenzo Ceccotti, conosciuto come LRNZ, artista visuale poliedrico, autore di una complessa allegoria come Golem (Bao Publishing).
Principalmente all'inizio la folgorazione fu la poesia, poi c'è stato l'incontro con i filosofi. Da ragazzo, accanto al poster di Siniša Mihajlović, avevo Hölderlin, Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard.

33 AGOSTO 2023
Adriano Ercolani
Ero violentemente anti-hegeliano, anche se poi ho dovuto fare i conti con lui. È un po' come con Nadal: io tifavo Federer, incarnazione tennistica del dio Apollo, però alla fine devi riconoscere la grandezza dell'avversario. Hegel per me è un genio che ha capito tutto all'incontrario. Del ritmo ternario dell'esistenza è come se lui descrivesse il percorso di ritorno, la discesa cabalistico-dantesca. Questo, mutuato dal materialismo storico, ha accentuato la concezione del tempo progressiva, opposta a quella ciclica della sapienza greca-orientale. Una svolta che arriva già dal cristianesimo e che, tramite un'interpretazione di Hegel che capovolge il suo idealismo e ne rimuove il fondo esoterico, giunge alla dialettica marxiana, alle “magnifiche sorti progressive”, come direbbe Leopardi.

Quando è nata la vocazione per la spiritualità orientale, la letteratura mistica, l'esoterismo?
Come ho detto, vengo da una famiglia, in questo senso, straordinaria, e da un'infanzia carica di elementi soprannaturali. Mia nonna, cresciuta davanti alla montagna sacra della Maiella, rifiutò l'iniziazione per diventare una strega. Mio padre – che sembrava Vittorio Gassman ma sapeva tramutarsi in Mario Brega, una persona di grande fascino, uno che sapeva cinque lingue negli anni Sessanta, quando la gente si guardava le trasmissioni in tv per imparare l'italiano, una persona vulcanica, dai tratti geniali ma anche violenti - si ammalò
di una malattia inspiegabile. Era sano come un pesce, ma quella enigmatica patologia lo condannava a una specie di paralisi apparente.
Ad un certo punto, disperato, si è rivolto al mondo del paranormale, ai maghi, agli stregoni, ai guru. Quindi io ho vissuto l'infanzia assistendo a questa quotidiana parata in casa di talismani, amuleti, grimori, sapienti e cialtroni. Ho visto anche con i miei occhi delle scene alla Gustavo Rol, fenomeni inspiegabili.
Ma ho sempre avuto un forte sentimento mistico dell'esistenza, non confessionale, pur nel dolore, per questo amavo molto Baudelaire, le sue "corrispondenze", cercavo quel “codice segreto”, intuivo quel tessuto di sincronicità, che per carità può anche diventare una banalità new age, ma con consapevolezza e discernimento può essere il fondamento filosofico di una Weltanshauung.
Impari a riconoscere i “segni” che ti manda l'universo.
Esatto. Un testo che per me è stato filosoficamente un'agnizione è la Lettera a un religioso di Simone Weil. Poi, sempre grazie a Daniele Capuano, ho scoperto Elémire Zolla, Giorgio Colli e tanti altri. Ma l'incontro decisivo è stato più tardi, quando avevo 22 anni. Da adolescente ero una specie di stilnovista, mi ero dedicato alla casta e distante venerazione esclusiva per una ragazza.
Risata terapeutica, sotto i vestiti utilizzati in "Salò o le 120 giornate di Sodoma" di Pasolini alla mostra a lui dedicata alla Galleria Nazionale. A fianco, in coppia con l'amico Daniele Capuano alla Libreria Rotondi per presentare i loro libri

34 AGOSTO 2023
Poi, una volta assaggiato il frutto proibito, mi sono smarrito completamente nel più dionisiaco libertinaggio. Un giorno dovevamo andare con degli amici in un pub in Trastevere, dove ogni giovedì facevano festa le ragazze della John Cabot University, studentesse americane in visita a Roma. Diciamo che non ero uscito per cercare il “ritorno all'Uno”, al massimo cercavo altri tipi di unione (anche se è quella la radice dello smarrimento nell'illusione della maya, nel XVI canto del Purgatorio Dante lo spiega meravigliosamente: “L'anima semplicetta che sa nulla...”). Esco con due amici, due fratelli: uno, come me, assolutamente scettico, orientato a portare a casa il risultato più materialistico. L'altro, animato da una ricerca inquieta e nobile, aperto alla meraviglia. La gag è che fummo noi due, non quest'ultimo, a convertirci in seguito a ciò che sto per raccontare.
Abbiamo incontrato un signore scalzo, con una rosa in bocca e una copia del Kamasutra in mano, che faceva strane posizioni di yoga. L'altro amico ha detto: “Fermiamoci, con questa persona ci dobbiamo parlare, perché ci dirà la verità!” La nostra reazione è stata: “Ma
te sei scemo, ma che stai a dì?” Il tipo era un classico ricercatore degli anni Sessanta, sconvolto da esperienze psichedeliche, che però stava riprovando a memoria delle posizioni meditative conosciute in un corso gratuito di yoga. Sta di fatto che l'amico, folgorato dall'incontro, inizia a frequentare questi corsi e per mesi mi rompe le scatole, “devi venire, devi venire”. Nel frattempo io frequento un corso di Storia delle religioni e mi capita proprio lo yoga. Pensavo: “Ma di tutte le cose che potevano capitarmi, proprio questa, che non mi interessa per niente!”. Avevo 20 anni, a me interessavano il cristianesimo ortodosso, la qabbalah, il sufismo, il taoismo, tutto tranne lo yoga! Per me era solo un percorso fisico. Ma sai quando un amico ti rompe così tanto le scatole che alla fine dici: vengo solo perché così la smetti.
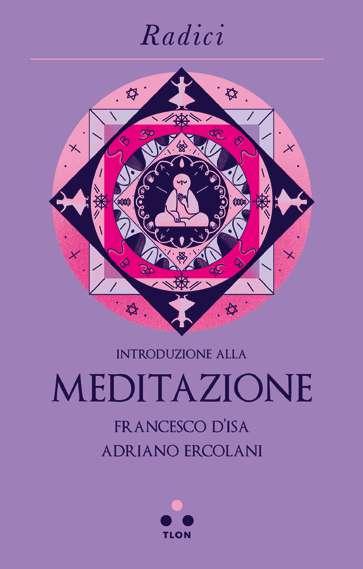
Ed ecco la “rivelazione”.
Corso gratuito di Sahaja Yoga, sala elegantissima in zona Colosseo. Io, un ritardatario per natura, arrivai dopo la spiegazione introduttiva, direttamente all'esperienza.
Meno male, perché avrei contestato tutto, col mio ego spocchioso da post-adolescente, permanentemente ebbro. Quando viene proposta l'esperienza, c'è un ragazzo, molto semplice, palesemente illetterato, che sembra l'Idiota di Dostoevskij, e dice, con una voce infantile: “Vuoi provare questa cosa?”. Io penso: “Ma 'ndo c... so' capitato, questo sembra aver subito una lesione cerebrale importante”. Invece poi quel ragazzo ha guidato la meditazione ed è stato il momento più bello della mia vita. Un'esperienza estatica. Una liberazione totale. Mentre ero immerso in quell'epifania, riconoscevo la sintomatologia di cui avevo letto nella letteratura mistica. Perché io, in quel periodo, nella mia follia, mi ero messo a fare da solo anche gli esercizi di Ignazio di Loyola e santa Teresa d'Avila. Poi ho incontrato Shri Mataji, e io che sono irriverente, sospettoso, mega-scettico, ho avuto delle prove talmente evidenti che non ho più avuto alcun dubbio. Nonostante una scepsi sistematica e rigorosissima, mi sono dovuto arrendere. Anche perché gli effetti non agivano solo su di me, il che poteva anche essere frutto dell'autosuggestione. Gli stessi effetti li ho empiricamente riscontrati sugli altri. Sono stato tra i fautori di un progetto internazionale di divulgazione della meditazione, con cui ho girato il mondo, che mi ha portato nelle scuole, nelle carceri, nei centri profughi, nelle case famiglia, nelle aziende, nelle università.
35 AGOSTO 2023
Adriano Ercolani
Ho incontrato persone di tutti i tipi, dai ragazzi di Scampia ai bambini indiani a diplomatici dell'Onu, e tutti, dopo aver sperimentato la tecnica di meditazione insegnata da Shri Mataji, descrivevano le stesse esperienze.
Non per niente, nel corso dei secoli, si è sviluppata la teologia negativa. Di certe cose forse puoi parlarne solo in quel modo. Penso alla Nube della non conoscenza
Quello infatti era il mio approccio di riferimento, ero cultore di Meister Eckhart, di Silesius, ancora prima di Plotino e Porfirio. Poi però, nella divulgazione, devi scontrarti con una comunicazione che talvolta suona quasi parrocchiale, che deve essere necessariamente "buona": qualcosa che a me personalmente crea delle reazioni cutanee vistose. Per me è una dialettica quotidiana, provare a esprimere in maniera degna un'esperienza sublime e abissale senza sembrare l'hippie di Carlo Verdone.
Eri consapevole del fatto che si trattava di temi, discipline e personaggi malvisti dal mondo culturale istituzionale?
Ero io il primo a pensarla così. Prima di entrarci, ero convinto che in quel mondo fossero tutti scemi manipolati da una setta. L'incontro con Shri Mataji mi ha cambiato la vita, quindi puoi immaginare il rispetto, e la fiera devozione, che nutro nei Suoi confronti. L'esperienza di meditazione era vera, profonda, autentica, “tornava tutto”. Però c'era anche la reazione umana, un certo sarcasmo goliardico che mi aiutava a sdrammatizzare il peso della “conversione”. Quando incontri un percorso spirituale così forte, avviene la cosiddetta periagogè, il percorso di trasformazione descritto da Platone ma anche nelle Upanishad, dopo l'affrancamento dalle illusioni materiali. Io nel giro di tre giorni ho smesso di bere, di fumare, ho vissuto per alcuni anni in modo quasi monacale. Felicissimo! Perché non era una rinuncia. Ho vissuto anche dei periodi di gioiosa castità. Perché la meditazione era uno stato così profondo che non avevo bisogno di soddisfare i sensi.
Poi gran parte della mia ricerca successiva è stata quella di dare una dignità anche intellettuale a un'esperienza che io so essere autentica, ma che per molti è difficile da prendere sul serio. Come fa dire Pasolini a Totò in Che cosa sono le nuvole?: "...la verità quando la dici...non c'è più". Quando provi a spiegare razionalmente una dimensione ineffabile sembra tutta una grandissima s... ciocchezza.
Qualche mese fa, a proposito di Meister Eckhart, abbiamo intervistato Marco Vannini.
Che Dio lo benedica! Mi è capitato di citarlo proprio ieri. Vannini ha scritto cose sublimi anche su Simone Weil. Lei diceva che tutte le mistiche si assomigliano quasi fino all'identità. Ma, come dice Vannini, in quel “quasi” c'è tutto. Anch'io credo nell'esistenza di una filosofia perenne, il rischio però è di arrivare alla confusione fatta dalla new age. Che dalla cosa più sacra e ineffabile si ricavino i concetti più banali e sciocchi. Non c'è peccato più grande per me.
Guénon, pensatore tradizionalista che sicuramente conosci, scriveva che il sincretismo è un errore diabolico, perché ci porta a confondere tradizioni, dottrine, discipline, rendendole inefficaci.
Ma certo. Dire che Pitagora e san Giovanni della Croce si assomigliano, non vuol dire che devi mischiare tutto. Spero che con questo libro siamo riusciti a dire qualcosa sul tema: c'è un'esperienza comune, c'è una convergenza dei sapienti, ma le tradizioni vanno distinte. Il sistema sottile di cui parla il sufismo non è uguale a quello della tradizione indiana.
Guénon diceva anche che la curiosità culturale, la conoscenza razionale, non portano nessuna autentica realizzazione spirituale.
Anzi, spesso le due cose sono in contraddizione. Una certa attitudine razionalista potrebbe essere un ostacolo.
36 AGOSTO 2023
Per me è una dialettica quotidiana, provare a esprimere in maniera degna un'esperienza sublime e abissale, senza sembrare l'hippie di Carlo Verdone
Lo scrivi nel libro: la cosa più difficile, quando si parla di meditazione e di esperienze spirituali, è trovare le parole, dare una forma razionale a ciò che va oltre la ragione, per provare a spiegare che si tratta di esperienze reali, concrete, che agiscono in modo misterioso sul corpo e la mente.
Stai descrivendo il mio dramma quotidiano. Dall'altra parte, in quel mondo, capita di incontrare persone in buonissima fede, che però non si rendono conto di sembrare esaltati e respingenti, una sorta di versione indiana di una setta apocalittica. Gli dico: "Che volete sembrare, i Testimoni dei Chakra?".
Poi c'è la questione politica e ideale. Quello è un mondo solitamente associato al pensiero tradizionalista, alla destra politica, a un'idea del mondo che ha poco a che vedere con quella che tu condividi. L'idea di un ordine spirituale che deve avere una corrispondenza nell'ordine temporale. Julius Evola, che pure ha scritto libri notevoli (sull'alchimia e il buddhismo delle origini, ad esempio), ha generato schiere di devoti pericolosissimi.
Io dico sempre che Evola è il più simpatico dei falsi maestri. Ha scritto cose importanti, ma ideologicamente è inaccettabile.

37 AGOSTO 2023
Adriano Ercolani
C'è perfino una lettera di Himmler (!) in cui parlando di lui consiglia "di moderarlo, per quanto tale cosa sia possibile"!
Evola ha una responsabilità karmica enorme nei confronti della storia, ha contribuito alla deformazione dei simboli sacri indù da parte dei nazisti. E questo criterio di valutazione, in maniera diversa, vale per tanti altri autori di quell'ambito.

Alain Daniélou ha scritto cose affascinanti su Shiva e Dioniso, Coomaraswamy cose sublimi sulla concezione dell'arte indiana, poi però se si arriva a giustificare i sacrifici umani o a proporre rapporti violenti per risvegliare la Kundalini, credo debba intervenire nel lettore il rasoio del discernimento. Succede anche con Eliade, Tucci, Filippani-Ronconi, Schuon, studiosi straordinari di cui non condivido le idee politiche.
Per fortuna c'è una nuova ondata, in cui forse umilmente mi posso inserire anch'io, Daniele Capuano, Alessandro Mazzi, Giorgiomaria Cornelio, Andrea Cafarella, figure diverse ma che studiano questi autori senza essere necessariamente nostalgici del nazisfascismo. Il problema è che continuiamo a vivere dentro una contrapposizione muro contro muro.

Umberto Eco, che tutti stimiamo, metteva Zolla e Guénon nello scaffale dei cretini. Il mio amato Pasolini e la mia amata Elsa Morante avevano isolato Cristina Campo, la cui penna era intinta nel nettare degli dei.
Ne usciremo mai da questa contrapposizione ideologica?
Non per essere ottimista – io essendo della Lazio sono sempre scaramantico – ma ci sono dei segnali. Penso
ad esempio al mio editore, Tlon, che pubblica Gurdjieff e il libro sull'esicasmo di Daniele Capuano... Scherzando un po', in confronto a quelle di Daniele, le pagine più criptiche di Ceronetti sembrano scritte da Fabio Volo. Citazioni in sanscrito, etimologie vertiginose in lingue antiche, una panoramica mostruosa, nell'etimo, della cultura mondiale. Tra l'altro Capuano mandò una lettera a Ceronetti per chiedergli conto della traduzione di una passo di Isaia (e lui gli rispose con garbo e apprezzamento). Daniele, infatti, conosce anche l'ebraico, il latino e il greco, l'arabo coranico e, in parte, il sanscrito (per limitarci alle lingue "morte"). Può praticamente leggersi i testi sacri delle religioni principali in originale.
La meditazione ha effetti evidenti sul benessere mentale, fisico, emotivo, da qui nasce l'equivoco di una pratica utilizzata come fosse l'ora di fitness in palestra. Noi occidentali pensiamo di essere più furbi ed evoluti degli altri e quindi separiamo la tecnica da un contesto religioso che non ci appartiene, per usarla a modo nostro. Di recente si è parlato ironicamente di McMindfulness, per dire come la meditazione sia diventata un business consumista.
Io ho un caro amico, un persona splendida, che con la sua agenzia fa consulenza filosofica per le aziende, e propone anche la mindfulness. Lui mi dice sempre che per le persone completamente a digiuno è comunque un modo per avvicinarsi alla meditazione. Però la tecnica della mindfulness, a chiunque abbia una minima esperienza con la meditazione, sembra inevitabilmente una presa in giro.
38 AGOSTO 2023
Due immagini di "SpinDoctors", la serie satirica prodotta da Tlon, in cui Adriano Ercolani veste i panni di uno spin doctor di estrema destra
È un po' come gli americani che fanno la carbonara con la panna. Sono stati dei geni del marketing. Però posso dire, per onestà, che ho incontrato manager di aziende che dopo aver sperimentato la mindfulness dicevano: grazie perché mi avete cambiato la vita! Il livello della coscienza collettiva è talmente basso che anche un surrogato della meditazione ti fa sentire meglio. Potremmo dire che è una sorta di alfabetizzazione meditativa.
Che però, nella stragrande maggioranza dei casi, non viene messa al servizio di una ricerca interiore, di una liberazione dai condizionamenti, dall'egoismo, ma al servizio del “sistema”, l'efficienza del lavoratore, la schiavitù dei desideri.
Certo. Se hai una capacità di attenzione migliore, se sei una persona più centrata, diventi un migliore padre, madre, figlio, e lavori anche meglio. Però la meditazio-

ne non può limitarsi a quello. Posso capirlo come “cavallo di Troia”, ma quando rimane solo quello, e il cavallo è vuoto, a cosa serve? Mettiamo perfino l'esperienza più sacra al servizio del neoliberismo?
Un altro equivoco è quello del nicciano “al di là del bene e del male”, l'illusione di poter vivere in una dimensione esistenziale che in realtà, tradizionalmente, è un approdo finale, il risultato di una liberazione. C'è chi pensa di poter fare a meno dell'etica. Lo yama e il niyama dello yoga, il retto comportamento del buddhismo, i comandamenti evangelici.


In India si dice che bisogna essere dharmatit, andare al di là del Dharma. Ma per arrivare di là, ci devi passare attraverso, non è che puoi startene... nell'al di qua. Lo devi attraversare il Dharma.
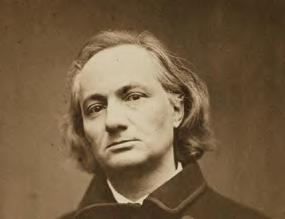
39 AGOSTO 2023
Adriano Ercolani
Numi tutelari: Charles Baudelaire, William Blake, Siniša Mihajlović, Bob Dylan
Nella sua somma sapienza, Dante – come per Florenskij lo è la Trinità di Andrej Rublëv, per me la Divina Commedia è prova dell'esistenza di Dio, non è possibile che un essere umano abbia potuto scrivere un'opera di quel livello spirituale senza "connessione" – lo sapeva benissimo. Perché si giunga a Beatrice, alla Shakti se vuoi dirlo in termini orientali, la Grazia che sola può schiudere le porte del Paradiso, bisogna seguire fedelmente Virgilio, che è l'uso corretto della ragione e il giusto comportamento, Ragion Pura e Ragion Pratica.
La zattera necessaria a raggiungere l'altra riva, nel buddhismo.
La barca poi l'abbandoni, ma ti serve per attraversare la vita. Se ti butti in mezzo al mare, affoghi. Se utilizzi lo strumento della meditazione senza riflessione, rischi di diventare un deficiente. Il de-pensare è un'altra cosa. Come diceva Carmelo Bene a Macao: se voi foste ancora più stupidi sareste divini, invece siete stupidi e basta.
La questione della “filosofia perenne” è centrale nel vostro libro. Va bene l'idea che esista un nu-
cleo comune a dottrine e religioni, ma bisogna stare attenti a non confondere le cose, separando le tecniche dal loro contesto culturale.
Io sono d'accordo con il concetto di filosofia perenne, non solo perché Huxley era un genio. Più che altro sono fondamentalmente d'accordo con Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. I sufi consideravano san Francesco uno di loro. È chiaro che l'imperatore Marco Aurelio era un illuminato. Che yogin e sufi, almeno nel periodo dell'imperatore Akbar, erano praticamente sinonimi. Il fatto è che prima di riuscire a dissolversi nell'Uno, prima di commuoversi dell'abbraccio che supera la divisione, bisogna essere consapevoli dell'alterità. I saggi indiani lo hanno riassunto meravigliosamente: l'Ātman, lo spirito, è Sat-Chit-Ananda. Sat è l'essere, la verità dell'essere, ciò che è, la realtà; Chit è la consapevolezza della realtà; solo dopo c'è Ananda, la beatitudine. Non è il contrario. Realizzi il reale, ne prendi coscienza e poi ti abbandoni al divino. È il percorso di Dante. Non puoi saltare le tappe dell'iniziazione. Questo è il problema di tanta spiritualità prêt-à-porter che promette di bruciare le tappe.

Come distinguere tra maestri e cialtroni, fra tradizioni vive e fossili spirituali?

40 AGOSTO 2023
Shri Mataji Nirmala Devi
Sono d'accordo con il concetto di "filosofia perenne". Ma prima di riuscire a dissolversi nell'Uno, prima di commuoversi dell'abbraccio che supera la divisione, bisogna essere consapevoli dell'alterità
Non è semplice. Innanzitutto si può comprare il libro che ho scritto insieme a Francesco d'Isa! Ma al di là della pessima battuta di marketing, penso che un sintomo di serietà possa essere la gratuità dell'insegnamento. Chi si fa pagare i livelli per “sbloccare i chakra”, non credo proponga un percorso autentico. E poi, banalmente, c'è il discorso empirico: tu, quando provi questa esperienza, come ti senti? Il motivo per cui ho seguito Shri Mataji, la cosa secondo me più convincente in quell'approccio, è che la priorità è data all'esperienza. Devi diventare il maestro di te stesso. Shri Mataji dice: prima conosci te stesso. Altrimenti è l'ennesima rivelazione apodittica, l'ennesima deriva dogmatica.
Non ti viene voglia, a volte, di ritirarti dal mondo, di portare la tua ricerca interiore ancora più in profondità, uscire dall'iper-stimolazione e l'iper-attività della vita occidentale?
L'ho fatto. Sono andato in India, più volte, ho fatto dei lunghi ritiri. Però io penso che ognuno abbia il suo daimon. Sono convinto che per trascendere la tua identità la devi vivere fino in fondo. Non identificandoti con l'ego, ma portando alla massima potenza quella che in sanscrito si dice vritti, la tua inclinazione.
I Gemelli come temperamento sono mercuriali, comunicatori, teoricamente molto distanti dalla meditazione, immersi nel mondo esterno, sempre a duemila, ma paradossalmente, proprio perché visitati dalla mercurialità, hanno una sorta di distacco sapiente, nel loro pacchetto di base, che li porta più vicini, non dico alla verità, ma alla natura cangiante del divenire, alla consapevolezza di non sapere socratica. Quella che ti consente di rimetterti sempre in discussione e di aprirti alla meraviglia, alle possibili epifanie.
Krishna dice ad Arjuna che quella battaglia la deve combattere. Evitando l'attaccamento ai frutti delle sue azioni.
Hai colto perfettamente la divinità di riferimento. Il Dio giocoso, che si manifesta come totalità. Se mi chiedessi qual è secondo me il testo sacro definitivo, ti citerei proprio la Bhagavad Gita.
Qual è la tua redness, la cosa che ti dà la forza di alzarti la mattina?
Io, quando mi sveglio la mattina, ho l'abitudine più anti-meditativa della storia. L'idea di rompere l'incantesimo del sonno è terribile per me. Se tu mi dicessi - consentimi una battuta volgare, materialistica – che alzandomi, e andando nella stanza accanto, troverei 100 mila euro, tre fotomodelle e Bottura che mi prepara la colazione, io comunque mi rimetterei a dormire. Per me l'incontro con la necessità materiale, il pendolo schopenhaueriano tra dolore e noia, è traumatico. Anzi, è talmente traumatico che a quel punto, per redimermi, affrancarmi da questo "affanno continuo" leopardiano, necessariamente infelice, dalla volontà di vita shopenhaueriana, lo scopo, la passione, diventa scoprire, al di là della maya, dell'illusione dolorosa, le trame meravigliose di sincronicità dietro le quali si cela la coscienza suprema del puro spirito perennemente sorridente che si fa beffe di noi.
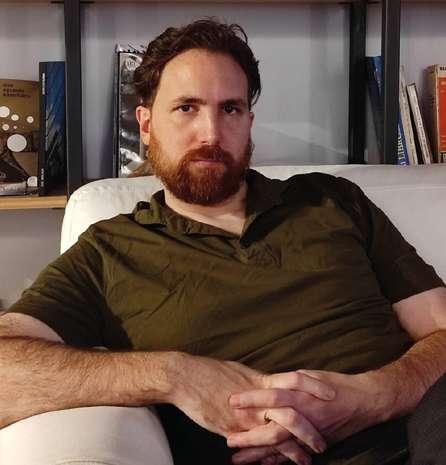
Wow!
Il finale è una citazione da una poesia di Shri Mataji, quando la lessi la prima volta mi ci riconobbi perfettamente.
41 AGOSTO 2023
(f.t.) Adriano Ercolani
Una foresta di segni e colori. Di forme che sono arte e natura, realtà anfibie, mutanti, frutto della contemplazione e dell'immaginazione. Alberi, foglie, grovigli di rami, geometrie e arabeschi vegetali, uomini che diventano animali che assomigliano a spiriti della foresta. Trasformazioni sciamaniche e apparizioni selvatiche, visioni che si trasformano in quadri, dentro cui ritroviamo il legame profondo, ancestrale, che unisce umani e non umani, esseri animali e vegetali, visibili e invisibili. Da una parte ci sono le culture indigene, che quel legame lo conservano, nel sangue e nei sogni, anche quando sono popoli dispersi e dimenticati, costretti dentro un'arida modernità fondata sulla scissione tra civiltà e natura (ma anche tra corpo e spirito). Dall'altra c'è l'Occidente benestante, alle prese con un ripensamento epocale, provocato dalla crisi ambientale, ma anche da una rivoluzione digitale che esalta la smaterializzazione della realtà e l'intelligenza artificiale.
Siamo Foresta è una mostra (molto
bella), un'esperienza sensoriale, ma anche una proposta ideale. Non per niente la direzione artistica è affidata a un antropologo, Bruce Albert, l'allestimento è opera di un artista, Luis Zerbini, e c'è un “public program” curato da un filosofo, Emanuele Coccia, che ha scritto anche un libro (Metamorfosi, molto affascinante) per dire che “siamo un'unica, sola vita”. Gran parte delle opere in esposizione arrivano dalla Fondation Cartier pour l'art contemporain, che ha organizzato l'evento insieme alla Triennale di
Milano. Ventisette artisti in mostra, per (citiamo Bruce Albert) «un dialogo senza precedenti tra pensatori e difensori della foresta; tra artisti indigeni–dal New Mexico al Chaco paraguaiano passando per l’Amazzonia (Brasile, Perù e Venezuela) – e artisti non indigeni (Brasile, Cina, Colombia e Francia», proponendo una «visione estetica e politica della foresta come multiverso egualitario di popoli viventi, umani e non umani, una vibrante allegoria di un mondo possibile al di là del nostro antropocentrismo».

"Siamo foresta", arte e natura Resistere e rinascere insieme
42 MESE 2022
E VENTI
UNA (BELLA) MOSTRA ALLA TRIENNALE DI MILANO RACCONTA L'UNITÀ POSSIBILE TRA DIVERSI, "UMANI E NON UMANI"
(foto Andrea Rossetti)
La Fondation Cartier porta avanti da tempo un rapporto con gli artisti di alcune comunità indigene sudamericane, di cui si parla anche nei video messi a disposizione del visitatore. Uomini e donne, giovani e anziani, che a volte appaiono spaesati, quasi spaventati, davanti alla macchina da presa, alla necessità di spiegare il proprio lavoro, e che poi realizzano disegni vivi, vibranti, nella loro tecnica elementare ma espressiva, in cui c'è la realtà della foresta, osservata da dentro, quotidianamente, insieme alla sua elaborazione simbolica, i motivi decorativi radicati in quella specifica cultura. Poi ci sono gli artisti di professione, che si fanno carico della propria appartenenza indigena, esaltandola e contaminandola, e che realizzano opere dotate di una forza dirompente, quasi magica, che ti investono con la loro sovrabbondanza di forme e colori.
Soprattutto ci sono i sodalizi proposti dalla Fondation Cartier, artisti yanomami che incontrano artisti europei, americani, orientali, particolarmente sensibili al tema. Tutti
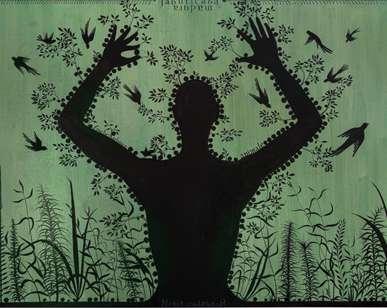
proiettati verso un lavoro creativo che da una parte è denuncia e rivendicazione, e dall'altra (soprattutto)

è l'espressione, la messa in opera (d'arte), la visione di una nuova e diversa unità, formata da tutti i viventi, una “terra-foresta-mondo” in cui i popoli convivono su un piano di uguaglianza (che valorizza la diversità, non cerca di uniformarla) insieme alla natura.
Una visione resa anche plasticamente dall'allestimento di Zerbini, che ha creato corridoi di piante tropicali, percorsi da raggi luminosi provenienti dall'alto, e ha disposto le opere secondo linee sinuose, lungo le pareti, in dialogo con i grandi alberi oltre le finestre, in posizioni che ti costringono ad allargare o ad alzare lo sguardo, come in una foresta, fino alla parete finale attraversata da una striscia di luce che si fa arcobaleno.
43 AGOSTO 2023
Bruno Novelli, Colossal, 2022, acrilico su tela, Collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (© Bruno Novelli © Samuel Esteves) In basso, Alex Cerveny, Jabuticaba, 2021, olio su tela di lino, Collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (© Alex Cerveny © Renato Parada)
L'accoglienza è garantita da Fabrice Hyber, e non poteva esserci scelta migliore. L'artista francese (e poeta, e imprenditore, e ricercatore) ha infatti creato in Vandea una vera e propria foresta, in 40 anni di lavoro e 300 mila alberi piantati. L'incontro con Sheroanawe Hakihiiwe, originario dell'Amazzonia venezuelana, ha generato grandi tele dipinte a quattro mani, che raccontano un mondo in perenne mutamento, ricondotto alle sue componenti fondamentali (cellule, linee, colori), in cui l'uomo e il tapiro sono solo forme diverse riempite dello stesso tutto, e una grande tela, attraversata da una linea di verde e rosso autunnale, da cui emerge un grande albero, è tappezzata da un cielo di foglie. Affreschi “bambini”, pittoreschi e selvaggi, scientifici e fiabeschi. Che dialogano con le opere dell'uno e dell'altro: da una parte l'ibridazione creativa di Hyber, i suoi innesti vegetali sui corpi umani, dall'altra i dettagli poetici di Hakihiiwe che diventano astrazio-
ni, come i segni tatuati sui corpi del popolo yanomami. Qualche passo più in là e si entra nel regno del brasiliano Luis Zerbini, tra i suoi “monotipi vegetali” e le grandi tele spettacolari, dai colori vividi, epici racconti sul colonialismo e l'espropriazione delle terre indigene. La Piccola Foresta Sognata va percorsa senza fretta, omaggiando gli spiriti della “terra-bosco” creati da André Taniki, per poi approdare davanti alla Natureza Espiritual de Realidade, un albero-totem al centro di un grande tavolo pieno di cose raccolte, trovate, conservate.
INDIGENI
Virgil Ortiz, che proviene dalla comunità dei Pueblo Cochiti (Nuovo Messico) si ispira alla ceramica della sua tradizione, realizzando
creature ibride e forme fantastiche, ribadendo una storia fatta di «resilienza, resistenza e rinascita» (con opere realizzate appositamente per questa mostra). Un po' come Brus Rubio Churay e i suoi affascinanti lavori, che partono dalla mitologia Murui-Bora e raccontano l'oppressione e la predazione delle risorse. Bello l'accostamento tra i grandi uccelli monocromatici di Solange Pessoa, il suo monumentale Mundao II e i disegni in bianco e nero provenienti da una comunità indigena del Paraguay, i Nivaklé, che hanno qualcosa di fiabesco, nel loro naturalismo lirico e grafico, animali, piante e trasformazioni sciamaniche, primitivi e modernissimi. E proprio lì accanto, ecco gli stupefacenti paesaggi onirici di Bruno Novelli, ispirati all'Amazzonia brasiliana (come la vedono e la vivono gli indigeni Huni Kuin), che catturano la lussureggiante vegetazione tropicale e le geometrie del simbolismo indigeno, dentro quadri enormi che hanno il respiro di affreschi medievali, oltre che la loro sacralità (sensuale, in questo caso, animale).

44 AGOSTO 2023
L'allestimento di Luis Zerbini dialoga con l'architettura della Triennale, le sue finestre che danno sul parco, la luce che penetra dall'alto
E NON, DIFENSORI DELLA TERRA, DIALOGANO ATTRAVERSO FORME, COLORI, TRADIZIONI
(foto Andrea Rossetti)
A proposito di sacro, c'è qualcosa di ipnotico nelle opere di Cleiber Bane, che mesmerizzano lo sguardo e lo proiettano in una dimensione invisibile, dentro forme fatte di altre piccole forme, percorse da segni e puntini, i colori vividi, decisi, il disegno che si muove come una danza, un canto, con un suo ritmo segreto. Adriana Varejão e Joseca Mokahesi affrontano direttamente la figura dello sciamano, che viene anche messo a testa in giù, iniziato all'altra faccia della realtà, a una nuova dimensione della percezione, rievocando l'Ecce homo di Leonardo da Vinci, ma invertendo la direzione del corpo simbolico rispetto a quello fisico.
La dimensione magica e quella politica, dentro il tema-luogo-ideale della foresta, si incontrano in un'opera della colombiana Johanna Calle, che ha realizzato un albero gigantesco con i testi (su carta notarile) di una legge sulla restituzione delle terre ai contadini indigeni (ci sono contadini che non costruiscono recinzioni, ma piantano alberi per segnare il pezzo di terra che coltivano).
Lo scambio inter-culturale, altro tema centrale di questa esposizione, è celebrato anche dall'incontro fra l’artista cinese Cai Guo-Qiang (che lavora a New York) e l’artista yanomami brasiliana Ehuana Yaira, nella forma di un'opera-performance scintillante. Un sogno fatto da Yaira, una donna in un bosco ricoperto di fiori fino all'altezza della sua vita, è diventato uno stencil, che Cai ha ricoperto di polvere da sparo colorata, per poi far esplodere il disegno, dando una nuova vita alla donna sognata.


 (foto Andrea Rossetti)
(foto Andrea Rossetti)
(foto Redness)
(foto Andrea Rossetti)
(foto Andrea Rossetti)
(foto Redness)
L'ultima parete porta la firma di Alex Cerveny, ed è una meraviglia, un compendio fantasmagorico, su cui troneggia una frase di Claude
Levy Strauss (scritta nel 1973): «Si è cominciato a separare l'uomo dalla natura, e con il costituirlo a regno sovrano; si è così creduto di cancellare

il suo carattere più inconfutabile, ovverosia che egli è in primo luogo un essere vivente. E, rimanendo ciechi a questa proprietà comune, si è dato campo libero a tutti gli abusi». Qui, in effetti, si celebra la compresenza, quasi la compenetrazione tra mondi ed esseri diversi, personaggi mitologici e forme vegetali, facendo appello alle culture indigene della foresta amazzonica brasiliana. Ci sono le bellissime miniature di Cerveny, ma anche un'opera realizzata per l'occasione, una delle più suggestive tra quelle in mostra, Pharmacopoeia: sullo sfondo nero si ergono alberi della foresta brasiliana, percorsi da scritte, nomi di piante, rimedi medicinali della tradizione yanomami; e dentro la terra, in basso, tra le radici, capsule d'aria e di sogno, esseri umani e animali, il terreno comune da cui nasce il tutto.
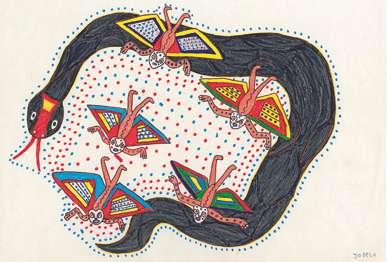
46 AGOSTO 2023
(foto Andrea Rossetti)
Joseca Mokahesi, Õkarimari a, the anaconda spirit and its sons-in-law, 2002-2010, matita e pennarello su carta, Collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (© Joseca Mokahesi / Bruce Albert)
Incanto. Ecco qual è l'impressione lasciata da questa mostra-installazione, che dialoga con l'architettura della Triennale, come è giusto che sia dentro una concezione organicista del mondo, in cui c'è continuità e trasformazione tra una forma e l'altra, interdipendenza, così come tra le creazioni della natura e quelle dell'arte, la bellezza della foresta e la sua rielaborazione in chiave estetica, grafica, pittorica, simbolica. Quell'incanto che Luiz Zerbini racconta di aver percepito già nel 2019, quando a Parigi (alla Fondation Cartier) venne allestita una mostra strettamente legata a quella milanese, intitolata Nous les arbres (Noi gli alberi). «Fu come se ognuno avesse l’opportunità di dimostrare amore e rispetto per la natura attraverso il proprio lavoro. Eravamo consapevoli dell’importanza e dell’urgenza di attirare l’attenzione sul dibattito sulla conservazione di tutte le foreste del mondo, per onorare la loro bellezza, la loro enorme fonte di ricchezza
e di conoscenza, e per mostrare la nostra totale dipendenza fisica e spirituale da esse». Quello spirito si ritrova anche in questa esposizione, in cui Zerbini ha lavorato con il sole, le possibilità offerte dai lucernari della Triennale, e quindi l'opportunità di ospitare piante vive (scelte in serre locali dal botanico Stefano Mancuso) in dialogo con quelle osservate, ri-create, immagi-
nate dagli artisti coinvolti. Come sottolinea Hyber, non dobbiamo pensare alla foresta come realtà esotica, luogo di fuga, ai margini del mondo. «La foresta come luogo di residenza è un luogo di vita, non certo un luogo di ritiro, è uno spazio di libertà e di creazione di nuove forme. La creazione è viva, virale, e se fa atto di resistenza, è qualcosa di più.
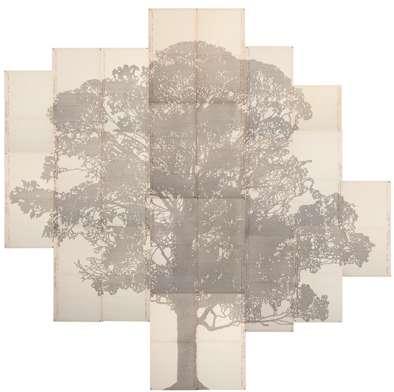
 Sheroanawe Hakihiiwe & Fabrice Hyber, Untitled, 2023, acrilico e carboncino su tela, Collezione di Fabrice Hyber e Sheroanawe Hakihiiwe (© Fabrice Hyber & Sheroanawe Hakihiiwe, © Charles-Henri Paysan / Lumento) In basso, Johanna Calle, Sangregado, 2014, testo dattiloscritto su vecchia carta notarile, Collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (© Johanna Calle, © Archivos Pérez & Calle)
Sheroanawe Hakihiiwe & Fabrice Hyber, Untitled, 2023, acrilico e carboncino su tela, Collezione di Fabrice Hyber e Sheroanawe Hakihiiwe (© Fabrice Hyber & Sheroanawe Hakihiiwe, © Charles-Henri Paysan / Lumento) In basso, Johanna Calle, Sangregado, 2014, testo dattiloscritto su vecchia carta notarile, Collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (© Johanna Calle, © Archivos Pérez & Calle)
In questo senso, la foresta è un luogo di valore aggiunto essenziale: luogo e tempo per la creatività, condivisione di conoscenza, interrogazione, acquisizione di nuovi punti di riferimento. Dove fare il pieno di ossigeno, nutrimento e immagini. Tutto diventa fonte di conoscenza, la forza ha il sopravvento sul potere, trasformando il negativo in positivo. Questo è ciò che gli artisti yanomami fanno attraverso le loro creazioni». Creazioni che sono popolate da uomini, animali e spiriti.
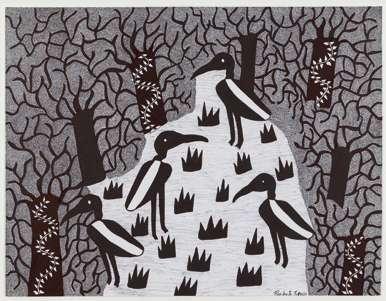
Nel film The Tree of Dream, realizzato da Morzaniel Iramari, e messo a disposizione dei visitatori nella sala cinema (insieme ad altri due video, uno dedicato agli artisti di alcune comunità indigene, l'altro a una tecnica di pesca yanomami), possiamo conoscere le proprietà dell'albero Māri, i cui fiori fanno sbocciare anche i sogni. Ma soprattutto possiamo incontrare uno sciamano, Davi Kopenawa, che ci introduce nell'universo onirico dei popoli della foresta. Cinema che si mette al servizio dell'invisibile.
A proposito di sciamanesimo e arte, di creatività che celebra la creazione,

ristabilendo l'unione tra alto e basso, visibile e invisibile, ricordiamo le parole di Elémire Zolla: «Le arti che noi conosciamo e pratichiamo sono sfaldature di un'originaria unità dello spettacolo rituale nel quale lo sciamano si assumeva tutti i ruoli. Via via nel tempo si scollarono i singoli aspetti di questa recita sacramentale e ne nacquero le varie funzioni astratte, separate l'una dall'altra, spezzettate, del compositore e dell'esecutore, del poeta e del musicista, del sacerdote-psichiatra e dell'attore... In tempi a noi prossimi nessuno ha mai più avuto la forza e la competenza necessaria a investirsi del ruolo dell'arte “tota-
le”». Senza dimenticare che «tutta la civiltà sciamanica è un tentativo di assimilarsi dl mondo animale», per attingere alla “mente naturale “ (che in Oriente viene detta "spontanea", "originale", non-mente, mente-cuore), una condizione di pienezza totale. «Forse lo yoga, le arti marziali, l'allenamento meditativo all'attenzione spassionata e ininterrotta, lo stesso impulso che ci spinge a mormorare una preghiera, sono tracce residue di una pienezza venuta meno; la pienezza di chi si riconosce parte intrinseca del mondo vivente, suo complice e alleato, dalla roccia all'ameba, dall'oceano al cielo»
Floriberta Fermin, Untitled, 2021, penna a sfera e pennarello nero su carta, Collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (© Fermin Floriberta).
A fianco, Alex Cerveny, Farmacopéia (Pharmacopoeia), 2023, acrilico su tela (© Alex Cerveny, © Ana Pigosso)
(foto Andrea Rossetti)
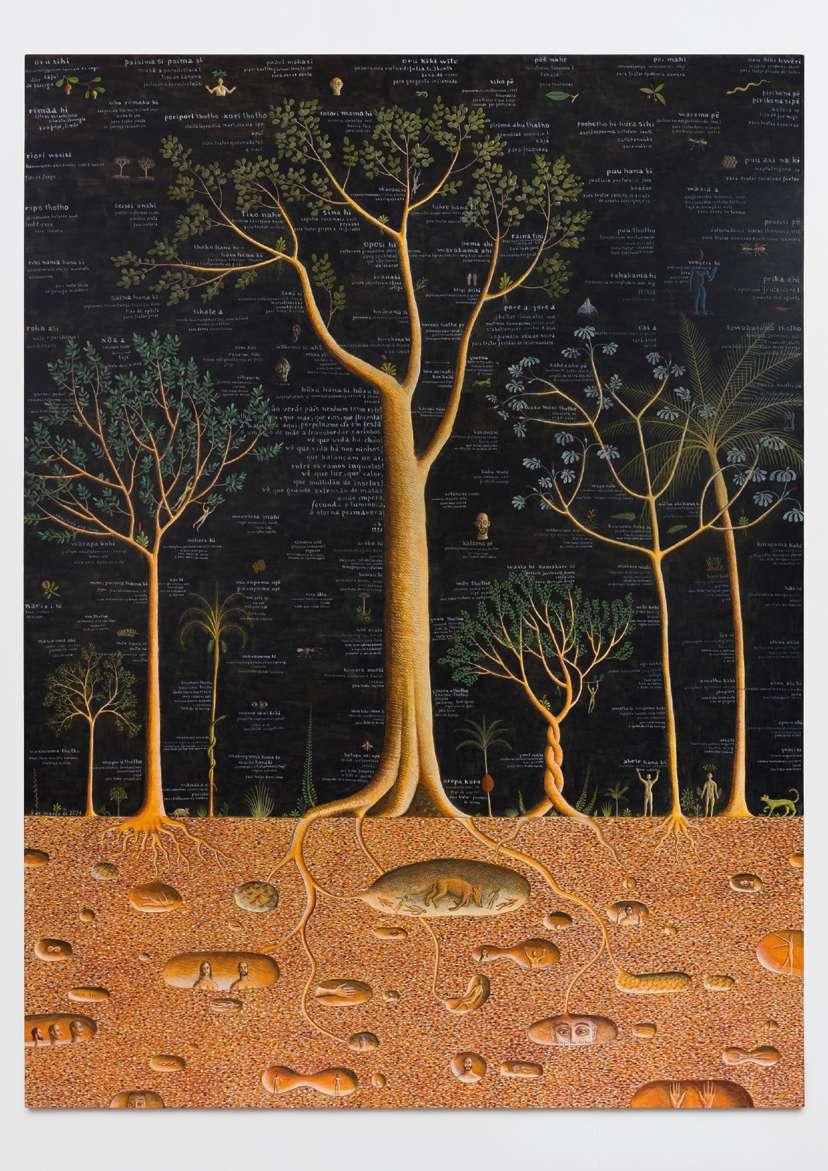
La vacanza è un luogo da abitare
Aguardarlo da lontano sembra quasi un miraggio. E in un certo senso lo è. Lo vedi apparire in mezzo ai boschi e agli ulivi, nel silenzio della Val Pennavaria, a 300 metri di altezza. Siamo nell'entroterra di Albenga, in provincia di Savona. Case in pietra, come fossimo ancora tra il Duecento e il Trecento (le origini del luogo sono medievali).
Un borgo antico che è andato completamente distrutto in un terremoto, a fine Ottocento, e che è stato ricostruito nel 1995, grazie a un intervento affidato all'architetto Giancarlo De Carlo. Il progetto si fece notare anche perché era tecnologicamente all'avanguardia, con l'idea di costruire

un villaggio telematico (già a quei tempi si parlava della possibilità di dedicarsi al “telelavoro” in mezzo alla natura). Previsti anche il bar, la piscina, il teatro, luoghi per la socialità.
Ricostruzioni meticolose, ma anche integrazioni, affacci e belvedere che si aprono ovunque, archi, scale, selciati, parapetti, vicoli, verande armoniose, finestre dai colori tenui, e una piazzetta con travi in legno e un grande glicine. Si chiama Colletta di Castelbianco ed è l'incarnazione ideale di Abitare la Vacanza, il Festival di Architettura che lo ha scelto come emblema.
Il tema è questo: andare oltre il turismo mordi e fuggi, con tutte le problematiche connesse, dal cosiddetto overtourism - quando l'impatto del turismo eccede la soglia delle capacità fisiche, sociali, ecologiche di un certo luogo - alla crisi climatica, alimentata da pratiche sbagliate, da una concezione dello sviluppo (anche urbanistico) non più sostenibile, oltre che non inclusivo.
L'idea è quella di ripartire «dalle case dei maestri Alberto Ponis, Giancarlo De Carlo e Vittorio Giorgini come modello e bene culturale da proteggere e valorizzare per una nuova filosofia dell’abitare i territori della vacanza oltre il turismo». Oltre al borgo medievale ricostruito in Liguria (58 appartamenti per 4000 mq), si parla infatti di altri due interventi celebri: le opere di Vittorio Giorgini realizzate a Baratti (Piombino) e le case di Alberto Ponis a Costa Paradiso (Sassari), che risalgono agli anni Sessanta.
50 AGOSTO 2023
L UOGHI
Tre progetti storici da riscoprire e ripensare, in Liguria, Toscana e Sardegna, andando oltre il turismo di massa
(foto Emanuele Piccardo)
Sono questi i tre luoghi in cui è andato in scena in aprile il festival Abitare la Vacanza (ideato dall'associazione plug-in insieme ad altre realtà: U-Boot-Lab, B.A.Co. Archivio Vittorio Giorgini, LandWorks). Tre luoghi che sono anche idee, progetti, occasioni di riflessione per ripensare "l'abitare" in mezzo alla natura, che sia davanti al mare o in mezzo a un bosco, tra le colline. L'intenzione infatti è quella di andare oltre «l'evento effimero», creando un «percorso di ricerca che si fa azione concreta, partendo dall'analisi dello stato di fatto e usando modalità e competenze diverse, come la residenza di artisti, fotografi, architetti, nei tre siti» Un'azione che vuole promuovere
«buona pratiche di gestione territoriale» oltre a un'architettura e un'urbanistica di qualità.

Due immagini dell'installazione "Le Tre Torri", tre stanze nel bosco realizzate davanti a Colletta di Castelbianco (Savona). In basso, una visione panoramica del borgo ricostruito
 (foto Emanuele Piccardo)
(foto Olivia Travers)
(foto Emanuele Piccardo)
(foto Olivia Travers)
Come ha scritto il curatore scientifico del festival Emanuele Piccardo: «In che modo possiamo oggi, di fronte all’urgenza del climate change, ripensare il modo in cui si interviene nei paesaggi fragili delle coste? Il festival vuole elaborare un pensiero critico, fare proposte concrete affinché si possa imparare dai maestri che hanno progettato la vacanza degli italiani per immaginare un presente coerente con la crisi ambientale».
Oltre ad aprire al pubblico queste “architetture per le vacanze” , il festival ha anche coinvolto le comunità locali nella costruzione di "microarchitetture" «finalizzate a rinsaldare il rapporto tra i fruitori del paesaggio e la natura».


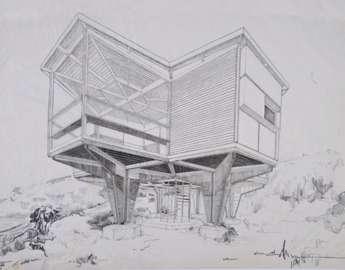
A Colletta, ad esempio, il collettivo GRRIZ (Luigi Greco e Mattia Paco Rizzi), con la collaborazione di alcuni studenti italiani e francesi, ha realizzato le Tre Torri,
ovvero “tre stanze nel bosco su un terreno di fronte al borgo”. L'idea alla base del collettivo è quella di progettare installazioni che richiedono al massimo dieci giorni di lavoro: «La premessa fondamentale è il profondo fascino comune verso l'essere umano inteso come animale sociale e il nostro amore verso l'architettura
e l'artigianato, consentendo la sperimentazione nello spazio pubblico, evidenziando il ruolo sociale dell'architettura e dell'architetto».
Una visita a Baratti, sul litorale tirrenico, può essere invece l'occasione per vedere la Casa Esagono, realizzata alla fine degli anni Cinquanta da Vittorio Giorgini.

52 AGOSTO 2023
La Casa Esagono realizzata da Vittorio Giorgini alla fine degli anni Cinquanta, in Toscana
(foto Emanuele Piccardo)
(foto Vittorio Giorgini)
Un'abitazione unifamiliare ispirata alle forme della natura e realizzata in mezzo a un bosco.

La terza proposta si trova nella macchia mediterranea, tra le rocce rosse di granito, la sabbia bianca e il mare cristallino della Sardegna.
Costa Paradiso ci riporta alla mente una celebre area vacanza, nata alla fine degli anni Sessanta. La progettazione delle residenze venne assegnata all'architetto Alberto Ponis, con il contributo di Dante Bini, che qui ideò la celeberrima Cupola per Michelangelo Antonioni e Monica Vitti.

Il Festival LandWorks ha proposto laboratori di progettazione e costruzione partecipata che hanno portato alla realizzazione di una “piazza sul mare”, una piattaforma in legno costruita su un tratto roccioso della costa, diventato uno spazio di condivisione e socialità, «capace di trasformare il privilegio privato di una casa per le vacanze in privilegio comune».
Le architetture per le vacanze, secondo gli organizzatori del festival, «possono essere il punto di partenza per ri-imparare a progettare nel paesaggio. Le domande fondamentali da porsi sono: è ancora valido il modello di sviluppo turistico degli anni Settanta? Come cambieranno i territori con il cambiamento climatico? La scienza ci informa che dobbiamo cambiare il modo di vivere il pianeta e questo vale ancora di più per territori fragili e maggiormente esposti agli effetti della crisi climatica come le aree costiere».
Di tutto questo si parlerà il 14 e 15 ottobre nella sede della Maison de l’architecture a Marsiglia dove verranno presentati risultati e
programmi futuri di Abitare la Vacanza, in un confronto tra studiosi, esperti, architetti. Il futuro va progettato (immaginato) oggi.
La piattaforma in legno costruita su un tratto della costa sarda. L'occasione per ripensare l'insediamento di Costa Paradiso, progettato alla fine degli anni '60 da Alberto Ponis (a cui si riferisce anche la foto in basso nell'altra pagina)
53 AGOSTO 2023
(foto Emanuele Piccardo)
(foto Andrea Maspero)
Pochi dubbi, il futuro è vegetariano Per la nostra salute e per il Pianeta
LA DOTT.SSA LUCIANA BARONI CI SPIEGA TUTTI I VANTAGGI DI UNA DIETA
SENZA CARNE, CONTRO I PREGIUDIZI E CERTI INTERESSI ECONOMICI
«L'alimentazione vegetariana non solo è totalmente priva di rischi, ma è addirittura protettiva nei confronti di malattie che flagellano i Paesi ricchi, che sono ormai con certezza correlabili all'alimentazione di tipo occidentale, basata sulla carne: le "malattie dell'abbondanza"»

Partiamo da qui, da quella che ormai dovrebbe essere un'ovvietà, se non fosse che molte persone continuano ad avere pregiudizi incomprensibili nei confronti della dieta vegetariana. La dottoressa Luciana Baroni, specializzata in Neurologia e Geriatria, con master in Nutrizione e Dietetica, nel 2000 ha fondato la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana (www.scienzavegetariana.it)
per combattere la disinformazione e sottolineare che «alla luce di quanto è presente nella letteratura medica degli ultimi 25-30 anni, il problema di scegliere se passare ad una dieta vegetariana potrebbe non essere tanto del "perché farlo", ma piuttosto del "perché non farlo"». Si sa che, oltre alla questione salutistica, ci sono anche altri motivi per fare questa scelta, soprattutto di tipo etico ed ecologico. E in teoria siamo abbastanza evoluti, ormai, per lasciarci alle spalle l'idea che la dieta vegetariana sia una scelta punitiva, quasi ascetica, una rinuncia ai piaceri del cibo, visto che l'arte gastronomica ha fatto enormi passi avanti e abbiamo innumerevoli possibilità in fatto di sapori, colori e piatti prelibati senza carne.
I DEE
(foto Maarten Van Den Heuveli)
Fatevi un giro, per curiosità, sul sito di PiattoVeg (www. piattoveg.info), ideato proprio dalla SSNV, per farvi un'idea delle combinazioni possibili, imparando ad associare i gruppi alimentari ed evitare eventuali carenze. Questo nostro articolo è dedicato soprattutto agli scettici, a chi non ha mai approfondito la questione, a chi magari sta pensando di cambiare dieta ma non sa da dove cominciare. La dott.ssa Baroni sarà la nostra guida. A partire da una questione terminologica che è anche tecnica, scientifica e ideale: la scelta di parlare di "dieta vegetariana" in generale, includendo sia quella latto-ovo-vegetariana, che quella vegana (cioè senza prodotti e derivati animali, latte e uova compresi).
I numeri: secondo l'Eurispes in Italia i vegetariani sono il 6,6% della popolazione, di cui un 2,4% è vegano (nel 2014 era lo 0,6%). Ma tra i più giovani (18-24 anni) la percentuale sale all'8,3%, indice di un cambiamento in atto, che probabilmente porterà i suoi frutti nei prossimi anni. C'è anche una larga fetta di popolazione (il 7%) che ci ha provato in passato, ma ha rinunciato per motivi personali o di comodità. Un dato che fa riflettere.
Avolte si parla del vegetarianesimo come fosse un'invenzione moderna, quasi un capriccio, figlio del benessere (che un tempo invece si misurava sulla disponibilità di carne), soprattutto nella sua variante esclusivamente vegetale. In realtà parliamo di scelte alimentari che hanno una lunga storia, diffuse in varie culture e latitudini. Quali sono le prime testimonianze storiche? Quali le più interessanti e importanti?
I nostri antenati si sono nutriti di cibi vegetali per milioni di anni. Il vegetarismo come scelta personale nasce nell’antica Grecia con Pitagora e altre importanti figure, tra cui Platone e Plutarco, per motivazioni etiche ma anche salutistiche ed ecologiste (ricordiamo che Platone, nel suo saggio La Repubblica, sosteneva che una dieta vegetale richiedeva meno terra di una basata su cibi animali). Ovidio e Seneca diffusero il vegetarismo nell’Impero Romano. Abbiamo poi nei secoli a venire Leonardo da Vinci, Rousseau, Tolstoj, Shelley, GB. Shaw, il Mahatma Gandhi, solo per citare i più noti.

55 AGOSTO 2023
Varie religioni (come gli Avventisti del Settimo giorno) sostengono il vegetarismo come scelta purificatrice e che mantiene in salute il tempio dell’anima (cioè il corpo). A partire dal secolo scorso, infine, vengono fondate varie associazioni a promozione del vegetarismo, inizialmente concepito come scelta etica, ma che poi è stata estesa anche alle motivazioni ecologista e salutista. Molte associazioni animaliste, che fino a pochi decenni fa non consideravano che la scelta vegetariana fosse coerente con il rispetto degli animali, l’hanno finalmente capito e la stanno promuovendo.
I sostenitori della dieta onnivora fanno spesso appello alla conformazione fisica dell'uomo (dentatura, apparato digestivo), ma anche alla storia della sua evoluzione. Oltretutto la dieta proteica, negli ultimi anni, è diventata di gran moda, per motivi legati per lo più al dimagrimento e all'estetica. Non è possibile affrontare in questo ambito argomenti che richiedono un’analisi approfondita dei dati scientifici e non hanno niente a che fare con mode o tendenze. La specie umana è in continua evoluzione da quando è comparsa sul Pianeta, in risposta soprattutto alla necessità di adattarsi all’ambiente. In questa fase dell’evoluzione umana la sopravvivenza della nostra specie dipende dalla capacità del Pianeta di fornirle le risorse necessarie. Se molti comportamenti umani non cambieranno, ivi compresa la dieta, andremo a sbattere.
Quali sono i motivi principali, oggi, per decidere di adottare una dieta vegetariana?
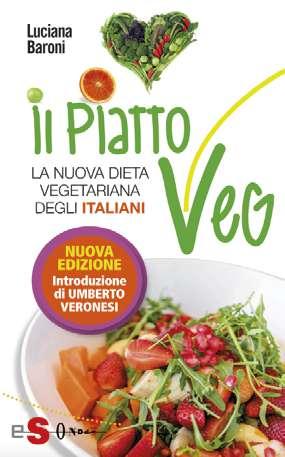
I principali, non in ordine di importanza, sono ambientali, salutistici, di equità sociale e di rispetto per gli animali.
Parlando di benessere e di prevenzione, quali sono le ricerche più recenti, e quelle più decisive, per dimostrare che una dieta vegetariana è più salutare di una dieta carnivora?
La ricerca in questo campo è molto vasta, e alcuni autori hanno cercato di sintetizzare i risultati in metanalisi e revisioni, in cui vengono analizzati i diversi studi, arrivando a una conclusione univoca. Segnalo ad esempio la umbrella review di Oussalah (Oussalah A et al., Health outcomes associated with vegetarian diets: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses, Clinical Nutrition, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.02.037, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.02.037), secondo cui gli esiti di salute negativi sono minori in chi segue una dieta vegetariana rispetto a chi segue una dieta onnivora. E la recentissima revisione della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), (Agnoli C et al., A comprehensive review of healthy effects of vegetarian diets, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, https://doi.org/10.1016/j.numecd.2023.04.005, https://doi. org/10.1016/j.numecd.2023.04.005), da cui si evince che le diete vegetariane sono più vantaggiose per la salute di quelle non-vegetariane.
Facciamo qualche numero per chiarire l'impatto sull'ambiente degli allevamenti animali?
I numeri sono drammatici: per ogni chilo di carne ottenuto, è necessario che vengano impiegati mediamente 15 chili di vegetali, appositamente coltivati per l’animale, quando invece potrebbero essere usati come cibo per l’uomo.
È stato calcolato che la quantità di terreno necessaria per sostenere un’alimentazione a base di prodotti vegetali è circa 10 volte inferiore a quella di una dieta a base di prodotti animali, il consumo di acqua 15 volte inferiore, il consumo di energia 12 volte inferiore.
In sostanza, produrre carne a partire da un essere vivente, o ricavare i suoi prodotti, richiede che l’animale venga fatto nascere e crescere, il che significa utilizzare la maggior parte delle risorse per le sue funzioni vitali, senza considerare le scorie che si formano durante tutto il processo.
56 AGOSTO 2023
Lo spreco per la produzione di cibi animali è stato stimato essere pari all’81%: cioè di tutto quello che entra nel processo produttivo, le risorse convertite in cibo sono solo il 19%. E per quanto riguarda le emissioni, la produzione di cibi vegetali genera solo il 4% delle emissioni di CO2, un sesto delle emissioni totali di inquinanti prodotte da carne, pesce, latticini e uova.

Cosa ne pensa delle proposte alternative che stanno emergendo in questi anni, dall'idea di un'alimentazione basata su insetti alla carne sintetica?
L’idea di alimentarsi con gli insetti mi pare inquietante e potenzialmente molto pericolosa (pensiamo alle cavallette in Australia), oltre che capace di suscitare resistenze psicologiche nei consumatori.
Invece sulla carne coltivata ho una posizione differente, perché credo sarebbe molto utile per ridurre gran parte dei problemi che derivano dall’allevamento animale. Anche se la migliore soluzione ai problemi ambientali e della sofferenza animale sarebbe quella di mangiare solo vegetale naturale, mi rendo conto che si tratta di un traguardo difficile da raggiungere. Se vogliamo ridurre i danni dell’allevamento intensivo dobbiamo dare ai carnivori, cioè a quelle persone che mai rinuncerebbero alla carne, un cibo ottenuto nel modo maggiormente sostenibile per l’ambiente e per la sofferenza animale.
La dieta vegana può essere considerata uno step successivo? È davvero adatta a tutti o richiede una maggiore consapevolezza?
Una dieta vegana composta da cibi vegetali non trasformati dovrebbe essere il modello su cui costruire qualunque dieta sana, che secondo le principali linee guida internazionali dovrebbe basarsi per l’80% proprio su cibi vegetali. Cereali, verdura, frutta, frutta a guscio e semi dovrebbero essere presenti in modo variato in tutti i tipi di dieta. La differenza tra i vari tipi di dieta dovrebbe essere solo nella composizione dei cibi proteici, che costituiscono uno dei 5 gruppi alimentari, e che per tutti dovrebbe contenere legumi (inclusi derivati della soia).
L'unica differenza dovrebbe consistere nell’inclusione di piccole quantità di latticini e uova per i latto-ovo vegetariani e latticini, uova, carne e pesce per gli onnivori. La dieta vegana è quella con il minor impatto ambientale, che causa il minor sfruttamento animale e che apporta maggiori benefici per la salute.
In alto, uno degli opuscoli che la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana distribuisce gratuitamente online, nel sito internet www.scienzavegetariana.it.
A proposito di luoghi comuni da sfatare, in basso trovate una tabella pubblicata nell'opuscolo in cui si mette a confronto la quantita di ferro contenuta nei principali alimenti (i vegetariani non soffrono di carenze, se la dieta è varia ed equilibrata).
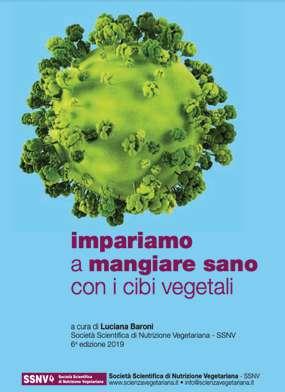
57 AGOSTO 2023
A proposito di dieta vegana, esiste una pubblicistica anche piuttosto violenta contro quella che viene considerata una moda (radical-chic), a volte perfino un'ideologia assimilabile a un credo religioso. Per certi versi alimentata da alcune posizioni estreme all'interno del mondo vegano. Eppure si tratta di una scelta sempre più popolare, che ha prodotto anche una sua nicchia di mercato, figlia di una sensibilità animalista molto diffusa. Da una parte ci sono interessi che portano a rappresentare come “estrema” una scelta che potrebbe incidere su settori economici oggi molto rilevanti. Dall'altra parte, possono esserci persone con problemi psichiatrici nella popolazione generale, e alcune di queste optano per scelte estreme nell’alimentazione, a volte molto restrittive e spacciate per “dieta vegana”. Queste persone sono facilmente riconoscibili perché hanno un comportamento che non è quello della maggior parte di vegani, tra cui mi colloco anch’io, vegana da 22 anni.

Esiste la possibilità che un maggior numero di vegetariani (latto-ovo e vegani) possa produrre un cambiamento nell'economia, inducendo i produttori ad abbandonare certe forme di allevamento intensivo?
Questo sta già avvenendo ed è auspicabile che il trend sia in ascesa: gli allevatori reagiscono sia con scelte aggressive e “integraliste”, che con scelte responsabili dirette ad una riconversione del mercato della carne verso alternative sostenibili. Non a caso alcuni colossi stanno investendo nella ricerca sulle carni da coltura cellulare. Credo che la scelta di vietare per legge la ricerca pensando di tutelare gli interessi di una categoria si rivelerà alla lunga perdente, non solo per gli allevatori ma per il paese intero, e dannosa per tutti gli abitanti del Pianeta.
Vantaggi e svantaggi di una dieta vegana rispetto a quella latto-ovo-vegetariana.
I vantaggi sono quelli già citati, per l’ambiente, la salute e gli animali, quindi anche per la propria coscienza. Svantaggi non ne vedo, le attenzioni da riservare ad alcuni nutrienti sono le stesse per tutti i vegetariani (adeguati apporti di omega-3, calcio, vitamina D e B12), ma anche per molti onnivori (calcio, vitamina D e B12), sempre che parliamo di tutte diete correttamente pianificate, altrimenti gli svantaggi aumentano per qualunque tipo di dieta.
Ci sono elementi della dieta che bisogna imparare a integrare (B12, calcio, vitamina D). Certe possibili carenze, soprattutto in relazione alla dieta vegana, sono spesso portate come esempio dei limiti di questo approccio, il suo essere un fatto culturale più che naturale. Soprattutto quando si parla di persone con deficit metabolici, donne in gravidanza, persone con malattie croniche.
Se parliamo di diete correttamente pianificate, non esiste una sostanziale differenza nutrizionale tra le diete, se non una peggiore qualità delle diete che comprendono cibi animali, in quanto più ricche di componenti potenzialmente dannosi per la salute (grassi saturi, ferro eme). Dal 2005 dedico parte del mio tempo a fornire indicazioni per l’adeguatezza delle diete vegetariane (indicazioni che, intervenendo sul gruppo dei cibi proteici, possono essere utili anche a costruire una dieta onnivora equilibrata), e negli anni ho prodotto una guida alimentare, il PiattoVeg, che propone indicazioni per adulti, bambini, donne in gravidanza e allattamento, sportivi, anziani e soggetti affetti da patologie croniche.
Il vegetariano è mediamente più consapevole nella sua alimentazione, ad esempio riguardo la provenienza di ciò che consuma, oltre che nello stile di vita (la necessità di attività fisica, ma anche l'adozione di tecniche e discipline mentali e spirituali). Come convincere della bontà di questo approccio chi non ha tempo ed energia per occuparsene, chi ha a malapena la possibilità di passare dieci minuti in un supermercato per comprare un piatto pronto da consumare a cena?
(foto Taryn Elliott)
Alla mia età sono arrivata alla conclusione che ognuno può fare della sua vita quel che vuole, purché le sue azioni non danneggino altri esseri viventi. Ma sappiamo che molte persone non rispettano niente e nessuno, ce lo raccontano tutti i giorni i media. In questo panorama desolante, si fa quel che si può. Ognuno getterà dei semi e le persone responsabili se ne prenderanno cura e modificheranno le proprie abitudini di vita. Se si vuole fare una cosa, si fa. Lo so bene io, che ho fatto il medico per più di 40 anni, con turni massacranti e notti di guardia, eppure ho trovato il tempo di dedicarmi allo studio dell’alimentazione vegetariana.
Poi, o forse prima, c'è la questione del piacere, il gusto. Per molti, il sapore della carne è qualcosa di irrinunciabile. Magari sono anche possibilisti, e provano a diminuire il consumo di carne rossa (quella più pericolosa dal punto di vista della salute), ma ritengono che la dieta vegetariana sia priva di gusto e monotona.
Evidentemente non hanno mai provato la cucina vegetariana, che è ormai argomento di moltissimi libri di ricette: questo è un limite loro, non della dieta. È la dieta a base di cibi animali a essere monotona. In una dieta vegetariana, la varietà delle preparazioni è praticamente infinita e il gusto è decisamente diverso ma non per questo peggiore. Tutti coloro che provano a mangiare vegetale rimangono entusiasti dall’esperienza.

Lei porta avanti un lavoro di informazione e divulgazione da molti anni ormai, soprattutto attraverso la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana o strumenti come il sito piattoveg.info. Come ha visto cambiare la sensibilità della società italiana su questo tema negli ultimi decenni? Parliamo dei cittadini, ma anche dell'economia, la politica, il mondo intellettuale. Quali Paesi possono darci il buon esempio?
Direi che da quando ho fondato SSNV, nel 2000, le cose sono sicuramente migliorate. Tuttavia, il numero di cittadini che ancora non si mostra aperto e sensibile a queste tematiche è elevato. Mi spiace dirlo, ma questo atteggiamento è alimentato dai media che dispensano informazioni scorrette e spesso terroristiche. Prendiamo ad esempio il problema del riscaldamento
globale: avete mai sentito qualcuno dire in televisione che la scelta di mangiare vegetale avrebbe un effetto rilevante sulla riduzione delle emissioni? Nel Regno Unito, ma soprattutto in Germania, paese con elevato livello medio di civiltà, sono molto più avanti nel coinvolgere la popolazione in queste tematiche. Qui da noi, chi comanda sull’alimentazione (…che non è il governo) tutela solo i propri profitti.
Cosa consiglierebbe a chi vuole provare ad adottare un regime vegetariano? Come procedere? Meglio un approccio graduale o un intervento deciso e ben pianificato?
Dipende dalla persona. C’è chi smette “cold turkey” e chi lo fa gradualmente. Nel primo caso, bisogna naturalmente già aver acquisito alcune nozioni e competenze, mentre forse nel secondo caso l’esperienza si fa “sul campo”, aumentando gradualmente i cibi vegetali della dieta, il che automaticamente toglie i cibi animali fino ad azzerarli. Esistono ormai moltissimi libri o siti che forniscono indicazioni e suggerimenti alimentari a chi sia interessato a compiere questa scelta. Ad esempio si possono trovare info utili nei miei libri e sul sito www. piattoveg.info o quello di scienzavegetariana.it. Chi abbia esigenze speciali di tipo alimentare o sanitario oggi può rivolgersi a professionisti preparati che possono fornire supporto per situazioni individuali particolari. Le possibilità sono a disposizione di chiunque voglia farlo e spero che possano favorire l’aumento del numero di persone che compiono questa scelta.
59 AGOSTO 2023
(foto Vanessa Loring)
Sporgersi per guardare l'abisso Oppenheimer, l'uomo e la bomba

RIFLESSIONI SUL FILM CAPOLAVORO DI CHRISTOPHER NOLAN, CHE ARRIVERÀ
Ci sono registi che amano sfidare l'impossibile. Che portano il cinema a sporgersi oltre il limite del visibile. Ecco il perché della vertigine che provocano certi film. A prescindere dal fatto che siano arte o industria, cinema poetico, astratto, oppure narrativo. Ci sono registi che riescono perfino a conciliare gli opposti, a realizzare opere così potenti e comunicative da trasformarsi in classici istantanei. Film che racchiudono lo spirito di un'epoca (anche
più di una) mentre parlano di temi universali, di quelli che accompagnano l'umanità da quando è nata e che continueranno a interrogarla per sempre.
Oppenheimer è uno di quei film. Il regista Christopher Nolan appartiene a un gruppo ristretto di autori che pensano il cinema in grande, anzi in grandissimo, al massimo delle sue possibilità tecnologiche ed espressive, realizzando opere che sono insieme ricerca e intrattenimento, spettacolo e pensiero.
IN ITALIA IL 23 AGOSTO (ERA ORA). CINEMA CHE MOSTRA L'INVISIBILE M EDITAZIONI 60 AGOSTO 2023
A lui dobbiamo abili giochi mentali come Memento (il cinema è il meccanismo che lo anima) e affreschi epici come Dunkirk, il Batman più vero e inquietante (Il cavaliere oscuro) e il delizioso The Prestige, il labirinto di Inception, che ci ha fatto perdere la testa, e la fantascienza filosofica melò di Interstellar, che ci ha fatto scoppiare il cuore.
Il tempo è la sua ossessione. Generatore di enigmi, paradossi, illuminazioni. Anche Oppenheimer è condotto su linee temporali diverse che si intrecciano.
Da una parte c'è il non-processo (a colori) a cui venne sottoposto lo scienziato, molti anni dopo aver creato la prima bomba atomica, nel 1954, quando fu costretto a difendersi dall'accusa di essere un comunista, amico dei nemici sovietici. Dall'altra il dibattimento (in bianco e nero) del 1958 in cui Lewis Strauss dovette raccontare il suo rapporto con Oppenheimer (lo aiutò? lo ostacolò? aveva dei sospetti su di lui?), per dimostrarsi degno di diventare il Segretario al commercio di Eisenhower.

Tre linee temporali. Due punti di vista. Cinema storico e biografico, dramma, legal thriller, melò, orrorifico, visionario
Poi c'è la terza linea narrativa, quella principale, anche se è il frutto della sovrapposizione di flashback e ricordi: la vicenda biografica, che parte dal 1926, quando Oppenheimer era un giovane studente di fisica all'Università di Cambridge. Una linea che si intreccia con le altre, ritrovandosi a saltare avanti e indietro, a tornare sul già detto e il già visto in modo nuovo, mentre porta avanti il crescendo drammatico (vi ritroverete con il cuore in gola, anche se conoscete perfettamente la vicenda). Tanto per farci capire che lo scopo del film non è raccontarci la storia dello scienziato, ma il suo enigma interiore, il mistero del suo genio, le contraddizioni etiche e politiche, intellettuali e sentimentali. E parlando dell'uomo, parlare dell'umanità, la storia, il potere, la conoscenza, l'abisso morale.
61 AGOSTO 2023
Robert Oppenheimer è interpretato da Cillian Murphy (straordinario). Nell'altra pagina, Robert Downey Jr. nella parte di Lewis Strauss
Stavolta però la questione centrale non è la durata (relativa) del tempo, la sua diversa percezione interiore, la possibilità di comprimerlo o di espanderlo. Qui la relatività è innanzitutto una questione scientifica, che permea di sé la visione, il modo in cui guardiamo la realtà, l'illusione e la sostanza che la alimenta: da una parte ci sono le solide forme del cinema narrativo, i personaggi con le loro storie, i gesti e le parole, e dall'altra le astrazioni visive, le intuizioni metafisiche, i colori e i suoni che formano geroglifici sensoriali. Ma di relativo c'è soprattutto l'etica, la complessità della coscienza a confronto con la realtà pedestre del mondo, complicata ulteriormente dai sentimenti dell'uomo, dal suo orgoglio e la sua meschinità, dai desideri e le ambizioni (tutte cose che si evincono dalla notevole biografia da cui è tratto il film, American Prometheus di Kai Bird e Martin J. Sherwin, diventato in Italia un più semplice Oppenheimer).
La questione più evidente è quella nota e dibattuta nel corso dei decenni: è lecito creare un ordigno in grado di seminare morte e distruzione con lo scopo di porre fine alla distruzione e alla morte?
Difficile districarsi tra l'Oppenheimer patriota, consapevole di ciò che è capace una bomba atomica, ma convinto che sia necessaria a sconfiggere i nazisti (in un primo momento) e a porre fine alla Seconda guerra mondiale (quando a combattere è rimasto solo il Giappone), e quello "pacifista", a cui piace pensare che la creazione di un'arma così potente porrà fine a ogni conflitto in futuro, perché le nazioni del mondo avranno conosciuto il suo potere apocalittico.
C'è lo scienziato ambizioso, con la sua sete di conoscenza, che vede letteralmente i segreti dell'universo e intuisce il suo destino provvidenziale, quasi un mistico visionario («Ora sono diventato Morte, il frantumatore di mondi»), e c'è l'uomo fragile, incerto, imbrigliato in relazioni che non riesce a decifrare fino in fondo, che non lo potranno mai soddisfare, realizzare.

62 AGOSTO 2023
L'invisibile che sta oltre l'illusione della materia.
E quello dell'animo umano, con le sue contraddizioni
L'invisibile, dicevamo. E i registi che provano a mostrarlo attraverso il visibile. Qui gli abissi sono due. Il primo, quello più spettacolare ed evidente, è la sostanza (meta)fisica dell'universo, il mistero quantistico della materia che in realtà è energia, la matematica della verità subatomica. Ed ecco il lato "malickiano" di Oppenheimer, le sequenze che provano a tradurre in immagini le percezioni interiori dello scienziato, in misteriosa connessione con le vibrazioni del cosmo (lui che è in grado di leggere la Bhagavad Gita in sanscrito...). Vedere le visioni di Oppenheimer, significa riuscire a penetrare l'illusione (estremamente convincente) della materia solida. L'impresa è ovviamente impossibile. Non è un mostrare ma un indicare, un evocare. E ogni volta è affascinante assistere al modo in cui il regista di turno fallisce nello scopo. Ogni "fallimento" ha una sua vertigine speciale. Poi c'è l'invisibile dell'anima, della coscienza. Oppenheimer è uno dei personaggi più straordinari e complessi incontrati nel cinema degli ultimi decenni. D'altra parte si parla di un uomo che viene a disporre di un potere "divino", con i dilemmi etici insolubili che ciò porta con sé. Ed ecco allora l'insistenza con cui Nolan osserva da vicino il volto di Cillian Murphy (che interpretazione memorabile la sua), lo scava quasi, lo squaderna implacabilmente sullo schermo gigantesco su cui il film andrebbe visto. Nolan ha girato in Imax 70mm (peraltro in bianco e nero non era mai stato fatto prima) e sarebbe bello che tutti potessero vivere l'esperienza del film in una sala adeguata all'impresa (noi l'abbiamo fatto all'Arcadia di Melzo, dotato di uno schermo di 30 metri), con l'immagine che sembra avvolgerti e stringerti in un abbraccio (im)mortale, una visione che perde la sua abituale bidimensionalità e invita all'immersione.
I diversi piani temporali, in questo film, sono meno importanti della differenza di prospettiva su cui sono costruiti. Perché da un parte c'è il racconto soggettivo di Oppenheimer, le immagini a colori, il modo in cui lui vede, scopre, sperimenta, interpreta, sceglie, agisce.



63 AGOSTO 2023
Tre immagini del regista Christopher Nolan al lavoro sul set di "Oppenheimer".
Dall'altra, in bianco e nero, una sorta di oggettività storica, che si fa documento, dentro la forma di un legal thriller, con tanto di sorpresa finale che cambia il significato della vicenda. Oppenheimer, in effetti, contiene diversi film in uno. C'è innanzitutto la storia dello scienziato raccontata stando dentro il suo sguardo e i suoi pensieri, con un montaggio libero, quasi musicale, sinfonico, che lavora per accostamenti di senso e forma. Qui siamo fuori dalle dimensioni del tempo e dello spazio, anche se la narrazione sembra procedere lungo le tappe della vita del protagonista. C'è qualcosa che va al di là dei limiti del visibile e della bidimensionalità del cinema. Un effetto "stereofonico" e sinestesico a cui contribuiscono il lavoro sul suono e la notevole colonna sonora firmata da Ludwig Göransson.
tutti, ma anche Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Benny Safdie, Kenneth Branagh, Dylan Arnold, Gustaf Skarsgård, David Krumholtz, Matthew Modine...).
C'è il film storico-biografico, che rispetta le regole del "viaggio dell'eroe", ma anche il melodramma sentimentale, c'è qualcosa di orrorifico, quasi paranormale (gli abissi mentali prodotti da un orrore reso normale) e ci sono sprazzi di profonda umanità, con tutta la sua complessità emotiva, erotica, intellettuale, razionale o irragionevole, magicamente ispirata e poi misteriosamente cieca.
Poi c'è il thriller, che si intreccia con le forme del cinema di impegno civile, dove la parola acquista un ruolo fondamentale, così come le interpretazioni di un cast che evidentemente ha percepito la grandezza di ciò che stava contribuendo a realizzare (Robert Downey Jr su

Tutto però converge verso un punto, quello della deflagrazione. E tutto riparte da lì, come le onde concentriche da cui comincia il film. È formidabile la tensione che ci porta fino al conto alla rovescia, talmente convincente, mimetica, esaltante che quasi viene voglia di sperare che non accada (il tempo è relativo, giusto?). La rappresentazione dell'esplosione ha una forza vista raramente nel cinema recente (ma anche quello più lontano). Tutto è silenzio, sospensione, implosione, dentro di noi, come sullo schermo, solo luce nel silenzio, che sembra essersi ingoiato il tempo e lo spazio. Poi tutto esplode, romba, deflagra. Quel suono, quel rumore-tremore tremendo, che avevamo già percepito nell' intuizione mentale di Oppenheimer, lo ritroveremo anche nel momento della "gloria", i piedi che battono a ritmo, le urla degli invasati dalla vittoria e dalla volontà di potenza.

64 AGOSTO 2023
Tutto converge verso la deflagrazione atomica e tutto riparte da lì. In cerchi concentrici. L'espolsione travolge ogni cosa, le vite dei protagonisti e la storia dell'uomo
Perché l'esplosione deflagra anche nelle menti, nei pensieri della gente, così come nella politica, nei programmi militari, nei rapporti tra le nazioni. L'onda lunga di quell'esplosione si riverbera nella vita privata delle persone così come nella storia dell'uomo. E quanta America c'è, nel bene e nel male, in questa storia prometeica, trasformata in un miserabile fascicolo qualsiasi dell'epopea maccartista.
È successo l'impensabile. Qualcosa che si colloca in una dimensione a metà strada fra l'umano e il divino, la possibilità di manipolare i segreti della natura. Non per niente all'inizio si evoca Prometeo, il fuoco rubato, il tormento senza fine a cui è destinato. Il controcampo è un'immagine pacifica di Einstein in lontananza, il paradigma del genio umano al servizio della pura conoscenza. Che diventa una sorta di saggio eremita, spettatore di un mondo che non riesce a capire, anche perché un conto è svelare i segreti dell'universo, un altro decriptare i misteri del cuore e della mente dell'uomo. Un film del genere non poteva essere figlio del digitale, l'apparato virtuale che simula la realtà. La verità doveva emergere dai volti, i suoni, le visioni analogiche. Ed ecco che il passaggio dalla fisica di Newton alla meccanica quantistica prende corpo in immagini ottenute gettando vernici sui muri o usando soluzioni luminose di magnesio. Ecco i violini di Göransson che creano un'atmosfera in cui convivono bellezza e terrore, ma anche i sintetizzatori che evocano una sorta di dimensione ultraterrena quando si prepara il test Trinity. Ecco la scelta di ricreare Los Alamos, base del Progetto Manhattan (una scenografia western), ma di girare le scene interne nei veri edifici in cui vissero i protagonisti, utilizzando il vecchio ufficio di Einstein
a Princeton per farne l'ufficio di Oppenheimer. Dice Nolan: «Che vi piaccia o meno, J. Robert Oppenheimer è la persona più importante che sia mai vissuta. Ha modellato il mondo in cui viviamo, nel bene o nel male. E la sua storia deve essere vista per essere compresa». Non siamo sicuri di averla compresa davvero, di sicuro l'abbiamo sentita e vissuta. Abbiamo gettato un'occhiata verso l'abisso. Bellissimo e terrificante. Anche perché non si tratta di storia, ma di attualità. Questo non è un film su una cosa accaduta nel secolo scorso, ma su qualcosa che potrebbe sempre accadere. Tremendo quel dettaglio, quello "zero virgola" che tormenta Oppenheimer (ma poi quasi lo diverte), la possibilità matematica che la bomba, esplodendo, potesse distruggere l'intero Pianeta. Sì, abbiamo corso anche quel rischio. Lo corriamo ogni giorno. (f.t.)


INAUGURATA DA UN RE, ABITATA DA PRINCIPI, SOLDATI E FANTASMI
Villa Giovanelli Fogaccia è stata una delle prime residenze storiche ad essere aperte al pubblico

Sposarsi in una villa inaugurata da un re. Sopravvissuta grazie a un “miracolo” alla Seconda guerra mondiale e ai nazisti, che cercarono di farla saltare in aria. Utilizzata da Bruno Corbucci per girare un film culto degli anni '80, con Renato Pozzetto e Gloria Guida: La casa stregata. Una villa “nordica”, liberty, in terra romana: antica, elegante, ma diversa dalle case storiche che si incontrano a decine nella capitale. C'è il
travertino, certamente, ma ci sono anche il tufo, i pavimenti in cotto di Perugia, i ferri battuti forgiati in Val Seriana. L'origine della famiglia, infatti, è bergamasca. E la villa romana, fatta costruire dai Fogaccia quando la corte si spostò nella nuova Capitale, doveva somigliare alla loro residenza di Clusone (seicentesca, bellissima, ma chiusa al pubblico).
La conoscono tutti come Villa Giovanelli, si trova tra la via Aurelia
e via Boccea, ospita matrimoni, convention, ricevimenti di ogni tipo. Ma la padrona di casa, Ginevra Giovanelli, ci tiene a ricordare la famiglia Fogaccia, che la fece costruire a inizio Novecento. Ed ecco allora la “Villa Giovanelli Fogaccia”, con il suo spettacolare Salone delle Feste, il Salotto verde e il Giardino d'inverno, uniti da uno scalone centrale a due rampe, con archi e pilastri massicci, in un suggestivo gioco di linee e prospettive. Con il suo Prato sul lago (700 mq), la Corte dei venti (450 mq) e un grande parco di fronte alla villa. D'altra parte la residenza fu progettata dall'architetto Marcello Piacentini, lo stesso che a Roma ha realizzato Villa Nobili e la chiesa di Cristo Re, il Palazzo del Rettorato della Sapienza e la sede del Ministero dello Sviluppo Economico (un tempo Palazzo delle Corporazioni), dopo aver trasformato la città di Bergamo. La principessa Ginevra è il valore aggiunto di questa residenza, la sua anima e la sua memoria storica. Lei che è stata tra i pionieri, in Italia, nell'apertura al pubblico delle ville storiche, trentacinque anni fa, tanto da essere chiamata a tenere dei corsi ai proprietari di case nobili. Ginevra Giovanelli custodisce i segreti di questa casa e quindi è la guida ideale per chi vuole conoscere le storie che racchiude, le particolarità architettoniche, ma anche gli aneddoti leggendari.
«Noi siamo di origine bergamasca-veneziana – racconta la principessa. - I Fogaccia scesero a Roma con la corte italiana. Il conte, il mio pro-pro-zio, aveva una nipote che adorava, dama di corte della regina Elena.
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA
Quando arrivarono a Roma comprarono mille ettari fuori città. La proprietà poi venne divisa in varie parti e fecero costruire questa villa, che doveva essere una residenza estiva, la casa di campagna, dove iniziava la tenuta dell'azienda agricola». Erano anni molto particolari, pieni di fervore. «Ci eravamo liberati della guerra, tutti erano pieni di speranza, finalmente si ricominciava a lavorare e a godersi la vita. La villa venne edificata per ospitare balli, feste, ricevimenti».


Ma la pace durò poco e con la Seconda guerra mondiale arrivarono anche i nazisti, che occuparono la villa e la scelsero come base SS fuori Roma. Nasce da qui uno dei misteri più noti legati alla storia di questa residenza. «La leggenda vuole che i miei nonni, scappando verso il nord Italia, senza accorgersene, lasciarono alla villa una reliquia, giunta qui ai tempi del loro matrimonio (la sacra reliquia della Santa Croce, ndr). Quando arrivarono gli americani, l'ultima bomba esplose sul cancello della villa. I tedeschi prima
di scappare avevano completamente minato la casa, che non è saltata in aria per miracolo, solo perché gli americani sono arrivati con 4-5 ore di anticipo e quindi sono riusciti a disinnescare l'esplosivo». Chi non crede ai prodigi parlerà di fortuna, per tutti gli altri invece è opera della provvidenza divina: «I Fogaccia e i Giovanelli sono estremamente cat-
tolici». Ma non chiedetele di mostrarvi la reliquia. «Me lo chiedono tutti. È ancora nella villa, non l'ho mai rimandata su a Clusone. Ritengo che debba rimanere qui. Ma non la faccio mai vedere a nessuno. È una di quelle cose che le famiglie si tramandano, che non hanno un valore effettivo, ma simbolico» Ad un certo punto la linea ereditaria dei Fogaccia si è esaurita. «La mia celebre nonna, l'ultima dei Fogaccia, sposò il principe Giovanelli, veneziano, prendendo il suo nome. Ecco perché io preferisco chiamare la villa Giovanelli Fogaccia». La residenza è stata aperta al pubblico proprio grazie a Ginevra Giovanelli. «Mia mamma qui c'è stata molto poco. Quando avevo 7-8 anni ha deciso di trasferirsi in centro a Roma dove possedeva un altro palazzo. A quel punto la villa è rimasta chiusa. Ci sono ritornata 10-15 anni dopo, quando avevo vent'anni.
67 AGOSTO 2023
Ce ne parla Ginevra Giovanelli, che racconta storia, architettura e misteri di questa residenza, oggi luogo di ricevimenti, matrimoni, convention
Ho detto a mio padre: la villa sta morendo, proviamo a organizzare dei ricevimenti, vediamo se funziona, così magari potrà rifiorire. L'idea è nata così, per volontà di una ragazzina. Era il mio secondo lavoro, a quel tempo facevo la giornalista, lavoravo alla Quotidiana Associati (Gazzetta del Mezzogiorno)».
Ora sono passati 35 anni, la Villa è sempre molto ambita e ammirata e Ginevra Giovanelli ha trovato un equilibrio tra pubblico e privato. Perché non è una scelta banale aprire la propria casa a degli sconosciuti. «Ma quando tenevo i miei corsi sulla gestione delle residenze d'epoca, ai proprietari spiegavo che c'è una cosa ancora più difficile rispetto alla necessità di staccarsi dal bene: chiedere dei soldi. Le persone ti dicono: tu sei ricca, cosa ci fai con quei soldi? A quel punto bisogna avere il coraggio di rispondere che se apriamo al pubblico è perché di quei soldi abbiamo bisogno».

Oggi la villa svolge serenamente la sua doppia funzione. «Ho diviso la casa in una parte abitata e un'altra per il pubblico, su cui mi sono concentrata come se fosse una specie di albergo-ristorante. La vedo molto come luogo di lavoro. Abbiamo tolto gli arredi, le consolle del '700-'800, le cose più antiche. Essendo una villa liberty non è stato difficile. Non ci sono affreschi, solo quadri di famiglia». Si tratta comunque di condividere un tesoro. Che ha un valore culturale, oltre che affettivo. «Io faccio spesso l'esempio della costruzione della strada di Assisi. Chiesero alle persone di comprare un mattone, su cui poi venivano incisi i nomi dei benefattori. Ecco io dico sempre a tutti i miei sposi che è come se fossero i co-proprietari della villa. Dovrei dire grazie ad ognuno di loro per ogni mattone di questa residenza. Grazie a loro riusciamo a mantenere un bene che viene aperto al pubblico».

Un bene che, a proposito di misteri, ha anche un'altra particolarità, visto che c'è chi viene qui a caccia di fantasmi.
«La villa ha ospitato il film La casa stregata e in tanti la chiamano
ancora così. Ci sono un sacco di estimatori di questo cult. Mi scrivono perfino delle lettere per Pozzetto, come se lui abitasse qui».
Inutile dire che la clientela della villa è molto selezionata. «All'inizio dovevamo lavorare il più possibile, adesso invece ci bastano pochi matrimoni. Per cui ho fatto un discorso di selettività. La nostra clientela è di nicchia. Ci sono anche palazzi più belli del nostro a Roma, ma questa villa è davvero unica. Ha il fascino dell'antico, ma anche quello del nord Italia». Di sicuro non è un luogo adatto a chi cerca cerimonie informali, con rinfreschi veloci, sempre più diffuse anche nel nostro paese. «Ne risentiamo anche noi. Prima avevano 250 ospiti per ogni matrimonio, oggi si va dai 50 ai 100. A volte anche meno. In questo tipo di villa il mercato è cambiato. È una cosa che bisogna potersi permettere Questo però ci consente di concentrarci sulla qualità e di avere una clientela più tranquilla. Ora noi affittiamo solo nel weekend, di solito per due giorni. Ne ospitiamo tre solo se siamo costretti, ad esempio se si fa vivo un vecchio cliente all'ultimo momento».
Il catering è doc. «Per tanti anni abbiamo lavorato solo con Natalizi. Poi, dopo il Covid, si è aggiunta anche California, altra ditta di livello altissimo, tra le più importanti di Roma. Abbiamo scelto loro perché ci assicurano la massima qualità possibile, in tutti gli aspetti. All'inizio, tanti anni fa, essendo figlia di mia madre, davo perfino lezioni ai camerieri. Poi abbiamo deciso di delegare». Per quanto riguarda la struttura, la villa si presenta da sé. Ma ci sono alcune caratteristiche storiche e architettoniche molto particolari. «La struttura nasce intorno a una torre pre-esistente che in realtà non esisteva. È la caratteristica propria al liberty, che giocava molto sulla finzione, il copiare l'antico. Doveva assomigliare al palazzo di Clusone, e infatti il corpo centrale gli assomiglia davvero. I due corpi laterali, invece, dovevano dare l'impressione che un secondo proprietario avesse allargato la villa. Nella parte bassa ora ci sono le cucine, che una volta erano le stalle. Lo spazio per le carrozze oggi ospita il garage». Altro aneddoto curioso. «Mentre la villa veniva costruita, la modernità stava avanzando. Il giorno in cui venne inaugurata dal re Vittorio Emanuele III, si accesero le prime luci nelle borgate romane, e un cordone, un filo che saltava da un palo all'altro, venne fatto arrivare dal Vaticano alla villa, così si accesero le prime luci anche da noi».

Il giardino, nel corso della sua storia, ha ospitato 70 mila essenze arboree. «La villa nasce con un giardino all'italiana davanti e uno mediterraneo sul retro. Ma negli

otto ettari della proprietà c'erano anche frutteti e piante di ogni tipo. Durante la Seconda guerra mondiale, la maggior parte vennero abbattute. A quel punto i prozii fecero arrivare degli ulivi, che si vedono ancora nella parte retrostante. Ora stiamo cercando di rimettere altri alberi, nei limiti concessi dalla legge romana, che chiede di usare piante autoctone (come se a Roma ce ne fossero: alloro? Oleandro?). Abbiamo scelto le piante perenni, che offrono colori diversi a seconda della stagione». Chiediamo alla principessa se lei è presente durante le cerimonie. «Dico sempre a tutti che non sono compresa nel prezzo. Ma io vivo lì. E devo dire che negli ultimi anni mi capita spesso di affezionarmi alle persone. Vedo dei ragazzi che
potrebbero essere i miei figli, seguo queste famiglie per un anno, durante la preparazione del matrimonio, spesso condivido le loro gioie e i dolori. Rimaniamo legati. A volte mi avvisano quando nasce un bambino, vengono per il battesimo... A ottobre ospiteremo il matrimonio del padre di una ragazza che ha celebrato qui i 18 anni: si risposa». Il lato umano di questo lavoro. Dentro una villa che ha «tante sfaccettature interessanti e quindi l'opportunità di dare a ognuno una cosa diversa». Per le informazioni di base c'è il sito: www.villagiovanelli.it. Per il resto c'è Ginevra Giovanelli, che vi accoglierà volentieri (su appuntamento). Sarà l'occasione per conoscere da vicino la storia e la magia di villa Giovanelli Fogaccia.
69 AGOSTO 2023
CASE? PER VENDERE BISOGNA CONOSCERE
C'era una volta il “venditore di case”. Oggi invece c'è un esperto in economia e diritto, che sa tutto di risparmio energetico e legislazione sulla casa, conosce le dinamiche dei mutui e i bonus per le ristrutturazioni, si muove con agilità nei meandri della burocrazia (che fa impazzire noi comuni mortali) e grazie a questo bagaglio, vende case.
L'agente immobiliare non è più quello di una volta (anche se ce ne sono ancora), un abile piazzista, spesso improvvisato, che andava a caccia di immobili in vendita in quantità, seguendo il vento del mercato e sperando nella fortuna.
Lo sa bene Alberto Fornasari, che questo lavoro lo fa dal 2001, in un'agenzia nata con lui, che ha chiamato La Maison e che ha generato svariate imitazioni (la sede è a Merate: www.lamaisonmerate. com). Se un'agenzia indipendente ha una storia lunga 22 anni, un motivo ci deve essere.

Qui ce ne sono almeno tre. Il primo è legato alla competenza, visto che Fornasari è laureato in Economia e Commercio e dopo aver fatto il corso di agente immobiliare non ha mai smesso di
aggiornarsi e circondarsi di esperti. Il secondo è la scelta di mantenere una struttura snella e professionale: qui non troverete la mediazione di ragazzini inesperti a caccia di “gettoni” legati alle acquisizioni, chi compra e chi vende avrà sempre a che fare con il titolare dell'agenzia, dalla prima all'ultima fase. Il terzo si chiama Brianza, un territorio particolarmente appetibile, soprattutto per chi arriva dalla città, e con immobili di qualità, soprattutto ville con giardino immerse nel verde.
«Dopo essermi laureato in Economia e Commercio ho cominciato ad appassionarmi al settore immobiliare – racconta Alberto Fornasari. - Ho iniziato a lavorare negli anni migliori, tra il 2001 e il 2006, quando il mercato tirava parecchio. Siamo partiti subito bene». Il nome nasceva da un viaggio in Costa Azzurra. «Ai tempi c'era ancora mio suocero, ottimo venditore. Visto che tutte le altre agenzie avevano la “casa” dentro il nome, noi abbiamo scelto La Maison (casa in francese, ndr). Suonava anche bene. A quei tempi eravamo gli unici, abbiamo registrato il marchio, poi ci sono stati vari tentativi di copiatura»
Come ci si prepara a un mestiere del genere? «Visti i miei studi universitari, tutta la parte legata al diritto e alla legislazione già la conoscevo. Dopo il corso da agente immobiliare, ho fatto anche tanti altri corsi di formazione.
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA 70 AGOSTO 2023
"La Maison": storia esemplare (lunga 22 anni) di un'agenzia che offre servizi e risolve problemi
Io sono iscritto alla Fiaip (la Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali), che organizza corsi di aggiornamento sul fisco, sui contratti, su tutta la parte tecnica, i vari obblighi, le responsabilità. Sono molto utili, perché in vent'anni la normativa si è evoluta, è cambiata, anche nella parte urbanistica. Il nostro sta diventando sempre più anche un lavoro di consulenza, non solo di vendita». Questa è la parte meno conosciuta, me sempre più importante, del lavoro di un'agenzia immobiliare. «C'è gente che

viene per vendere, ma poi si scopre che bisogna fare una sanatoria e noi abbiamo l'architetto in studio che risolve questi problemi. Siamo strutturati per offrire un servizio a 360°. Una volta c'erano meno obblighi e ci si arrangiava. Ora capita spesso che un privato, dopo aver cercato di vendere la casa da solo per qualche mese, viene e

la affida a noi, perché è stanco di affrontare tutte le “rogne” legate alla vendita».
È una questione di tutela, da un punto di vista legislativo e burocratico, oltre che di efficacia.
«Il cliente che viene in agenzia sa che offriamo un certo tipo di servizio. Se arriva un giovane che ha paura di non avere il mutuo, noi prima di fare qualsiasi cosa, coinvolgiamo un consulente che fa la sua analisi, per capire se potrà avere 50, 90 o 150 mila euro, poi andiamo a cercare una casa che stia dentro quei parametri. Così non si perde tempo a girare dieci banche diverse e a fare cinquanta appuntamenti».
71 AGOSTO 2023
Alberto Fornasari si è laureato in Economia e Commercio e poi si è dedicato al settore immobiliare in Brianza
Ovviamente, in un lavoro del genere, ci vuole anche capacità di ascolto ed empatia. «Assolutamente. Bisogna essere predisposti al contatto con le persone. Ma questo non basta più. Mentre prima una qualsiasi persona brillante, capace, poteva fare questo lavoro senza problemi, adesso ci vuole anche una grande preparazione. Tante volte ci capita di incontrare persone che dicono di essere state “in quell'agenzia là” in cui non sapevano dare
le informazioni base. Purtroppo c'è ancora gente che lavora senza patentino, con collaborazioni estemporanee. Ma le agenzie serie si riconosco, perché dopo vent'anni sono ancora lì».
Il riferimento è chiaro, così come le parole di Alberto Fornasari, pacate e competenti. «Da noi non esiste la figura (brutta) dell'agente immobiliare che apre la porta, per far visitare una casa in vendita, e si prende la provvigione. Io faccio

sempre il paragone con il commercialista o con l'avvocato, che viene pagato anche se perde la causa. Al contrario, se noi non vendiamo, non veniamo pagati, quindi a maggior ragione il servizio deve essere di qualità. Poi, per carità, capita anche di non vendere, anche se è una cosa rara, in caso ci siano problematiche enormi. Ma normalmente quando prendiamo un incarico lo portiamo a termine. Non abbiamo mai lasciato nessuno per strada. Facciamo tutto il possibile e anche di più. Per questo ci tocca essere un po' psicologi, un po' architetti, un po' fiscalisti, un po' di tutto».
I clienti arrivano soprattutto dal passaparola. «Quando i clienti si sentono trattati bene, poi mandano l'amico, il parente, il collega. L'altro canale è la consulenza che noi facciamo. Il cliente magari mi chiama perché ha un problema con un'eredità difficoltosa o perché deve fare una sanatoria e poi, dopo che l'abbiamo seguito in tutto e per tutto, ci affida anche l'immobile da vendere. Io sono anche consulente per tutta la provincia di Lecco di UniCredit Subito Casa, agenzia immobiliare del gruppo UniCredit. La nostra è una piccola agenzia a gestione familiare, ma siamo bravi. E portiamo sempre avanti un rapporto personale con venditori e compratori. Non c'è il ragazzino che viene ad acquisire l'immobile, perché prende 100 euro di provvigione dalla casa madre e si accontenta di quello. Sono io, personalmente, che vado, faccio la perizia (le faccio anche per le banche, quindi sono obiettive), e poi sono sempre io che seguo la vendita, il compromesso, il rogito.

72 AGOSTO 2023
I tassi crescono, ma c'è un mercato che non soffre, quello delle ville con giardino e degli immobili di qualità
Ci sono anche il giorno della firma dal notaio. Il cliente conosce me il primo giorno e mi saluta quando ritira le chiavi. Poi in ufficio ci sono i collaboratori, ma sono sempre io il referente che segue tutto l'iter». Cosa cerca un cliente che compra in Brianza? «Il pezzo forte da noi sono le case con giardino, ville e appartamenti in villa. Parliamo del classico cliente che arriva dalla grande città ed è stufo di vivere nel traffico, che cerca tranquillità. Ci sono anche le palazzine, ma qui è difficile trovare il palazzone da cento appartamenti. È un territorio adatto a chi vuole una vita nel verde, in un luogo però ben collegato a Milano, grazie alla ferrovia. Siamo a mezz'ora dalla città. Poi trattiamo anche case in affitto, edifici commerciali, capannoni. E se c'è bisogno, ci spostiamo. Ho venduto l'anno scorso una villa a Menaggio, ho venduto in Valsassina e a Barzio, per clienti affezionati».
Come va il mercato immobiliare in questo periodo? «Non ci possiamo lamentare. Arriviamo da un 2021 e 2022 molto forti, dopo la pandemia. Adesso c'è stato un pic-


colo rallentamento dovuto ai tassi alti, però se si vendono immobili di un certo livello - e noi stiamo man mano spostandoci verso questo tipo di mercato, dai 350 mila euro in su - lo si sente molto meno. La nostra zona è fatta di ville, villette, qui il mercato non si ferma mai. E non c'è abbondanza di immobili, motivo per cui i prezzi restano abbastanza alti e c'è poca disponibilità di case facilmente commerciabili. Non abbiamo i prezzi di Monza
o Milano, ma siamo comunque in fascia medio-alta».
I tassi incidono, ma incide anche la qualità del lavoro di un'agenzia e il tipo di clientela con cui si lavora. «Oggi il mutuo al 90% o al 100% è difficile da ottenere. Il mercato dei ragazzi più giovani si sta spostando sull'affitto, aspettando che i tassi scendano, perché non dureranno all'infinito. Anche se poi va detto che sono alti rispetto a quelli che c'erano uno o due anni fa. Dieci anni fa avevamo il tasso fisso al 6% e si vendeva lo stesso. Magari si vende solo a persone che hanno un'alta liquidità. Di sicuro ora si vendono meglio gli immobili nuovi, efficienti dal punto di vista del risparmio energetico, non quelli da ristrutturare. Non siamo al 10% sopra l'anno scorso, e l'anno scorso eravamo al 16% sopra l'anno prima. Certo, non sono risultati che piovono dal cielo, bisogna correre. Il mercato ha le sue dinamiche, ma se seguiamo bene i nostri clienti, problemi non ce ne sono».
73 AGOSTO 2023
Terra «solitaria, senza Dio, desolata, mortale, spoglia, priva d’acqua, senza sentieri, impraticabile, infestata, maledetta, dimenticata e tuttavia, allo stesso tempo, luogo di rivelazione, di contemplazione, e santuario. In mezzo a tanti orrori, la pace; una pace esaltata da quegli orrori». Il deserto. Anzi, i deserti. Di sabbia rosa, gialla, pallida, di “ciottoli simili a uovza annerite”, solidi o granulari, scabri o lisci, grigi e pietrosi, oppure fatti di soffici dune, da cavalcare come fossero onde in mare aperto.
William Atkins attraversa sette deserti, che in realtà sono pieni di storie e di esseri umani. Monaci, indigeni, migranti, dissidenti esiliati. Il silenzio, sì, la vastità sconfinata che ci attrae, il “luogo metafisico per eccellenza”. Ma Atkins non si accontenta dei luoghi comuni. Studia i percorsi dei pionieri, che rischiavano la vita per attraversare quelle terre, e si inoltra in aree inospitali che si riempiono di incontri (spesso surreali) e riflessioni. Un diario, una guida, un romanzo, un saggio di scienze, storia, biologia, politica, sociologia, storia delle religioni, antropologia. Che guarda con orrore a questo nostro mondo fatto di «avventurieri, nuova specie di fanatici: ragazzi slanciati dal sorriso abbagliante che non cercano conoscenza e nemmeno nuove terre ma soltanto la novità, la sofferenza organizzata, l’"esperienza"»
Un mondo senza confini (Adelphi) è un libro bellissimo. Che parte da un'attrazione irresistibile e improvvisa, approdata nell'Oman, il “Quarto Vuoto”, tra beduini e viaggiatori in fuga da qualcosa. In Australia, nel deserto Victoria, incontriamo gli Anangu e il loro culto degli Antenati e della terra, «che è il nesso tra il fisico e lo spirituale, fra il temporale e l’eterno», la cui difesa è un dovere morale perché siamo natura anche noi, non c'è separazione. La terza tappa è in Cina, tra il Gobi e il Taklamakan, tra grotte sacre buddhiste e ricordi di “criminali” deportati a migliaia laggiù. C'è l'Aralkum in Kazakistan, ma anche il deserto di Sonora negli States, la rotta dei migranti al confine tra Messico e Stati Uniti (Atkins aiuta gli attivisti). Nel Black Rock vive insieme ai “burners", accampati per celebrare il “Burning Man” (i principi? «Inclusione radicale, Demercificazione, Autonomia radicale, Espressione di sé radicale, Sforzo comune, Senso civico, Donare, Non lasciare tracce, Spontaneità, Partecipazione») mentre in Egitto vive nella cella di un monastero. Hippie e padri del deserto, emarginati e illuminati, pazzi e sopravvissuti, tutti attratti dal deserto, spietato, meraviglioso, immenso.
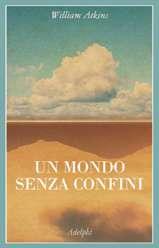
«Oltre che a un caprone, ammetteva di somigliare, da vecchio, all’altra presenza costante nella sua vita, il Don Chisciotte di Cervantes, che chiama il suo «daimon». È da Don Chisciotte che ha imparato quella che chiama «erraticità», un principio-guida della sua vita – «andare oltre i modi stabiliti da una società, vivere secondo le proprie direttive interiori». Quando Corbett non era ancora trentenne, il suo matrimonio di cinque anni finì e la moglie ottenne la custodia dei figli. Lui si ritirò da solo sulle pendici del monte Black Bear, al confine tra Messico e Arizona. «La prima lezione è quella da cui partono tutti: è la disperazione che rende possibile il cambiamento» (...) Aveva anche pensato di diventare un insegnante di filosofia, «ma la cosa principale che ho imparato dallo studio della filosofia è che non ho nulla da insegnare». Fu allora che ebbe un’epifania; era certo che il suo cuore si fosse fermato.
«Dall’immobilità che scambiai per la mia morte, l’amore mi fece rinascere – o fu qualcosa di simile all’amore, ma che a differenza dell’amore non si divide in amare e essere amato». Non era la morte, ma qualcosa di più significativo. Diede via tutto ciò di cui non aveva bisogno, e si mise in viaggio (...) Quando, alla fine, entrò in conflitto con lo Stato fu perché vide che era lo Stato stesso a contravvenire alle leggi o a non farle rispettare; in altre parole, a non mantenere le sue promesse.
E fra quelle promesse, imposte non solo dalle leggi internazionali ma anche da quelle federali degli Stati Uniti, c’era l’obbligo di dare asilo ai rifugiati»
(William Atkins)
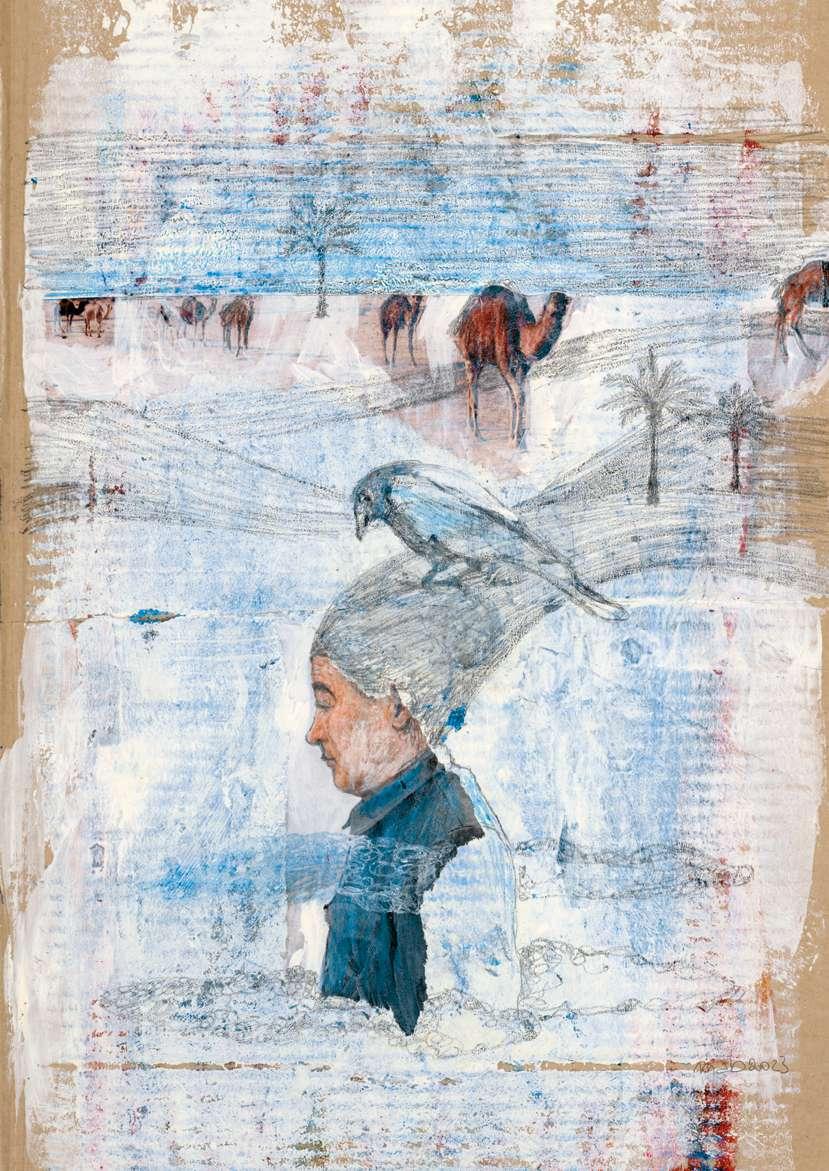







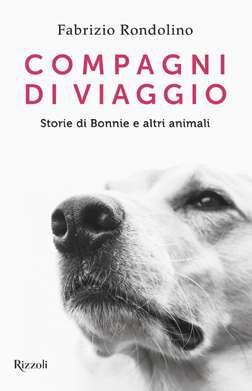









 (foto Thomas Darlis)
(foto Thomas Darlis)













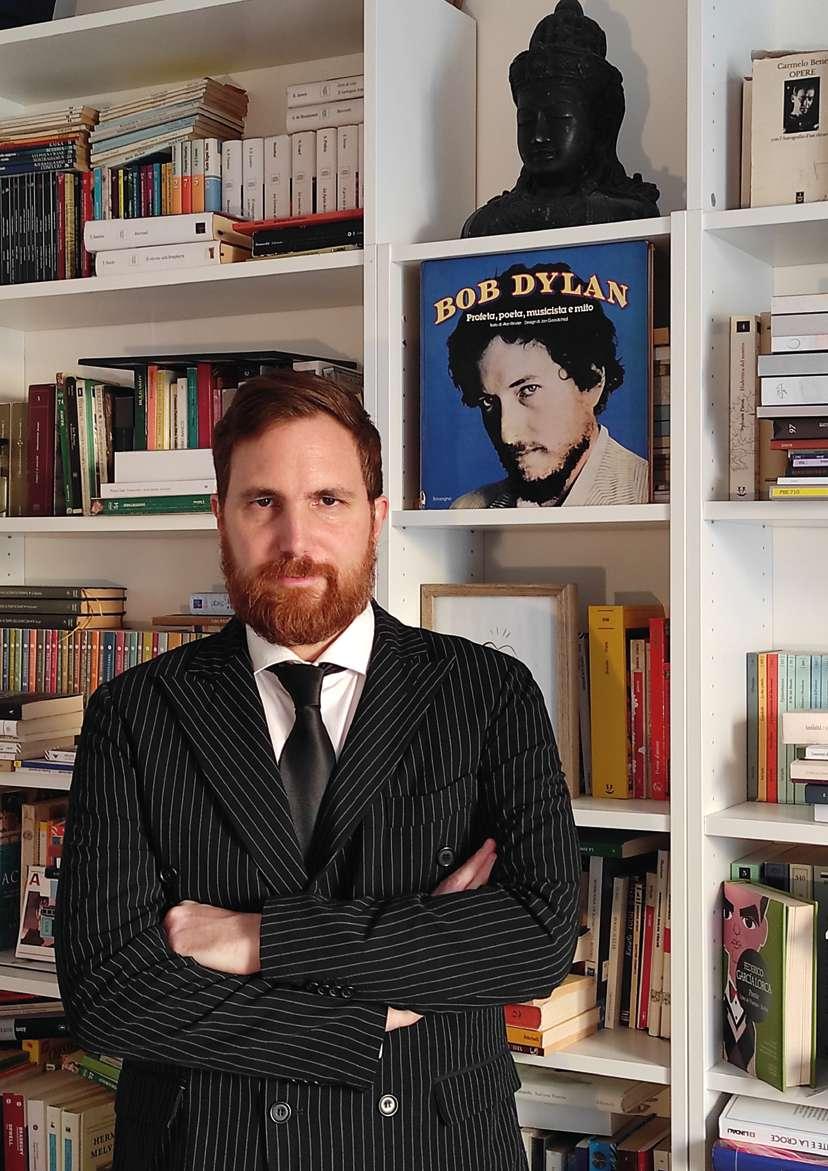




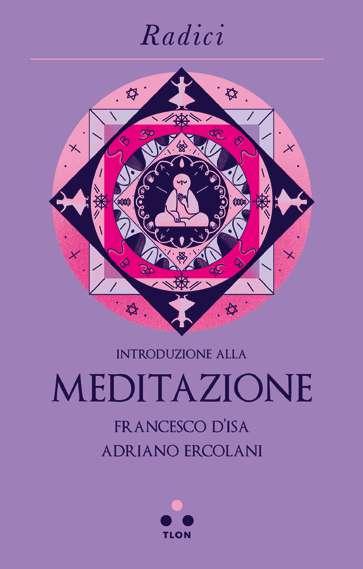






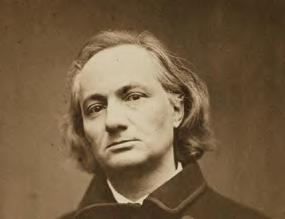


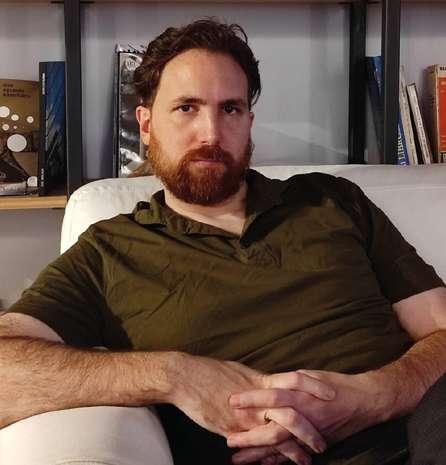

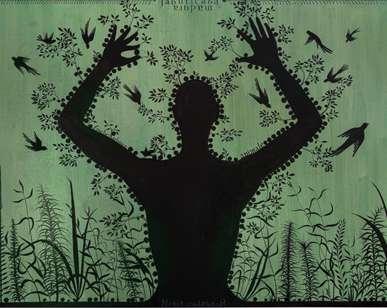




 (foto Andrea Rossetti)
(foto Andrea Rossetti)
(foto Redness)
(foto Andrea Rossetti)
(foto Andrea Rossetti)
(foto Redness)

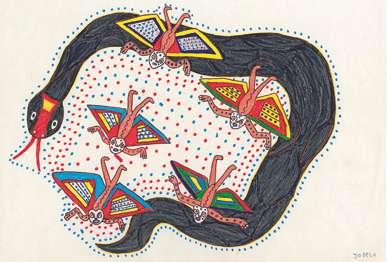
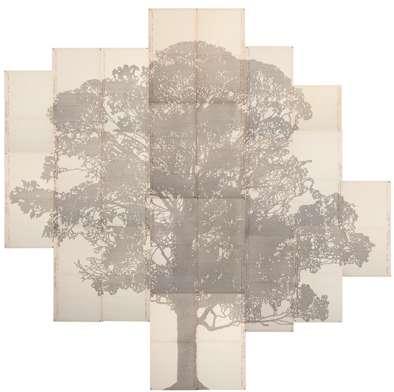
 Sheroanawe Hakihiiwe & Fabrice Hyber, Untitled, 2023, acrilico e carboncino su tela, Collezione di Fabrice Hyber e Sheroanawe Hakihiiwe (© Fabrice Hyber & Sheroanawe Hakihiiwe, © Charles-Henri Paysan / Lumento) In basso, Johanna Calle, Sangregado, 2014, testo dattiloscritto su vecchia carta notarile, Collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (© Johanna Calle, © Archivos Pérez & Calle)
Sheroanawe Hakihiiwe & Fabrice Hyber, Untitled, 2023, acrilico e carboncino su tela, Collezione di Fabrice Hyber e Sheroanawe Hakihiiwe (© Fabrice Hyber & Sheroanawe Hakihiiwe, © Charles-Henri Paysan / Lumento) In basso, Johanna Calle, Sangregado, 2014, testo dattiloscritto su vecchia carta notarile, Collezione Fondation Cartier pour l’art contemporain (© Johanna Calle, © Archivos Pérez & Calle)
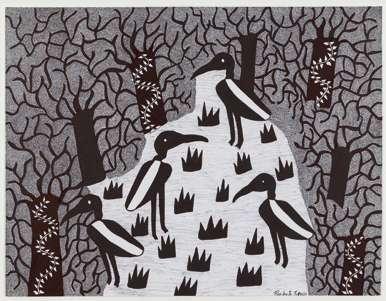

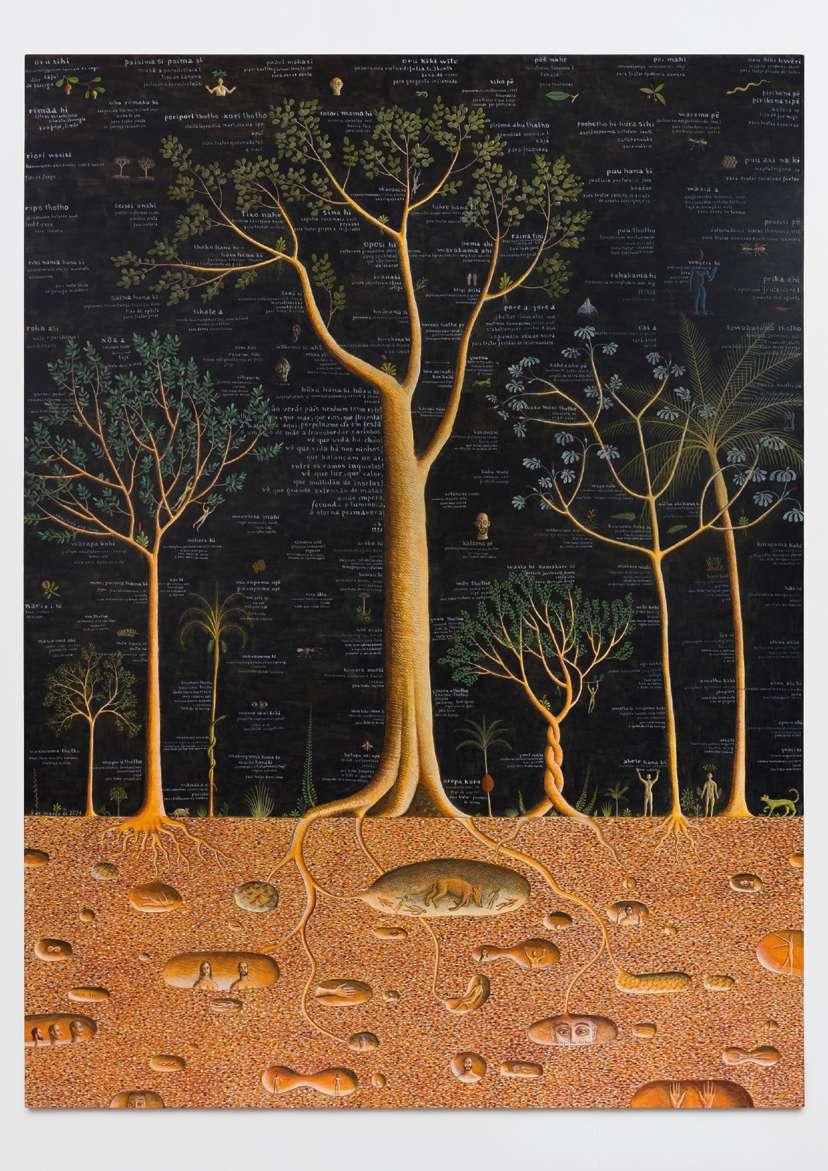


 (foto Emanuele Piccardo)
(foto Olivia Travers)
(foto Emanuele Piccardo)
(foto Olivia Travers)