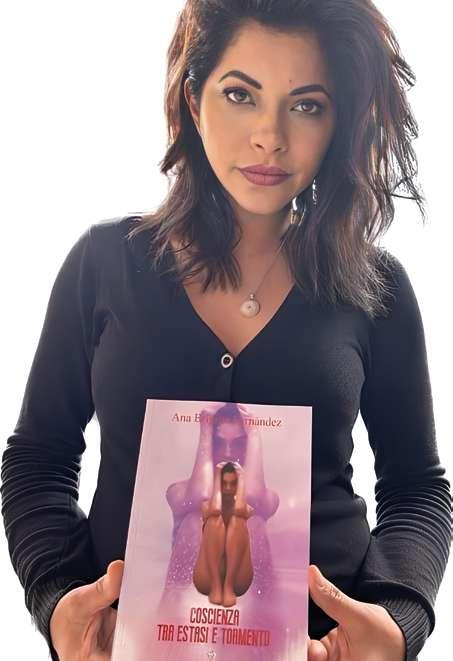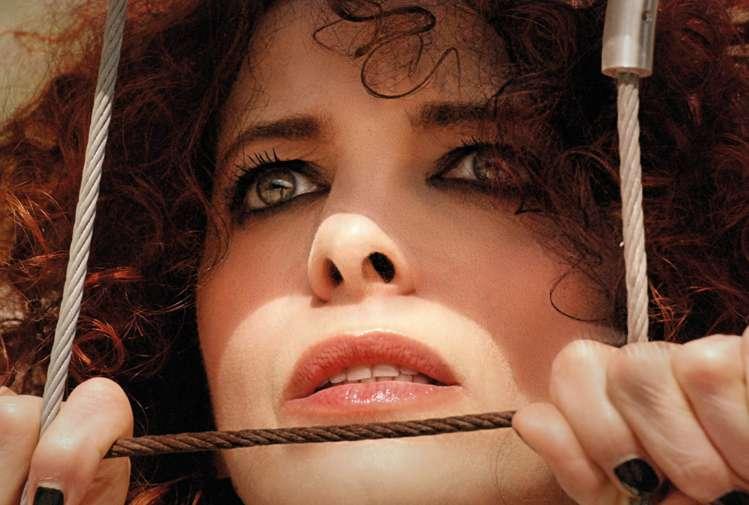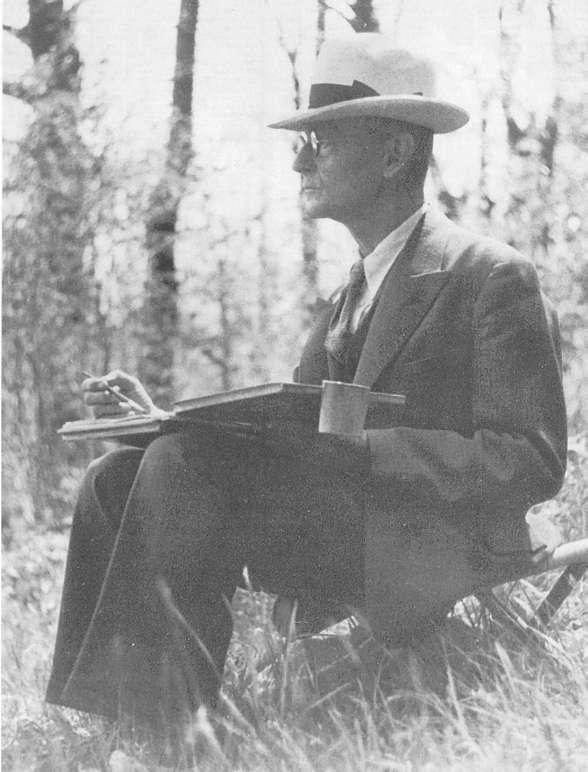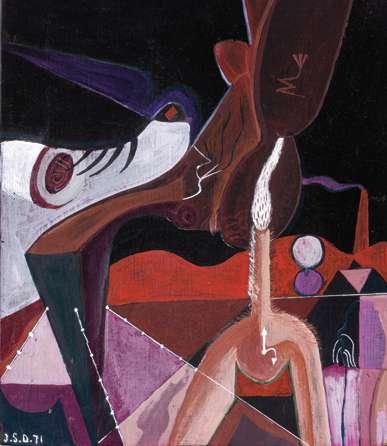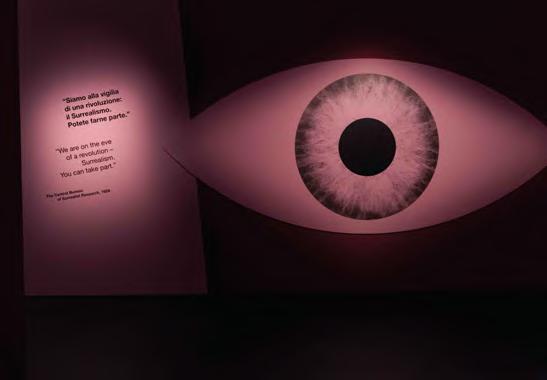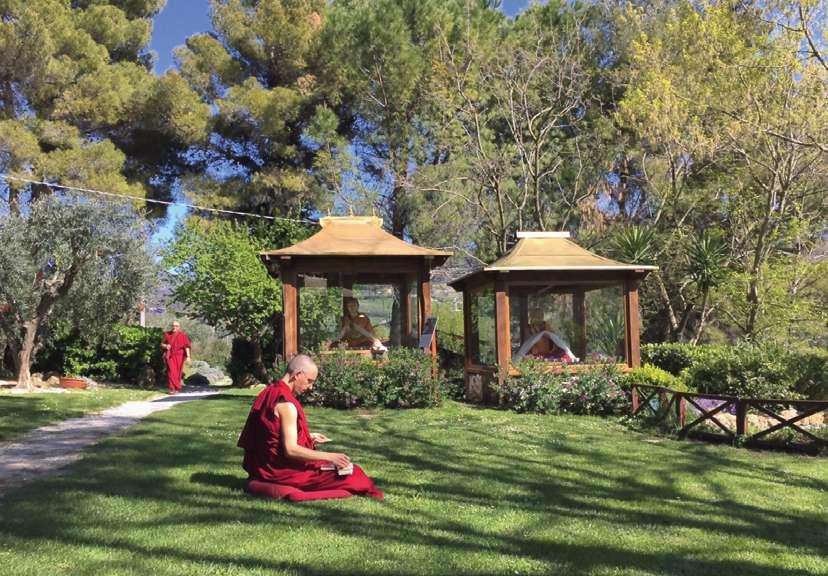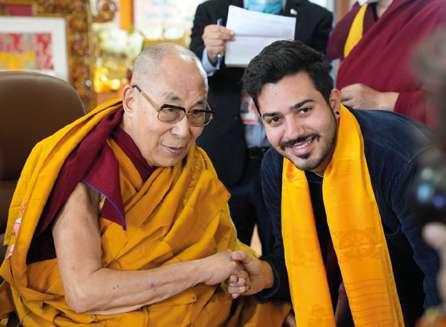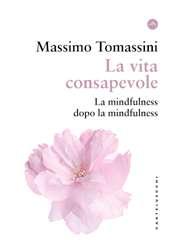Dove si parla del mestiere dell’attrice, di poesia che guarda all’infinito, di canzone d’autore dalla parte degli “ultimi”, della vita e le opere di Hermann Hesse, di visioni surrealiste che aprono la mente, di karma e meditazione buddhista N 11 | LUGLIO 2023

Sonia Bergamasco
Ana Brígitte Fernández
Hermann Hesse
Pomaia
Rossella Seno
Il surrealismo
Valerio Tallarico
REDness
È il "rossore" provocato dalle emozioni forti.
Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.
La redness
è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina.
È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi.
Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità...
Va bene tutto, purché sia fatto con redness.
In copertina: La statua del Buddha
all'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia
Foto: Manuela Ferro (servizio a pag. 58)
Direttore: Fabrizio Tassi
Progetto grafico: Marta Carraro
Redazione: MondoRed
Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano
Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore
4 EDITORIALE
4 L'In-Nessun-Luogo
6 INCONTRI
6 Sonia Bergamasco: l'attrice? Un "corpo per tutti"
18 Ana Brígitte Fernández: estasi e tormento, tra recitazione e poesia
32 Rossella Seno: canzoni (d'autore) per chi non ha voce
S44 MEDITAZIONI
44 Hermann Hesse e l'arte di diventare umani
50 EVENTI
50 Il surrealismo? Uno stile di vita
58 LUOGHI
58 A Pomaia, per ritrovare la pace, sulle tracce del Buddha
68
IDEE
68 Torna "Il silenzio fra due onde" di Corrado Pensa
70
STORIE D’IMPRESA
70 Lazzarin: il pavimento in legno che fa bene al bosco
74 Alessandro Zanirato: l'arte dell'empatia
78
COMMIATO
78 Massimo Tomassini: “La vita consapevole”
3 LUGLIO 2023 2 MESE 2022
è passione, arte, impresa, comunicazione.
OMMARIO
L'In-Nessun-Luogo
L'Oriente per Hermann Hesse non era solo un luogo geografico. Era un modo di essere, un ideale, era la “patria dell'anima” e la sua giovinezza, «il Dappertutto e l'In-Nessun-Luogo» Nel suo (e nostro) Occidente vedeva un'umanità schiava della tecnica, resa arida dall'intellettualismo e dal nichilismo, priva di qualsiasi slancio e vitalità, che la società di massa avrebbe trasformato in un'insieme informe di individui omologati e conformisti. La sua non era un'analisi politica, non faceva della sociologia. Era l'intuizione di un artista, di un cercatore visionario e se vogliamo anche naÏf (non è sempre un difetto). L'Oriente era l'orizzonte del possibile (davanti a noi, ma radicato nel passato), il richiamo di una comunità e di una visione spirituale della vita (l'essere prima dell'avere). Era un modo di percepire la realtà come un tutto in cui siamo legati gli uni agli altri (e con la natura), ognuno alla ricerca di una misteriosa patria perduta.
È a quell'Oriente che guarda Redness questo mese. Lo fa in modo esplicito, quando va a Pomaia per raccontare un pezzo di Tibet in Toscana, un luogo fuori dal tempo, in cui è possibile sperimentare le virtù salvifiche del silenzio, del vuoto, della meditazione. Quando parla di mindfulness - che deve finalmente approdare alla maggiore età, se non vuole rimanere una moda alla mercé di qualsiasi banalizzazione commerciale – e raccoglie i pensieri illuminanti di un maestro come Corrado Pensa, a proposito dell'Oriente interiore, la possibilità reale di liberarsi dalla prigione dell'ego, con i suoi capricci e il suo carico di sofferenza inutile.
È Oriente anche il surrealismo (in mostra al Mudec di Milano), che pure guardava alle culture indigene d'Occidente per ritrovare un po' di magia e di immaginazione, di sovrannaturale. Un tuffo nell'inconscio, per andare oltre i limiti e le convenzioni del razionalismo, dell'ipocrisia borghese.

Ma c'è un po' di quell'Oriente anche nei nostri incontri di apertura. Tre donne e tre artiste che vivono di slanci e poesia, di scelte coraggiose, passioni estreme, vita vissuta fino in fondo, senza un attimo di respiro. Tre donne che, oltretutto, non si accontentano di avere solo un talento, perché il bisogno di esprimersi e di comunicare è tale che passa attraverso varie strade, parole e musica, cinema e teatro, canzoni e composizioni liriche. Incontriamo Sonia Bergamasco, che da ragazza si è diplomata in pianoforte e quella musica l'ha poi portata sul palcoscenico, lavorando con i più grandi (da Giorgio Strehler a Carmelo Bene), l'ha incarnata al cinema, l'ha trasformata anche in versi poetici. Dall'avanguardia alla commedia popolare, senza snobismi. Con un'intelligenza e un'energia che non lasciano mai indifferenti. Ma anche con grande consapevolezza, come dimostrano le sue riflessioni sul mestiere dell'attrice (Un corpo per tutti).
Anche Ana Brígitte Fernández si esprime in poesia, lo fa da quando era piccolissima e viveva in Colombia. Lo fa per mettere ordine nella sua anima in tumulto, nelle intuizioni “cosmiche” (ha sempre amato le stelle), nella vita avventurosa. O meglio, lo fa per dare un corpo a emozioni e pensieri, anche quelli più caotici e misteriosi, basta che siano vivi e veri. Anche lei attrice. Con
un percorso pieno di “estasi e tormento” (come dice il titolo della sua prima raccolta poetica).
E poi c'è Rossella Seno, che abbiamo visto in teatro e in tv (nazionalpopolare, anche qui), ma che ormai conosciamo soprattutto per il coraggio e la determinazione con cui ha fatto rinascere la canzone d'autore che fu, quella che dava la parola agli ultimi, che aveva il coraggio di affrontare i grandi temi, che denunciava e smuoveva le coscienze. Sfruttamento, povertà, immigrazione, eutanasia, diritti degli animali, difesa dell'ambiente. Temi cantati con la grinta di una “figlia di Dio” che non ha nessuna intenzione di starsene in silenzio a subire il male.
Tornando a citare Hermann Hesse, a cui dedichiamo varie pagine, piene di foto d'epoca e d'Oriente: «Anch'essa, la mia anima, soffre sorridendo di tutte le crudeltà e violenze del pensiero avido di potere (…) Oh, quest'anima, questo bel mare oscuro, natio, pericoloso! Mentre io instancabilmente studio, accarezzo, interrogo e assedio la sua superficie dai colori cangianti, essa, come per scherzo, continua a gettare ai miei piedi, da profondità senza fondo, un enigma dagli strani colori, conchiglie che parlano di spazi smisurati e ignoti, come il frammento di un antichissimo gioiello evoca isolate, incerte memorie di un lontano tempo sepolto». Un tempo da ritrovare. (f.t.)
5 LUGLIO 2023 4 LUGLIO 2023
E DITORIALE
Sonia Bergamasco
L'attrice? Un "corpo per tutti", effimero, politico, spregiudicato. Un mistero fragile. Che ti insegna a stare nell'attimo, totalmente

I NCONTRI
di Fabrizio Tassi
(foto Gianmarco Chieregato)
«Il grande specchio appoggiato alla parete dietro la porta della camera dei grandi. Passi di danza – le scarpette rosa – fronteggio un corpo piccolo inguainato di nero. Lo sguardo nello sguardo e il tempo fra le nuvole, calcolo distanze tra vertebre e fantasmi. Strade, tombe, stelle, cattedrali – parole bellissime e l’inferno può aspettare»
Comincia in poesia, Un corpo per tutti di Sonia Bergamasco. Con il ricordo di quel grande specchio, incorniciato dal legno scuro, che stava nella camera da letto dei suoi genitori. «Quando ero bambina passavo molto tempo da sola davanti a uno spec-
Il mestiere dell'attrice non era nei miei piani di bambina. Quando poi ho cominciato, è partita da subito una lotta con me stessa per ritrovare quell'energia libera e spregiudicata dell'infanzia, che era già dentro di me (è in tutti noi, se non ci hanno fatto troppo del male)
chio. Mi cercavo, occhi negli occhi di quel piccolo corpo sconosciuto e familiare (…) Una specie di ipnosi. Era comunque un’altra, quella lí: sconosciuta. Dovevo ammaestrarla. Quella pratica dello sguardo è proseguita negli anni, con una determinazione sempre più affilata. Da una parte c’era lei, quella creatura bionda che cominciavo a conoscere, e dall’altra c’era il desiderio di scolpire, di sfidare l’immagine per avvicinarla a quella del mio desiderio. Quella “riflessione” era una lotta, una sfida»
Se Il quaderno (pubblicato nel 2022 per La Nave di Teseo) era un diario in poesia, Un corpo per tutti (libro pubblicato quest'anno per Einaudi) è una sorta di parafrasi, un diario in prosa, pieno di ricordi e riflessioni. Una “biografia del mestiere di attrice” in cui in realtà si può ritrovare chiunque abbia una vocazione creativa, un consapevole bisogno di esprimersi e conoscersi attraverso il gesto, il suono, la parola, dentro la carne e le sue emozioni, l'anima e le viscere. Scriveva, in poesia: «Il corpo effimero, il fiore. Bellezza che spunta da un altrove, cresce e si prepara a godere del sole. / Corpo che cerca, corpo malato. Ferito, pervertito, desiderante. / Per l’effimero di un fiore una foresta di segni, di sguardi, di torti di sogni e premure. Per un fiore che muore e che sa di morire tutta questa cerimonia. Perché? / (un fiore che per giunta, scopriamo, non è il solo ma rosa fra le rose di un immenso giardino)»
Sonia Bergamasco è la Fatina in maschera, in forma di bambola meccanica, scelta da Carmelo Bene per il suo Pinocchio, sottoposta alla “tortura” di parole e gesti millimetrici ripetuti, per trasformarsi in Volpe, Gatto, Mangiafuoco, in dialogo col burattino incatenato, dando forma a uno spettacolo inquietante, poetico, irriverente, che lei contribuì a rendere indimenticabile. Ma è anche la dottoressa Sironi, spietata dirigente statale, messa a dura prova da Checco Zalone, ossessionato dal posto fisso, in un inedito tandem comico, che ci ha regalato alcuni dei dialoghi più spassosi della commedia popolare recente (Quo vado).
È Sofia, l'attrice raccontata da Giuseppe Bertolucci, prigioniera della sua arte, il talento nel recitare la vita, l'attitudine alla menzogna (L'amore probabilmente).
Ed è Giulia Monfalco, che abbandona la musica e la famiglia per dedicarsi alla lotta armata, personaggio duro, durissimo, emblema di una passione ideale che si trasforma in ossessione e autodistruzione (La meglio gioventù).
Sonia Bergamasco passa con disinvoltura dal teatro di ricerca alla tv. Ha recitato per Giorgio Strehler, Glauco Mauri e Massimo Castri, per Jan Fabre e Antonio Latella, ma è stata anche l'antipatica (e buffa) Lea De Angelis in Tutti pazzi per amore - Riccardo Milani fu il primo a vedere il suo lato comico, lei fece resistenza ma capitolò di fronte a un cabaret di pasticcini - per poi diventate Livia nel Commissario Montalbano. L'abbiamo vista al cinema diretta da Marco Tullio Giordana e Bernardo Bertolucci, da Battiato, Piccioni e Roberta Torre, ma si è anche cimentata nella scrittura e nella regia, attrice-autrice sempre intelligente e intrigante, in solitaria o in coppia col marito Fabrizio Gifuni: le “prove aperte di infelicità” nel nome di Anna Karénina e Il Piccolo Principe in concerto, Dante (Le sante corde dei canti) e i Mémoires di Balzac, Il ballo di Némirovsky e l'amicizia in versi tra Bertolucci e Pasolini. Tutto è cominciato dalla musica e dallo studio del pianoforte in Conservatorio. O meglio, dalla scelta di fare altro nella vita. Quasi ci sembra di vederla (e di ascoltarla), davanti a Giorgio Strehler, nel suo provino al Piccolo Teatro (una svolta improvvisa, «un giro su

se stessa»), mentre canta letteralmente Guido Cavalcanti, Christa Wolf e Samuel Beckett, come se i loro testi fossero partiture vocali (non è difficile immaginare cosa vide Strehler in quella giovane donna, la sua personalità, la presenza scenica). C'è pure questo, nel suo libro, insieme a tanto altro. Anche cose molto personali. Tipo il pensiero che ogni scena potrebbe essere l'ultima, e allora bisogna metterci l'anima, perché «la storia che racconto, la donna, la creatura che incarno hanno diritto di vita, in assoluto; vivono in un tempo irripetibile, respirano con me, nell’istante. E devo rendere loro ragione e respiro, glielo devo – lo devo a me stessa, e a chi mi vedrà: è un gioco vitale».
Un diario-racconto pieno di cose e di idee, in cui incontriamo Carmelo Bene, Peter Brook e il ricordo di un'estate sui trampoli, per le strade della Spagna, vestita come una «gallinella con fiocco rosso e campanellino, agganciati al fondoschiena». In cui si parla di Narciso e del Simposio di Platone, di Eros e del desiderio universale di essere riconosciuti e apprezzati, che in questo presente digitale diventa una «foresta di segni» dentro cui ognuno si crea una propria immagine, un'identità.

8 LUGLIO 2023
9 LUGLIO 2023
Sonia Bergamasco
("Chi ha paura di Virginia Woolf?" foto Brunella Giolivo)
In cui troviamo Montaigne e Molière (balbuziente), riflessioni estetiche e politiche, la ricerca della propria voce e il brivido del “vuoto di memoria”, la distinzione tra attori immersivi e assertivi («Meryl Streep e Valeria Bruni Tedeschi; Daniel Day-Lewis e Roberto Benigni»), l'ironia sul rigido assurdo galateo richiesto al pubblico teatrale (abbasso il “silenzio religioso” dei nostri tempi borghesi, viva il vibrante teatro elisabettiano).
C'è anche il ricordo di una sua invenzione, ai tempi in cui studiava con Marise Flach, una performance in forma di marionetta abbandonata in cui inciampa un uomo, «che in una notte di solitudine alcolica la solleva, la abbraccia e la conduce sulle note di un tango sempre più sfrenato» Un corpo a disposizione, appunto. Del pubblico e dei personaggi che prendono vita sul palco e sullo schermo. Inseguendo, perché no, la «presenza emotivamente conturbante» dell'amata Eleonora Duse, «capace di trasmettere un’energia indescrivibile». Un corpo attraverso cui riconoscersi in qualche modo, la “trama” di una vita, con le sue metamorfosi e i suoi tanti significati possibili.


Partiamo dalla bambina, “silenziosa e introversa”, che passava tanto tempo davanti allo specchio. Ce la racconti un po'? La tua famiglia, il luogo in cui vivevi, i sogni che facevi.
Diciamo che passavo un po’ di tempo davanti allo specchio. Il resto (del tempo) era, nei miei ricordi, di puro gioco, di corse per il quartiere (vivevamo alla periferia ovest di Milano), di ginocchia sbucciate e di emozioni accese dalle fantasie dell’età.
Un’infanzia giocata per strada, insomma. Mescolata agli altri. E però anche caratterizzata da una tendenza a filtrare le esperienze e le emozioni in una zona segreta, non accessibile agli altri. Ero fra quei bambini che da soli inventano storie, si intrattengono e proiettano immagini a proprio uso e consumo. Sono nata a Milano, dove ho vissuto a lungo. Mio padre è morto a 48 anni. Mia madre era ancora giovane, e si è trovata da sola con tre figli. Una situazione faticosa, non facile.
C'è qualcosa di quell'infanzia che è rimasta impressa in te per sempre? Una persona, un sentimento, un'intuizione che ti ha fatto prendere coscienza di essere viva, con uno scopo da trovare in qualche modo?
Da bambina ero troppo occupata a vivere, a stare nelle cose. Quando ho cominciato a studiare musica in Conservatorio – molto presto, a 10 anni – ho cominciata invece ad avvertire una fatica, una tensione contrastante. Il peso delle cose, degli studi e dei doveri, a cui mi sono in qualche modo sottomessa, l’ho vissuto sempre come un problema. Quirino Principe, mio professore al Liceo artistico musicale del Conservatorio Giuseppe Verdi, è stato il primo incontro con qualcuno che mi ha dato fiducia, che mi ha indicato una strada diversa, una via di fuga nella creatività e nella libertà espressiva legata all’arte e alla scrittura.
Nel libro parli del mestiere dell'attrice come qualcosa che “è successo”, che ti è capitato. Quindi non una vocazione irrinunciabile e neppure un'ossessione. In un certo senso, è una cosa che si vede (o meglio che non si vede) nel tuo modo di recitare: non c'è sforzo, artificio, i tuoi personaggi sembrano persone capitate in quella storia, sul palco, sullo schermo, e vivono davanti a noi. Non c'è la “performance d'attrice”, ma il frutto quasi spontaneo di un meticoloso lavoro di preparazione (quello forse sì a volte ossessivo).
Sì, il mestiere dell’attrice non era nei miei piani di bambina, non ci avevo mai pensato. Quando poi ho cominciato, è partita da subito una lotta con me stessa per ritrovare quell’energia spregiudicata e libera dell’infanzia, che era già dentro di me (è in tutto noi, se non ci hanno fatto troppo del male). Ma il mio percorso non l’ho mai sentito “facile”. Ho lavorato tanto su di me, ho anche sbagliato tanto, ma ho cercato in tutti i modi di avvicinarmi a quell’immagine dello specchio che da bambina mi interrogava. Tutto questo, inizialmente, non come un progetto consapevole, ma come una necessità, un processo, uno svelamento.
Credo di aver avuto sempre un carattere tenace, ma carico di contrasti e di fragilità. Da una parte un grande orgoglio (qualcosa che ha a che vedere con la dignità del-
la persona) e dall’altro il desiderio di essere riconosciuti e amati. Per raggiungere quella “facilità” di cui parli, c’è voluto tanto lavoro. Ma era quello che desideravo raggiungere, era il luogo dove volevo ritornare. Quel luogo radioso e insieme spaventoso che conosce il bambino.
Riguardo al Conservatorio, parli di anni difficili ma fondamentali. La tecnica, la ricerca della perfezione, possono irrigidire definitivamente chi ha già quella disposizione d'animo. E però la musica, la musicalità, il ritmo, l'intonazione emotiva, ti hanno rivelato una possibilità espressiva, anche un modo di porgere la parola, grazie al quale hai trovato la tua strada.
È stata mia madre, Francesca, a volere che tutti noi figli suonassimo uno strumento. I miei fratelli, negli anni, hanno poi abbandonato gli studi musicali, mentre io (pur con fatica) sono andata avanti. E dopo il diploma di pianoforte, quando mi ero detta che con la musica avevo chiuso, è cominciata una storia diversa.
11 LUGLIO 2023 10 LUGLIO 2023
Sonia Bergamasco
("Esse di Salomè" foto E. Macumelli)
(foto Jacopo Brogioni)
Il Funambolo di Genet mi ha fatto "vedere" quello che stavo cercando di fare. Me lo ha saputo dire. Ma sono tanti i libri della mia biblioteca del cuore e, come dice Montaigne, tutto viene dimenticato per poi essere assorbito ed entrare a far parte del tuo mondo
Attraverso il mestiere d’attrice mi sono riavvicinata da subito alla mia lingua “madre”, perché sentivo che non potevo farne a meno, che il mio corpo d’attrice era immerso in quell’elemento, che la musica, semplicemente, faceva parte di me. Oggi posso dire, con sicurezza, che la musica è il mio filo rosso. È inscritta nel mio patrimonio biologico. In realtà non l’ho mai abbandonata, anzi, lei non mi ha mai abbandonato.

Nel tuo racconto troviamo Artaud e Céline, Ovidio e Agostino, Montaigne, Beckett, Viktor Šklovskij... Sei sempre stata una lettrice vorace, fin da ragazza. C'è un libro in particolare che porti nel
cuore da sempre e che torni a rileggere ogni tanto? Una specie di stella polare che ti aiuta a mantenere la rotta?
In Un corpo per tutti parlo molto del Funambolo di Jean Genet. È quello un libro del cuore. Mi ha fatto “vedere” quello che stavo cercando, quello che cercavo di fare. Me lo ha saputo dire. Ma sono tanti i libri che compongono la mia biblioteca del cuore e, come dice Montaigne, tutto viene dimenticato per essere poi assorbito ed entrare a far parte del tuo mondo. Le tante letture non mi servono per offrire citazioni brillanti o per stupire gli altri. Sono un nutrimento invisibile. Non potrei immaginare una vita senza libri.
E i film che ti hanno iniziata al piacere del cinema?
Tarkovskij, sicuramente. Il suo Andrej Rublëv. A Milano seguivo le retrospettive dedicate a Tarkovskij, rivedendo i suoi film per giorni e giorni. E, in ordine sparso, Cassavetes, Wilder, Mankiewicz (Eva contro Eva) Hitchcock, Lubitsch (To be or not to be), Renoir (La regola del gioco) Truffaut, Olmi, Bellocchio, Scorsese, Jane Campion… Ma ho appena visto As bestas, di Rodrigo Sorogoyen: la potenza espressiva di quel film mi brilla ancora negli occhi. Amo lo sguardo di Valeria Bruni Tedeschi, anche quello di Alice Rohrwacher. E ho amato appassionatamente Piccolo corpo di Laura Samani.
Parlaci invece del ruolo che ha la scrittura nella tua vita. C'è chi scrive per chiarire idee e sentimenti, a cui non riesce a dare una forma, chi cerca una valvola di sfogo, quasi una terapia, chi è mosso semplicemente dall'urgenza di farlo... Qual è la tua motivazione?
La scrittura è venuta presto, come per tanti, in forma di poesia. Imitazione di poeti che mi impressionavano, che pensavo di amare, o amavo sinceramente. Avevo circa quindici anni. Negli anni, poi, la scrittura è riaffiorata con insistenza, e con maggiore consapevolezza. Posso dire che quando scrivo, se scrivo qualcosa di compiuto e di efficace, il cuore batte più forte, con un ritmo diverso, che mi sospende in uno stato di spaventosa felicità.
Come conciliare il “devi riuscire a essere insostituibile”, suggerito da Carmelo Bene (quindi la personalità), con la “pluralità di voci” a cui ti ha avviato Gabriella Bartolomei? Essere l'attrice giusta per quel ruolo, per quella certa cosa che si adatta al tuo stile e al tuo carattere, ma riuscire anche a prestate il proprio corpo a qualsiasi personaggio?
Scelgo la strada della polifonia. Scelgo di immergermi nella differenza. Portiamo già sempre noi stessi in dote, in ogni nostro gesto, in ogni nostro atto. Cercare di sparire è un’opportunità prelibata, un privilegio concesso a pochi. Dobbiamo approfittarne!
A proposito di Carmelo Bene, oggi è ridotto a una specie di santino, mitizzato e forse anche banalizzato. Tu che l'hai conosciuto molto bene e hai lavorato tanto con lui, come lo ricordi? Cosa amavi e cosa non sopportavi in lui? Dovendo raccontarlo a un giovane che lo conosce appena: perché è stato così importante?
Carmelo Bene è stato per me un incontro della vita. Un incontro con l’arte che si fa. Con un artista artigiano. Lo temevo, ma non volevo farglielo capire. Reggevo lo sguardo e le provocazioni, era il mio modo di accettare la sfida. Carmelo era feroce e delicatissimo insieme. Credo di aver intravisto qualcosa di lui, nel periodo in cui ho lavorato insieme. Ne conservo un ricordo luminoso. No, non un ricordo, un sentimento.
Tu sei partita da una ricerca (soprattutto teatrale) profonda, originale, anche avanguardista, hai lavorato con Strehler e con Castri, ma in tanti ti conoscono per Tutti pazzi per amore, Il commissario Montalbano o il film con Checco Zalone. Come hai vissuto il passaggio verso questo mondo, il prodotto per il “grande pubblico” televisivo e cinematografico? Come convive con quell'altro? In un certo senso, forse, ti ha fatto scoprire il tuo talento comico (che c'è e si vede)

13 LUGLIO 2023 12 LUGLIO 2023
(foto Marco Minniti)
Sonia Bergamasco
(foto Daniela Zedda)
(foto Alberto Terrile)
Per molti anni ho vissuto il tempo come qualcosa da rincorrere. Volevo diventare grande al più presto, faticavo a stare nelle cose. Chiamiamola ansia. Attraverso il mestiere di attrice, ho percepito la necessità assoluta di stare nell'attimo con
C’è qualcosa di buffo in questo mio approdo “nazional popolare” raggiunto per caso: come l’incontro di un marziano con un tifoso del Manchester United. Divertente! Io che sono partita per la mia avventura di attrice musicale interpretando, nel tempo “libero”, e per passione, il Pierrot lunaire di Schoenberg (niente di orecchiabile), sono oggi riconosciuta per strada come dottoressa Sironi o Luce del Gatto in Tangenziale, o Livia di Montalbano. A equilibrare le cose, tra concerti e teatro d’autore c’è poi il cinema di Giuseppe Bertolucci – l’ adorato, il grande Giuseppe – con il quale ho avuto la gioia di cominciare, e Marco Tullio Giordana, che con la sua Meglio gioventù ha impresso un segno duraturo nella narrazione italiana contemporanea.
Cosa fai appena prima di andare in scena a teatro?
Hai un tuo rito, una routine? Cosa cambia, invece, quando devi girare una scena cinematografica?


Mi faccio il segno della croce (non ridere!). La cosa è nata così: anni fa ho interpretato Karénina, in uno spettacolo con la regia di Giuseppe Bertolucci di cui avevo curato anche la drammaturgia insieme a uno scrittore. Il segno della croce ortodosso era un gesto che ricorreva,
nell’ultima parte dello spettacolo, e quindi è diventato in breve, per me, un gesto rituale prima di entrare in scena. Me lo sono portato in dote da allora come un talismano. Sul set, niente segno della croce. Lì ci sono modi diversi, equilibri diversi.
C'è un linguaggio espressivo a cui ti senti più legata?
Tra cinema e teatro non voglio scegliere, li amo entrambi, ma so che del teatro ho un bisogno fisico.
Come vivi la crisi di questi anni? Da una parte il mondo del cinema che si sente sotto attacco, per lo strapotere delle piattaforme e l'attitudine allo streaming, la visione privata. Dall'altra il teatro che ha vissuto la crisi dell'emergenza sanitaria, alle prese con il cambiamento generazionale del pubblico, ma anche di chi lo fa. Ci sono gli apocalittici, legati alla tradizione, spaventati dai cambiamenti in atto, e quelli convinti che al di là delle modalità di fruizione, degli strumenti di diffusione, la sostanza non cambia e non cambierà.
Il 25 e 26 agosto sarò al teatro antico di Segesta per lo spettacolo Resurrexit Cassandra. Sono sola in scena, in compagnia di una ventina di serpenti di legno (!). La regia è dell’artista Jan Fabre. Con questo spettacolo abbiamo debuttato al Teatro antico di Pompei due anni fa. Il teatro è frequentato da parecchio tempo, ne abbiamo le prove. Non c’è guerra che tenga, non c’è crisi che tenga. Certo, c’è sempre la possibilità che tutto finisca, che il disastro diventi irreversibile.
L’arte, quando è vera arte, possiede gli anticorpi per resistere, per non farci naufragare. In questo presente tragico che stiamo vivendo è necessario dare agli artisti più spazio e più responsabilità.
Nel libro parli della “concentrazione aperta”, che suona quasi come un ossimoro. È qualcosa che funziona anche nella vita, oltre che in scena? Ricorda quel “rilassamento cosciente” che si cerca, ad esempio, nello yoga, disciplina che tu pratichi. Oggi si parla molto dell'importanza della consapevolezza, la spiritualità dell'essere presenti nel qui e ora.
Per molti anni, da quando ero bambina, ho vissuto il tempo come qualcosa da rincorrere. Volevo diventare grande al più presto, faticavo a stare nelle cose. Chiamiamola ansia. Attraverso il mestiere di attrice, ho percepito la necessità assoluta di stare nell’attimo con tutta me stessa, senza sfuggire. Di dare fiducia all’istante. Anche lo yoga mi ha aiutato, e continua ad aiutarmi.
Il corpo è al centro del tuo libro. La sua forza erotica. A questo proposito, viviamo in tempi contraddittori, che da una parte esaltano l'apparire, l'esposizione dei corpi, la libertà sessuale (a parole), ma dall'altra rimangono ancorati a tabù e pregiudizi, a un moralismo che sembra figlio della paura, paura della forza dirompente dell'eros. Anche questa è stata una scoperta lungo il cammino?
A proposito: molto bella la tua Salomè in guêpière e tacco dodici, per l'Erodiade di Mallarmé.
Il corpo è il mistero e lo strumento vitale. Per l’attore e per ognuno di noi. Tentare di conoscerlo, di addestrarlo e mettersi in ascolto dei suoi bisogni e dei suoi impulsi è una pratica lunga una vita. Una pratica che mi affa-
scina, mi sorprende e guida la mia ricerca quotidiana. Sono una persona mediamente riservata, poco incline all’apparire. La nudità esteriore è più facilmente praticabile di quella dei sentimenti e delle angosce. È quell’esplorazione invisibile che mi attira e determina il mio modo di essere. E credo di aver scelto il mestiere giusto per fare questo viaggio.
Parliamo anche di “impegno”. Che detto così, sembra quasi una tassa che devi pagare per sentirti utile al mondo, inscenando certi testi, firmando manifesti, facendo dichiarazioni pubbliche politiche. Ma che forse è legato soprattutto al modo in cui lavori, al rapporto che stabilisci col pubblico e anche con i colleghi, ai messaggi che lanci in scena senza neanche il bisogno di esplicitarli troppo (altrimenti diventano comizi).
Viviamo in tempi particolarmente difficili, e credo che oggi l’impegno sia più che mai necessario dentro e fuori dalla scena. E se la politica non dà risposte all’altezza dobbiamo cercare la strada, la rete, per poter far valere le giuste ragioni, per poter alzare la voce e farsi sentire.
15 LUGLIO 2023 14 LUGLIO 2023
tutta me
Sonia Bergamasco
stessa, senza sfuggire
(sul set di "L'amore probabilmente") foto Angelo Turetta)
("La meglio gioventù" foto Angelo Turetta)
L’associazione UNITA nasce nel 2020 per dare voce e corpo alla nostra categoria, indipendente dalla politica e dai sindacati, ma in dialogo con tutti per offrire risposte alle tante questioni aperte e irrisolte o mai affrontate, e per poter stimolare con le armi della creatività uno sviluppo più umano della nostra società, a partire dal sistema scolastico.
La leggerezza è la mia conquista di oggi. In un mondo sfinito, finito, in guerra con se stesso, un mondo demenziale e feroce, la leggerezza è un'arma politica. E non è distacco o menefreghismo, anzi.
Accende un sentimento di empatia e di compassione. È la consapevolezza della nostra fragilità
Personaggi a cui sei particolarmente legata, tra quelli che hai interpretato a teatro, al cinema, in tv? Per chi, come te, si sforza di immergersi nel personaggio – con tutte le responsabilità che ciò comporta – immagino sia più affascinante dare vita a caratteri o storie lontane dalla tua.
Giulia della Meglio gioventù è una donna che porto dentro, con le sue profonde contraddizioni. E poi Sofia di L’Amore probabilmente di Giuseppe Bertolucci, ma anche la Martha di Chi ha paura di Virginia Woolf?, che ho portato a teatro fino a qualche mese fa. Una donna indimenticabile, sfrenata, disastrata e struggente. E poi, sicuramente, Luce, la svampita di Come un gatto in tangenziale. Sì, mi piace cambiare.
Provi ancora la sensazione di camminare sul filo, come il funambolo di Genet? Quel senso di pericolo e di gioco un po' folle, che suscita stupore? O è qualcosa che con gli anni rischia di essere soffocato dalla routine, dal mestiere?
Se non provassi ancora quella sensazione, quel brivido, non potrei più lavorare. La parola routine è inconciliabile con il nostro mestiere. Lo uccide. Certamente le esperienze, gli anni di lavoro, gli incontri, mi consentono di
farmi largo con una carica diversa nell’affrontare le cose nuove, e anche con qualche anticorpo in più per non venire inutilmente feriti. Ma resta l’emozione di scoprire ogni volta che il corpo si dispone alla prova con paura, con fragilità e con entusiasmo. Non voglio rinunciare a questi ingredienti del cuore.
Cosa ti attrae di Eleonora Duse, di cui parli come un punto di riferimento che ti accompagna da sempre? In che cosa vorresti assomigliarle? Altre interpreti a cui ti senti legata in qualche modo? (Chi ti guarda pensa facilmente al modello offerto dalla grande Monica Vitti, che citi nel libro)
Eleonora Duse è uno spirito guida. Non l’ho mai vista, ma la posso immaginare. L’energia che la sua testimonianza d’artista ci ha lasciato (attraverso foto, lettere, lo sguardo e l’emozione di chi l’ha vista e ne ha scritto o ne ha parlato) è così potente da trascinare al presente generazioni di attrici e di artisti che credono in quello che fanno. Monica Vitti è un’artista che è riuscita a muoversi con una leggerezza radiosa tra cinema e teatro. Ma anche Franca Valeri, la milanese, la grande. Devo dire che i modelli, del passato, i grandi amori (che ci sono, che vivo e che mi danno forza per continuare il lavoro), sono un dato di realtà. Al presente, Viola Davis è l’attrice che più mi sorprende e mi seduce. Ma è il lavoro di tante interpreti, giovani e non, che mi ispira e mi fa amare il mestiere con prepotenza. Pochi giorni fa, quando ho visto il film As bestas, sono rimasta colpita dalla adesione emotiva assoluta di Marina Foïs. Una luce.

Quali sono i tuoi progetti nel prossimo futuro? Film o serie tv in cui ti vedremo? Anche cose magari più piccole o particolari, a cui tieni in modo speciale, a cui stai lavorando. E il sogno più grande, invece? Il tuo orizzonte sarà sempre più quello dell'autrice-attrice?
In questi giorni sono sul set del nuovo film di Marco Tullio Giordana, La vita accanto. Dopo vent’anni, ritrovo il regista che mi ha chiesto di suonare il pianoforte in scena, nella Meglio gioventù. E anche oggi mi chiede di farlo, nel ruolo di una concertista. Il film è prodotto dalla Kavak e la sceneggiatura è firmata anche da Marco Bellocchio e Gloria Malatesta.
Dall’autunno poi sarò in scena a teatro nella Locandiera di Goldoni, con la regia di Antonio Latella. Contemporaneamente, sono partite le prime riprese del film documentario intitolato The greatest, che attraverso la figura di Eleonora Duse esplora lo spazio creativo del mestiere d’attrice al presente. Questo è il mio progetto del cuore. Il trattamento di questo film, scritto con Mariapaola Pierini, è prodotto da Marina Marzotto (Propaganda Italia) e Quoiat film. Il progetto è appena stato premiato al Bio to B Biografilm Festival di Bologna: un riconoscimento prezioso per un lavoro che sta nascendo!
La sfida allo specchio è finita? Quando ti guardi, oggi, cosa vedi? Ti riconosci?
Vedo una donna che sta invecchiando. Ne sono orgogliosa, anche se questo movimento sottile e inarrestabile preme, con dolcezza. Quella bambina che ora è una donna che si guarda ancora parecchio allo specchio (è necessario, è una faccenda che riguarda il lavoro) continua a interrogarmi. Sicuramente non sono stata capace di darmi tutte le risposte, non ci riuscirò, ma so che mi sto ponendo le domande giuste e che lo sguardo è meno appannato. E c’è sicuramente una maggiore leggerezza di tocco. Ecco, la
leggerezza è la mia conquista di oggi. In un mondo sfinito, finito, in guerra con se stesso, un mondo demenziale e feroce, la leggerezza è un’arma politica. E non è distacco o menefreghismo, anzi. Accende un sentimento di empatia e di compassione. È la consapevolezza della nostra fragilità, del nostro essere qui per un attimo per poi volare via. Nell’Amleto c’è un passo famoso che ogni volta mi tocca: c’è una speciale provvidenza anche nella caduta di un passero. Se è ora, non sarà dopo; se non sarà dopo, deve succedere ora; e se non è ora, prima o poi succederà. Essere pronti è tutto. Se non sappiamo niente di ciò che potremmo rimpiangere, che importanza ha lasciarlo prima o dopo? The readiness is all.
Qual è la tua “redness”, l'idea o il sentimento che ti motiva, ciò che ti dà la forza di alzarti la mattina e che ti spinge a fare, andare, provare?
L’amore per la vita, malgrado tutto. Sono una di quelle che si alza la mattina (generalmente presto) con il desiderio di fare, di vivere, di misurarmi con le cose. E la consapevolezza di avere accanto a me persone che amo mi sostiene anche nei momenti difficili. Le amicizie vere, le persone che amo sono il mio nutrimento essenziale.
17 LUGLIO 2023 16 LUGLIO 2023
Sonia
Bergamasco
(foto Gianmarco Chieregato)
Ana Brígitte Fernández

Estasi e tormento di una donna che ama, recita, scrive poesie. Le origini colombiane, la lotta ai pregiudizi, la voglia di infinito
«Le stelle siamo noi. / I nostri corpi come veicoli / per ritornare all'infinito». L'orizzonte è questo, evocato in esergo, come una premessa ideale, augurale, un haiku che riassume il senso del cammino. Ana Brígitte Fernández è attrice e scrittrice, è colombiana ma anche italiana e “figlia delle stelle”, è donna, madre, artista innamorata della vita. E ora ha deciso finalmente di pubblicare le sue poesie, di condividere col mondo ciò che ha di più intimo e segreto.
Quel verso, in apertura di libro, è come una stella polare, che indica un “destino cosmico”, una fiducia nell'esistenza, con tutte le sue contraddizioni, nel senso più profondo del nostro essere al mondo. Lo ribadisce anche nella dedica iniziale di Coscienza, tra estasi e tormento, titolo scelto per la raccolta di poesie pubblicata da Aletti Editore. Ai genitori, ai fratelli «di sangue e di anima», ai figli («se dovessi dare la vita per voi, in questo istante, lo farei»), ai gatti della sua vita, agli “esseri invisibili”. E poi naturalmente all'amore e alla Poesia «per avermi dato un luogo dove rifugiarmi da questo mondo spietato ma incantato al contempo».
Lo sguardo è puntato verso l'alto, ma non manca l'ironia, la consapevolezza disincantata di chi ha già attraversato un bel pezzo di vita, tra gioie inattese, esperienze dolorose, intuizioni che illuminano: «Io sono una persona piena di poemi / ma me li risolvo io».
La sua biografia è un film d'avventura, attraversato anche da eventi tragici (l'assassinio dello zio nel 1989, la morte a 26 anni di un uomo di cui era innamorata), che si fa notare anche per un matrimonio a 17 anni (fu la prima sposa minorenne registrata in Campidoglio) e per il rapporto di amicizia nato per caso con Vittorio Gasmann.
Il cinema è entrato nella sua vita quando era ancora una ragazzina. Ma nella sua esistenza ci sono sempre stati il teatro, la musica, la scrittura, fin da piccolissima. E anche il desiderio di viaggiare, insieme al sogno di studiare recitazione in Europa. Lo ha fatto, a Roma, dove è arrivata nel 1995, studiando al Duse e approdando anche sul set de La Cena di Scola.
Un percorso non facile, in un mondo cinematografico che per una donna, spesso, è un campo minato (infestato da certe attenzioni non gradite e proposte indecenti), e che a un'attrice di origine sudamericana riserva solo ruoli molto, troppo caratterizzati (quando ci libereremo da questo imbarazzante provincialismo?). L'abbiamo vista in tanti spot, al cinema (da Piovono mucche a Dio salvi la regina) e in tv (da Romanzo criminale a Rocco schiavone), con tutto il suo fascino e l'intensità emotiva di cui è capace. La poesia la accompagna da sempre. Ma Coscienza, estasi e tormento è la sua prima pubblicazione. Con l'introduzione d'autore di uno che con le parole ci sa fare, Alfredo Rapetti Mogol (“Cheope”), autore di canzoni celeberrime, al servizio di un esercito di artisti, da Laura Pausini a Mina, da Cocciante a Celentano, da Marracash a Fiorella Mannoia.
19 LUGLIO 2023
I NCONTRI
Scrive di lei: «Il territorio poetico di Ana Brígitte Fernández è costituito in gran parte di cielo, aria pura, di desiderio di ascensione, ma soprattutto del rapporto tra l’ora e l’oltre. E questa lacerazione interiore senza soluzione di continuità ne misura la grandissima profondità. Tutto il suo lavoro verte sul passaggio di stato, sul confine fisico e spirituale tra il prima e il dopo».
Un bisogno di eternità, una sacralità spontanea, che attraversa tutti suoi versi, insieme a un desiderio di vera umanità («Voglio esseri genuini, semplici e trasparenti»), di natura («Mi ritrovai ad abbracciare la quercia / e giuro che la sentii respirare»), di normalità sorridente («Ho un capello bianco in mostra / e mi commuove la vita»), di amori vissuti fino in fondo e “cuori rivoluzionari” («sei spina che ricorda la rosa perfetta che possiede / sei l'acqua che salva dal morire di sete»), di verità: «Questo mondo umano non è altro che un’aggregazione di armadi pieni di crisalidi sudate / deposte in stampelle dorate. / Di cieli pieni di farfalle coraggiose e felici difendenti la propria verità. / Di bruchi che non vedono speranza / temendo che la trasformazione li porti alla morte, / perdendo così il paradiso».
Eravamo una grande famiglia, unita da valori e doveri anche nei confronti della società. Mio zio, sindaco, mi insegnò che contano i fatti non le parole, e che la cosa più importante è avere il senso di umanità. L'unione fa la forza

Cosa ricordi della tua infanzia colombiana? Noi conosciamo Barrancabermeja, dove sei nata, come la sede della più grande raffineria di petrolio del Paese. Per te, invece, cosa ha significato?

Questa città rappresenta per me la spensieratezza dell’infanzia, il luogo dove ho visto tutta la mia famiglia paterna radunata, nel senso vero della parola. Una grande famiglia, unita da valori e doveri anche nei confronti della società. Mio zio, fratello di mio padre, era il sindaco, molto amato da tutti. Ha fatto veramente tanto per questo luogo, migliorandolo e rendendo i suoi cittadini fieri di farne parte. Aveva anche il ruolo di collante per tutti noi della famiglia. Ci ha insegnato che ciò che conta davvero sono i fatti, che le parole e le promesse non servono a niente. Il suo moto era “Mis palabras son los hechos”
(“Le mie parole sono i fatti”). Una frase che credo sia impressa in ogni membro della nostra famiglia. Indimenticabili i raduni di tutti i Fernández, ogni fine settimana. Ci insegnava che ancora prima di avere un mestiere, bisogna avere il senso di umanità. Cosa che dimostrava aiutando i suoi cittadini.
Faceva portare loro carne e latte ogni giorno, quando per impegni non poteva farlo personalmente. Sapeva bene che le condizioni economiche non erano uguali per tutti. Ogni Natale portava beni alimentari alle famiglie bisognose e regali ai bambini, che lo aspettavano come qui fanno con Babbo Natale.
Mio padre e miei zii sono sempre stati presenti nelle nostre vite, ognuno con una propria personalità, ma legati dal concetto che l’unione fa la forza.
Da una parte ci sono le origini nobili di tuo padre, dall'altra tua madre che arriva dalla classe proletaria. Due modi diversi di essere, due eredità importanti.
Mio padre mi insegnò a montare a cavallo. Amavo andare in “ritiro” con lui, nonostante mi invadesse spesso un grande senso di solitudine, poiché erano “fincas”, fuori della città. Lo preferivo, piuttosto che rimanere a casa a giocare con gli altri bambini. Mi portava a vedere come le persone lavoravano la terra, come si dedicavano al loro compito, umilmente. Ci svegliava alle 4 del mattino per farci vedere come nascevano la frutta e le verdure, come si munge una mucca per avere il suo latte. Fu tutto molto importante.
Mi aiutò a capire fin da piccola che il lavoro è nobiltà e che solo le cose fatte con passione portano a un risultato. Per quanto riguarda mia madre, posso dire che l’eredità più grande che porto con me è aver capito che vivere di apparenza logora, che la semplicità e le piccole cose della vita sono la vera felicità. Che la fede può salvare e che il cielo è di quelli che credono e non di quelli che dubitano. Ovviamente parlando metaforicamente, il cielo inteso come obiettivo, come meta, come desiderio da realizzare.
21 LUGLIO 2023 20 LUGLIO 2023
(foto di Ivana Noto) Ana Brígitte Fernández
La storia della tua famiglia si intreccia con la storia politica del tuo Paese in modo drammatico.
Barrancabermeja è anche la città dei petrolieri, per lo più persone molto benestanti che hanno tirato su una realtà senza precedenti per tutta la Colombia. Realtà che continua a esistere tuttora. Ricordo la guerra tra politici, le proteste e la violenza a cui venne sottomessa la città per il conflitto con il narcotraffico e “los guerrilleros”.
Non era una situazione facile per noi bambini poiché era l’epoca di Pablo Escobar. Per tanti, nel mondo, è solo il protagonista di film e fiction da seguire con interesse da una comoda poltrona o dal divano di casa, ma per noi era una dura realtà. Ambire alla pace era il senso comune che univa (quasi) tutti.
Purtroppo nel 1989 mio zio, il sindaco, che ormai era una nota figura politica nazionale, venne ucciso in un attentato dalla guerriglia, appena dopo essere stato nominato ambasciatore colombiano a Madrid. Questa vicenda segnò le sorti della mia famiglia, costringendola a dividersi e a spostarsi in luoghi diversi del Paese. Avevo undici anni e mi resi veramente conto di come la violenza possa distruggere in un batter d’occhio un grande sogno comune.
Ci sono episodi o esperienze in quegli anni che ricordi come fossero rivelazioni?
Che ti hanno indicato il cammino?
Ho sempre sentito il mondo come un luogo molto grande che volevo scoprire, nonostante non ci fosse ancora internet. Intuivo con forza che viaggiare fosse una specie di magia. Che visitare nuovi luoghi, scoprire nuovi profumi e nuovi sapori, fosse un dono con un valore infinito. Sentivo dentro di me che sarei partita molto giovane alla ricerca di tutto questo.
Poi a quattro anni ho imparato a leggere e non mi sono fermata più. Leggevo tutto ciò che era possibile, amavo immergermi nelle favole per bambini, nella poesia, nei testi sull'astronomia, che fu la mia prima vera passione. Sognavo di andare a lavorare per la Nasa e diventare un’astronauta.
Ma cominciai a scrivere anch’io le mie poesie e testi per canzoni, che collezionavo come altri bambini collezionavano giocattoli. Sapevo senza dubbio che la scrittura mi avrebbe sempre accompagnata, che mi avrebbe persino portata a raggiungere le stelle, o l’universo misterioso che le persone hanno dentro, poiché osservandole, sentendole attraverso il mio proprio modo, scaturivano in me riflessioni e anche rivelazioni del fatto che tutti siamo connessi e che nessuno si salva da solo. La salvezza intesa come melodia che ci accompagna nel superamento delle nostre difficoltà. La bellezza assoluta del fatto che ci venga permesso di poter condividere le gioie e le nostre più alte emozioni con gli esseri che ci circondano.

L'approdo a Cartagena per te è stato una rinascita. Cosa è cambiato nella tua vita?
Avevo 11 anni. Andavo in una terra molto diversa da quella in cui ero cresciuta. C'era il mare, e la cosa mi eccitava moltissimo, lo trovavo affascinante e misterioso come il cielo.
Non sono mai stata legata ai muri: ricordo che durante la mia infanzia i miei genitori si trasferirono molte volte e la cosa non mi creava mai dei problemi. Ero pronta a fare nuove amicizie e affrontare nuove sfide.

Le persone parlavano con un accento diverso, tipico della costa, dei “luoghi del mare”. Si mangiava anche diversamente e vedevo la gente possedere una felicità incorporata, anche davanti a situazione difficili. La musica arrivava nelle mie orecchie dalla mattina alla sera e guai a lamentarsi! Ballare e cantare fa parte della cultura di quel luogo ed è meglio abituarsi. Fu facile per me innamorami di quella città.
Cosa ti ricordi del primo set cinematografico con Claudia Cardinale e Colin Firth?
Avevo 16 anni, mi trovavo a lezione di teatro nella mia scuola ed entrò il nostro insegnante che disse: “È arrivato un set italo-inglese qui a Cartagena, gireranno un film che si chiama Nostromo e cercano due ragazze che facciano una piccola parte e recitino delle battute in inglese”.
22 LUGLIO 2023
Ana Brígitte Fernández
(foto Giorgia Zamboni)
(foto Gianni Falconieri)
Poi si rivolse a me e mi disse: “Vai no?” E io risposi: “Ma io non parlo inglese”. E lui: “Ma hai una memoria fantastica e puoi imparare le battute!”. Accettai e andai. Trovai centinaia di ragazze in fila, ma aspettai lo stesso il mio turno. Il responsabile del casting, Fabrizio, fu gentile e paziente e mi aiutò con la pronuncia. Finito il provino tornai a casa soddisfatta di avere fatto quello che dovevo fare e con mia grande sorpresa, dopo qualche giorno, ricevetti una telefonata di qualcuno della produzione che mi comunicava che il ruolo era mio. Non potevo crederci, ma ero divertita da quel risultato. Così iniziò questa avventura. C'erano star del cinema internazionale ed era bellissimo vederli lavorare proprio lì davanti a me.
C'era questo attore anziano, gentile e premuroso, con cui è nata una grande simpatia. Poi ho scoperto che si chiamava Vittorio Gassman
Erano persone semplici, tranquille, senza nessun atteggiamento da “primedonne”. Mangiavo accanto a loro e mi invitavano sempre a tutte le cene e le uscite che facevano in giro per la città.
Nacque anche una storia d'amore.
Un colpo di fulmine, con il figlio del direttore della fotografia Franco Di Giacomo. Lui, Francesco, era il “camera assistant”. Aveva solo qualche anno più di me e tutti erano inteneriti da questa nostra storia. Fu accolta con grande amore da parte di tutti. Ancora oggi re-incontro qualcuno di loro qui a Roma ed è sempre bellissimo ritrovarsi. Anche con Francesco. Siamo rimasti in ottimi rapporti, dopo una storia durata quasi 6 anni.
Il tuo arrivo in Italia è stato a dir poco movimentato, dopo una tappa a Londra. Mia sorella abitava a Londra già da un po' e ci demmo appuntamento lì, con questo mio ragazzo. Ma ero minorenne e le versioni del mio ragazzo, di mia sorella e del nostro amico che ci ospitava, non corrispondevano. Eravamo tutti emozionati, non eravamo pronti a essere interrogati dalle guardie inglesi. Mia sorella diceva che ero lì per trascorrere qualche mese, il mio ragazzo diceva che ero a Londra per studiare inglese, mentre Alex Reid, figlio del regista e grande amico di Francesco, pensando di fare una buona cosa, disse: “Lei vivrà qui, la ospiterò senza problemi”. Il risultato fu che mi diedero quattro giorni per girare Londra, sequestrandomi il passaporto, con obbligo di rientro in Colombia. Dopo quei quattro giorni mi recai in aeroporto. Da una parte c’era il gate per Bogotà, dall’altra quello per Roma, e mentre la guardia si girava... Ovviamente avevamo già pianificato la fuga, avevamo anche i biglietti, e così iniziò la corsa verso l’aereo che mi avrebbe portato in Italia.

La tua avventura italiana è cominciata con Scola.
Al mio arrivo mi dissero che Ettore, uno dei migliori amici del padre di Francesco, avrebbe girato un film che si intitolava La cena. Cercava una ragazza, così andai a fare il provino a casa sua. Mi presero e cominciò la mia avventura in questo set tutto italiano. Ricordo un'attrice che raccontava sempre quante fette di pane si era mangiata. I suoi racconti erano divertenti, era molto simpatica. Capii con gli anni che lei era Stefania Sandrelli. Io vedevo tutti questi attori che per me erano anonimi, non sapevo chi fosse chi. Solo con il tempo capii che ero circondata da grandissimi interpreti, tra cui Giancarlo Giannini, Fanny Ardant, Antonio Catania, Marie Gillain, Rolando Ravello, Giorgio Colangeli, Nello Mascia, Giorgio Tirabassi.
C'era anche un certo Vittorio Gassman, con cui nacque un rapporto speciale. Raccontaci di lui.
Sì, c’era questo attore anziano con il quale legai fin da subito, gentile e premuroso. Era nata una grande simpatia tra noi due. Non so perché gli ero così simpatica, ma io per lui provavo una grande tenerezza. Era molto riflessivo, proprio come me. Io non avevo avuto rapporti con i miei nonni, che non ho mai conosciuto, e quindi lo vedevo un po' così. In quei mesi, che furono molto speciali, mi raccontava della vita, dell’importanza di stare in silenzio quando gli altri lavoravano su un set, mi raccomandava di non fare come gli altri casinari e come le tante “gallinacce” che aveva incontrato nella sua vita, che andavano di qua e di là senza pace, e ribadiva l’importanza di studiare. Diceva che se avessi creduto in quel lavoro avrei potuto ottenere risultati, che dovevo credere in me e che lui quel mestiere lo aveva iniziato grazie a sua madre che insistette molto. Non erano quelli i suoi programmi, ma con il tempo il lavoro dell'attore diventò parte della sua vita.
Ci sedevamo in disparte, mi dava consigli e mi raccontava storie del suo passato. Mi affezionai molto a lui e lui a me. Finite le riprese, mi diede il suo numero di telefono fisso e il fax. I telefonini non c'erano ancora. Mi disse che avrebbe aspettato la mia telefonata per farmi vedere Roma come la vedeva lui, ma io, un po' per l’età e l'imbarazzo, un po' per le distrazioni della vita in generale, non lo cercai subito. Anche se lo ricordavo e mi ripromettevo sempre di farlo.

25 LUGLIO 2023 24 LUGLIO 2023
Alena Ettea
Ana Brígitte Fernández
(foto Sham Hinchey)
Dopo quasi due anni, mentre ero davanti alla tv, vidi i telegiornali che parlavano del “nonno” e lo chiamavano “Vittorio Gassman”. Solo dopo molto tempo mi venne voglia di indagare su di lui, arrivando a scoprire e capire chi fosse veramente. Sono stata molto fortunata a conoscerlo senza neanche sapere chi fosse. Ora comprendo perché gli altri ragazzi avessero quasi timore ad avvicinarlo. Per me era solo un uomo anziano con cui amavo stare. È tornato a trovarmi in sogno, in tre momenti particolari e difficili della mia vita, portando sempre pietre preziose tra le mani, di colore rosso. Per me è uno dei miei angeli, lo sarà per sempre.
Cos'era l'Italia per te? Un sogno? Un'opportunità? Era più l'entusiasmo o la paura per questo cambiamento?
L’Italia non era il paese dove pensavo di rimanere a vivere, ma sapevo che sarei arrivata a conoscerlo, visto che il mio ragazzo era italiano. Non ho mai avuto timore del cambiamento, credo sia parte fondamentale della vita. L’entusiasmo nasce dalla volontà con cui si affrontano le sfide che la vita presenta, tutto il resto è ignoto, il luogo delle mille possibilità. Ho amato Italia fin da subito, la sua gente, la sua cultura, il suo mangiare. Un gioiello.
Il tuo essere colombiana è stato un problema?
Sono sempre stata accolta bene dalla maggior parte delle persone. Ma non si può e non si deve piacere a tutti! Con gli anni ho capito che sarebbe stato molto difficile per me emergere come attrice, nonostante mi dedicassi allo studio giorno e notte. La mia fisionomia veniva quasi sempre inquadrata in certi ruoli, che per me non erano certo il massimo, non erano quello che avrei voluto fare, a parte alcune esperienze molto belle.
Il cinema italiano deve ancora fare tanti passi avanti per togliersi di dosso l'abitudine alla discriminazione e la classificazione dei personaggi in base all'etnia e al paese di provenienza. Qui non c'è un'industria del cinema. Il cinema è fatto per lo più per gli italiani. E le straniere che sono arrivate o hanno avuto la fortuna di trovare qualcuno che credesse veramente in loro oppure hanno scelto vie facili... Compromessi ai quali io non sono mai scesa. Se vengo scelta, è perché ho fatto un provino, non perché sono andata a letto con qualcuno. In tanti casi subisci dei ricatti morali. Addirittura, a volte, dopo aver vinto un provino, avendo convinto il regista, accade di venire scartati perché la produzione vuole “il nome” o perché qualcun altro è già stato imposto dall’alto. Ma questa non è una novità.
L’innovazione, la crescita culturale, non sono cose per tutte le società, ne sono sempre stata cosciente. Nonostante tutto, però, continuo a prepararmi. Non mollo i miei sogni, anche perché ormai sono loro ad avere me tra le mani. Il futuro non esiste. I sogni sono radicati nel presente, solo lì esistono.
Hai avuto delle storie d'amore travagliate. Da fuori, vediamo solo incontri e addii, matrimoni, la superficie delle relazioni. Nella tua poesia invece c'è il fuoco, la passione che le nutre, la verità dei sentimenti. Parlaci del tuo modo di vivere l'amore (sempre che se ne possa parlare davvero... in prosa).
Non credo che l’amore abbia un “modo” di essere vissuto. È come una corrente di fiume, spontanea, che cambia ogni istante e che non è mai la stessa, ma che a volte, al posto di finire in mare, trabocca, perdendo così l’occasione di andare in un oceano che potrebbe riservare mille sorprese.
Ogni storia che ho vissuto mi ha portato nuove cose che mi hanno permesso di conoscermi meglio. Penso che nella ricerca dell’amore tutto ciò che abbiamo vissuto poi rimane nella sacralità del nostro essere. Si va oltre il concetto di giusto o sbagliato, il fallire o il raggiungere le conquiste tanto ambite.


Poi ci sono i tuoi figli. Anzi forse prima. Nel senso che la famiglia per te non è solo una parola.
I miei figli li ho desiderati fortemente. Non è un’amore che può essere descritto. Inutile spiegarlo solo con frasi con il fiocco. Va oltre. Questo sentimento può innalzarti fino al cielo come farti sprofondare negli abissi.
Hai sempre studiato recitazione, ma anche la scrittura ti ha sempre accompagnato. Sembrano quasi due progetti di vita paralleli, uno “esteriore” e l'altro “interiore”.
Sì, ma mentre per svolgere il mestiere di attrice hai bisogno di qualcuno che creda in te, per la scrittura è diverso. Non ho bisogno di nessuno per mettere per iscritto le mie emozioni o le mie riflessioni. La recitazione dipende da qualcosa al di fuori di te, la scrittura è totalmente indipendente.
26 LUGLIO 2023 27 LUGLIO 2023
(foto Andrea Ciccalè)
Ana Brígitte Fernández
(foto Giorgia Zamboni)
(foto Luca Ranzato)
Quando e come scrivi?
Scrivo quando mi arriva l’ispirazione. In qualunque luogo mi trovi. Spesso registro con la mente per poi mettere nero su bianco quando sarò sola. Sono una persona che passa molto tempo in compagnia di se stessa.
Quello che sembrava più un diario personale, un dialogo fra te e te, poi è diventato poesia da condividere. Chi ti ha convinto a farlo? Come è nato questo libro?
Ho sempre avuto la certezza interiore che quello che scrivevo potesse in qualche modo arrivare agli altri. Ho condiviso alcuni scritti in passato con amici e familiari che mi hanno sempre detto all'unisono: “Condividi ciò che scrivi!”. Vedendo le emozioni che suscitavano in loro, ho pensato che prima o poi avrei trovato il coraggio di denudarmi davanti al mondo.

La felicità è l'insieme di tutte le volte in cui sono riuscita a riconoscermi nel momento presente. Bisogna avere il coraggio di abbracciare la trasformazione e tagliare i rami secchi dall'albero della propria vita. La poesia è una casa che viene data alle emozioni, dove vanno ad abitare per sempre
Non temo i giudizi, non me n'è mai importato un granché. Le persone non sanno delle lotte interiori altrui e delle difficoltà nell'attraversare questo viaggio che è la vita. Se vedi le situazioni più dure come un’opportunità per evolvere, allora sai che buttarti nell'ignoto è come lasciar agire in te un mondo di nuove vie e possibilità. Ma per entrare devi pagare un biglietto che si chiama rischio. La poesia è importante per me, è come una condizione fisiologica, essenziale. Non potrei farne a meno. Non mi metto lì a pensare che devo scrivere o meno. Le poesie nascono spontanee, esattamente come le riflessioni. Non penso se a qualcuno possano dare fastidio o ad altri piacere. È come la filosofia, deve solo far riflettere, nel male o nel bene. Tutto qui.
"Estasi e tormento". Forse non esistono uno senza l'altro. Ma in quali proporzioni? Quanto dolore e solitudine bisogna sopportare per avere un po' di autentica felicità? O forse è la nostra prospettiva che è sbagliata, non è questione di “quanto” ma di “come”.
Vedi, se senti il dolore e la solitudine come qualcosa di negativo, credi che sia solo una questione di sopportazione. Ma se vedi queste condizioni come necessarie, o inevitabili, allora impari anche a conviverci e trarre il meglio che puoi da loro.
La felicità non è legata né all’una né all’altra, poiché tutto si trasforma. La felicità, per me, è l’insieme di tutte le volte in cui sono riuscita a riconoscermi nel momento presente, sapendo che qualunque emozione che nasce, è come un bocciolo che si apre nell'albero dell'esistenza. Credo che la vita di tutti sia un insieme di fiori che sono riusciti ad aprirsi e di boccioli che potrebbero rimanere chiusi per sempre.
Altre volte è come una pianta, un grande albero; alcuni trovano il coraggio di abbracciare la trasformazione e togliere i rami secchi e altri li lasceranno lì a ingombrare uno spazio sacro, senza dare la possibilità ai rami nuovi di emergere.
Se non trovi il coraggio di lasciare andare quello che non apporta più del bene all’albero della tua vita, non potrai mai vedere quale natura frondosa poteva esplodere, dovrai accontentarti di una pianta che piano piano si seccherà, o addirittura morirà.
Credo che la coscienza sia il senso dell’esistere. Si sviluppa non attraverso le esperienze che abbiamo in questa vita, bensì nel modo in cui reagiamo a ognuna di esse. Nella nostra memoria possiamo custodire la testimonianza di noi. La poesia è appunto una casa che viene data alle emozioni, dove vanno ad abitare per sempre e in cui si possono ritrovare, caso mai scappassero via.
La coscienza si forma attraverso il dolore, la delusione (tormento), le gioie e la felicità (estasi). Nell’alternanza di questi stati, costruiamo quello che siamo. Non voglio generalizzare poiché le circostanze della vita non sono uguali per tutti, ma mentre l’estasi può non far mai parte di tante esistenze, la sofferenza e il dolore non risparmiano nessuno.
28 LUGLIO 2023 29 LUGLIO 2023
Ana Brígitte Fernández
"Solo all'infinito appartengo”. Lo scrivi in una poesia. È una cosa che hai scoperto lungo il cammino? È un'idea, una convinzione, o una realtà che vivi, sotto forma di intuizione ed esperienze?
Tutti apparteniamo solo all’infinito. L’ego può ribellarsi a questa verità, ma lo spirito sa che è così.
Quanto è importante per te l'aspetto spirituale dell'esistenza? Nella tua poesia è molto presente. Come invocazione a Dio (un “Dio Cosmo”), come tracce di sacro che emergono anche dalle cose più quotidiane, ma soprattutto come una specie di vocazione.
Non so spiegarlo, posso solo cercare di mettere per scritto questo mio essere così. Senza troppe giustificazioni. Ma ho sempre sentito, ogni volta che sollevo il mio sguardo verso il cielo e oltre, l’amore per le stelle e gli astri, che mi accompagnano fin da bambina. Sento che viviamo in una dimensione fatta di energia, dove il visibile e l'invisibile si uniscono. Se riusciamo a percepirlo, possiamo utilizzare questa consapevolezza per avviare un dialogo interiore con il nostro spirito che va aldilà di ciò che ci circonda di tangibile e materiale. Ho sempre avuto la sensazione che non siamo corpi con uno spirito, ma spiriti con un corpo, che transitano nell’esistenza terrena concessa, affinché l’evoluzione della nostra coscienza possa avvenire.
Viviamo in una dimensione fatta di energia, dove il visibile e l'invisibile si uniscono. Se riusciamo a percepirlo, possiamo utilizzare questa consapevolezza per avviare un dialogo interiore con il nostro spirito
Poi c'è l'aspetto carnale, sensuale. Sui social a volte hai polemizzato con chi è sempre pronto a giudicare, hai rivendicato il diritto e l'orgoglio della bellezza, del desiderio, che non è per forza qualcosa di superficiale o banale.

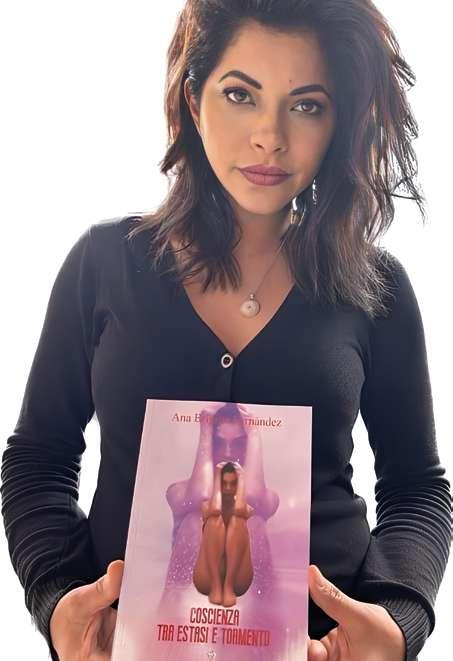
Che senso ha giudicare la bellezza esteriore? La vera bellezza di qualcuno è un aspetto che va oltre l’apparenza. Se rimani nell’esteriorità è una tua condizione, un tuo problema.
Nei tuoi versi sembra di leggere una sfiducia nei confronti degli ideali generici, della politica, ma un senso di comunione con le persone, tutte, il “Dio diviso in tutti noi”.
Credo che il concetto di relatività lo spieghi bene. Non possiamo conoscere qualcosa senza l’esistenza del suo opposto.
Cosa significa esprimersi, in poesia, in una lingua che non è quella della tua infanzia? Bella l'idea dei “pensieri dei poeti mentre attraversano la soglia”. In quel non-luogo profondo non ci sono lingue diverse.
Quando una lingua diversa diviene parte della tua vita, con naturale spontaneità, non ti soffermi sui limiti o la distinzione tra l’una e l’altra.
La lingua italiana è meravigliosa, proprio come la lingua spagnola o come le altre lingue. Hanno termini insostituibili. E se un pensiero o una riflessione nasce in una di queste, dai la possibilità al tuo essere di esprimersi in essa, senza pensare che è la tua lingua natale o meno.
Qual è il messaggio, se c'è, del tuo fare poetico? Il sentimento o l'ideale che tiene insieme tutte le tue parole?
Attraverso la scrittura voglio salvare e custodire la forza dell’amore; le meraviglie della trasformazione; l’importanza di avere presente la nostra mortalità qui, per non essere ingannati dalla trappola dell’eterno rimandare il modo in cui autenticamente desideriamo vivere; l'innocenza dei sentimenti, l'immediatezza e lo stupore contro ogni ipocrisia, pregiudizio e violenza.
Preservare i pensieri e le riflessioni in una casa forte, che conservi la memoria e renda immortale quell’attimo in cui l’orologio segnava l’ora in cui nasceva un verso, per non morire mai più. Non è forse questo la poesia? (f.t.)
31 LUGLIO 2023 30 LUGLIO 2023
Ana Brígitte Fernández
Rossella Seno
Canzoni per chi non ha voce. Un grido, una "bestemmia".
La rossa di Venezia è una "figlia di Dio" che non accetta il male
Ti sembra quasi di vederlo e ascoltarlo, don Gallo, «voce di lupo, sigaro in bocca», che chiama a raccolta i poveri e gli umiliati, gli emarginati, i “rifiuti della società”. Un «barcaiolo che porta tutti in salvo», nel nome di Dio, ma con «una bestemmia sempre pronta»
Rossella Seno lo evoca, lo canta, lo fa rivivere per noi. Così come ha cantato Dj Fabo o Stefano Cucchi, la ragazza deportata, usata come schiava sessuale, o il ragazzo affogato nel Mediterraneo, perché «di confine si muore». Rossella canta Zohra, la bambina pachistana, domestica a 8 anni, uccisa dai suoi “padroni” per aver liberato due pappagalli dalla gabbia. Canta Simona Kossak, scienziata ecologista, biologa attivista e anche un po' magica (“strega”, la definiva qualcuno), che visse immersa nella natura incontaminata, battendosi per la salvaguardia delle foreste.

Sì, perché anche la natura è vittima di un sistema che schiaccia, opprime, travolge senza pietà. Gli animali appartengono alla categoria degli “ultimi”, insieme a clochard, carcerati, pazzi, puttane, da cantare con la cruda poesia di chi ama De André, con l'amorevole foga di Don Gallo: «Se il tuo Dio è bambino di strada umiliato, maltrattato, assassinato, bambina, ragazza, donna violentata, venduta, usata, omosessuale che si dà fuoco senza diritto di esistere, handicappato fisico, mentale, compatito, prostituta dell’Africa o dei paesi dell’Est, che tenta di sfuggire la fame e la miseria creata dai nostri stessi pesi... di qualsiasi Chiesa o setta non m’importa, egli sarà anche il mio Dio, perché manifestandosi negli ultimi è Amore».
Ecco, Rossella Seno canta l'Amore (o la mancanza d'Amore), che è tutt'altra cosa rispetto ai sospiri amorosi, gli abbracci e gli addii, lui che bacia lei che bacia me. Ma a dispetto dei temi impegnativi, alti, e della vocazione antagonista, è un'artista tutt'altro che meditabonda o seriosa. D'altra parte lei ha fatto un po' di tutto nella vita, dalla modella all'attrice, dopo aver studiato teatro (Avogaria a Venezia) e cinema (metodo Actors Studio a Roma). Anche se i più la ricordano soprattutto per le sue apparizioni nelle serie tv: Un posto al sole La dottoressa Giò, Il bello delle donne, Carabinieri, La squadra. Lei ci ride su, raccontando la fatica che ha dovuto fare per farsi prendere sul serio, cantando Piero Ciampi e la mitica Milly, arrivando finalmente a realizzare i dischi che aveva sempre sognato, da Pura come una bestemmia al recente La Figlia di Dio (prodotto dalla casa discografica Azzurra Musica, in collaborazione con l'associazione culturale Disobedience e il patrocinio della Comunità San Benedetto al Porto di Genova, fondata da don Andrea Gallo).
Vegana, militante, innamorata della vita, “la rossa di Venezia” sorride sempre, nonostante tutto (tutta la rabbia per come vanno le cose in questa società malata), è un fiume di parole a ruota libera (appassionate, sincere, mai addomesticate), un concentrato di energia contagiosa. Una cantattrice impegnata in cause sempre nuove (dall'Animal Live Aid al Calendario Solidale, passando per la onlus “Ti amo da morire” anti-femminicidio), innamorata di quella musica che voleva cambiare il mondo e le persone, e che lei interpreta oggi con la sua voce espressiva, da teatro-canzone.
32 LUGLIO 2023
I NCONTRI
(foto di Carlo Bellincampi)
Dicono che con la musica di qualità non si campa. Il nostro è diventato un mestiere per ricchi, se lo fai in un certo modo, badando ai contenuti. Oppure è un hobby, un secondo lavoro.
È musica fatta per durare, che non si presta al consumo usa e getta. Richiede la partecipazione emotiva di un ascoltatore complice.
Ma proprio per questo, perché vuole rimanere nel tempo, andrebbe trattata in un altro modo, con più rispetto. Parlo per me ma anche per tutti gli altri che fanno questo mestiere mettendo contenuti importanti nella loro musica. Non sono dischi che ascolti per una stagione e poi li butti. Hanno tempi lunghi, vanno ascoltati con attenzione. Sono convinta che potrebbero avere un mercato, se riuscissero ad arrivare al loro pubblico. I complimenti fanno piacere, per carità, anche le recensioni positive, però...
Amo la vita, la leggerezza. C'è stato un tempo in cui giravo con le treccine, vestita da Mago di Oz, e con la scimmietta. Potrei farlo ancora. Ma ciò non toglie il dolore che mi porto dentro, che è quello del mondo, oltre al mio
...però la musica è fatta per essere ascoltata, ti capisco. In compenso hai la soddisfazione di fare ciò che ami, senza tradire te stessa.
Quella l'ho avuta soprattutto per Pura come una bestemmia, nel 2020. Finalmente avevo fatto il disco che volevo. Ci ho messo tanto tempo. Non era facile avere un certo tipo di credibilità per una come me, che viene dalla televisione e che ha fatto tremila cose. Questo è un Paese in cui ciò che fai non viene visto come esperienza, anzi. Ti dicono: “Ecco, fa tante cose perché non sa cosa vuole fare”. Io lo sapevo benissimo, ma non me lo facevano fare. Avevo un'immagine troppo “leggera”, e la leggerezza viene spesso confusa con la superficialità. Mi spingevano verso un genere che non era il mio e che rifiutavo.
Tu però hai fatto cose importanti e impegnative anche a teatro.
Ma le ho fatte quando avevo già una bella età. Prima certe cose non me le facevano fare. L'Italia è un paese bizzarro, in cui l'immagine deve corrispondere al genere che fai. Lo disse anche Fiorella Mannoia in un'intervista. Chi fa musica impegnata, a quanto pare, deve avere un'immagine seriosa. Io negli anni scorsi, per provocazione, pur non essendo il mio genere, postavo delle foto quasi sexy, solo per far capire che anche se fai musica d'autore, sei comunque una donna, con la tua sensualità.
Colpa dell'epoca in cui viviamo. Siamo talmente assediati da musica, libri, immagini, che il supermercato del tempo libero ha bisogno di scaffali molto rigidi in cui collocare le cose e le persone, per riuscire a venderle. Tipo: “Musica leggera da consumare il sabato sera con gli amici”. Se fai altro, li lasci spiazzati.

Li spiazzi, infatti. A me è successo con Ciampi, che mi ha aperto la strada nella musica d'autore. Non sono stato io a cercarlo, è Piero che mi è venuto a cercare. Lo ha sempre fatto, come se avessimo un conto in sospeso, come se ci fossimo conosciuti in un'altra vita e mi dovesse qualche cosa, non lo so. Torna sempre nei momenti più difficili. Ho creato tempo fa un'associazione che si chiama Disobedience, e la prima cosa che ha fatto è stato uno spettacolo su di lui, perché il Premio Ciampi mi ha chiamato per una commemorazione.
Quando ho cominciato il percorso ciampiano, però, mi è stato chiesto di allontanarmi dalla televisione e da tutto quello che facevo, per non confondere le cose. Io non ci ho pensato un nanosecondo.
Tu ami farti interpreti di questi personaggi straordinari, ma poco frequentati dal grande pubblico odierno. Parlo di Ciampi, ma anche di Milly.
Milly è stata dimenticata, sì, e non sai quanto mi hanno ringraziata, soprattutto i giovani, per averla fatta riscoprire. Oltretutto ho portato in scena le sue canzoni più impegnate (contro la guerra, ad esempio). C'è un parallelismo tra i nostri tempi e quelli di allora. Da un certo punto di vista non è cambiato niente. La donna ha sempre bisogno di un appoggio maschile per fare determinate cose. Lei, con la sua forte personalità, aveva fatto tutto da sola, ma aveva le sue fragilità. Noi donne cosiddette forti ci portiamo un peso addos-
so... Ogni tanto ti viene da dire: mi dai una spalla?
Ma come diceva Milly, se ti appoggi alla spalla poi cadi, perché quello se scansa. Quando la gente vede che hai carattere, pensa che puoi sopportare tutto. Anzi, ti danno anche della “rompicoglioni”. Viviamo ancora in un'epoca maschilista.
Ti piace la definizione di cantattrice? Forse manca qualcosa: tu non scrivi le tue canzoni, ma sei comunque autrice della tua musica, nel senso che i temi li scegli tu, l'intenzione è chiara e forte, molto personale.
Quando si tratta di scrivere una canzone, io mi affido a chi lo sa fare. Nella vita bisogna anche sapersi affidare. Ma i messaggi e gli argomenti sono i miei. Anche la cover di De André (Si chiamava Gesù) l'ho scelta io. Sono io che decido il percorso, però poi individuo l'autore adatto a quel tipo di canzone.

34 LUGLIO 2023 35 LUGLIO 2023
(foto di Luca Brunetti) Rossella Seno
Pavone è più visionario, Caccamo è duro e ha un linguaggio assolutamente unico, provocatorio, Passante è più poetico... Di Allan Taylor ho eseguito una cover, grazie alla sua approvazione, La colomba (The Dove), ma successivamente gli ho chiesto di scrivere una canzone proprio per me e con mia grande gioia lui ha accettato subito. Mi ha addirittura chiesto di cosa volessi parlare, e gli ho risposto: “l'amore universale; voglio denunciare, portare alla luce ciò che non va". E così è nata Sing me, Cantami. Allan è una persona gentile e disponibile, ben lontana da certi divismi italiani.
Quando eri bambina cosa volevi fare da grande?
Volevo semplicemente riscattarmi. Sono nata in una famiglia in cui c'erano parecchi problemi. I miei si sono separati quando avevo 3 anni, e mia madre si è trovata
a crescere da sola tre figlie. Avevamo difficoltà economiche, anche se non mi è mancato mai nulla (come si dice in questi casi). Diciamo che non si è dato molto spazio alla “cultura” e questa cosa a me è mancata tanto. Ecco perché poi ho sempre cercato di andare verso quella direzione. Ho letto molto, mi sono informata, e ancora mi sento ignorante come una capra. Sì, probabilmente per me era una forma di riscatto. Forse è per questo che ho sempre voluto evitare le cose facili, leggere.
Ma qual era la cosa di cui non potevi fare a meno? La tua forma di creatività preferita?
Cantare, ma cose che avessero un senso. È stato così fin da subito. Volevo dare un significato a quello che facevo. Ho vissuto tanti anni di frustrazione, musicalmente parlando, perché non mi facevano cantare ciò che proponevo, e piuttosto che scendere a compromessi mi sono ritrovata a fare altro. Dovevo mantenermi. Ho fatto la direttrice di casting, le fiction, i fotoromanzi, la modella, un sacco di cose.
Hai fatto anche la corista in un programma di Pippo Baudo, Numero Uno.
Questa te la racconto bene, perché tanto ormai è caduta in prescrizione. Ho fatto il provino e sono stato presa. Mi sono fatta tre mesi di studio, ho registrato tutto, ho lavorato come una matta. Finché arriva la puntata zero. Mi mettono una minigonna, mi dicono “sorridi alla camera” e io mi dico: “Non gliela posso fa', non gliela posso fa'”... E lì mi sono “ammalata”. Quindi non ho proseguito. Se guardi le registrazioni, vedi una ragazza al posto mio che canta “ballo ballo ballo da capogiro”.
Molto indicativo di come sei fatta.
In realtà ho fatto anche delle porcate che “con la Seno del poi”, come dico io... Cose che non rifarei, credimi. Mi giustifica il fatto che a farlo fosse l’attrice. Era un ruolo, non ero io. È evidente come sia la musica la mia forma di espressione.
Oggi ti vedono tutti come un'artista impegnata
Sì, impegnata a complicarmi la vita.
Anche. Però una che ci mette la faccia. Che parla di cose di cui gli altri di solito non hanno voglia di parlare. Il bello è che poi tanti ti conoscono per Un posto al sole o La dottoressa Giò
Non credo sia tanto quello a fregarmi, quanto il fatto di amare la vita, la leggerezza. Mi piace cazzeggiare, non prendermi troppo sul serio. C’è stato un tempo in cui giravo con le treccine, vestita da Mago di Oz, e con una scimmietta. Ecco, potrei farlo ancora. Non sono cambiata. Ma ciò non toglie il dolore che mi porto dentro, che è quello del mondo, oltre al mio. È il mio modo di esorcizzarlo.
Ti piace se la gente ride quando sei sul palco di Sex in the City (era il 2006).
Non ho mai capito perché la gente cominciasse a ridere prima ancora che dicessi le mie battute. A volte mi succede anche per strada. Io cammino e la gente mi sorride. Evidentemente metto allegria. Faccio “simpatia”. La trovo una cosa bella.
Inviti alla felicità. Al dialogo.
Mi piace la gente. Mi interessano le vite altrui. E questo evidentemente viene percepito. Accade che, se sono alla fermata dell'autobus, nell’attesa, la gente mi comincia a raccontare la sua vita, per dire.
La prima cosa che hai fatto a teatro si intitolava La Rossa di Venezia.
Già. Ho debuttato a teatro con uno "one woman show". Non avevo realizzato cosa volesse dire finché mi sono ritrovata sul palco. A quel punto mi è presa la strizza, ho pensato che forse non ero in grado, che non lo volevo fare. Dovevo cantare, recitare, con Claudio Insegno che mi faceva fare la qualunque, andare su, andare giù, fare questo, fare quello.

Però non è da me tirarmi indietro, non me lo sarei perdonato e infatti ce l'ho fatta. Ero al Piccolo Ambra Jovinelli, teatro importante pur se piccolino. Lo abbiamo riempito tutta la settimana

37 LUGLIO 2023 36 LUGLIO 2023
Rossella Seno
Era teatro-canzone.


Sì, scritto con Giò Alajmo. Autobiografico. Ero nel periodo anti-berlusconiano. Uno spettacolo di denuncia. Ho debuttato così, con incoscienza. Si parlava di Venezia, c'era tanta roba mia, le mie problematiche con gli uomini. Era uno spettacolo anche divertente. Dovrei riprenderlo.
Te ne sei andata presto da casa tua.
Molto presto. Ho fatto prima Milano-Mestre per un periodo, perché lavoravo come modella a Milano. Poi sono
venuta in vacanza a Roma, dove sono stata accolta in un modo straordinario, tanto da decidere di trasferirmi. Mica era la Roma becera di adesso, si viveva per strada, c'era un confronto, uno scambio. C’è da dire che prediligevo gli ambienti gay , sono sempre stata attratta dalle personalità particolari, da tutto ciò che va fuori dagli schemi. Ecco perché sto vivendo molto male questo periodo, con la sua omologazione, il pensiero unico, e bisogna mangiare tutti le stesse cose, e vestirsi nello stesso modo, ma soprattutto pensare allo stesso modo. Proprio oggi ho letto di una serie di multe che hanno deciso di dare a chi va in bici, il mio mezzo di trasporto, e mi è partito un bellissimo “ma vaffanculo”. Se vai su Facebook lo trovi. Oggi è tutto una regola, un divieto, costretti dentro a quell’unico pensiero che poi è quello del profitto. Non del cittadino, ovviamente.
Tempi difficili.
L'avere ha preso definitivamente il sopravvento sull'essere. Quando la gente ti chiede “come stai?” in realtà ti sta chiedendo “cosa fai?”. Di certo non ti sta chiedendo “come stai dentro”. La mia “guru”, insegnante di teatro Beatrice Bracco, argentina, mi spiegò che dalle sue parti si fa così: ti chiedono “Come stai?” e la risposta è “Bene, o vuoi che ti racconti?”.
Tu affronti sempre temi impegnativi, dal femminicidio (lo spettacolo L'amore nero) alla guerra e la paura dello straniero. Racconti storie strazianti, come quella di Zohra, che non conoscevo.
La storia di Zohra mi ha colpito tantissimo. Quando ho letto quella notizia ho pianto. Già il fatto che una bimba a 8 anni faccia la domestica, nell'età in cui bisognerebbe giocare, studiare, l'età della leggerezza, della bellezza. Infanzia rubata. Poi ti massacrano di botte perché liberi due pappagallini.
Ora io non so se l’abbia fatto inconsciamente o volutamente. Magari quei due pappagallini liberi stavano a significare quella libertà che a lei era stata negata. Ma l'hanno massacrata di botte! Quando ho letto questa cosa, le ho giurato che l'avrei cantata. Ho trovato l'autore perfetto per quel tipo di testo, Passante. Non potevo lasciare che la sua morte rimanesse sconosciuta, che fosse avvenuta inutilmente.
Possibile che nel 2023 succedano ancora cose del genere?
La tua vita non ha valore se sei povero. E infatti si dice che se sei ricco non sei un immigrato, ma un viaggiatore. Si sta sempre più evidenziando questo squilibrio, questa spaccatura tra poveri e ricchi. Se non riusciamo a fermarla precipiteremo in una situazione irrecuperabile. Ecco cosa cerco di combattere.
Musicalmente parlando, le tue canzoni sembrano venire da un altro tempo. Ricordano il cantautorato alto (o altro).
Sono una signora anziana.
Sei ancora una ragazzina. Ma nella tua musica ci si trova De André, Branduardi, Guccini, il folk, la ballata e il passo di danza, chitarre, violini e flauti. Spesso sono narrazioni più che canzoni.
Ho voluto restituire alla canzone d'autore il suo ruolo, quello di stare al centro della musica, con dei testi importanti, che avessero un contenuto, capaci di scuotere le coscienze. Ultimamente la musica d'autore è considera-
ta la musica di uno che se la canta e se la suona. Io sono rimasta a quella che ha un ruolo ben preciso e che ha smarrito.
Oggi la canzone d'autore di un tempo è solo un repertorio su cui mettersi alla prova.
Si è aperta a un mondo più leggero, pop, mainstream. Per me invece continua ad essere quella dei Gaber, De Gregori, Fossati, Leonard Cohen, quelli che hanno affrontato le tematiche più disparate, mettendoci a confronto con ciò che non va. Credo che il mio sia un “disco d'altri tempi” ma assolutamente attuale, per i temi che affronta. Pensa a Cantami, l'orrore della guerra che sta avanzando, mentre noi siamo ignari, forse anche ignavi. La gente non capisce che stiamo rischiando grosso. La guerra è molto più vicina di quanto possiamo immaginare e questa cosa mi spaventa tanto.
Spesso si usa l'impegno come fosse una sorta di ingrediente da inserire nel bouquet, il disco-calderone. Nel tuo album, invece, sono tutte canzoni “impegnate”. Sembra più una ragione di vita.
39 LUGLIO 2023 38 LUGLIO 2023
Ho voluto restituire alla canzone d'autore il suo ruolo, quello di stare al centro della musica, con dei testi importanti, capaci di scuotere le coscienze
Rossella Seno
Infatti quando parlo del mio mestiere dico che è una missione. Se fosse un mestiere, ci dovrei vivere bene. Non potrei fare altro. Mi è stato anche proposto Sanremo, anni fa, ma (non vorrei essere ripetitiva) quello che voglio non è semplicemente “cantare”. Voglio portare alla luce determinate situazioni e storie.
Penso ad esempio a quella di Dj Fabo, il tema dell'eutanasia, che è un nostro diritto: non può essere lo Stato, o la Chiesa, a decidere della mia morte. Se io non ho più una vita dignitosa e voglio andarmene, io me ne vado, non puoi obbligarmi a non farlo.
Hai citato Sanremo. Ma davvero non ti è mai venuto il desiderio di una grande ribalta?
No. Anzi, mi fa paura un palco del genere. Non ho mai avuto l’ idea di sfondare nel mondo della musica. La musica è un veicolo per portare il mio messaggio. Sono la Figlia di Dio... (ride)
Quella è una bellissima canzone.
Ti spiego come è nata. Nella copertina di Pura come una bestemmia ci sono io col Cristo in croce, non volevo essere né blasfema né provocatoria, solo sottolineare che “siamo stati tutti messi in croce” (dal consumismo, dal dio profitto, non c'è scampo né per noi né per la natura, tanto che nel retro copertina la croce è piantata su un mare di rifiuti). Quando l’ha vista Siriani mi fa: “C'è una canzone che ho scritto, ma che è già stata data a un'altra cantante, che sarebbe stata perfetta per questo disco”. Me la fa sentire, leggo il testo e mi dico: deve essere mia! Ho messo in atto una vera e propria forma di stalkeraggio, l'ho lavorato ai fianchi, finché a un certo punto si è arreso e mi ha detto: “La canzone è di chi la canta per prima”, e così me l'ha data. Solo dopo averla incisa ho scoperto che l'aveva scritta dopo aver visto Dio esiste e vive a Bruxelles, film che ho amato tantissimo. Condivido l'idea di questo Dio perfido, cattivo, vendicativo. Sai, con Dio ho un rapporto molto strano. A volte gli dico: scendi! Parliamone! Soprattutto in quei periodi in cui te ne capitano di ogni. Bella la figura di Ea, salvatrice del mondo. È convinzione di Siriani che solo una donna possa sopportare quella fatica, quel dolore, da cui l'idea di un Gesù donna. Nel mio disco, cosi come nella mia mente, continua a rimanere uomo, ma questa figura femminile salvifica mi attrae non poco.
La copertina di Pura come una bestemmia un po' blasfema lo è, ma in senso positivo. C'è la bellezza, la purezza della tua immagine, ma anche la bestemmia, il sovrapporsi del tuo corpo nudo a quello sofferente di Cristo. A volte una bestemmia, un urlo di rabbia, un “perché?” gridato dalle profondità del proprio essere, è più religioso di un'appartenenza tiepida e ipocrita che tradisce il messaggio evangelico.
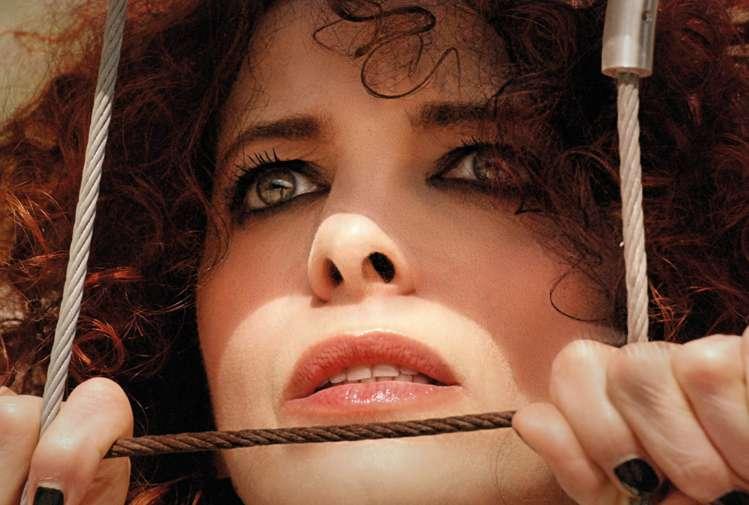
Era un po' anche questo: contro l'ipocrisia di quelli che vanno in Chiesa e si sentono buoni, ma poi quando escono se la prendono con il ragazzo di colore. In effetti quel disco, come quest’ultimo, era un grido d'aiuto. Tutte le mie canzoni lo sono. Dico: prendiamoci per mano! Se non facciamo qualcosa, andiamo incontro a un mondo che non ha un senso. Pensa a quei ragazzi che hanno ucciso un bambino di 5 anni e i genitori dicono “si sistema tutto, è stata una bravata”. Questo ti fa capire la pochezza che sta regnando. Siamo dentro un grande inganno, quello dei like. Che ti puoi comprare. Ieri mi è arrivata un'offerta: ne compri tot pagando un certo prezzo. Io forse avrò pochi like, ma almeno sono veri. Ormai compri tutto. Un mondo di ricchi per ricchi.
La tua religiosità è alla don Gallo, una fede anticlericale.
Infatti don Gallo è ben presente nel disco. Ma potrei citare anche don Ciotti, un altro prete che a me piace molto, quelli che vanno un po' fuori dagli spazi della Chiesa.
Tu sei credente? La spiritualità, nelle tue canzoni, c'è, anche il senso del sacro.

Credo in “un'entità”. Se non ti aggrappi a qualche cosa, come fai? Un senso lo devi dare a questa vita che non è una passeggiata. Ma guardando come tutto funziona, in un mondo in cui il più forte deve avere il sopravvento sul più debole, come accede in natura, in cui nessuno ha una vita facile, in cui tutto è molto faticoso, a volte mi dico: se è un Dio a creare e gestire tutto questo, mi viene da pensare che non sia buono.
Però canti la possibilità di un “nuovo sentimento”, una speranza di bontà.
Perché credo nel bene. Ma Dio è il bene? A questo non so dare una risposta. Vogliamo che il male sia il demonio? Va bene. Lo faccio parlare in Un tempo immondo e gli dico che vinceremo sul suo nero, perché siamo più forti. Ma questa cosa la devi far percepire alla coscienza delle persone, che non riescono più a distinguere il bene dal male. Dio deve essere il bene, ma quello che ci viene raccontato dalle istituzioni non lo è.
Certe tue canzoni sembrano salmi biblici. La denuncia del male, la disperazione, che però si apre alla luce.
40 LUGLIO 2023
Rossella Seno
Il rispetto verso gli animali, la natura, non è una cosa che ho deciso. È una cosa che sento. Di cui non posso fare a meno. Ero vegana quando il veganesimo ancora non esisteva. In tournée facevo la fame


Hai visto il film Il Corvo? Lui ad un certo punto dice: “Sento addosso tutto il dolore del mondo”. È una battuta che sento molto mia. Io sento davvero il dolore addosso, nulla mi lascia indifferente. Sento perfino i terremoti: un attimo prima che arrivino, comincio a sentirmi male, mi viene da piangere, sono frastornata. Ti racconto una cosa stranissima che mi è successa, quando vivevo in via degli Scipioni. C'era una piccola piantina a cui forse avevo dato troppa acqua, che si era ammosciata. L'ho tagliata, ho lasciato due tre foglioline cascanti, poi sono andata a dormire e ho sognato questa pianta che tornava a essere rigogliosa, con le foglie all'insù. Quando mi sono svegliata, dimenticandomi del sogno, sono andata alla finestra e ho visto la pianta esattamente come l'avevo sognata. Si era ripresa! Non saprei spiegare a parole la sensazione che ho provato.

Tu sei molto legata alla natura, gli alberi, gli animali.
Se tu mi regali un fiore ti ringrazio, ma non mi fai un vero regalo, perché il fiore che hai reciso, lo hai ucciso. Il mio rispetto verso gli animali, la natura, non è
una cosa che ho deciso. È una cosa che sento. Di cui non posso fare a meno. Qualche giorno fa mi hanno chiesto da quando sono vegana: lo sono da una ventina d'anni, e vegetariana da trenta. Ma quando io ero vegana, il veganesimo ancora non esisteva. Ho fatto la fame, soprattutto in tournée. Ma non potevo più mangiare certe cose. Tutto quello che faccio e dico non è mai ponderato, mi viene, la sento.
Come hai vissuto la vicenda dell'orsa in Trentino? Tu hai anche contribuito al progetto “Il cielo degli orsi”.
Ho inciso una canzone sugli “orsi della luna”, contro le “fattorie della bile” (gli allevamenti intensivi di orsi tibetani, rinchiusi in gabbie strettissime per estrarne la bile, ingrediente molto utilizzato nella medicina cinese, ndr). Quando ho visto i documentari che ne parlano, mi sono sentita male. Orsi con organi che andavano in putrefazione, in gabbie che non riuscivano a contenerli. Gli segano le unghie e i denti, per evitare che si suicidino. L'uomo è capace di tutto.
L'orsa del Trentino? Ho scritto al sindaco. Sulla sua bacheca ci sono anche i miei insulti. Non sono stata zitta, sono andata a dirgli direttamente ciò che pensavo. A parte il fatto che ormai si è capito che non è stata quell'orsa a uccidere il ragazzo, davvero non riesco a capire il suo odio. Ma che problemi ha? Ha subito un trauma da piccolo? Ne stanno uccidendo un sacco, ormai. Ogni giorno trovano un orso morto. In Abruzzo invece li vedi che camminano per strada, tranquilli, sereni. È una caccia alle streghe. Adesso c'è anche Cruciani che si mangia la carne d'orso...
Lui si diverte a provocare.
Lo so, conosco benissimo Giuseppe e mi dispiace per lui, perché alla fine se la gioca male. Potrebbe provocare in modo più costruttivo.
Si è scelto la parte del libertario contrario a tutte le regole, le restrizioni, i moralismi, il cosiddetto “politicamente corretto”.
Sono d'accordo sull'essere libertari, anti-moralisti e anti-conformisti, ma allora dovrebbe diventare vegano, perché quello sì che significa disobbedire, disobbedire a una regola, a una catena alimentare imposta negli anni. A quel punto sei tu che stai alle norme imposte e al pensiero unico. Così come in tante altre cose. Pensa alla guerra. Non puoi andare fuori dalla narrazione corrente. Se dici qualcosa contro Zelensky diventi putiniana. So benissimo che Putin è un dittatore, è talmente evidente, ma metto in dubbio la figura dell’eroe Zelensky, osservo il fatto che dietro ci siano altri interessi, legati agli Usa e alla Nato. Queste cose però non le puoi dire, perché vieni bannata. Ma sai che c’è? Le dico lo stesso!
Qual è la tua “redness”, ciò che ti dà la forza di alzarti la mattina?
Devo avere sempre un obiettivo, un progetto. La vita, per quanto sia difficile, è sempre bella da vivere. Già il fatto che ti alzi è tanta roba. Però sai anche che a differenza di prima dovrai affrontare una serie infinita di problemi. Giusto ieri mi hanno chiesto qual è stato il giorno più bello della mia vita. Ho risposto: credo che debba ancora arrivare.
La risposta della pessimista.
No, al contrario! Non voglio pensare che il bello sia già avvenuto! Ho vissuto dei momenti felici ma sono possibilista: confido in qualcosa di ancora più bello. Cosa mi fa alzare la mattina? Un disco da promuovere, spettacoli da fare, nuove idee da realizzare. Con Disobedience mi piacerebbe creare un luogo di aggregazione, dove unire le persone di qualsiasi età, estrazione sociale, etnia, un luogo culturale, ma nel centro della città. Perché in realtà, oggi, è in centro che mancano le cose. Qui sono tutti abituati solo a lavorare, correre, non fermarsi mai. Fermiamoci, ogni tanto. E guardiamoci l’un l’altro. (f.t.)
43 LUGLIO 2023 42 LUGLIO 2023
Rossella Seno
"Cara Milly"
"La Rossa di Venezia"
Hesse e l'arte di diventare umani L'Oriente come patria dell'anima
VIAGGIO TRA LE SUE OPERE (E LE SUE FOTO), OLTRE L'EQUIVOCO DELLO SCRITTORE-GURU. UN "RIVOLTOSO CONSERVATORE" SEMPRE IN CAMMINO
«Se guardo indietro, tutta la mia vita è stata sotto il segno di questo desiderio di poteri magici; come io a poco a poco abbia mirato a trasformare non più le cose, ma me stesso, come poi abbia imparato a cercare di sostituire la goffa invisibilità del mantello magico con l'invisibilità del saggio che, pur
conoscendo, rimane sempre sconosciuto: questo potrebbe essere il vero contenuto della storia della mia vita»
Scriveva così, Hermann Hesse, ai tempi dell'Infanzia del mago. Era solo a metà del suo cammino, ma quell'intuizione valeva tutta una vita (tutta l'opera di una vita). D'altra parte, da ragazzo, uscendo dall'incubo del seminario di Maulbronn, mentre scopriva la libertà e la scrittura, si era convinto (con Novalis) che «diventare un essere umano è un'arte»

Hesse nei suoi romanzi ha sempre fatto dell'autobiografia, ha raccontato la sua ricerca di sé, le umanissime debolezze e le intuizioni profonde, la tirannia degli istinti e il richiamo dell'assoluto, dell'infinito. Ecco forse dova sta la forza e la bellezza dei suoi romanzi, la loro capacità di parlare a chiunque. Sta in quella continua ricerca interiore, così come nella meta vagheggiata, incarnata in un Oriente che «non era soltanto un paese e un'entità geografica, ma era la patria e la giovinezza dell'anima, era il Dappertutto e l'In-Nessun-Luogo, era l'unificazione di tutti i tempi».
Il rischio, ancora oggi, quando si parla di lui, è quello di farne un guru, un santino, un generatore di frasi edificanti. Intorno alla sua figura sono sorti vari equivoci e appropriazioni forzose, oltre a vertiginosi alti e bassi dal punto di vista della fama letteraria, dal Nobel che consacrò la sua opera ai giudizi sprezzanti che la critica ha spesso riservato a questo autore straordinariamente (fastidiosamente?) popolare.
Il saggio che gli dedicò Giorgio Cusatelli nel 1991, ancora oggi è un ottimo antidoto a questi eccessi, una rilettura equilibrata e un'efficace premessa per chiunque voglia ripercorrere la sua opera.
Torna l'ottimo saggio di Giorgio Cusatelli, in un libro Studio Tesi (Mediterranee), con un ricordo del figlio Heiner e tante belle immagini
La nuova edizione del suo Hermann Hesse (Edizioni Studio Tesi, quindi Edizioni Mediterranee) ha anche il pregio di essere affiancata da un testo del figlio Heiner, il secondogenito, scomparso nel 2003, dopo aver presieduto per anni la fondazione dedicata al padre. Un breve saggio che racconta l'amore di Hermann Hesse per l'Italia, ricordando i testi biografici dedicati a san Francesco e Boccaccio, le storie ambientate a Como o Firenze, ma anche gli aneddoti famigliari. Sottolineando che lui «non appartenne alla schiera degli entusiasti che venerarono la grandezza di Roma». Amava l'arte e la storia

del Paese, ma anche la sua umanità: «Non trascurava mai di familiarizzare con la gente del luogo, di scherzare con i bambini e di scambiare quattro chiacchiere con l'oste o gli avventori di qualche bettola».
Altro merito di questa nuova edizione è l'abbondante repertorio iconografico, che ripercorre la vita dell'autore. Ci sono immagini dei genitori e delle case in cui ha vissuto, gli amici artisti e letterati, le donne che ha amato e sposato (tre matrimoni), i figli, i luoghi importanti per la sua formazione.
45 LUGLIO 2023
M EDITAZIONI 44 LUGLIO 2023
di Alba Daya (immagini @ Gruppo Editoriale Edizioni Mediterranee Hermes Edizioni, Arkeios Edizioni, Edizioni Studio Tesi, Roma 1991/2023)
Hesse a Fiesole nel 1906, in uno dei suoi numerosi soggiorni in Italia. A fianco, un foto-ritratto del 1954
«La vita dell'anima di un occidentale appare primitiva e in balia del caso se la paragoniamo alla religiosità protettiva, fiduciosa degli asiatici»
Ci sono soprattutto vari ritratti fotografici, che ci possono dare l'impressione di intuire chi era davvero Hermann Hesse, la sua fame di luce e verità spirituale, le sue ombre dolorose, andando oltre il muro di chiacchiere che circonda la sua opera e la sua biografia (a proposito, è utile e abbondante la cronologia introduttiva che associa la sua vita ai più importanti eventi storici e culturali dell'epoca).



Il testo di Cusatelli non intende indagare la vita di Hermann Hesse. Non troverete dettagli pruriginosi o considerazioni melodrammatiche. L'essenziale è dato per scontato: l'educazione pietista (oppressiva), la salute cagionevole che lo perseguiterà per tutta l'esistenza, il tentato suicidio giovanile (la follia lambita, le cliniche, i problemi psichiatrici), le ricadute nella depressione, la
scoperta dell'Oriente (e del vegetarianesimo), l'ingresso nella società letteraria, le fughe e i ritorni, il pacifismo durante la Prima guerra mondiale, la sorte dei suoi libri durante il nazismo (prima stimati, poi censurati), la sua scarsa propensione a prendere una posizione politica. In compenso c'è l'essenziale, il tentativo di capire il mondo che si agitava dentro e oltre le sue parole. Per chi non lo sapesse, Giorgio Cusatelli (scomparso nel 2007) è stato un grande germanista, oltre che un protagonista della scena editoriale italiana, per il lavoro svolto alla Garzanti (Quirino Principe ha dedicato bellissime pagine alla sua immensa cultura e alla sua instancabile professionalità) e poi come docente di Lingua e Letteratura tedesca in varie università.
Niente di più efficace delle sue stesse parole per riassumere il senso del saggio: «Votato alla sobrietà, esplicito, esso non propone, per Hesse, quel “vivere inimitabile” che l'epoca pretendeva dai suoi eroi, né contribuisce a quel leggendario che ne fa oggi, per molti giovani, una sorta di santo. Restituisce piuttosto un individuo, con tutta la sua impulsività, alle contraddizioni di tempi ovunque terribili, segnati dalla bruta violenza e dall'inganno; profila la solitudine dell'intellettuale, insieme inerme e vittoriosa; ammette, se occorre, le lacune e le incertezze dell'artista».
Ma è anche efficacissimo nel tratteggiare in poche frasi le fondamenta dell'uomo, dalla “madre rassegnata” al “padre esitante”, passando per il “nonno irradiante magia”. Dopo la fuga dal seminario, il suo approdo fu una libreria di Tubingen, dove faceva il commesso. Non era certo un lavoro di prestigio, ma gli permise di mettere via i soldi per il suo primo viaggio in Italia (insieme alla vendita di un librino improvvisato per gli amici, con suoi scritti ad hoc). Hesse conobbe «la libertà inebriante dell'autodidatta», cosa che, in un certo senso, la “società letteraria” non gli ha mai perdonato del tutto. Come il paradosso del suo carattere, quel suo essere un «un rivoltoso mosso da fini di conservazione».
Il viaggio in Asia gli aprì gli occhi su ciò che l'Occidente stava inesorabilmente e drammaticamente perdendo, infilandosi sulla stretta via dell'intellettualismo e del materialismo: «Tutto l'Oriente si alimenta di religione così come l'Occidente si alimenta di tecnica e di razionalità.
La vita dell'anima di un occidentale appare primitiva e in balia del caso se la paragoniamo alla religiosità protettiva, coltivata, fiduciosa degli asiatici».
Il suo pacifismo, spiega Cusatelli, è strettamente legato alla spinta universalistica. Il suo amore per l'Oriente non diventò mai vago e apologetico orientalismo, al di là di ciò che ne possono pensare gli hippy o i simpatizzanti new age. In compenso non fece mai mancare le sue «veementi denunce contro la società di massa, l'organizzazione scolastica che emargina il singolo, i valori cristiani sottoposti a burocratizzazione» (il celeberrimo Siddharta fu la sua definitiva “liberazione da ogni dogma”).
Tutto comincia da Peter Camezind e da un sentimento che in molti conoscono ma tendono a sottovalutare: «Sentivo che un giorno o l'altro la vita m'avrebbe dovuto riversare ai piedi una straordinaria felicità ridente, la gloria, forse l'amore, che avrebbe placato i miei confusi desideri, facendo di me una persona migliore». Hesse, per cercarla, è passato dalla psicoanalisi al sorriso di Buddha, dalle fantasie del mago-poeta, la disposizione al mitico e al leggendario, alle fatiche del viandante pellegrino, dall'immersione nella natura all'ascetismo «libero e gioioso» di Francesco, «esempio di perfetta realizzazione dello spirito».
E l'ha cercato scrivendo, naturalmente, e dipingendo, con risultati alterni (Cusatelli non ha nessuna remora nell'osservare i limiti della sua scrittura, quando ci sono). Mentre si manifestava, sempre più chiaramente, la sua disposizione religiosa, molto lontana dal soffocante pietismo a cui era stato educato. Che trovava nell'Oriente non una fuga esotica – ecco l'equivoco del successo di Hesse negli anni Settanta – ma la possibile fondazione di un modo diverso di essere Occidente: «Noi ci rechiamo verso il Sud e l'Oriente, spinti da un oscuro presentimento di patria, e troviamo qui il paradiso, la pienezza e la ricca abbondanza di ogni dono della natura, troviamo gli schietti, semplici e infantili uomini del paradiso. Ma noi qui siamo stranieri e senza cittadinanza, da gran tempo abbiamo perso il paradiso, e quello nuovo che abbiamo e che vogliamo costruire non è da cercare all'equatore o nei mari caldi d'Oriente, ma si trova in noi stessi e nel nostro nordico futuro».
47 LUGLIO 2023 46 LUGLIO 2023
«Sentivo che un giorno o l'altro la vita m'avrebbe dovuto riversare ai piedi una straordinaria felicità ridente»
In alto, Hesse e il figlio Bruno in una foto del 1908. A fianco, lo scrittore a Monaco nel 1907. Nell'altra pagina, in villeggiatura a St.Moritz (insieme a Thomas Mann) nel 1932
«Gli uomini vivono per lo più in un mondo così irreale perché prendono per reali le immagini esterne e non lasciano parlare il loro proprio mondo. Ma quando si viene a sapere l'alternativa, non si ha più la scelta di mettersi per la via dei più»
È con Knulp che Hesse entra nella “maggiore età” letteraria, e come scrive Cusatelli c'è «l'acquisizione dell'immagine, inconfondibilmente mistica, del ricongiungimento con la potenza generatrice, dell'attraversamento delle nubi sino alla luce della verità». Che qui
passa dalla commovente bellezza della caducità, più che il rigido splendore accecante dell'eternità. Poi arrivano le sue Fiabe fuori da ogni convenzione (anche se con qualche spiritualismo alla moda), il pittore Klingsor «che vuole capire e possedere il cosmo nella sua totalità», fino all'intuizione di Siddharta, destinato a diventare una sorta di testo spirituale, ad uso devozionale, per intere generazioni. La (ri)scoperta del divino nell'umano, dentro «una cosmologia fondata sull'ordine, sull'armonia, sull'incardinamento dei segmenti individuali ad un logos prestabilito dal divino».
Hesse è lo scrittore dell'interiorizzazione della realtà. Come scriveva già in Demian: «Le cose che vediamo, sono le stesse che abbiamo dentro di noi. Gli uomini vivono per lo più in un mondo così irreale perché prendono per realtà le immagini esterne e non lasciano parlare il loro proprio mondo. In tal maniera si può essere felici, ma quando si viene a sapere l'altra alternativa, non si ha più la scelta di mettersi per la via dei più». No, non si ha più la scelta dopo aver intuito la realtà superiore riflessa nell'interiorità dell'anima. A quel punto la ricerca diventa una questione di vita o di morte, di felicità beata, divina, o disperazione. Perché intorno c'è solo caos, come sa il Lupo della steppa, c'è quel crollo dei valori umanistici che fa intuire ad Hermann Hesse lo strapotere della società di massa e l'affermazione dei regimi totalitari. “L'apostolo della totalità” non poteva che essere fermamente anti-fascista (da artista, non da militante), ma nel secondo dopoguerra sarà anche preoccupato dall'americanizzazione del mondo, dalla massificazione del cittadino-consumatore, così come dal blocco sovietico, l'appiattimento dell'individualità nel nome del collettivo, la cancellazione dello spirituale e dell'interiore.
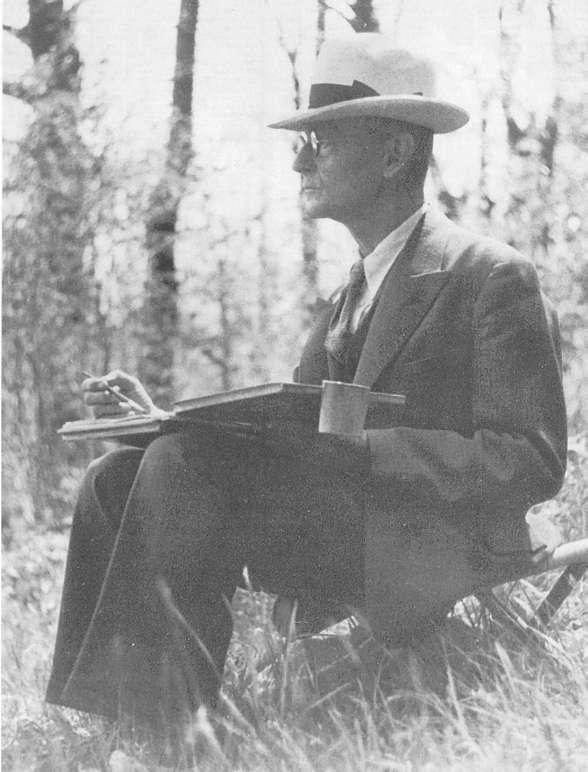

L'artista-cercatore, nel frattempo, prosegue nella usa autoformazione, si sdoppia in Narciso e Boccadoro, nella contemplazione e nell'estroversione, solo per trovare una possibile conciliazione, dentro il Medioevo, tempo mitico dell'unità cristiana. Oppure in Oriente, in un pellegrinaggio «immaginato come itinerario di edificazione, secondo un modulo antico, di antica e perduta religiosità» (scrive Cusatelli). Hesse dovette assistere «all'umiliazione dei principi, alla distruzione della natura, alla mercificazione dell'arte». E la sua risposta fu un libro straordinario come Giuoco delle perle di vetro In cui sembrava abbandonare definitivamente l'idea di una ricerca spirituale solitaria, e la comunità già idealizzata ne Il pellegrinaggio d'Oriente «diventa vagheggiamento di un'accademia» che sa di utopia. Scrive Cusatelli che quel romanzo ha il «fascino dell'incompletezza che lo aiuta a negare alla sua storia un approdo e ad immaginarla, oltre l'ultima pagina, come un movimento perenne, un cammino da proseguire senza sosta verso una meta che, recedendo via via, conferisce ad esso costante necessità». Ecco cosa ci attrae nell'opera di Hesse. Tutti noi siamo in cammino verso quella meta. Ognuno con la sua “bil-
dung”, il suo processo di formazione, che parte quasi sempre da uno strappo (i valori imposti) e deve scoprire che la soluzione non è un luogo, una parola, un ruolo, ma è un'attitudine, un'apertura, una consapevolezza del presente (l'eterno presente). Prendendo in prestito le parole di Cusatelli: «Dopo la successione delle prove iniziatiche, la metafora dell'ottenuto ricongiungimento con l'assoluto è, sul volto di Siddharta ormai simile a quello del Buddha, il segnale d'una imperscrutabile onnicomprensione, “il sorriso dell'unità sopra il fluttuar delle forme”».
Quella meta è reale, Hesse l'ha intuita, forse sperimentata, per poi perderla e ritrovarla ancora. Quell'unità che sta sotto l'apparenza della moltitudine. «Non vide più il volto dell'amico Siddharta, vedeva invece altri volti, molti, una lunga fila, un fiume di volti, centinaia, migliaia di volti, che tutti venivano e passavano, ma pure apparivano anche tutti insieme, e tutti si mutavano e rinnovavano continuamente, eppure erano tutti Siddharta”».
49 LUGLIO 2023 48 LUGLIO 2023
Hermann Hesse e il musicista Othmar Schoeck durante un viaggio in Italia nella primavera del 1911. A fianco, lo scrittore mentre dipinge un'acquarello nel '37
Prima vedi la mano, che sembra quasi sporgersi oltre il quadro, in modo vagamente minaccioso. È una richiesta di aiuto? Un gesto magico, ipnotico, illusionista? Un appello a chi guarda, provocatorio, perché non pensi di poter rimanere nascosto nel suo cantuccio riparato, al di qua del quadro? Dietro la mano, vedi il volto in ombra, inquietante, e la camicia aperta. La tela non dovrebbe stare lì, in mezzo, a ostruire lo sguardo. In alto fluttua il volto fantasmatico della moglie Gala. I suoi occhi sono anche finestre (un edificio coloniale? Ma anche il corpo di un asino).
Personaggi sparsi, senza volto, che si fondono con il paesaggio, il deserto e profili di montagne, colori che sembrano irreali, anche se ricordano il mondo come lo conosciamo (o come lo immaginiamo?).
È questa la surrealtà. Una realtà superiore. E interiore. Che sembra quasi fluttuare sotto i nostri occhi, dentro di noi. Un luogo dello spirito che è più vero del vero.
Il quadro si chiama Impressioni d'Africa e lo ha realizzato Salvator
Dalì nel 1938. È una delle opere più affascinanti e stranianti tra quelle esposte nella mostra al Mudec dedicata al surrealismo. Una di quelle che riescono ancora ad aprire porte segrete, a spalancare finestre verso non si sa bene dove. Se lo sapessimo, saremmo ancora nell'ambito del noto e del consueto, del significato esplicito e razionale, proprio ciò che il surrealismo rifuggiva per principio.


Percorrendo le stanze della mo-
stra milanese, è facile imbattersi in qualche lavoro che, a posteriori, risulta ovvio, scontato. Quel tipo di provocazione che è diventata quasi un'abitudine. Quel gesto pittorico avanguardista che i posteri hanno trasformato in accademia. La libertà da tutti i codici – indispensabile, a inizio Novecento, per lanciare un messaggio di liberazione, di rivolta interiore - destinata a scivolare verso la maniera, a tratti puramente concettuale.
Ma poi ti imbatti in Veleno di Magritte e rimani folgorato dalla semplicità con cui riesce a suscitare un sentimento di malinconia e di stupore. Un gouache su carta (del 1939) che per due terzi è solo nero, il buio di un agglomerato di case, il cui profilo si staglia sul cielo al crepuscolo, insieme a un albero spoglio, puri segni grafici dentro un'esplicita bidimensionalità. Il giallo delle finestre è caldo, l'interno delle case è un segmento di luce artificiale ma accogliente. Ma ciò che rende il quadro misterioso ed eloquente è quel cielo che si disegna nel buio delle case, la luna che si accende come un segno, l'illustrazione di una forma ancestrale, e un tappeto di stelle sceso dal cielo all'ombra delle case, nei luoghi segreti della vita.
“Facile”, si potrebbe anche pensare, se non fosse così magico.
C'è chi riduce il surrealismo a un movimento, un insieme di opere collocate nel tempo e nello spazio, un capitolo nei manuali di storia dell'arte. Quando in realtà la sua attitudine visionaria e incantata, lo spirito (intimamente, oltre che so-
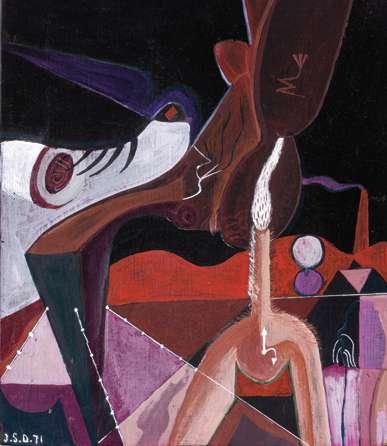
cialmente) rivoluzionario, ha continuato a produrre frutti (e continua tuttora).
Vedi ad esempio il magnifico Erotic
di Jan Schlechter Duvall – ricordiamo i suoi celebri bellissimi ritratti – che dice chiaramente senza mostrare (quasi) niente, svolgendo il desiderio in geometria dei sensi, forme e colori, ricordandoci quanto è stato importante il tema ante-litteram della liberazione sessuale.
50 MESE 2022
C'È ANCORA UN MESE DI TEMPO PER VEDERE LE OPERE DI DALÌ, MAGRITTE, MAN RAY E MOLTI ALTRI, AL MUDEC DI MILANO
Il surrealismo? Uno stile di vita Tra sogno e "bellezza compulsiva"
E VENTI
UN MODO DI GUARDARE LA REALTÀ, PER UNA "RIVOLUZIONE DELLA MENTE" E DELLA SOCIETÀ BORGHESE
(foto Carlotta Coppo)
(foto Carlotta Coppo)
Jan Schlechter Duvall, Erotic 1971 Olio su tavola, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
«Dobbiamo imparare a leggere e guardare con gli occhi di eros – scriveva Breton, in tempi tragici, nel 1941 – al quale spetta il compito di ristabilire, in futuro, l'equilibrio rotto a vantaggio della morte».
Oppure vedi Spiegare gli enigmi, opera recentissima, datata 2009, che ha il merito di ricordarci l'arte di Jacques Lacomblez (per noi, uno dei pezzi migliori esposti a Milano, anche a confronto con gli antenati eccellenti): cosa raccontare di queste forme, segni e colori, che parlano direttamente all'inconscio (ma qui sarebbe meglio dire il “superconscio”), con una tavolozza che sembra attingere alle sfumature di un'altra dimensione, il suo reticolo di linee che disegnano una geografia della possibilità infinita, i suoi simboli ancestrali che si muovono dentro il quadro come in una cerimonia sacra notturna, un allineamento cosmico (o interiore), intorno a uno spazio di luce informale.
OFFICAECTO ET OCCUM
Ore), promossa dal Comune di Milano e curata dalla storica dell'arte Els Hoek (museo Bojimans) insieme ad Alessandro Nigro, docente della Storia della critica d'arte a Firenze – ha soprattutto il merito di ricordarci che il surrealismo non era un movimento strutturato, un insieme di artisti che si riconoscevano in uno stile o in una tecnica, ma era soprattutto un modo di guardare e vivere la realtà. Ecco cosa è interessante, ancora oggi, per noi, che abbiamo conosciuto (assimilato, rielaborato) le avanguardie storiche, siamo sopravvissuti al “secolo breve” e al post-moderno, e ci ritroviamo dentro una realtà (in gran parte digitale e virtuale) che in teoria dovrebbe aver assimilato le istanze culturali, sociali, se vogliamo anche spirituali, del surrealismo.
Il riferimento principale era quello all'inconscio. Come scrive Els Oak, nel catalogo della mostra, «concentrandosi su sistemi di pensiero e di esperienza rifiutati dalla società convenzionale, Breton presentò il Surrealismo come la via a una realtà diversa e più ampia. I surrealisti miravano ad accedere al “funzionamento reale del pensiero” attingendo alla mente inconscia, sfuggendo così ai confini limitanti della ragione, dell’estetica e dei codici sociali o morali».

C'
è ancora un mese di tempo (fino al 31 luglio) per visitare la mostra “Dalì, Magritte, Man Ray e il surrealismo”, che ha portato a Milano i capolavori del museo Boijmans Van Beuningen, di Rotterdam, messi in dialogo con i pezzi conservati al Mudec. Perché il surrealismo, nel suo furore anti-razionalista (e quindi sostanzialmente anti-occidentale), aveva dato molta importanza alle culture indigene, ai manufatti amerindi, agli Inuit, alle civiltà dell'Oceania, a tutto ciò che poteva evocare il senso del meraviglioso e del soprannaturale.
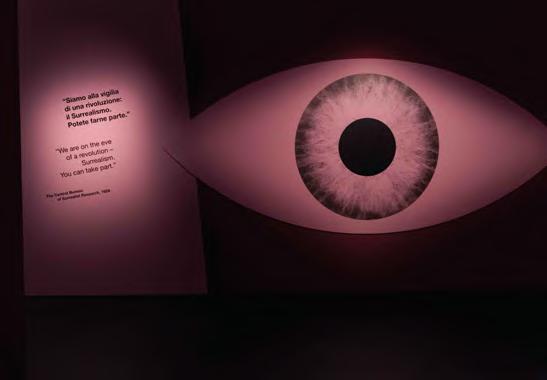


Ma la mostra del Mudec – prodotta da 24 Ore Cultura (Gruppo 24
André Breton, quando scrisse il “Manifesto del surrealismo” (in mostra trovate l'originale del 1924), prendendo in prestito una parola utilizzata per la prima volta da Apollinaire nel 1917, si appellò all'onirico e all'irrazionale, alla follia, all'universo del meraviglioso.
Si trattava di espandere la realtà conosciuta, di abbattere i muri del razionalismo e del materialismo. Con l'idea di rivoluzionare l'esistenza dei singoli e della collettività, suggerendo un nuovo modo di stare nel mondo. Si trattava di agire, attraverso ogni modo possibile, per «provocare e minare i principi “razionali” che governavano la società europea. Attraverso il loro lavoro, i surrealisti speravano di avviare una rivoluzione della mente, che avrebbe infine portato a un profondo cambiamento sociale e politico». E gli strumenti per farlo erano la pittura, la fotografia, il cinema, ma anche la scrittura automatica, il gioco, le droghe, le sedute spiritiche, l'amore libero, tutto ciò che poteva assicurare un contatto con le forze dell'inconscio, con il misterioso e lo straordinario, con una verità ulteriore che non scaturiva dal pensiero conscio, regolato dalla logica, plasmato dalla società e dalla cultura occidentale. Tutto, in un certo senso, era partito dal dadaismo, dalle sue istanze distruttive, liberatorie. L'inconscio evocato aveva poco a che fare con quello della psicanalisi, messo al servizio della vita cosciente, l'emersione e la risoluzione dei conflitti interiori.

52 LUGLIO 2023 (foto
Jacques Lacomblez, Déplier les énigmes - 2009 Olio su tela Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Carlotta Coppo)
IN MOSTRA ANCHE LE CULTURE INDIGENE, MOLTO AMATE DAI SURREALISTI, ALLA RICERCA DEL "MAGICO"
«Viceversa, i surrealisti sostenevano che i sogni e le allucinazioni dovessero essere riconosciuti come un’altra forma di realtà, contraddistinta da un diverso e nuovo tipo di bellezza»

E per trovare quella bellezza, ogni mezzo era lecito. Anche i più artisticamente ludici. Come quelli utilizzati da Max Ernst, che prima ha ritagliato le illustrazioni di romanzi popolari ottocenteschi per creare dei collage, e poi si è inventato il frottage: «Posava un foglio di carta su un oggetto, poi lo strofinava (in francese, frotter) con il carboncino o la matita per creare un’impressione della consistenza e della forma di quell’oggetto». L'automatismo era fondamentale, cioè l'idea di lasciar spazio alla psiche profonda, evitando un controllo cosciente dello strumento. Con tutti i rischi del caso. Perché l'inconscio, come ormai sappiamo, è anche un contenitore di orrori e nefandezze, e il passo successivo inevitabile è quello della consapevolezza, della
discriminazione creativa, forse anche della trasformazione alchemica dei suoi contenuti. Ma in partenza, l'unica preoccupazione era quella di andare in direzione contraria rispetto a quella della società europea del tempo, e svelare l'ipocrisia dell'uomo “razionale”. Come scriveva Breton nel Manifesto: «Automatismo psichico allo stato puro, con il quale ci proponiamo di esprimere verbalmente, per iscritto o in qualunque altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato dal pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, esente da qualsiasi preoccupazione estetica o morale»
Ecco allora la riscoperta della pittura medievale, di Bosch e Arcimboldo, ma anche l'Angelus di Millet (chiodo fisso di Dalì), gli scrittori gotici, l'amore per i racconti di Poe, la riscoperta di Les chants de Maldoror. Ecco il “metodo paranoico-critico” di Dalì, il suo illusionismo destabilizzante, che
«mirava a provocare un “delirio interpretativo” capace di generare svariati significati inconsci e irrazionali». Ecco l'indagine sula rapporto tra realtà e rappresentazione di Magritte: «Il suo lavoro mette in discussione i sistemi di rappresentazione e sconvolge la confortante illusione di poter comprendere e descrivere il mondo creando una realtà nuova e straniante e, allo stesso tempo, sottolineando il fatto che tutti noi creiamo la nostra realtà»

Come spiega Alessandro Nigro, era propria del surrealismo anche una critica politica molto chiara al colonialismo. Dentro cui stava una visione forse un po' ingenua delle culture non occidentali (dentro la logica evoluzionista del tempo, poi smentita dall'antropologia successiva): «Le culture non occidentali apparivano agli occhi dei surrealisti come autentiche, spontanee e in diretto contatto con valori ormai perduti nella civiltà moderna, quali il mito, il sacro, il soprannaturale e il magico».
Niente di meglio del meraviglioso, come «via di accesso alla pienezza della “surrealtà” rispetto ad una realtà quotidiana dimidiata dai falsi ideali della borghesia e del progresso tecnologico, e della “bellezza convulsiva”, ovvero una bellezza che consisteva disarmonicamente nel contrasto e nella tensione tra polarità contrapposte»
Il concetto di “bellezza compulsiva” può essere un'ottima guida per questa mostra, che ti accoglie con il Divano Mae West a forma di labbra e la celebre Coppia di teste piene di nuvole, a ricordarci che Dalì era sì un abile illusionista, un uomo abbondantemente sopra le righe, un artista esageratamente consapevole del valore economico delle sue opere, ma era dotato anche di una tecnica sopraffina e un genio innegabile (incredibili quei colori e la finezza evocativa di quei

dettagli). A quei tempi, dopo la Prima guerra mondiale, c'era ben poca fiducia nel “progresso”. Bisognava muoversi e indagare in altre direzioni. E non è certo un caso – a proposito di semi gettati e cresciuti col tempo – che qui ci sia
anche un'opera datata 1968 di Jan Schlechter Duvall, intitolata Sogni di libertà
Nella seconda sezione ci sono i cugini dadaisti, che cercavano lo scandalo, la sovversione delle convenzioni sociali.
Sopra, alcuni disegni di Max Ernst della serie Histoires Naturelles . In basso, Piet Ouborg Compositie (Composizione) - 1931 Olio su tela - Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
(foto Carlotta Coppo)
(foto Carlotta Coppo)
Dove trovate le opere di Man Ray, insieme a quel capolavoro che è La coppia di Max Ernst, ma anche la mitica Scatola nella valigia di Marcel Duchamp, e l'opera di preparaione che ha portato a La mariée mise à nu par ses célibataires, lo stupefacente Grande Vetro, con i suoi significati multipli, intrecciati, stratificati (anche un simbolismo misterico e iniziatico molto evidente, come sottolineò Maurizio Calvesi in un suo Art Dossier dedicato ad Arte e Alchimia). Fermatevi qui a godervi Entr'Acte, uno dei film più noti di René Clair. Per farvi un'idea di cosa si intende con “cinema di poesia” e del perché, secondo il regista francese, «cinema è tutto ciò che non può essere raccontato». Qui l'espressione passa attraverso le componenti base del linguaggio cinematografico, i legami ritmici, formali e strutturali tra le inquadrature, la libertà della composizione, quasi musicale, fatta di assonanze formali e tematiche, di associazioni libere. Opera dadaista, certamente, in cui gli oggetti si rivoltano contro l'uomo, le attese dello spettatore sono
puntualmente trasgredite e un carro funebre fugge per la città, tra rallenty e accelerazioni stranianti. Ma anche un'opera che andrebbe ricollocata nel suo contesto, quello di una “serata dadaista” costruita sullo choc e la sfida al pubblico, sulla casualità e l'improvvisazione, a cui contribuirono personaggi come Picabia, Satie, Man Ray, Duchamp. Il dadaismo, cocì come il surrealismo, era soprattutto visione del mondo, azione, stile di vita.
Clair nel 1923 sosteneva che «bisognerebbe mandare tutto il pubblico a una scuola in cui non si imparasse nulla. Milioni di teste sarebbero sbarazzate da tutti quei detriti di scadente letteratura, da tutti quei calmanti artistici, che vengono assorbiti dall'infanzia e che soffocano la parte ancora selvaggia della vostra sensibilità».
Nel surrealismo, spiega la terza sezione, il sogno aveva una funzione fondamentale.
Qui lo dicono soprattutto le opere di Dalì (molto bella la Tavola solare, inquietanti la sua Spagna e Il grande paranoico), che invocava «il totale discredito del mondo della realtà». Ma ci sono anche Brauner, Ouborg, Tonny, Matta, Delvaux.
La sezione dedicata al caso e all'irrazionale ci regala alcune opere affascinanti di Eileen Agar, qualche scherzo di Man Ray e la notevole serie del portfolio “Histoires naturelles”, evocando l'epopea del Minotauro e facendoci scoprire (per chi non lo conoscesse) il misterioso universo di Unica Zürn.

La sala del desiderio è dominata dalla Venere restaurata di Man Ray, il seno in gommapiuma che Duchamp invitava a toccare nel
'47, un Picabia doc (Vieni laggiù con me) e le stampe disturbanti di Hans Bellmer.

Poi, nella sala dello “stranamente familiare”, si entra nel mondo di Maldoror illustrato da Dalì e nell'opera di Magritte, con la sua capacità più unica che rara di trasformare l'ovvio e l'evidente in qualcosa di perturbante.
L'ultima sezione è quella etnografica, fatta di statuette, manufatti e immagini degli studi in cui i surrealisti ammassavano artefatti provenienti per lo più dell'America del Nord e dall'Oceania.
D'altra parte gli oggetti etnografici diventarono presto co-protagonisti nelle grandi mostre parigine del movimento. Alessandro Nigro evoca, tra gli altri, la storia esemplare dell'artista cubano
Wilfredo Lam, che «definì la propria pittura “un atto di decolonizzazione”: il suo percorso esisten-
PER ABBATTERE I MURI DEL RAZIONALISMO E DEL MATERIALISMO
ziale e creativo sembra esserne la dimostrazione».
Qui trovate anche un'opera bellissima di Leonora Carrington, I Gemelli sono di nuovo nel frutteto, a proposito di dimensioni intrecciate, sogno e realtà, latitudini e geografie. E con lei, artista brittanica di nascita e messicana di azione, il cerchio si chiude, anche pensan-

do al cuore surrealista dell'ultima
Biennale, il cui titolo era ispirato proprio a una sua opera: Il latte dei sogni (l'abbiamo raccontata su Redness di ottobre 2022). Octavio
Paz la descriveva così: «Una poesia che cammina, che a un tratto sorride e si trasforma in un uccello e poi in un pesce, e scompare»
Non è male, in effetti, come descrizione dello spirito surrealista incarnato, di quell'attitudine a svelare/ trasformare la realtà attraverso il prisma dell'immaginazione, per vederla nella sua complessità poliforme e misteriosa.
57 LUGLIO 2023 56 LUGLIO 2023
(foto Carlotta Coppo)
Eileen Agar, Seated Figure - 1956 Olio su tela Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
"Entr'acte"
Sulle tracce del Buddha in Toscana A Pomaia, per ritrovare la pace
CORSI, MEDITAZIONE, OSPITALITÀ ALL'ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA INTERVISTA AL GIOVANE DIRETTORE VALERIO TALLARICO (30 ANNI)
Fuori dal tempo. Dentro uno spazio che è soprattutto mentale, interiore, prima ancora di essere fisico o geografico. C'è la Toscana, certamente, la linea morbida delle colline in lontananza e il mare a vista, gli ulivi, il boschetto di querce e lecci. C'è l'Oriente, gli stupa, le ruote di preghiera, le statue del Buddha, le bandierine di stoffa colorata che ci ricordano il Tibet. Ma ciò che colpisce è la pace che si percepisce chiaramente appena varcata la soglia dell'Istituto Lama Tzong Khapa. Il silenzio, l'atmosfera sospesa, l'armonia di quei sentieri ordinati e del parco-giardino.
Una serenità luminosa, che invita a respirare a fondo, con un sorriso (in città, nello stress della vita quotidiana,
il respiro è spesso corto, affannoso, abbiamo fame d'aria), e che permette di allargare la percezione e la consapevolezza (di solito sovrastata dal rumore dei pensieri e delle cose da fare). L'effetto è fisico e spirituale insieme. D'altra parte qui a Pomaia (in provincia di Pisa) si viene soprattutto per meditare e studiare, per dedicarsi alla conoscenza di sé, alla ricerca interiore, o per godersi un po' di solitudine e autentica libertà. C'è una comunità residente, un sangha, diviso tra monaci e laici. E ci sono le tante persone che vengono a frequentare i corsi, a partecipare ai ritiri, a immergersi nel silenzio, utilizzando gli alloggi messi a disposizione, in pensione completa, con pasti rigorosamente vegetariani.
La prima volta si rimane sorpresi dalla spettacolare casa-castello, con la sua torre, l'edificio principale dentro cui si svolge la vita quotidiana dell'Istituto. Ma ci sono anche le casette in legno, in mezzo alla natura, per gli ospiti di passaggio, che si ritrovano immersi in un'atmosfera d'altri tempi e latitudini. C'è il Giardino del tè, vicino a un piccolo stagno, dove sostare in compagnia, scambiando qualche parola gentile con monaci o laici, sentendosi accolti ma senza troppe formalità, perché qui si ha un grande rispetto per chi vuole rimanere da solo. Nelle aule e lungo i sentieri, invece, è richiesto un rispettoso silenzio, così come nella sala di meditazione principale (gompa), dove si percepisce una straordinaria energia.

L'Istituto Lama Tzong Khapa è un luogo reale e immaginario insieme. Lo si percepisce soprattutto in luoghi sacri come il Gompa di Cenresig, situato al centro del boschetto, affrescato da due pittori tibetani (immagini di Tara e Buddha Shakyamuni) o la Casetta degli Tsa Tsa, con i suoi centomila bassorilievi. Non è la scenografia di un film, anche se qui è conservata l'enorme statua del Bud-
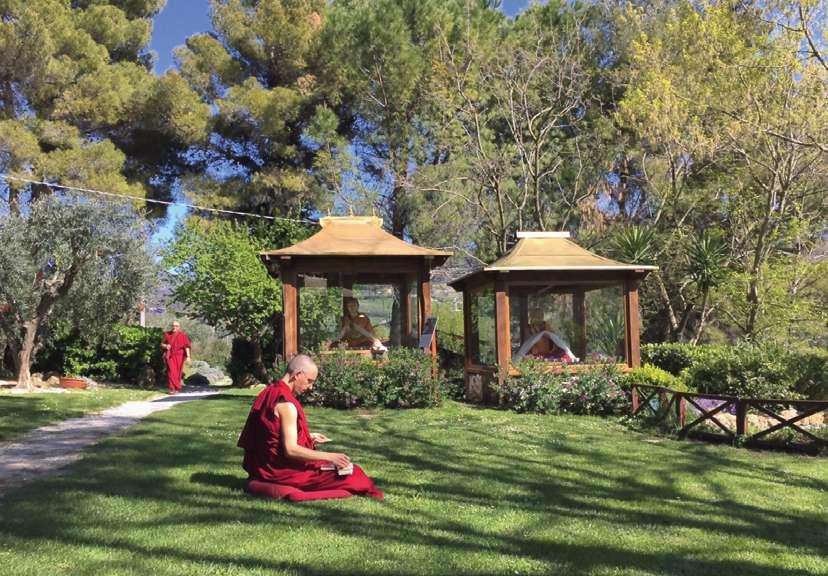
È uno dei centri buddhisti più importanti d'Europa, consacrato nel 1982 dal Dalai Lama, aperto a studenti e pellegrini di ogni credo
dha della compassione, alta 7 metri, che Dante Ferretti fece costruire per Kundun di Martin Scorsese, davanti a cui c'è sempre qualcuno in contemplazione o preghiera (se volete conoscere la storia del Dalai Lama e avvicinarvi alla cultura tibetana, quel film è un buon inizio, è cinema che incarna, anche stilisticamente, la filosofia dell'impermanenza e dell'interconnessione). Non è la rappresentazione di un'utopia, anche se per stare qui bisogna essere consapevoli di far parte di una comunità e quindi bisogna osservare i “5 precetti”, semplici regole legate alla tradizione buddhista, che invitano ad astenersi da una serie di comportamenti: «far male agli esseri viventi», «prendere il non dato», «far danni con una condotta sessuale irresponsabile», «mentire, offendere», «abusare di sostanze inebrianti». Si richiedono gentilezza, uso parsimonioso del cellulare (una buona occasione per disintossicarsi), rispetto del silenzio (anche durante i pasti, per allenarsi a mangiare in presenza e consapevolezza).
59 LUGLIO 2023
L UOGHI
Ciò che potrebbe sembrare pittoresco, in realtà si rivela ben presto autentico, vissuto. È il segreto di questo luogo, che non si è trasformato in una comunità improvvisata o informale, vagamente new age, ma in un centro di studi tra i più importanti in Europa. La sua storia è partita nel 1977, anno in cui è stata acquistata l'area grazie alla famiglia Corona di Milano. La villa padronale è stata ristrutturata, i terreni bonificati e nel novembre del 1982 il Dalai Lama in persona consacrò il luogo, trasformato in scuola internazionale per lo studio e la pratica del buddhismo tibetano, grazie soprattutto all'instancabile lavoro del direttore
spirituale Lama Zopa Rinpoche nei 160 centri sparsi in tutto il mondo. «In un’epoca sempre più gravata da tensioni e crisi di natura politica, economica e culturale e quando appare che persino le religioni siano quasi un ostacolo alla pace, l’Istituto svolge un ruolo prezioso, testimoniando la possibilità di coltivare compassione e saggezza quali antidoti alle afflizioni mentali che sono all’origine di ogni genere di conflitto. In questo percorso siamo ispirati dalle attività di Sua Santità il Dalai Lama così attento nel presentare il buddhismo sotto il profilo religioso ma anche sotto quello filosofico e scientifico e promuovendo in questo senso lo sviluppo di un’etica secolare. Da qui il primato della difesa e della promozione dei valori fondamentali dell’uomo come nucleo irrinunciabile di qualsiasi tradizione religiosa e come principi ispiratori della convivenza tra popoli e culture. All’insegna della pace».
Da una parte c'è l'attività istituzionale. Dall'altra lo spazio concesso alla ricerca personale, secondo le finalità riassunte da Lama Thubten Yesce, ideatore della FPMT (Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana), che organizza “master program” di studi buddhisti, i quali richiedono anche sei anni di scuola, più uno di ritiro, nella tradizione Ghelug, ispirati alle tradizionali comunità monastiche: «Lo scopo del Centro è prodigarsi per gli altri. Questo è un Centro internazionale, aperto a tutti, a ogni persona di qualunque etnia, nazionalità e retroterra socio-culturale.

È un luogo dove imparare come liberare la mente dalle concezioni dannose profondamente radicate e come vivere in armonia con gli altri, mettendo la meditazione in pratica nella vita quotidiana».
I corsi, gli incontri e i ritiri proposti dal Centro, o quelli semplicemente ospitati, sono vari e numerosi e riguardano anche l'etica, il benessere e forme di meditazioni diverse da quella tradizionale tibetana. Scorrendo il calendario di luglio, tanto per fare qualche esempio, trovate la Dharma Art Academy, dedicata alla pittura tibetana (il 6 luglio), e il ritiro di Palden Lhamo (il 10 luglio). Ci sono corsi che avviano alla pratica, come “ABC della meditazione” o “Alla scoperta del buddhismo” (tutti e due il 14 luglio). L'esperienza affascinante e impegnativa del Nyung-ne (tre giorni di ritiro, con digiuno, in cui si prendono gli otto precetti Mahayana), ma anche riflessioni sul lavoro (“Produttività e pace interiore”, il 17 luglio), sulla funzione del respiro, l'equanimità (il 19 luglio), l'igiene emotiva (21 luglio), i 5 riti tibetani (21 luglio). Vincenzo Tallarico parla di meditazione dal punto di vista di uno psicologo junghiano (27 luglio), mentre Paolo Francesco Testa offre un ritiro dedicato a “Saggezza e compassione nella meditazione vipassana” (dal 31 luglio al 10 agosto). Poi ci sono gli eventi online: ce ne sarà uno l'8 luglio dedicato al rapporto tra buddhismo e neuroscienze, “Come la meditazione cambia il cervello”, una delle tante collaborazioni del centro toscano con istituzioni scientifiche, accademiche, religiose, in Italia e in Europa.

Non è difficile immaginare quanto sia complesso amministrare un luogo del genere. Per questo impressiona (positivamente) il fatto che questa responsabilità, dall'anno scorso, sia stata affidata a un giovane trentenne, Valerio Tallarico. La sua storia è molto particolare, visto che è praticamente nato e cresciuto a Pomaia. Segni particolari? Una laurea in Ingegneria Gestionale (ideale, visto il ruolo che ricopre), un grande amore per i cavalli (si parla di “equitazione etica”), una semplicità e una sincerità senza fronzoli, frutto della cultura in cui è cresciuto. Lo abbiamo intervistato, per conoscere meglio lui e l'Istituto.
Partiamo da una parola: Dharma. Un concetto fondamentale per il buddhismo. Ci puoi spiegare cosa significa praticare il Dharma?
Dharma per noi è l'insieme degli insegnamenti buddhisti. Una macro-categoria dentro cui trovi concetti fondamentali come quello del karma, la necessità dello studio e l'applicazione della logica, del dibattito. Praticare il Dharma significa studiare il buddhismo, ma anche applicarlo nella quotidianità, perché se rimane sul piano astratto, teorico, non serve. Il karma è un concetto fondamentale. È quella legge per cui ogni azione comporta una reazione. Molto diversa dal concetto cristiano della punizione e della gratificazione. L'idea è che ognuno raccoglie quello che semina in questa vita o in quelle successive. La reazione si produce quando si creano le condizioni giuste, quando c'è la maturazione del karma. Si tratta di una presa di responsabilità verso le proprie azioni. Bisogna mettere in pratica la teoria del karma per il beneficio di tutti gli esseri senzienti.

Alla base di questa concezione c'è l'idea che esista un ordine superiore in cui tutti i fatti di tutte le vite si intrecciano nel formare un disegno complessivo. La vita di ognuno segue una logica misteriosa (per chi non la sa vedere) e le innumerevoli vite individuali formano questo affresco universale. Nell'Occidente moderno, invece, prevale l'idea del caso e del caos.
Una delle prime azioni compiute da chi decide di essere buddhista è “prendere rifugio” nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha.
61 LUGLIO 2023 60 LUGLIO 2023
Il direttore del Centro ci racconta il suo percorso (partito proprio da Pomaia) e ci parla di Dharma, karma e meditazione
Valerio Tallarico
Il Dharma è l'insieme degli insegnamenti a cui ci si affida per uscire dal Samsara (il ciclo di vita, morte e rinascita, ndr); il Buddha è colui che ha messo a disposizione il Dharma, gli insegnamenti e l'esempio da seguire per uscire dalla sofferenza; il Sangha è la comunità degli studenti, dei praticanti con cui condividi un percorso. Poi a volte si dice che il guru, in un certo senso, è più importante del Buddha, perché è la persona con cui ti interfacci in maniera diretta, il maestro che ti insegna il Dharma - come può esserlo il Dalai Lama, che per noi è l'incarnazione umana del Buddha della compassione - una forma con cui possiamo interagire.

Immagino sia una questione di “fede” oltre che di esperienza, nel senso della capacità di vedere le tracce, i segni, di un percorso di vita, cercando il suo significato.
Il buddhismo si basa tantissimo sullo studio. Un titolo di studio, quando sei monaco, richiede più di vent'anni di impegno quotidiano. C'è una mole enorme di informazioni da studiare e praticare. Ed è fondamentale anche la logica, il metodo del dibattito, strumento utilizzato molto in Oriente. Il Dalai Lama e lo stesso Buddha dicono: non prendete le mie parole come oro colato, ma fatele vostre, cercate di metterle in dubbio e scopritene il significato vivendole. Poi, certo, ci sono delle basi di fede: se uno non crede nella reincarnazione e nel karma, i ragionamenti successivi non hanno fondamenta stabili. Per capire il karma serve anche l'analisi logica, fondata sui principi base del buddhismo: perché se faccio del male accumulo karma negativo? Perché creo sofferenza agli altri. E allo stesso tempo, fare del bene senza una motivazione pura, cioè per scopi egoistici, per ottenere qualcosa in cambio, non funziona. È una cosa che riguarda la quotidianità di tutti. Chiaro, non è semplice essere sempre coerenti. Chi ha una vita particolarmente incasinata e stressante può pensare con meno attenzione alle proprie azioni, e qui entra in gioco la presa di consapevolezza, la centratura.
Questa forse è una delle differenze maggiori rispetto alla religione cristiana, che ha il concetto di peccato e il sacramento della riconciliazione.
Anche nel buddhismo esistono pratiche di “purificazione del karma” molto potenti. Così come c'è la lo-
gica del pentimento, inteso come presa di coscienza e di consapevolezza. Poi ci sono pratiche più mistiche, rituali, per purificarsi, ma di base c'è una responsabilità personale. Con risvolti anche difficili da metabolizzare. Pensa ai bambini che muoiono di fame in Africa. Se prendo come vera la legge del karma, quella in teoria è una sofferenza che stanno sperimentando per condizioni che a loro volta hanno creato nelle vite precedenti.
Una cosa non facile da accettare. Al contempo, quando qualcuno compie azioni estremamente negative, l'idea del karma creato, di ciò che potrebbe capitare nel suo futuro, potrebbe suscitare un'emozione di compassione verso di lui, che va oltre la rabbia e il disprezzo del presente. Il karma allarga l'orizzonte.
Non è un invito a subire ciò che ti capita, ma a capirne le motivazioni e ad agire. Il rischio è il fatalismo, mentre il Dalai Lama invita spesso a impegnarsi per migliorare le cose, la propria vita e quella degli altri. La legge del karma però ti porta ad accettare di essere nato in un certo luogo e di fare certe esperienze, che in teoria ti servono per procedere nella tua evoluzione.
Ti fa capire perché nasci in una famiglia agiata o povera - magari povera ma con persone che ti possono dare una cultura o un insegnamento importantissimo - bello o brutto, sano o non sano. Ti dici: ok, questo accade grazie a ciò che ho seminato. Ma poi continuo a seminare in questa vita, quindi devo fare le mie scelte, agire in un certo modo.
Tu sei nato in un contesto molto particolare.
I miei genitori si sono conosciuti come volontari nell'Istituto negli anni Ottanta. Poi hanno completato il loro percorso di studi e sono andati a vivere a Pomaia, dove è nata mia sorella. Quando hanno cambiato casa e si sono trasferiti in campagna, sono nato io. I miei genitori sono nati cristiani e si sono convertiti al buddhismo, prima che nascessi. Quindi io ho vissuto una vicinanza naturale al buddhismo. A 5 anni aiutavo mio zio a costruire gli stupa, per quanto può farlo un bambino così piccolo. Ho vissuto da sempre nell'Istituto.
Cosa significa nascere in un angolo d'Oriente in pieno Occidente? Hai sofferto questa contraddizione in qualche modo?
Sembra quasi una scenografia - c'è anche una statua del Buddha alta 7 metri opera di Dante Ferretti - ma si respira un'atmosfera di grande autenticità
No. L'unica cosa che faceva un po' strano, quando andavo a scuola, era dire: sono buddhista. Non c'erano altri casi oltre al mio. I compagni di classe facevano le comunioni e le cresime e io no, ovviamente. Però a livello di ambiente, di paese, non ho percepito nessuna particolarità. In Istituto vai, pratichi, entri in un contesto buddhista, ma nella quotidianità non hai “quell'odore orientale” che puoi avere in India o in Nepal in contesti spirituali di un certo tipo. Rimane comunque un mondo occidentale.
Com'è stato crescere a Pomaia?
In realtà Pomaia, in sé, l'ho frequentata poco, anche se la casa in cui ho sempre vissuto è a un chilometro e mezzo dall'Istituto.
63 LUGLIO 2023 62 LUGLIO 2023
Ho fatto l'asilo a Castellina, lì vicino, le elementari a Rosignano, le superiori a Cecina. Pomaia è un paesino molto piccolo, non c'erano coetanei. L'ho vissuta come un qualsiasi ragazzo della zona. Come uno che al pomeriggio va all'oratorio.
Da fuori sembra una realtà esotica, invece è molto radicata nel territorio.
Assolutamente radicata. È molto ben inserita nel suo contesto. Io sono cresciuto da occidentale dentro una cultura buddhista. Anzi, essendo nato buddhista, ho studiato meno di quelli che decidono di diventare buddhisti.



Non hai vissuto la frenesia del convertito, che legge tutto e vuole sapere tutto.
Chi ha studiato per diventare buddhista, può darsi che abbia più competenze di me. Io non ho seguito corsi per anni, non ho fatto ritiri intensivi. So tante cose, ma tante ancora non le so.
Però hai avuto genitori che pensavano e parlavano in un certo modo. Ci sei cresciuto dentro in quel modo di essere e di vivere
Sì, decisamente.
Poi hai scelto di studiare ingegneria.
L'ho scelto per esclusione... (ride). Certo, ero bravo in matematica, ma alle superiori studiavo molto poco, galleggiavo sul 6-6,5. Arrivavo ad aprile rischiando tanti debiti, poi in quei tre mesi studiavo e recuperavo per andare al mare tranquillo. Facevo il liceo scientifico. Alle Olimpiadi di matematica però ero sempre al primo o al secondo posto. Volevo fare l'università per due motivi: il primo è che solo con il diploma del liceo non fai granché, dal punto di vista lavorativo; l'altro è che nella mia famiglia erano tutti laureati e sentivo questa pressione. Ho cominciato con Ingegneria Energetica, poi sono passato a Gestionale e mi sono laureato.
Mentre studiavi hai anche lavorato e hai portato avanti la tua passione per i cavalli.
Ho sempre lavorato, sì. Quanto ai cavalli, fino a 18 anni ho fatto agonismo, salto a ostacoli. Poi ho conosciuto una persona che mi ha fatto cambiare approccio al cavallo.
Insegno ad andare a cavallo senza imboccatura, senza sella, con i cavalli che vivono in branco.
Hai vissuto anche dalle parti di Milano.
La mia ragazza abitava a Legnano, vicino a Milano, e ho deciso di trasferirmi là, sia per dare stabilità alla relazione, sia per un discorso lavorativo. Ho iniziato a fare l'ingegnere per alcune aziende a Milano. Ma era un ambiente che non mi apparteneva per niente. Anzi, a dir la verità ero già partito con un pregiudizio, con l'idea di rimanere non più di quattro anni. Un pregiudizio che mi ha messo dei limiti, visto che ho vissuto lì con una certa sofferenza. Per fortuna mi ero portato il cavallo, che era la mia salvezza.
L'anno scorso, nell'aprile del 2022, mi hanno chiesto se volevo candidarmi nel Consiglio direttivo dell'Istituto e sono stato votato, assumendo anche il ruolo di vicepresidente. Era un lavoro impegnativo, ma di volontariato, ci si incontrava su Zoom per discutere, e quindi sono rimasto a lavorare a Milano. Ma durante l'estate il direttore in carica ha dato le dimissioni e mi hanno chiesto di prendere il suo posto. Questo per me voleva dire poter tornare a casa e avere un ruolo dirigenziale, che era proprio ciò che avevo studiato all'università. Era lo sbocco di un percorso che avevo fatto. Si sono incastrate diverse cose. A casa ho un po' di campagna, ho costruito anche un recinto per i cavalli.
Quando si dice il karma... Immagino sia un lavoro complesso.
Estremamente complesso. E faticoso.
Di quali numeri si parla dal punto di vista del personale?
I dipendenti sono 38. E questa è la parte più difficile dal punto di vista della gestione. C'è l'amministrazione, la segreteria, il bar e lo shop, la parte alberghiera, con una cucina, i cuochi, il personale delle pulizie, c'è il giardiniere, il manutentore, la comunicazione... Poi c'è il reparto della didattica che è molto ampio. Insegnanti, interpreti, traduttori. Tutto questo ha un costo pazzesco rispetto alle entrate che un posto del genere può avere. E quindi si fa fatica a far tornare i conti.


64 LUGLIO 2023
Il rischio di realtà del genere è che l'azienda prenda il sopravvento sulla “missione”. Il turismo religioso, il business dello spirituale. Qui invece si respira qualcosa di autentico. Forse grazie anche alla comunità residente.
Credo che siamo bravi nel non trasmettere la fatica del lavoro e permettere a chi viene da noi di vivere un ambiente sano, in cui si può star bene. A livello lavorativo c'è lo stress di una qualsiasi azienda, anzi forse di più, il lavoro è tantissimo. Ciò che “produciamo” noi è molto complesso, porta via tanta energia. Ci aiutano i volontari, che sono tra i cinque e i dieci. Poi abbiamo un ricircolo che va dalle 80 alle 100 persone a weekend che ospitiamo. Oltre a tutte quelle che frequentano quotidianamente il centro.
Immagino che sentiate la responsabilità della tradizione millenaria che portate avanti. Questo è uno dei centri più importanti d'Europa.
Vero. Ci sono diverse tradizioni nel buddhismo. La nostra è quella del buddhismo tibetano ghelug. Sono tantissimi anni che esiste questo centro, dall'inizio degli anni '80. Ha la sua particolarità geografica, un ambiente suggestivo, il parco, il castello. Ma la cosa più importante è che negli anni si sono susseguiti tanti
maestri eccezionali, da Sua Santità il Dalai Lama e Lama Yeshe e Lama Zopa Rinpoche, i suoi fondatori, tra i più importanti lama in Occidente. In questo centro hanno insegnato alcuni dei più grandi maestri di buddhismo del mondo. Anche adesso i più importanti vengono da noi. Questo ci permette di mantenere viva la tradizione. Poi c'è sempre da bilanciare l'aspetto religioso con quello economico, cercando di non snaturarci. Vengono fatti anche corsi più specifici, dal counseling al vipassana, a pagamento. Ma negli anni è stato deciso di lasciare l'insegnamento del buddhismo puro a offerta libera.



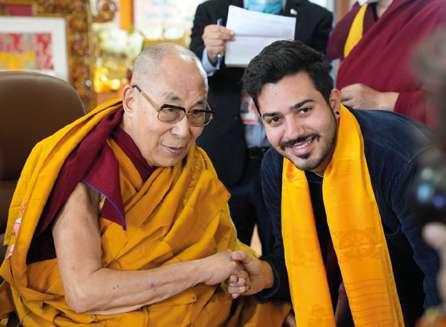
Nel 2018 l'Unione Buddhista Italiana ha iniziato a ricevere l'8 per mille e ci supporta nelle spese di gestione, come tutti i centri iscritti all'Unione. Per noi i contributi dell'Ubi sono essenziali. Il processo di regolarizzazione che abbiamo portato avanti nel corso degli anni ha aumentato i costi di gestione. In Istituto risiedono i volontari, alcuni religiosi che vivono nel monastero, gestito in maniera indipendente, poi ci sono alcuni studenti a cui diamo una disponibilità di alloggio fissa e diversi lavoratori che vivono all'interno. Altre persone vivono nei paraggi.
Hai conosciuto il Dalai Lama?
L'ho incontrato già due volte come direttore, a dicembre e a giugno.
Il Dalai Lama è diventato un punto di riferimento per tante persone, molto al di là del buddhismo, un leader spirituale globale. Ma questa sovraesposizione mediatica, a volte, genera anche fraintendimenti culturali e veleni, come per l'episodio del bacio col bambino, che ha suscitato scandalo... Qual è stata la tua esperienza personale incontrandolo?
I miei sono stati incontri veloci più che conversazioni. Ci siamo detti qualche parola e ci siamo stretti la mano. Una “connessione”.
La prima volta è stata un'emozione incredibile. Per me era un sogno incontrarlo. Gli ho toccato la mano e ho sentito un calore che non sai da dove arriva, una potenza, ma anche una tranquillità assoluta. Una presenza potente, ferma, una grande energia.
La seconda volta è stata un mese fa. Gli avevo chiesto di incontrarmi insieme ad altre persone del direttivo. Avevo un po' di cose da dirgli, ma quando sono andato lì le parole non mi uscivano. Lui mi guardava, io lo guardavo, senza dire nulla, e ci siamo fissati negli occhi per dieci-quindici secondi, che è un'eternità. Lì mi sono reso conto che non avevo niente da dire. Che tutto quello che avrei potuto dire sarebbe stato inutile. Non c'era alcun bisogno che uscissero delle parole.
Il buddhismo tibetano ha anche una forte componente rituale, cerimoniale, molto diversa dal buddhismo laico, minimalista, che ha generato anche tecniche come la mindfulness. Come vivete la diffusione di queste forme di pratica?
È importante che ci siano più livelli di pratica per le necessità di persone diverse. Se una persona non è abituata, non può stare 3 o 4 ore seduta a meditare. Ognuno deve agire in base alle proprie potenzialità e al proprio allenamento. Non ci vedo nulla di male. Non c'è bisogno di arroccarsi, anzi, bisogna trasmettere certi valori anche a chi non è buddhista. Fondamentalmente l'obiettivo non è convertire le persone al buddhismo, ma offrire certi mezzi e strumenti anche a chi non lo è, se questi lo fanno star bene. Ora, ad esempio, stiamo puntando sulla formazione nelle aziende, senza bisogno di presentarci come buddhisti. Se poi qualcuno vuole approfondire, ha a disposizione lo studio, le iniziazioni, le pratiche tradizionali, la recita delle preghiere, le Puja.
Perché l'occidentale oggi è così attratto dalla meditazione di origine buddhista, da questa particolare esperienza dello spirito?
In Occidente abbiamo una predisposizione particolare per l'investigazione. Il buddhismo dà l'opportunità di investigare la realtà, la mente, di ottenere delle risposte partendo anche dal ragionamento, la discussione. Poi c'è la parte legata alla meditazione, che ormai non è più una cosa strana, tutti conoscono l'impatto positivo che ha sul nostro benessere. Gli effetti della meditazione sono studiati e dimostrati dalla scienza. Migliora la salute e l'efficienza della mente. Noi cerchiamo di portarla al maggior numero di persone possibili. (f.t.)
66 LUGLIO 2023
Valerio Tallarico insieme al Dalai Lama
«Si può cominciare a praticare per curiosità, magari con una motivazione piuttosto vaga, e scoprire in seguito che si tratta di un dono prezioso, che apprezziamo sempre di più, per il quale l’espressione “amore per la pratica” risulta certamente la più appropriata. È un amore che si sviluppa negli anni e che ci nutre (...) Nei primi tempi questo amore sembra non corrisposto, ma se non ci perdiamo d’animo e andiamo avanti, imparando a non prendere più tanto sul serio
la nostra avida aspettativa di risultati immediati, cominceremo a capire la differenza tra amore (per la pratica) e attaccamento (alla pratica), e anche il detto “se fai un passo verso Dio, Lui ne fa dieci verso di te” ci apparirà meno enigmatico. In mezzo ai travagli della pratica incontriamo una “cosa” molto intima e buona, presente dentro di noi, benché nascosta, che neppure immaginavamo di avere e di cui ci rallegriamo. E più siamo solleciti nel praticare, più cresce questo amore che si manifesta come apertura».
Beata semplicità dei maestri, che non hanno bisogno di parole difficili o pensieri contorti per andare in profondità nelle cose. Ma non dite a Corrado Pensa che è un "maestro", perché lui non ama essere definito tale (come capita spesso ai veri maestri).

L'umiltà fa parte del suo - lieve, luminoso, liberatorio - bagaglio, accumulato in decenni di pratica e di insegnamento.
Corrado Pensa è stato psicoterapeuta junghiano e docente di Religioni e filosofie dell'India alla Sapienza. Ma tutti lo conosco
come uno dei più autorevoli e amati insegnanti di meditazione in Italia ("meditazione di consapevolezza", come la definisce lui, strettamente legata alla vipassana buddhista), trasmessa nei suoi corsi all'A.me.co., insieme a Neva Papachristou, e in lunghi ritiri, proposti spesso anche a Pomaia. Il ritorno in libreria del suo Il silenzio tra due onde (grazie alla Ubiliber, benemerita casa editrice dell'Unione Buddhista Italiana) ci permette di ricordare quanto sia importante la sua opera di divulgazione, anche dal punto di vista editoriale.

Pochi sanno raccontare la meditazione come lui e dare fondamentali suggerimenti di pratica, rielaborando le parole dei più importanti pensatori-praticanti buddhisti, accostati spesso alla mistica cristiana. Poco importa, in realtà, la fede professata, perché quando si va in profondità nella ricerca spirituale ci si rende conto dell'unità fondamentale delle varie tradizioni e discipline.
Il libro raccoglie lezioni e "discorsi di Dharma", rivolti a chi pratica ( o a chi vuole cominciare).
Partendo da un'idea di "fiducia" che è molto diversa dalla fede cieca, che si nutre dell'impegno concreto, del retto sforzo, dell'esperienza sul campo, cercando un «progressivo riorientamento della vita», alimentato da percezioni e aperture improvvise, insieme alla sensazione che «la verità delle cose abbia a che fare con una sorta di profonda semplicità». L'umiltà come qualità dell'attenzione. Insieme all'allenamento a percepire i nostri attaccamenti, ciò che indurisce l'io e quindi produce sofferenza. «In generale, attaccamento è afferrare e stringere da una parte, ma anche essere afferrati, stretti e tenuti. È importante cogliere questo aspetto primordiale, misterioso dell'attaccamento (...) Una risposta sbagliata al nostro naturale desiderio di benessere. Il cogliere molte volte, con crescente chiarezza, questa verità è un vero e proprio initium sapientiae (...) Una mente-cuore bhāvita, maturata, risvegliata alle qualità salutari in essa presenti, non offre appigli all'attaccamento (...) Se l'attaccamento non trova appiglio, vuol dire che in essa c'è una contentezza intrinseca, non dovuta cioè a questa o quella gratificazione, e anche un sereno disincanto (nibbida) nei confronti dell'attaccamento stesso. Ciò si traduce in una capacità di spaziosità, rilassamento, lasciare andare». Le quattro nobili verità del buddhismo vengono "tradotte" nel quotidiano, perché è qui che bisogna agire, avendo il coraggio di chiederci se per caso stiamo contribuendo alla nostra sofferenza. «Ci si deve porre la domanda con dolcezza e precisione», senza giudicarsi, animati «da un senso di amicizia
verso noi stessi. Questo è cruciale e va imparato e reimparato». Sì, perché praticare non significa solo sedersi a meditare qualche minuto al giorno, ma esercitare la presenza mentale e la consapevolezza in ogni momento della nostra giornata. Scoprendo di avere dentro di noi risorse inaspettate. «In India, nelle Upaniṣad, si parla della “caverna del cuore”, ovvero quel luogo nel nostro intimo nel quale ritirarci. San Francesco di Sales, nell’Introduzione alla vita devota, dice: "Ricordati, o Filotea, di ritirarti più volte durante il giorno nella solitudine del tuo cuore, mentre fisicamente rimani in mezzo alle conversazioni e alle faccende. Le conversazioni non sono in genere così serie che non si possa di tanto in tanto ritirare da esse il nostro cuore". Per favorire questi moti di raccoglimento è utile scandire molto lentamente alcune frasi di mettā (benevolenza) o di presa di rifugio; o fare piccole pause durante le quali si pratica l’attenzione al respiro. A volte non occorre alcun supporto, perché
si stabilisce una specie di “silenzio tra due onde”, che viene in primo piano non appena ci ricordiamo della pratica».
Leggendo questo libro imparerete, tra le altre cose, cosa significa "stare nel presente", che cos'è la vera comunicazione , esercitata con ascolto e compassione, come utilizzare l'attenzione per non finire vittime delle vostre sensazioni ed emozioni negative.
Attenzione, però: non sono banali istruzioni per l'uso, non è uno di quei manuali che promettono facili conquiste e felicità per tutti. Sono consigli, riflessioni, suggerimenti pratici spesso illuminanti (vi ritroverete a dire: come fa a sapere proprio ciò di cui avevo bisogno?). Ricordandoci che «abituati come siamo ad avere la mente alla deriva, anche poche occasioni al giorno di consapevolezza equanime e benevolente ci aprono il cuore e l'intelligenza». Leggete e diffondete! (f.t.)
69 LUGLIO 2023 68 LUGLIO 2023
I DEE
«La verità delle cose ha a che fare con una sorta di profonda semplicità»
TORNA "IL SILENZIO TRA DUE ONDE" DI CORRADO PENSA, CHE INSEGNA COME SVILUPPARE UNA MENTE-CUORE CONSAPEVOLE E RISVEGLIATA
IL PAVIMENTO IN LEGNO CHE FA BENE AI BOSCHI
Bello, ecologico, salutare. Pregi e vantaggi del "made in Italy" posato dai fratelli Lazzarin
dire, uno slogan. Tutti ne parlano, tutti la vogliono, ma poi bisogna anche riconoscere il suo valore. Solo così si può creare quel circolo virtuoso che fa bene a tutti: al cliente e al lavoratore, all'economia e all'ambiente.
Il legno non è tutto uguale. E non è uguale il modo in cui le aziende lo lavorano, per creare pavimenti, porte, scale. Per non parlare, poi, di come viene utilizzato dagli artigiani, professionisti che hanno imparato un'arte, un mestiere, e lo fanno nel miglior modo possibile, senza risparmiarsi.



La storia dell'azienda Lazzarin – che lavora soprattutto nel Padovano (ma ha portato avanti cantieri anche in giro per l'Italia) - sta proprio in questa differenza. Nei materiali scelti, nei fornitori, nella qualità del lavoro assicurato. Con la convinzione che la parola “qualità” non sia solo un modo di
Se utilizzi legno certificato, eviti la devastazione di boschi e foreste, dato che vengono tagliati solo alberi selezionati (e ne vengono piantati altrettanti), favorendo la salute di quei polmoni verdi. Se poi il legno viene lavorato in un certo modo, evitando inquinanti dannosi, si preserva la salute delle persone. E alla fine il lavoro di qualità dell'artigiano viene ripagato il giusto, finanziando chi fa scelte per l'ambiente e il benessere delle persone.
Nicola ed Emanuele Lazzarin sono fratelli. Nicola, che ha 53 anni, prima di aprire l'azienda con Emanuele (che ne ha 45), ha fatto un po' di tutto: «Ho sempre lavorato, fin da ragazzo, facendo vari mestieri». A fare i pavimenti in legno l'ha imparato dai professionisti del mestiere. «Lo facevo part-time, avevo mezza giornata libera e la impiegavo così, insieme ad alcuni amici» Quando poi il fratello ha finito la scuola, si è messo a lavorare proprio in quel campo. Tempo due anni ed ecco l'idea: licenziarsi e mettersi in proprio.
«Questo è un mestiere che si impara sul campo, facendolo – spiega Nicola. - Adesso è un po' più semplice, perché si lavora principalmente con il prefinito. Una volta oltre alla posa c'era tutta la parte di levigatura, che è più complicata da imparare, ci vuole tanto tempo, è molto delicata e bisogna farla come si deve».
L'azienda è sul mercato da 21 anni, in un periodo non certo facile. Qualche motivo ci deve essere. Il principale, come sempre, si chiama “passaparola”: non c'è niente di più efficace, per farsi conoscere, che lavorare bene. I clienti ti consigliano ad altri clienti e poi ti richiamano, dopo anni, se hanno bisogno di nuovi lavori. L'altro motivo è la scelta di lavorare con materiali di qualità. «Noi lavoriamo con un'azienda 100 per cento “made in Italy”, con prodotti costruiti qui in Italia, che hanno delle caratteristiche molto alte dal punto di vista della qualità. Poi, certo, c'è anche chi non se lo può permettere, allora in quel caso lavoriamo con prodotti di importazione». Ma la scelta principale è quella del legno certificato e di una particolare attenzione alla salute. «Parliamo di un prodotto che ha le schede tecniche, le certificazioni e rispecchia tutte le normative europee e italiane (che sono ancora più restrittive). Non c'è esalazione di formaldeide. La vernice è all'acqua. Un prodotto molto più salutare, nel
suo complesso. Anche la colla non ha esalazioni di solventi. E questo è importante prima di tutto perché ci siamo noi a respirarla tutto il giorno,
quando lavoriamo, e poi perché il cliente ci deve vivere tutta una vita e se continua a respirare porcherie non è il massimo. È un materiale che ha le sue particolarità anche in termini di finitura, un multistrato di betulla, con una vernice con all'interno particelle di argento che lo rendono sanificante».
È quasi inutile dire che un pavimento del genere dura di più.
«Quando si mette un pavimento in legno non è poi così facile, nel tempo, fare una levigatura e riprodurlo uguale, in opera. Però quando si posa un pavimento di qualità, può durare anche 30-40 anni. Una volta sapevi che ogni 5-10 anni dovevi levigarlo. Ora non è più pensabile». C'è anche la questione ecologica.
71 LUGLIO 2023
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA
Sul mercato da 21 anni, lavorano con prodotti certificati. Un mestiere che unisce tradizione e innovazione
“Legno selezionato” vuol dire che non vengono distrutte foreste. «Tutto è tracciato. Siamo sicuri che non vengano tagliati boschi a caso. Tanti dicono che non bisognerebbe usare il legno, perché così disboschiamo il pianeta. Ma è vero il contrario. Se parliamo di aziende certificate, che lavorano in un certo modo, facciamo sì che il bosco venga protetto e mantenuto. Le piante dopo una certa età non producono più l'ossigeno come prima, e rischiano di far morire quelle più giovani. Tagliarle vuol dire far vivere meglio il bosco. Il legno è un materiale che si rigenera da solo. Se la filiera è certificata, fa bene al bosco e anche alla nostra salute».

Purtroppo, poi, interviene sempre il discorso economico. «Un prodotto certificato, costruito in un determinato modo, ha un costo, e ce l'ha per tutte le aziende, la differenza è di qualche euro. Se qualcuno ti propone il legno a 40 euro al metro quadro invece che a 80, anche se magari gli assomiglia esteticamente, deve farti pensare: non è la stessa cosa, non è un prodotto che dura, non c'è attenzione alla salute... A volte ti dicono: senti che profumo di legno! Ma il legno, una volta che è trattato e finito, non deve aver odore. Quegli odori che senti non sono
del legno (che profuma solo quando lo levighi) ma sono sostanze nocive che escono dal pavimento. Meglio che il “profumo” non ci sia». L'elenco delle certificazioni aziendali dei Lazzarin è più che abbondante. C'è l'FSC, che identifica il legno proveniente da “foreste gestite responsabilmente, secondo rigorosi standard”, ma anche l'E1, ovvero il multistrato di betulla caratterizzato dall'assenza di emissione di formaldeide. C'è il classico CE (la certificazione europea) e il 100% Made in Italy, certificato dall'Istituto per la Tutela dei Prodotti Italiani. Ma ci sono anche il Codice Trasparenza Parquet (della FederlegnoArredo), il CFLV, che valorizza le aziende venete del legno, e soprattutto il marchio “Confindustria per la sostenibilità”, una carta di principi condivisa dalle aziende che intendono salvaguardare il contesto
ambientale e sociale. Le specialità dell'azienda Lazzarin?
«Noi facciamo tutto ciò che riguarda il pavimento. Fornitura e posa del prefinito in legno, o materiali tecnici, fornitura e posa pavimenti esterni, che non hanno bisogno di manutenzione. Ma facciamo anche la levigatura, in opera, che abbiamo imparato quando abbiamo cominciato. Per le scale ci avvaliamo di una falegnameria che fa queste lavorazioni. Se poi il cliente sta ristrutturando, cerchiamo di fornire un servizio completo, garantendo anche porte ed altri complementi, appoggiandoci ad artigiani collaboratori». Fra poco arriverà anche un negozio-esposizione, per facilitare la scelta del cliente. Ma la differenza, ovviamente, la fa soprattutto il lavoro eseguito a regola d'arte. Con tutta la fatica del caso.


«Un po' di macchine ci hanno aiutato, è un lavoro un po' meno pesante rispetto al passato, ma sei sempre per terra, in ginocchio, piegato.... Non c'è da divertirsi. Quando l'azienda è tua, poi, non hai mai finito. Perché quando arrivi a casa ci sono le carte da sistemare». Le soddisfazioni però ci sono. E anche il guadagno. «Lavoro ne abbiamo, non ci lamentiamo. Sul lato economico i margini si sono ristretti, come per tutti, ma ci si difende»

Resta l'incognita sul futuro, in un mercato in cui si cerca soprattutto il risparmio. Non tutti capiscono che la qualità artigianale fa la differenza. Ed è difficile anche il ricambio generazionale. «Sarà un problema per tutti i lavori artigianali. In tanti hanno bisogno di personale, perché il lavoro c'è, ma non riescono a trovarlo. Produttori e commercianti vanno sempre più in cerca di prodotti per abbassare il prezzo. E così capita che noi andiamo a comprare i materiali scadenti
cinesi, mentre i cinesi importano i nostri prodotti d'élite». Come rispondono le aziende di qualità? Scegliendo chi innova. Una delle caratteristiche dei Lazzarin è quella di aver adottato una
posa con un sistema nuovissimo, un brevetto a livello mondiale, creato dall'azienda fornitrice. Si chiama “Clip-Up”. «È un sistema di posa. Generalmente col prefinito si lavora con la maschiatura classica, per livellare il pavimento (maschio-femmina). In questo caso la fresatura sulla superficie inferiore va ad agganciarsi con delle clip. È un sistema di posa flottante che a differenza degli altri è molto più aderente al pavimento, sembra quasi incollato, e in più ci permette di sostituire una doga in qualsiasi punto della casa, usando una semplice ventosa: la doga si sgancia e poi la si riaggancia senza problemi, quindi si può fare una sostituzione in un minuto, senza sporcare, senza fare rumore. Va bene anche per i pavimenti ispezionabili, in caso di sopraelevati. Puoi staccare porzioni di pavimento per poi riagganciarle». Mica male come idea.
73 LUGLIO 2023
L'ARTE DELL'EMPATIA: ASCOLTARE E ONORARE
Alessandro Zanirato racconta il suo mestiere, una missione, al servizio di famiglie e defunti
C'è un tema più difficile di cui parlare? Probabilmente no. Basta nominare la morte e subito cala il gelo. È ancora un argomento tabù. Anzi forse lo è sempre di più, in un'epoca in cui si è perso quel significato più profondo della vita che era quasi ovvio quando era
diffusa una visione religiosa dell'esistenza. La morte è un momento di passaggio fondamentale. Per questo andrebbe celebrata e condivisa con i propri cari nel miglior modo possibile.

Ecco allora la funzione di chi si occupa di “onoranze funebri”. Che si distinguono, tra loro, anche per la consapevolezza con cui fanno il loro lavoro. No, non sono tutti uguali. C'è chi ne fa una questione di business, un mestiere come un
altro, una routine, in cui conta solo il fattore economico, secondo il luogo comune, anche un po' cinico, per cui “questo è un settore che non va mai in crisi”. E chi invece conosce l'importanza dell'ascolto e dell'empatia, ed è consapevole di cosa significhi per le persone varcare le soglie di un ufficio per organizzare una cerimonia funebre, cercando in ogni occasione di metterci la sensibilità e l'attenzione della prima volta.
Alessandro Zanirato appartiene a questa seconda categoria. Anche per una questione di familiarità con questi temi. Suo padre, infatti, lavora nel settore dagli anni Sessanta. A quei tempi a Rovigo esisteva una sola ditta di onoranze funebri. Lui, insieme ad alcuni soci, aprì un'altra realtà, divisa in due (una si occupava dei trasporti comunali, quando c'era ancora questa opzione). Vent'anni di lavoro intenso.
Alessandro non ha seguito subito le orme del padre. Ha vissuto una parentesi di dieci anni a Treviso, un'esperienza a Ferrara (sempre in questo campo), e poi ha scelto di tornare a casa. Ad Arquà Polesine, a due passi da Rovigo (neanche dieci chilometri). La ditta si chiama “Zanirato Alessandro, onoranze funebri” (www.ofzaniratoalessandro.it). Un nome molto conosciuto sul territorio. Parliamo con Alessandro della delicatezza del suo lavoro e di come viene recepito, l'idea diffusa secondo cui per fare un mestiere del genere serve una grande forza mentale, visto che si sta quotidianamente a contatto con la morte e il dolore delle persone. «Ci vuole sicuramente una grande forza d'animo e anche “di stomaco”, per lavorare con i defunti. E ci vuole esperienza. C'è chi intraprende questa attività non avendo un know how nel settore, ma poi si rende conto molto presto di quanto sia difficile. Io sono nato in questo mondo. E posso dire che in questo lavoro c'è soprattutto bisogno di tanta psicologia. Quando ti entra in ufficio una persona che ha perso un famigliare, bisogna saperla ascoltare e capire quali sono le sue esigenze, in un momento emotivamente difficile».

A questo aspetto, più umano, va poi unito quello economico, perché comunque si tratta di servizi che comportano costi importanti.
«A noi spetta anche capire se, chi entra in ufficio, è in grado di pagare i servizi, e quanto. Le persone, purtroppo, hanno bisogno di venire qui. Non è come quando devi acquistare un'auto e quindi puoi anche


decidere di aspettare. Non puoi fare a meno dei servizi funebri, quando capita, e quindi emergono le difficoltà delle persone. Devo dire che, per la mia esperienza, chi ha di meno tende comunque a fare di tutto per assolvere l'impegno. Mentre capita che persone più facoltose facciano
i conti con le questioni legate alla successione, ai possibili contrasti con i famigliari... Ci si trova in mezzo anche a problemi del genere e bisogna saperli gestire». Ma al primo posto, tra le qualità richieste a chi fa questo lavoro, c'è l'empatia.
75 LUGLIO 2023
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA 74 LUGLIO 2023
Un lavoro delicato, a contatto con il dolore delle persone Servono esperienza, dedizione, attenzione ai dettagli
«Ascoltiamo spesso i racconti di tutta una vita. Dobbiamo anche provare a capire chi era il defunto, la sua storia, per poterlo onorare come si deve. Bisogna anche far fronte ad esigenze particolari.
Tempo fa ci è capitato di onorare un carabiniere, un funerale di Stato, e abbiamo fatto tutto il possibile perché ricevesse il giusto omaggio, ospitando i colleghi in alta uniforme e creando un cuscino adatto perché il defunto potesse indossare il suo cappello militare. Il nostro lavoro è quello di capire le necessità di chi abbiamo di fronte».
Necessità che possono essere tante e diverse. Spesso è una questione di dettagli, che magari esulano dal servizio base. «Noi facciamo sempre tutto il possibile. Penso ad esempio ai fiori. A volte arrivano anche richieste strane. Ma negli anni abbiamo sviluppato una buona intesa con il nostro fornitore, il fioraio. Capita che ti chiedano
anche un ruolo sociale. «Ci raccontano anche cose molto personali. Spesso si entra in confidenza con la famiglia».
rose bianche con una particolare sfumatura di rosa, e noi le troviamo». Chi si occupa di onoranze funebri non deve giudicare, ma avere la sensibilità di capire il momento vissuto dai cari, gli amici, i famigliari, e andare incontro alle loro esigenze. «Io la vedo come una cerimonia. In un certo senso è come se fosse un matrimonio. Solo che il matrimonio hai tanto tempo per organizzarlo, qui invece devi fare tutto da un giorno all'altro. Ma da noi si viene solo in quella occasione e noi dobbiamo fare il massimo per celebrare il defunto. Io dico sempre ai parenti di chiamarmi senza problemi, a qualsiasi ora, in caso di dubbi o richieste. Capita di avere a che fare per la prima volta con le onoranze funebri e di avere tante domande in testa. Io sono sempre a disposizione. Questo lavoro va affrontato come una missione». Chi fa questo lavoro onestamente ha
La “Zanirato Alessandro” offre un servizio completo. «Cofani, fiori, tutto ciò che concerne il servizio, trasporto». Il “tutto incluso”, che può sembrare uno slogan irrispettoso in questo particolare settore, in realtà è una facilitazione per le famiglie, in un momento in cui non si ha la voglia e l'energia per pensare a queste cose. «Noi facciamo tutto anche a livello burocratico. Abbiamo anche un servizio “post-mortem” per quanto riguarda le questioni legate alla successione. In teoria bisognerebbe girare per i vari uffici. E invece ci pensiamo noi».
C'è anche il “Programma oggi per domani”, la previdenza funeraria. Come scrivono sul sito: «La morte fa parte della vita. La morte arriva all’improvviso, senza avvisare, porta dolore, sconforto e molte volte non si sa come comportarsi per espletare le onoranze al proprio caro e soprattutto può essere un costo economico, oltre che morale da affrontare. Questo progetto va a risolvere tutte le esigenze che si devono affrontare nel momento del decesso di una persona, quando però questa persona è ancora in vita». Si tratta di scegliere una tipologia di servizio standard e di pagarla attraverso un prodotto assicurativo, evitando di pesare in futuro sulla famiglia, magari in un momento di difficoltà.


Viviamo in un'epoca molto particolare, in cui la morte è diventata qualcosa da cancellare, da rimuovere, da nascondere.
Una volta la cerimonia funebre era un momento da condividere con una comunità. «C'è stato un cambiamento radicale per quanto riguarda l'approccio alla morte.
La bara scoperta in casa si tiene solo in rari casi. E vediamo anche un modo diverso di vivere la morte, difficile oggi assistere alle scene di disperazione di un tempo. C'è più distacco».

Ma a volte i cambiamenti sono anche positivi. Vedi ad esempio la crescita del ricorso alla cremazione. «Che va sempre spiegata. Ha un costo in più, poi però le ceneri si possono tenere a casa o disperderle, e c'è un risparmio a lungo termine. I loculi adesso hanno un costo importante e dopo 30 anni c'è l'estumulazione dei resti ossei, che è anche una cosa spiacevole. I morti andrebbero lasciati tranquilli»
La questione è anche ecologica, nel rispetto della sacralità dell'atto. Leggiamo dal sito: «Rito di antichissime tradizione, quella della cremazione appare oggi anche come una pratica di concezione moderna o come un'efficace soluzione ai problemi territoriali, igienici e urbanistici. Una scelta razionale, ecologica, che rispetta la vita, non sottrae spazio o risorse ai vivi e non inquina la terra, l’aria
colori, invece dei soliti bianco e bronzo. Oggi ci si può sbizzarrire anche in questo campo. Ricordo una cassa per la cremazione su cui abbiamo fatto dei buchi col trapano aggiungendo degli strass, su richiesta del cliente. Sono stati molto apprezzati». La seriosità disperata non è obbligatoria. «Diciamo che Taffo ha fatto scuola in questo senso».
e l’acqua. Un rito universale, uguale per tutti, che, evitando ai corpi lo squallore del disfacimento appare non come la negazione, ma come affermazione della sacralità della persona umana».
Ci sono molti modi di vivere la morte. C'è anche chi sceglie di sdrammatizzare. E chi non si accontenta di “fare come tutti”, scegliendo soluzioni particolari.
«Ad esempio c'è una nuova cultura delle lapidi, con lettere incise invece che applicate e con l'uso dei
Ciò che non cambia, è l'arte dell'empatia. «Si può piacere o non piacere alle persone, ma si cerca sempre di ascoltare. E quando le persone tornano da te, vuol dire che hai fatto un buon lavoro. Non può essere solo un business. Bisogna capire ciò che stanno passando le persone in quel momento. Tanto che spesso di instaura un rapporto di amicizia. Se dai l'impressione di essere professionale e di avere anche un lato umano, le persone si appoggiano a te».
76 LUGLIO 2023
Cresce sempre di più il ricorso alla cremazione, scelta più ecologica e, alla lunga, anche più economica, nel rispetto della sacralità della persona umana
«Cercare ciò che è piacevole e sottrarsi a ciò che è spiacevole». Non è questo a cui tutti miriamo, soprattutto in tempi come i nostri, ossessionati dallo “star bene”? Il rischio è che questa ricerca frenetica finisca per produrre l'effetto contrario (o sollievi illusori, transitori), anche quando si tratta di quella pratica che, in teoria, dovrebbe aiutarci a costruire uno spazio di quiete, autenticità, consapevolezza. «Molti si costruiscono un’isoletta felice di benessere privato, intitolata “meditazione”, nella quale trovare riparo dalle angosce». Ma lo scopo non dovrebbe essere anche quello di andare oltre l'ego?
Questo è uno degli argomenti più interessanti, tra quelli affrontati da Massimo Tomassini nel suo La vita consapevole (Castelvecchi Editore), che già nel sottotitolo – La mindfulness dopo la mindfulness – rivela la sua natura di riflessione cardine, dedicata a una "moda" che attende di essere trasformata in uno strumento sostanziale, radicato, di crescita individuale e collettiva. Una riflessione che affronta tanti temi, anche decisivi, mettendo a confronto la tradizione con la sua rielaborazione moderna, il nucleo spirituale orientale con il pensiero filosofico occidentale. È tempo di andare oltre la manualistica self-help, approfondendo l'argomento e la pratica, a seconda delle esigenze di ognuno, laica o spirituale, sulle tracce del “buddhismo impegnato” (secolare) o della "neurofenomenologia" (un salto di paradigma?), o anche semplicemente alla ricerca di un'esistenza più autentica e meno schiava dei condizionamenti, interiori ed esteriori. Qui trovate i concetti fondamentali del buddhismo, dal nonsé («inteso come contributo a un regime per lo sviluppo dell’“io sano”») alla liberazione («aperta al raggiungimento di ciò che si può definire l’“al-dilà-del-sé”»). I fondamenti della MBSR ideata da Kabat-Zinn, ma anche la critica a quel fenomeno commerciale che qualcuno ha ironicamente chiamato “McMindfulness”.
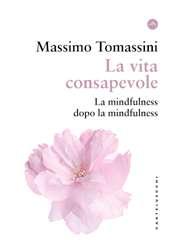

Trovate tanti nomi importanti e il loro pensiero, da Sumedho a Bacthelor, da Kornfield a Thanissaro, da Analayo a Varela.
«Ci alleniamo a vedere la realtà esattamente com’è e designiamo come consapevolezza questo particolare modo di percezione. Solitamente infatti non guardiamo dentro ciò che ci sta effettivamente di fronte. Vediamo la vita attraverso uno schermo di pensieri e concetti e confondiamo questi oggetti mentali con la realtà» Lo scopo è quello di essere più liberi, ma anche più solidali e compassionevoli.
Esiste tuttavia un tratto fondamentale che accomuna tutti coloro che in diversi modi si ingaggiano nell’esperienza del meditare, e che può essere definito in termini di “desiderio di liberazione”, per molti versi il desiderio più profondo e autentico dell’umano, situato al di là della sfera dei bisogni (…)
Il desiderio di liberazione può essere infatti considerato come ciò che supporta la meditazione e che contiene l’energia necessaria per il riconoscimento e il depotenziamento dei veleni che inquinano la vita e generano sofferenza. Il desiderio in questo senso si caratterizza come una aspirazione a un “bene” ulteriore, perseguito con una “cura” (appamada) che ha un carattere allo stesso tempo etico ed energetico (…)
Il desiderio di risveglio è, in questo senso, antagonista diretto del desiderio comunemente inteso. Sul desiderio di risveglio può imperniarsi una cura di sé, o meglio “del sé”, basata sulla necessità di lasciare andare l’illusione del sé autonomo: una costruzione immaginaria intorno alla quale si solidificano i fattori della sofferenza (…) Si avvia così un “prendersi cura” che assume la liberazione come una meta non a portata di mano ma da conseguire attraverso il cammino nella pratica meditativa e nella vita consapevole
(Massimo Tomassini)