Dove si parla di pane buono e giusto e di silenzio, di uomini che vogliono cambiare il mondo e cercare se stessi, di musica eccentrica e cinema d’autore (Cannes!), dell’Yijing e dell’arte di Tullio Pericoli, del trionfo di Harrison Ford
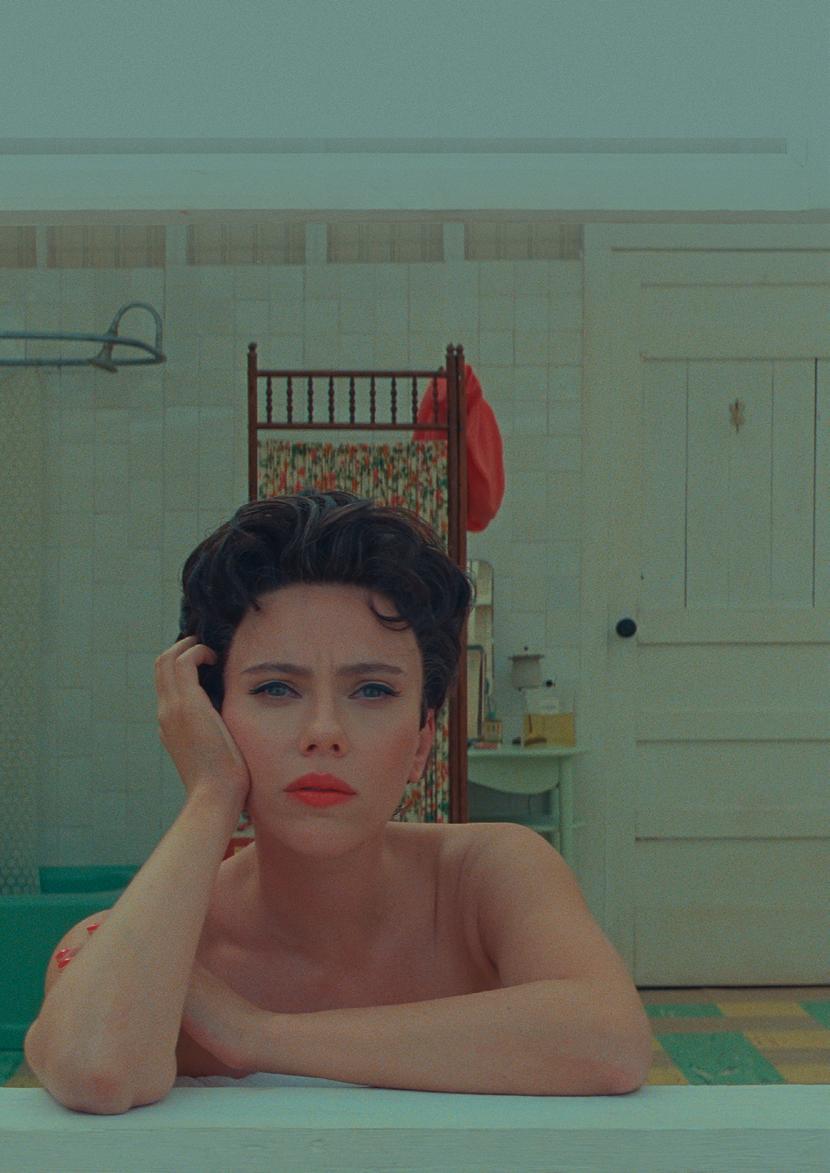
N 10 | GIUGNO 2023
Fabio Cappelletti
Alessandro Deho’
Johnny Depp
Scarlett Johansson
Harrison Ford
Lily Gladstone
N.A.I.P.
REDness
48
EVENTI
spinge a fare e creare. La redness
è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina.
fuoco sacro, la bellezza,
rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi.
Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità... Va bene tutto, purché sia fatto con redness.
In copertina: Scarlett Johansson
nel film "Asteroid City" di Wes Anderson (servizio sul Festival di Cannes da pag 48)
Direttore: Fabrizio Tassi
Progetto grafico: Marta Carraro
Redazione: MondoRed
Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore
4 EDITORIALE
4 Il film della vita
6 INCONTRI
6 Fabio Cappelletti: nel nome del pane buono e giusto
18 N.A.I.P.: la musica come performance liberatoria
S28 Alessandro Deho': vita solitaria di un prete immerso nella natura
42
MEDITAZIONI
42 Yijing: quelle linee che svelano il cosmo
48 Festival di Cannes 76: un'edizione da ricordare
52 La realtà, tra banalità del male e bellezza delle piccole cose
56 Film da vedere: Aki Kaurismaki, Todd Haynes, Martin Scorsese, Wang Bing, James Mangold, Marco Bellocchio, Maïwenn, Hirokazu Kore-eda
62 Johnny Depp
64 Lily Gladstone
66 Scarlett Johansson
68 Harrison Ford
70 Julianne Moore e Natalie Portman
72
STORIE D’IMPRESA
72 Isofam: il pronto soccorso dei camion frigo
76 La Baita: pasticceria e buonumore
78
COMMIATO
78 Tullio Pericoli: “Ritratti di ritratti”
3 GIUGNO 2023 2 MESE 2022
è passione, arte, impresa, comunicazione.
È il "rossore" provocato dalle emozioni forti.
Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci
È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il
l'idea
OMMARIO
Il film della vita

Vivere la vita come fosse un film. La metafora ha una sua nobile tradizione. Che affonda le proprie radici nel simbolismo della maschera e del teatro: la vita come una recita sul palcoscenico del mondo. L'hanno usata filosofi, poeti, romanzieri. Anche uomini e donne dedite allo spirito, per sottolineare la natura illusoria della realtà. Che però va vissuta al massimo delle sue possibilità. Come dire: non prendere la vita troppo sul serio (troppe cose sono fuori dal nostro controllo) ma dai il meglio di te nel ruolo che hai scelto o che ti è toccato (attitudine, vocazione, accidente). Perché? Per capire qual è il tuo posto nel mondo; per imparare la "lezione" (karma? provvidenza?); per scoprire l'unità che sta sotto (sopra) la molteplicità delle cose; per non arrivare alla fine dei giorni senza aver conosciuto l'amore, la bellezza, possibilmente anche una qualche verità.
Poco importa cosa fai nella vita. La differenza la fa il "come". Per questo a noi di Redness piacciono quelli che fanno le cose fino in fondo, magari andando controcorrente, dando un senso profondo alla propria vita, mentre cercano di aiutare gli altri.
Ci piace la storia di Fabio Cappelletti, che non capiva le fatiche di suo padre, fornaio, ma poi ha scoperto il piacere di fare il pane, anzi, di farlo buono e giusto, come lo si faceva una volta, lavorato a mano, partendo da grani antichi, costruendo una filiera che faccia bene al territorio e a chi lo vive. "Nel nome del pane" è un piccolo forno che ha un grande sogno, quello di cambiare il mondo (cominciando dal cibo, dal modo in cui lo produciamo e consumiamo). Lo fa partendo dalla Romagna, terra meravigliosa e sfortunata, che vogliamo omaggiare in questo modo. Auspicando un cambiamento sempre più urgente.
Ci piace Alessandro Deho', un prete che ha scelto di abbandonare la sua parrocchia e i suoi "grandi progetti" per ritirarsi in una casa isolata su una collina, nella Lunigiana, immergendosi nella natura e nel silenzio. Non basta "aiutare i poveri", bisogna diventare poveri, questo fa la differenza, come ha insegnato san Francesco, uno dei suoi punti di riferimento. In quel luogo ora arrivano tante persone, per confrontarsi con lui, raccontare la loro storia, anche solo per stare qualche ora insieme. Lo chiamano "eremita", ma la sua solitudine è diventata un'occasione per coltivare tante relazioni autenticamente umane.
Ci piace N.A.I.P., musicista solitario, eccentrico, creativo, che se ne frega dei generi e delle mode, che è passato dall'avanguardia a X Factor rimanendo fedele a se stesso. Il "sistema" si può criticare e sbeffeggiare standoci dentro.
Ma sul numero di giugno - visto che a noi piacciono anche la complessità e la diversità - a queste storie di ricerca, impegno, solitudine, abbiamo affiancato i divi del cinema e i grandi film visti a Cannes.
Siamo stati sulla Croisette per raccontarvi il festival. La seconda parte della rivista è dedicata a quelle due settimane di folle oceaniche, presentazioni glamour, proiezioni in anteprima mondiale.
Abbiamo scelto di seguire da vicino e raccontarvi alcune attrici e attori: da Lily Gladstone, che ha prestato le sue origini amerindia-
ne al genio di Scorsese, a Johnny Depp, tornato sotto i riflettori del cinema dopo tante polemiche e giornate passate in tribunale; da Harrison Ford, travolto dall'affetto dei fan e particolarmente commosso, a Scarlett Johansson, la diva che vuole essere "una di noi"; da Julianne Moore, che quando parla di donne non le manda a dire, a Natalie Portman, con cui ha duettato in May December. Nello speciale, però, troverete soprattutto titoli, idee, proposte di visione, nell'ottica di un cinema che non sia solo intrattenimento, ma invenzione, intuizione, provocazione. Cinema che ci aiuta a guardare meglio la realtà, o a immaginarla diversamente. I film più belli visti quest'anno evocano il passato come fosse un fantasma che aleggia tra le rovine del presente. Raccontano la fatica di capire cosa è vero e falso, come distinguere la realtà dalla sua rappresentazione. Parlano del cinema come fonte di una narrazione alternativa del mondo, rispetto a quella caotica, grossolana, spettacolare, fatta dai mezzi di comunicazione. Ecco allora che l'apparente contrapposizione tra la prima e la seconda parte si ricompone, dentro le ragioni della redness, la passione per la vita, il senso, la voglia di provarci, l'attitudine al cambiamento. Non per niente, a metà strada fra le due sezioni, parliamo di Yijing, di yin e yang, del dualismo alla base dell'universo, che l'uomo aspira a ricomporre in qualche modo. (f.t.)
5 GIUGNO 2023 4 GIUGNO 2023
E DITORIALE
Fabio Cappelletti
Nel nome del pane buono e giusto. Storia di un piccolo forno che vuole cambiare il mondo, partendo dal territorio (romagnolo)

«Fare il pane è un atto politico»
I NCONTRI
di Fabrizio Tassi
(foto Silvia Bertozzi)
Cosa c'è di più semplice e nutriente del pane? L'alimento base. Fatto solo (in teoria) di acqua e farina. Il cibo più importante, anche da un punto di vista simbolico. Quello che, tradizionalmente, è sempre stato alla portata di tutti, e che tutti, più o meno, cucinavano in casa. Poi è arrivato il tempo dei fornai e della loro arte, ognuno col suo particolare modo di dosare gli ingredienti e il levito, di impastare e cuocere, che ha generato varie qualità, forme, sapori. Ma la società è cambiata, l'economia è cresciuta vorticosamente, così come le dinamiche del profitto. È cambiato il modo di lavorare e anche quello di stare insieme, le esigenze delle famiglie. La produzione è diventata industriale, fondata solo sull'efficienza, sulla

Non ho mai pensato di fare il fornaio, non capivo il senso di tutti quei sacrifici. Pensavo solo a godermela. Poi ho cominciato a ragionare sul modo in cui mangiamo e l'impatto che noi esseri umani abbiamo sulla terra
legge della quantità, e il pane non è stato più lo stesso. In certi casi è difficile definirlo ancora pane. Ed ecco che l'alimento base, essenziale, si rivela una specie di unità di misura, un modo per constatare quanto è diventata artificiale la nostra vita, spesso frettolosa, insensata, insalubre, priva di sapore. Il pane simbolo di come eravamo e di ciò che siamo diventati. Ma anche di come potremmo essere domani. Nasce da qui il sogno (la realtà!) di un progetto come Nel nome del pane. Che prima di tutto è un forno, un luogo in cui si produce un pane sostenibile, fatto con grani antichi, biologico, artigianale, impastato rigorosamente a mano, radicato nell'economia locale, dentro una filiera fondata sulla qualità delle materie prime e sulla necessità che tutti ricavino il giusto profitto dal loro lavoro, senza essere schiavi dei grandi marchi e delle fluttuazioni del mercato. Ma il piccolo forno, ormai, è diventato un grande progetto che non sta generando solo pane – e nuovi punti vendita, e un'azienda agricola – ma anche consapevolezza diffusa.
Il suo portavoce è Fabio Cappelletti. Che da ragazzo non aveva nessuna intenzione di fare il fornaio. Anzi, non capiva proprio perché qualcuno dovesse fare tutta quella fatica. La sua storia è emblematica. Quasi propiziatoria. È la dimostrazione di ciò che accade quando si forma una coscienza critica e si decide di cambiare stile di vita, dando un senso diverso al come e al perché lavoriamo (e produciamo e consumiamo).
Oggi Fabio non ha paura di dire che “fare il pane è un atto politico”. E viene chiamato a parlare in convegni e incontri in cui si prova a immaginare una società più sostenibile (la parola forse è un po' abusata, sostituitela pure con vivibile, giusta, bella, fondata sulla felicità e non sul profitto).
Ma questa sua “missione” non ha intaccato per nulla la schiettezza e la solare semplicità (romagnola) con cui parla di temi anche impegnativi, dopo aver accumulato tanta esperienza ma anche conoscenza, frutto di letture, incontri, scelte controcorrente.
Il pane artigianale prodotto dalla sua famiglia, oggi, contribuisce ad aumentare il benessere di chi vive nel territorio. Ha ricadute positive per tutti i cittadini. E sta diventando anche un modello, che potrebbe “contagiare” positivamente altri produttori, anche nell'idea di creare una filiera virtuosa, che parte da pratiche rivoluzionarie, come quella di evitare l'aratura dei campi.
Raccontaci come è nato il forno di Dovadola, un comune di 1500 abitanti, a venti chilometri da Forlì.
I miei genitori hanno cominciato nel 1979, tre anni prima che nascessi. Erano molto giovani. Mio padre già faceva il fornaio, dall'età di 13 anni, a Predappio. Poi ha incontra mia mamma e insieme hanno deciso di partire con questa avventura a Dovadola. Il forno del paese aveva chiuso. Alcuni conoscenti, che stavano aprendo i primi punti macrobiotici (il biologico non esisteva ancora, il cibo naturale era quello), gli avevano suggerito di prendere in mano quel forno. Gli dissero: se fai il lievito madre, se usi farine integrali, se lavori in un certo modo, noi veniamo a prendere il pane da te. E comunque era un tempo in cui i forni di paese funzionavano ancora bene. Era un forno a legna. Mi ricordo mio padre che faceva le fascine di legno da mettere nella camera di combustione.
Un lavoro duro.
Cominciava alle 9 di sera e lavorava tutta la notte. Arrivava tutti i giorni da Predappio (20 chilometri) con mia madre, che andava a dormire nel retrobottega, su una brandina. Quando mio padre sfornava il pane,
alle 6 di mattina, la svegliava e lei apriva il negozio. Il babbo portava il pane con un carretto, dal forno al negozio, che era dall'altra parte della piazza. Ce l'ha ancora, è molto orgoglioso di questo carretto. Sembra un'epoca lontana, ma non lo è. Quando ho preso in mano la contabilità del negozio, mi è capitato di sfogliare i documenti dell'epoca: il primo anno incassavano 38 mila lire al giorno.

Da ragazzino non pensavi di fare questo mestiere.
Mai pensato. Non capivo che senso avesse fare tutti quei sacrifici. La vedevo come una cosa estremamente impegnativa, a cui non riuscivo a dare un significato. Appena ho potuto, ho iniziato a lavorare a Forlì. Avevo un'azienda insieme a mio zio, facevamo impianti industriali per allevamenti intensivi. Quindi ho conosciuto quel mondo. Ho visto con i miei occhi quell'approccio nella produzione di cibo. Un modo che oggi faccio davvero fatica a capire e giustificare.
Poi ho fatto un'altra esperienza, gestendo un gruppo di sei farmacie private. Anche qui ho vissuto un insieme di cose, di esperienze, in cui mi sono accorto che il denaro era più importante delle persone. Non ne ero ancora così cosciente, però mi sono reso conto che non stavo bene.
8 GIUGNO 2023
9 GIUGNO 2023
Fabio Cappelletti
Non mi piaceva vedere le persone trattate in malo modo con l'unico scopo di guadagnare di più. Ho smesso anche lì e per un anno ho lavorato a Bologna in un'azienda di consulenza nella gestione delle risorse umane. Se non altro in quel posto ho avuto l'opportunità di capire l'importanza delle persone, che sono la risorsa più importante di un'azienda, ancora oggi, anche se non si sa ancora per quanto... Alla fine ho preso la decisione di tornare al forno dei miei genitori.
A quel punto hai cambiato anche stile di vita.
Le cose in realtà non stavano funzionando benissimo per me. A quel tempo per me le cose più importanti erano girare con una bella macchina, vestirsi in un certo modo, uscire la sera con gli amici. Ma non riuscivo più a permettermelo. E grazie a quel cambio radicale, mi sono trovato in una realtà in cui avevo tanto tempo per me. Quando gestivo le farmacie, lavoravo praticamente sempre. Al forno dei miei genitori, invece, andavo a lavorare alle 3-4 di notte, e spesso alle 8-9 del mattino avevo finito di fare le consegne. Finito davvero! Non avevo pensieri, re-
sponsabilità. Un cambiamento incredibile. Questo vuoto mi ha permesso di andare a fondo su temi che prima non avevo mai considerato: come noi esseri umani impattiamo sulla società, sulla terra, come produciamo l'energia che consumiamo e il cibo che mangiamo, perché è meglio mangiare un certo cibo piuttosto che in un altro, che cosa succede nel nostro organismo... Ho letto, ho studiato. E ho deciso di fare un cambio radicale nella mia vita. Non mi interessavano più la macchina o i vestiti. Ho cominciato ad alimentarmi in modo diverso. Per dire, da ragazzo sono sempre stato un grande mangiatore di carne, ma mi sono ritrovato a fare tre anni di veganesimo.


Ecco perché il “sistema” vuole riempirci le giornate, tra lavoro e tempo libero: finché siamo occupati a sopravvivere, o a trovare nuovi modi per divertirci, non abbiamo tempo per pensare. Per quello, serve il “vuoto”.



tagne. Anthony Robbins (Come ottenere il meglio da sé e dagli altri). Io ho un difetto che forse è un pregio, non lo so: quando leggo e scopro certe cose, poi faccio fatica a fare in un altro modo. Se prendi coscienza di come funzionano le cose, poi devi agire.
Avevi anche di fronte l'esempio di tuo padre, che faceva già le cose in un certo modo, magari senza una “consapevolezza politica”.
Assolutamente. È stato un percorso bello e difficile, perché comunque quando si lavora in famiglia è sempre tosta. Ma c'era già una direzione. L'idea di fare le cose in modo molto artigianale. Mancava la presa di
coscienza, la scelta di prendere una direzione ben definita. Quando sono arrivato io, nel 2009, abbiamo fatto la certificazione del biologico. Questo ci ha dato la possibilità di accedere a nuovi mercati. Abbiamo potuto partecipare anche ai mercatini biologici: sembra una cosa così, ma per me andare tutti i giovedì mattina in piazza, essere a contatto diretto con la gente, poter raccontare perché facciamo le cose in un certo modo, ascoltare le persone, è stato un modo per crescere. Poi, in realtà, affrontare certi cambiamenti, con mio padre non è sempre stato facile. Io sono quello originale. Mi dice: ma perché dovremmo farlo? A volte vengo anche un po' “coglionato”, in senso buono.
Facci un esempio di cambiamento radicale.
Io ho avuto un incontro chiave con Nicolas Supiot, un panificatore francese. Il suo approccio alla panificazione mi ha stimolato tanto e mi ha fatto crescere molto. Lui panifica solo a mano, ha una certa attenzione per l'acqua, la dinamizza. Fare il pane per lui è una sorta di rituale. Dopo questo incontro, ho iniziato da solo, al forno, a fare una linea di pane impastato a mano. Mio babbo aveva lavorato per una vita in un altro modo, con l'impastatrice, e questa cosa sembrava un'utopia. Invece ormai sono anni che impasta a mano, tutti i giorni. È diventata la sua passione, non ci rinuncerebbe mai.
Qual è la differenza dal punto di vista del prodotto finale?
Noi abbiamo fatto un percorso intenso sulla materia prima, a partire dalla farina, dai grani. Ma ad un certo punto ho iniziato ad aprire gli occhi anche sull'acqua, imbattendomi negli studi di Masaru Emoto. Noi siamo fatti di acqua, tutto ciò che mangiamo è fatto di acqua, entriamo continuamente in risonanza con altri organismi fatti di acqua. Ci influenziamo a vicenda, c'è un'interazione. Il pane si fa con la farina e l'acqua. Una mia ricetta per un chilo di pane prevede l'uso di 700 grammi di farina e 500 di acqua. Se l'acqua “ha una memoria”, come dice Emoto, cioè è in grado di assorbire e trasmettere informazioni, quando si usa l'impastatrice, che è fatta di metallo ed è alimentata dalla corrente elettrica, assorbe quell'informazione.
11 GIUGNO 2023 10 GIUGNO 2023
Ricordo alcune letture chiave. The China Study di Colin Campbell. Andrea Bizzocchi. Pensare come le mon-
Fabio Cappelletti
Il pane comprato al supermercato?
Bisognerebbe cambiargli il nome. Non è pane. Oggi mangiamo un surrogato, qualcosa che non gli assomiglia nemmeno. Lo scopo non è più prendersi cura di chi si alimenta, conta solo guadagnare
Si imprime nell'impasto una certa frequenza, che è molto diversa da quella che noi imprimiamo se impastiamo con le mani. Soprattutto se lo facciamo in maniera cosciente.
E se non sei nervoso e arrabbiato.
Certo. Sono cose che, in un certo senso, si sanno da sempre.
Un panificatore industriale ti direbbe che sono cose new age.
In realtà le dicevano già le nostre bisnonne.
Dicevano anche che è meglio consumare la carne di un animale che ha avuto una vita felice, perché ha un altro sapore.
Sì, è lo stesso concetto. Se panifichi a mano e sai cosa stai facendo, dai un certo imprinting al pane. Stai operando una trasformazione, una delle prime alchimie fatte dall'essere umano, quella di mischiare l'acqua con la farina. A quel punto il pane diventa anche una responsabilità. È qualcosa di cui le persone si nutrono. Ed è molto diverso farlo in maniera industriale o in modo artigianale.
Cosa mangiamo oggi quando compriamo il pane al supermercato?
Secondo me dovremmo cambiargli il nome, perché è un'altra cosa rispetto al pane. Completamente. Ecco perché ho chiamato il progetto Nel nome del pane Oggi mangiamo un surrogato, qualcosa che non gli assomiglia nemmeno. Lo scopo è il business, non il prendersi cura di chi si alimenta. Si lavora per quel fine e quindi si risparmia il più possibile sulla materia prima, sui costi di produzione, sull'acqua, ecc.
Le farine vengono da chissà dove, prodotte in chissà quale modo, raffinate all'inverosimile. Certi tipi di pane che si trovano nella grande distribuzione spesso sono fatti con dei miscelati, preparati per la panificazione, dei sacchi in cui non c'è solo la farina, ma conservanti, miglioratori, agenti lievitanti, tutte quelle sostanze che cominciano con E e che non ho mai visto in natura.
Faccio l'avvocato del diavolo. Un industriale ti potrebbe dire che grazie alla meccanizzazione, la tecnologia, la produzione intensiva di grano, siamo in grado di sfamare milioni di persone. Portiamo il pane ovunque. Se tornassimo a una produzione artigianale come potremmo riuscirci?
La prima cosa che chiederei a questo industriale è: quanto pane viene buttato in realtà? Viene gettata una grandissima percentuale del pane prodotto, inimmaginabile. Già questo è un tema. In più, quel tipo di pane lo mangi in quantità differente.
Il pane fatto dalle nonne, che si occupavano dell'alimentazione della famiglia, garantiva un certo tipo di nutrimento con poche fette, e durava molti più giorni.


Riguardo la produzione, ci sono anche delle “vie di mezzo”. Non voglio sembrare un estremista, anche se nella mia realtà, nel mio panificio, lo sono. Ma se parliamo di politiche su larga scala bisogna fare riflessioni più profonde, non integraliste.
C'è da dire che in Italia un campo di grano su cinque è stato dedicato a un altro tipo di agricoltura, perché conviene comprare il grano che viene dai paesi dell'est, piuttosto che produrlo, con tutti i vari problemi di micotossine e muffe. Non ho il controllo preciso dei numeri, ma sono certo che se tornassimo ad ottimizzare la produzione del nostro cereale, a trasformarlo e consumarlo autonomamente, riusciremmo a farcela tranquillamente.
Tu dici: “Fare il pane è un atto politico”. Non è solo una metafora. Pensi davvero che cambiando il modo di produrre il cibo, cambierebbero anche l'economia e la società in cui viviamo?
Anche questa è una presa di coscienza maturata negli anni, che mi ha appassionato a questo mondo e mi
ha dato stimoli incredibili. Questa ora è la mia vita, non è solo un lavoro. Mi rendo conto che sto facendo qualcosa che va oltre il produrre pane. Magari è solo un semino, non lo so. Ma almeno sono a posto con la mia coscienza.
Quando nel forno utilizzavamo ancora farine di grandi mulini, ho iniziato ad approfondire questa cosa, cercando di capire da dove venivano, come venivano coltivate. Domande a cui era impossibile ottenere delle risposte. Poi mi sono imbattuto in Salvatore Ceccarelli, personaggio chiave, che ha fatto ricerche sui grani antichi, ha scritto testi che per me sono bibbie (“Mescolate contadini, mescolate”), che ci ha aperto gli occhi su che cosa è successo storicamente, come sono stai modificati i grani e perché.
Allora ho iniziato a fare certe scelte, ad esempio utilizzando solo farine che provengono da grani antichi, che non hanno subito modifiche in laboratorio, che mantengono caratteristiche naturali, e quindi hanno un glutine più digeribile, che vengono coltivati solo con metodi biologici.
13 GIUGNO 2023 12 GIUGNO 2023
(foto Marco Minniti)
Fabio Cappelletti
Noi consumiamo 1200 quintali di farina all'anno e io so che sto sostenendo e alimentando persone del mio territorio. Questa cosa ha una ricaduta sull'economia locale e sulla comunità. L'agricoltore non è più in balia degli eventi. Meno agricoltura intensiva significa anche meno pesticidi e inquinamento delle falde
Perché questa è una scelta anche politica, oltre che legata alla qualità alimentare?
Quando scegli di utilizzare un certo tipo di materia prima hai un impatto politico e sociale, perché io ho scelto di utilizzare solo farine ottenute da grani coltivati da aziende locali. Noi consumiamo 1200 quintali di farina all'anno circa e io so che sto sostenendo e alimentando persone che conosco, amici, famiglie del mio territorio. Questa cosa ha una ricaduta sull'economia locale e sulla comunità. Abbiamo una sorta di piano di sostenibilità con il mulino con cui collaboria-
mo e con gli agricoltori, nel senso che garantiamo un reddito minimo per ettaro. L'agricoltore così non è in balia degli eventi, delle quotazioni del grano, non ha l'obbligo di conferire a un consorzio. Ecco l'atto politico, l'impatto sul benessere del territorio. Se più aziende vengono stimolate a coltivare in questo modo, ci saranno dei benefici per tutti gli abitanti, anche perché fare meno agricoltura intensiva significa meno pesticidi e meno inquinamento delle falde acquifere. Li vediamo i disastri causati sempre più spesso dalle alluvioni. Hai visto cosa è successo nel nostro territorio in questi giorni? I disastri causati da piogge anomale. Ma se hai un approccio sul terreno di un certo tipo, queste calamità hanno effetti diversi.
Nel 2019 ho avviato un progetto agricolo. Ho rilevato dei terreni in stato di semi abbandono. Volevo sperimentare tutto quello che avevo letto e studiato (ora produciamo il 50% del grano di cui abbiamo bisogno). Ad esempio noi non facciamo l'aratura. Un atto rivoluzionario, anche questo.

Spiegaci perché l'aratura è da evitare.
Nella coscienza comune, fino a qualche anno fa era normale, anzi obbligatorio, fare l'aratura, ribaltare la terra, per poi andare a mettere sotto la sostanza organica, che di solito sta nei primi cinque centimetri. La si va a reintegrare con fertilizzanti e letami, andando a introdurre sostanze per rendere fertile anche in superficie la terra che abbiamo ribaltato. Oltre ad essere un dispendio di energie e di costi, queste lavorazioni hanno un impatto sul terreno. La parte di terra che noi giriamo è quella in cui le radici riescono a penetrare e a lavorare. Ma nello strato più profondo, con l'aratura, si finisce per creare una sorta di soletta, che diventa una specie di pavimento impenetrabile, per le radici ma anche per l'acqua. Quindi da una parte ciò che mangiamo è meno nutriente, perché le radici hanno una minore capacità di andare a prendere le sostanze che si trovano a una certa profondità. E dall'altra c'è un peggioramento del suolo: le piogge non riescono a penetrare in profondità ed è facile che creino disastri come quelli che accadono sempre più spesso. Oggi in molti stanno aprendo gli occhi, Ma per trenta-quarant'anni abbiamo arato tutti i terreni fino a quaranta centimetri di profondità.
Come si possono convincere gli agricoltori a cambiare i loro metodi di produzione? Ci vuole un cambiamento totale di sistema? O basta un “contagio” positivo, dal basso?

Ho collaborato a un paio di progetti con l'Università di Bologna, sulla ricerca di grani antichi per la panificazione. Abbiamo messo insieme un'associazione che si occupa del recupero di vecchie varietà romagnole, che non coltiva nessuno da anni. Ma mi sono reso conto che in questo tipo di progetti siamo sempre “i soliti”: soliti professori universitari, gli stessi due-tre fornai, quelle dieci aziende agricole... Però c'è un aumento dell'attenzione da parte del consumatore - se vogliamo definirlo in questo modo orribile. Ciò che secondo me può dare veramente la svolta è creare una politica di sensibilizzazione sociale su questi temi. Io ci sono arrivato perché avevo un forno in casa, perché ho cambiato delle cose nella mia vita, ho conosciuto dei professori universitari che fanno ricerche e mi hanno dato certe informazioni. Ma se non navighi in queste acque è difficile che ti venga lo stimolo di andare a capire cosa c'è dentro il pane che mangi. A scuola questi temi non vengono trattati. E invece si dovrebbe parlare di alimentazione legata al territorio,
quindi perché mangiare una cosa piuttosto che un'altra, la stagionalità, ecc. Chi può spostare l'ago della bilancia siamo noi. Noi, ad esempio, potremmo andare da un fornaio e dirgli che vorremmo mangiare un pano fatto con grani antichi e lievito madre. La domanda può influenzare l'offerta. Ma prima bisogna prendere coscienza di queste cose, occorre mettere le persone in condizione di fare certe scelte.
Quindi credi di più nella consapevolezza del cittadino, piuttosto che in una sorta di “decrescita felice” imposta dall'alto.
Siamo in un momento storico un po' delicato, non sappiamo bene cosa succederà. Io cerco di stare coi piedi per terra e di seguire il mio sentire. Sono molto convinto delle mie scelte, della strada che ho preso, e continuerò in questo modo, cercando di condividere la mia esperienza. La condivisione di esperienze è la cosa migliore che si possa fare.
Il tuo lavoro ormai è questo, hai smesso di fare materialmente il pane.
Lo faccio solo il sabato mattina.
15 GIUGNO 2023 14 GIUGNO 2023
Fabio Cappelletti
(foto Silvia Bertozzi)
(foto Silvia Bertozzi)
E se nascesse una specie di brand? Se Nel nome del pane fosse presente in ogni città? O magari anche solo quel modo di fare il pane. Una catena di fornai consapevoli.
Mi hai letto tra le righe. Questa è una delle operazioni aziendali che sto facendo. Oggi diamo il 65% del pane che produciamo a rivenditori specializzati nel biologico e il naturale. Lo facciamo in Romagna, in un raggio sostenibile di un centinaio di chilometri, tra Forlì, Cesena, Rimini e Faenza. Vorrei invertire questa percentuale e vendere più pane direttamente. Il pane fatto con questa filosofia, messo di fianco ad altri pani, anche se biologici, perde di valore. Chi lo vende non sa trasmettere cosa c'è dietro. Per me è importante che l'attenzione, la fatica fatta nel tempo per arrivare a questo pane, venga poi percepita da chi lo mangia. L'unica soluzione probabilmente è quella di essere di più in prima linea, dove poter raccontare meglio il prodotto. A settembre ad esempio avremo un nuovo punto vendita a Forlimpopoli. La catena è un'opzione. Ma bisogna trovare il giusto equilibrio.

Forse dovremmo rivedere il nostro concetto di "buono". È buono ciò che mi piace, certo, ma come è arrivato quel cibo sulla mia tavola? Quando mangi il pane dovresti percepire che viene da quei campi, da quel mugnaio, da quel fornaio
Alla fine, comunque, immagino che la soddisfazione più grande sia sempre quella di sentirvi dire che il vostro pane ha un sapore diverso, che è più buono.
Sì. Anche se in realtà, avendo più coscienza del cibo che mangiamo, dovremmo essere in grado di capire cosa c'è dietro. Forse dovremmo anche rivedere il concetto di cos'è “buono”. È buono ciò mi piace, sì, ma se per far arrivare
quel cibo sulla mia tavola ho dovuto inquinare mezzo mondo... Quando mangi il pane, dovresti percepire che viene da quei campi, da quel mugnaio, da quel fornaio.
È anche un prodotto simbolicamente potente, povero, basico, ma fondamentale. Ha perfino un significato religioso. È qualcosa di sacro. Sacralità della terra.
Nel nome del pane ha anche questo senso. È un ridare al pane il valore che ha sempre avuto. Il pane accompagna l'essere umano da centinaia di anni. Forse è il primo alimento che abbiamo trasformato. Il pane è condivisione. Il pane è in tutte le religioni e in mille modi di dire, fa parte della nostra storia su questo pianeta. Vedere come oggi produciamo pane, e che tipo di pane mangiamo, lascia l'amaro in bocca. Ma non c'è solo il pane, potremmo parlare di tanti altri aspetti della vita di oggi. Abbiamo delegato ogni cosa. Una volta il pane ce lo facevamo in casa. E la differenza era abissale. Il pane lo facevi per sostenere la tua famiglia. Ora viene fatto solo per ricavarne un profitto. Ma cosa stiamo mangiando, in realtà?
Romagna, disastro annunciato
Questa intervista è stata fatta prima della catastrofe che ha sconvolto la Romagna. C'erano già state delle avvisaglie il 2 e il 3 maggio (Fabio Cappelletti ne parla, in una risposta). Poi dal 15 al 20 maggio sono scesi 500 millimetri di acqua, per un totale di 350 milioni di metri cubi scaricati su un territorio di 800 chilometri quadrati. Sono esondati contemporaneamente 23 fiumi. L'alluvione ha coinvolto più di 100 comuni, causando 280 frane. Il bilancio parla di 15 morti e quasi 40 mila sfollati. Oltre 5 mila le aziende agricole colpite tra Forlì, Cesena e Ravenna. Raggiunto al telefono in quei giorni da incubo (lunedì 22) - gli chiedevamo se avesse bisogno di aiuto, se poteva essere utile un appello fatto ai nostri lettori - Fabio ci aveva risposto con la voce strozzata, ringraziando per l'offerta, ma dicendosi "miracolato": «Siamo stati a un passo dall'essere allagati in laboratorio, al panificio. Quando abbiamo iniziato a mettere i sacchi di farina davanti alle porte, l'acqua ha cominciato a defluire, probabilmente perché è staripato il fiume più a valle. Le cose importanti le abbiamo salvate. Nel centro di Dovadola siamo stati fortunati. Ma tutt'intorno è un disastro. I problemi più grossi li abbiuamo avuti al podere, in azienda agricola. Però ci sono tante persone che si sono offerte di aiutarci. Ciò che c'è bisogno ora è di mezzi in grado di liberare le stra-

de. Alcune vanno ricostruite letteralmente, perché sono scomparse. La strada per andare in azienda agricola, che usavo di solito, non esiste più. Ma se mi guardo intorno, se penso a ciò che hanno patito a Forlì, Faenza, Ravenna, Cesena... Lì ci sono persone che hanno perso tutto ciò che avevano.
Anche qui purtroppo c'è chi non ha più la casa e la sua azienda agricola. Ci sono persone che hanno molto più bisogno di noi, in questo momento. Aiutate loro se potete. Aiutiamo il popolo romagnolo. Vedo molto sostegno, tante persone che si stanno dando da fare per noi e questa è una cosa bella e importante»
Questa tragedia rende ancora più urgenti le riflessioni di Fabio e di tutti quelli che, come lui, stanno cercando di diffondere un modo diverso di produrre cibo e di fare economia (sostenibile), ragionando in termini di territorio, sviluppando filiere che rispettano la terra e le sue necessità. Tutti conoscono il problema del consumo di suolo e del rischio idrogeologico, dei terreni che non sono più in grado di assorbire la pioggia. Tutti sanno ormai che non serve più contenere (i fiumi che esondano) ma ripensare i piani urbanistici. Tutti dovrebbero capire che il cambiamento climatico porterà a una moltiplicazione di questi disastri. Serve un cambiamento drastico nel nostro modo di coltivare, di consumare, di abitare. Serve oggi, non domani.
17 GIUGNO 2023 16 GIUGNO 2023
N.A.I.P.
Creativo, anomalo, solitario. Dall'avanguardia al palcoscenico di X Factor, e ritorno. La musica come performance liberatoria
Quando fece la sua apparizione a X Factor, lasciò tutti straniti. Cosa ci fa in tv quel tizio strambo, dinoccolato, con la barba fitta e scura, la voce profonda, l'espressione perplessa, come di uno che si chiede “dove sono capitato”? Attenti al loop fu un'autentica rivelazione e divenne presto un fenomeno collettivo. Originale, elettro-pop sperimentale, piena di ironia ma anche di malinconia. «Ogni giorno spunta nuova gente seguita da un sacco di gente», cantava N.A.I.P., che giocava e (si) divertiva, prendendo in giro la bulimia dell'immagine (e della canzone). Ma poi, al di là dello scherzo, quella canzone finiva con un amarissimo «così c'è più nulla di importante da amare». In un mondo fondato sull'esserci, il presenziare, in cui l'algoritmo ha preso il posto della critica e della divulgazione informata (formativa), X Factor segnò la nascita artistica di Michelangelo Mercuri. Ma i più attenti avevano già notato questa presenza eccentrica, difficilmente classificabile, nel panorama musicale italiano. Il suo Nessun album in particolare cominciava con un implacabile mantra: «Dovercela, dovercela fare, dovercela, dovercela fare, ad ogni costo, dovercela». Proponeva canzoni surreali e titoli strani (Oh oh oh, È tutta colpa della Juve Bravi nel breve), ma anche un Teatrino mercatino musicale che non faceva sconti, ironizzando sulla musica che piace, con tanto di nomi e cognomi. Forse qualcuno lo aveva perfino incrociato ai tempi del suo periodo metal, con una band che si chiamava Dissidio. Un amore per i suoni duri e violenti che ritroviamo, a posteriori, in certe asprezze della sua musica, anche quando passa per una loop station, utilizzata con un'attitudine più rock che pop.
Oggi Nessun Artista In Particolare è un musicista che, dopo essere transitato dall'underground al circo mediatico (che gli ha dato l'occasione di mettere alla prova il suo talento), può permettersi di scegliere cosa fare e come farlo, sapendo di avere un seguito importante. Lo dimostra con canzoni (e video) notevoli come Dovrei dire la mia e Ho bisogno di tempo (li trovate in un Ep uscito di recente). Ma anche la volontà di rimanere fedele alla propria libertà, da autodidatta curioso e vorace, che domani potrebbe anche smentire ludicamente ciò che ha fatto ieri, e che un giorno magari vedremo approdare al cinema. Intanto ci ritroviamo a parlare di questo strano presente, in cui il tempo più che scorrere si precipita verso il futuro. Dove andremo non lo sappiamo, ma ci piace rievocare da dove veniamo, i pomeriggi trascorsi a registrare canzoni alla radio o ad aspettare che su Tmc2 passassero i Nirvana. Lui non smette mai di scoprire e riscoprire cose, anche le più inaspettate, vedi ad esempio Parsifal, «disco pazzesco dei Pooh che non avevo mai ascoltato, prog di alto livello, sembrano i King Crimson» (anche se poi, sapendo di averla sparata grossa, sussurra divertito: «beh, forse con i King Crimson ho esagerato un po'»).
Cita anche Giovanni Truppi che «dice questa cosa bellissima: sembra passato più tempo dal 2007 che dal '96. Da un certo momento poi sono successe così tante cose che il resto sembra preistoria».

19 GIUGNO 2023
I NCONTRI (foto Edoardo Conforti)
Partiamo dalla biografia. Sei calabrese di nascita e bolognese di adozione.
Mi sono trasferito a Bologna a 29 anni. Ma da tre mesi vivo a Nord di Milano. Fondamentalmente avevo tutto qua. Bologna è una città stupenda, ma prendevo due treni a settimana, a un certo punto ci potevo pagare l'affitto.
Tornando alle origini: che ragazzo eri? Introverso? Originale?

Ero un metallaro. E infatti poi ho avuto anche un gruppo hard-metal. Ma prima dei sedici anni volevo fare il calciatore. Ero un gran terzino sinistro, secondo me, avevo un mancino niente male.
Di quelli che “arano” la fascia?
Sì, il mio mito era Zambrotta, che in quel periodo giocava nel Bari. Facevo tutta la fascia, avanti e indietro... Poi, a 16 anni, c'è stato questo incontro felice - anzi felice no, perché è partito dolorosamente – con il mondo della musica. Mi regalarono una chitarra. Ma mi ruppi il braccio. Quindi il primo mese da chitarrista l'ho passato col braccio rotto. Poi ho imparato a suonare stampandomi i giri degli accordi a scuola. A casa li ripetevo ogni giorno.
Quindi all'inizio eri un autodidatta.
Ero un metallaro. Bello tormentato. Autodidatta. Ero fan dei Korn. Ma ascoltavo anche la techno che mi passava mio fratello
Lo sono tutt'oggi! Solo ultimamente mi sto approcciando alla teoria della musica. Sono sempre stato autodidatta, anche quando ho messo insieme la mia prima band, che era hard rock ma è diventata subito più aggressiva, in zona metal. Con i Dissidio abbiamo fatto un disco e un tour molto bello. Un'esperienza che si è chiusa tra il 2016 e il 2017. Poi è nato N.A.I.P.
Ma eri un metallaro anche interiormente, uno arrabbiato col mondo?
Ero bello tormentato.
Cosa ascoltavi in quel periodo?
Dagli Slayer ai Korn. Da adolescente ero molto fan dei Korn, del doom metal, i System of a Down e tutta quella roba là, mischiata ai Nirvana e anche alla techno che mio fratello mi passava in maniera clandestina.
Quindi la curiosità per l'elettronica risale a quegli anni.
Probabilmente sì. Ascoltavo la musica che mettevano nei rave, molto aggressiva. Ma ai tempi non sapevo distinguerla dal resto. Un fatto abbastanza comico che mi è capitato da ragazzo è quando ho capito che la musica che piace a me non piace a tutti.
Era la festa di fine anno, non ricordo di quale classe, forse la prima media. Una profes-
soressa ci chiese di portare un disco. Io ne portai due: uno degli Offspring che mi piaceva tantissimo, Ignition e uno di hardcore elettronico da rave, molto pesante. Per me era divertente, ma quando lo misi, i miei compagni di classe dopo tre secondi mi costrinsero a toglierlo. “Ma cos'è sta cosa?”, dicevano. E io: “Ma come fa a non piacervi?”.
La scoperta sconvolgente dell'altro.
Anche la scoperta dei generi musicali, che non ho mai voluto accettare.
Che esperienza è stata con i Dissidio?
Molto formativa. L'esperienza di una band è sempre una figata, soprattutto quando è composta da amici. È il sogno di tutti i musicisti: la classica storia degli amici di scuola che fanno una band e crescono insieme. C'è una band che si chiama Gojira, fa progressive metal e ha proprio questa storia; io li adoro musicalmente ma mi piace anche il romanticismo che c'è dietro.
Imparai tutto in quegli anni. Imparai a sbattere contro tantissimi muri, anche perché il genere era difficile. Forse oggi – visto che anche grazie ai Maneskin c'è stato un ritorno alle chitarre in Italia – con una band del genere le cose sarebbero andate diversamente. A quei tempi era un progetto completamente anacronistico.
21 GIUGNO 2023 20 GIUGNO 2023
N.A.I.P. (foto di Ivana Noto)
(foto Edoardo Conforti)
La decisione di diventare solista è stata il frutto delle circostanze o è una cosa che meditavi da tempo? Chi ti conosce, oggi, pensa a te come un musicista indipendente, che sperimenta suoni e che crea le sue opere in assoluta solitudine.
La genesi di N.A.I.P. è questa. Venivo da un'esperienza di band, ma mi rendevo conto che la mia mente, la mia scrittura, andava più veloce di quello che riusciva ad accadere. Anche perché lentamente stavamo diventando tutti più grandi, ognuno lavorava a cose diverse e le prove erano sempre più rare. Banalmente quello che ho fatto è stato acquistare degli strumenti elettronici e guardarmi un botto di tutorial online. Poi ho iniziato. N.A.I.P. nasce dall'improvvisazione.

Ci ricordi come è nato il nome del progetto? Era già particolare all'inizio, ma lo è ancora di più ora che sei un artista riconosciuto come “molto particolare”.
La primissima volta in cui pensai al nome ero in auto. Quando mettevi un disco che lo stereo non riconosceva, compariva la scritta “nessun album in particolare”, oppure “nessun artista in particolare”, o “artista sconosciuto”. Ricordo che ero sulla Citroën ZX di mio fratello (io ho due fratelli molto più grandi di me). Leggendo questa cosa, mi veniva sempre da ridere, e una volta pensai: “Se mai avrò un progetto musicale, un giorno, lo chiamerò “artista sconosciuto” o una cosa del genere”.

È stato più traumatico o più affascinante, il passaggio dal mondo dell'underground a quello dell'intrattenimento televisivo?
Mi ha aiutato molto il fatto di aver fatto tanto teatro. Anche con i Dissidio eravamo molto teatrali, avevo messo questa cifra all'interno del progetto.
Da sempre ho avuto questa spinta del voler rendere tutto scenicamente impattante. Quando sono arrivato nel mondo dell'avanspettacolo televisivo, l'ho visto come un potenziamento possibile di cose che avevo in testa. È come se a un bambino che ha cinque giocattoli gliene avessero regalati altri cinquanta.
Non avevi paura di “tradire te stesso”, o qualcosa del genere?
C'è stata una fase iniziale, le prime due settimane, in cui ero totalmente in crisi. Era arrivato il momento in cui dovevo capire se questa cosa volevo farla davvero. Ciò che intendevo difendere, a ogni costo, a cui tenevo di più, era la credibilità, la coerenza con me stesso. Quando perdi quella è finita. Quindi ho cercato di farmi un'idea, chiedendo anche ad amici e colleghi. E devo dire che la scelta si è rivelata felice, anche perché ho smesso di fare mille lavori, o meglio, mi sono messo a fare solo questo come lavoro, declinato in mille modi. La fase della crisi è stata superata con la costruzione e la produzione di ogni spettacolo, ogni cosa da fare. Ero dentro “la mia roba”.
Riguardandoti in televisione forse ti sei resi conto anche dell'impatto che potevi avere sullo schermo, con una produzione importante. Ancora adesso le tue performance a X Factor sono pezzi di tv e live notevoli.
Quella era una cosa di cui, lì per lì, non mi rendevo conto. Ora ogni tanto mi riguardo delle cose e ancora oggi, dopo un po' di distacco, mi dico: “Cazzo, comunque, figo!”. Se le persone ricordano ancora con piacere quell'edizione, non posso che riconoscere il buon lavoro fatto.
Adesso come la vivi? Rimarrà una parentesi, in un mondo comunque lontano da te? Ti senti destinato a una nicchia di ascoltatori esigenti? Oppure segui il flusso?
Di base seguo il flusso. Sicuramente quella cosa mi ha permesso di fare delle esperienze, mi ha aperto delle porte, ha iniziato a farmi pensare e a pensarmi in un altro modo. A volte si trovano solo tante porte chiuse e si persiste in una specie di tormento, che può essere anche liberatorio. Ma nel momento in cui all'incompreso viene aperta la porta della comprensione, allora dice: “E ora che mi hanno capito chi sono? Da chi scappo? Con chi ce l'ho?”. Tutte queste cose sono successe negli ultimi due anni e quindi ora, lentamente, seguendo il flusso, mi sto dando delle risposte. Sto cercando la mia nuova nicchia, il mio nuovo piccolo medio grande pubblico. Ho fatto un tour nei club di recente ed è andato molto bene. Questa bella risposta del pubblico esiste.
23 GIUGNO 2023 22 GIUGNO 2023
N.A.I.P.
Due immagini di un recente concerto al Locomotiv di Bologna
(foto Giorgia Zamboni)
(foto Giorgia Zamboni)
La tua musica suona come una critica al sistema, anche quando viene dall'interno del sistema. Immagino che sia lo stesso paradosso con cui giochi nei tuoi testi, che ti consente di ironizzare su chi dice sempre la sua, dicendo la tua, o di scrivere di un autore che non riesce a scrivere.
Certo. Prima scrivevo in un contesto che era molto lontano da questa industria. Ora in questa industria ci ho fatto una passerella, conosco tantissime persone, tante dinamiche. All'inizio sembra un paese dei balocchi, dove accade una specie di magia. Ma col tempo ti rendi conto delle cose marce, malate, assolutamente incoerenti, che educano anche male l'ascolto, il ragazzo che vuole suonare. Anche chi è “educato” viene diseducato. Oggi ho voglia di comunicare questo nuovo fastidio. Ci sto lavorando su, sto riflettendo sulle sensazioni che provavo guardando da lontano cose che ora vedo da vicinissimo.
Ma tu sei un metodico che si siede davanti al foglio bianco, per creare? Oppure inciampi nelle cose, ti affidi all'intuizione?
Tutte le cose che creo nascono da una voglia di liberazione. Ma oggi, nella nuova regola dello strano, l'essere normale ti fa strano
Una cosa non esclude l'altra. Io prendo tanti appunti, sia musicali che in parole. In questo periodo sto riordinando gli appunti presi negli ultimi tre anni ed è come sfogliare un album dei ricordi. Come dicevamo prima, tre anni fa sembrano quindici anni fa. Prendo appunti e poi li metto insieme, faccio dei collage, cerco di capire come possono essere in armonia cose apparentemente lontane. A volte però utilizzo anche altri metodi. Magari mi metto davanti ad Ableton, butto giù una batteria, ci metto su delle armonie, sperimento. A volte è una cosa molto istintiva.
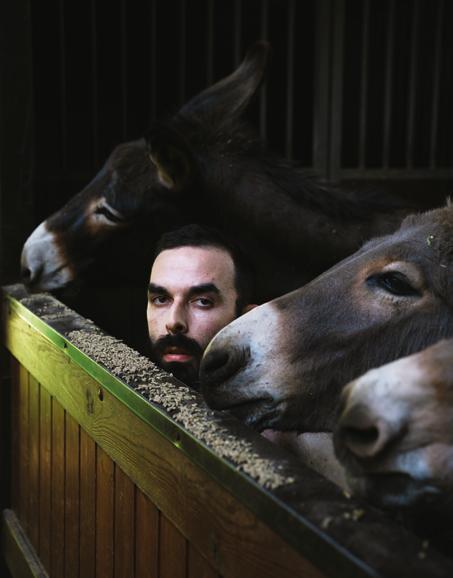
Immagino che non ti fai ispirare solo dalla musica. Dentro i tuoi lavori c'è di tutto, soprattutto le arti performative.
Ora ad esempio sto lavorando su un beat che è partito da un colpo di tosse. Ci sentivo una strana cosa dentro, l'ho registrato, l'ho modulato, poi boh... Ragionando su una possibile performance, penso già che all'interno di un ipotetico spettacolo io mi possa ammalare trasformando il colpo di tosse in una canzone. Dopo di che una cosa tira l'altra.
So che gli artisti non amano spiegare la propria opera...
...Non sono un artista, ma un operatore dello spettacolo
So che gli operatori dello spettacolo non amano spiegare il loro lavoro. Ma qual è l'idea centrale, il messaggio, se c'è, il sentimento che attraversa la tua musica?
Alla fine mi sono reso conto che tutte le cose che compongo nascono da una voglia di liberazione.
Poi è tutto cangiante. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno ci sono varie voglie di liberarsi da qualcosa. Ma credo che il sentimento che tiene insieme tutti i brani sia proprio questo desiderio di sfogarsi. Una sorta di preghiera senza Dio. Un “alleggerimento”.
In effetti la tua musica porta dentro di sé delle note cupe, dei suoni duri, anche quando sembra essere divertita.
L'ironia che deriva da uno stato di disperazione. Il focus potrebbe essere questo. Ora che mi ci fai pensare, lo penso. Ma ci dovrei riflettere meglio per metterlo a fuoco.
Il fatto di essere sempre indicato come l'originale, l'eccentrico, da cui ti aspetti sempre qualcosa di strano, non rischia a volte di essere un peso? Il dover essere un'anomalia.
Dipende da quanto ho voglia di divertirmi. In questo periodo, l'assist che ti dà la realtà che viviamo, è che a volte quando non fai quello strano diventi strano. Nella nuova regola dello strano, l'essere normale ti fa strano. Quello che ora sto cercando è l'assenza di questo elemento. Ma vorrei strutturarlo.
Tutto ciò che ho scritto deriva da anni in cui ero molto tormentato da tantissime cose. Negli ultimi tre anni sento di essere cambiato per vari motivi, varie cose che sono successe. Quindi sono curioso di sommare le due esperienze in una nuova combinazione.
25 GIUGNO 2023 24 GIUGNO 2023
N.A.I.P.
Alena Ettea
(foto Agnese Cornelio)
Nel mondo della musica, soprattutto dei live, finita l'emergenza sanitaria c'è stata una sorta di “liberi tutti” che è diventata una valanga perfino esagerata.

Infatti l'anno scorso ci sono stati dei buchi pazzeschi e c'è anche chi si è cappottato. E questa è una disgrazia. È come un'invasione di campo prima della fine della partita.
Come lo vedi questo periodo? La musica gratis, gli eventi che si moltiplicano senza una logica. Com'è essere artisti in un momento del genere? Immagino che sia difficile anche per voi orientarvi.
Da un lato, questa cosa mi dà l'assist per poter spingere ancora di più il lato creativo del live. Oggi il musicista vive di concerti, il fatto che il palco sia ancora più importante, mi stimola a offrire live ancora più belli. Ma dall'altro lato, posso dire che non ci si capisce un cazzo. Le major non ci capiscono nulla da tantissimo e inglobano realtà più piccole di cui non sanno cosa farsene, hanno capitali che non sanno come investire. Viviamo in un canzonificio continuo, un vero macello. Tanto che in questo periodo sto lavorando a insonorizzazioni di eventi non musicali, su commissione.
Tipo un evento del Corriere della Sera in cui dovrò insonorizzare dei suoni del pianeta Terra. Facendo delle cose di ricerca, il lavoro diventa anche interessante. Continuo a tenere un piede dentro e uno fuori per preservare la mia salute psichica.
Hai un sogno proibito, artisticamente parlando?
Vorrei fare un film. Ad oggi è un percorso ancora bello lungo, ma la cosa mi stimola. Ho tante idee, bisogna inquadrarne una e andarci dritto e deciso. C'è bisogno di tanto tempo e tante cose, però perché non immaginarlo, intanto?
Ti vedo bene in un film alla Tati.
Sarebbe bello un nuovo Playtime. Ma tra i miei film preferiti c'è Taxi driver. Mi ha sempre affascinato tantissimo quel tipo di personaggio, ai margini della società, la sua inquietudine e la sua poesia. Mi piacerebbe costruire un personaggio di questo tipo e raccontarlo in maniera credibile e sincera.

Qual è la tua redness? Cosa ti dà la voglia di alzarti la mattina?
A volte può essere un evento, un concerto che devo vedere, un film nuovo che è uscito, l'attesa di qualcosa di bello, da “fruitore di”. Ma in realtà quello che mi fa scendere dal
letto, che mi fa compiere quell'azione con entusiasmo, è pensare che, potenzialmente, ogni giorno potrei fare qualcosa di bello, anzi di così bello come non l'ho mai fatto prima. Ogni giorno potrebbe essere quello in cui faccio qualcosa del genere dal punto di vista creativo. È un match aperto. Mi dico: magari è oggi. Poi invece non è oggi, ma il fatto che non accada non mi toglie l'entusiasmo per il giorno dopo. Anzi. Mi piace questa cosa.
Molto bello. Anche romantico.
Un po' matto, forse. Quando sei solo, o sei ricco o sei pazzo. E io non sono ricco. (f.t.)
27 GIUGNO 2023
N.A.I.P.
(foto Andrea Ciccalè)
(foto Edoardo Conforti)
(foto Giorgia Zamboni)
Alessandro Deho'
La luce in fondo al buio. Vita solitaria (ma piena di incontri) di un prete che ha
«Ti anticipo che la mia esperienza di vita è molto ordinaria, spero di non farti fare un viaggio a vuoto». Mi scrive così, Alessandro Deho', mentre ci accordiamo sul giorno in cui incontrarci a casa sua, nelle colline della Lunigiana. Anzi, scrive “davvero molto molto ordinaria”, per rafforzare il concetto. Il che suona quasi paradossale, pensando a quanto in realtà sia speciale, rara, profonda, la sua esperienza, così come il pensiero e le scelte di vita che ha generato. Un sacerdote appassionato, super-impegnato, amante dei progetti articolati (per “aiutare gli ultimi”), fatti anche di arte e cinema, che diventa una specie di eremita, dopo aver sistemato una casa abbandonata, in un paesino con cinque residenti, vicino a un santuario rimasto fuori dal circuito del turismo religioso. Ma forse ha ragione lui, bisognerebbe capovolgere la prospettiva, il nostro senso dell'ordinario e dello straordinario. In fondo Alessandro Deho' ha “solo” fatto l'infermiere e il prete da oratorio, ha soccorso anziani e malati psichiatrici, ha scritto qualche libro, e alla fine ha scelto una vita di preghiera e solitudine in un luogo fuori dal mondo ma non troppo, lontano dalle istituzioni ma rimanendo “istituzionale” (nella forma, così come nell'ostinata umiltà con cui rifiuta di proclamarsi diverso).
Cosa c'è di più ordinario della voglia di capire chi siamo e cosa ci rende umani, il senso di ciò che facciamo?
Chi non conosce la malattia, la solitudine, la morte?
La differenza la fa il modo in cui vivi queste esperienze. Sprofondare dentro la vita e le sue passioni, senza trasformarle in astrazioni filosofiche, teologiche o
pastorali. La differenza la fa il coraggio di guardare la disperazione negli occhi, di stare accanto a chi soffre, di ascoltare chi ha bisogno, per poi abbandonarsi (alla vita, a Dio). La luce si trova in fondo al buio. Sta qui la verità della sua “ordinarietà”, come quella di tante altre persone che lo fanno giorno per giorno, lontano dai riflettori, nella loro semplice vita. Ci accordiamo, scherzosamente ma non troppo, sul fatto di essere fin da subito “diretti e sinceri come fossimo vecchi amici”. Lui confessa di essere un po' stanco di parlare di sé. Ma poi lo fa con una sincerità e generosità commoventi, anche quando si tratta di raccontare uno dei momenti più dolorosi della sua vita, la morte di suo padre, durante la prima ondata Covid, ricordando le parole con cui lo ha lasciato, benedicendolo, “liberandolo” in qualche modo da tutto ciò che si sentiva obbligato ad essere.
Crocetta si trova in fondo a una strada tortuosa, che si arrampica su una collina. Un luogo che si trova a metà strada fra la Toscana, l'Emilia e la Liguria. Più si procede lungo i tornanti, oltre Mulazzo (dalle parti di Pontremoli), più la strada si fa stretta. Chi si inoltra fin quassù deve avere una forte motivazione per farlo. In cima c'è il Santuario della Madonna del Monte, semi-abbandonato, in cui la messa è tornata proprio grazie ad Alessandro (la cui storia è partita dal Bergamasco, a Romano di Lombardia, 48 anni fa).
Un chilometro prima c'è un gruppo di edifici – e un punto di ristoro riaperto di recente – tra i quali ci si incammina a piedi.

28 GIUGNO 2023
scelto il silenzio, la natura, la "normalità"
I NCONTRI
di Fabrizio Tassi
La sua casa è l'ultima, in fondo alla stradina. È semplice e bella, un magnifico rifugio che si affaccia sulla valle, con un orto, uno spazio in giardino da condividere con gli ospiti, un capanno in legno. Ci vive insieme al suo cane, Dulcinea, in onore di Don Chisciotte, personaggio che ha sempre amato.

È uno di quei luoghi in cui passeresti volentieri qualche giorno in ritiro, a leggere, a meditare, a confrontarsi con altri “cercatori”. In effetti Alessandro ha immaginato questa possibilità. O meglio, aveva pensato che il Santuario potesse diventare un luogo di ospitalità per viandanti e pellegrini. Poi c'è stata l'emergenza sanitaria, e i pensieri sono cambiati insieme alla vita e alle scoperte fatte lungo il cammino.
Io sono cresciuto dentro l'istituzione e ne ho subito il fascino. Non la giudico. Ha una sua funzione. Ma qualsiasi modello, per quanto bello, se non ascolta l'altro è una violenza. Mi sono accorto che amavo la riuscita dei progetti più delle persone
Su una panchina di legno c'è scritto “I Care”. Lui viene da quel modo di intendere il mondo, da Don Milani. Su un'altra troviamo un “Pace e bene”, l'altro punto di riferimento, san Francesco, presente in forma di immagine anche nel luogo in cui prega, dove la Croce convive con una statuetta del Buddha. Ci sono anche stanze piene di libri, cd, dvd. L'opera completa di Ozu (straordinario regista giapponese, capolavori per cinefili) convive con quelle di Mozart e Beethoven, e un grande poster dedicato a Pollock. Alessandro è un uomo di cultura. Non esibita, ma fruita ed elaborata. Lo si capisce dall'ordine disordinato, le cose accumulate e impilate una sull'altra. Ed è anche uomo di accoglienza, che ha sempre un letto pronto per l'ospite eventuale, anche improvviso.
Ci sediamo all'aperto, è una bella giornata di sole. Gli chiedo del libro che ha scritto insieme a Davide Brullo, Nuovo alfabeto del sacro (pubblicato da Aliberti), da cui è nata l'occasione di questo incontro. Lui risponde che è stato una sorpresa. «Per me Davide è un fuori-
classe assoluto. Non mi aspettavo di scrivere un libro con lui. Ero andato a trovarlo in uno dei miei giri, a un festival, a Pietrasanta. Avevo appena letto Rinuncio il suo romanzo. In quel periodo stavo cercando di capire perché ero finito in questo posto. Credevo di averlo capito, ma non era vero». Partiamo proprio da qui. E qui torneremo, alla fine.
Ora lo hai capito perché sei venuto qui? Sì. Anche se a volte faccio finta di no.
Sembra complicato. La mia è una formazione lombarda, da parrocchia militante. Sono cresciuto con l'idea del servizio agli ultimi. La mia famiglia è sempre stata molto cattolica. Tanto per capirci, ogni tanto si andava a messa da Turoldo. I nomi e i libri che giravano in casa erano don Milani e Primo Mazzolari.
Chiesa cattolico-sociale. Molto sociale. In fondo la mia vocazione è da oratorio, non è “da eremita”.
Prima però hai fatto l'infermiere. Io vado avanti per passioni. Non ho mai avuto un grande sguardo sul futuro. Sono cresciuto timido e appassionato. Dentro la vita. Ho divorato di tutto, libri, teatro, cinema, senza una minima istruzione. Anche nella Chiesa ero timido ma propositivo, sempre dentro le cose fino in fondo. Terzo mondo? Vado in missione! Conosco il commercio equosolidale? Entro nell'equosolidale. Scopro la montagna? Vado a fare il corso di roccia... Tutto così. Era lo stile di mio papà. A livello scolastico è sempre stato un trauma. Non ho mai trovato nessuno che desse fiducia a quel ragazzino che era appassionato ma non sistematico. Che non sapeva studiare. Infatti la mia storia scolastica è devastante. Ho fatto due anni di Itis senza sapere nemmeno perché. Non l'ho capito ancora adesso. Mi piaceva scrivere, ma il latino e il greco erano troppo difficili e allora niente liceo. Poi ho lasciato l'Itis e mi sono iscritto alla scuola per infermieri.
Sei stato in Africa ?
Quando avevo vent'anni, con i missionari di Treviglio. Sono stato in Marocco, un'esperienza di incontro con l'Islam, che all'epoca non era così scontata.
Un missionario mi chiese se volevo diventare missionario. Non ci pensavo minimamente. Avevo finito la scuola per infermieri e stavo aspettando di fare l'altra esperienza forte della mia vita, l'anno di obiezione di coscienza. L'ho fatto da pacifista convinto. Ci credevo davvero tanto. Avevo scelto un centro per malati terminali di Aids, ma la presentazione andò malissimo, arrivai tardi. La Caritas mi dirottò provvidenzialmente a Lecco, a Somasca, in una casa famiglia per minori a rischio, allontanati dal loro nucleo famigliare. Io arrivavo dal triennio della scuola per infermieri professionali. Studiavo e lavoravo insieme. Cinque ore di lavoro al giorno e quattro di scuola. Poi, secondo loro, avrei dovuto andare a casa a studiare, ma io avevo in mente il Terzo mondo, il Rwanda, il pacifismo, i libri, il cinema...
Quindi fu un disastro. Mi piaceva il lavoro, la scuola invece no. Alla Maturità mi ha salvato il fatto che è uscito un tema sugli anziani, un tema sociale.
Perché l'anno a Somasca è stato provvidenziale?
Sono arrivato negli stessi giorni di un altro ragazzo, più grande di me. Lui doveva diventare prete, ma l'hanno fermato e gli hanno chiesto di fare questa esperienza. Claudio era di Ossona ed era molto diverso da me. Arrivava da scuole private, con una formazione di destra, anarchismo cattolico, conservatore. Ci siamo incrociati grazie ai film di Nanni Moretti. Abbiamo visto insieme La messa è finita... Lui è stato un vero educatore per me. Mi prendeva anche in giro, ma sapeva cogliere la mia essenza, la mia singolarità. Mi ha dato fiducia. Io arrivavo sfasciato dalla scuola, credendo di essere mezzo scemo. Per me era una lotta, io dovevo fregare loro e loro dovevano fregare me. Lui invece mi diceva che avrei dovuto fare il liceo. A quel tempo avevo finalmente scoperto il gusto di leggere ciò che volevo. In quel periodo era Il mondo di Sofia. Lui, che era laureato in Filosofia, alla Statale, invece di prendermi in giro mi ha detto: “Aiutami a stare in allenamento, se hai voglia partiamo dai tuoi filosofi e facciamo filosofia insieme”. Mi ha spiegato Marx, Nietzsche...
31 GIUGNO 2023 30 GIUGNO 2023
Deho'
(foto di Luca Brunetti)
Alessandro
Seguivamo i ragazzi durante il giorno, ma la sera e la mattina presto ci dedicavamo alla preghiera e alla filosofia. Siamo rimasti amici, tanto. Lui non mi ha mai forzato ad andare in seminario. Ma mi raccontava la fatica di essere prete dentro il sistema.
Poi in seminario ci sei andato, dopo anni. Claudio, purtroppo, è morto quando era ancora giovane. Una storia incredibile. Io come infermiere ho lavorato in psichiatria e in ematologia. A quel tempo c'era un ragazzo somasco che è morto nel mio reparto, a causa della leucemia. Io raccontavo tutto di quel ragazzo a Claudio. Ma un giorno, quando io ero già entrato in seminario e lui era diventato padre spirituale a Como, mi ha chiamato e mi ha detto di avere la leucemia. È morto mentre frequentavo il primo anno di Teologia. Di fatto, in quell'anno passato insieme, io gli ho raccontato la sua fine e lui mi ha raccontato la mia storia.
Non lo dimenticherò mai. Sono stati anni commoventi. Ho imparato la bellezza di chi è lontano da te, quanta ricchezza ci sia in questi incontri.

Facciamo un passo indietro: ci racconti perché avevi scelto psichiatria? È una scelta impegnativa. Avevo vinto un concorso, miracolosamente. A Bergamo, a Borgo Palazzo, dove c'era il famoso manicomio. Io era stato assunto a tempo determinato ai Riuniti di Bergamo dove c'era il reparto di acuti, i casi da sedare e riconsegnare ai Cps. Ero un ragazzino. Mi ricordo la violenza, i pazienti legati... Ma se oggi dovessi fare di nuovo l'infermiere chiederei di tornare lì.

Lo hai anche scritto. Torneresti in psichiatria o in una casa per anziani. Perché?
Sono luoghi in cui tocchi la sofferenza, a volte la disperazione. L'impotenza.
Lì non vai a salvare qualcuno, ma ad accompagnare. Esattamente! Ecco perché sono qui, ora! Io ho fatto il prete perché in qualche modo c'era sempre questa idea di essere utile e di servire. Avevo bisogno di andare oltre. Forse ero un po' stanco della parte organizzativa della parrocchia. L'illusione che servisse un programma pastorale raffinato.
Il mio era bellissimo, c'era la Bibbia, c'era l'arte, il sociale, il cinema. Però era vuoto. Alla fine rischiava di diventare una corazza che mi teneva lontano dall'incontro personale con gli altri.
Non era anche l'occasione di provare a ispirare, consigliare, educare? Chi guarda la tua storia da fuori, può pensare a una specie di fuga.
Sì, me l'hanno detto e forse c'è anche una parte di verità. Forse sono scappato. Come sono scappato dall'Itis alla scuola per Infermieri, e da lì al seminario. Forse erano tentativi di sopravvivenza.
O forse andavi semplicemente incontro a te stesso, al luogo in cui dovevi essere. Quello di sicuro. Ma evidentemente per andarmi incontro dovevo anche scappare da una parte di me o da qualcos'altro.
Dall'organizzazione e dall'istituzione, probabilmente. Sembri allergico a qualsiasi forma di potere e gerarchia. Adesso sì. Ma perché in passato ne ho subito il fascino e
l'ho esercitato anch'io. Non ci sarà mai un mio giudizio negativo su chi è dentro il sistema, perché io sono cresciuto in quella logica, che credevo fosse giusta. Il seminario per me è stato una rivincita, perché lì dentro sono sempre stato apprezzato tanto, forse troppo, mi sono rinforzato. Uscito da lì, alla prima esperienza, il vescovo mi aveva dato tantissima responsabilità: dovevo iniziare a pensare all'inter-parrocchialità. Avevo una fortissima fiducia nel progetto pastorale. Era il sogno di una vita: il centro cattolico sociale cristiano, con spruzzate orientaleggianti, aperto agli altri. C'era tutto il mio mondo. Ma qualsiasi modello così forte, per quanto bello, se non ascolta l'altro è una violenza. Mi sono accorto che amavo di più la riuscita del progetto delle persone. Gli adolescenti in fondo sono adolescenti e ti dicono di no. I campi estivi, ad esempio, erano momenti in cui cercavo di dare “l'essenza”: la montagna, l'arte, cinema (ho fatto perfino un campo su “Caro diario)”. Ma nell'ultimo che ho fatto, prima di venire qui, non ho preparato niente. Prima di partire ho semplicemente chiesto loro di dirmi tre canzoni che ascoltano. Erano canzoni di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza. C'era molto rap e trap, musica inglese, Mengoni, Pausini. Questo è l'adolescente, e bisogna partire da lui.
33 GIUGNO 2023 32 GIUGNO 2023
Alessandro Deho'
Come ha fatto Claudio con te. Claudio infatti non mi ha imposto la sua visione del mondo, ma ha raccolto la mia. Io invece ero così preoccupato di far vedere che ero bravo a fare il prete, che la diocesi si fidava di me, che rischiavo di schiacciare le persone. Sono arrivato qui dicendomi che in parrocchia è andata bene, ma io non sono fatto per fare l'uomo di potere. Vengo a Crocetta e sfilo fuori le cose che so fare: scrivo, vado in giro a predicare esercizi, accompagno la gente sulla Francigena, vado a recuperare un po' di cose di arte, organizzo cose legate al cinema... Lascio fuori tutto ciò che è organizzazione e potere. Sono arrivato qui con questa idea. Il padre
Faccio fatica a definirmi eremita. Non voglio invadere quel campo sacro. Vivo nel silenzio, nella preghiera, nell'accoglienza, ma per me è fondamentale l'incontro
gesuita che mi segue mi ha detto: “Tu pensi che Crocetta sia la tua terra promessa? Invece è il tuo deserto. Vediamo cosa ti sta chiedendo il Signore”.
Il deserto è anche il luogo della tentazione. Altro che! Tutte le parole qua diventano violente. Finché fai poesia sull'insignificanza è un conto, ma poi quando lo sei... Il timido doveva lasciar fuori tutti i ruoli che si era costruito con tanta forza. Io che mi ero vestito da prete, prete progressista, prete scrittore, prete riconosciuto, qua ero zero. Dovevo essere Alessandro e basta. Con tutte le sue fragilità. Sono tornato davvero a casa. Il rapporto con la montagna, la natura, il silenzio, quella parte mistica che un po' mi fa ancora sorridere ma che forse c'era già.
Dici di non sentirti un eremita, ma di fatto l'eremita sceglie una vita come la tua, di preghiera e di silenzio, fuori dalle logiche istituzionali, anche per riscoprire la propria capacità di ascolto, l'essenza della relazione con l'altro.
In effetti faccio fatica a definirmi eremita, ma comunque vivo nel silenzio, nella preghiera, nell'accoglienza. Io però alzo tanto l'asticella sull'incontro. Anche questa è stata una scoperta. Dopo la parrocchia avevo bisogno di silenzio e distanza. Adesso invece sono contento di incontrare le persone, ne incontro tante, mi sposto anche, se serve. Non voglio andare a invadere un campo che sento sacro, la spiritualità dell'eremita e di chi sceglie quella strada. Non voglio quell'etichetta, fingerei se mi definissi eremita fino in fondo. La mia è davvero una vita normale. Avevo questa idea di pagarmi il mutuo, di dover stare attento alle spese, pulire, farmi da mangiare. Mi ricordo che ho esultato quando mi è arrivata la tassa dei rifiuti. Mi sono detto: finalmente sono normale!
Che tipo di preghiera o di meditazione pratichi? Come cerchi l'esperienza di Dio?
In seminario ho praticato tantissimo la preghiera ignaziana. Sono molto legato alla spiritualità di Ignazio, la riscrittura del Vangelo, entrarci con quello sguardo, anche se all’inizio facevo sempre fatica a passare dalla meditazione alla contemplazione (una forma di preghiera più passiva). Ho cercato per anni esperienze di confine col mondo orientale, però sono sempre rimasto legato alla Parola, tantissimo.
Ricordo di aver partecipato a un corso di esercizi incentrato sulla meditazione silenziosa che mi mise in difficoltà: ero in crisi d'astinenza da libro. Adesso invece lascio molto spazio al Silenzio. C'è poi tutto il tema della liturgia delle ore, che mi appartiene. E l'Eucaristia, ovviamente, tutti i giorni. Diciamo che ho messo insieme tante cose, esperienze diverse. Quando sono venuto qui mi ricordo un momento da Into the Wild, la libertà più totale, che un po' mi faceva paura. Sono subito andato a rileggermi alcune regole classiche del monachesimo, perché temevo di smarrirmi dentro questa libertà. Lì è stato bravo il padre gesuita che mi accompagna e che mi suggerì di essere più libero, di non andare a costruire una chiesa, una religiosità, fuori dalla chiesa. Se il Signore mi ha chiesto di abitare a Crocetta... Quando prima sentivo dire che “tutto è preghiera”, mi veniva il sospetto che dietro non ci fosse niente. Ora rimango aperto a tutte le esperienze. Di sicuro questo è diventato un luogo in cui l'incontro con le persone è facile. Anni fa avrei arricciato il naso di fronte a certe formule che mi sembravano un po' vuote, ma l'incontro con l'altro è davvero la manifestazione di un incontro e di una prossimità con Dio. Così come lo sono
la natura e lo stare nel silenzio. A volte devo solo ricordarmi di spegnere il cellulare e allora anche camminare diventa un modo di pregare.
Tu hai incontrato una Chiesa molto aperta. In questo sono stato davvero fortunato, hai ragione. Ho incontrato persone che si fidano e che accettano questa cosa. Anche perché faccio un servizio in tre parrocchie, senza essere parroco. Si tratta di un impegno davvero minimo, la messa della domenica, i funerali. Ieri ho celebrato per tre persone. Sono comunità che resistono, ma piccolissime. Sono contento che ci sia questa fiducia nei miei confronti e, per certi versi, non mi sono mai sentito prete come adesso. Adesso che c'è una chiesa che incrocio e incontro quotidianamente, nelle persone che vengono qui e che stanno diventando tante.


Che tipo di persone?
Qualsiasi. E per i motivi più vari. Mi fa sorridere questa cosa: io, che ero riuscito a trovare questo “spazio di protezione” così bello, ora incontro persone che non conosco fino a quando parcheggiano in piazza e vengono da me.
35 GIUGNO 2023 34 GIUGNO 2023
Alessandro Deho'
Persone “alla ricerca”. Sì. Spesso anche persone in crisi. Qualcuno è incuriosito da quello che ho scritto.
Che limite ti dai? Rischia di diventare una valanga. Il limite è il tempo. La mia fatica, il mio timore, ancora oggi, è quello di deludere. Io sono una persona che ascolta, ma non sono un guru illuminato. Ed è anche difficile dover dire di no alle persone. Faccio quello che posso. Sto riscoprendo tanto il valore dell'amicizia. Ricordi il finale de La messa è finita?
Quando dice: “vado dove hanno bisogno di un amico”. In seminario quel finale lo avevano devastato: “noi non siamo amici, siamo preti”. Sembrava un finale stupido, una fuga. Poi lui se ne va Patagonia. Sorrido perché anni dopo anch'io ci sono andato per davvero. E poi la mia Patagonia è diventata questa.
Mi chiedo: perché siamo così sospettosi sulla qualità spirituale dell'amicizia? Il problema vero è che non posso essere amico di tutti, perché non ce la faccio fi-
sicamente, mi arriva addosso tanta di quella roba. Quando ci sono, sono per loro totalmente, ma poi sono così tanti, cosa posso fare? Dico: Dio te li affido! Sarà infantile, ma non posso fare altro. Faccio sempre più fatica a pensarmi nella parte del predicatore. Due settimane fa ero ad Albino, in un eremo francescano. Mi hanno chiamato quattro frati, a predicare gli esercizi. Mi hanno detto: vogliamo fare una cosa nuova, vogliamo vivere insieme, scambiarci impressioni, ascoltarci. È stata un'esperienza commovente. Abbiamo fatto cinque giorni insieme in cui ognuno è riuscito a mettersi nelle mani dell'altro. Qui accadono cose di questo tipo. Anche solo il prete che viene dal Sud Italia per confessarsi e poi se ne torna a casa.
Tu comunichi gioia, calore. Quando scrivi, invece, c'è tanta sofferenza. Il Nuovo alfabeto del sacro, per certi versi, sembra un libro profetico della Bibbia. Ha delle pagine molto cupe. I tuoi “misteri”, i ricordi delle tue esperienze da infermiere, sembrano contemplazioni ai piedi della croce. Se andiamo a parlare di gioia, come facciamo spesso anche nelle parrocchie, in modo superficiale, ci contraddiciamo subito. Si capisce che è una gioia senza radici. Per dire questa cosa della felicità, ho dovuto fare un attraversamento. Il mistero del Cristianesimo è questo: la gioia non è distaccarsi dalle passioni, ma sprofondarci dentro così tanto fino al punto che stai per morire. Ho questa fissa per la morte da quando ho pochissimi anni. Ho visto morire tante persone, mio padre, il mio amico Claudio... Il mistero vero è che devi scendere fino in fondo a quel gorgo nero per intravvedere dei lampi di luce. Non si dà la resurrezione fuori dal crocefisso. Bisogna avere le stigmate. Se parliamo di felicità senza il pianto e la povertà, senza sentire che questa cosa è viva e massacrata dalla vita, non siamo credibili.
Qui forse è dove Oriente e Occidente si divaricano in due strade diverse. L'incarnazione. Io non voglio distaccarmi dal corpo. Ricordo ancora, in terza superiore, la puzza di piscio dei vecchi della casa di riposo, che noi dovevamo pulire, a cui dovevamo cambiare i pannoloni. Ricordo le ferite, la sofferenza.
Lì ti senti vicino alla croce. Ma questa cosa l'ho capita dopo. Ho capito lo sprofondare dentro. Per me la mistica è quella. Ciò che sprofonda continuamente. La perfetta letizia di Francesco si porta dentro le stigmate della Verna e l'incomprensione dei suoi. Non è la perfetta letizia del ragazzino viziato che dà le sue cose ai poveri.
La Chiesa rischia di diventare astrazione, così come certe parole come “salvezza”, “gioia”, “solidarietà”. Ma quando sei istituzione devi dare delle risposte. Io mi sento istituzione, faccio parte di questa Chiesa, non sono fuori, e ringrazio per tutti i passaggi intermedi che ho vissuto. Nelle varie fasi c'è sempre stata la presenza di san Francesco, anzi dei san Franceschi, di come li ho vissuti io. Da ragazzino ero rimasto folgorato dal film di Zeffirelli, visto in una sala parrocchiale. Mi piaceva quel Francesco così dolce. Così come potrei ritrovare la sedia su cui ho visto alle medie quello della Cavani. Ho vissuto anche quella parte sognante. Avevo l'immaginetta di Francesco con la faccia di Mickey Rourke, e una foglia presa ad Assisi. C'era anche tutta la parte ideologica di sinistra. Poi sono cresciuto, anche grazie ai libri, ma l'illuminazione è arrivata quando mi hanno spiegato una cosa fondamentale: san Francesco ad un
certo punto ha smesso di aiutare i poveri ed è diventato povero. Sembra una banalità, ma quando l'ho ascoltata mi sono detto: ecco, è questo! In parrocchia aiuti i poveri, e va benissimo, ci sono istituzioni pazzesche, ma la mia formazione e la mia storia mi portavano a pensare che ero bravo ad aiutare gli altri per dimenticarmi di essere povero. Qui ho riscoperto la povertà.
La Chiesa quindi non dovrebbe solo aiutare i poveri ma dovrebbe farsi povera.
Vengono a chiedermi: cosa dobbiamo fare con gli adolescenti? Se agli adolescenti leggi il Vangelo quelli se ne vanno, giustamente. Allora noi parliamo di “giustizia”. Il Vangelo però è ingiusto. La mistica è questo: diventare folli. I folli di Cristo, quelli che non servono a niente. Questo non è spendibile in un progetto pastorale. Anche se l'idea dell'essere inutili oggi andrebbe rigiocata in qualche modo. Se metti il saio, diventi un personaggio.
Raccontaci di tuo padre, che è stato così importante per te.
È sempre stato un padre bellissimo, fin troppo. Quello che volevo fare io lo aveva già fatto lui. Si appassionava a una cosa e la faceva al massimo. Fotografia? Comprava tutto ciò che serviva e sviluppava in casa.
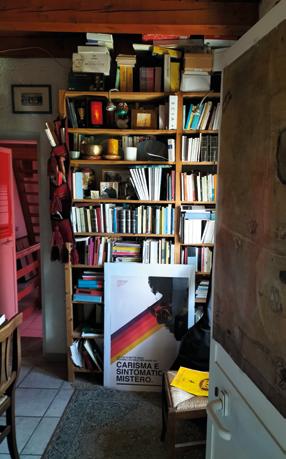

36 GIUGNO 2023
Alessandro Deho'
Windsurf? Si attrezzava e andava al lago. Lavoro, sport, impegno sociale. Anche cose enormi. Lui ci sapeva fare. Ha sistemato perfettamente la Caritas parrocchiale quando è andato in pensione. Gli hanno poi chiesto di diventare responsabile ai livelli più alti. Ad un certo punto gli ho detto “fermati”, ma lui non ce la faceva. Se a Natale qualcuno lo chiamava, lui andava. Era disponibile 24 ore su 24. Poi ha avuto un infarto. Guarda caso proprio quando gli hanno detto che non serviva più alla Caritas. Era settantenne. In quel periodo è nata la mia ripartenza.

Quando sono andato a trovarlo, dopo l'infarto, ero ancora parroco (sarei venuto qui dopo l'estate). Era un giorno di marzo e all'ospedale scoprii un papà che aveva bisogno degli altri, che si faceva aiutare ad andare in bagno, che non aveva più vergogna. Eravamo io e lui sul letto dell'ospedale e mi disse: “Don Alessandro”. La prima e
Io non sono niente. Accolgo le esperienze di tutti, ma non voglio costruire niente.
Qualsiasi cosa rischia di diventare istituzione. Per questo bisogna tenere sempre aperto il dialogo con la profezia. Le strutture troppo rigide vanno fatte saltare
unica volta che mi chiamava così. Era come se riconoscesse la mia storia. Mi disse: “Don Alessandro, quello che stai facendo, io non ho avuto il coraggio di farlo”. Io, da buon lombardo, ero imbarazzatissimo. Disse anche: “Non posso aiutarti economicamente ma sappi che io ci sono e che sarò sempre dalla tua parte”. Ecco perché nella Bibbia le benedizioni paterne sono così importanti! Dopo una benedizione così puoi fare qualsiasi cosa. Era un “Ti libero dal dovermi dimostrare che sei bravo. Tu sei tu”. Lì ho capito mille cose. Per essere benedicente devi andare nell'insignificanza. Ho sentito una mancanza di figli, in quel momento, qualcuno da benedire. Ho sentito all'improvviso che se non diventi povero non riesci a fare quella cosa grande. Ho capito che dovevo venire qui per abbandonare l'idea del prete bravo, quello che è seguito, che vende i libri. Io qui ho una fortuna gigantesca. Non vedo le categorie, ma le persone, le storie, e non mi viene difficile commuovermi per loro. Non ho niente da dare e da chiedere. Quel giorno ho avuto come un'illuminazione: smetti di correre!
Poi tuoi padre è morto per il Covid. In quel periodo hai visto tante persone lasciate sole. Nel libro hai scritto che dopo quell'esperienza hai deciso che non voterai più.
È stata una devastazione totale. Ho perso la fiducia in tutte le istituzioni. Negli uomini no, presi uno alla volta. Ho visto l'abbandono, le persone che non vengono tutelate. Non hanno chiuso le fabbriche pur sapendo ciò che stava accadendo. E nessuno, alla fine, ha chiesto scusa. Un'amica, leggendo quelle mie parole, mi ha detto: finalmente ti sei arrabbiato. Ma non sono arrabbiato. Il fatto è che non voglio far parte, per delega, di un'istituzione che dimentica gli uomini. Io sarò sempre vicino a una persona alla volta. È chiaro che ci vuole un'istituzione, non pretendo che diventino tutti come me, ma la mia storia mi ha portato qua, anche se un tempo sono stato fieramente, ideologicamente schierato.
Tu eri il tipico prete sociale, progressista, ma ormai ti dà fastidio anche questa categoria. Quando dico che reazionari e rivoluzionari sono uguali, non intendo dire ovviamente che sostengono le stesse cose o che gli effetti delle loro azioni sono identici. Ma che la ritualità, la grammatica del potere è uguale. Io ho subìto il fascino di un mondo che doveva diventare alternativo.
Ma anche l'istituzione “alternativa” alla fine rimetterà sempre insieme ciò che l'istituzione vuole. E l'istituzione vuole una cosa sola: rimanere, non morire, per questo diventa idolo, un idolo che vuole il sacrificio delle persone, a prescindere dal fatto che sia di sinistra o di destra.
Il cosiddetto “progressismo” sbaglia forse anche nell'ansia di inseguire la modernità e cercare di farsi piacere, di compiacere, quando il Vangelo, in realtà, è la cosa meno compiacente che ci sia. In questo senso è lo specchio di quell'altra idea, secondo cui il mondo è tutto sbagliato, e cerca di conservare riti, idee, parole d'ordine che hanno perso significato.
Bisogna franare dentro la storia delle persone. Questo è ciò che provo a fare qui. Accettare che vengano qui persone di ogni tipo, togliersi i sandali e inchinarsi davanti a loro. Qui viene chi è stato a Medugorje, ma anche Davide Brullo, amici in crisi, missionari... Io non sono niente. Accolgo le esperienza parziali di tutti, ma non voglio costruire niente. Il rischio è che mi dicano: non si può vivere nell'utopia. In realtà qualsiasi cosa rischia di diventare istituzione, anche Crocetta. Per questo bisogna sempre tenere aperto il dialogo tra istituzione e profezia. Il profeta ha bisogno dell'istituzione e l'istituzione della
profezia. Davide è geniale quando fa il terrorista sulle grotte di Adullam, ma appena mette piede a Gerusalemme sistema le cose, ordina, uccide, e lo dice anche: ogni guerra vuole le sue vittime. E alla fine va a cercare il profeta, si fa scardinare da lui. Dentro di noi c'è tutto questo movimento. Io sento di essere un istituzionale che deve continuamente far saltare questa cosa, destrutturarsi. Il Vangelo e la preghiera passano da qui. Quando cominciamo ad avere strutture mentali, fisiche, ideologiche troppo rigide, vanno fatte saltare.
E poi bisogna imparare a morire. Ci sono istituzioni anche bellissime, ma che sarebbero ancora più belle se sapessero morire. Istituzioni che magari hanno fatto un bene enorme ma che poi avrebbero bisogno di sciogliersi e dire a tutti: portate questa cosa dove volete. Altrimenti c'è sempre la questione dell'eredità, della spartizione. Se qui a Crocetta fossimo in tre, già sarebbe un problema. Tra i miei riferimenti letterari e di vita c'è Adriana Zarri, anima eremitica, poetica, politica. Quando sono venuto qui è come se lei fosse stata qua ad aspettarmi. C'è questa cosa nei suoi diari. Le chiedono: “Cosa ne sarà di questa cascina quando non ci sarai più?”. E lei risponde: “La natura entrerà e se la riprenderà”. Quella è la libertà. Se vuoi che permanga una struttura dopo di te, per non essere dimenticato, vuol dire che non ci credi. Devi essere dimenticato!

39 GIUGNO 2023 38 GIUGNO 2023
Alessandro Deho'
Questa è una cosa molto mistica. Il mistico arriva fino allo scandaloso “prego Dio che mi liberi da Dio” di Meister Eckhart, la liberazione anche da un'entità superiore usata come sostegno, consolazione, in molti casi anche come giustificazione di un potere. Annullarsi a tal punto da svuotarsi completamente del proprio io, solo allora può entrare Dio.
Oppure sprofondi così tanto che te lo ritrovi lì, quasi fosse il fondo del tuo essere. Il silenzio e la mistica per me erano solo parole. Certo, mi era piaciuto San Giovanni della Croce, ma un conto è che ti piaccia, un altro è che scavi dentro di te. Il prete diocesano è quello secolare, da battaglia, mentre il mistico è lo “svalvolato”. Mi sto accorgendo che ora mi affascina molto quel mondo. Però deve essere una mistica quotidiana. Non staccata dalla realtà. Deve essere l'esperienza dell'infermiere, la luce nel buio.
Quando mio papà era ricoverato, per il Covid, mi hanno permesso di entrare in ospedale. Era legato al letto, irriconoscibile. Fu un dolore insostenibile.
Penso che sotto la croce i discepoli abbiano sentito una cosa del genere

L'esperienza della morte di tuo padre è stata sconvolgente.
Quando mio papà era ricoverato, durante la prima ondata Covid, mi hanno permesso di entrare in ospedale. Tutto bardato, come quando ero in ematologia, ma con gli arnesi del prete. Quando vedo mio padre nel letto, legato, perché non ne poteva più del casco, lo guardo e non lo riconosco. Ma aveva il suo pigiama. Vedo quegli occhi che mi trapassano e voglio scappare, perché è una cosa troppo forte. Ecco l'esperienza mistica. So il “regalo” che mi sta facendo chissà chi, ma non vedo l'ora che vengano a strapparmi via, perché il dolore è insostenibile. Farfuglio qualcosa, piango, gli dico che gli voglio bene, ma non capisco nulla. Penso che sotto la croce i discepoli devono aver sentito una cosa del genere. Non sono scappati perché erano dei vigliacchi, ma perché il dolore era insostenibile. Porto con me quegli occhi, che sono anche gli occhi di Claudio, sformato dalla leucemia, e di un'altra signora che ho raccolto in bagno quando lavoravo come infermiere.
In seguito ci sono stati tre anni di preghiera, per riuscire a rimanere sotto la croce, ma non farsela bastare. La resurrezione è un rischio, perché sembra un colpo di teatro. Vedere un uomo che muore così, perdonando, benedicendo, è già un modello altissimo. Invece alla fine c'è questa esplosione di racconti, di gente che l'ha visto.
Ognuno alla fine deve risorgere. Non devi più raccontare una cosa accaduta, esterna, ma devi far vedere che sei risorto tu. Pregarci dentro, piangere, sentire che se osi ancora dire che sei felice, non è uno sgarro fatto a chi è morto così, non è un'offesa a tuo padre, un dimenticare il dolore, ma è un andare in profondità, crocifiggersi al dolore che ti porti dentro. Entrare nel sepolcro. Fino in fondo. Non puoi essere felice senza la morte. Non può esserci luce senza ombra. Non può esserci resurrezione. La fede senza corpo non esiste. È questa la mistica che mi interessa. Te lo dico da ignorante.
La bella sapiente “ignoranza” di chi ha ritrovato la semplicità – lui forse la definirebbe insignificanza – dopo aver letto, studiato, agito, sperimentato, dopo aver riempito mente e cuore, con la cultura e con tutti quei sentimenti buoni e giusti che riassumiamo dentro la formula “solidarietà”. Tutto importante, certo, ma anche tutto illusorio. Serve prossimità vera, non astrazioni umanistiche. Svuotamento e sprofondamento dentro di sé, non un banale “esercizio spirituale” proiettato verso il “benessere interiore”.
Alessandro mi prepara il pranzo, sempre sorridente, curioso, attento a ciò che dico, sempre a suo agio nella dimensione del quotidiano. Parliamo di cinema, di famiglia, della grandinata recente che ha maltrattato il suo orto. Parliamo anche di come è arrivato qui: ricordava le parole con cui un sacerdote aveva decantato questi luoghi, poi ha cercato una casa su in sito immobiliare, come fanno tutti i comuni mortali, salvo poi imbattersi in questo luogo semi-abbandonato e capire immediatamente che era quello giusto.
Alla fine camminiamo verso il santuario, che ha il fascino delle cose dimenticate, la bellezza della devozione più rustica e domestica. C'è un punto, oltre quelle colline, in cui si può già vedere il mare. Mi mostra anche un luogo, laggiù in fondo, che probabilmente è “la valle oscura” cantata da Dante, che in Lunigiana trascorse un periodo breve e intenso della sua vita. Dulcinea è sempre con noi. Mi aveva accolto facendomi le feste, come fossi una vecchia conoscenza. È così, in effetti, che ci si sente, in questo luogo, così sperduto e affascinante, accolti da un prete, una specie di eremita, un uomo che ha trovato la luce in fondo al buio e la condivide con altri esseri umani, anime alla ricerca di una risposta, o anche solo di qualcuno che le ascolti.
"Un nuovo vocabolario per la spiritualità di oggi". Detto così, sembrerebbe quasi un capriccio editoriale, un saggio teologico, un innocuo manuale per aspiranti praticanti (del sacro). E invece Nuovo alfabeto del sacro (edito da Aliberti) è fuoco che brucia, è provocazione e profezia, è "un atto di disobbedienza", che va a cercare lo spirituale nei luoghi più impervi e bui del Vangelo e del messaggio cristiano, "nelle stimmate del nulla".
Non poteva essere altrimenti, visto che è stato scritto da un prete "eremita" deciso a rifiutare ogni forma di potere e istituzione (Alessandro Deho') e da uno scrittore-poeta che ama l'impervio e l'innominabile, non per niente anche traduttore biblico (Davide Brullo).
D'altra parte Gesù è una «miccia che infiamma un movimento», è conversione, è l'Ecce Homo di Wallinger, vulnerabile, incompreso, è la capitolazione totale del proprio essere. Si parla di Caino e Giuda, di Satana e di Nulla, di idolatria e di estasi (non una uscita fuori di sé, ma un ingresso), di come trovare i misteri della gioia e della luce in un ospizio o un manicomio criminale, nel dolore e nella disperazione. Si parla di Maria, «usata, falsificata, riscritta» e del Vangelo che «non insegna nulla» perché in realtà è «una sequela, inseguimento bimillenario, necessità di farsi nulla». Occhio a non bruciarvi. O meglio, divampate pure in libertà.
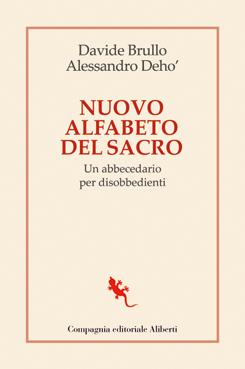
41 GIUGNO 2023
Quelle linee che svelano il cosmo Teoria e pratica dell'Yijing
DIVINAZIONE O SCOPERTA DI SÉ? UN METODO TRADIZIONALE (CINESE) PER CONOSCERE IL MOMENTO PRESENTE E LE SUE POSSIBILITÀ NASCOSTE
Cosa c'è di meno contemporaneo e post-moderno di una «visione del mondo che coinvolge il ruolo degli esseri umani in un cosmo che possiede un proprio senso ultimo»? O forse no, forse è finito il tempo del relativismo spinto, del caso e del caos, di quel pensiero che vede l'universo come un accidente e la vita come una cosa “capitata”, contro ogni probabilità. Forse torneranno in auge le concezioni
filosofiche e religiose fondate sull'esistenza di una verità (più o meno nascosta), una legge orientata a uno scopo (un insieme di leggi da cui emerge un significato), un ordine e un'armonia universale (il Dharma, per citare un concetto orientale).
L'Yijing - o se preferite: I Ching - è una delle manifestazioni più affascinanti di quel modo di guardare la realtà. È una forma di divinazione, ma anche una visione del mondo, la convinzione che l'universo segua determinati schemi che si ripetono, dentro combinazioni di eventi misteriosamente collegati tra loro. In realtà, come dice Joseph Adler nel suo libro Yijing - Una guida (pubblicato in Italia da Ubaldini), non è una visione molto diversa da quella che ha portato alla nascita della scienza, fondata su una lettura matematica della realtà. E visti gli sviluppi recenti del pensiero scientifico – dalla fisica quantistica all'equivalenza tra materia ed energia, dalle riflessioni sull'emergenza della complessità a quelle sull'universo finalisticamente (naturalmente) orientato alla vita e alla coscienza – la questione diventa ancora più interessante e fertile.

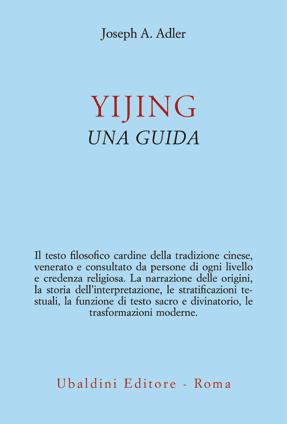
Joseph Adler, che dopo il dottorato in Studi religiosi alla University of California è diventato professore di Studi asiatici e religiosi al Kenyon College di Gambier (Ohio), è sistematico e scientifico nella sua trattazione, non concede nulla allo "spiritualismo" di consumo, ma propone una visione a suo modo spirituale di questa antichissima tradizione. E innanzitutto ricostruisce la fortuna editoriale del libro edito dalla Princeton University Press, I Ching or Book of Changes, a partire dagli anni Sessanta, quando esplose letteralmente l'interesse per la cultura e la spiritualità orientale.
30 mila copie vendute, nel giro di qualche anno, destinate a diventare mezzo milione nel 1982. Anche se, in realtà, l'origine del testo (XI-XII secolo a.C.) è tutt'altro che lineare, tra oscuri antenati, attribuzioni mitiche e aggiunte posteriori, soprattutto le “Ali”, scritte secondo la tradizione da Confucio. Di sicuro è interessante il revival vissuto dal testo in Cina, dove per decenni il regime ha cercato di estirpare ogni traccia di religiosità e tradizione sacra. Dagli anni '80 invece è cominciata una riscoperta a tutti i livelli, intellettuale e popolare. Per chi non lo sapesse, l'Yijing è basato su 64 esagrammi, cioè diagrammi di sei linee, che possono essere spezzate o intere. Alla base del sistema, come di tutto il pensiero cinese, c'è la distinzione tra lo yang (chiaro, caldo, crescente) e lo yin (scuro, freddo, calante). In realtà questi due aspetti della realtà non sono poli in opposizione tra loro, il dualismo è solo relativo (alla percezione materiale dell’universo).
Un libro di Joseph Adler, professore americano di Studi asiatici e religiosi, edito da Ubaldini

43 GIUGNO 2023
M EDITAZIONI 42 GIUGNO 2023
di Alba Daya
Vita di Confucio (@ Met Museum, OA). In basso, le monete utilizzate per la divinazione
Le linee Yin (spezzata) e Yang (intera) vanno a formare 64 esagrammi, che sono vari aspetti della realtà. La consultazione avviene con steli di achillea essiccati o monete di bronzo
Dentro lo Yang c’è un po’ di yin e viceversa, come illustra il noto simbolo del Taiji, il “supremo ultimo”, lo stato che precede la differenziazione delle cose, ma che sta anche alla fine della ricerca, come unità fondamentale da ritrovare. La realtà è cambiamento, come insegna la natura, con le sue trasformazioni cicliche, dalle stagioni all’alternanza tra giorno e notte. E la sostanza ultima del cambiamento è il Qi, in cui coincidono materia ed energia, corpo e mente (la traduzione più accurata del titolo originale, secondo Adler, è “Testo sacro del mutamento”).

Ogni esagramma corrisponde a una determinata situazione, una certa disposizione delle cose, riassunta in nomi evocativi: il Creativo (sei linee intere) e il Ricettivo (sei linee spezzate), la Lite e l'Avvenenza, il Ritorno e l'Innocenza, Mordere, Ascendere, Spaccarsi
in due, il Pozzo e la Famiglia, il Viandante e l'Eccitante... Sono tutti aspetti di quell'ordine universale, quel modello, che viene chiamato Dao (o Tao), la Via, concetto straordinariamente complesso, nella sua semplicità, realtà metafisica difficile da spiegare, essendo per sua natura indefinibile.
Il mondo naturale e quello sociale sono riflessi di quel modello, che bisogna provare a seguire, per avere una vita prospera, fortunata, giusta, magari anche per aspirare a una realizzazione non solo materiale ma spirituale. Si scoprirà solo più tardi, lungo il percorso, che non c’è alcuna differenza tra i due aspetti della realtà, il materiale e lo spirituale, il profano e il sacro, il buio e la luce. È questa la realtà assoluta del non-dualismo, a cui aspira ogni religione, sacralità, attitudine spirituale: «Le differenze sono reali ma hanno una relazione complementare, quindi insieme racchiudono un'unità ancor più fondamentale».

Le linee si ottengono gettando degli steli di achillea essiccati, oppure delle monete di bronzo. Sta poi alla coscienza di ognuno decidere da dove arriva la risposta, che sia un essere spirituale, una divinità personale, o una realtà metafisica impersonale (come il Dao, appunto).
L'Yijing può essere letto nel fluire delle sue linee, quindi nel suo simbolismo grafico, fondato sull’associazione tra diversi trigrammi (ognuno col suo significato). Oppure si possono leggere i commenti lasciati dalla tradizione. Ad esempio, ecco a cosa può alludere l’esagramma 32: «Sole e luna hanno il cielo e possono quindi risplendere per sempre. Le quattro stagioni mutano e trasformano, e possono per questo operare per sempre. Il sant'uomo “si attiene stabilmente al proprio corso”, e il mondo rimodella se stesso fino al compimento. Se meditiamo su che cosa conferisce a un oggetto la sua durata, saremo allora in grado di comprendere la natura di cielo e terra e di tutti gli esseri». A volte i commenti e le sentenze sono molto precisi nell’indicazione fornita. Altre volte invece sembrano vaghi, astratti. Sta qui il margine di interpretazione lasciato a chi si appella a questo metodo divinatorio. Che può essere inteso, tradizionalmente, come una sorta di oracolo, o più modernamente come un canale di comunicazione aperto con l'inconscio (o la supercoscienza). «Possiamo vedere nell'Yijing tutte le configurazioni mutevoli delle forze nell'universo come un ordine unificato. Poiché queste forze hanno tutte una direzione di mutamento, possiamo osservare a cosa stanno conducendo o tendendo; in altre parole, possiamo prevedere ciò che accadrà. Inoltre, poiché queste configurazioni seguono non solo l'ordine naturale ma anche l'ordine morale, possiamo comprendere il carattere etico e le implicazioni del quadro di eventi in cui è inserito il nostro comportamento. Questa comprensione unificata dell'ordine naturale e dell'ordine morale è la saggezza». Giustamente Adler evoca Carl Gustav Jung, forse il pensatore più noto tra tutti quelli che hanno studiato a lungo l’Yijing, che ne hanno scritto sistematicamente (era sua la prefazione all’edizione Princeton), riconoscendo il suo valore. Anche perché Jung aveva elaborato la terra della sincronicità, che si sposa perfettamente con questa interpretazione della realtà. Siamo al di fuori della causalità lineare su cui è fondata la logica occidentale.
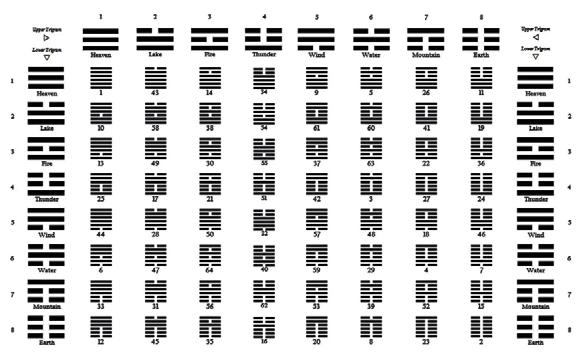
«Possiamo vedere nell'Yijing tutte le configurazioni mutevoli delle forze dell'universo come un ordine unificato.
Poiché queste forze hanno tutte una direzione di mutamento, possiamo prevedere ciò che accadrà»
L'Yijing in un'edizione cinese (@ Valley Spirit Arts). In alto, i trigrammi disposti intotno al Taiji, dal quale vengono originati lo Yin e lo Yang.
Nell'altra pagina, i 64 esagrammi
45 GIUGNO 2023 44 GIUGNO 2023
«In base a esso, un momento nel tempo possiede precise specificità (determinate dalla configurazione di tutti gli eventi che si verificano in quel momento) che influenza gli eventi che si configurano in quel momento». Quindi esiste «una connessione significativa tra la caduta apparentemente casuale degli steli di achillea e lo stato psicologico di colui che divina in quel momento». Gli steli o le monete che cadono in quel modo sono un segno del carattere specifico di quel momento: cadono in quel modo e non in un altro perché la realtà in quel momento presenta quell’aspetto, quella specifica somma di fatti, cose, sentimenti, elementi dell’universo che si configurano secondo una certa modalità. Una sorta di fotografia del momento (che può durare giorni o settimane).
Sta poi alla sensibilità e alla cultura di ognuno decidere se questo è solo uno strumento per far emergere contenuti latenti nell’inconscio, quindi per conoscere
se stessi («L'esagramma e le delucidazioni sull'esagramma e le linee possono fornire uno “schermo” su cui il divinatore può proiettare i dubbi inconsci sulla convenienza della linea d'azione. LYijing diventa così un dispositivo per esternare l'inconscio, ossia per renderlo cosciente»). Oppure se si tratta di un sistema per leggere la realtà al di fuori dei suoi meccanismi causali, per ottenere risposte che hanno un valore interiore, secondo meccanismi quasi magici (così come accade con i tarocchi o con l’astrologia, al di fuori delle sue banalizzazioni commerciali odierne).
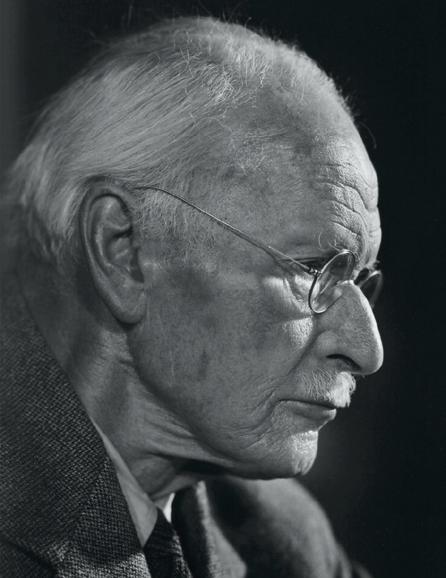
Ed ecco la filosofia, oltre il metodo. Come spiega Adler, qui il tempo non è sfondo neutro newtoniano, ma varia qualitativamente. «L'Yijing come sistema di simboli “schiude le cose” rappresentando l'ordine naturale in forma grafica, rendendone più facile la comprensione». Può risolvere dubbi, aiutare a muoversi nella direzione più appropriata.
Chi lo utilizza regolarmente, sa come e perché funziona. Non si tratta, ingenuamente, di avere risposte sul proprio futuro. Ma di farsi delle domande sulle possibilità e le scelte in campo, sulla configurazione degli eventi e su come la stiamo interpretando.
«L'Yijing simboleggia la non-dualità di ciò che è in ultima analisi reale (ovvero il mutamento yin-yang) e la prosperità morale del cosmo. Simboleggia, quindi, l'intuizione confuciana per la quale il significato ultimo (o scopo) dell'essere umano è attuare il potenziale morale del mondo naturale mettendo in pratica il potenziale morale incarnato nella natura umana». La scienza è nata dall’idea di comprendere le leggi universali, di entrare nella “mente di Dio”, che avrebbe un corrispettivo nell’ordine naturale. Cosa che non è così lontana dalla mentalità dei pensatori cinesi: «L'Yijing combina una visione del mondo non teistica, ma spirituale, con una struttura razionale e quasi matematica. Esso, dunque, combina l'accesso a questioni di “interesse ultimo” con una riduzione ai principi primi della natura: yin-yang, bipolarità, e la sostanza psico-fisico-spirituale del qi» In pratica l’universo è morale, ma la moralità è inscritta nella natura. Ecco una possibile interpretazione non religiosa, ma spirituale, di questa realtà ordinata, che potrebbe essere un terreno di confronto fra chi crede a un Logos, un Dio, una Realtà Ultima che governa l'universo e chi invece vede solo natura e materia che si organizza nelle sue componenti fondamentali per far emergere la consapevolezza. In ogni caso, la realtà è molto più della somma dei mattoni che la compongono.


47 GIUGNO 2023 46 GIUGNO 2023
Sopra, Carl Gustav Jung, psicoanalista e grande pensatore, che ha studiato a lungo l'Yijing. In basso, una statua dedicata a Lao Tse, fondatore del taoismo
«Un momento nel tempo possiede precise specificità. Esiste una connessione significativa tra la caduta apparentemente casuale degli steli di achillea e lo stato psicologico di chi divina in quel momento»
Liu Chen e Ruan Zhao entrano nel Tiantai, montagne sacre sia per il taosimo che per il buddhismo (@ Met Museum, OA)
Una scalinata rossa, e il mondo intorno. Il Festival di Cannes coincide simbolicamente con la Montée des marches. I gradini rossi che attori e registi devono percorrere per raggiungere il Grand Théâtre Lumière, la mitica mastodontica sala che ospita le anteprime mondiali dei film e può contenere più di duemila spettatori. È una scala che separa e che unisce, allo stesso tempo. Così lunga e ripida da dare visivamente l'idea della distanza che divide il mondo di noi comuni mortali dall'olimpo dei divi e dei grandi autori. Ma allo stesso tempo è la possibilità di un incontro, il luogo in cui lo spettatore può “scavalcare” lo schermo e incontrare i suoi eroi. Tanto per ricordarci che il cinema è fondato su questa relazione, ha bisogno dell'opera e di chi la fruisce, è un immaginario condiviso: artisti che creano, attori che incarnano idee ed emozioni, appassionati che le vivono e le rielaborano.



Ancora meglio se in cima a quella scala capita Martin Scorsese insieme a Leonardo DiCaprio e Robert
(© Festival di CannesJean-Louis Hupe)
De Niro, come è successo il giorno della presentazione di Killers of The Flower Moon. La storia del cinema e il suo presente più folgorante, l'arte e l'industria (in questo caso Apple, perché i capitali arrivano sempre più spesso dalle piattaforme). Che spettacolo vedere quei tre insieme, accompagnati dai membri del popolo Osage, protagonista del film. Perché Cannes è anche l'occasione per raccontare storie dimenticate, per offrire un palcoscenico a
rivendicazioni e diritti, e ricordarci che il cinema non è un innocuo passatempo. Sì, è una macchina che genera sogni (a volte anche incubi), ma è soprattutto uno strumento che ci insegna a guardare (la realtà, il mondo e noi stessi), che ci consente di vedere più lontano e in profondità. Cannes a volte è anche il palcoscenico di ritorni e rinascite, come quella di Johnny Depp, che ha aperto il festival.
Appassionatamente Cannes Lacrime (di gioia) e cinema doc
UN'EDIZIONE DA RICORDARE. GLI OMAGGI A HARRISON FORD
E MICHAEL DOUGLAS, TANTI DIVI, AUTORI IN GRAN FORMA
È stato lui il primo divo a richiamare fan e cacciatori di autografi, quelli che si piazzano fin dall'alba (a volte anche la notte) davanti alla passerella, il luogo dello “star watching”. Dopo anni di chiacchiere, scandali, processi (e dopo una sentenza che ha fatto rumore) Depp è tornato nel suo mondo. Lo abbiamo visto mentre salutava la folla adorante, firmando autografi e concedendosi ai selfie dei fan. Con quell'espressione tra lo scettico e l'ironico di chi forse vorrebbe essere altrove, ma in fondo è felice di essere tornato a casa. Ricorderemo a lungo anche la commozione di Harrison Ford, che alla veneranda età di 80 anni si emoziona ancora di fronte alla folla che lo acclama. Era letteralmente in lacrime, davanti al pubblico del Lumière, tutti in piedi ad omaggiarlo, la sera in cui gli è stata consegnata la Palma d'Oro onoraria. Si è commosso anche Michael Douglas, altra Palma d'Oro alla carriera, altro volto che si è impresso indelebilmente nell'immaginario dello spettatore. Mica male il
TUTTO IL MONDO GIRA INTORNO AI GRADINI ROSSI DELLA MONTÉE DES MARCHES
ria, che aveva minacciato di rifilare al cinema un colpo fatale (le sale chiuse per tanti mesi, le difficoltà produttive, lo streaming casalingo che esplode).
48 MESE 2022
duetto con Catherine Deneuve (a proposito di icone immortali), la sera dell'apertura del festival, con l'attrice che ha letto le parole di una poetessa ucraina, ricordandoci cosa sta accadendo là fuori, mentre noi celebriamo il cinema. L'edizione 2023 del Festival di Cannes è stata un concentrato di grandi attrici e grandi attori, una specie di reunion planetaria, dopo lo spavento dell'emergenza sanitaE VENTI
Lo aveva detto Thierry Frémaux, in sede di presentazione: è la rivincita del cinema (e di Cannes) alla faccia dei profeti di sventura e degli avvoltoi pronti ad approfittarne. Una festa per gli occhi, oltre che per la mente e il cuore. Non capita tutti i giorni di vedere insieme Julianne Moore e Natalie Portman, unite dal talento indiscutibile di Todd Haynes, oltre che da una classe che non cade mai nell'ostentazione. Così come la parata di stelle che Wes Anderson ha messo insieme per il suo ennesimo cine-divertimento, intitolato Asteroid City. La scalinata faticava a contenerli tutti, da Scarlett Johansson a Tom Hanks, da Steve Carell a Jason Schwarztman.
Ma Cannes è divismo solo per metà, anzi un terzo (a differenza, ad esempio, di Hollywood e dei suoi Oscar, in cui c'è quasi solo quello). Tutto il resto è “autorialità”.

Una parata dei migliori registi in circolazione, provenienti da tutti i continenti, anche quelli che badano solo all'arte, l'espressione, l'originalità della creazione (e per certi versi anche della provocazione), che l'industria la praticano solo per
VI RACCONTIAMO I PROTAGONISTI DEL FESTIVAL, VISTI DA VICINO, E I FILM DA ATTENDERE IN SALA
racimolare i soldi con cui fare film. È sempre un piacere rivedere lassù in cima gente come il finlandese Kaurismaki, che sulla Montée si è divertito come un bambino, mandando all'aria tutte le formalità della Croisette. Bellissimo applaudire il turco Ceylan, il cinese Wang Bing,
i giapponesi Kore-eda e Kitano (bentornato!), l'austriaca Hausner, la tunisina Ben Hania, in una sorta di internazionale della cinefilia, tra temi forti, realtà rivelata, panorami esotici più crudi che poetici. Poi ci sono quelli che passano nelle altre sale del festival, dalla Debussy alla Bazin, dalla Buñuel alla Varda (giusto omaggio alla grande Agnès, scomparsa nel 2019). Autori meno conosciuti dal grande pubblico, ma spesso geniali, registi che non hanno trovato spazio in Concorso, ma hanno lasciato il segno, da Steve McQueen a Victor Erice, da Kleber Mendonça Filho a Lisandro Alonso (quattro ottimi film).
Ed è un piacere anche constatare la considerazione in cui viene tenuto il cinema italiano, visto che il Concorso ha ospitato due grandi autori nostrani come Bellocchio (83 anni) e Moretti (69 anni), insieme a una giovane regista (41 anni) come Alice Rohrwacher, che i francesi forse hanno capito e amato prima di noi (siamo rimasti senza premi, è vero, ma quest'anno il Concorso era pieno di opere notevoli).

Cannes, da sempre, è un mondo a parte in cui si intrecciano il potere dei soldi e la forza delle idee. Da una parte ci sono le major americane, gli yacht ormeggiati "in vetrina", nel Porto Vecchio, davanti al Casinò, gli alberghi a cinque stelle da migliaia di euro a notte, i cocktail organizzati dai finanziatori (anche sauditi: Maïwenn, in conferenza stampa, ha difeso la scelta di farsi produrre dal Red Sea Fund, perché «le cose in quel Paese si stanno muovendo, e comunque tra i finanziatori ci sono anche i fratelli Dardenne»). Dall'altra ci sono i produttori indipendenti, i film nati dall'incontro di tante realtà, private e istituzionali, gli addetti ai lavori e i cinefili appassionati che corrono da una sala all'altra sperando di imbattersi in qualche cine-rivelazione.


Quest'anno c'eravamo anche noi di Redness, impegnati nel tour de force di ogni festivaliero che si rispetti. Sveglia all'alba – perché il primo film del giorno è alle 8.30 – tre o quattro proiezioni al giorno (anche cinque, è capitato, per un totale di dodici ore in sala), un incontro al mattino con registi e interpreti, vari appuntamenti istituzionali e infine il film delle 23, per chi riesce a tenere gli occhi aperti, o anche una festa sulla spiaggia o nei meandri di Cannes, per i più impavidi. In questo speciale vi racconteremo alcuni dei protagonisti, visti da vicino. Ma soprattutto vi parleremo dei film, le idee, le emozioni, ovvero ciò che ci interessa davvero: il cinema come passione, meraviglia, senso, redness. Un esercizio di consapevolezza. Cannes è una vetrina. La vera festa poi è al cinema.
 Michael Douglas scherza con i fotografi. In basso, Harrison Ford ringrazia il pubblico
Michael Douglas scherza con i fotografi. In basso, Harrison Ford ringrazia il pubblico
50 GIUGNO 2023
La realtà, tra banalità del male e bellezza delle piccole cose IL MIGLIOR
CINEMA VISTO A CANNES: LE AMBIGUITÀ DEL PRESENTE, I FANTASMI DEL PASSATO, LA GRAZIA DELLA SEMPLICITÀ
Scorrono le immagini di Amsterdam, oggi. Vie, case, palazzi, anche l'interno di appartamenti e locali pubblici, con la gente che vive la sua vita, più o meno tranquilla. Ma la voce fuori campo parla di cose e persone vissute tra il 1940 e il 1945, ai tempi dell'occupazione nazista. Persecuzioni, deportazioni, brutali omicidi, storie tragiche, aneddoti raccolti dalla voce di testimoni e famigliari. Il passato è

come una presenza fantasmatica, che aleggia nell'aria, in forma di suono e memoria, e che si insinua tra le pieghe del presente, immagini dense o rarefatte, pittoresche o astratte, disegnate con occhio d'artista dall'inglese Steve McQueen (fotografo e scultore, prima di diventare regista).
Ma il presente è anche quello dell'emergenza sanitaria, le piazze vuote, i locali chiusi, le manifestazioni contro il lockdown, mentre
il racconto parla di guerra e privazione della libertà.
Occupied City per certi versi è il film-simbolo di questa edizione del festival. L'esempio più clamoroso, per l'eloquenza e la durata (quattro ore!), di uno spirito che ha aleggiato su Cannes, in tante forme diverse. L'urgenza di ragionare sul presente appellandosi al passato, di riscrivere le regole di convivenza e gli strumenti di interpretazione del mondo.

Anche solo (solo?) il bisogno di ribadire quanto sia potente quello strumento che chiamiamo cinema, l'occasione di una narrazione diversa, di una coscienza critica fondata sullo stupore e su immagini capaci di mettere in crisi le nostre abitudini di sguardo. Non è un caso che molti dei film visti in questa ricca, ricchissima edizione, siano nati ai tempi del Covid, quando in molti hanno avuto la sensazione che fosse tutto finito. Progetti bloccati dall'emergenza, sceneggiature rimaste in stand-by, oppure nate proprio in quel periodo.
A proposito di nazismo e male assoluto (assolutamente “banale”)
– e del perché bisogna continuare a parlarne - The Zone of Interest sceglie di rimanere al di qua del lager di Auschwitz, nella vita quotidiana di una famigliola felice (?), nel lussureggiante giardino addossato al muro del campo di concentramento, nei gesti alienati, da burocrati dello sterminio, dei gerarchi e degli ingegneri
che ragionano sull'efficienza dei forni crematori. Niente che non sapessimo già. Eppure c'è qualcosa di estremamente perturbante nel modo in cui Jonathan Glazer racconta quella realtà, in immagini piatte e larghe, geometrie claustrofobiche, carrelli che invece di ampliare lo sguardo lo ingabbiano e lo inchiodano all'orizzonte delle
ciminiere. Se Il figlio di Saul di Nemes ci immergeva nell'orrore, pur lasciandolo fuori fuoco, per sentirlo di più e meglio, qui il fuori campo è assoluto, ma la presenza della morte quasi si respira, si percepisce l'odore dei corpi bruciati, si sente un rumore di fondo che è impossibile rimuovere dalla coscienza.

53 GIUGNO 2023
Sopra, The Zone of Interest di Jonathan Glazer. In basso, Retratos fantasmas di Kleber Mendonça Filho (@ Cinemascopio). Nell'altra pagina, Occupied City di Steve McQueen (@ A24 @ Family Affair Films & Lammas Park)
E VENTI
di Fabrizio Tassi
Un nero lunghissimo come prologo, un rosso angosciante in cui precipita il film, una musica che fa quasi girare la testa, fino alla nausea. Un film che ci ricorda quanto è facile diventare ciechi e sordi, se il mondo intorno (i forti, i vincenti, i padroni del mondo) ti dice che in fondo “è giusto così”. Sembrava giusto agli americani bianchi, nell'Oklahoma degli anni '20, ingannare, derubare, uccidere gli Osage, la tribù che si era ritrovata improvvisamente ricca, grazie al petrolio. Martin Scorsese in Killers of the Flower Moon non si limita a una ricostruzione storica, non si accontenta dello spettacolo della violenza, non è interessato a facili comizi o moralismi didascalici. Lui possiede la lucidità intellettuale e la maestria stilistica necessarie a raccontare anche l'umanità del “malvagio”, la sua desolante ingenuità, per dire che in realtà il nostro mondo è figlio di quella mentalità, che il benessere americano è fondato anche sul sangue e la rapina, che è troppo facile
riconoscere gli errori passati senza metterli in prospettiva col presente. Non è solo una questione politica. E non si tratta solo di memoria storica. C'è anche un gran bisogno di ripercorrere la propria vita, il senso del proprio lavoro, di fronte a un mondo sempre più caotico, di cui si sono perse le misure. Vedi Retratos fantasmas di Kleber Mendonça Filho, uno dei film più belli in assoluto visti a Cannes (anche questo fuori concorso, così come Scorsese e McQueen), che
racconta i cinema chiusi di Recife - vittime del sistema economico, della società che cambia, della smaterializzazione delle immagini – dentro un diario personale pieno di affetto (per la madre, ad esempio), di oggetti raccolti lungo la via, di documenti storici. Fotografa il mutamento della città e quello delle persone. Non per appellarsi alla nostalgia, alla resistenza contro la modernità, ma per cercare una via possibile per il futuro, consapevole di ciò che è stato.
Vari autori hanno realizzato film che sembrano voler fare i conti con il proprio cinema, e allo stesso tempo ragionano su ciò che è vero e ciò che non lo è, sull'ambiguità del reale e soprattutto della sua rappresentazione (uno dei problemi capitali della modernità, in cui è sempre più difficile distinguere il fake, e la scelta tra fonti diverse e punti di vista sembra diventata puramente ideologica, o peggio, sentimentale). Monster di Kore-eda semina false piste e sovrappone varie prospettive, per dire quanto è facile ingannarsi e giudicare, soprattutto in una società che promuove la dissimulazione e il perbenismo. May December di Todd Haynes mette in scena la messinscena, mostra il cinema allo specchio, nella sua illusione di verità, l'arroganza con cui pretende di capire le persone e raccontarle. Parla di ambiguità del reale (della parola, in questo caso, e dei sentimenti), anche Anatomie d'une chute di Justine Trier, che ha vinto la Palma d'Oro come miglior film

PER UNA DIVERSA NARRAZIONE DEL MONDO
(forse troppo generosa, visti i concorrenti, ma non scandalosa). Più bello - e sottilmente ambiguo - è il film del turco Nuri Bilge Ceylan, About Dry Grasses, storia di un insegnante esiliato in Anatolia, accusato di molestie da un'allieva, incapace di condividere un qualsiasi ideale collettivo.

Poi arriva il cinese Wang Bing, che ha trascorso cinque anni della sua vita a documentare il lavoro delle fabbriche in cui si producono vestiti (per il mercato interno, ma anche per noi), e ti annichilisce.

Guardare la realtà, senza filtri, senza abbellimenti, a volte è un esercizio difficile, faticoso da un punto di vista intellettuale (tre ore di cinema che non lasciano scampo), sentimentale (come tollerare tanta miseria?), spirituale (eppure c'è così tanta umanità, vitalità, per-
fino gioia, in quella vita ai limiti del degrado e oltre).
Non ci sono risposte. Se non l'appello unanime alle ragioni dell'umanità, della dignità, di ciò che ci unisce (il bisogno di amore, sicurezza, felicità), sempre più importante di ciò che ci divide (il luogo in cui siamo nati, la religione che professiamo, il colore della pelle). Questa sembra essere l'unica bussola. Per questo sono benvenuti i premi a Glazer (Grand Prix) e a Kore-eda (miglior sceneggiatura), ma soprattutto quello ad Aki Kaurismaki (Fallen Leaves), che sa raccontare la speranza come nessun altro, pur dentro un contesto che sembra senza vie d'uscita. E fa piacere il premio al grande Kōji Yakusho, protagonista del film di Wim Wenders, Perfect Days, in cui si racconta un uomo che di mestiere pulisce i bagni. Le giornate (in apparenza) sempre uguali, la vita semplice, ma anche la poesia delle piccole cose, la capacità di radicarsi nell'attimo presente, nella sua bellezza gratuita, la sua grazia.
54 GIUGNO 2023
Sopra, About Dry Grasses (@ Nuri Bilge Ceylan). In basso, Anatomie d'une chute (@ Les Films Pelléas - Les Films de Pierre). Nella pagina a fronte, Perfect Days di Wim Webders (@ Master Mind Ltd)
KUOLLEET LEHDET (Le foglie morte) di Aki Kaurismaki
Helsinki operaia. Due anime sole. Due lavoratori, vittime del precariato, che provano a restare umani. Una tragicommedia surreale, stralunata, umanista. Con sentimento ma senza mai essere banalmente sentimentale.
Nel repertorio del regista finlandese ci sono solo piccoli grandi film, spesso grandissimi, da Ariel a Nuvole in viaggio, da L'uomo senza passato a Miracolo a Le Havre
Kaurismaki ci dice che si può essere insieme ironici e gentili, disincantati e romantici. Che i cinefili non sono per forza aridi citazionisti.
Che gli “ultimi” sono migliori dei “primi”, e generalmente si aiutano tra di loro. La morale? Il mondo è brutto, ma noi possiamo essere bellissimi; l'amore è vivo e lotta insieme a noi.
MAY DECEMBER
di Todd Haynes
Storia di un amore proibito. O almeno così sembrerebbe. In realtà lo scandalo – una donna rimasta incinta di un tredicenne, il carcere, la nascita del figlio e poi un matrimonio felice - è solo la premessa della storia, sospesa tra melodramma e thriller psicologico.
Da una parte c'è un'attrice (Julianne Moore) che interpreta una persona "reale" (o meglio, ispirata a una storia vera).
Dall'altra un'attrice (Natalie
Portman) nei panni di un'attrice, protagonista di un film in cui interpreta il personaggio ispirato alla persona, e quindi impegnata a mimare i suoi gesti, a decodificare le sue azioni, creando un effetto straniante (un'attrice che imita l'interpretazione di un'altra attrice).

Natalie Portman è il cinema con la sua presunzione di verità alle prese con l'opacità delle cose e delle persone, che pensa di poter capire, spiegare, magari anche giudicare, sperimentando un surrogato di realtà. Julianne Moore è la realtà in forma cinematografica, già incarnata, l'assunzione di responsabilità che ciò comporta, che ne accetta i limiti, le ambiguità, il non detto.
È davvero felice quella donna? È davvero così unita la sua famiglia?
È davvero sincera, l'attrice, nella sua indagine umana, nella sua presunta serenità?
Tutto ciò che accade è insieme banale e al limite del precipizio, tra piccole e grandi bugie, tra buone intenzioni e cattive intuizioni, mentre una musica bellissima ed esageratamente melò viene a provocarci dentro inquadrature che sono dettagli urlati e resi quasi astratti, solo colori e sensazioni.
Todd Haynes gioca con lo spettatore, le attrici si specchiano una nell'altra e insieme guardano verso di noi, che chiediamo al cinema di intrattenerci mentre ci aiuta a capire come funziona il mondo, ben sapendo che è solo un riflesso. Chi rinasce, dentro il film - la metafora è insistita, plateale - è il terzo incomodo, preso in mezzo alla rappresentazione delle due protagoniste. La "rinascita" di noi spettatori passa invece dalla consapevolezza dell'illusione e dalla capacità di abbandonarsi alla sua seduzione.


KILLERS OF THE FLOWER MOON
di Martin Scorsese
Ci sono i registi che fanno cinema (la maggior parte) e poi ci sono quelli (pochi, pochissimi) che sono il cinema. Martin Scorsese, ad esempio. Killers of the Flower Moon è stupefacente per la limpidezza, il piacere del racconto, ma anche la ferocia. La storia vera del popolo Osage, che negli anni venti, in Oklahoma, scoprì di possedere terre ricche di petrolio, attirando gli appetiti di tanti, che finsero di essere loro amici. Scorsese ha realizzato un film che ne contiene tanti – azione e meditazione, commedia e sentimento,
generi che si incastrano, senza diluirsi o mescolarsi. Un film anche politico, implacabile. Che costringe lo spettatore a identificarsi con un tizio stupido e codardo, l'incarnazione dell'uomo medio (di ogni tempo e ogni luogo; uno specchio crudele, un messaggio). In cui i buoni, quelli
che in teoria dovrebbero sistemare le cose (e consolare chi va al cinema per sentirsi migliore), sono i cattivi di domani.
Un altro capitolo nella storia della nascita dell'America moderna – ma diciamo pure del mondo come lo conosciamo, fondato sul profitto e la fine di ogni mito, fede, ideale.
57 GIUGNO 2023 56 GIUGNO 2023
SUGGESTIONI DA CANNES: FILM DA RICORDARE, DA DISCUTERE, DA RIVEDERE IN SALA
Sopra, May December (@ Productions 2022 LLC). In basso, Killers of the Flower Moon (@ Apple). Nell'altra pagina, Fallen Leaves (@Sputnik)
I nativi Osage trovano la ricchezza grazie al petrolio, ma insieme a quella trovano anche il tradimento, la violenza, la dissipazione, diventando facilmente vittime del “sistema”.
Ci sono Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, con il loro proverbiale mestiere (De Niro, in particolare, mai così in forma negli ultimi anni). C'è il western in versione capitalista, con i cowboy avidi affaristi parassiti che uccidono gli indiani imborghesiti, appellandosi alle ragioni implacabili della storia. C'è l'invocazione iniziale, malickiana, alla Madre Terra e al Padre Sole, che viene soffocata nell'avidità, dopo essere stata battezzata nel petrolio (il prologo è memorabile).
Ma c'è soprattutto un finale che, nel suo atroce spasso, non lascia scampo, dando ragione alla profezia del cattivo, mentre satireggia la nostra cultura della rappresentazione, che si crede così colta, impegnata, sapiente, ma non impara mai niente.
QING CHUN (CHUN)
(Giovinezza - Primavera) di Wang Bing

Un'immersione totale, senza filtri, senza giudizi, senza "fare cinema" (nessun estetismo, un rigore estremo) dentro la realtà operaia cinese,
a Zhili, dove vengono realizzati vestiti per bambini in quantità inimmaginabili. Ragazzi che ripetono sempre gli stessi gesti, alla macchina da cucire, quasi acrobati, veloci e abilissimi, oppressi da ritmi, paghe, condizioni di vita disumane. Ma anche ragazzi che amano, ridono, giocano, litigano, chiedono al padrone qualche centesimo in più. C'è la misera più nera, il degrado, insieme alla vitalità, l'umanità, dentro un modello di società che non lascia scampo. Ecco la forza del cinema. Alla faccia di tutte le analisi e gli editoriali, che provano a dire e spiegare. Ecco la capacità di mostrare, rivelare la realtà, nella sua complessità e
nella sua sostanza radicale. Wang Bing, ancora una volta, sceglie di riportare l'atto del fare cinema alla sua natura primordiale, quella di occhio che osserva. Salvo poi, in montaggio (dopo cinque anni di riprese), scegliere e isolare i “personaggi”, delineare le storie, provare a decifrare i sentimenti che stanno dietro i gesti più quotidiani. Ne risulta una specie di (durissima) soap documentaria che sembra accadere sotto i nostri occhi.
INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO di James Mangold

“Dove non ti fa male?”. “Qui”. Il finale è questo, e a Cannes ha fatto piangere la sala (nel tempio del cinema d'autore, mica in una multisala qualsiasi). Questo per dire la forza di quell'epilogo, che non sveleremo, che riassume la forza e la sincerità di questa operazione ludica. L'intrattenimento si può fare in tanti modi, eleganti o pacchiani, onesti o sfacciati.
Indiana Jones, creatura del multiforme ingegno spielberghiano, sembrava aver già dato tutto, anche troppo, dopo il quarto capitolo. Ma James Mangold ha avuto l'umiltà e l'intelligenza di mettersi al servizio del mito, oltre che di Harrison Ford. Lui, arrivato a 80 anni, non poteva certo pensare di mettersi a correre, saltare, impegnarsi in inseguimenti rocamboleschi. O meglio, non poteva farlo alla vecchia maniera. E allora eccolo nei panni di un professore un po' stanco, sulle tracce di un oggetto mitico (l'Antikythera di Archimede), che potrebbe aprire un passaggio nel tempo, e quindi consentire a un nostalgico del nazismo di prendersi la sua rivincita. In effetti si parte da lì, dal '44, con un Harrison Ford ringiovanito e un tentativo di ricreare la magia del vecchio Indy. Una specie di dichiarazione di principio, soprattutto quando poi ci ritroviamo nel '69 e Indiana Jones è alle prese con
una ragazza che incarna la famelica generazione successiva (affamata di soldi e di vita, impersonata da una strepitosa Phoebe Waller-Bridge). No, non è una banale questione di nostalgia (di cosa, poi?). L'ultimo Indiana Jones funziona – nonostante certe sequenze d'azione dilatate all'inverosimile - diverte, gioca col passato e col presente, senza limitarsi al “fan service”, e diventa una specie di omaggio al cinema d'avventura d'antan.
RAPITO
di Marco Bellocchio
A tratti ha la forza espressiva del cinema muto, certi volti che si stagliano sullo schermo e urlano, imprecano, soffrono con un'intensità lacerante, certi gesti così plateali da risultare subito universali. A tratti sembra un fumetto iperrealista, ma anche un'astrazione sokuroviana, il cui presunto “verismo” manifesta la sua natura di sogno. E poi quel montaggio alternato,
che può permettersi solo un regista ottantatreenne libero da pudori o reticenze, in cui la ritualità cristiana risuona dentro e contro quella ebraica, in cui la madre Chiesa e la madre Patria si disputano l'anima del figlio che il padre non ha saputo proteggere.
Edgardo Mortara, il bambino ebreo fatto rapire da papa Pio IX (“non possumus”), cerca l'assoluto della fede sotto la gonna del pontefice, dopo aver perso quello del sangue, della famiglia, la gonna della madre. Si gioca tanto a nascondino, nel film di Bellocchio. Si canta, si prega, si cerca disperatamente di fare i conti con il desiderio frustrato, con il nostro esilio nel mondo, che ha sempre bisogno di aggrapparsi a qualcosa e a qualcuno. Edgardo Mortara abbraccerà il Cristo, la sua promessa di salvezza, dopo averlo liberato dalla croce, in modo che possa perdersi nel mondo, fuori dalle stanze vaticane (dentro cui lui finisce per rinchiudersi).

59 GIUGNO 2023 58 GIUGNO 2023
Sopra, Rapito (@ Kavac Film & IBCmovie). Nell'altra pagina, Qing Chun (@ Gladys Glove) e Indiana Jones
Chi crederà a quelle date e quelle didascalie, come se si trattasse di un affresco storico, si dovrà accontentare di una specie di feuilleton anticlericale (che è forse l'aspetto meno interessante del film, il Papa è una maschera grottesca, sembra più il mostro delle fiabe). No, “Rapito” non è cronaca, ovviamente, non è ricostruzione processuale e men che meno politica. La breccia di Porta Pia, in soggettiva papalina, è uno squarcio interiore, che in realtà non apre nulla, lascia solo nuove macerie destinate ad essere ricostruite da un'altra autorità, una nuova forma di potere sulle coscienze. L'ateo Bellocchio si commuove davanti ai segni della fede, fatto umano e quindi intrinsecamente dotato di una sua bellezza e verità, e si scaglia contro l'ideologia (il rapimento Mortara riecheggia il rapimento Moro). La religione qui è solo nei suoi segni esteriori. Dio è solo parole, paramenti, dogmi, ritualità (tutte cose che lo spirito dovrebbe rifuggire e trascendere, per trovarlo davvero, ma sarebbe un altro film). L'invisibile è l'inconscio che Bellocchio esplora
in ogni sua opera, come fosse una mappa interiore, che non indica un tesoro, ma un percorso, un processo, inevitabilmente personale. I suoi limiti sono anche la sua grandezza. Un cinema così lucido ed evocativo è cosa rara.
JEANNE DU BARRY di MaÏwenn Ascesa di una cortigiana. Una donna del popolo che si ritrova nell'olimpo della corte francese – la forma resa sostanza, il potere sclerotizzato – appena prima della ghigliottina. Con Versailles come personaggio principale, bellezza, sfarzo e cultura rimasti senza contenuto. Con Johnny Depp che risorge in forma di re Luigi XV, l'espressione di chi potrebbe essere chiunque, in ogni tempo e
in ogni luogo, perché tanto non è più padrone di sé, si è trasformato in una mera immagine (al servizio della corte francese, o del cinema). Un disagio che fa il gioco del film, coi suoi costumi a cui non riesci a credere, che guarda l'abisso che separa (unisce?) il vecchio e il nuovo mondo con la consapevolezza rock di chi ha amato la Marie Antoinette di Sofia Coppola, ma osa la veste classica, l'afflato epico e fiabesco (e i suoi alti innominabili rimandi) con tratti caricaturali, il filmone che dovrebbe esplodere dall'interno, come un male incurabile che poi emerge in superficie, sulla pelle. Dovrebbe, appunto. Trovare la realtà, o addirittura la verità, attraverso il grottesco, è sempre difficile. In parte Maïwenn ci riesce pure quando, verso la fine, un gesto ridicolo diventa lo strumento per esprimere un sentimento profondo, commovente. Al di là anche dei soliti temi, le forme del potere, la verità dell'uomo contro quella dell'istituzione, la donna che usa il desiderio in modo eversivo, per diventare soggetto e non più solo oggetto di sguardo e possesso.
Peccato che il film ondeggi tra eccessi didascalici ed emozioni fuori fuoco. Il buono che c'è (che non è poco) naufraga nella difficoltà di gestire quel formidabile dispiegamento di mezzi e le sue ambizioni.

MONSTER
di Hirokazu Kore-eda Dovrebbero andare (quasi) tutti a scuola da Hirokazu Kore-eda. Per imparare a dare una sostanza alla forma, un'anima al meccanismo cinematografico, una qualità emotiva alla “bella inquadratura”. Perché sono (quasi) tutti bravi a impacchettare una storia, a giocare con i punti di vista, ad appellarsi a Rashomon o chissà cos'altro. Ma poi bisogna metterci un po' di vita e verità. Monster ce la mette in abbondanza. Ce la mette con la consapevolezza di chi usa il meccanismo per trasformarlo in senso, per dire la società e l'idea di mondo che sta raccontando attraverso quel modo di fare cinema.

C'è un ragazzino strano, che soffre visibilmente e parla di esseri umani trasformati in mostri. C'è un professore crudele, che lo tormenta, forse. Ma forse in realtà è solo bullismo, una storia tra ragazzi, di cui è vittima uno studente stravagante, accusato di essere poco “maschio”. O forse, ancora, è tutto un equivoco paradossale, dentro cui ognuno ha il suo segreto da custodire, anzi da soffocare, dentro una realtà in cui ciò che conta è la rispettabilità, la dissimulazione dei sentimenti.
Non si può dire molto di questo film, per non correre il rischio di rovinare la "sorpresa", che però non è un trucco, una rivelazione fine a se stessa, per il gusto di fare cinema. La realtà è la somma di tante verità, di una moltitudine di errori, aspettative, scelte, debolezze, chi può pretendere di sapere cosa è giusto e sbagliato senza ombra di dubbio?
Il bello di Monster è che per lunghi tratti rimani col sospetto che lo svolgimento sia troppo meccanico, che gli ingranaggi si incastrino con esagerata precisione (questo è il fraintendimento a cui si presta).
Ma Kore-eda semina gesti, sguardi, dettagli emozionanti, che illuminano il racconto, che lo scardinano, che gli danno una misteriosa profondità, mentre emerge la bellezza di un'amicizia e di un amore.
C'è un suono, che riecheggia dentro il film, raccordando le vite e le storie, una specie di richiamo, apparentemente stonato, un messaggio segreto, che ha la forza della parola sussurrata nel finale di In the Mood for Love.
L'universo, un giorno, finirà di espandersi, il tempo si accartoccerà, tornerà all'indietro, e quei due ragazzi continueranno a correre verso la libertà.
60 GIUGNO 2023
I MIGLIORI? PER NOI SONO I FILM DI KORE-EDA, SCORSESE E KAURISMAKI
Sopra, Jeanne du Barry (@ Stéphanie Branchu / Why Not Productions). Nell'altra pagina, Monster
JOHNNY DEPP
«Non mi sento boicottato da Hollywood, perché non penso in alcun modo a Hollywood. Non ho bisogno di Hollywood. Viviamo in tempi strani e curiosi, in cui tutti vorrebbero essere se stessi, ma non possono, perché devono conformarsi. Se volete vivere in questo modo, fate pure, io sarò da un'altra parte».
Johnny Depp non gira troppo intorno alle questioni. Ma non ha neanche troppa fretta di spiegarsi. Non è scosso da chissà quale urgenza espressiva. Anzi, se ne sta lì, tranquillo, come fosse appena arrivato dalla luna, immerso in lunghi silenzi, tra una frase e l'altra. A volte sembra che non trovi le parole, esita, cincischia, mormora qualcosa, per poi divagare. Altre volte, invece, le sue sembrano pause teatrali, dentro cui probabilmente vorrebbe veder scomparire il mondo, e soprattutto chi continua a chiedergli del processo, della sua carriera spezzata, del suo "ritorno al cinema".
«Le persone usano spesso questa espressione, che è un po' un cliché. A sentir loro avrei già avuto diciassette ritorni. La parola "ritorno" mi lascia perplesso perché io non sono andato da nessuna parte. A essere preciso, vivo a 45 minuti da qui. In realtà le persone hanno smesso di chiamarmi, per qualche ragione. Non so di cosa avessero paura. Io non sono andato da nessuna parte, ero là. Parlare di ritorno è come se io me ne fossi venuto fuori ballando il tip tap o qualcosa del genere. Suona bizzarro»
Johnny Depp era sembrato quasi sorpreso dalla folla che lo acclamava, il giorno della presentazione del film, prima della Montée. Non era poi così scontato che gli appassionati di cinema facessero tutti il tifo per lui, soprattutto dopo le polemiche che avevano accompagnato l'annuncio della sua presenza, anche in Francia. Qualcuno non vedeva di buon occhio che il festival venisse aperto da un uomo accusato di violenze domestiche (che poi, ricordiamolo, ha vinto il processo contro la ex-moglie, accusata di averlo diffamato). Troppo forte l'eco di quella guerra in tribunale, in cui
Johnny Depp e Amber Heard hanno fatto di tutto per distruggersi, tra storie di sopraffazione, alcool, droga.
Ma la sua carriera ora è ripartita, MaÏwenn lo ha scelto per interpretare re Luigi XV, Cannes ha scelto Jeanne du Barry come film d'apertura, e gli appassionati sono corsi a tributare il loro omaggio.
Una specie di rivincita. Che lo ha rinfrancato e frastornato. Ha firmato qualsiasi pezzo di carta gli mettessero sotto gli occhi, ha posato davanti agli smartphone dei fan, ha sorriso anche quando gli costava fatica. Alla fine della proiezione, accolta da un lunghissimo applauso, aveva gli occhi lucidi.
In conferenza stampa, invece, è arrivato con 40 minuti di ritardo, con i capelli sciolti sulle spalle, come una rockstar, e un'espressione tra il sarcastico e l'abbacchiato, come chi deve andare incontro al patibolo, ma in fondo è curioso di scoprire di che morte deve morire. «So che ci sono delle persone che non volevano che venissi al Festival di Cannes. Magari un giorno qualcuno mi impedirà anche di andare da MacDonald's, e da qualche parte ci saranno 39 persone furiose contro di me che sto mangiando un BigMac. Ma non penso che mi interessi molto di chi siano queste persone. Perché si preoccupano? Le persone dovrebbero riflettere un po' di più». Non è sempre facile decifrare le sue risposte. A parte quando dice che su di lui e la sua vita è stata scritta una «fiction immaginaria e orribile»
Ma per fortuna si è parlato anche di cinema. E si è scherzato a lungo sulla (buonissima) pronuncia francese di Johnny Depp e sull'allenamento che ha dovuto subire: «Avevo un'insegnante che ha abusato di me (no, scherzo, la adoro). Mi ha insegnato a porgere le parole atteggiando la bocca in certe forme bizzarre». In realtà, ha raccontato MaÏwenn, tutti sono rimasti stupefatti dalla naturalezza con cui pronunciava le sue battute. Ma anche dalla conoscenza che aveva della storia francese. Depp ha scherzato sul fatto di essere stato scelto per quella parte: «Temevo che fosse un equivoco. MaÏwenn è stata abbastanza coraggiosa nello scegliere un bifolco del Kentucky per interpretare Re Luigi XV. Ero un po' intimorito. Ma sono felice che lei abbia insistito».
A quanto pare Johnny Depp utilizzava una musica ad hoc per preparare ogni scena (Bach soprattutto). Era meticoloso e aveva un suo sguardo personale, la sua visione sul film. A questo proposito, si vociferava di litigi tra i due. Ma a Cannes sono stati sempre vicini, molto teneri l'uno con l'altra, spesso mano nella mano. «Parliamo di cinema, il resto è noioso» come direbbe Depp.





63 GIUGNO 2023
E VENTI
«Viviamo in tempi strani e curiosi, in cui tutti vorrebbero essere se stessi, ma poi devono conformarsi. Io non ci sto»
(Jeanne du Barry @ Stéphanie Branchu / Why Not Production)
LILY GLADSTONE
"Nasi Forati" e "Piedi Neri". Le sue origini sono queste. Nimiipu e Niitsìtapi, nativi americani. Lily Gladstone ne va particolarmente fiera. Anche per questo - oltre che per il suo indiscutibile talento - Martin Scorsese l'ha scelta come "guida morale e spirituale" del suo film. Killers of the Flower Moon è il film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, due mostri sacri del cinema di ieri e di oggi. Eppure se c'è un personaggio che ti rimane nella mente e nel cuore, è quello di Molly, la donna Osage che si innamora di Ernest Burkhart (DiCaprio), che si fida di lui, mentre tutti muoiono intorno a lei (la sua famiglia, i suoi amici), che sta al suo fianco anche quando emergono gli intrighi e le bugie, salvo poi metterlo di fronte alla realtà delle cose, con una dolcezza gentile che è più potente e perentoria di qualsiasi violenza.

Lily Gladstone ha prestato a Molly la sua intelligenza, la coscienza di sé e quel sorriso che dice tante cose insieme, è ironia e comprensione, orgoglio e pietà. È lei la vera protagonista di un film in cui gli uomini bianchi sono degli stupidi o degli impostori, invasati, ossessionati dal denaro e dal potere.

Lily Gladstone ha 36 anni ed è originaria del Montana. La sua è una formazione teatrale, con laurea all'Università di Washington e una particolare predilezione per Shakespeare. La sua prima apparizione al cinema risale a più di dieci anni fa, nel 2012, grazie ad Arnaud Desplechin e al suo Jimmy P., che non per niente raccontava un nativo della tribù dei Piedi Neri (Benicio Del Toro) reduce dalla Seconda Guerra Mondiale.
Ma la notorietà è arrivata grazie all'incontro con Kelly Reichardt, che l'ha scelta per interpretare una delle quattro sorelle del Montana protagoniste del film Certain Women (che ha fruttato a Lily un paio di premi della critica), oltre a First Cow Con il film di Scorsese, però, entriamo in un'altra dimensione, che le si addice perfettamente. Anche se lei ha confessato di tremare la prima volta in cui ha incontrato DiCaprio. Salvo poi sentirsi tranquillizzata dalla sua umanità e generosità. Lei che si fa portavoce dell'orgoglio e dei diritti dei nativi, non poteva che trovarsi a proprio agio con un attivista (green) come lui.


A proprio agio è apparsa anche sulla Montée, col suo vestito scuro e largo tappezzato di grandi fiori bianchi e gialli, che sembrava voler tenere insieme le radici amerindiane e le ragioni dell'eleganza cannense. Ma non parlatele di "glamour", perché per lei un film come questo è l'occasione per raccontare le ragioni, i sentimenti, la verità umana e spirituale di un popolo, anzi, di tanti popoli, che hanno avuto una storia simile di sopraffazione e ingiustizia. Ha detto: «Per raccontare la verità di questa storia al cinema ho chiesto il permesso di condividere i racconti privati degli Osage. Me li hanno affidati perché il mondo li conosca e io sono orgogliosa di raccogliere queste testimonianze autentiche. La vita d’altronde è come l’acqua: non può stagnare, ma deve muoversi continuamente». All'incontro con la stampa, a Cannes, era presente anche il capo della nazione Osage, Standing Bear, che ha parlato di un «popolo che ha sofferto molto» e di come questo film abbia ristabilito in qualche modo la «fiducia nei confronti del mondo intorno» Martin Scorsese ha raccontato di una lavorazione complessa, che ha cambiato il focus lungo il percorso (fino a quando ha capito l'importanza del personaggio poi interpretato da DiCaprio), in stretto rapporto con gli Osage: «Al primo incontro mi ricordo che si sono alzati, hanno detto una preghiera, hanno fatto un rituale e io ero talmente colpito ed emozionato. Ho capito sempre meglio i valori di questo popolo, il rispetto, l'amore per la terra. Loro conoscono la verità su come vivere su questo pianeta. Certi aspetti della loro organizzazione corrispondono alla fondazione della nazione americana, la Dichiarazione di indipendenza». Che è distante anni luce da Trump (definito da De Niro «uno stupido») o dalle violenze che hanno generato il Black Lives Matter. Lily Gladstone ha parlato della verità dell'arte, che è diversa da quella dell'antropologia, che «deve portare alla luce ciò che è nascosto in una società» e magari rispondere alla sfida della "supremazia bianca". «Difficile interpretare un personaggio come Mollie, spiegarne l'eredità, il suo umorismo, la forza, il suo profondo significato culturale. Da piccola mi parlavano di mia nonna, che era contemporanea di Mollie. Ecco, più che trovare Mollie forse ho ritrovato me stessa».

65 GIUGNO 2023
«L'arte deve portare alla luce ciò che c'è di nascosto. Gli Osage mi hanno affidato i loro racconti perché il mondo li conosca»
E VENTI
(Lily Gladstone e Martin Scorsese sul set di Killers of the Flower Moon)
SCARLETT JOHANSSON
Si fa presto a dire "diva". C'è chi lo fa o si atteggia, chi ha un'alta considerazione di sé e la esterna in capricci e gesti plateali. E c'è chi lo è, semplicemente. Luminosa. Numinosa (d'altra parte l'etimologia è quella: divus, divino). Scarlett Johansson è un'attrice che ruba gli occhi, un magnete che attira sguardi e desideri. Il suo fascino non ha nulla di siderale, anzi, sembra del tutto "naturale", sorridente, spontaneo. Eppure ha qualcosa di inarrivabile. Per questo è diventata un'icona di bellezza, materia ideale nelle mani di un regista in cerca di malìa, che vuole accendere lo schermo. Ma l'attrice newyorchese (nata nel 1984) - di padre danese e madre statunitense - ha dato ampie dimostrazioni, nel corso della sua carriera, di saper maneggiare le emozioni più complesse, le sfumature della recitazione. Partita dalla commedia senza troppe pretese, ha fatto il primo salto di qualità grazie all'incontro con Sofia Coppola, in Lost in Translation Match Point di Woody Allen è un altro snodo importante. Seguito da un'attività frenetica, che l'ha portata anche a girare quattro film in un anno e che l'ha trasformata in un punto fermo dell'universo Marvel, entrata nell'immaginario pop collettivo con la sua Vedova Nera. Per poi fare ritorno al cinema d'autore con Storia da un matrimonio (con cui finalmente è arrivata una candidatura agli Oscar), dopo aver accettato sfide impegnative come quelle di Jonathan Glazer (Under the Skin) e Luc Besson (Lucy), due film che magari non sono capolavori, ma che lei ha reso speciali.
Potrebbe gestirsi meglio e scegliere con più attenzione copioni e produzioni? Certamente. Sta di fatto che ogni sua apparizione è una festa per gli spettatori, oltre che per i produttori (non per niente è l'attrice più pagata in circolazione).
Scarlett Johansson è una diva che non ha bisogno di fare la diva. La guardi e lo capisci, punto. La vedi in quel tubino rosa con cui ha percorso la Montée a Cannes e non c'è bisogno di dire altro. Non è solo una questione di bellezza o eleganza. È l'aura. Per quanto diversa da quella manifestata da star come Charlize Theron o Nicole Kidman, che attingono a un'altra dimensione (oggi forse su quella "lunghezza d'onda" si potrebbe citare Margot Robbie). Scarlett è

"una di noi", eppure è sempre un passo oltre le nostre possibilità e la nostra immaginazione.
Il pubblico di Cannes, che ha aspettato ore e ore per poter vedere da vicino il cast stellare di Asteroid City, ha consumato gli smartphone, in raffiche di fotografie, per immortalare il suo Prada, il tatuaggio (rose, ma con le spine!) che spuntava dalla scollatura sulla schiena, il rossetto rosso, rossissimo (da diva).




All'incontro con la stampa si è presentata con un vestito più semplice, a righe, dai colori vivaci. Lei che ha raccontato più di una volta la sua sorpresa, quando le offrivano ruoli sexy alla Marilyn, visto che in realtà sente di essere «una persona semplice, anche nel look» (diva modesta).
In Asteroid City è un'attrice con i capelli corti e neri, cotonati, come si portavano negli anni '50. Wes Anderson e il suo universo cinematografico non sono mai banali. «Lavorare con lui è un'esperienza appassionante - ha raccontato Scarlett - perché Wes crea un ambiente particolare, concreto, fisico, in cui tutto vibra, ed è come essere a teatro, dentro uno spazio dato. Il suo metodo è unico» Chiamata a riflettere sulla natura del cinema - realtà o sogno? - se n'è uscita con un ragionamento sulla sua vita onirica (e sull'importanza dei sogni, che prova a interpretare) «Fare un film, interpretare un personaggio, è come un prolungamento della mia coscienza, e infatti io utilizzo i miei sogni. È un'estensione della nostra vita interiore».

Scarlett Johansson era a Cannes con il marito Colin Jost, insieme a cui sta sostenendo la battaglia degli sceneggiatori di Hollywood. Lei che ha sponsorizzato volentieri le lotte per i diritti civili, che ha combattuto e vinto una battaglia legale per i diritti di Black Widow contro la Disney (che ha fatto uscire il film direttamente su piattaforma, senza passaggi in sala), è diventata anche un punto di riferimento per il confronto (ormai ineludibile) con il mondo dello streaming e delle piattaforme. Come ha detto anche in un'intervista a Repubblica: «Ci troviamo in un territorio tutto nuovo, questo è il momento di stabilire dei limiti. Gli artisti devono affrontare la questione, perché riguarda tutte le categorie, facciamo tutti parte di un tutto».

67 GIUGNO 2023
«Fare un film, interpretare un personaggio, è come un prolungamento della coscienza, della mia vita interiore»
E VENTI
(Asteroid City)
HARRISON FORD
«Dicono che quando stai per morire ti scorre tutta la vita davanti. Io l'ho appena vista...». Harrison Ford scherza sulla sua età, trattenendo a stento le lacrime, mentre si celebra la sua carriera. Siamo a Cannes, nel tempio del cinema, e lui si rende perfettamente conto che non si tratta di un omaggio formale, di maniera. L'edizione 2023 ha visto passare sulla Croisette decine di star e di autori amati dal pubblico, ma lui è stato letteralmente travolto dall'affetto.

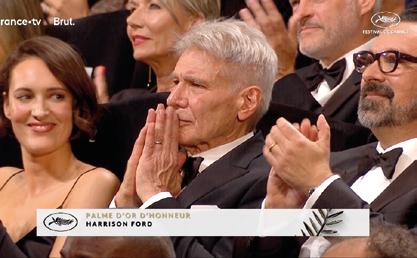
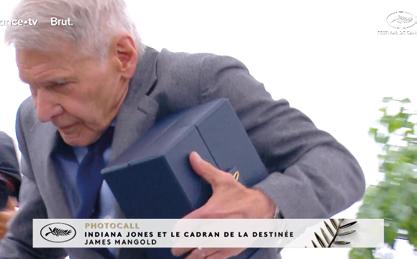

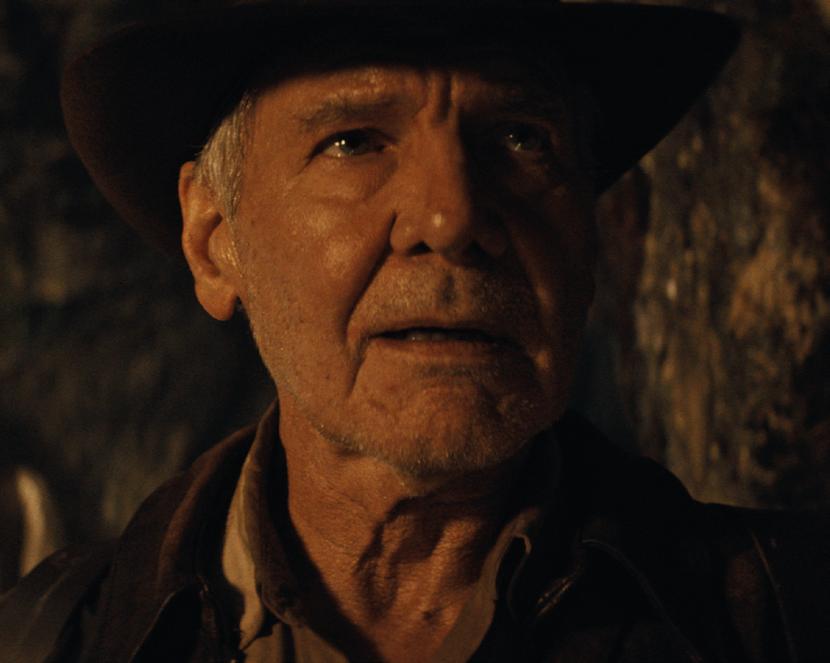
Scorrono le immagini dei suoi personaggi, sul grande schermo.
Pochi dubbi sui più memorabili: se la giocano Ian Solo (Guerre Stellari) e Rick Deckard (Blade Runner). Poi ovviamente c'è
Indiana Jones, che senza di lui non avrebbe un senso (e infatti con lui scomparirà, o almeno questa è la promessa). Ma ci sono anche Richard Kimble (Il fuggitivo), John Book (Witness - Il testimone), Jack Ryan (Giochi di potere)... Niente male per uno “sbocciato in ritardo”, come ama definirsi. La Montée è stata una marcia trionfale. Lui continuava a sgranare gli occhi e a sfoggiare quel sorriso un po' storto, da sbruffone col cuore d'oro, come è stato spesso al cinema, un duro che sa essere autoironico, un uomo d'azione che non ci crede mai fino in fondo, ma alla fine ci mette tutto se stesso. L'ovazione l'ha ricevuta anche in sala stampa, quando è venuto a parlare con noi giornalisti. Ed è partito proprio da lì, dall'emozione del giorno prima: «È stato indescrivibile. Non riesco a trovare le parole per dirlo». E non le trovava davvero, emozionato come un ragazzino, lui che di anni ne ha 80 e di palcoscenici ne ha visti tanti nella vita. «È stato straordinario vedere tutta la propria vita in un istante. Straordinario sentire il calore di questo luogo. Il sentimento di appartenere a una comunità. L'accoglienza inimmaginabile. Mi ha fatto sentire davvero bene». La sua partecipazione a questo nuovo, ultimo episodio di Indiana Jones non era affatto scontata. «Adoro questo personaggio. So cosa ha portato nella mia vita. L’unica cosa che volevo era che fosse un buon film, che riassumesse in qualche modo i quattro episodi precedenti, chiudendo la storia. Volevo che questo personaggio si ricordasse del vigore della sua giovinezza, ma che vivesse fino in
fondo la sua vita, sentendo il peso del passato sulle spalle, rassegnandosi al fatto che il tempo passa. Volevo che fosse un film di relazioni umane, non solo d'azione, che ci fosse una relazione profonda con qualcuno. E volevo lavorare con James. Non potevo chiedere un cast migliore. Tutti mi hanno supportato nella mia vecchiaia. Sono così grato alla vita per avermi dato l’opportunità di fare questo mestiere. Adoro questo lavoro. Voglio lavorare, voglio raccontare delle storie». E lo farà ancora. «Amo la commedia, farò ancora una stagione di Shrinking e ci sono altri progetti. Esistono talenti che non vedono mai la luce del sole. A volte non ci si trova nel posto giusto. Io ho aspettato il mio momento, ma l’ho aspettato dandomi da fare e migliorandomi di continuo».
James Mangold - che ha raccontato di aver visto I predatori dell'arca perduta a 17 anni, in un cinema dello stato di New York, un film che gli ha fatto venir voglia di fare il regista (così come a Mads Mikkelsen, il "cattivo", ha fatto venir voglia di fare l'attore, quando aveva 15 anni) - ha spiegato che il film è nato proprio grazie allo spirito con cui ci ha lavorato Harrison Ford. Non è mai stata solo una questione economica (e chi l'ha visto sa che non sono solo parole, c'è davvero qualcosa di vitale e sincero, è un finale ideale).
Si è parlato anche di tecnologia, della sequenza iniziale in cui Harrison Ford appare ringiovanito: «So che quel volto è il mio. Non è una sorta di magia in stile Photoshop, è proprio così che ero 35 anni fa perché la Lucasfilm ha ogni fotogramma dei film che abbiamo fatto insieme in tutti questi anni». E si è parlato di magia: «Tutto è pianificato, ma poi è grazie al lavoro di tutti che diventa reale. Ecco la magia, che viene dalla collaborazione. I personaggi sostengono la storia e la storia sostiene i personaggi. È veramente qualcosa di magico quando funziona. Quando non funziona invece diventa un incubo».
Spazio anche per le risate, quando una giornalista gli ha detto di trovarlo molto "hot", chiedendogli se è ancora in grado di montare a cavallo. Risposta ironica, a tono «Certo che sono in grado, se me lo lasciano fare. Ma ho dimenticato tutto sull'equitazione. Ho avuto fortuna a possedere un corpo del genere. Grazie di averlo notato».
69 GIUGNO 2023
E VENTI
«È stato straordinario vedere tutta la propria vita in un istante. Un'emozione indescribile. Sento di far parte di una comunità»
(Indiana Jones e il quadrante magico)
JULIANNE MOORE NATALIE PORTMAN
«Le donne non sono un gruppo di minoranza. Siamo il 50% della popolazione. Quindi è importante che siamo trattate come tali». Parole di Julianne Moore. Pronunciate con il sorriso sulle labbra, ma con un tono deciso, glaciale, inappellabile. Tanto per chiarire che lei non ama i vittimismi e i discorsi che affrontano la "questione femminile" come se si trattasse di una categoria da proteggere (al cinema, come in ogni altro ambito della società).
A Julianne Moore non manca certo la personalità. Così come non manca a Natalie Portman. Un bel concentrato di carattere e talento, quello messo insieme da Todd Haynes per il suo May December (titolo che allude alle coppie in cui esiste una grande differenza di età). E loro due hanno calcato il palcoscenico di Cannes a modo loro: con classe. Vedi anche lo stile con cui hanno affrontato la Montée. Julianne Moore in un abito lungo, verde, estremamente semplice e classico. Natalie Portman con uno scintillante Dior bianco e blu, la gonna ampia, le spalle scoperte. Ma non provate a parlare di abiti e di glamour con Julianne Moore, che ha usato Cannes come esempio di ciò che il mondo si attende dalle donne, obbligate a indossare tacchi alti e vestiti da copertina: «È diverso ciò che ci si aspetta dal comportamento di noi donne rispetto agli uomini, il modo in cui dovremmo apparire. E queste aspettative influiscono sul modo in cui ti comporti, sia che tu le stia accettando o rifiutando. Sei comunque definito dalle strutture sociali che vengono applicate su di te».

O per dirla con Natalie Portman, sottolineando un'ovvietà che a quanto pare non è tale: «L'intera gamma del comportamento umano dovrebbe essere accessibile alle donne, perché le donne sono semplicemente esseri umani».

D'altra parte è (anche) di questo che si parla nel film, estremamente raffinato anche nel modo in cui finge di piegarsi alla logica dei tabloid, dello scandalo tradotto in cinema, della chiacchiera
che alimenta i pregiudizi. Si parla pur sempre di una donna che ha una relazione con un ragazzino di 13 anni.
Haynes ha raccontato di un film che «esplora il nostro rifiuto di guardarci onestamente. Reprimiamo molti dei nostri desideri per buone ragioni. Una società civile esiste proprio perché ci tratteniamo. Film come questo sono sempre più difficili perché la società non si sente più a suo agio nell'essere a disagio. Penso che sia la morte del pensiero, della critica sociale... Ci sono aspetti problematici su come sia iniziata questa relazione, che però è durata. Sì, c’è disparità di età, ci sono trasgressioni umane, ma sono opportunità per guardare noi stessi e la cultura in cui viviamo».

Julianne Moore ha le idee chiare in proposito: «Il mio personaggio è qualcuno che trasgredisce, e come lo affrontiamo? Quando l'età è inappropriata? Qui il problema è che c'è un adulto che ha un rapporto con un ragazzo. Gracie trasgredisce, ma anche tutti gli altri lo fanno. E sembra così pericoloso perché non sai dove siano i confini di nessuno, è spaventoso. Questo è ciò che Todd ha catturato così magnificamente» E Natalie Portman: «La visione di Todd del lato oscuro che si cela sotto questo idillio americano riesce a creare tensione e dramma in modo molto sottile».

Ma la questione principale è cosa rimane di vero, dentro una realtà che ci «definisce nella nostra cultura, la nostra etnia, la nostra età, un sistema che ci impone ciò che siamo, tanto che non esiste più un libero arbitrio - come ha detto Julianne Moore. - Il mio personaggio non fa che replicare ciò che le è stato insegnato» Ci sono voluti 23 giorni di riprese. Pochi. Ma julianne Moore conosceva già molto bene lo stile di Todd Haynes (insieme hanno girato Lontano dal paradiso, Io non sono qui, La stanza delle meraviglie) e lui ne ha parlato come di un'artista «che riesce a mettere nel film cose che neanche io vede durante le riprese» Le due (grandi) attrici non si conoscevano, ma si sono scambiate tanti complimenti e un reciproco "ti adoro". Le adoriamo anche noi.

71 GIUGNO 2023
«È diverso ciò che ci si aspetta dal comportamento di noi donne rispetto agli uomini. Siamo definite da queste aspettative»
E VENTI
(@ May December Productions 2022 LLC)
IDEE CHE FUNZIONANO: IL PRONTO SOCCORSO PER CAMION FRIGO


Licenziato,
Quando si dice “trasformare un problema in un'opportunità”. Sembra una frase fatta, un luogo comune, e invece per tante persone è vita
vissuta, quotidianamente. Quando Marco Martello è stato licenziato dal suo posto di lavoro, erano tempi difficili. Nel 2007 era iniziata una crisi mondiale che aveva fatto
tremare migliaia di aziende anche in Italia. Da lì è partita la “Grande recessione” che ha fatto sentire i suoi effetti fino al 2010.
Marco incassò 10 mila euro per il licenziamento e invece di metterli in banca, aspettando tempi migliori, cercando un altro posto di lavoro dipendente, decise di mettersi in proprio. Si comprò un furgoncino da 1000 euro, un po' di attrezzatura, e cominciò a correre in soccorso di aziende e camionisti in difficoltà, quelli che lavorato con le celle frigorifere, perché trasportano merce che deve essere conservata al freddo.
È cominciata così l'avventura di quella che si chiamava Frigo Assistance e che poi è diventata Isofam. All'inizio era solo un “pronto intervento”. Poi è diventata anche officina con servizi di riparazione di veicoli industriali isotermici, verniciatura, coibentazione, installazioni e modifiche strutturali.
Chi lavora in Veneto nel campo del trasporto alimentari, conosce molto bene questa realtà, cresciuta a ritmi impressionanti.
Pochi sanno però che è nata dall'iniziativa di una sola persona e da un furgoncino scalcagnato, che ha percorso migliaia di chilometri in lungo e in largo per il nordest italiano, a qualsiasi ora del giorno e della sera.
«Io ho cominciato da elettricista –racconta Marco Martello, titolare della Isofam. – Venivo da una famiglia di elettricisti. Ma era un settore con troppa concorrenza. Per questo sono andato a lavorare in un'officina che riparava celle frigorifere. Ci sono rimasto una decina d'anni. Poi si sono rotti i rapporti».
Non c'era più spazio per lui in quell'azienda, ma intanto aveva imparato un sacco di cose. «Avevo fatto dei corsi, mi ero specializzato.
Mi sentivo pronto per cominciare una mia attività. Ho investito 1000 euro per un furgone, un vecchio Ducato degli anni '80, ho comprato l'attrezzatura e ho iniziato a lavorare da solo, andando a fare assistenza nelle sedi delle aziende»
Il nome doveva echeggiare quello delle società che lavorano nell'assistenza degli automobilisti e nelle assicurazioni. Nacque così Frigo Assistance, al servizio dei mezzi di trasporto con gruppi frigoriferi. Chi non è del settore non ha idea della quantità di mezzi impegnati quotidianamente nel trasporto alimentare. Abituati come siamo ad avere il cibo sotto casa, nei negozi e nei supermercati, nei ristoranti, nei servizi a domicilio, non pensiamo a tutto ciò che c'è dietro e all'impor-
tanza fondamentale della catena del freddo. Ecco, Marco Martello è uno di quei lavoratori invisibili che quotidianamente fanno in modo che quella catena continui a funzionare, anche in caso di guasti e incidenti.
«Avevo 33 anni. Eravamo in piena crisi economica. Non era certo il momento migliore. Ma questo è un settore particolare. Gli alimentari non subiscono così tanto le crisi. E il mio era un lavoro che facevo a domicilio, per le aziende. Spaziavo nelle varie province del Veneto, tra Padova, Venezia, Treviso, Rovigo, Vicenza. Seguo ancora queste zone. All'inizio la sede era casa mia. Ora ho un'officina a Venezia Marghera».
La fatica di certo non mancava, ma anche la soddisfazione. «Facevo tanta strada tutti i giorni. Arrivavo a casa tardissimo la sera. Mi sentivo una specie di “eroe” che andava in giro a salvare i camionisti e i frigoriferi. Erano tutte chiamate urgenti, per salvare la merce ed evitare di buttare il carico del frigorifero. D'estate era una corsa continua». Poi, si sa, se lavori bene il tuo nome comincia a girare. Frigo Assistance è cresciuta grazie al passaparola. «Ci sono delle province che hanno un'officina meccanica che fa questo lavoro, ma il loro limite è quello di non uscire. La mia forza è stata quella di partire con l'assistenza esterna.
73 GIUGNO 2023 72 GIUGNO 2023
si è comprato un furgone e ha creato un'azienda cresciuta a ritmi vertiginosi
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA
Marco Martello nel 2007 ha avviato la Frigo Assistance. Poi, nel 2013, è nata la Isofam, con officina a Venezia
Poi, dopo qualche anno, ho cominciato a prendere un capannone per fare il magazzino, per far venire qualche mezzo o lasciarlo in deposito, nel caso di lavori un po' più complessi. È stata una cosa secondaria, aggiunta successivamente. Che però è cresciuta anche lei. Ho cominciato a prendere del personale per farmi aiutare. L'azienda si è sviluppata velocemente, perché i fatturati raddoppiavano di anno in anno».
Isofam nasce dieci anni fa da quella crescita impetuosa. «Nasce da un'occasione. Comprai una cabina di verniciatura usata, da una ditta che era fallita. Ma fu una stupidaggine, poi non l'ho neanche montata, c'erano delle questioni legate alla sicurezza. Ho buttato 5 mila euro. E ne ho comprata una nuova da 100 mila euro».
La sigla Isofam sta per Isotermica Frigo Assistance Meccatronica. Il cuore è sempre quello, l'officina mobile in grado di intervenire per riparazioni immediate, sistemazioni di motori frigo e manutenzioni di varie entità. Ma ora c'è anche l'officina di Venezia, il centro
Gli interventi possibili? Si va da problematiche meccaniche dei frigoriferi ai danni da urto al cassone, dal surriscaldamento dell'unità di raffreddamento all'incendio del motore frigo.
In questo caso la manutenzione è quella di una macchina, bisogna cambiare olio, filtri, cinghie. C'è un tagliando da fare»
assistenza autorizzato per varie marche di impianti frigoriferi su veicoli industriali, le coibentazioni isotermiche con rivestimenti a norma Haccp, il montaggio e la manutenzione di gruppi frigo (sul sito www.isofamsrl.it trovate l'elenco completo).


«Oggi è come se fossimo due aziende. Abbiamo un capannone per la riparazione dei frigo e un altro per le carrozzerie. Le celle frigo sono in vetroresina, quindi si tratta di un lavoro diverso dal solito dal punto di vista della carrozzeria, sono in pochi a farlo. Ma noi siamo in grado di verniciare anche cabine di camion, cisterne, telai. Facciamo anche piccole celle nuove, coibentazioni, allacciamenti e allestimenti. Lavoriamo sia sui camion più piccoli, quelli che hanno un frigorifero non autonomo, che funziona con il mezzo acceso, sia quelli sopra i 35 quintali, in cui il frigorifero ha un suo motore diesel.

Isofam fornisce anche la certificazione Atp: «È una revisione che si fa alla cella frigo. Ci sono scadenze a 6 anni, a 9, a 12 e dal quindicesimo ogni 6 anni. Si controlla la tenuta della cella, che sia ancora in buone condizioni, sia per il freddo che per l'igiene. È obbligatoria per la maggior parte dei mezzi».
Il lavoro più importante rimane quello dell'officina mobile, cioè l'intervento immediato in caso di bisogno. Ora i furgoni sono due, molto più recenti. «Questa è l'attività che mi ha portato i clienti e che mi assicura continuità. È una cosa che gli altri non fanno. Riesco a raggiungere la clientela anche un po' fuori, rispetto a dove sono io. Oggi ad esempio ero a Ferrara con due ragazzi, per fare manutenzioni su diversi automezzi».
Nel corso degli anni sono nati anche rapporti con concessionari e con assicurazioni, visto che a volte le aziende fanno contratti per la manutenzione di certe marche di frigoriferi. «Oppure ci sono i noleggiatori che ci tengono come punto di riferimento per i loro clienti». Il noleggio, in effetti, potrebbe essere lo sviluppo del futuro. «A volte il cliente che ha un mezzo incidentato, avrebbero bisogno del furgoncino sostitutivo. L'idea è cominciare a costruire un parco mezzi, a partire dai furgoncini un po' più piccoli».
Questo è un settore che non conosce crisi irrimediabili. «L'alimentare ha tenuto botta anche durante il Covid. Ricordo quei
mesi incredibili. In certi giorni mi trovavo ad andare in giro col furgoncino e per le strade non c'era assolutamente nessuno. Non c'erano auto e la natura si era ripresa il suo spazio, intorno era tutto fiorito.
Venezia era completamente vuota, nessuno l'aveva mai vista così. Se non pensavi a cosa c'era dietro, era davvero bello, affascinante, oltre che comodo».
Il segreto dell'azienda? Oltre alla competenza e la voglia di lavorare, anche la gestione famigliare. «L'azienda è una società unipersonale, una srl. Siamo partiti io e la mia compagna, che mi seguiva nell'am-
ministrazione. Poi lei è entrata nell'azienda, lavora in ufficio». Il che assicura una gestione più flessibile del lavoro. Anche se c'è sempre il rischio di lavorare troppo. «Con gli anni ci siamo strutturati, poi abbiamo preso le misure. Altrimenti il rischio è di dare la vita al lavoro. L'estate è molto impegnativa. I mesi fulcro sono da aprile a ottobre, è un lavoro quasi stagionale. L'inverno poi c'è un calo. La carrozzeria serve a continuare ad avere lavoro anche nei mesi successivi». Una scelta che funziona. Sempre di più. Senza mai dimenticare che il lavoro serve a vivere (meglio), non viceversa.
75 GIUGNO 2023
Assistenza e installazioni, interventi di carrozzeria, coibentazioni, certificazioni Atp. E il lavoro cresce
PASTICCERIA BAITA E TORNA IL BUONUMORE


Una vita dietro il bancone. Poi l'intuizione, nell'anno del Covid: un luogo in cui stare bene
Avete presente quei luoghi che ti fanno star bene, anche nelle giornate storte?
Quelli in cui entri e vieni avvolto da un profumo di croissant, torte e pasticcini che sono un presagio di felicità (culinaria)? Anzi, il piacere comincia già da fuori, quando ti avvicini alla vetrina e ti
ritrovi davanti a una festa di forme e colori. Come scrive Fabrizio Caramagna, abile aforista: chi non si è trovato a «sfogliare i pasticcini nella vetrina come se fossero un catalogo di buonumore»?
La Baita, pasticceria a caffetteria, è uno di quei luoghi in cui è bello rifugiarsi. Dove puoi sederti a bere un caffè o un cappuccino, facendo due chiacchiere con gli amici. Dove puoi perderti tra gli scaffali, in cerca del dolce preferito, o di quello che non hai mai assaggiato prima. Dove puoi ordinare una torta su misura, per festeggiare un evento importante (personalizzabile, con foto, disegni, immagini di ogni tipo).

È soprattutto un luogo conosciuto per i migliori croissant in circolazione. Con crema, marmel-
lata, cioccolato bianco, pistacchi, zabaione, tutto quello che volete, ma rigorosamente freschi. «Io non ho nulla contro chi vende croissant surgelati. Basta che la gente sappia cosa sta mangiando. I nostri vengono fatti lievitare e cotti durante la notte. Ce li consegnano tutte le mattine». Parola di Simone Arcelli, il titolare di questo locale, che ha aperto i battenti a Brandizzo, nel Torinese, dalle parti di Chivasso, nell'ottobre del 2020.
L'inaugurazione è arrivata proprio nell'anno diventato tristemente famoso per il Covid. Ci voleva un bel coraggio. Lui l'ha avuto. «Era tutto pronto già a marzo, poi è successo quello che sappiamo. È stato un tira e molla continuo. Alla fine ci siamo riusciti, abbiamo aperto a ottobre, osservando le norme anti-Covid. Abbiamo passato due mesi a servire il caffè all'esterno, una persona alla volta. Ma non abbiamo mai chiuso, visto che ho la licenza per vendere beni di prima necessità (latte, biscotti, grissini)». La Baita di Simone è anche una storia di riscatto e di rinascita. Lui, in realtà, aveva passato la vita (trent'anni) a vendere carni, salumi e formaggi.
«I miei genitori possedevano un mini-market, in cui vendevamo di tutto. Le vicissitudini della vita mi hanno portato a lavorare in un supermercato. Sono stato assunto come vice-caporeparto. Poi sono diventato caporeparto e capoarea» Una carriera veloce, a dimostrazione del fatto che ci sapeva fare. Ma anche un mestiere che non dava le giuste soddisfazioni. Quando si lavora “sotto padrone” è facile che lui si prenda i meriti dei tuoi risultati, mentre a te toccano i problemi e le cose che non vanno. «Promettevano mari e monti e dopo non ti davano neppure una collina. Dopo tre anni mi sono stancato. Ma a 52 anni non potevo certo stare con le mani in mano. E così mi sono buttato». Un bel rischio, ma calcolato, visto che Simone ha passato la vita dietro un bancone e sa come si fa. «Ho aperto una pasticceria perché mancava nel mio paese. Ma non essendo un pasticciere, mi sono affidato al laboratorio di un marchio molto conosciuto nel territorio. Il mio non è un franchising. Ma vendo solo i loro prodotti, che sono buonissimi».
Il marchio La Baita ha una lunga storia alle spalle. Come scrivono loro: «Il nostro laboratorio è il luogo in cui sono gelosamente custodite le ricette che da 60 anni la famiglia Pogliano utilizza per realizzare i propri prodotti. Un posto "magico" dove ogni giorno vengono create torte e dolci come quelli di una volta ma con un pizzico di innovazione e di modernità. I nostri prodotti artigianali sono creati utilizzando solo ingredienti freschi e di prima qualità per garantire il massimo della genuinità». D'altra parte non
si sta sulla cresta per tutti quegli anni se non si producono cose buone e genuine. Volendo, anche bio e senza glutine.
È questo uno dei segreti della caffetteria e pasticceria di Simone Arcelli, che vende solo prodotti artigianali, croissant ma anche salatini, ciambelle e focacce a tranci, biscotti e grissini. E che a Brandizzo sta creando una piccola comunità di golosi e di fedeli frequentatori. Anche perché l'accoglienza è calorosa e sempre gentile. «Mi piace stare dietro un bancone. Dialogare con le persone. Per fare questo lavoro

devi avere sempre il sorriso sulle labbra, anche quando sei arrabbiato. Devi aver voglia di ascoltare la persona sola che ha bisogno di parlare con qualcuno. Ho anche il mio gruppo di anziani fedeli, che ormai sono qui quasi tutti i giorni, a fare colazione». Luoghi del genere, in un paesone di 10 mila abitanti, hanno anche una funzione sociale. Non fanno solo commercio, ma comunità.
L'ambizione però è quella di arrivare molto più in là. Già ci sono i clienti che vengono da fuori, dopo aver scoperto i suoi croissant. Poi ci sono quelli che ordinano torte di ogni tipo, dalla sacher alla foresta nera, dai semifreddi alle meringate. C'è pure la consegna a domicilio. E ormai c'è una clientela affezionata che sta crescendo a un ritmo insperato, nonostante il Covid, la guerra, i costi dell'energia... Il segreto, come sempre, è il passaparola: «C'è chi assaggia una fetta di torta a un compleanno, chiede chi l'ha fatta e poi diventa nostro cliente». Non c'è crisi che tenga, di fronte al piacere garantito da un pasticcino di qualità. Piccoli “vizi” che rendono la vita più dolce. Meglio ancora insieme agli amici, in una Baita di pianura, insieme a un buon caffè. Il buonumore è garantito.

77 GIUGNO 2023
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA
Caffetteria, torte, croissant, biscotti artigianali. Addio al supermercato, per aprire un locale a misura d'uomo (goloso)
Carmelo Bene l'alieno e lo sfuggente Pessoa, Darwin mitologico ed Einstein fiabesco, un Orson Welles diabolico e un patafisico Woody Allen. Che meraviglia i ritratti di Tullio Pericoli! C'è l'intelligenza di Canetti e l'anima vibrante di Calvino, insieme a un Ezra Pound selvaggio, che è inquietante e affascinante insieme. C'è un Buzzati che parla, lo puoi letteralmente ascoltare, perché il disegno è vivo, comunicativo.
Sfogli le opere di Tullio Pericoli e ti ritrovi a passeggiare tra scrittori, musicisti, registi, scienziati. Con alcuni è possibile anche dialogare, tanto sono veri (la verosimiglianza c'entra fino a un certo punto). Altri li guardi da lontano, perché incutono timore, sembrano icone più che persone. Non ci sono solo i volti, ma le loro storie, «la loro psicologia» (come scriveva Kundera). Per dirla con Umberto Eco: «Come tutti i grandi ritrattisti, Pericoli punta all'anima, sia quando c'è, sia quando non c'è, e spesso, col ritrarre un volto, di fatto ritrae un pensiero, una visione del mondo, uno stile poetico o narrativo».
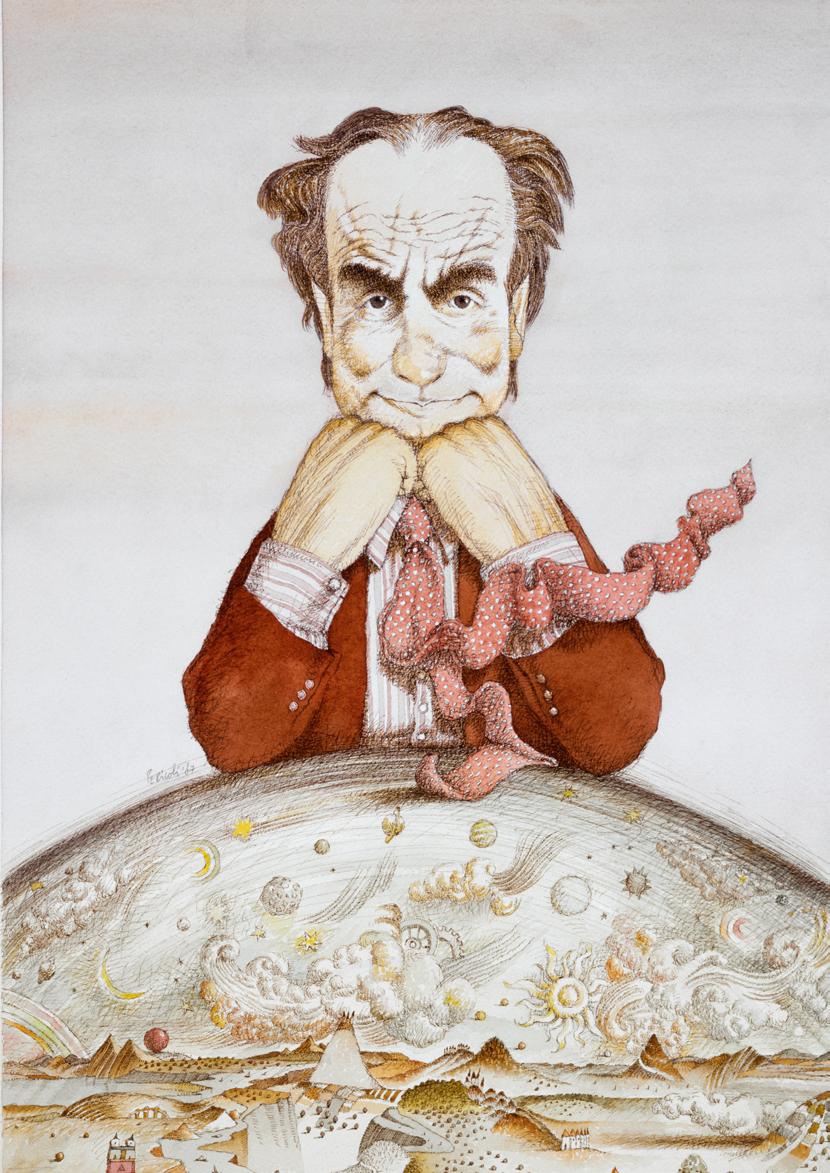
Adelphi aveva già dedicato varie edizioni alle opere di Tullio Pericoli, ma questo Ritratti di ritratti è un pozzo senza fine, in cui non vediamo solo l'opera terminata, ma anche il processo che l'ha generata, gli schizzi, gli abbozzi, le idee accantonate, le intuizioni rimaste come in sospeso (che a volte sono le migliori, rivelano lati nascosti dei personaggi ritratti).
Si va da Theodor Adorno (a labbra serrate) e Cesare Zavattini, da scrittori amici ad artisti solo immaginati. Ci sono Baudelaire, Dostoevskij, Goethe, Proust, Tolstoj, il viso di pietra di Samuel Beckett, nelle sue innumerevoli versioni (parti di sé? immagini che noi ci facciamo di lui?).
Ci sono Virginia Woolf, Hitchcock e Buñuel, Roberto Calasso (quella cosa “che lui solo sa”), e una moltitudine di ritratti dedicati a Umberto Eco che valgono una biografia (buffo, colto, burlone, geniale giocoliere).
Tanti, e notevoli, anche i disegni dedicati a Stevenson. Alcuni personaggi ti sembra di incontrarli e forse capirli per la prima volta: Gadda, ad esempio, ma anche Joyce o Stravinskij. Bellissimi i ritratti di Kundera e Doris Lessing, la serie dedicata ad Eugenio Montale, Schnitzler, Pasolini, Picasso catturato in poche linee.
La somiglianza è importante, certo, ma è la prima cosa da dimenticare. Perdersi nei dettagli significherebbe perdere ciò che caratterizza davvero un volto, e quindi una persona, quella cosa che ci fa dire “ecco, è proprio lei”. A prescindere dalla possibilità di dare un nome a quella particolarità, che a volte è la sua essenza. Altrimenti a cosa servirebbe l'arte?
Nel silenzio del mio studio talvolta sento un fruscio lieve, un brusio, quasi un raspare che ora mi sorprende, ora mi fa compagnia. So che viene dai miei cassetti, dove conservo i tanti ritratti che ho disegnato negli anni. L’uno sopra l’altro, sia quelli finiti che quelli fatti in corso d’opera. Mi fermo e ascolto: i rumori smettono, poi sommessamente riprendono. I miei disegni, mi dico, riposano; dormono, sognano e si agitano. Un giorno mi sono deciso e sono andato a vedere che cosa succedeva.
Dal fondo del cassetto i disegni sorpresi mi guardavano, ma non erano più gli stessi. La convivenza per tanti anni con gli schizzi, gli studi, le prove e gli errori, gli azzardi e gli sforzi che avevano preceduto la loro forma compiuta, li aveva contagiati –trasformati. Una buffa storia, ho pensato. Ho preso il contenuto di quei cassetti così com’era e l’ho versato in questo libro.
(Tullio
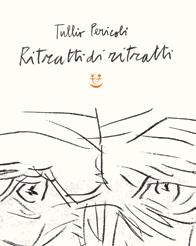 Pericoli)
( Italo Calvino ©Tullio Pericoli. Tutti i diritti riservati)
Pericoli)
( Italo Calvino ©Tullio Pericoli. Tutti i diritti riservati)

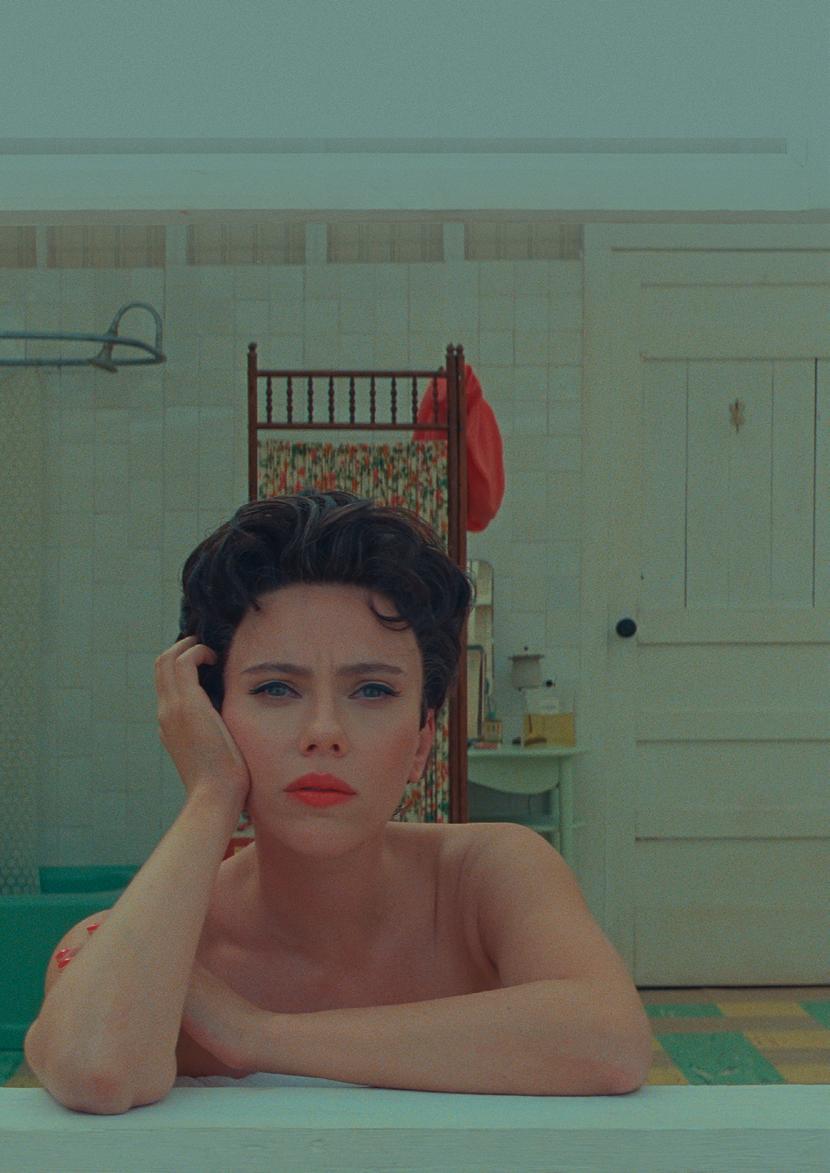




















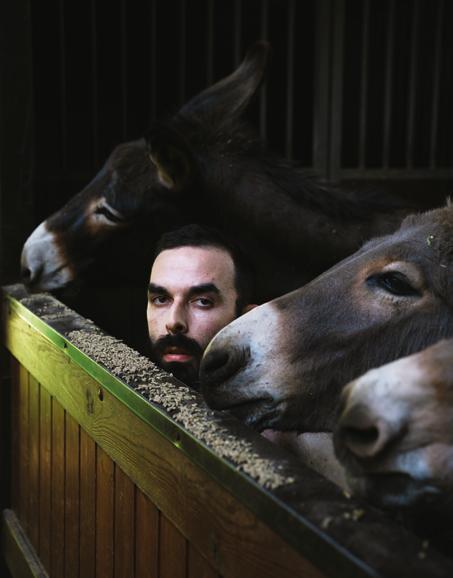








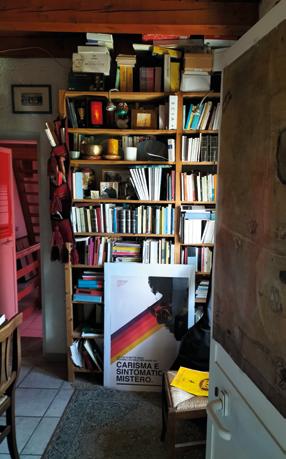




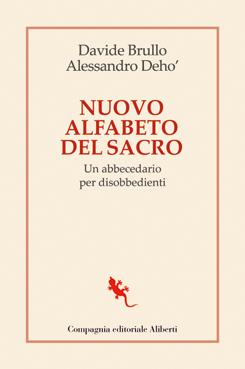

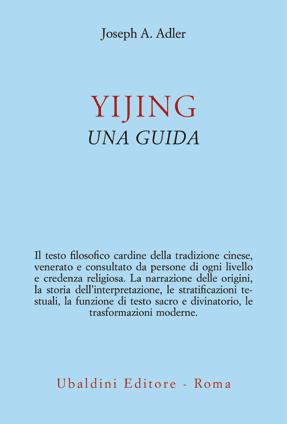



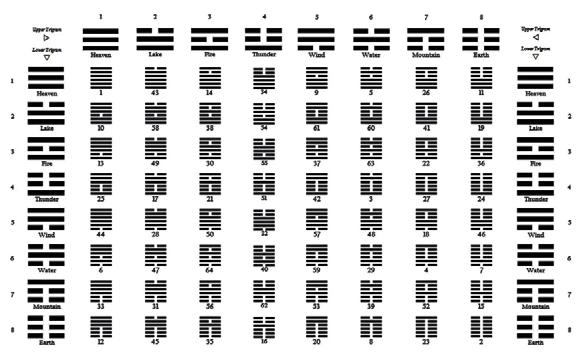
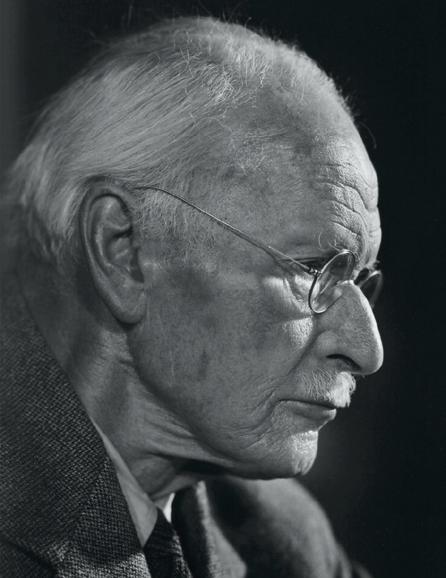









 Michael Douglas scherza con i fotografi. In basso, Harrison Ford ringrazia il pubblico
Michael Douglas scherza con i fotografi. In basso, Harrison Ford ringrazia il pubblico
































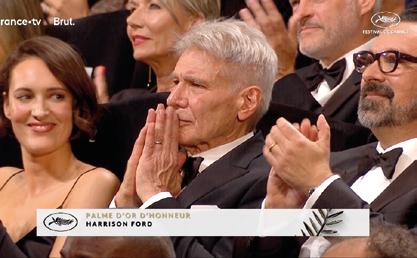
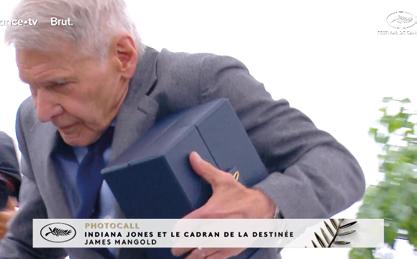

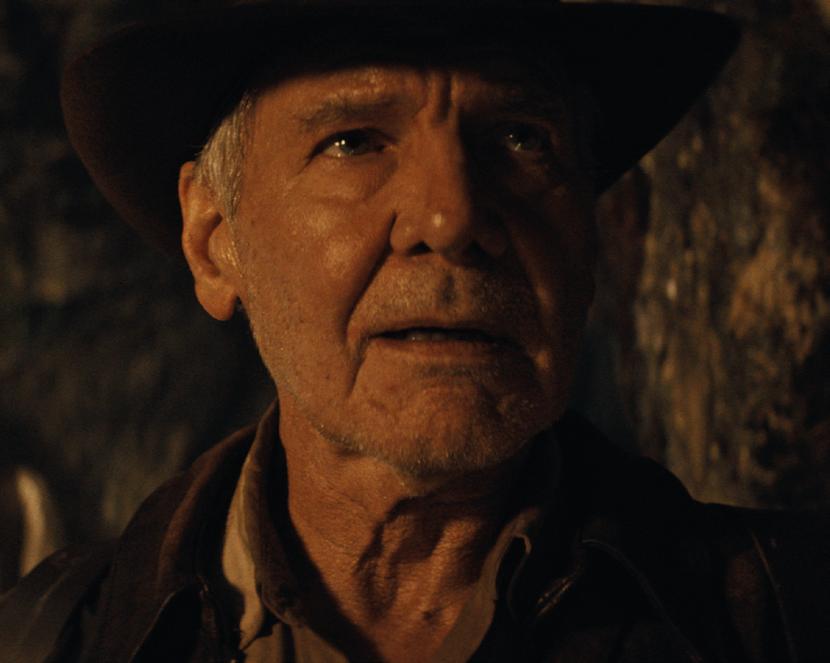















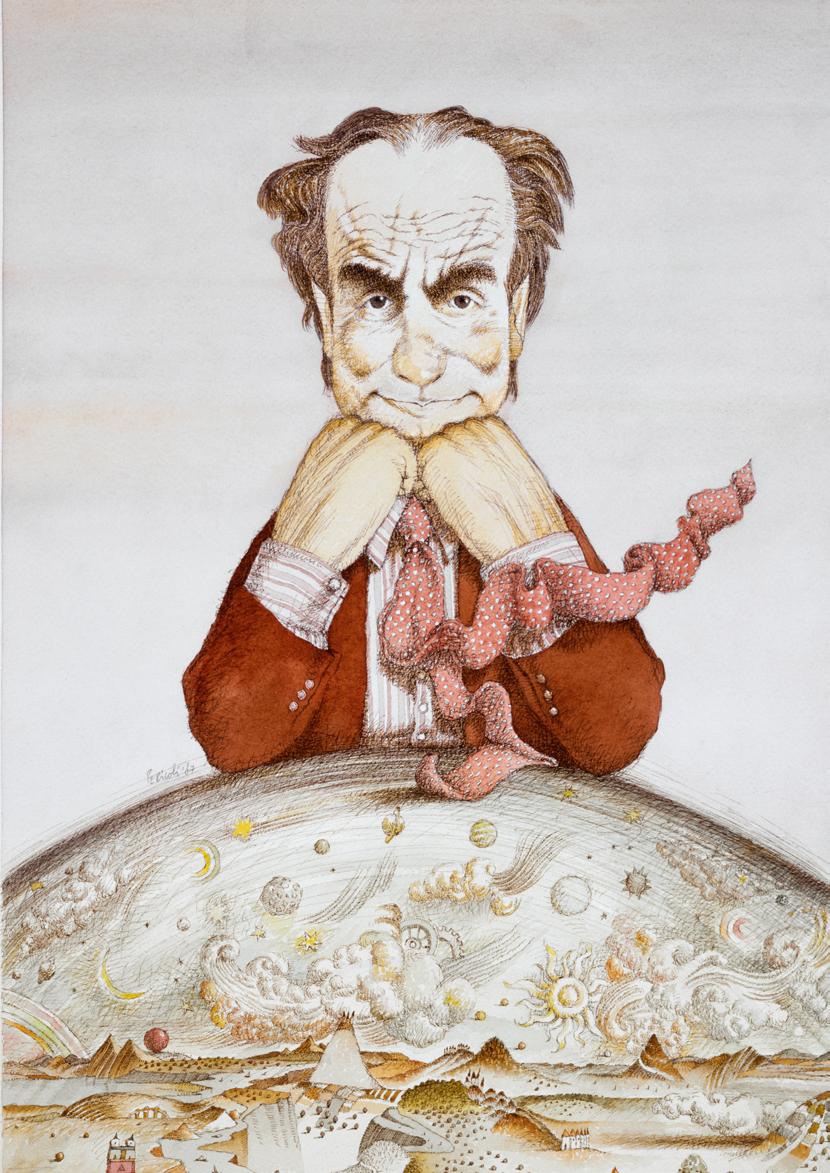
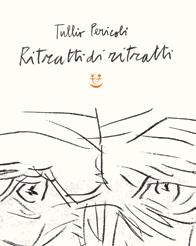 Pericoli)
( Italo Calvino ©Tullio Pericoli. Tutti i diritti riservati)
Pericoli)
( Italo Calvino ©Tullio Pericoli. Tutti i diritti riservati)
