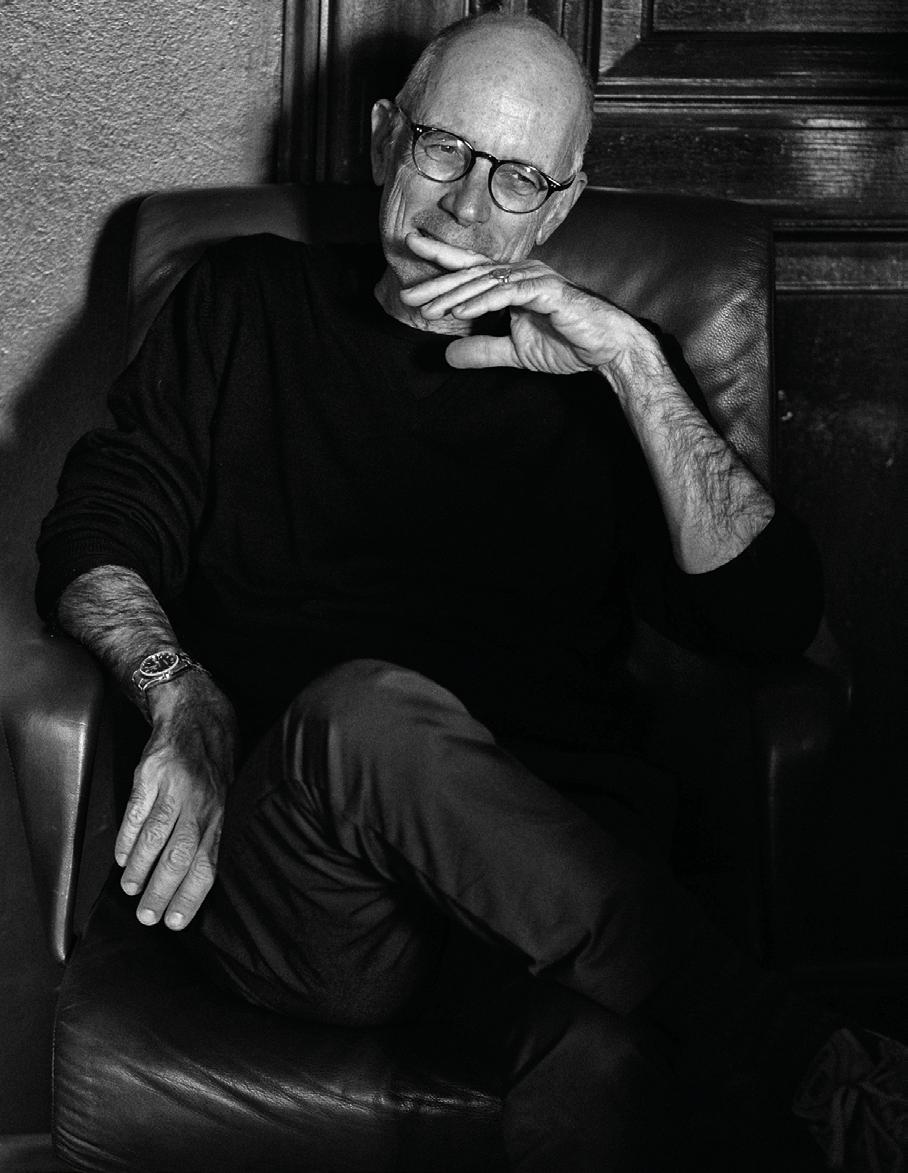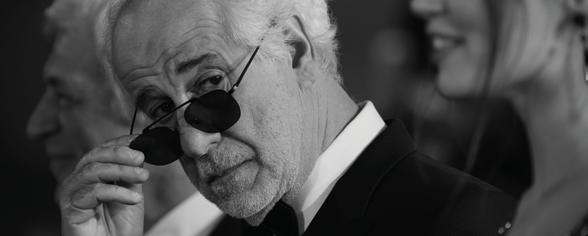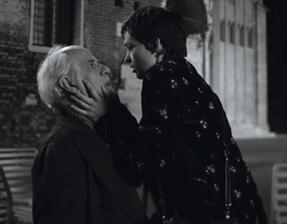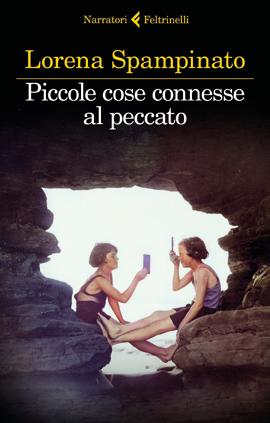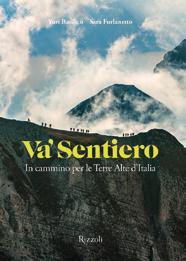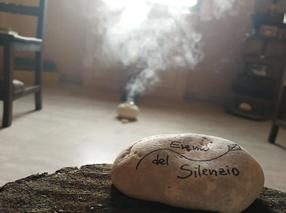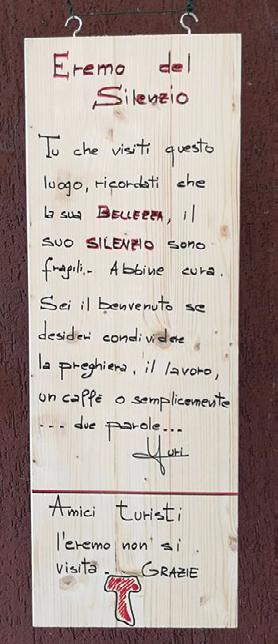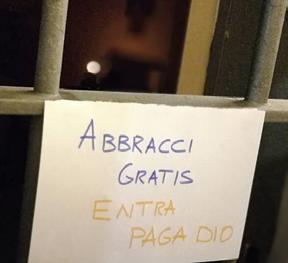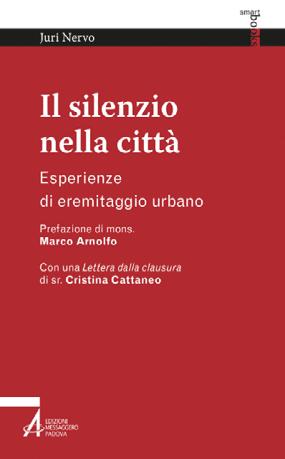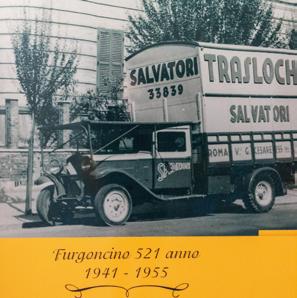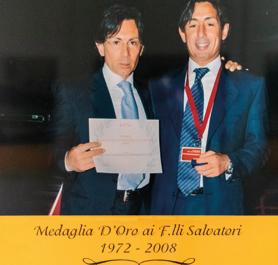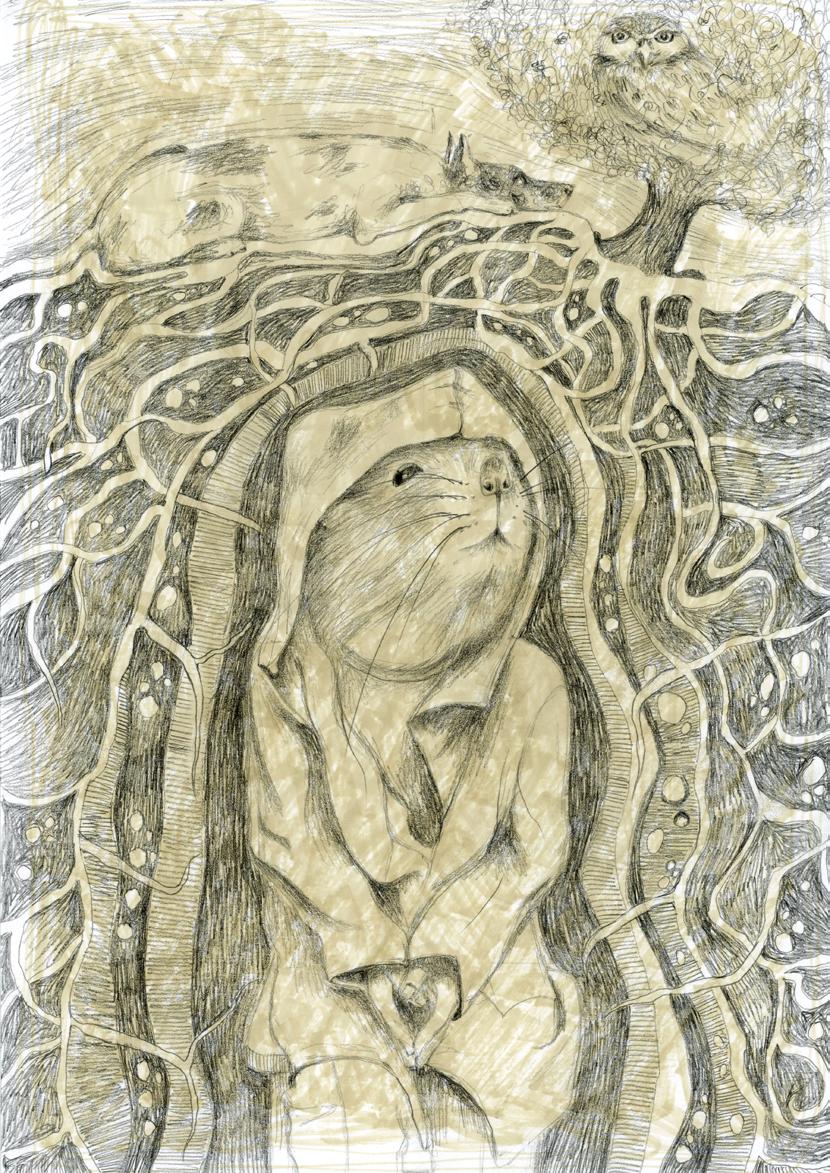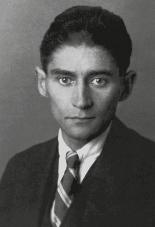Dove si parla di Casanova e di cinema, di corpo e seduzione, di femminismo e donne-soggetto che desiderano, della vita delle ragazze, di estasi e Teatro, di Italia da scoprire a piedi e voli su Marte, di eremitaggi metropolitani N 8 | APRILE 2023

Yuri Basilicò
Martina Catalfamo
Martina Galletta
Juri Nervo
Gabriele Salvatores
Lorena Spampinato
REDness
è passione, arte, impresa, comunicazione.
È il "rossore"
provocato dalle emozioni forti.
Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.
La redness
è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina.
È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria.
REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi.
Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità...
Va bene tutto, purché sia fatto con redness.
In
copertina: Un'immagine tratta
dal film "Il ritorno di Casanova"
(servizio a pag 6)
4
EDITORIALE
4 Tra le sue braccia
6
INCONTRI
6 Gabriele Salvatores: “Il ritorno di Casanova”, tra cinema e vita
18 Martina Catalfamo: un’attrice e cantautrice in volo su Marte
26 Lorena Spampinato: un romanzo che svela “la vita delle ragazze”
32 Martina Galletta: la provocazione della libertà, a Teatro e nella vita
44
LUOGHI
44 Va’ Sentiero: 7887 chilometri in cammino per scoprire l’Italia
50 Yuri Basilicò: “In questi luoghi si è conservato qualcosa di autentico”
56 In mostra alla Triennale: la bellezza, ma anche l’abbandono
58
MEDITAZIONI
58 Juri Nervo: il silenzio al centro della città. L’eremo interiore
68
STORIE D’IMPRESA
68 Salvatori Traslochi: che storia! Dal 1941 con stile e simpatia
74
COMMIATO
74 Roberto Calasso: “L’animale della foresta”
Direttore: Fabrizio Tassi
Progetto grafico: Marta Carraro
Redazione: MondoRed
Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore
3 APRILE 2023 2 MESE 2022
S OMMARIO
Tra le sue braccia
«Teneva tra le braccia la donna alla quale poteva dare tutto se stesso e sentirsi inesauribile: sul suo seno l’istante dell’ultimo abbandono e del nuovo desiderio coincidevano in un’unica, inimmaginata estasi spirituale. Su quelle labbra non erano la stessa cosa vita e morte, tempo ed eternità?»

Partiamo da qui, dal Casanova di Schnitzler. Il vecchio conquistatore che trova il senso di tutto il suo cercare, amare, desiderare, in una giovane bellezza inarrivabile. Però lo trova con l’inganno, in un attimo che si dilata in un sogno, un’immaginazione di felicità, per qualche pagina di romanzo, salvo poi rivelarsi un’illusione (d’infinito).
Gabriele Salvatores lo racconta a modo suo, in un gioco di specchi (doppi!) tra un regista e il suo personaggio (in cui è personaggio anche il regista), sospeso tra l’arte e la vita, tra quel sogno di
eternità che è il cinema e l’imperfezione, il dubbio, il limite proprio all’essere umano, dentro quella trama che stiamo scrivendo giorno dopo giorno (in cui sono previste anche la vecchiaia e l’accettazione dei limiti).
Ma non c’è bisogno di scomodare il Settecento, Schnitzler e l’amico Freud, il punto di vista del solito seduttore impenitente che cerca l’eternità tra le braccia di una donna (da possedere). Basta l’intuizione di una ragazza che sta scoprendo se stessa e l’altro, come la racconta Lorena Spampinato nel suo nuovo romanzo. Un istante (ancora), forse meno spettacolare ma ugualmente totale, vissuto intorno a un falò sulla spiaggia: «Qualunque istante, dopo quello, sarebbe stato inutile, ridicolo. Questo pensavamo, capendo per sbaglio il senso di quella nostra età: scoprire, una sola volta nella vita, il gusto delle cose eterne».
La prima parte di Redness, ad aprile, parla di questo. Di corpi e desideri. Il miraggio della bellezza che completa, realizza. La passione travolgente che ci porta oltre i nostri limiti, col rischio anche di perdersi. L’arte come strumento di ricerca, esplorazione di territori ignoti, fuori e dentro di noi.
Martina Galletta reclama la sua libertà, anzi, la pratica senza bisogno di troppe parole, consapevolmente, sul palcoscenico come nella vita. Shakespeare e Dostoevskij, la musica classica e la drammaturgia contemporanea, il romanzo e i social. Con il proprio talento (anzi, i talenti) e con il proprio corpo, la provocazione lucida, la donna-soggetto che non si fa dettare le regole dai moralisti, ma neanche dai consumatori di immagini ed emozioni facili.
Un altro concentrato di talenti e di libertà è Martina Catalfamo, che recita, scrive, canta, che vive una dimensione sensuale e spirituale insieme, tra la Sicilia in cui è nata e il pianeta Marte, verso cui è diretta. Perdersi nell’aria, in volo, trasportata dal vento, sciogliersi nell’acqua del mare, diventare terra, albero. Un corpo che desidera e un’anima che non si può accontentare di questo o di quello, perché vuole tutto (il Tutto).
E così arriviamo alla seconda parte della rivista, quella dedicata
al silenzio e al vuoto. Alla dilatazione dello spazio e del tempo, camminando sulla cresta di una montagna o dentro di sé. Da una parte raccontiamo il cammino dei cammini, il Sentiero Italia, che attraversa le Alpi e gli Appennini, unisce popoli e culture, tradizioni e dialetti. Il viaggio inteso non come esperienza da consumare, ma come ricerca e autentica libertà, secondo la filosofia di Va’ Sentiero. Dall’altra “l’eremo del silenzio”, l’esperienza dello spirito, la solitudine ma anche la vera comunità, al centro della città (Torino, in questo caso, ma potrebbe essere ovunque).
La contemplazione dentro l’azione, perseguendo l’obiettivo più grande, la liberazione dalla schiavitù dell’ego.
Partiamo da Schnitzler e arriviamo a Kafka (grazie a Calasso), che racconta il nostro tempo, il popolo dei topi, reso inquieto dalla “potenza del canto”. «Siamo troppo vecchi per la musica, la sua eccitazione, il suo slancio non si addicono alla nostra pesantezza, stancamente la respingiamo; ci siamo ritirati nel fischiare; un po’ di fischi qua e là, questa è la cosa giusta per noi»
Ma nei “cercatori” resta il desiderio di tornare a casa, di amare ed essere amati senza compromessi, di “abbracciare qualcosa di illimitato”. Lì siamo noi. (f.t.)
5 APRILE 2023 4 APRILE 2023
E DITORIALE
Gabriele Salvatores
Arriva in sala “Il ritorno di Casanova”, riflessione sul tempo che passa, sulla seduzione, sul rapporto tra arte e realtà
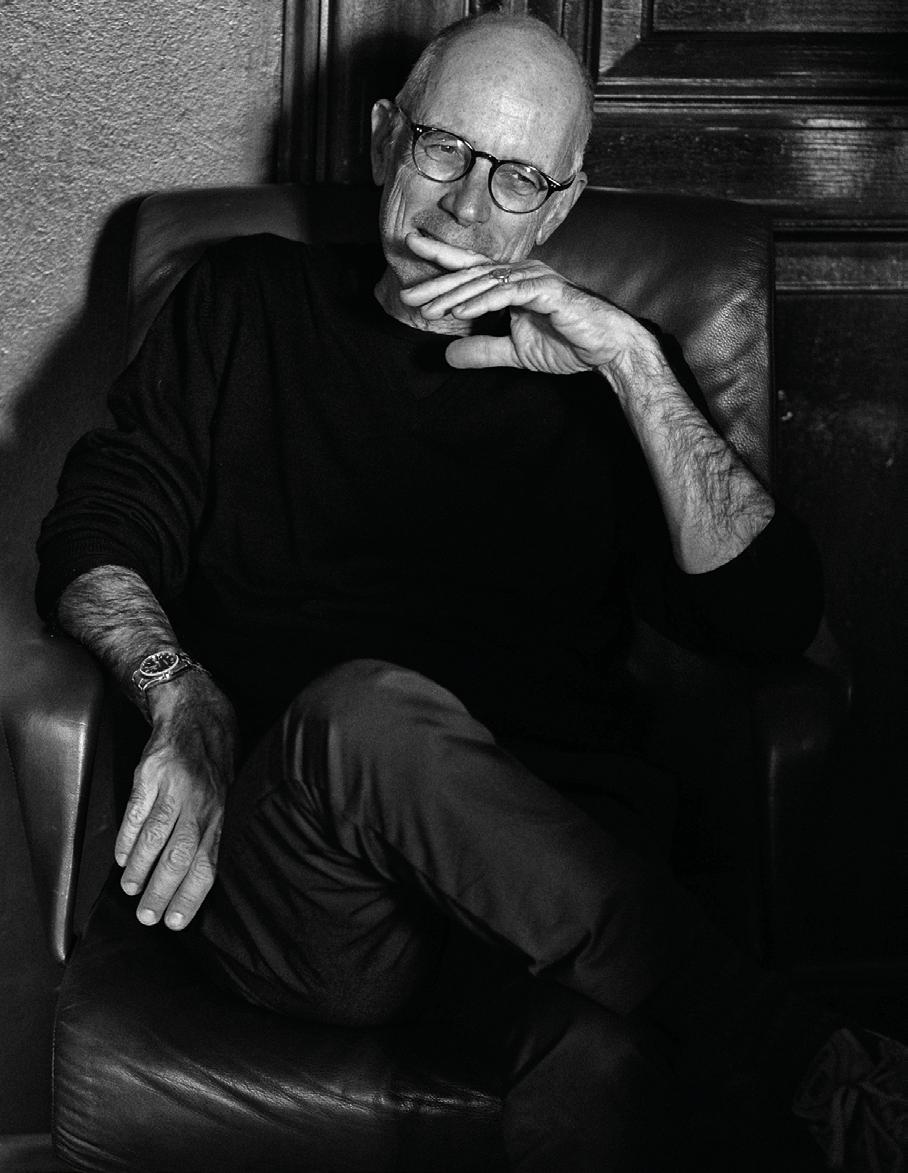
«Il cinema era tutto. Ora mi accorgo che la vita probabilmente è più importante»
I NCONTRI (foto Claudio Iannone)
Sono passati poco più di cinquant’anni da quando Gabriele Salvatores ha fondato il Teatro dell’Elfo a Milano, insieme a Ferdinando Bruni (era il 1972). Quarant’anni esatti dal suo esordio sul grande schermo, con un Sogno di una notte di mezza estate in versione musical rock.
Trent’anni fa ha letteralmente inventato un modo di fare cinema, con la “trilogia della fuga” (1989-1991), che ha fruttato anche un Oscar, oltre a storie e personaggi entrati nel nostro immaginario (a Marrakech Express, Turné e Mediterraneo andrebbe aggiunto anche Puerto Escondido): quell’idea di viaggio, di lontananza che è insieme buffa, naïf e malinconica, quel perdersi per ritrovarsi.
Se c’è una cosa che caratterizza da sempre Salvatores, è questa sua capacità di rendere semplici anche le cose più complicate, di fare cinema non per sé (o per la critica) ma per il pubblico, di affrontare l’arte e l’industria con il sorriso gentile di chi conosce i trucchi del mestiere e li utilizza in modo trasparente, in un dialogo alla pari, che rimane intelligente e personale anche quando ammicca e gioca apertamente.
Non sembri oziosa questa memoria del suo cinema. Il ritorno di Casanova, il suo nuovo film, è costruito proprio intorno al concetto di “passato”. L’idea del tempo trascorso, della vita irrimediabilmente persa, della giovinezza (anche la gloria, la gioia di vivere e di fare cinema) che non tornerà più. E quindi la necessità di imparare a vivere il presente, con la consapevolezza di ciò che è stato, ma anche la coscienza di ciò che potrebbe essere. Una grazia nuova, diversa.

Per giunta è un film che parla di un film, che racconta un regista famoso, alle prese con una crisi esistenziale. No, non c’è autobiografia, ma quando un regista racconta un regista c’è inevitabilmente una riflessione sul proprio lavoro, le paure, le idiosincrasie, così come le ragioni che spingono a fare cinema (o a non farlo).

Sono trascorsi più di vent’anni dai fuochi d’artificio del “periodo sperimentale”, quello in cui Salvatores ha osato, anticipato, re-inventato, soprattutto con Nirvana (era il 1997, provate a riguardarlo col senno di poi, con l’occhio di chi ha visto il cinema del nuovo millennio), ma anche con Denti (2000) e Amnèsia (2001).
Subito dopo, esattamente vent’anni fa (nel 2003), è arrivato un film che sembrava fatto per mandare in tilt le nostre categorie: cinema di genere o d’autore, dramma, fantasy, horror, anche un po’ fantascienza (“post-spielberghiano”, come ha scritto qualcuno). Io non ho paura fu il suo approdo al “cinema puro”, lirico e realista insieme, una fiaba che rivela un mondo spietato.
Poi è stato tutto un susseguirsi di progetti che davano l’impressione di essere nati da innamoramenti più che da programmi – senza la presunzione di seguire chissà quale logica espressiva o autoriale – da Quo vadis baby (2005) a Educazione siberiana (2013), da Il ragazzo invisibile (2014-2018) a Comedians (2021).
Non per niente nel suo Casanova Salvatores ha coinvolto Ferdinando Bruni, voce narrante del film nel film settecentesco, oltre a Elio De Capitani, altra colonna portante dell’Elfo (che recitò nel Sogno di Salvatores e qui è un memorabile marchese cinico e senza vergogna). E non manca neppure Fabrizio Bentivoglio, che lo accompagna fin dai tempi di Marrakech, per un totale di sette film insieme.
Arthur Schnitzler iniziò a scrivere Il ritorno di Casanova nel 1915 (venne poi pubblicato nel 1918), quando aveva 53 anni, la stessa età del suo eroe in crisi. In un momento di passaggio per la storia continentale, la fine di un’epoca, forse anche di un’illusione, e l’inizio del “secolo breve”, con i suoi orrori. Un magnifico racconto, dolce e crudele, una riflessione sulla vecchiaia, ma anche sul desiderio che non invecchia mai e si mette “in maschera”, sul rapporto (lo scontro, l’incontro) tra amore e morte, sulla necessità di confrontarsi con il proprio Doppio (Freud pensava a Schnitzler come a un suo “doppio”), sulla vita in forma di inganno.
Leo Bernardi (Toni Servillo, perfettamente a suo agio), regista riconosciuto da tutti come “maestro”, all’età di 63 anni decide di trasformare in cinema il testo di Schnitzler. Nella parte di Casanova c’è il suo attore feticcio (Fabrizio Bentivoglio, maschera quasi grottesca). Ma del film, per lo più, si occupa il montatore (Natalino Balasso!). Leo è troppo occupato a fuggire dalla vita, nella sua casa domotica, che sembra essere più sensibile di lui. Casanova è il suo specchio, in cui però non ha il coraggio di specchiarsi fino in fondo.
C’è il bianco e nero della realtà che fa da contrappunto ai colori del cinema. Ci sono i continui rimandi tra vita e finzione, dentro un montaggio che è quasi matematico e geometrico nell’ostinazione poetica con cui unisce i due livelli narrativi. C’è la vita che si dipana dentro una sala di montaggio, per provare a sistemare i pezzi, uno accanto all’altro, sperando che abbiano un senso.
«Se ti senti sbandato, facciamo un film sbandato» si dice, ad un certo punto, dentro il film, mentre il film di fuori sbanda alla ricerca di una direzione, aggrappandosi al racconto di Schnitzler.
Casanova si ritrova spiazzato dalla bella Marcolina (Bianca Panconi) – la ragazza troppo giovane di cui si invaghisce a Mantova, mentre aspetta di poter ritornare nella sua Venezia. Lui che sta scrivendo un libello contro Voltaire, “sofista esemplare”, si ritrova davanti
una donna appassionata di scienze, libera di pensiero e di costumi, che reputa Voltaire “il più grande spirito del secolo” e pensa argutamente che la sua sapienza e la sua onestà, nonostante la mancanza di fede, siano «più graditi a Dio dell’umiltà dei devoti».
8 APRILE 2023
9 APRILE 2023
Ci ho messo dentro delle cose mie, personali. Toni Servillio mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto piacere. “Devo esserti grato perché finalmente ho potuto fare una persona e non un personaggio”
Gabriele Salvatores
E che dire del regista Leo, alle prese con Silvia (Sara Serraiocco), la contadina, che sa molto bene ciò che vuole e non ha nessuna intenzione di lasciare a lui la regia della propria vita.
Tutti e due sono alle prese con il proprio doppio (maschio, giovane): uno si trova sfidato in camera da letto e l’altro sul tappeto rosso del festival di Venezia. È bello ritrovare, in un film di Salvatores, l’ennesima rappresentazione del gusto tutto maschile per la competizione, dalla partita Italia-Marocco di Marrakech alla battaglia fra galli di Puerto Escondido, dalla sfida tra uomo e intelligenza artificiale di Nirvana al duello de Il ritorno di Casanova, alla vecchia maniera, settecentesca, con un particolare piccante che lasceremo scoprire allo spettatore (da Schnitzler a Salvatores, passando per tante memorie cinematografiche e letterarie).
Alla fine tocca accettare la nostra fragile, imperfetta, incasinata umanità. Con i suoi momenti di estasi. Come scriveva Schnitzler, quando Casanova trova il modo di arrivare a Marcolina, a quell’esaltazione che è fisica ma è quasi spirituale: «Su quelle labbra non erano la stessa cosa vita e morte, tempo ed eternità? Non era egli un dio? Gioventù e vecchiaia solo una favola inventata dagli uomini? Patria ed esilio, splendore e miseria, fama e oblio: distinzioni privi di essenza ad uso dei senza fama, dei soli, dei vani, diventate assurde se si era Casanova e si era trovata Marcolina?».
In realtà c’è anche un’altra felicità possibile, meno spettacolare, forse, ma non meno profonda, che si trova oltre lo specchio, al di là del doppio, quando si ha il coraggio di abbandonarsi alla vita. Ecco, Il ritorno di Casanova parla (anche) di questo.
Come è nato il film? Qual è la sua genesi?
È tanti anni che sto dietro a questo racconto lungo, o romanzo breve, di Arthur Schintzler. Volevo farlo a teatro ancora prima che al cinema. È molto denso ed è stato scritto in un momento in cui l’Impero austroungarico stava perdendo la sua egemonia. Un cambio di stagione. È una riflessione sul passaggio del tempo e su molto altro. Schnitzler era amico di Freud, che era convinto di morire a 50 anni. C’è una riflessione sulla vecchiaia, sul passaggio delle stagioni, sia sociali che personali, umane. Soprattutto c’è il tema importante del doppio, che mi ha sempre molto interessato.
Il doppio è la giovinezza che non c’è più.
Casanova vuole tornare a Venezia, capisce che non ha più la stessa forza, lo stesso fascino di una volta. E incontra questa ragazza molto giovane e bella, Marcolina. Naturalmente lei non se lo fila minimamente. Il doppio è un giovane tenente di cui questa ragazza è innamorata. Lui si rispecchia nel rivale. Mi interessava molto questa cosa: un vecchio seduttore che non è più al massimo della sua forma, a confronto con un uomo che gli ricorda la giovinezza perduta.
Nel presente, invece, c’è un regista in là con gli anni geloso di un giovane che sta avendo un grande successo, al secondo film.
Esatto. Anche il regista è in qualche modo un seduttore. È abituato a sedurre il pubblico.
Ma ci sono dei giovani che vogliono prendere il suo posto. Quindi mi sono inventato questo regista che deve fare un film su Casanova e che trova continue corrispondenze tra la propria vita e quella del suo personaggio. Tutto si svolge su due piani: uno è il Settecento, il film che il regista sta realizzando, l’altro è il presente, la realtà del regista.
La realtà è in bianco e nero e il cinema a colori. È qualcosa che, metaforicamente parlando, vive davvero chi fa questo mestiere?
Ci sono tanti motivi per questa scelta. Il più banale è che così il pubblico, dopo pochissimo, passa senza problemi da una situazione all’altra, immediatamente, grazie al cambio visivo molto forte.
Il secondo motivo è legato alla visione del regista interpretato da Servillo: la vita è in bianco e nero e il cinema è a colori. Lui ha rifiutato in qualche modo la vita per il cinema. Ha investito tutto nella finzione.
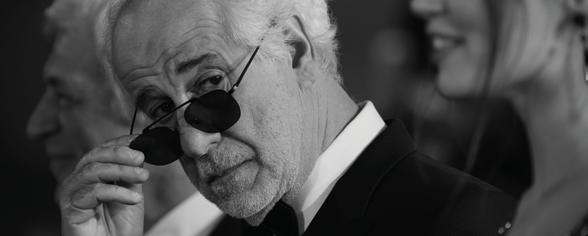
Il terzo motivo, il più importante, è che il bianco e nero
è più affascinante per noi che siamo abituati a vedere tutto a colori. Avendo una visione molto forte del Settecento, colorato, illuminato, con le candele, gli arredi e tutto il resto, avevo paura che la realtà risultasse banale.
Il bianco e nero in qualche modo la nobilita, la rende più magica, più epica.
I riferimenti cinematografici, parlando di Settecento, sono altissimi, anche se sembrano più omaggi devoti che allusioni o citazioni, da BarryLyndon in giù.

È ovvio che molti penseranno a quello, visto che il film nel film è ambientato nel Settecento. Tutti, ad esempio, conoscono la storia delle candele, di Kubrick che fu costretto a farsi costruire degli obiettivi apposta. Oggi, con le macchine da presa a disposizione, è possibile girare anche con poca luce, rievocando quell’atmosfera. Barry Lyndon è uno dei film che amo di più. Probabilmente e anche inconsciamente certe cose passano. Ma non ci sono riferimenti diretti, a parte l’epoca e la sua ricostruzione.
Guardando un film in cui il protagonista è un regista, lo spettatore inevitabilmente si chiede: quanto somiglia al regista “vero”?
In effetti è la prima volta che faccio una cosa del genere. Ecco perché ci tengo a questo film. Non è autobiografico, perché ovviamente non è la mia storia, ma è la prima volta che metto in un film parecchie cose mie, ossessioni, riflessioni, paure. Servillo è più giovane di me, ma non così più giovane, e si è molto identificato. Mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto piacere: “Devo esserti grato perché finalmente ho potuto fare una persona e non un personaggio”. Ci ha messo dentro delle cose mie, personali.
Gabriele Salvatores
11 APRILE 2023 10 APRILE 2023
Come diceva Fellini, a volte la realtà è scadente e allora ci si rifugia al cinema. Nel mio film da una parte c’è una messinscena ricercata, diciamo così, e dall’altra il dubbio, l’incertezza, il “Que sera sera” cantato da Doris Day.
Casanova è un personaggio, per certi aspetti, “fuori moda”, rispetto ai tempi in cui viviamo. È l’uomo libertino, il conquistatore seriale. Ma nel tuo film emerge quanto siano ingenui e sciocchi gli uomini e quanto invece siano straordinarie le due ragazze, Silvia e Marcolina, per la loro forza di volontà, il coraggio, l’intelligenza.
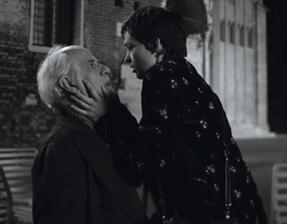
Ho fatto vedere il film a Paolo Sorrentino, visto che siamo amici, e mi ha detto esattamente la stessa cosa: è rimasto molto colpito da queste due ragazze forti, alle prese con due uomini importanti, uomini di potere in qualche modo. Riescono a tenere testa agli uomini e danno loro anche regole molto precise.

Casanova però è un personaggio molto particolare, non è Don Giovanni, non è uno che mette le tacche sul suo fucile. Casanova in realtà si innamorava davvero delle donne che conquistava, addirittura dava una dote alle ragazze per “difenderle dagli altri uomini”, come scrive lui testualmente. Un personaggio curioso. La seduzione, comunque, non va mai fuori moda.
Hai rivisto i Casanova del passato? Fellini, Scola, Freda, Comencini...
Sono tutte visioni molto personali. Quello di Fellini si chiama addirittura Il Casanova di Federico Fellini. Anche in quello di Scola, Casanova c’entra fino a un certo punto. Quello con Alain Delon (Il ritorno di Casanova di Édouard Niermans del ‘92, ndr) sinceramente non mi è piaciuto per niente. Il film con Heath Ledger (Casanova di Lasse Hallström, del 2005, ndr), attore che amavo molto, è cinema di cappa e spada... Devo dire che anche il mio tutto sommato non c’entra molto con Casanova. Raccontiamo questo personaggio per l’idea che ci siamo fatti di lui leggendo le sue memorie, ma non è la storia di Casanova.
Il cast è molto interessante. Ci sono i due mostri sacri, ci sono attori con una grande storia teatrale, ma anche comici con parti drammatiche, che danno al film il suo carattere tragicomico.
Sì, c’è comunque uno sguardo ironico. È un cast a cui ho pensato a lungo. Ci sono i due attori carismatici, ma intorno c’è un mondo che è il mondo, che non è solamente tragico e non è solamente comico. E poi ci sono delle attrici che a me piacciono molto, che secondo me sono le vere protagoniste.
Leo dice, citando Hitchcock: “Per voi quello che ho fatto è solo un film, per me è tutta la vita”. Sei d’accordo con lui?
È stato così per tanto tempo. Ma in questo momento mi accorgo che la vita probabilmente è più importante del cinema. Anche se a volte, come diceva Fellini, “la realtà è scadente” e allora ci si rifugia al cinema.
C’è un grande gioco di formati e di stile, bianco e nero e colori, lo schermo panoramico ma anche
quello del cellulare, i campi lunghissimi, le inquadrature geometriche, i salti dentro e fuori il film... E però, in tutta questa finzione esibita, in tutto questo cinema, ciò che emerge poi è la verità umana dell’imperfezione.
Sono contento che tu lo dica perché è proprio ciò che cercavo di far venire fuori. Da una parte una messinscena ricercata, diciamo così, e dall’altra il dubbio, l’incertezza, il Que sera sera, come canta Doris Day alla fine.
13 APRILE 2023 12 APRILE 2023
(foto Marco Minniti)
Gabriele Salvatores
MARTINA CATALFAMO

Vieni con me / Ti porterò lontano / Tra i fiori del mio prato / Ti tocco la mano e ti sento al sicuro / E ce ne andiamo insieme / Tra petali di miele / La sera scende distesa in silenzio tra noi / La vita si scatena / È come un fiume in piena (…) Sei la creazione del plasma / Scissa tra me ed il Panta / Goccia dispersa nel flusso / Alla sorgente del tutto / Onda di un moto costante / Eternamente pulsante / L’acqua che sgorga dal cosmo.
Il corpo e il volto di una donna, che ci guarda negli occhi, che cammina verso di noi. Dentro un corpo di acqua e sabbia, di roccia e mare, la natura madre, che la avvolge, abbracciandola. Bellezza dentro bellezza. Amore umano dentro l’amore cosmico. Lei è Martina Catalfamo, indossa costume e cappotto, ha una voce ruvida che ti entra dentro e fa vibrare la spina dorsale. “L’altra” è un profilo di donna che vedi solo se guardi da lontano, disegnata intorno ai laghetti di Marinello, nel Messinese, sotto il promontorio di Tindari. L’antichissima Tindari. Come è antico il desiderio, l’anelito cantato da Martina.
Siamo dentro il video (regista Graziano Molino) di Vieni con me, un pezzo elettronico e melodico, moderno e rétro, come i Volosumarte. Una canzone senza tempo. Questa è la dimensione che Martina persegue in tutto ciò che fa, dal cinema alla musica, dalla recitazione alla scrittura. La vocazione misteriosa che la portava a consultare le stelle, fin da bambina, a immaginare un filo che la collegava all’universo. L’infinito, l’invisibile. Ma anche il corpo, la natura, l’istinto.
Ballo da sola in un bar / Tutta la notte in un bar / Io ballo per me. Canta così in Schiavi del sesso, reclamando la sua libertà, in un mondo che sfoga il suo “bisogno represso” nei modi più stupidi, violenti, umilianti (per le donne, soprattutto).
Così come cantava la sua follia liberatoria in una delle sue prime canzoni: Mia madre dice che sono pazza / Perché parlo sola / Il grande puffo non risponde / Voglio vivere, studiare / Senza tutti quei tormenti / (Dio?) / Non mi risponde / (No) / Non è normale / (No) / Chi è normale? / (Boh).
L’incontro con il pianista-producer Francesco Santalucia ha trasformato in realtà, in suoni e segni, le sue fantasie, popolate da sirene, baccanali, voli pindarici e surreali, voglia di abbracciare la terra e scomparire nel mare: Vado via / Volo su Marte / Niente fermerà la mia follia / Martedì / Facciamo l’amore / Per strada esco come / Una vergine al sole.
L’abbiamo vista in Dei, magico film di Cosimo Terlizzi, dare corpo al desiderio, alla ricerca di sé, di una sintonia profonda con la natura. L’abbiamo incontrata nei panni di Lietta, la figlia di Pirandello, in un film di Paolo Taviani. La vedremo presto in tv, nella serie I leoni di Sicilia. Martina vive a Roma, ma il legame con la sua terra, con la cittadina di Patti in cui è nata, rimane fortissimo. Così come la sua ricerca del “senza tempo”, che persegue nella musica e nella scrittura.
15 APRILE 2023
La sintonia con la natura, l’amore cosmico, il sensuale e lo spirituale. La ricerca di un’attrice e cantautrice, dalla Sicilia in volo su Marte
di Fabrizio Tassi
I NCONTRI
Foto di Marco Fato Maiorana
Che legame hai con il luogo in cui sei nata?
Molto forte. Ancestrale. Senza quel legame non ci sarebbe neanche la mia scrittura, probabilmente.
Hai ricordi di quando eri bambina?
Il ricordo più forte è quello dei viaggi che facevo con i miei genitori, sia in Sicilia che in altri paesi, all’estero. Sono state esperienze forti per me. Ricordo soprattutto la Tunisia e l’Egitto, motivo per cui forse oggi sono ancora attratta da quelle culture, quei territori.
Infanzia felice?
Sì, molto.
Poi arriva l’adolescenza e di solito si vuole scappare dal nido.
Quando sei adolescente scopri l’altra faccia della medaglia. Da buona siciliana, un po’ come tutti i siciliani, volevo scappare dalla mia terra, perché sembrava che non ci fossero opportunità. C’è sempre in noi questo modo di pensare, per cui forse soltanto scappando possiamo realizzare noi stessi. In realtà, probabilmente, non è così. Oggi vivrei volentieri in Sicilia.

C’è sempre stato qualcosa di mistico nella mia scrittura, fin da bambina. Me ne stavo con la penna e l’atlante astronomico in mano pensando a quel filo che ci unisce al Tutto
È un percorso che hanno fatto in tanti, anche grandi artisti. Battiato fuggì a Milano per cercare la sua strada e poi tornò in Sicilia dopo averla trovata (interiormente), per percorrerla fino in fondo.
Un altro che è scappato è Pirandello, che ha studiato a Roma ma odiava Roma. Sentimento che anch’io ho provato, dopo qualche anno nella Capitale. La Sicilia ti lascia dentro qualcosa che poi si traduce in nostalgia. Forse chiunque scappa da casa sua poi ha dentro di sé quel senso forte di nòstos, come dicevano i Greci. Ulisse che vuole tornare a Itaca. Ma in noi siciliani questa cosa è particolarmente spiccata. Siamo nati e cresciuti in un’isola e, come diceva Verga, “si rimane aggrappati allo scoglio”. Ho voluto vincere questo pensiero immobilistico e tagliare il cordone ombelicale, per poi finalmente innamorarmi della mia terra.
Noi conosciamo Patti soprattutto per il santuario di Tindari.
Lì abbiamo girato anche l’ultimo videoclip, Vieni con me, nella riserva naturale dei laghetto di Marinello, di cui fa parte anche Tindari con il suo teatro greco. A Tindari c’era una polis. Non a caso in quel luogo si percepisce una grande forza. I greci costruivano in posti non soltanto strategici, ma energeticamente particolari. Guarda caso i cristiani poi hanno legato a Tindari il mito della Madonna nera. Il santuario è dedicato a lei.
Secondo la tradizione, ha salvato una bambina che stava cadendo dal promontorio, ricoprendo le acque di sabbia. Il profilo del laghetto, visto dall’alto, ricorda quello di una donna, che secondo la tradizione cristiana sarebbe proprio la Madonna.
I luoghi di culto cristiani sono nati spesso sulle rovine di quelli pagani.
Credo ci sia una radice comune in tutte le religioni. Probabilmente è da ricercare nel suono, nella vibrazione della preghiera.
Quando eri piccola cosa volevi fare da grande?
L’attrice!
Quando lo hai scoperto?
Nelle recite scolastiche. Ma non lo dicevo a nessuno. Ero molto timida, non mi andava di dire le cose, le scrivevo. La scrittura è una cosa che mi ha sempre accompagnata, alimentando la mia fantasia. Già all’età di otto anni mi sono ritrovata a scrivere poesie. Anche cose legate “all’universo”. C’è sempre stato qualcosa di mistico nella mia scrittura, fin da quando ero bambina. Non so come mai. Mio nonno mi aveva regalato un atlante astronomico e così ho iniziato a fantasticare sui pianeti... La conferma di voler diventare attrice l’ho avuta ai tempi del liceo classico, quando sono andata a vedere le tragedie al teatro greco di Siracusa. Quella è stata la consacrazione. Mi dicevo: vorrei tanto essere lì, interpretare quei personaggi!
I tuoi prendevano sul serio la tua vocazione?
Erano preoccupati perché la vedevano come una strada incerta, piena di insidie. Penso di essere stata molto coraggiosa. Qualche anno dopo ho aiutato tantissimo mia sorella a trovare la sua strada e ne sono fiera. Io non ho avuto delle guide, mi sono sempre affidata al mio sentire.
Hai finito il liceo in Sicilia e poi sei fuggita.
Sono letteralmente scappata dalla Sicilia. Ho detto ai miei che avrei seguito i miei sogni, ma al contempo che avrei fatto l’università. E infatti l’ho fatta. L’ho portata a termine.
16 APRILE 2023
MARTINA CATALFAMO (foto di Ivana Noto)
Ma in realtà cercavo altro. Volevo iniziare a studiare seriamente recitazione. Io comunque ho sempre amato studiare. Quindi l’università per me è stata un piacere. Ho studiato Scienze politiche alla Sapienza, nell’ambito della cooperazione internazionale, dedicandomi soprattutto a quei paesi di cui mi ero innamorata quando ero piccola, al Nordafrica e al Medioriente. Luoghi per i quali nutro una grande fascinazione. Lo studio di un attore o di un’attrice non può limitarsi al metodo e alla tecnica. È fondamentale scoprire l’altro, staccarsi in qualche modo dalla propria cultura.
Hai cominciato studiando Lecoq.
Lecoq è stato uno dei primi, in effetti. L’ho scoperto grazie a un corso di teatro universitario.
Poi sei andata anche a Los Angeles.
Per studiare al Lee Strasberg. Ero con un gruppo di amici, ma alla fine mi sono distaccata per esplorare la città. Volevo trovare delle realtà autentiche, che potessero essere utili alla mia crescita artistica. Sono un po’ un’outsider. Alla fine in qualche modo mi distacco sempre dal gruppo per assecondare la mia curiosità. Tra l’altro recitare in lingua inglese, americana in questo caso, mi piace tantissimo. Sono stata diretta da Michael Radford ne La musica del silenzio ed è stato davvero divertente.

La tua prima apparizione in assoluto è stata in tv, La Mafia uccide solo d’estate 2. Poi è arrivato l’incontro con Cosimo Terlizzi (regista e videoartista geniale) che ti ha “scoperto”. Così sei diventata Laura in Dei.
Con La mafia uccide solo d’estate 2 ho realizzato il sogno di girare in Sicilia, a Palermo. Dei invece è stata la mia prima esperienza da protagonista, un’esperienza pazzesca. Stimo tantissimo Cosimo. È diventato anche un caro amico. Stimo anche il coraggio che ha avuto nel costruire il suo progetto in Puglia, Lamia Santolina. L’attenzione che dedica alla natura. Vorrei avere anch’io quel coraggio, tornare in Sicilia e costruire il mio “giardino” sostenibile, ma ancora non ce la faccio.
Dei è un film bellissimo, delicato e profondo, che forse avrebbe meritato maggior fortuna.
È un film speciale, molto particolare, che parla anche a un pubblico adolescente, ai ragazzi. Ogni volta che mi capita di rivederlo, lo trovo sempre molto attuale. È un viaggio. Bisogna guardarlo lasciandosi trasportare dall’inconscio.
Che esperienza è stata girare quel film?
Un’esperienza totale, che mi ha coinvolta a 360°. Si è creata una famiglia con i ragazzi, con gli altri attori, oltre che con Cosimo e Damien Modolo. Hanno fatto in modo che nel gruppo si instaurasse un legame autentico in modo da rendere tutto naturale davanti alla macchina da presa. Cosimo ci teneva che sul set fossimo il più possibile fedeli a una realtà che avevamo trovato durante le prove. Abbiamo provato a lungo per scoprire sfumature diverse dei personaggi.
Elementi che magari non erano neanche in sceneggiatura, ma che attraverso il confronto siamo riusciti a trovare. È stata l’esperienza più bella che ho vissuto finora. Ho scoperto anche la Puglia, a partire da Bari. Una terra pazzesca. Come in tanti luoghi del sud c’è un forte contrasto tra la natura e ciò che l’uomo ha costruito, andando spesso a usurpare il paesaggio. Questo aspetto Cosimo riesce a sottolinearlo magistralmente nel film.
In Dei, come nelle tue canzoni, c’è un intreccio tra il carnale e lo spirituale, c’è un’energia misteriosa, si esalta il legame con la natura. È una cosa che ti appartiene.
Assolutamente, sì. Quando ho letto la sceneggiatura di Dei ho pensato: “ma parla di me!”. È un testo pieno di metafore, simboli, i dialoghi sono piuttosto astratti, ma proprio quel tipo di contenuto fa parte della mia ricerca da sempre. Io da piccola me ne stavo con la penna e l’atlante astronomico in mano per cercare di capire le posizioni degli astri, pensando a quel filo che ci unisce al Tutto. Sono temi che poi ho ritrovato studiando filosofia al Classico.
19 APRILE 2023 18 APRILE 2023
MARTINA CATALFAMO
Con Cosimo hai lavorato anche nel 2019, per il documentario Dentro di te c’è la terra.
Lì abbiamo esplorato ancora di più il rapporto con la terra e l’ambiente che ci circonda. Abbiamo girato in parte ad Alicudi, che tra tutte le Eolie era quella in cui ero stata solo di passaggio, per un pranzo di Ferragosto. Ricordo che faceva caldissimo ed essendo piena di gradini ho preferito il mare all’esplorazione via terra. Meglio così, perché quando ho girato Dentro di te c’è la terra era tutto nuovo per me. Ho vissuto dei giorni incredibili. Mi sono resa conto di quanto il nostro modo di vivere in città sia artificiale, finto, proprio perché distante dalla natura e quindi da noi stessi. Ad Alicudi entri in una dimensione in cui il tempo segue il sorgere e il tramontare del sole.

Un’altra esperienza importante è stata quella con Paolo Taviani, per Leonora addio.
La notizia di “aver vinto” il provino l’ho avuta quando è scoppiata la pandemia. Quindi ho vissuto quel brutto periodo con questa speranza. Una bella esperienza, sì. Mi ricordo quando ero al trucco la prima volta ed è entrato Taviani sul set. L’ho capito perché a un certo punto è calato il silenzio.
Lui è la storia del cinema. Un uomo di grande cultura e sensibilità.
Sì, un vero Maestro.
Cosa ami guardare al cinema. Hai un film del cuore?
Sono una fan di Monica Vitti, quindi tra i miei film preferiti ci sono quelli della trilogia di Antonioni: L’avventura, La notte e L’eclisse. Poi io mi affeziono molto ai registi e alle registe. Ad esempio mi piace tantissimo Céline Sciamma: Petite Maman è un film incredibile. Di recente ho amato molto Tár di Todd Fiel. Cate Blanchett è una delle mie attrici preferite, tra quelle contemporanee.
I video musicali di Volosumarte hanno sempre un’idea forte, un gusto cinematografico.
Non amiamo il videoclip classico. Cerchiamo di creare sempre una sorta di video-arte. Lo scorso anno è nata una collaborazione con il regista Dario Albertini che ha voluto un brano del progetto Volosumarte per il suo ultimo film Anima bella. Ascoltare una mia canzone sul grande schermo mi ha emozionata molto. Mi piacerebbe continuare a unire queste due passioni.
La musica c’è sempre stata nella tua vita.
Scrivevo. Volevo scrivere un romanzo, ma all’improvviso hanno preso vita nella mia testa delle melodie. Ho iniziato a suonare la chitarra e a unire la musica alle parole. Scrivere canzoni è più fedele ai miei ritmi. Per scrivere un romanzo avrei bisogno di vivere in un tempo lento, quello di Alicudi per intenderci. Ma nella frenesia dello spazio urbano, lo scrivere canzoni si concilia benissimo con le mie esigenze. Si esaurisce in un arco di tempo più breve. Porti a compimento un’emozione anche nel giro di un’ora. Poi devi solo limare le parole nel momento in cui metti a fuoco il testo.

Fa parte della tua ricerca personale.
Del mio dáimōn, quel demone che collega il terreno e l’ultraterreno. Sto facendo una ricerca costante dentro di me, che mi porta a spaziare dal cinema alla musica, trovando però dei progetti che in qualche modo si allineano alla mia visione delle cose.
20 APRILE 2023
MARTINA CATALFAMO
Ad Alicudi mi sono resa conto di quanto il nostro modo di vivere in città sia artificiale, finto, proprio perché distante dalla natura e quindi da noi stessi
Alena Ettea
Viviamo un periodo storico delicato e avverto l’esigenza di portare avanti delle tematiche che mi rappresentano e che possano lasciare un segno.
Nel cinema indossi un personaggio, la musica forse è una cosa più personale e interiore
Si fa una ricerca anche quando si studia un personaggio. Chi recita cerca di trovare dei punti di contatto tra se stesso e chi interpreta. Deve piacerti molto “scavare” dentro di te, per poter dar vita ad una sceneggiatura. Con la musica invece non c’è la maschera del personaggio. Ci sono nodi che devi andare a sciogliere, mettendoli su carta, ma soprattutto c’è il tuo interlocutore, quello a cui non riesci a dire le cose in faccia. Allora la musica diventa lo strumento di comunicazione più forte per dire le cose che non hai mai avuto il coraggio di dire. Fare la cantante tout court non mi interessa. La mia necessità è comunicare.
Come è nato il progetto Volosumarte?
È nato quando ho incontrato Francesco Santalucia, che è un producer e un pianista pugliese, ma vive a Roma. Ha scritto anche le musiche per la serie Suburra insieme a Piotta. Gli ho fatto ascoltare un po’ di canzoni che avevo registrato sul telefono e mi ha detto: proviamo! Era incuriosito dai miei testi un po’ criptici, surreali, con quelle parole non usuali.
Da dove arriva il nome?
Schiavi del sesso è una canzone che parla di libertà, di corpi, della voglia di salire sul tavolo e ballare, fregandosene del giudizio degli altri. Viviamo sempre più relazioni stereotipate, fittizie
Dalla nostra canzone manifesto: Volo su Marte. Anche qui c’entra la Sicilia. Ho scritto questa canzone a Siracusa. Mi ricordo che ero lì per la stagione delle tragedie greche, nel 2018. Ero in un bar sul lungomare di Ortigia. A un certo punto ho sentito questa melodia e ho cominciato a vedere delle sirene, delle figure mitologiche, e la terra brulla, che è tipica di quel territorio. Il brano è nato così. Da un lato c’è dentro la nostra voglia di scappare, di evadere dalla realtà per cercare di costruire una società diversa, utopica, su un altro pianeta, ancora integro. Dall’altra c’è una critica al tempo in cui viviamo: siamo in grado di volare su Marte ma non di salvare la Terra, di ritrovare il contatto con la natura, con una dimensione più sana dell’esistenza.
Lo sapevi già di avere questa voce molto particolare, che “gratta l’anima”, che scava dentro? Oggi si sentono voci troppo pulite, lineari. La tua sembra venire da un altro tempo.
Probabilmente sì, c’è qualcosa di antico. Anche questa scoperta è merito di Dei. Ricordo le truccatrici che mi dicevano: “Tu hai una voce pazzesca, ci canti qualcosa?” Io mi vergognavo della mia voce. Lì ho capito che forse potevo cantare, che forse questa voce può piacere, perché è particolare. Prima questa particolarità mi sembrava un difetto.
Nella vostra musica c’è l’elettronica e la melodia, una ricerca del suono molto moderna, ma anche qualcosa di antico (anche qui), c’è l’ironia surreale, ma anche il sentimento. Vieni con me, l’ultima canzone, parla di un amore che diventa cosmico.
È una canzone che parte dal particolare per andare all’universale. Come se ci smaterializzassimo nella natura, diventando acqua che scorre, panta rei. Ci rappresenta molto. L’elettronica l’ho scoperta grazie a Francesco. Io sono una grande appassionata di musica italiana anni Settanta (anche lui), da Battisti a Battiato, che tra l’altro usava tantissimo i sintetizzatori. Ho scoperto l’elettronica contemporanea, delle sonorità che non rientravano tra i miei ascolti, e che si sposano bene con le mie canzoni. Cerchiamo di non rimanere fermi. Di sperimentare e spingerci sempre più oltre, in maniera libera.
Fate musica molto personale. Meglio andare avanti per la propria strada, con sincerità e passione, che pensare al marketing e alla “comunicazione”. Magari un giorno il grande pubblico vi scoprirà.
Sì, lo facciamo soprattutto per noi. Non vogliamo essere schiavi dell’industria musicale. Viviamo una libertà totale. Poi, se capita, perché no?
Una canzone a cui sei particolarmente legata?
Quella che sento di più è Schiavi del sesso. Abbiamo realizzato un cortometraggio, coinvolgendo tante attrici, chiamando la regista macedone Dejana Poposka. Abbiamo cercato di rompere gli schemi, andando verso il surreale e facendo ruotare il soggetto intorno al tema dell’Uovo. Abbiamo inserito anche una citazione cinematografica della pellicola giapponese Tampopo. È una canzone che parla di libertà, di corpi, di femminile, del non essere schiavi degli stereotipi. La voglia di salire sul tavolo e ballare davanti a tutti, fregandosene dei giudizi degli altri. Viviamo sempre più relazioni stereotipate, fittizie, piene di convenzioni. Spesso ci vuole del tempo per riconoscere un amore malato. L’amore non deve mai limitare la libertà dell’altro. Penso sia l’unica bussola che può indicarci la strada. Quindi balliamo sui tavoli, se lo desideriamo.

23 APRILE 2023 22 APRILE 2023
MARTINA CATALFAMO (foto
Andrea Ciccalè)
Quella del “diritto al desiderio”, del rendersi soggetto invece che oggetto, è una battaglia ancora da vincere.
La donna spesso ha paura ancora oggi di prendersi certe libertà. Proprio perché la società ha creato degli stereotipi, dei sensi di colpa, legati spesso alla tradizione cristiana. Penso al libro di Michela Murgia, Ave Mary, in cui vengono messe a confronto le due più grandi figure femminili della cristianità, Eva e Maria. Purtroppo c’è un retaggio nell’inconscio collettivo che ha portato all’oggettificazione della donna, fenomeno esasperato oggi dalla società dei consumi.
Il mese scorso su Redness abbiamo parlato della Maria Brasca, donna che reclamava la sua libertà in un’opera scritta da Testori nel ‘59, che però sembra ancora di attualità.
Ci sono tantissime donne da cui possiamo prendere spunto per avere la forza di sentire che possiamo farcela. Mi viene in mente, ad esempio, Franca Viola. La cosa che mi preoccupa del tempo in cui viviamo è che sembra che la società stia subendo un’involuzione rispetto a certe conquiste che erano state fatte negli anni Settanta. Ma rimango fiduciosa.

Che rapporto hai con il femminismo? Ci sono molte discussioni, anche fra donne, su come portare avanti certe battaglie.
Mi viene in mente un’esperienza che ho fatto sul set de I leoni di Sicilia, pochi mesi fa. Io interpreto una nobildonna palermitana. Mi sono resa conto di quale fosse la condizione delle donne dell’Ottocento dal modo in cui vestivano. A un certo punto volevo gridare: “Datemi un pantalone!”. Quei vestiti non ti permettevano di vestirti da sola, avevi sempre bisogno di qualcuno che ti aiutasse. Ti ingabbiavano e ti rendevano schiava.
Oggi sicuramente siamo molto più libere, ma ho un po’ paura che la libertà sia più nella forma che nella sostanza. È importante che tutti si rendano conto che la visione femminile è necessaria perché inevitabilmente fornisce un altro punto di vista sulle cose. Il rispetto reciproco è la chiave per una società inclusiva e paritaria.
Una ragazzina siciliana che sogna di fare l’attrice ha il diritto di seguire la sua vocazione, di realizzare il suo desiderio. Questa è la cosa importante. Al di là dei ruoli, delle tradizioni, dei luoghi comuni.

A volte pensiamo di negare o allontanare il desiderio per adottare un comportamento conforme alla società, al “cosa si aspettano da me”, al “come mi vogliono gli/le altri/e”. Forse è la mente la nostra vera gabbia, non il corpo. Il corpo deve essere libero, la mente a volte deve tacere e lasciar fluire le cose.
Cosa ti dà la forza di alzarti la mattina? Qual è la tua "redness"?
Il dáimōn, la ricerca, il desiderio di trovare la chiave che unisca il terreno e l’ultraterreno. Può essere la ricerca musicale, oppure la ricerca d’attrice. Per vivere bisogna lasciarsi andare alle cose. Mantenere accesa la curiosità e seguirla per trovare la strada. È tutto strettamente legato ad una costante ricerca interiore. Alla fine capendo te stesso capisci meglio anche l’altro, conoscendoti riesci a entrare più facilmente in contatto con chi ti sta intorno. Se non conosci te stesso non riesci ad amare gli altri.
Progetti futuri?
Ci saranno molte sorprese. Sia a livello cinematografico che musicale. Magari ci vedremo anche su qualche palco. Nel frattempo continuo a fluire. Vado là dove mi porta l’istinto. Cerco di capire i segnali che mi dà il corpo. Se senti che quella cosa ti sta dicendo “vieni da me”, forse la devi seguire.
25 APRILE 2023
MARTINA CATALFAMO
Siciliana, 33 anni, dopo l’ottimo “Il silenzio dell’acciuga” (Nutrimenti) ha scritto un romanzo ancora più bello: “Piccole cose connesse al peccato” (Feltrinelli). Un’estate al mare, due amiche, l’incontro con una ragazza indomabile e un gruppo di ragazzi che vive di espedienti. La scoperta del desiderio, in una terra arcaica.
LORENA SPAMPINATO
La scrittura, le convenzioni da superare, la vita delle ragazze.
Ricordi la prima volta che hai scritto? Cosa, come, dove?
Ero una bambina (otto, nove anni) e avevo appena chiuso Marigold di Lucy Maud Montgomery, quello che ricordo come il primo romanzo letto. Scrissi un piccolo racconto che ricordava molto quel libro: la storia di un’amicizia tra una bambina e la sua amica immaginaria.
Hai capito subito che era ciò che volevi fare, la “tua cosa”? Oppure è stato un innamoramento lento, una presa di coscienza lunga e tormentata?
Credo di averlo capito molto presto. Quando ero adolescente scrivevo regolarmente, poi per un lungo periodo ho preso altre strade, anche molto lontane dalla scrittura. Ho ricominciato a scrivere quando sono tornata a vivere in Sicilia, sei anni fa. La lettura invece non l’ho mai abbandonata.
Che bambina eri? E che ragazza sei diventata? Aneddoti, eventi memorabili?
Ero una bambina silenziosa, osservavo molto. Buona, diligente, molto attenta alle regole. Allegra ma anche piena di malinconie sotterranee. Quando avevo sette o otto anni, durante una festa di compleanno, un ragazzino mi fece un dispetto che non ricordo e io mi chiusi in una stanza a piangere fino alla fine della festa. Da ragazza quelle tristezze le ho tenute nascoste.
Facciamo un po’ di biografia? Catania, Londra, Roma, Catania. L’esordio a 18 anni (cosa rara), l’università, il lavoro editoriale, il ritorno a casa. Sei anarchica, agisci d’impulso, o sei più programmatrice, metodica? Cerchi di capire dove ti sta portando la vita, inseguendo il “destino”, magari pure amandolo (con spirito stoico), o vai dritta verso la meta?

Ho sempre agito d’impulso, le scelte più importanti della mia vita le ho prese in pochi secondi. Seguo spesso l’umore del momento, ma mai in modo incosciente: sono anche prudente, timorosa. Divento metodica nel lavoro, nella scrittura. So darmi orari e scadenze che rispetto diligentemente.
Che rapporto hai con maestre e maestri, con i classici? Sono un conforto, un’ispirazione? Quali sono le opere decisive per la tua formazione?
27 APRILE 2023
I NCONTRI
«Nell’adolescenza riceviamo una spinta verso chi saremo un giorno»
26 APRILE 2023
Li rileggo spesso, rileggo i passi che ho sottolineato, anche mentre scrivo. Le opere che sono state decisive sono moltissime, eccone alcune: Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, le poesie di Antonia Pozzi, Rebecca di Daphne Du Maurier, L’isola di Arturo di Elsa Morante, Memorie di una ragazza perbene di Simone de Beauvoir, L’arte della gioia di Goliarda Sapienza.
Come scrivi? Hai i tuoi riti, dei luoghi in cui ti riesce meglio, hai bisogno di un particolare stato d’animo?
Non seguo particolari riti, ho bisogno di silenzio e di spazi senza vita. Non riesco a scrivere nei parchi o nei bar. Poi deve essere mattina, meglio se molto presto.
Cose che hai scritto di cui vai particolarmente fiera e perché. Possono essere romanzi, articoli, anche cose mai pubblicate.
Oltre ai romanzi ho scritto qualche racconto. Particolarmente fiera? Non saprei, davvero. Sono, in genere, molto critica con me stessa.
Come è nato Piccole cose connesse al peccato? Qual è stata la molla, l’idea, il sentimento che lo ha ispirato?
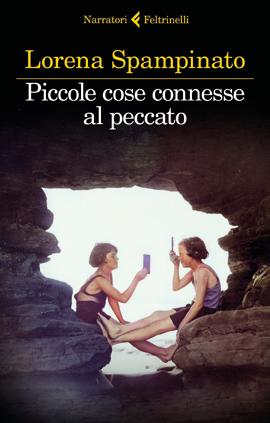
Per me era importante raccontare un’età fondamentale della vita, dove si forma tutto ciò che ci riguarda. Credo che la vera epifania dell’età adulta sia riconoscere che il nostro nucleo più vero sta lì
Volevo scrivere un libro in cui ci fosse dentro la vita delle ragazze, le cose piccole della vita delle ragazze. Una risonanza infinita della giovinezza: della leggerezza che sprofonda nel buio. Un luogo dove persino la fruizione degli spazi è risemantizzata dalla giovinezza: lo spazio esiste in funzione dell’esperienza personale, c’è un egoismo altissimo, esitiamo solo noi nel mondo, e poi tutto il contrario: quell’egoismo altissimo si ridimensiona appena scopre la comunità.
Per me era importante raccontare un’età fondamentale della vita, dove si forma tutto ciò che ci riguarda. È nell’adolescenza che riceviamo una spinta verso chi saremo un giorno. Parte tutto da lì. Credo anche che la vera epifania dell’età adulta sia riconoscere questo: che il nostro nucleo più vero sta lì, e che nonostante tutte le strade che abbiamo preso per separarcene, in qualche modo quel nucleo ci appartiene per sempre perché ci definisce. Non è un caso che attorno all’adolescenza si addensi una nebulosa letteraria fittissima. Gli elementi interessanti sono parecchi: la perdita dei mondi infantili spazzati via dalle trasformazioni del corpo, della personalità; l’immagine infranta della sacralità degli adulti; l’idea di dover superare una soglia per approdare a una nuova identità.
Quanto c’è della tua esperienza nei luoghi che racconti, le persone che li abitano, i sentimenti vissuti? Quanto invece lo hai scoperto mentre scrivevi? C’è qualcosa di inaspettato che ti ha lasciato questo romanzo? Intendo qualcosa che non avevi previsto all’inizio, che si è rivelato lungo il cammino.
Di mio c’è lo sguardo che avevo da adolescente sul mondo e sulle mie coetanee. Ho tanto ammirato le ragazze, le vedevo tutte bellissime. Scrivendo il romanzo è stato quello sguardo a scrivere la storia, non avevo previsto molto di ciò che poi è accaduto.

Il titolo lo hai pensato tu? C’era fin dall’inizio o è una scelta editoriale? In effetti è una storia fatta di piccole cose che diventano grandi, enormi, quasi insostenibili. La parola “peccato” evoca un retaggio, più che un’esperienza, un modo di intendere le cose che portiamo dentro più o meno consapevolmente, e con cui bisogna fare i conti.
Il titolo è una frase interna al libro, l’idea è stata di Helena Janeczek che ha lavorato con me al romanzo (un onore!) e mi è subito piaciuta.
Può essere davvero così «triste - ridicola, disperata - una mattina d’estate quando si è solo ragazze»? La tua scrittura - la (ricca, densa, poetica) semplicità con cui racconti le emozioni e le sensazioni - è una specie di lente di ingrandimento, che allarga la nostra percezione e la spinge in profondità. C’è l’attimo in cui tutto sembra giusto, perfetto, «l’allegria sentita nell’addome, nella gola», il segreto richiamo della sensualità, ma anche la «sciocca imitazione del dolore, la sciocca imitazione della felicità» con cui ci illudiamo a volte. Forse solo provando a fissare quell’attimo (magari davanti a un falò) si riesce davvero a «scoprire il gusto delle cose eterne».
Può essere anche più triste, ridicola, disperata di così: c’è una scena molto bella di un libro che cito anche nel mio, Le vergini suicide di Jeffrey Eugenides, ed è il dialogo tra una ragazzina di tredici anni che ha appena tentato il suicidio e un dottore in ospedale. Lui le dice: Che ci fai qui? Non puoi sapere quanto è brutta la vita, giovane come sei. E lei subito risponde: Dottore, è evidente che lei non è mai stato una ragazza di tredici anni.
29 28 APRILE 2023
LORENA SPAMPINATO (foto Imma Petricciuoli) APRILE 2023
Bella anche la delicatezza con cui si parla di desiderio, si raccontano baci e carezze, si evoca la scoperta del sesso. Un po’ come in quei film in cui si lascia il corpo, il godimento, fuori campo, in realtà per farcelo vedere e sentire meglio e di più.
Grazie, questo genere di morbidezza fa parte della mia scrittura. È anche il motivo per cui ho evitato riferimenti ed effetti vintage-pop che oggi vanno tantissimo.
In questi tempi di presunta libertà totale ed esibita sembra in realtà che tante ragazze/donne facciano fatica a “farsi carico del desiderio”, ad assumersi la responsabilità e forse anche l’orgoglio di essere “soggetti desideranti”. Lo hai scritto parlando di un libro di Tamara Tenenbaum che ragiona sulla fine dell’amore romantico (che poi forse è l’inizio di un’altra cosa, non meno bella, liberatoria).
In quel pezzo scrivevo che Tenenbaum invita le donne a riappropriarsi del proprio desiderio, dilaniato da anni di narrazioni fuorvianti sull’amore romantico, come l’idea che sia meritevole di amore solo chi dà tutto: il suo tempo, le sue energie, e persino il desiderio.
Come vive il femminismo una donna della tua generazione? La parola-movimento in sé è ancora utile? Quelle battaglie hanno bisogno di una nuova consapevolezza, un nuovo linguaggio, o bisogna prima tornare ai “fondamentali”?
Che sciocchezza dire che la scrittura femminile è intima o sentimentale... Le donne e gli uomini vivono, del mondo, esperienze diverse perché immersi in una tradizione che facilità gli uomini e penalizza le donne
I femminismi di oggi hanno una voce molto forte e potente. Soprattutto grazie a Internet che è la cassa di risonanza di molte battaglie come è successo con il movimento #MeToo. Mi sembra che ci sia, da parte di molte donne e molti uomini, un desiderio crescente di decostruzione dei vecchi sistemi. I social ci hanno permesso di conoscere persone e realtà diverse dalla nostra e di confrontarci. Si parla di identità sessuale, abilismo, discriminazioni razziali, di corpi non conformi, disparità salariale, rappresentazione, violenza di genere, omolesbobitransfobia, sex working.
Quanto ti dà fastidio la definizione “scrittura femminile”? Anche questo è un bello stereotipo da superare, questa idea per cui ci sarebbe "la letteratura" (maschile, soprattutto) e poi le autrici donne che si soffermano più sull’intimo, sui sentimenti. Qual è la reale differenza, se c’è, tra il modo in cui scrivono donne e uomini, secondo te?
Femminile e maschile sono convenzioni sociali, anche quando applicati alla scrittura: che sciocchezza dire che la scrittura femminile è intima o sentimentale, e che quella maschile è la scrittura universale. L’unica differenza, per me, sta nello sguardo, nella postura. Le donne e gli uomini vivono, del mondo, esperienze diverse perché immersi in una tradizione culturale che facilita gli uomini e penalizza le donne. Dunque la differenza andrebbe esplorata a partire da qui, non certo dai temi, o dai modi.


Tornando alla tua vita: progetti per il futuro? Di scrittura, di lavoro, di viaggi, rivoluzioni personali o collettive.
Per il momento porterò un po’ in giro questo romanzo. Il resto si vedrà.
Qual è la tua “redness”, ciò che ti dà la forza di alzarti la mattina?
Le persone che amo.
31 APRILE 2023
LORENA SPAMPINATO
(foto Francesca Cassaro)
Martina Galletta

La provocazione della libertà. Teatro, cinema, scrittura e vita. Contro
Acuore aperto. A mente spalancata. A corpo libero. Martina Galletta è un’esperienza travolgente. Un flusso ininterrotto di parole, idee, ricordi, emozioni. Anche di provocazioni. E stereotipi che saltano per aria. Ruoli e maschere. A lei hanno chiesto spesso di interpretare «suore e prostitute». Per esaurire il ruolo della donna, secondo l’immaginario tipico nostrano, mancherebbe solo “l’angelo del focolare”. Niente di più lontano dal suo stile di vita. Martina è più l’anima della festa. Forse anche il “diavolo tentatore”. Non per niente si diverte a esibire la sua bellezza e il suo corpo sui social («io in realtà non mi sento bella e ho un pessimo rapporto col mio corpo», dice però lei, provocando un vivace dibattito). Risultato? Tanti commenti “ormonali” e reprimende “morali”. Ma anche l’ammirazione di chi capisce il suo gioco spericolato. Perché lei la sua libertà la vive fino in fondo, sul palco, nella vita, sui social, senza bisogno di troppe parole - di comizi o dichiarazioni di principio - facendone anche una questione politica e ideale, oltre che ludica.
Ci sta pure l’ironia anti-sentimentale, quasi cinica, con cui commenta l’immagine (proposta dal giornalista) di un lui e una lei innamorati da una vita, sposati da sessant’anni, ancora mano nella mano: «Secondo me è sindrome di Stoccolma». Mentre parliamo di “coppie aperte” e/o “matrimoni che funzionano”, quando osservo che gli uomini amano la libertà per ragioni puramente biologiche, diverse da quelle delle donne, lei se ne esce con uno sconcertante «infatti io sarei un ottimo marito, ma una pessima moglie». Si dà il caso che lei un figlio lo farebbe volentieri, se non fosse che
l’uomo “libero” se la fa sotto al solo pensiero. Perché noi a volte siamo fatti così: la sera leoni, la mattina gattini spaventati. Le sue confidenze, a proposito di libertà sessuale, farebbero arrossire chiunque. Eppure, o proprio per questo, Martina Galletta è anche un’anima antica – anche il suo volto lo è, arriva da un altro secolo, forse anche da un’altra latitudine - che frequenta i classici come fossero amici d’infanzia, che mentre fa running ascolta musica rinascimentale (corre anche 200 chilometri in un mese), che suona il pianoforte da quando ha 3 anni, e compone pure (merito del nonno musicista), che ha un debole per il primo Novecento (la contemporaneità la tollera appena), che dipinge e si diverte a costruire interni di case in miniatura (ce n’è una appesa nel suo appartamento, appena entrati). Se poi deve farsi un tatuaggio, si imprime sulla pelle il nome di Tamora, perché nutre una passione viscerale per il Tito Andronico di Shakespeare.
Martina Galletta ha recitato nei più importanti teatri italiani. Ha messo in scena Čecov, Dostoevskij, ma anche nomi noti della drammaturgia contemporanea. Ha interpretato Giulietta Masina al cinema e svariati personaggi in serie tv popolari. Ha pubblicato un romanzo, La dimora degli dei (Infinito Edizioni), ambientato ai tempi del nazismo, e ne sta già scrivendo un altro. È attrice, ma anche musicista, cantante, scrittrice. È sempre in viaggio e in movimento, un treno dopo l’altro, tra Milano, Roma, Napoli e i luoghi in cui si trova a recitare o presentare il suo libro.
32 APRILE 2023
I NCONTRI (foto di Paolo Gavardi)
i moralismi, con il “Tito Andronico” tatuato addosso di Fabrizio Tassi
Noi l’abbiamo incontrata nella sua casa milanese, che ovviamente le somiglia, moderna e antica come lei. Un piccolo nido in un vecchio palazzo elegante con vista su City Life. Il suo pied-à-terre. Si entra attraverso un ballatoio che ci ricorda la Milano di una volta, con le sue corti. Un appartamento accogliente, in cui spicca un pianoforte, con la foto dell’amatissimo nonno, e le pareti tappezzate di libri. C’è Anna Karenina in bella vista. Tutto Murakami. Ma anche Dumas e Allende. Una mensola nel corridoio è ricoperta di libri gialli: decine di Agatha Christie.
Il Teatro è meraviglioso. Sei lì a provare, giorno dopo giorno, ripeti il testo, lo vivi. Quando abbiamo fatto Dostoevskij al Bellini passavamo i pomeriggi ad accapigliarci su ciò che volesse dire ogni singola pagina. Dove lo trovi, nel mondo di oggi, un privilegio del genere?
L’intervista comincia con acqua e caffè, ma presto passiamo al vino.
«Sono nata a Milano, vivo a Roma da una decina d’anni e ho vissuto per molto tempo a Napoli, facendo la pendolare, quando lavoravo al Teatro Bellini. Facevo sei mesi giù e sei mesi in tournée». Vita d’attrice, dal teatro al set, da una replica in qualche luogo sperduto all’ennesimo provino, perché i provini non finiscono mai. «Mio padre è un medico. Mia madre ha iniziato a lavorare giovanissima, non ha potuto studiare come avrebbe voluto. Ha cominciato come dattilografa e alla fine è diventata dirigente dell’azienda per cui lavorava. È una figa pazzesca. Quando si è pre-pensionata ha preso due lauree e ha scritto un romanzo. Ora fa la pittrice astrattista. È complicato avere una mamma così, devi essere all’altezza. Lei però dice di aver preso ispirazione da me. Abbiamo un rapporto bellissimo. Ci diciamo tutto. Fin troppo». La vocazione artistica le arriva dal nonno pianista e da una nonna pittrice, in quel ramo della famiglia che ha un’origine croata. Ricordi di gioventù? «Infanzia felicissima e adolescenza terrificante. L’infanzia è stata molto bella anche grazie a mio nonno Dante, che mi ha messo davanti al pianoforte a 3 anni. Avevo un rapporto stupendo con lui e con tutta la famiglia. Da adolescente invece ero “satana”. Colpa degli altri, di situazioni traumatiche che mi hanno fatto vivere, ma anche colpa mia, che ho reagito in modo altrettanto traumatico. A 20 anni mi sono innamorata di un quarantenne e ho vissuto insieme a lui per cinque anni».


All’inizio pensava che avrebbe fatto la musicista. «Finché non ho messo il piede sul palco. Quando è successo la prima volta, ho detto: lasciatemi qui e buttate la chiave! La vita del musicista è molto solitaria, quasi ossessiva. Un po’ mi spaventa. Devi essere abituato a stare solo con te stesso. A me invece piace andare a cena con i colleghi e sbronzarmi, questo è il mio spirito. Preferisco una vita adrenalinica come quella teatrale».
La prima performance? Al liceo Leone XIII, con un insegnante di nome Federico Bellone, oggi noto regista e produttore. Lei era molto brava a cantare (lo è tuttora) e lui le assegnò la parte da protagonista in un saggio in forma di musical. «Poi ho scoperto che il musical non fa per me. Preferisco la prosa. Ho rispetto del musical come genere ma non mi piace guardarlo, figuriamoci farlo. Io voglio Shakespeare, voglio Čecov, la parola.
Mi fa impazzire tutta la drammaturgia contemporanea, sono drogata di Spregelburd, l’ho anche conosciuto perché è venuto a vederci quando abbiamo messo in scena un suo spettacolo qualche anno fa (“Tutto”, ndr)». I genitori erano piuttosto preoccupati dalle aspirazioni artistiche della figlia. Ma è grazie alla madre se, appena finito il liceo, è entrata alla Paolo Grassi, scuola teatrale tra le più prestigiose in Italia. «Io volevo entrare al Piccolo, mi ero fissata, esisteva solo il Piccolo. Mia madre, per aiutarmi, convinse un allievo che si stava diplomando a darmi qualche lezione. Volevo portare un pezzo da Tre sorelle, io che non avevo mai studiato dizione. Preparai l’esame con questo ragazzo, mi innamorai disperatamente di lui (voglio sperare anche lui un pochino di me), ma feci un provino orribile, perché ero terrorizzata. Bocciata e disperata. Fu mia madre a insistere perché provassi anche alla Grassi. Andai con l’atteggiamento di chi “voleva il Piccolo”, senza nessuna preoccupazione, e mi presero subito». Inutile dire che quella non-scelta fu fondamentale per la sua carriera. «Era la scuola migliore che potessi fare. Alla Grassi si mischiano i generi, non viene insegnato un solo metodo, ma vari stili. Mi sono trovata benissimo con il modo di affrontare il lavoro teatrale di Vasiliev (con cui poi ho anche lavorato, perché ho voluto cono-
scerlo). Ho visto uscire da altre scuole allievi dogmatici, convinti che il loro modo di fare teatro fosse l’unico giusto. Io odio il “si fa così”».
Ne approfitto per chiederle se lei crede nel caso-caos oppure nel destino, la provvidenza, il karma, nel fatto che ci sia una qualche “strada tracciata” da scoprire.
«Io sto tra lo scettico e il disperato. La mia unica religione è il Teatro. Può darsi che una strada ci sia, o almeno una consequenzialità, ma io vivo alla giornata, soprattutto in questo periodo» (ci tiene alla T maiuscola associata al Teatro, per lei è cosa sacra e noi la rispettiamo).
Segue un dialogo-siparietto:
«Vivo un’età di passaggio. Spero che passi presto»
Le età di passaggio passano sempre.
«Non vedo l’ora di avere quarant’anni così non ci penso più».
Cosa c’è di così orribile nella tua età?
«Io ho 36 anni!»
Ma ne dimostri dieci in meno.
«Però ne ho 36».
Che importanza ha? Ci sono attori settantenni che fanno parti da cinquantenni.
«In teatro, forse. Sul palco la mia età non è un problema».
35 APRILE 2023 34 APRILE 2023
Martina Galletta
(foto di Paolo Gavardi)
(foto di Luca Brunetti)
Al cinema è diverso?
«La mia agente, giustamente, mi manda ai provini per “mamma 42”. Io vado al provino e non mi prendono».
Perché sembri troppo giovane.
«Ma non mi prendono neanche per fare la figlia, perché vedono l’età scritta sul curriculum. Per questo dico “età di mezzo” terribile».
L’età di mezzo credo sia un tormento soprattutto femminile.
«Per non parlare della menata dei figli: e li fai e non li fai e con chi li fai...»
Ti fanno spesso questa domanda?
«Me la faccio anch’io».
Se te la fai tu va bene, è la tua vita, ci mancherebbe. È antipatico quando la fanno gli altri.
«Sì. Anche perché io questo desiderio ce l’ho. Ma solo io a quanto pare».
Non penso che tu abbia dei problemi a trovare un uomo con un desiderio di paternità.
«Il problema è che deve piacermi... Ho anche pensato a un certo punto: perché mi serve per forza un uomo?
Ma per adesso non riesco a gestire nemmeno me stessa, figuriamoci un’altra persona. Mi metto la mano sulla coscienza».
Il musical è il genere che l’ha rivelata da ragazza, la prosa è il suo pane da professionista, ma l’esordio vero e proprio è arrivato dietro una marionetta, con la Compagnia Colla. Era il 2009. Anche qui c’entra l’amore, perché vita e arte viaggiano spesso a braccetto, soprattutto quando si passano tante ore chiusi in un teatro. «Galeotto fu Pinocchio. Luca mi ha insegnato a manovrare quelle grandi marionette. Io ero piccola di statura e loro cercavano attrici minute. Avevo vent’anni ma sembravo una bambina. Luca doveva insegnarmi a muovere Pinocchio. Ci siamo innamorati persi dopo due secondi e siamo stati insieme cinque anni. (Siamo ancora legatissimi). Ho fatto due anni di tournée con loro. Però intanto lavoravo all’Elfo e in seguito ho cominciato al Piccolo».

Ho studiato la tua storia. Al Piccolo nel 2010 hai fatto Garcia Lorca, Donna Rosita nubile, e sei stata nominata ai Golden Graal come miglior attrice drammatica. In quello stesso anno hai fatto Sirene al Libero e il Processo a Cavour con Ruggero Cara e Gherardo Colombo, scritto da Augias e Ruffolo.
«Ma prima c’è stato Happy Family già ai tempi della scuola. Al secondo anno di Paolo Grassi sono stata notata da Alessandro Genovesi, che all’epoca cercava una ragazza che sembrasse una minorenne. In teoria non potevi lavorare in Teatro se eri al secondo anno, ma il direttore lungimirante dell’epoca mi disse: “Vai pure”. Da lì ho iniziata una lunga tournée con l’Elfo, che poi si è prolungata per due anni. Intanto però ho fatto un provino al Piccolo, dove mi hanno presa, e ho lasciato Happy Family. Poi ho lasciato il Piccolo per andare al Bellini di Napoli».
Una vita movimentata. Al Bellini sei partita da La Ciociara.

«Ero Rosetta, la figlia di Donatella Finocchiaro. È stato lo spettacolo che mi ha fatto conoscere a Napoli. Da lì poi non me ne sono andata più. Ho fatto tutti gli spettacoli prodotti in seguito, l’Odissea, Arancia Meccanica, Il giocatore di Dostoevskij, l’Otello...»
Per l’Elfo invece hai fatto due spettacoli di cui si è parlato molto: Strada Provinciale40 e La prostituzione raccontata al mio omeopata.
«Che mi hanno permesso di conoscere quelle che sono tuttora le mie migliori amiche. Le due registe avevano iniziato a collaborare con i Padri Somaschi per portare il tè alle prostitute. C’è un luogo comune sulle ragazze che
lavorano per strada, l’idea che facciano uso di alcolici, che si ubriachino, mentre in realtà loro stanno attentissime, devono rimanere lucide, in modalità sopravvivenza, e quando fa freddo bevono tanto tè caldo. Abbiamo dovuto conoscere quel mondo. Io sono rimasta sconvolta dalle testimonianze di quelle donne. Ho ancora i brividi adesso, se ci penso. Quell’esperienza ha unito tantissimo noi ragazze. Il Teatro è meraviglioso per questo. Sei lì a provare giorno dopo giorno, ripeti il testo, lo vivi, entri nei dettagli. Quando abbiamo fatto Dostoevskij al Bellini passavamo i pomeriggi ad accapigliarci su ciò che volesse dire ogni singola pagina. È bellissimo. Cresci come persona. Dove lo trovi, oggi, un privilegio del genere?»
Una citazione la merita anche il Tito Andronico per la regia di Gabriele Russo.
«L’ho perfino tatuato. Mi sono incisa Tamora sulla pelle. Io amo il Tito Andronico, è uno dei miei testi preferiti di Shakespeare. È poco conosciuto, quasi horror, splatter. È gratuitamente crudele. Un sequel di orrori reiterati. In Paolo Grassi al secondo anno l’avevo portato come studio. Quando mi hanno chiamato per fare Tamora è come se si fosse chiuso un cerchio. In più nel 2019 abbiamo debuttato al Teatro Argentina di Roma, il sogno di chiunque».
Da sinistra, Martina Galletta in “Lezioni da Sarah”, nei panni di Giulietta Masina, in “Din Don” e nello spettacolo “Dignità autonome di prostituzione”



37 APRILE 2023 36 APRILE 2023
Galletta
Martina
(foto di Max Moore)
Io alterno prostitute e suore, solitamente. Di suore ne ho fatte parecchie, in tutti i “Din Don” con Enzo Salvi. Le prostitute soprattutto a teatro. In un certo senso, trovo che sia una mia responsabilità femminista dare voce anche a loro
Sul tema della prostituzione, in senso lato, c’è anche Dignità autonoma di prostituzione. Più che uno spettacolo, un’esperienza. Che tornerà in scena a giugno a Napoli a Castel Sant’Elmo (in co-produzione col Bellini).
«Lo faccio ormai da 9 anni. Il format è di Luciano Melchionna da un’idea di Betta Cianchini e Luciano. Lui il teatro lo destruttura, lo fa letteralmente esplodere, toglie la platea, le sedie. Di solito arriva tanta gente, anche mille-duemila persone, e si ritrova dentro un inizio che cambia sempre, con canzoni, performance, attori dappertutto che fanno cose... La gente a volte si siede per terra, non capisce cosa sta succedendo. Poi, dopo un’oretta, c’è una presentazione, vengono distribuiti dei dollarini finti, e noi, attrici e attori, veniamo presentati come nei bordelli. La gente sceglie e ci compra. Veniamo venduti come prostitute che fanno sesso. Ognuno poi ha un luogo in cui andare, c’è chi si porta dietro un gruppo di persone e chi un solo spettatore, e una volta arrivati sul posto c’è il monologo, drammaticissimo. La gente rimane sconvolta. Poi torniamo giù e prendiamo altra gente. Una follia organizzata. Lo abbiamo fatto al Bellini per dieci anni. Ma anche al Colosseo di Torino, al Parenti di Milano, al Brancaccio di Roma... Facciamo la gara a chi perde più chili per lo sforzo. Io ne ho persi sei quest’anno».
Sei già stata nei teatri più grandi d’Italia. «Grazie soprattutto al Bellini, oltre che al Piccolo. Ho avuto la fortuna di vivere l’era delle grandi tournée, ormai quasi scomparse. Le produzioni che partono e stanno in giro per sei mesi. Ora lavoro di più nell’audiovisivo, che dà più visibilità e popolarità, ma il teatro mi manca». Uno spettacolo a cui tieni particolarmente?
«Lezione da Sarah. Partito in epoca pre-pandemica. Lo abbiamo presentato in anteprima al Festival di Todi, ma dovevamo debuttare a Roma. Il giorno prima dell’esordio hanno deciso il lockdown. I miei genitori erano venuti per vederlo e sono dovuti scappare a Milano prima che i treni venissero fermati. È uno spettacolo bellissimo e tostissimo. Sulla falsariga dell’Elvira di Jouvet, meta-meta-teatrale. Si ipotizza una Sarah Bernhardt, che è Galatea Ranzi, e una giovane allieva alle prime armi, che sono io. Sono tre blocchi: all’inizio Marie, l’allieva, non è capace, è quasi patetica, ma alla fine diventa bravissima. A livello attoriale è molto difficile, devi dosare le cose. Galatea mi propone vari testi, faccio sia Ofelia che Amleto. L’idea, alla fine, è di riuscire a interpretare Fedra. Questo spettacolo ha tutta la poesia del Teatro come la intendo io, la sua magia, i vecchi attori morti che stanno lì con te. La regia è di Ferdinando Ceriani. Lo riprenderemo».
A proposito di spettacoli di cui hai anche scritto la musica, c’è il delirio di FreeTime (testo dei fratelli Presnyakov e di Gian Maria Cervo, regia di Pierpaolo Sepe).
«Una follia chimica totale, in cui io suono il synth, canto, accompagno quasi tutto lo spettacolo e poi divento un personaggio, entrando in scena. E tutto questo lo faccio quasi nuda. Lo facciamo da tre anni e ancora non abbiamo capito di cosa parla».
Parliamo anche di cinema e tv? Immagino sia stato emozionante interpretare Giulietta Masina (Permette? Alberto Sordi).
«Quando mi hanno chiamato per assegnarmi la parte, dopo un momento di grande felicità, mi sono detta: “Oddio adesso devo fare Giulietta Masina davvero, come faccio?”. Mi ero documentata tantissimo. Non parlavo d’altro, non mangiavo, non dormivo, stavo solo con Giulietta. So tutto su di lei, tutto. È stato molto bello, un set pazzesco, a partire dal lavoro con Edoardo Pesce, ma anche con tutti gli altri colleghi di quel film, per non parlare del regista Luca Manfredi».
La prima esperienza cinematografica però è stata con Roberta Torre.
«I baci mai dati. Anche quella è stata una bella botta, perché siamo andati a Venezia, con il red carpet e tutto. Siamo stati anche a Cannes».


In tv l’elenco è lungo: Din Don, Don Matteo, Un passo dal cielo, Il paradiso delle signore...
«Io alterno prostitute e suore, solitamente. Di suore ne ho fatte parecchie, in tutti i Din Don con Enzo Salvi. Le prostitute soprattutto a teatro. In un certo senso, trovo che sia una mia responsabilità femminista dare voce anche a loro. Una volta ho fatto anche la suora prostituta... Nel Paradiso delle signore ero cattivissima. Finalmente, per una volta, potevo essere perfida.
La perfida Giovanna. Ho vissuto molto il set girando quella serie».
Cose che vorresti fare in futuro?
«A teatro Tennessee Williams, Un tram che si chiama desiderio Ma anche l’Arkàdina del Gabbiano».
Cose nuove in arrivo?
«Ho appena girato un film molto bello. Un action movie. Ho un ruolo fighissimo, con tante scene di fight. Ho lavorato con degli stunt molto bravi perché ho dovuto imparare a combattere. Il regista è Mario Parruccini. L’ultimo ciak è stato qualche giorno fa (inizio marzo, ndr). Serviva una bella ragazza con i capelli lunghissimi, stronza, che mena la gente. Mi piace fare la cattiva».
39 APRILE 2023 38 APRILE 2023
Martina Galletta
(foto di Eolo Perfido)
(foto di Paolo Gavardi)
E a teatro?
«Adesso sto facendo Una relazione erotica. Questa estate lo porteremo ai festival e poi andremo in tournée. È uno spettacolo che indaga sul rapporto aperto. In scena c’è una coppia in cui un lui e una lei si raccontano le proprie fantasie. Ma a un certo punto lei (io) decide di fare sul serio, di aprire davvero il rapporto. La coppia con cui flirtiamo viene presa dal pubblico.

Lavorare con Marco (Gobetti, attore co-protagonista, ndr) e Giulio (Baraldi, autore del testo e regista dello spettacolo, ndr) è stato molto bello. Le musiche di Marco Turriziani sono meravigliose».
Nel frattempo hai anche scritto un romanzo. Da dove è uscita Britta, la protagonista? «Boh».
Un po’ ti assomiglia.
«Magari! In realtà ho cercato di mettere pezzi di me in tutti i personaggi. Non tutti sono riusciti. La suora, ad esempio, è troppo bidimensionale».
Ma la suora, più che un personaggio, è una funzione. Serve a far avanzare la trama.
«In effetti il giallo ha bisogno di funzioni più che di personaggi. Ma Agatha Christie, il mio modello, riusciva a far diventare i suoi personaggi così profondi! Per questo sono così belli i suoi romanzi, molto al di là del “chi ha ucciso chi”. In Poirot e la salma, ad esempio, c’è la descrizione di un rapporto d’amore che è di una bellezza! La trovo molto sottovalutata come autrice. Come si può definirla semplicemente “giallista”?»
Nel tuo libro, in realtà, oltre al giallo ci sono anche il noir e il mélo, c’è la commedia di costume, il romanzo storico...

«Sì, è una commistione di generi».
Perché l’hai ambientato in quell’epoca?
«Io adoro quell’epoca. Anche il nuovo romanzo sarà ambientato nel ‘38-’39. Ho letto qualsiasi cosa su quel periodo».
C’è anche “l’impegno”: storia, politica, la follia nazista, l’odio razziale.
«Infatti nel prossimo toglieremo il giallo, sarà un romanzo solamente storico. La seconda parte della storia di Britta la scriverò più in là».
Dove hai trovato il tempo per scriverlo?
«All’inizio non sapevo come fare. Lo scrivevo giorno per giorno, non avevo le idee chiarissime. Ma in realtà io ho sempre scritto per il Teatro. Ho adattato testi, ho scritto monologhi. Anni fa un mio racconto è stato tra i finalisti del Campiello Giovani... Diciamo che l’ho preso come un lavoro. Mi alzavo la mattina, studiavo, poi pranzavo e scrivevo finché non avevo finito dieci cartelle. Infatti ci ho messo quaranta giorni esatti. Non potevo fare altrimenti, se no mi sarebbe sfuggito. Dovevo stargli appresso. A un certo punto ho avuto la chiara percezione che fossero i personaggi a indirizzarmi. Ed è successa una cosa assurda: mi sono innamorata del mio protagonista maschile. A volte, mentre ero in giro a correre, speravo di incontrarlo girando l’angolo».
Già, la corsa, il “running”. È una delle mille cose di cui potremmo parlare con Martina. Dopo un’oretta e mezza di chiacchiere e vino che fa girare la testa, Martina rimane una “macchina da guerra”, ricorda, riflette, risponde a ogni domanda senza perdere un colpo. Appena si svuota il bicchiere, lei si alza e lo riempie, continuando a parlare, senza perdere il filo del discorso. In un certo senso, Martina Galletta è un suo personaggio. Che però non nasconde le sue fragilità. Che si racconta con sincerità. E fa dell’autoironia per non dover parlare d’amore: «Beviamoci su che è meglio... Esco da una relazione
di quasi dieci anni. Funzionava. Ora è finita». Martina è molto orgogliosa delle donne da cui è sbocciata: la madre, «cinquanta chili di forza», e la nonna, «bellissima, incinta a 18 anni, abbandonata dal nonno che scappò con una barista. Pittrice stupenda. È bella anche adesso che ha novant’anni».
E così arriviamo al tema del “femminismo”. Io me ne esco con una di quelle frasi che usano gli uomini per fare bella figura. Tipo: “Mi piacerebbe che tutti i ruoli occupati dagli uomini venissero dati alle donne, per una cinquantina d’anni almeno, sono certo che molti problemi del mondo verrebbero risolti”.
40 APRILE 2023
Martina Galletta
(foto di Paolo
(foto di Sebastiano Gavasso)
Gavardi)
Io ovviamente voglio essere amata per la mia intelligenza, anzi, per la persona che sono. Ma non vedo perché dovrei vestirmi di più o di meno per essere amata...
I social sono un giocattolo per adulti. Che senso ha che io mi metta a filosofeggiare su Instagram? Se mi vuoi vedere o vuoi capire chi sono, vieni a Teatro
Di sicuro, dice lei, «se governassero le donne non ci sarebbero più guerre. Noi siamo “matrice vitale”. La guerra è una cosa maschile, fa parte del suo essere possessivo, la territorialità. Io vorrei un mondo in cui non ci sono il mio e il tuo, ma il nostro. Ho anche sempre cercato di aprire la coppia, con serenità, senza sotterfugi. Se lo fai con consapevolezza è bellissimo, non c’è nulla di male, è molto interessante e divertente. Non è che non sia gelosa o possessiva, ma cerco di portare questa cosa su un altro piano».
Poi arriva un’annotazione di linguaggio. «Ti faccio notare che hai detto: “che tutti i ruoli venissero dati...”». Beccato! «La società in cui viviamo è così. Voi ci date. Come fosse una concessione. Perciò dico che in questo mo-
mento non c’è alcun tipo di parità. È una cosa inconscia. Perché sono sicura che tu non la pensi così. Ecco il “male”. Per questo il linguaggio è importante. Ma l’eccesso di pedanteria nel politically correct sta rendendo la questione del tutto ridicola. Io credo profondamente in questa battaglia, ma il linguaggio è importante se si cambiano il significante e il significato, non le desinenze. Altrimenti è solo forma. Altrimenti è solo “Me Too”, che ce l’ha messo in quel posto»
Ed eccoci al dunque. Il suo modo di essere e di porsi. Il significato della sua libertà.
«Io sono molto criticata per come mi pongo, dagli uomini e dalle donne».
Per l’immagine che dai di te?
«Sì. Perché io apparentemente posso sembrare figlia del patriarcato, e invece sono proprio il contrario. Semplicemente non ho paura di mostrare il mio corpo. Non ho paura della libertà sessuale».
Ti giudicano.
«La mia “esposizione fisica” viene ritenuta eccessiva. La cosa divertente è che poi c’è invece chi mi dice: “che bello il rapporto che hai con il tuo corpo”. In realtà io ho un rapporto terrificante col mio corpo, sono anoressica, dismorfofobica, ce le ho tutte. Ma non ho problemi a esporlo».
A dir la verità, se uno guarda le tue foto social, l’impressione è che ti piaci. Ma a volte c’è anche una paradossale timidezza in ciò che fai.
«Infatti sono timidissima. Grazie Signore che qualcuno se ne accorge! Ma lo sono in certe cose. Non ho problemi a parlare di sesso, ho una timidezza che è legata ad altro». Quindi che rapporto hai con la tua bellezza?

«Che io non ritengo tale, francamente». Questo lo devi lasciar dire agli altri... Il problema è la “donna oggetto”, la mercificazione della bellezza. Tanto che molti finiscono per pensarla in contrapposizione all’intelligenza, arrivando a nasconderla o negarne il valore per principio.
«Io ovviamente voglio essere amata per la mia intelligenza, anzi, per la persona che sono, per la mia affettività. Ma non vedo perché dovrei vestirmi di più per essere amata di più. Così come non vedo perché dovrei svestirmi di più. Io penso di poter fare quel cazzo che mi pare ed essere guardata per ciò che sono. Semmai odio lo sfruttamento della bellezza. Questo sì che è meschino. Mi è successo di ricevere proposte molto esplicite, sul lavoro, ma non ho mai ceduto.
In questo sono di una serietà glaciale. E se si crea il minimo sentore di dubbio, mollo. Ho perso tante occasioni per questo. Quello sì che è un utilizzo “patriarcale” della bellezza. Peraltro è una cosa che fanno anche gli uomini. Ma se voglio postare una foto delle mie tette, perché non dovrei farlo? Tra dieci anni non saranno più così, godiamocele! Ti dicono “tu devi essere libera” ma in realtà non sei libera di fare niente». Forse i giudizi dipendono da chi ti conosce solo sui social.
«I social sono un giocattolo per adulti, che senso ha che io mi metta a filosofeggiare su Instagram o Facebook? Se mi vuoi vedere o vuoi capire chi sono, vieni a Teatro. Mi sono sempre sentita impegnata anche a livello politico, ho sempre fatto cose, ma non ne parlerei mai sui social, perché mi sembrerebbe di spoetizzare, di togliere valore a idee che hanno un’estrema importanza. Il desiderio di piacere a tutti, che è quello che ci porta ai social, è ridicolo. Non piaceremo mai a tutti. Ci possono capire tre o quattro persone nella vita».

Tante vale giocare, dici tu.
«Se tu scrivi su un social un pensiero strutturato, puoi avere l’illusione di aver fatto qualcosa. E invece non hai fatto niente. Anche questo è un modo che hanno trovato per “controllarci”. Se tu invece molli i social e vai a raccogliere la plastica per terra, o vai a una manifestazione, hai fatto davvero qualcosa.
Mi ricordo una manifestazione, dopo la morte di George Floyd, in cui hanno fermato me e a una trentina di ragazzine: ci hanno sequestrato i documenti. Ma almeno abbiamo fatto qualcosa. Se scrivo Black Lives Metter su Facebook ho solo scritto una frase».
Tu non sei l’oggetto ma il soggetto che gioca. Questo si vede.
«E mi fa piacere. Io le foto le scelgo e le edito». Ma il fruitore dei social vede ciò che vuole.
«So come vengo percepita. Ti farei leggere i messaggi che mi arrivano in Direct. Sono comicissimi. Ci sono anche persone che ho conosciuto così e che stimo. Ma la mediocrità della maggior parte dei messaggi è pazzesca. Si va dall’insulto, cioè il complimento pesantissimo, al romanticismo, perché c’è anche chi si vuole accasare, fino allo stalking».
E tu come reagisci?
«Mi ferisce. Mi ferirà sempre».
Il gioco vale la candela?
«Sì. Vorrei essere in qualche modo di esempio. Non perché io sono “stocazzo” ma perché la mia libertà me la sono conquistata. Lo so che c’è tantissima oggettificazione delle ragazzine, ovviamente non voglio spingerle in quella direzione, però non vorrei neanche dare l’idea che puoi essere giudicata intelligente solo se ti metti il maglione a collo alto. Ma chi l’ha deciso? Ma perché? Mi sfugge il senso di questa cosa. Mi faccio i miei pianti, perché a volte è doloroso, ma vado avanti».
Qual è la tua "redness", ciò che ti dà la forza di alzarti la mattina?
«Ne ho due. Una forte spinta creativa, che a volte è quasi ossessiva. E il Gewurztraminer».
E allora, cin cin! Al teatro, alla bellezza, a chi sfida il presente guardandolo negli occhi, mentre l’anima vaga altrove, nel senza-tempo. Un brindisi al desiderio e all’amore, che spesso è un casino, aperto o chiuso, sadico o romantico, ma vale sempre la pena. Quasi sempre. Tamora non va fatta arrabbiare.
43 APRILE 2023 42 APRILE 2023
Martina Galletta
(foto di Paolo Gavardi)
(foto di Paolo Gavardi)
Va’ Sentiero: in cammino per scoprire la vera Italia
7887 chilometri in tre anni, un’impresa collettiva, attraversando a piedi Alpi e Appennini, da Nord a Sud
«Camminare, scoprire, condividere: Va’ Sentiero è molto più di un viaggio. È un nuovo approccio alla montagna, il seme di un cambiamento, il primo passo di un lungo cammino»
La premessa è questa. E contiene il senso di un progetto che già di per sé è grande, anzi gigantesco (lungo quasi 8000 chilometri), ma per certi versi è solo l’inizio di qualcosa che deve ancora accadere. Un nuovo modo di intendere il “cammino”.
Di percorsi da fare a piedi, in giro per l’Italia, ce ne sono tanti, sempre di più (su Redness ne abbiamo già parlato diffusamente sul numero di settembre). Ma
qui si parla di qualcosa che tiene insieme il locale e il globale, un percorso che unisce l’Italia ma che esalta e preserva le sue differenze, la specificità di ogni singola valle, con la sua identità popolare.
Che mette insieme un approccio moderno, web e social, di condivisione della conoscenza, con la valorizzazione della comunità, dello stare fisicamente insieme, coinvolgendo le persone e le realtà locali nella costruzione dei vari percorsi.
Che riscopre la montagna – tutta la montagna, Alpi e Appennini, dal Trentino alla Sicilia, passando attraverso Abruzzo e Molise - non come luna park salutista, luogo di settimane bianche e di turismo slow di lusso, ma nella sua storia, cultura, spiritualità, nella sua bellezza naturale e nell’esperienza umana che consente di fare.
Trovate la premessa nella home page del sito vasentiero.org, che già è un viaggio di per sé, con le sue immagini spettacolari, i video che riassumono luoghi e volti, il percorso spiegato tappa per tappa, con una messe notevole di informazioni.
Si parla del “trekking più lungo del mondo”: «Il Sentiero Italia è un lungo filo rosso che unisce tutto lo Stivale: un caleidoscopio delle montagne italiane. 350.000 metri di dislivello. 20 regioni. 364 tappe.

Giovanni Ciulla, pastore siciliano, è uno dei personaggi incontrati lungo il cammino, protagonisti della mostra dedicata a “Va’ Sentiero”. Nell’altra pagina, un’immagine di Monte Marmagna, sull’Appennino tosco-emiliano

Tra il 2019 e il 2021 la spedizione Va’ Sentiero lo ha percorso e documentato per realizzare una guida digitale a disposizione di tutti: mappe, tracce, info tecniche e culturali, foto, video».
Tutto è partito da tre persone, Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono, che alla fine ne hanno coinvolte più di tremila nella «spedizione più pazza del mondo, sul sentiero più lungo del mondo, nel paese più bello del mondo». Entrate nella sessione
“Il racconto” e vi farete un’idea del perché si parla di un percorso «corale e condiviso»: qui ci sono i video-reportage, i ventisei capitoli del viaggio narrato (in parole e immagini) per il Touring Club Italiano, ma anche la sezione “terra & gusto”, per ricordarci che «c’è sempre un piatto locale da scoprire, un vino per brindare. E dietro, un mondo».
«Nuto Revelli lo chiamò “il mondo dei vinti”. Un’Italia che ci ha accolti a braccia aperte, coi suoi paesaggi diversi, i dialetti, le storie, le ricette, i personaggi così generosi»
Ma soprattutto c’è l’immane guida digitale dedicata al Sentiero Italia. Un tesoro formidabile, pieno di mappe, descrizioni dei sentieri, highlights, strutture in cui soggiornare, cose da fare, vedere, assaggiare, sperimentare, regione per regione. Cliccate, tanto per provare, sulla Lombardia, e scoprirete 35 possibili tappe per 635 chilometri. In Trentino ce ne sono 18, tutte imprescindibili. In Molise (7 tappe) e Basilicata (8 tappe) quelle forse meno conosciute e percorse, ma che vale davvero la pena scoprire. 42 le tappe in Piemonte, 32 in Sardegna e Sicilia, 30 in Puglia. Per ogni tappa trovate una mappa dettagliatissima, la traccia Gpx da scaricare, i dislivelli, le fotografie,
ma anche il periodo migliore per intraprendere il cammino, la percorribilità e varie “note particolari”, dettagli su “cosa mangiare” e “dove dormire”.
Un lavoro prezioso, la cui portata verrà apprezzata nel corso degli anni a venire, anche perché si tratta di una piattaforma che può essere ampliata e approfondita all’infinito.
Partendo da un patrimonio del genere, era quasi inevitabile che ne nascesse anche un libro. Infatti è uscito a metà marzo un volume edito da Rizzoli, Va’ Sentiero – In cammino per le Terre Alte d’Italia, che riassume l’impresa, lo spirito del progetto.
45 APRILE 2023 44 APRILE 2023
Foto di Sara Furlanetto
L UOGHI
Ci trovate una scelta di venticinque percorsi, con le parole di Yuri Basilicò (che abbiamo intervistato) e le immagini di Sara Furlanetto. Inutile dire che l’apparato iconografico è notevolissimo. Ma ciò che spicca è soprattutto il tono e lo stile della scrittura, personale e ricco di spunti, lontano dal linguaggio asettico del tradizionale libro-guida.
Lo si capisce fin dall’introduzione, in cui Yuri racconta l’inizio buffo, quasi naïf, di questa storia, quando nel gennaio del 2017 si presentò alla sede del Club Alpino Italiano chiedendo di parlare per cinque minuti col presidente: «Dall’altro capo del citofono, dopo qualche secondo di malcelato sgomento, la portinaia mi ha dovuto spiegare che per parlare col presidente o con chiunque altro occorreva, chiaramente, avere un appuntamento».
Voleva parlare del Sentiero Italia, che lui, italiano, aveva sentito nominare per la prima volta da tre ragazzi scandinavi in Corsica, suscitando la sua curiosità.

Progettato a lungo, realizzato (in parte) e presentato alla stampa,
quel lungo percorso in realtà non è mai diventato realtà. «Più leggevo e più il Sentiero Italia mi sembrava l’emblema (croci e delizie) delle montagne che avevo iniziato ad amare durante l’università, quando avevo scoperto che per viaggiare lassù non servivano quattrini, c’erano i bivacchi (…) Mi sono figurato un semplice piano: realizzare una spedizione aperta a tutti, in stile Forrest Gump, che esplorasse e documentasse l’intero percorso, per farlo conoscere in tutto il mondo. Di getto, ho scritto un paio di pagine, alla mattina le ho infilate in uno zainetto e ho preso il treno per Milano».


Quel giorno riuscì a parlare sulle scale con un redattore del Touring Club Italiano, ottenendo i nomi delle tre persone che avevano ideato il Sentiero Italia, Riccardo Carnovalini, Teresio Valsesia e Giancarlo Corbellini, che lo convinsero ad andare fino in fondo.
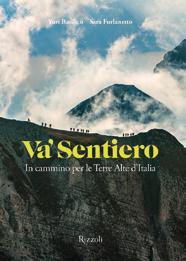
Lo fece creando l’associazione Va’ Sentiero insieme a due amici, Sara e Giacomo, «con cui in passato avevamo fantasticato di cambiare vita». C’era tanta ingenuità, certamente, ma anche un grande
sogno, tanta passione e un bel po’ di talento (ognuno il suo, fare o pensare, scrivere o fotografare, organizzare o comunicare). Due anni di lavoro, una promettente coincidenza - il CAI ha intrapreso un progetto di restauro di tutto il percorso - e la spedizione era pronta per partire con un team di giovani volontari: «Il 1° maggio 2019, in una mattina di sole sulle rive del Golfo di Trieste, abbiamo letto ad alta voce i versi di una poesia di Kavafis: “Quando ti metterai in viaggio per Itaca…”. E siamo partiti, sulla strada per Itaca».
La storia è tutta da leggere e scoprire, alimentata dal motto “walk, discover, share”, dilatata dall’emergenza sanitaria (tre anni invece dei due preventivati), diventata «un esperimento di viaggio collettivo» a cui hanno partecipato più di tremila persone provenienti da sedici Paesi diversi, oltre che dai territori attraversati. «Abbiamo dormito ovunque: tenda, stalla, rifugio, palestra, bivacco, canonica, casa di chi apriva la porta. Sono nati grandi amori e amicizie, abbiamo sudato insieme e, su tutto, abbiamo cantato, mangiato e bevuto». 7887 chilometri percorsi, toccando sedici parchi nazionali, scoprendo «un’Italia spesso contadina, rimasta fuori dai grandi circuiti, in parte preservata dalla livella della globalizzazione ma logorata dallo spopolamento, depredata dalle sirene dell’industrializzazione. “Il mondo dei vinti”, come lo chiamò Nuto Revelli. Un’Italia a noi sconosciuta, che ci ha

accolti a braccia aperte e fatto innamorare coi paesaggi sempre diversi, i dialetti mutevoli e le storie, le ricette, i personaggi così generosi». Il libro è “un atlante ispiraziona-
le”, una specie di introduzione alle bellezze e i segreti del Sentiero Italia. Non è stato facile scegliere venticinque tappe tra le 365 descritte nella guida digitale.
46 APRILE 2023
A Sicignano degli Alburni (Campania). A fianco, il Rifugio Val Viola (Lombardia). Nell’altra pagina, l’Eremo di Santa Maria Infra Saxa (Grotte di Frasassi, Marche). Più in basso, Sara Furlanetto scatta delle foto sotto il Bernina.
Il risultato, però, è un suggestivo viaggio dall’estremo nord-est alle isole, ascoltando Il Piave che mormora e attraversando I Monti Corallini, inseguendo pizzoccheri, stambecchi e aquile randagie, ammirando I Ciclopi delle Alpi, Laghi santi e diavoli tentatori, L’eco della Sibilla e la Cresta degli Dei, il Cilento, il Pollino e la Calabria selvaggia, fino ad arrivare Ai piedi di Venere e farsi contagiare dal
Mal di Sardegna
Le descrizioni sono piene di emozioni, ma anche di storia, folklore, mitologia, scienza, letteratura, tradizioni locali. Ci sono aneddoti e curiosità. La «dimensione crepuscolare e insieme elettrica,
inspiegabilmente spirituale» della Slavia Friulana e una Lombardia inaspettata, in cui scoprire il piacere del bouldering (l’arrampicata libera su pareti in granito, ad esempio al Ghiandone). C’è il Marguareis, definito la montagna più bella delle Alpi, e la macaia, di cui cantava Paolo Conte, la bonaccia di mare che crea un suggestivo strato di nubi basse trafitte dalla luce. C’è un percorso tra guerra e pace, che parte dalla Linea Gotica e arriva all’Eremo di Camaldoli, e c’è la Costiera Amalfitana vista dall’Alta via dei Lattari.
Per finire con una pagina poetica dedicata al fascino della montagna, «sinonimo del “sovrumano”», dove

«il nostro sguardo trova uno sconfinato appetito. La montagna ci dona la vastità, liberandoci dall’ortodossia dei perimetri – crea spazio e non importa se quello spazio è indicibile, o impercorribile. La montagna sopravvive ai nostri limiti e, con lei, il nostro senso del magico». Quando si cammina in alta quota, si possono studiare le mappe, intuire le pendenze, capire le distanze, ma la dimensione più importante è quella del tempo, quello necessario ad esempio a superare una vallata (prima che faccia buio), ma anche quello interiore, esistenziale, «il solo bene su cui definiamo il nostro grado di libertà, insegna Pepe Mujica». Scrive Juri Basilicò: «Poche altre cose, come la montagna, sanno riempire e insieme svuotare, regalare l’essenziale e sgomberare il superfluo. Inspira, respira, sembra dirti solo questo».
Verrorep erfererum inus aut ea voles nosanis samus et diamet eos modi cus ut venda volesti onsequi aut libus accatem eseque ommodip saestio

49 APRILE 2023 48 APRILE 2023
«Poche altre cose, come la montagna, sanno riempire e svuotare, regalare l’essenziale e sgomberare il superfluo»
Supramonte di Oliena, in Sardegna. Nell’altra pagina: la Rocca di Sciara svetta tra le vie di Caltalvuturo (Madonie, Sicilia)
YURI BASILICÒ CI RACCONTA COME È NATA QUESTA AVVENTURA: LONDRA IN AUTOSTOP, LA CORSICA A PIEDI, I BIVACCHI, IL
La storia del Sentiero Italia (ri)parte nel 2017 da uno “smarrimento personale”. Ci racconti come è nata questa avventura? Cosa c’è dietro?
Quando ho terminato l’università, sono finito a Londra, in modo del tutto casuale, insieme al mio migliore amico. Stavamo viaggiando in autostop, ma quando siamo arrivati in quella città, abbiamo deciso di fermarci per un po’. Alla fine ci siamo rimasti due anni. A quei tempi suonavamo, eravamo un duo: io chitarra e lui voce. Suonare era il nostro sogno. Poi però le cose non sono andate esattamente come ci aspettavamo, Londra è una città molto impegnativa e alla fine ci siamo un po’ “persi”. A quel punto, anche per preservare l’amicizia, abbiamo deciso di separarci e ciascuno ha cercato la sua via.
Tu l’hai trovata camminando.
Avevo ormai 29 anni, non ero più un pivellino. Quando ho lasciato Londra ho vissuto uno di quei momenti in cui ti sembra mancare la terra sotto i piedi. In maniera piuttosto istintiva ho pensato di fare un viaggio a piedi e sono andato in Corsica, dove la via è arrivata, in qualche modo.
In Corsica hai scoperto casualmente l’esistenza del Sentiero Italia e ti è venuta voglia di approfondire l’argomento.
Sì, è andata così. Stavo camminando sul GR20 e ho incontrato degli escursionisti svedesi che mi hanno parlato del Sentiero Italia.
Quindi non eri un camminatore assiduo, un frequentatore di montagne. Assiduo no, ma amavo camminare, mi è sempre piaciuto viaggiare, in particolare durante gli anni dell’università. Non vengo certo da una famiglia di montanari, ma mentre studiavo ho scoperto l’esistenza dei bivacchi, luoghi sostanzialmente gratuiti, ideali per uno che frequenta l’università. Mi sono innamorato dei bivacchi e ho fatto innamorare anche amici e amiche. Della montagna ho sempre amato la sensazione di spazio, di silenzio, di avventura.


Hai coinvolto due amici, che volevano cambiare vita come te, e insieme avete risvegliato il “gigante addormentato”, il Sentiero Italia. Evidentemente ci stava aspettando.
Ma perché quel progetto era stato abbandonato?
Domanda da un milione di dollari. Io mi sono fatto un’idea in base alle chiacchierate che ho potuto fare con le tante persone che lo avevano immaginato. Quando l’idea nacque, negli anni ‘80, era assolutamente in anticipo sui tempi, non c’era la slow way, non c’era Santiago, figuriamoci le “alte vie”. La montagna era frequentata da un pubblico ristretto, era appannaggio di pochi. Il progetto all’epoca ebbe un successo più che altro mediatico. Dal punto di vista dell’infrastruttura, nel 1995, ci fu una segnatura parziale, più funzionale all’evento in sé dell’inaugurazione, piuttosto che a costruire un sentiero che restasse. La prima forma di manutenzione di un sentiero viene fatta dalle persone che lo frequentano e lo battono, altrimenti viene perso nel giro di pochi mesi.
Immagino ci fossero anche problemi di tipo economico. Era un’operazione molto costosa. Assolutamente.
Cosa significa concretamente riattivare un sentiero di 7800 chilometri? Noi come Va’ Sentiero non ci siamo occupati della manutenzione fisica. Quello è un lavoro molto vasto fatto dal CAI, tuttora in corso. La prima fase è quella del tracciamento. Le montagne cambiano nel tempo, quindi bisogna andare a capire se si può ancora passare per una certa via o farla deviare. Poi c’è tutta la parte segnaletica, perché in quarant’anni era bella che andata. Ma l’elemento più importante forse è quello della verifica logistica: dove facciamo dormire i camminatori? E qui c’è la possibile scelta tra i rifugi CAI (stando ad una certa quota) e altri luoghi che invece avvantaggiano l’economia locale, portando un indotto alle varie comunità sul territorio. C’è anche un grande disparità riguardo la presenza e il funzionamento dei rifugi tra alcune parti d’Italia e altre. Nell’Appennino è più difficile che sulle Alpi. Quindi la verifica delle tappe è un tema importante. Ci vorrà un assestamento che magari durerà anni. Il sentiero è molto lungo, alcuni tratti funzionano e altri ancora no. Se le cose vanno come spero, l’attenzione crescerà e anche territori che attualmente sono indietro capiranno l’opportunità e si allineeranno.
A tre mesi dalla partenza non avevamo un euro. In tre settimane abbiamo fatto un crowdfunding e abbiamo raccolto 32mila euro. Poi un sacco di persone si sono unite a noi lungo il percorso
51 APRILE 2023
Yuri Basilicò in alta montagna. Nella pagina a fianco, la carovana di Va’ Sentiero in arrivo a Visso
«In questi luoghi si è conservato qualcosa di autentico»
“GIGANTE ADDORMENTATO”
L UOGHI
Il Sentiero Italia si intreccia con altri Cammini già funzionanti. L’idea originale era proprio quello di inanellare diversi percorsi già esistenti. Cammini sparsi che sembravano quasi richiamarsi a vicenda.
Ma ci sono anche tratti pochi battuti, da scoprire. Penso ad esempio alla scelta di percorrere la Costiera Amalfitana più internamente.
Sì, abbiamo percorso l’alta via lungo la dorsale dei Monti Lattari. Un luogo incredibile.
Economicamente come avete fatto a organizzarvi? Sono tre anni di viaggio. L’economia della spedizione è stata un grosso problema. L’idea era di lavorare al sentiero come volontari. Senza stipendio. Il progetto ci piaceva, era una cosa bella da realizzare. L’obiettivo era finire la spedizione e avere un progetto in mano, una credibilità, un capitale esperienziale e conoscitivo, da trasformare poi in attività lavorativa. Quindi a bilancio nella spedizione c’era davvero poco. Ma erano comunque previsti tanti mesi di viaggio, alloggi, attrezzature... Quindi abbiamo cominciato a chiedere la sponsorizzazione di vari partner: a tutti l’idea piaceva, ma nessuno voleva essere il primo a esporsi economicamente. A pochi mesi dalla partenza eravamo ancora senza un quattrino.
Di quanti soldi avevate bisogno?
Avevamo calcolato 20 mila euro, per cominciare. Per sbloccare la situazione abbiamo deciso di fare un crowdfunding. Dovevamo partire entro tre mesi. Ci siamo detti: “Se le cose si sbloccano bene, altrimenti ci metteremo il cuore in pace”. In dieci giorni, letteralmente, abbiamo creato una campagna e abbiamo aperto i social. Fortunatamente il progetto è piaciuto, i media ci hanno aiutato molto e la campagna ha fatto il botto. Abbiamo superato di gran lunga l’obiettivo, arrivando a 32 mila euro. Successivamente abbiamo fatte altre due raccolte e complessivamente siamo arrivati ad oltre 100 mila euro. Questa cosa ci ha galvanizzato. E il successo del crowdfunding ha aperto tutte le altre porte, anche quelle degli sponsor.
Questi luoghi rimasti periferici non sono stati intaccati dalla globalizzazione, dall’uniformizzazione culturale. E poi c’è un legame delle persone col territorio in cui vivono che altrove si è perso completamente
E ha reso il progetto partecipato. Le persone, oltre a finanziarvi, vi hanno accompagnati nel cammino.
Questa è stata la chiave di volta, il fatto di avere le persone al seguito. Sostanzialmente siamo diventati un format. Chiedevamo alle persone di iscriversi. Alla fine abbiamo avuto 3000 iscritti, ma ne sono venute molte di più, un sacco di persone sapevano che passavamo e poi rimanevano con noi nel cammino.
Che Italia avete scoperto?
Tante Italie diverse. Estremizzando, potrei dire che ogni valle è diversa dall’altra. Oggi il cuore pulsante del paese, economico e culturale, è in pianura e sulle coste.
Le montagne e le valli si sono trasformate e si sono spopolate, nel giro di un secolo. Si percepisce chiaramente questo senso di abbandono, anche un certo scoramento. Non solo sull’Appennino, ma anche in una larga fetta delle Alpi (anche in Lombardia o nel Friuli, al di fuori dei grossi circuiti).

Si sentono alla periferia del mondo. Esattamente. Però in questo luoghi si è conservato anche qualcosa di autentico che non c’è più altrove. A me è sempre piaciuta la storia, sono una persona curiosa, ma in questi anni è come se avessi fatto tre master diversi dedicati alla nostra identità popolare, che non conoscevo. Questi luoghi rimasti periferici non sono stati intaccati dalla globalizzazione, dall’uniformizzazione culturale. Lo vedi anche semplicemente nel cibo. La varietà che c’è in montagna è incredibile. E poi c’è un legame delle persone col territorio in cui vivono che altrove si è perso completamente. Io ho vissuto per tanti anni a Pregnana, un piccolo paese in provincia di Milano. Ma io di Pregnana non sapevo assolutamente nulla. La cosa che mi colpisce sempre nei luoghi di montagna è l’attaccamento delle persone rimaste per i luoghi in cui vivono e anche l’orgoglio con cui li raccontano. C’è una rete fittissima di storie che si è cristallizzata. Per noi sono periferia, al massimo ci andiamo a passare il tempo libero, ma per secoli e millenni sono stati luoghi centrali, dal punto di vista difensivo, economico, culturale, specialmente l’Appennino. Si tratta di un’esperienza ricchissima e molto più profonda del solo camminare in luoghi bellissimi.
Cosa ne pensi dei Cammini? Rispondono a un bisogno profondo, a qualcosa di sostanziale, o pensi che siano una moda passeggera?
Che siano una moda è sotto gli occhi di tutti. Ma le mode, anche quando passano, spesso lasciano qualcosa. Il fatto che ci sia questo interesse crescente per il “turismo lento” ha fatto sì che ci sia stato un proliferare di Cammini. Di per sé questo è un dato positivo, c’è il desiderio locale di creare percorsi.
53 APRILE 2023 52 APRILE 2023
In cammino sui Monti Sibillini
Ma noi spesso abbiamo riscontrato che nascono dei Cammini senza avere un’infrastruttura fisica e organizzativa seria. E questo è problematico nel momento in cui c’è una dispersione di risorse e idee. Se una regione ha quarantasette cammini ma ne funzionano solo due, è un problema grosso. Se la persona che viene non trova una risposta efficace, non ci torna più. Forse sarebbe meglio individuare una strategia e, invece di quarantasette cammini, svilupparne bene cinque o dieci. L’anno scorso abbiamo lavorato con il Touring Club che ci ha chiesto una sorta di consulenza per individuare e censire i Cammini e capire quali funzionassero e quali meno.
Ce ne sono tanti fatti anche da persone in buona fede, con sincero entusiasmo, che però sono più sulla carta che per terra. Mi sembra che manchi una visione chiara a livello istituzionale.
Quando ho parlato con alcuni dirigenti al Ministero del Turismo, mi è sembrato che ci fosse la consapevolezza che in Italia i Cammini stanno crescendo, ma che manchi una strategia chiara.
Nel libro (e nel sito) ci sono indicazioni su cosa fare e vedere, dove andare a mangiare. Ma ci sono anche riferimenti culturali importanti, da Pepe Mujica a Nuto Revelli, personaggi storici, citazioni letterarie. C’è un pensiero dietro. Mi piacciono i collegamenti. E comunque il viaggio è stato davvero un continuo trovare dei riferimenti. Questo ci ha colpito molto. Quando abbiamo finito il viaggio avevo un’idea dell’evoluzione storica del nostro paese molto più chiara rispetto a quando avevo fatto l’esame di storia moderna italiana all’università.
Sviluppi futuri di Va’ Sentiero?
Vogliamo portare avanti il progetto, anche nel suo format. Ci siamo specializzati in una sorta di marketing territoriale, che è una cosa molto importante, nonostante la brutta parola. La documentazione di sentieri e lunghi percorsi, la ricostruzione della sovrastruttura informativa, ma dando anche una forma sociale a questo lavoro, portando fisicamente le persone a camminare con noi. Dopo il Sentiero Italia, abbiamo lavorato per proporre il format a enti e uffici del turismo. Ci piacerebbe portarlo avanti su queste tipologie di percorsi. Ad esempio tra un mese e mezzo saremo in Lazio e Abruzzo per un’esperienza sul Cammino Naturale dei Parchi, che va da Roma a L’Aquila, attraversando una serie di aree protette.
Quindi continuerai a vivere in cammino per un po’ “Per un po’”, hai detto bene. A me piace quando le cose cominciano a camminare con le proprie gambe. Anche perché io ormai vado per i 36 anni e questa è una cosa molto dispendiosa a livello energetico. Va’ Sentiero ormai è un format consolidato, su cui lavorano dei giovani che potrebbero anche esportarlo. Mi piacerebbe molto che diventasse internazionale.
Aspettiamo quindi anche un Sentiero Europa e un Sentiero Mondo. Perché no?
A settembre su Redness abbiamo dedicato un servizio a questo tema, citando il poeta-camminatore Luigi Nacci, che fa una distinzione netta tra il tempo vuoto della vacanza, tipico del turista, e quello pieno del viandante, in cammino. Sì, è una distinzione importante. Un po’ come quella tra il viaggiatore e il turista.
Tra il consumo e il vivere un’esperienza.
Per questo non bisogna applicare ai Cammini vecchie logiche. Il Cammino può offrire un’esperienza di turismo molto diversa da quella a cui siamo abituati, quindi è un errore cercare di replicare in questo ambito offerte che si trovano altrove, ad esempio dal punto di vista logistico. Non devi snaturare la realtà, l’autenticità di un luogo, che è il suo valore aggiunto, la sua diversità e la sua bellezza.


54 APRILE 2023
Il Cammino può offrire un’esperienza di turismo molto diversa da quella a cui siamo abituati. Non devi snaturare la realtà, l’autenticità di un luogo, che è il suo valore aggiunto, la sua diversità e la sua bellezza
L’arrivo
a Messina, il 25 settembre 2021, a Forte San Jachiddu. Nell’altra pagina, si celebra la fine della spedizione
La bellezza, ma anche l’isolamento e l’abbandono
Ma si può evocare la ricchezza ambientale e culturale incontrata in questi tre anni di viaggio. Si può dare un’idea della bellezza mozzafiato di certi luoghi, tra Alpi e Appennino, ma anche dell’atmosfera di abbandono che si respira in alcune valli italiane. Soprattutto si possono raccontare alcune delle persone conosciute lungo la via, con le loro storie, invitando noi che guardiamo e leggiamo a metterci in cammino.
zioni, coltivazioni. C’è il paesaggio trasformato dall’uomo, così come ciò che lo supera, da sempre, e che desta la nostra sconfinata ammirazione, un sacro timore ancestrale.
A dimostrazione di quanto i giovani siano consapevoli del fatto che «la salute del suolo, degli animali, dell’ambiente è imprescindibilmente legata a quella dell’uomo».
Non si possono riassumere 800 chilometri di cammino (quasi) e 3000 incontri (almeno) in una mostra.
Va’ Sentiero è approdata anche in Triennale a Milano (fino al 7 aprile, a ingresso gratuito, con il contributo di Cariplo), con un centinaio di immagini e un video per capire come è stato pensato e realizzato il progetto. Molto belle le fotografie di Sara Furlanetto, che raccontano cime e vallate, creste rocciose e faggeti magici, paesini fatti di poche case, pianure innevate, ma anche ghiacciai scomparsi nel nulla, luoghi spopolati e lasciati alla natura selvaggia. Ci sono panorami spettacolari accanto al racconto di feste, tradi-



Scrive Sara: «Il viaggio, la spedizione a cui ci siamo dedicati anima e corpo per raccontare una parte di Paese poco conosciuta, ci ha dato molto più di quanto ci potessimo aspettare. Passo dopo passo, valle dopo valle, abbiamo incontrato un’Italia inaspettata che ci ha accolti a braccia aperte e fatto innamorare con paesaggi sempre diversi, dialetti mutevoli e storie, ricette, personaggi così generosi. Allo stesso tempo, col passare dei chilometri e delle stagioni, abbiamo toccato con mano gli effetti del parossismo climatico e dell’abbandono, il senso di isolamento sociale, culturale, economico. Nei miei scatti ho provato a catturare la consistenza di quelle terre, di chi le abita; di restituire la loro bellezza e di ritrarre le loro criticità». Da notare i ritratti e le storie che punteggiano la piccola mostra-viaggio. A partire da quello di Giovanni “Lumeri” Ciulla, pastore siciliano dei Monti Peloritani, che ama gli animali più delle persone, perché «ti accettano per quello che sei e apprezzano se fai loro del bene». Silenzio, solitudine, semplicità, seguendo il ritmo delle stagioni, spesso lavorando anche di notte, alla luce di una lanterna (la lumera).
Accanto a lui la storia di Cristina Laurenti, impegnata in uno stage in una cooperativa agricola palermitana, dove si lavora seguendo i principi della sostenibilità ambientale e sociale.
C’è Angelo Canovo, il “contadino tuttofare dall’animo gentile”, che porta le sue vacche al maggengo in Alpe Lago (Sondrio) e produce il formaggio scimut nella sua baita. Michele Galmerini, storico gestore del Rifugio Cai Castiglioni all’Alpe Devero (Val d’Ossola), che lotta contro le speculazioni edilizie e gli impianti sciistici. La ventinovenne Vida Rucli, nata al confine con la Slovenia, che vuole vivere in montagna «in maniera contemporanea», fuori da certi stereotipi tradizionali, e ha fondato un collettivo di artisti (Robida).
Vediamo uno degli otto abitanti di Quarzina, in provincia di Cuneo («Sapeste quanti eravamo, una volta! Facevamo i terrazzamenti, dove adesso è tutto coperto dalla vegetazione»); un giovane maniscalco marchigiano orgoglioso di esserlo; una donna che porta avanti la tradizione della tessitura ligure nel borgo di Lorsica; un ottantenne (Pasetta) simbolo delle
montagne abruzzesi, emigrato ventenne in America e tornato sette anni dopo al paese d’infanzia, dove è letteralmente rinato.
La prima parte della mostra (allestita da Rica Cerbarano) dà un’idea dei luoghi scoperti lungo il cammino, testimonia la diversità ambientale e la ricchezza culturale, ma parla anche dello spopolamento, dell’immobilismo politico, del dissesto idrogeologico dovuto alla mancanza della cura dell’uomo che «nei secoli ha costruito e mantenuto gli argini e curato i boschi.
La recente scomparsa dell’interazione umana ha profondamente alterato l’equilibrio ambientale. Una zona che torna selvaggia dopo secoli di cura e manutenzione non è una visione romantica; è la tragedia di chi vi ha messo mani, cuore, vita» Si parla anche dei danni causati dal turismo di massa e la necessità di favorire «modalità sostenibili e capaci di generare una ricchezza diffusa sui territori». Esplorare a piedi le terre alte, interagire con luoghi e persone, «contribuisce ad aumentare la consapevolezza» di chi vive in città, «arricchisce le reciproche prospettive e diventa un canale di dialogo fondamentale tra dimensioni socio-culturali apparentemente distanti l’una dall’altra». La seconda parte della mostra è tutta dedicata alla spedizione dell'associazione Va’ Sentiero, che ha incarnato questa filosofia, la volontà di scoprire, conoscere, ma anche di “ricucire” tra loro pezzi d’Italia dimenticati. La montagna come cerniera che congiunge, non come barriera che separa.
56 APRILE 2023
L UOGHI
Va’ Sentiero è in mostra alla Triennale di Milano fino al 7 aprile: luoghi, volti, riflessioni
UN CARCERE TRASFORMATO IN ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA E LIBERTÀ

NEL NOME DI SAN FRANCESCO. SUCCEDE A TORINO, GRAZIE A JURI NERVO.

Un eremo al centro della città (Torino). Un luogo di silenzio, meditazione, incontro. Dove non ti viene chiesto da dove arrivi o che cosa hai fatto prima di approdare lì. Perché l’eremo, innanzitutto, è un luogo di accoglienza. Ma soprattutto, come scrivono loro, «l’eremo è un luogo interiore. L’eremita secolare è un uomo libero e in pace anche nel caos della città». Non è richiesta una fede, un’appartenenza religio-

sa, cose che magari si scoprono lungo il cammino. È richiesta una ricerca (personale, spirituale), un bisogno di spazio (interiore), un desiderio di libertà, quella vera, libera anche dai condizionamenti ereditati, le abitudini ossessive, le comode convinzioni. L’ego. Non è un caso che l’Eremo del Silenzio di Torino nasca in un carcere, un luogo di prigionia e di dolore, trasformato in un’occasione di fraternità e liberazione.
Come non è un caso che la onlus con la quale collabora si chiami Essere Umani (essereumani.org). Una “utopia reale” creata da Juri Nervo, «un movimento di giustizia sociale che opera negli ambienti a rischio di disumanizzazione». Le parole con cui viene presentata questa missione suonano come un programma di vita: «Mi riconosco nell’altro, perché credo nell’empatia. Sono aperto all’incontro, perché credo nella mediazione. Mi fermo e vivo il silenzio, perché credo nella lentezza. Sono capace di meravigliarmi, perché credo nella bellezza...».
Juri Nervo, un tempo, si presentava come “ricercatore sociale” (jurinervo.it). Poi è diventato un attivatore di progetti e comunità, un counselor, un esperto in mediazione dei conflitti e relazioni d’aiuto. Ma c’è anche quell’altra vocazione – che in realtà è la stessa, vista da un punto di vista diverso – la ricerca spirituale, le “grandi domande”, l’amore per san Francesco. Nascono (anche) da qui realtà come l’Università del Perdono, il Centro SoStare, le proposte didattiche.
59 APRILE 2023
Il silenzio al centro della città
L’eremo è un “luogo interiore”
M EDITAZIONI
di Fabrizio Tassi
L’Eremo del Silenzio (eremodelsilenzio.it) si trova nelle carceri torinesi Le Nuove, in via Paolo Borsellino 3, vicino alla stazione di Porta Susa, oggi Museo del Carcere gestito dall’Associazione “Nessun Uomo è un’isola” (museolenuove.it). Nasce dall’idea che l’eremita non sia per forza un anacoreta che fugge il mondo per ritirarsi nel deserto. «L’eremita è da sempre, e soprattutto oggi, colui che impara uno stile di vita interiore e lo coltiva anche nel tumulto della vita quotidiana e del caos di una grande città. L’eremita ricerca l’eremo non come fuga dal mondo, ma come luogo di silenzio per fare verità su di sé con la quiete e la preghiera. E per dare, attraverso la meditazione e l’orazione, benedizione e impulso alla propria attività e a quella degli altri».
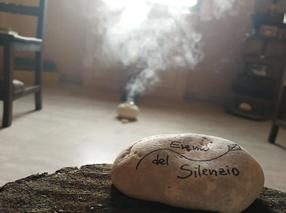

C’è anche la possibilità di diventare un “Piccolo fratello secolare”, per chi scopre che lo stile dell’Eremo gli appartiene, e vuole adottare la sua «proposta di vita di contemplazione nell’azione». In questo caso c’è perfino una Regola personale, come accade negli ordini
monacali e nelle fraternità, «una strada per il deserto nella città», che parte dal Vangelo, parla di umiltà, fiducia, pace, propone le formule per la preghiera continua, oltre a un certo modo (interiore) di vivere i voti tradizionali di castità, povertà e obbedienza. Ma l’Eremo è un luogo aperto, libero, offerto a coloro che vogliono «sperimentare per un po’ la vita dell’eremita. E soprattutto vogliono portarsene dietro per sempre le regole di vita un po’ come un ritratto o una mappa, per ritrovare il ‘proprio eremo’ ovunque e in ogni momento»
Ne abbiamo parlato con Juri Nervo, di cui colpisce la serenità sorridente, l’approccio laico e anti-dogmatico alla spiritualità, l’energia (tranquilla).
Qual è la tua storia? Non si può riassumere una vita in poche righe, ma ci proviamo.
«Io facevo il disegnatore meccanico, andavo nei cantieri. Ad un certo punto, però, ho incontrato il mondo della disabilità, e la mia vita ha cominciato a cambiare, a vacillare. Ho cominciato a farmi le “grandi domande”, con un po’ più di forza. Inizialmente pensavo: “Studio medicina, così vado ad aiutare la gente, salvo le persone”. Ma in realtà queste cose le dici per salvare te stesso, non gli altri.
Alla fine ho mollato tutto e, grazie al servizio civile fatto con i salesiani, ho ripreso gli studi in ambito educativo. Ho iniziato a lavorare come educatore e animatore professionale, sono uscito di casa, ho recuperato un certo equilibrio, e nel frattempo mi sono iscritto alla Facoltà di Teologia. Ho cominciato a cercare risposte per queste grandi domande di senso. Risposte che alla fine non ho trovato lì. Le ho trovate dentro la cella di un carcere. Nel silenzio. La frase che dico sempre è: mentre curavo quel luogo, ho iniziato a curare me stesso, a capirmi un po’ di più».

Hai sempre fatto scelte radicali. «Insieme a Matteo, il mio socio, ho cambiato due enti religiosi e una fondazione. Ogni volta mi licenziavo. Le persone che avevo vicino mi dicevano: “Sei matto!”. Dicevano che forse il problema ero io. Allora mi è venuta voglia di aprire una realtà che fosse solo nostra. In questi enti molto grandi, più si cresce e più si dimentica per chi si sta lavorando. Le domande spicciole che mi faccio tutti i giorni, “Gianluca come sta? E Marilena?”, tutti quei nomi e quelle storie di persone, bambini, anziani, a quel livello esistono sempre meno. Si parla di entrate e di uscite. Non si producono bulloni ma girano milioni di euro. E alla fine due domande te le fai. Abbiamo mollato tutto e abbiamo aperto un ente che si chiama Essere Umani, proprio per la volontà di ricordarci che cosa dobbiamo essere. Così è iniziato il nostro viaggio».
Era il 2015. Da allora ne sono successe di cose. «Ormai eravamo conosciuti come operatori e quindi molte persone hanno deciso di venire a lavorare con noi. E così sono nate varie realtà, come l’Università
del Perdono, è nato un piccolo movimento sul tema dell’accoglienza, la relazione, la cura delle ferite, il non-giudizio...»
Sul web citi un proverbio cinese: “L’inizio di ogni saggezza consiste nel perdonare agli altri il fatto di essere diversi da noi”.
«Infatti uno dei nostri strumenti si chiama Passaporto per Essere Umani, con cui diciamo che siamo tutti unici e irripetibili. Nessuno può mettere in dubbio questa cosa».
Nel mondo del carcere, invece, quando ci sei arrivato?
«È un amore nato prima del 2015. Uno degli enti in cui lavoravo aveva vinto una gara di appalto. Mi hanno chiamato un sabato pomeriggio dicendomi: complimenti, da lunedì ti assumiamo a tempo indeterminato, ma dovrai lavorare in un carcere (il Ferrante Aporti, il carcere minorile di Torino). Io non ci volevo andare. Avevo paura. Ma avevo anche bisogno di lavorare. Volevo andare a vivere da solo. Così mi sono buttato. E mi sono trovato a casa! Forse mi ha aiutato anche l’esperienza che avevo sulla dimensione della disabilità, come approccio con gli altri. Non c’erano giudizi o pregiudizi da parte mia, e loro questa cosa la respiravano. È nato un rapporto molto interessante. Nei primi dieci anni facendo attività sportiva, quattro ore tutti i giorni con i ragazzi. Poi, durante uno di questi pomeriggi, mi sono rotto un ginocchio, e mi sono reinventato lavorando sulla formazione, l’avviamento al lavoro, il sostegno allo studio. Il Ferrante è stato un po’ la mia palestra».
61 APRILE 2023 60 APRILE 2023
«Mi sono iscritto alla Facoltà di Teologia per cercare delle risposte. Ma alla fine le ho trovate dentro la cella di un carcere
Poi siete passati al carcere per adulti.
«Negli ultimi anni abbiamo cominciato a lavorare dentro il carcere di Torino, con uomini e donne. Ultimamente la collaborazione con due centri di mediazione del Piemonte ci ha portato dentro altre quattro carceri. Facciamo interventi sulla mediazione dei conflitti, sulla giustizia riparativa. È nata anche una collaborazione con il Museo del Carcere. I servizi sociali del Ministero ci hanno detto: andate anche nelle scuole. Ho cominciato ad andare nelle classi e ho visto che i ragazzi erano interessati. Dicevano: “Parliamo con uno che puzza di carcere”, la cosa piaceva, ma la cella rimaneva una cosa distante, i ragazzi hanno tanti pregiudizi, vedono le fiction, hanno un’idea distorta della realtà. Alla fine, grazie al Museo del Carcere, siamo entrati in questa struttura che si chiama Le Nuove. Quello che si vede lì è carcere vero. Per noi è uno strumento preziosissimo, perché i ragazzi delle scuole vengono e fanno un’esperienza, collegata a un laboratorio sulla giustizia e la legalità».
«Chiunque può passare da noi, a nessuno viene chiesto da dove arriva. A noi interessa il passo successivo, quello che possiamo fare insieme
Come nasce l’idea dell’Eremo?
«Ai tempi in cui studiavo Teologia ero rimasto folgorato dall’idea del silenzio, dagli eremiti e gli eremitaggi. Un pomeriggio, mentre aspettavo una classe che stava arrivando, mi sono messo a gironzolare e sono finito in una zona che non era museale. C’era una casetta di un piano, con un giardino e una tettoia, e dietro c’era una chiesa ancora consacrata che usavano le detenute. Ho chiesto al direttore Felice Tagliente (che è mancato lo scorso anno, un uomo fantastico) e lui mi ha spiegato che lì stavano le donne terroriste. Era un luogo abbandonato. Non c’erano acqua, luce, riscaldamento, ma mi è venuta voglia di sistemarla. E lui me l’ha lasciato fare. Mi venne l’idea che quel piccolo spazio potesse diventare una sorta di eremo. La proposta ha trovato un terreno fertile, perché anche lui aveva frequentato il seminario prima di diventare psicologo e filosofo. Quel luogo è “carico”, di qui è passato padre Ruggero Cipolla, francescano mino-
re, un cappellano che ha gestito 72 condannati a morte, una figura religiosa molto forte. Il nostro non è stato un inventare, ma un tornare a casa. Verso qualcosa che era già stato seminato inconsapevolmente».
Questa è la storia del “mattone”, il luogo fisico. Quello spirituale come si è sviluppato?
«Mentre ero lì che raschiavo i muri, un amico è passato per vedere cosa stavo combinando. Mi ha invitato al Convento sant’Antonio (proprio quello di padre Ruggero, vicino a Porta Susa) a una riunione col mondo francescano. C’erano tante persone, ho raccontato il mio progetto, mi hanno fatto i complimenti, ma non è successo nulla. Mentre me ne stavo andando a testa bassa, si è avvicinato padre Zeno e mi ha dato appuntamento per un caffè al carcere. Da buon francescano, quando è venuto mi ha regalato una Regola di san Francesco, il primo libro arrivato dentro l’Eremo. Gli ho proposto di fare due o tre incontri su san Francesco. C’erano una decina di amici che venivano a dare una mano, a pulire e imbiancare; ci siamo attrezzati con delle torce e un proiettore e abbiamo parlato di Francesco. C’era voglia di sapere, di incontrarsi, di confrontarsi. Quando abbiamo portato la luce dentro l’eremo, ci siamo trasferiti dentro una cella, e da lì è nato il “gruppo del giovedì”, che si ritrova da dieci anni ormai. Abbiamo letto i Vangeli, le lettere di San Paolo, l’Apocalisse. È un gruppo aperto. Persone provenienti da realtà culturali completamente diverse.

C’è il nonno, c’è la ragazza, la coppia, il separato... Ci tengo a dirlo perché a volte sono passati da noi i “grandi esclusi”, che si portavano delle ferite e non trovavano un luogo che li accogliesse. E lì è venuta fuori questa cosa per cui chiunque può passare qui da noi e a nessuno viene chiesto da dove arrivi. A noi interessa il passo successivo, il passo che possiamo fare insieme. Puoi essere un farabutto per la società, un tossico, cosa che è già successa, puoi essere chiunque. A me interessa perché sei qui».
A parte i giovedì, chiunque può sperimentare il silenzio dell’Eremo? Come funziona? Se io volessi venire una mattina a meditare?
«Ci sentiamo e ci organizziamo. L’eremo è dentro questa struttura chiamata Museo, quindi c’è un equilibrio da rispettare. Ci conosciamo e insieme organizziamo il percorso. È un'esperienza semplice, aperta, anche liquida, tenendo conto che ci sono piccoli spazi, tre cellette e un micro-giardino che se lo molli per tre settimane diventa una selva oscura».
Un eremo al centro della città è una specie di provocazione.
«La provocazione che porto avanti da sempre. Che è un impegno: trovare la libertà all’interno di una cella, di un ex carcere. Noi giochiamo con la parola, ma ci sono tanti tipi di carcere, il carcere della malattia, il carcere dell’egoismo...»
Questo è solo un seme, che volendo può attecchire altrove.
«Di solito c’è la mania, soprattutto a Torino, per cui ognuno deve costruirsi il proprio tempio, il proprio centro. Mi dicono: perché non ti allarghi? Perché non ne apri altri? Io in realtà spero che l’eremo chiuda, perché vorrebbe dire che le cose funzionano senza di me e l’idea va avanti. A pensarci bene non ci sarebbe bisogno di un eremo, soprattutto a Torino, perché abbiamo tante chiese vuote. Ma è il modo in cui è nata è cresciuta questa cosa che è importante, il gruppo, la fraternità».
Ricorda il cristianesimo delle origini. Anzi, da quello che ho capito non devi essere neanche un credente, basta essere una persona “alla ricerca” (anche solo di silenzio). Forse è proprio questo il fascino di un’esperienza del genere.

«No, non serve essere credenti, anzi! Un gruppo di ragazzi, di scout, che abbiamo ospitato una volta, mi ha detto: noi andiamo in tanti posti, belli, funzionali, luccicanti, però qui sentiamo un calore diverso. E faceva pure freddo, ce ne stavamo con il giubbotto e la cuffia. Non c’è solo accoglienza materiale, l’accoglienza è spirituale, qualunque sia la spiritualità, indipendentemente dal Dio che indichiamo».
C’è anche una Regola, altra provocazione, in un tempo in cui l’unico punto di riferimento sembra essere la libertà senza regole.
«C’è una Regola, ma personale, e un gruppo dell’Eremo che sta facendo un percorso vocazionale, perché il prossimo anno dovrebbe nascere una fraternità francescana. In questo pellegrinaggio del “capiamo chi siamo e cosa vogliamo fare nel mondo” è nato anche l’incontro con papa Francesco, attraverso la nostra Icona dell’abbraccio, il simbolo dell’accoglienza».
63 APRILE 2023 62 APRILE 2023
Ci racconti la storia dell’Icona?
«È nata da un errore. Io ho avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco due volte. La prima volta abbiamo disegnato il logo dell’Eremo su un drappo, con l’intento di portarlo negli incontri in carcere, facendolo firmare alle persone, impegnandoci a consegnarlo al Papa “per rompere il silenzio sul carcere”. Alla fine, dopo aver tampinato un sacco di persone, abbiamo avuto l'occasione di incontrare il Santo Padre durante un'udienza generale. Pochi minuti che volarono via, ma di una intensità notevole. Però ci siamo resi conto che quel movimento era più per noi che per le persone che erano in carcere. Ci siamo presi del tempo ed è venuta fuori l’intuizione dell’Icona del Figliol prodigo di Rembrandt, in cui mi sono ritrovato. È apparsa una
ragazza all’Eremo, un’iconista, e ho chiesto il suo aiuto per trasformare il quadro in icona. Siamo riusciti a organizzare un altro incontro con il Papa. Una gliela abbiamo regalata, l’altra ce l’ha benedetta e l’abbiamo riportata indietro. Adesso abbiamo una storia, un racconto, quando incontriamo le persone, un messaggio forte. Questa immagine vuole essere un abbraccio che raggiunge le persone in carcere. La presunzione buona di dire: se vieni da me quell’abbraccio lo trovi».


La Regola, il “Piccolo fratello secolare”, la contemplazione nell’azione... Sono tutte cose che fanno pensare a un concetto del cristianesimo d’Oriente, il “monachesimo interiore”, l’idea che si possa essere monaci (eremiti), cercatori di Dio, anche stando nel mondo, senza bisogno di ritirarsi nel deserto o in una grotta. Praticando la meditazione, la preghiera del cuore, la ripetizione del Nome... Questa cosa in Occidente, nel cattolicesimo, si è persa completamente.
«Assolutamente sì. Quando non c’era ancora stata la divisione tra cattolici e ortodossi, questa pratica era nel seno di tutti».
Siamo diventati anche moralisti, oltre che dogmatici, e concentrati nelle opere esteriori.
«Sì. E si è persa la dimensione spirituale trasformante. Abbiamo smarrito quell’idea del “prego perché voglio trasformarmi, perché voglio divinizzarmi”. Quel tipo di percorso oltre ad essere molto importante e interessante, può essere anche accattivante, soprattutto per i giovani. Padre Carlo Carretto ha scritto un bellissimo libro, “Il deserto nella città”. Ha raccontato gli errori che ha commesso e cosa ha scoperto. Lui camminava per Torino, vedeva le vie alberate e quelle vie erano l’entrata del suo eremo. Geniale. Chissà cosa aveva capito lui, che era stato nel deserto vero!»
In tanti, oggi, quando sentono di voler cominciare un percorso interiore, si rivolgono inevitabilmente all’Oriente, al buddhismo, lo zen, lo yoga. C’è chi si accontenta della mindfulness. Chi magari scopre l’esicasmo o la preghiera del cuore, grazie ai “Racconti di un pellegrino russo”, ma è una cosa lasciata all’intuizione del singolo, a ciò che gli capita di leggere.
«L’eremo, in questo senso, può essere veramente una pietra di inciampo».
Come ti poni nei confronti delle tecniche di meditazione?
«Quando mi dicono: cosa fai tu? Mi insegni? Io dico “no”. Come si insegna una cosa del genere? È come dire: insegnami ad amare. Come si prega, come si medita? Non è come la regola di un gioco. Come si fa a respirare? Più respiri, più capisci come farlo. Qualche regola può essere utile, alcuni si trovano bene con la tecnica del Pellegrino Russo, altri con le tecniche di respirazione, però è l’obiettivo che interessa. Metti in campo questa cosa per andare dove? Se non sai il dove, alla fine ti deludi. Continui a ripetere quella parola e non succede niente. Anzi, magari ti annoi.
Se vai a leggere i testi dei monaci del deserto, sono così affascinanti! C’è anche tutta una dimensione psicologica che noi ci stiamo dimenticando. Non si può piegare la dimensione religiosa per curare le ferite psicologiche, questo è un errore madornale».

65 APRILE 2023 64 APRILE 2023
«Si è persa la dimensione spirituale trasformante. Abbiamo smarrito l’idea del “prego perché voglio divinizzarmi”.
Quel tipo di percorso, oltre ad essere molto importante, può anche essere accattivante, soprattutto per i giovani
«Il bisogno di silenzio è innato, naturale. Lo vedo negli adulti, ma soprattutto nei ragazzi. Così come il bisogno di essere ascoltati e riconosciuti
Tempo fa su Redness abbiamo intervistato Marco Vannini, uno dei massimi esperti di mistica e di Meister Eckhart in Italia, che ci ha parlato delle tecniche come un possibile ostacolo, a volte anche un idolo, che finisce per rafforzare l’ego, proprio ciò che bisognerebbe superare.
«Mi vengono due riflessioni. La prima è che le persone cercano spesso qualcuno che dica loro cosa fare. La seconda è che quando cominci ad avere il tuo crocchio di persone intorno, poi rischi di sentirti il profeta del profeta».
Però sei convinto che ci sia un bisogno di silenzio diffuso, anche se inconsapevole.
«È innato. Lo vedo negli adulti. Ma lo vedo anche nei ragazzi, a conferma del fatto che è una cosa naturale. Lo vedo nelle scuole. I ragazzi cambiano, mutano, è interessante stare nel mondo della scuola proprio perché vedi la società com’è e come sta diventando. Ma trovi sempre questo elemento, questa necessità: essere ascoltati ed essere riconosciuti.
Sono due cose potentissime, che fanno funzionare le relazioni. Anche con gli adulti: quando li ascolti e li riconosci vedi la loro faccia che cambia. È veramente una dimensione naturale. La preghiera e il silenzio sono davvero come respirare».
Il silenzio aiuta anche a comunicare meglio, ad ascoltare.
«Certo. Penso a quelli che vanno nei monasteri e incontrano le suore di clausura e poi dicono: ma hai visto che occhi hanno? Beh, tu vivi in un modo, loro vivono in un altro, questo è il risultato. Se loro venissero da te, ti troverebbero agitato, con gli occhi rossi, mezzo arrabbiato col mondo. C’è anche questa dimensione fisica, del sentire e vedere le cose in modo diverso.
La mindfulness è il “voglio stare bene con me stesso”, se uno cerca quella cosa. Altra cosa è utilizzare quegli stessi strumenti per fare “un salto”. Il bisogno del salto lo devi sentire dentro di te».
Per chi sente il richiamo del “salto”, può essere utile leggere il libretto che Juri Nervo ha scritto e pubblicato con le Edizioni Messaggero Padova: Il silenzio nella città. Esperienze di eremitaggio urbano In cui si parte da una convinzione: «Il mondo ha fame di silenzio. Per lo più non lo conosce, ma spesso ugualmente lo teme e lo combatte». E dalla certezza che il silenzio sia una cosa naturale, connaturata all’essenza umana. «Non posso non vivere il silenzio nella vita spirituale, e siamo tutti spirituali: ecco perché c’è sete di silenzio in questi anni. Viviamo nel deserto rumoroso delle città e per assurdo devo andare in un deserto spirituale per sentire la voce di Dio e abbeverarmi a essa». Il silenzio lo si impara come un bambino impara a camminare, sapendo di non essere solo: «Possiamo sentirci strani (i primi passi), possiamo dubitare e non comprendere (traballiamo e oscilliamo), ma sappiamo che stiamo conquistando un nuovo territorio dentro di noi... sapendo di essere guardati». Perché alla fine (anzi, fin dall’inizio) si percepisce la “presenza”, come diceva santa Teresa, parlando del silenzio: «Non è altro che un intimo rapporto di amicizia, un frequente dialogo da solo a solo con Colui da cui sappiamo essere amati». Il libro parla in modo semplice e discorsivo del silenzio come luogo dell’incontro con Dio, in cui si scopre la dimensione dell’abbandono (nel senso di “abbandonarsi a”) e si ritrova il valore del tempo. L’Eremo in città è solo il segno di un’esperienza che si può vivere ovunque, «è ogni casa, è ogni persona, è ogni cuore»
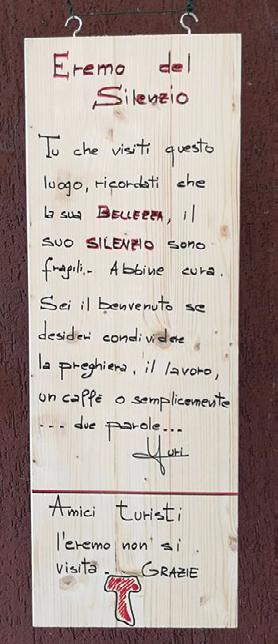
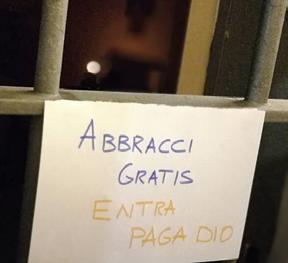
Come san Francesco che si nasconde sotto il mantello, nel mezzo di un mercato, e quando i confratelli gli chiedono cosa sta facendo, lui risponde: «Sono dentro il mio eremo».
Nei vari capitoli (brevi) si parla di vocazione, di gentilezza, di comunicazione non giudicante, dell’importanza della natura («cammino e respiro, e tutto il mondo entra in me, tutta la natura è con me»). Si parla di “mortificazione”, vista nel suo aspetto positivo di disciplina che libera. Si evoca quell’arma potentissima che è la “preghiera del cuore” («Gesù Cristo figlio di Dio abbi pietà di me peccatore»), con la quale ci si può connettere a sé, a Dio, al presente, in ogni momento e in ogni luogo (san Francesco, ad esempio, ripeteva: «Mio Dio, mio tutto»).
C’è anche un po’ di storia dell’Eremo di Torino e di autobiografia, fatta con sincerità: «Ero peccatore e lo
«Siamo tutti spirituali» e quindi tutti abbiamo bisogno di silenzio. Lo scrive Juri Nervo in un libro che parla di vocazione, gentilezza, ascolto attivo, l’importanza della natura, la pratica della preghiera continua. Il silenzio, diceva santa Teresa, «è un dialogo da solo a solo con Colui da cui sappiamo essere amati»
sono ancora di più, sono a tratti felice e molte volte mi perdo in un bicchier d’acqua... Credo di poter dire di essere consapevolmente umano». Come dice lui, ognuno all’Eremo “cerca quel che trova”. Ricordandoci il significato interiore, spirituale, di certe formule rese inerti dall’abuso, dalla religione trasformata in routine esteriore: «Gesù è venuto a liberarci. Sono figlio, quindi libero. Solo Gesù ci rivela cosa è la vera libertà: una totale rinuncia a se stessi per affermare l’altro. Il peccato è esattamente il contrario: fare riferimento solo a sé e mettere il proprio io al centro dell’universo. È questa la schiavitù da cui ci ha liberato!». Il silenzio aiuta a ritrovare quella dimensione misteriosa di cui parla L’Imitazione di Cristo: «Soltanto chi sente tutte le cose come una cosa sola, e le porta verso l’unità e le vede nell’unità, può avere tranquillità interiore e abitare in Dio nella pace».
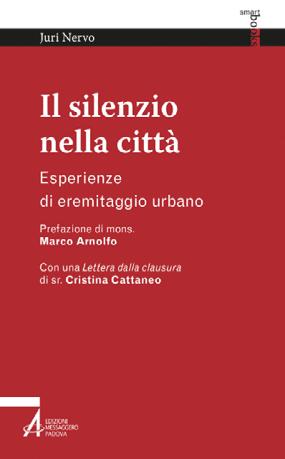
67 APRILE 2023 66 APRILE 2023
IL TRASLOCO È STORIA SALVATORI: DAL 1941, CON STILE E SIMPATIA
Ottant’anni di esperienza. Anzi ottantadue, per la precisione. Attraversando la storia del nostro Paese, dagli anni Quaranta all’Italia del boom, dai magnifici Sessanta ai frenetici Ottanta, fino a scavallare il millennio
e ad approdare nell’era digitale. Cambia tutto, la realtà diventa sempre più virtuale, ma non cambia la necessità di spostare le cose, di smontare e rimontare mobili per trasportarli altrove, di affidarsi alle mani di traslocatori capaci quando
arriva il momento di cambiare casa, di ricominciare la propria vita in un altro luogo.


Se ci pensate, c’è spesso una squadra di traslocatori ad accompagnare i momenti più importanti (belli o difficili) della nostra vita. Tanto vale rivolgersi a qualcuno che, oltre a saper fare il proprio mestiere, è consapevole di cosa significhi per il cliente e quindi ci mette anche una dose massiccia di gentilezza, magari pure di buonumore. «Lavoriamo nelle case degli altri come se fossero le nostre» dice Massimiliano, che insieme al fratello Marco è l’erede della gloriosa storia della Salvatori Traslochi. «Sappiamo quanto sia difficile il momento del trasloco, quanta preoccupazione suscita nelle persone. A volte nelle case c’è tutta una vita. Per questo ci mettiamo la massima attenzione e delicatezza.
Il rapporto con le persone, nel nostro lavoro, viene al primo posto. La gentilezza. L’ascolto. Siamo anche un po’ psicologi. E alla fine la cosa più bella è sentirsi ringraziare dai clienti». Queste cose Massimiliano Salvatori non le dice tanto per dire. Lo senti dal tono della voce sorridente, dall’entusiasmo che ci mette nel raccontare il suo lavoro, che è faticoso, a volte è complicato, ma è sempre stato la sua vita, fin da ragazzino, e non lo cambierebbe mai. Anche perché la storia della sua azienda assomiglia a un romanzo. Nell’album di famiglia ci sono foto in bianco e nero che risalgono agli anni Quaranta, in una Roma che non c’è più, in veloce cambiamento, attraversata da camion, furgoni, automezzi sempre più capienti e tecnologici, via via che scorrono i decenni.

Il nonno di Marco e Massimiliano Salvatori nel 1941 comprò un camioncino con i soldi guadagnati lavorando nelle colonie italiane dell’Africa Orientale.
L’azienda romana dal 1989 è guidata dai fratelli Marco e Massimiliano. Il nonno fu costretto a nascondere il furgone per evitare che i tedeschi glielo portassero via
69 APRILE 2023 68 APRILE 2023
Le origini romanzesche, la gestione familiare, l’arte della gentilezza. «Lavoriamo nelle case degli altri come se fossero le nostre»
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA
No, non erano tempi facili e nemmeno felici, l’ingiustizia regnava sovrana, ma ci si rimboccava le maniche e si cercava di costruire un futuro. Il nonno dovette anche nascondere il furgone, ai tempi della guerra, perché non venisse sequestrato dai tedeschi, quando fecero razzia dei mezzi in circola-
zione per portarsi via tutto ciò che potevano rubare. Si dice che a quei tempi si dedicava anche alla “borsa nera”, nel senso che portava in città cose acquistate dai contadini sulle colline, in un periodo in cui era difficile avere anche lo stretto indispensabile per sfamare la famiglia. Poi, finita la guerra, si
mise al servizio dell’Italia che rinasceva dalle sue macerie: traslochi, collettame, bagagli da trasportare, spedizioni di carri ferroviari, merci di ogni tipo, ma anche un primo servizio di “custodia mobili”. Era formidabile quel nonno, allegro, avventuroso, sportivo, che ebbe anche un’esperienza nelle giovanili della Roma e infatti contagiò figli e nipoti con la sua passione. Era anche un bell’uomo, chiamato scherzosamente il “Rodolfo Valentino del Trionfale”. Ma soprattutto era un lavoratore instancabile. Uno come lui non poteva che fare bene negli anni della ricostruzione, in cui c’era un gran fervore in Italia, oltre che tanta merce da spostare.
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta arrivarono i primi automezzi furgonati, per rendere il lavoro più efficace. Fu il figlio Sergio a insistere perché si investisse in nuovi autoveicoli, in un periodo in cui il trasloco non era più improvvisazione, alla portata di tutti, ma cominciava ad essere una professione che richiedeva esperienza e competenza.
«Un tempo nelle case c’erano poche cose – ci spiega Massimiliano. - Poi sono arrivati mobili sempre più complicati, elettrodomestici, oggetti, soprammobili... Oggi è diventato un lavoro super-specializzato. Soprattutto quando si tratta di lavorare sullo smontaggio e rimontaggio delle cucine, sempre più complesse e delicate, o sui mobili con parti a scomparsa».

Salvatori Traslochi può vantare una storia lunga quanto la Repubblica italiana – 55.990 traslochi effettuati, più o meno – e una famiglia che l’ha portata avanti come fosse una missione.
I due fratelli Marco e Massimiliano, figli di Sergio, sono diventati titolari dell’azienda nel 1989. E non hanno mai avuto dubbi su quale sarebbe stato il loro futuro. «Noi abbiamo sempre amato questo lavoro. Anche da ragazzi. Quando marinavo la scuola io non andavo al bar o alla bisca, ma andavo a fare i traslochi. Anche perché ci scappava sempre qualche mancia. E poi avevamo la passione dei furgoni e dei camion». Insomma, nessuna paura di fare fatica. «Al primo posto per noi c’è sempre stata la famiglia, quindi ci si rendeva utili anche da ragazzini. Ci piace stare insieme, anche lavorare insieme. Io comunque il primo stipendio l’ho preso quando avevo 28 anni. Prima di allora i soldi li ho sempre lasciati in casa». La forza di questa azienda è proprio la “gestione familiare”.
«Noi siamo i titolari, ma siamo anche lavoratori. Quante volte ci è capitato di scaricare i camion da soli per portare avanti il lavoro! E comunque siamo sempre presenti. Mio fratello giù ai camion e io nelle case. Anche per gestire le cose più complicate, occuparsi dei mobili più delicati. Ma soprattutto per avere


un rapporto diretto con il cliente. A volte, nelle case delle persone più anziane, capita anche di trovare oro e soldi dimenticati in un angolo nascosto o in un cassetto, e potete immaginare quanto ci ringraziano. Bisogna stare attenti ai dettagli. Fare in modo che le persone siano contente»

71 APRILE 2023 70 APRILE 2023
«Per fare questo lavoro, oggi, serve una grande professionalità, non è più come una volta. Ma bisogna anche sapersi rapportare con le persone nel modo giusto
Massimiliano sa quanto possa essere stressante un trasloco. «Per questo cerchiamo di creare un clima di gioia, si parla, si scherza. Per fare questo mestiere, oggi, bisogna avere una grande professionalità, bisogna saper fare molte cose, non è più come una volta. Ma è fondamentale anche saper rapportarsi alle persone». Non si lavora solo per i soldi. «Bisogna guadagnare, ovviamente. Questo è un lavoro faticoso e per nulla facile. Mi capi-
ta anche di non dormire la notte pensando a come risolvere certi problemi. Ma io lavoro soprattutto per il piacere di vedere i clienti soddisfatti. Quando ci telefonano, alla fine, per farci i complimenti, per dire che gli operai hanno lavorato bene, che non si è rotto nulla, che siamo stati veloci e anche simpatici, io sono felicissimo»


La simpatia la si intuisce anche durante l’intervista, tra una frase in romanesco e le esclamazioni
spassose con cui accompagna il suo racconto. Che evoca anche traslochi impegnativi e memorabili, come quando ha accompagnato la tournée dell’Orchestra del Venezuela in giro per l’Italia e poi anche all’estero. Salvatori Traslochi lavora per i privati ma anche per enti e aziende. E ha da sempre un ottimo rapporto con Il Sole 24Ore, che si è fatto aiutare dall’azienda romana nei suoi vari spostamenti da una sede all’altra, nel corso degli anni.
Da qui è nata anche l’amicizia con vari grandi giornalisti, che li hanno chiamati anche per i loro spostamenti all’estero, da Corrado Augias a Corradino Mineo («Mi sono occupato di persona del suo ritorno dagli Stati Uniti a Roma»). L’azienda è attrezzata anche per traslochi internazionali. E ha un sistema di “custodia mobili” all’avanguardia, un vero e proprio hangar, diviso in sezioni, in cui gli arredi vengono protetti dalle intemperie senza essere ammassati uno sull’altro.
C’è poi un progetto portato avanti insieme ad altre aziende, per far fronte a varie necessità: la pulizia di abitazioni e uffici, sia ordinarie che straordinarie, la sanificazione e igienizzazione profonda di ambienti piccoli o grandi, ma anche la digitalizzazione l’archiviazione di informazioni: «La Salvatori Traslochi rinnova la vita dei vostri archivi, informazioni, ricordi, tutelandoli e rendendoli disponibili a portata di click»
L’ultima idea? Un accordo con Compass, per finanziamenti a interessi zero. «Se posso pagare a rate, perché dovrei sborsare tutti i soldi subito? Anch’io lo faccio spesso. Quando la gente fa un trasloco,
spesso ha già avuto tante spese, è un costo che può pesare. Mi sembra giusto rendere le cose più facili. Questo è un altro modo per andare incontro al cliente».
“Al servizio del cliente”. Ecco il mantra aziendale. Per poi finire magari anche nell’album di ricordi di una famiglia, visto che i traslochi sono spesso legati a eventi felici, un matrimonio, la nascita di un figlio. «Quando è toccato a me traslocare ovviamente ho utilizzato i mezzi e gli operai della nostra azienda. E quando c’era il camion giù in strada, pieno di mobili, tutta casa mia, mi sono reso conto di quanta fiducia bisogna avere nelle persone che ti fanno un trasloco. Ecco, noi vogliamo essere all’altezza di quella fiducia». Lo fanno da più di 80 anni. Con efficienza, onestà e competenza. Oltre a tanta simpatia.

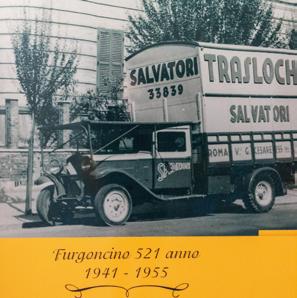
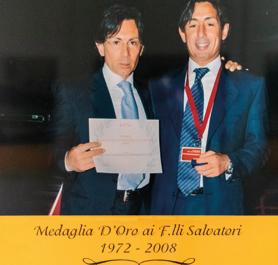

73 APRILE 2023
72 APRILE 2023
Immagini che riverberano. Parole acuminate e allusive. Brandelli di testo che non vengono spiegati, ma detti e cantati, “rivelati”. Roberto Calasso legge
Franz Kafka come leggerebbe la Bibbia, i Veda o il Bardo Thodol. Come ha letto Baudelaire, Nabokov o l’opera del Tiepolo, la mitologia greca o quella induista. Mitografia misterica. Setaccio di parole che lasciano una schiuma luminosa. Ora, da “postumo”, ogni suo scritto appare ancora più arcano.
L’animale della foresta (che uscirà il 18 aprile nella Piccola Biblioteca Adelphi) si concentra sugli ultimi mesi della vita di Kafka, in cui compose tre racconti di animali, «quasi un sigillo»: Ricerche di un cane, La tana, Josefine la cantante o Il popolo dei topi. Chi ha già letto K. (pubblicato nel 2002) amerà questo libretto e lo infilerà in qualche tasca, per poi tirarlo fuori nell’angolo ombroso di una stanzetta segreta, il bordo di un fiume, una parete di montagna che si affaccia su un dirupo. Kafka fa quasi autobiografia, raccontandosi come «un cane tra i cani», il malessere provato in mezzo alla gente, la necessità di trasformarsi in “ricercatore”. La decadenza delle generazioni che si credono evolute, ma sono solo vecchie, sovraccariche. La «scaltrezza pratica» dei topi, che non conoscono «la potenza del canto» e quando lo ascoltano scoprono di poterne fare a meno. E infine “la tana”, che dà concretezza a quella presenza del Nemico di cui Kafka ha scritto in ogni sua opera. Frammenti che dialogano tra loro, concentrati o dilatati, quasi aforismi o versetti di un testo sacro. Calasso torna anche sulle origini del mistero K, e la sua possibile soluzione. Alla fine c’è qualcosa che Kafka aveva sempre taciuto, oltre il limite della letteratura, «una certa dottrina segreta, “una cabbala”, che avrebbe dovuto gettare “le sue radici nei secoli antichi o ricreare i secoli antichi”. A quella dottrina segreta, al tentativo di darle una figura, Kafka dedicò gli ultimi due anni della sua vita»
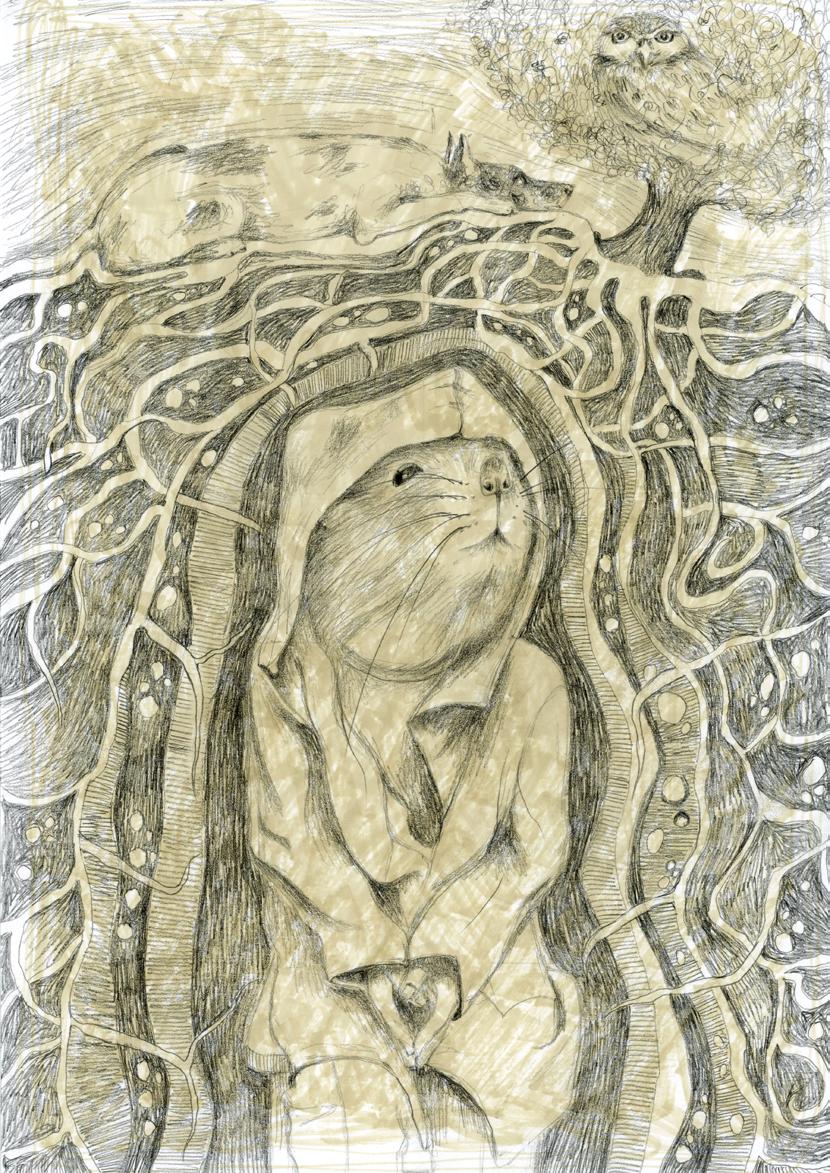
C’è anche «l’euforia, quella inspiegabile ebbrezza che emana dalla “forza di convinzione dell’aria dopo il temporale”. Basta così poco per abbracciare qualcosa di illimitato»
Una specie di grazia immeritata, di cui finisci per dubitare «anche se la finestra è aperta e “c’è ancora musica in un giardino”». (f.t.)
Il fatto è che tutti noi all’apparenza siamo capaci di vivere perché in una certa occasione abbiamo trovato rifugio nella menzogna, nella cecità, nell’entusiasmo, nell’ottimismo, in una convinzione, nel pessimismo o in qualcos’altro ancora. Lui invece non ha mai cercato un rifugio che lo proteggesse. È assolutamente incapace di mentire, così come è incapace di ubriacarsi. Non ha neanche il più piccolo rifugio, non ha un tetto. Per questo è alla mercé di tutte le cose dalle quali noi siamo al riparo. È come fosse un uomo nudo in mezzo a gente vestita. E non è nemmeno tutta la verità ciò che dice, ciò che è e ciò che vive. È in sé e per sé un essere determinato, spoglio di tutti gli elementi che potrebbero aiutarlo a trasformare la sua vita – in bellezza o in miseria, fa lo stesso. La sua ascesi è assolutamente antieroica – e per questo dunque tanto più grande e tanto più elevata. Ogni forma di “eroismo” è menzogna e viltà. Non è un uomo che costruisca la propria ascesi come mezzo per un fine, è un uomo costretto all’ascesi dalla sua terribile chiaroveggenza, purezza e incapacità di scendere a compromessi. Esistono uomini molto intelligenti, anch’essi indisponibili al compromesso. Ma inforcano occhiali magici, con i quali vedono tutto diversamente. Per questo non hanno bisogno di compromessi. E allora sanno scrivere a macchina con grande rapidità e hanno delle amanti. Lui sta loro accanto e li guarda meravigliato, e guarda tutto così, anche quella macchina da scrivere e quelle donne.
Però non riuscirà mai a capirne qualcosa. I suoi libri destano stupore. Lui ancora di più.
(Milena parla di Franz Kafka a Max Broad in una lettera dell’agosto 1929. Da “L’animale della foresta”)
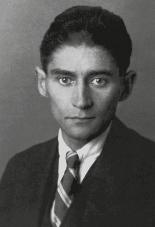
WEB AGENCY

76 MESE 2022
www.mondored.it