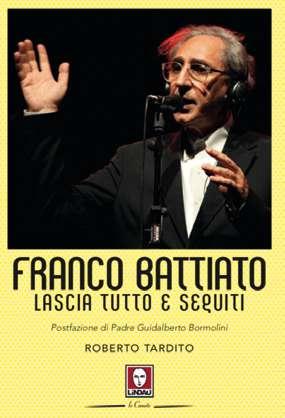Dove si parla di yoga e videoarte, di Matera, Napoli e Giappone (nagomi), di alta moda fatta con l’anima, dei ragazzi di “Mare fuori”, di Pino Daniele e Franco Battiato, di musica che nasce dalla vita (popolare) e dalla ricerca (interiore) N 7 | MARZO 2023
Franco Battiato
Silvio Bernelli
Alessandro Daniele
Pino Daniele
Alena Ettea

Giovanna Sannino
Caterina Erica Shanta
Roberto Tardito
In copertina: Erika Laba (per Elena Attea)
Foto di: Paola Dossi (servizio a pag. 36)
REDness
4
EDITORIALE
4 La filosofia del karaoke
6
INCONTRI
6 Alessandro Daniele: vita e musica di Pino Daniele, l’uomo e l’artista
18 Giovanna Sannino: il destino di un’attrice in “Mare fuori”
S26 Roberto Tardito: “Lascia tutto e seguiti” come diceva Battiato
34 Padre Guidalberto Bormolini: l’amore che trasforma
36 Alena Ettea: l’anima della moda, tra meditazione, stelle e perle
48
MEDITAZIONI
48 Luigi Bernelli: lo yoga visto “da dentro”. Inabissarsi in se stessi
56
IDEE
56 Caterina Erica Shanta: la realtà ritrovata nel digitale
68
STORIE D’IMPRESA
68 Maxi Clima: la piccola azienda diventa grande con la qualità
72 Macla Consulting: una guida sicura nella giungla burocratica
78
COMMIATO
78 Ken Mogi: “La via del nagomi”
Direttore: Fabrizio Tassi
Progetto grafico: Marta Carraro
Redazione: MondoRed
Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore
3 MARZO 2023 2 MESE 2022
è passione, arte, impresa, comunicazione.
È il "rossore" provocato dalle emozioni forti.
Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare. La redness
è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina.
È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi. Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità... Va bene tutto, purché sia fatto con redness.
OMMARIO
La filosofia del karaoke
Il karaoke in Giappone è quasi uno stile di vita. È un gioco, sì, un divertimento, ma nel senso più puro e innocente del termine. Come dice Ken Mogi in La via del nagomi (di cui parliamo nel Commiato), «molto sta nel riuscire a tenere vivo il nostro bambino interiore». Non si tratta di esibire le proprie capacità canore, o dimostrare di essere i migliori, come fosse un talent show. Al contrario, chi è troppo bravo a cantare è quasi intimidito, preoccupato dalla possibilità che la sua performance venga percepita come un’esibizione egocentrica. «In generale in Giappone non ha nessuna importanza se uno canta bene o male». Bella questa idea del fare e del creare senza essere ossessionati dalla performance, senza preoccuparsi di cosa gli altri potrebbero pensare di noi.
In generale in Giappone non c’è neanche una distinzione netta tra cultura alta e bassa. E il “genio” non è qualcosa che arriva da chissà dove, disceso sulla terra da un qualche iperuranio, per ispi-
rare un individuo fortunato, che impone il suo talento al mondo. Il talento, l’intuizione, il saper fare e creare, stanno dentro il “grande cerchio della vita”, una fusione organica tra la propria interiorità e l’ambiente circostante, «un delicato equilibrio tra l’affermazione e la negazione di sé, tra i valori assoluti e quelli relativi dell’unicità».
Da qui anche l’idea dell’apprendimento continuo, la necessità di far lavorare il cervello per tutta la vita, di esercitare la curiosità e di considerare ciò che si impara non un modo per avere più nozioni o informazioni, ma uno strumento «per farci diventare persone migliori». La parola magica è dō e «corrisponde all’idea che imparando ci si evolve e ci si rinnova. Judō, per esempio, indica la via della cedevolezza; kendō quella della spada, la katana; shodō è la via della scrittura (la calligrafia), sadō quella del tè, kadō quella della composizione floreale». Sono discipline che ci fanno crescere anche sul piano spirituale.

Non sarebbe male saper vivere la vita con questa leggerezza e pienezza, come un continuo imparare e creare e condividere. Questo mese Redness apre con un lungo ricordo di Pino Daniele, che ha tradotto la sua vita in musica, ha trasformato gioie e dolori in canzoni, arrangiamenti, melodie, ha fatto incontrare lo spirito di Napoli con l’anima del mondo (dall’Africa agli States, da Cuba al Mediterraneo). Ce ne parla il figlio Alessandro, che ha scritto un libro sull’uomo e l’artista, sottolineando quanto i due siano indissolubili.
A proposito di musica che sgorga dalla vita – e dalla ricerca interiore – questo mese parliamo anche di Franco Battiato, della sua capacità di cambiare rimanendo se stesso (anzi trovando, realizzando se stesso), dalla biografia musicale di Roberto Tardito (cantautore anche lui) a quella spirituale di padre Guidalberto Bormolini, che ci ricorda la necessità di imparare a vedere «l’alba dentro l’imbrunire» in questi tempi bui. Creare, sperimentare, mettersi alla prova, cercare la bellezza ovunque. Alena Ettea ci mette l’anima nelle sue creazioni. Poco importa che si tratti di scarpe o gioielli. Perle che simboleggiano la rinascita, foglie preziose che evocano l’albero della vita, le radici immerse nella terra e i rami aperti verso il cielo. L’eleganza non
deve essere per forza ostentazione. Si parla di moda, ma soprattutto di ricerca ed espressione di sé. La copertina è dedicata a lei e alla sua storia affascinante.
Poi c’è Giovanna Sannino, giovane attrice che è la dimostrazione vivente di come lavora il “destino” e del perché bisogna essere pronti a raccogliere i messaggi della vita: ieri faceva teatro con i ragazzi di un istituto penitenziario minorile, oggi racconta la storia di quei giovani carcerati nella serie tv Mare fuori. Fra tradizione e modernità, memoria e (ri)creazione artistica, si muove anche Caterina Erica Shanta, col suo progetto sulla Festa della Bruna di Matera, il carro trionfale distrutto ogni anno in un rito quasi dionisiaco e ricostruito in forma di fotogrammetria. Tutto passa e tutto si trasforma. Ma c’è qualcosa che rimane sempre intatto, anche dentro i cambiamenti più grandi, che si conosce e si rivela insieme a loro, e che in Oriente chiamano Sé.
Ce ne parla Silvio Bernelli, scrittore e insegnante yoga, senza fare troppa filosofia, perché è qualcosa di cui bisogna fare esperienza nella pratica, dentro la vita. È lui a ricordarci una massima preziosa firmata HÜsker DÜ (che non è un guru indiano, ma un gruppo rock): «La rivoluzione comincia a casa, preferibilmente davanti allo specchio del bagno». (f.t.)
5 MARZO 2023 4 MARZO 2023
E DITORIALE
Alessandro Daniele
L’uomo e l’artista, il padre e il professionista, l’eterno ragazzo cresciuto per strada e il musicista geniale, raccontati in un libro
in

«Ognuno ha il suo Pino Daniele, anche io ho il mio, accanto al papà che ho vissuto e amato
tanti modi diversi, da figlio, da amico, da collaboratore»
I NCONTRI
di Fabrizio Tassi
Pino e Alessandro Daniele (foto Giovanni Canitano)
Nel suo studio ci sono chitarre e microfoni usati da Pino Daniele. Manifesti, pupazzi, copertine di dischi, ricordi di tutta una vita. C’è anche il mandolino di Napule è. E la prima incisione di quella magnifica canzone, datata 1977. «Napule è mille culure / Napule è mille paure / Napule è a voce de’ criature / Che saglie chianu chianu / E tu sai ca’ nun si sulo»
Alessandro Daniele ha lavorato per quindici anni con lui. Conosce l’uomo e conosce l’artista. Il padre e il professionista. Il napoletano verace, cresciuto per strada, tra mille difficoltà, e il cittadino del mondo, che studia le altre culture musicali e le fa sue. L’eterno ragazzo, umile e gran lavoratore, che pur di fare musica arrivava a dormire su una panchina (quando non c’erano soldi), ma anche il cantautore geniale e di successo, che arrivò a riempire gli stadi e a vendere milioni di dischi inventando un suono e un genere.
Mio padre è entrato nella vita delle persone con le sue canzoni. La musica ci aiuta, ci fa star bene. Ma può far bene anche conoscere la sua storia. Perché lui, con tutte le difficoltà che ha avuto, è riuscito a venirne fuori
e la capacità di trasformare la vita in musica. «Vi racconto la mia storia attraverso le canzoni» diceva spesso al pubblico dei suoi concerti. Ma provate a riascoltarle dopo aver letto questo libro. Acquistano una dimensione in più. Che non è la spiegazione prosaica o la parafrasi biografica, ma la sua verità umana, la sua anima. Conoscere la vita di Pino Daniele, capire il valore delle sue scelte, il coraggio con cui ha combattuto contro le difficoltà, pur di restare fedele alla vocazione d’artista, rende la sua musica ancora più speciale. «Ognuno ha un suo Pino Daniele, anche io ho il mio, accanto al papà che ho vissuto e amato, in tanti modi diversi, da figlio, da amico e da collaboratore (…) Sono partito proprio dai suoi racconti, quelli che ascoltavo avvolto nella nube del fumo del suo mezzo sigaro, nella mia stanza d’ufficio dove ci riunivamo nella pausa caffè del dopo pranzo. Io seduto sul divano ad ascoltare le sue storie e lui in piedi appoggiato alla soglia della finestra a fumare.
Ho recuperato le sue parole dai miei ricordi più limpidi, altre dalle interviste, dalla famiglia, dai suoi amici e da alcuni collaboratori, tutti scelti con cura per tracciare un profilo da me riconoscibile: ognuno di loro ha avuto a che fare con il suo Pino Daniele. Ed è proprio alla fine di questa ricerca che ho davvero messo a fuoco il mio».
«Chi era Pino Daniele? Sulla sua carta d’identità avrebbe indicato semplicemente “chitarrista” o “musicista”. Non amava le definizioni e non voleva etichette sulla sua musica, suonava la chitarra come mezzo principale per esprimere le sue emozioni e dialogare con altre culture». Comincia così il libro che Alessandro ha dedicato al padre, pubblicato da Rai Libri: Pino Daniele – Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce Ci sono ricordi, racconti, aneddoti, testi di canzoni, le parole di Pino e quelle delle persone che lo hanno amato. Una storia che sembra un film. Con i suoi trionfi e le sue tragedie, i colpi di scena, i dolori, ma anche le pagine buffe, gli incontri spassosi, le scene di vita quotidiana. E al centro di tutto, una creatività instancabile

Il libro comincia dalla povera casa dei genitori (una sola stanza con cucinotto, letto e mini-bagno), i ragazzi del quartiere (ci si trovava al Bar Battelli), l’amicizia con l’inseparabile Salvatore, che ebbe il merito di prestargli la prima chitarra, una Eko pagata 5000 lire (mai più tornata indietro). Ci sono l’amore per Elvis Presley, le giornate al cinema, nei primi anni Sessanta, a guardare i film di Maciste e Totò, la passione per i panzerotti e quella per il mare, che rimarrà per sempre («Negli anni Duemila, quando papà aveva la possibilità di studiare la chitarra vicino al mare, sembrava che cercasse di sintonizzarsi sulle sue frequenze, cercava l’accordo tra il mare e lo strumento»).
Ma c’è anche il dramma: i genitori, sommersi dai problemi economici (e un padre col vizio del gioco), che lo mandano via da casa; la vita randagia di un fratello che
finisce in riformatorio; la scoperta di un grave problema alla vista, che lo costringerà a quel suo gesto tipico, quel guardare di traverso, che era dovuto alla presenza di punti ciechi nei suoi occhi.
A 12 anni già se la cavava con la chitarra. E mentre si affermavano i Beatles, lui scopriva il blues e il progressive, inventandosi anche un gruppo dal nome colto e impronunciabile: Batracomiomachia.
Ma era un ragazzo con la testa sulle spalle, che continuava a studiare, per tener fede ai suoi impegni, alla promessa fatta alle zie con cui viveva.
Il libro racconta quel giorno in cui improvvisamente capì: «Ma che cazz’ aggia fa’ co’ tutti sti numeri! I’ aggia fa’ ’o musicista... cheste nun hanno capit’! Io nun ’o vogl’ fa’ ’o raggiuniere!». Un altro momento topico fu quello in cui si trovò a scegliere tra il primo contratto discografico e un posto di lavoro come assistente di volo.
Pino Daniele era un uomo che amava la semplicità e la sincerità. Quando decise di sposare la donna di cui si era innamorato, lo fece con un rito civile, insieme agli affetti più stretti, in aperto contrasto con le attese della famiglia e con la tradizione napoletana.

8 MARZO 2023
9 MARZO 2023
Alessandro Daniele
(foto Giuseppe D’Angelo, 1991)
Ma nessuno era più napoletano di lui, che non aveva certo paura di utilizzare il dialetto per fare musica (il suo dialetto era musica) e che se ne andava in giro con la moka e il caffè preferito in una valigetta.
Sembra quasi di vederlo lo sgabuzzino di casa in cui ricavò il suo studio, che era piccolo ma aveva l’atmosfera giusta, una “bella ‘mbriana”, come si dice a Napoli. Ma anche la chiacchierata con Bob Marley, che gli fece mille domande e lo ascoltò con grande interesse quando gli parlò delle scale arabe che utilizzava nelle sue canzoni. Il successo arrivò all’improvviso e si trasformò in trionfo, da Nero a metà in poi. Pino Daniele era il creatore del “soul mediterraneo”, era un “ricercatore che fa il musicista”, sempre impegnato a studiare, conoscere, imparare cose nuove. Era il “mascalzone latino” che amava i nativi americani, la loro spiritualità legata agli elementi, e che pregava prima di salire sul palco, per cercare di gestire l’onda emotiva. Negli anni ‘80 scrisse così tante canzoni memorabili che è difficile elencarle tutte.
Poi nel 1989 il dramma improvviso, l’infarto, i tre bypass, la vita che improvvisamente cambiava, i medici che gli vietavano di tornare sul palcoscenico. Ma trovò la forza di superare anche quello. Diceva: «Io mi ritengo un uomo molto fortunato, con tutti gli acciacchi e
i problemi che ho avuto nei percorsi della mia vita. Anche perché oltre a continuare a fare quello che faccio, ho cinque figli meravigliosi. Ho sempre avuto questo amore per i miei figli e i figli mi hanno sempre aiutato… come questa [la chitarra, nda], non mi ha mai lasciato a piedi, nei momenti difficili ho sempre imbracciato la chitarra e ho continuato, quando sono stato male, quando mi è andata male, quando mi hanno tradito, quando mi hanno rubato tutto. La chitarra, i figli e l’amore mi hanno salvato»
Alessandro racconta tutto questo e anche di più. Lo fa con i ricordi e l’amore di un figlio, ma anche con la competenza del professionista che è diventato, lui che è stato personal manager di Pino Daniele e che oggi è produttore artistico e insegna al Conservatorio Verdi (discipline dell’organizzazione e della gestione dello spettacolo). È anche direttore della Fondazione Pino Daniele, organizzazione no profit a cui andranno i proventi del libro. Un motivo in più per comprarlo. La Fondazione porta avanti attività sociali e culturali, preservando la memoria di Pino Daniele e il suo modo di intendere la musica. Come diceva lui: «La musica stimola lo spirito a capire, a essere un po’ più socievoli e dare socialità a quello che uno fa. La musica aiuta a vivere».

Il libro è avvincente come un romanzo. Ma è anche uno studio critico, disco per disco.
Ho cercato di seguire il racconto cronologico, mettendo però in luce alcuni aspetti in particolare. Non volevo limitarmi al suo percorso artistico, a fare una cosa schematica, enciclopedica. Per questo ho cercato di raccontare anche il suo percorso umano. Che non vuol dire guardare nel buco della serratura, come ho scritto nella prefazione. L’idea non era svelare il privato di Pino Daniele. Mi interessa di più che questo libro possa avere anche una funzione sociale.
La sua vita e la sua musica come esempio.
Mi sono detto: papà è entrato nella vita delle persone con le sue canzoni e ognuno le fa proprie, anche senza il bisogno di andare a fondo nel loro significato. La musica, con le sue vibrazioni, ci fa stare bene, ci aiuta, anche inconsciamente, nelle nostre giornate. Però anche la storia personale di mio padre può aiutare le persone a stare bene. Perché lui, con tutte le difficoltà che ha avuto,
è riuscito a venirne fuori. Con le sue canzoni ci aiuta a vedere non solo il problema, ma anche cosa posso fare per risolverlo. I talenti nella vita sono tanti, non c’è solo quello artistico. La gente a volte confonde il successo con la riconoscibilità popolare di una persona, con i numeri. In realtà è un talento anche essere genitore, amico, fare un buon lavoro nel proprio campo. Come diceva mio papà: mi realizzo nel mio microcosmo.
La sua vita, comunque, ha la trama di un film. Gli inizi difficili, la scoperta della vocazione, il romanzo di formazione, poi il successo, il trionfo, ma anche il dramma improvviso che rischia di distruggere tutto. Le parole delle canzoni sgorgano dalle cose della vita.
Non solo le parole, ma proprio il suo modo di fare musica. È la cosa che ho cercato di portare alla luce. Uso sempre questa espressione, che infatti poi è entrata nel titolo: Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce All’inizio ne avevo in mente un altro. La cartella che ho sul computer ha ancora il vecchio titolo I Got the Blues.

11 MARZO 2023 10 MARZO 2023
Alessandro Daniele
(foto Roberto Panucci, 2012)
Ma verso la fine del lavoro, cercando tra le cose dette da mio padre, mi è capitata questa e ho pensato subito: è esattamente questo il libro! Pino faceva biografia con la musica. Portava la sua identità culturale, artistica, umana, nella melodia e nell’arrangiamento. Questa ricerca mi ha aiutato anche a capire certe cose che lui mi diceva. Sono cose che già sapevo, ma una conto è viverle, starci dentro, un’altra è analizzarle dall’esterno.
Lui si sentiva molto connesso al mondo. Ma l’essere Pino Daniele in qualche modo interrompeva questo flusso: era visto come un diverso, non poteva andare in giro liberamente, non riusciva a godersi il momento.
Per lui è stato un conflitto continuo
D’altra parte fu lui a dirti: “Solo tu e tua madre avere capito chi è Pino Daniele”.
Ovviamente non lo intendeva dal punto di vista umano, ma da quello artistico. Io e mia madre abbiamo lavorato con lui. E però mi sono sempre chiesto: come fa a dirlo? Cosa lo rende così sicuro? Credo che questo libro mi abbia aiutato a trovare una risposta.
Tuo padre ha sempre avuto dei problemi “con Pino Daniele”, con il personaggio. C’è quella sua frase che ricorre “Nun c’a facc’ cchiù, m’ha rutto ’o cazz ’stu Pino Daniele!”

Mi sembra ancora di sentirlo, come se fosse la settima scorsa. L’ultima volta è stata nel 2014. Il libro parte da quella giornata, in cui ci siamo detti tantissime cose. Quella volta però non lo aveva detto con rabbia. Mentre altre volte era più scocciato, in quell’occasione lo ha detto con stanchezza, quasi rassegnato, come a dire: “cosa ci posso fare”? È stato un conflitto continuo.
La sua arte forse nasce anche da questa tensione. Da una parte l’esigenza di affermarsi come artista, di farsi ascoltare, dall’altra il bisogno di “normali-
tà”, la voglia di passeggiare tranquillamente per le strade di Napoli, la vita in mezzo alla gente.
Lui si sentiva molto connesso al mondo. Nei suoi testi utilizza spesso le parole “sole” e “mare” come metafora di tante cose, del legame con gli elementi, con l’energia intorno. L’essere Pino Daniele in qualche modo interrompeva questo flusso: era visto come un diverso, non poteva andare in giro liberamente, non riusciva a godersi il momento. Per lui è stato un conflitto continuo. Aveva questa necessità di ritornare a Napoli a farsi anche solo una passeggiata. Solo nel 2014 ha cominciato a fregarsene.
In che modo?
Ricordo che eravamo lì per una serie di concerti. Eravamo abituati ad andare in giro con una persona, un assistente che all’occorrenza sapeva arginare le persone, fungeva da “sicurezza”. Quel giorno però mi dice: “Andiamo a fare una passeggiata io e te”. Io sgrano gli occhi: “A Napoli? Io e te da soli? E se arrivano in dieci, come ne usciamo fuori? Come facciamo a trovare un modo carino di dire: scusate dobbiamo andare?” Però lui ha detto: “Fidati”. Si è messo il cappellino, come per nascondersi, e lo abbiamo fatto. Nell’ultima fase della sua vita ha cominciato a fare quel salto, a dire: me ne fotto di Pino Daniele, lo voglio fare comunque. Aveva un atteggiamento quasi di sfida. Voleva andare a comprarsi i pantaloni della tuta al centro commerciale, apposta.
È stato difficile per te, da un punto di vista emotivo, scrivere questo libro?
Emotivamente la botta vera l’ho avuta quando ho letto i testi di mia madre. Lei ha scritto tanto, ma solo per se stessa, non certo per farsi leggere. È sempre rimasta dietro le quinte, non amava la mondanità. Lei ha scelto l’uomo non l’artista. Hanno condiviso un sogno insieme. Quando ho scoperto i suoi scritti le ho chiesto: mi fai leggere qualcosa? Ricordo i pianti mentre leggevo, perché mi è arrivata addosso la sua sofferenza. È stato importante per me guardare ciò che avevo vissuto anch’io da un’altra finestra. Rendermi conto del dolore che aveva cercato di nascondere, con grande dignità, per la famiglia, per i figli. Così come papà, accettava tutto e andava dritto, non aveva paura del cambiamento.
Hai utilizzato varie fonti.
Buona parte del libro è dedicata agli inizi. Papà mi ha raccontato tante cose, ma non poteva bastare. Tante gliele avrei volute chiedere, ma non ho mai voluto essere invadente. Questo forse è l’unico rammarico della mia vita. Avrei potuto chiedergli qualcosa in più sulle canzo-
ni, su come erano nate, su ciò che raccontavano, ma non l’ho fatto per rispetto del suo privato. Avvertivo cosa c’era dentro certe canzoni, la sofferenza, ma aspettavo sempre che fosse lui a parlarne. Scrivendo degli inizi, avevo bisogno che qualcuno raccontasse quelle cose, che desse alla storia un calore che io non potevo darle. E quindi le ho fatte dire allo zio, a mia madre, a Gino.
13 MARZO 2023 12 MARZO 2023
(foto Marco Minniti)
Alessandro Daniele
(foto Giovanni Canitano)
Ma sono tutte cose che si trovano nelle canzoni. A volte tristi e a volte felici. In Quanno chiove, ad esempio, ci sono tre storie dentro: c’è la storia di papà che non la voleva scrivere, c’è la melodia dedicata a mia madre, ma c’è anche quando con Gino sentiva il rumore dei tacchi di quella signora che andava a lavorare, che faceva la prostituta, e si affacciavano per guardare sotto la gonna. La parte più divertente del racconto è quella dello zio Roberto.
Non molti conoscono l’infanzia drammatica di Pino Daniele: la povertà, i suoi genitori che lo mandano a vivere in un’altra casa, i problemi del fratello.

E tante cose le ho tolte. Ma qualcosa andava detto, perché ci sono tante persone che si trovano in quelle stesse condizioni e che possono riconoscersi in questa storia. Papà avrebbe voluto coinvolgere anche Salvatore nel suo lavoro, ma da giovane era un tipo che inciampava spesso in vari tipi di problemi, anche con la giustizia... Lui comunque ha sempre cercato di avere un rapporto con lui. Nel libro cerco di mandare un messaggio positivo. Così
come faceva sempre papà. Mi diceva: nelle mie canzoni anche quando racconto un dramma alla fine ci deve essere sempre un’apertura, una possibilità. Questa cosa mi è rimasta impressa. Ho costruito il libro con l’atteggiamento con cui lui costruiva le canzoni. Non mi sono inventato nulla. Ho cercato di agganciarmi al suo modo di scrivere, al suo metodo, che è anche un sistema di valori. La sincerità, senza romanzare.
La misura c’è e si sente. Sei riuscito anche a tenere una certa distanza, che però non è mai lontananza. Racconti la sua vita e la sua musica senza trasformare il racconto in un tuo diario personale. Il rischio era quello.
All’inizio volevo addirittura scriverlo tutto in terza persona. Ma sarebbe stato troppo. Alla fine credo che il successo del libro risieda nel mix tra ciò che è personale e ciò che non lo è. Volevo lasciare il faro acceso su di lui.
A chi mi ha proposto di scrivere questo libro, Antonio Riccardi, consulente di Rai Libri, un giorno ho detto: “Ho un’idea, leviamo tutto, lasciamo solo Pino, senza neanche mettere il mio nome”. Lui, dopo un attimo di silenzio, si è messo a ridere: “No Way”.
Se dovessi raccontare a un ragazzo di oggi chi era Pino Daniele e perché è stato unico come artista, cosa gli diresti?

Bella domanda. In realtà ci vuole tempo, come per tutte le cose importanti, quelle che restano, che hanno dei valori. Non le puoi riassumere come fossero un post. È un lavoro. Io ho la grande fortuna di lavorare nei conservatori (ci deve essere il suo zampino...), di avere a che fare con tanti giovani che si approcciano alla musica, ognuno con la sua motivazione, simile, diversa, unica. Il modo migliore non è parlare direttamente di Pino, ma del suo sistema di lavoro e di valori. Bisogna partire dai loro interessi e agganciarsi a quelli. Il percorso di mio padre può davvero ispirare questi ragazzi. Quando insegno ai giovani come si organizza un disco o un live, come si scelgono i professionisti, come si lavora in studio, cerco anche di spiegare che ciò che creano e registrano è una responsabilità. Non solo per ciò che dicono con le parole, ma anche per il messaggio che stanno trasferendo agli altri musicalmente.
Viviamo un tempo in cui si avverte sempre più l’esigenza di cercare una “connessione” che non sia solo materiale, superficiale, legata a internet e alle possibilità della comunicazione, ma anche più profonda, interiore. Nella musica di Pino Daniele c’è dentro l’Africa, l’America degli anni Sessanta, Cuba, le culture del Mediterraneo... E non è una banale fusion
Tutte queste culture le faceva sue e diventavano “alla Pino Daniele”. All’interno delle altre culture cercava le sue radici. La sua ricerca era un modo per trovare se stesso, non per scimmiottare gli altri. Era una ricerca interiore. Cercava delle tracce di sé e lasciava delle tracce di sé. Mi sono spesso domandato quanto questa sua esigenza di ricercarsi in altre etnie fosse collegata alla sua infanzia, al fatto che non avesse vissuto con i genitori, ma con delle zie che zie non erano. Nonostante tutto ha sempre cercato di ritrovare una connessione con i genitori. Ma come per le canzoni, non è giusto spiegare tutto. Ognuno deve essere libero di ascoltare, lasciarsi ispirare, immedesimarsi.
Mario Martone ha presentato a Berlino un film in cui parla di Massimo Troisi (e naturalmente ci sono pezzi di tuo padre). Com’era il rapporto di
Pino con lui? È molto commovente la pagina in cui tua madre racconta l’ultimo saluto di Massimo.
Io ero piccolo, vedevo Massimo che veniva e si presentava, come una specie di zio. Non giocavamo tanto con lui, ma lui era molto presente, mangiava con noi, andava a riposare in una stanzetta, era uno di famiglia. Ad un certo punto io mi arrabbiai, mi diventò quasi antipatico, quando papà lo coinvolse per fargli cantare Saglie saglie Dicevo a mio padre: “Ma perché? È stonato! Ha rovinato il pezzo”. Mi aveva dato così fastidio quella cosa. Ero piccolo... Mio padre mi raccontava delle cose che non si possono scrivere. Erano un film, tutti e due. Le comiche. Era come se fossero due fratelli. Stessa generazione, stesso approccio e visione, un modo di parlare di Napoli che non cade mai nel folkloristico. Avevano lo stesso metodo, uno con il linguaggio della musica e l’altro col cinema.
Tu hai lavorato con lui per tanti anni, dal 2000 al 2015. Cosa ti ha dato quell’esperienza?
Io non volevo lavorare con lui. Ho resistito fino all’ultimo, fino a quando le vicissitudini della vita me lo hanno permesso. Poi lui ha chiuso un contratto importante con la Bmg: nuovo ufficio, nuovo studio, aveva bisogno di personale.
15 MARZO 2023 14 MARZO 2023
Alessandro Daniele
(foto Roberto Panucci, 2014)
(foto Archivio Fondazione Pino Daniele, 2014)
Mi disse: “Adesso vieni a lavorare con me”. E io: “Mannaggia la miseria”. Anch’io dovevo pagare l’affitto... All’inizio dissi che non volevo niente: prima vediamo se funziona, se “suoniamo insieme”, poi si vedrà. Alla fine ho scoperto che quello era il mio mondo. Lui mi ha dato grande fiducia. A un certo punto saliva sul palco e non sapeva neanche che scenografia c’era. Mi diceva: “Fai tu”.
Eppure era un perfezionista.
Un rompiscatole, sì. Mi sono preso anch’io le mie secchiate di merda... Ma si è creata una fiducia anche tecnica, in maniera perfino esagerata. A volte io stavo dall’altra parte del palazzetto e mi venivano a chiamare per attaccare la pedaliera. “Lo sa Alessandro!”, diceva lui... È un’esperienza che mi ha formato non solo come professionista ma come uomo. Papà diceva: ho studiato con i migliori chitarristi del mondo, ma non è solo una cosa nozionistica, è importante ciò che ti danno umanamente, l’approccio con la musica, con lo strumento. Uno più bravo tecnicamente di te lo troverai sempre, ma non c’è solo quello.
Viviamo in tempi allucinanti, ma più che lamentarmi sto con le antenne puntate per capire chi fra i giovani fa anche un discorso culturale, una ricerca. Che non è per forza un discorso difficile, come ha dimostrato mio padre. La differenza sta nell’avere coscienza di ciò che si fa
Il libro si ferma al 1993. Ma fino al 2015 ci sono ancora tante cose da raccontare.
Per questo ci sarà un secondo volume. Si tratta di anni che conosco molto bene, quelli in cui ho lavorato con lui. Lì però dovrò avere anche l’avvocato vicino, perché altrimenti i proventi non vanno in beneficenza, ma per pagare i legali. Anche la prima parte, a dir la verità, l’ho data da leggere a un amico avvocato. Ci sono persone che hanno massacrato mio padre. Come faccio a spiegare perché lui ha fatto certe cose o ha reagito in un certo modo, senza raccontare ciò che ha dovuto subire? A volte dire le cose come stanno è scomodo e io non volevo dare l’impressione di togliermi dei sassolini. Lascio dire a mio padre che certi “manager erano dei magna-ger”. Io lo so perché lo dice, ma non posso raccontare esattamente cosa è successo. Dovrei anche fare i nomi, ma non è la funzione di un libro del genere.
C’è qualcuno che ha raccolto l’eredità musicale di tuo padre e la porta avanti, almeno in parte? Il panorama contemporaneo è caotico. Sono tutti un po’ schiavi dell’algoritmo. E mancano i maestri. Tu ad un certo punto citi i dischi usciti nel ‘79, non secoli fa, ed è un elenco incredibile: Pino Daniele, Lucio Dalla, Battiato, Fossati, De Gregori, De André con la PFM, Gianna Nannini...

Voglio fare qualcosa che lo ricordi, che sia connesso a lui, col suo sistema di valori, per incentivare la produzione di brani con questo atteggiamento: cosciente, consapevole, con un contenuto.
Ci racconti il lavoro della Fondazione?
Dopo l’operazione avete vissuto momenti difficili, delicati. La gente non comprendeva ciò che stava accadendo. Anche lì ti sei preso le tue “secchiate”.
Sì. E le ha prese anche lui. Ma alla fine è riuscito a non farsi incartare. Ha continuato a fare la sua musica. Qualche volta è caduto nella rete, e ha fatto cose troppo commerciali (ne parlerò nel prossimo libro), ma anche in quei dischi c’erano cose importanti..
È un discorso molto difficile da fare. Più che tempi caotici, questi sono tempi di grande narcisismo. Che portano in molti a seguire l’algoritmo e a generare mediocrità e consumismo. Non c’è la cultura del creare qualcosa che resterà. C’è solo il presente. Ma non nel senso del “vivere il presente” di cui parlano certe forme di spiritualità, che è ben più profondo. È solo consumo dell’immediato. Sono tempi allucinanti, in cui servono dei riferimenti. Ma più che lamentarmi, sto con le antenne puntate per capire chi fra i giovani fa anche un discorso culturale, una ricerca. Che non è per forza un discorso difficile, come ha dimostrato mio padre. La differenza sta nell’avere coscienza di quello che si fa. Pino magari metteva tre note in una canzone, ma era uno che studiava sei ore al giorno, ne faceva ottomila di note per riuscire ad avere la coscienza di fare una canzone con tre accordi. Sto lavorando per fare qualcosa dedicato a papà, un premio, che però non sia il “Premio Pino Daniele”, troppo autoreferenziale.
Abbiamo fatto davvero tante cose, in varie direzioni. Poi ci siamo specializzati nella valorizzazione dei talenti, appoggiando concorsi, borse di studi, riconoscimenti, premi in strumenti musicali, dando visibilità a ragazzi che hanno talento; non “al cantante”, ma al compositore, a chi ha un proprio colore, ha un suono e fa una ricerca. A Napoli il 29 dicembre abbiamo organizzato un concerto dedicato a papà sotto la Galleria Umberto I, in cui dei ragazzi, provenienti dai conservatori italiani, hanno rielaborato le sue canzoni in chiave jazz, pop, rock, audiovisiva. Non volevo delle cover, ma dei brani nuovi. C’è perfino chi ha fatto dei duetti virtuali con lui. È stato bellissimo.
La Fondazione investe molto sulle attività per combattere la “povertà educativa”.
Sì, organizziamo dei laboratori, un progetto che vorrei portare nelle carceri, oltre che nelle scuole. Inse-
gniamo come ci si può relazionare agli altri ed esprimere i propri sentimenti con la musica. Come faceva mio padre. Diamo ai ragazzi un drum pad: ci sono dieci tasti rossi per la rabbia (con chitarre distorte, batterie metal, certi accordi che usava papà), dieci tasti blu per la malinconia, e poi il giallo dell’allegria e il verde della calma. I bambini e i ragazzi, anche senza saper suonare, trasferiscono le loro emozioni attraverso i colori, creando dei brani. Li facciamo relazionare con i ragazzi dei conservatori e scoprono la possibilità di esprimersi con la musica. Molti di questi ragazzi parlano in dialetto, anche in Trentino, in Veneto o in altre regioni, non solo a Napoli. Il messaggio è: non sentitevi a disagio. Pino Daniele è andato all’estero facendosi capire. Come usava lui il dialetto? Foneticamente, ritmicamente. Questo non vuol dire rimanere fermi, anzi. È un modo di spingerli ad andare avanti. Si tratta di un lavoro molto bello ma costoso, dipende dai fondi che abbiamo. A volte si riescono anche a scrivere dei testi e registrare delle canzoni insieme, portandole sul palco. Per l’anno prossimo vorrei organizzare delle presentazioni, per far conoscere ciò facciamo. Lo faremo, come sempre, nel nome di Pino Daniele.
17 MARZO 2023 16 MARZO 2023
Alessandro Daniele
(foto Giuseppe D’Angelo, 1991)
GIOVANNA SANNINO

Il destino di un’attrice, dall’esperienza teatrale all’IPM di Nisida al ruolo di Carmela in “Mare fuori”. Ricordi, emozioni, sogni
“Non possono chiudere a chiave i tuoi sogni”. È questo il pensiero da cui è nata la serie televisiva Mare fuori, che racconta i ragazzi detenuti in un IPM (un Istituto Penitenziale Minorile) a Napoli. Oltre quelle mura c’è il mare, la libertà, il futuro possibile ma indefinito. Dentro invece c’è il mare interiore, l’amore e l’odio, le passioni, la rabbia, il bisogno di credere in qualcosa.
Giovanna Sannino conosce molto bene quei sentimenti. Li ha “toccati con mano”, da ragazza, quando il teatro l’ha portata nell’IPM di Nisida. Il destino, la vita, a volte è così, prepara le cose per noi e ci mette alla prova. Lei, che ha sempre voluto fare l’attrice, che fa teatro fin da piccola ed è cresciuta coi testi di Eduardo De Filippo, si è ritrovata a interpretare il primo ruolo importante proprio in una storia ambientata in un IPM.
Giovanna Sannino ha anche scritto un libro, pubblicato nel 2020 da Licosia: Non sempre gli incubi svaniscono al mattino. In copertina, le sbarre di una prigione e una piccola finestra-feritoia che si apre su un campo di girasoli. “Tratto da una storia vera”, che poi sarebbe la sua, quella della sua famiglia. Cronaca, diario intimo e storia di un uomo, un sindaco, accusato di corruzione (ingiustamente, si racconta) e detenuto in carcere, in custodia cautelare (il libro denuncia l’abuso di questo strumento giuridico in Italia) per un tempo che le sembrò infinito. La paura, il dolore, il desiderio di capire. A proposito di destino...
La prima stagione di Mare fuori risale proprio al 2020. Una serie che, come recitava la note di produzione, racconta «ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine. Quando si è adolescenti, il confine tra bene e male è spesso labile, un sottile filo su cui si vuole camminare per mettersi alla prova».
Giovanna Sannino (nata nel 2000 a Napoli, dove vive tuttora) ha messo nel suo lavoro l’esperienza di Nisida e il ricordo della sofferenza familiare. Ed è cresciuta insieme al suo personaggio, Carmela, che sta diventando sempre più importante, una stagione dopo l’altra (soprattutto nella terza: se non l’avete ancora guardata, attenzione agli spoiler). Nel frattempo Mare fuori è diventato un fenomeno di massa, battendo ogni record. E gli interpreti della serie sono stati travolti da una notorietà improvvisa, inaspettata.
Giovanna Sannino la vive a modo suo, condividendo con gli spettatori il suo emozionante rapporto con Carmela: «Ho amato Carmela prima ancora di conoscerla a fondo. Quest’anno, però, mi ha spaventata e non poco. Tante volte ho perso tempo credendo di non essere all’altezza, poi ho capito. Ho capito che quelle parole che spesso mi vengono dette e ripetute da chi l’amore me lo dimostra ogni giorno racchiudevano un mondo enorme. Ho amato incondizionatamente quella piccola anima tra le mie braccia (...) Spero di essere riuscita a donarvi una parte di me, nel frattempo io ho vissuto un bellissimo viaggio. Ho scoperto la forza più potente del mondo: l’amore di una madre».
19 MARZO 2023
I NCONTRI (foto
Imma Petricciuoli)
A15 anni hai partecipato a un laboratorio teatrale all’IPM di Nisida. Cosa hai pensato quando hai scoperto di essere nel cast di una serie ambientata proprio in un luogo simile?
Ho subito sentito un forte senso di responsabilità. Ho iniziato a credere nel destino; è stato come se Nisida avesse aperto le porte a quella che sarebbe stata, poi, la mia strada. Credo che nulla avvenga per caso e questo evento me lo ha testimoniato. Nel momento in cui mi hanno detto che ero stata presa per Mare fuori, una serie che parla proprio dei ragazzi dell’IPM, mi sono sentita responsabile nei loro confronti. Nella mia esperienza c’erano le vite vissute dai veri ragazzi di Nisida. Mi sentivo la portavoce di quei ragazzi. Avevo la possibilità di raccontarli attraverso una serie televisiva che avrebbe avuto sicuramente una grande visibilità. Mi sono armata di tanta buona volontà e tanto amore.

Cosa ti ricordi di quell’esperienza all’istituto minorile? Su cosa avevate lavorato insieme ai ragazzi detenuti? Hai avuto modo di conoscerli, di parlare con loro, di farti raccontare le loro storie?
I ragazzi di Nisida mi hanno raccontato le loro emozioni, non i motivi per i quali erano lì. Mi hanno raccontato il loro “pre-Nisida”. Ho visto dei bambini dagli occhi spenti che non avevano mai conosciuto la spensieratezza
Con i ragazzi, abbiamo lavorato prima di tutto sull’affetto. Più che un laboratorio teatrale, è stato fatto un laboratorio di alfabetizzazione emotiva. Abbiamo lavorato sul significato di un abbraccio, di una stretta di mano, di un sorriso, perché erano gesti che non conoscevano. Siamo partiti dalle basi per poi arrivare a Romeo e Giulietta in una chiave rivisitata, scritta in napoletano da loro stessi, che hanno ascoltato la storia di William Shakespeare e l’hanno rielaborata. Abbiamo lavorato sull’universalità di un autore come Shakespeare e sui loro freni inibitori. Questi ragazzi si pongono tanti limiti, difficilmente si spingono oltre. Mi hanno raccontato le loro emozioni, non i motivi per i quali erano arrivati a Nisida. Io non ho voluto sapere di più, per non compromettere la purezza del nostro lavoro. Mi hanno raccontato il loro ‘’pre-Nisida’’. Ho visto dei bambini dagli occhi spenti che non avevano mai conosciuto la spensieratezza. Erano dei bambini nati soli, nati vecchi. Questo ha reso il lavoro che stavamo facendo insieme sempre più profondo e sempre più sensoriale.
Tu hai vissuto anche una vicenda personale molto dolorosa legata al carcere. Una brutta storia in cui è rimasto coinvolto tuo padre. Lo hai raccontato anche in un libro. Hai voglia di parlarne?
L’esigenza di scrivere un libro era quella di voler mettere ordine. C’era tanta confusione nella mia vita e soprattutto nella mia testa. Ero una bambina di quattordici anni che si era ritrovata in una tempesta. Non capivo cosa mi stava succedendo, non sapevo cosa sarebbe accaduto. La scrittura ha rappresentato un po’ il mio rifugio da tutto quello che stava accadendo intorno a me che non mi piaceva: è stato come un volersi mettere sotto le coperte quando hai paura del mostro cattivo. Ma la scrittura è stata anche una terapia.
20 MARZO 2023
GIOVANNA SANNINO (foto Imma Petricciuoli)
Mettendo nero su bianco quello che stava accadendo nella mia testa, che viaggiava da un pensiero all’altro continuamente, quel disordine è stato messo in ordine. Ordinando le parole su un foglio, riuscivo a esprimere i pensieri fatti in quei momenti.
In quel libro c’è molta rabbia e amarezza. È il racconto di una ragazza alle prese con un sistema giudiziario che a volte può rivelarsi ingiusto. Hai ritrovato un po’ di fiducia nella Giustizia in questi anni? Come ha influito quell’esperienza nel tuo lavoro per Mare fuori?
Nel libro più che rabbia, che credo sia un sentimento fine a se stesso che oscura semplicemente i pensieri, c’è una grande fame di verità. Quando sei bambina, credi di vivere in un mondo delle favole, dove tutto accade perché deve accadere, secondo dei criteri giusti. Invece ho scoperto subito che di giusto c’è molto poco. La mia ricerca della verità e la mia curiosità sono state riversate nel mio lavoro.
Questa storia è stata raccontata tante volte in maniera ingiusta e sbagliata e con tanto poco tatto, senza considerare cosa c’era dietro un uomo. Credo che sia stato dato tanto spazio a un giornalismo di inchiesta folle e spietato, senza alcun freno. Quando interpreto un personaggio, cerco sempre di indagare come se fossi un giudice che non punta il dito ma prova a comprendere qualsiasi azione il personaggio compie, per dare dignità a ciò che faccio. Non possiamo essere interpreti che diventano giudici di una certa realtà, altrimenti il nostro lavoro diventa inutile. Dico sempre che un attore salva vite esattamente come le salva un medico. Ho riversato nel lavoro questa ricerca di verità, in maniera quasi ossessiva. Quando ho la necessità di provare forti emozioni, cerco di riversare nel mio lavoro questo dolore che mi porto dentro come una cicatrice, fortunatamente chiusa. Nella terza stagione, quel dolore mi ha accompagnata a lungo.
Tu avevi deciso di recitare già da alcuni anni. È una vocazione che hai scoperto da giovanissima. Ti ricordi come e quando?
Ho sempre visto questo mestiere come una grande passione a cui non potevo rinunciare. Sapevo che avrebbe fatto sempre parte della mia vita. Poi, all’improvviso, mi sono ritrovata a lavorare e ad avere paura che tutto questo potesse finire. Una volta, un maestro di regia della Silvio d’Amico mi disse: ‘’Devi fare questo mestiere solo se è indispensabile, solo se ti fa troppo male non farlo’’. Negli ultimi anni ho capito che se un giorno non dovessi fare l’attrice, per me, sarebbe un grande dolore, quasi un lutto. Nel momento in cui ho realizzato questa cosa, ho scelto di fare l’attrice nella vita.
Come è cambiato il rapporto con Carmela, il personaggio che interpreti, in questi anni? Qual è stata la difficoltà più grande?


L’approccio con Carmela è cambiato perché ho percepito una svolta, una crescita molto lenta, come è stata la mia. Carmela è cresciuta insieme a me, ha scoperto la vita e i dolori insieme a me. E insieme, abbiamo scoperto che il dolore arriva quando meno te lo aspetti.
Il mio approccio al personaggio è cambiato, soprattutto durante la seconda e la terza stagione, dove c’è una sorta di passo in avanti per Carmela. Nella seconda stagione Carmela diventa mamma e, inevitabilmente, il suo modo di vedere la vita e la sua sensibilità cambiano in funzione del suo bambino. Ho visto in maniera diversa le responsabilità di questa giovane donna. Ora la sua anima è divisa in due. Nonostante io non abbia condiviso tante scelte di questo personaggio, non le ho mai puntato il dito contro.
23 MARZO 2023
GIOVANNA SANNINO
22 MARZO 2023
Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino e Francesco Panarella in “Mare fuori” 3 (foto Sabrina Cirillo)
(foto Francesca Cassaro)
“Ondine” (foto Lorenzo Passoni)
“Mare fuori” 3 (foto Sabrina Cirillo)
Ho compreso le sue azioni. C’è stata una forte dedizione e una grande attenzione al suo dolore, che ho sempre trattato con tanta comprensione. Considero Carmela una donna di cristallo, meravigliosamente bella in quanto madre, ma anche tanto fragile come donna.
Nella terza serie il tuo personaggio diventa sempre più importante, Carmela comincia a capire come funziona il “sistema” e non è più disposta ad accettarlo.

Sì, Carmela inizia a comprendere come funziona il sistema e comincia a rifiutarlo. Adesso ha una famiglia. Il sistema va ad urtare il suo nucleo, la sua comfort zone, che vuole conservare intatta. Edoardo non può comprendere tutto questo, ma lei deve. Questa donna è incastrata in una ragnatela che si è costruita da sola nel corso degli anni. Ma nonostante tutto, non è una mosca che resta imprigionata. Tenta di liberarsi da questi vincoli, non rispettando le regole di gerarchia del sistema. Le conosce ma le scavalca, soprattutto negli episodi finali della terza stagione, dove vediamo Carmela ribellarsi a tutte quelle regole, a quell’asservimento, pur di salvare la propria famiglia. Questo, per me, rappresenta un messaggio positivo: nonostante lei viva nel sistema, quando si rende conto che è troppo pericoloso e tutto è a rischio, gira le spalle e non ha paura, affronta tutto a testa alta.
In Mare fuori ci sono ragazzi che sbagliano e si rovinano la vita quasi senza rendersene conto. Altri invece lo fanno consapevolmente, immersi dentro una logica mafiosa, agiscono in nome di valori che si rivelano trappole, disvalori (l’onore, la famiglia, la fedeltà a un patto di sangue). Qual è il messaggio della serie, se c’è? Quale l’intenzione più profonda che sta dietro al racconto di queste storie?
In “Mare fuori” ci sono i grandi che sbagliano e i ragazzi che ne pagano le conseguenze. Il messaggio è che nessuno si salva da solo
In Mare fuori ci sono i grandi che sbagliano e i ragazzi che ne pagano le conseguenze. È una serie che racconta di responsabilità, di sbagli e di speranze. Il messaggio che emerge è che insieme si fa la forza, non da soli. Nessuno si salva da solo.
Sogni? Per il tuo futuro di attrice e di donna.
Sogno di recitare in un film diretto da Paolo Sorrentino. Voglio lavorare nel cinema “impegnato” e, perché no, anche all’estero. Mi piacerebbe anche recitare in una serie fantasy o “soprannaturale”. Ho amato molto The Vampire Diaries, per esempio. Come donna, mi auguro di avere una famiglia.
Qual è la tua redness, la cosa che ti dà la forza di alzarti la mattina, che ti motiva?
La mia mamma è la mia redness. Mi dona la forza di alzarmi tutte le mattine; è la persona che più di tutte crede in me, vive le mie ansie e le mie paure quando non credo in me stessa.
24 MARZO 2023
GIOVANNA SANNINO (foto Imma Petricciuoli)
Roberto Tardito
«Lascia tutto e seguiti» è un invito, un compito, che vale tutta una vita. Anche più di una. Franco Battiato lo cantava ne Il mantello e la spiga, che infatti evocava “vite trascorse” in forma di auriga, di ape, di «gentile mantello che coprì le spalle di qualcuno»
Echeggia un verso evangelico, in un modo che potrebbe sembrare quasi blasfemo, capovolgendo il senso della sequela (che dice “lascia tutto e seguimi”). Se non fosse che Battiato cantava, lì come altrove, la necessità di seguire la parte più profonda e più vera di sé - quella che in Oriente chiamerebbero Sé – dove l’umano e il Divino si uniscono. L’esatto contrario dell’individualismo e l’edonismo egocentrico che governa i nostri tempi. Una ricerca spirituale che in lui è sempre andata di pari passo con quella artistica, con un’originalità fatta apposta per sorprendere e sorprendersi, nel senso di portarci fuori dalle consuetudini, dall’ordinarietà. Cercare, esplorare, perdersi per ritrovarsi.
«Sotto l’ombra sospiravi / Pastore di ombre e di sotterranei segreti (…) Intona i canti dei veggenti, cedi alla saggezza, alle scintille di fuochi ormai spenti / Règolati alle temperature e alle frescure delle notti / Lascia tutto e seguiti (...) Guardo le distese dei campi / perditi in essi e non chiedere altro / Lasci un’orma attraverso cui tu stesso ti segui nel tempo e ti riconosci».

Franco Battiato - Lascia tutto e seguiti è il titolo di un libro edito da Lindau che ripercorre vita, opere e idee dell’artista siciliano. Lo ha scritto Roberto Tardito, 38 anni, musicista anche lui, cantautore (sette dischi all’at-
tivo), che coltiva una sua sensibilità per lo “spirituale” e che, non per niente, aveva già dedicato un libro ad Angelo Branduardi. Lascia tutto e seguiti ripercorre il viaggio di Battiato dall’inizio alla fine, un disco dopo l’altro, ma anche “dal fuori al dentro”, attraverso i temi e le idee. E finisce con una postfazione di padre Guidalberto Bormolini, figura importante per il percorso spirituale di Battiato, nell’ultima parte della sua vita (troverete le sue parole a pagina 34). Un uomo religioso che è stato anche liutaio, un esperto di meditazione cristiana e discipline ascetiche, sacerdote della comunità monacale “Ricostruttori nella preghiera”, ma soprattutto tanatologo, che si occupa di accompagnamento spirituale dei morenti (e docente al master Death Studies and the End of Life all’Università di Padova).
«Un’aria assente, quasi disinteressata a ciò che gli stava intorno. Un po’ mistico tibetano e un po’ prete di campagna. Vestito come un commesso viaggiatore neanche troppo fortunato, con un impermeabile beige di due taglie più grande. Così si presentò Franco Battiato nelle sue prime apparizioni televisive alla fine degli anni ’70. Artisticamente parlando aveva già cambiato almeno due vite, passando dalle canzonette degli anni ’60 alla musica sperimentale del decennio successivo (…) Negli anni ’80, poi, ottenne un successo incredibile, deridendo i costumi e le convinzioni dei suoi contemporanei, prendendo a schiaffi tutto e tutti: le ideologie, la cultura, la musica ma anche il sesso, i sentimenti e le frivolezze».
26 MARZO 2023 Roberto Tardito
I NCONTRI
“Lascia tutto e seguiti”: vita e opere di Franco Battiato raccontate da un cantautore. Musica, misticismo e libertà
Roberto Tardito riassume così, nell’introduzione, l’uomo e l’artista fuori da ogni canone, che sconcertò e poi conquistò tutti. Un musicista che «ballò con feroce ironia sulle ceneri degli anni dell’impegno e su quelle future, facilmente prevedibili, del decennio edonista»

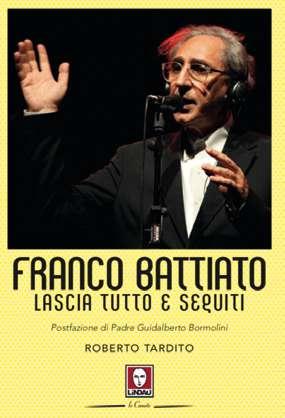

Che «cantò la società e le sue contraddizioni, ma anche la spiritualità, il misticismo, la reincarnazione. Quando scrisse di politica lo fece con lucidità e con violenza, attaccando apertamente il potere». Un artista che «non scordò mai le sue origini. Appena ottenuto il grande suc-
Ballò con feroce ironia sulle ceneri degli anni dell’impegno e su quelle future, facilmente prevedibili, del decennio edonista. Cantò la società e le sue contraddizioni, attaccando apertamente il potere
cesso la Sicilia iniziò a entrare nelle sue canzoni, per non uscirne mai più. Il ritorno a casa coincise con una nuova fase di grande ispirazione, come se finalmente tutto gli fosse apparso più chiaro. Pian piano iniziarono ad affiorare le radici arabe, le influenze orientali e tutto fiorì come fosse primavera».
La prima parte del libro riassume la sua vicenda biografica. L’approdo a Milano, il lavoro come magazziniere alla Settimana Enigmistica e le prime incisioni, l’incontro con Gaber al Cab 64, in cui fingeva di interpretare canzoni tradizionali siciliane (in realtà scritte da lui). Ma anche la vocazione spirituale, la prima esperienza estatica ascoltando Bach, l’incontro con la spiritualità orientale. E poi l’esordio con Fetus, le 20 mila copie vendute con l’apocalittico Pollution nel ‘72, pezzi sperimentali come L’Egitto prima delle sabbie (1978), «oltre il quale sembrerebbe non esistere più il suono», che rimarrà per molti anni il suo preferito. La fuga dalla musica contemporanea, chiusa in se stessa, ridotta a un “museo delle cere”, lo porterà verso il pop (a modo suo) e al milione di copie vendute da La voce del padrone. Ma vaglielo a spiegare all’ascoltatore distratto che il “centro di gravità permanente” in realtà è un riferimento al pensiero spirituale di Gurdjieff, alla sua disciplina del “risveglio”, che comparirà in altre canzoni. Di cambiamenti poi ne arriveranno altri, dal periodo elettronico a quello acustico, dalla svolta mistica alla collaborazione con Manlio Sgalambro. Tardito ci accompagna alla scoperta dei temi e delle idee, dentro le canzoni. C’è la ricerca spirituale, naturalmente, e la necessità di allenare la mente a nuovi stati di coscienza. Ma si parla anche d’amore, a modo suo (lui che diceva di non esseri mai innamorato, di non sopportare l’abitudine e la noia dei rapporti scontati, la quotidianità che ti trascina verso il basso), e dell’amata Sicilia, dove si costruì un angolo di paradiso a Milo, alle pendici dell’Etna. C’è il tramonto dell’Occidente, il vuoto, il senso di oppressione generato dalla società in cui viviamo, abitata da “neo-primitivi”, “rozzi cibernetici”, ma anche la possibilità di ritrovare “le sacre sinfonie del tempo”. «Provate a ripercorrere l’intera sua opera, andando in ordine cronologico. Non trascurate nulla: le prime canzoni, le sperimentazioni, il pop, i film. Avrete la sensazione di trovarvi di fronte un principe libero, con le vele aperte ad accogliere il vento, e proverete al tempo stesso una sensazione di malinconia, come quando si spegne qualcosa di irripetibile, mentre lo guarderete di spalle allontanarsi nel deserto»
Da quale esigenza nasce questo libro?
Dal desiderio di andare a toccare i vari temi che lui ha affrontato, sia nelle canzoni che nei film o addirittura nella pittura. Battiato era un uomo dai tanti talenti. Quando Ezio Quarantelli, direttore di Lindau, mi ha proposto di scrivere questo libro, ho pensato di non limitarmi alla sua vita e al suo percorso musicale, ma di raccontare le sue idee. Avevo già scritto per Lindau un libro su Angelo Branduardi: si tratta di due autori che possono essere accomunati per diversi aspetti.
Non è così frequente che un musicista si presti a studiare vita e opere di un collega, anche se è un mito come Battiato. Lo hai fatto con umiltà, quasi

studiandolo canzone per canzone.

L’intenzione era quella di andare a fondo. Quindi prima di cominciare a scrivere ho riascoltato tutto. Volevo avere il quadro totale della sua opera, prima di raccontarla, e infatti ho riscoperto anche diversi aspetti del suo lavoro. Nel caso di Battiato si può e si deve parlare di evoluzione artistica. Non molti musicisti hanno avuto un percorso così importante, passato attraverso fasi di totale cambiamento.
Non ti soffermi sul privato.
Conoscendo il personaggio Battiato, ho cercato di evitare ciò che lui avrebbe detestato.
29 MARZO 2023 28 MARZO 2023
Roberto Tardito
Ha passato tutta una vita a lottare con l’ego, con il “piccolo io”.
Esatto. Non aveva senso una biografia che andasse troppo sul personale.
Ci spieghi la scelta del titolo: Lascia tutto e seguiti?
È il verso di una sua canzone molto bella, Il mantello e la spiga, che è veramente emblematico, racchiude il suo pensiero, lo sintetizza bene. È un richiamo all’abbandonare le proprie certezze. Lui lo ha fatto spesso, in diverse fasi della sua vita artistica:
ha lasciato tutto, completamente, anche certezze faticosamente raggiunte, per ricominciare di nuovo, seguendo l’istinto.
Battiato è un artista paradossale per la nostra contemporaneità. Da una parte ha cambiato spesso stile, riuscendo ad essere sempre originale, ma dall’altra ha usato anche codici “di massa”, dal pop alla canzone italiana.


Dal punto di vista filosofico e spirituale, la sua ricerca è stata personalissima, ma allo stesso tempo si rifaceva a tradizioni antiche e discipline millenarie.
Paradossale, sì, ma fino a un certo punto. Quelle fonti antiche che citava e utilizzava hanno il vantaggio di aver resistito nel tempo. Si parla di idee e questioni che l’uomo si pone da migliaia di anni e che quindi hanno una forza intrinseca. In qualche modo il discorso vale anche per Branduardi, che utilizzava fonti musicali antichissime, sopravvissute ai secoli, ai millenni, proprio per la loro forza.
Quando le conosci in profondità, puoi anche provare a renderle pop.
Battiato non si è chiuso in un eremo a fare una musica eccessivamente cerebrale o elitaria. Ha cercato di diffondere certi argomenti nella cultura di massa. È stato uno dei pochi in Italia a fare una cosa del genere. Ha portato idee alte a un pubblico enorme.


Da una parte si sentiva respinto dal “sentimento delle masse” e parlava spesso del bisogno di silenzio e solitudine. Dall’altra però aveva voglia di farsi capire, di arrivare. Era un divulgatore.
Stavo proprio per usare questa parola. Io credo che si sentisse un divulgatore. Trovava uno spunto nelle sue letture, un’idea che gli sembrava particolarmente interessante e ci costruiva intorno una canzone. Intendeva se stesso come un veicolo: leggo una bella riflessione di Sant’Agostino, la faccio mia, mi stimola un’idea musi-
cale, ci costruisco intorno una canzone e divento veicolo di quel pensiero.
Se dovessi raccontare a un giovane di oggi, che non lo conosce, chi è Battiato e perché lo dovrebbe ascoltare, cosa gli diresti?
Che dovrebbe ascoltarlo per il suo coraggio musicale. Per la sua sfrontatezza. È questa l’impressione che ho avuto man mano che uscivano i suoi dischi, ma anche riascoltando quelli dei primi anni, quando ancora non c’ero. Era un artista sempre pronto a lasciare una strada che funziona per cercare qualcos’altro. E aveva la sfrontatezza di farlo senza curarsi più di tanto del pubblico. Se sentiva che una cosa era giusta lo faceva. Nella musica pop, oggi, sempre di più, c’è una totale assenza di coraggio, un adeguarsi a stili e standard che comunque sono imposti dall’alto.

La “sfrontatezza” di oggi per lo più è spettacolo, un modo per attirare l’attenzione, i like.
Lui invece ha lasciato tutto e si è seguito. Non ha mai calcolato. Ma quando lo ha fatto, ha funzionato sempre. Quando ha deciso di intraprendere il percorso pop, con L’era del cinghiale bianco, veniva da un lungo periodo di sperimentazione, di album estremi, senza mediazioni. Ma quando ha fatto il salto, non ha strizzato l’occhio a nessuno, non ha cercato di imitare alcun canone dell’epoca. Questo lo si percepisce lungo tutta la sua produzione.
31 MARZO 2023 30 MARZO 2023
Roberto Tardito
Roberto Tardito in concerto
Il coraggio ha anche pagato dal punto di vista commerciale: nessuno si sarebbe aspettato quelle vendite.
Assolutamente. Dal punto di vista discografico Battiato resta un fenomeno assurdo.
Ma tu da dove consiglieresti di partire per conoscerlo? Quali sono le cose imprescindibili da ascoltare?
Il consiglio più scontato è La voce del padrone perché li dentro c’è un mondo. C’è il suo passato, ma anche il suo futuro. C’è il misticismo, la satira sociale e politica, il sentimento ma visto in modo diverso. Suggerirei anche un disco secondo me molto interessante: Come un cammello nella grondaia, che è conosciuto per il brano Povera patria, e contiene canzoni per pianoforte, voce e orchestra, un bel cambio di direzione. Lì dentro ci sono brani di musicisti classici e cose molto riuscite come L’ombra della luce Come terzo direi Gommalacca, disco estremamente curato, con suoni che per l’epoca erano all’avanguardia, realizzato insieme a musicisti giovani legati al rock alternativo di quegli anni. Un lavoro molto aggressivo e molto profondo.
Battiato è l’emblema di un ritorno alla spiritualità intesa fuori da qualsiasi credo e dogma, seguendo però una disciplina rigorosa, a partire dalla meditazione quotidiana (evitando i rischi e le aberrazioni della spiritualità fai da te). Ma il suo messaggio era anche politico. Inteso come necessità di cambiare la coscienza per cambiare il mondo.
Esatto. Non una politica legata alla “sfera terrena”, per quanto questo possa sembrare una contraddizione. Per lui la politica era qualcosa di legato all’evoluzione dell’uomo, alla sua crescita spirituale, all’autodisciplina, di cui parla in tante canzoni. Lo diceva spesso: l’uomo avrebbe bisogno di ritrovare una disciplina. Dovrebbe guardare verso l’alto.
Nella tua musica cosa c’è di Battiato?
Io faccio cose diverse. Ciò che provo a mettere nella mia musica forse è il rigore, che accomuna Battiato e Branduardi. Rigore sia a livello lirico che a livello musicale.
C’è un altro aspetto che accomuna entrambi e su cui mi rendo conto che mi sto orientando: la dimensione spirituale, non in senso religioso, ma come evoluzione umana, interiore.
In passato hai parlato di te stesso come musicista troppo indipendente per essere mainstream, ma troppo mainstream per essere indie.
Lo aveva detto una giornalista. Mi ci riconosco.
Sei ancora in questo limbo?
Credo di sì. La scena indie ha i suoi codici, che non mi appartengono.
Tu sei più un cantautore.
Appartengo a quella sfera, sì. Ma non amo le cose arroccate negli intellettualismi. La musica è comunicazione. Come diceva Tom Petty: mai capito cosa ci sia di tanto figo nel fare dischi che poi ascoltano in quattro. Può accadere, per carità, niente di più facile, io ne sono la prova vivente, ma non può essere quello lo scopo.

C’è chi dice: “Non mi hanno capito perché sono troppo avanti”.
Il pubblico ha sempre ragione.
Tu come la vedi la scena attuale? Ci capiscono poco anche gli esperti, ormai.
La rivoluzione tecnologica e il cambiamento dei supporti, in un certo senso hanno avviato un processo di “democratizzazione”: ognuno può pubblicare ciò che vuole. Non si passa più attraverso la casa discografica che ascolta, ti segue, fa un investimento su di te. Con poche centinaia o migliaia di euro ognuno può farsi un mini-studio in casa, registrare ciò che vuole e metterlo in commercio. Questo moltiplica la libertà d’espressione a livello esponenziale.
Il problema è che c’è un’offerta smisurata rispetto alla richiesta. La musica non ha più quella funzione che aveva trenta o quarant’anni fa, quando era aggregatrice. Un tempo ci si scambiava le musicassette, si comprava il disco insieme per poi passarselo tra amici, era un rito sociale.
Dovevi stare anche molto attento a ciò che compravi. Ora puoi ascoltare qualsiasi canzone e skipparla dopo venti secondi se non ti ha convinto.
Difficile capire dove finisca la libertà e inizi il becero consumismo. Per volere tutto rischi di non avere più davvero niente.
Adesso abbiamo accesso a una biblioteca mondiale, a qualsiasi cosa prodotta in qualsiasi paese. Una volta certi dischi non arrivavano neppure, dovevi aspettarli per settimane. Per chi ha fatto tutta quella trafila, è come aver ricevuto un gigantesco regalo, che però sa apprezzare. Chi ha sempre vissuto in questo mondo, forse lo dà per scontato.
Non ci sono strumenti di orientamento
Prima o poi andranno trovati. Anche perché altrimenti l’industria discografica non può sopravvivere. Dopo il
crollo verticale di qualche anno fa, quando si scaricava la musica clandestinamente, in qualche modo le case discografiche sono riuscite a ritagliarsi un mercato grazie a Spotify, Youtube, Apple Music.
Resta il fatto che un artista non viene più seguito come una volta. Se non ti va bene il singolo, finisce lì. Un talento di 25 anni può essere bruciato in un attimo. Ma non voglio mettermi a fare discorsi da anziano sui “bei tempi andati”. Non li sopporto.
Libri come il tuo in fondo servono a ricordarci che esistono i maestri, i geni come Battiato, a cui ci si può ispirare.
Credo sia proprio questo l’aspetto interessante. Prenderli come esempio, non per fare la “buona vecchia musica di una volta”, che è una cosa che mi fa venire la gastrite, così come l’antologizzazione dei cantautori. Bisogna prendere esempio e andare oltre, fare altro.
32 MARZO 2023
Roberto Tardito
«Ha cercato la bellezza ovunque Cantava l’amore che trasforma»
UNA TESTIMONIANZA DI PADRE BORMOLINI, DALLA POSTFAZIONE DEL LIBRO LA RICERCA SPIRITUALE DI BATTIATO, LA SUA TESTIMONIANZA IN TEMPI BUI
«Che io sia ammaliato dalla tua bellezza, che io sia tratto vicino a te, che l’incandescenza dell’amore puro, penetrando nella roccia del mio essere, lo trasformi in un puro rubino». I versi del poeta mistico persiano Gialâl ad-Dîn Rûmî mi sembrano i più adatti a portare la mia testimonianza sull’opera di uno dei più grandi artisti e dei più grandi personaggi di cultura del nostro Novecento, Franco Battiato. Lui è stato un cantore della bellezza, ha cercato bellezza ovunque, ha portato bellezza dove questa non c’era. Ha messo bellezza nei cuori di chi l’ascoltava, perché più belle fossero le anime degli ascoltatori del suo canto e della sua musica (...)
Franco conosceva l’arte del canto segreto, l’arte della recita intima del Nome divino. Riempire il proprio respiro di parole divine in qualche modo è partecipare alla sinfonia della Creazione
uomo dello spettacolo. Se lo spettacolo è la sua vita, non può arrivare con questo distacco su quel palcoscenico. Era un uomo di arte, e l’arte per lui era soprattutto uno strumento per donare un altro sguardo sulla vita alle persone, cioè per cantare l’amore, l’amore che trasforma. Un artista, che non è uomo di spettacolo, deve essere anche un profeta, cioè qualcuno non tanto che prevede il futuro, ma qualcuno che anticipa il futuro. Lo stato beato della vita dell’oltre è una condizione d’incanto, e la bellezza dell’artista ce lo fa assaggiare, lo anticipa. Per questo è un vero profeta. E la profezia non si può mai ostacolare, non si può sopprimere, perché la profezia va sempre e comunque oltre. Così come successe a Gesù, che a Nazareth, quando volevano gettarlo dal dirupo, non fuggì, ma passando oltre se ne andò. È l’incarnazione della profezia, che passa oltre e se ne va. Aveva ragione De André, che cantava: «Non puoi fermare il vento, gli fai soltanto perdere tempo»
Credevano alle proprie ideologie, non sognavano quel mondo nuovo, non lo incarnavano. Sono più rivoluzionari i poeti e gli artisti. Ebbene, aveva ragione il rivoluzionario e poeta Padre Turoldo quando dichiarava che un solo verso veramente poetico avrebbe potuto far più grande tutto l’universo. È vero: cantare, poetare, è rifare il mondo, ricrearlo, partecipare all’opera del Creatore. Tutto ciò che è bello e che ci circonda ci insegna ad armonizzarci, a cantare insieme. Franco conosceva bene l’arte che gli orientali hanno fatto riscoprire al nostro mondo. L’arte del canto segreto, l’arte della recita intima nel Nome divino, l’arte del mantra. Riempire il proprio respiro di parole divine in qualche modo è partecipare alla sinfonia della Creazione. Il Nome divino, la sacra giaculatoria, cambia il potere della parola. Franco aveva la sua invocazione, recitava il Nome segreto, che sussurrava nei momenti preziosi, ed è ciò che ha permesso a lui, secondo me, di entrare nell’altra vita e far subito parte di una misteriosa sinfonia di bellezza, che dietro le quinte, nell’invisibile, contribuisce, insieme a tutti gli esseri visibili che pregano e cantano la bellezza, a che il mondo sussista, che sussista nonostante tutti gli errori che noi umani siamo capaci di creare nella nostra disumanità.
Franco non era un uomo di spettacolo. Era un artista. L’ha dimostrato con me più volte. Passare le giornate con lui e arrivare la sera a un concerto importante, meditare insieme, cenare insieme, e arrivare fino all’ultimo minuto stando piacevolmente insieme, e vederlo salire sul palco come nulla fosse. Non lo potrebbe fare un

Purtroppo gli artisti che sono anche profeti, anche se portano parole di meraviglia, non trovano sempre orecchie disposte ad ascoltarli, cioè orecchie disposte a udire, a obbedire, cioè ad ascoltare e mettere in pratica. Ringraziando il cielo, la storia dell’umanità è stata attraversata da mistici, profeti, sognatori coraggiosi, cantori, artisti, il mondo non ha mai cessato di suscitarli, ma troppo pochi sono quelli che ne accettano la sfida. Anch’io ho attraversato tante stagioni di lotte, di illusioni dentro e fuori la Chiesa, e ho visto tanti delusi, e mi rendo conto soltanto invecchiando di quanta rabbia, di quanto odio, di quanto opposto di bellezza c’era in chi diceva di credere in un mondo nuovo.
Tanti mi hanno chiesto: «Ma qual era la religione di Franco? Qual era il suo credo?». Io continuerò a fare quanto fatto finora: non rispondo! So che lui era affascinato dal mistero e il mistero deve rimanere il suo credo profondo, per non profanare la libertà di un artista. Posso però garantire che era un profondo conoscitore del cristianesimo e molto affascinato da esso, e che non è stato indifferente al messaggio cristiano nella sua vita (...)
Certo Franco ha lasciato un vuoto, però questo vuoto ci interpella, perché è il vuoto ciò che delimita lo spazio della creatività. Un architetto sa che non sono i muri che determinano l’opera della costruzione, ma è il vuoto ritmato dei muri. Ecco, sta a noi ritmare questo vuoto prendendo un frammento di questa eredità e incarnandola, rendendola vita. E in fin dei conti meditazione è svuotarci, è svuotarci per creare uno spazio in cui avvenga qualcosa di infinito (...)
Come insegnano i grandi Padri della Chiesa, come insegna tutta la tradizione mistica cristiana, come insegnano le mistiche di tanti popoli, occorre «essere
un’immagine divina di questa realtà», come Franco ha cantato nel famoso concerto nell’Aula Nervi. Che tristezza questi tempi in cui, come cantò in Come un cammello in una grondaia, «come piombo pesa il cielo questa notte, quante pene e inutili dolori. [...] E cosa devono vedere ancora gli occhi e sopportare». Certo è grande la tentazione, che canta lui, di prendere le ali e abbandonare il pianeta. Ma invece la nostra missione è stare qui, stare al fianco della gente.
In Conforto alla vita ci dice: «Nella sventura non ti colga sgomento [...] sii forte e sereno anche nei giorni dell’avverso fato». Sono proprio quelli che stiamo vivendo i giorni dell’avverso fato. Sono questi qui i giorni in cui dobbiamo dimostrare che siamo capaci di vedere «l’alba dentro l’imbrunire». Perché questo è il momento dell’imbrunire, questo è il momento della rovina. E un cantore, un poeta, un mistico è capace di vedere proprio in questa rovina, così come nel tempo in cui scrivo queste righe, che è il tempo che prepara il Natale, l’umanità ha sempre visto che nel buio incombente del sole che sembra spegnersi in realtà c’è già il seme della nuova luce, della nuova alba, di quel solstizio che dimostra che la luce incessantemente vince sempre.
35 MARZO 2023 34 MARZO 2023
di Padre Guidalberto Bormolini (©2023 Lindau, Torino)
Padre Guidalberto Bormolini ha accompagnato Franco Battiato nella sua ricerca spirituale nell’ultimo periodo della sua vita
ALENA ETTEA
Il disegno, i viaggi, la meditazione, la passione per le stelle (e le perle)
Dall’infanzia
Dice di venire dalla Romania. Ma è più probabile che arrivi da un qualche pianeta lontano, un sistema stellare perso nello spazio profondo, da dove qualcuno ci osserva e forse ride di noi. Lei ci scherza su, ma ammette di sentirsi un po’ aliena. Ricorda che da piccola era attratta in modo irresistibile dal cielo stellato. Passava ore a contemplarlo.
Quelle stelle, poi, sono diventate gioielli, che ha disegnato e che accompagnano le sue scarpe, le sue creazioni. Alena Ettea: segnatevi questo nome, destinato a diventare un brand importante. Accadrà, è inevitabile, anzi sta già accadendo. Nel frattempo Alena cammina per il mondo quasi senza toccare terra, concentrata com’è sull’unica cosa che le interessa davvero e che lei definisce “soul consciousness”, la ricerca dell’anima, la connessione con l’universo.

Lo dice nel suo incantevole italiano, che scivola, inciampa e a volte si rifugia nella lingua inglese, alla ricerca della parola giusta, del concetto esatto. Il tono della voce è pacato, gentile. Gli occhi azzurrissimi confermano la provenienza extra-terrestre. Una bellezza che non ha alcun bisogno di mettersi in mostra, talmente è evidente. “Semplicità” è un’altra parola che ama. Così come ama la meditazione, la prima cosa di cui ci troviamo a conversare. Toccherà poi alle scarpe, alla moda, al White Milano, il prestigioso tradeshow al quale è stata invitata (andato in scena dal 24 al 27 febbraio), in scena nel distretto di Tortona, tra linee d’avanguardia, designer sperimentali e nuove tendenze.
«Essere consapevoli, questa è la cosa importante» dice sorridendo. Concordiamo sull’essenziale, al di là delle tecniche e le filosofie, Steve Nobel o l’ipnosi regressiva (che lei ha sperimentato). Una consapevolezza che si esercita anche creando un gioiello o un accessorio. Anche indossandolo, se non vogliamo che sia solo «ostentazione».
Incontriamo Alena Ettea a Milano, nella sede della Garbo Press & Pr, che dovrebbe essere un ufficio e invece somiglia a un accogliente salotto, con i suoi divani e i dettagli raffinati, i mobili antichi accanto alla palla glitter da discoteca, le foto di Greta Garbo. L’atmosfera, insieme moderna e rétro, si presta perfettamente allo scopo.
«Le sue esperienze di vita e i suoi viaggi in vari paesi accrescono la sua sensibilità e la sua curiosità per tutto ciò che è diverso, profondo e insondabile. Alena ama qualsiasi cosa abbia un’anima e incarna uno spirito indipendente, profondo e genuino: semplicemente, ama la bellezza in ogni sua forma»
Queste le parole che ci hanno incuriosito, nel racconto firmato Garbo, in cui si parla di una «bambina che ama dipingere, ma il suo sogno è ideare e creare gioielli». Non per niente le sue scarpe, invece della chiusura tradizionale, hanno orecchini e gemelli. Ecco il tocco in più dell’Alena Ettea’s Luxury Shoes Collection.
37 MARZO 2023
I NCONTRI
difficile a un brand di lusso, all’insegna dell’anima di Fabrizio Tassi
Alena Ettea fotografata da Daniele Ventola
Perché di questo si tratta: scarpe di lusso, che uniscono «elementi classici e i tessuti italiani più moderni» e in cui spicca l’uso della perla, «simbolo essenziale della femminilità creatrice». Una collezione che arriva dopo l’esperienza con un marchio di abbigliamento maschile e gli studi all’Istituto di Moda Burgo a Milano e al London Collage of Fashion. Anche il marketing, ovviamente, vuole la sua parte e la comunicazione è fondamentale. In realtà non bisogna essere esperti di moda per notare il fascino e l’eleganza «senza tempo» delle sue scarpe. Ma ciò che più ci incuriosisce è il percorso che porta alla creazione. La storia di una bambina nata in Romania da una famiglia semplice, cresciuta praticamente da sola, che disegna gioielli e scarpe di lusso pensando a una donna capace di apprezzare “l’anima”, l’energia delle cose, oltre alla loro estetica.


Dove sei nata?
A Iaşi, nel nordest della Romania, nella Moldova romena.
Che infanzia hai vissuto?
Complicata. Vengo da una famiglia molto semplice. I miei genitori hanno divorziato quando avevo due anni e mezzo. Sono cresciuta con i miei nonni. Credo di aver visto mio padre cinque o sei volte in tutto.
Ti ricordi che bambina eri?
Da bambina sognavo di volare nello spazio. Mi chiedevo: come farò a uscire da questo pianeta?
Una bambina sola. Eravamo ai tempi di CeauŞescu. Mia madre lavorava in fabbrica, faceva tre turni, non poteva prendersi cura di me.
Ho vissuto fino ai 7 anni con i nonni, che erano semplici contadini. Forse proprio perché ero sola ero così attratta dal cielo stellato. Cercavo rifugio nell’universo. Ricordo le estati, la sera, a guardare la mia stella. Le mie domande erano lassù. Sapevo che esisteva vita oltre il cielo. Mi chiedevo: come farò a uscire da questo pianeta? A spargermi nel cosmo?
Quando hai scoperto che amavi disegnare?
Quando iniziai ad andare a scuola. Avevo 7 anni. In Romania negli anni Ottanta non c’era un’educazione come quella di oggi, in cui si portano i bambini ai corsi di danza, di arte... C’erano luoghi in cui potevi studiare musica, recitazione, io ero anche attratta dal pianoforte, ma vivevo in una zona in cui non esistevano cose del genere.
Quindi nessuno ha incoraggiato il tuo talento?
No. Disegnavo a scuola. Ho iniziato con gli animali, i paesaggi della natura, poi ho iniziato a interessarmi al corpo umano, al ritratto. Ho cominciato a sviluppare questo gift Ma poi l’ho lasciato da parte, ci sono tornata molto più avanti nella vita... Ho vissuto tante cose pesanti da bambina, di cui non mi piace parlare. Ma l’infanzia shape your personality accadono cose che ti marcano, episodi tristi e felici. Oggi non credo più che esistano il positivo e il negativo. Anche ciò che ti porta dolore, in realtà, ti fa crescere; è ciò che deve accadere in quel momento per il tuo sviluppo personale. Certe cose che a quei tempi non capivo, oggi hanno un senso.
39 MARZO 2023 38 MARZO 2023
ALENA
ETTEA
Swan White
(foto Daniele Ventola)
Come accade che in un ambiente del genere, con quelle difficoltà, a una ragazzina venga l’idea di creare dei gioielli?

Forse nasce tutto dall’attrazione per le stelle. O da qualcosa che era nel mio subconscio. Se prendi in mano un cristallo vero, puro, senti la sua energia
Un’attrazione più spirituale che materiale.
Esatto. Io mi rendo conto che viviamo in un mondo che mette al primo posto ciò che è materiale, ma non mi interessa. A me interessa lo sviluppo della mia anima. Crescendo, già verso i 10-12 anni, avrei voluto studiare le gemme e i diamanti. Avevo visto una scuola in California, ma naturalmente non avevo i mezzi per andarci.
Quando sei arrivata in Italia per la prima volta?
Nel 2013, ero fidanzata con un italiano, ci siamo quasi sposati. Sono rimasta a Pescara fino al 2015. Poi sono tornata in Romania. E ho cominciato a pensare che dovevo fare qualcos’altro nella vita. Ero molto affascinata da Milano. Nel 2019 ho vissuto a Hong Kong, che ha una bellissima energia. Quel luogo mi ha portato tanta pace.

Hai
Abbastanza, sì. Amo viaggiare. E viaggiando ho scoperto la mia anima gemella. Ne parlava Platone: la stessa anima incarnata in due corpi. Si dovrebbe dire twin flame, ma io la chiamo twin soul. Si dice siano estremamente rare. In uno dei miei viaggi ho incontrato questa persona ed è stata un’esperienza travolgente
Gli occhi le brillano, quando parla delle sue “esperienze umane”, come fossero qualcosa di esotico. Sa che quando si affrontano certi argomenti è meglio farlo con il sorriso sulle labbra: energie, vibrazioni, viaggi astrali, stati alterati di coscienza. Rischi facilmente di trovare qualcuno che ti guarda strano. Lei alza le spalle, con quel suo sguardo ammaliante, che si accompagna a un sorriso timido, sincero: «La gente a volte non capisce».
41 MARZO 2023 40 MARZO 2023
viaggiato molto nella vita?
ALENA ETTEA
Anais Nude Silver
Anais Nude Gold (Erika Laba, foto Paola Dossi)
Capirà invece le sue creazioni. Che hanno nomi di donna, Alena, Charlotte, Anais; che a volte sono “aggressive”, sensuali, ma hanno anche l’eleganza di un cigno (Swan); che sono Black, White e Gold, Sparkling o Nude, Coral, Green e Hot Pink, aperte o chiuse, per ragazza o per signora, a rete, a sandalo o con la punta stretta e tacchi spesso altissimi e sottili. Tutte, rigorosamente, con il proprio gioiello.

Raccontaci il tuo approdo nella moda.
Ho cominciato lavorando per un produttore di abbigliamento in Puglia, che aveva una licenza con vari brand importanti. Ero creative director. All’epoca il produttore voleva lanciare un brand. Per questo ho voluto approfondire il patterning (il cartamodello) all’Istituto Burgo. Dovevamo uscire con una linea di abbigliamento uomo. Un progetto che non si è finalizzato per vari motivi. Sono rimasta di nuovo sola, ma con una gran voglia di creare, di fare. Ho cominciato a immaginare una linea di accessori, scarpe e borse. Mi sono fermata alla scarpa. E ho subito pensato al gemello, che collega uomo e donna.
In che modo?
La perla e la conchiglia hanno un significato di rinascita. Parlano di esperienze che ho vissuto. Sono rinata più di una volta. Ammiro chi si reinventa
Di solito è l’uomo a indossare i gemelli. L’ho visto come un legame, come una congiunzione possibile. Che non riguarda necessariamente solo le coppie o le persone sposate. In realtà anche la donna può indossare una camicia con un gemello. Infatti ho in progetto di realizzare qualche camicia in organza e seta. Il secondo gemello verrà offerto come gadget.
Usi molto le perle, come mai?
Amo le perle. La perla e la conchiglia hanno un significato di rinascita. Parlano di esperienze che ho vissuto. Io sono rinata più di una volta. Credo molto in questa possibilità. Ammiro chi si reinventa dopo ogni caduta, tornando più forte di prima, scoprendo nuovi orizzonti, nuove passioni.
Per le tue creazioni parti dal disegno?
Io disegno raramente. Prima devo avere un’idea precisa, formata nella mia mente. Parto dall’accessorio e in base a quello realizzo la scarpa. Quando ho un’idea chiara la metto su un foglio e cerco dei materiali adeguati, verificando se è fattibile dal punto di vista tecnico.
Le tue fonti di ispirazione?
Faccio le mie ricerche. Amo molto Dior. Ma più che altro l’ispirazione è interiore, personale, almeno per ciò che ho creato fino adesso. Swan ad esempio è collegata alla storia delle twin soul. Lì ho messo proprio la mia anima. L’orecchino ha un significato profondo. All’inizio doveva essere a forma di cuore, poi ho visto dei cristalli molto belli ed è diventata una leaf, una foglia.




43 MARZO 2023 42 MARZO 2023
ALENA ETTEA
Dall’alto a sinistra: Evolet, Charlotte Gold, Swan Green e Anais Black (Erika Laba, foto Paola Dossi)
Alena Ettea
Ogni scarpa sembra avere una sua storia, un carattere diverso. Hai in mente la persona che potrebbe indossare ciò che stai creando?
In realtà penso a me stessa. A come mi immagino. Diverse sfaccettature di me. Ciò che esprimiamo rispecchia ciò che siamo. Dipende dagli stati emotivi. Io sono molto moody. Posso partire da un sogno, un’immagine, un desiderio, un qualche ricordo, anche qualcosa di cui non sono ancora consapevole.
Perché una scarpa di lusso?
Da bambina volevo creare una linea di gioielli. Da lì parte il concetto dell’accessorio prezioso, i gemelli da camicia, gli orecchini, l’anello. Volevo creare qualcosa di diverso, unico. La scarpa è ciò che ci connette alla terra, attraverso la pianta del piede. Crea un legame con la Madre Terra e da lì al piano cosmico, alla coscienza universale.

Cosa vorresti portare nel mondo della moda?
Una nuova energia. Ce n’è un grande bisogno, non solo nella moda. Serve nuova energia per cambiare il mondo. Ma vorrei portare anche eleganza, sensualità, autenticità, unicità.

La strada per diventare un brand è lunga.
C’è tanto da fare, sì. Non è stato facile trovare i collaboratori giusti. Superata questa fase, i prototipi, la campionatura, arriverà quella più difficile: il marketing, la vendita. Fra poco ci sarà un e-shop online. Sono anche alla ricerca di uno show room. Poi entreremo nei negozi
Dove ti vedi fra un anno?
A livello di brand? In Lane Crawford, Harvey Nichols, Rinascente... Perché no? Lavorando tanto si arriva, prima o poi. Io ho sempre seguito ciò in cui credevo. Senza fretta. Ogni situazione, ogni persona, arriva nella nostra vita quando siamo pronti, quando è il momento di fare un certo percorso
La moda, in genere, è vista come il regno dell’effimero.
La moda è un mix tra arte e design, è uno strumento per esprimere la propria creatività, le proprie emozioni. Può aiutare le persone ad essere se stesse, cercando il proprio stile. Dipende anche dalla sensibilità e dalla cultura di una persona. Chi ha un certo livello di coscienza non ama ostentare.
C’è un grande bisogno di una nuova energia, non solo nel mondo della moda. La moda è anche arte, espressione. Dipende dalla sensibilità e la cultura di una persona. Chi ha un certo livello di coscienza non ama ostentare
45 MARZO 2023 44 MARZO 2023
ALENA ETTEA
(foto Andrea Ciccalè)
Alena Ettea
Swan Black (Erika Laba, foto Paola Dossi)
Cosa cerco? Lo sviluppo della mia anima. La mia filosofia di vita? Segui i tuoi sogni. Cerca di avere una mente aperta, libera. Vivi momento per momento. Con gioia, amore, kindness
Qual è la tua filosofia di vita? La tua redness, ciò che dà un senso alle tue giornate?
Ciò che cerco più di ogni altra cosa è lo sviluppo della mia anima. Soul consciousness. Nel passato ero quasi ossessionata da questa ricerca, avevo molte domande. Ora ho iniziato ad avere una maggiore percezione e consapevolezza delle cose. La filosofia di vita? Segui i tuoi sogni, credi in te stessa, sempre, non ascoltare chi cerca di scoraggiarti. Se avessi ascoltato certa gente non avrei mai creato una collezione. Devi sapere cosa vuoi nella vita. Poi bisogna avere una mente molto aperta, libera. Vivere momento per momento. Vivere con gioia, amore, kindness
È un cammino lungo.
Ho scoperto che se cerco una cosa, quella non arriva. Magari ho una domanda, me la faccio nella testa, ma la risposta arriva quando la lascio andare. Succede anche nella meditazione. Se hai delle aspettative finisci per nutrire l’ego.
Anche la passione ti può portare all’ego, se vissuta male. Io ho sofferto molto per questo. Credo faccia parte del mio background di bambina: non avendo una figura di madre e padre davanti, non sapevo cos’era l’amore. Fino a vent’anni ho avuto un concetto sbagliato dell’amore. Ho imparato dai film, dalle cose che ho letto, dalle persone. Ho dovuto educarmi da sola alla vita.
Torni spesso a casa?
Nel periodo Covid non ho visto mia madre per due anni e mezzo. L’ho rivista l’anno scorso. Ma vorrei essere più presente. Io ho avuto un rapporto molto forte con mia nonna, una parte di ciò che sono lo devo a lei, a livello di anima. Ma non c’ero quando lei se n’è andata. Mi sono sentita in colpa. È stata un’emozione molto forte.
Tua madre come vive la tua carriera?
All’inizio non ci credeva. Pensava fosse impossibile che una ragazza arrivasse dalla Romania per costruire un suo brand a Milano. Ha cominciato a crederci solo dopo aver visto la collezione, lo shooting, i feedback che ho cominciato a ricevere


Sei una persona solitaria?
Mi piace molto la solitudine. Essere con me stessa, le mie idee.
Ci sono esperienze interiori di cui è difficile parlare.
Io faccio fatica a esprimermi a parole. Ma amo la profondità delle cose. Guardo l’anima delle persone, non il loro “avatar”. Siamo tutti speciali. Cerchiamo la libertà, l’amore puro, incondizionato. Una volta l’ho sperimentato...
Giorni fa, sui social, Alena Ettea ha pubblicato una frase di Giordano Bruno. Quando mancano le parole, ci si può sempre esprimere con le azioni, i sentimenti, le creazioni (anche scarpe e gioielli, perché no?). Oppure citando le parole di qualcuno che le sapeva usare: «Verrà un giorno che l’uomo si sveglierà dall’oblio e finalmente comprenderà chi è veramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo. L’uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo (…) In tanti siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze, porre i semi della nuova cultura che fiorirà, inattesa, improvvisa, proprio quando il potere si illuderà di avere vinto».
47 MARZO 2023 46 MARZO 2023
ALENA ETTEA
Swan Hot Pink (Erika Laba foto Paola Dossi)
«Il praticante entra in sala con un solo obiettivo: evadere dalla persona che gli altri ritengono sia e inabissarsi in se stesso, al di là di se stesso e oltre ogni concepibile ipotesi di personalità e carattere per poi dimorare nella sua essenza (...) Il verbo “inabissarsi” potrebbe sembrare ammantato di pericoli, come se si trattasse di calarsi in una forra oscura, ma per il praticante l’uomo e la donna non nascondono alcuna cavità maligna, bensì una breccia, un canyon, una
profondità a suo modo piacevolmente vertiginosa. Benché sia impossibile scorgerne pareti e fondo, è uno spazio di consapevolezza e sicurezza infinite. In questo luogo remoto dimora il Sé, un’entità per la quale lo yoga ha molti nomi e diverse interpretazioni»

Lo lasciamo dire a lui, visto che Silvio Bernelli ci sa fare con le parole. È editor e scrittore, insegna alla Scuola Holden di Torino, ha pubblicato romanzi come Dopo il lampo bianco e Il biografo di Botto&Bruno. Ha anche un (grande) passato da musicista, come ha raccontato ne I ragazzi del Mucchio (vi dicono qualcosa le band Declino e Indigesti, la scena hard core punk degli anni ‘80?). Ma qui lo incontriamo come insegnante di yoga, fondatore di Yoga Tyaga Torino (www. yogatyagatorino.it), e soprattutto come praticante di lunga data.
Lo lasciamo dire a lui perché Silvio Bernelli ha trovato il modo giusto, anzi forse l’unico possibile, per parlare di yoga: portarci dentro la pratica. Un vero e proprio “racconto sullo yoga”, dentro una seduta, vissuta come un praticante, ascoltando le indicazioni del maestro. Succede in un libretto prezioso intitolato In Yoga, edito da Aliberti (sì, ancora loro: ogni mese troviamo una buona occasione per citare la collana “I libri della Salamandra”). Sono innumerevoli i libri dedicati a questo argomento, ma spesso (quasi sempre) sono i soliti manuali, che riciclano altri manuali, in forma di “collezione di asana” (le posizioni dell’hatha yoga), riflessioni teoriche più o meno astratte, volumi divulgativi che elencano nozioni, categorie di esercizi, classificazioni filosofiche.
«È un fatto però che queste classificazioni appassionino soprattutto gli studiosi, i docenti universitari, i sanscritisti di professione e ben poco il praticante. Con passo cauto, ben attento a non calpestare qualcosa o qualcuno, sta attraversando la sala yoga. A lui basta indovinare l’esistenza di questo Sé così riservato per trovarlo, e di conseguenza trovarsi, immediatamente e senza ombra di dubbio, neanche uno, nella sua vera casa: inaccessibile dall’esterno, incardinata in qualche anfratto della personalità, intoccabile, intoccata. L’adepto yoga sa che questo luogo si raggiunge al termine di un viaggio all’insegna della ritualità (…) Ciascuna delle persone in sala è intenta a compiere quei piccoli gesti che frastagliano il cerimoniale comune in una miriade di riti privati: il tentativo di far aderire perfettamente il telo di spugna allo stuoino, ad esempio; oppure la perizia con cui si posiziona a terra il pacchetto dei fazzolettini di carta e la spessa coperta di lana con la quale ci si coprirà dai piedi al mento durante il rilassamento che chiuderà la lezione; lo sguardo fugace che si dedica alla riproduzione incorniciata della divinità induista Ganesha, vera star delle sale yoga in tutto il mondo».

Il libro è un viaggio all’interno della pratica, tra sensazioni fisiche, emozioni e intuizioni ineffabili, passando da un esercizio all’altro. Nomi, spiegazioni e informazioni scaturiscono dalla pratica, a volte per darle un contesto o un significato, altre volte per indicare una possibile evoluzione, un approfondimento (pratico e teorico) della ricerca. Senza far mancare la voce dei grandi saggi che hanno lasciato traccia scritta dei loro insegnamenti.
Sapere dove si trova il muladhara chakra può essere utile per il praticante, ma è molto più utile che impari a concentrarsi sulle sensazioni suscitate da una posizione a gambe incrociate e gli effetti che produce sul corpo e sulla mente. Lo yoga non si esaurisce certo nella asana, anche quando è hatha yoga (uno dei rami in cui si è sviluppata questa millenaria disciplina orientale), nonostante le semplificazioni e le banalizzazioni a cui è stato sottoposto in Occidente. Ma Bernelli lo dice senza bisogno di dirlo, dentro la seduta, suggerendo l’importanza di ascoltare i suoni (dall’esterno all’interno) e l’attenzione al respiro, aprendo la via a pratyahara e dharana.
49 MARZO 2023
Lo yoga visto “da dentro” Inabissarsi in se stessi, fino al Sé
M EDITAZIONI 48 MARZO 2023
SILVIO BERNELLI HA SCRITTO UN LIBRO CHE CI ACCOMPAGNA NELLA PRATICA CON GENTILEZZA E SAPIENZA. NE PARLIAMO CON LUI, IN CONSAPEVOLEZZA
Si cita Patanjali per ricordarci quanto sia importante il suo magistero (e stimolarci a leggerlo), si intona l’Om tutti insieme, si evoca una spiritualità slegata da ogni pratica religiosa specifica (lo yoga è adatto anche agli atei). Capiamo cos’è il corpo emozionale, perché la sushumna, che percorre la spina dorsale (in una sorta di “corpo immateriale”) è «un canale immaginario ma non per questo inesistente», e come vada inteso il cosiddetto tantrismo. Mentre scopriamo alcune posizioni essenziali, nel senso che le viviamo nel loro svolgimento, ci imbattiamo in concetti che attirano la nostra attenzione, come quello della “liberazione”, scopriamo l’importanza della gratitudine, la capacità di accettare i propri limiti senza farci tiranneggiare dalle nostre debolezze, l’importanza del momento presente, da vivere qui e adesso. Ma la cosa più importante che impariamo è lasciare da parte, almeno per qualche tempo, la nostra componente razionale, di cui abusiamo spesso, per lasciarci guidare dall’esperienza, nel silenzio e nella consapevolezza. Per qualcuno si può anche aprire la percezione del «tutti siamo tutto», visto che ognuno di noi condivide lo stesso Sé.
Di sicuro un libro del genere è utilissimo come primo approccio per chi vuole farsi un’idea di cosa sia una seduta di yoga, senza perdersi in concetti astrusi. Ma è illuminante anche per il praticante, che trova le parole giuste per dire cose di cui ha già fatto esperienza.
Ci racconti il tuo primo incontro con lo yoga?

Io sono un signore di quasi 58 anni, quindi non di primissimo pelo. Ho scoperto lo yoga vent’anni fa, abbastanza per caso, come capita a molti. Avevo un fastidioso problema alla sciatica che non riuscivo a risolvere e ne parlai con una mia amica, che era una praticante yoga. Lei mi disse una cosa piuttosto sorprendente: che dovevo provare lo yoga perché secondo lei era in linea con le cose che avevo fatto in passato, con certe esperienze che avevo vissuto. Io di yoga non sapevo assolutamente nulla, ma mi aveva molto colpito tantissimi anni prima, quando ero ragazzo, ciò che avevo sentito dire da un maestro di karate. Sono stato, per qualche tempo, un giovanissimo karateka. Qui a Torino c’era un grande maestro, Buzzetti, che davanti a una platea di giovani disse: un vero karateka non combatte, un vero karateka fa yoga. Quella fu la prima volta che lo sentii nominare.

Era prima dei tempi dei “ragazzi del Mucchio”. Sì, erano gli anni ‘80. Ho smesso di praticare l’arte marziale proprio perché era incompatibile con la vita che facevo, ero troppo spesso in giro.
Con lo yoga è stato amore a prima vista? Già alla prima lezione sono caduto nell’innamoramento immediato. È stata un’esperienza straordinaria che, effettivamente, mi ha ricordato tante cose che avevo vissuto, ma me ne ha fatte scoprire di nuove. Da quel momento non ho mai smesso di praticare. Poi è accaduto un fatto molto importante: qualche anno dopo ho avuto uno spaventoso incidente stradale nelle campagne della Thailandia. L’ho raccontato in Dopo il lampo bianco. C’è anche podcast in rete, di una trasmissione Rai in cui avevo parlato di questa esperienza. La pratica yoga mi ha
aiutato a tirarmi fuori da una situazione veramente molto complessa.
In che modo?
Dopo l’incidente sono rimasto molti giorni in terapia intensiva in un ospedale di Bangkok. Sono stato operato cinque volte in dieci giorni. Mi hanno salvato. La pratica mi ha aiutato a rimanere concentrato, a vivere giorno per giorno. Conta quello che succede adesso, quello che accadrà domani non si sa. Quando sono tornato a casa ho cominciato a elaborare l’idea che avrei dovuto condividere ciò che avevo imparato. Poi è andata proprio così. Anni dopo, quando mi sono sentito pronto, mi sono iscritto a un corso per insegnanti yoga, poi a un corso di specializzazione a Rishikesh in India. Nel frattempo avevo cominciato a insegnare. Ormai sono più di vent’anni.
51 MARZO 2023 50 MARZO 2023
«Con lo yoga c’è stato un innamoramento immediato. Anni dopo ho avuto uno spaventoso incidente. La pratica mi ha aiutato molto
Che cosa ti ha insegnato in particolare la pratica? Cosa ti ha fatto scoprire di te stesso e della vita?
Contrariamente alla grande maggioranza dei praticanti, io ho avuto una vita un po’ strana, anche molto lontana da ambienti come quello dello yoga. Sono stato per molti anni musicista di un gruppo hard core punk. Ho suonato in tanti concerti, in giro per il mondo. Ero una persona che aveva già la consapevolezza di aver vissuto bene gli anni che ci sono dati a disposizione. Lo yoga me lo ha confermato e mi ha aiutato a scoprirmi un po’ di più. Mi ha riportato a contatto con il mio Sé, quello con la S maiuscola. Ciascuno ha il proprio. Il mio ha bisogno di una serie di attività artistiche. Per molti anni è stato suonare e per molti altri scrivere. Io condivido l’idea di Eric Baret dello yoga come arte. Un’arte di cura del Sé.
Un’arte che unisce l’aspetto fisco, mentale e spirituale.
Non riesco a fare queste suddivisioni, sono più per il tutto.
Noi occidentali lo facciamo per abitudine da secoli. Anch’io sono occidentale, ma proprio per questo dico che ci vuole un tutto. Siamo troppo abituati a selezionare.
«Mi ferisce e trovo orribile la volgarizzazione subita dallo yoga negli ultimi dieci anni. Ma non accade soltanto nello yoga
cazione solo per alcune persone. Alcuni di questi testi sono anche eccezionalmente complessi. Quando mi chiedono di consigliare un libro sono sempre in difficoltà. O c’è il classico manuale di Yoga – quello di Iyengar per dire il più famoso – oppure ci sono testi non sono per tutti. Non posso pensare che chi si avvicina alla pratica riesca a leggere La sintesi dello yoga di Aurobindo: sono tre volumi, 1200 pagine anche molto complesse. È la pratica che dà questa risposta ed è una risposta che ciascuno troverà da sé. Più la si trova da sé e più è autentica.
In Occidente lo yoga è stato spesso ridotto a una ginnastica esotica, presente nei palinsesti di tutte le palestre. Per non parlare delle innumerevoli versioni create da varie celebrità, soprattutto negli Usa. Una disciplina che in teoria insegna ad esser meno ego-centrati, è diventata spesso un pretesto per esaltare l’individualismo.

Il problema di chi si imbatte nello yoga per la prima volta, e magari vuole approfondirne la filosofia, è anche di tipo terminologico. Come si spiega ad esempio la differenza tra il Sé con la maiuscola e il sé con la minuscola?
Io sono restio nel dare spiegazioni di questo tipo. Ho scritto questo libro anche per dire che nella pratica ci sono tutte le risposte. Poi, certo, sono importanti anche gli insegnamenti sapienziali. I libri ce li ho e sono anche libri straordinari. Ma in generale l’oggetto libro, per lo yoga, va bene come mezzo di comuni-
La sindrome della celebrity è uno dei mali della società contemporanea, non mi sorprende. Viene promossa tramite i social media e il mondo interconnesso in cui viviamo oggi. Diciamo che noi, insegnanti di yoga, siamo un po’ i guardiani di una tradizione millenaria che comunque corrompiamo nel momento stesso in cui la utilizziamo. Io sono ben consapevole di prendere una pratica e una filosofia nate in contesti e tempi completamente diversi. Cerco tramite alcuni strumenti – la cultura, l’attenzione, la contemporaneità – di portare questi insegnamenti nel mondo di oggi. Poi c’è chi ha deciso semplicemente che questa roba andava volgarizzata. Ma questo fa parte della volgarità dei tempi. Mi ferisce e trovo orribile soprattutto la volgarizzazione subita dallo yoga negli ultimi dieci anni. Ma non accade soltanto nello yoga.
Cosa rispondere a chi dice che lo yoga è nato in un’altra cultura ed è adatta a un altro tipo umano?
Io credo che lo yoga offra un percorso dal fuori al dentro, che è il contrario di quello tipico della società contemporanea, dal dentro al fuori. In questo senso è, di per sé, una cosa che va bene ovunque. Poi è vero che l’insegnamento viene declinato in maniere molto diverse in Occidente o in India.
Ma l’India non è affatto ciò che molti praticanti (che non ci sono mai stati) credono che sia. Anche l’insegnamento non è come credono che sia. Noi qui, in Europa, in particolare in Italia, abbiamo vissuto sull’onda lunga degli anni Settanta, la scoperta un po’ fricchettona del mondo. Ma già gli indiani di quel tempo non avevano l’idea dello yoga che avevamo qui. Tornando invece al discorso precedente: ci sono tante tecniche che dello yoga hanno rubato solo il nome. E quelle sono le cose che ci sono soltanto in Occidente. Come dice un mio insegnante: quando c’è la parola yoga accanto a una parola inglese, ti stai comprando una fregatura. Ti vendono qualcos’altro.
In Occidente lo yoga è quasi solo una sequenza di asana (posizioni). Ma se leggi Patanjali scopri che questa è solo una parte del cammino, uno degli otto passi necessari per arrivare alla meta, il samadhi e la liberazione. Oltretutto l’asana è preceduta da yama e niyama (astensioni e osservanze), ci deve essere un’etica di base, altra cosa che si dimentica spesso. Nel testo sono inseriti brani da testi sapienziali molto antichi: gli Aforismi dello yoga di Patanjali, ma
«Ero una persona che aveva già la consapevolezza di aver vissuto bene i suoi anni. Lo yoga mi ha aiutato a scoprirmi un po’ di più. Mi ha riportato a contatto con il mio Sé. Condivido l’idea di Eric Baret dello yoga come arte. Un’arte di cura del Sé
anche la Shiva Samhita, l’Hatha yoga Pradipika, la Gheranda Samhita... Insomma, i testi di riferimento dell’hatha yoga. L’idea era proprio quella di far vedere come un insegnamento che può sembrare così astratto e anche così difficile da leggere, in realtà nella pratica trova un’applicazione semplicissima. Nella pratica non è necessaria chissà quale spiegazione, basta mettersi lì e quella cosa sorge da se stessi, fiorisce dentro di noi, trova la sua realizzazione. Io pratico e insegno hatha yoga, l’interfaccia del corpo è molto importante, ma c’è anche l’insegnamento sapienziale. Quando ci sono entrambi, allora c’è lo yoga. Altrimenti è solo insegnamento teorico o solo fare ginnastica.
53 MARZO 2023 52 MARZO 2023
Oppure diventa tantrismo “alla Sting”, che vantava la durata delle sue performance sessuali. Quell’intervista è rimasta famosa... Io comunque non sono un asceta. Tutto dipende dalla consapevolezza con cui si fanno le cose. Lo yoga va benissimo anche per quello.
C’è una pagina molto bella nel tuo libro in cui spieghi che attraverso lo yoga ci si riappropria dell’affidarsi a qualcuno, a un maestro e a una tradizione. E però allo stesso tempo la pratica ci insegna che siamo liberi e quindi l’unica verità è quella che si scopre nella nostra esperienza. È esattamente così. Noi ci muoviamo in quello che può sembrare un paradosso. Più ci si affida alla guida e all’insegnamento di un maestro, più possiamo essere responsabili di ciò che facciamo. Noi viviamo in un mondo che sembra l’esatto contrario: basta aprire i giornali e viene raccontato di insegnanti aggrediti dai genitori dei figli; un classico esempio di incapacità di delega. Ma delegando, in realtà, si rafforza anche la propria personalità. Molte persone hanno bisogno dello yoga per ricordarselo.
«Lo yoga non serve a rifugiarsi in un paradiso immaginario. Anzi è molto importante costruire questo paradiso qui, nel rispetto degli altri
Lo yoga non è una fuga, la ricerca di una fetta di paradiso personale. Si cresce anche da un punto di vista etico, sociale, politico.
È l’esatto contrario di una fuga. C’è una frase del gruppo rock Hüsker Dü che per me era una stella polare quando ero un ragazzo: “La rivoluzione comincia a casa, preferibilmente davanti allo specchio del bagno”. Lo yoga è esattamente questa cosa. Un modo per imparare a guardare in quello specchio e capire se siamo contenti di ciò che stiamo facendo oppure no. Non sono una persona che pratica per costruirsi un paradiso immaginario. Anzi è molto importante costruire questo paradiso qui, nei giorni che sicuramente abbiamo, cercando di viverli nel rispetto degli altri. Niente di troppo complicato.
La sessione di gruppo è importante per quello. Lo yoga è qualcosa che si fa insieme. Adesso c’è questa grossa vicenda dello yoga in streaming. Anch’io tengo lezioni in streaming, però è necessario che qualche volta i praticanti stiano insieme, anche perché è molto bello vivere il gruppo, la comunità dei praticanti. Lo yoga è anche un mezzo per stare insieme, perché insieme si sviluppa l’energia e anche una voglia di ascolto che viene rinforzata da quella degli altri.
La pratica si integra bene nella tua giornata? Tu sei una persona che lavora molto con le parole, con l’intelletto.
Le parole sono il mio mestiere. Ma la mia giornata comincia con una pratica mattutina. Poi ci sono le lezioni durante il giorno. Per fortuna sono riuscito finalmente a tornare anche dal mio maestro. Calcola che la mia è una giornata molto regolare per via delle cure che devo riservare al mio corpo, molto complesse, visto che ho un corpo ricostruito. Ogni giorno ho sessioni di ginnastica, movimento, allenamento, che mi garantiscono di avere una vita normale, nonostante le quindici operazioni, di cui nove alle gambe. Ho una manutenzione complessa.
Sei la dimostrazione che lo yoga è proprio per tutti.
Lo dico sempre alle persone che me lo chiedono. Mi dicono: “Io ho un po’ male al ginocchio, posso praticare?” Io ho avuto la rotula spaccata in sessanta pezzi e mi hanno operato tre volte al ginocchio... Mi fa molto ridere questa cosa. Lo yoga ci aiuta ad andare oltre i nostri limiti. Basta capire prima quali sono. Il punto è questo. Se non li conosci ti sforzi troppo. Lo yoga aiuta ad avvicinarsi al limite e poi pian piano a superarlo, rimanendo lì vicino.
Lo yoga è nato come disciplina spirituale, ricerca dell’unione col divino, con l’assoluto. Tu personalmente vivi questo aspetto della pratica? E come lo comunichi?
È certamente parte della mia pratica, ma questo è il risultato della mia ricerca personale. Parlare dei risultati possibili prima che questa ricerca personale venga compiuta da ciascuno, è molto pericoloso. Perché può sembrare qualcosa di eccezionalmente complesso.
Non lo è affatto. L’idea della gradualità, che è la stessa che c’è nello yoga, è importante anche per questo aspetto.
È un percorso che ciascuno deve compiere, e più parole vengono dette prima, secondo me, meno questo percorso si compie.
Quindi non fai grandi discorsi a chi comincia i tuoi corsi.
Io offro gli strumenti per fare quel percorso: se lo desidera lo farà, altrimenti non lo farà. Non mi ergo a censore.
Tu cosa cerchi dallo yoga? La pace, la felicità, l’illuminazione...
La consapevolezza.
È significativa la diffusione sempre più grande di discipline come lo yoga, la mindfulness, la vipassana buddhista, che sottolineano tutte l’importanza di vivere nel momento. Lo stare qui, ora, con ciò che c’è.
Qualunque cosa che porta all’introspezione per me va già bene. È un passo. La vita di oggi è diventata eccessivamente complicata. La tensione che viviamo è molto forte, la vedo spesso negli occhi delle persone che si avvicinano per la prima volta allo yoga. C’è una grande richiesta di quiete. Lo yoga nella società occidentale è stato messo nella casella “benessere”, in realtà è ben di più. Però già riuscire a trovare un po’ di questa quiete è importante, perché è quella che permette l’esplorazione, il viaggio interiore, è già qualcosa di straordinario. Il successo di tutte queste discipline è la prova che il viaggio che dobbiamo intraprendere all’interno di noi stessi ormai è necessario a tutti. Prima o poi ci si arriverà. È un processo cominciato molto tempo fa, migliaia di anni fa, nelle foreste dell’India, e pian piano conquisterà il mondo. Speriamo.
(f.t.)
Una statua di Buddha tra le rovine di Ayutthaya, in Thailandia, dove Silvio Bernelli ha avuto l’incidente che gli ha cambiato la vita

55 MARZO 2023 54 MARZO 2023
La realtà ritrovata nel digitale Un rito collettivo: arte e memoria
IL CIELO STELLATO DI MATERA, IL CARRO DELLA BRUNA, LA FOTOGRAMMETRIA
IL SUGGESTIVO LAVORO DI CATERINA ERICA SHANTA IN MOSTRA A MILANO

Ci vogliono più di cinque mesi per realizzare il “carro della Bruna”, che ogni 2 luglio percorre la città di Matera, trainato da otto muli. Ma bastano cinque minuti per farlo a pezzi, in un delirio collettivo che è insieme affascinante e terrificante. È il famoso “strazzo”, l’assalto. Il carro trionfale di cartapesta - una vera opera d’arte, piena di statue, fregi, decorazioni colorate e una torre da cui emerge la statua della Madonna (portata in salvo prima della solenne scorreria) – viene smembrato e ridotto a uno scheletro di legno. Quasi un rito dionisiaco. Il mistero della fine, la morte, la distruzione della materia, destinata a rinascere l’anno successivo, in una forma migliore, perché il prossimo carro deve essere sempre il più bello.

Da qualche anno però c’è qualcosa di nuovo dentro quel rito. Qualcosa che avviene intorno al carro, fuori dalla scena principale. È lo spettacolo dei telefoni accessi e delle macchine digitali, le luci elettroniche che illuminano la notte della festa, sopra le teste della folla. C’è chi riesce a rubare un pezzo del carro, una sorta di reliquia – tradizionalmente, una parte dell’oggetto sacro, della divinità smembrata, dell’animale sacrificato, conserva la sua “energia divina” - e chi si limita a fotografarlo, a conservarne un’immagine.
Tanto che, unendo tutte quelle visioni parziali, è possibile “ricostruire” l’oggetto: il carro, quindi, torna a rivivere, in un certo senso continua ad esistere, in forma di creazione digitale tridimensionale.
È su questo aspetto della Festa della Bruna su cui lavora da anni (dal 2016) Caterina Erica Shanta, artista che vive a Pordenone, regista conosciuta per le sue opere video, i montaggi su materiali d’archivio, il footage creativo. Alla Fabbrica del Vapore di Milano, fino al 17 marzo (grazie a Careof, organizzazione non profit per l’arte contemporanea) è possibile vedere un allestimento dedicato a questo progetto, intitolato Il cielo stellato: un video-documentario di 50 minuti sulla festa e un altro più breve dedicato alla transumanza delle mucche murgiane (entrambi prodotti da Careof e Invisible Film, con il sostegno di Lucana Film Commission), fotografie, documenti provenienti dall’Archivio storico Franco Palumbo e alcuni esempi di fotogrammetria, di “soggetti ricostruiti”.
La gente si reca in un luogo, fotografa e ipoteticamente puoi ricostruire qualunque cosa, un doppio della realtà
57 MARZO 2023
I DEE
La questione è tutt’altro che banale. Ha a che vedere con la nostra contemporaneità, al di là dei giudizi di merito sul fenomeno. Oggi tutti abbiamo strumenti a portata di mano per fotografare qualsiasi cosa. E questo ha risvolti legati alle possibilità del digitale, l’iper-connessione, la condivisione di immagini sul web e attraverso i social. Possibilità tecnologiche che ci inducono anche a ragionare sul passato, gli archivi dimenticati o quelli mai realizzati, le immagini disperse che attendono di essere riscoperte e ripensate per riflettere su luoghi, persone, eventi storici o sociali. A volte anche per provare a ricostruire ciò che non c’è più, per studiarlo, conoscerlo, per ritrovare il monumento o il paesaggio. Da una parte c’è la cosa, il luogo, la realtà, e “dall’altra parte” c’è chi la fotografa. Generalmente la viviamo e la pensiamo così. Come se fotografare fosse solo un atto passivo, nel tentativo anche un po’ ingenuo di conservare un ricordo. Ognuno lo fa a modo suo, per i motivi più disparati, a volte quasi senza pensarci, ma ogni foto trattiene comunque qualcosa, una visione, un momento. E l’oggetto fotografato si ritrova riprodotto e frammentato in decine, migliaia, milioni di immagini diverse. Unire quei frammenti, affiancare quegli innumerevoli punti di vista, ci può restituire un “doppio” di quella realtà, una sua ricostruzione virtuale, che diventa fondamentale quando l’oggetto, l’evento, il paesaggio non c’è più. Ed ecco che l’atto singolo, lo scatto personale, diventa parte di un lavoro collettivo, per quanto inconsapevole. Il passaggio successivo è unire i pezzi e dare loro un significato.

Il terzo cielo stellato viene formato dall’insieme dei telefoni, che creano la fotogrammetria, una nube di punti nello spazio nero digitale
Ecco uno dei filoni di ricerca portati avanti da Caterina Shanta, che è nata in Germania nel 1986, si è formata a Venezia, dove ha conseguito anche un Master in Arti Visive allo IUAV (Istituto universitario di architettura) e ha già prodotto molti lavori interessanti. Citiamo ad esempio A History About Silence (2018), dedicato a due ex-militari italiani internati nei campi di concentramento (realizzato a Pieve di Cadore, al Forte di Montericco), o Palmyra (2015), proiezione video di “immagini rubate”, per rievocare un sito archeologico trasfigurato. La tempesta (2019) è “un excursus sui frammenti rimasti a seguito di un disastro climatico”, gli effetti di Vaia, capace di distruggere quasi interamente una foresta che era stata piantumata dopo la Prima guerra mondiale. Sogni (2014) racconta la Venezia del ‘43-’45, utilizzando vecchi archivi e rovine di cemento armato, la propaganda cinematografica di Salò e i rifugi antiaerei tra le calli. Terre emerse (2020) è un viaggio nelle aree bonificate, lungo i fiumi tra il Veneto e il Friuli, oggi particolarmente soggette ad alluvioni, insieme all’architetto Antonio Angelucci, per ragionare sull’acqua, l’abitare, la colonizzazione indiscriminata della terra. Ma ci sono anche lavori più personali come l’autobiografico è troppo vicino per mettere a fuoco (2012) realizzato utilizzando l’archivio di famiglia.
Il lavoro più lungo e impegnativo, però, è quello dedicato a Il cielo stellato, frutto di una lunga ricerca, tra materiali d’archivio, immagini raccolte con una open call e vari mesi passati in Basilicata, esplorando i cambiamenti storici, sociali e tecnologici legati alla Festa della Madonna della Bruna. La leggenda risale all’epoca medievale e racconta di un contadino che diede un passaggio a una giovane sconosciuta, la Madonna in persona, che gli chiese di consegnare un messaggio al vescovo di Matera.
Sul luogo dell’apparizione venne trovata un’immagine della Vergine, che venne portata in trionfo fino alla cattedrale su un carretto ornato. Sono tanti e spesso indecifrabili i significati simbolici e gli eventi, più o meno storici, che si sono sovrapposti nel generare la festa, che vanta più di 600 anni di vita. In particolare riesce difficile capire come e dove è nata la tradizione dello strazzo, che è testimoniato solo a partire dal secolo scorso. Il video intreccia testimonianze e visioni, volti e paesaggi, immagini d’archivio e riflessioni sul passato, per arrivare al rito collettivo, l’assalto finale, e alle fantasmatiche figure ottenute con la fotogrammetria. Il concreto e il virtuale come luoghi ugualmente veri, reali, che si rispecchiano uno nell’altro, guadagnando una dimensione in più.
Perché parli di “terzo cielo stellato”?
Il primo è quello che veniva visto dai viaggiatori in arrivo a Matera per la prima volta: la vallata dei sassi tutta buia con i lumini sulle finestre, che formavano un cielo speculare alla volta stellata. Il secondo è l’orizzonte tecnologico che si costruisce nella piazza: i telefoni che creano una costellazione luminosa. Il terzo cielo viene formato dall’insieme di tutti questi telefoni, che creano la fotogrammetria, una nube di punti nello spazio nero digitale.
Il progetto su Matera in realtà è nato... a Palmyra.
Tutto è partito da un lavoro che ho fatto nel 2015, l’anno della guerra in Siria. L’Isis aveva distrutto diversi siti archeologici e con l’Università IUAV di Venezia abbiamo realizzato uno spettacolo teatrale: “Omaggio di Venezia a Palmyra”. Io ero stata coinvolta per creare le scenografie, tramite una proiezione video. In quell’anno Khaled Al-Asaad, il direttore degli scavi archeologici di Palmyra, fu brutalmente ucciso dall’Isis e poco dopo l’Arco trionfale venne fatto saltare in aria.
59 MARZO 2023 58 MARZO 2023
Mi sono interrogata su come realizzare questo video e ho cominciato a cercare immagini dell’area archeologica di Palmyra prima dell’Isis. A seguito della distruzione dell’Arco trionfale ci fu una reazione molto forte da parte della comunità archeologica, che ha cominciato a chiedersi: come facciamo a salvare un patrimonio che non esiste più? Da lì è nata un’azione collettiva online di raccolta di materiali fotografici. L’idea era provare a ricreare il patrimonio distrutto attraverso la tecnica della fotogrammetria. La mappatura del sito archeologico attraverso i rilievi classici non era sufficiente e quindi si è tentata la strada digitale. Alla fine hanno realizzato dei modelli 3D attraverso la fotogrammetria e sono riusciti a stampare la parte centrale dell’Arco trionfale su pietra.
Questa tecnica, quindi, ha possibilità potenzialmente infinite. Si può applicare ovunque. La gente si reca in un luogo, fotografa e ipoteticamente puoi ricostruire qualunque cosa, puoi creare un doppio della realtà. Lo puoi fare ad esempio con il Partenone, il Colosseo, ma anche con un concerto.
O una manifestazione storica come quella di Matera. Ho cercato qualcosa che avesse delle affinità con il tema della “perdita dell’oggetto”. E ho trovato la Festa della Bruna. La manifestazione in sé è complicatissima, si intrecciano moltissime storie e motivazioni diverse sull’esistenza delle cose e il loro significato.
Però la sostanza è che viene costruito un carro trionfale gigantesco in cartapesta che a fine giornata viene distrutto, fatto a pezzi. È una specie di “grande abbuffata”, in cui tutti quanti cercano di portarsi via un pezzetto. Ma ci sono anche tante persone si dispongono intorno al carro e scattano foto. Quindi io nel 2017 ho lanciato una open call per raccogliere queste immagini.
Le ho accumulate per un anno e mezzo, con l’aiuto della Fondazione Matera-Balisicata 2019, ho coinvolto i giornali locali, ho usato i social e ogni mezzo di comunicazione per raggiungere quante più persone possibili.


Quanto materiale hai accumulato?
Stiamo parlando di cellulari del 2017 e precedenti, quindi una fotografia pesava un megabyte o poco più. Abbiamo raccolto più di 6 gigabyte di immagini. Alla mia casella di posta elettronica sono giunti materiali di ogni sorta, tra fotografie dei carri, della manifestazione e video delle varie fasi della festa. Molti dei video che sono arrivati poi li ho inseriti nel film. E a partire dalle fotografie dei carri scomparsi sono riuscita a ricostruire i modelli 3D.
Per chi vive a Matera la Festa della Bruna è molto più che folklore. Ha significati storici, sociali, religiosi. È un momento fondamentale. Poi il suo significato dipende da chi lo racconta. Per l’ambito ecclesiastico è certamente una festa religiosa. Ma è anche una festa popolare, corredata da momenti quasi dionisiaci, pagani. L’origine del rito risale alla cultura agreste. Probabilmente alcune cose sono anche pre-cristiane. Il percorso fatto dall’immagine della Madonna della Bruna intende unire la civitas medievale alla campagna, due realtà tradizionalmente opposte (ciò che era fuori dalla civitas era considerato selvaggio, altro, fuori dalle regole cittadine). In questa festa quasi carnevalesca, vengono sovvertiti i ruoli, c’è un rovesciamento dei rapporti, dove la campagna entra nella città.
Quando l’Isis ha distrutto l’arco trionfale del sito archeologico di Palmyra in molti hanno cominciato a chiedersi: come facciamo a salvare un patrimonio che non esiste più? Da lì è nata un’azione collettiva online di raccolta di materiali fotografici
61 MARZO 2023 60 MARZO 2023
Due immagini dell’allestimento ideato da Careof alla Fabbrica del Vapore di Milano, visitabile fino al 17 marzo
La storicità dello strazzo è problematica. Avendo radici così antiche e incerte sì, la festa e lo strazzo non sono corredate da una chiara documentazione. Ad esempio c’è una parte di mitologia popolare legata al conte Tramontano che, stando a un racconto del 1400 (presunto tale), aveva promesso alla popolazione un carro, per tenerla buona. Il conte era di Napoli ed era considerato un tiranno a Matera. La leggenda dice che la popolazione si ribellò e distrusse il carro per costringere il conte a regalarne uno ancora più bello, anche se poi venne pure ammazzato. C’è una strada dietro la cattedrale di Matera che si chiama via Riscatto, quella in cui il conte fu ucciso e che rappresenterebbe il riscatto del popolo materano contro il despota. Questo personaggio è stato raccontato da un film, Il conte di Matera di Luigi Capuano, che ha limato e arricchito la storia di dettagli fantasiosi, proiettato negli anni ’50 al cinema Impero di Matera. Il film raccontava alcuni aspetti, ad esempio la pratica dello Ius Prime Noctis, entrata poi a far parte della leggenda del conte Tramontano. La leggenda e la storia hanno una differenza sostanziale, difatti Mimì Andrisani, ex presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, riferisce che i primi documenti che attestano lo strazzo del carro risalgono a dopo l’Unità d’Italia.
L’atto di fotografare e filmare è entrato dentro la festa, nel vivere comune delle persone. Ma non si perde nulla della tradizione, semmai si cambia, e il nostro ruolo è capire come si cambia
Quale significato ha il pezzo di carro portato a casa e conservato?
È di buon auspicio. Poi dipende dalle diverse sensibilità. C’è chi lo vive come simbolo religioso, qualcosa in grado di proteggere. Altri invece vogliono semplicemente partecipare e prendersi un pezzo. Chi si porta via una statua intera è un eroe. L’obiettivo è quello. Alla fine la sistemi - perché avere una statua completamente integra dopo lo strazzo è davvero difficile - e il fatto di avere quella più imponente ti dà prestigio e protezione. Le puoi vedere anche nelle vetrine dei negozi quando cammini per la città.
Tutto l’anno gira intorno a quel momento.
Sì. E poi c’è il detto: “A mogghj a mogghj all’onn c’ vaèn”, che vuol dire “al meglio al meglio il prossimo anno”. Se ti sei preso un pezzo piccolo, l’anno prossimo magari ne prenderai uno grosso. Quando alla fine portano via il carro, per terra è pieno di frammenti e c’è chi cerca anche fra quelli, il pezzetto di carta dipinto, il pezzo di legno da portare a casa...
Una parte della festa è legata al ruolo dei pastori. C’è un tuo video, ipnotico, Acheronte, dedicato alla transumanza.
Il primo momento della festa, alle 4 del mattino, è la processione dei pastori. Un segno dell’esterno che entra nella città. Ma di pastori non ne sono rimasti molti. Sulla Murgia però ho trovato un vaccaro, che vive davvero di quello, con le sue cinquecento mucche, e ho documentato la transumanza. Le mucche, le vacche podoliche, si possono vedere per alcuni momenti nell’incipit del film Il cielo stellato. Volevo fornire una radice visiva che davvero cominciasse fuori dalla città.
Il video della transumanza invece racconta il tragitto che le mucche compiono dall’alta Murgia sino ad oltre il fiume Bradano, una volta chiamato Acheronte.
Come sei stata accolta? Qual è stata la reazione alla tua ricerca, che era anche di tipo antropologico?
È stato molto bello. Ho trovato una grande facilità nel parlare con le persone. Ogni volta che incontravo qualcuno, poi gli chiedevo chi altro poteva essere interessato a parlare della festa. Quindi arrivavo sempre accompagnata da un intermediario. Se non si fa così è difficile trovare le storie e le persone giuste. Sono stata anche a casa di uno “strazzatore” che ha una sua collezione privata molto grande di pezzi portati via dai carri, ovviamente in un posto segreto.
Ci sono dei veri propri figuranti: i cavalieri, gli Angeli del carro che lo difendono, gli assalitori.
Sono ruoli che le persone si danno per il giorno della festa, come il Generale della Cavalcata, che nella vita normale fa tutt’altro, o gli altri cavalieri, gli assalitori o strazzatori. Ad esempio i cavalieri indossano un costume che si può visivamente far risalire all’occupazione spagnola. Per dire che i ruoli che ognuno interpreta sono legati ad una rappresentazione della città e della sua popolazione, come una sorta di storia non scritta ma tramandata nelle forme. Poi ci sarebbe anche un discorso legato all’espropriazione dei campi, alla colonizzazione, ma anche alla ridistribuzione delle terre negli anni ‘50.
A proposito degli anni ‘50, nel tuo video si parla anche dello spostamento di migliaia di persone dai “sassi” alle case popolari. Fu un evento straordinario e anche traumatico. Allora non ci si poneva il problema di cosa si potesse conservare, riadattare, reinventare. Come dice qualcuno nel video, c’era davvero il rischio di “perdere l’anima”. Serviva qualcosa per tenere unita la comunità. Quella è stata un’operazione anche simbolica per un Paese che non poteva più far vedere che era povero - qui ad esempio mi sovviene il documentario di Joris Ivens, L’Italia non è un paese povero del 1960, commissionato da Eni, in cui si raccontava il boom economico ma anche i drammi collaterali che questo poteva significare.

63 MARZO 2023 62 MARZO 2023
A Matera si offriva un tetto, senza andare per il sottile, in un’ottica tipicamente anni Cinquanta, di welfare assistenzialista, per cui circa 15.000 persone furono sfollate nei nuovi quartieri costruiti appositamente. È stata un’operazione enorme, necessaria per certi versi a causa dello stato di sofferenza in cui molti versavano, ma traumatica, poiché la popolazione visse quel distacco come una storia passata di cui vergognarsi. Molti anni dopo in occasione de la “Capitale della Cultura Matera 2019”, il rischio è stato quello di trasformare quegli stessi sassi in una Disneyland per attrarre turismo di massa.
La digitalizzazione di solito viene intesa come smaterializzazione del mondo. La Festa della Bruna, invece, è una cosa molto concreta, materiale, c’è il lavoro dell’artigiano, il gesto della processione, la partecipazione fisica della gente. Sembrano cose in antitesi. Lo sono, o per meglio dire, lo erano. L’atto di fotografare e filmare è entrata dentro la festa, nel vivere comune delle persone. Noi viviamo nella contemporaneità e con essa cambia anche il nostro stile di vita, il modo di approcciarci alle cose tramite linguaggi e strumenti che utilizziamo. Nel momento dello strazzo ci sono le persone che si lanciano e prendono i pezzi, ma dietro ci sono tutte le altre che le seguono coi telefoni in mano, come se “strazzassero” anche loro. È un modo per partecipare, non più scindibile dall’altro.
Lo smartphone di solito ha una connotazione negativa, viene associato a chi osserva passivamente, al cittadino consumatore che guarda e non partecipa. Accade con ogni innovazione del costume. In passato mi è stato chiesto “cosa si perde”. Secondo il mio modesto parere non si perde niente, ma si cambia, e il nostro ruolo semmai è capire come si cambia. Ma non si perde la tradizione in senso lato, questa è un’idea a mio avviso errata. La tradizione è un concetto astratto che si modifica e si adatta continuamente al contesto, di per sé non esiste, è un ideale. Questo lavoro è un’osservazione del fenomeno, non mi spingo certo a dare dei giudizi etici, che non sono di mia competenza. Tuttalpiù è un modo per dire: c’è anche questo. Il resto è retorica.
La fotogrammetria è il risultato di centinaia di immagini messe insieme. Sì, è una tecnica di rilievo e conservazione archeologica digitale. Si usa ordinariamente anche in architettura e altri ambiti. Solitamente per essere più precisi si usano dei laser - laserscan - molto più precisi, ma che però possono rovinare gli oggetti. Con la fotografia invece eviti di “intaccare” l’oggetto con la luce e ottieni un risultato molto simile. Quindi un oggetto virtuale tridimensionale che puoi manipolare per l’eventuale progettazione.

Ad esempio a Pompei stanno facendo una mappatura con la fotogrammetria usando degli I-Pad Pro dotati di tecnologia Lidar con i quali ricostruiscono varie aree dello scavo al fine di poter fare progettazione non invasiva. Ora è una tecnica utilizzata tantissimo. Nel 2015 se ne iniziava a parlare in maniera più seria.
Qual è l’intenzione artistica di questo tuo lavoro? Il messaggio, se c’è?

Noi agiamo anche attraverso i dispositivi.
L’attitudine a fotografare è talmente dentro il nostro modo di agire che lo facciamo senza pensarci, inconsciamente.
I dispositivi fanno parte della nostra vita, noi ci comportiamo di conseguenza e agiamo anche attraverso questi oggetti. Si definisce così un’attitudine comportamentale. L’intento de Il Cielo Stellato è mettere in evidenza questo aspetto, portandolo all’estremo, con la sparizione dell’oggetto e la sua conseguente conservazione digitale. Ne Il Cielo Stellato si parla di un rito che non è nato per questo, ma questa attitudine è talmente dentro al nostro modo di agire che lo facciamo senza pensarci, inconsciamente. Quindi la piazza digitale agisce senza saperlo.
Quindi la piazza digitale agisce senza saperlo
Ognuno ha il suo punto di vista, ma è solo dalla somma di tutte le individualità che si ottiene il risultato.
65 MARZO 2023 64 MARZO 2023
Questi processi, le fotogrammetrie di questo tipo, sono azioni collettive, per cui emerge che il singolo conta nella somma con tutti gli altri. Per farle serve un grande numero di dati, possiamo parlare di big-data su macroscale. Potrebbero essere materiali fotografici che si caricano collettivamente su internet e che una I.A. può poi utilizzare per essere addestrata. Le nutri di immagini per poi chiederle di ricostruire gli elementi desiderati. Se non avessimo agito collettivamente negli anni, caricando miliardi di fotografie, all’infinito, su internet, queste I.A. forse non sarebbero in grado di funzionare.
Un giorno la I.A. utilizzerà il tuo archivio per ricostruire il carro della Bruna con una stampante digitale.
Allora sì che si arrabbieranno...
Spesso lavoro con gli archivi o comunque li creo. Queste masse di materiali hanno anche una valenza sociale. Contengono il personale che diventa collettivo, politico, storico
Come si colloca questo lavoro nella tua produzione?
Spesso lavoro con gli archivi o comunque li creo. Questa prassi si è affinata negli anni. Il Cielo stellato è cominciato nel 2016, è stato un processo molto lungo e inteso per esserlo, intanto ho continuato a lavorare soprattutto sugli archivi privati, di famiglia, e ho realizzato altri lavori. Questi archivi che ricerco o che creo, queste masse di materiali, spesso hanno una valenza sociale. Contengono il personale che diventa collettivo, politico e storico.
Con AHistory About Silence è successa una cosa del genere.
Il cortometraggio è nato da uno spunto, quando a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, ho trovato un monumento al centro di una piazza e mi sono chiesta cosa fosse. Solitamente i monumenti risalenti alle guerre mondiali commemorano i caduti. Questo commemorava gli ex-internati militari, quindi persone ancora in vita? Ne è nato un piccolo lavoro di ricerca, per cui ho scoperto una storia italiana dimenticata o sotto-rappresentata. A Pieve ho trovato due sopravvissuti all’internato militare ancora in vita e li ho intervistati.


Mi hanno raccontato la loro storia a partire da un pacchettino di fotografie. La loro vicenda è misconosciuta a causa dello stigma della vergogna vissuto al rientro dai campi di concentramento tedeschi. È un piccolo lavoro, ma ha un grande potenziale.
Ora su cosa stai lavorando?
È un piccolo segreto. Sto collaborando con Rawsht Twana, archivista e fotografo curdo-iracheno proprietario di un archivio sterminato non completamente catalogato. È di una bellezza inimmaginabile. L’idea è quella di fare assieme un film documentario. Attualmente stiamo lavorando all’archivio e siamo in fase di sviluppo con due case di produzione.

Viviamo in un’epoca strana: siamo assediati dalle immagini, quasi ci affoghiamo dentro, ma a volte questo ci rende paradossalmente più ciechi. Non riusciamo a “metterle in ordine”, a distinguere, a elaborare.
A volte gli archivi bisogna crearli. Un altro lavoro che ho fatto è l’archivio Misha a Progetto Borca di Dolomiti Contemporanee, a Borca di Cadore, dove c’era una colonia Eni per bambini, aperta negli anni Cinquanta. I dipendenti della Eni mandavano i figli lì per passare l’estate. E in mezzo a questa colonia c’era una gabbia con un orso dentro di nome Misha. Enrico Mattei lo ricevette in dono da Nikita Krusciov. A quell’epoca nessuno voleva trattare coi russi e invece Mattei lo fece: prezzi calmierati sul gas in cambio di gomma e tubature.
Molto attuale.
Tremendamente attuale. Credo che dopo l’omicidio di Enrico Mattei e la costruzione del Muro di Berlino, molte domande relative a quell’operazione siano rimaste in sospeso. Lo sono ancora oggi in cui vediamo una guerra novecentesca contro l’Ucraina. Krusciov apprezzava Mattei anche perché era attento al sociale - con l’idea che all’epoca si aveva del sociale. Nel 1960 gli spedì fino a Roma questo orso, simbolo della Russia sovietica, con un aereo. Forse Mattei fece l’associazione orsetto/bambino e lo fece portare alla colonia. Poi però Misha è cresciuto ed è diventato enorme, era un orso bruno. I bambini della colonia non potevano neanche avvicinarsi troppo perché era pericoloso. Ho chiesto a molti “ex-eniani” (si chiamavano così) di raccontarmi dell’orso, di mandarmi delle foto e ho cominciato a raccogliere materiali su questo animale che non ha storia. Conosci il modo di dire “raccontare la storia dell’orso”, per dire che una cosa è incredibile, al limite tra realtà e fantasia? Ecco, quando racconto l’archivio Misha, racconto la storia dell’orso. Il mio lavoro è anche questo. (f.t.)

67 MARZO 2023 66 MARZO 2023
Video e progetti realizzati da Caterina Erica Shanta in questi anni. Da sinistra: A History About Silence, Palmyra, Sogni e Misha
LA PICCOLA AZIENDA DIVENTA GRANDE CON IL LAVORO E LA QUALITÀ
Riscaldamento, idraulica, risparmio energetico.
Maxi Clima lavora per privati e grandi marchi. Tanti sacrifici, ma anche tante soddisfazioni
Avviare un’azienda, a volte, vuol dire improvvisare un ufficio nel bilocale in cui abiti, lavorando in camera da letto, su una scrivania, appoggiando le carte per terra, infilando il materiale di lavoro dove capita.
Per poi magari trasferirsi in garage,
quando le commesse crescono, portando avanti l’azienda e la famiglia insieme, scrivendo un preventivo tra una lavatrice e un’asciugatrice, a qualsiasi ora del giorno o della sera.
Quanti hanno cominciato così?
Mettendosi in proprio, dopo aver
imparato un mestiere e aver scoperto di essere bravi, dando anche del lavoro ad altre persone, magari assumendo l’amico professionista, dopo aver collaborato con lui. Per poi arrivare un giorno a rifare gli impianti di un grande albergo veneziano, di una famosa università, di una celebre catena di negozi o di supermercati italiani.
Maxi Clima, piccola azienda padovana (Ponte San Nicolò, per la precisione) è diventata grande così. Grande nelle competenze, nella qualità del lavoro e nella complessità degli interventi che si ritrova a fare. Perché in realtà è rimasta un’azienda famigliare, che impegna sei persone e che conserva lo stile tipico della piccola impresa italiana: in cui il titolare è anche un lavoratore (anzi, il lavoratore più impegnato sul campo); in cui c’è un rapporto diretto e trasparente con il cliente; in cui si garantisce la massima flessibilità e si ha la capacità di risolvere problemi che farebbero ammattire un’azienda più strutturata.
Chi sono i clienti? Si va dal privato che vuole installare un climatizzatore, all’albergo di lusso che deve ottimizzare l’impianto di riscaldamento. Dalla villa in cui vanno installati i pannelli radianti sotto il pavimento, a complessi interventi idraulici in maxi-strutture aziendali. Climatizzazione, riscaldamento, idraulica e fotovoltaico. Materia complessa, che ha bisogno di essere continuamente aggiornata, in fatto di nuove tecnologie, ma anche di varie burocrazie, legate magari agli incentivi e al risparmio energetico. Con una particolare attenzione riservata alla manutenzione.
Andrea Masiero è la dimostrazione che il lavoro e i sacrifici pagano sempre. Ha cominciato come installatore per alcune ditte quando aveva poco più di vent’anni, creandosi anche un suo pacchetto di clienti, per poi decidere di intraprendere questa strada da solo nel 2003.
Come? All’inizio lavorando con le stesse aziende con cui è cresciuto. Perché il mondo dell’idraulica è così, una grande famiglia: la concorrenza è tanta, a volte è anche spietata, ma poi ci si scambia favori e collaborazioni. Tanto che ancora oggi, vent’anni dopo, gli capita di lavorare per l’ex capo, quando lui ha bisogno di manodopera particolarmente qualificata.
Si parla comunque di lavoro per conto terzi. Una piccola azienda non può avere gli strumenti per “fare da sola”. Ma poi è Maxi Clima che ci mette la faccia quando si tratta di realizzare i lavori nel negozio Benetton, l’hotel Bellini di Venezia o la filiale di Banca Intesa. Perché è questo il prestigio dei clienti con i quali si è cimentata la ditta di Masiero. L’elenco è molto lungo: si va dal Gabrielli al Grand Hotel dei Dogi a Venezia, dai Supermercati Ali al Lidl di Padova, dal Gruppo Calzedonia a Swarovski a Bologna, e poi Ducati, Credem, San Pellegrino, le università di Padova, Verona e Venezia, la Prefettura di Trieste...
L’ultima acquisizione è Umana (l’agenzia interinale), in Veneto e Friuli, per la manutenzione e altre lavorazioni extra. Ma c’è stato anche un sopralluogo alla Pinko di Parigi e il rifacimento degli
Inaugurato nel 2009, il centro commerciale MyZeil è un gioiello architettonico, progettato da Massimiliano Fuksas e situato al centro di Francoforte. È proprio lì che Maxi Clima ha rifatto gli impianti di un negozio North Face


impianti di un North Face Store nel centro commerciale più grande di Francoforte. Mica male come referenze.

Anche se Maxi Clima oggi punta soprattutto sui privati. Dopo tanti
anni di lavoro ed esperienza accumulata ora si punta ad ampliare il portafoglio clienti. Immaginando la possibilità di ingrandirsi e di dotarsi delle certificazioni necessarie a operare in autonomia.
69 MARZO 2023 68 MARZO 2023
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA
Nel frattempo si collabora con alcune delle realtà più importanti e conosciute della provincia di Padova. E si conserva anche la struttura “casalinga” della ditta. Con tutti i sacrifici del caso. E anche gli aneddoti, soprattutto al femminile (componente indispensabile). Tipo i bonifici inviati dal letto d’ospedale il giorno dopo il parto. O le telefonate di lavoro con allattamento in corso.

È la piccola impresa italiana, fatta di fatica e ingegno. Di artigiani e professionisti che arrivano a conoscere alla perfezione il proprio mestiere e lo mettono alla prova anche a casa propria. Vedi ad esempio il luogo in cui vive oggi Masiero, trasformato in una specie di laboratorio: impianti a pavimento, canalizzazione, classe energetica +++ con materiali di altissima qualità, pannelli solari che consentono di far andare lavatrice e asciugatrice di giorno, il climatizzatore che va h24, per una spesa mensile minima.

A dimostrazione del fatto che il risparmio energetico è possibile. Basta investire a tempo debito in tecnologia.
Ciò che manca, per ora, è solo il tempo, visto che ci si trova impegnati in interventi molto complessi, che richiedono anche settimane di lavoro. Ma quando la clientela si sposterà dall’aziendale al privato, cambierà anche l’organizzazione dell’azienda. In questi anni Maxi Clima ha lavorato soprattutto nel rifacimento di impianti obsoleti, la climatizzazione, con pompa di calore, le canalizzazioni. Progetti anche di grandi dimensioni, messi su carta da uffici tecnici e ingegneri, anche se ormai l’esperienza è tale che capita spesso di intervenire proponendo modifiche sul campo. La politica degli incentivi? Si
certi casi è il più vantaggioso: per alcune pompe di calore e caldaie, lo Stato paga una parte del costo rimborsato in 6 mesi, invece dei dieci anni necessari per i rimborsi delle detrazioni classiche (che però comprendono anche la manodopera).


Alla domanda “cosa chiedereste allo Stato per aiutare le aziende come la vostra?”, la risposta però non è certo “più incentivi” ma “meno tasse”. Anche perché un lavoratore costa l’80% in più rispetto ai soldi messi in busta paga. E non si può certo far pagare quel costo al cliente.
lavora molto sul 50% e il 65%, senza dimenticare il “conto termico”, che pochi conoscono ma in
Il risultato? Si lavora di più, per provare ad ammortizzare. In un’azienda come questa, in cui ci si conosce da anni, conta anche il modo in cui si lavora insieme. La qualità viene prima di ogni altra cosa, perché è bello sentirsi fare i complimenti alla fine di una giornata di lavoro. Tanto sacrificio, sì, ma anche tante soddisfazioni.
Grandi o piccoli, poco importa. L’azienda padovana interviene anche in mega-store e capannoni (in alto). In basso, un impianto di riscaldamento a pavimento
UNA GUIDA SICURA NELLA GIUNGLA DELLA BUROCRAZIA
Corsi, documenti, certificazioni, ma anche un servizio di segreteria per le piccole aziende.
E una certezza: la sicurezza è una cosa seria
Sicurezza sul lavoro e sistemi di prevenzione, D.V.R. (Documento di valutazione rischi) e D.U.V.R.I. (rischi interferenziali), data protection e procedure in caso di infortuni, corsi, certificazioni, pratiche, mappature, norme sulla privacy e modelli gestionali...
Roba da far venire il mal di testa. Far funzionare un’azienda non

significa solo cercare clienti e fatturare. Non basta organizzare il lavoro e gestire la contabilità. Ci sono norme che bisogna conoscere e rispettare, documenti da compilare, certificati che richiedono l’intervento di un professionista.
Macla Consulting è nata per questo, dieci anni fa. O meglio, è nata per offrire questi servizi con «la massima professionalità e tra-
sparenza». Che non è solo uno slogan, un modo di dire: se il 70% dei suoi clienti sono arrivati grazie al passaparola, ci sarà pure un motivo. Non basta conoscere norme e leggi, bisogna anche saperle applicare nel miglior modo possibile, nell’interesse dell’azienda e del lavoratore. E rimanere costantemente aggiornati sui cambiamenti, che in Italia sono all’ordine del giorno. Solo così è possibile semplificare le cose, invece di complicarle. La burocrazia italiana è una giungla. Per sopravvivere bisogna essere ben attrezzati e accompagnati da qualcuno che la conosce bene. Matteo Sforza e Gianfranco Menna questo lavoro, in realtà, lo fanno da decenni. Ma ad un certo punto della loro vita hanno deciso di unire le forze ed essere più efficaci nel gestire la loro attività, coinvolgendo vari collaboratori.
I due soci che hanno dato vita a Macla Consulting dieci anni fa: Matteo Sforza e Gianfranco Menna
Macla, che ha la sua sede a San Giuliano Milanese, è una “società di servizi specializzata in consulenza e gestione dei processi aziendali”. Che detto così vuol dire tutto e niente. Ma se vai a guardare i servizi offerti, c’è un elenco che non finisce più (lo trovate nel sito maclaconsulting.it). Ci sono i classici corsi (Rspp, antincendio, primo soccorso, Haccp, utilizzo attrezzature e macchine...) ma anche la gestione e l’assistenza (organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, aggiornamenti delle valutazioni, affiancamenti per riunioni ed evacuazioni...). C’è la lavorazione e stesura di documenti, oltre all’aiuto fornito alle aziende che vogliono ottenere la certificazione UNI EN ISO. Ma
c’è anche un innovativo servizio di segreteria, fatto apposta per chi non riesce a stare dietro a tutti gli impegni amministrativi e non può permettersi di assumere un impiegato in più (ne parliamo più avanti).
Gran parte del lavoro di Macla Consulting però riguarda la sicurezza sul lavoro. Una questione su cui c’è poco da scherzare. «Di morti sul lavoro in Italia ce ne sono davvero troppi – sottolinea Matteo Sforza. - Non dico che sono tanti, dico che sono proprio troppi. È una cosa inaccettabile». Qui le norme ci devono assolutamente essere e,

anche se a volte sembrano tante e complicate, vanno accettate e seguite con scrupolo. La legge non può azzerare i rischi, ma può cercare di arginare il problema. Poi, certo, c’è anche una questione culturale, «soprattutto per certe tipologie di mestieri. Parlo di aziende che magari sono nate 40 anni fa, il cui personale ha più di 60 anni. Abituate a lavorare in un certo modo per trent’anni, fanno fatica a capire che si può, anzi si deve, evolvere nel modo di operare, aggiornando le procedure, aprendosi a tecnologie e attrezzature sempre migliori.

73 MARZO 2023 72 MARZO 2023
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA
Macla Consulting si occupa di formazione e consulenza. Valuta i rischi e insegna la prevenzione ai lavoratori
Se per trent’anni ti è andata bene forse è solo una questione di fortuna. Quando facciamo i corsi di formazione in aziende che hanno inserito dei ragazzi, notiamo che il giovane parte con una predisposizione a utilizzare i sistemi di protezione e le procedure di sicurezza. Ma poi si ritrovano il collega più esperto che dice: “io ho sempre fatto in un altro modo”». Va cambiata anche la testa di imprenditori e lavoratori. Senza dare mai nulla per scontato. «Anche montare le luci di Natale sulle strade può essere pericoloso. Le norme dicono che sulle piattaforme bisogna imbragarsi perché comunque si va a 6 metri di altezza. Sei sul cestello, è vero, ma c’è sempre il rischio di cadere».
Gianfranco Menna si era specializzato in aziende dell’ambito metalmeccanico ed edile. Matteo Sforza invece si occupava soprattutto di attività commerciali, sanitarie e di tipo logistico. Sono entrambi docenti formatori, abilitati anche come auditor per le certificazioni Iso (fanno consulenze alle aziende che vogliono certificarsi) e come Dpo (Data protection officer). «Io e il mio socio dobbiamo saper fare tutto, per avere il polso di ciò che accade in azienda e per intervenire in caso di bisogno».
Questa è un’attività in cui non si può vivere sugli allori. «Serve un continuo aggiornamento e studio, indipendentemente dalle normative che ti impongono di fare dei corsi per rimanere abilitato come formatore e come Rspp. Al di là degli obblighi, è una questione di professionalità.
Siamo in un Paese in cui qualsiasi tipo di norma subisce prima o poi una revisione o un’aggiustatina».
Per non parlare di quando la legge viene scritta senza poter essere attuata pienamente. Vedi ad esempio l’ultimo decreto Draghi, dedicato alla sicurezza sul lavoro. «Ha voluto giustamente calcare la mano su alcune peculiarità. Si parla, tra le altre cose, di obblighi del datore di lavoro e dell’inserimento di una figura obbligatoria, quello del preposto. Ma si rimandava parte dell’operatività della legge (relativamente alla formazione) a un accordo Stato-Regioni che poi non c’è stato. Esiste quindi una legge, perché il decreto è attuativo, ma non sappiamo come metterla in pratica».
L’era Covid non ha certo semplificato le cose. «In quegli anni, con i vari governi Conte, il venerdì sera emettevano un decreto che entrava in vigore sabato mattina. Nessuno era preparato a gestire una pandemia. Hanno tutti improvvisato, più o meno. E l’imprenditore italiano – per mancanza di tempo, a volte anche per pigrizia – faticava a interpretare le norme. Le procedure Covid erano inserite in decreti che non erano difficili da leggere, ma a volte facevano riferimento ad altre normative regionali».
L’emergenza sanitaria «ha fatto una grossa selezione tra chi era imprenditore e chi non lo era. Ma c’è stata anche qualche vittima illustre, soprattutto nel settore del commercio e della ristorazione»
Macla non ne ha risentito più di tanto, a parte doversi adeguare ai sopralluoghi virtuali, da remoto. Per andare incontro ai propri clienti, ha fornito anche dei servizi gratuiti. «A tutti i nostri clienti, indipendentemente dalla loro


dimensione, abbiamo garantito tutto ciò che riguardava gli adeguamenti procedurali, gli accessi in azienda, la gestione del caso sintomatico... Sono servizi per cui non abbiamo fatto pagare un euro. Perché in un momento di difficoltà era giusto aiutare chi ha subito uno stop importante dal punto di vista economico, soprattutto parrucchieri, ristoranti, imprese edili».

Tornando all’impegno quotidiano della Macla, il lavoro si divide tra formazione e consulenza. «Sono due rami gestiti in modo separato. Una collega si occupa di tutta la parte formativa, l’organizzazione dei corsi, il reperimento dei docenti per quelli che non possiamo erogare direttamente (per il primo soccorso, ad esempio, serve un medico). Per quanto riguarda la consulenza,
gran parte del lavoro riguarda ciò che classicamente viene fatto da una società come la nostra: il sopralluogo presso l’azienda, il colloquio con l’impresa, una sorta di check up della situazione, per verificare gli adeguamenti necessari.... Ci possiamo anche assumere l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il famoso Rspp, e avere un ruolo attivo all’interno dell’azienda»
Capita raramente, ma c’è anche chi, saggiamente, prima di aprire un’azienda chiede un check up completo, per verificare che sia tutto in regola. «Un cliente, una ditta seria, ci ha chiamato perché dovevano spostarsi con i capannoni delle attività produttive e ci ha chiesto di fare i sopralluoghi tecnici e organizzativi. Voleva capire se i capannoni erano adeguati o se dovevano investire dei soldi per sistemarli»
75 MARZO 2023 74 MARZO 2023
«In questo settore serve un continuo aggiornamento e studio. Siamo in un Paese in cui qualsiasi tipo di norma subisce prima o poi una revisione o un’aggiustatina
Ma generalmente c’è poca attenzione a questo tipo di discorso. C’è chi pensa di risparmiare, evitando di rivolgersi a un consulente, e poi si ritrova a pagare multe o a non sapere cosa fare durante i controlli.
«C’è anche poca informazione. Chi apre un mini-market di cibo confezionato dovrebbe sapere di essere soggetto ad Hccp. Una cultura su questi temi andrebbe portata avanti già in ambito scolastico».
Parlando di privacy, ad esempio, capita di trovare di tutto. «Noi lavoriamo sull’adeguamento e il miglioramento. Ma quando è entrato in vigore il Gdpr, ci siamo accorti che c’erano aziende che non utilizzavano neanche le regole precedenti in vigore in Italia. Non si erano proprio mai posti il problema».
I corsi di Macla vengono erogati sia in presenza che in modalità
virtuale e ovviamente sono tutti garantiti e riconosciuti. Il futuro sarà online? Non per tutti, visto che ci sono delle tipologie di corsi che prevedono anche un addestramento sui macchinari.
L’innovazione, semmai, passa per
un servizio che Macla Consulting si è letteralmente inventato, in via sperimentale, nel periodo post-pandemia, e che verrà implementato nei prossimi mesi, inserendo un cliente per volta. Si chiama Segreteria 81 ed è rivolta in particolare alle micro-imprese, fatte di tre-quattro persone, non strutturate dal punto di vista amministrativo. Particolarmente utile per chi lavora in ambito edile. «Sono aziende che si sono trovate ad affrontare un turbine di burocrazia, che è la stesso per la micro-ditta come per la grande impresa che costruisce i grattacieli. Il titolare che è anche lavoratore va in difficoltà: chiedono dei documenti per accedere al cantiere, devo ricordarmi che devo aggiornare la formazione e prenotare le visite mediche, vogliono il Durc, intanto devo chiamare il commercialista... Passano settimane a rincorrere la burocrazia, con il rischio che poi mancano i documenti e non possono entrare in cantiere, magari con una penale da pagare perché sono in subappalto.
Non offriamo una persona che risponde al telefono al posto loro. Ma una professionista che ha la capacità di relazionarsi con il coordinatore della sicurezza, parlando la sua lingua, che conosce la documentazione necessaria a seconda della tipologia di servizio, che può interfacciarsi con lo studio paghe o il commercialista. Siamo arrivati anche a creare un software che permette di inserire i documenti in un portale cloud, per averli sempre a disposizione». Si risparmiano tempo e denaro. «Si parla di un servizio con un canone mensile intorno ai 300 euro. Che poi, volendo, si può anche implementare».
Il settore della formazione e della consulenza è piuttosto affollato, ma bisogna stare attenti a chi ci si rivolge. «C’è tanta improvvisazione. Anche perché qui non si tratta di vendere un prodotto, l’azienda è obbligata a fare certe cose per legge. Il cliente magari pensa di risparmiare dei soldi, affidandosi a un consulente improvvisato, ma non deve mai dimenticare che, in fase di controllo e verifica, o peggio ancora in caso di infortunio, le documentazioni vengono visionate. Il problema può ricadere sul datore di lavoro. Un documento di valutazione dei rischi che costa 100-150 euro – in cui non vengono fatte pagare le ore di lavoro che ci dovrebbero essere dietro – è probabile che sia un copia e incolla di qualcos’altro. In passato abbiamo trovato documenti in cui c’era una descrizione dell’azienda senza la valutazione vera e propria, per cui in realtà esiste una normativa che stabilisce dei criteri molto precisi». Per fortuna ci sono anche
professionisti e aziende serie, «loro però non li chiamo concorrenti, ma colleghi. Abbiamo anche collaborazioni storiche con altre realtà. Anni fa abbiamo partecipato tutti insieme a un progetto per un grosso gruppo italiano nell’ambito della security»

Per il resto, l’unione fa la forza: «Noi abbiamo sempre creduto nel concetto di rete di imprese. Tante competenze e professionalità diverse devono collaborare e darsi una mano. Se un’impresa ha la necessità di elettricisti, noi forniamo volentieri i contatti con i professionisti che seguiamo. Siamo un collante di conoscenze».
A volte il rapporto con i clienti diventa tale che ti chiamano per risolvere qualsiasi problema, anche al di fuori del campo specifico di cui si occupa Macla. «È capitato che ci chiamassero per questioni legate alle buste paghe o per risolvere un problema informatico. Questo però lo leggo come un
messaggio positivo. Vuol dire che si fidano di noi».
Qualcuno ha anche evitato di finire nella rete del “superbonus edilizio”. «Ci sono tante piccole aziende in sofferenza, che lavorano in subappalto, ma non ricevono i soldi per i lavori effettuati. Chi ha una struttura con una certa forza economica può farcela, ma la piccola impresa no. Coi clienti con cui eravamo in confidenza, ci siamo permessi di sconsigliare di infilarsi in queste situazioni. Qualcuno ci ha ascoltato e oggi ci ringrazia». Se tanti clienti rinnovano il servizio, anno dopo anno, un motivo ci sarà. «C’è anche chi riesce ad arrivare alla pensione. È successo di recente, con il primo cliente della Macla, che seguiamo da dieci anni. Si creano anche delle amicizie».

Professionalità e trasparenza sono requisiti base che alla lunga pagano. Meglio essere onesti e diretti, piuttosto che vendere fumo. Il tempo è galantuomo.

77 MARZO 2023
Ukiyo è una parola giapponese che significa “mondo fluttuante”. Ci ricorda la bellezza dell’effimero, la fioritura dei ciliegi, che va amata e ammirata in quanto tale, nel momento in cui c’è, senza preoccuparsi del fatto che domani non ci sarà più. Ci dice che il mondo è in perenne cambiamento e che il modo migliore di vivere è cercare un equilibrio, un’armonia, tra il dentro e il fuori, l’individuo e la collettività, la cultura e la natura. Sta qui la sostanza del nagomi Un concetto fondamentale per chi vive in Giappone. «Non è un’esagerazione affermare che si trova al vertice della cultura e al centro della filosofia di vita giapponesi» come scrive il neuroscienziato Ken Mogi in La via del nagomi – Per vivere in pace e armonia (Einaudi). Noi occidentali abbiamo molto da imparare da quel modo di intendere la vita. Non bisogna essere monaci buddisti per capire quanto sia importante alimentarsi in modo consapevole e provare gratitudine per il cibo che mangiamo. Neanche per tenere una stanza in ordine e pulita, esercitando l’arte dell’attenzione e della misura. Non è necessario essere nati in Giappone per imparare a convivere serenamente con gli altri, per esercitare le virtù del riserbo e del silenzio, l’importanza della curiosità, l’accettare se stessi, l’accogliere ciò che non si può cambiare (il gaman, legato all’autodisciplina dei samurai e allo zen).

Ken Mogi, con grande semplicità, ci spiega che il nagomi è «equilibrio, benessere e tranquillità del cuore e della mente». Riguarda qualsiasi aspetto della vita, che sia il giusto mix di sapori e ingredienti in cucina o il modo per costruire un giardino, l’attività fisica e quella intellettuale, il rapporto con noi stessi (accettare i limiti) e con gli altri (lo zatsudan la chiacchiera che appiana i conflitti).

Dentro ci trovate l’ikigai, la tradizione del kintsugi, il satoyama (equilibrio tra civiltà e natura) e concetti come l’hara hachi bu («stomaco all’80 per cento», perché è meglio non saziarsi completamente a tavola).
Chi impara la via del nagomi sa come mantenere buoni rapporti con gli altri, anche quando c’è disaccordo, imparare sempre cose nuove, pur restando fedeli a se stessi, trovare un senso di pace in tutto ciò che fa. Vale la pena provarci.
L’approccio giapponese al mantenersi giovani non è quello di rifiutare il cambiamento, ma di accoglierlo come un evento del tutto naturale nel mondo fluttuante. Da noi esiste il concetto di tokowaka, che letteralmente significa «giovane per sempre». Nella nostra filosofia di vita il tokowaka occupa una posizione di rilievo, ma l’aspetto più interessante è che si riferisce a un processo: niente rimane uguale e tutto si rinnova (...)
Per restare eternamente giovani, insegna questa filosofia, è necessario lasciare andare il passato e accogliere, persino salutare con gioia, i cambiamenti. In pratica il tokowaka è un processo in cui si instaura un nagomi con l’invecchiamento.
La filosofia tokowaka è celebrata anche dai fondatori del teatro No, tradizione giapponese oggi inserita nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco (...)
Zeami ci ha lasciato un’analisi teorica scritta dove si fa la distinzione fra due tipi di «fiore» di un attore: uno è il «fiore di un momento», che caratterizza l’attore o l’attrice nella sua giovinezza, e l’altro il «fiore autentico», che resiste al tempo o si manifesta in età matura, quando l’interprete ha ormai le rughe, si muove lentamente e magari ha anche la schiena curva.
Il «fiore autentico» è l’eterno giovane della filosofia tokowaka, realizzato dalla grande arte del teatro No attraverso la disciplina e il duro lavoro. Un esempio di tokowaka nel mondo naturale è la fioritura dei ciliegi a cui assistiamo in primavera.
I deliziosi fiori rosa dell’albero di ciliegio sono indelebilmente associati al Giappone e celebrati proprio per la loro effimera esplosione (...) L’hanami, la tradizione giapponese di ammirare i fiori, è in fondo sinonimo di apprezzamento della vita nell’attimo presente, perché sappiamo che un giorno finirà.
Dovendo riassumerla in una frase, la filosofia di vita giapponese suonerebbe all’incirca «il cambiamento è l’unica forma di permanenza di questo mondo».
(Ken
Mogi)

80 MESE 2022
www.mondored.it
WEB AGENCY