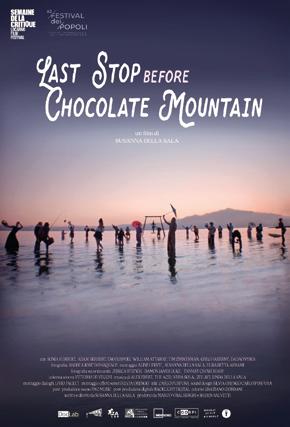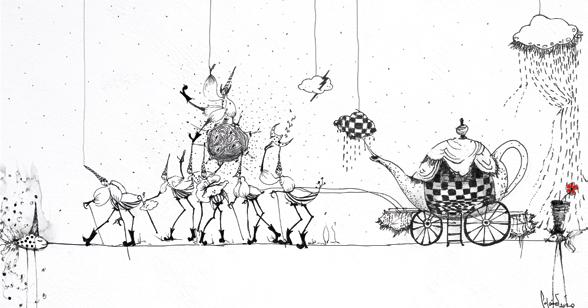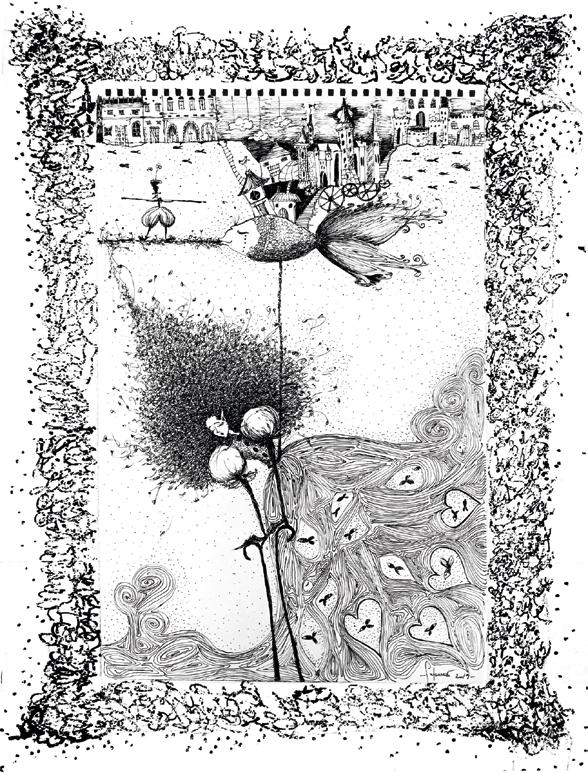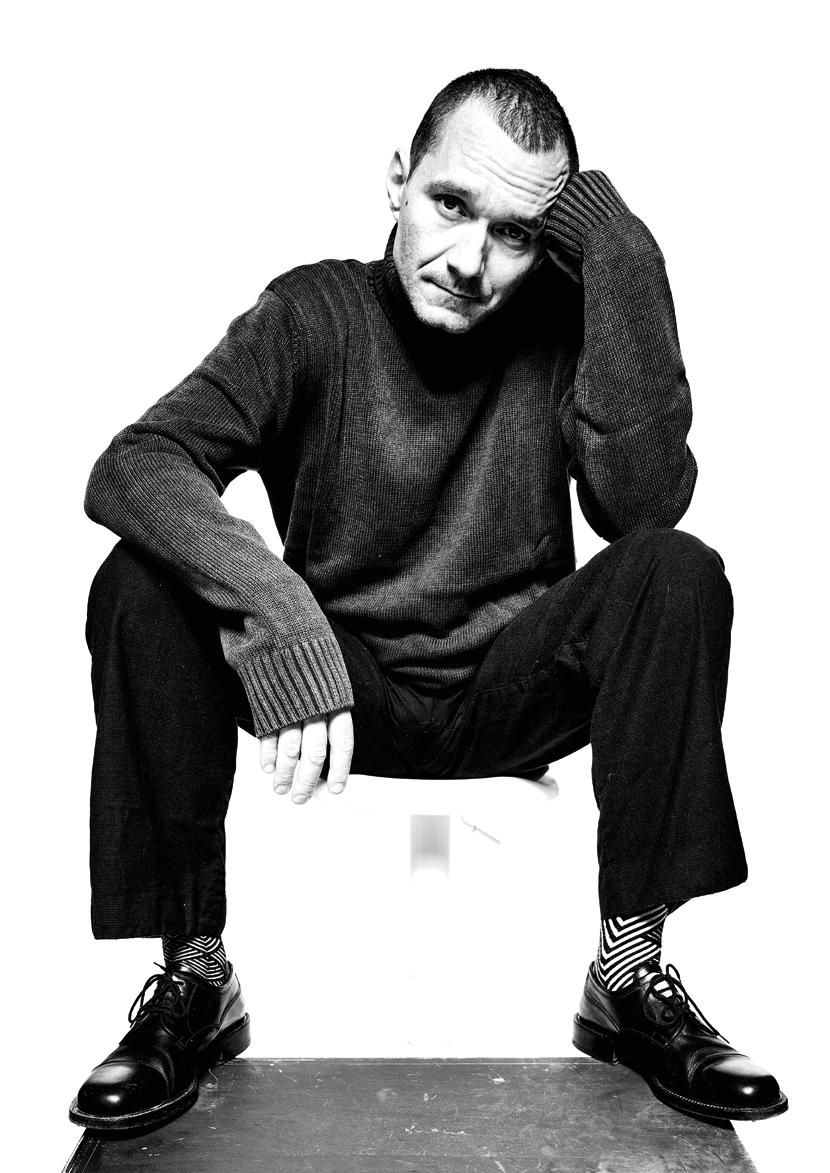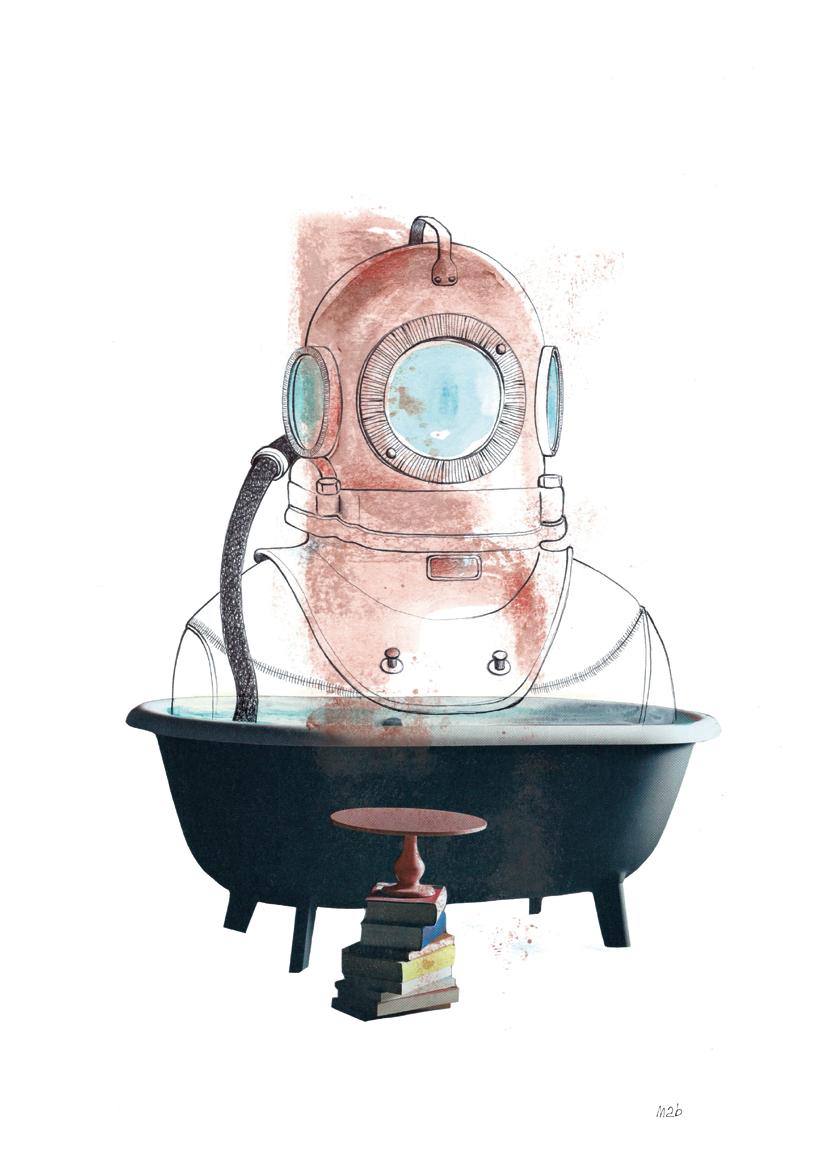Dove si parla dell’utopia di Pandora e l’inferno di Bosch, di comunità nel deserto (californiano) dove l’arte è di casa, di “essere natura”, poesia e anima, del cuore grande di Etty Hillesum, di paesaggi sonori interiori in cui è bello perdersi N 5 | GENNAIO 2023

Avatar Boosta Jheronymus Bosch Susanna della Sala Elisabetta Rasy Davide Rondoni Andrea Staid
REDness
è passione, arte, impresa, comunicazione.
È il "rossore" provocato dalle emozioni forti. Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.
La redness
è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina. È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria.
REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi.
Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità... Va bene tutto, purché sia fatto con redness.
In copertina: performance di Joséphine Wister Faure dal film “Last Stop Before Chocolate Mountain”
Foto di: Jessica Steiner (servizio a pag. 6)
Direttore: Fabrizio Tassi
Progetto grafico: Marta Carraro
Redazione: MondoRed
Redness è un mensile edito da MondoRed, Corso Buenos Aires 20, Milano
Contatti: info@redness.it, direzione@redness.it
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore
60
EDITORIALE
4 Ode al pesce-civetta
L
UOGHI
I
NCONTRI
6 Susanna della Sala: raccontare la poesia degli outsider
Andrea Staid: trovare un nuovo equilibrio tra uomo e natura 28 Boosta: le tante vite di un musicista che non si accontenta 36 Davide Rondoni: un poeta al servizio dell’anima
60 Avatar: viaggio a Pandora tra utopia e (ir)realtà 68
STORIE D’IMPRESA
74 Ambra Barbagallo: un medico sub contro i luoghi comuni 74
C
OMMIATO
74 Pietro Citati: “La ragazza dagli occhi d’oro”
MEDITAZIONI
46 Elisabetta Rasy rilegge il diario di Etty Hillesum, maestra di giovinezza 50
E
VENTI
50 Jheronymus Bosch a Milano: la verità è stravagante
3 GENNAIO 2023 2 MESE 2022 4
6
20
46
S OMMARIO
Ode al pesce-civetta
«Quando apriva gli occhi, Bosch vedeva i conigli, le streghe al sabba, gli elefanti, le scimmie, le civette, i grifoni, la luna in cielo e l’elefante-civetta, il pesce-civetta, tutte cose confuse e mescolate, che a lui sembravano quotidiane e naturalissime»

Citiamo Citati, per cominciare, e le parole che dedicò a Jheronymus Bosch - «l’ingenuo, il folle, lo spiritoso, il sapientissimo Bosch», «l’immaginoso teologo», «pittore unico, capace di attrarre tutti e di nascondersi a tutti, come un oggetto misterioso e mostruoso». A Pietro Citati, su questo numero, dedichiamo un devoto commiato. A Bosch un appassionato omaggio, come si conviene a questo genio per metà medievale e per metà rinascimentale (un ibrido che non ci dispiace affatto) e ai suoi quadri stupefacenti. Partiamo da qui per ricordarci che l’arte non è passatempo, arida
invenzione, sollazzo culturale, creazione fine a sé stessa. L’arte è un modo di guardare il mondo e dargli un ordine (o un disordine), è visione che svela, è un esercizio di consapevolezza. Bosch vedeva davvero ciò che dipingeva e lo mostrava anche a noi, con tutti i suoi significati evidenti o nascosti, che parlano all’intelletto e al sentimento. Che sia ludica o pedagogica, solenne o rivoluzionaria, l’arte è uno sguardo altro, che ci consente di vedere la verità delle cose, la loro bellezza.
Lo racconta la storia che apre la rivista di questo mese. L’arte è arrivata a Bombay Beach, nel deserto californiano, e ha trasformato un’intera comunità, che viveva ai margini del mondo, vicino a un lago tossico. Salvo poi scoprire che l’arte c’era già, praticata dagli abitanti del posto, indossata, disegnata, trasformata in giardini e canzoni, ritrovata nelle cose e nella natura.
Ce ne parla Susanna della Sala, che ha raccontato quel luogo in un bellissimo documentario, arte su arte, quindi realtà all’ennesima potenza, perché è a questo che servono film, disegni, musiche, installazioni, a farci vedere meglio, più lontano e in profondità. Qualcuno l’aveva raccontata come la storia edificante dell’arte che trasforma e salva (fin troppo radical-chic). Susanna, invece, si concentra sull’anima e la magia, l’incontro tra due mondi che si completano, la (ri)nascita di una comunità, che trova nell’arte il suo rito liberatorio, uno strumento per conoscersi meglio e provare ad andare oltre i propri limiti. Riusciremo un giorno a vivere in armonia con gli altri e la natura? Sembra una domanda un po’ naÏf. E invece è la questione che dovrebbe occupare ogni nostro pensiero - di individui e collettività, artisti e società, menti libere e governi illuminati - come ci spiega l’antropologo Andrea Staid. Essere natura non significa darsi una mano di verde (anzi “green”), comprare “bio” e parlare con gli alberi (o almeno, non solo). Significa cambiare il nostro modo di vivere e consumare, smetterla di pensarci al centro del mondo, aprirsi ad altri modi di intendere l’esistenza (vedi quelle culture extra-occidentali che concepiscono la foresta come un organismo vivente e vedono un’anima in ogni cosa). Fine della
distopia della crescita infinita. Il che non significa “tornare indietro” o vivere una vita di “rinuncia”, ma guadagnare in tempo, salute (fisica e mentale), libertà, spirito, armonia.
Quell’armonia che, guarda caso, è al centro dell’utopia cinematografica di Pandora, scelto come luogo del mese: reale o immaginario, poco importa, basta che sia “vero”. Avatar è un grande giocattolo tecnologico, ma anche una fiaba limpida, che attinge al pensiero orientale, celebra la sensibilità ecologica delle nuove generazioni, e dice qualcosa sul presente e il futuro possibile.
A proposito di anima, il poeta Davide Rondoni ci regala parole di grande ispirazione, oltre a un romanzo che provoca e affascina come lui sa fare. Mentre Elisabetta Rasy ci accompagna nell’universo interiore di Etty Hillesum, raccontata per ciò che era davvero, una ragazza che cercava la felicità, la libertà, l’amore, e che ha resistito all’orrore con la fede e l’umanità.
La colonna sonora del mese? Post Piano Session di Boosta. Musica-mondo da ascoltare (e guardare) a occhi chiusi: paesaggi interiori, contemplazioni elettriche, frammenti di melodie, distorsioni, improvvise illuminazioni, attraversando generi, suoni e rumori. L’arte non spiega, non si limita a intrattenere o rassicurare, ma aiuta a vedere e sentire. (f.t.)
5 GENNAIO 2023 4 GENNAIO 2023
E DITORIALE
Susanna della Sala
Dal disegno alla regia per raccontare la poesia degli outsider
Il mondo magico di un’artista che ha trovato l’America, quella vera
Nel deserto di Bombay Beach (California) per riscoprire cosa significa essere comunità

I NCONTRI
di Fabrizio Tassi
Ci sono storie e personaggi che solo la realtà sa scrivere. Ecco perché il miglior cinema, a volte, è quello che ha l’umiltà di mettersi in ascolto, di osservare, di “lasciarsi usare”. Quello che si mette al servizio del reale (la sua folle bellezza, la sua verità nascosta). Last Stop Before Chocolate Mountain, ad esempio. Non è certo un caso che la regista Susanna della Sala venga dal disegno e dalla scenografia, che sia anche scrittrice e montatrice – non un solo talento, ma tante passioni creative, non l’ossessione di “arrivare”, ma il gusto di cercare, sperimentare, magari anche cambiare insieme a ciò che incontri.
Il suo mondo poetico è magico e delicato, abitato da figure surreali e personaggi eccentrici, pesci, sirene, pierrot circensi. Un antidoto alla durezza e al cinismo dei tempi in cui viviamo. Un po’ come la storia che racconta nel suo film, fatta di outsider filosofi e artisti in fuga dalla società di massa, emarginati mezzi matti e musicisti anarchici. Persone sole che si fanno comunità, in un luogo incantato ai margini del mondo.
Avevo letto di un lago tossico, di un luogo definito una “discarica”, di una cittadina fantasma. Eppure quei “fantasmi” si sono rivelati di una vitalità che non avevo mai incontrato prima, spinti dalla voglia di ricostruire, creare, comunicare
tà-fantasma, abitata solo da chi non poteva permettersi di andare via o da chi era troppo legato a quella terra per abbandonarla. Una terra di nessuno, un rifugio per disperati (apparentemente), ma anche un luogo con un suo fascino misterioso, di quelli che attraggono artisti, creativi, “mistici” nomadi. Nasce da qui la seconda vita di Bombay Beach. La città ripulita, le case ricomprate, la creazione di un evento artistico, una Biennale, che ha attirato anche grandi nomi della musica, della pittura, del teatro.
Ma ciò che spicca, qui, sono le persone. La matriarca del luogo, una signora gentile approdata da giovane in questa terra con i figli, in fuga da un marito violento. Un rapinatore di banche in pensione, che passa il suo tempo girando in bici nel deserto e realizzando disegni poetici. Un “aristocratico” creativo, figlio di un uomo straordinario e ingombrante (il principe Dado Ruspoli, amico di Salvator Dalì e Brigitte Bardot, sperperatore di ricchezze, dedito all’oppio). Un poeta dai mille talenti che riesce a trasformare dei pezzi di ferro arrugginito in opere d’arte, improvvisa strofe rap e ha un modo tutto suo di celebrare il sacro della vita e del mondo.
Bombay Beach è un luogo unico, un angolo di mondo sperduto, ma è anche una metafora universale. È resistenza e riscatto. È la ricerca della realizzazione e della liberazione individuale, che si concretizza nella riscoperta della collettività, dentro una mini-società anarchica, senza leggi, senza classi, completamente autogestita, ma anche senza l’arroganza di diventare un esempio, una comunità alternativa. Susanna della Sala si è innamorata a prima vista di questo luogo e ha avuto la sua dose di “risposte” (di esperienza collettiva e liberazione personale). Il cinema - e l’arte, in generale – dovrebbe essere sempre così: non una rappresentazione di sé, ma un’immersione in una realtà altra, una diversa possibilità, da vivere e da condividere.
è certo un caso che a Milano venga presentato al Beltrade, oasi del cinema indipendente, di culto, d’autore (oggi 20 dicembre, tanto per dire, mentre scriviamo, vanno in scena sette film, dalle 11 di mattina all’1 di notte, da Singin’ in the Rain a Bones and All, passando per Last Stop Before Chocolate Mountain, Il Cristo in gola di Rezza e il ritorno de I misteri del giardino di Compton House). Così come è giusto che una delle prossime tappe, a gennaio, sia al Cinemino, altra avamposto milanese del cinema di qualità.
Come sei arrivata a Bombay Beach?
Chi potrebbe inventarsi un posto come Bombay Beach? Poche case sperdute, nel deserto californiano, vicino a un lago tossico. Qualche roulotte, tante abitazioni abbandonate, montagne di rifiuti ovunque. Era un luogo alla moda, un tempo, frequentato da gente come Frank Sinatra e Bing Crosby. I filmati di repertorio mostrano bagnanti sorridenti e gente che fa sci d’acqua nel lago. Poi un disastro ambientale ha allontanato i turisti, ha sterminato la fauna del lago (il Salton Sea), ha spopolato la contea (nel 2010 si contavano 295 abitanti).
Una meta vacanziera à la page trasformata in una cit-
Ne parliamo con lei in un locale di Milano, vicino al cinema Beltrade, mentre aspettiamo che arrivi l’ora della proiezione. È una tappa del tour del film in giro per l’Italia. Fra poco lo presenteremo al pubblico milanese, dopo che il documentario è stato selezionato dal festival di Locarno e proiettato al Festival dei Popoli (dove ha vinto tre premi). Oltre a Firenze è già stato a Roma, Bologna e Genova. Lei, ovviamente, non manca mai, perché questo è uno di quei film che vanno accompagnati e sostenuti in ogni modo, per trovare il suo spazio in un mercato bulimico e impietoso, in cui sopravvive solo il più forte. Non
Grazie a Tao Ruspoli, uno dei protagonisti del film, che ho conosciuto per caso nel 2011. Mia sorella lavorava in America a San Francisco. Sono andata a trovarla e volevamo improvvisare un road trip di due giorni. Abbiamo trovato un camper da affittare e il proprietario era lui.
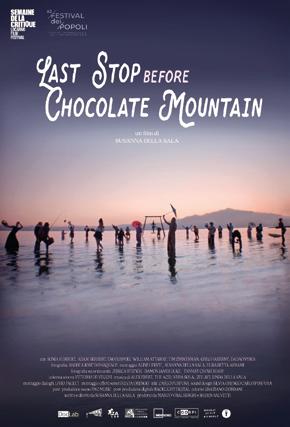

Quindi è una storia cominciata per puro caso, più di dieci anni fa.
Assolutamente casuale. Tra l’altro, alla fine, il camper non lo abbiamo più affittato. Ma lui ha questa personalità così forte, eccentrica, e visto che eravamo italiane come lui, ci ha invitato a casa sua a Venice Beach, a Los Angeles. Lo abbiamo conosciuto, abbiamo bevuto un caffè e ci ha raccontato la sua storia. Poi siamo rimasti in contatto, perché lui a quel tempo faceva il documentarista.
Susanna della Sala
8 GENNAIO 2023
9 GENNAIO 2023
(foto Jessica Steiner)
Tu eri ancora agli inizi.
Non avevo ancora girato il primo corto. Siamo rimasti in contatto a distanza. Uno scambio artistico. Gli chiedevo consigli. Quando poi gli ho mandato il corto Il Dottore dei pesci - che in fondo parla di emarginazione e di accettazione, il protagonista è un outsider eccentrico - lui mi ha detto che si stava trasferendo a Bombay Beach e mi ha suggerito di cercare quel luogo online. Mi ha detto: “È un posto che fa per te, vieni a girare qualcosa!”.
Era un luogo già conosciuto?
Quando ho iniziato a fare ricerche ho letto di un lago tossico, di un luogo definito “discarica”, di una cittadina fantasma fatta di rovine, di un progetto imprenditoriale fallimentare. Eppure quei “fantasmi” si sono rivelati
di una vitalità che non avevo mai incontrato prima, spinti dalla voglia di ricostruire, di creare, di collaborare, di comunicare.
In quel momento gli artisti non c’erano ancora, ma sapevo che Tao aveva intenzione di coinvolgerli. Ha fatto i primi tentativi nel 2015-2016 con pochi artisti. Quando sono arrivata io, alcuni avevano già iniziato a trasferirsi a Bombay Beach, comprando le proprietà.
Hai deciso subito di girare?
Sì, ho fatto una scelta di pancia. Alla fine sono rimasta 9-10 mesi in totale, facendo tre mesi alla volta, per questioni di visto. Inizialmente abbiamo prodotto il documentario con una raccolta fondi, lanciata in Italia, su Indiegogo. Non era una produzione ufficiale. Anzi, all’inizio avevamo anche paura di essere cacciati. È girato tutto con la camera a mano anche per questo motivo. All’inizio non sapevo cosa sarei andata a raccontare. Ma nello stesso momento in cui siamo arrivati, ho iniziato a girare. So che ci sono documentaristi che prima fanno lunghe ricerche. Io invece ho pensato fosse meglio che si abituassero a me con il terzo occhio. Era un piccolo terzo occhio, si parla di un budget bassissimo: il primo anno abbiamo raccolto 6mila euro. Avevamo una piccola 5D, con un piccolissimo microfono, ed eravamo in due. Dopo quaranta giorni il direttore della fotografia se n’è andato e sono rimasta sola. A volte tenevo anche la videocamera abbassata, per non perdere mai il contatto con la persona che avevo davanti. Andavo a sentimento.
Gli abitanti del posto ti hanno dato subito fiducia? No, anzi, è stato difficile. Ci sono tanti filmati su quel luogo finiti online che per loro sono “porno-povertà” (poverty porn). Avevano paura che anch’io fossi lì per guardarli in modo morboso, tirando fuori il peggio di quel luogo.
Il rischio c’è sempre: l’autore intellettuale che osserva i marginali e li racconta per edificare il pubblico borghese.
Per fortuna col tempo hanno capito che il mio sguardo era di tutt’altro tipo. Forse anche perché non ho mai invaso i loro spazi, non sono mai entrata nelle loro case, che spesso sono arrabattate alla meglio. Hanno cominciato a fidarsi quando hanno capito che a me interessava ciò che loro volevano raccontare, non il mio punto di vista.
Io non avevo nessuna pretesa o richiesta, anche dal punto di vista del linguaggio cinematografico. Ero lì per ascoltare ciò che volevano dirmi. Più che scegliere io i personaggi, sono loro che hanno scelto me.

Chi ha voluto mi ha cercato spinto dall’esigenza di raccontare la propria storia, a volte per esorcizzare il proprio passato e a volte per gioco, un modo per stare assieme e comunicare. In questo senso il film è nato in maniera spontanea e collettiva, proprio come le innumerevoli installazioni, le performance, le parate.
Il mio metodo di approccio a questo film è stato quello di lasciare libertà, di non imporre il mio sguardo. Bombay Beach è un luogo libero e stravagante, non potevo incatenarlo in un linguaggio unico prestabilito e formale.



Ci sono personaggi davvero incredibili, a partire da Sonia, la magnifica matriarca, e da suo figlio Adam, l’ex-rapinatore di banche.
Lui è il primo che ho conosciuto quando sono arrivata. È un personaggio fantastico, che non si può inventare, lo puoi solo trovare. Lo abbiamo incontrato appena approdati a Bombay Beach. Un uomo sui 50 anni con le braccia ricoperte di tatuaggi intento a scarabocchiare su
scarti di cartone. Mi sono avvicinata attratta dai suoi disegni che lui mi ha presentato come “scarabocchi”. Mi ha colpito, perché anch’io disegno e curo una pagina che si chiama “la scarabocchiatrice”. Ci siamo seduti con lui e ci ha raccontato la sua storia. “Ho imparato a disegnare in carcere, ci sono stato 26 anni per aver rapinato 8 banche” ha detto. “Disegnare è la mia terapia”. È stato quell’incontro a far scattare la scintilla.
A scriverlo, un personaggio del genere, risulterebbe poco credibile.
Forzato, sì. Lui ha questa personalità estrosa, esuberante, ma i disegni sono esattamente all’opposto, molto geometrici. La sua mente riesce a sintetizzare ciò che vede in modo simbolico. Quando parla, fatichi a seguire il filo di ciò che sta dicendo. Ma poi realizza opere come l’immagine finale del film, con quella porta in fondo alla strada che rivela finalmente una via d’uscita.
Lui ha trovato un senso grazie all’incontro con gli artisti.
Perché ha scoperto di far parte di quella realtà, della comunità degli artisti.
Susanna della Sala
11 GENNAIO 2023 10 GENNAIO 2023
Tre protagonisti del film: William Attaway, Sonia e Adam Herbert
(foto Damon James Duke)
(foto Jessica Steiner)
(foto Andrea Josè di Pasquale)
(da “Neolovismo”)
In ogni cosa che dicono c’è una saggezza, una profondità incredibile, che forse deriva anche dal contesto ostile. È stato illuminante anche a livello personale.
Sono stati dei maestri di vita
Ma al di là del camera a mano, delle scene “rubate” alla realtà o improvvisate, ci sono anche immagini poetiche, piani lunghi, inquadrature che sembrano quasi video-installazioni. Il tuo film, in un certo senso, corrisponde a ciò che guarda e dà vita a quel progetto artistico, oltre a raccontare la verità di quelle persone.

L’intenzione era raccontare il luogo e i personaggi. Ma sottolineando l’emotività, ciò che provano le persone, e la magia del luogo. Man mano che sono entrata in confidenza con loro e con il posto, con la comunità, ho avuto anche la possibilità di trovare un linguaggio per il film che fosse meno improvvisato. Sicuramente c’è stata anche un’evoluzione stilistica. Però l’intenzione principale era quella di raccontare le loro emozioni e il modo in cui loro percepiscono il luogo in cui vivono. Sonia, la matriarca, lo dice espressamente: qui c’è una magia che non so spiegare ma c’è. Ci sono aspetti del reale che sono nascosti, legati alla sfera emotiva del luogo e delle persone ma che per me esistono, fanno parte della realtà anche se poco tangibili. È
stato proprio questo che ho cercato di indagare e rappresentare. Quelle sensazioni, la poesia, la magia, l’energia di quelle persone. Sicuramente il contesto mi ha aiutato. Il deserto è un luogo violento dove sopravvive solo ciò che ha davvero una forza. Forse è per questo che gli artisti sono attratti da questo posto. È rimasta l’essenza delle cose.
La rinascita di quel luogo è reale? Sta continuando? Il luogo si è trasformato e anche le persone, la loro storia individuale. Nel film ad esempio vediamo che Sonia supera il lutto per suo figlio. Vediamo il veterano che ritrova sé stesso e riesce a definirsi in modo nuovo (“io sono Timmy, non sono più il marine”). C’è una rinascita, per le persone e per la cittadina. Ed è dovuta anche all’arrivo degli artisti. L’arte alla fine è diventata un modo per fare delle cose insieme, semplicemente, fisicamente. Non si parla di una trasformazione radicale del luogo. Esiste il rischio della gentrificazione di cui si parla nel film. Ma è comunque un luogo molto ostile, c’è il deserto, un lago tossico, il vento perenne, il freddo.
Per costruire qualcosa lì, devi davvero metterci l’anima, perché il deserto si mangia tutto. Certamente però il luogo si è trasformato a livello umano.
Cosa ti ha colpito in particolare di Bombay Beach?

Le persone. È stato un innamoramento. In ogni cosa che dicono, che improvvisano, che cantano nelle scene rap, c’è una saggezza, una profondità incredibile. Sono frasi che scriverei, che inciderei sulla pietra. Una saggezza che probabilmente deriva anche dal contesto ostile, dal fatto che sono persone partite dal niente. È stato illuminante anche a livello personale. Erano degli insegnanti per me. Maestri di vita. C’è stata una trasformazione anche mia.


In quanti momenti diversi lo hai girato? Quattro momenti. I primi tre mesi nel 2018, nel 2019 altri tre e nel 2020 a distanza: un operatore che ho conosciuto lì e che fa parte della comunità teneva il cellulare in mano e io interagivo con Adam e Sonia al telefono. Una delle scene che ho girato così è quella finale,
in spiaggia. Io stavo parlando con Adam e gli ho chiesto se aveva ricominciato a parlare con sua madre. Lui mi ha detto che quel giorno stavano andando a camminare sulla spiaggia. Ho chiesto di poterli riprendere. Ero lontana, ma ero lì con loro.
Ad un certo punto l’emozione è talmente forte che entri addirittura nel film, dal fuoricampo, e abbracci Sonia. Non so se lo hai fatto apposta, ma il messaggio arriva chiaro: questo è un cinema che non se ne sta a contemplare la realtà dall’alto, in disparte.
Non riuscivo a rimanere lì e limitarmi a guardare. Conoscevo il suo trauma, la morte del figlio, l’avevo vissuto con lei. Impossibile non intervenire in quel momento. Si parla di persone vere, il film passa in secondo piano.
Qual è il messaggio che arriva da questa storia, secondo te?
Ce ne sono diversi. Sicuramente dà un messaggio di speranza: si può sempre ripartire e ricostruire.
Susanna della Sala
12 GENNAIO 2023
(foto Marco Minniti)
Susanna della Sala con Shirley Long, una residente di Bombay Beach (foto Jessica Steiner). In basso, con il musicista Alex Ebert (foto Stephen Wilkes) e in costume da giullare (foto Damon James Duke)
Bombay Beach per me non è un luogo fisico in un determinato contesto, rappresenta un luogo metaforico e universale che racchiude l’esigenza di tutti noi di sentirci parte di qualcosa, di sentirci accettati, di poter ricostruire partendo dalle rovine del nostro passato. Il film è un tributo alla collettività, al potere della condivisione ma è anche una storia di genitori e di figli. Tutto ciò che fa Sonia, in fondo, il suo promuovere gli artisti, è nella speranza di integrare il figlio. Tao fonda una Biennale d’arte come un monumento al padre.
Sei rimasta in contatto con loro. Sì, assolutamente. Tornerò a Bombay Beach a marzo, per la prima del film. Alcuni lo hanno già visto, volevo che sapessero cosa andavo a raccontare di loro. Sonia, ad



esempio. Altri lo stanno aspettando. Lo proietteremo nel loro improbabile drive in, fatto di macchine abbandonate e devastate.
Il lago tossico è quasi solo contesto, se ne parla unicamente quando è citato dagli abitanti di Bombay Beach. Ma è una presenza costante, anche inquietante.
La storia di quel posto è molto complessa e stratificata e io non volevo fare un film d’inchiesta o ambientalista. Non era ciò che mi interessava raccontare. Ma il lago ha la sua importanza. A Roma, dopo una proiezione, Vito Mancusi, che insegna recitazione al Centro Sperimentale, ne ha parlato come di un personaggio che, nella sua tossicità, vomita degli scarti, e questo suo liberarsi porta a qualcosa che si rigenera e rinasce. Mi è piaciuta come descrizione. Così come mi piace pensare a quel luogo come una specie di miraggio. La scena finale (l’immagine della locandina, ndr) è l’unica installazione che ho fatto con loro. Non hanno avuto nessuna paura a entrare nel lago e sono entrata anch’io. Hanno sfidato il lago tossico.
Questo per quanto riguarda il film. Poi c’è la regista. Anzi, prima. C’è il suo percorso professionale ed esistenziale. Non è un caso che ci sia anche lei, fisicamente, dentro Last Stop Before Chocolate Mountain, seppure solo per qualche secondo.
È anche lei un personaggio della storia. Lo è il suo sguardo (lirico, sognante) prestato allo sguardo degli abitanti di Bombay Beach (e viceversa). Lei che invece è nata nella “Po Valley”, per citare la sua biografia online.
Ci ridiamo su. Lei ride spesso e volentieri. È un’ottimista per natura. E il senso dell’umorismo è parte fondamentale della sua poetica.
Lo sa chi ha visto il suo stravagante corto d’esordio, Il Dottore dei pesci (che pure ha una sua malinconia). Ma soprattutto chi ha potuto godersi l’auto-fiction di Neolovismo (visto al festival di Pesaro nel 2021), spassoso ritratto di una coppia alle prese con l’amore e la noia, il desiderio e l’incomprensione, realizzato a quattro mani (e due cuori) con Mike Bruce: buffo, cinefilo, eccentrico, anzi completamente matto, con “trascendenza” finale (e addio). Tra l’altro qui Susanna rivela anche doti inaspettate da attrice. Ma la definizione giusta per lei è “artista visiva”. Al di là delle forme, gli strumenti, i mezzi utilizzati. La formazione ufficiale passa attraverso il Politecnico di Milano (design degli interni) e il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Quella informale invece spazia dalla scrittura al montaggio. E se la professione l’ha portata anche a lavorare per grandi produzioni (da Wonder Woman al film Netflix Murder Mistery passando per la pubblicità, anche la mini-serie di Gus Van Sant per Gucci), la vocazione l’ha spinta verso «personaggi e storie non-convenzionali, gli outsider, i marginalizzati, le vittime della modernità».
Il cuore della sua immaginazione? I Doodles, gli scarabocchi che la accompagnano da sempre e che potete vedere sul sito susannadellasala.com, nel segno del realismo magico e del surreale.
Se a Los Angeles leggono “Po Valley” chissà cosa si immaginano.
Invece è semplicemente Val Padana, zanzare e nebbia.
Come mai sei fuggita da Pavia?
Principalmente per la mentalità, gli stimoli, gli spazi. Per la voglia di ricercare.
Fuga creativa sognando il cinema?
Non ho mai deciso di “fare la regista”. Non sono tra quelli che hanno preso in mano la telecamera da bambini. Non sono un’intellettuale e neppure un’esperta di cinema. Io disegnavo. Sono partita da lì. Il disegno mi ha anche permesso di campare finora, passando dal design alla scenografia, per poi arrivare al cinema. I disegni in fondo sono dei racconti, sono personaggi che poi ho trasformato in parole. È così che è nato il mio primo cortometraggio, da una serie di illustrazioni.
Sei anche montatrice.
Questo però l’ho imparato da sola. Per necessità, quando ho girato Il Dottore dei pesci.
Susanna della Sala
15 GENNAIO 2023 14 GENNAIO 2023
(foto Tao Ruspoli)
Ammetto onestamente di averlo fatto con dei tutorial online. Per me, in generale, è molto difficile comunicare a parole. Penso e mi esprimo per immagini. Quando mi sono trovata a lavorare con le montatrici del film, per me era più facile spiegare ciò che avevo in testa facendolo, montandolo in prima persona. Loro poi lo aggiustavano per trovare una struttura più funzionale. Non riuscivo a spiegare ciò che volevo a livello di emotività e di atmosfera.
A proposito di stranezze, anche Neolovismo non scherza.
Quel film l’ho girato insieme a Mike Bruce. L’ho conosciuto a Bombay Beach. Io stavo lavorando al documentario e lui stava girando in spiaggia un video musicale per Noel Gallagher. L’ho anche ripreso, quando ancora non ci conoscevamo. Uno degli artisti mi ha detto: lui è un film-maker come te, parlatevi! Ci siamo conosciuti e ci siamo messi insieme.
È una società così difficile in cui vivere, in cui ci si deve adattare a questa idea di avere successo... Ora è il momento di creare, non di arrivare (William Attaway)
“Equilibristi della vita”, un disegno di Susanna della Sala
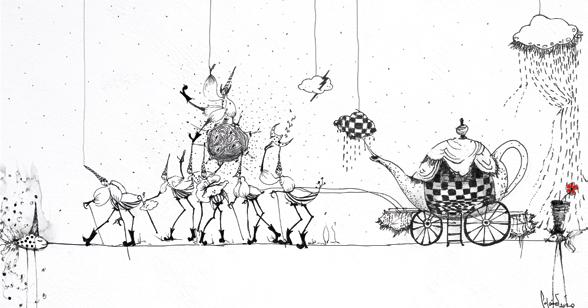
Un film sulla fine di un amore. Divertentissimo, però. Sembra quasi girato in epoca Covid. Due registi innamorati in isolamento.
In realtà era l’estate 2019. Eravamo stati ingaggiati per scrivere l’episodio di una serie. Avevamo deciso di metterci in isolamento in Italia. Ci sembrava un’ottima idea, invece non è stata una scelta molto intelligente. Sono usciti i problemi. E quei problemi li abbiamo trasformati in un film. Lui ha un occhio fotografico speciale. Io mi sono dedicata di più alla scrittura.
Ti senti un po’ una outsider anche tu? Probabilmente sì.
Una fuga che non finisce mai... Sì, in effetti, mi sento un po’ fuori posto. Non posso dire di essere propriamente un’outsider, in realtà, perché vivo in un contesto normale, una vita canonica. Però forse ammiro gli outsider perché hanno una vita che io vorrei, ma che non ho il coraggio di perseguire fino in fondo.
Nel frattempo fai cose che belle e fuori moda, difficilmente collocabili nel mercato dell’audiovisivo. Motivo per cui continuo a fare la scenografa. Ma non ho mai avuto l’idea di “arrivare”, guadagnare, vincere premi. Non ho quel tipo di astuzia. Mi piace credere che se una cosa è fatta con sentimento, a qualcuno arriva. Sono cose che faccio perché ne sento la necessità.
Quello della regista è un mestiere che “ho trovato”. Ora ho capito che è quello più adatto a me, perché riesce a mettere insieme tutte le mie inclinazioni.
Quindi non sei la tipica regista indipendente che vive la sofferenza di non poter campare con il proprio lavoro.
È chiaro che mi piacerebbe vivere di questo, ma sono anche realista. Ho avuto la fortuna di avere un piano B. Non ho quell’esigenza economica che potrebbe portarmi all’esaurimento. Non ho ancora quel tipo di frustrazione.
La vita ti ha riportato in America, dove hai vissuto da piccola.
Mio padre è ingegnere e in quegli anni lavorava per una compagnia statunitense. Un’esperienza ostica. Le scuole elementari e medie le ho fatte lì. Eravamo in New Jersey. Io ero l’unico studente straniero nella storia di quella scuola.
Vittima di razzismo?
Mi chiedevano:“Is your father from mafia?”
Tua madre, invece, cosa faceva?
Mia madre si occupava di noi aprendoci lo sguardo all’arte, alla musica, al teatro. Ama il rock, era al famoso concerto di Jimi Hendrix a Londra nel ‘66.
E ha cresciuto tre figlie creative. Silvia, la sorella grande, che insegna Lettere e Storia, ha fatto da consulente nella scrittura del film e ha scritto il documentario Res Creata per la regia di Alessandro Cattaneo. Linda, la musicista, ha composto un pezzo per il film.
A proposito di contributi eccellenti, il pezzo finale è firmato da Alex Ebert che tutti conoscono per la colonna sonora di All Is Lost.
Lui è quello che in una performance, come fosse una cerimonia di purificazione, vomita e scrive su una vecchia parete: “the heaven”. È un musicista straordinario, che ha vinto il Golden Globe per la migliore colonna sonora, ma ha deciso di regalarmi un suo pezzo. Io che sono sua fan da anni ero sotto shock. Quella di Bombay Beach è una comunità, sono cose che accadono solo in quel posto.
Il video per il suo pezzo Hands Up (regia di Tao Ruspoli, assistente alla regia e costumi Susanna della Sala) sembra uscito dal film. Così come quello di Vera Sola per The Colony.
Sono stati girati tutti e due a Bombay Beach. Tutti i progetti artistici in quel luogo sono atti collettivi e in qualche modo sono legati uno all’altro.
Tornando ai disegni, il tuo è un mondo poetico e sognante.

Anche un po’ infantile, se vuoi.
Io direi soprattutto delicato. Se non ti dispiace come aggettivo.
No, anzi, mi ci ritrovo benissimo.
Pesci, sirene, nasi buffi, esseri circensi...
Ho sempre amato il mondo circense, che ho ritrovato in Adam. Lui ricorda il giullare di corte, che fa il matto ma in realtà ha una profonda saggezza, offre una visuale straordinaria sulla realtà. Il giullare era l’unico, in un ambiente rigido e pieno di regole, che poteva mettere in discussione le azioni del re.
Susanna della Sala
17 GENNAIO 2023 16 GENNAIO 2023
Disegni in mostra a Bombay Beach
È l’eroe misconosciuto della creatività. Un po’ come il dottore dei pesci, uno che di mestiere cura i pesci rossi, ma ha una saggezza tutta sua. Amo anche cercare la personalità in oggetti e cose apparentemente inanimate.
C’è chi nutre un certo sospetto verso chi racconta la marginalità arrivando da situazioni privilegiate. Mi viene in mente Diane Arbus, che fotografava emarginati ed eccentrici. Era di famiglia borghese, e in tanti le dicevano: perché proprio tu? E lei rispondeva: perché è necessario, è uno scuotersi, un risvegliarsi. È una ricerca dell’essenza.

Il tuo film sembra che racconti un gruppo di artisti che salva una cittadina e i suoi abitanti. In realtà succede anche il contrario. È un rapporto reciproco. Non credo che gli artisti salvino la cittadina. L’arte è già dentro Bombay Beach, sta tra le bambole e le bizzarre sculture del giardino della signora Shirley, nell’istallazione di pietre colorate di Lloyd geologo in pensione, nel modo di vestire di Sonia, nella voce del cantante dello Ski Inn, nei disegni di Adam, nei colori del deserto. Gli artisti arrivano attratti da tutto questo e ritrovano anche una dimensione famigliare, come l’ho ritrovata io. In America non è come in Italia, la famiglia multi-generazionale non è così diffusa. Gli anziani in America vanno nelle case di riposo. Per gli artisti era strano vedere un giovane a cena bersi una birra insieme a un vecchietto di 80 anni. Oltretutto gli anziani del posto sono più vitali dei giovani, che invece sono i più conservatori. Sonia, a 76 anni, diceva: noi porteremo avanti la festa!
Il tuo prossimo passo? Sto scrivendo e sto preparando un altro documentario.
Alla fine la sala era piena. Tanti applausi, tante emozioni. E, come accade spesso al Beltrade, il pubblico ha potuto fare le sue domande alla regista. Che ci ha tenuto a ribadire la natura collettiva del film (prodotto da DocLab, distribuito da ZaLab, fotografato da Andrea José di Pasquale, montato insieme ad Aline Hervé ed Elisabetta Abrami, musicato da Vittorio De Vecchi, ecc.). In sala c’erano molti di quelli che hanno dato un piccolo o grande contributo economico per trasformare l’impresa in realtà (collettività!). E Susanna della Sala ha spiegato che a lei interessavano le emozioni di quelle persone, la loro storia, il loro modo di guardare il mondo. Perché è questo che fa la differenza, e indica una direzione anche per noi, oltre che per loro. È lo sguardo dell’innamorato del mondo e della vita, nonostante tutto, che vede la magia dietro il dolore, oltre lo squallore, trasfigurandoli letteralmente. Che reagisce all’ingiustizia rimboccandosi le maniche, costruendo, collaborando a un sogno strambo. Cose difficili da vedere stando al “centro del mondo”, con la sua narrazione meccanica fatta di sviluppo, consumo, successo, socialità virtuale. Stando ai margini del mondo, a volte, si può vedere meglio, più lontano.

Chi se lo dimentica più il rapinatore di banche in pensione che ama il Rinascimento e si chiede come mai sia scomparso così all’improvviso? O l’ex marine che difende gli artisti, quando qualcuno in città comincia a criticarli, con la sua saggezza semplice: «La gente scatta fotografie e le appende al muro. Raccoglie piante... E questa è arte. Da quello che vedo, ciò che state facendo è solo bellezza.
Molte persone sono perse, vivono rinchiuse nelle loro case, se venissero qui a guardare cosa fate e parlassero con voi, ne resterebbero stupite. Insomma, è una connessione». Soprattutto ricorderemo Sonia, che cammina sulla spiaggia, al tramonto, ricordando il figlio a cui non ha potuto dire addio, e dice cose che nessuno sceneggiatore potrebbe scrivere, perché rischierebbe di sembrare retorico, mentre questa è vita, con la sua verità: «Penso che le persone vadano in un luogo di riposo, dove tutto è pensiero, tutti quanti si conoscono e hanno qualcosa da fare. È come un arazzo dove tutto si mescola a meraviglia. Un bellis-
simo mondo fatto di arte». L’arazzo è fatto di vita, cinema, poesia, canzoni (Bowie sulla luna!), parole d’amore, meditazioni. E un mondo da (ri)costruire. Per dirla con l’artista William Attaway, folgorato sulla via di Bombay Beach: «Qui puoi guarire, serve solo tempo e spazio, e che le persone intorno a te facciano qualcosa di stimolante. Le anime delle persone si elevano quando sentono che chi è intorno a loro vive quella stessa elevazione. È una società così difficile in cui vivere, in cui ci si deve adattare a questa idea di avere successo.... Ora è il momento di creare non di arrivare».
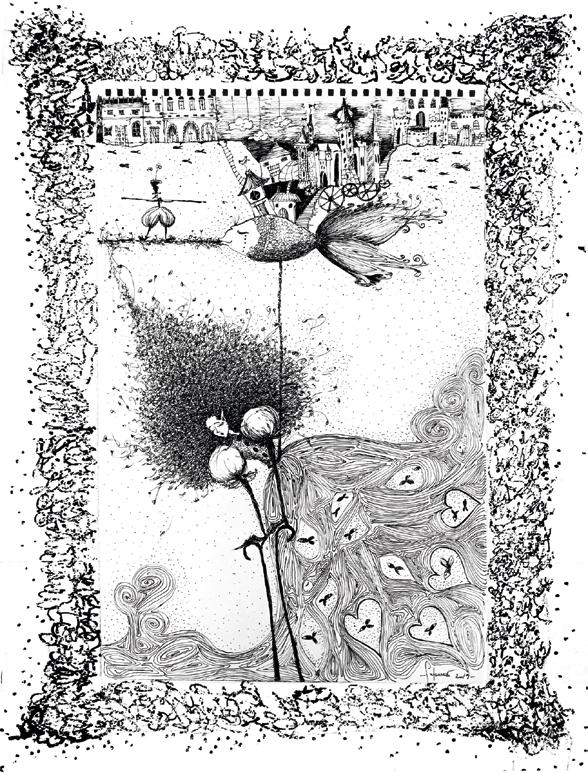
Susanna della Sala
19 GENNAIO 2023 18 GENNAIO 2023
All’inizio pensavo di essere più portata per la finzione, per l’immaginario fantastico. Poi ho capito che la mia strada è un’altra. Il fantastico deve essere estratto dal reale.
“The Salton Sea (Il lago di Salton)”
(foto Ilaria Costanzo)
da “Neolovismo”
ANDREA STAID
Come costruire un nuovo equilibrio tra uomo e natura?
Le risposte di un antropologo che ha detto addio alla città
Questo libro nasce in un orto. O meglio, è lì che comincia, in una serata di fine luglio, rinfrescata da un vento di tramontana. Nasce dal senso di connessione - con le piante, la natura, ma anche con sé stessi - che dà la coltivazione di un orto. Ma anche dall’allarme suscitato dalla siccità. E da tutti quegli eventi atmosferici estremi che ormai caratterizzano il nostro paese, come il resto del mondo.
«Il nostro è uno stile di vita che non ha voluto accettare compromessi...». Comincia così Essere natura (edizioni Utet) di Andrea Staid, che offre “uno sguardo antropologico per cambiare il nostro rapporto con l’ambiente”. Il modo in cui unisce ricerca, riflessione ed esperienza personale, è insieme un metodo e un messaggio, in un’epoca che esige scelte radicali, collettive e individuali. La sua decisione di andare a vivere nelle montagne liguri, fuori città, è in coerenza con il suo modo di intendere la contemporaneità.

Andrea Staid è un antropologo che negli anni si è fatto apprezzare per le sue ricerche sui migranti, gli emarginati, gli oppressi, in libri come I dannati delle metropoli, Le nostre braccia, Abitare illegale e “l’etnographic novel” Senza confini (edizioni Le milieu).
Viene da ricerche etnografiche fatte in Laos, Vietnam, Thailandia, Cina, Mongolia, Birmania, e immersioni nelle culture indigene Tzao e Hmong, sfociate nell’analisi di un modello di convivenza e organizzazione sociale diverso da quello occidentale, che funziona “senza stato” (Contro la gerarchia e il dominio). È docente di Antropologia culturale all’Università degli Studi di Genova e alla Naba (dove insegna anche antropologia visuale) ed è curatore di una collana antropologica per Melteni.
Tutte esperienze che gli hanno consentito di verificare, da una parte, l’ingiustizia intrinseca su cui si fonda il nostro sistema economico e sociale, che ha finito anche per depredare le risorse del pianeta, e dall’altra, conoscere modalità diverse di concepire la vita di comunità e il rapporto con la natura.
Il libro nasce nell’orto e nei boschi, racconta esperienze personali, scoperte, intuizioni, legate alla “natura che ci cura”, sottolineando che il nostro (occidentale) è solo un modo tra i tanti di vivere. Non è obbligatoria la contrapposizione tra natura e cultura che sta alla base della nostra società (messa in crisi dalle ricerche etnografiche). Ci sono capitoli dedicati al colonialismo, all’estrattivismo, all’ecocidio, ma anche appunti di etologia cognitiva, pagine dedicate alla soggettività delle altre specie, così come a quelle culture in cui non esiste neanche una parola per indicare la “natura”, perché tutto ha un’anima e la foresta è un organismo vivente, a cui bisognerebbe riconoscere dei diritti che hanno un valore in sé e per sé. Forse è arrivato davvero il momento di lasciar perdere il modello della “crescita infinita” e di costruire un “nuovo equilibrio tra uomo e natura”. Non è una rinuncia, ma un guadagno di vita, tempo e libertà. Gli esempi concreti, le storie raccontate alla fine del libro, offrono qualche spunto possibile. Si può fare.
21 GENNAIO 2023 20 GENNAIO 2023
I NCONTRI
Partiamo dalle tue scelte di vita. Questo, in effetti, è un libro che sembra nascere dalla pratica, più che dalla teoria. È anche molto personale. L’antropologo teorizza sempre a partire dall’esperienza sul campo, ma qui si propone una diversa visione della realtà che in un certo senso presuppone un diverso modo di pensare e vivere il mondo. Ci racconti quando e perché hai deciso di vivere in mezzo alla natura?
Questo mio nuovo libro è un piccolo esperimento tra etnografia, antropologia e racconto. Il motivo che mi ha spinto personalmente a lasciare la vita del “comfort” cittadino è senza dubbio l’esperienza etnografica, il viaggio. Ogni volta che tornavo a casa nel mio appartamento al settimo piano di un palazzo mi sentivo incarcerato e di fatto non riuscivo più a riconoscermi in quel luogo. Negli anni ho imparato che abitare un luogo non significa solamente starci ma soprattutto è un esserci. Più che vivere nella natura finalmente ho l’esperienza o la consapevolezza di esserne parte. Ovviamente non è l’unica via quella di andarsene dalla città, ma è quella che faceva per me.
Cosa ti ha insegnato il bosco? Ci sono esperienze molto concrete - per certi versi anche dimenticate in questa parte del mondo - che hanno anche risvolti e significati universali.
Il bosco mi insegna tutti i giorni qualcosa, ma soprattutto mi dà consapevolezza che siamo interconnessi tra specie diverse. Non solo, il bosco è vita e morte allo stesso tempo e mi aiuta ad accettare la finitudine. E poi il bosco mi fa bene, entrare in connessione con alberi, animali, piante, funghi mi fa percepire l’esperienza presente e quotidiana della vita.
Ogni volta che tornavo a casa nel mio appartamento al settimo piano di un palazzo mi sentivo incarcerato, non riuscivo a riconoscermi in quel luogo. Abitare un luogo non significa solamente starci ma è soprattutto un esserci

Quanto hanno influito gli incontri fatti nel corso delle tue ricerche, l’immersione in altre culture, popoli indigeni, visioni del mondo alternative a quella occidentale? Se nel nord globale parli di intelligenza e sensibilità degli alberi, di comunicazione inter-specie - per quanto la scienza abbia fatto passi avanti su questi temi - ti prendono per uno spiritualista o un tardo-hippy. Non è passato molto tempo da quando si parlava con paternalismo delle civiltà “primitive” e della loro concezione magica del mondo.
L’incontro con l’alterità culturale, ha cambiato il mio sé più profondo, è stato fondamentale per mettere in discussione le mie certezze e forse per farmi crescere. Sono convinto che la soggettività del vivente non sia un qualcosa da hippy 2.0 (comunque non ho nulla contro una visione hippy) ma la consapevolezza profonda che non siamo soli come homo sapiens, che siamo immersi in una rete di relazioni, e che non dovremmo considerarci superiori o al centro del cosmo. La “nostra” cosmovisione antropocentrica ed etnocentrica è causa di molti dei danni che ora stiamo pagando in tutto il globo, non per ultimo il cambiamento climatico.
La contrapposizione natura/cultura ha una lunga storia e testimonial eccellenti, da Aristotele alla teologia cristiana, arrivando a Cartesio e quindi alla modernità. Come si fa a superare un’idea così radicata, quasi onnipresente nella cultura occidentale, dalla filosofia alla letteratura, dalle scienze al pensiero comune?
Ovviamente non è cosa facile, è un percorso, un cammino da intraprendere di de-costruzione delle nostre certezze. Sono convinto che un cambiamento rivoluzionario, nel vero senso del termine, sia un processo, una mutazione culturale collettiva e non un mero evento che arriva da un momento all’altro. Quindi non ho ricette, ma relativizzare il nostro sguardo e relazionarci con culture che hanno cosmologie diverse dalla nostra è una delle possibilità per vivere in modo diverso, nel rispetto di quello che ci circonda.
Non ho ricette, ma relativizzare il nostro sguardo e relazionarci con culture che hanno cosmologie diverse dalla nostra è una delle possibilità per vivere in modo diverso, nel rispetto di ciò che ci circonda
A volte si tende a contrapporre la riflessione sulla natura, la difesa dell’ambiente, le ragioni dell’ecologia, con quelle che riguardano l’ingiustizia sociale, la disuguaglianza, la lotta per i diritti (a partire da quelli di chi vive nel sud del mondo). Ma alla fine è la contrapposizione natura/cultura, e l’idea dell’uomo padrone/sfruttatore del mondo che ha generato il colonialismo e l’ecocidio, con effetti a catena di cui ci stiamo accorgendo solo oggi e che hanno effetti potenzialmente letali per tutto il mondo.
Questo è proprio il tema perno del libro. La visione antropocentrica che separa l’umanità dalla natura e che pone homo sapiens come superiore e quindi dominatore di tutto quello che lo circonda, non soltanto ha portato alla distruzione della terra e degli altri viventi, ma è stata uno dei motori del colonialismo. Gli europei, nel loro movimento di espansione e conquista, oltre a occupare militarmente terre, rubarne le risorse, colonizzare interi territori attraverso l’uso indiscriminato della violenza, esportare virus e produrre pandemie senza precedenti, hanno anche esportato e imposto con la forza la loro visione antropocentrica, che molto spesso era qualcosa di assolutamente estraneo alle popolazioni indigene.

23 GENNAIO 2023 22 GENNAIO 2023
STAID
ANDREA
Il colonialismo è anche distruzione della memoria dei luoghi, del tempo, delle lingue che vengono sradicate, dei modi di vita cancellati. Il colonialismo inoltre ha generato cambiamenti drammatici negli ecosistemi
Il colonialismo è stato, ed è tuttora, una politica economica di furto ed espansione, ma non solo: è anche la distruzione della memoria dei luoghi, del tempo, delle lingue che vengono sradicate, delle comunità e dei modi di vita che vengono cancellati. La storia del colonialismo, per quanto ancora oggi venga spesso cancellata dalla coscienza storica, dovrebbe essere ricordata per molte ragioni, non ultima la nostra attuale preoccupazione per il cambiamento climatico. Il colonialismo, nella sua esuberante distruzione − spazzando via gli ecosistemi e soggiogando le comunità che li sostenevano − ha scatenato un forte aumento delle emissioni. Il colonialismo ha cambiato il ritmo, la portata e l’entità della distruzione ecologica. Ha generato cambiamenti drammatici negli ecosistemi terrestri e marini e ha trasformato le dinamiche di crescita. Dobbiamo fare i conti con tutto questo e comprendere l’importanza di un approccio ecologista decoloniale, che ci porti a capire che il problema non è solo il cambiamento climatico, o meglio, che se stiamo vivendo nell’era dell’Antropocene è anche e soprattutto a causa di un sistema coloniale, razzista, patriarcale e antropocentrico che è stato imposto a gran parte del mondo dall’Europa attraverso un violento processo di colonizzazione durato più di cinque secoli.
Quello che stiamo vivendo oggi è il risultato di una modernità che si è basata sulla morte, sull’asservimento delle comunità indigene e sulla sottomissione degli altri esseri viventi. Una modernità che è stata costruita non solo sulla separazione degli esseri umani sotto l’idea di “razza”, ma anche sulla separazione tra “uomo” e “natura”.
C’è anche il pericolo di un discorso sulla natura edulcorato, figlio del “greenwashing”, un parlare di riconversione ecologica in modo astratto, fondato comunque su categorie concettuali che non cambiano il nostro modo di rapportarci con la natura.

Esattamente, non basta aggiungere le parole magiche bio, eco, verde per uscire dalla crisi climatica, dobbiamo ricodificare il modo umano di stare al mondo, di relazionarci con quello che ci circonda, dobbiamo ripensare quegli usi e costumi che hanno velocemente distrutto Gaia.

25 GENNAIO 2023 24 GENNAIO 2023
STAID
ANDREA
Quali sono i concetti, le parole, le visioni del mondo di altre culture che potrebbero aiutarci a guardare la realtà e la natura in un modo diverso? Puoi farci degli esempi?

Ti rispondo citando Don Sabino Gualinga, leader politico dell’originaria popolazione Kichwa di Sarayaku, che cercando di spiegare alla Corte interamericana dei diritti umani cosa rappresenta una foresta per la sua popolazione, ha dichiarato che è un organismo vivente, non quello che le foreste sembrano a noi abitualmente: ambienti naturali vuoti, sotto forma di riserve biologiche o di depositi di materie prime da trasformare in prodotto. Le montagne, gli alberi, le paludi e i fiumi sono villaggi o città. Formano un’architettura cosmologica complessa che ospita tutti i generi di esseri viventi, sia umani sia non umani, in stretta relazione uno con l’altro, reciprocamente costitutivi e interdipendenti. Ecco se cominciassimo ad ascoltare e a relazionarci con altre visioni cosmologiche che non sono solo quella che si è strutturata in Occidente, forse potremmo trovare delle soluzioni interessanti per il prossimo futuro.

In un certo senso questa nuova, possibile, concezione della natura, fondata sulla connessione tra tutti gli esseri viventi, può avere anche un risvolto “spirituale”. Così come è arrivato il momento di superare la contrapposizione tra cultura e natura, o tra discipline scientifiche e umanistiche, forse è anche tempo di riscoprire la dimensione del sacro.
Don Sabino Gualinga, cercando di spiegare cosa rappresenta una foresta per la sua popolazione, ha detto che è un organismo vivente. Le montagne e gli alberi formano un’architettura cosmologica che ospita tutti i generi di esseri viventi, in stretta relazione uno con l’altro
Sì, credo che questa concezione della natura come “luogo di vite” o di anime possa essere interessante anche per riscoprire la dimensione del sacro.

Sono tante ormai le voci che si contrappongono all’idea della crescita infinita, sono invece poche le teorizzazioni che propongono alternative praticabili su larga scala, anche perché si tratta di mettere in discussione l’intero sistema economico-sociale, oltre che la coscienza delle persone. Tu alla fine del libro raccogli alcune testimonianze. Ma come si fa ad andare oltre queste esperienze singolari o a quelle delle piccole comunità alternative?
Come si fa non credo di saperlo, l’antropologia costruisce la possibilità di vedere meglio quello che ci circonda, poi le soluzioni dobbiamo pensarle e attuarle tutte e tutti insieme. Credo, anzi sono convinto che l’immaginazione, per la costruzione dell’avvenire, abbia un ruolo fondamentale perché ci aiuta a risolvere problemi, a interpretare dati, a progettare ricerche, a formulare ipotesi, a conquistare nuove conoscenze e a vedere le mille possibilità che abbiamo di vivere in una comunità ecologica e sociale.
L’attitudine ecologica alla quale penso non è un pensiero di rinuncia, ma una grande possibilità per “guadagnare” tempo, libertà, autonomia, capacità e saper fare, un modo per riscoprire i sapori della vita legati ai territori, alla prossimità, al prossimo e per ritrovare la lentezza. Cambiare rotta è una grande occasione che abbiamo davanti a noi.

Il libro comincia nel tuo orto. Anche l’orto ha molto da insegnarci. Per molti può essere un punto di partenza.
L’orto per me è esperienza di vita, è cura e stabilità tra mente e corpo. Nel mio quotidiano coltivo non solo per mangiare i frutti del mio lavoro, ma anche per capire meglio com’è possibile slegarsi da una società che prevede soltanto lo scambio di merci. Da quando mangio i prodotti del mio orto la mia vita è cambiata sotto molti aspetti, non meramente alimentari. L’attività giornaliera tra gli ortaggi, il prendersi cura delle piante, l’entrarci in relazione notando i cambiamenti e osservandone i movimenti, mi dona una consapevolezza del reale che mi gratifica giorno per giorno. (f.t.)
L’attitudine ecologica non è un pensiero di rinuncia, ma una grande possibilità per guadagnare tempo, libertà, autonomia, capacità e saper fare, un modo per riscoprire i sapori della vita legati ai territori
27 GENNAIO 2023 26 GENNAIO 2023
ANDREA STAID
BOOSTA
Dalla canzone (Subsonica) alla sperimentazione (Post Piano)
Le tante vite di un musicista che non si accontenta mai
Chiudete gli occhi e immergetevi. Sentirete suoni che pulsano, echi, riverberi, un accenno di melodia potente, e poi accordi di piano, dentro un paesaggio elettrico rarefatto, nostalgia di qualcosa, poesia lunare. Tape 1, Walkman 1 Il viaggio comincia da qui e si svolge in sei movimenti. Sei EP (Tape) che sono esplorazioni e contemplazioni. Elettronica e pianoforte, post-rock e ambient, avanguardia colta e art-disco, paesaggi sonori, miniature, melodie destrutturate, musiche “astrali”, momenti incantati e altri inquietanti, rumori e distorsioni in quantità, frammenti, illuminazioni.
Non c’è un percorso prestabilito da seguire. Lo spazio della musica è infinito, così come quello dei pensieri e dell’immaginazione. Davide “Boosta” Dileo è uno di quelli che amano percorrerlo in lungo e in largo. E chiede a chi lo ascolta di fare altrettanto.
Sì, tutti conoscono i Subsonica, che lui ha contribuito a fondare e di cui è il tastierista. Ci hanno regalato pezzi indimenticabili, nove album in studio, quattro dal vivo (otto dischi di platino) e spettacoli live che ci sono rimasti negli occhi e nel cuore. Ma Boosta è andato oltre. Anche perché dentro di lui si intrecciano le influenze e le sonorità più disparate.
I sei capitoli di Post Piano Session (il primo è stato presentato in settembre, l’ultimo è arrivato sotto Natale) sono come uno spazio in espansione, nato da una stella esplosa. Nel primo Tape l’elettronica dialoga con il piano, tra paesaggi interiori, pianismo classico e distorsioni. Il due ci porta nei territori del post-rock, con momenti quasi solenni, emozioni forti e un pezzo intitolato 1974 (la data di nascita di Boosta) che è pura energia. Il terzo è forse il più affascinante, soprattutto se amate il ‘900, ed è anche il più radicale: qui troverete suoni che arrivano da un altrove misterioso, minimalismi e impressionismi, melodie (molto belle) ripetute, sgualcite, smembrate, echi di Schönberg. Con il quarto si torna all’elettronica, tra pezzi che sono quasi fantasmi di canzoni disco, un paio di idee per chi volesse rilanciare (sublimare) la techno e un Butterfly Compass in cui torna il pianoforte e ci emoziona profondamente.
La quinta tappa evoca Brian Eno e Harold Budd, disegnando luoghi sonori sconfinati, con l’aggiunta di un Preludio in C che, in un certo senso, non comincia mai. Infine, la sesta tappa rievoca la magia di Facile (il suo album precedente) andando oltre, con le sue melodie sognanti, il pianismo contemporaneo, accenni di canzone jazz, Paolo Conte e una meraviglia intitolata MMF. Sentiamo anche sospiri, voci, rumori di passi. L’anima torna ad essere nuda.
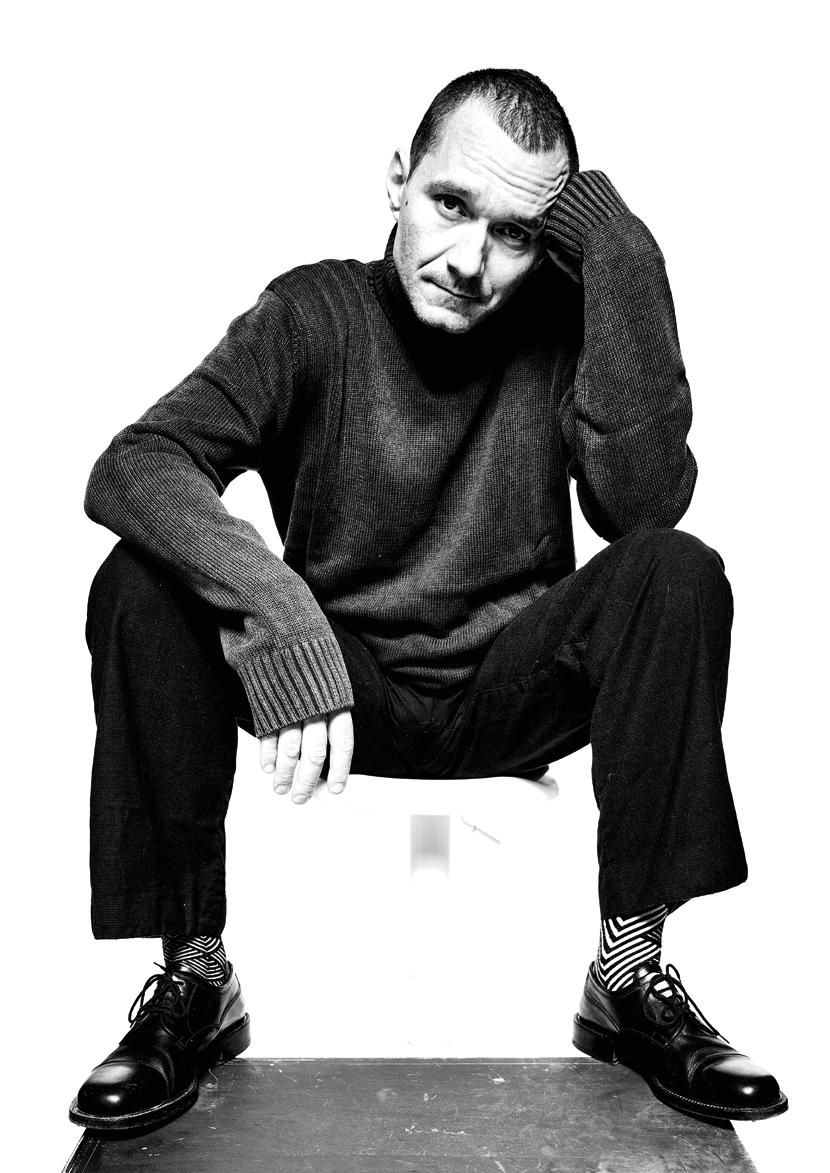
29 GENNAIO 2023
I NCONTRI (foto Damiano Andreotti)
Alla fine capita di pensare che questo sia anche un viaggio cinematografico, una colonna sonora che non ha bisogno di immagini. In Boosta convivono tanti mondi espressivi. Ha scritto romanzi e musicato film e serie televisive; è uno dei migliori dj italiani ma è anche un sound artist raffinato che realizza installazioni e cura spazi sonori; ha remixato i Depeche Mode, ha scritto canzoni per Mina e ha fatto danzare Roberto Bolle (Waves, in scena alla Scala); è editore, produttore, conduttore televisivo e radiofonico; docente di tastiere elettroniche al Conservatorio di Como, è tornato studente a Torino perché non si finisce mai di imparare. Non gli mancano certo la curiosità e la voglia di sperimentare. Per questo Post Piano Session più che un approdo sembra un nuovo inizio, l’ennesimo. E alla fine ti dispiace che i Tape siano solo sei.
Perché questo titolo?

Intanto perché io un disco di pezzi per pianoforte già l’ho fatto (Facile) e continua a piacermi molto l’idea che questa sia un’esplorazione, un viaggio. C’è una mappa di base, il percorso è tratteggiato, ma non è definitivo, quindi l’idea è quella di portarmi un po’ avanti. Alla fine se io faccio musica è perché ho ancora voglia di farla e spero di continuare utilizzando l’ingrediente migliore, che è quello della curiosità. Ho un grande rispetto per la musica, mi piace tantissimo e vorrei essere in grado di fare cose che mi sorprendono. Poi, per la proprietà transitiva, mi auguro che possano anche piacere a qualcun altro.
Ognuno ascolta la musica come vuole, anche in maniera distratta, o come puro intrattenimento. Ma la musica può anche essere utilizzata come strumento di riflessione, di introspezione, di viaggio. Mi piace pensare che porti più domande che risposte. Anche se la musica può essere una consolazione formidabile.
È una mappa della tua anima, una cosa personale, interiore, oppure ha anche l’ambizione di essere una sorta di riepilogo, per mostrare quante cose può essere il pianoforte, magari anche in polemica con l’appiattimento contemporaneo?
Ognuno ascolta la musica come vuole, anche in maniera distratta, o come puro intrattenimento.
Ma la musica può anche essere uno strumento di riflessione, di introspezione, di viaggio. Mi piace pensare che porti più domande che risposte
Post Piano anche perché è legato a un utilizzo del pianoforte non convenzionale. Questa è un’epoca in cui il piano neo-classico ha già dato, ampiamente. L’idea era quella di spingermi un po’ oltre, utilizzarlo come colore principale, ma in tutte le sue sfumature. Pianoforte vuol dire, sì, “i tasti”, ma anche il rumore dei tasti e quello delle corde. Per carità, non è niente di nuovo nella musica contemporanea, il pianoforte preparato non lo scopriamo adesso, sono passati cinquant’anni da quando lo faceva John Cage. L’idea è quella di usare il piano come una tavolozza di colori infinita E comunque Post Piano è anche tutta quella parte legata al mio percorso di amante dell’elettronica, dell’esplorazione del suono, delle distorsioni, che per me sono un elemento fondamentale della musica.
Hai accennato alla mappa. In effetti è la prima cosa a cui si pensa ascoltando i vari capitoli del progetto. Una mappa che però non ha l’ambizione o l’arroganza di indicare una direzione precisa. Non è una caccia al tesoro. Ci sono tante direzioni diverse, che hanno tutte un senso, un significato.
È il motivo per cui il lavoro è diviso in sei parti. Quando realizzi un disco, in generale, devi fare un riassunto di quello che è il tuo pensiero creativo. Invece l’idea delle sei release, i sei tape, è quella di sei punti di esplorazione diversi in cui ti puoi fermare un pochino di più. Hanno un collante stilistico che naturalmente è la mia ispirazione. Ma all’interno dei vari tape ti fermi o vai dove vuoi. In un certo senso è un concept album diviso in sei parti, che va inteso come deve essere sempre intesa la musica, cioè come uno strumento.
L’exposé non c’è, non ho bisogno di dire a nessuno “guarda quanto è figo il piano e quante cose ci si possono fare”. Sicuramente è un viaggio dentro ciò che volevo raccontare, che avevo bisogno di fare. Non c’è nessuna critica, anche perché io credo veramente che ognuno sia libero di usare la musica come vuole. Ciò su cui non sono d’accordo è che l’utilizzo principale della musica sia quello dell’intrattenimento. In questo senso l’appiattimento mi intristisce un pochino, perché perdiamo una possibilità incredibile di esplorare e di vivere meglio la vita. Ma non è una battaglia che puoi fare gridando e obbligando all’ascolto. A maggior ragione in questa società in cui si ascolta veramente poco. Quello che puoi fare è mettere sul piatto ciò che hai. Per una questione di grandi numeri, io sono convinto che ci siano persone che hanno l’esigenza di fare un viaggio e un ascolto differente.
I tuoi concerti lo dimostrano. C’è anche chi viene ad ascoltare il “tastierista dei Subsonica” e vive un’esperienza inattesa.
In effetti qualcuno sa cosa aspettarsi, perché mi ha seguito un po’ di più, mentre altri sono più distratti e vengono a vedere il tastierista in azione. Ma alla fine diventa un viaggio per tutti. L’applauso più bello che ricevo a fine concerto è nel silenzio che dura sempre una decina di secondi prima che scatti l’applauso. È un silenzio meraviglioso, partecipe. Le persone hanno bisogno di un attimo di tempo per uscire dalla stanza in cui sono entrati, poi si riconnettono con la realtà e allora, se dio vuole, parte l’applauso. Un silenzio pieno di gratitudine, la mia per primo, perché mi piace da matti questa esperienza.
Un conto è quando riconosci la musica e ami condividerla in un evento collettivo. Un altro è quella musica che hai bisogno di elaborare, che ti entra dentro e deve trovare il suo spazio, che non è mai uguale.
Non è una frase ad effetto: io credo davvero che questa musica possa essere la colonna sonora del silenzio di chi ascolta. Perché al suo interno c’è tutto quello che serve. Non hai neanche la distrazione delle parole.
31
2023 30 GENNAIO 2023
GENNAIO
BOOSTA
(foto Damiano Andreotti)
Le canzoni piacciono a tutti, piacciono anche a me, però mi piace anche l’idea che i pensieri di ognuno possano essere il tema, le immagini create nella mente, accompagnate dalla musica. Voglio immaginare che le persone si facciano il proprio viaggio, il proprio film, che magari ci mettano anche le proprie parole, perché comunque i pensieri viaggiano con le parole e le immagini.
Essendo un concept album, ha anche una sua evoluzione? C’è un percorso? Non c’è, anzi, credo che questa sia la parte più affascinante. È un po’ come chiedere: come si scrivono le canzoni? Io non so rispondere a questa domanda. Non credo ci sia un modo. Credo che la musica sia un atto di libertà meraviglioso. Gli steccati sono forzosi. La musica vale tutta, alta, bassa, delicata, potente, accomodante, disturbante.

La canzone pop ti piace ancora?
In questo momento non tantissimo. Rimango affezionato ad alcune canzoni, quello sì. Poco fa stavo riascoltando per caso Hotel California: ci sono delle cose che ti rimangono nel cuore e quando le senti sei felice di ascoltarle, perché è davvero come tornare a casa. Però adesso non ho tanta voglia di scrivere canzoni. È anche bello vivere nel flusso in cui sei. È inutile forzarsi a fare altre cose. A un certo punto ho scritto tantissime canzoni, poi non ne ho avuto più voglia. Mi auguro che un giorno torni. Quando mi riverrà voglia, ci sarà anche questo bagaglio, nuove frecce nella faretra, per cui magari la musica diventerà un’altra cosa. È molto affascinante anche questo viaggio che sto facendo al Conservatorio da allievo, esplorando il significato del suono.
Cosa stai studiando?
Sono iscritto allo Smet di Torino, dipartimento di musica elettronica, il secondo più antico d’Italia dopo quello di Milano. Molto affascinante. Si esplora il perché noi percepiamo qualcosa quando l’aria si sposta e vibra, e come la percezione di ciò che ascoltiamo si trasforma in un racconto. La grammatica di questi segni uditivi.

Fai musica da vent’anni ma continui a studiare. A che età hai cominciato a suonare il pianoforte? Avevo 6 anni.
Da ragazzo hai fatto anche piano bar. Ho fatto di tutto. All’inizio davo lezioni di qualunque cosa. Poi a 18 anni ho preso la patente, mi sono iscritto all’università e ho lavorato per un ristorante che faceva il dopo-teatro a Torino. Gli servivano tre sere alla settimana, il mercoledì, il venerdì e il sabato, che poi sono proprio i giorni in cui puoi uscire con gli amici. La paga era buona: 100 mila lire a sera, dalle 8 all’1 di mattina. Mi offrirono un tre per due: io suonavo tre sere, ma me ne pagavano solo due...
800 mila lire al mese, ai tempi, non erano male. Infatti ho cominciato a comprarmi gli strumenti e a vivere di musica.
Hai un piano per il secondo tempo della tua vita? Mettiamola così: il piano A non ce l’ho ancora, però mi sono riempito di piani B e C nella mia testa. Vorrei sperare di poter continuare l’esplorazione. Detto questo, se devo esprimere un desiderio, nel caso non avessi più ispirazione, vorrei non essere obbligato a suonare solo perché questo è il mio lavoro. Ho amato quando Fossati si è ritirato, anche se lo avrei ascoltato volentieri altre mille volte, sia in concerto che nei dischi. Mi piace quell’idea di consapevolezza. Certo, devi averne la possibilità, non solo economica, ma anche morale, devi essere a posto con te stesso, con quello che hai fatto, e accettare il fatto che l’ispirazione cambia, può finire, o puoi non avere più voglia. Finché ci sono voglia ed energia vorrei avere la possibilità di continuare a fare la mia musica, ma nel momento in cui non la sentirò più, spero di essere così onesto da ammetterlo, e non dover fare musica per vivere.
Tu però sei un creativo a 360°, sei compositore, scrittore, musicista, dj, editore, produttore... Si direbbero tanti talenti diversi. Cos’è che li unisce? Un’idea? Un’ispirazione?
Mi è sempre piaciuto fare tante cose diverse. E spero che l’ispirazione duri ancora. Spero che rimanga la curiosità, che è il carburante del motore della creazione. Per adesso ne ho tanta. Forse per questo sono così avido di stimoli. Adesso ho davanti questi cinque anni di scuola, saranno abbastanza challenging. Ieri sono uscito da 9 ore di lezione di fila.
Chissà che stanchezza!
La stanchezza è tanta, sì, infatti non vedo l’ora di fare le ultime ore e mollare un po’. Però poi devo studiare. C’è tutta una parte della musica che non avevo mai considerato. Quanto studi il suono e gli eventi sonori in quello che ti circonda, c’è dentro tantissima fisica, acustica, matematica, trigonometria... Io ho fatto il classico trent’anni fa. Quando mi spiegano che una cosa si muove in maniera logaritmica, penso “sì, certo, aspetta un attimo che vado a vedere che cazzo vuol dire”. Mi auguro che sia come quando vai in palestra e sei fuori forma: al primo sollevamento muori, ma poi ti alleni e le cose migliorano. Spero che sia una ginnastica per il cervello.
Parliamo del panorama musicale contemporaneo. Viviamo in tempi liquidi, ma poi ci si divide tra apocalittici ed entusiasti. C’è chi dice che la musica è finita, che viviamo una libertà fasulla perché le nostre scelte sono condizionate dall’algoritmo. E ci sono gli entusiasti, secondo cui non c’è mai stata questa libertà, ognuno può comporre e far ascoltare la sua musica, possiamo ascoltare tutto ciò che vogliamo. Tu da che parte stai?
Io sono relativamente laico. Sono convinto che questa accelerazione tecnologica, questa rivoluzione, non sia andata di pari passo con l’evoluzione del nostro cervello e con le connessioni neuronali. Abbiamo dei cervelli giovani, che hanno bisogno di tempo per introiettare le cose.
33 GENNAIO 2023
BOOSTA
Ma non c’è bisogno di scomodare le neuroscienze. Pensa quanto fosse diverso il rapporto che potevi avere con chi ti vendeva i dischi perché ti conosceva e ti consigliava quella cosa specifica.
Sei un po’ nostalgico dell’analogico e del magnetico?
È molto bello avere accesso a qualunque cosa.
Però servirebbe anche una sorta di indice di esplorazione. Devi sapere dove mettere le mani, che cosa serve alla tua vita. La mole di informazioni è immensa, come fa il nostro cervello a gestirla?
Certo è molto bello poter aver accesso alla qualunque. Però servirebbe anche una sorta di indice di esplorazione. Devi sapere dove mettere le mani, che cosa serve alla tua vita. La mole di informazioni è immensa, come fa il nostro cervello a gestirla? È inevitabile che si finisca per muoversi in modo superficiale. E questo mi dispiace. Per quanto riguarda la musica, come per ogni cosa nella storia dell’umanità, ma anche nella natura, credo che l’andamento sia sinusoidale. Ci sono momenti “più” e momenti “meno”, non vedo il problema. Ma è affascinante riflettere su come la musica nel secolo scorso sia stata un motore di evoluzione incredibile. Penso alla musica di massa, i figli dei fiori, il rock anni ‘70, l’avvento dell’album... La possibilità di registrare qualcosa è stata una rivoluzione clamorosa ed è passato poco più di un secolo. Sono passati 120 anni dalla prima volta che hanno registrato col magnetofono e il rullo di cera. Pochissimo. E in 120 anni siamo arrivati all’atomizzazione della musica. È un viaggio fantastico. La musica negli anni ‘50 è stata un fenomeno distruttivo, nell’accezione inglese del termini, disrupting, ha spostato codici, canoni, la gente era entusiasta per quei cambiamenti. Oggi siamo abituati ad ascoltare di tutto. Ma immagina cose poteva voler dire vedere una coreografia di ballo a teatro fatta con musica contemporanea, cioè con suoni che non derivavano da oscillatori, solo rumori. Pezzi di nastro registrato. Oppure all’inizio del ‘900 l’arrivo della dodecafonia Pensa cosa possa essere ascoltare qualcosa di assolutamente lontano da ciò che avevamo ascoltato finora. Tutte le propulsioni rivoluzionarie ad un certo punto perdono energia e rientrano nell’alveo. Sarebbe bello sapere dove possiamo arrivare adesso. Le possibilità del computer sono infinite e meravigliose. Ma bisogna metterle al servizio di una grande creatività dell’intelletto.
Tu ricevi tante proposte, demo, cose da ascoltare?
Grazie al cielo no. Forse sono talmente scorbutico che non mi mandano più niente... Ma va bene così. Ogni tanto comunque trovo delle cose molto interessanti.
Forse oggi mancano i maestri, le guide, qualcuno che provi a dire cosa ascoltare, da dove cominciare.
Quello è un lavoro che mi piace molto. I consigli di ascolto sono sempre molto belli. Anche adesso a scuola, quando abbiamo le lezioni di storia e il mio maestro mi dice di ascoltare delle cose degli anni ‘20, ‘50, ‘70, musicisti che non ho mai ascoltato, andare a esplorare la loro discografia è una fonte di ispirazione pazzesca. Soprattutto ti riporta con i piedi per terra. Perché tu puoi pensare di essere un gran figo, di aver fatto grande musica, ma poi ti rendi conto che ogni minima idea brillante che hai avuto è già stata pensata, peraltro in condizioni più pionieristiche. Oggi è facile avere tanti oscillatori, io sono pieno di tastiere, che fanno tanti suoni diversi. È facile accendere il computer e registrare. Ma mi affascina quel tipo di difficoltà che si viveva un tempo.
Guarda, non mi nascondo... (ci mostra walkman di ogni tipo, registratori, mangianastri, supporti magnetici, sparsi un po’ ovunque, ndr.). Nutro una discreta passione per questo tipo di oggetti.
A me il nastro piace moltissimo. Sono affascinato dai supporti. Sono creativi, sono strumenti loro stessi, non servono solo per registrare un’informazione e riproportela. Nel momento in cui la ripropongono, o nel momento in cui li utilizzi per riproporre un suono, già diventano altro. Mi piace l’idea di traslare il significato di questa catena: faccio, si propaga, ascolto, ma in mezzo ci sono tantissime variazioni sul tema. Bisogna capire ora dove andremo.
Oggi si parla di smaterializzazione del mondo.
Io sono affezionato all’oggetto. Mi rendo conto che ci sono vantaggi nella tecnologia, la diffusione veloce, un certo tipo di fruizione, ma credo che il supporto fisico sia una sorta di milestone, una cosa che ti fa fermare un attimo: possedere qualcosa è importante per ricordare che ce l’hai davanti. Ho aperto una piccola etichetta, che è come se fosse il mio atelier. Adesso sto cercando di far uscire il disco fisico, ma da solo, senza una grossa etichetta alle spalle, è tutto più complicato, c’è carenza di materiale, le fabbriche ti chiedono 120 giorni per fare le cose… Però io voglio una cosa fisica, quindi cosa faccio? Magari costruisco una radio per pezzo, ti vendo tutta la radio, non lo so...
(foto Damiano Andreotti)

LA PLAYLIST DI BOOSTA
1. Sound Patterns di Pauline Oliveros, Brandeis University Chamber Choir, Alvin Lucier
2. L’espace-temps di Bernard Parmegiani
3. Rainforest I di David Tudor e Takehisa Kosugi
4. Rothko Chapel 3 di Morton Feldman
Sarebbe bello: magari puoi vendere un walkman con dentro la tua musica. È un’idea che ho da tanto. Vediamo come va questo viaggio, poi ci penserò su. L’idea di immaginare strumenti nuovi, in base alla mia esperienza, ciò di cui avrei bisogno quando suono, quella l’ho sempre avuta: ogni tanto mi faccio costruire delle cose. Un nuovo supporto fisico potrebbe anche essere un’idea. Alla fine la musica è bella, perché limitarsi al fatto di ascoltarla o suonarla? Il linguaggio è uno, io parlo quella lingua, vorrei esplorarla in tutte le possibilità di suono che ho davanti.
E visto che anche noi amiamo i “consigli di ascolto”, ne abbiamo approfittato per chiedere a Boosta una playing list. Pezzi che ama, che ritiene essenziali, cose che bisogna ascoltare almeno una volta o che vale la pena riscoprire. La sua lista, che ora diventa anche la nostra.
La potete ascoltare su Spotify: si chiama “La mia playlist n.100”. Raffinata e potente, con brani storici, avanguardia d’autore e proposte fuori dai canoni. Due ore e trentasette minuti di ascolto doc. I titoli dei brani li trovate qui accanto. (f.t.)

5. Kontakte di Karlheinz Stockausen
6. For Organ and Brass di Ellen Arkbro
7. Touch, Pt.1 di Morton Subotnick
8. Improvisation Sep. 1975 Part.2 di Toshi Ichiyanagi, Micheal Ranta, Takehisa Kosugi
9. Criss-Cross (excerpt) di Alvin Lucier
10. In C (remastered 2009) di Terry Riley
11. Sonatas and Interludes for prepared piano di Jokn Cage, Boris Berman
12. Revolution 9 (remastered 2009) di The Beatles
35 GENNAIO 2023 34 GENNAIO 2023
BOOSTA
Davide Rondoni
Un poeta (e un romanziere) al servizio dell’anima «La verà libertà non è avere, comprare, è un’energia dell’essere»
Benito Mussolini e il brigatista Giovanni Senzani sono passati sotto quei lecci, a Forlì. Un viale esagerato per una città di provincia. Una strada che starebbe bene a Parigi, forse, a Londra o a Berlino, e invece se ne sta lì, come se niente fosse, in piena Romagna. Viale Mussolini, si chiamava. Poi è diventato viale della Libertà (“giustamente” sottolinea l’autore, più di una volta, enfaticamente, non senza ironia). Ciò che non cambia è il suo essere fuori luogo, in dittatura o in democrazia, la sua sontuosa e surreale sicumera. Sotto quei lecci è nato e cresciuto anche un poeta, che allora non sapeva di esserlo. La poesia, a quei tempi, gli appariva sotto forma di un uomo tetraplegico, che avanzava su una moto giocattolo, il poeta Franchini: «Scriveva cose piene di dolore e di amore. La poesia per me arriva ancora così. Una strana creatura sotto lecci strepitosi. Un Icaro inchiodato al proprio corpo».
Davide Rondoni non poteva immaginare che un giorno avrebbe scritto di quei lecci, con il loro concerto di uccelli che strepitano in maniera assordante, lungo un viale che è stato attraversato dalla “grande storia”, ma anche dal «romanzo degli umili» (a cui il poeta forlivese dedica le pagine più emozionanti, come emozionano sempre le sue «poesie innamorate dei passanti»).
Il concerto del viale dei Lecci (edizioni Aboca), platealmente autobiografico, sembrerebbe uno di quei romanzi che l’autore custodisce per anni dentro di sé, aspettando il momento giusto per “dire la verità”. Invece è l’esatto contrario. Un libro nato quasi per caso, su commissione, dentro una collana dedicata agli alberi, e
quindi sgorgato all’improvviso, con l’irruenza delle cose che non sono state preparate, organizzate, pensate per “funzionare”. Sta qui la sua verità e la sua ispirata anomalia. È prosa, ma è anche poesia, è memoria storica, ma è soprattutto diario intimo, personale, è un intreccio di racconto, visione e riflessione, in cui l’invenzione è mischiata alla realtà, con una tale libertà che rende oziosa qualsiasi curiosità su cosa sia “vero” e cosa no. Davide Rondoni non ha bisogno di troppe presentazioni. Un tempo, per parlare del suo lavoro, si usava citare Mario Luzi, suo grande maestro, che gli aveva dedicato parole importanti: «Respiriamo prima di tutto la levità di questa scrittura che invita le nostre percezioni a uscire dalla cornice abituale entro la quale si dispongono; a liberarsi dalle loro obbligatorie coordinate...». Ma da molti anni ormai le sue poesie sono tradotte in tutto il mondo e stanno in varie antologie che raccolgono il meglio della poesia italiana contemporanea, oltre che in raccolte come Il bar del tempo (Guanda 1999), Compianto, vita (Marietti 2004), Apocalisse amore (Mondadori 2008), La natura del bastardo (Mondadori 2016). In più ci sono i romanzi, i programmi radio e tv, i progetti culturali importanti (come Infinito 200, dedicato a Leopardi). Ci sono la rivista clanDestino (di cui è direttore editoriale), il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna (di cui è fondatore), l’attività di divulgazione che lo porta in giro per l’Italia. E c’è l’intellettuale polemista, nel senso che non si tira certo indietro quando deve esprimere la sua opinione, anche se politicamente scorretta.
Davide Rondoni

36 GENNAIO 2023
I NCONTRI
di Fabrizio Tassi
Nell’anomalo romanzo, in un certo senso, c’è tutto questo e anche di più. La storia gira intorno al rapporto tra un ragazzo e suo nonno. Enea è un uomo silenzioso, che porta dentro di sé il dolore immenso della perdita di una figlia, oltre a dieci anni passati in Eritrea. All’improvviso, dal passato, salta fuori un uomo che vuole ucciderlo. Ed ecco che la trama diventa quasi noir. Ma intanto il ragazzo osserva la vita, impara l’amore, soffre, immagina, sperimenta. Mentre il poeta commenta e ricorda, si lancia in digressioni liriche e

Mi chiedono a cosa serve la poesia. A niente. Splendore di questa parola. Suona vertiginosa quando indica il punto in cui manca ogni convenienza. Ogni economia. Niente scambio, niente in cambio di niente. I bambini e i mistici (e i poeti) sanno cosa è questo “niente”
giudizi taglienti, scrive capitoli che a volte sono lunghi una frase o due.
Un’opera musicale, ecco cosa sembra, con i suoi temi che ritornano, le frasi ripetute in piccole variazioni che cambiano di significato, il viale, i lecci, gli amici, gli incontri casuali e quelli fatali. Ci sono gli “anarchici” Mussolini e Nenni, destinati a guidare il partito fascista e comunista. Il mistero del brigatista Senzani e una riflessione sulla spettacolarizzazione dell’orrore. Gli anni Sessanta e un programma che oggi sembra essere arrivato a compimento: «Autonomia assoluta dell’individuo, de-sacralizzazione del reale e del corpo, politicizzazione di tutto». Ci sono i cappelletti, Pasolini, Apocalypse Now e una grande statua, un Icaro, che Mussolini dedicò al figlio morto e oggi suscita più di un imbarazzo. Ma soprattutto c’è la mano del poeta, che trasfigura le storie, oltre alla Storia, perché la poesia non è questione di opinioni o di giudizi. Trasfigura anche i lecci –diventano segno, simbolo, accompagnano e commentano la storia, custodiscono segreti - perché la natura non è solo “scenario”.
Al tema Rondoni ha dedicato anche un libro, l’anno scorso (Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti, edito da Fazi), con l’intenzione di scardinare l’idea/ideologia della “madre trascendente”, dell’astrazione misurabile, l’idolo a cui sacrificare ogni cosa: la natura ama nascondersi, va oltre le apparenze e le pretese di chi la vuole possedere. A volte però si rivela ai poeti, ovvero «coloro che proseguono il primo atto del bambino che esce nel mondo e dell’uomo che esce dalla caverna e vede la Natura» Che cos’è la poesia, a cosa serve? Ecco la domanda delle domande, che i poeti non amano sentirsi fare. Tra tutte le risposte possibili, ci piace citare quella che Rondoni ha dato in L’allodola e il fuoco, pubblicato da La nave di Teseo tre anni fa: «La poesia è quasi niente nell’aria del mondo (...) Mi chiedono a cosa serva la poesia. E come tutti quelli che l’hanno conosciuta non so bene cosa dire (...) È più di trent’anni che ne parlo. E non so cosa dire. Eppure le ho dedicato la vita, me l’ha presa. Allora dico piano: “Niente”. Niente. Splendore di questa parola. Suona vertiginosa quando indica il punto in cui manca ogni convenienza. Ogni economia. Niente scambio, niente in cambio di niente (...) I bambini e i mistici (e i poeti) sanno cosa è questo “niente” – quello dei pomeriggi dove non si fa nulla di importante ma si cresce, o che si sente dentro finché la mamma non ti abbraccia, quello che acceca per un istante la vista che ha visto tutto».
L’
incontro con Rondoni avviene in un chiostro, a Vercelli. Siamo accanto alla basilica di Sant’Andrea, che per chi non lo sapesse è una delle più belle dell’intero Piemonte, al tempo stesso spettacolare e austera, con il suo intreccio di romanico e gotico, la sua storia che affonda nel Duecento di Enrico III, Federico II, papa Onorio III. È l’8 dicembre e va in scena una tappa di Animae loci, “itinerario letterario e artistico” ideato dall’associazione La Nottola di Minerva. Parola chiave: anima. Da cui la scelta dei protagonisti, due che se ne intendono: il poeta Davide Rondoni e la magnifica Linda Messerklinger (sì, proprio lei, che abbiamo già incontrato a settembre su queste pagine, perché il caso non esiste e i portatori di redness sono ovunque in mezzo a noi).

Ci godiamo la malia del luogo, quando il sole è appena tramontato, sotto gli archi a tutto sesto e le volte a crociera, vicino a una lunetta duecentesca in cui l’Agnus Dei è attorniato dal Battista e San Giovanni Evangelista.

Davide Rondoni
39 GENNAIO 2023
Due immagini della basilica di Sant’Andrea a Vercelli
Rondoni non è tipo da interviste lunghe e cerimoniose. Se ne sta in piedi, con il sigaro perennemente in bocca, la mentre sempre in movimento (entro un paio d’ore deve scrivere un articolo su un giovane iraniano giustiziato), l’anima pure.
Uno strano libro.

Denso e non scontato.
Sembra uno di quei libri che si nutrono segretamente per tutta una vita, fino a quando arriva il momento di scriverli davvero.
E invece è un libro commissionato. Certo, è molto personale, perché ci sono cose che fanno parte di me. Ma non è tutto vero, ovviamente. È un romanzo. Ci sono cose che in parte avevo dentro di me, cose che so, cose che ho vissuto. E c’è la storia... Aboca ha chiesto a me e ad altri scrittori un libro che parlasse di alberi. Non ci avevo mai pensato prima. Poi mi sono ricordato dei lecci sul viale di casa mia. Un viale strano. Il Novecento è passato sotto quegli alberi. Ci è passato Mussolini, ci è passato Senzani, il capo delle Brigate Rosse.
Un viale esagerato per Forlì.
I segni della storia dentro la provincia italiana... Da bambino sentivo lo stormire continuo di uccelli, sia all’alba che al tramonto, per un’ora. Era una cosa impressionante. Il leccio è un albero simbolico, l’ho scoperto scrivendo il libro: si dice che abbia dato il legno alla croce di Cristo, maledetto e benedetto al tempo stesso. Questo è fondamentalmente un libro sul senso della storia. Un temone.

A proposito di storia, e del passato ingombrante che tendiamo a rimuovere, a un certo punto scrivi: “Siamo gente così, in Italia, eredi imbarazzati e stupiti”. Come si supera l’imbarazzo?
Intanto conoscendo la storia. Gli imbarazzi si superano conoscendo le cose. Però la conoscenza non è mai un atto puramente intellettuale, è anche morale e affettivo. L’imbarazzo si supera con l’affetto. Uno può essere imbarazzato da qualcosa fino a quando comincia a volergli bene. Questo vale per tutte le cose della vita. Si tratta di trovare un nucleo, un elemento di bello e di buono anche in quella realtà che ti mette in imbarazzo. Pensa anche, banalmente, all’imbarazzo che molti vivono di fronte a una presenza strana, che sia l’handicappato, lo straniero, il bizzarro, il matto: tu sei in imbarazzo, ma chi gli vuole bene no.
Ci sono anche monumenti che suscitano imbarazzi.
A Forlì c’è questo Icaro di dieci-quindici metri, molto bello. Quasi nessuno sa perché è lì. Mussolini lo dedicò al figlio morto in un incidente aereo. Uno può dire: questa è roba da buttar via. Ma io non riesco a buttare via il dolore di un padre per la morte di un figlio, anche se il padre è un criminale. Il modo per superare l’imbarazzo è trovare i punti di affetto.
Strano intreccio di ideologie contrapposte, in quel viale di Forlì.
Ci è passato Mussolini, ma anche Senzani, personaggio inquietante che secondo me ha lavorato per quattro o cinque servizi segreti, e pare sia chi ha davvero interrogato Moro nel carcere BR . È ancora vivo. Si è visto in un film di Pippo Delbono (“Sangue”, molto bello, ndr). L’Italia è un posto strano.
Che impressione ti fanno i dibattiti politici di queste settimane?
Già Pasolini nel ‘73 aveva detto che era insensato continuare a parlare di fascismo. Si va avanti con questa farsa, come se davvero il problema in Italia fosse quello.
Si continua a giocare su una cosa automatica che legittima e delegittima contemporaneamente. Credo che sia fondamentalmente una pigrizia nel leggere la società. E questo è un problema, perché se continui a leggere la società con le categorie sbagliate non solo non la capisci, ma non la aiuti nemmeno, non riesci a mettere in campo iniziative sufficienti a risolvere i problemi. A Bologna, città rossa per eccellenza, il 17% delle persone che vivono nelle periferie ha votato Lega: non è che sono diventati improvvisamente fascisti, sono le stesse persone di prima. Non sopporto questa pigrizia intellettuale.
Proviamo a definire la “libertà autentica” di cui parli nel romanzo? Quando si parla di libertà, si continua spesso a intenderla come “fare ciò che voglio”.
Questa è la grande fregatura della contemporaneità. Mi è capitato di confrontarmi su questo tema con i
ragazzi di una scuola. Erano in quattrocento. Ho chiesto: ditemi il nome di un uomo davvero libero. Non ne hanno detto nessuno. Essendo false le idee di libertà che circolano, per loro di libero non c’è nessuno. Nessuno tra le persone che conoscono, parenti, amici. Ma se non siamo davvero liberi, allora siamo tutti schiavi. Questa è la fregatura. Se tu hai un’idea di libertà sbagliata, la fregatura è che la libertà non c’è. E quindi cominci a ragionare da schiavo.
La vera libertà non è quella di avere, potere, comprare, ma è un’energia dell’essere. E infatti si dimostra come disponibilità. Capisci che un uomo è libero dal fatto che è disponibile a darti una mezz’ora del suo tempo se hai bisogno, dal fatto che è disposto ad ascoltarti. Quell’energia lì è la libertà. La “libertà di avere” è una grande fola, e lo è da sempre. È una libertà astratta e impossibile, tanto che finiamo per concepirci come schiavi. Lo capisce anche un ragazzino di seconda superiore. Se di libero non c’è nessuno, la gara è tra una maggiore e una minore schiavitù. A quel punto il ragazzo dice: ma perché io dovrei trattare bene la cella in cui vivo? Se sono schiavo, perché devo tener pulita la galera? Lo farà qualcun altro.
41 GENNAIO 2023 40 GENNAIO 2023
Davide Rondoni
Bisogna romperlo il proprio sguardo. Bisogna spaccarsi gli occhi per guardare la realtà. Se la guardi come sei già, non la guardi davvero. Se c’è una qualità dello sguardo poetico, è quella di vedere la realtà sempre nuovamente
come purezza è un’ideologia spaventosa. Compra quell’aspirapolvere e salva il pianeta... La natura è un idolo molto potente e sponsorizzato. L’idea della natura come purezza è sbagliata. Viviamo in un’epoca dove l’idea di perfezione non ha più nulla di spirituale, è puramente organica, e quindi pericolosa. Anche non dichiarandolo, vai verso l’idea della razza pura, che è ciò che sta succedendo.
L’umanità è anche fragilità, errore, consapevolezza dei limiti, volontà d’amare che va oltre le nostre debolezze. Emoziona molto la storia d’amore che racconti tra un padre e un figlio non suo. La libertà è quella. La libertà di amare, l’energia di amare una cosa che non hai deciso.
Tornando al libro e alla sua scrittura: ha un andamento quasi sinfonico. Evidentemente non riesco a fare cose che non abbiano anche un ritmo.
Tu dici: “La poesia mette a fuoco la vita”. È un modo di guardare le cose. Questo sguardo si può allenare? Possiamo imparare a sederci su quella panchina nel viale dei Lecci e vedere le cose in modo nuovo?
C’è chi dice che “siamo tutti religiosi”, a volte senza saperlo. Troppo facile? Il sacro oggi è per lo più dileggiato.
«Come si dice da noi, questa è un po’ una “pugnetta”. Purtroppo il discorso religioso si è inquinato in tanti modi, si è offuscato, si è appesantito. È sempre difficile parlare di queste cose. Io credo che l’uomo sia un essere religioso, cioè un essere che ha sempre cercato di legare il particolare all’assoluto. Questa è la sua natura da sempre. L’uomo ha il senso del sacro connaturato. Può essere sacra la luna, l’albero, qualsiasi cosa. Lo sguardo che cerca il sacro l’uomo lo ha sempre avuto. Ma se spariscono i simboli del sacro è un problema.


Lo diceva Eliot, che fa iniziare Terra desolata con la morte della Sibilla: se muore la Sibilla, la donna della soglia, del sacro, l’elemento che mette in collegamento il qua e il là, inizia la terra desolata, dove tutto è consumabile. Pasolini diceva che l’unica cosa che si oppone a ciò che lui chiamava il nuovo fascismo, cioè l’iper-consumismo, non è il marxismo, ma il sacro, il senso del sacro, qualcosa a cui doni una reverenza e un timore assoluto, qualcosa che non si può consumare, che non è commerciabile. Se questo va via...
Non c’è sacro senza anima, senza spirito. Sempre che si tratti di un’anima viva, aperta al possibile, al mistero, disposta anche a perdersi pur di andare incontro all’altro. Charles Péguy diceva: «Non sopporto quelli che hanno un’anima bell’e fatta». Lo ha citato Davide Rondoni, all’inizio dell’incontro nella basilica di Sant’Andrea.
A fine intervista ci piace tornare lì, al centro della questione, l’anima, o meglio, il rischio di ritrovarsi «un’anima ferma, che non vibra più, un’anima morta» Niente di meglio della (grande) poesia e della (buona) musica, per provare a risvegliarla, come possono testimoniare le persone presenti in basilica, che hanno applaudito le parole di Rondoni e si sono lasciati incantare dalla voce di Linda Messerklinger.
Come non sussultare di fronte ai versi di poeti come Rainer Maria Rilke? «Questo soltanto io so, tu sei cresciuto, sei cresciuto, figlio / dismisuratamente, per superare l’angoscia senza limiti, / l’ambito smisurato del mio cuore. / Ora sul grembo tu mi giaci tutto sghembo e riverso, / e non ti posso, non ti posso, figlio, più partorire».
Tu hai parlato di un “libro sul senso della storia”, ma questo è anche un libro sulla gioia. Cito: “Ho visto gioia in faccia a persone sottoposte alle peggiori limitazioni, di natura politica, di natura fisica. Io cerco la gioia. Quando c’è significa che lì vi è la libertà”.
Potrei farti molti nomi di persone davvero libere. Anche persone che magari sono inchiodate a un letto, ma hanno un’energia di vivere, una disponibilità, un’apertura all’esistenza, alla vita per com’è non per come me la immagino
L’opposto della libertà - legato alle ideologie politiche, ma anche a un certo modo di intendere la religione - è il concetto di perfezione. Cito ancora: “Quelli che immaginano un’umanità senza difetti”. La purezza, se esiste, è solo spirituale. Può esistere uno spirito puro, quello sì. Per il resto è tutto impuro, tutto bastardo, mescolato, ambiguo. Se uno confonde i livelli fa casino. Se ci pensi, oggi, anche una certa idea di natura
Certamente. Ma ci si allena imparando dagli altri. Non è che ti metti lì, sulla panchina, ti sforzi e la poesia viene. Semmai puoi leggere le parole che Luzi dedica a Simone Martini (che abbiamo letto poco fa) e cominciare a capire cos’è la poesia. Non si può imparare da soli. Al massimo ti metti sulla panchina e ti ricordi che hai visto uno che “ha fatto così”, o leggi qualcuno che guarda così, e allora impari.
Di solito guardiamo ma non vediamo, o meglio vediamo le nostre abitudini di sguardo, le idee preconcette, i giudizi ereditati. Infatti bisogna romperlo il proprio sguardo. Bisogna spaccarseli gli occhi per guardare la realtà. Se la guardi come sei già, non la guardi davvero. Devi imparare la disponibilità a rompere lo sguardo che hai di solito. Se c’è una qualità dello sguardo poetico è quella di vedere la realtà sempre nuovamente. La novità è l’effetto della disponibilità.
È anche una cosa spirituale.
È una cosa spirituale, senza anche.
Davide Rondoni
42 GENNAIO 2023
La voce di Linda Messerklinger ha accompagnato Davide Rondoni nell’evento organizzato da La Nottola di Minerva (foto Michela Talamucci)
Le poesie non si capiscono, bisogna comprenderle, come le persone, prenderle con sé, lasciare che ci stupiscano, che ci meraviglino, che ci conducano al cuore delle cose
che scorre normalmente, in maniera apparentemente ordinata, dall’inizio alla fine. È successo qualcosa che ha scardinato il tempo».
Parole fortissime, dilanianti, che vanno sentite più che capite. Come ha detto Rondoni: «Le poesie non si capiscono, bisogna comprenderle, come le persone, prenderle con sé, lasciare che ci stupiscano, che ci meraviglino, che ci conducano al cuore delle cose».


Rilke scrisse quella poesia ispirato dalla Pietà di Michelangelo. Da quella ragazzina che disse “sì” e che ora tiene in braccio il Cristo morto. «Il cardinale che l’aveva commissionata non capiva. Come è possibile che Maria sia così giovane? Non tornano i conti. E Michelangelo, che teneva sempre in tasca la Divina Commedia di Dante, rispose con i versi del poeta: “Figlia del tuo figlio...” Michelangelo capisce che nell’incarnazione il tempo è diventato un’altra cosa. Non è più il tempo

A proposito di Dante, ecco i celebri versi dedicati alla Vergine, nel giorno dell’Immacolata. Soprattutto quella parole che a volte ci lasciano straniti: «termine fisso d’etterno consiglio». Ne ha parlato spesso anche Benigni, utilizzando proprio il commento dell’amico Rondoni. «Termine vuol dire parola, ma è anche il bordo, la fine di una cosa. Qui Dante ci dice che Dio, l’eterno consiglio, l’eterno pensiero di Dio, a un certo punto si fissa su quel termine, quel nome, che è Maria. Un’immagine straordinaria. È come se Dante dipingesse Dio come un innamorato che si fissa su una ragazza e che non è tranquillo finché non va da lei a dirle: sì o no? Ci stai? E infatti è quello che succede, durante l’Annunciazione: Dio manda un angelo a chiederle “sì o no?”. È come se Dio dall’eternità dei tempi avesse aspettato il sì di questa ragazza. Dio cosa vuole come tutti i padri? Il bene dei suoi figli. E nel caso di Dio, il bene dei suoi figli coincide con l’amare Lui, con l’avere un senso, una speranza, a fondamento della vita. Solo che l’amore non può essere obbligatorio, nessuno vuole essere amato per forza, nemmeno un padre.
Allora Dio si pone il problema: come faccio a farmi amare liberamente dagli uomini? E si fissa su quella ragazza, perché se lei dice sì, allora può iniziare una strana storia d’amore libera, tra Dio e gli uomini».
Chi compare, dentro la preghiera a Maria, in Paradiso? Beatrice, «la ragazza per cui ha scritto la Commedia, per dare un senso alla sua morte. Dante ha voluto fare questo viaggio per andare fino in faccia a Dio, e vedere cose c’è nei suoi occhi. Se mi dai Beatrice e poi me la togli, cos’hai negli occhi Dio, uno scherzo, una beffa? Dante non vuole che Beatrice diventi un nulla (...) Ed ecco che alla fine del suo viaggio Beatrice appare tra i beati, un puntino nella folla, così come Dante l’aveva vista a Firenze. E cosa fa questa ragazza? Unisce le mani e dice: così sia, che il tuo viaggio sia. Tutte le volte che ci penso mi commuovo... Dante, almeno lui, ha capito cos’è l’amore: l’amore è diventare un “così sia” per l’altro. Che la tua vita sia! Ecco il fondamento dell’amore vero». L’esperienza d’amore dà all’anima la vera libertà. E la poesia, quando è anima, ci prepara a quell’esperienza. Non è certo un caso che Rondoni abbia scritto spesso d’amore:
dammi l’albero - e dammi la parola albero dammi l’incanto - e dammi la parola incanto dammi il mare - e dammi la parola mare e il cielo dammi - e, se c’è, la parola che lo può chiamare dammi lei - e dammi la parola amore dammi il silenzio che a volte parla più di tutte le parole e poi dammi le parole che dicono questa cosa del silenzio dammi mio padre di spalle e mia madre con una foto in mano e nella foto ho mia figlia addormentata sulle spalle e dammi la parola nascita dammi la vita - e la parola che la abita e ovunque brucia e si stèrmina costa sangue e si rompe voce sempre croce in un ritmo e sembra dire a vanvera ma è semina io non sono degno ma di’ soltanto una parola un sospiro un uccelletto di fiato e io sarò salvato dalle iene che m’han piantato gli occhi negli occhi e m’han sbranato dammi il bosco - e dammi la parola bosco dammi il suo viso - e dammi la parola del suo sorriso
Rondoni
Davide
45 GENNAIO 2023 44 GENNAIO 2023
Altre immagini dell’appuntamento di Vercelli, inserito nella rassegna “Animae Loci”, con Davide Rondoni e Linda Messerklinger (foto Michela Talamucci)
Etty, «maestra di giovinezza» Diario di una ragazza “inedita”
ELISABETTA RASY RILEGGE, CON GRANDE SENSIBILITÀ, LE PAGINE
DI UN’ANIMA INQUIETA E RIBELLE: L’AMORE, LE IDEE, LA FEDE INCROLLABILE
Il problema è sempre lo stesso: incontrare sé stessi. Ognuno lo fa come può, dentro il suo tempo e la sua cultura, adattandosi al contesto o mettendolo in discussione. Etty Hillesum, giovane inquieta, irriverente, appassionata, voleva «vivere a modo proprio, vivere soprattutto una diversa giovinezza femminile, diventare donna in modo diverso dalle generazioni precedenti, inventarsi un modo sperimentale di essere una ragazza». Voleva amare, studiare, scrivere, essere libera, andando oltre il “retaggio famigliare”, in un
«continuo ascolto di sé» che faceva i conti con «una incontenibile ansia di assoluto».
Sta (anche) qui la sua forza, la sua bellezza, ciò che la rende «la perfetta maestra della giovinezza», come scrive Elisabetta Rasy in Dio ci vuole felici. Etty Hillesum o della giovinezza. Un libro molto bello, edito da HarperCollins, in uscita il 17 gennaio, che inaugura la collana Scrittrici/Scrittori e che ha tanti meriti.

Il primo è quello di offrire un duplice romanzo di formazione: da una parte c’è la giovane Etty, il suo racconto di sé, la scoperta dell’amore, la necessità di non soccombere all’orrore; dall’altra Elisabetta Rasy, che rievoca la sua giovinezza, racconta l’incontro con Etty e il suo diario, riflette sul bisogno di scrivere.
Il secondo merito sta nella scrittura libera, verrebbe da dire quasi diaristica, la grazia e la freschezza con cui le memorie si rincorrono, intrecciando la vita interiore di Etty, i ricordi dell’autrice e un caleidoscopio di libri, personaggi, scrittrici e scrittori che ampliano il discorso e lo chiariscono, da Katherine Mansfield a Edith Wharton, da Anna Frank a Primo Levi, e poi Marguerite Duras, Edith Stein, Simone Weil, Puškin, Conrad, Rilke...
Ma il merito più grande sta nell’approccio scelto, che ci restituisce una Etty Hillesum più viva, vera, autentica. Non solo la giovane donna eroica che scelse di seguire il destino del suo popolo (lei era un’ebrea olandese) fino alla morte ad Auschwitz a 29 anni, esempio di una fede straordinaria, simbolo della resistenza (umana e spirituale) al Male. Ma anche la ragazza che è stata, i suoi dubbi e le contraddizioni, la gioia e la fatica di crescere.
Elisabetta Rasy - giornalista e scrittrice, che in passato ci ha già ha aiutato a conoscere tante autrici e intellettuali del ‘900 e che ha scritto romanzi e saggi di grande valore (citiamo tra gli altri Posillipo e La scienza degli addii, Memorie di una lettrice notturna e Le regole del fuoco, Le disobbedienti e Le indiscrete) - ci mostra la via di un possibile dialogo con Etty, intrecciando note autobiografiche e riflessioni ispirate dalla lettura del suo diario. Prima di diventare il “cuore pensante della baracca” Etty è stata il «cuore pensante di sé stessa», dentro una storia d’amore controversa e impossibile con un uomo molto più grande di lei, Julius Spier, che occupa così tante pagine del suo diario. Elisabetta Rasy ci porta nella sua stanza-mondo, tra i suoi libri (sant’Agostino, il Vangelo di Matteo, Rilke, Jung...), dentro la sua “paura indefinita”, le nausee, l’irrequietezza, ma anche gli entusiasmi, i piaceri, le scoperte. Ci racconta le telefonate quotidiane di Etty con Julius, mentre ricorda il vecchio telefono “a disco” di casa (pagine tenere e ironiche, emozionanti). Nel frattempo evoca Julianne Moore in Magnolia che dice “che ne sai tu della mia vita?” (già, che ne sanno gli altri della nostra vita, come possono pretendere di giudicarci?) o associa le avventure erotiche di Etty a L’amante di Duras, per ricordare «quelle ragazze

del Novecento che decidono che la libertà sessuale è una necessaria estensione della libertà personale: non trasgressione o perversione, tantomeno debolezza colpevole, ma diritto alle passioni del corpo».
Tutto questo non toglie nulla all’esperienza della prigionia e al modo straordinario con cui Etty l’affrontò, in un dialogo intenso e costante con Dio. Anzi. Nel suo diario «ogni frase, ogni riga è un tentativo di risposta, una ricerca di senso che non si lasci travolgere dal male assoluto che è lo spettacolo osceno dell’epoca». Fosse stata sua amica, Elisabetta Rasy, come tutti noi, avrebbe cercato di convincerla a salvarsi. È allo stesso tempo turbata e affascinata dalla sua «accettazione del destino, accettazione della vita, accettazione dei misteri di Dio»
Etty aveva le idee chiarissime: «Una cosa, tuttavia, è certa: si deve contribuire ad aumentare la scorta di amore su questa terra». Era questa la sua risposta all’odio e all’orrore. Per questo scelse «non la fuga, non l’odio, ma l’amicizia, l’amore, la preghiera». Lei si sentiva «nelle braccia di Dio». Fino ad arrivare a quella sua frase indimenticabile e per certi versi “scandalosa”: «Se Dio non mi aiuterà più, allora sarò io ad aiutarlo». D’altra parte, lo dice il titolo del libro, lo scriveva Etty, «Dio ci vuole felici».
47 GENNAIO 2023
M EDITAZIONI Elisabetta Rasy
Etty Hillesum
Quando ha incontrato per la prima volta Etty Hillesum? Si ricorda che cosa la colpì, in particolare, nelle pagine del suo diario?
Alla metà degli anni Ottanta mi capitò tra le mani un libro di una perfetta sconosciuta, pubblicato da Adelphi. Era un diario. Sulla copertina c’era la foto di una ragazza che per qualche ragione mi riuscì famigliare anche se non l’avevo mai vista. Avrebbe potuto essere una mia compagna di scuola, me ne ricordava qualcuna, o io stessa, all’inizio dell’università. Cominciai a leggere e scoprii che si trattava di una giovane donna, Etty Hillesum, vissuta e morta molti anni prima di me, una donna della generazione di mia madre, nata in Olanda nel 1914. Ma a differenza di mia madre non aveva potuto sposarsi e avere figli perché era morta nel 1943 a Auschwitz. In realtà non fu solo questo destino tragico a interessarmi. A quell’epoca la mia movimentata giovinezza stava finendo, o almeno io volevo che finisse per diventare finalmente una persona adulta e responsabile. E su quegli anni giovanili in bianco e nero, pieni di passioni, felicità, tormenti non avevo le idee chiare, anzi mi apparivano un groviglio inesplicabile. Leggendo Etty mi sembrò che, invece che della sua, stesse parlando proprio della mia giovinezza, e mi aiutasse a capirla, a darle un senso.
Lei scrive che Etty voleva essere una “ragazza inedita”, voleva “diventare donna in modo diverso dalle generazioni precedenti”. A proposito di esperienze e pensieri in cui tante forse possono
riconoscersi... Cosa ha aiutato Elisabetta Rasy ad essere “inedita”, nella sua vita e nel suo lavoro?

Ci sono scelte che vengono fatte più per rompere che per costruire, ma sono fondamentali per diventare ciò che siamo.
In realtà non avevo aspettato il diario di Etty per cercare la mia via “inedita”, tra mille rotture, rifiuti, colpi di testa contro il buon senso, contestazioni del tradizionale ordine delle cose, soprattutto quello femminile. Non mi riferisco solo a contestazioni politiche: tutti gli anni Settanta dalla fine del liceo in poi erano stati dedicati, anche inconsapevolmente, alla ricerca di un modo di vivere che fosse mio e voluto da me, non deciso dagli altri. Non parlo tanto della mia famiglia, la mia non era una famiglia tradizionale, anzi, come si dice oggi, parecchio disfunzionale, anche se a me erano simpatici e nella loro disfunzionalità erano originali e bizzarri. Intendo rotture rispetto a quello che il mondo, anche apparentemente evoluto, si aspetta da un essere umano di genere femminile. E non è una questione solo di parte politica: le leggi del patriarcato, e quelle del conformismo, erano durissime a destra e a sinistra. Naturalmente tutte queste rotture non seguivano una linea ideale o un programma: erano istintive, a volte catastrofiche, certo dolorose, e spesso, se ci ripensavo, anche incomprensibili. Etty mi ha dato una chiave per decifrarle.
Il libro è dedicato a Etty Hillesum, ma dentro ci troviamo anche Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Edith Stein, Tatiana (dall’Eugenio Onegin di Puškin), Linda Partridge (il personaggio interpretato da Julianne Moore in Magnolia)... Ci racconta come è nata questa scelta e perché?

In fondo il mio libro è anche un diario di lettura di un diario, cioè è un libro che racconta una bellissima e drammatica storia femminile che è pure un po’ la mia. Una storia di formazione dedicata soprattutto alle persone che sono giovani oggi. Ci sono degli incontri nella vita che ci segnano o che ci rivelano qualcosa di noi: non sono sempre incontri con persone in carne e ossa, voglio dire che possono essere personaggi di un libro, autrici o anche autori di cui ci ha affascinato la vita, oppure personaggi di un film, persino personaggi di una canzone.
Ricordo che impressione mi fece a vent’anni la canzone dei Beatles intitolata She’s living home la storia di una ragazza che all’alba mentre i genitori dormono se ne va per sempre da casa: la ascoltavo per ore. Per questo nel mio libro ci sono storie di altre figure e personaggi, dalla Micol del Giardino dei Finzi Contini di Bassani al marinaio Marlow di Conrad, oppure scrittrici inquiete come Katherine Mansfield … Tutte figure in cerca di libertà.
Fin dall’inizio dice che non può seguire Etty a Westerbork, che intende rispettare il “segreto della sua anima”. E però alla fine le sue scelte e il modo in cui ha vissuto la prigionia, acquistano ancora più forza grazie al modo in cui l’ha raccontata. Etty Hillesum è spesso avvolta in un’aura mistica ed eroica, trasformata in una specie di “santino” (laico o religioso, a seconda di chi scrive), e quindi un po’ distante, quasi irreale. Nel suo libro invece ritrova la sua concretezza e vitalità. Le sue scelte (effettivamente eroiche, come è effettiva la sua fede, anche il suo misticismo), acquistano più forza e verità, parlano anche al nostro presente, sono qualcosa con cui ci si può confrontare.
Etty è stata letta da molti studiosi soprattutto in relazione all’Olocausto e alla sua speciale posizione
di resistenza al male, ovviamente non c’è niente di sbagliato in questo, ma lei ha lasciato pagine, e molte, che non parlano solo della tragica fase finale della sua vita femminile, ma anche della storia di una giovane donna in cerca di sé stessa piena di gioia e di dolore, che cercava un modo di amare, di affrontare il sesso, di venire a patti con i propri desideri, di mettere insieme eros e intelletto. E che vive una grande storia d’amore.
Scrivere per “trovare una forma” è una bella definizione. Anche leggere aiuta a trovarla. Oggi siamo nell’epoca del tutto è leggibile, guardabile, ascoltabile, e questo spesso confonde, non si sa più da cosa partire o come muoversi in questo oceano sterminato di possibilità. Quali sono stati, per lei, i libri e gli autori fondamentali, quelli che l’hanno aiutata a trovare la sua forma?
L’elenco è talmente lungo, e non saprei dove cominciare e dove finire. Posso dire che io ho cominciato a leggere da bambina, i classici per l’infanzia che mi regalavano i miei, Dickens in testa, però fin da allora mi sceglievo le letture che mi riguardavano, personaggi con cui sentivo un’affinità, anche se non avevano una somiglianza reale con me, per esempio Kim, il ragazzino indiano protagonista dell’omonimo romanzo di Kipling. Ma non leggevo solo alta letteratura: mi innamorai di un libro intitolato La piccola principessa letteratura rosa per l’infanzia, e più tardi di Sherlock Holmes. Poi scoprii Joseph Conrad, Cuore di Tenebra e Lord Jim, libri di viaggi in mondi lontani che sono però anche viaggi dell’anima. Quindi tanti altri insieme alla decisiva scoperta di alcune autrici, voglio dire che nel mio universo di lettrice entrarono prepotentemente le donne, le donne che scrivevano. La più amata per un periodo fu Marguerite Duras, con le sue storie un po’ criptiche e le sue eroine disperate, ma anche con la terribile e meravigliosa storia autobiografica che racconta nell’Amante Ma come faccio a enumerarle? Citando alla rinfusa: Jane Austen, la nostra Grazia Deledda, Carson Mc Cullers, Flannery O’ Connor e poi Ingeborg Bachman, Clarice Lispector… L’unica cosa che hanno in comune è che raccontano un femminile non ovvio, non pittoresco, non sempre vincente o determinato al successo, anzi tutt’altro: un po’ enigmatico e misterioso, in cui ci sono tutti i contrasti e le contraddizioni che rendono interessante la vita.
49 GENNAIO 2023 48 GENNAIO 2023
Guardare un’opera di Jheronimus Bosch non è mai un atto banale. La sua fama, diventata quasi pop, fa sì che le sue invenzioni stravaganti, i mostri, i diavoli, gli esseri chimerici e grotteschi, siano ampiamente conosciuti dal grande pubblico (la mostra del 2016 per il cinquecentenario fece quasi 600mila visitatori al Prado di Madrid).


Ma poi, quando ti ritrovi davanti ai suoi quadri in carne e ossa - in tela, colori e materia pittorica - ti stordiscono e ti portano via. Dove, non si sa. E allora capisci che il gusto un po’ superficiale per il bizzarro e l’originale, per il freak e l’orrorifico visionario, sono quasi un equivoco. Non siamo di fronte a uno spettacolo da fiera, un innocuo intrattenimento stravagante, ma a un’opera potente, che scava e apre varchi verso altre dimensioni.
Il suo caos apparente, che sembra il frutto dell’improvvisazione e di un’ispirazione deflagrante, nascondono in realtà un misterioso disegno, un discorso complesso, stratificato, che tuttora rimane
ampiamente inesplorato. L’opera d’arte è sempre una finestra aperta verso l’altrove, che sia l’inconscio o il super-cosciente, l’al di là, il regno dell’immaginazione o l’al di qua della realtà rivelata.
Ma ci sono opere, come quelle di Bosch, in cui l’apertura è uno spalancamento temerario, e l’altrove finisce per invadere il nostro mondo, lasciandoci affascinati e sconcertati.
L’atto di guardare un’opera di Bosch ha una sua dinamica, anche fisica, una ginnastica sensoriale, che prepara all’esperienza (interiore). È un piegarsi verso l’opera, un avvicinarsi, per entrare letteralmente dentro, catturati dagli innumerevoli dettagli, i simboli e le storie che raccontano, fino a precipitare oltre il bordo della materia pittorica, che si fa permeabile.
anche solo per questo capolavoro (soprattutto per chi non ha mai potuto vederlo a Lisbona, al Museo Nacional de Arte Antiga).
Un quadro di Bosch cominci ad ammirarlo da lontano, come si fa con un paesaggio sublime, nel senso in cui questa parola era utilizzata nel Settecento da Edmund Burke, “l’orrendo che affascina”, ciò che ci sovrasta e ci lascia smarriti. Ma è anche (con Schopenhauer) un sentimento di piacere legato alla vastità e alla potente magnificenza di qualcosa che potrebbe distruggerci.
L’occhio è ammaliato dalla ricchezza di forme, miniature, cromatismi, è attratto dall’incendio devastante che sta sullo sfondo della tavola centrale e dal paesaggio in rovina.
interiore di chi vede il mondo sotto forma di virtù e peccati, di chi percepisce l’assurdo e l’orrore dentro l’illusione della materia e delle sue tentazioni.
Sempre più piegato verso il quadro, attratto dai particolari, salti da una tavola all’altra, e cominci a viaggiare dentro l’opera, il suo folle bestiario, gli atti blasfemi, le allusioni erotiche, le micro-storie che ti fanno viaggiare con l’immaginazione.
Prendiamo ad esempio il Trittico delle Tentazioni di sant’Antonio. Lo potete vedere a Palazzo Reale, in questi giorni: è la prima opera incontrata una volta entrati nella mostra Bosch e un altro Rinascimento, che vale la pena visitare
Poi ti avvicini e lo sguardo comincia a saltare da una figura all’altra, esseri antropomorfi, diaboliche entità, ibridi animali, deliri vegetali, senza che (in apparenza) ci sia una direzione obbligata, un’armonia, uno scopo, perché questo è il paesaggio
Jheronimus Bosch
“Trittico delle Tentazioni di sant’Antonio” (1500 circa, olio su tavola) Lisbona, Museu Nacional de Arte Antiga © DGPC/Luísa Oliveira In alto, un dettaglio dell’opera

50 MESE 2022
Dipingere l’uomo com’è dentro Bosch, la verità stravagante CAPOLAVORI IN MOSTRA A MILANO, A PALAZZO REALE CHE TORNA AD APPROFONDIRE “L’ALTRO RINASCIMENTO”
UN’ESPOSIZIONE REALIZZATA DA 24 ORE CULTURA CON UN CENTINAIO DI OPERE FINO AL 12 MARZO 2023
E VENTI
(foto Carlotta Coppo)
Vedi ad esempio un vecchio e una donna-pesce con bambino, su un topo gigantesco, che inevitabilmente fanno pensare a una parodia della fuga in Egitto. Vedi un corteo mostruoso e la caricatura diabolica di una messa, un pesce-barca corazzato, la Lussuria che fiorisce nel ventre di un salice, un mago amputato con cappello a cilindro, uomini con la faccia da maiale, uccelli a zampogna, caverne umanoidi... C’è la Bibbia e il folklore popolare, la magia negromantica, la kaballah, i tarocchi, ci sono la farmacopea antica e l’arte gotica. Quando poi l’attenzione sembra fatalmente travolta dalle apparizioni, la fantasia eccitata e quindi accecata, ecco che l’occhio torna a guardare verso il centro, fai un passo indietro (mentalmente e fisicamente) e vedi quella figura scura, esile, inginocchiata, che sembra quasi piegata sotto il peso di ciò che gli sta intorno, ma in realtà ha un’espressione serena: Sant’Antonio guarda verso di noi, ci benedice e indica un crocefisso semi-nascosto. Il messaggio, quindi, arriva forte e chiaro. Ha lottato e ha vinto, nonostante tutto.
Poi, volendo, si può provare a decifrare l’opera, visto che nei quadri di Bosch sono chiare le allusioni alchemiche (l’arte della trasformazione interiore) come le citazioni bibliche e l’ispirazione tratta dai bestiari medievali. I suoi
quadri si aprono a interpretazioni psicanalitiche, etiche, esoteriche, politiche, teologiche, allegoriche. Sono innumerevoli i tentativi di spiegare ciò che forse andrebbe solo sentito o intuito.
E IL VISIONARIO OLTRE IL “CLASSICO”
La mostra, realizzata da 24Ore Cultura-Gruppo 24Ore e promossa dal Comune di Milano (che rimarrà aperta fino al
12 marzo), forse non si fa notare per la quantità, ma è un concentrato di opere stupefacenti. E continua il lavoro di approfondimento dell’altro Rinascimento – il bizzarro, l’eccentrico, il comico, il visionario, oltre il classicismo - che Palazzo Reale porta avanti da tempo, che passa attraverso l’esposizione del 2011 dedicata a Giuseppe Arcimboldo e quella su Dürer del 2018. Perché è vero che, oltre al canone classicista, ai Raffaello e i Michelangelo, tra il XV e il XVII secolo l’arte è stata anche molto altro.
Lo scrivono i curatori della mostra Bernard Aikema, Fernando Checa Cremades e Claudio Salsi: «Lo storico dell’arte Eugenio Battisti ha introdotto, in questo contesto, il termine di “antirinascimento”. Noi preferiamo parlare di un Rinascimento alternativo, o, per l’appunto, di “Rinascimenti”, al plurale». D’altra parte quelli erano anche gli anni in cui si diffondevano le Wunderkammer, le collezioni di “meraviglie”, stranezze, reperti naturali e artificiali, cimeli e oggetti rari. Un collezionismo enciclopedico fondato sulla varietà, l’eccezione, lo stravagante. Si esaltavano il sogno e la fantasia, si parlava di grottesco e buffonesco.
Leonardo da Vinci
“Codice Trivulziano”
(Ultimo quarto XV secolo)
Milano, Archivio Storico Civico
e Biblioteca Trivulziana
© Comune di Milano
Di Bosch, che in realtà si chiamava Jheronimus van Aken, sappiamo pochissimo. È nato intorno al 1450, ha vissuto per tutta la vita nella città natale fiamminga (Hertogenbosch, ovvero Boscoducale), e aveva una sua bottega fiorente. Il resto è mistero. Non ci sono documenti, mancano le testimonianze ed è dubbia anche l’autenticità della firma su alcuni quadri. Ciò non toglie che la sua opera suscitò grande risonanza fin da subito. Il paradosso, sottolineato dai curatori della mostra, è che i quadri di Bosch furono apprezzati e imitati soprattutto nei paesi mediterranei, dalla Spagna all’Italia, che in teoria era la patria dell’arte classica, misurata, monumentale. Nulla di più lontano dall’onirico e folle immaginario boschiano. Anche se forse bisognerebbe rivedere l’idea dell’opposizione classico/ anticlassico così diffusa nei libri

di storia dell’arte. Vedi il gusto per il grottesco e la caricatura di un artista come Leonardo da Vinci, presente in mostra nelle pagine del Codice trivulziano. Vedi Il mostro marino di Albrecht Dürer, che con grande realismo associa un nudo femminile classico (che potrebbe essere uscita da un
quadro di Giorgione o Tiziano) a un immaginifico essere barbuto con corno e coda di pesce, dentro un guscio di tartaruga. Oppure il magnifico Corteo magico di Benvenuto Tisi, con il suo paesaggio in stile fiammingo e una bizzarra sfilata danzante in primo piano, popolata da strane creature.

53 GENNAIO 2023 52 GENNAIO 2023
Jheronimus Bosch, “Le tentazioni di sant’Antonio” (1500-1525 circa, olio su tavola) - Madrid, Museo Nacional del Prado © Archivio fotografico, Museo Nacional del Prado, Madrid
L’INSOLITO
Tra le opere più affascinanti in mostra, c’è l’impressionante Visione di Tundalo (solo fino al 12 febbraio) ispirata al viaggio iniziatico di questo leggendario cavaliere del XII secolo che fece visita all’al di là.
Uscita dalla bottega di Bosch, è una visione surreale (i surrealisti, secoli dopo, attingeranno a piene mani alla sua opera), costellata di corpi nudi, piccoli mostri e bestie bizzarre, animata da azioni allegoriche, costruita intorno a un inquietante grande cranio con le orbite vuote.
Ma c’è anche una Discesa di Cristo al limbo in cui la figura di Gesù è quasi un piccolo dettaglio, una comparsa, dentro un alone di luce: ciò che interessa all’autore (“seguace di Bosch”) in realtà è dipingere un grande affresco infernale, un caleidoscopio tenebroso, in cui un mostro dalla bocca enorme divora
le anime sospinte dai diavoli. Il tema della mostra è l’influenza che Bosch ha esercitato sulla storia dell’arte (e non solo). Vedi l’Allegoria del fuoco di Jan Brueghel il vecchio, che nasce da quell’immaginario, per il tono cupo, i bagliori infernali, lo spettacolare e dettagliato armamentario che riempie il quadro (tra alambicchi, armature, oreficeria).


Tra le variazioni sulle tentazioni di Sant’Antonio si fa notare un’opera attribuita a Pieter Stevens il Giovane, che è un incubo animato, quasi una sequenza cinematografica, in cui spiccano un drago sputafuoco e uno scheletro a cavallo che emette fiamme da occhi e bocca. Anche se l’opera più impressionante forse è quella che un anonimo fiammingo ha ricavato da una celebre stampa a bulino di
Martin Schongauer: il santo levita, mentre i demoni gli afferrano la veste, i capelli, le braccia; i mostri sono descritti con virtuosistica dedizione, per renderli ancora più reali e terribili, ed esaltare la forza d’animo dell’eremita, la sua serenità soprannaturale. In mostra non ci sono solo opere pittoriche. Sono tanti gli spunti interessanti. C’è ad esempio un’incisione al bulino di Pieter van der Heyden del 1561 (da Bruegel il Vecchio) che sembra un fumetto macabro e fantasmagorico. Ci sono legni dipinti e dorati (dal Monastero di San Benito a Valladolid) tempestati di satiri, mostri, crani, teste alate. Soprattutto ci sono gli impressionanti arazzi “alla maniera di Bosch” entrati nella collezione reale spagnola già ai tempi di Filippo II (forse).
«I panni sono tutti incorniciati da architetture classiciste e da alcune spettacolari bordure floreali – scrivono i curatori nel catalogo della mostra. - Le architetture sono tipiche della metà del XVI secolo: qui non appare contraddizione, secondo il gusto del momento, tra il loro aspetto classico e la natura anticlassica dell’immaginario boschiano» Ma vale la pena segnalare anche la «ricostruzione “ideale” di una Wunderkammer, quasi un teatro, composto da una serie di oggetti di varie provenienze, fra i quali calici e boccali, fialette, un nautilo, dei calamai, una statuetta di corallo, (tutti manufatti estremamente elaborati), vari bronzetti, uno stipo, un magnifico ventaglio in avorio intagliato dello Sri Lanka, prodotto per il re del Portogallo, e, non ultima, la copia dello spettacolare automa diabolico della collezione Settala del XVII secolo» Ci sono perfino degli uccelli imbalsamati provenienti dal Museo di Scienze Naturali milanese, le stesse specie dipinte da Bosch nel Giardino delle delizie.
E per chiudere il cerchio – sul classicismo “altro” - ecco anche l’Arcimboldo, con il suo Vertumnus, in cui ritrae l’imperatore del Sacro Romano Impero Rodolfo II d’Asburgo in forma di frutti, fiori e verdure. Ecco un altro “pittore di chimere” che sembra contraddire la direzione aurea della storia dell’arte, esaltando il fantastico, il bizzarro, il curioso, ma il cui discorso è molto più
profondo di quanto appaia a prima vista. Certo, ci sono il gioco e la dotta facezia, proprie dell’ambiente di corte, ma anche il simbolo e l’allegoria, l’esaltazione degli Asburgo nella logica di una nuova età dell’oro, associata alla prosperità della natura e al dio delle stagioni, rimandando alle Metamorfosi di Ovidio (più classico di così).
Ma torniamo a Bosch e lì rimaniamo. Anche perché i suoi quadri andrebbero contemplati a lungo, percorsi in lungo e in largo, in altezza e anche in profondità (la dimensione dell’intuizione).
Pieter Van der Heyden (da disegno di Pieter Bruegel il Vecchio)

“Discesa di Cristo al Limbo” (1561 circa, bulino)
Milano, Civica Raccolta delle
Stampe “Achille Bertarelli” © Comune di Milano
55 GENNAIO 2023 54 GENNAIO 2023
Bottega di Jheronimus Bosch, “La visione di Tundalo” (1490-1525 circa, olio su tavola) Madrid, Museo Lázaro Galdiano © Museo Lázaro Galdiano, Madrid
(foto Carlotta Coppo)
Non è solo la quantità e varietà degli elementi presenti nel quadro, ma anche la ricchezza cromatica, la luce (e il buio), la magia che comunicano.
Ammirando quella meraviglia che è il Trittico dei santi eremiti viene in mente ciò che scriveva la studiosa belga Lucie Ninane: «In lui la libertà ideativa era sorretta da un’uguale libertà di esecuzione; e restano da ammirare al tempo stesso la maestria del suo pennello, la sensibilità del tocco, l’acume coloristico e l’infinita ricchezza spirituale». C’è qualcosa di mistico (e di ermetico), pur nella sua ap-
parente crudezza realistica, nel San Girolamo al centro del quadro, dentro un paesaggio che è insieme reale e fantastico, per certi versi astratto, simbolico, per altri dettagliatissimo e minuzioso, finanche nei bassorilievi dipinti sulle rovine davanti a cui è inginocchiato.
“PITTORE DI GRIGI” MA ANCHE DI CROMATISMI SORPRENDENTI
A sinistra c’è un Sant’Antonio cupo, col suo consueto contorno
di tentazioni sensuali e mostruose.
A destra un luminoso Sant’Egidio, accompagnato dalla cerva che lo nutriva, in dialogo con il fuoricampo (fuori-quadro) dentro la caverna, che ci riporta al crocifisso al centro.
Bosch risulta misterioso anche quando realizza quadri apparentemente sereni, come Meditazioni di San Giovanni Battista (in mostra solo fino al 12 febbraio) rapito da chissà quale pensiero o visione, per nulla estatico, quasi un vecchio fanciullo, coperto per metà da una pianta improbabile che è la somma di varie piante, immerso in una paesaggio che appare quasi alieno.


Ed ecco «i rosa più squisiti e lillà, celesti, nocciola, verdi giada» di cui parlava Robert Genaille, che un po’ sorprendono in questo «pittore di grigi, sensibile all’incanto dei toni sottili», salvo poi utilizzare anche cromatismi «sonori e consistenti come smalti, di arancio, carminio, azzurro cupo, nero violaceo; e vi proietta sopra bagliori rosso fuoco o giallo zolfo»
A volte ci sono blocchi di materia opaca, corposa, dentro cui l’occhio rimane invischiato, come fosse una palude che impantana lo sguardo.
Altre volte invece la materia è traslucida, la pittura chiara, liquida, vivace.
Bosch disegna sogni, incubi, passioni deliranti, impulsi grotteschi,
realtà interiori, quindi ha bisogno che le sue immagini risultino visivamente immediate e potenti. Il suo è un paradossale realismo che cerca di rendere visibile l’invisibile. Così come accade davanti al celebre Il giardino delle delizie (qua evocato da un copia del pannello centrale opera della sua bottega), potremmo stare delle ore a contemplare il suo Giudizio finale (che arriva dal Groeningemuseum di Bruges), in cui il mondo appare sotto forma di bolgia peccaminosa, mentre il Cristo è dentro una bolla di cielo che è lì, al centro, in evidenza, ma anche terribilmente distante. Che incredibile ricchezza di forme, stramberie, metamorfosi, deliri! Ma dentro un’architettu-
“Trittico dei Santi Eremiti” (1495-1505 circa, olio su tavola) Venezia, Gallerie dell’Accademia © Archivio fotografico Gallerie dell’Accademia di Venezia
ra segreta che trasfigura il caos. Scriveva lo scrittore-critico Roger Caillois quasi sessant’anni fa: «Mi sono domandato molte volte perché, davanti ai quadri del Bosch, non provo l’impressione d’insuperabile stravaganza che dopotutto sarebbe ragionevole proporre, sotto qualunque aspetto, come pietra di paragone del fantastico. Eppure ogni particolare testimonia, là dentro, un’inventiva prodigiosa: i domini vi si mescolano, le combinazioni più remote sono usuali e un uomo perforato dalle corde di un’arpa è il minimo che ci si possa aspettare da questi sovrabbondanti accumuli di meraviglie.
57 GENNAIO 2023 56 GENNAIO 2023
Manifattura di Bruxelles, “Il carro di fieno (Tribolazioni della vita umana)” (1550-1570 circa, arazzo) Madrid, Palazzo Reale, Patrimonio Nacional © Patrimonio Nacional
Jheronimus Bosch
Il fatto è che, a furia di accatastarsi l’una sull’altra, queste meraviglie finiscono col formare un insieme coerente: derivano da un partito preso che fa della magia una norma; sono lì per forza, a illustrare la legge di un universo tutto quanto insolito … E il fantastico non è fantastico se non crea uno scandalo inammissibile per l’esperienza e per la ragione. Se per caso o, peggio, in seguito a un piano preciso, diventi l’inizio d’un nuovo ordine di cose, immediatamente il fantastico crolla; non riesce più a suscitare né angoscia né sorpresa, ma diviene l’applicazione conseguente, metodica, di una volontà deliberata che non lascia nulla fuori del nuovo sistema. In verità il mondo di Bosch è propriamente un mondo sistematico». In effetti non è solo una questione di stravaganza, non è solo il fantastico che apre a
un’altra dimensione della realtà. È anche semplicemente (si fa per dire) un altro modo di guardare l’uomo e il suo universo (im)morale, sotto forma di simboli e visioni, come se venisse tolto un velo.
LA SPIEGAZIONE DEL SIMBOLO? INTERMINABILE. È IL SUO MISTERO
Bosch è da una parte il frutto tardo dell’immaginario medievale e dall’altra un anticipatore della “scoperta” dell’inconscio e dell’arte di decifrare i segni interiori più segreti. Lui non dipingeva l’uomo come è fuori, ma come è dentro. Possiamo elaborare tutte le interpretazioni che vogliamo, utilizzando la psicologia o l’astrologia, l’ermetismo, la religione o la filosofia,

ma alla fine dobbiamo accettare il fatto che non ci sia possibilità di decifrarlo in modo definitivo. Massimo Cacciari, scrivendo di Bosch, evocava la «natura del simbolo, ai modi in cui il simbolo opera. La sua spiegazione appare perciò, sotto certi aspetti, “interminabile”: essa non darà mai capo a una solida sostanza, a un contenuto univocamente determinato. Gli elementi del simbolo racchiudono polarità in continua metamorfosi». Anche questo, in un certo senso, ha un significato “iniziatico”. Quando una figura smette di simboleggiare qualcosa in modo chiaro, decifrabile in modo razionale, acquista una forza singolare, che va oltre una certa idea di “senso”. Contemplate a lungo un quadro di Bosch e lo capirete. O forse lo sentirete soltanto. Tanto basta.

59 GENNAIO 2023
Jheronimus Bosch, “Giudizio finale” (1500 circa, olio su tavola) Musea Brugge, Groeningemuseum, Bruges © Lukas - Art in Flanders VZW/Bridgeman Images
Jheronimus Bosch, “San Giovanni Battista” (1495 circa, olio su tavola) Madrid, Museo Lázaro Galdiano © Museo Lázaro Galdiano, Madrid
Viaggio a Pandora tra utopia e (ir)realtà
Arte e spettacolo si incontrano di nuovo in un kolossal che parla di riscoperta dell’anima e connessione con gli altri e la natura
di quegli esseri blu, giganteschi, quegli indigeni di un altro pianeta, più umani degli umani, che sono insieme attori e personaggi animati, corpi trasfigurati, interpreti mascherati elettronicamente (foto-video-ritocco in performance-capture)?
da una parte è fantascienza futuribile, evoca tecnologie in grado di trasportare una coscienza da un corpo umano a un’altra entità, dall’altra ha un’anima antichissima, spirituale, panteista, che guarda al pensiero orientale e alla sua tradizione filosofica e religiosa.
Su Pandora tutto vive in armonia, Na’vi e natura, essere animali e vegetali, attraverso una divinità chiamata Eywa, in una inter-connessione che ricorda un concetto fondamentale di varie discipline spirituali orientali.
Ci sono luoghi dell’immaginazione che sembrano più veri di quelli “reali”. Uno di questi è Pandora. Anche se, parlando di Avatar, la distinzione reale/immaginario rischia di risultare inadeguata, oltre che invecchiata male. Un po’ come quella tra animazione e cinema live (“live action” è l’azione dal vivo, il film interpretato da attori in carne e ossa).
Che cos’è Pandora se non una gigantesca opera d’arte virtuale, digitale, che prende forma sulla schermo, e diventa reale, sfidando la nostra incredulità? E cosa dire
Avatar parla di incarnazioni, trasformazioni, superamento di vecchie categorie, già a partire dal titolo. Oggi la parola indica il personaggio virtuale che ci rappresenta sul web, che ci raffigura, oppure che ci trasfigura, in tutti quei casi in cui assomiglia più a come ci vediamo (o ci immaginiamo) che a come siamo (o come gli altri ci vedono). Ma l’avatar, in India, è soprattutto l’incarnazione di un dio, l’apparizione in forma terrestre di un’entità sovrannaturale, che di solito avviene in periodi di crisi, quando l’umanità ha smarrito la strada, per ristabilire una connessione tra terra e cielo. Guarda caso Krishna – l’avatar per eccellenza – è tradizionalmente dipinto di blu.
I due significati convivono nella creazione di James Cameron, che
Ma allo stesso tempo quell’essere connessi rievoca in qualche modo anche il web, il grande villaggio virtuale globale - “villaggio”, appunto, come se tutto il mondo fosse una grande tribù con cui ognuno può condividere immagini, pensieri, ricordi – alludendo alle sue potenzialità positive, ancora inesplorate.
Pandora non è un banale contesto, non è solo scenografia spettacolare. Sì, certo, si parla di visioni che devono suscitare stupore, perché il (grande) cinema deve catturare l’occhio, oltre al cuore.
Ma Pandora è anche un’ipotesi di realtà futura, uno stile di vita alternativo, un’idea di mondo che assomiglia a un Eden perduto (ma ritrovabile), un’utopia realizzabile, in cui umani (e umanoidi) vivono in armonia tra loro e con la natura.
Sono passati 13 anni da quando Avatar ci ha restituito la meraviglia del cinema. Lo stupore infantile che accompagnava i primi fantasmagorici film di Méliès.
Quelli che lasciavano gli spettatori a bocca aperta di fronte a un’arte-tecnologia in grado di dare vita anche a mondi immaginari. Troppo cinema tutto uguale, frastornante, povero di idee e di immaginazione, è passato sotto i nostri occhi, soprattutto dopo la moltiplicazione degli schermi e dei sistemi di riproduzione (dalla tv allo smartphone), che hanno esaltato la quantità più che la qualità e l’ambizione. Sono pochi i registi contemporanei che hanno provato a conciliare le ragioni dell’arte e quelle del sogno, la ricerca estetica e l’universalità del messaggio (l’eterno Spielberg, Nolan, Villeneuve...).
James Cameron non è mai stato uno che si accontenta, come ha dimostrato la visionaria megalomania di Titanic (il finale di Avatar 2 ci riporta ai momenti più spettacolari di quel film).
Avatar non era semplicemente un gigantesco blockbuster, frutto di investimenti milionari. Era il


prodotto di una nuova tecnologia, su cui il regista di Terminator e Aliens scontro finale lavorava da tempo. Un film pensato, girato e realizzato in 3D con apposite telecamere - a differenza dei soliti film tridimensionali, frutto di un trucco in post-produzione – che generava sostanzialmente una nuova dimensione, la profondità di schermo, la
possibilità di sviluppare la scena in direzioni finora solo immaginate. Indimenticabile l’impatto di quelle sequenze di volo, nei cieli di Pandora, che andavano ben al di là dell’effetto luna park dei movimenti 3D, e suggerivano la necessità di guardare le cose in modo nuovo, di andare più in là con lo sguardo, più in profondità.
Dopo aver esplorato i cieli, andiamo alla scoperta della “via dell’acqua”, tra ecologia e filosofia orientale. Una fiaba fantascientifica con un vecchio cuore western, ma anche e soprattutto un’esperienza sensoriale

60 GENNAIO 2023
L UOGHI
Era il tema principale del film: “Io ti vedo”, dicevano (e dicono) i Na’vi per evocare un modo di guardare che è anche un sentire, un entrare in connessione profonda con l’altro.
poi c’era la storia d’amore, la vicenda fondativa dell’esploratore-invasore che si innamora dell’indigena, la coppia di amanti nemici che manda all’aria le categorie ed evoca la convivenza possibile.
Bisogna rinunciare al proprio piccolo falso io (l’ego) per scoprire il vero sé, che è connesso al resto dell’universo.
Il primo Avatar aveva la struttura narrativa di una fiaba, evocava temi e trame ancestrali, i buoni e i cattivi, un popolo indigeno che vive in armonia (con un’innocenza edenica che ricorda i nativi di Terrence Malick) e un esercito invasore che uccide e distrugge senza pietà, per depredare le sue risorse. C’era la solita storia di resistenza, ma dentro un discorso fortemente ecologico. E
Ma sotto la trama-tema principale, c’era anche un discorso fondamentale sull’io e i suoi limiti, esplorato secondo categorie tipicamente orientali. La coscienza di un uomo che dentro un altro corpo, un altro sguardo, un diverso modo di intendere la vita, scopre di poter andare letteralmente oltre i propri limiti e vivere la “verità” di un mondo che non riusciva a capire.
Avatar 2, tredici anni dopo, riparte da lì, in tutti i sensi. Innanzitutto per lo spettacolo “bigger than life”, un cinema alla vecchia maniera che però utilizza una tecnologia nuovissima e ha senso solo nelle dimensioni del grande schermo (anzi, più grande è meglio è). Si va in direzione contraria rispetto alla stragrande maggioranza delle produzioni odierne, i film nati con un occhio allo streaming, nella consapevolezza che la maggior parte delle persone lo vedranno a casa propria, su una qualche piattaforma digitale. Torna la cara vecchia esperienza dell’immersione in un mondo immaginario ma verissimo, nel buio di una sala.



Immersione favorita dall’idea visiva alla base del film. Le possibilità del 3D (che non hanno avuto lo sviluppo sperato, in questi tredici anni) non hanno un valore in sé, meramente ludico, ma permettono di sperimentare quasi fisicamente quella “scoperta dell’acqua” che vivono i protagonisti del film. Nel primo episodio si trattava di ampliare lo sguardo, vedere in modo nuovo, qui invece si tratta di buttarsi e nuotare, di lasciarsi andare, di sentire. Ancora una volta Avatar è una straordinaria esperienza sensoriale. Le poetiche rocce galleggianti delle Hallelujah Mountains lasciano spazio alle magnifiche vastità sottomarine. Ma cambia anche l’approccio “filosofico”. Il tema principale non è più il superamento del vecchio sé, ma la connessione con il “tutto”, da esplorare in modo nuovo, ancora più profondo. Vedi la figlia della coppia meticcia (un uomo diventato Na’vi e una nativa) che sente il divino, si perde nella contemplazione del mondo, e cade in vere e proprie estasi mistiche (che per l’uomo occidentale, moderno, sono il frutto di epilessia...). Al posto dell’aria, stavolta, c’è l’elemento acqua, qualcosa che è dentro e fuori di noi. «La via dell’acqua non ha inizio e non ha fine», si dice, rievocando temi taoisti. Ma c’è anche il pranayama yogico, la necessità di imparare a respirare, che sono i figli a insegnare ai genitori, perché sono i giovani a vivere più intensamente quella connessione (sono i giovani, nei nostri tempi, che lottano per salvare il pianeta Terra, distrutto dai padri).

63 GENNAIO 2023 62 GENNAIO 2023
Il massimo della tecnologia, ma anche tanto artigianato. Andiamo dietro le quinte del film di James Cameron
La “performance capture”, che trasforma gli attori in Na’vi, ha raggiunto livelli straordinari

Quello che vediamo sott’acqua è quasi un mondo astrale, come fosse la dimensione in cui si entra in un altro stato di coscienza, che si raggiunge attraverso la meditazione. Un terzo del film è pura contemplazione, con momenti alti, poetici, e altri più scontati e già visti. Ma è questa la logica di Cameron e di un cinema proiettato nel futuro, in cui l’azione è sempre fondamentale, spettacolare, ma il messaggio passa anche solo attraverso l’esperienza visiva, formale.
Poi c’è la cara vecchia epica e la forza espressiva tipica di ogni fiaba, che va a toccare i grandi temi della vita e della morte, dell’amicizia e dell’amore. Per certi versi, in Avatar 2, sembra di stare ancora dentro un vecchio film western. Il
tema, in questo caso, è provare a coniugare valori antichi ancestrali, come l’appartenenza, la famiglia, il sacrificio per l’altro, con il “nuovo sguardo” che connette alla natura, l’unità con l’universo e la comunità, che vale più dell’individuo, gli dà un senso.
Nel frattempo i cattivi sono pronti a incarnare i propri (dis)valori, l’odio, la vendetta, la volontà di potenza, in nuovi corpi. Stavolta non si cerca un’energia inesauribile, ma un liquido che dà la longevità, che guarda caso si chiama amrita, come l’acqua della vita eterna della mitologia indiana. I poveri stolti occidentali, gli invasori, spietati cacciatori di balene in formato tulkun (splendidi animali marini, intelligentissimi, al centro della trama di Avatar 2), pensano che il problema sia avere qualche anno in più, l’immortalità del corpo. Non possono capire quell’altra
forma di immortalità (evocata simbolicamente dall’amrita). Così come non capiscono che «l’energia è sempre in prestito» e prima o poi va restituita, come ci insegna il commovente finale.
Ma proviamo a inoltrarci nel processo creativo di James Cameron e dei suoi collaboratori, per a capire il modo in cui nasce e si sviluppa un luogo (narrativo) complesso come quello che va in scena in Avatar, ormai destinato a diventare una saga.

Jake Sully e Neytiry - interpretati da Sam Worthington e Zoe Saldaña - ora hanno quattro figli, di cui una adottata (una nascita “miracolosa”) e devono convivere con un diverso popolo di Pandora, il clan acquatico Metkayina. Ebbene sì, Pandora è molto più grande e varia di quanto immaginassimo.
Lo scopriremo un sequel dopo l’altro, visto che sono già stati girati anche il terzo, il quarto e il quinto, che usciranno ogni due anni (nel 2024, nel 2026, nel 2028).
Si dice che James Cameron abbia accumulato più di 15 mila pagine tra note, idee narrative e variazioni della storia, poi affidate a un team di sceneggiatori per svilupparle intorno al tema centrale della famiglia. Dentro quelle pagine ci sono anche i vari ambienti di cui è fatta Pandora, che è una luna orbitante intorno al pianeta Polifemo, nel sistema stellare Alpha Centauri-A. Come dice il co-produttore Jon Landau «Pandora è un personaggio del film. Abbiamo usato Pandora come metafora del nostro mondo: potremmo viaggiare per secoli e non vedere tutte le meraviglie che contiene. Quindi, Jim (Cameron, ndr) ha deciso di esplorare nuovi ambienti e nuove culture di Pandora».

Niente di più affascinante, per un amante del mare come Cameron, immaginare un nuovo popolo legato all’oceano, che è anche fisicamente diverso rispetto agli
abitanti della foresta, adattato alla vita in acqua, ma non sfugge alle dinamiche tipiche dei popoli terrestri, quando vengono in contatto con il simile ma diverso.
65 GENNAIO 2023 64 GENNAIO 2023
Cameron ha fatto costruire una vasca enorme in cui girare le scene sott’acqua (senza respiratori!).
Jack Champion intepreta Spider, un umano cresciuto con i Na’vi. In basso James Cameron spiega una scena a Sigourney Weaver. Nell’altra pagina vediamo il concept di un set e il regista impegnato in una ripresa subacquea.


Ma il meglio dell’immaginario cameroniano si esprime nella creazione delle specie acquatiche, variazioni visionarie degli animali marini della cara vecchia Terra.

Per testimoniare la vocazione ambientalista e animalista di Avatar, non c’è nulla di più efficace della spietata sequenza di caccia al tulkun, che ci riporta a scene sanguinose viste tante volte nei mari terrestri, e che esaltano l’orrore sottolineando l’intelligenza di quelle fantasmagoriche balene, in grado di comporre musica, di comunicare con i Na’vi, di provare emozioni anche più intense delle nostre. Cameron ha fatto creare al
Manhattan Beach Studios un’enorme cisterna, perché bisognava replicare le condizioni di vita reali in un oceano, per poi procedere con la performance-capture, che riproduce digitalmente i movimenti degli attori e le loro espressioni. Il problema è che non era possibile utilizzare bombole e respiratori, bisognava evitare le bolle d’aria che disturbavano il sistema di cattura delle immagini: da qui la necessità di recitare, e riprendere le scene, trattenendo il respiro (si dice che Kate Winslet fosse capace di trattenerlo per più di 7 minuti). Come capita spesso nel cinema di Cameron, siamo di

fronte alla tecnologia più avanzata, ma anche alla massima artigianalità, alla necessità del realismo più accurato e minuzioso.
Poi, certo, se sei Cameron puoi lavorare anche con una rivoluzionaria Virtual Camera che consente di girare dentro un ambiente digitale come se fosse reale. Il regista con quella macchina da presa poteva vedere i giganti blu nel loro ambiente, invece degli attori in movimento in spazi vuoti. La performance-capture ha ormai raggiunto livelli impressionanti, soprattutto dal punto di vista delle espressioni del viso, riprodotte con una fedeltà mai vista prima.
Il lavoro fatto insieme alla Weta di Peter Jackson ha permesso poi di creare l’incredibile complessità e accuratezza di quel mondo acquatico. Ci sono voluti cinque anni per riuscire a sviluppare software e hardware adeguati all’impresa.
Per usare le parole di Cameron: «Abbiamo dovuto capire come si muove l’acqua quando un’enorme creatura ne sposta tonnellate con la sua pinna o quando la più piccola goccia di pioggia cade sulla fronte di qualcuno, scendendo lungo il sopracciglio e lungo il viso» Sembrano dettagli, ma fanno la differenza. Come fa la differenza poter lavorare su alcune sequenze in 48 frame al secondo (HFR), invece dei canonici 24, garantendo una maggiore luminosità, fluidità e realismo alle scene d’azione in 3D (sì, il film va visto in una sala 3D, altrimenti perde gran parte del suo fascino e del suo senso).
Ma tutto questo sarebbe solo un’esibizione di muscoli (cinema come
industria) se Avatar non avesse il fascino senza tempo delle fiabe, la semplicità per nulla banale di quelle storie che sanno toccare corde profonde, che parlano di noi, delle nostre paure, così come dei grandi temi del nostro tempo. In più c’è l’elaborazione pop di suggestioni antiche, filosofiche e spirituali, che aprono a una diversa percezione
della realtà, a un altro possibile modo di stare al mondo. A volte il cinema cosiddetto mainstream, quando è opera di un artista visionario a cui tutti è concesso (visti i suoi risultati al botteghino), sa fare spettacolo e arte insieme, mostrando la via. «La via dell’acqua non ha inizio e non ha una fine, è dentro e fuori di noi».
67 GENNAIO 2023 66 GENNAIO 2023
L’ARTE DI OSARE DI UN MEDICO SUB CHE HA UNITO PASSIONE E LAVORO
La dottoressa Ambra Barbagallo ha sfidato pregiudizi e luoghi comuni. «Sono un’outsider»
Ci sono i medici, bravi e meno bravi, che hanno la loro routine sempre uguale, la burocrazia ospedaliera o l’attività privata, un certo numero di pazienti da visitare ogni giorno, gli esami, gli interventi: per qualcuno è una missione, per altri è solo un lavoro redditizio. Ma ci
sono anche quelli che non smettono mai di studiare e cercano nuove strade, pronti a rinunciare alle loro sicurezze pur di seguire le proprie passioni, fosse anche necessario andare in capo al mondo (o duecento metri sott’acqua...).
La dottoressa Ambra Barbagallo appartiene alla seconda categoria.

Ed è la dimostrazione vivente del fatto che è possibile unire la competenza nel proprio campo specifico, l’attenzione al paziente, con la voglia di sperimentare e di mettersi alla prova. Da una parte c’è la sua esperienza, ormai ventennale, nel campo dell’otorinolaringoiatria e dell’audiologia. Dall’altra un amore per il mondo subacqueo che l’ha portata ad approfondire la medicina subacquea e iperbarica e le ha aperto prospettive avventurose in un campo molto specifico, difficile, pericoloso, ma anche pieno di possibilità affascinanti. Perché non capita tutti i giorni di occuparsi dei problemi di chi frequenta le profondità del mare (per sport o per lavoro) o studiare le procedure per l’evacuazione in sicurezza di un sottomarino. Ecco perché nel suo curriculum potete leggere sia l’iter normale di un dottore laureato in Medicina a Milano (Università Vita-Salute del San Raffaele), con specializzazioni in Otorinolaringoiatria (Pavia) e Audiologia e Foniatria (Milano), sia un master di secondo livello in Medicina subacquea e iperbarica, di cui ha discusso la tesi proprio una settimana prima di questa intervista. Ci vuole una bella forza di volontà. E anche la voglia di andare oltre i luoghi comuni, sui lavori maschili o femminili, sulla fortuna di avere un posto fisso (oppure no?), sul fatto che un anestesista sia più adatto alla medicina iperbarica di un otorino. Pregiudizi e aspettative che lei si è impegnata a smentire, uno dopo l’altro. D’altra parte la sua storia racconta di una persona appassionata e ostinata, che non ama farsi dire cose deve fare nella vita.
«Volevo fare il medico fin da quando avevo 5 o 6 anni. Non so perché. So solo che avevo questo nella mia testa. E alla fine l’ho fatto, anche se i miei genitori non erano d’accordo». Immaginatevi una ragazza di Siracusa che dimostra grandi note nelle materie scientifiche, dalla matematica alla fisica. Insegnanti e tutor, al liceo, le raccomandavano di scegliere ingegneria come materia universitaria. La famiglia era d’accordo. «Ma io ho fatto una cosa che a me piace molto fare: ho sbattuto in faccia a tutti la verità». E lo ha fatto a modo suo, testardo e spettacolare, senza mancare di rispetto a nessuno. Si è iscritta a vari test di ingresso in giro per l’Italia – tre a Medicina e tre a Ingegneria – e li ha passati tutti. Tanto per dire: non esistono strade obbligate, ci sono tante possibilità e io mi voglio concedere il lusso della scelta. Da Bologna arrivò pure una lettera del rettore che si congratulava per il suo quattordicesimo posto (su centinaia di aspiranti) e le raccomandava l’iscrizione a Ingegneria. Detto fatto, lei scelse Medicina a Milano. «Io sono fatta così: non mi devi dire cosa devo fare. Sono una outsider» L’outsider però non ha avuto problemi a trovare un posto in ospedale, viste le sue conoscenze mediche e le capacità dimostrate fin da giovanissima.
Cosa la attraeva della medicina? «Il “materiale” con cui lavori, i corpi, la scienza, le malattie». Mai pensato di fare ricerca? «No, ho sempre pensato di voler lavorare “sul campo”, all’inizio
Ambra Barbagallo impegnata nelle esercitazioni con il casco per lavori in bassofondale

addirittura pensavo di lavorare per enti come “Medici senza frontiere”. Poi mi sono scontrata con la realtà di dover diventare autonoma in fretta perché i miei non mi hanno mai particolarmente supportata in questa cosa. Fortunatamente non ho mai avuto problema a trovare lavoro. Ogni tot anni rinasco, come la fenice».
Specializzata in Otorinolaringoiatria e Audiologia, ha aperto uno studio a Milano. Ma il suo futuro è sott’acqua
Perché ha scelto questo campo specifico?
«Come per tante altre cose, credo dipenda dalle persone che incontri. Io all’inizio avevo scelto la traumatologia. Naturalmente la famiglia si era opposta, dicendo che tra tutte le chirurgie era la meno adatta a una donna. Poi ho incontrato un professore, un otorinolaringoiatra, che mi ha colpito molto e mi ha invitato a frequentare il suo reparto. Alla fine sono rimasta là».
La vocazione resiste anche ai problemi vissuti in questi ultimi anni, la burocrazia soffocante, il lavoro del medico trasformato in routine?
«La vocazione va rimodellata. Altrimenti ci si imbruttisce, come quelli che passano il loro tempo a lamentarsi. Non puoi pensare di combattere il mondo da solo e di cambiarlo. Ma puoi cambiare la tua figura professionale e il modo in cui vivi, il rapporto che hai con il
mondo, per cercare qualcosa di più affine a te. Quando ho cominciato a lavorare, vent’anni fa, c’era ancora la vecchia mentalità per cui si pensava di entrare in un posto di lavoro e stare lì fino a morirci. Adesso invece bisogna essere dei trasformisti. I miei colleghi più giovani mi hanno insegnato tanto, in questo senso. Loro hanno ben chiara questa idea». Nel senso che hanno accettato la precarietà?
«Più che precari, sono anticonformisti, abituati ai cambiamenti. Noi pensavamo che uscendo dall’università ci aspettassero l’ospedale, la casa, il mutuo, la famiglia... Loro sanno di dover sperimentare e trovare una dimensione più adatta. Io, nei miei secondi quarant’anni, ho deciso di abbracciare questa filosofia». Noi pazienti abbiamo molta nostalgia del vecchio medico che dedicava tanto tempo alle viste e cercava di curare le persone nella loro totalità e complessità.
69 GENNAIO 2023
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA
«Io sono una nostalgica, in realtà. Se si potesse davvero tornare a quella figura di medico, lo farei subito. Il problema è che non sono i medici ad essere cambiati, ma la società. È cambiato il servizio che devi erogare e le sue modalità, e quindi il rapporto tra medico e paziente. Quella è una figura che verosimilmente non tornerà mai più, almeno nella nostra società, visto che in altri paesi c’è ancora. La sanità è diventata un’azienda e i medici si devono adattare: noi siamo le figure attraverso cui l’azienda per cui lavoriamo crea profitto e fatturato».
Però poi, dentro questo sistema, ognuno può trovare il suo stile. Di lei, ad esempio, si parla come di una persona empatica, che ascolta il paziente e rimane
in contatto con lui anche oltre la prestazione in studio (oggi ci sono anche le recensioni online dei pazienti...).
«Il carattere alla fine viene fuori. È anche importante trovare un ambiente più consono a ciò che sei. È il ragionamento che ho voluto fare io dopo vent’anni di ospedale.
Trovare una modalità di lavoro più vicina alla mia natura, che potesse concedermi di tirare fuori la parte migliore di me, dopo anni in cui tiravo fuori la peggiore, lo stress, il nervosismo, per le troppe cose da fare tutte insieme. Sta a noi non diventare dei workaholic, ma puntare a una qualità del lavoro e della vita che si riversi anche nella nostra interiorità. Se alle 7 di mattina siamo già arrabbiati
o abbiamo letto cinque mail piene di problemi, che ci costringono a passare la giornata a risolverli, quello non è il posto per noi. Se invece la mattina andiamo a lavorare col sorriso e la gente che incontriamo è cordiale, abbiamo dei colleghi con cui fare squadra e ci sentiamo parte attiva del sistema, allora riusciamo davvero a dare il meglio di noi. Se così non è bisogna avere la forza di dire basta e cambiare, perché non necessariamente dobbiamo essere noi ad adattarci alle cose, a volte sono le cose che devono adattarsi a noi».
Alla fine ciò che importa al paziente è trovare un medico disponibile e competente. Sta qui il “segreto” di Ambra Barbagallo, sia che si tratti del suo lavoro in ospedale (oggi portato avanti alla Asst Fatebenefratelli di Milano), sia soprattutto quello privato nel suo studio Audiomedica di via Santa Sofia 1 a Milano. «Ho deciso di mantenere un part-time ospedaliero per potermi dedicare a varie attività imprenditoriali in ambito sanitario, lavoro nel mio studio, sono consulente otorino per la Holding Pirelli e per il comando generale della Guardia di Finanza della Lombardia, inoltre sto portando avanti progetti nell’ambito più interessante per me» (ci arriveremo alla fine). C’entra anche il Covid. «Cosa è cambiato? L’emergenza sanitaria ha canalizzato le energie, le attenzioni e le risorse verso la parte più generalista del mio lavoro. La nicchia di cui mi occupavo io, la chirurgia dell’orecchio, purtroppo è andata a morire nell’ospedale in cui lavoravo.

Questo mi ha tolto un po’ l’identità professionale. Io dal Policlinico ero passata in un gruppo ospedaliero privato per occuparmi solo di quello. Sparita quella dimensione del mio lavoro, non era più ciò che volevo fare. Ora lavoro in un’altra struttura con contratto part-time, perché ho bisogno di tanto tempo per portare avanti le nicchie che sono a me particolarmente care e che danno lustro alla mia professione. In questo momento mi sento un’imprenditrice che porta avanti quello che vuole fare, anche grazie a una stabilità economica che non mi costringe a fare le cose solo perché ne ho bisogno».
Ed ecco ad esempio l’attività allo studio Audiomedica, «un bel gruppo, dove esprimo la mia anima otologica, circondata da colleghi che conosco da tanto tempo e lavoravano con me nello storico reparto di Audiologia del Policlinico.
Ci occupiamo di tutto, ma la nostra fama è dovuta alla metodologia di cura del paziente con problemi otologici, anche pazienti complessi, con patologie particolari, fino alla riabilitazione. Ci conosciamo da tanti anni, siamo molto affiatati.
La bellezza e l’ospitalità di quel posto è un po’ lo specchio di come siamo, una piccola famiglia». Qui si portano avanti due obiettivi: da una parte ritrovare la disponibilità e l’ascolto del vecchio medico di famiglia, dall’altra assicurare il meglio della tecnologia contemporanea, per assicurare prestazioni di livello ospedaliero. «Da me vengono persone che hanno problematiche auditive complesse, oppure di equilibrio, patologie vestibolari che necessitano di un’atten-


zione particolare. Ma affrontiamo ogni tipo di patologia, anche le più semplici.
La nostra modalità di lavoro è legata all’utilizzo di nuove tecnologie, oltre che alla cura, l’attenzione, l’ascolto. Organizziamo le visite in modo che il paziente abbia la possibilità di parlare e spiegare il suo problema senza stare a guardare l’orologio. Siamo accoglienti. Cerchiamo di fare la differenza in un mercato sanitario sempre più massificato e impersonale. In più siamo preparati, abbiamo un background di eccellenza, con modalità di lavoro che ci hanno insegnato vent’anni fa».
Qui, ad esempio, si utilizza l’otomicroscopio, che non è così diffuso negli ambulatori privati, visti i suoi costi. «È un microscopio gigante, uno strumento derivato dalla sala operatoria, che serve per ingrandire l’orecchio enormemente, avere un eccellente dettaglio e poter lavorare con entrambe le mani molto delicatamente. Permette
di essere molto precisi sulla parte diagnostica e anche nella cura, ad esempio nei piccoli interventi. Abbiamo tutte le attrezzature per la diagnostica otologica avanzata e ogni anno investiamo in nuove tecnologie. Se il paziente viene con un problema semplice, facciamo solo la classica visita. Se viene con un problema complesso, cerchiamo di erogare ogni prestazione possibile anche in un’unica seduta, per quanto è nelle nostre possibilità, senza mandarlo troppo in giro a impazzire. Accentriamo la parte diagnostica e strumentale, anche per la comodità dei pazienti, che per il 70% sono anziani. Ma ci occupiamo di ogni età, a partire dai neonati».
70 GENNAIO 2023
La vocazione da bambina (contro tutto e tutti), i vent’anni di lavoro al Policlinico, poi l’avventura di Audiomedica e il master in Medicina subacquea e iperbarica
La dottoressa Barbagallo con i colleghi dello studio Audiomedica
In questo campo la prevenzione è molto efficace, basta saperne approfittare. «La visita dall’otorino è semplice, rapida e indolore. Quindi potrebbe essere una classica visita preventiva che tutte le persone fanno con una cadenza regolare. Come diceva un mio professore: noi siamo tra i pochi che possono vedere ciò che la gente ha. Il nostro è un distretto che si vede, a differenza di altre parti del corpo. Noi possiamo visualizzare tutto, soprattutto con le tecnologie endoscopiche che io spingo molto»
anche qui si tratta di esami molto semplici e indolori, quasi un gioco. La raccomandazione di buon senso è: non aspettare. Qualunque cosa tu abbia, dal mal d’orecchi a problemi di sinusite, a un mal di gola curato male, la patologia potrebbe complicarsi anche fino a dieci volte». Il problema, soprattutto in Italia, è proprio questo. Si aspetta troppo, si tergiversa, magari si chiede all’amico o al parente, e intanto il problema si aggrava. «Ricordo un meme efficace visto in un social, una vignetta: dalla multa al vigile, dal problema all’avvocato, dalla bolletta alla Posta, mentre dalla malattie partiva una linea tortuosa che passava attraverso Google, amici e parenti prima di arrivare al dottore.
«Voglio andare a lavorare sul campo, con i marinai, i sommozzatori, i sommergibilisti. In barba a tutti i luoghi comuni. Questa è la chiave per mia libertà di spirito»
L’età critica, in ambito uditivo, comincia verso i 55-60 anni, «a meno che ci siano state problematiche precedenti, esposizioni lavorative, eredità famigliari. Consigliamo lo screening uditivo da quell’età:
La gente prima di andare dal medico fa tanti giri improponibili. Mi capita di vedere pazienti complicati che si sono tenuti un problema per mesi: meglio rivolgersi al medico di fiducia appena insorge il problema
Unire lavoro e passione è il sogno di tutti. Nella foto a fianco, la dottoressa Barbagallo con il suo rebreather



e risolverlo subito. Perché chiedere all’amico, al vicino, a Google o magari al farmacista, che con tutto il rispetto fa un altro mestiere? Io non mi permetterei mai di fare il tagliando alla mia macchina, lo lascio fare al meccanico».
Ma arriviamo al dunque. Il futuro prossimo venturo. La medicina applicata al mondo che sta sotto il livello del mare. «Io sono una subacquea di vecchia data. E da 5-6 anni faccio la consulente per un ente medico assicurativo che si occupa di subacquei a livello internazionale. Ora questa passione si è evoluta. Nella primavera del 2020 stavo facendo dei corsi per poter rilasciare l’idoneità in ambito subacqueo (turistica e lavorativa). L’organizzatore di questi corsi in Italia, un collega molto bravo, direttore del Centro iperbarico di Ravenna, mi ha spinto a continuare in questo ambito. Quindi ho deciso di iscrivermi al master di secondo livello alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in Medicina subacquea e iperbarica. È un titolo sostanzialmente assimilabile alla vecchia specializzazione, equiparato secondo le nuove normative della Comunità Europea e valido a livello internazionale». Come trasformare una passione in un lavoro, con prospettive infinite. Il punto di partenza è sempre quello: la voglia di fare e di imparare. «È stato un bellissimo master, con professori esperti a livello internazionale.
Mi sono buttata a capofitto nello studio, volevo divorare qualsiasi cosa. Studiavamo fisiologia dell’uomo negli ambienti straordinari, studiavamo i protocolli della Marina Militare, anche cose come evacuare un sottomarino in avaria, esercitazioni su come salvare i sommergibilisti, procedure che sembrano quasi cose da film di guerra... Due anni di esperienze straordinariamente interessanti, di contatti di eccellenza, con attività pratiche e di ricerca. La scuola Sant’Anna poi è già pazzesca di per sé. Venerdì scorso ho discusso la tesi (poco prima di Natale, ndr). Un progetto realizzato con un ammiraglio della marina militare che è stato mio relatore: una rimodulazione dei profili decompressivi su immersioni profonde».
Il futuro è già presente. «Ho già cominciato a fare divulgazione in ambito scientifico con la collaborazione delle diverse didattiche subacquee. Abbiamo già un bel calendario per
il 2023, eventi divulgativi, contatti con la comunità sub, la mia comunità, corsi che realizzeremo in giro per l’Italia. È la mia professione 2.0. Voglio fare il medico subacqueo e iperbarico e voglio vedere dove mi porterà questa cosa. Sono pronta anche a lasciare l’ospedale, il “posto fisso”. La mia vita la vedo così, avventurosa, stimolante. Quando riesci a coniugare passione e lavoro non c’è nulla di più appagante». Si tratta di attività anche molto rischiose. «Qui si parla di gente che magari lavora in cantieri a 200-300 metri sott’acqua, sono attività ad altissimo rischio anche di morte. Quindi serve personale molto qualificato, ma anche con una certa attitudine a quell’attività. È la mia forza, quella che tutti mi hanno riconosciuto. Io ero un po’ la pecora nera del gruppo, perché erano quasi tutti anestesisti (quasi sempre le camere iperbariche sono gestite da anestesisti), ma ero anche l’unica ad
avere idea di cosa volesse dire andare tanti metri sotto il livello del mare, perché l’ho sempre fatto in prima persona. Riesco a capire e a visualizzare ciò che i subacquei devono fare ed è come se lo stessi facendo io. Se qualcuno mi parla di un problema che ha avuto, io so esattamente ciò di cui sta parlando. Mentre i miei colleghi andranno a fare i medici iperbarici nelle camere, io voglio andare a lavorare sul campo, con i marinai, i sommozzatori, i sommergibilisti, gli incursori. Lo so già facendo e questa per me è una soddisfazione pazzesca. In barba a tutti i luoghi comuni, i posti fissi, ciò che è adatto agli uomini o alle donne... Credo di aver infranto qualsiasi regola con questa cosa. Ma è la chiave per la mia libertà di spirito, da outsider». È anche la chiave per una medicina moderna ed efficace. Di sicuro è sempre meglio incontrare un medico che ama il suo lavoro e lo fa con passione.
73 GENNAIO 2023 72 GENNAIO 2023
La prosa meravigliosa di Pietro Citati, la sua cultura sterminata, il gusto per l’epigramma, il cammeo elegante, l’inciso sferzante. Ma soprattutto la profondità metafisica del suo pensiero, che tanto spesso si è cimentato con la questione dell’origine (i racconti mitici e religiosi della creazione), il mistero del male, la ricerca della felicità.
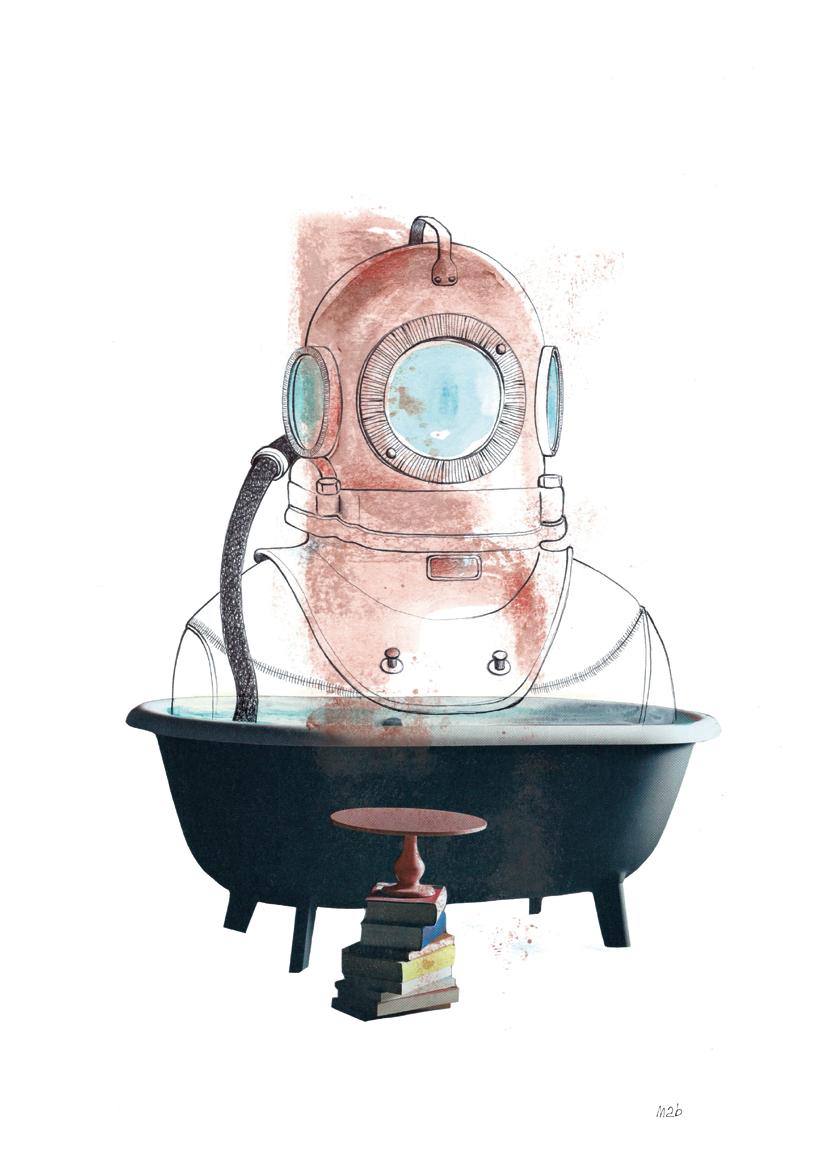
Leggere Citati è sempre un piacere, fonte di conoscenza e occasione di meditazione. Un libro come La ragazza dagli occhi d’oro (con cui Adelphi lo celebra, a pochi mesi dalla sua scomparsa) è una vera festa per i curiosi, i lettori voraci, gli assetati di sapere, i viaggiatori dello spirito. Ci sono biografie e recensioni, scritti dedicati all’arte, alla musica, alla letteratura, riflessioni alte, ma anche ricordi personali. Nessuno è capace, come lui, di raccontare una vita e un personaggio in poche righe. Qui trovate ritratti di Pisanello e Ildegarda di Bingen, El Greco ed Epitteto, Caravaggio e Groucho Marx. Si parte dal “libro dei libri” (la Bibbia) secondo Roberto Calasso (giusto omaggio anche a lui, a proposito di scrittori metafisici), la Teogonia di Esiodo «poeta totale» (più di Omero, Virgilio, Dante), e Il libro dei Re di Ferdowsi, capolavoro persiano «sconfinato, inesorabile, incontenibile». Si prosegue attraverso evocazioni mistiche e cosmologie disperate (il Copernico di Banville), la divina umiltà di Silvano del Monte Athos, il “teologo” Bosch, Michelangelo e il suo “io smisurato”, I viaggi di Gulliver, Balzac (che ispira il titolo della raccolta), i divertimenti degli ultimi libertini. Bellissimo il ricordo dei giorni passati con Cioran («quanto abbiamo riso!»). Da assaporare pagina dopo pagina.

Seneca era d’accordo sia con gli epicurei sia con gli stoici nel seguire la natura, e nel non allontanarsi mai dalla sua legge e dal suo esempio. «La vita felice è quella che si accorda con la natura»: con la natura di ognuno; sebbene possiamo accordarci con lei solo se il nostro spirito è «sano, forte, vigoroso, paziente, resistente a tutte le prove, capace di godere dei doni della fortuna ma senza rendersene schiavo». Se vogliamo obbedire alla natura, non dobbiamo percorrere i mari, o seguire la carriera delle armi. Bisogna seguirla naturalmente: senza sforzo, violenza, ostentazione, disprezzo, ambizione teatrale; solo in pochissime pagine Seneca ci raccomanda lo sforzo. La natura vuole il limite e la misura: ciò che essa chiede è facile, prossimo, alla nostra portata. Se vogliamo accrescere il suo spazio, cadiamo nell’imperfezione. La natura esige pazienza: non la pazienza a cui ci costringe il dolore o lo sforzo, ma quella che ispira la gioia. Non dobbiamo rincorrere la grandezza, ma il giusto mezzo: accettare, tollerare, obbedire agli dèi, acquistando così la libertà suprema. «Qualsiasi avvenimento tu tema, mettiti in capo che avverrà immancabilmente». Ama e sopporta l’inevitabile, accetta la necessità; e così sfuggirai alla necessità. Vivi nel presente, giorno per giorno, senza temere il futuro, senza pensare all’indomani, e uscirai dal tempo. Così Seneca educava e castigava la propria anima vagabonda. «Il tuo primo dovere, eccolo, mio caro Lucilio» diceva: «impara a conoscere non la speranza, ma la gioia»: una serenità di cuore e di viso, che potrebbe passare per insensibilità, ma non ha nulla a che fare con lei. L’anima del saggio è come il cielo sopra di lui: lassù, diceva Montaigne, c’è una serenità inalterabile. Nulla perisce: niente si spegne; tutte le cose ritornano, in quell’eterno ritorno circolare al quale obbedisce l’universo e al quale anche noi dobbiamo obbedire.
(Pietro Citati)
74 MESE 2022

76 MESE 2022
AGENCY www.mondored.it
WEB