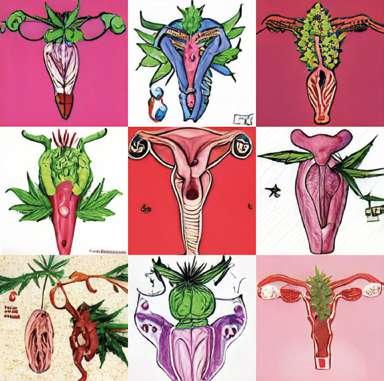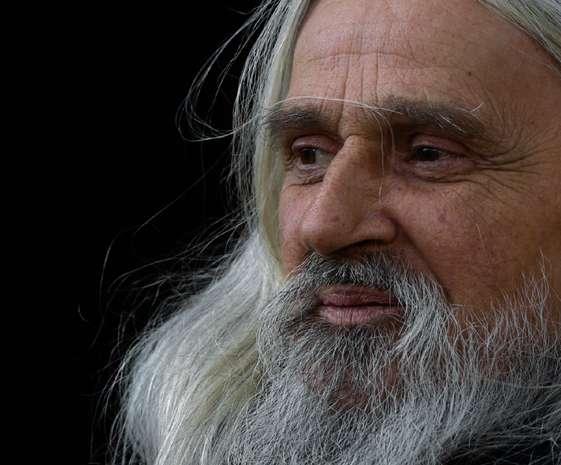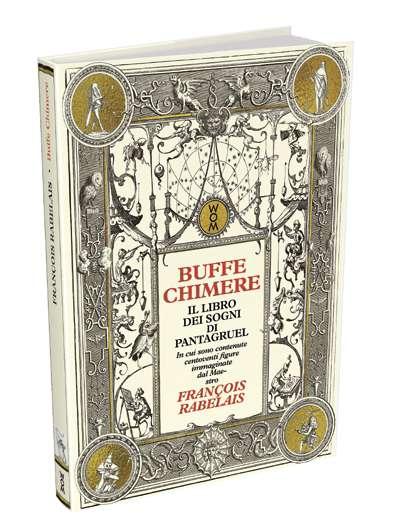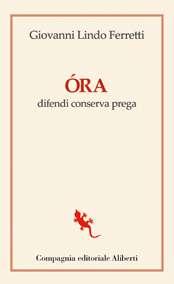Laura Boella Donato Carrisi
Little Pieces of Marmelade Franco Michieli Alessandro Seidita Joshua Wahlen WoM Edizioni
Dove si parla di viaggi avventurosi senza bussola, di filosofia ed empatia, di serial killer che suscitano compassione, di BookCity e libri col buco, di musica rock liberatoria, di eremiti che cercano la verità nel silenzio e nella natura N 3 | NOVEMBRE 2022
Laura Boella Donato Carrisi
Little Pieces of Marmelade Franco Michieli Alessandro Seidita Joshua Wahlen WoM Edizioni
Dove si parla di viaggi avventurosi senza bussola, di filosofia ed empatia, di serial killer che suscitano compassione, di BookCity e libri col buco, di musica rock liberatoria, di eremiti che cercano la verità nel silenzio e nella natura N 3 | NOVEMBRE 2022
REDness è passione, arte, impresa, comunicazione.
È il "rossore" provocato dalle emozioni forti. Ma è soprattutto la “rossità”, la qualità del rosso, quella cosa (qualsiasi essa sia) che ci spinge a fare e creare.
La redness è ciò che ci dà la forza di alzarci la mattina. È l'entusiasmo, la motivazione, il senso, il fuoco sacro, la bellezza, l'idea rivoluzionaria, l'allegria. REDness è la rivista di MondoRED, fatta di incontri e storie, di persone e personaggi. Cultura, economia, arte, moda, scienza, cinema, sport, attualità... Va bene tutto, purché sia fatto con redness.
In copertina: Franco Michieli in Norvegia d’inverno: “La meta appare davanti agli occhi” (Foto archivio Franco Michieli, servizio a pag. 6)
Direttore: Fabrizio Tassi
Progetto grafico: Marta Carraro
Redazione: MondoRed
Redness è un mensile edito da MondoRed, via Cattaneo 16, Gallarate (VA)
Contatti: info@redness.it, direttore@redness.it
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta del direttore o dell’editore
EDITORIALE
4 Prima devi perderti
EVENTI
56 BookCity Milano: la festa della lettura racconta la vita ibrida
INCONTRI
6 Franco Michieli: esplorare l’ignoto senza bussola
18 Little Pieces of Marmelade: rock temerario e liberatorio
26 Laura Boella: una filosofa che è “pensiero vivente”
34 Donato Carrisi: il maestro della paura firma il terzo film
DEE
62 WoM Edizioni: il libro è erotico, eretico e irriverente
LUOGHI
44 Eremiti d’Italia: viaggio interiore nel silenzio e nella natura
52 Alessandro Seidita, Joshua Wahlen: la presenza e l’ascolto
STORIE DI VITA
E D’IMPRESA
70 CMR Borgomanero: il lato umano della tecnologia
74 Dottoressa Shamini: salute e bellezza? Ci vuole natura!
COMMIATO
78 Óra di Giovanni Lindo Ferretti
3NOVEMBRE 2022 4
6
44
56
62 I
70
78
S OMMARIO
Prima devi perderti
“Perdersi per ritrovarsi”. Quante volte lo abbiamo letto o ascoltato? La frase è potenzialmente letale - per l’e go, per le nostre abitudini di pensiero, per la comoda routine che governa le nostre giornate. Se non fosse per il fatto che suona un po’ astratta. Perdersi dove? In che modo? È una questio ne psicologica, spirituale? Anche, sì. È una metafora? Certamente. Ma come fare a vivere l’esperienza che riusciamo a intuire dietro il limite delle parole?
Franco Michieli, esploratore, geografo, narratore (di luoghi e di av venture), che apre la rivista di questo mese, quella frase l’ha tradot ta in realtà, in una pratica che va esercitata con tutti i sensi - anche quelli invisibili, legati all’intuizione.
Guardare, ascoltare, sentire, connettersi all’ambiente circostante, in luoghi sperduti, pianure desertiche, spazi vuoti resi inabitabili da condizioni meteo proibitive, per provare a trovare la via, anzi per “essere trovati”. Perché la questione è tutta qui. Riconoscere i

propri limiti, abbandonare l’ossessione del controllo e l’illusione di bastare a se stessi, per entrare in relazione con l’altro, connettersi a qualcosa di più grande, e scoprire risorse misteriose che non sape vamo di avere.
Il titolo del suo ultimo libro inverte la formula, “Per ritrovarti devi prima perderti”, trasformandola in un’esortazione nata dall’espe rienza di tanti giorni, settimane, mesi, trascorsi in mezzo alla natu ra, senza quegli strumenti tecnologici che trasformano il viaggio e l’avventura in un hobby innocuo, prevedibile, anche un po’ noio so. Al contrario, usare tutti i sensi e accettare l’ignoto significa en trare in rapporto con la natura, vivere una realtà multi-dimensio nale, per poi lasciare che quella relazione generi nuove possibilità, anche vie inattese, che portano a scoperte insperate.
«Ogni volta - scrive Franco Michieli - con emozione profonda, mi sono sentito parte di una relazione invisibile, che deve esserci, visto che funziona, anche se la mente non la sa individuare.
Sono momenti che descriverei come esperienze spirituali: qualcosa che cambia il nostro sguardo sul mondo e ribalta le priorità tipiche della civiltà tecnologica, ossessionata dal controllo degli eventi. La possibilità di perdersi e di vivere il ritrovamento diviene allora un valore così alto da rendere insulso ogni accorgimento che vorrebbe tenerci sempre su strade certificate (...) Tutto nell’esistenza è in reci proca relazione».
Anche gli eremiti hanno abbandonato le “strade certificate”. Han no detto addio ai ritmi frenetici e i rapporti superficiali della vita di città, per ritrovare se stessi. Hanno perso tutto, dal punto di vista del “vivere civile”, quello che fonda la felicità sulla quantità di desideri che riesce a soddisfare. Eppure hanno guadagnato qual cosa di inestimabile. A loro dedichiamo un servizio che nasce dal lavoro di Alessandro Seidita e Joshua Wahlen, due cineasti-autori nomadi, dotati di una rara sensibilità, che anni fa hanno percorso tutta l’Italia per incontrarli.
Ma noi di Redness amiamo anche la varietà e la diversità. Ci sono tanti modi di uscire dalle strade certificate, di rinunciare a una parte di sé per trasformarsi in una cosa nuova, o meglio, per diventare se stessi. Vedi la traiettoria di DD e Frankie, meglio conosciuti come Little Pieces of Marmelade, che dopo gli onori della tv versione ta lent show, si sono riappropriati della propria musica, senza cercare di assomigliare a ciò che gli altri si aspettavano da loro, incidendo un disco che è un’esperienza esplosiva e liberatoria. Non ci si evolve
solo in modo darwiniano, in un processo di adattamento e lotta per la sopravvivenza. A volte bisogna rinchiudersi, isolarsi, per ritrovare il senso e l’autenticità: non per niente il disco lo hanno chiamato Ologenesi (sempre di evoluzione si tratta, ma d’altro genere).
E che dire di Donato Carrisi, scrittore e creatore di bestseller, che si ostina a tradurre le sue storie in cinema, e ci porta su un inedito Lago di Como, tra personaggi senza nome, dentro una trama in cui ci ritroviamo a commuoverci per il “mostro”?
Poi c’è Laura Boella, con la sua storia di libertà, ricerca, pensiero vivente. Che ci ha fatto conoscere le filosofe più importanti del ‘900, idee e intuizioni che in molti casi sono vere e proprie rivela zioni. Proposte rivoluzionarie rispetto al canone novecentesco, alla riflessione corrente. Una luce nell’oscurità. Una via trovata dentro la notte di un pensiero che si stava attorcigliando su se stesso, che forse aveva bisogno di perdersi per ritrovarsi (sì, c’è anche tanta mi stica dentro le loro parole).
E se l’evento del mese per noi è il BookCity di Milano - i libri ci aiutano a vivere, a ritrovarci - alla fine ci appelliamo all’anarchia di WoM Edizioni per non rischiare di scivolare nell’ovvio. Va bene la letteratura “certificata”, ma va anche meglio perdersi dentro testi dinamitardi, che conciliano la sovversione.
Infine, per concludere, cosa c’è di più sovversivo di Giovanni Lindo Ferretti? Il suo urlo è diventato una preghiera, o forse lo è sempre stato. (f.t.)
5NOVEMBRE 20224NOVEMBRE 2022
E DITORIALE

«Da bambino sognavo di conquistare una terra dopo l’altra, per proteggerle dall’uomo...» Franco Michieli Esplorare l’ignoto, senza bussole e mappe, tra montagne e deserti, per “farsi trovare” dalla via. Orientarsi nella natura (e nell’anima) di Fabrizio Tassi (foto archivio Franco Michieli) I NCONTRI Lapponia, 1998
19anni, Maturità appena finita, una vita in tera davanti, tutta da immaginare. E lui cosa fa? Decide di percorrere le Alpi dal Mar Ligure all’Adriatico. 81 giorni di cammino tra bo schi e ghiacciai, cime e alpeggi, con gli amici che si dan no il cambio, tappa dopo tappa, accompagnandolo nella traversata. Voglia d’impresa? No, piuttosto il bisogno di capire, di stare in mezzo alla natura “senza reti”, nella durata, anche nelle difficoltà. Non un esercizio fisico, ma quasi filosofico. Un’iniziazione. Fatta di fatica, movi mento, mani che arrampicano, piedi che affondano nella neve, sole, pioggia, nebbia. Perché è così che si impara. E magari si scopre che il bello della vita non sta nelle cose facili e sicure, che la natura ha tante cose da insegnar ci, che se ci siamo persi (come persone o come società) possiamo anche ritrovarci, una volta che abbiamo re-im parato a convivere con il limite, il mistero, l’imprevisto. Franco Michieli, in un certo senso, (ri)nasce lì. Oggi lo conosciamo come esploratore e autore, come geografo ed esperto di montagna. Oggi è forse il massimo esperto

di orientamento in Italia (e non solo), anche perché ne gli anni ‘90 ha deciso di viaggiare senza bussole, mappe, orologi, e soprattutto senza Gps. È così che nel suo An dare per silenzi (titolo di un libro pubblicato da Sperling & Kupfer nel 2018) ha scoperto La vocazione di perdersi (un piccolo saggio essenziale, proposta da Ediciclo nel 2015). Ha capito che una via alla fine si trova sempre, anche se magari non è quella che avevi programmato in partenza, facendoti scoprire cose nuove.
Di aneddoti ce ne sarebbero a decine. Qualcuno lo rac conteremo, ambientato nelle vastità nordiche, in lunghe giornate trascorse muovendosi nel nulla, e trovando puntualmente “la strada giusta”. La morale è che Per ritrovarti devi prima perderti, come spiega già il titolo dell’ultimo libro (sempre Ediciclo editore), che riassu me la sua filosofia ma è anche un guida tecnica su come orientarsi usando il sole, la luna, le stelle, il vento, le for me della terra, l’ascolto del mondo (!), l’empatia (!!).
L’ho sperimentato tante volte anche in modo molto forte, ed è diventata la cosa più importante da raccontare: accetti di poterti perdere ma nella fiducia che poi accada qualcosa per cui riesci a ritrovarti
E che chiarisce quanto questo esercizio fisico sia anche fondamentale per il nostro stare nel mondo, perché «le motivazioni che stimolano a recuperare il “senso dell’o rientamento”» non riguardano solo l’ambiente naturale, ma anche «l’interiorità e le relazioni presenti nel contesto quotidiano». Saper distinguere e interpretare è il «fon damento della libertà», aiuta a non subire passivamente le «vie predisposte da altri», allena a non cadere vittima di «sentimenti di inadeguatezza» o all’opposto nella «cieca fiducia in qualunque sciocchezza propagata», soprattutto sui social media. Ci vuole meno virtualità e più serendipity, che è quel misterioso meccanismo per cui ti capita di trovare una cosa senza neanche sapere che la stavi cercando.
Incontro Franco Michieli in Val Camonica, nella sua Bienno, uno dei “borghi più belli d’Italia”, dove vive da 28 anni. 3.800 abitati, 445 metri di altezza, un nucleo medievale fatto di stradine che si inerpicano tra case di pie tra, chiese affrescate, cortili pittoreschi e la memoria delle antiche fucine che ne fanno un museo all’aperto.

Un esploratore non si può intervistare al telefono o chiusi tra quattro mura. Ci incontriamo alla periferia del paese e lui appare così come te lo immagini: barba folta, camicia a quadri, scarpe sportive, zaino in spalla, sorriso sulle lab bra. Sempre pronto a partire. Anche se l’emergenza sani taria lo ha costretto a fermarsi per un po’. Un po’ troppo. E infatti non vede l’ora di tornare a viaggiare.
«Sono nato a Milano, sessant’anni fa, ma sono sempre stato legato alla montagna. La mia nonna paterna era delle Dolomiti, di Agordo. Avevano due casette vicino a un al peggio a 1800 metri. E mio papà, quando avevo 3 anni, è riuscito a costruire una specie di bivacco, 4 metri per 4, in cui c’era tutto il necessario. Fin da quando sono nato passa vamo del tempo in questo ambiente, senza elettricità, senza telefono, dove si arrivava solo a piedi. Praticamente è dalla primissima infanzia che ho assorbito lo stare all’aperto».


Franco Michieli
9NOVEMBRE 2022
Due immagini della traversata delle Alpi nel 1981. Nell’altra pagina, Franco Michieli durante l’incontro-intervista
Poi c’è sua moglie, che avrebbe anche lei molto da rac contare. Forse qualcuno ricorda la storia della prima donna guardiaparco in Italia. «Anche Giovanna è nata a Milano, si è laureata in Scienze forestali e subito è di ventata guardiaparco al Gran Paradiso. Era il 1985.
Dopo ha lasciato quel posto per venire in Val Camonica a fare il tecnico forestale. Oggi faremmo molta fatica a tornare in città».
Prendiamo un sentiero in salita, naturalmente, sulla collina che porta alla statua dorata di Cristo Re, 8 me tri (e mezzo) di altezza per 8 metri di apertura braccia, rivolte verso la valle. Gli chiedo della sua “iniziazione” all’avventura, narrata nel libro L’abbraccio selvatico del le Alpi (Ponte alle Grazie, 2020). «L’estate precedente avevamo già passato tutte le vacanze in giro per le Alpi, una cosa classica. Ma io volevo eliminare le interruzio ni tra un’escursione e l’altra, capire cosa sarebbe successo nella durata, restando nell’am biente della montagna». Fare la traversata in modalità alpi nistica, dormendo all’aperto e senza fornello, era una cosa decisamente originale per quei tempi. «Avevamo l’attrezzatu ra da ghiacciaio e da arrampi cata non difficile: corda, picozza, ramponi, imbragatura, cordini e moschettoni. Per fortuna ce li avevamo già fin dalla spiaggia di Ventimiglia, perché ci sono
serviti dal primo giorno: abbiamo dovuto fare delle cala te su una scogliera sopra al torrente Roia».
Il compagno di banco, Andrea, che avrebbe dovuto viaggiare con lui, approfittò dell’occasione improvvisa di andare in America e partecipò solo alla prima settima na. Allora Franco Michieli si organizzò per condividere l’impresa con altri amici. «A volte arrivavo in un paese e, usando una cabina a gettoni o il telefono di un bar, chia mavo l’amico che aveva ipotizzato di essere libero nel pe riodo successivo. Ci si dava un appuntamento in un certo luogo e ci si trovava sempre».
Domanda: fu una sfida, una prova d’abilità, oppure una fuga, un tentativo di rimandare l’entrata nel “mondo adulto” degli obblighi e delle responsabilità? «Era so prattutto una ricerca. C’era un’esigenza fortissima di mettere alla prova il rapporto con la natura e con le mon tagne. Avevo cominciato a intravvedere situazioni in cui la natura dava delle risposte impreviste e volevo approfon dire soprattutto questa relazione. Ovviamente avevamo studiato Leopardi e vari filosofi...»
Inevitabilmente il pensiero va a “Into the Wild”. «Ma io sapevo che sarei tornato. E poi non ho mai pensato di riuscire a sopravvivere in modo selvaggio. Semmai volevo trovare qualcosa che fosse utile per modificare il nostro stile di vita. Alla base c’era un sentimento, una specie di vocazione, che avevo fin da bambino: il riconoscimento del valore della natura. Quando ero piccolo soffrivo nel percepire i soprusi dell’uomo sulla natura e sugli animali. Alle elementari prendevo l’atlante e le carte geografiche e sognavo di conqui stare una terra dopo l’altra per proteggerla dall’uomo».

La passeggiata è breve. Arriviamo in cima, ci godia mo la vista della valle a 360° e poi ci sediamo all’om bra della statua, perché siamo a ottobre ma sembra quasi luglio e il sole picchia. Gli chiedo dei suoi studi e delle sue passioni, che in qualche modo traspaiono dalla bibliografia del libro, visto che accanto ai testi scientifici e ai racconti di viaggio si citano anche Dante Alighie ri, Hermann Hesse, Werner Herzog e Omero. «Subito dopo la traversata delle Alpi avevo cominciato Geologia, ma con molti dubbi, perché ero anche appassionato di let teratura. C’era la natura, però c’era anche la voglia di saperla raccontare. E alla fine mi sono laureato in Geo grafia. Non ho mai visto l’avventura in montagna come una cosa di settore, una disciplina, anche se all’inizio la vivevo un po’ più sportivamente. Al liceo facevo atletica leggera, correvo i 3000 siepi (anzi i 2000, quando ero ra gazzo) ma la passione per la montagna era troppo grande e non potevo più fare agonismo. Dopo ho continuato a cor rere sulle montagne, ma non “per sport”, per il piacere del movimento naturale, la sua bellezza» Il problema, a quel punto, è diventato il rientro. «Anche le esperienze più estreme nella natura, per chi ha questa passione, sono più facili del ritorno. La traversata può es sere molto impegnativa, ma quando si rientra, si rischia di non ritrovarsi più, di non riconoscersi. Non trovi più stimoli, incentivi». Parliamo di un ragazzo che dopo
aver attraversato le Alpi a 19 anni, a 20 anni ha percor so i Pirenei dal Mediterraneo all’Atlantico insieme a due amici e a 21 ha finalmente dato sfogo alla sua attrazione per il grande Nord, attraversando tutta la Scandinavia in bicicletta, senza farsi mancare delle “puntate sulle mon tagne”. E che dire della traversata integrale a piedi della Norvegia durata 150 giorni, a 23 anni?
Verrebbe da pensare che per fare cose del genere bisogna anche avere mezzi economici. «In realtà sono sempre sta ti viaggi estremamente sobri. Si raggiungeva il luogo con l’Interrail, dormivamo sempre in tenda o all’aperto, bivaccando fuori, e compravamo da mangiare in negozietti. Le giornate passate in viaggio costavano meno di quelle passate a casa. E comunque subito dopo le Alpi avevo cominciato a tenere conferenze di montagna, girando il Nord Italia. A un certo punto facevo anche trenta serate all’anno e con quell’attività pagavo i viaggi. Avessi fatto delle spedizioni classiche, l’Himalaya, l’Antartide, non sarebbe stato soste nibile, sarebbero serviti dei capitali diversi e quindi delle sponsorizzazioni. Facendo in quel modo invece sono rimasto indipendente. Per me era importante anche come messag gio: si può fare con poco. E allo stesso tempo, meno mezzi si hanno più autentica è l’esperienza»
Esplorando penisole e monti della Groenlandia. Accanto, la traversata della Lapponia in inverno


Franco Michieli
10NOVEMBRE 2022
Arriviamo al dunque. Il viaggio senza strumenti. Che agli occhi di un profano può anche sem brare una follia, un rischio eccessivo. E che in vece è la sostanza dell’avventura e dell’esplorazione, la sua anima. «Questo modo di viaggiare l’ho ideato molto tempo dopo, negli anni ‘90. Ma i primi pensieri sul fatto di perdersi e ritrovarsi erano nati già negli anni di fine liceo. Ci si muoveva anche col maltempo e cominciavamo ad apprezzare tutti i tipi di condizione meteo. A quel punto si perde la distinzione tra “brutto tempo” e “bel tempo”. Nel “maltempo” ci sono mutamenti di paesaggio straordinari, aperture e chiusure molto più emozionanti, vivi sentimenti fortissimi e ti rendi conto che la bellezza del paesaggio dipende da questo alternarsi di condizioni diverse. Nella traversata delle Alpi, soprattutto nella se conda metà, ci siamo mossi tra piogge, nevicate sulle cime, tormente, nebbia fittissima, si vagava sui ghiacciai senza più tracce, ma abbiamo imparato a dare fiducia alla pos sibilità di trovare la strada giusta, o di “essere trovati”». Ecco il concetto essenziale, che è anche filosofico e poeti co. Il viandante non è colui che cerca la via, ma che si fa trovare dalla via. «L’ho sperimentato tante volte, anche in
modo molto forte, ed è diventata la cosa più importante da raccontare. Penso che sia una cosa presente nella vita di ognuno, oltre che in tante culture e tradizioni». “Perdersi per trovarsi” è anche un concetto tradizionale dell’espe rienza mistica, spirituale. «Certo, è così. Siddharta è un libro che leggiamo tutti da giovani e che lascia sempre il segno... Sì, questa esperienza ha anche una dimensione spirituale, che può esistere a livello solo teorico (e puoi iden tificare con la provvidenza, il karma o quello che vuoi), ma sperimentato concretamente, fisicamente, ha una for za diversa. Non è una cosa che sto pensando, è una cosa successa tante volte e anche in modo clamoroso. È questo che cambia la percezione: accetti di poterti perdere, quindi la necessità di stare nel dubbio, me nella fiducia che poi accada qualcosa per cui riesci a ritrovarti». Ci facciamo raccontare uno di questi episodi tra i tanti possibili. Ambientato in Islanda, dove ci sono luoghi va sti e uniformi. Qui, nel momento in cui sparisce la visi bilità, si vede solo il terreno sotto i piedi.
«Nel 2001, con due amici, abbiamo fatto un giro con gli sci tirando la nostra slitta. Era volutamente un vagabon daggio: abbiamo deciso di entrare da nord, dove c’è un villaggio che si chiama Reykjahlid, sulla Ring Road, con viveri per venti giorni e il carburante per sciogliere la neve, e siamo andati verso l’interno, il cuore dell’isola, nell’Ód áðahraun, il più grande deserto lavico dell’Islanda. Dopo una settimana di maltempo, ci è capitata una tormenta molto lunga, che rendeva impossibile muoversi, e ci ha co stretto a star fermi per tre giorni in tenda mentre fuori si accumulava sempre più neve.

Uscendo, si veniva ricoperti nel giro di due-tre minuti. Ma abbiamo notato che di notte calava il vento e così la quarta notte siamo ripartiti. Eravamo senza mappe, sen za bussole, senza orologio. La nebbia era quasi continua, ma c’erano tratti con dei sassi: se riesci a traguardare da un sasso all’altro, se non altro tieni una direzione.
Erano passati undici giorni in questa situazione e abbia mo cominciato a tornare indietro. A un certo punto la
nebbia si è aperta per un attimo e abbiamo visto un bas sopiano a distanza, che ritenevamo fosse il nordest, verso la strada. Soffiava un vento che sembrava venire da est, e quando il cielo si è richiuso ci siamo fatti guidare proprio dal vento, tenendolo a 45° dietro di noi. È un sistema di orientamento tipico dei popoli artici: loro hanno il parka, con la pelliccia a pelo lungo intorno al cappuccio, che si pie ga secondo la direzione del vento.
Quel giorno era tutto bianco, eravamo nel vuoto più asso luto. Quando, per un attimo, un mattino, abbiamo intra visto il tondo del sole che traspariva nella nebbia, individuando il sud-est, abbiamo capito che il vento aveva girato di circa 180° senza che ce ne fossimo accorti. Stavamo tor nando indietro. Ma alla fine abbiamo ritrovato la via. Di più: ci siamo resi conto che il vento ci aveva condotto a nostra insaputa all’imbocco della via migliore esistente nel deserto per rientrare al villaggio! In queste situazioni bisogna sempre fermarsi, riflettere, dare valore alla pa zienza. Infine, arriva la rivelazione».

Franco Michieli
12NOVEMBRE 2022
Nelle isole Lofoten, in Norvegia, nel 1991. Accanto, ci si orienta col sole nella nebbia in Islanda
La domanda che tutti si fanno è: perché metter si in pericolo?
«Influisce moltissimo la concezione odierna del ri schio. Questo imperversare della politica della sicurezza, che in realtà è un grande pericolo, perché confonde la pru denza, le precauzioni, con il volersi sentire assolutamente sicuri e col fatto che ci debba essere sempre qualcuno re sponsabile di ciò che ci accade. Si pretende che vangano annullate le incognite normali dell’universo. Un obiettivo impossibile. Così non facciamo altro che tirarci indietro da esperienze che ci farebbero crescere, che ci darebbero una visione del mondo più realista, più vera»
Se non hai strumenti, ti metti in relazione con un ambiente in quattro dimensioni, non con una linea. Il Gps ti dà una traccia da seguire e ti avvisa se sei fuori percorso. Mentre se non hai il sentiero segnalato devi guardarti intorno e capire
la società in classi. Un sistema che per una parte cospicua della popolazione non ha rappresentato un vero miglio ramento delle condizioni di vita. Il cacciatore-raccoglito re faceva paradossalmente una vita meno dura rispetto a quella delle successive società stanziali, con dei rischi in più, certamente, ma anche più in armonia con l’ambien te. L’ultima rivoluzione, quella digitale, ci sta staccando dal reale: saremo sempre più incapaci affrontare le diffi coltà che arriveranno dalla natura, perché comunque noi siamo dei corpi».
Q uindi dici che per avere una maggiore sicurezza e longevità individuale abbiamo sacrificato il benes sere collettivo?
«Il tempo di risposta della natura è più lungo delle nostre vite e delle singole civiltà. Siamo a soli 11 mila anni dalle prime rivoluzione agricole. Per la natura è pochissimo. E sono solo 2-300 anni dalla rivoluzione industriale. Per non correre rischi individuali, si accetta un rischio globa le. Ce la prendiamo con i singoli che non ci avrebbero av visato dell’arrivo di un’alluvione e non agiamo sulle cause che determinano l’alluvione. Il nostro cervello, adatto a rapportarsi con i fenomeni intensi della natura, adesso deve confrontarsi con cose impalpabili, invisibili, teoriche, anche troppo estese, nella virtualità. Tutti siamo soggetti a un certo tipo di squilibrio per questo».
Ecco perché quando siamo in mezzo alla natura ci sentiamo rinascere.
«Anche dopo un cammino semplicissimo (quello di San tiago, ad esempio) la gente si sente trasformata, gli sem bra di ritrovare la vita e se stesso. È un ritorno al reale.
Tutti raccontano il trauma del rientro e la voglia di ri partire appena possibile».
Q uali sono i viaggi più memorabili, tra quelli che hai fatto?
Ci spieghi il perché di quella scelta?
Michieli
Ma non abbiamo costruito una civiltà anche per sen tirci più sicuri? In fondo viviamo di più e meglio.
«L’inganno sta nel fatto che noi vediamo gli effetti sul breve periodo rispetto a quelli che sono i tempi della Terra. Non ci accorgiamo di come stiamo modificando l’ambien te e le nostre capacità di affrontare gli imprevisti. Lo stori co Harari chiama le varie rivoluzioni tecnologiche “trap pole”. Fin dalla prima, quella agricola, che ha portato a una crescita molto forte della popolazione da cui non si poteva più tornare indietro e ha generato la divisione del
«Tra le pietre miliari, oltre alla traversata delle Alpi e della Norvegia, c’è quella dell’Islanda fatta a 29 anni, dalla costa Est alle penisole di Nord-Ovest, attraversan do tutto l’interno, tra cui il ghiacciaio Vatnajökull. Sono partito con un zaino da 35 chili e io ne pesavo 60, poi sic come il cibo era razionato, dimagrivo. Quella è stata una cosa quasi psichedelica. Era come camminare in mezzo al mare, da un orizzonte all’altro c’era solo bianco. Una fa tica incredibile, una fame!»



E la prima senza strumenti?
«Nel ‘98. La traversata della Lapponia senza mappe. Ma avevo diciassette anni di esperienze alle spalle».
«Il primo motivo è che ero così abituato a inventare percorsi sulla carta topografica, che ormai guardare la carta era un po’ come immaginarsi già il paesaggio. Di ventava una cosa scontata, ripetitiva. Non c’era più il gusto della scoperta. Il secondo motivo è la nascita del Gps. Conosciuto durante la prima Guerra del Golfo, quando gli americani usavano il sistema satellitare per centrare gli obiettivi, negli anni seguenti l’hanno reso disponibile per usi civili. Ed è stato subito proposto ai grandi dell’avventura. Poi è diventato di uso comune. Io avevo imparato che è l’incertezza della strada a far capitare tutte le cose più interessanti. Se non hai stru menti, ti metti in relazione con un ambiente in quattro dimensioni, non con una linea.
15NOVEMBRE 202214NOVEMBRE 2022
Franco
Sulle Ande peruviane: Cordillera Raura. In basso, in Scozia nel 2016. Nell’altra pagina, la tenda protetta dalle tempeste in Islanda nel 2001
Il Gps ti dà una traccia da seguire e ti avvisa se sei fuo ri percorso. Mentre se non hai il sentiero segnalato devi guardarti intorno e capire, e intanto il tempo scorre, ci sono eventi e fenomeni che si succedono, devi interpretare le varie dimensioni per trovare la tua rotta. Mi sembrava una perdita davvero grossa per l’uomo. Allora ho deciso di tenere in vita questa esperienza. A quei tempi anda va di moda Sector No Limits. Ecco, l’idea era ritrovare il limite».
Gravissima perdita della nostra cultura, quella del limite. Eppure veniamo da lì, dai greci.
«Nelle avventure di Ulisse, spesso succedono disgrazie per ché ci si è dimenticati di sacrificare agli dèi. Ulisse viene respinto e continua le sue peregrinazioni perché i suoi compagni si dimenticano del limite, il rispetto per qualcosa di più grande. Lo abbiamo perso anche nelle cose più banali, i piccoli piaceri. Se non ti dai un limite, non puoi avere ne anche una meta ideale. Si tratta di una ricerca interiore personale che ha anche un valore universale.


La considero una ricerca al pari di quella della filosofia o della scienza, con un altro metodo, utilizzando l’esperien za umana».
Èora di scendere. Gli chiedo se davvero questa prati ca-filosofia è alla portata di tutti. «Come scrivo alla fine del libro, bisogna partire dai dintorni di casa, magari imboccando qualche viottolo mai preso. Si comincia dall’esperienza di ciò che si ha. Il nostro cervello non ha una struttura diversa da quella dei cacciatori-raccoglitori. È la parte culturale che è diversa. Bisogna un po’ immergersi». Mentre torniamo verso il paese, mi guardo intorno e mi rendo conto di quanto sia astratto il nostro modo di rapportarci all’ambiente circostante. Ci sono alberi, stra de, profili di montagne, un percorso prestabilito dentro un orario programmato. Poi, se provi a esercitare uno sguardo più consapevole, focalizzato e allo stesso tempo aperto al rapporto con l’ambiente, ecco che le cose si ani mano: l’albero ha quel colore e quella forma, anche una storia e un nome, noti i dettagli, percepisci la ricchezza di forme, colori, odori e le sensazioni che suscitano, e ti ritrovi dentro un mondo molto più ricco, in cui sei lega to a tutto e il tutto comprende anche te.
Franco Michieli ama parlare di empatia: «È uno stru mento che permette di relazionarsi, di collaborare. Lo specchiarsi in un altro essere. Per ottenere una collabora zione da parte dell’ambiente è importante essere empati ci. Se piove, vediamo di capire cosa ci dice questa pioggia, invece di lamentarci. Vediamo dove ci porta quella salita, cosa mi racconta quel pendio. Anche le tracce degli ani mali sono importanti, magari per scoprire che lì c’è un passaggio utile. Sentire questa sorta di immedesimazio ne reciproca. Orientarsi non come atto individualistico, ma come forma di collaborazione, dentro questo trovare ed essere trovati dalla strada. Tutto quello che abbiamo intorno contribuisce a ciò che siamo e che facciamo». Ci sono tanti punti di vista sul mondo quanti sono gli esseri viventi, non c’è solo il nostro modo di stare in mezzo alle cose. Bisognerebbe ritrovare la connessione che abbia mo perso per strada, nel nostro forsennato individuali smo e nell’atomizzazione della società. Imparare a stare in mezzo alla natura in un certo modo, è una cosa che si può anche imparare. Franco Michieli collabora con la Compagnia dei Cammini, condivide esperienze anche a due passi da casa sua e tiene seminari all’aperto con l’associazione Movimento Lento
Poi c’è l’apertura al mistero, oltre che all’imprevisto. Spesso Franco Michieli è andato in Perù, formando gui de locali e collaborando con l’Operazione Mato Grosso. Bellissimo il ricordo di quella volta nel 2015 in cui sco prirono una sorta di villaggio megalitico, scoperta poi approfondita due anni dopo e che aspetta ancora di es sere portata a termine. «Era una valle chiusa, circonda ta da pareti di roccia, sotto massi giganteschi. Stavamo esplorando il territorio in quota 4700 metri e abbiamo trovato una cresta di granito che impediva l’accesso. Non riuscivamo a trovare un passaggio, ma quando stavamo per abbandonare l’idea, come accade sempre, abbiamo intravisto una specie di canale cengia che attraversava la parete, un passaggio incredibile, in mezzo alle placche. Arrivati sul fondo abbiamo trovato delle dimore antichis sime». Con sorpresa finale: «Mentre tornavo su, a un certo punto decido di scattarmi una foto, e davanti agli occhi, proprio lì dove mi ero fermato “per caso”, vedo un omino dipinto, una pittura preistorica. Era una specie di sciamano, forse un segnavia del passaggio segreto verso il villaggio». Che luogo straordinario è il mondo, quando hai il coraggio, la curiosità e l’umiltà necessari a esplo rarlo!
Franco Michieli
17NOVEMBRE 202216NOVEMBRE 2022
La traversata della Norvegia nel 1985. A fianco, un’ immagine poetica della traversata delle Alpi
LITTLE PIECES OF MARMELADE
pacca tutto!” è una di quelle espressioni che, a forza di ripeterle, non dicono più nulla. Usata un tempo come esortazione rock, è diventata un’interazione pop, di quelle che si usano in tv per fare i giovani, oppure sui social per adeguarsi al repertorio corrente. D’altra parte viviamo in tempi in cui tutto è sempre “unico”, “straor dinario”, “geniale” quando viene comunicato al pubblico, salvo poi rivelarsi un po’ mo scio e tediosamente fedele allo standard (che sia “buono” o “cattivo”, indie o mainstream, apocalittico o integrato).
Fino a quando, un giorno, ascolti il disco che ti fa saltare sulla sedia, grattandoti via un bel po’ d’anni (se ne hai) o aggiungendone di botto (se non hai vissuto certa musica d’antan), e allora ti rimangi tutto. Ologenesi è quel disco. Firmato da un duo che si è fatto notare a X Factor, dove è stato adottato da Manuel Agnelli, e che oggi è ufficialmente ri-nato: i Little Pieces of Marmelade.
Ologenesi, indubbiamente, “spacca tutto”. Per le sonorità sporche e consapevoli, la vio lenza liberatoria, la psichedelia, la maleducazione temeraria (dal punto di vista artistico ed espressivo). Sembra quasi un disco d’esordio (per questo la ri-nascita). Uno di quegli album che vanno al di là della canzone più o meno riuscita, del ritmo azzeccato o il giro di basso trovato, del testo lirico o grezzo, perché non è una sfilata di moda, un’ossessiva ricerca del pezzo che funziona, si sente che la musica arriva così com’è nata, furibonda, onesta, divertita, suonata.
DD, voce e batteria, e Frankie, chitarre, hanno scelto la libertà e la sperimentazione, con tro l’estetica “pettinata”, tra urla e melodie strambe, hip hop e distorsioni, testi espliciti, provocatori, ma a tratti anche poetici, avverando definitivamente quel “Porn rock / Punk the Blues / Psychedelic crossover” che era il loro biglietto da visita, ma anche aprendo qualche porta verso un futuro inedito.

Produce Manuel Agnelli – che li aveva portati anche in tour - di cui immaginiamo il sorri so sornione, di fronte alla scelta di non titolare i brani. Conta l’energia, la cosa che comu nichi, non come la chiami o che significato le dai.
Li abbiamo intervistati prima che iniziasse il mini-tour partito da Treviso, Senigallia e Bo logna, che a novembre (info sul sito lpom.it) approderà anche all’Hiroshima Mon Amour di Torino (3 novembre), oltre che a Firenze (il 4), a Brescia (l’11) e a Modena (il 12).
Avevano appena finito una sessione di prove in studio. Un’intervista, forse, non è la cosa che desideri di più, in quel momento. Ma non si sono sottratti e hanno risposta con la sincerità che li contraddistingue, senza troppe cerimonie.
19NOVEMBRE 2022
“S
La seconda nascita di un duo potente, anarchico, fuori da ogni moda Ologenesi è un album temerario, che suona “sporco” e liberatorio
I NCONTRI
(foto Francesca Tilio)
Com’è la vostra giornata tipica? Siete super-professio nali, con orari fissi?
Frankie: «Ma chi? Magari!»
Anarchici, quindi.
Frankie: «Esatto. Ultimamente, però, abbiamo lavorato sul live. Da due settimane stiamo provando tutti i giorni. Una scaletta al gior no, non di più. Ma è impegnativo. Cerchiamo ogni volta di fare la prova del nove e il giorno dopo mettiamo a posto i pezzi, scriviamo, ci facciamo degli appunti... Ti senti sempre un po’ sotto pressione quan do fai la scaletta».
Il mese scorso abbiamo intervistato Manuel Agnelli, ora tocca a voi. Un bel pas saggio di testimone.
Frankie: «Avoja!»
Il disco è una bomba, ma prima vorremmo fare un po’ di storia. Magari ripartendo da Filottrano, dove siete cresciuti. (Visi perplessi, facce che dicono: “Ancora?”)
Q uando avete cominciato a suonare?
Abbiamo sempre avuto questo chiodo fisso della musica. Non era un hobby. Non era “studio, faccio i compiti e il sabato pomeriggio vado a fare le prove”.
Volevamo farlo, ma non sapevamo come.
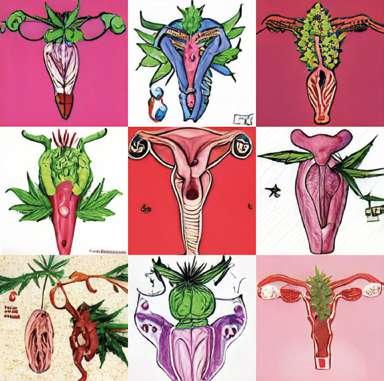
A Filottrano dai 14 ai 19 anni non hai molte certezze sul futuro. Non le abbiamo neache adesso
DD: «Io e Frankie abbiamo iniziato insie me nel 2010».
E da soli?
DD: «Io a 3 anni ho iniziato a canta re. Ho sempre coltivato la musica fin da piccolo».
Frankie: «Io invece mi ero avvicinato alla musica pochi anni prima del 2010. Lui aveva già un gruppetto, mi ha invitato e siamo andati avanti fino al 2016. Poi, sai com’è, nel periodo adolescenziale è come se un giorno durasse una settimana, sei pieno di cose, di stimoli. Io e Dani abbiamo sempre avuto questo chiodo fisso della musica, ma non come hobby. Non era: “studio, faccio i com piti, la mia prospettiva è quella, e il sabato pomeriggio vado a fare le prove”. C’è sempre stato questo sogno. Volevamo farlo, ma non sapevamo come, perché, quando. A Filottrano dai 14 ai 19 anni non è che hai molte certezze sul futuro. Anzi, non ce le abbiamo ne anche adesso. Non ce le ha neanche chi ha una carriera da trent’anni. Stiamo scoprendo piano piano che in questo mondo non ci sono certezze». DD: «È tutto precario».

Frankie: «Essendo nella provincia della provincia della provincia, la strada era quella di partecipare a piccoli contest per band. Erano spazi che ci offrivano...» DD: «...palchi...»
Frankie: «...e quindi ci buttavamo su ‘ste cose. Vincevamo. E ci siamo resi conto che il progetto in due, rispetto a quello in quattro, era più a fuoco, suscitava più interesse, sia nel pubblico di amici che tra gli addetti ai lavori».
Perché era insolito.
Frankie: «Sì, anche se non si scopriva l’acqua calda. L’esperienza che ci ha segnato è stata l’incontro con il produttore Giacomo Fiorenza, che nel 2016 ci ha visto in un concorso e ci ha offerto di fare un disco. Lui era appena uscito dal produrre Bud Spencer, quindi un altro duo. Giacomo ci ha tolto tutta la parte degli assoli di chitarra e tutto ciò che era freak. Ci ha fatto capire che noi eravamo l’altra faccia del power duo, la faccia più psichedelica, viscerale, meno tecnica, meno esercizio di stile»
Vi ha aiutato a diventare ciò che siete.
Frankie: «Sì. È stato un incontro fondamentale per questo. Noi non ci siamo mai acchiap pati con Giacomo, quel modo di registrare in studio, di produrre il disco, ma grazie a lui siamo stra-cresciuti. Dopo aver preso tanti muri in faccia, abbiamo trovato la nostra strada.
OF MARMELADE
21NOVEMBRE 202220NOVEMBRE 2022
Q uando vi siete accorti che eravate bravi?
LITTLE PIECES
Con Manuel Agnelli (foto Henry Ruggeri)
La copertina dell’album
Poi il disco non l’avevamo chiuso, non eravamo usciti con la sua etichetta. Avevamo questo disco in mano e non sapevamo che cazzo farci, perché non lo voleva nessuno. Era iniziata la pandemia e quindi stavamo in mezzo alla strada. Era un disco pieno di sogni, di volontà di fare, e vederlo lì, così, era davvero un colpo al cuore».
E a quel punto arriva X Factor.
Frankie: «Durante la pandemia noi non avevamo neanche una sala prove. Andavamo in un posto a 40 minuti dal paesello nostro, perché ci facevano pagare 2 euro l’ora. Si è soprav vissuto male. Poi arriva la chiamata della scout di X Factor che dice: “Siete interessati? Cer chiamo band inedite che fanno inediti, quest’anno è una cosa nuova, torna Manuel, stiamo cercando una band come la vostra...”. Inizialmente la cosa ci ha un po’ spaventato, ma poi l’abbiamo vista come l’unica possibilità di andare oltre la situazione in cui eravamo».
Q uando Manuel Agnelli, in trasmissione, diceva che gli sarebbe piaciuto lavorare con voi, non scherzava. Avete fatto un tour insieme, ora produce il disco, è scatta to qualcosa di speciale.
Frankie: «Sì!»
Manuel ha realizzato il suo disco solista in casa, durante il Covid. Ha detto che quella situazione gli ha permesso di suonare come quando era un ragazzo, solo per il gusto di farlo, senza pensieri. In un certo senso il vostro disco è nato in una situazione simile.
Frankie: «Ma il nostro non è figlio della spensieratezza. Prima di X Factor eravamo i due più spensierati di questo mondo, invece preparando questo disco stavamo sotto pressione. Fi nito il passaggio in tv e quel periodo, nel nostro team c’era questa cosa del dover fare un disco, e c’era da farlo in italiano. Lo abbiamo cominciato nei primi mesi del 2021, qualcosina si è fatta anche l’estate stando in tour, e poi in autunno lo abbiamo finito».
In effetti non c’è spensieratezza, ma c’è una grande libertà. Non sembra il disco di chi è preoccupato dalle aspettative create.
DD: «Beh, oddio, un po’ sì. È comunque un disco che non c’entra niente con ciò che eravamo. Anche perché erano tanti anni che non componevamo brani, in realtà. One Cup of Happiness
e le canzoni del primo disco sono del 2016-2017, risalgono al discorso con Giacomo Fiorenza, pre-pandemia, con i problemi che abbiamo avuto a pubblicare. Siamo stati tanto tempo coi nostri brani in mano e gente che non ci cagava. Il fatto è quello. Ma la libertà di scrivere c’era, avevamo voglia di farlo. Può sembrare totalmente diverso da ciò che eravamo proprio per questo. Comunque sono passati degli anni».
Sembra un album che precede certe mode degli ultimi anni, che hanno reso la mu sica troppo “comfort”, edulcorata, anche quella indie e rock. È arrabbiato e vero.


Frankie: «Lo scopo era quello».
L’essere “puliti” non vi appartiene.
Frankie: «Volevamo andare oltre quella patina. Soprattutto nel suono, nella produzione. Di solito una band va in studio, lo affitta per settimane e settimane, si fanno mille interventi sul suono perché sia bello, professionale, hi-fi, noi invece volevamo andare dall’altra parte. Non per essere alternativi e basta, ma perché questo è ciò che siamo. Manuel, in trasmissione e dopo, ci ha fatto capire che si possono fare dischi e live così. Uno è libero di fare come cazzo gli pare. Quindi, grazie Manuel!».
Come avete lavorato sul suono?
Frankie: «Ci siamo limitati tanto. Si è detto: facciamo dei provini a casa e registriamo col materiale più povero che abbiamo. Abbiamo usato quattro canali per tutto, quando di solito solo per la batteria si registra su 12 canali. Questa “povertà”, tra virgolette, ci ha spinto ad andare oltre: fare le chitarre non dagli amplificatori ma dal mixer direttamen te, fare le batterie con dei suoni che non hanno senso... Ci siamo spinti oltre anche a livello compositivo. Lo abbiamo fatto con il Rec: fai il beat, ok, ci faccio sto riff, poi vediamo che cazzo inventarci... Abbiamo scritto tutto il disco così e poi si è imparato a suonare. Una cosa che non avevamo mai provato. Lavorare in questo modo è un dito nel didietro, ma dal punto di vista della produzione del disco è stato stra-divertente. Prepararlo live, invece, un po’ meno».
OF MARMELADE
22NOVEMBRE 2022
LITTLE PIECES
(foto Francesca Tilio)
(foto Francesca Tilio)
Anche nei testi c’è quella libertà. Di solito uno, al secondo disco, magari ha la pre occupazione di apparire impegnato, di scrivere il testo intellettuale.
DD: «Non c’è da diventare più intellettuali, ma il contrario»
Nei testi ci sono un bel po’ di “culi”, sesso esplicito, urla contro i social, la musica finta, i cortei borghesi...
DD: «Tutta la vita!»
Anche se poi c’è un “Siamo figli della guerra, senza Stato, senza padri, vomitati sulla Terra per consumare”. Una dichiarazione generazionale: siamo questa roba, questo volete da noi, a ci siamo rotti le palle.
DD: «Avoja! Direi che è già abbastanza esplicito».
Il titolo Ologenesi da dove viene?
DD: «Lo abbiamo trovato a ridosso della consegna del disco, in pratica. Arrivati alla fine abbiamo detto: cosa ci rappresenta questo disco? Cerchiamo qualcosa sulla genesi e arriviamo a ologenesi: la parola mi piaceva e scopriamo che anche il significato è azzeccato. È la teoria evoluzionistica secondo cui la specie muta indipendentemente da fattori esterni. Era perfetto per il nostro concept, il modo in cui è nato il disco, il nostro rinchiuderci in sala prove senza guardare e ascoltare gli altri».
Frankie: «Se ci ispiravamo a quello che avevano intorno in quel momento... Tutto chiuso, mascherine, paura, era un po’ come vivere la morte della musica. Forse è stato anche un po’ egoista, questo chiudersi dentro, ma abbiamo pensato al bene della nostra creatività».
Ologenesi? Ci piaceva la parola e il significato è azzeccato. Era perfetto per il nostro concept, il modo in cui è nato il disco, il nostro rinchiuderci in sala prove senza guardare e ascoltare gli altri
A volte fare la cosa buona per te è una cosa buona anche per gli altri, perché alla fine la musica suona autentica.
Frankie: «Sì, non volevamo lasciarci ab battere».
E la scelta dei non-titoli? Provocatoria, anti-commerciale? È come se il disco fosse un flusso continuo, diviso in vari episodi, che non hanno bisogno di un titolo.
Frankie: «Mi piace questa visione, è interessante, ma noi semplicemente, mentre scrivevamo il disco ragionavamo così: canzone 1 ok, manca la voce, canzone 2, manca il ritornello in ita liano, canzone 12, abbiamo finito... Poi c’era anche quell’essere presi bene del sentirci unici a fare questa cosa; essendo anche il primo lavoro in italiano, sembrava un bell’ingresso».

Cosa vi augurate per il futuro? Andrete avanti alla giornata? Finito il tour cosa farete?
DD: «Si inizia a scrivere un altro disco».
OF MARMELADE
Sempre con questa modalità anarchica?
Frankie: «Quello che abbiamo affrontato con questo disco, come modus operandi, ci è stra-piaciuto, quindi proseguiremo su questa strada. È stato molto divertente, e quando uno si diverte ritorna lì. Poi se arriva il team che dice “devi fare così per fare i milioni”, ci pense remo... (ridono, ndr). Speriamo di suonare tantissimo l’anno prossimo. Poi abbiamo altre cose in serbo. Siamo arrivati da Manuel anche con altre proposte, e lui ci ha detto: il disco comincia qua e finisce qua, concentriamoci su questo. Non c’è mai la soddisfazione di dire “ho finito”, non ci si accontenta mai. Neanche John Lennon dopo Sgt. Pepper’s si era accon tentato. Jimi Hendrix non era mai contento. Nessuno si accontenta».
Certo è che questo disco sembra la cosa più lontana che ci possa essere da X Factor. Lì devi mettere tutto in cornice, anche l’urlo, la sezione ritmica folle. Qui siete usciti completamente dalla cornice.
Frankie: «Sì! La speranza è che chi lo ascolta dica: questi sono stati lì e hanno fatto come cazzo vogliono. Magari possiamo essere di ispirazione per altri, come abbiamo fatto quando ci siamo andati. Tanti hanno detto: se ci so’ andati quelli..!»
25NOVEMBRE 202224NOVEMBRE 2022
LITTLE PIECES
(foto Henry Ruggeri)
Laura Boella
di Fabrizio Tassi
La chiamiamo “intervista peripatetica”. Il peripatos ce l’abbiamo, visto che siamo davanti alla Statale: è Milano, non Atene, ma la Ca’ Gran da ispira grandi cose, la facciata del Filarete è una mera viglia e i chiostri interni ti fanno venir voglia di passeg giare e pensare.

Abbiamo anche la filosofia, visto che Laura Boella è pensiero vivente, oltre ad essere un’autentica istitu zione: in questa università ha insegnato per 40 anni, ha formato un paio di generazioni di aspiranti filosofi (morali) e ha scritto tanti libri importanti, che hanno il merito di aver raggiunto un vasto pubblico, ben al di là dell’alveo degli specialisti (difficile scegliere cosa citare, dagli studi su Lukács, Bloch e Simmel ad Han nah Arendt e Maria Zambrano, da Cuori pensanti a Le imperdonabili, da Sentire l’altro a Neuroetica, fino al libro dedicato a Maria Callas e Ingeborg Bachmann, Con voce umana).
Infine, c’è la voglia di camminare, chiacchierando e ri cordando, soprattutto in una giornata come questa, con un sole estivo capitato per sbaglio a metà ottobre, e la Statale che pullula di vita.
Laura Boella arriva in bicicletta. La sua energia, da sem pre, come sempre, si percepisce anche a distanza. Lo sa bene chi ha frequentato i suoi corsi e poi è tornato anche solo come uditore. Grazie alla sua cattedra di “Storia del
la filosofia morale” abbiamo conosciuto pensatrici fon damentali, lontane anni luce da un’idea di filosofia come oziosa astrazione o esercizio concettuale.
Abbiamo letto e studiato Hannah Arendt, che, parlan do della condizione umana, questa «paradossale plu ralità di esseri unici», ci ricorda che «ci inseriamo nel mondo umano con la parola e con l’agire», ed è questa «seconda nascita», non imposta dalla necessità, a con traddistinguerci, perché «il principio della libertà fu cre ato quando fu creato l’uomo».
Ci siamo persi felicemente nei Chiari del bosco di Maria Zambrano, l’idea del “sentire originario”, la vertigine (mistica) di quel luogo dell’anima in cui bisogna «so spendere la domanda» per «non essere divorati dal nul la e il vuoto», mentre «se non si cerca nulla l’offerta sarà imprevedibile, illimitata»
Abbiamo ritrovato Il problema dell’empatia di Edith Stein e quell’esperienza fondamentale che è “la scoperta dell’esistenza dell’altro”, da cui Laura Boella è partita per un’emozionante avventura del pensiero che recu pera le premesse di ogni teoria filosofica o sociologica, «situate nell’esperienza concreta, emotiva, cognitiva, volitiva di ciascuno».
E ora siamo molto curiosi di conoscere come affronterà l’ultimo approdo della sua riflessione creativa: l’empatia per la natura.
26NOVEMBRE 2022
Quarant’anni di docenza alla Statale, la riscoperta dell’empatia, i libri (fondamentali) su Lukács, Bloch e le filosofe del ‘900. Intervista peripatetica con una donna che è “pensiero vivente”
I NCONTRI (foto Roberto Gandola)
Intanto la natura ce la godiamo nel parco giardino della Guastalla. Giriamo intorno all’università – qua rant’anni di frequentazione quotidiana bastano e avanzano – e finiamo in questo spazio verde, al centro di Milano, con i suoi vecchi alberi spettacolari e il ricordo di tante pause di lavoro: «Venivo spesso, tra le 13 e le 14, e mi sdraiavo sull’erba». Oggi ci accontentiamo di cam minare lungo il sentiero che percorre il parco, mentre le chiedo di partire dall’inizio, da Cuneo, dove è cresciuta, per capire come nasce una filosofa.

Negli anni in cui montava il Sessantotto bigiavo per andare a Palazzo Campana occupato, con Luigi Bobbio, di cui ero ovviamente innamorata, da lontano
«Ero figlia di due professori. Mio padre insegnava al li ceo classico di Cuneo, mia madre ha insegnato filosofia e pedagogia alle magistrali, ma poi ha scelto di diventare preside, quindi burocrate, cosa che continuo a non accetta re». Il rapporto con la madre era piuttosto burrascoso. «Lei, come capita spesso alle madri, inseguiva progetti di eccellenza per la figlia. Quindi mi fece fare un concorso
per il Collegio Europa a Ivrea, un istituto sperimentale dell’Olivetti, che peraltro è durato solo due anni. Era mol to costoso, frequentato dai rampolli dell’alta borghesia milanese. Io sono entrata con una borsa di studio, ho fatto il ginnasio lì. Poi ho frequentato il liceo a Cuneo»
Quelli erano gli anni in cui montava il Sessantotto. «Bi giavo per andare a Palazzo Campana occupato, con Luigi Bobbio, di cui ero ovviamente innamorata, da lontano. L’atmosfera era quella. Viva» La grande svolta, come capita spesso, fu l’allontanamento da casa. «Finita la maturità ho fatto il concorso sia in Normale a Pisa che al Ghisleri di Pavia. Non volevo assolutamente iscrivermi a una facoltà umanistica, a Lettere o Filosofia, perché c’era no i miei genitori in agguato, che mi avrebbero costretta a stare a Torino. Quindi ho scelto Giurisprudenza»
A volte, anzi quasi sempre, le scelte non sono il frutto di ponderate riflessioni o approfondite analisi dei pro e dei contro: vale di più, ad esempio, il desiderio di stare il più possibile lontani da casa. Da qui la scelta di Pisa. Senza alcun pentimento per Giurisprudenza. «Per me il diritto rimane una passione. Sono veramente felice di aver fatto l’esame di Diritto privato, che non era ancora quello “alla Rodotà”, ma era una specie di logica. Il peri colo di quegli anni era quello di perdersi in chiacchiere. Il diritto mi ha dato questo pensiero quadrato. Un ordine, una disciplina mentale». Non le dispiaceva l’idea di di ventare giudice: «Però ero troppo in anticipo sui tempi.
In quel momento i giudici erano ancora “servi del potere”. Poco dopo è nata Magistratura Democratica, è cambiato tutto, ma per me i giochi erano fatti».
Col senno di poi, è facile dire che è stato meglio così. «A Pisa ho conquistato la mia libertà. Ho conosciuto persone nuove. Ma al di là delle libertà giovanili, lì ho impara to cosa vuol dire fare ricerca. In Normale potevi prendere qualsiasi tipo di libro, in qualsiasi lingua, portarlo in ca mera tua e studiarlo. Ogni anno c’erano i cosiddetti “col loqui”, per cui sceglievi un argomento e facevi una specie di tesina che non c’entrava niente con gli esami, un esercizio di scrittura e di ricerca. C’era anche un grande scambio di opinioni, una condivisione con i compagni di corso» Le chiedo se c’è un libro da cui è partito tutto. Ma è più una questione di incontri, occasioni, una sequenza di letture e relazioni: «Non so se ci sia stato qualcosa di pro grammato, so solo che è successo». È successo, ad esempio, che nel 1968 è stata pubblicata la prima traduzione ita liana di Storia e coscienza di classe di Lukács.
«Sono entrata in una certa costellazione di interessi, per cui ho deciso di andare a Budapest a incontrarlo, per far gli un’intervista. Non esiste traccia di quel dialogo. Non ho registrato, non ho preso appunti, mi sono fidata della mia memoria. È stata un’esperienza vissuta e basta». Ci piace immaginare che il vecchio Lukács fosse affascinato da questa studiosa giovane e intelligente (lei non nega, gli aneddoti non mancano). Anche se poi è “il giovane Lukács” che ha inaugurato la sua opera di divulgazione. Grazie anche a chi le aveva consigliato di approfondire il pensiero premarxista del filosofo ungherese. «Io mi ero polarizzata sull’insegnamento di “Filosofia del diritto” e avevo portato all’esame orale i Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, tanto per essere modesta». Intanto però si andava formando una via di ricerca. «Dopo la morte di Lukács, vengono pubblicati su “aut aut” alcuni articoli della “Scuola di Budapest”, che sostanzialmente fu una sua invenzione. In una lettera al Times aveva difeso un gruppo di suoi allievi che in quel momento erano minacciati perché oppositori del regime kadariano. Io leggo quei saggi e scrivo ad Ágnes Heller (filosofa ungherese, massima esponente della Scuola di Budapest, celebre per “la teoria dei biso gni”, ndr). Ci siamo scambiate lunghe lettere e poi lei mi ha invitata a Budapest, dove stava aprendo l’archivio Lukács,
quello che Orbán ha chiuso di recente». Potete immagi nare come dovevano vivere degli intellettuali dissidenti nell’Ungheria di allora (c’erano anche il marito Ferenc Fehér oltre a Gyorgy e Maria Marcus e Mihàly Vajda, al tri esponenti di quel gruppo). «A casa loro ascoltavamo i Lieder di Schubert, perché c’erano microfoni dappertutto. Parlavamo liberamente solo per la strada. Credo di essere stata la prima ad andare a lavorare all’archivio. Mi han no dato la possibilità di allargare l’orizzonte. Ed è nata anche un’amicizia. Un’amicizia difficile, visto che Ágnes Heller era una donna molto dura. Il mio ultimo corso l’ho dedicato proprio a lei. Tra l’altro, dopo la fuga in Australia e l’approdo in America, Heller ha insegnato proprio sulla cattedra di Hannah Arendt». Intrecci misteriosi e affa scinanti. Scoperte intellettuali che diventano esperienze esistenziali straordinarie. D’altra parte nel ‘77, quando approdò a Milano, c’era il gruppo di “aut aut”, «che stava facendo un lavoro sull’opposizione jugoslava, polacca, ceco slovacca. Bisognava tradurre e diffondere quel pensiero».

Laura Boella
29NOVEMBRE 202228NOVEMBRE 2022
Il parco giardino della Guastalla risale al 1555 ed è stato acquisito dal Comune di Milano nel 1938 (foto blog.urbanlife.com). Nella pagina a fronte la Statale in Ca’ Granda: la facciata del Filarete veglia sui festeggiamenti di un neo-laureato
Un’intervista non basta, ci vorrebbe un libro in tero per raccontare le esperienze, gli aneddoti, le linee di ricerca che si sviluppavano e si intrec ciavano allora. Laura Boella ha un’ottima memoria ed è fluviale nel suo racconto. In quegli anni diventò impor tante anche Georg Simmel («lo è tuttora!») e terminato il primo libro sul giovane Lukács scoprì Bloch, «che, caso strano, era stato suo amico» (Ernst Bloch, trame della spe ranza è il titolo del testo che gli dedicò).



Leggevi Adorno, leggevi Benjamin, e ti parlavano di politica, ma intesa in modo esistenziale, come forma di vita. Un giudizio critico nei confronti del mondo
Qui ci sta bene la digressione su un volume in via di pub blicazione: «Ultimamente ho rivisto la traduzione di al cune conversazioni di Bloch. Ce n’è una sorprendente, pro prio con Lukács. Da lui lo dividevano tante cose, anche se erano stati amicissimi. Lukács è rimasto un comunista ed è sempre stato un po’ gesuitico, Bloch invece fu molto critico con il partito comunista tedesco durante il nazismo e, in seguito, con la gestione burocratica e autoritaria dei paesi del “socialismo reale”. L’uno amava il romanzo classico dell’800 e l’altro l’espressionismo e le avanguardie. Erano molto diversi anche nel carattere. Ma in questa conver sazione parlano della loro gioventù simbiotica e dei loro dissidi con grande serenità: si sente che sono stati amici. Una cosa che fra gli intellettuali di oggi non succedereb
be mai. Un’altra conversazione è con Adorno, che a Bloch avrebbe messo le dita negli occhi, metaforicamente lo ha anche fatto. Ma anche qui, due pensatori molto diversi arrivano a dire “guarda anch’io mi sto occupando della morte”... Dopo tante discussioni sono ancora in grado di pensare insieme. Queste sono cose che rimangono». Ri mane l’umanità, anche la nobiltà d’animo, e una certa concezione della filosofia e del lavoro intellettuale, rap presentata da pensatori oggi messi in disparte, «classici che non leggi nemmeno».
Sembrano lontanissimi quei tempi in cui la specia lizzazione non era poi così importante. «Lukács ha scritto dei saggi fondamentali sulla letteratura tedesca. Bloch ha dedicato tante pagine alla musica. Entrava tutto in circolo, l’arte, la letteratura, la filosofia, la poli tica...». E non c’era un separazione netta fra domanda esistenziale e trasformazione della società. «Leggevi Adorno, Minima Moralia, leggevi Benjamin, e ti par lavano di politica, che poteva anche diventare “andia mo tutti in piazza”, ma era soprattutto intesa in modo esistenziale, come forma di vita. Un giudizio critico nei confronti di un mondo, quello dei padri e delle madri, di una certa economia e finanza». Laura Boella non era una militante, ma viveva quel fermento, un modo di essere in cui pensiero e vita si nutrivano a vicenda. «Non c’era soluzione di continuità. La vita cambiava dal punto di vista delle relazioni affettive e personali, ma allo stesso tempo non è che ti guardavi l’ombelico. La Scuola di Budapest viveva in una specie di comune. Erano esperimenti anche esistenziali, che avevano un valore di per sé, di critica della famiglia tradizionale, del ruolo della donna»
Dopo la laurea (nel ‘71) e il perfezionamento a Pisa, dopo vari “contratti”, arrivò il posto di assistente ordinaria che le consentì di trasferirsi a Milano. Era il ‘78. Un anno dopo, al primo tentativo, vinse il concorso per diventare “professore associato”. Ma non avendo padrini e gruppi di appartenenza, poi ci sono voluti più di vent’anni (nel 2001) per diventare “professore ordinario”. C’è voluto un po’ di tempo anche per innamorarsi di Milano. «È stata dura all’inizio. Abituata a Pisa, in cui conoscevo tutti, e il pomeriggio andavo al mare a Tirrenia, mi sono ritrovata in un posto in cui erano tutti anonimi. Fu uno shock. Ma si impara anche dal disagio: questa durezza di Milano mi ha aperto gli occhi». Rievochiamo gli anni dell’insegnamento. Da un elenco di libri studiati a quei tempi (da chi scrive), Laura Boella riesce incredibilmente a risalire al titolo di un corso pro posto nel 1982, in cui si parlava di nascita, vita e mor te, anche con accenni di bioetica, insoliti per la Statale. «Erano gli anni che precedono la famigerata riforma dei crediti. È cambiato tutto da allora. Il sistema dei crediti è stato devastante. I programmi erano il doppio di quelli at tuali, i libri suggeriti erano degli input per sviluppare la riflessione, il pensiero». Ma a prescindere dalle riforme e dalle vicissitudini istituzionali, lei sarà sempre grata del la libertà garantita dalla Statale. «Io sono sempre andata avanti in maniera autonoma e solitaria».
In questo senso, acquista un valore anche simbolico il lavoro fatto da Laura Boella per far conoscere il pensie ro filosofico femminile del ‘900. Nato, come sempre, da occasioni, relazioni, intrecci. «Nel 1987 esce la traduzione italiana de La vita della mente di Hannah Arendt e deci do di dedicarle un corso, probabilmente uno dei primi in Italia dedicato a una pensatrice. E la Libreria delle donne di Milano spedisce “in missione” una ragazza alle mie le zioni. Loro cominciano a coinvolgermi e mi danno anche uno stimolo. Capisco che la scoperta delle pensatrici del ‘900 aveva un significato che non era semplicemente accademico. Negli anni ‘90 il pensiero femminile era molto vivo. Allora ho deciso di fare dei corsi sulle filosofe, seguiti da donne che venivano da varie parti di Italia, un’audience femminile che andava al di là degli studenti universitari. Ho fatto un corso su Maria Zambrano, con un seminario su La tomba di Antigone, e poi su Edith Stein, anche se non era molto amata, per la sua storia di vita... A me piaceva andare con trovento» (le piace ancora!).
L’incontro con Edith Stein sta alla base anche del lavoro
di Laura Boella sull’empatia, che ha generato libri decisi vi e un filone di ricerca che ha portato molti frutti. «Am miravo molto la fenomenologia. Ritenevo che Husserl fos se una figura fondamentale, a differenza di Heidegger che non sopportavo (Hannah Arendt mi ha insegnato a leggerlo). Il libro sull’empatia di Edith Stein (allieva e assistente di Husserl, prima di diventare monaca carme litana, ndr) andava controvento rispetto ad Husserl, che l’empatia non riusciva a digerirla. La cosiddetta allieva, utilizzando il suo metodo, è andata in una direzione del tutto autonoma e inesplorata»

Da quell’esplorazione nasce l’intuizione di Laura Boella, legata anche al fatto che in Statale non si insegnava la bio etica - come se fosse una materia legata esclusivamente al pensiero cattolico - cercando di andare oltre i temi tradizio nali (eutanasia, aborto, fecondazione assistita). «Ho capito che si poteva proporre un taglio diverso, quello del rapporto tra neuroscienze e filosofia morale. Eravamo dopo il 2000. In quel periodo i neuroni specchio erano diventati molto po polari. Ho cominciato a leggere letteratura scientifica ed è scattata la moda dell’empatia, riscoperta dalle neuroscien ze - sicuramente non dai filosofi: i colleghi non la degnava no, perché Heidegger l’aveva buttata nel cestino. L’empatia è diventata la mia chiave per affrontare il rapporto tra la costituzione neurobiologica, la vita psichica, affettiva, ormo nale, e la filosofia, l’etica, la responsabilità. Ed ecco la neuroetica. Il primo libro sull’empatia è del 2006 (Sentire l’altro: conoscere e praticare l’empatia, edito da Raffaello Cortina, ndr). A volte dico basta, ma poi ci ricasco. C’è il Covid, la guerra, l’empatia è un tema fondamentale»
Lo sviluppo ulteriore passa attraverso un’altra esperienza didattica, la richiesta di occuparsi di “etica dell’ambien te”. Il tema? «L’empatia per la natura. Un’altra terra incognita, al di là di ciò che ne hanno detto i poeti».
Laura Boella
31NOVEMBRE 2022
(foto Roberto Gandola)
Fare filosofia significa anche respirare l’aria del tempo. «Hannah Arendt ha sempre detto: si pensa quando qual cosa nella realtà ti colpisce». La filosofia non è un’astra zione, un mondo a parte fatto di idee e concetti. «Anche se questo continua ad essere il modo di fare filosofia in ambito anglo-americano”». Arrivati alle due ore di dialogo (che potrebbero tran quillamente diventare quattro, sei, dieci, forse ce ne ac corgeremmo solo con l’arrivo del buio) le faccio i nomi di quattro pensatrici – al centro del suo Cuori pensanti - chiedendole qual è la loro idea fondamentale, quella che può essere utile al nostro tempo. Ne viene fuori un piccolo vademecum da mandare a memoria.
L’idea centrale di Maria Zambrano è quella della nascita. Un controcanto all’essere per la morte che domina la filosofia del ‘900.
Non nasciamo solo quando veniamo al mondo, ma continuiamo a nascere
rotture, il dis-nascere, le lacerazioni che possono intervenire nella vita umana come nella storia e nella politica, forze reali che provocano angoscia e incertezza. Il suo ca polavoro è La tomba di Antigone, che riscrive il dramma sofocleo e non lo fa finire con Antigone sepolta viva ma che continua a nascere nella tomba, re-incontrando le figu re fondamentali della sua vita, ri-articolando i legami, sciogliendo il groviglio determinato dal nascere in un de terminato contesto. L’immagine emblematica è la scena in cui Antigone, invece di spargere sabbia sul cadavere del fratello, sparge acqua, che scioglie, fluidifica il sangue rappreso, l’emblema della violenza, e rifluisce nella terra diventando potenza rigeneratrice».
Si apre così lo spazio per qualcosa di diverso, perché allora emerge ciò che sta nell’intimo, nel fondo di ogni essere uma no, il desiderio di bene e di felicità, che si incarna nel grido “perché mi fai del male?”».
EDITH STEIN
donne preferisco parlare di una libertà incarnata. Edith Stein, pur convertita, continuava ad andare in sinagoga con sua madre... Una libertà incarnata in esistenze e vite di donne. Non ne farei una legge generale. Ci sono state grande mistiche donne, ma c’è anche San Giovanni della Croce. Ben vengano scoperte di altre esperienze incarnate ignote. Ma che bisogno c’è di generalizzare? Non è vero che tutti gli uomini sono falsi, ipocriti, mentitori, egoisti. Non mi va di dire che sia una prerogativa maschile». Giusto, non generalizziamo mai, nel bene e nel male. E non dia mo per scontata la nostra esperienza, il nostro modo di vivere e vedere le cose.
HANNAH ARENDT

«L’idea di politica (che tratta soprattutto in Vita Acti va) fondata sulla consapevolezza che non l’Uomo con la U maiuscola, ma gli uomini e le donne abitano la Terra. L’idea della pluralità umana: noi abitiamo il mondo in sieme ad altri. La politica non è la politique politicienne di cui vediamo la crisi e il triste spettacolo odierno, ma è la massima espressione della dignità umana, perché rappre senta il modo in cui uomini e donne abbandonano la pro tezione del privato, si liberano dei vincoli della vita quoti diana, delle appartenenze, e si espongono con gesti e parole agli altri, entrano in relazione, scambiando esperienze».
MARIA ZAMBRANO
«La sua filosofia nasce da uno scambio con le tematiche del sacro, del sentire originario, attraverso le viscere, che sono anche il cuore. L’idea centrale è quella della nascita (lo è anche in Hannah Arendt). Un controcanto all’essere per la morte che domina il pensiero heideggeriano e la fi losofia dell’esistenza in generale nel ‘900. L’idea di una dinamica esistenziale sempre in movimento, in metamor fosi. Non nasciamo solo quando veniamo al mondo, ma continuiamo a nascere. Ecco il ruolo fondamentale delle
SIMONE WEIL
«Anche lei è una filosofa con una forte spinta spirituale, che però non le ha impedito di prendere posizione nei confron ti della storia, della politica, dell’economia del suo tempo. Una donna di sublime intelligenza e rigore intellettuale che fa l’operaia in catena di montaggio, fa la contadina, par tecipa alla Guerra di Spagna, va in Germania poco prima della vittoria di Hitler per fare la “reporter”. Importante è l’idea della sventura (malheur), emblema della condizione umana. L’oppressione sociale dell’operaio, l’umiliazione del povero per la strada, l’emarginazione politico-sociale produ cono un effetto non solo sul fisico, ma anche sull’anima delle persone. E generano la “servitù volontaria” rappresentata dalle operaie davanti al portone della Renault, che non entrano finché non scocca l’ora. Lo sfruttamento penetra nella psiche, oltre che nella ferita, nella mano schiacciata dalla pressa perché non tiene il ritmo. Ma Simone Weil vede due piani eterogenei, che per lei erano i bracci della croce: da una parte la necessità, la sventura dell’umiliato, trattato come un verme, come una cosa; dall’altra il bene. Questo nostro stare nel mezzo vuol dire che se l’essere umano riesce a reggere la sventura, se non si autodistrugge.
«Grande maestra di empatia. La sua vicenda filosofica e spirituale è molto complessa, perché in lei c’è stata la conversione (Simone Weil invece si è fermata sulla so glia). Lei cambia stile e riferimenti filosofici dopo la con versione, però mantiene un’idea di filosofia molto con creta, l’andare alla cosa stessa (lezione di Husserl), che le deriva dall’aver imparato la descrizione degli infiniti profili dell’esperienza, irriducibile a un’unica prospet tiva. Compito del filosofo è descrivere e approfondire la ricchezza dell’esperienza, una cosa che lei trasporta come metodo nei suoi scritti spirituali. La sapienza fenome nologica viene reinterpretata in un contesto che è quello delle vie della conoscenza di Dio, il cammino di un’ani ma verso la fede. Lei è l’emblema di un’idea di filosofia parlante, che coinvolge tutti gli aspetti dell’esperienza, della realtà».

Mentre torniamo verso l’università, arriva un’ul tima importante lezione. Le chiedo se pensa trici come Maria Zambrano e Simone Weil non siano anche l’emblema di un diverso modo di inten dere la spiritualità, una ricerca che predilige la mistica, la necessità di abitare il mistero, rifiutando il dogmati smo e il precetto. Una via femminile al sacro. La risposta vale per il tema specifico e per ogni altra occasione in cui ci ostiniamo a parlare di maschile e femminile come se fossero categorie metafisiche astratte: «Certamente in loro c’è una libertà assoluta, che però vale già di per sé, così com’è, visto che si chiamano Hannah e non Edmund, Maria e non Luigi... Sono donne, e dato che sono nate
La parola magica è, ancora una volta, “empatia”. Anche quella con la natura – che, ci dice Laura Boella, in real tà è nata nel ‘700, come riflessione consapevole, prima dell’empatia inter-soggettiva, insieme all’empatia per l’opera d’arte. Il suo prossimo libro probabilmente af fronterà questo tema. Arrivando magari anche ai suoi risvolti paradossali: «Si può empatizzare con un virus?». Conveniamo che è meglio farlo a distanza, mentre pas seggiamo davanti alla Statale, dove transita una folla di giovani esseri umani, insieme a una moltitudine di orga nismi invisibili.
Torniamo verso la storica Libreria Cortina, dove Laura Boella ha lasciato la bici legata con un catenaccio spesso e pesantissimo. Chissà perché, mi viene in mente quell’ha dith musulmano che dice: “Abbi fiducia in Allah, ma lega il tuo cammello”. Che al di là dell’ironia pedestre, nascon de anche un significato spirituale e filosofico: Allah (o chi per lui) non ha mani, tocca a noi fare ciò che è giusto, sen sato, necessario. Il fatalismo è pigrizia e ignoranza. Dopo di che sta nei limiti delle cose umane che qualcosa possa andare storto, bisogna abbandonarsi alla “sua volontà”, e possibilmente fare meglio la prossima volta.
Laura Boella ha insegnato fino al 2019. Le chiediamo se le capita di essere riconosciuta e salutata dai suoi ex-stu denti. «Mi capita di incontrarli nei posti più strani, anche perché la filosofia non dà grandi opportunità di lavoro. Ne ho incontrato uno di recente in un negozio di abbigliamento, anche nell’ufficio del Catasto. Una volta un agente immobiliare mi ha detto che aveva seguito un mio corso». In effetti non ci dispiacerebbe incontrare un immobiliarista con un debole per la filosofia morale. Anzi, la filosofia morale andrebbe inserita nel curricu lum di tutte le professioni (a partire dalla politica). Ma gari con esercitazioni pratiche di empatia.
Laura Boella
33NOVEMBRE 202232NOVEMBRE 2022
Hannah Arendt
Maria Zambrano
DONATO CARRISI
Scrittore e regista, criminologo ed editorialista, autore teatrale, sceneggiatore televi sivo, generatore infallibile di bestseller, commentatore di cronaca nera con “licenza di uccidere”... Chiamatelo come volete, ma la sostanza non cambia: Donato Carrisi è sempre stato e sarà sempre un narratore. È questa la sua forza. Il motivo per cui i lettori amano i suoi thriller psicologici, tradotti in più di trenta lingue, capaci di vendere milioni di copie, tanto da renderlo uno degli scrittori italiani più letti al mondo.
Donato Carrisi è un creatore di storie (avvincenti, paurose, inquietanti) che può permet tersi di passare con nonchalance dalla pagina scritta al grande schermo, scegliendo magari di girare un film sul Lago di Como (location inedita per il cinema italiano), parlando di femminicidio, violenza domestica, revenge porn, e riuscendo anche a farci commuovere per la sorte di un serial killer.

Io sono l’abisso è il suo terzo film da regista. Col primo, La ragazza nella nebbia aveva già incassato un David per il miglior esordio italiano. Così come aveva vinto un Premio Ban carella - e un Prix du Polar in Francia - al primo romanzo, nel 2009, grazie a Il suggeritore I libri ora sono tredici (l’ultimo pubblicato è La casa senza ricordi). Poi ci sono le sceneg giature di film e serie tv per Rai (Casa Famiglia), Mediaset (Squadra antimafia – Palermo oggi) o Sky (Moana), e certi pezzi scritti per il Corriere che, partendo dalla riflessione su fatti di cronaca, sono diventati veri e propri racconti. Cambiano i linguaggi, gli strumenti, i travestimenti, ma l’istinto del narratore non cambia mai, o meglio, si evolve, muta, si prende le sue libertà.
Io sono l’abisso forse è il tuo film più bello, il più personale, anche nello stile. Nei film precedenti i riferimenti al cinema che ami erano molto evidenti, questo invece sembra solamente tuo, ha un’atmosfera molto particolare e un tono emotivo che colpisce. Non ti chiederemo di fare la tua classifica...
Sarebbe come chiedere al padre qual è il figlio preferito. Ogni film ha una sua ragione. Cer tamente c’è stato un cambiamento, rispetto ai primi due. Grazie, comunque, per avermelo detto, perché questi sono giorni di angoscia, si avvicina la data di uscita... (lo dice sorriden do, ma non troppo: l’intervista risale al 19 ottobre, il film è uscito in sala il 27, ndr)
Aiuta molto anche il luogo scelto. Il Lago di Como è praticamente un personag gio. Sembra il vero “mostro” della storia.
Sì, è un personaggio fondamentale. Tra l’altro avvertivo anche una certa responsabilità a girare lì, visto che non ci ha mai girato nessuno.
35NOVEMBRE 2022
Affezionarsi a un serial killer sulle rive del Lago di Como Il maestro della paura firma il suo terzo film
(foto di Loris Zambelli)
I NCONTRI
Il cinema ha “depredato” quei luoghi - ricordo ad esempio una scena di Star Wars – li ha usati per cose di passaggio. Mi sono chiesto: perché non si girano film sul Lago di Como, che pure è una location internazionale? Questa cosa mi ha molto stupito e penso che rispecchi il nostro modo di essere italiani. Se una cosa è troppo bella, tendiamo a non raccontarla, la diamo per scontata. Poi, però, quando lo facciamo siamo sempre efficaci: penso ad esempio a come Sorrentino fa splendere Roma più di quanto sia già splendente. Lo stesso ha fatto con Napoli.
Più che la bellezza del lago, però, si racconta qualcosa di inquietante. Non ci sono immagini-cartolina, non c’è il pittoresco, semmai c’è lo scorcio misterioso, l’acqua che fa paura e restituisce pezzi di corpo.
La nostra esperienza sul lago è stata proprio questa. Volevo che il protagonista del film fosse l’acqua, dalla piscina che apre la storia alla scena finale. Il lago ha un suo ruolo, perché è respingente, soprattutto il Lago di Como. Molti stranieri comprano case che poi rimangono disabitate, perché il lago ti respinge. O ci nasci in quei luoghi, oppure tendono a rifiutarti. Noi abbiamo patito parecchio durante le settimane di riprese. Il lago non ci voleva. Mentre giravamo una scena, quella del ritrovamento del braccio, a un certo punto si è scatenata una tempesta, una tromba d’aria. E io, bastardo, non davo lo stop, perché volevo quella tromba d’aria! Nel film ce n’è un pezzettino. L’unica stoica, in quella scena, è la cacciatrice, gli altri, gli uomini, erano terrorizzati.
L’orrido di Nesso è un luogo formidabile.
Il mare è collerico, può essere spietato, ma sa anche essere tranquillo. Il lago no, perché nell’apparente tranquillità si nasconde di tutto. Il lago poi ha una strana memoria: restituisce le cose solo quando vuole. È il luogo migliore per nascondere un cadavere
Un posto assurdo. Hitchcock voleva girarci un film.
Parlando del romanzo, qualcuno ha scritto, giustamente, che il lago è una specie di inconscio collettivo. È come se lì dentro ci fosse tutto il male rimos so che non vogliamo vedere, ma che a volte riemerge. Nel film questa cosa è ancora più evidente.
Volevo sottolineare la differenza che c’è tra il lago e il mare. Il mare è collerico, può esse re spietato, ma sa anche essere tranquillo. Il lago no, perché nell’apparente tranquillità si nasconde di tutto. Nel Lago di Como ci sono dei vortici che ti risucchiano, e noi ne sappiamo qualcosa, perché abbiamo girato anche in condizioni abbastanza estreme. E poi il lago ha una strana memoria: mentre il mare tende a restituire sempre le cose, il lago lo fa soltanto quando vuole.

Infatti è il luogo migliore per nascondere un cadavere. In particolare il Lago di Como. È strano ciò che l’acqua periodicamente restituisce. Se ascolti le storie di chi abita in quei posti, si parla di continui ritrovamenti sulle rive, anche di cose arrivate da altri luoghi che si se dimentano lì.
Il lago ha un nome e un’identità molto precisa, mentre i personaggi sono senza nome. Hanno tutti una loro particolarità e allo stesso tempo sembrano degli ar chetipi.
D’accordo con gli attori, abbiamo deciso di non comunicare il loro nome (anche se sono reperi bili facilmente online). Volevamo invitare il pubblico ad andare a vedere il film senza sapere chi sono gli attori. Una spersonalizzazione che in realtà serve proprio all’apposto. Visto che nel romanzo i protagonisti non hanno un nome, per togliere completamente l’identità ai perso naggi era necessario toglierla anche agli interpreti. L’attore protagonista, l’uomo che pulisce, è praticamente irriconoscibile, anche per gli addetti ai lavori, così come la cacciatrice.
C’è anche un uso particolare della musica, che arriva solo negli ultimi venti minuti, in un unico pezzo. È stata una sofferenza per l’autore delle mie musiche, che è sempre Vito Lo Re, a cui ho chiesto di fare la non-colonna sonora: mi serviva un solo pezzo che rimanesse nella testa del pubblico. Un pezzo che arriva alla fine, quando hai spogliato completamente il film e hai lasciato solo la freddezza del male, che poi si incontra con il bene. È da questo incontro strano e ambiguo che nasce la storia.
L’aspetto più affascinante del film è il sentimento che siamo costretti a provare per il serial killer, nonostante sia un personaggio sanguinario e respingente. Volevo essere maledetto dal lettore e dallo spettatore, che tende a parteggiare per il serial killer, a commuoversi per lui. Parteggia anche per la cacciatrice, ma se sapesse chi è davvero...

37NOVEMBRE 2022
DONATO CARRISI
Accade anche con la ragazzina, che è viziata, che ha tutto e si va a cacciare in un guaio tre mendo, dovrebbe risultare antipatica, però parteggi per lei, la senti vicina, perché capisci che non è colpa sua. Mi sono arrivati molti messaggi da parte di lettori del romanzo arrabbiati con me. Dicevano: “mi hai costretto a prendere le parti di un personaggio negativo”, “non volevo commuovermi per quello lì, invece ho dovuto piangere per il mostro”. Ho pensato alla mia esperienza, quando stavo per laurearmi.
Laurea in Criminologia.
Ho fatto la testi su Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, che ho incontrato. Mi ricordo quando raccontava i suoi efferati delitti: era un serial killer di bambini, la figura forse più schifosa che possa esistere sulla faccia della Terra. Però quando parlava di se stesso bambino, dell’abbando no della madre, di tutte le violenze subite, gli istituti, i genitori affidatari, eri costretto a empa tizzare con lui. Non lo giustificavo, questo mai, ma ricordo che tornavo a casa ed ero disperato.
Avevo 23 anni e mi chiedevo: ma perché empatizzo con questo mostro? Dovrei disprezzarlo e basta! Questa cosa è diventata parte del mio cammino come narratore. Questa idea del male che non è necessariamente solo nero, così come il bene non è solo bianco. È tutto grigio.

In questo film c’è la paura, ma c’è anche l’amore. Forse non è una storia d’amore, ma quasi.
Lo è! È una storia romantica. Ho voluto innestare il dramma nel thriller. Non volevo che i colpi di scena fossero legati ai meccanismi della detection. Io dico subito chi è il mostro, ti posso anche raccontare il finale, serenamente, perché i colpi di scena sono altri, arrivano dove meno te li aspetti, dal cuore.
Non sono neanche colpi di scena, sono shock emotivi, dici: “wow, perché sto provando questa cosa”? I critici psicanalitici parleranno di liquido amniotico, di ri nascita, di battesimo.
Vorrei solo che si evitassero due aggettivi per questo film e per il mio cinema in generale: che non si dica è un film “necessario”, parola che a me mette i brividi (necessario a chi? Ma quando, perché?); oppure “l’urgenza” della storia, parola che collego a un’altra urgenza...
Ci sono tanti temi, dalla violenza domestica al revenge porn, ma non sono “tema tizzati”, non ci sono tesi, sembrano tutte perversioni del sentimento.
Mi sono concentrato sui temi che forse sono più attuali da un punto di vista criminologico, non certo da un punto di vista sociale. Si parla della violenza sulle donne, ma farlo dal punto di vista di quella madre è molto più forte. Il revenge porn coinvolge tantissimo i ra gazzini, è molto diffuso, perché loro non hanno un’idea di privacy, considerano il cellulare un’appendice vera e propria, tendono a fidarsi del mezzo e dimenticano tutte le cautele. Ma per me la violenza è pornografia, tendo sempre a non rappresentarla e raccontarla, arrivo un minuto prima o un minuto dopo, perché è giusto così.
Mi sono arrivati molti messaggi da parte di lettori del romanzo arrabbiati con me. Dicevano: “non volevo commuovermi per quello lì, invece ho dovuto piangere per il mostro”. In fondo questa è una storia d’amore
Come lavori con il linguaggio cinematografico? Parti dalle immagini che avevi già visto scrivendo il romanzo? Come scegli la “grammatica visiva”?
In realtà io ho cominciato scrivendo per immagini, e dalle sceneggiature poi ho ricavato i ro manzi. Molti lettori mi dicono che leggere i miei libri è come guardare un film. Comunque scelgo un linguaggio diverso ogni volta.

39NOVEMBRE 202238NOVEMBRE 2022
DONATO CARRISI
La ragazza nella nebbia volevo che fosse un film caldo, accogliente. Al direttore della fotogra fia dissi: io non voglio la selva gelida del thriller nordico, voglio quella fiabesca, quella in cui una bambina cappuccetto rosso si avventurerebbe. Ne L’uomo del labirinto avevo fatto una scelta stilistica precisa, dopo aver visto il set di Psycho che è conservato a Los Angeles. Noi lo abbiamo visto in bianco e nero, ma Hitchcock in realtà aveva pensato a un film molto colo rato, solo che non aveva i soldi per il technicolor. Guardando le foto di scena e il set ti rendi conto che era tutto estremamente colorato, e anche in quel caso lo stile doveva rispecchiare un po’ questa idea.
In questo caso, invece, che scelte hai fatto?
Intanto gli obiettivi sono tutti anamorfici, degli anni ‘70, li siamo andati a recuperare con il direttore della fotografia che si arrampicava sugli scaffali del deposito e li tirava fuori, con la loro polvere preziosissima, perché riesce a creare degli effetti particolari, a spostare la luce. Nel film c’è un ricorso continuo a queste imperfezioni. Dovendo esaminare la mente, cosa ho fatto? Siccome il serial killer è un maniaco dell’orga nizzazione e della pulizia, ho messo dei carrelli e delle geometrie precise della macchina da presa: quando c’è lui in scena è tutto molto kubrickiano. La cacciatrice, la matta, l’ho seguita invece con la macchina a spalla. Quando poi la ragazzina piomba nella vita del serial killer, scombinando i suoi piani, lui perde quest’ordine, la cacciatrice capisce che c’è qualcuno da se guire, recupera l’ordine, e io inverto le macchine: metto la mdp a spalla sull’uomo che pulisce e la precisione geometrica sulla cacciatrice.

Un uso molto consapevole del linguag gio cinematografico.
Prima di tutto viene la storia, poi vengo io. Io non ho un ruolo nel film, non voglio trasmettere un messaggio attraverso ciò che faccio e che scrivo. Sono uno storyteller. Non mi definisco né scrittore, né regista. Narro con le immagini e con le parole.
Sono un maniaco di queste cose.
Ci sono anche tanti piani inclinati, che oltre a comunicare inquietudine, danno a volte l’impressione di uno scivola mento lungo la storia.
Quando noi guardiamo, non guardiamo mai una cosa dritta. Il nostro sguardo è sempre inclinato. Dovendo portare lo spettatore dentro la storia, per coinvolgerlo, per fargli sporcare le mani, abbiamo cercato di riprodurre lo sguardo umano.
Come romanziere ti definisci un intrattenitore. Questo film, invece, sembra che abbia un carattere molto “autoriale”, come si diceva una volta.
Il significato che do alla parola intrattenitore è quello americano. Non voglio fare paragoni, per l’amor di Dio, ma Steven Spielberg è un intrattenitore, anche se di lusso, lo è anche quan do fa Schindler’s List La stessa cosa si può dire di Kubrick o Lynch. Ciò che volevo dire è che prima di tutto viene la storia, i personaggi, poi vengo io. Io non ho un ruolo nel film, non voglio trasmettere un messaggio attraverso ciò che faccio e che scrivo.
Io semplicemente racconto una storia. Sono uno storyteller. Poi, in un certo senso, sono un outsider in entrambi i mondi, quello della letteratura e quello del cinema.
Alla faccia dell’outsider, i tuoi libri vengono letti in mezzo mondo.
Intendo dire che sono un ibrido: quando faccio il regista mi dicono “sei uno scrittore”, quan do scrivo un libro mi dicono che sono un regista. Io non utilizzo nessuna di queste due parole, proprio perché mi sento di più un narratore, con le immagini e con le parole.
Domanda filosofica: perché noi essere umani siamo così affascinati dal male? Per ché amiamo libri e film che ne parlano?
Perché è una parte di noi. E perché nei libri e nei film noi tendiamo sempre a trovare una soluzione, che sia positiva o negativa. Nella vita reale questa soluzione non corrisponde né con le sentenze di condanna o assoluzione, né con la scoperta del colpevole. In questo senso è consolatorio andare a cercare una soluzione al male.
Un tentativo di mettere ordine nel mondo e nella vita.
Sì, è questo che offriamo, alla fine. Io non faccio splatter, horror, il racconto è quello del brivi do, della suspense, quel solletico nella pancia che si unisce alla curiosità di sapere le cose. Non c’è nessuna perversione.
41NOVEMBRE 202240NOVEMBRE 2022
DONATO CARRISI
È questo che ti attraeva quando hai scelto di fare Crimino logia all’università? Tu hai spesso raccontato di essere una persona piena di paure.
E lo confermo. In realtà io ci sono capitato per caso in Criminologia. Mi sentivo più portato per il diritto civile. Avevo una compagnia teatrale e scrivevo commedie. Poi è successa una cosa: ho fatto l’esame di Criminologia e il professore, vedendo la mia preparazione, mi ha offerto la possibilità di fare una tesi su Chiatti, visto che era uno dei periti del processo d’appello. Era una tesi pluri-disciplinare. Nessuno in Italia aveva mai parlato di serial killer, tema che non era mai stato affrontato dal punto di vista del diritto. Quell’espressione non era neanche mai entrata nei processi. Tanto che poi mi sono laureato con 109 su 110: non mi hanno riconosciuto l’ultimo punto, perché non hanno riconosciuto piena dignità giuridica alla tesi.
Chiaramente un dispetto.
Questa volta ho voluto bene ai personaggi.
Io di solito non mi affeziono mai a loro, perché poi possono perseguitarti. In questo caso è stato complesso gestire quell’emotività
Ma è una storia! Una cosa che posso raccontare. Facile prendere 110, ma 109... Dopo la laurea ho cominciato ad approfondire il racconto del male, cercando una via nuova per farlo. Posso raccontare il male utilizzando nuovi strumenti, senza voyeurismo, senza indul gere nella violenza, attraversando la psiche umana e il cuore?

Con la cronaca nera che rapporto hai oggi?
De Bortoli sul Corriere si era inventato un ruolo per me: “il narratore con licenza di uccide re”. Nel senso che dovevo raccontare quegli aspetti che con la cronaca non si possono racconta re. Anche ciò che non si vede. Anche le ipotesi. Ricordo quando venne ritrovato il corpo di Yara Gambirasio e io raccontai“il sabato del villaggio”. Nel senso che finalmente veniva ritrovato questo corpo e finalmente tutti avevano la certezza che ci fosse un mostro. Anche il mostro finalmente poteva “liberarsi”: magari sperava che quel corpo venisse trovato. E ho immagi nato il mostro che andava in giro per il paese, entrava in un bar, dove si parlava di questo, sfogliava i giornali, godendo della propria invisibilità... Quel tipo di racconto mi ha aiutato. Poi ho smesso di farlo – o meglio, lo faccio più raramente e controvoglia – perché parlare del crimine in questo momento storico può essere fuorviante, può distrarre, l’essenza oggi è un’altra. Preferisco raccontare gli aspetti inediti dei crimini, quello sì che continua a interessarmi.
Il romanzo è nato quando eravamo chiusi in casa per l’emergenza sanitaria e c’era un mostro invisibile che ci perseguitava.

L’ho scritta nel 2020, ma la storia esisteva già da un paio d’anni. Se non ci fosse stata la pandemia sarebbe stata un’altra storia. Ha influito (positivamente) sul mio modo di raccontare la vicenda. Stavo per mettermi a scrivere quando è cominciato il casino, e a quel punto mi sono bloccato.
Non riuscivo a trovare una confidenza con la storia. È venuto fuori un racconto completamente diverso da quella che avevo in testa all’inizio.
Emozioni più vive, un racconto di cuore e viscere, più che di testa.
Sicuramente questa volta sono più coinvolto emotivamente e ho voluto bene a questi personaggi, cosa che non faccio mai. Io non mi affeziono ai personaggi perché poi possono anche perseguitar ti. Tendo sempre a tenerli a distanza. Quando li evoco so benissimo che esistono delle regole. In questo caso mi sono lasciato andare ed è stato complesso anche gestire quell’emotività.
Non ti chiediamo qual è il tuo abisso perché è giusto che rimanga solo tuo.
Meglio...
Dal libro al cinema, dalla tv ai giornali, hai trovato la tua dimensione? O continuerai a esplorare varie possibilità?
Ho lavorato anche parecchio per la radio. La cosa importante per me è raccontare, lo stru mento è molto relativo. Se mi togliessero questo, sarei finito. Poi ogni storia ha la sua forma. Alcuni miei libri non sono traducibili sullo schermo. Alcuni era giusto che li trasformassi io in cinema, per non tradire il lettore, che è la cosa fondamentale.
Lo spettatore può guardare il film anche senza aver letto il romanzo.
E chi ha letto il romanzo può scoprire cose nuove grazie al film.

43NOVEMBRE 202242NOVEMBRE 2022
DONATO CARRISI
Viaggio interiore nel silenzio della natura

Luoghi fisici e luoghi dello spirito. Boschi, montagne, grotte, eremi nascosti. Ma anche selve interiori, torrenti impe tuosi di emozioni, mari di quiete e pace profonda.
Eremiti d’Italia: donne e uomini che scelgono la solitudine e l’isolamento per trovare se stessi e Dio
Voci dal silenzio (edizioni Tea) è “un viaggio tra gli eremiti d’Italia” pieno di scoperte, emozioni, illu minazioni. Ed è anche un’ottima occasione per andare al di là dei luoghi comuni sull’eremita, visto a volte come un folle in fuga dal mondo e dalla realtà, quando inve ce si tratta di donne e uomini che la realtà la vogliono conoscere in profondità. Persone in cerca di se stesse e della comunione con Dio, e che per questo scelgono di vivere in mezzo alla natura, lontano dalle chiacchiere, la frenesia, la violenza della cosiddetta civiltà. E che in quel loro ritirarsi riscoprono anche il senso della relazione con l’altro, oltre a una vita più autentica.
Alessandro Seidita e Joshua Wah len hanno percorso l’Italia da nord a sud per incontrarli e realizzare nel 2018 un film che ha avuto un incredibile successo in termini di proiezioni, incontri, relazioni e riflessioni che ha suscitato.
Motivo per cui è nato anche un libro - fatto di racconti, interviste (anche non presenti nel documen tario) e 63 fotografie realizzate dagli autori - riedito alla fine del 2021 da Tea.
Un volume preziosissimo, di cui pubblichiamo alcuni estratti, accompagnati da immagini inedite e da una breve intervista ad Ales sandro e Joshua, per capire cosa è rimasto di quella straordinaria avventura.
Come scrive Antonella Lumini

nella prefazione, al di là degli incontri sorprendenti, del gusto di scoprire come e dove vivono questi esploratori dello spirito, e quindi il “viaggio esteriore” in giro per l’Italia, il libro «fa intravedere le tracce di quell’itinerario interiore a cui anelano, spesso inconsapevolmen te, ogni donna e ogni uomo», «una sete di spiritualità che cerca nuove modalità per emergere e ritrovare una giusta collocazione nel cuore di un’umanità inquieta e disillusa»
Gli incontri risalgono al 2016. I due cineasti parlano, all’inizio del libro, del fascino per quella vita estrema, immersa nella natura, e dell’ammi razione nei confronti di chi «per abitare le proprie profondità e dare un senso al proprio vivere, erano disposti a lasciare tutto e intrapren dere un percorso di ricerca intimo e solitario» Una fascinazione che risale al 2010, mentre giravano l’Ita lia con il loro camper per realizzare il primo progetto cinematografico, alla ricerca di «monaci, alchimisti, sufisti e curanderi»
Cosa chiedono allo spettatore e al lettore? Un “animo curioso”: «Il nostro augurio è che ognuno possa trovarvi qualche parola che entri in risonanza con la propria ricerca di senso, in un momento storico che richiede di rimanere lucidi e centra ti, in comunione con gli altri esseri, solidali con i nostri simili e con chi simile non è».
Sapevamo che l’eremo era incastonato tra le vette del monte Aspra, ma non ave vamo idea di quale strada potesse condurci fin lì (...)

La marcia durò diverse ore, ma lo scenario che si aprì all’arrivo ripagò tutti gli sforzi. Immerso in una natura non domata dall’uomo, l’eremo di Pietro sorgeva solitario, silenzioso e ben protetto dai miraggi urbani (...)
Ai suoni della foresta facevano ades so da contrappunto le dolci note di un flauto traverso. Pietro s’accorse subito del nostro arrivo, ripose il flauto e ci venne incontro alla maniera dei vecchi amici, con un amabile sorriso e le braccia aperte in segno d’accoglien za: «Vi aspettavo per fare colazione, vi ho preparato pane e marmellate, ovviamente fatte in casa!».
La giornata prese così un’altra piega e il tempo sembrò quasi dilatarsi (...)
«La mia conversione non ha bussato alla porta: è entrata prepotente mente. Da quel momento la realtà spirituale si è sovrapposta totalmente a tutto ciò che stavo vivendo».
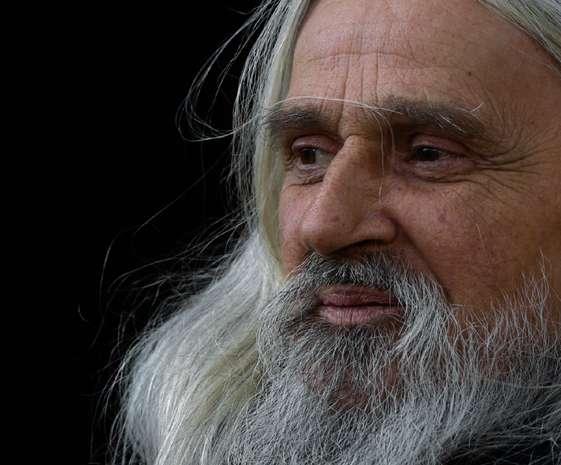
44NOVEMBRE 2022
L UOGHI
Pietro, Eremo di Monte Aspra (Umbria)
Vedemmo spuntare quest’uo mo alto e giovane, dagli occhi tondi e lo sguardo pro fondo (...) Fra Cristiano ci permise d’entrare rapidamente all’interno del suo quotidiano. Le interviste si svilupparono mentre lui proseguiva serenamente le sue attività: l’impa sto del pane, la cura dell’orto, i lavo ri in bottega, le funzioni liturgiche, la pulizia del bosco (...) «Lo spirito dell’eremo francescano si costruisce sull’accoglienza. San Fran cesco diceva ai suoi frati di accogliere con bontà chiunque arrivasse presso di loro, fossero anche ladri o briganti (...)
Il silenzio è una parte importantis sima nella vita di ogni eremita, al di là delle tradizioni religiose. Essere presenti al presente. Un’opportunità per eliminare il di più della vita. Una condizione di povertà che rende la parola essenziale (...) Io non sono fuggito dalla mia co munità. Non sono fuggito dalle mie mansioni. Non sono fuggito dalla città. Se c’è stata una fuga, è stata quella dai luoghi anonimi, dall’im possibilità che dà la vita frenetica di creare relazioni profonde. Quello che si cerca nella vita eremitica è un luogo che sappia veramente restituir


ti a Dio, agli altri, a te stesso (...)
La mia esperienza inizia dallo sporcarsi le mani. La contemplazio ne inizia da lì. Inizia dal prendere in mano una scopa e mettersi a pulire. Tutto è preghiera se l’uomo si trasforma in una preghiera».
Ex pugile ed ex idraulico, Swami Atmananda incarna l’immagine dei santoni indiani, pratica giornalmente la meditazione ed è un esperto di filoso fie orientali. Eppure il suo eremo, si tuato in un suggestivo appezzamento di terra che domina l’intera conca sottostante, è costellato di riferimenti cristiani (...) «Per incarnare ciò che realmente siamo occorre attenzione. L’atten zione la possiamo declinare in varie forme: c’è un’attenzione al visibile, poi un’attenzione ai pensieri e poi c’è un’attenzione che si trasforma in contemplazione, nella contempla zione di ciò che realmente siamo. Io sono Lo disse anche Gesù, io sono... hic et nunc. Se viviamo l’attimo pre sente, ecco che l’immenso comincia a fiorire nell’intimo, si apre qualcosa. Cominciando a vivere questo attimo unico e immenso, inizierà a fiorire nell’intimo questa stupenda corolla, questo fiore della realizzazione (...) È come entrare in una primavera permanente in cui questa identità


suprema è sempre in boccio, la senti sempre sgorgare, ti attraversa ma allo stesso tempo sgorga dal tuo cuore e rinnova tutto quello che c’è attorno. Il divino è sempre attorno a noi, ha sempre parlato, e nel momento in cui si entra in contatto con questa presenza si va oltre (...) Ecco, questa fiaccola adesso la passo a te, Alessandro, e a te, Joshua. Ma neggiatela con cura e custoditela con riguardo: è una fiaccola che deve ri manere accesa, altrimenti si alimen ta la confusione, la frammentazione di ciò che è. Molti si identificano con l’individualità, col senso del mio e dell’io, e questo vela (...)
Il creato merita rispetto. Senza questo rispetto per la natura non c’è cammino spirituale, non c’è realizzazione dell’identità. Nel creato vi sono infatti le tracce visibili per incontrare l’invisibile: un amore incommensurabile di cui non si può dire niente, c’è solo da viverlo».

47NOVEMBRE 2022
Fra Cristiano, Eremo di Santa Maria Maddalena (Toscana)
Swami Atmananda, Eremo dell’Armonia Primigenia (Calabria)
«Oh, degli ospiti, ma che piacere!» furono le prime parole che ci rivolse Daniele. «Sentite che aria fresca e rigenerante. Se non andate di fretta, potremmo badare insieme al bestiame e fare due chiacchiere passeggiando».
Daniele indossava degli stivali da pescatore e una camicia scozzese con sopra un gilet di lana scura ben stirata (...) Si dava un gran da fare nel comunicare agli animali e questi sembravano comprenderlo e seguirne le indicazioni. La nostra prima impressione fu quella di un uomo attivo, sereno, in pace con la vita e incline a prendersi cura di sé e degli altri (...)

Era il 2010 quando tre ladri fecero irruzione nella sacrestia, lo legarono a una sedia, lo incappucciarono e,


puntandogli contro un cacciavite, gli intimarono di svelare dove tenesse soldi e oggetti preziosi. Come avrebbero riportato le cronache, ai momenti di violenza e terrore segui rono dei tentativi di dialogo e alla fine Daniele riuscì a persuaderli parlando loro di fede e compassione: i tre rapinatori gli riconsegnarono il portafoglio e andarono via con dei barattoli di miele che Daniele volle offrirgli in dono.
Incontrammo Rosalba dopo una breve ricerca. Nel paese erano in molti a conoscerla. Alcuni la descrivevano come una mistica, altri come una pazza, altri ancora ci sve larono i particolari del suo passato. Rosalba era stata una donna di mondo: lavorava insieme al marito nell’editoria e gli affari le andava no molto bene. Amava la moda, il lusso, i viaggi. Un evento importante, tuttavia, la strappò a quella vita di agi per portarla all’interno di una grotta umida e buia e affrontare un percorso di privazioni e preghiera (...) La Madonna le era apparsa dinnanzi. Rosalba non era mai stata credente, pensò di essere uscita di senno ma la visione si manifestò nuovamente. La Vergine aveva un messaggio per lei: abbandona
tutto... perché la vita che hai scelto non è quella a cui sei destinata e ti porterebbe a una grande infelicità Rosalba comprese allora che tutta l’abbondanza di cui si era sempre circondata nascondeva una grande tristezza, e decise così di lasciare casa, affetti e averi e di vivere alla maniera degli antichi Padri del deserto. La sua nuova missione era portare la parola di Dio nei cuori della gente (...) Quando le parlammo la prima volta del documentario Rosalba ci rispose titubante: «Devo chiedere al Signore. Se lui vorrà potrete inter vistarmi». Per giorni ci recammo all’interno della grotta, con la pioggia che cadeva senza sosta, e la trovammo a pregare in ginocchio di fronte alla statua della Vergine.

NOVEMBRE 2022 48
Rosalba, Grotta di Oulx (Piemonte)
Padre Daniele, Eremo di San Martino (Toscana)
Pochi passi dopo, superato il cancelletto, di animali ne avremmo conosciuti tanti altri: quel piccolo eden era popolato da oche, tortore, pesci rossi, capre, galline, gatti, un asino, un maiale e una tartaruga centenaria che secondo Gianni era la vera custode del posto (...)

«Impari una lingua che non viene capita da altre persone. Io amo que sto luogo più di me stesso. Conosco tutte le creature che ci vivono. Però come puoi spiegarlo agli altri? A ben poche persone puoi spiegarlo. È un’esperienza mistica che in realtà non puoi descrivere con parole comprensibili.

Appartiene a una lingua più vicina al mondo delle sensazioni e dei sentimenti che a quello della suprema logica intellettuale, di cui d’altronde diffido. La natura stessa è infinita mente generosa e può essere infinita mente crudele (...)
Io non credo alle battaglie, detesto le guerre e la violenza ma, passatemi il termine, il cammino di ricerca è una continua battaglia con se stessi, spesso dolorosa, difficile. È come andare in un luogo dove nessuno è mai stato: ognuno di noi dovrà rifarsi alla propria esperienza. Bisogna entrare in una terra che non ha nessuna mappa, che non è conosciuta e lì trovare il proprio sentiero».

Fummo accolti con grande amore, materno, contagioso, sincero. La tavola era già ap parecchiata (...) La sua storia ci colpì parecchio. Originaria di Siderno, in Calabria, ricercatrice dal 1977 al 1989 alla Sorbona di Parigi in Letteratura comparata, un matri monio civile, una figlia impegnata nel sociale in Amazzonia, l’esperien za della malattia e una vocazione avvertita fin dalla tenera età (...) «Sì, è proprio a partire dalla soli tudine che si comprende meglio la profondità delle relazioni. La solitu dine non è isolamento. Lo è forse nel senso di un distacco fisico, ma non è un ritirarsi dalle vicende umane, con le quali s’instaura invece una co munione più profonda. Quando sia mo immersi nel flusso delle relazioni ordinarie e quotidiane, varie e tal volta contraddittorie, non abbiamo né il modo, né il tempo, né il distacco necessari per sentire quello che passa realmente in una relazione. Ancora meno per mettere qualcuno al centro delle nostre attenzioni (...)
Credo davvero, come dice un padre della chiesa d’Oriente che amo mol tissimo, Massimo il Confessore, che tutte le cose abbiano radici celesti e che tutto il creato, se noi sapessimo guardarlo, vederlo, è come il roveto ardente che Mosè contemplò nel deserto. Ecco, a me sembra proprio così, soprattutto in certi momenti della giornata, come nel passaggio dal crepuscolo all’alba o al tramon to o alla notte fonda... la percezione della vita, che tutto vive non per


una meccanica interna, automa tica e scontata, ma che tutto vive veramente per amore e per l’amore di qualcuno».
Suor Mirella, Eremo dell’Unità (Calabria)
51NOVEMBRE 2022
Gianni Menichetti, Eremo di Positano (Campania)
Quel vostro viaggio con tinua a portare frutti dopo anni. Vi aspetta vate un interesse del genere per un tema così apparentemente lontano dalla sensibilità contem poranea?
Quando sei anni fa abbiamo comin ciato questo viaggio, eravamo mossi da una personale insoddisfazione rispetto a qualcosa che allora non comprendevamo chiaramente, ma che sentivamo essere il riflesso di un malessere che andava al di là della nostra storia personale.

Ci sembrava urgente provare a cercare degli approcci differenti all’esistenza che potessero restituire un senso nuovo del vivere e l’eremita ci appariva l’esempio perfetto di que sto equilibrio che stavamo cercando, costruito tra vita attiva e contempla tiva, tra teoria e pratica.
In fondo, la prima immagine che arriva dalla vita di queste persone, ancor prima dell’esperienza della preghiera e del silenzio, è la concre tezza del loro quotidiano: la relazio ne con la terra, con l’acqua, col fuoco, la costruzione di un dialogo perduto col mondo animale e vegetale.
Erano tutti aspetti che sentivamo mancare all’interno della nostra vita e di cui nutrivamo una profon da nostalgia.
Quando è uscito il documentario, e successivamente il libro, pur non es sendo preparati a tutta l’esposizione che ha generato, è stata per noi una grande emozione avere la conferma che quel sentire era il richiamo di un bisogno comune, che non avevamo fatto altro che dare voce a quel desi derio di ritorno all’essenzialità che continua a vivere silenziosamente tra il fare scomposto e contradditto rio della società contemporanea.
Siete rimasti in contatto con alcuni di loro? Li avete incontra ti di nuovo?
Con la maggior parte di loro abbiamo costruito un dialogo che si mantiene vivo e acceso ancora oggi, fatto di condivisione d’esperienze, di amicizia, di trasformazioni emotive che si contagiano reciprocamente.
Con altri invece mantenere il contatto è stato più complesso, se non addirittura impossibile. Non tutti hanno un cellulare, un’email, o un indirizzo fisico di residenza.
Ogni eremita, in fondo, sceglie le modalità che caratterizza meglio la sua idea di silenzio e solitudine.
Per alcuni, l’incontro continuo con il pellegrino, con l’ospite, è una risorsa imprescindibile per il silenzio e la solitudine: ci si rende in qualche modo rintracciabili, si adibisce una stanza all’interno dell’eremo dedicata all’accoglienza, si organiz zano momenti d’incontro, preghiera o raccoglimento collettivo.

Per altri invece preservare il silenzio dalle voci del mondo diventa un ele mento fondamentale per viverlo in
autenticità, e allora tutti i contatti vanno soppesati e spesso ci si limita alle comunicazioni più urgenti.
Dove posizionare questa “giusta misura” tra silenzio e conviviali tà non sta a noi dirlo, è qualcosa di assolutamente personale che si sviluppa a partire dalla storia e dalle attitudini di ognuno di loro. Tuttavia, ogni ponte tra eremo e il mondo, può restituire una misura di questa collocazione.
C’è qualcuno di loro che ha voluto vedere il vostro film o leggere il libro? Avete aneddoti in proposito? Anche sulle esperienze che avete fatto in tournée in giro per l’Italia, presentando il vostro lavoro.

Terminato il lavoro di montaggio, era forte in noi il desiderio di condi videre la visione del documentario. Eppure, solo a partire da quell’istan te, realizzavamo che nessuno degli eremiti incontrati aveva richiesto di vedere il documentario.
Era forse per mancanza d’interesse? Per pudore? Per l’assenza di un coinvolgimento? Ci volle del tempo prima che riuscissimo a trovare una spiegazione.
Ogni intervista raccolta durante il viaggio era stata il frutto di un atto condiviso, di un grande gesto di fiducia. E dietro quella fiducia, accordataci pienamente, potevamo in fondo scorgere il riflesso di qual cosa di più grande, di una piena apertura alla vita.
53NOVEMBRE 2022
«Gli eremiti sono maestri di realtà: ci insegnano la presenza e l’ascolto»
ALESSANDRO SEIDITA E JOSHUA WAHLEN RICORDANO QUELL’ESPERIENZA
MEMORABILE, CHE HA ISPIRATO CENTINAIA DI INCONTRI E DIBATTITI
L UOGHI
D’altronde, quando l’adesione al mistero dell’esistenza è sincera e pro fonda, il bisogno di preoccuparsi se la fiducia è stata bene o mal riposta eva pora, non v’è più brama di conferme.
Questa è la risposta che azzarderemmo oggi quando quasi tutti gli eremiti, se non tutti, hanno avuto modo di vedere il documentario, restituendoci sempre parole di grande affetto.


Quello però che non avremmo mai immaginato è che lo stesso affetto sarebbe arrivato anche da migliaia di altre persone.
Non è semplice descrivere a parole la magia che si è creata all’indomani delle pubblicazioni, con centinaia d’incontri e dibattiti organizzati
spontaneamente e attraverso il passaparola in tutta Italia. Intuiamo però che questa attenzione, questo grande movimento, abbia poco a che fare con i nostri meriti artistici.
Crediamo, invece, che le diverse testi monianze raccolte siano state capaci di intercettare quel desiderio, presente in ognuno di noi, di voler restituire dignità e valore alla vita.

Le parole degli eremiti danno voce e forma proprio a questo nostro bisogno.
Cosa vi è rimasto di quell’espe rienza? C’è un messaggio per noi, oggi, qualcosa che magari avete messo a fuoco solo succes sivamente, ripensandoci?
Probabilmente un certo tipo di relazione con la vita, o meglio, con il quotidiano. Una maniera per provare ad abitare poeticamente il mondo, per non smettere mai di meravigliarsi per tutto quello che accade sotto il nostro sguardo, all’interno delle relazioni più prossime. Tutte queste persone sono, in fondo, dei maestri della realtà: ci insegnano a vivere in presenza e ascolto, a non perdere mai la no stra visione autentica, irripetibile, nei confronti delle cose, invitandoci così ad abbandonare stereotipi e modelli estranei alla nostra reale natura.
Le loro suggestioni non ci portano verso realtà soffuse, astratte, ma nella concretezza del mondo, delle cose, nella profondità del gesto o dello sguardo scambiato.
Il Dio di cui parlano è un Dio che si può trovare soltanto nella vita dunque, impastato di vicende umane, delle gioie e delle fatiche di tutti i giorni. Ed è questo l’insegna mento più grande che ci arriva: non perdere mai l’attenzione per ogni istante, perché è solo in quel presente che l’esperienza del sacro può venire a farci visita.
Avete immaginato anche degli sviluppi per quella ricerca? Su cosa state lavorando in questo momento?
Con Voci dal Silenzio abbiamo provato ad intercettare quella linea sapienziale che ha sempre viag giato tra epoche e tradizioni, una “philosophia perennis” che si lascia intravedere nelle interiorità dell’a nimo umano, nell’ascolto sincero dei moti profondi che caratterizzano la storia di ognuno.
Ci siamo dunque chiesti: chi, oltre
l’eremita, può offrire una chiara testimonianza di questa voce inte riore? Ed è così che abbiamo pensato alle donne, al pensiero femminile. Un mondo troppo spesso silenziato nel corso della storia e trascurato dalla narrazione globale, in un tem po che continua a rivelarsi dominato dal predominio maschile, votato alla prepotenza e al potere.
La nascita e la morte, le scelte personali, la ricerca dell’ispirazione, la relazione con la natura e con il
divino, su questi e molti altri temi vorremmo confrontarci con le donne di oggi attraverso un documenta rio che sappia chiamarle in causa senza distinzione di status sociale e culturale, per avventurarci nell’enig ma e nello stupore della loro nascita al mondo, ma soprattutto del loro respiro nel presente. Un modo, anche questo, per leggere in profondità la realtà attuale e interrogarci sulle prospettive future dell’evoluzione umana.
54NOVEMBRE 2022
«L’insegnamento più grande che ci arriva è: non perdere mai l’attenzione per ogni istante, è solo in quel presente che l’esperienza del sacro può farci visita»
Indagare l’animo umano. Si partirà da qui, mercoledì 16 no vembre alle 20.30 al Teatro Dal Verme. Con il misterioso scrittore norvegese Karl Ove Knausgård, che tutti conoscono ma pochi hanno incontrato di persona, alla prima apparizione pubblica in Italia, intervistato da Emanuele Trevi (con un monologo finale di Melania Mazzucco). Perché quel suo modo di mescolare romanzo, saggio e autobiografia è una forma letteraria ibrida che assomiglia molto al no stro tempo mutante, confusamente (creativamente) alla ricerca di una via, un nuovo modo di abitare il mondo.
La vita ibrida, infatti, è il tema scelto per l’undicesima edizione di BookCity Milano. E l’incontro di chiusura, domenica 20 alle 20 al Museo nazionale della scienza Le onardo da Vinci, affronterà la que stione sottolineando Il valore della scienza, con Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria Aeronautica, che ci aiuterà a guardare le cose dal punto di vista dello spazio, l’immunologo Alberto Mantovani, che parlerà di ricerca medica, e Giorgio Metta, esperto di intelligenza artificiale,


ovvero il futuro prossimo venturo, praticamente già presente.
Tra questi due appuntamenti, ci saranno 3000 autori e autrici, 1350 eventi in 290 luoghi diversi, il coinvolgimento di 193 editori e 860 classi scolastiche, la partecipazione di 47 librerie, 34 biblioteche e 12 università e accademie.
Numeri da capogiro, per questo vero e proprio paradiso dei lettori (non per niente si cita Virginia Wo olf: «Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine»). Anche perché “La festa del libro e della lettura”, in scena dal 16
al 20 novembre, è “diffusa, gratuita, partecipata”. Basta solo uscire di casa – ne abbiamo sempre più biso gno – e scegliere chi ascoltare e cosa condividere, sfogliando il chilome trico programma, che trovate nel sito www.bookcitymilano.it. Partendo dalla riflessione che sta alla base dell’edizione 2022: «Il mondo di oggi è ibrido. Ibrido il lavoro, ibri da la vita, sempre più scissa tra onli ne e offline, ibride la comunicazione e la narrazione, ibridi sono l’identità e i generi, ibrida è l’esperienza delle nuove generazioni e, dall’alba dei tempi, ibride sono le culture.
In un mondo alla ricerca di sempli ficazioni rassicuranti, la parola ibri do può spaventare; eppure, ibrido è da sempre il terreno più fertile per il germogliare della cultura e delle arti: ibrido è un invito alla conta minazione feconda delle discipline, all’attraversamento degli steccati della conoscenza, un et et che si sostituisce all’aut aut». Viene in mente ciò che scriveva Paul Feyerabend trent’anni fa: «Il mondo in cui abitiamo è abbondan te al di là della nostra più audace immaginazione. Vi sono alberi,
sogni, tramonti; temporali, ombre, fiumi; guerre, punture di zanzara, relazioni amorose; ci vivono persone, Dei, intere galassie» (dal libro po stumo Conquista dell’abbondanza). Chi vuole togliere, negare, sempli ficare la “ricchezza dell’Essere” e le sue innumerevoli trasformazioni, attraverso l’astrazione o la negazione della realtà, non fa un buon servizio all’umanità.
La manifestazione è organiz zata dal Comune di Milano e dall’Associazione BookCity Milano, costituita da fondazioni importanti (Corriere della Sera, Giangiacomo Feltrinelli, Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori) e dall’AIE. E il lungo elenco di soste nitori istituzionali, sponsor privati e media partner (tra cui Rai Radio3 e Corsera) fanno capire quanto
sia imponente il dispiegamento di mezzi (economici, culturali, crea tivi) per realizzare la festa del libro. Che tra l’altro continuerà a offrire anche i BCM Papers, nati in epoca Covid, un format digitale con ospiti internazionali che può essere seguito su YouTube e la pagina Facebook @bookcitymi.
Un’immagine dell’edizione 2015 di BookCity: l’incontro con Philippe Daverio nella Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi (foto Yuma Martellanz) In alto, il Castello di Milano (foto Alessandra Lanza). A fronte, la presentazione dell’edizione 2022

Festa della lettura in 1350 eventi BookCity racconta la vita ibrida 3000 AUTORI E AUTRICI, TANTI NOMI IMPORTANTI, ATTUALITÀ, SCIENZA, POESIA, ALL’INSEGNA DELLA “CONTAMINAZIONE”
IBRIDO È DA SEMPRE
IL TERRENO PIÙ FERTILE PER IL GERMOGLIARE DELLA CULTURA E DELLE ARTI
E VENTI
Quest’anno, ad esempio, potremo ascoltare il premio Pulitzer 2022 per la letteratura Joshua Cohen, intervistato da Sofia Mattioli, e il National Book Award 2021 Jason Mott insieme a Marco Bruna. Ma l’elenco comprende, tra gli altri, anche Georgi Gospodinov, Camila Sosa Villada, Sheena Patel, Lauren Groff e una lectio di Jeremy Rifkin. Una particolare attenzione verrà riservata ai «17 temi dell’Agenda 2030, ovvero gli obiettivi tracciati dall’Onu per uno sviluppo sostenibi le». I libri, si sa, aiutano a conosce re, capire, e quindi anche ad agire, soprattutto in un’epoca «di radi cale cambiamento come quella che stiamo vivendo, tra nuove minacce e nuove sfide. Attraverso centinaia di incontri, in un dibattito pubblico che coinvolge ogni anno decine di migliaia di lettori, BookCity offre a tutti i cittadini la possibilità di diventare attori consapevoli del cambiamento».
Il tema delle ibridazioni possibili e necessarie verrà affrontato in tanti modi diversi, ragionando su vari in trecci. A partire da quello tra uomo e natura, che verrà approfondito da Andrea Staid e Marco Aime (tra gli altri) all’Adi Design Museum, per «un’ecologia dove tutto il vivente interagisca senza frontiere di specie, e la natura sia pensata e vissuta non come separata dall’uomo ma come un insieme di relazioni». Del rapporto tra uomo e animale (ma anche tra uomo e virus) parleranno invece David Quammen e Telmo Pievani alla Triennale.
Sono diverse le sedi caratterizza te da focus tematici: l’Acquario Civico ospiterà gli incontri sul tema dell’ambiente e del mare, all’Anteo si terranno gli eventi legati al cine ma e alla televisione, l’Arci Bellezza si conferma la sede della letteratura noir e dei gialli, alla Casa della Me moria troveranno spazio la storia e gli incontri dedicati all’anniversario

della Marcia su Roma, MEET ospiterà gli incontri dell’arte e del digitale, mentre la Sala Apparta mento del Teatro Franco Parenti sarà la sede della poesia. Al Parenti troveremo anche Gior gio Fontana e Vittorio Lingiardi che ci aiuteranno a scoprire il senso profondo della metamorfosi in letteratura, da Ovidio a Kafka.
Aproposito di grandi temi, non potrà mancare la guerra, o meglio «la brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia». A BookCity arriverà una delegazione di Leopoli, con due appuntamenti al Castello Sforzesco. Presente anche Ivan Franko, il direttore della Biblioteca dell’Università della città ucraina, che di recente ha dichiarato: «Per me una biblioteca è come un esercito. Può creare una rivoluzione intellet tuale. Una biblioteca è un’arma più potente dell’aviazione di Putin».
Ma ci saranno anche riflessioni geopolitiche sulla guerra all’Ispi-Pa lazzo Clerici (con Giuliano Da Empoli, Andrea Graziosi, Fabio Mini, Franco Cardini e Gianni Barbacetto), incontri al Pime e alla Fondazione Corriere della Sera (Paolo Mieli e Bruno Vespa) e un evento dal forte valore simbolico ospitato al Memoriale della Shoah di Milano: Ucraina: dove siamo, dove andiamo, di Lorenzo Cre monesi e Francesco Cataluccio, in collaborazione con Gariwo.
Per “La grande storia” al Salone degli Affreschi della Società Umani taria si parlerà di Falcone e Bor sellino: «Cosa sappiamo di quelle stragi e dei loro mandanti? Stiamo ancora combattendo la criminalità organizzata con la stessa determi nazione?». Ma ci saranno anche Nicola Gratteri che parlerà di affari mafiosi, Gherardo Colombo che rievocherà la Loggia P2, Luca Sofri che, con Giuliano Pisapia e Lisa Noja, presenterà il nuovo numero
di Cose spiegate bene dedicato alla giustizia.
Corrado Augias invece ci accom pagnerà alla scoperta della fine dell’Impero Romano al Circolo Filologico Milanese.
“La battaglia dei diritti” è un altro macro-tema che proporrà tanti ap puntamenti, soprattutto sul fronte della diversità, dell’inclusione e dell’equità.
A proposito di “empowerment femminile” segnaliamo un percorso ideato da Benedetta Tobagi, intito lato Diventare pioggia, diventare tempesta. La Resistenza delle donne ieri e oggi, in guerra e oltre. Previsti tre incontri sulla storia, la memoria e la voce delle donne della resisten za, dalle 14 alle 17 di sabato 19 no vembre, al Museo del Risorgimen to. Ma anche la versione teatrale del libro La resistenza delle donne, venerdì 18 novembre alle 20.30 al Gerolamo, interpretata sul palco proprio dalla sua autrice Benedetta Tobagi, insieme ad Anna Bonaiuto,
con la regia di Lorenzo Pavolini. Il tema dell’emancipazione femmi nile, a partire dal mondo del lavoro, sarà il fulcro del palinsesto del Mi lano Luiss Hub, “contro il mondo a misura di maschio” con Emanuela Grigliè, anche perché “adesso tocca a noi donne” come spiega Chiara Tintori. Tra i diversi appuntamenti citiamo il ricordo di Rita Levi Montalcini con la nipote Piera.
Arrivando alle autrici e agli autori, l’elenco rischia di occupare tutto lo spazio a disposizione, quindi rinviamo al sito per i dettagli. Se dobbiamo cercare un evento-simbolo, citiamo l’omaggio a Italo Calvino che anticipa le celebrazioni del cente nario della nascita (previste l’anno prossimo): Peppe Servillo proporrà la lettura integrale di Marcovaldo ovvero Le stagioni in città vener dì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre dalle 10.30 alle 12.30 al Teatro Gerolamo.

59NOVEMBRE 202258NOVEMBRE 2022
(foto Ruggiero Scardigno)
(foto Yuma Martellanz)
Altri omaggi? A Dino Buzzati, con il “processo” a Un amore di Marco Missiroli ai Frigoriferi Milanesi; a Umberto Eco, con la proiezione di un documentario di Davide Ferrario all’Anteo; a Beppe Fenoglio, celebrato al Teatro Parenti; a Giorgio Manganelli, ricordato al Castello Sforzesco, così come Luciano Bianciardi (a cento anni dalla nascita). E poi Herman Melville (Antonio Moresco alla Società Editrice Milanese e Corrado d’Elia all’Acquario), James Joyce e Franz Kafka (alla Sormani), José Saramago (un altro anniversario da celebrare, con la moglie Pilar del Rio Gonçalves al Castello).
Dopo due anni di pandemia, torne ranno anche gli ospiti stranieri: tra gli altri Charles Bernstein, Geral dine Brooks, Roy Chen, Jonathan Coe, Robert Harris, Olivia Laing, Clara Sanchez, Elisa Victoria, Wil liam Wall. E gli italiani? Francesco Carofiglio, Teresa Ciabatti, Mauro Corona, Serena Dandini, Andrea De Carlo, Paolo Giordano, Marco Missiroli con Paolo Cognetti, Pif, Bianca Pitzorno, Andrea Vitali, Walter Veltroni.
Si scommette anche sul pubblico giovane, con Una domenica mattina per leggere insieme, una lettura dal vivo organizzata in collaborazione con ilLibraio.it e pensata per i TikTokers appassionati di lettura, come richiede l’ascesa di #BookTok, che porta migliaia di persone a ritrovarsi online per condividere le loro letture. In questo caso non ci si fermerà al mondo virtuale, ma si approderà in quello fisico, dome nica 20 novembre all’Auditorium
Enzo Baldoni, alle 10: si comincerà con due giovani booktokers, Megi Bulla e Valentina Ghetti, in dialogo con Jolanda Di Virgilio e Sara Canfailla (autrici di Non è questo che sognavo da bambina), e si pro
seguirà con un momento dedicato alla lettura silenziosa e collettiva. E per i bambini? Laboratori al Muba, Discarilandia (ambiente) al Museo della scienza, ma anche “le piccole grandi risposte alle do mande dell’esistenza” di don Gino Rigoldi, Zita Dazzi e il rapper El Simba al Pime.
Compie dieci anni “BookCity nelle Scuole”, che ha portato 1700 progetti in più di 11.000 classi.
Oltre a presentare un progetto e un incontro per la promozione della lettura nelle scuole, ci saranno due cento proposte diverse «che spazia no da temi di attualità, ad esempio un dibattito costruttivo sull’identità di genere, ai percorsi umanistici e letterari, con un affondo su autori del Novecento come Pasolini, Pavese e Fenoglio, ma con un’attenzione particolare anche alle autrici, quelle poco note, poco tradotte o dimenti cate, per proporre un controcanone della letteratura all’insegna della pluralità delle voci e dei punti di vista. Tanto spazio è riservato ai generi letterari, dal fantasy al giallo alla fantascienza, fino a laboratori e contest sul fumetto e sulla graphic novel».

Sono tantissime anche le realtà che partecipano a “BookCity per il Sociale”, che coinvolge le carceri di San Vittore, Opera, Bollate, Becca ria e Icam, l’ospedale di Niguarda e il San Carlo Borromeo, Casa
Amici del Trivulzio: numerosi gli incontri organizzati in questi spazi sul tema dell’anno, ma anche gli spettacoli teatrali e musicali. A questo proposito ricordiamo gli eventi proposti in giro per la città, tra cui il cinema degli anni Settanta all’Anteo, il ricordo di Giorgio Strehler al Piccolo, le arti visive a

Ogni occasione è buona per cele brare il libro, ma anche per incon trarsi e condividere. Per ibridarsi, in qualche modo.

60NOVEMBRE 2022
Jannacci, Casa della Carità, Centro Ronda, Barrio’s e Fondazione
Palazzo Reale, fumetti e graphic novel in Triennale, al Castello e nel lo spazio Wow, la guida all’ascolto di Battiato all’Auditorium Stefano Cerri, e tanto altro. Compresa la “cucina da favola” alla Cascina Cuccagna.
TANTI GLI OMAGGI, DA ITALO CALVINO A DINO BUZZATI, DA MELVILLE A JOYCE FINO A SARAMAGO
(foto Yuma Martellanz)
Luis Sepulveda al Museo della scienza e della tecnologia nel 2015 (foto Yuma Martellanz)
(foto Ruggiero Scardigno)
Erotico, eretico e irriverente Il libro secondo WoM: Hic Bibitur!
Contro «tutto ciò che appesantisce la vita con un sentimento di serietà e afflizione»
Mica male come programma edi toriale. Lo “spirito dissacratorio”, di questi tempi, è un toccasana. Per questo, in cerca di un po’ di redness
nel mercato editoriale italiano, abbiamo scelto WoM.
Il libro dovrebbe sempre avere an che un suo erotismo, bello da guar dare e da toccare, stimolante, capace di infiammare l’immaginazione. Ed ecco allora i “libri col buco”, che in copertina fanno intravvedere cosa
c’è sotto; ecco la creativa ricerca ico nografia; ecco i fantasiosi “gadget” di accompagnamento, tra segnalibri artistici, favole d’autore sigillate con ceralacca, estratti dalle lettere di Oscar Wilde all’amante, e un gior nalino in stile giapponese dell’era Edo. Vedi ad esempio il “pacchetto rivoluzionario” che accompagna La rivolta degli appesi di Traven, con la spilla “Tierra Y Libertad!”, la ricetta per un cocktail “Molotov” e l’inserto Gli Utopisti di Ricardo Flores Magòn.
Fuori da qualsiasi moda o logica, che non sia quella del piacere e della provocazione, WoM pubblica letteratura inedita o dimenticata, sceglie il comico e lo humour nero, dedica uno spazio vietato ai minori al pre-porno, pubblica libelli Contro il lavoro (Giuseppe Rensi) o per fare Guerra alla guerra! (Ernst Fri edrich), ma anche Cento vedute del monte Fuji di Hokusai, Uccidiamo lo zio di Rohan O’Grady, Oscar Wilde (Teleny) e le Confessioni di un omosessuale a Émile Zola Inutile immaginare un’intervista normale, con loro. Li abbiamo lasciati fare, e il risultato è folle, fluviale, ironico, irriverente.
Bigino biografico: chi siete? Vale tutto: età, studi, vizi, virtù, manie, predilezioni.
Esseri poco idonei all’assoggetta mento identitario, l’intero staff di WoM è composto da elettroni liberi vaganti nel psicocosmo onirico della non-realtà; ovvero, detto altrimenti, siamo ciò che facciamo e il nostro gu sto, sapore, profumo, i nostri deliri, le nostre predilezioni, vizi, sarca smi, serietà, preghiere e bestemmie, studi, ecc., le si possono conoscere solo e unicamente scoprendo il nostro catalogo e l’elaborazione concettuale e formale della nostra casa editrice, intesa quale generatrice di simulacri metaletterari – ossia balocchi cono scitivi per menti plastiche, variegate, multiformi e metamorfiche. Quindi, non per fare a tutti i costi

gli antipatici o per tirarsela snobisti camente col mistero dell’anonimato wuminghiano-elenaferrantiano – davvero, non vale minimamente la pena soffermarsi sul catasto quoti diano dei disastri di CHI fa WoM. L’unica cosa sensata e indispensabile per la propria salute e quella della propria famiglia, come per l’igiene mentale della Società tutta intera, è mettersi immediatamente al cor rente di COSA è WoM e soprattutto di cosa non è e ancor più di cosa potrebbe diventare, e abbonarsi ad ogni sua manifestazione, reale o fantasmatica che sia.
Copertine col buco, formati ori ginali, pacchetti rivoluzionari in omaggio... Il libro come oggetto, esperienza tattile, anche come gioco e scoperta.
Quale oggetto parafiliaco per anto nomasia, il libro deve avere la sua intensa parte di gioco ed essere uno stimolatore di desiderio in quanto feticcio, oltreché nel suo contenuto che ovviamente è parte fondamentale per il più intenso erotismo psichico – nulla vale l’orgiastico silenzioso chiacchiericcio di chi, solitario, al chiarore di una lampada, onanisti camente, si abbandona alle profon dità melliflue della lettura… Tuttavia, come ogni esperto amante saprà, prima di giungere all’orgasmo è necessaria una intensa prepa razione e stimolazione, e in questa, una buona dose viene giocata dalla parte feticistica del nostro desiderio: chi negherà l’importanza della biancheria intima, delle trasparen ze, dei pizzi e merletti, quale lusinga ad ogni sedotta corporalità?

63NOVEMBRE 202262NOVEMBRE 2022
I DEE
ALLA SCOPERTA DI UNA CASA EDITRICE CHE PUBBLICA TESTI DIMENTICATI
E REALIZZA “OGGETTI” BELLI DA GUARDARE, LEGGERE, TOCCARE
Il caso di WoM, con la sua ricerca della realizzazione di un oggetto ossessivamente attraente e edonisti camente erotico, dovrebbe dunque essere la normalità nell’editoria se gli editori rispettassero per davvero la natura desiderante ed estrema mente erogena del Lettore, eppure non è così.
L’erotizzazione del libro in quanto oggetto da alcova, scrigno da collezionare e inserire nel proprio catalogo di conquiste che un giorno un Lepo rello canterà a squarciagola, è prati ca del tutto minoritaria, e questo per una colpa fondamentale imputabile alla predominanza utilitaristica, sansimoniana e capitalisticamente merciologica del privilegio accordato al rendimento del contenuto, a scapi to appunto della Forma, del gioco e di quel surplus desiderante su cui si fonda la vita, quella part maudite a cui Bataille ha dedicato un saggio fondamentale a cui si rimanda per maggiori precisazioni.

Inoltre, questa mancanza di mor bosità per l’oggetto-libro, la si deve ad un limite fisiologico di concezione artigianale dell’oggetto da parte di entità editoriale sempre più distratte da Nobel e Palmarès vari, dove tutt’al più, generalmente, ci si limita a variare qualche griglia in copertina scimmiottando Adelphi, i Bollati-Boringhieri degli albori o le Edizioni SE, o dove al meglio ci si affida a qualche buon grafico, con risultati tuttavia che spersonalizzano il progetto editoriale, in un rapporto forma-contenuto che immancabil mente viene meno, dal momento che, come ricorda perentoriamente Jan Tschichold: «Il lavoro dell’artista del libro si distingue da quello di un grafico: mentre quest’ultimo è

costantemente alla ricerca di nuovi mezzi d’espressione nel desiderio di acquisire uno “stile personale”, l’artista del libro deve essere il servo fedele e avere un tatto particolare per la parola scritta.
Il lavoro del grafico deve corri spondere alla richiesta e ai gusti del momento e raramente vive a lungo – al di fuori degli scaffali dei collezionisti –, mentre il libro deve attraversare i secoli. Lo scopo del gra fico è la realizzazione di sé, mentre il compito di un artista del libro è quella di disfarsi di se stesso».
Ci raccontate da dove nasce Word of Mouth e il suo spirito dissacratorio?
«In principio era WoM e presso di lui stavano le Parole e le Immagi ni», scrive il profeta.
Da qui in poi si è trattato di articolare una strategia di rielabo razione dell’immaginario che vada a rigenerare il potere sia delle prime,
le Parole, che delle seconde, le Imma gini, in un’ottica che può apparire «dissacratoria», ma che in realtà risulta tale solo perché ciò che viene presupposto come sacro, vero, inviola bile, serio, ecc., è, nella sua dinamica sclerotizzata dagli stilemi e stereo tipi sociali, una forma di paralisi mentale a cui naturalmente, chi ha per vocazione la rivitalizzazione del linguaggio, sembra opporsi scardinandone i presupposti e i cliché. Perché rielaborare il linguaggio, o meglio, giocare con le convenzioni di senso, manipolarne scientemente e patafisicamente le modalità e i for malismi, significa automaticamente andare a infliggere alle forme stere otipate che avvolgono le nostre menti come delle strette fasce di psicomani polazione e di virale «conformismo logico» (secondo la definizione di Durkheim) una deflagrazione e con esse ai fondamenti di ogni Potere, dal momento che qualsiasi strut tura di potere trova le sue assise sul linguaggio.
Da qui lo spirito carnevalesco, festivo, goliardico, anarcoide che si sprigiona dal progetto WoM, nel suo alacre animo infantile di creazione sfrenata e dissennata (nell’etimo, priva di senno, dal momento che l’essere assen nati – «mettere la testa a posto» - è la morte di ogni vigore conoscitivo perché significa l’entrata nella forma adulta e arteriosclerotica dell’esse re, passando dallo stato amorfo e anomico, pinocchiesco, multipolare e potenzialmente pluriforme del pezzo di legno, a quello crapulo, che sa legge re, scrivere e far di conto, del bambino avviato al lavoro).
Fateci qualche esempio pratico, libri di cui andate particolarmente fieri.
I libri di cui andiamo particolar mente fieri sono tutti, dal momento che il progetto ha una sua unitarietà, come una bomba ha il suo punto di deflagrazione, da cui poi si dipartono le diverse schegge; ma poter dire quale
tra queste schegge sia maggiormente rappresentativa della bomba e della sua deflagrazione, diventa empiri camente impossibile da determinare,
militarmente e strategicamente inopportuno, e nella visione dina mitarda del gioco che anima WoM, assolutamente impensabile.
65NOVEMBRE 202264NOVEMBRE 2022
Al limite è possibile indicare il libro feticcio di WoM – di cui qui anticipiamo in esclusiva per voi di Redness la prossima uscita nel mese di novembre – ovvero le Buffe Chimere, un catalogo di centoventi sogni di Pantagruel, volume che raccoglie le visioni polimorfe di un campionario di emblemi e simboli dalle forme mostruose e cangianti, libro attribuito a François Rabelais – sommo padre putativo del Comico e nostro nume tutelare – in cui si verrà a scoprire anche chi è e da dove viene l’emblema che correda il frontespizio dei nostri volumi e dove anche si chiarirà il nostro moto, Hic Bibitur.

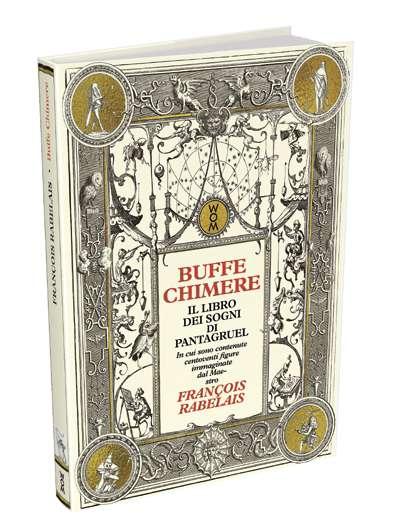
Inoltre, il volume verrà accompa gnato da un mazzo di Tarocchi Pantagruelici di Divinazione Pata fisica, attraverso cui potersi accostare mistericamente ai principi teurgici che quotidianamente operano in casa editrice e da cui, ad ogni Sabba, vengono fuori le idee guida più fuorvianti.
Anche sul fronte dei temi, non ci andate per il sottile. O meglio, siete “sottilissimi”, vi piacciono gli anfratti, le nicchie: lotta di classe, (pre)pornografia, libertà sessuale, contro il lavoro, contro la guerra…
Dal momento che, come dicevamo, il principio di WoM è uno scardinamento delle istanze che sorreggono l’Ordine del Discorso (che poi è, di conseguenza, il Discorso dell’Ordi ne), i temi che le forme editoriali si trovano magneticamente ad attrar re sono quelli che si oppongono alle istanze di Potere che, per riprendere la vostra lista a controcorrente sono:
le Gerarchie di stampo borghese nel loro mellifluo e diffuso adagiarsi sulle norme classiste di perbenismo e fascistizzante decoro; l’Eros (pre)por nografico liberato – va da sé –, dalle pruderie moraleggianti di stampo catto-borghesi da un lato (mi pare il minimo) coi loro sensi di colpa, inviti alla castità, alla repressione di ogni forma di piacere, ecc., ma anche da quella psicologizzante forma mefitica da «sacerdozio del rimosso» che si trova in moltissima letteratura – la scuola della repressione libidi nale – le cui due icone emblematiche sono certamente Bontempelli da una parte e Moravia dall’altro, con tutta
la loro sequela di inconsci e inco scienti imitatori premiati, incorona ti e elogiati; e infine il (pre)porno e la conseguente libertà (pan)sessuale è anche, in terzia istanza, un elogio della fluidità sessuale, orgiastica concezione psichica della gnosi e del corpo, che però non rivendica e non chiede a nessuno Stato e a nessuna Società riconoscimenti di alcuna sorta, e che spinge per una libertà sessuale che si azzarda ad essere libera soprattutto dalle neoprofezie di «diritti per tutti» che si rivelano essere unicamente una richiesta di elemosina di riconoscenza alle istan ze repressive di potere.
Il (pre)porno che si agita in WoM auspica e presuppone una rivolta globale, in cui la sessualità ha la funzione trasformatrice delineata, per esempio, da un pensatore come Mario Mieli nel suo fondamentale Elementi di critica omosessuale, in lotta con l’ortodossia eteronormata che va ben al di là di una semplice rivendicazione di tolleranza, pro spettando invece la trasformazione totale delle strutture repressive, tanto culturali quanto tecnico-produt tive – quelle stesse che mobilitano, giustificano e promuovono lo schia vismo salariale (ed ecco il Contro il lavoro di Giuseppe Rensi), nonché le guerre (da cui il Guerra alla Guerra! di Ernst Friedrich), e tutte le altre forme di repressione, compresa quella mentale razional-cartesia na – ragion per cui presto verrà
pubblicata da noi una graphic novel sulla scoperta dell’Lsd inteso quale porta della percezione verso diversi e più plastici cablaggi mentali.

La “società segreta” dei lettori liberi, invisibili (rimandiamo alla leggenda-esortazione sul sito womedizioni.it), è una constatazione, ci sono numeri ed esperienze che ne dimostrano l’esistenza, o è solo un’aspirazione?
La società segreta dei lettori è una constatazione – che tuttavia non è numerica o statistica, bensì è una condizione dell’anima, determinata dalla natura del lettore nella sua specifica realtà di colui che legge non per il sollazzo domenicale sotto l’om brellone giusto per passare il tempo come stesse sorbendosi l’ennesimo pa
nettone Netflix, o di chi legge al solo fine di tenersi aggiornato dell’ulti ma moda e si catapulta a collezio nare e instagrammare tutti i grandi successi stagionali di storielle da Campiello, bensì di colui che legge come respira e che respira come pen sa. Anzi, è possibile affermare senza timore di poter venire contraddetti, che la realtà di tale società segreta è esistente anche se a farne parte è un solo individuo, ed anzi, a maggior ragione se a farne parte è un solo individuo, o persino se – considerato lo spirito altamente irriverente ed esclusivo dei suoi membri –, se neppure quello stesso unico individuo che costituisce tale società decidesse di farne parte, fedele all’insegnamento marxista di Groucho: «I refuse to join any club that would have me as a member».
67NOVEMBRE 202266NOVEMBRE 2022
Tutti coloro che ci hanno insegnato a pensare.
Poco sopra si è fatto il nome di François Rabelais, ma la lista potrebbe essere lunghetta, andando da Johann Sebastian Bach a Jack lo Squartatore, da Baudelaire a Kurt Gödel, da Leopardi, Divine, Erwin Schrödinger, a Lobo il sicario della regalità, con tutte le sfumature nel mezzo.

Tendenzialmente il pantheon di WoM è costituito da quella pletora di persone che, qualunque sia o sia stato il proprio dominio tecnico-ar tistico, ha spinto il cervello dei com ponenti della casa editrice a pensare contro se stessi – assecondando uno dei principi fondanti l’anarco-pa tafisica: «Mi applico volentieri a
pensare alle cose alle quali penso che gli altri non penseranno», massi ma di Robert de Flers, marchese de La Motte-Lézeau, signore dalla calzamaglia variegata e dalla rosa parrucca.
Cosa non va nel mercato edito riale italiano?
La risposta è quantomai semplice: il fatto che WoM Edizioni ancora oggi non abbia un fatturato almeno triplo rispetto al Gruppo Rizzoli, e una sede centrale la cui planimetria sia almeno il quadruplo di quella delle Edizioni Mondadori a Segrate. Questi due fondamentali aspetti mi sembrano sintomatici di un grossissimo problema nell’edito ria italiana e spero davvero che ci si affretti a risolverli entrambi nel più breve tempo possibile.
Teniamo a precisare, giacché ce ne viene data l’occasione, che riguardo alla prossima futura sede centrale di WoM, a dispetto del modello mondadoriano, il progetto non verrà affidato di certo ad un emulo di Oscar Niemeyer con le sue magnilo quenti visioni distopiche di ciclopici socialismi orwelliani a venire (sul modello Brasilia), bensì a un quid di ispirazioni vicine alla Psicogeografia e alla Città Nuda di un Guy Debord; mentre per il parco anti stante, lo stile di Pietro Porcinai – in particolare col suo Parco Pinocchio a Collodi a mo’ d’esempio – andrebbe benissimo.
Libri che tutti amano e che voi non sopportate.

Per far semplice e andare sul sicuro, partiamo dal super-snobbistico presupposto che «se piace a tutti, a noi no», così non rischiamo di sbagliare.
E anche in questo caso la lista sarebbe lunga, e poi facendo dei nomi rischieremmo di dimen ticarne tanti e quindi di non scontentare e irritare abbastanza persone… Diciamo che, per sparare nel mucchio, l’odio feroce di WoM è rivolto a quella letteratura d’ac compagnamento, allo sdolcinato e melenso mercatino della narrazio ne di quegli eserciti di libri che non smuovono neppure di un granello il senso delle cose e non obbligano ad alcuno sforzo di conoscenza, e non hanno nessunissima interazione con la Forma, ma si limitano a titillare i sentimenti basici, spesso accarezzando il lettore nel senso del pelo per non rischiare neppure in superficie di scuoterlo un minimo.
E di questo genere ce ne sono tantis simi e non solo sfornati dai “grandi editori” che per far cassa ad ogni stagione propinano i loro best-seller a colpi di lacrimosi melodrammi e storie di rivincite esistenziali, di romanzi di formazione in cui coppie scoppiate imparano a sopportarsi nonostante tutto o mandano tutto all’aria per una vacanza andata e ritorno in oriente a riscoprirsi e la bellezza della natura, ecc. ecc., che sa rebbe il minimo; il problema è quan do anche i “piccoli editori” corrono dietro al titolo a successo (o presunto tale) ricercando storielle strappala crime, melensi ripescaggi secondo l’aria che tira – se va di moda il fem minismo si sfornano libri scritti da donne su donne; se vanno di moda i libri di viaggio, si aprono collane sui viaggi, paraguide turistiche o similia; se va di moda la lotta di classe, ci si ritrova a pubblicare libri di lotta di classe; ecc., annacquando il panorama di proposte in ondate tutte identiche, in cui poi i lettori si ritrovano a galleggiare facendosi di volta in volta selfie femministi, selfie turistici, selfie di lotta di classe, ecc., a seconda della risacca del momento.
Controprove? Libri che il mer cato non sopporta (supporta) e che voi amate.
La controprova sono i libri che nel catalogo hanno il senso di pedine nel gioco del Go. Che devono stare laddo ve stanno al di là delle intemperie, le ondate, le mode, i selfie, ecc.
I libri in fondo sono lo specchio della società che li produce e li diffonde. Vi danno una “bac chetta magica”, cosa cambiate
subito, da domani? (nella società e quindi anche nello specchio).
Beh innanzitutto, come già detto, decuplicare il fatturato di WoM Edi zioni e costruire subito una megaliti ca sede con dentro tutti i parchi giochi necessari. Poi, una volta requisita l’intera Silicon Valley e dintorni, e li cenzianti in tronco i vari Zuckerberg, Musk, Dorsey, Agrawal, Cook e combriccole d’apparato varie, e dismessi i loro infestanti sevizi, assumere una pletora di ingegneri specializzati nel la costruzione di macchine di Rube Goldberg, per mettere in piedi la costruzione e diffusione su scala pla
netaria della Macchina per Decer vellare prospettata dal sommo Ubu e, testa dopo testa, per otto miliardi di cervelli, strappare quella melassa gelatinosa che – visti i risultati – ha avuto una più che pessima e nefasta funzionalità, per sostituirla con una pompetta per inalare protossido di azoto (più conosciuto come gas esila rante) nel sistema nervoso periferico, ottima soluzione quale analgesico per qualsiasi male e – come testimonia il più grande filosofo americano, William James –, perfetto quale veicolo per le indagini filosofiche e psicopompo per le più ilari e gioiose intuizioni mistiche.
69NOVEMBRE 202268NOVEMBRE 2022
Numi tutelari? Viventi, trapas sati o anche solo immaginari.
IL LATO UMANO DELLA TECNOLOGIA, CON DIAGNOSI LAMPO
Sanità d’avanguardia al CMR di Borgomanero dove si investe in macchine sempre più efficaci
qualche mese fa è stata rinnovata la Moc Dexa, garantendo più preci sione e meno radiazioni.
«Buongiorno, devo prenotare un’ecografia, quando c’è posto?»
«Oggi pomeriggio, se vuole»
In un mondo ideale, questo dovreb be essere il dialogo quotidiano tra un paziente e un centro diagnostico o un ospedale. Nel mondo reale, invece, occorre rivolgersi alla sanità privata, possibilmente a chi reinveste
gli utili nell’aggiornamento dei mac chinari, riuscendo ad assicurare la tecnologia più recente - che non è un dettaglio, perché significa diagnosi più accurate - a prezzi accessibili.
Al CMR (Centro Medico Radiolo gico) di Borgomanero la macchina più “vecchia” ha cinque anni di vita, la risonanza magnetica artico lare si fa anche in versione aperta e

Fabrizio Pomoni, il titolare, ci fa da guida, giustamente orgoglioso, mo strandoci i vari macchinari, dentro un “piccolo centro” che in realtà non è poi così piccolo, visto che si contano una quindicina di ambien ti distribuiti su due piani. Sembra quasi di stare dentro un’astronave, con quelle apparecchiature ultra moderne, l’arredamento sobrio, la struttura minimalista ed elegante. Anche se si capisce subito – dai sorrisi in reception e dall’accoglien za simpatica e informale del titolare – che qui si punta soprattutto sul “fattore umano”.
Per certi versi è simbolico il fatto che questo centro sorga a due passi dall’Istituto Rosmini, in via Profes sor Fornari 8/A, dentro un edificio moderno, che potrebbe sembrare una palazzina residenziale e invece si rivela quasi una clinica.
Da una parte c’è un’istituzione educativa storica, presente in città fin dalla metà dell’800, con il suo antico edificio spettacolare, dall’altra questo concentrato di tecnologia all’avanguardia, che serve un vasto territorio (arrivano pazienti anche dal resto del Piemonte e alcune zone della Lombardia).
Nato nel 2015, il CMR è guidato da Fabrizio Pomoni dalla fine del 2017.
E in questo breve periodo ha pratica mente decuplicato il fatturato, anche se lui preferisce dire «siamo cresciuti molto», che è quasi un eufemismo. Ce lo racconta nel suo studio, men tre chiacchieriamo di medici e sanità italiana, di macchinari all’avanguar dia e pazienti (giustamente) esigenti. Ma visto che a noi piace raccontare storie e conoscere le persone anche al di là del loro lavoro, finiamo anche per parlare di musica, di kart e mo torsport (Fabrizio Pomoni suona la batteria e ama la velocità in pista).
Prima però c’è il dovere, che è poi anche il piacere di fare un lavoro che dà molte soddisfa zioni. «Mia moglie è medico radio logo – ci racconta - quindi frequento questo mondo da 25 anni. Ma io vengo da tutt’altro campo. Facevo il consulente aziendale, lavoravo nella tecnologia, fibre ottiche». Un giorno però gli dicono che a Borgomanero vendono un centro radiologico, aperto solo un giorno la settimana: forse, con una buona gestione aziendale, si può provare ad ampliare la sua offerta. Detto fatto. Fabrizio Pomoni dice addio alle fibre ottiche e si dedica alla radiologia.
La differenza, rispetto al passato, è che qui i clienti sono anche pazienti. «Il mio compito, da amministra
tore unico, è quello di far crescere il centro. Gestire medici, tecnici, impiegati, ma soprattutto i pazien ti» Fondamentale, in un lavoro del genere, è l’aspetto del rapporto umano. «Insisto molto con i medici perché abbiano un certo approccio con il paziente, che ha bisogno di essere rassicurato. Il rapporto umano è fondamentale. Il paziente non deve ricevere il referto in segreteria e arrivederci: anche se non c’è niente da spiegare, perché fortunatamente è sano, gli si dice: “Non c’è nulla di cui preoccuparsi, ci rivediamo la prossi ma volta per un eventuale controllo, buona giornata”» Saranno pure clienti, ma sono soprattutto esseri umani, preoccupati per un dolore o
un problema di salute. Da due mesi è stato sperimentato anche un nuovo servizio che verrà lanciato nelle prossime settimane: l’ecografia a domicilio: «Il medico che va a casa dal paziente e gli fa l’esame. Ha un costo maggiore, ma è particolarmente utile per le persone anziane allettate, per evitare tutti i rischi e i problemi del trasporto». Quanto alle macchine, si fa ogni tipo di radiografia e di ecografia, oltre alla mammografia in To mosintesi. La Tac dentale 3D è sempre più richiesta dai dentisti, «soprattutto da chi fa impianti, perché garantisce un’immagine che ricostruisce il canale al millimetro, così come le misurazioni dell’osso».

71NOVEMBRE 2022
Il titolare Fabrizio Pomoni ci racconta la grande crescita di questo centro medico radiologico, che offre esami di qualità, anche in giornata, a prezzi accessibili
S TORIE DI VITA E D’IMPRESA
Prima il dovere, poi il piacere. Il titolare Fabrizio Pomoni è anche un batterista e ottimo pilota di kart

Poi c’è una Moc Dexa, «richiesta per lo più dai ginecologi ed endocri nologi per valutare la densità ossea, e quindi prevenire o curare l’oste oporosi. Abbiamo un apparecchio nuovo, appena cambiato. I medici preferiscono gli esami effettuati con macchinari di nuova generazione e noi ci siamo adeguati alle loro richieste». I due macchinari per la risonanza magnetica articolare sono stati installati da pochi mesi. «Una è più piccola, ma di grande qualità, così come quella più grande, aperta, adatta anche a chi soffre di claustro fobia». Di risonanze se ne fanno un gran numero, sicuramente dettato anche dal costo adeguato al livello del servizio offerto. Un piccolo cen tro, dicevamo, già quasi grande.
Al CMR di Borgomanero lavorano sei medici (che turnano), tre tecnici di radiologia e due impiegate di recep tion. Ma in Italia non è così facile


trovare tecnici e medici radiologi. E allora si va a caccia di giovani di talento. «Cercavo un terzo tecnico, l’anno scorso, ma non lo trovavo. Poi vengo contattato da un amico che mi segnala una ragazza appena laurea ta in tecnica radiologica. Le abbiamo offerto uno stage nel novembre scorso, dicendole che l’avremmo seguita per un paio di mesi. A gennaio, dopo aver verificato che lavorava bene, le abbiamo offerto un contratto». Se c’è una cosa di cui va fiero Fabri

zio Pomoni, oltre «all’incremento del fatturato, che è andato oltre ogni aspettativa», è la qualità dei rap porti umani in azienda. «Abbiamo creato un gruppo di lavoro molto bello, tra impiegati e tecnici di radio logia. Lavoriamo, ma ci divertiamo anche. Avevo promesso che, raggiunto un certo obiettivo, li avrei portati in vacanza. L’obiettivo è stato raggiun to e la vacanza è stata prenotata: ora, al primo ponte disponibile, si va tutti a Ibiza».
Passando dal lato impren ditoriale a quello umano, finiamo per parlare di musica e solidarietà. Fabrizio Pomoni è il batterista degli Hurricane, che ogni anno si radunano per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. «Siamo un gruppo di amici che suonano insieme da quando sono ragazzi. Alcuni sono diventati musi cisti professionisti, altri hanno scelto strade diverse. Purtroppo nel 2009 è venuta a mancare una cara amica, una ragazza di 30 anni, moglie del tastierista, morta per un tumore cerebrale. E abbiamo deciso di dedi carle un’associazione. Raccogliamo soldi per chi ne ha bisogno, facendo musica, pop anni ‘80».

L’altra passione di chiama kart, e ha “contagiato” anche il figlio di 8 anni (quasi 9), pure lui pilota, che accom pagna in allenamenti e gare. «È uno sport impegnativo economicamente, ma ne vale la pena. Bisogna avere una struttura, un meccanico personale e tanti pezzi di ricambio, perché il mo tore molto delicato, si rompe spesso, poi c’è la pista da pagare, l’iscrizione alle gare, le gomme...». Ci mostra una sua foto mentre sfreccia sulla pista di Franciacorta. 123-124 all’ora, con la curva da fare a tutto gas, confidando nella buona guida e nella buona sorte. «A luglio mi hanno tamponato e sono finito sopra un altro kart». Ma vuoi mettere il brivido della velocità? La conversazione è piacevole, ma il lavoro chiama. Essere imprenditori, in una piccola realtà che funziona, significa anche darsi da fare per siste mare un tappeto nuovo in reception o risolvere in fretta il problema a un macchinario che non può aspettare.
La visita finisce con un giro al primo piano: qui, volendo, si passa diretta mente dalla diagnosi (risonanza ma gnetica) allo studio di un fisioterapi sta, con la sua piccola palestra (non è collegato al centro, ma è comodo). In prospettiva, l’edificio si arricchirà di nuovi spazi sanitari.
Intanto al centralino del CMR (0322 81702, cmrborgomanero.it) c’è chi chiama per un appuntamento e gli viene detto che, volendo, c’è posto in giornata. «Possibile?», risponde qualcuno, quasi preso alla sprovvista. «Esami radiologici senza liste d’attesa, con referti immediati». Promessa mantenuta, per chi ha la possibilità di sostenere il costo di un esame privato. «La nostra qualità al servizio della tua salute». Semplice, diretto e veloce. Come un kart.

72NOVEMBRE 2022
SALUTE E BELLEZZA? C’È SOLO UNA REGOLA: ESSERE NATURALI
La dottoressa Shamini unisce cultura orientale e occidentale, medicina estetica e nutrizione
Natura. La parola d’ordine è questa. Essere il più possi bile naturali. Che detto così sembra facile, forse perfino ovvio, se non fosse che il nostro modo di vive re è diventato sempre più artificiale.
Quasi non ce ne accorgiamo più. Gli orari folli, i pasti frettolosi, lo stress, l’inquinamento, gli squilibri fisici e mentali, i farmaci e i cosmetici con cui cerchiamo di rimediare disordi natamente agli scompensi accu mulati. Tutte cose che si incidono letteralmente sui nostri volti, sulla pelle, e che influiscono sul nostro metabolismo.
Tornare alla natura, quindi. Che non vuol dire rinunciare alla civiltà e an dare ad abitare nella foresta, ma usare ciò che sappiamo per vivere meglio. Vale per la medicina estetica, la cura del corpo e della pelle, che aiuta a stare bene con se stessi e gli altri. E vale anche per l’alimentazione, che non deve essere in balia delle mode e delle diete, ma commisurata alle specifiche esigenze di ognuno, visto che siamo tutti unici, diversi, e dobbiamo trovare il nostro equilibrio, la nostra formula ideale di salute e bellezza.
La dottoressa Shamini è l’incarna zione di questa filosofia, con la sua semplicità sorridente e l’attitudine all’ascolto, fondamentale per capire chi hai davanti e di cosa ha bisogno davvero. Anche se lei ha qualcosa in più, legata alle sue origini orientali, la madre di origine cinese e il padre indiano (il cognome suona esotico e complicato: Sandanaeaspuran). Chiamatela pure intuizione, sensibilità, ma anche tradizione. «Nel mondo asiatico diamo molta importanza alla cura della pelle - ci
racconta. - Come si sta fuori è il riflesso di come si sta dentro. La cosa più importante è la cura. Ma non fino al punto di sembrare diversi, ciò che conta è stare bene». Aggiungete gli studi di Medicina a Dublino e la specializzazione in Estetica e Nutri zione a Roma, all’Università di Tor Vergata, ed ecco quel mix di cultura orientale e scienza occidentale che è la caratteristica principale della dottoressa Shamini e del suo studio attivo ormai da dieci anni. Perché quando si parla di medicina estetica e alimentazione, diventa fonda mentale essere sempre aggiornati sulle ricerche, le scoperte, i nuovi prodotti. Anche se poi ciò che conta davvero è la capacità di adattare la cura o la dieta alle caratteristiche e alle esigenze di ognuno. Non esi stono regole universali, ma semmai soluzioni individuali, da cercare con pragmatismo.
«Fin da piccola mi sono appassiona ta all’estetica. E mi interessava anche la nutrizione, la cura dell’alimenta zione, che poi si riflette anche a livello esterno». Come si sta fuori è una conseguenza di come si sta dentro.
La cura comincia dall’attenzione con cui ci alimentiamo. «Senza esagerare, però», dice la dottoressa, e lo ripete spesso, come un mantra, perché l’esagerazione, l’ossessione, non portano mai nulla di buono. Semplicità, conoscenza, concretezza, ecco cosa ci vuole. Qui, nello studio romano in via Tuscolana 739 (www. drshamini.it, 392 560 1244) non si applicano metodi o regole che vanno bene per tutti. Sia che si parli di estetica o di alimentazione. «Siamo tutti diversi», sottolinea, sempre sorridendo, senza mai usare parole ricercate o concetti difficili, perché le idee che funzionano non hanno bisogno di essere imbellettate (natu ralezza, anche qui). «Abbiamo una struttura fisica diversa, stili di vita differenti, quindi tutto va persona lizzato».
Qui si lavora con la “medici na estetica non invasiva”. «Ci prendiamo cura della pelle, delle rughe, le macchie, anche cose dermatologiche, e poi gli inesteti smi del corpo». Nulla a che vedere, insomma, con la chirurgia estetica, «in cui si parla di alterare il corpo. Se non ti piace la forma del tuo naso, puoi decidere di fare una rinoplastica. La medicina estetica, al massimo, cor regge la gobba o la punta del naso, La differenza fondamentale non è tanto sul risultato immediato, quanto sul fatto che la medicina estetica richiede una cura costante, un mantenimento nel tempo. Si parla di invecchiare bene, insomma. Le rughe magari ci sono lo stesso, ma meno brutte».


L’idea è che conti più la prevenzio ne, e l’attenzione costante, dell’in tervento risolutivo. Non ha senso provare a trasformare il volto e il
corpo, come per magia, dopo anni di trascuratezza. «Bisogna imparare a prendersi cura di sé» con amore e consapevolezza. «Anche piccoli trat tamenti e interventi curativi possono cambiare l’autostima di una donna. E di un uomo». Sì, perché anche gli uomini sono molto più attenti all’estetica. Ma per ora sono ancora una piccola minoranza («uno su venti, più o meno»).
La frase-simbolo dello studio Shamini è: “Riscopri la versione migliore di te stessa”. Perché spesso si pensa all’estetica come qualcosa di artificiale, un inganno, un trucco, che copre e cambia i connotati. Ma questo vale solo per la chirurgia. La medicina estetica, al contrario, può essere un modo per ritrovarsi, per assomigliare a ciò che siamo davvero, interiormente ed esteriormente.
75NOVEMBRE 202274NOVEMBRE 2022 S TORIE DI VITA E D’IMPRESA
Si tratta di «riscoprire la versione migliore di se stessi» attraverso interventi non invasivi e personalizzati
Non un nascondere, ma uno svela re. «Dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo. Non posso cambiare una persona, ma aiutarla a stare bene con se stessa, quello sì».
Sono tanti i trattamenti estetici a disposizione, ognuno con indica zioni diverse. «La carbossiterapia, ad esempio, è una terapia vera e pro pria, utile a chi soffre di insufficien za venosa, perfetta per la cellulite. La mesoterapia richiede l’iniezione di sostanze, principi attivi, per mi gliorare degli inestetismi e sciogliere l’adipe: non c’entra con il dimagri mento, però, si tratta di diminuire i centimetri, non il peso, e aiuta a tonificare». L’elenco comprende la radiofrequenza e la bioristruttu razione, il filler, il peeling, i fili di trazione, la tossina botulinica.
«In medicina estetica servono tanti macchinari. Io lavoro con una clinica che ha tutto ciò che serve. Ci sono i trattamenti per il ringiovanimento del viso, per migliorare il texture cuta neo, per le smagliature, le macchie, le cicatrici...». Non c’è trucco e non c’è inganno, solo un po’ di tecnologia che aiuta la natura.



Iconcetti sono simili anche quan do si parla di dietologia. Al bando le mode passeggere, il marketing che impone questo o quell’ali mento, le forme di alimentazione estreme. Prima c’era l’ossessione dei grassi, poi quella degli zuccheri, ora c’è chi vorrebbe eliminare per sempre i carboidrati. «Non piace neanche a me il modo in cui di solito si parla di alimentazione.
La base dell’alimentazione? La dieta mediterranea, sempre. Mangiare bene, riempiendo il piatto di colori e di gusto. Ma attenzione al fai da te: «La nutrizione è matematica»
Quello che va trasmesso al paziente è, molto semplicemente, l’importanza di un’alimentazione corretta. Bisogna mangiare bene. Adattando la dieta all’eventuale presenza di malattie e patologie. Nel caso di obesità e persone sovrappeso, ad esempio, ci sono terapie mirate, come la dieta chetogenica, che però va utilizzata sotto il controllo di un medico. Non ha senso improvvisa re, decidere da soli di non mangiare carboidrati, questo è il modo sbagliato di fare una dieta. C’è chi mi dice: “Io mangio solo insalata”. Ma questo è pericoloso, perché perdi massa musco lare e rallenti il metabolismo. Anche perché non basta perdere il peso. L’im portante è mantenere il peso perso». Insomma, il fai da te non funziona.
E quando la dottoressa Shamini parla di “semplicità” non intende dire che la cosa sia facile o approssi mativa. «La nutrizione è matemati ca. Io parto sempre da una misu razione della massa magra e della massa grassa. Non si può fare “ad occhio”, vanno misurate le quantità e seguite le regole, se vogliamo vedere dei risultati duraturi».
Sembra ovvio, ma vale la pena riba dirlo: non esiste la dieta universale. L’alimentazione va personalizzata. Le chiediamo se esistono comun que delle indicazioni minime, che possono andare bene per tutti, come base di partenza. «La dieta mediterranea, sempre. È ancora la migliore al mondo. Stando attenti a non mangiare olio in eccesso, o troppo fritto. E i dolci vanno limitati. Tutti sappiamo che cosa fa bene o fa male, il problema è riuscire a farlo» Anche perché spesso la questione è più psicologica che fisica. «La peggior partenza è quando mi dico no: “dottoressa non riesco”. Ci devi riuscire! È per il tuo benessere e la tua salute. Il nostro piano nutrizio nale bilanciato parte da una dieta molto varia, si mangia di tutto, carne, pesce, legumi, uova... Quello che cambia è il peso degli alimenti. Inoltre insegniamo alle persone che quando mangiamo lo facciamo già con gli occhi. Il piatto deve essere il più colorato e gustoso possibile, e allo stesso tempo poco calorico. La tristezza non aiuta la dieta, già abbiamo una vita stressante, il cibo non deve essere una sofferenza, così come non deve diventare uno sfogo». I “superfood” esistono davvero? «Certo. Ma anche qui con mode razione. Non ha senso nutrirsi di alimenti fuori stagione.
Servono probiotici o prebiotici. I prebiotici sono alimenti ricchi di fibre, antiossidanti. I probiotici sono yogurt, kefir, kimchi, alimenti fermentati. Ce ne sono tantissimi, spesso si tratta di alimenti che non si trovano in Italia. La curcuma va bene perché è in polvere, ma andrebbe sempre abbinata con qualcosa di piccante, pepe o pepe roncino, per valorizzare l’antios sidante. Yogurt e fermenti lattici sono importanti, ma non per tutti, così come le fibre, che non vanno bene per chi soffre di problemi intestinali. Insomma, è un mondo complesso». Come lo è quello degli integratori. «Io li utilizzo molto, ma vanno presi solo se serve. Per noi donne, ad esempio, la vitamina D è molto importante, già nella sta gione autunnale andrebbe integra ta, serve alle ossa, a darci energia, ad ammalarsi meno. Ma anche gli integratori vanno cambiati nel corso dell’anno. Bisogna prendere gli integratori ma non dipendere dagli integratori».
Aumentano sempre più le persone che scelgono di non mangiare car ne. E i vegani. «La dieta vegana è leggermente più povera rispetto alla mediterranea, quindi bisogna stare attenti. È fondamentale assumere la B12 e cambiare spesso gli alimen ti, altrimenti si rischiano carenze vitaminiche. L’alimentazione vegana va insegnata bene. Ma oggi ci sono tanti alimenti, tante ricette, anche sfiziose». Va bene anche il di giuno intermittente. «Anche questo valutato a seconda dei soggetti.
Cambia per le persone in sovrappeso o con patologie cardiovascolari». La filosofia di lavoro della dot toressa Shamini? La schiettezza. «Io sono molto sincera. Vedo la paziente, la ascolto, capisco di cosa ha bisogno e poi le dico cosa dovrebbe fare, ciò che è buono per lei, non ciò che vorrebbe sentirsi dire. Ognuno di noi è diverso. Non ho convinzioni da imporre. Non mi piace stressare le persone. Mi piace farle stare bene». Chi non vuole stare bene?
Possiamo quasi vederlo Giovanni Lindo Ferretti, con la cresta punk colorata, gli stivali dell’Armata Rossa, le braghe mi litari della DDR, mentre torna a casa dopo una giornata di prove con i suoi CCCP. Guida una vecchia R4 (rossa, naturalmen te). E mentre si avvicina alle sue colline, al paesino dell’Appennino in cui è nato, sente affiorare sulle labbra delle parole fuori tempo e fuori luogo: «Madre di Dio e dei suoi figli / Madre dei padri e delle madri / Madre! oh Madre, oh Madre mia / l’anima mia si volge a te». Una canzone citata spesso da chi si ostina a cercare una continuità, una logica (esistenziale, spirituale), un filo rosso (ancora) che unisca il Ferretti filo-sovietico e rivoluzionario con quello, criticatissimo, della “conversione”, della tradizione, dell’am mirazione devota per papa Benedetto XVI.
Ma il genio mistico e poetico va oltre le pole miche, le interpretazioni, le categorie. E lo si ritrova intatto in questo magnifico volumet to edito da Aliberti, Óra, in cui il libro stesso diventa tema e discorso.
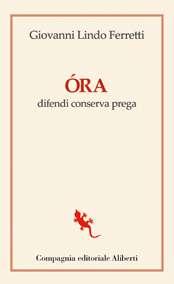
“difendi, conserva, prega”, recita il sottotito lo, rigorosamente in minuscolo. Dall’ultimo Pasolini all’ultimo Ferretti, che si dichiara “invecchiato”, “selvatico”, “residuale” (anche “stupido” e “debole”), che rievoca l’infanzia e la famiglia, che (re)cita e chiosa preghiere, esalta il Rosario, e poi rievoca canzoni e dischi che riascolta per la prima volta (la «dimensione religiosa» c’è sempre stata, lo riconosce anche lui). Ha creduto fosse una libera scelta, smettere di pregare. Ha ricominciato perché gli «si allargava il cuore». Orazioni, ricordi, pagine autografe, fotografie, ironie puntute sulla cultura del “produci e consuma”, parole imbevute di senso e umanità.
«Credo il pregare un ragionevole atto, intimo e sociale. Di valenza cosmica. Credo la preghiera fortezza pura, vivificante e il tempo del pregare un tempo eterno (...)
La mia preghiera, ne ringrazio Dio, è fiorita su un substrato pagano redento e salvato che mi appartiene. È cambiato l’orizzonte, la prospettiva, la teologia, non l’uomo che alza gli occhi al cielo pronunciando parole di lode, richiesta di aiuto, consolazione.
I miei avi pregavano, lo so.
Cammino gli stessi passi, gli stessi ambiti domestici, gli stessi spazi esterni nello stesso ordine di pensieri: si nasce, si vive, si muore.
Ci sono luoghi, momenti, situazioni in cui si può solo pregare e pregare fa la differenza.
Diventammo cristiani nella seconda metà del primo millennio, non è cambiato granché, da allora (...)
Ho imparato a pregare nel lettone di mia nonna prima di addormentarmi.
In casa eravamo solo io e lei, erano tempi difficili, di disgrazie, di dolore, ma non per me che crescevo bene e in salute.

Non c’era televisione né radio, chiacchieravamo, la nonna aveva le sue faccende, io le mie, il silenzio ci faceva compagnia, fortificava pensieri e azioni (...)
La preghiera apre uno spiraglio che concede al finito di percepire, accedere all’Infinito».
78MESE 2022
(Giovanni Lindo Ferretti)

WEB AGENCY www.mondored.it
 Laura Boella Donato Carrisi
Little Pieces of Marmelade Franco Michieli Alessandro Seidita Joshua Wahlen WoM Edizioni
Dove si parla di viaggi avventurosi senza bussola, di filosofia ed empatia, di serial killer che suscitano compassione, di BookCity e libri col buco, di musica rock liberatoria, di eremiti che cercano la verità nel silenzio e nella natura N 3 | NOVEMBRE 2022
Laura Boella Donato Carrisi
Little Pieces of Marmelade Franco Michieli Alessandro Seidita Joshua Wahlen WoM Edizioni
Dove si parla di viaggi avventurosi senza bussola, di filosofia ed empatia, di serial killer che suscitano compassione, di BookCity e libri col buco, di musica rock liberatoria, di eremiti che cercano la verità nel silenzio e nella natura N 3 | NOVEMBRE 2022