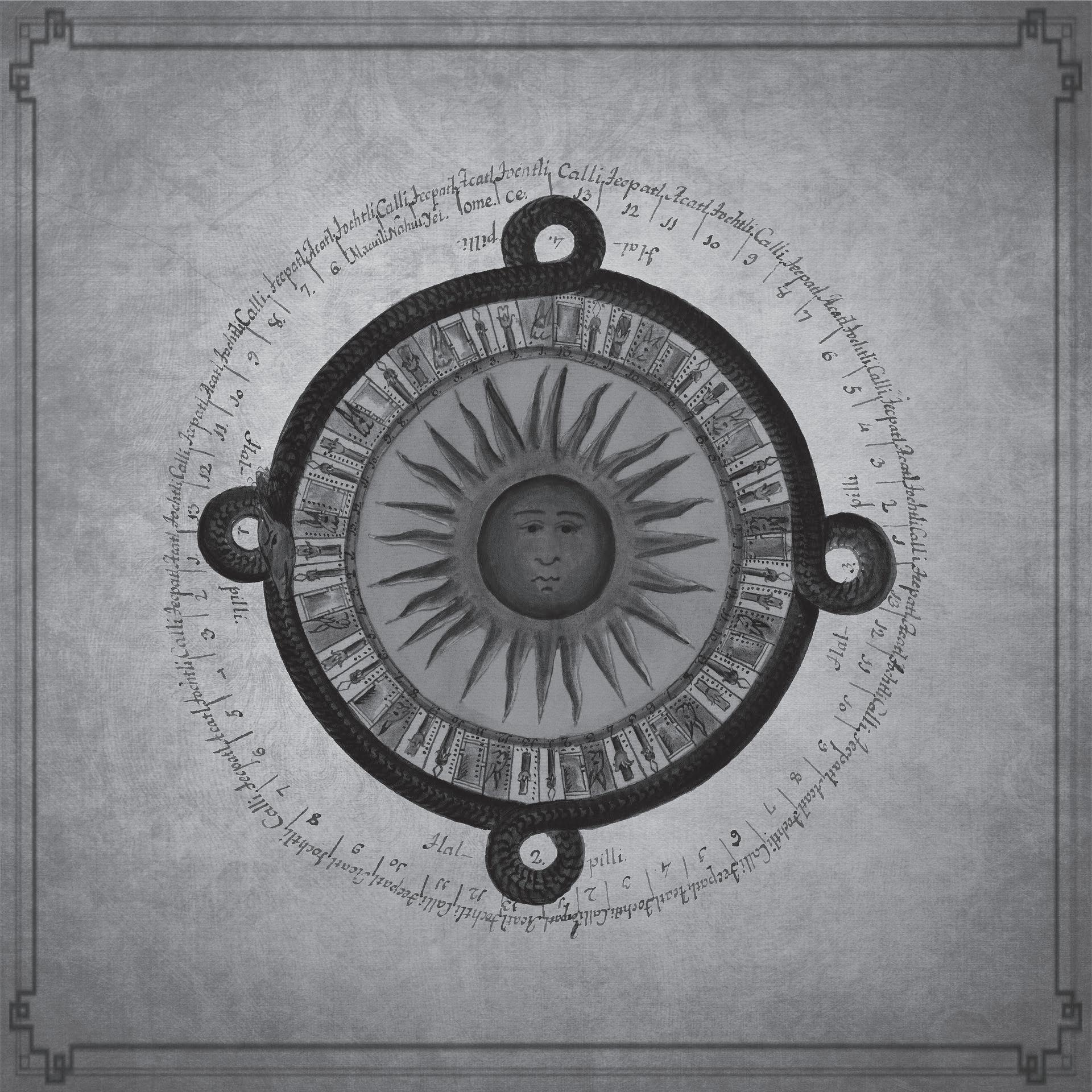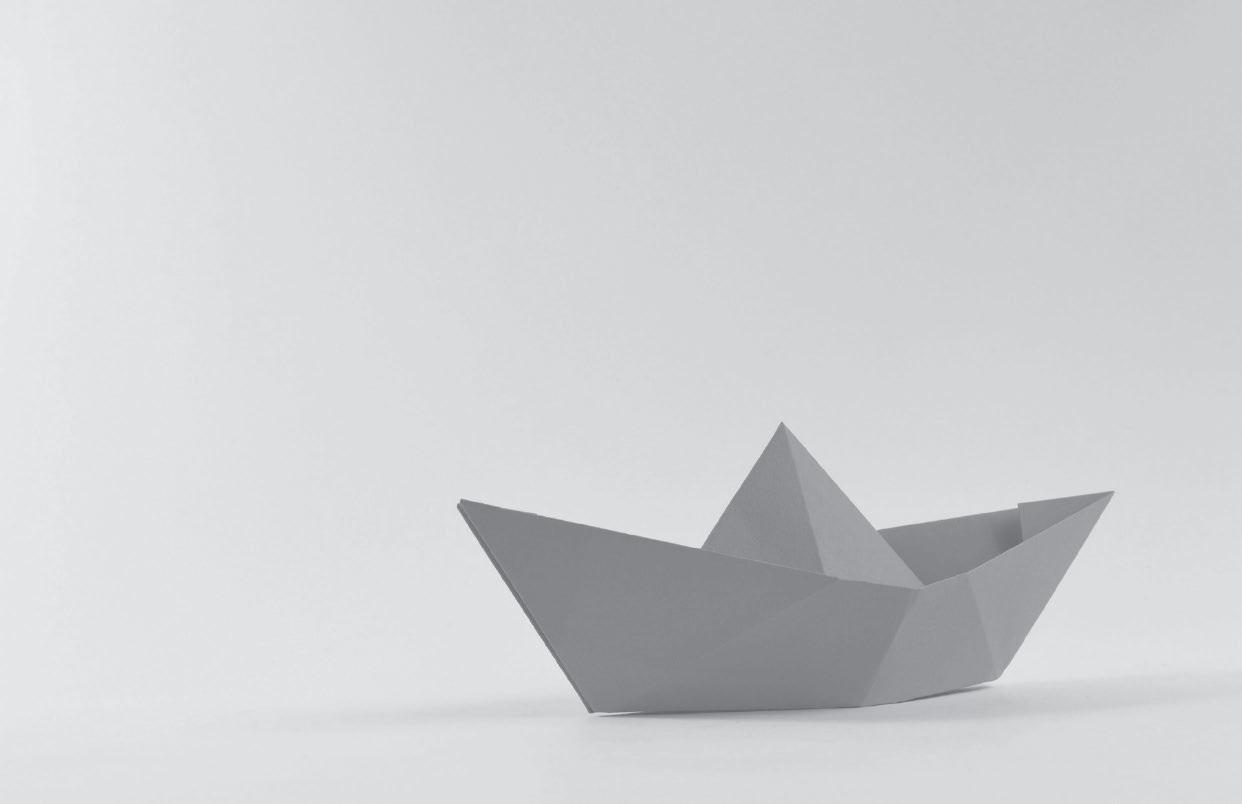L’ABBRACCIO
I figli venuti da lontano: I minori stranieri non accompagnati in Italia
Editoriale di S. E. Mons. Gian Carlo Perego
Minori stranieri non accompagnati: un impegno comune di Renato Franceschelli
Guerre, povertà, emergenze, carestie di Sandra Zampa
Come viene interpretata l’accoglienza dei minori stranieri?
C’è chi ispirato dalla spiritualità cristiana vede un’immagine giovanile di Dio.
C’è chi si riconosce nella spiritualità monoteistica e vede un giovane fratello.
C’è chi interpreta il DNA sociale di Genova e vede un’opportunità di energie giovani.
C’è chi è attento solo alla statistica.
C’è chi ne vede un problema di ordine pubblico Noi del CEIS interpretiamo l’accoglienza come dare a questi ragazzi la possibilità di far emergere in modo virtuoso i propri talenti accompagnandoli con un percorso sia educativo che formativo basato sulla costruzione di un rapporto di fiducia, in collaborazione con le istituzioni.

Convinti dell’importanza vitale di questo tema abbiamo chiesto a S.E. Mons. Gian Carlo Perego, Presidente della Fondazione Migrantes della CEI, di onorarci del suo editoriale e agli altri esperti più coinvolti di condividere le loro riflessioni e di questo siamo loro infinitamente grati.
Buona lettura!
Enrico Costa
Condizioni e protezione delle persone di minore età di Giuseppe Lococo
Il lungo viaggio dei minorenni stranieri non accompagnati di Carmela Pace
Minori Stranieri Non Accompagnati: quale realtà a cinque anni dalla legge Zampa? di Cristina Maggia
Quando lo Stato diventa genitore: la sfida dei minori stranieri non accompagnati di Daniele Frigeri
«Sono solo un ragazzo ma …voglio crescere!» di Carmelina Chiara Canta
Rivista trimestrale di informazione del CEIS Genova
16126 Genova • Via Asilo Garbarino, 6/B • Telefono 010.25.46.01 - Fax 010.25.46.002 r.a. N. 107 • 3° Trimestre 2022 • N. 3 del 2022 • Prezzo 1,00 euro Autorizzazione Tribunale di Genova 26/94 • Iscrizione al R.O.C. n° 16776 del 17/04/2008 Poste Italiane S.p.A. sped. abb. postale • D.L 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 N° 46) art 1 comma 1, DCB Genova 2022 n107
3
5
8
11
13
15
18
21
L’ABBRACCIO
Rivista trimestrale di informazione del CEIS Genova
Direttore responsabile Silvano Balestreri
Caporedattore Alessandro Censi Buffarini
In redazione Elisabetta Aicardi, Agnese Schiaffino
Hanno collaborato S.E. Mons. Enrico Costa, Renato Franceschelli, Sandra Zampa, Giuseppe Lococo, Carmela Pace, Cristina Maggia, Daniele Frigeri, Carmelina Chiara Canta
Direzione e redazione ASS. CENTRO DI SOLIDARIETÀ di GENOVA
Via Asilo Garbarino, 6 B 16126 Genova Telefono 010.25.46.01 Fax 010.25.46.002
Impaginazione Xedum srl
Stampa RESTART di Marina Cosco & C. sas Autorizzazione Tribunale di Genova 26/94 Sped. abb. postale 50% - Genova
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Presidente CEIS Genova Enrico Giuseppe Costa
Direttore Generale CEIS Genova Paolo Merello
Chi siamo
Fondazione Centro Di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus
Centro Di Solidarietà Di Genova Coop. Sociale Onlus
Associazione Centro Di Solidarietà Di Genova Onlus
Multiservice Società Cooperativa Sociale Il Boschetto Di Campi – Società
Cooperativa Agricola E Sociale
Ceis Genova Sport- Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. Unipersonale
Dove possiamo
incontrarci
Siamo anche in tutta Italia
Fassolo
Via Asilo Garbarino, 6-9/B - 16126 Genova Telefono 010.25.46.01 - Fax 010.25.46.002 ceisge@ceisge.org fondazione@pec.ceisge.org www.ceisge.org
Trasta
Salita Cà dei Trenta, 28 16161 Genova
Casa Bozzo


Via Edera 22 16144 Genova
Casa Apollaro
Via Cavassolo 23 16022 Davagna (GE)
Galata
Via Galata 39 16121 Genova
Loano
Via Sant’Agostino 13 17025 Loano (SV)
Quiliano
Via Convento 30 17047 Quiliano (SV)
Gianelline San Fruttuoso
Salita Nuova Signora del Monte 3B- 16143 Genova (GE)
LA NOSTRA FILOSOFIA
Siamo qui perché non c’è alcun rifugio dove nasconderci da noi stessi. Fino a quando una persona non confronta se stessa negli occhi e nei cuori degli altri, scappa. Fino a che non permette loro di condividere i suoi segreti, non ha scampo da questi. Timoroso di essere conosciuto né può conoscere se stesso né gli altri, sarà solo. Dove altro se non nei nostri punti comuni possiamo trovare un tale specchio? Qui insieme una persona può alla fine manifestarsi chiaramente a se stessa non come il gigante dei suoi sogni né il nano delle sue paure, ma come un uomo parte di un tutto con il suo contributo da offrire. Su questo terreno noi possiamo tutti mettere radici e crescere non più soli come nella morte, ma vivi a noi stessi e agli altri.
Aosta
Venezia Mantova Reggio Emilia Modena Bologna Ravenna La Spezia Pistoia Prato Firenze Arezzo Jesi Spoleto Muccia Viterbo Anguillara Civitavecchia
Roma Alba Adriatica Pescara Anzio Formia Caserta Avellino Bari Gravina Cosenza Catanzaro Messina Reggio Calabria Catania Cagliari
2 L’ABBRACCIO
Ivrea Torino Varese Vercelli Sanremo Genova Milano Piacenza Parma Cremona Verona Vicenza Trento Bolzano Belluno Treviso Padova
I figli venuti da lontano: I
minori stranieri non accompagnati
in Italia
Editoriale di S. E. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
della CEI
Gli sbarchi nei porti del Mediterraneo e dell’Adriatico o del Tirreno, i valichi delle frontiere – entrambi cresciuti del 70% nel 2022 rispetto all’anno precedente - ci hanno fatto incontrare sempre di più in questi anni i volti di migranti minori non accompagnati. Non è un fenomeno nuovo, ma che sempre ha accompagnato le migrazioni, anche le migrazioni italiane, come ci ricorda il noto racconto di Edmondo De Amicis “Dagli Appennini alle Ande”, che ricorda il viaggio di un bambino genovese alla ricerca della madre emigrata in Argentina.
I minori stranieri non accompagnati sono ragazzi e ragazze che arrivano in Italia senza i genitori e senza un adulto che sia per loro legalmente responsabile. Per questo motivo sono particolarmente vulnerabili e necessitano di una speciale protezione: devono essere collocati in un luogo sicuro, familiare che garantisca condizioni di accoglienza, di tutela e di integrazione adeguate. Il loro numero è significativamente aumentato negli ultimi dieci anni passando dai circa 3000 all’anno del 2011 agli oltre 13.000 nel 2014 e nel 2020 ai previsti 10.000 di quest’anno. In accoglienza in Italia nel luglio 2021 risultano oltre 8000 minori stranieri non accompagnati; a ottobre 2022 sono oltre 15.000 i minori stranieri non accompagnati, con quasi un raddoppio. Una prima considerazione è che l’85% dei MSNA presenti sul territorio italiano, confermando una tendenza ormai consolidata, sono 16-17enni, ormai prossimi alla cosiddetta “maggiore età”, che segna la sospensione delle protezioni dovute per legge ai minori in genere e anche ai minori stranieri non accompagnati che possono far conto, fin quando restano tali, di una specifica protezione.
Una seconda considerazione è che oltre la metà di
questi minori stranieri non accompagnati non trovano subito una collocazione in un contesto familiare o di casa-famiglia, ma il più delle volte in strutture di accoglienza provvisorie o nei CAS, cioè nei Centri di Accoglienza Straordinari.
Una terza considerazione è che la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sul nostro territorio considerano l’Italia una tappa del loro cammino verso l’Europa: dal 2017 al 2022 sono oltre 150.000 i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia e ne sono rimasti solo il 10%, cioè 15.000.
Da queste considerazioni viene una prima indicazione: serve, e manca in Italia, un sistema diffuso e strutturale di accoglienza familiare dei minori non accompagnati che risponda alle esigenze della legge Zampa del 2017, ma che tenga anche presente della necessità di considerare la diversa età, ma soprattutto di accompagnare dopo la maggiore età il minore e di monitorare il cammino di un minore dall’Italia verso altri Paesi europei.
La distribuzione dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nelle Regioni italiane non è certamente omogenea. Si rileva una grande concentrazione in Sicilia (oltre il 30%), terra di porti e di sbarchi dal Mediterraneo, seguita dalla Puglia (10%), altra regione interessata dagli arrivi dal Mediterraneo e dall’Adriatico, dal Friuli-Venezia Giulia (10%), regione di frontiera con i Balcani e dalla Lombardia (10%), dove più forte si sente l’attrazione della possibilità di lavoro e delle catene migratorie.
Se la concentrazione delle presenze interessa maggiormente queste regioni, pure tutte le regioni italiane sono interessate dal fenomeno, con numeri
L’ABBRACCIO 3
e Presidente della Fondazione Migrantes
anche rilevanti, come l’Emilia-Romagna, la Calabria e il Lazio.
Per le ragazze la distribuzione varia in parte: al primo posto sempre la Sicilia e la Puglia al secondo, ma il Piemonte è al terzo posto.
Da questa distribuzione dell’accoglienza emerge una seconda indicazione: c’è una differenziazione dell’accoglienza dei minori nelle diverse regioni.
I volti e le storie dei minori stranieri non accompagnati arrivati in questo ultimo decennio in Italia sono stati diversi. Abbiamo avuto minori provenienti dall’Albania, dalla Romania, dall’Ucraina, dalla Moldavia: un volto europeo; dalla Tunisia, dal Marocco, dall’Egitto: un volto Nord Africano; dalla Costa d’Avorio, dal Mali, dalla Guinea e dalla Nigeria: un volto centro-africano; dalla Somalia, dall’Eritrea: un volto dell’Africa orientale; dalla Siria, dalla Palestina: un volto Medio-Orientale, dall’Afganistan, dall’Iran, dal Pakistan, dal Bangladesh: un volto orientale, dal Perù, dall’Equador, dalla Colombia: un volto latino americano.
Da questi volti e storie diverse dei minori stranieri non accompagnati viene una terza indicazione: servono risposte e strutture diverse, mediazioni linguistiche diverse e un progetto educativo condiviso.
Tutti i minori, compresi i MSNA che entrano in Italia, sono titolari dei diritti sanciti dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989), che stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti il minore, senza alcun tipo di discriminazione, si debba considerare come preminente il suo superiore interesse.
Il cosiddetto sistema Dublino considera “l’interesse superiore del minore” un criterio fondamentale per la determinazione dello Stato membro competente a esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da un minore straniero non accompagnato. In Italia, la più recente normativa per la protezione dei MSNA (l. 47/2017 detta legge Zampa) ha riaffermato il principio del superiore interesse del minore con particolare riferimento ad alcuni aspetti.
La l. 47/2017 ha introdotto una procedura unica di identificazione dei MSNA, con l’obiettivo di uniformare le diverse prassi a livello nazionale, Tutti i minori, compresi i MSNA che entrano in Italia, sono titolari dei
diritti sanciti dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989), che stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti il minore, senza alcun tipo di discriminazione, si debba considerare come preminente il suo superiore interesse.
Il cosiddetto sistema Dublino considera “l’interesse superiore del minore” un criterio fondamentale per la determinazione dello Stato membro competente a esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da un minore straniero non accompagnato.
La legge Zampa ha, in primo luogo, chiesto agli enti locali di privilegiare l’affido familiare al posto dell’inserimento in una struttura di accoglienza (art. 7) e di attuare specifiche azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sulla possibilità di diventare affidatari.
Con la legge 47/2017 l’Italia si è dotata di un quadro normativo avanzato in materia di riconoscimento dei diritti e protezione dei MSNA. Tale legge ha ribadito il principio assoluto di non respingimento nei confronti di MSNA, ha introdotto nuove disposizioni in merito alle misure di identificazione, ha previsto la creazione di una cartella sociale per ciascun minore, ha introdotto la figura nuova del tutore volontario e le disposizioni per favorire l’effettività del diritto all’istruzione e alla salute
A fronte della legge Zampa, il modello di accoglienza, le strutture di accoglienza e i percorsi differenziali di tutela indicano una distanza tra l’affermazione di un diritto del minore straniero non accompagnato di essere accolto in un contesto familiare e la realtà.
In conclusione, a fronte di una nuova legislazione a tutela dei minori stranieri non accompagnati, nata anche dalle esperienze realizzate dal mondo ecclesiale, del volontariato e del terzo settore il cammino di identificazione, di accoglienza, di tutela e di integrazione del minore straniero non accompagnato chiede di assumere un volto familiare, diffuso sostitutivo delle figure parentali ed educative lontane per accompagnare all’età adulta.
Un cammino ancora pieno di ostacoli burocratici, di pregiudizi che faticano ad essere superati per riuscire a dare da subito una famiglia a un minore straniero non accompagnato che arriva nelle nostre città, nel nostro Paese, in Europa.
Per un approfondimento del tema: D. SIMEONE ( cura di), Transizioni. Un patto educativo per i minori stranieri non accompagnati, Milano, Vita e pensiero, 2022.
4 L’ABBRACCIO
Minori stranieri non accompagnati: un impegno comune
di Renato Franceschelli, Prefetto di Genova
Il fenomeno migratorio che ha interessato a partire dagli anni ’90 il nostro Paese con numeri sempre più consistenti ha ricompreso una quota sempre più importante di minori che giungono privi di qualunque sostegno genitoriale o parentale.
Tale fenomeno non è solo italiano ma ha interessato e continua a interessare gran parte dei Paesi Europei.
Dai dati riportati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 30 giugno 2022 risultano censiti in Italia oltre 1700 minori non accompagnati di cui 718 in Liguria.
Il dato è sicuramente sottostimato per il non sempre contestuale inserimento dei dati nella banca dati del Ministero ma anche per i minori che non vengono intercettati e presi in carico presso i centri.
A riprova di ciò il fatto che il solo Comune di Genova tra il gennaio e l’ottobre 2022 ha preso in carico 670 minori. In questi ultimi anni al fenomeno che grava pesantemente sui Comuni, anche in termini finanziari, lo Stato ha dato risposta con l’ampliamento dei posti disponibili e finanziati nelle strutture dei Progetti SAI e l’elevazione delle quote rimborsate ai Comuni per le spese di accoglienza.
Va comunque notato che tale apprezzabile sforzo, resosi necessario anche in ragione degli eventi dell’Afghanistan prima e dell’Ucraina da ultimo, ha tempi di realizzazione e di selezione dei progetti, spesso incompatibili con la necessità di dare risposte urgenti alla necessità di protezione di minori che quotidianamente sono introdotti sul territorio.
Dai report del Ministero del Lavoro si rileva anche un dato, che trova conferma per il territorio genovese, di
una presenza per oltre il 60% di minori compresi nelle fasce di età 16 – 17 anni.
Sul nostro territorio le nazionalità maggiormente rappresentate confermano il quadro nazionale con un incremento di presenze tunisine e egiziane.
Tali numeri non si giustificano con la presenza di un importante varco di confine quale il porto di Genova, ma è invece conseguenza di movimenti interni al nostro Paese di minori che si spostano soprattutto da e verso le Regioni del Nord (Lombardia e Piemonte in particolare).
La normativa italiana, in ossequio agli obblighi internazionali di protezione dei minori e alla normativa europea in materia, ha da ultimo con la c.d. “Legge Zampa” definito il percorso di accoglienza e di tutela degli stranieri minori.
Particolare attenzione viene giustamente rivolta ai percorsi di educazione e integrazione che per ciascun minore devono essere assicurati nei centri di accoglienza.
La pressione alla quale sono sottoposte le Amministrazioni Comunali rischia di andare a detrimento della qualità dell’accoglienza e dei servizi educativi.
La ricerca, spesso affannosa di posti dove accogliere, ha inevitabilmente spinto in alcune occasioni a soluzioni alloggiative certamente non idonee, ma espongono anche al rischio concreto che gli operatori delle strutture si trovino in difficoltà a seguire ospiti in numeri non confacenti ai progetti presentati o addirittura a far fronte alla difficoltà di trovare operatori qualificati, situazione già verificatasi anche per gli operatori che gestiscono i Centri di Accoglienza Straordinaria per gli stranieri adulti.
L’ABBRACCIO 5
Non possiamo nascondere comunque il fatto che, proprio in ragione della stragrande maggioranza di minori rientranti nella fascia 16 / 17 anni, fra di essi si nascondano anche maggiorenni che, in mancanza di documenti, si definiscono minorenni per beneficiare delle migliori condizioni di accoglienza e soprattutto dell’inespellibilità che spetta ai minorenni.
Occorre pertanto uno sforzo comune al quale non possono sottrarsi né l’Autorità Giudiziaria minorile né le Autorità Sanitarie regionali, affinché la verifica dell’effettiva età avvenga in tempi rapidi e adeguati alle circostanze in tutti quei casi nei quali esista il fondato sospetto di una strumentale dichiarazione di minore età. Ciò deve avvenire, a mio parere, proprio nell’interesse prioritario del minore verso il quale vanno indirizzati risorse e professionalità in un percorso educativo e professionalmente indirizzato senza disperderle verso soggetti che non ne sono legittimi destinatari.
Gli episodi di violenza all’interno dei centri educativi o addirittura gli episodi di natura delinquenziali compiuti da alcuni ospiti nei mesi passati sono deprecabili e vanno affrontai con la necessaria determinazione. L’eco di tali gesta, ampiamente riportato dalle cronache giornalistiche, ha giustamente destato preoccupazione nella popolazione residente nelle zone interessate.
Un’attenta attività di prevenzione e di investigazione operata dalle Forze di Polizia ha consentito di individuare la gran parte degli autori dei fatti denunciati.
Tali comportamenti criminali, spesso reiterati, meritano interventi sanzionatori da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile anche per l’evidente effetto educativo che ha nei confronti dei coetanei ospiti della stessa Comunità. Il rispetto delle regole e un comportamento consono alla vita della comunità non può ottenersi con una “militarizzazione” della stessa. La richiesta di presidi fissi di Polizia o l’introduzione di vigilantes all’esterno o, peggio ancora, all’interno delle comunità sono, a mio parere, non solo improprie e non previste ma rappresentano il fallimento di un programma educativo che non riesce evidentemente nel suo scopo se non con la dimostrazione della “forza”
Compete certamente a chi è gestore di tali comunità mettere in campo le risorse e lo sforzo affinché i regolamenti, che pure in ciascun ambito devono esistere, vengano rispettati.
L’osservanza delle regole è l’impegno che ciascun genitore pone nell’educazione di un figlio. Lo stesso vale per chi si adopera in un percorso di crescita e di educazione di un minore. Spetta alle Amministrazioni valutare la congruità degli operatori previsti e vigilare affinché le presenze siano effettivamente assicurate.
Non posso esimermi da due ultime considerazioni. I numeri che stanno interessando soprattutto la città di Genova non possono essere certamente casuali. Sicuramente un effetto va riconosciuto ad un “tam tam” che fornisce informazioni sulla garanzia di accoglienza

6 L’ABBRACCIO
finora sempre assicurata dal territorio. Ma fondato è il sospetto che dietro a tali arrivi ci sia una regia di sfruttatori che non solo operano per assicurare l’ingresso clandestino nel Paese ma indirizzino i minori verso le località nelle quali possono trovare sistemazione. Il rischio che tali soggetti manipolino la vita di questi ragazzi anche destinandoli ad attività criminali, è un rischio che va prevenuto. A tal fine è lo sforzo delle Forze di Polizia territoriali nell’investigare sui rapporti e i contatti che i ragazzi hanno nelle fasi del viaggio e dell’arrivo ma sono convinto che l’attività d’indagine debba necessariamente svilupparsi ed intensificarsi sotto la guida della Direzione Nazionale Antimafia per approfondire i legami di criminalità internazionale e organizzata che probabilmente governa il fenomeno. Parimenti il fenomeno dei minori non accompagnati merita una riflessione politica. L’utilizzo di tale modalità di ingresso da parte di un così considerevole numero
di soggetti in maggior parte ai limiti della minore età, rappresenta sicuramente un escamotage utilizzato dai trafficanti e dalle famiglie di origine per avviare i giovani verso migliori condizioni di vita. Tralasciando coloro che fuggono da guerra e pericoli di vita, la maggior parte di essi sono da considerarsi migranti economici. Il fenomeno è, a mio parere, anche la diretta conseguenza di una inefficace politica di ingressi legali che ha caratterizzato il nostro Paese negli ultimi decenni. L’oggettiva impossibilità di canali di ingresso legale ha accentuato il ricorso strumentale alle domande di asilo per i maggiorenni e l’ingresso di minori non accompagnati.
Mi auguro che un sereno dibattito nel Paese possa trovare, anche alla luce delle esperienze presenti in altri Paesi europei, delle soluzioni che riescano a soddisfare i bisogni del mercato del lavoro con una più efficace politica dei visti e di soggiorno.
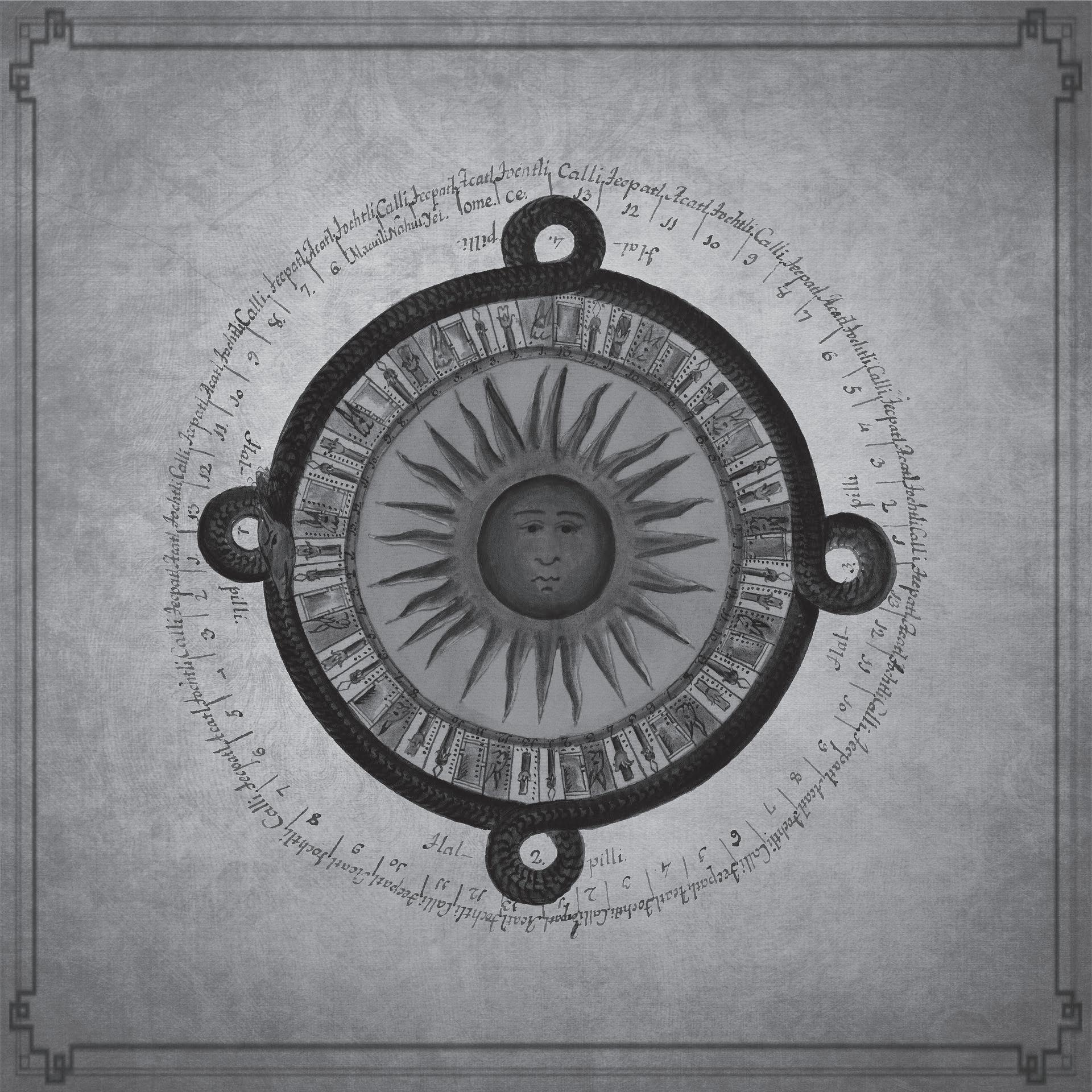
7
Guerre, povertà, emergenze, carestie
Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in prevalenza in Italia, come in Grecia e in Spagna, e dalla terra di primo sbarco raggiungono gli altri paesi europei, ha origini lontane nel tempo (venti anni) e occupa da tempo un posto importante nel dibattito pubblico e istituzionale italiano tanto da avere visto venire alla luce una legge all’avanguardia che l’Europa indica come un modello. Parliamo della legge 47 del 2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) che ha suscitato, al momento della sua approvazione, un consenso larghissimo sia a livello politico che presso le organizzazioni che operano a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza così come dei migranti. In una sintesi ammirevole per efficacia, Papa Francesco indicò con quattro verbi le azioni necessarie a dare risposta al grande tema dei minori migranti: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Dentro a questo perimetro si muovono le norme messe in campo dalla legge di cui sono stata prima firmataria e ostinata promotrice.
Una carica innovativa straordinaria solo in parte compresa. Si è dovuto attendere anni per i decreti attuativi (l’ultimo di qualche mese fa lo dobbiamo all’iniziativa della ministra Lamorgese), ma soprattutto c’è stata scarsa corrispondenza tra l’impegno a realizzare il dettato normativo rispetto all’entusiasmo che ha accompagnato l’approvazione della legge e all’innovazione che essa porta con sé. La fatica del cambiamento è stata in parte rigettata dal sistema burocratico-amministrativo. E anche la risposta dei tutori volontari che nei mesi immediatamente successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge è stata importante, ha dovuto fare i conti con la disattenzione o la freddezza burocratica delle istituzioni anche della giustizia minorile. Così come non è mai decollato l’affido familiare e insufficiente continua ad essere l’impegno a fare in modo che i tempi del passaggio dalla prima alla seconda accoglienza (i più
rischiosi perché favoriscono la “scomparsa” dei minori) siano rispettati secondo le indicazioni normative. Non ancora sufficiente la progettazione pubblica per attuare una vera integrazione: vi sono davvero eccellenti realizzazioni ma c’è una grande disomogeneità nei territori. Quanti altri ragazzi potrebbero essere “salvati” dall’abbandono e integrati in modo reale in ragione di percorsi scolastici e di formazione professionale? Mi domando se ce lo chiediamo abbastanza. Ma andiamo per ordine.
La legge ha il merito di avere sistematizzato la materia ancorandola ai principi internazionali, primo tra tutti la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e sul diritto interno relativo alla tutela dei minori. A fondamento della legge l’affermazione del principio della parità di trattamento dei minori stranieri (ossia di paesi esterni all’Unione europea, a cui essa si applica) con i minori italiani o dell’Unione Europea.
Tra le conquiste più solide la normativa registra il divieto esplicito del respingimento del minore non accompagnato alla frontiera e la sua espulsione (art. 3) salvo casi eccezionali (ossia motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, secondo quanto previsto dal Testo Unico Immigrazione), in cui è comunque necessario un provvedimento del Tribunale per i minorenni che non può essere emesso a fronte di “un rischio di danni gravi per il minore”.
L’art. 5, contiene una delle disposizioni più innovative della legge che colma un preoccupante vuoto normativo, sancendo regole per l’identificazione del minore e l’accertamento della sua età in caso di dubbio. In questo modo si sottrae “il destino” del minore alla discrezionalità amministrativa, essendo previsto il coinvolgimento della magistratura minorile in un ruolo di garanzia. In particolare, la normativa crea un sistema unico che richiede il rispetto di criteri essenziali nella determinazione dell’età, quali il principio di gradualità
8 L’ABBRACCIO
di Sandra Zampa, senatrice e prima firmataria della legge 47/2017 (Protezione dei MSNA)
delle azioni previste ai fini dell’accertamento, la minore invasività possibile del metodo utilizzato, la presunzione di minore età, il beneficio del dubbio, l’efficace informazione al minore e a chi lo rappresenta, ovvero il tutore, e l’accesso a un ricorso effettivo. In particolare la legge stabilisce che l’identificazione del minore a cura delle autorità di pubblica sicurezza vada svolta alla presenza di un mediatore culturale e che l’eventuale accertamento della sua età – qualora e soltanto se sussista un dubbio su quanto dichiaratodebba basarsi in via principale sulla documentazione in possesso del migrante e soltanto in seconda battuta, se il dubbio è fondato e persiste, su esami sociosanitari multidisciplinari disposti dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni, sino all’adozione di un provvedimento giudiziario di attribuzione dell’età. Si tratta di una vera rivoluzione, questa volta davvero compiuta. Quanti si sono occupati del problema conoscono la confusione, la discrezionalità e l’enorme ingiustizia che hanno contraddistinto l’operato delle amministrazioni e delle burocrazie.
Negativo invece il bilancio relativo all’articolo 4 secondo cui la durata massima della prima accoglienza deve essere compresa in 30 giorni alla scadenza
dei quali ha luogo il collocamento nel sistema di accoglienza diffuso – ora SAI, Sistema di accoglienza e integrazione (art. 12). La materia dei permessi di soggiorno è stata semplificata (art.10), in quanto le nuove norme prevedono due soli tipi di permesso: per minore età (su richiesta del minore anche prima della nomina del tutore) e per motivi familiari (in caso di affidamento in famiglia). Su questo una profonda novità riguarda la conversione dei permessi per minore età al compimento del diciottesimo anno in permessi di altro tipo (studio, lavoro o attesa occupazione), procedura che viene sottoposta alle norme sul silenzio-assenso (art. 13 co. 1) e non può, di conseguenza, essere sospesa a tempo indefinito dal mancato rilascio del parere.
Le norme inoltre trasferiscono al Tribunale per i minorenni le competenze in materia di rimpatrio assistito del minore (art. 8 co.1), prima disposto dall’autorità amministrativa, e consolidano quelle relative al prolungamento dell’affidamento ai servizi sociali oltre il compimento della maggiore età e sino al ventunesimo anno d’età (c.d. “prosieguo amministrativo”),
Come ho già accennato resta al palo la straordinaria opportunità offerta dall’articolo 7 che attribuisce agli

L’ABBRACCIO 9
enti locali un ruolo di sensibilizzazione sull’affidamento familiare, considerato da prediligere all’accoglienza in strutture. Su questo l’iniziativa dei comuni che pure nella fase di elaborazione e approvazione della legge è stata importante, si è rivelata pressoché nulla.

Tutt’altro destino hanno avuto le disposizioni relative ai tutori volontari, privati cittadini che mettono a disposizione tempo, capacità e disponibilità anche emotiva per seguire i minori stranieri privi di punti di riferimento familiare in Italia. Il Paese rimase sorpreso quando si fecero avanti ma le istituzioni non sono state sempre all’altezza della loro generosità.
La loro nomina è stata facilitata attraverso l’istituzione di appositi elenchi presso ogni Tribunale per i minorenni, composti da nominativi di persone selezionate e formate dai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza (art. 11). In base alla norma ogni tutore può esercitare la tutela per un massimo di tre minori, così garantendo un rapporto personale prima esistente solo in alcune virtuose realtà, essendo in larga parte la tutela dei MSNA rimessa ai Comuni. Ma molti ostacoli, davvero troppi, vengono messi ancora sul loro cammino. Tempi lunghi della magistratura minorile, disinteresse per i problemi che incontrano nell’esercizio del proprio ruolo, incomprensioni con le istituzioni coinvolte nel percorso,
scarso ascolto. Elementi negativi che finiscono con il “frustrare” i tutori. Molte per fortuna le esperienze di successo realizzate in tante regioni del Paese spesso grazie all’intelligenza e alle capacità del volontariato sostenuto da saggi amministratori. Sono convinta che sarebbe opportuno diffonderne la conoscenza perché mostrano che la strada per realizzare integrazione si può percorrere con successo. Quale Paese può essere così cieco da non comprendere che investire sui giovani stranieri – tanto più nel pieno di un inverno demografico – significa lavorare per la collettività e non sprecare risorse valorizzando vite e competenze?
In questi anni ho avuto modo di vedere personalmente progetti di integrazione realizzati in comunità di seconda accoglienza. Per arrivare a “promuovere” e “integrare”, per tornare ai verbi scelti da Papa Francesco, occorre ascoltare seriamente i ragazzi e le ragazze: se hanno un progetto per il futuro, qual è il paese scelto per la destinazione finale, se ci sono familiari rispetto ai quali si progettano ricongiungimenti, qual è la condizione della famiglia. Lavorare con loro con la fiducia che possano riuscire, e con la pazienza necessaria a comprendere e a far comprendere la diversità. Il Ceis lo sa fare molto bene e di questo tanti tra noi, oltre ai ragazzi, siamo grati.
10 L’ABBRACCIO
Condizioni e protezione delle persone di minore età
Quasi la metà degli sfollati forzati nel mondo ha meno di diciotto anni. Si stima infatti che mentre le persone di minore età rappresentano circa il 30% della popolazione mondiale, le ragazze e i ragazzi sotto i 18 anni costituiscono il 41% delle persone costrette a fuggire. Il loro numero è in costante crescita. Alla fine del 2021 il numero di persone costrette a fuggire a causa di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e turbative dell’ordine pubblico ha superato gli 89 milioni, ben l’8% in più rispetto all’anno precedente. Il numero di Paesi colpiti da conflitti è raddoppiato nell’ultimo decennio, con donne e bambini esposti in modo sproporzionato a discriminazione radicata ed estrema vulnerabilità. Nel 2022 è scoppiato il conflitto in Ucraina. Si tratta di una delle più grandi crisi di sfollamenti forzati dalla Seconda guerra mondiale. Ciò insieme alle altre emergenze
dall’Africa all’Afghanistan, ha spinto il numero degli sfollati forzati oltre la soglia dei cento milioni. Le persone sfollate all’interno dei propri Paesi poi, rappresentano circa il 60% di tutte le persone sfollate. Circa il 45% delle persone sfollate all’interno dei loro Paesi sono minorenni. La proporzione varia a seconda dei luoghi. Ad esempio, in Niger, Burkina Faso, Somalia, Afghanistan e Yemen i bambini hanno costituito una quota sostanzialmente maggiore della popolazione sfollata rispetto agli adulti. In Colombia, invece, le persone minorenni hanno rappresentato il 23% della popolazione sfollata. Non vanno poi dimenticati i bambini e le bambine apolidi. Si stima che alla fine del 2021 oltre 4,3 milioni di persone nel mondo fossero apolidi o di cittadinanza indeterminata. Non riconosciuti come cittadini da nessuno Stato, gli apolidi spesso non sono in grado di accedere ai servizi essenziali e di godere dei diritti fondamentali, compresi

1Global Trends 2021, UNHCR, https://www.unhcr.org/publications/brochures/62a9d1494/global-trends-report-2021.html
2https://www.unicef.org/press-releases/despite-significant-increase-birth-registration-quarter-worlds-children-remain
3Raccomandazioni del tavolo apolidia sulla protezione degli apolidi e sulla riduzione dell’apolidia in Italia, Tavolo Apolidia, https:// tavoloapolidia.org/app/uploads/2021/09/Advocacy-Paper-Tavolo-Apolidia_2021_def.pdf
L’ABBRACCIO 11
di Giuseppe Lococo, Rappresentante UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati,) per l’Italia, Santa Sede e Repubblica di San Marino
l’accesso all’istruzione ed all’assistenza sanitaria. La stima rappresenta un aumento rispetto al 2020. Tale aumento deriva da diversi fattori, quali nuovi Paesi che hanno riportato dati sulla popolazione apolide, migliori sistemi di registrazione, ma anche la nascita di bambini, nati apolidi1 . Va ricordato a questo proposito che l’iscrizione della nascita di ogni figlio in un registro civile è fondamentale in quanto fornisce ai bambini la prova dell’identità legale, presupposto per la capacità di esercitare i diritti e di accedere ai servizi. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile hanno riconosciuto l’importanza della registrazione delle nascite, impegnandosi a fornire identità legale a tutti, inclusa la registrazione delle nascite, entro il 2030. Tuttavia, nonostante i significativi progressi globali nella registrazione delle nascite, l’UNICEF ha stimato che un bambino su quattro sotto i cinque anni di età - circa 166 milioni - non era registrato alla fine del 20192. In Italia, secondo le stime disponibili, vivono circa 3.000 persone apolidi, di cui molti sono minorenni3 . Nonostante l’Italia si ponga all’avanguardia nel contrasto all’apolidia e possa vantare un sistema di registrazione delle nascite pienamente efficace, sono ancora numerosi i casi in cui la condizione dei genitori viene trasmessa ai figli che nascono quindi apolidi, un fenomeno che colpisce in particolare le comunità Rom.
Molti bambini rifugiati trascorrono tutta la loro infanzia in sfollamento, incerti sul loro futuro. I bambini, siano essi rifugiati, sfollati interni o apolidi, corrono un rischio di abusi, negligenza, violenza, sfruttamento, tratta o reclutamento forzato in gruppi armati maggiore rispetto agli adulti. Possono sperimentare e assistere a eventi inquietanti o essere separati dalla propria famiglia. Allo stesso tempo, la famiglia e altre reti di supporto sociale possono essere indebolite e l’istruzione interrotta. Queste esperienze possono avere un profondo effetto sui bambini, dall’infanzia all’adolescenza. In occasione di emergenza e sfollamento, le ragazze affrontano particolari rischi di protezione legati al genere. Bambini e bambine sono anche molto resilienti e trovano il modo e la forza di andare avanti nonostante
le difficoltà e la sofferenza. Traggono forza dalle loro famiglie e trovano gioia nelle amicizie. Frequentando la scuola, praticando lo sport, avendo il necessario spazio creativo per scoprire e valorizzare i loro talenti e utilizzare le loro abilità, i bambini e le bambine possono essere membri attivi della loro comunità. C’è bisogno di lavorare con loro e metterli in grado a difendere i propri diritti. I diritti dei bambini sono sanciti a livello internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (UNCRC)4. Si tratta del principale strumento giuridico in materia di protezione dei minorenni e comprende quattro principi generali, che informano l’intera Convenzione: l’interesse superiore del minore, la non discriminazione, Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto all’ascolto ed alla partecipazione. Accanto a questi quattro principi, la Convenzione prevede una serie di diritti fondamentali che comprendono tra gli altri, la necessità di fornire protezione da abusi, sfruttamento ed abbandono, nonché l’importanza dello sviluppo fisico ed intellettuale del minore. Essa dedica particolare attenzione al ruolo della famiglia nell’assicurare assistenza alle persone di minore età ed alle esigenze specifiche di protezione di coloro che sono privi del loro ambiente familiare. Il Comitato delle Nazioni Unite dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza svolge un ruolo di guida autorevole circa l’interpretazione e l’attuazione della Convenzione. Tra i suoi Commenti Generali più rilevanti in relazione ai minori non accompagnati e separati sono da richiamare, tra gli altri, il C.G. N. 6, relativo al trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese di origine, il C.G. N. 12 relativo ad ascolto e partecipazione, il C.G. N. 14 relativo al rispetto del Superiore interesse della persona di minore età5, il Commento Generale congiunto N. 4 del Comitato per la Protezione dei Diritti del Lavoratori Migranti ed il N. 23 del Comitato per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che dedica spazio ai diritti dei minorenni nei contesti di migrazione internazionale6
4A Framework for the protection of children, UNHCR 2012, https://www.unhcr.org/protection/children/50f6cf0b9/frameworkprotection-children.html
5Sani e salvi, cosa possono fare gli stati per garantire il rispetto dell’interesse superiore dei minori non accompagnati e separati in Europa, UNHCR UNICEF 2014 https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Safe_and_sound_final-1.pdf
6Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return, https://www.refworld.org/ docid/5a12942a2b.html
12 L’ABBRACCIO
Il lungo viaggio dei minorenni stranieri non accompagnati
di Carmela Pace, Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus
Mamajang aveva 13 anni quando nel 2016 è fuggito da solo dal suo Paese d’origine dove viveva con la famiglia. Per trovare migliori opportunità ha attraversato l’Africa occidentale, il deserto del Sahara e la Libia. La Libia è stata la tappa più difficile, ma l’ultima prima di raggiungere la Sicilia, uno dei principali punti di ingresso in Europa.
“Molte persone in Libia vengono catturate e detenute, picchiate, o sono costrette a fare lavori molto duri per pochi soldi. Tanti cercano di venire in Europa, ma solo alcuni ci riescono. Altri muoiono mentre cercano di raggiungere l’Italia. Mi considero estremamente fortunato a essere qui oggi”, ha detto. Quando è arrivato in Sicilia, a Palermo, è stato ospitato in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, dove ha vissuto quasi due anni.
Troppo spesso minorenni come Mamajang arrivano da soli sulle coste del nostro paese. Solo nei primi 9 mesi del 2022, sono sbarcati in Italia oltre 8.500 minori stranieri non accompagnati. Il numero sale a 17 mila se si considerano anche i 5.000 bambini e adolescenti arrivati soli dall’Ucraina. Una parte di questi bambini diventa “irreperibile” se sfugge ai sistemi di protezione.
Negli ultimi anni, proprio per risolvere il problema dell’aumento degli arrivi dei minori stranieri non accompagnati, l’Italia ha adottato la cosiddetta “legge Zampa” (l. n. 47 del 7 aprile 2017), a oggi considerata una delle leggi più avanzate sul riconoscimento dei diritti dei minorenni migranti e rifugiati e sulla loro protezione. Ma sono ancora molte le sfide che continuano ad affrontare: adolescenti e giovani che viaggiano lungo la rotta del Mediterraneo centrale hanno molte più probabilità degli adulti di essere sfruttati e abusati, non solo nel Paese d’origine, ma anche in quelli di transito e di arrivo. Durante i conflitti e la fuga, donne, ragazze e bambine in particolare affrontano i rischi più gravi delle violenze di genere.
Inoltre, il percorso di inserimento di tanti ragazzi che arrivano in Italia è ostacolato dalla disomogeneità nelle condizioni di accoglienza sul nostro territorio, un fattore che non solo incide sull’accoglienza in sé ma anche sulla qualità dei servizi offerti, con conseguenze concrete nella vita dei minorenni in termini di alloggio e opportunità socioeconomiche. Poi, una volta maggiorenni, molti giovani fuoriescono improvvisamente dai sistemi di protezione che li tutelavano.
L’UNICEF, insieme all’OIM e all’UNHCR, ha commissionato alla fondazione ISMU uno studio, “A un bivio. La transizione all’età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia”. Secondo lo studio, un minorenne straniero non accompagnato deve affrontare diversi cambiamenti: il passaggio dall’adolescenza all’età adulta che accompagna ogni essere umano; la migrazione, che costringe al distacco dalla propria famiglia e dalle proprie tradizioni e ad affrontare una nuova vita in un contesto culturale e sociale diverso; e, infine, il superamento dei traumi vissuti prima, durante o dopo il viaggio compiuto.
Questa ricerca ha evidenziato come gli ostacoli che rischiano di compromettere il percorso di inserimento dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni nella società di accoglienza sono principalmente tre: le disfunzionalità del sistema di rilascio dei titoli di soggiorno, che prevedono un percorso lungo e complesso; il breve tempo che hanno a disposizione prima di essere considerati “adulti” (la maggior parte di loro, infatti, arriva in Italia tra i 16 e i 17 anni); i traumi vissuti nel paese di origine e durante il viaggio.
La netta separazione del regime giuridico fra la minore età e i 18 anni è dunque un passaggio che non permette uno sviluppo armonico e non tiene conto delle grandi fragilità di questi ragazzi.
Come UNICEF, cerchiamo di sostenere i ragazzi che arrivano in Italia in questa fase di tripla transizione. Mamajang è uno di loro.
L’ABBRACCIO 13
A partire dal 2019, Mamajang ha iniziato il percorso per essere accolto da una famiglia affidataria ed è andato a vivere con Desjrè e Mauro in un piccolo paese del Nord Italia.
Tutto ciò è stato possibile grazie al programma Terreferme, condotto in collaborazione con il Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza (CNCA) e promosso nell’ambito di Child Guarantee, un programma europeo per il contrasto della povertà e dell’esclusione sociale dei minorenni in condizioni di particolare vulnerabilità.
“All’inizio è una vita completamente nuova, ma dopo un po’ ti rendi conto che va tutto bene, incontri gli amici e li inviti a giocare o a uscire insieme”, dice Mamajang. “Ora capisco come funzionano le cose. Era anche la prima volta che andavo alla scuola secondaria e c’erano molte materie, quindi ho avuto difficoltà ad ingranare. Ora sta andando bene”.
Nei sogni di Mamajang, che tra le varie materie studia il francese e il cinese, c’è quello di diventare un pilota.
Dal 2016 l’UNICEF in Italia promuove un Programma a sostegno dei bambini e degli adolescenti migranti e rifugiati, che si fonda su tre pilastri: protezione dell’infanzia – con interventi di supporto legale e psico-sociale, individuando forme di accoglienza alternative alla vita nei centri, tra cui l’affido familiare; sviluppo dell’adolescenza,
con interventi che spaziano dall’educazione non formale alla partecipazione e inclusione sociale; un programma di prevenzione e risposta alla violenza di genere.
Nel 2021 l’Ufficio per l’Europa e l’Asia Centrale dell’UNICEF ha attivato una risposta operativa in Italia a favore dei minorenni migranti e rifugiati. Sono stati raggiunti oltre 12.000 minorenni che hanno ricevuto sostegno e protezione con attività di supporto legale, sanitario, per la salute mentale e il supporto psicosociale. È stato rivolto un particolare impegno all’affido familiare, al modello di mentoring e al sistema dei tutori volontari. Tra le molte attività sono stati messe in atto una serie di misure di prevenzione e risposta alla violenza di genere per donne e ragazze rifugiate e migranti.
Sono stati inoltre promossi programmi di supporto ai percorsi educativi e formativi e di orientamento al lavoro e allo sviluppo delle competenze per l’inclusione socioeconomica. Tra le azioni, interventi di supporto anche nelle zone di frontiera come Lampedusa e Ventimiglia.
Nel 2022 l’UNICEF ha inoltre rafforzato l’azione di risposta e potenziato l’intervento anche nel confine nordorientale, per rispondere alla crisi dei rifugiati in fuga dall’Ucraina.

14 L’ABBRACCIO
Minori Stranieri Non Accompagnati: quale realtà a cinque anni dalla legge Zampa?
di Cristina Maggia, Presidente Associazione Nazionale Magistrati Minorili,
Per quanto mi rivolga ad un pubblico di lettori “ben orientati”, mi pare utile sottolineare quanto la migrazione non rappresenti un dramma esclusivo del mondo contemporaneo, ma un fenomeno con cui tutte le civiltà hanno dovuto prima o poi fare i conti. Credo sia necessario andare oltre le semplificazioni individuando una amplissima varietà dei percorsi di migrazione, dai quali scaturiscono differenti traiettorie di vita. I cosiddetti “migranti” constano di molteplici tipi sociali e sono portatori di risorse, valori e bisogni spesso talmente dissimili tra loro che l’unico punto in comune sembra essere il fatto di non essere nati nel paese di destinazione; di essere, appunto, «stranieri». È in questo quadro che occorre contestualizzare il tema dei minori soli giunti nel nostro paese senza genitori e non accompagnati da adulti che possano assisterli e assumerne la legale rappresentanza. Risale ormai a cinque anni orsono l’introduzione della normativa cui fare riferimento la legge n.47/2017 cosiddetta legge Zampa, dal nome dell’onorevole Sandra Zampa che l’ha fortemente voluta. Questa civilissima legge ha avuto il pregio di definire in modo puntuale chi sono i Minori Stranieri Non Accompagnati, ossia migranti per i quali alla qualità di straniero si aggiunge lo status di persona di età minore da considerare perciò maggiormente vulnerabile a prescindere dalle ragioni sottese al percorso migratorio. In base alla legge essi “sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea” e “al minore straniero che si trova nel territorio dello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e i provvedimenti necessari in caso d’urgenza”. Dal sistema di fonti nazionali e internazionali si ricava il principio che al minore straniero solo nel nostro paese, deve essere assicurata la massima protezione e il riconoscimento dei diritti inviolabili di
rappresentanza legale, di cura, assistenza, accoglienza e più in generale di tutela con provvedimenti urgenti e corrispondenti all’interesse o benessere della persona di età minore come previsto dall’ articolo 3 della Convenzione di New York del 1989 entrata in vigore nel 1991. La legge Zampa ha pienamente recepito i principi costituzionali di non discriminazione e di uguaglianza delle persone straniere di età minore tenendo conto delle direttive europee e della legislazione nazionale. Il concetto di tutela che ne deriva riguarda sia la rappresentanza legale che la cura della persona minorenne. Il tribunale per i minorenni è l’organo giudiziario destinato alla realizzazione pratica del concetto di tutela, attraverso la nomina di un tutore a chi è privo di adulti legalmente responsabili, ma la tutela non si esaurisce nella rappresentanza, attenendo anche alla cura della persona. La nomina di un tutore è solo una delle misure di protezione possibili in favore dei minori, dal momento che occorre garantire loro la dovuta assistenza con la destinazione, da parte degli enti preposti, di sufficienti risorse materiali, realizzata attraverso la predisposizione di progetti educativi e di integrazione sociale. Con la legge Zampa è stato messo a sistema un percorso integrato che ha previsto il concomitante intervento del giudice minorile, delle amministrazioni locali con i Servizi Sociali, dell’Autorità Garante Nazionale e dei Garanti Regionali responsabili della selezione e formazione dei tutori volontari dei MSNA, il cui elenco va poi trasmesso ai tribunali per i minorenni per le relative nomine. A fronte di una normativa di grande civiltà, l’esistenza in Italia di modelli operativi diversificati da zona a zona – determinati dalla quantità e tipologia di MSNA nelle varie regioni, dalla minore o maggiore attività dei Garanti Regionali nel reperimento e formazione dei tutori volontari, dalla presenza o meno di campagne promozionali che diffondano nella comunità l’opportunità di prestare la propria attività solidaristica, dalla maggiore
L’ABBRACCIO 15
Presidente Tribunale Minorenni di Brescia
certamente dato vita a situazioni poco assimilabili le une alle altre. Il diritto all’accoglienza è stato declinato in modi difformi e non sempre davvero tutelanti, così come gli auspicati percorsi di formazione e integrazione dei minori sono stati interpretati da molte amministrazioni quasi con fastidio. Ciò ovviamente può avere influito anche sulla possibilità che ragazzi, in definitiva ancora soli, senza mezzi e con pochissime speranze, possano essere stati sedotti dal facile ingresso in organizzazioni criminali. Devo però rendere noto che nella Lombardia Orientale dove lavoro, in cui le province di Cremona e di Bergamo sono luoghi di reale eccellenza nell’accoglienza dei MSNA, a fronte di un notevole aumento degli arrivi negli scorsi mesi di ragazzi al limite della maggiore età, spesso attratti dalla possibilità di lavorare nell’edilizia e talora in possesso di contatti con amici o parenti, il tasso di devianza è limitatissimo: nel 2021 su 180 MSNA solo 8 sono stati coinvolti in un processo penale, cioè il 4%, mentre finora a tutto settembre 2022 a fronte di 180 arrivi il tasso di devianza è quello del 5%, a mio parere di non particolare significato. La migliore o peggiore qualità della accoglienza sembra essere il dato che fa la differenza rispetto ai loro destini. Pare opportuno evidenziare che questi minori sono vittime di almeno tre traumi: il primo dato dalla separazione dalla famiglia che in alcuni casi o è mancata, o li ha “espulsi” perché problematici, o li incoraggia a migrare per reperire modalità di sopravvivenza che non è in grado di garantire loro; il
secondo è dato dal viaggio avvenuto spesso in condizioni davvero disumane; il terzo è il trauma migratorio in senso proprio dato dallo sradicamento e dalla perdita dei riferimenti geografici, culturali, affettivi. Purtroppo, le comunità che li ospitano, quando ci sono, dedicano loro trattamenti indifferenziati, non sono attrezzate a fronteggiare bisogni speciali, derivati dai traumi subiti, sono prive dell’appoggio di servizi di etnopsichiatria che sarebbero indispensabili, sono spesso carenti anche di personale educativo con esperienze di multiculturalità. In alcuni territori, come nel distretto di Corte di Appello di Brescia nel cui T.M. opero, proprio per contenere il trauma aggiuntivo dello spaesamento, si è valutato di impedire lo spostamento del minore in comunità di un differente territorio nel caso in cui abbia già iniziato positivamente un percorso di integrazione fatto principalmente della costruzione di relazioni di fiducia e della capacità di affidarsi agli adulti di riferimento, assolutamente non scontate in chi proviene da storie così dolorose. Ogni strappo, ogni spostamento, se provocati da ragioni meramente organizzative, sono fonte di ulteriore trauma e di ulteriori chiusure nella capacità di fidarsi: se sono vissute come ingiustizie e non comprese possono provocare precoci allontanamenti e la fuga del ragazzo in contesti di devianza. L’obiettivo al contrario è assicurare a questi minori una possibilità di vita onesta con la costruzione di relazioni positive in un determinato contesto geografico e sociale ove si sentano accolti e al quale sentano di appartenere anche per restituire ciò che

16 L’ABBRACCIO
hanno ricevuto. Non sono palline da ping pong, non sono fascicoli né oggetti, ma persone. La nostra attuale legislazione, lungimirante e efficace rispetto ai temi della cittadinanza sociale, costituisce risposta di giustizia, prova a costruire percorsi di integrazione e senso di appartenenza ad un territorio ove molti dei ragazzi e ragazze migranti arrivano per migliorare la loro vita, per sfuggire allo sfruttamento, alla sofferenza e da situazioni familiari e sociali disgregate, per realizzare un sogno in base alle loro aspirazioni e inclinazioni. Anche con riferimento ai minori soli, al di là delle scelte politiche contingenti, il dibattito sulle migrazioni si gioca anzitutto sul terreno culturale quale luogo fertile per la ricerca di una identità possibile da parte di questi giovani che rappresentano oggi il movimento di popoli con cui dobbiamo confrontarci. In questo confronto non può
sfuggire il fatto che l’idea di «identità» dovrà essere declinata al plurale e se l’identità si configura anche come luogo e spazio della memoria, allora noi con questa memoria dobbiamo fare i conti. Nella memoria dell’Italia non c’è spazio per la semplificazione mitica del popolo indiviso, omogeneo, incontaminato. Ce lo testimonia la storia, ce lo confermano i racconti mitici, la letteratura. La nostra nuova inevitabile identità si realizza oltrepassando i confini, in quella costruzione di sé che è cambiamento, incontro, contaminazione. Non c’è civiltà senza questo continuo uscire da sé e incontrarsi con l’altro, senza quel sentirsi a proprio agio nella complessità delle differenze. Questa è la sfida educativa e culturale delle migrazioni: apprendere dalle giovani generazioni tutto ciò che non sia uniformità e livellamento e prendere atto che un’emergenza c’è ed è culturale e di giustizia.

L’ABBRACCIO 17
Quando lo Stato diventa genitore: la sfida dei minori stranieri non accompagnati
di Daniele Frigeri, Direttore Scientifico Osservatorio MSNA CESPI
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i Minori Stranieri Non Accompagnati presenti sul nostro territorio al 31 agosto 2022 erano 17.668. Circa 6.400 ragazzi in più rispetto a gennaio (+53%). Un dato significativo, ma non così straordinario, se consideriamo due aspetti: con riferimento allo stesso periodo del 2021, la crescita era stata del 40% e vanno considerati gli effetti della Guerra in Ucraina. Il dettaglio dei dati mostra infatti come, mentre a gennaio 2022 le prime quattro nazionalità per presenza di MSNA erano Bangladesh, Egitto, Tunisia e Albania (pari al 65% delle presenze complessive), ad agosto è l’Ucraina a detenere il primato di presenze, con il 31%, seguito da Egitto, Tunisia e Albania (che insieme pesano per il 35% delle presenze). La guerra in Ucraina ha comportato dei cambiamenti profondi nella presenza e nelle caratteristiche dei MSNA presenti sul nostro territorio. Oltre all’arrivo di un numero significativo di minori ucraini, si è abbassata la media dell’età (a gennaio 2022 l’87% dei MSNA avevano fra i 16 e i 17 anni, ad agosto tale percentuale è scesa al 65%), la Lombardia è diventata la seconda regione per numero di MSNA (con il 16% delle presenze), dopo la Sicilia (20% delle presenze). I dati dei nuovi arrivi indicano che il flusso di minori ucraini si è arrestato, almeno per ora.
Chiarito il quadro relativo a presenze, arrivi e composizione, il tema chiave è comprendere come il sistema di accoglienza riesca a prendersi carico di questi minori e accompagnarli in un processo di integrazione che determinerà il loro futuro. È ciò che l’Osservatorio sui Minori Stranieri Non Accompagnati del CeSPI, in collaborazione con Defence for Children International, cerca di fare attraverso la definizione e la misurazione di una serie di indicatori, che prendono il nome di Rapid Assessment, che intendono monitorare il grado
e la qualità dell’applicazione della Legge 47 del 2017 sui minorenni stranieri non accompagnati su specifici territori1
La normativa italiana, attraverso la Legge 47 del 2017, rappresenta una buona pratica internazionale e un passo avanti importante. Essa, nel riconoscere il minore come avente diritto di tutela in quanto tale, indipendentemente dalla provenienza o dalle cause che lo hanno spinto a lasciare il suo paese, disegna un sistema organico di accoglienza, impone criteri omogenei, garantisce il diritto alla salute e all’istruzione, il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari, pone al cento il supremo interesse del minore e istituisce la figura del tutore volontario, quale riferimento per la crescita e l’integrazione del minore, oltre che per gli aspetti giuridici della rappresentanza.
Fare un bilancio della reale applicazione della legge e dello stato dell’arte del processo di integrazione dei minori sul territorio è impresa assai complessa. E questo per due ordini di motivi: da una parte la profonda disomogeneità ancora presente sul territorio in termini di procedure, prassi, risorse, sensibilità delle istituzioni, che influiscono direttamente sull’esigibilità dei diritti e sui tempi e l’efficacia dei percorsi di integrazione e che rimandano in parte al punto successivo. Il secondo ordine di motivi rinvia alla molteplicità degli ambiti che contribuiscono alla crescita e all’integrazione di un minore, ambiti che a loro volta rimandano a competenze diverse. Tale processo è infatti la risultanza di un interagire di un sistema multidimensionale che non può essere analizzato per compartimenti stagni o ignorare il vissuto e la realtà specifica di ogni singolo individuo. Basta una fragilità in più o più accentuata e i bisogni e le risposte da mettere in campo cambiano anche in modo significativo. Molteplici le competenze coinvolte,
18 L’ABBRACCIO
dal Tribunale dei Minori, alla Prefettura, ai Comuni, al sistema sanitario, quello educativo, solo per citarne alcuni. Si tratta di una sfida di dialogo e coordinamento, che dovrebbe avere al centro il supremo interesse del minore, ma a cui strutturalmente e culturalmente le diverse istituzioni coinvolte non sono familiari e a cui sarebbe necessario rispondere attraverso una strategia pianificata che ancora manca o è incompleta. Il terzo settore svolge un ruolo di sussidiarietà importante rispetto alle istituzioni, ma molto spesso si trova in difficoltà, laddove il dialogo con le istituzioni appare non sempre facile e le risorse disponibili spesso inadeguate e disomogenee rispetto ai minori italiani, creando ulteriori disfunzionalità e discriminazioni. Alla normativa è infatti mancata la previsione di una dotazione di risorse finanziarie adeguate, mancando quindi di uno degli elementi chiave per la sua traduzione in concreto. Anche l’istituto della tutela volontaria, a cui la cittadinanza ha dato una risposta ampia e generosa, garantendo un ruolo insostituibile nel sostenere il processo di integrazione del minore, appare ancora disomogenea sul territorio, in parte messa in difficoltà dalla pandemia. Una figura chiave che richiede, oltre che la previsione di risorse economiche che l’istituzione del Fondo per la tutela volontaria ha in parte colmato, di un sostegno istituzionale che la rilanci e la valorizzi, uniformandola maggiormente sul piano nazionale. Ne deriva un quadro complesso, in cui inadempienze, disfunzionalità, tempi lunghi, rappresentano degli ostacoli oggettivi al realizzarsi di una piena integrazione del minore, soprattutto considerati i tempi molto stretti che l’età media di chi arriva in Italia (fra i 16 e i 17 anni) impone per poter accedere ad un’autonomia e ad un permesso di soggiorno raggiunta la maggiore età.
Uno dei punti chiave del processo è infatti legato all’ambito educativo, che vede due sfide principali: l’insegnamento dell’Italiano e il raggiungimento di un titolo di studio e una professionalità riconosciuta, che gli consentano di entrare nel mondo del lavoro. Sfide che sono state demandate in prevalenza ai CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), dove la presenza dei minori stranieri raggiunge percentuali prossime all’80% in molti istituti. Se da un lato i CPIA hanno un grado di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo maggiore e possono contare su un personale docente motivato e competente, permangono alcune rigidità, in quanto istituti pensati per fornire un titolo di scuola media, mentre spesso i minori stranieri hanno bisogno di corsi professionalizzanti che gli consentano, raggiunta la maggiore età, di ottenere un permesso di soggiorno lavorativo. Non adeguate appaiono inoltre le dotazioni in termini di mediatori culturali, percorsi specifici di pre-alfabetizzazione, disponibilità di insegnanti della scuola primaria, formati ad hoc per questa tipologia di utenti2. Un secondo limite evidenziato dall’esperienza riguarda l’incidenza dei minori stranieri all’interno di queste strutture educative che impedisce, di fatto, una integrazione con i coetanei italiani. Il minore straniero si ritrova così a vivere prevalentemente in luoghi che diventano, pur senza volerlo, ghettizzanti, fra la comunità di accoglienza e la scuola, interagendo quasi esclusivamente con ragazzi stranieri.
Il secondo aspetto critico riguarda il passaggio alla maggiore età, che, come accennato riguarda una percentuale significativa dei minori stranieri non accompagnati, prima della crisi Ucraina. Un passaggio che avviene a brevissima distanza dall’arrivo. In questo tempo il giovane deve acquisire tutti quegli strumenti che gli consentano di raggiungere l’autonomia e un permesso di soggiorno (sia esso per studio o per lavoro). L’istituto del proseguo amministrativo dovrebbe consentire di allungare il periodo di accoglienza, ampliando le possibilità, ma spesso si scontra con lunghezze burocratiche e ostacoli amministrativi. Il passaggio alla maggiore età e in modo particolare la fuoriuscita dal circuito di accoglienza, viene vissuto come un ulteriore trauma dal giovane, con ostacoli
1Il rapporto annuale “Legge 47/2017 un sistema di analisi e azione” ed. 2022 è disponibile sul sito dell’Osservatorio Minori Stranieri Non Accompagnati | CeSPI
2Un’analisi del ruolo dei CPIA nel processo di integrazione dei MSNA in Italia è contenuto nel il Rapporto dell’Osservatorio sui MSNA del CeSPI “Il ruolo dell’inserimento nei CPIA nel processo di crescita e autonomia dei MSNA” a cura di Brauzzi, Galli, Sodano, disponibile al link: approf._7_cpia.pdf (cespi.it)
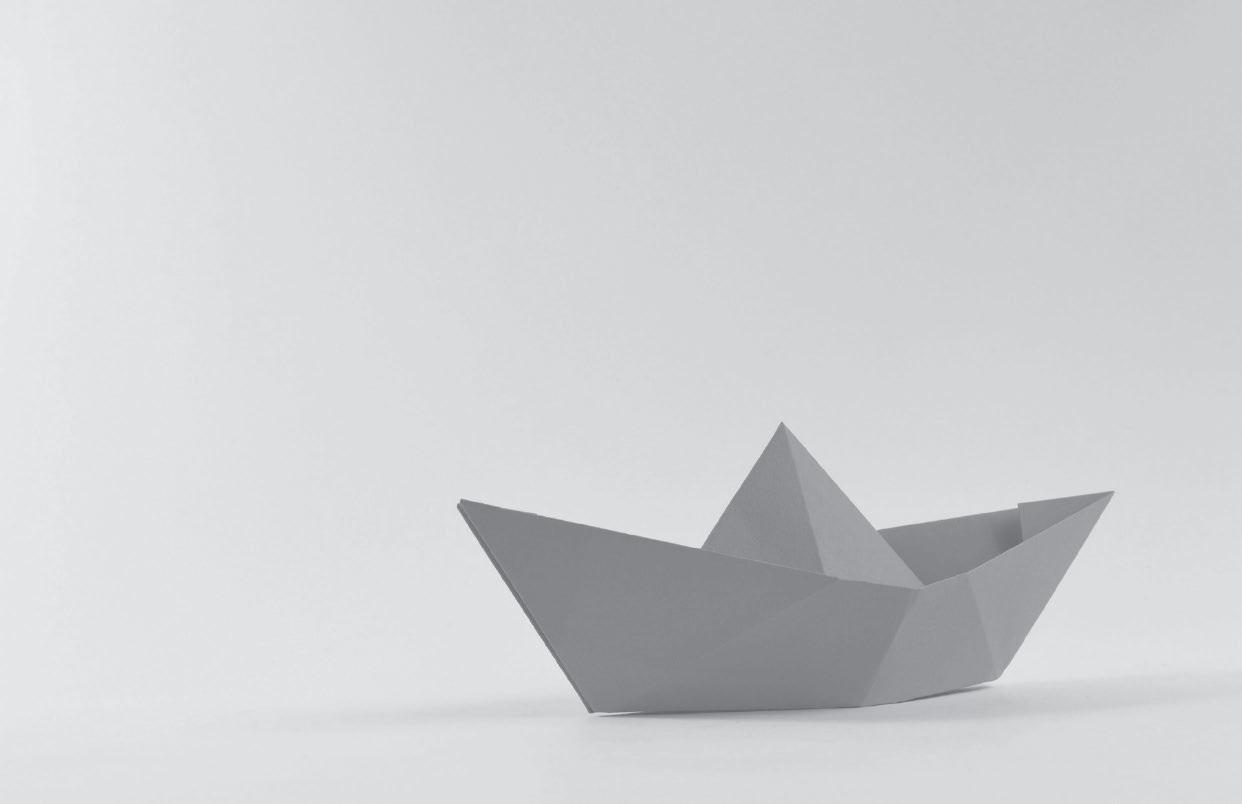
L’ABBRACCIO 19
criticità importanti legate all’inserimento lavorativo e alla ricerca di un alloggio. Questo porta con sé frustrazione, ulteriore ghettizzazione, legata al ricorso a forme precarie di alloggio fra connazionali e a condizioni lavorative precarie, dove spesso si verificano situazioni di sfruttamento, fino all’ingresso in circuiti malavitosi. Da più parti si evidenzia l’esigenza di rendere più graduale l’interruzione il sistema delle tutele e dell’accoglienza al raggiungimento della maggiore età. In questa direzione si è osservato che le strutture di semiautonomia, ancora poco diffuse in Italia, sono particolarmente efficaci, consentendo sia la prosecuzione degli studi, sia un inserimento graduale nel mercato del lavoro. È solo all’interno di questo quadro che possono essere letti fenomeni di criticità che si verificano in alcune grandi città italiane del Nord e del Centro e a cui la stampa sta dando grande risalto. I dati del Ministero di Giustizia restituiscono un quadro articolato e complesso, non allarmante, ma sicuramente indicatore di un disagio specifico e cartina tornasole dell’efficacia dei percorsi di integrazione realizzati. Rispetto ai reati commessi dai minori stranieri, emerge un’incidenza maggiore rispetto agli italiani con riferimento ai reati contro il patrimonio (55% rispetto al 40% degli italiani), nello specifico furto e rapina. Se in termini assoluti il 64% dei reati di questo tipo sono attribuibili a minori italiani, il dato dell’incidenza relativa evidenzia un dato da attenzionare. Al secondo
posto (12% dei rati complessivi nel 2021 commessi da minori stranieri, contro il 14% dei minori italiani) sono i reati legati a lesioni personali e volontarie. Entrambe le categorie di reati evidenziati, rimandano a condizioni di povertà e bisogno da un lato e a emarginazione e disagio dall’altro, che, in ultima analisi, chiamano in causa le difficoltà di integrazione nel mondo del lavoro e di acquisizione di quel livello adeguato di autonomia che consentano un processo di crescita e integrazione adeguati.
Guardare al minore straniero non accompagnato significa fare riferimento a quel complesso interagire di elementi che determinano e condizionano la crescita e lo sviluppo di ogni minore, con alcune fragilità e specificità che lo contraddistinguono: come la mancanza o dalla lontananza delle figure genitoriali o famigliari di riferimento, o il vissuto che spesso porta con sé traumi importanti legati alla partenza o al viaggio. Ciò richiede una capacità di lettura del processo di crescita verso l’essere adulto, prima che di integrazione, nella sua integrità e multidimensionalità e non può essere relegato ad un dato o ad un singolo fattore. Accompagnare questi processi in modo organico e nel rispetto dell’interesse del minore, rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per entrambi, per il minore e per la società di accoglienza.4

20
«Sono solo un ragazzo ma … voglio crescere!»
di Carmelina Chiara Canta, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi Università Roma Tre
La maggior parte di minori migranti e rifugiati è arrivato in Europa attraverso la rotta del Mediterraneo, molti dei quali da soli, senza genitori o adulti, appunto minori stranieri non accompagnati (MSNA). Il fenomeno, iniziato in forma massiccia all’inizio degli anni Novanta, è aumentato significativamente: al 31 agosto 2022 sono presenti in Italia 17.668, secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È cresciuto anche il numero dei neomaggiorenni, MSNA che hanno concluso il percorso educativo nelle comunità di accoglienza al compimento dei 18 anni. Questi ultimi diventano presto invisibili, ignorati dalle istituzioni e dai media ma esistono e sono moltissimi. Da anni i MSNA sono stati soggetti delle politiche statali e non e, ancora oggi, costituiscono motivo di crescente attenzione e richiedono una più ampia e completa comprensione delle sfide e delle opportunità per la loro protezione e inclusione sociale. Di questi la maggior parte (82%) sono maschi e il 76% hanno un’età compresa tra i 1517 anni. Ucraina (30,7%), Egitto (19,2%), Tunisia (9,4), Bangladesh (5,4%) e Pakistan (5%), sono i primi cinque paesi di provenienza, che fotografano il mutato contesto internazionale. Il flusso dei giovani immigrati non si è fermato neppure negli anni della pandemia che ha visto aumentare in modo massiccio il numero dei MSNA: anzi, con il Covid-19 sono passati da 5.016 del 30 giugno 2020 a 17.668 al 31 agosto 2022 (+99,9% rispetto al 30/06/2021 e +212,9% rispetto al 30/06/2020)!
Costretti da povertà e miseria, conflitti, guerre, disastri ambientali o semplicemente in cerca di opportunità, durante il viaggio hanno affrontato pericoli, stenti, costrizioni, violenza, sfruttamento e abusi di ogni sorta. Questa situazione ha spinto il governo italiano, la società civile e le associazioni di volontariato all’ organizzazione di risposte adeguate per l’accoglienza, l’inclusione sociale e la messa a punto di procedure per la richiesta di protezione internazionale e di permessi di soggiorno. Le comunità (case-famiglia e strutture di I° e II° accoglienza)
sorte inizialmente come risposta all’emergenza, hanno svolto un ruolo di accoglienza, educativo e di inclusione sociale non indifferente. Col passare del tempo e man mano che l’esperienza diventava più matura, le politiche del governo hanno affinato la loro mission ai cambiamenti che il contesto nazionale e internazionale richiedeva. Le strutture ospitanti i MSNA si sono dotate di figure professionali specifiche (educatori, mediatori culturali, psicologi, assistenti sociali, etc) in grado di comprendere e rispondere ai bisogni dei ragazzi nelle diverse fasce di età, fino ai 18 anni.
Una tappa importante, introdotta per colmare un vuoto educativo, con l’istituzione della figura di un “tutor” che prevede che ogni minore abbia un tutor individuale che si occupi di lui, è stata la “cosiddetta legge Zampa” (l. n. 47 del 7 aprile 2017), considerata una delle leggi più avanzate sul riconoscimento dei diritti dei minori migranti e rifugiati e sulla loro protezione. Prima del 2017, in Italia i tutori erano i sindaci delle città dove risiedevano i minori, che erano affidatari di moltissimi ragazzi, anche oltre 1000!
In questa breve riflessione, pur riconoscendo di trascurare aspetti importanti, ci si soffermerà sulle aspettative, i desideri e le aspirazioni legate al progetto migratorio dei MSNA, nella convinzione che solo dando risposte ad essi e alle richieste esplicite si attiva un percorso di aiuto nel processo di inclusione e di crescita sia nelle comunità che li ospitano che in altri luoghi dove potrebbero essere accolti. Infatti, accanto alle strutture esistenti e che offrono un buon servizio, ci si chiede se non possano esserci altre forme più adatte a favorire la crescita degli adolescenti, anche neomaggiorenni (dal momento che le comunità esistenti li accolgono solo fino ai 18 anni). Oltre alle comunità e strutture esistenti, che svolgono un ruolo significativo di educazione e inclusione sociale, è possibile sperimentare altre modalità di accoglienza? In un’Italia matura, consapevole che il processo migratorio non è più una questione emergenziale ma di ordinaria
L’ABBRACCIO 21
amministrazione, possiamo costruire scenari alternativi che coinvolgano direttamente i cittadini autoctoni? Nell’ambito di questo intervento cerco di rispondere a questi interrogativi stimolata dal confronto con i tanti MSNA che mi hanno interrogato nel profondo.
«Sono solo un ragazzo ma …voglio crescere!». Ha urlato in maniera diretta e con forte emozione e rabbia, un adolescente sedicenne del Gambia, incontrato in una comunità dell’Italia centrale.
Gli adolescenti, che sono la maggior parte dei MSNA presenti in Italia, crescono quando gli educatori conoscono le loro aspettative e i loro desideri e individuano risposte coerenti e concrete. Nel percorso di cambiamento di mentalità, operato dai ragazzi nel corso del loro processo di crescita, hanno un ruolo importante alcune figure e modelli educativi positivi di adulti incontrati nella loro esperienza in comunità.
Nei racconti degli adolescenti emerge la prospettiva di una migliore qualità della vita, che si concretizza nel desiderio di una preparazione a un lavoro soddisfacente. Sono presenti anche la capacità di alimentare sogni,

aspirazioni e di proiettarsi nel futuro sebbene si individui una certa flessibilità nelle scelte di un futuro desiderabile suscettibile di cambiamenti e adattamenti anche in relazione ai luoghi dove vivere. Emerge più di frequente, il desiderio di costruire un futuro in Italia, in particolare là dove hanno percorso le tappe più significative del loro processo di crescita: le aspettative e i desideri diventano un punto di lancio per un percorso che inizia nelle città conosciute e che li renderà cittadini di questi luoghi: «sicuramente vivo in Italia perché mi trovo bene… la mia famiglia mi ha insegnato l’educazione, ma qua mi hanno insegnato a crescere», afferma un ragazzo egiziano. Ciò rappresenta un importante passo per la loro crescita e l’affermazione della propria realizzazione, la dimostrazione, a sé stessi e anche agli altri, nel Paese di origine e in Italia, di “avercela fatta”.
«Sono solo un ragazzo…ma voglio crescere!». Ma qual è il luogo naturale della crescita se non la famiglia? Può esserci un altro ambiente affettivamente accogliente, dove si vive una relazione “filiale” con un adulto? Mi spingo a dire che possa essere proposta un’accoglienza del minore in una famiglia italiana, come già stanno
22 L’ABBRACCIO
sperimentando alcune associazioni (Famiglie affidatarie di Borgo don Bosco) che si rivolgono ad adolescenti o a neomaggiorenni (ALI- Accoglienza Libera Integrata). Questa esperienza potrebbe essere “diffusa” in tutto il territorio italiano e coinvolgere molti cittadini. Non un’adozione o un affido, strumenti che già esistono e spesso diventano di difficile attuazione, né di un tutor come proposto dalla legge Zampa, ma una sorta di “fille d’anima”, secondo un’antica consuetudine sarda, che si sperimenta ancora nell’isola. Il MSNA può non avere più i genitori, persi nel viaggio della speranza o ha i genitori nella propria terra di origine ma in Italia potrebbe avere un riferimento affettivo, relazionale e una bussola che lo aiuti nel suo cammino, in una famiglia o una singola persona che, senza chiedere nulla e in forma assolutamente gratuita, lo aiuti a crescere, lo accompagni a diventare adulto/a, come un figlio, appunto un “fill’e anima”, “fillus de anima”, cioè figlio dell’anima, accogliendolo nella propria casa. Con questa espressione, nella lingua sarda, si fa riferimento al
prendersi cura o prendersi “a cuore” le sorti di qualcuno più giovane: una pratica tradizionalmente diffusa in varie zone della Sardegna, che prevedeva l’affidamento volontario di uno o più bambini, da parte dei genitori biologici, ad altri adulti. L’usanza, testimoniata oggi da quarantenni che sono stati “fill’e anima”, è stata viva nelle piccole comunità fino alla metà degli anni Settanta, al momento dell’introduzione del nuovo diritto di famiglia (1975), sebbene sia ancora presente ai nostri giorni. La decisione di far crescere un bambino all’interno di un nucleo familiare diverso da quello di nascita era motivata da una condizione di difficoltà, di tipo materiale, economico, relazionale o sociale: oggi i nostri fill’i e anima possono essere i MSNA! Oltre all’accoglienza in comunità e strutture per minori, l’adozione, l’affido, il tutorato, i cittadini italiani che hanno sempre meno figli, potrebbero farsi carico, aiutati anche da un’apposita normativa, si questa forma educativa di aiuto alla crescita, più umana e maggiormente rispondente ai desideri e ai bisogni dei MSNA.

L’ABBRACCIO 23
SOSTIENI IL CEIS GENOVA
24 L’ABBRACCIO
il tuo contributo potremo portare avanti i progetti di agricoltura sociale, finanziare le attività sportive per le comunità di minori, potremo finanziare progetti di reinserimento lavorativo e sviluppare campagne di prevenzione.
PUOI SOSTENERCI Tramite Bonifico Bancario presso Banca Prossima S.p.A. Iban IT85 B033 5901 6001 0000 0007 632 Tramite Donazione on line collegandoti all’ indirizzo www.ceisge.org/ceis-genova-sostienici oppure Devolvi il tuo 5x1000 a Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus C.F. 95080550106 www.gruppoboero.it L’ECCELLENZA ITALIANA DEL COLORE
Con
COME