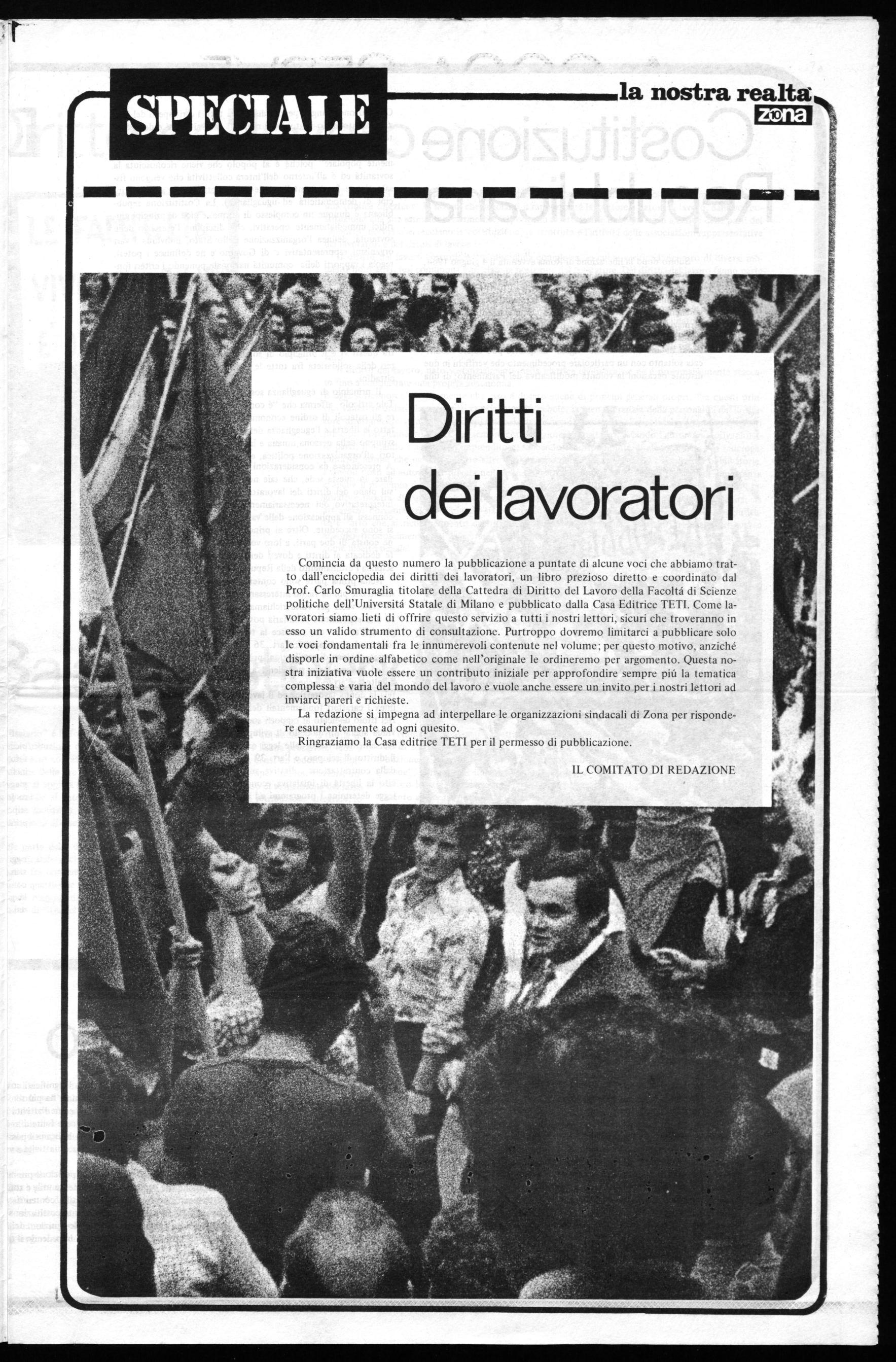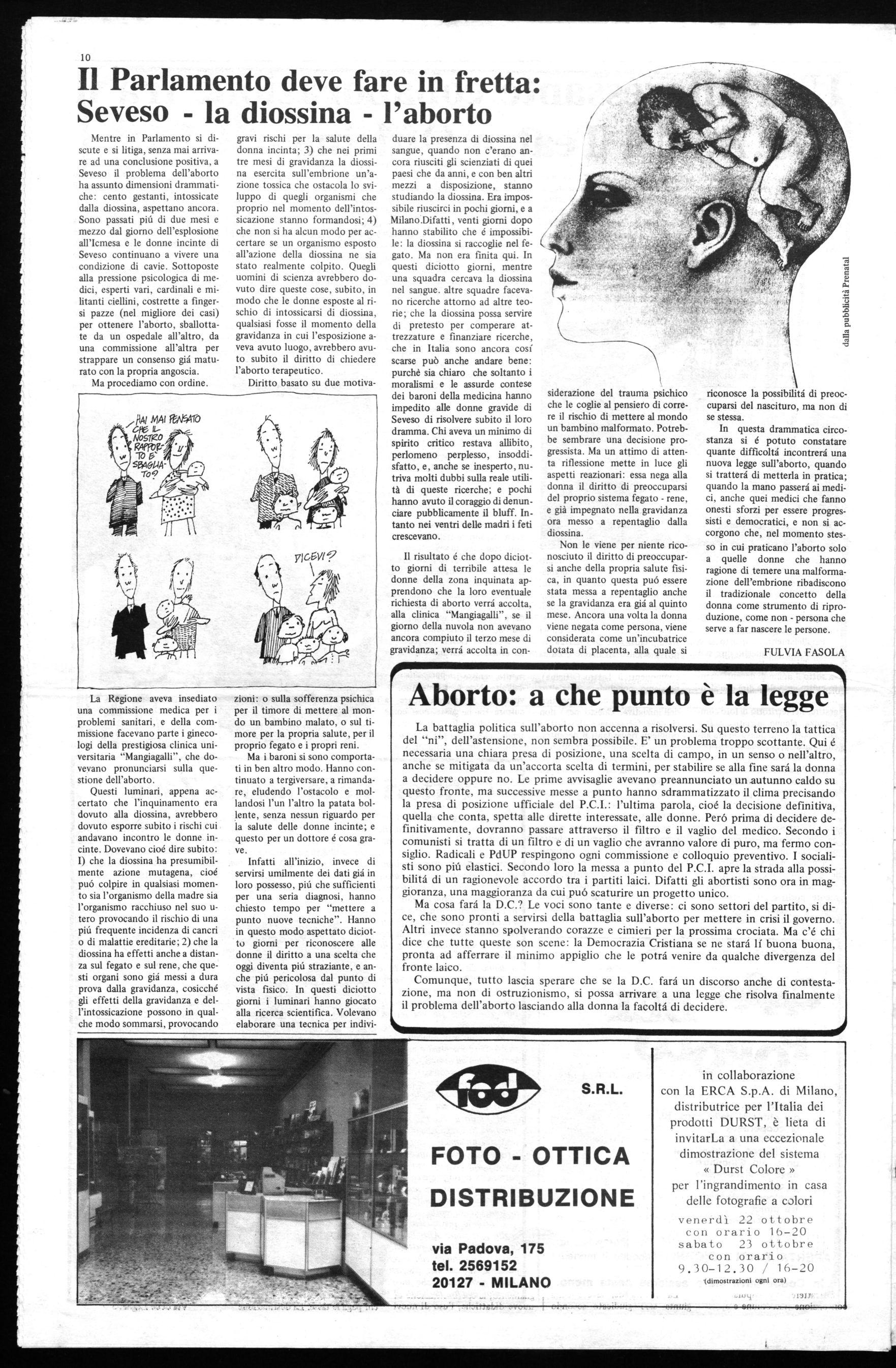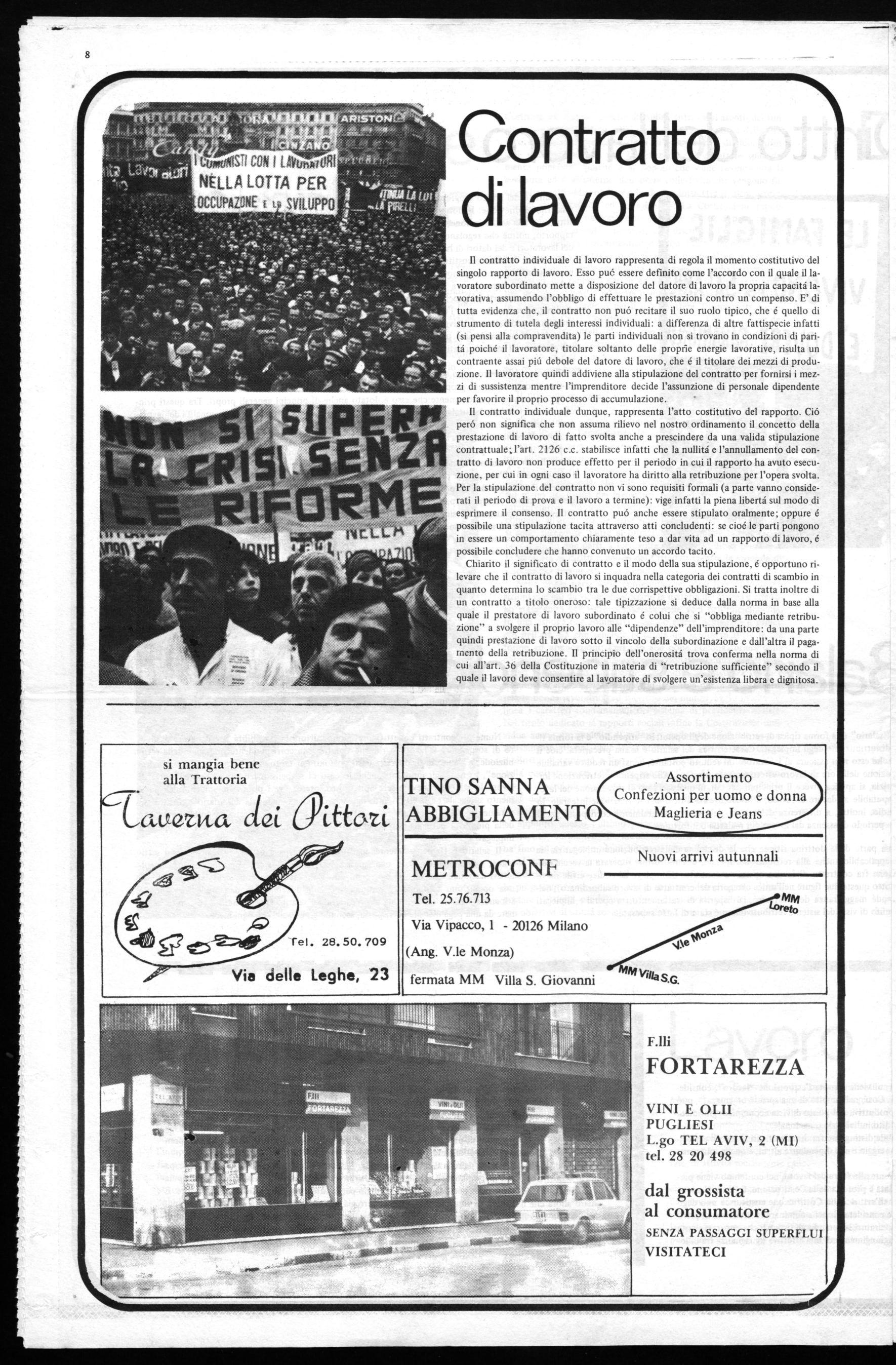5 minute read
Diritto del lavoro Costituzione Repubblicana
Subito dopo la liberazione di Roma avvenuta il 4 giugno 1944, Ivanoe Bonomi, capo del Comitato centrale di liberazione nazionale, costituí il primo Governo di CLN fra partiti democratici; fra i primi atti vi fú l'emanazione del D.L. lgt. (decreto legge luogotenenziale) che prevedeva, a Italia completamente liberata, la formazione di una Assemblea. Il progetto di Costituzione, promulgata il 27 dicembre, entro in vigore il 1 gennaio 1948. Si tratta di una Costituzione "rigida" in quanto puó essere modificata soltanto con un particolare procedimento che verifichi in due distinte occasioni la volontà modificativa del Parlamento; di una
Costituzione "lunga" perché disciplina tutti i vari aspetti del funzionamento dello Stato e dei rapporti fra cittadini e dello Stato con i cittadini, senza limitarsi all'enunciazione di alcuni principi fondamentali; di una Costituzione "di carattere spiccatamente popolare" poiché é al popolo che viene riconosciuta la sovranità ed é all'interno dell'intera collettività che vengono fissate alcune fondamentali regole di condotta (tra le altre, i principi di democraticità ed uguaglianza). La Costituzione repubblicana é dunque un complesso di norme, e cioé di principi giuridici immediatamente operativi, che disciplina l'esercizio delle sovranità, delinea l'organizzazione dello Stato, individua i vari organismi rappresentativi e di Governo e ne definisce i poteri, regola rapporti della comunità nazionale ponendo i criteri fondamentali dei rapporti sociali ed economici. In questa prospettiva la Costituzione si presenta come uno strumento di immediata applicazione appunto per il suo carattere di specificità e concretezza. La Carta Costituzionale si apre con l'enunciazione dei principi fondamentali, che possono essere considerati come regole giuridiche di interpretazione dell'intero complesso di leggi: tra questi vi é il principio di solidarietà sociale e cioé il principio della solidarietà fra tutte le componenti della comunità dei cittadini.
Advertisement
Il principio di eguaglianza sostanziale é contenuto nell'art. 3. Tale articolo afferma che "é compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto le libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
A prescindere da considerazioni piú generali, é opportuno ricordare, in questa sede, che tale norma riveste enorme importanza sul piano dei diritti dei lavoratori, poiché rappresenta un metro interpretativo cui necessariamente ricondurre tutti i problemi connessi all'applicazione delle 'varie leggi di tutela del lavoro che si sono succedute. Oltre ai principi fondamentali, la Costituzione consta di due parti, a loro volta divise in titoli: la prima parte dedicata ai diritti e doveri dei Cittadini mentre la seconda disciplina l'ordinamento della Repubblica.
Nella prima parte sono contenute, nei titoli II e III le disposizioni che piú da vicino interessano la materia del lavoro e che sono state volta per volta richiamate nelle voci dell'Enciclopedia. In una esposizione sommaria possOno essere richiamati il principio dell'art. 35 che sancisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; l'art. 36 che pone l'obbligatorietà della corresponsione di retribuzioni proporzionate alla quanta del lavo: ro ed in ogni caso sufficienti a garantire un'esistenza libera e dignitosa; l'art. 37 che insieme con la norma di cui all'art. 29 tutela la donna lavoratrice ed il lavoro dei minori; l'art. 38 che delinea i caratteri fondamentali del sistema di previdenza sociale. Nel titolo dedicato ai rapporti sociali infine la Costituzione individua anche un modello di sviluppo sindacale e politico ancora scarsamente attuato dalle leggi ordinarie. L'art. 40 pone infatti il diritto di sciopero e l'art. 39 quello della libertà sindacale e della contrattazione collettiva, mentre l'art. 41, dopo aver sancito la libertà di iniziativa economica privata, stabilisce che la legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché tale attività possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. E' appunto questo l'ultimo principio che richiede un ulteriore intervento normativo. E' indubbio infatti che il sistema non ha fino ad ora posto alcun limite al libero modo di estrinsecarsi del processo di accumulazione, che anzi ha seguito solo impulsi individualistici in vista del massimo profitto. L'obiettivo della programmazione quindi dovrà appunto essere quello di impostare l'attività produttiva in una dimensione piú rispondente agli obiettivi di utilità sociale posti dalla Carta Costituzionale.
Diritto al lavoro
In base all'art. 4 della Costituzione, la Repubblica riconosce a tutti cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto, certamente tale norma pone l'obiettivo del pieno impiego nel quadro di quei principi di emancipazione che caratterizzano la Costituzione repubblicana: cosí se é vero che compito della Repubblica é quello di rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che si oppongono all'uguaglianza effettiva dei cittadini, non vi é dubbio che l'indipendenza economica conseguente allo svolgimento del lavoro rappresenta la condizione necessaria per il conseguimento di una effettiva uguaglianza. Certamente la norma di cui all'art. 4 non crea un diritto soggettivo azionabile in giudizio da parte di chi si trova nella condizione di non occupare un posto di lavoro: la norma pone peró le premesse per un effettivo controllo dell'attività economica, pubblica e privata.
Nel quadro degli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto al lavoro vanno annoverati i provvedimenti statali in materia di mantenimento ed incremento dell'occupazione: Gepi, Cassa per il mezzogiorno, eccetera.
Lavoro
Il diritto del lavoro rappresenta quel complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro, in una triplice direzione: le norme che regolano il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, dalla sua costituzione alla sua estinzione; norme che impongono direttamente obblighi legali a carico delle parti del rapporto; norme che regolano la costituzione, la struttura e l'attività delle associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il diritto del lavoro costituisce una disciplina complessa, in cui si verifica l'incontro di diversi momenti normativi, tesi comunque a tutelare la posizione del lavoratore. Del diritto del lavoro fanno parte poi norme che rispondono a finalità e presentano caratteri diversi: vi sono, innanzitutto norme che disciplinano rapporti reciproci tra le parti, imponendo obblighi e stabilendo diritti. Vi sono poi norme di diritto penale, che sono l'espressione dell'interesse diretto della comunità nazionale al rispetto dei principi di protezione del lavoro dell'ordinamento: ogni dovere posto a carico del datore di lavoro presenta infatti un particolare presidio penale. Vi sono infine i "contratti collettivi" che non sono leggi ma contratti di natura privatistica: essi peró contribuiscono a formare nel complesso, il diritto del lavoro.
Il diritto del lavoro, nato sostanzialmente dalla matrice civilistica, se ne é progressivamente staccato fino a conquistare una propria autonomia.
E oggi si riconosce pacificamente che esso é dotato anche di principi generali propri. Tra questi principi vanno ricordati: la tutela del contraente piú debole, la piena garanzia della personalità del lavoratore direttamente implicato nel rapporto, il favore per il lavoratore, l'autotutela. In virtù di questi principi, l'ordinamento interviene sempre con maggiore intensità, vincolando l'autonomia privata delle parti; limitando poteri dell'imprenditore; sancendo l'indisponibilita di alcuni diritti e la inderogabilità di norme che ne riconoscono altri. Basterà ricordare i numerosi casi di assunzioni obbligatorie, vincoli posti all'autonomia privata nella fase di costituzione, e cosí via. Ma di particolare importanza é anche il principio dell'autotutela, consacrato negli art. 39 e 40 della Costituzione: in sostanza il legislatore mostra di riporre particolare affidamento nella facoltà degli stessi lavoratori di tutelarsi sia attraverso l'organizzazione sindacale sia attraverso l'azione sindacale diretta. E non é senza significato il fatto che al riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero (art. 40) non faccia riscontro analogo riconoscimento per la serrata, che anzi deve ritenersi come illecito civile e, in alcuni casi, come illecito penale.