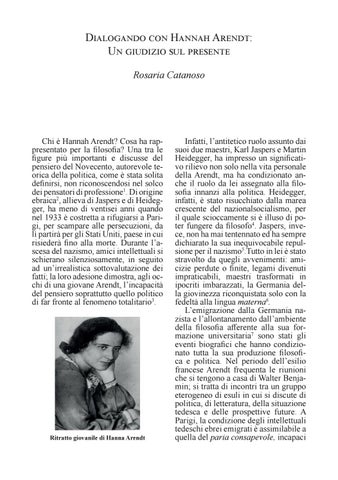Dialogando con Hannah Arendt: Un giudizio sul presente Rosaria Catanoso
Chi è Hannah Arendt? Cosa ha rappresentato per la filosofia? Una tra le figure più importanti e discusse del pensiero del Novecento, autorevole teorica della politica, come è stata solita definirsi, non riconoscendosi nel solco dei pensatori di professione1. Di origine ebraica2, allieva di Jaspers e di Heidegger, ha meno di ventisei anni quando nel 1933 è costretta a rifugiarsi a Parigi, per scampare alle persecuzioni, da lì partirà per gli Stati Uniti, paese in cui risiederà fino alla morte. Durante l’ascesa del nazismo, amici intellettuali si schierano silenziosamente, in seguito ad un’irrealistica sottovalutazione dei fatti; la loro adesione dimostra, agli occhi di una giovane Arendt, l’incapacità del pensiero soprattutto quello politico di far fronte al fenomeno totalitario3.
Ritratto giovanile di Hanna Arendt
Infatti, l’antitetico ruolo assunto dai suoi due maestri, Karl Jaspers e Martin Heidegger, ha impresso un significativo rilievo non solo nella vita personale della Arendt, ma ha condizionato anche il ruolo da lei assegnato alla filosofia innanzi alla politica. Heidegger, infatti, è stato risucchiato dalla marea crescente del nazionalsocialismo, per il quale scioccamente si è illuso di poter fungere da filosofo4. Jaspers, invece, non ha mai tentennato ed ha sempre dichiarato la sua inequivocabile repulsione per il nazismo5.Tutto in lei è stato stravolto da quegli avvenimenti: amicizie perdute o finite, legami divenuti impraticabili, maestri trasformati in ipocriti imbarazzati, la Germania della giovinezza riconquistata solo con la fedeltà alla lingua materna6. L’emigrazione dalla Germania nazista e l’allontanamento dall’ambiente della filosofia afferente alla sua formazione universitaria7 sono stati gli eventi biografici che hanno condizionato tutta la sua produzione filosofica e politica. Nel periodo dell’esilio francese Arendt frequenta le riunioni che si tengono a casa di Walter Benjamin; si tratta di incontri tra un gruppo eterogeneo di esuli in cui si discute di politica, di letteratura, della situazione tedesca e delle prospettive future. A Parigi, la condizione degli intellettuali tedeschi ebrei emigrati è assimilabile a quella del paria consapevole, incapaci