
5 minute read
In questo numero
Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo: in piedi, signori, davanti a una Donna! William Shakespeare
Il tema biblico di Giuditta e Oloferne – che ancora oggi e non a caso ci appare di esemplare efficacia e di tragica attualità – è stato ripreso più volte da Artemisia Gentileschi, sia nella versione più drammatica dell’atto della decapitazione conservata agli Uffizi (1620), che riproduciamo in copertina, sia – come nella tela qui riprodotta – quando Giuditta e la sua ancella Abra si accingono a fuggire dalla tenda del generale ucciso e dal campo nemico. Impossibile non cogliere in queste ricorrenze artistiche il drammatico nesso autobiografico, il ritorno di un’ossessione, il rito di una rinnovata liberazione, l’anelito compulsivo di giustizia. Cruento riscatto sull’uomo, contro l’uomo. Scrivendo e ragionando di Donne contro, la cover di questo «Tempo Presente» non poteva che essere dedicata a Giuditta e la mano che la tramanda a noi non poteva non essere quella di Artemisia…
Advertisement
Artemisia Gentileschi, Giuditta e la fantesca Abra (1613 circa; Firenze, Palazzo Pitti)
Giuditta, ovviamente, patentemente, con la lucida e determinata violenza del suo gesto non è solo la liberatrice di Betulia e del suo popolo dall’assedio assiro. Giuditta è Artemisia. Ma è anche Antigone, è Medea. Passano i secoli, i millenni e Giuditta veste i panni combattenti di Maria Giulia Cardini, comandante partigiano (…forte il cuore e il braccio è nel colpir…) con il nome di battaglia di Antonio; né è un caso che il bel ritratto che della ribelle «Ciclone» ci restituisce Rossella Pace si apra proprio con l’evocazione di Giuditta e Abra che, saldamente sodali nell’azione e in perfetta intesa, avvolte dalla policrome e drappeggiate vesti si stagliano risolute e potenti dal tenebrismo caravaggesco magistralmente ricreato dalla grande pittrice romana.
Giuditta, Antigone, Medea, Maria Giulia, storie diverse e un unico denominatore: donne in un mondo di uomini. La loro condizione nella storia, e nell’età moderna in particolare, la loro ricerca di uno spazio culturale, spirituale e politico è efficacemente tratteggiata da Giovanna Motta nell’ampio, brillante e documentato saggio che apre questo numero e che ci introduce in una teoria di ritratti che si apre sull’Antigone, nata contro già nel nome, di Patrizia Arizza e prosegue con Medea (Angelo S. Angeloni), simbolo tragico di un conflitto insanabile, radicale, totale, autolesionista.
Rispetto a queste storie di sradicamento sociale tramandate della classicità, quella di Eleonora d’Arborea è diversa ma non meno grande. “Regina fra i re” Eleonora ci viene presentata, nell’efficace e documentato studio di Antonio Casu, nel suo rivoluzionario ruolo di legislatrice, il cui destino è indissolubilmente legato alla Carta de Logu. Così come quello di Lady Morgan, restituitoci con elegante analisi storica da Ester Capuzzo, si intreccia alla appassionata testimonianza di Italy, un reportage letterario, un diario di viaggio, un manifesto ideale e patriottico destinato a segnare la nostra cultura risorgimentale. Diversa, eppure straordinariamente affine, è poi la storia che ci racconta Elena Campana nel suo ritratto di «un’americana a Roma»: Margaret Fuller, singolare ed eccentrica figura di intellettuale, polemista, giornalista, patriota mazziniana, coraggiosa anticonformista destinata a una fine prematura quanto tragica.
Dal primo Novecento si propongono due ritratti diversi e diversamente affascinanti: quello di Argentina Altobelli e di Velia Titta. La vita di Argentina Bonetti Altobelli, come emerge con efficacia dal bel saggio di Anna Salfi, è straordinaria testimonianza di attivismo politico e sindacale di un’appassionata socialista antesignana di molte battaglie per l’emancipazione femminile, compresa quella per il divorzio. Non meno avvincente la vicenda letteraria, culturale e umana di una sensibile intellettuale, Velia Titta Matteotti – ce la racconta Alberto Aghemo – il cui spessore è stato troppo spesso mortificato dalla riduttiva immagine di “vedova del martire”. Completa questo trittico italiano novecentesco Rossella Pace che –lo abbiamo già accennato – ci restituisce una storia avvincente e troppo a lungo
relegata ai margini della vulgata resistenziale: quella della comandante partigiana liberale Maria Giulia Cardini.
Donna contro è stata senz’altro anche Hannah Arendt: la sua intelligenza provocatoria e controversa, il suo essere fuori dagli schemi, la sua affascinante carica eversiva ne fanno un punto di riferimento imprescindibile del pensiero filosofico-politico, e non solo, del Novecento. E non è un caso, ce lo ricorda Rosaria Catanoso, che la sua fortuna sia quanto mai viva e attuale.
Uno spazio a sé si ritaglia, in questa galleria di personalità femminili esemplari, Liliana Gadaleta Minervini, intervistata da Mirko Grasso: una bella figura di intellettuale che racconta il suo straordinario rapporto con Gaetano Salvemini e arricchisce con la sua originale testimonianza il percorso salveminiano che abbiamo inaugurato nello scorso fascicolo e che ci accompagnerà a lungo.
Questa galleria di ritratti – che non pretende di essere né esaustiva né tantomeno sistematica, ma ha la sola ambizione di dipanare il filo di una coerente passione – si chiude sul profilo di una persona a noi molto cara: Liliana Segre. Si può essere contro mille cose: le opere, i giorni, la cieca brutalità della Storia. Liliana Segre ha scelto di essere contro l’oblìo. Di più: contro l’indifferenza. Ce la ricorda, con le parole giuste, vibranti e partecipi della «persona coinvolta», Maria Paola Gargiulo.
Una rivista è luogo di lettura non meno che di scrittura. «Tempo Presente» lo sa bene e nella sua sezione finale, dedicata alle recensioni, vi racconta tre bei saggi: di Emilio Gentile, di Franco Ferrarotti e di un gruppo di ricercatori esperti in plurilinguismo e migrazioni del CNR. Li hanno letti per voi Gerardo Padulo, Angelo S. Angeloni e Alberto Aghemo.
E sul prossimo numero: Intellettuali e potere!
AGS e AA
La Fondazione Giacomo Matteotti e la Fondazione di Studi storici Filippo Turati per i tipi di Pisa University Press presentano
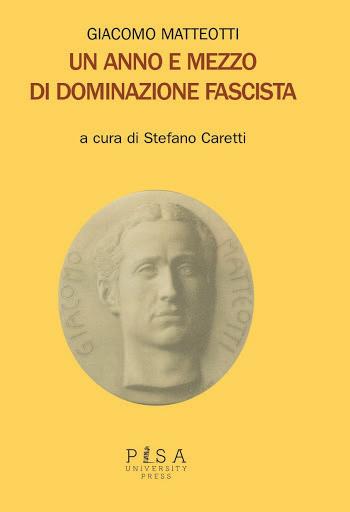
13° e ultimo volume delle Opere di Giacomo Matteotti, realizzato sulla base di documenti inediti recentemente rinvenuti presso l’Archivio storico della Biblioteca della Camera dei deputati
A cura e con un’Introduzione di Stefano Caretti Premessa di Maurizio Degl’Innocenti, con saggi di Angelo G. Sabatini e Alberto Aghemo e una Prostfazione di Paolo Evangelisti
371 pagine, € 28,00 - gennaio 2020 ISBN 978-88-3399-267-7










