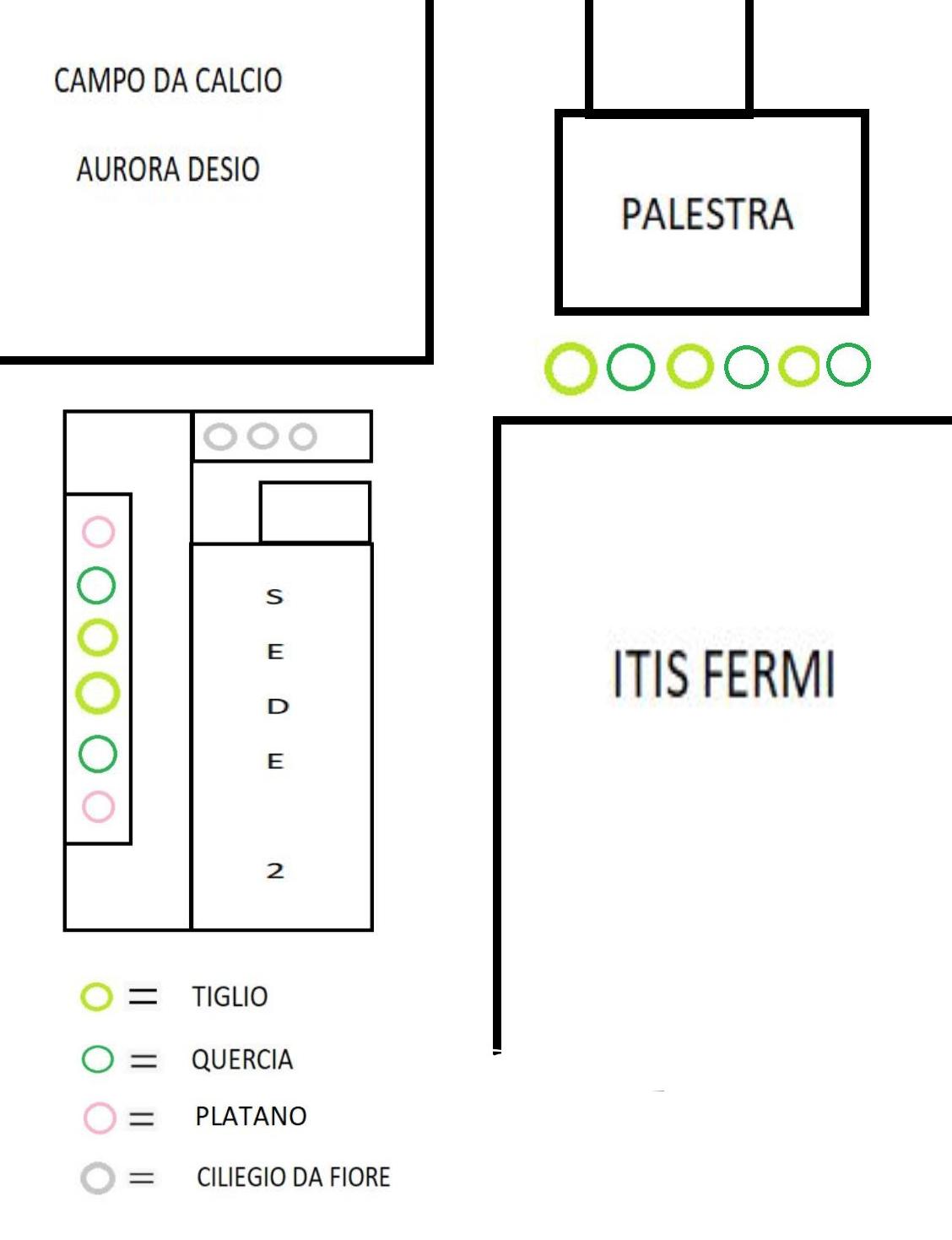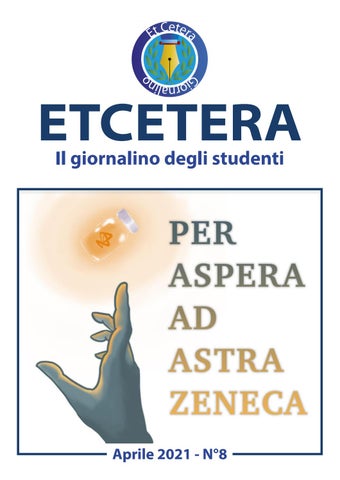7 minute read
La loro lotta è la nostra lotta: un’intervista ad Albertina So liani sulla crisi in Myanmar
ATTUALITÀ LA LORO LOTTA È LA NOSTRA LOTTTA
UN’INTERVISTA AD ALBERTINA SO LIANI SULLA CRISI IN MYANMAR
Advertisement
EMMA LAURA LONGONI, 3aa Nei primi giorni di febbraio era circolato su molti dei profili ironici che popolano Instagram un video: protagonista era una donna intorno ai 30 anni, in abbigliamento sportivo, intenta in alcuni esercizi di aerobica; una lezione di ginnastica trasmessa in streaming, con tanto di musica di sottofondo. Insomma, niente di strano, apparentemente. Senonchè, a un certo punto del video, dietro all’insegnante hanno iniziato a sfilare delle macchine corazzate. Prima una, poi due ed infine una decina.
Questo è il Myanmar.
Il Myanmar – o Birmania, per come si chiamava prima dell’imposizione, datata 1989, di una legge che ne cambiò il nome – è un Paese particolare: posto tra le enormi Cina ed India, presenta una popolazione divisa in 130 gruppi etnici e, appena conclusa la Seconda Guerra Mondiale, era lo Stato con l’istruzione migliore di tutta l’Asia. Oggi, invece, quella è una Nazione dal sistema educativo completamente smantellato e da cui scappano oltre 300.000 sfollati, a causa di inondazioni, insicurezza alimentare, conflitti armati, scontri tra comunità e massicci spostamenti oltre confine.
La colpa? Sicuramente della feroce dittatura militare che si impose violentemente nel 1962 e non allentò mai la morsa, fino a quando, nel 2012, si fu costretti ad ammettere in Parlamento la Lega Nazionale per la Democrazia, Partito che aveva stravinto tutte le elezioni precedenti, più o meno eque che fossero.
La comunità interzionale tutta era dunque convinta che il Paese fosse destinato a transitare, piano piano, verso un destino sempre più democratico. D’altronde, che cosa sarebbe potuto andare storto?
Nessun errore di valutazione fu più fatale: il video che si citava inizialmente, infatti, è datato 1 febbraio 2021 e le macchine corazzate, in quel momento, si stavano muovendo per sequestrare
il Presidente regolarmente eletto e la Consigliera di Stato (una sorta di Prima Ministra), per poi arrestare tutti i membri di spicco del Partito al governo. Insomma, da due mesi il Paese è ostaggio di 500.000 militari che, dal giorno successivo al golpe in poi, hanno iniziato a scontrarsi con la popolazione, scesa in piazza in massa contro la dittatura ed a sostegno di Daw Aung San Suu Kyi, la Consigliera di Stato che si citava.
Per comprendere le ragioni del colpo di stato e delle proteste successive, nonchè del profondo rapporto che lega * birman* e Suu Kyi, abbiamo intervistato Albertina Soliani, ex Senatrice, amica personale della donna e membra di spicco dell’”Associazione Amicizia Italia-Birmania”, che da anni si occupa di favorire il processo democratico nel Paese.
Quali sono le ragioni profonde del golpe? Sicuramente una: il timore dei militari di perdere un potere e delle ricchezze accumulate in 50 anni a causa delle ultime elezioni, quelle di novembre, che ancora una volta erano state vinte dalla Lega Nazionale per la Democrazia (si parla di una vittoria con percentuali larghissime, addirittura l’80% dei voti) e delle accuse che pesano sul capo del generale Hlaing, leader dell’esercito, a causa delle violenze da lui perpetrate contro i Rohingya, etnia birmana che è stata vittima negli ultimi anni di un violento genocidio. I militari, insomma, hanno avuto paura e, dopo una serie di dichiarazioni con cui denunciavano presunti brogli elettorali, hanno attuato una terribile mossa contro il popolo, che si è ribellato e sta resistendo grandemente. In Myanmar/Birmania sta accadendo un confronto quasi estremo tra una dittatura che vuole imporsi e la democrazia che la gente rivendica.
Sappiamo che nessun ente esterno al Paese si aspettava un evento del genere. É stato poi fatto qualcosa per condannare il gesto? Ci sono state numerose reazioni di condanne a parole, ma pochi gesti: lo stesso Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che ha il compito di dare una direzione concreta all’Organizzazione, per il momento non ha ancora mosso alcun provvedi-
mento concreto ai danni dei militari. Il Consiglio è infatti costituito anche da Cina e Russia, che sono vicine al regime del Paese e non hanno particolari sensibilità democratiche. Le uniche potenze che hanno messo in atto alcuni interventi fattuali sono state innanzitutto gli Stati Uniti, e successivamente l’Unione Europea, che hanno entrambi imposto sanzioni economiche al Paese e congelato i beni dei generali birmani all’estero, lasciandoli di fatto senza soldi. Ma i vertici dell’esercito avevano tenuto in conto che sarebbero rimasti isolati: il piano era preparato e sono decisi a giocarsi tutto per il potere.
Perchè il „giocarsi tutto“ di cui parla ha significato sequestrare proprio Daw Aung San Suu Kyi? Perchè era necessario togliere di mezzo tutte le figure di spicco della Lega Nazionale per la Democrazia e lei è senza dubbio la prima a cui si è pensato: basti pensare che i birmani la chiamano „Madre“. Il fatto è che, nel toglierla di mezzo, non si è tenuto conto di un elemento fondamentale (che poi è il motivo per cui viene chiamata „Madre“, come dicevamo): nella figura di San Suu Kyi c’è un’identificazione profonda con la vita del popolo, che è profondamente grato nei suoi confronti e vive la Politica con il suo stesso spirito. Lei è infatti la persona che ha di fatto reso possibile l’apertura del regime verso una modalità di governo meno impositiva; addirittura la isolarono in casa per più di 10 anni per questo. Stiamo parlando di un Premio Nobel per la Pace. Il popolo ora va in piazza con il suo modo di pensare la politica e la democrazia, che si riassume in una convintissima “non violenza”. Quella di Suu Kyi è, proprio a sua detta, una “rivoluzione spirituale” e lei, per i birmani, è una luce che illumina sui valori di rispetto e giustizia. Dunque la gente è scesa in piazza. Ci può raccontare le dinamiche delle proteste? Le manifestazioni sono iniziate il giorno stesso del golpe, in maniera spontanea, per poi divenire fortemente organizzate; così sono iniziati gli scioperi: innanzitutto numerosi medici e sanitari hanno iniziato ad uscire dagli ospedali pubblici e curare le persone in ambulatori di fortuna, gratuitamente. Poi i bancari si sono rifiutati di entrare nelle banche, i ferrovieri di guidare i treni e gli insegnanti di fare lezione. Queste persone stanno bloccando un Paese: siamo in una condizione tale per cui i militari hanno il potere ma il Paese non ne vuole più sapere di loro e da ormai quasi due mesi l’esercito è impiegato unicamente per contrastare le proteste.
Che ruolo hanno * giovani in tutto questo? I ragazzi sono sicuramente l’anima e la mente delle manifestazioni di piazza, prima di tutto perché costituiscono il 45% della
popolazione e dunque la parte preponderante della vita sociale, poi in quanto sono i più determinati (tanto da essere sempre più spesso vittime di pestaggi e uccisioni). Sono in contatto con alcuni di loro, nonostante il bloccaggio della rete Internet, e non di rado mi è capitato di leggere frasi quali “come si permettono di rubarci il futuro”. Quelli sono giovani che non sono cresciuti con la dittatura, ma con la speranza che lo spiraglio di democrazia che si stava concretizzando sempre di più e non sono disposti a rinunciare a tutto questo. E le modalità con cui si proteste sono figlie di questa componente sociale: si utilizzano molto i social per organizzarsi – sempre attenti a non incappare nel già citato blocco di Internet – e in piazza si canta, si balla, si urlano slogan.
Quali scenari prevede per il futuro? È difficile prevedere uno scenario, tutto è ancora in gioco: sappiamo che i militari non vogliono arrendersi e non fanno entrare nessuno nel Paese, neppure l’inviata delle Nazioni Unite Christine Schraner Burgener, che da ormai due mesi tenta in tutti i modi di passare il confine. Dall’altra parte, i manifestanti continuano a protestare, nonostante la significativa escalation di violenze: si contano ad oggi, infatti, più di 400 morti ed il28 febbraio un bambino di addirittura 4 mesi è rimasto vittima di un proiettile, perdendo l’occhio sinistr. La gente insomma, nonostante l’esercito spari ormai praticamente in modo indiscriminato su chiunque passi per strada, non ha intenzione di cedere. Inoltre, è ormai noto che i movimenti di Myanmar/ Birmania e di altre zone dell’Asia (Thailandia, Hong Kong, Taiwan) si stanno unendo, per farsi forza vicendevolmente. È ormai, ad esempio, unico il simbolo delle formazioni di tutte e tre queste Nazioni: le tre dita alzate, sul modello del film “Hunger Games”. Infine, alcuni dei politici eletti nelle elezioni di novembre sono riusciti a fuggire alle retate ed a riunirsi online, costituendo un gruppo di rappresentanza provvisoria del Parlamento per come era pre-golpe e cercando appoggi anche nelle milizie etniche armate, con il rischio che si possa innestare un conflitto violento.
Ci pare dunque che la situazione, come ci ha raccontato Soliani, sia ancora sospesa: non ci resta che aspettare e, soprattutto, sperare che la rivoluzione spirituale della gentilezza di Suu Kyi possa fare davvero la differenza.
Perché la posta in campo è molto alta: la vita o la morte, la libertà o l’oppressione.
E in un mondo sempre più connesso, la loro lotta è anche la nostra. Anzi, deve esserlo.