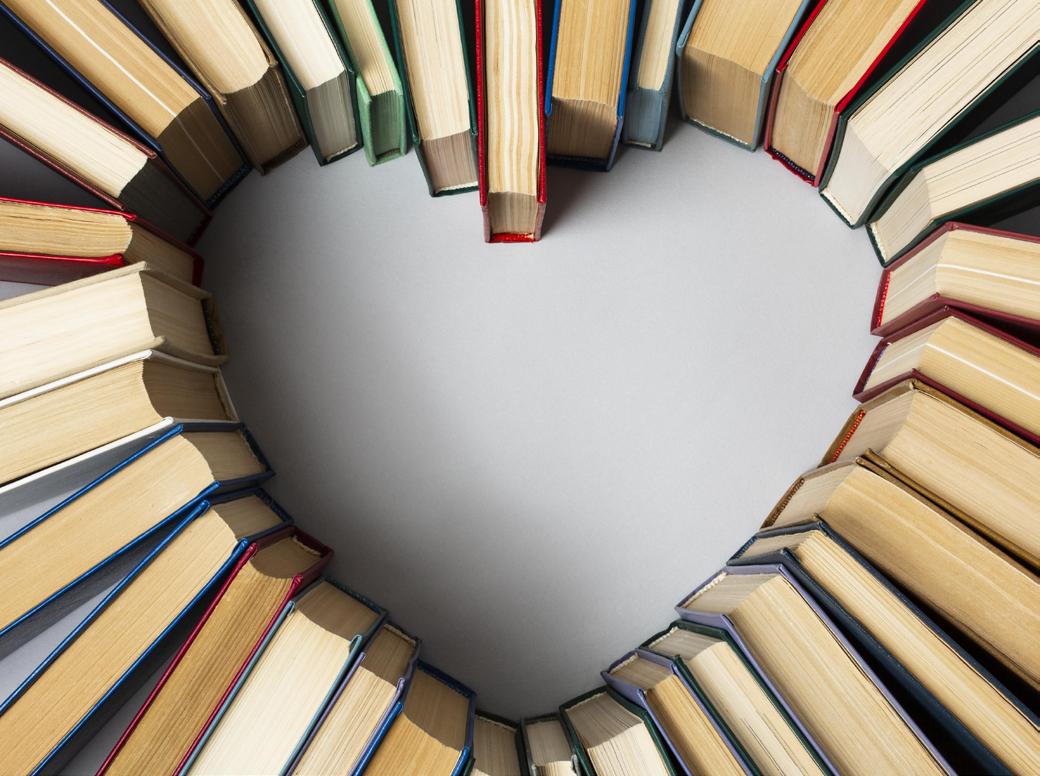7 minute read
BIBLIOTERAPIA: IL POTERE DELLA LETTURA
di Martina Campanelli
Leggere “fa bene”: lo sostengono da sempre le insegnanti, scrittori, filosofi, psicologi, e chiunque coltivi la passione per la lettura, ma non sempre ci soffermiamo sugli specifici benefici della stessa. Numerosi studi hanno dimostrato che leggere stimola la mente, riduce lo stress, migliora le conoscenze, espande il vocabolario, migliora la memoria, rende più forte la capacità analitica del pensiero, migliora il livello di attenzione e di concentrazione, migliora le abilità di scrittura. A partire dai dimostrati benefici della lettura nasce la biblioterapia, che utilizza il potenziale delle storie, dei racconti, appunto della lettura.
Advertisement
Al di là del termine che ha iniziato ad essere usato all’inizio del secolo scorso (per la prima volta dal teologo americano Samuel Crothers nel 1916), la biblioterapia è sempre esistita: sembra che, in antico Egitto, sulla porta della biblioteca di Alessandria, ci fosse scritto “ospedale dell’anima”. Aristotele, nel trattato Poetica, elabora il concetto di catarsi: l’uomo, assistendo ad uno spettacolo teatrale, si immedesima completamente nei personaggi vivendone stesse emozioni ed esperienze. L’ imitazione del reale consente di innescare un processo di liberazione dalle proprie passioni. Il concetto di biblioterapia è lo stesso: immergersi in una esperienza imitativa e quindi apprendere e comprendere tale esperienza.
La lettura dei libri, infatti, può avere un’influenza positiva sui sentimenti, aiutando le persone a riconoscere aspetti della propria personalità, a gestire problemi di natura psichica o a prevenirli. Infatti, è proprio dalla dinamica interazione tra libro e lettore che emerge spesso una prospettiva positiva nell’affrontare il problema che si manifesta nel presente. La biblioterapia può essere praticata in completa autonomia o con l’aiuto di un facilitatore (psicologo/psicoterapeuta). Si può scegliere, quindi, di fare esperienze di lettura traendo libera ispirazione in base al momento di vita in cui si è e in base alla curiosità o attrattiva che un dato libro in quel momento ci suscita, oppure di affidarsi ad un esperto di benessere e della salute mentale per approcciare ad un percorso di biblioterapia più strutturato, costruito sulle esigenze peculiari della singola persona. La lettura fa comunque parte della nostra crescita formativa, culturale e psicologica rappresentando una risorsa in tutto il ciclo della vita. Nell’infanzia, ascoltare una favola favorisce processi di crescita ed apprendimento sia sul piano cognitivo che emozionale e favorisce l’acquisizione di regole sociali, ruoli e norme. Nella fase adolescenziale l’intreccio delle relazioni con gli altri protagonisti del libro contribuisce alla costruzione della propria identità e delle relazioni sociali, a stimolare la ricerca della complessità interiore e lo sviluppo di capacità critiche e riflessive. Nella fase adulta può essere valido aiuto per elaborare situazioni che si presentano nella quotidianità e nella fase della vecchiaia il libro può riempire gli spazi di solitudine, può stimolare le funzioni mnemoniche, può riempire un tempo che diventa improvvisamente vuoto, con pochi impegni e in molti casi con pochi affetti. Leggere un libro apre la nostra mente: ci porta ad assumere una prospettiva nuova, ad elaborare il nostro vissuto attraverso altre vite e storie. I passaggi principali sono tre: • identifichiamo in quello che leggiamo riconoscendo nei personaggi e nelle vicende narrate qualcosa che nel bene e/o male ci appartiene;
• L’ identificazione ci porta a provare emozioni reali, quasi come fossimo anche noi partecipi della storia; • Da questo processo di identificazione usciamo arricchiti di un nuovo punto di vista, con una consapevolezza in più su noi stessi. Le chiavi sono infinite e non elencabili o etichettabili e differenti in base alla fase della vita in cui siamo: una situazione per noi problematica viene raccontata con ironia e impariamo così a ridere un po’ di noi stessi relativizzando quello che poteva sembrare un problema irrisolvibile, vediamo rispecchiate le nostre zone d’ombra e questo ci aiuta ad accettare aspetti della nostra personalità che magari non amiamo particolarmente, c’è un conflitto che esiste anche nella nostra vita ed il romanzo ci suggerisce una possibile soluzione, il poter fronteggiare gli ostacoli in un modo nuovo e diverso da quello cui si era abituati in precedenza.… In sintesi, un libro non offre mai un’unica direzione percorribile, ma ne nasconde infinite: tutto dipende dagli occhi e dallo stato d’animo di chi lo legge e in che momento della tua vita sei. A tal proposito, una piccola curiosità, è che a Firenze è stata aperta la “Piccola Farmacia Letteraria”, un luogo in cui puoi trovare il libro adatto alla situazione che stai vivendo. Su ogni libro trovi un cartellino colorato facendo ogni colore riferimento ad un problema specifico.
Porto quattro esempi di biblioterapia, il primo si basa su un libro che amo particolarmente gli altri su tre libri che fanno parte della cultura popolare, difficilmente non letti sui banchi di scuola o per propria curiosità:
1. ORGOGLIO E PREGIUDIZIO DI JANE AUSTEN
Elisabeth Bennet ed il Signor Darcy sono tra le coppie più famose della storia con il loro amore moderno, nonostante sia ambientato nella campagna inglese tra la fine del 1700 ed inizio 1800. Il Signor Darcy è un uomo ricco, chiuso e scorbutico mentre lei è una giovane di famiglia più modesta, non bellissima, intelligente e di carattere. Elisabeth all’ inizio lo respinge, non lo tratta mai con compiacenza ed alla fine, conoscendolo, se ne innamora. Elisabeth è un modello di donna anche a distanza di secoli: non è dominata o sottomessa da un uomo e non è influenzata dal fatto che sia più ricco o affascinante di lei…potrebbe insegnare molto sull’ innamoramento e sui rapporti uomo-donna.
2. “IL DESERTO DEI TARTARI” DI DINO BUZZATI
La fortezza Bastiani, dove Giovanni Drogo trascorrerà il resto della vita, è un avamposto militare dove si aspetta che i Tartari tornino a minacciare i confini e nell’ attesa i giorni passano sempre uguali, scanditi dai tempi della vita militare. Giovanni Drogo rimane fermo lì, nell’ attesa di quell’ evento che non si concretizza mai. Questo romanzo parla del tempo che passa, di come una vita intera possa trascorrere inchiodati alla nostra routine quotidiana. L’ interrogativo che ci poniamo è quindi: vogliamo consumare la nostra vita in attesa di quell’ evento che ci farà sentire realizzati? O il senso della vita lo troviamo nunc et ora? Il tempo resta inafferrabile: è il nostro bene più prezioso ma spesso più mal gestito. il libro è molto ricco di metafore ed è scritto con linguaggio semplice e lineare. La storia del pilota che a causa di un incidente con l’aeroplano si ritrova nel deserto è la storia di molte persone che si smarriscono per i cambiamenti imposti dalle fasi evolutive o per un evento tragico che improvvisamente impatta sulle loro vite, trasformandole. Il dolore e la paura impediscono al protagonista, e a coloro che stanno soffrendo, di vedere il problema da prospettive diverse. Le frustrazioni del pilota sono le frustrazioni di molti adulti che crescendo hanno rinunciato ai sogni disimparando ad ascoltare se stessi e gli altri e a vedere con gli occhi del cuore; l’incontro che il protagonista fa nel deserto con il Piccolo Principe è l’incontro che ogni adulto dovrebbe fare con il bambino che è stato, con quella parte infantile che ci permette di riappropriarci di sentimenti puri e semplici perché “Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano”. Gli uomini che il Piccolo Principe incontra nel suo pellegrinaggio sono uomini che hanno smarrito i sentimenti semplici e puri sostituendoli con legami fittizi, ritrovandosi soli nel deserto e soli anche con gli uomini; lo smarrimento degli uomini del romanzo è lo smarrimento che leggiamo nello sguardo di coloro continuamente in viaggio con «il vento che li spinge qua e là» per paura di rimanere fermi e pensare, impauriti e non così forti per attraversare il dolore. Il “Piccolo Principe” è un libro per affrontare il deserto che ognuno di noi a volte costruisce intorno a sé.
4. “LA COSCIENZA DI ZENO” DI ITALO SVEVO
Le memorie di Zeno Cosini vengono narrate dal suo analista per vendetta, deluso che il paziente si sia sottratto alle cure proprio quando iniziavano a mostrarsi i primi risultati. Zeno, con le sue inadeguatezze ed incapacità di smettere di fumare, ci insegna che a volte dobbiamo imparare ad accettarci come siamo, smettendoci di farci condizionare da chi ci dice che siamo sbagliati; quel sentimento di inadeguatezza che talvolta mina la nostra possibilità di essere felici, spesso è immotivato.
Ogni libro letto o suggerito può generare un esempio di identificazione o messaggio “biblioterapeutico; potrei sintetizzare il concetto di biblioterapia con un inciso di Petrarca: “Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me: alcuni mi portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso.”