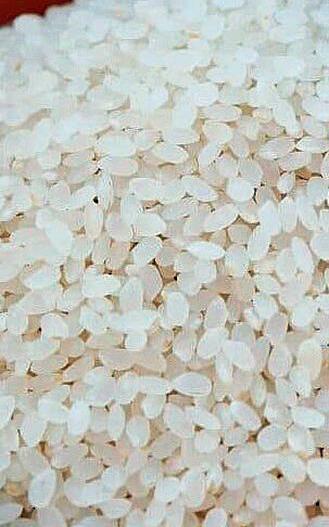2 minute read
Nelle Marche coltivato il riso almeno per 4 secoli
Due secoli fa nel
Fermano e nell’Ascolano piantati 96 ettari, nel Maceratese 19 e nell’Anconetano 6
Advertisement
A fine ’800 il declino e l’abbandono della coltura
DI UGO BELLESI noto che il riso ha avuto origine dalla Mesopotamia e che ebbe un grande sviluppo soprattutto in Giappone, Cina, India e Indocina, ma pochi sanno che anche i marchigiani sono stati produttori di riso. Questa pianta era giunta in Italia attraverso gli arabi che l’avevano diffusa in tutti i paesi del Mediterraneo. La prima documentazione scritta nelle Marche la troviamo nel racconto “Una lieta cena quaresimale” consumata l’8 marzo 1446 e offerta dal Comune di Fabriano al duca di Camerino, Giulio Cesare Varano, e al figlio Giovanni Maria. Nel menù figurava appunto una “Menestra di riso” con noci, mandorle, uva passa e zucchero. La coltivazione del riso nelle Marche iniziò solo nel ’600 e si protrasse con successo fin quasi alla fine dell’800. Si è accertato che nel 1826 venivano coltivati a riso nell’Ascolano e nel Fermano 96 ettari, nel Maceratese 19 ettari e nell’Anconetano 6 ettari. Nei documenti del tempo veniva chiamato “grano-riso” e già nel ’700 il riso delle Marche era apprezzato anche nelle altre regioni al pari di quello della Lombardia. Spesso in autunno, con lo straripamento dei fiumi, si creavano delle zone acquitrinose che per- manevano a lungo. È per questo che i contadini sceglievano una di queste aree per creare, tutto intorno, una specie di “argine” mentre all’interno si portava una grande quantità di terra asciutta fino a creare uno spazio rialzato di almeno 80/90 centimetri rispetto al livello del fiume o torrente. Era questo il sistema detto “a colmata” in cui il terreno rimaneva a lungo umido e questa era l’area preferita per coltivare il riso. Altro sistema era quello “delle vasche”. Si creavano, a fianco del corso d’acqua, come tante aree di terreno rialzato ma di poco, in modo tale che il lato a monte fosse un po’ più basso per fare entrare l’acqua, e più alto nel lato a valle, in modo tale che l’acqua penetrasse lentamente, così bagnava la prima vasca e, dopo aver inzuppato tutta la terra, travalicava nella seconda vasca e così via fino all’ultima vasca.Il criterio più semplice (e meno faticoso) era quello di approfittare delle periodiche inondazioni dei torrenti e piantare il riso in quelle zone paludose. Poi, una volta che le acque si erano ritirate, portare avanti la coltivazione del riso innaffiandolo periodicamente come si fa anche con altre piantagioni. Il riso si coltivava alla foce dei fiumi Aso, Chienti, Potenza, Esino, Cesano, Tesino, Menocchia, Ete Vivo ed Ete Morto. Il massimo della produzione si raggiunse nel 1878 quando il raccolto fu considerato “abbondante” nel Fermano, nell’Ascolano e nel Maceratese, “significativo” nell’Anconetano e “sufficiente ma di qualità buono” nel Pesarese. Il riso creò dei problemi perché si disse che l’acqua stagnante provocava la malaria, e protestarono anche i mugnai perché le risaie sottraevano acqua ai mulini che dovevano macinare il grano. Il segretario di Stato di papa Leone XII, cardinale Giulio Maria Somaglia, creò una commissione la quale sentenziò che le risaie non provocavano malaria. Però furono imposti dei vincoli, appesantiti più tardi da due leggi firmate nel 1866 e nel 1876 dal re d’Italia con cui si rese non più conveniente coltivare il riso nella regione.