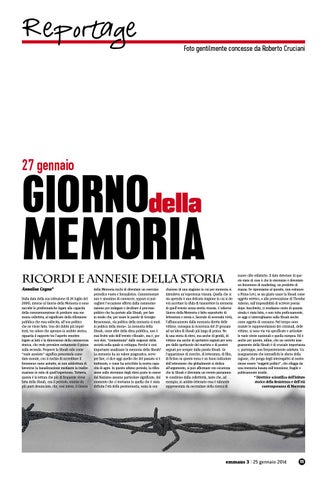Reportage
Foto gentilmente concesse da Roberto Cruciani
27 gennaio
GIORNOdella
MEMORIA ricordi e annesie della storia Annalisa Cegna* Dalla data della sua istituzione (il 20 luglio del 2000), intorno al Giorno della Memoria si sono raccolte le problematiche legate alla capacità della commemorazione di produrre una memoria collettiva, al significato della riflessione pubblica che essa sollecita, all’uso politico che ne viene fatto. Uno dei dubbi più impellenti, tra coloro che operano in ambito storico, riguarda il rapporto tra l’aspetto emotivo legato ai fatti e la dimensione della conoscenza storica, che vede prevalere nettamente il primo sulla seconda. Proporre la Shoah solo come “male assoluto” significa presentarla come dato morale, con il rischio di accreditare il fenomeno come astratto, se non addirittura di favorirne la banalizzazione mediante la trasformazione in mito di quell’esperienza. Tuttavia, questa è la lettura che più di frequente viene fatta della Shoah, con il pericolo, oramai da più parti denunciato, che, così inteso, il Giorno
della Memoria rischi di diventare un esercizio periodico vuoto e formalistico. Commemorare non è sinonimo di conoscere, eppure si può cogliere l’occasione offerta dalla commemorazione per indagare e decifrare il processo politico che ha portato alla Shoah, per fare in modo che, per usare le parole di Georges Bensoussan, «la politica della memoria si muti in politica della storia». La memoria della Shoah, come altre della sfera pubblica, non è mai frutto solo dell’evento «Shoah», ma è, per così dire, “contaminata” dalle esigenze della società nella quale si sviluppa. Perché è così importante analizzare la memoria della Shoah? La memoria ha un valore pragmatico, serve per fare, ci dice oggi quello che del passato si è trattenuto, e come ha arricchito la nostra capacità di agire. In questo ultimo periodo, la riflessione sullo sterminio degli ebrei posto in essere dal Nazismo assume particolare significato, dal momento che ci troviamo in quella che è stata definita l’età della postmemoria, ossia la con-
clusione di una stagione in cui per memoria si intendeva un’esperienza vissuta. Quella che si sta aprendo è una delicata stagione in cui si dovrà accettare la sfida di trasmettere la memoria di quell’evento senza averla vissuta. L’odierno Giorno della Memoria è fatto soprattutto di letteratura e storia e, facendo di necessità virtù, l’affrancamento dalla memoria diretta delle vittime, consegna la ricorrenza del 27 gennaio ad un’idea di Shoah più larga di prima. Ne fa una storia di ebrei, ma anche di gentili, di vittime ma anche di spettatori segnati per sempre dallo spettacolo del martirio e di posteri segnati per sempre dalla parola Shoah. Se l’apparizione di ricerche, di letteratura, di film, di fiction su questo tema è un buon indicatore dell’attenzione che globalmente si dedica all’argomento, si può affermare con sicurezza che la Shoah è diventata un evento pienamente condiviso dalla collettività, tanto che, ad esempio, in ambito letterario essa è talmente rappresentata da necessitare della ricerca di
nuove cifre stilistiche. Il dato deteriore di questo stato di cose è che lo sterminio è diventato un fenomeno di marketing, un prodotto di massa. Se ripensiamo al quesito, non estraneo a Primo Levi, se sia giusto usare la Shoah come oggetto estetico, o alla provocazione di Theodor Adorno, sull’impossibilità di scrivere poesia dopo Auschwitz, ci rendiamo conto di quanta strada è stata fatta, e non tutta proficuamente, se oggi ci interroghiamo sulla Shoah anche come oggetto di consumo. Nel tempo sono mutate le rappresentazioni dei criminali, delle vittime, si sono via via specificate e articolate le varie storie nazionali e quella europea. Ed è anche per questo, infine, che un corretto insegnamento della Shoah è di cruciale importanza e, purtroppo, non frequentemente adottato. Un insegnamento che intensifichi lo sforzo della ragione, che ponga degli interrogativi al nostro stesso essere “soggetti politici”, che rifugga da una memoria basata sull’emozione, fragile e politicamente inutile. * Direttrice scientifica dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Macerata
emmaus 3 | 25 gennaio 2014
11