

Sostenibilità speciale
I protagonisti dell’approfondimento:

p. 64
Daniel Dubas
p. 63
Antonio Hautle
Direttore esecutivo UN Global Compact Network Switzerland & Liechtenstein
Delegato del Consiglio federale all’Agenda 2030

p. 67

p. 65
Reto Knutti Fisico del Clima, docente e ricercatore ETH Zürich
Jonathan Normand Fondatore e Ceo di B Lab Svizzera

p. 69
Pasqualino
Pansardi

p. 68 Giovanni Facchinetti
Fondatore e Managing Director di Positive Organizations
Ceo di GhenPower

p. 73
Patrick Calcagni
Direttore di Ferelca SA

p. 75
Roberto Ferroni
Sostenibilità speciale
A cura di Susanna Cattaneo

Ip. 70
Lorens Re Direttore di CASADA SA

p. 74
Michele Foletti Sindaco della Città di Lugano
Direttore dei Trasporti
Pubblici Luganesi

mperativo morale, economico o normativo? Maturano i tempi e la sostenibilità aziendale, da vocazione etica inscritta nella sensibilità di pochi virtuosi o nella natura stessa del proprio business, è assurta a driver strategico di performance e competitività, dimostrando ‘non solo’ di generare un impatto positivo su ambiente e comunità, ma anche di contribuire a ottimizzare costi e attrarre talenti, clienti e investitori. Volenti… o nolenti, perché anche attorno a chi non fosse ancora persuaso dalle prospettive di profitto iniziano a stringersi le maglie della regolamentazione, introducendo nuovi obblighi di rendicontazione e conformità. Mentre si avvicina il primo grande traguardo calendarizzato al 2030 dall’Agenda dell’Onu, parte il conto alla rovescia. Il momento non è dei più propizi, con l’Amministrazione Trump che, bollato il cambiamento climatico “la più grande truffa mai perpetrata ai danni del mondo”, rischia di indurre altri se non a imitarla disertando l’Accordo di Parigi, almeno a rallentare il ritmo quando la necessità primaria diventa quella di sopravvivere nell’immediato, reindirizzando le risorse per far fronte a bordate commerciali e tensioni geopolitiche che insidiano l’esistenza stessa di non poche imprese. Tuttavia dovrebbe ormai esser chiaro che le sfide ecologiche e sociali non si vincono con gli sprint ma richiedono un impegno continuativo, coerente e condiviso.
La politica può e dovrebbe incentivare ulteriormente con un quadro di riferimento chiaro e che sia, a sua volta, sostenibile. Porre paletti più rigidi potrebbe accelerare il processo, ma la verità è che alla fine tutto dipende dalla capacità (che non è solo volontà ma anche fattibilità) delle aziende di recepire le indicazioni e rispettare gli obblighi, trasferendo gli alti principi sul terreno. Certo, anche la domanda ha la sua parte: i consumatori possono incidere con le loro scelte di acquisto, sapendo però che allo stato attuale questo significa ancora spesso sborsare di più, a fronte di un costo della vita già in ascesa.
Insomma, se di progressi ne sono stati fatti negli ultimi decenni, le aziende svizzere - grandi e piccole - hanno davvero integrato gli obiettivi di sostenibilità nelle loro strategie o agiscono soprattutto sotto la pressione di reputazione e regolamentazioni? Prima di osservare da vicino esempi concreti di buone pratiche di realtà del territorio, la parola a cinque voci autorevoli, cinque promotori del cambiamento: Antonio Hautle, direttore esecutivo dell’UN Global Compact Network Switzerland & Liechtenstein; il fisico del clima Reto Knutti, docente e ricercatore dell’ETH di Zurigo; Daniel Dubas, delegato del Consiglio federale all’Agenda 2030; Jonathan Normand, fondatore e Ceo di B Lab Svizzera; Giovanni Facchinetti, fondatore e Managing Direcor di Positive Organizations.
Responsabilità e profitto in simbiosi
Dopo i verdi anni, la sostenibilità si avvia a entrare nell’età matura. Quella in cui ha dimostrato che responsabilità e profitto possono svilupparsi con reciproco vantaggio. Fondamentale la disponibilità di strumenti adeguati e il sostegno di un quadro normativo chiaro ma non invalidante, affinché incertezze del momento ed oneri di rendicontazione non compromettano competitività e sforzi delle Pmi.
Proprio in Svizzera, al World Economic Forum del 1999, Kofi Annan lanciava ai leader dell’economia mondiale un appello che ha fatto storia: sottoscrivere con le Nazioni Unite un “Global Compact of shared values and principles, which will give a human face to the global market”. Venticinque anni dopo, la rete internazionale che ne è nata unisce governi, imprese, agenzie Onu, organizzazioni sindacali e della società civile nella condivisione e nella diffusione di dieci principi guida nell’ambito dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della lotta alla corruzione.
In particolare negli ultimi anni, la consapevolezza della responsabilità e della sostenibilità è notevolmente aumentata. «In Svizzera dalle 14 aziende aderenti iniziali, la nostra rete nazionale è cresciuta fino a contare circa 400 membri. Nostro obiettivo è sostenere il maggior numero possibile di aziende con conoscenze, corsi di formazione, coaching, iniziative e strumenti. Grazie a un network internazionale molto ampio (25mila aziende, 120 paesi e 62 reti nazionali), siamo in grado di offrire fino a 120 proposte all’anno», sottolinea Antonio Hautle, direttore esecutivo dell’UN Global Compact Network Switzerland & Liechtenstein. Che la massimizzazione dei profitti non sia più sufficiente a rispondere alle sfide contemporanee sembra ormai una visione condivisa. I limiti planetari, la perdita di biodiversità e l’indebolimento della coesione sociale impongono un cambio di paradigma: «È tempo di integrare quattro capitali - umano, sociale, naturale ed economico - e misurare la performance non più attraverso tabelle di marcia isolate ma lungo traiettorie condivise», afferma Jonathan Normand, fondatore e Ceo della Fondazione B Lab Svizzera, parte di un movimento globale che conta quasi 10mila aziende certificate B Corp, un modello ibrido, dove profitto e impatto positivo convivono. «Molte Pmi e aziende familiari hanno
«Fino al termine dello scorso anno è cresciuta la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità e dell’Agenda 2030, fonte di ispirazione per un’economia responsabile. Al momento si avverte un vento contrario dagli Stati Uniti. Ma una cosa è chiara: se l’economia non diventerà più sostenibile, a lungo termine distruggerà le basi della vita, e quindi se stessa. Non abbiamo altra scelta»
già un forte radicamento sociale, che il ricambio generazionale e le aspettative dei collaboratori e dei clienti rafforzano. Ma siamo ancora in un’adolescenza della sostenibilità: è ora di consolidare le pratiche e radicarle nella governance», esorta Normand.
Ma se le reti internazionali offrono strumenti concreti e network, è la politica a fornire la cornice. Con la Strategia per lo sviluppo sostenibile 2030, la Svizzera collega obiettivi globali e misure nazionali, concentrandosi su tre priorità interdipendenti: consumo e produzione, clima-energia-biodiversità e dimensione sociale. «Abbiamo già compiuto progressi in settori quali l’istituzione di un quadro giuridico per promuovere il consumo sostenibile e l’economia circolare, l’adozione della legge sul clima e l’innovazione, l’elaborazione di strategie in materia di biodiversità, alimentazione, istruzione e uguaglianza, nonché l’attuazione di iniziative volte a ridurre le sovvenzioni alle energie fossili», rileva Daniel Dubas, delegato del Consiglio federale all’Agenda 2030. Tuttavia permangono alcune sfide ancora aperte:

Antonio Hautle
UN Global Compact Network Switzerland & Liechtenstein
5.600+ partecipanti coinvolti nelle sue attività
partecipanti 12% nuovi arrivi
Direttore esecutivo
Sostenibilità

Delegato del Consiglio federale all’Agenda 2030
In qualità di autorità federale incaricata del coordinamento della politica nazionale in materia di sviluppo sostenibile, l’ARE dispone in particolare dei seguenti strumenti di sostegno:

• Il programma di promozione dello sviluppo sostenibile sostiene finanziariamente, ogni anno, progetti innovativi che possono essere trasferiti e adattati ad altre regioni o contesti.
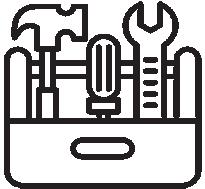
• I due Toolbox Agenda 2030: uno per i Cantoni e i Comuni e l’altro per le imprese, in particolare le Pmi. Quest’ultima offre alle imprese sostegno e orientamento sulla via della sostenibilità.
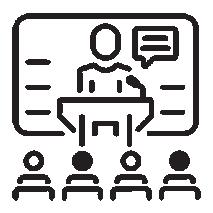
• Inoltre l’Are organizza conferenze sul tema. Prossimo appuntamento il 4 novembre, alla Eventfabrik di Berna, per il Dialogo 2030 per lo sviluppo sostenibile, sul tema “Sostenibilità grazie all’intelligenza artificiale? Opportunità e sfide per l’Agenda 2030”.
«Spesso le piccole e medie imprese non dispongono di personale e mezzi finanziari per dedicarsi intensamente anche alla sostenibilità oltre alle loro attività quotidiane. Indirettamente si trovano però a sottostare agli stringenti requisiti che i grandi gruppi regolamentati trasferiscono lungo le catene di approvvigionamento.
Un “effetto a cascata” già chiaramente visibile»
«L’attuazione degli obiettivi climatici, la decarbonizzazione, lo sviluppo dell’economia circolare e della biodiversità sono talvolta insufficienti, le sovvenzioni alle energie fossili persistono e l’efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili procedono troppo lentamente. Lo sviluppo sostenibile richiede un quadro normativo stabile, norme vincolanti e risorse finanziarie e umane sufficienti», osserva Daniel Dubas.
Un rallentamento che preoccupa anche il mondo scientifico. Per il Prof.Reto Knutti, a capo del gruppo di Fisica del clima del Politecnico di Zurigo, l’approvazione della Legge sul clima e l’innovazione nel 2023 e della Legge federale sull’approvvigionamento elettrico nel 2024 hanno sì gettato basi importanti per permettere alla Svizzera di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ma da sole non bastano. «A mancare non sono soluzioni e finanziamenti, ma un piano di attuazione concreto, con misure ambiziose che promuovano innovazione, energia pulita e business sostenibile. Persiste invece la percezione che la sostenibilità sia costosa, complicata e poco attraente», nota il Prof. Knutti.
Anche economia privata e politica non sempre viaggiano alla stessa velocità. Ad esempio, malgrado l’ampio sostegno da parte del mondo imprenditoriale, l’iniziativa promossa dall’Alleanza per le Imprese Sostenibili per introdurre una nuova categoria legale di “Impresa so-
stenibile”, che garantisca un quadro volontario, chiaro e credibile, per riconoscere le aziende virtuose, non ha ottenuto l’avvallo di economiesuisse e dell’Usam, prima di arenarsi alla Commissione degli affari giuridici del Nazionale. «Questo episodio è indicativo del divario tra le posizioni politiche e le esigenze operative delle imprese, che richiedono soprattutto chiarezza e coerenza dei riferimenti normativi, come conferma anche la nostra diagnosi sul campo, supportata dal nostro barometro Csr», avverte il Ceo di B Lab Svizzera che coordina l’Alleanza per le Imprese Sostenibili, coalizione che riunisce circa 500 aziende e associazioni.
Dalla teoria alla pratica
Strumenti e certificazioni a disposizione di chi voglia intraprendere un serio percorso di sostenibilità (Esg, Esg2go, Gli, Cdp, SbTi, Ecovadis, B-cop ecc.) non mancano. Paradossalmente la difficoltà diventa orientarsi verso quelli più adatti alla propria realtà e stabilire le priorità. «A prima vista, la gestione della sostenibilità è complessa, non diversamente da quella finanziaria. La domanda iniziale da porsi è: “Perché gestisco la mia azienda in questo modo? A cosa servono le nostre attività economiche?”», suggerisce Antonio Hautle, citando anche la necessità di una “doppia analisi di materialità” per avere una visione integrata del rapporto tra impresa, ambiente e dimensione sociale e valutare i maggiori rischi, le opportunità e le responsabilità verso gli stakeholder. «Dapprima occorre concentrarsi sull’impatto delle proprie attività commerciali materiali. Ad esempio, una piccola società di consulenza si occuperà in via prioritaria degli effetti dei propri servizi di consulenza. Anche i pannelli solari sul tetto sono utili, ma non hanno la priorità. Seguono: 2-4 obiettivi per il primo anno, poi lo sviluppo (o l’adeguamento) di una strategia semplice e sostenibile. Solo in seconda battuta diventano rilevanti tutte le normative, in parte complesse, utili per tenere conto dei fattori rilevanti nel proprio settore economico e supportare il processo di transizione», consiglia il direttore esecutivo dell’UN Global Compact Switzerland & Liechtenstein. Per andare oltre iniziative frammentarie e integrare criteri Esg, è imprescindibile combinare strumenti di misurazione,
Daniel Dubas
governance e percorso di miglioramento continuo. «Occorre adottare un quadro di valutazione riconosciuto, tradurre gli impatti in indicatori comparabili e collegarli a obiettivi concreti. Al contempo il CdA va responsabilizzato, creando rituali di pilotaggio - comitati Esg, Kpi legati alla remunerazione, revisioni trimestrali - e introducendo negli statuti societari quello che chiamiamo mission lock, ovvero la tutela della finalità sostenibile dell’azienda anche in caso di cambiamento degli azionisti», osserva il Ceo di B Lab Svizzera. Accanto ai percorsi ad hoc, a poter fare la differenza sono anche coalizioni settoriali: nel comparto orologiero, ad esempio, B Lab Svizzera promuove acquisti collettivi di oro riciclato, standard comuni di ecoprogettazione e piattaforme condivise di due diligence sui fornitori. «È così che la sostenibilità diventa strutturale e operativa», sottolinea Jonathan Normand.
Le regole del gioco
La crescente complessità degli obblighi di rendicontazione pone però sfide significative, soprattutto alle Pmi. «Spesso le piccole e medie imprese non dispongono del personale e dei mezzi finanziari per dedicarsi intensamente anche alla sostenibilità oltre alle loro attività quotidiane. Indirettamente si trovano però a sottostare agli stringenti requisiti che i grandi gruppi regolamentati trasferiscono lungo le catene di approvvigionamento. Un “effetto a cascata” che è già chiaramente visibile», nota Daniel Dubas.
Burocrazia e barriere amministrative sproporzionate rischiano di minare la competitività delle aziende più piccole. «Mentre le aziende più grandi, spinte da opportunità, pressione e guadagni in termini di efficienza derivanti dagli investimenti compiono progressi più rapidi, le piccole sono costrette a convogliare tutte le risorse per cercare di redigere i rapporti richiesti finendo per spendere il meno possibile in misure durature», conferma il Prof. Reto Knutti.
Se in patria le normative sono ancora in via di definizione, l’economia elvetica votata all’export è già investita dalle numerose e complesse norme del Green Deal dell’Ue, principale partner commerciale della Svizzera e destinata ad assumere ulteriore rilevanza a fronte
«Contrariamente alla nostra percezione di noi stessi, siamo in ritardo rispetto ad altri come l’UE o la Cina che, ad esempio, controlla 57 delle 64 tecnologie chiave per la transizione, tra cui batterie, energia solare e chip. Capiscono che guidare l’innovazione garantisce la prosperità futura. La tecnologia climatica ed energetica è un importante mercato emergente, che dovremmo prendere più sul serio»
Quota emissioni CO2 incorporate nel commercio, 2022
Emissioni exp/imp in % emissioni produzione interna
Svizzera
Paesi a basso reddito
dei dazi Usa. Pur senza essere direttamente presenti sul mercato interno europeo, molte Pmi elvetiche sono integrate nelle catene di valore, pertanto la rendicontazione diventa un elemento critico per la loro legittimità operativa: 50mila, secondo le proiezioni di Avenir Suisse, sarebbero le aziende potenzialmente interessate e ulteriori oneri potrebbero sommarsi qualora il Consiglio federale, mettendo al primo posto la compatibilità, recepisse la direttiva Ue nella forma attuale. «L’Unione europea ha rinviato di due anni l’adozione degli standard della Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (Csrd), al 30 giugno 2026, il che lascia tempo per concentrarsi sul primo pilastro, mentre la Direttiva sui doveri di diligenza in materia di sostenibilità aziendale (Csddd) è entrata in

Reto Knutti
vigore nel luglio 2024. Pur applicandosi solo a grandi aziende genererà un effetto domino attraverso le catene di approvvigionamento anche sulla conformità delle Pmi loro fornitrici, che abbiano o meno filiali nell’ Ue. Per ridurre gli oneri e migliorare la trasparenza proponiamo insieme ai nostri partner un quadro di dieci temi prioritari, compatibile con i requisiti Ue e adattabile alle Pmi», dichiara il Ceo di B Lab Svizzera. Ma troppe norme non rischiano anche di frenare l’innovazione, cifra elvetica, che come noto non prospera quando si accede in regolamentazione? «Al contrario, la Svizzera può utilizzare proprio il suo potere economico per incoraggiare le innovazioni ecologiche, ad esempio attraverso investimenti in energie rinnovabili, economia circolare e prodotti finanziari
Fisico del Clima, docente e ricercatore ETH Zürich
Fonte: Global Carbon Budget (2024)
Fonte: Global Carbon Budget (2024)
Sostenibilità
“Perché avete deciso di redigere un rapporto sulla sostenibilità?”
Documentazione/ comunicazione volontaria
Preparazione a futuri possibili obblighi di legge
Richiesta clienti/fornitori
Richiesta azionisti/proprietari/ società madre
Favorire assunzione di capitale di terzi
Fonte: Mazars / ZHAW
Flussi annuali di fondi Esg globali mld Usd
Fonte: Morningstar Direct
sostenibili», suggerisce Daniel Dubas. Anche perché c’è chi ben lo ha capito e ci sta superando. «La Cina controlla già 57 delle 64 tecnologie chiave della transizione, tra cui batterie, energia solare e chip. Hanno capito che guidare l’innovazione garantisce la prosperità futura. Le tecnologie per il clima e l’energia sono un importante mercato emergente che dovremmo prendere più sul serio», avverte Reto Knutti.
Può però venire da chiedersi perché un paese che pesa solo per lo 0,1% delle emissioni globali debba impegnarsi tanto. «In realtà la nostra impronta di consumo è circa tre volte maggiore a causa delle importazioni. Ma, al di là del peso specifico, sono problemi che richiedono un’azione collettiva. Anzi: in quanto paese con maggiori risorse, tecnologia ed emissioni storiche siamo chiamati a dare l’esempio, come esplicita anche il principio della “responsabilità comune ma differenziata” formulato dall’Accordo di Parigi», puntualizza il climatologo.
Fonte: Mazars / ZHAW
Evidenza di greenhushing nella terminologia dei fondi sostenibili
sociale, bisogna investire nelle persone e contribuire a una transizione equa per tutte le parti interessate. I progetti con un impatto duraturo sono quelli che trattano la sostenibilità non come un’operazione di pubbliche relazioni, ma come un motore di innovazione, efficienza e resilienza aziendale a lungo termine», sottolinea Reto Knutti.
Paradossi insidiosi
C’è però una tendenza insidiosa che si sta diffondendo fra chi la sostenibilità la pratica seriamente: farlo lontano dai riflettori. È il cosiddetto greenhushing, che ha diverse motivazioni: da chi teme di essere accusato di non fare abbastanza a chi di fare solo in apparenza. «Lo si vede anche nel marketing: sempre più aziende includono la componente sociale ed ecologica nei loro prodotti e servizi come parte dei requisiti di qualità, ma quando li devono promuovere e vendere diventa scivoloso comunicarlo nel giusto modo. I confini con il greenwashing sono delicati. Anche su questo fronte, stiamo sviluppando strumenti per supportare le Pmi», rileva il direttore esecutivo dell’UN Global Compact Network Switzerland & Liechtenstein.
Fonte: Morningstar Direct
Il tempo però stringe: ormai difficile pensare di centrare la prima scadenza - il dimezzamento delle emissioni di gas serra entro il 2030. «Se lo faremo, sarà in parte perché acquisteremo compensazioni altrove, il che è altamente problematico. Molti speravano che le compensazioni a basso costo all’estero fossero sufficienti, ma la maggior parte di questi progetti non mantiene le promesse. Ad esempio, la Svizzera ha finanziato la sostituzione dei bus diesel con quelli elettrici in Thailandia, una transizione che probabilmente sarebbe avvenuta comunque e che quindi non ha evitato emissioni di CO2 aggiuntive. Inoltre, in un mondo a zero emissioni nette, l’unica opzione sarà investire nella rimozione permanente e di alta qualità dell’anidride carbonica», avverte il professore dell’Eth. La via è chiara: investire in rinnovabili, elettrificare dove possibile, ridurre le emissioni lungo la catena del valore (Scope 3) seguendo un percorso di obiettivi scientificamente fondati. «E poiché il vero impatto è anche
La sfida investe anche la finanza sostenibile: solo tra aprile e giugno, 382 fondi hanno purgato dall’acronimo Esg il loro nome, in conformità con l’entrata in vigore del Regolamento Ue sulla trasparenza della sostenibilità nei servizi finanziari (Sfdr), che impone agli asset manager di fornire informazioni più dettagliate riguardo ai rischi legati alla sostenibilità e all’impatto dei prodotti distribuiti nell’Unione europea. Insieme a rendimenti sottotono, tensioni geopolitiche e, in particolare, i venti ostili da oltreoceano, il sovraccarico normativo sta contribuendo a raffreddare la partecipazione ai fondi sostenibili, dopo la forte crescita che negli ultimi 20 anni da mercato di nicchia ne ha fatto tendenza dominante. «Ma al calo del primo trimestre 2025 è già seguito un rimbalzo», chiarisce Normand: «Si tratta di una correzione ciclica, non strutturale. I rischi sistemici (clima, biodiversità, equità) purtroppo permangono e sia gli investitori che le autorità di regolamentazione si concentrano sempre più sugli impatti reali e sulle rivelazioni utili alle decisioni. La Svizzera
può svolgere un ruolo di allineamento del capitale con risultati misurabili - al di là della “battaglia delle etichette” - basandosi su standard credibili e strumenti di finanza di transizione».
Come conclude anche un recente studio dello Swiss Finance Institute (Sfi), potrebbe essere l’inizio di una “finanza sostenibile 2.0”: più mirata, pragmatica, e meno suscettibile all’hype, ma meglio integrata nelle pratiche finanziarie tradizionali e guidata da obiettivi chiaramente articolati e credibili, con metodologie e risultati costantemente verificabili. Una traiettoria che ricorda da vicino quella delle imprese sostenibili: dopo l’adolescenza, è tempo di maturare.
Non farsi abbattere da venti contrari
La diserzione degli Stati Uniti, sfilatisi dall’Accordo di Parigi, non può che generare la preoccupazione che altri ne seguano il (cattivo) esempio.«Per ora tutti gli altri Stati stanno mantenendo fede agli impegni presi. C’erano e ci sono ancora voci che chiedono un impegno maggiore, come ho visto alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile dello scorso luglio. Una cosa è chiara: se l’economia non diventa più sostenibile, a lungo termine distruggerà le basi della vita e quindi se stessa. Non abbiamo altra scelta», conclude Antonio Hautle.
La maggior parte dei paesi sembra aver compreso che una rapida transizione dall’uso dei combustibili fossili è vantaggiosa sia dal punto di vista economico che geopolitico. «Più preoccupante è lo smantellamento sistematico della scienza e delle istituzioni da parte dell’amministrazione statunitense: le persone vengono licenziate, i finanziamenti tagliati, i siti web rimossi, gli strumenti spenti e le istituzioni smantellate. Tutto questo con l’obiettivo di mettere a tacere le voci critiche, sopprimere le prove e consolidare il potere», ammonisce il climatologo dell’Eth Zurich.
Essenziale sarà considerare la sostenibilità non come un “compito aggiuntivo”. «Sono proprio le disuguaglianze sociali, la crescita non sostenibile, i cambiamenti climatici, la distruzione dell’ambiente o i movimenti migratori causati dai conflitti che spesso sono all’origine di queste tensioni. L’Agenda 2030 rimane rilevante come quadro preventivo, poiché punta
«Molte Pmi e aziende di famiglia hanno già un forte radicamento sociale, rafforzato dal ricambio generazionale e dalle aspettative di collaboratori e clienti. Ma siamo ancora in una sorta di “adolescenza della sostenibilità”: è necessario consolidare le pratiche Esg e integrarle nella governance, anche inscrivendo l’impegno negli statuti societari per tutelarne la continuità nel tempo»
su una distribuzione più equa, sulla protezione del clima e sul rafforzamento della resilienza, consentendo di evitare instabilità e conflitti a lungo termine», dichiara il delegato per il Consiglio federale all’Agenda 2030, che il 17 ottobre sarà a Lugano, dove co-organizza un simposio con i sindaci di diverse città svizzere impegnate nello sviluppo sostenibile. «Torno con piacere in Ticino, un laboratorio interessante per l’attuazione dello sviluppo sostenibile, in particolare grazie alla stretta collaborazione tra gli enti pubblici locali, le Pmi e il mondo della ricerca (con l’Usi e la Supsi)», evidenzia Daniel Dubas.
Politica, scienza, economia e società civile: la sostenibilità è una missione corale, che richiede la partecipazione di tutti. Forse non sarà possibile soddisfare i primi traguardi che ci si è posti, strumenti e incentivi sono perfettibili, le strategie vanno affinate, le norme ponderate, gli sforzi moltiplicati, ma è ormai chiaro che il tempo di misurare il progresso in base alla capacità di sottomettere il pianeta e le sue risorse - naturali e umane - ai nostri egoismi è finito. La vera leadership non è forse quella di chi sa ascoltare e fare lavoro di squadra al posto di imporsi con autorità? Per finire magari per scoprire che, facendo di necessità virtù, ci sia molto più profitto da trarre che non a perseguirlo senza riguardi.
Susanna Cattaneo

~10.000 B Corps in oltre 160 settori industriali 1 milione di posti di lavoro presso le B Corps > 300.000 aziende utilizzano gli strumenti di valutazione di B Lab (tra cui il BIA)
Requisiti chiave: punteggio ≥ 80 nel BIA, mission lock (modifica statutaria), trasparenza pubblica, revisione dei rischi Nuovi standard (2025): requisiti obbligatori per tema di impatto, attuazione progressiva
>1.000 membri dell’ecosistema
600 aziende coinvolte (135 certificate)
55 settori rappresentati
>3.000 studenti hanno beneficiato di azioni di istruzione e formazione
B Corp svizzere per fatturato (mio Chf)
B Corp svizzere per Etp
Fondatore e Ceo di B Lab Svizzera
Jonathan Normand
L’ecosistema di B Corp
Scelta strategica con benefici misurabili

Giovanni
Facchinetti
Fondatore e Managing Director di Positive Organizations
Da molte aziende della Svizzera italiana la sostenibilità è ancora percepita come un impegno opzionale, se non una moda in declino. Ma chi fa parte di supply chain di clienti internazionali è ben cosciente che la realtà è cambiata: le richieste di certificazioni, rendicontazioni e impegni formali su obiettivi Esg non sono più l’eccezione, bensì la regola. I grandi gruppi, i buyer di enti pubblici, le aziende controllate da fondi di private equity non si limitano a implementare le proprie strategie climatiche, ma trasferiscono la responsabilità lungo tutta la catena del valore. Questo significa che anche la Pmi ticinese fornitrice deve dichiarare la propria impronta carbonica, fissare obiettivi di riduzione secondo standard riconosciuti (come la Science Based Targets initiative, SBTi) e dimostrare pratiche solide di gestione ambientale e sociale.
Tali richieste mobilitano risorse, umane ed economiche. Ma si tratta davvero di un costo? O piuttosto di un investimento, con un ritorno positivo e misurabile?
Per le aziende del nostro territorio che operano sui mercati internazionali o forniscono enti pubblici (ad esempio Armasuisse o l’Nhs britannico), questa pressione si traduce in due scenari concreti. Da un lato, chi si attrezza in tempo gua-
«Anche in tempi incerti, la sostenibilità non è un lusso da tagliare: è la lingua in cui il mercato globale comunica e negozia. Le aziende che la parlano fluentemente sono quelle che mostrano resilienza, accedono a nuove opportunità e riescono a garantire continuità operativa. Le altre rischiano di pagarne il prezzo: commesse perse, finanziamenti negati, dover correre ai ripari a brevissimo termine con importanti investimenti»
dagna continuità di mercato, affidabilità e un vantaggio competitivo. Dall’altro, chi rimane fermo rischia di essere escluso da gare d’appalto o di perdere clienti storici. In mercati globali sempre più regolati, la mancanza di dati Esg non è solo una debolezza reputazionale, ma sempre più un ostacolo commerciale.
A ciò si aggiungono i contesti normativi regionali e nazionali che, malgrado una decelerazione negli ultimi mesi da parte degli Usa e dell’Ue con il cosiddetto “Decreto Omnibus”, impongono a migliaia di aziende la rendicontazione dettagliata del proprio impatto ambientale e sociale. Molte di queste aziende hanno già filiali o clienti in Svizzera, e stanno trasferendo questi obblighi anche ai partner locali. Non è più una questione di se, ma di quando anche la Pmi ticinese riceverà la richiesta di fornire numeri precisi su emissioni di gas serra, uso di energie rinnovabili, diversità di genere o gestione dei fornitori.
In tempi incerti, è facile pensare di ridurre gli investimenti in ambiti considerati “non core” rispetto al fatturato immediato. Ma la sostenibilità non è un lusso da tagliare: è la lingua in cui il mercato globale, sempre di più, comunica e negozia. Le aziende che la parlano fluentemente sono quelle che mostrano resilienza, ac-
cedono a nuove opportunità e riescono a garantire continuità operativa. Le altre rischiano di pagare il prezzo dell’inazione: commesse perse, finanziamenti negati, dover correre ai ripari a brevissimo termine con importanti investimenti.
La sostenibilità è anche - e in alcuni casi soprattutto - gestione del rischio. Integrare i fattori Esg nella governance aziendale significa ridurre l’esposizione a volatilità esterne, come eventi climatici estremi, cambiamenti normativi o crisi reputazionali. Ma significa anche costruire una base solida per cogliere opportunità: innovazione, efficienza operativa, accesso a strumenti finanziari agevolati, maggiore competitività.
Non solo. Una solida strategia di sostenibilità può contribuire in modo diretto all’aumento della valutazione aziendale. Una maggiore trasparenza nei dati, la riduzione dell’incertezza e la capacità di anticipare i rischi rendono un’azienda decisamente più interessante per investitori, istituti di credito e potenziali acquirenti. In un contesto in cui il capitale è sempre più selettivo, disporre di metriche Esg affidabili può fare la differenza tra ottenere o meno un finanziamento agevolato.
C’è infine un altro aspetto spesso sottovalutato: l’attrazione dei talenti, in un momento storico in cui trattenere competenze qualificate è una sfida. Sempre più giovani professionisti scelgono di lavorare in organizzazioni che dimostrano una visione chiara sul proprio impatto sociale e ambientale.
Una strategia sostenibile non richiede investimenti sproporzionati: può partire da un’analisi delle emissioni, dal miglioramento dell’efficienza energetica, da politiche chiare sulla gestione della filiera. Passi concreti, integrati in una visione e una strategia di lungo periodo, che rafforzano la credibilità dell’impresa. La vera sfida oggi non è più decidere se investire nella sostenibilità, ma come farlo con intelligenza. Una strategia mirata - semplice, chiara e comunicata con precisione - può trasformare un obbligo indigesto in una leva competitiva. In definitiva, la sostenibilità non è più una questione etica o comunicativa: è un indicatore concreto del valore e della solidità futura di un’impresa.

Idrogeno, il propulsore della transizione
Con un approccio integrato, GhenPower trasforma il potenziale dell’idrogeno verde in soluzioni concrete per diversi settori. Fra le prime applicazioni, le comunità energetiche e gli zero net building.
Potrebbe rappresentare il propulsore chiave della decarbonizzazione: dotato di un’elevata densità energetica, l’idrogeno permette lo stoccaggio a lungo termine e, se generato tramite elettrolisi alimentata da fonti rinnovabili, rilascia soltanto vapore acqueo, senza emissioni di gas serra. Purtroppo tuttora il 95% della sua produzione a livello mondiale deriva da fonti fossili. Europa in testa, e Svizzera inclusa, sempre più sono ormai i governi a varare strategie per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle infrastrutture necessarie a concretizzarne il potenziale.
Fra gli alfieri del settore c’è la bellinzonese GhenPower SA, spin-off di Premel SA, leader nei sistemi di generazione di energia di emergenza. Fondata nel 2023, offre sistemi energetici fissi e mobili alimentati a idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili, come fotovoltaico, eolico e idrolettrico. I suoi servizi coprono l’intera catena di approvigionamento: dalla produzione allo stoccaggio (anche con idruri metallici, insieme al partner vodese GRZ Technologies), dalla distribuzione ai sistemi a celle a combustibile, servizi di integrazione e manutenzione. Un approccio completo e integrato per offrire soluzioni personalizzate a diversi settori, quali industria, residenziale, commercio e trasporti. Dopo i primi progetti pilota in Spagna e Regno Unito, GhenPower si concentra sul mercato con applicazioni concrete, come le Comunità energetiche rinnovabili. «Questo modello che aggrega individui, aziende o enti locali che collaborano per produrre, consumare e gestire energia da fonti rinnovabili, può trarre dall’integrazione dell’idrogeno vantaggi in termini di
efficienza, sostenibilità, autonomia e convenienza economica», spiega Pasqualino Pansardi, Ceo di GhenPower. L’energia in eccesso prodotta dal fotovoltaico può infatti essere accumulata nelle batterie per coprire i consumi quotidiani, oppure trasformata tramite elettrolisi in idrogeno da immagazzinare a lungo termine. Una riserva utile soprattutto nei mesi invernali o in caso di blackout, con il valore aggiunto di recuperare calore dal processo di conversione da destinare a riscaldamento e acqua calda. «Così le comunità energetiche raggiungono un’autonomia superiore all’85%», afferma l’Ing. Pansardi. Mercati chiave, Australia e Brasile, dove GhenPower si propone di rispondere all’approvvigionamento sostenibile delle aree meno servite dalla rete.
È invece tutto locale l’altro progetto di punta a cui sta lavorando GhenPower, uno dei primi Zero Energy Building (Zeb) non solo in Svizzera, ma in Europa. Il sistema integrato di elettrolizzatori, stoccaggio e celle a combustibile di GhenPower renderà il Figino Resort - già concepito con soluzioni tecnologiche e architettoniche in grado di garantire elevate prestazioni energetiche passive - capace di autoprodurre il restante fabbisogno di elettricità e calore senza emissioni. «Siamo particolarmente orgogliosi di esser stati scelti da System Evergreen AG, promotore del progetto, per fornire le nostre competenze chiave in ingegneria e concetto di sicurezza, sistemi di controllo, assemblaggio e messa in servizio, monitoraggio da remoto e manutenzione continua», sottolinea il Ceo di GhenPower. «Tutti i nostri sistemi prevedono monitoraggi ridondanti, con sistemi di backup che

Pasqualino Pansardi, Ceo di GhenPower.
permettono anche in caso di blackout di garantire una ventilazione continua: una misura semplice ma essenziale per mantenere la concentrazione dell’idrogeno al di sotto della soglia di sicurezza, trattandosi di un gas molto volatile - è la più piccola molecola esistente - altamente infiammabile e di cui, essendo inodore e incolore, è difficile individuare le fughe», osserva l’Ing. Pansardi.
Parallelamente, GhenPower sta valutando nuove opportunità, come l’impiego dell’ammoniaca (NH3) per semplificare il trasporto dell’idrogeno. L’ammoniaca occupa infatti meno volume a parità di energia e gode di una rete consolidata di trasporto e stoccaggio grazie al largo impiego nella produzione di fertilizzanti agricoli. Tramite il cracking, le sue molecole vengono separate nei loro elementi base: idrogeno e azoto. Di nuovo, Australia e Brasile in testa, ma anche Svizzera.
Ci sono poi diverse collaborazioni sul territorio, come le iniziative formative intraprese con la Scuola di Arti e Mestieri (SAM) e la Scuola Specializzata Superiore di Tecnica (SSST) di Bellinzona, o in prospettiva, progetti più articolati con SUPSI e USI per rendere ancor più efficienti e intelligenti i propri sistemi. A poco più di due anni dalla fondazione, GhenPower si conferma così in prima linea per portare sul mercato sistemi a idrogeno realmente sostenibili, coniugando innovazione, efficienza e indipendenza energetica.
GhenPower SA
Via Riale Righetti 24
6503 Bellinzona
+41 (0)79 156 68 27 ghenpower.ch
Un cantiere circolare dove lo scarto diventa risorsa

Dal progetto AET di Bodio, dove Casada SA è riuscita a riutilizzare in loco il 90% dei materiali di scavo, emerge il modello di un’impresa edile che fa della sostenibilità uno dei suoi valori competitivi.

Con 148 anni di esperienza nel settore delle costruzioni (eredità combinata della propria storia e di quella di Reali Costruzioni, confluite nel 2023), Casada SA rappresenta un esempio virtuoso di come tradizione e innovazione possano convergere verso un modello di business sostenibile. Il Rapporto di sostenibilità 2023, certificato dalla Camera di Commercio ticinese con un punteggio di 26/30, racconta di un’azienda che ha trasformato la sensibilità ambientale delle proprie origini montane in una strategia ESG strutturata e misurabile.
Ne parliamo con il direttore Lorens Re, che ci guida attraverso i progetti più significativi e le sfide future.
Fra i progetti recenti che vedono protagonista Casada SA, il riordino del comparto AET nella zona industriale di Bodio rappresenta l’eccellenza della vostra expertise in sostenibilità. Può spiegare nel dettaglio le innovazioni tecniche e ambientali che lo rendono così emblematico? L’intervento prevede la costruzione di un nuovo edificio di 4.500 metri quadri per i servizi amministrativi e operativi, la realizzazione di una nuova officina di 1.200 mq con tecnologie all’avanguardia, e il completo rifacimento della viabilità interna con standard di sicurezza elevati. Ma quello che rende questo progetto davvero unico dal punto di vista della sostenibilità è il nostro approccio alla rivalorizzazione del materiale di scavo.
Il progetto del riordino del comparto AET di Bodio richiede la massima competenza tecnica e sensibilità verso il patrimonio storico-industriale di un sito che racchiude oltre un secolo di storia energetica.
Abbiamo raggiunto un traguardo straordinario: il 90% di questo materiale è stato lavorato e riutilizzato direttamente in cantiere attraverso tecnologie innovative. Il cuore del sistema è il nostro vaglio e frantoio ibrido, macchine di ultima generazione alimentate da un sistema che riduce drasticamente i consumi energetici e le emissioni di CO2 nell’aria. Questo impianto trasforma il materiale grezzo in prodotti finiti di alta qualità: dai misti granulari per i sistemi di drenaggio delle nuove infrastrutture, al misto per i sottofondi delle aree di circolazione pesante, dagli inerti selezionati per i getti di calcestruzzo della nuova officina agli aggregati per le pavimentazioni specializzate. Il nostro parco macchine riflette questa filosofia: utilizziamo escavatori ibridi che combinano motore diesel ed elettrico, riducendo consumi ed emissioni del 30% rispetto ai modelli tradizionali. Queste tecnologie non solo minimizzano l’impatto ambientale, ma ottimizzano i costi operativi del 15-20%, dimostrando che sostenibilità ed efficienza economica vanno di pari passo. Quali sono state le principali sfide tecniche? Le sfide tecniche sono state notevoli: gestire questo volume di materiale senza conferimenti esterni, garantire la piena continuità operativa dell’impianto AET durante tutto il periodo dei lavori - aspetto critico per il servizio elettrico cantonalee rispettare i severi standard ambientali per le emissioni acustiche e atmosferiche. La soluzione è stata un approccio sistemico integrato: eliminando i trasporti esterni abbiamo azzerato centinaia di viaggi di camion che sarebbero stati necessari per il conferimento in discarica e l’approvvigionamento di materiali dall’esterno. Questo significa riduzione dra -
stica di traffico pesante, polveri, rumore e inquinamento per le Tre Valli. Inoltre, la lavorazione in loco ci ha permesso di controllare ogni fase della trasformazione, garantendo materiali di qualità superiore perfettamente calibrati sulle specifiche tecniche di ogni applicazione. È economia circolare nella sua forma più pura: quello che tradizionalmente sarebbe considerato “rifiuto da smaltire” diventa risorsa preziosa per la costruzione stessa. Il rispetto dell’ambiente fa parte del Dna di Casada. Questa sensibilità come si è evoluta in una strategia ESG strutturata?
Siamo partiti dal rispetto per l’ambiente tipico di chi vive in Valle di Blenio. Questa sensibilità si è trasformata in strategia strutturata con l’ottenimento delle certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 nel 2023. Abbiamo sviluppato un Sistema di Gestione Integrato che amalgama qualità, ambiente e sicurezza, trasformando ogni vincolo normativo in opportunità di efficienza. Il cambio di passo è avvenuto quando abbiamo compreso che le sfide del XXI secolo richiedono risposte sistemiche e misurabili.
« A rendere unico il progetto AET di Bodio è il nostro approccio alla rivalorizzazione del materiale di scavo: ben il 90% è stato lavorato e riutilizzato direttamente in loco attraverso tecnologie innovative. Quello che tradizionalmente sarebbe considerato “rifiuto da smaltire” diventa risorsa preziosa per la costruzione stessa»
Lorens Re, Direttore di CASADA SA

Quanto contano le certificazioni ISO nei rapporti con clienti e stakeholder?
Le certificazioni ISO rappresentano un fattore competitivo fondamentale, dimostrando la nostra capacità di gestire progetti complessi rispettando i più alti standard. Tuttavia, il mercato presenta ancora resistenze: il “premium” dei prodotti sostenibili viene spesso percepito come costo ingiustificato quando non si considera il ciclo di vita completo. La committenza pubblica mostra maggiore sensibilità rispetto a quella privata. Per sensibilizzare serve più formazione sui benefici economici a lungo termine: manutenzione ridotta, valore dell’immobile, qualità di vita degli utenti. Come create valore per l’economia locale? Attraverso scelte concrete e misurabili: oltre il 96% dei nostri acquisti proviene da fornitori ticinesi, il 70% dei nostri 124 collaboratori risiede nella comunità locale. Offriamo opportunità di apprendistato ai giovani e sosteniamo associazioni locali non solo finanziariamente, ma fornendo competenze e mezzi. Nei rapporti con le comunità cerchiamo sempre

Al centro del sistema che ha permesso a Casada di valorizzare il 90% degli scarti sul cantiere AET di Bodio, il vagliofrantoio ibrido, che riduce consumi ed emissioni, evitando centinaia di trasporti esterni e trasformando gli scarti in materiali di alta qualità.

di minimizzare l’impatto negativo delle nostre attività e siamo aperti al dialogo, puntando a un rapporto costruttivo con il territorio.
E il vostro personale come è coinvolto nella strategia ESG?
Nel 2023 e 2024, oltre il 32% dei collaboratori ha partecipato a corsi formativi non obbligatori, inclusi programmi di primo soccorso che arricchiscono il valore sociale delle persone. Abbiamo designato una figura specializzata in gestione integrata e istituito una sezione web dedicata alle storie dei dipendenti. Le risorse umane sono il cuore della sostenibilità: chi lavora con noi deve essere parte attiva della strategia.
Qual è il risultato in sostenibilità di cui siete più fieri?
La dimostrazione pratica che crescita e sostenibilità sono compatibili. Nel 2024, con un fatturato cresciuto a 31 milioni di franchi, abbiamo ridotto le emissioni, migliorato la sicurezza e mantenuto un tasso di soddisfazione clienti pubblici superiore al 95%. Abbiamo dimostrato che si può crescere riducendo l’impatto ambientale.
Quali sono le novità ESG del 2025 e i prossimi passi?
Nel 2024 abbiamo migliorato il sistema di raccolta dati e introdotto sondaggi sulla soddisfazione gestiti da consulenti esterni. I prossimi passi prevedono corsi sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per tutto il personale, investimenti su macchinari sempre più efficienti dal punto di vista ambientale e il potenziamento della comunicazione con fornitori e stakeholder. L’obiettivo è creare una rete sempre più ampia di imprese responsabili, perché la sostenibilità è una sfida collettiva che richiede l’impegno di tutti gli attori del mercato ticinese.

Via Brugaio 5
6713 Malvaglia
Tel. +41 (0)91 8701217 malvaglia@casada.ch casada.ch
La solidità della leggerezza che valorizza gli edifici
Da oltre quarant’anni Ferelca realizza strutture in carpenteria metallica leggera e posa i serramenti ad alte prestazioni di Finstral, combinando qualità artigianale, innovazione tecnica e materiali selezionati per creare soluzioni su misura, durevoli e ad alto valore estetico e funzionale.
Resistenza, leggerezza e versatilità: sono le caratteristiche che fanno della carpenteria metallica leggera un settore strategico per l’edilizia contemporanea. Nata come alternativa funzionale, è diventata a pieno titolo uno strumento progettuale, in grado di unire creatività, efficienza e sostenibilità. Strutture su misura, come cancelli, recinzioni, scale o parapetti, uniscono utilità pratica, estetica e durata nel tempo, contribuendo a costruzioni più efficienti e sostenibili, dall’industria agli spazi pubblici alle abitazioni private.
In Ticino, Ferelca SA rappresenta un punto di riferimento in questo ambito. «Con oltre quattro decenni di attività, abbiamo sviluppato una profonda conoscenza del settore, che ci permette di offrire servizi di consulenza e progettazione seguendo ogni fase, dalla concezione alla realizzazione finale», sottolinea Patrick Calcagni che, dopo la carriera da ciclista professionista, ha raccolto una decina di anni fa il testimone del padre Elio, fondatore dell’azienda nel 1983.
L’offerta spazia dalla carpenteria leggera ai serramenti. Quest’ultima divisione è stata sviluppata sin dai primissimi anni di attività grazie alla partnership con Finstral, gruppo altoatesino leader a livello europeo, di cui nel 1985 l’azienda ticinese ottenne la rappresentanza esclusiva per il Cantone.
«La nostra esperienza e la capacità di ascolto ci permettono di lavorare a stretto contatto con imprese generali, architetti, designer di interni e clienti privati, trasformando le loro visioni in realtà tangibili e funzionali. L’attenzione al cliente resta il fulcro della filosofia aziendale: ogni

Due progetti emblematici delle competenze di Ferelca SA. Sopra, il complesso di lusso del Nizza Paradise Residence, affacciato sul lago di Lugano, perfetto connubio di arte, natura e architettura d’avanguardia. Sotto, i serramenti Finstral posati da Ferelca valorizzano le due ville sorelle immerse nel paesaggio spettacolare grigionese, a Cauco, con dettagli raffinati e innovativi.
struttura metallica è un pezzo unico, progettato e realizzato nella sede di Montagnola dal nostro team specializzato, adattandosi di volta in volta alle richieste specifiche e alle diverse necessità territoriali», spiega Patrick Calcagni.
Negli anni Ferelca ha esteso la gamma di prodotti che oggi include recinzioni, ringhiere, scale, parapetti, verande finestre, portoncini, porte antincendio con certificazione federale, costruzioni per l’edilizia e l’industria. Un’attività equamente ripartita fra carpenteria leggera e serramenti, abbinando alla creatività e alle competenze specialistiche richieste dall’ideazione e dalla realizzazione delle strutture metalliche, l’aggiornamento continuo sulle ultime tecniche di installazione e sui nuovi modelli di Finstral. Con quasi 80 tipologie di anta per finestre, pareti vetrate, porte-finestre scorrevoli e a libro in quattro materiali e infinite colorazioni, l’azienda di Bolzano offre l’assortimento più completo d’Europa.

In un comparto come quello delle costruzioni, fra i più impattanti sul piano ambientale, la sostenibilità diventa un principio guida. Un primo elemento è la durabilità dei prodotti: le strutture metalliche progettate da Ferelca e i serramenti di Finstral installati decenni fa continuano a garantire prestazioni elevate, limitando la necessità di sostituzioni e consumo di nuove risorse. Nel caso della carpenteria leggera, la resistenza dei metalli impiegati agli agenti atmosferici e la possibilità di trattamenti anticorrosione allungano ulteriormente la vita delle opere.
E, già di per sé, le strutture metalliche leggere richiedono meno fondazioni rispetto a quelle in muratura o calcestruzzo, riducendo l’impatto sul suolo e sulle risorse naturali.
D’altra parte, i serramenti Finstral contribuiscono all’efficienza energetica degli edifici: grazie al nucleo isolante in PVC consentono, ad esempio, di ridurre fino al 20% l’energia necessaria al riscaldamento, con un impatto diretto sulla riduzione delle emissioni di CO2. L’azienda altoatesina è fra le più avanzate del suo settore per sostenibilità e ogni anno redige ormai un bilancio dedicato. «Un impegno che noi, come piccola azienda di famiglia, non possiamo ancora permetterci. Il nostro ciclo produttivo rispetta però le norma-
« La nostra esperienza e la capacità di ascolto ci permettono di lavorare a stretto contatto con imprese generali, architetti, designer di interni e privati, trasformando le loro visioni in realtà tangibili e funzionali. L’attenzione al cliente resta il fulcro della filosofia aziendale: ogni nostro progetto si adatta alle richieste specifiche e alle diverse necessità territoriali»
Patrick Calcagni, Direttore di Ferelca SA
Una visione cristallina
Oltre a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, i serramenti di Finstral si distinguono per un approccio alla produzione tra i più sostenibili in Europa.
L’azienda altoatesina segue internamente tutte le fasi della filiera, dallo sviluppo dei profili alla produzione diretta fino alla posa, per garantire non solo massima libertà progettuale ma anche sostenibilità e circolarità.
Dal 2012, anno in cui ha cominciato a concentrarsi sulla neutralità climatica che punta a raggiungere nel 2030, Finstral è riuscita a ridurre le proprie emissioni dirette di CO2 del 93% (trasporti esclusi), grazie a misure come il passaggio all’energia verde, l’ottimizzazione degli stabilimenti e l’installazione di impianti fotovoltaici su quasi tutti i tetti produttivi.
L’azienda ha inoltre sviluppato il Finstral Environmental Impact Board, uno strumento integrale per misurare la propria impronta ecologica, e pubblica ogni anno un bilancio di sostenibilità. A ciò si aggiungono le certificazioni ISO, che consentono di monitorare qualità, efficienza energetica, sicurezza e impatti ambientali, orientando gli investimenti verso processi sempre più sostenibili.

Il moderno impianto di riciclaggio consente a Finstral di riutilizzare internamente tutti gli scarti dei profili in PVC di propria produzione.

Le emissioni residue riguardano ormai soprattutto processi e attività precedenti e successivi alla produzione della stessa Finstral: i prossimi sforzi si concentreranno sull’ulteriore miglioramento dei materiali impiegati, come PVC, alluminio e vetro, su logistica e montaggio. Un esempio è la posa innovativa dei serramenti: al posto di lavorare direttamente sulla muratura, nelle ristrutturazioni Finstral propone il rivestimento del vecchio telaio e nelle nuove costruzioni privilegia la posa in due fasi con controtelaio e preassemblaggio. Poter contare su partner qualificati e costantemente aggiornati, come Ferelca, è dunque essenziale per assicurare la massima coerenza e sostenibilità.

tive e le certificazioni, offrendo massima sicurezza, trasparenza e rapidità di montaggio. Acciaio, metalli ferrosi, alluminio e vetro recuperati smantellando precedenti strutture sui cantieri edili sono sempre correttamente smaltiti, conferendoli alle imprese specializzate nel loro riciclo e valorizzazione in un’ottica di economia circolare. Con altrettanta attenzione selezioniamo i nostri fornitori fra aziende che garantiscano standard qualitativi, ambientali e sociali elevati. laddove possibile pressoché a chilometro zero: svizzeri, ticinesi o della fascia in confine. Dal 2023, la nostra officina, a Montagnola, è alimentata da un impianto fotovoltaico che copre oltre il 90% del fabbisogno energetico aziendale, con l’energia in eccesso reimmessa in rete nei periodi di chiusura. E un prossimo passo potrebbe essere la conversione della flotta aziendale all’elettrico», anticipa Patrick Calcagni. Misure che confermano l’impegno costante verso la qualità e la soddisfazione del cliente, capisaldi dell’approccio che ha permesso a Ferelca di distinguersi nel mercato, raccogliendo continuamente nuove sfide con motivazione e competenza per garantire l’eccellenza nel campo delle metalcostruzioni e dei serramenti.
Via Cadepiano 6
6926 Montagnola
Tel +41 (0)91 994 17 23 info@ferelca.ch
Il ruolo centrale delle politiche urbane
Conciliando una sana crescita socio-economica e la tutela del patrimonio ambientale, le città possono assumere un ruolo centrale nella transizione verso modelli di sviluppo sostenibile.
Equità sociale, inclusione, rispetto per l’ambiente e una gestione finanziaria oculata e trasparente, sempre più guidano non solo le strategie aziendali ma diventano anche le fondamenta su cui costruire lo sviluppo delle città, assicurando il benessere e la qualità della vita delle generazioni presenti e future. L’esponenziale urbanizzazione continua infatti ad aumentare la pressione sulle risorse naturali e sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Una sfida esplicitata anche da uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 - undicesimo della serie - esortando a “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”. Sebbene le aree urbane coprano appena il 3% della superficie terrestre, consumano tre quarti delle risorse mondiali e generano il 75% delle emissioni globali. Una pressione destinata ad aumentare, se si prevede che entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vi abiterà.
Sono diverse le iniziative a fare di Lugano un modello di sviluppo equilibrato e innovativo, tanto da avere ottenuto la nomina a città rappresentante della Svizzera al quinto Forum of Mayors 2025 svoltosi a Ginevra a inizio mese, quest’anno dedicato alle “Città che plasmano il futuro”. E sempre Lugano è stata scelta come sede del simposio in programma il 17 ottobre, in occasione dell’Sdg Flag Day promosso dall’UN Global Compact. Evento con cui culmina un anno da protagonista della prima campagna nazionale annuale di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo urbano sostenibile. Lugano ne è stata designata città-pilota, distinguendosi grazie al progetto #Luganosostenibile. Lanciato nel 2021 dalla Divisione Socialità per coinvolgere attiva-
mente i cittadini in iniziative che rendano la città sempre più sostenibile, resiliente e inclusiva, si è aggiudicato il concorso federale dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (Are).
Un percorso iniziato però già ben prima, nel 2016, con l’adozione della politica ambientale ed energetica, ulteriormente corroborato dalle Linee di sviluppo 2018-2028, aggiornate nel 2024 con il documento strategico “Lugano Duemilatrenta”.
«Oggi più che mai, lo sviluppo economico e sociale è strettamente legato alla capacità di creare comunità coese, inclusive e consapevoli del valore delle risorse naturali», afferma il sindaco Michele Foletti.
Visione strategica, politiche mirate, progetti innovativi, risultati raggiunti e futuri obiettivi della Città di Lugano sono illustrati nella seconda edizione del suo Rapporto di sostenibilità, pubblicato quest’estate.Tra le azioni prioritarie intraprese: l’ampliamento delle aree verdi cittadine, la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso, la creazione di spazi pubblici di qualità. La Città ha inoltre adottato un approccio strategico per la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana e l’efficienza energetica.
«Novità fondamentale di quest’anno è poi il Piano direttore comunale (PDCom), che traccia una visione strategica per lo sviluppo territoriale e urbanistico della città con orizzonte 2050. Integrando i 23 Piani regolatori esistenti, punta a valorizzare le identità locali, tutelare il patrimonio urbano e paesaggistico e affrontare i cambiamenti climatici con misure sostenibili», sottolinea Michele Foletti.
Lugano ha inoltre voluto cogliere l’occasione della seconda edizione del

Michele Foletti, Sindaco della Città di Lugano.
suo Rapporto di sostenibilità anche per un’analisi comparativa rispetto alle pratiche di monitoraggio e rendicontazione in materia di sostenibilità di otto altre città svizzere - Zurigo, Ginevra, Basilea, Berna, Losanna, Lucerna, San Gallo e Winterthur.
«Valutare il nostro posizionamento rispetto ad altre realtà svizzere rappresenta un passaggio strategico essenziale per orientare in modo mirato le scelte future dell’Amministrazione comunale e offrire una visione chiara delle pratiche esistenti e delle aree di miglioramento. Allo stesso modo consideriamo l’intero Rapporto di sostenibilità non solo un bilancio trasparente dello stato attuale del nostro Comune, ma anche una base ben strutturata da cui partire per consolidare e ampliare, anno dopo anno, le buone pratiche in tutti i settori della vita cittadina. Il nostro obiettivo è continuare a costruire una Lugano che sappia rispondere con efficacia alle sfide future, mantenendo al centro la sostenibilità in ogni sua dimensione: ambientale, economica e sociale», conclude il Sindaco Michele Foletti.
Il confronto fra buone pratiche è anche al centro del simposio in programma venerdì 17 ottobre, che invita i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, del mondo economico, accademico e della società civile a discutere sulle responsabilità e sulle opportunità che le città ricoprono quali motori della sostenibilità. Momento centrale, la tavola rotonda con i sindaci di Berna, Ginevra, Zurigo che testimonieranno le loro esperienze accanto a quella di Lugano, presentata da Michele Foletti.
© Città di Lugano
In linea col territorio

L’elettrificazione della Linea 5 rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno di TPL per una mobilità sostenibile e responsabile, al servizio della comunità e del territorio.
L’elettrificazione della Linea 5 rappresenta una svolta all’interno della strategia ambientale dei Trasporti Pubblici Luganesi (TPL). Il direttore Roberto Ferroni presenta il progetto, che vedrà l’entrata in servizio dei primi 8 bus elettrici entro fine 2025, anno in cui TPL festeggia anche il suo venticinquesimo anniversario.
Ing. Ferroni, perché si è scelto di partire dalla Linea 5 fra le sedici di TPL?
Testare la trazione elettrica su questa linea significa verificare l’affidabilità del servizio anche nelle condizioni più complesse. Il percorso, fra i più lunghi della rete, copre 16,4 km (andata e ritorno) con un dislivello di 117 metri. Con oltre 2,3 milioni di passeggeri all’anno, è una linea molto sollecitata, in servizio per 19,5 ore al giorno, con frequenze fino a 10 minuti, ed è servita unicamente da veicoli articolati, i più esigenti in termini di prestazioni. Inoltre, toccando ben sette comuni (Lugano, Massagno, Savosa, Vezia, Lamone, Cadempino e Manno), consente di mostrare concretamente i vantaggi della mobilità elettrica a un territorio più ampio. Quali benefici concreti porta la transizione a bus con propulsione elettrica? Oggi questa linea consuma circa 340mila litri di carburante all’anno, generando 845 tonnellate di CO2. Emissioni e polveri sottili che, passando all’elettrico, verranno eliminate, contribunedo al miglioramento della qualità dell’aria nel Luganese.
Inoltre, la silenziosità dei motori permetterà di ridurre l’inquinamento acustico, mentre la riduzione delle vibrazioni interne renderà più confortevole il viaggio e le condizioni di lavoro degli autisti. Elettrificare una linea non implica soltanto l’acquisto di nuovi veicoli… Esatto. È infatti necessario progettare e implementare un sistema integrato di ricarica. La difficoltà principale è stata individuare le ubicazioni più adatte per collocare le infrastrutture tecniche, come pantografi, armadi elettrici e cabine di trasformazione. Lungo la linea sono state installate due postazioni di ricarica rapida e in rimessa è stata realizzata una postazione di ricarica lenta. Trovare spazi idonei non era importante solo per ragioni logistiche, ma anche per armonizzare l’installazione con l’ambiente circostante, garantire la sostenibilità dei costi e assicurare la capacità di sostenere i carichi elettrici necessari. Un altro aspetto critico è stato il coordinamento con i fornitori di energia elettrica, per assicurare che le aree selezionate potessero ricevere la potenza necessaria in modo continuo e affidabile. Una sfida altrettanto rilevante l’ha posta la gestione del personale per formare gli addetti all’uso sicuro dei sistemi di ricarica e sensibilizzarli a una guida ecologica, in grado di ottimizzare l’efficienza energetica dei mezzi e ridurre i consumi.
A quanto ammonta l’investimento complessivo per il progetto?
L’investimento complessivo supera i 9

Roberto Ferroni, Direttore dei Trasporti Pubblici Luganesi (TPL).
milioni di franchi. Il finanziamento è stato garantito dai committenti, ossia il Cantone e i Comuni serviti dalla Linea 5, insieme a partner privati come AIL, BancaStato e Vaudoise Assicurazioni. Importante anche il sostegno dei contributi federali (Fondazione myclimate, UFAM e UFT), grazie a cui Cantone e Comuni non hanno dovuto sostenere costi supplementari rispetto all’impiego del vettore diesel.
Quali saranno i passi successivi?
Il piano è sostituire progressivamente i mezzi diesel dell’intera flotta con veicoli a propulsione elettrica, avviando un percorso di transizione sostenibile. Stiamo finalizzando lo studio per la Linea 3, con l’obiettivo di renderla completamente elettrica entro il 2030.
Il trasporto pubblico è sempre più al centro delle strategie urbane. A quali altre iniziative sta lavorando TPL?
Tra i progetti attuali, stiamo considerando ulteriori soluzioni innovative per ottimizzare l’uso di fonti di energia alternative nella flotta.
Un’ulteriore riflessione in atto è quella di massimizzare l’efficienza energetica, per favorire la condivisione tra imprese di trasporto delle risorse disponibili e per ridurre gli sprechi. Queste iniziative fanno parte di un percorso più ampio, volto a migliorare il servizio offerto alla comunità, integrando la mobilità pubblica con le esigenze del territorio e le opportunità tecnologiche del futuro.
