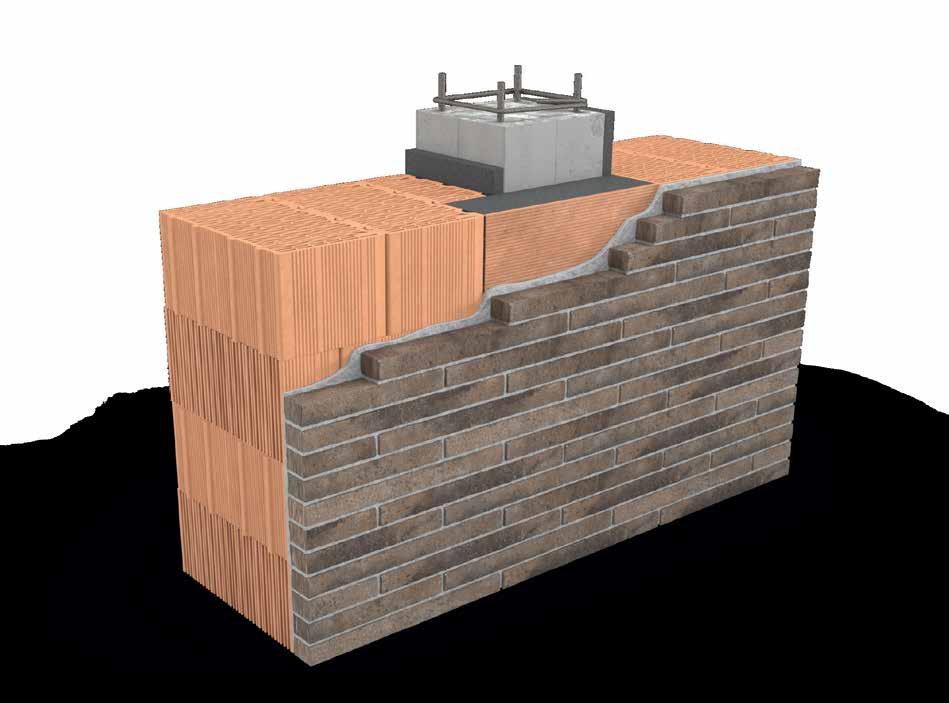C’È TUTTO UN MONDO DI SOLUZIONI.


Ponti Termici All Round




Muratura Armata High Performance Taglio Termico
Normablok® Più è il Sistema Costruttivo in laterizio completo adatto ad ogni esigenza progettuale e di cantiere. I blocchi sono realizzati in Poroton® e integrati con isolante Neopor® di Basf®: il risultato è un sistema costruttivo ad alta efficienza energetica, sicuro in tutte le zone sismiche. Normablok® Più è disponibile in diversi formati e adatto ad ogni specifica applicazione. Normablok® Più: più che un unico sistema, un sistema unico.
La Fiera delle Costruzioni
progettazione, edilizia, impianti
QUARTA EDIZIONE

SAIE BARI: l'evento che cresce con te!
Nelle sue tre edizioni, SAIE Bari ha registrato una crescita costante: nell'ultima edizione + 37% di visitatori e +44% di espositori. Un punto di riferimento per il settore, in continua evoluzione
Saloni speciali dedicati a: Infrastrutture, Calcestruzzo, Pavimenti e Rivestimenti, Serramenti, Sismica, Macchine e Attrezzature, Sicurezza in Cantiere, Nuovi sistemi costruttivi, Finiture Tecniche e Colore
Nuove soluzioni per i professionisti delle costruzioni
25.527
VISITATORI PROFESSIONALI
Dati ultima edizione
SAIE Bari 2023
407 ESPOSITORI
Inquadra il QRCODE per richiedere informazioni per esporre
75 ASSOCIAZIONI PARTNER

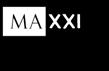

Conferenza promossa da

con la Direzione di Francesco Rutelli

Con la partecipazione di


In copertina:
•
6 PANORAMA
• a cura della redazione
EDITORIALE
10 Cura e trasformazione dell’eredità
• Francesco Rutelli
PROGETTI
Label architecture
12 Centro per la cura dei bambini
Porcheresse, Belgio
• Adolfo F. L. Baratta, Elena Bellini
C.F. Møller Architects
20 Dalum Paper Mill
Odense, Danimarca
• Pasqualino Solomita
AFF Architekten
28 Ex granaio
Berlino, Germania
• Roberto Gamba
Act_Romegialli - Paolo Donà
38 Biblioteca di Arconate
Arconate, Milano
• Antonio Acocella

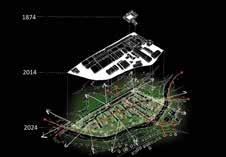

28

INTERVISTA
Eliana Cangelli

46 Le qualità a supporto dei processi di trasformazione del costruito
• Massimo Mariani
DESIGN
Angelo Lavanga
52 Installazioni del divenire
Valdarno, Pistoia, Milano
• Chiara Testoni
STORIA E RESTAURO
58 La parabola degli apparati decorativi fittili, evento ‘globale’ di fine Ottocento
• Fabrizio De Cesaris, Liliana Ninarello
NORMATIVA
64 Oltre la direttiva “case green”. L’impatto dell’economia circolare sul mercato edilizio
• Federico Della Puppa
TECNOLOGIA
70 Polo scientifico di Grugliasco: sostenibilità e innovazione nell’edilizia universitaria
• Laura Calcagnini, Marina Tonolo
CANTIERE
76 Sistemi costruttivi in muratura armata di laterizio per edifici residenziali
• Antonio Magarò
CRONACHE
84 Suggestioni di laterizio: la materia che conquista la Biennale 2025
• Flavia Santia
DETTAGLI
MDU Architetti
90 Costruire sul costruito
• Andrea Campioli
94 RECENSIONI
• a cura di Roberto Gamba

1945–2025: 80 anni di storia del laterizio italiano
Il mattone accompagna la storia dell’uomo fin dalle origini e, con la civiltà romana, il laterizio diventa protagonista di una tradizione costruttiva che arriva fino ai nostri giorni, mantenendo intatto il valore simbolico e materico della terra, sempre più attuale nell’edilizia sostenibile del futuro.
Già negli anni ‘20, l’industria dei laterizi in Italia aveva raggiunto una solida dimensione economica e produttiva. Ma è nel dopoguerra, il 7 novembre 1945 a Milano, che nasce l’ANDIL – Associazione Nazionale fra gli Industriali dei Laterizi – con l’intento di rappresentare un comparto strategico per la ricostruzione e lo sviluppo del Paese. Oggi, a ottant’anni da quella data, l’industria dei laterizi si inserisce in un
“Città nel Futuro 2030/2050”
per ripensare l’abitare
Dal 7 al 9 ottobre 2025, il MAXXI di Roma ospiterà la Conferenza Città nel Futuro 2030/2050, un’iniziativa promossa da ANCE con la direzione di Francesco Rutelli e il contributo di importanti partner nazionali – tra cui Confindustria Ceramica - e internazionali. L’obiettivo è ambizioso e necessario: costruire una visione condivisa per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e l’adattamento ai cambiamenti climatici, unendo concretezza progettuale e prospettive di lungo periodo. Due le date simbolo che guidano l’agenda dei lavori: il 2030, per ciò che è possibile e urgente realizzare fin da subito, e il 2050, come orizzonte delle trasformazioni più profonde, in linea con le grandi transizioni in atto, da quella climatica a quella energetica. La Conferenza si rivolge a istituzioni, imprese, comunità

contesto consolidato di rappresentanza unitaria: dal 2019, infatti, ANDIL è stata incorporata in Confindustria Ceramica, dando vita a un’unica associazione a cui aderiscono tutti i comparti industriali italiani che lavorano l’argilla. La collaborazione tra le due associazioni era attiva già dal 2010 attraverso la Federazione Confindustria Ceramica e Laterizi, e la fusione ha portato a una rappresentanza rafforzata, anche a livello europeo, dove entrambe le realtà appartenevano alla medesima
locali, progettisti, mondo associativo e del volontariato, promuovendo un confronto trasversale e aperto alle migliori esperienze internazionali. Il programma ruoterà attorno a due macro-temi: da un lato la rigenerazione urbana, la gestione delle risorse idriche e l’adattamento al clima estremo; dall’altro il diritto a un’abitazione dignitosa, accessibile e sostenibile per tutti. Sotto il profilo ambientale, la Conferenza punta a rilanciare il ruolo strategico di interventi integrati, tra pubblico e privato, in grado di affrontare con pragmatismo le sfide della crisi climatica: infrastrutture più resilienti, cittàspugna, depurazione e desalinizzazione, manutenzione programmata, governo delle acque e prevenzione del rischio sismico e idrogeologico. Sul versante sociale, si affronterà la crisi abitativa che investe l’Europa e l’Italia, con un focus sull’affordable housing. Giovani, studenti, anziani e famiglie a reddito medio-basso
Federazione, Cerame-Unie. Oggi quindi si celebra con orgoglio questo importante anniversario, nella cornice della Conferenza “Città nel futuro 2030–2050”, promossa da ANCE. L’evento, che si svolgerà nel pomeriggio dell’8 ottobre, sarà l’occasione per riflettere insieme a due ospiti speciali: Francesco Rutelli, curatore della Conferenza, e il Presidente di Cerame-Unie Heimo Scheuch, sul contributo del laterizio alla rigenerazione urbana, all’adattamento climatico e alla crisi abitativa, temi centrali per il futuro delle città. L’80esimo anniversario della rappresentanza associativa delle aziende produttrici di laterizi non è solo una celebrazione del passato, ma una dichiarazione d’intenti per il futuro: costruire in modo sostenibile, umano e innovativo, con un materiale che continua a parlare all’uomo e alla città che verrà.
faticano sempre più a trovare una casa accessibile, mentre il patrimonio edilizio dismesso resta inutilizzato. La Conferenza intende proporre soluzioni concrete, anche in dialogo con le politiche europee, come dimostra la recente istituzione del Commissario UE per gli alloggi. Un’occasione per superare la logica dell’emergenza e rilanciare – con visione e responsabilità – un nuovo modello di sviluppo urbano e territoriale, che metta al centro le persone, l’ambiente e la qualità della vita.
Aprile 2025, lancio della Conferenza: Federica Brancaccio (presidente di ANCE) e Francesco Rutelli

SAIE 2025, all’insegna della responsabilità
Dal 23 al 25 ottobre 2025 Confindustria Ceramica sarà protagonista al SAIE di Bari con uno spazio che riunisce alcune delle aziende del comparto italiano dei laterizi: SIAI Laterizi, Wieneberger, FBM e Fornaci DCB. La Piazza, nel nuovo padiglione fieristico, ospiterà lo stand associativo su una superficie di circa 64 m², con mockup di un sistema in laterizio e un’area dimostrativa della posa di lastre ceramiche, pensato per valorizzare l’innovazione tecnica, la qualità esecutiva e la sicurezza nei cantieri. Questo tema si inserisce nella campagna Ceramics of Italy 2025 “Io scelgo la responsabilità. Fallo anche tu”, che rilancia con forza i valori di sostenibilità ambientale e attenzione
Ediltrophy arriva alla finale
Ediltrophy, gara di arte muraria nata per volontà delle Parti Sociali dell’edilizia (Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl E FilleaCgil, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Claai, Casartigiani, Confapi Aniem, Agci, Confcooperative, Legacoop), promuove da anni la formazione, il lavoro regolare e la sicurezza in edilizia.
Organizzata dal Formedil, in collaborazione con SAIE, Formedil Bari e IIPLE, e il patrocinio di Confindustria Ceramica, l’iniziativa in previsione della finalissima nazionale, ha visto lo svolgimento di preselezioni regionali con la fornitura di laterizi da parte di diverse aziende del settore (Cotto Cusimano, FBM, S.Anselmo, Fornace Ballatore, Fornace di Fosdondo, Solava e wienerberger). Al SAIE Bari 2025, presso il Pala Formedil viene riproposto il Cantiere
alla persona. Il racconto iniziato con lo slogan “È per tutti. E dura per sempre!”, lanciato al SAIE 2024, continua oggi mettendo al centro il ruolo della ceramica e del laterizio nella resilienza e inclusività edilizia, aspetti trattati anche negli ultimi numeri di Costruire in Laterizio, “Case italiane” e “Trasformazione”, che saranno illustrati in fiera. Presso il Pala Formedil poi si concentreranno le attività curate da Formedil, in collaborazione con Confindustria Ceramica. Venerdì 24 mattina, è in programma un seminario formativo dedicato alle best practices di cantiere per i sistemi in laterizio, condotto dall’Arch. Gazmend Llanaj e con la partecipazione del Prof. Marco D’Orazio, durante il quale le aziende avranno uno spazio di racconto dedicato a esperienze costruttive di
unico digitale, dedicato all’innovazione e presentato anche il Cantiere tecnologico, con la finale nazionale del Concorso Ediltrophy Progettazioni visibili in realtà aumentata, che dal 2023, valorizza la fase ideativa e progettuale, coinvolgendo studenti dei percorsi di formazione secondaria, post-diploma e universitari. Quest’anno, nella categoria Senior del concorso Ediltrophy Progettazioni si è classificato primo l’elaborato “Terra Urbana”, sviluppato dall’Università dell’Aquila, presentato da ESE CPT L’Aquila.
Nella categoria Junior, ha vinto la fontana “Infinity”, opera promossa dal Formedil Bari e realizzata dai ragazzi dell’ITT Panetti-Pitagora di Bari. Il progetto della fontana, modellato in 3D e renderizzato con Enscape è stato concepito come manufatto urbano in mattoni faccia a vista; prevede quattro postazioni: due destinate a persone

cantiere. Sarà visitabile il Cantiere unico digitale, con una pavimentazione ceramica a secco e un rivestimento in laterizio con soluzione prefabbricata. Sempre al Pala Formedil si terrà la finale della storica gara di arte muraria Ediltrophy, con la realizzazione di due manufatti simbolici – una fontana infinita e un barbecue – che metteranno in luce le competenze pratiche dei giovani e dei professionisti del settore.
adulte e bambini (con gradini per facilitare i più piccoli), una pensata per gli animali (la vasca più in basso) e una fioriera irrigata in modo naturale tramite un canale di deflusso.
Nella gara della finalissima nazionale, nell’ultimo giorno della fiera Saie, il 25 ottobre è prevista la costruzione dei manufatti, in un tempo massimo di 5 ore. I concorrenti devono analizzare gli elaborati grafici, organizzare i materiali, posare i mattoni, curare le fughe, pulire il cantiere, come in un vero intervento urbano. Le squadre migliori accederanno all’European Ediltrophy 2026.
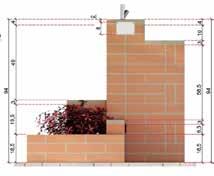

Nuove Residenze a Brugherio (MB)
È un edificio a tre piani fuori terra, articolato a “Y” nel parco esistente, in modo da garantire la migliore esposizione e riservatezza a tutte le singole unità abitative, esaltandone l’esposizione al sole, le vedute sul parco e le relazioni quotidiane interno-esterno in tutte le stagioni.
È situato a Brugherio, cittadina nella provincia di Monza Brianza, tra la via S.G.Bosco e il viale Brianza. Il progetto è dell’architetto Luca M. Salvatore.
La struttura è realizzata in cemento armato con facciate in mattoni firmati SanMarco, di recente entrato a far parte di wienerberger, leader di soluzioni innovative e sostenibili per l’intero involucro edilizio. Questo rivestimento di 12 cm di spessore garantisce durabilità, bassa manutenzione e ricche suggestioni di uno storico e tipico materiale della tradizione costruttiva locale.
Questi mattoni, prodotti nello stabilimento di Noale con tecnologia tradizionale a stampo , tipo a mano, raccontano l’autenticità della lavorazione artigianale e arricchiscono la facciata con sfumature materiche e imperfezioni naturali, conferendo unicità, espressività materica e valore architettonico all’edificio. Si compone di 16 unità abitative, in classe energetica A4 – gas free.
Ogni abitazione è dotata di grandi spazi esterni, o a giardino, o a terrazzi, con forme e orientamenti diversi.

SCHEDA TECNICA
Oggetto Residenze
Localizzazione Brugherio (MB)
Progettista Arch. Luca M.Salvatore
Materiale utilzzato mattoni SanMarco by wienerberger
L’immobile è dotato di finiture di pregio, di avvolgibili in alluminio motorizzati, di sanitari sospesi, videocitofono e predisposizione di antifurto con controllo volumetrico e videocamere.
Le pareti all’interno sono in fibrogesso, cioè una parete fono e termoisolante, incombustibile, robusta e chiodabile, con azione antibatterica. La stessa stratigrafia è proposta sul lato interno delle pareti perimetrali. In una unità abitativa il soggiorno con spazio a doppia altezza diventa il fulcro delle diverse funzioni dell’abitare.
WIENERBERGER ITALIA
Contatto diretto davide.desiderio@wienerberger.com




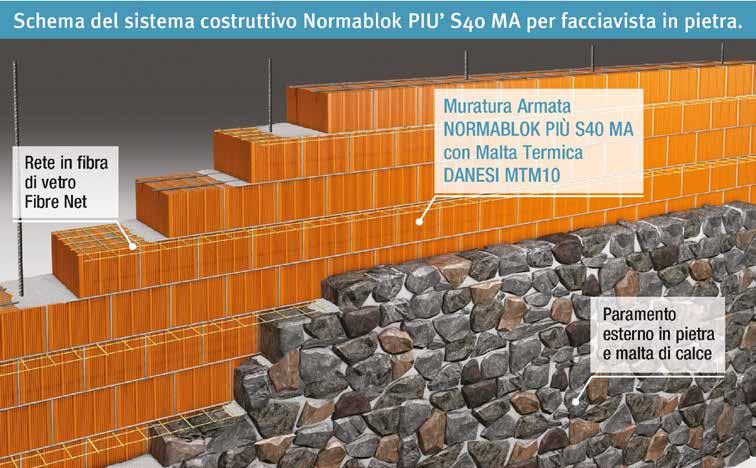
Ricostruire borghi con sicurezza sismica e rispetto del passato
Gli edifici storici del nostro Paese, in particolare quelli in pietra a vista, risultano fortemente vulnerabili agli eventi sismici, come ha dimostrato il sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016, causando il crollo totale o parziale di numerosi edifici nei borghi storici. Ricostruire “com’era, dov’era” in aree ad alta sismicità e fragilità idrogeologica è una sfida tecnica e culturale: significa rispettare il paesaggio, la memoria architettonica e la tradizione, ma garantendo al tempo stesso sicurezza, durabilità, sostenibilità ambientale e prestazioni energetiche adeguate. È qui che entra in gioco la tecnologia moderna, capace di conciliare estetica e ingegneria.
Per rispondere a queste esigenze, Fornaci Laterizi Danesi propone il sistema NORMABLOK PIÙ S40 MA, una muratura armata innovativa che consente di ancorare un paramento esterno in pietra facciavista alla
parete strutturale mediante una rete in fibra di vetro. In questo modo si crea una struttura monolitica e resistente, in grado di affrontare le più elevate sollecitazioni sismiche.
Il cuore del sistema è costituito da blocchi in laterizio Poroton P800, integrati con polistirene espanso additivato con grafite, che assicurano ottime prestazioni sia meccaniche che termiche. Le pareti realizzate con NORMABLOK PIÙ S40 MA raggiungono una trasmittanza termica di 0,21 W/m²K, valore che rende superflua la posa di un cappotto esterno, mantenendo a lungo le prestazioni senza ulteriori interventi.
Nel contesto di una ricerca congiunta tra le Università Roma Tre e La Sapienza, l’ENEA, la Regione Lazio, Fibre Net e il Consorzio POROTON® Italia, è stata sviluppata e testata una tecnologia per la ricostruzione post-sisma. Il sistema è stato sottoposto a simulazioni in scala reale
su tavola vibrante, riproducendo fedelmente i terremoti che hanno colpito Norcia, Amatrice e Castelsantangelo sul Nera nel 2016. I test hanno dimostrato che la parete, anche sottoposta a eventi sismici di intensità doppia rispetto a quelli realmente registrati, mantiene la sua monoliticità e non mostra segni di danneggiamento, né fenomeni di distacco del rivestimento in pietra.
La ricostruzione avviene con materiali di recupero: sostenibilità e rispetto del paesaggio. Il sistema sviluppato prevede:
• un paramento esterno in pietra facciavista, spesso 20-22 cm, realizzato utilizzando le pietre recuperate dal crollo, allettate con malta a base di calce idraulica naturale (classe M10), per rispettare il contesto storico e ridurre l’impatto ambientale;
• una muratura armata interna in blocchi POROTON® da 40 cm, allettati con malta cementizia (classe M10), che garantisce resistenza, isolamento termico e acustico, oltre a una posa rapida in cantiere;
• una rete in fibra di vetro Fibre Net a maglia larga (135x135 mm), inserita a letti di malta alternati, che collega efficacemente le due strutture, migliorando l’aderenza tra i materiali e prevenendo disgregazioni.
I risultati sperimentali
Durante le prove dinamiche, gli input sismici sono stati applicati in direzione orizzontale e verticale, con incrementi progressivi (step da 0.20), fino a un fattore di scala 2.2 per il segnale registrato a Norcia il 24/08/2016. Anche sotto queste sollecitazioni estreme, la parete ha conservato integrità strutturale e continuità tra i materiali, dimostrando la validità della soluzione costruttiva.
La tecnologia sviluppata da Fornaci Laterizi Danesi offre una risposta concreta alle esigenze della ricostruzione post-sisma, coniugando sicurezza sismica, efficienza energetica e tutela del patrimonio architettonico. Il sistema composto da muratura armata POROTON® e paramento in pietra di recupero, collegati da rete in fibra di vetro, rappresenta una soluzione affidabile, durevole e rispettosa del contesto paesaggistico, ideale per i borghi storici italiani. Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Regione Lazio, nell’ambito dei progetti SICURA e RIPARA, dedicati alla protezione sismica del patrimonio culturale. Un ringraziamento speciale alla comunità di Accumoli, che ha partecipato attivamente alle attività di ricerca, dimostrando attenzione e sensibilità per la rinascita del proprio territorio.
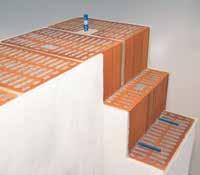
SCHEDA TECNICA

Oggetto NORMABLOK PIÙ S40 MA
Localizzazione
Materiale utilzzato
Accumoli
Pietra facciavista e NORMABLOK PIÙ S40 MA
FORNACI LATERIZI DANESI
Contatto diretto info@danesilaterizi.it
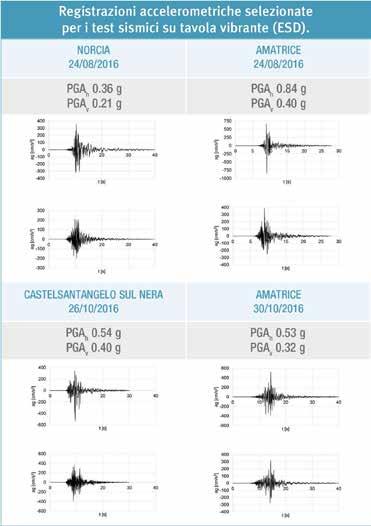
Cura e trasformazione dell’eredità
KEYWORDS
Modernità
Tradizione
Città
Rigenerazione urbana
Case accessibili
Adattamento climatico
Modernity
Tradition
Cities
Urban regeneration
Affordable housing
Climate adaptation
MFrancesco Rutelli
Eletto sei volte in Parlamento italiano dal 1983 al 2013 e come deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2004. Sindaco di Roma per due mandati nel periodo 1993-1997, in cui l’Amministrazione da lui guidata ha realizzato profonde trasformazioni nella Capitale. Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i Beni e le Attività Culturali del Governo italiano (2006-2008). Ha svolto diversi incarichi istituzionali.
odernità della tradizione, e tradizione nella modernità: queste parole d’ordine di “Costruire in Laterizio” sono assolutamente condivisibili.
Nel presentare la Conferenza “Città nel Futuro 2030-2050”, che l’ANCE ha deciso di organizzare per il 7 Ottobre mattina (alla Camera dei Deputati) e nel pomeriggio dello stesso giorno e nelle giornate dell’8 e 9 presso il MAXXI, a Roma1 - per la cui Direzione ho molto volentieri accettato di impegnarmi sin dall’inizio - vorrei innanzitutto spiegare la mia personale passione per il costruire in laterizio.
Qui parla innanzitutto l’ex-Sindaco di Roma, che potrebbe riempire ben più che lo spazio di questo Editoriale per descrivere l’unicità del lascito di queste tecniche e materiali da costruzione, trasformazione e rinnovamento urbano - e della loro attualità.
Mi trovavo poche settimane fa underground, per una cerimonia nella Basilica dei SS. Nereo e Achilleo nelle Catacombe di Domitilla. Certamente gli interventi erano forti e coinvolgenti. Ma la veduta della grande struttura absidale in laterizi ben restaurati, e l’insieme del compendio (pure con elementi straordinari in laterizio all’esterno) attiravano, fortemente, la mia attenzione. Ogni frammento in laterizio custodisce la memoria di una città che non smette mai di rigenerarsi: stratificazioni storiche che diventano lezioni di resilienza e innovazione per l’architettura contemporanea.
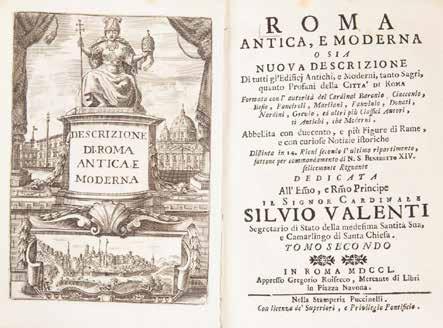
Gregorio Roisecco - Roma antica e moderna o sia Descrizione di tutti gl’Edificj Antichi, e Moderni, tanto Sagri, quanto Profani della Città Di Roma. Puccinelli, Roma 1750 (© Casa d'Aste Arcadia).
“Costruire in Laterizio” affirms and embodies a vital principle: modernity of tradition and tradition within modernity. Cities that deny their inherited qualities inevitably lose hope, while those that do not transform incessantly have no future. This vision guides the reflection on sustainable growth, urban regeneration, and architectural excellence
Mi viene da chiedere: avete mai organizzato una visita a Via della Dataria, alla Cella del Sepolcro dei Sempronii nel Palazzo San Felice presso il Quirinale (destinato a diventare la nuova sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte)?
Se il Sepolcro è in travertino, i brani in laterizio della Cella sono una delle prime realizzazioni visitabili tra le opere conosciute: risale alla metà del I secolo a.C.
Ma cosa c’è di più affascinante, sempre nella Capitale, che scoprire la maestà del più grande Campanile, quello di Santa Maria Maggiore, alto 75 metri, e realizzato con una successione di interventi, da una prima struttura del Mille-Millecento, all’erezione nel terzo quarto del Trecento, al completamento a fine Quattrocento, sino
alla cuspide posta da Giulio II; per poi recarsi accanto all’Isola Tiberina e ammirare il più piccolo delle decine di campanili in laterizio e in stile romanico che popolano la città, quello di San Benedetto in Piscinula (che all’interno conserva anche la più antica, e la più piccola campana romana).
Con questo invito all’esplorazione della Città Eterna, non intendo esaltare l’intangibilità delle sue stratificazioni; piuttosto, sottoline are che la sua forza bimillenaria risiede nelle incessanti trasformazioni. E voglio mettere in rilievo l’utilizzo dei laterizi in molti e qualificati interventi contemporanei, che si tratti di edilizia, di arredo urbano, o - ad esempio - del vasto Programma Cento Piazze, che ho ideato e promosso da Sindaco, e le cui realizzazioni sono nell’esperienza quotidiana di milioni di persone: non solo il restauro e la riqualificazione di luoghi storici, come Piazza del Popolo, ma nuovi spazi di aggregazione nei quartieri popolari (ne cito uno solo, Piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio).

Ovvero, chi guardi le nostre città e territori con spirito di immobilismo tradisce in modo imperdonabile le capacità trasformative che hanno fatto l’unicità dell’Italia nel mondo. E proprio sfogliando, e leggendo, le pubblicazioni di “Costruire in Laterizio“ si coglie un messaggio potente di qualità architettonica, competenze produttive e realizzative, funzionalità, vivibilità. Il laterizio non è solo materia da costruzione, ma linguaggio culturale che attraversa secoli e continenti, capace di raccontare l’identità italiana nel mondo e di confrontarsi con le sfide del presente.
In questa modernità c’è una piena convergenza con gli obiettivi della nostra Conferenza sulle “Città nel Futuro”. Se non hanno speranza le Città che rinnegano le qualità ereditate, non conoscono avvenire le Città che non si trasformino incessantemente. E i contenuti e le proposte che il Raggruppamento Laterizi di Confindustria Ceramica porta nella Conferenza contribuiscono a farne un momento di incontro, dialogo e iniziativa pragmatici. E' anche apprezzabile che la rappresentanza associativa del laterizio italiano abbia voluto celebrare così gli 80 anni di storia, proprio nel contesto della Conferenza con un evento, nel pomeriggio dell’8 ottobre, dove riflettere su <<Da dove veniamo, chi siamo, che futuro vogliamo costruire!>>.
Un buon incrocio con i cruciali trattati con qualificate, rappresentative, plurali partecipazioni nella Conferenza plenaria della mattina: dalla rigenerazione urbana - con un moderno governo delle acque, e l’indispensabile adattamento al clima che cambia - alle strategie per case accessibili.
Per programmare bene, progettare e costruire bene.
Per abitare realtà da ammirare, e soprattutto in cui vivere bene.
Note
1. Città nel futuro 2030–2050: tre giorni di confronto a Roma sulle grandi sfide urbane (https://ance.it/events/citta-nel-futuro-2030-2050-tre-giorni-di-confronto-a-roma-sulle-grandi-sfide-urbane/)
Garbatella, Piazza Damiano Sauli, trasformata nell'ambito del Programma Cento Piazze di Roma (© Bruno Panieri, www.machebellacitta.it).

Label architecture Centro per la cura dei bambini Porcheresse, Belgio

KEYWORDS
Trasformazione
edilizia
Architettura della cura
Ambienti
autism-friendly
Disturbi dello Spettro
Autistico
Building transformation
Healing architecture
Autism-friendly spaces
Autism spectrum disorder
IDisturbi dello Spettro Autistico, come definito anche dal DSM V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders redatto dall’Associazione Americana degli Psichiatri, sono definiti come disturbi neurologici con deficit persistenti nella comunicazione e nell’interazione sociale, che presentano comportamenti, interessi e/o attività ristrette e ripetitive e una caratterizzazione comune di sensibilità all’ambiente, attraverso iper o ipo-reattività agli stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti sensoriali dell’ambiente. Quest’ultimo aspetto è di particolare importanza poiché coinvolge direttamente l’ambiente costruito.
L’ultimo report dell’U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stima 1 bambino di 8 anni su 31 con autismo, rilevando un costante aumento nell’ultimo decennio. La dicitura “Spettro nell’autismo” dipende dalla manifestazione in uno “spettro” di diversi modi nelle persone, rendendo molto difficile trovare linee guida universali per la progettazione di ambienti autism-friendly e preferendo la possibilità di personalizzare gli spazi o renderli flessibili.
È stato provato come trasformare l’ambiente possa migliorare la qualità di vita delle persone con autismo e favorire il benessere, i comportamenti positivi, la relazione con gli altri, il gioco e l’apprendimento.
Fin da piccoli l’apprendimento avviene dall’interazione con l’ambiente circostante proprio attraverso i sensi. Le sensibilità e le percezioni sensoriali sono pertanto all’origine della comprensione del mondo circostante, ma anche delle problematiche spesso riscontrate nella comunicazione e nel rapporto con gli altri e dei cosiddetti “comportamenti problema”, derivati dalla sovrastimolazione e dall’accumulo di
Label architecture, with a transformation intervention and the integration of two volumes located at the end of the existing building, realises a centre for children with autistic spectrum disorders. The project presents a simple and clear layout, an effective and functional distribution that reduces sensorial and environmental discomfort also thanks to the use of durable and familiar material such as brick.
stress e ansia.
Tutto questo è ben chiaro a Label architecture, studio di architettura fondato a Bruxelles nel 2004, che è stato incaricato di un intervento di trasformazione edilizia nella zona rurale di Porcheresse, nel sud del Belgio.
L’area, situata tra i boschi e i campi della Vallonia, offre qualità eccezionali per l’accoglienza di giovani con disturbo dello spettro autistico. La natura costituisce infatti un aspetto di grande importanza, con benefici terapeutici, come generatore di benessere sia fisico sia mentale: riduzione dello stress, auto-regolazione degli stimoli sensoriali, sviluppo emotivo e sociale, aumento dell’agilità e della coordinazione, promozione della attività di gioco e, di conseguenza, della collaborazione e del linguaggio, secondo gli approcci di healing architecture e biophilic design
Il progetto ha proposto di trasformare e integrare l’edificio esistente mediante due ampliamenti: collocati simmetricamente alle due estremità, i nuovi volumi completano il programma funzionale e stabiliscono una stretta connessione con il parco.
Il complesso architettonico presenta un impianto planimetrico semplice e chiaro, una distribuzione spaziale efficace e funzionale degli ambienti, connettivi ampi, non lunghi e strutturati con aree di sosta e filtro, una chiara identificazione degli ambienti rispetto alla funzione, prevedibilità e sequenzialità degli spazi.
Gli ambienti risultano in grado di ridurre il disagio sensoriale e ambientale, ovvero evitare la condizione di “sovraccarico” che può rendere il mondo circostante intollerabile e incomprensibile. La qualità ambientale degli spazi, in particolare quella acustica, luminosa e dell’aria, sono stati caratteri dell’ambiente essenziali per il progetto.
Spazi calmi e di quiete che favoriscono l’equilibrio sensoriale, spazi di filtro e transizione tra le diverse zone e luoghi di partecipazione protetta che consentono un coinvolgimento e una partecipazione continua anche in momenti di sovraccarico, con il supporto di punti di regolazione sensoriale.
La compartimentazione e la strutturazione

Il complesso architettonico.
degli spazi, la distribuzione “sensoriale” degli ambienti, la proporzione e la prossemica favoriscono l’utilizzo degli ambienti, anche in modo autonomo, il rapporto con i propri pari e la qualità dell’apprendimento. Ovviamente anche la sicurezza costituisce un requisito fondamentale di tutti questi ambienti, unita alla durabilità, senza perdere quei caratteri familiari che rendono gli spazi accoglienti e confortevoli, soprattutto attraverso l’uso di materiali e textures.
In questo senso l’ampio impiego del laterizio, materiale durevole e familiare, rappresenta una cifra stilistica dell’intervento: a titolo esemplificativo, si veda come vengono mani-
polati e rafforzati gli elementi della partitura delle facciate nuove in continuità con quelle esistenti, quali le aperture, i cornicioni e l’attacco a terra.
SCHEDA TECNICA
Oggetto
Località
Progetto architettonico
Cronologia
Superficie
Centro per bambini con disturbo dello spettro autistico
Porcheresse (Belgio)
Label architecture
2020 (progettazione) - 2021 (realizzazione)
1.750 m2
Fotografie © Stijn Bollaert
Label architecture | Centro per la cura dei bambini | Porcheresse, Belgio

L’ampliamento all’estremità orientale.
Label architecture | Centro per la cura dei bambini | Porcheresse, Belgio
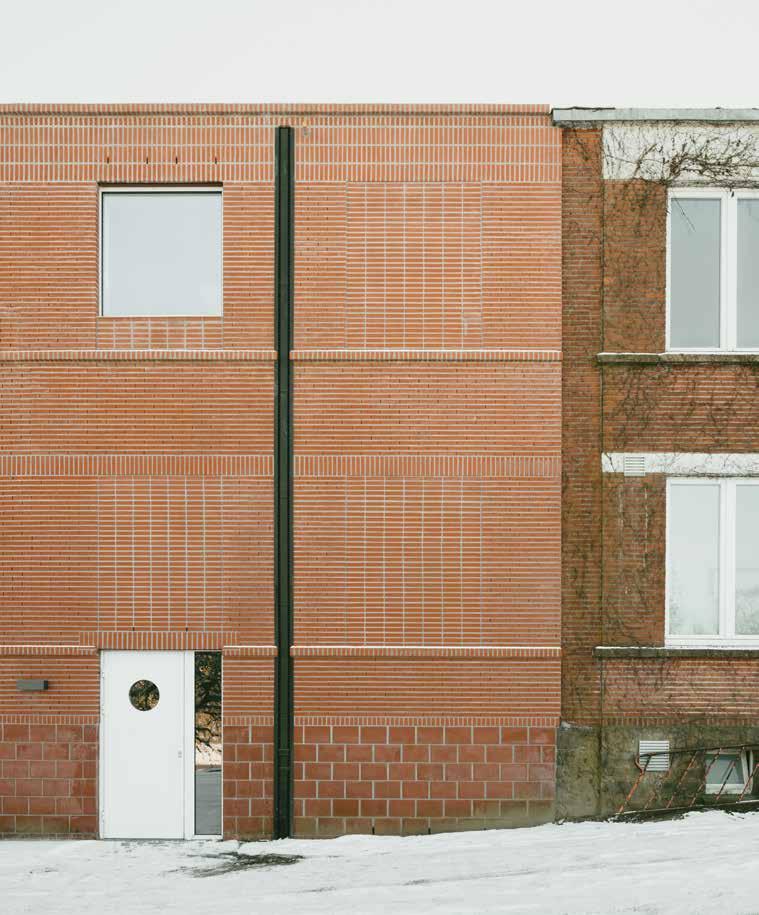


KEYWORDS
Mattoni
Trasformazione
Demolizione e ricostruzione
Rigenerazione urbana
Volumi
Verde
Bricks
Transformation
Demolition and reconstruction
Urban regeneration
Volumes
Green
TPROGETTI
Schizzo d’insieme della nuova configurazione d’intervento.
erza per ordine di importanza, Odense è una cittadina danese situata sull’isola di Fionia, nella regione della Danimarca Meridionale. Celebre per aver dato i natali ad Hans Andersen, qui trova sede anche la più antica cartiera danese costruita nel 1874 a Dalum, proprio lungo il fiume Odense. Attiva per oltre 130 anni con un ruolo di rilievo nello sviluppo urbano, sia a livello locale, nazionale e internazionale, la cartiera raggiunse il suo apice negli anni Settanta registrando un impiego di oltre 700 addetti e una forte crescita in termini di produzione, culminati nella realizzazione di carta riciclata per gran parte dell’Europa, fino all’anno 2012 che segna la chiusura della più antica, grande e ultima cartiera attiva in Danimarca. Il grande successo della cartiera, soprattutto dopo la seconda metà del secolo scorso, ha contribuito a una continua espansione del complesso produttivo con edifici caratterizzati eterogeneamente nelle loro caratteristiche costruttive. Alla chiusura della cartiera ha fatto seguito un lento processo di abbandono e incuria di tutto il complesso che risultava nel suo sedime densamente cementificato e soggetto a uno stato di degrado e fatiscenza.
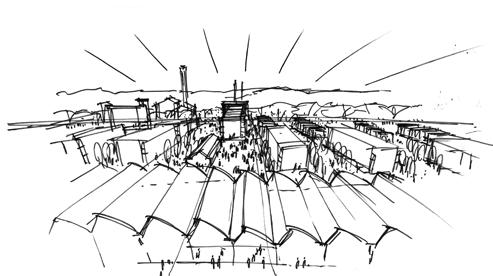
The area of the old paper mill sees the transformation of the historic industrial area into a new heterogeneous neighborhood. The selective demolition of some buildings and the recovery and reuse of the material, in particular bricks, allows to preserve the historical memory giving a new vitality to the neighborhood.
Su una superficie complessiva di oltre 9 ettari, con un processo tutt’ora in corso, a partire dal 2018 l’ambito della vecchia cartiera vede la trasformazione della storica area industriale in un nuovo quartiere eterogeneo, posto in prossimità del centro della città di Odense e a stretto contatto con la natura.
Il progetto di trasformazione e recupero dell’area è a cura dello studio C.F. Møller Architects, fondato nel 1924 da Christian Frederick Møller, che si caratterizza nei suoi diversi progetti per la particolare attenzione al contesto con un approccio olistico. L’analisi rigorosa del contesto locale e il metodo progettuale che integra in modo univoco pianificazione urbana, paesaggio, architettura e sviluppo di specifici componenti edilizi sono alla base del processo virtuoso del recupero degli edifici industriali esistenti della cartiera. Il masterplan mira a valorizzare la conservazione e la memoria del sito industriale con nuovi utilizzi attenti ai valori sociali e alle questioni ambientali attraverso la configurazione di nuovi spazi urbani. La strategia di progetto ha innescato una significativa trasformazione da area industriale chiusa a quartiere eterogeno aperto e dinamico.
La trasformazione in atto garantisce il mantenimento del carattere e della memoria storica della vecchia cartiera pur intervenendo attraverso una demolizione selettiva di diversi edifici esistenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’adeguata superficie aperta, di cui l’elemento naturale è parte rilevante che si riappropria degli spazi connettendo il paesaggio circostante attraverso nuovi “corridoi verdi”. Con le demolizioni la superficie coperta dell’area complessiva passa dal 90% al 40%, connotando l’intervento in termini di sostenibilità.
In particolare l’asse culturale che si trova al centro dell’area - con le sue offerte culturali, i negozi e le attività - collega il quartiere alla città con l’area di fronte al fiume. In questo modo la natura è integrata nel piano, creando una relazione con il paesaggio e l’acqua circostanti, che è ulteriormente migliorata dai cunei verdi progettati tra gli edifici. Il carattere verde dell’area è esaltato da una cintura verde larga 40 metri lungo il fiume. Se la cura degli spazi aperti e

le connessioni tra il quartiere e gli spazi limitrofi assumono un ruolo fondante nel nuovo assetto urbanistico, analogamente anche il programma funzionale ambisce a ritagliarsi un ruolo sociale per la comunità. Con una superficie calpestabile di oltre 45.000 m2 da completarsi entro il 2027, il piano include la costruzione di 450 case di diverse tipologie, di cui 58 unità riservate agli anziani, tutte ricavate direttamente dal recupero degli edifici industriali preesistenti. La ristrutturazione è stata realizzata mantenendo l’architettura industriale nella sua conformazione estetica, ottimizzando il comfort e le funzionalità agli usi contemporanei. La conservazione delle strutture originali in calcestruzzo, delle volte e delle colonne conferisce personalità e autenticità, mentre i materiali provenienti dalle parti demolite sono stati riutilizzati, inclusi i mattoni provenienti dagli ex capannoni industriali, che ora creano calore e struttura soprattutto nei nuovi interni. In particolare, il capannone industriale che caratterizza il bordo principale dell’area di intervento tramite le sue facciate ricostruite e ristrutturate con i mattoni chiari originali, diviene un punto di riferimento identitario per il nuovo quartiere. La volta in calcestruzzo gettato in
opera è stata pulita e conserva l’aspetto originale, mentre i tetti a shed sono stati dotati di nuovi lucernari che garantiscono abbondante luce naturale e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro sano e piacevole, sia negli uffici che nell’ambiente aziendale.
SCHEDA TECNICA
Oggetto Dalum Paper Mill Masterplan Località Odense, Danimarca Committente MT Højgaard Progetto architettonico C.F. Møller Progetto esecutivo e Direzione lavori
C.F. Møller
Impresa di costruzione MT Højgaard Cronologia 2018-2027
Superficie 45.000 m2 residenziale e commerciale
Fotografie C.F. Møller
SITOGRAFIA
• https://www.cfmoller.com/p/Dalum-Paper-MillMasterplan-i3559.html
• https://www.museumsilkeborg.dk/dalum-papirfabrik
• https://renover.dk/projekt/papirhallerne-dalumpapirfabrik/

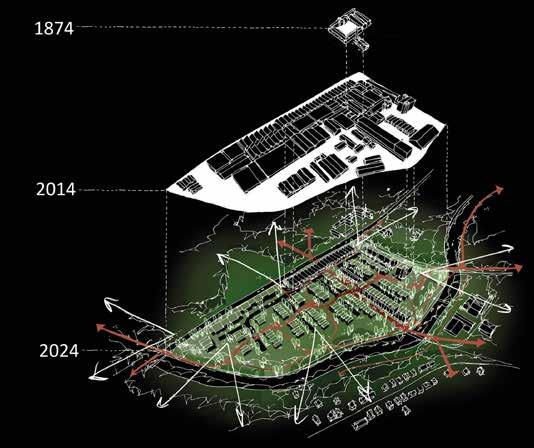
Schema della strategia d’intervento del Masterplan.
C.F. Møller Architects | Dalum Paper Mill | Odense, Danimarca






AFF Architekten Ex granaio Berlino, Germania

KEYWORDS
Granaio
Restauro
Sottotetto
Soffitto a imbuto
Muratura di mattoni
Granary
Restoriation
Attic
Funnel ceiling
Brick masonry
L'edificio fu costruito come granaio sperimentale di sei piani alla fine del diciannovesimo secolo (1897/98) sulla riva del canale Berlino-Spandau e lungo i binari dello scalo merci Lehrter, adatto a ricerca scientifica e stoccaggio dei cereali, per una popolazione in crescita alla fine del XIX secolo.
Nel 1916, fu ampliato e la struttura in legno composta da soffitti a imbuto, colonne e travi fu sostituita da uno scheletro in cemento armato. Nel complesso poteva contenere 1.110 tonnellate di grano e l’ampliamento consentì, tra l’altro, di valutare i sistemi di stoccaggio a silos e a riempimento sfuso e a testare l’ingegneria meccanica moderna.
Oggi, che è un simbolo della storia industriale e sociale di Berlino, dopo anni di utilizzo commerciale, di parziale non utilizzo e utilizzo temporaneo come spazio per l’arte, considerando la precocità in Germania della sua struttura in cemento armato e quei rari soffitti a tramoggia, è divenuto testimone degli albori tecnologici delle costruzioni in calcestruzzo, monumento del patrimonio storico culturale e ha richiesto, per essere riconvertito a nuova destinazione, un attento intervento di restauro su diverse parti in carente stato di manutenzione.
La trasformazione odierna è opera dello studio berlinese AFF Architekten e ha ottenuto vari premi, fra cui il Deutscher Ziegelpreis 2024Premio Speciale tedesco del laterizio per l’Edilizia in Strutture Esistenti, bandito dall’Associazione federale dell’industria tedesca dei laterizi e delle ceramiche, con sede a Monaco di Baviera.
Si è proceduto, da un lato, nello smantellamento parziale delle strutture portanti in calcestruzzo esistenti e in altri interventi di grande impatto, nonché nell’aggiunta di un piano al sottotetto, attraverso una definizione spaziale,
The building, originally an experimental granary, was restored with the addition of a floor to the attic and finished with the same solid brick masonry system as the existing facades. The wooden scaffolding of the lantern roof was faithfully reconstructed; in any case, the original height of the ridge was maintained, confirming its volumetric characteristics and urban presence.
sviluppata in armonia con l’edificio storico, per una riconversione a un uso contemporaneo. L’edificio, posizionato ai bordi del bacino portuale, unico manufatto storico conservato nell’attuale “Wasserstadt Mitte”, diviene così parte e testata della rete di recenti edifici residenziali, nel nuovo quartiere Europacity, progetto ambizioso, esteso a nord della stazione di Hauptbahnhof.
Raggruppa in sé memoria e tecnologia architettonica, ponendo a confronto la modernità dell’intorno costruito con la gabbia strutturale di cemento armato recuperata; con le semplici morfologie della prima architettura industriale e con l’analogia materica e cromatica del nuovo sopralzo, che non diversifica la sua presenza urbana.
Infatti, pur se la semplice impalcatura lignea del tetto a lanterna è stata sostituita completamente, basandosi sulla documentazione storica della struttura originale, l’altezza del colmo e i suoi caratteri di impatto volumetrico e altimetrico sono stati mantenuti.
L’intera struttura in cemento ha richiesto consistenti interventi di riparazione, così come le facciate, a causa di anni di deterioramento dovuto agli agenti atmosferici.
La finitura del nuovo sottotetto è stata concepita con lo stesso sistema di muratura in mattoni pieni delle facciate esistenti; mentre gli elementi del parapetto, sempre in mattoni, sono stati arricchiti di una giunzione ornamentale a rilievo, creata con rientranze e fori.
In sommità due terrazze fiancheggiano i lati lunghi dell’edificio e offrono uno spazio all’aperto e una vista panoramica sul canale e su Europacity.
La facciata storica, costituita da mattoni pieni di due formati imperiali (l/p/h - 250/120/65 mm - 190/120/65 mm) con fughe di 10 mm, posati secondo il modello storico esistente, con blocchi in laterizio, isolamento termico, setto in calcestruzzo armato spessore 300 mm a vista, è stata ripresa, restaurata, pulita e integrata nelle zone mancanti.
A motivo della prevista conversione in uffici e spazi di lavoro, le basse altezze dei soffitti, l’illuminazione parzialmente sfavorevole

e la mancanza di un accesso senza barriere architettoniche hanno richiesto una ristrutturazione completa e un ammodernamento energetico del complesso.
A piani alterni, una parte dei soffitti è stata rimossa poiché in molte aree non era disponibile l’altezza libera necessaria per il successivo utilizzo; le finestre del sottotetto sono state restaurate o sostituite, secondo modelli storici, concordati con le autorità preposte alla conservazione dei monumenti; inoltre, per garantire una luce naturale adeguata, i tamponamenti sono stati integrati in alcune aree con vetrate di grande formato.
I serramenti sono a porte scorrevoli a tre ante ad alto isolamento termico, in alluminio, colore RAL rosso, simile alla facciata in laterizio.
Il tetto è rivestito con tegole marsigliesi, cromaticamente e matericamente coordinate con i mattoni della facciata.
Un nuovo nucleo di accesso con una scala multipiano, l’ascensore e i servizi igienici è
stato posizionato all’incrocio tra le due sezioni dell’edificio. Le uscite di sicurezza sono state installate sulla facciata nord, sempre nel rispetto dell’obiettivo di conservazione del patrimonio storico.
SCHEDA TECNICA
Oggetto Kornversuchsspeicher.
Trasformazione di un ex granaio
Località Berlino - Hedwig-Porschütz-Straße 20 Committente Adler Group - Heide Siegmund-Schultze
Progetto architettonico AFF Architekten
Progetto strutturale ISKP Ingenieure, Berlin
Progetto impiantistico ISRW Institut für Schalltechnik, Raumakustik, Wärmeschutz
Impresa di costruzione Apleona R&M Expansion
Cronologia 2016-2023
Superficie 3.588 m2
Fotografie Tjark Spille
K o r n v e r s u c h s s p e i c h e r 1 0 5 1 0

Sezione trasversale.
Sezione longitudinale.

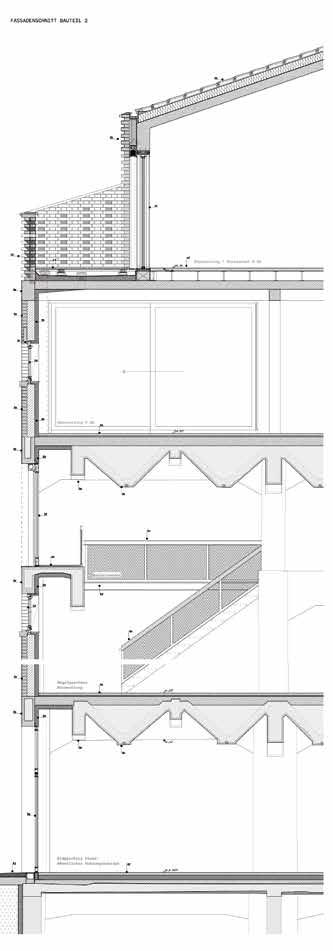
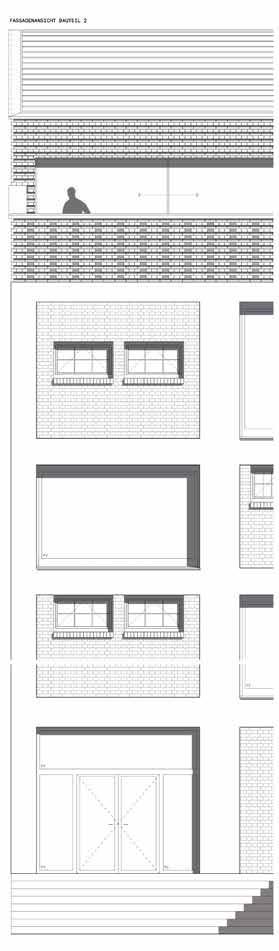

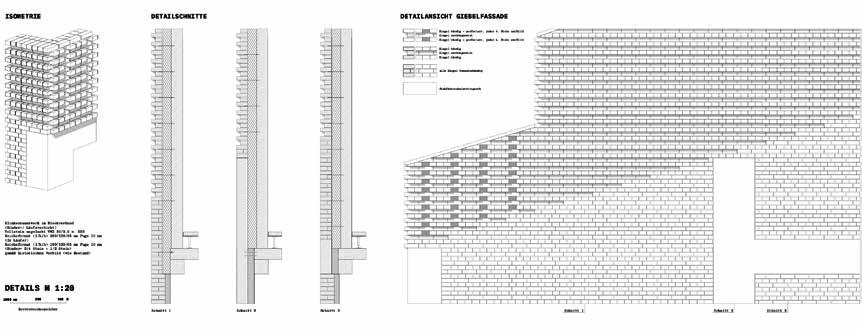


KEYWORDS
Regionalismo critico
Riuso adattivo
Biblioteca
Rurale
Tetto
Critical regionalism
Adaptive reuse
Library
Rural
Roofing
Il progetto per una piccola biblioteca comunale ad Arconate si pone come un esercizio di misura, un gesto di attenzione nei confronti di un manufatto agricolo preesistente che, pur nel suo silenzio, custodisce tracce sedimentate di lavoro, di tempo, di spazio condiviso. La scelta progettuale fondante è radicale nella sua discrezione: il volume originario, sviluppato su due livelli, non viene colonizzato interamente. Al contrario, si rinuncia deliberatamente all’uso del sottotetto, evitando interventi strutturali e impiantistici che ne avrebbero compromesso l’equilibrio statico e, ancor più, la valenza simbolica. Il grande vuoto ligneo, con le sue travi e le sue ombre, è mantenuto intatto, non più accessibile fisicamente, ma visivamente presente con la sua profonda e mutevole ombra.
zionale, ma un dispositivo spaziale e simbolico, eco delle corti rurali, ma anche metafora di un tempo ritrovato.
Schema planimetrico di inserimento.

Il piano terra diventa allora il campo operativo, con la rimozione dei volumi di epoca recente volta a liberare il ritmo originario degli slanciati pilastri in mattoni. Dentro questa trama strutturale si inserisce un nuovo volume leggero realizzato con struttura in acciaio, tamponamenti coibentati e rivestimento ligneo, che si attesta in altezza a circa la metà del volume del cascinale originario.
Due ulteriori corpi ortogonali parallelepipedi, costruiti con materiali semplici e di facile messa in opera - blocchi in laterizio portanti e isolanti, solai misti in laterizio e calcestruzzo armato, acciaio e legno - si affiancano al corpo originario generando una piccola corte, uno spazio di soglia tra interno ed esterno. Questo vuoto, protetto ma permeabile, si configura come luogo pubblico capace di assorbire e restituire usi imprevisti: lettura all’aperto, incontri, pausa. La corte non è solo uno spazio fun-
The project for the municipal library in Arconate is the result of a careful dialogue with a pre-existing farmhouse, enhanced by a sober and measured intervention. The large wooden void in the attic is kept intact, while on the ground floor volumes are inserted in dialogue with the original structure. The use of essential materials and the centrality of the brick wall structure guide a discreet transformation capable of interweaving rural memory and new community needs.
Sul piano linguistico, il progetto costruisce una tensione consapevole tra i due registri materiali: da un lato, la solidità del perimetro esterno, fondato sulla tessitura muraria con basamento in granito ghiandone, mattoni a faccia vista con trama gotica e spessi giunti orizzontali, intonaco grezzo, esili profili in metallo brunito; dall’altro, la leggerezza dei fronti interni, interamente vetrati, che si aprono verso la corte attraverso la mediazione di un porticato articolato in un elegante bilanciamento strutturale tra esili profili in acciaio e massive colonne laterizie. L’edificio si dichiara pubblicamente sulla strada con misurata severità, ma si smaterializza nella relazione interna, lasciando spazio a una domesticità pubblica che raccorda le parti mediante il vuoto centrale.
L’organizzazione funzionale interna segue questa logica di apertura e molteplicità: due accessi autonomi — uno per l’uso quotidiano della biblioteca, uno per eventi — suggeriscono una pluralità di tempi e usi. Il ridotto abaco materico degli spazi interni, declinato in una scala di grigi (pavimento, arredi fissi, pareti, soffitti), esalta l’espressività dei toni rossobruni delle pareti fondali in laterizio, nella zona della reception, e degli elementi strutturali metallici. L’allestimento interno, essenziale e calibrato, favorisce una lettura unitaria degli spazi e consente una fruizione adattabile nel tempo, in grado di accogliere configurazioni d’uso differenti.
L’intervento si fonda su una grammatica essenziale a servizio di una costruzione sincera, fatta di materiali grezzi, duraturi, riconoscibili; tra cui il laterizio faccia a vista e il granito tagliato a “piano sega”. La logica strutturale dell’intervento si ancora al mattone come elemento portante e misuratore dello spazio. I pilastri originari — lasciati a vista, restaurati nella loro scansione — sono interpreti di una grammatica muraria che non viene smentita, ma tradotta. Anche nei nuovi corpi di fabbrica, il mattone resta riferimento implicito: la sua logica modulare informa le proporzioni, scandisce i pieni, determina il passo visivo delle aperture.
Act_Romegialli - Paolo Donà | Biblioteca di Arconate | Arconate (MI), Italia

SCHEDA TECNICA
Oggetto Biblioteca di Arconate
Località Arconate (MI), Italia
Committente Comune di Arconate
Progetto architettonico Act_Romegialli
Arch. Paolo Donà
Progetto strutturale Studio Ingegneria Moncechi Associati
Progetto impiantistico Studio Forgad
Impresa di costruzione M.G. Costruzioni (lotto 01)
GI.GA. Project S.r.L. (lotto 02)
Cronologia 2016/2018 (progettazione) 2018/2020 (realizzazione)
Superficie 340 m2
Fotografie Marcello Mariana

L’edificio agricolo preesistente.
Act_Romegialli - Paolo Donà | Biblioteca di Arconate | Arconate (MI), Italia


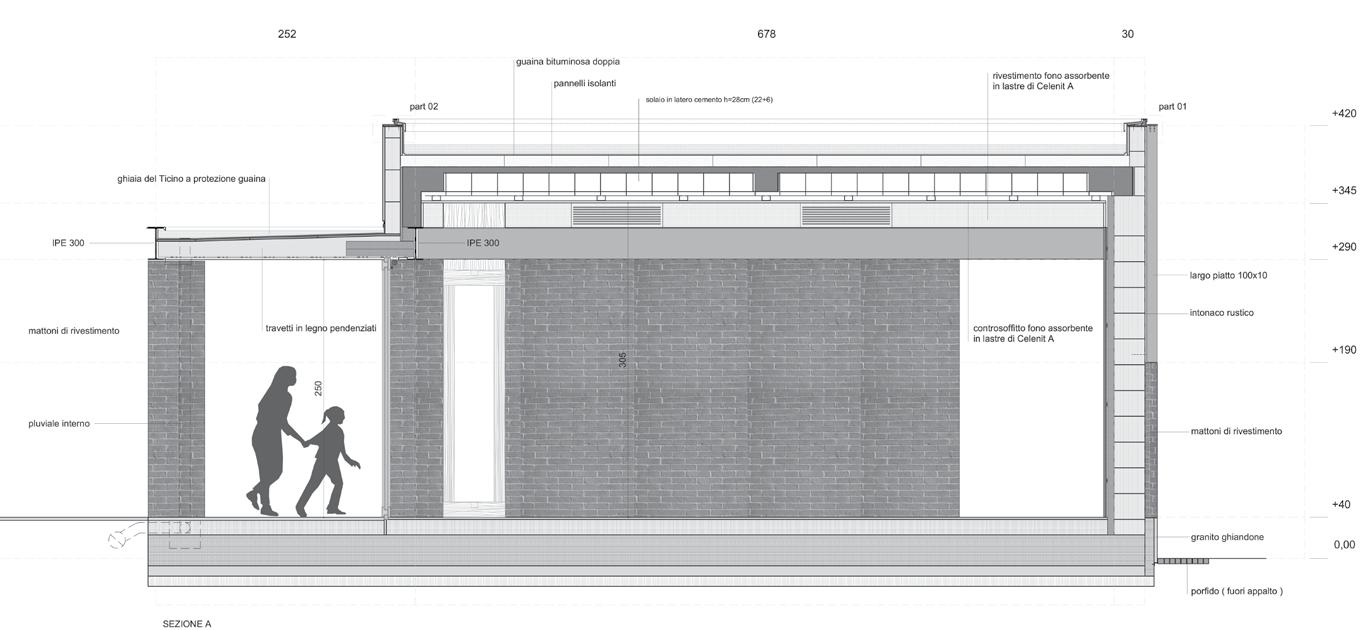
Act_Romegialli - Paolo Donà | Biblioteca di Arconate | Arconate (MI), Italia

Il dialogo tra il nuovo e il preesistente.
Eliana Cangelli Le qualità a supporto dei processi di trasformazione del costruito
Massimo Mariani, Architetto, PhD, Assegnista di ricerca, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre

KEYWORDS
Trasformazione edilizia
Rigenerazione urbana
Piani e programmi
Prodotti da costruzione
Building tranformation
Urban regeneration
Plans and Programmes
Brick
Elena Cangelli
Professore Ordinario in Progettazione Tecnologica e Ambientale presso il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma; Vicepresidente del Board Europeo di European Association for Renewable Energy (EUROsolar); Coordinatore nazionale del Cluster di ricerca “Abitare” della Società Scientifica di Tecnologia dell’Architettura (SITdA); Presidente del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia (Co.Q.U.E) di Roma Capitale, organo consultivo istituito al fine di garantire la qualità architettonica e urbana degli interventi sul territorio della città.
La sua attività di ricerca e di sperimentazione progettuale si concentra sui temi della progettazione tecnologica e ambientale applicata alla gestione delle trasformazioni del territorio urbano e rurale, alla valorizzazione e al recupero del patrimonio pubblico e alle forme dell’abitare sociale.
Secondo il vocabolario Treccani, la trasformazione è “l’operazione che comporta un cambiamento, per lo più profondo e definitivo, di forma, aspetto, strutture o di altre qualità e caratteristiche”: perché è necessaria la trasformazione?
La trasformazione è necessaria perché i sistemi urbani, così come quelli sociali ed ecologici, hanno raggiunto un punto di saturazione: uno stato in cui le logiche di crescita illimitata, di consumo di suolo, di frammentazione territoriale e di disuguaglianza sociale non sono più sostenibili. In questo contesto, il progetto urbano e architettonico è chiamato a farsi carico non solo della forma dello spazio, ma anche del destino delle comunità che lo abitano.
The challenge today is to strengthen the link between physical regeneration and welfare policies, proximity services, quality public spaces and environmental infrastructures, reconnecting territories. Planning takes on a strategic role as a mediating and directing tool: it is not limited to shaping spaces, but creates the conditions for better living, for reconnecting real resources and citizens expectations, for making a shared future visible and accessible.
Come afferma Edgar Morin nel suo “Elogio della metamorfosi” (Le Monde, 09.01.2010), quando un sistema non riesce più a risolvere i propri problemi vitali, si disintegra, oppure “riesce a suscitare un metasistema capace di risolverli: si trasforma”. Nel nostro campo, questa metamorfosi si esprime attraverso l’abbandono del modello espansivo e speculativo, e l’adozione di un approccio rigenerativo: non si tratta solo di riqualificare edifici o spazi pubblici, ma di produrre qualità nuove a partire dalle strutture esistenti, proprio come il bruco che, attraverso un processo di parziale distruzione, si ricostituisce in farfalla. La trasformazione, dunque, diventa un atto di cura, di ricomposizione e di responsabilità intergenerazionale. Il progetto, in tal senso, non è solo uno strumento tecnico, ma un gesto politico e culturale che incarna una visione del futuro, alimenta la speranza e crea le condizioni per un nuovo inizio, profondamente necessario.
La trasformazione edilizia, così come gli interventi di demolizione e ricostruzione, rappresenta una delle principali strate-
gie per la riduzione dell’impatto umano sull’ambiente. Rigenerare, rifunzionalizzare, trasformare, significa affrontare riforme amministrative, direttive prescrittive e prestazionali, assetti organizzativi e operativi, programmi e processi tecnico-progettuali. A tal fine, quali sono gli approcci che ritiene maggiormente efficaci e quanto risulta necessario sviluppare un dialogo costante tra gli attori coinvolti nei processi?
Nel mio lavoro di ricercatore e architetto, ho potuto constatare come i processi di trasformazione urbana più efficaci siano quelli capaci di misurarsi con la complessità reale dei contesti, rifiutando ogni visione riduttiva o prescrittiva. Intervenire sul costruito non significa semplicemente sostituire, ma rileggere criticamente, ristrutturare, densificare, valorizzare, generare nuove possibilità d’uso, promuovendo un equilibrio tra esigenze ambientali, sociali ed economiche. In questo senso, rigenerare non è solo una questione di sostenibilità tecnica, ma un’azione culturale fondata sull’ascolto dei territori e sulla cooperazione tra saperi e soggetti diversi. Il dialogo tra istituzioni, progettisti, cittadini, enti di gestione, portatori di interesse e investitori rappresenta non solo un’opportunità, ma una necessità operativa per innescare meccanismi virtuosi e condivisi. Quando questo dialogo è reale e strutturato, si creano le condizioni per passare da un modello interventista a una logica adattiva e incrementale, capace di rispondere con efficacia alle mutazioni demografiche, economiche e climatiche. Alcune esperienze recenti, come il Programma PINQuA o i Piani Urbani Integrati (PUI) finanziati dal PNRR, hanno mostrato, pur tra difficoltà di governance e disomogeneità esecutiva, la potenzialità di un approccio sistemico alla trasformazione del patrimonio residenziale pubblico. La sfida oggi è rafforzare il legame tra rigenerazione fisica e politiche di welfare, servizi di prossimità, spazi pubblici di qualità e infrastrutture ambientali, ricucendo territori spesso frammentati o marginalizzati. In questo scenario, la progettazione assume un
ruolo strategico come strumento di mediazione e regia: non si limita a dare forma agli spazi, ma costruisce le condizioni per abitare meglio, per riconnettere risorse reali e aspettative della cittadinanza, per rendere visibile e accessibile un futuro condiviso. La trasformazione urbana non può essere intesa come un evento puntuale, ma deve essere intesa come un processo continuo e articolato, capace di produrre senso e coesione; credo che solo così si possa superare l’approccio emergenziale e innescare processi di cambiamento sistemico delle città.
Lei ha preso parte a numerose esperienze in grado di sviluppare proposte concrete per la rigenerazione urbana e la trasformazione del patrimonio pubblico, in particolare nella città di Roma. In questo senso, quali sono le potenzialità inespresse e le nuove linee di ricerca?
Il tema della rigenerazione urbana non consente risposte univoche né la definizione di linee di ricerca esaustive, soprattutto in una città come Roma che, per la sua estensione territoriale, la stratificazione storica e la complessità del tessuto urbano e architettonico, rappresenta un contesto unico per osservare e sperimentare processi di trasformazione urbana. In questa città, dove la sovrapposizione dei segni convive con fragilità sociali, ambientali e infrastrutturali, il tema della rigenerazione richiede strumenti interpretativi e operativi capaci di tenere insieme memoria e progetto, permanenza e cambiamento. Più che delineare linee di ricerca posso individuare ambiti di ricerca e progetto, approfonditi nel tempo attraverso le esperienze che ho avuto l’opportunità di sviluppare in contesti complessi e differenziati della città di Roma. Contesti che vanno dalla periferia pubblica progettata nell’ambito dei grandi programmi di edilizia economica e popolare, alla città informale a crescita spontanea, fino allo spazio pubblico del centro storico. Luoghi tra loro distanti per morfologia, densità simbolica e assetti sociali, ma accomunati dalla necessità di ripensare il progetto urbano come strumento di riequilibrio territoriale, riconoscimento civico e qualità dell’abitare.

Tor Bella Monaca: Via dell’Archeologia e i nuovi servizi di prossimità al primo piano dell’edificio (credits: PFTE Tor Bella Monaca).
Un primo ambito di ricerca riguarda proprio questo: superare la parcellizzazione disciplinare e funzionale che ha spesso caratterizzato gli interventi sul patrimonio pubblico. Le periferie nate con i piani di edilizia economica e popolare mostrano oggi i limiti di un modello fondato sulla standardizzazione e su una manutenzione mai realmente attuata. Riattivare questi contesti non significa solo intervenire sugli edifici, ma costruire condizioni durature di vivibilità, intrecciando risposte tecnologiche, dispositivi sociali e modelli economici inediti. È in questi contesti che si afferma l’idea della città come bene comune.
Un secondo ambito, forse ancora più delicato, riguarda la città informale, quello della periferia abusiva condonata, delle borgate spesso relegate a margine del dibattito urbanistico. Qui la trasformazione non può ridursi a operazioni di densificazione edilizia, ma deve misurarsi con la possibilità di ridisegnare la relazione tra insediamento e territorio, agendo sulla mobilità, sulla resilienza ecologica, sulla gestione delle risorse e sull’accesso ai servizi di base. Il progetto in questi casi assume un ruolo di mediazione, capace di attivare risorse locali, riconoscere forme di abitare esistenti e tradurle in nuove grammatiche urbane.
Un terzo ambito, più sperimentale e minuto, si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico nei contesti storici, come ad esempio il progetto sviluppato lungo l’asse Via Nazionale – Corso Vittorio Emanuele II. In questo caso, il lavoro ha messo al centro la possibilità di valorizzare piccole aree – slarghi, intersezioni, spazi residui – nel cuore del centro storico della città, lungo un asse di attraversamento fondamentale che collega la stazione Termini al Vaticano. Si tratta di porzioni di città disarticolate tra loro ma di grande rilevanza per la loro densità storica e architettonica, che vengono restituite ad un uso collettivo attraverso interventi leggeri ma strategici, capaci di conferire nuova continuità spaziale e visibilità al tessuto urbano. Il progetto si è confrontato con i temi della mobilità, della sicurezza e dell’accessibilità, restituendo allo spazio pubblico il suo valore di infrastruttura am-
bientale e sociale. Un quarto ambito di riflessione, trasversale ai precedenti e forse più urgente, riguarda, come già detto, la costruzione di una governance cooperativa e continuativa. I progetti più riusciti degli ultimi anni sono infatti quelli in cui si è riusciti a stabilire alleanze istituzionali solide, capaci di garantire continuità ai processi, scongiurare derive tecnocratiche e mantenere coerenza tra visione politica, gestione amministrativa e progetto. Un esempio virtuoso è rappresentato dal modello sperimentato per la definizione dei progetti PNRR, nato dalla collaborazione tra Roma Capitale e le università Sapienza, Roma Tre e LUISS. Questo approccio ha consentito di sviluppare interventi che vanno oltre la contingenza del bando, contribuendo a delineare una politica urbana strutturata, fondata su obiettivi misurabili, condivisi e capaci di produrre effetti durevoli. Infine, un’ultima riflessione riguarda la necessità di ridefinire il lessico stesso della trasformazione urbana. Troppe parole – “sostenibilità”, “inclusione”, “innovazione” – sono diventate formule retoriche svuotate di significato. La sfida consiste nel restituire concretezza a questi termini, ancorandoli a pratiche operative, a metriche verificabili e a processi di riconoscimento. In questa direzione si muove anche il progetto di rigenerazione del rione Testaccio, che ha cercato di salvaguardare e valorizzare la specificità di un tessuto urbano identitario e stratificato, evitando di cristallizzarlo in una dimensione conservativa e riconoscendo invece la vitalità quotidiana del rione come risorsa da sostenere attraverso un disegno capace di restituire continuità spaziale, visibilità e accessibilità agli spazi collettivi. In sintesi, le potenzialità inespresse della trasformazione urbana non si esauriscono nella sola materia costruita, ma risiedono nella capacità di tenere insieme approcci plurali, competenze diverse e sensibilità territoriali. Roma, in ragione della sua complessità, può diventare un vero laboratorio di pratiche urbane consapevoli, capaci di incidere nei contesti più fragili senza rinunciare alla qualità, alla bellezza e all’equità.
La trasformazione del patrimonio, in particolar modo di quello pubblico, passa inevitabilmente da contributi e da stanziamenti sviluppati con l’obiettivo di accrescere la qualità ambientale e sociale. Tra gli altri, il PINQuA ha promosso e finanziato progetti di notevole interesse e Roma
Capitale è risultata tra le più virtuose per l’integrazione di differenti soggetti e per i luoghi oggetto di intervento. Può raccontare i passaggi salienti dello studio di fattibilità per la trasformazione del comparto R5 di Tor Bella Monaca che ha predisposto con la Sapienza Università di Roma?
Il comparto R5 di Tor Bella Monaca è uno degli interventi più rappresentativi tra quelli avviati nell’ambito del PINQuA, non solo per la scala e la complessità dell’intervento, ma per il valore metodologico dello studio di fattibilità che lo ha originato. Il PFTE, infatti, è stato sviluppato grazie a un innovativo modello cooperativo tra amministrazione e università (Sapienza, Roma Tre e LUISS), volto a integrare competenze tecnico-scientifiche e visione urbana, costruendo un processo condiviso e interistituzionale. Questo modello ha garantito continuità istituzionale e coerenza progettuale, un valore raro nelle trasformazioni urbane. Il progetto si è concentrato su uno dei contesti più vulnerabili della città, non solo per le condizioni fisiche del patrimonio edilizio, ma anche per la marginalità sociale e simbolica che caratterizza il quartiere. L’attività di progettazione, nell’ambito del PFTE, non si è limitata alla definizione di soluzioni architettoniche e tecniche, ma ha previsto una profonda analisi del contesto territoriale, l’ascolto attivo delle comunità locali, proseguito e intensificato nella fase di cantiere in corso, e una valutazione concreta delle effettive possibilità di trasformazione del patrimonio pubblico. Un elemento determinante emerso fin dall’inizio è stata l’impossibilità di delocalizzare gli abitanti durante i lavori: la presenza di oltre 4.000 residenti distribuiti in 1.236 alloggi ha reso imprescindibile la progettazione di interventi realizzabili con gli abitanti all’interno degli edifici, condizione che ha orientato tutte le scelte successive in termini
tecnologici, logistici e organizzativi. Progettato da Pietro Barucci nei primi anni ’80, il comparto R5 costituisce una delle più estese realizzazioni del primo Piano di Edilizia Economica e Popolare di Roma. Realizzato in tempi brevissimi con tecniche di prefabbricazione pesante, ha subito un rapido deterioramento a causa della mancata manutenzione prevista in fase di progettazione. Alla fragilità materiale si è sommata quella funzionale e sociale: il comparto è oggi privo di servizi, gli alloggi risultano fortemente degradati, e gli spazi collettivi sono diventati luoghi di marginalità e insicurezza. Lo studio di fattibilità si è articolato in due PFTE distinti: il primo, elaborato con i fondi PINQuA, ha riguardato la corte centrale del comparto; il secondo, successivo e finanziato nell’ambito dei PUI, ha esteso gli interventi alle corti laterali (nord e sud). Questo sviluppo su due fasi ha portato all’assegnazione a due gruppi di progettazione e a due imprese diverse, che hanno adottato soluzioni tecniche differenti ma convergenti negli obiettivi prestazionali e di efficienza energetica. L’efficienza energetica è stata perseguita come obiettivo primario, attraverso soluzioni tecniche compatibili con la complessità abitativa, che tenessero conto della presenza costante dei residenti. Il confronto tra le due tecnologie potrà essere oggetto di monitoraggio nel tempo, per valutarne efficacia, durabilità e qualità percepita. Accanto agli interventi sul patrimonio edilizio, il progetto ha puntato a riposizionare il comparto nella mappa simbolica e urbana della città, restituendogli dignità e nuove funzioni. Tra le azioni più significative c’è la destinazione della corte nord a Museo delle Periferie, il primo museo civico del Comune di Roma realizzato oltre il GRA: un gesto concreto che non vuole compensare, ma cambiare prospettiva. L’idea non è portare la periferia al centro, ma portare il centro in periferia: creare un presidio culturale che renda Tor Bella Monaca parte integrante della città, senza retorica, ma con la forza della presenza. Il museo, collocato in uno degli spazi più trascurati, nasce per generare connessioni, accogliere iniziative, raccontare nuove storie. Il progetto ha previsto la riattivazione di spazi
Planimetria generale del nuovo assetto progettuale del comparto R5 e di Via dell’Archeologia (credit: PFTE Tor Bella Monaca).

comunitari esistenti e il rafforzamento delle pratiche sociali già presenti nel territorio. Particolarmente significativa è stata l’attenzione alla ludoteca “Casa di Alice”, nella corte sud, avviata da un gruppo di madri del quartiere come spazio educativo per i più piccoli. Il progetto ne prevede la ristrutturazione e il potenziamento, valorizzandone la funzione sociale e riconoscendo il ruolo fondamentale dell’autorganizzazione nella costruzione della coesione territoriale. A questo si aggiungono piccoli servizi di prossimità – spazi studio, coworking, commercio minuto – pensati per rigenerare la trama relazionale del comparto e contribuire alla produzione quotidiana di spazio pubblico.
Infine, lo studio di fattibilità affronta una questione strutturale che riguarda l’intera città: la necessità di intervenire sull’enorme patrimonio ERP costruito a Roma negli anni ’80, stimato in circa 20 milioni di m3, e realizzato con sistemi industrializzati che, pur innovativi all’epoca, si sono rivelati vulnerabili senza adeguati cicli di manutenzione. La definizione di soluzioni tecnologiche e operative replicabili, come quelle testate nel R5, rappresenta un contributo concreto alla rigenerazione sistemica del patrimonio pubblico urbano, in grado di fornire modelli esportabili anche in altri contesti. Ad oggi, i cantieri procedono regolarmente e la consegna degli edifici avverrà nei tempi stabiliti. Si tratta di un segnale concreto della validità di un approccio integrato e strutturato, che ha saputo tenere insieme visione politica, capacità amministrativa, progettazione tecnica e partecipazione locale. Trasformare Tor Bella Monaca in modo credibile e misurabile significa dimostrare che anche nei contesti urbani più fragili è possibile attuare un cambiamento reale, sostenibile e duraturo.
La trasformazione edilizia avviene anche con l’applicazione di materiali e di sistemi costruttivi innovativi. A tal proposito, un materiale della tradizione come il laterizio, caratterizzato comunque da processi di evoluzione sia nel processo sia nella tecnologia costruttiva, in che modo può influenzare la qualità di un intervento?
Molte delle occasioni di rigenerazione, di riqualificazione e di trasformazione edilizia, trattano un patrimonio costruito consolidato nel tempo per morfologia, funzione e sistemi tecnologici. Ciò impone, in particolar modo nel nostro Paese, di investigare materiali e tecniche appartenenti alla tradizione del costruire come appunto quelli in laterizio. Il laterizio è il principale materiale attraverso il quale si identifica la nostra storia.
Conoscere le caratteristiche e le prestazioni di prodotti e sistemi derivanti da un materiale naturale come l’argilla, risulta fondamentale per sviluppare strategie in linea con le esigenze costruttive e ambientali del settore edilizio. Infatti, a fronte di importanti sviluppi socioeconomici e ambientali, gli indirizzi attuali inquadrano una circolarità in grado di incrementare la sostenibilità, dall’attenzione all’origine dei materiali al ciclo di vita, dalla gestione consapevole alla prestazione rispettosa dell’ambiente, dal fine vita degli elementi costruttivi al possibile riutilizzo e riciclo fino alla naturalità. Tutti i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) hanno, ad esempio, sollecitato e vincolato gli interventi ad approcci volti al recupero e al riciclo delle risorse già dalla fase progettuale: i Criteri Ambientali Minimi (CAM), il principio Do No Significant Harm (DNSH) e l’orientamento a interventi di trasformazione o demolizione e ricostruzione (Green Field), oltre ad accrescere la tendenza a ridurre l’impatto sull’ambiente e sulla comunità anche attraverso specifici strumenti di valutazione, mirano a soluzioni durature, anche quando facilmente reversibili, ma sempre in grado di dimostrare l’assenza di sostanze potenzialmente pericolose per l’uomo e di inquinanti per l’ambiente. Si tratta di punti di una tipologia di prodotti capaci di coniugare elevati livelli prestazionali con versatilità funzionale ed estetica. In questo senso, l’impiego del laterizio si distingue anche per la ricerca, la sperimentazione e l’applicazione di soluzioni innovative, che possono incrementare la qualità di un intervento sull’esistente. Una pregevole risorsa per il benessere sociale e ambientale dei luoghi.




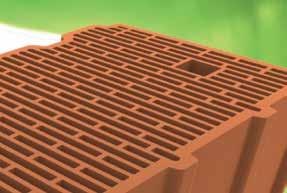


























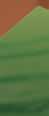











Angelo Lavanga Installazioni del divenire Valdarno, Pistoia, Milano
Chiara Testoni, Architetto, PhD
KEYWORDS
Laterizio
Arte
Macerie
Trasformazione
Rinascita
Brick
Art
Wreckage
Transformation
Rebirth
Il laterizio è un materiale “a-temporale” che, come insegna la storia del costruire, attraversa i secoli adattandosi agevolmente ai contesti più disparati, grazie alla sua intrinseca resistenza e durevolezza. Ed è proprio il suo carattere “imperituro”, dall’anima robusta ma anche profondamente poetica, che lo rende il materiale “manifesto” di un’“architettura della permanenza”, indifferente alle stagioni delle mode e responsabilmente concepita per registrare il passare degli anni senza subirne gli strali (come invece spesso accade ad opere “giovani” ma drasticamente effimere per caratteristiche costruttive).
tra costruzione e decostruzione e plasmando la materia per generare nuove visioni inaspettate in un continuo (ed eracliteo) divenire: le opere nascono come “rovine” ma al contempo sono tracce germinali di una ricomposizione e di una futura dissoluzione.
Cinquecento, Pistoia
© Ivan Rossi

Il pensiero artistico e creativo getta tuttavia una nuova luce interpretativa sulle potenzialità semantiche di questo materiale stravolgendone il significato di simbolo di resistenza e durabilità, e introducendo una riflessione che trascende il tema del ciclo di vita utile (per quanto lungo, nel caso del laterizio) e si spinge a indagare il rapporto dicotomico tra artificio e natura, tra memoria e futuro, tra vita e morte.
A maturare questa riflessione è il designer Angelo Lavanga. Nell’ambito di allestimenti en plein air ed indoor, dal pacificante paesaggio toscano alla frenetica Milano Design Week, Lavanga conduce un’appassionata sperimentazione sul laterizio con cui rimarca la propria urgenza a ”mescolare le carte”, sfumando i confini
In different site-specific installations immersed in the Tuscan landscape or placed inside an industrial building in the context of Milan Design Week 2025, Angelo Lavanga explores the semantic potential of brick through material experiments investigating the dichotomous connection between artifice and nature, memory and future, construction and de-construction, life and death.
L’installazione “Monte dei Cocci”, immersa nel contesto naturale/artificiale del Valdarno, indaga le potenzialità rigenerative dello scarto e del riciclo. L’opera si colloca tra due diverse cave di materiali: una naturale, di argilla, l’altra di origine antropica costituita da montagne di frammenti di laterizio, a comporre l’orografia di un nuovo, onirico paesaggio in trasformazione. Tra le rovine, si stagliano sorprendentemente volumi dalla geometria rigorosa formati da elementi di laterizio forato che presagiscono una ”rinascita” del materiale (e della vita) dalle macerie attraverso l’architettura, prima di tornare nuovamente a disfarsi, terminato il proprio ciclo di vita, nella terra da cui originano. Nell’installazione “Cinquecento”, immersa nel verde del Campus Vannucci di Pistoia (il vivaio più grande d’Europa) e riflessa in un piccolo specchio d’acqua, la trasparenza è utilizzata come strumento di meditazione sul tempo e come trait d’union tra l’opera artificiale e il paesaggio naturale che filtra dalle trame materiche del laterizio. Il volume plasmato da linee rigorose e superfici plastiche è composto da elementi di laterizio forato, utilizzato in orizzontale nel verso opposto alla posa tradizionale: l’opera si percepisce in movimento, da diversi punti di vista e secondo varie forme di interazione con il paesaggio e con la luce, in funzione degli agenti atmosferici e delle ore del giorno, fino a che con il passare del tempo non si dissolverà in pol-
Le opere sono realizzate grazie alla fornitura dei laterizi di SO.LA.VA spa

vere, lasciando di sé viva solo la memoria. Infine, l’allestimento site-specific “Controluce” all’interno di un ex stabilimento industriale, nel contesto del Fuori Salone del Mobile a Milano durante l’Isola Design Festival 2025, celebra il processo di ricomposizione delle macerie e di rinascita della materia attraverso un intervento leggero e completamente reversibile. Per l’allestimento degli spazi, schermi frangisole e pianelle in terracotta compongono una serie di dispositivi orizzontali e verticali, pensati per accogliere le opere dei vari designers selezionati dalla manifestazione. Le pareti in cotto, erette a secco, assicurate tra loro da giunti metallici che evidenziano i punti di tensione, attraversano delicatamente lo spazio senza “invaderlo”, modulando la luce naturale che filtra dalle grandi finestre e che crea vivaci giochi chiaroscurali nello spazio, a seconda delle ore del giorno. Dalla terra, al frammento, alla fornace, al progetto, e poi di nuovo al frammento, alla polvere e alla terra: il laterizio come cifra di un processo vitale continuamente in evoluzione che trova la chiave della permanenza proprio nella sua inesorabile e ciclica trasformazione. Nella convinzione che, in fondo, niente finisce realmente.
SCHEDE TECNICHE
Oggetto Monte dei Cocci
Località Fornace Solava, Valdarno
Progetto Angelo Lavanga
Allestimento Angelo Lavanga, Enrico Acquasanta, Leonardo Vitti, Raffaele Capasso
Fotografie Ivan Rossi
Oggetto Cinquecento
Località Campus Vannucci, Pistoia
Progetto Angelo Lavanga
Allestimento Angelo Lavanga, Enrico Acquasanta
Fotografie Ivan Rossi
Oggetto Controluce
Località Basic Village, Milano
Progetto Angelo Lavanga, Enrico Acquasanta
Allestimento Angelo Lavanga, Enrico Acquasanta, Danilo Freguglia, Bernardo del Buffa, Federico Marchetti, Vincenzo Notarnicola
Fotografie Luca Ferrara

Monte dei Cocci, Valdarno © Ivan Rossi
Cinquecento, Pistoia. Trasparenze e paesaggio © Ivan Rossi



Controluce, Milano. Leggerezza e reversibilità © Luca Ferrara



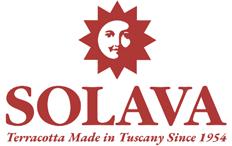





La parabola degli apparati decorativi fittili, evento ‘globale’ di fine Ottocento
Le “terrecotte ornamentali” di fine XIX secolo sono state un fenomeno italiano, europeo e oltre oceanico, una breve parabola temporale tra tradizione artigianale e innovazione preindustriale. La valenza estetica e protettiva rispetto a smog e incendi potrebbe essere rinverdita dalle recenti possibilità di stampa 3D
Fabrizio De Cesaris, Professore Associato, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma
Liliana Ninarello, PhD, Research Fellow, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma
KEYWORDS
Terrecotte decorative
Fornaci
XIX-XX secolo
Evoluzione
Protezione al fuoco
Europa America
Backed clay
Kilns
19th–20th century
Evolution
Fire Protection
Europe America
L’abituale traiettoria degli studi italiani sui materiali fittili, almeno in ambito storico conservativo, tende a ripercorrere l’evoluzione storica dal mondo classico, talvolta interrompendosi agli albori della modernità o proseguendo fino alle più aggiornate tecniche di produzione dei materiali laterizi per il restauro1
Sembra interessante sondare un percorso speculativo diverso, focalizzato su una stagione creativa fortemente caratterizzata che nel momento stesso in cui raggiunse l’apice concluse anche la sua parabola. Si tratta della produzione fittile nell’ambito del fenomeno moderno delle ‘terrecotte decorative’ da circoscrivere, nella sua delimitata e specifica iden-
tità temporale, costruttiva e architettonica, tra la seconda metà dell’Ottocento e il primo Novecento [1]. Una produzione che si concretizzò anche in Italia ma che si manifestò in Europa e in altri ambiti che possono considerarsi estensioni delle culture europee (Americhe e Australia, ma non solo) configurandosi, ante litteram, come un fenomeno globale o almeno internazionale. Sicuramente, data la diffusione del materiale e della tecnica laterizia, possono ritrovarsi esempi ancora in altre produzioni costruttive ma alcune, quelle menzionate, sembrano accomunate dallo sviluppo sincrono e dalle connotazioni artistiche, sociali e produttive basate sui forni evoluti (a fuoco continuo) anche
The parable of the fictile decorative apparatus, a “global” event of the late 19th century
Th e primary focus of the essay is the production of ornamental terracotta, extensively documented in the catalogues of manufacturing firms between the mid-nineteenth and early twentieth century. This phenomenon unfolded across numerous European nations, with particular prominence in the Anglo-Saxon context, driven by the proliferation of steel-framed buildings clad and safeguarded with brick. It soon assumed a transatlantic dimension, extending its influence to the Americas
and Australia.
Initially, manufacturers relied on indigenous and traditional techniques, which they gradually reinterpreted through pre-industrial innovations. Production facilities were progressively modernized with the adoption of continuous-fire kilns. Terracotta was employed in conjunction with worked stone to construct richly ornamented façades, articulating an architectural language that was simultaneously avant-garde and rooted in established stylistic motifs and archetypes,
situated within the broader context of eclectic architecture.
In post-unification Italy, numerous factories played a pivotal role in crafting a national architectural identity, an identity that sought to renew visual expression while drawing upon vernacular traditions and the classical heritage. The ornamental terracotta production centres, concentrated in northern and central Italy, not only supplied the domestic market but also emerged as prominent contributors on both the European and global stage.
se non specificamente indirizzati alla produzione seriale come i famosi Hoffmann. La produzione si basava sulla realizzazione di pezzi ripetitivi, semplici o complessi, che andavano a comporre gli elementi fondamentali della tettonica delle facciate (cornici, mensole, bassorilievi, decori) o delle falde di copertura (acroteri, pinnacoli e comignoli). Naturalmente non erano le prime realizzazioni di questo tipo, anticipate da esempi antichi e rinascimentali, ma diverso era l’approccio semi industriale che consentiva un’economica razionalizzazione del cantiere basata su modelli, ripetibili e innovativi, e su tecniche semplificate di sicura e rapida applicazione per la facilitazione dell’ancoraggio in opera. Soprattutto, consentiva ancora l’adozione di una ricca decorazione architettonica senza dover affrontare costi ormai insostenibili, animando facciate sostanzialmente piane con l’articolazione degli elementi architettonici classici, talvolta speciali, giustapposti a rilievo. Un atteggiamento certamente allineato alle ricerche tese alla linearità ed economicità delle costruzioni che condurrà al Movimento Moderno, mantenendo però ancora un legame con le decorazioni tradizionali che saranno poi considerate ‘orpelli’ e quindi escluse.
L’attività produttiva si sviluppò per qualche decennio e si ridusse poi per l’adozione sostitutiva del calcestruzzo cementizio e per l’affievolirsi della domanda di decorazioni da applicare sui fronti architettonici ispirati ormai da scelte stilistiche geometriche e lineari [2].
Alla fortuna delle terrecotte artistiche contribuì la pubblicazione a stampa colorata di ricchi atlanti di architetture in mattoni a vista, spesso corredati da centinaia di cromolitografie con accurati disegni quotati che mostravano tecniche e uso decorativo del laterizio2 [3,4]. Spesso, oltremare, arrivavano trattati d’architettura italiana con magnifici e dettagliati disegni su costruzioni laterizie da cui sicuramente venivano tratti utili riferimenti per i cantieri americani. In alternativa alla scelta sul campionario, una seconda modalità di fornitura prevedeva l’esecuzione di pezzi eseguiti su disegno dei progettisti. Dalle notizie storiche, si può infatti desumere che molte ceramiche decorative fossero
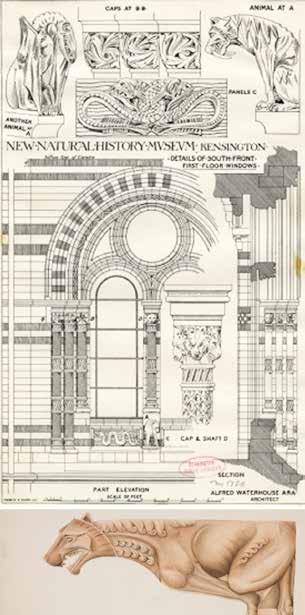
elaborate sulla base di un disegno e di un prototipo scultoreo affidati a un artista appositamente ingaggiato; gli stampi utilizzati rimanevano però disponibili per ulteriori riproduzioni spesso anche combinate in modi diversi dalla configurazione originaria3 [5].
D’altra parte, nei Paesi europei tradizionalmente dediti alla produzione laterizia come Inghilterra, Francia, Germania e Austria, esistevano altrettanto rinomati centri di produzione che si ammodernarono a seguito della rivoluzione industriale, orientandosi verso speciali produzioni artistiche, con fenomeni simili ma anche anticipati rispetto a quelli italiani. Uno sviluppo che fu esportato tramite la scuola artigianale britannica, talvolta anche con contaminazioni italiane, ai Paesi del Commonwealth e, in particolare, all’America settentrionale e all’Australia. A Londra, è rinomata la Gibbs e Canning Limited sita a Glascote, Tamworth, fondata nel 1847, capace di produrre rivesti-
1. Museo di storia naturale, dettagli costruttivi delle finestre del primo piano (in alto) e illustrazione a colori della finitura dei rilievi di terracotta (in basso) (M.Girouard, Alfred Waterhouse and The Natural History Museum, London, 1998).

2. Rappresentazione
della Holborn Bars di Alfred Waterhouse (1879) (https://www. prudentialplc.com/en/ about-us/our-history/ holborn-bars).
3. The Northwestern Terra Cotta Company, dettagli decorativi in terracotta (Northwestern Terra Cotta Co., The Northwestern Terra Cotta Company Chicago, Chicago, 1925).

menti omogenei per intere facciate, compresi decori a rilievo e parti piane, come nel caso del Museo di storia naturale (Londra, 1873-1880) in forma neogotica (con la partecipazione degli architetti Francis Fowke e Alfred Waterhouse) o del Prudential Assurance Company (Holborn Bars), Holborn, Londra di Alfred e Paul Waterhouse (realizzato dal 1876)4 (figg.1-2) [6].
Le piastrelle e le decorazioni sono protette da particolari finiture (invetriatura) per garantire la resistenza all’inquinamento della Londra vittoriana e al fuoco.
La citazione di questo caso sembra opportuna per evidenziare una comune matrice tra le produzioni inglesi e americane. In America, infatti, si ha una grande attività documentata dai cataloghi della The Northwestern Terra Cotta Company, con una produzione caratterizzata dalla resistenza alle fiamme nello speciale ruolo di rivestimento delle strutture metalliche e dal formato variabile tra le piccole dimensioni delle piastrelle invetriate e le grandi dimensioni per i fregi dei moderni grattacieli (fig.3) [7].
Tra le altre esperienze sembra interessante annotare la collezione australiana intitolata al professor Miles Lewis incentrata proprio sulle terrecotte locali di fine Ottocento e primo Novecento, segno evidente di una diffusione inaspettata ma ormai storica e documentata 5 . Nella collezione si ritrovano pezzi ordinari invetriati, protettivi contro il fuoco, e pezzi speciali
destinati a rivestimenti decorativi per i quali si studiarono appositi e razionali metodi di assemblaggio e ancoraggio.
La ricostruzione di Chicago, dopo l’incendio del 10 ottobre 1871, sembra essere lo spunto propulsivo ma le realizzazioni sono diffuse su un ampio distretto; la tipologia del grattacielo a struttura metallica viene, infatti, a fornire un paradigma costruttivo dove le ceramiche decorative rivestono e proteggono le parti piane, con colori e finiture variegati; a completamento dei fronti si aggiungono cantonali e cornicioni in cui la declinazione scultorea trova ampio spazio di creatività con gli architetti della Scuola di Chicago, tra cui gli storici pionieri dell’architettura moderna come William Le Baron Jenney, Henry Richardson, Daniel Burnham, John Root, Louis Sullivan, Dankmar Adler.
Per i grattacieli, si dovevano adottare grosse sculture, molto profonde per creare gli opportuni chiaroscuri necessari per essere correttamente percepite e godute dalla grande distanza, che potevano realizzarsi componendo gli elementi cotti appositamente congegnati. La richiesta della speciale qualità ignifuga era divenuta inderogabile per le strutture americane ormai composte con telai metallici e poi rivestite con maioliche. In quei casi, per ottenere l’attesa resistenza ignifuga risultava congeniale l’invetriatura londinese, citata, che per le fabbriche murarie italiane ha una rilevanza soprattutto cromatica e protettiva dagli agenti atmosferici. L’apparato documentario della Northwestern è impressionante per la dovizia di dettagli che rendono la terracotta compatibile con le strutture metalliche (fig.4).
Tra l’altro, una modalità che è presente, in piccolo, anche nelle nostre architetture, quando l’introduzione dei profilati metallici comincia ad adottarsi di frequente per realizzare le parti in aggetto, rivestite spesso con rivestimenti e decori laterizi.
Tale campo delle tecniche costruttive tradizionali, agli albori dell'architettura moderna, appare aperto a future indagini e approfondimenti maggiormente in merito alle specifiche fasi di formatura e finitura dei pezzi in terracotta.
I poli di produzione italiani di fine Ottocento
In Italia, a metà Ottocento, il processo realizzativo delle terrecotte subì una naturale evoluzione rispetto alle procedure tradizionali sfruttando, tra rallentamenti, riprese e accelerazioni della produzione, l’evoluzione delle nuove tecniche di cottura. È possibile documentare diversi centri di produzione di grande rilievo, capaci di proporre manufatti per i cantieri italiani, a seguito dell’unificazione del Regno e la conseguente maggiore facilità di commercio, ma anche di esporre i prodotti alla ribalta internazionale come attesta la partecipazione a varie esposizioni internazionali di cui gli imprenditori si vantavano nella propria pubblicistica commerciale.
Con il raggiungimento dell’Unità nazionale, le condizioni di arretratezza tecnologica diffusa furono parzialmente ridotte anche per l’estensione su tutto il territorio italiano dei dazi piemontesi, particolarmente vantaggiosi. Lo sviluppo di un mercato interno, sovvenzionato da fondi stranieri anche tramite nuovi istituti bancari contribuì a un lento ma generale rinnovamento tecnico e allo scambio delle conoscenze, oltre che dei materiali. La modernizzazione dei sistemi di produzione di laterizi e terrecotte si concretò nella diffusione del forno Hoffmann che, seppure non impiegato per gli elementi decorativi, contribuì a rafforzare le capacità imprenditoriali del settore [8,9].
Quest’ultima specifica attività si diffuse ancor più nell’ultimo quarto del secolo per l’impegno di produttori che sfruttarono non solo la propria capacità realizzativa ma anche un vero e proprio estro artistico che si combinò felicemente con le esigenze architettoniche del momento. In particolare, si sviluppò un filone produttivo rivolto alle aggettivazioni artistiche per le facciate architettoniche attraverso la produzione di figure articolate e definite nel dettaglio fino all’introduzione di vere e proprie sculture a basso e ad altorilievo, da inserire nelle specchiature murarie piane. Emerse quindi l’attività di alcuni poli produttivi, rappresentativi di rinomate e tradizionali scuole di fornaciai, che si adeguarono alle esigenze e ai ritmi richie-
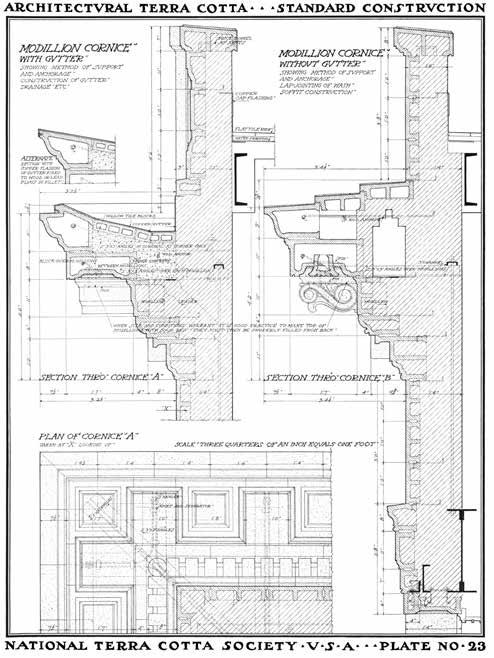
sti dal nuovo contesto produttivo e dal gusto eclettico imperante. A Milano, dagli anni Sessanta del XIX secolo, s’impose la Ditta Andrea Boni e compagni, specializzata in decori fittili tramite processi industriali, che partecipò alla Fiera Mondiale di New York, affiancandosi alla Chicago Terra Cotta Company, produttrice degli elementi in cotto utilizzati nella prima ricostruzione di Chicago. Nella stessa area geografica milanese, si distinsero anche le attività di altre ditte quali la Curti (XV sec.), la Riccardo Dall’Ara, la Airaghi e Boni, la Pruvini, Righetti e C.[arlo] Candiani [10,11]. Quest’ultima, già attiva nel 1836, in pochi decenni s’impose sul mercato milanese e lombardo attraverso un linguaggio ornamentale che si rivolgeva allo stile bramantesco e d’ispirazione neoromanica, lavorando in sinergia con l’archi-
4. The Northwestern Terra Cotta Company, rappresentazione dettagliata di cornice modanata in terracotta (Northwestern Terra Cotta Co., The Northwestern Terra Cotta Company Chicago, Chicago, 1925).

5. Manifattura di Lastra a Signa, estratto da catalogo di mensole in terracotta. (Manifattura di Signa, Catalogo, decorazioni architettoniche bassorilievi decorativi, S.P.E.S., Firenze 1986).
tetto Luigi Broggi, allievo di Boito. Nei cataloghi della ditta Boni, come in quelli della ditta Candiani, è manifesta la grande varietà di prodotti, per pavimenti, decori, pinnacoli, statue e sculture a tutto tondo.
Negli stessi anni, notevole importanza assunse l’attività dei poli produttivi umbri, che si distinse per la qualità dei prodotti e per l’ampia capacità produttiva; fabbriche di laterizi che risposero alle esigenze dei cantieri edilizi moderni, anche di Roma. Tra le fabbriche di terrecotte artistiche più attive nel distretto umbro vi furono le fornaci di Gaetano Possenti e Luigi Matascioli a Terni, la fornace di Filippo Muscini a Città di Castello, la celeberrima Premiata Fabbrica di Terre Cotte
Artistiche Decorative fondata a Perugia nel 1865 dagli scultori Francesco Biscarini (1838-1903) e Raffaele Angeletti (1842-1899) [12,13]. L’attività della Premiata Fabbrica proseguirà fino agli anni Trenta del XX secolo e sarà tra le più estese per varietà di stile e tipologia degli elementi. Nei cataloghi e negli abachi tridimensionali composti sulle facciate delle sedi, appaiono lesene, candelabre, cornici, rosoni, festoni, protomi leonine, capitelli, mensole, stemmi, busti, vasi, balaustre, edicole, portali, fastigi, ma anche giochi realizzati da mattoni albasi, gialli e ferrigni; prodotti derivanti da morfemi storico-tradizionali che furono ampiamente adottati dagli artisti e dagli architetti attivi nei decenni tra i due

secoli e attraverso i quali è possibile ricostruire i fitti rapporti tra la Premiata Fabbrica e i progettisti [14].
Più tarda (1888-1940) sarà la vicenda della Manifattura di Signa (Firenze), dei fratelli Camillo e Angelo Bondi la cui produzione s’innesterà in una nicchia di mercato orientata sia verso forme decorative contemporanee sia alla riproduzione di prodotti ispirati alla storia [15]. Si tratta di riproduzioni ottenute da calco di originali, trattate poi in superficie per ottenere particolari effetti materici (imitativi e invecchianti) che s’imporranno rapidamente sul mercato nazionale e internazionale, influendo sul gusto dell’epoca (fig.5). La produzione delle fornaci attive in ambito romano negli ultimi decenni del XIX secolo appare, in confronto, piuttosto limitata e priva di spunti creativi, forse perché limitata alla produzione standard nonostante l’ampia domanda, legata allo straordinario sviluppo urbano che investì la città, nuova capitale italiana [16]. In effetti, restano in opera tracce notevolissime, per sagoma, varietà e dimensione, di forme decorative in terracotta (come anche in laterizio e metallo, in stucco, in getto cementizio, in pietra) esposte sulle facciate degli edifici dei nuovi quartieri Esquilino, Flaminio, Prati, Nomentano, Castro Pretorio e Celio. Le terrecotte decorative, evidentemente provenienti dalla vicina Umbria, formarono gli apparati decorativi aggettanti dai prospetti di architetture rilevanti ma anche ornamento più modesto di numerosi edifici residenziali meno noti (fig.6) [17].
Nella produzione di questo periodo, gli elementi decorativi ripetitivi (mensole, volute, rosette etc.) sono spesso costituiti da elementi cotti e cavi (particolarmente leggeri) che essendo perciò svincolati dalle esigenze strutturali delle modanature murarie tradizionali, sovente consentono ampiezze e aggetti generosi che ne lasciano trasparire la particolare natura costitutiva. D’altra parte, trattandosi sovente di componenti asservite all’immagine architettonica complessiva, sono in gran parte coperte con trattamenti imitativi dei più nobili materiali lapidei, finiture che impediscono la riconoscibilità dei materiali costitutivi se non quando il degrado delle superfici ne sveli la reale consistenza.

Conclusioni
Effettivamente, dalle considerazioni sinteticamente svolte, emerge un fenomeno produttivo dai risvolti internazionali, che prende le mosse dalla tradizione costruttiva italiana ed europea ma che trae energia dalle nuove esigenze del XIX secolo, dai revival stilistici, dalle innovazioni tecniche e dalle competizioni tecnologiche. Un contesto, determinato dalla trasformazione economica e sociopolitica, che coinvolge la produzione artigiana verso i processi industriali e le relazioni transnazionali.
Un’attività produttiva che si riscontra in forma eclatante nei grandi cantieri nordamericani ma anche in Europa e soprattutto, per quello che ci riguarda, in Italia dove alcuni maestri e centri di produzione, ricchi di grandi tradizioni artigianali nella produzione fittile ma votati alle innovazioni positive del XIX secolo, diffondono manufatti di grande qualità, largamente adottati nei cantieri dell’epoca. Terrecotte e ceramiche decorative a stampo lasciano quindi un segno rilevante ma ristretto a pochi decenni. In controtendenza, rispetto a questo ramo discendente della parabola, sembrano oggi intravedersi i segni di un rinnovato interesse per il materiale fittile, ancora una volta sollecitato da istanze estetiche e necessità protettive (isolamento dal calore e dall’incendio) e con caratteri globali (per le attuali inclinazioni del mercato) (fig.7) [19]. Una ripresa resa compatibile dalle tecniche di produzione, basate ora sul controllo numerico nella formazione degli elementi, ma ancora incentrate su quel processo di cottura che, certo nelle modalità attuali volte alla ricerca di razionalità e qualità, ci ricollega a secoli lontani e a possibilità future.
7. Laterizi e ceramica stampati in 3D per la facciata di The Ceramic House, boutique di Amsterdam, Riccardo De Vecchi per Studio Rap.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
[1] G. Pedrocco, “Un’industria tra innovazione e tradizione: le fornaci da laterizi nei primi decenni del Novecento”, in Maristella Casciato, Stefania Mornati, C. Paola Scavizzi (a cura di), Il modo di costruire, Atti del I seminario internazionale, Edilstampa, Roma, 1990, pp. 447-459.
[2] T. Iori, Il cemento armato in Italia. Dalle origini alla Seconda guerra mondiale, Edilstampa, Roma, 2001.
[3] M. G. D’Amelio, F. De Cesaris, “Perugia dopo l’unità d’Italia: materiali e tecniche costruttive”, in: Paolo Belardi, Simone Bori (a cura di), 1861-1939 l’architettura della Perugia postunitaria Atti del convegno, Marsciano (PG), 24 marzo 2012, Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, 2013, pp. 97-108.
[4] F. De Cesaris, L. Ninarello, Le terrecotte decorative fra tradizione fittile e innovazione preindustriale, in Quaderni di Storia della Costruzione 3, Produrre per costruire, a cura di M.L. Barelli e M. Volpiano (Construction History Group), Politecnico di Torino DAD, Torino, 2024, pp. 279-296.
[5] I. Andreani, L’arte dei mestieri. Il muratore, Hoepli, Milano, (1910) 1915.
[6] M.Girouard, Alfred Waterhouse and The Natural History Museum, the Natural History Museum, London, 1998.
[7] Northwestern Terra Cotta Co., The Northwestern Terra Cotta Company Chicago, Chicago, 1925.
[8] L. Cadorin, Studii teorici e pratici di architettura e ornato per la erezione delle fabbriche principalmente in terracotta, tip. G. Grimaldo, Venezia, 1860.
[9] G. Musso, G. Copperi, Particolari di costruzioni murali e finimenti di fabbricati, Opere di finimento e affini (parte seconda), Paravia, Torino, 1889 (II ed.).
[10] G. De Castro, “Dell’industria delle terre cotte in Italia e segnatamente in Lombardia”, Il Politecnico, 2, XXIV, 105 (1865), pp. 282-297.
[11] A. Boni, Album di decorazioni eseguite in Terra Cotta nello stabilimento Andrea Boni e C. Premiato con medaglia d’oro e d’argento dall’I.R. Istituto di Milano e con medaglia di bronzo dal Giuri nell’Esposizione Mondiale di Nuova Jork, Andrea Boni e Co, Milano, 1860.
[12] E. Venturelli, “Terrecotte a stampo per l’arredo della casa e del giardino, un prodotto di successo della fabbrica milanese di Andrea Boni (1815 - 1874)”, Faenza, 2 (2014), pp. 81-91.
[13] A. Berioli, “La fornace Angeletti Biscarini nella formazione di Angelo Biscarini”, in: Arianna Berioli, Alessandra Migliorati, Franco Venanti (a cura di), Angelo Biscarini e la fornace di via del Laberinto. Bozzetti dalla collezione Venanti, Ali&no, Perugia, 2007, pp. 27-36.
[14] P. Malentacchi, “Terracotta ornamentale tra progettazione e restauro. Il sodalizio artistico tra l’architetto orvietano Paolo Zampi e la «Premiata Fabbrica Angeletti & Biscarini» di Perugia”, BISAO, 48-49 (1992-1993), pp. 211-222.
[15] M. Asciutti, “Le terrecotte artistiche della premiata fabbrica Angeletti e Biscarini. Il caso di palazzo Bianchi a Perugia”, Costruire in laterizio, 178 (2019), pp. 58-65.
[16] A. Baldinotti, Lucia Bassignana, Lia Bernini, Lucia Ciulli (a cura di), La Manifattura di Signa, S.P.E.S., Firenze, 1986.
[17] Ministero Agricoltura Industria e Commercio, “Elenco delle cave e delle fornaci a Roma al 31 dicembre 1886” (Firenze 1889), in L. Giustini, Fornaci e laterizi a Roma dal XV al XIX, Edizioni Kappa, Roma,1997, pp. 49-52.
[18] S.a., “Villini al Macao”, L’Illustrazione italiana, 9, (IV 1877), pp. 130-131.
[19] A. Magarò, “L’approccio algoritmico alla progettazione dell’involucro e la stampa 3D”, Costruire in Laterizio, 194 (2024), pp. 80-89.
Note
1. Per gli autori è un piacere ricordare che lo spunto di questo studio, iniziato qualche anno fa, è stato innescato da Maria Grazia D’Amelio a cui facciamo spesso riferimento. Si segnala, ai soli esiti di una specifica attribuzione, che la prima parte del contributo è stata composta da F. De Cesaris, la seconda parte da L. Ninarello.
2. Emerge rinnovata attenzione al laterizio ornamentale, come descritto da Pagan De Paganis in Cornici di terracotta in Bologna (D’Amelio, De Cesaris 2013).
3. De Cesaris Ninarello 2024.
4. Per ulteriori approfondimenti si veda http://cirrus.me.uk/html/AngellasPage/index.html.
5. The Miles Lewis Heritage Building Materials Collection, ACAHUCH - Australian Centre for Architectural History, Urban and Cultural Heritage, Università di Melbourne. Si veda la voce Acahuch: https://acahuch.msd.unimelb.edu.au/mileslewis-heritage-building-collection (consultato il 2.04.2023).
Oltre la direttiva “case green”.
L’impatto dell’economia circolare sul mercato edilizio
L’economia circolare è una sfida alla quale tutti i settori economici oggi sono chiamati a rispondere. Per il settore delle costruzioni significa avere una visione sistemica dei processi, con particolare attenzione al riuso, anche del territorio
Federico Della Puppa, Responsabile area Analisi & Strategie, Smart Land - Coordinatore scientifico Centro studi YouTrade
KEYWORDS
Economia circolare
EPBD
Riuso
Sostituzione edilizia
Visione sistemica
Rigenerazione urbana
Circular economy
EPBD
Reuse
Building replacement
Systemic vision
Urban regeneration
Viviamo tempi di incertezza e di grande trasformazione. La situazione economica internazionale sta vivendo da molti mesi una condizione di forte instabilità e incertezza dovuta all’arrivo della nuova amministrazione Trump e alle scelte, sia di politica internazionale sia nazionale, che hanno contraddistinto fino ad oggi l’operato del tycoon. The Donald infatti ha avviato, fin dai primi giorni del suo mandato, un'azione di destabilizzazione relativa agli accordi commerciali storicamente consolidati con Paesi terzi che non ha eguali, non solo in termini di peso e dimensione, ma anche in relazione agli impatti globali che il nuovo corso protezionista della politica statunitense rischia di innescare a livello mondiale.
Questo scenario nuovo, e non facile con il quale confrontarci, si somma a un altro scena-
rio di lungo periodo con il quale dobbiamo confrontarci e che riguarda il passaggio da un’economia tipicamente analogica ad un’economia governata dal digitale, dove il passaggio da materiale e immateriale sancisce una profonda metamorfosi dei riferimenti. In poco più di 100 anni siamo passati dall’economia fordista alla sharing economy, dal modello produttivo dove l’offerta dominava la domanda (famosa la franse di Henry Ford che diceva: “Ogni cliente può ottenere un’auto di qualunque colore desideri, purché sia nero ” - 1909) a un modello nel quale è la domanda che vince, con l’estrema personalizzazione dei prodotti, compresa la catena distributiva che oggi arriva direttamente nelle nostre case con consegne ad hoc non solo per i prodotti nuovi, attraverso Amazon, ma anche per l’usato, via Vinted. Questo passaggio epocale riguarda una tra-
Beyond the “green buildings” directive: the impact of the circular economy on the construction market
We live in times of uncertainty and scenarios of great transformation that are not easy to deal with. The challenges of sustainability and the circular economy are engaging the construction industry in seeking new solutions, but the challenge is also territorial. We need to intervene
on the built environment so as not to consume land. We need to study the type of intervention based on the specific conditions of the works to be redeveloped and help in this sense can come from the EPBD IV Directive of the European Union, which pushes us to find convenient solutions not only from an environmental
point of view, but also from an economic point of view. The concrete step we need to take is to move from “what we do” to “how we do it”, according to a systemic vision of construction processes, going beyond the single product, which represents the real challenge for the construction sector.

sformazione della quale abbiamo finora colto solo una parte della potenza del suo cambiamento, ovvero il passaggio da una logica di prodotto a una di processo (fig. 1).
Oggi nelle catene del valore la logistica ha assunto un ruolo e un peso fondamentale rispetto alla qualità del prodotto in sé, e il servizio pre e post-vendita assume un ruolo determinante nel definire il valore di un oggetto, di un prodotto.
Dall’economia lineare all’economia circolare
Nel mondo delle costruzioni questo cambiamento si inizia a sentire, ma va inserito nell’altra grande dinamica di trasformazione che sta cambiando l’approccio ai processi economici e produttivi, ovvero il passaggio dall’economia lineare all’economia circolare (fig. 2). L’economia circolare non è una novità, l’abbiamo studiata inconsapevolmente a scuola con Lavoisier (“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”) ma non l’avevamo ancora collocata nel mondo reale.
La direttiva europea [1] che l’ha introdotta, e i vari piani di azione successivi, hanno sancito la fine dell’economia lineare del passato (estraggo-produco-vendo-consumo-elimino) e l’avvio di una rivoluzione che sul riuso e il riciclo sta introducendo cambiamenti epocali in tutti i settori, compreso il settore delle costruzioni.
Ma se per i prodotti di consumo l’economia circolare è un elemento che fa parte del processo produttivo se il prodotto è progettato in modo adeguato a essere, a fine ciclo di vita, smontato, disassemblato e avviato nelle catene del riutilizzo delle materie di cui è fatto, nell’edilizia e nelle costruzioni si tratta di rivedere interamente il processo, in quanto è nella progettazione che si costruisce la circolarità, prima ancora che nella produzione. Certo, agire su prodotti che sono edifici, ponti e strade è qualcosa di più difficile, ma le pratiche si stanno evolvendo rapidamente anche attraverso esperienze di urban mining, valevole processo di recupero e riutilizzo dei materiali di una città. Diverse sperimentazioni, infatti, sono state compiute in questi anni, introducendo strategie circolari innovative a scala urbana ed edilizia, come quella
Materie prime
Progettazione
Produzione
Distribuzione
Consumo
Scambio
Eliminazione
1. La metamorfosi profonda dei riferimenti. (Fonte Smart Land)
2. Il cambio di paradigma: dall’economia lineare all’economia circolare. (Fonte Smart Land)
Materie prime
Riciclaggio
Progettazione
Produzione
Distribuzione
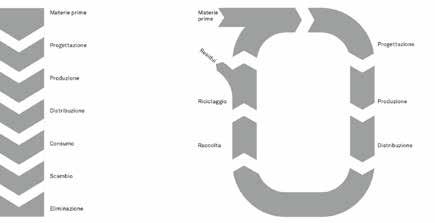

messa in atto dai progettisti di Lendager (Copenaghen) che hanno inserito nell’edificio residenziale Resource Rows (fig. 3) materiali recuperati nel perimetro della città: porzioni di muratura in laterizio provenienti da diverse costruzioni in disuso (una birreria, scuole, edifici industriali), assemblate per una nuova vita [2].
Il problema principale, comunque, non risiede nel prodotto in sé, in quanto l’edilizia, più di altri settori, è un prodotto di prodotti. Gli edifici sono costruiti combinando e assemblando componenti diversi e facilitarne la reversibilità, con apposite valutazioni già in fase progettuale, può senz’altro contribuire a incrementare le pratiche di riuso e riciclo a fine vita (fig. 4). In tal senso, anche la demolizione selettiva va opportunamente incentivata, altrimenti continueremo ad avere sparsi nel nostro territorio prodotti edilizi abbandonati e non più utilizzati che abbiamo seminato nel territorio e che rimangono lì come corpi separati, residui inutili e spesso neppure riutilizzabili.
Sostenibilità è temporaneità durevole
A seconda della tipologia costruttiva, il reimpiego delle risorse edilizie è attuabile, oltre che tramite smontaggio a secco, anche grazie a
specifiche operazioni di taglio o decostruzione e pulizia puntuale di elementi, porzioni e/o sistemi modulari, la cui integrità deve essere sempre necessariamente preservata e le caratteristiche tecnico-funzionali garantite per il riutilizzo. Dunque, l’aspetto prioritario del reimpiego non è la modalità di estrazione/recupero del componente edilizio ma la sua versatilità, adattabilità e capacità di mantenere i requisiti ovvero il livello di effettiva durabilità [3].
Va quindi sempre favorito l’uso di componenti e sistemi durabili, facilmente mantenibili e riparabili in quanto ciò prolungherà il ciclo di vita degli edifici. Infatti, operazioni di riuso e riciclo risultano del tutto inefficaci quando basati su logica consumistica di produzione-uso-riprocessamento che accelera i cicli piuttosto che ampliarli, con conseguente aumento di consumi delle risorse e degli impatti sull’ambiente [4].
Va posta poi la dovuta attenzione al ruolo nell’organismo edilizio del componente che si intende reimpiegare: se il componente per l’uso previsto deve assolvere al requisito di sicurezza strutturale e sismica, non si può assolutamente prescindere da verifiche progettuali e prove di accettazione in cantiere come disciplinato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni [5]. La durabilità e la sostenibilità sono concetti centrali anche nel recente rapporto sull’economia circolare di Confindustria [6], che focalizza l’attenzione proprio sulla progettazione di edifici resilienti con una lunga vita utile e basse necessità di manutenzione, approccio utile a contenere non solo i consumi, ma anche le emissioni di CO 2 . Per promuovere la circolarità nel settore delle costruzioni, il rapporto propone più soluzioni strategiche, e tra queste: la durabilità dei materiali; pianificazione a lungo periodo; utilizzo di componenti manutenibili e riparabili; incentivi e agevolazioni fiscali per uso di riciclati e di demolizione selettiva; semplificazione della normativa per il recupero degli aggregati.
Costruire sul costruito
Alcuni dati ci ricordano l’estrema rilevanza del problema del costruito abbandonato, basti pensare che in Veneto, la Regione che più di
Oltre la direttiva “case green”. L’impatto dell’economia circolare sul mercato edilizio
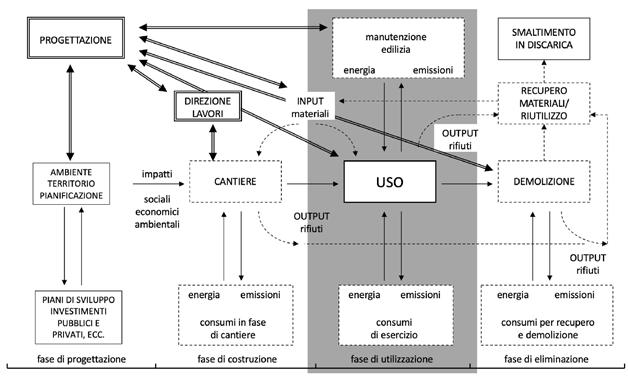
tutte in Italia ha consumato suolo, secondo recenti ricerche svolte da Smart Land per Confartigianato Imprese Veneto, ci sono 9.200 capannoni industriali-artigianali abbandonati e inutilizzati e altri 4.900 unità immobiliare pubbliche inutilizzate [7]. Oltre 14 mila oggetti sparsi nel territorio e lasciati lì come monadi a ricordarci che in edilizia affrontare il tema dell’economia circolare significa interrogarsi sul rapporto tra ciò che costruiamo e il consumo di suolo.
Perché il tema vero è questo: l’impossibilità di procedere con un modello che consuma irreversibilmente una risorsa non riproducibile, come il suolo. Ecco che parlare di economia circolare nelle costruzioni significa affrontare la questione delle nuove strategie urbanistiche, in primo luogo, che devono concorrere a determinare le regole del gioco per il futuro delle nostre città e dei nostri territori. Un futuro nel quale si dovrà intervenire costruendo sul costruito, limitando possibilmente il consumo di ulteriore suolo, e trovando soluzioni adeguate; aprendo a una stagione di sostituzione edilizia e di integrazione dei materiali e delle tecniche costruttive e di intervento sul costruito, grazie allo sviluppo
tecnologico relativo ai prodotti per edilizia e costruzioni che già oggi è possibile attivare.
Il punto centrale del ragionamento, la domanda cruciale per il futuro dell’edilizia in un ambito di economia circolare, è “dove inizia il processo?”
La risposta non può essere che nella progettazione, ma in realtà la domanda è più complicata se dall’ambito della nuova costruzione ci spostiamo su quello del costruito, ovvero del riuso, riciclo o demolizione dell’esistente (fig. 5).
E un nodo particolare che dobbiamo superare
4. Edilizia e sostenibilità, il ruolo del processo. (Fonte Federico Della Puppa, Repertorio di VilleGiardini 2006)
5. Demolizioni e ricostruzioni, analisi di un campione di 30 mila permessi di costruire per anno. (Fonte Smart Land)
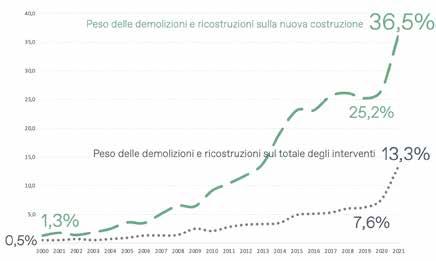

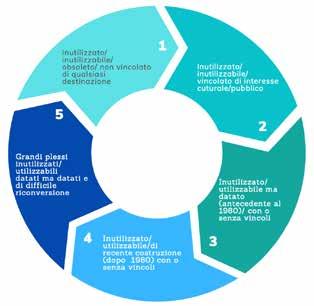
è quello collegato al valore degli oggetti edilizi inutilizzati e sparsi nel nostro territorio. Il territorio, come lo abbiamo costruito nel dopoguerra, è stato pensato attraverso criteri urbanistici che, nel disegno urbano e territoriale, separavano le funzioni, con i luoghi dell’abitare, quelli del produrre, quelli per il tempo libero. La crescita delle città e lo sviluppo di un’urbanistica sempre più densa e diffusa, ha di fatto costruito sistemi territoriali nei quali spesso le diverse parti si fondono e si intersecano. Ma l’evoluzione delle funzioni urbane e territoriali oggi non è più affrontabile con la logica della vecchia “urbanistica del retino”, perché di fatto quell’approccio è per la maggior parte fallito.
L’urbanistica in Italia non è stata in grado di garantire un’espansione coerente delle nostre città, e oggi ci troviamo di fronte alla sfida della rigenerazione urbana con vuoti urbani che non sappiamo come affrontare, sia a livello di grandi città sia di piccoli centri, luoghi nei quali si sono riprodotti, su scala “matrioskale”, gli stessi modelli e gli stessi problemi delle grandi città e delle metropoli. Il nodo è aver concentrato tutta l’attenzione sul solo valore economico dei luoghi, sulla possibilità di un loro uso e sfruttamento, puntando a regolare le scelte costruttive in termini di volumetrie e di “cittadini equivalenti”, ciò che possiamo definire, senza ombra di dubbio, l’insuccesso dell’urbanistica italiana. Pensare circolare in tema di rigenerazione urbana e di territorio, e con essi l’urbanistica, si-
gnifica pensare come se avessimo di fronte a noi un sistema di vasi comunicanti. Se vogliamo città vive che funzionano, la trasformazione del costruire deve innanzitutto svuotare, cambiando strategia e mettendo mano al patrimonio costruito per ottenerne nuove realtà non solo più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche più sicure e salubri, migliorando al contempo il rapporto con il paesaggio naturale, sia nelle città che nei territori diffusi (fig. 6).
L’impulso della direttiva EPBD
La sfida è partire da ciò che già c’è, dalla grande quantità di patrimonio sul quale intervenire e per il quale l’Unione europea, con la nuova direttiva EPBD IV [8], detta “case green”, ci spinge a intervenire.
L’85% degli edifici dell’UE è stato costruito prima del 2000 e il 75% presenta scarse prestazioni energetiche. Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti è quindi fondamentale per risparmiare energia, ridurre le bollette per cittadini e imprese e raggiungere un parco immobiliare a zero emissioni e completamente decarbonizzato entro il 2050 [9].
Tuttavia, va ben compreso che non basta installare cappotti [10] e pannelli fotovoltaici per migliorare il nostro patrimonio costruito. Occorre studiare il tipo di intervento in funzione delle condizioni specifiche delle opere da riqualificare. La conoscenza approfondita dell’opera è la prima basilare azione da svolgere e poi, ipotizzati gli interventi, va eseguita - come peraltro richiesto dalla EPBD - la relativa analisi costi/benefici, sia in temini economici che ambientali, e se necessario anche rispetto agli aspetti sociali. Demolire e ricostruire, il più delle volte può risultare anche economicamente e ambientalmente più vantaggioso rispetto a una ristrutturazione profonda [11].
Dobbiamo imparare a trasformare, a sostituire, a demolire e ricostruire, sono le uniche significative operazioni che permetterebbero di raggiungere effettivamente gli obiettivi sfidanti della direttiva EPBD insieme alle finalità della rigenerazione urbana, che l’Italia fatica
Oltre la direttiva “case green”. L’impatto dell’economia circolare sul mercato edilizio
a regolamentare, con bozze di leggi che non affrontano in modo sistemico il problema. La demolizione e ricostruzione in questi anni ha avuto, anche grazie ai bonus, un forte incremento, iniziando a modificare quell’atteggiamento tutto italiano del “metro cubo che vale per sempre”. Oggi siamo più consapevoli che un metro cubo edificato inutilizzabileperché non più adeguato - può e deve essere demolito e sostituito. Negli ultimi 20 anni, in Italia siamo passati nel rapporto tra demolizioni e nuove costruzioni da 1 su 100 (un cantiere di demolizione e ricostruzione ogni 100 cantieri di nuova costruzione) a 1 su 3. Quindi, parlare di economia circolare in edilizia significa agire su molti fronti, con la direttiva EPBD che è uno dei fronti, ma non certo l’unico. Anzi, è proprio dalla integrazione delle pratiche e delle modalità di intervento che noi possiamo traguardare il futuro delle costruzioni secondo un approccio non solo logico e necessario, ma anche economicamente sostenibile.
Conclusioni
La sostenibilità non è una opzione, sia in senso ambientale che in senso economico, e solo quando saremo pienamente consapevoli che la sostenibilità è indispensabile e genera numerosi indotti, solo allora avremo capito che il cambiamento di paradigma sarà anche un cambiamento strutturale delle nostre filiere operative, dove il ragionamento non sarà più “dalla culla alla tomba”, ma realmente “dalla culla alla culla” (fig. 7).
Il passo concreto e decisivo sarà quando tutti saremo consci che essere sostenibili è conveniente sotto tutti i punti di vista.
Gli studi e le analisi ci dicono che è già così, ma per capirlo bene e soprattutto per metterlo in atto dobbiamo passare dal domandarci “cosa” facciamo al chiederci “come” lo facciamo. Perché la sostenibilità la costruiamo con una visione sistemica di processo, non occupandoci solo del nostro prodotto. È questa la vera sfida, ed è a questa sfida che il futuro ci chiama intraprendere.
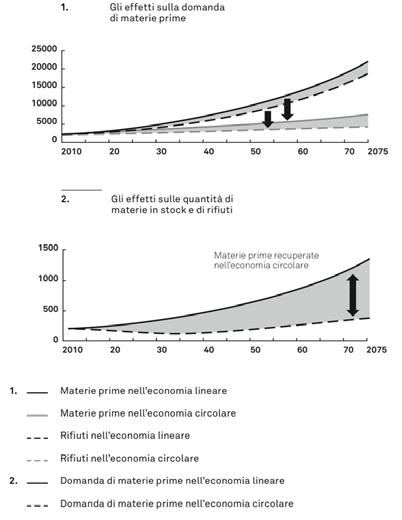
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
7. Gli effetti dell’economia circolare.
(Fonte Bonomi, Masiero, Della Puppa, La società circolare, 2015)
[1] Consiglio dell’Unione europea, 12791/19, More circularrity – Transition to a sustainable society (4 ottobre 2019).
[2] Massimiliano Condotta, Elisa Zatta, Riuso del Tempo in architettura. La pratica del reimpiego di prodotti e componenti edilizi, TECHNE 20-2020, 113-1.
[3] Jacopo Andreotti, Elena Montacchini, Silvia Tedesco, Schermi avanzati: il riuso di pareti in mattoni dall’esistente, Costruire in Laterizio, 193 (2023), 60-65.
[4] Monica Lavagna, Andrea Campioli, Anna Dalla Valle, Serena Giorgi, Tecla Caroli, Strategie costruttive e valutazioni ambientali per la temporaneità, circolarità e reversibilità, TECHNE 20-2020, 157-16
[5] NTC - D.M. 17/01/2018. Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018). Suppl. Ord. n.8. alla G.U. n. 42 del 20/02/2018.
[6] Confindustria, Economia circolare: strategie e prospettive per l’industria. Il secondo rapporto di Confindustria, Marzo 2025.
[7] Confartigiananto Imprese Veneto-Smart Land, Patrimonio edilizio artigianaleindustriale inutilizzato in Veneto. Quantità, caratteristiche e dinamiche 20172023 (2023).
[8] EPBD4 - DIRETTIVA (UE) 2024/1275 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
[9] Commissione europea, EPBD. Key facts on energy and EU buildings - Energy, Climate change, Environment (Giugno 2025) https://energy.ec.europa.eu/ topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/energy-performancebuildings-directive_en
[10] Di Perna, C., Remia, G., 4° versione dell’EPBD: dall’efficientamento energetico alla decarbonizzazione degli edifici, Costruire in Laterizio, 196 (2024), 66-71.
[11] Confindustria Ceramica, La transizione ecologica in edilizia - Oltre la direttiva EPBD, Giugno 2024 https://confindustriaceramica.it/w/paper-transizioneecologica-in-edilizia
Polo scientifico di Grugliasco: sostenibilità e innovazione nell’edilizia universitaria
Il progetto della Città delle Scienze e dell’Ambiente di Grugliasco rappresenta un caso virtuoso, sviluppato dall’Università di Torino secondo i protocolli energetico-ambientali LEED. Il campus, in project financing adotta soluzioni nZEB, materiali a basso impatto e gestione centralizzata degli impianti
Laura Calcagnini, Ricercatrice, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre Marina Tonolo, Dottoranda, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre
KEYWORDS
Sostenibilità
Campus universitario
LEED Italia
Progettazione integrata
Nuova costruzione
Social well-being
University campus
LEED Italy
Integrated design
New building
Il progetto del nuovo polo scientifico di Grugliasco rappresenta un ambizioso progetto di edilizia universitaria realizzato con l’obiettivo di assolvere agli obiettivi di sostenibilità e innovazione nell’edilizia universitaria nella progettualità di un Campus. Il Campus universitario occuperà un’area libera compresa nella fascia nordorientale del territorio comunale di Grugliasco, destinata allo sviluppo di infrastrutture universitarie e delimitata a nord dalla linea ferroviaria Torino-Modane, a sud dall’asse viario di Corso Torino, a ovest dall’esistente complesso universitario, a est con edifici privati a destinazione prevalentemente mista produttiva e residenziale. Questo progetto rap-
presenta una sfida significativa per il perseguimento degli obiettivi ambientali della certificazione LEED Gold di un Campus su un’area libera di circa 200 ettari e con oltre 85 ettari di nuove superfici costruite (fig. 1).
L’ambizione di ottenere una certificazione ambientale ha condizionato la scelta delle soluzioni tecnologiche e materiche in risposta al soddisfacimento di specifici requisiti che sono dipesi dal protocollo e dall’approccio scelto.
I protocolli energetico-ambientali e il contesto del progetto Il ruolo delle certificazioni e dei protocolli ambientali è oggi consolidato e affermato nel
Grugliasco’s scientific campus: sustainability and innovation in university architecture
The City of Science and Environment project in Grugliasco represents a virtuous example of sustainable university architecture, developed by the University of Turin following the LEED environmental and energy certification protocols. The campus, realized through a project financing operation and designed using BIM methodology, integrates principles of environmental sustainability, technological innovation, and user wellbeing. It adopts nZEB solutions, integrated
energy systems, low-impact materials, and centralized infrastructure management. Developed using Level 3 BIM methodology, the project also promotes sustainable mobility and user well-being through green areas, cycling paths, and a sports center. Special attention was given to the choice of clay masonry blocks for the building envelope: blocks with less than 45% perforation and a thickness of 30 cm, laid with thermal mortar. This solution enabled the construction of a
high-performance thermal envelope with optimal mass, enhancing thermal inertia and indoor comfort. The adoption of a consistent technical solution across the site ensured efficient installation and streamlined supply logistics, completing all masonry work in under six months. Clay masonry thus plays a central role in a broader strategy focused on durability, recyclability, and reduced environmental impact, in line with circular economy principles.
riconoscere che essi promuovono un approccio per il controllo e la realizzazione del progetto che considera l’edificio in modo olistico come somma di parti che concorrono alla minimizzazione degli impatti ambientali e al soddisfacimento delle esigenze degli utenti. I protocolli e sistemi di certificazione ambientale sono strumenti volontari che consentono di misurare l’impatto ambientale di un edificio o di un complesso di edifici oggetto di diversi interventi, proprio a questa ultima categoria si rivolgono le più recenti e innovative applicazioni dei protocolli [1]. Essi oggi non si limitano a misurare la prestazione energetica dell’edificio (climatizzazione, illuminazione, acqua calda sanitaria, dati e altre utenze elettriche…), ma comprendono altri aspetti come la gestione dell’edificio, la minimizzazione dell’impronta ambientale (dalla permeabilità dei terreni, all’effetto “isola di calore”, alla biodiversità), il contenimento dell’inquinamento generato dallo spostamento di mezzi e persone da e per gli edifici, l’inquinamento dell’aria, l’utilizzo di materiali da costruzione a basso impatto ambientale ed energia incorporata (materiali locali, riusati o riciclati) e privi di emissioni nocive, la minimizzazione del consumo delle acque sia per uso interno sia per irrigazione, nonché il comfort degli spazi (inteso in tutte le sue accezioni termoigrometriche, illuminotecniche, acustiche e di qualità dell’aria interna).
Tra tali sistemi il LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di valutazione promosso dall’associazione USGBC (U.S. Green Building Council) e gestito da un ente terzo indipendente, che basa la misura della sostenibilità ambientale in crediti (opzionali) e prerequisiti (obbligatori), ordinati in categorie ambientali omogenee. Al fine di raggiungere la certificazione è necessario perseguire tutti i requisiti previsti da LEED nei prerequisiti e un certo numero crediti. In base al punteggio raggiunto è possibile raggiungere il livello minimo di certificazione (almeno 40 punti) o ambire a livelli superiori: Silver (50 punti), Gold (60 punti) o Platinum (80 punti) [2].
Il protocollo LEED ha la possibilità di adattarsi, attraverso specifiche articolazioni delle

check list di verifica e quindi dei crediti e prerequisiti che il progetto deve assolvere, alle differenti tipologie di edificio su cui può essere applicato (scuole, spazi commerciali, etc), ai differenti tipi di intervento (nuove costruzioni, ristrutturazioni, etc) e permette di
SCHEDA TECNICA
Oggetto Città delle Scienze e dell’Ambiente
Località Grugliasco, Torino
Committente Università di Torino
Project manager arch. Dante D’Agostino, ing. Stefania Boni
Progetto architettonico arch. Antonio D’Addario (Proger S.p.A Capogruppo)
Progetto degli allestimenti arch. Maria Antonietta Di Savino, arch. Diana Tamburi
Progetto strutturale ing. Stefano Pallavicini et al.
Progetto impiantistico ing. Massimo Cadorin (coordinatore) (Manens-Tifs S.p.A.)
Consulenza per la sostenibilità ing. Andra Fornasiero, ing. Fabio Viero
Impresa di costruzione Grugliasco Scarl
RUP ing. Sandro Petruzzi – Arch. Battista Tortorella Direzione lavori ing. Davide Zeppegno (Università di Torino)
Cronologia 2019 - in corso
Superficie certificata 84.609 m2 (edifici), 92.085 m2 (spazi sterni)
Fotografie
Proger S.p.A

valutare l’edificio durante il ciclo di vita.
Inoltre, il protocollo, tra gli specifici approcci per la certificazione di più edifici, consente la possibilità di certificare singoli edifici reciprocamente coordinati all’interno di un complesso, ivi inclusi complessi a destinazione scolastica. In tal senso il progetto del nuovo campus di Grugliasco è perfetto luogo di applicazione di un protocollo che consente di certificare i singoli edifici, con i relativi crediti e requisiti tecnologici, tenendo in considerazione l’intero Campus di progetto. Per tale motivo dai progettisti è stato scelto di certificare il progetto attraverso il protocollo LEED BD+C Approccio Campus.
L’approccio Campus nasce infatti dall’esigenza dei complessi a destinazione formativa, nei quali i vari edifici sono realizzati all’interno del medesimo confine di proprietà e gestiti dallo stesso ente, in modo del tutto analogo a quanto avverrà per il complesso di Grugliasco. In questo modo ciascun edificio può essere soggetto a certificazione in modo sistematico rispetto alla intera superficie di intervento e rispetto alla quale si dovranno assolvere specifici crediti (quali parcheggi, gestione delle acque meteoriche, etc) con un approccio alla valutazione del progetto compatibile con le esigenze progettuali e costruttive, basate sulla gestione unica dell’intera area dell’insediamento.
L’approccio LEED Campus consente dunque di documentare e applicare alcuni prerequisiti e crediti a livello di campus, e di definire nel dettaglio il livello qualitativo progettuale e il percorso di sostenibilità ambientale [2].
Il caso studio virtuoso della Città delle Scienze e dell’Ambiente
Il progetto della nuova Città delle Scienze e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Torino a Grugliasco è esito di un programma che ha reso l’Università uno dei principali attori della trasformazione urbana del capoluogo piemontese. Il progetto della nuova Città delle Scienze e dell’Ambiente a Grugliasco, risultato del Protocollo di Intesa tra l’Università di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana, Camera di Commercio, Politecnico di Torino e Comune di Grugliasco, ha previsto un investimento di circa 160 milioni di euro, finanziato dal Gruppo Intesa Sanpaolo attraverso un’operazione di project financing [3].
Il progetto (fig. 2) è stato affidato tramite una gara di Partenariato Pubblico Privato (PPP) bandita nel 2019 e aggiudicata al raggruppamento Grugliasco Scarl, insieme la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento delle opere di realizzazione, la fornitura degli arredi e la manutenzione per i successivi 20 anni.
L’Università ha curato il progetto di fattibilità tecnico-economica, mentre la progettazione definitiva ed esecutiva è stata sviluppata da Proger S.p.A. e Manens-Tifs S.p.A., con particolare attenzione agli aspetti di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva hanno accolto le soluzioni progettuali del PFTE e le richieste espresse nel Quadro Esigenziale del 2019, che hanno comportato una modifica pla-
nimetrica per il dimensionamento e la distribuzione più efficaci dei locali e dei laboratori. I progetti definitivo ed esecutivo, completati rispettivamente nel 2020 e nel 2021, sono stati progressivamente aggiornati in seguito ai riscontri da parte dei Direttori dei Dipartimenti universitari e della Stazione Appaltante, riguardanti prevalentemente il layout funzionale degli edifici, le componenti tecnologiche e impiantistiche, e la realizzazione del Parco Urbano. L’esecuzione è stata affidata a un consorzio di imprese composto da Itinera S.p.A., Costruzioni Generali Gilardi S.p.A., Euroimpianti S.p.A. e Semana S.r.l., che cureranno anche le attività manutentive [4]. Il cantiere è iniziato a marzo 2022 e ad oggi sono in chiusura le opere edili degli edifici per la didattica, ricerca e amministrazione.
L’impianto complessivo prevede una superficie edificata di circa 85.000 metri quadrati, distribuita in quattro edifici principali (figg. 3 e 4), disposti in un contesto urbano più ampio che valorizza la presenza di un centro sportivo, spazi pubblici, aree verdi e percorsi sostenibili. Tra questi, un parco urbano di 40.000 metri quadrati costituisce un elemento centrale del progetto, articolato in percorsi pedonali, piste ciclabili e spazi dedicati alla socializzazione, con una capacità di accoglienza che supera gli 11.000 utenti. L’approccio progettuale si fonda su una visione integrata, in cui la distribuzione degli spazi, le soluzioni costruttive e i servizi erogati mirano a creare un ecosistema di prossimità, basato su principi di accessibilità, inclusività e sostenibilità a lungo termine.
Il nuovo Polo Scientifico Universitario di Grugliasco è destinato a ospitare le attività di didattica e ricerca dell’Università di Torino, con particolare riferimento ai Dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Veterinarie. L’impianto funzionale del campus è articolato in più corpi edilizi autonomi ma interconnessi, ottimizzando l’organizzazione interna degli edifici e garantendo l’accessibilità trasversale degli spazi [4].
L’edificio destinato alla Didattica e alla Ricerca si configura come un edificio a pettine con quattro corpi destinati ai laboratori di-
dattici, laboratori di ricerca e studi di ricercatori, dottori e tecnici, orientate secondo l’asse est-ovest, e una spina centrale di distribuzione secondo l’asse nord-sud. I corpi di fabbrica presentano un piano interrato e 3 piani fuori terra che accolgono i vari dipartimenti. L’edificio Didattica e Amministrazione è invece articolato in due corpi di fabbrica, uno orientato secondo l’asse est-ovest, l’altro secondo l’asse nord-sud. Il corpo principale nord-sud, più grande, è destinato alla didattica e presenta quattro piani fuori terra. All’interno dell’edificio sono presenti due sale convegni (250 e 200 posti), due grandi aule (250 e 200 posti) e le restanti aule destinate alla didattica universitaria per un totale di 32 aule con una capienza complessiva di circa 3000 posti. Il corpo est-ovest è composto da due piani fuori terra destinati agli spazi e uffici per l’amministrazione, mentre il piano terra è destinato ai locali mensa.
3. Rendering di progetto dell’edificio destinato a didattica e amministrazione
4. Rendering di progetto dell’edificio destinato a didattica e ricerca, che evidenzia la soluzione progettuale per accogliere in facciata le componenti impiantistiche.



5.
6. Gli edifici in costruzione con struttura portante in calcestruzzo armato e sistemi di tamponatura in blocchi di laterizio (marzo 2024).
Il progetto del nuovo campus universitario di Grugliasco si basa su obiettivi strategici indicati dall’Università di Torino, mirati a garantire sostenibilità ambientale e integrazione con il territorio. Tra questi emergono la conservazione della permeabilità del suolo per la gestione sostenibile delle acque, la connessione con i parchi e la rete ecologica della Corona Verde territoriale, la riduzione dei consumi energetici e idrici, e la minimizzazione delle emissioni climalteranti. Gli edifici sono progettati secondo criteri di comfort, durabilità, riciclabilità e basso impatto ambientale, in linea con i principi dell’economia circolare. Inoltre, ulteriore aspetto qualificante del nuovo campus è la particolare attenzione rivolta al benessere psicofisico degli utenti, considerato elemento centrale della qualità dello spazio universitario. Per questo motivo è presente nell’area un centro sportivo (fig.

5) dedicato alle attività sportive indoor e outdoor, per una superficie di circa 7.200 m 2 che comprende: campi polivalenti per basket e pallavolo, una tribuna da 250 posti, una palestra attrezzata, tre sale dedicate ad attività di fitness, pesistica e benessere, gli spogliatoi, impianti sportivi all’aperto, i locali per l’assistenza sanitaria e spazi di supporto. Nella porzione meridionale dell’area sorgerà un edificio tecnico destinato a ospitare la Centrale Tecnologica del campus. Collocata strategicamente a distanza dalle zone residenziali e dagli spazi maggiormente frequentati, questa struttura garantirà l’approvvigionamento energetico per l’intero complesso universitario. L’edificio si svilupperà su due livelli – uno interrato e uno fuori terra – e accoglierà al suo interno gli impianti per il funzionamento del polo: una centrale antincendio, un’unità per la gestione delle risorse idriche e una centrale frigorifera dedicata alla climatizzazione. La scelta di concentrare queste infrastrutture in un unico punto mira a ottimizzare l’efficienza operativa e a minimizzare l’impatto sulle aree a più alta frequentazione [4].
Le soluzioni per la sostenibilità della Città delle Scienze e dell’Ambiente
Il progetto della Città delle Scienze e dell’Ambiente è stato sviluppato adottando criteri di sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e integrazione urbana, configurandosi come un’infrastruttura universitaria avanzata e aperta al territorio.
Il progetto del nuovo campus è stato sviluppato adottando una metodologia BIM integrata di Livello 3, che prevede l’utilizzo di un modello digitale unificato e condiviso da tutte le figure coinvolte – progettisti, imprese esecutrici e gestori manutentivi. Questa impostazione ha consentito una collaborazione coordinata tra le discipline, migliorando l’efficienza nella progettazione, realizzazione e futura gestione dell’opera.
L’impiego di strumenti digitali avanzati si rivela particolarmente strategico nel soddisfare le esigenze della committenza in termini di prestazioni ambientali ed energetiche. Il progetto
già nZEB (Nearly Zero Energy Building) per vincolo normativo mira all’ottenimento delle certificazioni LEED Gold attraverso una serie di accorgimenti progettuali e costruttivi orientati alla sostenibilità [5]. Tra questi si segnalano:
• l’utilizzo di materiali biocompatibili e riciclabili, involucri edilizi ad alte prestazioni;
• l’adozione di criteri tipici dell’architettura solare passiva (orientamento ottimizzato, geometrie compatte, sistemi di schermatura, impianti fotovoltaici e solare termico);
• la produzione di energia tramite trigenerazione e teleriscaldamento;
• il recupero delle acque meteoriche per usi non potabili (come irrigazione e impianti antincendio);
• l’impiego di sistemi idrici a basso consumo, come rubinetterie con limitatori di portata. L’intero insediamento è stato progettato e realizzato all’interno di un piano di coordinamento generale, che prevede la condivisione delle infrastrutture generali e la gestione centralizzata del territorio e degli impianti, aspetto che ha avuto influenza sulla strutturazione delle attività della certificazione LEED.
Per quanto riguarda la suddivisione tra gli edifici ai fini LEED la certificazione deve avvenire per corpo di fabbrica unico, contiguo e interconnesso dal punto di vista impiantistico.
In tal senso sono certificabili i seguenti edifici:
• Edificio Didattica e Amministrazione - uso prevalente: didattica; usi secondari: amministrazione, ristorazione;
• Edificio Didattica e Ricerca - uso prevalente: ricerca; usi secondari: didattica;
• Edifici per lo Sport (palestra, ad esclusione degli spogliatoi esterni) - uso unico: sportivo.
Tutti gli edifici facenti parte del complesso hanno seguito l’iter certificativo LEED BD+C for New Construction.
Le tamponature sono realizzate con blocchi di laterizio con foratura <45% e spessore 30 cm posati con malta termica (fig. 6): gli elementi individuati hanno consentito di costruire un involucro in grado di garantire massa volumica e, con isolamento a cappotto, una adeguata prestazione termica agli standard normativi.


Inoltre, grazie allo spessore del blocco, che ha consentito una rapida posa in opera e la diffusione della medesima soluzione tecnica per l’intera estensione del cantiere, con una evidente razionalizzazione delle forniture, si è ottenuto il completamento delle murature sull’intero complesso in meno di 6 mesi di tempo1 (figg. 7 e 8).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
[1] Calcagnini L., Mariani M. [2025]. “La qualità certificata dello spazio urbano: l’esperienza del quartiere città verde a Roma”, Costruire in Laterizio, n. 198 pp. 64-71
[2] I Sistemi LEED. Disponibile da https://gbcitalia.org/certificazione/leed/ (consultato il 19.06.2025)
[3] Milan, L. (2021). “Verde e sostenibile, ecco il nuovo campus universitario di Grugliasco” https://www.teknoring.com/architettura/campus-universitario-digrugliasco-torino-verde/
[4] Città delle Scienze e dell’ambiente di Grugliasco. Disponibile da: https:// cantierecittascienzegrugliasco.it/progetto/ (consultato il 19.06.2025)
[5] Proger. Città delle Scienze e dell’Ambiente di Grugliasco, Torino. Disponibile da: https://www.proger.it/progetto/citta-scienze-ambiente-grugliasc/ (consultato il 19.06.2025)
Note
1. Le fasi di cantiere sono visibili dal sito https://cantierecittascienzegrugliasco.it/
Sistemi costruttivi in muratura armata di laterizio per edifici residenziali
La muratura armata è la tecnologia costruttiva ideale per gli edifici residenziali. Per poterne sfruttare al meglio le potenzialità è raccomandato utilizzare dei sistemi costruttivi appositamente progettati. È il caso dei sistemi costruttivi prodotti da Fornaci Laterizi Danesi, che conciliano requisiti di norma ed esigenze di progetto
Antonio Magarò, Architetto, PhD, Assegnista
di Ricerca, Università degli Studi Roma Tre
KEYWORDS
Muratura armata
Edifici residenziali
Demolizione e ricostruzione
Sistemi costruttivi
Reinforced masonry
Residential buildings
Demolition and reconstruction
Building systems
La grande versatilità del laterizio e la sua affinità con le malte consentono di ottenere un proficuo abbinamento anche con l’acciaio, aprendo alla possibilità di realizzare sistemi costruttivi in muratura armata.
Si tratta di una tecnologia costruttiva storicizzata, dal momento che la prima applicazione consapevole di armature di rinforzo a paramenti in laterizio risale al 1813, quando l’ingegnere francese naturalizzato statunitense Sir Marc Isambard Brunel (1769-1849) ne propose l’applicazione alla realizzazione di una ciminiera in Inghilterra [1]. Sir Brunel fu un grande innovatore: ad egli si deve il brevetto (1918) dello scudo per perforazioni in avanzamento (oggi noto come “talpa”), in occasione del recupero del fallito progetto di un tunnel sotto la manica del 1807 [2]. I lavori durarono dal 1825 al 1842, tuttavia con un fermo dal 1827 al 1835 per conflitti con la committenza. Sicuro della sfida, anche nel caso del tunnel sotto la manica egli utilizzò la muratura armata, costruendo due pozzi in mattoni dello spessore di 76 cm, del diametro di 15 m che arrivavano a 21 m di profondità. Le murature furono armate verticalmente con barre in ferro battuto di 25 mm di diametro e orizzontalmente con piatti larghi 230 mm di spessore 13 mm [3]. A seguito di tale dimostrazione di poderosità nella realizzazione di strutture sollecitate, l’interesse per questa tecnologia crebbe in tutto il mondo. Nel 1837,
Charles Pasley (1780-1861), comandante del Genio militare inglese (Corps of Royal Engineers) condusse una serie di stress test su delle travi, conseguendo risultati molto simili a quelli di Brunel, sebbene all’epoca non si comprendeva completamente la relazione matematica in grado di esprimere la collaborazione intima tra laterizio e acciaio [1]. Le formule impiegate erano empiriche e inapplicabili al calcolo delle sezioni resistenti di laterizio e acciaio, tuttavia, grazie al diffondersi dei cementi anche nelle malte, l’interesse per questa tecnologia continuò a crescere. Le potenzialità diventano evidenti non solo nelle strutture fortemente sollecitate, ma soprattutto per la resistenza sismica: Nel 1906, a seguito del devastante terremoto che colpì San Francisco, uno dei pochi edifici a non subire crolli fu il Palace Hotel, costruito nel 1875. La pianta coincidente con il sedime di un intero isolato e alto 7 piani, era realizzato in muratura dello spessore di 90 cm, armata con barre d’acciaio disposte in orizzontale, ogni 90 cm, determinando una sorta di cerchiatura attorno all’intero edificio [4]. Le applicazioni si diradano fino al 1920, anche per effetto degli innamoramenti verso il calcestruzzo armato, finché, nel 1923, il Dipartimento dei Lavori Pubblici indiano pubblica una serie di studi comparativi tra la muratura armata e non armata, svolti in maniera sistematica su ogni tipo di elemento strutturale [5]. Tale rapporto dà inizio allo svi-

luppo moderno della muratura armata, soprattutto in India e Giappone, fortemente interessati dalle problematiche sismiche, come il nostro Paese.
In Italia, la muratura armata viene contemplata all’interno della normativa tecnica nel 1984 [6], tra i sistemi di prefabbricazione, ed era sottoposta a un Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici. Tale adempimento viene superato nel 1996 [7] e rimane solo per le strutture prefabbricate. I requisiti degli elementi tecnici, i criteri progettuali, la definizione dei dettagli costruttivi e le modalità di verifica vengono aggiunti progressivamente fino a quando le Norme Tecniche per le Costruzioni sanciscono il definitivo affermarsi della muratura armata tra i tre sistemi costruttivi ammessi [8; 9].
Caratteristiche meccaniche e criteri progettuali
Come per la muratura ordinaria, i blocchi da impiegare per la muratura armata possono essere pieni e semipieni, quindi con una percentuale di foratura verticale non superiore al 45%. Per le costruzioni caratterizzate allo stato limite di salvaguardia della vita da accelerazione massima del suolo a g S > 0,075g, condizione che potenzialmente si verifica in tre delle quattro zone sismiche in cui è classificato il territorio italiano, sono previsti specifici valori di resi-
stenza a rottura dei blocchi nella direzione portante o, in alternativa, specifici valori di resistenza media normalizzata nella medesima direzione e, contestualmente, valori specifici di resistenza caratteristica a rottura nella direzione perpendicolare a quella portante. La normativa individua una dimensione minima delle cavità in cui alloggiare le armature verticali, in modo da consentire l’inscrivibilità di un cilindro di almeno 6 cm di diametro, oltre a indicare la classe di resistenza minima della malte (M10) o dei calcestruzzi (C12/15) da utilizzare per il riempimento di tali cavità. Le risultanze sperimentali influenzano la normativa imponendo il completo riempimento dei giunti, escludendo quindi, in verticale, gli incastri o le tasche [9].
I criteri progettuali sono volti a garantire il mi-
SCHEDA TECNICA
Oggetto Due unità residenziali private Località Soncino, Cremona (Italia)
Committente Moroni coperture s.n.c.
Progetto architettonico
Progetto strutturale
Studio Piccioni Associato
Studio Piccioni Associato
Cronologia 2022 (progettazione), 2025 (costruzione)
Superficie complessiva 1.317,54 m2
Fotografie
Studio Piccioni Associato
CANTIERE

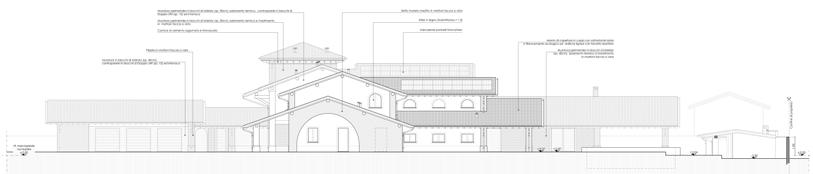
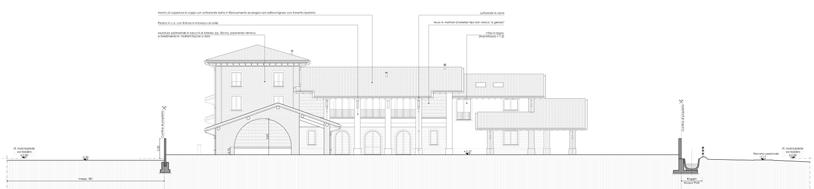
glior comportamento scatolare: sono escluse le murature “in falso”, sono predilette le strutture regolari in pianta e in alzato con una sufficiente densità muraria nelle due direzioni ortogonali. I solai devono garantire un comportamento a diaframma e, per tramite dei cordoli, ripartire oltre ai carichi verticali, anche le sollecitazioni orizzontali vincolando i muri alle azioni fuori dal piano. Le coperture non devono essere spingenti, tuttavia, anche utilizzando il legno, si possono ottenere comportamenti rigidi senza l’impiego di cappe armate in calcestruzzo (che avrebbero l’effetto di incrementare la massa e quindi le azioni sismiche), utilizzando pannelli o tavolati doppi e tripli, a orditura incrociata.
Le prescrizioni specifiche per le zone sismiche sono solo due: spessore minimo 24 cm e rapporto di snellezza massimo pari a 15 che corrisponde a un’altezza massima di 3,75 m per muri di 25 cm di spessore. Tali normative hanno funzionato da stimolo anziché da vincolo per il progetto di Soncino.
L’edificio di Soncino: un caso applicativo da manuale, sebbene complesso
Il cambio di destinazione d’uso da rurale a residenziale di un edificio situato nel quadrante nordoccidentale del Comune di Soncino, già circondato dal tessuto cittadino più recente, ha consentito di ripensare e riprogettare l’edificio, demolendolo e ricostruendolo (con mantenimento del volume) e, pertanto, migliorandone la sicurezza strutturale e la prestazione termica, impiegando il sistema costruttivo in muratura armata basato sulle linee di blocchi Poroton P800 e Normablok Più delle Fornaci Laterizi Danesi.
Vengono realizzate due unità abitative, una disposta su tre livelli, l’altra su due, raccordati mediante scale interne e, nel caso dell’unità su tre piani, anche di una piattaforma elevatrice. Le due unità abitative, pur condividendo il medesimo lotto, hanno accessi indipendenti: quella su tre livelli si attesta su Via Nobilini, sul versante nord, mentre quella su due livelli è accessibile dal percorso incidente di Via Benzi, sul lato ovest. Entrambe le unità abitative presen-

tano un’organizzazione funzionale semplice con la zona giorno e una serie di spazi serventi al piano terra, mentre al piano primo si distribuisce la zona notte e i servizi igienici privati. Il terzo livello della prima unità abitativa è articolato in una serie di locali di servizio di altezza 2,40 m, di supporto all’abitazione. Oltre agli spazi privati, sono previsti una serie di aree comuni, per la maggior parte spazi aperti, come la piscina o il grande giardino, mentre gli spazi compartimentati sono ancora una volta serventi e contigui agli spazi aperti: servizi igienici, spogliatoi, depositi, locali tecnici e un pergolato. Tale articolazione determina un corpo a “C” delimitato da bracci leggermente asimmetrici sull’asse nord-sud mentre sull’asse ortogonale, l’impianto è bilanciato dalla contrapposizione di spazi residenziali e spazi comuni di servizio. Laddove si presentino delle irregolarità,


Disposizione delle armature orizzontali con relative sovrapposizioni.
queste sono sempre lievi e comunque equilibrate nel computo delle masse, per effetto dell’ampliamento delle parti più corte o dell’interruzione sapiente dei corpi di fabbrica.
Tale impianto è naturalmente vocato ad essere realizzato in muratura armata, per la compattezza che tuttavia, non compromette l’ariosità e l’apertura degli spazi, la distribuzione oculata delle masse, il rapporto minimo tra i lati del rettangolo di inscrizione della pianta, etc. A completamento, il sistema costruttivo in blocchi Poroton P800 per muratura armata esalta la resistenza sismica della struttura regolare, e ne consente la sua realizzazione secondo le normative tecniche, garantendo sicurezza, semplicità di posa in opera, e una dislocazione distribuita dei carichi. Sui cordoli in calcestruzzo armato degli ultimi livelli si impostano una serie di portali in acciaio, ai quali si relazionano delle coperture lignee, impermeabilizzate, isolate e microventilate, rivestite da un manto di coppi in laterizio.
Disposizione della struttura in acciaio in relazione ai cordoli da gettare.
La prestazione termica è garantita, utilizzando un cappotto termico in lana di roccia, per non inficiare l’ottima traspirabilità del laterizio e la sua capacità di raggiungere l’equilibrio termo-igrometrico. Il Comune di Soncino si colloca in zona climatica E, con ben 2.389 gradi giorno, pertanto, la prestazione termica che l’involucro deve garantire non è banale. Il blocco di laterizio ad isolamento diffuso Normablok Più presenta all’interno dei fori un riempimento di polistirene espanso additivato di grafite. Tale combinazione tra un polimero di sintesi e un prodotto organico naturale vede

l’incremento della prestazione termica grazie alla capacità della grafite di assorbire e riflettere la radiazione infrarossa tipica della trasmissione per irraggiamento, riducendo il passaggio di calore. Il blocco Normablok Più si dispone al perimetro ed è in grado di relazionarsi perfettamente al blocco Poroton P800, del quale preserva la morfologia, la capacità portante e di alloggiare l’armatura, e al quale aggiunge un livello di isolamento termico elevato, finalizzato alla chiusura di eventuali ponti termici in prossimità dello spiccato dalle fondazioni in calcestruzzo armato. La possibilità di utilizzare un intero sistema costruttivo, che prevede due tipi di blocchi con i relativi sottomultipli e un’apposita malta che coniuga prestazione termica e meccanica, riduce gli errori di posa potenziali a tutto vantaggio della durabilità della costruzione. Completano l’involucro i serramenti in legno progettati per il risparmio energetico e per l’isolamento acustico, mentre il rivestimento è in parte in intonaco (tinteggiato ai silicati e decorato secondo indicazioni preesistenti e prescrizioni comunali), in parte in materiale lapideo locale o in cotto paramano, tipico dell’edilizia lombarda.
Il sistema costruttivo in muratura armata
L’edificio in muratura armata è pensato come una struttura tridimensionale, in grado di resistere in maniera scatolare alle sollecitazioni da qualsiasi parte provengano, coinvolgendo tutti i muri come diaframmi rigidi perfettamente ammorsati. Ciascuno di essi deve svolgere funzione portante per i carichi verticali e di controvento quando la sollecitazione è orizzontale. Questo vale anche per gli orizzontamenti che devono assicurare, per resistenza e rigidezza, la ripartizione delle azioni orizzontali tra i muri di controventamento. Per garantire tale comportamento d’insieme, la soluzione migliore è quella di affidarsi ad un sistema costruttivo, anziché all’impiego di un singolo elemento per la realizzazione di murature.
Elementi fondanti del sistema costruttivo in muratura armata impiegato sono i blocchi Poroton P800 40.19.25 e 30.19.21 delle Fornaci
Sistemi costruttivi in muratura armata di laterizio per edifici residenziali
Tabella 1. Confronto prestazionale tra i blocchi del sistema in muratura armata di Fornaci Laterizi Danesi, spessore 40 cm
Caratteristiche
Caratteristiche strutturali
Caratteristiche termiche
Trasmittanza termica (con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale)
Capacità termica areica interna periodica (prestazione che garantisce il comfort abitativo)
(malta tradizionale, parete intonacata)
(malta tradizionale, parete intonacata)
Trasmittanza termica periodica (malta tradizionale, parete intonacata)
Massa superficiale (al netto degli intonaci)
specifico
Coefficiente
Comportamento al fuoco
Laterizi Danesi. Tali blocchi sono ideali per la realizzazione di murature armate (anche se si utilizzano anche per le murature ordinarie) in tutte le zone sismiche, negli spessori, rispettivamente, di 40 e 30 cm. La percentuale di foratura è inferiore al 45%, il che li configura come blocchi semipieni. Gli spessori (insieme al blocco da 25 cm) sono stati studiati per migliorare la messa in opera del materiale, assecondando le armature verticali, anche nel caso di interassi ridotti. I setti dei blocchi che si di-
di dettaglio del sistema Fornaci Laterizi Danesi.
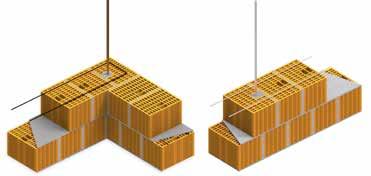

spongono parallelamente al piano sono continui e rettilinei e si interrompono solo localmente in corrispondenza della tasca di alloggiamento dell’armatura.
La configurazione geometrica dei blocchi è regolare ed essi sono progettati per avere una cartella facilmente rimovibile per la realizzazione dell’alloggiamento continuo per l’armatura verticale, favorendo l’inserimento laterale del blocco. Il vano che si determina è dell’ampiezza minima prevista dalla normativa. La continuità verticale consente di essere saturata agevolmente di malta fluida o calcestruzzo. Le armature sono ad aderenza migliorata in acciaio B450A o B450C, di uso comune nelle strutture in calcestruzzo armato. Le barre verticali hanno diametro 16 mm ovvero di sezione pari a circa 2,01 cm 2 , appena superiore a quanto prescritto dalla normativa. Le armature orizzontali sono

L’edificio in fase di completamento.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
[1] The brick Industry Association, Technical Notes on Brick Construction, Technical Notes, n. 17 – Reinforced Brick Masonry, Reiussued Oct. 1996.
[2] H. Bagust, The Greater Genius?, Ian Allan Publishing, London (UK), 2006.
[3] R. Beamish, Memoirs of the Life of Sire Marc Isambard Brunel, Longmans, London (UK), 1862.
[4] M.W. Berger, The Old High-Tech Hotel. Invention and Technology, (1995), 46-52.
[5] A. Brebner, Notes on reinforced brickwork, Technical Paper, no. 38, Government of India, Public Works Department, India, 1923.
[6] Ministero Lavori Pubblici, Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche, D.M.LL.PP. 19/06/1984.
[7] Ministero Lavori Pubblici, Norma tecniche per le costruzioni in zone sismiche, D.M.LL.PP. 16/01/1996.
[8] Ministero delle Infrastrutture, Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008.
[9] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018.
[10] A. Baratta; L. Calcagnini; A. Magarò; C. Piferi, L’evoluzione dei prodotti in laterizio. I blocchi ad isolamento diffuso per le murature armate, Costruire in Laterizio, 176 (2018), pp. 82-87.
barre da 6 mm di diametro (> 5 indicato sulla norma), e sono annegate nei giunti di malta (due barre ogni sei corsi), al fine di fornire un incremento della resistenza ai carichi fuori dal piano, contribuire al controllo della fessurazione e fornire flessibilità all’insieme. Il sistema è completato da un’apposita malta che garantisce una resistenza a compressione di 10 N/mm 2
Conclusioni
I sistemi costruttivi in laterizio per muratura armata prodotti da Fornaci Laterizi Danesi rispondono in maniera esemplare alle prescrizioni di norma, grazie anche alla gamma completa di prodotti a integrazione degli elementi principali. Oltre alle malte che rispondono tanto alla prestazione meccanica quanto alla prestazione termica, Fornaci Laterizi Danesi produce alcuni sottomultipli del blocco, con conformazione a “C” per disporsi in maniera speculare a generare l’alloggiamento dell’armatura, o con conformazione parallelepipeda per garantire l’ammorsamento corretto soprattutto nei giunti a “T” delle murature. I fori di questi semplici pezzi speciali, al netto di piccole variazioni nella sezione dei blocchi, consentono di inserire l’isolamento diffuso [10] ed eventualmente completare il sistema costruttivo anche dal punto di vista della prestazione termica.
Tale sistema costruttivo consente di contenere la superficie in pianta della sezione resistente in zona sismica, incrementando la flessibilità distributiva e riducendo il peso proprio della struttura. Inoltre, consente di realizzare muri più snelli e, pertanto, più alti a parità di spessore, risultando ideale per la realizzazione di edifici residenziali del tipo a villa isolata. Come dimostrato nell’ambito della descrizione del cantiere di Soncino, la muratura armata si coniuga in maniera eccellente tanto con il calcestruzzo armato per fondazioni e cordoli, quanto con le strutture lignee o in acciaio di solai e coperture. Infine, per effetto dell’assenza di casseforme, rispetto a una costruzione a telaio in calcestruzzo armato, è possibile (con un’adeguata progettazione) risparmiare sui costi di costruzione, e sui tempi di esecuzione.
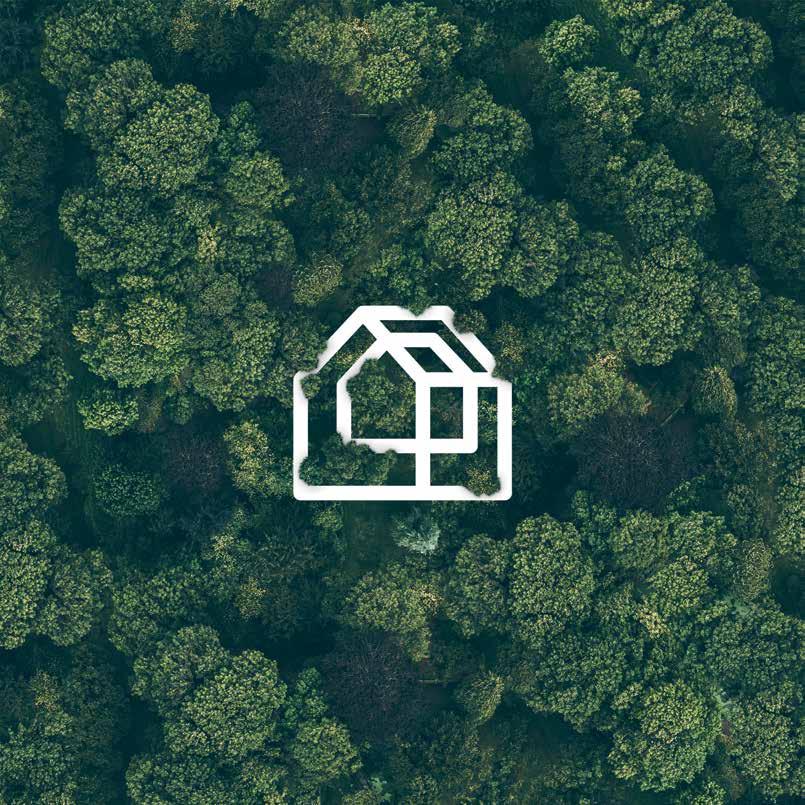
Suggestioni di laterizio: la materia che conquista la Biennale 2025
Flavia Santia, Confindustria Ceramica
KEYWORDS
Architettura
Trasformazione
edilizia
Cambiamenti climatici
Abitare
Cultura
Architecture
Building Transformation
Climate Change
Living Culture
La 19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, curata da Carlo Ratti e intitolata “ Intelligens. Natural. Artificial. Collective, l’intelligenza, umana, artificiale e collettiva”, diventa una lente attraverso cui ripensare l’ambiente costruito. Un’esplorazione che riempie la distanza tra naturale e artificiale e propone l’architettura come risposta collettiva e aperta al cambiamento del nostro tempo.
È in questo scenario di trasformazione che il mondo delle costruzioni entra per la prima volta da protagonista nel cuore dell’Arsenale con Construction Future , lo spazio della filiera “Fondamentale”, promosso da ANCE e dalle sigle del comparto edilizio: un’installazione immersiva che fonde visione e concretezza, dove robot umanoidi e sistemi costruttivi evolutivi delineano il profilo di un’edilizia del futuro: intelligente, interattiva, adattabile. La sfida è passare dalla progettualità alla sperimentazione reale, unendo formazione e innovazione in un laboratorio permanente.
Qui il laterizio si afferma come materia viva, capace di un dialogo sorprendente tra artigianalità e automazione. All’interno del padiglione, un robot industriale sposta in tempo reale la-
The transformation of the building sector is currently at the center of international debate, driven by urgent environmental challenges, digitalization, and technological innovation. In this evolving landscape, traditional materials such as clay brick are demonstrating a surprising ability to adapt. Through a selection of installations presented at this year’s Biennale, we explore how this material—deeply rooted in historical legacy— is being renewed in contemporary design and applications, becoming both a symbol and a tool of transformation.
terizi, a testimoniare come i materiali della tradizione siano al centro anche del linguaggio della robotica. A corredo di questa narrazione, l’installazione Elephant Chapel dell’architetto Boonserm Premthada - una struttura ad archi, alti quattro metri realizzati con mattoncini cilindrici a base di sterco di elefante – sperimenta in chiave ecologica un assemblaggio etereo. Sempre alle Corderie dell’Arsenale, Resourceful Intelligence dello studio Park propone un approccio circolare alla progettazione architettonica. Tra i due elementi principali dell’installazione, una parete in elementi di clinker recuperati dalla decostruzione dell’Hotel Michelangelo di Milano mette in evidenza le potenzialità espressive e strutturali del laterizio riutilizzato, nel segno di una sostenibilità che parte dalla materia.
A queste esperienze si affianca Insieme, una struttura realizzata con mattoni di recupero provenienti da diverse demolizioni, che promuove il riutilizzo creativo dei materiali nell'edilizia comunitaria. Questo progetto di design partecipativo, frutto della collaborazione tra Svizzera, Venezuela e Sudafrica, combina strumenti digitali con pratiche circolari tradizionali. I passaporti digitali dei materiali consentono ai visitatori di tracciare la storia di ciascuno di essi e di scoprirne il potenziale di riutilizzo futuro. Insieme invita all'interazione, incoraggiando i visitatori a scoprire le origini dei materiali e il modo in cui contribuiscono a un design circolare. Così, alla Biennale 2025 il laterizio si presenta come interprete silenzioso ma incisivo, un materiale iconico che non ha bisogno di imporsi per lasciare il segno; è resistente, sì, ma anche narrativo: racconta storie di luoghi, di mani che costruiscono, di conoscenze tramandate




e trasformate, attraversando culture, climi e modi di abitare. Il laterizio si mostra in tutte le sue forme: crudo, cotto, riciclato, reinterpretato. Lo si ritrova come struttura, fondazione, rivestimento, simbolo. A volte evidente, altre volte nascosto sotto la superficie, ma sempre presente come filo “rosso” materico che cuce insieme passato e futuro. Alla Biennale di quest’anno, dedicata al tema dell’abitare come gesto politico, ecologico e relazionale,

il laterizio si fa veicolo di senso, strumento di rigenerazione, piattaforma concreta per ripensare il modo in cui progettiamo e costruiamo. Una materia che costruisce, protegge, racconta e, oggi più che mai, trasforma. Ecco allora un itinerario illustrativo tra alcuni dei padiglioni più rappresentativi, dove la bellezza del laterizio si manifesta come memoria viva, architettura del possibile, segno di una cultura del costruire che non rinuncia alla materia, ma la ascolta e la rinnova.

Spagna: materiali da pesare
Il padiglione spagnolo Internalities, curato da Roi Salgueiro e Manuel Bouzas, affronta con lucidità la questione della decarbonizzazione dell’architettura. La proposta si articola attorno a cinque assi tematici - Materiali, Energia, Mestieri, Rifiuti, Emissioniche mappano e mettono in rete pratiche costruttive locali, artigianali e circolari.
All’interno del padiglione, una sala raccolta ospita una serie di bilance disposte su una griglia, ciascuna delle quali sorregge un materiale da costruzione – terra, laterizio, calce, scarti ceramici, materiali riciclati. Questo gesto, semplice ma potente, visualizza fisicamente il peso della materia, invitando a riflettere su ciò che spesso non si vede: l’impronta ecologica del costruire. Le bilance non sono strumenti di precisione, ma metafore di responsabilità: ogni materiale si misura, letteralmente e simbolicamente, con le conseguenze ambientali della sua estrazione, trasformazione e messa in opera. È una chiamata etica all’architettura, che deve interrogarsi sulla sostenibilità reale dei suoi componenti, non solo in termini di emissioni, ma di provenienza, rigenerabilità, impatto locale.
In questo contesto, il laterizio assume un valore emblematico: è presente come materiale da soppesare, ma anche come elemento storico e circolare, in grado di attraversare i cicli del tempo senza perdere valore. Le bilance raccontano la fragile equazione tra bellezza, tecnica e responsabilità, e ricordano che ogni scelta progettuale ha un peso, anche invisibile.
Austria: il diritto alla casa
Nel Padiglione austriaco, Agency for Better Living, curato da Sabine Pollak, Michael Obrist e Lorenzo Romito, il laterizio assume un ruolo significativo nel confronto tra due modelli urbani profondamente diversi: Vienna, capitale dell’edilizia pubblica e dell’abitare collettivo pianificato, e Roma, dove la casa nasce anche da processi informali, auto-organizzati e privati. Il cortile del padiglione ospita una rilettura in chiave contemporanea della celebre vasca a forma di rene di Josef Hoffmann: l’opera viene

reinterpretata attraverso una composizione libera e scultorea di blocchi di argilla locale. Questi blocchi non sono destinati allo scarto ma verranno reimpiegati nella filiera edilizia urbana, in un ciclo produttivo che mira alla sostenibilità e alla rigenerazione.
Il laterizio qui diventa uno strumento di dialogo tra pratiche urbane, simbolo di un costruire non fatto di sprechi, ma accessibile e democratico. Incarna la possibilità di un’architettura che non è più solo considerata un oggetto, ma un processo: partecipata, politica, connessa alle lotte per il diritto all’abitare. Così questo materiale assume, tra gli altri, un valore sociale e collettivo, raccontando un’Europa urbana che cerca nuovi paradigmi di inclusione, dove il progetto non è più solo forma, ma strumento di giustizia.
menti prefabbricati di terra battuta, calcestruzzo riciclato e mattoni in laterizio, montati tramite un sistema di post-tensionamento innovativo, già testato in contesti reali come il recente terremoto in Marocco. Il laterizio è qui materia in equilibrio tra antichità e futuro. Insieme alla terra cruda, diventa Suggestioni
of
Marocco: resilienza e identità
Materiae Palimpsest, il padiglione marocchino curato da Khalil Morad El Ghilali ed El Mehdi Belyasmine, propone una narrazione stratificata sull’architettura di terra come pratica ecologica, culturale e tecnologica. Al centro della scena, 72 colonne e pilastri realizzati con ele-

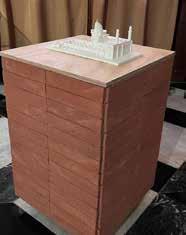
parte di una grammatica architettonica che si adatta ai cambiamenti climatici e alle azioni sismiche, mantenendo una forte connessione con il territorio. Il sistema costruttivo è sostenibile, reversibile e replicabile: l’installazione si configura come una micro-infrastruttura educativa, capace di trasmettere sapere tecnico e visione ambientale.
Completano l’allestimento una suggestiva facciata tessile realizzata dall’artista Soumiya Jalal, ispirata all’architettura nomade e al ruolo delle donne nel paesaggio marocchino. Il padiglione si presenta come una vera e propria architettura palinsesto, in cui ogni materia, incluso il laterizio, è memoria attiva e strumento progettuale.
Stati Uniti: la veranda delle relazioni
Nel padiglione statunitense Porch: An Architecture of Generosity, il tema dell’abitare si declina attraverso la figura del porch, la veranda americana, pensata come luogo di soglia tra l’intimità e la collettività. Il progetto, sviluppato da Marlon Blackwell Architects in collaborazione con MASS Design Group e altri partner, propone una grande piattaforma pubblica, istallata su terra battuta veneziana, con al centro un evocativo tappeto pavimentato in mattoni di terracotta a spina di pesce, trasformando così lo spazio espositivo in una piazza relazionale. La terra veneziana riciclata è stata impilata sotto i bordi della veranda, creando un col-

legamento diretto tra la piattaforma e il suolo. Lo spessore soffice di elementi in terra cruda compressa fornisce una base tattile e fisica al progetto, collegando la veranda al terreno come un margine materico e simbolico. L’utilizzo della terra cruda richiama dunque l’origine geologica del mattone, condividendone la vocazione ecologica, la traspirabilità e la vicinanza alla natura. Il porch ospita modelli architettonici, librerie, dibattiti e proiezioni: è un luogo di trasmissione di saperi e di accoglienza, capace di rafforzare l’idea di un’architettura, anche vernacolare, che costruisce comunità.
UNESCO: memoria attiva di Mosul
Nella suggestiva cornice della Biblioteca Marciana, la mostra Mosul, una rinascita architettonica racconta il progetto di ricostruzione promosso da UNESCO nei territori devastati dalla guerra. I modelli architettonici in esposizione (templi, moschee, scuole) poggiano su piedistalli rivestiti da sottili listelli in terracotta, evocando l’uso originale del laterizio nella tradizione costruttiva di Mosul.
Qui il laterizio diventa simbolo di compatibilità materiale, poiché viene impiegato seguendo le tecniche originarie del luogo, come dimostrato nel restauro del celebre minareto Al-Hadba. È anche rispetto per il patrimonio: il laterizio consente una ricostruzione filologica e sostenibile, lontana dalle logiche della ricostruzione frettolosa. Infine, è strumento educativo: la mostra valorizza il lavoro degli artigiani locali e dei giovani restauratori, formando competenze e ricucendo ferite urbane e sociali.
All’Arsenale, surriscaldamento urbano Underground Climate Change solleva un tema poco visibile ma cruciale: il surriscaldamento del sottosuolo urbano, causato da un'urbanizzazione non sempre responsabile e dai flussi termici di infrastrutture sotterranee. In alcune città, il terreno raggiunge i 70°C, compromettendo la stabilità e la funzionalità delle fondazioni.
L’installazione presenta un modello in scala reale della stratigrafia urbana: dalle reti tecnologiche agli impianti fino alle fondamenta.
Suggestioni di laterizio: la materia che conquista la Biennale 2025
Il laterizio è ancora presente come materiale storico, testimone silenzioso delle trasformazioni urbane. Il progetto propone l’uso di sensori wireless per mappare il calore e suggerisce strategie di geo scambio per riutilizzarlo in chiave energetica. Così, il mattone si trasforma da elemento passivo a componente intelligente di una nuova infrastruttura termica sostenibile.
All’Arsenale, Fricks
Curata da Juliana Mariz de Oliveira Simantob e colleghi, l’istallazione Fricks: Upcycled Foamed Bricks esplora il potenziale dei mattoni in chiave circolare. Il progetto propone un sistema di mattoni geopolimerici ottenuti al 100% da scarti ceramici e frammenti di laterizi da demolizione, attraverso un processo di riciclo avanzato che controlla porosità e densità del materiale. Ne nasce un prodotto leggero e performante, adatto all’isolamento e alla costruzione di facciate, capace di ridurre l’impatto ambientale del ciclo edilizio.
Questi nuovi prodotti non solo possono offrire una risposta al problema dei rifiuti, ma testimoniano una visione evolutiva del mattone come materia rigenerabile, capace di adattarsi alle urgenze contemporanee senza perdere la propria identità storica. Un’ulteriore conferma di come il laterizio possa farsi strumento di sperimentazione e transizione ecologica.
Architettura come essenza della materia
In questa Biennale che si interroga sull’abitare del futuro, il laterizio (non solo con le opere qui descritte) riaffiora come protagonista eloquente, capace di custodire memoria, incarnare valori e promuovere visioni sostenibili. Nei padiglioni che ne celebrano l’uso, esplicito o simbolico, il mattone si rivela materia di confine tra passato e futuro, tra tecnica e cultura, tra locale e globale. È una presenza che non grida, ma che si fa sentire, solida e familiare, sempre pronta a trasformarsi senza perdere la propria identità. Non è solo costruzione: è racconto, politica, artigianato, geografia. È gesto quotidiano e scelta strategica. Dalle pratiche sociali all’educazione, dalla ricostruzione post-bellica alle

strategie per il clima, dalla valorizzazione delle risorse locali alla trasmissione di saperi antichi, il laterizio si impone come fil rouge che attraversa i padiglioni, saldando estetica, etica e tecnica. È una materia umile ma generosa, che resiste al tempo e si lascia reinterpretare, che parla di case, città, comunità. E così, tra installazioni, allestimenti, progetti e visioni, il laterizio ci ricorda che costruire non è solo un atto tecnico, ma un gesto culturale e politico. Ci invita a rallentare, a osservare, a scegliere materiali che non siano semplici mezzi, ma compagni di viaggio nel progetto di un abitare più consapevole. Perché, in fondo, la bellezza dell’architettura, come quella della materia, sta nella sua capacità di durare, cambiare e resistere. Ma anche nel suo potere di raccontare chi siamo, dove viviamo e che futuro vogliamo costruire.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
[1] C. Ratti (a cura di), Intelligens. Natural. Artificial. Collective, 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, 2025.
[2] ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, Comunicato stampa: Construction Future alla Biennale Architettura 2025, Venezia, maggio 2025.
[3] F. Brancaccio, Conferenza stampa padiglione Fondamentale, Arsenale di Venezia, 20 maggio 2025.
[4] D. Pitteri (a cura di), Construction Future, Installazione della Filiera Fondamentale, Biennale Architettura 2025, Venezia.
[5] B. Premthada, Elephant Chapel, Biennale Architettura 2025, installazione in laterizio di sterco di elefante, 2025.
[6] Park Associati, Resourceful Intelligence, progetto esposto alla Biennale Architettura 2025, con il contributo del Politecnico di Milano e Accurat, 2025.
Costruire sul costruito
L’intervento di MDU Architetti a Panzano in Chianti riqualifica un edificio esistente con una sopraelevazione in laterizio che dialoga con il paesaggio e la tradizione costruttiva locale.
Un esempio di trasformazione consapevole che unisce memoria, innovazione e sostenibilità
Andrea Campioli, Professore ordinario, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle
KEYWORDS
Riuso adattivo
Ampliamento
Sopraelevazione
Trasformazione
edilizia
Rivestimento in mattoni faccia a vista
Adaptive reuse
Expansion
Adding a storey
Building transformation
Facing bricks cladding
Nel panorama architettonico attuale, il tema del “costruire sul costruito” si afferma come strategia centrale nella definizione di una nuova sensibilità progettuale, dove istanze ambientali, esigenze funzionali e consapevolezza culturale convergono. In un territorio come quello italiano, storicamente stratificato e già densamente edificato, il progetto di trasformazione diventa occasione per reinterpretare, attraverso linguaggi aggiornati, il rapporto tra preesistenze e innovazione.
Costruire sul costruito significa confrontarsi con l’eredità materiale del luogo nel quale si interviene, misurandosi con la complessità del già esistente indipendentemente dal suo valore storico culturale, cercando un equilibrio tra conservazione, trasformazione e innovazione. In questa prospettiva l’intervento sul costruito diventa un’occasione per rigenerare luoghi, rivitalizzare funzioni, per stabilire nuovi rapporti con il contesto, per riscrivere identità. Materiali, volumi e linguaggi si intrecciano, dando origine ad architetture capaci di dialogare con il passato, ma al contempo in grado di rispondere alle rinnovate esigenze dell’abitare.
L’intervento realizzato da MDU Architetti a Panzano in Chianti si colloca in questo scenario, dimostrando come anche un edificio privo di valore storico intrinseco possa diventare terreno fertile per un’operazione progettuale
MDU Architects’ project in Panzano in Chianti upgrades an existing building through a brick-clad rooftop extension that engages in dialogue with both the landscape and local building traditions. A thoughtful example of transformation combining innovation, memory, and sustainability.
colta e consapevole. Il progetto prevede la riqualificazione funzionale dell’organismo edilizio esistente, con la definizione di due unità abitative e la realizzazione di una sopraelevazione volumetrica destinata a ospitare la zona giorno di uno degli alloggi.
La nuova addizione è un corpo semplice realizzato con murature massive in blocchi di laterizio e rivestimento in mattoni faccia a vista e con copertura doppia falda, dichiaratamente ispirato all'archetipo dell'abitazione rurale. L’organizzazione dei fronti – aperti a sud, chiusi a nord – ricalca logiche tipiche dell’edilizia vernacolare, mentre la relazione con il paesaggio viene affidata a un sistema di grandi aperture vetrate schermate da pannelli scorrevoli costituiti da elementi in cotto montati su telai in acciaio.
Questi elementi svolgono una duplice funzione: da un lato permettono la regolazione del flusso luminoso e della radiazione solare; dall’altro introducono un dispositivo figurativo che stabilisce una relazione tra l’interno e il contesto collinare circostante.
Il laterizio a vista, impiegato in maniera estesa per il nuovo volume, rafforza l’aderenza al vocabolario costruttivo locale, pur evidenziando la discontinuità temporale tra l’intervento contemporaneo e il preesistente e proponendo quindi una relazione critica, capace di valorizzare la permanenza attraverso la trasformazione.
Il progetto si propone come esempio efficace di un approccio integrato alla rigenerazione dell’esistente, nel quale la tecnologia costruttiva, la sintassi formale e l’attenzione per il contesto convergono verso un risultato equilibrato, in grado di innovare rinsaldando al contempo i legami con il luogo.
MDU Architetti, Casa bifamiliare, Panzano in Chianti, 2017
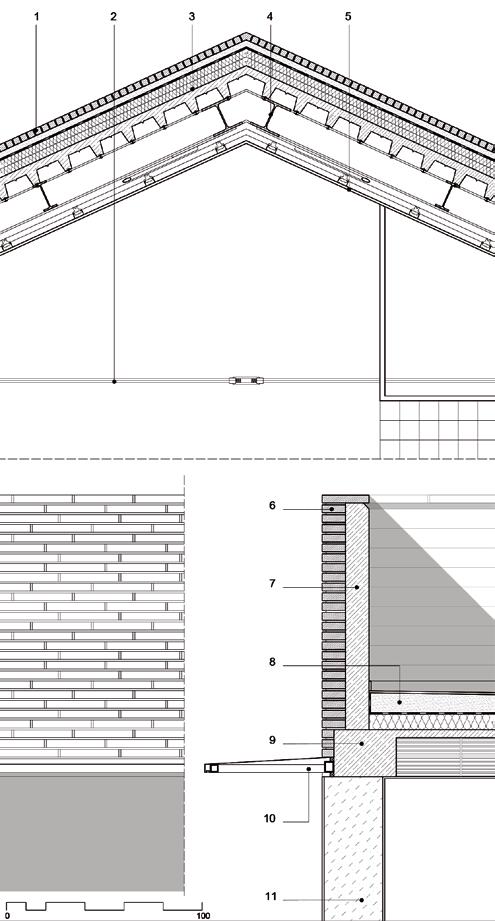
Dettagli 1 e 2
Sezione verticale del colmo della copertura e sezione verticale e vista del parapetto della terrazza
La copertura a doppia falda del volume in elevazione è costituita da una struttura in profilati di acciaio con lamiera grecata e strato isolante e un manto impermeabile con rivestimento in mattoncini di laterizio che si pone in continuità con i rivestimenti in laterizio faccia a vista dei fronti. La continuità prosegue anche in corrispondenza del parapetto che delimita la terrazza, che verso l’interno, lascia a vista il setto in calcestruzzo armato.
Legenda
1. mattoncini in laterizio
2. catena in acciaio
3. solaio isolato in lamiera grecata
4. struttura in profilati di acciaio
5. controsoffitto
6. rivestimento in mattoni faccia a vista
7. struttura in calcestruzzo armato
8. massetto di pendenza
9. solaio in laterocemento
10. sporto in lamiera metallica
11. muratura esistente

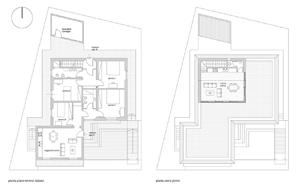
Vista della casa e piante dei due livelli.
MDU
Architetti, Casa bifamiliare, Panzano in Chianti, 2017
Dettaglio 3
Sezione verticale e prospetto del fronte sud
I fronti sud ed est del volume in elevazione sono caratterizzati da una grande finestratura che si sviluppa senza soluzione di continuità in corrispondenza dell’angolo dell’edificio. L’ampia superficie trasparente è protetta da un sistema di schermatura scorrevole costituito da elementi in laterizio montati su telai in acciaio. La sovrapponibilità dei pannelli consente una elevata libertà nella gestione dell’ingresso della radiazione solare nello spazio interno e del rapporto visivo con il paesaggio circostante.
Legenda
1. canale di gronda
2. rivestimento in mattoni faccia a vista
3. schermatura in laterizio
4. serramento
5. solaio in laterocemento
6. muratura in blocchi di laterizio
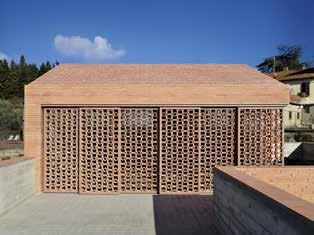

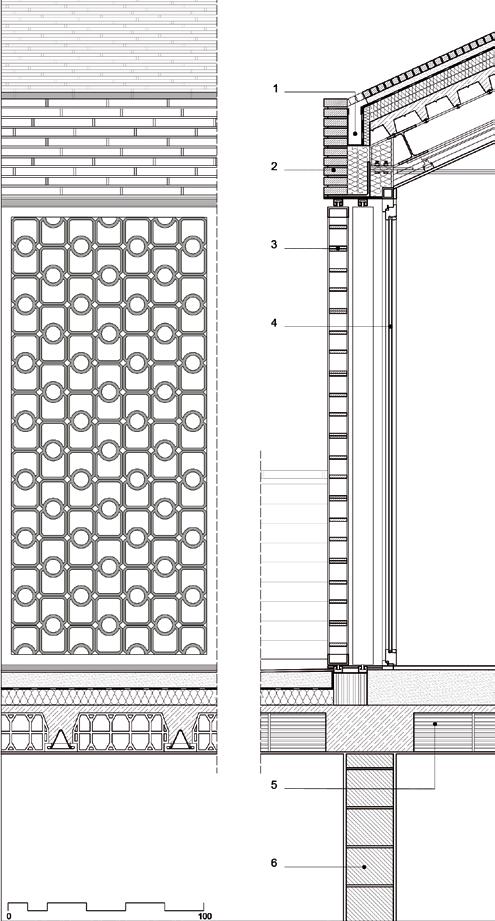
HARQUITECTES , Cantina Clos Pachem, Gratallops, 2019
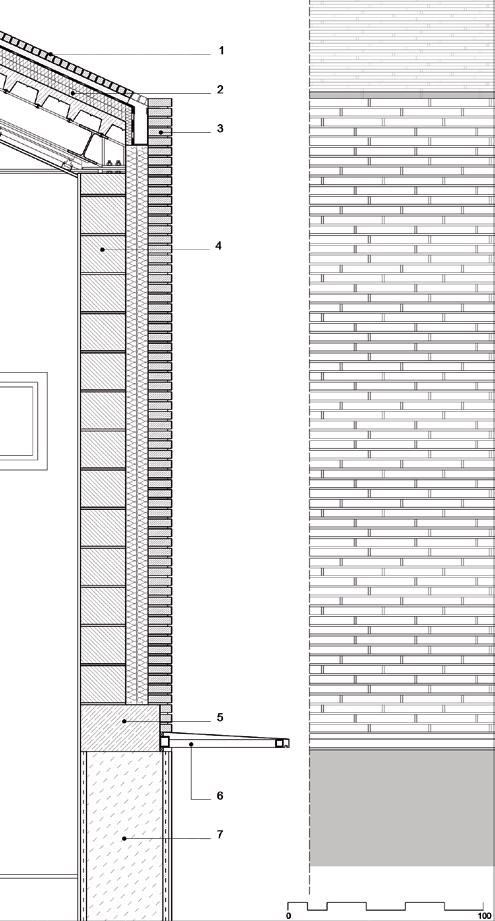
Dettaglio 4
Sezione verticale e prospetto del fronte nord
Le chiusure del volume in elevazione esposte a nord e a ovest sono completamente cieche, fatta eccezione per una piccola finestra a sud. Sono costituite da una muratura in blocchi isolata con rivestimento in mattoni faccia vista allungati. La separazione tra il nuovo intervento e l’esistente, sottolineata dalla differenza materica tra laterizio e intonaco, è rimarcata da uno sporto realizzato in lamiera metallica.
Legenda
1. mattoncini in laterizio
2. solaio isolato in lamiera grecata
3. rivestimento in mattoni faccia a vista
4. muratura in blocchi di laterizio
5. cordolo in c.a.
6. sporto in lamiera metallica
7. muratura esistente



Città in graduatoria
In questo libro, l’autore (già sindaco di Roma) classifica trionfi industriali, attenzione all’ambiente, centri di ricerca di città di ogni continente e i primati di realtà asiatiche. In 8 capitoli, ne mette in graduatoria attrattività e vivibilità, tecnologie, abitanti, spese per l’innovazione. Ricorda come le città con i grandi eventi (Olimpiadi, Fiere, il Giubileo a Roma, l’Expo a Milano), o con spettacolari architetture cerchino di attirare su di sé l’attenzione; si concentrino su clima, decarbonizzazione, degrado, compattazione degli insediamenti.
Nota in positivo Oslo (elettrificazione dei veicoli), in negativo la Norvegia (perforazioni estrattive offshore); Giacarta che sprofonda; le ondate di calore, le alluvioni, la carenza d’acqua; le novità di: “lavoro remoto” dopo la pandemia, “affitti brevi”, commercio on-line, invecchiamento demografico, veicoli a guida autonoma; metamorfosi degli uffici, concorsi di architettura; Parigi e le periferie, Londra dopo la Brexit. Dedica un capitolo alle città di nuova fondazione come capitali di stato, o iniziative di miliardari (da Chendigarh a Starbase, Forest, Naypydaw, Eko Atlantic, Neom).
Auspica giuste strategie di investimento, tecnologie e buoni progettisti per lo sviluppo del modello umanistico italiano.
Città vince, città perde.
Come cambiano le città del mondo e come dobbiamo cambiare in Italia
■ Francesco Rutelli
Editori Laterza (Bari), 2024
Pagine: 168, € 16,00


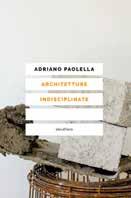
Progetti per le periferie
Autorità, istituzioni municipali e vari docenti inquadrano nel libro il tema della riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, nel contesto delle esperienze europee. Poi i curatori, docenti di tecnologia (alla Sapienza, Roma Tre, al Politecnico di Milano, a Camerino-Ascoli Piceno, Chieti-Pescara,) nella prima parte, ragionano sugli spazi inbeetween – aree urbane degradate della metropoli meritevoli di riconversioneriferendosi: a esperienze europee e londinesi; a sperimentazioni tecnologiche e tipologiche, normative, industrializzazione edilizia, comfort, durabilità, economia, tutela ambientale; a materiali e tecnologie per intervenire sul moderno e sul contemporaneo; al quartiere romano di Tor Bella Monaca, all'origine, lo stato attuale e al recupero programmato. La seconda parte è invece dedicata al Workshop Re Live “Architettura e Tecnologia per l’abitare” (Roma 2020) e alle 13 proposte progettuali di studiosi italiani, focalizzate sul soddisfacimento dei fabbisogni abitativi delle periferie. Tale questione e il patrimonio residenziale pubblico italiano sono infine analizzati da Elena Mussinelli, riguardo a produzione contemporanea, innovatività, regolamentazioni, soluzioni tipologiche.
Architettura e Tecnologia per l’abitare. Upcycling degli edifici ERP di Tor Bella Monaca a Roma ■ Eugenio Arbizzani, Adolfo Baratta, Eliana Cangelli, Laura Daglio, Federica Ottone, Donatella Radogn
Maggioli Editore – The Plan, 2021 Pp. 250, Ebook free
Rinnovo urbano partecipativo
Il volume intende la rigenerazione "l’insieme di interventi e processi partecipativi di adeguamento e rinnovo, per la tutela delle categorie più fragili; per la valorizzazione dei caratteri specifici dei luoghi". Gli autori, docenti di Urbanistica (a Roma Tre e alla Sapienza), dichiarano che l’azione istituzionale cerca di riorientare le convenienze economiche e imprenditoriali alla rigenerazione qualitativa per ambienti di vita più sostenibili.
Nella prima parte “Sperimentazioni e linee di tendenza”, auspica alternative alle pratiche di sostituzione dei tessuti preesistenti; approfondisce le esperienze internazionali per le emergenze abitative; la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio in Italia, la regolarizzazione di difformità o violazioni normative (condoni edilizi); le esperienze pilota estere.
Nella seconda: “Procedimenti, dispositivi, approcci formali alla via italiana alla rigenerazione”, considera la nozione di governo del territorio, la produzione legislativa nazionale e regionale; l’obiettivo europeo del consumo di suolo a saldo zero; la sfida tra interventi di conservazione e di trasformazione. In conclusione sollecita un dialogo multidisciplinare per favorire il confronto tra le direttrici di ricerca, nonché un’azione di coordinamento normativo.
Rigenerazione urbana. Sfide e strategie
■ Anna Laura Palazzo, Antonio Cappuccitti
Carocci editore (Roma), 2024 Pp. 216, € 21,00
Creatività e autocostruzione
Oggi gli architetti, abdicando a ogni funzione critica, sembra si siano arresi al volere delle grandi committenze pubbliche e private.
Paolella (docente di Tecnologia a Reggio Calabria e collaboratore di Italia Nostra) sostiene che un’architettura demiurgica e tecnologica, perduta la sapienza vernacolare accumulata in millenni di abitare, ha adottato l’idea di ordine di tali poteri forti. Ma ovunque c’è anche un’altra architettura, «indisciplinata», di straordinaria creatività, che interagisce con il «disordine», attenta all’ambiente e al sociale.
Il libro, partendo da architetti come Geddes, Morris, Turner, Ward, Kroll e Illich, ripercorre esperienze di progettisti «anomali», d’accordo con le comunità, fuori dai linguaggi disciplinari e dalle regole codificate.
I diversi approcci sono stati aggregati in quattro capitoli, ricchi di citazioni e racconti: l’abitare autogestito (costruzioni direttamente realizzate dagli abitanti); l’autocostruzione progettata (soluzioni predisposte da progettisti per facilitare la costruttività degli abitanti); l’innovazione della tradizione (uso di linguaggi e tecniche prossime alla cultura e alla partecipazione degli abitanti); la co-progettazione (definizione partecipata di forme e funzionalità delle costruzioni).
Architetture indisciplinate
■ Adriano Paolella Edizioni Elèuthera (Milano), 2024 Pp. 192, € 16,00
Direttore responsabile/Editor in Chief
Andrea Serri aserri@confindustriaceramica.it tel. +39 (0)536.818280
Direttore editoriale/Editorial Direction
Alfonsina Di Fusco adifusco@confindustriaceramica.it tel. +39 (0)644236926
Redazione/Editorial O ffice: Livia Randaccio (responsabile) Livia@vgambinoeditore.it tel. +39 (0)2 47761275
Comitato di redazione/Editorial Board
Alberto Ferraresi, Giovanni D’Anna, Adalgisa Donatelli, Elisa Di Giuseppe, Roberto Gamba, Flavia Santia, Pasqualino Solomita, Chiara Testoni
Comitato scientifico/ Scientific Advisory Board
Alfonso Acocella (Università di Ferrara), Adolfo F. L. Baratta (Università Roma Tre), Andrea Campioli (Politecnico di Milano), Jean Luc Chevalier (CSTB Parigi), Marco D’Orazio (Università Politecnica delle Marche, Ancona), Manuel Garcìa Roig (ETSAM Madrid), Zheng Shilling (Tongji University Shanghai), M. Chiara Torricelli (Università di Firenze)
Comitato direttivo/Managing Board
Luigi Di Carlantonio, Vincenzo Briziarelli, Mario Cunial, Roberto Danesi
Coordinamento stampa, grafica e impaginazione/Printing Coordination, Graphic & Editing
Raffaella Sesia
Hanno collaborato a questo fascicolo/ Contributors to This Edition
Adolfo Baratta (curatore Architettura), Antonio Acocella, Elena Bellini, Laura Calcagnini, Andrea Campioli, Fabrizio De Cesaris, Federico Della Puppa, Roberto Gamba, Antonio Magarò, Massimo Mariani, Liliana Ninarello, Francesco Rutelli, Flavia Santia, Pasqualino Solomita, Chiara Testoni, Marina Tonolo
Abbonamenti/Subscriptions
Edi.Cer. SpA Società Unipersonale, viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (MO) tel. 0536 804585 - email info@edicer.it
Tariffe per l'Italia
cartaceo annuale € 34,00 (estero € 44,00 ); cartaceo biennale € 60,00; digitale annuale € 24,00.;

copia singola € 15, 00. Per abbonarsi a Costruire in Laterizio è sufficiente versare l’importo sul C/C postale n° 10505410 intestato a Edi.Cer. SpA Società Unipersonale, viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (MO). Gli abbonamenti decorrono dal mese successivo al ricevimento del pagamento.
Ufficio commerciale
vendita spazi pubblicitari/ Commercial Department Sale of Advertising Spaces
Pool Media di Mariarosa Morselli tel. 059 344455 -335391555
m.morselli@pool.mo.it
Virginia Gambino Editore Tel. +39 02 47761275 - cell. + 39 340 1761951 info@vgambinoeditore.it
Stampa/Printing
Pixartprinting S.p.A. stabilimento Lavis – Trento
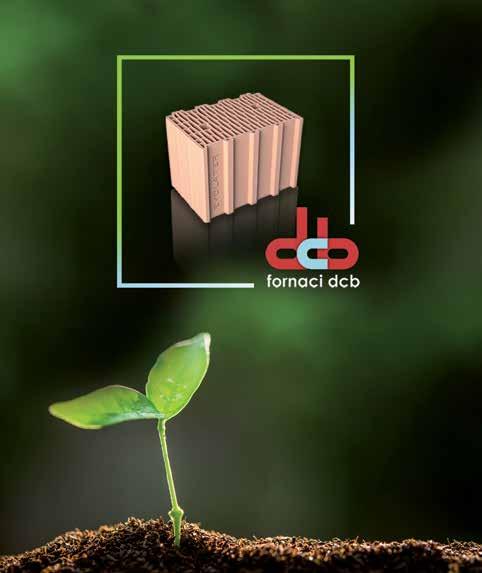
LATERIZIO
Produciamo l’intera gamma dei laterizi
Responsabilità/Responsibility
La riproduzione delle illustrazioni e articoli pubblicati dalla rivista, nonché la loro traduzione è riservata e non può avvenire senza espressa autorizzazione della Casa editrice. I manoscritti e le illustrazioni inviati alla redazione non saranno restituiti, anche se non pubblicati e la Casa editrice non si assume responsabilità nel caso di eventuali errori contenuti negli articoli pubblicati o di errori in cui fosse incorsa nella loro riproduzione sulla rivista.
Periodicità/Frequency of Publication: Quadrimestrale.
Diffusione cartacea 5.000
Diffusione digitale 50.000
Registrazione/Registration: n. 5 del 28/04/2025 - Tribunale di Modena, già precedentemente n. 869 del 18/12/1987 - Tribunale di Milano
Per comunicare con la nostra redazione: costruire@laterizio.it www.laterizio.it

4 Elementi per divisori
4 Blocchi termici per tamponatura
4 Blocchi ad elevato isolamento acustico
4 Elementi massivi per tamponatura
4 Tramezze a incastro a fori verticali
4 Blocchi acustici
4 Blocchi termici per tamponatura
4 Blocchi DL311 per tamponatura a setti sottili
4 Blocchi DL311 incastro a setti sottili per tamponatura a fori verticali
4 Blocchi NZEB incastro a setti sottili per tamponatura a fori verticali
4 Blocchi portanti per zona sismica - Categoria I
4 Pezzi speciali per blocchi portanti Z.S.- Categoria I
4 Blocchi portanti a incastro - Categoria I
4 EVOLATER® per muratura portante ordinaria e armata in zona sismicaNZEB
4 Blocchi interposti per montaggio su travetto
4 Blocchi per solaio gettato in opera - Volterrane
4 Blocchi per solaio gettato in opera - Provera


brick by brick ... Conoscere,
Sì, desidero abbonarmi per un anno a 34,00 € (car ta + digitale)
Sì, desidero abbonarmi per un anno a 24,00 € (solo digitale)
Cognome Nome
E-mail*
Azienda
Indirizzo
CAP Città Prov Naz
Telefono Fax
Attività/Settore
Cod Fiscale P.IVA
C/C postale n° 10505410 intestato a Edi.Cer. SpA Società Unipersonale, viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (MO)
IBAN EDI.CER. SPA: IT 54 N 05387 67010 0000 0000 7316 - Per info: tel. 0536 804585 - email info@edicer.it
*AT TENZIONE L’indirizzo e-mail è fondamentale per poterti inviare i dati d’accesso alla versione digitale della rivista. Modalità di pagamento
Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
Agenzia esclusiva per la pubblicità
In conformità agli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) La informiamo che Edi. Cer. S.p.A., in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati per l’erogazione del servizio di abbonamento annuale a CIL come descritto nel presente modulo. Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo, ma si rende necessario per adempiere alla sua richiesta. I suoi dati personali saranno trattati con modalità elettroniche e/o telematiche, nel rispetto delle misure previste dagli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I dati saranno trattati da personale debitamente autorizzato al trattamento dal Titolare per l'esecuzione delle attività necessarie ad una corretta gestione del servizio e - in caso di abbonamento cartaceo - comunicati ad un soggetto esterno che opera in qualità di Responsabile del trattamento, limitatamente alle attività di lavorazione e spedizione necessarie all'erogazione del servizio. È possibile richiedere informazioni sul Responsabile del trattamento scrivendo al Titolare. I Suoi dati non saranno diffusi. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati conferiti saranno conservati solo per il periodo strettamente necessario all'erogazione del servizio. Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è Edi.Cer. S.p.A. - Viale Monte Santo 40 -41049 Sassuolo (MO). Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l’informativa estesa ed esercitare i diritti generali previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo 2016/679 nonché la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano la possibilitàdi effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo scrivendo a info@edicer.it.
Acconsento all’utilizzo dei dati per la finalità di registrazione e fruizione del servizio di abbonamento a CIL
Acconsento all’utilizzo dei dati per inviare aggiornamenti su attività collaterali (ceramica, laterizi e/o arredo bagno) del Titolare del trattamento [SI] [NO]
<<LA

ECO FULLBLOCK
[LATERIZIO]+[ISOLANTE IN FIBRE NATURALI]
PARETE NATURALE AD ALTE PRESTAZIONI>>
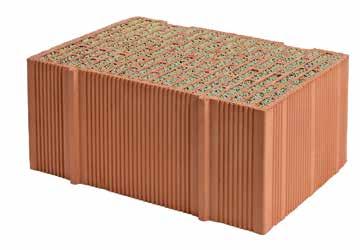

Soluzioni per pareti massive ad alta efficienza energetica
Con le soluzioni wienerberger e i brand iconici Porotherm, SanMarco e Pica, è possibile realizzare pareti ad alta efficienza in grado di ottenere ottimali prestazioni di protezione termica senza ricorrere a materiali isolanti, grazie alla massa e al design prestazionale degli elementi.
SISTEMI PER L’INVOLUCRO