ITALIAN SOCIAL
VITA S.p.A
— Impresa sociale Via E. Barigozzi 24, 20138 Milano Iscrizione al ROC n. 3275
Direttore responsabile: Stefano Arduni
Responsabile scientifico progetto “Italian Social District”: Aldo Bonomi
Grafica: Antonio Mola Matteo Riva

VITA S.p.A
— Impresa sociale Via E. Barigozzi 24, 20138 Milano Iscrizione al ROC n. 3275
Direttore responsabile: Stefano Arduni
Responsabile scientifico progetto “Italian Social District”: Aldo Bonomi
Grafica: Antonio Mola Matteo Riva
Un viaggio in 14 tappe alla scoperta dei distretti sociali evoluti italiani, che per tre anni ha popolato le pagine di VITA magazine e che oggi diventa una collezione che i nostri lettori possono scaricare gratuitamente. La prima tappa a Padova nel marzo del 2019 alla scoperta del nuovo attivismo civico generato dalla nomina del capoluogo veneto (prima città italiana) a capitale europea del volontariato. L’ultima fermata 1.389 chilometri più a sud; nel giugno del 2022 infatti siamo stati allo Zen di Palermo dove associazioni e società civile si sono messe in rete per dare risposte tangibili alla domanda di educazione e socialità dei ragazzi e degli adolescenti della Zona Espansione Nord della maggiore città siciliana. In mezzo tante altre comunità che hanno voluto sperimentare processi di innovazione sociale costituendo reti ed aprendosi a forme ibride di collaborazione: pensiamo al distretto del Piceno con l’interessantissimo hub della Bottega del Terzo Settore o a quello di Cuneo che ha immaginato un nuovo modello per rigenerare spazi dismessi. E ancora a Napoli dove mondo del credito e Terzo settore si sono alleati contro la dispersione scolastica. E via via tutti gli altri distretti sociali di cui potete avere traccia in queste pagine. A cucire insieme questa trama, che si avvale della direzione scientifica del sociologo e fondatore di Aaster Aldo Bonomi, c’è l’idea che il sociale sia sempre di più un volano per lo sviluppo. E la convinzione che la cura delle persone e della comunità e la crescita economica siano dinamiche inscindibili che si nutrono l’una dell’altra.
MAR 2019
Il nuovo attivismo civico nato dal basso che sta cambiando pelle alla capitale europea del volontariato 2020 pag 5
APR 2019
Il laboratorio di Barriera Milano. Curare le ferite per costruire comunità pag 13
GIU 2019
Il distretto sociale evoluto che ha cambiato lo sguardo della città sullo stretto pag 21
OTT 2019
Dopo un anno da “capitale” la città riscrive il suo futuro. Scommettendo su cultura e cooperazione pag 29
DIC 2019
Impresa sociale e coprogettazione: l’economia del welfare per fermare la fuga dei giovani pag 37
GIU 2020
Reti associative e cinture verdi, nella Cittàintorno le periferie non ballano più da sole pag 45
MAR 2021
Un hub del credito ad impatto per riaccendere le microimprese dell’area metropolitana dopo la crisi Covid pag 61
APR 2021
Dal nord ovest un nuovo modello per rigenerare spazi dismessi e dare forza alla comunità pag 69
MAG 2021
Credito e Terzo settore alleati nel distretto della formazione nella città simbolo del Mezzogiorno pag 77
NOV 2021
La città simbolo della pandemia rifiorisce coltivando un nuovo modello di welfare municipale pag 85
FEB 2021
Le mascherine del distretto diffuso pag 53
DIC 2021
Arte e cultura scommettono su civismo e cura. Così la città riscopre la sua anima sociale pag 93
APR 2022
La scommessa sull’agricoltura sociale per far crescere la terra del Levante pag 101
GIU 2022
Le associazioni a fianco dei ragazzi dimenticati dello Zen: la nostra sfida è il loro futuro pag 109

Caffè Pedrocchi, uno dei simboli di Padova, a due passi da Palazzo Bo, sede dell’Università, e da Palazzo Moroni, sede del Comune. Sono le 10 di mattina e, come sempre, è pieno di clienti. In una sala, la sala verde ci sono otto persone. Uno legge il giornale, poi c’è chi si scalda le mani al termosifone, chi lavora al computer e chi semplicemente chiacchiera. Nella sale verde nessun cameriere entra per chiedere le consumazioni. Non entra oggi, come non è mai entrato sin dalla fondazione, nel 1831. Questo ambiente infatti è stato pensato per permettere ai cittadini meno abbienti di avere... semplicemente un luogo dove stare. È da qui che nasce l’espressione “essere al verde”. Questa attenzione ai bisogni è un fil rouge che lega insieme
la storia della città. Da sempre capace di sperimentare una solidarietà concreta e allo stesso tempo visionaria che ha regalato all’Italia iniziative di impegno civile diventate nel tempo patrimonio nazionale come Civitas e i Beati costruttori di Pace. E che è stata il nido di personalità dirompenti come quella del pacifista Tom Benetollo o del fondatore della Caritas don Giovanni Nervo. Una storia gloriosa che continua anche oggi. Ma in modo nuovo e sorprendente. Per capire cosa muova e come si muova questo dna solidale patavino bisogna però allontanarsi dal Pedrocchi e dalla sua sala verde.
Arcella: sale il valore delle case Raggiunta la stazione dei treni nella zona nord e
de si trova, separato fisicamente e spiritualmente, dal resto del tessuto cittadino, il grande quartiere Arcella. Padova conta 250mila abitanti, 50mila dei quali risiedono qui. Una zona che da sola è più popolosa della vicina Rovigo.
Arcella, come spesso accade per le periferie, nella memoria cittadina è sinonimo di delinquenza, insicurezza e degrado. Il quartiere è bello, fatto di edifici bassi e punteggiato di villette in stile liberty. A popolare la zona, visti anche i prezzi abbordabili, un grande melting pot di studenti, immigrati e giovani famiglie che negli anni sono andate a vivere a fianco dei residenti storici, la classe operaia della Padova che fu. E proprio da questa fama di “brutto posto” che qui è nato qualcosa di straordinario. Tanto straordinario che può capitare di finire dentro ad una spettacolo teatrale. Il tram 91 percorre la linea che copre per intero via Tiziano Aspetti, l’arteria principale della periferia nord. È questo il modo più veloce per attraversare il quartiere, ma è anche viaggio alla scoperta di un’onda civica davvero sorprendente. È proprio sul 91 che la compagnia del Teatro delle Correnti in alcuni giorni dell’anno mette in scena “Una scarrozzata in tram”: un tuffo nella storia della “Società dei Tramvia di Padova”. Ad ogni fermata un cambio di scena.
Scena numero 1: fermata Borgomagno, i passeggeri vengono incantati dalle storie, dai colori e dai sapori d’oriente creati dall’Osteria di Fuori Porta e dalla libreria Limerick. Scena numero 2: alla fermata Arcella c’è “Music is the answer”, un concerto live acustico presso il barbiere Ruvido Barber Rock Club a cura della Cooperativa Il Sestante Onlus. Scena numero 3: la stessa cooperativa accoglie i passeggeri alla fermata Dazio con “Gentilezza rivoluzionaria Condivisione di storie attraverso la Libreria Umana”. Lo storytelling è accompagnato da tè e dolcetti dal mondo. Scena numero 4: la fermata San Carlo è all’insegna di “Sport e musica di strada” e propone tornei di Street Football e Basket insieme a concertini reggae-rap, tutto gestito dalla Polisportiva SanPrecario. Scena numero 5: fermata San Gregorio, le associazioni Le Mille e Una Arcella e Le Sablon Padova con omaggi golosi e cioccolata calda Grand Cru invitano a prendere parte al mix di culture del quartiere. Scena numero 6: il capolinea, fermata Saimp. È di scena il “Carnival Christmas” a base di colori, musica, castagne e vin brulé gentilmente offerte da Gasoline Padova e ArcellaGround. «Mi sembra ormai assodato che la fama della zona è largamente immeritata», spiega Simone Pillitteri professore di religione e consigliere del Comune delegato dal sindaco all’Arcella. «Io sono nato e cresciuto qui ed è chiaro che qualche problema esiste. Ma niente a che vedere con il modo in cui queste vie vengono raccontate e percepite da media e cittadinanza». Ma perché un incarico politico ad hoc per uno specifico quartiere? Semplicemente per capire come si stia trasformando questo pezzo di città, che per l’amministrazione è diventato un laboratorio a cielo aperto. Può succedere infatti, la sera, di imbattersi in vie chiuse spontaneamente al traffico
Il concorso per la Capitale del Volontariato Europea, giunto alla sesta edizione, è promosso dal Centro europeo volontariato e aperto ai comuni e municipalità di tutta Europa che dimostrino uno spiccata sensibilità nella promozione di percorsi di cittadinanza attiva e volontariato. La giuria, composta da un pool di esperti internazionali, effettua il suo lavoro valutando la misura in cui le città candidate sanno implementare le raccomandazioni elencate nell’Agenda Politica del Volontariato in Europa e le priorità politiche delle “5R” (Recognition, Real Value, Regulatory Framework, Resources, Refugees) individuate nel report della Conferenza “Helping Hands” a 5 anni di distanza dall’Anno Europeo del Volontariato 2011. Per l’anno 2020 a vincere è stata Padova, l’assegnazione è arrivata ad Aarhus, in Danimarca, capitale 2018. Quest’anno il testimone è passato alla slovacca Kosice. Padova, unica candidata per il nostro Paese, ha battuto la concorrenza di Stirling, cittadina della Scozia. È la prima volta che la scelta premia una città italiana.
in cui gli abitanti cenano in mezzo alla strada. Tutti insieme. O che sui portoni di tutto il quartiere si vedono appesi i disegni dei bambini dell’asilo e delle elementari. «Ci siamo svegliati una mattina e abbiamo trovato sulle nostre porte questi regali colorati. Non sappiamo chi li abbia fatti e chi li abbia messi qui. Ma di certo mettono allegria», racconta una signora parlando dalla finestra intenta a cucinare il sugo. E poi decine di saracinesche dipinte dai writers della zona identificano laboratori artigianali, officine e spazi sociali. Ognuno di quegli immobili, ex negozi e garage, è stato concesso gratuitamente dai proprietari per permettere a chi voglia di portare avanti attività pensate per la collettività. C’è il pittore che dà lezioni e vende le proprie opere, chi fa lezione di italiano ai migranti e chi insegna i rudimenti della falegnameria. «È difficile anche fare un censimento di quante siano le proposte spontanee», sottolinea Pillitteri. Si va dall’associazione di fotografi di strada Siamo Arcella ai giovani artisti del Collettivo Pictor, passando per l’associazione Mimosa che si occupa di lotta alla prostituzione e la cooperativa Orizzonti che lavora sull’integrazione sociale, arrivando agli esercizi commerciali più disparati, come il Kebab del quartiere gestito da Samer. Tutti collaborano, partecipano, propongono in un grande entusiasmo disorganizzato. «Per mettere ordine sono riuscito ad ottenere dal Comune l’ex istituto scolastico Marchesi, chiuso dal 2016, per convertirlo in casa delle associazioni. Un’ope-
Il boom di Solidaria.
Oltre 340 associazioni coinvolte, 5mila persone presenti ai 50 eventi che hanno proposto l’incontro con 150 ospiti nell’arco di una settimana e 10mila presenze per la festa conclusiva in Prato della Valle.

ASono questi i numeri della prima edizione di Solidaria dello scorso settembre. Una kermesse dedicata al sociale che ha contaminato l’intera città, grazie al supporto dell’amministrazione comunale, dell’Università, delle associazioni di categoria. Fra cui l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi Padova che ha coinvolto i propri affiliati e tutti gli ordini professionali che hanno organizzato per l’occasione incontri formativi. Di grande successo le serate che hanno portato in città, tra gli altri, il jazzista Stefano Bollani, lo scrittore Andrea Pennacchi, l’alpinista Simone Moro e l’architetto Stefano Boeri. Tre i filoni principali che sono emersi dagli appuntamenti: la Riforma del Terzo settore con le problematiche e le sfide che comporta, la necessità di ridare valore alle parole come strumento efficace di relazione e il fenomeno del cambiamento climatico visto come contingente e che riguarda tutti per le implicazioni che comporta nel quotidiano. Un successo che ha permesso la calendarizzazione di Solidaria 2019 rendendo l’evento una piattaforma in preparazione di Padova Capitale del Volontariato 2020.
L’impresa sociale del food. Si chiama “Strada Facendo” ed è il ristorante etico dalla cooperativa Percorso Vita di don Luca Favarin. Si trova in via Chiesanuova 131, nella sede di un ex circolo del Pci totalmente ristrutturato.
La particolarità è che, insieme allo chef italiano, vi lavorano sei profughi. Sei ragazzi africani, chi in città da un anno, chi da sei mesi, chi da quattro, che dopo aver frequentato i corsi d’italiano e dopo aver ottenuto la certificazione Haccp, hanno deciso di cimentarsi nel campo della ristorazione. Ciascuno di loro a turno lavora sia in cucina sia in sala, a contatto con i clienti. «Si tratta di un locale di cucina italiana di altissima qualità, dove vengono utilizzati prodotti biologici e a chilometro zero», spiega don Luca Favarin, anima del progetto. «La nostra è una sfida che coinvolge i profughi in un percorso di formazione che li porta a saper cucinare e lavorare in un ristorante. Noi chiediamo loro di fare uno sforzo di integrazione, di studiare a fianco del cuoco la cucina italiana, e loro stanno rispondendo davvero bene. Sono entusiasti». Ma “Strada Facendo” non è solo ristorante è anche luogo di conferenze, concerti, dibattiti, spettacoli. «Il posto è molto grande, tra l’interno e l’esterno ci sono un centinaio di posti, e c’è un bellissimo palco all’aperto», sottolinea il sacerdote. Che conclude: «Nonostante il decreto Sicurezza e il clima ostile che si respira da un po’ di tempo a questa parte non intendiamo fermarci o cambiare il nostro approccio».

-razione da oltre 900mila euro. Ad oggi sono già 21 le realtà che popoleranno le vecchie aule», aggiunge Pillitteri. Tutto questo fermento ha già alcuni risvolti molto concreti: «una cosa che non dice nessuno», conclude Pillitteri, «è che da quando sono iniziate le attività del volontariato arcellano gli appartamenti della zona hanno cominciato ad aumentare di valore e di prezzo. È un segnale incredibile. Cui si aggiunge la scelta di Renzo Piano di proporre proprio qui uno dei progetti che sovvenziona con il suo stipendio da senatore a vita».
A fronte di questo volontariato underground Padova vanta anche un panorama sociale tradizionale, ma molto dinamico e pronto a giocare la sfida dell’innovazione. Solo nel territorio comunale oggi si contano 2.102 associazioni (ben 56 nate nell’ultimo anno). Di queste 110 sono cooperative sociali, 68 ong e 269 associazioni sportive. «Ogni anno facciamo la mappatura per vedere i cambiamenti», sottolinea Emanuele Alecci, presidente del Csv Padova. La città è il fiore all’occhiello di un distretto sociale più ampio che coinvolge provincia e regione. «Il Veneto è terza in Italia per numero di enti non profit dietro a Lazio e Lombardia con 29.871 organizzazioni», sottolinea il presidente, «e se prendiamo in esame la provincia padovana scopriamo che il 2018 ha registrato la presenza sul nostro territorio di 6.374 associazioni, con un incremento di 270 unità rispetto all’anno precedente». Per Alecci, «sono stati proprio gli studi promossi dal nostro Centro a rendere evidente come i tempi siano maturi per un salto di qualità culturale del volontariato di questo territorio».


Una sensibilità della città che ha contaminato anche l’Università. «Oggi miriamo a forgiare non professionisti esclusivi per il Terzo settore, ma professionisti generalisti attenti al sociale, in grado di dare valore a questa sensibilità nei campi più diversi», sottolinea Laura Nota, delegata del rettore in materia di inclusione e disabilità, «le faccio un esempio: un architetto formato qui difficilmente si “dimenticherà” di installare un ascensore destinato alle persone con disabilità dove non era stato previsto, ma lo prevederà sin dalla prima bozza di progetto. Un’attenzione che vale per ogni ambito professionale e non solo per le barriere architettoniche». A Padova è cambiato il paradigma. «Non ci concentriamo solamente sulla persona esclusa, ma anche sul contesto che la circonda», chiarisce Nota. Come? Formazione, educazione e ricerca. Queste sono le armi. «Lavoriamo in forma interdisciplinare e multidisciplinare. Abbiamo il corso “Diritti umani e inclusione”, alla sua terza edizione, che è trasversale, aperto a tutti gli studenti di tutti i corsi di laurea e messo a punto da docenti di tutti i dipartimenti» sottolinea la delegata. Poi c’è anche un master, “Inclusione e innovazione sociale”, che è proposto da tutti gli atenei veneti grazie a un documento fir-
mato da tutti i rettori delle università del Triveneto. «Un master da 1.500 ore di formazione, rivolto sia ai professionisti del territorio sia ai molti dipendenti universitari. L’idea è che oltre ad intervenire nella formazione dei giovani è necessario impattare anche sul mondo del lavoro». L’obiettivo finale? «Creare un contesto in cui le persone con vulnerabilità non siano destinate alla marginalizzazione. Penso a disabili fisici, agli psichiatrici, ai poveri o ai migranti. Il nostro ateneo oggi lavora per creare una rete diffusa e trasversale che abbia a cuore la questione dell’inclusione di queste persone», conclude Nota.
La culla delle startup sociali Per Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo il volontariato padovano è una fucina di startup in ambito sociale. «È una fonte inesauribile di innovazione sociale. Nascono ogni giorno bisogni nuovi che mutano in tempi rapidi e in modo imprevedibile. Il volontariato cerca spontaneamente soluzioni nuove efficaci e a costi modesti, sia nel merito sia nei processi». Muraro ricorda poi come sia stato coniato proprio a Padova il temine “welfare generativo” grazie alle pubblicazioni di Fondazione Zancan. «Come spiega bene Tiziano Vecchiato è un termine che significa appunto staccarsi dai cliché tradizionali delle organizzazioni pubbliche e spingere gli stessi soggetti da aiutare ad immaginare soluzioni dal basso». Una modalità che ha fatto nascere nuovi approcci e nuovi modi di agire. Alcuni esempi sono i casi premiati negli anni dal premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale che vede Cariparo all’interno della giuria.
Il volontariato padovano è una fonte inesauribile di innovazione sociale perché cerca spontaneamente soluzioni nuove efficaci e a costi modesti
«Penso ad una organizzazione che dava l’asilo gratuitamente ai figli di famiglie in difficoltà chiedendo in cambio alle madri di collaborare alla gestione stessa dell’asilo in un’ottica inclusiva. Le rendeva partecipi facendole sentire coinvolte», racconta Muraro. «Oppure ad un’associazione che riciclava vecchi tessuti di risulta della produzione industriale in un’ottica di economia circolare, creando una serie di prodotti a marchio che hanno avuto un grande successo e dando lavoro a donne in stato di disagio. Innovazioni che è difficile che nascano in ambito pubblico».
Ma come si sa ogni startup di successo decolla anche grazie alla scia di un acceleratore di qualita. «È proprio questo il nostro ruolo. Attraverso i nostri bandi, sosteniamo la rete sociale del territorio. Negli ultimi tre anni abbiamo destinato 6 milioni di euro per il sostegno dei Csv territoriali» conclude il presidente di Cariparo.
Sergio Giordani a Padova era conosciuto come imprenditore e in particolare come presidente del Padova Calcio. Quando nel 2017 si candida alle elezioni comunali come volto di un Partito Democratico in difficoltà la scelta sorprende. «Non avevo mai pensato di fare politica, è stata una congiuntura di avvenimenti. Ho deciso che era il caso di mettersi a disposizione di una città che mi ha dato tanto». Durante quella campagna elettorale Giordani è colpito da un’ischemia, nonostante la quale vince le elezioni. Lo descrivono come un sindaco atipico e “molto umano”, particolarmente attento al sociale: «Ma io in realtà non avevo idea che la mia città fosse così viva».

La prima cosa che ha deciso come sindaco, costruendo la sua giunta, è stata di destinare al mondo del Terzo settore non uno ma due assessori…
Sì, abbiamo deciso di avere un assessorato Sociale e uno invece dedicato esclusivamente al Volontariato. Una scelta dovuta alla ricchezza sociale di questa città. Sembra quasi sorpreso dalla sua stessa città...
Sì, non sapevo che Padova avesse una tale vivacità. L’ho scoperto incontrando questo mondo in campagna elettorale. E ne sono rimasto colpitissimo. Ho sempre lavorato nel mondo dell’impresa e dello sport. Eppure non sapevo che abbiamo oltre 269 associazioni di volontariato sportivo che si occupano dei nostri giovani. Non c’è qui un servizio che potremmo

Ho sempre lavorato nel mondo dell’impresa e dello sport. Eppure non sapevo che abbiamo oltre 269 associazioni di volontariato sportivo che si occupano dei nostri giovani.
Non c’è un servizio che potremmo garantire senza i volontari, dalla sanità alla sicurezza.
Senza volontariato Padova chiuderebbe. Siamo una città che si regge sul gusto, sul piacere e sulla voglia del fare per gli altri

garantire senza i volontari, dalla sanità alla sicurezza fino all’educazione e all’inclusione. Senza volontariato Padova chiuderebbe. Siamo una città che si regge sul gusto, sul piacere e sulla voglia del fare per gli altri. Una peculiarità che è valsa alla città la nomina a Capitale del Volontariato Europea… Chiariamo subito: il merito è di questa grande effervescenza sociale e del nostro centro di servi-
zio al volontariato che l’ha intercettata, non del Comune. E non è un riconoscimento all’amministrazione, ma alla città , che è davvero un diamante sul fronte sociale e della cittadinanza attiva.
Però voi sia in termini di investimenti che di sforzi cercate di dare una mano… Questo sì. La nostra scelta è quella dell’ascolto. Siamo un Comune dove le persone si danno da fare, creano proposte e progetti. È una grande ricchezza. Noi siamo chiamati ad aiutarli. Non solo perché è intelligente e giusto, ma perché ci conviene, da tutti i punti di vista, anche economico. Poi naturalmente investiamo quel che possiamo. Sul 2019 ad esempio abbiamo stanziato 250mila euro, l’anno scorso erano 150mila, per la “Città delle idee” nella convinzione che incentivare dal basso le energie sia la cosa migliore. Al quartiere Arcella abbiamo investito 921mila euro per rilevare una scuola del demanio da destinare alle associazioni. Come amministrazione dobbiamo fare di tutto per aiutare quel quartiere che è oggi la locomotiva della città. Come?
Sul fronte sicurezza abbiamo appena cominciato i lavori per la nuova illuminazione a led del quartiere che va a braccetto con la scelta di incentivare l’apertura di nuovi esercizi tagliando le tasse a chi decide di investire. Nel futuro c’è poi un grande progetto di riqualificazione urbanistica, su cui stiamo lavorando con l’ordine degli architetti. Vogliamo abbattere le barriere che tengono l’Arcella isolato. Ci vorranno anni, ma diventerà un vero gioiello.
La coop fa parte si un coordinamento volontariato di oltre 40 realtà sociali che lavorano all’interno del carcere di Padova. Si va dalla chiesa Avventista fino al giornale Ristretti Orizzonti. Un penitenziario che è fiore all’occhiello dell’amministrazione carceraria italiana. Solo Giotto dà lavoro a circa 140 dei 640 ospiti impiegati nel laboratorio per assemblare le valigie, in pasticceria e in un call center. «Negli anni abbiamo capito che la prospettiva andava rovesciata. I destinatari dovevano diventare protagonisti. Così è nato un corso di formazione in cui i detenuti imparavano a curare da sé le aree verdi del carcere. Vent’anni dopo le cifre sono diverse, ma l’intuizione è la stessa, confermata da centinaia di casi che stupiscono noi per primi. Le persone detenute possono diventare protagoniste della loro vicenda professionale e umana. E la chiave di volta è l’occupazione. Il tasso di recidiva di chi lavora con noi è compreso tra il 2 e il 3%», conclude Boscoletto, «quello medio è del 70%. I nostri calcoli dimostrano che ogni punto di recidiva abbattuto farebbe risparmiare allo Stato 40 milioni l’anno».

«Si tratta di una delle zone più complesse e disgregate della città, interessata dalla metà degli anni 90 da una serie di fenomeni di disagio e conflittualità sociale acuiti dal fatto di essere un luogo ad alto transito con 18 milioni di persone di passaggio all’anno, 50mila in media al giorno», spiega la presidente Barbara Maculan. «Il nostro obiettivo è la promozione di azioni finalizzate a migliorare la qualità della vita e in questa direzione abbiamo anche proposto due progetti: Greenline e On Line Station». Il primo è un intervento di arredo urbano temporaneo dove organizzare attività aggregative. «Eventi, feste e attività in ambito culturale e sociale che compongono un calendario nell’arco dei 24 mesi della progettualità», sottolinea la presidente. Il secondo invece è l’attivazione di una “rete di comunità online” che «alimenti la coesione sociale dei residenti e promuova la loro capacità di interazione e autorganizzazione per risolvere problemi condivisi nella zona di residenza», sottolinea Maculan.

Il network delle associazioni del carcere . «L’attenzione per i detenuti a Padova arriva da lontano. Sant’Antonio ebbe una predilezione per i carcerati», spiega Nicola Boscoletto presidente della Cooperativa sociale Giotto.
La riqualificazione urbana si fa off, ma anche online. L’associazione Mimosa è impegnata nella rivitalizzazione dell’area della stazione ferroviaria insieme a Banca Etica, Comune, Confesercenti ed altri enti.
Astata una scelta giusta quella di iniziare da Padova questo viaggio nei distretti dell’innovazione sociale in Italia. Padova come sappiamo è stata scelta come capitale europea del volontariato per il 2020 e quando ci si trova davanti a queste dinamiche proprie dell’eventologia il rischio è sempre quello di essere risucchiati da un gorgo tipico della società dello spettacolo, che produce rappresentazione senza rappresentanza, o storytelling che copre il racconto e non fa sentire le voci reali. È legittimo l’orgoglio di un territorio che entra in questo modo in un grande circuito europeo, tuttavia bisogna stare all’erta rispetto a quei dinamismi che producono community senza comunità.
Un aspetto interessante di questo racconto è che, partendo da Padova, si precipita nel cuore di “lover”, acronimo che identifica l’area tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. È quel triangolo industriale che abbraccia anche il Nord Est e che vive una doppia dinamica. Da una parte ci sono i campioni che vanno oltre frontiera e conquistano spazi di mercato; dall’altra ci sono i tanti che invece fanno i conti con le difficoltà e che vengono intercettati dal nostro racconto. Come ha documentato la Cgia di Mestre questo territorio sta facendo i conti con un impoverimento del tessuto diffuso dell’imprenditoria. Gli indicatori ci testimoniano inoltre come ci sia preoccupazione non solo per il rallentamento dell’economia ma anche per le ricadute in termini di qualità dei servizi, di qualità dell’ambiente e anche di costo della vita. I quasi 7mila soggetti non profit che sono un patrimonio specifico in particolare di Padova possono dare risposte seguendo un metodo già collaudato in altre stagioni: mettersi in mezzo. Per questo è stata azzeccata la scelta di mettere al centro di questa narrazione il grande quartiere di Arcella, con quella grande ed emblematica fotografia in cui si documenta che laddove si volevano costruire muri, la risposta è stata quella di riprendersi invece la strada. Arcella è un contesto caratterizzato da una nuova composizione sociale: dove c’erano operai oggi ci sono migranti, studenti, giovani coppie. E dove c’era una sezione del Pci oggi c’è un ristorante etico ed etnico gestito da una cooperativa che si chiama, non a caso, “Strada facendo”. Cosa insegna il caso di Arcella? Innanzitutto che, come si evince dalla narrazione, le relazioni tra i soggetti prevalgono rispetto alle loro identità. Questo investimento nel capitale sociale delle relazioni ha anche abbassato il portato di paura causato dalle incertezze dello scenario economico. Non solo, la riqualificazione sociale ha portato ad un aumento del valore delle case. Questo dinamismo di relazione riguarda anche le istituzioni, a partire dal Comune che non ha caso ha deciso di mettere al lavoro un doppio assessorato sulle periferie, ma poi sono entrate in gioco anche l’università e le parti sociali: la marginalità ha conquistato il centro. Da questo punto di vista è emblematico il caso del carcere di Padova, che non sta ad Arcella, e che è esempio di come il contesto più marginale possa farsi centro.
In un contesto in cui ci si chiede cosa resti del welfare europeo, il caso Arcella pone la sfida del welfare generativo. Una sfida che parte da una domanda: chi genera il welfare generativo? Come ci spiega Stefano Zamagni le ipotesi possono essere due: o attraverso una dinamica di sussidiarietà dall’alto o invece di sussidiarietà orizzontale. Nel primo caso si va verso una finanziarizzazione del welfare con tutte le conseguenze che possiamo immaginare: in pratica, il capitale con il suo narcisismo conquista il sociale; nel secondo caso invece è la creatività della comunità di cura che contamina la comunità operosa, cioè la comunità economica, e quindi determina l’assetto di un welfare pensato e generato da chi sta nel mezzo. Come dice Miguel Benasayag, che ha documentato meglio di ogni altro le dinamiche di quest’epoca dominata dalle passioni tristi, per superare la solitudine, a volte anche cupa, dei soggetti bisogna praticare una creatività condivisa.
Come mi è più volte capitato di sottolineare oggi il sociale sopravvive in oasi che sono però circondate da un deserto. Il compito importante e ambizioso è dunque quello di cercare di connettere queste oasi. Poi nel 2020 torneremo a Padova per una verifica, proponendo tutto il racconto del percorso fatto e, speriamo, delle connessioni stabilite.
Offrire servizi ai nuovi bisogni e proporsi come nodi territoriali per sostenere processi di integrazione dei migranti. Così tante non profit stanno interpretando un ruolo innovativo. E molto proattivo


Uno spettacolo in strada del Teatro dell’Oppresso. Un progetto dell’associazione Mamre pensato per incoraggiare le persone alla cittadinanza attiva e a partecipare alla vita politica e sociale del territorio
Alterità e lavoro. Sono queste le parole chiave che riassumono la storia di Torino. La città ha sempre trovato le energie e la vitalità per cambiare ed evolversi dentro il rapporto con l’altro. Come in epoca napoleonica, quando per via dei dazi francesi la quantità di cacao che giungeva in Europa era ridotta e con prezzi esorbitanti, gli artigiani torinesi della Caffarel decisero di tagliare il cacao con le nocciole e inventarono il cioccolato gianduja, uno dei simboli della città piemontese. Allo stesso modo in età più recente l’altro è stato alla base della crescita industriale della città grazie alle ondate di migranti, prima interni e poi stranieri, approdati sotto la Mole per lavorare.
I quartieri degli ultimi arrivati
Oggi quel meccanismo si è inceppato: un’evidenza che salta agli occhi osservando la conformazione urbana di Barriera di Milano storica, quel tratto di città che si stende a nord est, oltre quella linea di demarcazione tra la città benestante e “l’altra città” che è corso Regina
Margherita. La Barriera storica si sviluppò tra 800 e 900 in prossimità di alcuni grandi insediamenti industriali, oggi in parte abbattuti ma in parte ancora in piedi. Solo alcuni hanno trovato nuove destinazioni, gli altri sono testimoni di un passato fordista che si è polverizzato. Oggi la composizione sociale di Barriera di Milano è definita da questi due numeri: 42% di residenti stranieri nella zona intorno a via Monte Rosa e 35% nella zona opposta, oltre Corso Vercelli, l’area Monte Bianco: il che ne fa uno dei quartieri a più alta densità di immigrati in Italia, con una evidente supremazia delle seconde generazioni. Il risultato è che questa è la sola zona di Torino che abbia visto un incremento di popolazione e soprattutto un abbassamento dell’età media.
Sono caratteristiche che si perdono man mano che si esce dalla città, attraversando quella che viene chiamata Nuova Barriera, vera periferia stile anni ’60 che oggi paga il peso della crisi, con il crollo dei valori immobiliare e l’accantonamento del sogno della seconda linea della metropolitana. Se la Barriera storica oggi è segnata da una vivacità di iniziative so -
la percentuale record di popolazione straniera intorno a via Monte Rosa
La percentuale di popolazione under 25 a Barriera Milano storica

una povertà che ha aggredito anche la popolazione autoctona. Un osservatorio privilegiato per seguire questi due differenti territori è certamente l’associazione Mamre: la sede è in Strada Maddalena, in una zona di cerniera, e ora si sposterà in spazi più adeguati al volume di attività in piazza Croce Rossa. Un ex capannone abbandonato che ora trova dunque una nuova funzione. “Trova casa la onlus che ricuce gli strappi dell’anima”, aveva titolato La Stampa all’indomani dell’avvio del cantiere a fine gennaio. Il know how di Mamre infatti è l’etnopsichiatria, la consulenza psicologica e la mediazione culturale. L’associazione era stata fondata nel 2001 da una suora dell’ordine del Cottolengo, suor Giuliana Galli e da una psicoterapeuta, Francesca Vallarino Gancia. «Il nostro nome non è un acronimo ma nasce dalla Genesi 18 quando Abramo sotto le Querce di Mamre incontra tre stranieri, li accoglie, li ascolta e fa un tratto di strada
Abramo sia il padre delle tre religioni». Un indirizzo che ha intercettato un grande bisogno, in quanto anche le nuove generazioni immigrate soffrono di una grande fragilità psicologica che non trova luoghi “di cura”. Vallarino Gancia ha un curriculum corroborato da esperienze fatte anche sulle navi che recuperavano i migranti nel Mediterraneo, proprio facendo assistenza psicologica della prima ora a persone che venivano da percorsi drammatici. Nella mission di Mamre al primo punto si legge «sostegno psicologico, psicoterapia, consultazioni etnopsichiatriche, mediazione culturale, prevenzione e cura del disagio psichico e sociale delle persone». Mamre, come spiega suor Giuliana Galli, oggi ha alzato l’asticella. E la nuova sede è il segno anche fisico di questa nuova ambizione. «Sin dall’inizio», spiega a Vita, «il nostro sforzo è sempre stato rivolto alle fragilità della popolazio
Fondazione Compagnia di Sanpaolo
SocialFare
Piccola casa della Divina Provvidenza
Arsenale della Pace
Sede attuale di Mamre
Sede nuova di Mamre
8.
Piazza dei Mestieri
Barriera di Milano storica Barriera di Milano nuovane immigrata. Ora, dopo anni di impegno il Comune ci ha concesso un edificio, sempre in Barriera, dove nascerà la nuova sede. L’auspicio è che possa essere, oltre che la nostra nuova casa, anche il luogo dove chi oggi anima la comunità del quartiere possa addensarsi e diventare quel corpo intermedio di cui oggi la società ha bisogno».
OAddensamento è una parola chiave, perché esprime l’auspicio che quella polverizzazione che contrassegna la vivacità di Barriera storica possa assumere maggiore autoconsapevolezza e farsi soggetto capace di interloquire con le istituzioni. È un processo sul quale “veglia” con attenzione la Compagnia di Sanpaolo, una delle due grandi fondazioni ex bancarie che tanto peso hanno nella vita di Torino. «Siamo impegnati a sostenere processi di integrazione e inclusione sociale di lungo periodo», spiega a Vita Francesco Profumo. «In questo senso guadiamo alla componente immigrata nella nostra società non come a una “popolazione-target” in quanto tale, ma come un gruppo umano eterogeneo in rapporto con altri gruppi, categorie, fasce sociali che convivono nei nostri territori». Per questo la Fondazione collabora e sostiene organizzazioni ed enti che «a partire da competenze di elevata qualità stanno interpretando in modo innovativo e proattivo il proprio ruolo di nodo territoriale al servizio di tutta la comunità».
Carlotta Salerno, nata e cresciuta in Barriera è oggi presidente della Circoscrizione 6. «Sono sempre stata molto orgogliosa di essere nata e cresciuta qui», racconta, «e ho sempre voluto impegnarmi per valorizzare le tante attività di animazione sociale di questa porzione di città. È un territorio che vive di estremi, con un terzo della popolazione under25, quindi giovanissimo, e un altro terzo over65. Il cuore di tutte le difficoltà e le fragilità delle persone di questo territorio riguarda l’integrazione. Ed è per questo che è nato il Tavolo del Lavoro», sottolinea. Al Tavolo partecipano istituzioni, enti interinali, cooperative e imprese. «Ci siamo accorti sin da subito», continua Salerno, «che la nostra grande ricchezza era l’artigianato locale che viene portato avanti da aziende ed esercenti del territorio. Si va da grandi marchi come Aurora, che produce penne, fino alle piccole botteghe che producono accessori in pelle». Tutte realtà che hanno bisogno in alcuni casi di nuove competenze in altri di trovare qualcuno cui affidare saperi e futuro. Al Tavolo si fa matching per creare opportunità.
In Barriera si può provare a trovare lavoro anche ai Bagni Pubblici di

Sono arrivato in Italia nel 2007 con mia moglie e i nostri due figli. Sono scappato dalla provincia di Odessa, dove facevo l’imprenditore, perché stava arrivando la guerra. Appena arrivato in Italia ho preso la licenza media e ho cercato dei corsi professionalizzanti. L’unico in cui mi hanno preso, anche per via delle mie difficoltà con la lingua, è stato alla Piazza dei Mestieri. Dopo il loro corso di ristorazione mi hanno aiutato a trovare lavoro e a prendere il diploma alberghiero. A quel punto ho aperto un locale di prodotti gastronomici e souvenir dell’Europa dell’Est. Quell’attività oggi è chiusa perché ho venduto la licenza e ho aperto una nuova attività familiare: si chiama Più Feste, una società di wedding planners. Nel frattempo continuo a collaborare come insegnante di cucina nei progetti di Inclusione della Piazza perché aiutare i giovani rende la mia vita più felice. Voglio insegnare che non è importante che escano da lì come cuochi, pasticceri o panettieri ma che imparino a prendere in mano il proprio destino.
Sono arrivato in Italia con la mia famiglia il 15 luglio 2007. I miei genitori mi hanno iscritto a scuola. Dopo le medie ho scelto di andare all’Istituto Professionale Statale Colombatto. Ma non mi trovavo bene: si faceva troppa teoria e poca pratica. Gli insegnanti mi hanno così indirizzato alla Piazza dei Mestieri. Lì ho fatto un corso di formazione biennale come cuoco. Ho ottenuto la qualifica e ho cominciato a lavorare facendo stage e imparando il mestiere nei ristoranti di Torino. Nel 2015 ho aperto Girarrosto Pizzeria Regina, il mio locale, insieme a mio fratello e mia sorella. Oggi sono anche peer tutor all’interno dei progetti di inclusione della Piazza e affianco i ragazzi soprattutto sulla lingua. Lo faccio perché la Piazza mi ha dato la possibilità di fare quello che mi piace. Voglio fare il possibile per dare le stesse opportunità che sono state date a me anche ad altri ragazzi.



via Aglié. Erika Mattarella, che vive e lavora nel quartiere, a 26 anni decide di impegnarsi come cittadina attiva. Da socia della cooperativa LiberiTutti partecipa attivamente alla rete delle case del quartiere che nel 2012 ha rigenerato la struttura creando un centro multiculturale e di servizio per la collettività. «Ai Bagni oltre al servizio di docce pubbliche hanno trovato casa diverse proposte», racconta Mattarella. «Abbiamo lo sportello di segretariato sociale che si occupa di fornire assistenza nella compilazione di curriculum vitae, assistenza per le richieste di sussidio e assistenza nella ricerca di lavoro e casa. Poi ci sono corsi di cucina, panificazione, radio e ciclofficina», continua la fondatrice. «Sempre qui abbiamo l’unico Bistrot italiano certificato halal che si chiama “Acqua Alta” e Baobab Couture la sartoria di moda afro-europea». Per Mattarella quello che è chiaro è che «non esiste una ricetta: questo territorio è un luogo dove facciamo test, proviamo, anche a costo di sbagliare». Qualche esempio? «Eravamo convinti di dover tutelare gli immigrati. Invece i primi da integrare siamo noi italiani. È un cambio di paradigma che abbiamo imparato facendo le cose nel modo sbagliato».
OLa conclusione è di don Danilo Magni della Congregazione del Murialdo, che è l’anima di proposte per l’innovazione sociale tecnologica come SocialFare: «Quella che rischiava di essere una bomba ad orologeria sociale si è rivelata una ricchezza e una grande possibilità. Grazie alla presenza del Terzo settore, queste persone, da sempre considerate fragili e marginali, hanno cominciato a dimostrare non solo di essere delle risorse ma addirittura di poter generare energie e competenze creando opportunità e lavoro anche dove non c’erano».
Poco sotto il confine di Corso Regina Margherita c’è la Piazza dei Mestieri. Anche qui l’altro e il lavoro al centro. «Ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie. Dalle medie fino al liceo», spiega Mauro Battuello, responsabile dei progetti speciali. Piazza dei Mestieri ha intercettato con i suoi progetti oltre 300 ragazzi, grazie al rapporto con una decina di scuole del territorio, cui propone oltre ad un tradizionale aiuto allo studio e di reinforce linguistico anche attività pratiche con corsi di cucina, bar, pasticceria e panetteria. «La grande vittoria, per noi, sono i tanti ragazzi che attraverso le nostre attività hanno trovato la propria strada e che continuano a frequentare la Piazza e addirittura sono diventati docenti e tutor per i nuovi arrivati, trasformandosi loro stessi in operatori di comunità».


Nel 2000 sono partito dal Senegal, dove facevo il sarto, e sono andato in Francia prendendo il visto. Ho lasciato a casa mia moglie e mio figlio. Mi sono poi spostato a Torino dove ho incontrato la cooperativa LiberiTutti con cui ho partecipato sin dall’inizio al progetto dei Bagni Pubblici. Inizialmente tenevo dei corsi di cucito che fossero anche dei luoghi e momenti di aggregazione e integrazione. È nata poi l’idea di creare un atelier, Baobab Couture, che col tempo ha cominciato a ricevere commesse dai negozi del centro e da alcuni marchi. Propongo uno stile che si chiama afro-europeo e che è una sorta di inno all’integrazione. Oggi la sartoria sta arrivando a quella sostenibilità che mi permetterà finalmente di fare il ricongiungimento familiare. Se dovessi identificare la cosa che più ha fatto la differenza nella mia storia è stata la fiducia che le persone che mi hanno aiutato hanno voluto riporre in me.
Sono arrivato in Italia nel 2015. Ero laureato in Analisi, Metodi quantitativi e Politica economica con un corso di 4 anni Una volta arrivato avevo come obiettivo di continuare gli studi. Così ho provato ad iscrivermi in Università. Purtroppo ho avuto alcune difficoltà burocratiche. Fortunatamente ho scoperto che esisteva questo programma, che si chiama Extra Titoli. Loro mi hanno guidato per affrontare la burocrazia universitaria. Mi hanno aiutato in particolare nel farmi riconoscere il titolo di studio maliano qui in Italia. Oggi sono iscritto l’Università degli Studi di Torino e studio economia dell’ambiente. Il mio Paese di riferimento ha il proprio sistema economico basata sullo sfruttamento delle risorse naturali. Per me è fondamentale avere le competenze per poter lavorare in modo che un giorno nel mio Paese si faccia business preservando l’ambiente e la natura.

«L’amministrazione ha sempre avuto ben chiaro che dobbiamo cambiare la cultura che vede il sociale esclusivamente come volontariato. Sappiamo invece che esiste un modo di fare sociale che porta lavoro e reddito. Il mercato sociale è un mercato interno ad alto potenziale che va servito in un’ottica di innovazione». Paola Pisano, assessore all’Innovazione del Comune di Torino è sempre stata molto attenta alle periferia della città. Se da oltre un decennio l’amministrazione promuove e sostiene interventi di rigenerazione urbana come parte integrante delle strategie di sviluppo locale e dei processi di governance del territorio urbano la novità è la volontà di «spingere e investire perché prenda sempre più piede la figura dell’imprenditore sociale», sottolinea Pisano.
Perché è così importante l’imprenditoria sociale?
Perché si tratta di imprenditori a tutto tondo, quindi che creano lavoro e reddito nei quartieri, ma lo fanno trovando soluzioni innovative ai problemi specifici dei territori in cui operano. Investire sulla crescita di queste figure significa indirettamente investire sullo sviluppo di welfare e servizi che il Comune non solo non può garantire ma magari non sa nemmeno immaginare.
La periferia di Torino è da questo punto di vista molto
«Stiamo spingendo e investendo molto perché prenda sempre più piede, nei quartieri della periferia, la figura dell’imprenditore sociale»
—
«Barriera è un quartiere giovane e multiculturale e per questo molto aperto alla sperimentazione soprattutto sul fronte dell’integrazione vista l’ampia presenza di stranieri»
attiva, un terreno molto fertile…
Non c’è dubbio. Barriera di Milano e la periferia nord sono un laboratorio molto importante da questo punto di vista. Ogni territorio se ingaggiato reagisce in modo diverso. In alcune zone nascono testing più tecnologici mentre in altre aree nascono proposte di innovazione ed economia circolare. Il tessuto sociale risponde agli stimoli per le caratteristiche che ha. Barriera è un quartiere giovane e multiculturale ed è per questo molto aperto alla sperimentazione soprattutto sul fronte dell’integrazione vista l’ampia presenza di stranieri.
E quali sono i progetti che il Comune sta implementando su questi temi?
Principalmente due. Il primo si chiama Torino Social Factory, che sovvenziona con 1.4 milioni di euro 14 progetti che si trasformeranno in attività imprenditoriali. Si tratta di una proposta di finanziamento e accompagnamento che prevede anche la misurazione di impatto. Il secondo è la Crowdfunding Academy. Un percorso con cui insegnare all’imprenditore sociale a ottenere budget per la propria attività a impatto sociale sul territorio attraverso piattaforme come Eppela e Kickstarter. Il nostro obiettivo è movimentare l’ecosistema dell’innovazione sociale perché si generino autonomamente progetti e imprese che rispondano ai bisogni delle comunità locali e delle circoscrizioni.
Con la prima puntata di questo nostro viaggio, nel quartiere di Arcella a Padova, abbiamo visto come si struttura una comunità di cura in un contesto dove la comunità operosa del capitalismo molecolare del Nord Est genera lavoro e garantisce ricchezza al territorio. Con Torino e Barriera di Milano invece ci inoltriamo nella company town che cerca di darsi un futuro sulle ceneri del fordismo. Sullo storico asse Torino-Ivrea abbiamo visto due diverse declinazioni del fordismo: quello hard di Valletta che ha generato situazioni di concentrazione abitativa come questa di Barriera di Milano o anche Mirafiori Sud, e quello dolce di Adriano Olivetti, ben documentato dal libro di Carlo Olmo, Patrizia Bonifazi e Luca Lazzarini Le case di Adriano (editore Il Mulino). Olivetti aveva lavorato sul rapporto tra fabbrica e territorio, coinvolgendo i dipendenti nel rapporto con i progettisti grazie ad un Ufficio di Consulenza appositamente predisposto.
Di solito contesti come questo di Barriera di Milano vengono osservati in una prospettiva tutta verticale, nella convinzione che una progettazione dall’alto sia necessaria per affrontare le questioni del territorio. Noi invece abbiamo voluto privilegiare uno sguardo orizzontale, facendo perno sull’esperienza innovativa di associazione Mamre. Come si spiega nell’inchiesta, Mamre evoca la quercia di Abramo di cui racconta la Genesi e sotto la quale si incontrano le diversità. Se guardiamo in prospettiva orizzontale Barriera di Milano, scopriamo che è un territorio che si inoltra sino a Porta Palazzo, quindi a ridosso del centro della città e poi si allunga verso Nord est. La Barriera evoca, sin dal nome, l’idea di un confine. Sono contesti in cui chi fa ricerca si trova a dover cambiare la forma delle domande. La questione non è più quella del “che lavoro fai”, come accadeva nella città fordista, ma “di che genere sei”, da “quale mondo vieni” e soprattutto “quale concezioni del mondo hai”. Tutte domande che nella cultura fordista si annullavano nella visione dell’operaio massa. Chi ha cominciato a capire la necessità di questo cambio di approccio è stato il sociale, come dimostra l’esperienza di Mamre. In questo modo il sociale ha iniziato a contaminare anche alcune rappresentanze, come ad esempio il sindacato.
Non a caso il punto di partenza per questo viaggio è stato rappresentato da un incontro, organizzato dall’associazione con l’attivissima presidente della circoscrizione 6 Carlotta Salerno, e che ha visto attorno al tavolo tanti soggetti che portavano la voce e il punto di vista di esperienze attive in Barriera. Si andava dalla scuola, ai volontari dell’Ecomuseo, dall’associazione di donne immigrate, alle parrocchie e così via. Sotto la quercia di Mamre si sono ritrovati e confrontati tanti tentativi di risposta allo spaesamento dell’abitare e del vivere. È un percorso di elaborazione, fatto sul campo che ha nelle competenze messe a punto da Mamre uno strumento prezioso: una delle due fondatrici, Francesca Vallarino Gancia, ha approfondito competenze in etnopsichiatria, anche con missioni sulle navi dei migranti. È un approccio che affronta le nuove fragilità, sempre più spesso di carattere psicologico, senza cercare risposte in formule benevolmente banalizzanti. Il protagonismo femminile in questo percorso è ulteriormente confermato dall’altra fondatrice, suor Giuliana Galli che garantisce il raccordo con la Fondazione Compagnia di San Paolo. La Fondazione infatti sostiene e sorveglia, come spiega il suo presidente Francesco Profumo in queste pagine, il “laboratorio” di Barriera di Milano. Il nostro viaggio è quindi una fotografia di questa proliferazione di esperienze, grazie alle quali il sociale si mette in mezzo tra i buchi, ben visibili nella struttura urbana, causati dalla ritirata del fordismo. Ed è interessante notare come questo lavoro di costruzione dal basso e di connessione abbia restituito attrattività a Barriera: lo dimostra il nuovo insediamento di un big player come Lavazza.

Tra le storie di ninfe e mostri marini che evocano le due sponde dello stretto di Messina, verrebbe da chiedersi se Ulisse riuscirà ancora a salvarsi dai vortici marini generati da Cariddi aggrappandosi a un albero di fico. Benvenuti a Messina, in Sicilia, la terra del mito, dove la parola salvezza fa rima con bellezza. Almeno, quando ci si riesce. Messina è una città di oltre 230mila abitanti e vista da Forte Petrazza, il parco sociale dove ha sede la Fondazione di comunità di Messina, non sembra affatto la città fantasma descritta dagli americani a seguito dei bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. E nemmeno quella devastata dal terremoto del 1908 che ha visto la città siciliana rialzarsi con fatica in un contesto che vede ancora oggi vivere circa 2mila famiglie nelle baraccopoli, prima in mano a una gestione clientelare di stampo mafioso e che ora sono state trasformate da una rivoluzione dell’abitare.
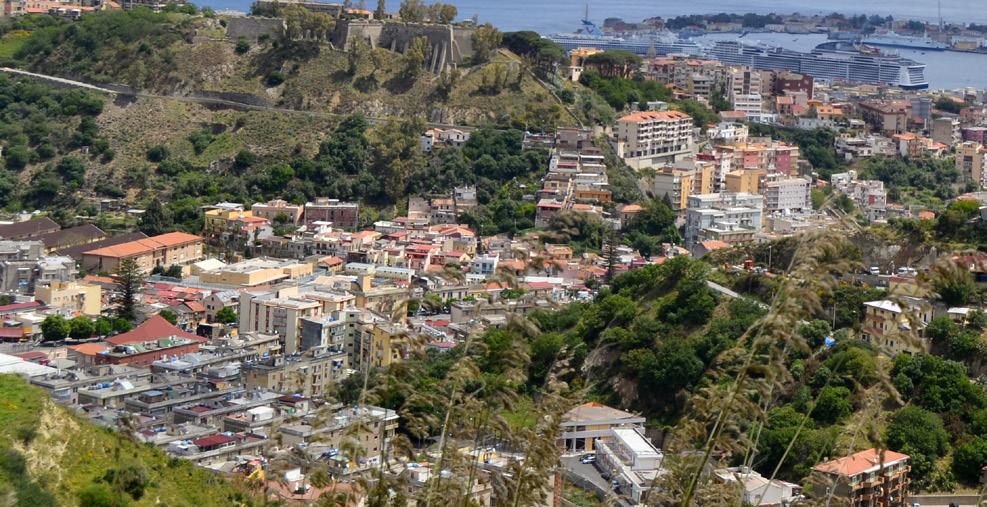
Se Messina geograficamente appare come un serpente che si snoda lungo il mare con alle spalle le
sue montagne torrentizie che sembrano delle roccaforti per conoscerla occorre attrezzarsi come in una vera caccia al tesoro, avendo in mano una chiave magica che possa aprire luoghi isolati, appartati, separati, sconosciuti ai più e fino a ieri inaccessibili perché occupati abusivamente dalla mafia locale o ridotti a discariche a cielo aperto, a cominciare proprio dalla sede di Forte Petrazza, un complesso di 17 roccaforti realizzate dall’arma del genio militare alla fine del diciannovesimo secolo e la cui vista domina indisturbata la stretto di Messina, qui a portata di mano. «Cerchiamo di costruire bellezza», chiosa Gaetano Giunta, 59 anni, segretario generale di Fondazione di comunità di Messina che quelle chiavi le affida alla collettività, a un territorio rigenerato e amato: «Sono un fisico teorico, ma dopo la strage di Capaci il sogno della primavera siciliana ha prevalso, ho rifiutato lavori importanti all’estero per dedicarmi al riscatto della mia terra».
Giunta, nel suo studio ritratto in una foto abbracciato dal magistrato Antonino Caponnetto, decide dopo le grandi stragi di mafia di creare, insieme ad amici che a sua volta avevano lasciato il proprio lavoro, un gruppo di studi socio-economici Ecos-
1. Forte Petrazza: sede della Fondazione di comunità di Messina, negli anni occupato abusivamente dalla mafia locale è ora un parco sociale

2. Birrificio Messina: nella frazione di Larderia gli storici stabilimenti rischiavano di chiudere, ma gli operai hanno salvato la produzione creando una società cooperativa
3. Fondazione Horcynus Orca: nell’estremità più a nord della Sicilia orientale nasce il polo culturale innovativo che ha all’interno il museo di arte contemporanea sul Mediterraneo
4. Progetto Capacity: aree di baraccopoli in passato gestite dalla mafia sono state smantellate e 200 famiglie bisognose vivono oggi in una casa di proprietà
5. Luce e libertà: è uno dei primi progetti della Fondazione di comunità di Messina destinato al reinserimento lavorativo di 60 internati dell’ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto
6. Castello di Mirabella Imbaccari: Nel Catanese un nuovo polo multidisciplinare con la scuola di economia etica e dove nascerà l’archivio delle stragi di mafia

Med. Il think tank vede la luce nel 1998 con l’obiettivo di creare interconnessioni tra realtà imprenditoriali che rivalutano l’economia meridionale, creando una policy di sviluppo umano del territorio, in un’ottica di processo che mira ad accompagnare le persone una ad una.
Da questa esperienza il 21 luglio 2010 nasce la Fondazione di comunità di Messina e insieme il Distretto Sociale Evoluto. Ne fanno parte Ecos-Med, la fondazione Horcynus Orca (centro di ricerca culturale e sulle tecnologie ambientali), il consorzio Sol.E (cooperative sociali impegnate sul versante dell’inclusione al lavoro dei soggetti deboli) e la fondazione antiusura Pino Puglisi, impegnata nella lotta all’usura ma anche sul fronte dello sviluppo economico territoriale. Dal bisogno di sperimentare altre forme di economia che guardano ai beni relazionali si sono aggiunti alleati nazionali e internazionali tra cui Caritas Italiana, Banca Etica e la rete europea del consorzio delle banche etiche Sefea. La Fondazione di Comunità di Messina — Distretto Sociale Evoluto nasce con un patrimonio di
500mila euro, nell’ambito di un programma promosso e finanziato da Fondazione Con il Sud che ha raddoppiato di altri 500mila euro la dotazione iniziale. «Oggi a distanza di nove anni chiuderemo il bilancio con un patrimonio di circa 15 milioni di euro», spiega Giunta.
Dal 2010 la Fondazione ha dato vita a un centinaio di imprese, ha creato, attraverso modalità diverse, circa 400 posti di lavoro, ha rigenerato (come nel caso di Capo Peloro o Forte Petrazza) sei aree territoriali che erano in condizioni di altissimo degrado e ora sono state trasformate in parchi culturali, tecnologici, urbani. Oltre a dare una casa a circa 200 famiglie che prima vivevano nelle baraccopoli grazie a quella che a Messina è stata la più grande opera di redistribuzione della ricchezza dal dopoguerra ad oggi. Attraverso processi personalizzati la Fondazione ha poi seguito il reinserimento sociale e lavorativo i circa un centinaio di persone con un passato di estrema esclusione sociale. «Sessanta provenivano dall’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e altre 40 erano tossicodipendenti, donne in condizioni di fragilità o ex carcerati», aggiunge Giunta.
Gaetano Giunta 59 anni, segretario generale della Fondazione di Comunità di Messina
Più che un progetto di riqualificazione urbana è una rivoluzione dell’abitare. Il progetto Capacity — ideato dalla Fondazione di comunità e con la guida della Presidenza del consiglio dei Ministri - ha permesso a 200 famiglie messinesi che prima erano costrette a vivere nelle baraccopoli di avere una casa di proprietà. Messina dopo essere stata distrutta dal terremoto del 1908, ma soprattutto dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, ha visto il pullulare di vere e proprie bidonville in mano alla criminalità organizzata che decideva chi aveva il diritto di accedere alle case popolari e chi no. La “città fantasma” come veniva battezzata dagli americani sta vivendo grazie a questo intervento una profonda opera di trasformazione e di riqualificazione urbana. «Chi è in cerca di una casa si rivolge a un mediatore sociale che segue i bisogni della famiglia
e una volta scelto il luogo in cui vivere, si dà alle famiglie un capitale personale di capacitazione, un contributo a fondo perduto per permettere di avere una casa propria», spiega l’architetto Giuseppina Sindoni, 53 anni, vice presidente del consiglio della Fondazione di comunità di Messina.
I beneficiari devono tuttavia contribuire seppure in minima parte all’acquisto della casa, e la fondazione attraverso strumenti di microcredito aiuta le famiglie in modo da poter coprire il contributo pari al 25% del costo totale. Uno strumento “accendibile” in base a una convenzione antimafia: chi ha commesso un reato di mafia non può e non potrà avere accesso alla facilitazione. Accanto al progetto Capacity, poi, la fondazione ha già realizzato alcuni prototipi sperimentali per cambiare il volto anche delle baraccopoli grazie a un intervento di edilizia sostenibile.
Iresti del faro romano più grande del Mediterraneo si trovano a due passi dallo Stretto, a Capo Peloro, nella località Torre Faro, zona in passato in mano alle narcomafie e sovrastata da rifiuti di ogni tipo. Nel 2001 quel faro descritto da Strabone è venuto alla luce grazie ai lavori della fondazione Horcynus Orca, uno dei cluster della Fondazione di comunità di Messina, che qui ha trasformato l’ultimo lembo della Sicilia nord orientale, recuperando la bellezza qui ascritta da tempi preistorici. Il nome Horcynus Orca deriva dal titolo del libro di Stefano D’Arrigo che l’ente ha fatto suo restituendo a questo luogo il suo aspetto multidisciplinare creando centri per la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e le arti visive. Un polo culturale che oltre al suo parco archeologico, stupisce soprattutto i più piccoli con un zona “immersiva”, dove toccando con una mano le pareti si
scoprono i pesci abissali che popolano lo Stretto, un museo d’arte contemporanea che ospita un centinaio di opere e un archivio video di 200 artisti provenienti dal Mediterraneo che raccontano le frontiere. Dal muro del pianto fatto di fili di lana rossa, ai pianoforti invasi dalle formiche di Emilio Isgrò per onorare la memoria del compositore messinese Riccardo Casalaina morto nel terremoto del 1908: «Le formiche rappresentano il popolo siciliano spesso calpestato», raccontano Massimo Barilla e Giacomo Farina due delle anime del parco Horcynus Orca. La fondazione negli anni ha lanciato un festival del cinema che oggi è itinerante in tutta Italia ed è strutturato in un Lab festival che ha il compito di mostrare gli esiti delle ricerche, l’Edu festival e il Social Festival portando la cultura nei territori che la fondazione comunità di Messina è in grado di trasformare.

di CARLO BORGOMEO presidente Fondazione con il Sud �
200
La Fondazione comunità di Messina è partita investendo nella creazione di un parco diffuso di energie rinnovabili e coinvolgendo, attraverso bandi pubblici, oltre 200 soggetti tra famiglie, organizzazioni e istituzioni. Grazie ai rendimenti del Parco l’ente ha quindi finanziato i primi programmi sociali, ambientali, culturali e di democrazia partecipativa. «Ogni meccanismo economico della fondazione è pensato nella logica del mutuo vantaggio. La fondazione ha realizzato gli impianti e fornito energia pulita, potendo così incassare il conto energia, l’incentivo statale previsto per 20 anni come premio per aiutare il Paese nel raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. I conti? Noi eroghiamo al territorio circa 250mila euro all’anno di energia e circa il doppio vanno alla fondazione per finanziare i progetti. Per alzare l’asticella abbiamo inoltre chiesto l’adesione ad un grande gruppo d’azione solidale per acquistare prodotti che raccontano storie di responsabilità sociale e ambientale. Ad oggi abbiamo costruito 184 impianti fotovoltaici su tetti di famiglie, scuole e alcuni anche su tetti di beni confiscati alla mafia», spiega Giunta.
circa 100
imprese posti di lavoro aree territoriali trasformate in parchi culturali e sociali famiglie che vivevano in baraccopoli hanno ricevuto una casa persone aiutate nel reinserimento lavorativo
L’obiettivo e è quello di continuare a sperimentare nuovi approcci economici e sociali: «A sopravvivere non sono le specie più forti come sosteneva Darwin, ma chi sviluppa comportamenti relazionali e cooperativi», dice Giunta spiegando che alla base di Fondazione di comunità di Messina c’è un movimento sociale unitario più che una realtà frammentaria fatta di progetti su progetti.
Una logica che si regge su “cluster”, contenitori di soggetti imprenditoriali e non, che operano per una finalità comune condividendo un sistema di sviluppo umano del territorio con caratteristiche compatibili. «Aziende che ad esempio hanno denunciato il pizzo», spiega Giunta. Che aggiunge: «Il nostro modello si pone al di fuori della filantropia tradizionale e da quello delle erogazioni a pioggia».
Attraverso i cluster si genera sviluppo, ma anche bellezza. Ed è attraverso i cluster che si snoda la caccia al tesoro nel distretto sociale di Messina. Che passa dal primissimo progetto speciale chiamato Luce e Libertà perché destinato al recupero sociale e al reinserimento lavorativo di sessanta internati dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, un’esperienza che è stata in parte
Messina è una città difficile, con situazioni di disagio diffuso e con livelli di sperequazione particolarmente gravi. Vaste aree di degrado dal punto di vista urbanistico, ampie sacche di povertà, un contesto politico istituzionale che lascia a desiderare. E poi un simbolo, davvero assurdo, di immobilismo e di impotenza costituito dalle baraccopoli costruite dopo il terremoto del 1908 ed i bombardamenti della seconda guerra mondiale che ospitano ancora quasi 2mila famiglie. Ed ovviamente il peso delle mafie. In questo contesto, quasi dieci anni fa, nasce la Fondazione di comunità di Messina, che non solo per noi della Fondazione Con il Sud, rappresenta una delle espressioni più chiare e convincenti di come sia necessario, anzi indispensabile, rovesciare il paradigma dello sviluppo. Invece di inseguire improbabili grandi progetti capaci di portare crescita ed occupazione nella scia di una politica pigra, clientelare e spesso corruttiva, invece di chiacchierare in astratto di trasferimenti di progetti e risorse dall’esterno, invece di esaurire la funzione politica nella lamentela e nella denuncia, si fa un’operazione opposta; appunto, si rovescia il paradigma. Si parte dalle “pietre di scarto”, in particolare dai detenuti dell’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto, per costruire interventi di solidarietà e di sviluppo. La Fondazione di Comunità di Messina è oggi una realtà forte, prestigiosa, innovativa anche a livello internazionale, con interventi efficaci, innovativi ed autosostenibili nei servizi alla persona, in particolare bambini; in iniziative di housing sociale; in sperimentazioni (non convegni!) di finanza etica; di economia civile.
Ma guardando alle tante iniziative che ha messo in campo non è sufficiente meravigliarsi e stupirsi per i grandi risultati raggiunti. Bisogna chiedersi quale altro tipo di intervento avrebbe avuto gli stessi risultati in una realtà come Messina. E bisogna convincersi che, affermare che il capitale sociale è la premessa dello sviluppo, non è un sogno, un auspicio o uno slogan: deve diventare una politica.
Birrificio dello Stretto. I 15 operai diventati imprenditori che si sono bevuti la crisi
AMessina la birra è una tradizione. E quando Domenico Correnti, 60 anni (in foto), apre le porte degli stabilimenti del birrificio dello Stretto nella frazione di Larderia, si capisce subito il perché: «Facciamo la birra da tre generazioni e ora si sta per avvicinare anche la quarta: mio nonno Mimmo faceva la birra, mio padre Giuseppe pure e ora si è unito anche mio figlio. Perdere una produzione di birra a Messina che in 100 anni ha dato da vivere a tante famiglie sarebbe stato un peccato».

La storia del birrificio dello Stretto è legata a quella dei suoi 15 operai diventati imprenditori. Sono stati loro grazie all’intervento di Fondazione di comunità di Messina a salvare i vecchi stabilimenti della birra Messina nati nel 1915 e che, dopo vari passaggi, rischiavano di chiudere definitivamente nel 2011. «Ci abbiamo creduto, eravamo rima-
sti disoccupati ed eravamo tutti disperati. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo fondato una società cooperativa per salvare ciò che sentivamo profondamente nostro», spiega Correnti, presidente di Birrificio Messina società cooperativa. Che aggiunge: «Quando inizialmente andavamo nelle banche ci chiedevano chi eravamo, grazie alla Fondazione di comunità di Messina abbiamo creato un piano finanziario e attratto l’interesse degli investitori».
Dal giorno della presentazione ad Expo 2015 il birrificio dello Stretto è ormai una realtà con una produzione che da 50mila elettroliti l’anno tocca oggi i 70mila.
«Abbiamo dieci serbatoi e abbiamo fatto un investimento per averne altri sette. Curiamo ogni singola fase, dall’inizio alla fine del processo, dall’orzo di malto fino all’imbottigliamento, ma non andiamo a pastorizzare per-
ché altrimenti la birra perde parte del suo profumo e aroma».
Le birre prodotte dai 15 operai che hanno salvato la storia della birra a Messina sono: la doc 15, la birra dello stretto, la doc 15 cruda, la birra dello stretto premium, mentre a breve sarà in commercio la birra dello stretto non filtrata: «Ogni birra qui ha la sua ricetta», aggiunge Correnti.
E da quest’anno in partnership con Heineken il birrificio dello Stretto ha cominciato la produzione della birra Messina cristalli di sale: «Sta andando molto bene, l’accordo prevede che Heineken dovrà distribuire la nostra birra nei suoi canali. In questo modo sbarcheremo sui mercati nazionali della distribuzione». Un bel salto in avanti
Il prossimo passo del birrificio dello Stretto sarà quindi quello di ampliare la produzione, assumendo giovani, in un’ottica di continuità con quella tradizione avviata dai nonni mastri birrai.
raccontata nel film Primula Rossa del regista Franco Jannuzzi prodotto in collaborazione proprio con Fondazione di comunità di Messina. La storia del protagonista del film coincide proprio con uno dei sessanta destinatari del progetto.
Nonostante le attività si affaccino anche nel resto d’Italia e abbraccino l’intera Sicilia, come nel caso di Palazzo Biscari a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, che oggi ospita la scuola euro-mediterranea di economia etica e dove verrà creato il primo grande archivio sulle stragi di mafia, la fondazione ha da sempre avuto una forte vocazione territoriale. È andata così a caccia di luoghi simbolici, appartenenti alla storia e al mito e che ora sono letteralmente rinati, come è accaduto nella frazione Torre Faro, a Capo Peloro, la punta estrema a nord della Sicilia che per moltissimi
anni è stata una discarica abusiva a cielo aperto e zona di spaccio di eroina in mano alle narcomafie. Qui l’ente guidato da Giunta è intervenuto supportando la fondazione Horcynus Orca trasformando e rigenerando quell’edificio diroccato che si affaccia sullo stretto in un parco culturale multidisciplinare. Si è scoperto così, attraverso il coinvolgimento di enti pubblici come l’università di Messina e il Consiglio nazionale delle Ricerche che in quel sito, addossati da rifiuti di ogni tipo, c’erano i resti del faro romano più importante del Mediterraneo, tanto da essere inciso sulle monete dell’epoca in mezzo ai mostri marini Scilla e Cariddi. Oggi la fondazione Horcynus Orca a Capo Peloro vanta numerose attività: da un festival del cinema itinerante con tappe in tutta Italia, ai laboratori sociali, educativi e divulgativi, alla presenza di un raffinato museo d’arte contemporanea.

Nonostante la Fondazione comunità di Messina abbia una vocazione laica, la presenza organica della Chiesa e della Diocesi di Messina è un punto di forza in un processo di crescita sociale del territorio. A far parte del comitato dei garanti della fondazione è il vescovo ausiliario di Messina, monsignor Cesare Di Pietro, prima rettore del seminario arcivescovile.
Il vescovo segue da vicino le iniziative della fondazione come nel caso del progetto Capacity che sta permettendo a numerose famiglie di lasciare il contesto di degrado delle baraccopoli per abitare in una casa che spesso diventa di proprietà:«Il risanamento edilizio interpella la comunità cristiana, il tema della casa non è secondario in ordine alla dignità umana, alla dignità delle famiglie e alle capacità di produrre un lavoro».
Le attività della Fondazione di comunità di Messina hanno rivoluzionato il modo dell’abitare, sconfiggendo una logica di tipo clientelare spesso dettata dal malaffare nell’assegnazione delle case. Come collocare questa emergenza abitativa?
L’emergenza abitativa è data dal fatto che nonostante siano trascorsi decenni permangono sacche di baraccopoli con famiglie che vivono in condizioni subumane. Il risanamento edilizio che si è verificato per rispondere a delle leggi regio-
nali promulgate anni fa si è realizzato a macchia di leopardo e non in maniera sistematica e diffusiva per cui si è generata una subcultura della baracca in cui si è annidata una mentalità di delinquenza e connivenza. Nel momento in cui venivano abbattute delle baracche ne sorgevano subito altre, il progetto Capacity mira a offrire soluzioni abitative a queste famiglie disagiate su un piano organico e sistematico.
La Fondazione e la diocesi di Messina sono impegnate in un univoco piano di sviluppo del territorio?
La gratuità dei gesti è frutto di una libertà interiore di chi si dona, e non sono pagati da un corrispettivo o da un interesse secondario. Le nostre attività si snodano su più fronti, come Caritas diocesana cerchiamo di trasmettere il pensiero cristiano, negli oratori facendo giocare i ragazzi, nelle attività di volontariato all’interno delle famiglie. L’azione della chiesa messinese a promuovere lo sviluppo dell’uomo, come nel recupero dei minori a rischio, magari usciti dal carcere minorile, che a volte vengono assegnati alla rete di case d’accoglienza della Caritas dislocate in più zone. A Giampilieri abbiamo una casa per ragazze madri e a Messina altre strutture per accogliere i senzatetto. Le nostre attività sono supportate anche dall’associazione Santa Maria della Strada legata alla Caritas diocesana.
Messina è stato anche uno dei porti italiani più interessato in questi ultimi anni al fenomeno degli sbarchi. Come ha risposto la città?
Noi ci siamo spesi mettendo a disposizione le nostre strutture, dal seminario estivo a Santa Lucia del Mela, a una bella villa ristrutturata a Castanea, una zona di campagna a 15 minuti dal centro, e abbiamo fatto aprire anche un castello, il Castello di Federico II, un luogo storico di Messina: così siamo riusciti ad accogliere centinaia e centinaia di migranti che sono approdati nelle nostre coste.
In quasi dieci anni di attività la Fondazione ha anche restituito il sorriso a chi, ad esempio, aveva perso il lavoro?
Gli operai dell’ex birrificio Messina sono degli eroi, un simbolo di riscatto sociale del territorio. Attraverso l’aiuto sostanziale della Fondazione questi operai si sono sollevati e hanno deciso di riprendere quell’azienda che invece l’imprenditore storico aveva deciso di vendere. Oggi producono un prodotto di eccellenza esportato in tutto il mondo. Una speranza che nasce da una logica che deve presiedere in tutto ciò che noi facciamo, noi dobbiamo promuovere il lavoro perché il lavoro è fonte di riscatto sociale. Non basta soltanto tamponare con qualche azione caritativa che dia un po’ di sollievo al bisogno, ma bisogna costruire un futuro per dare un’opportunità alle famiglie.
Il racconto del modello della Fondazione di Comunità di Messina ci mette davanti all’ipotesi di un altro modello di sviluppo: come dice giustamente Carlo Borgomeo siamo davanti ad un rovesciamento di paradigma in quanto questo modello parte dalla pietra di scarto. Questa è un’esperienza che interroga e mette in discussione sia il meccanismo di sviluppo che quello fondazionale. Iniziamo dal primo. Il modello che ha dominato dal Dopoguerra è stato quello dell’intervento dall’alto, facendo piovere sui territori un’offerta che prescindeva completamente dalla domanda. Non a caso si parlava di “interventi straordinari” che si muovevano nell’ottica di esportare a Sud i modelli di sviluppo tipicamente fordista, fondato sull’industrializzazione. E non sono stati calati dall’alto solo i progetti imprenditoriali ma anche le reti di rappresentanza che avrebbero dovuto regolare i rapporti sociali. Tutto questo ha prodotto una retorica, alla quale a chi stava in basso non è restato che adeguarsi, ponendosi quasi esclusivamente nell’atteggiamento del “chiedere”. Questo modello è ampiamente fallito ed è rimasto senza alternative.
Ora, l’esperienza messinese disegna quale potrebbe essere un’alternativa. Come detto, il paradigma è stato rovesciato, e si è impostato un modello di sviluppo anche economico che parte dall’organizzazione della domanda, cioè proprio da quella pietra di scarto che sono le questioni sociali. L’assunto è che la mobilitazione dei processi sociali genera processi economici, e non viceversa. Gli esiti dell’esperienza messinese confermano che l’assunto è assolutamente affidabile e il sociale può essere traino di un processo di sviluppo a 360 gradi.
Per questo siamo di fronte anche ad un rovesciamento del meccanismo “fondazionale” classico che si regge su una visione caritatevole, che davanti ai bisogni prevede solo flussi di denaro dall’alto. Ora invece la dinamica è opposta: si parte dai bisogni degli ultimi per generare non solo risposte ma anche dinamismi economici allargati. Nel racconto di queste pagine emerge molto bene questa novità, dove, la mobilitazione intelligente della “comunità della cura” locale conferma come il sociale sappia anche innescare una mobilitazione che coinvolge anche la “comunità operosa”, in una dinamica di sviluppo che riguarda tutti. In questo senso sottolineavo che l’esperienza messinese dimostra la capacità del sociale di allargarsi e di coinvolgere tutti gli altri soggetti. C’è qualcosa di sorprendente in tutto questo, perché sono dinamiche che non ci si aspetta; sono risposte alle emergenze che superano la logica emergenziale. Uno dei segreti sta nel fatto che il processo di elaborazione è partito da una check su saperi e competenze, realizzato attraverso un think tank, per creare interconnessioni con le attività imprenditoriali in grado di rivitalizzare il territorio. In questo modo si conferma che il sociale certamente lo “si abita”, ma anche lo “si pensa”.
Il risultato è che la comunità di cura si è dimostrata capace di interagire e di progettare, in una prospettiva di orizzontalità operosa che coinvolge tutto il territorio, generando dinamiche nuove e mettendo tutti al lavoro, superando il vecchio meccanismo dell’attesa. Le pratiche raccontate in queste pagine sono in molti casi pratiche che non ci si aspetta, come il progetto Luce e Libertà, emblematico sin dal nome perché indica come il sociale voglia vedere la luce e farsi centro delle dinamiche di sviluppo. Così il progetto Capacity, grazie al quale è stato smantellato un ghetto trovando casa a 200 nuclei familiari, si pone come risposta al modello devastante e conflittuale dei ghetti stile Rosarno. È un processo che mette al lavoro anche la creatività, sia in senso culturale che imprenditoriale, come dimostra il caso di successo del birrificio dello Stretto.
In sintesi, siamo di fronte ad un modello di “distretto sociale evoluto”, che supera anche la vecchia filosofia dei distretti che si era tentato di esportare attraverso la pratica dei patti territoriali: l’economia non basta se non allarga non solo alla cultura ma anche a questa mobilitazione che parte dalle “pietre di scarto”. L’aver generato uno sviluppatore di competenze come è la scuola di economia civile di Catania, è la dimostrazione di quanto sia strutturata l’idea e il modello che ne sta nascendo.

ISassi di Matera visti da lontano somigliano molto ad un alveare. Ogni alveare ruota intorno ad una regina, il motore che crea la colonia. Poi grazie all’emulazione ogni membro, guardando i suoi pari, sa il suo ruolo e il suo posto nella comunità. Ognuno ha la propria occupazione che si interseca e amalgama con le altre mansioni e concorre al bene comune. Anche qui a Matera c’è stato questo motore ed è il Consorzio cooperativo La Città Essenziale. Composto da 25 cooperative sociali che occupano oltre 900 persone per un fatturato aggregato di oltre 23 milioni di euro generati da 30 tipologie diverse di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo. Grazie all’esperienza consolidata di cooperative storicamente radicate nel terri-
torio come Vita Nuova, Collettivo Colobrarese, CS, L’Abbraccio, Il Giardino di Alice, La Formica, Prato Verde, la rete consortile è il punto di riferimento del welfare generativo lucano. Un esempio che ha aperto, anche e soprattutto culturalmente, nuove strade e nuove prospettive. La Capitale europea della Cultura 2019 è stata la ciliegina sulla torta. Il riconoscimento per la rinascita dell’alveare passata attraverso la comunità operosa e il fare rete. La Città Essenziale, infatti vanta oltre 150 stakeholder fra enti pubblici, organizzazioni non profit e società profit. «Tutto quello che è stato costruito in questi anni era già qui sotto forma di humus favorevole su cui il nostro impegno ha attecchito», racconta il presidente Giuseppe Bruno, «lavoro, servizi, progetti, welfare. Tutto era già sul territorio seppur polverizzato e

un po’ seduto. C’era bisogno di trovare nuove energie e nuovo entusiasmo e indicare strade concrete».
Il Consorzio è partito dall’esistente creando nuove dinamiche, capitalizzando le energie presenti, offrendo visione e prospettiva, e quindi stimolando di fatto un cambio di paradigma culturale.
La sorpresa è stata la compatibilità naturale tra il dna materano e l’imprenditorialità cooperativa che innescati dall’occasione dell’assegnazione della Capitale culturale hanno riacceso la città. «La vita della comunità dei “Sassi” si è storicamente sviluppata intorno a luoghi chiamati “vicinati”», spiega Bruno, «piccole piazze deputate alla vita comunitaria, dove prendeva corpo la relazione operosa delle famiglie. Passato e presente qui si fondono e la stratificazione dei tempi è patrimonio identitario. In questa era di grande trasformazione, di accelerazione digitale, dove le nuove generazioni faticano a inserirsi nel mondo del lavoro, era necessario ricomporre le fratture per innovare praticando un’azione di riconnessione diffusa». Tutto questo si sposa perfettamente nella consistenza imprenditoriale della cooperazione sociale che per Bruno «risiede nella mutualità delle relazioni, nella capacità di scambiare competenze ed energie, nell’attitudine alla gestione efficiente ed efficace delle risorse». A Matera la cooperazione è diventata il nuovo “vicinato”: è diventata il legante sociale che connette le varie anime del territorio. Ma ha anche significato un futuro possibile al di là del 2019. Se infatti i riflettori si spegneranno finita la kermesse la rete, l’alveare, rimarrà.
«Sin da prima della candidatura alla competizione internazionale avevamo chiaro che la carta vincente sarebbe stata l’immaginare Matera come un organismo unitario», racconta Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019, il veicolo scelto per costruire il programma della manifestazione. «Il coinvolgimento di tutti gli stakeholder del territorio e dei cittadini è stato il leit motiv di tutto il nostro impegno. Questa era l’unica via possibile perché questo evento potesse innescare un circuito virtuoso di ampio respiro», sottolinea Adduce, «ecco perché il titolo scelto è stato “Open Future”. L’oggi come trampolino verso il domani. L’obiettivo è stato quello di cambiare il destino di una comunità attraverso le proprie energie messe a fattor comune».

«Un’esperienza che ci lascia in dote un modello di economia sociale e culturale diffusa», aggiunge invece l’assessore alla Salute e Politiche sociali della Regione Basilicata, Rocco Leone. «Un modello fondato sulla consapevolezza che la cultura c’entra con ogni ambito ed è un fattore competitivo di sviluppo. La cultura non è solo musei e turismo. È un modo nuovo di guardare ad ogni settore economico e sociale, dai servizi al welfare, dall’impresa alla pubblica amministrazione».
Ne è un esempio il Cluster Cultura Basilicata Creativa che aggrega tre organismi di ricerca (Università della Basilicata, Consiglio Nazionale delle Ricerche ed Enea) e oltre 50 imprese del settore culturale e creativo. È uno dei cinque distretti ufficiali del-
Uno degli eventi che ha anticipato Matera Capitale. Un gioco di comunità in piazza per co-costruire il futuro

la Regione su cui l’Unione Europea investe 14 milioni di euro. «Il portafoglio di cui siamo dotati è un contributo di gestione triennale di 200mila euro e un finanziamento di 4,5 milioni di euro per il progetto Basilicata Heritage Smart Lab, il più grande laboratorio italiano di sperimentazione delle nuove tecnologie applicate al rilievo, recupero, fruizione e comunicazione dei beni culturali», sottolinea il presidente Raffaelle Vitulli, «prima della Capitale era inimmaginabile che la Regione potesse ritenere questo settore strategico. Grazie alla collaborazione tra la ricerca e le imprese l’impatto degli investimenti, in particolare delle imprese sociali, è esponenziale. Stare insieme aiuta a pensare in maniera sinergica. Lavoriamo su oltre trenta siti pilota, da aree archeologiche a ex monasteri fino a centri di piccoli comuni, dove le esperienze di ricercatori, imprenditori, creativi, artisti e professionisti generano nuovi modelli di innovazione».
I confini però sono porosi e le iniziative sul territorio si contaminano gemmando nuove proposte. Il progetto “Idea19 - Creative Hub”, costruito da La Città Essenziale come ente promotore (insieme a Fondazione Sassi di Matera, Cofidi e Confcooperative Basilicata) sta già costruendo alcuni protocolli d’intesa con Cluster Cultura e Fondazione Basilicata-Matera 2019. È un incubatore culturale nel distretto socio-economico lucano che investirà e sosterrà le attività imprenditoriali e associative di giovani under 40, con particolare attenzione alle donne, volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla parallela attrazione di risorse di natura filantropica e di illuminati investitori privati. Pubblico e sociale insomma hanno preso posto nell’alveare materano. Ma ci sono anche le imprese. Che non solo fanno la loro parte ma che hanno cominciato a cooperare con il resto del sistema. Fattorie Donna Giulia, nata nel 2003, è la centrale del latte della Basilicata con una rete di distribuzione su 115 comuni della Basilicata e ulteriori 90 nelle
Le energie di una comunità messe a fattor comune


Coop nata nel 2006 dall’incontro di diverse professionalità ed esperienze formative, si occupa di progettazione e gestione di interventi di assistenza agli anziani e ai minori, accoglienza dei migranti e inserimento lavorativo di persone svantaggiate. «Siamo project leader di Matera 2019. Un’opportunità che ci ha permesso di intercettare altre realtà culturali del territorio con cui abbiamo fatto rete», sottolinea il presidente Michele Plati. In particolare, da un’idea di impresa del consorzio La Città Essenziale (pionieristica dell’ormai diffuso modello profit-non profit), è nato Panecotto Ethical Bistrot. «Un ristorante che ha l’ambizione di promuovere e sostenere la territorialità delle risorse valorizzando la tradizione dei luoghi sotto tre aspetti: l’enogastronomia, l’artigianato artistico e l’esperienza turistica», chiarisce Plati, «È un modello imprenditoriale che prevede l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati e il reperimento di nuove risorse economiche da investire su azioni di welfare. Oggi occupiamo, oltre ad un ragazzo che supervisiona il lavoro, 3 migranti e un disabile. Ma l’idea è quella di un franchising etico, che possa quindi essere replicato».

La cooperativa Sociale Oltre l’Arte, fondata nel luglio del 2007 nell’ambito del Progetto Policoro, un percorso di rete promosso dalla Cei, è nata dal desiderio di alcuni giovani di crearsi opportunità di lavoro nel proprio territorio. «L’idea è mettere insieme più soggetti che aiutino i ragazzi a mettere a sistema i propri talenti e competenze con le risorse del territorio», sottolinea la presidente Rosangela Maino. La valorizzazione del patrimonio culturale materano passa dalla gestione delle quattro chiese rupestri, della Basilica Cattedrale della città, il Museo Diocesano, e il Vicinato a Pozzo di Rione Malve con visite guidate professionali «ma va oltre, immaginando nuovi modi di vivere il turismo culturale, come la bellezza narrata, cioè uno storytelling teatrale in cui ricreiamo e rappresentiamo la storia con degli attori», chiarisce Maino. Nuove forme di immaginare l’esperienza turistica innovative e che funzionano. «Abbiano iniziato in 7 soci, l’anno scorso avevamo 30 dipendenti, oggi sono 57, di cui 10 persone con disabilità. Il fatturato 2018 è stato di 700mila euro. Sul 2019 questa cifra dovrebbe raddoppiare», conclude la presidente.
regioni limitrofe. Cosa differenzia Fattoria Donna Giulia dalle tante altre srl del settore caseario italiano? «Abbiamo sempre pensato che il termine competere fosse da interpretare come procedere assieme. Così fin dall’inizio siamo nati con l’impegno di non redistribuire mai gli utili tra i soci ma reinvestire tutto nel nostro territorio», spiega Paola Saraceno, socio fondatore e responsabile marketing. Il motivo è una consapevolezza forte: «Il sud è il massimo produttore di materie prime italiano, dal grano al vino fino all’ortofrutta. Ma ci siamo sempre fermati a questo. Non abbiamo mai pensato di trasformare direttamente qui i nostri prodotti. Una mancanza di ambizione che è strettamente legata alla crisi del senso di appartenenza». Così per provare a ricostruire questa identità dimenticata Fattorie Donna Giulia esce dalle mura dello stabilimento. «Siamo attivi in tantissimi territori e Comuni, in Basilicata ma anche nelle altre regioni del sud, dove sosteniamo quello che è il collante sociale specifico di ogni luogo».
Come per la Festa patronale della Madonna della Bruna che «qui a Matera è il momento più importante», spiega Valeria Piscopiello, coordinatrice didattica per la cooperativa sociale Il Puzzle, «un vero collante identitario e di fede per l’intera comunità». Grazie all’iniziativa della scuola L’Albero Azzurro, sostenuta anche dalla centrale del latte, è nata e si è consolidata negli anni quella che è diventata un evento tradizionale attesissimo da bambini e famiglie, la Bruna dei Piccoli. Una conferma dell’attenzione posta dal Consorzio al benessere dell’infanzia e dell’adolescenza, quotidianamente espresse anche dalle altre realtà dell’area educativa: Giocooperativa, Divertimente, Spes Nostra, Anthos, Pippo’s House.
Datacontact invece è «una srl che si occupa di comunicazione», racconta la presidente Laura Tosto, «siamo nati nel 2001 e a Matera occupiamo, tra dipendenti e collaboratori, 900 persone». Da sempre attenta al welfare aziendale, «abbiamo sviluppato politiche di attenzione alle risorse interne in partnership con le eccellenze associative e sociali di Matera, in particolar modo con il consorzio cooperativo La Città Essenziale».
Bonus in busta paga per matrimoni e nascite dei figli, centri estivi, doposcuola, bike sharing elettrico interno e smart working. «L’entusiasmo portato da Matera 2019 ci ha fatto fare un salto di qualità: oggi proponiamo ai dipendenti anche tipologie di attività totalmente nuove, fortemente culturali, come ad esempio la partecipazione attiva agli eventi organizzati da Fondazione Matera 2019. Nel Consorzio La Città Essenziale, ogni proposta viene coprogettata con le realtà locali. Se Tutto questo esisteva già prima della Capitale, grazie a questa occasione si è potuto fare un salto culturale a partire da una diversa consapevolezza: finché non si superano gli steccati tra scienza, sociale, impresa, territori, politica e non si lavora all’unisono non si possono raggiungere obiettivi a lungo termine e sostenibili».

Tre giorni di incontri, workshop e percorsi guidati, tra arte e musica. È la convention Cgm che si terrà a Matera, in occasione della Capitale Europea della Cultura, dal 29 al 31 ottobre. Giunto nel 2019 alla sua XIV edizione, è l’evento con cui il Gruppo Cooperativo Gino Mattarelli riunisce le oltre 700 cooperative e imprese sociali aderenti, organizzate in 58 gruppi territoriali con quasi 50mila lavoratori occupati. «La scelta di Matera per l’evento, che quest’anno si intitola Sharing Future», spiega il presidente nazionale Giuseppe Bruno, «è stata fatta perché la città rappresenta la capacità trasformativa della cooperazione sociale che innova tenendo insieme, ricomponendo e connettendo. In questa era di competenze e relazioni “liquide”, di accelerazione digitale, dove le nuove generazioni faticano a trovare opportunità lavorative e di espressione, Matera è il simbolo di come l’economia sociale contenga in sé il naturale legame fra valori e sviluppo. Che da sempre genera ricchezza con una visione aperta alla modernità, di cui il mondo della cooperazione è l’espressione più vivida, concreta ed efficace».

Sono 24 (più una in arrivo) le cooperative sociali aderenti al consorzio cooperativo La Città Essenziale (socio di Cgm). Occupano 900 persone con un fatturato aggregato di oltre 23 milioni di euro ed erogano 30 tipologie diverse di servizi: socio assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo.
Aliante Anthos Ass.ne L’Albero Azzurro Benessere Cambiamenti
Cerchio Aperto Collettivo Colobrarese CS Cooperazione e Solidarietà
Divertimente Fratello Sole Giocooperativa Il giardino di Alice
Il Puzzle
Il Sicomoro L’albero Azzurro soc. coop. La Commenda La Formica L’Abbraccio Mest Oltre L’Arte Pippo’s House Prato Verde Spes Nostra Vita Nuova
Calabrese di Isola Capo Rizzuto, 63 anni, a lungo parroco nella periferia di Crotone, a Matera da tre anni e mezzo. È questo l’identikit di monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, vescovo della città. Caiazzo è stata uno dei motori più attivi nel costruire ponti tra le tante anime del tessuto sociale ed economico materano. Poco prima dell’evento l’amministrazione comunale era andata in crisi e si profilava il rischio del commissariamento.
«In quei giorni sentii il bisogno di scrivere una lettera a tutte le istituzioni pubbliche e civili della città invitandole a riunirsi intorno ad un tavolo per trovare quelle soluzioni necessarie per non perdere l’opportunità di Matera 2019. Un gesto che feci con molta timidezza, ma che fu raccolto con grande entusiasmo», sottolinea il monsignore.
Lei è indicato come un vescovo illuminato, in particolare perché ha aperto porte e finestre della sua diocesi. È vero?
Non credo di avere meriti particolari. L’esperienza di tanti anni da parroco di periferia accanto ai lavoratori e ai giovani e a stretto contatto con il disagio e la sofferenza mi ha formato. Quando sono venuto qui ho capito che avrei continuato a fare il parroco, anche da vescovo. Come ha detto una volta Papa Francesco dobbiamo essere pastori che odorano delle proprie pecore.
Come ha contribuito la sua diocesi al percorso di

oltre cento ospiti. Con la Caritas poi facciamo corsi di formazione per l’inserimento lavorativo. Abbiamo infine anche realizzato cinque mini appartamenti che sono gestiti come bed and breakfast da giovani. E poi c’è la collaborazione con l’Università Cattolica di Milano
Matera Capitale europea della Cultura?
Il mio predecessore aveva intuito che in vista di questo appuntamento la Chiesa dovesse elaborare e presentare un programma. Proposito che ho fatto mio appena arrivato. Ne è nata una proposta articolata in 110 iniziative diffuse su tutto il territorio della Diocesi. Le abbiamo chiamate “i cammini”, cioè strade per mettere a disposizione della collettività tutte quelle che sono le ricchezze della Chiesa. Un modo per mettere in moto tanti giovani e riscoprire radici e bellezze dimenticate.
Nel concreto queste iniziative in cosa consistono? È nato il Parco Culturale Ecclesiale, cofinanziato dalla Cei con 100mila euro, che ha portato qui tanti eventi culturali e artistici. Abbiamo promosso il progetto Policoro, che attraverso corsi di formazione stimola la nascita di cooperative per creare posti di lavoro. Così sono nate le cooperative Oltre l’Arte e Il Sicomoro. Ho sentito poi l’urgenza di aiutare ulteriormente i giovani affidando a queste loro cooperative oltre alle chiese rupestri, la cattedrale, il museo e anche una casa per anziani con
Un asse Matera — Milano. Con quale obiettivo?
Due anni fa sono andato a parlare con i responsabili dell’ateneo meneghino chiedendo loro qualcosa che al momento sembrava utopistico: aiutarmi affinché i nostri giovani che vanno via per studiare possano un domani tornare qui in Basilicata per poter dare il proprio contributo. Per farlo chiedevo un contributo concreto sia di formazione sia di progetti. Oggi abbiamo incominciato a incontrare i giovani studenti delle nostre scuole, sono stati immaginati i primi progetti formativi che hanno coinvolto un centinaio di ragazzini e per la prima volta la Cattolica ha tenuto uno dei suoi seminari fuori dalle proprie sedi, venendo qui a Matera.
Non è così consueto che la Chiesa condivida il suo patrimonio. Com’è nata questa scelta?
Le differenze di fronte al bene comune devono venire meno. Era necessario mettere insieme le forze per riuscire a costruire questo riscatto. Di fronte a questa consapevolezza collaborare con tutte le realtà del territorio e mettersi in rete è stato doveroso. E poi come dice il grande Totò “da cosa nasce cosa”.
Mons.
Caiazzo: «Con l’Università Cattolica progetti formativi proposti qui in città»

Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, avvocato eletto con una lista civica nel 2015, classe 1935, oltre che la memoria storica della città, è l’anima del movimento civico che ha voluto “salvare” i Sassi dalla condanna all’oblio causata dalle parole di Palmiro Togliatti prima (“vergogna nazionale”) e dallo sgombero imposto dell’allora primo ministro Alcide de Gasperi poi.
Quando ha deciso di portare Matera a diventare Capitale europea della cultura era consapevole che sarebbe stata una svolta per la città e per l’intera regione?
La candidatura di Matera a Capitale europea della cultura è la tappa più recente del processo di rinascita della città che è stato avviato negli anni ’50 puntando al recupero dell’identità e alla trasformazione della rassegnazione in protagonismo. A Matera è avvenuto uno scandalo: la questione culturale è diventata una questione politica, nel senso più alto del termine, e cioè dell’adesione e del protagonismo dei cittadini nel determinare il destino della polis. L’idea di candidare Matera a Capitale europea della cultura è venuta da un gruppo di ragazzi materani, non da un sindaco o da un presidente di Regione. Sono stati questi giovani, nel 2007, a proporre al sindaco di candidare la città a rappresentare l’Italia come capitale europea della cultura nel 2019. Il percorso è stato portato avanti dai sindaci e ha raccolto l’adesione convinta dei materani.
Il tema delle reti, di cittadini e di realtà del territorio, si sta rivelando la carta vincente per far cambiare marcia a Matera. Gli attori erano già sul territorio. Cosa è cambiato e li ha fatti mettere in relazione?
È cambiata la consapevolezza di vivere in un luogo unico ed universale e di appartenere ad una comunità che vive ininterrottamente su questo territorio da oltre 8mila anni. L’energia sociale che questa città sprigiona è l’elemento che ha impressionato i commissari europei che, quando hanno dovuto scegliere tra una città in movimento e protesa nel raggiungimento di obiettivi di crescita e altre che invece erano sedute sull’acquisita aristocrazia urbana, non hanno avuto dubbi.
Una volta che si spegneranno i riflettori della capitale della cultura cosa resterà a Matera?
I materani, oggi, vivono il presente come anticipazione del futuro e non come semplice continuità del passato. La fiducia e la voglia di costruire il futuro di questa città
è l’eredità sociale del 2019: i cittadini si sono trasformati in abitanti culturali e sono partecipi del patrimonio di storia che custodiscono e che hanno trasformato nel capitale determinante per lo sviluppo. Il nostro ruolo è stato quello di indirizzare questa energia e di coniugare identità e tecnica, autenticità e innovazione. Abbiamo dato vita ad un Hub tecnologico in cui si insedieranno a breve tredici imprese dell’hi-tech oltre che il Cnr che porterà a Matera il polo della ricerca quantistica applicata alla sicurezza informatica e la rete di infrastrutture digitali al servizio della conservazione del patrimonio culturale. A questo si aggiungerà la Casa delle tecnologie emergenti, il progetto voluto dal Mise e che a Matera si occuperà della tecnologia applicata al settore cinematografico. C’è poi il Parco della storia dell’Uomo che vedrà la luce nel 2020 e che comprende quattro sezioni: Preistoria, Civiltà rupestre, Civiltà contadina e Città dello Spazio. Attraverso i luoghi della città viva più antica del mondo, si può raccontare la storia dell’uomo dai buchi neri di una grotta preistorica ai buchi neri dello spazio. Il primo tassello del parco, il Vicinato a Pozzo, è già fruibile e racconta la Matera laboratorio degli anni 50 attraverso le testimonianze tra gli altri, di Adriano Olivetti e di Carlo Levi, due uomini che hanno studiato, compreso e amato Matera.
Qual è l’orizzonte con cui il Comune insieme a tutti gli attori del mondo produttivo e sociale materano stanno lavorando?
Superare la monocultura del turismo per creare opportunità di lavoro e di sviluppo. Matera ha l’ambizione di diventare il modello di un Mezzogiorno vincente che supera i fatalismi e si proietta nel futuro in competizione con gli altri territori ma con le proprie peculiarità.
È questo distretto sociale popolato da una comunità operosa il vero lascito di questa esperienza?
Sicuramente sì. La comunità è il fulcro della vita di una città e la comunità materana è sempre riuscita a creare nuova storia. In questi luoghi Olivetti ha trovato terreno fertile per sperimentare la sua città dell’uomo che ha trasportato nel progetto del Borgo rurale di La Martella. Il concetto di comunità è un marcatore identitario incancellabile del Dna dei materani ed è il suo tratto distintivo che oggi torna a risultare vincente in un’epoca in cui l’omologazione spinta del globalismo sta determinando crisi di rigetto.
CAome Matera deve guardare al suo futuro, una volta finito l’anno che l’ha vista Capitale europea della Cultura? La contemporaneità con i suoi miti e i suoi riti offre queste opportunità che sono però anche delle insidie; è un’agenda che se affrontata sul serio interroga la coscienza di luogo. Mettersi in una prospettiva principalmente economica, significa importare una logica che appartiene in particolare ai distretti produttivi, diffusi al nord e molto meno al sud: i distretti sono sovrapponibili alla carta agricola dell’Italia della mezzadria. Nell’Italia che era segnata dai latifondi le dinamiche economiche che si sono sviluppate sono molto diverse.
I distretti manifatturieri in molti casi hanno imboccato il percorso per trasformarsi in distretti culturali evoluti. Come può una dinamica come questa attuarsi in un territorio, quello materano, che non ha conosciuto una rete di attività manifatturiere? Non può essere certo inteso come tale l’insediamento della Fiat nella non lontana Melfi: un grande impianto che è polo di un distretto del Nord e non ha generato un distretto sul territorio. A Matera il grande tema, e non certo di oggi, è quello del luogo dove una civiltà antica, con insediamenti dalle caratteristiche primitive come i Sassi, è stata scagliata nella contemporaneità. Un tema che Adriano Olivetti aveva affrontato nella stagione della prima modernità, progettando La Martella; già allora davanti ad una modernità che procedeva a balzi, si poneva la questione di come rimettere al centro il concetto di comunità. Personaggi come Rocco Scotellaro e Carlo Levi hanno dato la loro risposta, facendo della questione sociale la leva per recuperare una forma nuova di comunità.
E oggi? Essere Capitale della Cultura ha significato mettere il sociale al centro dell’idea di cultura, come dimostra quel pullulare di iniziative e di realtà che sono venute avanti e che hanno comportato una mobilitazione di tutto il tessuto del territorio.
La Fondazione Con il Sud ha svolto un ruolo prezioso nel favorire questo dinamismo diffuso. Il traguardo oggi è quello di fare del modello dell’impresa sociale il motore che può fare di Matera un distretto sociale evoluto. Al cammino fin qui fatto un primo merito va riconosciuto: quello di essere stato dentro la contemporaneità con le sue opportunità e anche le sue contraddizioni.
Quello che ora attende Matera è il compito di rinnovare la mobilitazione attorno alla questione che già con La Martella era stata messa sul tappeto: come si parte da una coscienza del luogo? In seconda battuta Matera non può immaginarsi come un’enclave estranea al contesto. Il caso della città dei Sassi deve allargarsi e generare una nuova questione meridionale, che deve passare necessariamente per una mobilitazione sociale. In terzo luogo non si può prescindere da una relazione con il Nord, com’è avvenuto per esempio, con l’esperienza di For Mat, acronimo che indica Forlì e Matera: le due città si sono messe in relazione per condividere buone pratiche legate al bene comune e per diffondere il valore dell’essere comunità, come processo innovativo.
Anche il fatto di aver scelto Matera come laboratorio per la ridefinizione della Rete Cgm va in questa direzione. Oltre al Meridione, oltre al Nord c’è anche la dimensione europea che i territori devono rafforzare nelle sue valenze sociali, dopo la fase storica dei rinserramenti. Il percorso è iniziato: come insegna il caso di Padova, da cui avevamo iniziato questo percorso nei nuovi distretti sociali, queste scadenze indotte dall’agenda della contemporaneità, con le loro ambivalenze, possono essere delle grandi opportunità.

Il weekend di formazione dei ragazzi fra i 14 e i 20 anni che hanno partecipato al concorso “Crescere Innovatori-Noi al Centro” si è tenuto alla Bottega del Terzo Settore di Ascoli a inizio novembre
Il Piceno e la provincia di Ascoli sorgono su una faglia storica e geografica. Da qui passava la frontiera fra Stato della Chiesa e Regno di Napoli, qui scorre il Tronto, il fiume che separa le Marche dall’Abruzzo, questo era il confine settentrionale della Cassa del Mezzogiorno. E se dall’asse nord-sud guardiamo a quello est-ovest, ecco emergere un’altra crepa. Di là sulla costa, San Benedetto del Tronto. Di qui, poco più di trenta chilometri all’interno, Ascoli Piceno.
Di là una città che non ha mai fatto vanto della sua storia, una città sorprendentemente in crescita demografica (grazie anche all’arrivo delle popolazioni dell’interno vittime del terremo) che sta cercando di sostituire l’antica vocazione della pesca, con un turismo familiare poco spendaccione, ma spesso fedele. Di qui uno dei più bei borghi d’Italia, il vecchio capoluogo signorile e per certi versi feudale, sempre meno popolato, che fatica ancora oggi a farsi una ragione della fine dell’epoca dei finanziamenti a pioggia del -
la Casmez e del rinsecchimento delle casse delle pubbliche amministrazioni che tanta occupazione hanno dato da queste parti. A collegare i due poli, oltre al raccordo autostradale, una ferrovia e una linea di autobus molto poco utilizzate.
Eppure come documenta la recente “Analisi dei fabbisogni del territorio” ben curata dall’università Politecnica delle Marche su mandato della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli c’è un’istantanea che lega assieme questo crocevia: «L’immagine di un

territorio debole dal punto di vista economico e con fragilità sociali che, sebbene non emergano in modo marcato al pari di quelle di natura economica, potrebbero diventare sempre più evidenti in un prossimo futuro». Continua il documento: «Un primo e rilevante elemento di criticità è rappresentato dagli andamenti demografici particolarmente negativi, che stanno portando ampie porzioni del territorio – soprattutto nell’entroterra – in una direzione di progressivo spopolamento… In tale contesto, il tema della “fuga dei giovani” dal territorio (soprattutto dei soggetti con elevata scolarizzazione) assume un’importanza centrale e rende opportuno ragionare sui processi da innescare per fare in modo che le nuove generazioni trovino opportunità professionali in questa area e scelgano di sviluppare qui i loro “progetti familiari”. Creare le condizioni per un mercato del lavoro più dinamico e attrattivo potrebbe così rappresentare una possibile chiave per la rigenerazione non solo economica, ma anche sociale del territorio». Mai come in questo territorio e in questa epoca, occorre dunque creare “luoghi comuni”.
Da dove partire, allora? A gettare il sasso nello stagno è stata proprio la Fondazione Carisap che a novembre ha definito gli indirizzi, gli obiettivi e le linee strategiche per il prossimo triennio 2020-2022 con una grande novità: l’inaugurazione di una linea di fondi (la seconda per entità come si evince dalla tabella che trovate in queste pagine) dedicata espressamente allo sviluppo locale. Una scelta che arriva da lontano. La costituzione dell’associazione della Bottega del Terzo Settore nel dicembre 2016 con l’inaugurazione della sede il primo ottobre dell’anno successivo insieme all’elezione a grande maggioranza al vertice della Fondazione di un giovane imprenditore come Angelo Davide Galeati nel febbraio 2018 sono stati passaggi cruciali nel gettare le basi di una concezione innovativa di sviluppo imprenditoriale fortemente orientato al sociale e basato su un modello originale di

la popolazione di riferimento di Fondazione Carisap distribuita in 38 comuni (31 nella provincia di Ascoli Piceno, 7 in quella di Fermo)
il tasso negativo di decrescita demografica sensibilmente maggiore della media nazionale (-3,2%)
l’indice di vecchiaia della provincia (il rapporto fra la over 65 e under 14 , moltiplicata per 100). Media italiana: 168,9
26%
il tasso di disoccupazione giovanile, superiore di 4 punti alla media regionale
16.620
il reddito medio disponibile, inferiore di 1.568 euro alla media nazionale
2,4
il numero medio di componenti per famiglia
la speranza di vita di un ascolano a fronte di una media italiana di 82,5 anni
la spesa sociale per abitante: 47esima posizione fra le 107 province italiane
72,6
organizzazioni non profit ogni 10mila abitanti (in Italia sono 56,7)
welfare di comunità.
Galeati, 42 anni è uno dei due amministratori delegati del caseificio di famiglia Sabelli spa, una delle poche aziende dell’area che in questi anni non ha smesso di assumere. L’altro amministratore delegato è il cugino di Galeati, Simone Mariani, presidente della Confindustria locale che riunisce Ascoli Piceno e Fermo. È di Galeati la scelta di affiancare al segretario generale della Fondazione Fabrizio Zappasodi una vera e propria direzione d’area strategica, ricerca e pianificazione affidata a Marco Perosa che ha curato la lunga fase di audit e ascolto del territorio da cui è nato il piano di azione. Piano che si dovrà sviluppare, precisa Galeati (lo incontriamo nel suo ufficio al primo piano della sede che Fondazione Carisap condivide con la Bottega del Terzo Settore a due passi da piazza dell’Arengo), «sostenendo preferibilmente l’avvio di nuove forme sostenibili di impresa sociale, in grado di generare benessere al di là delle risorse stanziate dalla Fondazione, favorendo la costruzione di reti collaborative e la coprogettazione per produrre un effetto moltiplicatore di ricaduta sul territorio». «Inoltre», aggiunge il presidente, «occorrerà introdurre meccanismi di valutazione degli impatti generati». Una piccola rivoluzione all’interno di un motore, quello di una Fondazione da 300 milioni di attivo patrimoniale, che la continuità dei 17 anni della precedente presidenza, avevano reso molto affidabile e rodato,

I vini bianchi e rossi, la norcineria di suino della Marca, i mieli, la pasta e il pane, l’olio extra vergine, le confetture, le marmellate, le passata di pomodoro, i sottolio, il caffè d’orzo e perfino le erbe aromatiche e officinali. È ricco il menu di Ama Terra, la fattoria bio-sociale nata nell’alveo di Ama Aquilone, l’impresa sociale che a Castel di Lama gestisce 6 comunità di accoglienza (per psichiatrici, adolescenti e tossicodipendenti). Con il sostegno della cooperativa Officina 1981, l’impresa agricola che già oggi sta dando lavoro a dieci persone e fatturando circa 200mila euro (grazie alla vendita diretta e via internet), si occupa della coltivazione in biologico di 30 ettari di terra e alleva suini e bovini allo stato brado. Lo fa all’interno di un programma ribat-
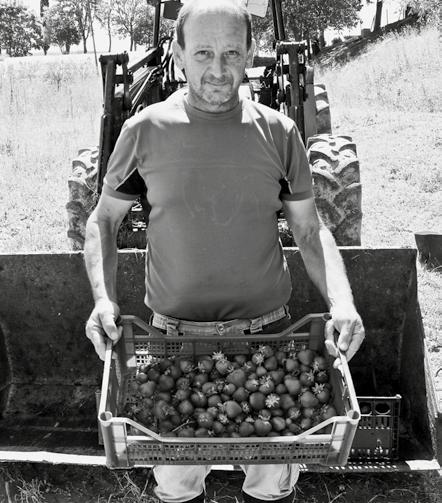
A metà strada fra la riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno nel comune di Spinetoli c’è ristorante che per il secondo anno di fila ha ottenuto il prestigioso inserimento nella guida Slow Food. Non solo. Se provate a digitare locanda Centimetro Zero su Tripadvisor scoprire che è la prima in classifica quanto a recensioni digitali. Scrive Marco A5892: «Abbattuta ogni barriera di spazio e sociale. Non mangi per gratificarti solidalmente, semplicemente mangi “veramente bene” aggiungendo plusvalore alla tua cena». Eh, sì. Perché non bastano la buona cucina (ottimi per varietà di scelta e qualità gli antipasti, mentre fra i primi in questa stagione vanno per la maggiore i ravioli verdi pistacchio e limo-

tezzato Arbì, dal nome dialettale del vento di libeccio, detto anche garbino, che spira da sud ovest «e quindi è sia di mare, sia di terra a seconda della latitudine da cui lo si coglie: per noi simboleggia il movimento e la diversità delle prospettive», spiegano il presidente di Ama Aquilone Francesco Cicchi e l’agronoma Valentina Sguigna, vicepresidente di Officina 1981. Il progetto ha previsto la realizzazione di un bio-concept store. Uno spazio fisico e un contenitore di idee capace: di coniugare finalità diversificate e offrire opportunità di formazione e inclusione lavorativa per giovani e/o disoccupati; di essere spazio per la commercializzazione di prodotti biologici, provenienti da filiera corta, da aziende biologiche locali con particolare attenzione a quelle delle zone colpite dal sisma 2016/2017; di essere luogo di degustazione di prodotti biologici locali e di iniziative di convivialità; di costituire uno spazio animato da iniziative di solidarietà, dedicate alla sostenibilità ambientale, all’economia solidale, eventi musicali, letterari e culturali. «Noi rifiutiamo la logica assistenziale, chi entra nelle nostre comunità, ma chiunque sia occupato all’interno dei nostri progetti si assume almeno una parte di responsabilità in una logica imprenditoriale», conclude Cicchi.
ne, gli spaghettoni al pesto al cavolo nero e le zuppe di zucca, porro o castagne) e non bastano nemmeno i prezzi alla portata di tutti (si mangia mediamente con 25 euro a testa). «A fare la differenza sono loro, se non ci fossero loro in fondo saremmo un buon ristorante come tanti altri», racconta la responsabile del progetto Roberta D’Emidio. Loro sono 15 ragazzi in borsa lavoro, tutti dai 20 ai 40 anni, con disabilità intellettive, più o meno gravi, sindrome di down, autismo. Martina, Veronica, Giulia, Francesca, Clarissa, Davide, Fabio, Daniele, Marino, Gabriele, Costantino, Riccardo, Emidio, Alessio e Lorenzo si prendono cura dell’orto e degli arredi, della cucina e della sala, dei clienti. Lavorano 20 ore a settimana, tre giorni su sette. «Non è stato facile formali, per loro è importante avere e riconoscere una guida e lavorare in un ambiente conosciuto, ma presto credo alcuni siano pronti per andare a lavorare in altri ristoranti, magari sotto la nostra supervisione, ma con una buona dose di autonomia», spiega D’Emidio. Il prossimo passo? «Aprire una locanda gemella sul mare sulla riviera di San Benedetto, ci sono tanti altri ragazzi e tante altre famiglie che vorrebbe partecipare a questo progetto», conclude la responsabile.
«ma che» è sempre il suo successore a parlare, «aveva bisogno di cambiare marcia per poter rispondere in modo più elastico ed efficiente all’emerge di bisogni nuovi come appunto quello occupazionale e alla fuga dei giovani. Da qui la necessità di massimizzare l’effetto dei nostri interventi avendo ben presente che sviluppo locale e welfare privato non possono che innovare operando su un piano comune». Conclude Galeati: «Jeff Bezos con Amazon ha saputo registrare prima di tutti un bisogno, immaginare una soluzione e farsi trovare pronto quando il bisogno è diventata una domanda di mercato. Lo dico da imprenditore: noi dovremo fare lo stesso con le imprese sociali che sapremo formare e avviare sul territorio. È un rischio e una sfida. Ma faremo di tutto per vincerla». “L’esplosione” della Bottega del Terzo Settore è già un primo segno tangibile. Dagli undici fondatori, i soci ormai sono quasi 150, «una bella fetta delle circa 800 organizzazioni del Terzo settore maggiormente attive sul territorio. E nei prossimi mesi cresceremo ancora», prevede il presidente dell’associazione Roberto Paoletti. Oggi questo spazio rigenerato dopo la chiusura del cinema Olimpia è diventato un vero e proprio hub di innovazione sociale a disposizione dei soci, ma anche della città. Un co-working, uno spazio multimediale, un’area lab: è in questo perimetro che nel solo 2018 si sono registrate 12.583 visite, 108 eventi, 105 riunioni e 50 conferenze stampa. Dalla scuola di cooperazione alla formazione sul fundraising, dagli incontri con le aziende profit del territorio ai corsi di trasformazione digitale e di change management tenuti in collaborazione con Techsoup («è un luogo estremamente vivace», conferma il ceo di Techsoup Italia Davide Minelli) «l’obiettivo», ragiona Paoletti, «è quello di sostenere una nuova generazione di imprenditori sociali che possano immaginare strade nuove al di



presidente della Fondazione Carisap
presidente della Bottega del Terzo Settore
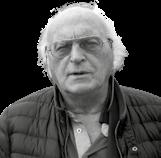
presidente dell’associazione Pas
presidente della coop Primavera e vice di Bottega del Terzo Settore
là della crisi del manifatturiero e al di fuori dalla dinamiche del finanziamento pubblico».
ONIl Pas è un primo mattoncino che va nella direzione indicata da Galeati e Paoletti. Pas sta per Polo Accoglienza e Solidarietà e si trova a ridosso del centro storico di Ascoli Piceno. È stato inaugurato a metà ottobre ed è stato costituito con il supporto della Fondazione e della diocesi da un network di dieci associazioni (di diversa estrazione culturale e dimensione), che prima dell’inaugurazione erano diventate già 17. A uno sguardo di superficie potrebbe essere qualcosa di già visto: mensa, centro diurno (il primo in città), distribuzione di vivere e vestiti, docce, barbiere, centro d’ascolto a cui presto si aggiungeranno un ambulatorio, 2 poltrone dentistiche e un dispensario farmacologico. «In realtà», interviene il presidente di Pas Giuseppe Felicetti, «questa è soltanto la prima soglia e la modalità per rispondere all’emergenza povertà che viviamo, ma noi vogliamo fare non uno ma due passi in avanti: il primo è quello di mettere a disposizione della città questi spazi partendo dalle scuole in modo che non siano un luogo a se stante, ma uno spazio fruito dalla comunità. Il secondo passaggio sarà quello di creare meccanismi di reinserimento sociale e occupazione anche grazie alla rete e alla formazione di Bottega del Terzo Settore». Insomma un presidio sociale «che si deve evolvere in un’ottica di rete e di sviluppo locale», chiosa Felicetti.
Un’impostazione che fa il paio con quella di Franco Zazzetta che, oltre ad essere vicepresidente della Bottega del Terzo Settore, è il presidente della cooperativa sociale Primavera di San Benedetto del Tronto: con il progetto La fabbrica dei Fiori impiega stabilmente 9 persone di cui 7 con disabilità mentali impegnati nella coltivazione in serra di piante da fiori e di fiori in vivaio destinati alla vendita diretta oltre che in attività di manutenzione di par-
2020 2021 2022
Educazione, istruzione e formazione 300.000 300.000 350.000 950.000
Salute pubblica, medicina preventiva 300.000 300.000 300.000 900.000
Sviluppo locale 750.000 800.000 765.000 2.135.000 Volontariato, filantropia e beneficenza 1.475.000 1.845.000 2.045.000 5.635.000
Arte, attività e beni culturali 400.000 400.000 400.000 1.200.000 3.495.000 3.645.000 3.860.000 11.000.000
In tabella trovate la ripartizione delle risorse che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha impegnato nella prossima programmazione: complessivamente, nel triennio 2020/22, «la Fondazione realizzerà la propria attività istituzionale per gli importi indicati salvo modifica da effettuarsi anno per anno in considerazione delle variazioni relative agli andamenti dei mercati finanziari ed ai riflessi sull’avanzo di servizio», precisano da Fondazione Carisap.
chi e giardini presso committenze private. «Considerando il turn over dei soggetti titolari di borse lavoro e gli assunti diretti, possiamo dire che l’intervento coinvolge almeno 35 giovani con disagio sviluppando complessivamente 8mila ore circa di lavoro assistito», specifica Zazzetta. Che aggiunge: «Per conservare la sostenibilità economica sempre di più dovremo emanciparci dal circuito dei servizi pubblici stando sul mercato e creando alleanze con soggetti non profit e profit come abbiamo fatto per un verso con Ama Aquilone grazie alla rete di Bottega e per l’altro verso con Conad e Brosway». La strada è tracciata.

Docente di Marketing e Business Marketing, Gian Luca Gregori dallo scorso giugno è il rettore dell’università Politecnica delle Marche. L’interesse scientifico di Gregori verso il mondo del Terzo settore è consolidato con particolare riferimento alla progettazione europea e alle tecniche di marketing. «Io credo», esordisce, «che la nostra università debba fare un investimento forte nei confronti delle imprese che si occupano di welfare. Un pezzo di futuro dell’economia della nostra terra passa da qui».
In che modo vi state attrezzando professore?
Lo sforzo che dobbiamo fare è quello di avvicinare alcuni concetti propri della comunicazione e della gestione delle aziende profit alle imprese sociali: controllo di gestione, marketing, politica dei finanziamenti, budgeting e gestione del personale per fare qualche esempio. Concetti che non possono essere trasferiti sic et simpliciter al non profit, ma che oramai sono imprescindibili. La spinta ideale e la grande voglia di fare del non profit da sole non bastano più. L’obiettivo è quello di creare una vera e propria economia
di comunità, dove profit e non profit parlino una lingua comune. In un tessuto dove il 99% delle aziende hanno meno di 50 addetti l’ipotesi di creare meccanismi di collaborazione sistemici non è scontata. Ma è una via che, di fronte alla crisi dei distretti industriali tradizionali, non può non essere esplorata.
Quale riscontro hanno i moduli sul non profit che già avere in università?
La domanda è alta, i tassi di iscrizione sono elevati. Il nostro non profit ha fame di competenze. Per questo credo che forse sia venuto il momento di pensare a uno strumento più ambizioso.
A cosa si riferisce?
Ad una vera e propria Academy del non profit e dell’impresa sociale che dia coerenza, uniformità e arricchisca la nostra proposta. In fin dei conti sarebbe un’evoluzione naturale di quello che già facciamo e una risposta alle esigenze formative che questo territorio esprime.
Dallo scorso luglio lo stabilimento della Pfizer di Ascoli Piceno si è dotato di una responsabile della Ssr: ovvero della “site social responsability”, una sorta di csr a chilometro zero. La funzione è stata assegnata a Serena Minischetti. Per il comune piceno la fabbrica della multinazionale del farmaco americana rappresenta il maggiore polo occupazionale con i suoi circa 700 dipendenti, che con l’indotto arrivano a superare il migliaio. Incontriamo Minischetti nella sede che Fondazione Carisap condivide con la Bottega del Terzo Settore.
Da dove nasce l’esigenza per Pfizer di dotarsi di una figura come la sua?
Noi che lavoriamo in questo stabilimento abbiamo la consapevolezza di essere fortunati in un territorio che sta vivendo una crisi importante. Ma siamo
anche coscienti che questo non basta. La “felicità” di un’azienda è determinata anche dal contesto. Per questo è fondamentale il grado di soddisfazione delle comunità a cui noi dobbiamo contribuire. Tra i nostri obiettivi c’è quello di fare la nostra parte affinché i colleghi possano lavorare nella maniera più serena possibile. Oltre a varie misure di welfare già esistenti in stabilimento, ci stiamo guardando intorno a livello locale per capire come possiamo aiutare i colleghi, soprattutto nel bilanciare vita lavorativa e vita privata, ad esempio con supporti per assistenza di familiari con problemi di salute, rete di baby sitter qualificate da chiamare in caso di necessità.

Pfizer Italia ha una politica di csr consolidata e una Fondazione corporate. Perché serviva un presidio sociale sul territorio?
Infatti non partiamo da zero: ci atteniamo alle indicazioni che ci arrivano dalla sede centrale e abbiamo già attive diverse iniziative solidali per esempio con Aism e Ail. Ma in questo momento avevamo la necessità di impattare maggiormente sulla realtà locale. Da qui la necessità di conoscere bene le organizzazioni del Terzo settore della provincia: il dialogo con la Fondazione è decisivo.
Le è stato assegnato un budget?

Non ancora. Siamo nella fase di monitoraggio. Individuati i progetti penseremo alle risorse da destinare. Avete qualche idea in merito?
Oltre all’assistenza ai non autosufficienti, un’altra linea di lavoro potrebbe essere quella della formazione che i nostri manager possono mettere a disposizione delle giovani imprese del settore non profit.
Per ragionare rispetto a quanto ben documentato in queste pagine, occorre fare una precisazione sulla denominazione: con l’area Picena non siamo di fronte a quelli che abbiamo chiamato distretti sociali ma ad un progetto sociale di coalizione di area vasta. Siamo in presenza di un territorio che alza lo sguardo, dove non si resta trincerati dentro le rispettive “oasi”, ma si incomincia a capire che l’identità non sta solo nei soggetti ma nelle relazioni, come insegna Lévinas. Accade nel Piceno qualcosa che abbiam visto maturare a Matera, dove il sociale è stato chiamato ad alzare lo sguardo in occasione del “grande evento” della Capitale europea della cultura e così ha allargato il raggio dei ragionamenti alla questione del Mezzogiorno.
Quanto al Piceno occorre partire dallo scomporre le parole, per capire che tipo di percorso ci attende. “Area vasta” indica che il patto coalizionale si colloca in quell’area che abbraccia i Monti Sibillini, dove è prioritaria la questione del terremoto e della ricostruzione; in mezzo c’è la città, Ascoli, con la sua densità di storia; infine c’è San Benedetto, con il suo profilo di città adriatica. L’area vasta è quindi composta da queste tre diversità, che hanno sguardi diversi anche per ragioni dei dislivelli – dalla montagna al mare – che le caratterizzano: alle spalle c’è il rapporto irrisolto tra terre alte e terre di mare.
L’area vasta del Piceno si colloca poi su quell’asse che avevo definito della “città adriatica” che non è solo quella del turismo e del “loisir” ma è anche quell’isola di mezzo da cui, per dirla con le parole di Giorgio Fuà, sono partiti i distretti produttivi. Un territorio che se lo guardiamo in orizzontale è contrassegnato da una densa spiritualità, e dal radicarsi dell’eredità rinascimentale delle “virtù civiche”; è l’Italia di mezzo, che per dirla con Robert Putman è un territorio dove «l’Italia è più Italia». È in questo contesto che è potuto attecchire il modello del capitalismo “dolce” marchigiano, un modello produttivo che ha fatto leva sulla coesione sociale e territoriale.
La seconda parola da scomporre è il “sociale coalizionale”. L’obiettivo dello sviluppo locale interroga i processi e chiama a creare inedite coalizioni tra una molteplicità di attori. Nell’area vasta del Piceno il sociale ha intercettato alcuni attori forti, come la Fondazione, che è stata capace di staccarsi dalle logiche della finanziarizzazione e ha rivolto le sue attenzioni al territorio; o l’università Politecnica che sotto la guida di Gian Luca Gregori lavora a rafforzare le competenze per un’economia di comunità varando l’Accademia del Non profit. Ma tra gli attori forti non bisogna dimenticare la diocesi e la rete del commercio equo solidale. È un tessuto di innovazione dall’alto che incrocia una spinta di innovazione dal basso e che trova nella Bottega del Terzo settore il luogo dove fare condensa. Questo “sociale coalizionale” arriva anche ad interrogare la grande multinazionale farmaceutica, soggetto chiave nell’economia del territorio con i suoi 700 addetti; una grande impresa che ha scelto di rapportarsi con il Terzo settore nella prospettiva di far crescere il welfare aziendale sui temi della non autosufficienza e dei figli dei dipendenti. Obiettivi ambiziosi resi possibili solo se si continua a investire su questo processo di consolidamento delle coalizioni tra diversi attori.


Per capire quanto a Milano il tema delle zone marginali sia sentito basta tornare con la memoria al 2016, in piena campagna elettorale per la corsa a sindaco quando Giuseppe Sala, che sarebbe poi andato a palazzo Marino, dichiarava «le periferie saranno una nostra ossessione». Una centralità che si spiega anche con una particolarità: in città, come certificava già nel 2017 l’Istat, «il ceto medio abita in periferia», e cioè il 58,1% degli allora 1.3 milioni di abitanti (oggi sono 1,4 milioni). «Nel centro e nelle aree semicentrali c’è una forte presenza di popolazione anziana e non mancano le zone abitate da stranieri di antico insediamento (come la comunità cinese)», spiega l’istituto, «quasi assente il ceto medio che via via nel tempo si è trasferito verso l’hinterland nei complessi di edilizia residenziale pubblica e convenzio -
nata a causa della lievitazione dei prezzi intervenuta sul mercato immobiliare nell’ultimo mezzo secolo»
protagonisti? Gli abitanti stessi
Un mutamento che ha generato distanze tra centro e margine, sfilacciatura sociale e isolamento. Così, per immaginare un destino diverso di queste zone e dei suoi abitanti, nasce Lacittàintorno. Un programma di fondazione Cariplo che si propone di coinvolgere gli abitanti dei quartieri periferici intorno al centro storico di Milano nella riattivazione e risignificazione degli spazi per migliorare la qualità della vita e costruire nuovi “centri” all’interno della città.
«Si tratta di un’iniziativa di rigenerazione urbana a base culturale, con un investimento complessivo di 10 milioni di euro», spiega Chiara Bartolozzi, referente del programma per la Fondazione, «un intervento che
punta all’attivazione del vivace tessuto sociale presente – fatto di associazioni, cooperative, scuole, gruppi informali e attivisti – come protagonista di nuovi interventi di natura culturale, aggregativa e di cittadinanza attiva». In una prima fase, il terreno di ricaduta è rappresentato dall’area via Padova - quartiere Adriano e dalla zona di Corvetto-Chiaravalle, che definiscono la periferia est della città. Il progetto si muoverà lungo tre direttive che hanno una declinazione specifica per ogni quartiere (Punti di comunità, Luoghicomuni/Ideebambine e Sottocasa) e un’azione corale (Abbracciami).
Come fare però a realizzare un’idea come questa dopo l’avvento dell’emergenza Coronavirus? A dettare la linea generale è naturalmente Giovanni Fosti, presidente di fondazione Cariplo spiegando che «in questo momento di grande incertezza non è venuta meno la chiarezza rispetto al compito e all’obiettivo a cui rispondiamo: investiamo sulle persone più deboli, sulla cultura, sulla ricerca e sull’ambiente come punti chiave da cui partire per generare valore e guardare al futuro. Siamo un soggetto attivo che non solo mette in campo risorse finanziarie, ma promuove e stimola iniziative di costruzione e coesione della comunità come elementi di crescita. La coesione delle comunità e lo sviluppo delle persone non sono solo i nostri valori di riferimento, ma la condizione essenziale per superare la fase critica che stiamo vivendo. La pan-
1. PuntoCom Trotter. La Fabbrica di Olinda, Comin, Centro Servizi Formazione, Ludwig, Salumeria del design
2. Residenza Urban Art ex Convitto Trotter. Atelier Spazio Xpo’, B-CAM
3. Nolo Fringe Festival. Nolo Fringe Festival
4. Sottocasa. BeatMI, Creativity for Urban and Rural Empowerment - CURE
1. Circolo virtuoso. Compagnia Teatrale Sanpapié
2. Adriano Community Days. Pro.ges
3. 8Pagine. Enciclopedia delle donne
4. Sottocasa. Chiamale Storie, Compagnia Teatrale Dionisi, Fondazione Nazionale della Danza, Architetti senza Frontiere Italia
1. Made in Corvetto. La Strada, Milano Bicycle Coalition, Terzo Paesaggio
2. Portale dei saperi. Rete Italiana di Cultura Popolare, Laboratorio di Quartiere Mazzini

3. Cortili inVersi. VerdeFestival
4. Sottocasa. Accademia Scacchi, Arti e Corti, bARTolomeo, Musicamorfosi, Terzo Paesaggio, VerdeFestival, Witness Journal
I PuntoCom sono centri di gravità aperti e plurali, dove le persone potranno incontrarsi, fruire di servizi e partecipare ad attività culturali, aggregative, formative, orientate al lavoro e alla cittadinanza attiva. Ambienti polifunzionali e in taluni casi con cucina. Il primo ad essere strutturato è stato Made in Corvetto, sorto grazie al riutilizzo del mercato comunale di piazza Ferrara, al cui interno ci sono anche una ciclofficina, un’impresa creativa e una cucina collaborativa.
-demia ha profondamente cambiato la realtà sociale ed economica del nostro Paese e del mondo. Questo ci impone di riorientare i nostri interventi per essere più coerenti con le esigenze di oggi e di domani». La declinazione concreta di questo orizzonte, per quello che riguarda Lacittàintorno, ha significato ridisegnare le azioni già previste dal piano così che possano essere ancora più impattanti nel nuovo contesto perché «le persone devono tornare a sentirsi parte di un destino comune. Il futuro della città dev’essere di tutte le persone e di tutti i quartieri e sarebbe un guaio se la ripartenza dovesse generare la percezione di un divario che si accentua:», chiosa Fosti, «ecco perché abbiamo promosso e continuiamo a lavorare su Lacittàintorno, perché le opportunità hanno bisogno di luoghi per esprimersi e di protagonisti che abbiano a cuore il bene comune».
Una prima declinazione sta nel Romanzo Popolare che al Corvetto, tramite il Portale dei saperi, incrocia domanda e offerta sociale all’interno del quartiere. «Siamo una sorta di jobbing delle passioni», spiega ridendo Antonio Damasco, direttore
della Rete Italiana di Cultura Popolare e responsabile del progetto. Nel concreto cosa vuol dire? «Facciamo storytelling, raccontiamo come fanno tanti, cosa c’è nel quartiere, partendo dagli abitanti. Ma con una consapevolezza in più: la narrazione senza una ricaduta generativa non ha senso. Ecco che attraverso il Portale mettiamo in relazione le persone, le loro passioni, capacità ed esigenze. Relazione che per via del Covid non potrà essere fisica, ma necessariamente e almeno in parte anche virtuale».

Due azioni distinte ma strettamente connesse. La prima punta al coinvolgimento dei cittadini nella riqualificazione e cura dei giardini di comunità e degli orti urbani, visti come beni comuni, e alla diffusione di comportamenti e stili di vita sani e sostenibili. La seconda promuove la partecipazione attiva dei bambini delle scuole primarie dei quartieri nel ripensamento dello spazio pubblico.
Settimanalmente i canali social della Rete, de Lacittàintorno e di Made in Corvetto, il punto di comunità del quartiere, presenteranno i “capitoli” di questo romanzo popolare. Dalle storie di solidarietà di Domenico e Andrea del Centro Polifunzionale Polo Ferrara (#ceraunavoltailcorvetto), ai racconti di cibo e inclusione della giovane Sara e di Silvana di My Comfort Food (#lecucinedelcorvetto), passando attraverso le passioni che hanno preso forma al Corvetto creando momenti di scambio culturale con Mattia e Francesca della libreria Punta alla Luna e la Casa di Giacomo (#libriacorvetto). E ancora esperimenti di agricoltura urbana e solidarietà con Maddalena di associazione Nocetum e Alessandro di CasciNet (#corvettometteradici), e storie di quanti hanno scelto Corvetto come sede professionale, come Alessandro di CVing e Carola di Lascia la Scia (#direzionecorvetto). Racconti di famiglie e di mestieri antichi come quella di Edoardo di Bonvini 1909 (#imestieridicorvetto), ma anche di ragazzi – come Thomas, Jennifer, Soukeye, Dina – alla ricerca dell’occasione propizia per mettersi alla prova.
«La Rete ad un certo punto uscirà di scena, ma il Portale rimarrà operativo, per permettere al quartiere di continuare a raccontarsi e prendersi cura di sé», sottolinea Damasco, «il potere di queste singole storie sta nella diversità delle esperienze e dei saperi che raccontano. Età, genere, cultura di origine, mestieri, personalità. Da questi racconti si può ripartire, rendendoli patrimonio condiviso, un bene comune da valorizzare, risorsa necessaria per ritrovare la propria dimensione e identità in una comunità che guarda al domani».
La Casa degli Artisti
In zona Trotter, via Padova, l’associazione Atelier Spazio Xpo’, all’interno del progetto di residenze di Casa degli Artisti, presenta Residenza Urban Art ex Convitto Trotter. «Si tratta di un’esperienza collettiva applicata alla street art che invita il pubblico a progettare, insieme al duo di artisti Sten Lex, un’opera murale per l’ex Convitto Trotter, stimolando una riflessione concreta sul tema del lavoro sociale, nodo fondamentale in un tempo di ricostruzione e ripensamento del domani come quello che viviamo in questa epoca di Coronavirus», spiega Bartolozzi.
L’iniziativa consiste nella progettazione partecipata ai contenuti di un’imponente opera d’arte murale
proprio nel punto in cui è prevista la nascita di PuntoCom, hub locale di integrazione sociale, culturale e formativa. «La prima fase della progettualità attiverà un network digitale, aperto a curatori, scuole, critici, appassionati d’arte e urban art, artisti e cittadini, utile ad approfondire, tramite dibattiti e momenti di confronto, il tema dell’opera esplorando la varietà del lavoro vocato alla rigenerazione territoriale e sociale», continua la referente del programma, «L’opera rappresenterà la sintesi e quasi il manifesto del “bene comune” a cui si intende dare valore», aggiunge.
Nella fase successiva il duo Sten Lex definirà il soggetto e le modalità realizzative del murale, tenendosi in costante dialogo con le realtà coinvolte secondo un’ottica di committenza di comunità. La concreta realizzazione durerà circa due settimane e la cittadinan-
Serenate Metropolitane di Bandakadabria all’interno di Made in Corvetto per il festival La città che Sale, un progetto a cura di Musicamorfosi

za avrà modo di seguirla attraverso i social. Da ultimo ci si concentrerà sulla comunicazione e sull’attivazione di ulteriori panel per analizzare l’eredità artistica, culturale e sociale che il progetto avrà portato al territorio e alla città in generale.
Nel costruire il progetto, Atelier Spazio Xpo’ ha riunito importanti realtà socioeducative del quartiere, ma anche della città: si va da La Fabbrica di Olinda, Coop Comin, Coop B-CAM, passando da associazione T12, associazione Amici del Parco Trotter, Circolo Reteambiente - Legambiente, per arrivare all’associazione Via Padova viva.

Non sarà però un’oasi artistica isolata. «L’opera di Sten Lex si inserisce in un sistema locale pensato per valorizzare l’arte nello spazio pubblico che, dopo i numero-
Questa azione porta nei quartieri periferici un’offerta culturale di qualità e pensata in chiave partecipativa. L’obiettivo duplice: coinvolgere gli abitanti e inserire questi quartieri nei percorsi e nei palinsesti cittadini. L’idea è attrarre anche le persone che vivono il resto della città e normalmente non frequenterebbero queste zone. Per farlo, oltre a partecipare degli eventi milanesi come Piano City, nasceranno proposte ad hoc come concerti jazz, performance di light art, maratone di lettura, cene di condominio.
O-si graffiti e murales che già compongono una galleria d’arte urbana a cielo aperto sui “muri liberi” della ferrovia in via Pontano, dei muri di cinta del Parco Trotter e del Liceo Caravaggio, oggi si arricchisce del nuovo tassello “Tunnel Boulevard”, un’iniziativa di urbanistica tattica che coniuga mobilità, light design e urban art, con al centro i tunnel ferroviari tra via Padova e viale Monza», sottolinea Bartolozzi.
La circonvallazione green
Come in ogni progetto diffuso c’è sempre un fil rouge che tiene tutto unito. In questo caso è la circle line che mette in collegamento 23 parchi periurbani dando vita così ad unico percorso nel verde per un totale di circa 70 chilometri. Si chiama Abbracciami, ed è l’azione corale che coinvolge tutte le aree del progetto e che metterà in contatto zone extra urbane con zone urbane. «Si tratta di una sorta di circonvallazione pedonale e ciclabile. L’itinerario entra ed esce dal tessuto urbano, passando da aree verdi, strade di campagna e strade di città componendo un anello che percorre tutto il perimetro di Milano» spiega il responsabile del progetto Marco Mazzei, tra i protagonisti del video Yesmilano con Ghali. «Grazie a questo viaggio si scoprono territori limitrofi che oggi vengono percepiti come distanti, si colgono le peculiarità dei vari territori e si scoprono vere perle dimenticate del paesaggio meneghino. La chiave è stata collegare una serie di punti che sulla carta erano separati riuscendo a ricucire, anche nell’immaginario, i frammenti del tessuto milanese. Questo, vista l’emergenza sanitaria, avrà molto valore sia in termini di mobilità sia di turismo di prossimità», continua Mazzei. La green road sarà dotata del primo sistema di indicazione stradale dedicato esclusivamente alle biciclette, che non solo indicherà il percorso ma darà informazioni utili sui luoghi: una sorta di google maps per bikers.
«Ma non sarà solo un tragitto che ciascuno potrà percorrere liberamente in bici e a piedi per andare da un quartiere all’altro senza passare dal centro. Sarà la vera e propria catena di trasmissione de Lacittàintorno per unire via Padova e il quartiere Adriano con Cor-

Dedicata a una mobilità nuova, sostenibile e ciclopedonale, sarà la prima circle line di Milano, un percorso da seguire per scoprire tutte le azioni de Lacittàintorno. Collegherà i tre quartieri pilota senza passare dal centro. Inizialmente sarà solo una “strada”, ma nel tempo si arricchirà di servizi dedicati che porteranno i cittadini a scoprire i luoghi di una nuova socialità grazie anche a una sorta di google maps per le bici.
10 milioni € investiti da fondazione Cariplo sul progetto Lacittàintorno in tre anni 140 le organizzazioni coinvolte Numero di persone attivate 500 bambini 42 insegnanti 250 genitori
Luoghicomuni sono stati firmati 5 patti di collaborazione, per un totale di circa 80 firmatari. In attesa di firma tra il 2020 e 2021 altri 20 patti
vetto e Chiaravalle, i luoghi che abbiamo scelto per le prime azioni di rigenerazione urbana al resto della città. Lungo questo percorso si potranno scoprire le azioni di cittadinanza attiva di Luoghicomuni, le guide dei quartieri realizzate dai bambini delle scuole di Ideebambine, le attività culturali di Sottocasa; grazie alle partnership con le strutture ricettive del territorio, le gestioni dei parchi e il Comune esisterà un vero e proprio palinsesto di attività di cui il cittadino potrà usufruire per ritornare a vivere la città», conclude
Sala: «La prossima sfida è quella di portare nelle periferie i flussi economici e il turismo»
«Vogliamo andare al di là del concetto di periferie, non solo nelle parole ma anche nei fatti. È innegabile che tanti quartieri hanno dei problemi ma fanno sforzi ed esprimono ogni giorno la volontà di recuperare immagine, storia, dimensione e visione per il futuro». Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala sintetizza la visione che sta portando avanti. Un orizzonte testimoniato dal piano delle periferie poi diventato piano dei quartieri con cui il Comune ha programmato investimenti per 1,6 miliardi di euro di cui 200 milioni destinati a progettualità segnalate dagli stessi cittadini.
Lei ha spesso parlato di periferie al centro, cosa significa?
È uno slogan per dire che oggi l’economia che arriva a Milano, fatta da imprese che investono sul territorio e dal turismo, è prevalentemente indirizzata sul centro. La vera sfida è come deviare una parte dell’interesse economico
e dei flussi turistici nelle zone non centrali della città. È questa la vera domanda.
Si è dato una risposta?
Se ci sono dei luoghi simbolo è più facile. Probabilmente è questa la via da seguire: immaginare dei luoghi simbolo, un mercato particolare, un museo, un distretto artigianale con le sue peculiarità che induca la gente a visitare luoghi periferici.
Per questo il Comune ha subito abbracciato il progetto Lacittàintorno?
Le periferie non sono cosa altra e il comune di Milano, attraverso questo progetto, porterà economia e presenza sociale. Teniamo molto ai quartieri coinvolti. Siamo consci dei problemi che esistono ancora e non sarà facile mettere tutti d’accordo, però la strada maestra è questa. La comunità ha bisogno di luoghi in cui raccontare la propria storia, esprimere la propria identità e costruire il proprio futuro e Lacittàintorno risponde a queste esigenze.
Cognetti: «La ripartenza post Covid parte dal basso»
«Parlare di periferie al plurale serve a comprenderle, a circoscriverne limiti e individuare punti di forza», sottolinea Francesca Cognetti, urbanista e docente del dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, che ha contribuito a Lacittàintorno realizzando una ricerca multidisciplinare, coinvolgendo le comunità di abitanti con cui sono state elaborate le “mappe di comunità”: «Conoscere i contesti è l’unico modo per sfruttare le potenzialità dei territori e generare economie locali e servizi».

Lei ha guidato un gruppo di urbanisti, antropologi e architetti del Politecnico in una ricerca sul campo. Qual era l’obiettivo?
Grazie alla ricerca sono stati prodotti dei quadri conoscitivi e strategici relativi allo sviluppo dei contesti di intervento che, in una

prima fase, hanno supportato la realizzazione de Lacittàintorno e successivamente sono stati pubblicati sotto forma di “Quaderni” (scaricabili dal sito del programma), con l’auspicio che la conoscenza condivisa tra tutti gli attori della rigenerazione possa essere la base per un piano di interventi coerente ed efficace.
In che modo questo ha una ricaduta sugli abitanti?
La metropoli contemporanea spesso offre poche possibilità ai cittadini. Non è abilitante, non mette cioè le persone nelle condizione di fare ed esprimersi. Ma, soprattutto nei momenti di crisi come quello che stiamo vivendo, gli abitanti sono una grandissima risorsa.
Un lavoro che assume più rilevanza nell’epoca del Covid19?
Non c’è dubbio. Questi quartieri con le loro specificità e il loro
tessuto sociale sono miniere di innovazione. Che vanno sfruttate e attivate. Insegnare loro a esprimere le proprie competenze e le proprie capacità potrà essere un’arma nella costruzione della Milano di domani.
Quindi il vostro lavoro viene donato ai cittadini?
Molto di più. Il nostro lavoro è stato fatto in collaborazione e sinergia con la Fondazione e con gli abitanti. Non solo noi abbiamo consegnato e spiegato i risultati della ricerca ai cittadini ma gli abbiamo anche insegnato come affrontare e condurre un’analisi di questo tipo, in particolare nell’ambito di progetti che partono dalla cura dello spazio pubblico e del riuso. Abbiamo trasferito questo know how ai quartieri. Crediamo in una città che nasce dal basso e che queste esperienze vadano facilitate e aiutate. E il modo migliore per facilitarle è creare consapevolezza.
In questo numero si raccontano i microprogetti di quartiere che stanno ai margini della smart city: sono esperienze che delineano dei distretti sociali evoluti nella dimensione metropolitana. Già era chiaro che era impossibile immaginare una smart city senza social city. Ora, dopo avere attraversato la pandemia, è ancora più evidente come questi progetti che sembravano ai margini siano diventati centrali nel processo più che mai necessario di riprogettazione della città.
Abbiamo assistito, prima della crisi che ci ha coinvolti, ad una retorica della smart city, che ha privilegiato la Milano dei flussi e delle iper relazioni, in una fase in cui il modello di città anseatica con vocazione commerciale e di rete stava trasformandosi in polo della “città globale”. È una visione che non teneva conto che gli uomini non sorvolano le città, ma le abitano e che quindi trascurava la prospettiva orizzontale.
Invece questo percorso nei distretti sociali evoluti che stanno prendendo forma, ci riporta alla necessità di pensare in questa dimensione orizzontale. Si può fare l’esempio del territorio che conosco meglio, quello dell’asse che unisce Sesto San Giovanni al Duomo, attraverso viale Monza e piazzale Loreto. Giustamente è un asse che viene riprogettato in chiave ecologica con la proposta della ciclabile che percorre tutto questo asse, ma non ci si può limitare a questo. Non basta una bella metafora ecologica per dar luogo ad una smart city: deve entrare in gioco l’esperienza orizzontale del laboratorio dell’asse parallelo, quello di via Padova, laboratorio di convivenze e di incroci di culture e identità che da piazza Loreto porta al quartiere Adriano dove c’è la Casa della Carità di don Colmegna.
Le esperienze raccontate in queste pagine ci costringono a ripensare la forma della città, quella che avevamo sintetizzato nell’idea dei cinque cerchi. Il primo cerchio è quello della finanza, nodo di una rete globale, oggi alle prese con le problematiche inedite dello smart working; il secondo è quello della Milano del terziario, in particolare del “parco a tema” della moda; il terzo coincide con le grandi vie commerciali, da corso Buenos Aires a corso Vercelli; il quarto corrisponde alle periferie in accelerato cambiamento, ad esempio quelle che hanno inglobato i poli universitari, dalla Bicocca alla Bovisa. Infine il quinto cerchio, che è quello dei quartieri soglia, come ad esempio il Corvetto, di cui si racconta in queste pagine: contesti della nuova composizione sociale, dove la città nello stesso tempo accoglie e respinge. Sono periferie che hanno accolto autonomie funzionali di eccellenza, come per esempio il caso dello Ieo sull’asse del Corvetto. Nel quinto cerchio assistiamo ad una dinamica grazie alla quale il margine si fa centro.
Questo può accadere se quelle che io chiamo “oasi” diventano distretto sociale. Attori fondamentali di questo processo sono le fondazioni, capaci di mobilitare attraverso lo strumento delle fondazioni di comunità le risorse dei territori, sul modello esemplare della Fondazione Con il Sud. È un processo nel quale le fondazioni come Cariplo nei casi raccontati in queste pagine ma anche Crt a Torino attraverso l’operazione degli Stati Generali, giocano perciò un ruolo strategico. Concludo con una considerazione e una proposta. La considerazione è che oggi più che mai il tema è quello di decidere quale città vogliamo, se quella disegnata dalla statualità dall’alto o dalle necessità della smart city tecnologica, oppure quella che porta il margine al centro e ascolta i saperi orizzontali delle “oasi” in un processo di rafforzamento della “social city”.
E poi la proposta: le città medie come Parma, Bergamo e Brescia, queste ultime emblematicamente toccate dalla pandemia, saranno le prossime capitali della cultura. Parma ha spostato al 2022 il programma, Bergamo e Brescia si sono candidate insieme per il 2023. Sarebbe importante cogliere l’occasione perché i temi qui affrontati sulle dimensioni di una metropoli come Milano, diventino materia di dibattito e di riflessione anche in quei contesti che poi rispecchiano la tipologia della gran parte delle città italiane. Del resto il nostro percorso sui distretti sociali evoluti era partito proprio da una città media, Padova e lì in quell’occasione aveva trovato un riscontro autorevole anche nella parole del Presidente Mattarella.

Ogni mascherina è composta da tre strati: un lato interno in cotone di qualità antibatterico; un Melt Blown filtrante al 99% e un lato esterno, lo Spunbond. Gli elastici per fissare la mascherina sono anallergici latex free

Due elastici da fissare alle orecchie e abbastanza tessuto da coprire naso e bocca. Penserete che ci sia solo questo dietro una mascherina. Invece ci può essere molto di più. Lo dimostra la storia di un gruppo di imprenditrici e imprenditori sociali che hanno “buttato il cuore oltre l’ostacolo” e si sono tuffati nel tornado in cui ci ha catapultato il Coronavirus. All’inizio ne avevamo un’urgenza disperata, oggi per fortuna le mascherine ci sono. Eppure, l’Italia trasformata dalla pandemia, non aveva bisogno solo di protezio-
ni. Ma di un progetto per realizzare un prodotto equo, accessibile a tutti. Che fosse sostenibile dal punto di vista ambientale, che tutelasse i posti di lavoro e ne creasse addirittura di nuovi. La storia che vi raccontiamo è fatta di persone, idee, desideri, fallimenti, innovazione. È da questo mix che è nato il primo Distretto Diffuso che realizza le mascherine Social Mask, sostenibili e lavabili fino a dieci volte. «L’idea di base», interviene Luca Raffaele (foto a destra), presidente di Next Social Commerce società benefit, già Direttore Generale di NeXt Nuova Economia per Tutti «è stata quella di avviare un
processo di riconversione nazionale di imprese sociali e cooperative tessili, che hanno deciso di mettersi insieme e produrre un “bene comune”». L’idea nasce dall’esperienza della rete Next Nuova Economia per Tutti, realtà associativa fondata nel 2011 con l’obiettivo di facilitare l’incontro di buone pratiche e avviare processi di rete e co-progettazione. Nel 2019 viene costituito lo spin-off società benefit Next Social Commerce, che attraverso i suoi servizi e la piattaforma cooperativa Gioosto, riesce a

consolidare e a realizzare il progetto di una filiera sociale condivisa.
«Nei primissimi giorni dopo l’inizio della pandemia abbiamo fatto una ricognizione nella nostra rete di imprese sociali», continua Raffaele. «Tutti avevano “qualcosa” da condividere: chi le competenze tecniche, chi quelle scientifiche. Qualcuno la manodopera e i macchinari.
Ci siamo chiesti “Ma qual è il modo migliore per aggregarli e creare valore aggiunto sia per le aziende che per il territorio in cui operano?”. Abbiamo pensato alla formula del Distretto. In questo caso non un Distretto legato alle logiche territoriali, ma che al contrario potesse unire l’intero Paese: un Distretto Diffuso nato dalla collaborazione di 36 realtà, che ha coinvolto fino a 550 lavoratrici e lavoratori nella prima fase di sperimentazione e test».
Ad aprile dello scorso anno l’idea del Distretto diventa concreta. Next, la Scuola di Economia Civile e le imprese sociali attraverso Vita.it scrivono al Commissario Domenico Arcuri. «La realizzazione di un prodotto non può non fare i conti con i costi di produzione, la dignità dei lavoratori e delle sue componenti, sociali e ambientali, oltre che economiche». Le realtà che aderiscono al Distretto chiedono un incontro con il commissario e lo ottengono. Raccontano la loro idea e le Social Mask diventano realtà.
A oggi sono già stati prodotti 4 milioni di pezzi. «Superare abitudini e modelli operativi differenti non è stato facile», scrive Elena Granata, vicepresidente della Scuola di Economia Civile. «Esiste un vasto mondo di piccole imprese, che desiderano coniugare la capacità di stare sul mercato con l’impatto sociale e ambientale delle loro scelte. Ed esiste una domanda di investimento finanziario e di prodotto, di taglia troppo elevata per le loro piccole dimensioni. Per questo motivo è cruciale il ruolo di “mediatori” capaci di aggregare piccole organizzazioni sociali dei nostri territori, costruendo reti di fiducia e condizioni di
le realtà che si sono messe insieme per far nascere in Italia il primo modello di Distretto Diffuso
i lavoratori e le lavoratrici coinvolte nei primi mesi di progetto per mettere a sistema, con la condivisione di conoscenze e competenze, un modello di mascherina sostenibile. Tra loro: 70% donne e 30% uomini
i lavoratori del Sud Italia che realizzano e confezionano le mascherine
i lavoratori del Sud Italia in condizione di fragilità impegnati nel progetto
le mascherine già prodotte
mutuo e reciproco interesse».
La scommessa di Next Social Commerce e di Luca Raffaele è stata di coinvolgere aziende, cooperative sociali, organizzazioni locali e Università per rispondere alle istituzioni e alle esigenze del Paese, con una proposta di qualità e di grande valore sociale. Tutti perseguono una missione comune. «Gli attori sociali che fanno parte del Distretto», ha ricordato Anna Fiscale, presidente di Quid, impresa sociale che opera nel campo delle moda sostenibile, «con il loro impegno quotidiano lavorano per creare un’economia più giusta e dei prodotti sicuri per questo momento di crisi».
IL LOGO
Disegnato da Matteo Riva il logo indica la circolarità di una produzione inclusiva, partecipata e amica dell’ambiente
« Il lavoro del Distretto è stato complicato», continua Raffaele. «Ma l’innovazione passa anche dai fallimenti. La Social Mask doveva essere assolutamente sicura dal punto di vista sanitario. I primi mesi di lavoro sono stati uno scambio di competenze, idee, costruzione di quel sapere che ci ha portato alla realizzazione del prodotto così com’è oggi». Alla fine di maggio, il Distretto Diffuso aveva realizzato il primo prototipo di mascherina lavabile. «Però», spiega Raffaele, «una serie di sperimentazioni e insuccessi si sono avvicendati nel processo produttivo e quel primo prototipo realizzato alla fine non è stato messo in commercio.
Le realtà del Distretto hanno tutte compilato l’Autovalutazione Partecipata di NeXt. Il questionario è diviso in 6 aree: 1 l’azienda e il governo dell’organizzazione; 2 — le persone e l’ambiente di lavoro; 3 — i rapporti con i cittadini; 4 — la catena di fornitura; 5 — i comportamenti verso l’ambiente naturale; 6 — i comportamenti verso la comunità locale. Ogni area è composta da 5 indicatori, collegati al BES e agli SDGs dell’Agenda 2030 che, dopo la validazione del Comitato Scientifico di NeXt, restituisce una “fotografia” dell’impegno di sostenibilità delle aziende. Dai dati emerge che il rapporto tra imprese e le comunità locali è quello più carente; ed è proprio sulla collaborazione e sulla costruzione di reti, che il Distretto Diffuso sta lavorando. Il questionario sarà ripetuto a distanza di un anno, per valutare il miglioramento delle aree e il consolidamento delle buone pratiche.
Dallo scorso ottobre Gennaro ogni mattina si alza più felice. Sa che alle nove in punto inizia il suo turno di lavoro. «Non avevo mai lavorato prima. Vorrei lavorare per sempre». Gennaro ha 44 anni e vive a Benevento. «Io, mio padre, mia madre e mio fratello più piccolo, stiamo insieme nella stessa casa», racconta. È meticoloso Gennaro, lo potete immaginare mentre con la perizia dei gesti di una volta organizza, nel laboratorio sterile di produzione, pile di dieci mascherine alla volta e le imbusta. «Ho fatto un corso di formazione da luglio a settembre. Ora sono diventato bravo».
Gennaro ha una disabilità psichica, un ritardo mentale di media intensità. Lavora nel laboratorio tessile del consorzio Sale della Terra di Benevento. «Ora che ho i miei soldi se mi piacciono le scarpe me le compro», ammette entusiasta. «Anche i vestiti se voglio», aggiunge. Il consorzio l’aveva conosciuto nei giorni passati al centro polifunzionale per disabili “È più bello insieme” nato nel 2001 a Benevento per favorire e potenziare la qualità della vita delle persone con disabilità. Quando è nata l’idea del Distretto Diffuso Social Mask, a cui Sale delle Terra aderisce, Gennaro è stato uno dei primi utenti del centro ad essere chiamato. «Sto bene anche con gli altri. Il lavoro piace a tutti».

Tra le mascherine che ci salvano la vita ci sono anche quelle a cui lavora Gennaro e quelle a cui lavora la sua ormai collega Faye, 28 anni (nella foto qui a lato), che per arrivare a Benevento, nella città che oggi chiama casa, ha vagato per un anno e cinque mesi: «Sono partita sei anni fa dal Gambia», rivela. «Ho attraversato il Senegal, il Mali, Burkina Faso, poi mi sono ritrovata a Tripoli in Libia. A Palermo sono arrivata su un barcone».
Faye è sopravvissuta, insieme a sua figlia Kaddijatou, che allora era poco più che una neonata, lungo tutta la rotta del Mediterraneo centrale. Portate in uno Sprar di Reggio
Calabria, ci sono voluti diversi mesi prima che si spostassero a Benevento. «All’inizio, con mia figlia, siamo state in un centro di accoglienza», racconta. «Ma adesso viviamo in un piccolo appartamento in città. Ho lavorato alla mensa della Caritas, poi da ottobre, invece, lavoro al distretto delle mascherine. Mi piace tanto
lavorare mentre mia figlia, che oggi ha sei anni, va a scuola. Io sono musulmana. Ho sempre pregato Dio e qui a Benevento ho trovato un bel futuro per me e per mia figlia. Appena mi arriva lo stipendio mi piace pagare da sola l’affitto». Investire in un progetto di innovazione sociale come il Distretto Diffuso significa anche questo. Far in modo che ogni mese Faye con i suoi soldi possa pagare l’affitto della casa. O mettere da parte i soldi per gli studi di sua figlia che quando sarà grande «forse farà l’avvocato», dice orgogliosa la sua mamma. Investire in questo Distretto Diffuso significa anche permettere a Gennaro e a tante altre persone, che non hanno mai avuto uno stipendio loro né un pizzico di autonomia, di scoprire un po’ di indipendenza.
Il Distretto Diffuso promuove l’inserimento lavorativo delle categorie più fragili, tra loro: disabili, detenuti in misura alternativa, titolari di protezione internazionale, vittime di tratta, richiedenti asilo. Nella foto a sinistra Faye durante il corso di formazione
Ma non ci siamo scoraggiati». Infatti, la Social Mask oggi in produzione è una mascherina Iir lavabile 10 volte, approvata dall’Istituto Superiore di Sanità, che garantisce il massimo livello di efficacia di Bfe (Bacterial Filtration Efficiency) e dei parametri previsti per ottenere lo standard 14683:2019 e la marcatura CE. Questo è stato reso possibile, grazie all’utilizzo di una catena di fornitura di eccellenza e di materiali di qualità, tra cui un cotone antibatterico e il tessuto-non tessuto “Melt Blown” fornito dall’azienda Graziano Ramina fondata nel 1990 leader sul mercato nella costruzione di macchine e impianti per il settore dei tessuti-non-tessuti. L’azienda con sede a Grantorto, piccolo paese nel cuore del Nord Est ha messo a punto un materiale in polipropilene, di livello superiore. Il tessuto-non-tessuto è un prodotto industriale ottenuto con processi diversi da quelli del settore tessile e magliaio. «Il “Melt Blown” compone la parte centrale della mascherina», spiega Graziano Ramina, presidente dell’azienda. «Questo particolare non tessuto garantisce un filtraggio superiore al 99%. La tecnologia innovativa che per-
mette la realizzazione del Melt Blown filtrante è l’impianto Leonardo 1.0, un brevetto della nostra azienda nel 2018 e installato nel 2019 in uno dei nostri centri di ricerca e sviluppo». Quando è scoppiata la pandemia l’azienda era l’unica in Italia ad avere questo tipo di tecnologia. «Nell’arco del 2020», continua Ramina, «abbiamo realizzato e installato altri 3 impianti Leonardo 1.0. Tre quarti delle nostre commesse sono destinate alla Protezione Civile».
Dopo i primi test e le sperimentazioni realizzate in modo diffuso su tutto il territorio, la fase di produzione delle mascherine si è concentrata nella filiera Sud Italia, precisamente nel beneventano, dov’è presente la Rete di Economia Civile Consorzio Sale della Terra che aderisce al Distretto. «Assembliamo e confezioniamo le mascherine», spiega Liliana Apollonio, responsabile del comparto tessile del Consorzio. «Abbiamo realizzato dei veri percorsi sterili di produzione e le cento persone che lavorano al Distretto al Sud, prima di iniziare, hanno completato un corso di formazione di due mesi. Tra loro ci sono disabili, detenuti in misura alternativa,
migranti, vittime di tratta, richiedenti asilo. Se il Distretto continuerà a esistere garantirà a queste persone una stabilità economica e permetterà l’attivazione di altri posti di lavoro che daranno a chi vive in queste zone la possibilità di restare nei nostri piccoli comuni, e ridargli vitalità».

Quella del Distretto Diffuso «è una storia bellissima», sottolinea Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Con il Sud. «Come tutte le storie meglio riuscite nell’ambito del Terzo settore parte da un’esigenza, da un impulso di darsi da fare per il bene comune». Gli utili del progetto serviranno per avviare percorsi complementari e paralleli con le lavoratrici e lavoratori coinvolti e per consolidare le realtà tessili che in questo modo non hanno chiuso un processo produttivo episodico o emergenziale, ma hanno investito in un reale processo di riconversione industriale, umana e ambientale. Le mascherine ci accompagneranno per molti mesi ancora e il Distretto Diffuso ha tutto il tempo per sperimentare e sperimentarsi in altri prodotti e progetti.
Non ne possiamo e soprattutto non ne dobbiamo fare a meno. Proteggono e ci proteggono. Da quando lo scorso marzo è iniziata la pandemia le mascherine sono un bene primario. Mentre ne nascevano di ogni tipo, modello, colore, abbiamo perso di vista l’unica domanda seria che bisognava porsi: Ma le mascherine quanto “costano” all’ambiente? Fare una scelta responsabile è possibile. Una ricerca dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, diretta dal professore di politica economica Piergiuseppe Morone — “An environmental analysis of single-use vs multi-use face masks via Lca” — ha calcolato e messo a confronto l’impatto ambientale delle mascherine chirurgiche monouso con quelle riutilizzabili fino a dieci volte, attraverso la metodologia del “cradle-to-grave”, tradotto in italiano “dalla culla alla tomba”, che analizza come e quanto tutte le variabili del processo produttivo impattano sull’ambiente e di conseguenza sulla nostra salute: estrazione della materia prima, trasporto, produzione, distribuzione, smaltimento. Un esempio. Solo per soddisfare il bisogno delle scuole italiane sono necessari 33 milioni di mascherine alla settimana. «Quindi il quesito a cui abbiamo provato a rispondere», spiega il professor Morone, «è stato: “A parità di obiettivo, la protezione della popolazione, è possibile ridurre l’impatto sull’ambiente?”».
Professore da quale dato siete partiti per sviluppare l’analisi? Da un’unità funzionale, ovvero: il volume complessivo di mascherine prodotte e utilizzate in Italia nell’arco di un anno. L’impiego di volume utilizzato nel 2020 per realizzare le mascherine monouso è stato pari a 3,92 chilo tonnellate (migliaia di tonnellate); per quelle lavabili il valore scende fino a 0,31 chilo tonnellate. Di conseguenza a cambiare è anche il volume di materiale utilizzato per il packaging. Per le confezioni in plastica si passa dalle 25,76 chilo tonnellate delle mascherine monouso alle 3,35 chilo tonnellate per quelle lavabili, e il trend rimane simile per gli imballaggi di cartone, infatti il volume usato per quelle monouso è di 33,17 chilo tonnellate, quello necessario per le mascherine lavabili si ferma a 3,63 chilo tonnellate.

Quali sono state le variabili prese in considerazione?
Abbiamo calcolato che impatto ha la produzione di mascherine in termini di cambiamento climatico. Più precisamente abbiamo stimato il volume di Co2 equivalente che viene sprigionato nell’aria per produrre la mascherina, sempre ragionando in una logica di ciclo di vita
del prodotto, dall’estrazione della materia prima fino al suo smaltimento. I punteggi complessivi sono 5.84x10 alla sesta kg di Co2 equivalente per le mascherine monouso e 2.35x10 alla sesta kg di Co2 equivalente per le mascherine lavabili. Anche in questo caso la differenza è davvero notevole.
Quale potrebbe essere l’impatto sulla salute?
Ogni volta che produciamo qualcosa consumiamo energia, immettiamo Co2 nell’aria, realizziamo prodotti che poi dovranno essere smaltiti e per farlo avremmo bisogno di altra energia ancora. L’obiettivo è quindi quello di prendere la miglior decisione possibile. Nel caso delle mascherine, quelle lavabili dal punto di vista ambientale sono migliori rispetto a quelle monouso. Nell’ultima parte dell’analisi abbiamo calcolato qual è l’impatto sulla salute umana in relazione, tra le altre cose, alla quantità di particolato che viene immesso in atmosfera per la produzione, il consumo e lo smaltimento delle mascherine e abbiamo poi aggregato questo dato con l’impatto di materie prime e risorse utilizzate e l’impatto sull’ecosistema. Il dato aggregato che abbiamo calcolato, in termini di “carico ambientale”, passa da 726 per le mascherine monouso a 325 per le mascherine lavabili fino a 10 volte. Ciò significa che l’impatto sull’ambiente delle mascherine lavabili è significativamente inferiore: meno della metà rispetto a quelle monouso.

Il percorso del progetto Distretto Diffuso delle mascherine sociali sin dall’inizio è stato accompagnato dalla struttura commissariale preposta all’emergenza Covid-19. La Social Mask frutto di knowhow, esperienze e competenze condivise ha unito a livello nazionale imprese per realizzare un prodotto volto, da una parte a percorsi di inclusione sociale e dall’altra a garantire il massimo livello di efficacia sanitaria.
Commissario nessuno più di lei può dare una lettura di quanto fatto sin qui da questo Distretto Diffuso.
Voglio ringraziare quanti hanno contribuito alla nascita di questo Distretto così significativo per i valori che incarna e per la sua capacità di produrre qualità. Le imprese sociali che hanno partecipato a questo percorso hanno avuto una parte molto più importante di quanto si pensi nel far fronte alla fase dell’emergenza. Credo sia doveroso ricordare che quando mi sono insediato come Commissario, il 18 marzo 2020, non esisteva in Italia nessuna struttura produttiva per le mascherine. Venivano per la gran parte prodotte in un Paese lontano non solo geograficamente e linguisticamente, ma anche per gli standard di produzione e di certificazione dei prodotti. Ricordo, e credo sia importante farne memoria, che i primi giorni avevamo difficoltà a trovare le mascherine da mandare agli ospedali per il personale sanitario.
Dopo tanti mesi, oggi produciamo milioni di mascherine sul nostro territorio, un numero sufficiente a soddisfare la totalità dei fabbisogni del nostro Paese. Ecco, in questo percorso la vostra esperienza e il vostro contributo è stato importantissimo, e non piccolo come pensate, ma grande e significativo. Importante in un percorso che ha visto lo Stato accompagnare la nascita e la crescita di una filiera che non esisteva attraverso un contributo pubblico in due forme: l’incentivo alle imprese che volessero iniziare la produzione di Dispositivi di protezione individuale o disponibili a riconvertire la produzione, e la produzione diretta da parte dello Stato. Oggi abbiamo 133 imprese che producono Dpi e 55 macchine di proprietà dello Stato che producono mascherine. In questo percorso, la collaborazione con il Distretto della Social Mask, e con il suo modello produttivo sostenibile e inclusivo, ha rappresentato anche un atto simbolico da contrapporre a chi speculava sulla paura e sulla salute, come chi vendeva a 5 euro la mascherina chirurgica che produttivamente
costa al massino 0,20 centesimi. Il mercato è sempre libero, questa è la regola, ma non quando calpesta il diritto alla salute delle persone. Sulla salute non si può speculare. Accompagnare la vostra filiera sociale è stato importante anche per questo.
La storia del Distretto sociale delle mascherine dimostra che anche l’impresa sociale può cogliere le opportunità di un nuovo mercato e presentarsi come player, il Distretto, infatti, ha coinvolto 36 imprese e 550 lavoratori. I tempi sono maturi per evoluzione del “sociale” in qualcosa di sempre più professionale. Ricordo che lei in un’intervista ha detto che “alla fine dell’emergenza, l’ottimo sarebbe ci fosse più mercato grazie allo Stato”. Può spiegare meglio?
Per molti anni la discussione economica si è svolta tra due estremi: da una parte i cantori del mercato, dall’altro chi sosteneva che lo Stato dovesse ossessionarlo di regole. Affrontando la pandemia abbiamo usato entrambe le leve, il mercato con la nascita delle 133 imprese impegnate nella produzione dei Dpi, e lo Stato con le 51 macchine di sua proprietà. Quando l’emergenza finirà sarà interessante vedere se le imprese riusciranno a vivere continuando la produzione di beni primari, e se il Commissario, il giorno prima della scadenza del suo mandato, riuscirà a dare a quelle macchine una destinazione diversa dalla produzione di mascherine, mettendole nella disponibilità di un segmento di mercato. Se questo succederà, se anche il Distretto Diffuso continuerà a funzionare a seguito della commessa pubblica che ha permesso di riconvertire aziende e persone, magari cominciando a produrre altri “beni comuni” (oltre le mascherine anche camici, copri calzari e cuffie mediche), saremo passati dall’assenza di mercato e dall’assenza dello Stato in un settore tanto importante (e oggi lo sappiamo bene) a una combinazione tra Stato e mercato virtuosa, avremo rinforzato il mercato grazie allo Stato. Qual è il mercato che lo Stato deve aiutare a strutturarsi? È un mercato meno speculativo e più sociale, un mercato dove si trova il modo di dare lavoro dignitoso a sé e agli altri, includendo anche i più fragili. Ecco, per un segmento di mercato così serve più Stato. Sono certo che l’evidente e crescente attenzione dello Stato nei confronti delle imprese sociali si possa anche tradurre in un potenziamento degli incentivi destinati a questa particolare forma di impresa, a partire da “Italia Economia Sociale”, uno strumento finanziario specificamente rivolto a questo comparto di attività.
Il dramma della pandemia come sappiamo, oltre al suo impatto in termini di vittime, ha paralizzato l’attività economica di interi settori produttivi. Non a caso in questi mesi difficili è diventata di moda una parola difficile come resilienza. La resilienza è la capacità di adattarsi a situazioni difficili o a improvvisi cambiamenti, riprendendosi rapidamente da uno shock. Sono stati resilienti quei lavoratori e quelle imprese che hanno saputo reinventarsi adattandosi ai nuovi vincoli e alla nuova situazione, che hanno colto un’opportunità nella difficoltà.
Le mascherine ne sono un esempio. Diventate essenziali nella vita quotidiana degli italiani, acquistare mascherine è, in tempi di pandemia, un’attività strategica regolata dal committente pubblico che ha progressivamente modificato il suo modo di agire comprendendo appieno come il Voto col Portafoglio potesse diventare strumento di realizzazione anche di altri obiettivi sociali e ambientali. La scelta di come approvvigionarsi ci ha fatto ancora una volta toccare con mano l’illusione che il prezzo minimo coincida con l’obiettivo del bene comune. Nel caso specifico il prezzo minimo significava approvvigionamento da fabbriche cinesi di mascherine usa e getta.
Oltre all’impossibilità di valutare effetti sociali e ambientali, un bene diventato strategico può dipendere completamente da una produzione dislocata in un Paese terzo? Produrre le mascherine in Italia risponde all’esigenza di una maggiore indipendenza per un bene strategico, farlo in modo socialmente e ambientalmente responsabile è un vero e proprio investimento sulle persone e sul loro futuro
La scelta coraggiosa di produrre mascherine certificate secondo i rigidi parametri normativi con un progetto di riconversione, di grande attenzione alla componente sociale e all’ambiente non arriva dai grandi player chiamati a rispondere a questa sfida. Arriva da una giovane e rivoluzionaria impresa sociale, in grado di creare una rete di piccoli produttori, fornitori di qualità, associazioni del territorio e fare squadra per costruire una filiera in grado di creare lavoro producendo in Italia mascherine riusabili e riciclabili.
Creare una filiera produttiva di aziende locali è spesso considerato un traguardo. Raggiungere lo sviluppo condiviso di un prodotto che deve rispondere ad altissimi standard qualitativi coniugando attenzione ai lavoratori, inserimento di soggetti fragili e sostenibilità ambientale è un investimento sociale che a oggi non riusciamo a leggere nel valore economico di una commessa
In un momento difficile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, affrontare l’emergenza rischiava di assorbire tutte le energie facendo perdere di vista il “come” della produzione di prodotti necessari alla salute e gli impatti delle iniziative poste in essere.
L’esperienza del Distretto Diffuso ci dimostra come ci sia una grande differenza nel fare impresa e impresa sociale: la formula del profitto, indispensabile per far funzionare qualsiasi attività economica, si arricchisce della componente umana, comunitaria, ambientale con un effetto moltiplicatore della ricchezza generata.
Se puntiamo al bene comune dobbiamo imparare sempre di più a misurarne la generatività, l’impatto di iniziative sociali ed economiche in un’ottica multidimensionale che non consideri solo il benessere del consumatore ma anche le ricadute su tutte le altre dimensioni del ben vivere.


La crisi nell’area della Città Metropolitana di Torino ha colpito duramente le aziende con meno di 9 addetti che hanno registrato un calo del -5%.
La richiesta di accesso al credito è cresciuta del + 42,4%
Con i suoi 6.827 chilometri quadrati la Città Metropolitana di Torino è il primo ente territoriale di area vasta per estensione e numero di comuni. Ne comprende 312, suddivisi in undici zone. Come leggere i bisogni, capire le necessità, generare risposte in un’area così grande? Lavorando in rete, attraverso due categorie socio-economiche fondamentali: la fiducia e il credito.

Tom Dealessandri ha una lunga esperienza nel tessuto socia-
le piemontese. È stato vicesindaco della città della Mole e, oggi, è presidente della fondazione don Mario Operti, ente di Terzo settore e braccio operativo dell’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Torino. È lui a raccontare cosa sta accadendo in conseguenza di una crisi che ha colpito duramente il territorio, mettendo a dura prova un tessuto fatto di piccole e microimprese.
Il fondo So.rri.so.
Per trovare risposte ad alcune “dimensioni fondamentali” emer-
se dal territorio, prima su tutte l’esigenza del fare impresa, la logica da seguire, racconta il presidente, «non è quella dell’assistenzialismo, ma quella del microcredito». La Fondazione si è data così un duplice compito: raccogliere le risorse necessarie alla composizione di un Fondo economico, depositato presso le banche convenzionate, a garanzia dei prestiti erogati a condizioni di favore e «accompagnare le persone all’utilizzo dei prestiti sociali in una logica di sostegno, di ascolto dei bisogni e di supporto all’equilibrio nella gestione del-
le aziende del tessuto socio-economico piemontese colpite dalla crisi e dalle conseguenze della pandemia
i lavoratori collocati in Cassa integrazione in deroga a dicembre 2020
la spesa stimata in conseguenza della crisi che ha colpito le imprese piemontesi
la stima delle assunzioni in meno, tra gennaio e novembre 2020, rispetto all’anno precedente
le famiglie dell’area piemontese che hanno richiesto il reddito di emergenza. Un valore superiore alle altre regioni del Nord, ad accezione della Liguria e dell’Emilia-Romagna
i finanziamenti erogati da Intesa Sanpaolo in aiuto a famiglie e imprese nel 2020, di cui 1,7 miliardi di euro per iniziative in risposta alla crisi del Covid
le organizzazioni del Terzo settore piemontese che hanno beneficiato di sostegno da parte di Intesa Sanpaolo (per un totale di 89 milioni di euro)
il valore dei prestiti stimati per il progetto del Fondo Sorriso a sostegno del distretto torinese
i Comuni della Città metropolitana di Torino, oltre a 15 in provincia di Cuneo e 6 in provincia di Asti, coinvolti nel progetto del Fondo Sorriso sostenuto da Intesa Sanpaolo e Arcidiocesi di Torino

il tasso dei microcrediti, rimborsabili in massimo 6 anni
gnor Cesare Nosiglia, «il lavoro esiste solo se fioriscono imprese». La partnership con Intesa Sanpaolo si inserisce in questa sfida e parte da una constatazione, che l’arcivescovo spiega così: «Ci serve avere un partner solido, affidabile e attento alle richieste sociali del nostro territorio».

L’iniziativa per il credito alle piccole imprese, che potranno godere, grazie alla garanzia prestata dalla fondazione Operti, moltiplicata da Intesa Sanpaolo, di finanziamenti rimborsabili in un periodo massimo di sei anni al tasso dello 0,4%, riguarda un territorio che coincide con il perimetro dell’arcidiocesi torinese, toccando 137 comuni della Città metropolitana, 15 comuni in provincia di Cuneo e altri sei in provincia di Asti. Il progetto dell’arcidiocesi, osserva Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, unisce «l’anima creditizia e quella filantropica in modo innovativo e apre un nuovo capitolo di collaborazione con la Diocesi». Una collaborazione, spiega ancora Gros-Pietro, che in un periodo di grande complessità scommette sul «sostegno allo sviluppo del territorio, con criteri di impatto, che per una banca significano: tassi contenuti e lunghi tempi di restituzione». Al tempo stesso, Intesa Sanpaolo «ha maturato notevole esperienza, in tredici anni di attività creditizia al fianco degli enti del Terzo settore».
le risorse ricevute e da restituire».
Così lo scorso maggio è nato il fondo So.rri.so-La Solidarietà che riavvicina e sostiene. Nato dapprima per le famiglie, oggi si rivolge anche alle imprese del territorio, con un’idea forte: permettere alle aziende, attraverso un prestito sociale, di recuperare gradualmente autonomia e mantenere merito creditizio.
Il lavoro è il principale veicolo di inclusione sociale, uno degli strumenti principali di realizzazione stessa della persona ma, spiega l’arcivescovo di Torino, monsi -
Una solidarietà circolare Oltre al beneficio immediato, il progetto sul microcredito è in grado di attivare investimenti «che renderanno le imprese beneficiarie più resilienti, rendendo al contempo più solido e attrezzato anche il tessuto economico del nostro territorio». Servono ulteriori strumenti che, conclude Gros-Pietro, «permettano di sostenere il debito in un’ottica di più lungo periodo».
Nella linea di intervento a favore delle piccole imprese, oltre che da Intesa Sanpaolo, la fondazione Operti è affiancata dalla rete delle associazioni di categoria del commercio,
artigianato, piccola industria e agricoltura, da Cna a Coldiretti, da Confesercenti a Confcommercio, Confartigianato e Api. «Questo intervento può effettivamente consentire ai piccoli imprenditori di effettuare degli investimenti e provare a restare competitivi. Aiutare loro significa aiutare molto di quella che è l’attività e l’occupazione del nostro territorio» sottolinea Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo.
OSpiega monsignor Nosiglia: «Vanno pertanto messe in campo tutte quelle azioni necessarie a salvaguardare l’autonomia, il benessere delle persone e le opportunità di sviluppo». L’esperienza del Fondo, ha fatto emergere il potenziale di una «rete di intervento multiattore», composta da soggetti pubblici, istituti di credito, enti del Terzo settore, rappresentanze d’impresa. Ne deriva, avverte monsignor

Piccole imprese, artigiani, lavoratori autonomi non agiscono con criteri meramente economicistici. Se lo facessero, spiega Filippo Provenzano, segretario provinciale del Cna «semplicemente non esisterebbero e, con loro, se ne andrebbe la parte più viva del nostro tessuto economico e sociale».

Qual è il contesto in cui si inserisce l’intervento sul microcredito del Fondo?
Oltre a tassi di chiusura aziendali molto alti, registriamo il ricorso imponente alle misure del decreto Liquidità. Questo fatto è importante e non deve essere letto unicamente in chiave negativa, perché se un piccolo imprenditore accede a queste risorse… significa che vuole costruire, non solo tamponare. Vuole andare avanti.
Che cosa spinge un piccolo imprenditore a continuare?
La propensione alla resilienza. Le piccole imprese non sono semplici “imprese”, sono la vita stessa degli imprenditori. Un po’ perché sono imprese di famiglia, un po’ perché sono un bacino di senso. Questo spiega la loro incredibile resilienza anche in un contesto di crisi come quello che stiamo attraversando. Fosse solo per l’utile, chiuderebbero. Ma queste imprese generano qualcosa di più dell’utile, generano valore.
Vanno dunque aiutate per questo di più?
Esattamente e, per aiutarle, va sostenuta la loro propensione alla resilienza e il fondo So.rri.so., messo in campo da due realtà importantissime come la Diocesi e Intesa Sanpaolo, va esattamente in questa direzione.
Quando afferma che la piccola impresa non segue criteri meramente economicistici, cosa intende?
Nosiglia, «una concezione circolare della solidarietà fortemente legata alla logica del microcredito e al prestito d’impatto».
Questa logica, infatti, accompagnando persone e imprese nel processo di restituzione non esaurisce il proprio percorso nel gioco tra credito e debito, ma genera valore, fiducia, nuove risorse che, una volta rientrate nel Fondo, «saranno nuovamente messe a disposizione di chi, successivamente, avrà bisogno ancora di un temporaneo e necessario sostegno».
Intendo dire che genera valore per il territorio, per le relazioni, per le famiglie, di conseguenza, se va in crisi è inevitabile che vadano in crisi non solo le fonti primarie di reddito per chi in quelle imprese lavora, ma tutta la catena di valore e di valori che dalle microimprese si genera.
C’è chi applica criteri tradizionali: costi e ricavi. Le micro e piccole imprese sostenute dal Fondo sono imprese di territorio, vivono delle dinamiche del territorio sia dal punto di vista territoriale e commerciale, sia da quello sociale.
L’intervento di Intesa Sanpaolo e della Diocesi ha caratteristiche specifiche e tecniche che vanno in questa direzione…
Assolutamente sì, ma credo che la forza di questo intervento sia di scenario. Va a fondo di una questione: il valore comunitario del fare impresa. In prospettiva è necessario sostenere la propensione alla resilienza alimentandola con una forte iniezione di fiducia.
«Sostenere le Pmi significa dare ossigeno a famiglie e territorio»Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino
Un evento del “Settembre chierese”. Reagire alla crisi con il credito: è la sfida del comune di Chieri che ha garantito liquidità con 35mila euro di prestiti a imprese e partite Iva considerate “non bancabili” dai canali tradizionali

Alessandro Sicchiero, primo cittadino di Chieri, uno dei comuni dell’area metropolitana di Torino
«Tendiamo a dividere famiglie e microimprese, ma sui territori sono realtà interconnesse». Il Covid, racconta Alessandro Sicchiero, sindaco di Chieri, città di 36mila abitanti che, dal 2019, ha allargato come mai prima la fascia della povertà. «Ci arrivano richieste di aiuto», spiega Sicchiero, «da artigiani, e partite Iva. Rispondere è necessario affinché il tessuto sociale non si sgretoli, ma servono strumenti nuovi che rigenerino fiducia e legame».
Quando siete entrati in contatto con il Fondo So.rri.so. e le iniziative di microcredito?
A metà del 2020, quando dovevamo affrontare proprio l’annoso problema della ex Embraco, una questione che si trascina da oltre quindici anni e coinvolge circa quattrocento lavoratori e le loro famiglie. In seguito a questo primo contatto, come amministrazione, abbiamo capito subito la potenzialità e la forza di questo progetto.

Un progetto di microcredito che non si limita a erogare sussidi —
con tutte le complicazioni, anche di tipo emotivo, personale, relazionale che questo comporta — ma segue logiche di rigenerazione del tessuto economico e sociale. Abbiamo dunque aderito al Fondo anche perché i segnali che arrivano dal territorio ci sembrano chiari: stanno entrando nella fascia della povertà cittadini che, normalmente, non si avvicinavano agli uffici per le politiche sociali del comune, mentre oggi osservando la composizione sociale di chi fruisce dei buoni spesa ci accorgiamo che la realtà è cambiata.
Dal punto di vista di un amministratore pubblico, il Fondo è una risposta a questa crisi?
Lo è proprio per questa fascia media di persone che, in conseguenza della pandemia, sono sconosciute ai servizi sociali, non riescono a reperire risorse per far fronte alle spese vive e si trovano in difficoltà anche solo nel chiedere aiuto seguendo i canali tradizionali. Non è facile ritrovarsi da un giorno all’altro in condizioni di bisogno, talvolta di estremo bisogno
o di morosità incolpevole. Io stesso, che arrivo da vent’anni di lavoro come professionista con partita Iva, quando guardo questa crisi mi accorgo che sarebbe bastato niente, per trovarmi coinvolto in prima persona.
Nel 2020, la convenzione col Fondo puntava a sostenere famiglie e liberi professionisti, oggi si allarga alle microimprese.
È la sua forza. A Chieri siamo partiti da una somma di 35mila euro, con prestiti dai 3 ai 5mila euro restituibili in 60 mesi.
Poco, tanto?
Né poco, né tanto: è diversa la logica. Proprio per come è strutturato l’intervento questi soldi fungono da leva moltiplicatrice, con una ricaduta positiva sul territorio. Come numeri, oggi, siamo a circa venti soggetti (famiglie e microimprese) che sono già riuscite ad accedere a questo fondo, ma questi venti soggetti sono destinati a crescere e quando cresceranno troveranno non solo una risposta a un problema immediato, ma una leva generatrice di futuro.
MOaria ha quarant’anni, due figlie adolescenti di 13 e 15 anni. Il suo ex marito è lontano, si sono separati da tempo. Assieme hanno infatti deciso di provvedere alla cura delle figlie al 50%. Così Maria non percepisce il mantenimento. Da due anni, lavora in un bar nell’area torinese. «Faccio la cameriera all’interno di una struttura sanitaria per anziani. Mi piace incontrare le persone che vengono nella struttura, nasce sempre un bel rapporto con loro».
Poi, nel marzo scorso, la pandemia ha sconvolto i suoi piani di lavoro e di vita: il primo lockdown «mi ha portato via molto, ma non tutto». Ma in quel “molto” c’è la perdita temporanea dell’impiego. Il bar ha dovuto chiudere, perché è
considerato un servizio non essenziale per la struttura e ad oggi non ha ancora riaperto. Il lockdown, per lei, ha significato cassa integrazione. «Sono entrata in cassa integrazione al 40% e, con me, anche il mio nuovo compagno che, essendo cuoco, si è trovato nella medesima mia situazione». Spiega Maria: «Non pensavo di trovarmi improvvisamente in questa situazione, perdendo da un giorno all’altro tutti i punti di riferimento». Poi Maria ha letto una notizia pubblicata sul quotidiano della città: si parlava del Fondo So.rri.so. «Mi sono fatta forza e ho preso contatti con la fondazione Operti che mi ha accolta e ascoltata con molta cura». «Avevo paura, non avevo mai fatto richieste del genere. In più… c’era un limite, diciamo così, tecnologico:
oi lo chiamiamo così: un mattone per il nostro futuro». Andrea si illumina quando parla del fondo So.rri.so e del piccolo prestito a cui ha avuto accesso. Abita a Collegno, 50mila abitanti. «Ho 33 anni. Non so se sono vecchio o sono giovane, ma di certo avevo impostato la mia vita lungo un binario preciso: il lavoro autonomo». Sposato, un figlio di tre anni che adora, Andrea è autonomo solo da due anni. «Era il mio sogno nel cassetto e continua ad
esserlo», spiega. «Ho fatto di tutto nella vita, ma sempre come dipendente, e dopo molti sacrifici sono riuscito ad aprire una mia piccola attività». Torniamo indietro, al mese di febbraio del 2019. «Nell’inverno di due anni fa, grazie al contatto con un mio amico ho aperto la partita Iva come noleggio con conducente. Ho fatto degli investimenti e lavoravo soprattutto per aziende e privati per il trasporto dall’aeroporto di Caselle». L’attività si svolge anche all’interno di un consorzio del settore, dove condivide rischi e occasioni con altri quindici imprenditori. La strada sembrava tranquilla ma, racconta, «la pandemia ha colpito subito duramente: per la mia impresa, in pochi mesi, c’è stato un calo del fatturato pari all’80%». Quasi tutte le aziende con cui lavorava hanno chiuso, chi temporaneamente chi, purtroppo, per sempre. «Le aziende che hanno continuato la loro attività, però, non mi hanno garantito di continuare perché hanno annullato tutte le trasferte a causa dello smart working e il blocco dell’aeroporto». Arrendersi? «No, ma la volontà non basta, serve qualcosa che ti aiuti a non cadere e ti permetta di costruire un futuro
l’ascolto avveniva in videochiamata, ma ho trovato persone che hanno saputo creare empatia e comprensione anche così». Le difficoltà?
«Legate alla vita quotidiana: soprattutto agli arretrati dell’affitto, alle spese condominiali e alle utenze, che si sono accumulati a causa del crollo delle entrate della mia famiglia». L’erogazione del microprestito le ha ridato fiducia, le ha permesso di trovare un nuovo punto di riferimento. «Mi hanno garantito la possibilità di ricostruire un equilibrio economico familiare, coprendo gli arretrati». Le hanno ridato speranza e usa questa parola Maria «respiro». Le rate di restituzione si inseriscono in uno schema che giudica «validissimo per sostenere famiglie che, come la mia, hanno sempre condotto vite normali e che purtroppo un evento del tutto inaspettato ha fatto solo momentaneamente cadere».
diverso». Un mattone di futuro, appunto. «Sono venuto a conoscenza del Fondo So.rri.so grazie al comune di Collegno». Il Comune, infatti, ha aderito all’iniziativa fornendo la garanzia necessaria per consentire di erogare credito a persone, soprattutto i cosiddetti «non bancabili» tra i quali le partite Iva e i lavoratori autonomi sono la maggioranza, che hanno bisogno di un limitato sussidio di liquidità per le proprie esigenze. «Nel 2020, ho ricevuto solo 3mila euro di “ristori” statali. Utili, certamente, ma non sufficienti. Il Fondo mi ha invece permesso di sistemare gli arretrati, non finendo tra i cattivi pagatori, dando liquidità immediata alla mia piccola attività. Non solo mi hanno aiutato a non cadere, ma mi stanno dando lo slancio giusto per non abbattermi e per ripartire».
Tessuti Arcobaleno è un’impresa a conduzione familiare. La sua storia viene da lontano, dal 1959. Per molti anni ha avuto due punti vendita al dettaglio e all’ingrosso di tessuti per l’abbigliamento e l’arredo. Uno si trovava in via della Bartola, in pieno centro a Torino e un altro di proprietà l’unico ad oggi attivo in corso Regina Margherita. Fulvio è il titolare di questa piccola, importante impresa e spiega: «Abbiamo sempre offerto materiali di prima qualità». Un’impresa, per quanto piccola, racconta Fulvio «è come un ecosistema, attorno ad essa ruotano altre piccole imprese». Ne tocchi una e l’ecosistema si rompe. Così è stato: lockdown, chiusure, difficoltà ad andare avanti. Una situazione imprevedibile, non solo imprevista. «Ho saputo del Fondo leggendo La Stampa Ho poi sentito anche la mia Banca, Intesa Sanpaolo, e ho capito che potevamo rivolgerci a loro». Nel 2020, racconta Fulvio, «la mia impresa ha avuto un calo importante delle vendite, nonostante abbia cercato di attrezzarmi online. ma senza grandi risultati». Dopo sessant’anni ininterrotti di attività, Fulvio ha così dovuto fermare completamente la Tessuti Arcobaleno. Primo stop a marzo, secondo stop a novembre. Qualche aiuto statale, ma anche «conseguenze economiche che non sono riuscito a risolvere del tutto». L’impresa è un’eredità di famiglia, ricevuta dai parenti e da lasciare ai figli. Un bene relazionale e generazionale, prima ancora che la fonte di reddito per sé e i suoi cari. «La mia intenzione, mediante l’accesso al Fondo, è quella di dare respiro all’attività, con un’iniezione di liquidità e, possibilmente, investire nel magazzino con l’intenzione di ritornare, come già in passato, ad assumere giovani interessati al mio settore». Assumere, in tempo di crisi: già questa idea dice molto. Dice «di un atto di fiducia verso le microimprese, da parte del Fondo, che dobbiamo impegnarci a moltiplicare una volta usciti dalla crisi». È un momento difficile, conclude Fulvio, «ma questa iniziativa è un ponte, un piccolo grande ponte, verso il domani».
«Ogni piccola impresa è un ecosistema attorno a cui ne ruotano altre»
«Anche
La nascita del Fondo So.rri.so ci offre un esempio materiale di cosa può una “comunità di cura” che si fa “comunità operosa”. Il microcredito promosso dalla Diocesi di Torino e Susa rivolto alle microimprese, grazie alle garanzie del circuito delle fondazioni e sostenuto dalla grande banca, evoca, nel mio linguaggio, quattro parole.
Fiducia e credito sono concetti gemelli, nel senso comune prima che nella lingua degli operatori finanziari. Niente credito senza fiducia e viceversa, senza credito è difficile ottenere fiducia. Da quando la crisi Covid ha bastonato l’economia rasoterra che tiene insieme le città e i territori, ci siamo tutti resi conto che no, il mercato da solo non basta, e neanche lo Stato, ritornato provvidenza nelle attese di tanti, potrà supplire a questo deficit. I ristori (necessari) sono a tempo, si consumano in fretta. La fiducia è moneta che si valorizza usandola.
Lo scivolamento dei penultimi. La volontà di andare avanti che trova testimonianza nel “ricorso imponente” alle misure del Decreto Liquidità è l’altra faccia delle serrande abbassate e delle officine dismesse. In Piemonte, il reddito medio dei lavoratori autonomi si è ridotto del 28% tra il 2007 e la vigilia di Covid, più ancora del pure impressionante calo osservato tra i salariati dipendenti (-11%). In tutte le cronache sui nuovi indigenti, ma anche di quanti faticano a far quadrare i bilanci di famiglia, la componente dei microimprenditori occupa da tempo uno spazio crescente. Ce lo dice esplicitamente il sindaco di un comune della cintura, Chieri, un centro che ieri si sarebbe potuto definire in media benestante, quando osserva che la composizione sociale di chi fruisce dei buoni spesa è cambiata. Territorio. Parola per alcuni fumosa e per altri terribilmente concreta: ce lo spiega con semplicità il presidente della Cna locale, Filippo Provenzano, quando afferma che le micro e piccole attività sostenute dal Fondo sono imprese di territorio, ossia, vivono delle dinamiche del territorio, in simbiosi con la sua vita sociale e con le sue relazioni. Territorio non è inerte spazio geografico né contabilità di residenti da profilare per creare valore finanziario, digitale, o mercato di destinazione e di produzione; è spazio di relazione tra economia e società, intimità dei nessi connettivi, forma vitale. Quando i nessi si indeboliscono, saltano anche le forme di convivenza e di solidarietà. Comunità. Forse, poiché come diceva il poeta laddove massimo è il pericolo cresce anche ciò che salva, Torino è anche territorio dove le comunità della cura, le reti associative e d’impresa che tanta parte hanno avuto nel tenere la rete sociale nei mesi più duri della pandemia, trovano istituzioni sufficientemente solide a cui agganciarsi. Le Fondazioni di origine bancaria, in primis, protagoniste di questa come di altre virtuose vicende, e quelle come la Fondazione Operti che danno sede al tessuto operoso del civismo cattolico, come in questo caso, e laico del territorio. Ed è ciò che chiamo “comunità di cura” ad essersi attivata, con il peso e l’autorevolezza dell’Arcidiocesi in prima fila. E tuttavia, la “comunità di cura”, questa la lezione che apprendiamo da Torino, deve sapersi fare “larga” e contaminare, come in questo caso, il mondo economico con le sue rappresentanze, che anche nel dare risposta ai penultimi possono trovare senso e ragion di esistere, oltre che nel Recovery fund. È quanto a Torino hanno fatto le associazioni del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e della piccola industria. E la finanza, in questo caso rappresentata dal primo gruppo bancario italiano. Intesa Sanpaolo aderisce all’iniziativa cercando un punto avanzato di sintesi tra anima creditizia e filantropica, per usare le parole del presidente Gros-Pietro.
Comunità di cura che interroga e contamina la comunità operosa, il mondo economico e degli affari, chiamato a cercare di sciogliere la complicata matassa di economia e società.
In una visione non assistenziale, come rimarca Tom Dealessandri; accento che forse, almeno in qualche occasione, si potrebbe anche omettere, per nostra opinione.

Rigenerare spazi, riconnettere generazioni e territorio, essere attivatori di coesione sociale attraverso l’arte e la bellezza, l’innovazione e l’educazione.
Sono questi gli obiettivi strategici messi in atto da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo attraverso una serie di interventi strutturali, di promozione e sostegno che puntano a tenere assieme due assi portanti della comunità: il welfare e la cultura. L a Fondazione CRC, una delle 10 maggiori Fondazioni di origine bancaria italiane, ente non profit che dal 1992 persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, lo fa attraverso le chiavi dell’inclusività e dell’impatto. Investire sul futuro significa promuovere la coesione tra stakeholder del territorio dando vita a economie e azioni virtuose. Obiettivi virtuosi che, nell’azione di Fondazione CRC, sono esemplificati da tre fra i numerosi interventi messi in campo: il Bando Distruzione, la rigenerazione del Rondò dei Talenti e dell’ex Frigorifero Militare e gli interventi di transizione ecologica. Un asse d’intervento che ha preso avvio dai risultati della ricerca pubblicata nel Quaderno 37 della Fondazione dal titolo Rigenerare spazi dismessi.
«Ogni atto di creazione», raccontava Pablo Picasso, è al contempo
«un atto di distruzione». Le parole del pittore spagnolo sono il claim ideale per il Bando Distruzione della Fondazione CRC, avviato nel 2017, finalizzato a eliminare incoerenze e brutture per ripristinare la bellezza e a incrementare la sostenibilità di un territorio straordinario e da rigenerare, soprattutto nei suoi piccoli borghi.


Nelle prime tre edizioni, sono stati 29 i progetti finanziati: quattordici demolizioni, otto interventi di riqualificazione e sette installazioni di arte pubblica per un totale di 1,55 milioni di euro di valore complessivo degli interventi. Già nella seconda edizione, il numero di progetti presentati era quadruplicato, segno dell’effetto positivo generato sul territorio, anche in termini di consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità. In totale, sono stati 131 i progetti presentati con un imponente riscontro di partecipazione attiva
che ne fanno un modello di platform society.
Le comunità protagoniste
Le comunità territoriali, infatti, sono chiamate a votare i progetti su una piattaforma web. «Interloquire attivamente nelle varie fasi che portano alla realizzazione di un’opera permette di rigenerare gli spazi, ma anche i percorsi partecipativi», raccon-
In provincia si sperimentano soluzioni locali a problemi di carattere globale: dalla cura dell’ambiente alla riscoperta della bellezza. A sinistra, l’esempio di Monticello d’Alba con un intervento di land art di Valerio Berruti.
In basso un momento espositivo realizzato da Fondazione CRC: la bellezza e l’arte come forme di rigenerazione sociale
dell’associazione Art.ur, partner del bando, insegnante d’arte nella stessa scuola, dice: «Le generazioni che gravitano attorno alla scuola sono tantissime, è una porta d’ingresso della città nella provincia e viceversa». Arte, transizione ambientale, coscienza di luogo: «I ragazzi hanno lavorato per dare all’artista delle suggestioni, lui le ha introiettate nei suoi bozzetti e la comunità sta scoprendo, in questo processo tra il cuneese e New York, dove vive l’artista, la forza del dare risposte concrete a problemi globali». Il progetto, conclude Giuggia, «è infatti un lavoro context specific, studiato non per un luogo, ma per uno specifico contesto comunitario in cui i cittadini sono protagonisti dell’intero percorso».
ta Silvio Artusio, sindaco di Monticello d’Alba, tra i luoghi simbolo del Bando Distruzione.
A Monticello d’Alba, splendido borgo medievale situato al centro del Roero e deturpato da una muraglia in cemento armato, si può vedere uno degli interventi pilota realizzati grazie al Bando Distruzione. L’opera è di Valerio Berruti. Berruti ha trasformato quel muro in un’opera di land art, ricoprendola con formelle e in parte lasciando che sia l’edera a fare il resto. Un’opera che, spiega l’artista, «ha di mira il bene pubblico e la comunità che lo deve continuamente alimentare e curare: l’edera andrà seguita. In questo senso, l’opera di rigenerazione viene a sua volta continuamente rigenerata dagli abitanti».
Un altro, recentissimo progetto, legato alla terza edizione del bando è quello di Madonna dell’Olmo. L’artista Federico Massa, alias iena cruz, ha iniziato un pionieristico intervento di street art sull’ingresso della scuola media. Michela Giuggia, presidente e direttore

I numeri del territorio
6895 km2
terza provincia italiana per estensione territoriale 590.309 abitanti tra le principali province del Nord Ovest per numero di abitanti 247 comuni 50,8% del territorio cuneese è a caratterizzazione montana
I numeri dell’economia
26.500 €
Cuneo è la provincia piemontese con il più alto valore aggiunto pro capite 70mila imprese il 15,8% di quelle piemontesi
I numeri della cultura
160
realtà museali e istituti culturali 3mila micro-imprese “creative e culturali” 4,4% del totale delle imprese opera nel settore turismo, gusto, artigianato
Se il Bando Distruzione mira a ridare consapevolezza comunitaria rispetto al valore e alle risorse paesaggistiche, economiche e ambientali del territorio, la rigenerazione degli spazi dismessi per farne centri di riferimento culturale aperti alle comunità è un altro dei punti strategici dell’azione della Fondazione. Importante è la riqualificazione dell’ex Frigorifero militare, che diverrà polo culturale nel centro della città di Cuneo. Nato come deposito, dagli anni 80 il Frigorifero non è più stato usato. Il fabbricato, acquistato da Fondazione CRC nel 2019, sarà presto il cuore di un distretto culturale della rigenerazione che vede a pochi passi il Complesso Monumentale di San Francesco, oggetto di un restauro sostenuto dalla Fondazione con 6 milioni, oggi sede di mostre ed eventi culturali annessa al Museo Civico. Un processo di rigenerazione che continua poche centinaia di metri più in là, su una delle principali porte d’ingresso della città, con il progetto del Rondò dei Talenti, vecchia sede di Ubi Banca, su cui Fondazione CRC ha promosso un restyling attraverso un concorso nazionale per professionisti under 40: 70 i progetti candidati da tutta Italia. «La rigenerazione urbana genera qualità
Una vigna può generare sviluppo, educazione, nuova economia. Soprattutto se è una vigna storica, bene relazionale oltre che materiale situato proprio sotto il famoso Castello sede dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour

Proprietà della Cassa di Risparmio di Cuneo, prima, poi della Banca Regionale Europea e infine di Ubi Banca la vigna “Cascina Gustava” a Grinzane Cavour, che ha sempre assolto anche finalità educative, grazie alla Scuola Enologica di Alba, è stata acquistata della Fondazione CRC. Lo scopo? Non solo preservare un bene storicamente rilevante, ma metterlo a disposizione della comunità grazie a una collaborazione di lunga durata con la Scuola Enologica, che può continuare a servirsene per lo sviluppo di un territorio fortemente vocato alla produzione vitivinicola. Proprio l’intervento della Fondazione CRC permette ora alla Scuola Enologica di consolidare la formazione sul campo dei propri studenti e di immaginare nuovi sviluppi di queste attività. Si tratta di una nuova modalità operativa, di intervento ibrido su un asset territoriale rilevante, che permette di integrare sviluppo locale, attivazione delle comunità, formazione e impresa. Tutto al servizio del bene comune: con la vendemmia 2020 di questi vitigni storici, infatti, è stato prodotto un Barolo unico che verrà messo all’asta con un evento altrettanto unico previsto per il prossimo autunno. La Fondazione sta infatti organizzando la prima asta italiana di vino en primeur: le barriques e i tonneaux, dentro a cui il vino è stato fatto invecchiare, saranno vendute e il ricavato della vendita verrà interamente devoluto per iniziative a finalità sociale. In totale, con la vendemmia del settembre scorso sono stati vinificati 65 quintali di uve. Il raccolto è stato vinificato in modo differenziato: in questo modo sarà possibile ottenere Barolo con diverse caratteristiche, seppur appartenenti allo stesso vigneto. Nella realizzazione dell’iniziativa è stato coinvolto il Laboratorio Enosis Meraviglia di Donato Lanati enologo di fama internazionale, “padre” di alcune delle migliori etichette presenti sul mercato mondiale al quale la Fondazione CRC ha affidato l’incarico di guidare l’intero percorso produttivo, dalla maturazione delle uve, alla vinificazione e al successivo affinamento in bottiglia.
Imprese, associazioni, organizzazioni locali interessate a creare collaborazioni o a investire in nuove realtà vengono guidate in un percorso che favorisce la condivisione di esperienze e il contatto con player di primaria importanza nell’ambito del mondo impact
Generare impatto sociale, promuovendo innovazione. La sfida di GrandUp!, progetto promosso da Fondazione CRC e Camera di Commercio di Cuneo, in collaborazione con il Cisem (Comitato per l’imprenditorialità sociale e il microcredito) e con il supporto tecnico di SocialFare – Centro per l’innovazione sociale, è chiara: promuovere un’ampia azione di sistema volta a rendere la provincia di Cuneo un territorio ideale per lo sviluppo di imprese a impatto sociale, con importanti ricadute in termini occupazionali, di sviluppo e di rafforzamento del sistema di servizi offerti ai cittadini. Per generare un impatto socialmente positivo, GrandUp! fa leva su due poli. Il primo polo è quello dell’imprenditorialità sociale. Il secondo è l’attivazione del territorio. Se dal lato dell’imprenditorialità sociale si tratta di promuovere percorsi di consapevolezza, conoscenza e formazione, su quello dell’attivazione viene invece incrementata la capacità del territorio di attrarre investimenti, creando occasioni di incontro e scambio, attraverso webinar o talks strategici, con operatori di livello regionale, nazionale ed europeo. Creare sinergie virtuose, premiando progetti innovativi, è la chiave di volta del progetto. Un progetto che, sottolinea Laura Orestano, ceo di Social Fare, «ha permesso di far emergere ancora una volta la ricchezza di questo territorio, la sua disponibilità ad apprendere e confrontarsi e la sua generatività in termini di imprenditoria a impatto sociale. Un “modello Granda” che potrebbe servire da esempio per altri territori italiani». L’obiettivo del progetto è infatti favorire investimenti in realtà provinciali nascenti da parte di società, organizzazioni e fondi con l’intento di generare un benefico impatto che sia misurabile, in campo sociale o ambientale, e promuovendo una cultura dell’investimento responsabile.

umana e questa genera a sua volta sostenibilità», osserva il trentaseienne architetto milanese Marco Oriani, vincitore del concorso.

Inaugurata nel 2020, la Città dei Talenti è al tempo stesso un polo di orientamento professionale, una comunità educante e un hub capace di connettere esperienze sul territorio mettendole a disposizione dei più giovani
Èun punto di riferimento per i più giovani. Bambini e ragazzi, dai sette ai tredici anni, hanno ora un loro spazio nella Città dei Talenti. Situata nel Rondò dei Talenti a Cuneo, la Città mette i propri laboratori didattici a disposizione di tutti coloro che hanno a cuore la crescita, l’educazione, l’orientamento, in una parola: il futuro dei giovani. Insegnanti, genitori e imprese trovano in questo progetto, ideato da Fondazione CRC e finanziato con 950mila euro complessivi, insieme a Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, un punto di snodo capace di connettere professione e formazione, vocazione e orientamento professionale. Il tutto grazie al coinvolgimento delle agenzie educative: dalla Regione Piemonte all’Ufficio scolastico territoriale, fino alle cooperative e alle agenzie formative del territorio. Nella Città ragazze e ragazzi, bambine e bambini hanno la possibilità di giocare imparando e imparare giocando: attraverso il gioco, sia analogico sia digitale, usato come strumento esperienziale, è possibile per i più giovani calarsi nel vivo di situazioni che permettono di aprire lo sguardo sulle professioni
ed il mondo del lavoro. Importante farlo. Importantissimo farlo a partire da giovanissima età. «Attivare una comunità che crede e investe nel potenziale dei giovani è fondamentale», spiega Andrea Genova, presidente della cooperativa Orso, impegnata attivamente nella Città dei Talenti. Bisogna, spiega Genova, «costruire per loro percorsi
di futuro, ma per farlo occorre rispondere anche a un’altra sfida: farlo assieme a tutti gli attori del territorio».
Per questo la Città dei Talenti è anche un hub territoriale che integra e connette realtà lavorative della provincia in una rete territorialmente diffusa capace di valorizzare ogni territorio-esperienza, anche il più difficile da raggiungere, collegandolo al centro. Sistema integrato di interventi educativi e formativi condotti in modo coerente su tutto il territorio provinciale, attraverso i quattro quadranti del cuneesi AlbaBra, Cuneo, Cebano-Monregalese e Monviso (Fossano, Saluzzo e Savigliano), la Città dei Talenti in meno di un anno di vita è riuscita a diventare uno spazio comunitario importante per i ragazzi e i loro genitori, ma anche per gli insegnanti, gli operatori e gli orientatori che vengono a loro volta coinvolti in corsi di Alta Formazione sulle tecniche di orientamento precoce attraverso un’idea di formazione circolare e intergenerazionale.
La sostenibilità, interviene Oriani, «è vera se non pensa solo ai numeri, ma alla qualità di vita». Se sostenibilità significa incontro e relazione, prosegue, «allora l’edificio del Rondò dei Talenti non poteva che essere pensato come spazio di relazione». E anche sul lato tecnico, la sostenibilità è uno degli assi portanti del progetto: l’edificio ha infatti ricevuto la certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), standard riconosciuto a livello internazionale che certifica il livello di efficienza energetica e l’impronta verde degli edifici, esaminando tutti gli aspetti del processo di sviluppo e costruzione. L’edificio, che già ospita la Città dei Talenti, «avrà vetrate panoramiche sulla città e le Alpi per uno sguardo a 360 gradi». Il tutto nella logica di «nuove idee per attivare la coscienza etica ed estetica legata al senso dei luoghi grazie a un’innovazione sociale che investe sul futuro», conclude l’architetto.
Nuove idee che, oggi, si stanno sempre più orientando verso una cultura della transizione ecologica oltre che sociale. La smart land rigenerata da Fondazione CRC sta diventando una green land: ed è in questa direzione che vanno gli interventi su energie rinnovabili e riduzione dei consumi energetici, che a fine 2019 uno studio di Environment Park attesta abbiano attirato sulla provincia di Cuneo, tra il 2010 e il 2018, un totale di 40 milioni di euro. A cui si aggiungono i recenti contributi e interventi deliberati dal bando Smart & Green Economy, con il quale si attiveranno investimenti complessivi per quasi 3,4 milioni di euro, con un effetto leva rigenerativo che sfiorerà i 5 milioni. Più sostenibilità, più comunità, più competenze: sono queste le chiavi su cui far leva per il futuro. Un futuro su cui, nei prossimi quattro anni, Fondazione CRC ha già previsto una dotazione erogativa prevista di almeno 80 milioni di euro.
Attivare la comunità significa rigenerarne i luoghi formando nuovi talenti
ostenibilità”, “comunità”, “competenze” sono le parole chiave del nuovo Piano pluriennale della Fondazione CRC. Come si declineranno nell’impegno concreto della Fondazione?
“+Sostenibilità” per noi vuol dire partire dall’educazione ambientale e dalla ricerca di nuovi modelli di sviluppo, più equi e compatibili, ma anche occuparci del nostro patrimonio territoriale per valorizzarlo o “rigenerarlo”.
“+Comunità” significa invece contribuire a una società coesa, laddove oggi l’aumento delle disuguaglianze e il rischio di forti lacerazioni sono purtroppo una realtà: lavoreremo quindi sul benessere delle persone, sull’inclusione di chi è più fragile, sulla partecipazione attiva dei cittadini e del Terzo settore, e molto anche sulla cultura, un linguaggio universale capace di parlare a tutti, e di creare un riconoscimento reciproco.
Infine “+Competenze” sono quelle indispensabili al mantenimento di un ecosistema innovativo, e quindi competitivo, capace di creare lavoro e sviluppo per il territorio. Lavoreremo sulla formazione permanente, sulla transizione digitale in tutti i campi, dalla produzione, alla scuola, alla sanità, con l’obiettivo di aiutare ogni giovane a riconoscere e valorizzare i propri talenti.

In che modo il tema della rigenerazione è trasversale e, al tempo stesso, costituisce il minimo comune denominatore delle tre chiavi di lettura (“+Sostenibilità”, “+ Comunità”, “+Competenze”) del Piano?
La rigenerazione di spazi dismessi, o di aree marginali, per ospitare progetti di sviluppo richiede notevoli energie, ma genera anche ricadute molteplici. Gli spazi rigenerati, infatti, aprono strade nuove, scatenando l’inventiva e le potenzialità delle iniziative imprenditoriali, spesso a forte impatto sociale, che prima covavano sotto la cenere e attendevano l’innesco. Ma la rigenerazione ha un secondo, potente, “effetto collaterale”: la mobilitazione delle comunità. La presa in carico di problemi e responsabilità intorno a sé è fondamentale per riscoprirsi “cittadini attivi”, moltiplicare le energie in campo e riscoprire anche uno spirito di fratellanza, che in certi casi sembra smarrito.
direttore generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, oltre che membro del Supervisory Board della European Cultural Foundation
Rigenerare i territori, riconnettere i luoghi: una vision importante...
Il bilancio del mio primo mandato da presidente della Fondazione CRC si intitolava Generare risorse, restituire energie: un motto che ben sintetizza il lavoro fatto e quello in corso. Grazie all’attenta gestione del patrimonio siamo riusciti, anche in anni difficili, a generare ingenti risorse per sostenere interventi in grado di creare innovazione e stimolare la crescita delle energie e delle grandi potenzialità di cui sono ricche le nostre comunità. La rigenerazione dei territori passa così per la presa in carico di spazi dismessi, che diventano nuovi luoghi di aggregazione e di crescita; per la promozione di interventi che ripristinano la bellezza nei luoghi in cui viviamo, coinvolgendo le comunità; per il rafforzamento della proposta culturale ed artistica, grazie alla collaborazione di importanti realtà culturali; per il sostegno all’innovazione e la costruzione di un ecosistema adatto alla nascita di imprese a impatto sociale; per la spinta alla transizione ecologica e alla capacità di attrarre risorse.
Qual è il bilancio del bando Distruzione?
Il bilancio è davvero positivo: in 3 edizioni abbiamo raccolto 131 proposte progettuali da tutta la provincia di Cuneo, 29 delle quali sono state sostenute e hanno portato a interventi di demolizione, di mitigazione e a installazioni di opere d’arte pubblica. Il bando ha poi promosso la partecipazione e la mobilitazione delle comunità coinvolte, con risultati inaspettati: i 22mila i voti raccolti
Moltiplicare le energie sociali per rigenerare spazi dismessi È questa la chiave per innescare l’imprenditorialità a impatto e mobilitare le comunità
Da problema a risorsa di sviluppo: così abbiamo ribaltato il paradigma delle aree marginali
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo componente del Comitato Esecutivo dell’Acri, consigliere di amministrazione della Fondazione Con il Sud

sulla nostra piattaforma online sono un dato molto significativo. L’idea del bando nasce da una doppia possibile lettura del suo nome: distruzione, perché sostiene l’eliminazione delle bruttezze per ripristinare la bellezza, e d’istruzione, perché vuole sottolineare il valore sociale della bellezza. Credo si possa dire che entrambi gli obiettivi sono stati centrati. E, intanto, è aperta la nuova edizione del bando, che chiuderà a fine aprile.
Le piccole realtà sono spesso viste come marginali, fuori dai luoghi decisivi del nostro sistema. È davvero così?
In una provincia come quella di Cuneo è indispensabile ragionare sulle cosiddette “zone marginali” non come problema, ma come risorsa. Si tratta di territori segnati da processi di spopolamento e invecchiamento demografico, di isolamento digitale e di rischio idrogeologico. Ma che stanno evidenziando dinamiche di rivitalizzazione, reinsediamento e innovazione. Qui si incrociano sfide trasversali e centrali per tutti noi: la riduzione del digital divide, l’innovazione in campo agroalimentare, la promozione del patrimonio naturale e delle tradizioni locali, la lotta alla dispersione scolastica, la valorizzazione dei talenti e la necessità di garantire i servizi essenziali. Solo innovandoci profondamente e raccogliendo le lezioni di questo ultimo anno di pandemia sarà possibile costruire un futuro di prosperità e benessere.
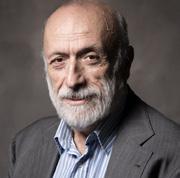
In che modo la transizione ecologica e la produzione agroalimentare stanno ridisegnando il nostro futuro?
Le buone idee, quantomeno dal punto di vista teorico, sono arrivate a contaminare anche i livelli politici più alti. Bisogna però attendere affinché queste si traducano in pratiche che, se saranno veramente ecologiche, dovranno prendere consapevolezza della profonda interconnessione tra ambiente, società ed economia. In tutto ciò, data la sua intrinseca complessità e trasversalità, penso che il sistema agroalimentare possa avere un ruolo strategico per intraprendere azioni in grado di intercettare tutti e tre i sistemi contemporaneamente.
Dentro questo scenario, di quali paradigmi hanno bisogno economia e territorio per stringere una nuova alleanza?
Giunti a questo punto e attanagliati dalle tre crisi, pandemica, economica e ambientale, il paradigma è uno solo: rigenerazione. Risulta più che mai necessario rigenerare un modello economico ormai passato, superato e evidentemente sconfitto: il capitalismo spietato, fondato su consumismo e logica del profitto non è riuscito nella sua sfida e gli innumerevoli tentativi di greenwashing di questo periodo ne sono la più limpida testimonianza. Il processo rigenerativo deve di certo passare anche per una logica della cura volta a innestare nelle coscienze dei più il rispetto per la terra e per il territorio: dobbiamo sempre ricordarci che ogni forma di vita, non solo umana, è strettamente connessa alla salute del nostro Pianeta. Tutto questo però sarà possibile solo se si rigenera il pensiero. In questo momento c’è tanto bisogno di azioni in grado di concretizzare a livello sociale, economico e politico gli slogan sostenibilità e rigenerazione.
I territori, anche quelli più marginali, possono diventare un traino per una nuova idea di sostenibilità e rigenerazione?
La pandemia ci ha fatto accorgere del valore di una passeggiata nel verde o del respirare aria pulita. Questa possibilità è tanto più concreta quanto più si vive in quelle aree cosiddette marginali: montagne, piccoli centri abitati o le stesse periferie di una grande città, ed è lì quindi che bisogna concentrarsi per dar forma ad uno scenario post-pandemico sostenibile e rigenerato. Dotiamo questi territori di tutti i servizi e le infrastrutture necessari a garantire una buona qualità della vita, e sono certo che si popoleranno di persone che, riconoscendo la bellezza della natura che li circonda, si sentiranno responsabili della sua cura.
pioniere dell’agroalimentarre, è fondatore di Slow Food. Ha inoltre ideato l’Università di Scienze gastronomiche e la rete di Terra Madre
L’agroalimentare? Un laboratorio per mettere a sistema le connessioni fra ambiente, società ed economia
Le pratiche di territorio raccolte in queste pagine ci dicono di cosa può quello che chiamo comunitarismo fondazionale.
La provincia di Cuneo, la “Granda”, tra quanti di noi si sono occupati per professione e per passione di sviluppo dei territori, rappresenta da oltre due decenni un piacevole rompicapo. Fino al secondo dopoguerra era il parente povero, il cugino di campagna di quella Torino che costruiva la produzione di massa, svuotando le campagne settentrionali prima, le terre dell’osso meridionali poi. Poi arrivarono le industrie. Solo alla fine del secolo scorso però ci accorgemmo tutti che, laddove la grande (Torino) e le piccole (Ivrea, Biella) company town perdevano imprese, occupati, abitanti, il “secondo Piemonte” stava diventando una “storia di successo”. Là si esauriva la spinta del big capitalism e si solidificava un agglomerato “di mezzo” capace di abbracciare il nuovo “rigenerando” le radici. Non stupisce che “rigenerare” sia parola-chiave nei progetti accompagnati dalla Fondazione originata dalla vecchia Cassa di Risparmio di Cuneo nonché paradigma, nella triplice crisi economica, pandemica e climatica, con cui Petrini ridisegna le prospettive del presente. Cuneo, negli anni d’oro, cresceva “rigenerando”. Apprendimento, legame, connessioni sociali si nutrono della prossimità e proprio per questo sono in grado di usare, ma a proprio vantaggio, la simultaneità delle reti globali. Tracce di comunità avrebbe detto qualcuno, ma forse le “tracce” sono parola incompleta: comunità non è qui un residuo del passato sopravvissuto all’assalto della storia, ma forza “rigenerativa” che riproduce senso, reddito, riconoscimento. Tanti capaci interlocutori mi hanno spiegato mille volte che Cuneo tiene perché ha un’economia varia, in grado di ammortizzare le crisi settoriali e di attivare ulteriore varietà correlata. È vero, ma è un pezzo della storia. La sua base sostanziale risiede nella comunità e nelle sue istituzioni. Sul territorio vi sono buone scuole e buone amministrazioni. L’associazionismo è forte, come il volontariato territoriale e ambientale, in una terra periodicamente devastata da alluvioni e smottamenti, e anche il vecchio associazionismo economico è più vivace che altrove. Il policentrico disegno urbano delle “sette sorelle” (da Cuneo ad Alba, da Fossano a Saluzzo, da Bra a Mondovì a Savigliano) ha distribuito welfare e reti creditizie, oggi assorbite nel risiko bancario post Lehman Brothers, sebbene il credito cooperativo e la banca locale qui contino ancora. Soprattutto, hanno consegnato una rete di Fondazioni banca-
rie con pochi eguali nel Paese. Le storie raccolte in questo dossier pongono in primo piano l’operato di Fondazione CRC: protagonista della rigenerazione con gli investimenti diretti in città, gli ex Frigoriferi Militari come distretto educativo e culturale, e nelle colline del Barolo, in cui il valore incorporato nella terra è usato per restituire beni alla comunità che quella terra, che oggi si vende a prezzi da gentrification milanese, ha trasformato e curato negli anni (se vi piace di più, chiamatelo give back). Oppure, per sostenere impresa sociale, per fare comunità educativa, per mobilitare la comunità nel riprendersi il paesaggio. Una Fondazione, la settima in Italia per patrimonio, capace, con il suo vitale Centro Studi, di dare sostanza all’assioma per cui il territorio prima lo si pensa, poi lo si abita.
Storie che ci raccontano della metamorfosi sotto traccia di queste istituzioni. All’indomani della “legge Amato” che le istituì nel 1990 e per molto tempo, il legame con il mondo finanziario di cui potevano essere considerate “braccio sociale” o “cinghia di trasmissione” ne legittimava la descrizione in termini di capitalismo fondazionale. Non era un insulto, almeno per quanti hanno avuto sempre chiaro che il capitalismo è da sempre un sistema di delicati equilibri tra produzione e riproduzione.
Questa prospettiva rimane al centro delle istituzioni filantropiche, che hanno nella manutenzione delle agenzie riproduttive il senso della loro missione. Di acqua sotto i ponti tuttavia ne è passata molta, da allora, e con essa anche due crisi economico-finanziarie, la seconda intrecciata al collasso pandemico a sua volta connesso con la crisi climatica. Cuneo non ha percorso indenne questi tornanti. Anche qui il mondo dell’impresa agganciata alla domanda estera si è disallineato rispetto all’economia di tutti i giorni, il lavoro autonomo è entrato in crisi, il reddito medio moderatamente ridotto. E la pandemia ha disseccato, almeno temporaneamente, la risorsa del turismo. Nella crisi il territorio ha però fatto leva sulla sua risorsa più preziosa, il senso e l’agire di comunità, appunto. E su queste basi può oggi pensare la propria modernizzazione, adoperando in modo credibile le parole che occupano il centro del vocabolario dei nostri giorni: sostenibilità, competenza, cittadinanza attiva. Le Fondazioni, più che mai, sono oggi istituzioni di riferimento delle comunità e devono incorporare nel loro orizzonte simbolico l’istanza di riprodurre comunità. Comunitarismo fondazionale, dunque, come pratica insieme di modernizzazione fondata sulle obbligazioni verso il territorio, e come logica istituzionale in grado di rafforzarne ulteriormente il ruolo.

Uno dei laboratori di Proud of You durante l’edizione 2019. L’iniziativa è finanziata, come i progetti che vi presentiamo nelle prossime pagine, dal Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo. L’obiettivo dei progetti è contrastare la dispersione scolastica nei quartieri più fragili della città
Napoli è una città febbrile. Difficile starci dentro, impossibile circoscriverla. Il Golfo e il Vesuvio, il mare e il fuoco, i reticoli di strade del centro storico, l’aria aperta di Castel Sant’Elmo che la domina dall’alto. La collina di Capodimonte e i quartieri popolari che più che avvolgerla, la stringono. Napoli bellissima, ma faticosa. Tre milioni di abitanti nell’area metropolitana della città, il 18% minori. Un tasso di disoccupazione del 23,3%, che arriva al 44,8% se guardiamo ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni. A Napoli il tasso di abbandono scolastico arriva al 22,10%. I Neet, giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano e non
lavorano, raggiungono nella provincia il 38%, dato che fa posizionare la provincia tra le peggiori in Italia. Eppure Napoli, nel bene e nel male, ti imprigiona.
Con la cultura si mangia, altro che chiacchiere Ma qual è la strada per migliorare? «Investire in formazione è la chiave di volta», non ha dubbi Giovanna Paladino, responsabile della Segreteria Tecnica di Presidenza di Intesa Sanpaolo. Il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo ha sostenuto, tra il 2019 e il 2020, 111 progetti in città. «Ci concentriamo», continua, «soprattutto su quelli che contrastano la dispersione scolastica e si sviluppano in rete: da soli
non si va da nessuna parte. L’istruzione paga sempre. Non è vero che chi studia non trova lavoro. Questa è solo una favola metropolitana messa in giro per evitare che sacche della popolazione riescano a fare un passaggio sociale. Lo studio è l’unico ascensore sociale per cambiare condizione di vita e condizione economica». Ogni progetto sostenuto viene discusso e studiato insieme alle università del territorio per valutarne l’impatto sociale: serve a noi come selezionatori e al progetto stesso che può sempre essere migliorato».
Non solo contrasto alla dispersione scolastica, ma interventi che diano ai ragazzi la possibilità di continuare gli studi. «Con la

gli abitanti nell’area metropolitana 22,10%
111
i progetti finanziati dal Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo per il biennio 2019/2020
286
i prestiti erogarti nel 2020 “per Merito” agli studenti in città 4.500
le istituzioni non profit che lavorano con Intesa Sanpaolo
impieghi erogati da Intesa Sanpaolo al Terzo Settore, di cui 15 milioni nel 2020
cultura si mangia», dice Elena Jacobs, responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo. «Lavoriamo con più università della città. Sviluppiamo progetti in sinergia, prime tra tutte, le iniziative di recruiting e orientamento al lavoro, finanziamo diverse borse di studio ed eroghiamo prestiti agevolati per gli studenti».
Intesa Sanpaolo è partner della Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per il Fondo StudioSì, un finanziamento a tasso zero. Il prestito ha lo scopo di sostenere le spese di iscrizione e le ulteriori spese vive connesse allo studio, è rivolto ai laureati che risiedono o studiano nel Mezzogiorno, non richiede alcuna garanzia, può ar-
rivare a un massimo di 50mila euro ed essere restituito in 20 anni. Questa misura si affianca a “per Merito”, il prestito avviato da Intesa Sanpaolo nel 2019 che ha già erogato 90 milioni di euro in logica impact a favore di oltre 7mila studenti iscritti a tutti i corsi della formazione terziaria. In Campania le richieste totali di studenti di prestiti “per Merito” sono state 538, a Napoli 286.
Più istruzione significa più sviluppo Sviluppo economico di una città e livello d’istruzione sono fattori indivisibili, uno è lo specchio dell’altro: «La prima ragione per cui bisogna investire in istruzione», aggiunge Marco Morganti,
Intesa Sanpaolo, «è che da questa dipende l’essere pienamente cittadini. C’è un filo rosso tra il livello d’istruzione e la capacità produttiva di un Paese. Quando sono a Napoli mi guardo attorno e vedo una popolazione di ragazzi svegli, brillanti, che studiando, laureandosi, possono cambiare il destino di un intero Paese, non solo del Sud. Il pezzo di carta non produce qualcosa, ma allo stesso tempo è vero che l’assenza di quel pezzo di carta ti porterà a guadagnare il 40% in meno rispetto a chi ha conseguito la laurea». Solo le donazioni o i finanziamenti agevolati non bastano. Servono opportunità lavorative: «I giovani napoletani, devono avere davanti a sé una strada tracciata, non solo nebbia», dice Morganti. E allora che opportunità dare a chi vuole restare?
Il Terzo settore offre un contributo significativo per lo sviluppo nelle aree e nelle fasce più deboli del Paese. In Campania sono 21.315 le istituzioni non profit (dato aggiornato al 31 dicembre 2018) e occupano circa 33.500 dipendenti. «Per supportare i giovani che sono il futuro della città», spiega Anna Maria Giordano, responsabile Area Terzo settore Campania, Calabria, Sicilia, «dobbiamo lavorare in sinergia con il Terzo settore, che arriva dove non arriva lo Stato. Per un’azienda di credito come la nostra supportare il privato sociale a Napoli, significa contribuire direttamente allo sviluppo di quella società. Su Napoli abbiamo 4.500 clienti tra le istituzioni non profit e abbiamo erogato prestiti per 58 milioni di euro. Interveniamo per sopperire la carenza di liquidità dovuta ai ritardi dei pagamenti degli enti pubblici. Il nostro compito non è solo quello di erogare credito ma di accompagnarli in una crescita culturale e di educazione finanziaria. Il Terzo settore lavora per noi, per il nostro domani, lavora soprattutto per i giovani. Una banca di impatto è una banca che deve avere ricadute sul territorio o attraverso il credito o attraverso la liberalità. Credito e liberalità sono un binomio importante, se coordinati bene possono fare la differenza».

Nei quartieri più fragili di Napoli venti tutor universitari hanno supportato il lavoro di trenta docenti e realizzato con loro 120 ore di lezioni innovative di didattica a distanza per prevenire il rischio di dispersione scolastica: 600 i ragazzi coinvolti
Dal Rione Bussola a quello dell’Amicizia fino a Poggioreale, dove si sente forte la presenza della casa circondariale Giuseppe Salvia. Zone difficili di Napoli, dove a disegnare le geometrie dei quartieri sono le case popolari, le famiglie spezzate dal muro spianato, un po’ dentro e un po’ fuori il carcere, i ragazzi che a scuola non ci vanno. Tre zone con tre scuole che fanno parte dell’istituto comprensivo Radice Sanzio Ammaturo. È qui che l’associazione Next Level, in partenariato con la scuola, la cooperativa sociale i Millepiedi e l’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, con la collaborazione della Scuola Holden di Torino, sta portando avanti “Proud of You”, un progetto di didattica di italiano e matematica per prevenire il rischio di dispersione scolastica ed incoraggiare l’apprendimento e la crescita dei ragazzi. «Ad oggi», spiega Caterina Corapi, presidente di Next Level e project manager di Proud of You, «abbiamo coinvolto circa 600 studenti e 30 insegnanti». Il progetto, partito a gennaio 2020 e che si concluderà a settembre 2021, è nato su un’iniziativa simile sviluppata nel quartiere di Scampia negli anni precedenti che ha ottenuto risultati straordinari: «I ragazzi che hanno partecipato alla prima edizione di Proud of You», continua Corapi, «hanno registrato l’8% di assenze in meno rispetto a chi non ha partecipato». Quest’anno con l’emergenza sanitaria il progetto ha previsto in una prima fase la formazione degli insegnanti sull’utilizzo di strumenti digitali: «Con 20 tutor dell’università abbiamo progettato 120 ore di lezioni di didattica a distanza. Una versione digitale di tutte le attività sarà sempre disponibile per studenti e insegnanti su una piattaforma messa a disposizione da Next Level. E il prossimo 28 giugno partirà un Summer camp in presenza per fare insieme ai ragazzi attività ricreative e culturali che coinvolgerà 100 ragazzi».
A Scampia è nato un intervento all’interno della scuola pubblica del territorio. Attraverso un lavoro co-partecipato con il gruppo docente e attività di didattica informale ispirata alle arti circensi si sono tenuti corsi per i ragazzi più difficili e di formazione per il gruppo docente con psicologi e pedagogisti

Scampia, periferia nord di Napoli. Qui le Vele, i sette palazzi, o ancora il Lotto P con le case dei Puffi che dovevano essere case provvisorie per tamponare l’emergenza abitativa dopo il terremoto dell’Irpinia nell’80, invece poi l’emergenza lo sono diventate erano la roccaforte delle camorra che aveva aperto un “supermercato” della droga: 25 piazze di spaccio. In questo pezzo di Napoli che lega il centro città con l’hinterland, promuovere progetti che tutelino le giovani generazioni è prioritario. “Allenarsi Alla Bellezza: la strada, il viaggio e tutto il resto” è nato con l’obiettivo di realizzare un intervento direttamente nella scuola pubblica locale attraverso un lavoro co-partecipato con il gruppo docente e attività di didattica non formale. «In questo quartiere», dice Marco Benini, presidente di New Life For Children Onlus, «l’infanzia vive una condizione limite. Per questo motivo abbiamo pensato ad un progetto contro l’abbandono scolastico che permettesse anche l’accesso ad attività extrascolastiche, ludico-ricreative e di formazione attraverso il consolidamento di una rete territoriale. Ci muoviamo in partenariato con l’istituto comprensivo statale Virgilio IV, l’associazione Chi Rom e chi No, la cooperativa sociale L’uomo e il Legno e la scuola di Circo Corsaro». Sono selezionati i giovani e le famiglie più a rischio che presentano condotte aggressive e violente; legami con la criminalità organizzata o genitori in estrema povertà; disabilità fisiche o psichiche; vittime di bullismo; orfani, situazioni di negligenza o abbandono genitoriale. «Abbiamo coinvolto», continua Benini, «175 ragazzi e 50 adulti in diverse attività, tra cui laboratori creativi, laboratori di didattica informale ispirata alle arti circensi, corsi di formazione per il gruppo docente con psicologi e pedagogisti».

14/18 ANNI
14/18 ANNI
Con il progetto saranno riqualificati tre luoghi storici che saranno messi a disposizone degli adolescenti: la chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi; la chiesa dei Cristallini e la basilica di San Severo fuori le mura

«Qui a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, i ragazzi vivono per strada, senza regole», ammette con molta onestà Laura Badolato, coordinatrice del progetto “ApprendiAMO Insieme. Il cuore oltre gli ostacoli”. «Sono abbandonati a loro stessi e non tutti hanno alle spalle famiglie capaci di indirizzarli». Il nome del progetto non è stato scelto a caso: «Più che focalizzarci sulle questione didattiche con gli educatori e i volontari proviamo proprio a costruire strade diverse per questi ragazzi, proviamo a salvarli per quanto è possibile. Con i bambini è più facile, ma per gli adolescenti già “formati” il lavoro è molto più complesso. Loro non immaginano di essere in grado di studiare o imparare un mestiere. Non credono mai in loro stessi. Hanno modelli di genitori che entrano ed escono dal carcere, sono coinvolti in attività illecite e credono che per loro non ci sia nessuna alternativa possibile: invece c’è». Il progetto gestito dall’associazione Figli in famiglia Onlus coinvolge 130 ragazzi, i beneficiari diretti usufruiscono delle prestazioni, in alcuni casi, a richiesta degli interessati, in altri, su indicazione

della parrocchia, in altri ancora, su segnalazione del Tribunale, dei servizi sociali o delle stesse scuole del territorio. «Facciamo attività di dopo-scuola», continua la coordinatrice, «cerchiamo di dare un metodo di studio ai ragazzi e poi sviluppiamo laboratori di teatro, lavorazione della creta, falegnameria, cucina e arte. Per i genitori invece abbiamo aperto uno sportello legale e sociale con loro facciamo percorsi di accompagnamento, di sostegno alla genitorialità, le famiglie prese in carico sono in prevalenza monogenitoriali, con coniuge deceduto o in carcere. Siamo costantemente in contatto con la rete dei docenti per capire se i ragazzi vanno a scuola o se si sono connessi durante la didattica a distanza. Abbiamo anche sviluppato una dad solidale per i ragazzi che a casa non avevano connessione internet o un device da cui connettersi».
Rione Sanità, accucciolato sotto la collina di Capodimonte di Napoli, è sempre stato un quartiere dentro il cuore della città ma allo stesso tempo emarginato da tutti. Qui un gruppo di ragazzi guidati da padre Antonio Loffredo, un parroco ribelle e illuminato, ha messo in piedi quello che si chiama il “Miracolo del Rione Sanità”. Un processo che ha visto un proliferare di cooperative e associazioni di giovani del territorio che attraverso l’arte, la musica, la bellezza hanno innescato un movimento di sviluppo che ha trasformato la Sanità in una delle principali mete turistiche della città. Nel 2006 padre Antonio e un gruppo di giovani volontari nati e cresciuti alla Sanità decidono di fondare insieme la cooperativa sociale La Paranza onlus, sono loro che ridanno nuova vita alle catacombe di San Gennaro che passano da 6mila visitatori l’anno a 160mila. Nonostante la crisi e il momento storico difficile, al Rione Sanità si continua a sognare, progettare, creare bellezza e arte trasformando spazi abbandonati in luoghi di vita. È infatti appena partito “Luce”. Con il progetto saranno riqualificate tre strutture abbandonate: la chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi chiusa al pubblico da oltre 40 anni e oggi sede del laboratorio dell’artista di fama internazionale Jago; la chiesa dei Cristallini e la basilica di San Severo fuori le mura. Nel modello Sanità ogni azione ha come risvolto il lavoro. Aprire questi spazi al pubblico significa dare lavoro a nuove guide, giovani del territorio. Saranno anche attivati laboratori per 30 adolescenti del Rione di cinematografia, grafica, fotografia, murales. «Luce come le luci accese», dice padre Loffredo, «per mettere in ombra ciò che mette paura, ciò che ruba la libertà. Altri spazi che diventano luoghi. Altri luoghi sacri pronti ad accogliere qualcosa di sacro come l’arte, la scultura, la pittura, la musica, il teatro. Sono per noi del Rione Sanità un nutrimento indispensabile per la crescita del capitale umano. L’ arte deve diventare ciò che è: via della folgorazione, via carnale che parla ai sensi e al cuore dell’uomo e al contempo fattore di produzione indispensabile per un futuro economico e per creare lavoro».
“ApprendiAMOA San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli gli adolescenti pensando di non avere futuro. Ma con i laboratori di teatro, lavorazione della creta, falegnameria, cucina e arte gli educatori gli mostrano un’altra strada
19/30 ANNI
Corsi di formazione gratuita nei settori dell’hi-tech, vendite, alberghiero e ristorazione. A Napoli sono partite 14 classi che hanno coinvolto 349 ragazze e ragazzi
Rompere gli stereotipi. Sulle donne in generale ma ancora di più romperli per quelle che vivono nel Sud Italia. Yep-Young Women Empowerment Program, realizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Ortygia Business School, è nato per supportare la crescita personale e professionale di 40 studentesse universitarie di facoltà Stem del Sud Italia che per sei mesi vengono accompagnate da altrettante manager di Intesa Sanpaolo che lavorano nel Mezzogiorno. La percentuale di donne che occupano posizioni tecnico-scientifiche è tra le più basse dei Paesi Ocse:
il 31,7% contro il 68,9% di uomini e solo il 5% delle 15enni italiane aspira a intraprendere professioni tecniche o scientifiche. A Napoli è stata coinvolta l’Università Federico II. «Il progetto fornisce alle studentesse strumenti
utili per orientare le scelte, universitarie e di carriera, in maniera consapevole. Ma soprattutto le incoraggia a guardare al loro futuro professionale con più apertura e sicurezza in loro stesse, devono credere di più nelle loro capacità», racconta Antonella Mancini (nella foto), responsabile del Personale e Assistenza Rete della Direzione Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. «Ciascuna mentee è abbinata alla propria mentor sulla base di obiettivi e interessi accademici e professionali». La coppia mentor e mentee svolge la propria relazione di mentorship nell’arco di sei mesi, sono previste 6 sessioni individuali di persona o da remoto.«Come manager», spiega Mancini, «è fondamentale condividere e raccontare la nostra storia o quelle che sono state le nostre difficoltà o timori. Questo le aiuta a capire che non esistono barriere, che la barriera vera è il pregiudizio. Le aiuta a capire che non ci sono situazioni che non le possano riguardare, che sono loro che tra qualche anno potrebbero occupare ruoli manageriali e decisionali, basta abbandonare la paura di mettersi in gioco».
Alessia Gargiulio (nella foto) ha 25 anni. Vive a Cercola, un comune in provincia di Napoli. «Finita la scuola superiore mi sono iscritta all’Università, volevo studiare informatica», racconta. «Ma dopo un anno ho lasciato gli studi, mi sentivo insicura, non adatta. Ho iniziato a lavorare come cameriera, poi è arrivato il Covid e a marzo dello scorso anno, dopo 5 anni, mi sono trovata senza lavoro e ancora con il pallino dell’informatica». Alessia viene a conoscenza del progetto”Giovani e Lavoro” di Intesa Sanpaolo in partnership con Generation Italy, attraverso un’inserzione su Facebook. «Mi sono detta “perché no?” E ho inviato la mia candidatura». Giovani e Lavoro ha come obiettivo la formazione gratuita e l’inserimento di 5mila giovani tra i 18 e i 29 anni nel mercato del lavoro, in particolare nei settori hi-tech, vendite, alberghiero e ristorazione. Tra la città di Napoli e la sua provincia sono 129mila i giovani disoccupati. Qui sono partite 14 classi suddivise per tipologia di corso che hanno coinvolto 349 ragazze e ragazzi. «Dopo la candidatura ho fatto un colloquio conoscitivo. Mi hanno presa e ho cominciato questo corso per sviluppatore Java: 4 mesi di lezioni full time totalmente gratuite. Il corso non mi ha solo dato competenze tecniche con una formazione intensiva esperienziale sulla professione target ma anche soft skills. A settembre dello scorso anno sono stata assunta come tirocinante in un’azienda e adesso quello stage si è trasformato in un contratto di apprendistato. È un bel traguardo. Devo tutto a questo progetto: ero intrappolata in un lavoro che non mi piaceva, ho deciso che riprenderò gli studi per conseguire la laurea, adesso mi sento pronta. Sono stata fortunata: ho incontrato le persone giuste al momento giusto».


“Yep”,Quaranta studentesse universitarie delle facoltà Stem (acronimo per: Science, Technology, Engineering and Mathematics) per sei mesi vengono accompagnate da altrettante manager di Intesa Sanpaolo
Che opportunità può offrire Napoli ai giovani?
Non c’è spazio per il lamento in questa nuova visione di della città, che poi è una nuova visione del Sud. Il nostro è un territorio fertile, ricchissimo. Il dipartimento di scienze sociali, molto vicino alle tematiche del Terzo settore, ha incrementato gli iscritti del 25%. Le giovani generazioni stanno capendo che investire in formazione è cruciale. La tendenza che qui si sta sviluppando molto è quella di creare organizzazioni ibride che mixano elementi del non profit ed elementi del profit per far convivere l’aspetto sociale e quello economico.
L’elemento che scontiamo però è che molti degli studenti che formiamo non riescono a realizzare la loro idea sul territorio e vanno in cerca di un’occupazione lontano da casa. Di fatto creiamo competenze che poi non riusciamo a valorizzare all’interno delle nostre realtà. Manca un ponte con la struttura lavorativa, il nostro è un sistema paese asimmetrico.
Quali sfide per il sistema bancario per riallineare questa asimmetria?
Il non profit e le organizzazioni ibride nei prossimi anni affronteranno una vera rivoluzione. Il modello di welfare e quello di impresa
Giovanpaolo Gaudino presidente del Consorzio Co.Re. e di Federsolidarietà Campania

tradizionale fanno fatica a rispondere ai bisogni sociali.
E il Terzo settore?
Le cooperative sociali sono una risposta concreta. Gli istituti di credito, oltre ad emettere credito, devono costruire percorsi di accompagnamento e servizi per favorire i progetti che hanno dimostrato o hanno innescato un percorso di progressiva solidità e che sono riusciti a stabilizzare posti di lavoro al loro interno. Il mondo finanziario deve sempre più tener conto della natura ibrida di queste realtà e dell’impatto sociale che il loro lavoro crea nel territorio.
Che significa fare impresa sociale a Napoli?
Fare impresa sociale è una sfida consapevole e farla a Napoli dà un brivido in più ed anche qualche piacere in più. La nostra missione è chiara: riconnettere e ricucire i legami sul territorio. L’impresa sociale diventa un soggetto che fornisce risposte economiche e di inserimento lavorativo. Ha come obiettivo l’inclusione. Il contesto difficile ti mette alla prova da un lato, ma dall’altro rende le organizzazioni resilienti e le spinge a trovare soluzioni creative per rispondere alla difficoltà di gestione come i tempi di pagamento molto lunghi dell’amministrazione pubblica, che spesso vanno ben oltre i 18 mesi canonici. Inoltre, per propria mission, in questo contesto l’impresa sociale è motivata ad investire per rendere la propria azione realmente efficace e duratura nel tempo, diventando in alcuni contesti tra i soggetti economici più significativi.
Da quante cooperative è composto il consorzio Co.Re. - Cooperazione e Reciprocità?
Undici, tra cooperative di tipo A e di tipo B. Che lavorano
tra l’area metropolitana e l’hinterland. Contiamo 263 dipendenti.
In che modo gli enti creditizi dovrebbero supportare il vostro lavoro sul territorio?
In questi ultimi anni il nostro è sempre di più un lavoro di collaborazione, abbiamo insomma un dialogo aperto, in modo particolare con Banca Prossima prima e quindi Banca Intesa oggi. Sicuramente è importante sostenere gli investimenti che spesso sono generativi di benessere. È chiaro che, vista la lentezza dei pagamenti, i nostri stati patrimoniali sono un po’ statici. Questo rappresenta un elemento di debolezza nelle valutazioni. Credo però che vada valorizzato di più l’impatto sociale che generano le nostre imprese. Quindi diventa importante che nel sostenere le imprese sociali ci si chieda “Quanto beneficio portano alle comunità queste imprese?”, “quanto beneficio portano anche ai giovani?”. Sono convinto che il valore aggiunto di concedere credito ad un’impresa sociale stia proprio nella capacità di guardare l’impatto che questa è in grado di generare su un territorio.
«La missione di noi imprenditori sociali? Includere chi è fuori dal mercato del lavoro»
Napoli è la porta del Mezzogiorno, incessante laboratorio di un sociale forse troppo spesso rappresentato nei suoi chiaroscuri più netti, sospesi tra realtà dura e stereotipo un po’ fumettistico.
Nel panorama delle città di scala metropolitana il capoluogo campano si caratterizza da sempre per una particolare densità del sociale, che scorre come un magma di inesauribile energia in movimento che fatica a passare dallo stato liquido dell’informalità fluida allo stato solido della forma organizzata o dell’istituzione.
Per lavorare nel sociale occorre allora innanzitutto saper navigare nel magma, comprenderne le direzioni e poi successivamente provare ad intervenire sul corso per rendere la materia più malleabile e poi terreno fertile di crescita inclusiva e di nuova comunità di destino. Perché in effetti è su questo che le iniziative raccontate nel dossier tentano di agire: contribuire a cambiare il corso di vita delle persone, in questo caso particolare i più giovani e le donne, spesso segnato dall’indurirsi delle vite dei tanti posti, sin dalla nascita, ai margini di quel potente flusso sociale dal quale si generano le opportunità di cambiamento.
In altre parti del Paese nella fase postbellica i percorsi di inclusione, di emancipazione, di civilizzazione, di mobilità sociale, hanno fatto leva sui due grandi dispositivi del mercato (impresa e lavoro) e del welfare pubblico orientato alla produzione di cittadinanza. È ormai storia nota come nel Mezzogiorno, così come a Napoli, tanti sono stati i fallimenti dell’uno e dell’altro in epoca fordista. Tali fallimenti dipendevano in buona misura dalla prevalenza di un’idea di sviluppo calata dall’alto, laddove invece occorreva prendersi il rischio di percorrere le vie tortuose dello sviluppo endogeno a base sociale in un rapporto di dialettica costruttiva con le politiche programmatorie pubbliche.
In un’epoca in cui la dialettica di sistema si esprime nel rapporto tra flussi (oggi in particolare il flusso Covid) e luoghi, ripartire dal sociale significa immaginare e praticare una
nuova “coscienza di luogo” preludio di una normalità migliore della precedente, nella quale ricomporre bisogni di protezione collettiva e processi di crescita economica sostenibile, coniugando valori ed interessi di cooperazione e mutualità tra attori “diversi” che si riconoscono in una “comunità larga”. Fare tessiture sociali, come evidenziato dal racconto delle esperienze napoletane, rappresenta una delle principali opportunità anche per produrre una rigenerazione del tessuto produttivo. Mi pare anche un po’ questa la logica portata avanti dai progetti promossi dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo: fare in modo che il sociale sia terreno di investimenti e di innovazione, non solo luogo del contenimento dei costi della crisi.
Innovazione che passa perciò anche da un processo di coscientizzazione di un flusso finanziario che accompagna la strutturazione di un sociale organizzato in grado di farsi forza istituente (per riprendere le parole del filosofo napoletano Roberto Esposito) nei confronti della trama fragile delle istituzioni pubbliche, scuola in primis.
In questo quadro rilevante è anche il ruolo assunto dalle Università nell’ambito della loro “terza missione” che anche a Napoli, come in altre aree metropolitane (Milano, Torino, Bologna, Padova, Bari, e via dicendo) si fanno attori di uno sviluppo che innerva di saperi formali le organizzazioni del sociale cui spetta la commutazione dei linguaggi nell’ultimo miglio che porta dentro Scampia o San Giovanni a Teduccio, dove fare tessuto sociale intorno all’Apple Academy.
Se a Napoli viene avanti un Terzo settore capace di farsi settore economico a pieno titolo, che non produce “solo” assistenza o supplenza istituzionale, ma anche valore economico commisurato alla mission sociale (come sempre prospettato da Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Con il Sud), ecco trovare conferma l’immagine di una Napoli che articola il suo essere porta di ingresso del Mezzogiorno non solo sul piano funzionale, culturale o simbolico, ma anche sul piano dell’innovazione sociale e del welfare da ripensare e ridisegnare.
Imprese, partite Iva, commercianti: la ripartenza è stata possibile anche grazie agli sforzi di queste categorie economiche. È il caso dell’Antica Fioreria Rebussi, fondata nel 1931

Anche il negozio di Monica Cerri, in pieno centro, si è rivelato un vero luogo di socialità e relazione. Ha goduto di un sostegno per far fronte all’emergenza e per rilanciarsi, ampliando e rinnovando i propri locali
Una città di 129mila abitanti. Un tessuto industriale e sociale solido e intraprendente. La pandemia da Covid-19 che ha scosso il nostro Paese è partita da qui. Nel 2020, secondo l’Istat l’area bergamasca ha registrato 100mila morti in più rispetto all’anno precedente.
«Il tessuto ha retto bene», spiega Giuseppe Guerini, alla guida di Confcooperative Bergamo. Ha retto «anche grazie al suo sostrato mutualistico e cooperati-
vo, che oggi chiede uno scatto in avanti in termini di coprogettazione tra pubblico, privato e privato sociale».
Secondo uno studio del Cerved, tra i principali operatori italiani nella gestione del rischio di credito, realizzato per Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, a causa della pandemia nel biennio 20-21 le perdite economiche in città e provincia sono state tra gli 11 e 15 miliardi. Perdite che hanno mes-
so a rischio il 37% dei lavoratori occupati nei settori più colpiti (parliamo di circa 91mila persone impiegate nella ristorazione, nel commercio, nel turismo e nei trasporti), intaccando il 4,15% del fatturato complessivo del si-

«Coprogettazione, stiamo facendo uno scatto in avanti»
Giuseppe Guerini (Confcoop)

Inclusione sociale e sostenibilità. Questi i due criteri guida del percorso di welfare locale avviato a Bergamo. Grazie a due strumenti: il progetto Rinascimento Bergamo e le destinazioni del Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo.
Promosso dal comune di Bergamo in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Fondazione Cesvi (Cooperazione e Sviluppo), il programma è uno strumento di sostegno per il tessuto economico e produttivo della città, soprattutto nel fronteggiare i danni dell’emergenza Covid-19 e per rilanciare l’economia locale. Intesa Sanpaolo ha impegnato 30 milioni di euro, oltre a competenze per supportare concretamente il rilancio del tessuto economico del capoluogo lombardo.
Le risorse messe a disposizione tramite i vari bandi sono sia sotto forma di contributi a fondo perduto, sia come finanziamenti denominati “prestito d’impatto“ della durata di dieci anni.
Nel 2021 ammontano a 16 milioni di euro le risorse che il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, in capo alla Presidenza, ha stabilito di erogare per offrire sostegno alle persone più fragili, finanziando i progetti realizzati da enti non profit impegnati a dare una risposta ai problemi del Paese causati dalla crisi sanitaria, economica e sociale. Una parte dello stanziamento è stata messa a disposizione della Banca dei Territori per il sostegno con interventi entro i 5mila euro di progetti a diretto impatto locale, espressione della comunità di riferimento. Proprio questo strumento, pensato per tutto il territorio nazionale, a Bergamo si è rivelato fondamentale per superare le conseguenze economiche più drammatiche innescate dalla crisi pandemica.
tivati da Intesa Sanpaolo, e proseguito con un ventaglio di prestiti a impatto e senza garanzia per micro e piccole imprese, oltre che per le organizzazioni del Terzo settore. Ed è successo con il Fondo Beneficenza. Con una particolarità: proprio una di queste organizzazioni, Fondazione Cesvi, è stata parte attiva nella coprogettazione dei bandi, nell’attività di rendicontazione e di monitoraggio.
stema Bergamo. Eppure, nonostante una crisi sanitaria senza precedenti, Bergamo non si è arresa. È diventata, come spiega il sindaco Giorgio Gori, «il contesto ideale per un welfare municipale innovativo, che mostra la via per una ripresa». Un welfare capace di connettere pubblico, privato e Terzo settore. Come è stato possibile lo spiega monsignor Beschi, vescovo della città: «Grazie all’innovazione, promuovendo nuove forme di alleanze tra corpi intermedi», rafforzando il welfare cittadino e
sostenendo al tempo stesso «il tessuto commerciale e produttivo chiamati a una nuova responsabilità sociale».
È successo questo con il programma Rinascimento Bergamo, iniziato con una serie di contributi a fondo perduto at-
Partiamo da Rinascimento Bergamo e dai suoi numeri. Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione della città risorse economiche che hanno finanziato 739 progetti e sono state “giocate” sul territorio sia tramite bandi disegnati ad hoc, sia come contributi a fondo perduto o tramite microcredito a impatto: prestiti della durata di 10 anni che prevedono la restituzione del capitale al quinto anno per una quota del 40% del capitale inizialmente erogato e del rimanente 60% al decimo anno, con un interesse dello 0,40% annuo senza la necessità di garanzie accessorie. Per venire incontro alle esigenze di una realtà economica molto sfaccettata, sono stati creati sette bandi diversi in grado di rappresentate ogni ambito dell’economia e del sociale: piccole imprese (negozi, bar, ristoranti, artigiani), professionisti, imprese sociali, associazioni culturali, Terzo settore ed aziende di dimensioni maggiori (dai 2,5 ai 10 milioni di fatturato con un massimo di 50 dipendenti). In totale a oggi sono stati erogati oltre 12 milioni di euro tra fondo perduto e prestiti, uno straordinario intervento in favore della tenuta economica della città. Contributi e prestiti che hanno aiutato nel complesso 4.473 soggetti. Una particolarità: i contributi a fondo perduto sono stati erogati direttamente da Cesvi. La ragione di questa scelta è chiara e la spiega ancora il direttore della divisione Impact di Intesa Sanpaolo: «Occorre una sinergia complessa per rispondere a
LE DUE LEVE DI SVILUPPO«Per bisogni complessi, servono nuove sinergie»
Marco Morganti (Intesa Sanpaolo)
problemi complessi. Il mondo for profit ha bisogno, per integrarsi al meglio in questa complessità e contribuire alla crescita sociale, di alleanze sempre più stringenti con i soggetti dell’economia civile». Cesvi, in questo, come organizzazione radicata sul territorio ha lavorato per raccogliere i bisogni, ma anche per articolare una risposta. La fase della coprogettazione dei bandi, infatti, è stata la più delicata: bisognava rispondere con efficacia, ma anche con competenza, per evitare la dispersione di risorse e produrre quell’effetto-domino generativo che, solo, può dar vita a un welfare di prossimità. Al Progetto Rinascimento Bergamo si è affiancato anche l’intervento del Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo pensato per il sostegno di progetti che hanno come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale e il valore della persona. Un fondo, spiega Giovanna Paladino, Senior Director del Fondo, che agisce a livello nazionale ed è indirizzato a opere di carattere sociale e culturale, ma che su Bergamo ha mostrato la propria generatività: «Nel 2020 sono stati erogati in totale oltre 16 milioni di euro a livello nazionale. A Bergamo sono stati sostenuti 25 progetti per un erogato totale di 260mila euro» distribuiti secondo una logica di capillarità, nella forma di erogazioni liberali da 5mila euro. Il Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo è oggi gestito in base a un documento che ne indirizza l’attività nei prossimi due anni (2021-2022) attraverso alcuni focus, «individuati grazie a un’analisi di contesto dei nuovi bisogni sociali che stanno emergendo: l’effetto della pandemia sull’economia e sul welfare in primo luogo».
Ed è su questi pilastri — integrazione fra tessuto economico e sociale, cooperazione fra economia for profit e Terzo settore, circolarità progettuale tra enti pubblici, private e privato sociale — che la comunità bergamasca sta riedificando il proprio welfare. Rilanciandolo.
IOl ruolo di un sindaco sta cambiando. Dinanzi a uno scenario sociale ed economico sempre più complesso un sindaco spiega Giorgio Gori, al suo secondo mandato deve essere «connesso». Connesso «con i bisogni e le necessità del territorio, ma anche con quegli attori, privati e del privato sociale, senza i quali non è possibile creare modelli di coprogettazione efficace».
La pandemia ha marcato fortemente un prima e un dopo anche sul tema del welfare locale. Anche in tema di presenza di un sindaco nei percorsi di nuovo welfare?
Penso di dire una cosa ovvia e scontata ribadendo che un sindaco e un’amministrazione comunale sono quelle parti del “corpo pubblico” più vicine ai territori e, di conseguenza, alle persone. C’è però qualcosa di meno scontato che è emerso con chiarezza durante e dopo la pandemia: non possiamo più “disegnare” a tavolino percorsi o progetti di welfare senza un intervento dei sindaci.
«Le competenze del Terzo settore sono necessarie affinché dalla risposta ai bisogni si generi nuovo valore». Roberto Vignola è Deputy General Manager di Cesvi, organizzazione umanitaria fondata a Bergamo nel 1985, con una solida esperienza territoriale e globale.
Salute, ambiente, lotta alla povertà e alla fame. Ora anche “impatto”. È accaduto con il Progetto Rinascimento Bergamo e il Fondo Beneficenza…
Cesvi opera nelle più gravi emergenze umanitarie del mondo: situazioni complesse che possono essere causate da calamità e disastri naturali oppure dall’azione dell’uomo. Questo è un punto che dobbiamo tenere in considerazione anche quando parliamo di welfare locale. Perché, con la pandemia, la complessità se così possiamo dire ci è entrata definitivamente in casa.
Da qui l’impegno su questo modello di risposta alla crisi del tessuto economico e sociale provocata dalla pandemia… Siamo coinvolti sia nel livello della coprogettazione, sia in quello del-
Di che tipo di intervento parliamo?
Parliamo di regia, di coordinamento, di raccordo tra coloro che si impegnano per la tutela di ciò che chiamiamo “bene comune”. Nel nostro caso è successo in particolare con il progetto Rinascimento Bergamo: dall’idea siamo passati subito all’azione. Azione che è stata diretta al coinvolgimento di altri soggetti in questa progettualità innovativa. Abbiamo quindi contattato, sentito, raccordato, invitato a partecipare..
Una regia nella progettualità, dunque, non solo nell’erogazione di servizi?
Questo è il senso forte di ciò che chiamiamo “coprogettazione”. Nel nostro caso, il Comune non ha delegato, ma coinvolto. Per prima cosa abbiamo cercato la collaborazione di un gruppo bancario di prima grandezza, interessato a far sì che il territorio e la sua economia tornassero prospere, e abbiamo coinvolto competenze del Terzo settore. Questo ha permesso di creare un modellino di intervento in cui il Comune è stato una sorta di perno attorno cui creare un piccolo ecosistema sociale basato su tre criteri: la responsabilità condivisa (tanto di chi dà, quanto di chi riceve), la fiducia (elemento imprescindibile) e la compartecipazione tra soggetti (pubblico, privato e privato sociale).
la rendicontazione. Nello specifico, Cesvi si occupa della gestione, dell’erogazione dei contributi e delle relative attività di monitoraggio e rendicontazione.
Dopo un primo bando, “Spese Inderogabili”, utile per tamponare le emergenze durante il lockdown, nell’ambito di Rinascimento Bergamo avete coprogettato altri bandi. Un esempio?
Prendiamo il bando “Raffaello”. Un bando finalizzato a sostenere le imprese che vogliono intraprendere percorsi di innovazione e digitalizzazione. Questo bando ci offre un esempio chiaro di come stia evolvendo il sistema: da una fase emergenziale, a una fase sempre più progettuale.
Possiamo dire che questo passaggio è stato possibile grazie al Terzo settore, chiamato a monitorare efficacia e impatto, oltre che a disegnare bandi a misura di bisogno e non di burocrazia?
La certezza che le risorse, siano esse a fondo perduto o di microcredito, vadano a buon fine è possibile solo attraverso questo tipo di sinergia tra soggetti. Il comune ci mette l’impulso e la regia, la banca mette risorse e competenze e noi mettiamo altre competenze e l’esperienza. Credo sia un modello di “sostegno circolare” che sta mostrando i propri frutti a Bergamo ma che è facilmente replicabile altrove. Anche nella gestione dei fondi del Pnrr.
«Quando abbiamo riaperto», racconta Claudio Tognoli, «abbiamo avuto un fortissimo aumento di lavoro». Tognoli è titolare di Labo Bike, laboratorio di vendita e riparazione di biciclette. La sostenibilità, ma anche l’innovazione racconta passano da questo mezzo antico, ma incredibilmente votato al futuro. Tecnologia e sapere artigiano si uniscono nelle due ruote. Ma nel periodo del lockdown, spiega, «era difficile immaginare un futuro. Ed era ancor più difficile far fronte alle piccole spese che un’attività commerciale richiede». Ripartire è stato fondamentale, ma senza il supporto di Rinascimento Bergamo per decine di commercianti e artigiani e imprenditori come lui «sarebbe stato impensabile». Oggi, spiega, «il boom delle biciclette è legato a una serie di fattori. Il primo emotivo: il senso di libertà che accompagna la possibilità di muoversi su due ruote. Il secondo è l’idea di una sostenibilità concreta», a cui ognuno anche solo usando una bicicletta anziché dei mezzi inquinanti può contribuire. Quando gli chiediamo come è venuto a conoscenza della possibilità di accedere ai fondi del programma Rinascimento Bergamo ci svela che è stato tutto molto semplice: «Il mio commercialista mi ha detto che c’era questa possibilità, ho presentato le carte e in pochi giorni ho avuto il sostegno». E conclude «credo sia stato e sia molto importante il fatto che le informazioni circolino a tutti i livelli, cosa che permette di non sprecare occasioni importanti e rendere gli aiuti alla portata di tutti».
«Un piccolo aiuto può diventare un grande incentivo a non mollare»
a Ivo Lizzola professore di pedagogia, Università di Bergamo

Cura, fragilità, persona. Sono queste le parole attorno cui si è raccolta la comunità. Parole che stanno dando una spinta a un nuovo welfare di prossimità. Così spiega Ivo Lizzola, professore all’Università di Bergamo, tra i più acuti osservatori della società civile.
OPartiamo da ciò che è accaduto a Bergamo: lo sguardo del mondo si è concentrato sulla pandemia. Ora è tempo di cambiare anche la rappresentazione che diamo della città e del territorio, affinché si guardi cosa è accaduto dopo, in termini di reazione, innovazione, cambiamento…

La pandemia ha certamente trasformato la presenza, il ruolo e la percezione di chi opera in contesti vulnerabili. Una trasformazione, probabilmente, radicale e definitiva, che sta interessando soprattutto nozione e pratiche del welfare.
Il welfare come si sta trasformando? Spesso parliamo degli aspetti negativi, ma ce ne sono anche di positivi, in termini di rilancio e progetto?
Va subito chiarito che la pandemia ha posto un aut aut sul dopo. Il “dopo” è qualcosa che stiamo ancora vivendo, che è in piena trasformazione, ma di cui possiamo iniziare a comprendere modalità e linee di sviluppo. In particolare, comprendiamo — nella difficoltà e nella fatica che ogni “ripartire” comporta — come sia impossibile tornare alla forma del mero servizio erogato da un erogatore. Insisterei su questo, perché la pandemia ha mostrato come questa logica non risponda per nulla alle esigenze di un welfare della complessità e della prossimità.
Che cosa intende per welfare della complessità e della prossimità?
Un welfare capace di rispondere alle sfide complesse, globali, dando risposte concrete…
Locali?
Usiamo il termine «di prossimità». Locale ci riporta alla mente le stagioni del localismo, mentre la prossimità è qualcosa di aperto, alle sfide e all’alterità. Un riequilibrio concreto a sfide che non possono essere unicamente declinate in chiave ideale, ma di servizio.
Non più un welfare di servizi, dunque, ma di servizio?
Esattamente, perché il servizio è esattamente ciò che ha permesso di uscire dalla pandemia. Un
servizio che si trasforma, però, deve al contempo trasformare: avere cura della relazione, non solo delle procedure. Ma attenzione: il percorso è ancora lungo. Questo, infatti, è il momento della fatica. Fatica per ciò che abbiamo vissuto, fatica per il cammino che dobbiamo intraprendere. La sfida, allora, per un nuovo welfare della prossimità è riuscire ad accompagnare gli operatori del bene nell’elaborare non solo il lutto, ma il cambiamento. Prima dovevamo stare in piedi accanto alle persone più fragili, ora dobbiamo riscoprire queste realtà come realtà comunitarie, di incontro umano, di ricerca e riflessione anche su di noi. Sul nostro essere Terzo settore, società civile, comunità nella comunità. Si è aperta una importante fase di ricerca, ora sarà cruciale indicare una direzione, per non lasciare questa domanda senza risposta. Una fase in cui la ricerca diventi azione unendo soggetti come l’università, le amministrazioni locali, i corpi intermedi, il privato e il privato sociale.
«La pandemia ci ha dimostrato che costruire welfare non significa “erogare servizi”»intervista
Grazie al progetto Rinascimento, Anna e Stefania, le proprietarie del negozio di abbigliamento Dress Salad, hanno scelto di ampliare la propria attività offrendo oggi un servizio di mobilità sostenibile ai cittadini grazie al noleggio di e-bike

dialogo con don Roberto Trussardi, direttore della Caritas Diocesana Bergamo

La Caritas di Bergamo è nata nel 1975. È un punto di riferimento importante per tutto il territorio. Soprattutto sui temi del contrasto alla povertà, del sostegno alle fragilità. E, non da ultimo, nelle pratiche attive di sussidiarietà.
Oggi, spiega don Roberto Trussardi, cinquant’anni, alla guida della Caritas diocesana dal 2018, il ruolo di questa istituzione in termini di ricomposizione del welfare è sempre più proattivo, non solo reattivo. Soprattutto dopo la pandemia. «Il nostro compito», spiega, «è indirizzato alla formazione e all’educazione». Un’educazione e una formazione a quello che nel linguaggio della fede si definisce come “carità”. Ma è una carità di sistema, una filantropia attiva, precisa don Roberto, «volta al servizio, con un ruolo pedagogico preciso, non solo assistenziale».
In questo, chiediamo al direttore, come si rapporta la Caritas con gli altri soggetti? «Facendo sistema». Con chi? Con le istituzioni, i
soggetti della società civile. I corpi intermedi. I cambiamenti, oggi, sono visibili sia fuori che dentro. In termini di struttura, se all’inizio Caritas era composta da gruppi di volontari, ora è una squadra che ai volontari stessi affianca quaranta operatori specializzati. Ma è mutata anche la società. E, con essa, dopo la pandemia, è cambiata la struttura stessa del bisogno. «Se ci interroghiamo sulle risposte, senza partire dal bisogno, rischiamo di dissipare energie e risorse, senza rendere pienamente efficace la nostra azione». Se la pandemia ha lasciato una lezione da imparare è che «non ce lo possiamo permettere». «La fragilità di oggi è molto più complessa di quanto non fosse qualche decennio fa», continua don Roberto. «Si è trasformata in vulnerabilità sociale: espone al rischio fasce sempre più ampie della popolazione»
Oggi, infatti, abbiamo molteplici povertà, situazioni molto diverse tra loro e inimmaginabili ad esempio
negli anni Ottanta. Pensiamo alla situazione dei migranti, ma anche ai problemi psicologici e psichiatrici acuiti dal post-Covid. Ma pensiamo anche alla questione occupazionale: trent’anni fa era impensabile parlare di disoccupazione diffusa, eppure questa è un’altra tendenza degli ultimi tempi che il Covid ha contribuito a rendere ancora più scottante. In quarantasei anni è cambiato il mondo e, dopo la pandemia, è cambiato ancora più rapidamente».
La pandemia ha lasciato molte ferite, ma la capacità di reagire da parte della società civile bergamasca è stata esemplare. «Serve un nuovo paradigma: generativo e capace di integrare in forme ibride, nuove, i vari soggetti attivi sul territorio per poter agire tutti assieme e rispondere alle sfide che verranno».
Ora, spiega il direttore, si tratta di riflettere su questa nuova sussidiarietà: circolare, attiva, rapida nel rispondere a tutte le fratture del sociale.
«Nuovi bisogni chiamano a un nuovo impegno: non più solo assistenziale, ma pedagogico»
Quello che con giusto senso della misura il sindaco Giorgio Gori chiama “un modellino di intervento”, riferendosi alle pratiche messe in campo per accompagnare la comunità bergamasca nel percorso di risalita dalla terribile esperienza della pandemia, corrisponde a una prima realizzazione concreta di una “comunità larga”, intesa come ventaglio di attori e soggetti organizzati che si riconoscono in obiettivi di cura e pratiche di ritessitura della maglia sociale ed economica lacerata dalla pandemia. Una ritessitura che si regge sulla mobilitazione civile radicata nel senso di un comune destino e che si muove investendo in fiducia collettiva.
OLa fiducia è quella merce leggera che più la usi più si riproduce, ma ci deve essere un’intelligenza sociale ed un impalcatura istituzionale che ne favorisca la diffusione. Questa intelligenza sociale si compone di un intreccio di relazioni che si sostanzia in obiettivi solidaristici tra attori connotati da missioni apparentemente estranee come la cura delle persone e gli interessi materiali che afferiscono alla sfera dei rapporti economici dell’impresa e del lavoro. Nel caso bergamasco questa commistione virtuosa è stata per altro manifesta sin da subito nell’aprile 2020 con l’allestimento dell’ospedale da campo presso le strutture della fiera con il coinvolgimento delle industrie locali, delle associazioni artigiane, degli Alpini, delle fondazioni e del mondo del credito. Segno di una tradizione civico-comunitaria che trova eco anche nel movimento cooperativo di matrice cattolica e in un sindacato che ha saputo contemperare difesa dei lavoratori dell’ultimo miglio e promozione di una mutualità diffusa. Questa base fiduciaria, cresciuta nell’emergenza e che affonda in radici profonde della storia bergamasca, è stata investita in questa fase di uscita faticosa e non certo indolore con operazioni che hanno declinato l’innovazione a partire dal bisogno, ovvero “obbligando” weberianamente l’innovazione ad ancorarsi alla prossimità, ripartendo dai corpi, dalla salute, dalle relazioni e, da qui, agire sulla dimensione dei micro-rapporti economici. Un sociale che genera e sostiene l’economico, accompagnato da umanesimo istituzionale che coinvolge anziché delegare.
Leggendo il resoconto delle esperienze raccolte in queste pagine si coglie la forte declinazione umanistica della logica sottesa agli interventi. Accanto all’umanesimo istituzionale degli attori pubblici locali, che ci dice come sia importante ragionare di qualità dell’azione pubblica oltre che di quantità di risorse disponibili in epoca di Pnrr, emerge un umanesimo sociale che àncora le competenze e le tecnicalità del Terzo settore alla capillarità dell’ultimo miglio del volontariato e dell’associazionismo mettendosi in relazione con le fibrillazioni dell’orizzontalità del sociale, accettando la sfida della voglia di comunità, promuovendo capacità di auto-organizzazione dal basso come insieme di contesti vitali, nel costante tentativo di rigenerazione delle forme partecipative e di protagonismo alla vita sociale, economica e politica. Il che rappresenta l’unica vera modalità, a mio modo di vedere, per lavorare sulle paure sociali che alimentano quelle forme di chiusura comunitaria che corrodono il capitale sociale di fiducia. C’è poi da registrare una terza forma di umanesimo, quella che connota maggiormente la componente operosa degli interessi, che io chiamo umanesimo industriale, alludendo, nella fattispecie, al ruolo degli attori del credito, nella fattispecie Intesa Sanpaolo, che ha assunto la posizione di attore inter pares, segno di una legittimazione sociale che probabilmente va al di là del perimetro delle competenze bancarie in senso stretto. Sono progetti di costruzione sociale del territorio che evidenziano la consapevolezza del valore della reciproca contaminazione, di confini organizzativi porosi e di relazione in cui l’affermazione della propria identità avviene per reciproca legittimazione, nel rispetto dei ruoli. Qui l’istituzione non si esprime solo come “tenuta difensiva”, o come potere ordinativo del sociale, ma come fatto sociale di istituzioni viventi oltre le pure funzioni regolative. L’esperienza bergamasca denota la formazione di piattaforme del sociale basate sulla coscienza di luogo in cui le istituzioni comunitarie (dall’ente locale, al Terzo settore e all’impresa) agiscono come attori di un processo consapevole di cambiamento governato, ridando linfa alla società di mezzo dei corpi intermedi che si candida così ad avere un ruolo incisivo nello stare in mezzo tra i flussi (che sono la pandemia ma anche i flussi del Pnrr, o quelli legati alla logistica distributiva delle piattaforme digitali, o ancora alle forme dell’abitare) e le lunghe derive dei luoghi depositarie di civiltà materiale e memoria del futuro.

Con 5,5 milioni di turisti e 12 milioni di presenze l’anno (dati 2019, il 2020 non fa testo), Venezia inevitabilmente ha nel patrimonio culturale il suo tesoro. Tesoro non solo simbolico, ma anche economico. Si parla spesso di una città costretta a convivere con il proprio declino, con popolazione in diminuzione e fuga verso la terraferma. Ma è una lettura a senso unico e macchiata da uno spirito conservatorista. In realtà “Venezia vive” come Mario Isnenghi, importante storico, docente emerito dell’Università Ca’ Foscari, ha intitolato il suo libro uscito pochi mesi fa. «La morte a Venezia è un genere letterario», scrive Isnenghi. «È un cliché che ha trasformato la città da luogo del buongoverno a trionfo di una narrazione declinista». Proprio l’organizzazione del patrimonio dimostra che in realtà Venezia si è mossa con intelligenza e dando vita a forme di governance innovative. L’esempio più importante è certamente quello della Fondazione Musei Civici di Venezia, un soggetto privato con unico socio fondatore, il Comune di Venezia, che gestisce un patrimonio pubblico straordinario: ben 11 musei, tra i quali
gli enti non profit censiti dall’Istat a Venezia e provincia
i volontari impegnati nelle 460 associazioni aderenti al Centro servizi per il volontariato di Venezia
la quota di Ets iscritti al Csv di Venezia che si occupano di cultura e tutela dei beni culturali e ambientali. Solo gli ambiti sociale e sociosanitario sono più rappresentati
il visitatissimo Palazzo Ducale (2,5 milioni di ingressi l’anno), e complessivamente ben 700mila opere d’arte. A questi s’aggiungono cinque biblioteche specialistiche, un archivio fotografico e un grande deposito nel Vega Stock a Marghera.
La Fondazione che è stata istituita con delibera del Comune il 3 marzo 2008, in sostanza è un network di musei autonomi con una regia centrale che sovrintende alle tradizionali attività museali (ricovero, conservazione, studio, valorizzazione), ma che favorisce attività e servizi culturali: ricerca, formazione, divulgazione, didattica, produzione di eventi temporanei, in un dialogo incessante con il territorio e con i suoi frequentatori. Altra caratteristica importante: come Fondazione, il Muve autofinanzia tutte le proprie attività. È un modello seguito da altre città italiane, Torino in particolare, che dimostra grandi potenzialità, con il soggetto pubblico che mantiene il controllo e quello privato che porta processi più dinamici e intercetta nuove risorse per la gestione del patrimonio.
Anche un altro soggetto cardine del sistema Venezia, una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo, la Biennale, dal 2004 è diventata Fondazione, dopo che nel 1998 il Governo ne aveva approvata la trasformazione in persona giuridica privata, ovvero in “Società di cultu-
Gloria Rogliani (al centro della foto) insegna i rudimenti della voga veneta, la tecnica remiera della Laguna, ai giovani partecipanti alle attività dell’associazione (vd pag 87)

Una nuova metodologia allargata per la valutazione del rating per le imprese culturali non profit. È Giudizio Strutturato Cultura, uno strumento messo a punto da Intesa Sanpaolo, per accompagnare il rilancio di un settore che più di ogni altro è stato colpito dalla pandemia, uno strumento che serve a un miglioramento “culturale” della relazione fra il gestore e le realtà culturali non profit. «Ci siamo chiesti se avevamo un metodo di valutazione capace di catturare la specificità del “settore culturale”, che è un aggregato eterogeneo e dotato fortemente di asset intangibili», spiega Marco Ratti (foto), della direzione Impact della banca, che ha curato il progetto con Silvia Angeli, consulente moda e cultura. «Il rischio senza attivare una conoscenza più profonda di queste realtà è che si arrivi a negare il credito o a darlo a condizioni esorbitanti».
Per mettere a punto il nuovo strumento sono stati ingaggiati gli operatori attraverso vari round di interviste, con due questionari commisurati alle dimensioni delle 60 organizzazioni coinvolte per mettere a punto lo strumento. «Siamo stati sorpresi della quantità di indicazioni che ne sono venute», continua Ratti. «Così sono stato individuati sei driver, fattori che misurano la sostenibilità: la capacità di gestire e stimolare la domanda, l’orientamento all’innovazione e in particolare alla digitalizzazione, la qualità del management, il controllo dei costi, soprattutto di quelli
più spesso non gestiti, la propensione a fare rete e la solidità del legame con gli stakeholder e nel raccogliere supporto dai rispettivi territori».
Da parte di tutte le parti in causa, gestori e organizzazioni, lo strumento è stato giudicato utile per la capacità di migliorare la conoscenza, senza imporre pesi eccessivi in termini di impegno. «Dalle prime applicazioni è emersa una tendenza interessante», spiega Ratti. «L’aggiunta di questa nuova componente ai criteri tradizionali di rating ha portato in un 15% dei casi ad una correzione della valutazione. Il tema della sostenibilità intesa come progettualità futura per esempio non rientrava nelle valutazioni tradizionali. Anche il controllo dei costi e capacità di networking si sono rivelati due driver particolarmente strategici». Tra i contesti più interessati alle novità di questo strumento c’è Venezia, per l’importanza che il settore cultura ha assunto nell’economia della città. Il confronto con Maria Cristina Gribaudi, presidente della Fondazione dei Musei Civici (ne parliamo a pag 86) è stato molto importante per la validazione di Giudizio Strutturato Cultura. Tra le prime case history c’è quella del Circuito teatrale del Veneto, uscito molto bene da questo screening valutativo. «Lo strumento è nato per essere usato nella cerchia bancaria», conclude Ratti, «ma abbiamo contatti con altri operatori che desiderano valutare la sostenibilità delle organizzazioni culturali. Può poi essere utile agli stessi enti per misurare la propria salute organizzativa e propensione al futuro».

-ra La Biennale di Venezia”. Interessante anche il caso di Fondazione Venezia Servizi nata nel 2014 da due soci fondatori le Ipab “Antica Scuola dei Battuti” e “Istituzione di Ricovero e di Educazione”. È un’organizzazione che offre servizi di welfare ad un’utenza molto larga e che ha puntato sull’arte come strumento per migliorare il benessere e la cura dei propri assistiti. Il patrimonio come strumento di cura: per questo la Fondazione a partire dal 2016 ha iniziato un lavoro di recupero e di apertura al pubblico di beni architettonici che appartenevano alla storia dell’assistenza cittadina, come il complesso dell’Ospedaletto, una delle più antiche istituzioni di ricovero per anziani, vedove, orfane, indigenti, creata a Venezia. Ma è stata recuperata e riaperta anche la Scala del Bovolo, una scala a chiocciola del 1400 che porta ad uno dei più bei belvederi su Venezia e che ha riscosso un grande successo di pubblico.
Il patrimonio artistico e culturale della città in buona parte è costituito da chiese dal grande valore storico. Oggi sono chiese con pochissimi fedeli e che però hanno l’obbligo di restare aperte per accogliere invece i tanti turisti che le vogliono visitare. Per questo la Diocesi di Venezia ha costituito un’Associazione, Chorus Cultura, che ha come obiettivo quello di contribuire a tutelare, conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio architettonico e artistico delle chiese della città di Venezia e delle altre chiese del Patriarcato. Tra i suoi compiti c’è anche quello molto importante di garantire l’apertura e la custodia di questi monumenti, tra i quali ci sono straordinari gioielli come la Basilica dei Frari o quella dei Santi Giovanni e Paolo. L’Associazione sostie -

Possiamo pensare Venezia senza artigianato? «No, è impossibile anche solo immaginarla», spiega Stefano Micelli, tra i più attenti osservatori delle trasformazioni “4.0” nel territorio del Nord Est. Ma c’è un punto: di quale artigianato parliamo, quando parliamo di Venezia? Perché cultura artigiana e artigianato culturale sono così compenetrati, tanto da formare un tutt’uno, nella città lagunare?
Quando parliamo di cultura, spesso dissociamo il sapere e il fare. Accade anche con l’artigianato e con le sue evoluzioni? Partiamo da un’espressione come “economia della conoscenza”. Che cos’è centrale in questa economia? L’immateriale? Io ritengo che, accanto agli aspetti immateriali, esista una dimensione del fare. Una dimensione tipicamente artigiana dell’economia della conoscenza che porta in sé semi di passato, ma li rigioca nel futuro. Tutto questo accade a Venezia?
Non accade soltanto a Venezia, ma a Venezia, per la storia della città e per il suo vissuto, assume un senso particolare. Il sapere artigiano, il saper fare, lo vediamo all’opera a Venezia, ma lo possiamo vedere anche messo in opera: nei palazzi, nelle chiese, ovunque. Qui l’artigianato si sposa indissolubilmente alla bellezza. C’è dunque una circolarità tra artigianato e cultura che, a Venezia, trova una sua sintesi virtuosa?
Esattamente. Ma dobbiamo aggiungere un ultimo tassello: quando parliamo di sapere artigiano, anche a Venezia parliamo oramai di una cultura di artigianato 4.0.
L’artigianato di custodia e di tradizione sposa la cultura dell’innovazione, quindi?
Sempre più le forme del saper fare devono approcciarsi alla grande sfida tecnologica senza attestarsi a tradizioni già date, ma aprendo strade nuove. Il “già visto”, lo “scontato”, tutto ciò che rientra in un cliché consolidato non funziona più. E funzionerà sempre meno nel dopo-pandemia. Oramai abbiamo capito che l’innovazione non passa solo dai reparti di “ricerca e sviluppo”. Passa dalle mani, dal saper fare. Perché senza un sapere artigiano l’innovazione non si innesca. (Marco Dotti)
Economista, insegna all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Attento osservatore della trasformazione del sistema industriale italiano, è direttore scientifico della Fondazione Nord Est. Tra i suoi libri: Futuro artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani (Marsilio 2011).
Dall’artigianato culturale alla
artigiana «L’economia della conoscenza è solo immateriale, ma ha una dimensione concreta»
Questo luogo sta riscoprendo i sensi. Per comprenderlo a fondo servono naso, bocca, pelle, cuore e gambe
“Vorresti assorbirla, amalgamarti, farne parte, sentirti avvolgere completamente da lei. Vorresti sentire Venezia addosso, sulla pelle. Sentirla tua. Ma di chi è Venezia? A chi appartiene? A chi la visita per qualche giorno? Ai pendolari? Ai residenti? A tutti e nessuno?». A vent’anni dalla sua prima edizione, sollecitato dagli impatti della pandemia sulla «città più globale del mondo», Tiziano Scarpa ha sentito l’urgenza di riscrivere uno dei suoi libri di maggior successo, Venezia è un pesce (Feltrinelli, 2020). Sorta di contro guida, mappa rovesciata della città: Scarpa invita a guardare bene la forma della città. Per capirla a fondo. «Venezia è un pesce», dice. «Guardala su una carta geografica. Assomiglia a una sogliola colossale distesa sul fondo, o a un’orata che guizza su un’onda. Come mai questo animale prodigioso ha risalito l’Adriatico ed è venuto a rintanarsi proprio qui? Poteva scorrazzare ancora, fare scalo un po’ dappertutto, secondo l’estro. Se si è ancorata da queste parti, un motivo ci dev’essere». Un motivo ci deve essere. Quale?
Osservare la città e le sue trasformazioni non è facile. Servono chiavi spiazzanti. Nel suo Venezia è un pesce lei usa quella del corpo…
Piedi, gambe, cuore, volto, naso, volto, pelle: sono questi gli “strumenti” che ci permettono di capire una città. Soprattutto una città come Venezia, che è una sorta di distretto dei sensi. La città va ascoltata, sentita, provata. Quando ci caliamo in una città d’arte e cultura come Venezia, il primo approccio o, meglio, la prima tentazione – giustissima, per carità – è quella di acquisire informazioni. Informazioni storiche, artistiche, geografiche e via discorrendo. Ma una città come Venezia va capita attraverso le piccole sensazioni che ci dà.
Prendiamo il tatto: che cosa toccano le mani a Venezia?
Partiamo da qui: Venezia è una città che si può toccare. In altre città, questo non è possibile. In altre città tocchiamo solo le merci. A Venezia si tocca tutto: le briccole di legno, i ponti, i bassorilievi sotto le chiese, il sale che affiora sugli intonaci umidi… Venezia è una città che si può toccare, che si lascia toccare, che non nasconde il suo corpo. Il rapporto con la città di Venezia è immediato, sensoriale, tattile ma anche olfattivo, visivo, uditivo…
Questo corpo della città è, di fatto, la sua infrastruttura culturale…
ne le proprie attività attraverso la bigliettazione, per altro a costi molto congrui. Oltre alla conservazione Chorus Cultura si occupa anche della promozione e della didattica: proprio in questo 2021 è stata lanciata l’iniziativa “Girotondo tra le chiese”, rivolta ai ragazzi, per familiarizzare in modo giocoso con questo patrimonio.
Sono una quarantina le organizzazioni di volontariato o le Aps iscritte al Csv di Venezia che si muovono in ambito culturale o di tutela dei beni ambientali. Csv che con le due edizioni del progetto #tuttamialacittà ha dato vita a processi virtuosi di rigenerazione urbana basati proprio sul binomio arte e creatività.
Come? Per esempio col festival di danza e arte performativa “Mon Amour” di Mestre o con i progetti “Semina: terreni creativi” e “Il Provvisorio”. Il primo utilizza il teatro e le arti performative per riappropriarsi del quartiere Piave di Mestre, una zona verde dedita allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Il secondo è un’azione di rigenerazione dell’edificio CZ95 (Centro Civico Zitelle) e dell’area pubblica attorno ad esso, situata nel quartiere Zitelle nell’isola della Giudecca.
Invece le guide, figure chiave per un città che deve prendere per mano milioni di turisti, hanno scelto la forma della cooperativa. La Cooperativa Guide Turistiche autorizzate, fondata nel 1991, è una presenza storica che però ha saputo aggiornare le sue proposte.
Scrittore, veneziano, premio Strega nel 2009 con Stabat Mater (Einaudi 2008), è tra i maggiori autori italiani. Tra i suoi libri, segnaliamo Una libellula di città (Minimum Fax, 2018) e Il cipiglio del gufo (Einaudi, 2020), dedicato a Venezia.

È la sua caratteristica culturale, ma direi esperienziale. Venezia è una città che non si può non esperire. Per questo la sua cultura deve essere dinamica e fluida, non può fissarsi su nessuna cartolina. Venezia è un corpo. Libero, in movimento. Anche quando la fissità della pandemia ce la rappresentava come deserta, quella città non lo era. Era in movimento. Era Venezia, appunto. (M.D.)
L’ultima si chiama “So e Zu Detour” è una proposta di turismo alternativo negli angoli più segreti, salendo e scendendo ponti. «È una proposta all’insegna del turismo sostenibile nel rispetto della città che ci ospita. Andiamo alla scoperta della sua arte e della sua storia, della sua vera anima, della sua essenza», dicono con una punta di legittimo orgoglio.
Gli undici poli dei Musei Civici di Venezia sono diventati un motore di cittadinanza attiva grazie alla guida dell’imprenditrice Mariacristina Gribaudi chiamata a dirigerli. Al centro del lavoro culturale la relazione con il territorio e i bisogni dei veneziani
La Fondazione Musei Civici di Venezia (Muve) nata nel 2008 comprende undici poli museali e un immenso patrimonio culturale, con oltre 700mila opere d’arte, cinque biblioteche specialistiche, un archivio fotografico e un attrezzato deposito nel Vega Stock a Marghera. Nel 2015 viene chiamata alle redini dell’ente un’imprenditrice, Mariacristina Gribaudi, classe 1959. «Mi è stato chiesto di portare il modello di business che ho sviluppato in tanti anni di esperienza all’interno della Fondazione. Sto cercando di farlo con la consapevolezza del fatto che sia una fondazione sia una azienda sono fatti di persone, uomini e donne. L’obiettivo era ed è provare a mettere una marcia, una velocità e uno spirito diversi». Per farlo Gribaudi ha subito capito che la chiave di volta era la partecipazione attiva della cittadinanza. «Abbiamo cominciato così a dotare le nostre strutture di servizi adatti alle famiglie e al pubblico più giovane e abbiamo guardato al modello del coworking, portando in tutte le nostre sedi il wi-fi». Continua Gribaudi: «Era importante che i musei tornassero ad essere alla portata di tutti e non soltanto di un turismo fagocitante. I musei devono interfacciarsi con la terraferma, con i 44 Comuni della Città Metropolitana, e guardare a un perimetro più largo, che da Belluno arriva a Vicenza». Poi è arrivato il Covid che «in un certo senso, se qualcosa di buono possiamo trovare fra le macerie che ci ha lasciato, ci ha dato la possibilità di metterci a tavolino partendo quasi da zero, elaborando nuove idee e nuove opportunità, nuovi schemi, nuovi paradigmi urbanistici, economici e sociali. Tutte le nuove proposte, dalle mostre, alle permanenti ai percorsi formativi con le scuole, sono nati così». (L.M.A.)

Il suo nome era Emanuela e prima ancora Rapido. Nata nei cantieri di Pola tra il 1942 e il 1943, l’Edipo Re è un’imbarcazione che dopo essere stata il rifugio di Pier Paolo Pasolini e Maria Callas oggi è un progetto di cooperazione sociale
Edipo Re è un peschereccio. Varato negli anni 40 però smise molto presto i propri panni natali e divenne un veicolo per esuli istriani. Fu negli anni 60 che, grazie al pittore e saggista Giuseppe Zigaina, l’imbarcazione prese vita una terza volta. A poppa è rimasto il tavolo dove hanno lavorato e scritto e bevuto vino Pasolini, Morante, Moravia, Ninetto Davoli e Callas. «Il sogno e l’identità di Edipo Re affonda le sue radici nel carico simbolico di questa imbarcazione che per decenni era stata salvezza per persone in fuga e successivamente luogo d’incontro tra arti e intelletti», racconta Sibylle, laureata in filosofia, figlia di colui che ha ritrovato la barca, Angelo Righetti, psichiatra allievo di Franco Basaglia. Sibylle insieme a Franca Ongaro e Silvia Jop Basaglia, antropologa e regista, sono state le ideatrici del progetto di cooperazione sociale Edipo Re. Hanno ristrutturato la barca dandole un ancoraggio insieme sociale e culturale. «La Edipo Re agisce sul territorio sviluppando attività che da un lato mettono in relazione il valore di diversi territori con una forma di turismo etico e responsabile e dall’altro sviluppa progettualità culturali, connotate da un forte impatto sociale, dove le arti e il territorio si intrecciano dando vita a spazi di socialità imprevisti», spiega Sibylle Righetti. Un esempio? «Isola Edipo, una manifestazione artistica e culturale annuale sviluppata in collaborazione con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove arti e sociale legano insieme sostenibilità ambientale, tutela della produzione enologico-alimentare a kilometro etico e rispetto dei diritti generando un Social Food Festival», conclude Righetti. (L.M.A.)


Il turismo esperienziale diventa leva occupazionale, rammendo sociale, riscoperta del territorio e cura dell’ambiente
«Iputei devono vedere e fare. Oggi si fanno troppi discorsi. Con i ragazzi io parlo poco. Li prendo e li butto in barca. I veneziani hanno perso tutto. I giovani fanno sport artificiali, in palestra e hanno smarrito la relazione con la Laguna che è una palestra di gran lunga più faticosa. Io li porto in acqua, estate e inverno. Riscoprire la fatica, le radici, la natura è la prima scuola». A parlare è Gloria Rogliani, fondatrice e presidente dell’Associazione sportivo dilettantistica omonima (Asd Gloria Rogliani). La fatica cui fa riferimento la fondatrice riguarda le modalità di navigazione: «I nostri ragazzi vanno per mare in modo tradizionale. A remi. Per farlo abbiamo una gondola del ‘600, una Batea da Fresco, che è una barca a fondo piatto e un Bragòzzo che è invece un’antica imbarcazione da pesca e da carico, l’unica della flotta a vela». «Sono un’educatrice sportiva», racconta, «ho fondato l’associazione dopo una lunga esperienza nel patronato dei padri canossiani di San Giobbe, vicino alla Baia del Re, una zona molto periferica. Era quello che generalmente viene chiamato oratorio, pensato per accogliere i ragazzi e toglierli dalla strada. Quello di cui mi ero resa conto è che serviva evolvere quell’esperienza dal punto di vista educativo e formativo». Un’esperienza che nasce più di trenta anni fa con altri nomi e che approda alla forma odierna sei anni fa. «Col tempo ci siamo accorti che l’impegno associativo per le sfide di questa città non bastava e così la asd ha fondato anche un liceo sportivo, le superiori Marinelli Fonte. È una scuola che si fonda sulla peer education e lo sport. L’idea è che uno i valori fondanti sono il volontariato e il mutuo aiuto. Scuola e associazione lavorano assieme tenendo insieme l’educazione e la formazione didattica e umana», sottolinea Rogliani. Un liceo sportivo anomalo che tra i propri percorsi annovera un corso di cinque anni per periti turistici. «Ma non formiamo tour operator tradizionali. Noi cresciamo quelli che definiamo conoscitori della Venezia segreta, invisibile, delle emozioni, non considerata. La prospettiva è
quella di creare posti di lavoro, residenzialità, volontariato. Vogliamo che i nostri giovani si ritrovino in questa città che ha bisogno di aiuto. Negli ultimi anni il turismo estrattivo ha lesionato irrimediabilmente le comunità, portando alla spopolamento. Il Covid ha dato il colpo di grazia», sottolinea la fondatrice. In cosa consiste questo turismo esperienziale? «Abbiamo reclutato delle guide d’eccezione. Tutte quelle persone che hanno vissuto di e per la Laguna negli ultimi trent’anni. Nonni, pescatori, artigiani. Persone che hanno cose da raccontare e ci permettono di scoprire luoghi e attività che sono state dimenticate, in primo luogo dai veneziani. È un’alleanza generazionale». Così potrà capitare di andare in barca a pescare i granchi o andare sull’isola di Sant’Erasmo a vedere lo storico orto biologico. «Ed è anche un percorso che guarda alla sostenibilità e all’ambiente», aggiunge Rogliani, «quello che oggi per essere cool definiremmo “green”. Noi però non preserviamo la natura andando in giro a raccogliere la plastica. Noi viviamo la Laguna, amandola, e in questo modo automaticamente cresciamo generazioni che si prendano cura del territorio». Tutto ruota però intorno ai remi. «Attraverso la voga, ho conosciuto persone che custodivano tesori di inestimabile valore:», conclude Rogliani, «storie e tradizioni da comprendere e tramandare ai più giovani, per conservare l’equilibrio delicato e l’identità di una città che è unica al mondo». (L.M.A.)
OAltre vent’anni fa delineai nel distretto del piacere una Venezia destinata a diventare, a suo modo, parco a tema collocato all’interno di una piattaforma territoriale del loisir che dal capoluogo lagunare scendeva lungo l’Adriatico, avendo nella riviera romagnola il suo epicentro. All’epoca sindaco di Venezia era Massimo Cacciari, che condivise quella mia definizione: Venezia come vittima di un processo di falsificazione del vero, in un rovesciamento del rapporto vero-falso tipico dei “veri” parchi a tema. Fui facile profeta, e spero di non avere contributo ad alimentare la “narrazione declinista” di questi anni, cui fa riferimento lo storico Mario Isnenghi. Perché in effetti esiste una Venezia che vive e pensa a se stessa, che prova a progettarsi per cambiare un destino comunque pesantemente segnato dalla violenza dell’incessante quanto potente flusso turistico di questi decenni, cui si è aggiunto l’altrettanto potente flusso della crisi climatica qui più visibile e simbolica che altrove in Italia.
A differenza di altre città toccate dall’itinerario dei “distretti sociali”, quello veneziano si distingue per la sua chiara connotazione culturale. Cultura come welfare, cultura come motore di crescita sostenibile per andare un giorno oltre la logica dei tornelli come unica risposta all’invasione, cultura come ricerca di identità, oltre gli stereotipi diventati maschere a buon mercato. È una ricerca che si muove lenta, partendo dai margini, dalle isole periferiche dell’arcipelago che circondano il “pesce” Venezia, ripartendo dall’esperienza dell’ecosistema lagunare, muovendosi a colpi di remi, come invita a fare Gloria Rogliani, alla ricerca dei beni culturali viventi che la abitano e la vivono, sotto la coltre della pesante rappresentazione stereotipata e un po’ malinconica. È questo un esempio di una carovana/flottiglia che si muove nel deserto/ mare della turistizzazione estrattiva e senz’anima che trova oasi/porti in un sistema fondazionale a regia pubblica con protagonismo di un privato paziente. È il caso dei
bonomi@aaster.it
Musei Civici che si sono mossi con piglio manageriale anteponendo all’offerta turistica funzioni di abilitazione per la popolazione locale e il più ampio retroterra veneto con il coinvolgimento degli stessi veneziani nella programmazione delle attività. O è il caso dell’Edipo Re, prima peschereccio e poi barcone per gli immigrati istriani convertito all’animazione culturale in perenne navigazione nell’arcipelago di una socialità che scava nell’archeologia basagliana, partendo dall’evoluzione dell’isola di San Servolo da manicomio a centro universitario internazionale e molto altro.
Nel dare a Venezia una connotazione da distretto culturale evoluto che intreccia saperi tecnologici applicati alle humanities e ricerca del radicamento nel contesto sociale si produce un effetto di trascinamento importante non solo per uscire dalle secche della rappresentazione monotona ma anche per fare dell’immenso patrimonio culturale un bene culturale vivente collettivo. Tanto da spingere Banca Intesa Sanpaolo a sperimentare qui forme di rating applicate all’industria culturale, ambito nel quale il peso degli assetti intangibili tende a sfuggire all’algoritmo di valutazione del merito di credito. Ma è da questa intangibilità che si genera creatività del fare bellezza, come ricorda anche Stefano Micelli, cosa diversa dall’innovazione strutturata rispetto alla quale l’evoluzione del distretto culturale veneziano è chiamato a compiere un ulteriore salto. Distretto culturale, ma anche distretto dei sensi, come acutamente fa notare Tiziano Scarpa, perché presuppone una frequentazione di contatto sensuale con la città per andare oltre la mercificazione del parco a tema. Il che ci ricorda che le città non sono la fantasmagoria delle merci che vi troviamo facendo shopping, siano esse imitazioni industriali o prodotti della secolare manualità artigiana. Le città non sono parchi a tema dello shopping ma anche luoghi di senso e di sensi. Lezione veneziana inaspettata, ma utile per dare con un nuovo sguardo alla grande bellezza di Venezia e delle città d’arte nelle accelerazioni interroganti della pandemia.
a cura di EMILIANO MOCCIA
Ragazzi dell’area penale impegnati in un percorso di formazione professionale ideato dalla cooperativa Semi di Vita, da 10 anni impegnata sul fronte dell’agricoltura sociale

Riqualificare il territorio e, allo stesso tempo, valorizzare i settori dell’agricoltura e dell’agroalimentare che sono patrimonio, identità e tradizione dell’area metropolitana della città di Bari. Perché la vocazione storica e agricola di questa fetta del Sud Italia si misura anche con la capacità di saper trasformare terreni ormai abbandonati o in disuso in luoghi in cui innescare processi di sviluppo, lavoro, economia, inclusione, benessere, cibo sano. È questo il modello a cui guarda l’agricoltura sociale, una sorta di welfare rigenerativo che alle normali attività dell’impresa agricola coniuga la bellezza delle relazioni, degli incontri, della produzione partecipata, dell’economia dello scarto che diventa economia di inclusione socio-lavorativa. Una scommessa che coinvolge enti del Terzo settore, cooperative, istituzioni, cittadini, associazioni di categoria.
«In questi anni abbiamo fatto un bel lavoro di sensibilizzazione sull’importanza dell’agricoltura sociale, sugli effetti benefici che può apportare e sul tipo di impatto che può avere in un contesto come quello dell’area metropolitana di Bari e delle aree rurali» spiega Fabrizio Guglielmi, portavoce del Forum dell’Agricoltura Sociale in Puglia che, al momento, conta 22 imprese associate. «Sono fiorite esperienze e progetti che vanno dal-

la promozione del turismo lento alle produzioni biologiche, dalla riproposizione di vecchie ricette alla cura di orti sociali, dalla pet therapy all’agrididattica, passando per la gestione di beni confiscati alla mafia. Uno degli aspetti più interessanti è rappresentato dalla qualità dei prodotti o dei servizi offerti e dalla diversificazione dei soggetti coinvolti in questo processo: migranti, donne, persone con disabilità, minori provenienti dall’area penale, adulti in difficoltà. Si tratta di esperienze positive non soltanto dal punto di vista didattico ed educativo, ma anche per la loro efficacia terapeutica, riabilitativa e di inserimento lavorativo di soggetti più fragili». I dati del 2020 relativi al primo rapporto della Coldiretti sull’agricoltura sociale attestano che in Italia le aziende agricole che si dedicano a questo tipo di attività sono
circa 9mila e la Puglia ospita il 9% delle pratiche, piazzandosi al secondo posto dietro il Piemonte (23%).
La sfida della contaminazione fra settori diversi Anche per questo, è opportuno mappare il territorio, conoscerlo. A giugno 2018 l’estensione dei terreni censiti grazie alla collaborazione dei Comuni dell’area metropolitana era di circa 68,28 ettari, relativi solo alla proprietà pubblica di 17 Comuni su un totale di 41. La nuova sfida è quella di completare la mappatura di beni e terreni per creare una sorta di Banca delle terre, come prevede il progetto “AgriCultura” promosso dalla Città metropolitana, in partenariato col Mediterranean Agronomic Institute (Ciheam) e il Teatro Pubblico
Un gruppo di ragazzi impegnati negli Orti didattici della città di Bari
In basso a sinistra durante un incontro Fabrizio Guglielmi, portavoce del Forum dell’Agricoltura Sociale in Puglia che conta 22 imprese associate


112.890
Pugliese. «L’iniziativa è un Pon legalità che vuole favorire l’inclusione sociale e lavorativa di giovani tra i 16 ed i 24 anni usciti anticipatamente dal percorso scolastico e a rischio devianza sociale» racconta Damiano Petruzzella, responsabile scientifico Ciheam Bari. «Stiamo accompagnando 300 ragazzi in un percorso di formazione e di inserimento lavorativo nelle aziende o tramite la creazione di startup. Perché fare agricoltura oggi non vuol dire esclusivamente lavorare la terra» evidenzia Petruzzella. «Fare agricultura oggi vuol dire anche fare ricerca, innovazione, cultura dell’agricoltura. Oltre ad avviare tipiche attività di impresa agricola, è importante immaginare degli interventi anche nelle aree rurali attraverso attività culturali, masserie sociali, teatri o cinema all’aperto, scuole di fotografia itineranti. Il progetto vuole incentivare la contaminazione fra settori produttivi, come quello agricolo e dell’industria culturale».


In questo percorso di recupero, valo-
I-rizzazione e messa a sistema dei terreni incolti, trova spazio l’azione dell’amministrazione comunale di Bari che fa parte delle 199 città di tutto il mondo che hanno siglato il “Milan Urban Food Policy Pact” durante Expo 2015. «La volontà è quella di dare vita alla costituzione della “Bari Food Policy”, che mira a rendere sostenibili i sistemi alimentari, garantire cibo sano e accessibile a tutti, lottare contro lo spreco» dice Paola Romano, assessora comunale alle Politiche educative e giovanili. Di conseguenza, «dopo aver introdotto la mensa biologica e a km 0, la realizzazione di nove orti didattici in altrettante scuole cittadine che ha preso il via poche settimane fa rientra in questo cammino» aggiunge l’assessora Romano. «Per noi le scuole sono uno spazio fondamentale per la costruzione del futuro. In questa fase, a partire dal 2014, si è registrato un cambiamento su questi temi e ormai possiamo guardare alla realtà della città di Bari come una comunità di pratica».
La capacità di stare sul mercato Con i suoi 386mila ettari quella di Bari è la seconda provincia pugliese più estesa. Di questi, 130mila ettari vedono impegnati sui terreni le aziende associate a Confagricoltura Bari-Bat, che «guarda con interesse lo sviluppo di attività imprenditoriali capaci di coniugare sostenibilità e innovazione. Oltre a svolgere un importante ruolo sociale» interviene Michele Lacenere, presidente provinciale dell’organizzazione agricola, «rappresenta un’opportunità per le imprese per creare lavoro e sviluppo. La sfida è di quelle stimolanti e possibili, ma va realizzata con le giuste competenze professionali, come dimostrano le diverse esperienze nazionali e regionali. È indispensabile riuscire a coniugare l’aspetto dell’inclusione socio-lavorativa con la necessità di mantenere una produzio -
«Progetti che coniugano agricoltura sociale ed industria culturale diventano occasioni essenziali per favorire l’inserimento lavorativo dei più giovani, che possono acquisire così nuove competenze professionali da poter spendere nel mercato occupazionale». Per Peppino D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese (Tpp), non ci sono dubbi. Il progetto “AgriCultura” promosso dalla Città metropolitana di Bari, in partenariato con il Ciheam Bari ed il Tpp «rappresenta per noi una sfida affascinante, che può avere ricadute positive sul futuro occupazionale dei giovani». Come si legano settori apparentemente diversi come quello dell’agricoltura e della cultura?
Tutte le attività di animazione territoriale, come spettacoli teatrali, iniziative culturali, eventi di vario genere sono assolutamente importanti ed essenziali, ma ciò su cui adesso dobbiamo spingere è la crescita del capitale umano. Quello dell’agricoltura è un settore economico vitale per la regione Puglia, che legato al mondo culturale può aprire nuovi scenari imprenditoriali e lavorativi. Si creano opportunità diverse, percorsi professionali inediti. Per questo, dobbiamo sostenere la formazione dei ragazzi, in modo che possano applicare nel campo dell’agricoltura sociale l’innovazione conferita dagli strumenti culturali.
Perché è importante per il Teatro Pubblico Pugliese sperimentare nuove forme di intervento?
Mettere insieme agricoltura e creatività è un esperimento molto interessante. Il segreto, a mio giudizio, è che l’attività produttiva si fonde con la crescita culturale. L’attenzione al sociale è per noi essenziale. Lo abbiamo riscontrato anche con il progetto “Periferie al centro”, un intervento di inclusione culturale e sociale che ha messo al centro della sua azione le periferie. Non solo quelle fisiche, ma anche e soprattutto quelle sociali e culturali con l’obiettivo di guardarle con occhi diversi, di incontrare i ragazzi che vivevano nelle aree di margine delle città più grandi, in modo da poter scoprire i loro talenti, le loro espressioni artistiche. Anche in quel caso, come nel binomio agricoltura-cultura, ciò su cui abbiamo voluto scommettere è stata la crescita del capitale umano.
Peppino D’Urso, foggiano, presiede il Teatro Pubblico Pugliese dal luglio del 2018. Sono 61 i comuni, che insieme alla Regione Puglia aderiscono al Tpp: ogni anno realizza quasi 800 spettacoli, con oltre 170mila spettatori.

Agricoltura & cultura: questo matrimonio s’ha da fare Peppino D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese: «Così valorizziamo il capitale umano»

«Scoprire quanto l’agricoltura possa redimere persone e luoghi è stata una continua scoperta. Il nostro legame con la terra è ancestrale, è dentro di noi, è come un complesso edipico che non possiamo dimenticare». Lorenzo Scaraggi ha compiuto un viaggio a bordo del suo camper per raccogliere storie e testimonianze fra orti sociali, terre confiscate alla mafia e comunità agricole delle campagne pugliesi. Da questo suo viaggio on the road è nato il documentario Madre nostra Com’è nata l’idea di realizzare un documentario che esplora e racconta il mondo dell’agricoltura sociale?
L’idea è nata dalla conoscenza della cooperativa agricola Semi di Vita che a Bari, nel quartiere Japigia, gestisce 26 ettari di terreno confiscati alla mafia. La volontà era quella di raccontare questo movimento che sta crescendo sempre di più, rovesciando l’immagine delle realtà del Terzo settore che se ne occupano solo per volontariato. Perché parliamo di aziende agricole a tutti gli effetti che mettono al centro della loro azione un guadagno invisibile, più grande di quello economico, legato alla cura delle persone.
Quali sono gli aspetti più importanti che hai scoperto con il tuo racconto?
Molti pensano che i beni confiscati alla mafia esistono solo in Sicilia, perché c’è questo stereotipo che va scardinato. Invece, ce ne sono tanti anche in Puglia e sono gestiti da cooperative sociali che lavorano per offrire nuove opportunità di riscatto sociale a persone che hanno sbagliato in passato e che attraverso l’agricoltura trovano la strada della redenzione. Poi ci sono i progetti per contrastare il caporalato. Non dobbiamo parlare di prodotti a km 0 ma di prodotti a sfruttamento 0, diventando consumatori attenti e responsabili, scegliendo con cura il cibo che mangiamo sulle nostre tavole. Se un prodotto proveniente da interventi di agricoltura sociale costa di più rispetto ad uno tradizionale, è perché dietro c’è un prezzo etico, che rispetta i diritti del bracciante e garantisce una paga giusta.
Che cos’è la “Madre nostra”? La sentiamo davvero così vicina?
ne di qualità, capace di stare sul mercato autonomamente». Del resto, l’agricoltura rappresenta la prima “industria” della Puglia con i suoi oltre 112mila addetti occupati con continuità e migliaia di lavoratrici e lavoratori impiegati stagionalmente nelle circa 77mila imprese. Un ruolo fondamentale lo svolge anche la distribuzione. Il Gruppo Megamark di Trani, con oltre 500 supermercati diretti e affiliati presenti al Sud, è molto attento a questi temi. «Siamo convinti che promuovendo prodotti etici possiamo sensibilizzare il consumatore al rispetto dei diritti che cerchiamo di garantire e tutelare» aggiunge Annabella Donnarumma, responsabile acquisti ortofrutta del Gruppo. «Questi prodotti hanno un costo leggermente più alto, ma il consumatore è disposto a pagare qualcosa in più consapevole del fatto che sta acquistando un prodotto buono, di qualità ed in più è etico e solidale».
Negli ultimi anni tanti ragazzi, anche giovani professionisti, stanno riscoprendo il piacere di lavorare appezzamenti di terra magari lasciati dai loro nonni o dai loro genitori. È un lavoro duro, faticoso, ma appagante. Prima, nel periodo del boom economico, quasi ci si vergognava di fare i contadini, oggi invece si registra un ritorno alla terra, anche se a mio parere è un legame che non si è mai sciolto. Perché è profondo, sentito, unico.
Terzo settore, cooperative, associazioni di volontariato, dunque, hanno raccolto senza paura la sfida del cambiamento e continuano a proporre idee e modelli nel settore dell’agricoltura sociale. Per questo, diventa prezioso il ruolo delle istituzioni pubbliche e di quelle private. Come nel caso di Intesa Sanpaolo, che «ha scelto di concentrare attenzione e impegno su di un settore fondamentale per il nostro Paese come l’agroalimentare» spiega Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo: «Sono le tradizioni, le diversità e l’innovazione che rendono questo settore un’eccellenza del nostro made in Italy che oggi più che mai dobbiamo sostenere e far crescere, prestando particolare attenzione anche al risvolto sociale che possono avere alcune iniziative, specialmente nel Sud Italia, non solo dal punto di vista della propria attività, ma anche per le ricadute positive nel contesto in cui operano».
“Madre Nostra”: l’agricoltura sociale è diventata un road-movie
Lorenzo Scaraggi, giornalista-viaggiatore, ha realizzato un documentario girato fra le comunità agricole pugliesi
Imparano a seminare, potare, coltivare, raccogliere. Imparano a trasformare in cucina marmellate, tisane, biscotti. Apprendono tutti i trucchi del lavoro della terra. Ed una volta al mese organizzano anche un mercatino per vendere gli ortaggi frutto del loro impegno. Perché la “Scuola del Contadino” è un progetto che ha l’ambizione di essere la prima scuola gratuita del Sud Italia «che offre attività educative e formative a ragazzi dagli 11 ai 17 anni con problemi di disagio socio-economico o con Bisogni Educativi Speciali per dare loro delle opportunità lavorative. Il percorso punta a far sì che al compimento dei 17 anni possano poi essere inseriti in attività occupazionali legate alla campagna». Cecilia Posca è la presidente della cooperativa sociale Tracceverdi, ente capofila del progetto sostenuto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, impegnata nel campo della sostenibilità sociale e territoriale.

La cooperativa gestisce a Gioia del Colle la masseria “Al Gelso Ritrovato”, luogo in cui si svolgono le lezioni della scuola del contadino. Al momento sono una trentina i ragazzi che seguono il percorso nelle ore pomeridiane della settimana, ma la classe punta ad arrivare almeno a cinquanta unità. «Cerchiamo di offrire una formazione parallela a quella scolastica, con la finalità di far acquisire competenze professionali ai nostri ragazzi da poter spendere nel settore agricolo» spiega Posca.
«L’estate svolgono venti giorni di stage nelle aziende agricole del territorio con l’idea di promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro». Una delle attività che più appassiona i giovani studenti della “Scuola del Contadino” è il processo di trasformazione dei prodotti raccolti. Come nel caso dei peperoni: «I ragazzi» conclude Posca «si sono occupati della raccolta dei prodotti dell’orto per poi procedere con la lavorazione e trasformazione dei peperoni in conserve e sott’olio.
Abdou sorride sempre. Anche se la fatica nei campi si fa sentire, specialmente quando il sole alto nel cielo di Puglia picchia con forza. Lo sanno bene i braccianti impegnati nella raccolta del pomodoro, soprattutto i migranti che troppo spesso sono vittime di caporalato e sfruttamento, disposti a lavorare anche per 3,50 euro a cassone o a vivere in ghetti in cui le condizioni igienico-sanitarie sono davvero drammatiche. Abdou viene dal Senegal, è un Imam ed è il punto di riferimento della comunità musulmana in cui vive. Anche lui è tra coloro che contribuiscono al progetto di agricoltura sociale “Pomovero, la passata solidale, biologica e libera dal caporalato. “Pomovero”, infatti, è un progetto di agricoltura sociale e sostenibile curato da una rete di associazioni, cooperative e imprese sociali pugliesi che ha l’obiettivo di produrre senza spreco, senza sfruttamento del lavoro e dell’ambiente, una passata di pomodoro trasparente nella filiera produttiva e capace di garantire al cliente un prodotto etico, equo e solidale. Quattro i protagonisti che compongono il gruppo di lavoro: le cooperative sociali “Unsolomondo” e “Semi di Vita” di Bari, la masseria didattica e sociale Terra d’Incontro di Casamassima (Ba) e la cooperativa sociale “Pietra di Scarto” di Cerignola (Fg). Lo scorso anno sono state prodotte 40mila bottiglie, distribuite attraverso i circuiti delle botteghe solidali, i Gruppi di Acquisto Solidali o la vendita diretta. Quando il progetto è iniziato in forma sperimentale nel 2016 erano appena 2mila i pezzi realizzati. Ad unire le organizzazioni nella produzione di “Pomovero” sono alcuni valori fondamentali: il prezzo equo della materia prima riconosciuto ai produttori, l’applicazione di contratti regolari per le lavoratrici ed i lavoratori nel rispetto di tutte le forme di tutela e di prevenzione, le tecniche di produzione sostenibili, la trasparenza e la qualità del prodotto per i consumatori.

passata di pomodoro che mette fuori gioco il caporalato
Quando ha scoperto che il terreno su cui avrebbe lavorato era proprio di fronte al mare, è scoppiato a piangere.

Perché Roberto (nome di fantasia) fino a venti giorni prima viveva in cella, ristretto insieme ad altri detenuti per un reato che aveva commesso quando di anni ne aveva solo 16. Doveva scontare una pena lunga 8 anni, ma adesso è tornato a respirare il profumo della libertà. E soprattutto, del riscatto sociale. La sua buona condotta in carcere e la sua determinazione gli hanno offerto una seconda possibilità. Anche se ai domiciliari, infatti, Roberto ha iniziato un percorso di inclusione socio-lavorativa sui terreni confiscati alla mafia presenti a Japigia, venendo coinvolto negli interventi di agricoltura sociale che la cooperativa Semi di Vita ha avviato nel 2014 realizzando opportunità di rinascita comunitaria in un’area particolarmente complessa della
città. Merito di “(ri) Abilita Agricoltura sociale per l’inserimento lavorativo di giovani dell’area penale”, il progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo. «L’iniziativa ha coinvolto venti ragazzi in un percorso di formazione sui temi dell’agricoltura sociale. Del gruppo iniziale di giovani, tutti con difficili situazioni di vita alle spalle, in quattro hanno svolto sei mesi di inserimento lavorativo. Al termine, due di loro sono stati assunti dalla cooperativa» spiega Angelo Santoro, presidente di Semi di Vita. «Entrambi saranno coinvolti nella “Cardoncelleria Fornelli”, la serra di 330 mq per la coltivazione di funghi cardoncelli e di un laboratorio di confezionamento di 70 mq che sta per partire all’interno dell’Istituto Penale per Minorenni Fornelli di Bari». Non solo.

Un’immagine delle attività di Semi di Vita
In alto nei tondini Angelo Santoro, presidente di Semi di Vita ed Elena Jacobs di Intesa Sanpaolo
Perché nei 26 ettari confiscati alla criminalità organizzata a Valenzano, i due ragazzi lavoreranno ne “La Fattoria dei Primi”, «dove stiamo per avviare un pollaio con 1.400 galline ovaiole. Inoltre» prosegue Santoro «abbiamo piantato 1.000 mandorli, 400 melograni e 150 ulivi che daranno i loro frutti tra circa due anni. I ragazzi lavoreranno anche nell’orto sociale di Japigia aperto alla comunità. Sono 40 le famiglie/ persone che gestiscono 50 metri di orto che consente di avvicinarsi al rapporto con la terra, la natura, il cibo sano». La missione principale di Semi di Vita, dunque, è quella di «curare la terra, curando le persone. Dare una possibilità a giovani dell’area penale di potersi riscattare attraverso il lavoro è per noi una missione molto importante». Anche per questo, Intesa Sanpaolo ha deciso di scommettere e di sostenere questa iniziativa di concreto riscatto sociale, confermando «il proprio impegno in termini di responsabilità sociale: la banca interviene su importanti nodi strutturali della missione Inclusione e Coesione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, promuovendo il lavoro come forza riabilitante per giovani in condizioni di fragilità, realizzando una vera e propria scommessa educativa e facilitando la rigenerazione di beni comuni» aggiunge Elena Jacobs, responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo. «Sosteniamo l’azione del Terzo settore in un importante territorio del Sud Italia, all’interno di un percorso che abbiamo intrapreso da tempo e che ci vede operare al fianco delle migliori realtà del Paese in ambito sociale».

Terra di Bari, terra “Madre nostra” come la narra Lorenzo Scaraggi nel suo documentario dedicato al mondo dell’agricoltura sociale. Una terra fertile di colture pregiate, basta pensare all’olio e all’uva da tavola, ma anche territorio di culture distintive. Terra lembo estremo della piattaforma del Mezzogiorno continentale che, con la sua tradizione levantina, guarda da sempre più ad Oriente che ad Occidente, verso i Balcani dai quali è unita dal suo mare corto. Una città che sedimenta nella sua storia passata e recente una tradizione di inclusione, contaminazione ed integrazione incardinata sul culto per il suo patrono San Nicola. Terra sincretica di scontro, incontro e confronto tra religioni, civiltà e culture. Una memoria che si è manifestata nella modernità di fine secolo scorso con l’accoglienza del primo flusso migratorio quello albanese, che ha cambiato la storia dell’Italia da paese d’emigrazione a terra d’immigrazione.
In questa area metropolitana e in questa regione più che altrove, a fronte dell’iper modernità che viene avanti con la sua drammatica questione ambientale e climatica, la terra come suolo da lavorare e patrimonio da coltivare sta diventando driver strategico attraverso il quale provare a costruire un nuovo territorio distintivo. Si “gioca” qui una nuova scommessa che pone la terra al centro di processi attrattivi di valorizzazione sostenibile, emancipazione e inclusione, laddove nella modernità fordista questa ha rappresentato il luogo dal quale fuggire in cerca di opportunità e di migliori condizioni di vita nel grande esodo verso il grande triangolo industriale del Nord. Riguardare alla memoria per costruire tracce di futuro, questa la grande sfida che in chiave iper moderna di cui si trova traccia nelle pratiche e nelle esperienze di nuova agricoltura sociale. Ce lo dicono i dati e le storie riportate nel dossier. Una Puglia seconda a livello nazionale per pratiche di agricoltura sociale (9%) portate avanti da circa 9mila aziende agricole. Un movimento in crescita che cerca di diventare intelletto collettivo sociale come dimostrano, ad esempio, le 22 imprese agricole aderenti al Forum dell’Agricoltura Sociale in Puglia. Con l’agricoltura e l’agroalimentare si sperimentano nuove alleanze, reti e connessioni tra comunità operosa di impresa e comunità di cura inclusiva al fine di produrre un welfare rigenerativo e
nuova tessitura sociale. Non dimentichiamo che 386mila sono gli ettari di terreno presenti nella sola provincia di Bari che i 41 Comuni della città Metropolitana stanno cercando di mappare per dar vita alla Banca delle Terre come previsto nel progetto AgriCultura e farne così un patrimonio da valorizzare e mettere a sistema in ottica di sviluppo sociale, occupazionale ed economico. Si cerca di avvicinare in modo sistemico mondi diversi: istituzioni locali, istituti di ricerca e formazione, istituzioni finanziarie, istituzioni culturali e creative, terzo settore, volontariato e cooperazione in tutte le sue forme. Le esperienze, le pratiche e le sperimentazioni come ci viene raccontato sono numerose e diverse e spesso riguardano mondi misconosciuti che proliferano all’ombra della retorica del racconto delle eccellenze, misurandosi su questioni di civilizzazione del lavoro come il caporalato o di diritto al lavoro per i soggetti più fragili in condizioni di disagio mentale, fisico e sociale. Realtà dove la scommessa si fa più difficile ma anche più affascinante e dirompente come comprovano le esperienze di Semi di Vita e Pomovero. Perché queste realtà così come i partner del progetto Agricultura: Città metropolitana di Bari, Ciheam e Teatro Pubblico Pugliese, ci rammentano che non potrà mai esserci un’economia verde senza una società verde ed inclusiva.
Si persegue quindi quella che io denomino la connessione tra le tracce di smart land di una campagna luogo di sviluppo e le tracce di la smart city, intese come pratiche di economia della conoscenza globale in rete a base urbana, un raccordo in cui la città metropolitana innesta il contado con le sue tante esperienze produttive e sociali. Basta pensare alle numerose fattorie didattiche e masserie sociali, alle cooperative agricole e imprese sociali che a partire dalla lavorazione della terra e dall’operosità dell’industria culturale e creativa cercano di alimentare una nuova costruzione sociale del territorio. Un territorio in cui la marginalità e la minorità non sono più confini invalicabili ma bacini di intelligenza sociale da cui attingere e da cui partire per sperimentare con madre terra, nuove forme di civilizzazione e produzione di capitale sociale mettendo in mezzo così tra stato e mercato la forza propulsiva delle comunità e dell’investimento paziente in infrastrutturazione sociale, per contribuire a cambiare il racconto del Mezzogiorno.
Uno dei 622 bambini che hanno partecipato al progetto “In Viaggio verso il Futuro” di Fondazione L’Albero della Vita che ha insegnato ai più piccoli ad usare le nuove tecnologie
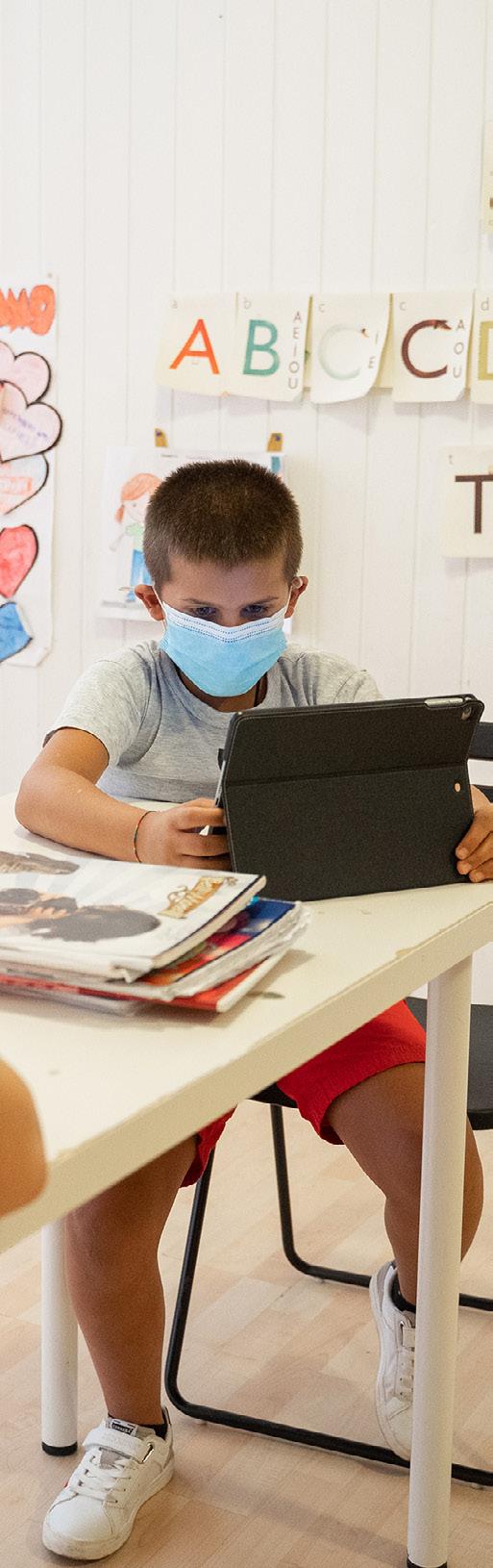
Non è certo stato il cambio di nome in “San Filippo Neri”, avvenuto intorno agli anni 90, ma in verità mai pienamente accettato dagli abitanti, ad avere determinato la sua lenta ma progressiva trasformazione in un quartiere nel quale oggi c’è tanta voglia di riscatto culturale. Al pari della sua altissima densità abitativa, lo Zen ha un tessuto sociale fortemente presente e capace di incidere nei processi di inclusione e di rigenerazione. Un tessuto sociale che, a partire dalla fine degli anni 80, ha cominciato a investire le proprie risorse in un territorio che era veramente terra di nessuno, un luogo nel quale andare a vivere ma anche a morire.
Zen 1 e Zen 2, due facce di una stessa medaglia che non hanno mai voluto sino in fondo dialogare tra di loro. Realizzati in fasi differenti, dal 1958 agli anni 80, prima sorgerà lo Zen 1 con le sue palazzine di edilizia popolare, raggiunte in gran parte dai servizi primari; intorno al 1970, invece, avrà inizio la storia dello Zen 2 per opera dello Iacp di Palermo sul progetto dell’architetto Vittorio Gregotti, che pensò a dei fabbricati da realizzare secondo la struttura architettonica delle insulae che, tanto per avere un’idea, ricordano non poco le Vele di Scampia. Due aspetti di uno stesso quartiere che ha sempre vissuto l’isolamento non solo geografico, dal momento che,
sono gli abitanti del quartiere “San Filippo Neri”, ex Zen di cui 1.495 anziani
sono gli alunni della VII circoscrizione segnalati dalle istituzioni scolastiche
nalità, pronta in ogni momento ad approfittare dall’assenza dello Stato.
è il tasso di disoccupazione generale (79,8% è il tasso di disoccupazione giovanile)
Un tema, quello della difficoltà di essere collegati al resto della città, sollevato anche dall’ultima Inchiesta sulla condizione minorile in Sicilia che ha sottolineato il fatto che i ragazzi, ancora oggi, quando devono allontanarsi anche di un solo chilometro per andare a scuola, dicono “andiamo a Palermo”, come se lo Zen fosse estraneo alla realtà cittadina. Capita spesso, inoltre, che molti abbandonano il liceo nel corso del biennio perché «partire dallo Zen vuol dire alzarsi alle 4 del mattino. Perché i pullman sono pochissimi, sono gremiti di gente che deve raggiungere il posto di lavoro e che, quindi, ha la priorità sul ragazzo che deve andare a studiare», spiega la gente del quartiere.
non essendo mai stato facilitato il suo avvicinamento al centro cittadino attraverso servizi di trasporto adeguati, ha sviluppato nel tempo anche un isolamento culturale, vissuto o sarebbe meglio dire “subìto” soprattutto dai più giovani. Una sorta di segregazione che ha inevitabilmente alimentato il fiorire della crimi-
Se la Commissione parlamentare Antimafia ha deciso di registrare questa e numerose altre problematiche tra quelle che la Sicilia vive sul fronte della condizione dell’infanzia, significa che si può parlare di vero e proprio allarme sociale che preoccupa operatori sociali, associazioni, scuola e istituzioni.
«Io non penso che lo Zen 2 debba ambire a diventare via Libertà», riferiva alla Commissione Antimafia Mariangela Di Gangi, ai tempi presidente dell’associazione Laboratorio Zen Insieme, «basterebbe che diventasse lo Zen 1, cioè ci accontenterem-
mo della regolarità. Allo Zen 2 molte cose che sembrano banali non sono consentite. Mi riferisco al fatto che qui sono state realizzate soltanto le parti di progetto relative alle abitazioni, non esistono spazi destinati alla socialità o alla vita di comunità. Condizioni di solitudine sociale che, ovviamente, hanno un loro immediato impatto sul versante dell’esperienza scolastica dei ragazzi». Un tema centrale, quello dello spostamento dallo Zen, che vale sia per l’istruzione sia per i servizi sanitari, in quanto trasversale a tutte le dinamiche riguardanti la famiglia.
E la scuola, infatti, diventa tasto dolente quando parliamo di dati. Qualche numero: nell’ultimo anno scolastico sono stati 1.993 gli alunni della VII circoscrizione, entro cui ricade lo Zen, segnalati dalle istituzioni scolastiche; 55 quelli segnalati al servizio sociale o alla procura. Solo il 10,09%consegue un diploma di scuola superiore, mentre la laurea viene conquistata dall’1,3% della popolazione. Preoccupante il dato riguardante i Neet, che
I soggetti del Terzo settore più attivi nel quartiere che si occupano di minori, adolescenti e delle loro famiglie sono: Laboratorio Zen Insieme , Fondazione L’Albero della Vita, Handala, Lievito e Bayty Byatik.
La piazza è diventa un luogo intergenerazionale che favorisce l’incontro tra bambini, giovani, genitori, operatori e istituzioni scolastiche. Sinergie che nascono anche grazie alle attività delle associazioni del territorio come “Laboratorio Zen Insieme” che oltre al sostegno scolastico realizza laboratori artistici, musicali e informatici per minori dai 6 ai 18 anni

si attesta al 34,11%. Sul problema della mancata entrata dei ragazzi a scuola interviene la dirigente dell’Istituto “G. Falcone”, Daniela Lo Verde, sottolineando che «ognuno dei pochi operatori scolastici in forza alla scuola ha il carico di circa 70 casi mensili. Veramente troppi. Se, poi, cerchiamo di coinvolgere i servizi sociali, non sempre questo tipo di aiuto è ben visto dal quartiere, perché ha la sensazione che assistente sociale equivalga a “mi tolgono i bambini”, quindi non si fidano».
Spezzare la catena Diventa quindi fondamentale il lavoro che fanno le associazioni, in particolare quando riescono a lavorare in rete, per spezzare quella catena che vede trasmettere l’esclusione sociale di padre in figlio, «perché una famiglia vittima di povertà educativa educa bambini e bambine che, a loro volta, restano intrappolati nel circuito della povertà educativa e, di conseguenza, dell’esclusio-
Palermo Monreale San Martino delle Scale San Martino delle Scale Mondello Sferracavallo MAR TIRRENOne sociale», chiosa Lo Verde. Tutto questo allo Zen è amplificato, ma costantemente attenzionato da chi vive il territorio.
Un quartiere che di strada ne ha fatta veramente tanta da tutti i punti di vista. Qualcuno ha ancora nostalgia dei tempi in cui, al posto delle insulae nelle quali sorgono le abitazioni, era un fiorire di arance, mandarini e limoni. Bastava sporgersi dalla finestra di casa e si veniva travolti dal profumo inebriante della zagara che rimandava agli antichi fasti del paesaggio tipico della Piana dei Colli.
«Certo era un’altra cosa», racconta Rosa Perrone, abitante del quartiere, ma anche una di quelle volontarie che ha vissuto proprio alla Zen la nascita di realtà sociali che oggi continuano a esistere e a fare la differenza. «Mio padre era un dipendente dell’Istituto Case Popolari e gli venne dato l’incarico di assegnare le abitazioni a quelle persone che avevano perso la casa nel centro storico in seguito al terremoto del ’68. Quando cominciarono ad assegnarle, una parte venne data alle persone che l’avevano persa in via Vetriera, alla Kalsa, mentre un’altra parte venne occupata dal giorno alla notte, nonostante ci fossero i cantieri in costruzione. Non credevamo ai nostri occhi. Stava cambiando tutto».
Lo Zen diverrà luogo di sperimentazione (come dimostrano le esperienze che leggere qui a lato), un modello di rete che, insieme all’Albergheria, quartiere del centro storico di Palermo, ispirerà non pochi. «Anche la politica entrava in gioco, ma senza alcuna strumentalizzazione perché l’idea era di fare insieme per migliorare la qualità di vita del quartiere. Lo posso dire? Stiamo riscrivendo la storia. Non so quanto ne fossimo consapevoli, ma oggi guardo indietro e al presente e sono felice di avere fatto e di continuare a fare la mia parte», conclude Perrone.
e non ci fossero stati loro nessuno di noi, compresi i bambini, avrebbe fatto nulla. Questo progetto ci ha dato la possibilità di uscire e condividere la bellezza di questa città». Parla cosi Rosy, una delle mamme dello Zen che partecipa al progetto “In Viaggio verso il Futuro”, promosso dalla Fondazione L’Albero della Vita sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Insieme a Rosy, nel foyer del Teatro Massimo, ad accompagnare i bambini a una mostra organizzata per il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, c’è pure Gianina, energica donna romena, anche lei qui per la prima volta: «Quanto è gratificante, poi, stare insieme ad altre donne e condividere con loro momenti come questo. È bello sapere di non essere sole». Fondamentale per gli operatori fare in modo che esperienze del genere aiutino la crescita dell’intero nucleo familiare. «Durante la prima annualità avremmo dovuto raggiungere 400 bambini e 200 famiglie», spiega Maria Francesca D’Alia, referente dell’area Povertà dell’Albero della Vita, «a fine progetto, siamo arrivati a 622 bambini e 740 famiglie. Con “Viaggio in Prima Classe”, poi, è stato possibile lavorare insieme ai più piccoli per accompagnarli nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla prima elementare. Un percorso che si concluderà il prossimo settembre. «Oggi seguiamo 40 bambini e 200 famiglie», afferma Serena Fleres, coordinatrice del progetto. «Durante la pandemia abbiamo portato avanti un’attività che servisse loro a sviluppare le competenze economiche. Abbiamo, per esempio, mandato loro sui cellulari dei tutorial per insegnare come fare il pane o la pasta in casa tenendo alta la qualità. Un successo».
«Devo dire veramente grazie a tutti loro», aggiunge in conclusione Loredana, un’altra mamma che ha partecipato all’attività della “Banca del Tempo” aiutando gli operatori a gestire i bambini «prima io stavo sempre a casa. La Fondazione ci sta dando aiuti economici, ma anche tanta sicurezza. Ora sono finalmente rinata».

Acontribuire al cambio di passo allo Zen è stato senza dubbio il lavoro di tante realtà del privato sociale che negli anni si sono alternate in questo territorio. Come quello dell’associazione “Laboratorio Zen Insieme” che ogni giorno apre le porte ad almeno 50 minori, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, per farli partecipare ad azioni di contrasto alla povertà educativa, che vanno dal sostegno scolastico alle attività laboratoriali, artistiche, informatiche, musicali e relative alla lettura.
«Il lavoro che facciamo in questa direzione», afferma Fabrizio Arena (nella foto), presidente dell’associazione Laboratorio Zen Insieme dal 2012, «parte dalla consapevolezza dei diritti perché solo così fai mancare il terreno alla mafia, andando a sgretolare quell’immagine di criminalità benefattrice che si sostituisce allo Stato».
Fondamentale anche il lavoro portato avanti da Save the Children che, proprio nei locali di via Costante Girardengo 18, ha il suo “Punto Luce”, un centro aggregativo a bassa soglia il cui obiettivo è quello di fornire ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze,
strumenti che diano loro l’opportunità di sviluppare le proprie inclinazioni, dal corso di pianoforte al corso di tennis, sino a quello di giocoleria; attività che le famiglie non sono in grado di offrire ai propri figli, non per mancanza di volontà ma perché non ai primi posti delle loro liste di bisogni primari.
Povertà educativa che viene combattuta con la cultura. Ecco il valore di “Giufà”, prima biblioteca comunale di quartiere, che oggi conta migliaia di prestiti ai residenti dello Zen. A tenerla aperta è Laura, una mamma che, da assidua utente lettrice, si è voluta specializzare e la si può trovare ogni giorno a curare i testi che la biblioteca custodisce gelosamente.

«Il problema è sempre la narrazione che deve cambiare quando si parla di realtà come la nostra. Dobbiamo fare anche in modo che ogni agenzia educativa sia messa nelle condizioni di dare il proprio contributo», conclude Arena «avendo come obiettivo il benessere dei minori. E poi lavorare sui sogni, sulle utopie che accomunano grandi e piccini, facendoci credere che un mondo diverso è veramente possibile».

Il diritto a sognare? Lo abbiamo tutti, ma se lo rivendicano i bambini abbiamo tutti il dovere di aiutarli a realizzare i loro desideri. Allo Zen i sogni sono tanti ma, diversamente da quel che si pensa, viaggiano a un livello superiore. Un viaggio che l’associazione Handala fa non solo con le donne, ma anche e soprattutto insieme ai più piccoli, aiutandoli a relazionarsi con altre realtà del territorio cittadino. Un esempio? Manifestazioni sportive come “Mediterraneo Antirazzista”, torneo di calcio a 5, basket, pallavolo, cricket e rugby che, nel corso delle sue cinque edizioni, ha visto la partecipazione di oltre 150 squadre e più di mille giocatori da tutti i quartieri di Palermo, in rappresentanza di moltissime comunità di immigrati presenti in città. Un’iniziativa che è andata anche fuori dai confini siciliani, dal momento che negli anni passati le tappe preliminari si sono svolte a Scampia e nel quartiere Prenestino, a Roma, ma anche nel quartiere S. Gottardo-
Molassana di Genova. «Crediamo che la contaminazione sia fondamentale per la crescita di tutti, tanto più per i bambini e i giovani», afferma la presidente di Handala, Lara Salomone (nella foto) «e, per questo cerchiamo sempre di organizzare attività che costruiscano ponti tra più quartieri e contesti. Un’occasione per aprire i territori, insieme alle menti». Con l’educativa di strada, poi, si parla di diritti negati, quindi dei “senza”, riguardanti tutto ciò che manca al quartiere e che va rivendicato con forza. Diritti che passano attraverso la conoscenza. «Proprio per questo ai primi di aprile, nella nostra sede di via Costante Girardengo 15, abbiamo inaugurato “Lucy”, la prima biblioteca diffusa che ha inglobato alcuni dei libri della Bibliofficina di quartiere “booq”, che ha sede alla Kalsa, nel centro storico di Palermo. Una piccola scelta di libri “adottati” dai ragazzi della scuola media dello Zen per parlare al momento di tematiche legate al mondo femminile».

cominciato a dimostrare concretamente che nelle periferie bisognava intervenire con competenza ma anche mettendoci il cuore.
La presenza di numerose realtà del Terzo settore, sensibilmente cresciuta negli anni, è stata vista come corpo estraneo o accolta come valore aggiunto?
Non ci sono dubbi. La presenza di volontari e operatori è sempre stata vista con favore dalla
anche dato il nuovo nome al quartiere, anche se sempre più spesso registro una sorta di nostalgia per quello originale.
La parrocchia San Filippo Neri, ma anche le forze dell’ordine oggi dimostrano che il quartiere è cambiato...
La caserma dei carabinieri ha sede in una delle insulae vicino alla sede della Fondazione L’Albero della Vita. I bambini hanno nell’Arma un punto di riferimento, infatti non è raro vederli organizzare iniziative insieme. Ciò dimostra anche che le famiglie, i genitori, vogliono altro per i loro figli.
Allo Zen è arrivata anche l’arte in senso più alto…
Con “Manifesta” abbiamo portato qui il paesaggista e filosofo Gilles Clément che, per la Biennale ha realizzato il “Giardino Planetario”. Erano presenti anche realtà come il “Laboratorio Zen Insieme” ma anche e soprattutto gli abitanti. L’opera è ancora esistente e la gente se ne prende cura come se fosse propria. È stata la conferma di come la cultura non può e non deve restare chiusa soltanto in alcuni salotti; gli stessi che utilizzano contesti come questo o anche molti altri per le loro passerelle durante celebrazioni come quella di quest’anno per il trentennale delle due Stragi del 1992. La gente, però, lo capisce e non si presta al gioco. Questa iniziativa come tante altre ci dicono che tutti possiamo essere protagonisti del nostro cambiamento, riconoscendo i diritti di tutti e di tutte e facendo dell’accoglienza e del dialogo il proprio punto di riferimento.
tutto questo possa essere cancellato?
Sarà la prova del fuoco. Se la cultura dei diritti resterà diffusa, allora il sindaco lo potrà fare chiunque. La qualità della vita della città non dipenderà da chi la amministrerà, ma da chi la pretenderà.
Lavorare nei contesti di fragilità che le nostre città esprimono, continuando a parlare di emergenza, non può allinearci con i bisogni davanti ai quali i nostri adolescenti ci mettono. Ne è convinto Pasquale D’Andrea, garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo. La sua storia affonda le radici proprio allo Zen, dove ha partecipato alla nascita di reti associative che hanno lasciato un segno nel campo delle politiche per l’infanzia
Erano gli anni 80 e si parlava di emergenza, ma la cosa preoccupante è che si continua a parlarne ancora oggi....
Allo Zen registriamo sempre un grosso indice di povertà educativa, anche se c’è una maggiore presenza del Terzo settore, peraltro più strutturata, come quella del “Laboratorio Zen Insieme”. C’è stato un miglioramento rispetto al passato, ma non rispetto ai tempi. La situazione è ancora oggi drammatica.
La scuola dovrebbe giocare un ruolo educativo importante…
Sicuramente le scuole del quartiere hanno un’apertura migliore al territorio; poi, dopo tanti anni, hanno anche acquisito una metodologia capace di relazionarsi con la realtà circostante. Oggi senti anche di un numero inferiore di scuole vandalizzate. Vengono, inoltre, coinvolte in progetti che danno loro un ruolo più importante e attivo. Sicuramente influisce in maniera positiva anche il fatto che ci sia l’Osservatorio scolastico a dare un buon supporto. Purtroppo, però, non è avvenuto il cambiamento che auspicavamo. Almeno non completamente.
Cosa manca, quindi, nel quartiere?
Non esiste l’educazione alla bellezza, ma lo dico in generale, non solo per lo Zen. Come si fa a essere educati all’ambiente, se quello che ti circonda non è curato?
Cosa si dovrebbe fare?
Prima di tutto non correre dietro all’emergenza perché non ci porta da nessuna parte. Cosa può fare la politica? In una parola: incominciare a guardare avanti per davvero. A partire dal futuro dei nostri ragazzi.
Sono le nuove povertà e il supporto delle fragilità di adolescenti e giovani alcune delle linee prioritarie dell’impegno di Intesa Sanpaolo attraverso il “Fondo di Beneficenza e opere di carattere sociale e culturale”. Giovanna Paladino, responsabile della segreteria tecnica di presidenza di Intesa Sanpaolo si occupa di questa misura.

Di che entità di investimenti si tratta?
Dal 2018 al 2021 abbiamo investito circa 55 milioni di euro, mentre sarà di 18 milioni di euro l’ammontare delle risorse che nel 2022 aiuteranno il Terzo settore a dare una risposta concreta a
tutte quelle situazioni rese ancora più gravi dalla crisi sanitaria, economica e sociale di questi anni.
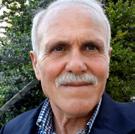
Fondazione L’Albero della Vita a Palermo è una delle associazioni che state sostenendo per il secondo anno consecutivo. Perché avete scelto proprio questa realtà?
Si tratta del progetto “In viaggio verso il futuro”. Si rivolge a centinaio di bambini e famiglie con minori, che ogni giorno partecipano attivamente a percorsi che danno loro nuove opportunità di crescita. È uno di quegli interventi al quale abbiamo creduto subito perché si tocca con mano la concretezza di un lavoro di qualità che incide veramente nel
tessuto sociale.
Il bisogno che si registra in molte realtà del Sud farebbe pensare che le richieste arrivino maggiormente da questi territori. È così?
Non proprio. Ci sono regioni che vanno un po’ meglio, per esempio proprio la Sicilia che rimane il quinto percettore del Fondo con un investimento di poco meno di un milione di euro. Certamente chi accede al nostro fondo deve sapere che non facciamo beneficenza, ma chiediamo professionalità. E questa non sempre la troviamo, specialmente quando chiediamo di presentare la domanda in formato digitale.
Pronti a sostenere le realtà del Sud: ma non basta il bisogno, serve professionalitàintervista a Pasquale D’Andrea garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo
Aleggere i numeri relativi alla disoccupazione e alla dispersione scolastica relativi alla popolazione che abita nelle insulae allo Zen, che ormai da tempo si chiama quartiere San Filippo Neri, tentando così di darsi un’identità di comunità capace di andare oltre l’acronimo di una stagione che sembra non passare mai, non c’è da stare molto allegri. Metà della popolazione risulta ufficialmente disoccupata, così come quattro giovani su cinque, mentre tre su quattro sono da annoverare tra i Neet. Un solo studente su dieci conclude il ciclo secondario (per altro non presente in loco), mentre una percentuale infima (1%) riesce a laurearsi. Fare distretto sociale rimane così una sfida aperta sulla faglia larga dell’esclusione, tessere società e fare rammendo sociale un lavoro che presuppone volontà, passione, competenza e dedizione continua.
Personalmente ne feci esperienza nei primi anni 90 quando accompagnai la Missione di Sviluppo promossea da Carlo Borgomeo, che allo Zen, come pure al Corviale a Roma, tentava di enucleare tracce di comunità operosa, tracce di autoimprenditorialità, per riempire i vuoti degli spazi pianificati per la prossimità commerciale e artigianale, e per contribuire ad innescare un minimo di auto-propulsività in un corpo sociale intrappolato nella spirale della segregazione spaziale e culturale.
Per cercare di scardinare questa trappola ereditaria che attanaglia gli abitanti di questa parte della città sono venuti in tanti, soprattutto tanti operatori del sociale che hanno lavorato e lavorano per fare delle insulae un arcipelago di reti e di comunità di cura alle prese con istituzioni scolastiche sovraccariche di disagio giovanile, dotate di risorse insufficienti rispetto al quadro delle necessità, ma sempre più competenti ed esperte nell’utilizzo di bandi e fondi europei, e con presidi sociosanitari a dir poco barcollanti. Eppure, come afferma il sindaco Orlando, abituato a get-
bonomi@aaster.it
tare il cuore oltre l’ostacolo delle inerzie e dell’apparente coazione a ripetere, le cose sembrano essere cambiate, alcune importanti barriere fisiche e culturali sono state abbattute, anche se, come ricorda il garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo, «c’è stato un miglioramento rispetto al passato, ma non rispetto ai tempi».
Se ancora, parti importanti di Zen 2 rimangono sostanzialmente poco connesse al resto della città, tema centrale nell’epoca delle reti per la circolazione di persone, merci e informazioni, la comunità di cura alleata a una politica dell’accompagnamento lungimirante, ha prodotto sperimentazioni interessanti come quella di Handala che costruisce reti translocali, ha sedimento un intelletto collettivo sociale capace di riprodursi nel tempo come il Laboratorio Zen Insieme, continuando a produrre un arcipelago di iniziative capaci di produrre fiducia e capitale sociale incardinati su una cultura dei diritti. Una cultura ed una pratica molto focalizzata sui bambini e sui giovanissimi, che parte dal gioco per farsi regola, che parte dall’accesso alla cultura e allo sport come premessa per cambiare la narrazione del luogo. Un grande processo di costruzione di una coscienza di luogo che parte dal rovesciamento dell’assunto della segregazione per farne contesto di una narrazione basata sulla capacitazione diffusa, alternativa alla cultura comunitaria degli interessi criminali. Delle esperienze riportate nel dossier colpisce la conferma di un protagonismo molto spesso al femminile, di mamme certo, ma non solo. Di donne che fanno leva su altre donne per uscire dalla solitudine e andare verso la bellezza, facendo carovana di interi nuclei familiari. Facendosi levatrici di futuro, quello dei loro figli e dello Zen in transizione all’interno di una città a sua volta attraversata da profonde trasformazioni. E allora è forse il caso di concludere riprendendo l’affermazione del sindaco secondo cui «Palermo è lo Zen e lo Zen è Palermo», riferendosi all’intreccio necessario tra centro e periferie, facendo sì che il margine si faccia centro.
Delle esperienze sociali di questo dossier colpisce il protagonismo delle mamme e delle donne tese le une verso le altre e insieme alla ricerca di un senso di bellezza

