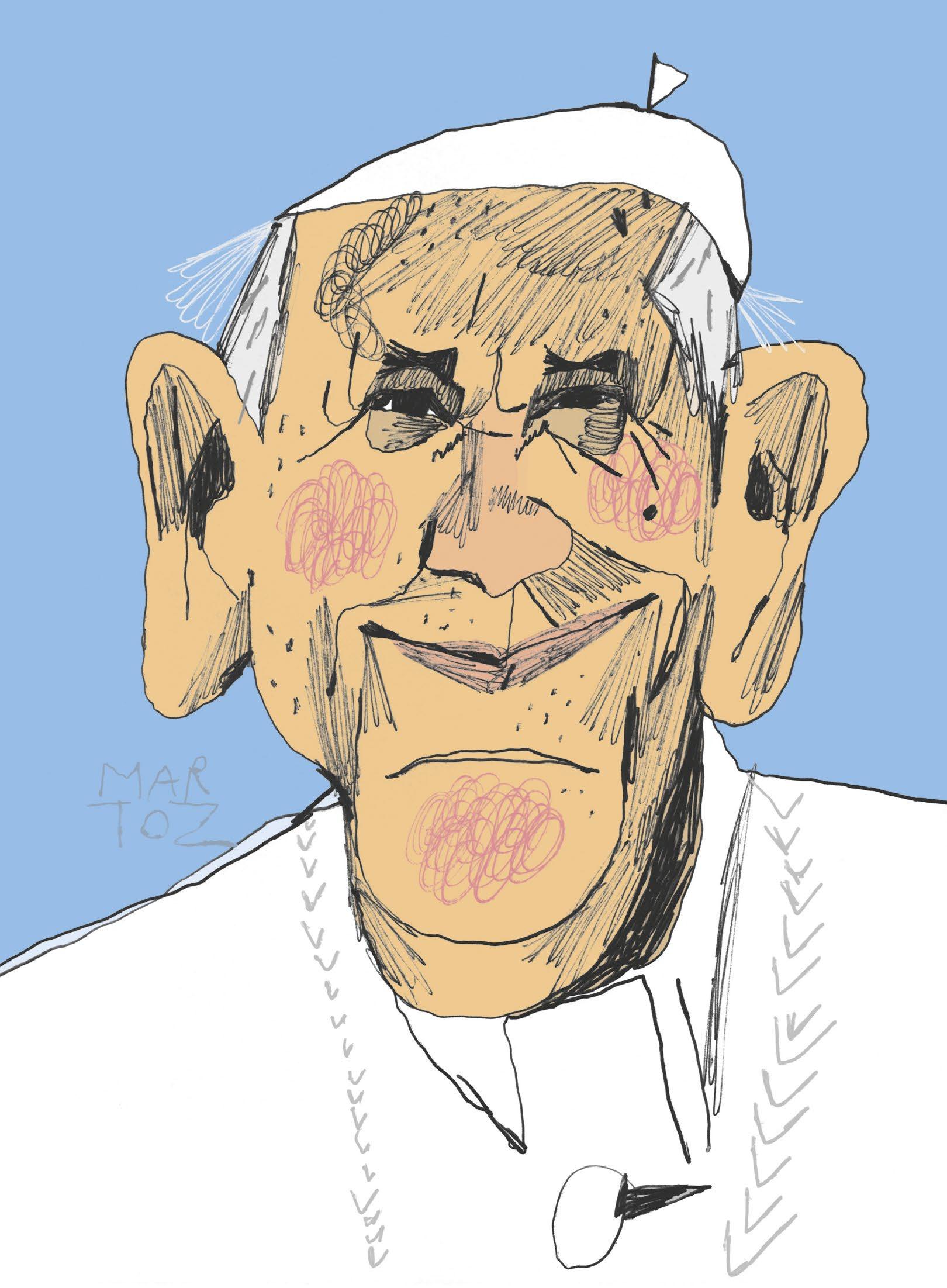
10 anni di

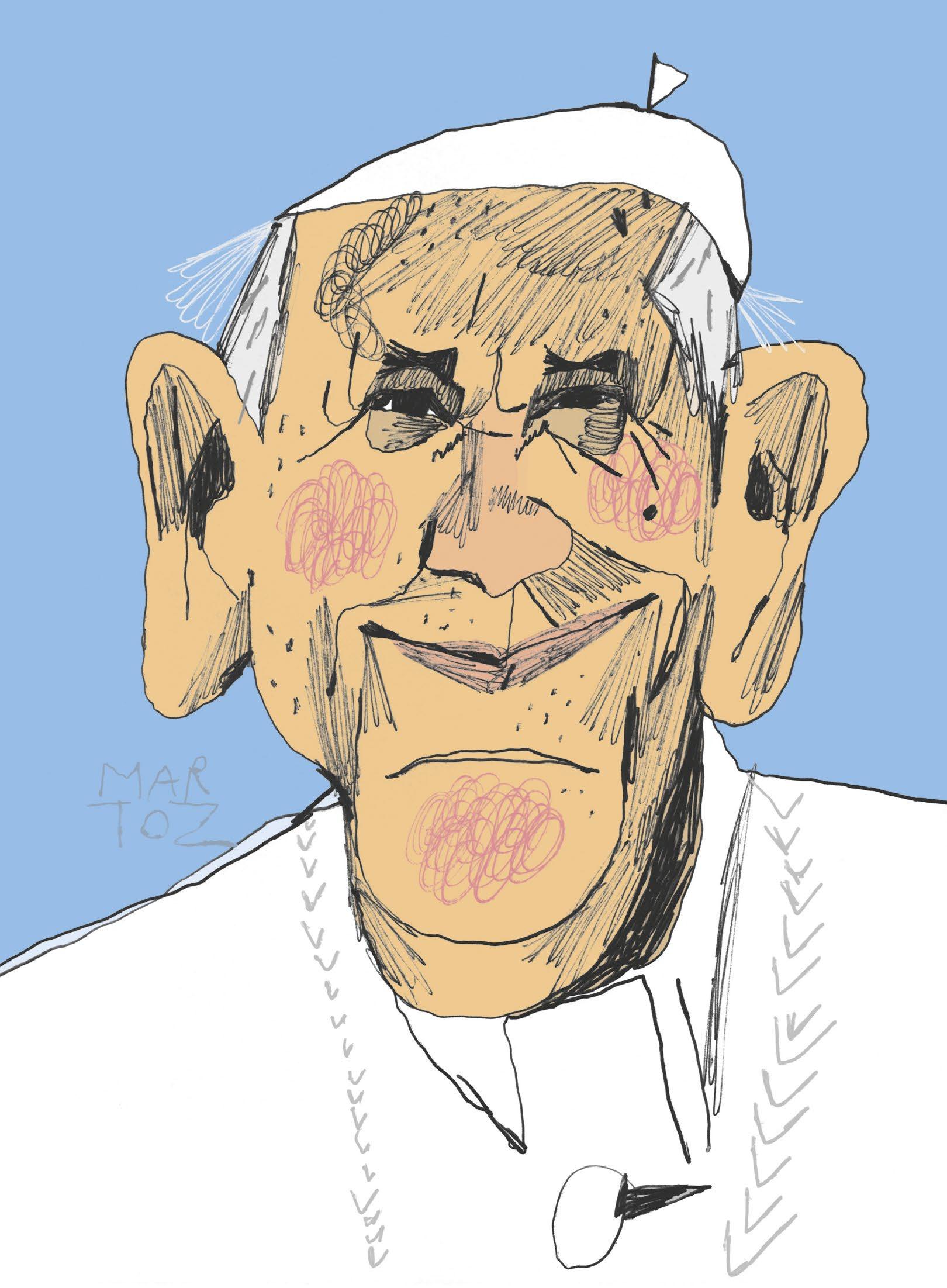
10 anni di
Il 13 marzo del 2013 Bergoglio diventava Francesco. Un papato che ha segnato in modo indelebile il pensiero e la pratica sociale

astensionismo registrato nelle elezioni regionali di Lombardia e Lazio trova certamente le sue radici nella separazione che la “politica” ha alimentato intorno a sé, ma non può essere letto solo utilizzando questa chiave. I suoi numeri, oramai vera e propria emergenza democratica e civile, mi pare costringano tutte e tutti noi a una riflessione seria. Non solo come cittadini e cittadine ma come soci, attivisti, operatori, dirigenti delle organizzazioni del civismo attivo, dell’associazionismo e del volontariato, dell’impresa sociale e delle loro reti o soggetti di coordinamento e rappresentanza. Soprattutto se pensiamo al nostro lavoro come ambito di cambiamento e non di contenimento; come insieme di azioni e interventi tesi sia all’abilitazione, tutela e promozione di diritti, sia a restituire “capacità di aspirare” a persone e comunità così lacerate e dense di disuguaglianze e povertà da fare percepire come impossibile anche la sola facoltà di immaginare un futuro differente, più giusto e dignitoso.
E, ancora, ci riguarda perché molto probabilmente tra quelli che sono rimasti a casa e anche tra quelli che handi Andrea Morniroli coordinatore Forum Disuguaglianze e Diversità
COVER ART: MARTOZ
no deciso di votare per le forze che esprimono posizioni radicalmente alternative all’idea di mondo e di giustizia sociale e ambientale che portiamo avanti ci sono molte delle persone con cui tutti i giorni proviamo a lavorare e che sono le prime vittime di tali politiche. In altre parole, se ormai riusciamo a comunicare il valore umano e sociale del nostro lavoro, non riusciamo ancora con la stessa chiarezza ad affermare il senso profondo e la prospettiva per cui quel lavoro serve per prevenire e arginare le dinamiche sociali, economiche e culturali in cui si alimentano povertà, disuguaglianze, cattive economie. Forse non ci riusciamo perché oramai da tempo molte e molti di noi hanno scelto di stare sui tecnicismi e le operatività o di giocare la rappresentanza sul solo piano sindacale e dell’advocacy. Una sorta di deriva tecnico-amministrativa-governista in cui con l’andar del tempo abbiamo messo di lato l’attenzione sul senso politico e culturale del nostro lavoro. Ci siamo accontentati del fare (spesso dell’ottimo fare) ragionando poco su quello che stavamo facendo. Un deficit di riflessività che ci ha resi più fragili di fronte ai processi di disinvestimento pubblico, economico, culturale e politico nei campi del welfare e dei diritti, facendoci in troppi casi perdere anima e visione esponendoci al rischio di colludere con scelte politiche errate e di essere interpretati e di interpretarci come meri gestori di politiche altrui. Insomma, mai come ora abbiamo bisogno di un doppio salto di qualità per preservare e innovare il nostro lavoro.
Il primo passo va teso a rendere più denso e a mettere a sistema il nostro fare insieme. Abbiamo bisogno di investire per costruire
maggior connessione tra tutti noi e tra le nostre reti, sapendo che per farlo davvero occorre considerare la fatica di mettere a repentaglio le nostre certezze e le nostre abitudini e di essere disponibili a considerare i nostri assunti come “verità penultime”, con la consapevolezza che mai come oggi il fare sistema è essenziale e indispensabile.
Il secondo passaggio necessario riguarda il ritrovare il gusto dello svelamento e della denuncia, per aprire vertenze e per abilitare conflitto come chiavi per ridefinire una nuova relazione con le persone e le comunità con cui lavoriamo o sono attorno a noi. In altre parole, per costruire una nuova alleanza dove ciò che lega e risponde ai bisogni delle persone sia da ritrovare nella mobilitazione comune e nella dimensione politica e culturale. Un piano indispensabile perché nel Paese si è diffuso e consolidato un profondo cambiamento del senso comune, per cui le disuguaglianze sono normali e le povertà una colpa, spostando l’attenzione non tanto sul contrasto della povertà stessa ma sul come trattare e contenere i poveri. Dove si è rotto il patto fiscale che prevedeva la redistribuzione di ricchezza per garantire educazione, salute, diritti, contrasto delle povertà. Dove la cura invece di essere intesa come responsabilità pubblica è stata declinata in una logica privata, mettendo in produzione la sofferenza, in una chiave di mero contenimento dei problemi. Se è giusto chiedere alla politica una profonda rivisitazione di approcci e metodi, ad iniziare dal fare spazio e stare in ascolto, facendo posto a chi, fuori, nel mondo, nella realtà e non nei palazzi, prova a costruire uno sviluppo giusto dal punto di vista sociale e ambientale, è altrettanto importante un richiamo per un rinnovato impegno anche ai soggetti del fare e del lavoro sociale e educativo.
Il lavoro sociale è vittima di una sorta di deriva tecnicoamministrativa-governista che ha messo all’angolo il senso politico e culturale di quello che facciamo. E così fatichiamo a farci capire anche dagli elettori
In questi anni, a fianco di tante magnifiche pratiche ed esperienze, troppe sono state le ambiguità e le confusioni, e il dialogo con la politica si è trasformato in collusione con scelte errate che hanno depotenziato l’idea di un welfare pubblico e universale. Dove hanno prevalso le timidezze piuttosto che la denuncia o l’affermazione di un rapporto attento e non ideologico, ma allo stesso tempo non appiattito alla sola gestione di politiche altrui, magari per il timore di subire perdite e ritorsioni
economiche. Dove troppo spesso si è persa l’abitudine a proporre e stare nel movimento e nelle vertenze.
Sono limiti e contraddizioni profondi che non possiamo più tenere di lato e non affrontare. Anche perché non farlo significa svilire e depotenziare le esperienze che tutti i giorni provano a costruire alternative, buone pratiche di governo locale, forme democratiche di partecipazione e cittadinanza dal basso. Che non rinunciano a farsi carico della complessità, che propongono cose che si possono fare perché già si stanno facendo.
In una recente intervista su Avvenire sul tema del rapporto tra cattolici, sociale, politica e consenso, Giuseppe De Rita dichiara: «I cattolici sono capaci di grande aggregazione sul versante della coesione sociale, ma la politica è un’altra cosa, è ricerca del consenso, ha un suo linguaggio, richiede tempo e volontà di sporcarsi le mani. Chi pensa da un giorno all’altro di poter tradurre in termini di consenso le aggregazioni costruite intorno alla coesione sociale rischia di restare solo, di non ritrovarsi al fianco nemmeno i suoi amici».
Ecco senza un rinnovato investimento sulla dimensione politica del proprio fare e senza un impegno sul promuovere e agire forme di mobilitazione, penso che anche il mondo del fare e del lavoro sociale corra lo stesso rischio.
Ivana Pais
Per capire il ruolo delle tecnologie nelle trasformazioni del lavoro non basta studiare i rider; ormai sono numerose le professioni che hanno introdotto strumenti digitali per l’organizzazione del lavoro. Karen Levy all’inizio dell’anno ha pubblicato Data driven. Truckers, Technology, and the New Workplace Surveillance sulla digitalizzazione del lavoro dei camionisti negli Stati Uniti. Il lavoro degli autotrasportatori è faticoso e pericoloso, per loro e per gli altri; per questo, fin dal 1930 sono state introdotte norme per limitare le ore di lavoro e ridurre i rischi di sovraffaticamento. Fino a pochi anni fa, il controllo veniva effettuato da ispettori che verificavano i registri cartacei fermando i camion a bordo strada o presso le stazioni. Gli autisti falsificavano di frequente questi documenti per lavorare più ore e aumentare il proprio compenso. Nel 2019 è stato introdotto l’obbligo di utilizzo di dispositivi tecnologici (gli electronic logging devices — Eld) che rilevano in automatico tutti i movimenti degli autisti. È l’apparecchio che viene imposto a Ricky, il protagonista del film Sorry we missed you di Ken Loach. Uno dei risultati di ricerca è che questi strumenti sono più efficaci dei registri cartacei nel verificare il rispetto delle norme ma non facilitano il raggiungimento dell’obiettivo per cui queste regole sono state introdotte: la riduzione degli incidenti. Inoltre, presentano effetti non previsti che peggiorano le condizioni di lavoro degli autisti. Oltre agli ispettori, sono numerosi gli attori che hanno accesso a questi dati: i datori di lavoro, per monitorare i percorsi e ridurre il consumo di carburante; le aziende di assicurazione, per migliorare i sistemi previsionali su cui sono basati i loro servizi e verificare le dinamiche degli incidenti.
Il risultato è una perdita di indipendenza del camionista, che ha sempre fatto della propria autonomia un tratto centrale nella costruzione dell’identità professionale. Questo contribuisce a ridurre l’attrattività di una professione in cui da anni si registra — anche in Italia — un calo nell’offerta di lavoro. Levy si chiede come mai la tecnologia venga utilizzata per aumentare il controllo e non per migliorare le condizioni di lavoro. Una domanda che non riguarda solo i camionisti.
finestra con vista sulle aule di oggi e di domani
Giovanni Biondi
Di recente la Finlandia ha reso l’apprendimento interdisciplinare centrale per l’istruzione degli studenti. Viene richiesto agli studenti di “pensare” come uno scienziato, come uno storico o come un filosofo contemporaneamente. Un modo per sviluppare le competenze necessarie sia nel mondo del lavoro sia nella nostra società. Alcune competenze di cui si parla spesso come il problem solving dipendono infatti dalla capacità di riunire elementi disparati per poi sintetizzarli e creare qualcosa di nuovo. Dobbiamo cioè scardinare alcuni capisaldi del secolo scorso. Si tende a pensare che l’innovazione nella scuola sia in grado di sviluppare competenze e realizzare questo “miracolo”. La tecnologia in sé non garantisce alcuna innovazione se alla base manca l’abilità di attingere a settori diversi. È questa capacità combinatoria che spesso determina il successo di molte startup che nascono magari in un garage, che non producono nessun manufatto ma sono in grado di utilizzare in modo nuovo e diverso conoscenze e risultati ottenuti in settori diversi.
Gli studenti però difficilmente potranno imparare a pensare in modo multidisciplinare se non avranno insegnanti con conoscenze adeguate in più materie e sapranno collaborare in modo integrato. Tutto questo non avviene ordinariamente nelle nostre scuole. In Italia infatti abbiamo oltre 80 diverse classi di concorso e nell’Università oltre 300 settori disciplinari. Una proliferazione figlia di esigenze accademiche o sindacali più che scientifiche. Per superare questa frammentazione anche dei profili professionali in uscita il mondo produttivo ha cercato di creare nuovi percorsi di studio come nel caso del consorzio Muner in Emilia Romagna che ha ibridato settori disciplinari nel comparto
automobilistico dove un ingegnere oggi deve avere competenze meccaniche ma anche elettroniche e via dicendo. Le capacità cognitive di routine, quelle che sono anche più facili da insegnare e da verificare, sono anche quelle destinate a essere digitalizzate e magari affidate ad un’intelligenza artificiale più veloce ed economica. Percorsi analoghi sono stati intrapresi dagli Its che con una struttura dinamica e flessibile puntano a formare negli studenti competenze che guardano al mondo del lavoro e ai suoi continui sviluppi. Nella scuola questi tentativi sono ancora molto sporadici e ostacolati da un sistema disciplinare consolidato e strutturato nei programmi come nei libri di testo. Anche l’organizzazione, gli orari di cattedra, le attività di programmazione didattica non favoriscono questa visione interdisciplinare.
L’apprendimento interdisciplinare è ormai decisivo per avviare gli studenti al lavoro. Ma il nostro sistema non l’ha ancora capito
Lo sviluppo delle competenze non può avvenire senza un profondo cambiamento del modello scolastico e di quello universitario ancora troppo legati ad una tassonomia disciplinare novecentesca. Se è vero che anche la rappresentazione e la diffusione delle conoscenze che circolano in rete privilegia appunto le connessioni tra i contenuti, i link tra le pagine del web generando un gigantesco ipertesto sempre in movimento, dovremmo ripensare in modo radicale anche quanto avviene nella scuola e nell’università. Questa situazione è anche alla base del fenomeno dei Neet e del mismatch tra domanda e offerta del mondo del lavoro: in moltissimi casi il lavoro c’è ma non ci sono le competenze adeguate degli studenti. In Italia uno studente su quattro vive in questo che potremmo chiamare “limbo”. Un mondo di mezzo nel quale galleggia più del 20% (23,2%) degli studenti: una percentuale tripla rispetto alla Germania (7,7% ) e doppia rispetto alla media europea. Al problema della mancanza di competenze adeguate si aggiunge in Italia anche il peso di una cultura familistica che tende a procrastinare i tempi di entrata nel modo del lavoro e a mantenere gli studenti in famiglia.
I risvolti di questa situazione gravano sempre di più sulla scuola che perde molto del suo prestigio perché non svolge più la funzione di ascensore sociale. È sempre meno in grado di assicurare un futuro ai suoi studenti e per questo perde una funzione essenziale ma soprattutto perde valore il suo lavoro. La percezione che hanno gli studenti è che il successo scolastico sia del tutto scollegato dal destino professionale tanto che si punta a prendere il diploma e “poi si vedrà”.
SEI UN ENTE DEL TERZO SETTORE E VUOI RAGGIUNGERE MILIONI DI CONTRIBUENTI?
PARTECIPA ALLA CAMPAGNA COLLETTIVA DI VITA DEDICATA AL 5 PER MILLE per info e costi scrivere a: a.perini@vita.it
nuovi percorsi per periferie e dintorni
Anna Detheridge
Un monaco buddista interroga i suoi discepoli e chiede loro «che cosa vedete in questa immagine?»
Si tratta di un uccello in volo. Tutti gli allievi rispondono: «Vediamo un uccello». Lui scuote la testa e dice: «Non si tratta di un uccello, ma di un uccello che in questo momento sta attraversando il cielo!». Chissà se questa piccola gemma di saggezza, il prodotto di lunghi anni di meditazione e di esperienza potrà essere compresa ed apprezzata un giorno dall’intelligenza artificiale?
Le promesse della tecnologia digitale in questa fase della sua evoluzione sono sempre più profetiche sia nelle previsioni di mondi virtuali dove potremo perderci nel nirvana di universi senza tempo, sia in quelle dove verremo cullati da un’intelligenza artificiale che risolverà magicamente tutti i nostri quesiti, ma non certo la nostra paura atavica di essere superati e dominati dalle macchine.
Ma le trasformazioni in atto oltre la fitta coltre di retorica stanno evidenziando altri futuri meno rosei che prefigurano per le fasce più deboli della società globale in costante crescita, un mondo di lavoro se non distopico sicuramente caratterizzato dall’assenza di un impiego definito da un luogo e da relazioni sociali come li abbiamo conosciuti fino ad oggi.
Ma come cercare in mezzo a tanta confusione i reali contorni di un
possibile scenario futuro? Procediamo con l’occhio dell’osservatore disincantato che come prima cosa applica la regola del follow the money
Lo sviluppo dell’IA (o meglio l’automazione) ha creato di fatto un mercato di lavoro precario e non ancora mappato per una serie di task ossia compiti anche i più imprevedibili. Come dichiara lo stesso sito di Amazon, Mechanical Turk, ciò che è difficile per i computer è facile per gli esseri umani. A ogni passo esiste la necessità di colmare quel gap che gli autori chiamano the last mile ossia l’ultimo miglio tra quello che è in grado di elaborare l’automazione e ciò che invece richiede l’apporto di un’intelligenza umana. Una serie di task o compiti, tra i quali il riconoscimento di immagini, definire e taggare, classificare, rimuovere doppioni, sono soprattutto compiti qualitativi affidati alle persone. Tra il 2010 e il 2017, raccontano gli autori, la rivoluzione IA è stata retta da uno sforzo immenso di milioni di esseri umani per insegnare alle macchine a identificare un oggetto come a esempio un divano.
Per farla breve dopo anni di tentativi e strategie diverse le piattaforme di servizi hanno trovato il modo di distribuire compiti automaticamente a milioni di persone per riconoscere le immagini, un lungo lavoro collettivo di persone organizzate in maniera automatica. Oggi un sito come

Nel mito dell’IA le persone sono interscambiabili, non hanno identità. Peccato che la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, fra il 2010 e il 2017, si è realizzata solo grazie a milioni di esseri umani
ImageNet, possiede un immenso database di oltre 14 milioni di immagini. I lavoratori invisibili di MTurk sono di fatto i veri eroi mai celebrati dietro l’IA.
Le piattaforme che impiegano lavoratori on demand oggi offrono alle aziende online in un rapporto business to business, una combinazione di mano d’opera umana e IA. Consegne immediate, soluzioni a una varietà inenarrabile di compiti logistici potranno diventare il lavoro del futuro. Un mondo per ora senza regole né trasparenza, tanto meno figure o luoghi di riferimento con dei ruoli riconosciuti e delle tutele. Eppure non si può certo parlare soltanto di sfruttamento perché come molti lavoratori sia negli Stati Uniti sia in India raccontano, è anche una scelta per chi vuole o deve lavorare da casa, part time, per

potersi permettere di studiare ecc. ecc. Un’idea di flessibilità molto propagata, ma che si rivela anch’esso un mito. Se la flessibilità evoca una vita dove il lavoratore può scegliere, regalarsi del tempo libero, la realtà di molti lavoratori del web è un’altra. La flessibilità richiede un’ipervigilanza, essere continuamente collegati, on call giorno e notte permanentemente disponibili. Se non si è sufficientemente flessibili, l’account del lavoratore potrà essere chiuso da un giorno all’altro senza preavviso, né spiegazioni. Il lavoro in rete non fornisce né chiede informazioni riguardo chi viene impiegato, la varietà dei task richiesti sono quasi infiniti, l’apprendimento e i costi di transazione sono tutti sulle spalle del lavoratore.
Nelle molte interviste realizzate dal team di autori emerge che in oltre il 50% dei casi la difficoltà maggiore è quella di farsi pagare. Nella corsa a legittimare il mito dell’IA le persone sono necessariamente interscambiabili, non hanno identità e sono dunque eliminabili alla prima difficoltà perché non costituiscono alcun costo.
In fin dei conti l’IA non è che una immensa condivisione di conoscenze uno sforzo collettivo orchestrato in tante parti del mondo, dove la povertà dei compensi non ripaga la grande intelligenza che molti lavoratori anonimi ci mettono quale valore aggiunto non riconosciuto. Un enorme cloud di intelligenze e competenze reali come affermano molti autori nel recente numero di Limes L’intelligenza non è artificiale (12/22). Oppure una sorta di wikipedia deviata (wikipedia, quello vero, è un bene comune), un’attività gratuita messa a disposizione da volontari al servizio di tutti. L’intelligenza collettiva non riconosciuta diventa mito e dunque “artificiale” perché come sapevano bene gli antichi greci, il mito non è che una menzogna utile. Utile per i grandi feudatari della rete per nascondere una verità tutt’altro che innovativa, e che ricorda molto da vicino il lavoro a cottimo nelle case dei contadini di diversi secoli fa.
l’informazione nell’era di internet
Luca De Biase
Ne L’età della ragione, Jean-Paul Sartre descrive le esitazioni di un personaggio di fronte alla sua possibile adesione al Partito Comunista Francese. Il libro, iniziato prima della guerra, nel 1939, viene pubblicato dopo. Ma la questione centrale, quella della libertà, resta a sottendere le sue scelte. Scrive, nel 1947: «La politica del comunismo staliniano è incompatibile con l’esercizio onesto del mestiere letterario» (Situations II, 1948, p. 280). Ne parla con Albert Camus, Simone de Beauvoir, Maurice MerleauPonty. Una bussola teorica guida Sartre nel contesto della rinascita sociale post-bellica, tra potenti tensioni sociali, scelte di campo tra le due superpotenze, decisioni collettive e leadership intellettuali da conquistare o difendere. Oggi, in piena guerra in Europa, dopo una pandemia mondiale, prima delle prossime emergenze climatiche, la scelta di aderire a un partito è altrettanto attuale, in teoria. Ma dopo la desertificazione ideale dell’epoca neoliberista, quello che manca per superare l’esitazione non è l’età della ragione ma il recupero dell’emozione autentica per il gesto di darsi a una causa politica. Con la trasformazione della democrazia in un mercato dei consensi, l’adesione a un partito sconfina con un’operazione di comunicazione dedicata a cercare
voti: la genuinità dell’ideale di partito si perde nell’interesse di parte. E tutto questo, paradossalmente, ripropone il dubbio di Sartre: l’adesione a un partito è compatibile con l’esercizio onesto del mestiere letterario? Anche perché mentre i mestieri letterari sono cambiati ciò che ne rende onesto l’esercizio è cambiato molto meno. La letteratura si è reincarnata in nuovi linguaggi adatti a nuovi mezzi di comunicazione. Ma la ricerca che la sottende e che la motiva resta possibile soltanto nella trasparenza degli interessi del ricercatore. La libertà del pensiero resta possibile solo nell’indipendenza da preconcetti e obiettivi di potere. La stessa credibilità del narratore resta solida soltanto nella sua disponibilità a entrare sinceramente nel punto di vista degli altri. La sua eventuale leadership deve essere prima culturale che politica. E la sua funzione è comunque la liberazione del pubblico, non la sua manipolazione. Certo, un equilibrio si deve pur trovare tra la funzione politica e quella intellettuale. Può essere un equilibrio diverso da quello del passato. Ma forse va cercato nell’evoluzione delle attività che una persona può svolgere nel corso della sua vita. Non nella loro sovrapposizione. L’età della ragione fa fare un passo avanti nella conoscenza. Ma l’emozione è la forza che può far fare quel passo avanti a molte persone insieme. L’una senza l’altra generano mostri.
il valore aggiunto del mutualismo
Sergio Gatti
Cala il prezzo del gas. Quindi diventa meno urgente la conversione energetica? Nella settimana in cui ricorre un anno dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe, il prezzo del gas è sceso sotto i 50 dollari. Questa riduzione non significa che la gravità della crisi energetica si sia attenuata né tantomeno che si avvicini alla conclusione. Basti pensare che negli stessi giorni la siccità irrompe in piena stagione invernale. Quindi la produzione di energia dovrà comunque rinunciare alle fonti fossili che generano anidride carbonica. Vale la pena tenere alta l’attenzione. E non sciupare le tante progressive consapevolezze che stanno maturando. Un contenitore prezioso di informazioni, dati, ragionamenti è rinvenibile nel rapporto Le Comunità energetiche rinnovabili contro la crisi, pubblicato lo scorso novembre da Symbola. È originale l’angolo di lettura dal quale muove lo sguardo il dossier che indaga per la prima volta insieme il “pianeta” dei cittadini, quello delle imprese e quello delle diocesi. Se la sensibilità degli imprenditori sulla questione energia non è una sorpresa, potrebbe invece meravigliare la diffusa attenzione da parte delle diocesi. Questo è uno dei fatti nuovi: «Le Cer sono uno strumento per veicolare il senso di comunità e dialogo con i soggetti laici. Le
Le strutture ecclesiali superano decisamente imprese e singoli cittadini nel grado di conoscenza del modello delle Cer. Come rivela il rapporto di Symbola
Cer hanno stimolato le strutture ecclesiali a scendere di nuovo in campo concretamente, ad affiancare i Comuni, la politica… per realizzare un progetto che ha la forza di mettere in connessione mondo laico e parrocchie», si legge in uno dei passaggi di natura qualitativa del rapporto.
E ancora: «Le Cer diventano un’occasione per alimentare la relazione, la partecipazione e combattere concretamente la povertà energetica, fenomeno sempre più diffuso, posto in evidenza anche nell’Enciclica Laudato si’ del 2015. Occorre infatti far leva sulla capacità delle Cer di generare valore sociale che diventa poi economico e ambientale. Ecco perché le diocesi si stanno muovendo per promuovere un dialogo con i soggetti laici e pubblici, così da diffondere informazione e coinvolgere in un’ottica trasversale». Il livello di conoscenza delle Cer da parte dei tre “pianeti” indagati
è buona. «Ne ha sentito parlare il 100% delle diocesi, tre esponenti su quattro del mondo delle imprese (75%) e l’85% della popolazione. Tuttavia, è solo il 13% dei cittadini a conoscere bene il concetto, il 32% delle imprese ma ben il 47% dei referenti diocesani». Le principali opportunità nel partecipare a una Cer, secondo la popolazione, «sono il risparmio economico e la garanzia di indipendenza e sicurezza energetica sul territorio, citate quasi a pari merito. Anche se numericamente più marginali, non mancano le aspettative positive in termini di impatti sulla società e sull’ambiente (l’adozione di un modello più sostenibile, la lotta alla povertà energetica, il rafforzamento dei legami di comunità). Preoccupano invece principalmente i lunghi tempi di realizzazione e gli investimenti economici che lo strumento richiede, seguiti dal cambio di mentalità, dall’incertezza degli incentivi e dalla burocrazia o necessità di conoscere le normative. Sia le imprese sia le diocesi auspicano un ruolo di promozione delle Cer da parte delle amministrazioni locali. Altri attori chiamati in gioco dalle diocesi sono le parrocchie e i cittadini, mentre per le imprese sono il Governo e le associazioni di categoria».
Anche elementi qualitativi offrono spunti sui quali lavorare. Le Cer evocano ingredienti-chiave “costitutivi”, pregiati e concretizzabili, quali la condivisione («l’idea di mettere a fattor comune l’energia come simbolo della capacità del vivere bene insieme e del senso di comunità»); l’educazione («uno strumento in grado di far comprendere concretamente i vantaggi economici del consumo condiviso, ma anche di educare a una nuova sensibilità e cambio di paradigma»); l’ambiente («uno strumento davvero proiettato al benessere dell’ambiente nella sua interezza che risponde a logiche attuali di autonomia, risparmio, comunità, scambio reciproco»); il futuro («un’idea realizzabile oggi ma che risponde a logiche già proiettate nel domani, anche grazie alle smart grid, alla domotica e ai sistemi di controllo consumi digitalizzati»).
sempre vince chi attacca
Stefano Granata
Le diverse anime del Terzo settore convivono, ormai da tempo, con un senso di latente frustrazione in riferimento alla rilevanza riscontrabile nel dibattito pubblico non tanto quanto istituzioni, ma quanto alle modalità con cui vengono trattate tematiche sociali che le sono proprie. Certamente la frammentarietà delle posizioni, piuttosto che un’acerba competenza di comunicazione o, a volte, gli atteggiamenti rivendicativi imbevuti di autoreferenzialità, non aiutano a valorizzare la necessità di approfondire, di cogliere la complessità e conseguentemente portare a fattori di interesse generali argomentazioni che indiscutibilmente lo meriterebbero. Le grandi questioni educative, di cura, di inclusione sociale per fare solo degli esempi, dovrebbero essere al centro non solo della vita politica, ma anche degli interessi di tutta la comunità nel senso più ampio. Spesso invece assistiamo ad approcci molto superficiali o, peggio ancora, strumentali che finiscono con il perdere di vista il senso più profondo dei problemi e soprattutto ci allontanano dall’individuare soluzioni condivise, costringendo le persone a schierarsi sterilmente con posizioni più o meno ideologiche. Basti pensare alle delicate quanto fondamentali questioni delle dipendenze ludiche o da sostanze, delle dilaganti patologie psichiatriche, piuttosto che dei flussi migratori o delle povertà crescenti. La proliferazione dei social gioca un ruolo di evidente responsabilità. Infatti assistiamo da una parte ad una pressoché totale disintermediazione da fonti autorevoli e riconosciute, dall’altra ad una incontrollata azione di incessante e determinata delegittimazione di organizzazioni e persone che le rappresentano. Altra considerazione di una certa rilevanza va individuata nel fatto che viviamo nell’era dell’emotività collettiva spesso abusata da messaggi finalizzati ad interessi commerciali e alla costruzione di consenso politico. I grandi temi sociali vengono semplicemente sfruttati per interessi particolari e non certamente per orientare il dibattito verso una vera presa di coscienza. La banalizzazione delle parole chiave è estremamente pericolosa in quanto rischia di svuotarne il senso e di

farci perdere la prossimità sincera e profonda in favore di comportamenti individualistici e speculativi.
Sempre in riferimento alla grande influenza emotiva, esasperata dalle conseguenze dell’ondata pandemica, va sottolineato quanto l’opinione pubblica si senta spontaneamente ingaggiata da eventi emergenziali, capaci tuttavia di avere un potere di coinvolgimento solo per un tempo limitato. La vicenda dei profughi ucraini ne è un esempio chiarissimo: dopo una fase di grande solidarietà che ha visto protagonista tutta la comunità, attualmente si registra una sorta di atteggiamento di distacco, certo complice una guerra che non sembra mostrare la prospettiva dei titoli di coda.
I temi sociali sono alle mercé di interessi particolari necessari alla costruzione del consenso. Come uscire da questo tunnel?
Una strada c’è
L’individuazione di vie d’uscita appare un esercizio assai complicato: va riconosciuto lo spirito lodevole con il quale diverse realtà come questo giornale non si arrendono e con coraggio assumono una posizione decisamente controcorrente. Tuttavia credo non sia sufficiente. La vera grande ferita del nostro tempo che condiziona la vita sociale, economica e politica è il venir meno dei legami fiduciari nei confronti delle istituzioni e tra le persone. La cultura egocentrica e individualista ha fortemente minato principi e comportamenti fondamentali per la convivenza civile.
Rimettere al centro le grandi questioni non può prescindere dal rimettersi in gioco a partire dalle relazioni personali per arrivare alla ridefinizione del senso delle nostre organizzazioni. Spesso ho messo in luce la disconnessione con le nuove generazioni: forse i giovani ci stanno chiedendo proprio questo per colmare quel grande vuoto nel quale li abbiamo trascinati.
retoriche, storie, comunicazione
Doriano Zurlo
Penso non ci siano mai state, in giro, così tante parole. E, allo stesso tempo, così poco amore per le parole. La chiacchiera è sempre esistita, per carità. In una certa misura essa è anche utile, serve a sgravare un po’ le afflizioni quotidiane. Ma che chiacchiera sia, e non si pretenda di farla passare per filosofia.
Il lettore penserà: ora parte il pippone sulla differenza tra cultura “popolare” e cultura “alta”. In realtà, no. Naturalmente, penso che preferire un libro di Zygmunt Bauman a un post di Fedez dovrebbe essere considerato normale, e non indicibilmente snob. Ma temo che il punto non sia davvero questo. Ho piuttosto il sospetto che, prima di avere a che fare con la qualità, la questione sia da porre in termini di quantità. Ci sono troppe parole.
Si dice che viviamo nella civiltà delle immagini. Secondo Horst Bredekamp, il mondo intero è avvolto in un “bozzolo iconico”. In buona misura questo è vero. Siamo bombardati. Ma delle centinaia, o migliaia di immagini che ci investono in qualsiasi momento della giornata, quali rimangono davvero? Fateci caso: rimangono quelle poche che generano torrenti di parole. Per vincere nel grande torneo della comunicazione, oggi, si devono generare torrenti verbali. Torrenti di vuoto, il più delle volte. Strumenti di ottundimento delle coscienze. I social forse ci stanno mutando.
ChatGpt, intelligenza artificiale...siamo preoccupati di macchine che scrivono e parlano come uomini. Ma il vero nodo è che sta accandendo il contrario
L’overwording, l’esondazione di parole cui siamo esposti in ogni istante della nostra vita, mina la nostra percezione della realtà. Livellando ogni ragionamento verso il basso, ci fa dimenticare che la vera dimensione del linguaggio è verticale prima che orizzontale, abissale prima che superficiale, siderale prima che tellurica.
Dice bene Ivano Dionigi: «Che ne è oggi della parola? Ridotta a chiacchiera, barattata come merce qualunque, preda dell’ignoranza e dell’ipocrisia, essa ci chiede di abbassare il volume, imboccare la strada del rigore, ricongiungersi alla cosa. Agostino direbbe che “noi blateriamo ma siamo muti”. Costruttori di una quotidiana Babele e sempre più votati all’incomprensione reciproca, avvertiamo il bisogno di una ecologia linguistica che restituisca alla parola il potere di svelare la verità» (da Benedetta parola, Il Mulino, 2022). E un grande pensatore del secolo

scorso, Hans Urs Von Balthasar, a proposito della parola che si impiglia nel dettato comune, che si uniforma al livellamento linguistico preconfezionato dalla convenzione sociale, diceva: «Ciò che doveva essere una libera comunicazione dello spirito, ora sembra diventata una sua disperata esteriorizzazione, una chiacchiera indegna; ciò che avrebbe dovuto porsi a disposizione dello spirito, in modo che potesse comporre forme sempre nuove e libere di discorso, sembra ora aver acquisito su di lui un tale potere che ormai non gli resta che di aggirarsi carico di catene» (da Verità del mondo, Jaca Book, 1989). Oggi vanno di moda le nuove ChatGtp gestite dall’intelligenza artificiale. Altri torrenti di parole inutili, con le quali intrattenerci. Ma cosa c’è, poi, di così stupefacente? Che una macchina sia in grado di dare risposte che “sembrano” prodotte da una coscienza a me pare — sbaglierò — la naturale e prevedibile evoluzione della pascalina, la macchina calcolatrice antesignana del computer inventata da Blaise Pascal. Che ci sia qualcuno interessato a quello che dice una macchina, invece, mi lascia davvero stupefatto. Ma è un segno dei tempi. Il transumanista, entusiasta, proclama: abbiamo inventato la macchina che parla come l’uomo! Non si accorge che forse è il contrario. Forse è l’uomo che, nella decadenza inarrestabile del suo rapporto con il linguaggio, oggi parla come la macchina.
l’economia sociale fuori dal giardino di casa
Gianluca Salvatori
C’era la sharing economy. Un approccio all’innovazione tecnologica in cui incanalare il dinamismo di una spinta partecipativa dal basso, basata sul principio di condivisione. Poi la sharing economy ha preso un’altra direzione. È prevalsa una reinterpretazione basata su modelli di business estrattivi, in cui la potenza di pochi soggetti tecnologicamente e finanziariamente robusti si è imposta con nuove forme di monopolio. Archiviati gli entusiasmi iniziali, l’attenzione si è quindi spostata sui modi per contenere il potere delle piattaforme, nate sull’onda di una filosofia della condivisione e finite con il rinnegarla. Ma la lezione della sharing economy dovrebbe aver chiarito che l’allineamento tra mezzi e fini non è affatto scontato. L’equivoco del “tech for good” nasce dalla convinzione che la rete e le sue tecnologie siano strumenti che con poco sforzo possono essere orientati allo sviluppo delle persone e delle comunità. Mezzi dalle finalità intrinsecamente sociali, sin dal nome, nei quali la logica dello sfruttamento commerciale si è infiltrata dall’esterno. L’esperienza di questi due decenni ha mostrato invece che all’economia delle piattaforme digitali per non soccombere è d’obbligo il

gigantismo, l’aspirazione a creare monopoli. Una piattaforma ha la necessità di dominare il proprio mercato di riferimento; maggiore il numero di utenti che la utilizzano, più attraente essa risulta (e, quindi, meglio funziona). È la logica stessa del social network a premiare gli strumenti che, per capillarità e prestazioni, attirano e trattengono la maggioranza degli utilizzatori. Perciò servono risorse finanziarie robuste e modelli di crescita accelerata: terreno ideale per gli investimenti della finanza globale. Sta qui il motivo, spesso incompreso dal mondo non profit, per cui il volontarismo non è sufficiente ad orientare il mezzo digitale in funzione del fine sociale. In questi due decenni l’economia dei big data si è affermata come economia di concentrazione; perciò l’impresa di capitali globalizzata è la sua espressione di maggiore successo. Nell’industria digitale i modelli di business alternativi sono una autentica rarità: Wikipedia non ha fatto scuola, e anche iniziative più recenti inizialmente in forma non profit — come OpenAI, la società di ricerca del celebrato sistema di intelligenza artificiale ChatGpt — quando dal laboratorio si sono mosse verso il mercato si sono convertite a modelli profit. Dunque, il rapporto tra digitale e Terzo settore è inevitabilmente di subalternità? La risposta è: dipende. Se l’ambizione è quella di affermare un modello sociale di business digitale, alternativo a quelli dominanti, la risposta è che la forza degli attuali player è talmente radicata nelle caratteristiche strutturali della tecnologia da rendere improbabile una loro sostituzione o riconversione. Viceversa, se l’approccio è quello di favorire la transizione digitale dei modelli di impresa sociale, sia nuove che attualmente esistenti, al fine di incrementarne l’efficacia, l’accessibilità e la portata, lo spazio di intervento non solo è consistente ma richiede anche urgentemente di dedicarvi energie e risorse. Pensiamo al settore dell’assistenza e della cura, dove se è vero che le prestazioni non possono fare a meno della dimensione empatica di una relazione personale è altrettanto vero che ci sono ampi margini di miglioramento nell’organizzazione dei servizi grazie ad un uso intelligente di tecnologie digitali. Il punto è quindi saper individuare il discrimine tra le innovazioni tecnologiche, da un lato, che permettono di incrementare l’efficacia delle attività delle organizzazioni dell’economia sociale e l’aspirazione, dall’altro, a trasformare in senso sociale e solidale il modello di business dell’economa digitale. Lo sforzo nella prima direzione è necessario e indifferibile; richiede una rinnovata lettura dei bisogni nonché una conoscenza approfondita delle opportunità che i processi di innovazione tecnologica mettono a disposizione. Il programma di trasformare i modelli di business dell’economia digitale, invece, non può essere affrontato basandosi sul presupposto di una diversa intenzionalità, ma richiede piuttosto interventi regolatori e normativi. C’è bisogno di forme di regolamentazione che contrastino le pratiche di sfruttamento estrattivo. Terzo settore ed economia sociale hanno sì un ruolo da svolgere, ma non è tanto quello di opporre alle attuali forme di business dei modelli alternativi e socialmente orientati, quanto piuttosto quello di far sentire la propria voce animando un dibattito pubblico sulle condizioni che l’economia digitale deve rispettare nel proprio sviluppo.
il mister X del mese
Maurizio Crippa
Ancora qualche giorno prima delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, sugli account social di alcun* esponent* dell’area di sinistra e in molti siti fiancheggiatori girava con commenti sarcastici la famosa immagine, invero grottesca, di Attilio Fontana, fine febbraio 2020, che non sapeva infilarsi la mascherina. L’indicazione di voto era chiara: non vorrete affidarvi ancora a questo incompetente? Fino alla primavera scorsa, quando fu archiviata la cervellotica inchiesta per “autoriciclaggio” e da quella sui “camici”, veniva additato, dalle opposizioni e dalla stampa ostile, come un personaggio screditato o nei ritratti più eleganti come un dead man walking della politica. E la cosa più strana, e non c’era nemmeno bisogno di aspettare l’esito del voto del 2023, è che i primi a considerarlo un morto che camminava erano molti dei suoi compagni di partito. A partire dal Capitano e Segretario federale Matteo Salvini. Molto del pasticcio politico che ha portato alla candidatura assai risentita di Letizia Moratti col Terzo polo nasceva dalla promessa che Salvini (Berlusconi acquiescente) aveva fatto all’ex vicepresidente e assessore al Welfare nel momento in cui il governo lombardo aveva disperato bisogno di rimettere in sesto la macchina sanitaria e avviare una campagna vaccinale che la notoria agenzia Aria — che avrebbe dovuto, per miope scelta politica, gestire la campagna
Ha vinto contro un centrosinistra che in Lombardia non tocca palla da 30 anni. Ma nemmeno i suoi ci credevano: qualcuno aveva perfino parlato di un dead man walking. E invece ha stupito tutti
vaccinale — non era in grado nemmeno di accendere i computer. Gallera si era dimesso per eccesso di stress, Fontana se ne stette buono, per lunghi mesi, nascosto all’ombra della energica e centralizzatrice Moratti. Ma, appunto, la scadenza del 2023 era data per impossibile per Fontana, che avrebbe dovuto inoltre trainare una Lega in affanno. Finché, appunto, le roboanti inchieste si sgonfiarono un niente, comprese quelle ardentissime sulle Rsa, la campagna vaccinale andò molto bene e nella nuova situazione di rivalità tra la Lega e l’arrembante Fratelli d’Italia divenne decisivo, per Salvini, tenere il punto su Attilio Fontana. Come sia andata la partita, è noto. La sinistra, segnatamente il suo partito egemone, il Pd, ha dimostrato ancora una volta e ormai fanno quasi trent’anni di non essere credibile per l’elettorato lombardo. Al di
fuori delle città-capoluogo ricco, dove pesa il voto della borghesia delle professioni e dell’economia delle banche – i lombardi votano destra-centro. Inoltre, Majorino e i suoi hanno insistito proprio sulla campagna giustizialista, aggressiva ad personam, contro il governatore. Così è finita che l’avvocato di Varese, uscito indenne dalle bufere e sempre low profile nello scontro politico, persino interno al Carroccio, è stato invece riconfermato ottenendo un consenso personale e di lista davvero netto.
Qualcuno è rimasto stupito: i soliti “osservatori” del mondo lombardo che non lo hanno mai compreso, soprattutto nelle sue componenti bergamo-bresciane e nelle subregioni padane e montane a vocazione agricola; ma persino nel partito e tra gli alleati la performance e di Fontana è stata una sorpresa. Per molti, ma non per lui. Profilo cauto, una venatura di timidezza, una fedeltà agli ideali del Carroccio che ancora fa della Lega un partito diverso, novecentesco, una onesta personale che gli elettori gli hanno sempre riconosciuto. Persino nelle zone più martirizzate dal Covid, la gente non ha creduto che la responsabilità fosse “soltanto” sua. E i lombardi sono così, alla fine: tra l’aggressività accusatoria di Majorino e la continuità di un’amministrazione conosciuta, compresi gli evidenti limiti, hanno scelto Fontana.
Per lui però ora c’è la partita più difficile. Il nuovo governo lombardo sarà trainato da Fratelli d’Italia, e molto della linea d’indirizzo sarà decisa sulle poltrone della Sanità e delle Infrastrutture e Trasporti: i due buchi “quasi neri” della Lombardia. Giorni fa, Fontana ripeteva un po’ impaurito che la linea politica alla fine non l’avrebbe decisa solo lui. Oggi è invece il vero vincitore politico, nella coalizione di destra: con una performance personale che lo accredita a vero punto d’equilibrio. Dovrà decidersi a comandare davvero, senza troppi riguardi né per il suo capo sovranista Salvini né per Romano la Russa e i luogotenenti lombardi di Giorgia Meloni. Avrà la forza per dimostrare di saper camminare da solo, nei prossimi anni?
CAPITOLO 1
Francesco, il Papa del fare sociale
Condivisione e cura. Così è nato il metodo Bergoglio a cura di Lucio Brunelli
Qui Buenos Aires. Ritorno a casa di Francesco di Alver Metalli
1. Fraternità di Stefano Zamagni
2. Povertà di Chiara Saraceno
3. Economia —di Luigino Bruni
CAPITOLO 2
Le parole di Francesco
CAPITOLO 3
Il segno di Francesco
4. Donna di Ritanna Armeni
5. Scarto di Carlin Petrini
6. Pena di Rita Bernadini
7. Volontariato di Riccardo Bonacina
8. Diritti —dialogo con Anna Paola Concia
Noi che lo abbiamo in contrato. Le testimonianze dirette dei dirigenti del Terzo settore
Acli, Emiliano Manfredonia
Fondazione Sacra Famiglia, don Marco Bove da p. 62
Lega del Filo d’Oro, Rossano Bartoli
Exodus, don Antonio Mazzi
Avsi, Giampaolo Silvestri da p. 64
Misericordie, Domenico Giani
Fondazione Don Carlo Gnocchi, don Vincenzo Barbante
Aism, Francesco Vacca
Movimento per la Vita, Marina Casini da p. 66
Arché, padre Giuseppe Bettoni
Cbm, Massimo Maggio
Moas, Regina Catrambone da p. 68
Missioni don Bosco, don Daniel Antúnez
Aido, Flavia Petrin
Aibi, Marco Griffini
Banco Alimentare, Giovanni Bruno da p. 70
Anteas, Loris Cavalletti
Agesci, Roberta Vincini e Francesco Scoppola
Don Bosco 2000, Agostino Sella Fondazione Mc Donald, Maria Chiara Roti da p. 72
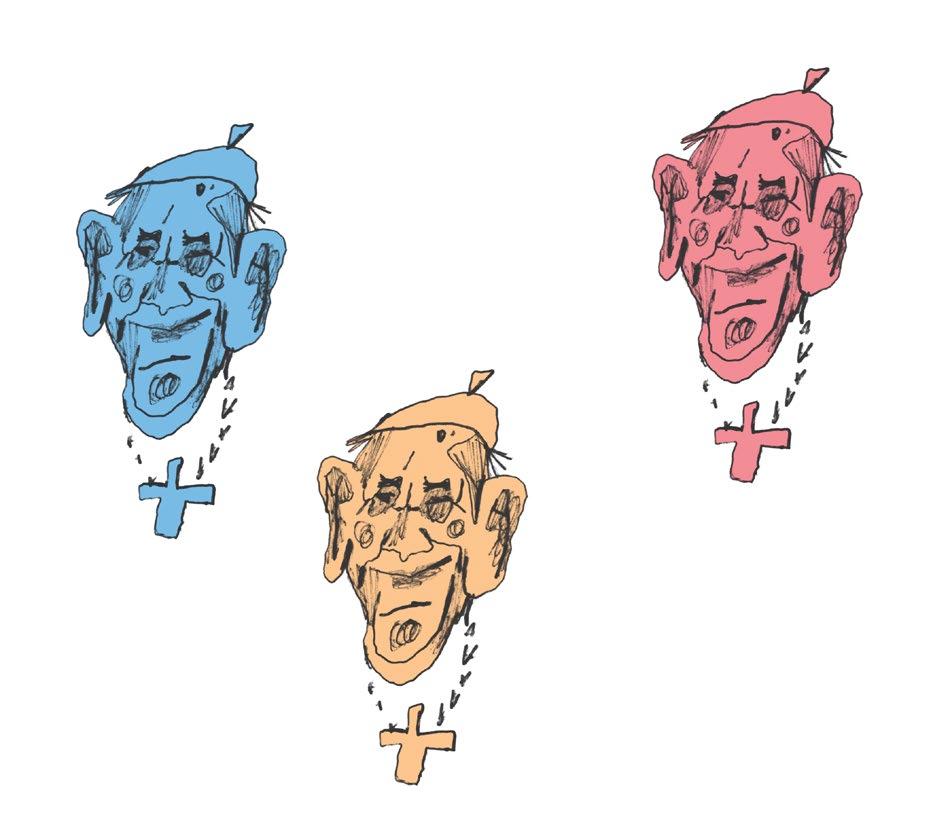
a cura di Lucio Brunelli
La decade di Bergoglio ripercorsa da un grande vaticanista che lo conosce fin dai tempi di Buenos Aires
di Lucio Brunelli
Dalla scelta del nome “Francesco” alla condanna della guerra. Antologia dei momenti più significativi di dieci anni che resteranno nella storia
Mancava una settimana o poco più all’inizio della primavera; quella sera del 13 marzo 2013 il cielo era piovigginoso ma l’aria già mite. Quando il fumo della vecchia stufa della Sistina finì di far tribolare noi giornalisti virando decisamente verso il bianco tutti corremmo verso le postazioni allestite in fondo a piazza san Pietro, pronti per le edizioni straordinarie del telegiornale. Di lì a poco le grandi vetrate della Loggia delle benedizioni si aprirono e il cardinale protodiacono, Jean-Louis Tauran, i segni del Parkinson scolpiti nel suo corpo, diede l’annuncio dell’habemus papam. Georgium Marium… bastò, a chi lo conosceva, udire il nome di battesimo in latino, per capire che il prescelto era proprio lui, Jorge Mario Bergoglio… Fu il tono di voce la prima cosa a colpire. La familiarità inattesa di quel «Buona sera» pronunciato come se fosse la cosa più normale del mondo, per il 266° successore dell’apostolo Pietro, salutare a quel modo la folla dei fedeli radunata all’interno del colonnato del Bernini e quella più vasta che, incuriosita, da casa stava guardando la tv. A colpire era il tono di voce, che non sapeva di sacrestia. E il suo sguardo, lieto, di un «peccatore guardato dal
FRANCESCO,
Roma, 18 aprile 2022.
Papa Francesco incontra i giovani che partecipano a un pellegrinaggio in piazza san Pietro in Vaticano

Signore». Perché lui poteva sentirsi un po’ furbo e nello stesso tempo un po’ ingenuo ma, come avrebbe raccontato a padre Antonio Spadaro nella sua prima intervista, la definizione più vera restava quella di un uomo cosciente delle sue fragilità, un peccatore («e non è un modo di dire, un genere letterario») che a un certo punto della sua vita aveva sperimentato su di sé lo sguardo amorevole di Cristo.
Conoscendolo bene ero sicuro che molte altre sarebbero state le sorprese del pontificato; il rifiuto della croce pettorale d’oro, la scelta di non abitare nel palazzo apostolico, le prime uscite informali dal Vaticano erano solo le prime avvisaglie. Sorprese tutte ruotanti attorno a un perno essenziale. Per grazia di Dio e per quello che umanamente è concesso in questo mondo, un testimone di Colui che, guardandolo, lo aveva “misericordiato” (uno dei suoi magnifici neologismi). Lo stesso sguardo misterioso che attraversa tutti i Vangeli: ribellione verso la doppiezza dei falsi moralisti, predilezione innata verso i più deboli e malfamati. «Ho conosciuto dei religiosi cattolici: e devo dire che mai lo spirito di Cristo mi è parso così vivido e dolce; un trapianto splendidamente riuscito», così Pier Paolo Pasolini scriveva di madre Teresa di Calcutta, incontrata nel suo lebbrosario in India nel 1961, quando la religiosa era ancora sconosciuta in Occidente. Francesco non è Teresa, la santità della suora albanese è imparagonabile, ma il Papa crede che quel “trapianto” di Cristo sia l’ideale: il miracolo (perché di miracolo si tratta) che ogni cristiano dovrebbe chiedere per la propria vita.
Vita settimanale 7 ottobre 2011, cover a cura della redazione


Vita mensile novembre 2013, cover di Francesco Poroli
Vita mensile aprile 2013, cover di Francesco Poroli
“Qui ci vuole un Francesco”: era stato il titolo premonitore di Vita nell’ottobre 2011. Allora era un auspicio, che una figura in sintonia con il genio di Assisi si affacciasse sulla scena del mondo per ristabilire le gerarchie delle priorità in senso umano. È stata una sorpresa veder quell’auspicio totalmente realizzato, non solo con un Papa come Bergoglio che obbediva in pieno a quel profilo, ma che decideva, primo Papa della storia, di prendere il nome di Francesco. Ecco la seconda copertina, ad aprile 2013, un mese dopo la nomina: “On the road” il titolo, con il dettaglio emblematico delle scarpe informali, da “strada”. Era un papa che parlava in modo diverso. Così nel novembre del 2013 abbiamo passato al setaccio il vocabolario rivoluzionario di Francesco. I disegni in tutt’e due i casi sono di Francesco Poroli. (Giuseppe Frangi)
Fin dalla sua elezione Bergoglio non parla solo di una Chiesa dalla parte dei poveri, ma del desiderio di una “Chiesa povera”
Non si può che partire da qui, da questo cuore e da questa intenzione, volendo raccontare la trama sociale di questo pontificato.
Toccare le piaghe della povertà
«Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri». Era un sabato mattina, tre giorni appena dopo l’elezione, il nuovo Vescovo di Roma mise da parte i fogli del discorso preparato e a braccio cominciò a raccontare ai giornalisti venuti a Roma per seguire il conclave, come era nata la scelta del nome, Francesco. «Non si dimentichi dei poveri», gli aveva sussurrato il suo amico e vicino di banco nella Sistina, il brasiliano Claudio Hummes, mentre lo scrutinio dei voti continuava ma la soglia dei voti necessari all’elezione era già stata raggiunta.
Non aveva parlato solo di una Chiesa dalla parte dei poveri. Ma di una “Chiesa povera”. In queste parole sentimmo risuonare l’eco dell’esperienza dei preti argentini delle villas miseria, le baraccopoli alla periferia di Buenos Aires: la condivisione della vita reale della gente e non i bei proclami della militanza rivoluzionaria come stile di una testimonianza cristiana fra gli emarginati. Condivisione che significava vivere con loro, in povertà, ed ascoltare i loro bisogni senza la pretesa di conoscerli a priori. Racconta padre Pepe che ad esempio lui, che veniva da una formazione più “impegnata” fu sorpreso nello scoprire che la prima richiesta che gli rivolgevano gli abitanti delle baraccopoli era quella di fare il prete, di fare le messe, i battesimi e le processioni con i santi e la Virgen più venerati nei loro Paesi di provenienza. Ciò non significava rinunciare alle battaglie sociali e politiche, che certo andavano fatte, per l’acqua potabile, per la corrente elettrica, in luoghi dove mancava tutto. Era piuttosto la scoperta di un metodo diverso, non ideologico, di stare nelle situazioni. Scelte di una radicalità evangelica, quelle di padre Pepe e dei suoi amici, come il giornalista italiano Alver Metalli che nel 2014 ha lasciato la sua bella casa in un quartiere residenziale di Buenos Aires per trasferirsi ne “La Carcova”, la bidonville dove sta tuttora vivendo la sua vocazione cristiana. Naturalmente sono scelte che non tutti possono compiere e sarebbe una pretesa sbagliata richiederlo. A tutti i cristiani Francesco indica però il metodo dello starci, del toccare con le proprie mani le piaghe della povertà. «Quando io andavo a confessare nella diocesi precedente, venivano alcuni e sempre facevo questa domanda: “Ma, lei dà l’elemosina?” – “Sì, padre!”. “Ah, bene, bene”. E gliene face -
vo due in più: “Mi dica, quando lei dà l’elemosina, guarda negli occhi quello o quella a cui dà l’elemosina?” – “Ah, non so, non me ne sono accorto”. Seconda domanda: “E quando lei dà l’elemosina, tocca la mano di quello al quale dà l’elemosina, o gli getta la moneta?”. Questo è il problema: la carne di Cristo, toccare la carne di Cristo, prendere su di noi questo dolore per i poveri. La povertà, per noi cristiani, non è una categoria sociologica o filosofica o culturale: no, è una categoria teologale» (incontro con i movimenti e le associazioni laicali, 18 maggio 2013).
Parlando a braccio ai volontari della Caritas durante la visita alla Cittadella della carità, a Roma, il 29 novembre 2018, Francesco tornava su questo approccio fisico, aggiungendo una notazione nuova e interessante: «È misterioso: quando tu tocchi quella piaga, ti accorgi della tua. E questa è la grazia che ci danno i poveri, la grazia che ci dà la vulnerabilità dei poveri: sapere che anche noi siamo vulnerabili. Questo è bellissimo, perché significa che anche noi abbiamo bisogno di salvezza, qualcuno che ci dica una parola buona: i volontari, anche i preti… Tutti abbiamo bisogno di un fratello Gesù. Abbiamo bisogno di salvezza, abbiamo bisogno di cura».
Vite di scarto
Scarto, scartati: le prime parole nuove che imparammo a conoscere nel vocabolario di Francesco. Per la prima volta ne trattò in un’udienza generale del mercoledì, il 5 giugno 2013: «Che alcune persone senza tetto muoiano di freddo per la strada non fa notizia. Al contrario, un abbassamento di dieci punti nelle borse di alcune città, costituisce una tragedia. Uno che muore non è una notizia, ma se si abbassano di dieci punti le borse è una tragedia! Così le persone vengono scartate, come se fossero rifiuti. Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora — come il nascituro —, o non serve più — come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione».
Non c’è solo sentimento, nell’agire del Papa. C’è giudizio. Un giudizio lucido sui meccanismi economici e sociali, dove a co -
La condivisione è un punto centrale del suo pensiero e della sua azione: toccando una piaga ci si accorge della propria
Non c’è solo desiderio nelle parole del Papa.
C’è giudizio. Un giudizio lucido su meccanismi economici e sociali
mandare è “il dio Denaro”. Bergoglio riprende il tema dello scarto dalla riflessione del sociologo polacco Zygmunt Bauman. Questi nel 2005 pubblicò Vite di scarto, libro in cui spiegava come accanto a quelli urbani, la società consumistica produce “rifiuti umani”, entrambi assimilati da una presunta inutilità; alla fine anche l’uomo diventa un rifiuto, l’uomo non perfetto diventa scarto della società.
Fu emozionante assistere all’incontro fra il primo papa latino-americano della storia e il più geniale osservatore della modernità “liquida”, il gesuita Bergoglio e l’ebreo Bauman, ad Assisi il 20 settembre 2016. L’occasione fu un raduno interreligioso per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Al termine del loro colloquio Bauman disse a Francesco: «Ho lavorato una vita per rendere l’umanità un posto più ospitale. Sono arrivato a 91 anni e ne ho viste di false partenze, fino a diventare pessimista. Grazie, perché lei è per me la luce alla fine del tunnel». La luce per i fedeli della Chiesa cattolica è Cristo, non il Papa. Ma la gioia dell’anziano sociologo era sincera.
Il direttore del pronto soccorso
Se stiamo all’immagine cara a Francesco della Chiesa come “ospedale da campo”, direttore del suo pronto soccorso è sicuramente il cardinale Konrad Krajewski. Il 3 agosto 2013, pochi mesi dopo l’elezione, Francesco lo nominò a capo dell’Elemosineria apostolica. Antichissima e gloriosa istituzione, le sue origini risalgono ai primi secoli cristiani quando a Roma i papi si facevano aiutare da alcuni diaconi nell’esercizio concreto della carità. Uno dei primi fu san Lorenzo, giustiziato per ordine dell’imperatore Valeriano nell’agosto dell’anno 258. Sembra che i suoi persecutori, dopo averlo imprigionato, gli avessero promesso la libertà a condizione che egli consegnasse all’imperatore le presunte ricchezze della comunità cristiana; Lorenzo tornò dai magistrati dopo tre giorni guidando un corteo di centinaia di poveracci da lui assistiti per conto di papa Sisto II: «Ecco questi sono i nostri tesori — esclamò -— i tesori della Chiesa». Origini eroiche, quindi, ma nei tempi moderni l’Elemosineria si era ridotta a svolgere un’attività decisamente più tranquilla: la vendita di pergamene e benedizioni papali (rilasciate in occasione di ricorrenze particolari) il cui ricavato alimentava un fondo destinato alla carità del Papa. Questa attività non è stata accantonata ma con l’avvento di Francesco non si può dire che l’opera dell’Ele -
Nel sociale è senz’altro lui l’agente speciale di Sua Santità 1.
mosiniere sia proceduta con la stessa tranquillità di prima. «Non ti voglio dietro quella scrivania» furono le prime parole del papa a Krajewski. Il monsignore polacco fino ad allora si era occupato delle cerimonie solenni nella basilica vaticana (compare nei filmati delle prime apparizioni degli ultimi due papi dal balcone di san Pietro), ma prese alla lettera e con notevole entusiasmo l’ordine del Papa: cominciò a girare come una trottola per le strade di Roma visitando istituti per anziani, case-famiglia per ex prostitute, centri di accoglienza per immigrati, ripari per senzatetto… Poi relazionava a Bergoglio e insieme decidevano quali forme d’aiuto fossero le più efficaci.
Fece allestire bagni e docce per i senzatetto in Piazza San Pietro, accompagnò alcuni gruppi di “barboni” al mare durante l’estate, portò aiuti alle persone danneggiate dal terremoto del 2016 ad Amatrice e Ascoli Piceno, organizzò la distribuzione di sacchi a pelo ai senza fissa dimora nei giorni di maggior freddo, provvide all’accoglienza di famiglie di rifugiati siriani lasciando loro per qualche giorno il suo stesso appartamento, poi aprì una lavanderia gratuita e pagò l’affitto per una spiaggia accessibile anche ai disabili… Alcune delle missioni più spericolate compiute da questo agente speciale di Sua Santità nel sociale sono finite sulle prime pagine dei giornali. Il 12 maggio 2019 si calò in un tombino dell’Acea per riattaccare l’elettricità in uno stabile occupato a Roma, a due passi dalla basilica di Santa Croce in Gerusalemme. L’edificio dava ospitalità a circa 400 indigenti, tra cui molti bambini. La luce era stata staccata non perché gli occupanti rifiutassero di pagare la bolletta ma perché non disponevano - ovviamente - di un contratto legale con l’ente erogatore. Il cardinale si armò di pinze e cacciavite e riattaccò il quadro elettrico, premurandosi di lasciare sul posto il suo biglietto da visita. Missione spericolata sul piano politico, questa. Spericolata sul piano della incolumità fisica fu invece quella compiuta il 17 settembre 2022 in Ucraina per conto del Papa. Mentre a Zaporizhzhya stava distribuendo aiuti alla popolazione, scortato da militari ucraini, Krajewski finì sotto il tiro delle truppe russe. L’Elemosiniere pontificio rischiò la vita ma ne trasse un insegnamento. «Ho imparato — raccontò sorridendoci su — che in certe situazioni non basta correre, bisogna sapere dove correre». Mai in tanti secoli un cardinale aveva presieduto l’Elemosineria, segno dell’importanza che Francesco attribuisce a quest’opera. Dopo la riforma della Curia romana, varata lo scorso anno, essa è
Il cardinale polacco Konrad Krajewski?




1 Roma, 7 marzo 2013. L’ancora cardinale Jorge Mario Bergoglio esce a piedi dalla Città del Vaticano
2 Roma, 13 marzo 2013. Elezione del nuovo Papa: il cardinale Bergoglio è Francesco.
3 Roma, 17 aprile 2014. Papa Fancesco durante la cerimonia della lavanda dei piedi al centro don Gnocchi.
4 Roma, 7 giugno 2014. Il papa incontra i componenti del Centro sportivo italiano
stata elevata di grado, prende il nome di Dicastero per il servizio della carità ed estende la sua opera in tutto il pianeta. Fra le innumerevoli iniziative promuove la Giornata mondiale dei poveri, istituita da Francesco nel 2016, a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia. La giornata viene celebrata ogni anno nel mese di novembre, porta a Roma migliaia di senza fissa dimora e volontari che li assistono, alimenta un certo numero di iniziative sociali (ad esempio visite mediche gratuite per non abbienti), si conclude solitamente con un grande pranzo con i poveri nei locali dell’Aula Paolo VI in Vaticano. Francesco ha confidato che l’idea della Giornata mondiale dei poveri gli venne suggerita da un giovane volontario francese: «Un’idea nata in modo un po’ strano, in una sagrestia. Io stavo per celebrare la Messa e uno di voi - si chiama Étienne - lo conoscete? È un enfant terrible – Étienne mi ha dato il suggerimento: “Facciamo la Giornata dei poveri”. Io sono uscito e sentivo che lo Spirito Santo, dentro, mi diceva di farla». (Assisi, 12 novembre 2021).
Il ragazzo terribile si chiama Étienne Villemain, già giornalista del settimanale Famille chretienne, nel 2005 iniziò ad ospitare in casa alcuni senza tetto, poi l’esperienza coinvolse altri amici e divenne una rete di solidarietà che ora si chiama Lazare, dal nome del mendicante del Vangelo che si nutriva delle briciole cadute dai banchetti del ricco epulone. L’idea è quella di prendersi cura di queste persone dalla vita sfortunata non relegandole in qualche struttura ma offrendo loro un ambiente familiare adatto a favorire il reinserimento nella società. Sono circa trecento oggi le persone ospitate nella rete di piccole comunità di accoglienza creata da Étienne. In occasione del Giubileo della Misericordia, gli amici del “ragazzo terribile” vennero a Roma per partecipare a un incontro col Papa, era l’11 novembre 2016, e fu allora che Étienne suggerì a Francesco l’idea di una Giornata mondiale dei poveri per sensibilizzare le chiese locali e di riflesso l’opinione pubblica. Le iniziative sociali connesse alla Giornata sono accompagnate ogni anno da un messaggio del Papa. Nel messaggio del 2021 viene posta sotto accusa la mentalità, sempre più diffusa in ambito politico, che vede nei poveri i responsabili della loro condizione. «Se i poveri sono messi ai margini — scrive Francesco — come se fossero i colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare…». Se da un lato Francesco sferza il

mondo politico, dall’altro non si accontenta di un approccio solo emotivo: «Si parla dei poveri in astratto, ci si ferma alle statistiche e si pensa di commuovere con qualche documentario. La povertà, al contrario, dovrebbe provocare ad una progettualità creativa».
Tra gli “scartati” che il Papa si è più esposto a difendere ci sono gli immigrati. Tutti ricorderanno il suo primo viaggio apostolico, compiuto nell’isola di Lampedusa l’8 luglio 2013. Francesco confidò che l’ispirazione gli era venuta leggendo sui giornali un trafiletto di cronaca: un centinaio di immigrati il 14 giugno aveva fatto naufragio nel canale di Sicilia e molti di loro s’erano salvati aggrappandosi alle reti dei pescatori: gli “uomini-tonno” (li chiamarono così) restarono molte ore in mare in attesa di soccorsi; alcuni però, almeno sette, non ce l’avevano fatta ed erano morti annegati. La notizia aveva ricevuto scarsa eco in tv e sui grandi giornali. «Sono venuto a piangere i morti che nessuno piange» disse Bergoglio, celebrando la messa a due passi dal cimitero dei barconi, un magazzino all’aperto dove sono accatastate una sopra l’altra le imbarcazioni che hanno fatto naufragio nei pressi dell’isola: «Chi di noi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del
Roma, 16 novembre 2016. Udienza generale in piazza San Pietro, i molti pellegrini presenti festeggiano e salutano papa Francesco
Sull’immigrazione
Bergoglio non è mai stato un “buonista”: «Se non si ha la possibilità di integrare, allora è meglio non accogliere»
piangere, del “patire con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere». Tre mesi dopo, il 3 ottobre, a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, un peschereccio stracarico di immigrati si inabissò tra i flutti, 368 le vittime accertate. «La prima parola che mi viene da dire è vergogna», commentò a caldo il Papa. Gli appelli all’accoglienza attirarono su Bergoglio una valanga di critiche. Venne dipinto come un pericoloso “buonista”, responsabile della “invasione” degli immigrati. Le contestazioni più rumorose, in ambito politico, vennero dalla Lega. Nel 2016 ad un raduno convocato da Salvini comparvero le magliette con la scritta: “Benedetto è il mio Papa”. A Joseph Ratzinger, con una notevole dose di ignoranza, si attribuivano posizioni di maggiore chiusura sull’immigrazione. Sui social impazzavano slogan e insulti contro il Papa amico di Soros e complice della “conquista islamica” dell’Europa. In realtà Francesco non ha mai proposto un’immigrazione senza limiti. Innumerevoli volte ha indicato con quattro verbi i pilastri di una giusta politica verso gli stranieri che cercano un futuro migliore in Europa: «Accogliere, proteggere, promuovere, integrare». Verso chi sta annegando in mare — ripete il Papa — non ci si può voltare dall’altra parte. Gli immigrati vanno salvati e accompagnati a un porto sicuro, non possono essere riconsegnati alle autorità libiche, sapendo a quali condizioni inumane andrebbero incontro. Su questo punto il Papa non transige: è in questione la soglia minima della dignità umana. Ma Francesco non ha mai preteso che l’Italia si sobbarcasse da sola il peso dell’accoglienza. Ha sempre chiesto con forza all’Unione Europea di non lasciare soli i Paesi del confine meridionale, Italia, Grecia, Spagna e Malta. Ha affermato che solo una valutazione di “prudenza” di ogni singolo Stato può decidere il tetto della sopportabilità sociale degli arrivi più massicci.
«Un popolo che può accogliere ma non ha possibilità di integrare, meglio non accolga» disse il 26 agosto 2018 ai giornalisti, in aereo, di ritorno da Dublino. Altrimenti non si fa accoglienza, si creano solo ghetti e frustrazione sociale in chi arriva e nei cittadini del Paese ospitante. Ma certo non si può chiedere a un Papa di tacere quando degli immigrati si parla con disprezzo come se fossero tutti delinquenti o potenziali terroristi oppure quando la loro vita in pericolo sembra valere meno di un carico di merci o di bestiame. «Bisogna ripartire dal significato della persona. Un immigrato è un essere umano, differente per provenienza, cul-
tura e tradizioni, ma è una persona da rispettare e con diritti e doveri, in particolare nell’ambito del lavoro dove è più facile la tentazione dello sfruttamento». Parole inequivocabili, queste. Non di Francesco ma di Benedetto XVI (Angelus del 10 gennaio 2010).
Nella società dell’immagine e dell’apparire, della produzione e del consumo, le persone con disabilità rischiano di essere percepite come uno sgradevole ingombro, da tenere il più possibile lontano dagli occhi. Le riflessioni e i gesti di Francesco nei loro confronti sono da annoverare tra i momenti più intensi di questi dieci anni di pontificato. Come giornalista ho seguito il Vaticano per quasi 40 anni; tutti gli ultimi Papi — lo posso testimoniare — hanno prestato un’attenzione particolare alle persone più fragili. Ma il tempo dedicato da Francesco ai disabili in ogni incontro pubblico o privato è una realtà senza precedenti. La novità più visibile riguarda le udienze generali con i fedeli, tenute ogni mercoledì, d’inverno nell’Aula Paolo VI e nella bella stagione all’aperto in piazza san Pietro. Una volta il saluto personale del Papa era riservato a una ristretta cerchia di persone ammesse al cosiddetto “baciamano”. Francesco invece si congeda dalla folla solo dopo aver salutato, uno ad uno, tutti i malati e i disabili presenti all’udienza. Per ogni persona c’è almeno una parola, una carezza, uno sguardo. Un’esperienza breve, ma che resta nella loro vita.
Impossibile citare tutti gli incontri con i disabili che hanno accompagnato ogni visita del Papa, nelle parrocchie romane, in diverse città italiane o all’estero. Uno dei più toccanti ebbe luogo ad Assisi, nel giorno di san Francesco, il 4 ottobre 2013, all’Istituto Serafico che ospita bambini malati e gravemente disabili. «Noi siamo tra le piaghe di Gesù» aveva detto la presidente dell’Istituto nel saluto introduttivo. Il Papa dopo aver salutato uno ad uno i bambini, col cuore gonfio di emozione, mise da parte il discorso preparato e a braccio commentò le parole della presidente. Lo ripropongo quasi integrale, è una citazione lunga, ma sono forse le parole più profonde e personali che su questo tema ha pronunciato Bergoglio: «Noi siamo fra le piaghe di Gesù, ha detto lei, signora. Ha anche detto che queste piaghe hanno bisogno di essere ascoltate, di essere riconosciute. E mi viene in mente quando il Signore Gesù andava in cammino con quei due discepoli tristi. Il
I gesti e le riflessioni nei confronti delle persone con disabilità sono fra i momenti più intensi di questi dieci anni di pontificato
Roma, 3 agosto 2022. In Aula Paolo VI
Papa Francesco cammina con l’aiuto di un bastone, durante l’Udienza generale del mercoledi nell’Aula Paolo VI in Vaticano

In questi anni Francesco ha elaborato un vero e proprio magistero sulla vecchiaia. Non si è limitato ai gesti
Signore Gesù, alla fine, ha fatto vedere le sue piaghe e loro hanno riconosciuto Lui. Poi il pane, dove Lui era lì. Fratello Domenico mi diceva che qui si fa l’Adorazione. Anche quel pane ha bisogno di essere ascoltato, perché Gesù è presente e nascosto dietro la semplicità e la mitezza di un pane. E qui è Gesù nascosto in questi ragazzi, in questi bambini, in queste persone. Sull’altare adoriamo la Carne di Gesù; in loro troviamo le piaghe di Gesù. Gesù nascosto nell’Eucaristia e Gesù nascosto in queste piaghe. Hanno bisogno di essere ascoltate! Forse non tanto sui giornali, come notizie; quello è un ascolto che dura uno, due, tre giorni, poi viene un altro, un altro… Devono essere ascoltate da quelli che si dicono cristiani. Il cristiano adora Gesù, il cristiano cerca Gesù, il cristiano sa riconoscere le piaghe di Gesù. E oggi, tutti noi, qui, abbiamo la necessità di dire: “Queste piaghe devono essere ascoltate!”… È interessante: Gesù, quando è Risorto era bellissimo. Non aveva nel suo corpo dei lividi, le ferite… niente! Era più bello! Soltanto ha voluto conservare le piaghe e se le è portate in Cielo. Le piaghe di Gesù sono qui e sono in Cielo davanti al Padre. Noi curiamo le piaghe di Gesù qui e Lui, dal Cielo, ci mostra le sue piaghe e dice a tutti noi, a tutti noi: “Ti sto aspettando!” Così sia».
1. FRANCESCO, IL
«Un vecchio e un bambino si preser per mano…»
Una eguale attenzione Francesco — 86 anni compiuti lo scorso dicembre — ha mostrato per le persone anziane. Non si è limitato ai gesti, in questi due lustri ha elaborato un vero magistero sulla vecchiaia. A questo tema ha dedicato un intero ciclo di catechesi (dal 23 febbraio al 25 maggio 2022). Severo è il suo giudizio sul trattamento “segregazionista” che la società riserva agli anziani: «A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di malattia con la quale è meglio evitare ogni tipo di contatto: i vecchi non ci riguardano — pensano — ed è opportuno che stiano il più lontano possibile, magari insieme tra loro, in strutture che se ne prendano cura e ci preservino dal farci carico dei loro affanni» (Messaggio per la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, 20 luglio 2022). Vanno recuperati, secondo Francesco, il senso e la bellezza dell’essere anziani, le opportunità positive che offre questa stagione della vita: «La vecchiaia, certamente, impone ritmi più lenti: ma non sono solo tempi di inerzia. La misura di questi ritmi apre, infatti, per tutti, spazi di senso della vita sconosciuti all’ossessione della velocità» (Messaggio cit. 20 luglio 2022). Fra i compiti più entusiasmanti che papa Francesco assegna all’anziano c’è il rapporto con le nuove generazioni; come erede, custode e veicolo di memoria. L’esperienza vissuta da milioni di genitori e nonni delle due guerre mondiali del ‘900 è stata per lunghi decenni un argine obiettivo al ripetersi di “inutili stragi”, come quella che ora sta insanguinando l’Ucraina. «Non è casuale - nota il Papa argentino - che la guerra sia tornata in Europa nel momento in cui la generazione che l’ha vissuta nel secolo scorso sta scomparendo» (Messaggio cit., 20 luglio 2022).
“Un vecchio e un bambino si preser per mano”: inizia così una delle più belle canzoni di Francesco Guccini, la storia di un anziano che trasmette al bambino la memoria di una natura non ancora violentata dall’uomo. Si tratta di costruire, dice il Papa, un’alleanza fra le generazioni. E aggiunge che i vecchi hanno una possibilità in più di essere persuasivi: «La testimonianza degli anziani è credibile per i bambini: i giovani e gli adulti non sono in grado di renderla così autentica, così tenera, così struggente, come possono fare gli anziani, i nonni. Quando l’anziano benedice la vita che gli viene incontro, deponendo ogni risentimento per la vita che se ne va, è irresistibile. Non è amareggiato perché passa il tempo e lui sta per andarsene: no. È con quella gioia del buon vino, del vino che si è fatto buono con gli anni. La testimonianza degli anziani
Vanno recuperati il senso e la bellezza di essere anziani, le opportunità positive che offre questa stagione della vita
Francesco ha visitato finora ben tredici penitenziari.
Nessun altro Papa
è stato in carcere quanto lui
unisce le età della vita e le stesse dimensioni del tempo: passato, presente e futuro, perché loro non sono solo la memoria, sono il presente e anche la promessa» (Udienza generale, 17 agosto 2022). Anche per condividere queste riflessioni Francesco ha istituito la Festa del nonno stabilendo che fosse celebrata ogni anno la quarta domenica di luglio, festa dei santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù.
Nelle carceri. «Perché lui sì ed io no…?»
I Papi hanno familiarità con le carceri. Il primo Papa, Pietro, fu detenuto a Roma nel carcere Mamertino. Ponziano, due secoli dopo, fu condannato ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna e si dimise prima della deportazione. In tempi più recenti, anno 1798, Pio VI fu fatto prigioniero da Napoleone e morì durante la reclusione in Francia. Si può dire che quasi tutti i suoi successori — da allora fino ai nostri giorni — misero piede in una galera ma, buon per loro, da uomini liberi; per fedeltà al comandamento di Gesù: «Ero in carcere e mi avete visitato». Francesco è il papa che in assoluto ha varcato più volte la soglia di un carcere. Ha visitato ben tredici penitenziari. Cinque volte il Papa ha celebrato in un carcere la messa del Giovedì Santo, chiamata messa in coena Domini, lavando con le sue mani i piedi di dodici detenuti: memoria del gesto compiuto da Gesù ai dodici apostoli nell’ultima cena a Gerusalemme, prima di essere arrestato per ordine dal gran Sinedrio. Le cinque carceri sono: Casal del Marmo (2013), Rebibbia (2015), Paliano (2017), Regina Coeli (2018), Velletri (2019). Specialmente all’inizio la scelta del Papa provocò scalpore; fino ad allora la messa del Giovedì Santo era stata sempre celebrata in modo solenne nella basilica di san Giovanni in Laterano o a san Pietro. Contestazioni da ambienti tradizionalisti furono mosse alla scelta di includere fra i dodici detenuti anche delle donne o dei reclusi di religione musulmana. Papa Francesco non apparve mai turbato da queste critiche. Nel carcere di Rebibbia, fra i dodici prigionieri selezionati, risultò esserci un transessuale portoghese. Il Papa venne informato in anticipo, chiese discrezione ma non volle che Isabel — questo il suo nome — fosse depennata dalla lista dei dodici solo a motivo del suo genere sessuale: «Non è forse anche lei - disseun figlio di Dio?». Il giorno dopo TV2000, appresa la notizia, intervistò Isabel in carcere: con gli occhi lucidi il trans raccontò la sua emozione, non poteva smettere di pensare allo sguardo del
Successore di Pietro mentre le lavava i piedi. Nessuno, nemmeno i telespettatori più tradizionalisti, ebbero il coraggio di inviare messaggi di protesta.
Difficile misurare l’impatto che i gesti di papa Francesco hanno avuto su tutti i detenuti incontrati, se essi abbiano indotto cambiamenti di vita o cammini di conversione. Sappiamo di dialoghi continuati a distanza, con scambi di lettere. Padre Giuseppe Giunti, già cappellano nel carcere di Alessandria ha reso questa testimonianza: «Siamo alla vigilia dell’Immacolata, il pomeriggio del 6 dicembre 2017 e qualcuno mi chiama per dirmi che c’è un nuovo arrivo, da un altro carcere. Vado a salutare, a stringere un’altra mano non più assassina. Salve, come va? Sono fra’ Beppe. “Un frate?” Sì. E allora sbottona la camicia e mi mostra con gioia un rosario, dicendo sottovoce “me lo ha regalato Papa Francesco”. Il mio sguardo è perplesso e interrogativo, come avrà mai fatto a girare in qualche udienza, chissà! E invece, invece. “Il Papa è venuto e ci ha lavato i piedi, era Giovedì Santo, ce li ha baciati e ha alzato lo sguardo. Dentro di me si è risvegliato qualcosa, ho sentito la nostalgia di una preghiera, di una amicizia col Signore. Non ero più quello di qualche ora prima” » (Padre nostro che sei in galera, Edizioni Messaggero Padova). Il legame di Bergoglio con le carceri è viscerale e comincia a Buenos Aires molti anni prima dell’elezione pontificia. Nell’ottobre 2013, ricevendo i cappellani delle carceri italiane, Francesco raccontò delle sue telefonate con alcuni carcerati della capitale argentina: «Ogni volta che chiamo i carcerati di Buenos Aires, ogni tanto la domenica per una chiacchiera, mi domando: perché lui e non io? Io che meriti ho più di lui per non stare lì?». Il 30 aprile 2015 incontrando i membri delle Comunità di vita cristiana, tornava sull’argomento: «Andare in carcere significa prima di tutto dire a se stesso: “Se io non sono qui, come questa, come questo, è per pura grazia di Dio”. Pura grazia di Dio. Se noi non siamo scivolati in questi sbagli, anche in questi reati o crimini, alcuni forti, è perché il Signore ci ha presi per mano. Non si può entrare in carcere con lo spirito di “ma io vengo qui a parlarti di Dio, perché abbi pazienza, perché tu sei di una classe inferiore, sei un peccatore”: no, no! Io sono più peccatore di te, e questo è il primo passo. Ma, nel carcere uno può dirlo con tanto coraggio, ma dobbiamo dirlo sempre: quando noi andiamo a predicare Gesù Cristo a gente che non lo conosce o che porta una vita che non sembra molto morale, fa bene pensare che io
Il legame di papa Bergoglio con le carceri è viscerale e comincia a Buenos Aires, molti anni prima dell’elezione pontificia
Papa Francesco
è contrario
sono più peccatore di lui, se io non sono caduto in quella situazione è per la grazia di Dio».
Insieme ai gesti ci sono le parole, importanti, pronunciate dal Papa sulla condizione carceraria, sulla pena di morte e sull’ergastolo. Il punto su cui batte di più è che la pena inflitta a chi commette reati dovrebbe avere un effetto “medicinale”, mirato cioè al recupero della persona e quindi al suo reinserimento nella società.
Raramente però a chi finisce in carcere viene offerta l’opportunità concreta di un percorso di riabilitazione: «A volte potrebbe sembrare che le carceri si propongano di mettere le persone in condizione di continuare a commettere delitti, più che a promuovere processi di reinserimento che permettano di far fronte ai problemi sociali, psicologici e familiari che hanno portato una persona ad un determinato atteggiamento» (17 febbraio 2016, visita al carcere di Ciudad Juarez, Messico).
Francesco ha voluto modificare il Catechismo della Chiesa cattolica per rendere più netta e inequivocabile la condanna della pena morte. Nell’enciclica Fratelli tutti, promulgata nel 2020, rispondendo implicitamente a chi lo accusava di aver alterato la dottrina cattolica chiamò in soccorso gli insegnamenti di sant’Agostino; il grande convertito di Ippona di fronte ad alcuni omicidi di sacerdoti cristiani aveva chiesto al giudice di non togliere la vita agli assassini: «Sdegnati contro l’iniquità in modo però da non dimenticare l’umanità; non sfogare la voluttà della vendetta contro le atrocità dei peccatori, ma rivolgi la volontà a curarne le ferite».
Nella stessa enciclica il Papa solennizzava anche il no all’ergastolo già espresso nel 2014, nell’udienza all’Associazione internazionale di diritto penale. «Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare non solo per l’abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà. E questo, io lo collego con l’ergastolo. […] L’ergastolo è una pena di morte nascosta». Presa di posizione accolta in Italia da generale freddezza o da silenzi imbarazzanti. Ma ribadita, l’anno seguente, in un’intervista natalizia a Canale 5: «Qualsiasi condanna per un delitto commesso deve avere una speranza, una finestra. Un carcere senza finestra non va, è un muro».
Laudato si’: enciclica sociale, non verde Fa parte della passione cristiana per il destino dell’uomo e dell’intera umanità l’interessamento degli ultimi Papi per una “ecologia integrale”. Benedetto XVI aveva già incluso questo tema all’interno del Magistero pontificio: memorabile il suo discorso nel parlamento tedesco (22 settembre 2011) in cui sorprese molti suoi ammiratori riconoscendo i meriti storici del movimento dei Verdi nel suo Paese. Francesco si inserisce in questo solco dedicando un’intera enciclica, la Laudato si’ (2015), alla “cura della casa comune”. I media la presentarono come un’“enciclica verde”, ma questa definizione non è mai piaciuta all’autore. «No, non è un’enciclica verde, è un’enciclica sociale», chiarì, dialogando con una settantina di sindaci durante l’incontro sul tema Modern Slavery and Climate Change: the Commitment of the Cities, organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze sociali. La dimensione sociale è nel fatto che sono i poveri a subire le più gravi conseguenze delle ferite inferte alla terra. I cambiamenti climatici, ad esempio, con l’estensione di zone non più coltivabili, provocano movimenti forzati delle popolazioni, specialmente in Africa, e alla lunga finiscono per pesare anche sul fenomeno dell’immigrazione clandestina diretta in Europa. Ambientalismo fortemente sociale quello che caratterizza l’azione di papa Bergoglio. Un altro tratto distintivo è l’accento posto non solo sulla necessità di una mobilitazione politica collettiva e globale, ma sul cambiamento dei comportamenti

La dimensione sociale sta nel fatto che sono i poveri a subire le più gravi conseguenze delle ferite inferte alla terra
Milano, 29 settembre 2021. Il video messaggio di papa Francesco in occasione del Summit Youth4Climate, Driving Ambition Italy
Roma, 13 novembre 2022. In occasione della VI Giornata Mondiale dei Poveri, papa Francesco partecipa al pranzo per i poveri organizzato in aula Paolo VI
individuali. Nella sua enciclica Francesco non esitava a fare esempi molto concreti: «Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l’impatto ambientale e i modelli di produzione. È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori. Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico. Per questo oggi il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi» (paragrafo 206). Curiosamente la Laudato si’, almeno a breve termine, ha entusiasmato più gli ambienti laici che quelli ecclesiastici. Numerose associazioni ambientaliste in tutto il mondo ne hanno fatto una propria bandiera, mettendo da parte, come superate, le antiche polemiche ideologiche che imputavano al presunto “antropocentrismo” della dottrina cattolica l’origine di un dominio arbitrario della natura da parte dell’uomo. In Italia il sostegno più cordiale e argomentato alle tesi del Papa è venuto da Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food e di Terra Madre. Insieme al vescovo Domenico Pompili, “Carlin” ha fondato una rete di piccole comunità — composte da credenti

e non credenti — che si prefiggono di diffondere i contenuti dell’enciclica e di adottare nella vita quotidiana gli stili di vita raccomandati dal testo pontificio. Le “Comunità Laudato si’”, sono state ricevute in Vaticano dal Papa il 12 settembre 2020. Francesco in quell’occasione ha proposto una riflessione imperniata su due parole chiave: contemplazione e compassione. «Oggi, la natura che ci circonda non viene più ammirata, contemplata, ma “divorata” — ha detto il Papa — Siamo diventati voraci, dipendenti dal profitto e dai risultati subito e a tutti i costi. Lo sguardo sulla realtà è sempre più rapido, distratto, superficiale, mentre in poco tempo si bruciano le notizie e le foreste. Malati di consumo. Questa è la nostra malattia! Malati di consumo. Ci si affanna per l’ultima “app”, ma non si sanno più i nomi dei vicini di casa, tanto meno si sa più distinguere un albero da un altro. E, ciò che è più grave, con questo stile di vita si perdono le radici, si smarrisce la gratitudine per quello che c’è e per chi ce l’ha dato». Oltre la pubblicazione della enciclica sulla cura della casa comune, fra i grandi gesti “ecologici” di Papa Francesco va ricordato il Sinodo sull’Amazzonia, convocato a Roma nell’ottobre del 2019. Si è discusso in primo luogo di questioni pastorali, come la scarsità del clero in un territorio sconfinato. Ma la tutela della terra e della cultura dei popoli indigeni nel grande polmone del pianeta sono stati fra gli impegni prioritari assunti dalla Chiesa. Alcune rumorose frange della destra cattolica hanno cercato di disturbare i lavori del Sinodo, accusando pretestuosamente il Papa di dare spazio alla religiosità “pagana” degli indios. Un militante tradizionalista riuscì a trafugare una statuetta devozionale portata dall’Amazzonia e la gettò nel Tevere: solo l’ignoranza e la mancanza totale di rispetto umano per la diversità hanno potuto fare, di questo misero gesto, una eroica difesa dell’ortodossia cattolica.
A mani nude contro la guerra
«Vi sarete accorti quanto spesso la nostra parola ripeta considerazioni ed esortazioni circa il tema della pace», lo facciamo «perché vorremmo che non mai ci fosse rimproverato da Dio e dalla storia di aver taciuto davanti al pericolo d’una nuova conflagrazione tra i popoli». Si esprimeva così Paolo VI nel messaggio con cui, l’8 dicembre 1967, istituiva la Giornata mondiale della Pace. Parole che papa Bergoglio potrebbe ripetere tali e quali oggi, che il pericolo di una nuova conflagrazione mondiale torna a po -
Dice il Papa: «Siamo malati di consumo. Questa è la nostra malattia. Ci si affanna per l’ultima
“app”, ma non si sanno i nomi dei vicini di casa
Francesco continua a denunciare le spese militari che nel 2021 per la prima volta hanno superato la mostruosa cifra di 2mila miliardi di dollari
polare i nostri incubi peggiori. «Questo mondo sempre più violento e guerriero mi spaventa davvero, lo dico davvero: mi spaventa!» (Udienza ai membri di Comunione e liberazione, 15 ottobre 2022)
Francesco era stato da poco eletto e subito dovette alzare la voce contro la possibilità di un intervento militare americano in Siria; secondo la Casa Bianca doveva servire a portare democrazia e pace ma di fatto minacciava gli equilibri già precari in Medio Oriente. «La pace si afferma solo con la pace» tuonò il Papa citando ancora una volta Paolo VI. Il 7 settembre 2013 convocò i fedeli (ma c’erano anche rappresentanti islamici e non credenti) in piazza san Pietro ad una veglia di preghiera per la pace in Siria. Obama per fortuna ci ripensò, ma un’atroce guerra combattuta per procura (dalle grandi potenze mondiali e regionali) devastò la Siria, ancora oggi ferita e lontana dalla sospirata pace. Purtroppo, è così. La voce dei Papi è fragile, inerme; lottano a mani nude con i padroni della guerra; invocano il dialogo, offrono canali diplomatici di mediazione. Le loro uniche armi sono “le armi di Dio”: preghiera, penitenza, conversione... ma quella dell’unica sede al mondo santa per definizione è forse l’unica voce al mondo che non è mossa da interessi (politici, economici, ideologici) ma dal solo interesse per il bene della gente.
Voci libere: papa Francesco in totale solitudine continua a denunciare il commercio delle armi, con le spese militari che nel 2021 hanno superato per la prima volta la mostruosa cifra di 2mila miliardi di dollari. Andando in direzione ostinata e contraria definisce “immorale” non solo l’uso ma anche il “possesso” delle armi nucleari.
Non c’è stata guerra, in questi dieci anni, che non abbia trovato parole di angoscia e di condanna da parte del Papa. Yemen, Sud Sudan, Congo, Repubblica Centrafricana, Israele e Palestina, Iraq, Myanmar, Armenia e Azerbaigian… Fino alla guerra più insensata e sanguinosa di tutte, l’aggressione russa dell’Ucraina. Il pezzo più esplosivo della “terza guerra mondiale a pezzi”. Eppure, anche in questo caso, anzi mai come in questo caso, il solo pronunciare la parola pace è costato al Papa critiche e insulti. Tutti professori in cattedra a insegnare a Francesco cosa dovesse dire, esattamente, per meritarsi una maggiore benevolenza mediatica. Dicevano: non ha mai menzionato il presidente Putin! Pretendendo che un Papa parlasse come loro, alle risse della sera che chiamano talk show. Ignorando che nessun Papa mai,

negli interventi più severi contro la guerra, nemmeno Giovanni XXIII nel radiomessaggio del 1962 sulla crisi cubana, nemmeno Giovanni Paolo II nei suoi Angelus contro la guerra del Golfo nel 1991 e nel 2003, aveva mai sentito il bisogno di fare i nomi dei leader politici ai quali si appellavano. Semplicemente perché la Chiesa condanna il peccato e non il peccatore; gli atti concreti e non il singolo individuo. Semplicemente per una questione di stile diplomatico, che lascia aperta a tutti, anche al peggior criminale della storia, la porta del ripensamento o di un dietro-front appena decoroso, quando le circostanze prima o poi lo imponessero. Semplicemente perché non ce n’era bisogno. Ecco un breve elenco degli aggettivi usati da Francesco per condannare l’ «aggressione armata» dell’Ucraina: ingiusta, inaccettabile, ingiustificata, barbara, insensata, orribile, ripugnante e sacrilega. C’era forse qualche dubbio sul pensiero del Papa circa l’invasione decisa da Putin? Incertezza su chi Francesco pensa sia l’aggredito e chi l’aggressore?
In occasione della Via Crucis al Colosseo, lo scorso aprile, il Vaticano pensò di chiedere a due donne, una russa e una ucraina, colleghe e amiche nel Campus biomedico (cattolicissimo ospedale romano dell’Opus Dei), di portare insieme la croce in una delle stazioni della via dolorosa. Perfino questo gesto di grande umanità fu considerato equivoco, accusato (purtroppo anche da alcuni vescovi ucraini) di mettere sullo stesso piano aggressore e aggredito. Ma se il cristianesimo non può rendere possibile che due donne, di due Paesi in guerra tra loro, esprimano la loro fra-
Roma, 10 aprile, 2020. Papa Francesco presiede la Via Crucis, in una Piazza San Pietro vuota e senza fedeli a causa dell’epidemia di Covid-19. Sono le settimane in cui il governo italiano ha adottato la misura di un blocco nazionale, chiudendo tutte le attività, fatta eccezione per i servizi essenziali, nel tentativo di combattere il Coronavirus
Roma, 13 marzo 2022. La preghiera di papa Francesco all’Angelus a pochi giorni dell’invasione dell’Ucraina: «Con il dolore nel cuore, unisco la mia voce a quella della gente comune, che chiede la fine della guerra. Nel nome di Dio, ascolta il grido di chi soffre... Nel nome di Dio . Ti chiedo: ferma questa carneficina!»
terna amicizia sotto la Croce, nella preghiera, allora, il cristianesimo, che cosa ci sta a fare nel mondo? Meglio chiudere la Chiesa, mandare in pensione tutti i papi, e lasciare la parola solo ai professorini del bon ton bellico.
Altro capo d’accusa verso Francesco. Parole di pietà pronunciate a braccio, per Darya Dugina, figlia di un ideologo russo vicino a Putin, fatta saltare in aria, nell’agosto 2022, in un attentato probabilmente concepito a Kiev. Certo, se l’unico criterio del Papa fosse la ricerca di titoli compiacenti sui giornali, quelle parole potevano ben essere evitate.
Ma la Chiesa per fortuna non è assimilabile in tutto al mondo. E di parole di umana pietà, comunque, non di una presa di posizione politica, si trattava. Alla gente che ascolta con cuore semplice il Papa questo era chiaro, nessuna ambiguità. Ma la “pietà l’è morta” e un giorno ci renderemo conto di quanta umanità abbiamo perso, perdendo la pietà, anche verso i nemici. In ogni appuntamento pubblico Francesco esprime la sua vicinanza al «martoriato popolo ucraino», vittima delle follie nazionaliste del nuovo zar del Cremlino, senza dimenticare il dolore delle mamme dei ragazzi russi morti a decine di migliaia per una guerra che probabilmente non desideravano combattere. Quando poi un giorno, che purtroppo sembra ancora lontano, i belligeranti saranno costretti a sedersi attorno a un tavolo per firmare la pace, qualcuno si ricorderà mestamente delle parole profetiche di quell’anziano Papa: »Che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?».

di ALVER METALLI giornalista e scrittore, vive in una villa miseria nella capitale argentina
Non si sa se papa Francesco tornerà mai nel Paese che l’ha visto nascere. Forse morirà in terra di missione, l’Italia, come i predecessori gesuiti che lasciavano le contrade d’Europa alla volta di quelle sconosciute d’Oriente e lì morivano senza tornare sui propri passi. Fatto sta che il decimo anniversario del suo pontificato coincide con un evento che non solo gli offrirebbe l’occasione di rivedere i suoi connazionali, ma mette in evidenza una dimensione del suo pontificato che ha proprio in Argentina la sua origine. Mi riferisco ad una attenzione agli emarginati che ha in parole come “droga”, “tratta”, “prostituzione”, “emigrazione” altrettanti concetti di sintesi, ed in altre parole come villas miseria, “povertà” ed “esclusione” l’indicazione dei contesti in cui le prime si collocano prioritariamente. Non è secondario ricordare questi tratti della predicazione di Bergoglio vescovo poi trapassati in quella di Francesco papa. Ed un momento in particolare, che dieci anni dopo la partenza da Buenos Aires alla volta di Roma con la sola ventiquattrore come bagaglio, per l’appunto, ha un rilievo particolare.
Molti in Argentina ricordano quel giovedì santo del marzo 2008, quando Bergoglio

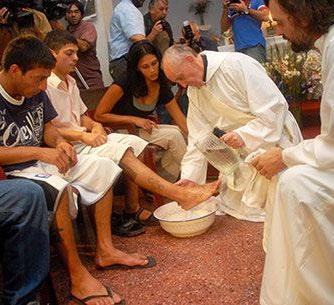
L’allora arcivescovo Bergoglio mentre bacia i piedi di sette ragazzi in procinto di cominciare un percorso di recupero dalla droga nella baraccopoli numero 21 di Buenos Aires
arcivescovo si chinava per lavare i piedi a sette ragazzi che iniziavano un percorso di recupero dalla droga in una popolosa baraccopoli della capitale, la 21, come si suole abbreviare con un numero per distinguerla dalle molte altre che prosperano nella capitale argentina e nei suoi dintorni. Il catino con l’acqua lo spostava da un piede all’altro un sacerdote di 46 anni, José Maria di Paola, che diverrà noto nel tempo come “padre Pepe”. Quel giorno, come ricorda ancora uno dei presenti alla cerimonia, il cardinale Bergoglio prese per mano una bambina molto piccola e per l’altra una donna anziana e disse che tra quelle due mani, una liscia e soave, l’altra rugosa e morena, passava «la strada della vita dal suo inizio alla fine». Poi sciolse i nastri messi all’entrata del primo Hogar de Cristo, che nelle parole di Bergoglio doveva essere «la casa di Gesù, dove, insieme a Maria sua madre e a Giuseppe suo padre, si impara ad amare e ad essere amati, a ridere e a piangere, ad essere grati e a chiedere, a festeggiare e a soffrire». Dove «si è sempre compresi, ascoltati, valorizzati, dove l’affetto e la tenerezza non sono mai negati, dove si impara ad amare la povertà, l’umiltà, il lavoro e la fatica, l’onestà, la coerenza, la pazienza e il saper tollerare l’ingiustizia, il saper
aspettare i tempi di Dio». Tutto un programma, come si vede, di quello che cercheranno di essere nel tempo e nel loro sviluppo.
Il centro di recupero, il primo, portava il nome di un santo cileno, San Alberto Hurtado, e come quelli creati dal gesuita canonizzato nel 2005 da Benedetto XVI, veniva chiamato hogar, casa. Era l’inizio di un processo, come userà dire Bergoglio, un cammino che da quel momento non si è mai interrotto, un processo che ha visto moltiplicarsi le case fino alle 200 e passa di oggi. Perché quella preoccupazione di allora, liberare dalla schiavitù della droga chi ne è vittima, ha intercettato un problema grave, diffuso nella società argentina, nelle sacche urbane di emarginazione più che altrove. Le case, gli hogar, sono cresciuti ovunque, e migliaia di ragazzi li frequentano. Nel tempo hanno affinato un metodo, fatto di passi graduali, di un mix di specialisti e di legami forti con la comunità dei quartieri e delle baraccopoli in cui sono inseriti.
Questi hogar, chi vi è transitato spezzato e ne è uscito intero, le migliaia di giovani che hanno visto la luce alla fine del tunnel che voleva inghiottirli, hanno iniziato un pellegrinaggio per tutta l’Argentina che si concluderà proprio la vigilia del 13 marzo nella basilica di Lujan, il cuore religioso e popolare del Paese.
Il primo centro di recupero fu chiamato hogar, ovvero “casa”.
Oggi ce ne sono oltre 200 e portano avanti un approccio basato sul forte rapporto con le comunità dei quartieri in cui sono inseriti
Fino a questo momento hanno percorso 4mila chilometri, toccato quindici province, una quarantina di città, sette santuari, carceri, scuole, quartieri popolari, comunità aborigene, ospedali, hanno occupato piazze per comunicare un messaggio prima ancora visivo che ragionato: che uscire dalla presa della droga si può. Come a suo tempo si ascoltò anche nel summit della Chiesa latino-americana di Aparecida, in Brasile, nel 2007 in cui Bergoglio ebbe parte e che secondo molti lo lanciò verso il pontificato. Ci fu qualcosa di profetico in quel momento che caratterizzerà tutto il pontificato. La centralità della povertà nella missione della Chiesa, e di nuovo ritornano quelle parole: tratta, prostituzione, emigrazione, droga. A quest’ultima, la droga, alla sua diffusione, al suo consumo, al dramma della tossicodipendenza, i vescovi dell’America Latina riuniti nel santuario brasiliano riconobbero la qualità precipua di una pandemia, proprio come quella che si abbatterà sul continente quindici anni dopo, una pandemia che alla pari del Covid «è come una macchia d’olio che invade tutto» si affermava al punto 422 del documento elaborato dalla commissione presieduta da Bergoglio, «non riconosce frontiere, né geografiche né umane, e attacca allo stesso modo Paesi ricchi e poveri, giovani, adulti e anziani, uomini e donne».
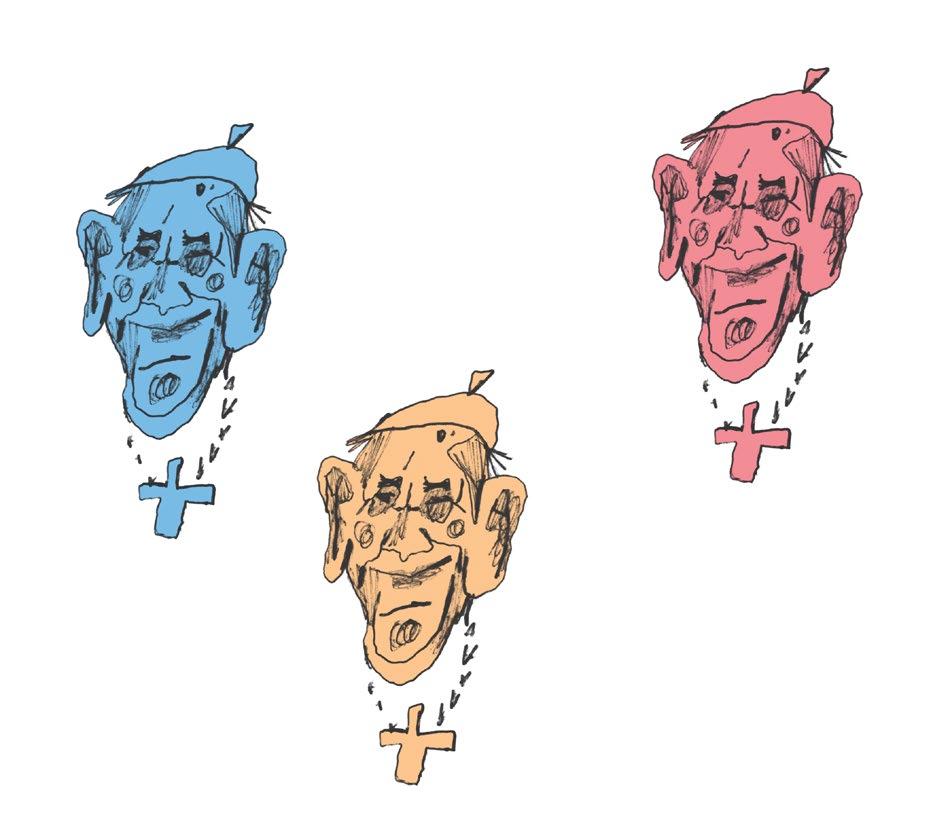
Con
Stefano Zamagni
Chiara Saraceno
Luigino Bruni
Ritanna Armeni
Carlin Petrini
Rita Bernardini
Riccardo Bonacina
Paola Concia
Fraternità, Povertà, Economia, Donna, Scarto, Pena, Volontariato, Diritti: il vocabolario sociale di papa Bergoglio
Fratelli tutti, sulla fraternità e l’amicizia sociale è una autentica ispiera — il raggio di luce che, penetrando da una fessura in un ambiente in ombra, lo illumina rendendo visibile ciò che in esso staziona. Si tratta della terza enciclica di papa Francesco, dopo la Lumen Fidei del 2013, scritta con papa Benedetto XVI, e la Laudato si’ del 2015. Un filo rosso attraversa questi tre documenti magisteriali che trattano, sia pure da angolature diverse, del medesimo tema di fondo, quello della sconnesione, rispettivamente, con Dio, col creato, con l’altro. Il peccato è dunque l’atto mediante il quale l’uomo recide il suo legame con Dio e allora l’esito è un progressismo disincantato oppure un tradizionalismo sterile; con la natura e allora l’esito è la crisi ecologica che è sotto gli occhi di tutti; con l’altro uomo e allora l’esito è l’indifferentismo sia sociale sia personale.
Tante sono ormai le presentazioni e le recensioni che questa enciclica ha ricevuto e continua a ricevere anche, e forse in misura maggiore, da chi si professa non credente. In queste poche righe desidero illustrare le implicazioni di natura sociale ed economica che derivano dalla presa in considerazione del principio di fraternità. Prima, però, desidero fare chiarezza su taluni concetti che troppo
superficialmente vengono presi come sinonimi o quasi. Alludo alle differenze che esistono tra fraternità, fratellanza e solidarietà. La confusione di pensiero che ne deriva non giova né al dialogo né alla prospettazione delle conseguenti linee di azione.
Fraternità non ha lo stesso significato di fratellanza e ancor meno di solidarietà. Mentre quello di fratellanza è un concetto che dice dell’appartenenza delle persone alla stessa specie o a una data comunità di destino, la fraternità è un concetto trascendente che pone il suo fondamento nel riconoscimento di una universale appartenenza. La fratellanza unisce gli amici, ma li separa dai non amici; rende soci e quindi chiude gli uniti nei confronti degli altri. La fraternità, invece, è universale e crea fratelli, non soci, e dunque tende a cancellare i confini naturali e storici che separano. Il gesto di Caino suggerisce che la fraternità non deriva dal sangue. Non esiste fraternità biologica, quanto a significare che non esiste fraternità senza riconoscimento della nostra responsabilità verso l’altro. Mentre la fratellanza ha un presupposto naturalistico, la fraternità ha il presupposto nel riferimento ad un legame, che ci rende custodi gli uni degli altri. La fraternità, in senso proprio, è un’invenzione del Cristianesimo,
Una
anche se l’opinione comune la colloca entro la triade repubblicana. Ma le cose non stanno in questi termini. Nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) ci sono libertà ed eguaglianza, ma non fraternità, parola che verrà successivamente inserita, e che non riceverà mai grandi attenzioni. Ne conosciamo la ragione: non si era dimenticato che tale parola era servita a giustificare e, addirittura a legittimare, le immani ingiustizie dell’Ancien Regime. Tale disposizione della sequenza da parte dell’Illuminismo francese si è rivelata deleteria: libertà e uguaglianza, concepite entrambe all’interno dell’individualismo
di fratellanza e tanto meno di solidarietà. È un concetto trascendente che si fonda su un’appartenza universale

— il valore prevalente della Modernità — sono di per sé valori intrinsecamente divergenti e concettualmente contradditori. È la fraternità che riesce a tenere in equilibrio, cioè in armonia, libertà e uguaglianza. L’eguaglianza, senza la coscienza che è anzitutto per l’altro, diventa solitudine mortale. Come ci ricorda Edgard Morin, la libertà può essere istituita e l’eguaglianza imposta. La fraternità, invece, non si stabilisce per legge; viene da un’esperienza personale di responsabilità e va praticata, in primis per il bene dell’altro, non perché ci sentiamo obbligati da un qualche codice.
Altrettanto distante è la fraternità dalla solidarietà. È merito grande della scuola di pensiero francescano quello di aver saputo declinare, in termini sia istituzionali sia economici, il principio di fraternità facendolo diventare un asse portante dell’ordine sociale. Ci sono pagine della Regola di Francesco che aiutano bene a comprendere il senso proprio del principio di fraternità. Che è quello di costituire, ad un tempo, il complemento e il superamento del principio di solidarietà. Infatti, mentre la solidarietà è il principio di organizzazione sociale che consente ai diseguali di diventare eguali, quello di fraternità è il principio che consente ai già eguali di esser
diversi – si badi, non differenti. La fraternità consente a persone che sono eguali nella loro dignità e nei loro diritti fondamentali di esprimere diversamente il loro piano di vita, cioè la loro specificità. (Si badi a non confondere differenza con diversità: la prima si oppone a eguaglianza; la seconda si oppone a uniformità. Ecco perché si può essere eguali e diversi; mentre non si può essere eguali e diseguali). Questa compresenza di uguaglianza e singolarità è ciò che caratterizza in modo unico il principio di fraternità. Le stagioni che abbiamo lasciato alle spalle, l’800 e soprattutto il ’900, sono state caratterizzate da grosse battaglie, sia culturali sia politiche, in nome della solidarietà e questa è stata cosa buona; si pensi alla storia del movimento sindacale e alla lotta per la conquista dei diritti civili. Ma la buona società in cui vivere non può accontentarsi dell’orizzonte della solidarietà, perché mentre la società fraterna è anche una società solidale, il viceversa non è vero. Cosa fa la differenza? La gratuità. Dove essa manca non può esserci fraternità. La gratuità, non è una virtù etica, come è la giustizia. Essa riguarda la dimensione sovraetica dell’agire umano; la sua logica è quella della sovrabbondanza. La logica della giustizia, invece, è quella dell’equivalenza, come già Aristotele insegnava. Capiamo allora perché la
fraternità va oltre la giustizia. In una società, solo perfettamente giusta – posto che ciò sia realizzabile - non vi sarebbe spazio per la speranza. Cosa potrebbero mai sperare per l’avvenire i suoi cittadini? Non così in una società dove il principio di fraternità fosse riuscito a mettere radici profonde, proprio perché la speranza si nutre di sovrabbondanza. Aver dimenticato il fatto che non è sostenibile una società di umani in cui si estingue il senso di fraternità e in cui tutto si riduce, per un verso, a migliorare le transazioni basate sullo scambio di equivalenti e, per l’altro verso, ad aumentare i trasferimenti attuati da strutture assistenziali pubbliche e private, ci dà conto del perché, nonostante la qualità delle forze intellettuali in campo, non si sia ancora addivenuti ad una soluzione credibile del trade-off tra equità e libertà. Non è capace di futuro la società in cui si dissolve il principio di fraternità; non è cioè capace di progredire quella società in cui esiste solamente il “dare per avere” oppure il “dare per dovere”. Ecco perché, né la visione liberal-individualista del mondo, in cui tutto (o quasi) è scambio, né la visione statocentrica della società, in cui tutto (o quasi) è doverosità, sono guide sicure per farci uscire dalle secche in cui sono oggi irretite le nostre società.
Lo sguardo di papa Francesco sui poveri e la povertà è duplice. È lo sguardo di chi si fa carico dei loro bisogni più urgenti anche dal punto di vista del mantenimento della dignità personale. Quindi, lungi dal far sgombrare gli accattoni e i senza dimora che frequentano piazza San Pietro, come hanno da qualche anno iniziato a fare non solo molti sindaci nelle vie e piazze dei centri urbani in nome del decoro, ma anche alcuni parroci sui sagrati delle chiese, fa installare docce per loro nel loggiato. Consente al suo elemosiniere di riallacciare la luce in un edificio romano abbandonato e occupato da persone che non hanno altro tetto sotto cui ripararsi. Sollecita tutte le parrocchie ad essere accoglienti con azioni pratiche verso i poveri e i migranti. Tutto sommato queste azioni, anche se erano diventate inusuali per un papa, rientrano, dovrebbero rientrare, nella normale attività e pedagogia del capo della Chiesa.

di Chiara Saraceno sociologa
Papa Francesco tuttavia rovescia lo sguardo sulla povertà proprio tradizionalmente della Chiesa, formulandolo come problema eminentemente politico, esito di decisioni che avvengono entro rapporti di potere asimmetrici— tra gruppi e classi sociali, anche se non usa questi termini — e tra Paesi. Per Francesco, infatti, la povertà e la condizione dei poveri vanno letti e affrontati innanzitutto nella prospettiva della, mancata, imperfetta, giustizia sociale e delle disuguaglianze, non della sfortuna o debolezza dei singoli. Nei suoi discorsi sulla povertà si trova niente di meno che l’indicazione al dovere di modificare i meccanismi che producono povertà ed emarginazione. «Solidarietà con i poveri è pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà: la disuguaglianza, la mancanza di un lavoro e di una casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. La solidarietà è un modo di fare la storia con

«Il principio del bene comune si trasforma in un appello alla solidarietà e in un’opzione preferenziale per i più poveri».
Il Papa ci sta dicendo che il povero non è la sua povertà
i poveri, rifuggendo da presunte opere altruistiche che riducono l’altro alla passività». Un’indicazione che riguarda anche la povertà e disuguaglianza come dimensione strutturale di relazioni internazionali asimmetriche nel mondo globalizzato, di cui occorre assumersi la responsabilità per cambiarle: «Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante inequità e sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali, il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla solidarietà e in un’opzione preferenziale per i più poveri. Questa opzione richiede di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni della terra». C’è nell’analisi di papa Francesco sulla povertà e nella pedagogia che ne scaturisce anche una critica ad atteggiamenti, misure, gesti che riducono il povero alla sua povertà, intesa anche come
Papa Francesco ha rovesciato il tradizionale sguardo sulla povertà della Chiesa. Che da individuale diventa questione sociale.
Nei suoi discorsi non si trova niente di meno che l’indicazione al dovere di modificare i meccanismi che producono emarginazione
Al Papa non piace l’assistenzialismo. E allo stesso tempo riconosce che non sono le capacità di stare sul mercato a dover determinare il valore di ciò che ciascuno è e può fare
incapacità di pensiero e giudizio autonomo, facendone un semplice terminale di interventi altrui, per quanto ben intenzionati. Di qui anche la critica all’assistenzialismo, termine che per altro considero molto scivoloso, che si presta troppo spesso ad usi impropri. Se è vero, infatti, come afferma il papa e non solo lui, che per molte persone in condizione di povertà il sostegno monetario deve essere «un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze e il vero obiettivo dovrebbe essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro», innanzitutto il sostegno economico andrebbe dato fino a che il bisogno persiste. In secondo luogo, anche se ci fossero abbastanza “lavori dignitosi” per tutti, non tutti sono in grado di svolgerli o di farlo a tempo pieno, quindi di ottenere sul mercato un reddito sufficiente per una vita dignitosa. Garantire un reddito sufficiente non è assistenzialismo passivizzante, ma riconoscimento del valore di ciascuno, di ciò che può essere e fare, a prescindere dalla sua capacità di mercato.
Il XX è stato il secolo che ha tentato una critica sistematica al capitalismo, proprio mentre questo raggiungeva il suo apice. Il movimento socialista e quello cristiano-sociale avevano in comune la ricerca di qualcosa di nuovo che superasse la forma capitalistica senza rinunciare a molti dei portati di civiltà del mercato — le tante “terze vie”. Nel XXI secolo il capitalismo è diventato l’ambiente dentro il quale viviamo e pensiamo, e così abbiamo perso la capacità culturale di guardarlo, analizzarlo, criticarlo per potergli rivolgere le domande fondamentali della giustizia, della verità, dell’uguaglianza. Anche le varie forme d’impresa responsabile, o la stessa economia sociale e non profit, si concepiscono spesso all’interno della logica capitalistica e sono a questo funzionali e sempre più necessari per chiudere il sistema. Infatti, come ricorda da tempo il sociologo francese Luc Boltanski, la cifra tipica di questo capitalismo è la sua capacità di riciclare i suoi nemici e “metterli a reddito”. La Chiesa di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI ha, in genere, sottovalutato la portata “religiosa” o idolatrica del capitalismo, perché tutti presi, da un lato, dalla lotta contro il comunismo e, dall’altro, dalla battaglia teologica contro il relativismo, e non si sono accorti che un nemico molto più subdolo perché rivestito dei panni culturali del cristianesimo (come ricordava W. Benjamin: «Il capitalismo è un parassita del cristianesimo») stava occupando l’anima dell’Occidente e del mondo intero.
In questo clima culturale fuori e dentro la chiesa il discorso di papa Francesco sull’economia rappresenta una discontinuità nei confronti dei suoi immediati predecessori, mentre si ricollega, per certi versi, alla Popolorum progressio di Paolo VI.
La prima parola economica del suo pontificato papa Bergoglio l’ha scritta la sera del 13 marzo 2013, quando scelse il suo nome. Francesco è un messaggio, un messaggio plurale, ed è anche un messaggio all’economia. Lo è non solo per la povertà, perché Francesco è un messaggio rivolto anche alla teoria economica e alla finanza. La prima scuola di economia nel Medioevo fiorì dai francescani, e le prime banche popolare europee nacquero da loro: sono i Monti di Pietà, centinaia di istituti di credito nati dai francescani osservanti tra il 1458 e il Concilio di Trento. Francesco d’Assisi non è solo povertà, è anche ricchezza, sebbene vista dalla prospettiva paradossale e profetica del vangelo e di “beati i poveri”. Papa Francesco ha da subito attribuito una grande importanza all’economia. Le sue encicliche, inclusa l’Amoris Letitia sulla famiglia, hanno molte parole e paragrafi dedicati all’economia. Ripercorrendo

Bergoglio l’ha scritta quando scelse il suo nome. Francesco è un messaggio, un messaggio plurale, ed è anche un messaggio all’economia. Non dimentichiamo: la prima scuola di economia del
All’inizio il giudizio di Francesco sull’economia era totalmente negativo, perché la assimilava alla incominciato a teorizzare l’economia del “buon samaritano”
il suo magistero e conomico dall’E vangelii gaudium al messaggio p er i giovani di “ Economy of Francesco” ad Assisi nel settembre 2022, p ossiamo tentare un primo bilancio e lanciare un primo sg uardo d’insieme.
All’inizio papa B ergoglio aveva uno sg uardo problematico e sostanzialmente negativo sull’e conomia, che ve deva come un luogo essenzialmente di sfruttamento dei p overi e di pro duzione di scarti umani e ambientali; è questo il senso delle tesi dell’E vangelii gaudium, racchiuse nella frase non a caso più nota: «L’e conomia che uccide» . Lo sg uardo critico di Francesco sull’e conomia nasceva soprattutto dalla sua
Inoltre, la grande attenzione di Francesco p er l’e cologia e p er l’ambiente (altra nota francescana) pro duceva e pro duce un giudizio molto duro sul capitalismo che sta danneggiando gravemente la creazione. Col passare degli anni Francesco, grazie al dialogo e alla sua capacità di ascolto, ha riconosciuto di più la convivenza in essa di luce e ombra, samaritano”, la parab ola intorno alla quale è costruita la sua Fratelli tutt i, che nella chiesa cresce accanto “all’e conomia di Giuda” e che la
che ispira anche tutti i suoi quattro messaggi ai giovani di “ Economy of Francesco ” , anche p erché se si parla ai giovani la critica deve essere sempre accompagnata da uno sg uardo generoso, che è essenziale p er ogni giovane e p er tutti, p erché non si migliora il sistema e conomico di domani se mentre denunciamo l’e conomia che uccide non indichiamo quell’altra e conomica che fa vivere.
In conclusione, la valutazione spirituale e d etica dell’e conomia da parte di papa Francesco è ispirata dall’ambivalenza. La vita e conomica non è altro che un’espressione della vita delle p ersone e dei p op oli, e la vita è ambivalente. L’antrop ologia biblica sa che l’Adam è padre di Ab ele e di C aino, come sa che Giuda era uno dei do dici ap ostoli, non solo l’e conomo
evitare le ide ologie, di destra o di sinistra, che dimenticando l’ambivalenza prendono la parte buona o cattiva dell’e conomia e la fanno diventare tutto. Il magistero di Francesco è dunque una cura dell’ide ologia e conomica dominante, una cura che è espressione concreta di uno dei principi
sup eriore all’idea. Anche in e conomia.
Eguaglianza, giustizia, diritto: le donne non mancano mai nei discorsi di Francesco. Nelle riflessioni con cui indica le sofferenze del mondo, lo sfruttamento, la crudeltà del sistema economico sociale dominante non le dimenticano mai. Spesso, molto spesso, sono al primo posto. Indicate come esempio di amore, dedizione, cura. Basta questo — che pure è molto — per dire che con Francesco si sta anche risolvendo “la questione femminile nella Chiesa”? Ancora. Il pontefice nei dieci anni in cui è stato a capo della Chiesa ha dato alle donne funzioni importanti nelle istituzioni della Santa Sede, ha dato loro ruoli di vertice, ha mostrato di comprendere bene discriminazioni e pregiudizi nascosti. Basta questo per affermare che ha compreso la spinta emancipatrice e liberatrice che da decenni scuote il pianeta? Per riconoscere loro una diversità e una cultura femminile che può modificare in meglio tutta la comunità ecclesiale?
A parere di chi scrive non basta. Riconoscere quel che Francesco sta facendo, le sue battaglie, le sue rotture, osservare la radicalità di pensiero con cui affronta la questione sociale, ribalta luoghi comuni, pronuncia senza timore parole che oggi sembrano bandite dal lessico globale quali sfruttamento, povertà, diseguaglianza. Ammirare senza remore la chiarezza e la determinazione con cui continua a chiedere la pace. Osservare con rispetto e fiducia il pragmatismo con cui interviene nelle situazioni di discriminazione e affronta (immaginiamo) la cecità di parte del clero non è sufficiente a farmi pensare che la soluzione del difficile rapporto fra le donne e la Chiesa sia in via di soluzione e che il Papa abbia compreso la nuova soggettività femminile che ha già, in parte, cambiato il pianeta. Le donne oggi non sono solo “questione sociale” per quanto questa possa essere importante. Il loro sfruttamento, il riconoscimento che esso sia maggiore di quello dell’uomo non va alla radice della discriminazione, e soprattutto non è solo questa all’origine del ruolo secondario che esse hanno nella Chiesa. Né è sufficiente per abbattere la paura delle donne che ancora alberga nel clero.

di Ritanna Armeni gionalista
Le credenti, che sono l’ossatura portante di una Chiesa sempre più femminile, aspettano con impazienza di poter vivere la conquistata libertà nel mondo anche nell’istituzione ecclesiastica.
Francesco è una grande occasione
Finché la struttura ecclesiale di potere rimane intatta, finché l’autorità rimane maschile, finché gli spazi decisionali sono degli uomini, finché il diritto canonico non si tocca, finché l’amministrazione del sacro è appannaggio del “primo sesso”, finché rimane degli uomini l’interpretazione dottrinale delle scritture, finché si nominano le donne ma non la loro cultura, finché non si pronuncia senza remore e non si valorizza il pensiero femminista che per molti ( e molte) nella Chiesa è quasi una parolaccia non ci sarà nessuna soluzione né radicale né parziale al problema.
Non so se Francesco saprà fare questa svolta. In tutta sincerità ne dubito. Dubito che il pontefice per il quale nutro tutto l’affetto e la riconoscenza di una laica che non trova più nel suo mondo le parole coraggiose che il Papa continua a dedicare agli oppressi e agli sfruttati, possa fare questo salto. Il pontefice non è la soluzione del problema delle donne nella Chiesa. Ma — e questo va detto con fiducia e speranza — è un’occasione. Un’occasione per le donne della Chiesa che oggi possono trovare nel suo pontificato un terreno più fertile, una comprensione senza pregiudizi, un ascolto attento. Non è poco anzi è moltissimo se l’occasione viene colta, se si eliminano quegli aspetti di subordinazione che ancora tengono legate tante credenti, se esse valorizzano la loro riflessione, se non hanno paura di aprire contraddizioni. Perché ancora una volta spetta a loro. Un uomo, un pontefice, il più attento, il più rispettoso può al massimo dare dei segnali. Sta alle donne coglierli e andare avanti. Molte già lo fanno. Le teologhe ad esempio hanno già rivoltato le Scritture. E le suore tante suore, vivono la loro autonomia con una nuova consapevolezza. Quanto alle credenti, che sono l’ossatura portante di una Chiesa sempre più femminile, aspettano con impazienza di poter vivere la conquistata libertà nel mondo anche nella istituzione ecclesiastica. Francesco è, appunto, una grande occasione.
ll pontefice non è la soluzione del problema delle donne nella Chiesa. Ma, e questo va detto con fiducia e speranza, è un’occasione. Un’occasione per le donne della Chiesa che possono trovare un terreno più fertile, una comprensione senza pregiudizi, un ascolto attento
di
Carlin Petrini gastronomo e attivista
La mia relazione con papa Francesco ebbe inizio poco dopo la sua nomina a Pontefice. Era il luglio del 2013 e Francesco decise di scegliere come destinazione del suo primo viaggio ufficiale Lampedusa; simbolo della «globalizzazione dell’indifferenza», come la definì lui stesso. Era una chiara presa di posizione, attenzione e sensibilità verso coloro che troppo spesso vengono ingiustamente considerati gli “ultimi” della nostra società (migranti, anziani, donne, indigeni, lavoratori della terra). Sentì da subito un’affinità di intenti con lui; nelle sue denunce di indifferenza verso il prossimo e di condanna della cultura dello scarto vidi rispecchiato il lavoro portato avanti dalla rete di comunità del cibo di Terra Madre (contadini, pescatori, allevatori, indigeni, artigiani), che dal 2004 difendono la diversità di colture e culture alimentari.
Così decisi di scrivergli una lettera in cui esprimevo riconoscenza per la scelta di Lampedusa, e a cui allegavo una copia del mio libro Terra Madre. A seguito di quella lettera, una sera mentre mi trovavo a Parigi per lavoro, ricevetti una chiamata da papa Francesco in persona. Conversammo per una mezz’oretta buona di agricoltura, dell’economia che ha distrutto i contadini e gli raccontai un aneddoto su una cuoca delle mie parti che teneva aperto il locale solo

di giorno. Molte erano le richieste da parte dei clienti di tenere aperto anche per la cena. Ma lei rifiutò sempre dicendo che non aveva nessuna intenzione di diventare la più ricca del camposanto. Un’affermazione contadina, che non sottintendeva svogliatezza sul lavoro, ma che si faceva portatrice di un diverso concetto di economia. Un’economia di sussistenza che rigetta la venerazione capitalista del “Dio Denaro” e dà spazio a valori impossibili da quantificare, quali la cura per il territorio e per le relazioni fra le persone. Da quel primo confronto ne sono seguiti molti altri
epistolari e fisici, che a dieci anni di distanza riescono ancora a stupirmi.
Nel 2015 le Edizioni Paoline mi chiesero la stesura dell’introduzione alla lettura dell’enciclica Laudato si’. Un testo poetico e politico straordinario in cui ho ritrovato molti dei principi che hanno delineato il mio lavoro negli anni. Nella prefazione scrivevo: «Immancabilmente, parlare di un’ecologia che inizi dentro di noi e si riverberi in tutta la sua potenza fuori con azioni concrete che portino alla pace e a un benessere pieno e condiviso da tutti e tutto,
Il Papa concepisce la lotta allo scarto come impegno a porre fine alle forme di ingiustizia che impediscono l’emancipazione umana.
Nulla ci deve spaventare in questo compito a cui siamo chiamati, credenti o non credenti
ci fa guardare senza filtri al depauperamento che abbiamo causato alle risorse naturali, alle possibilità future che ci neghiamo, allo svilimento del nostro esistere. [...] Finché una cosa— o un essere vivente, e una persona, purtroppo — serve a uno scopo preciso e mi dà ciò che voglio, la uso o intrattengo con essa una relazione. Nel momento in cui questo bisogno non è più soddisfatto si tronca il rapporto. È la cultura dello scarto, il consumismo che tenta di riempire i nostri vuoti. È quello che facciamo con la natura, ma anche con i nostri fratelli e sorelle che muoiono di fame e
malnutrizione, soffrono la povertà, con i quali non abbiamo rapporti diretti e non ci possono dare nulla di cui sentiamo bisogno». Tengo sempre a sottolineare come si tratti di un’enciclica sociale, ancora prima che ecologica, ahimè non ancora ben assorbita né dal mondo laico ma neppure da quello cattolico.
Nel 2019 invece fui invitato a partecipare al Sinodo Amazzonico. Nell’accettare tenni a ribadire al Pontefice di essere agnostico e lui mi rispose in maniera affabile definendomi “agnostico pio”, ossia capace di provare pietas per la natura — tutt’oggi ammetto che è una definizione che mi piace molto — . Poter prendere parte a quell’assise è stata un’esperienza straordinaria, dove ho potuto toccar con mano la potenza del dialogo come metodo e processo di apprendimento, un modo per far sì che l’inculturazione non sia qualcosa di univoco ma diventi scambio mutualistico da cui poter imparare. In quella sede decisi di utilizzare lo spazio di dialogo che mi fu offerto per parlare di due categorie di persone fondamentali per l’alimentazione di tutti noi, ma che più di altre nel tempo sono state bistrattate: le donne e gli indigeni. Le donne ovunque nel mondo sono le garanti della sicurezza alimentare delle comunità. Nella vita di ciascuno di noi c’è una mamma o una nonna che ci ha insegnato a
cucinare seguendo l’intelligenza del cuore: che ci ha raccolti intorno a un tavolo, ci ha accuditi trasmettendoci i valori del cibo giusto e sano, o quelli delle ricette che permettevano di riutilizzare gli avanzi. Gli indigeni invece, attraverso la pratica della raccolta, rispettano i delicati equilibri dell’ambiente, tutelano il patrimonio forestale, e salvaguardano la biodiversità garantendone presenza e continuità per le future generazioni.
Nei primi dieci anni del suo Magistero, la relazione tra me e papa Francesco si è basata su una comunanza di intenti che è in realtà universale e riguarda tutte le persone di buone volontà. Mi riferisco all’opposizione alla cultura dello scarto attraverso l’impegno a porre fine alle forme di ingiustizia che impediscono l’emancipazione umana, e l’ascolto del grido della Terra, schiacciata dal peso di un’economia che uccide e preclude un futuro degno per l’umanità su questo pianeta. Nulla ci deve spaventare in questo compito a cui siamo chiamati, credenti o non credenti, laici o religiosi: non possiamo più rimanere indifferenti dinanzi a un’umanità che sta devastando la terra e nel farlo sta procedendo a passo spedito verso il baratro. Anche nel nostro quotidiano e nelle nostre piccole vite si può incidere sul cambiamento.
Se penso a questo decennale di pontificato di papa Francesco non posso che partire dalla parola “pena”, quella dell’ergastolo, che lui volle abolire per la Città del Vaticano, nel luglio 2013, pochi mesi dopo esser stato eletto.
Un messaggio anche per l’Italia. Anche la nostra Costituzione, all’articolo 27, parla di pena, seppure al plurale. Ricorda che “le pene” non possono essere contrarie al senso di umanità. E d’altra parte le nostre carceri sono definite istituti penitenziari, c’era evidentemente già in chi ha scritto questi testi fondamentali, la volontà di punizione che, nel gergo giuridico, sarebbe “retribuzione”. C’è anche la parte risocializzante, come recita l’articolo 27, quando parla di rieducazione: una parte, come sappiamo, che nella realtà lascia molto a desiderare.
Anche nell’immaginario collettivo la pena viene sempre associata al carcere, non si considerano pene le pene alternative, che sono comunque forme di punizione. Non si considera pena la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà. Misure che sono previste dal nostro ordinamento, nel quale sono state rafforzate anche grazie alla riforma Cartabia, la messa alla prova e le pene sostitutive.
Sull’ergastolo, di papa Francesco mi ha colpito moltissimo, perché la reputo di altissimo spessore, sia politico sia giuridico, quella lezione magistrale che fece ai giuristi dell’Associazione internazionale di diritto penale, nel 2014. In quell’occasione infatti cominciò a usare espressioni anche molto forti: «L’ergastolo è una pena di morte nascosta», disse, e quindi è ipocrita cercare di mascherarla. Oppure, anche rispetto al carcere duro, in quella lectio, parlò dell’isolamento e dei luoghi che causano sofferenze psichiche e fisiche che finiscono per incrementare sensibilmente la tendenza al suicidio.
Per me Francesco resta il pontefice che ha lavato i piedi ai detenuti in occasione della messa in Coena Domini. Uno dei massimi gesti di umiltà, lavare i piedi. Cominciò nel carcere minorile di Casal del Marmo, nel 2013, e poi a Rebibbia, a Regina Coeli e ha continuato nelle carceri di Paliano e di Velletri.
Pensiamo a tutti quelli che dicono “buttiamo via la chiave” e pensiamo al pontefice che, chinandosi sui piedi di questi uomini, usava l’espressione: “Perché tu e non io?».
Lo diceva sapendo bene che le persone delinquono e a volte delinquono ripetutamente, in genere provenendo dalle parti più disagiate delle periferie delle città, segnate dalla povertà materiale ma anche dalla povertà educativa.
Con «Perché tu e non io», ricorda che molto dipende da dove siamo nati,

Per me Francesco resta il pontefice che ha lavato i piedi ai detenuti in occasione della messa in Coena Domini. Uno dei massimi gesti di umiltà, lavare i piedi
da che condizioni di vita e di crescita abbiamo avuto. Fatti purtroppo poco raccontati agli italiani, che così diventano giustizialisti. E anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha recentemente ricordato di voler essere «garantista nel processo e giustizialista nell’esecuzione penale», dimostra così d’essere vittima della medesima mancanza di informazione corretta. Non sa, probabilmente, che ci sono intere parti dell’ordinamento penitenziario — la legge n° 354/1975 — che non sono mai state attuate. E sono le parti, dall’articolo 74 in poi, che più corrispondono al dettato costituzionale sulle pene che «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». Quelle parti dell’ordinamento che prevederebbero l’istituzione dei Consigli di aiuto sociale in ogni circondario di Tribunale con la cooperazione, quindi l’azione sinergica e collettiva, del Tribunale di sorveglianza, dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle imprese, delle associazioni, in modo da intervenire nella famiglia del detenuto affinché a fine pena abbia una possibilità che non sia solo quella di tornare a delinquere. Articoli mai attuati. Di Consigli di aiuto sociale c’è n’è solamente uno, a Palermo, istituito non tantissimi anni fa, per l’iniziativa del presidente del Tribunale, Antonio Balsamo, un galantuomo che ascoltandomi protestare a Radio Radicale, decise di metterlo in piedi.
E pensando a papa Bergoglio e al carcere, non posso non ricordare il suo rapporto con Marco Pannella. Quella telefonata al Policlinico Gemelli, durante uno sciopero della sete che Pannella aveva intrapreso nel maggio del 2014, proprio sullo stato dei nostri istituti di pena. Era al sesto giorno e la sua vita era davvero a rischio, si temeva il blocco renale. Una domenica, ricevette questa chiamata dal pontefice, bellissima, che registrammo.
In quella occasione Pannella chiese al Papa di pronunciare la parola “amnistia”, di fare un’uscita pubblica sul tema. Il Papa accettò, Marco interruppe lo sciopero. E successivamente il pontefice mantenne la promessa. Purtroppo, furono inascoltati entrambi.
Di papa Francesco ho poi un ricordo personale e cioè di quando gli portai un libro con le lettere di quasi 20mila carcerati, che avevano digiunato due giorni in occasione della Marcia per l’amnistia che avevamo organizzato proprio per il Giubileo dei carcerati. Un volume che sarà pesato 10 chili.
Glielo consegnai in udienza ed era il periodo in cui lui insisteva sul fatto di portare sempre con sé il Vangelo, enfatizzando il fatto che fosse “tascabile”. Quando vide questo tomo, appoggiato alla balaustra mi guardò e mi disse ridendo: «Tascabile!».
Uno dei primi atti di governo di Francesco fu l’abolizione dell’ergastolo in Vaticano. Lo fece nel luglio 2013, pochi mesi dopo esser stato eletto. Un messaggio anche per l’Italia: la nostra
Costituzione dice che “le pene” non possono essere contrarie al senso di umanità
Si potrebbe davvero comporre una catechesi sul volontariato spulciando i discorsi, i messaggi e le encicliche di papa Francesco in questi dieci anni, la sua è stata un’attenzione crescente e tutta dentro i passi del magistero pontificio, è a Roma che Francesco scopre il volontariato, il suo valore che non consiste nel volontarismo.
Il Papa che pochi mesi dopo la sua elezione al soglio pontificio, nell’ottobre 2013, aveva avvertito che la Chiesa non è una Ong: «La Chiesa non è un’agenzia umanitaria, la Chiesa non è una Ong, la Chiesa è mandata a portare a tutti Cristo e il suo Vangelo; non porta se stessa la Chiesa porta Gesù». Ovvero, la sua ragione sociale non è umanitaria ma sacramentale.
Papa Francesco nel corso del suo magistero ha poi via via incontrato centinaia di volontari e centinaia di gruppi di volontariato, sui territori o nelle udienze e nei lunghi mesi della pandemia ha visto e ammirato la mobilitazione in aiuto dei più fragili quando nelle città dominava il deserto e il silenzio. Si può parlare di una vera e propria scoperta da parte del Papa del volontariato, una scoperta che lo ha portato a dire «Io ho trovato tre cose in Italia che non ho visto da altre parti.
Una di queste tre cose è il forte volontariato del popolo italiano, la forte vocazione al volontariato. È un tesoro: custoditelo! È un tesoro culturale vostro, custoditelo bene!» (Discorso ai volontari della Protezione civile, maggio 2022). E ancor più recentemente «Il volontariato è una delle tre cose che ho trovato in Italia come una caratteristica vostra, non l’ho trovato così altrove. Le altre cose sono gli oratori parrocchiali, al nord soprattutto, e poi le associazioni di aiuto economico, bancario, perché la gente prenda lì il mutuo e vada avanti, un aiuto di tipo economico. Tre cose tipicamente italiane». (Discorso ai rappresentanti della Focsiv il 14 novembre 2022).
Un “tesoro culturale”, sottolinea il Papa, ovvero qualcosa di cui essere coscienti, da salvaguardare, da nutrire. A delineare contorni e contenuti di questo tesoro scoperto strada facendo da Francesco è stata poi l’intenzione di preghiera per il mese di dicembre 2022, diffusa attraverso un video alla Rete mondiale di preghiera del Papa, così intitolata: Per le organizzazioni di volontariato. Un testo breve quanto un’intenzione di preghiera ma in cui c’è molto, forse tutto il pensiero del Papa sul tema. Vediamolo punto per punto perché questi sono i
cardini della catechesi del Papa sul volontariato svolta in questi anni. 1. Impegno per il bene comune. L’intenzione si apre con un invito perentorio: “Il mondo ha bisogno di volontari e di organizzazioni che vogliano impegnarsi per il bene comune. Sì, è la parola che oggi molti vogliono cancellare: “impegno”. E il mondo ha bisogno di volontari che si impegnino per il bene comune”. Il mondo ha bisogno di volontari ovvero di persone, uomini e donne, che non abbiamo paura dell’impegno, idea e parola che molti vorrebbero cancellare, e di un impegno, che sempre implica anche un minimo di sacrificio, non per la carriera, i soldi o il potere ma per la costruzione del bene comune, di una casa comune in cui tutti possano essere accolti con dignità.
2. Essere volontari è una scelta che rende liberi. “Essere volontari solidali è una scelta che ci rende liberi; ci rende aperti alle necessità dell’altro, alle richieste di giustizia, alla difesa dei poveri, alla cura del creato“. Essere volontari, sottolinea il Papa, non è un volontarismo ma una scelta ovvero un esercizio proprio della libertà, una scelta che apre all’altro, che apre al mondo impedendo di restare autocentrati su di sé in un circolo egoistico
di Riccardo Bonacina giornalista, fondatore di VITA
Si può parlare di una vera e propria scoperta da parte del Papa del volontariato, una scoperta che lo ha portato a dire: «Io ho trovato tre cose in Italia che non ho visto da altre parti. Una di queste è il forte volontariato. È un tesoro.
Custoditelo!»
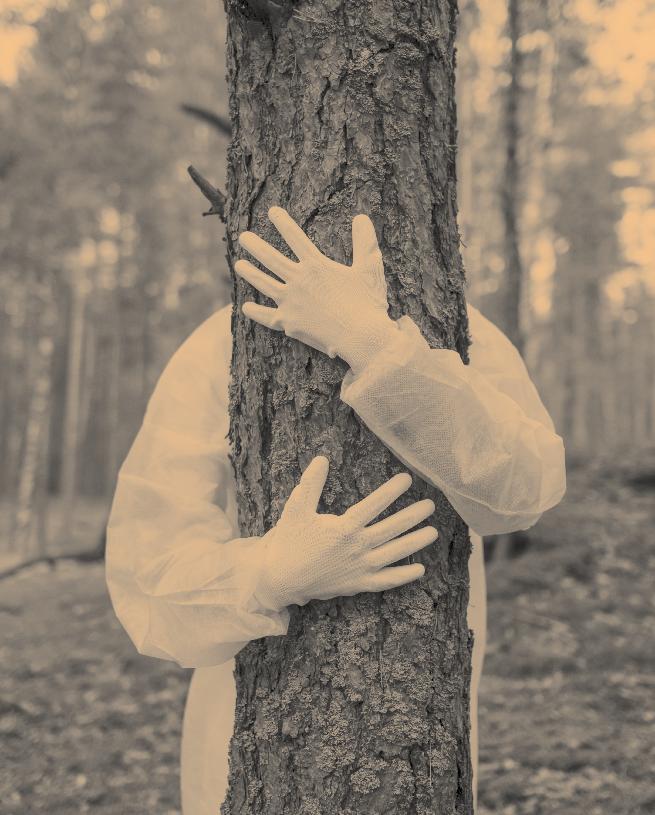
TOEssere volontari significa essere “con”, essere accanto all’altro, lavorare con lui, accompagnarlo e farsi accompagnare. Non “per” ma “con”, è il metodo del volontario, una pratica fraterna
deprimente e sterile.
3 Vicinanza, essere con, non per. «Essere volontari significa essere artigiani di misericordia: con le mani, con gli occhi, con gli orecchi attenti, con la vicinanza. Essere volontari vuol dire lavorare con la gente che si serve. Non solo per la gente, ma con la gente». Essere volontari significa essere “con”, essere accanto all’altro, lavorare con lui, accompagnarlo e farsi accompagnare. Non “per” ma “con”, questo è il metodo del volontario, una pratica fraterna, quindi per Francesco, una pratica che evoca e incarna il “Nessuno si salva da solo” della Fratelli tutti. 4. Collaborare per moltiplicare la speranza. “Il lavoro delle organizzazioni di volontariato è molto più efficace quando collaborano tra loro e anche con gli Stati. Lavorando in coordinamento, per quanto limitate possano essere le loro risorse, danno il meglio di sé e trasformano in realtà il miracolo della moltiplicazione della speranza. Abbiamo tanto bisogno di moltiplicare la speranza!”. Il Papa sottolinea qui il compito del volontariato, essere moltiplicatore di speranza, disseminare la speranza dentro la società, per questo è importante che le organizzazioni collaborino per permettere l’effetto moltiplicatore.

Non possiamo tirare il Papa per la giacchetta, anzi per la veste, per quello che ci piace – penso alla povertà – e poi criticarlo per cose che non ci piacciono. E fra le cose che mi piacciono io metto anche l’ultimo
appello a difesa degli omossessuali
«Il rapporto con i Papi del movimento omosessuale è sempre stato molto faticoso». La voce di Anna Paola Concia arriva al telefono dalla sua casa di Firenze, dove lavora a Didacta la grande fiera dell’innovazione scolastica. Classe 1963, abruzzese del Fucino, già parlamentare dem, dopo una lunga militanza iniziata dal Pci, Concia è sposata con Ricarda da cui vola, nei fine settimana, a Francoforte. È uno dei volti storici dei diritti Lgbt in Italia, provenendo, come ha spesso raccontato, da una famiglia cattolica: «I miei, Enzo e Maria Luisa, erano due dirigenti dell’Azione cattolica. Mio padre era il formatore di Gianni Letta, per dire», ricorda, «e hanno avuto quattro figli politicamente distanti: chi nel Pdup, chi nel Partito radicale: quella più a destra, un po’ piccolo-borghese, ero io, che stavo nel Pci. Ma ci hanno insegnato l’impegno civile».
Con quali pontefici avete fatto più fatica?
Quello che io mi ricordo più faticoso Giovanni Paolo II, che era un gran conservatore, ma quello con cui il rapporto è stato molto conflittuale e duro è stato Joseph Ratzinger.
Benedetto XVI era stato, d’altronde, anche prefetto della
Congregazione per la fede. E Bergoglio?
Francesco è un uomo che ha saputo leggere il cambiamento dei tempi. Un gesuita e all’interno della Chiesa cattolica i gesuiti sono stati sempre più aperti, “tolleranti” direbbero alcuni, anche se a me la parola non piace. Bergoglio è stato in linea cioè con la sua cultura. La Chiesa continua ad avere al suo interno un problema di conflittualità, che ora esploderà. Ma questa è un’altra storia.
Che cosa l’ha colpita in questo decennio di pontificato, in rapporto appunto alla condizione omosessuale?
Beh quel «Chi sono io per giudicare?», su quel volo per Rio de Janeiro, mi pare nel 2013. In me produsse un effetto distensivo. Ma intendiamoci…
Facciamolo..
Io non penso che la Chiesa debba o possa avere un atteggiamento favorevole ai matrimoni gay.
Non le farebbe piacere?
Certo che sì, ci sono molti omosessuali cattolici e cristiani che soffrono. Io non sono credente, sono a-religiosa ma sono rispettosa. Certo, sarebbe straordinario, per la potenza simbolica che ha la Chiesa ma non credo che avverrà mai.
E dunque?
E dunque voglio che la Chiesa sia contro l’omofobia, contro la discriminazione. Non pretendo che il Papa dica «siamo per i matrimoni egualitari». C’è l’articolo 7 dei Patti lateranensi, che distingue Stato e Chiesa, sempre e su qualsiasi tema. E lo Stato deve fare quello che crede. Matteo Renzi, quando approvò la legge sugli Unione civili, rispose ad alcune critiche, provenienti dai cattolici, proprio nel modo appropriato.
Ce lo ricordi...
Disse: «Non ho giurato sul Vangelo ma sulla Costituzione». Un’affermazione forte, da parte di un cattolico. E in quella frase c’era tutto.
Dunque lei si smarca da quanti pretenderebbero da Papa Francesco un’apertura maggiore?
Sono “lateranense”, se mi passa il concetto, nel bene e nel male: non possiamo tirare il Papa per la giacchetta, anzi per la veste, per quello che ci piace — penso alla povertà — e poi criticarlo per cose che non ci piacciono. E fra le cose che mi piacciono io metto anche l’ultimo appello a difesa degli omossessuali, puniti per legge in certi Stati. Come ha detto nell’intervista del mese scorso all’Associated Press. (G.C.)
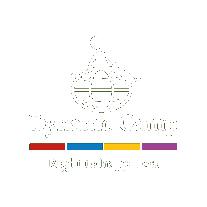


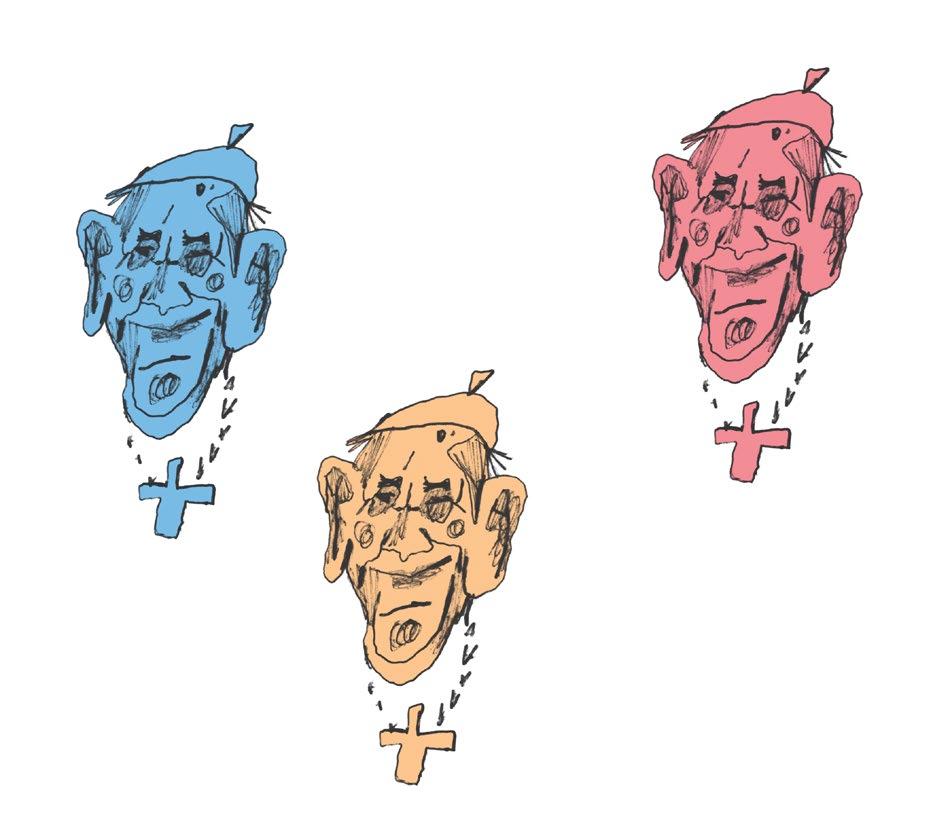
In questi anni sono state tante
le organizzazioni sociali che hanno dialogato con il Papa. Ecco nelle loro parole il significato di quell’incontro
Come il Papa ha inciso nella vita concreta delle organizzazioni del Terzo settore. Le testimonianze dei protagonisti
di Stefano Arduini
Abbiamo chiesto ai dirigenti di alcune delle maggiori organizzazioni di Terzo settore di rispondere a questa domanda: come l’incontro con Francesco ha impattato sul modo di agire della loro realtà? Quale è stato, in altre parole, il segno indelebile e concreto del magistero sociale del Papa argentino. Le risposte le trovate in queste pagine a loro modo costituiscono un documento prezioso e restituiscono la fisionomia di un pontefice fortemente orientato al fare, allo stare con e per, al condividere. La pragmaticità di Francesco emerge in modo esuberante e probabilmente anticipa e costruisce il suo pensiero. Come nota il presidente delle Acli Emiliano Manfredonia, in Bergoglio l’invito alla fratellanza umana in questi dieci anni è stato costante. Un invito vissuto in carne ed ossa, un invito basato sull’esempio e non sulla teoria. Un invito che per tante sigle del sociale è stato ed è, una sponda essenziale per rinnovare l’impegno pur dentro un contesto politico e sociale che riconosce troppo spesso solo sulla carta il ruolo essenziale dei corpi intermedi per l’inclusione e la pacificazione della nostra società. Scrive padre Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché: «Le parole di papa Francesco continuano ad essere una bussola che ci preserva dal creare dipendenza nelle persone accolte, dall’ambizione di dover diventare chissà che cosa e dal delirio di dover esserci a ogni costo». Lo “stare con” di Bergoglio in fondo sta tutto qui.
Un “Papa aclista”: per noi è stato come per il Napoli quando è arrivato
Maradona
Quando nell’aprile del 2015, per festeggiare i 70 anni delle Acli, abbiamo incontrato il Santo Padre in aula Nervi, un dirigente aclista di Avellino disse: «Per le Acli avere papa Francesco è come quando a Napoli è arrivato Maradona». Niente di più vero e di più efficace per descrivere il nostro rapporto di stima ma anche di sintonia e di ammirazione con il vescovo di Roma.
Francesco è un papa “aclista” nel senso proprio poiché le Acli della Capitale gli hanno fisicamente proposto e consegnato la nostra tessera associativa (ed egli non solo la ha favorevolmente accolta ma ha anche tentato di mettere mano al portafoglio con l’intento di pagare la quota sociale) ma soprattutto è per noi il Papa sociale che attendevamo ed è colui che ci ha donato una nuova ed unificante “fedeltà”, quella “ai poveri”, che riassume ed illumina le altre tre volute dalle madri e dai padri fondatori delle Acli: alla democrazia, al mondo del lavoro, alla Parola e alla Chiesa.
Francesco è un padre dell’umanità in un mondo che ha un grande bisogno di figure paterne ma è anche un maestro di coerenza tra le parole e i comportamenti personali e pubblici e, con queste sue caratteristiche, per noi laici cristiani — ma anche per le donne e gli uomini “di buona volontà” — è anche una guida autorevole che sta un passo avanti e dà il passo del nostro cammino.
L’Evangelii Gaudium, la Laudato
si’, l’Amoris laetitia e la Fratelli tutti, sono e sono stati per le Acli, “api operaie della dottrina sociale della Chiesa”, testi che abbiamo studiato, anzi “ruminato”, e provato a far divenire per noi “pane quotidiano” del nostro fare associazione, del nostro essere parte del Popolo di Dio.
L’invito costante di Bergoglio alla fratellanza umana, alla ricerca dell’incontro con l’altro per superare ogni muro, contrastando una guerra mondiale a pezzi che rischia di far crollare tutto, risuona oggi come una profezia sempre più attuale e un monito costante per la nostra associazione che si batte per gridare la pace, in Ucraina e in tutti gli altri territori martoriati da conflitti. Questi dieci anni di Bergoglio sono stati un dono grande per l’umanità nel “cambiamento d’epoca” ma anche nuova linfa e nuova vivificante prospettiva per la nostra associazione, con la sfida di essere anche noi coerenti e fattivi e non semplici ed incoerenti spettatori acclamanti.
Una persona non può essere ridotta a un oggetto: la sua lezione contro la cultura dello scarto
di don Marco Bove presidente Fondazione Sacra Famiglia
Il mondo delle persone disabili e della fragilità in generale spesso è stato ed è al centro dell’attenzione di papa Francesco e del suo magistero. Il Santo Padre ha più volte usato un’espressione forte e insieme chiarissima, la “cultura dello scarto”, per indicare come la società di oggi tenda a guardare e giudicare le persone più fragili,

considerandole inutili, “da buttare”, come uno scarto.
L’uso di questa espressione indica da una parte che non si tratta di qualcosa di estemporaneo o di isolato, ma di radicato e di pervasivo, una “cultura” appunto, e dall’altra come nella società dei consumi produrre “scarti” sia diventato qualcosa di inevitabile, frutto di un approccio utilitaristico nei confronti delle persone e delle cose.
Ma una persona non è, e non può mai essere, ridotta ad un oggetto, e dunque non può e non deve essere scartata, gettata via come qualcosa di inutile. L’anziano, il bambino, la persona disabile sono persone e, come ha continuato a ripetere papa Francesco in questi dieci anni di pontificato, sono oggetto della predilezione di Dio, perché Dio non scarta mai nessuno dei suoi figli. Questo messaggio forte e chiaro il Santo Padre lo ha ribadito con energia — e me lo ricordo con particolare commozione perché ero presente — nel mese di ottobre del 2021, in occasione dell’udienza privata per il Giubileo del Movimento Fede e Luce che in cinquant’anni ha creato comunità di incontro con persone con disabilità mentale, i loro familiari e i loro amici. Anche i responsabili della politica, purtroppo, non sempre fanno seguire alle dichiarazioni di principio le scelte conseguenti, così che le promesse elettorali restano spesso lettera morta, e le famiglie si trovano a dover portare da sole tutto il peso dei loro cari. Lo vediamo costantemente anche in Fondazione Sacra Famiglia, che da più di 125 anni è accanto ai più fragili e alle loro famiglie, e che della cultura dell’accoglienza e della cura ha fatto la propria missione.
Dunque più volte la voce del Papa si è levata a difesa della dignità della persona e, oggi più che mai, le realtà
legate al volontariato e al Terzo settore sono tra le poche rimaste a farsi carico di queste fragilità, accogliendo l’appello di Francesco e restando fedeli ai valori che le hanno ispirate.
Nessuno è uno scarto, mai, in nessun momento della propria vita e in nessuna condizione. Il pontificato di Papa Francesco, anche da questo di vista, è stato ed è portatore di un messaggio in controtendenza e profondamente evangelico. Di questo noi tutto dobbiamo essergli profondamente grati.
Non basta aiutare le persone con disabilità, bisogna imparare a renderle protagoniste
di Rossano Bartoli presidente Lega del Filo d’Oro
In questi ultimi anni, nella Chiesa, avvertiamo un coinvolgimento maggiore delle persone con disabilità. Non si tratta più soltanto di vederle come destinatarie di un’attenzione specifica, ma di lavorare perché diventino più protagoniste della vita delle comunità. È il cambiamento di passo che papa Francesco indica quando afferma che molte persone con disabilità, nelle società come nella chiesa, ancora sentono di esistere ma senza appartenere e senza partecipare. Nella nostra esperienza, in particolare nelle regioni in cui la Lega del Filo d’Oro è presente con un centro o una sede, stiamo percependo un’apertura maggiore da parte delle comunità parrocchiali. Sentire questo sguardo nuovo sulle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale che seguiamo ci spinge, come fondazione, da un lato a un impegno
ancora maggiore per garantire a chi lo desidera la possibilità di vivere la propria dimensione spirituale e, dall’altro, a mettere a disposizione la nostra esperienza, collaborando a livello nazionale e locale, con il coinvolgimento delle persone sordocieche, delle loro famiglie, del personale e dei volontari.
Colpito dalla
sua fraternità: abbiamo parlato della necessità di riscoprire la figura del “padre”
di
don Antonio Mazzi presidente Exodus
Èstato un incontro molto “caldo” quello con Francesco. Ciò che più mi ha meravigliato e affascinato è stato l’immediato spirito di fraternità, come se dovessi parlare con chi parlo ogni giorno. Sono trasalito dalla gioia. I pochi minuti a tu per tu, mi hanno permesso di dire due cose che mi stavano particolarmente a cuore: dedicare una Giornata annuale diocesana all’adolescenza e scrivere una “lettera ai padri”. Siamo in una crisi tremenda di paternità. Solo lui con la sua pastoralità innata può spedire ai padri parole capaci di smuoverli e di far loro capire quanto la figura del padre sia fondamentale per i figli adolescenti. Ha ascoltato e annuito. Il suo sguardo trascende ogni tua aspettativa.
E capisci subito che la diversità dei due Papi era dovuta a due personalità profondamente diverse. Da una parte la dottrina tradotta teleologicamente chiara, moderna, incentrata sull’unità della Chiesa, che richiede tempi di crescita e di maturazione (bello il titolo dell’ultimo libro di benedetto XVI:

Dio è sempre nuovo). E dall’altra parte, il Papa argentino che io ho conosciuto da cardinale a Buenos Aires, in una domenica, con la porte del Duomo spalancate, aperte a tutti e la piazza piena di gente, di cavalli della Polizia e di donne che invocavano pace, libertà e democrazia. Un abbraccio ha chiuso l’incontro con una crocetta sul volto e un suo invito ben preciso: «Ti raccomando di restare giovane». Straordinario!
“Inclusivi” e “concreti”: in due parole ci ha spiegato cosa significhi essere una Ong cattolica
di Giampaolo Silvestri segretario generale Avsi
Un incontro in particolare con papa Francesco ha segnato me personalmente e Avsi. Il 13 dicembre 2017, con il consiglio di amministrazione del Forum
delle ong cattoliche, ho partecipato a un’udienza privata con papa Francesco. Alla mia domanda, «Santità, cosa vuol dire oggi essere una ong cattolica?», il Pontefice rispose con parole nitide che non ho più dimenticato: «L’aggettivo cattolico deve equivalere all’essere inclusivi e concreti». Due concetti, inclusivo e concreto, che da quel momento hanno determinato ancora di più il nostro modo di lavorare nel mondo, nei 39 Paesi in cui da 50 anni Avsi accompagna le persone ad essere protagoniste del proprio sviluppo. Per noi, attori del Terzo settore, essere “inclusivi” significa porre l’accento su tutti i soggetti coinvolti, sia internamente che esternamente all’organizzazione, fare in modo che ognuno si senta accolto e sostenuto e diventi il vero protagonista della propria azione. Come avviene in Siria: nel progetto Ospedali aperti, che implementiamo a Damasco e Aleppo, si curano tutte le persone bisognose, a prescindere dalle loro appartenenze religiose. Qui accade che molti pazienti musulmani, dopo aver ricevuto accoglienza e cure nei tre ospedali gestiti da congregazioni cattoliche, una volta dimessi tornano e chiedono di poter svolgere servizio di volontariato nelle strutture ospedaliere stesse, per restituire in qualche modo quanto hanno ricevuto. Il secondo aggettivo utilizzato dal Papa, “concreto”, per una ong come
la nostra significa sottolineare l’importanza dell’implementazione dei progetti, cioè del come vengono realizzati: non è importante solo scriverli bene, o rispondere ai criteri dei bandi, vincendoli, ma siamo chiamati a verificare che effettivamente un progetto porti un impatto positivo, un cambiamento in meglio nella vita delle persone coinvolte.
Inclusivi e concreti: questi due aggettivi sono divenuti per noi un richiamo costante, arricchito da un nuovo incontro con papa Francesco con tutta Avsi lo scorso 3 settembre, in occasione del convegno dedicato ai primi cinque anni del progetto “Ospedali aperti in Siria” e al cinquantesimo dell’organizzazione. In questa occasione abbiamo consegnato al Pontefice le domande che come operatori umanitari ci poniamo ogni giorno: siamo chiamati a rispondere a infinite emergenze che mettono alla prova i più fragili, basti pensare al recente terremoto in Siria o allo scoppio della guerra in Ucraina. Tutte queste urgenze creano quasi una contesa: chi “merita” più aiuto?
C’è una gerarchia da rispettare nel bisogno? Come essere presenti? Francesco ha evocato l’immagine dei discepoli di Gesù di fronte alla numerosa folla da sfamare, che avevano la stessa domanda: «Non abbiamo altro che cinque pani e due pesci; ma che cosa è questo per tanta gente?» (Gv 6,5-9). Riferendosi ai nostri interventi sanitari in Siria il Papa ha parlato del pietroso deserto siriano che «dopo le prime piogge di primavera, si ammanta di una coltre di verde. Tante piccole gocce, tanti fili d’erba!».
Ci ha spronato a una nuova consapevolezza: se non possiamo aiutare tutti né salvare il mondo, possiamo però sempre lavorare insieme, metterci in rete, per avviare processi virtuosi per cui ogni persona possa essere protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità. Con le parole della Fratelli tutti ci ha spronato a riconoscere che per costruire sviluppo servono amicizia sociale e fraternità universale, consegne sulle quali noi tentiamo di impostare il nostro lavoro.
di Domenico Giani presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie
Dei dieci anni del Pontificato di Francesco, i primi sette ho avuto l’onore di trascorrerli accanto a lui come comandante della Gendarmeria Vaticana. La sua prossimità agli ultimi è un patrimonio per me indelebile. Ho ritrovato lo stesso spirito, e ne sono grato come presidente, nell’azione delle Misericordie, che da 8 secoli, dalla pandemia del 1244, compiono questi gesti, rinnovando anche loro l’attenzione agli ultimi. Questo Papa, con un suo stile, si inserisce a pieno nella scia della Misericordia dettata dal Vangelo, dall’esempio di decine di santi nella storia, e nella strada già tracciata da Paolo VI, Giovanni Paolo II, e papa Benedetto. L’immediata disponibilità di papa Francesco, che lo ha visto essere vicino anche fisicamente ai malati, ai carcerati, ai migranti è stata per tutti i cattolici e ovviamente anche per me di esempio. Gesti come la lavanda dei piedi ai carcerati hanno fatto capire a tutti l’attenzione del Pontefice verso gli ultimi, un atteggiamento che ha assunto un valore ancora maggiore durante la pandemia e la guerra in Ucraina, laddove non cessa mai di implorare la pace. Anche nei suoi viaggi internazionali viene costantemente testimoniato questo: il Pontefice si fa voce di chi non ha voce e di tutti gli invisibili della Terra. L’ultimo viaggio è stato ad esempio nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sudan del Sud, per un pellegrinaggio di pace. Risuonano forti le sue parole, pronunciate nel giardino del Palazzo presidenziale
in occasione dell’incontro con le autorità nella tappa in Sud Sudan. «Basta sangue versato, basta conflitti, basta violenze e accuse reciproche su chi le commette, basta lasciare il popolo assetato di pace. Basta distruzione, è l’ora della costruzione! Si getti alle spalle il tempo della guerra e sorga un tempo di pace!».
ha chiesto il coraggio di non chiuderci in noi stessi, di non aver paura delle grandi sfide di don Vincenzo Barbante presidente Fondaz. Don Carlo Gnocchi
Fondazione Don Gnocchi è stata ricevuta in udienza straordinaria da papa Francesco nell’ottobre 2019, in occasione del decennale della beatificazione di don Carlo. Questo incontro ha rilanciato l’esperienza della nostra fondazione. C’è un motto che papa Francesco ci ha consegnato: lavorare unendo compassione e competenza. Le sue parole hanno rafforzato la consapevolezza dell’importanza di dedicarsi alla cura della fragilità, un servizio importante per la Chiesa e per il Paese. Il servizio, ci ha ricordato il Papa, non è mai ideologico, dal momento che non serve idee ma persone. La nostra attività quotidiana si gioca proprio in questo prendersi cura concretamente delle persone, facendo nostri anche i sentimenti di disagio, fatica, solitudine che esse provano. Il servizio non può essere solo un atto superficiale o emotivo, ma chiede di essere riconfermato in ogni istante. Tante volte invece guardiamo chi è fragile solo come destinatario di un servizio e non cogliamo il suo provvidenziale essere segno eloquente di Dio
offerto agli uomini, che annuncia che la fragilità è una condizione comune: ricordarlo ci dispone al servizio come accoglienza di ogni uomo, nella sua globalità di persona. Un’altra lezione che Francesco ci ha dato è non avere paura di misurarci con situazioni più grandi di noi, che paiono sfide “fuori portata”. Conservo nel cuore l’immagine di papa Francesco solo sul sagrato di San Pietro, in piena pandemia: ci ha chiesto il coraggio di non chiudersi in sé, di non rassegnarsi. La terza cosa è la sua disponibilità all’incontro e al dialogo, l’impegno a servire l’umanità cercando di raggiungere l’altro. Questi due insegnamenti ci dicono che affrontare la grande sfida del servire la fragilità e le povertà è possibile solo creando una rete di rapporti e collaborazioni, in una logica di comunione e condivisione, di fraternità: perché proprio il riconoscerci fratelli è la condizione per affrontare le sfide più grandi.
di Francesco Vacca presidente nazionale Aism
C’ero anche io quando, nel 2018, in occasione della celebrazione dei 50 anni di Aism, una delegazione di 150 persone ha incontrato papa Francesco in aula Nervi. Disse alla nostra presidente di allora, Angela Martino, abbracciandola in rappresentanza di tutte noi persone con sclerosi multipla: «Siate forti, andate avanti con coraggio, vivete una vita piena».
E ci consegnò un messaggio: «Dio semina in noi la capacità di cambiare,

di trasformare il negativo in desideri positivi».
E noi l’abbiamo preso alla lettera: abbiamo trasformato i desideri in “Agenda” di priorità per cambiare insieme lo stato delle cose. Così come abbiamo preso sul serio la sua enciclica Fratelli tutti, quando ci propone (n° 189) di utilizzare il dialogo come strumento di crescita sociale: abbiamo costruito l’Agenda della sclerosi multipla e patologie correlate 2025, abbiamo identificato le quattro linee di missione, le 26 priorità strategiche, le 184 azioni che la contraddistinguono esattamente usando la bussola di papa Francesco, ossia coinvolgendo almeno 20mila persone tra tutti i portatori d’interesse (persone con Sm, caregiver, istituzioni, aziende, etc.) in 130mila confronti e interazioni avvenute in un anno di lavoro. Possiamo dire, insomma, che in papa Francesco e in particolare nella sua enciclica che ci vede e ci vuole “tutti fratelli” ritroviamo ispirazione e fonte rinnovata del nostro impegno quotidiano, perché vada sempre più a radicarsi in comportamenti e approcci autentici di sussidiarietà, di genuino impegno civico, di corresponsabilità tra persone, gruppi, organizzazioni, Stati. Lavoriamo anche noi, come papa Francesco non smette mai di ricordare a tutti, per arrivare a una convivenza di comunità in cui nessuno volga il proprio sguardo altrove, lasciando le persone fragili nell’ombra.
La meraviglia di accogliere una vita con speranza. È questo l’insegnamento che custodiamo
di Marina Casini
presidente Movimento per la Vita
Tra i tanti messaggi di speranza del Santo Padre ricordiamo quello del 2019, nell’udienza dedicata al Mpv in occasione della 41esima Giornata per la Vita quando ci ha invitati a guardare alla vocazione che difende la vita dal concepimento come un «patto che lega tra loro le generazioni, patto che consente di guardare avanti con speranza». La non rassegnazione, la gratitudine per la bellezza del nostro Movimento, di cui fanno parte anche tanti giovani, la meraviglia di poter accogliere una vita che nasce ed è accolta, oltre ogni difficoltà, perché c’è stato qualcuno a tendergli la mano: questo è quello che ci ha ricordato papa Francesco. Un insegnamento che custodiamo nel cuore.
Ci ha detto:
«La struttura deve essere sempre al servizio delle persone. Mai il contrario»
di padre Giuseppe Bettoni presidente Fondazione Arché
Uno dei momenti salienti delle celebrazioni per i 30 anni di Arché è stato l’incontro che papa Francesco ci ha riservato nella Sala Clementina il 2 settembre 2021: eravamo in 200 tra mamme, bambini, volontari e operatori. Tutt’altro che parole di circostanza, quelle che il Papa ci ha rivolto! Anzi, fin dalle prime battute ha messo a fuoco la nostra mission, arricchendola di una lettura profonda per imparare a stare sull’essenziale, sull’amore. Ecco le sue parole: «L’avete chiamato “Arché”, che richiama l’origine, il principio, e noi sappiamo che in principio c’è l’Amore, l’amore di Dio. Tutto ciò che è vita, tutto ciò che è bello, buono e vero viene da lì, da Dio che è amore, come dal cuore e dal grembo di una madre viene la vita umana, e come dal cuore e dal grembo di una Madre è venuto Gesù, che è l’Amore fattosi carne, fattosi uomo».
Un amore che deve continuamente essere alimentato da una lettura critica e attenta per far sì che, come ha ricordato nel concludere il suo messaggio, «la struttura sia sempre al servizio delle persone, non il contrario». Uno stimolo importantissimo a non cedere alla facile tentazione di alimentare l’organizzazione che finisce per essere autoreferenziale. Devo riconoscere che, con una certa audacia, già quando Arché muoveva i suoi primi passi, ci ripetevamo come un ritornello che quanto andavamo facendo doveva essere pensato e vissuto perché un giorno non ci dovesse essere più bisogno di noi.
Utopia, perché nel mondo le ingiustizie ci saranno sempre, ma al tempo stesso le parole di papa Francesco continuano ad essere una bussola che ci preserva dal creare dipendenza nelle persone accolte, dall’ambizione di dover diventare chissà che cosa e dal delirio di dover esserci a ogni costo. Per non “perdere la testa” papa Francesco ci ha suggerito la necessità di guardare sempre i volti: «E allora, in questa logica, in principio ci sono i volti: per voi sono i volti di quelle mamme e di quei bambini che avete accolto e aiutato a liberarsi dai lacci della violenza, del maltrattamento. Anche donne migranti che portano nella loro carne esperienze drammatiche».
Crediamo che ognuno di noi venga al mondo con una missione, quella di lasciare questa terra migliore di come l’ha trovata; ma non solo: ci assumiamo anche la responsabilità di non lasciare indietro chi pensa di non avere niente di buono da donare. Perché ciascuna persona, qualsiasi sia la sua ferita o la sua colpa, ha un dono da condividere.
Grazie papa Francesco: anche noi, insieme a te, «sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!» (Fratelli tutti, 8).

Non basta difendere i diritti, occorre adoperarsi per rispondere ai bisogni
Sono 115 anni che cerchiamo di fare la nostra parte al fianco delle persone con disabilità. Spesso penso a quanta profezia c’era nell’entusiasmo ma anche nella fatica del nostro fondatore Ernest Christoffel ad accogliere bambini ciechi e con disabilità. Era il lontano 1908. Un pensiero che è riemerso forte lo scorso 3 dicembre — Giornata Internazionale delle persone con disabilità — quando ho incontrato papa Francesco in Vaticano. La comprensione di questa dimensione profetica e carismatica mi ha richiamato ancora una volta alle nostre responsabilità di oggi sostenuta dalle parole del Papa


quando ricorda che siamo chiamati a «trasformare l’indifferenza in prossimità e vicinanza». E poi ancora: «Non basta difendere i diritti delle persone; occorre adoperarsi per rispondere anche ai loro bisogni esistenziali, nelle diverse dimensioni, corporea, psichica, sociale e spirituale». Come non pensare allora all’impegno quotidiano di noi di Cbm in difesa dei diritti delle persone con disabilità ma anche al nostro fare concreto nel cercare di dare risposta ai tanti bisogni. Un’operazione di cataratta a chi vive nel buio della cecità. Una protesi per quella gamba amputata a causa di una infezione. Un piatto di cibo per chi non mangia da giorni perché persona povera e disabile. Un lavoro che permetta di mantenersi assieme alla propria famiglia pur essendo su una carrozzina. Un banco di scuola per un bambino cieco. Ma mi accorgo così, richiamato dalle parole di Francesco, di quanto lavoro ancora c’è e ci sarà da fare per «generare e sostenere comunità inclusive (…), eliminare ogni discriminazione e soddisfare concretamente l’esigenza di ogni persona di sentirsi riconosciuta e di sentirsi parte. Non c’è inclusione, infatti, se manca l’esperienza della fraternità e della comunione reciproca».
Parole quelle di papa Francesco che evocano uno spirito di speranza sul solco dell’impegno concreto. Ecco cosa mi è entrato dentro, in profondità, incontrandolo. Un padre sapiente guidato dallo Spirito, certo provato dalla fatica dell’essere sempre a servizio, dalle prove fisiche imposte dalla vecchiaia eppure sempre capace di una «profezia concreta» che lui riesce a trasmettere con fermezza, con forza ma anche con tanta tenerezza. E con l’esempio. Come un padre.
Ho avuto la sensazione
incontrare
amico, una persona semplice e cara
Nel dicembre 2016 ho incontrato il Santo Padre in Vaticano. Mentre mi avvicinavo per parlargli e stringergli la mano, avevo la sensazione di incontrare un amico, una persona cara. La grandezza di papa Francesco sta proprio in questa sua capacità di porsi con semplicità ed immediatezza. Un uomo fra gli uomini, un uomo fra noi. Mi ha esortata a continuare a portare avanti l’impegno a favore delle persone migranti lanciando una riflessione sulle parole, le speranze e le azioni concrete che ci aiutano a custodire la nostra umanità e a contrastare l’indifferenza. Da quel giorno non ho mai smesso di pensare che non possiamo ignorare il dolore di chi scappa da situazioni di violenza, persecuzioni e fame. L’incontro con il Papa mi ha fatta interrogare a lungo su come si può accettare che altre creature — fatte ad immagine e somiglianza di Dio come noi — vengano torturate e umiliate perché sono nate nella parte sbagliata del mondo. Dopo l’incontro la nostra determinazione è stata sempre più forte. E ancora una volta, seguendo l’appello di papa Francesco che dopo l’esodo dei Rohingya del 2017 invitava tutti a non dimenticare la sofferenza di questa comunità storicamente perseguitata, abbiamo avviato con Moas (Migrant Offshore Aid Station) una missione per curare le persone che più ne avevano bisogno nei campi profughi del Bangladesh.
Se serve bisogna cambiare anche le abitudini più
granitiche: il “si è sempre fatto così”
regge
di don Daniel Antúnez presidente Missioni Don Bosco
Ho avuto la fortuna di conoscerlo quando era arcivescovo di Buenos Aires e vivevo lì con i salesiani; l’ho poi incontrato da Papa grazie all’associazione di cui sono presidente. In questi dieci anni lo avverto più carico di saggezza. Certo, il suo ruolo lo porta ad avere una visione elevata, ma è lui che è così. Si esprime con il senso di incarnazione nella realtà, nella vita. Per il nostro impegno la conferma maggiore che viene da lui è quella di rimanere decisamente a fianco dei giovani più poveri, con coloro che hanno bisogno. È la scelta della congregazione salesiana, fin dalle origini nei cortili di Torino e oggi — attraverso i missionari — nelle periferie del mondo. Il richiamo continuo di Francesco a «non dimenticare» i poveri ci fa molto bene: sai già che questi debbono essere privilegiati secondo Gesù, e il suo pensiero ti dà la forza, ti spinge ad affrontare nuove sfide. Da soli talvolta ci interroghiamo: è questa la strada giusta? L’insistenza del Papa ci incoraggia a dare sempre risposta positiva a questa domanda, ci fa sentire sul binario giusto. Questo è sul piano dell’azione quotidiana. Ma anche su quello della prossimità papa Francesco ci sta insegnando molto. Lui si approccia ai problemi e alle gioie di tutte le persone: veramente è capace di toccare il cuore. Il suo è l’invito ad aprire le finestre. Non si aggrappa al “si è sempre fatto così, dunque continuiamo”: quando è necessario si cambiano anche le abitudini più granitiche.
«La carità rende felici», così ci ha indicato la strada per diffondere la cultura del dono consapevole di Flavia Petrin presidente Aido
Per noi è difficile riassumere in poche righe come la figura del Papa “venuto dalla fine del mondo” abbia scosso le nostre coscienze e influenzato il nostro agire nel corso di questo decennio. Ci piace ricordare il pontefice come una figura che in più occasioni si è espressa favorevolmente alla donazione di organi, ribadendo la necessità di una scelta consapevole in vita da parte del donatore. Dal canto nostro crediamo che Aido rappresenti la somma dei valori di solidarietà, fraternità e altruismo verso il prossimo ben esplicitati nel messaggio cristiano ma validi anche per i non credenti, come ricordato dal Papa nel corso dell’udienza del 13 aprile 2019 alla Sala Clementina del Palazzo Apostolico. In quell’occasione una folta rappresentanza di volontari (ben 400 persone provenienti da tutta Italia) e i vertici dell’associazione furono ricevuti da Francesco che ricordò l’importanza della donazione quale «espressione della fraternità universale che lega tra loro tutti gli uomini e le donne». Donare, ci spiegò il Papa, non è solo una necessità sociale per chi non ha più altre possibilità di cura, un gesto che si esaurisce nella sua utilità hic et nunc, ma «un’esperienza profondamente umana e carica di amore» in quanto «ciascuno di noi realizza se stesso anche attraverso la partecipazione alla realizzazione del bene altrui». La donazione significa guardare e andare oltre i propri bisogni individuali e aprirsi con generosità,
tenendo sempre a mente che ciascuno di noi potrebbe aver bisogno di un trapianto. Un messaggio che il Santo Padre ha espresso più volte nel corso del suo pontificato: respingere i veleni dell’individualismo e dell’indifferenza, superare la logica dell’Io per abbracciare quella del Noi. Aido ha accolto con riconoscenza le parole del Papa. Continueremo nella strada della sensibilizzazione e della diffusione della cultura del dono affinché la scelta consapevole della donazione sia condivisa da sempre più persone.
Già allora papa Francesco con le sue parole ci diede tanta forza. Disse che i veri cristiani si vedono quando accolgono gli ultimi. Ci diede quella benedizione che poi ci ha portati a fare del tema dell’accoglienza il motivo portante della nostra vita. Oseremmo dire un motivo per cui vale la pena vivere, perché accogliere gli ultimi, fare la carità, è una cosa che ci rende felici.
Fondamentale quando ha spinto le coppie ad assumersi il rischio dell’adozione
di Marco Griffini presidente Aibi
Per Aibi (Amici dei Bambini) la figura del Papa è da sempre un riferimento fondamentale. Basti pensare che fu dopo aver ascoltato le parole di papa Giovanni Paolo II durante un Angelus, in una domenica del febbraio 1993, che decidemmo di partire (due giorni dopo!) per i Balcani, a portare aiuto ai cosiddetti “figli dell’odio”. Il pontificato di oapa Francesco non è stato diverso. Anzi, il suo schierarsi sempre dalla parte dei più deboli, il suo richiamo costante contro l’imperante
“cultura dello scarto” sono stati per noi uno stimolo costante ad agire. D’altra parte, che azione può andare maggiormente in questa direzione se non quella di impegnarsi per dare una famiglia ai bambini abbandonati, vero simbolo di questa “cultura dello scarto” che contraddistingue la società di oggi? Proprio nella prima udienza generale del 2022 papa Francesco ha dedicato parole importanti verso l’adozione, indicata «tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità», e ha spronato le coppie a «non avere paura di scegliere la via dell’adozione, di assumere il “rischio” dell’accoglienza». Ma anche sul versante della cooperazione i richiami di papa Francesco hanno risuonato quasi all’unisono con ciò che Aibi si stava impegnando a fare. Bergoglio è stato l’unico leader del mondo, per esempio, a tenere sempre accesa l’attenzione, nel disinteresse generale, verso la Siria, dove siamo una delle poche ong che era ed è presente nel dimenticato nord ovest del Paese. Lo stesso ha fatto per l’Ucraina o, per citare proprio il suo più recente viaggio, in Repubblica Democratica del Congo: in tutti questi casi le parole del Papa sono state per Aibi motivo di conforto, condivisione e stimolo per andare avanti nonostante le continue e sempre crescenti difficoltà.
Il nostro lavoro non è una buona azione, ma la realizzazione delle radici solidali europee
di Giovanni Bruno presidente Fondaz. Banco Alimentare
Impossibile per noi dimenticare le due udienze con papa Francesco, nel 2015 e nel 2019, che hanno segnato la storia recente del Banco Alimentare. La prima
per il nostro 25ennale, in aula Nervi con oltre 7mila partecipanti da tutta Italia, e la seconda, per il 30ennale, in occasione dell’incontro annuale dei rappresentanti dei Banchi Alimentari della Feba, la Federazione Europea dei Banchi Alimentari convocata a Roma e che il Papa ha voluto incontrare ad uno a uno. Entrambi i momenti sono stati occasione di rinnovare la consapevolezza che davvero è la gratitudine che genera operosità. Gratitudine che nasce dalla consapevolezza che nulla ci appartiene e tutto ci è dato: noi stessi, ciò che abbiamo, gli altri: «Voi siete quotidianamente impegnati sul fronte della povertà. In particolare, la vostra preoccupazione è quella di contrastare lo spreco di cibo, recuperarlo e distribuirlo alle famiglie in difficoltà e alle persone indigenti…La fame oggi ha assunto le dimensioni di un vero “scandalo…”». È stato fondamentale l’essere richiamati dalle parole del Papa sull’origine, sul perché, sul “per chi” della nostra opera! Il rischio, sempre, dopo anni di attività è quello di concentrarsi sul fare sempre di più e sempre meglio la propria attività, cercare di recuperare e distribuire più alimenti possibile, restringendo la visuale agli aspetti organizzativi. Oppure di richiamarsi costantemente all’ispirazione originaria senza preoccuparsi di fare sempre “il meglio possibile”, quasi le due dimensioni confliggessero inevitabilmente. E invece: «Nel mondo complesso di oggi è importante che il bene sia fatto bene: non può essere frutto di pura improvvisazione, necessita di intelligenza, progettualità e continuità. Ha bisogno di una visione d’insieme e di persone che stiano insieme: è difficile fare il bene senza volersi bene». E ancora il rischio di considerare il lavoro “una buona azione”, un impeto morale che riguarda il singolo con poca coscienza del valore per la società tutta: «Le vostre realtà ci riportano alle radici solidali dell’Europa, perché ricercano l’unità nel bene concreto: è bello vedere lingue, credo, tradizioni e orientamenti diversi ritrovarsi non per condividere i propri interessi, ma per provvedere alla dignità degli altri».
di Loris Cavalletti presidente nazionale Anteas
Ho incontrato papa Francesco nel 2020 a un simposio sul ruolo degli anziani nel mondo. Sono stato colpito dalla novità della sua riflessione sulla visione della terza età e del suo collocamento nella società: una novità culturale, di paradigma. Ancora, mi ha fortemente impressionato la sua esplicita condanna della politica dello scarto che l’occidente riserva agli anziani, a quelli non autosufficienti in particolare, invocando, viceversa, una collaborazione tra giovani e vecchi. Partendo da quell’incontro, ho avviato una riflessione sul suo magistero e, oggi, penso sia del tutto inutile chiedersi se il suo pensiero sia marxista o post marxista o di destra o di sinistra. Egli è al contempo radicalmente tradizionalista e radicalmente cosmopolita, non collocandosi mai agli estremi, ma abbracciandoli entrambi come lui stesso dichiara: «Se vogliamo provare a dare un contributo alla nostra Patria, non possiamo perdere di vista nessuno dei due poli: quello utopico e quello realistico, perché sono entrambi parte integrante della creatività storica». Dalla suggestione provocatami da papa Francesco è quindi nata in me l’idea di mettere al centro dell’azione di Anteas tre parole: bellezza, cura e giovani. La bellezza è in grado di creare comunione perché unisce Dio, l’Uomo e il Creato in un’unica sinfonia. Il mondo ha bisogno di bellezza perché ci eleva, ci nobilita, ci spinge ad andare oltre. La cura stessa ha bisogno di bellezza perché, come scriveva Platone unisce
i due concetti di bello e di bontà: «La potenza del bene si è rifugiata nella natura del bello». E tutto ciò ci fa trasmettere ai giovani un concetto di bellezza tale da destare stupore, da cui potrà scaturire l’entusiasmo di cui il mondo ha bisogno per costruire il futuro e superare le sfide cruciali che si annunciano all’orizzonte.
Grazie papa Francesco per questa nuova visione che sostiene nei nostri volontari la forza di alzarsi dal divano e uscire di casa per incontrare donne e uomini che hanno bisogno e a cui tendiamo la mano per camminare insieme. È così che si costruisce “la comunità” composta da noi e da chi aiutiamo, per poi scoprire che tutti siamo una risorsa, tutti siamo volontari attivi.
Ci ha richiamati alla necessità di essere gioiosi e “pazzi di amore” verso tutti gli uomini
di Roberta Vincini e Francesco Scoppola presidenti comitato nazionale Agesci
Lo scorso 11 ottobre come presidenti del Comitato nazionale dell’Associazione
Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci) eravamo nella Basilica di San Pietro per celebrare il 60esimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II. Non solo una ricorrenza, ma un’occasione di comunione. Queste le indimenticabili parole del Papa: «Una chiesa abitata dalla gioia se non gioisce smentisce se stessa, perché dimentica l’amore che l’ha creata. Riscopriamo il Concilio per ridare il primato a Dio, all’essenziale: a una Chiesa che sia pazza di amore per il suo Signore e per tutti gli uomini, da Lui amati; a una Chiesa che sia ricca di Gesù e povera di mezzi; a una
Chiesa che sia libera e liberante». Riconosciamo la nostra associazione in queste parole di papa Francesco, in questa gioia del legame a Cristo nella comunione ecclesiale, che egli ci indica come essenziale. Una via maestra che, come guide e scout dell’Agesci, ci impegniamo tutti i giorni a percorrere con il servizio nei nostri territori.
L’accoglienza dei
di Agostino Sella presidente Associazione Don Bosco 2000
Abbiamo incontrato papa
Francesco il 20 gennaio
2014 durante la sua visita ai salesiani nella Parrocchia Sacro Cuore di Roma vicino alla Stazione Termini, luogo già allora dedicato all’accoglienza di senza tetto e migranti. Proprio per questo papa
Francesco l’aveva scelto. Ci ha colpito la sua scelta di visitare le periferie, perché anche noi come associazione accogliamo i giovani della periferia del mondo, interessandoci degli ultimi e dando sostegno ai più poveri e abbandonati, come voleva Don Bosco. Allora eravamo all’inizio della nostra storia di accoglienza con i migranti, iniziata nel 2011, e già a quei tempi si vivevano grandi difficoltà poiché non tutti comprendevano il tema dell’accoglienza. Si avvertiva già un’Italia in cui aiutare il prossimo, accoglierlo, ti metteva — e ancora oggi è così — contro gran parte della popolazione. Molte persone purtroppo percepiscono lo straniero come colui che ci toglie qualcosa, il lavoro, i nostri privilegi. Il giorno della visita del Papa a Roma era una domenica pomeriggio, e noi ci siamo sentiti chiamati ad essere presenti a questo momento. Durante la visita ci siamo presentati e abbiamo raccontato delle nostre realtà, gli abbiamo spiegato che venivamo dalla Sicilia e l’abbiamo invitato a venirci a trovare. Un desiderio che si è avverato dopo qualche anno, quando il Santo Padre ha visitato Piazza Armerina e Palermo, in occasione del 25° anniversario della morte del Beato Pino Puglisi. Quando è venuto a Piazza Armerina non ha visitato i nostri centri, ma abbiamo fatto in modo che uno dei nostri ragazzi lo incontrasse. Già allora papa Francesco con le sue parole ci diede tanta forza. Disse che i veri cristiani

si vedono quando accolgono gli ultimi. Ci diede quella benedizione che poi ci ha portati a fare del tema dell’accoglienza il motivo portante della nostra vita. Oseremmo dire un motivo per cui vale la pena vivere, perché accogliere, fare la carità, rende felici
Il benessere delle persone come indicatore e obiettivo costante di ogni nostra scelta quotidiana
Un’esperienza determinante e arricchente l’incontro con papa Francesco dello scorso gennaio che ho avuto il privilegio di vivere insieme ad alcuni operatori sociali e famiglie ospiti delle Case Ronald. Questo momento, avvenuto grazie ad Assifero, ha avuto per me un grande significato perché ha permesso, ancora una volta, di ricordarmi i sentimenti e i valori che animano la missione di Fondazione Ronald McDonald. Porto con me l’invito del Papa ad ascoltare le comunità locali e i bisogni delle persone, il loro benessere come costante obiettivo e indicatore di ogni scelta quotidiana. La nostra organizzazione, commossa e in ascolto delle parole del Papa, con rinnovato impegno e vigore continua il lavoro nelle comunità dove già si trova ad operare, dove le Case Ronald sono presenti e attive nell’accoglienza, nel volontariato e nell’ascolto dei bisogni degli ospedali e delle città. Inoltre, papa Francesco ha ricordato l’importanza di uno sviluppo dell’individuo: che sia una mamma accolta, un volontario o un educatore, la fondazione si impegna nel valorizzare i talenti e potenziarli attraverso formazione e risposte ai bisogni dell’individuo.
Fra i primi 100 Ets per raccolta del 5 per mille, sei su 10 redigono un bilancio di impatto. È il dato che emerge dalla ricerca Milano School Management con Vita
di ANTONIETTA NEMBRI
Gli enti del Terzo settore che nel 2022 hanno pubblicato il loro bilancio sociale sono in crescita.
Tra i primi 100 enti di Terzo settore — Ets (nel quadriennio 2018-2021) per raccolta del 5 per mille, sono stati il 57,5%. A dirlo la seconda ricerca, realizzata da Vita e dalla Milano School of Management — Misom dell’Università di Milano, che è stata presentata nel corso dell’incontro La rendicontazione sociale degli enti del Terzo settore, tenutasi lo scorso 8 febbraio a Milano, nella sede della Fondazione Università di Milano.
Questa seconda edizione dello studio, oltre ad analizzare i contenuti dei bilanci sociali come definiti dal Decreto ministeriale 4 luglio 2019 ha potuto anche verificare la dinamica temporale dell’aderenza alle linee guida indicate dallo stesso decreto per l’intero quadriennio, nonché verificare come gli Ets che da più anni presentano la rendicontazione sociale delle proprie attività (experienced reporter) abbiano percentuali più alte, per esempio, nell’applicazione della misurazione degli impatti sociali (45,8% contro il 37,9% generale) o nell’andamento numerico dei propri beneficia-
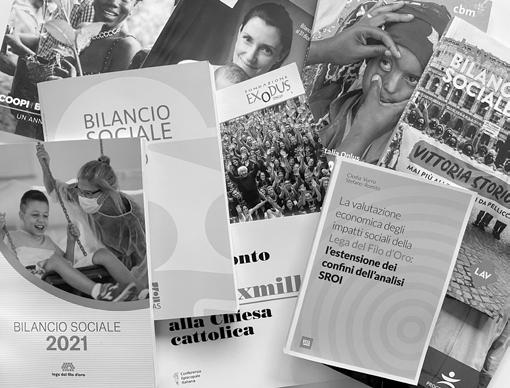
ri (44,2% contro il 40%). A sottolineare come nel confronto tra gli experienced reporter e tutti gli altri Ets i primi mostrino trend di crescita e di performance percentualmente migliori è stato nella sua illustrazione dei dati Stefano Romito, ricercatore del Misom. Romito ha anche sottolineato la crescita generale della capacità di dettagliare le informazioni.
Nel 2018, per esempio, le informazioni relative alle retribuzioni del personale dell’Ets erano dettagliate solo nel 8,9% dei casi mentre nell’ultimo
Alcuni bilanci sociali di organizzazioni di Terzo settore
anno analizzato il dato era presente nel 58,5% dei documenti.
In crescita anche l’attenzione al monitoraggio della soddisfazione dei dipendenti che segna un +12,8 punti percentuali.
Resta ancora limitata la misurazione dei risultati e la valutazione degli impatti sociali, anche se «il dato è in crescita nel quadriennio (37,9% partendo dal 17,9 del 2018) e tuttavia», ha precisato il ricercatore «nel 37,9% del
Bilancio sociale
Enti di Terzo settore che hanno pubblicato il Bilancio sociale nel 2022 (anno fiscale 2021) sul totale dei 100 con maggiore raccolta di 5 per mille negli anni 2018-2021
Ets che forniscono il numero dei beneficiari
Informazioni sulla retribuzione dei dipendenti (era 8,9% nel 2018)
Enti e analisi di materialità*
La quasi totolità ha coinvolto gli
campione che riporta di aver svolto la valutazione troviamo specificata la tecnica di valutazione utilizzata solo nel 20% dei casi».
Anche sul fronte del feedback dai beneficiari dell’attività dell’Ets la raccolta di questo dato è fatta solo dal 22,7% del totale. Per quanto riguarda gli obiettivi quasi 7 enti su 10 (il 69,7%) fa riferimento a un documento di pianificazione strategia «un dato in forte crescita nell’ultimo anno», ha chiosato Romito sottolineando gli oltre 19 punti di crescita.
Le organizzazioni che fanno ricorso al volontariato dedicano a esso quasi sempre una sezione ad hoc del proprio bilancio, ma avverte Romito «dovrebbe far riflettere un dato: si sono ridotte rispetto allo scorso anno le organizzazioni che segnalano la soddisfazione dei volontari».
Per quanto riguarda il personale degli Ets — sezione presente nella quasi totalità dei documenti analizzati — vengono riportati da oltre il 90% i dati relativi alla composizione della forza lavoro e il genere, mentre altre informazioni quali l’andamento pluriennale sulla variazione della forza lavoro stessa è limitato a circa la metà dei rendiconti come per le retribuzioni dei lavoratori, anche se si osserva nel quadriennio un aumento esponen-
Misurazione dei risultati
Valutazione dell’impatto sociale
Grado di raggiungimento degli obiettivi
La studiosa: «Dare i numeri per imparare a migliorarsi»

La seconda edizione della ricerca quantitativa permette di leggere più approfonditamente l’aderenza dei bilanci sociali alle linee guida del Dm 4 luglio 2019, entrate pienamente a regime nel 2021. La professoressa Clodia Vurro, coordinatrice, nel sottolineare il miglioramento dei dati forniti spiega: «Una ragione banale è il fatto che l’entrata in vigore del Dm ha obbigato gli enti a estendere l’ampiezza della rendicontazione, approfondendo temi legati ai contenuti richiesti dal decreto».
Poco più della metà degli Ets pubblicano la valutazione d’impatto. «È sicuramente un tema su cui migliorare. Molti citano di aver fatto la valutazione senza specificare l’approccio e comunque su specifici progetti. È un tema di sperimentazione, non c’è ancora uno standard e fare ricorso al Social Return on Investment - Sroi è una delle modalità, ma non l’unica».
Lei ha definito il bilancio sociale un percorso…
«Sempre più enti capiscono che questo documento innesca un processo di miglioramento e consapevolezza interna. Tale percorso apporta benefici quanto più è trasversale rispetto alle diverse aree dell’ente e multisciplinare. È attraverso il confronto con gli stakeholder che il bilacio sociale diviene uno strumento di gestione».
Come valuta la scarsa attenzione al tema ambientale?
«È un’area da sviluppare. Per molti enti la responsabilità ambientale è legata solo all’efficientamento energetico e all’utilizzo dell’energia. È sicuramente uno degli aspetti che necessitano di maggior attenzione in futuro».
ziale degli enti che danno informazioni su quest’ultimo punto, passati da poco meno del 10 per cento al 58,5%. In generale su questo capitolo si può osservare la crescita dell’attenzione verso il benessere dei propri dipendenti.
Per quanto riguarda l’analisi di materialità, ovvero la coerenza fra gli scopi dell’ente e le aspettative degli stakeholder (come si può vedere nella tabella di pagina precedente), il dato è in crescita di oltre 10 punti rispetto all’anno precedente e in questa azione quasi tutti hanno indicato di aver coinvolto gli stakeholder nella definizione e valutazione dei temi rilevanti. Nell’illustrazione dei dati emerge infine, il tema della responsabilità ambientale per la quale, rimarca Romito «c’è pochissima attenzione nei documenti. Non è una policy diffusa nonostante oggi sia un tema molto sensibile».
Non solo un adempimento
Nel corso della presentazione dello scorso febbraio Clodia Vurro, coordinatrice dell’Area sostenibilità e Terzo settore Misom e curatrice della ricerca ha richiamato l’attenzione sull’essere il bilancio sociale un percorso virtuoso.
«Si è potuto osservare in molti casi come si stia passando da una mera attenzione alla conformità del bilancio sociale alle richieste della norma al comprendere come la rendicontazione sia un vero e proprio processo di gestione, un’opportunità» ha sottolineato Vurro, «per innescare un percorso di consapevolezza da parte dell’ente del proprio ruolo e della propria capacità di gestire le risorse».
Il bilancio sociale in quest’ottica di rendicontazione diviene uno strumento trasversale per definire gli obiettivi e relazionare i risultati, ma anche per comunicare la propria azione agli stakeholder interni ed esterni.
Dai primi dati della ricerca del resto emerge come gli enti che si sono dotati di un sistema di gestione — come i vari Iso — (meno del 30% del campione analizzato) abbiano risultati più performanti nelle diverse aree del bilancio sociale: dalla descrizione di obiettivi e attività ai diversi aspetti relativi a dipendenti e volontari.
La ricerca può essere richiesta a vita@vita.it
sustainability Lab con Dynamo Academy
su Esg e Corporate social investment
Passare dal dire al fare. Mostrando l’azione concreta delle imprese italiane sotto il profilo della sostenibilità sociale e dei principi Esg. Con uno sguardo e un paragone a quanto succede fuori dall’Italia. È questo l’intento con cui Dynamo Academy e Sda Bocconi sustainability lab hanno presentato i risultati della ricerca Corporate social investment e Esg – Global impact at scale, giunta alla quinta edizione.
Il campione utilizzato dalla ricerca include 213 grandi aziende italiane, con fatturati superiore ai 50 milioni di euro e che effettuano la rendicontazione non finanziaria — Dnf, seguendo lo standard di rendicontazione Global reporting initiative — Gri. Emergono numeri molto interessanti sullo stato dell’arte dell’impegno verso la comunità e il territorio. E una “esse” che così diventa sempre più rivolta verso l’esterno. Senza con ciò trascurare la comunità aziendale.
imprese italiane, considera comunità e territorio come effettivi stakeholder di riferimento e contribuisce con donazioni in denaro, beni e servizi o progetti e partnership che generano valore.
Gli investimenti complessivi del campione sono pari a 635 milioni di euro, con valore aggiunto medio distribuito per comunità e territorio per azienda pari a 3,27 milioni, investendo il 2,7% del proprio utile ante imposte. Si tratta, spiega la ricerca, di valore economico direttamente generato e distribuito, e in particolare include contributi ad associazioni, ong e istituti di ricerca, fondi a sostegno delle infrastrutture per la comunità, costi diretti dei programmi sociali, inclusi eventi artistici e educativi.
«Si afferma sempre più un modello di filantropia attiva che vede nelle organizzazioni sociali partner attivi da coinvolgere e supportare, al fine di co-creare valore e generare un cambiamento duraturo nel modus operandi», spiega Francesco Perrini , direttore del Sustainability lab. «L’obiettivo», spiega il professore, «più in generale, è di comprendere quali sono le maggiori opportunità per le imprese per creare valore sostenibile sempre più concreto, misurabile e rendicontabile. Ciò in linea con il concetto di transformative sustainability: nella transizione in corso le imprese innovano i propri modelli di business sempre più sostenibili, con un approccio integrato alla strategia, al fine di massimizzare le opportunità che possono creare valore».
In media le imprese considerate impegnano in Esg il 2,7% del proprio utile ante imposta
Da questo punto di vista, il 78% delle imprese considerate dal campione preso in esame, indicativo delle medie
«Questa ricerca», gli fa eco Serena Porcari , presidente e ceo di Dynamo Academy, «consente una fotografia del nostro Paese e un confronto con l’indagine internazionale Cecp. Il benchmark dà indicazioni alle imprese italiane per incrementare l’impatto nelle comunità. Un’indicazione riguarda la necessità del reporting della “esse”, sia per trovare metriche condivise sia per valorizzare le azioni messe in campo. L’altro aspetto», conclude Porcari, «è l’opportunità di lavorare su diversity, equity e inclusion, con azioni concrete nelle aziende»
“Respira”, il progetto che investe su realtà costituite in forma cooperativa
Un nuovo e funzionale modello di coinvolgimento dei cittadini in progetti “energetici” sono le comunità energetiche, in grado di riportare le persone e le comunità al centro dei processi produttivi, generando benefici di carattere economico, restituendo risorse ai territori, con la possibilità di partecipare attivamente alla transizione energetica. È questa la visione alla base del progetto “Respira” lanciato da Coopfond insieme a Legacoop, Banca Etica ed Ecomill, piattaforma di crowdinvesting per la transizione energetica, con l’obiettivo di creare Comunità Energetiche Rinnovabili in forma cooperativa.
«Un progetto ambizioso che si propone di accompagnare cooperative e gruppi organizzati nella costituzione di una Cer, dall’ideazione del progetto alla formazione e gestione della cooperativa, offrendo una proposta finanziaria integrata, con strumenti appositi e idonei alla creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile in forma cooperativa», spiega Paola Bellotti della direzione Sostenibilità e Sviluppo di Coopfond.
Come opera il modello
Il primo passaggio prevede la presenza di una Energy Service Company (ESco)selezionata tra i partner, che agisce da
Progetto Respira per l’accompagnamento di Cer in forma cooperativa
PROMOTORE: Legacoop
BENEFICIARI: cooperative aderenti a Legacoop
STRUMENTI: equity e debito
VALORE: fino a 3 milioni di euro + premialità di Coopfond
VALUTATORE: Coopfond
MISURAZIONE: Coopfond valuta gli obiettivi misurabili durante l’istruttoria. Procede poi per Kpi anno per anno
Per saperne di più: www.socialimpactagenda.it
soggetto facilitatore e redige lo studio di fattibilità, finanziato per il 50% a fondo perduto da Coopfond. Dopo l’esito positivo dello studio, Coopfond e Legacoop forniscono supporto alla costituzione della comunità energetica in forma cooperativa. Definita la soluzione impiantistica e la struttura organizzativa e statutaria, si procede a una campagna dedicata di equity crowdfunding sul portale Ecomill (per nuovi soci finanziatori e/o soci cooperatori), in cui Coopfond garantisce un pre-commitment equity, mentre Banca Etica fornisce gli strumenti di debito necessari a completare il finanziamento. La ESCo, infine, si occupa di mettere in esercizio tutti gli impianti, gestire le relazioni con il Gse (Gestore servizi energetici), per avere accesso agli incentivi e coordinare tutti gli asset della nuova comunità energetica.
I primi tre interventi
Coopfond assegna una premialità dello 0,5% immediata e una premialità ulteriore fino allo 0,5%, condizionata al raggiungimento dei Kpi(Key performance indicator) previsti in fase di istruttoria e da verificare in fase di monitoraggio ogni anno. Gli obiettivi misurabili possono essere sociali e ambientali e sono negoziati di volta in volta con la cooperativa finanziata durante l’iter istruttorio.

Attualmente Coopfond ha deliberato interventi su tre cooperative (una in Friuli Venezia Giulia, una in Emilia Romagna e una in Campania) impegnate a far nascere una decina di comunità energetiche sui propri territori. La cooperativa Part-Energy è un caso emblematico perché si tratta della prima Cer registrata presso l’autorità di gestione, il Gse, in forma cooperativa, e opera come aggregatore territoriale in Friuli Venezia Giulia di produttori e consumatori di energia da fonte rinnovabile. Le comunità energetiche così aggregate sono plurime e possono beneficiare di un servizio tecnico importante per la canalizzazione degli incentivi, oltre che di un servizio mutualistico e culturale essenziale, tipico delle Cer: trasformare le comunità in gruppi di cittadini consapevoli, attenti, solidali ed efficaci nell’utilizzo dell’energia.
“Respira”, dunque, oltre a essere un progetto ambizioso, è un progetto assolutamente attuale poiché prevede l’applicazione di alcuni principi della finanza di transizione e della finanza a impatto a un settore di attività innovativo e di ampia potenziale crescita nei prossimi anni. Inoltre, mette in campo sia strumenti finanziari sia strumenti tecnici di accompagnamento e costruzione di capacità e competenze.
A partire dal numero di maggio Vita e Social Impact Agenda per l’Italia (Sia) hanno lanciato una serie di dieci focus su progetti d’impresa made in Italy realizzati tramite investimenti a impatto, selezionati e approfonditi da Sia

di ANNA SPENA
Mohammad, 20 anni, ha “sequestrato” Bader, 21. Sono uno davanti all’altra e lui sembra un maestro d’orchestra. Solo che non la dirige durante una riproduzione musicale, ma per scattare una fotografia: «hayaa ‘urid ‘an ‘ansharah ealaa Instagram» (Dai la voglio pubblicare su Instagram).
Ho pensato di andare via dal Libano.
Ma dove? Come?
Con quali soldi?
Mustafa, 24 anni
Mohammad è seduto e si gira di profilo, poi frontale, poi sceglie quello destro e ancora poi torna sul sinistro. E con il dito indica a Bader come posizionare il cellulare: «‘adnaa Bader ‘adnaa» (più in basso Bader, più in basso). Poi cambia idea «la rubama kan sayiyan min qabl» (forse era meglio prima). Mohammad e Ba-
der sono poco più che adolescenti, a loro piacciono le cose normali: i social media, gli amici, l’amore, lo sport. Siamo nella piana di Marjayoûn, nel Sud del Libano, la zona più rurale e sottosviluppata del Paese. Una distesa lenta dove si alternano — fino al confine con Israele, pattugliato dalle forze di Unifil (forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite) — campi profughi siriani, villaggi cristiani e roccaforti di Hezbollah. Mohammad e Bader sono due dei 15 ragazzi tra i 18 e 25 anni che fanno parte del progetto di sport ed educazione nato dalla collaborazione tra Fondazione Avsi e associazione italiana calciatori — Aic. L’iniziativa è partita lo scorso giugno. L’obiettivo era formare 15 giovani ragazzi e ragazze libanesi per farli diventate a loro volta allenatori dei minori siriani e libanesi che vivono nella piana di Marjayoûn. Ma l’attività ri-
entra in un programma molto più ampio di sostegno a distanza che Fondazione Avsi porta avanti in Libano da diversi anni, oggi sono 1.300 i minori sostenuti. Mohammad e Bader sono due ragazzi normali: i social media, gli amici, l’amore, lo sport, ma ad essere cambiato è il Paese in cui vivono. E quindi i progetti, i viaggi, il futuro vanno posticipati. Non il Libano ma la crisi abissale e dimenticata che lo sta attraversando, gli sta togliendo ogni possibilità. Ma i desideri, quelli no.
Il Libano al collasso
Una volta il Libano era chiamato la Svizzera del Medio Oriente. Le cose hanno iniziato a cambiare con la guerra civile tra il 1975 e il 1990, e poi il conflitto con Israele nel 2006. Sono cambiate con l’arrivo di un milione e mezzo di profughi siriani su una popolazione di 4 milioni di abitanti, e le stime sono la prima al ribasso, perché i profughi non vengono più registrati dall’Unhcr, e la seconda al rialzo perché l’ultimo censimento della popolazione libanese risale al 1932. La situazione è precipitata, quasi fino al collasso, nell’ottobre del 2019 quando sono partire le proteste di piazza in risposta all’incapacità del governo di trovare soluzioni alla crisi econo -
IL PROGETTO DI AVSI E AIC PER I GIOVANI LIBANESI
L’attività di sport ed educazione è un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Avsi e associazione italiana calciatori
Aic. Sono stati formati 15 giovani libanesi per diventare allenatori di calcio dei minori libanesi e siriani che vivono nella piana di Marjayoûn

mica. La pandemia di Coronavirus e l’esplosione al porto di Beirut nell’agosto del 2020 hanno dato il colpo di grazia. Il Libano ormai è un Paese che non respira più e dalle luci spente. L’elettricità non c’è, esistono dei generatori per chi può permetterseli, ma chi prima aveva i soldi per comprare il fuel adesso non ce li ha più. Le banche rimangono chiuse per settimane, impossibile prelevare. I conti aperti prima del 2019 sono stati tutti bloccati. Se sei malato ti puoi curare solo se sei molto ricco, altrimenti nelle cliniche non ti fanno neanche entrare. Anche le scuole scioperano spesso, lo stipendio medio di un insegnante è di 90 dollari al mese. E tutti i libanesi controllano spasmodici sui loro cellulari l’applicazione “Lira Exchange”, la moneta locale ormai è carta straccia e l’inflazione è schizzata alle stelle.
I giovani nel limbo
«Io sono un ingegnere», dice Mustafa, 24 anni, «ma non c’è nessun lavoro per me. Ho pensato di andare via. Ma dove? Come? Con quali soldi?». Mustafa è contento di essere diventato allenatore: «Dobbiamo puntare sui bambini», dice. «Libanesi, siriani, non ha importanza, basta puntare su di loro». Badar invece ha un grande desiderio: «Andare all’estero e trovare un buon lavoro: vorrei studiare risorse umane». Mohammad Fayad ancora dice: «Io avevo studiato letteratura araba. Poi ho lasciato quella strada perché mi sono detto: “Ma che lavoro posso fare qui? Nessuno. Forse solo l’insegnante, ma al momento fare l’insegnante in Libano, dopo il crollo degli stipendi, non è un’opzione”. Eppure mi sarebbe piaciuto lavorare con i bambini, dopo questo progetto ho capito di esserne capace». I ragazzi che
Nella foto di apertura, i formatori con i minori siriani e libanesi.
A sx Bader e due suoi compagni di corso. A dx Mustafa e Hanine nel campo profughi di Mary el Kokh durante l’attività con i minori siriani. In basso i coach dell’Aic Junior nel campo profughi di Amra


I numeri
2019
l’anno in cui i libanesi sono scesi in piazza a protestare contro il governo
4 milioni
i cittadini libanesi (stima al rialzo)
2 milioni
i profughi siriani e palestinesi in Libano (stima al ribasso)
90 dollari
lo stipendio medio di un insegnante
hanno preso parte al progetto «sono giovani che abitano in questa zona del Paese», spiega Alice Boffi, responsabile per Avsi del sostegno a distanza in Libano, Iraq e Giordania. «Sono giovani che hanno voglia di darsi da fare per la loro comunità. Alcuni sono ex bambini del sostegno a distanza, altri fratelli o sorelle di minori che Avsi sta ancora supportando». In Libano i ragazzi stanno smettendo di inseguire i sogni: «Non c’è tempo», dice Rafca, «dobbiamo lavorare per aiutare le nostre famiglia». Hanine lavora ma vorrebbe continuare a studiare: «L’università è a Saida, troppo lontano da qui, non posso chiedere ai miei genitori, ho altre due sorelle che stanno crescendo». Mohammad sorride, ecco che Bader finalmente gli ha scattato la foto che voleva. Lui, come tutti i ragazzi e le ragazze incontrati, chiedono solo una vita normale. Ma normale in Libano è un aggettivo che non esiste più.
In collaborazione con Welf@reIN
We l f@reIN è un’impresa sociale nata nel 2016 con l’obiettivo di promuovere il welfare aziendale in un’ottica mutualistica. Il suo principale ambito d’azione è fornire supporto alle imprese e agli enti del Terzo settore per erogare beni e servizi finalizzati ad accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere e la qualità della vita del lavoratore dipendente e dell’intero nucleo familiare. Con il suo presidente, Francesco Di Palma, parliamo di alcune novità introdotte di recente nella piattaforma.
A cosa mirano i nuovi servizi?
A fornire prestazioni ad alto contenuto sociale. Grazie alla stretta sinergia coi nostri partner, siamo la prima società di welfare in Italia a garantire sulla nostra piattaforma l’accesso ai piani assistenziali della Società nazionale di Mutuo soccorso Cesare Pozzo che, con oltre 350mila assistiti, è la mutua sani-
ANNIVERSARI
taria italiana che mette al centro delle sue attività il benessere del cittadino mediante servizi sanitari integrativi.
Quali i contenuti e le finalità?
I piani assistenziali della Snms Cesare Pozzo hanno l’obiettivo di fornire un supporto economico alle famiglie, non solo per far fronte agli imprevisti, ma anche per garantire un rimborso alle spese sanitarie sostenute per la prevenzione. Inabilità permanente, decesso, riduzione stipendio per malattia o infortunio, visite specialistiche, diagnostica strumentale e di laboratorio, gravidanza a rischio, maternità, ricoveri ospedalieri, day service, ricovero in pronto soccorso, cicli di terapie, sono solo alcuni dei sussidi erogati.
Quali le ragioni della scelta?
In quanto impresa sociale stiamo lavorando affinché Welf@reIN si differenzi dagli operatori for profit per l’elevata sensibilità e attenzione ai bisogni. L’introduzione di
Sassoli un anno dopo, un gesto e un libro per ricordarlo
«David Sassoli ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Unione europea e nell’orizzonte dell’associazionismo post pandemia». Così Acli, Agesci, Azione cattolica, Movimento politico per l’Unità (Focolarini) che il 16 febbraio scorso hanno ricordato a Roma il presidente del Parlamento europeo, scomparso un anno fa. Presentato anche il libro La saggezza e l’audacia (Feltrinelli), in cui Claudio Sardo ha raccolto 56 discorsi politici di Sassoli e che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha voluto prefare. Fra gli interventi Emiliano Manfredonia (Acli), Roberta Vincini e Francesco Scoppola (Agesci), Giuseppe Notarstefano (Ac) e Argia Valeria Albanese (Mppu).
nuovi servizi di welfare rappresenta solo una parte dello sforzo per la valorizzazione sociale delle nostre attività. Grazie anche alla collaborazione con DoubleYou del gruppo Zucchetti e alla cooperazione con la Snms Cesare Pozzo, siamo in grado di offrire la migliore soluzione alle imprese e rispondere alle richieste dei lavoratori.
Quali affinità hanno Cesare Pozzo e Welf@reIN?
Riteniamo che la promozione di piani di welfare aziendali diretti al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie sia strettamente collegata agli scopi mutualistici e solidaristici delle società di mutuo soccorso che, come risaputo, mirano ad aiutare le persone in situazione di disagio sociale ed economico. Un welfare aziendale evoluto e di alto impatto sociale può rappresentare un aiuto concreto per i lavoratori dipendenti in questo particolare periodo storico.
COMITATO EDITORIALE
Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Eos, nuovi ingressi
Continua a crescere la famiglia di Vita: hanno fatto ingresso nel Comitato editoriale, la Fondazione Edoardo Garrone di Genova e la Fondazione EosEdison orizzonte sociale di Milano. La prima, diretta da Francesca Campora, è nata nel 2004 per volontà di Riccardo Garrone, come evoluzione dell’impegno filantropico delle famiglie Garrone e Mondini. La seconda, diretta da Francesca Magliulo, è stata istuita nel 2021 dal gruppo energetico Edison «come attore abilitatore del cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile». Con progetti come Appennino (Garrone) e Traiettorie urbane (Eos), si sono segnalate come tra le più innovative della filantropia italiana dell’ultimo periodo.

Due studenti del corso di fomazione di Coopi per diventare financial officer
Occupy Ucraina, la pace possibile è andata in scena a Milano

Coopi dedica una “scuola” a una delle figure più ricercate nel mondo della cooperazione internazionale
Ricercatissima dalle organizzazioni umanitarie, poco conosciuta da chi vuole lavorare nel mondo della cooperazione internazionale. È l’amministratore di progetto, o financial officer, che lavora sempre dal “field”, quindi nel Paese in cui il progetto viene implementato. «L’amministratore di progetto», spiega Gaspare Rinicella, operation advisor dell’ong Coopi, che per l’organizzazione si occupa della sostenibilità economica, «è una figura con competenze tecnico — contabili. È di fatto la persona che traduce in termini finanziari la gestione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi fino alla rendicontazione ai donatori. È lui che si occupa degli acquisti dei materiali, delle relazioni con le banche, del pagamento degli stipendi dello staff locale, delle tasse da versare nel Paese di riferimento, e per questo deve sempre essere aggiornato su leggi e norme». Il background deve essere di tipo finanziario:«Laurea in economia o simili. Poi è necessaria
la conoscenza dell’inglese e del francese. Si parte con uno stipendio iniziale netto mensile di circa 1.500 euro al mese - compreso vitto, alloggio nel Paese in cui si lavora e spese di viaggio. Si può fare carriera, in base all’esperienza accumulata e al tipo di progetto che si gestisce, e arrivare fino ai 5mila euro mensili. E in alcuni casi parliamo di progetti molto complessi che superano il milione di euro». Eppure l’amministratore di progetto latita nel mondo della cooperazione. «Mentre c’è molta offerta per la figura del project manager», spiega Rinicella, «che potrebbe sembrare più stimolante perché vive direttamente nella dimensione del progetto e delle attività, quindi lavora a stretto contatto con i beneficiari, il financial officer rimane dietro le fila, ma senza di lui nessuna attività può partire o svilupparsi». Per avvicinare gli esperti in economia al mondo della cooperazione Coopi ha aperto anche corsi dedicati all’amministratore di progetto. «Dal 2020 a oggi», conclude Rinicella, «abbiamo formato 23 financial officer».
Anna Spena
Dall’invasione russa dell’Ucraina non abbiamo assistito solo al catalogo degli orrori ma anche ad una mobilitazione umanitaria senza precedenti. L’abbiamo raccontata prima sul numero scorso del magazine e poi lo scorso 20 febbraio durante l’evento “Occupy Ucrainala pace possibile”.
La Sala degli Angeli di Milano si è riempita di voci, storie, testimonianze di reti della società civile, associazioni, cittadini ucraini, dissidenti russi. Un evento, cui hanno partecipato oltre 230 persone, nato dalla collaborazione tra Vita, Teatro Oscar — Desidera e Mean — Movimento europeo di azione non violenta. Abbiamo ascoltato la testimonianza di Stefania Battistini, inviata del Tg1, il sottofondo delle sue parole era il suono drammatico delle bombe su Bachmut, nell’oblast’ di Donec’k. Ci siamo collegati con padre Ihor Boyko, rettore del seminario greco-cattolico di Leopoli: «Le facce dei volontari arrivati qui sono state la nostra speranza», ha tenuto a sottolineare. E poi sono intervenuti l’autore e attore Alessandro Bergonzoni e i rappresentanti di alcune delle organizzazioni umanitarie presenti in Ucraina. In chiusura l’incredibile ed emozionante testimonianza di Aleksander Bayanov, giornalista e sociologo, dissidente russo (vd a pag 82): «Dopo numerose minacce a me e alla mia famiglia siamo stati costretti a scappare in Europa, e solo quando siamo stati abbracciati dagli amici italiani abbiamo potuto respirare di nuovo». (A.S.)
di ALEXANDER BAYANOV giornalista dissidente russo
Gli avvenimenti accaduti in questi ultimi mesi in Russia, la decisione del tribunale di liquidare la più antica associazione per i diritti umani, il gruppo Moskovskij Hel’sinskij, l’iscrizione nel registro delle “Organizzazioni indesiderate” del Fondo Andrej Sakharov e il conseguente sfratto dai locali che occupava, così come l’iscrizione nello stesso registro di Medusa, il più popolare tra i portali di informazione indipendenti, che era già stato denunciato come “agente straniero” e l’accesso al cui sito era già stato bloccato dalle autorità (senza dimenticare l’eliminazione di Memorial, che si occupa della memoria storica delle repressioni staliniane, anch’esso inizialmente definito “agente straniero” e cui hanno tolto la sede in modo “illegale”) ci dicono che la società civile in Russia viene, di fatto, soffocata, schiacciata.
Se prima le autorità avevano bisogno di una legittimazione, che ottenevano grazie alle organizzazioni non governative e associazioni, ora, sullo sfondo della guerra in Ucraina, del patriottismo becero e della propaganda, non ne hanno più bisogno. Le maschere sono cadute. Il male allo stato puro ha mostrato il suo vero volto. La paura di perdere il potere muove Putin e chi lo circonda, la paura di trovarsi nel novero dell’indifesa minoranza dei dissidenti muove
Come è potuto
accadere che le organizzazioni
della società civile in Russia, il cui scopo era la difesa dei diritti umani, siano state di fatto silenziosamente
distrutte senza che vi fosse nessuna reazione da parte del popolo?
l’uomo russo, che non capisce ormai più nulla di ciò che sta accadendo. La paura è un’emozione molto potente, attraverso la quale il potere può controllare i propri cittadini, poiché esso sgorga da una solitudine ontologica e dall’apatia. Come è potuto accadere che le organizzazioni della società civile in Russia, il cui scopo era la difesa dei diritti umani, siano state di fatto silenziosamente distrutte senza che vi fosse nessuna reazione da parte del popolo?
La solitudine dell’uomo post sovietico è legata alla perdita della sua soggettività, all’assenza del desiderio di riconoscersi, di prendere coscienza di sé come

persona. Questo processo di distruzione dell’umanità è durato 105 anni, ed è iniziato nel 1917 con la rivoluzione di ottobre. Tre, quattro generazioni hanno vissuto la propria intera vita in una condizione di straniamento da sé. Non stiamo parlando solo dell’assenza di libertà, ma anche della proibizione di godere la vita, di avvicinarsi alla bellezza. Mi ricordo gli ultimi mesi di vita di mio padre. Era già in ospedale e — con il suo benestare — ho invitato un sacerdote mio amico perché lo confessasse e gli portasse l’eucarestia. All’inizio della confessione non sono riuscito ad allontanarmi abbastanza, e ho sentito la risposta di mio padre alla domanda del sacerdote: «Come è trascorsa la tua vita?». Mio padre ha risposto: «Nel grigiore, senza felicità». Sono rimasto basito: come è possibile dire così, come è possibile vivere così? Purtroppo
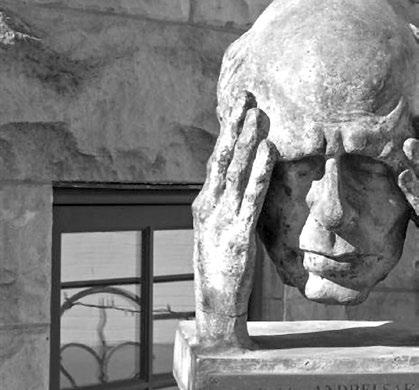
questa posizione resta in Russia quella della maggioranza della popolazione. Il breve ventennio di paradiso consumista non è riuscito a riscaldare e riempire il cuore delle persone. Ma come ha detto una cara amica, anche sotto questo mucchio di pietre il cuore continua a battere, a bussare. Forse i media e la società civile non hanno fatto tutto ciò che avrebbero potuto fare per risvegliare il desiderio nell’uomo post-sovietico. Trovandosi in una sfera intellettuale orgogliosamente chiusa, non sono stati in grado di mostrare e di raccontare alla gente l’autentica libertà del desiderio, che magari anche attraverso gli errori in un modo o nell’altro conduce sempre alla rinascita dell’umano. Lo schiacciamento che attualmente caratterizza la vita in Russia non può essere l’ultima parola: esiste una speranza. Lego questa speranza alla prima generazione post sovietica di giovani, quelli che ora hanno tra i 20 e i 25 anni. Ora si trovano in una condizione molto complessa di pressione da parte del potere. Da un lato sono chiamati ad uccidere, ad andare a combattere, e dall’altro non pensano nemmeno più alla costruzione di una società di tentazioni consumistiche, che copre di nebbia i desideri autentici, primo fra tutti l’esigenza dell’altro, degli uni verso gli altri. Possiamo dunque aspettarci manifestazioni di autentica solidarietà, di protesta sincera contro il male trasmesso dalle ciniche autorità russe, che non offrono niente altro che grigiore e assenza di felicità.

di FLAVIANO ZANDONAI Open innovation manager Cgm

Monumento ad Andrej Sakharov dalla pagina Facebook del direttore della Fondazione Sakharov Yuri Lukashevsk
L’Impact Hub presso Alta Valsugana Smart Valley

Costretti all’interno di campagne di marketing tutte incentrate su “tipicità” ed “eccellenze” ormai esauste e dentro confini sempre più determinati da soli indicatori di efficienza amministrativa ed economie di scala che ne liquefano l’identità, i territori si meritano una nuova narrazione. Se la meritano perché nonostante le condizioni non favorevoli prosegue quel lavorio territoriale fatto di istanze, progetti, programmi, analisi, coalizioni che si raccolgono sotto il cappello di un’innovazione sociale place based ormai giunta a maturazione e dunque pronta a scalare attraverso una nuova narrativa che ambisce a riallineare quanto sta già succedendo con le sfide socio ambientali di quest’epoca.
Tutt’altro che storytelling da agenzie pubblicitarie quindi, ma neanche manifesti engagé incentrati sul “contro” e su proposte poco praticabili. La nuova
IDEE
narrazione territoriale prende forma in modo distribuito e carsico dentro i documenti condivisi che alimentano politiche e progettazioni di sistema, nella diaristica social di chi abita, per davvero, i contesti, e ancora nella riproduzione di conoscenze radicate attraverso approcci di ricerca partecipanti. Ad alimentarla è una comunità variegata, e forse ancora troppo fluida, fatta di ricercatori, consulenti, cittadini attivi, funzionari che preferiscono sempre meno esternalizzarne l’elaborazione a consulenti e think tank tentando piuttosto un approccio di condivisione. Una strada quasi obbligata, e certamente più faticosa, se si vuole contare su una narrativa la cui autenticità consiste nel saper delineare orizzonti di senso per nuovi modelli di sviluppo.
Qualche esempio? A Reggio Emilia un gruppo di operatori culturali e delle politiche sociali organizzano eventi ed elaborano proposte di politica con l’intento di accreditare il welfare culturale come elemento portante di una nuova identità urbana. Nell’area metromontana torinese i distretti della coesione sociale cofinanziati dal programma regionale “we.ca.re” vengono riletti da ricercatori e designer secondo un approccio di sperimentalità che scaturisce non da scenari preconfezionati ma dal sostegno alla capacità di futuro degli attori locali. Così come nella Valsugana trentina, Impact Hub, il nodo di una rete glocale di infrastrutture per l’innovazione, sostiene la rigenerazione di sedi in dismissione della locale banca cooperativa creando una rete di spazi di coworking per lavoratori in smartworking e nuovi abitanti che non è un mero risarcimento ma un nuovo ramo aziendale. E ancora il programma Crearee di Unipol ha incubato una app digitale di project management per i propri presidi territoriali informali che non si limita a tracciare l’execution delle attività, ma a soppesare quello che dovrebbe essere il principale valore che scaturisce dai sempre più numerosi e diffusi progetti locali e di comunità ovvero le interdipendenze in chiave neomutualistica tra i diversi soggetti coinvolti. Uno strumento che potrebbe essere utile anche per Hermete, un’impresa sociale che nella Valdadige veronese lavora per “fare un passo indietro”, lasciando in eredità alla comunità locale risorse materiali e capacità
Occorre una capacità di distillare un profilo territoriale non semplicemente pronto all’uso per attività di policy making o di progettazione, ma rispondente rispetto alle aspirazioni e di chi il territorio lo fa abilitandolo
di autogoverno che ha contribuito a costruire negli anni grazie a risorse della filantropia locale. Infine, ma non per ultime, le grandi reti nazionali come il Consorzio Cgm che prova a trasformare il proprio marketplace digitale di servizi di welfare in una vera e propria piattaforma per incrementare la dotazione infrastrutturale dei territori, in particolare delle sue economie sociali e di prossimità. O il Forum Nazionale del Terzo Settore che converte la propria storica formazione quadri in progetti di sviluppo comunitario aperti e inclusivi trainati da enti di Terzo settore soprattutto nelle aree meridionali del Paese. Queste e molte altre attività consentono una sorta di “agopuntura territoriale” che richiede però di individuare punti sensibili come i seguenti. Una politica di missione co-costruita, non eterodiretta e non rituale che sappia declinare in modo originale e autentico le missioni trasformative (ambientali, sociali, tecnologiche) che caratterizzano questa “era delle transizioni” verso nuovi assetti, attraendo e combinando risorse dedicate. Una progettualità sociale che a prescindere dall’oggetto sia caratterizzata da un approccio sistemico in grado di incidere su tendenze strutturali e di lungo periodo rispetto alla protezione e alla coesione sociale, lavorando sulla qualità delle interdipendenze tra i soggetti coinvolti. Una catena del valore che sappia rigenerarsi rimettendo in gioco i suoi fattori di radicamento (risorse, competenze, culture) rispetto ai macro trend trasformativi dell’economia mainstream (digitalizzazione, sostenibilità) recuperando in tal senso capacità d’investimento. Un change maker in grado non solo di innescare ma anche di diffondere elementi di innovazione per disincagliare i modus operanti del “si è fatto sempre così”, potendo contare non solo su capacità e motivazioni proprie, ma anche su infrastrutture di accompagnamento, facilitazione e trasferimento. Certo non è solo agendo su questi punti che si riscrive la narrativa. Occorre, come sostengono le agenzie di sviluppo di nuova generazione quali l’ufficio Svolta del Csv Trentino o Appenninol’Hub nel riminese, una capacità di distillare un profilo territoriale non semplicemente pronto all’uso per attività di policy making o di progettazione, ma rispondente rispetto alle aspirazioni e di chi il territorio lo fa abilitandolo.

Registrazione presso il Tribunale di Milano n- 397 dell’8/7/1994
ISSN 1123-6760
Direttore responsabile
Stefano Arduini s.arduini@vita.it
Redazione redazione@vita.it
Giampaolo Cerri, caporedattore Antonio Mola, caposervizio grafico Matteo Riva, art director
Sara De Carli
Collaboratori
Cristina Barbetta, Daniele Biella, Luca Cereda, Francesco Dente, Fadia El Hazaymeh, Gabriella Debora Giorgione, Diletta Grella, Paolo Manzo, Antonietta Nembri, Agnese Palmucci, Sabina Pignataro, Alessandro Puglia, Veronica Rossi, Giulio Sensi, Anna Spena, Nicola Varcasia, Silvia Vicchi
Vita a Sud (vitaasud@vita.it)
Luigi Alfonso, Emiliano Moccia, Gilda Sciortino, Anna Spena
Rubriche
Giovanni Biondi, Maurizio Crippa, Luca De Biase, Anna Detheridge, Sergio Gatti, Stefano Granata, Ivana Pais, Gianluca Salvatori, Doriano Zurlo
Commentatori
Filippo Addarii, Luigi Bobba, Aldo Bonomi, Carlo Borgomeo, Carlo Borzaga, Lucio Brunelli, Luigino Bruni, Carola Carazzone, Luca Doninelli, Johnny Dotti, Elena Granata, Giuseppe Guerini, Paolo Iabichino, Mauro Magatti, Giovanna Melandri, Valerio Melandri, Angelo Moretti, Silvano Petrosino, Giacomo Poretti, Andrea Rapaccini, Marco Revelli, Giulio Sapelli, Marianella Sclavi, Gabriele Sepio, Gianpaolo Silvestri, Tiziano Vecchiato, Paolo Venturi, Stefano Zamagni, Flaviano Zandonai
Progetto grafico Matteo Riva
Editore
Vita Società Editoriale S.p.a. impresa sociale Via Ermanno Barigozzi, 24 20138 Milano (MI) Iscritta al ROC al n. 3275
Stampa AGF S.p.A. Unipersonale Via del Tecchione, 36 20098 Sesto Ulteriano (MI)
Distribuzione Per l’Italia: Distribuzione SO.DI.P. “Angelo Patuzzi” S.p.A. Via Bettola, 18 — 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel. 02.660301 — Fax. 02.6603032
Abbonamenti e copie abbonamenti@vita.it store.vita.it
Vita Tutto Compreso (cartaceo+digitale) Abbonamento 12 mesi Italia € 50,00 Abbonamento 12 mesi Area UE € 120,00
Vita digitale Abbonamento 12 mesi € 30,00
Numeri arretrati
Il doppio del prezzo di copertina (solo per l’Italia) store.vita.it
Vita, nello svolgimento della propria attività, tratta dati personali nel rispetto della normativa vigente, in particolare, il D.Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) e il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”).
Inoltre, raccoglie ed utilizza per scopi giornalistici dati personali che vengono conservati all’interno di banche dati di uso redazionale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Vita Società Editoriale S.p.A. Impresa Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Ermanno Barigozzi 24, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, partiva IVA e codice fiscale n. 11273390150.
L’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile all’indirizzo web privacy.vita.it. L’interessato al trattamento dei propri dati personali può in qualsiasi momento chiedere la disiscrizione ed esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) contattando il Titolare del trattamento dei dati personali ai seguenti recapiti: mail: amministrazione@vita.it, telefono: 02/40703333.
Vita Società Editoriale S.p.a. impresa sociale
Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Ambrosio presidente e amministratore delegato
Marcello Gallo vicepresidente vicario
Paolo Ainio
Giuseppe Frangi consiglieri di amministrazione
Presidente Onorario Riccardo Bonacina
Collegio sindacale
Piero Galbiati, presidente Fabio Mazzoleni, Guido Cinti
Advisory board
Riccardo Bonacina (coordinatore), Carola Carazzone, Alberto Fontana, Cristiano Gori, Stefano Granata, Vittorio Meloni, Ivana Pais, Giampaolo Silvestri, Clodia Vurro
Area Sviluppo
Alessandra Cutillo, Sergio De Marini, Teresa Selva Bonino (Comitato Editoriale), Francesca Spina
Area Operations
Miriam Benedetta Perego (responsabile), Valeria Pisà, Anna Ravera amministrazione@vita.it
Pubblicità e servizi editoriali
Aldo Perini advertising@vita.it
02.40703333
Previsto dallo Statuto societario di VITA, il Comitato Editoriale ne costituisce il cuore pulsante, segno della natura pubblica e partecipata del suo percorso editoriale, sin nel suo atto fondativo. Una vera e propria community operativa, partecipata dalle più importanti organizzazioni italiane di Terzo settore, in rappresentanza di migliaia di associazioni territoriali.
Il Comitato Editoriale è una comunità aperta che interagisce e collabora con la redazione, fornendo spunti di riflessione e linee di indirizzo per l’attività editoriale.
Il Comitato Editoriale è anche un tavolo di lavoro tra associazioni, giornalisti ed esperti per costruire campagne di mobilitazione, di attivazione civica e di comunicazione su istanze del Terzo settore. Per info e adesioni scrivi a comitato@vita.it
AABIO Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale | t. 02.45497494 www.abio.org
ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani t. 06.58401 | www.acli.it
ACTIONAID t. 02.742001 | www.actionaid.it
AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani | t. 06.681661 | www.agesci.it
AI.BI. Associazione Amici dei Bambini t. 02.988221 | www.aibi.it
AIC Associazione Italiana Celiachia t. 010.2510016 | www.celiachia.it
AIDO Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule t. 06.97614975 | www.aido.it
AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma Onlus t. 06.7038601 | www.ail.it
AIRC Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro t. 02.77971 | www.airc.it
AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica t. 02.66982114 | www.aisla.it
AISM APS/ETS
Associazione Italiana Sclerosi Multipla t. 010.27131 | www.aism.it
AMREF Health Africa onlus t. 06.99704650 | www.amref.it
ANCC-COOP Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori t. 06.441811 | www.e-coop.it
ANFFAS ONLUS Ass. Naz. Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale t. 06.3212391 | www.anffas.net
ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze t. 055.303821 | www.anpasnazionale.org
ANT Fondazione ANT Italia Onlus t. 051.7190111 | www.ant.it
ANTEAS Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà t. 0644881101 | www.anteas.org
ARCHÉ ONLUS t. 02.603603 | www.arche.it
ARCI t. 06.416091 | www.arci.it
ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS t. 06.4592.4447 | www.elis.org
ASSOCIAZIONE CON I FATEBENEFRATELLI PER I MALATI LONTANI t. 06.33253413 | www.afmal.org
ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 t. 3757008912 | www.donbosco2000.org
AVIS NAZIONALE Associazione Volontari Italiani Sangue | t. 02.70006786 | www.avis.it
AVSI Associazione Volontari per il Servizio Internazionale | t. 02.674988373 | www.avsi.org
C
CBM ITALIA ONLUS t. 02.72093670 | www.cbmitalia.org
CESVI Cooperazione e Sviluppo t. 035.2058058 | www.cesvi.org
CGM Consorzio Gino Mattarelli t. 02.36579650 | www.cgm.coop
CIAI Centro Italiano Aiuti all’Infanzia t. 02.848441 | www.ciai.it
CITTADINANZATTIVA ONLUS t. 06.367181 | www.cittadinanzattiva.it
COMITATO PADOVA CAPITALE DEL VOLONTARIATO t. 049 8686849 | www.padovaevcapital.it
CONFARTIGIANATO PERSONE ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati t. 06.703741 | www.anap.it
CONSORZIO SALE DELLA TERRA t. 393.8883549 - 393.8598913 www.consorziosaledellaterra.it
COOPI Cooperazione Internazionale t. 02.3085057 | www.coopi.org
CSI Centro Sportivo Italiano t. 06.68404550 | www.csi-net.it F
FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA t. 02.809767 | www.alzheimer.it
FEDERSOLIDARIETÀ CONFCOOPERATIVE t. 06.68000476 www.federsolidarieta.confcooperative.it
FISH ONLUS Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap t. 06.78851262 | www.fishonlus.it
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS t. 02 89658450 | www.bancoalimentare.it
FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS t. 02.40308910 | www.dongnocchi.it
FONDAZIONE DYNAMO CAMP ETS t. 02.8062941 | www.dynamocamp.org
FONDAZIONE ÈBBENE t. 800.082834 | www.ebbene.org
FONDAZIONE EDOARDO GARRONE ETS t. 010.8681530 | www.fondazionegarrone.it
FONDAZIONE EOS - EDISON ORIZZONTE SOCIALE ETS t. 02.62221 | www.fondazioneeos.it
FONDAZIONE EXODUS t. 02.210151 | www.exodus.it
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H. ITALIA ONLUS t. 02.54122917 | www.fondazionefrancescarava.org
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS t. 02.456771 | www.sacrafamiglia.org
FONDAZIONE ITALIA SOCIALE t. 02.8062957 | www.fondazioneitaliasociale.org
FONDAZIONE LAUREUS SPORT FOR GOOD ITALIA ONLUS t. 02.36577080 | www.laureus.it
FONDAZIONE LEGA DEL FILO D’ORO ONLUS t. 071.72451 | www.legadelfilodoro.it
FONDAZIONE MISSION BAMBINI ONLUS t. 02.2100241 | www.missionbambini.org
FONDAZIONE PER L’INFANZIA RONALD MCDONALD ITALIA ETS t. 02.74818331 | www.fondazioneronald.org/it
FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS t. 02.67076867 | www.progettoarca.org

FONDAZIONE SOLETERRE t. 02.57609307 | www.soleterre.org
FONDAZIONE TELETHON t. 06.440151 | www.telethon.it
FONDAZIONE TRIULZA t. 02.39297777 | www.fondazionetriulza.org
FONDAZIONE VINCENZO CASILLO t. 080.9172204 | www.fondazionecasillo.it
FONDAZIONI DI COMUNITÀ CAMPANE Coordinamento c/o Fondaz. Comunità Salernitana t. 089.253375
INTERSOS Organizzazione Umanitaria Onlus t. 06.8537431 | www.intersos.org
J
JA - JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA www.jaitalia.org
L
LEGACOOPSOCIALI t. 06.84439322 | www.legacoopsociali.it
M
MANAGERITALIA LOMBARDIA Gruppo Volontariato Professionale t. 02.6253501 | www.manageritalia.it
MCL Movimento Cristiano Lavoratori t. 06.7005110 | www.mcl.it
MISERICORDIE Confederazione Nazionale Misericordie D’Italia t. 055.32611 | www.misericordie.it
MISSIONI DON BOSCO VALDOCCO ONLUS t. 011.3990101 | www.missionidonbosco.org
MOAS onlus Migrant Offshore Aid Stations t. +356 22479770 | www.moas.eu
MPVI Movimento Per la Vita Italiano t. 06.68301121 | www.mpv.org
O
OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS ETS
t. 02.77122400 | www.operasanfrancesco.it
OSA - Cooperativa Operatori Sanitari Associati t. 06.710661 | www.osa.coop
S
SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS
t. 06.4807001 | www.savethechildren.it
SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS ONLUS t. 02.39445900 | www.savethedogs.eu
SISCOS - Servizi per la Cooperazione Internazionale t. 02.80012108 | www.siscos.org
SOS IL TELEFONO AZZURRO ONLUS t. 051.225222 | www.azzurro.it
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS t. 0461.926262 | 02.55231564 | www.sositalia.it
T
TOURING CLUB ITALIANO t. 02.8526842 | www.touringclub.it
U
UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare | t. 049.757361 | www.uildm.org
UNEBA LOMBARDIA
t. 02.72002018 | www.unebalombardia.org
W
WEWORLD ONLUS
t. 02.55231193 | www.weworld.it
In uscita la seconda pubblicazione della serie “Geografie Meridiane”: cosa si cela sotto il brand della “Primavera Pugliese”? La nostra inchiesta
Una regione a doppia velocità: da una parte innovazione, servizi, cultura, welfare, solidarietà; dall’altra mafia, povertà, dispersione scolastica, mancanza di lavoro, sostegno del pubblico. Quello che emerge dal book intitolato Puglia. Il sociale bifronte, la seconda pubblicazione della serie “Geografie Meridiane” promossa da Vita, rispecchia il pensiero con cui il sociologo pugliese Franco Cassano ha interpretato per anni la rinascita del Mezzogiorno: «In questo assalto volgare e trasformistico alla modernità, si sono venute affermando le due facce oggi dominanti del Sud: paradiso turistico e incubo mafioso».
Ed anche la Puglia per certi versi sembra non sfuggire da questo pensiero meridiano. Un quadro emerso anche a Bari lo scorso primo marzo in occasione della presentazione (svoltasi nella sede della Fondazione Puglia) nato all’interno del progetto Vita a Sud, che da oltre due anni racconta su Vita (sito e magazine) l’economia civile e l’innovazione sociale del nostro Mezzogiorno. Il book presenta un’inchiesta sul welfare della regione, il racconto di sette esperienze di realtà sociali innovative e a forte impatto sociale, e l’intervento di tre protagonisti del pensiero sociale che vivono e conoscono il territorio.
Le diverse voci e realtà fotografano una regione a doppia marcia. Innovazione, rigenerazione dei luoghi e marketing territoriale della “Primavera pugliese” sono diventati negli anni un brand che ha portato la Puglia ad affermarsi e ad essere ri-

conosciuta a livello nazionale ed internazionale; ma questa modernità si scontra con la crescita di criminalità e povertà, mettendo in evidenza le fratture sociali presenti nei territori. Tutte questioni che si intrecciano ed impattano sulla qualità della vita dei quasi 4 milioni di pugliesi che ne fanno l’ottava regione in Italia per popolazione. «Dalla terra si può ripartire, si possono creare opportunità di lavoro e di restanza, ma occorre avere il coraggio di osare e avere una visione di quello che si vuole costruire, senza lasciarsi schiacciare dal presente» dice Tiziana Colluto, presidente della Casa delle Agriculture “Tullia e Gino”, tra le esperienze raccontate in cui la parola visione è quella che si fa più spazio. Una visione capace di tenere insieme sociale ed economia. Come l’azione che scandisce le attività del Consorzio Meridia, che dal 1999 opera soprattutto in provincia di Bari nella gestione di servizi alle persone anche attraverso l’innovazione tecnologica. O la visione della Fondazione Vincenzo Casillo, impegnata in attività filantropiche per sostenere iniziative sociali e culturali nei territori pugliesi. Il M.Ar.TA. — Museo Archeologico Nazionale di Taranto, invece, è uno spazio di innovazione civica e sociale in cui si coltiva la cittadinanza, andando così oltre la sua mission di luogo espositivo. Un processo di partecipazione attiva che accompagna anche l’azione del Consorzio Oltre, nato a Foggia per promuovere processi di economia civile, di accoglienza e di inserimento lavorativo delle persone più fragili. Nel racconto delle esperienze ci sono anche Masseria Tagliatelle, frutto della collabora-

Il mulino di comunità realizzato presso la Casa delle Agricolture
“Tullia e Gino” di Castiglione d’Otranto in provincia di Lecce. Una delle sette esperienze esmplari raccontate nel book “Puglia, il sociale bifronte”
SCAFFALE DIGITALE
Letture per vivere meglio: ogni venerdì online su vita.it

Fzione tra Comune di Lecce e Fondazione Con il Sud che ha generato un nuovo modello di recupero e gestione di un bene pubblico, e Qualcosa di Diverso, la cooperativa che ha dato vita a “Xfarm agricoltura prossima”, un progetto che sui terreni confiscati alla mafia a San Vito dei Normanni (Brindisi) tutela la biodiversità e genera lavoro. Questa visione di cultura sociale che migliora la qualità della vita delle persone e contraddistingue il modello Puglia deve però volgere lo sguardo verso il Mediterraneo e non cercare di imitare i modelli del Nord, come ben analizzano nel capitolo riservato ai “pensieri meridiani” Elvira Zaccagnino, direttrice editoriale di Edizioni La Meridiana, Leonardo Palmisano, scrittore ed attivista, e Onofrio Romano, sociologo, erede del pensiero di Franco Cassano.
Il book sulla Puglia, curato da Emiliano Moccia costituisce la seconda uscita della collana
Geografie Meridiane nell’ambito del progetto Vita a Sud e segue quello sulla Sardegna (Il sociale isolato) pubblicato lo scorso novembre. Entrambi sono scaricabili gratuitamente dallo store di Vita.it
rancis Scott Fitzgerald scriveva che la parte più bella della letteratura è «scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni». Noi di Vita abbiamo pensato che nei nostri ragionamenti, approfondimenti, racconti fosse proficuo, attingere dalle parole di professionisti, scrittori, testimoni che attraverso i loro scritti ci aiutassero a non perdere la bussola. Per questo motivo da alcune settimane su vita.it abbiamo inaugurato una nuova rubrica dedicata ai libri. L’abbiamo proprio chiamata Libri di Vita, con l’intento di condividere, ogni venerdì, una selezione di titoli che secondo noi affrontano con maestria e particolare acume le tematiche che ci stanno molto a cuore.
La prima puntata è stata presentata in occasione della giornata della memoria, il 27 gennaio. Poi ci siamo dedicati ai libri che affrontano le tematiche ambientali, avendo cura di aggiungere un consiglio per i più giovani: in questo caso l’invito era a conoscere i nomi di chi ha dedicato la propria vita ai progetti per la salvaguardia dell’ambiente prima dei “Fridays for Future”. Il terzo appuntamento, invece, ha avuto come protagonisti i titoli che aiutano a comprendere l’incomprensibile: la guerra in Ucraina. Abbiamo scelto i libri di Nello Scavo, Andrea Nicastro, Domenico Quirico e Francesca Mannocchi affinché ci guidassero nel tentativo di cogliere i meccanismi, le cause e gli effetti devastanti del conflitto. Più recentemente, abbiamo proposto una selezione di volumi sul tema adozione: albi illustrati, fumetti, saggi, racconti e testimonianze. Seguiteci ogni venerdì su vita.it.
Sabina Pignataro
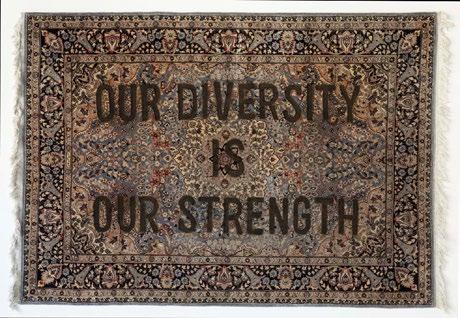

n vecchio tappeto dal quale sono state incise cinque parole: il gesto dell’incidere comunica immediatamente la credibilità di quello che ci dicono, il loro significato. “Our Diversity is our Strenght”. C’è un “noi” innanzitutto. Ed è il “noi” costituito dall’artista che si è mobilitata, Loredana Longo, catanese che oggi vive e lavora a Milano, e dai bambini e ragazzi di Dynamo Art Factory, l’esperienza che ha preso il via nel 2009, come spin off della grande avventura di Dynamo Camp, il camp di Terapia Ricreativa in Italia dedicato ai bambini con patologie. Sono 90 gli artisti che in questi 15 anni si sono avvicendati con i bambini e ragazzi di Dynamo Camp, donando la propria creatività oltre che il proprio tempo. Gran parte di questi laboratori si sono tenuti nell’Oasi di Limestre, sugli appennini pistoiesi, che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche, i fratelli sani e le loro famiglie, per periodi di vacanza e divertimento. Per festeggiare questo compleanno Dynamo Art Factory ha presentato una selezione dei lavori che fanno parte di questo straordinario “museo della vita” alla Triennale di Milano, con una mostra dall’impatto davvero spettacolare, curata da Diva Moriani e Marco Bazzini. La mostra alla Triennale è davvero sorprendente perché l’intenzionalità programmatica che c’è dietro ogni lavoro, viene assorbita nella gran parte dei casi dalla bellezza dell’esito che si impone senza bisogno di giustificazioni o spiegazioni. Non chiede spiegazioni l’opera realizzata da Loredana Longhi con i ragazzi, perché il semplice e ordinato gesto del levare materia dalla superficie del tappeto, parla di una convinzione: che la fragilità non è un problema ma un prezioso punto di vista altro sul mondo e sulla vita. E questo punto di vista non può essere certo prestabilito o vincolato a regole, come dimostra l’opera realizzata con Marco Fantini, vicentino, pure lui con base a Milano. È un’opera invece assolutamente irregolare, dove è stata liberata l’istintività sua come quella dei bambini che hanno lavorato con lui. Un panorama visivo anarchico e felice che comunica quel senso di libertà insopprimibile che è proprio dell’arte come della vita.
L’arte è Wow! Milano, Triennale, fino al 26 marzo, promossa da Fondazione Dynamo Camp
FRANGI (@robedachiodi)
Crediamo che una soluzione sia tale solo quando risolve un problema e rispetta le specifiche esigenze della singola Associazione o ente del Terzo Settore.
Per questo motivo li affianchiamo in ambiti complessi come contabilità, fundraising, gestione dei database e comunicazione, sapendo che la soluzione perfetta va cercata ogni volta.
Ogni progetto è una storia a sé. Ciò che non cambia è il valore della nostra consulenza.
Un impegno che cresce assieme a voi da oltre 10 anni.
#digital fundraising #CRM per il non profit
La piattaforma di digital fundraising più completa per gestire la relazione con i tuoi donatori.
La soluzione ideale per prenderti cura dei tuoi prospect e convertirli in donatori
Il sistema definitivo per le attività amministrative e il controllo di gestione di una ONP.


Non perderti i nostri appuntamenti. Sono un’occasione molto importante per aggiornarsi, fare il punto e mettere in comune strumenti operativi in ambito organizzativo, fiscale e gestionale.
Non perderti i nostri appuntamenti. Sono un’occasione molto importante per aggiornarsi, fare il punto e mettere in comune strumenti operativi in ambito organizzativo, fiscale e gestionale.
Per informazioni e iscrizioni visita la pagina: www.npsolutions.it/webinar/
Per informazioni e iscrizioni visita la pagina: www.npsolutions.it/webinar/


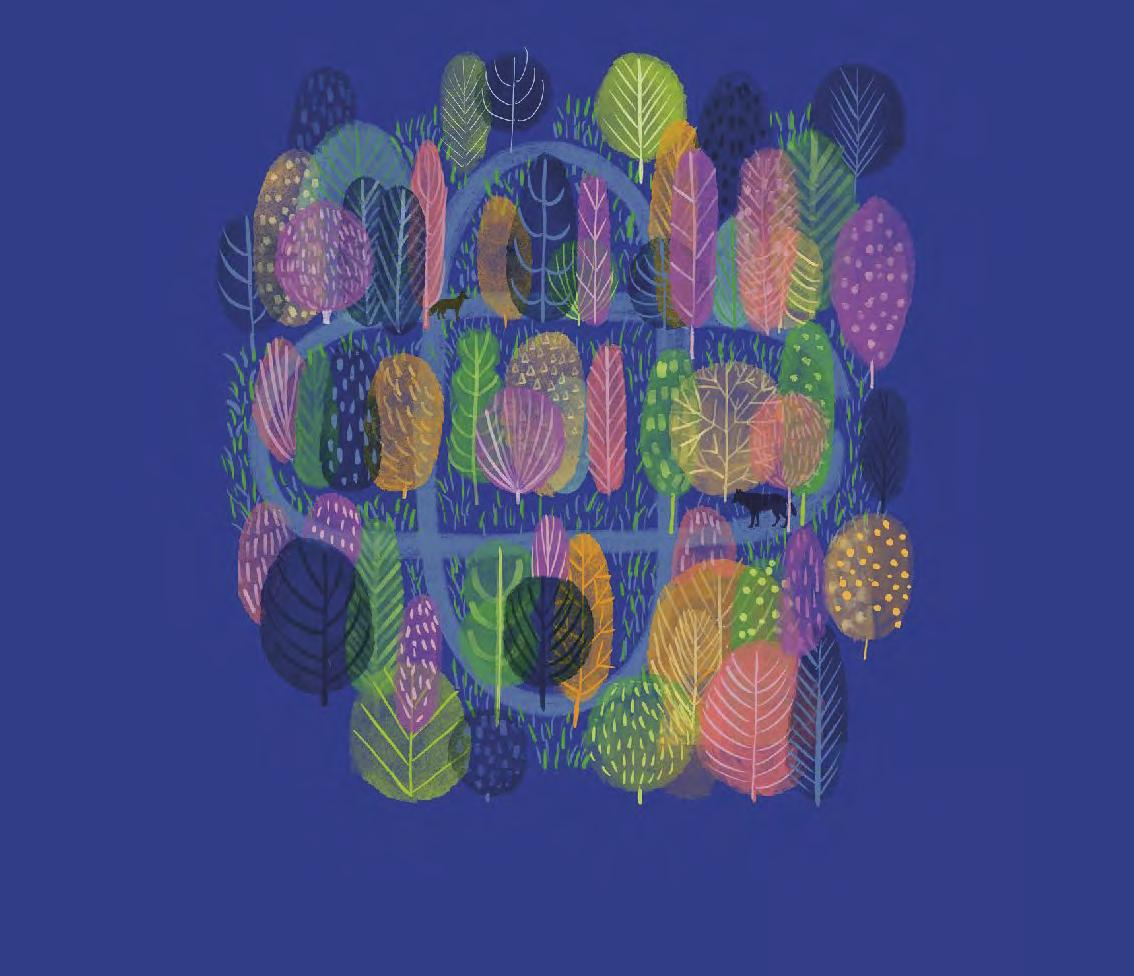
In sette località di tutta Italia stiamo piantando i primi alberi del “Bosco dei Giovani Soci del Credito Cooperativo”. Un’iniziativa, frutto dell’intesa tra Federcasse e Legambiente, con cui le Giovani Socie e i Giovani Soci del Credito Cooperativo danno il loro contributo contro il cambiamento climatico e per favorire una transizione ecologica partecipata e inclusiva. Secondo la logica della “sostenibilità integrale”.
www.creditocooperativo.it