

UNICAMILLUS

CONTENUTI
1 Editoriale
Salute sessuale: informare, prevenire, curare di Gianni Profita
4 Disfunzione erettile. Problemi di erezione e impotenza di Patrizio Vicini
10 Salute sessuale. Il ruolo dell’alimentazione di Laura Scappaticci
16 Concetti di Immunologia della Riproduzione.
Vantaggi nell’applicazione alle patologie ostetrico-ginecologiche di Valentina Bruno
20 Tecniche di fecondazione assistita. Successo, fattori influenti e strategie personalizzate di Ermanno Greco
24 AlmaLaurea.
I dati che confermano il successo di Ginevra Guidoni
26 HIV e Prevenzione. Il vaso di Pandora delle malattie sessualmente trasmesse di Daniele Armenia
33 Sesso e Sangue. Salute e malattie sessualmente trasmissibili in prospettiva storica di Christina Savino
40 Mestruazioni dolorose: possibile spia di una patologia ginecologica? di Giorgia Martino
46 UniCamillus Sport SSD Il primo torneo inter-universitario di Claudia Romano
50 Paracetamolo: sicuro o pericoloso? di Silvio Festinese
52 CINQUE NOTIZIE
54 GLOBAL HEALTH JOURNAL
56 Terza Missione UniCamillus. Dove la Scienza incontra la Società di Donatella Padua e Barbara Tavazzi
66 RICERCHE/ABSTRACT
EDITORIALE
Salutesessuale:informare,prevenire,educare. di Gianni Profita Rettore
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni giorno nel mondo si registrano oltre 1 milione di nuovi casi di infezioni sessualmente trasmissibili. In Italia circa il 15% delle coppie affronta difficoltà legate alla fertilità e si stima che una donna su dieci sia affetta da endometriosi, spesso senza una diagnosi tempestiva. Questi numeri ci ricordano quanto sia urgente, oggi più che mai, promuovere conoscenza, prevenzione e accesso a cure adeguate nell’ambito della salute sessuale. Il nostro Ateneo ha ospitato il Congresso Nazionale congiunto SIDR (Società Italiana della Riproduzione) e SIPo (Società Italiana della Psicologia e Psicosomatica Ostetrica), un evento di rilievo che ha riunito esperti da tutta Italia per confrontarsi sulle nuove frontiere della fertilità e della procreazione medicalmente assistita.
Dedicare il numero estivo di UniCamillus Magazine alla salute sessuale e riproduttiva è stata la logica conseguenza dell’importanza che tale tematica pone alla nostra attenzione ogni giorno e in tutto il mondo. La salute sessuale e riproduttiva rappresenta una componente essenziale del benessere individuale e collettivo e, come tale, merita un’attenzione scientifica, sociale e culturale che vada ben oltre i luoghi comuni. In questo nuovo numero, come sempre, ci siamo affidati alla competenza e alla passione dei nostri docenti, che ogni giorno si impegnano nella ricerca, nella didattica e nella cura.
Parlare di salute sessuale significa innanzitutto riconoscerne il ruolo centrale nella vita delle persone: non solo “assenza di malattia”, ma diritto di conoscenza, prevenzione, fertilità consapevole, vita relazionale e affettiva soddisfacente. È un campo in cui si intrecciano medicina, psicologia, società e diritti, e in cui la formazione dei professionisti della salute deve essere completa, aggiornata e profondamente umana.
In questo numero affronteremo, con rigore e chiarezza, il tema della disfunzione erettile, sfatando miti e portando la questione al centro di un discorso clinico moderno. Si parla di alimentazione e fertilità, di Procreazione Medicalmente Assistita, di immunologia della riproduzione: aspetti che mostrano quanto la salute riproduttiva sia frutto di un equilibrio complesso, che va tutelato con approccio multidisciplinare.
Non mancano i temi dell’informazione e della prevenzione: l’articolo sulle malattie sessualmente trasmissibili – con uno specifico caso clinico legato all’HIV – ci ricorda che l’allerta non può mai calare e che la lotta allo stigma è parte integrante della strategia di salute pubblica. A questo si affianca una preziosa ricostruzione storica su come le malattie veneree abbiano modellato la società a suon di pregiudizi e sensi di colpa, incidendo così su dinamiche culturali e morali nel corso dei secoli.
In questo contesto non poteva mancare uno spaccato su dismenorrea ed endometriosi, al fine di dar voce a una sofferenza troppo spesso sottovalutata, restituendole così la dignità e la centralità che merita nella pratica clinica.
Ma UniCamillus è anche una comunità viva, in continua crescita. Siamo orgogliosi di raccontare in queste pagine la nascita della nostra società sportiva universitaria UniCamillus Sport SSD e del primo torneo interuniversitario: rappresentano un segnale forte dell’importanza dello sport e della coesione nella formazione degli studenti.
Nella sezione dedicata alla Terza Missione mettiamo in evidenza due importanti iniziative che hanno caratterizzato il mese di maggio 2025: il convegno sulla medicina di prossimità per la gestione delle cronicità – tema strategico per un sistema sanitario moderno – e l’incontro sul concetto di One Health che connette la salute umana, animale e ambientale, in linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Abbiamo parlato di tematiche tanto delicate quanto cruciali. Abbiamo raccontato il frutto del nostro lavoro quotidiano per rendere questo Ateneo vicino ai nostri studenti e alla società che ci circonda. Una società in cui siamo attori e non semplici spettatori. Una società che abbiamo il dovere e il diritto di vivere con consapevolezza, cura e umanità, in ogni suo aspetto. Anche in questo numero abbiamo cercato di contribuire a questa necessità di sensibilizzare alla salute e al benessere: perché solo attraverso una conoscenza approfondita e condivisa possiamo costruire un futuro più sano, inclusivo e sostenibile.
Da parte mia posso assicurare che UniCamillus continuerà a farsi portavoce di questi valori, formando professionisti della salute preparati e sensibili, pronti a fare la differenza nella vita delle persone e nella società.


EDITORIAL
Sexualhealth:advising,preventingandeducating by Gianni Profita Rector
), over 1 million new cases of sexually transmitted infections are reported worldwide every day. In Italy, around 15% of couples experience fertility issues, and it is estimated that one in ten women suffers from endometriosis, often without receiving an early diagnopromote knowledge, prevention and access to adequate
National Conference of the Italian Society of Reproduction (SIdR) ). This significant event brought together experts from across Italy to share their insights on fertility and medically assisted procreation. Given the global to sexual essential component of individual and , and as such deserves sustained scientific, social and cultural attention that goes far beyond stereotypes. As always, in this new issue we have relied on the expertise and passion of our teach-
When we talk about sexual health, we must first recognise its central role in people’s lives. Indeed, it is not just the absence of disease, but also the right to knowledge, prevention and informed fertility, as well as the right to a satisfying relational and affective life. Sexual health is an area where medicine, psychology, must be comprehensive, up-to-date with rigour and clarity, dispelling myths and medically . These topics demonstrate that reproductive health is the result of a complex balance that must be protected through a multidisciplinary exually transmitted diseases, which presents a specific clinical case related to HIV, reminds us that we must always be vigilant and that historical of how venereal diseases have shaped society through prejudice and guilt, affecting cultural to raise awareness of conditions that are all too often overlooked, and to restore their dignity and importance in clinical practice. is also a vibrant and evolving community. In these pages, we recount the establishtournament. These initiatives highlight the importance of sport and cohesion in our students’ education. , we highlight two significant initiatives from May 2025: a for managing chronic conditions—a key issue for modern healthcare , connecting human, animal, and environmental
In this issue, we discuss sensitive yet important topics, and present the outcomes of our daily efforts to bring this University closer to our students and the surrounding community—a community in which we are active contributors, not mere spectators, and where we have the duty and the right to live with awareness, awareness of health and wellbeing, as it is only through in-depth, shared knowledge that we can build a healthier, more inclusive and sustainable
professionals who are well-prepared and compassionate, and who are ready to make a positive impact on
Problemi di Erezione e Impotenza
di Patrizio Vicini
Docente UniCamillus di Urologia
L’erezione peniena è quel fenomeno complesso determinato da una serie di eventi a catena che coinvolgono coscienza, sistema nervoso centrale e periferico, meccanismi ormonali e vascolari (integrità del sistema arterioso e veno-occlusivo penieno).
Tuttavia, ricerche sull’anatomia, la fisiologia e la biochimica della funzione erettile hanno reso possibile definire specifici disordini organici che possono dare origine alla Disfunzione Erettiva (DE) o Impotenza, definita come “incapacità di ottenere o mantenere un’erezione adeguata a portare a termine un soddisfacente rapporto sessuale”.
L’erezione è essenzialmente un evento emodinamico, in cui gioca un ruolo fondamentale l’equilibrio tra l’afflusso arterioso e il deflusso venoso. L’endotelio svolge un ruolo chiave nella regolazione del microcircolo, infatti è al centro dei meccanismi omeostatici di modulazione del diametro dei vasi e di controllo della perfusione tissutale. Le cellule endoteliali partecipano alla regolazione del flusso mediante il rilascio di fattori contrattili e vasodilatatori (Fig.1)
In particolari condizioni di ischemia (come quella secondaria alla vasculopatia diabetica),la riduzione del flusso, conseguente alla alterazione vascolare, induce una condizione di stress emodinamico che causa un profondo scompenso dell’omeostasi microcircolatoria. Tale stress determina l’attivazione dell’endotelio provocando un ulteriore aumento del consumo di ossigeno circolante. Le alterazioni del microcircolo innescano una serie di modificazioni (diminuizione del flusso arterioso, peggioramento dell’ipossia) che mantengono e aggravano i meccanismi patogenetici della DE. In queste circostanze il rilascio di neuromediatori
ad azione vasocostrittrice da parte dell’endotelio attivato – quali l’endotelina1, le citochine e gli altri radicali liberi – danneggiano ulteriormente la mem brana endoteliale. È sempre più evidente che fattori di rischio quali ipercolesterolemia, fumo, ipertensione e diabete mellito portano a un’alterata funzione dell’endotelio e della muscolatura liscia in tutto l’organismo, e questo nel pene può portare alla DE o “impotenza”. Studi epidemiologici ci indicano un Studi epidemiologici ci indicano un’incidenza della DE o deficit erettivo, dell’ordine del 10% nelle società occidentali.

La D.E. tende ad aumentare con l’età: il 40% dei maschi a 70 anni accusa problemi di erezione. Da dati recenti emerge che, in Italia, circa il 40% dei maschi di età compresa tra i 30 ed i 70 anni accusano disturbi della sfera sessuale e circa il 15% avrebbe problemi di “impotenza”, quindi circa 4 milioni di individui.
Il problema è esploso in questi ultimi anni innanzitutto per un progresso culturale per cui la DE non è più considerata una vergogna da nascondere, ma una malattia da affrontare e curare. Un secondo motivo è dovuto all’aumento di incidenza di fattori di rischio tipici dei Paesi industrializzati: stress, farmaci, droghe, inquinamento ambientale.
Va ricordato infine che la DE è spesso sintomo di esordio di malattie più gravi come: il dia-
bete, l’ipertensione, la cardiopatia ischemica. Inoltre, l’insorgenza della DE precede di circa 53 mesi la manifestazione clinica della cardiopatia ischemica di cui condivide gli stessi fattori di rischio: da qui l’estrema importanza di una corretta diagnosi e cura da parte dello specialista andrologo.
CLASSIFICAZIONE DISFUNZIONE ERETTILE
La disfunzione erettile o deficit erettivo viene sostanzialmente classificata in psicogena e organica. È psicogena quando i fattori psicologici, come l’ansia da prestazione, lo stress, hanno un ruolo chiaro e determinante nella sua insorgenza. Tale forma è più frequente nei soggetti giovani.
Nell’età più avanzata la DE è essenzialmente organica ed è determinata da molteplici cause: – anatomiche (condizioni anatomiche peniene, sia congenite che acquisite che non consentono la penetrazione)
– neurologiche (M. Parkinson, M. di Alzheimer, Sclerosi Multipla, lesioni del midollo spinale)
– farmacologiche (ansiolitici, antidepressivi, ed antipertensivi)
– chirurgiche (a livello pelvico e addomino-perineale, come ad esempio l’intervento di prostatectomia radicale per tumore della prostata oppure resezione del retto per tumore del retto)
– vascolari arteriose e venose (soprattutto nei soggetti diabetici)
– endocrine (ipertiroidismo, ipotiroidismo, ipogonadismo, iperprolattinemia)
– patologie organiche generali quali diabete mellito, insufficienza epatica e renale, ipertensione arteriosa – sostanze tossiche quali droghe, nicotina ed abuso di alcool.
L’Andrologo si trova spesso a dover gestire una DE che riconosce come cause principali incurvamenti penieni, legati alla malattia di La Peyronie o successivi a traumi.
Esistono anche una DE secondaria ad interventi demolitivi pelvici, come nel caso della prostatectomia radicale per tumore della prostata; e infine alterazioni delle funzioni sessuali associate all’ipertrofia prostatica benigna e/o al suo trattamento.
DIAGNOSI IMPOTENZA
La diagnosi della DE richiede un approccio sistematico e multidisciplinare, volto a identificare le cause sottostanti e a pianificare un trattamento adeguato. Questo processo diagnostico comprende diverse fasi, ciascuna mirata a raccogliere informazioni specifiche sul paziente.
1) Anamnesi:
• patologie concomitanti (endocrine e dismetaboliche)
• pregressi interventi chirurgici
• farmacoterapia
• tempo e modo di comparsa
• presenza di erezioni notturne o con masturbazione
• comparsa occasionale, situazionale o relazionale
• concomitanza di disturbi del desiderio, dell’eiaculazione o dell’orgasmo

2) Esame obiettivo:
• androgenizzazione generale (massa muscolare, apparato pilifero, distribuzione adipe)
• identificazione dei segni suggestivi di ipogonadismo (riduzioni delle dimensioni dei testicoli, riduzione del tono e del trofismo muscolare,
• perdita dei caratteri sessuali secondari)
• valutazione del pene (elasticità, presenza di placche fibrose o fibrosi generalizzata, presenza di fimosi o frenulo corto)
• valutazione dei testicoli
• esplorazione rettale per valutazione della prostata
3) Esami di laboratorio ed ormonali:
• glicemia a digiuno (o emoglobina glicosilata se il paziente è diabetico) e valutazione del profilo lipidico
Fig. 1 - Cellule endoteliali
• dosaggio del testosterone libero e totale, FSH, LH, Prolattina, DHEA-S.
Il riscontro di ridotti livelli ematici di testosterone impone il dosaggio dell’LH e dell’FSH per permettere la diagnosi differenziale tra ipogonadismo ipogonadotropo’ (livelli di testosterone e gonadotropine bassi) e ipogonadismo ipergonadotropo (livelli di testosterone bassi e gonadotropine alti).
In caso ipogonadismo ipogonadotropo sarà necessario indagare ulteriormente l’asse ipotalamo-ipofisario, attraverso esami ormonali di base e dinamici ed RMN o TC cerebrale. Se ci troviamo di fronte ad iperprolattinemia è necessario escludere cause farmacologiche e riconfermare il risultato tramite prelievi seriati nel tempo.
4) Rigiscan (Rigidometria ed Erettometria Peniena Notturna): valutazione obiettiva e quantitativa delle erezioni notturne che si verificano fisiologicamente durante le fasi REM del sonno. Permette la diagnosi differenziale tra DE psicogena e DEorganica: la presenza di erezioni notturne normali per numero e durata esclude una DE organica.
5) FIC test: Farmaco-infusione intracavernosa di PGE1, valuta l’integrità del meccanismo artero-venoso, utile quando l’anamnesi e le indagini non invasive non hanno chiarito l’origine della DE e per quei pazienti in cui potrebbe essere indicata come terapia la stessa farmacoterapia intracavernosa.
6) Eco-color doppler penieno dinamico (Fig. 2) è l’esame di II livello più importante che deve essere fatto in caso di risposta parziale o non dirimente al FIC test, oppure quando si rende necessario confermare il sospetto di DE su base vascolare.
L’esame viene eseguito sia in condizioni basali per valutare l’ecostruttura dei corpi cavernosi, sia in condizioni dinamiche dopo farmaco-infusione intracavernosa di PGE1 (10-20 mcg/ml), utile per valutare in modo “quantitativo” e “qualitativo” i flussi ematici delle arterie cavernose e dorsali.
Permette di rilevare la presenza di:
• alterazioni strutturali dei corpi cavernosi (fi-
brosi, placche)
• una normale emodinamica peniena
• un deficit erettile arteriogenico
• un deficit erettile secondario a disfunzione veno-occlusiva.
7) Cavernosometria-grafia: metodica utilizzata nella diagnosi della “fuga venosa”, ma ormai in disuso dopo l’avvento dell’ecocolordoppler.
8)Biotesiometria: metodica che permette di valutare la soglia neurologica allo stimolo vibratorio penieno per integrità funzionale della via della sensibilità esteropriopiocettiva con normalità dello stimolo vibratorio e normale percezione dell’incremento d’ intensità a livello delle zone peniene esaminate.
TERAPIA DISFUNZIONE ERETTILE
Il ruolo del medico anche nell’era delle “pillole che possono guarire tutto”, oltre che nell’accogliere, rassicurare ed eliminare eventuali fattori di rischio (fumo,alcool), risiede nel porre una diagnosi e nell’intervenire.
Nelle malattie psichiatriche (depressione, schizofrenia) è indispensabile l’intervento di uno psichiatra che tratterà il paziente con farmaci appropriati.
Nelle malattie endocrine (ipogonadismo, iperprolattinemia, malattie della tiroide), una corretta terapia potrà essere di notevole giovamento o addirittura risolutiva. Nel caso che dall’esame clinico risulti un diabete o un’ipertensione, si dovranno prendere le opportune misure terapeutiche. Nel caso di uso di farmaci che di per sé possono determinare un’interferenza con l’attività sessuale (antiipertensivi, glucosidi digitatici, gli anti-H2, antidepressivi, ansiolitici ealcuni iperlipimezzanti), se ne dovrà dare notizia al medico di base e suggerire le opportune sostituzioni.
Quando una terapia eziologica non sia possibile, si dovrà ricorrere ai presidi terapeutici disponibili: psicoterapia sessuale e terapia medica a sua volta distinta in “non invasiva” e “invasiva”.
PSICOTERAPIA PER L’IMPOTENZA
La psicoterapia sessuale può rappresentare una risorsa comunque, sia in assenza di una compo -
nente organica, sia in sua presenza, perché nel primo caso risolve spesso il disagio ripristinando un comportamento sessuale positivo e, nel secondo caso, aiuta il soggetto e la coppia a vivere la sessualità con margini di handicap conosciuti e con l’attivazione di aspetti generali che siano in grado di garantire piacere e scambio, attenuando il conflitto e la tensione e perciò ripristinando complicità e capacità comunicativa.
TERAPIA MEDICA ‘NON INVASIVA’
I trattamenti medici non invasivi sono rappresentati dai farmaci orali.
SILDENAFIL (VIAGRA)
La farmacoterapia orale costituisce il trattamento di prima linea della DE grazie al Sildenafil (VIAGRA) che ha rivoluzionato l’approccio a tale problema.
Perifericamente, un agente come il sildenafil, anche se non dà avvio ad un’erezione, facilita ed aumenta la risposta della muscolatura liscia ad ogni stimolo sessuale. Il sildenafil viene assunto per bocca un’ora circa prima del rapporto sessuale ed ha un’emivita di circa 4 ore. L’assunzione con i pasti ne rallenta l’assorbimento. La dose consigliata è 50 mg, ma il farmaco può essere efficace anche alla dose di 25 mg. La dose massima consigliata è 100 mg. Il valore terapeutico di questo farmaco è stato confermato dal successo nella pratica clinica essendosi dimostrato efficace in oltre il 70 % dei pazienti dei pazienti affetti da DE
IC351-TADALAFIL (CIALIS)
Rappresenta la “seconda generazione” di farmaci inibitori selettivi della PDE 5. La novità terapeutica rispetto al “vecchio“ Sildenafil risiede proprio nella selettività che risulta 10.000 volte maggiore verso la PDE 5 rispetto alle altre PDE (1-4-7-10), e 780 volte maggiore rispetto alla PDE 6. Tali livelli di selettività dovrebbero assicurare minori effetti collaterali e maggiore efficacia clinica.
L’efficacia clinica si evidenzia già entro 30 minuti (59%) ma è massima tra 4 e 36 ore dopo l’assunzione (80%). Un vantaggio di questa molecola rispetto agli altri inibitori delle PDE è la più lunga emivita (>17 ore). Tale aspetto farmaco-cinetico, liberando la coppia dalla necessità di “pianificazione temporale”
dell’attività sessuale,migliora la spontaneità dei rapporti e l’ansia da prestazione ad essi connessa, permettendo cosi somministrazioni rarefatte e non tipicamente situazionali. La lunga emivita lo rende anche il farmaco più utilizzato per la “riabilitazione” dei corpi cavernosi post-prostatectomia radicale per tumore della prostata
VARDENAFIL (LEVITRA)
E’ un potente inibitore della PDE 5. Studi farmacocinetici hanno documentato alcune specifiche peculiarità che lo differenziano dagli altri inibitori della PDE 5: il più rapido raggiungimento delle massime concentrazioni plasmatiche (entro 40-50 minuti), e l’emivita (in media 4-5 ore) alle dosi comunemente impiegate di 10-20 mg.
Non sono riportate significative variazioni dei parametri farmacocinetici con la contemporanea assunzione di alimenti, né in presenza di insufficienza renale nei pazienti dializzati.
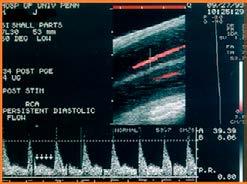
TERAPIA MEDICA “INVASIVA”
Pazienti candidati alla terapia iniettiva:
1. Pazienti che non possono usare la terapia orale
2. Pazienti che non rispondono alla terapia orale
3. Pazienti con esiti di chirurgia radicale della pelvi
La prostaglandina E1 (PGE1), somministrata per via intracavernosa, induce il rilasciamento della muscolatura liscia peniena dei corpi cavernosi determinando un’attivazione dell’ade -
Fig. 2 - Eco-color doppler penieno dinamico
nilatociclasi e quindi un aumento delle concentrazioni di AMPc. La prostaglandina E1, in dosi comprese tra 2,5 e 20 mcg, induce delle induce delle erezioni valide nell’80% circa dei soggetti trattati.
TERAPIA CON ONDE D’URTO A BASSA INTENSITÀ
Una tecnica recente che dimostra una buona efficacia è quella della litotrissia peniena, che consiste nel colpire il pene con onde d’urto a bassa intensità. Ciò determina una risposta infiammatoria con riparazione tissutale e facilita la neoangiogenesi, ossia lo sviluppo di ulteriori vasi sanguigni penieni, migliorando in tal modo l’erezione.
TERAPIA CON PLASMA PIASTRINICO (O PRP)
E CELLULE STAMINALI
Il PRP (plasma ricco di piastrine) si ottiene attraverso la centrifugazione del sangue autologo (cioè prelevato dallo stesso paziente), che produce un plasma ad alta concentrazione di piastrine, detto appunto concentrato piastrinico. Il plasma così ottenuto in andrologia si usa essenzialmente per due patologie con ottimi risultati: la disfunzione erettile e la malattia di La Peyronie.
TERAPIA CHIRURGICA PER LA DISFUNZIONE
ERETTILE: PROTESI PENIENE
Dove la terapia medica non permette di ottenere risultati soddisfacenti, la terapia protesica rappresenta la soluzione migliore.
I pazienti candidati all’impianto protesico sono in genere affetti da una DE organica e non rispondono alla terapia orale (Viagra, Cialis, Levitra) o alla terapia farmaco-iniettiva con PGE1, oppure sono affetti da DE organica e rifiutano il trattamento orale o farmaco-iniettivo, oppure ancora sono pazienti con una DE definitiva (diabete, chirurgia pelvica, malattia di La Peyronie in fase stabilizzata).
In caso di DE psicogena l’impianto protesico è indicato dopo il fallimento o la non attuabilità dei trattamenti sessuologici e psicoterapici e la scarsa accettazione dei farmaci orali e intracavernosi.
Le protesi di dividono in soffici, malleabili, e idrauliche e in genere vengono impiantate tramite un piccolo accesso peno-scrotale con l’ausilio del divaricatore di Scott.
1) Le protesi soffici e malleabili non gonfiabili sono indicate in soggetti con scarsa destrezza manuale, che hanno rapporti stabili di coppia e che rifiutano la protesi idraulica.
Vantaggi:
• Perfetta rigidità
• Accesso chirurgico minimo
• Non richiedono alcuna attivazione
• Bassa percentuale di rotture
• Costi relativamente contenuti
Svantaggi:
• Non perfetta simulazione della flaccidità
• Possibile deformazione durante il rapporto
• Manovre endo-urologiche difficoltose se il pene è lungo
2) Le protesi idrauliche bi o tricomponenti gonfiabili possono essere a due (cilindri e istema pompa-serbatoio unico) o tre componenti (cilindri, pompa e serbatoio), tali protesi forniscono risultati migliori sia da un punto di vista funzionale che estetico, e sono indicate in tutti i tipi di deficit erettivo, in pazienti privi di impedimenti fisici con necessità di occultare la presenza dell’impianto (Fig.3).

Fig. 3 - Protesi Idrauliche
Vantaggi:
• Ottima simulazione di flaccidità
• Ottima rigidità (maggiormente per le protesi tricomponenti rispetto alle bicomponenti)
Svantaggi:
• Necessità di attivazione manuale
• Possibili rotture o migrazione dei componenti
• Possibili compressioni della pseudocapsula fibrosa che si forma intorno all‘impianto
• Costi relativamente alti.
ERECTILE DySFUNCTION (ED): DIAGNOSIS, CAUSES AND TREATMENT
Erectile dysfunction (ED) is defined as the persistent inability to achieve or maintain an erection sufficient for satisfactory sexual intercourse. It is a common disorder whose prevalence increases with age, although it can also affect younger individuals. There may be psychogenic, organic, or mixed causes.
Major risk factors include cardiovascular disease, diabetes mellitus, hypertension, dyslipidaemia, obesity, smoking, a sedentary lifestyle, certain medications (e.g. antidepressants and antihypertensives), neurological diseases, endocrine disorders and anatomical abnormalities.
In young men, ED is more frequently linked to psychological factors such as performance anxiety, stress and trauma, whereas in men over 50 organic causes are predominant.
Diagnosis begins with a thorough patient history, examining medical, psychological and sexual factors, lifestyle habits and medications taken. An objective examination evaluates the external genitalia, secondary sexual characteristics and the prostate, as well as looking for any signs of systemic disease.
Laboratory tests include a hormone profile (total testosterone, LH, PRL and TSH) and metabolic testing to identify any endocrine dysfunctions or comorbidities.
The following tests can be performed to investigate the cause of ED:
• Fractional Inhibitory Concentration (FIC) test, involving an intracavernous injection of prostaglandin E1, is an effective method for evaluating vascular responsiveness;
• Nocturnal RigiScan, which analyses spontaneous erections during sleep;
• Dynamic penile echocolour Doppler ultrasound, to assess the arterial and venous components of the penis in response to prostaglandin.
ED is known to be an early indicator of cardiovascular disease; patients with ED are at an increased risk of ischaemic events, which often occur 2–5 years prior to the onset of cardiac symptoms. Therefore, an early diagnosis of ED can help to identify individuals at risk of cardiovascular disease.
The personalised treatment follows a step-by-step approach:
1. Lifestyle changes, such as changes to diet and physical activity, as well as quitting smoking and drinking alcohol.
2. Psychological support, particularly if the cause is psychosexual.
3. Oral medications (PDE5 inhibitors such as sildenafil, tadalafil, vardenafil and avanafil) are effective in the majority of patients and should be taken before intercourse. They are contraindicated with nitrates.
4. Intracavernous injections of prostaglandins are useful for patients who do not respond to PDE5i drugs
5. Experimental treatments include low-intensity penile shock waves, platelet-rich plasma (PRP) and stem cells.
6. Penile prostheses (hydraulic or semi-rigid) are indicated for severe and refractory cases.
Erectile dysfunction is a complex disorder with significant physical and psychological implications. It may also be an early sign of systemic disease, so an integrated, multidisciplinary approach is essential for effective management.
SALUTE SESSUALE.
Il ruolo dell’alimentazione
di Laura Scappaticci
Docente UniCamillus di Alimentazione, Patologie Ginecologiche e Fertilità
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute sessuale come “uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale in relazione alla sessualità, parte integrante della salute e del benessere dell’individuo”.
Ad influenzare la salute sessuale concorrono diversi fattori: biologici, nutrizionali, sociali. I fattori biologici sono principalmente rappresentati dagli ormoni, che giocano un ruolo chiave nella regolazione della salute sessuale, a partire dalla pubertà e per tutta la vita adulta. Sia l’apparato riproduttore femminile che quello maschile sono strutture deputate alla produzione di ormoni sessuali: tale produzione viene influenzata e finemente controllata – oltre che da sistemi di feedback – anche da altre vie che riguardano processi metabolici, a loro volta influenzati dallo stato nutrizionale del soggetto. Ad esempio, nella donna, il ciclo ovarico e il ciclo mestruale scandiscono la crescita e la maturazione degli ovociti, la preparazione dell’endometrio e la produzione di ormoni chiave come estrogeni e progesterone, i cui livelli e la cui funzione sono intimamente legati alla disponibilità energetica e ai nutrienti introdotti con la dieta.
Questa regolazione fine tra produzione di ormoni e processi metabolici è stata abbondantemente descritta in letteratura. È oggi chiaro che carenze nutrizionali, come allo stesso modo anche eccessi alimentari, oppure una dieta qualitativamente inadeguata, possono alterare la produzione di ormoni sessuali
sia nella donna che nell’uomo. Tale alterazione può portare a un malfunzionamento del sistema riproduttivo che si può manifestare a vari livel li. Ad esempio nella donna una dieta incon grua può alterare il ciclo mestruale, eventualmente compromettere la qualità dei gameti, può addirittura influire sulla recettività endometriale determinando effetti significativi sulla fertilità e sulla funzione sessuale. Un altro esempio paradigmatico di come una carenza nutrizionale interferisca sulla salute sessuale e riproduttiva è quello dell’amenorrea ipotalamica funzionale. In questa condizione una inadeguata disponibilità energetica, spesso esito di diete eccessivamente restrittive o di condizioni di stress psicofisico, innesca un blocco della secrezione pulsatile dell’ormone rilascio delle Gonadotropine (GnRH), che determina un’assenza di ovulazione e ciclo mestruale. Tale condizione ha ripercussioni anche sulla salute ossea e quella cardiovascolare della donna. Allo stesso modo anche nell’uomo c’è una forte interazione tra stato nutrizionale e benessere sessuale e riproduttivo. La spermatogenesi, ossia la produzione e la maturazione degli spermatozoi, dipende in modo stretto dalla sintesi di testosterone, ormone la cui produzione richiede un adeguato apporto di micro

e macronutrienti fondamentali.
Tra i macronutrienti particolarmente studiati ritroviamo i grassi. Questi si suddividono in:
• grassi saturi: privi di doppi legami, sono ricchi di atomi di idrogeno e si trovano soprattutto in alimenti di origine animale come uova, latte e derivati, ma anche in alcuni vegetali, come l’olio di cocco e di palma;
• grassi insaturi: contengono uno o più doppi legami. I monoinsaturi si trovano principalmente nell’olio d’oliva e nella frutta secca, mentre i polinsaturi (PUFA) abbondano nel pesce, nelle noci, nell’olio di girasole e in altri estratti vegetali. Gli Omega 3 sono grassi polinsaturi essenziali.
I grassi polinsaturi PUFA sembrano essere coinvolti positivamente in numerosi processi legati alla fertilità. In particolare, la composizione della membrana ovocitaria è un fattore chiave per la fecondazione, poiché il concepimento richiede una serie di processi che iniziano con il riconoscimento e la fusione delle membrane dello spermatozoo e dell’ovocita, e la composizione di queste membrane dipende al tipo di alimentazione che viene effettuata. Le diete ricche di acidi grassi monoinsaturi (ad es. l’olio d’oliva) e polinsaturi (come EPA e DHA) sono state correlate a un miglioramento della qualità ovocitaria, della recettività endometriale e a una riduzione del rischio di disturbi ovulatori. È per questo motivo che ne viene raccomandato l’introito nei casi di programmazione di una gravidanza, sia essa naturale o tramite tecniche di fecondazione assistita. Gli omega-3 contribuiscono alla sintesi delle prostaglandine, importanti nella fisiologia riproduttiva, e hanno effetti antinfiammatori che migliorano la qualità dell’ovocita e l’impianto dell’embrione. In generale un’alimentazione ricca di alimenti a basso indice infiammatorio (come avocado e noci, ricchi di grassi monoinsaturi, folati e antiossidanti) potrebbero favorire la fertilità e la salute ovarica. Al contrario, un’alimentazione ricca di alimenti ad alto indice pro infiammatorio, contenenti elevate quantità di acidi grassi saturi, è stata associata a un rischio maggiore di disturbi dell’ovulazione, infiammazione ovarica e alterazione dell’ambiente follicolare. Questi meccanismi
possono ridurre la probabilità di concepimento e aumentare il rischio di aborto spontaneo.
Anche nell’uomo i PUFA a catena lunga, come EPA e DHA, sono utili per mantenere una adeguata fluidità della membrana spermatica e di conseguenza aumentare la fertilità maschile. Inoltre, questi grassi svolgono un ruolo chiave nella sintesi di eicosanoidi, agenti biologici che regolano il metabolismo degli steroidi. Numerosi studi suggeriscono che l’integrazione alimentare di PUFA può migliorare la qualità dello sperma e modulare la funzionalità mitocondriale, aumentando la capacità energetica degli spermatozoi e proteggendoli dallo stress ossidativo. Al contrario, l’assunzione di grassi saturi e trans, tipica delle diete occidentali ad alto contenuto di alimenti trasformati e povera di fibre, è stata associata a un aumento dello stress ossidativo, a una maggiore produzione di citochine pro-infiammatorie e a disfunzioni mitocondriali.
MODELLI
ALIMENTARI ASSOCIATI AD UNA MIGLIORE SALUTE SESSUALE NEGLI UOMINI E NELLE DONNE
Il legame tra nutrizione e funzione sessuale è mediato da fattori fisiologici e fisiopatologici: entrano in gioco sicuramente il sistema metabolico-ormonale, quello gastrointestinale e quello cardiovascolare, ma anche la salute mentale, l’umore, e altri fattori come il microbiota intestinale e l’infiammazione cronica di basso grado. Rispetto alle abitudini alimentari per un’alimentazione protettiva verso la salute sessuale, sempre più evidenze scientifiche dimostrano che l’approccio vincente è quello di adottare una visione complessiva basata sui pattern alimentari, ovvero sull’insieme delle abitudini alimentari che caratterizzano la dieta nel suo complesso. È ormai acclarato che la dieta occidentale – caratterizzata da un elevato consumo di alimenti ultra processati, grassi saturi e zuccheri semplici – si associa a un aumento dello stress ossidativo e dell’infiammazione cronica di basso grado, due condizioni che danneggiano la microcircolazione in generale e quindi manifestano i loro effetti anche sulla circolazione degli organi genitali, così come lo stress ossidativo influisce sulla qualità dei gameti.
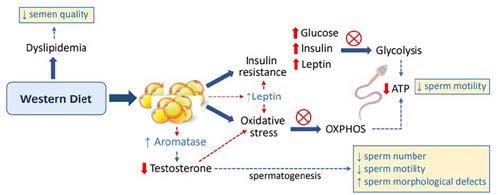
Al contrario, la Dieta Mediterranea, ricca di alimenti vegetali, pesce, olio extravergine d’oliva e povera di grassi saturi, rappresenta il modello più studiato e apprezzato nella letteratura scientifica internazionale anche in ambito di miglioramento della salute sessuale. Numerosi studi hanno infatti evidenziato come l’aderenza a questo pattern alimentare si associ a una salute sessuale e ad esiti riproduttivi migliori sia nell’uomo che nella donna. In particolare, per quanto riguarda la salute sessuale maschile, una revisione sistematica di Sultan et al. (2024) dimostra che la dieta mediterranea sia efficace nel prevenire e migliorare diverse condizioni urologiche maschili: la disfunzione erettile, la litiasi renale, i sintomi delle basse vie urinarie e l’incontinenza urinaria. Tali vantaggi risultano ancora più evidenti quando la dieta viene utilizzata in soggetti che soffrono di sindrome metabolica. La sindrome metabolica, condizione clinica caratterizzata dalla combinazione di obesità addominale, ipertensione, dislipidemia e insulino-resistenza, presenta purtroppo una prevalenza in costante ascesa, e rappresenta un importante fattore di rischio per numerose disfunzioni sessuali sia nell’uomo che nella donna. In questo contesto, la dieta mediterranea si distingue come un modello alimentare capace di influenzare positivamente la salute sessuale, grazie alle sue riconosciute proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e vasodilatatrici. Questa visione è confermata anche da una recente revisione della letteratura pubblicata su Nutrients (Oteri et al.,
2024), che mette in evidenza come l’adozione della dieta mediterranea possa favorire un miglioramento della funzione erettile nell’uomo e apportare benefici alla salute sessuale femminile, soprattutto in condizioni come la Sindrome dell’Ovaio Policisitico (PCOS) e l’endometriosi. Inoltre un altro aspetto importante è la connessione tra la salute cardiovascolare, l’umore e la funzionalità sessuale. I nutrienti assunti, infatti, interagiscono con i sistemi serotoninergico, dopaminergico e noradrenergico, modulando la risposta psico-emotiva legata alla sessualità. Alcuni alimenti specifici si sono mostrati particolarmente rilevanti in questo contesto, di seguito qualche esempio: la riduzione dell’apporto di sodio migliora la capacità di dilatazione dei vasi sanguigni, con un effetto diretto sull’eccitazione genitale; il cioccolato (ricco di flavonoidi) promuove la vasodilatazione mediata dall’ossido nitrico; l’anguria apporta citrullina, precursore dell’arginina, essenziale per la produzione di ossido nitrico; frutti ricchi di polifenoli, come le mele, grazie anche al contenuto di antiossidanti e fitoestrogeni, creano un ambiente antinfiammatorio e anti-aterosclerotico.
È noto ormai da molto tempo che stati carenziali di vitamina D e ferro sono correlati a disfunzioni sessuali. La vitamina D, i cui recettori si trovano anche nell’utero e nelle ovaie, influenza la steroidogenesi e l’aromatizzazione del testosterone, con effetti sui livelli ormonali. Nell’anemia sideropenica, infine, l’affaticamento cronico sembra mediare la relazione tra carenza di ferro
e disfunzione sessuale.
IL RUOLO DEL PESO CORPOREO NELLA SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA
Il peso corporeo rappresenta un determinante fondamentale della salute sessuale e riproduttiva, sia nella donna che nell’uomo.
Secondo uno studio pubblicato su Sexes da McNabney (2022), l’obesità può compromettere la funzione sessuale attraverso tre meccanismi principali: la disregolazione del tessuto adiposo, l’alterata regolazione glicemica e la presenza di infiammazione cronica.
Negli uomini, a livello ormonale, l’aumento dell’aromatasi, enzima che converte il testosterone in estradiolo, determina un calo dei livelli di testosterone e un aumento degli estrogeni con effetti negativi sulla sensibilità peniena, sull’erezione e sul desiderio.
Nelle donne, il ruolo di livelli di estrogeni persistentemente alti è più controverso, ma è noto che questi possono favorire la crescita di tumori estrogeno-dipendenti.
Persone con obesità presentano frequentemente un quadro di iperglicemia ed insulino resistenza. Studi su animali mostrano che queste condizioni riducono l’espressione di acquaporine, proteine fondamentali per la lubrificazione vaginale e la produzione delle secrezioni prostatiche e seminali.
L’infiammazione cronica tipica dell’obesità compromette la produzione di ossido nitrico (NO), fondamentale per vasodilatazione e vasocon-
gestione genitale, elemento centrale nella fase di eccitazione sessuale. Nella donna, l’obesità si associa a un rischio di infertilità triplicato rispetto alle coetanee normopeso, come evidenziato da numerosi studi epidemiologici. Questo legame si basa su una serie di meccanismi fisiopatologici che coinvolgono l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, l’iperinsulinemia e la resistenza insulinica, l’infiammazione cronica e la disregolazione ormonale. L’eccesso di tessuto adiposo determina un’aumentata aromatizzazione degli androgeni in estrogeni e una riduzione delle proteine leganti gli ormoni sessuali, favorendo uno stato di iperandrogenismo e di anovulazione cronica. Le adipochine secrete dal tessuto adiposo, come leptina e adiponectina, agiscono inoltre come modulatrici negative della funzione ovarica e della recettività endometriale, aggravando le difficoltà riproduttive. Gli studi mostrano come perdite di peso, anche modeste, migliorano sensibilmente la regolarità del ciclo mestruale, la qualità ovocitaria e la recettività endometriale, aumentando le probabilità di concepimento spontaneo o mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita. Anche nell’uomo l’obesità impatta negativamente sulla fertilità. L’eccesso di grasso viscerale e sottocutaneo si traduce in un’aumentata conversione periferica del testosterone in estrogeni, con una conseguente riduzione dei livelli di testosterone libero e un’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi.
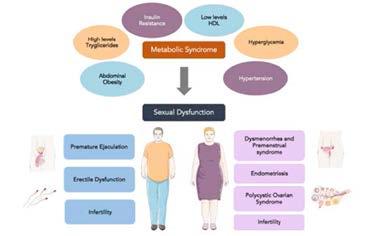

Effetti positivi della dieta mediterranea sulla disfunzione sessuale in uomini e donne con sindrome metabolica. Il verde chiaro indica un effetto positivo più debole, mentre il verde scuro indica un effetto positivo più forte.
Tale disfunzione ormonale si associa a una compromissione della spermatogenesi, con riduzione della concentrazione, della motilità e della morfologia degli spermatozoi, oltre a un aumento della frammentazione del DNA spermatico. L’obesità maschile è inoltre un fattore di rischio ben documentato per la disfunzione erettile, espressione sia di meccanismi organici (alterazioni vascolari e infiammatorie legate alla sindrome metabolica) sia di aspetti psicologici, quali la ridotta autostima e la percezione negativa della propria immagine corporea. Inoltre l’eccesso adiposo, in particolare a livello addominale e inguinale, aumenta la temperatura scrotale, compromettendo ulteriormente la spermatogenesi. Le evidenze più recenti indicano che un calo ponderale anche solo del 5-15% determina un significativo miglioramento dei parametri endocrini e seminali maschili, con benefici diretti sulla fertilità e sulla funzione sessuale.
MENOPAUSA E SALUTE SESSUALE
Un altro importante aspetto da considerare è quello relativo alla salute sessuale della donna in menopausa. Questa rappresenta una fase cruciale nella vita della donna, in cui la riduzione dei livelli di steroidi sessuali (estrogeni e androgeni) gioca un ruolo importante nella
compromissione della risposta sessuale. Inoltre i cambiamenti psicologici e relazionali correlati all’invecchiamento e l’aumento delle comorbilità metaboliche e cardiovascolari influiscono ulteriormente sulla salute sessuale.
Secondo una recente revisione della letteratura pubblicata su Nutrients (Silva et al., 2021), l’adozione di un modello alimentare mediterraneo si associa a numerosi benefici anche per le donne in post-menopausa, inclusa una riduzione della pressione arteriosa, una migliore regolazione del profilo lipidico e una composizione corporea più favorevole (riduzione del grasso viscerale e preservazione della massa magra). Tali miglioramenti si riflettono positivamente sulla funzione sessuale, poiché la salute vascolare e il bilancio ormonale sono strettamente connessi alla risposta sessuale femminile. Inoltre la dieta mediterranea, caratterizzata dall’elevato contenuto di grassi mono e polinsaturi, fibre alimentari, vitamine e minerali, è in grado di modulare l’infiammazione cronica di basso grado e lo stress ossidativo, due fattori centrali nel declino della funzione sessuale durante la menopausa. Tale pattern alimentare rappresenta pertanto un modello di riferimento per promuovere un invecchiamento sano e una funzione sessuale soddisfacente anche in età matura.
T HE ROLE OF NUTRITION IN SE x UAL HEALTH
According to the World Health Organisation (WHO), sexual health is defined as a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality. This state is influenced by multiple factors, including biological, nutritional, and social aspects. Sex hormones, produced by the male and female reproductive systems, are regulated by metabolic mechanisms that are strongly linked to nutritional status. Dietary deficiencies or excesses can alter hormone production, which can have a negative effect on fertility and sexual function. For example, in women, an inappropriate diet can alter the menstrual cycle, impair oocyte quality, and reduce endometrial receptivity. One example is functional hypothalamic amenorrhoea, which is linked to poor energy availability. Even in men, spermatogenesis and testosterone production require an adequate nutrient supply.
Among the macronutrients, fats play a crucial role. In particular, unsaturated fats such as PUFAs (e.g. omega-3) are beneficial for fertility as they improve oocyte and sperm quality, promote endometrial receptivity and reduce inflammation. PUFAs improve cell membrane fluidity and mitochondrial function, thereby enhancing sperm motility and vitality. In contrast, saturated and trans fats, which are typical of Western diets that are high in processed foods, are associated with oxidative stress, inflammation, and reduced gamete quality.
Numerous studies support the efficacy of dietary patterns rather than individual nutrients. The Mediterranean diet, which is rich in plant foods, fish and olive oil, and low in saturated fats, is particularly beneficial for sexual health. It has antioxidant, anti-inflammatory and vasodilator properties which improve microcirculation and gamete quality while reducing sexual dysfunction. A study by Sultan et al. (2024) showed that this type of diet can prevent and improve male urological dysfunctions such as erectile dysfunction and urinary disorders, particularly in individuals with metabolic syndrome. The Mediterranean diet has also been shown to be beneficial for female conditions such as polycystic ovary syndrome (PCOS) and endometriosis
There is a direct link between cardiovascular health, mood, and sexual function. Specific foods, such as chocolate (which contains flavonoids), watermelon (which contains citrulline) and apples and dried fruit (which contain polyphenols and antioxidants), can improve vasodilation and sexual response. Key micronutrients include vitamin D, which affects hormone production, and iron, whose deficiency is associated with fatigue and sexual dysfunction.
Body weight is a determining factor in sexual and reproductive health. Obesity can alter hormonal balance: in men, it increases the conversion of testosterone into oestrogen, which can lead to reduced libido and erectile dysfunction, while in women it can cause anovulation, ovarian dysfunction, and impaired endometrial receptivity. These disorders are underlying factors of insulin resistance, chronic inflammation and dysfunction of the hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis. Spermatogenesis is also impaired: obesity and high scrotal temperature can reduce sperm quality. However, modest weight loss (5-15%) can significantly improve hormonal parameters, fertility and sexual function in both sexes. Finally, menopause is a critical phase for female sexual health, characterised by a decline in sex hormones and physical and psychological changes. According to Silva et al. (2021), the Mediterranean diet is also effective during this phase, improving vascular health, lipid profile, and body composition. Its anti-inflammatory and antioxidant properties help to preserve sexual function in ageing women.
LVantaggi nell’applicazione alle patologie ostetricoginecologiche in campo clinico e di ricerca
di Valentina Bruno
Docente
UniCamillus di Ginecologia e Ostetricia

’Immunologia della Riproduzione studia le interazioni tra siste ma immunitario e apparato riproduttivo, contribuendo alla comprensione di numerose patologie ostetriche e ginecologiche, migliorando le strategie terapeutiche. Molte condizioni comuni – come pre-eclampsia, parto pretermine, poliabortività, infertili tà, repeated implantation failure (RIF), endometriosi, sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), insufficienza ovarica precoce (POF) e neoplasie ginecologiche – presentano un importante background immunologico, ancora in parte da chiarire.
Durante la gravidanza, l’ambiente immunitario materno viene finemente regolato. Inizialmente, è necessaria una risposta pro-infiammatoria a livello dell’ interfaccia materno- fetale per favorire l’impianto embrionale; questa è seguita da una fase antinfiammatoria, cruciale per il “non rigetto” del feto in quanto “semi-allogenico” (metà del patrimonio genetico è paterno) ed il mantenimento della gravidanza. Nelle ultime fasi gestazionali, una nuova attivazione infiammatoria favorisce l’insorgenza del travaglio. L’induzione di uno stato immunitario tollerante avviene tramite l’azione coordinata di cellule immunitarie specifiche, tra cui natural killer (NK), macrofagi, linfociti T, cellule dendritiche, APC e MDSC. Un’alterazione nei loro pathways può compromettere l’impianto e lo sviluppo fetale, favorendo l’insorgenza di complicanze ostetriche. Il sistema immunitario materno deve quindi adattarsi continuamente per garantire una corretta placentazione e sviluppo fetale.

Molte complicanze della gravidanza possono essere considerate manifestazioni diverse di un’unica alterazione nei meccanismi di infiammazione, immunomodulazione e placentazione.
ABORTO SPONTANEO RICORRENTE
Nonostante siano noti diversi fattori di rischio per la poliabortività (età, obesità, fumo, stress) e fattori eziologici certi (malformazioni uterine, anomalie cromosomiche, cause ormonali, autoimmunità, sindrome da anticorpi antifosfolipidi, trombofilie), circa il 40-50% dei casi rimane a eziologia sconosciuta. In questi, è stato ipotizzato un possibile coinvolgimento di un’alterata risposta immunitaria a livello dell’interfaccia materno-fetale. Studi suggeriscono una predisposizione alla rottura dei meccanismi di auto-tolleranza, un’aumentata risposta pro-infiammatoria e una disregolazione dell’immunitàmaterna verso antigeni fetali o trofoblastici. La poliabortività inspiegata rappresenta tuttora un campo controverso, soprattutto riguardo a quali esami includere nel work-up diagnostico. Per anni, sono stati richiesti test costosi senza che vi fossero evidenze scientifiche solide a sostegno. Lo studio dei meccanismi immunologici alla base della sua eziopatogenesi resta fondamentale, anche se attualmente non esiste un livello di evidenza sufficiente per raccomandare l’esecuzione routinaria di test immunologici, se non a fini esplorativi. Questo si riflette anche sull’utilizzo clinico di farmaci immuno-modulatori. Le linee guida raccomandano l’associazione di eparina a basso peso molecolare (LMWH) e aspirina a basse dosi solo nei casi con diagnosi di sindrome da anticorpi antifosfolipidi. In altri contesti, non vi

sono evidenze che LMWH e/o aspirina migliorino la prognosi. Nonostante ciò, LMWH è stata spesso usata come terapia empirica per le sue potenziali proprietà immuno-regolatorie, anche in assenza di forti raccomandazioni. Gli studi in merito, infatti, risultano troppo eterogenei per poter essere confrontati o inclusi in metanalisi: differenze nella definizione di poliabortività, nella selezione della popolazione, nella tempistica della terapia, nella concordanza dei test di screening per trombofilia e nei criteri di inclusione/diagnosi ne limitano l’affidabilità. Pertanto, è urgente approfondire la conoscenza dei meccanismi immunitari implicati, per poter comprendere meglio gli effetti delle terapie utilizzate empiricamente e sviluppare approcci più mirati.
PRE-ECLAMPSIA
Questa patologia deriva da alterati meccanismi di invasione trofoblastica e da un mancato rimodellamento delle arterie spirali dell’utero con una conseguente placentazione inadeguata. Il sistema immunitario gioca un ruolo importante, insieme a fattori genetici e stress ossidativo, mediando gli effetti della disfunzione placentare sia sul feto – ritardo di crescita intrauterino, parto prematuro, morte intrauterina fetale – che, a livello sistemico, sulla madre – ipertensione, proteinuria, HELLP syndrome, eclampsia, insufficienza renale ed epatica e coagulazione intravascolare disseminata. Alterazioni immuno-modulatorie nella fase di impianto compromettono la placentazione, causando ipoperfusione, rilascio di fattori anti-angiogenici e attivazione immunitaria materna, con conseguente infiammazione sistemica e sintomi clinici. A livello terapeutico, l’utilizzo dell’aspirina a basse dosi (oltre al suo noto effetto anti-aggregante), garantisce un’azione anti-ossidante, anti-infiammatoria ed immunomodulatoria. Sono stati pubblicati diversi studi randomizzati di grandi dimensioni che hanno dimostrato una riduzione dell’incidenza di pre-eclampsia nelle pazienti ad alto rischio trattate in profilassi mediante aspirina a basse dosi.
ENDOMETRIOSI
L’endometriosi colpisce il 10-15% delle donne in età fertile in Italia, influenzando negativamente la qualità della vita e la fertilità (30-40% dei casi). È anche associata a un aumento del rischio di neoplasie ginecologiche, in particolare nei tumori ormo -
no- dipendenti delle pazienti più giovani. L’eziologia è multifattoriale e coinvolge aspetti endocrini, immunologici e genetici, con un ruolo centrale dello stress ossidativo. L’attivazione dei macrofagi e la presenza di frammenti endometriali apoptotici contribuiscono a un ambiente pro-ossidante, con aumento delle lipoproteine ossidate (ox-LDL). Il profilo immunitario endometriale varia con il ciclo mestruale, e queste fluttuazioni ormonali influenzano anche la fisiopatologia dell’endometriosi. L’associazione tra endometriosi e alcuni tumori ginecologici suggerisce che i meccanismi endocrino-immunologici coinvolti possano contribuire sia alla malattia benigna sia ai meccanismi di immune escape tumorale. È stata descritta una “firma molecolare” dell’endometriosi, utile per comprendere i meccanismi che ne favoriscono la trasformazione maligna, evidenziando una possibile correlazione genetica trasversale. Tra i principali geni coinvolti, le mutazioni nei recettori di estrogeni e progesterone ne aumentano l’ipersensibilità, favorendo la progressione della malattia. Le vie di segnalazione ormono-dipendenti, influenzate dallo stress ossidativo, giocano un ruolo cruciale nella patogenesi. In questa prospettiva, la rete genetico-immuno-endocrina dell’endometriosi può rappresentare un utile strumento per lo sviluppo di terapie mirate contro i tumori correlati.
CANCRO DELL’ENDOMETRIO
Il cancro dell’endometrio è il tumore più frequente del tratto genitale femminile, con incidenza crescente anche sotto i 40 anni. Nelle fasi iniziali la prognosi è favorevole, ma in caso di patologia tumorale ricorrente o metastatica resta sfavorevole. L’ambiente immunologico dell’interfaccia materno-fetale condivide numerose caratteristiche con il microambiente tumorale (TME). Entrambi presentano una fase iniziale pro-infiammatoria seguita da una fase immunosoppressiva: nel primo caso per favorire il non rigetto fetale, nel secondo per permettere la sopravvivenza delle cellule tumorali. Tuttavia, nella gravidanza a termine si verifica un nuovo switching pro-infiammatorio che avvia il travaglio; nel tumore, invece, questo stadio manca, e il processo di immune escape prosegue in modo incontrollato. Comprendere il “timing” delle risposte immunitarie nella progressione tumorale e il ruolo di attori immunologici positivi e negativi è ancora una sfida. Tuttavia, l’analisi degli adatta-

menti immunitari ben regolati in gravidanza – e della loro alterazione nelle complicanze ostetriche – può rivelare un potenziale “orologio immunitario” anche nella cancerogenesi. Questo approccio potrebbe permettere l’identificazione di specifici pathways molecolari coinvolti nella transizione da lesione precancerosa a neoplasia, aprendo nuove prospettive in campo immunoterapico. Tradurre la conoscenza dei meccanismi di tolleranza immunitaria materno-fetale alla comprensione dell’immune escape tumorale può rappresentare una strategia innovativa: studiare ciò che in natura è stato già “programmato” con una precisa limitazione nel tempo e nello spazio, l’immunotolleranza materno-fetale, potrebbe portare a riconoscere questi pathways, per limitare nel tempo e nello spazio ciò che non è finemente regolato, come il processo di immune escape del cancro.
IMMUNOPERINATOLOGIA
L’immunoperinatologia mette in relazione l’immunologia e la medicina perinatale, studiando le interazioni immunologiche tra madre, placenta e feto, e le relative conseguenze fino al periodo neonatale. L’ambiente immunologico materno durante la gravidanza può determinare delle modificazioni sulla futura risposta immunitaria del neonato, predisponendolo ad un rischio aumentato di alcune patologie neonatali di tipo immunitario, neurologico e metabolico, quali disturbi dello spettro autistico (ASD), asma, dermatite atopica, allergie alimentari, disturbi metabolici e cardiovascolari come l’obesità, il diabete e l’ipertensione. Una disregolazione immunitaria a livello materno-fetale può quindi causare effetti a breve termine, che si manifestano alla nascita, o a lungo termine sul neonato portando ad una “programmazione fetale” mediante meccanismi epigenetici.
The immunology of reproduction: clinical and research benefits in obstetric and gynaecological diseases
The immunology of reproduction studies the interactions between the immune and reproductive systems, contributing to our understanding of many obstetric and gynaecological diseases and improving therapies. Common conditions such as pre-eclampsia, preterm delivery, recurrent miscarriage, infertility, repeated implantation failure (RIF), endometriosis, polycystic ovary syndrome (PCOS), premature ovarian failure (POF) and gynaecological cancers have an immunological basis that is not fully understood.
During pregnancy, the maternal immune environment undergoes dynamic regulation: an initial pro-inflammatory response promotes embryo implantation, followed by an anti-inflammatory phase that enables the body to tolerate the semi-allogeneic foetus. At the end of pregnancy, a new inflammatory activation initiates labour. This balance is coordinated by immune cells such as the NK cells, macrophages, T-lymphocytes, APCs and MDSCs. Alterations to these pathways can compromise implantation and placentation, favouring obstetric complications. These may represent different manifestations of a single immunological dysregulation. Recurrent Spontaneous Abortion: In 40-50% of cases of recurrent spontaneous abortion (RSA), the underlying cause remains unknown. In these cases, an altered immune response at the maternalfoetal interface is assumed to occur, involving loss of tolerance, inflammatory hyperactivation, and a reaction against foetal or trophoblastic antigens. However, there is currently no solid evidence to support the routine use of immunological testing. The LMWH + aspirin combination is only indicated in cases of antiphospholipid antibody syndrome. Other immune-modulating therapies (glucocorticoids, IVIG, G-CSF and scratching) are not recommended for unexplained RSA. New approaches, such as artificial intelligence, could help to identify effective predictors, optimise the diagnostic process and reduce costs, while improving therapeutic personalisation. Pre-eclampsia is a multifactorial disease due to inadequate trophoblastic invasion and failure to remodel spiral arteries. Placental hypoperfusion activates the immune system, resulting in the release of anti-angiogenic factors and systemic inflammation. Clinical manifestations affect both the mother and the foetus. In addition to its anti-platelet effect, low-dose aspirin exerts antioxidant, anti-inflammatory and immune-modulatory actions, thereby reducing the incidence of the disease in patients at risk.
Endometriosis: It affects 10-15% of women of childbearing age and has an impact on quality of life and fertility (30-40%), as well as increasing the risk of hormone-dependent gynaecological cancers. It has a multifactorial origin involving oxidative stress, immune dysfunction, activated macrophages and apoptotic fragments, which create a pro-oxidant environment. Fluctuations in the immune system during the menstrual cycle influence pathogenesis. A molecular signature associated with the risk of malignant transformation has been identified, involving alterations to oestrogen and progesterone receptors. Therapies involving hormones, Gn-RH, progestins and aromatase inhibitors also act through immune modulation.
Endometrial carcinoma: It is the most common gynaecological tumour, with a favourable prognosis in the early stages but an unfavourable prognosis in advanced forms. The tumour’s immune microenvironment shares mechanisms with the maternal-foetal interface, consisting of an initial pro-inflammatory phase followed by immune tolerance. However, unlike childbirth, it lacks the final inflammatory switching phase, which allows tumour immune escape. Studying the immune dynamics of pregnancy could provide valuable insights for developing new immunotherapeutic strategies. Immunoperinatology: This field links immunology and perinatal medicine, analysing the interaction between the maternal immune system, the placenta, and the foetus. Immune dysregulation can alter foetal programming via epigenetic mechanisms, predisposing the newborn to immune, neurological and metabolic disorders such as asthma, allergies, autism spectrum disorder (ASD), obesity and diabetes. Therefore, the immunological environment during pregnancy has an impact on neonatal immune development, with short- and long-term effects.
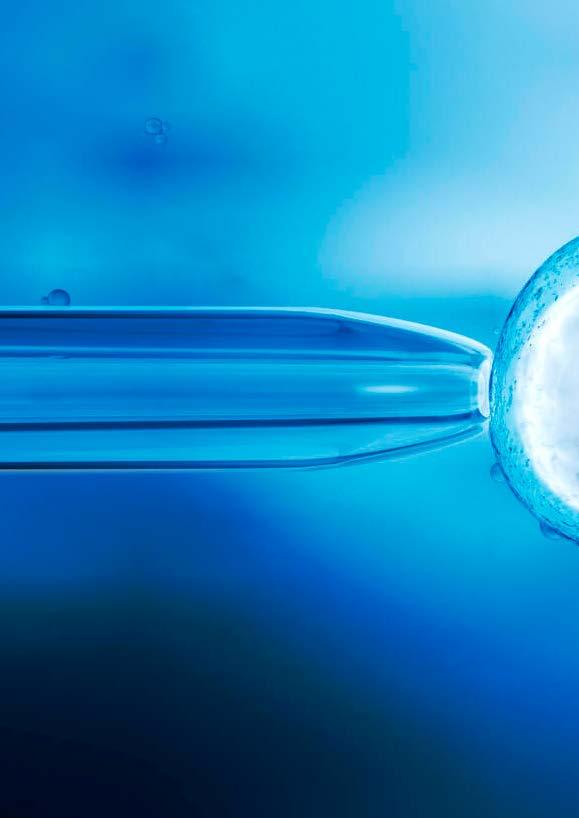
Successo, fattori influenti e strategie personalizzate
di Ermanno Greco
Docente
UniCamillus di Ostetricia e Ginecologia
Le tecniche di riproduzione assistita (ART – Assisted Reproductive Technology), la fecondazione in vitro (IVF – In Vi tro Fertilization) e l’iniezione intra citoplasmatica di spermatozoi (ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection), hanno molto successo per cercare di superare le molteplici cause alla base dell’infertilità femminile e maschile. Infatti, si calcola che fino ad oggi nel mondo siano nati almeno dodici milioni di bambini con queste procedure.
Percentuali di successo in italia

Il trasferimento embrionario è una delle fasi finali di un ciclo di fecondazione assistita, in particolare della fecondazione in vitro. Dopo che gli ovociti prelevati dalla donna sono stati fecondati in laboratorio con gli spermatozoi, gli embrioni che si sviluppano vengono osservati per alcuni giorni. Quelli ritenuti più vitali e promettenti vengono poi trasferiti nell’utero della donna, con l’obiettivo che si impiantino e portino a una gravidanza.
La reale percentuale media di successo di tali procedure in Italia – dove ne vengono effettuate circa centomila in un anno – oscilla tra il 17 e il 18% per ogni trasferimento embrionario, e di circa il 27-28% dopo trasferimenti ripetuti (fonte Istituto Superiore di Sanità e dati aggregati che non tengono conto però delle percentuali di successo specifiche di ogni singolo Centro di Procreazione Medicalmente Assistita).
Varietà delle tecniche e loro efficacia
È necessario specificare che le tecniche di fecondazione in vitro oggi adottate dai vari Centri di Procreazione Medicalmente Assistita possono
essere molteplici, e ciascuna ha una sua specifica percentuale di riuscita, cosa che deve essere chiarita con la coppia prima di affrontare il percorso.
fattori genetici dell’embrione e ruolo dell’età materna
La capacità degli embrioni di impiantarsi nell’utero dipende per il 70% dalla loro normalità genetica cromosomica, e per il 30% dalla capacità del tessuto all’interno dell’utero (endometrio) di essere recettivo.
La salute genetica dell’embrione è determinata per l’80% dalla qualità genetica degli ovociti e per il 20% da quella degli spermatozoi.
Bisogna precisare che tutte le donne, anche giovani, possiedono sempre una parte dei propri ovociti che non è sana cromosomicamente, e che tale quota aumenta con l’aumentare dell’età materna. Infatti, al di sotto dei 30 anni è del 30% circa, ma dopo i 35 anni è di almeno il 50-60%. Risulta evidente che, se l’embrione formato in vitro deriva da un ovocita malato, risulta anch’esso malato, e la natura non lo fa impiantare o lo fa abortire, e questo avviene più frequentemente dopo i 35-36 anni.
limiti della selezione morfologica degli embrioni Nella maggior parte dei Centri, la selezione degli embrioni da trasferire all’interno dell’utero avviene in base alla loro morfologia, ossia viene data la priorità al trasferimento agli embrioni di migliore qualità. Tuttavia, non esiste nessuna correlazione tra qualità morfologica e salute genetica, ossia anche un embrione esteticamente “perfetto” può essere non sano e viceversa, e di conseguenza il

tentativo fallisce.
Pertanto, la tecnica di fecondazione in vitro con selezione morfologica degli embrioni può essere adottata in coppie giovani con una buona riserva ovarica, perché le alterazioni genetiche ovocitarie non sono elevate.
tecnologie aVanzate e miglioramento delle Percentuali di successo
Diversi studi internazionali hanno evidenziato che in questo gruppo di pazienti, in condizioni ottimali di laboratorio, la percentuale di successo della fecondazione in vitro dopo trasferimento di una singola blastocisti (l’embrione del quinto giorno) è del 30%, e sale al 40% dopo trasferimento di eventuali embrioni congelati residui, al 55% dopo una seconda stimolazione ovarica, e al 62% dopo la terza stimolazione. È possibile aumentare queste percentuali se la selezione degli embrioni non avviene solo attraverso le caratteristiche morfologiche ma morfocinetiche, ossia in base alla velocità di sviluppo cellulare dell’embrione. Oggi questo può essere possibile se il laboratorio possiede un particolare strumento detto Embrioscope, dotato anche di un algoritmo di intelligenza artificiale (Kidscore, iDAscore) per la selezione embrionaria. Anche l’utilizzo di mezzi di coltura contenenti acido ialuronico per il trasferimento dell’embrione può aumentare le percentuali di successo di un ulteriore 10%.
la diagnosi genetica PreimPianto (Pgt-a): una risorsa Per coPPie a rischio
La selezione morfologica degli embrioni non è sicuramente il mezzo più adeguato per assicurare le giuste percentuali di riuscita per tutte quelle coppie che hanno un maggior rischio di produrre ovociti ed embrioni anomali cromosomicamente, come le donne con età superiore ai 35/36 anni, donne con una storia di poliabortività, coppie con ripetuti tentativi di fecondazione in vitro falliti e nei casi di infertilità maschile grave. Per queste coppie il successo può essere raggiunto più facilmente se l’embrione a livello di blastocisti, prima di essere trasferito, viene sottoposto ad una particolare tecnica diagnostica detta diagnosi genetica preimpianto (PGT-A), in grado di valutare l’assetto cromosomico.
Essa consiste nel prelevare dallo strato esterno della blastocisti (trofoectoderma) 5-10 cellule e analizzarne l’assetto cromosomico con la moderna tecnica NGS (Next Generation Sequencing). Tale procedura non compromette l’impianto dell’embrione se effettuato da biologi esperti. Con questa tecnica è possibile distinguere un embrione sano (euploide) da uno malato (aneuploide). Il trasferimento di un unico embrione sano dà circa il 60-70% di possibilità di impianto.
imPatto dell’età materna sul successo della Pgt-a L’età materna è il fattore principale in grado di influenzare la produzione di un embrione sano e quindi anche il successo di tali tecniche. Le alterazioni genetiche embrionarie sono circa il 55% tra i 35 e i 36 anni, 70% tra i 39 ed i 40 anni, 85% tra i 42 ed i 44 anni, 90% intorno ai 45 anni.
L’età materna avanzata può ridurre anche il tasso di formazione delle blastocisti, con la conseguenza di un minor numero di embrioni da analizzare e scegliere.
Valutazione della riserVa oVarica e Protocolli Personalizzati
Il successo della diagnosi preimpianto dipende anche dal numero di ovociti prodotti durante la stimolazione ovarica, cosa che può essere preventivamente accertata sottoponendo la donna a due esami con risposte giornaliere: la conta ecografica dei follicoli antrali ed il dosaggio dell’ormone AMH (Ormone Antimulleriano).
Le donne che hanno una bassa riserva ovarica possono comunque ricorrere ad un particolare tipo protocollo di stimolazione ormonale detto “DUOSTIM”: esso consiste nell’eseguire due protocolli di stimolazione nello stesso mese per raggiungere un numero adeguato di ovociti per la tecnica.
La tecnologia oggi ha fatto passi da gigante rispetto a dieci anni fa, e attualmente consente il successo anche a donne che prima venivano avviate a programmi di ovodonazione. L’importante è sempre individuare e personalizzare il percorso per ciascuna singola coppia.
A SSISTED R EPRODUCTIVE T ECHNI q UES : SUCCESS AND PERSONALISED STRATEGIES
Assisted Reproductive Techniques (ARTs), such as In Vitro Fertilisation (IVF) and Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI), are effective solutions for overcoming multiple causes of female and male infertility. To date, the number of children born worldwide thanks to these procedures has reached at least 12 million .
In Italy, where around 100,000 IVF cycles are performed annually, the average success rate per embryo transfer is 17–18%, increasing to 27–28% following repeated transfers. However, these figures are aggregate values and do not take into account differences between individual Medically-Assisted Procreation (MAP) centres.
There are many different IVF techniques in use today, each with different success rates, so it is important that couples are fully informed before starting the process. An embryo’s ability to implant in the uterus depends on its genetic chromosomal health (70%) and the receptivity of the endometrium (30%). The genetic health of the embryo depends on the quality of the oocytes for 80% and the sperm cells for 20%.
All women have a proportion of oocytes with chromosomal abnormalities, a figure which increases with maternal age. For example, around 30% of oocytes are abnormal in women under 30, compared to 50-60% in women over 35. If an embryo is derived from an abnormal oocyte, nature tends to prevent its implantation or cause a miscarriage. This phenomenon is more frequent after the age of 35 or 36.
Embryos are mainly selected on the basis of morphology, i.e. the quality that can be seen under a microscope. However, there is no correlation between morphology and genetic health; aesthetically ‘perfect’ embryos may be genetically abnormal, and vice versa. This technique is particularly recommended for young couples with a good ovarian reserve, as genetic alterations are less common in these cases.
Under optimal laboratory conditions, IVF involving the transfer of a single blastocyst (a day-5 embryo) has an approximate success rate of 30%. This percentage can increase to 40% with the transfer of frozen embryos, 55% after a second round of ovarian stimulation, and 62% after a third. Using more advanced techniques such as morphokinetic selection, which is based on the speed of cell development and uses tools like the EmbrioScope integrated with artificial intelligence algorithms (e.g. Kidscore and iDAscore), can further improve success rates. Using culture media containing hyaluronic acid for embryo transfer can also increase implantation chances by 10%.
Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A) is an important tool for couples at an increased risk of chromosomal abnormalities. This includes women aged 35 or over , individuals who have experienced multiple miscarriages or failed IVF attempts , and cases of severe male infertility .
PGT-A analyses use Next-Generation Sequencing (NGS) techniques to examine certain cells taken from the trophectoderm of the blastocyst, in order to assess the chromosomal setup and differentiate between healthy (euploid) and abnormal (aneuploid) embryos. Transferring a healthy embryo increases the probability of implantation to 60–70%. However, maternal age remains the main factor influencing the production of healthy embryos, with the percentage of abnormalities rising from around 55% at 35–36 years of
age to around 90% at 45 years of age. Furthermore, advanced maternal age can reduce blastocyst formation, thereby limiting the number of embryos available for selection.
The success of PGT-A also depends on the number of oocytes obtained during ovarian stimulation, which can be assessed using antral follicle counts and Anti-Müllerian Hormone (AMH) dosage . In cases of low ovarian reserve, ‘DUOSTIM’ stimulation protocols can be employed, involving two stimulations in the same month to increase the number of oocytes collected.
Great progress has been made in the field of assisted reproductive technology in the last ten years, to the extent that it is now possible to avoid egg donation for women with very low ovarian reserves. However, it is crucial to customise the procedure for each couple and identify the most suitable technique to maximise their chances of success.
DIETRO OGNI
NUMERO, UNA SCELTA CHE FA LA DIFFERENZA:
UNICAMILLUS PROTAGONISTA
NEI DATI ALMALAUREA
Le chiamano statistiche, ma sono storie di vita vera: studenti soddisfatti, laureati in corso, opportunità lavorative concrete. UniCamillus cresce, e lo fa insieme ai suoi studenti.
di Ginevra Guidoni
In un mondo dove scegliere “dove studiare” significa decidere “chi diventare”, ci sono numeri che non restano solo cifre, ma diventano storie. Storie di impegno, di sogni realizzati. Storie di passione e dedizione. Storie di un futuro che prende forma. E i numeri di UniCamillus raccontano esattamente questo: una comunità che cresce, matura, eccelle e costruisce ponti concreti verso il mondo del lavoro e verso una società che possa diventare sempre più umana. I numeri UniCamillus sono un dato di fatto, e vengono raccontati dal XXVII Rapporto AlmaLaurea, che fotografa in modo approfondito il profilo e la condizione occupazionale dei laureati italiani, e che pone UniCamillus tra le realtà universitarie più dinamiche, efficaci e promettenti del panorama nazionale.
Ciò che rafforza l’orgoglio di aver raggiunto tali risultati sta soprattutto nella giovane età del nostro Ateneo medico: nata nel 2018, UniCamillus si è da subito distinta per la sua vocazione inclusiva, la sua visione globale e la volontà di formare professionisti capaci di agire nel mondo, ovunque ci sia bisogno di cura, con lo sguardo ben oltre i confini.
Oggi, a soli sette anni dalla fondazione, i risultati parlano chiaro: una qualità formativa altissima, una soddisfazione degli studenti tra le più elevate in Italia e soprattutto, un rapporto diretto ed effettivo con il mondo del lavoro.
un’uniVersità a misura di mondo
Uno degli elementi che rende UniCamillus un caso eccezionale nel contesto accademico italiano è la sua vocazione internazionale. Il nu-
mero di studenti stranieri è il doppio della media nazionale. Inoltre, oltre il 64,8% degli iscritti proviene da fuori regione, contro una media nazionale del 24,5%.
Non si tratta solo di statistiche: si tratta di uno stile educativo, di un ambiente multiculturale. Dove si impara non solo dai docenti, ma anche dai compagni. Dove ogni lezione diventa anche uno scambio di visioni, esperienze, punti di vista che provengono da ogni angolo del mondo. Inoltre, per chi sogna una carriera internazionale, inutile dire che a UniCamillus si costruiscono relazioni che vanno ben oltre i confini geografici e di mentalità.
numeri oltre i numeri: il modello di un’uniVersità che funziona
Tra i dati più incoraggianti raccolti da AlmaLaurea, c’è quello relativo al tasso di laureati in corso, che per il nostro Ateneo raggiunge l’89,5%, contro una media nazionale ferma al 58,7%. È un risultato che racconta molto: non solo studenti determinati e organizzati, ma anche docenti disponibili, strutture adeguate, percorsi didattici ben costruiti e un sistema di supporto efficace. Come si può raccontare meglio un’università che “accompagna davvero per mano” i propri studenti?
Ma non solo: anche la media del voto di laurea (106,1 su 110) supera quella nazionale (103,8), riflettendo così la serietà e l’impegno richiesti, ma anche il clima di fiducia reciproca che si respira in Ateneo. A UniCamillus ricordiamo infatti che buona parte del merito accademico risiede nella serenità emotiva di uno studente: un ragazzo ascoltato e valorizzato non può che dare il meglio di sé.
Oltre alle aule, ai laboratori, alle simulazioni e allo studio teorico, la pratica è centrale: il 91,3% dei laureati triennali di UniCamillus ha svolto un tirocinio durante il proprio corso di studi. Una percentuale molto al di sopra della media nazionale (59,8%) e che sottolinea l’attenzione dell’Ateneo alla preparazione sul campo. Nel mondo medico e sanitario, questo fa la differenza: perché è nell’incontro con i pazienti e nella gestione reale delle criticità che si forgiano le competenze più importanti, sia umane che professionali.
Dietro ogni numero, ovviamente, c’è una scelta, e i laureati UniCamillus sono pienamente felici di averci scelto: il 95,2% degli studenti
si dichiara soddisfatto del percorso accademico, il 94,5% apprezza il rapporto con i docenti, l’81,9% sceglierebbe di nuovo UniCamillus. Sono numeri, ma non solo: sono anche il racconto di un’atmosfera, di un’energia che si respira ogni giorno nei corridoi, nei laboratori, nelle aule. Sono il racconto del rapporto di fiducia che si instaura con i docenti, figure che guidano gli studenti in un viaggio fatto di impegni, sacrifici, studio, ma anche enormi soddisfazioni. Sono il racconto di anni di scoperta di se stessi, delle proprie passioni, e del mondo in cui si andrà ad operare, come medici ma soprattutto come esseri umani.
laurearsi è solo l’inizio… di un Percorso laVoratiVo di successo!
E dopo la laurea? I numeri sono eloquenti: l’84,3% dei laureati triennali lavora già a un anno dal titolo, con stipendi superiori alla media nazionale. E un dato che colpisce è anche un altro: il 95,7% degli occupati ritiene la propria laurea molto efficace per il lavoro che svolge. Un risultato che va oltre la statistica, perché riflette la fiducia e la soddisfazione di chi ha scelto UniCamillus per costruire il proprio percorso.
Anche tra i laureati magistrali biennali, i numeri confermano la solidità della formazione: retribuzioni più alte della media e un livello di efficacia percepita del titolo che supera di oltre 10 punti la media nazionale.
Nel report AlmaLaurea dedicato al profilo occupazionale dei laureati non sono presenti i laureati UniCamillus in Medicina e Odontoiatria per ovvie ragioni: come già anticipato, il nostro Ateneo è molto giovane, e i primi medici formati da UniCamillus hanno conseguito il titolo solo nel 2024, ossia un anno dopo rispetto all’analisi AlmaLaurea; i nostri primi odontoiatri, invece, conseguiranno la laurea nell’anno accademico 20252026.
scegliere unicamillus: credere nella Vocazione di diVentare medico
Non è solo una questione di numeri. È una questione di scelte. Di orizzonti. Di futuro. UniCamillus non forma solo professionisti: forma cittadini del mondo, capaci di prendersi cura della salute delle persone ovunque vi sia bisogno. E, in un mondo che ha sempre più necessità di umanità e competenza, scegliere UniCamillus significa diventare protagonisti del cambiamento di domani. A partire da oggi!


HIV e prevenzione
Il vaso di Pandora delle malattie sessualmente trasmesse
di Daniele Armenia
Docente UniCamillus di Virologia
Nel corso dell’ultimo secolo, le infezioni sessualmente trasmesse (IST), hanno subito profondi cambiamenti epidemiologici. La modalità di trasmissione sessuale è molto particolare poiché, seppur meno comune di altre (ad esempio quella respiratoria), è strettamente relazionata ai comportamenti delle persone e, coinvolgendo una sfera molto intima, rimane spesso difficile da gestire a causa di vergogna e imbarazzo legati alle IST. Oltre a essere un problema sanitario, le IST sono quindi anche un problema sociologico che risulta strettamente legato alla disinformazione e allo stigma.


Le IST fanno parte della storia dell’uomo da sempre, ma nel secolo scorso, grazie all’utilizzo degli antibiotici, l’incidenza delle più comuni IST – come sifilide e gonorrea – è notevolmente calata. In questo contesto, si pensava che le IST fossero ormai sotto controllo, ma l’emergere della pandemia dovuta al virus dell’immunodeficienza umana (HIV) negli anni ’80 ha smentito questa convinzione. Questo virus causa una terribile sindrome, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), e ha terrorizzato il mondo negli anni 80-90, epoca in cui l’AIDS era diventata la prima causa di morte nel mondo.
Dopo l’avvento della terapia antiretrovirale –efficace a partire dal 1996 – gradualmente la mortalità da HIV è notevolmente diminuita e oggi, nei Paesi in cui terapie e assistenza sono ottimali, l’infezione è gestibile e le persone che
vivono con HIV hanno ottime aspettative di buona salute e sopravvivenza. Tuttavia, considerando il suo minore impatto, l’infezione non è ormai un argomento molto discusso e la percezione del rischio di acquisire HIV risulta molto diminuito. Non bisogna dimenticare che, dal momento della sua scoperta a oggi si stimano più di 45 milioni di morti causati all’AIDS, e questa sindrome ancora oggi uccide circa 800.000 persone l’anno di cui 90.000 bambini. Quindi, la morbilità e la mortalità legate all’HIV rimangono preoccupanti e l’infezione, essendo incurabile e gestibile solo in un contesto sanitario avanzato, rimane forse una delle peggiori preoccupazioni di sanità pubblica globale.
Dopo quasi 18 anni di esperienza nel campo dell’HIV, con questo breve articolo desidero mostrare quanto questa infezione sia, in realtà, più vicina alle nostre vite di quanto immaginiamo. Attraverso una storia semplice e reale, vorrei accendere l’attenzione sulla necessità di prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili.
Durante un evento congressuale rivolto a virologi e infettivologi, ho avuto il piacere di ascoltare una presentazione a due voci della Dott.ssa Barbara Rossetti (infettivologa presso l’Ospedale di Grosseto) e della Prof.ssa Maria Santoro (virologa, Università di Roma Tor Vergata), due colleghe e amiche che stimo profondamente per il loro impegno nello studio dell’HIV. Hanno raccontato una storia molto toccante e vicina a ciò che potrebbe accadere a
chiunque e ringrazio entrambe per aver accettato di divulgarla insieme a me in questa sede a un pubblico di non addetti. Si tratta del racconto di una delle tante diagnosi di HIV, di una persona comune, come tante che hanno visto esplodere nella loro vita un “Vaso di Pandora”.
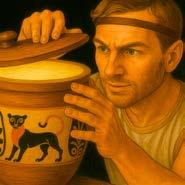
Mito greco di Pandora (qui raffigurato come uomo considerando la storia riportata in questo articolo) (immagine creata con AI)
il Vaso di Pandora: il racconto. Estate 2023.
Mario (nome di fantasia) ha circa 40 anni, è eterosessuale, un uomo comune, lavora, è in salute, con una vita senza particolari problemi. Durante le vacanze nota delle tumefazioni sulla parte destra del collo, ma non avendo avuto febbre né altri sintomi, inizialmente non dà molto peso alla cosa. I mesi passano, ma le tumefazioni persistono e iniziano a provocare fastidio. A dicembre decide di rivolgersi al medico, che richiede esami ematici di routine: tutto nella norma, eccetto una lieve piastrinopenia. Il medico richiede di eseguire un’ecografia del collo, che evidenzia numerosi linfonodi, alcuni reattivi, altri potenzialmente patologici e consiglia visita otorinolaringoiatrica e approfondimenti. A Gennaio 2024, la visita conferma ingrossamento tonsillare e linfonodale e l’otorino suggerisce una TAC e una biopsia linfonodale per escludere patologie più serie. Il quadro emerso finalmente induce però il medico a consultare telefonicamente un infettivologo, il quale, intuendo la possibile origine infettiva,
consiglia di fare immediatamente dei test per la ricerca di HIV, virus di Epstein Barr, citomegalovirus e toxoplasma gondii, insieme a una visita infettivologica urgente. Il sospetto si rivela fondato: il test HIV è positivo, con una carica virale di oltre 60.000 copie/ml nel plasma di Mario. Il numero di cellule CD4 – le cellule del sistema immunitario che il virus attacca – è ridotto, ma per fortuna non ancora a livelli preoccupanti. Gli esami mostrano infezioni pregresse da EBV e CMV (abbastanza comuni nella popolazione), mentre il test Quantiferon per la tubercolosi risulta negativo. Viene anche effettuata anche una TAC total body che non evidenzia alterazioni a livello cerebrale, toracico o addominale. Durante il couseling di prassi durante la visita infettivologica, emerge però un altro dato significativo: Mario riferisce rapporti eterosessuali con almeno 10 partner diverse al mese, non sempre protetti. Non aveva mai fatto test per HIV o altre IST, né aveva mai sentito parlare della profilassi pre-esposizione (PrEP). Nonostante il paziente sia tutto sommato in un buono stato generale, la situazione è delicata. Viene subito avviato un protocollo completo di esami e trattamenti: si analizzano i principali marcatori virali, si esegue un test genotipico del virus HIV per identificare eventuali resistenze ai farmaci, e si avvia uno screening completo per tutte altre IST. Viene subito iniziata la terapia antiretrovirale come da prassi, ma la diagnosi da HIV non è l’unica “sorpresa”. Alla visita di controllo, emerge che il virus che era stato trasmesso a Mario risultava un ceppo di HIV resistente ad alcuni antiretrovirali, inoltre Mario ha una sifilide in corso e risulta infetto da ben 4 IST batteriche (treponema pallidum [sifilide], Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma genitalium) e il tampone rettale rileva un ulteriore IST virale da papillomavirus (HPV) con identificazione del ceppo 16, noto per essere causa di tumori (ano, retto, utero e cavità orale). Mario pertanto ha contratto ben 6 IST inclusa un’infezione da HIV con ceppo potenzialmente meno suscettibile ai farmaci antiretrovirali e un’infezione da HPV con un ceppo ad alto rischio per sviluppo di cancro (rischio aumentato ancora di più essendo ormai HIV infetto). Nella vita di Mario è esploso il vaso di Pandora. Oggi Mario sta bene, ha risolto tutte le IST e grazie alla terapia antiretrovirale
ha una carica di HIV non rilevabile nel sangue e non può trasmettere il virus a nessuno. Tuttavia dovrà per sempre convivere con HIV, un virus che provoca un’infezione cronica incurabile e che espone a un aumentato rischio di sviluppare tumori, malattie metaboliche e cardiovascolari. Anche Mario come Pandora ha chiuso il suo “vaso” appena in tempo per riuscire a riacciuffare la sua salute e a chiudere la speranza di rimanervi il più a lungo possibile.
I fattori di rischio delle ist e la Percezione del rischio
Un quarantenne uomo eterosessuale può essere a rischio di IST come tutti gli altri. Le IST possono essere contratte da chiunque abbia rapporti sessuali non protetti, indipendentemente dall’età e dal sesso. Spesso diverse IST sono contratte contemporaneamente e averne una incrementa notevolmente il rischio di contrarre HIV, proprio come Mario. Certamente il rischio di contrarre una IST aumenta all’aumentare del numero dei rapporti o dal numero di rapporti che la persona con cui si fa sesso ha, ma in generale fare sesso non protetto espone sempre a rischi. Un concetto fondamentale rimane la percezione di questo rischio. Ogni individuo dovrebbe vivere la propria sessualità in maniera serena e libera da pregiudizi purché raggiunga la consapevolezza di quali siano i comportamenti a rischio e i mezzi per proteggersi. Questo non è scontato, e Mario ne risulta un perfetto esempio. In determinati contesti sociali, dove il pregiudizio attorno ai rischi dell’attività sessuale continua ad essere presente, le persone non vengono agganciate e sensibilizzate. Pertanto il raggiungimento di un appropriato livello di percezione del rischio è cruciale, e le istituzioni dovrebbero impegnarsi in maniera puntiforme a organizzare campagne di educazione sessuale e prevenzione delle IST a partire dalle scuole. Questo per spiegare alle persone come evitare le IST e quali siano gli eventuali sintomi e conseguenze di queste malattie. La sfera sessuale è assolutamente privata e strettamente dipendente dalle preferenze e scelte di ogni persona, ma da un punto di vista di sanità pubblica, anche i “medici di famiglia” hanno un ruolo. Il medico di fiducia, che conosce da anni il proprio assistito, ha le competenze per accorgersi di potenziali segni
clinici sospetti e ha il dovere di indagare se necessario sulle abitudini sessuali di un paziente potenzialmente a rischio. Mario non si è rifiutato di rispondere, ma gli è stato chiesto della sua vita sessuale al terzo controllo medico dopo mesi dall’esordio dei sui problemi. In un certo senso il caso di Mario è stato fortunato, la sua infezione da HIV è esordita con dei sintomi, che seppur con ritardo, hanno permesso di formulare un ipotesi clinica, una diagnosi e un trattamento. Questa non è la regola, Mario sarebbe potuto essere completamente asintomatico e non accorgersi di nulla per anni. In questo caso, ignaro di tutto, Mario avrebbe avuto nel suo corpo virus replicante in grado di poter essere trasmesso ad altri e inesorabilmente prima o poi avrebbe portato Mario nella grave condizione dell’AIDS. Nel 2023 circa l’84% delle diagnosi di AIDS sono avvenute in persone che avevano avuto la diagnosi di infezione da HIV negli ultimi 6 mesi. Si tratta di centinaia di persone ignare di essere in grave pericolo per sé e di essere in grado di trasmettere l’infezione ad altrettanti ignari partner.
il sesso sicuro
I rapporti sessuali non protetti (senza preservativo), per via vaginale, anale o orale, comportano un alto rischio di trasmissione di una IST. In particolare, i rapporti penetrativi possono provocare facilmente microlesioni alle mucose della vagina, del retto o del pene che favoriscono la penetrazione dei microrganismi. Non vanno sottovalutati anche i rapporti orali, che seppur con un minore rischio, possono permettere la trasmissione di microrganismi potenzialmente presenti in secrezioni vaginali, sperma, secrezione prespermatica e la saliva. Ricordiamo anche che i mezzi di protezione, ad esempio il preservativo, non sono infallibili e spesso non proteggono da infezione da contatto come la sifilide, il papillomavirus e l’herpes genitale. Certamente quindi il rischio di acquisire IST aumenta all’aumentare del numero dei rapporti o dal numero di rapporti che la persona con cui si fa sesso ha. Inoltre, il consumo di alcol o sostanze psicotrope possono determinare una ridotta lucidità mentale e facilitare
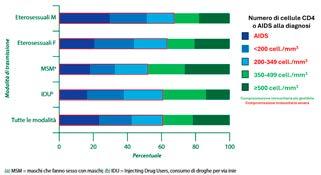
comportamenti sessuali a rischio. Recenti statistiche mostrano che il cosiddetto chemsex –ossia avere rapporti sessuali volutamente sotto l’effetto di stupefacenti– aumenti significativamente il rischio di contrarre HIV. Utilizzare sempre il preservativo in qualsiasi rapporto occasionale, e anche nel caso di una nuova relazione stabile finché non si abbia contezza di uno screening di coppia per le IST, rimane il miglior modo per evitare di contrarre infezioni. Ogni persona deve vivere la propria sessualità senza paure, ma deve passare chiaramente il concetto che avere rapporti sessuali occasionali e specialmente senza un costante utilizzo di protezioni necessita effettuare con regolarità (almeno 1 volta l’anno in funzione del numero dei rapporti) i test per le IST e per l’HIV.
nuoVe oPPortunità Per il sesso sicuro: PreP Oggi la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili si sta evolvendo, grazie a percorsi sanitari specifici che aiutano a monitorare e proteggere la salute sessuale. Mario, ad esempio, non aveva mai sentito parlare della PrEP: se lo avesse saputo, forse oggi non vivrebbe con l’HIV. La profilassi preesposizione (PrEP), consiste nell’assunzione di antiretrovirali in compresse o iniezioni periodiche (mensili e presto probabilmente semestrali) da parte di persone sieronegative per prevenire l’infezione da HIV. Numerosi studi internazionali hanno dimostrato che, se assunta correttamente, la PrEP ha un’efficacia vicina al 100%, persino superiore al preservativo nel prevenire l’HIV. La PrEP è disponibile nella maggior parte dei centri per le malattie infettive e sessualmente trasmissibili ed è consigliata –
sempre in abbinamento al preservativo – a chi ha comportamenti a rischio, soprattutto dopo la diagnosi di una IST. Questo perché la comparsa di una IST è più comune in chi ha un numero elevato di rapporti occasionali e predispone le persone ad acquisire il virus a causa della potenziale infiammazione genitale che può derivarne. Chi inizia la PrEP viene seguito con controlli regolari per HIV e altre IST, entrando così in un percorso di educazione prevenzione e consapevolezza, che migliora il benessere e la serenità nella vita sessuale. Naturalmente, la PrEP non protegge dalle altre IST. In chi la assume, può inizialmente aumentare l’incidenza di IST batteriche, ma queste sono curabili e non comportano rischi a lungo termine paragonabili all’HIV. Infine, è bene sapere che la rottura del preservativo durante un rapporto occasionale rappresenta una situazione a rischio elevato per l’acquisizione del virus. In questi casi, si può accedere a una misura di emergenza: la profilassi post-esposizione (PEP), da iniziare entro 48–72 ore dal contatto a rischio. La PEP consiste in una breve terapia antiretrovirale che, se somministrata tempestivamente, può impedire l’infezione da HIV. È disponibile per tutti nei pronto soccorso ospedalieri.
come gestire la ProPria salute sessuale in 5 Punti. Serenità e consapevolezza sessuale: avere una vita sessuale è un bisogno di tutti, sentimenti di imbarazzo o vergogna vanno scardinati e gestiti per poter vivere serenamente e evitare ostacoli per acquisire coscienza. Avvalersi se necessario di un supporto psicologico per superare eventuali disagi.
Consapevolezza del rischio: conoscere tutte le IST, i loro eventuali segni, sintomi e complicanze.
Nuove diagnosi di infezione da HIV per classi di CD4, diagnosi di AIDS e modalità di trasmissione (2023)
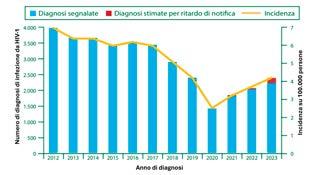
Sapere che il numero di rapporti occasionali o avere rapporti con una persona che ha molti rapporti occasionali è associato a un rischio aumentato in acquisire una IST.
Gestione del rischio: usare precauzioni in maniera corretta durante rapporti occasionali o nei nuovi rapporti stabili di coppia fino alla contezza di uno screening. Informarsi sull’evoluzione delle strategie di riduzione del rischio (preservativo, PrEP ecc..)
Test di screening: effettuare routinariamente test di screening per le IST, perché non è possibile stabilire la loro presenza solo dai sintomi che spesso non si manifestano.
hiV oggi in italia
I dati epidemiologici sull’infezione da HIV in Italia sono pubblici e disponibili online grazie al lavoro svolto dal Centro operativo AIDS (COA) dell’Istituto superiore di Sanità (https://www. epicentro.iss.it/aids/notiziario-coa). Nel 2023, sono state segnalate 2.349 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a un’incidenza di 4,0 nuove diagnosi ogni 100.000 residenti. Dal 2012 al 2020 si osserva una diminuzione delle nuove diagnosi HIV e un aumento dal 2021 al 2023 Il numero complessivo di persone che vive con l’infezione da HIV in Italia è stato stimato essere intorno a 140.000 unita (120.000-160.000) con tasso di prevalenza pari a 0,2% residenti. Nell’ultimo decennio è aumentata la quota di persone a cui è stata diagnosticata tardivamente l’infezione da HIV (persone in fase clinicamente avanzata, con un basso numero di CD4 o in AIDS). Il termine tardivo è indefinito, se un individuo non ha percezione del rischio si infetta e se non ha o non riconosce eventuali sintomi, può rimanere per anni in una condizione di buona salute fino al sopraggiungere dell’AIDS
che include gravissime malattie come tumori, polmoniti fungine, infezioni celebrali. Gli eterosessuali maschi sono i più colpiti nel ritardo della diagnosi. Nel 2023, il più alto tasso di diagnosi HIV tardiva (CD4<350cell/μL) è stato riscontrato infatti in questa categoria (66,8%), seguita dalle eterosessuali femmine (63,0%) e dai maschi che fanno sesso con i maschi (MSM, 51.4%). Nel 2023 sono state notificate 532 nuove diagnosi di AIDS pari a un’incidenza di 0,9 nuovi casi per 100.000 residenti, si è osservato un marcato aumento nel numero di casi rispetto al 2020 (+28%) e all’ultimo anno (+20%). La proporzione di persone con nuova diagnosi di AIDS che ignorava la propria sieropositività e che ha scoperto di essere HIV positiva nel semestre precedente la diagnosi di AIDS è aumentata nel tempo e si è stabilizzata intorno all’84% nell’ultimo triennio, nel 2023 questa proporzione è pari all’84,1%. Questo è un grande segnale di allarme perché ciò dimostra che moltissime persone si accorgono di essere infette solo quando sviluppano l’AIDS. La storia di Mario ci ricorda che l’HIV e le IST sono una realtà concreta, vicina alla nostra quotidianità. Ogni persona, proprio perché ha una vita sessuale, dovrebbe sentirsi coinvolta. La chiave per contrastare il diffondersi delle infezioni è la cultura: solo attraverso la conoscenza possiamo superare stigma, silenzi e pregiudizi. La consapevolezza è uno strumento potente, capace di restituirci il controllo e la libertà di vivere la nostra intimità in modo sereno, sicuro e dignitoso. In tempi incerti, prendersi cura della propria salute sessuale è anche un gesto di amore verso sé stessi e gli altri.
HIV AND PREVENTION: A DEEP DIVE INTO THE COMPLEx wORLD OF SExUALLy TRANSMITTED DISEASES (STDS)
Sexually transmitted infections (STIs) have undergone major epidemiological changes over the last century. Although sexual transmission is less common than other routes of transmission, such as respiratory transmission, it is highly dependent on personal behaviour. It is also often associated with shame and stigma, which makes the health and social management of STIs difficult. While antibiotics have reduced diseases such as syphilis and gonorrhoea, the emergence of HIV in the 1980s proved that STIs were not under control. Responsible for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), HIV has caused millions of deaths and still causes around 800,000 deaths a year, especially in countries with less advanced healthcare. Since the introduction of antiretroviral therapy in 1996, HIV mortality has fallen dramatically in countries with adequate treatment. However, perceptions of the risk of infection have declined, and many people are unaware of the need for prevention and early diagnosis. Mario’s story (a fictitious name) is a clear illustration of the issue. He is a 40-year-old heterosexual man who only discovered he was HIV-positive in the summer of 2023, following months of enlarged lymph nodes and discomfort. He had an active sex life involving numerous casual partners and unprotected intercourse, and had never been tested for HIV or heard of pre-exposure prophylaxis (PrEP). As well as HIV, Mario was infected with several other STIs, including syphilis, chlamydia, ureaplasma, mycoplasma and HPV strain 16, which carries a high oncogenic risk. His ‘Pandora’s box’ had thus been opened, but thanks to a timely diagnosis and treatment, he now lives with the infection under control, although he will have to do so forever. This case highlights the fact that the risk of contracting an STI affects anyone who has unprotected sex, regardless of age or sexual orientation. Having an STI increases the risk of acquiring HIV. However, people often perceive the risk as low, especially in social contexts where there is stigma and misinformation. Therefore, sex education and prevention campaigns in schools and the community are essential. GPs also play a key role in recognising suspicious signs and promoting testing. The main strategy for reducing risk is still safer sex: using condoms correctly and consistently, even during oral sex, and getting tested regularly for STIs and HIV, especially when having casual sex or with multiple partners. Alcohol and substances that reduce mental alertness can lead to risky behaviour, as can the growing phenomenon of chemsex. Pre-exposure prophylaxis (PrEP), which is available at many infectious disease centres, is an effective new preventive measure against HIV, providing almost 100% protection when taken correctly. However, it does not protect against other STIs. Post-exposure prophylaxis (PEP) should be started within 48–72 hours of risky contact to prevent infection.
Five points for managing sexual health:
1. Serenity and awareness: overcome embarrassment to experience sexuality serenely.
2. Know the risks and symptoms of STIs.
3. Manage risk by taking precautions and keeping up to date with new prevention strategies.
4. Undergo regular testing, even if you have no symptoms.
5. Ask your GP and specialist centres for education and prevention.
In Italy, 2,349 new HIV diagnoses were registered in 2023, giving an incidence rate of 4.0 per 100,000 inhabitants. The number of late diagnoses, often at an advanced stage or with AIDS, is increasing, particularly among heterosexual men. This signals a significant issue of missed or delayed diagnoses. 84% of new AIDS diagnoses concern individuals who were diagnosed as HIV-positive within the previous six months, suggesting that many infections are overlooked until serious complications arise.
In conclusion, HIV and STIs can affect anyone. Education and knowledge are powerful tools for breaking down stigma and prejudice and for enabling people to enjoy a fulfilling and safe sex life. Taking care of your sexual health is an act of responsibility towards yourself and others.
IL SESSO E IL SANGUE
Salute e malattie sessualmente trasmissibili
in prospettiva storica
di Christina Savino
Docente UniCamillus di Storia della Medicina
Le malattie sessualmente trasmissibili hanno afflitto l’uomo fin dalle origini, occupando nella storia un posto fortemente simbolico per gli aspetti coinvolti: sessualità e riproduzione anzitutto, ma anche identità di genere, orientamento sessuale, relazioni, desiderio, piacere e intimità. Nei diversi contesti la diffusione di queste malattie ha assunto valori diversi in rapporto a cultura, costume, morale e religione. Ma in molti ambienti alle malattie veneree si sono accompagnati l’orrore dei sintomi, il disagio e la vergogna dell’esame clinico, il peso del senso di colpa, l’angoscia per la condanna, il pregiudizio e l’isolamento sociale.
malattie Veneree: il loro studio risale all’antichità
La storia delle malattie sessualmente trasmesse ci è insegnata da una ricchissima letteratura che documenta una varietà di affezio ni. Un rotolo papiraceo di argomento medico, il Papiro Ebers (ca. 1550 a.C.), allude a un’uretrite acuta da trattare con instillazioni in vescica di olio di sandalo identificabile con gonorrea. Riferimenti a quest’infezione si trovano anche nella Bibbia, dove Levitico (ca. 1200 a.C.) parla di un disturbo contagioso caratterizzato da emissione continua di seme ed erezione dolorosa, e Numeri (VI-V a.C.) di una malattia simile, inflitta agli Ebrei per aver avuto rapporti con le lussuriose Moabite. Anche la medicina greca offre descrizioni cliniche di infezioni uretrali e vulvovaginali compatibili con la gonorrea: Ippocrate (ca. 460370 a.C.) parla ad esempio di ‘tisi dorsale’, con flusso di seme successivo alla minzione o alla de-
fecazione, tipica di giovani sposi e di individui sessualmente esuberanti, e in ambito ginecologico di scorrimento del seme femminile, correlato a calo della libido ed infertilità.
condilomi, ulcere genitali e Visione morale della sessualità
I medici antichi conoscevano inoltre i condilomi, o vegetazioni veneree: verruche molli, anche di dimensioni ingombranti, balano-prepuziali nell’uomo, vulvari e esterne alla vagina nella donna. Ippocrate spiega tali escrescenze con l’abuso dei genitali. Celso, enciclopedista romano di età imperiale (I d.C.), le associa alle abitudini sessuali dei pederasti, che spesso le presentavano nella zona perianale. La trasmissione venerea era nota anche ai profani, come testimoniano maliziosi versi satirici di Marziale e Giovenale

Nel trattato ippocratico Natura della donna si parla poi di ulcere vulvari di aspetto preoccupante: potrebbe trattarsi di ulcere molli o di ulcere tubercolari. Una diagnosi di tubercolosi uro-genitale è stata proposta nel caso storico di una coppia romana morta suicida riportato da Plinio il Giovane. L’ulcera molle invece non è propriamente descritta nei testi medici antichi, ma è stata identificata dagli studiosi in Celso, che parla di ulcera fagedenica, e nel medico Palladio (VI d.C.), che in un racconto moralizzante parla di un eremita smarritosi, tormentato da un’ulcera corrosiva al pene.
l’arriVo della sifilide: un Point tournant nella storia medica
L’infezione venerea di cui più si è scritto nei secoli è la sifilide, la peggiore delle malattie sessualmente trasmesse prima dell’AIDS. La sifilide rappresenta un point tournant nella storia della medicina non solo per la vastissima diffusione epidemica, ma anche per l’impulso dato allo sviluppo di un pensiero moderno, orientato alla comprensione dei meccanismi di contagio e alla ricerca di terapie.
Nella tesi più accreditata, quella americanista, la sifilide scoppiò in Europa a fine Quattrocento, portata dai marinai di Colombo contagiati nell’isola di Hispaniola (attuale Haiti), dove la malattia era endemica: per gli europei sprovvisti di difese immunitarie fu una peste. Il primo a parlare della sifilide come malattia nuova e di importazione fu il catalano Ruiz Diaz de Isla (1462-1542) che, nel Tractado contra el mal serpentino venido de la Isla Espaniola (1531), asserì di essere stato consultato nell’aprile 1493 per curare molti reduci ammalatisi di ulcera rodente ai genitali e bubboni inguinali durante il rientro dall’America. Il più importante fu invece Girolamo Fracastoro (ca. 1483-1553), veronese lettore di medicina a Padova, che alla sifilide diede importanti contributi e ancor prima il nome: ‘sifilide’ deriva infatti dal titolo del poemetto Syphilis (1530), in cui Fracastoro racconta la storia del pastore Sifilo, che in una delle isole scoperte da Colombo venerava il re Alcitoo offendendo il dio Sole, che quindi lo puniva inviandogli un terribile e disgustoso male con pustole su tutto il corpo. Altri studiosi sostengono l’origine precolombiana della sifilide: l’agente patogeno sarebbe stato trasmesso dal babbuino all’uomo in Africa già nel Paleolitico, quindi avrebbe avuto diffusione endemica in tutto il Mediterraneo per poi diversificarsi biologicamente; la virulenta epidemia rinascimentale sarebbe stata dovuta appunto a un ceppo differenziatosi nel Nuovo Mondo prima dell’ultima era glaciale. Il silenzio degli antichi si spiegherebbe col mancato riconoscimento della specificità della sifilide, erroneamente accomunata ad altre malattie infettive quali lebbra e scabbia. Nondimeno la sifilide sarebbe riconoscibile in vari testi, come il codice di Hammurabi, che vieta la vendita di schiavi affetti da ‘benu’, un’affezione con lesioni e gonfiori dei linfonodi inguinali, e gli stessi testi medici
greci, che riporterebbero l’esatta sintomatologia, al pari di autori medievali come Avicenna. Una tesi più recente è quella unitaria, per cui l’agente patogeno, endemico nei Paesi a clima caldo-umido come quelli del Centro America, al suo arrivo (o ritorno) in Europa a fine Quattrocento sarebbe stato spinto dal freddo a penetrare in profondità nell’ospite, causando esiti insoliti e devastanti.
È certo infatti che l’epidemia osservata da Fracastoro fu assai più severa delle ondate successive: la malattia esordiva con piaghe nella sede dell’inoculo, i genitali, che con la diffusione nel flusso sanguigno si estendevano a tutto il corpo. Poco a poco ricopriva la pelle di ulcere, vesciche e ascessi ripugnanti che corrodevano naso, bocca e ossa. Benché curabile con mercurio e guaiaco, un vegetale americano, era spesso letale. All’ultimo stadio poteva produrre disturbi mentali e demenza, per cui i malati finivano internati. Com’è noto, la prima diffusione avvenne nel 1493-94, durante l’assedio di Napoli da parte francese, e nel primo Cinquecento le vittime stimate erano già 20 milioni.
Sifilide e senso di colpa: l’impatto morale sulla società
L’impatto sulla società non fu meno catastrofico. Diversi elementi e fonti evidenziano, oltre alla sofferenza, il terrore della punizione per la lussuria e la trasgressione sessuale, i sentimenti di vergogna e colpa, la paura del giudizio e dell’emarginazione sociale, la volontà di allontanare da sé il sospetto del contagio, la negazione del male. Ne abbiamo un’idea già dal nome dato alla malattia prima dell’affermazione del termine coniato da Fracastoro: ‘mal francese’ o ‘morbo gallico’ per italiani e inglesi, ma ‘mal de Naples’ per i francesi, ‘mal spagnolo’ per portoghesi, olandesi e africani, e ‘mal dei cristiani’ per i turchi, come se ogni popolo avesse voluto additare lo straniero come colpevole di un male deprecabile e pericoloso. La paleopatologia inoltre ha rivelato illustri casi di sifilide non noti alla storia, come Maria d’Aragona (1503-1568), marchesa del Vasto e governatrice di Milano come consorte di Alfonso d’Avalos, la cui mummia mostra un’ulcera cutanea al braccio riconducibile a sifilide venerea al terzo stadio; e Maria Salviati (1499-1543), madre di Cosimo I Granduca di Toscana , il cui scheletro mostra segni di sifilide
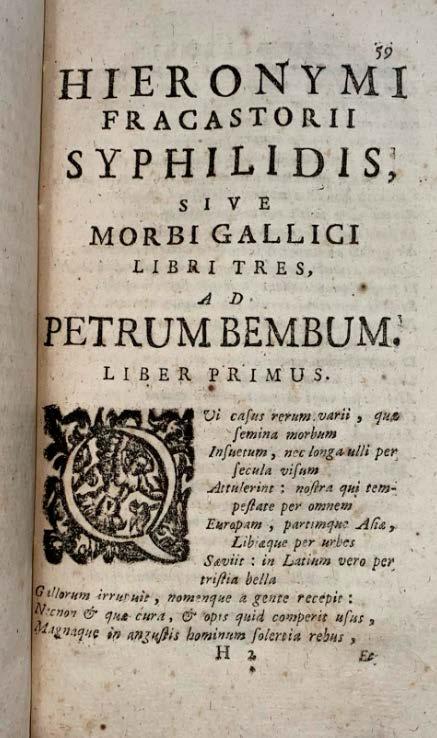
Syphilis, poemetto pubblicato da Girolamo Fracastoro a Verona nel 1530
quali lesioni sull’osso frontale del cranio. Queste diagnosi retrospettive mostrano come la sifilide venisse occultata in quanto socialmente stigmatizzata soprattutto per le donne. Infatti di Maria Salviati, che probabilmente fu contagiata dal marito Giovanni delle Bande Nere, dedito a frequentazione di cortigiane, sappiamo che evitava le visite mediche per nascondere il male. I medici non erano ignari di tali dissimulazioni, come racconta il milanese, perito del tribunale del Sant’Uffizio, Giovanni Battista Selvatico (1550-1621), che nel suo trattato De iis qui morbum simulant deprehendendis attesta che moltissimi sifilitici negavano la malattia – e in fondo la sua origine, ossia il «commercio con femmine infette» – fingendo di star male per altra causa: per questo i medici dovevano sospettare di chiunque presentasse uno o più sintomi, e persino tracce di sintomi passati del morbo gallico; osservazione ed esperienza erano indispensabili, ma ancor più efficace era il buonsenso, utile a valutare il possibile guadagno derivante dal nascondimento come pure l’atteggiamento del paziente: la non-compliance era da vedersi come tacita ammissione del crimine segreto.
contagio non sessuale della sifilide: le Prime intuizioni
Già allora in realtà si sapeva che la sifilide non è esclusivamente imputabile a eccessi sessuali. Sempre Fracastoro, nel trattato De contagione et contagiosis morbis (1546), fondamento della teoria contagionista, osservò che alcune lavandaie avevano contratto la malattia senza rapporti sessuali: queste presentavano ulcere sul dorso della mano, generalmente screpolato, quindi era plausibile che avessero preso la malattia indirettamente, tramite i panni dei malati, veicolo di esseri minuscoli e invisibili a occhio nudo responsabili del contagio. Così Fracastoro intuì, ben prima delle scoperte che avrebbero portato al costituirsi della teoria microbiologica delle malattie infettive, che il contagio deriva da particelle microscopiche assumibili anche per via indiretta. Altri analogamente intuirono che il contagio può avvenire in utero attraverso la placenta interessando il feto:
il primo a descrivere un caso di sifilide congenita fu Antonio Benivieni (1443-1502), seguito da Gabriele Falloppia (1523-1562) nella seconda metà del Cinquecento. Eppure, l’idea sessofobica di un castigo simbolico, inflitto a un’umanità schiava del piacere restò diffusa e dominante per secoli. Ancora nell’Ottocento il medico tedesco Julius Rosenbaum (1807-1874) sosteneva che la sifilide derivava dall’abuso dei genitali, fatti non per piacere ma per procreare. Il Novecento segnò una svolta. Nell’ottobre 1905, osservata una specie di microrganismi a forma di spirale detta spirocheta, Fritz Shaudinn (1871-1906) e Erich Hoffmann (1868-1959) attribuirono l’infezione da sifilide a un batterio dello stesso tipo, battezzato treponema pallidum. Pochi anni dopo, nel laboratorio di Paul Ehrlich (1854-1915), considerato il fondatore della chemioterapia, si scoprì che il ‘composto 606’, un arsenobenzolo testato sui topi, aveva effetti germicidi sulla spirocheta; la successiva sperimentazione sull’uomo diede risultati incoraggianti per la sifilide, portando alla produzione dei farmaci Salvarsan, nel 1910, e Neosalvarsan, nel 1912, entrambi tuttavia con gravi effetti collaterali. La miglior terapia fu trovata poco dopo, quando il microbiologo scozzese Alexander Fleming (18811955) scoprì la penicillina, isolata nel 1928 e disponibile dagli anni Quaranta.
il caso tuskegee: etica e razzismo nella ricerca medica Quel che il Novecento non portò alla storia delle malattie sessualmente trasmissibili è il superamento di pregiudizi e difficoltà nella comprensione e nel trattamento delle stesse. Per la sifilide lo mostra un controverso esperimento partito negli stessi anni in cui si ricercava una terapia e destinato a diventare un caso classico di etica medica: lo studio di Tuskegee. Nel 1932 lo U.S. Public Health Service individuò la regione americana col più alto tasso di sifilide – la contea di Macon, in Alabama, con capoluogo Tuskegee – per valutare gli effetti dell’infezione sulla popolazione afro-americana: dei soggetti reclutati, circa 600 tra contadini poveri e semianalfabeti, circa 400 erano affetti da sifilide congenita, gli altri erano sani. I risultati non furono comunicati ai diretti interessati come lo stesso obiettivo della sperimentazione: studiare sui malati l’avanzamento della malattia senza trattamento, sui sani l’assenza di prevenzione.
Lo studio proseguì per molti anni in cui i soggetti ricevettero soltanto placebo e nessuna cura effettiva, tantomeno la penicillina. Solo alla fine degli anni Sessanta, con l’avvento di un nuovo clima socio-culturale e del dibattito sui diritti civili, sorsero i primi dubbi sulla correttezza dello studio.
E solo nel 1972, quando i giornalisti dell’Associated Press appresero della sperimentazione, fu aperta un’inchiesta e l’esperimento fu interrotto: intanto 125 individui del gruppo erano morti di sifilide – tra cui dei sani che qui si erano ammalati – 40 mogli e 19 figli erano stati infettati. Un bilancio pesante per la violazione dei diritti dei soggetti coinvolti.
anni ‘80: l’aids e il ritorno del Pregiudizio
La fine del secolo vide poi lo scoppio di una malattia nuova, sconosciuta alla patologia classica, che resuscitò l’antica concezione di malattia come punizione per colpe commesse, e più in particolare per violazione di leggi non scritte riguardo ai tabù sessuali e alla convivenza civile. Intorno al 1980 infatti i medici statunitensi segnalarono l’emergenza di un’ignota malattia riconducibile a uno scompaginamento del sistema immunitario dell’organismo. Era l’AIDS, la sindrome da immunodeficienza acquisita, che avrebbe prodotto una delle più tremende epidemie del secolo. Le modalità di trasmissione non erano ancora chiare, ma i primi casi riguardavano soprattutto maschi omosessuali e tossicodipendenti: gruppi già discriminati, che presto vennero colpevolizzati per la malattia dall’opinione pubblica. Il New York Times parlò di «raro cancro osservato in 41 omosessuali», il Lancet di «gay compromise syndrome», i quotidiani di «gay-related immune deficiency (GRID)» e «gay cancer». Ancora una volta una malattia orribile e mortale connessa alla sessualità faceva irruzione in un mondo di convenzioni che tentava di bollarla e renderla estranea. Si parlò di un «virus venuto d’altrove». Ne scaturì una crisi profonda, con l’emarginazione di talune categorie di individui e il rifiuto del contatto col malato da parte dei consimili e persino degli operatori sanitari. Come per la sifilide, si è poi appurato che il contagio avviene o nei rapporti sessuali o attraverso il sangue, quindi con iniezioni, trasfusioni, trapianti d’organo, placenta e parto. Come per altre malattie sessualmente trasmissibili, sofferenza e morte
si insinuavano nell’intimo dell’uomo attraverso il sesso e il sangue, elementi essenziali della sua natura, indispensabili all’istinto e alla forza della vita, capaci di oscura attrazione e fascinazione sul singolo e sulla collettività. In questo intenso paesaggio clinico e metaforico si è fatta strada la medicina per comprendere, curare, garantire un’equa assistenza e promuovere la salute sessuale.
Il sifilitico, incisione realizzata da Albrecht Dürer nel 1496 per rappresentare la congiunzione astrale abnorme del 1484 che avrebbe causato l’epidemia di sifilide di fine Quattrocento

S E x AND BLOOD : HEALTH AND SE x UALLy TRANSMITTED DISEASES IN A HISTORICAL CONTE x T .
Sexually transmitted diseases (STDs) have existed since the beginning of times, becoming intertwined with deeply symbolic aspects of human life, such as sexuality, reproduction, gender identity, desire and morality. Historically, they have been associated with stigma, guilt, social fear and the tendency to link the disease with sin and blame.
The earliest references to STDs date back to ancient texts such as the Ebers Papyrus (1550 BC) and the Bible, which describe symptoms that are now recognised as being attributable to gonorrhoea. Hippocrates and other Greek and Roman physicians also described urethral and vulvovaginal infections, such as gonorrhoea, genital warts, soft ulcers and tubercular ulcers. They considered these diseases to be contagious and sometimes associated them with sexual practices that were regarded as deviant. Such diseases were also known to laypeople, among them Martial and Juvenal.
Syphilis was the most commonly treated venereal disease in history and was the most feared before AIDS. According to the most widely accepted theory, it appeared in Europe in the late 15th and early 16th century, having been imported from the New World by Christopher Columbus’s sailors. It was first described by Ruiz Díaz de Isla, but it is Girolamo Fracastoro’s approach that is best known. Fracastoro also named the disease in his poem Syphilis (1530). According to some theories, syphilis already existed in Europe but was initially confused with other diseases, such as leprosy.
Sixteenth-century syphilis was extremely virulent, causing extensive ulcerations and severe damage to the bones and mind. Although it was curable with mercury or guaiacum, it was often fatal. The social reaction was dramatic; the disease was seen as a punishment for lust and was always attributed to foreigners, as evidenced by the variety of names by which it was known (e.g. ‘French disease’, ‘Gallic disease’, ‘Neapolitan disease’). Many sufferers, especially noblewomen, concealed their condition due to the associated shame, as evidenced by retrospective diagnoses on the remains of Maria of Aragon and Maria Salviati.
Medical practitioners such as Giovanni Battista Selvatico criticised patients for frequently simulating or denying the disease, suggesting that common sense could be used to detect it. However, as early as the 16th century, it became clear that contagion could occur not only through sexual contact, but also through indirect contact, as Fracastoro observed among washerwomen, or congenitally, as described by Benivieni and Falloppia.
The discovery of Treponema pallidum by Shaudinn and Hoffmann in 1905 marked a turning point, leading to the development of effective treatments such as Ehrlich’s Salvarsan in 1910 and penicillin, discovered by Fleming in 1928. However, the 20th century also saw serious ethical violations, such as the Tuskegee study (1932–1972), in which hundreds of African Americans with syphilis were used as guinea pigs for scientific research without receiving treatment.
Towards the end of the century, the emergence of AIDS led to a resurgence in the belief that the disease was a punishment for sexual transgressions. The initial cases involved homosexuals and drug addicts, resulting in significant stigmatisation. As with syphilis, an external culprit was sought, with the terms ‘gay cancer’ and ‘disease from outside’ being used. It was only later that the real mechanisms of transmission were clarified: blood, sexual intercourse, the placenta, and childbirth.
A common theme throughout history is the complex relationship between sexually transmitted diseases, the body, and society. STDs have posed clinical challenges, besides raising issues of identity, culture and ethics, with implications that extend beyond medicine. Only an integrated, conscious approach—encompassing the clinical, cultural and social aspects—can promote true sexual health.
POSSIBILE SPIA DI UNA PATOLOGIA
GINECOLOGICA?
Il lato oscuro della dismenorrea
Intervista con la Prof.ssa Manuela Farris
Docente UniCamillus di Ginecologia e Ostetricia di Giorgia Martino
Per molte ragazze e donne il dolore mestruale è un appuntamento mensile dato quasi per scontato, un fastidio “da sopportare”. Fin dall’adolescenza, capita che venga liquidato con frasi come “è normale, ci passano tutte” o “passerà con l’età o dopo la prima gravidanza”. Eppure, quando quel dolore è intenso, ricorrente e limita la vita quotidiana, non è semplicemente un sintomo fisiologico, ma può diventare un segnale d’allarme.
In Italia, come nel resto del mondo, la dismenorrea è uno dei disturbi ginecologici più comuni, soprattutto tra le adolescenti e le giovani donne. Secondo uno studio del 2023 pubblicato sul Journal of Pain Research, “la prevalenza della dismenorrea varia notevolmente a seconda delle regioni e dei gruppi di età. La prevalenza complessiva oscilla tra il 15% e il 94%. La prevalenza tra le giovani donne di età compresa tra i 17 e i 24 anni è stata oggetto di studio e varia dal 67% al 90%, iniziando a diminuire dopo i 25 anni”.
Nelle sue forme più severe, compromette le attività quotidiane, riduce la produttività scolastica o lavorativa e ha un impatto diretto sulla salute mentale e sulla qualità della vita. Nonostante questi numeri, troppo spesso viene ancora considerata un aspetto “naturale” della femminilità, qualcosa da sopportare senza troppe domande.

Questa banalizzazione culturale del dolore mestruale è parte di un problema più ampio: la scarsa consapevolezza, anche medica, sui disturbi legati al ciclo e sulle patologie che possono manifestarsi attraverso di esso. In questo contesto, la dismenorrea può essere molto più di un semplice dolore da ciclo. In alcuni casi, infatti, è un primo campanello d’allarme che segnala condizioni ginecologiche sottostanti, tra cui una delle più complesse e sotto-diagnosticate: l’endometriosi.
L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica in cui il tessuto simile all’endometrio si sviluppa al di fuori dell’utero, provocando lesioni, aderenze e, spesso, un dolore pelvico ricorrente. Sebbene si stimi che colpisca circa una donna su dieci in età fertile, il ritardo diagnostico è ancora molto elevato: possono passare molti anni tra la comparsa dei sintomi e la diagnosi definitiva. Questo ritardo non è casuale, ma spesso è legato proprio alla difficoltà di distinguere un dolore “normale” da un dolore “patologico”.
Nel caso dell’endometriosi, il dolore mestruale può essere il primo sintomo, ma non è mai l’unico. Spesso si associa a disturbi intestinali, dolore durante i rapporti, affaticamento cronico e, nei casi più gravi, a difficoltà di concepimento. Tuttavia, se ci si ferma alla convinzione che il dolore mestruale sia fisiologico, questi segna-
li rischiano di non essere ascoltati. È per questo che una maggiore attenzione alla dismenorrea non deve essere vista come un’esagerazione o un allarmismo, ma come un passo fondamentale verso una diagnosi precoce e una migliore tutela della salute ginecologica.
Negli ultimi anni qualcosa si sta muovendo: l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad esempio, ritiene che il benessere mestruale debba essere riconosciu ta come un diritto alla salute. Eppure, nella pratica quotidiana, troppe giovani continuano a convivere con un dolore invalidante senza ricevere risposte adeguate. L’educazione alla salute mestruale, l’ascolto empatico da parte dei professionisti e l’accesso a percorsi diagnostici tem pestivi sono ancora obiettivi da rag giungere.

vengono considerati “normali” ma che possono incidere pesantemente sulla qualità della vita.»
Qual è la differenza tra dismenorrea primaria e secondaria?

Il corpo manda segnali precisi, e ignorarli può avere conseguenze nel tempo, anche sulla salute riproduttiva. Una maggiore consapevolezza su ciò che è fisiologico e ciò che non lo è rappresenta una forma concreta di prevenzione, nonché un atto di autodeterminazione e cura.
Per parlare di quel fil rouge che potrebbe legare la dismenorrea all’endometriosi, abbiamo intervistato la Prof.ssa Manuela Farris, Docente di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università UniCamillus.
Cos’è la dismenorrea e quanto è diffusa?
«La dismenorrea è un disturbo molto comune che si manifesta con dolore pelvico ciclico, tipicamente localizzato nella zona bassa dell’addome, che può insorgere qualche giorno prima o proprio all’inizio del ciclo mestruale, per poi proseguire fino a 24-48 ore dopo. Questo dolore è legato alle contrazioni uterine che, se eccessive, possono causare sofferenza locale. È una condizione che interessa una percentuale molto alta di giovani donne in età fertile: studi internazionali stimano che tra il 70% e il 93% delle ragazze e giovani donne ne soffrano almeno occasionalmente. Questo dato sottolinea quanto sia importante non sottovalutare questi sintomi, che spesso
«La dismenorrea primaria è una forma di dolore mestruale che si presenta in assenza di patologie evidenti dell’apparato riproduttivo. Generalmente compare nei primi anni dopo il menarca, cioè la prima mestruazione, spesso entro il primo anno. È dovuta a meccanismi fisiologici legati alla produzione di prostaglandine, sostanze chimiche che regolano la contrazione muscolare uterina e che aumentano in corrispondenza del calo dei livelli di progesterone nel sangue. Queste contrazioni possono provocare vasocostrizione e conseguente dolore. È importante sottolineare che in questo caso non è necessario eseguire esami diagnostici invasivi, ma si può intervenire con terapie mediche mirate a ridurre il dolore e l’infiammazione.
La dismenorrea secondaria, invece, compare in genere dopo un periodo più lungo dal menarca (oltre 12 mesi) ed è spesso legata a condizioni patologiche, come l’endometriosi o l’adenomiosi, che causano un peggioramento progressivo del dolore, a volte anche al di fuori del ciclo, con dolore cronico pelvico. Questi casi richiedono un approfondimento diagnostico più specifico per identificare la causa sottostante e poter programmare un trattamento mirato.»
Quando il dolore mestruale deve essere considerato “anomalo” e spingere a una visita ginecologica?
«Il dolore mestruale diventa anomalo quando compromette in modo significativo la qualità della vita della persona, impedendo di svolgere attività quotidiane come andare a scuola, lavorare, praticare sport o partecipare alla vita sociale. Spesso si tende a sottovalutare questo tipo di dolore perché culturalmente è percepito come “normale” per le donne, ma in realtà, se è intenso, ricorrente e invalidante, deve essere sempre valutato da un professionista. Ignorare questi segnali può ritardare la diagnosi di patologie importanti, come l’endometriosi, che possono aggravarsi nel tempo. Oggi c’è maggiore consa-

pevolezza sull’importanza di trattare tempestivamente il dolore mestruale per prevenire complicanze e migliorare il benessere generale.»
Ci può spiegare il legame tra dismenorrea e patologie ginecologiche più complesse?
«Assolutamente sì. La dismenorrea, soprattutto se severa e resistente ai comuni analgesici, può essere il campanello d’allarme di condizioni più complesse come l’endometriosi o l’adenomiosi. In queste patologie, il dolore è provocato da un’infiammazione cronica generata dalla presenza anomala di tessuto endometriale fuori dall’utero (nel caso dell’endometriosi) o nel muscolo uterino (adenomiosi), e questo stimola una risposta infiammatoria e genera dolore continuo e acuto. L’endometriosi soprattutto può interessare diversi organi pelvici, causando un dolore spesso intenso e invalidante, che non si limita al periodo mestruale ma può presentarsi anche in modo aciclico.»
Quali sono i principali segnali e sintomi dell’endometriosi?
«Oltre al dolore pelvico intenso e ricorrente, spesso legato al ciclo mestruale, l’endometriosi può manifestarsi con irregolarità del ciclo, flussi abbondanti o spotting, dolore durante i rapporti sessuali, dolore durante la minzione o la defecazione, e talvolta infertilità. La sintomatologia può variare molto da persona a persona, e talvolta può essere sottovalutata o confusa con altre condizioni, rendendo necessaria una diagnosi attenta e tempestiva.»
Anche i polipi uterini e i miomi possono essere causa di mestruazioni dolorose?
«I polipi uterini sono escrescenze benigne della mucosa uterina che solitamente non provocano dolore perché non generano infiammazione, ma possono causare sanguinamenti anomali o irregolari. I miomi uterini, invece, sono masse benigne che possono causare sia sanguinamenti abbondanti che dolore pelvico, specialmente quando sono di dimensioni rilevanti o localizzati in determinate aree dell’utero. È importante considerare anche il dolore pelvico post-partum, che può essere legato a processi di cicatrizzazione o altre complicanze dopo il parto.»
Quanto è difficile arrivare a una diagnosi di endometriosi? E quali strumenti diagnostici sono più utilizzati oggi?
«La diagnosi di endometriosi può essere complessa, soprattutto nei casi in cui la malattia coinvolge aree difficili da visualizzare con gli esami standard, come l’intestino o le vie urinarie. L’ecografia transvaginale è spesso il primo strumento utilizzato per identificare segni di endometriosi ovarica o cisti endometriosiche, ma nei casi più difficili può essere necessario ricorrere alla laparoscopia, che rimane il gold standard diagnostico e permette anche di intervenire chirurgicamente.»
Una volta ricevuta una diagnosi, quali opzioni terapeutiche sono disponibili?
«Il trattamento della dismenorrea e delle condizioni associate come l’endometriosi comprende principalmente terapie farmacologiche che modulano l’attività ormonale. I contraccettivi ormonali combinati o quelli a base di solo progestinico sono molto efficaci nel ridurre l’infiammazione e il dolore, regolando o sopprimendo il ciclo mestruale. Il dispositivo intrauterino a rilascio di levonorgestrel è un’opzione valida sia come metodo contraccettivo che come terapia per ridurre i sintomi.»
Le persone che desiderano una gravidanza e soffrono di queste patologie devono affrontare percorsi particolari o hanno possibilità paragonabili a chi non ne soffre?
«L’impatto sulla fertilità dipende dalla gravità e dall’estensione della patologia. Molte donne con dismenorrea primaria o forme lievi di endometriosi possono concepire senza difficoltà particolari. Tuttavia, nei casi più gravi di endometriosi o in presenza di patologie associate, può essere necessario un approccio multidisciplinare, che include la chirurgia e l’uso di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). È fondamentale che chi desidera una gravidanza venga seguito da specialisti per valutare le migliori strategie personalizzate, ma oggi molte donne con queste condizioni riescono comunque a realizzare il desiderio di maternità.»

Esistono strategie preventive o raccomandazioni per proteggere la salute riproduttiva fin dalla giovane età?
«Sì, la prevenzione passa innanzitutto da una buona educazione alla salute sessuale e riproduttiva, compresa la protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili, che possono complicare la salute pelvica. È importante inoltre sottoporsi a visite ginecologiche regolari, soprattutto in presenza di sintomi come flussi mestruali abbondanti, irregolari o dolorosi. La diagnosi precoce di eventuali patologie permette interventi tempestivi e migliori risultati nel trattamento.»
Quali sono, secondo lei, gli errori o i pregiudizi più comuni che ancora circondano la salute mestruale e riproduttiva?
«Uno degli errori più diffusi è considerare il dolore mestruale come un problema “normale” da sopportare, senza comprendere che può essere segno di patologie importanti. Inoltre, c’è spesso poca consapevolezza dell’importanza della protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili e della necessità di screening regolari, come quelli per il papillomavirus umano (HPV), fondamentale per la prevenzione del cancro cervicale. La mancanza di informazione porta molte donne a trascurare sintomi rilevanti o a non rivolgersi tempestivamente a un medico, ritardando diagnosi e trattamenti.»
Che consiglio darebbe a una giovane che soffre di dolori mestruali intensi ma ha sempre sentito dire che “è normale” o “ereditario”?
«Il consiglio principale è di non sottovalutare mai il proprio dolore e di rivolgersi a un ginecologo o una ginecologa per un controllo approfondito. Solo attraverso una valutazione medica è possibile capire le cause, escludere patologie più gravi e avviare un trattamento efficace. Inoltre, farsi accompagnare da familiari o amici può essere d’aiuto per superare la reticenza a parlare di questi problemi.»
I S PAINFUL MENSTRUATION A POSSIBLE SIGN OF G y NAECOLOGICAL PATHOLOG y ? T HE DAR k SIDE OF D y SMENORRHOEA
For many women, menstrual pain is an almost taken-for-granted monthly occurrence. Ever since adolescence, it is often dismissed with phrases such as ‘it’s normal’ or ‘it’ll pass with age’. However, when the pain is intense and recurrent to the point of limiting daily life, it can be a cause for concern. Dysmenorrhoea is one of the most common gynaecological disorders, particularly among teenage girls. In its most severe forms, it can affect school attendance, work performance, social life, and emotional well-being. Yet it is still trivialised, as if it were an unavoidable and normal part of being female.
In fact, menstrual pain can be an indicator of more complex conditions. One of the most underdiagnosed of these is endometriosis, a chronic inflammatory disease in which endometrium-like tissue develops outside the uterus, causing lesions, adhesions and pelvic pain.
We discussed this issue with Manuela Farris, lecturer in Gynaecology and Obstetrics at UniCamillus University.
What is dysmenorrhoea, and how common is it?
“It is cyclic pelvic pain that is often localised in the lower abdomen and occurs during the menstrual cycle. International studies estimate that between 70% and 93% of girls and young women experience it at least occasionally. It should not be underestimated, as it can greatly impair quality of life”.
What is the difference between primary and secondary dysmenorrhoea?
“Primary dysmenorrhoea is linked to physiological causes and arises shortly after the onset of menstruation (menarche). Secondary dysmenorrhoea, on the other hand, can result from pathologies such as endometriosis and adenomyosis. It manifests as pain that tends to worsen over time and requires a thorough clinical examination”.
When should menstrual pain be a concern?
“When it is disabling, preventing daily activities, or is resistant to common painkillers. In these cases, a gynaecological check-up is essential to rule out any disease”.
What is the link between dysmenorrhoea and endometriosis?
“With endometriosis, the pain is not only menstrual, but also often chronic and widespread. It is caused by the abnormal presence of endometrial tissue outside the uterus, which triggers inflammation. Ignoring these symptoms can result in a delayed diagnosis of several years”.
What are the most common symptoms of endometriosis?
“Besides recurrent pelvic pain, symptoms include heavy periods, spotting, pain during intercourse, urination or defecation, and sometimes infertility.”
Can polyps and uterine myomas also cause pain?
“Polyps rarely cause pain, but they can cause abnormal bleeding. Myomas can cause both pain and heavy bleeding, especially if they are large”.
How difficult is it to diagnose endometriosis?
“It can be complicated, especially if it affects organs such as the intestines or bladder. The first step is a transvaginal ultrasound. Laparoscopy remains the gold standard, but it is only used in the most complex cases”.
What are the treatment options?
“There is no need to wait for a diagnosis to start treating the pain. Hormonal therapies, including combined pills, progestins, and medicated intrauterine devices, are very effective. There are also specific treatments for endometriosis, such as dienogest”.
Do women who wish to become pregnant have a lower chance of success?
“It depends on the severity. Mild cases often do not affect fertility. In more serious cases, techniques such as medically assisted procreation can be used. A personalised approach is essential”.
What strategies are there to protect reproductive health?
“Sex education and regular gynaecological check-ups. It is important not to ignore symptoms such as irregular, abundant or painful menstrual cycles because an early diagnosis can improve outcomes”.
What prejudices still hinder gynaecological health today?
“The most common is considering any kind of menstrual pain ‘normal’. Other mistakes include underestimating the importance of screening and protection against sexually transmitted infections”.
What advice would you give to a young woman experiencing intense pain?
“Not to ignore the pain and to consult a gynaecologist. Only then can a diagnosis be made and, if necessary, treatment started”.

ACADEMIC LIFE News UNICAMILLUS SPORT SSD
Il primo torneo inter-universitario
di Claudia Romano
Quando lo sport crea legami, identità e futuro.
C’è un pallone che rimbalza. C’è un campo affollato di voci, risate e strette di mano. Ma soprattutto, c’è un’idea. Un “comandamento”, che chi ha fede nello sport conosce bene. Il concetto forte e gentile che lo sport sia molto di più di un’attività fisica. Che possa essere un linguaggio comune, uno strumento per creare comunità, amicizia, appartenenza.
È partendo da questa visione che UniCamillus ha dato vita a UniCamillus Sport SSD, la nuova società sportiva dilettantistica dell’Ateneo, voluta per strutturare in modo ufficiale un’attività già praticata in modo spontaneo da tanti studenti.
Per iniziare con il piede giusto, quale modo migliore che scendere in campo con il primo torneo interuniversitario, ospitato il 6 e 7 maggio scorsi presso il centro Sapienza Sport di Tor di Quinto: due giorni di sfide in calcio maschile, basket maschile e pallavolo femminile, che hanno coinvolto circa un centinaio di studenti provenienti da diverse università romane.
«Non ci interessava il risultato – racconta il Prof. Daniele Masala, campione olimpionico e ora Delegato allo Sport per UniCamillus, nonché Docente di Metodi e Didattiche delle Attività Sportive presso lo stesso Ateneo – quanto creare un’occasione per far nascere legami, conoscenze, scambi di idee. E, a giudicare dai sorrisi dei ragazzi a fine giornata, ci siamo riusciti».
DALL’INIZIATIVA SPONTANEA
ALLA STRUTTURA UFFICIALE
Fino a poco tempo fa, l’attività sportiva nell’Ateneo era portata avanti da UniSport, un gruppo di studenti appassionati che, pur senza un riconoscimento formale, erano riusciti a mantenere vivo l’interesse per tornei e allenamenti.
«È stata un’esperienza davvero meritoria, e per questo vanno ringraziati i promotori – spiega Masala – Ma ora l’università ha deciso di fare un salto di qualità e creare una vera e propria società sportiva, con una struttura organizzata e una visione a lungo termine».
Nasce così UniCamillus Sport SSD, di cui Masala è Amministratore
Unico voluto dal Magnifico Rettore Gianni Profita, con il sostegno della Dott.ssa Patrizia Maggi, Coordinatrice Sportiva.
Una realtà ancora giovane, ma già operativa: nuovo logo, divise ufficiali, affiliazione con l’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport - Ente di Promozione Sportiva), e soprattutto tanta voglia di coinvolgere la comunità universitaria in progetti che vanno ben oltre la semplice competizione.
IL TORNEO: UN BANCO DI PROVA RIUSCITO
A scendere in campo per questa prima edizione, oltre a UniCamillus, c’erano le squadre rappresentative di Sapienza, Link Campus, Campus Biomedico, Foro Italico e Università Cattolica. A trionfare sono state rispettivamente La Sapienza (calcio), il Foro Italico (basket) e l’Università Cattolica (volley), ma UniCamillus ha

conquistato due secondi posti (calcio e basket) e un terzo (volley), mostrando spirito e determinazione.
L’aspetto più bello? «I ragazzi ci hanno detto di essersi divertiti davvero: hanno conosciuto studenti di altri atenei e creato legami. È questo il nostro obiettivo: fare dello sport un’occasione di crescita personale e collettiva – risponde Masala – Ma non solo: sono stati corretti, leali, e non è scontato. Su questi aspetti non transigo, perché il rispetto dell’avversario e delle regole è la condizione essenziale dello sport, che solo in questo modo diventa crescita, educazione e socialità: si sta insieme, ma nel modo corretto». L’organizzazione, curata direttamente dal Prof. Masala e dalla Dott.ssa Patrizia Maggi, non è stata semplice: dalla prenotazione dei campi alla realizzazione delle divise, fino alla logistica di partite, medaglie, coppe e assistenza medica. «Abbiamo fatto tutto noi – continua Masala – senza coinvolgere gli studenti nella parte organizzativa: il loro compito era solo scendere in campo. Il nostro, dare loro l’occasione per farlo nel miglior modo possibile».
UNO SPORT CHE EDUCA, CURA, COSTRUISCE
Dietro l’entusiasmo e i numeri, c’è però una riflessione più ampia sul valore educativo e sociale dello sport. «Lo sport non è solo movimento: è cultura, è regola, è rispetto. È una forma di pedagogia. Accanto alla famiglia e alla scuola, rappresenta una delle agenzie educative più importanti. Soprattutto perché, a differenza delle altre, lo sport si sceglie. Ed è questa libertà a renderlo così potente nella formazione» osserva Masala. Ma lo sport è anche prevenzione, benessere, equilibrio psico-fisico: un valore ancora più forte all’interno di un’università dedicata alle scienze mediche. «Chi fa sport, studia meglio e vive meglio. E nel nostro contesto, lo sport ha anche un impatto professionale: chissà se in un prossimo futuro si attiverà un corso specialistico in Medicina dello Sport, perché c’è una carenza enorme di medici in questo campo, e sono invece fondamentali per i 28 milioni di italiani che praticano attività sportiva e che hanno bisogno obbligatoriamente di un certificato medico» prosegue il Prof. Masala. IN CANTIERE NUOVE DISCIPLINE, SPAZI E PROGETTI Il torneo è stato solo un inizio. L’obiettivo ora è espandere l’offerta, coinvolgere anche il personale amministrativo e creare uno spazio sportivo stabile per allenamenti e attività continue. «Stia-
mo cercando un impianto sportivo nei dintorni dell’università: vorremmo introdurre corsi di ginnastica, fitness, magari anche nuoto o atletica leggera. E perché no, un percorso in natura per la corsa sicura, fuori dal traffico. Tutto dipende dalle possibilità logistiche, ma l’intenzione c’è tutta – spiega Masala, assicurando un approccio inclusivo e flessibile, aperto a tutte le discipline – Se un gruppo di studenti ci proponesse di formare una squadra di rugby, la faremmo partire. Noi ascoltiamo, raccogliamo le proposte, e costruiamo insieme. Work in progress, come dicono quelli bravi».
UN MODELLO INTERNAZIONALE DI SPORT...
IN UN ATENEO INTERNAZIONALE.
La visione si ispira chiaramente al mondo anglosassone, , dove lo sport universitario è da sempre parte integrante della vita accademica. «Università come Oxford e Cambridge hanno inventato il concetto di sport nel campus – ricorda il Professor Masala – Basti pensare che la prima celebre sfida di canottaggio tra i due Atenei risale addirittura al 1829. È da lì che nasce l’idea di uno sport regolato, educativo e formativo». Proprio questo modello rappresenta oggi l’orizzonte di UniCamillus Sport: lo sport come lingua comune, spazio di educazione, strumento di coesione. Quando ha regole condivise, lo sport è un linguaggio universale. Non serve la traduzione per rispettare una regola di gioco: bastano il rispetto e la voglia di esserci. A credere per primo in questa impostazione è stato il Magnifico Rettore Gianni Profita, che ha fortemente voluto la nascita della SSD UniCamillus Sport, affidando proprio al Prof. Masala il compito di strutturare un progetto capace di integrare lo sport nel cuore della vita universitaria. «UniCamillus nasce con una vocazione internazionale e profondamente umana. Per questo lo sport non può essere un’attività accessoria, ma parte integrante del percorso formativo dei nostri studenti – commenta il Rettore Profita –VVogliamo che i futuri medici e professionisti della salute crescano non solo nelle conoscenze, ma anche nei valori: spirito di squadra, rispetto delle regole, cura di sé e degli altri. Lo sport insegna tutto questo, e lo fa con il linguaggio più diretto che esista: quello del corpo in movimento e delle emozioni condivise. Con UniCamillus Sport stiamo gettando le basi per qualcosa di più di una semplice società sportiva: vogliamo costruire una comunità».
Una comunità che corre, che gioca, che vince e perde insieme.

insieme.

E che cresce, dentro e fuori le aule.
Il Prof. Daniele Masala, Docente di Metodi e Didattiche delle Attività Sportive e Delegato, applaude il team UniCamillus di basket, in posa insieme alla Coordinatrice Sportiva Dott.ssa Patrizia Maggi.
ACADEMIC LIFE
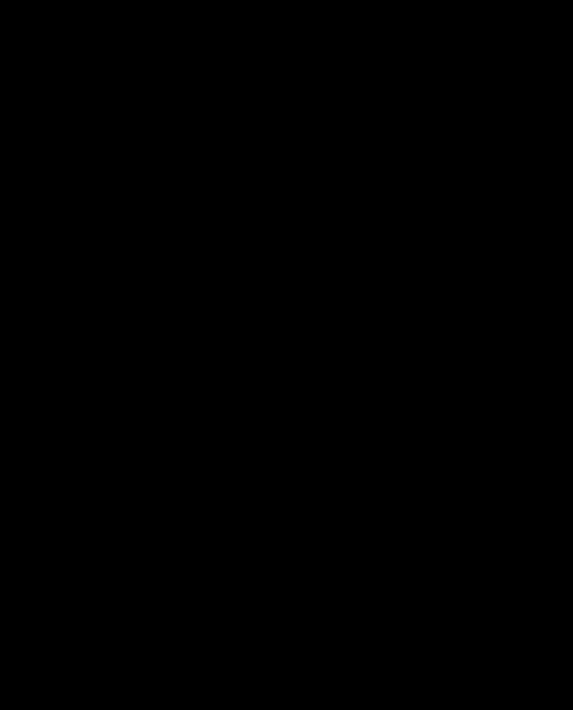
News da UniWeb
Paracetamolo: sicuro o pericoloso?
Il parere del Prof. Silvio Festinese Docente UniCamillus di Farmacologia

Il periodo a cavallo tra inverno e primavera è notoriamente “birichino” in termini di possibilità di contrarre una qualche forma di influenza o raffreddore: sbalzi di temperatura, dubbi sul come vestirsi, piogge inaspettate, ed eccoci lì con fazzoletti di carta e medicinali da banco.
Tra questi, uno dei più utilizzati è il paracetamolo, principio attivo dotato di azione analgesica e antipiretica.
sicuro, ma non Per gli anziani e non a lungo termine
Il paracetamolo è da sempre considerato un farmaco sicuro, e spesso viene raccomandato per la gestione dell’osteoartrite, una condizione cronica dolorosa molto comune tra gli over 65. Tuttavia, lo studio condotto dall’Università di Nottingham – basato su dati di oltre 180.000 pazienti con un’età media di 75 anni – ha evidenziato una correlazione tra l’uso prolungato del paracetamolo e l’aumento del rischio di complicazioni gravi.
Secondo i risultati della ricerca, l’assunzione continuativa del farmaco per sei mesi o più è stata associata a un incremento del:
• 36% del rischio di emorragie gastrointestinali;
• 20% del rischio di ulcere peptiche;
• 19% del rischio di malattia renale cronica;
• 9% del rischio di scompenso cardiaco;
• 7% del rischio di ipertensione. I dati mostrano anche una chiara relazione dose-risposta: più il farmaco viene prescritto e assunto, maggiore è la possibilità di sviluppare effetti collaterali potenzialmente pericolosi.
risultati scientifici non definitiVi: il Parere del Prof. festinese È importante sottolineare che, trattandosi di uno studio osservazionale, non è possibile stabilire con assoluta certezza un nesso causale diretto tra l’assunzione di paracetamolo e l’insorgenza di queste complicazioni. Tuttavia, i risultati suggeriscono la necessità di una maggiore cautela da parte dei medici nel somministrare il paracetamolo a lungo termine, soprattutto nei pazienti anziani, oltre che di una maggiore consapevolezza in chi lo assume.
Per approfondire l’argomento, abbiamo intervistato Silvio Festinese, Medico Specialista in Cardiologia nonché Docente di Farmacologia presso l’Università UniCamillus.
Secondo lei lo studio condotto dai ricercatori di Nottingham ha utilizzato una metodologia adeguata per trarre conclusioni? O piuttosto crede siano necessari ulteriori approfondimenti?
«Il disegno di questo studio è di tipo osservazionale di coorte condotto su dati provenienti dal ”The clinica Practice Research Datalink”. Spiego meglio cos’è uno studio di coorte osservazio-
Prof. Silvio Festinese
nale: si tratta di uno studio in cui i ricercatori osservano per anni un gruppo di persone (coorte). Le coorti sono gruppi di individui selezionati sulla base di determinate caratteristiche condivise e suddivisi in sottogruppi in base alle differenze nella loro esposizione a un particolare agente (in questo caso ad un farmaco) e seguiti attraverso un sistema di misurazione per vedere se sviluppano una particolare malattia o delle complicanze. Negli studi di coorte prospettici, le coorti sono identificate all’inizio dello studio e seguite nel corso del tempo. Detto ciò, la metodologia impiegata risulta adeguata ma, trattandosi di una “osservazione”, le conclusioni sono sempre da intendersi non conclusive bensì spunto per ulteriori e diversi approfondimenti.»
Gli effetti collaterali riportati a lungo termine erano già noti? Se sì, quali sono le novità?
«Gli effetti collaterali maggiori circa l’uso cronico del paracetamolo quali ipertensione, scompenso cardiaco, insufficienza renale, sanguinamenti del tratto gastrointestinale sono già noti. Questo studio osservazionale ha voluto attirare l’attenzione sui rapporti tra periodo di somministrazione, dosaggio e complicanze maggiori nel paziente anziano. Paziente che, d’altronde, richiederebbe maggiore attenzione in clinica pratica e maggiori studi in ricerca farmacologica.»
Esistono categorie di pazienti che dovrebbero usare il paracetamolo con cautela, o che dovrebbero evitarlo del tutto?
«In primis i bambini e gli anziani: per motivi diversi, entrambi dovrebbero usare il paracetamolo con cautela evitando accuratamente l’autogestione della terapia, e seguendo attentamente le indicazioni del proprio medico curante»

Esiste un dosaggio massimo sicuro nell’anziano?
E cosa si intende per “uso prolungato”?
«I farmaci vengo metabolizzati ed eliminati dal fegato e dal rene: il paziente anziano deve essere sempre trattato alla luce della sua specifica funzionalità epatica e renale. Alla luce di ciò, per ogni farmaco va stabilito il dosaggio più adeguato e sostenibile: questo vuol dire sia evitare di superare il massimo dosaggio sottoponendo il paziente a severi effetti collaterali, ma anche di sottodosare il farmaco esponendo il paziente ad altrettanti gravi rischi e complicanze della patologia da trattare.
Esami ematochimici di routine (creatinina, acido urico, GFR, microalbuminuria, transaminasi, gammagt, bilirubina, emocromo et al.), analizzati tenendo conto di età, sesso, peso, altezza, BMI, circonferenza addominale del paziente, forniscono queste informazioni, per una cura sempre più personalizzata del paziente anziano, spesso anche fragile.»
Alcuni anziani usano il paracetamolo per dolori cronici: esistono alternative più sicure e altrettanto efficaci?
«Diverse linee guida internazionali sulla terapia del dolore (ad esempio di natura ortopedica, neuropatica, oncologica) concordano in prima battuta nell’uso del paracetamolo sino a dosaggi superiori. Step by step si possono poi associare altre molecole, come analgesici del sistema nervoso periferico e centrale. [...]
PER LEGGERE L’INTERO
ARTICOLO E SCOPRIRE DI PIÙ
SUI TEMI TRATTATI, INQUADRA IL QR CODE E VISITA IL SITO DI UNICAMILLUS

CINQUE NOTIZIE
BIOPSIE MENO INVASIVE CON I NUOVI PATCH NANOSINTETICI
Un nuovo cerotto con milioni di nano-aghi microscopici potrebbe rivoluzionare le biopsie tradizionali: questo dispositivo innovativo, sviluppato al King’s College London, permette di raccogliere informazioni molecolari dai tessuti in modo rapido, indolore e senza danneggiarli. I nano-aghi, sottilissimi rispetto persino a un capello umano, riescono a “leggere” segnali come proteine, lipidi e mRNA dalle cellule. I dati vengono poi analizzati con tecnologie avanzate, come la spettrometria di massa e l’intelligenza artificiale. In soli 20 minuti è possibile ottenere un quadro dettagliato della presenza o evoluzione di malattie come tumori o Alzheimer Lo studio è stato pubblicato su Nature Nanotechnology, e apre la strada a diagnosi più frequenti, precise e meno invasive.
SALUTE MENTALE OBIETTIVO EUROPEO: ARRIVA LA “DICHIARAZIONE DI PARIGI”
Una persona su sei in Europa soffre di disturbi mentali, ma una su tre non riceve cure adeguate: a Parigi, 31 Paesi (Italia inclusa) hanno firmato la “Dichiarazione di Parigi”, stipulata durante una conferenza organizzata dall’OMS e dal Ministero della Salute francese. L’obiettivo è rendere la salute mentale una priorità in tutte le politiche pubbliche, coinvolgendo sanità, istruzione, giustizia e altri settori. Il suicidio è la prima causa di morte tra i giovani tra 15 e 29 anni, e la pandemia ha aumentato ansia e depressione. Inoltre, la carenza di operatori adeguatamente formati esaspera questa situazione. La dichiarazione richiede un approccio integrato, con finanziamenti condivisi, inclusione e prevenzione nelle scuole e nei luoghi di lavoro. La Francia, dunque, ha fatto della salute mentale un obiettivo fondamentale per il 2025: ora tocca passare dalla teoria alla pratica in tutta Europa.
BODyBUILDER A RISCHIO CARDIACO: RISCHI 5 VOLTE SUPERIORI TRA PROFESSIONISTI RISPETTO AGLI AMATORIALI Uno studio internazionale, coordinato dall’Università di Padova e a cui ha partecipato anche UniCamillus con il Prof. Stefano Palermi, è stato pubblicato sull’European Heart Journal. Tale studio ha analizzato oltre 20 mila bodybuilder maschi partecipanti a gare IFBB tra 2005 e 2020, con un follow-up di 8 anni. Sono stati registrati 121 decessi, di cui il 38% per morte cardiaca improvvisa, spesso legata ad alterazioni del cuore e uso di sostanze dopanti. Il rischio di morte cardiaca nei bodybuilder profe sionisti è oltre 5 volte superiore rispetto ai dilettanti. Nei referti disponibili si osservano ingrossamento cardiaco e malattie coronariche. Lo studio evidenzia dunque la necessità di maggiore attenzione e prevenzione in uno sport che, a livello agonistico, può unire modifiche strutturali cardiache e pratiche rischiose per la salute.
PRIMO BAMBINO AL MONDO GUARITO DA MALATTIA RARA GRAZIE ALL’EDITING GENOMICO
Un bambino di 9 mesi, KJ Muldoon, è stato il primo al mondo a essere curato con successo con una terapia genica CRISPR personalizzata: affetto da Deficit di CPS1 – una rara e grave malattia metabolica che colpisce il ciclo dell’urea – rischiava gravi danni neurologici e addirittura la morte. Di solito chi ha questa malattia potrebbe necessitare di un trapianto di fegato, ma KJ ha ricevuto una terapia su misura che ha corretto il difetto genetico direttamente nelle sue cellule del fegato. Dopo la somministrazione a febbraio al Children’s Hospital of Philadelphia, il bambino sta bene e cresce normalmente. La terapia, sviluppata grazie ad anni di ricerca, segna un passo storico: è la prima volta che la terapia CRISPR viene usata con successo per creare una cura “su misura” per una malattia così rara. Si spera ora che questo sia solo l’inizio di una nuova era per trattare malattie genetiche difficili da curare.
NUOVA SPERANZA TERAPEUTICA PER CHI SOFFRE DI DEMENZA FRONTOTEMPORALE GENETICA
La biotech britannica AviadoBio ha completato la somministrazione della seconda dose della sua terapia genica sperimentale AVB-101 per trattare la demenza frontotemporale genetica (FTD-GRN). La FTD è una malattia neurodegenerativa che causa perdita di memoria, cambiamenti nel comportamento e difficoltà nel linguaggio, colpendo soprattutto le aree frontali e temporali del cervello. La forma genetica (FTD-GRN) è causata da una mutazione che riduce la produzione di una proteina chiamata progranulina. La terapia viene iniettata direttamente nel talamo – una parte del cervello definibile come “la porta d’accesso alla corteccia cerebrale – superando la barriera che solitamente impedisce ai farmaci di arrivare al sistema nervoso centrale. AVB-101 mira a ripristinare i livelli di progranulina, per rallentare o fermare la malattia. La sperimentazione coinvolge pazienti in vari Paesi e proseguirà con un terzo gruppo entro fine 2025. I primi risultati sono incoraggianti, tanto che si spera in una soluzione efficace per chi soffre di questa grave patologia neurodegenerativa.


ACADEMIC LIFE
Global Health Journal
TThe Global Right to Health and Access to Medicines
Arnold Vahrenwald; Giovanni A. Pedde
he right to health is universally recognized as a fundamental human right, enshrined in various international legal frameworks, including the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). According to Article 25 of the UDHR, “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family,” including access to medical care. The World Health Organization (WHO) further underscores this principle, affirming that the “enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being.” While these declarations provide a strong moral and legal foundation for the right to health, in practice, access to life-saving medicines remains deeply unequal across the globe. This inequality is particularly stark between high-income and LMICs. Pharmaceutical patents and the resulting high drug prices are often seen as one of the key barriers to achieving equitable access to medicines, creating a tension between IP protection and public health needs. The issue of access to medicines is most acute in LMICs, where the majority of the global population resides, but where healthcare systems are often underfunded and fragmented. In these regions, essential medicines –those that satisfy the priority health needs of the population – are often unavailable or unaffordable. [...]
Il diritto alla salute è universalmente riconosciuto come un diritto umano fondamentale, sancito in vari quadri giuridici internazionali, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) e il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR). Secondo l’articolo 25 della UDHR, “Ogni individuo ha diritto a uno standard di vita adeguato per la salute e il benessere di se stesso e della sua famiglia”, compreso l’accesso alle cure mediche. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sottolinea ulteriormente questo principio, affermando che “il godimento del più alto standard di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano”. Mentre queste dichiarazioni forniscono una solida base morale e legale per il diritto alla salute, in pratica, l’accesso ai farmaci salvavita rimane profondamente disuguale in tutto il mondo. Questa disuguaglianza è particolarmente netta tra alto reddito e LMIC. I brevetti farmaceutici e i conseguenti alti prezzi dei farmaci sono spesso visti come uno degli ostacoli principali al raggiungimento di un accesso equo ai farmaci, creando una tensione tra la protezione della PI e le esigenze di salute pubblica.
La questione dell’accesso ai farmaci è più acuta nei LMIC, dove risiede la maggior parte della popolazione globale, ma dove i sistemi sanitari sono spesso sottofinanziati e frammentati.
Traduzione tratta dal sito di UniCamillus

PER LEGGERE L’INTERO
ARTICOLO E SCOPRIRE DI
PIÙ SUI TEMI TRATTATI, INQUADRA IL QR CODE
E SCARICA L’ULTIMO
NUMERO DI UNICAMILLUS
GLOBAL HEALTH JOURNAL




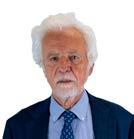





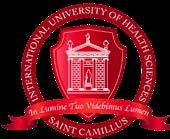
Prof. Pietro Refolo Dr. Omar Hallab
Prof. Leonardo Villani
Dr.ssa Ludovica Nesbitt
Prof.ssa Donatella Padua Prof.ssa Barbara Tavazzi Prof. Alessandro Boccanelli
Prof.ssa Dagmar Rinnemburger



L’intervento
di una studentessa



Il Prof. Leonardo Villani, Docente UniCamillus di Igiene generale ed applicata, ha ampliato ulteriormente l’orizzonte, introducendo il concetto di salute planetaria, che lega indissolubilmente il benessere umano alla salute degli ecosistemi. Ha illustrato i costi ambientali del progresso umano: dall’urbanizzazione incontrollata al crescente utilizzo di risorse, dalle emissioni climalteranti all’aumento delle temperature globali. Gli effetti sanitari del cambiamento climatico sono già evidenti: ondate di calore, diffusione di nuove malattie infettive, stress psicologico, migrazioni forzate e insicurezza alimentare. La sua riflessione ha ribadito che l’approccio alla salute non può più essere settoriale: serve una visione integrata che coinvolga medicina, architettura, economia, giurisprudenza e politiche pubbliche.
Su questa linea si è inserito anche l’intervento del Prof. Pietro Refolo, Docente di Storia della Medicina che ha richiamato l’importanza dell’antropologia medica per comprendere come la salute e la malattia siano vissute e interpretate nei diversi contesti culturali. Riconoscere il paziente come soggetto culturale, dotato di vissuti, credenze e valori propri, è fondamentale per una medicina realmente umana e inclusiva. Le future professioni sanitarie dovranno essere capaci di leggere le diversità culturali non come ostacolo, ma come risorsa per una cura più efficace e rispettosa.
A chiudere l’incontro è stato il Dr. Omar Hallab della Planetary Health Alliance, che ha ricordato come il nostro Pianeta, unico nella sua abitabilità, sia oggi profondamente minacciato. «Non c’è un Pianeta B» ha affermato, e per questo è urgente attivare collaborazioni globali per mitigare gli effetti della crisi ambientale sulla salute delle popolazioni. Gli studenti sono stati sollecitati a uscire dai confini della clinica per farsi promotori di una visione sistemica, capace di legare diritti, ambiente, salute e giustizia sociale.
Questo invito ha assunto un significato concreto: non solo una sollecitazione teorica, ma una chiamata all’azione rivolta a chi si sta formando come medico, infermiere, ricercatore o operatore della salute pubblica. Agire oggi significa non limitarsi alla cura del sintomo, ma contribuire alla costruzione di ambienti salubri, sistemi alimentari equi, città resilienti, relazioni di fiducia con le comunità. Significa integrare nella pratica quotidiana le competenze cliniche con la capacità di leggere le disuguaglianze, riconoscere i determinanti sociali della salute, dialogare con istituzioni, enti locali, realtà del terzo settore.
Il sapere medico non è più confinato nei reparti ospedalieri: si espande nelle scuole, nei quartieri, nei contesti interculturali, nelle scelte politiche e urbanistiche. In questo senso, il ruolo dell’università si rafforza come piattaforma di cambiamento sociale, capace di connettere formazione, ricerca e azione sul campo.
Come ha ricordato nei saluti finali la Prof.ssa Donatella Padua, Coordinatore scientifico del Ciclo di Conferenze di Terza Missione, questa visione si traduce in un impegno continuativo, che proseguirà nel terzo ciclo delle conferenze. Un ciclo che si preannuncia come spazio generativo, in cui l’università potrà continuare a coltivare alleanze tra scienza e società, tra giovani e istituzioni, tra saperi accademici e urgenze planetarie.

Gli studenti UniCamillus compilano il form di recupero feedback ideato dalla Prof.ssa Padua


La relazione del Dott. Omar Hallab della Planetary Health Alliance


La relazione al podio della Dott.ssa Nesbitt


La Prof.ssa Tavazzi insieme alla Dott.ssa Nesbitt in dialogo con i Proff. Villani e Refolo


RICERCHE/ABSTRACT
Una selezione delle ricerche più recenti e interessanti condotte dai ricercatori UniCamillus.
A disposizione, l’abstract del lavoro. Per consultare il testo completo è necessario inquadrare il relativo QR Code. La fruizione delle ricerche è subordinata ad abbonamenti o affiliazioni specifiche alle piattaforme che contengono il lavoro esteso.
Hydrocortisone in very preterm neonates for BPD prevention: meta-analysis and effect size modifiers
De Luca D, Ferraioli S, Watterberg K L, Baud O, Gualano M R; (2024)
Hydrocortisone in very preterm neonates for BPD prevention: meta-analysis and effect size modifiers Archives of Disease in Childhood
Fetal and Neonatal Edition Published Online First: 17 January 2024. doi: 10.1136/ archdischild-2023-326254

Inositols in treating polycystic ovary syndrome and non-insulin dependent diabetes mellitus: now and the future
Laganà A S, Myers S H, Forte G, Naem A, Krentel H, Allahqoli L, Alkatout I, Unfer V; (2024)
Inositols in treating polycystic ovary syndrome and non-insulin dependent diabetes mellitus: now and the future, Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology
DOI: 10.1080/17425255.2024.2306851
Critical care of severe bronchiolitis during shortage of ICU resources
De Luca D, Pezza L, Vivalda L, Di Nardo M, Lepainteur M, Baraldi E, Piastra M, Ricciardi W, Conti G, Gualano M R; (2024)
EClinicalMedicine - Elsevier https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102450.
Beyond Inflammaging: The Impact of Immune System Aging on Age-Related Muscle Decline, Results From the InCHIANTI Study
Pellegrino R, Paganelli R, Di Iorio A, Bandinelli S, Moretti A, Iolascon G, Sparvieri E, Tarantino D, Tanaka T, Ferrucci L; (2023)
The Journals of Gerontology: Series A, Volume 79, Issue 2, February 2024, glad238. https://doi.org/10.1093/gerona/glad238



Assessment of hemodynamic dysfunction in septic newborns by functional echocardiography: a systematic review
Pugnaloni F, De Rose DU, Kipfmueller F, Patel N, Ronchetti MP, Dotta A, Bagolan P, Capolupo I, Auriti C; (2024)
Assessment of hemodynamic dysfunction in septic newborns by functional echocardiography: a systematic review. Pediatr Res. 2024 Jan 20. doi: 10.1038/s41390-024-03045-2. Epub ahead of print. PMID: 38245631.

Lipoic acid reduces mitochondrial unfolded protein response and attenuates oxidative stress and aging in an in vitro model of non-alcoholic fatty liver disease
Longhitano L, Distefano A, Musso N, Bonacci P, Orlando L, Giallongo S, Tibullo D, Denaro S, Lazzarino G, Ferrigno J, Nicolosi A, Alanazi A M, Salomone F, Tropea E, Barbagallo I A, Bramanti V, Li Volti G, Torella D, Amorini A M; (2024)
Lipoic acid reduces mitochondrial unfolded protein response and attenuates oxidative stress and aging in an in vitro model of non-alcoholic fatty liver disease. J Transl Med. 2024 Jan 20;22(1):82. doi: 10.1186/s12967-024-04880-x. PMID: 38245790; PMCID: PMC10799515.
Low expression levels of miRNA-155 and miRNA-499a are associated with obesity in Type 2 diabetes
Latini A, Benedittis G, Ciccacci C, Novelli G, Spallone V, Borgiani P; (2024)
Low expression levels of miRNA-155 and miRNA-499a are associated with obesity in Type 2 diabetes. Epigenomics. 2024 Jan;16(2):85-91. doi: 10.2217/epi-2023-0320. Epub 2024 Jan 15. PMID: 38221897.


Dopamine neuron degeneration in the Ventral Tegmental Area causes hippocampal hyperexcitability in experimental Alzheimer’s Disease
Spoleti E, La Barbera L, Cauzzi E, De Paolis ML, Saba L, Marino R, Sciamanna G, Di Lazzaro V, Keller F, Nobili A, Krashia P, D’Amelio M; (2024)
Dopamine neuron degeneration in the Ventral Tegmental Area causes hippocampal hyperexcitability in experimental Alzheimer’s Disease. Mol Psychiatry. 2024 Jan 16. doi: 10.1038/s41380-02402408-9. Epub ahead of print. PMID: 38228889.

Anticoagulation in atrial fibrillation. A large real-world update
Bo M, Fumagalli S, Degli Esposti L, Perrone V, Dovizio M, Poli D, Marcucci R, Verdecchia P, Reboldi G, Lip GYH, Ungar A, Boccanelli A, Fumagalli C, Marchionni N; (2023)
Italian Society of Geriatric Cardiology (SICGe). Anticoagulation in atrial fibrillation. A large real-world update. Eur J Intern Med. 2024 Mar;121:88-94. doi: 10.1016/j.ejim.2023.10.010. Epub 2023 Oct 23. PMID: 37879969.




Direttore responsabile: Gianni Profita
Redazione a cura di: Giorgia Martino
Progetto grafico a cura di: Federico Calogero, Giulia Francini
Immagini: UniCamillus Media, Adobe Stock
Traduzioni a cura del Centro Linguistico d’Ateneo
Alessandro Rotatori, Ylenia Marcucci Faure
UniCamillus: Federica Alota, Damiano Giani, Ginevra Guidoni, Giorgia Martino, Claudia Romano
Stampa: tipografia Miligraf
Chiuso in redazione: Luglio 2025
Copia gratuita
www.unicamillus.org


