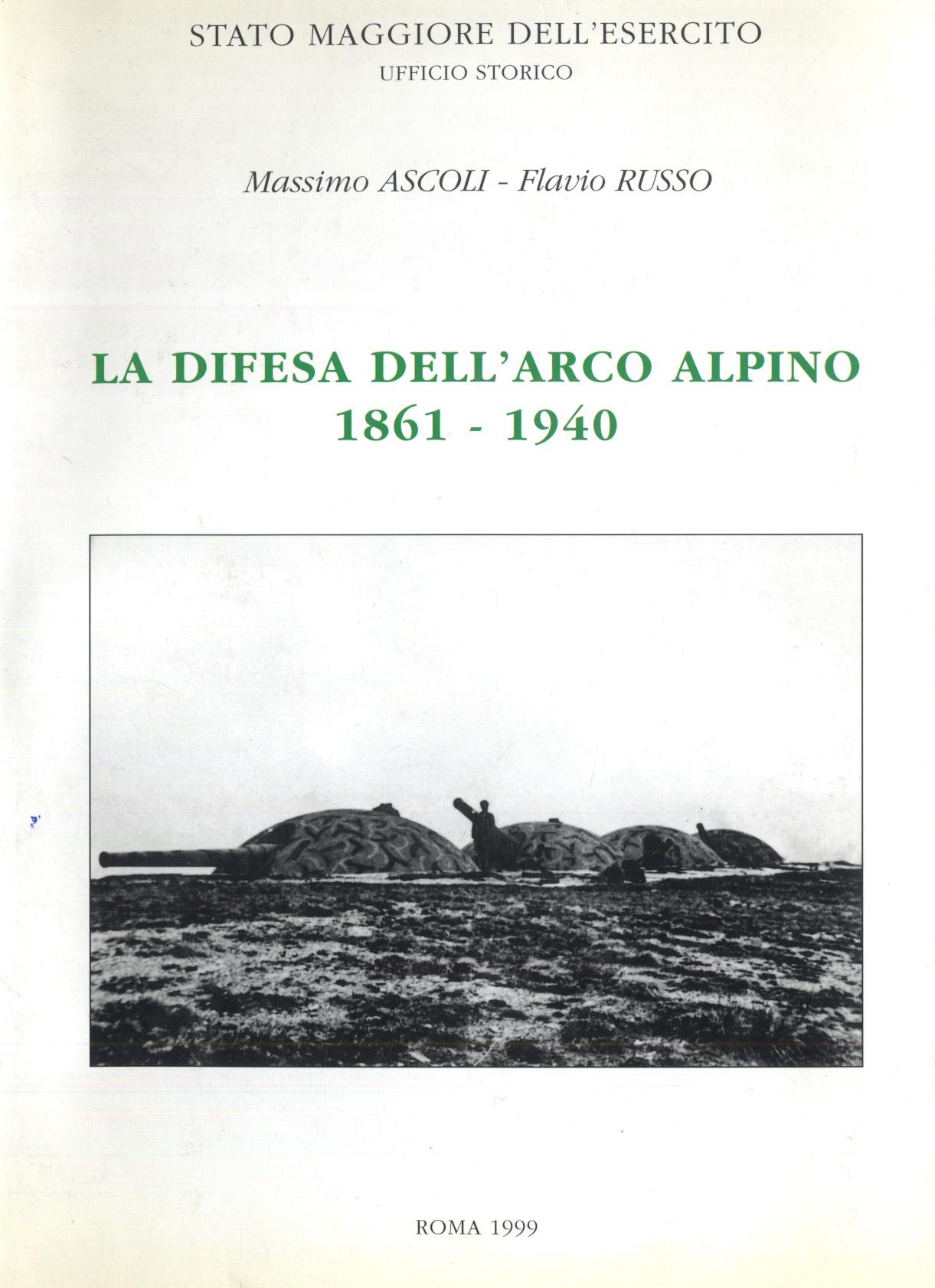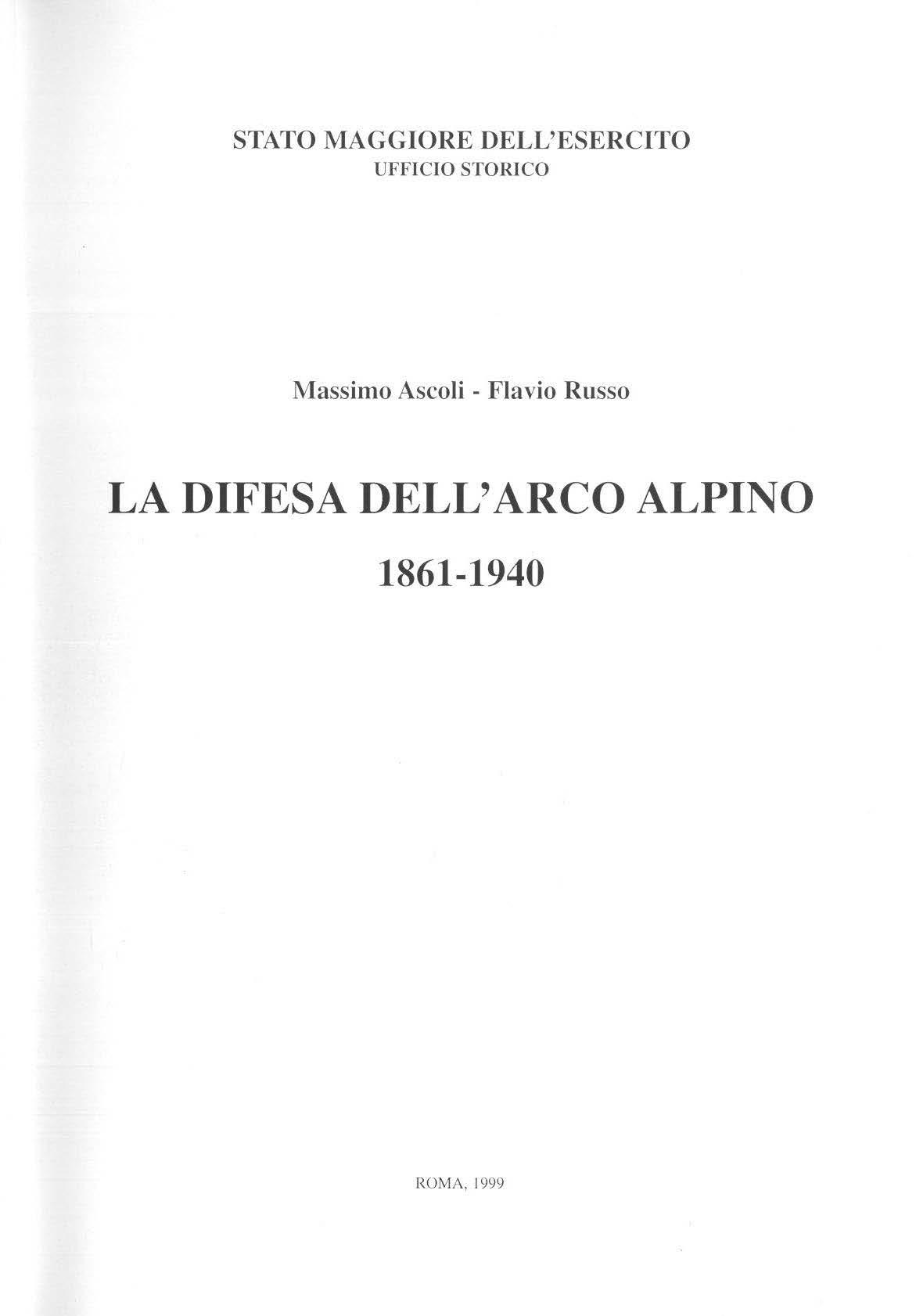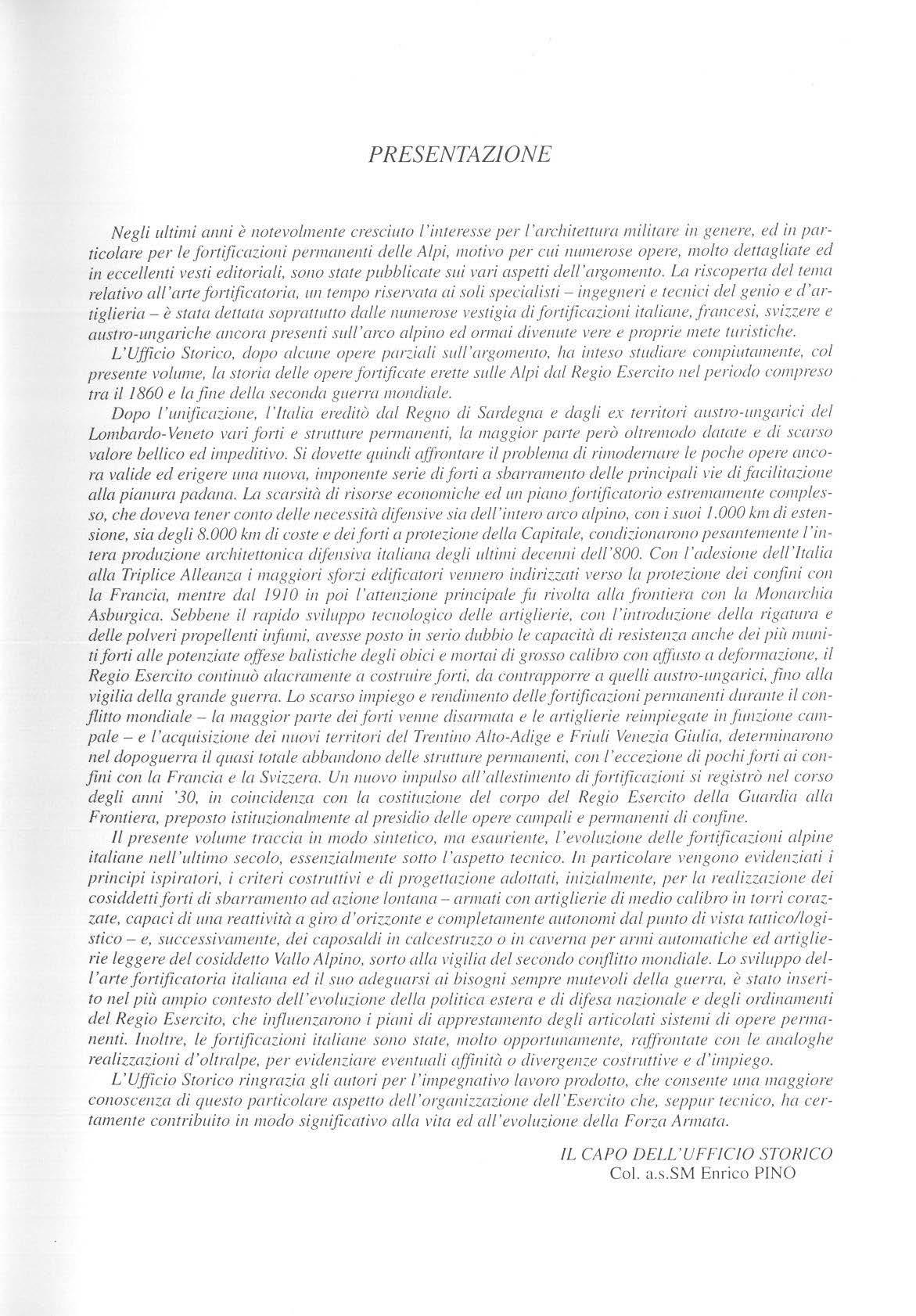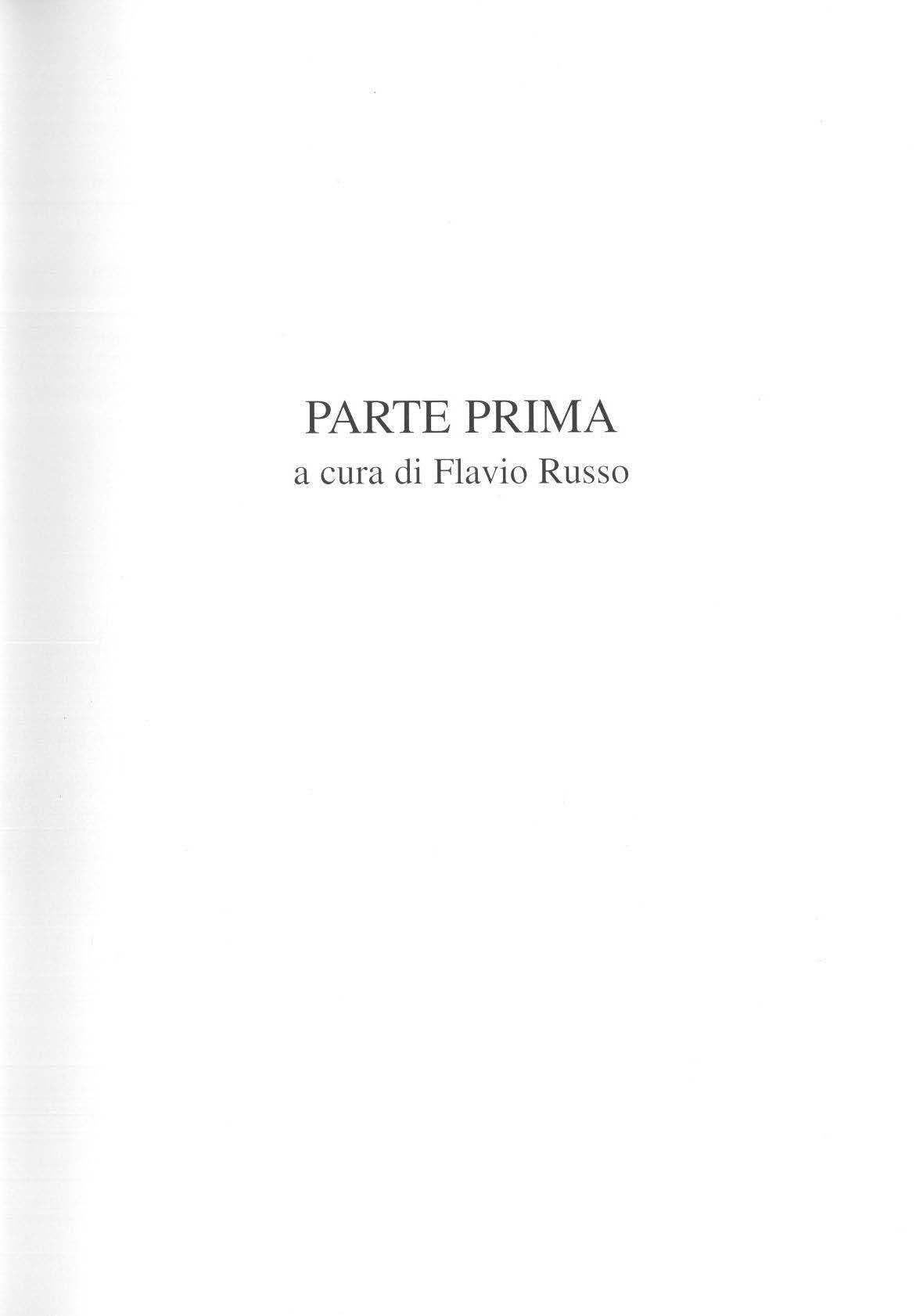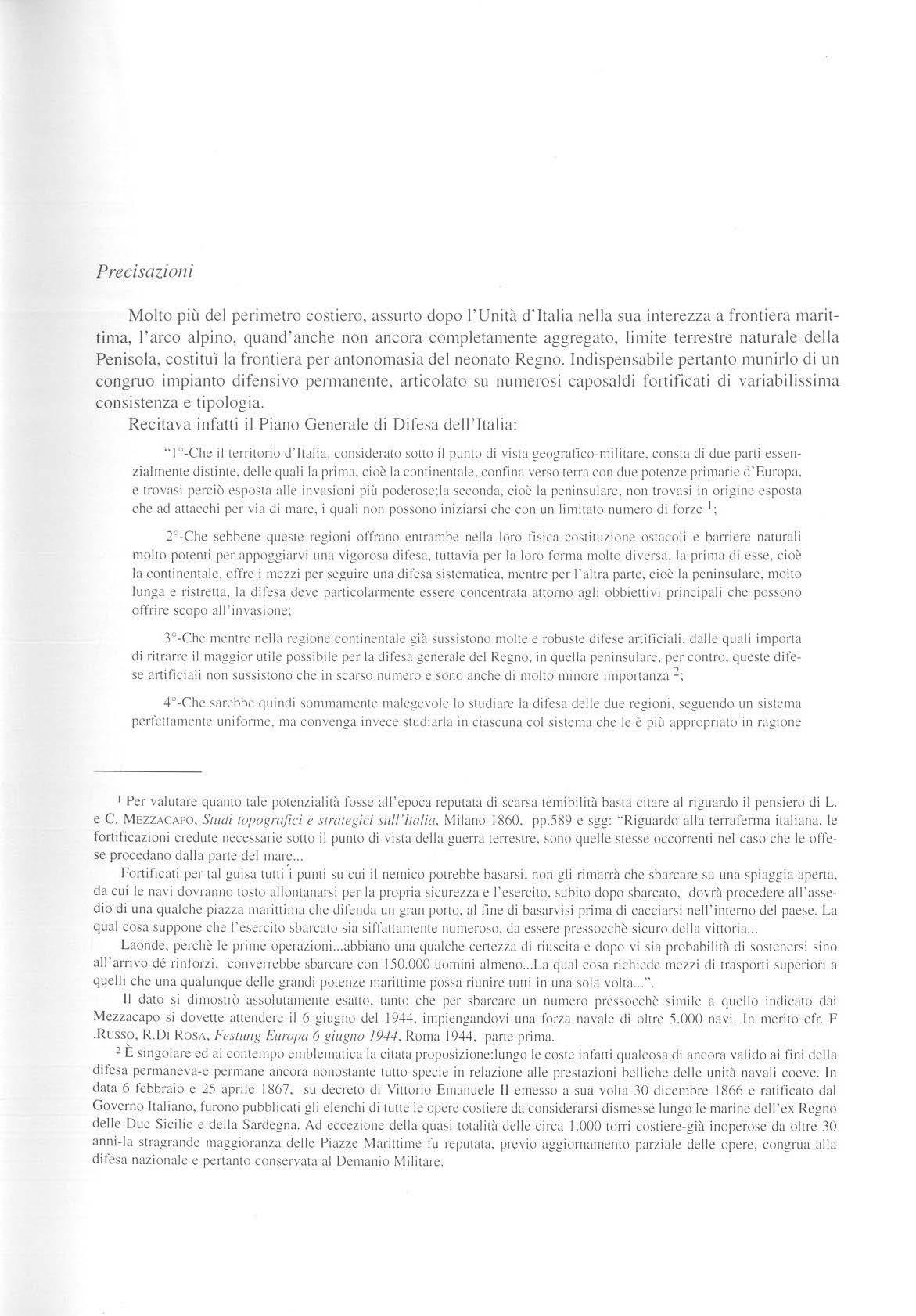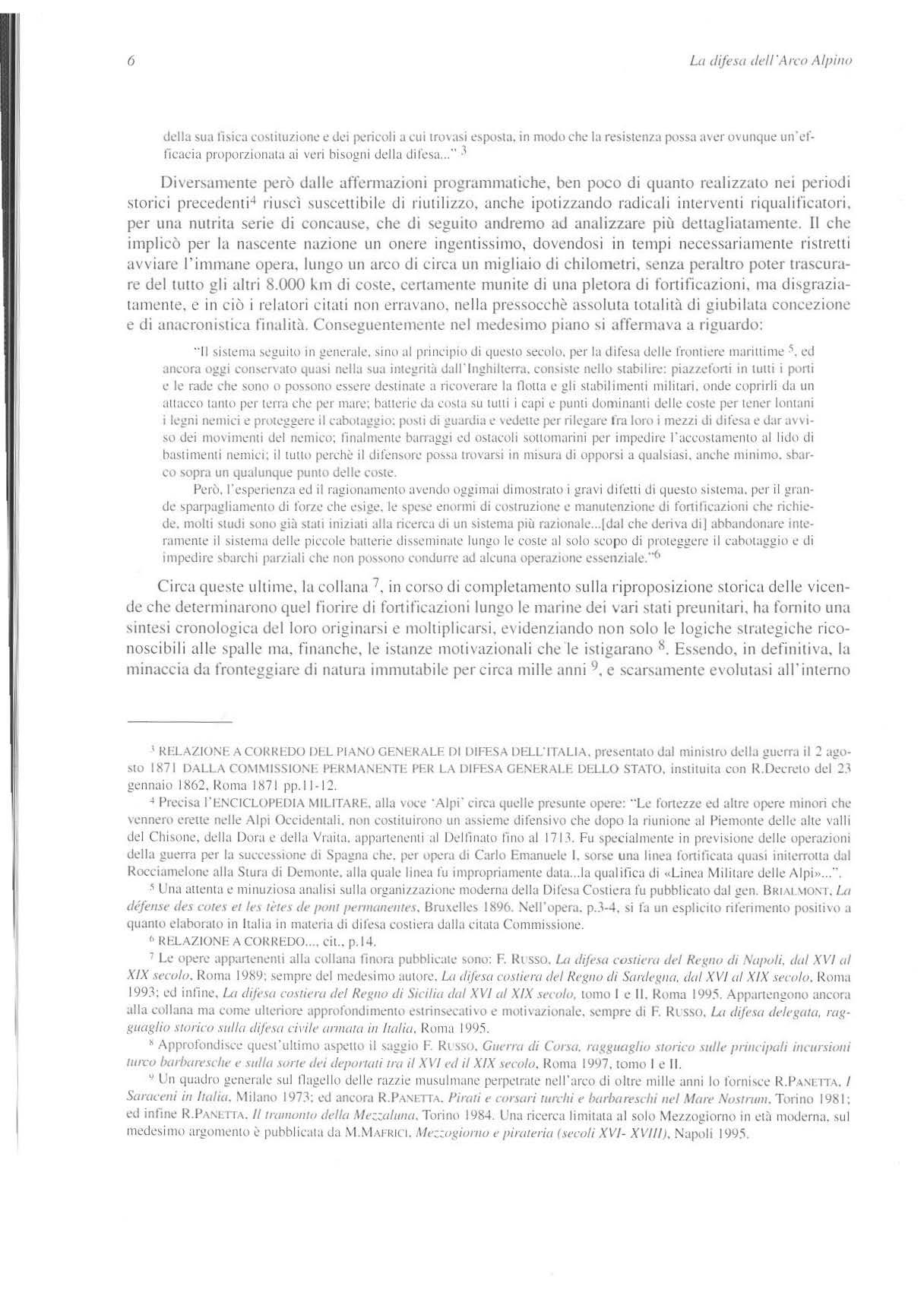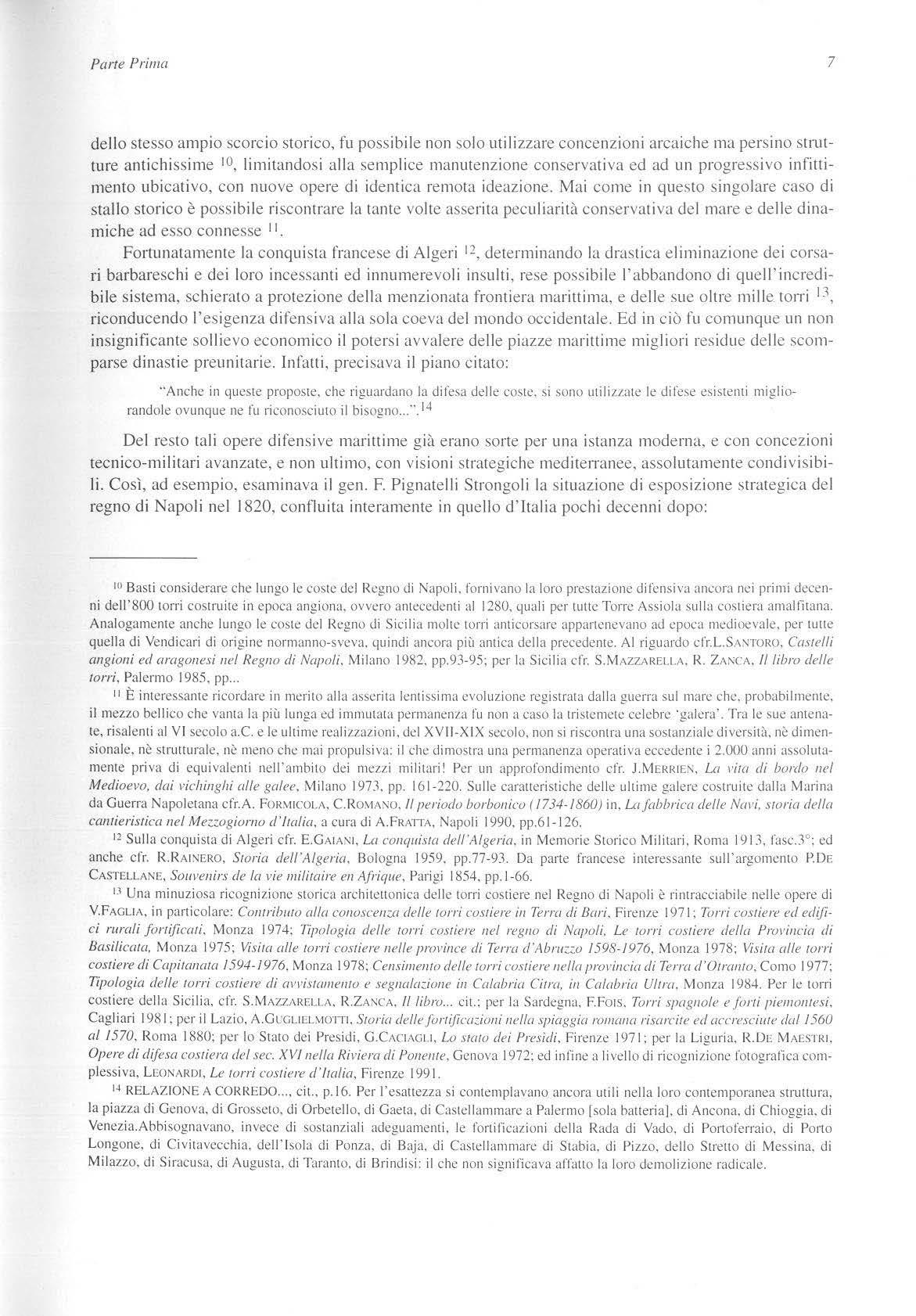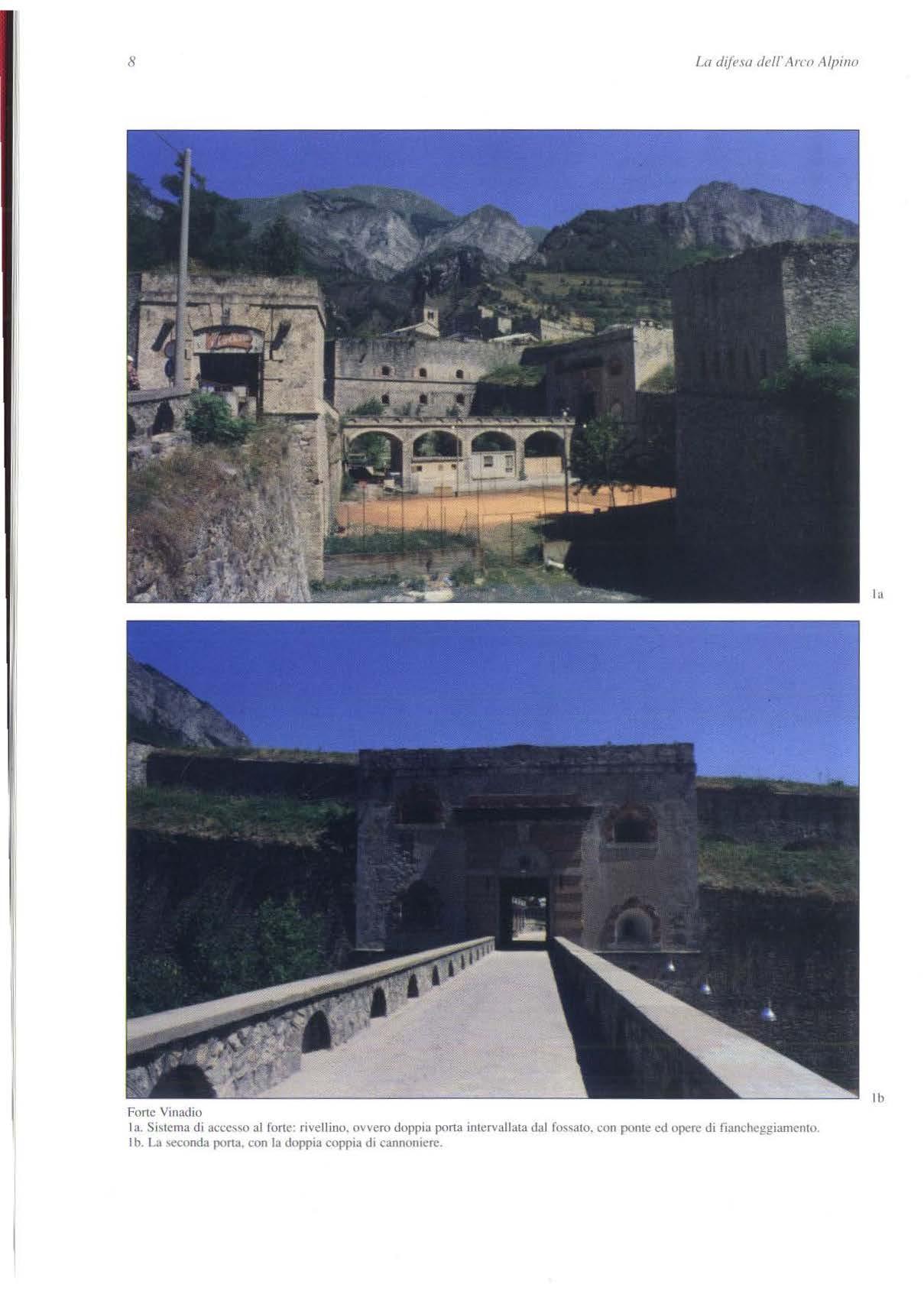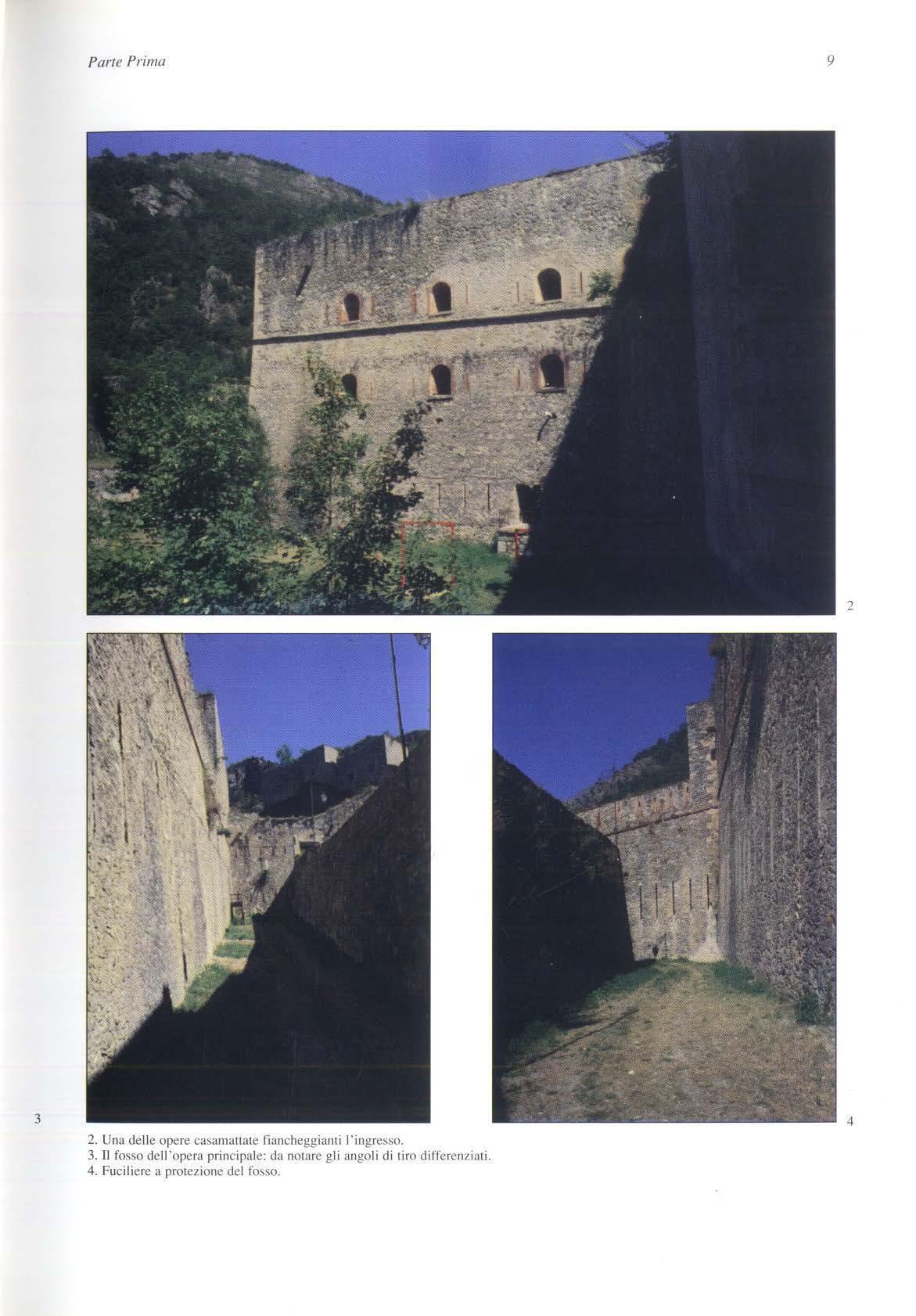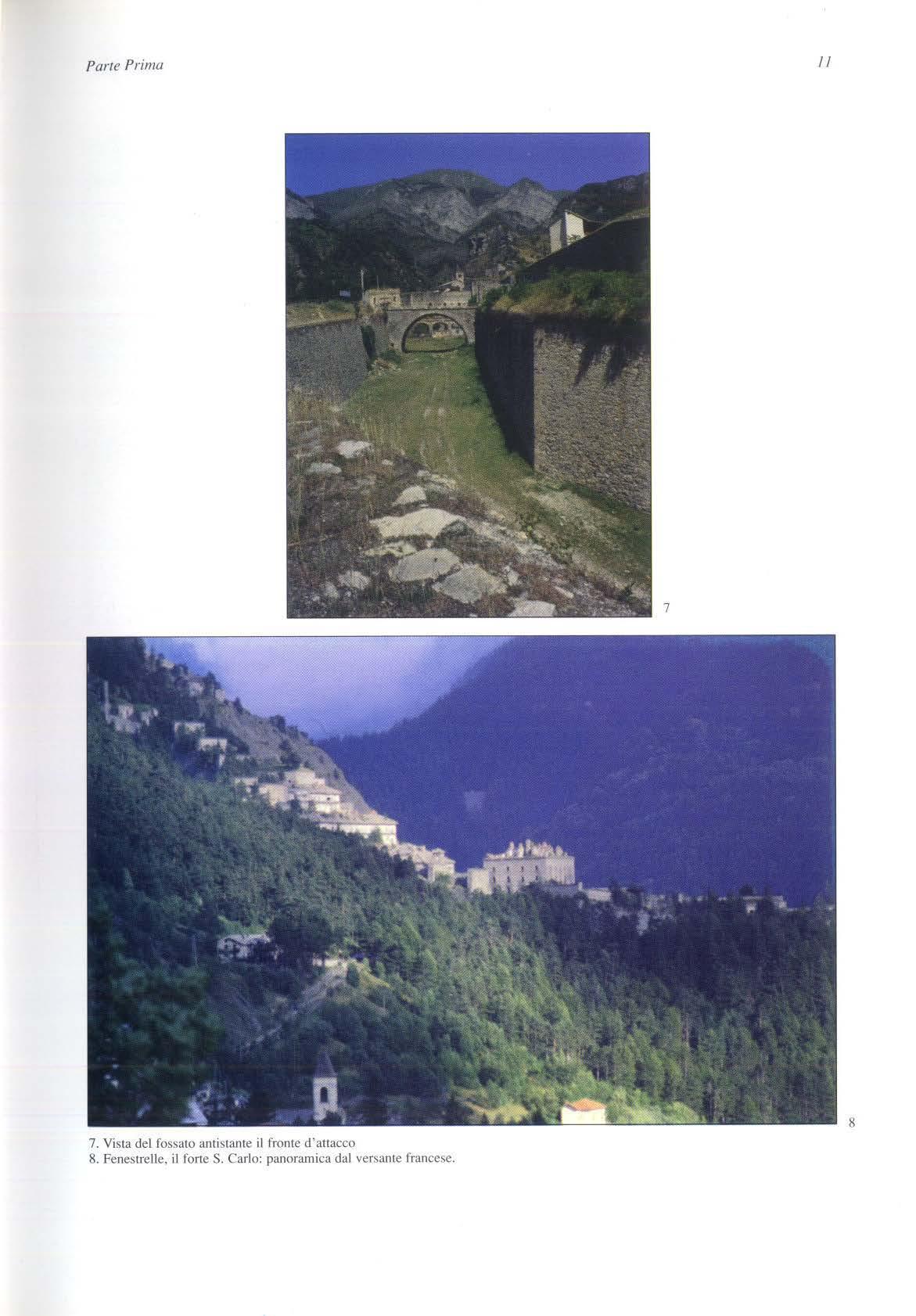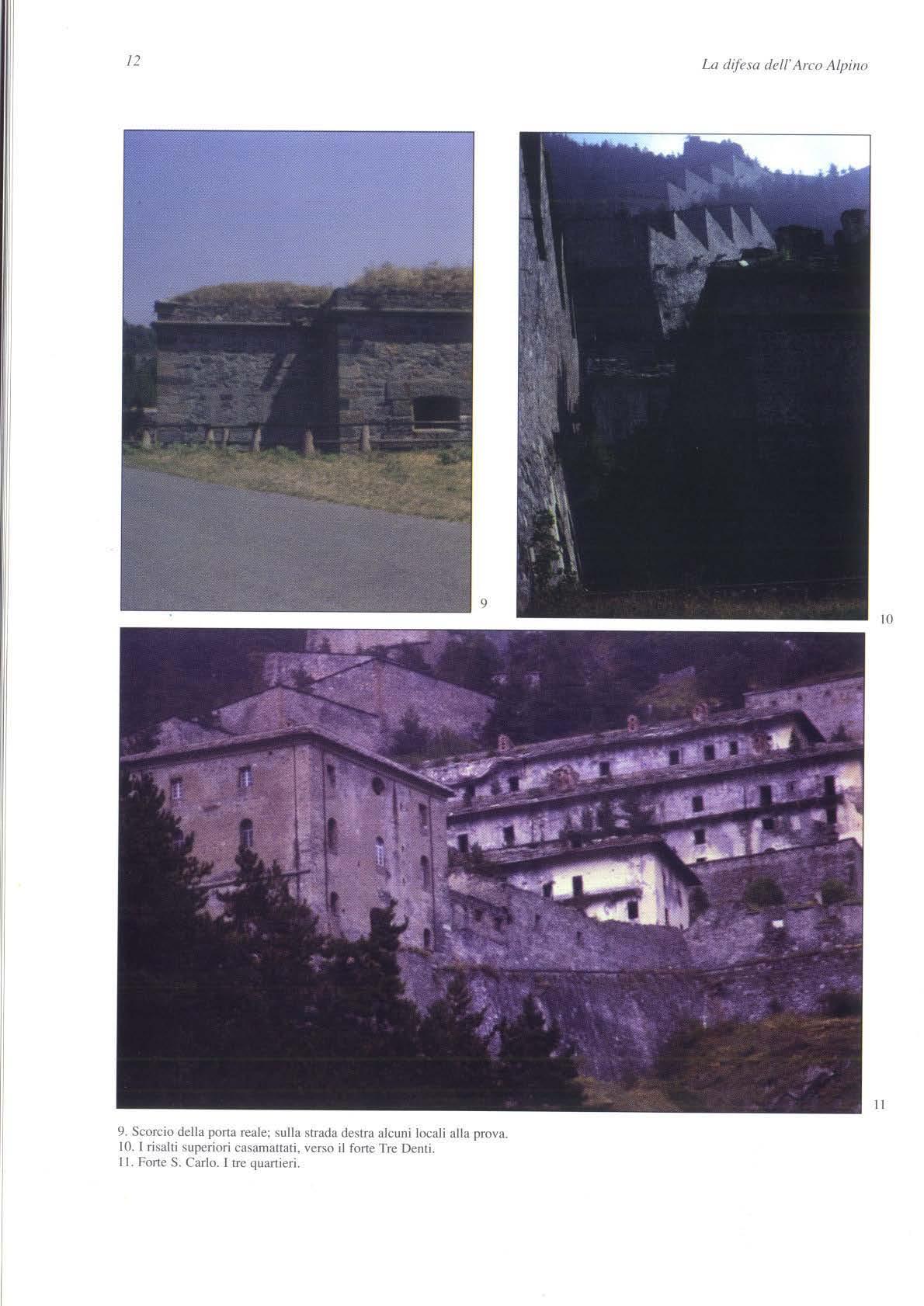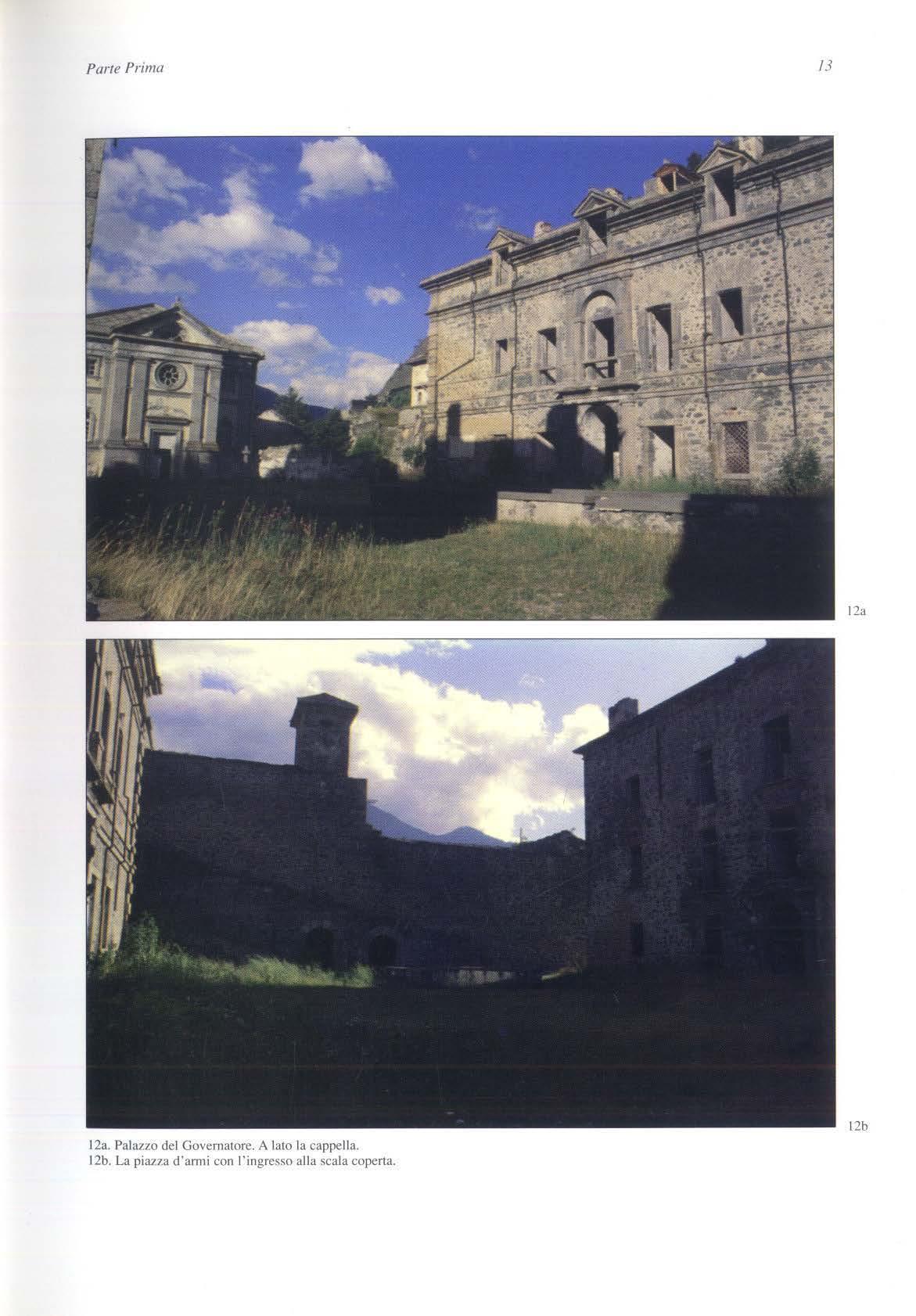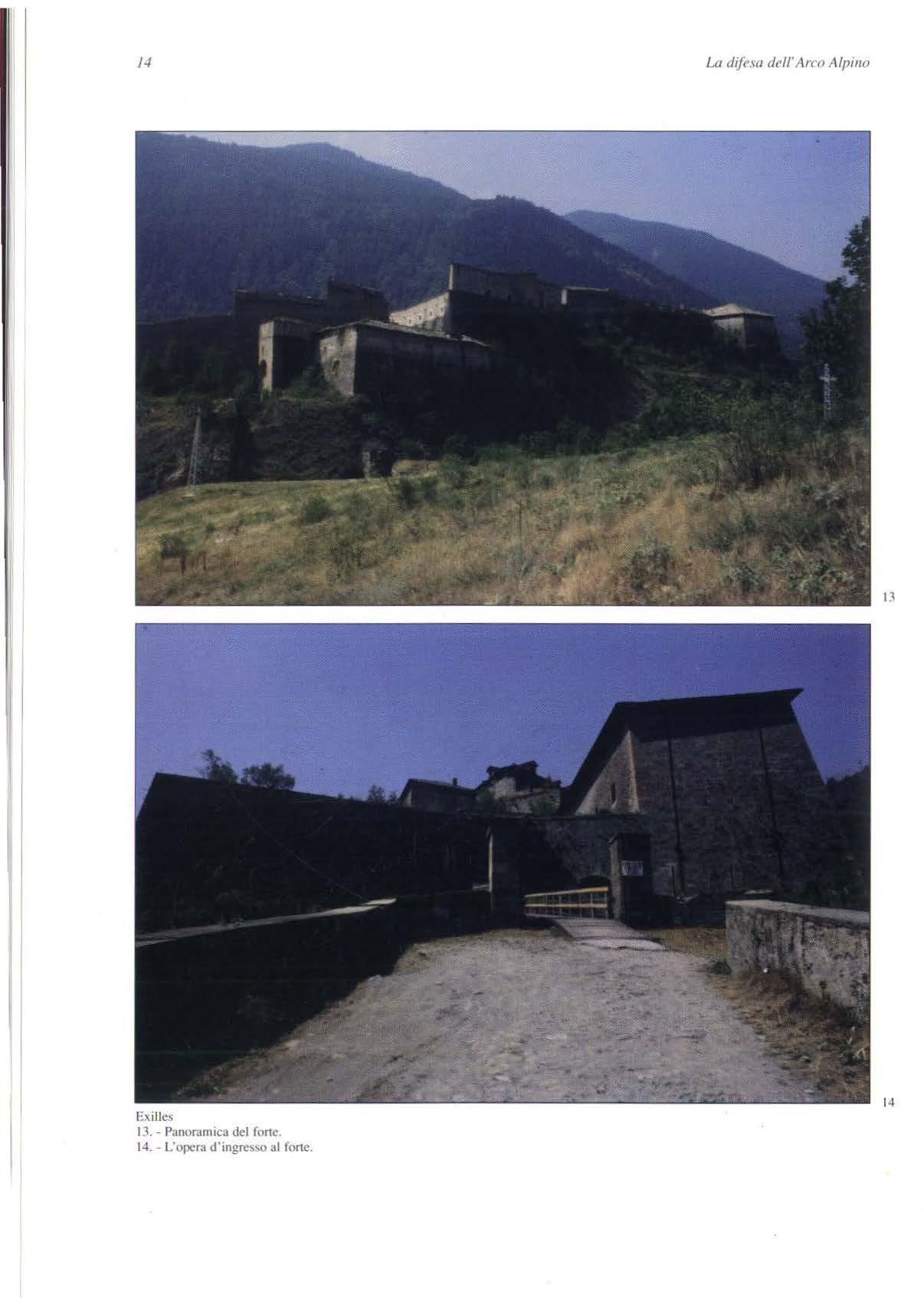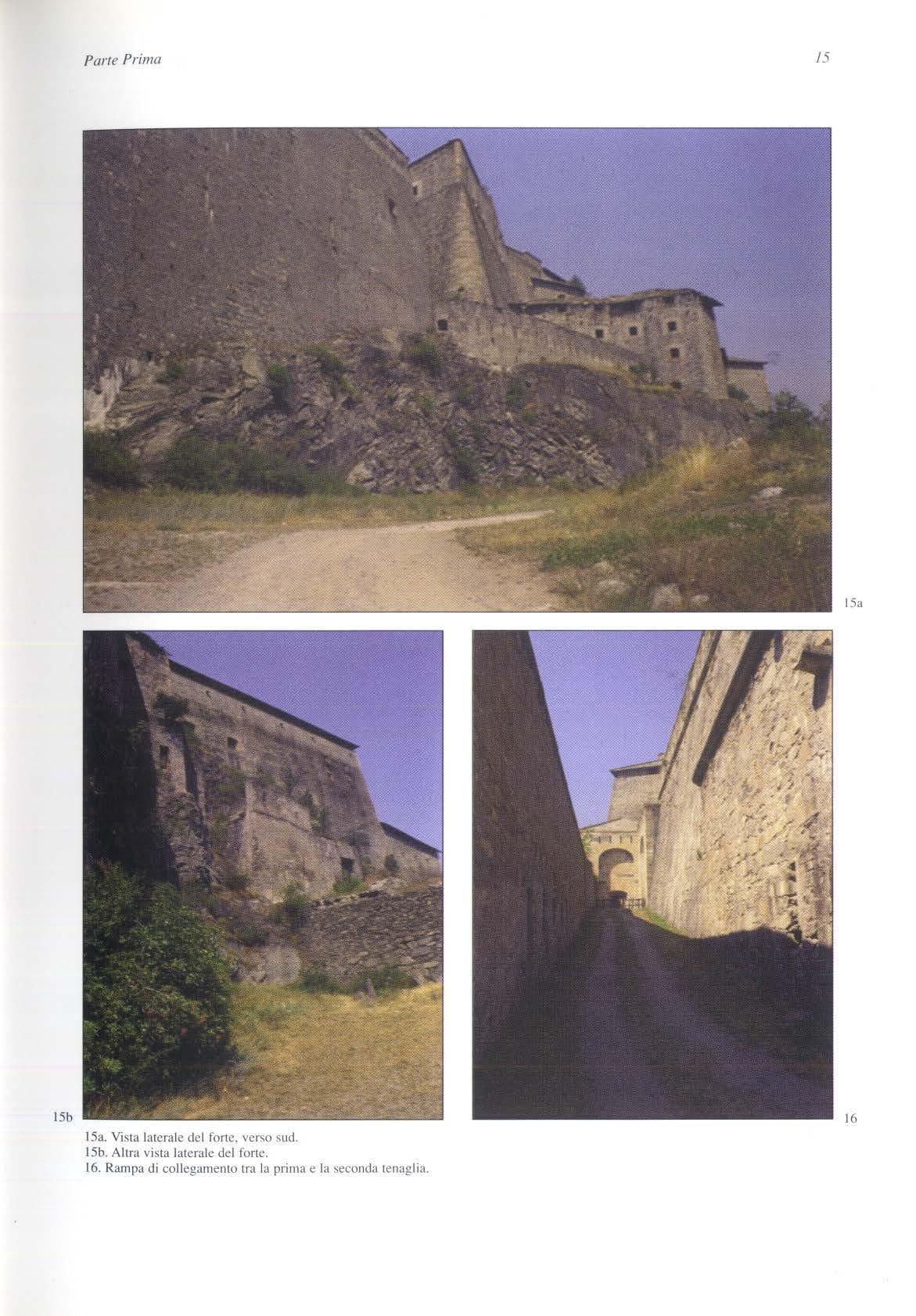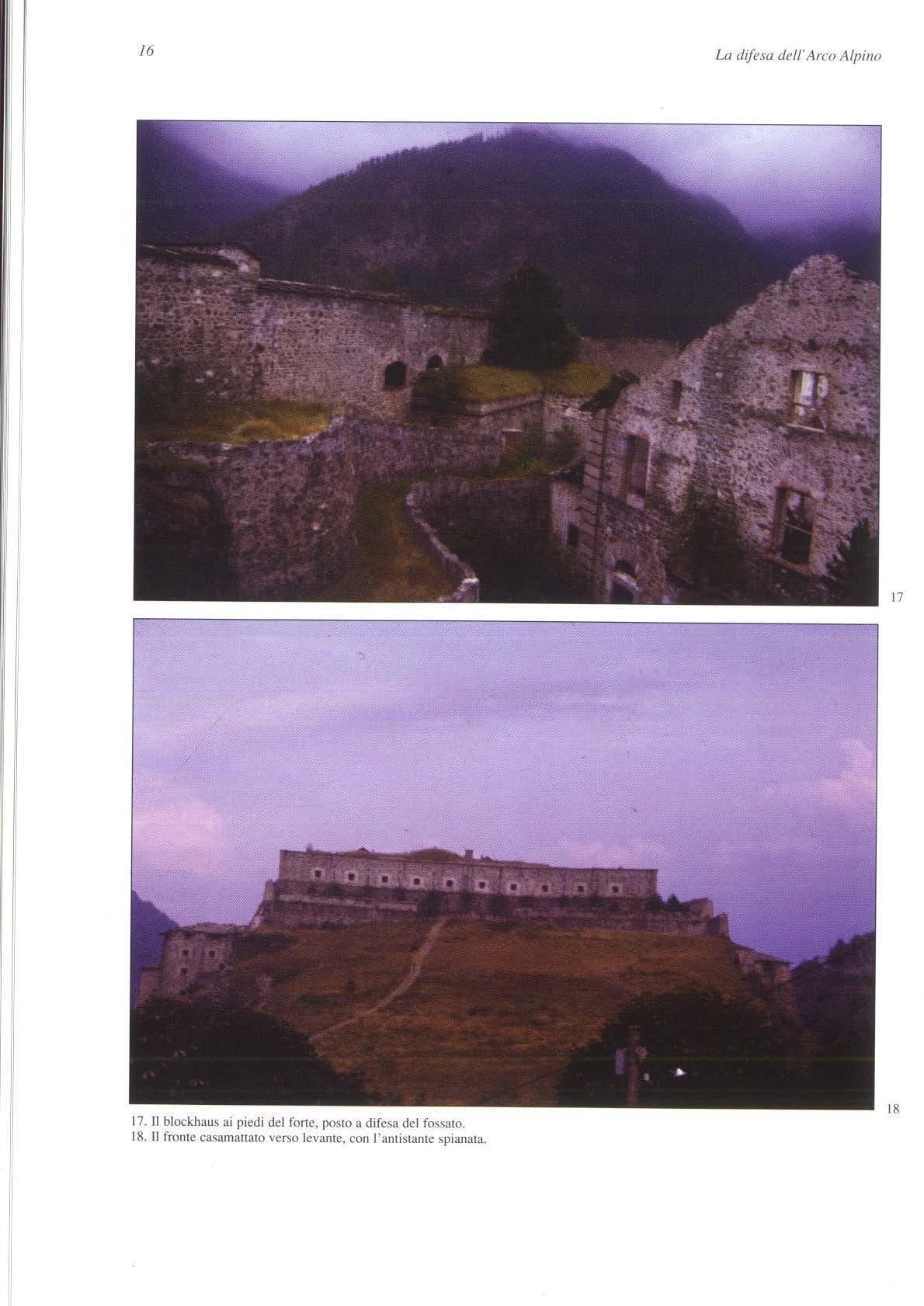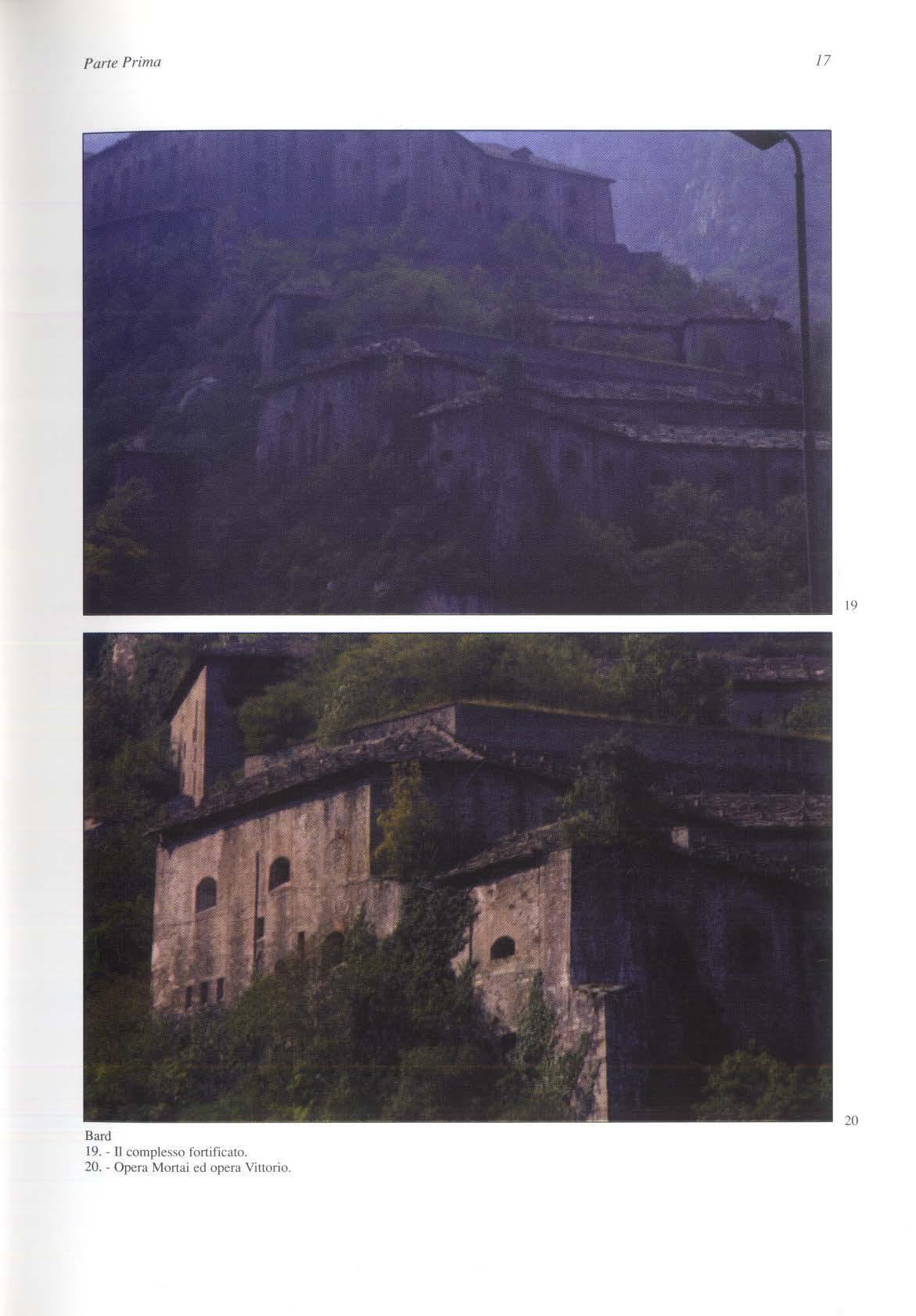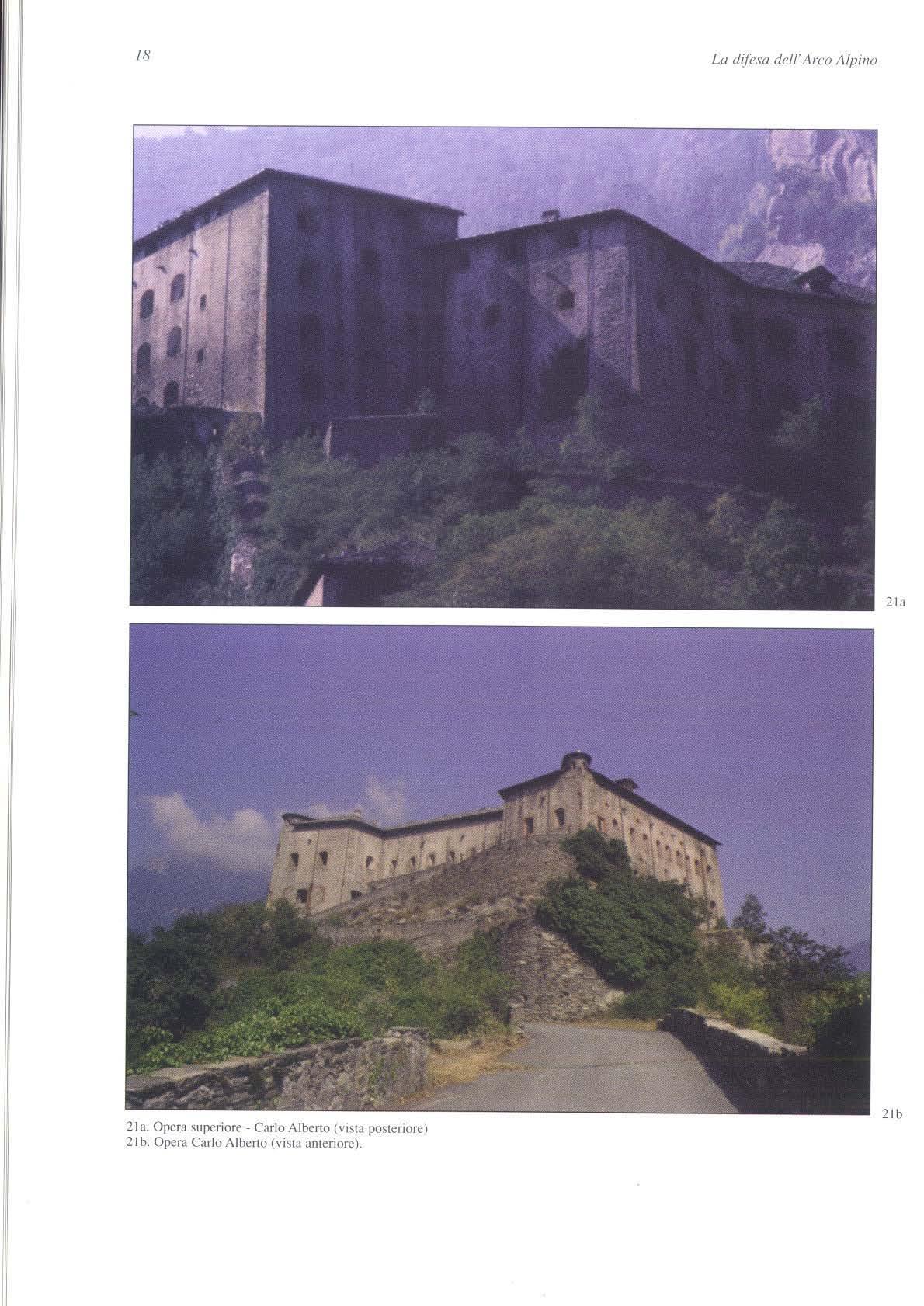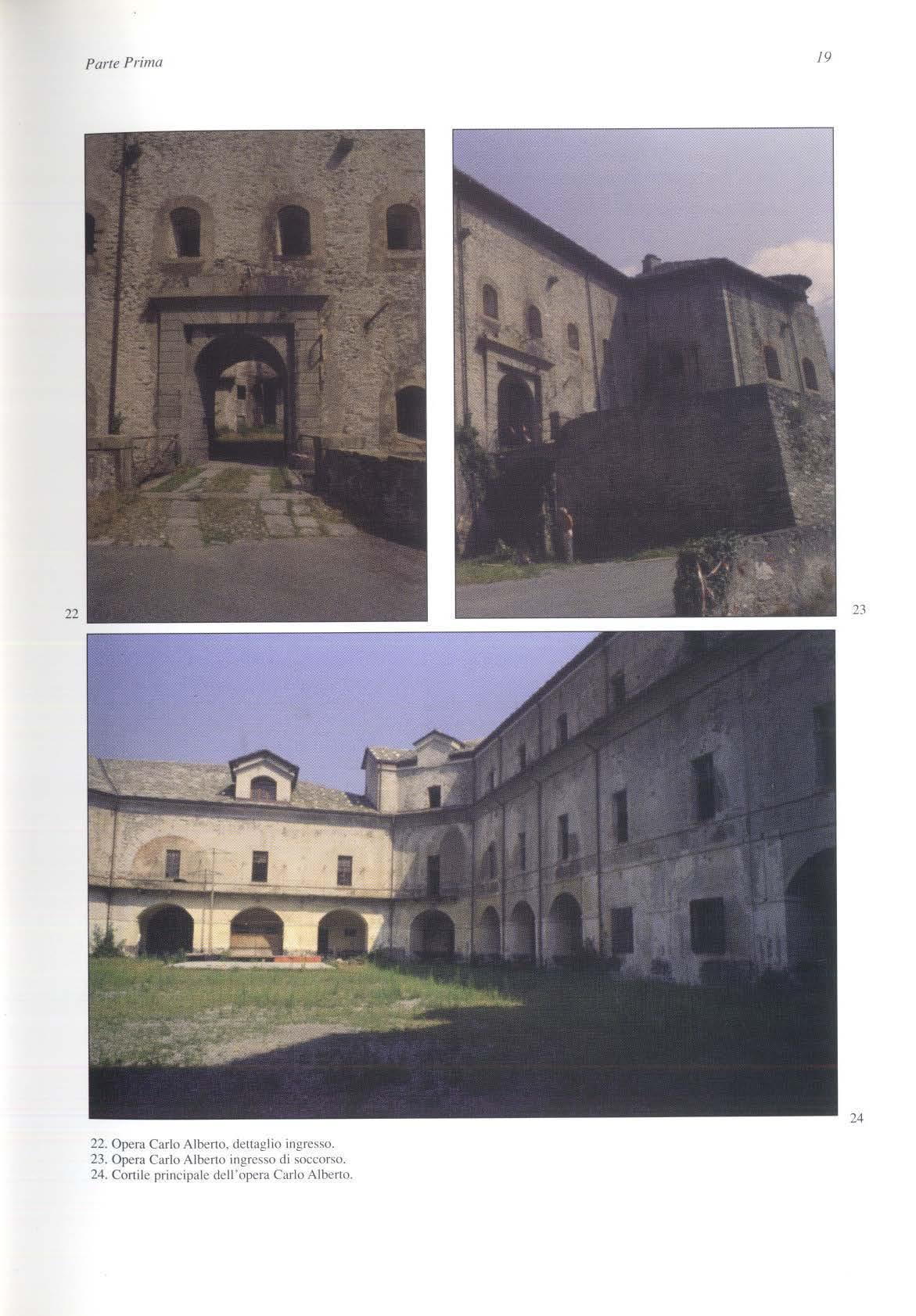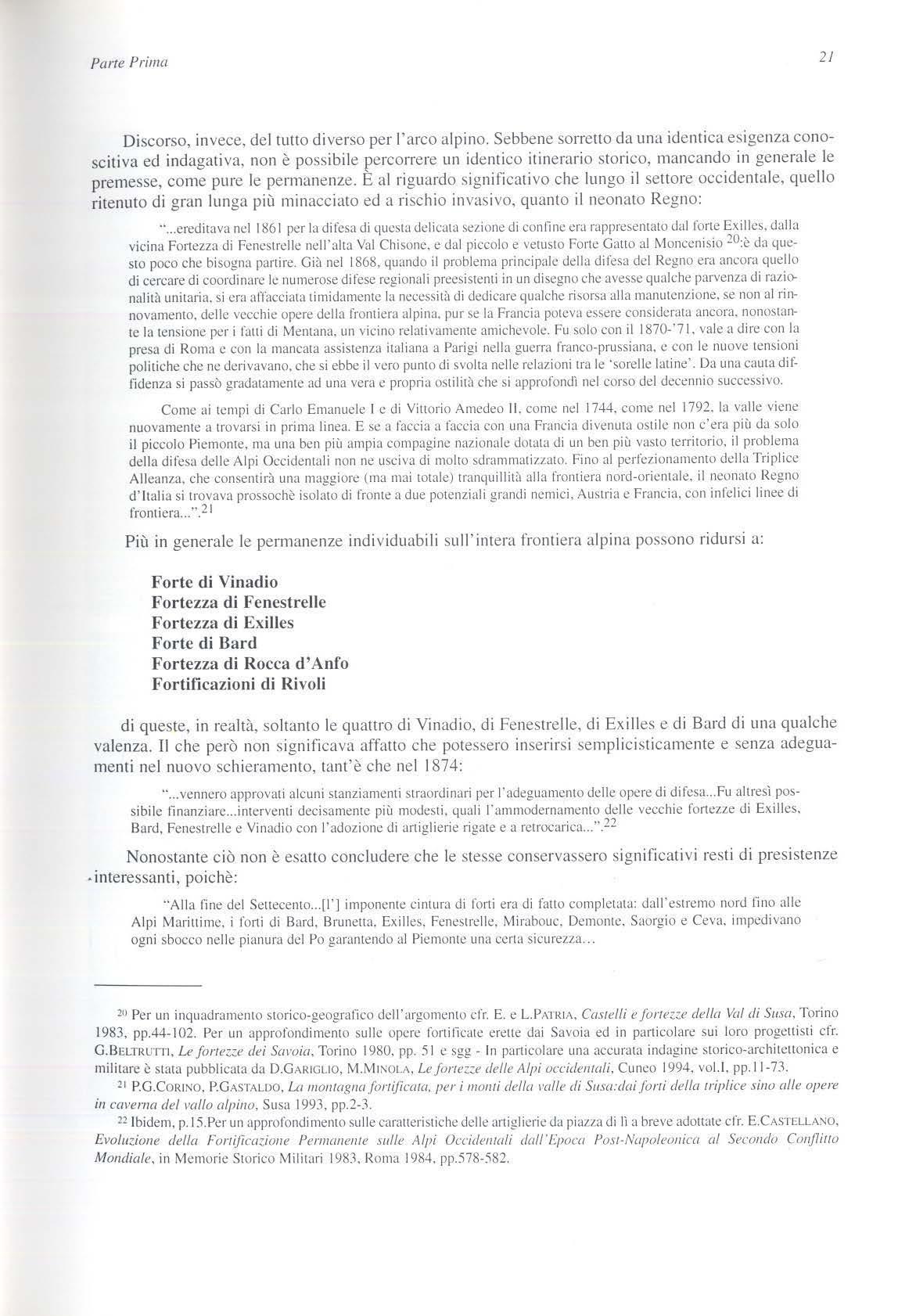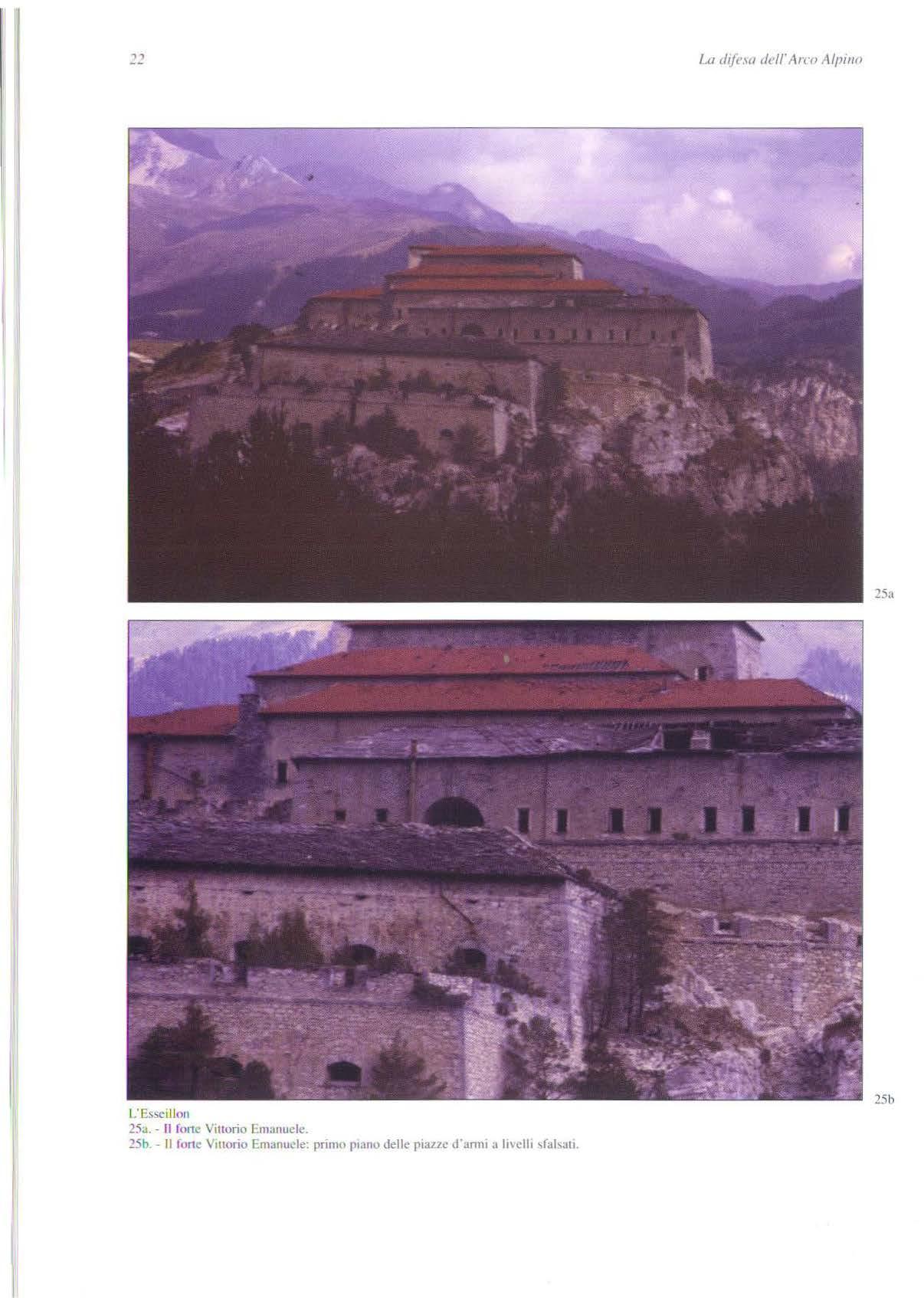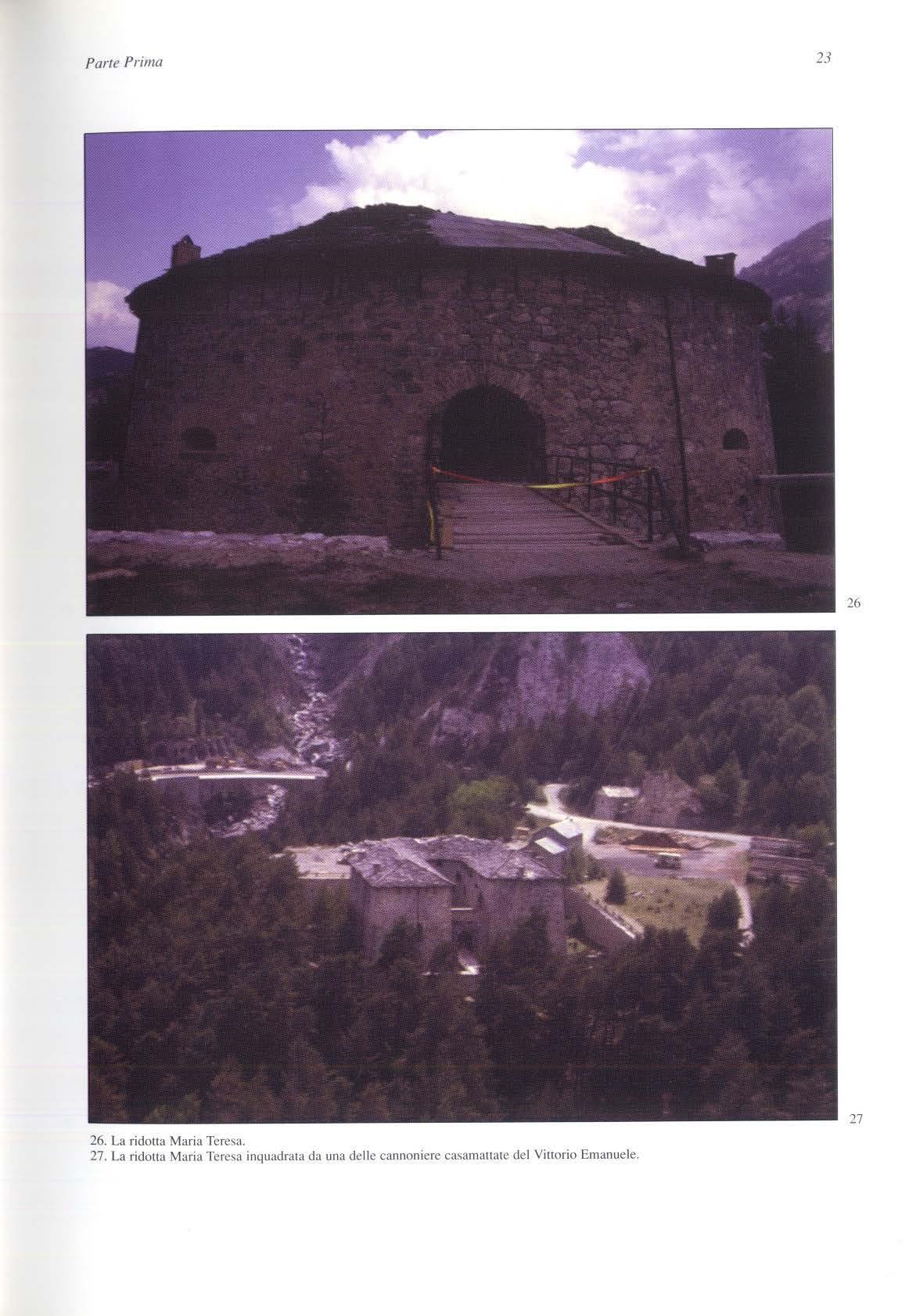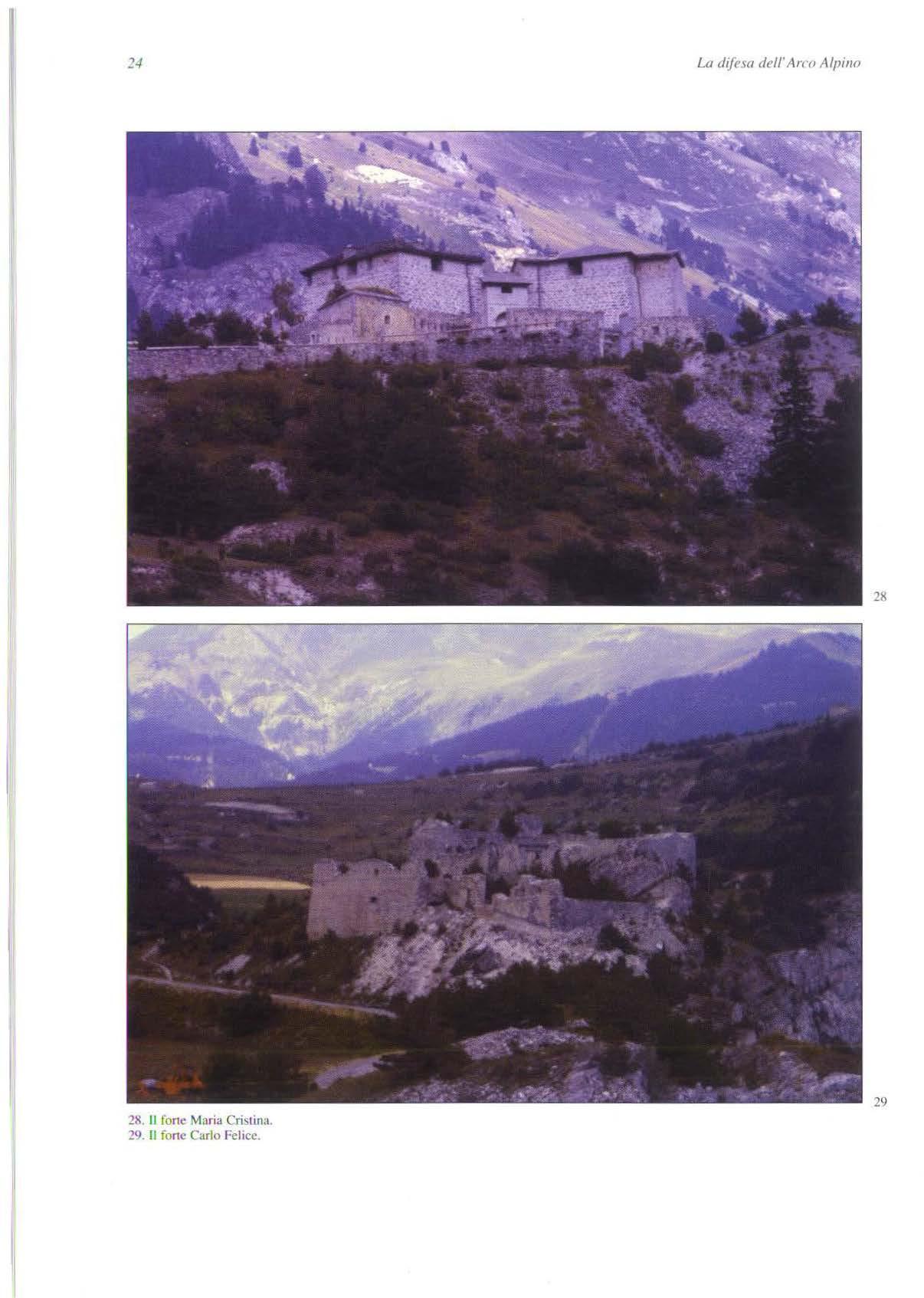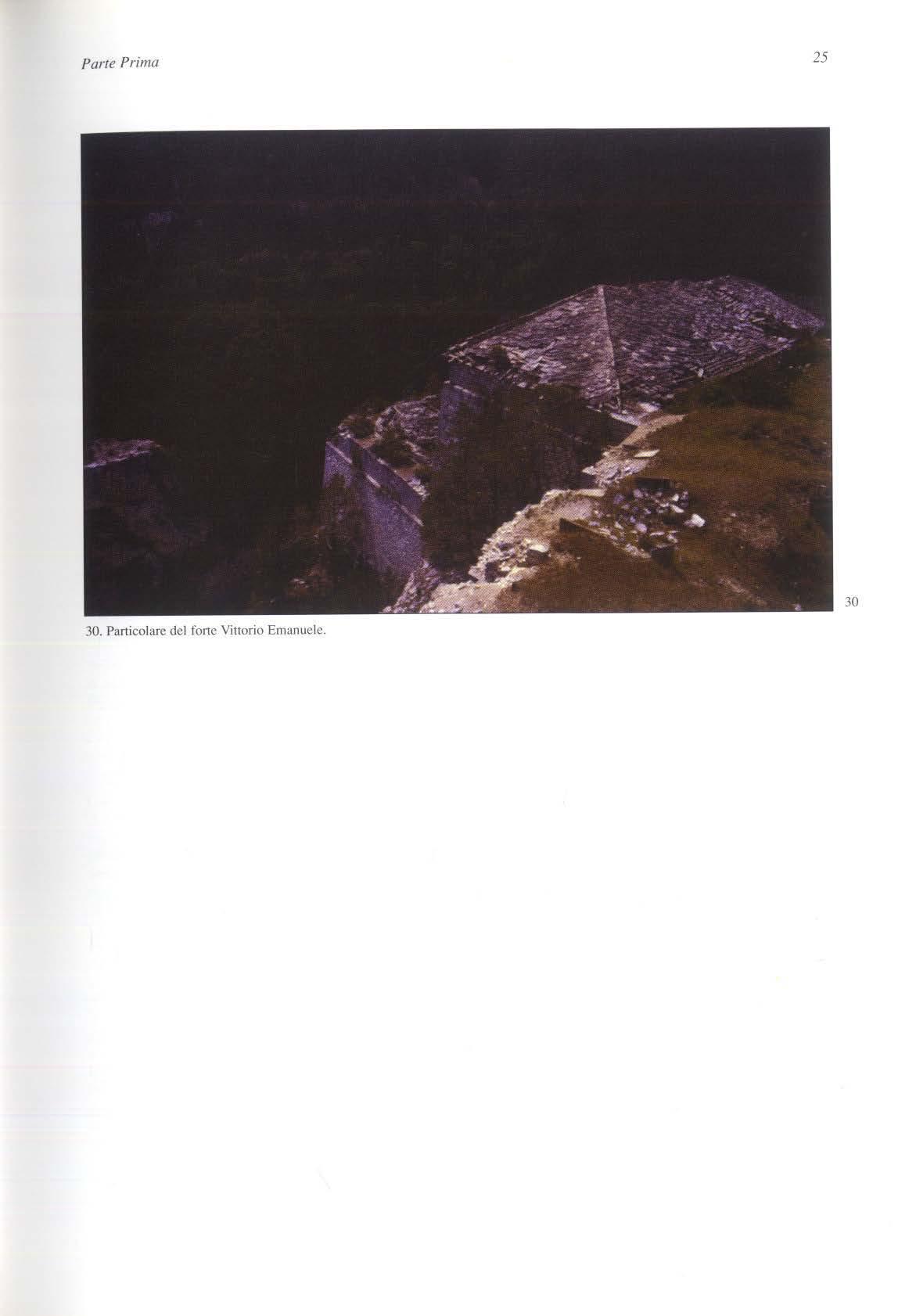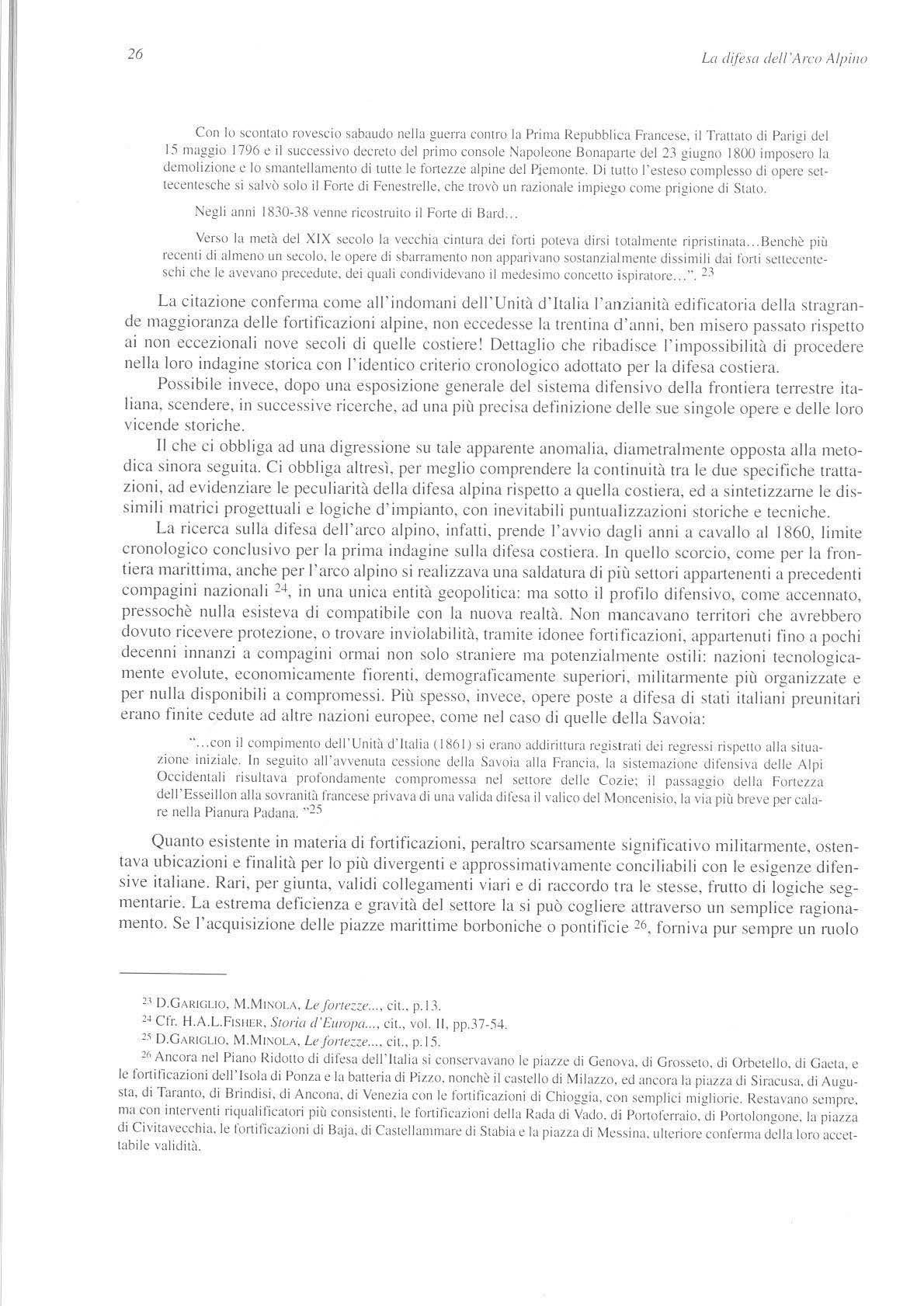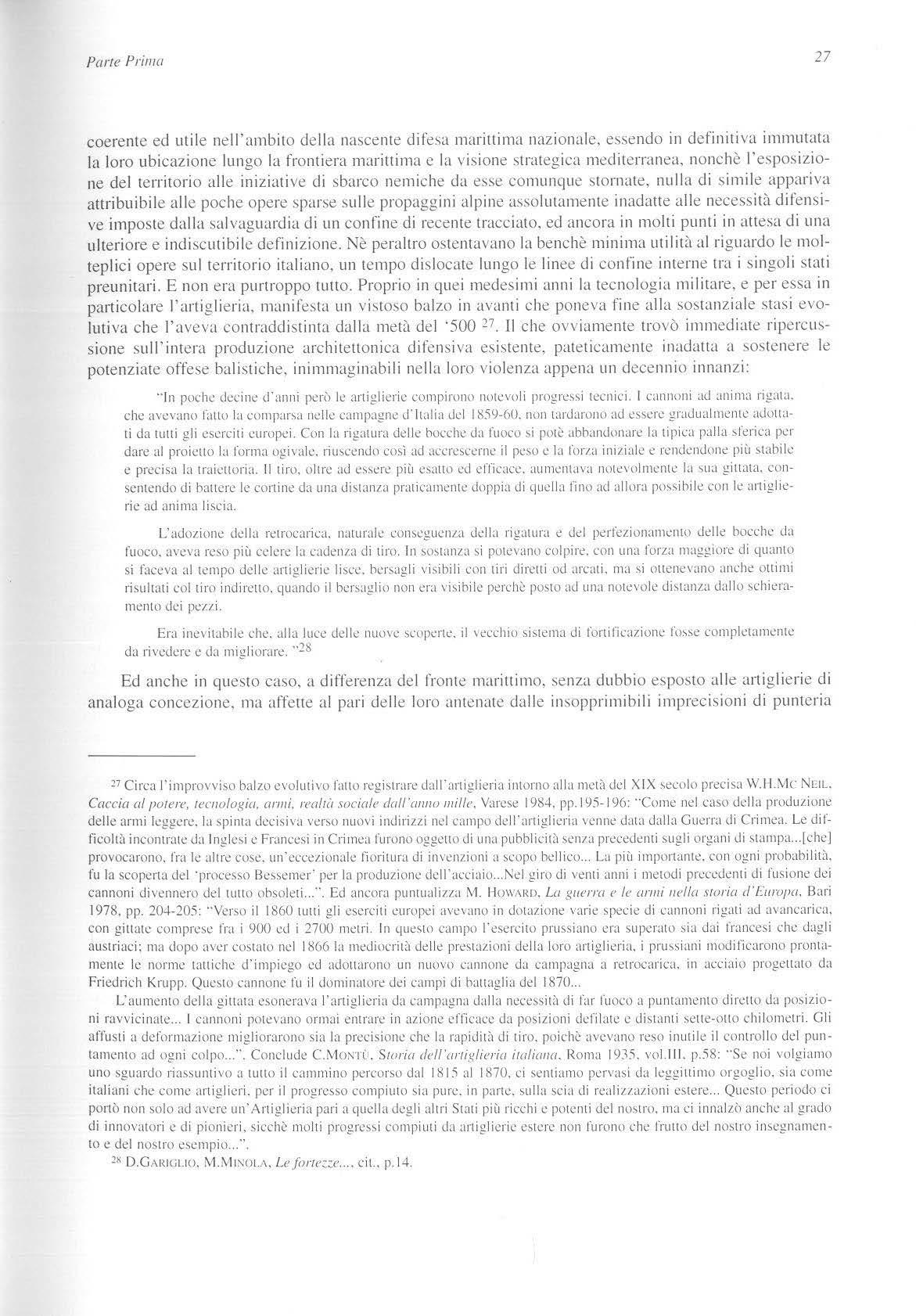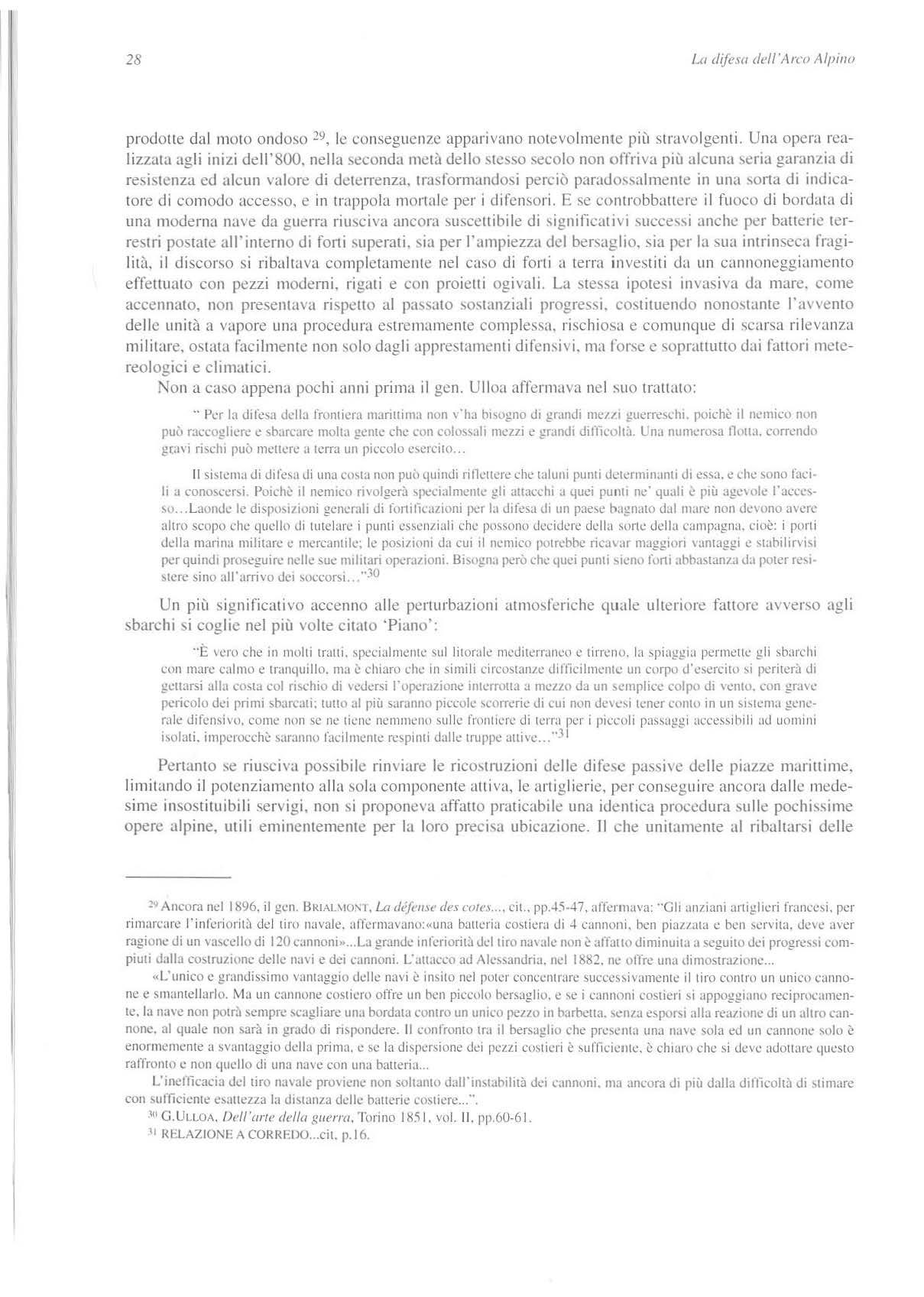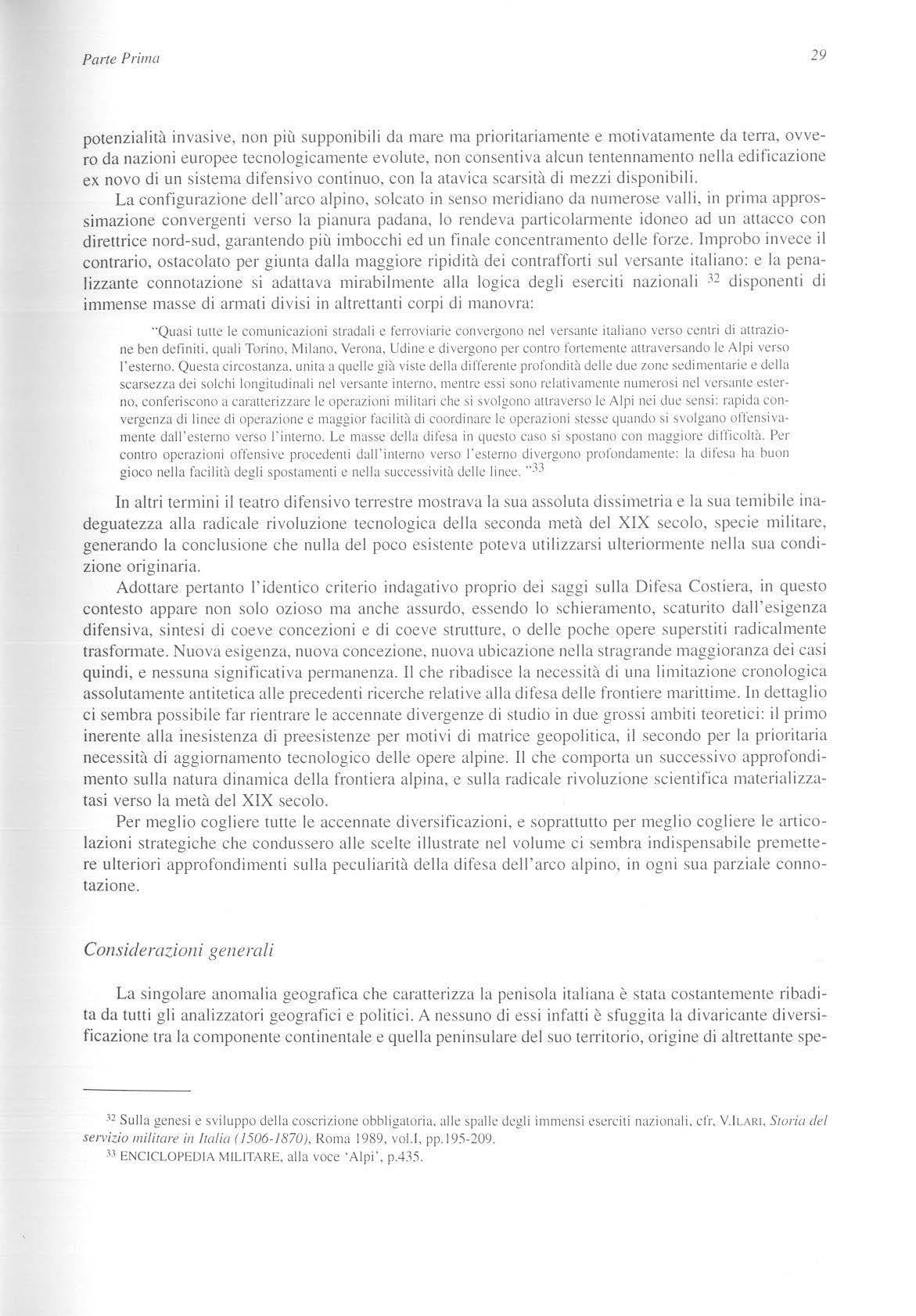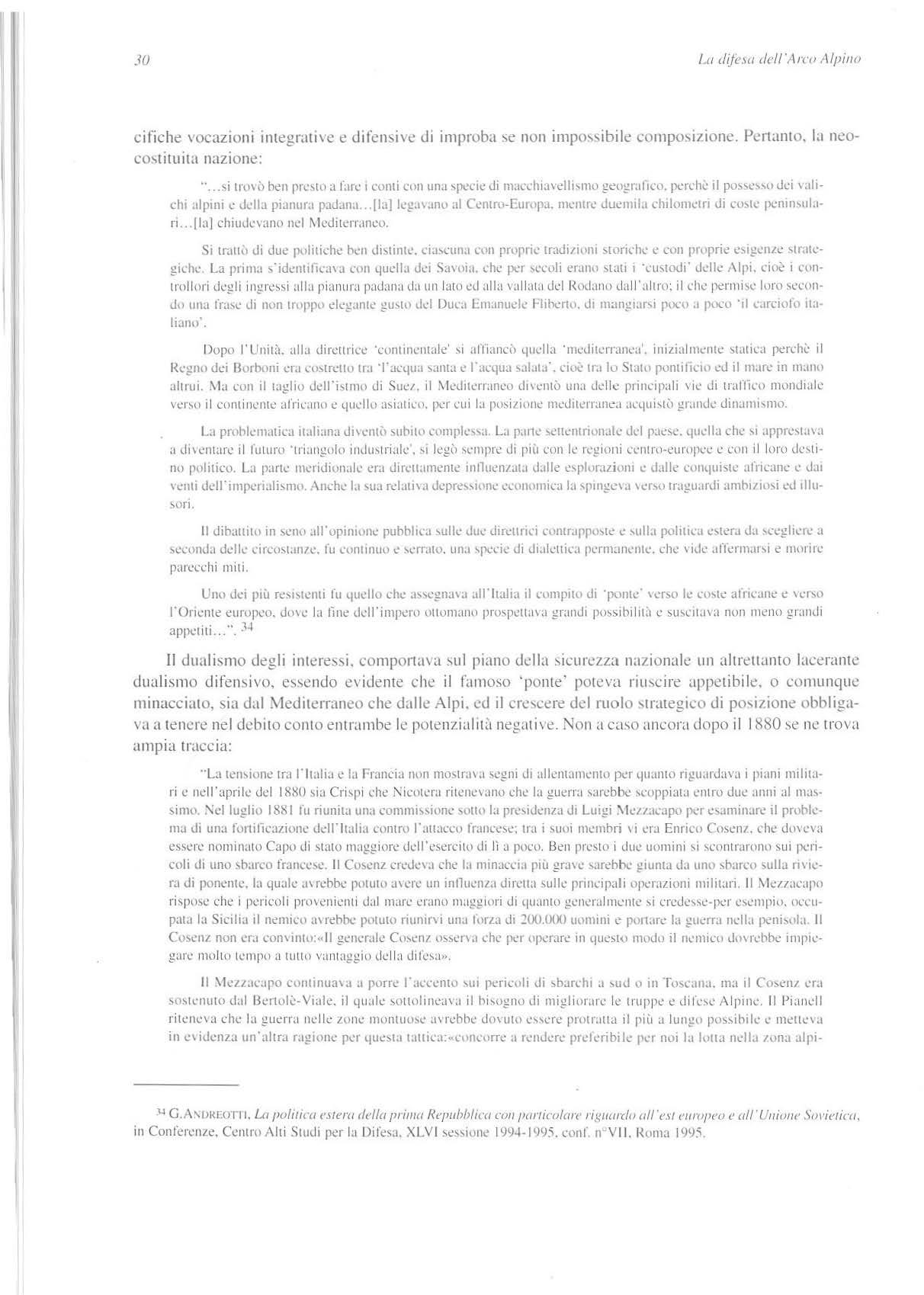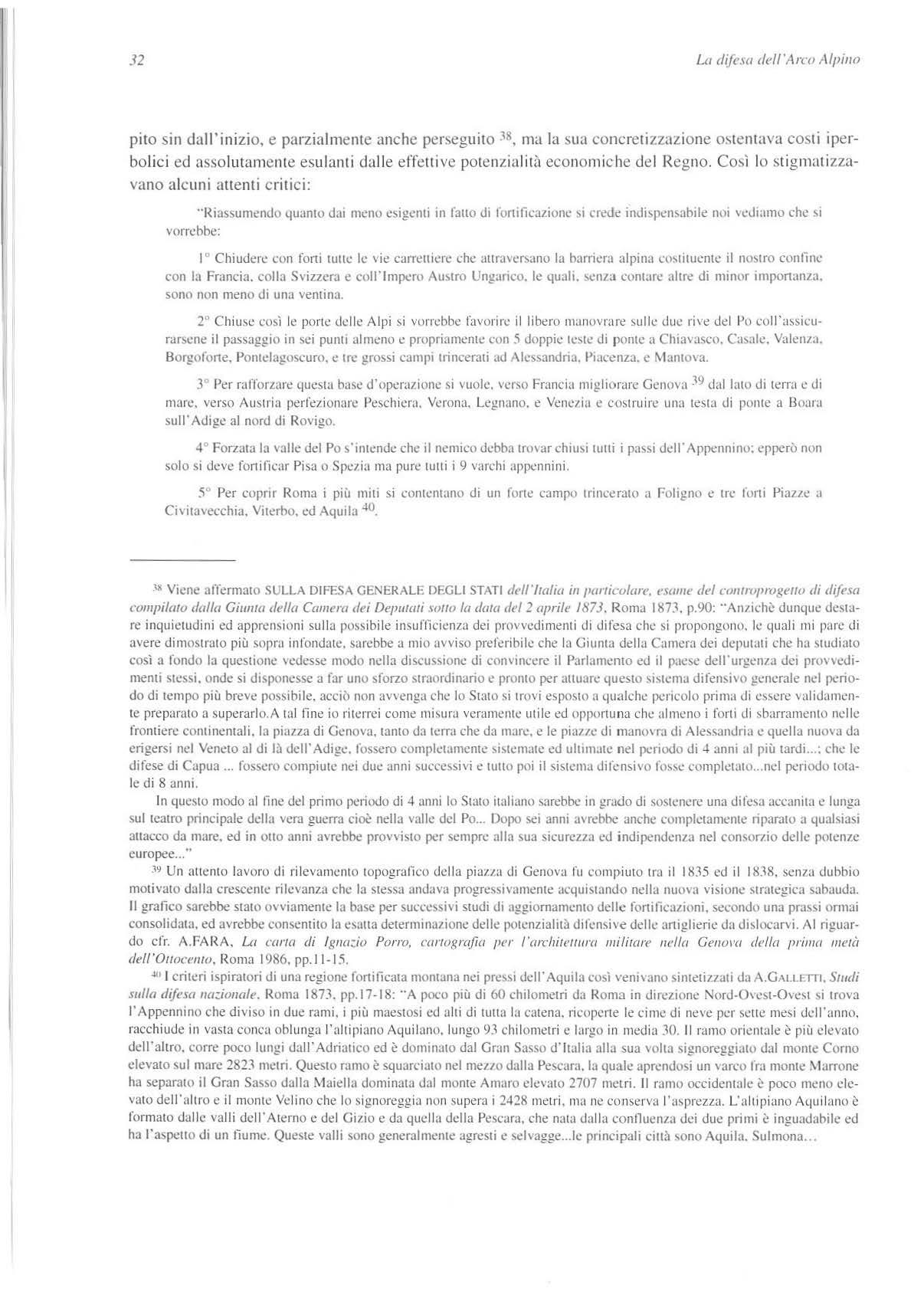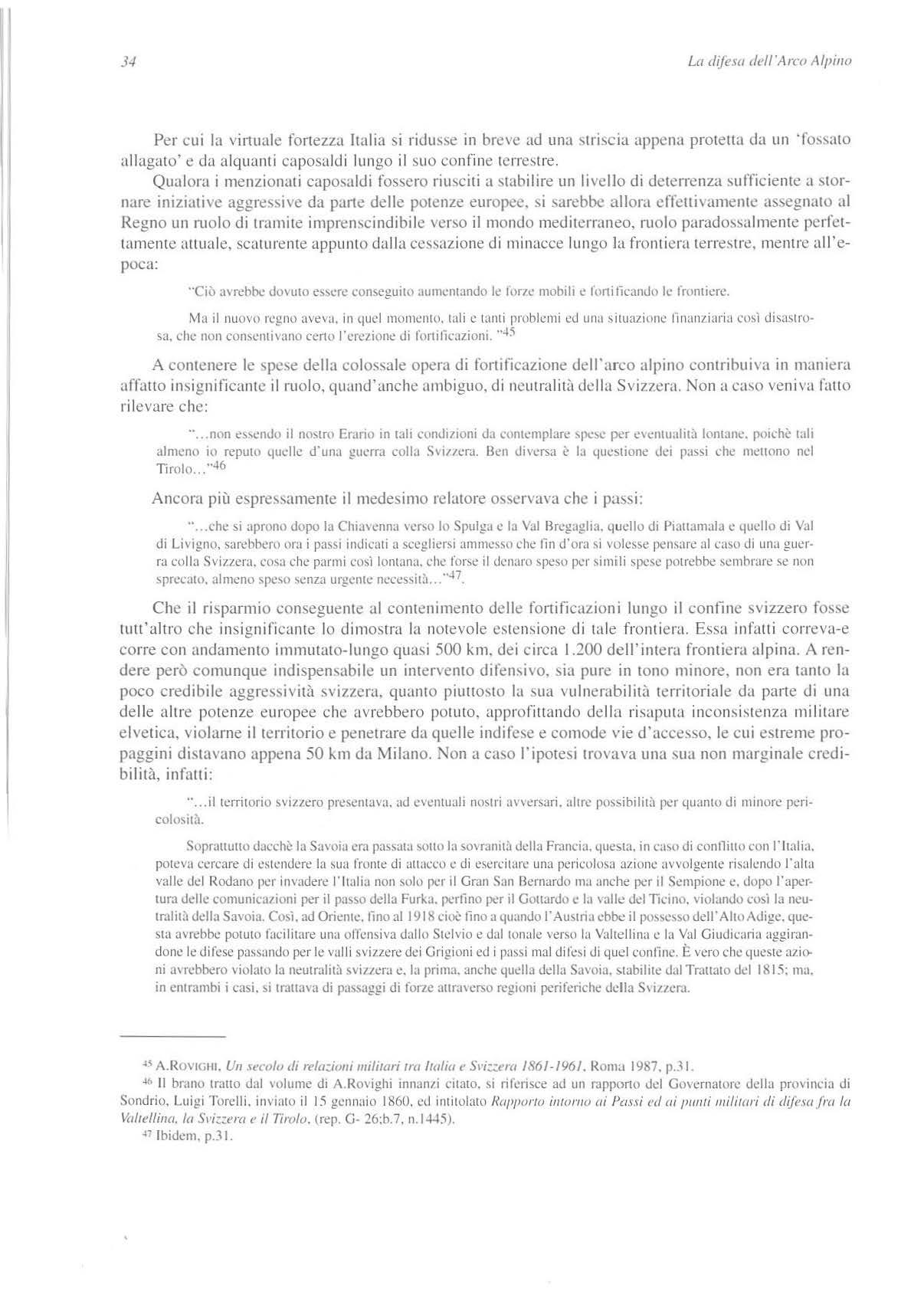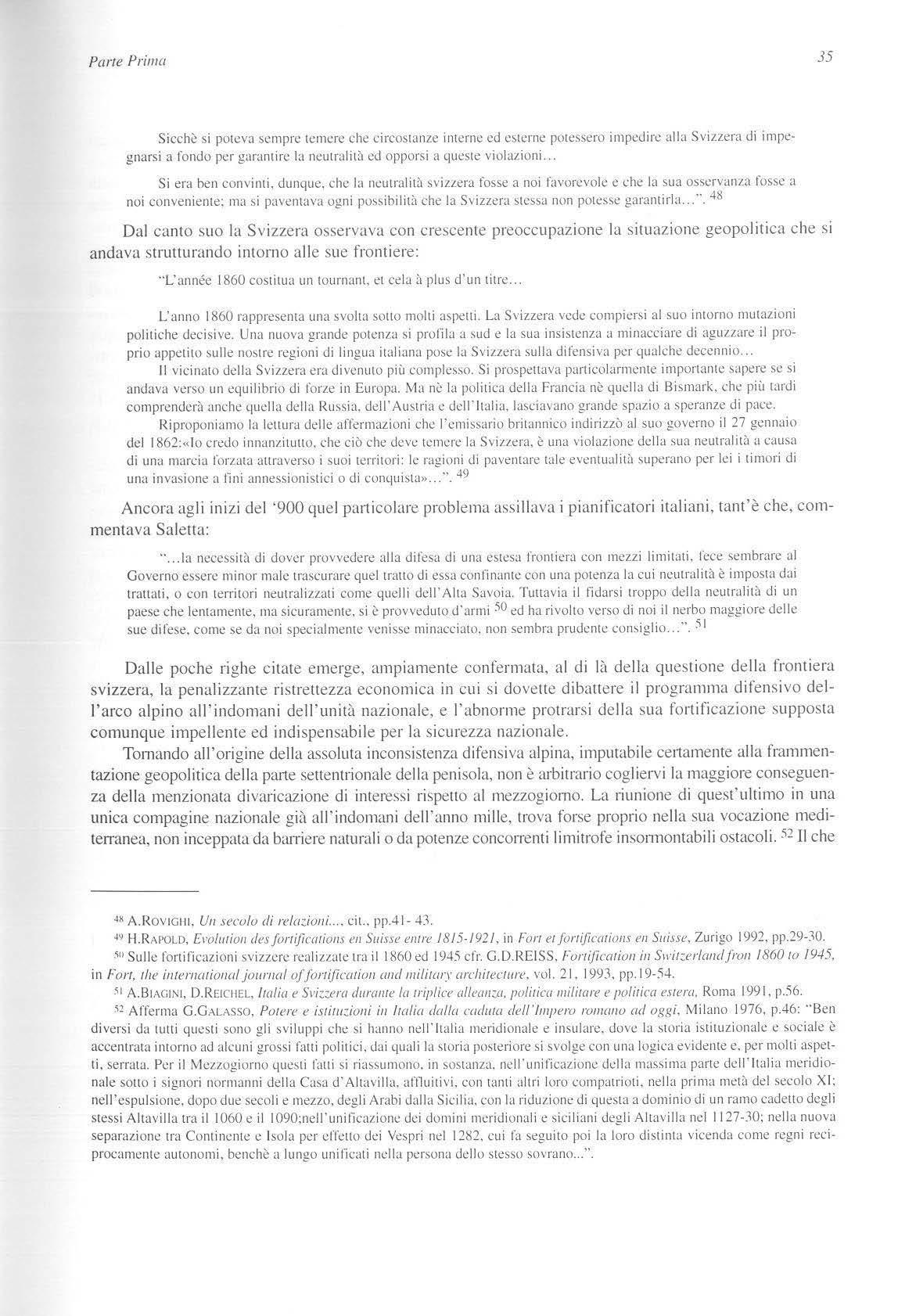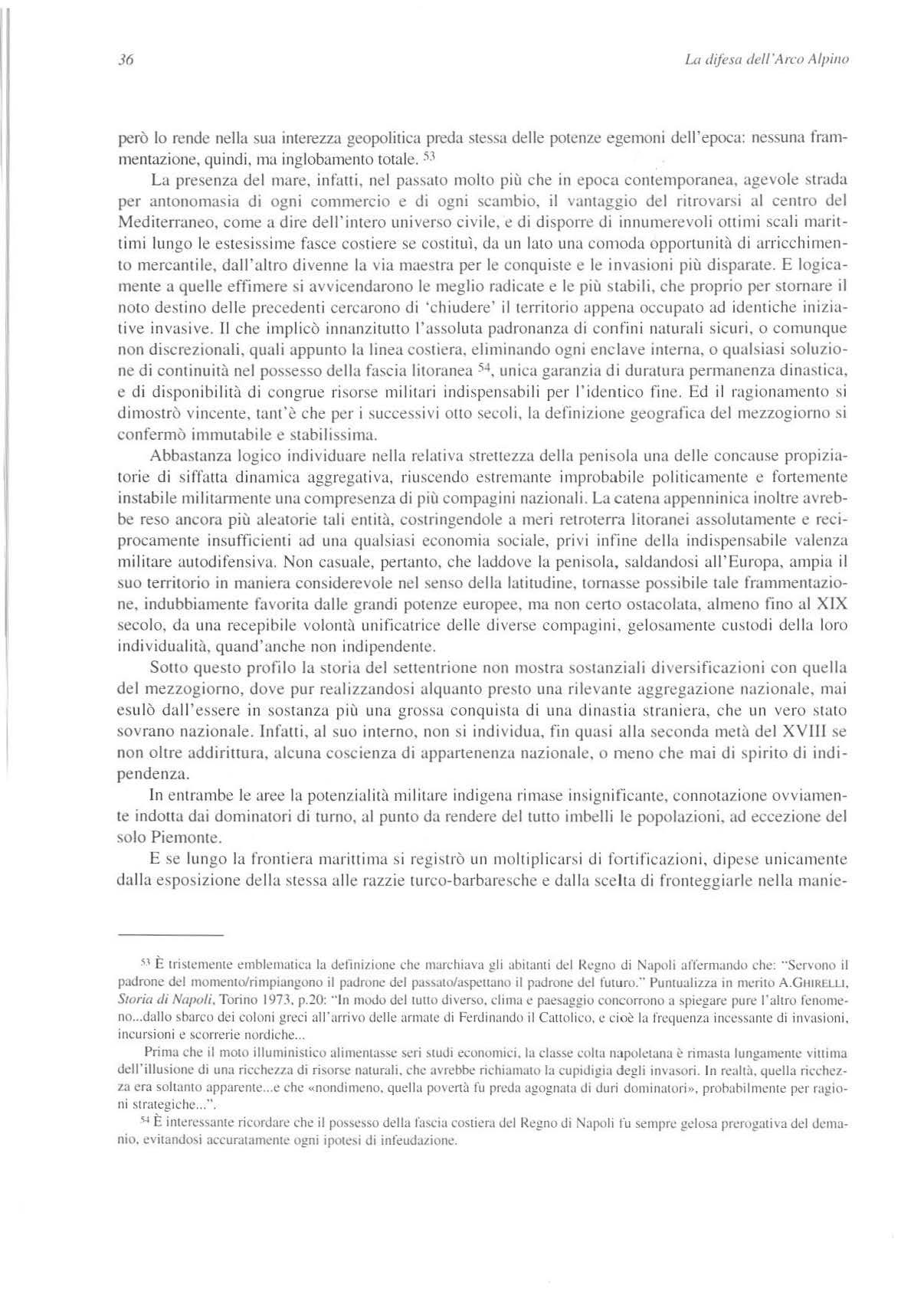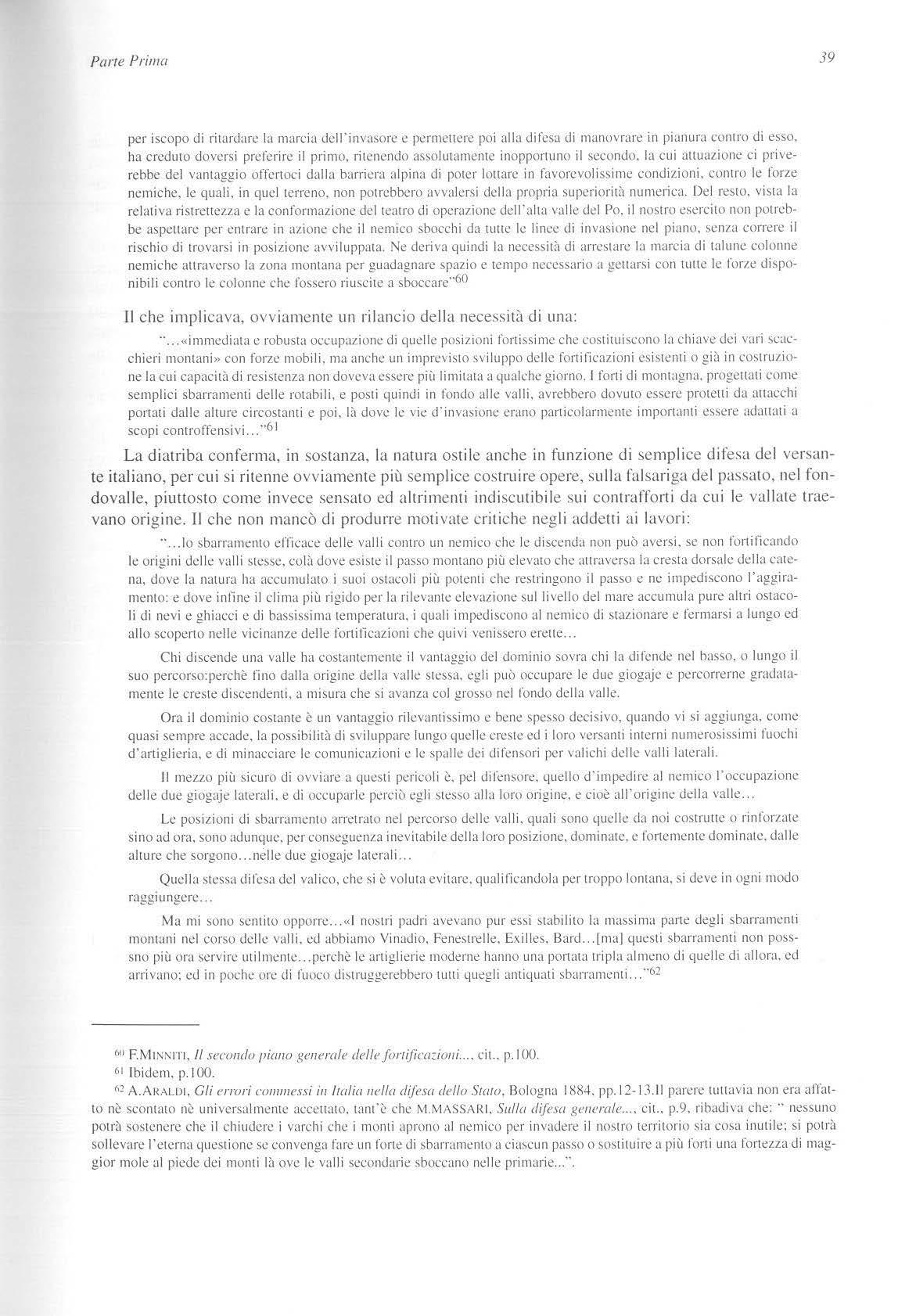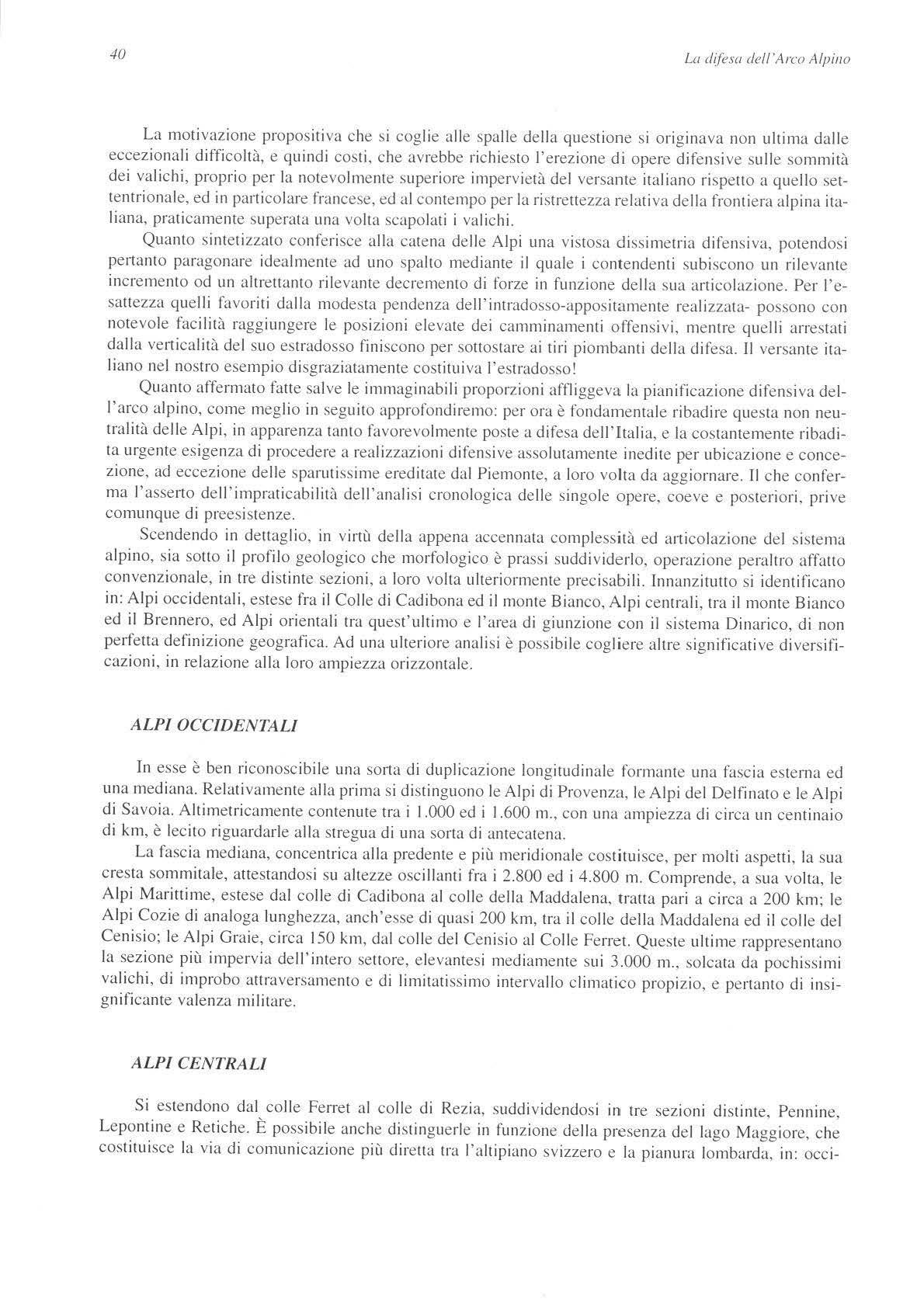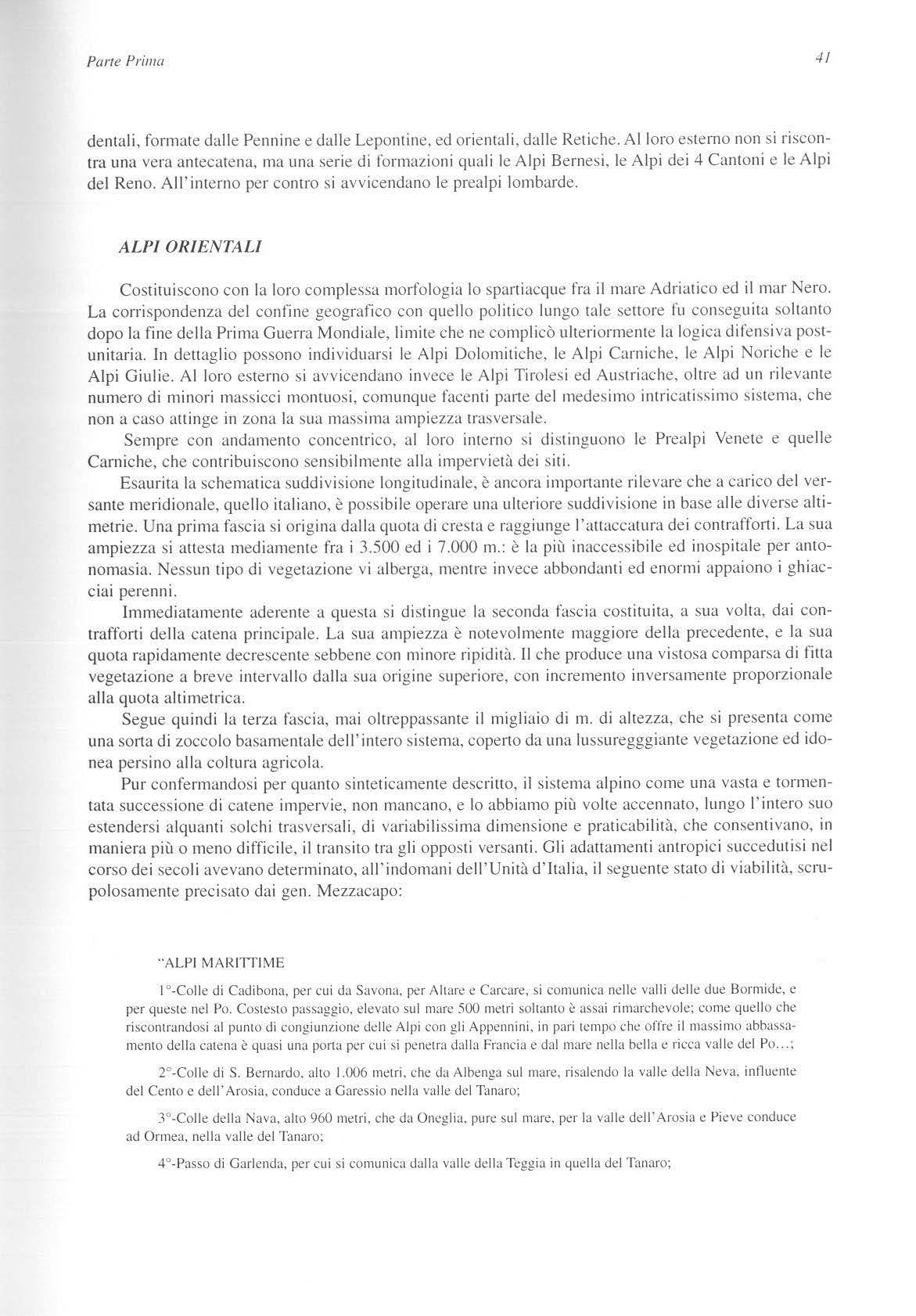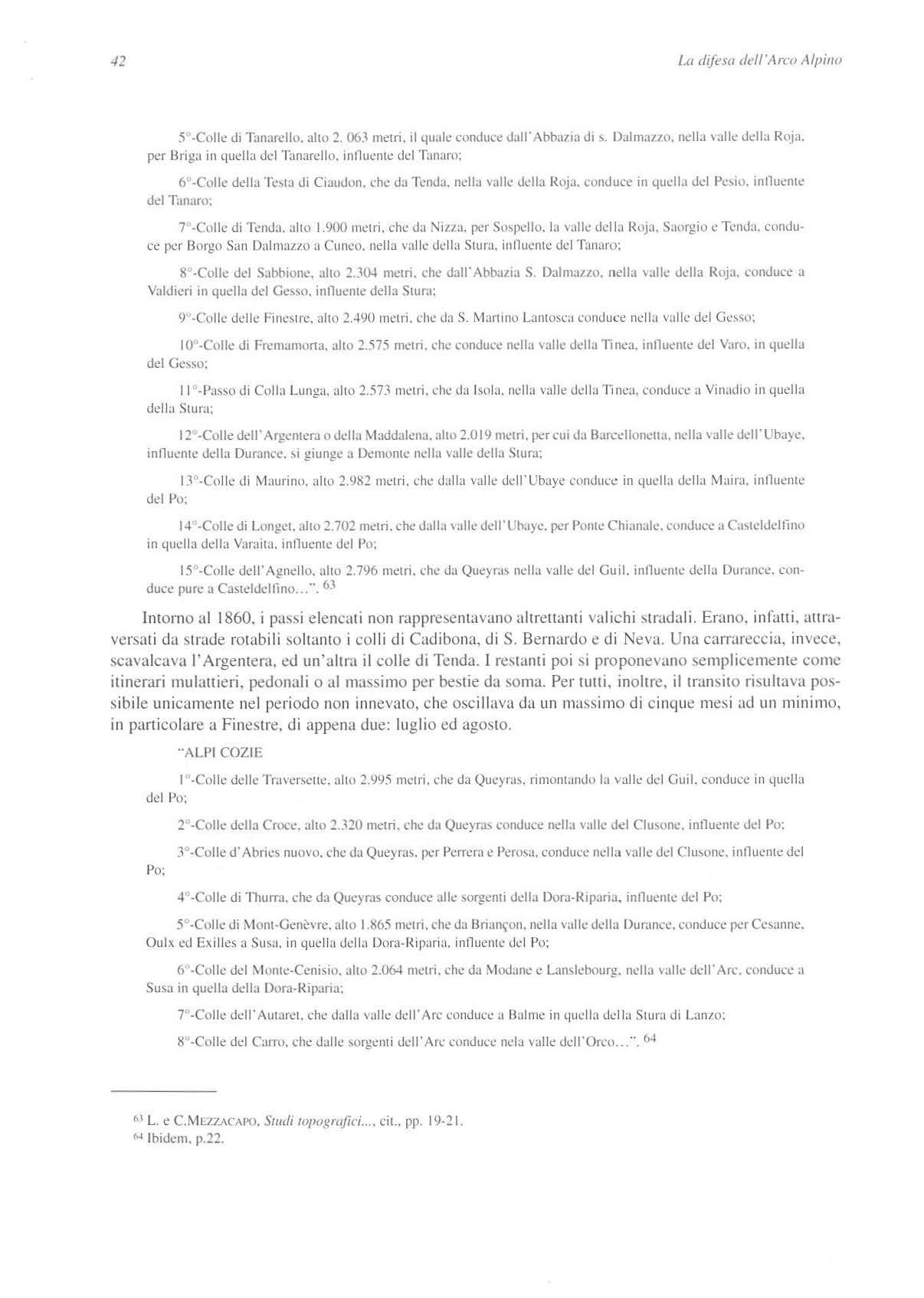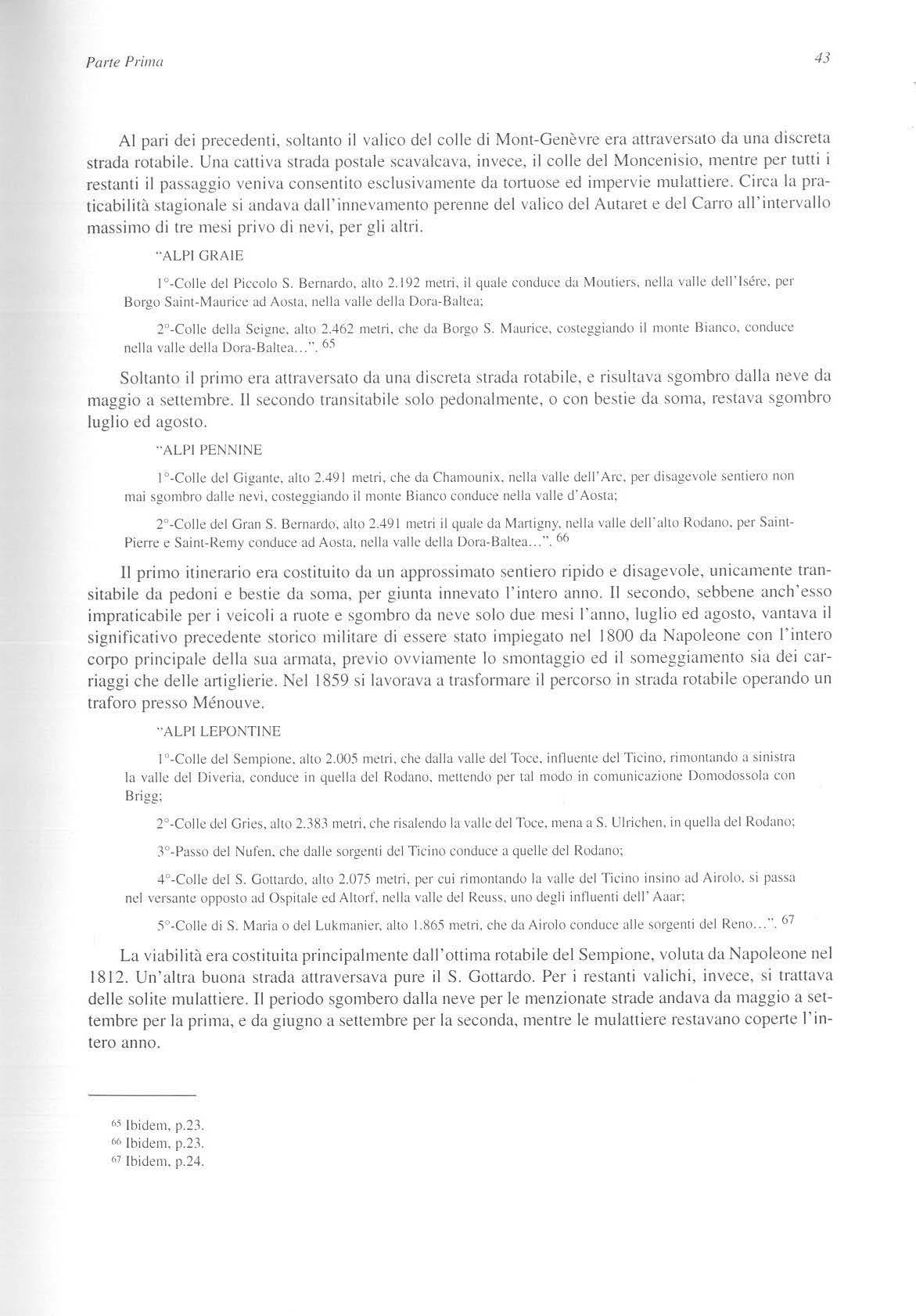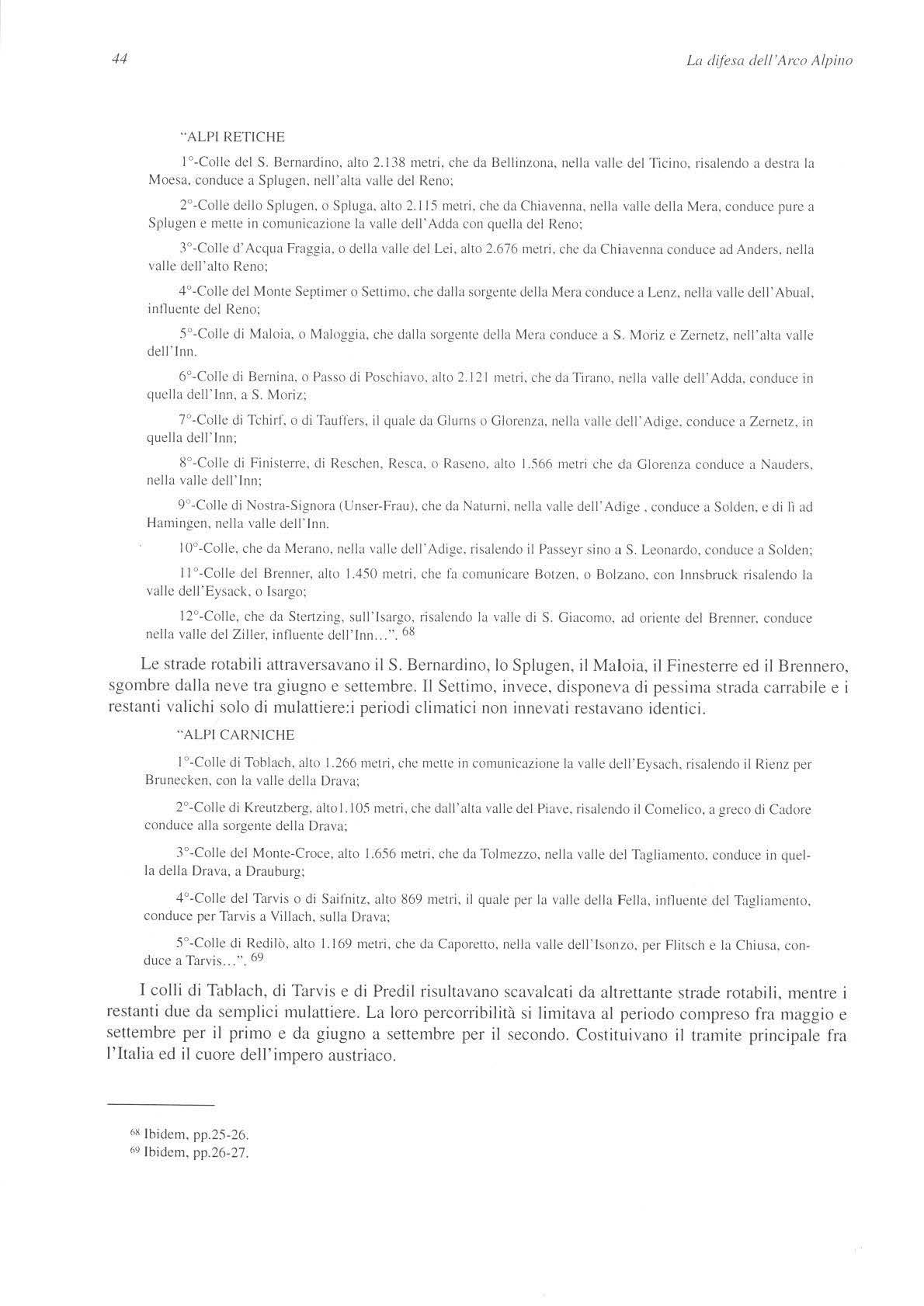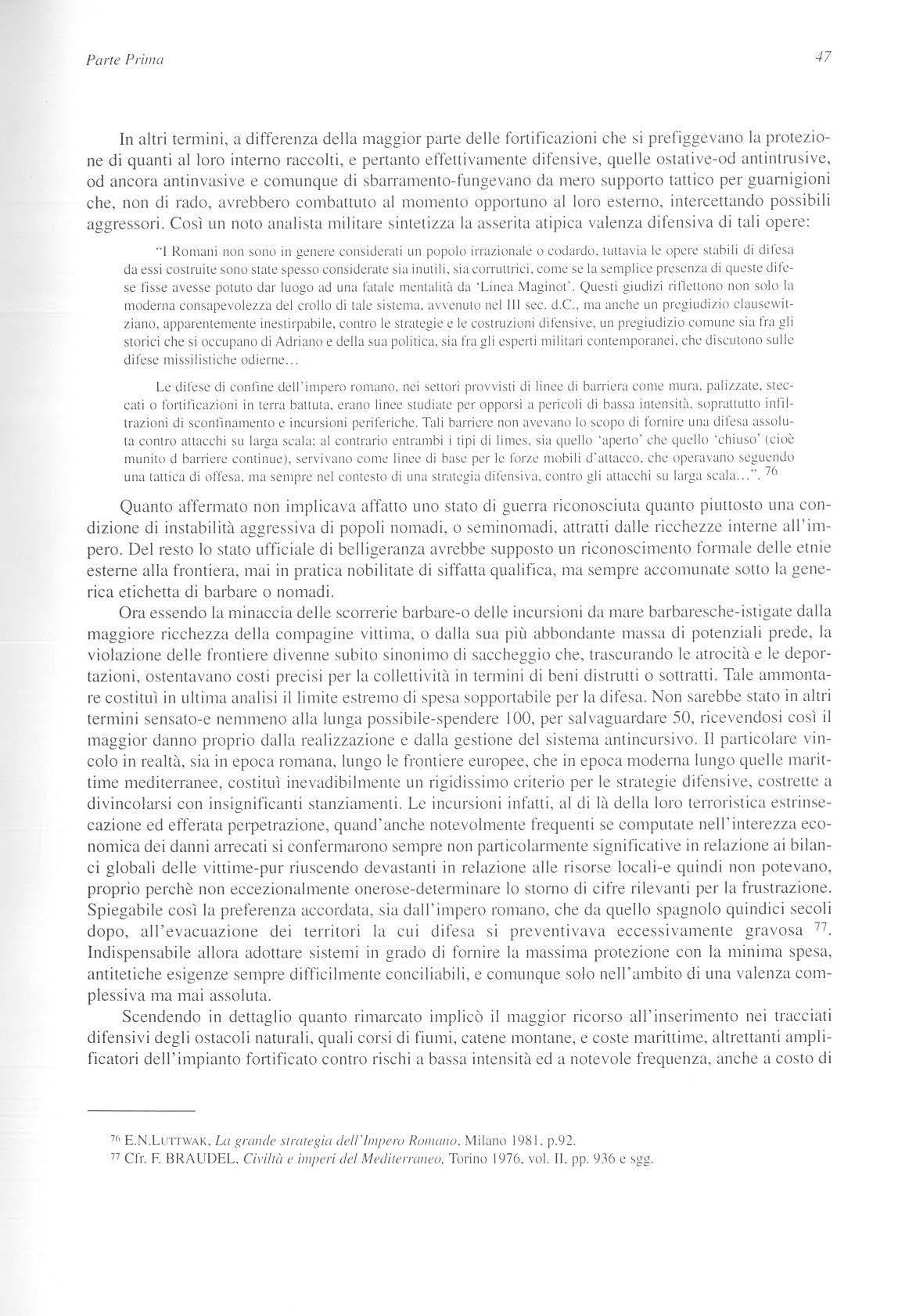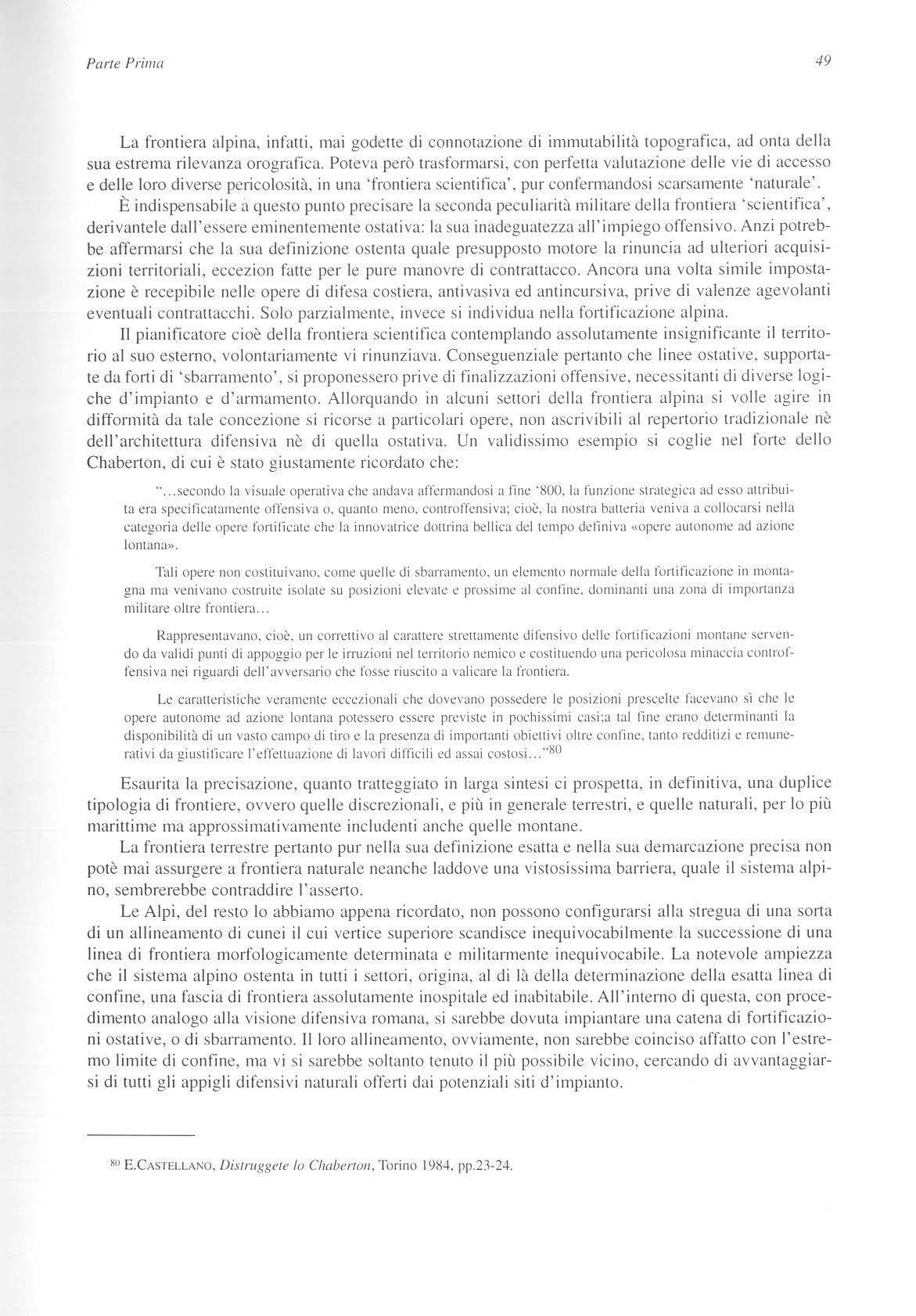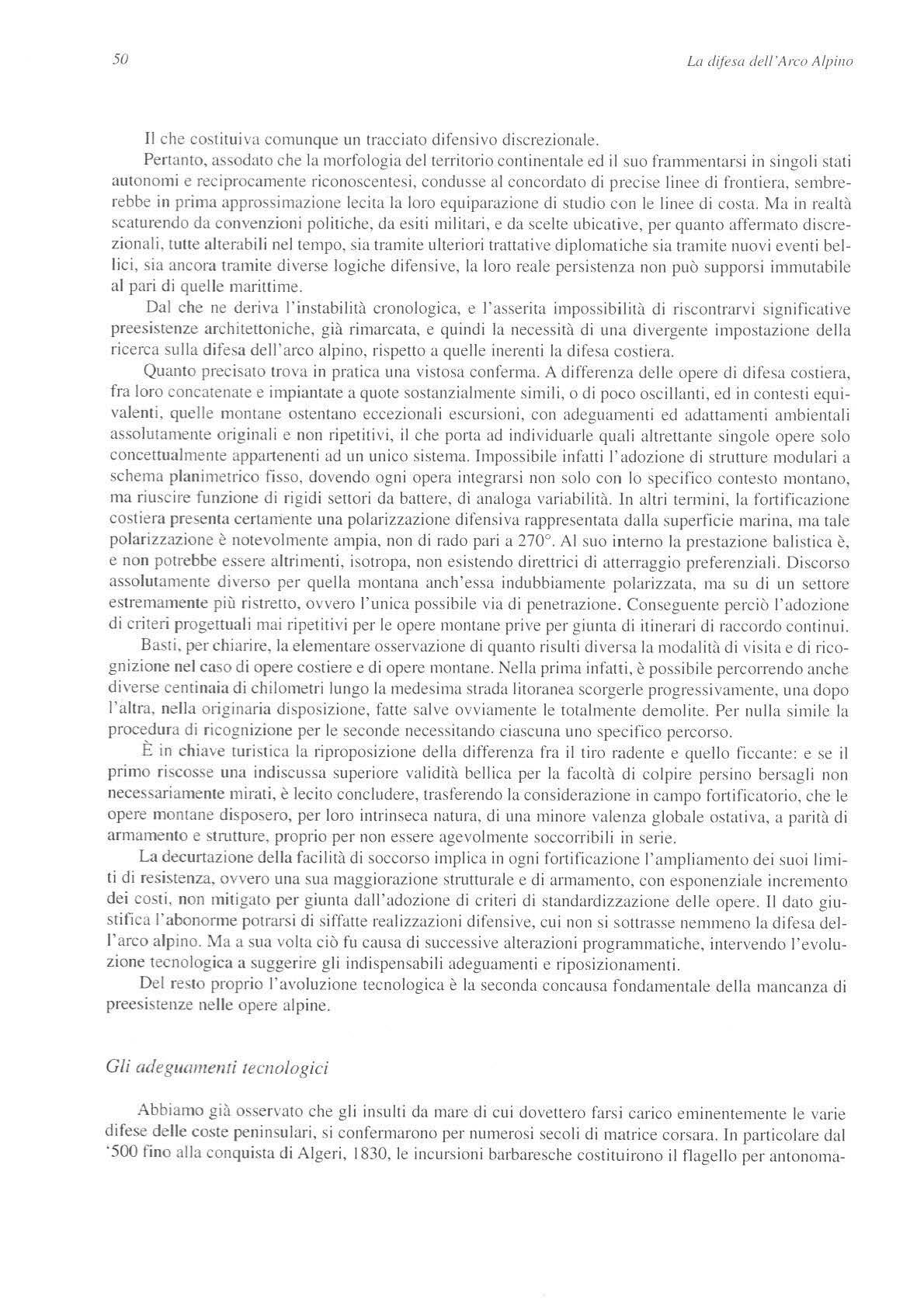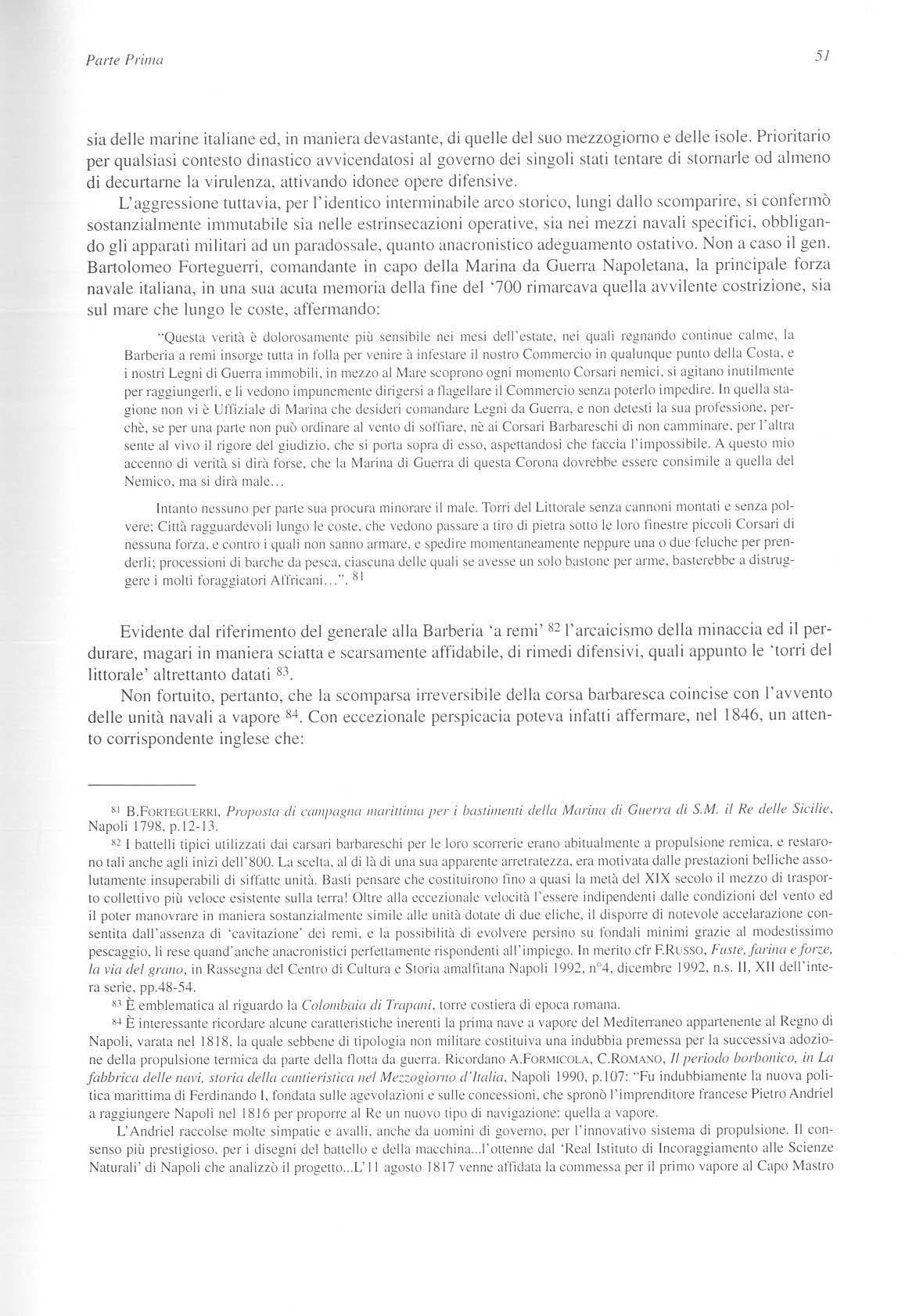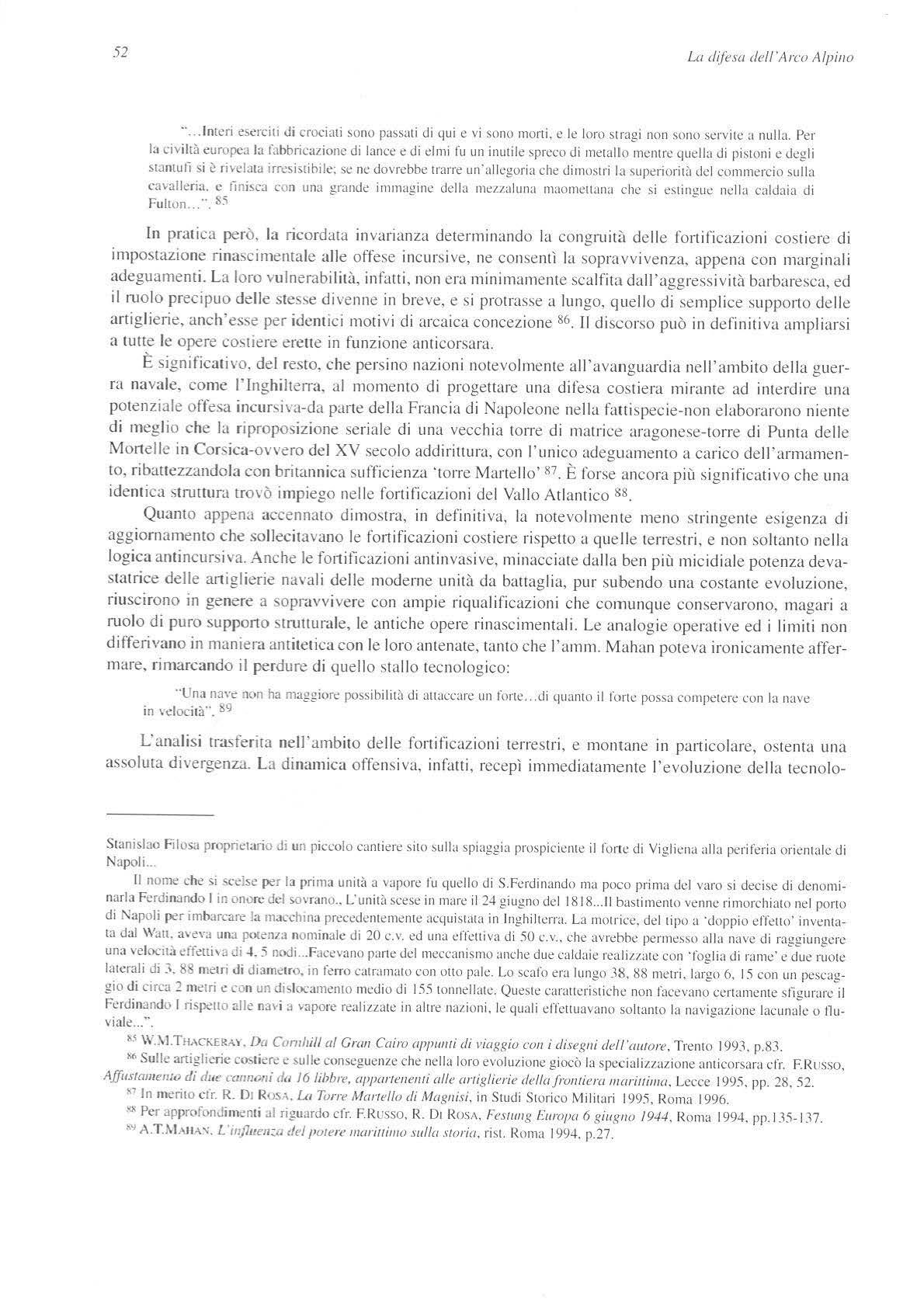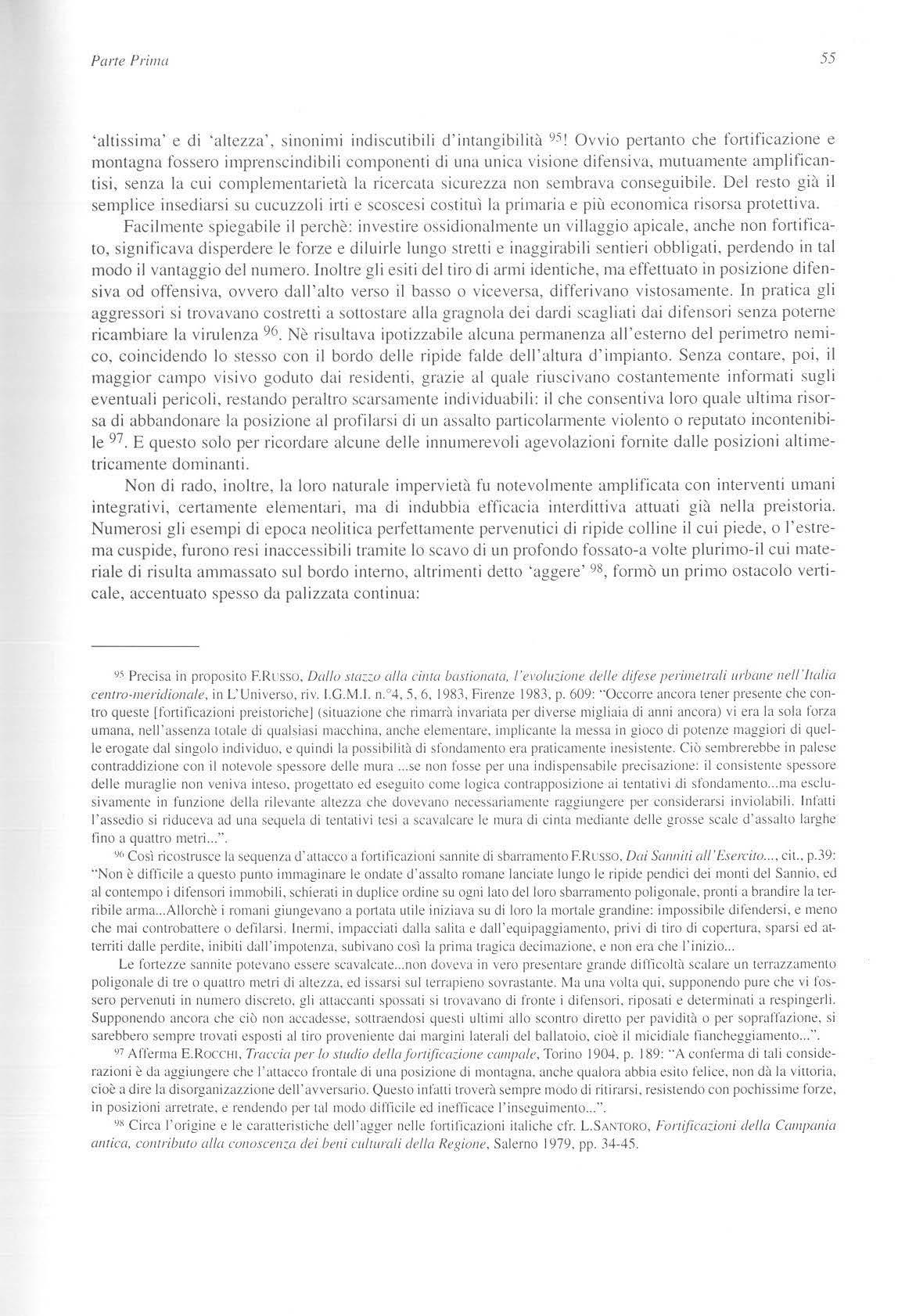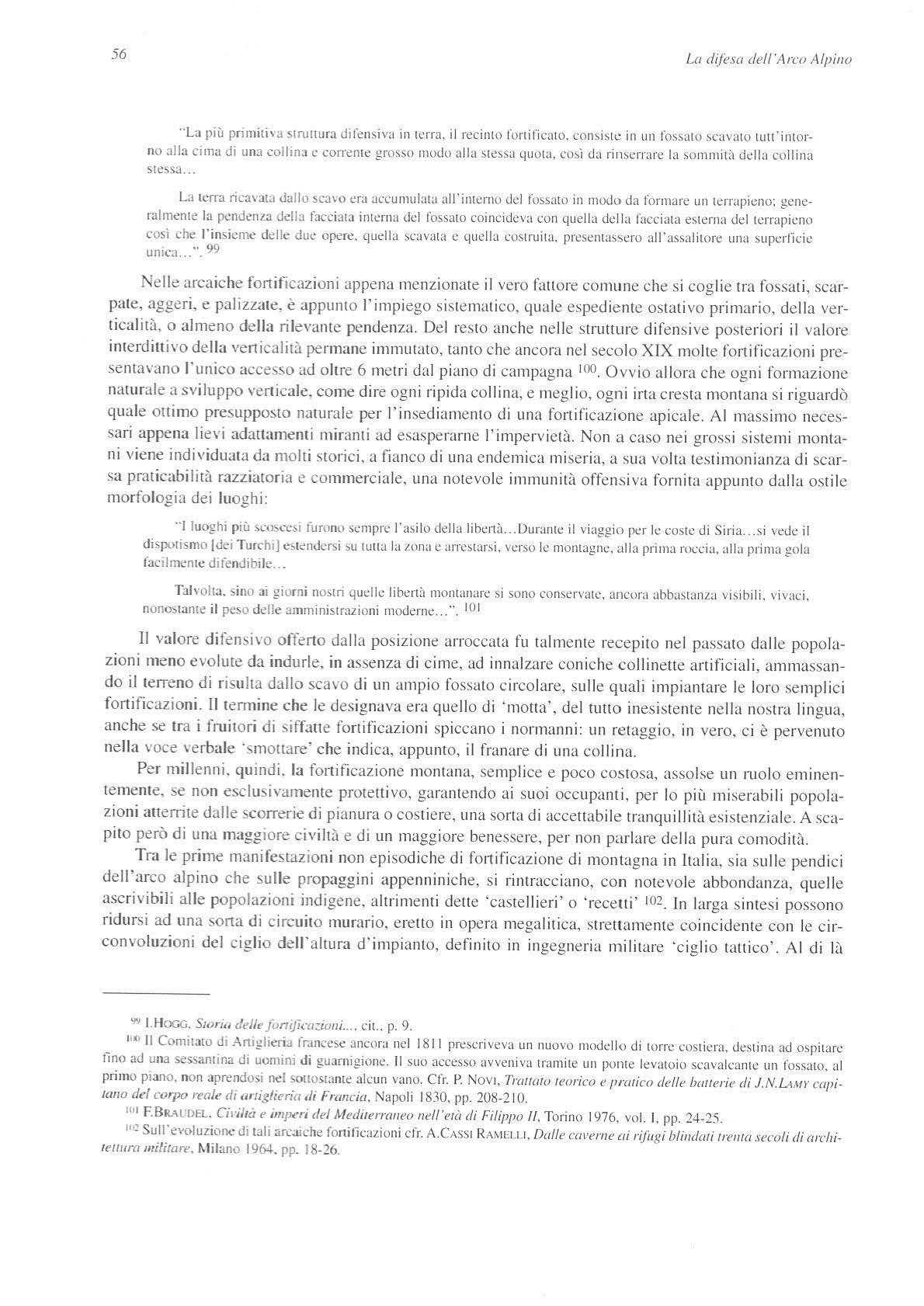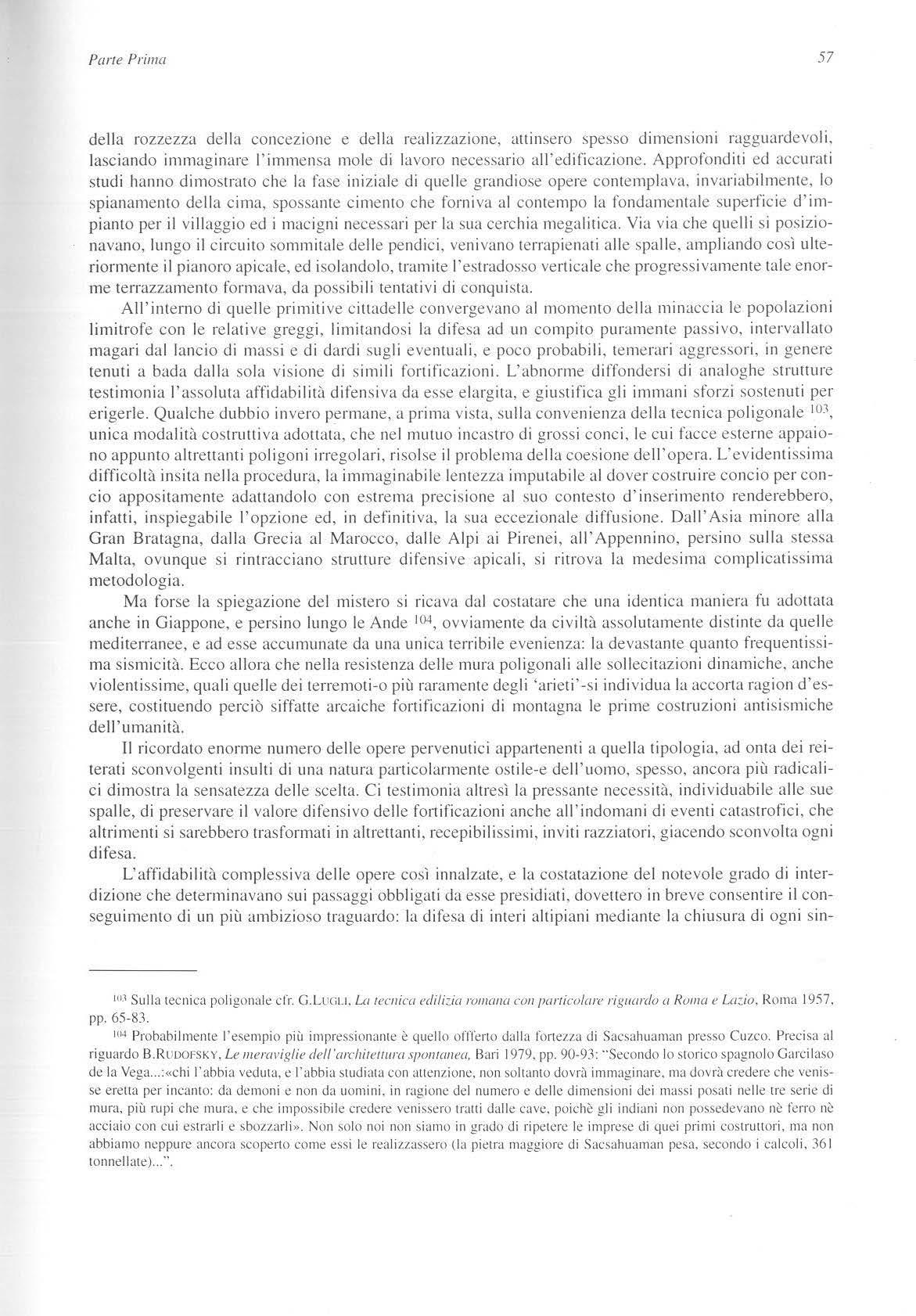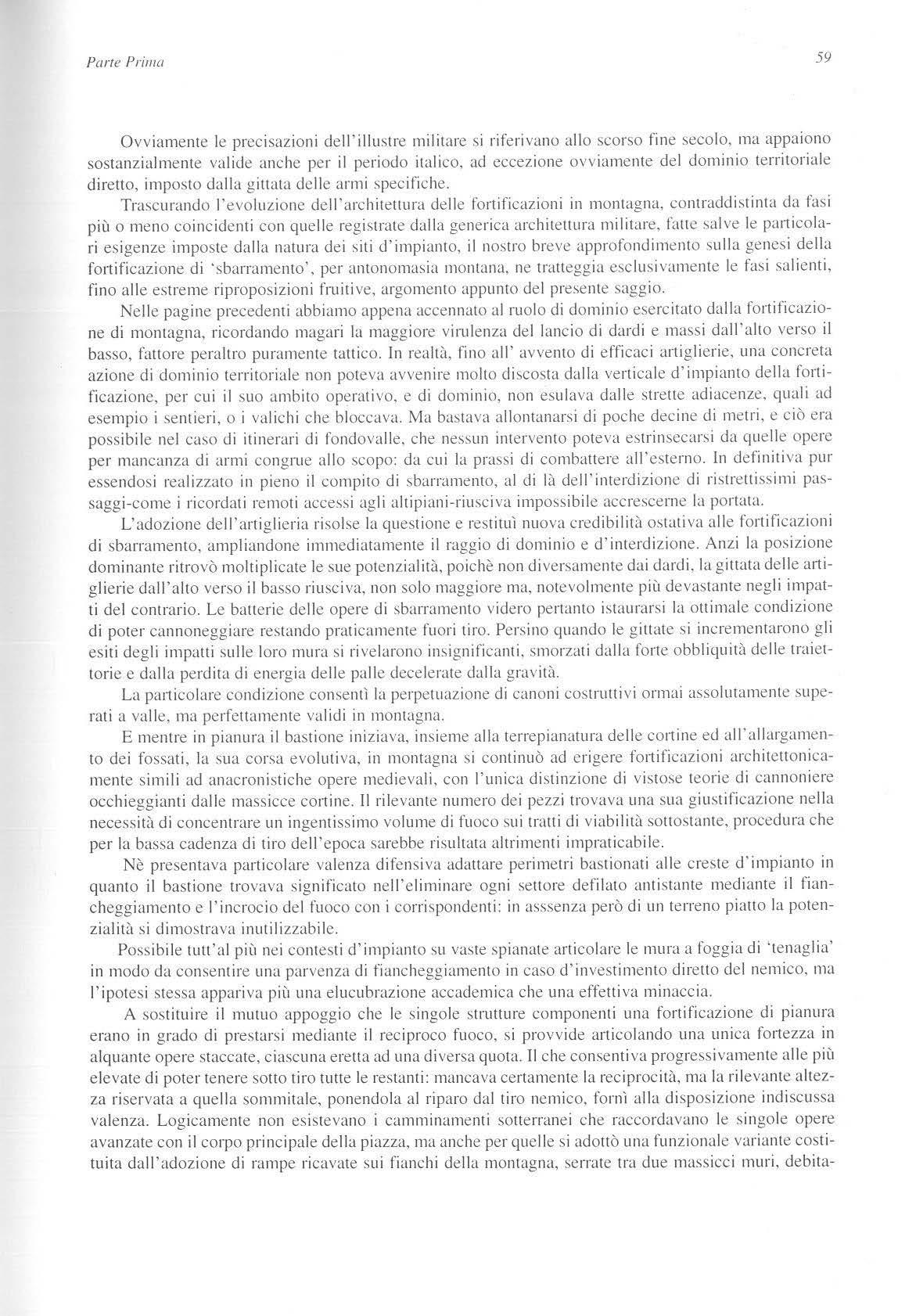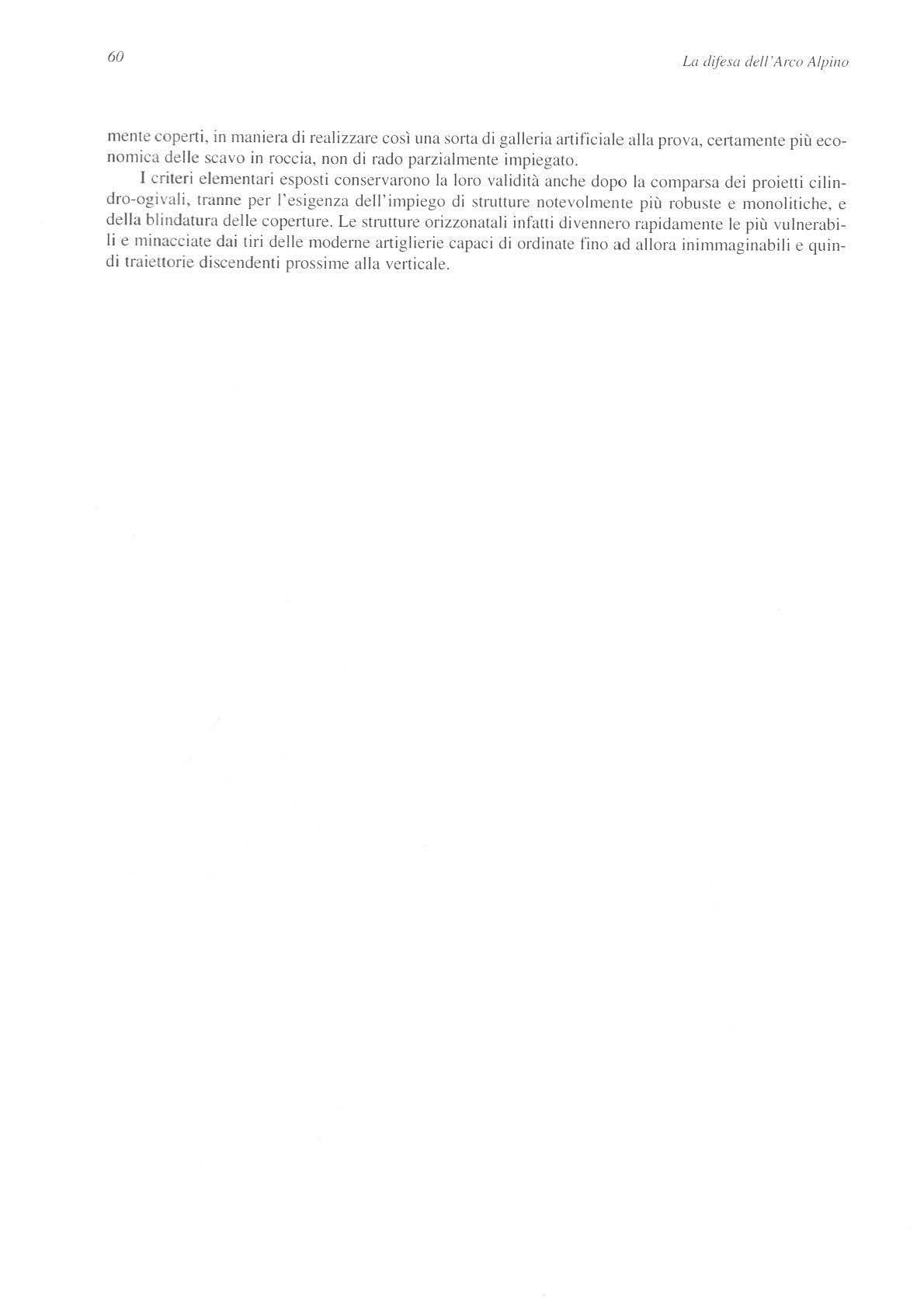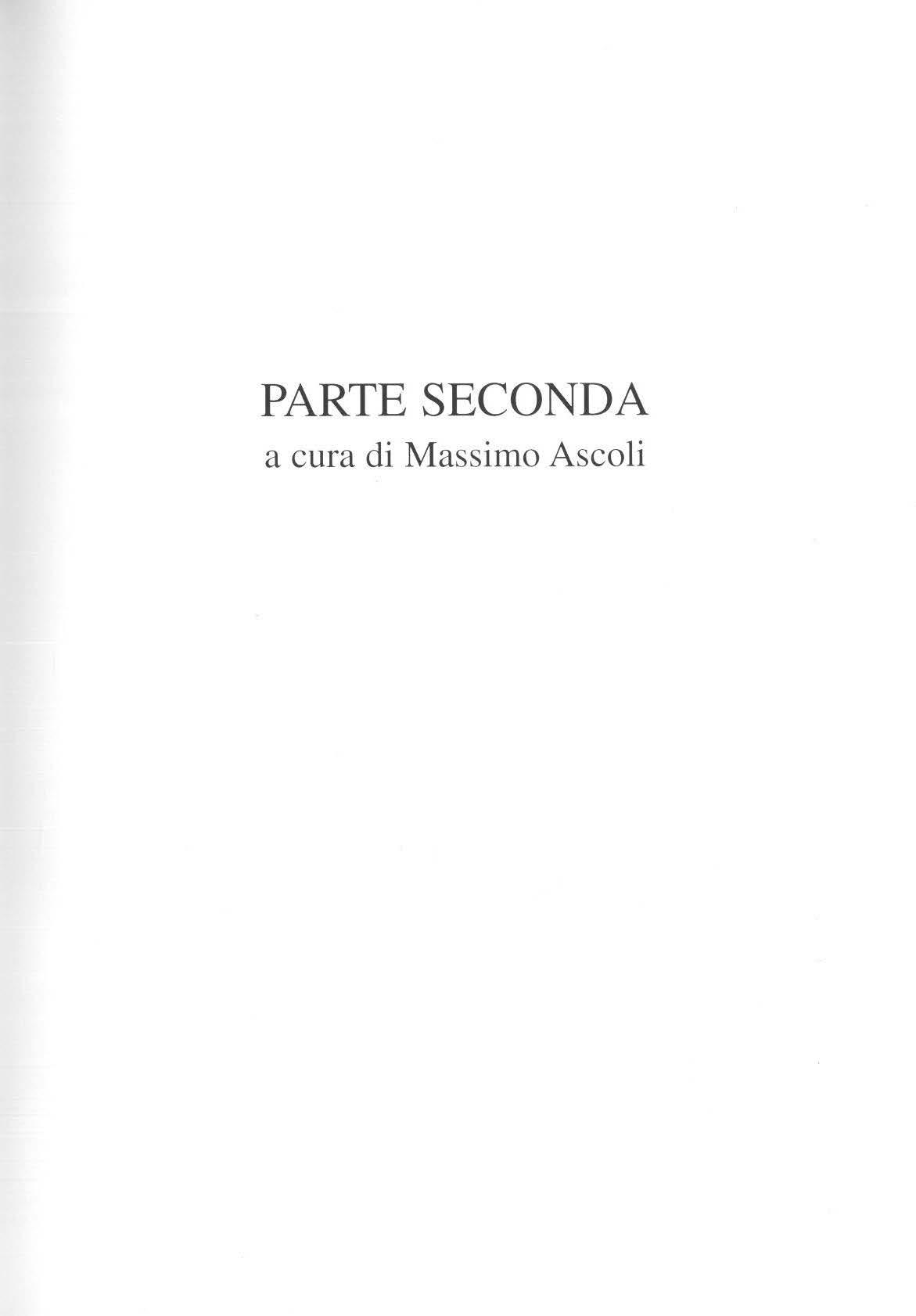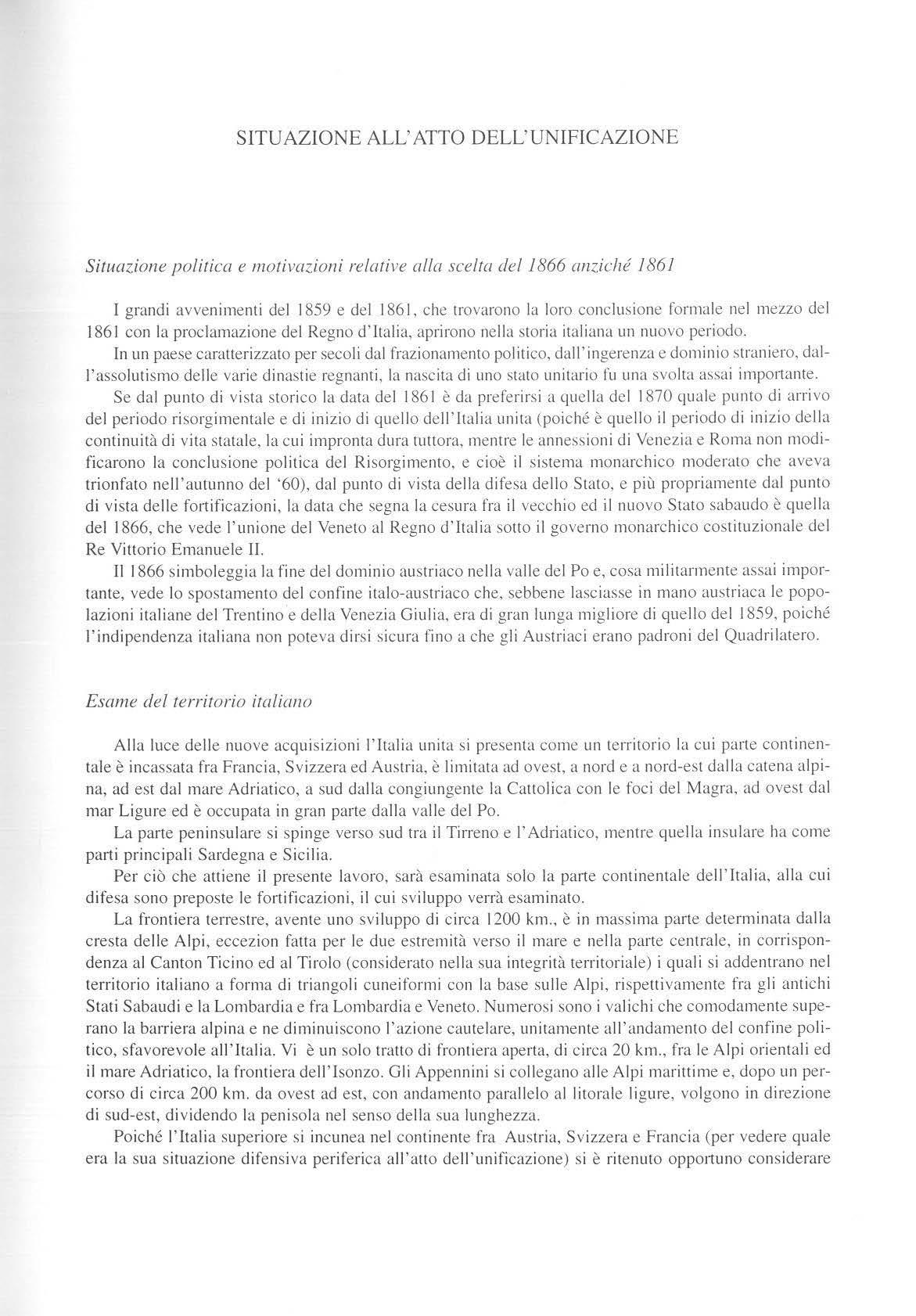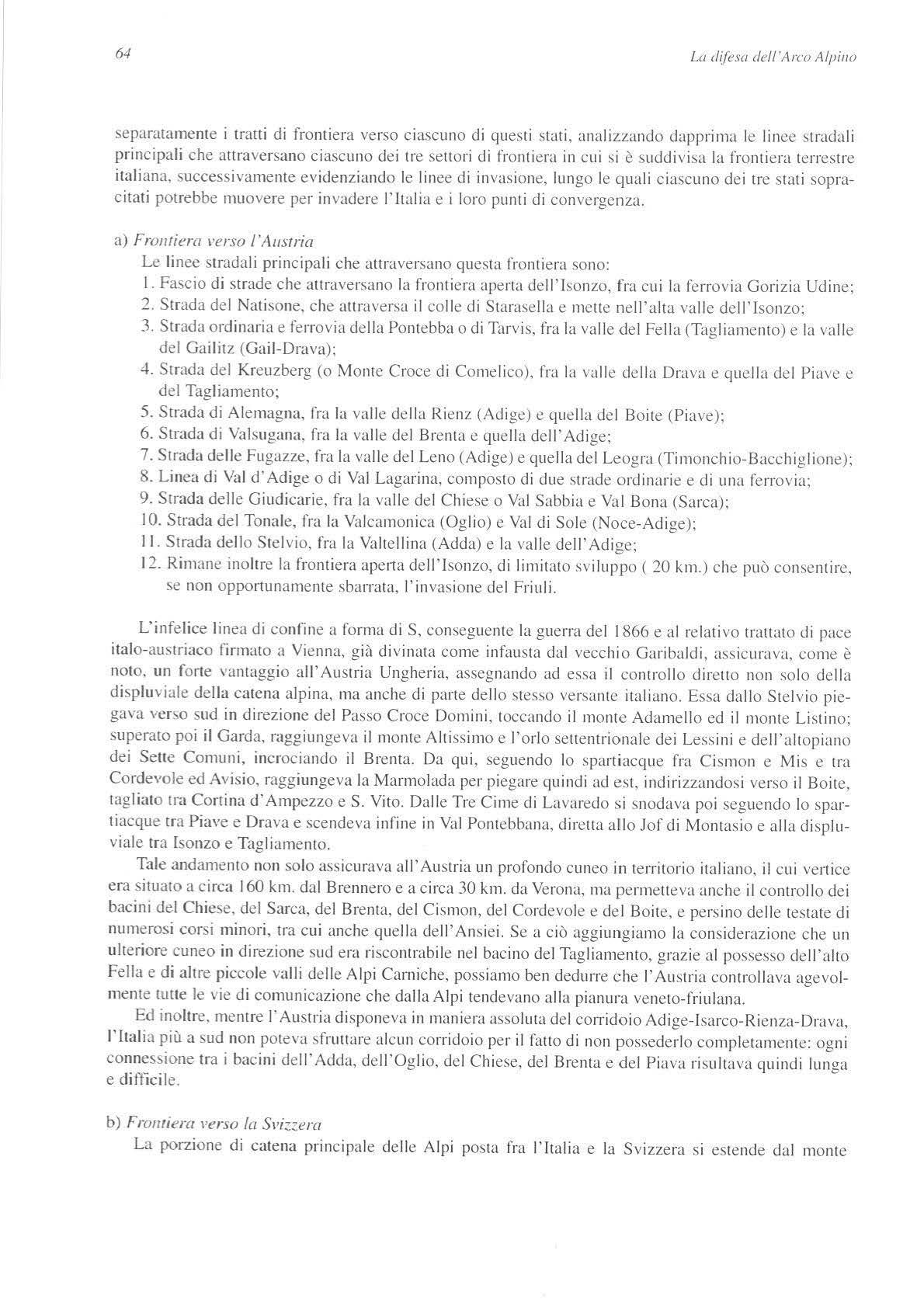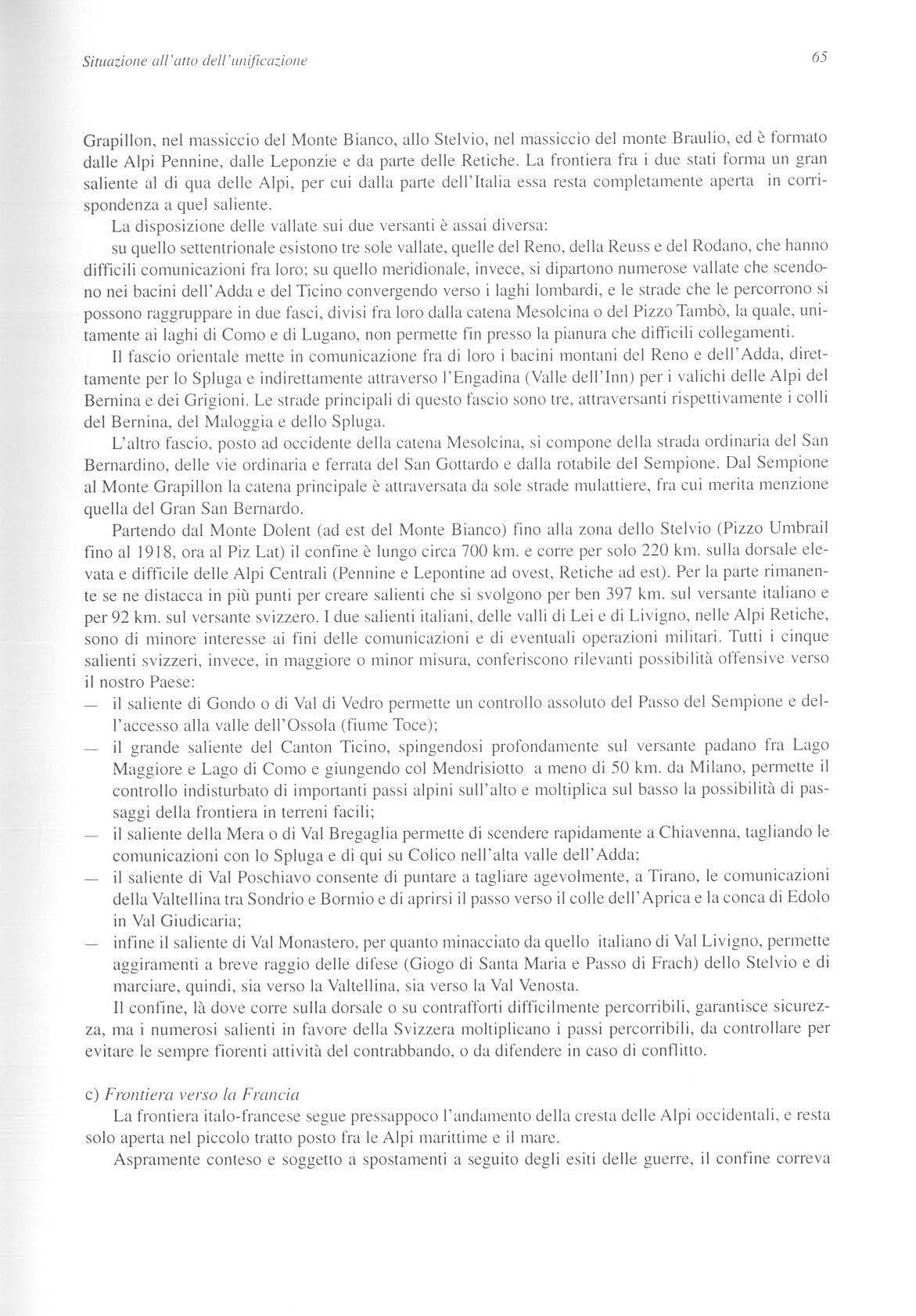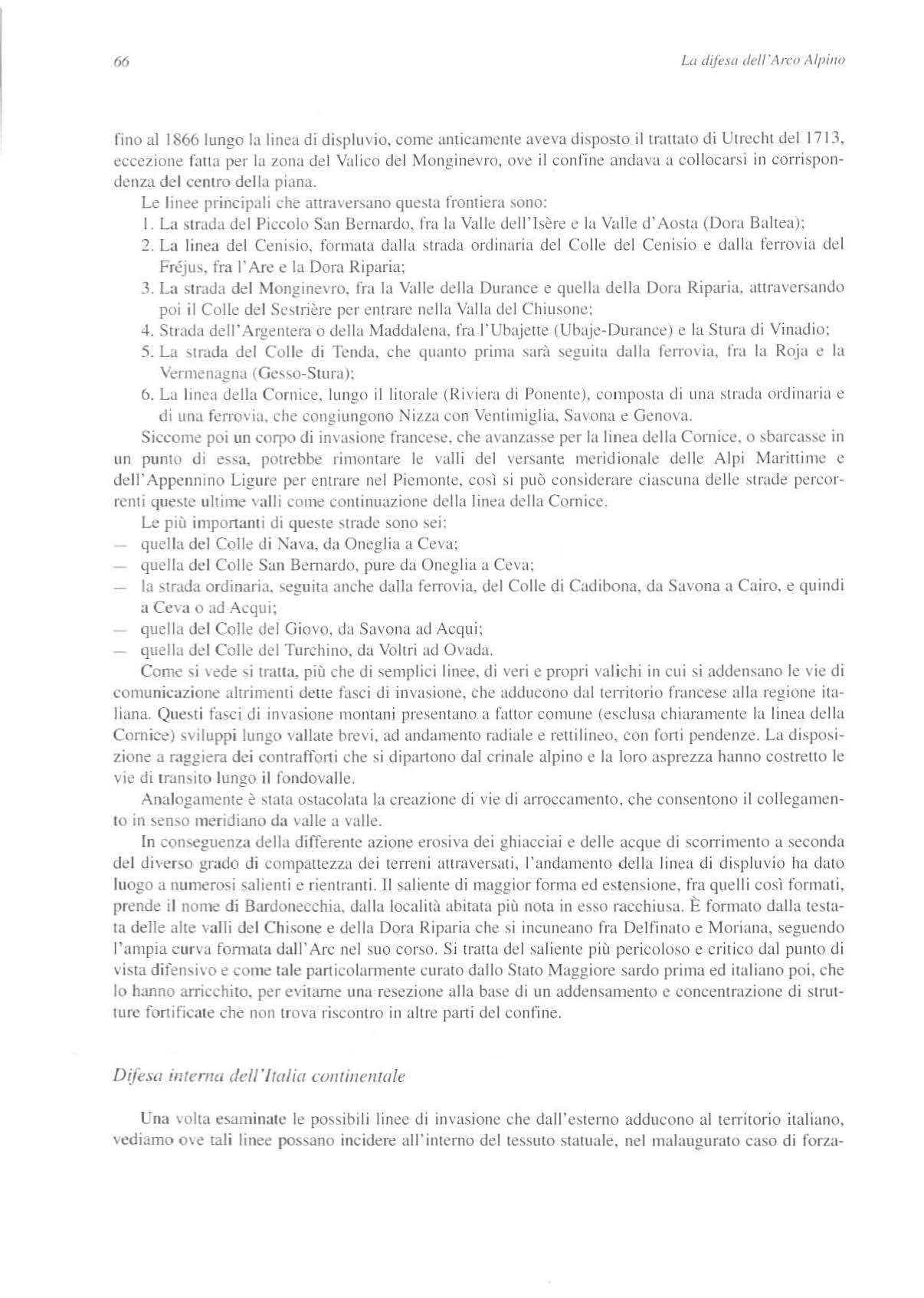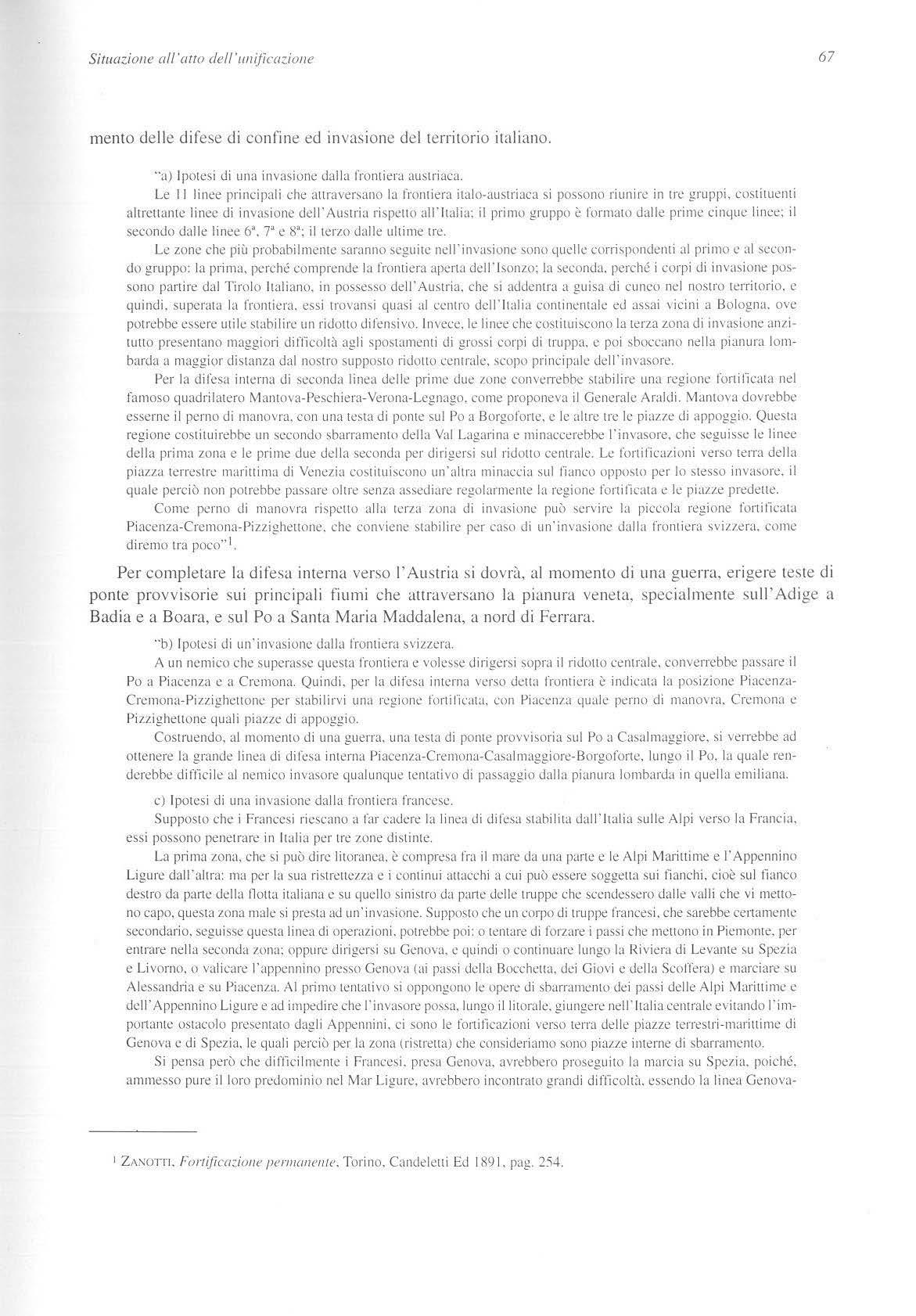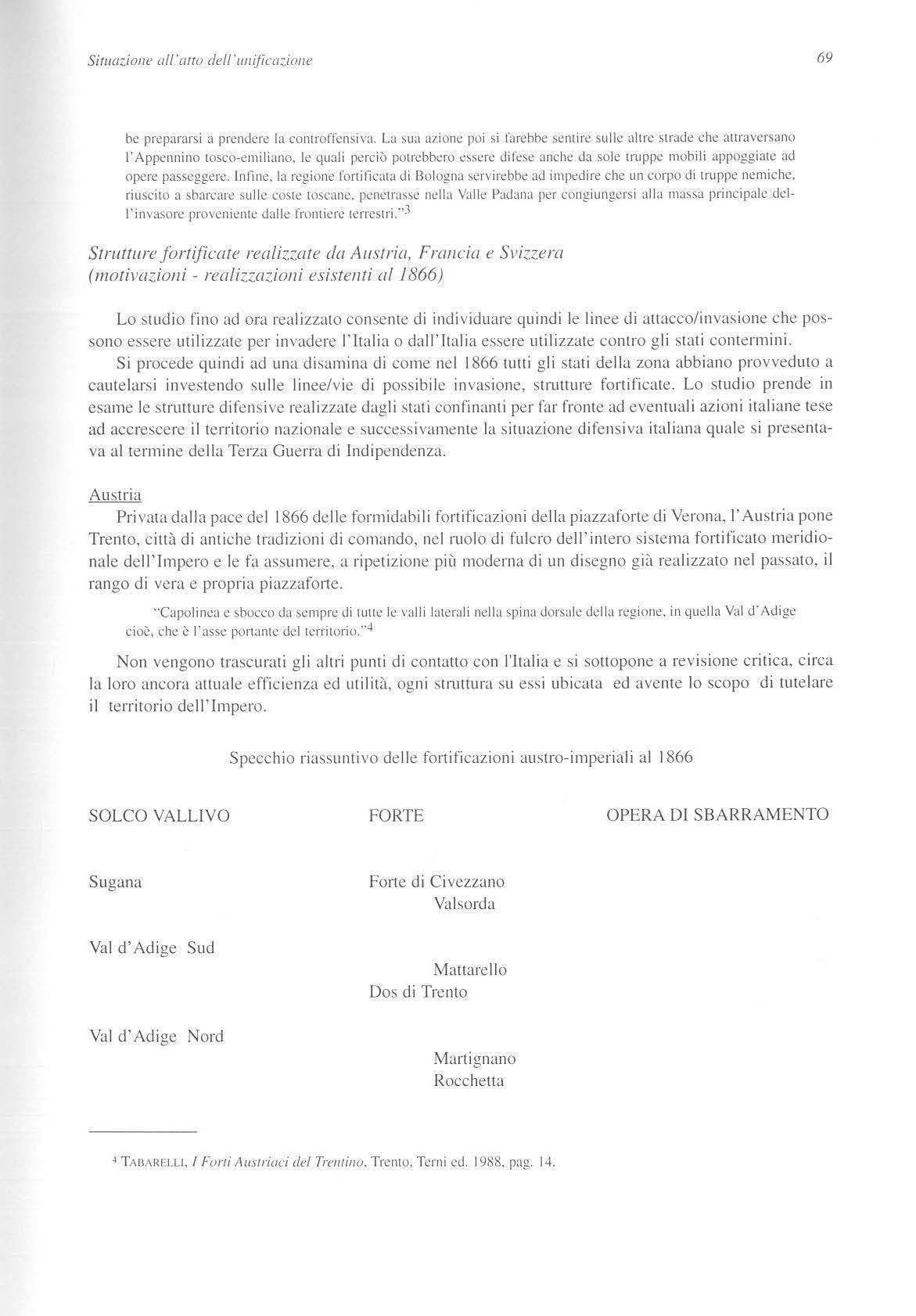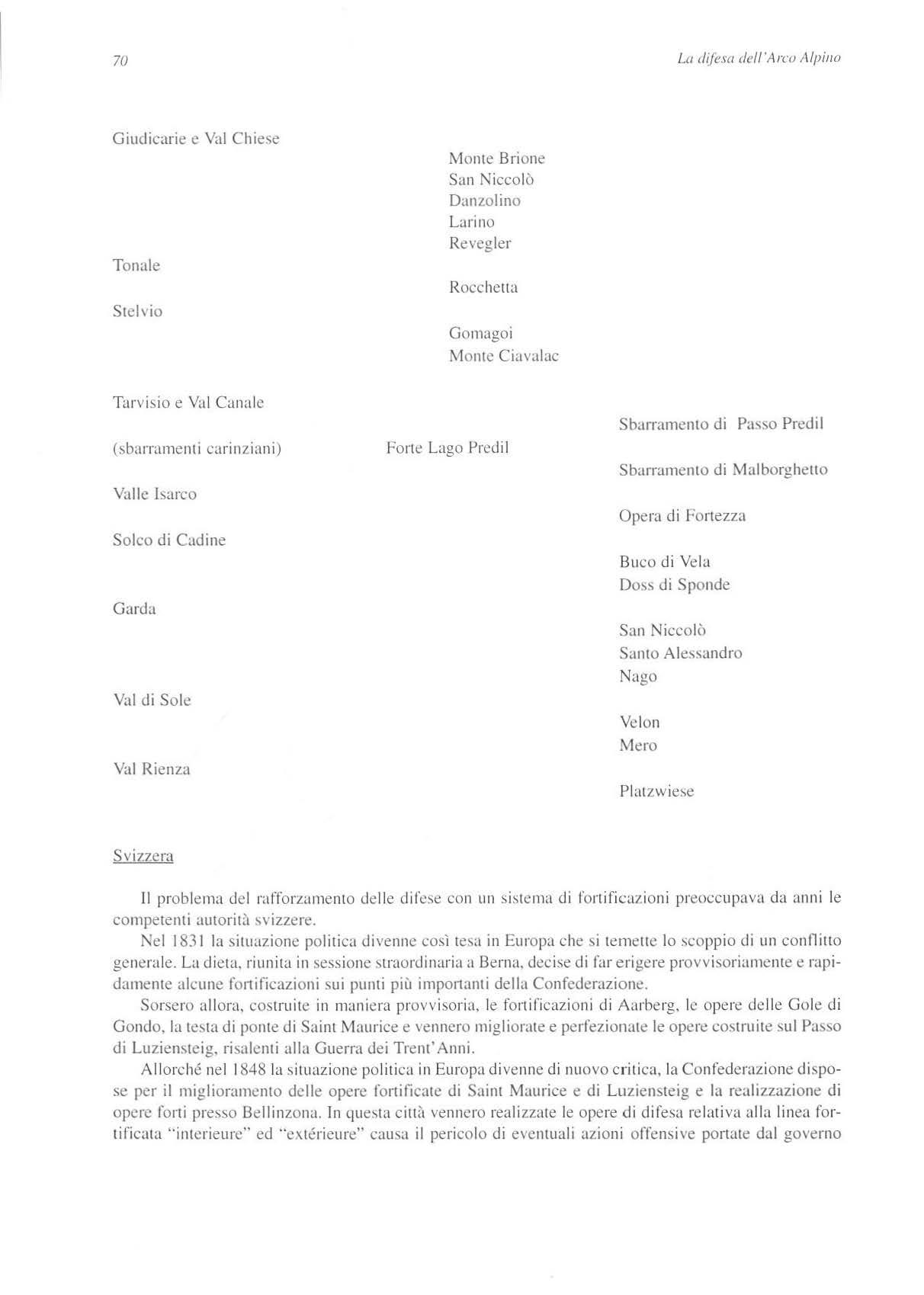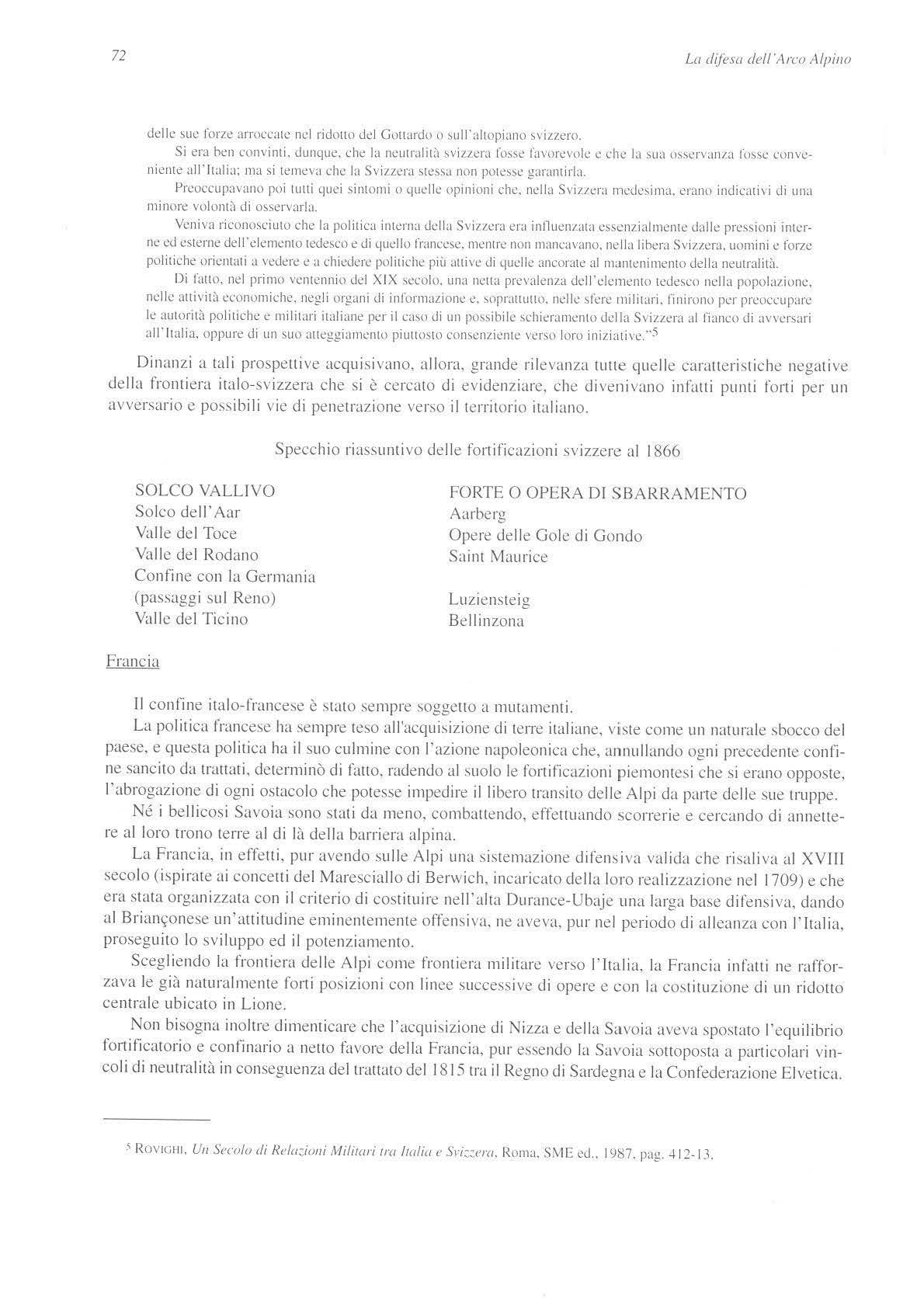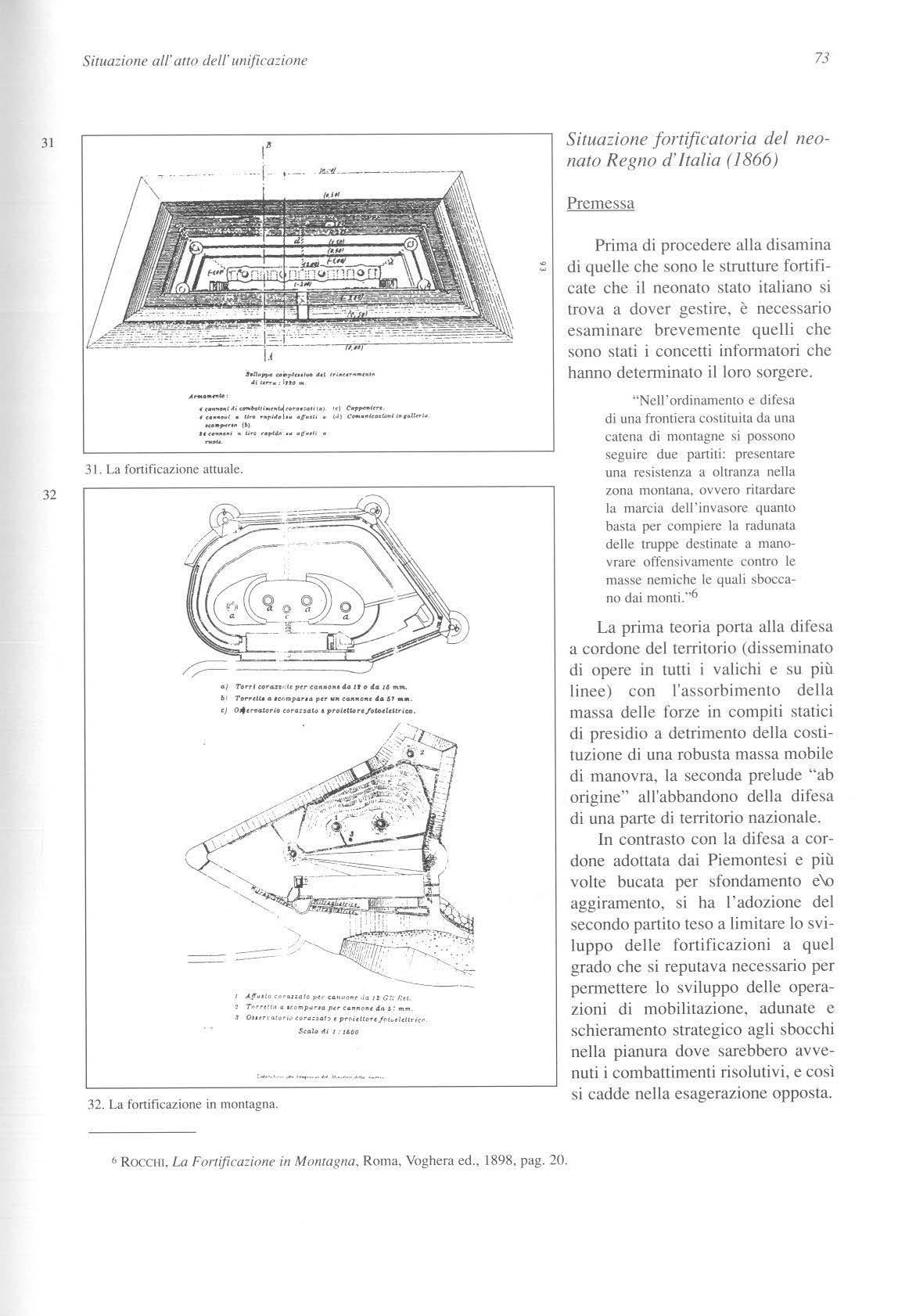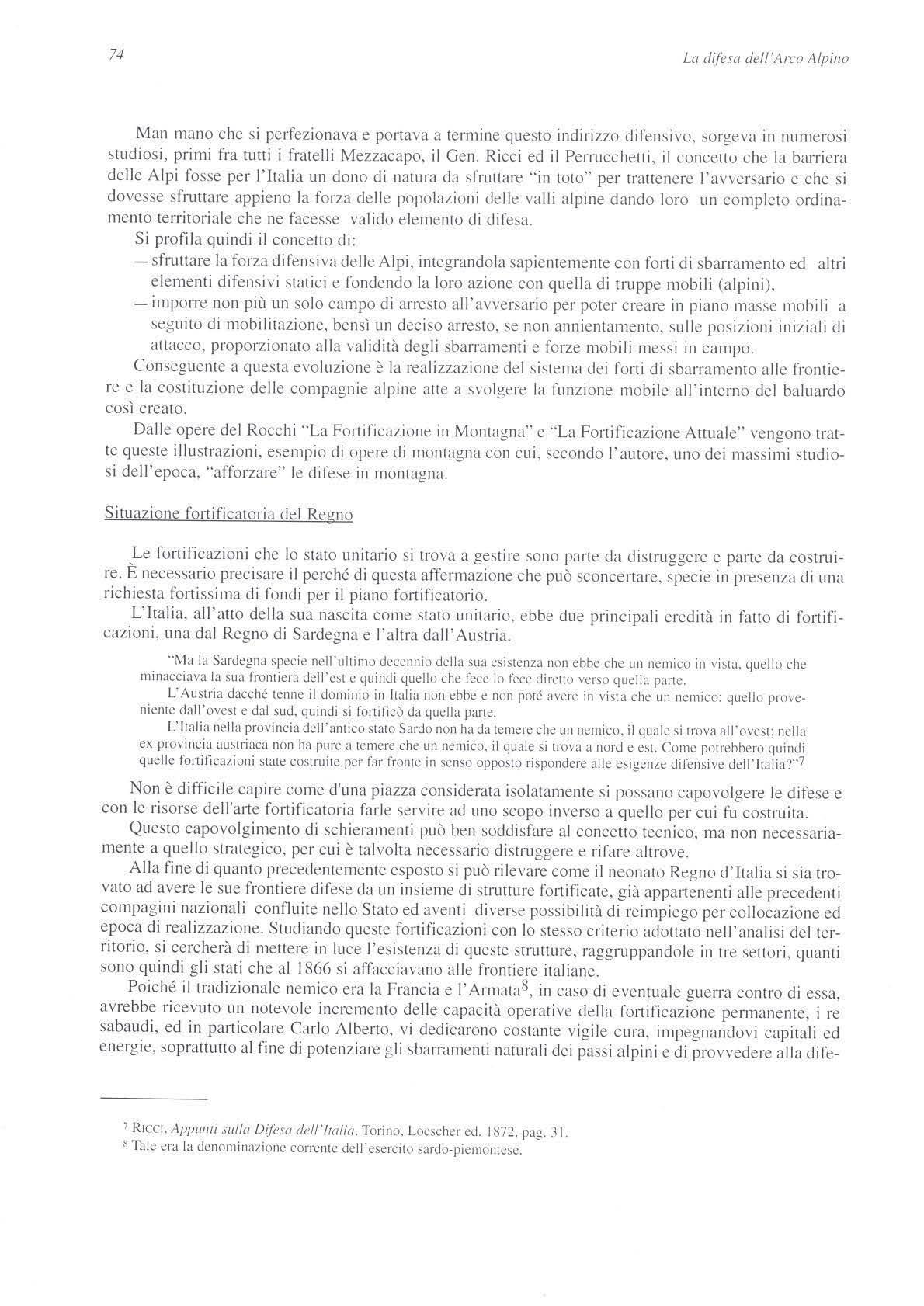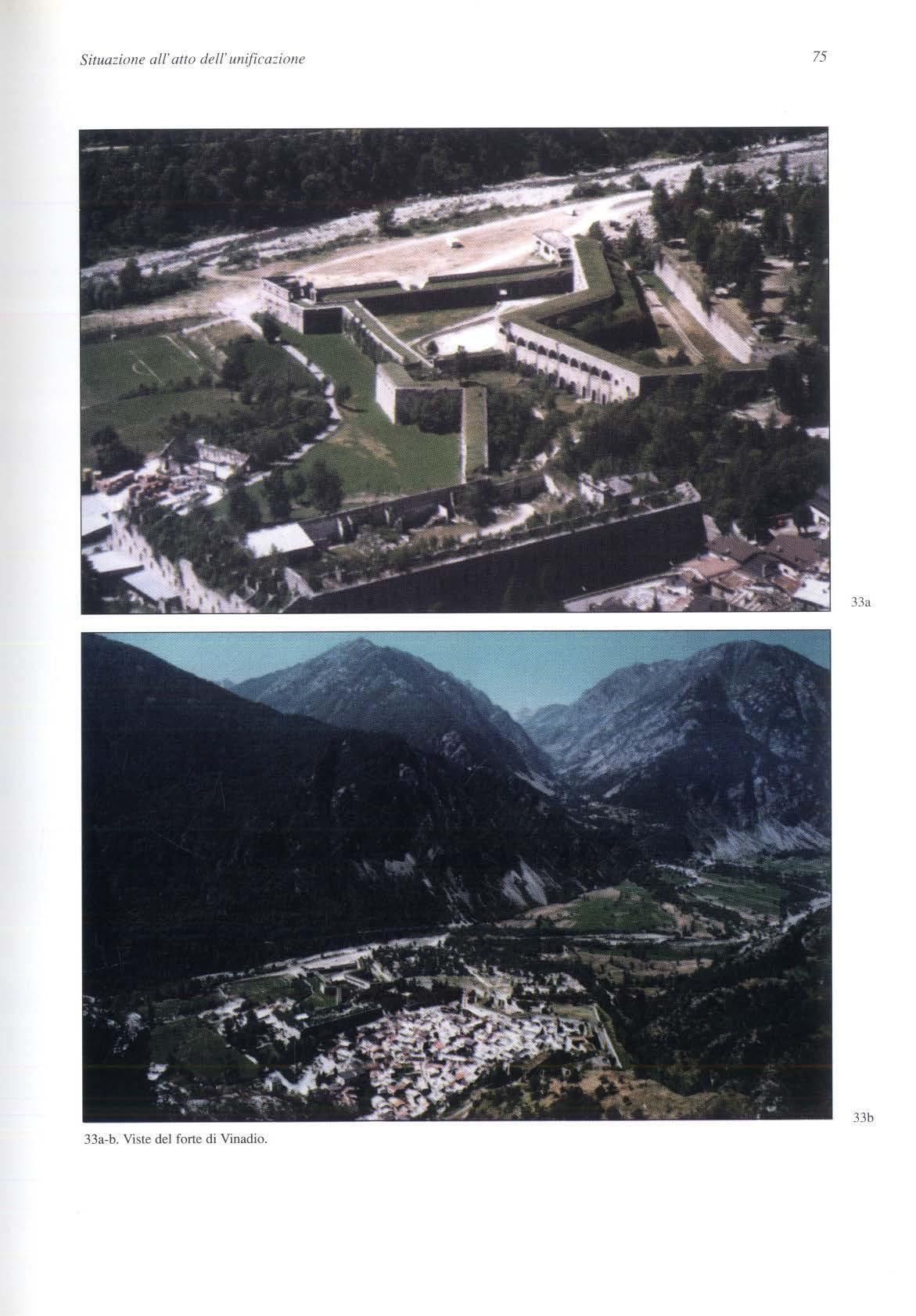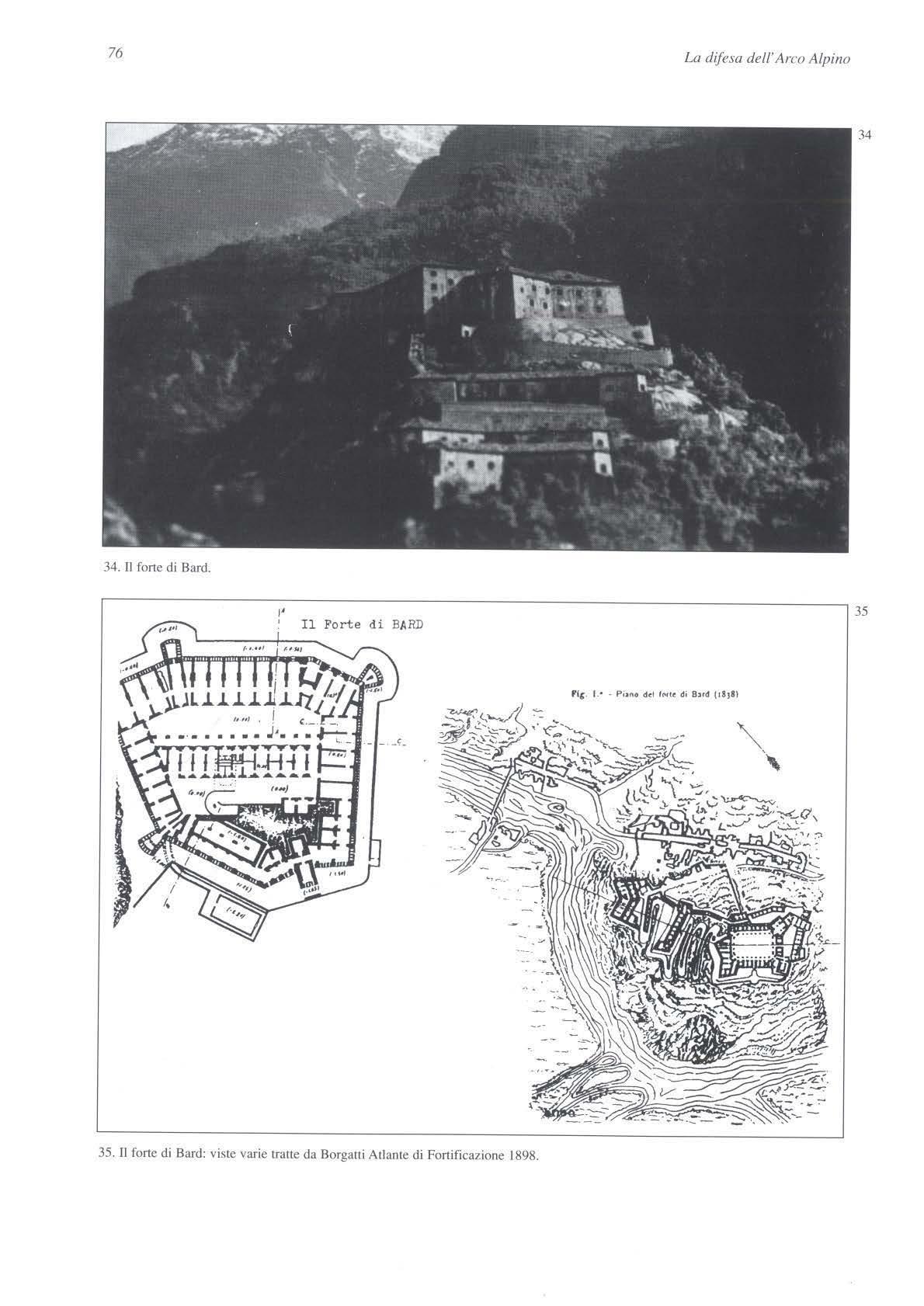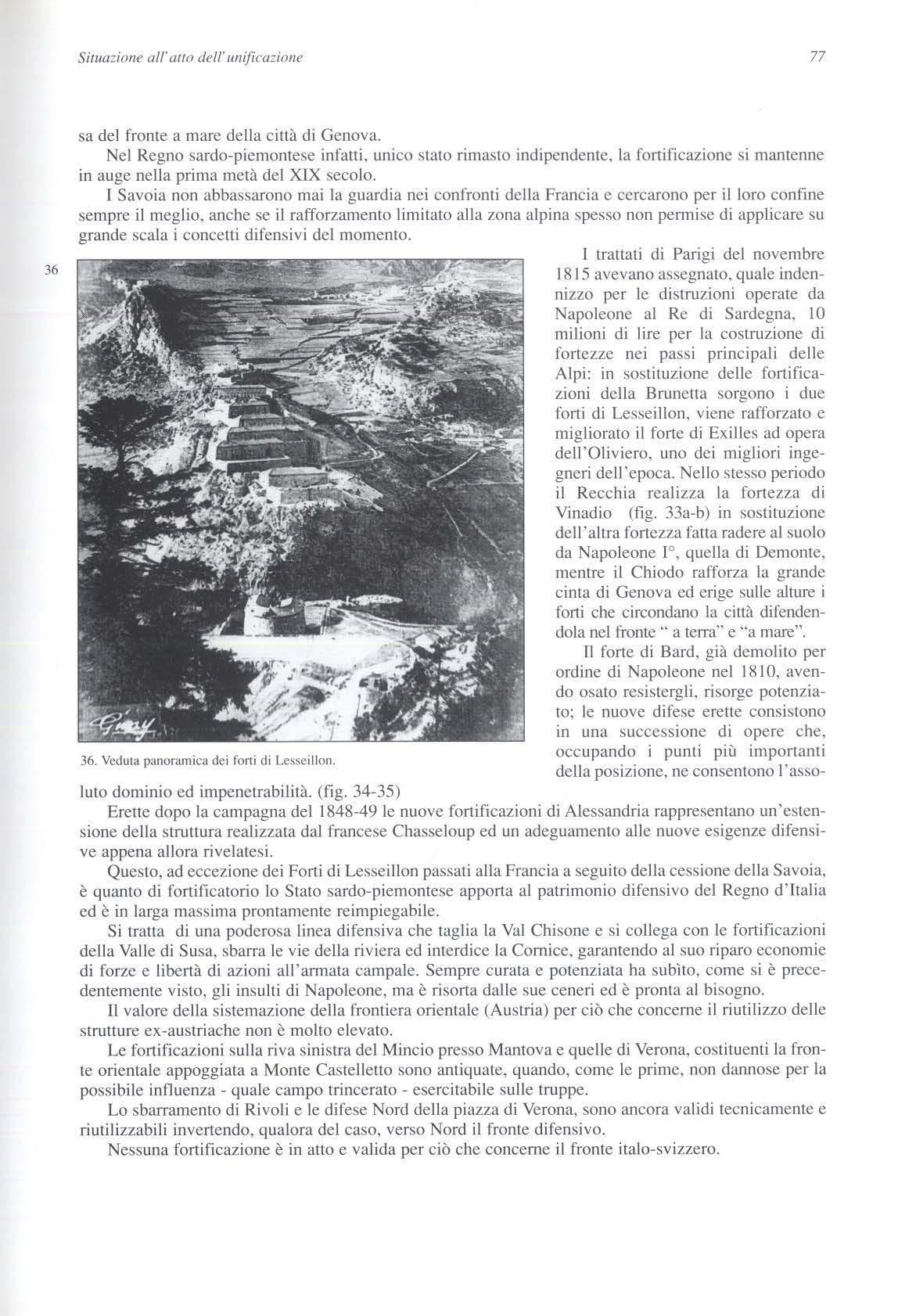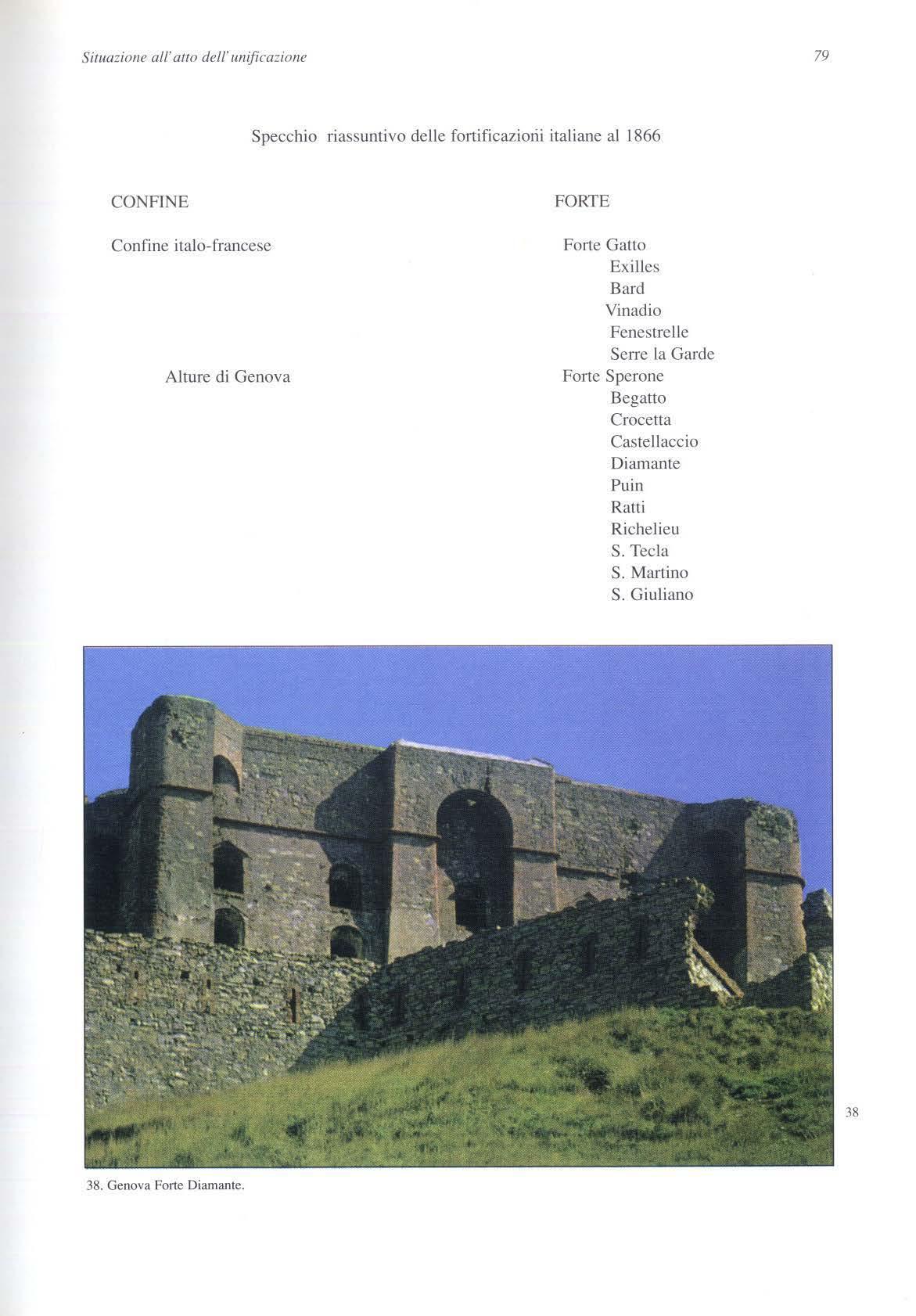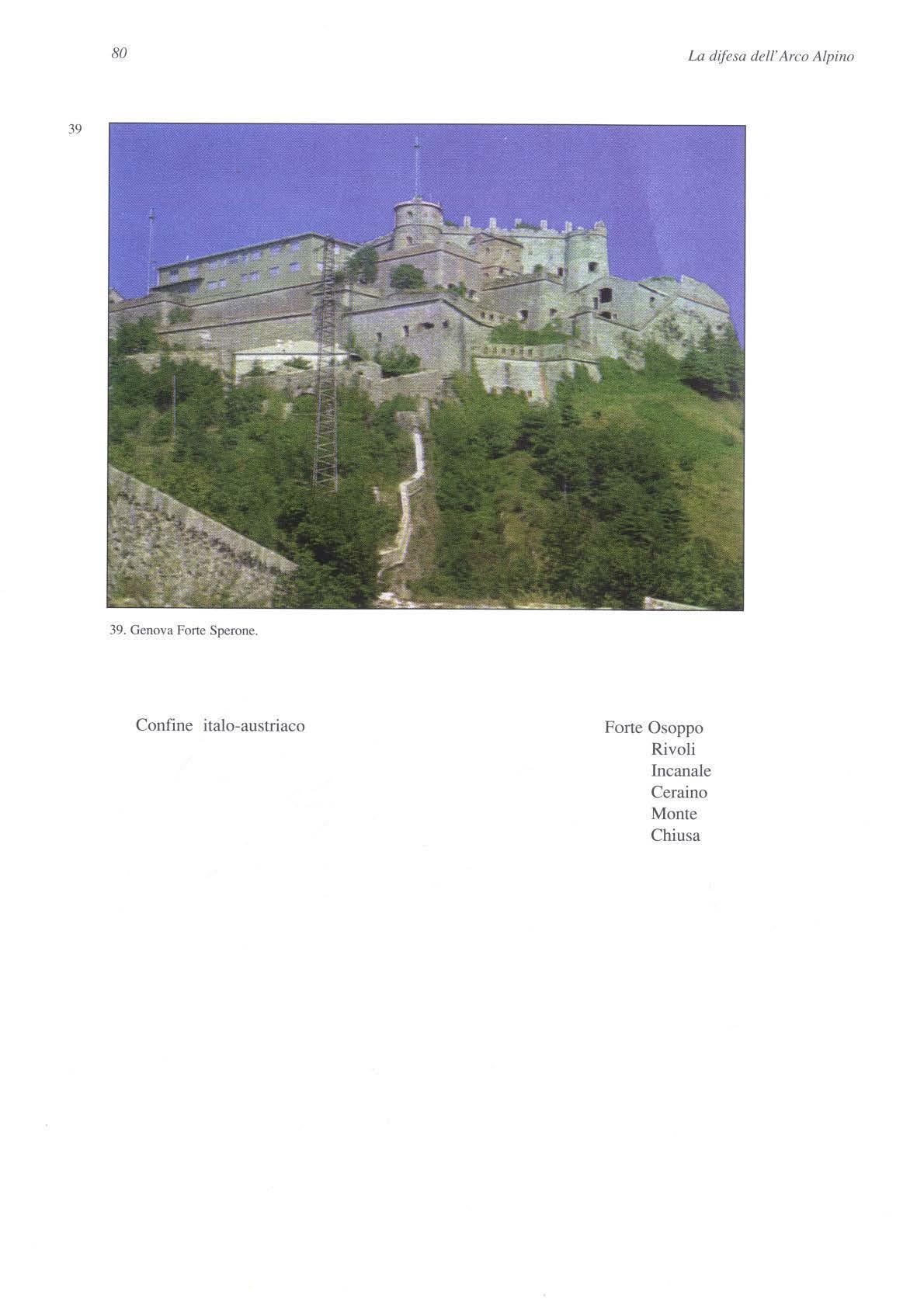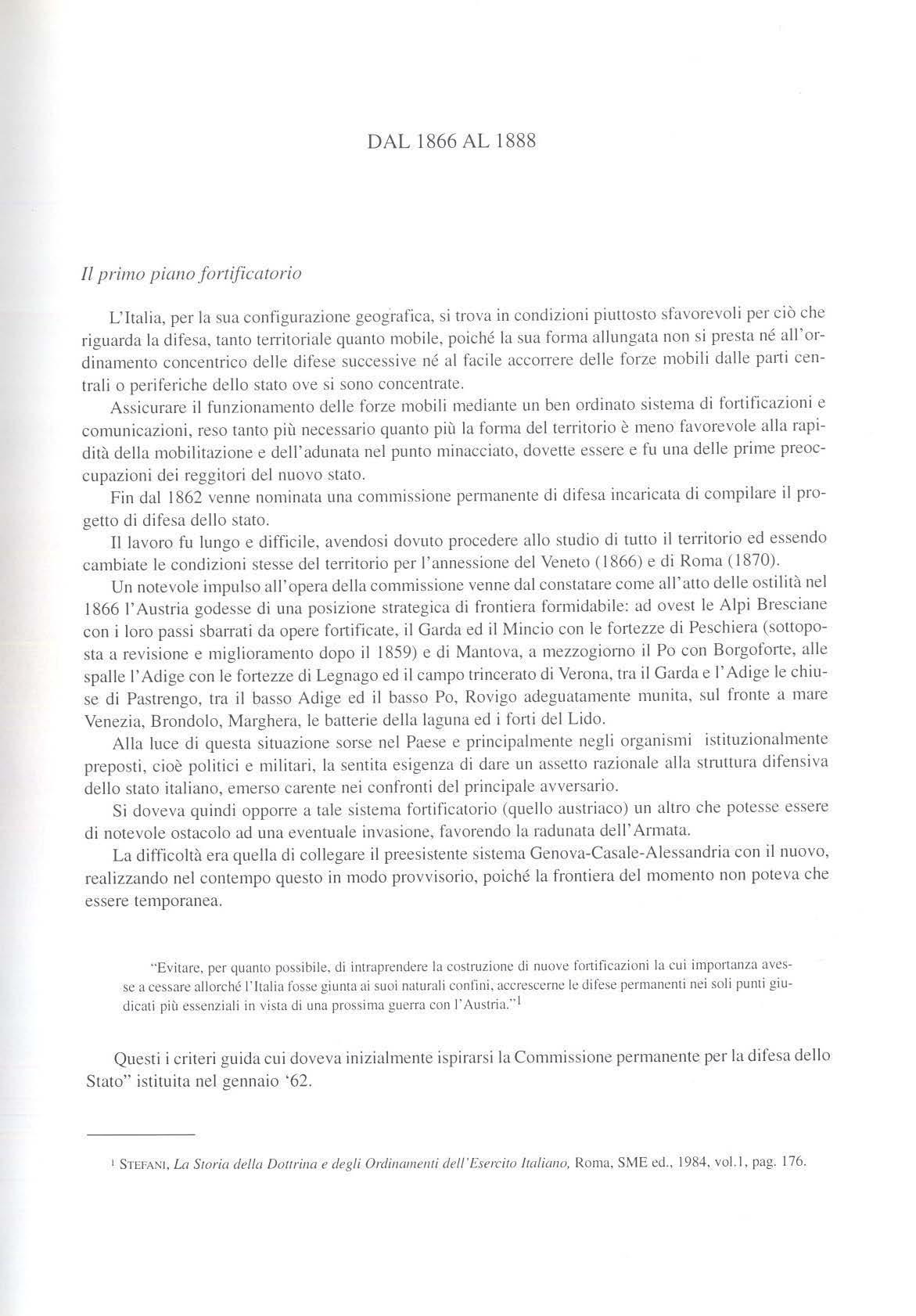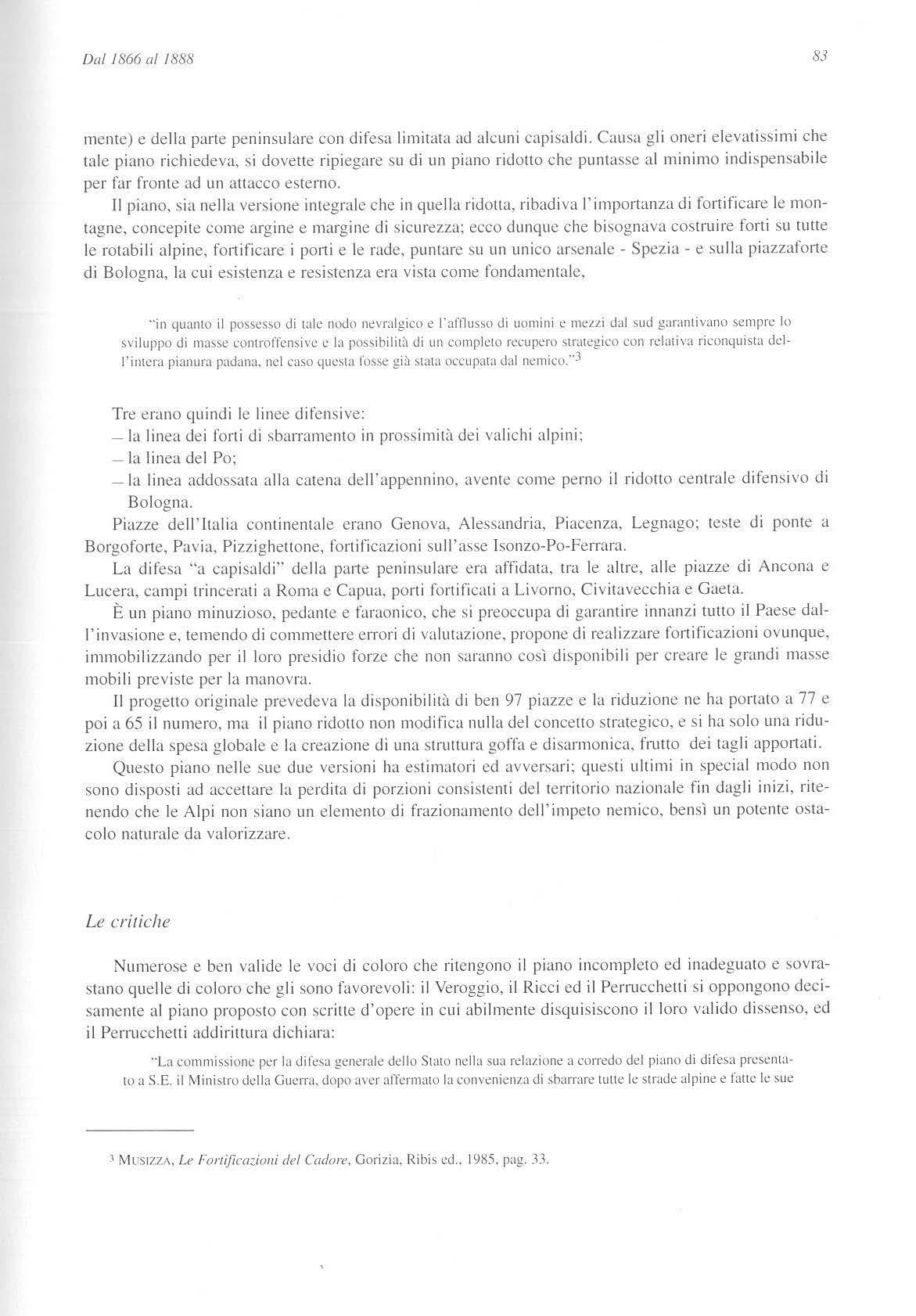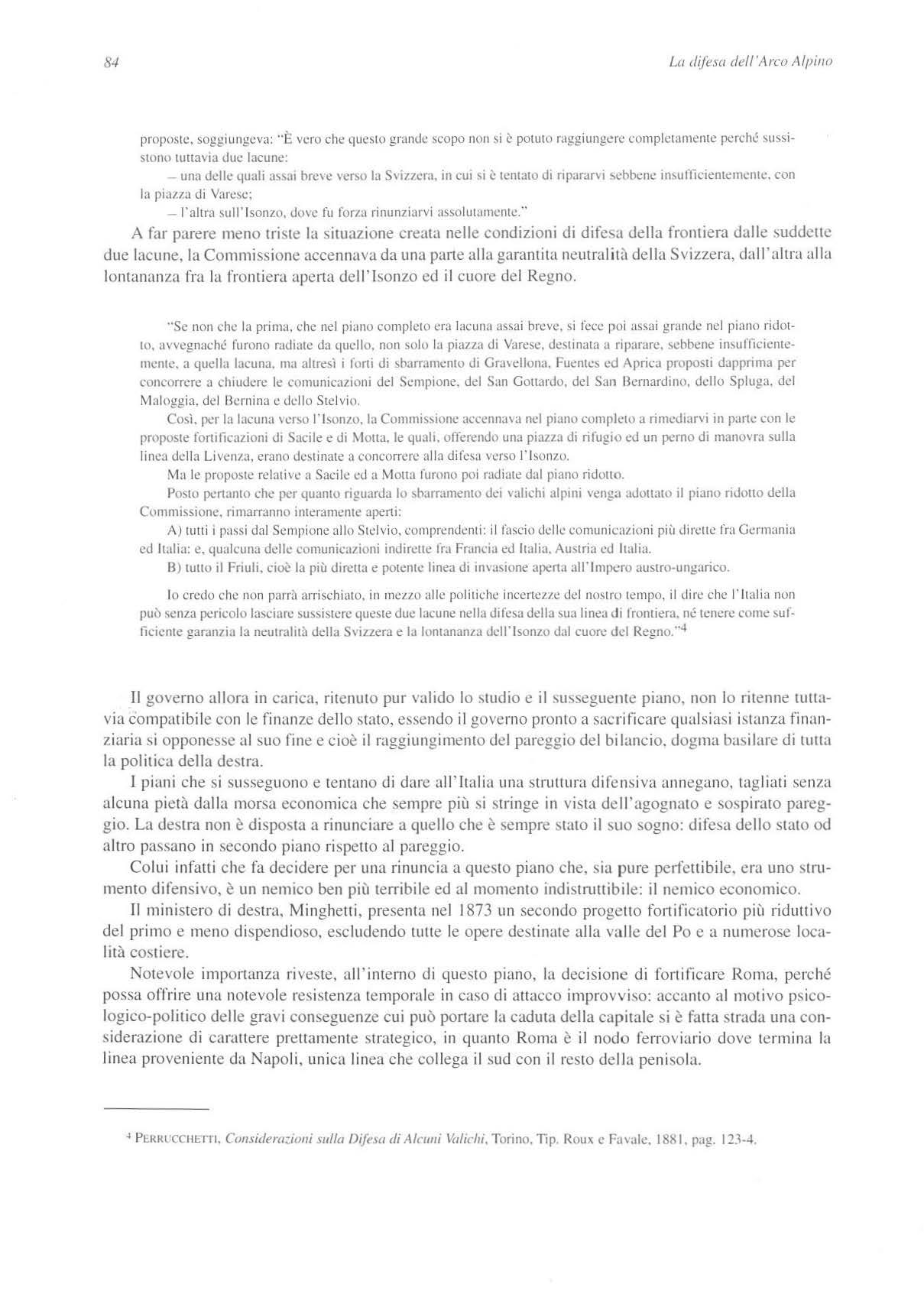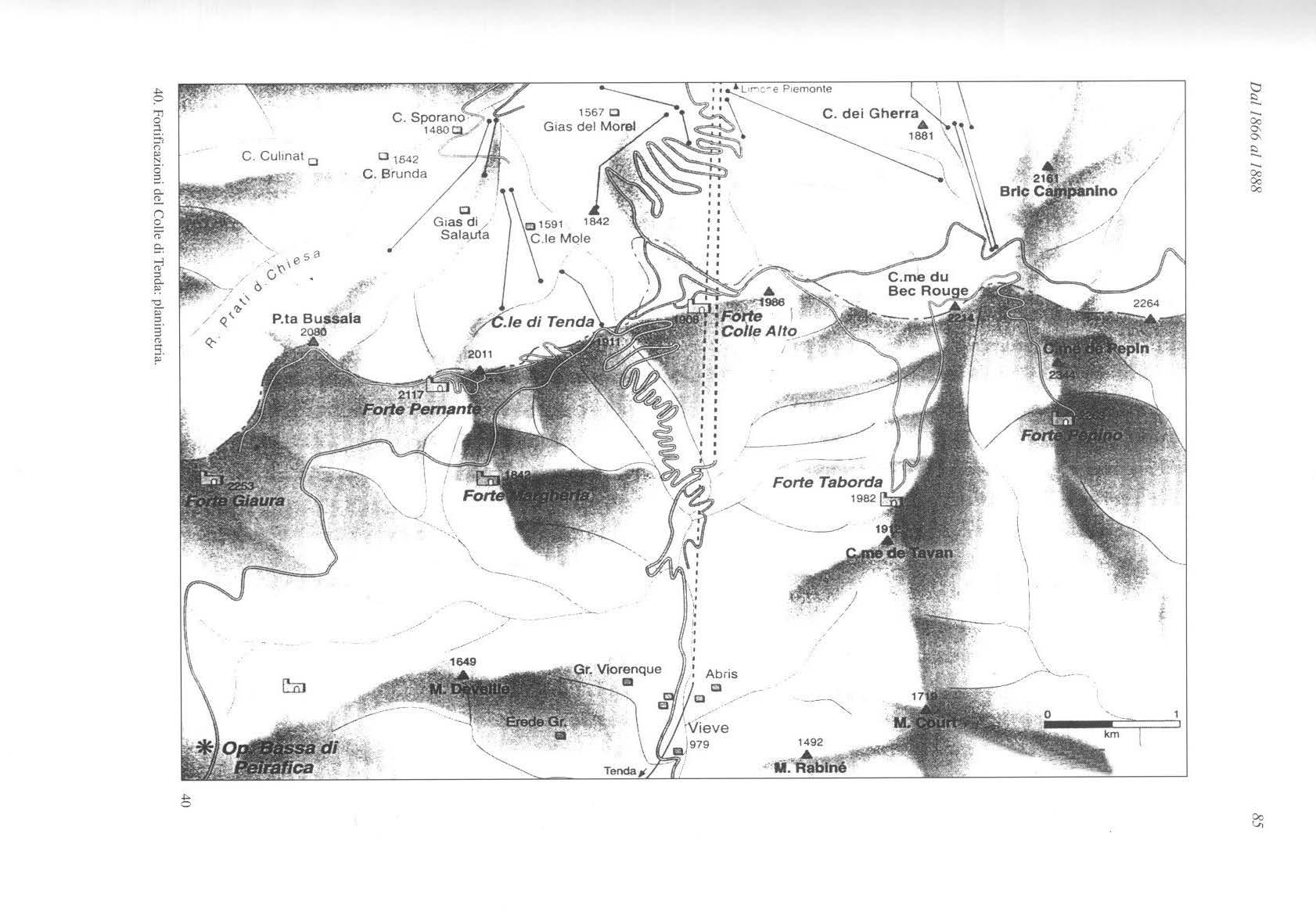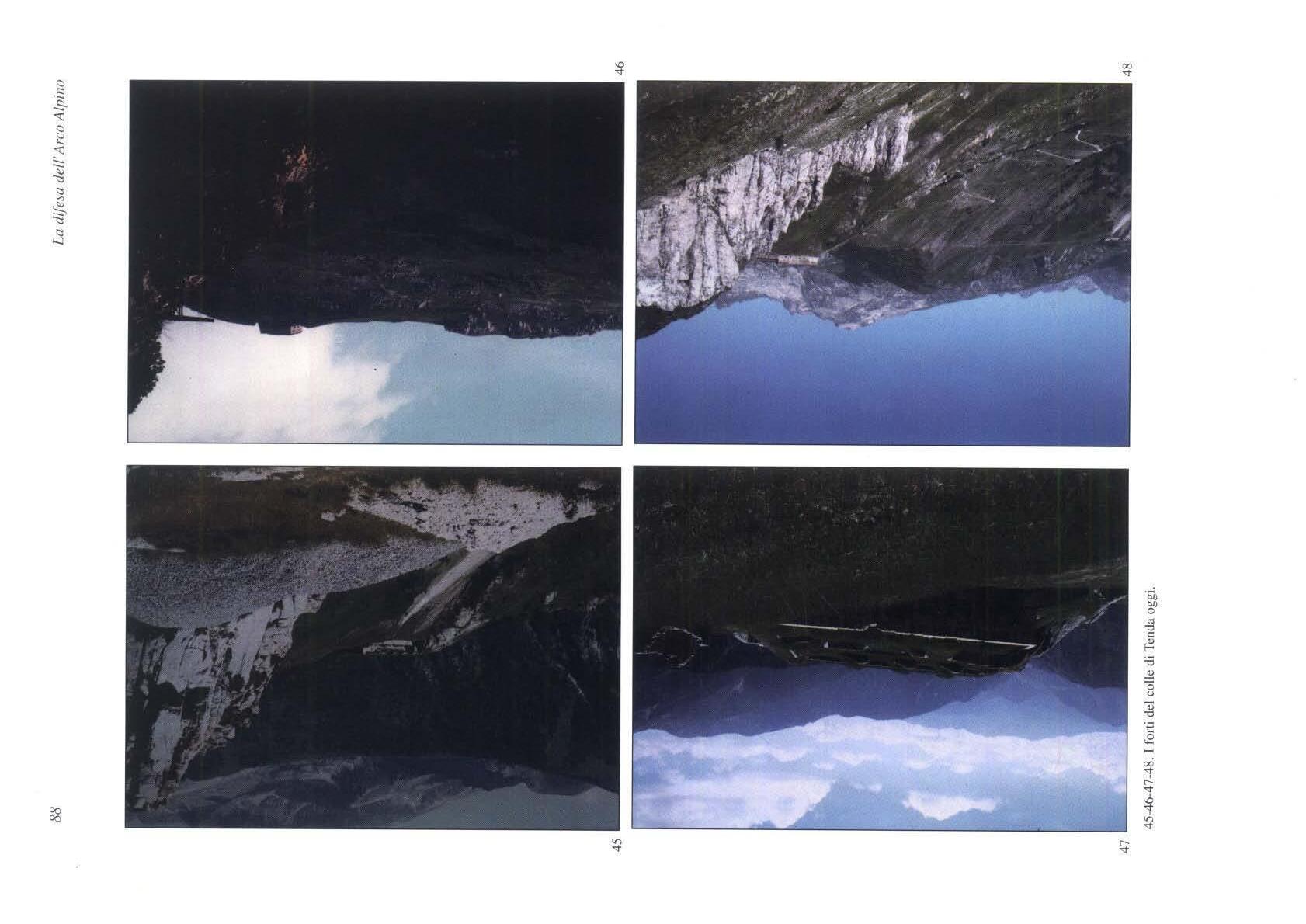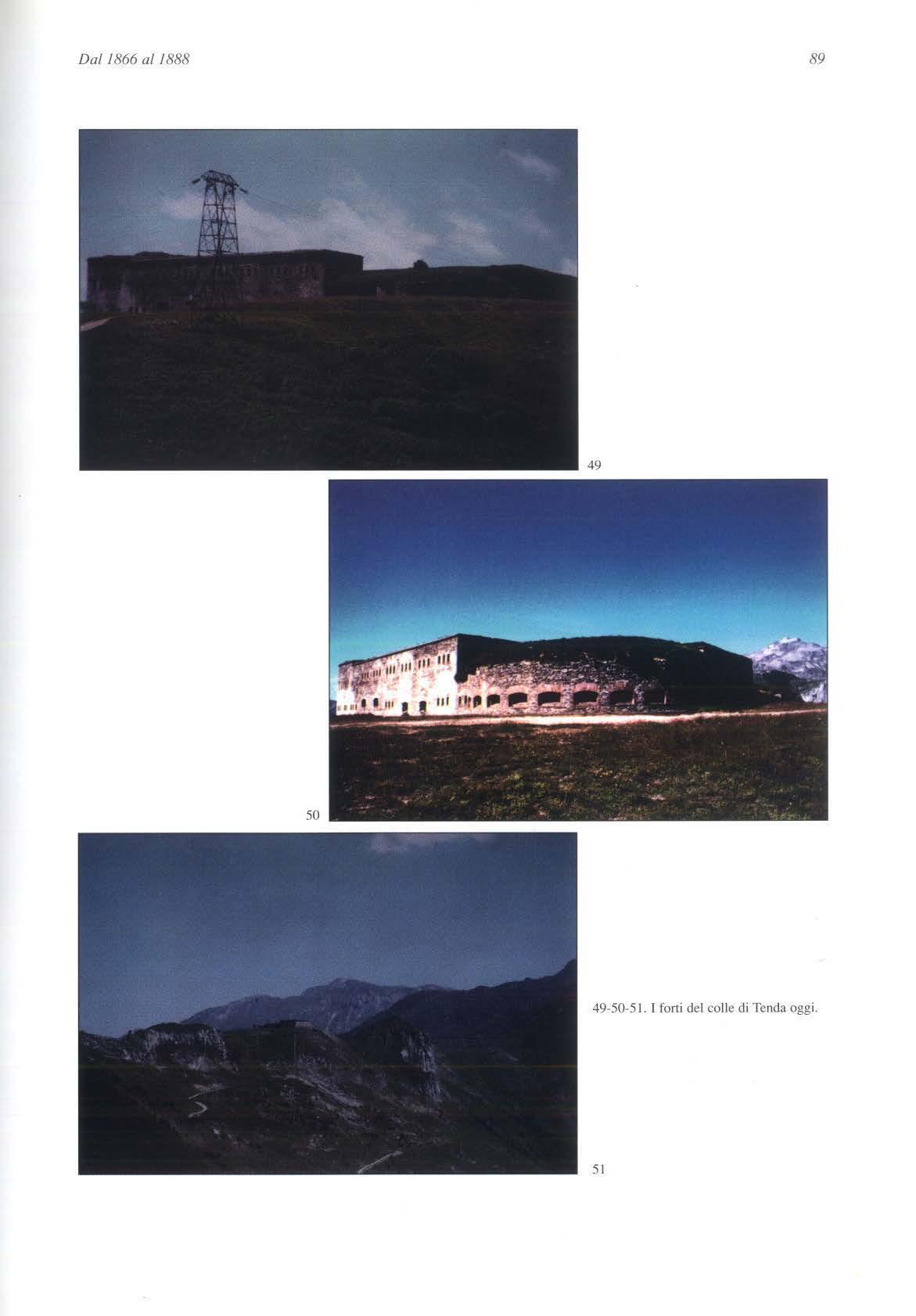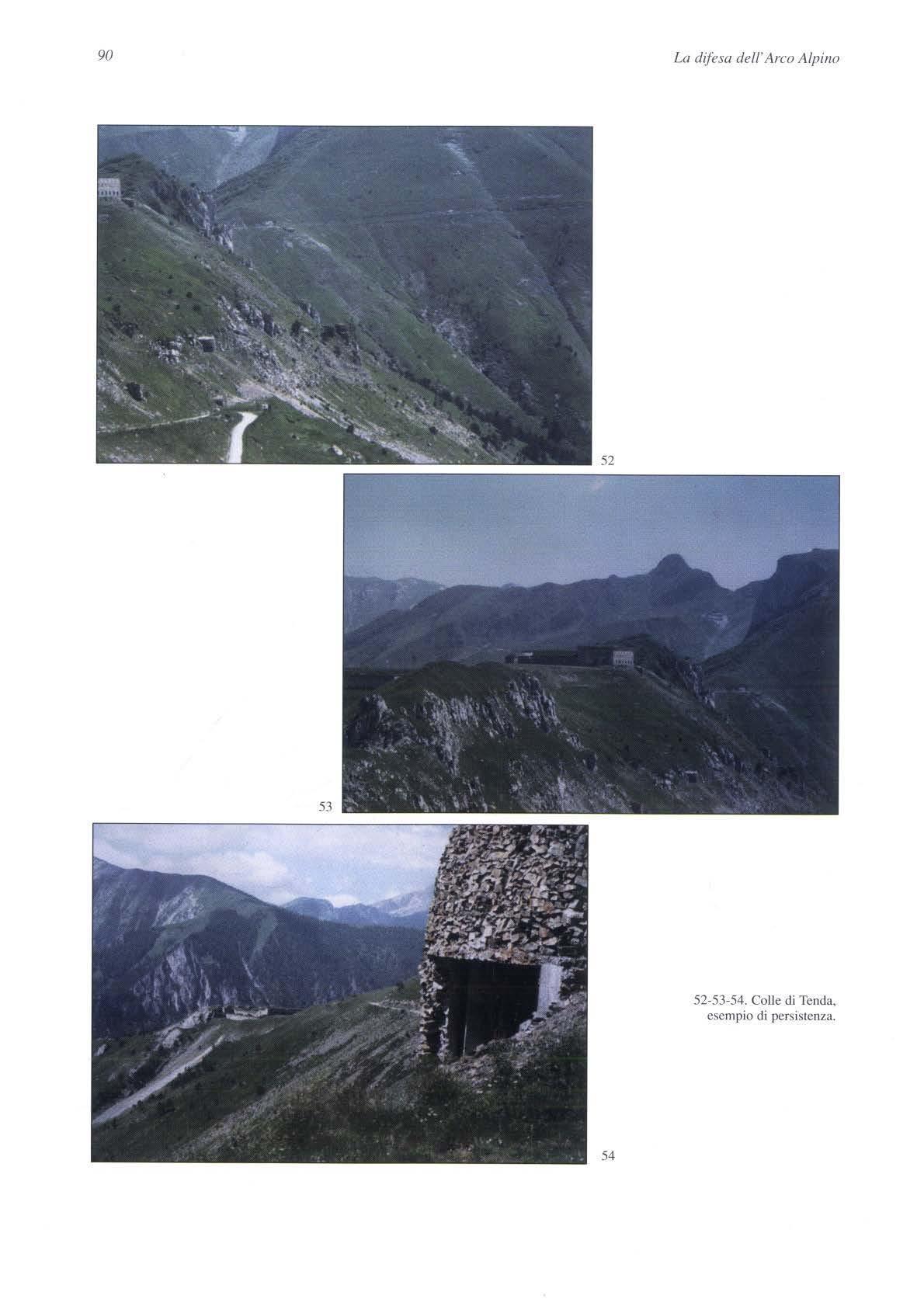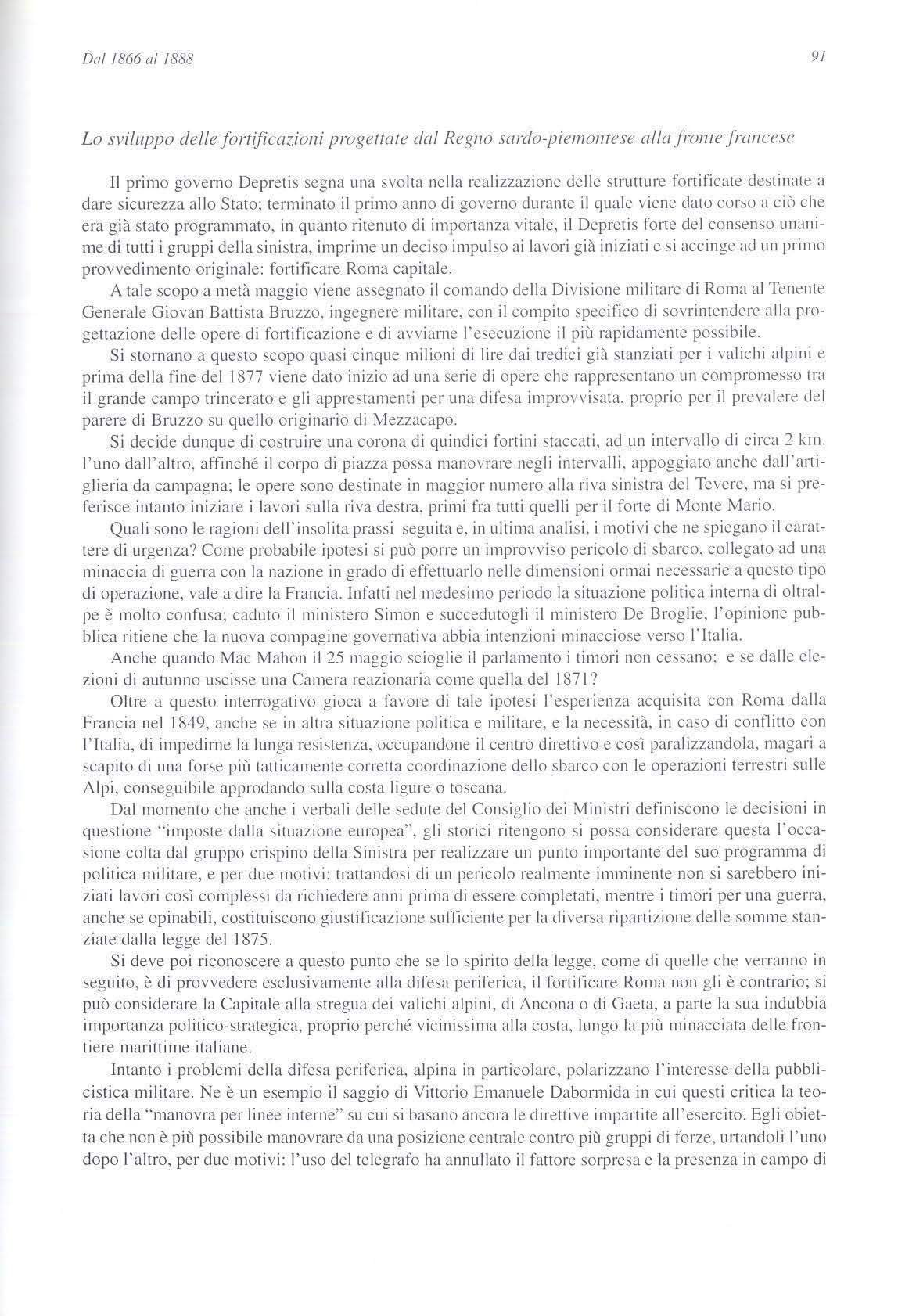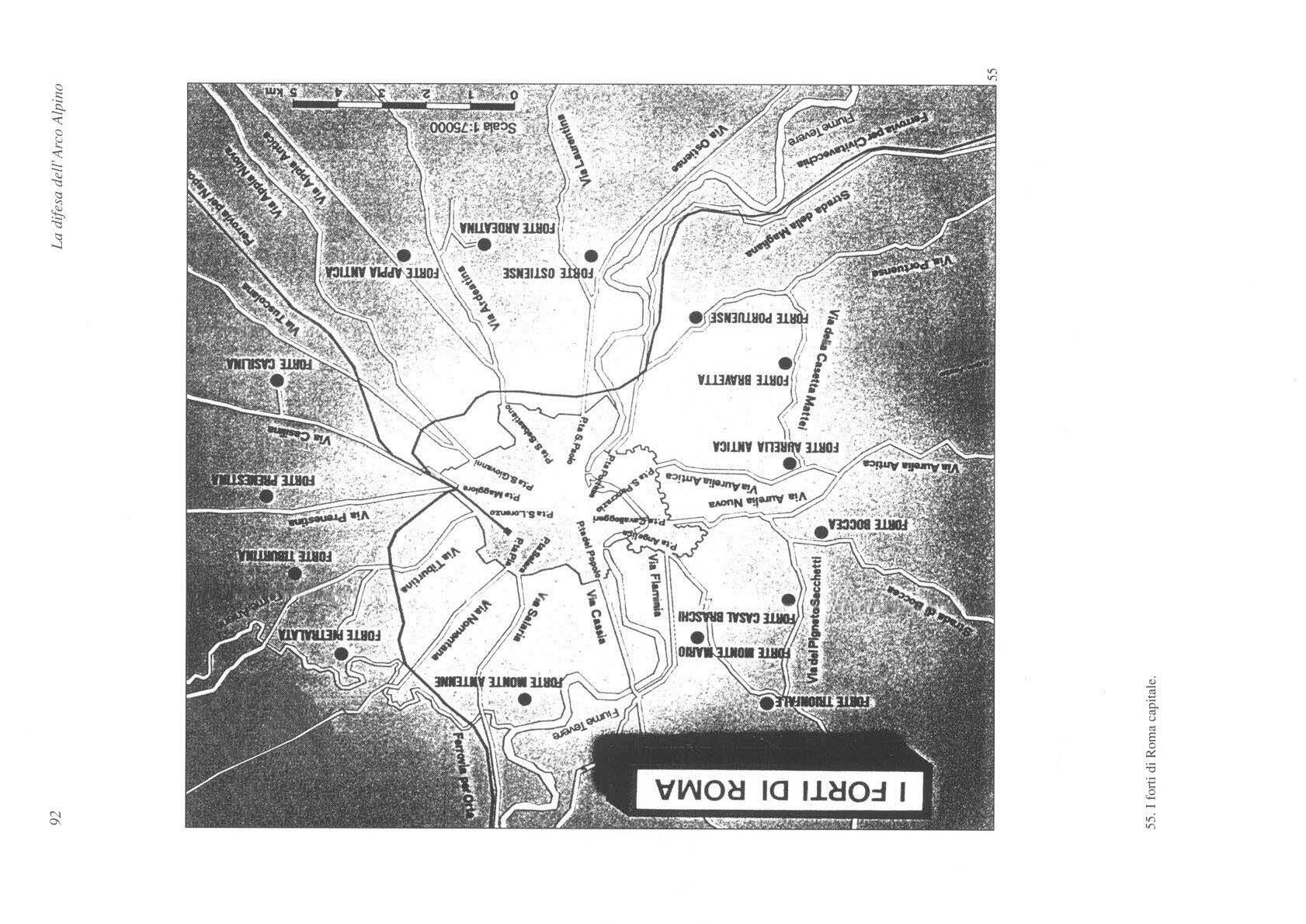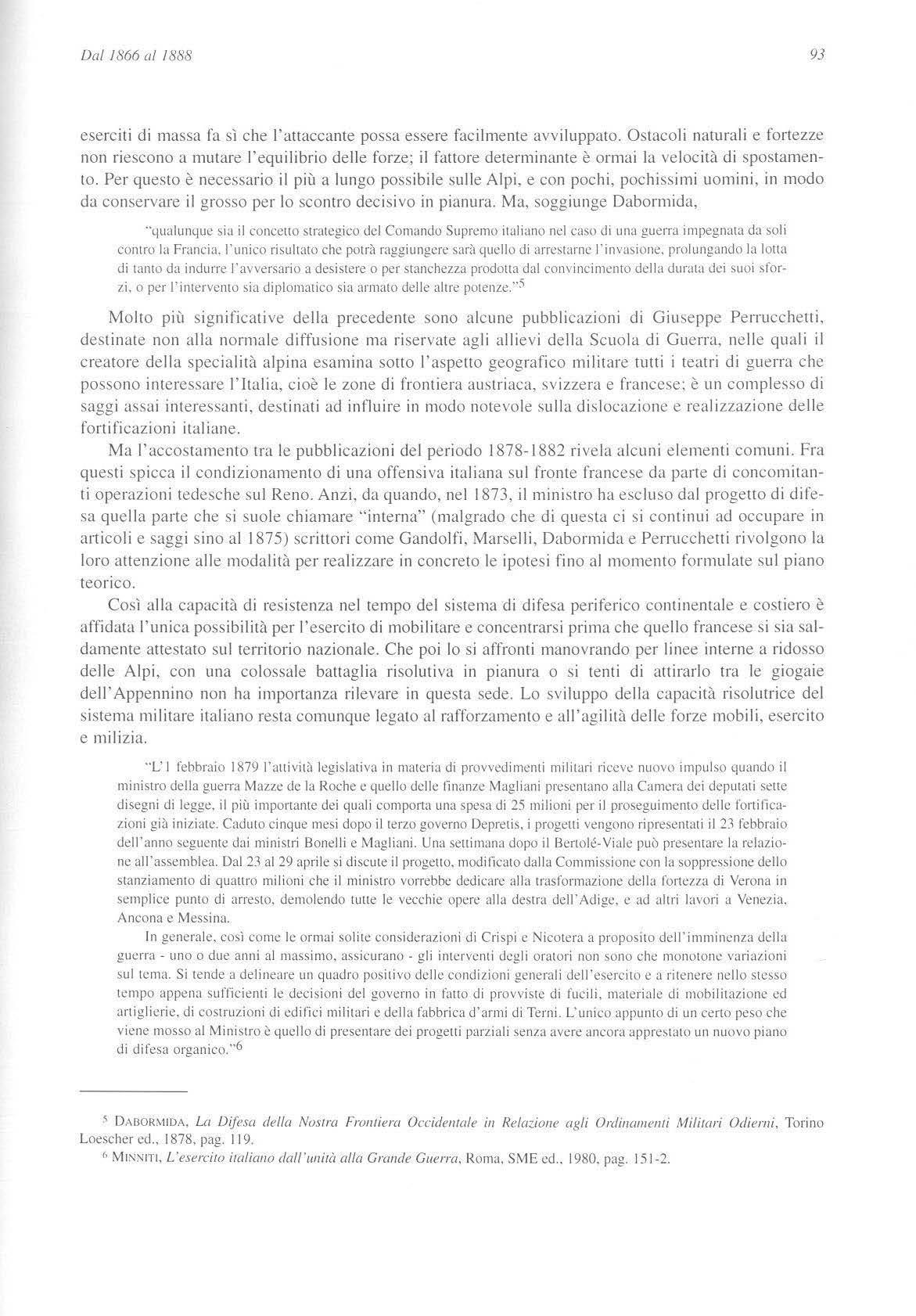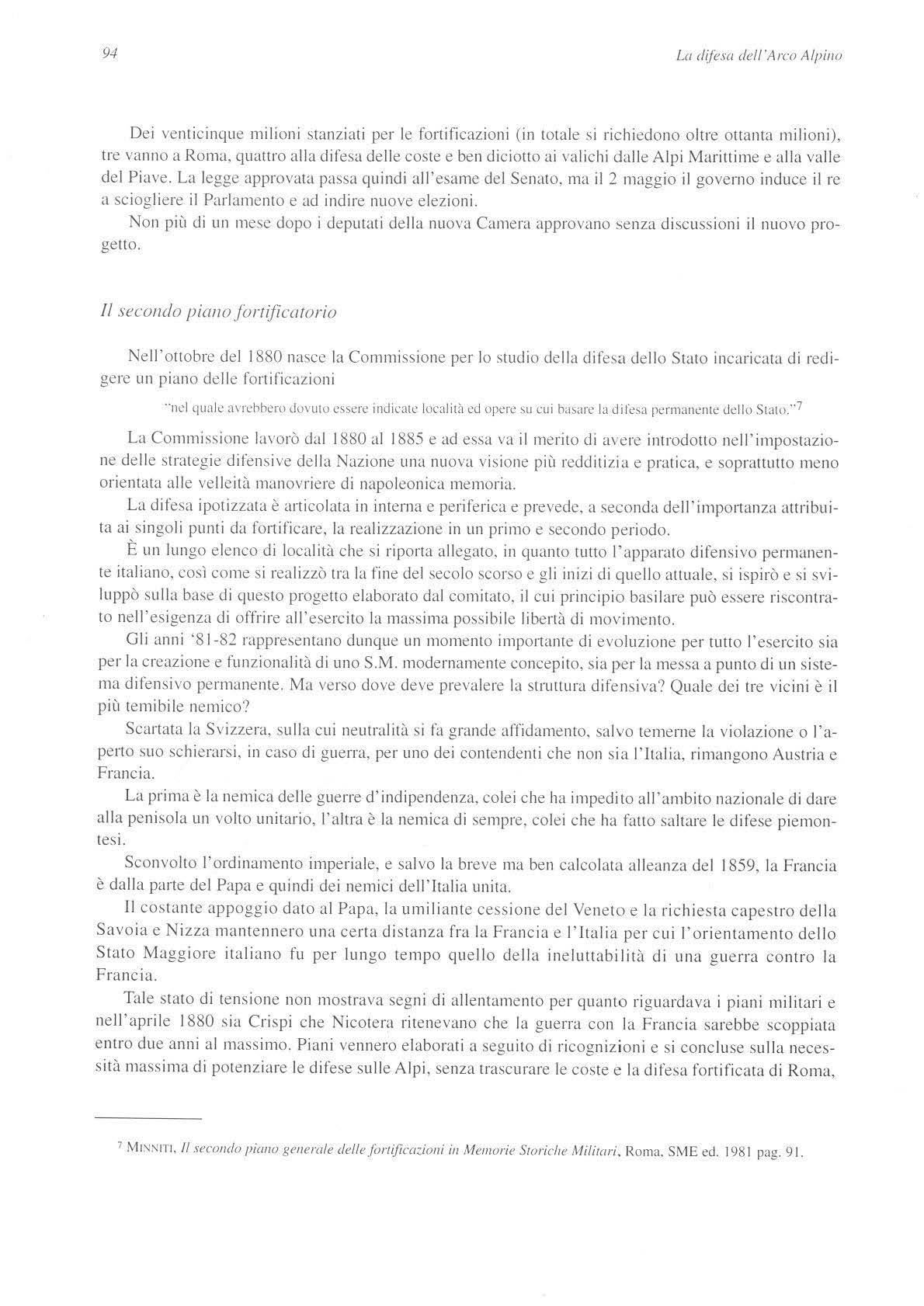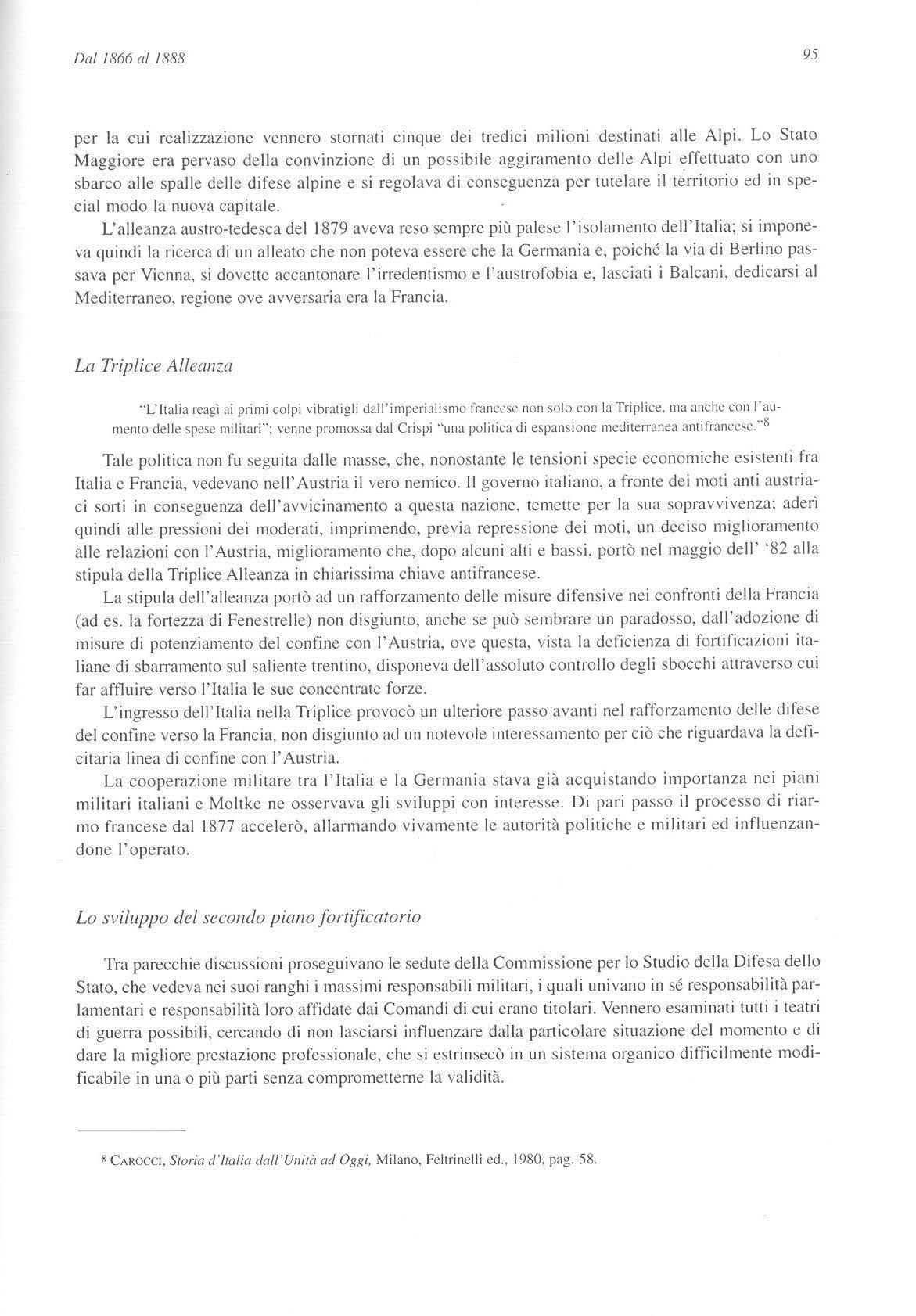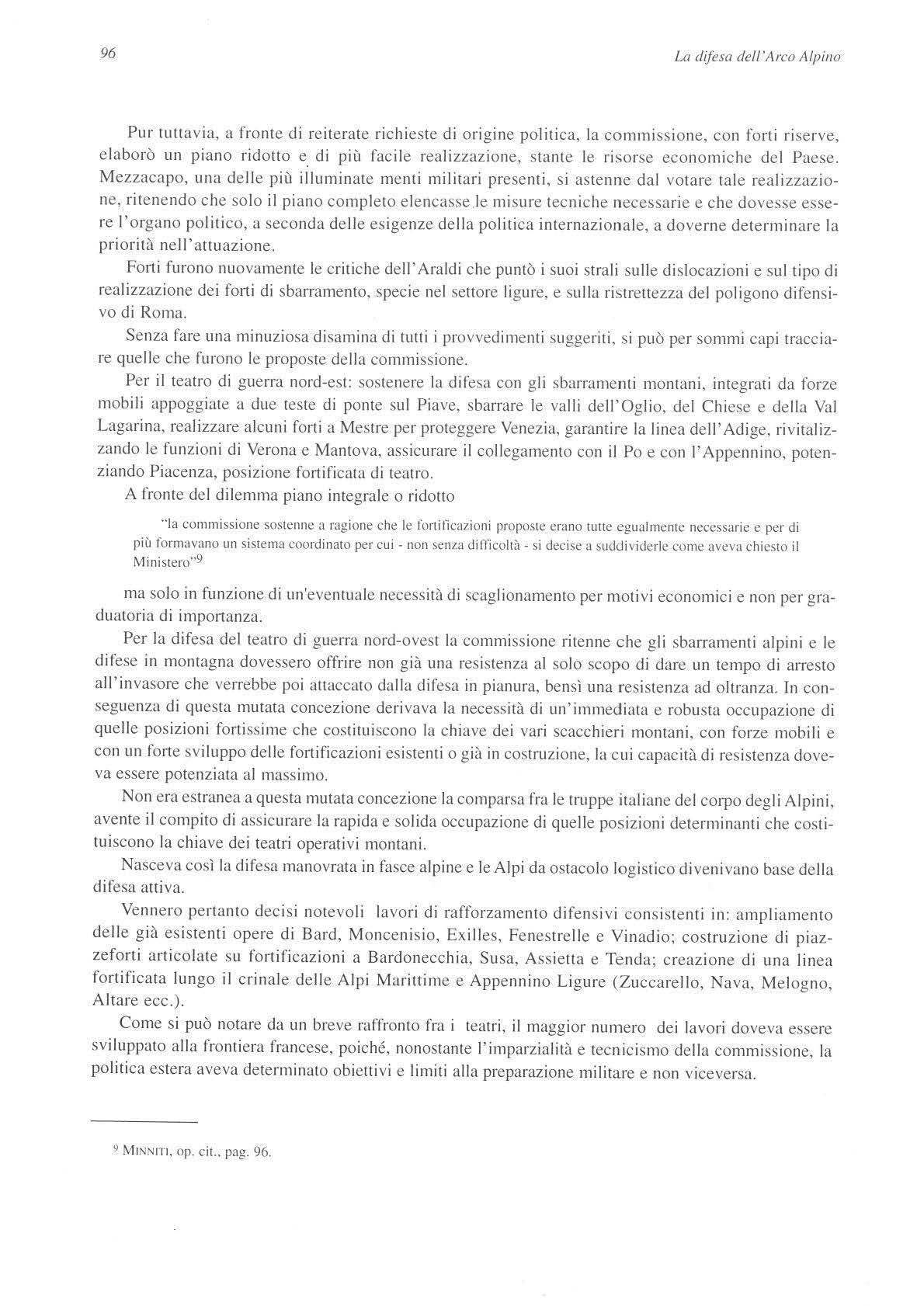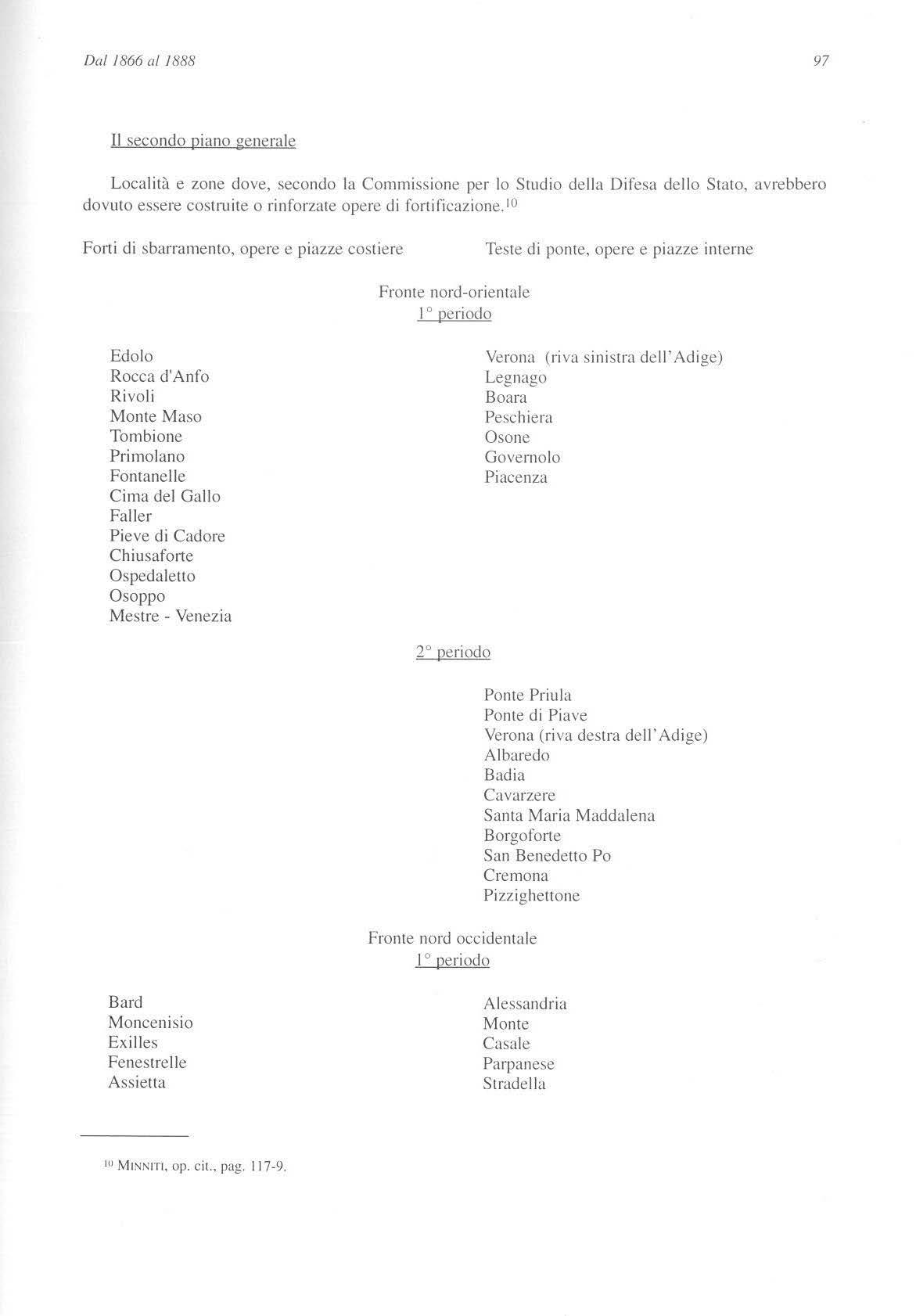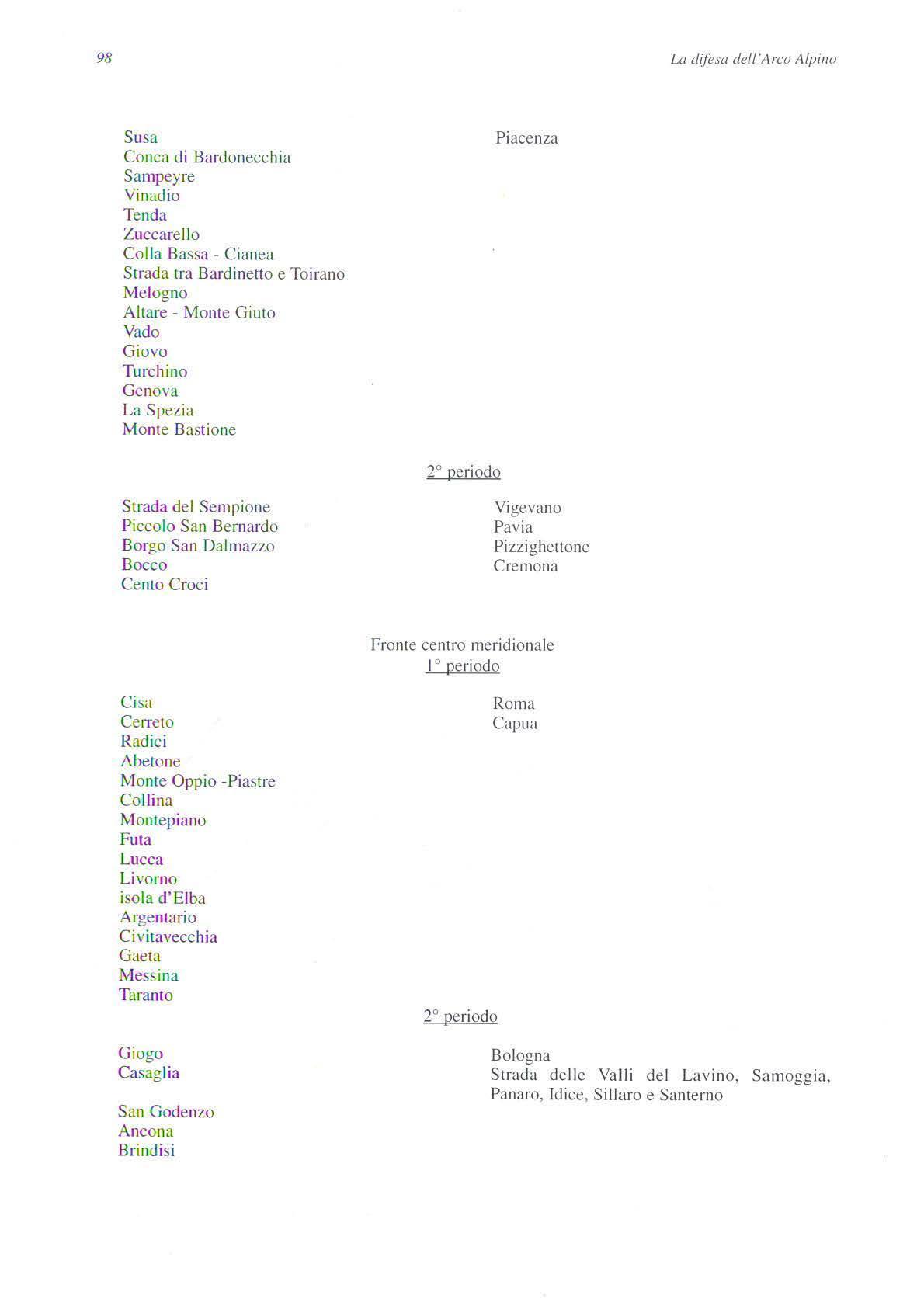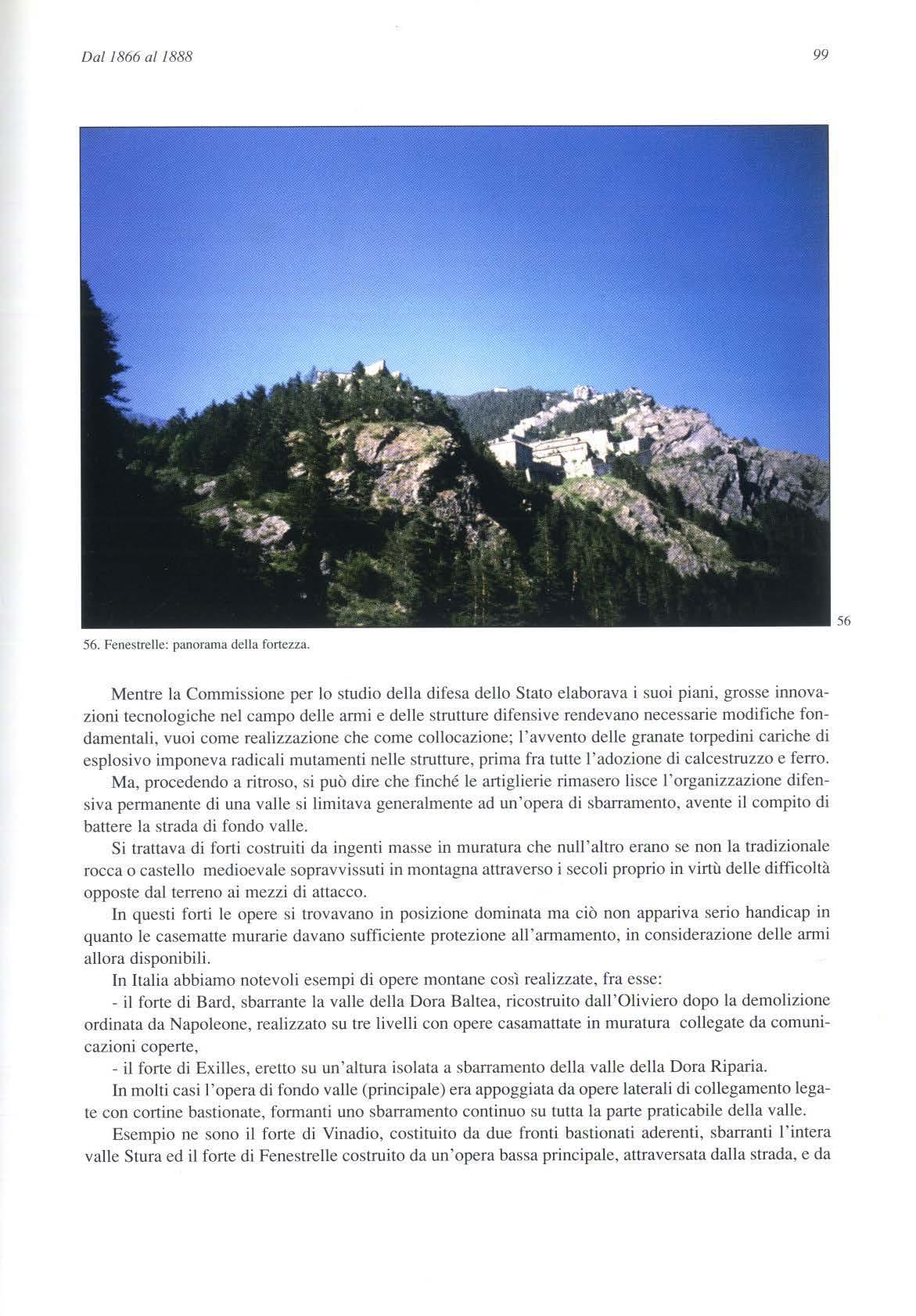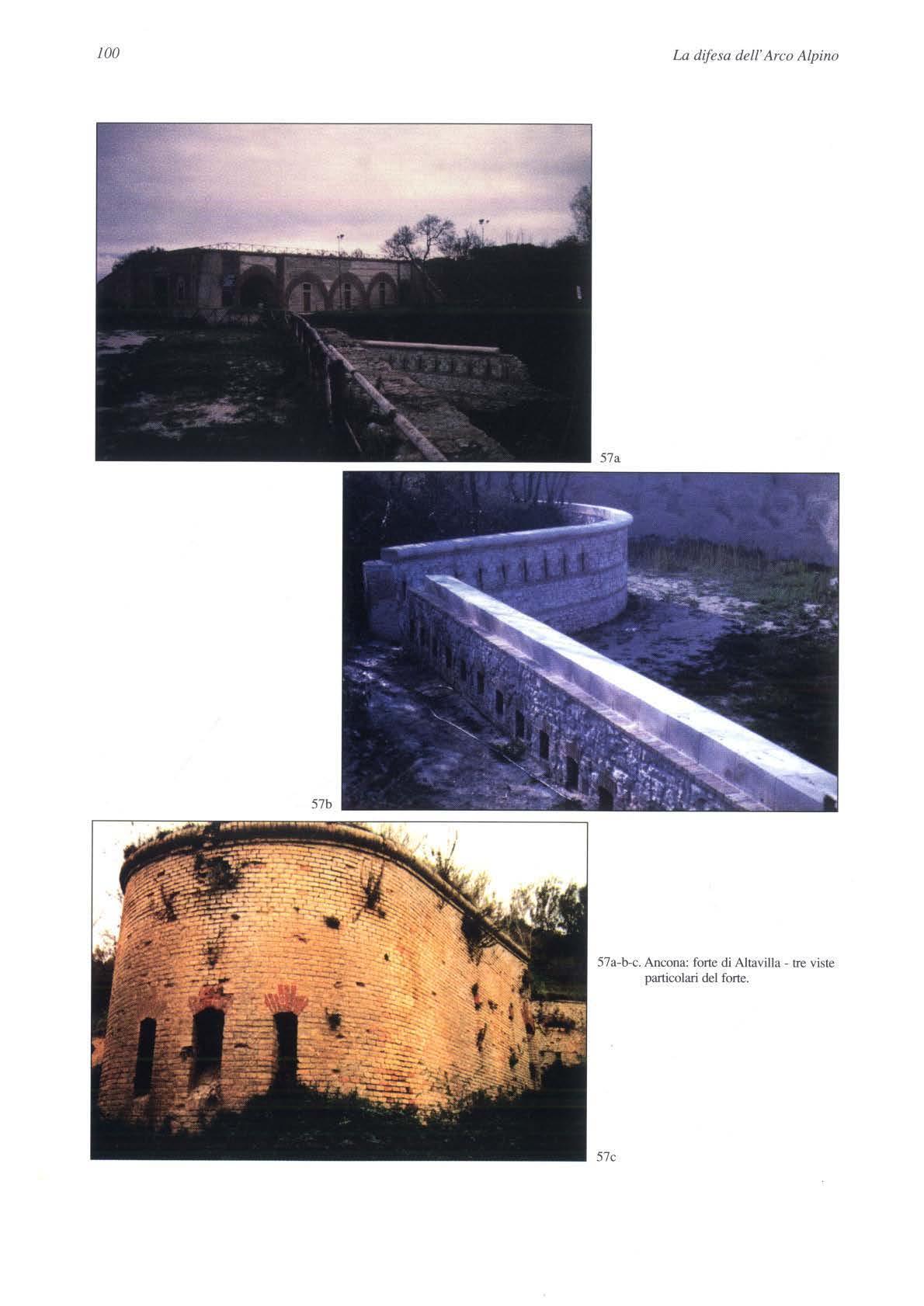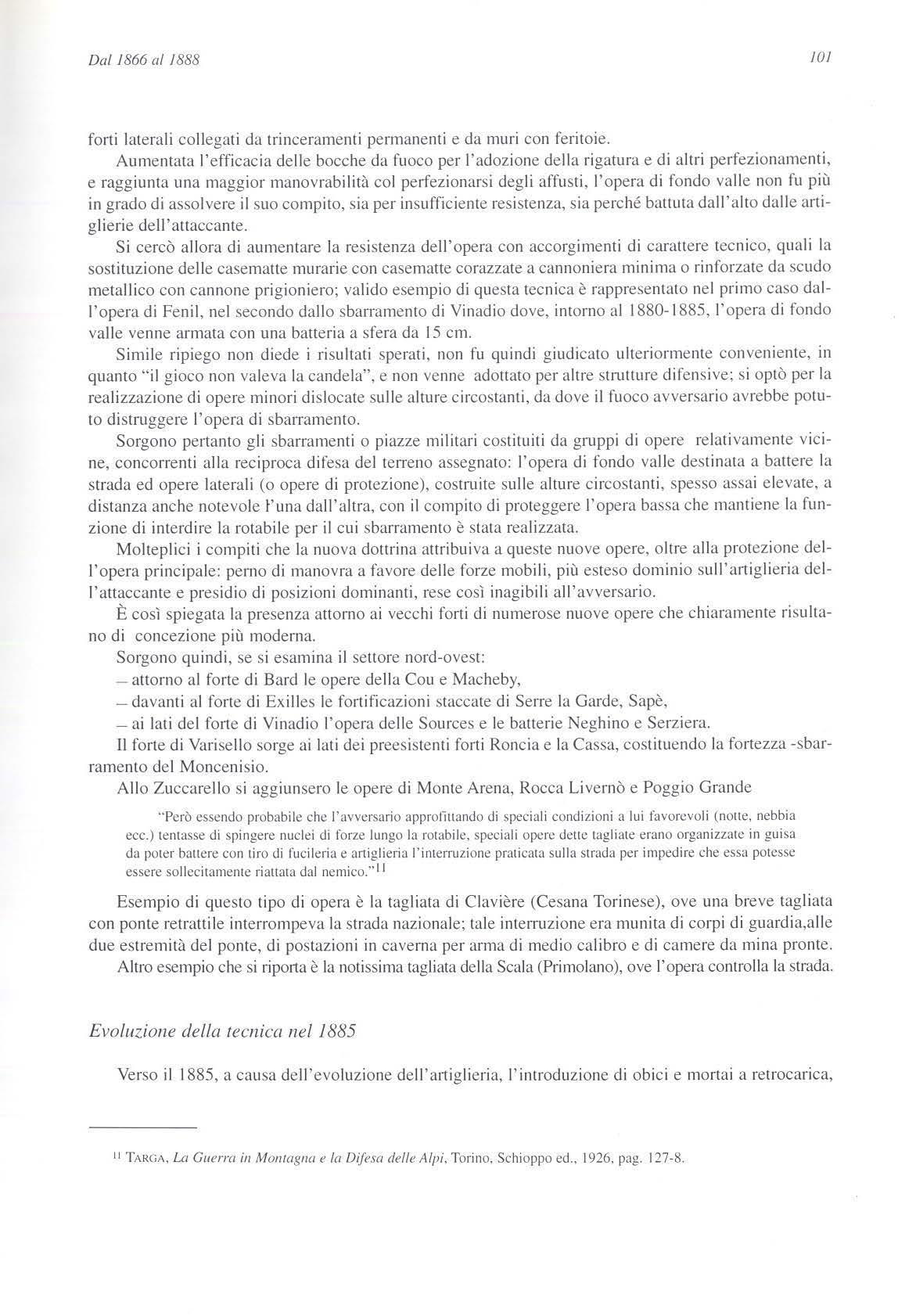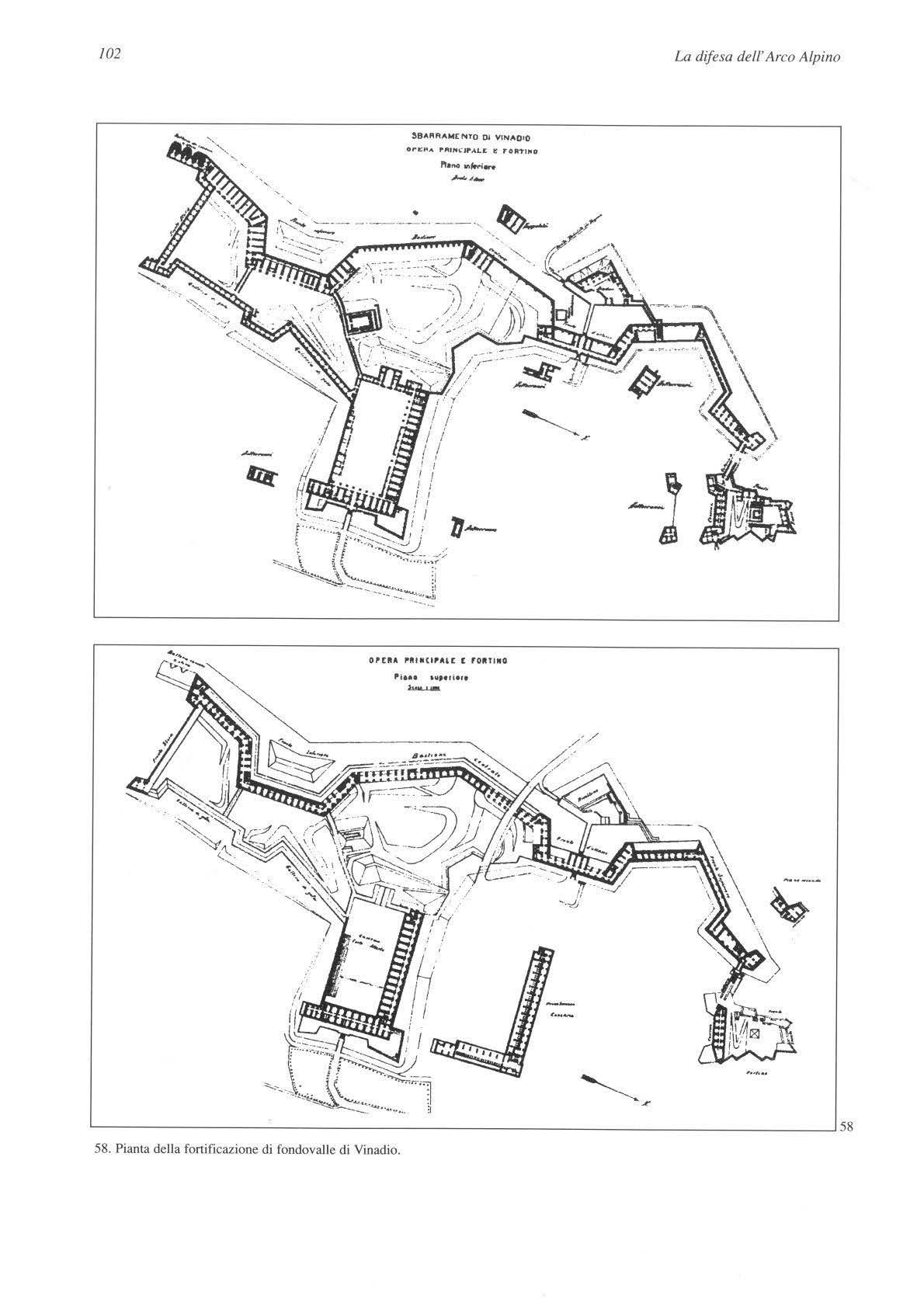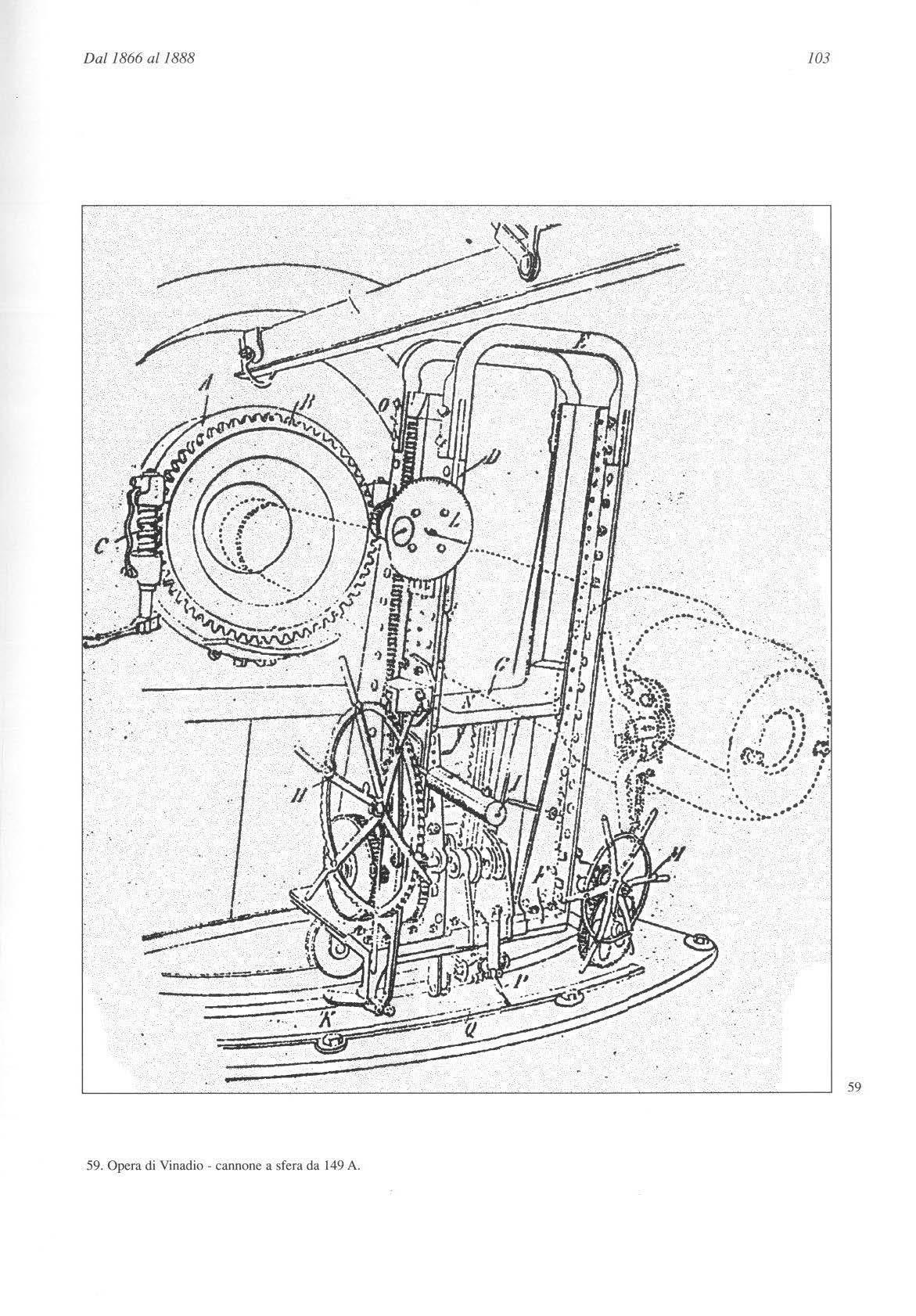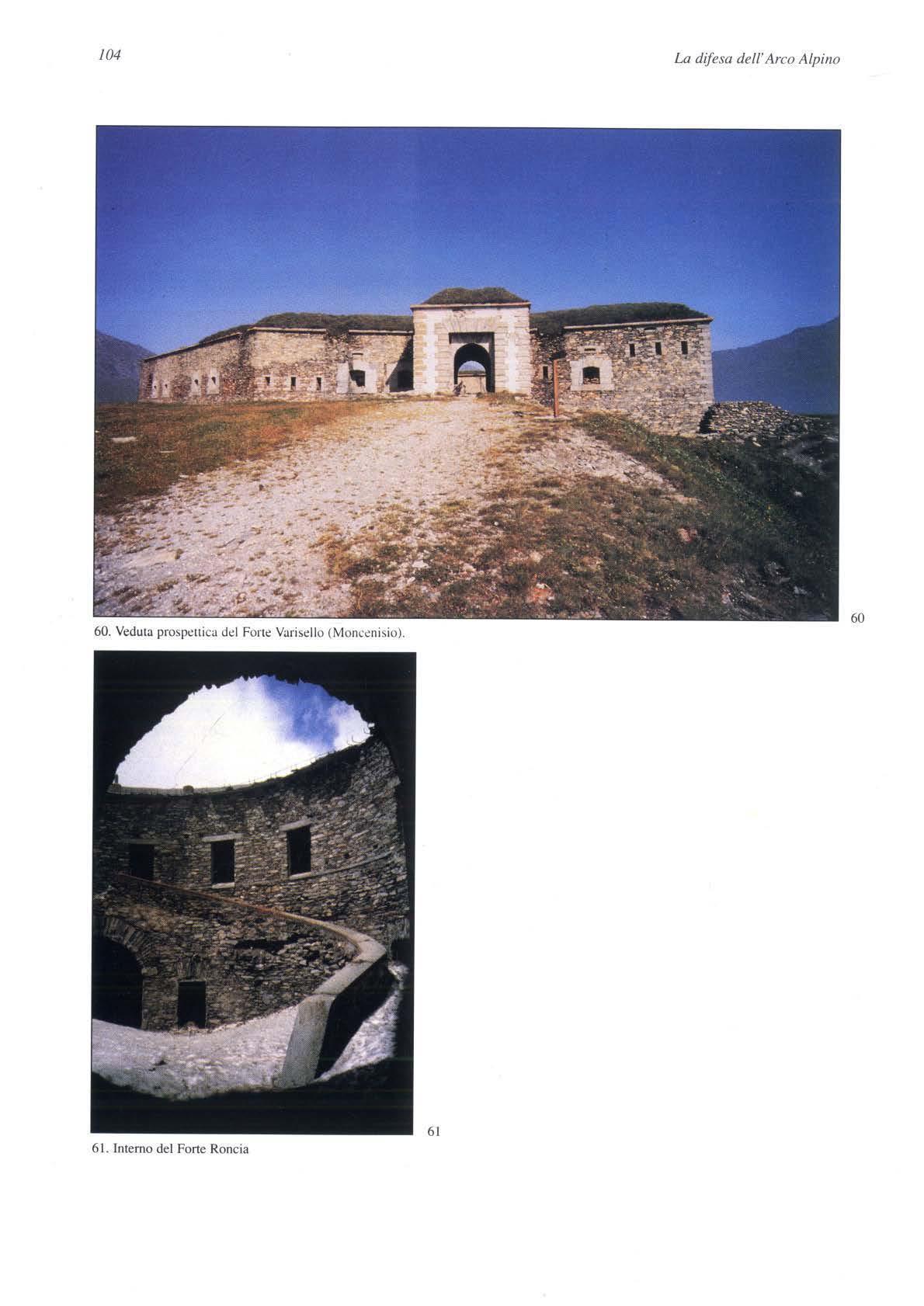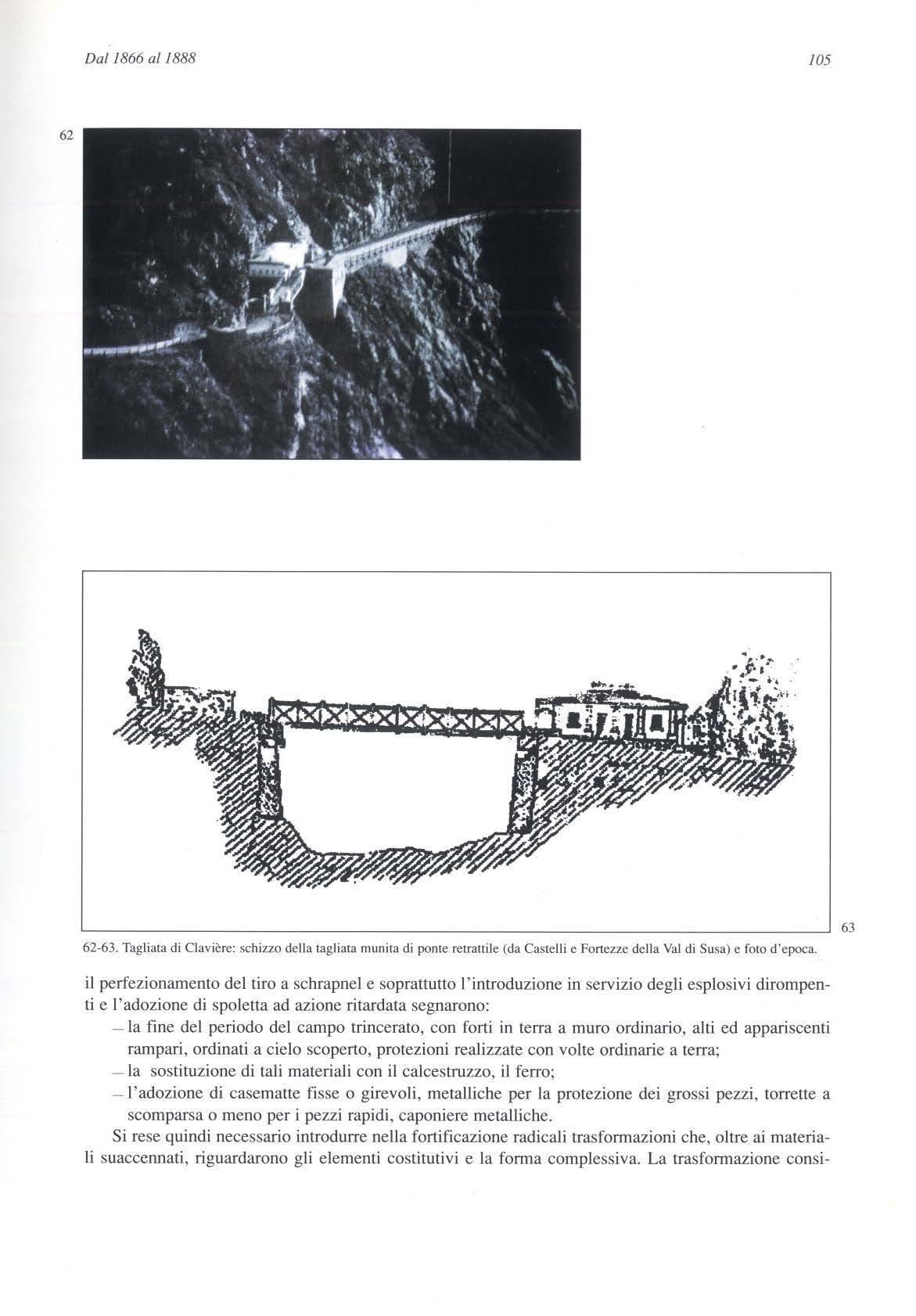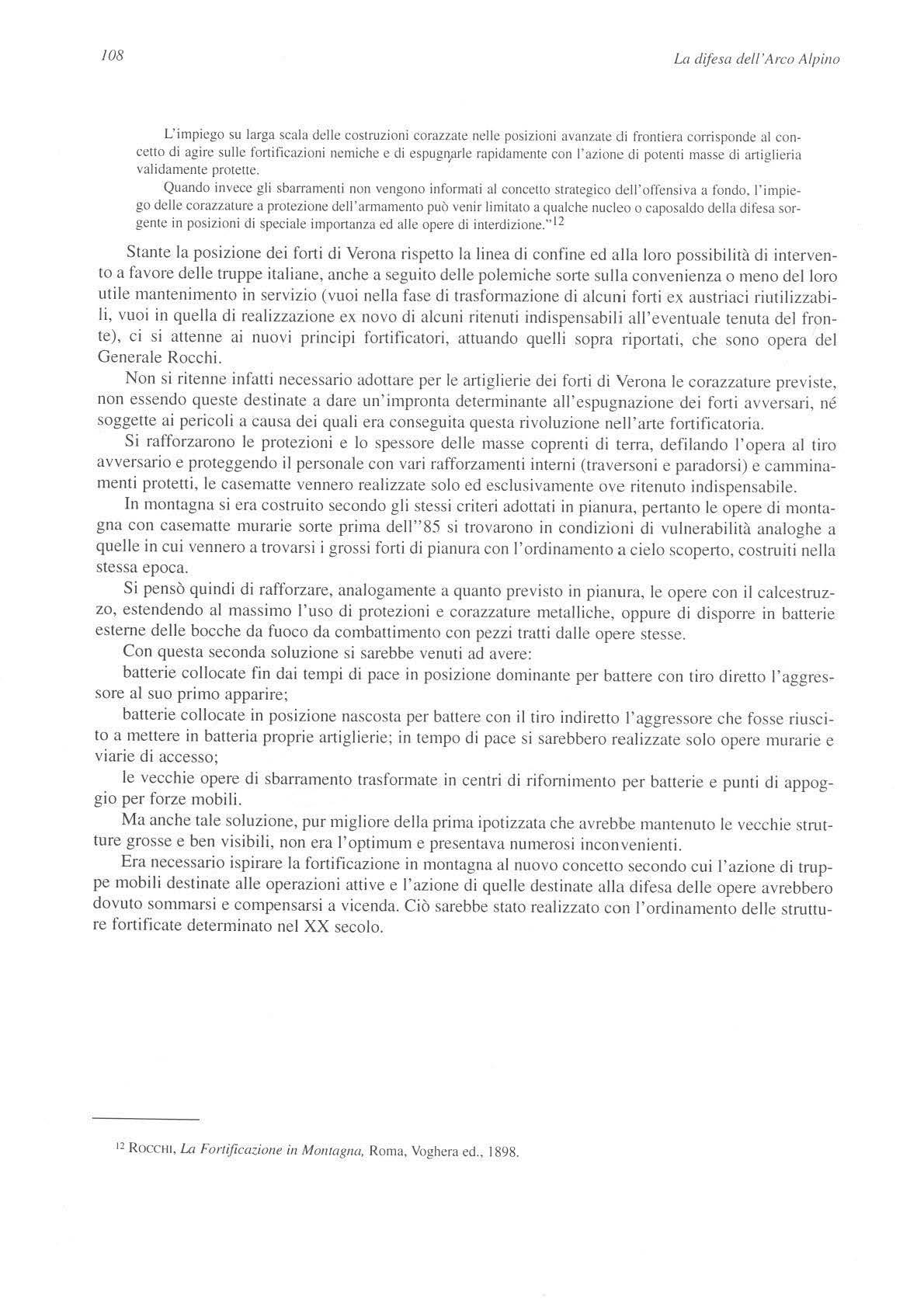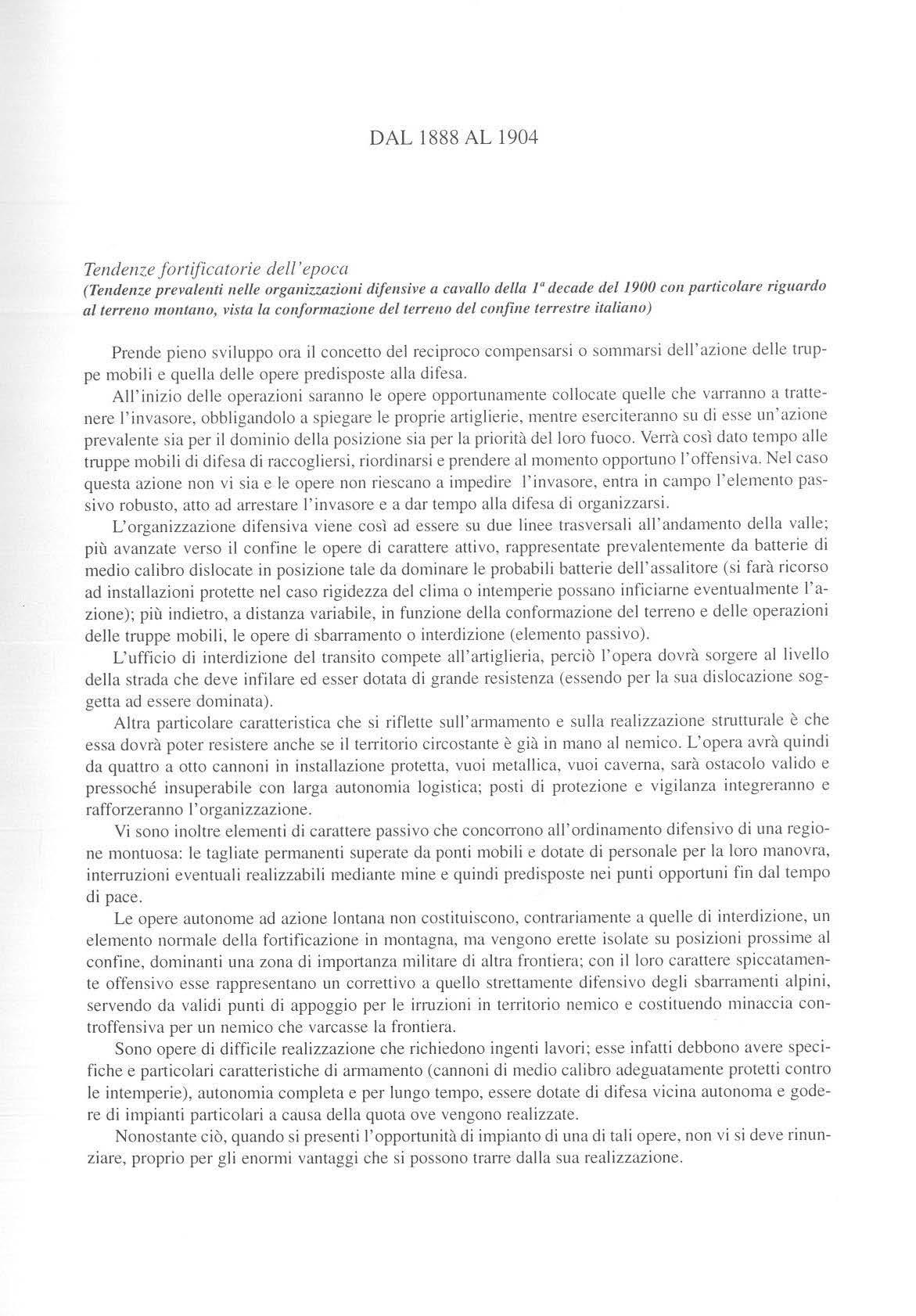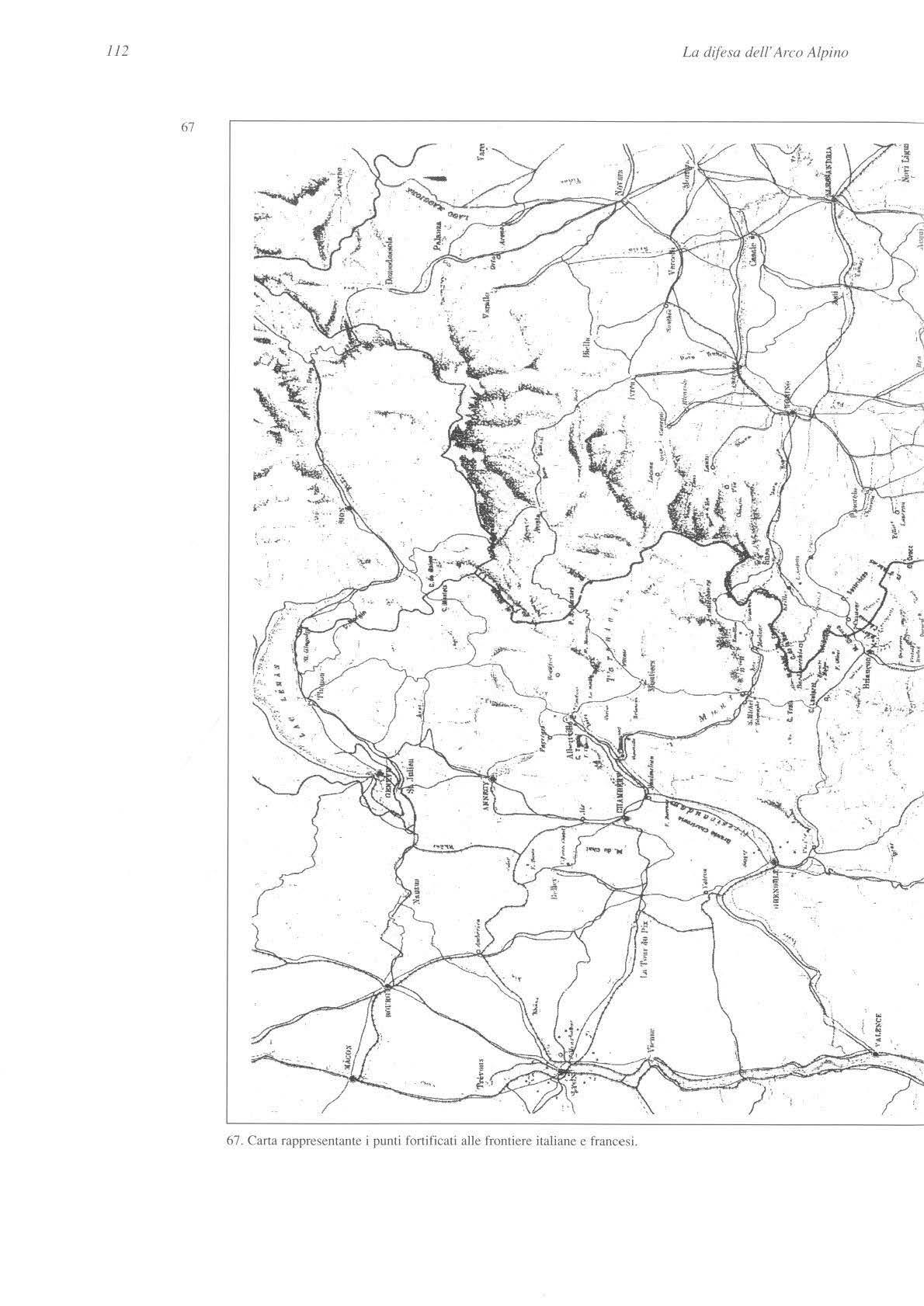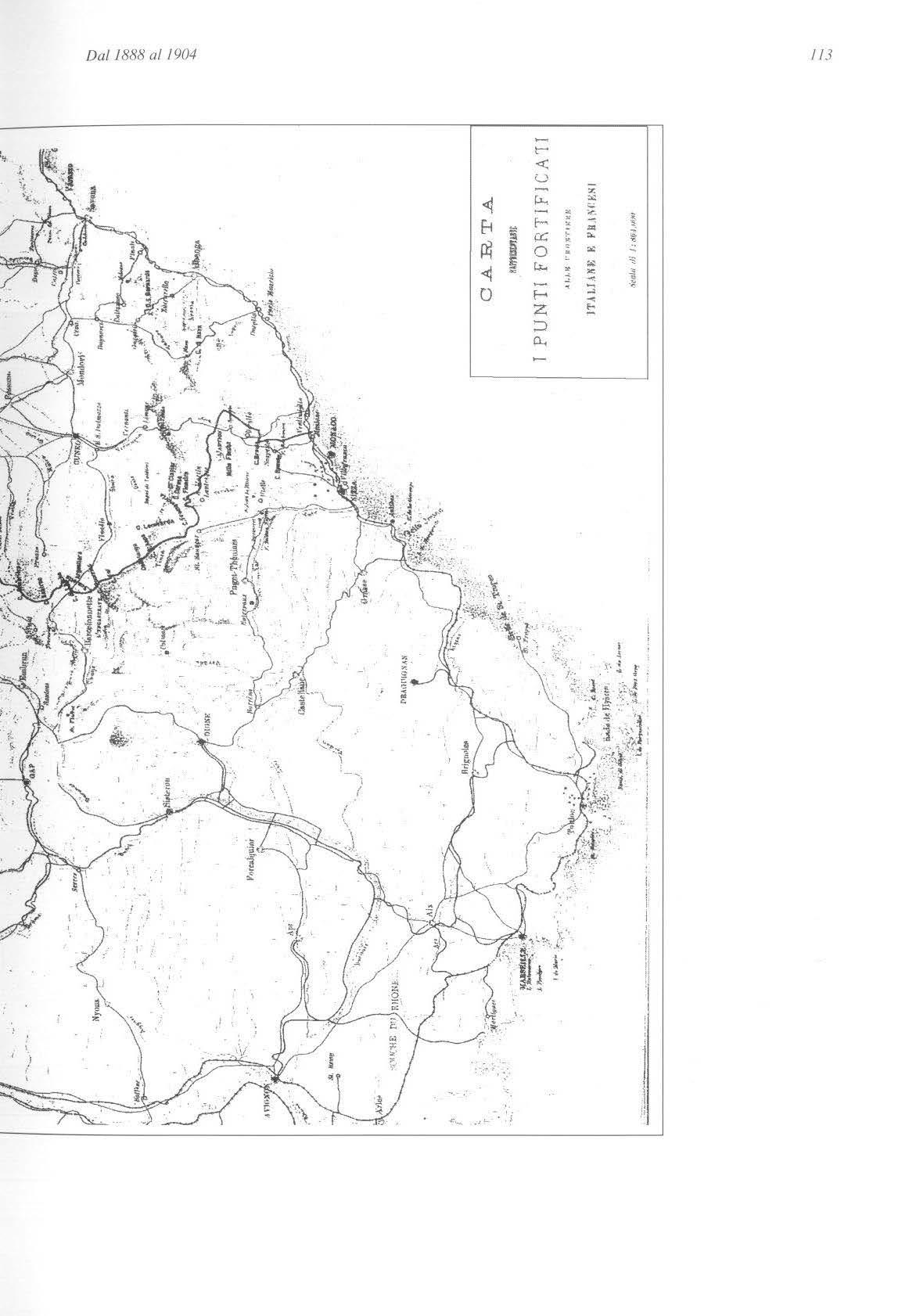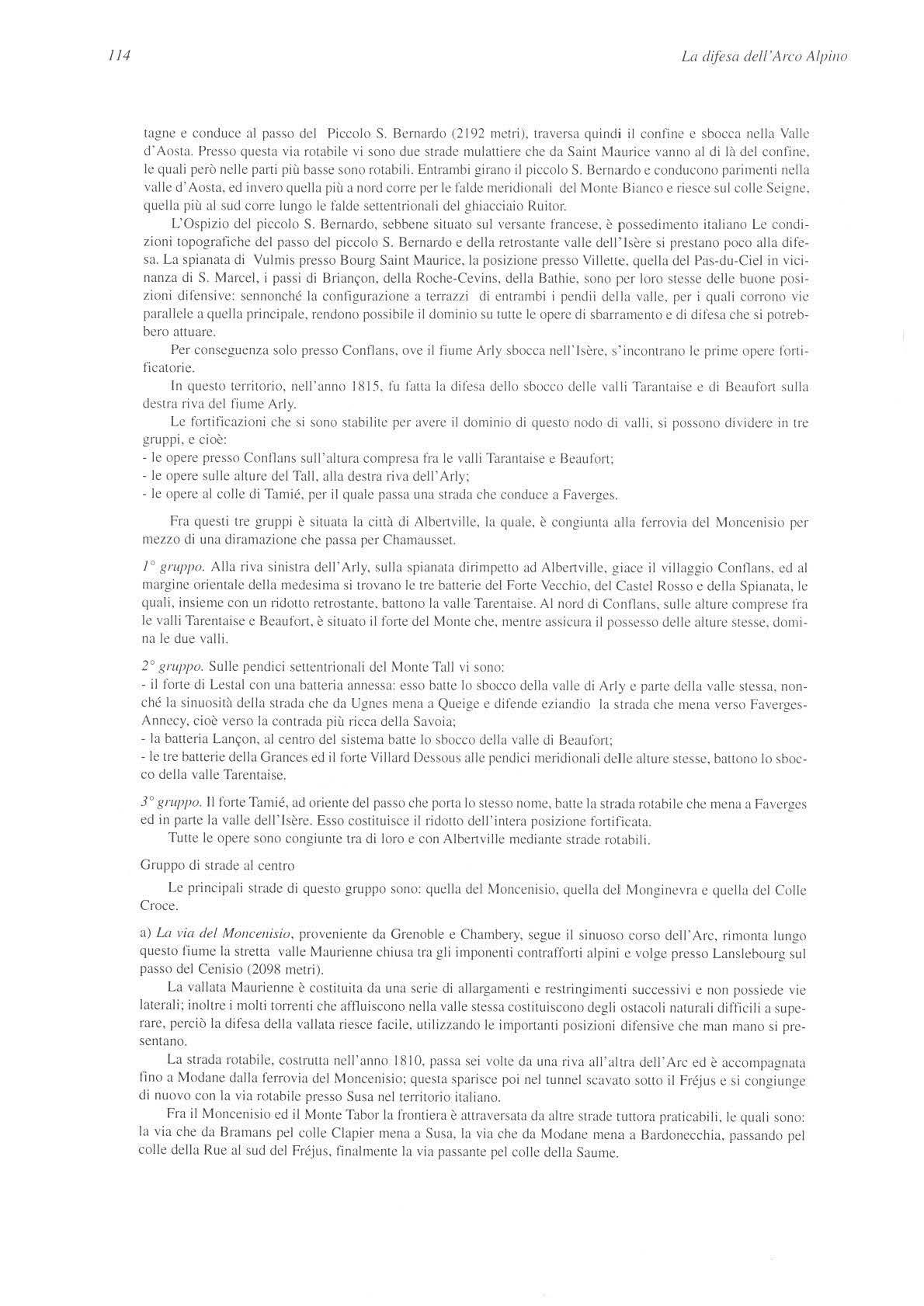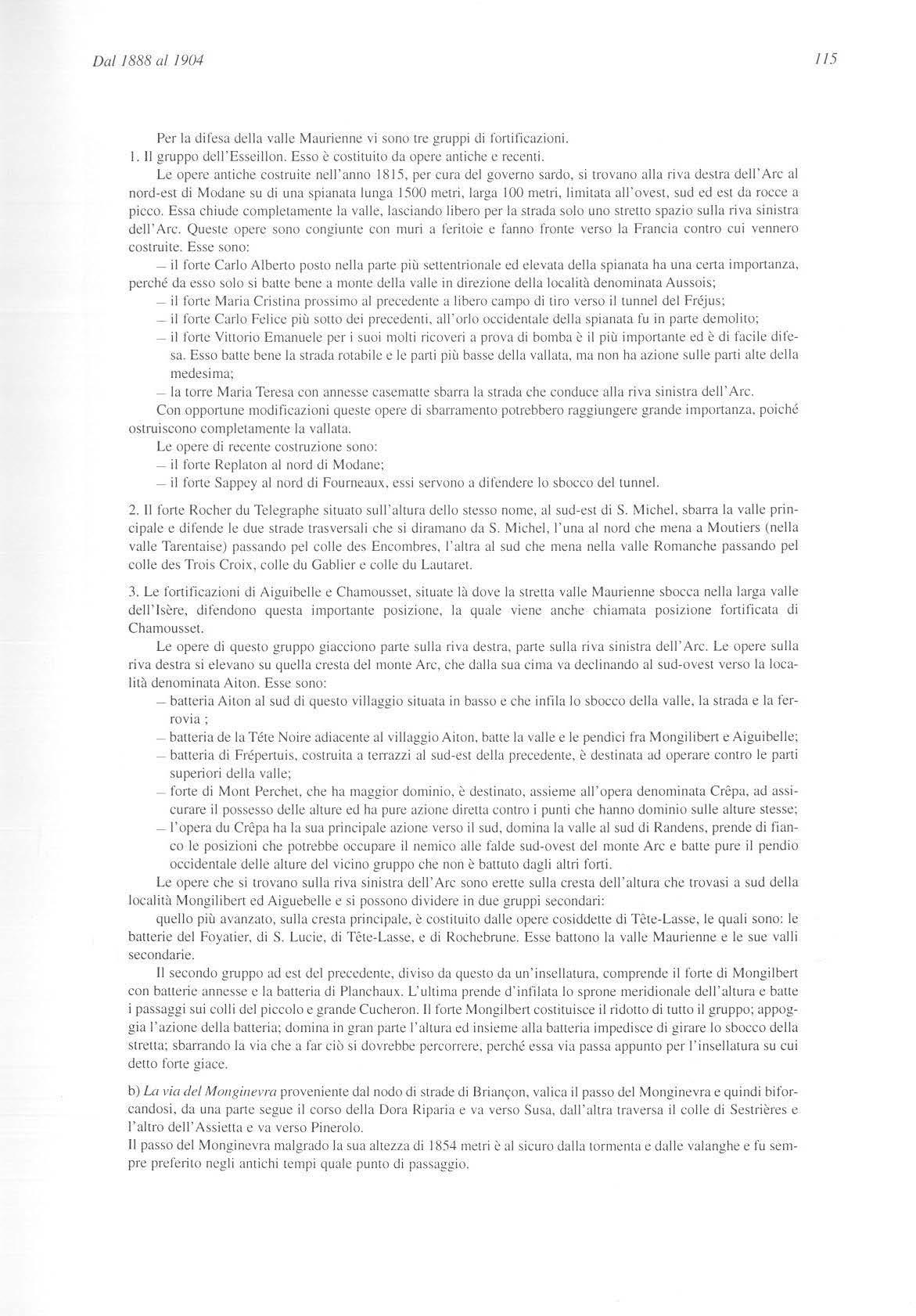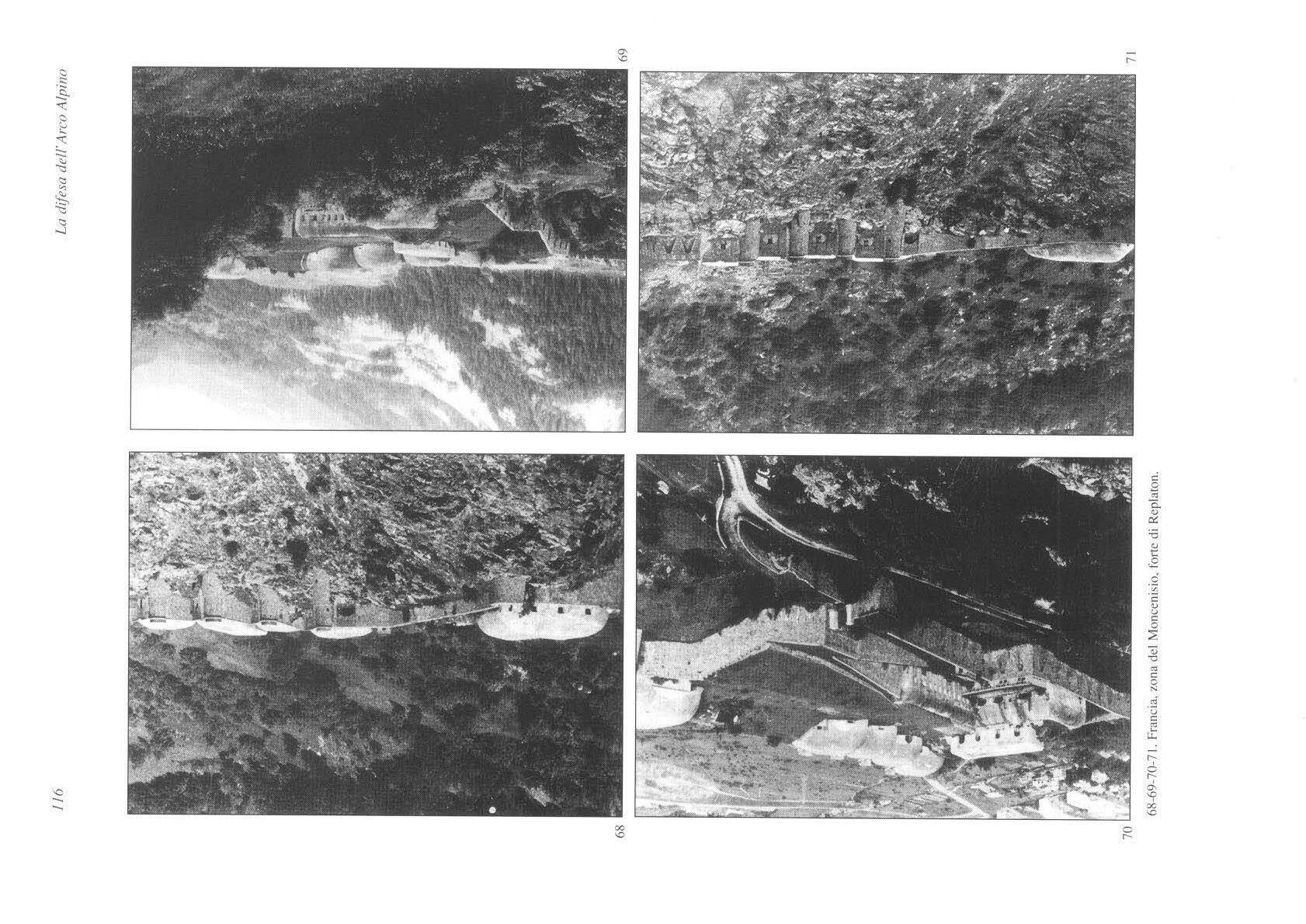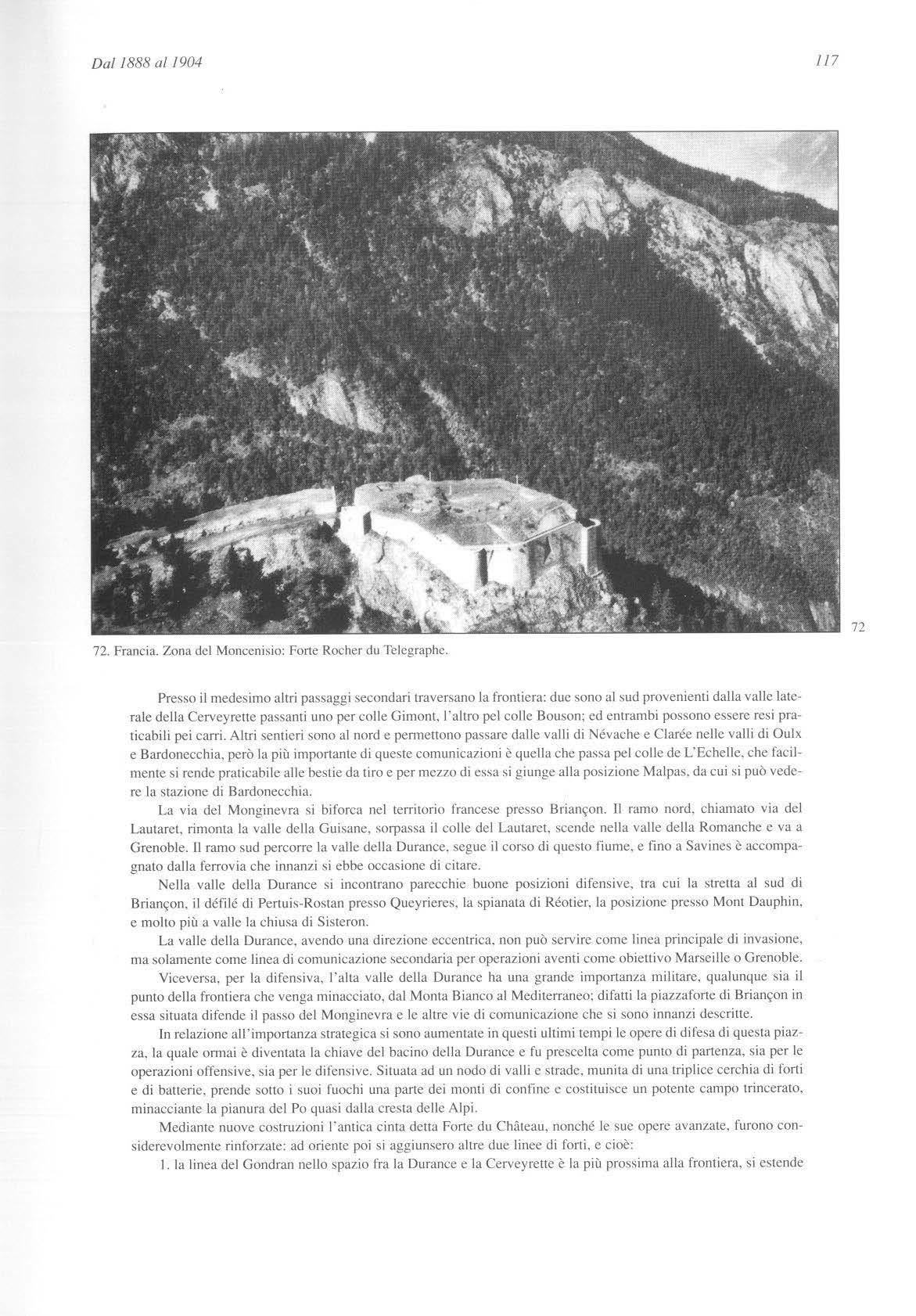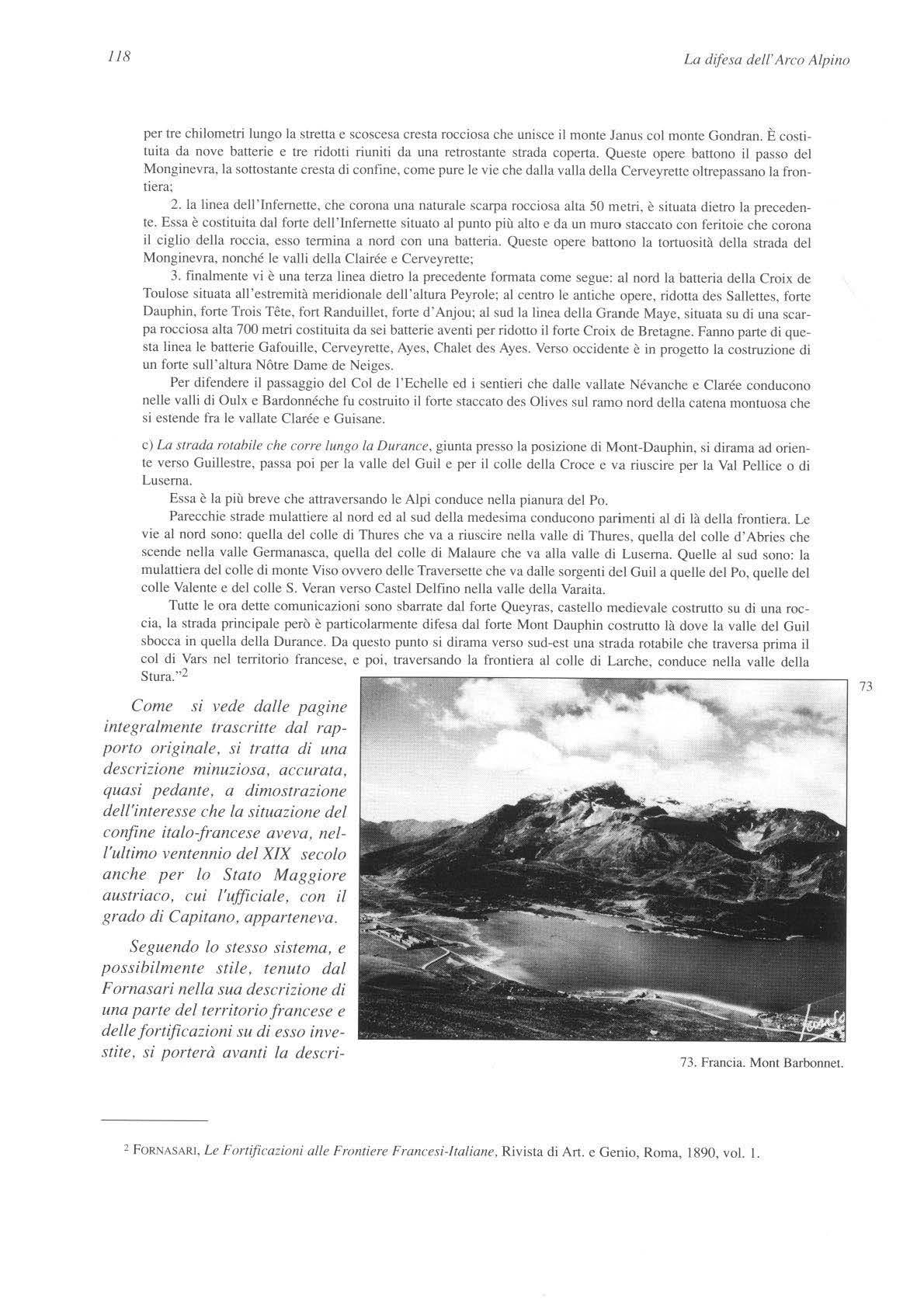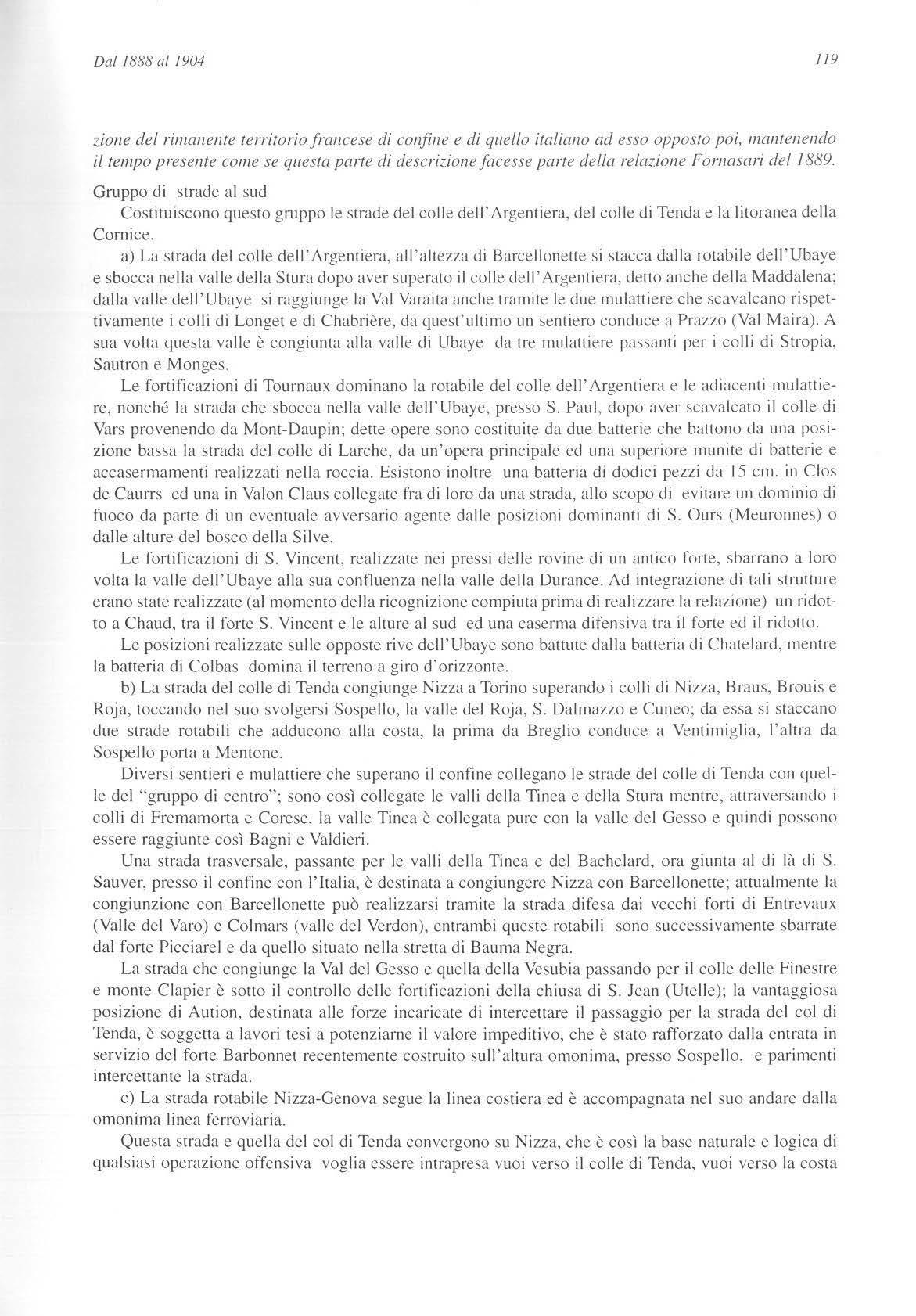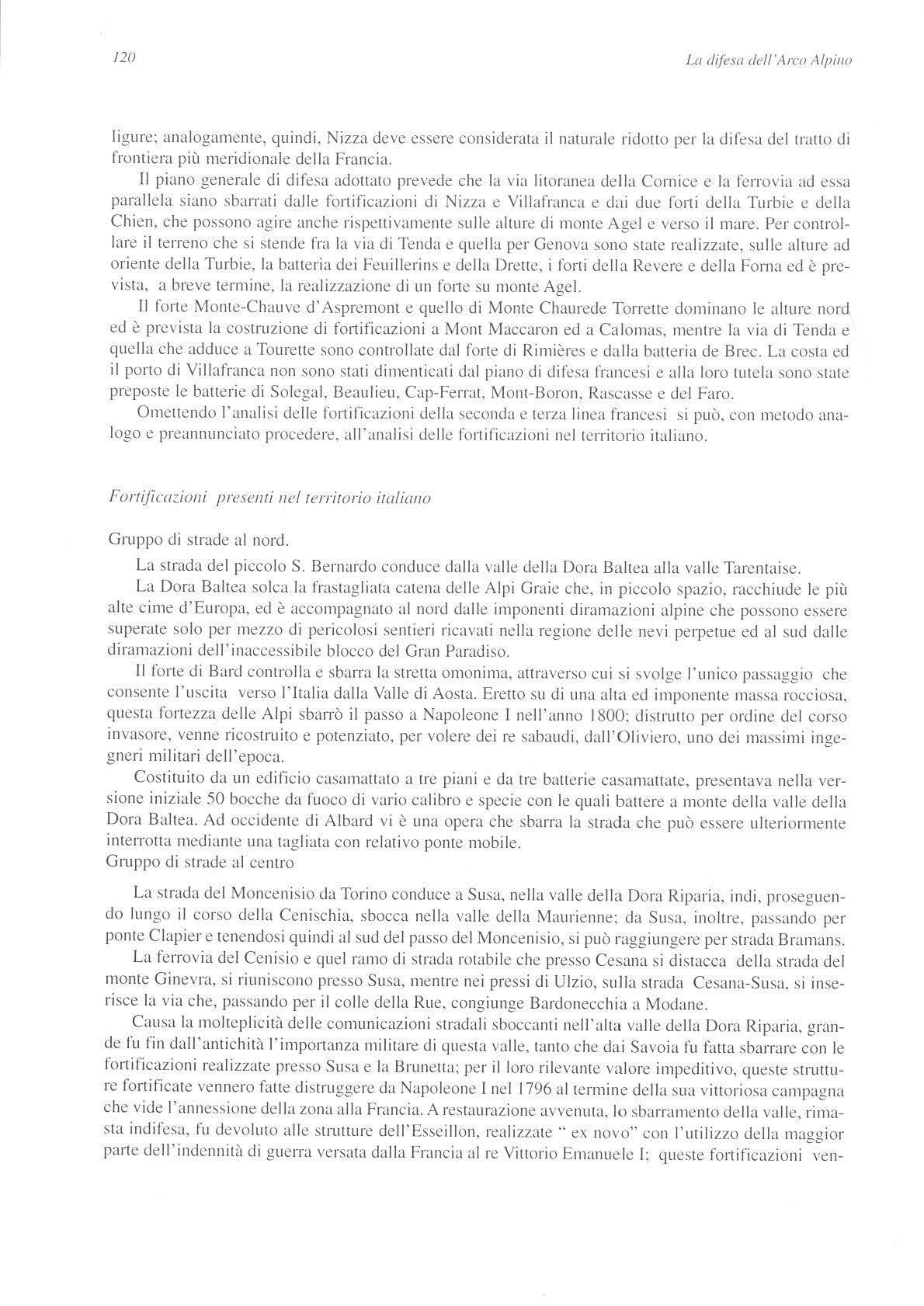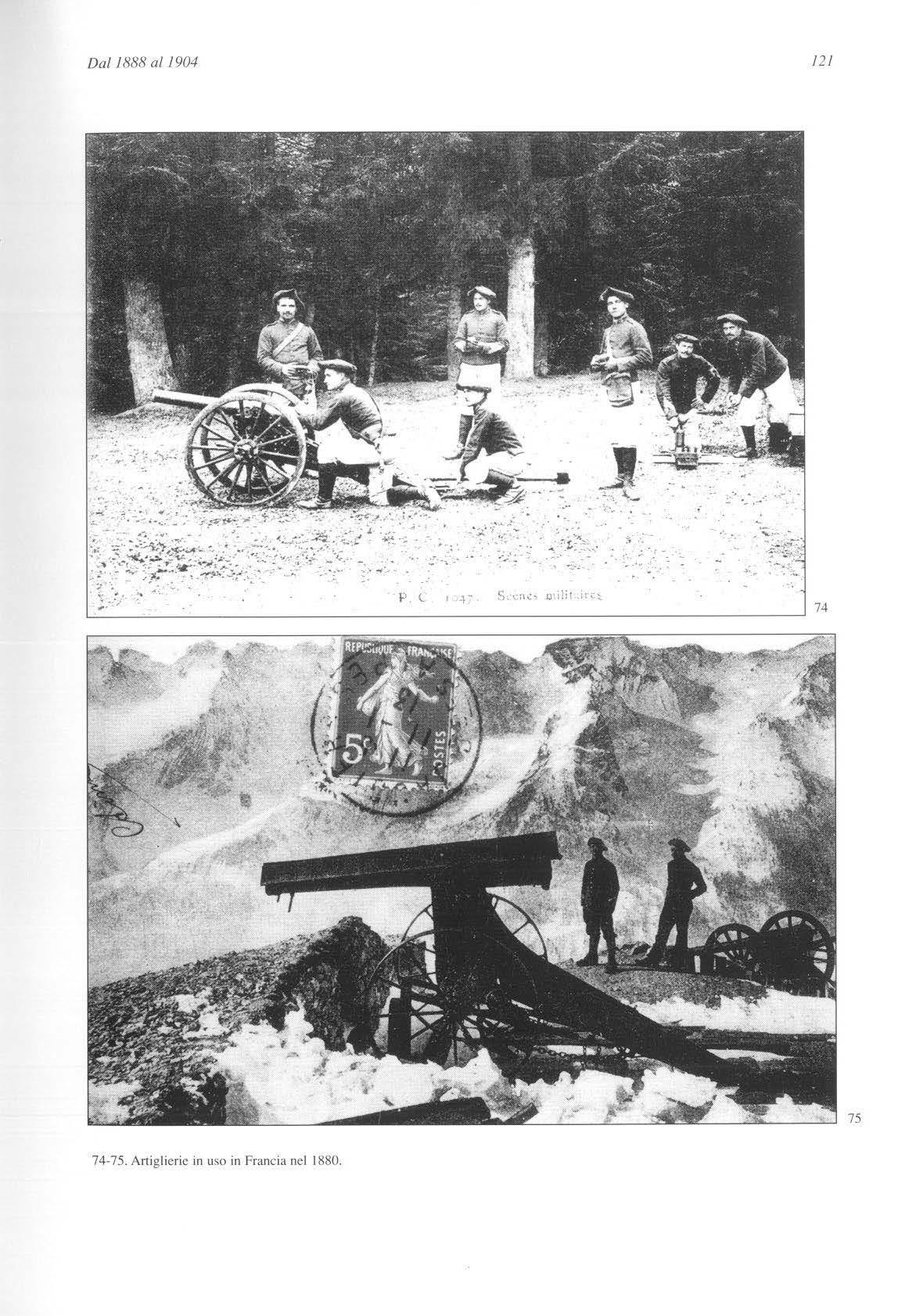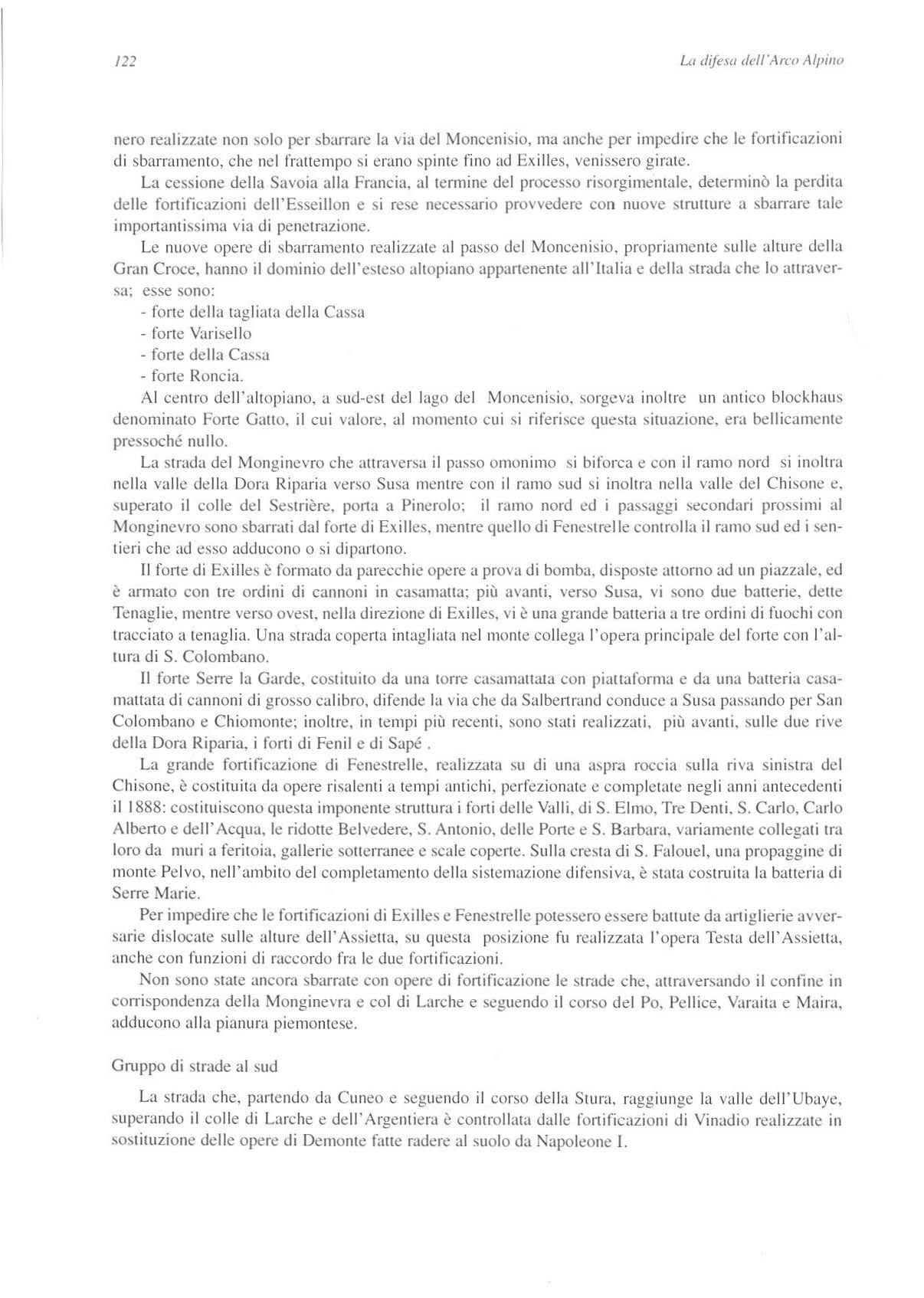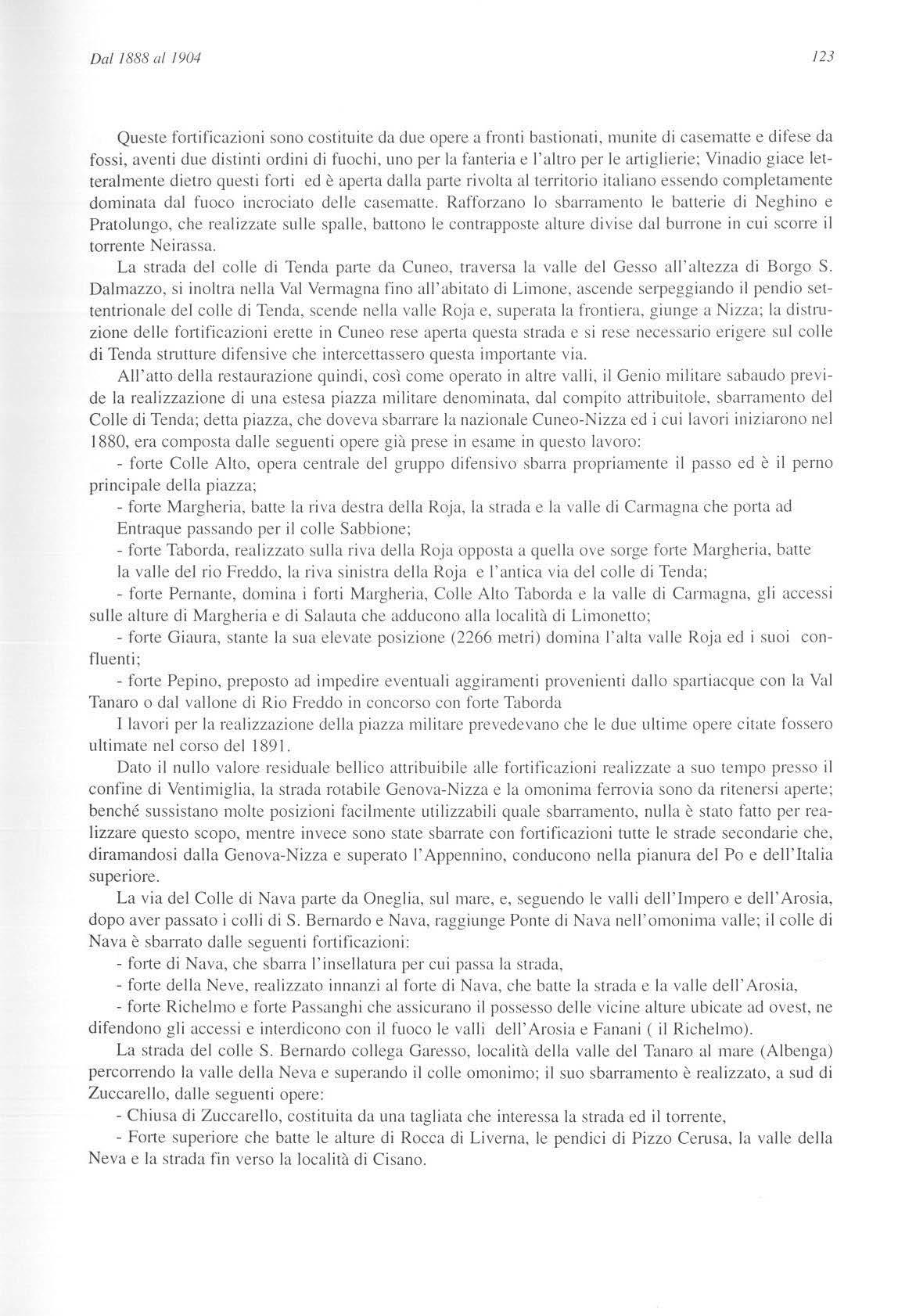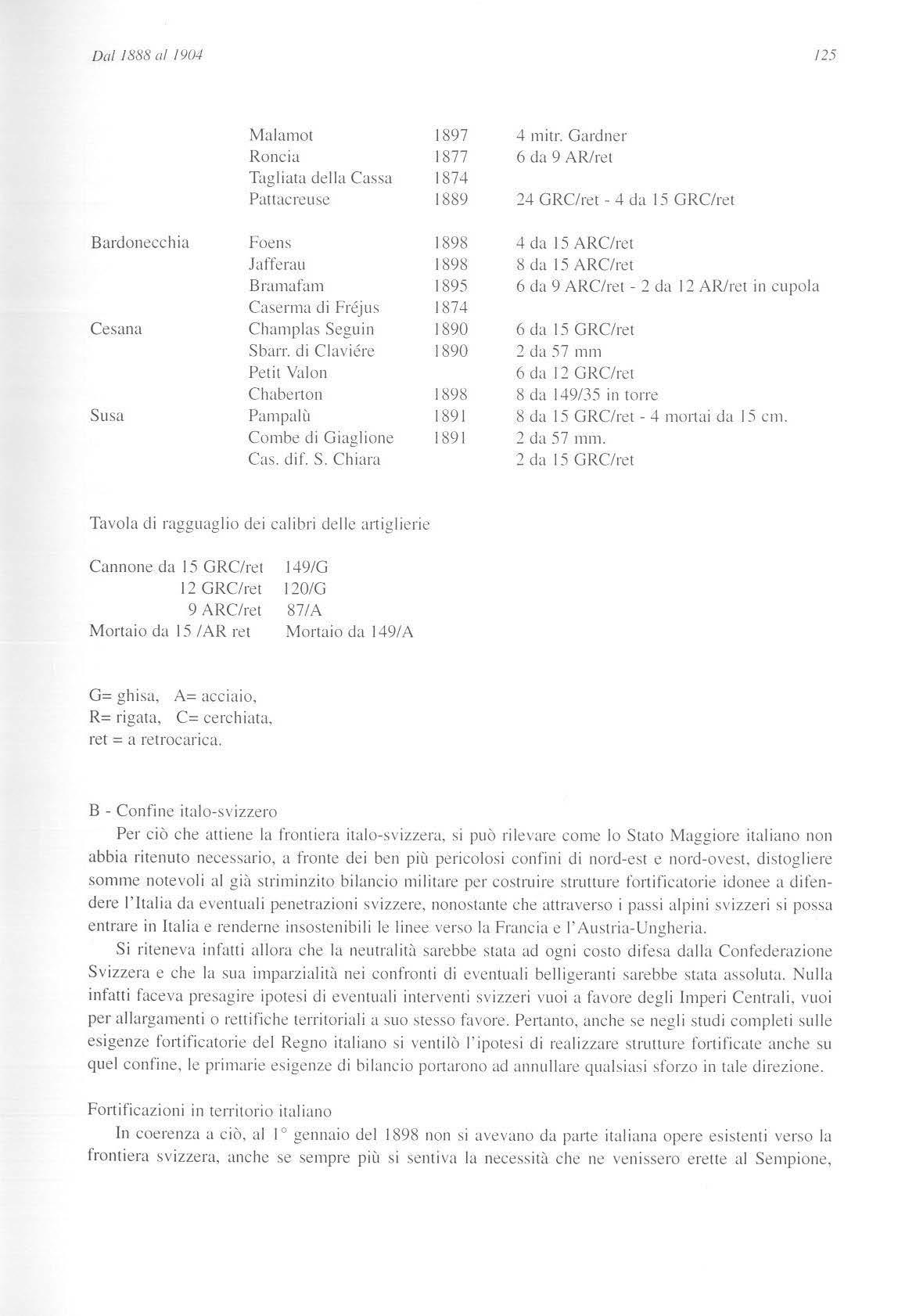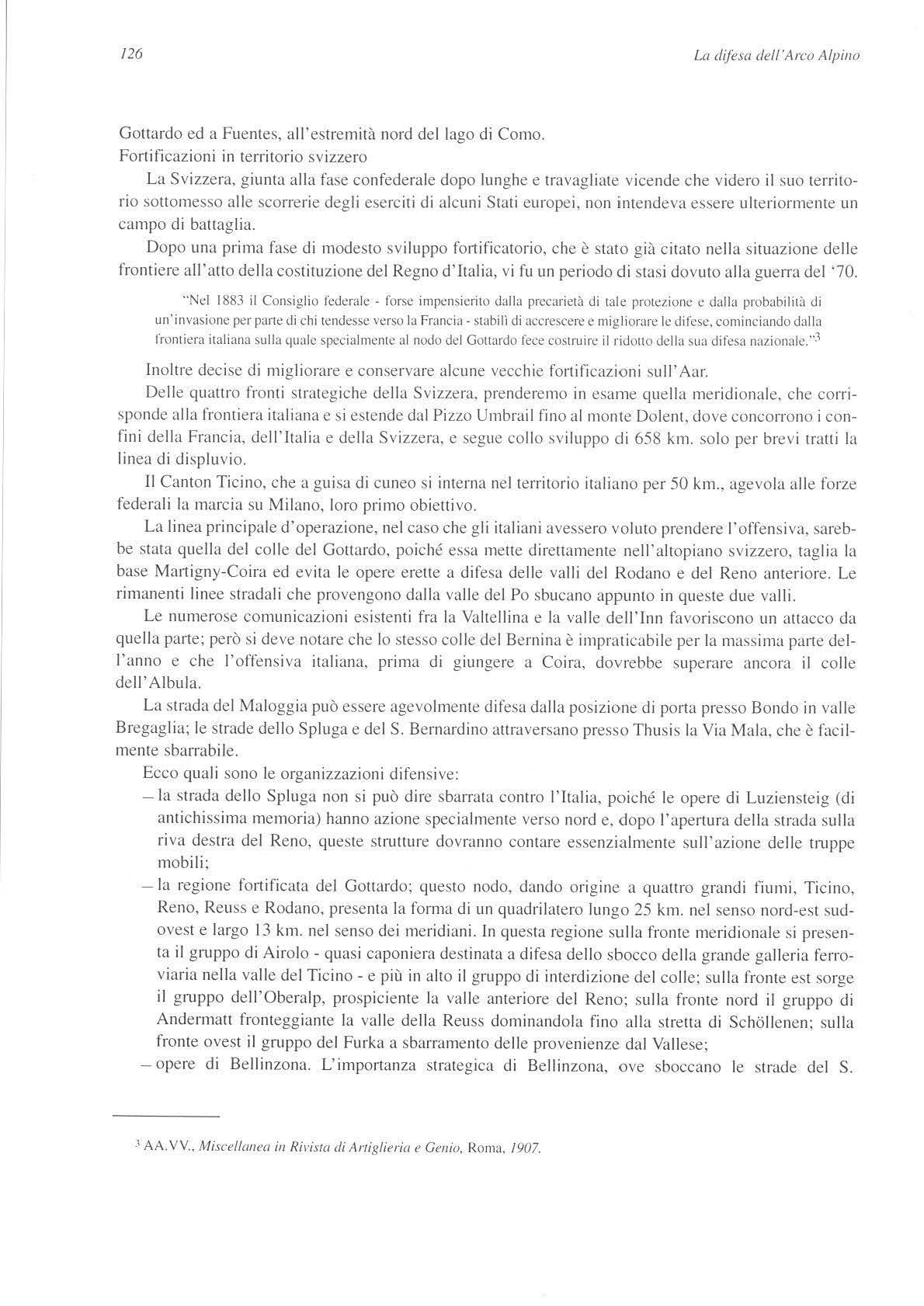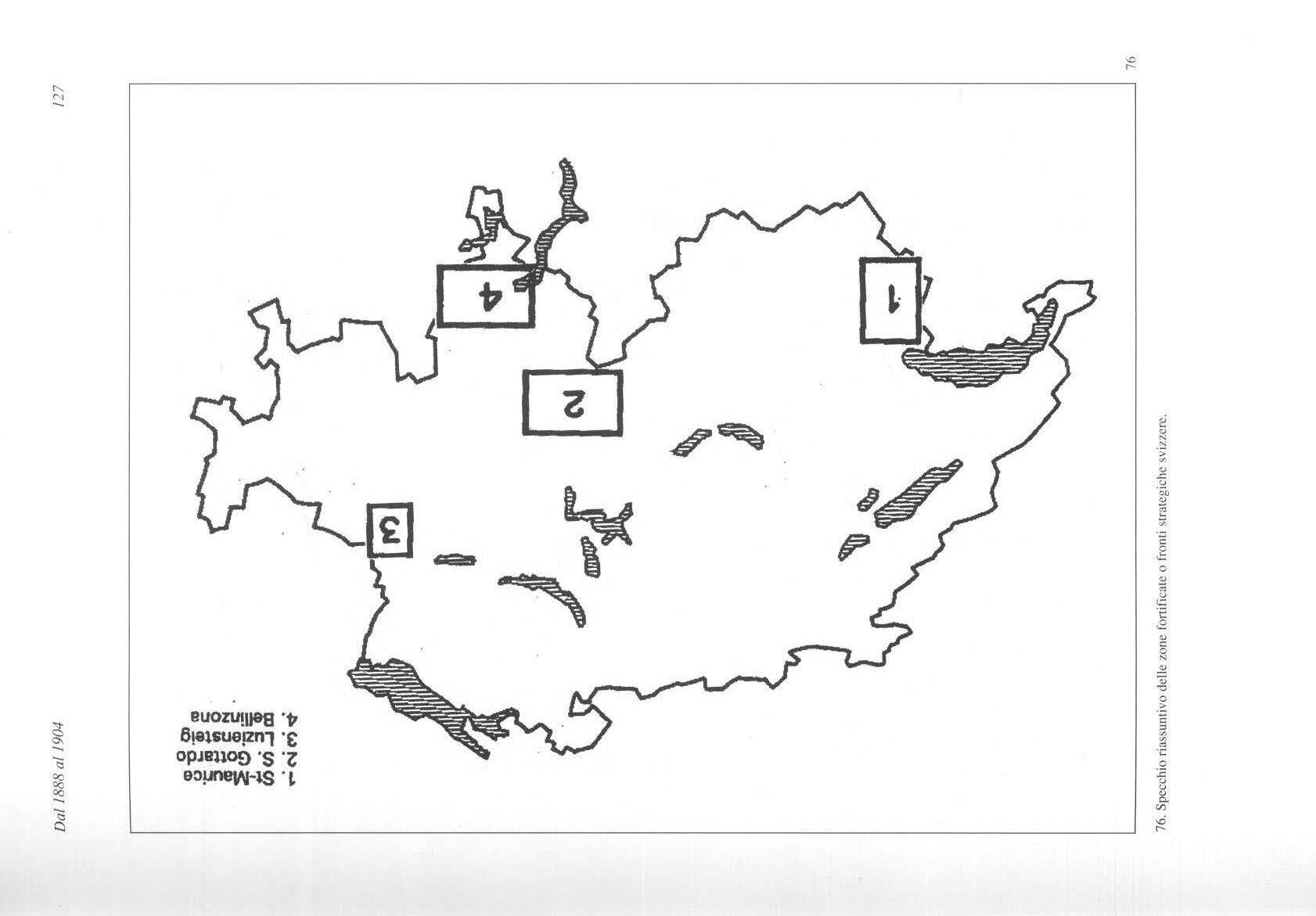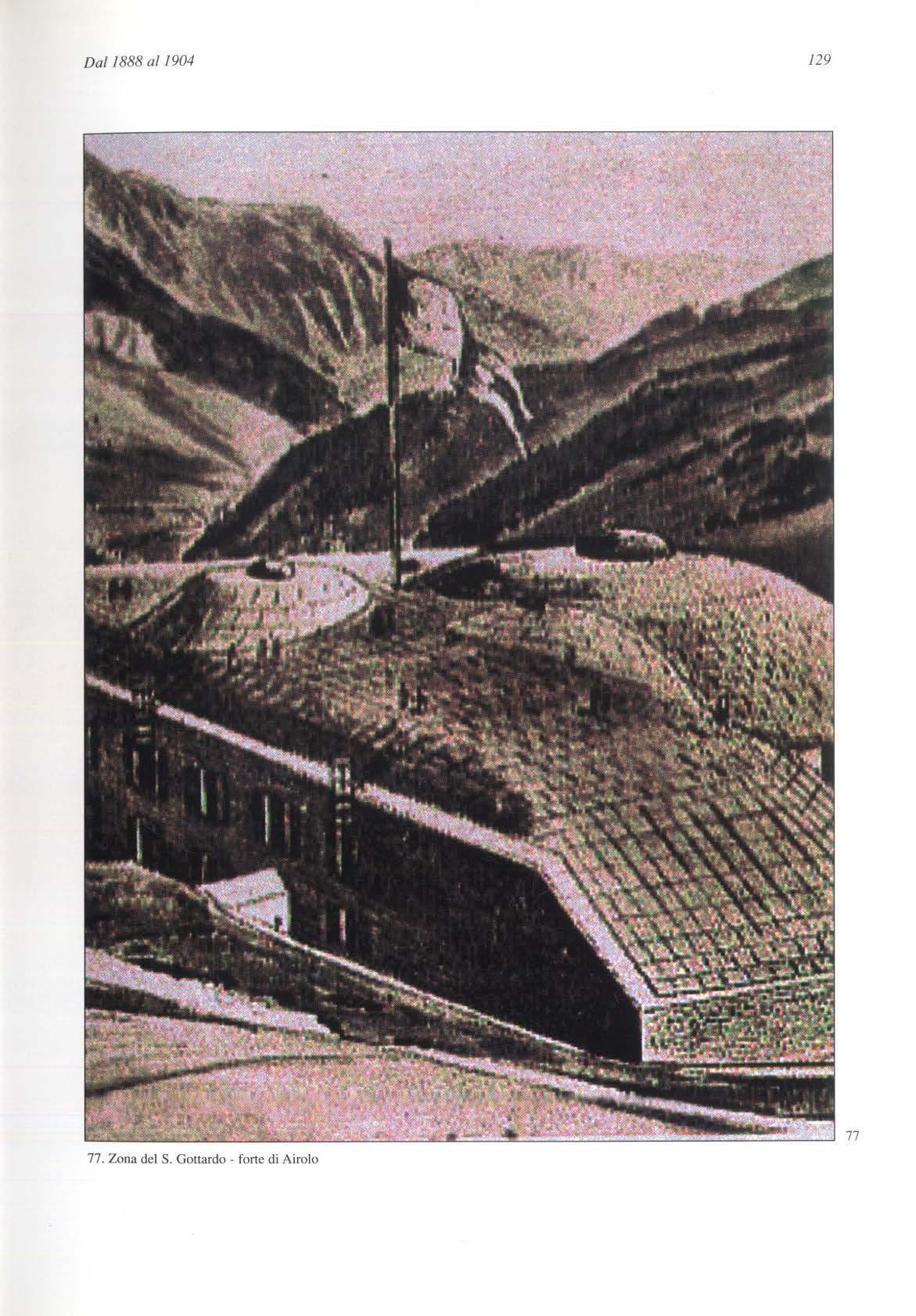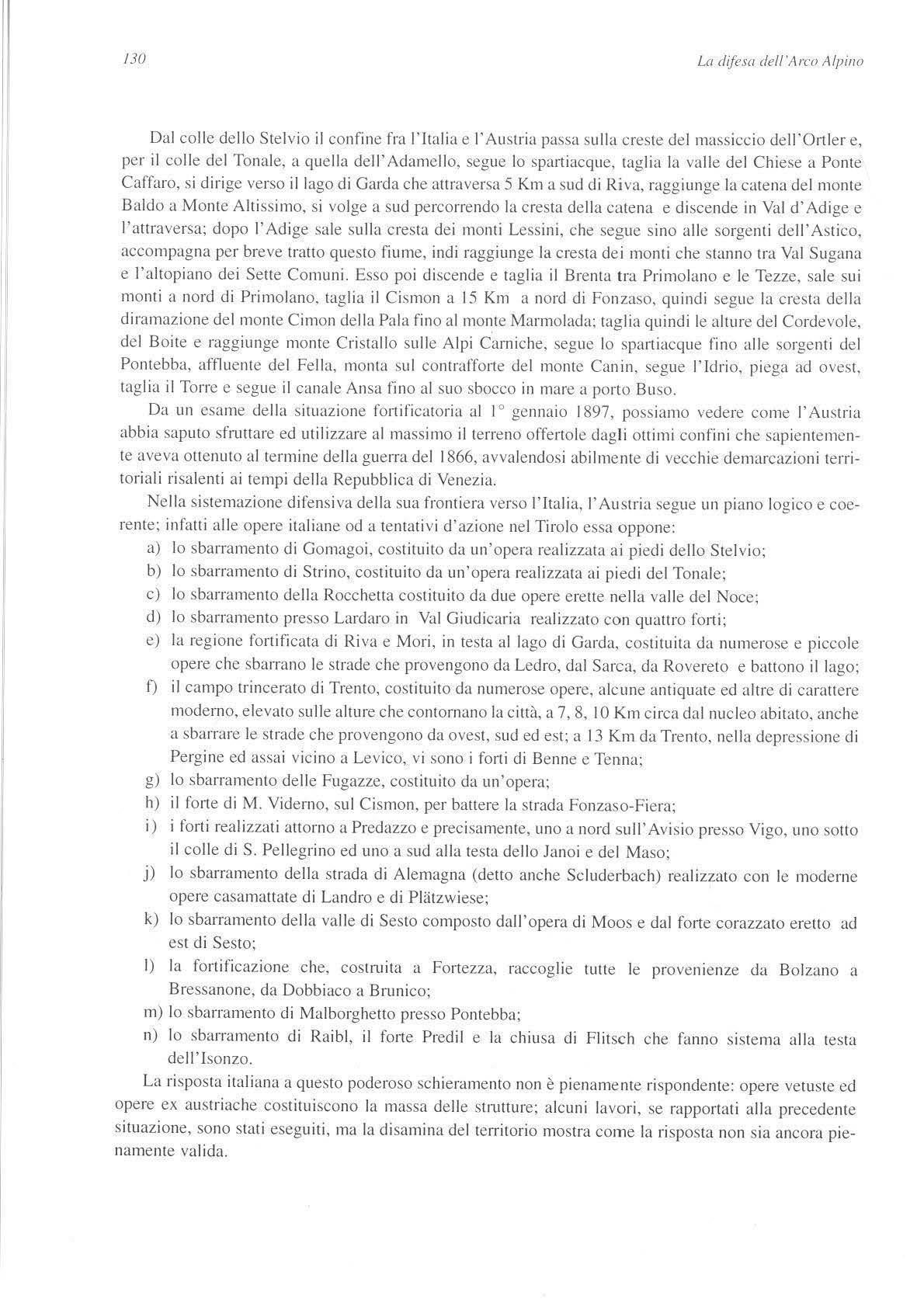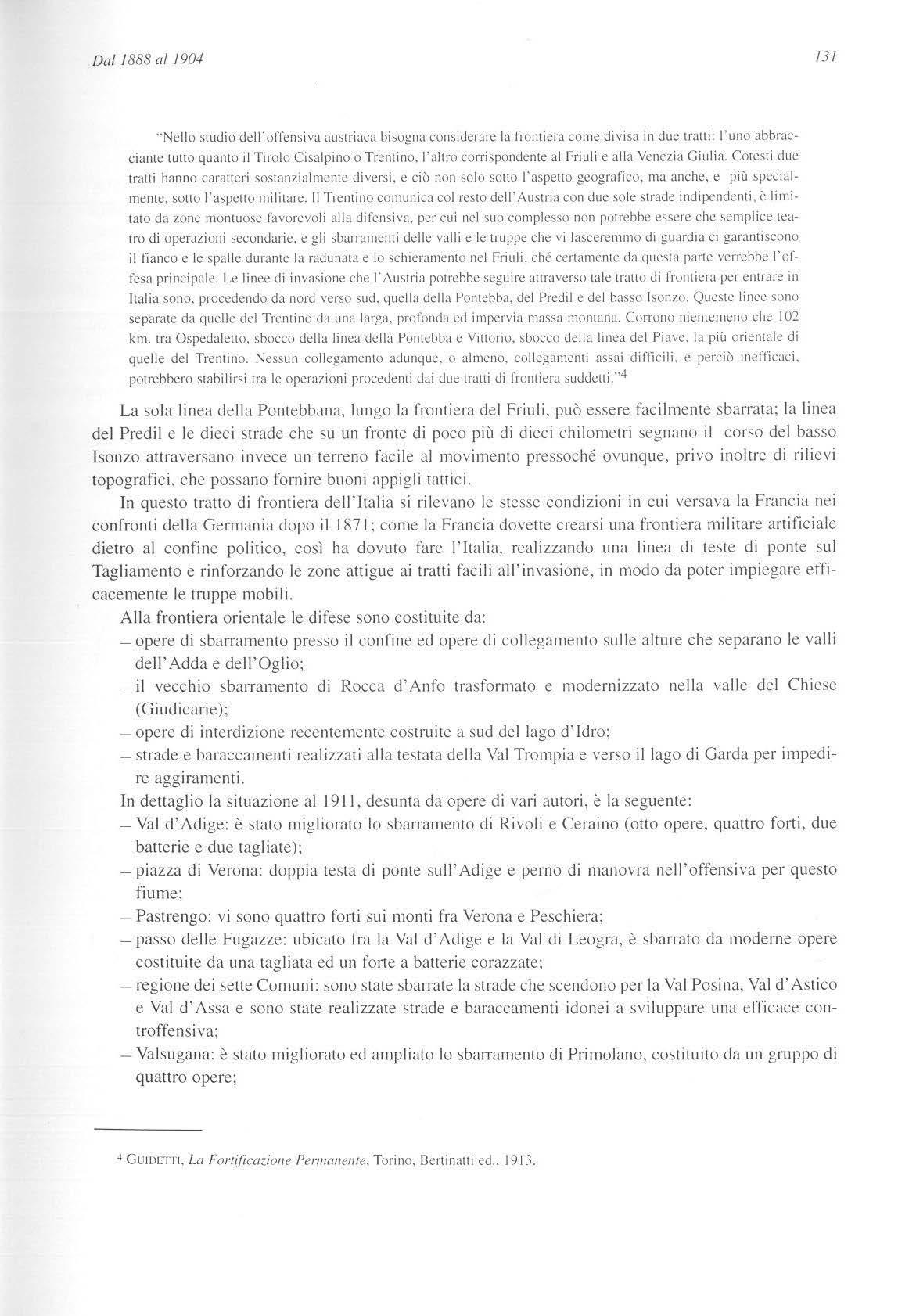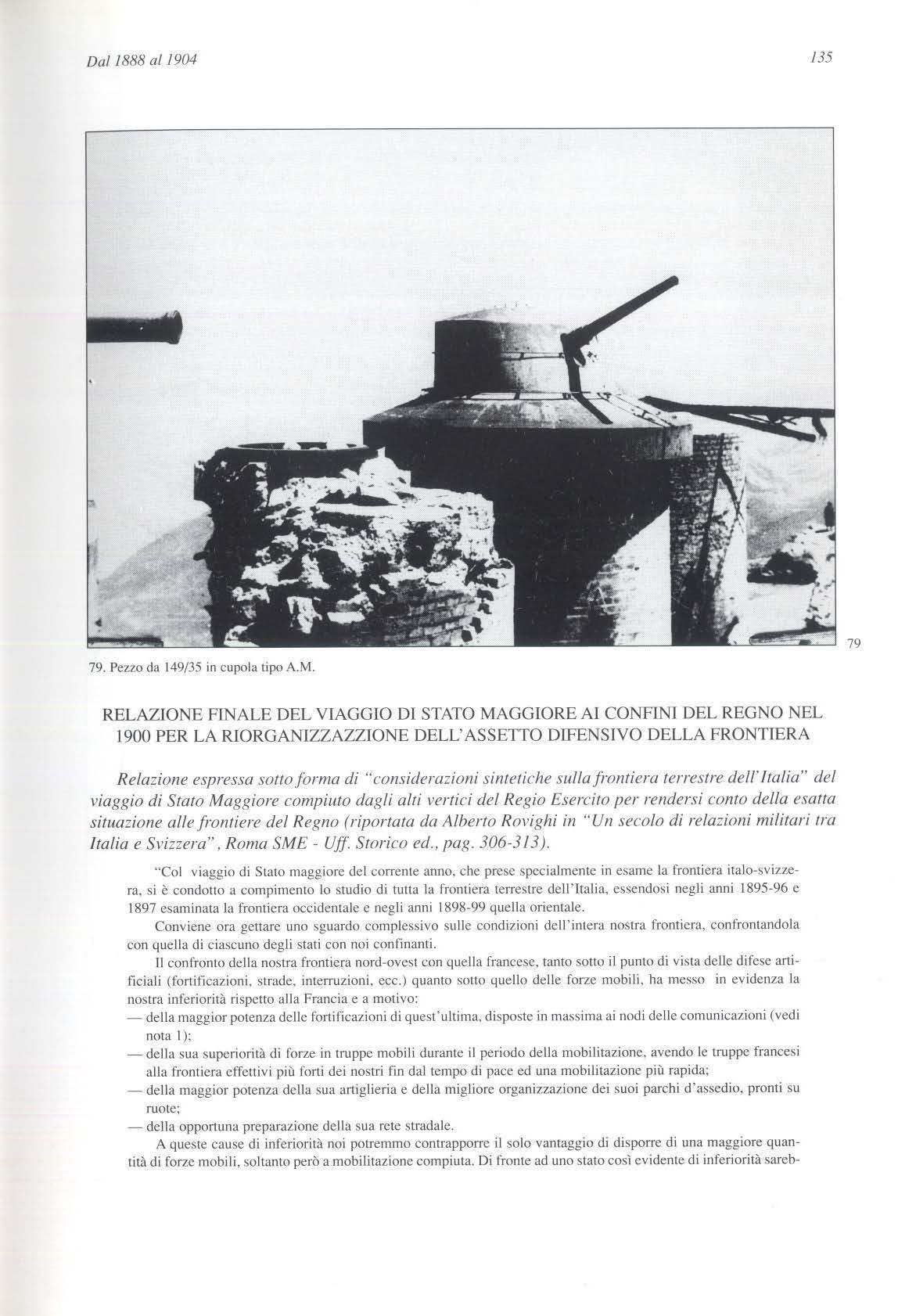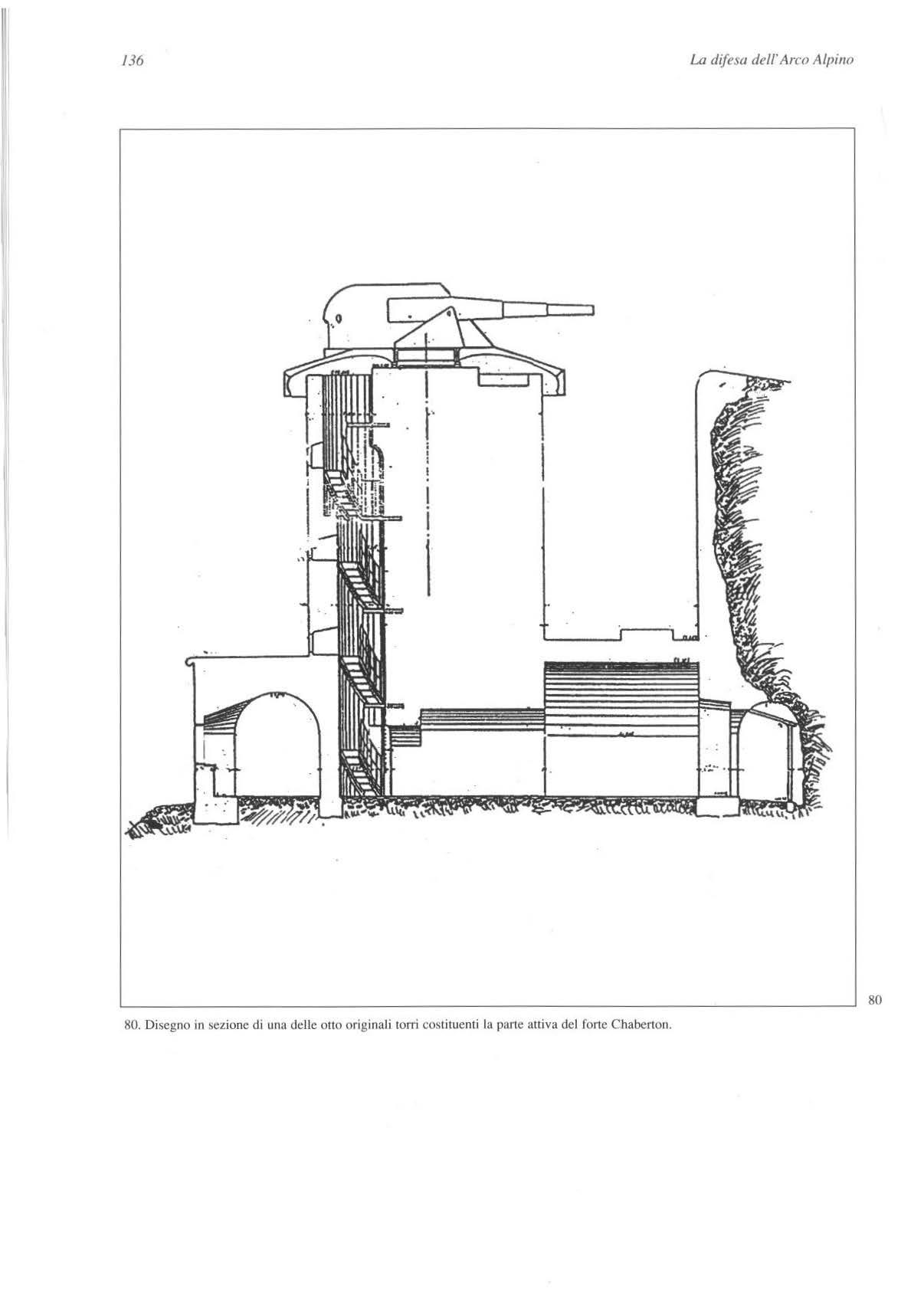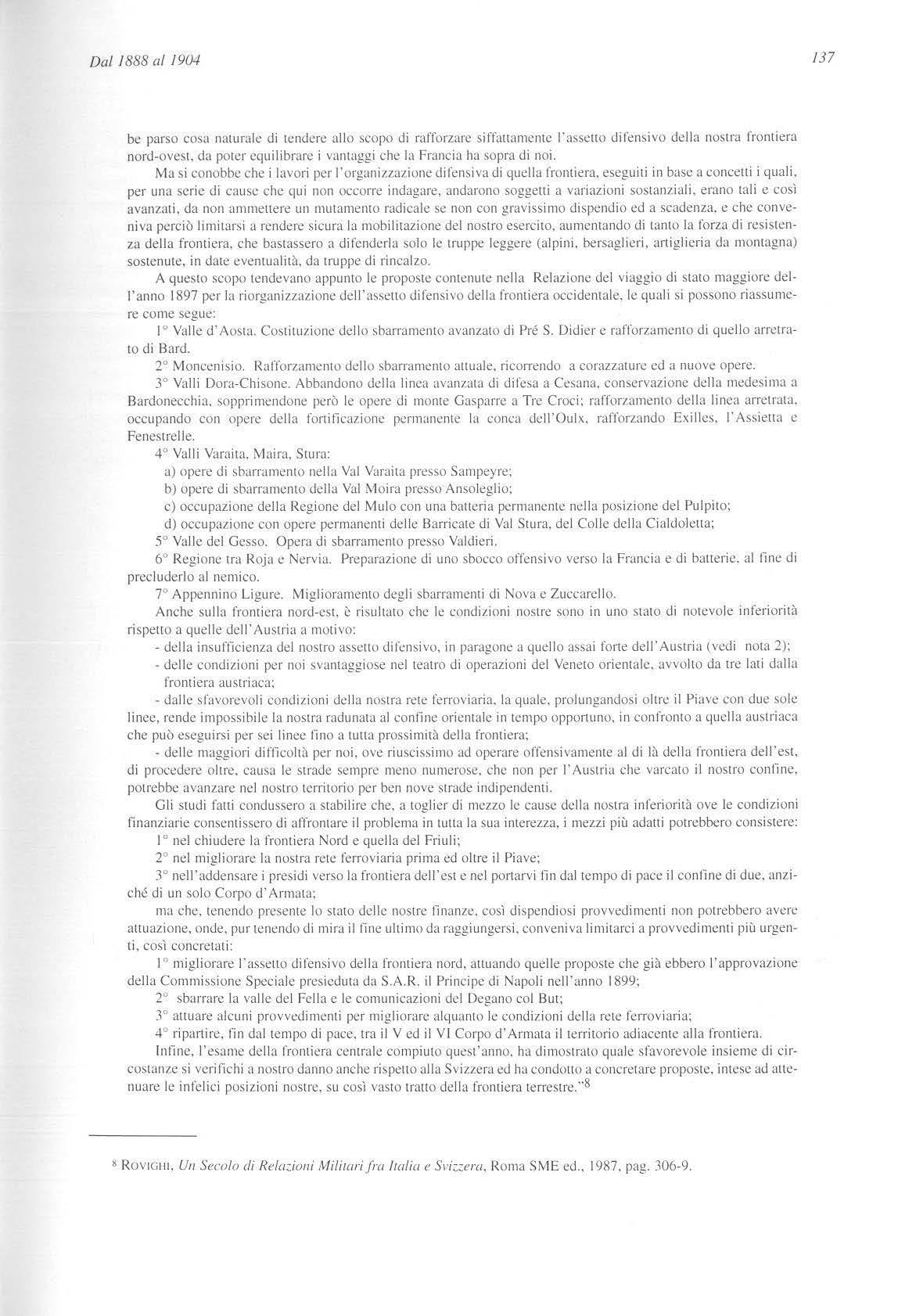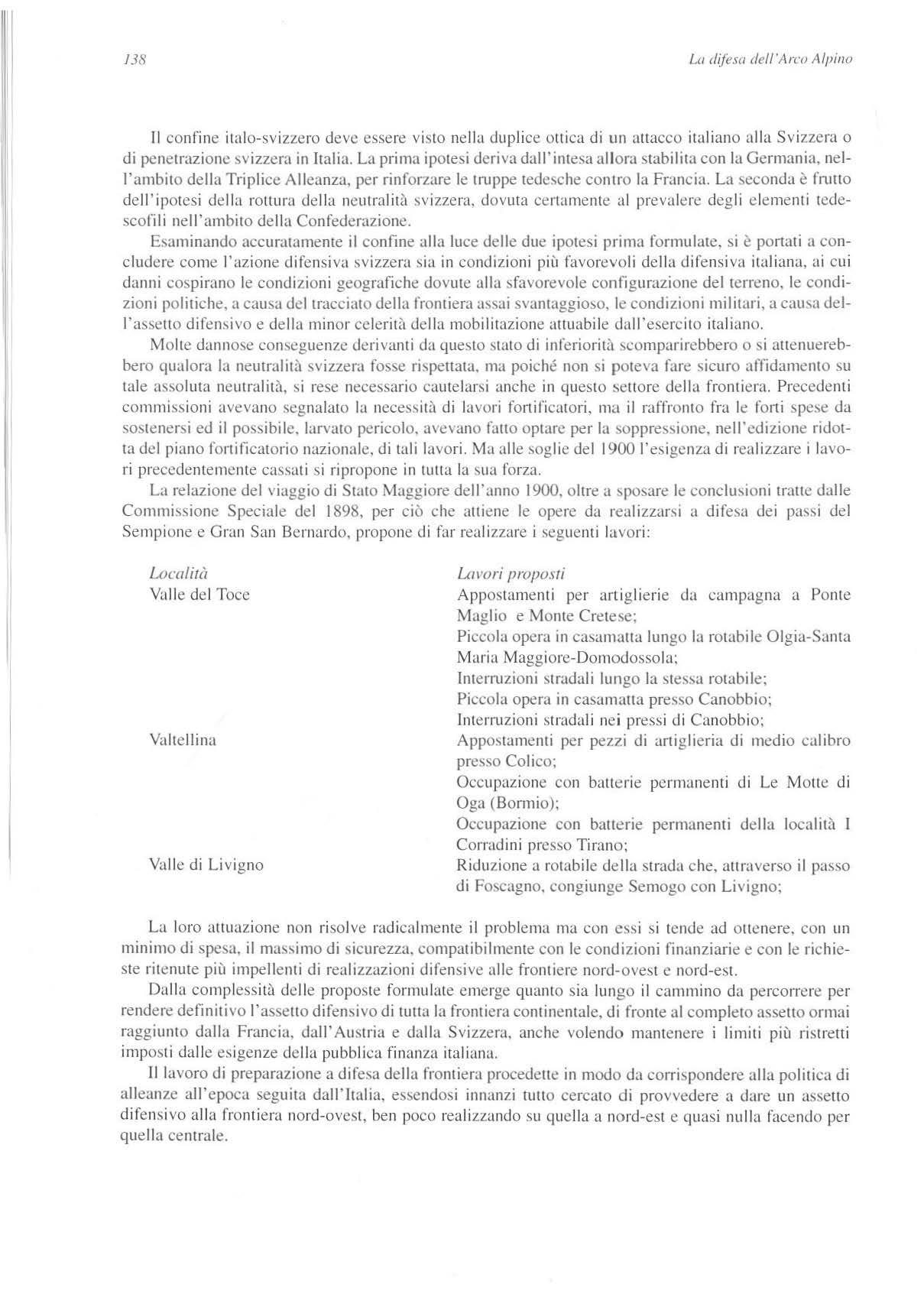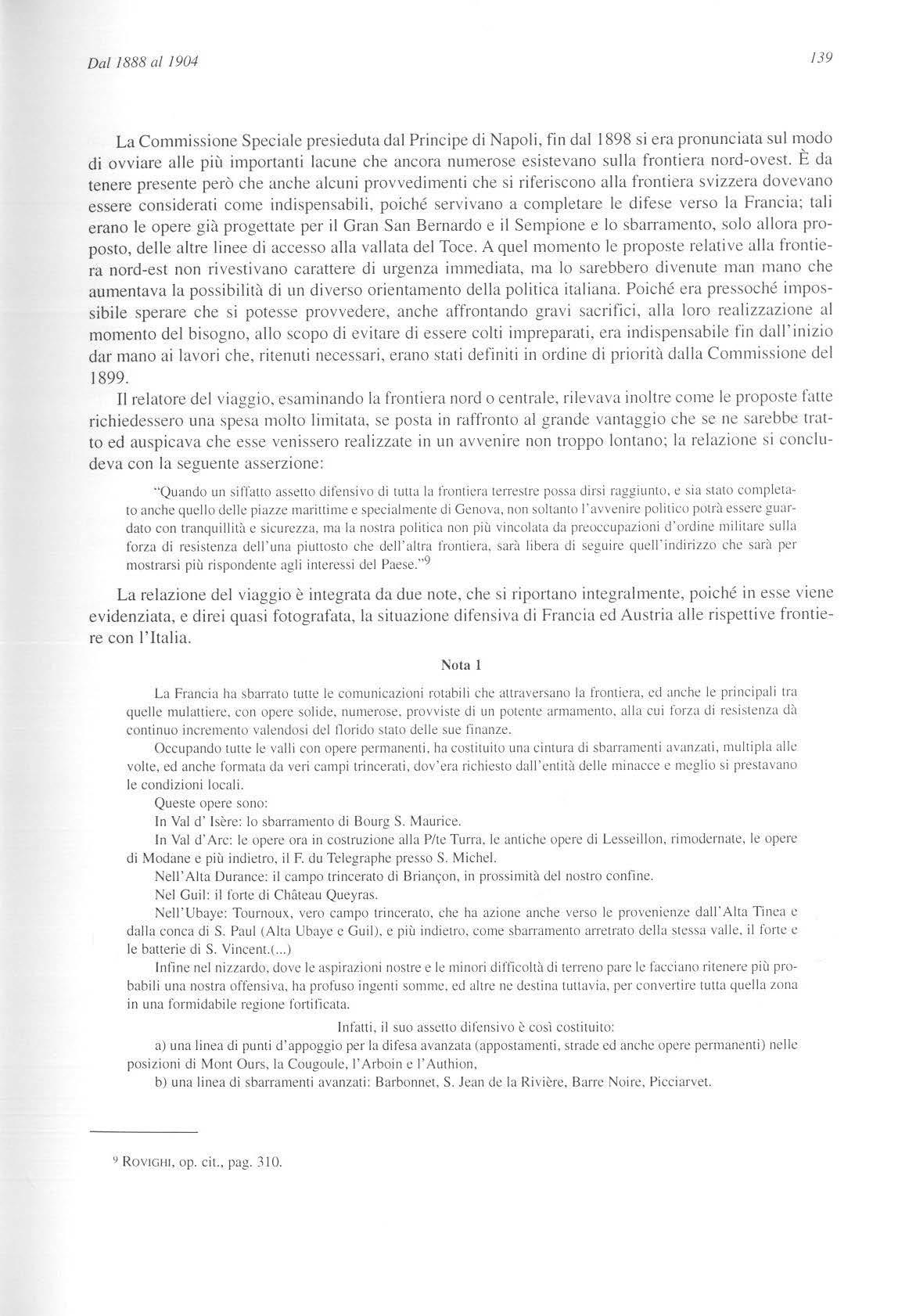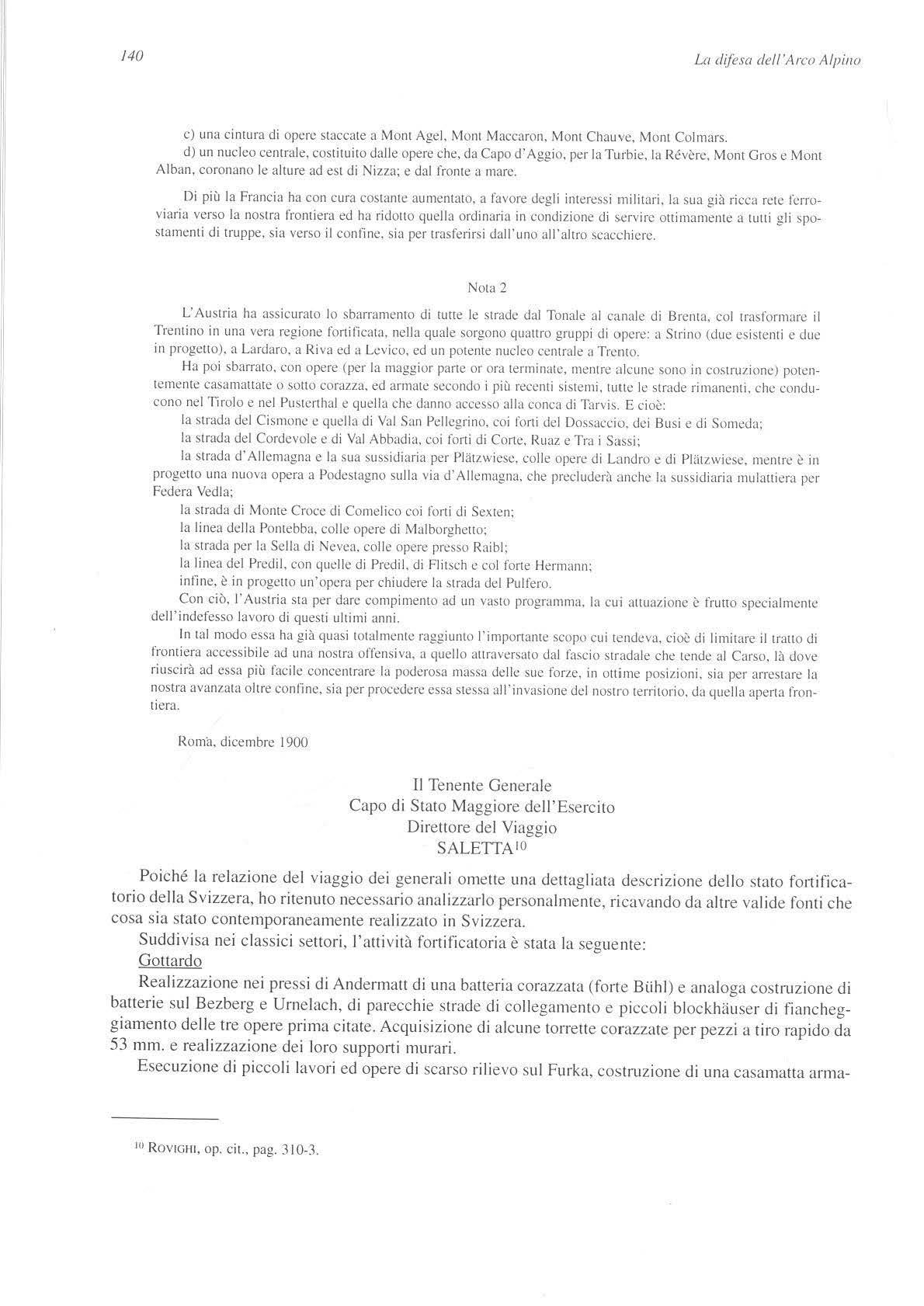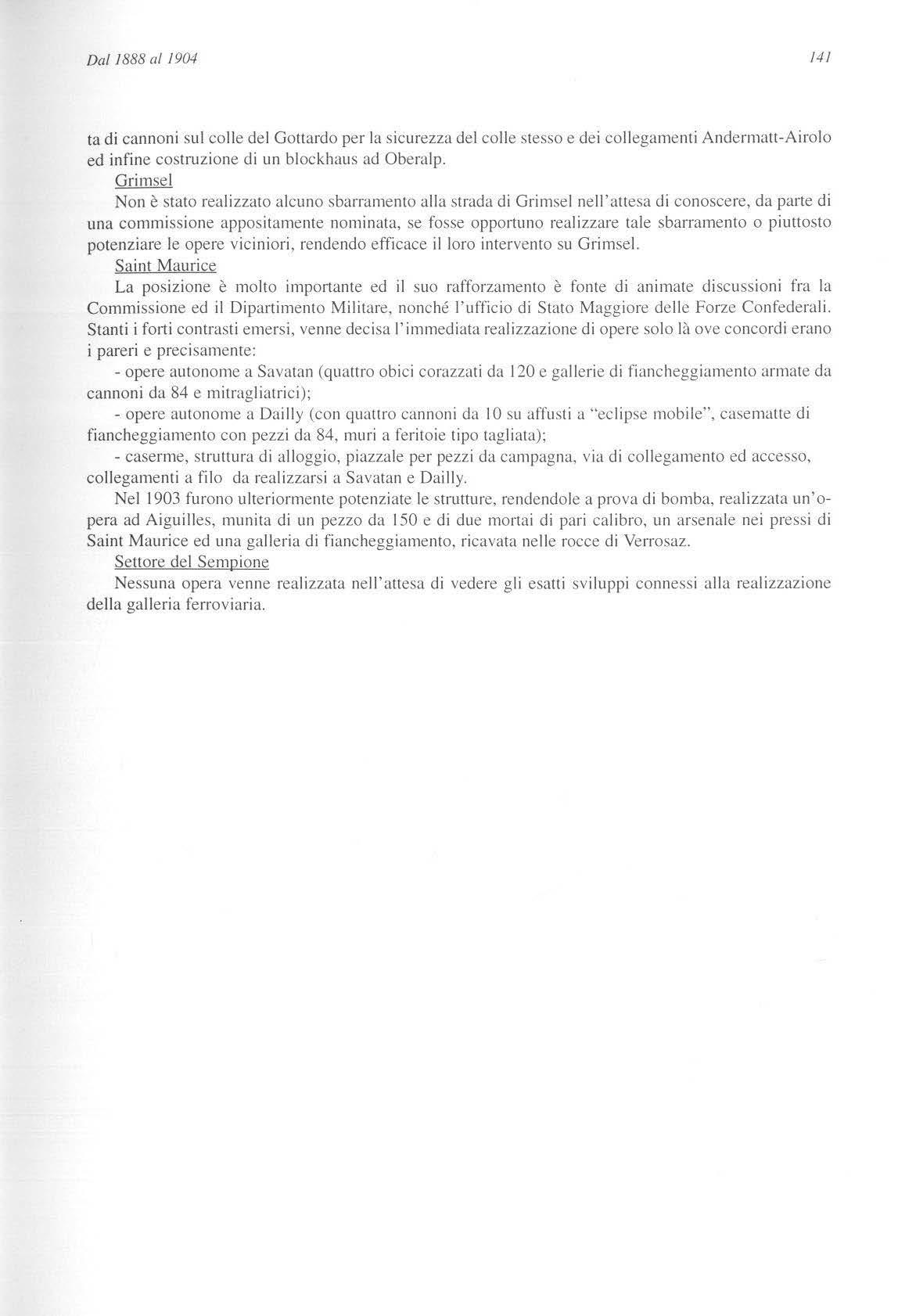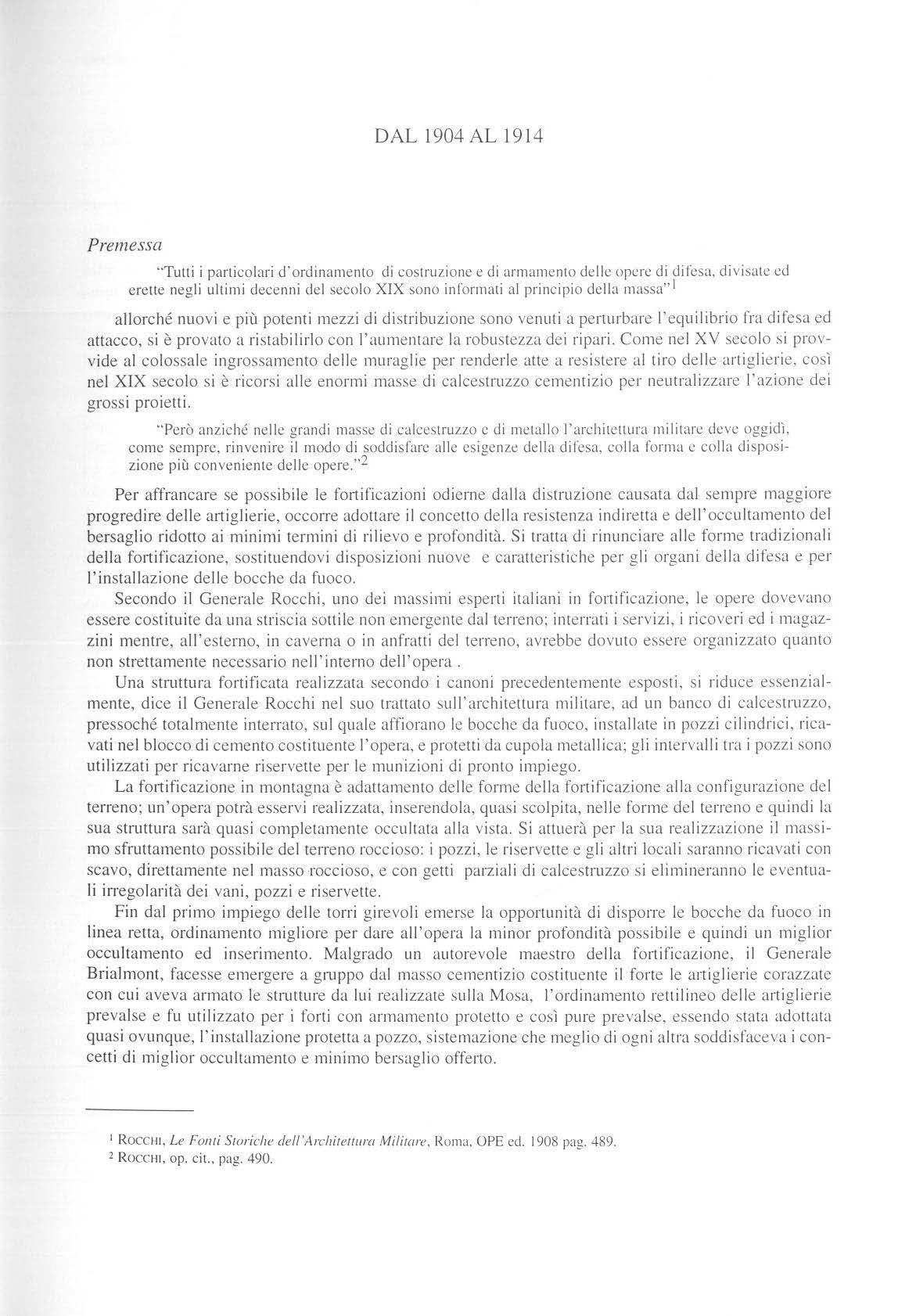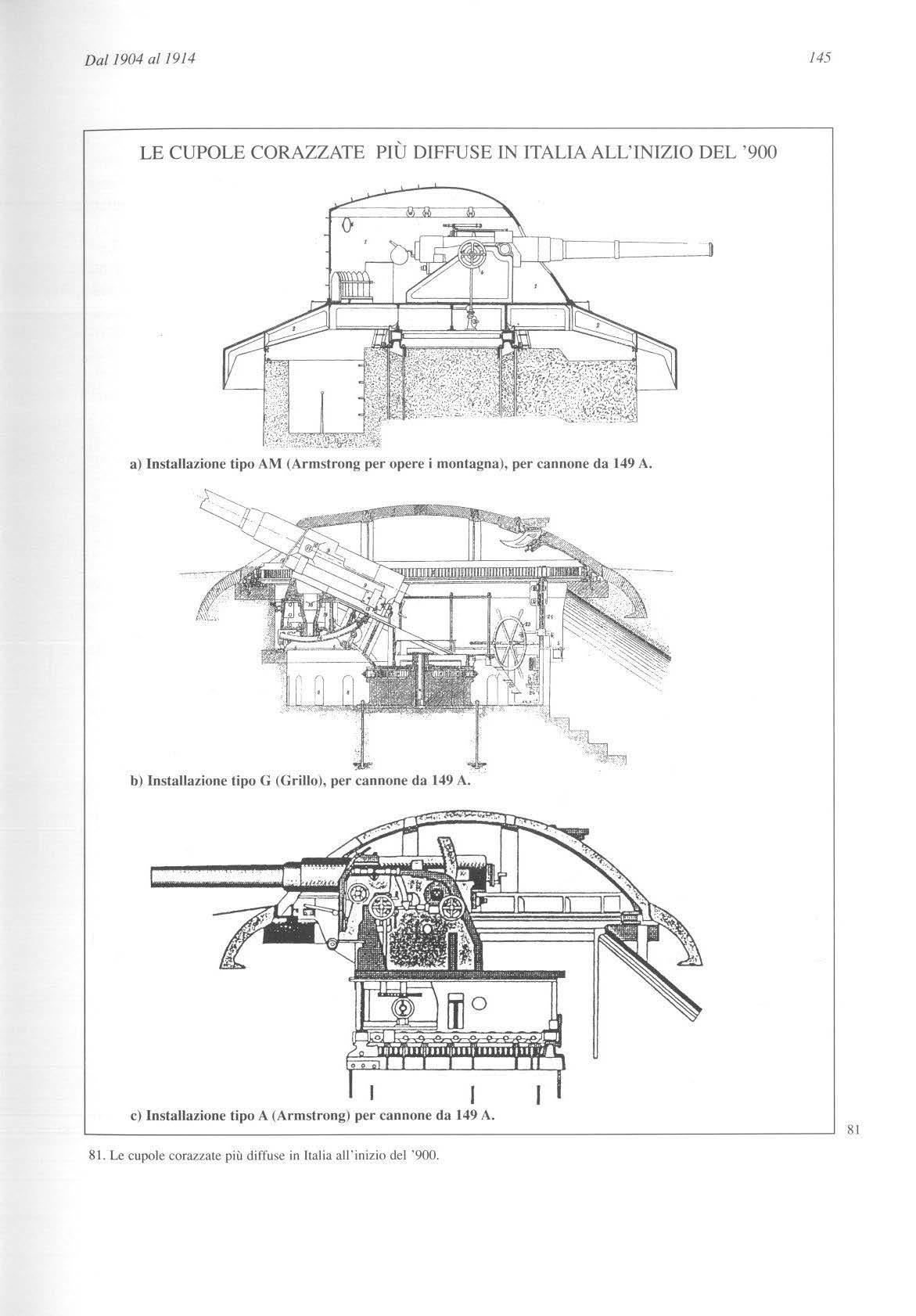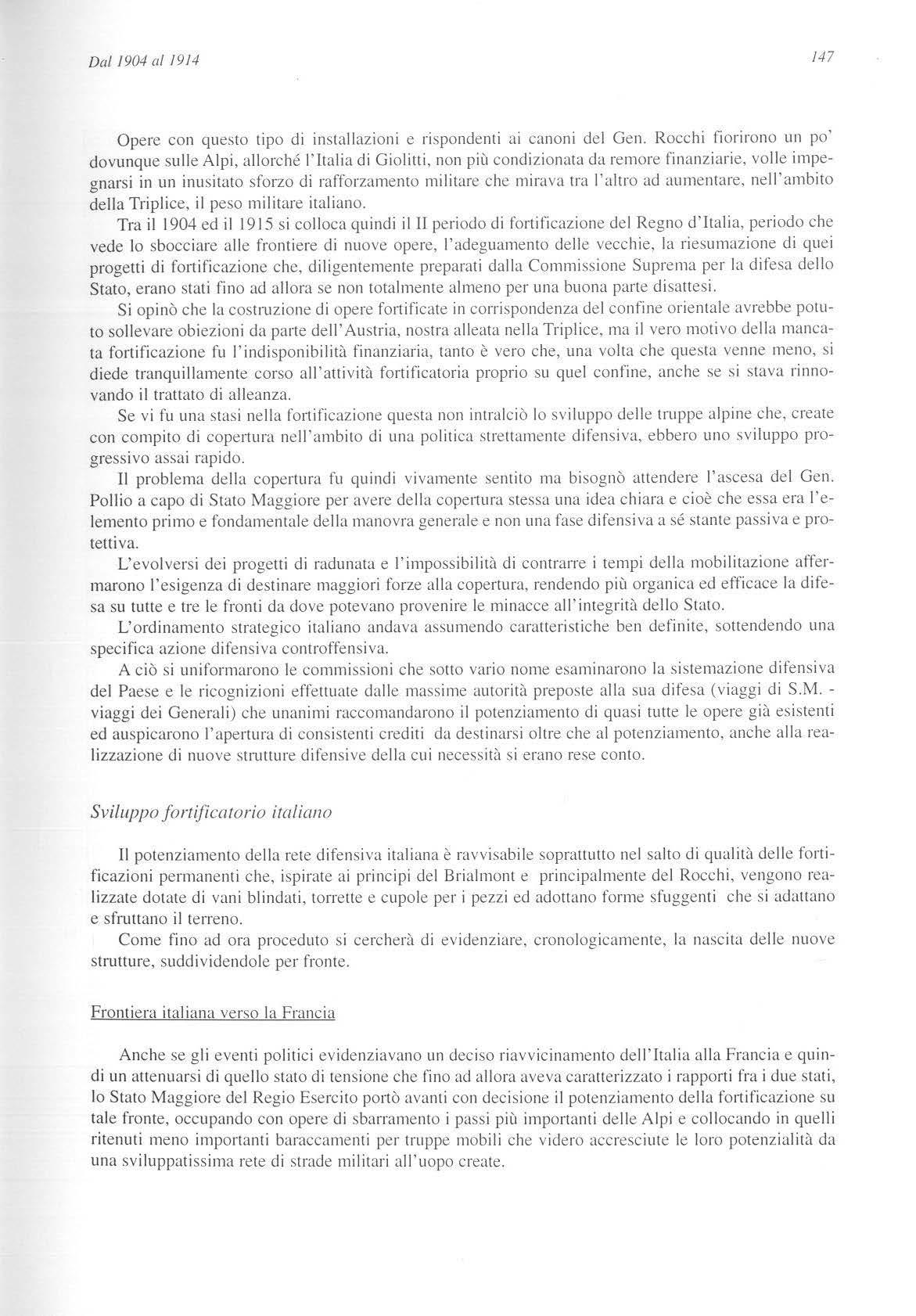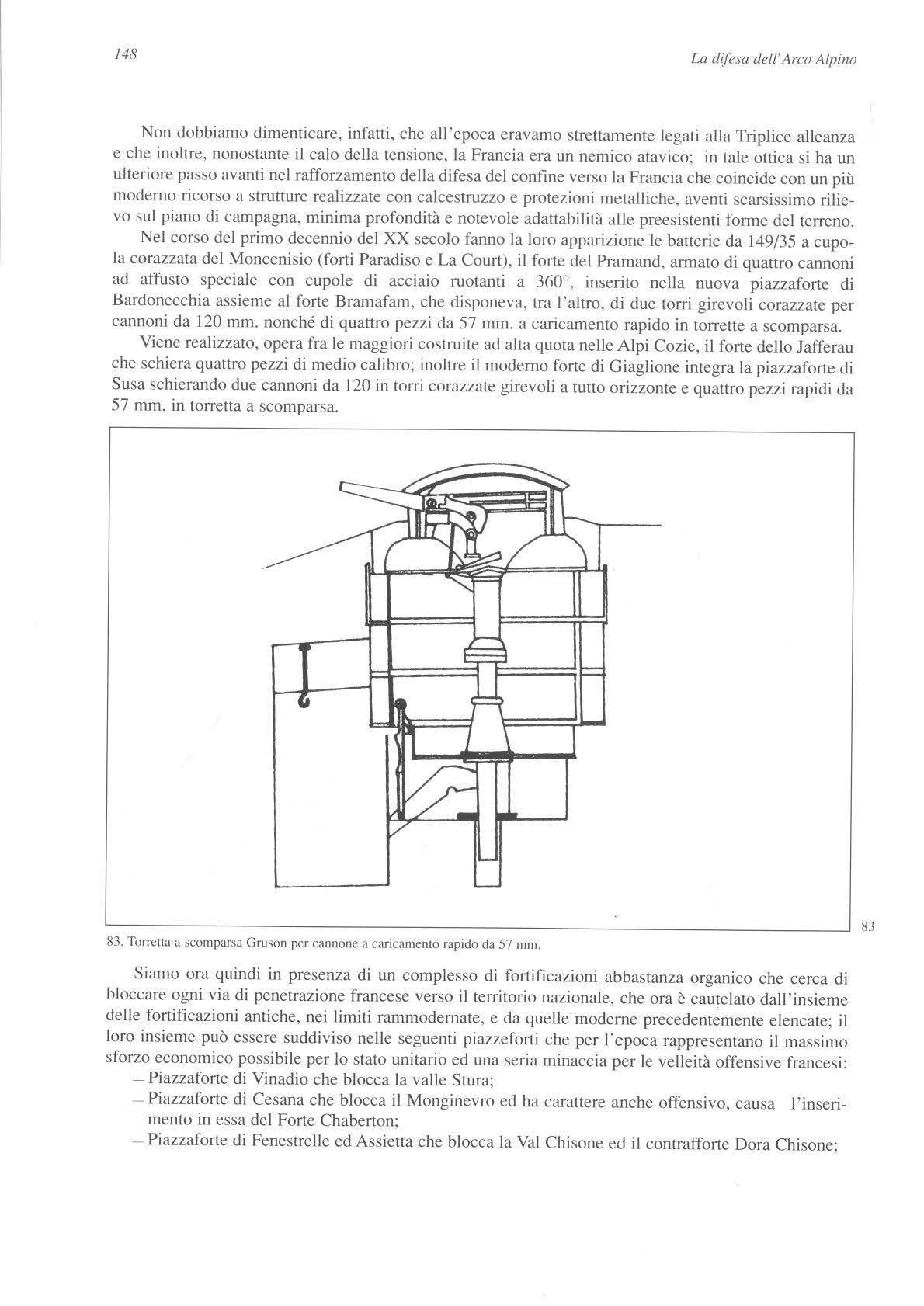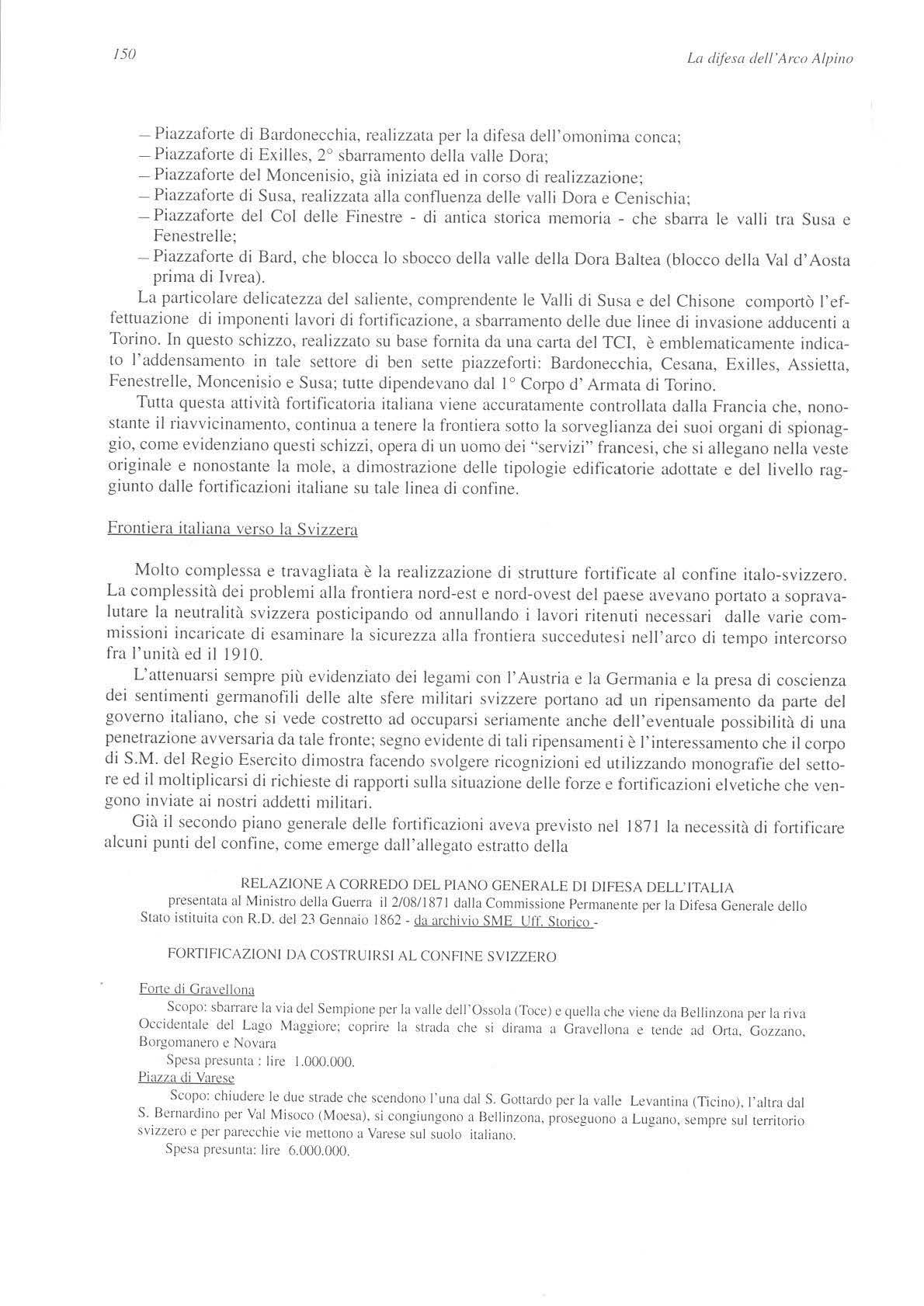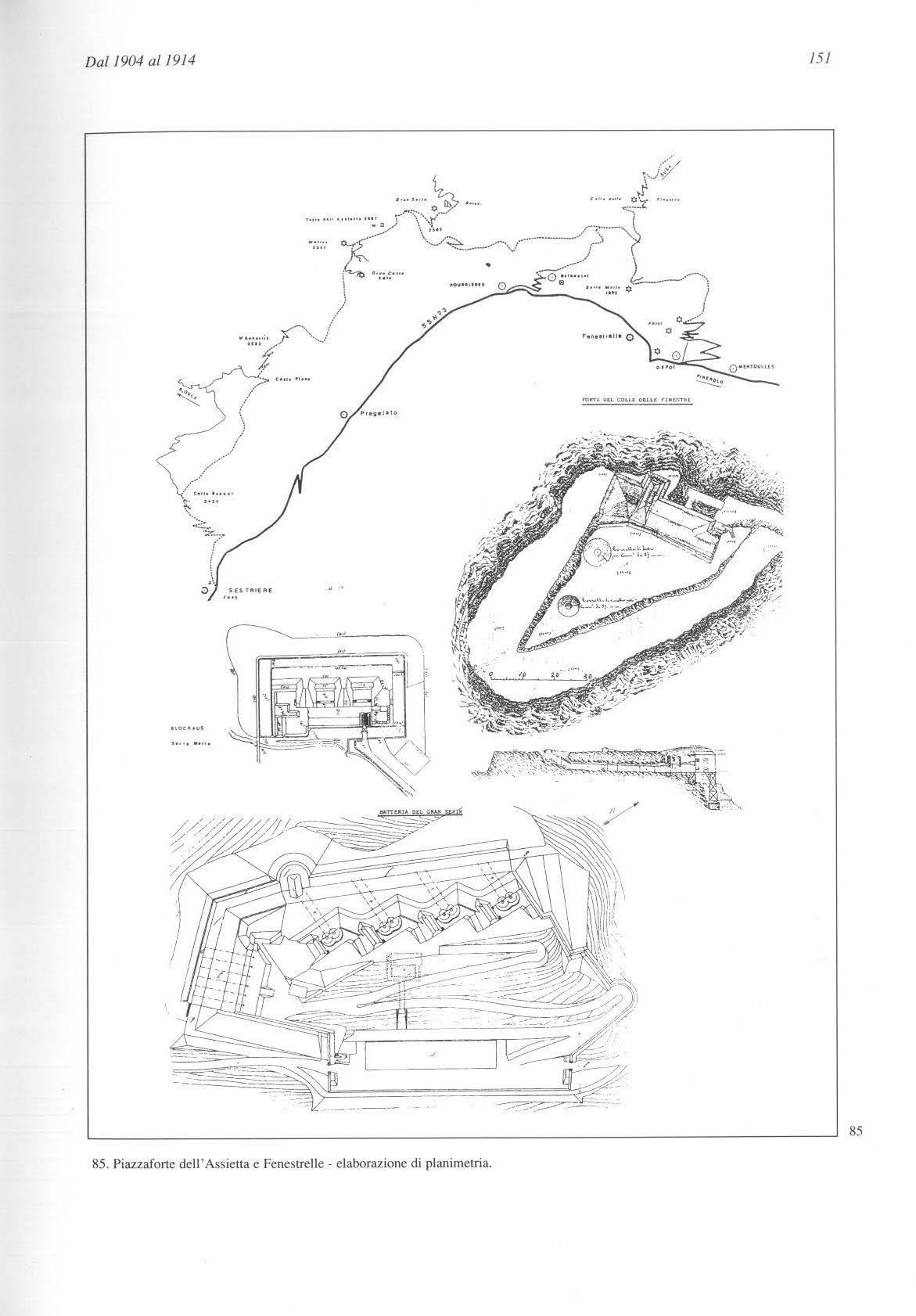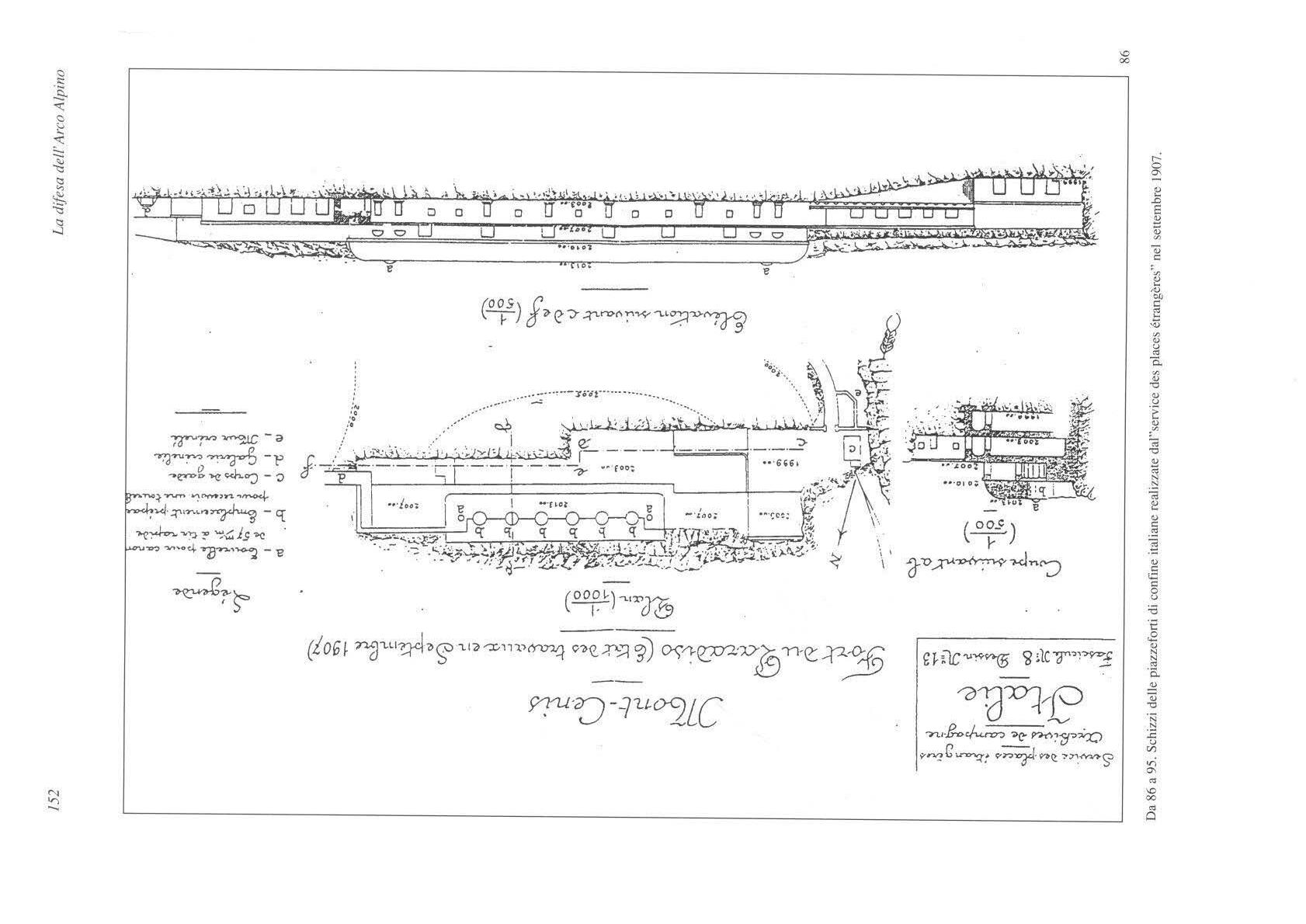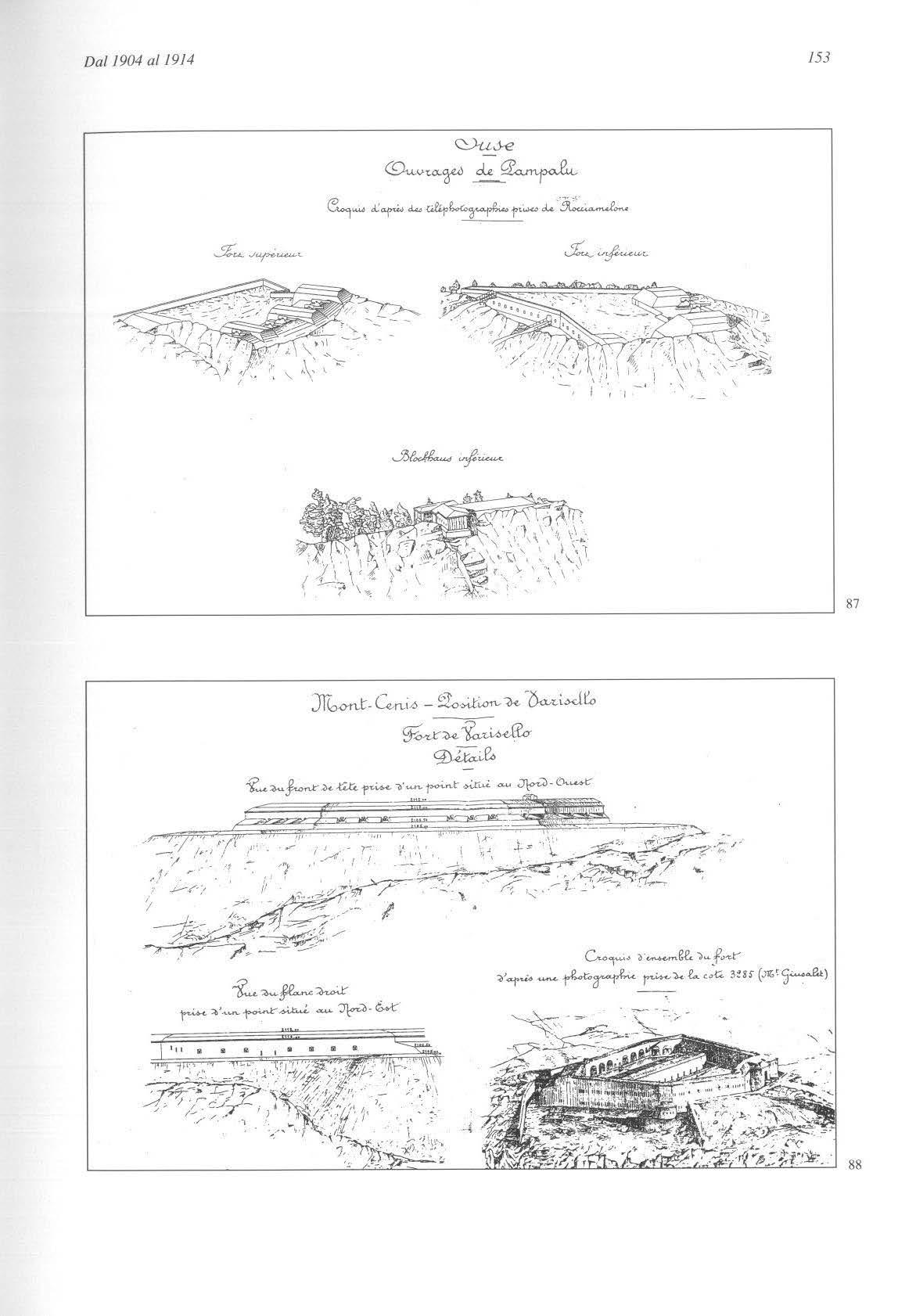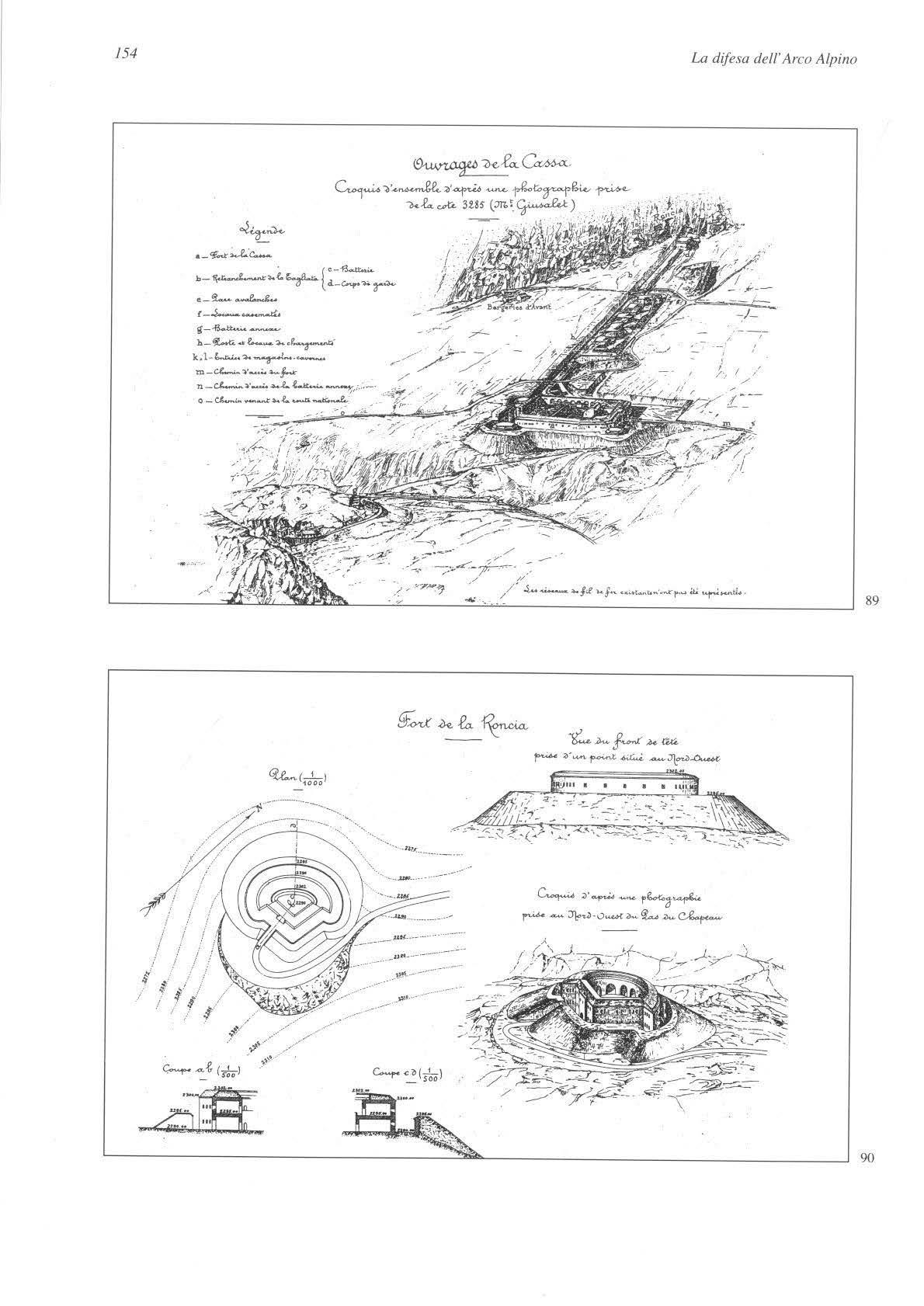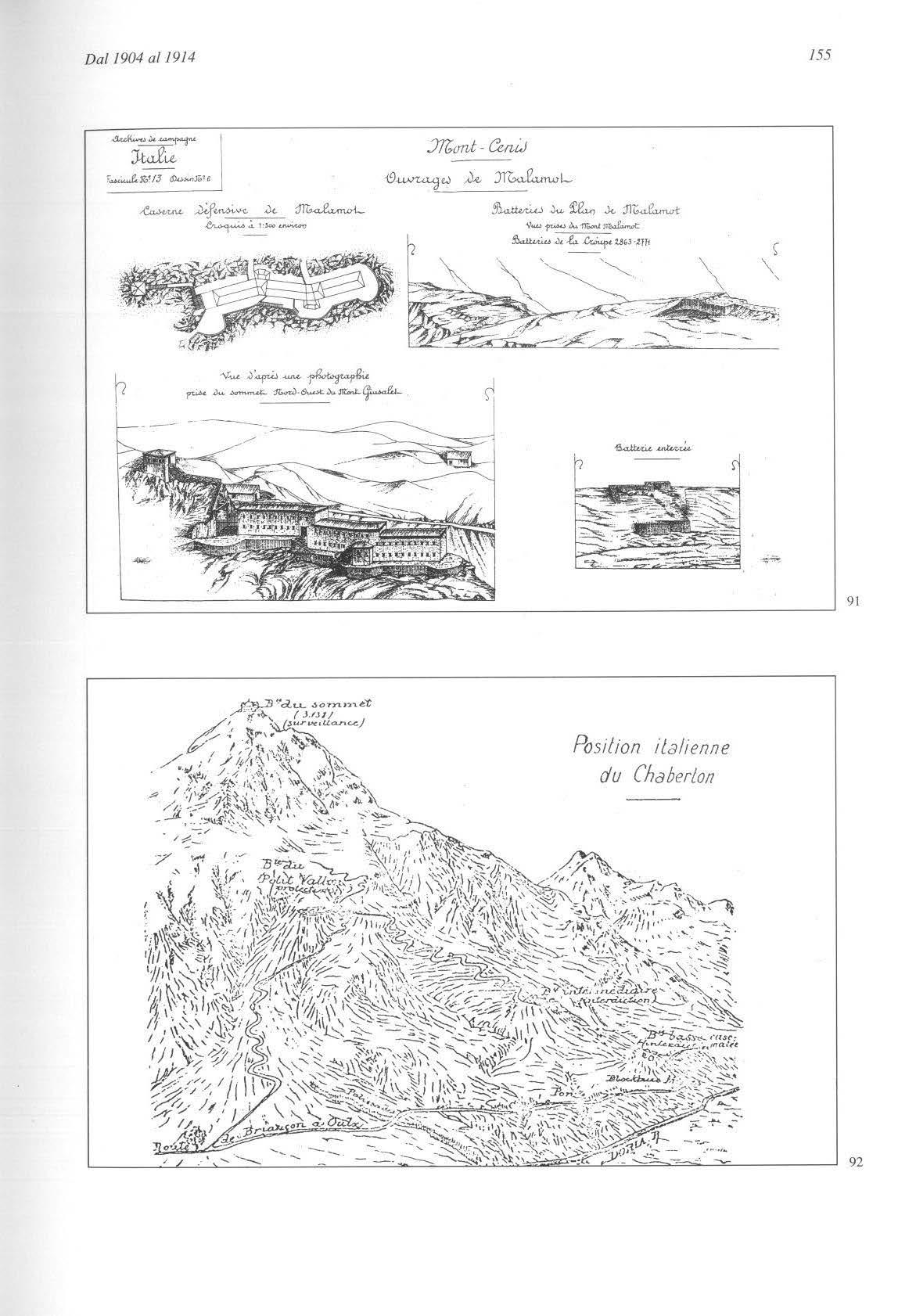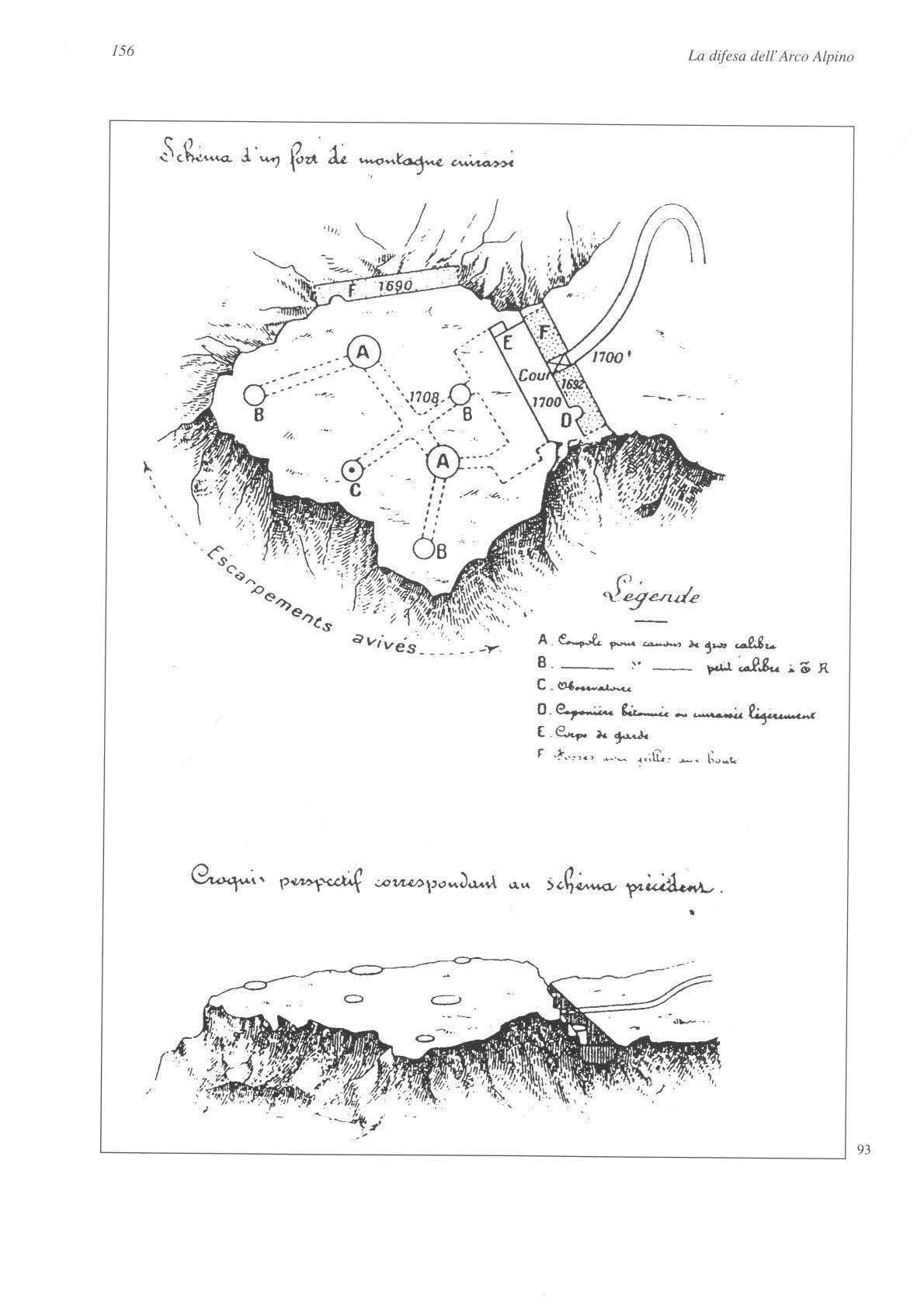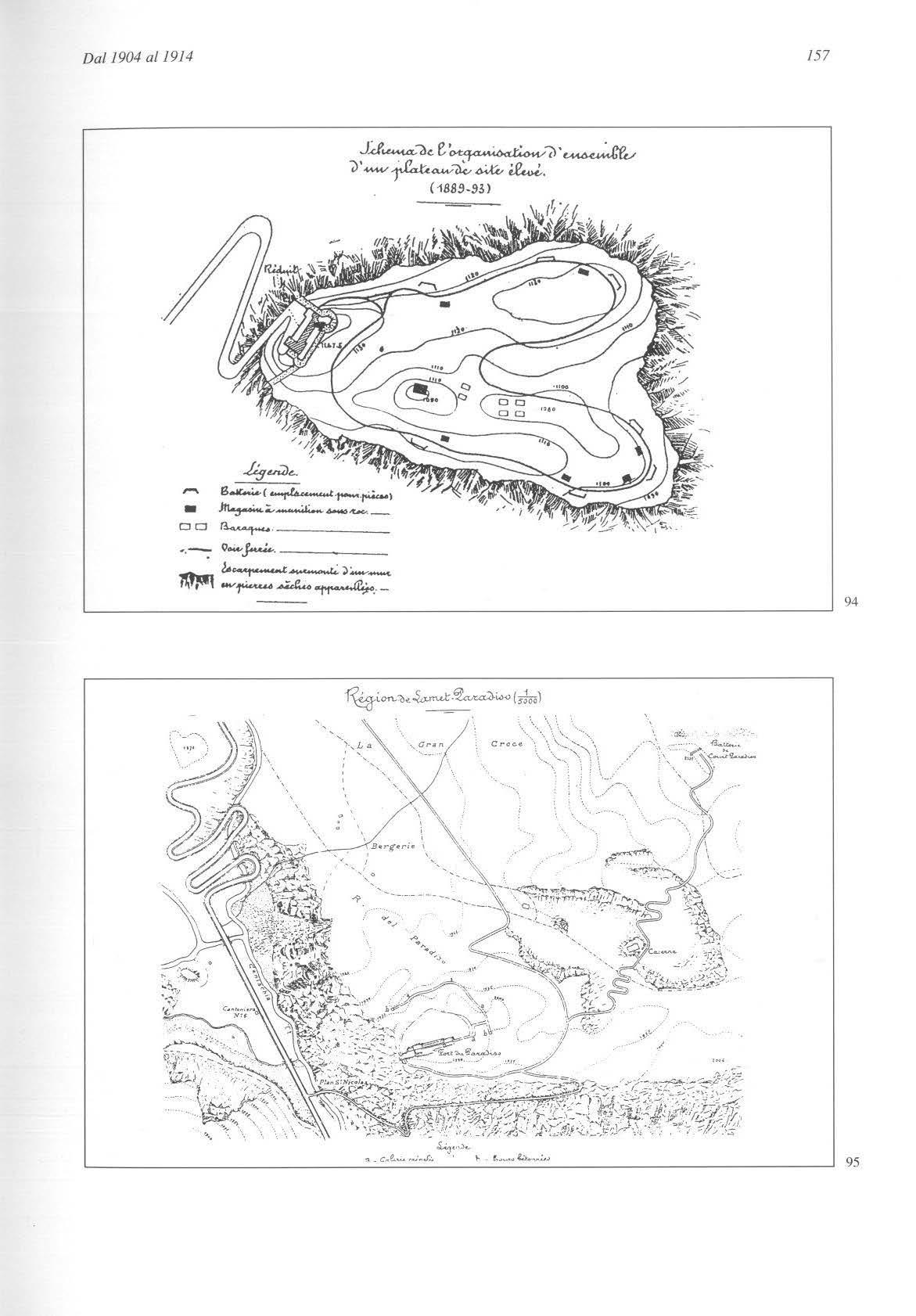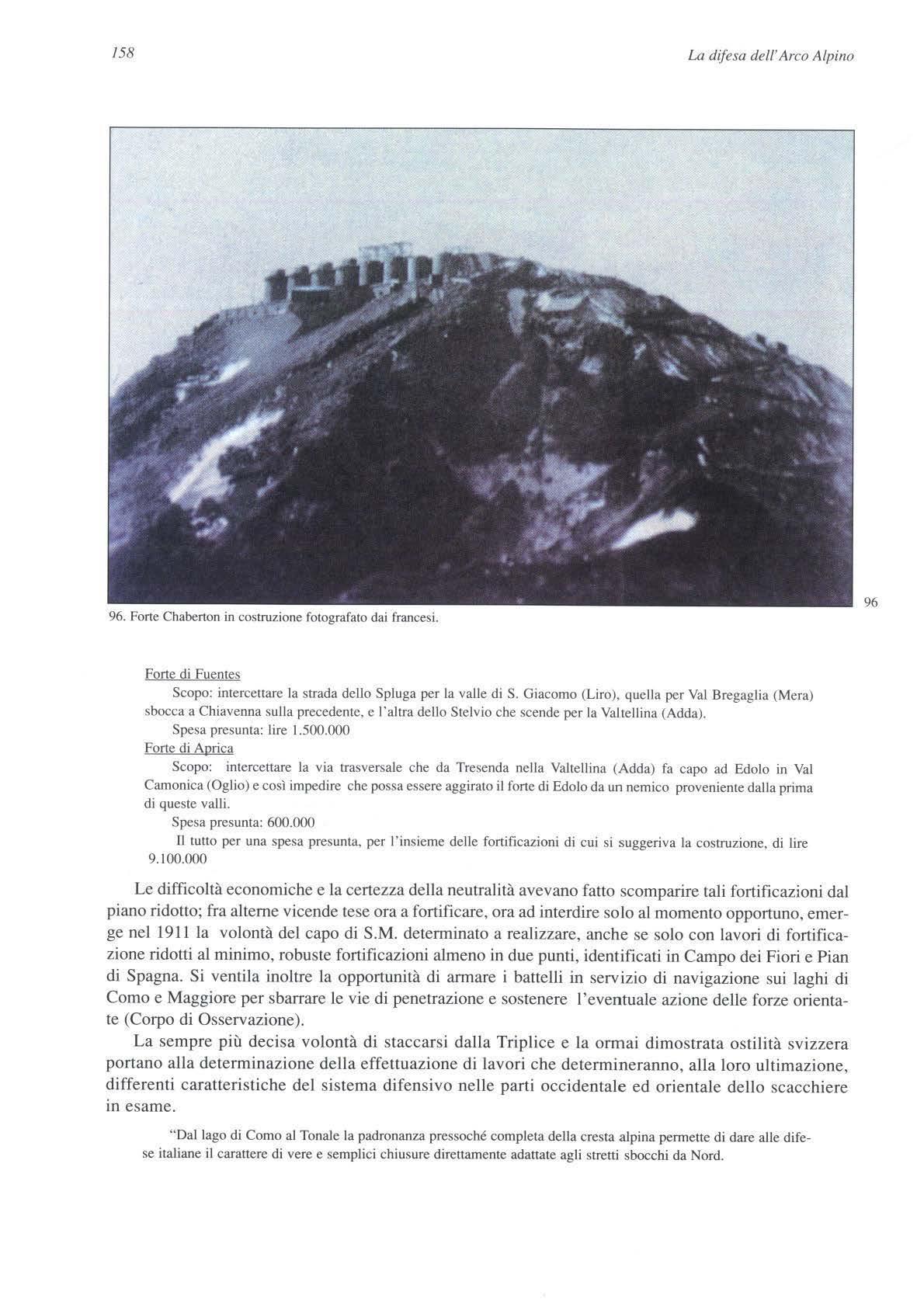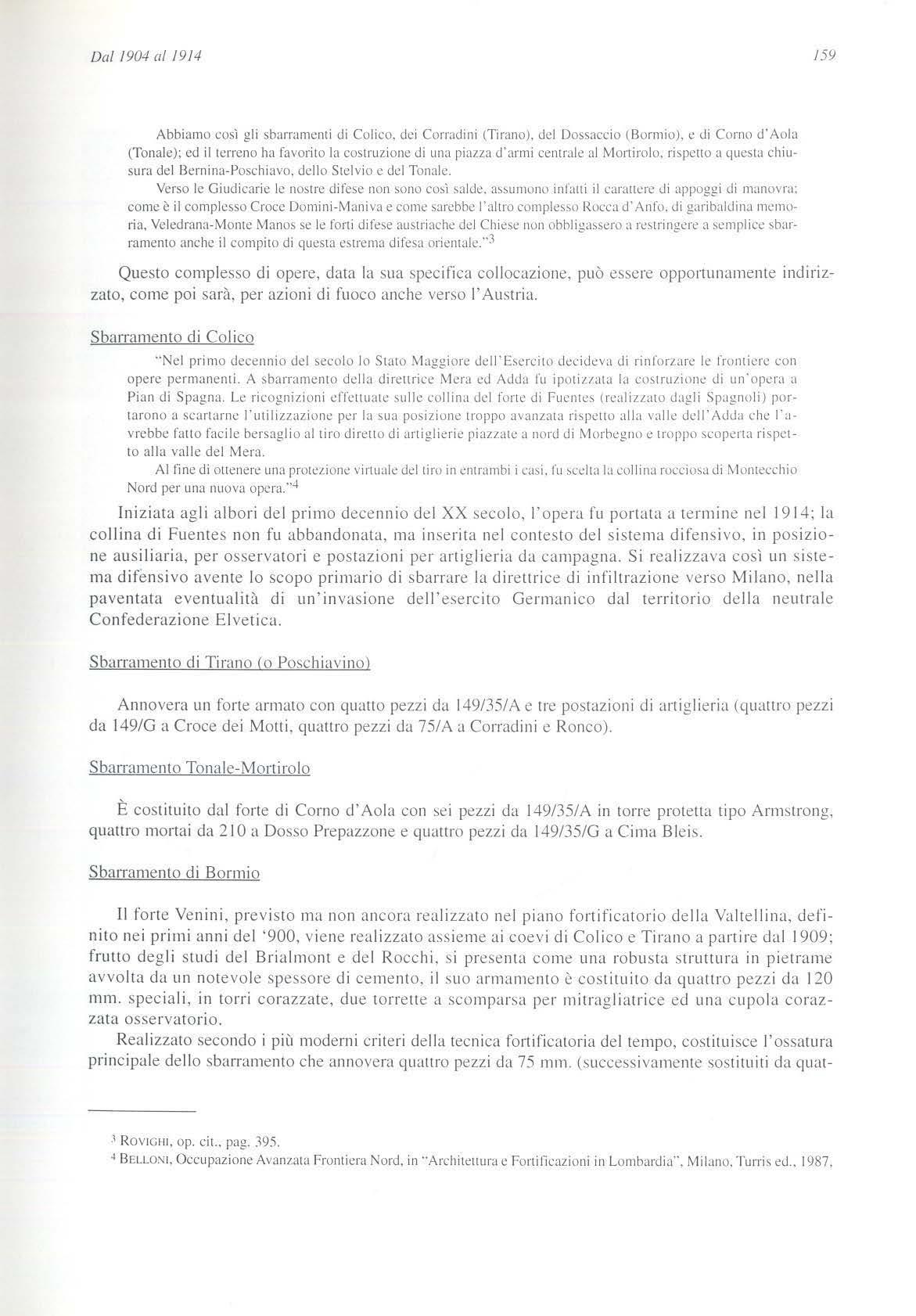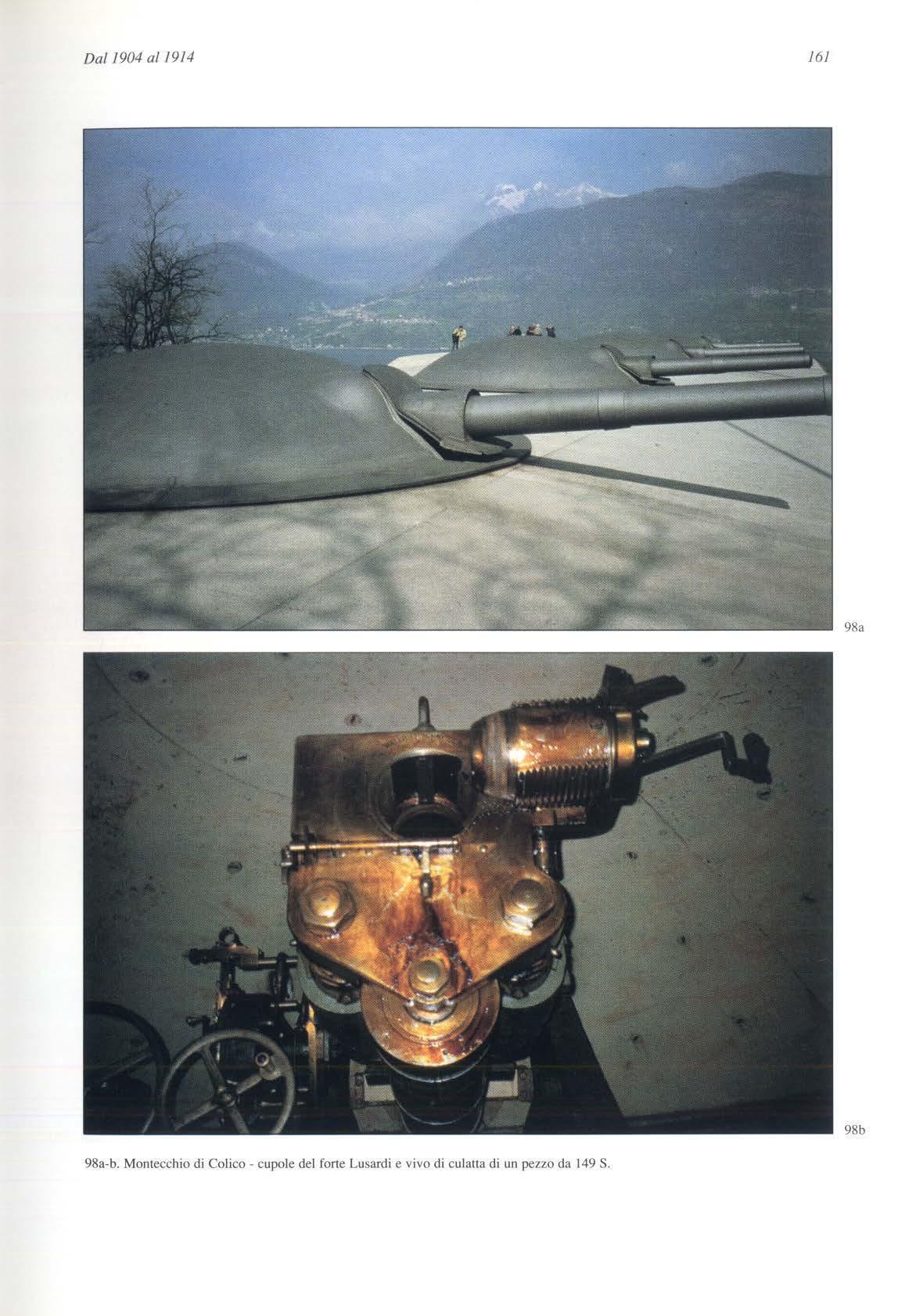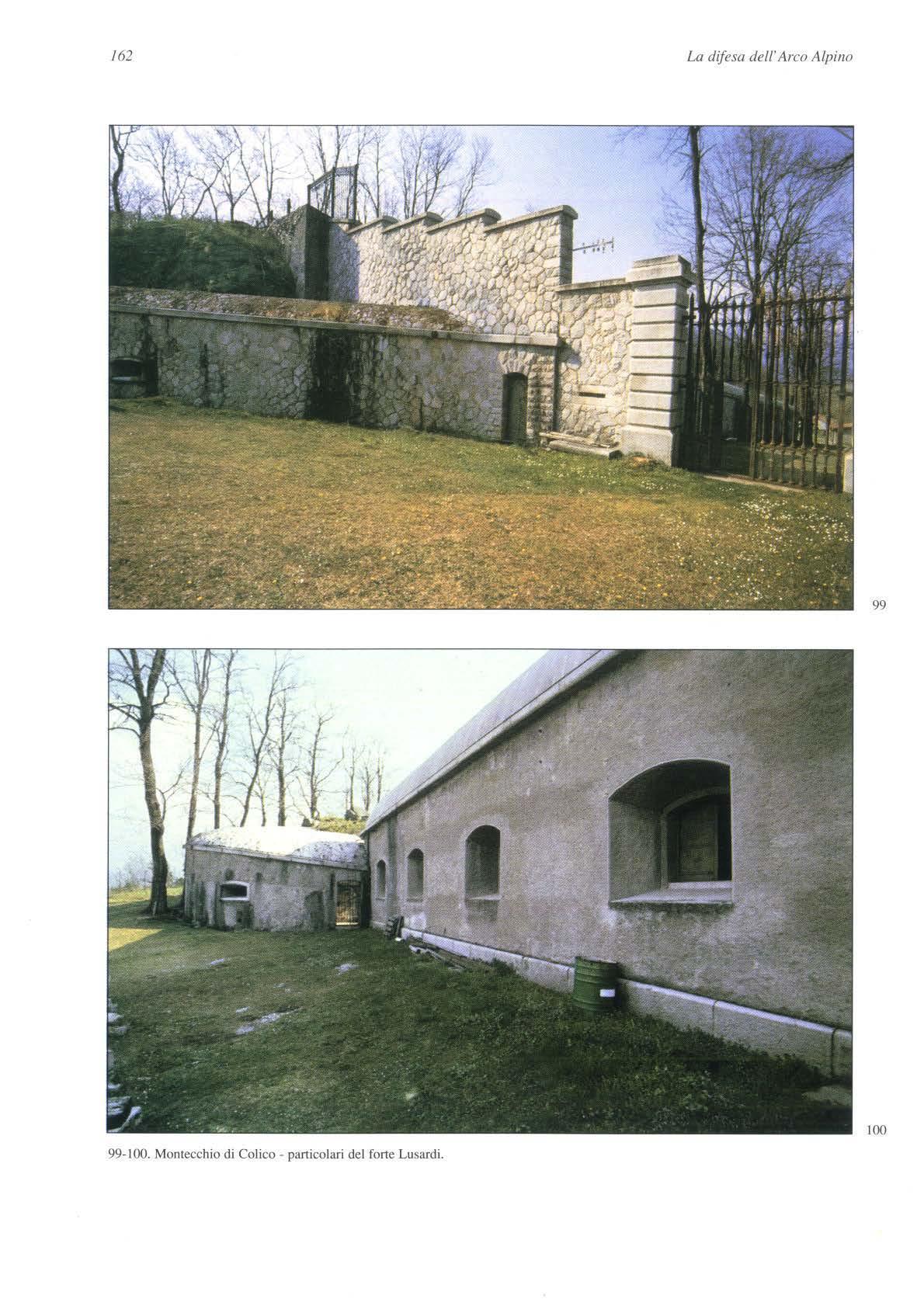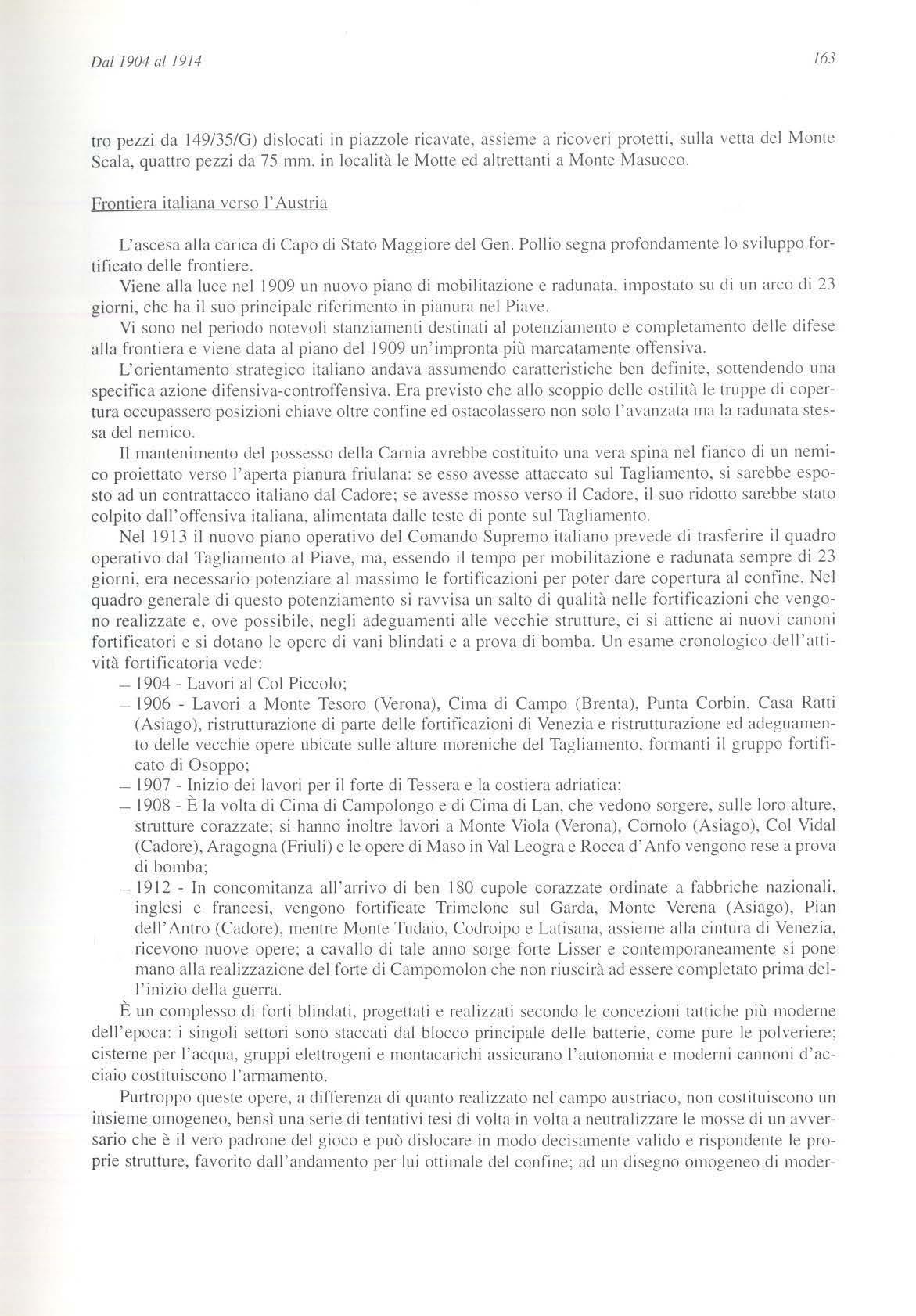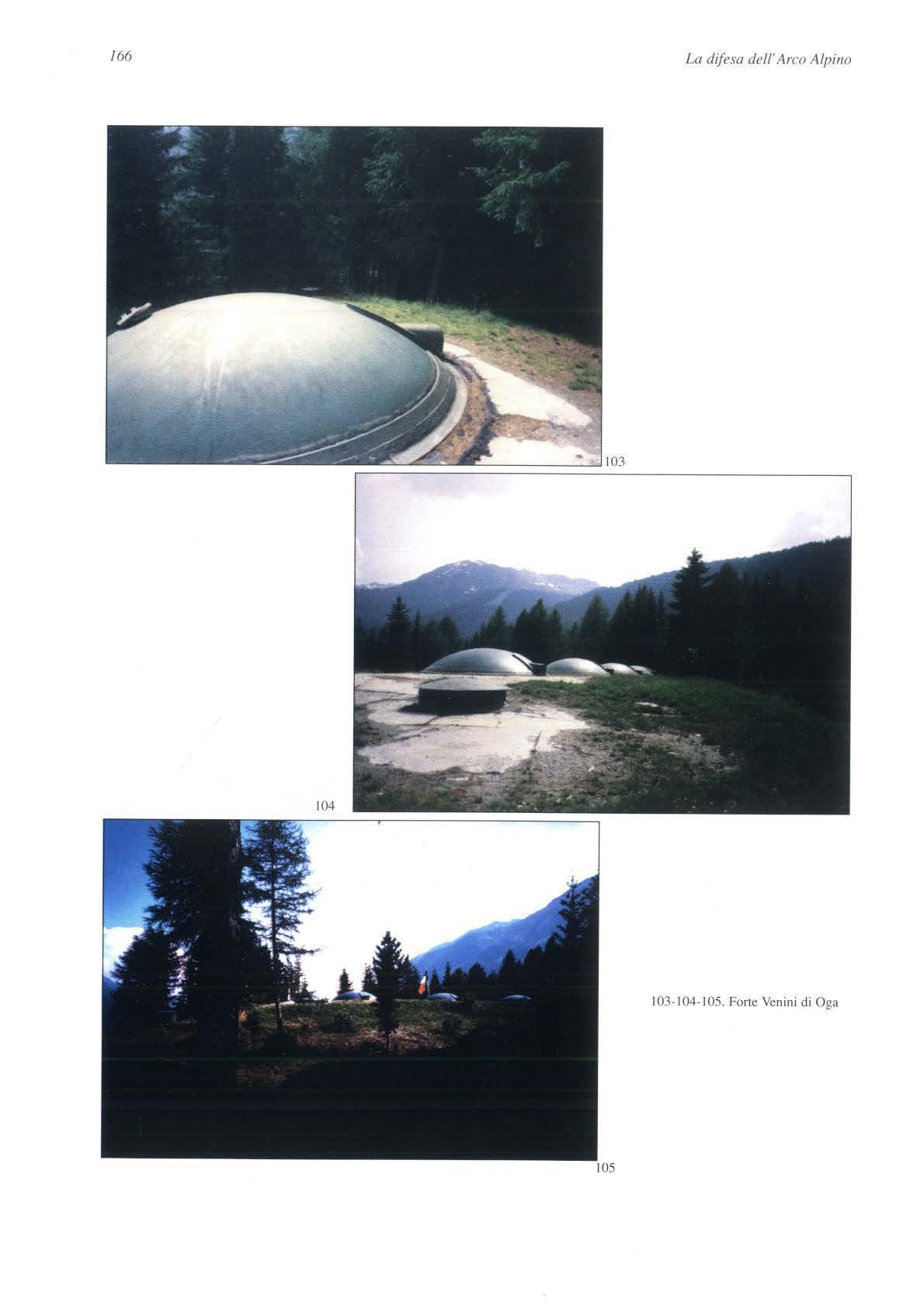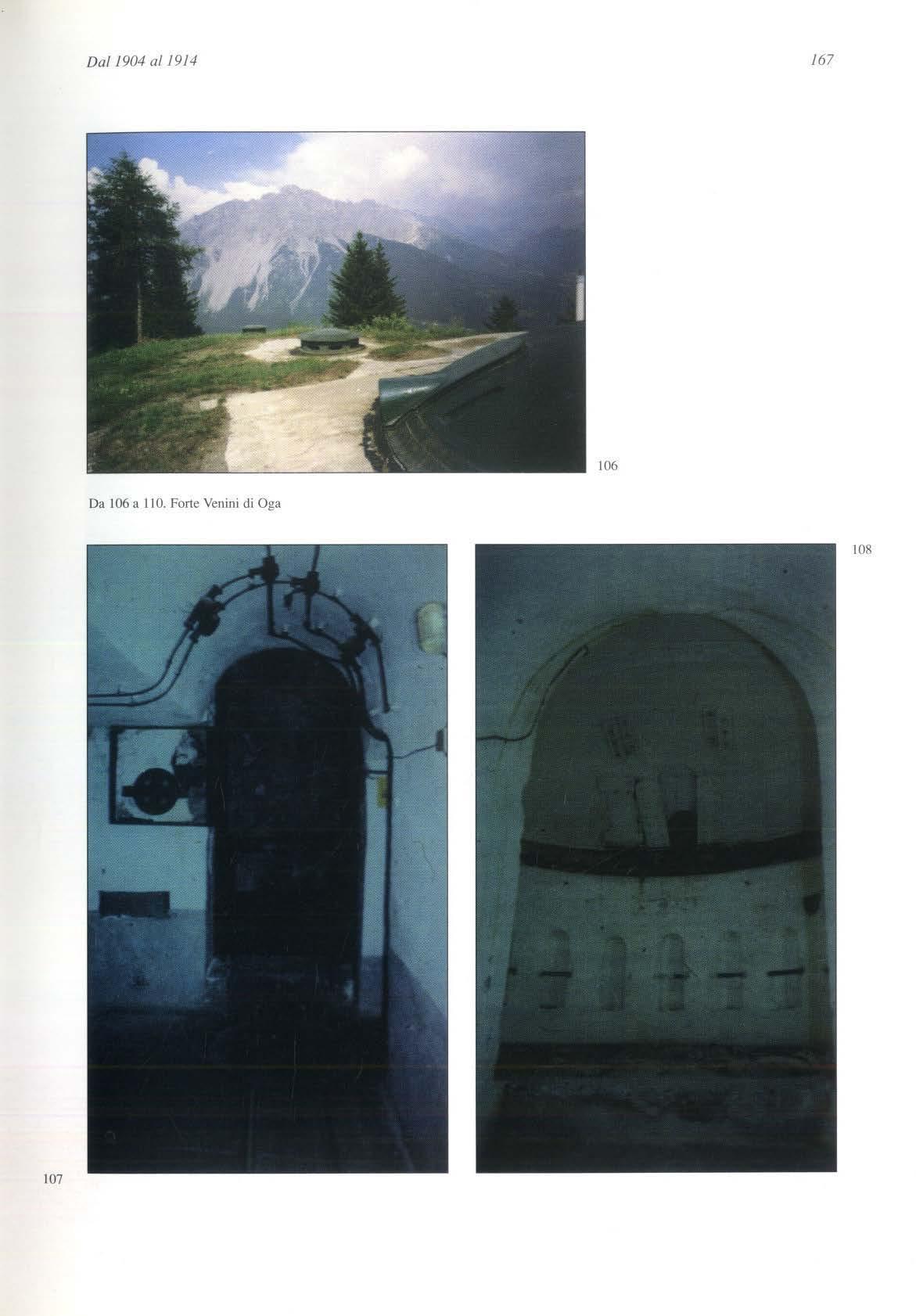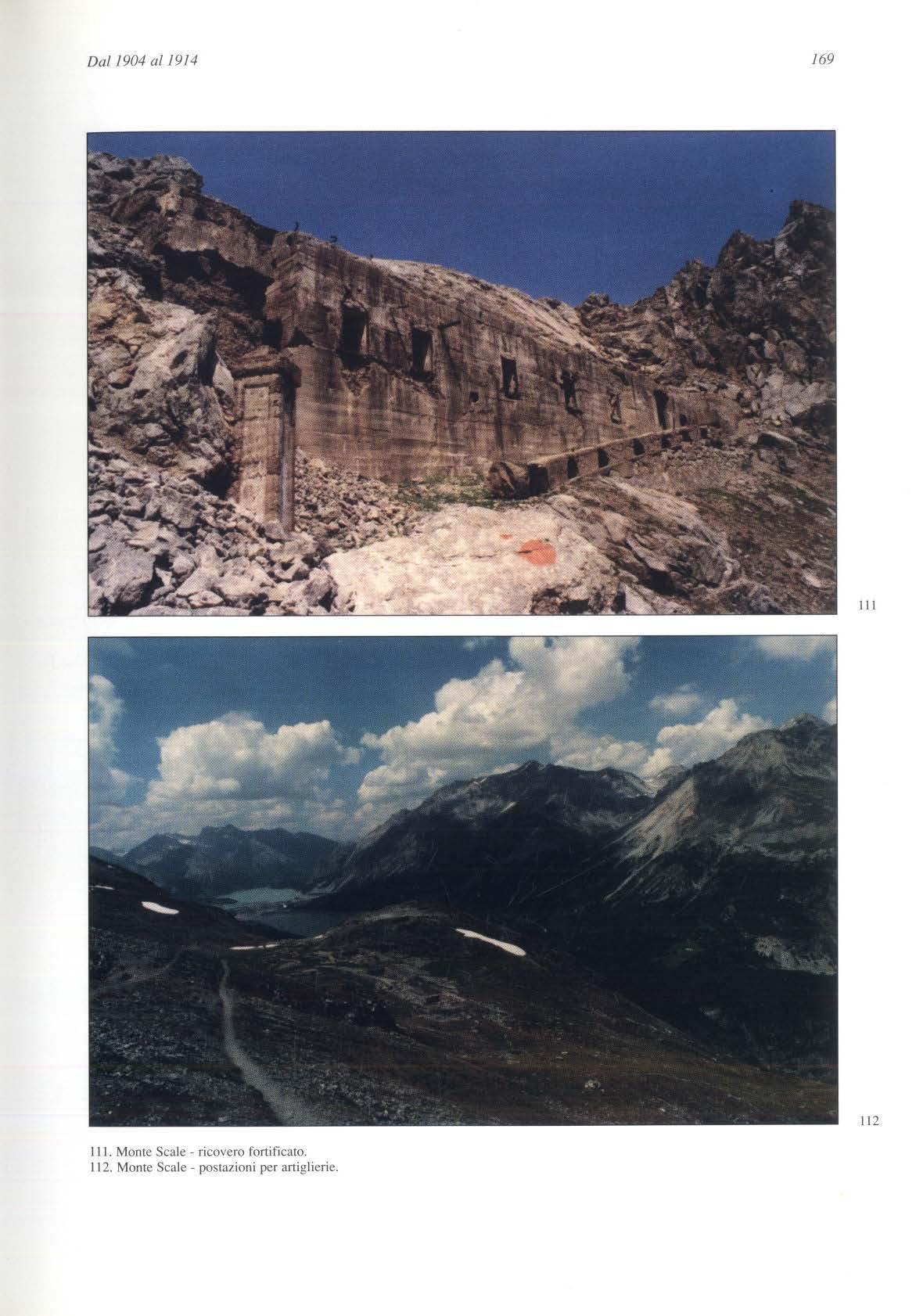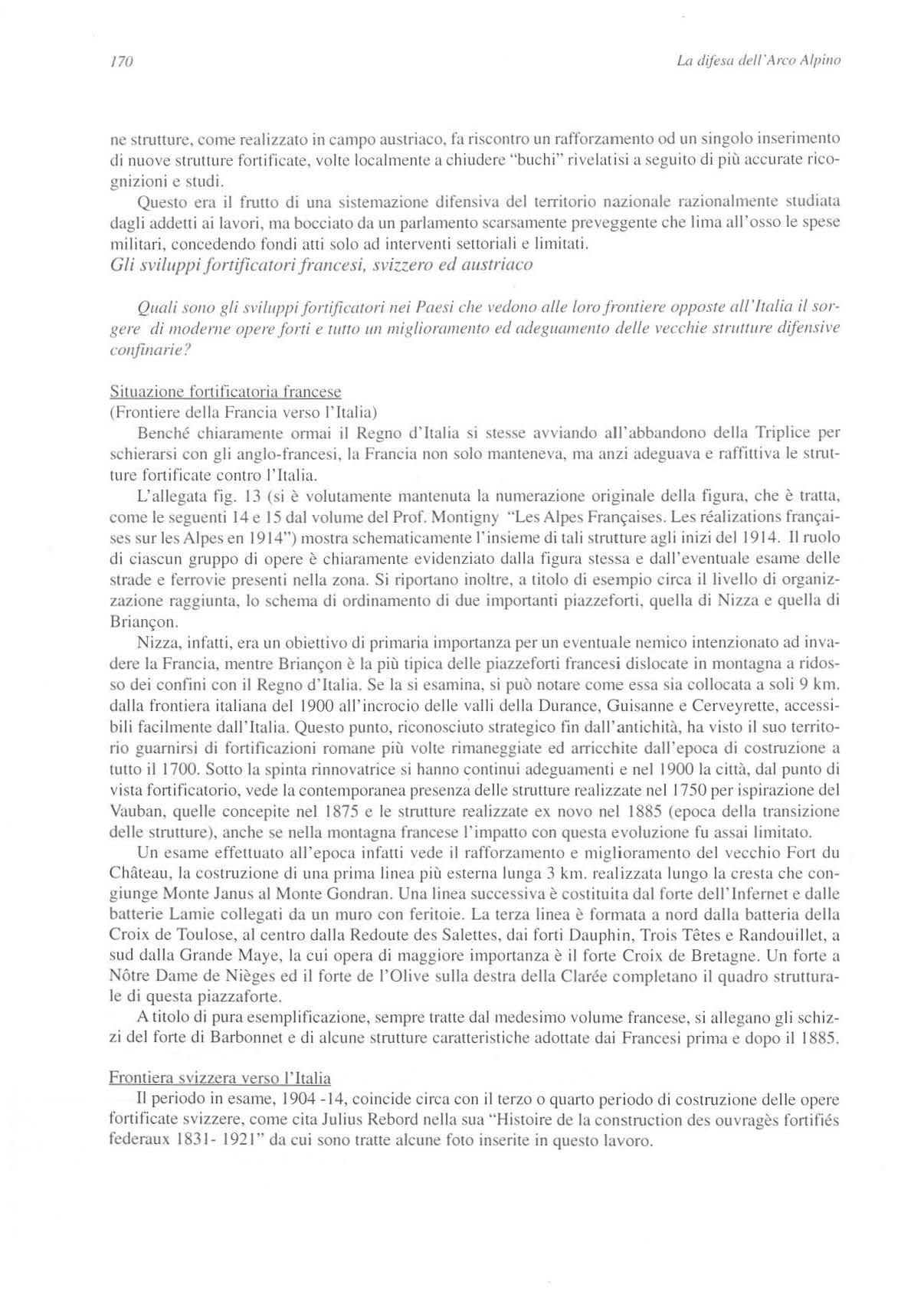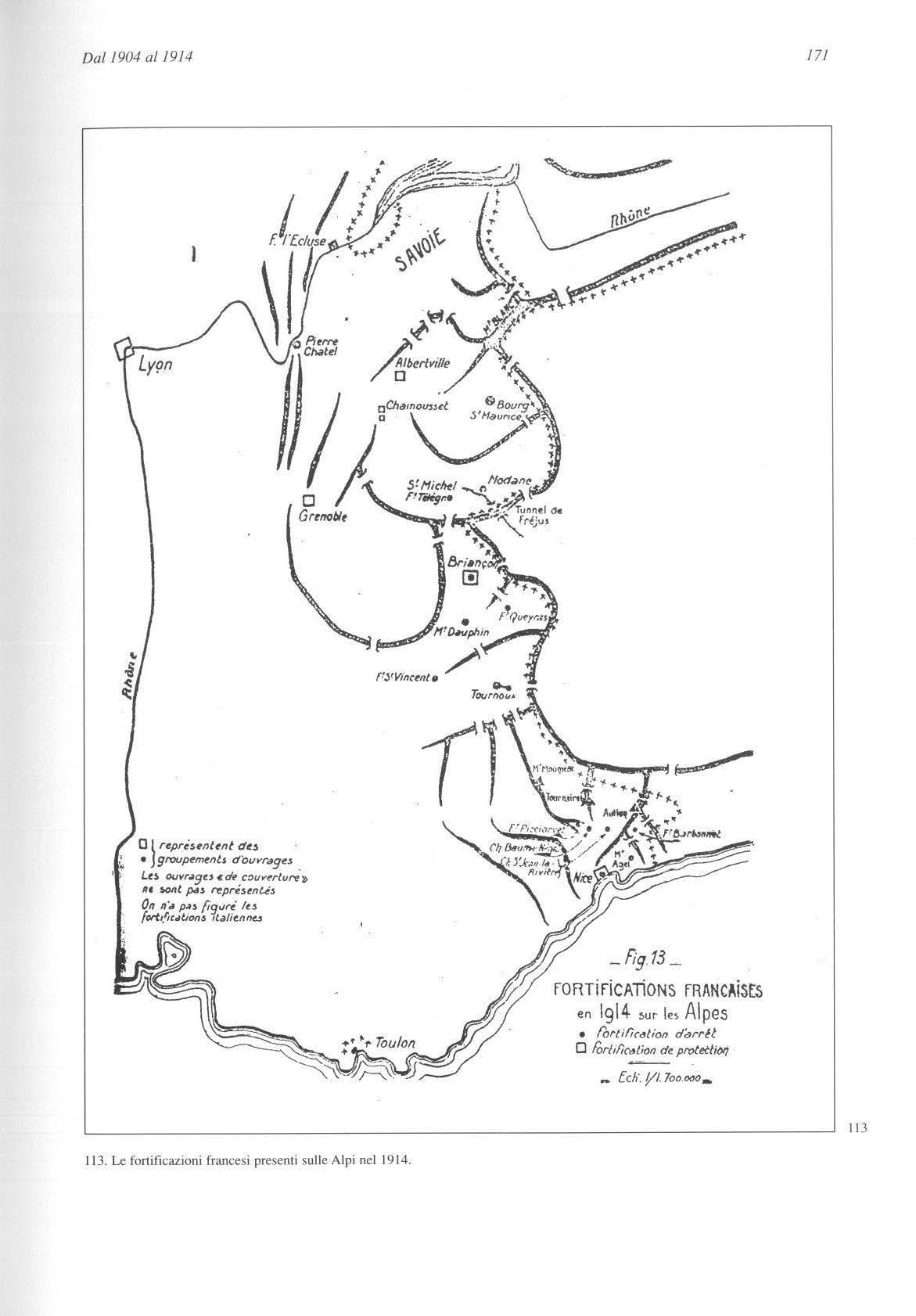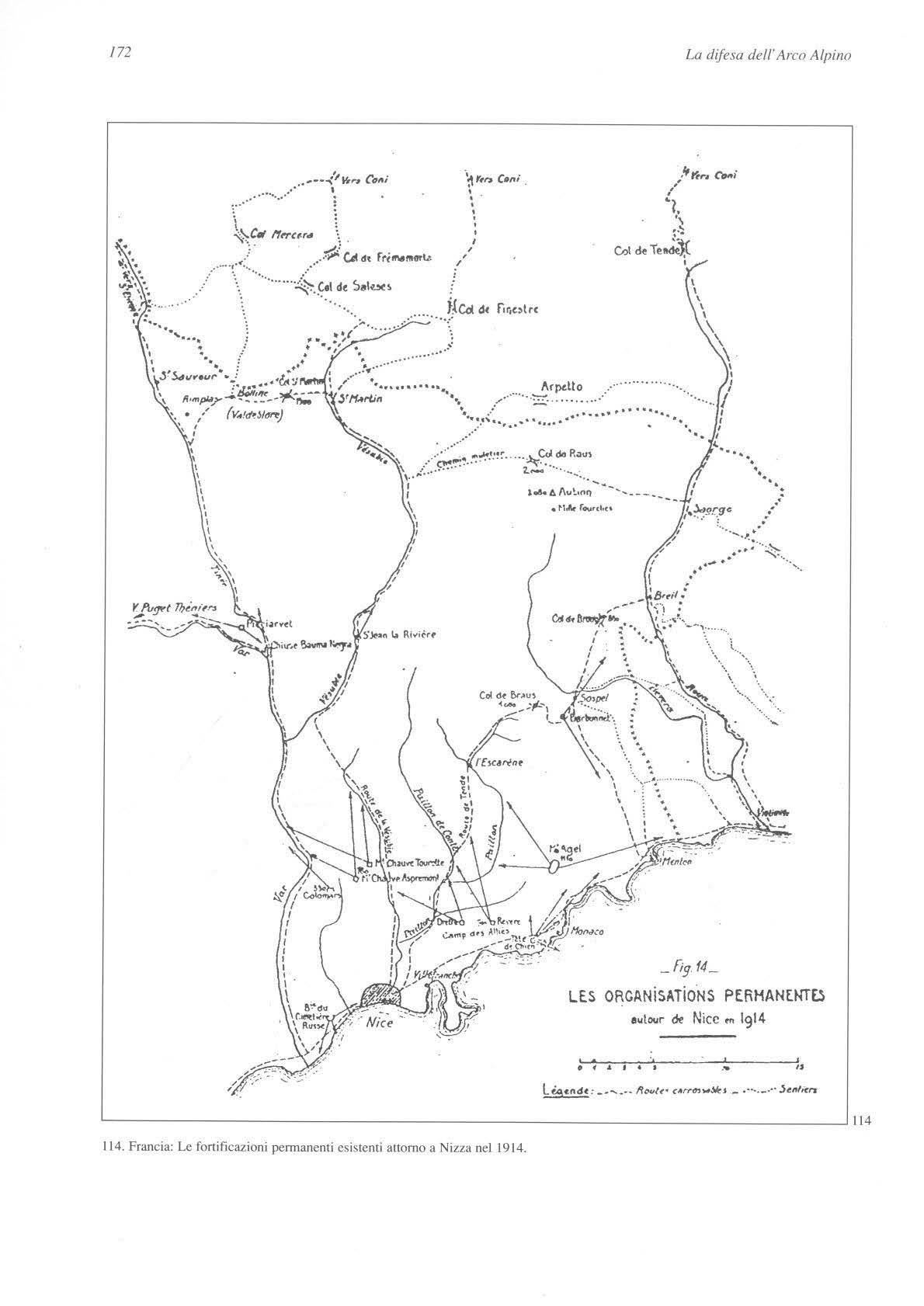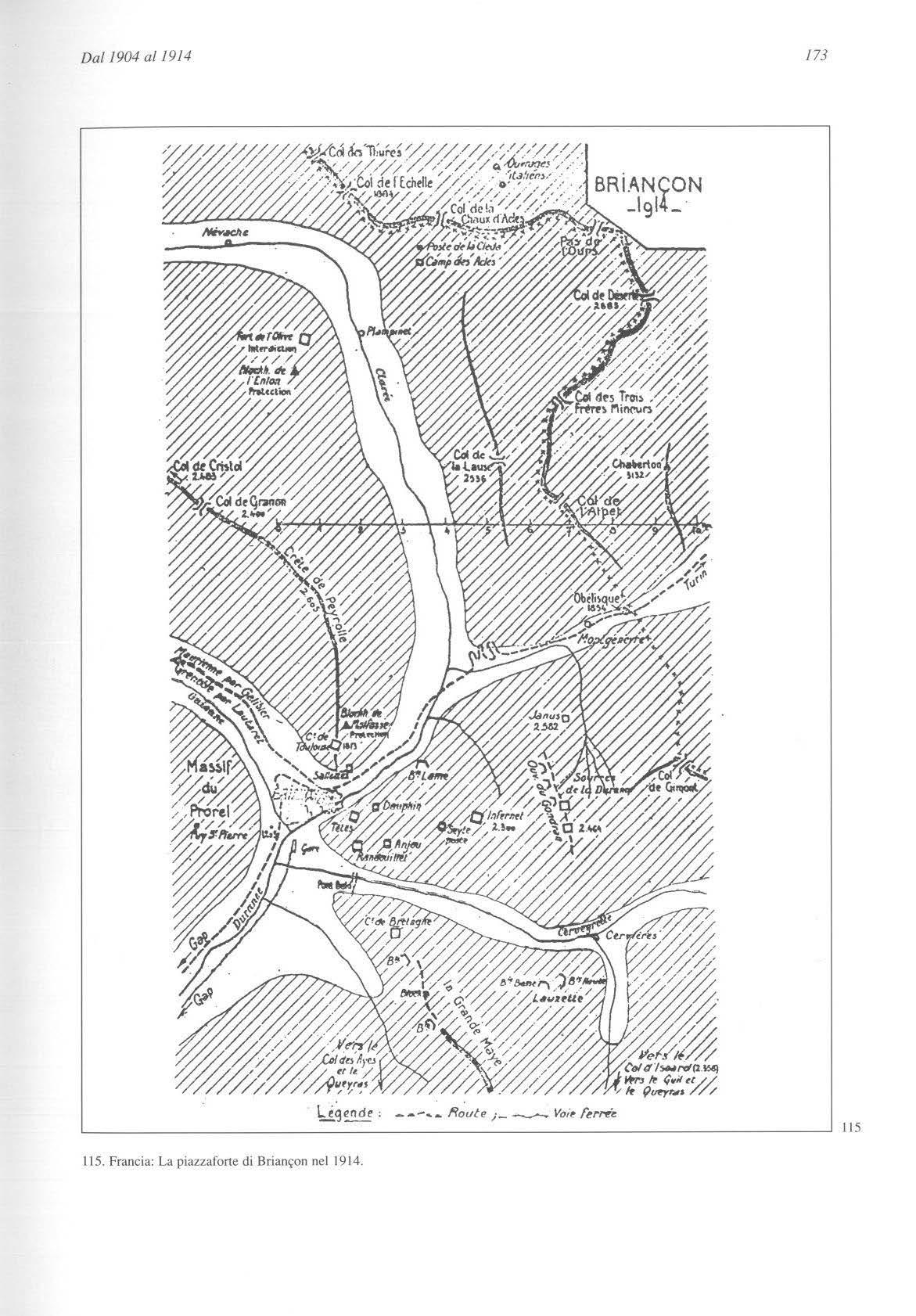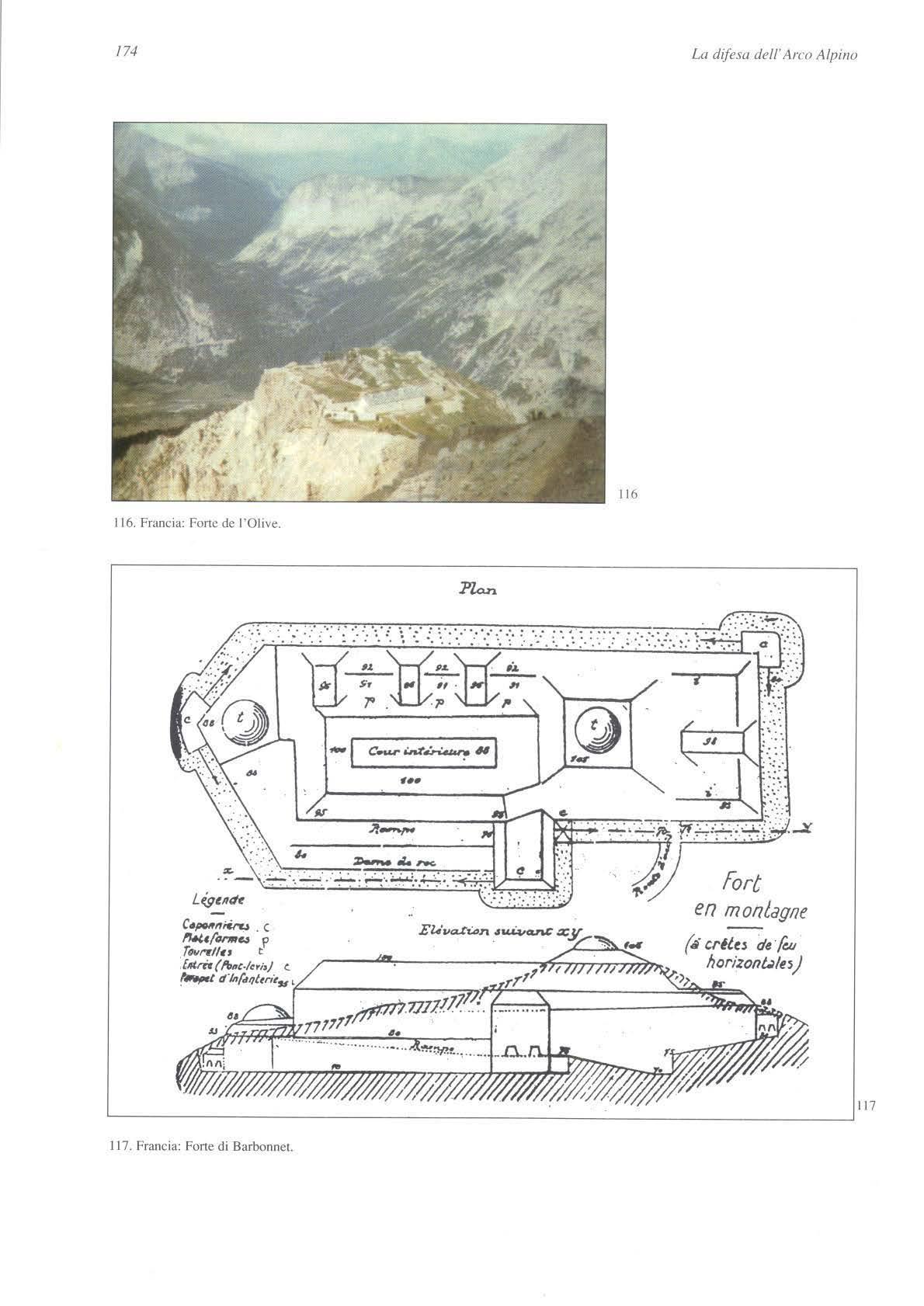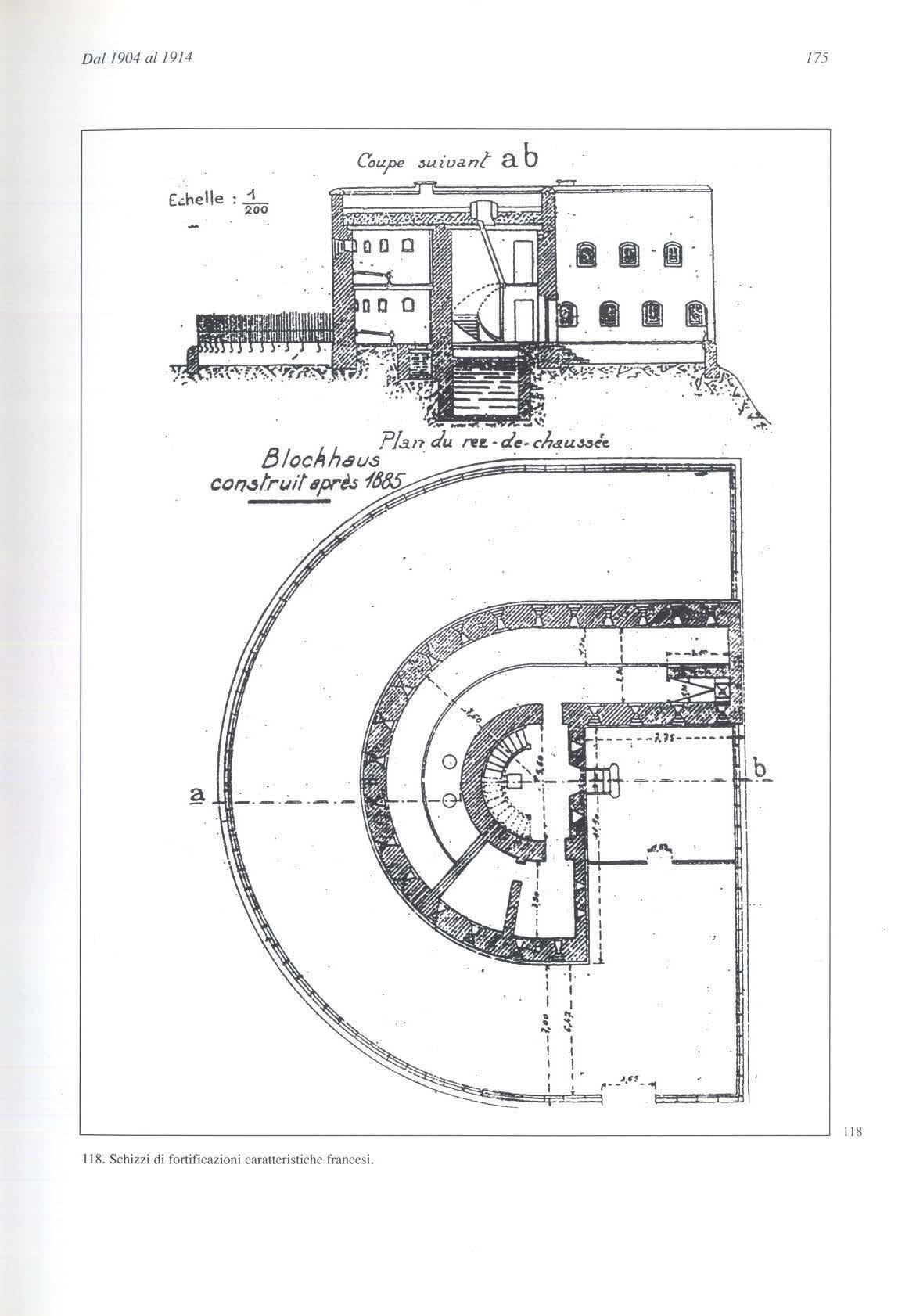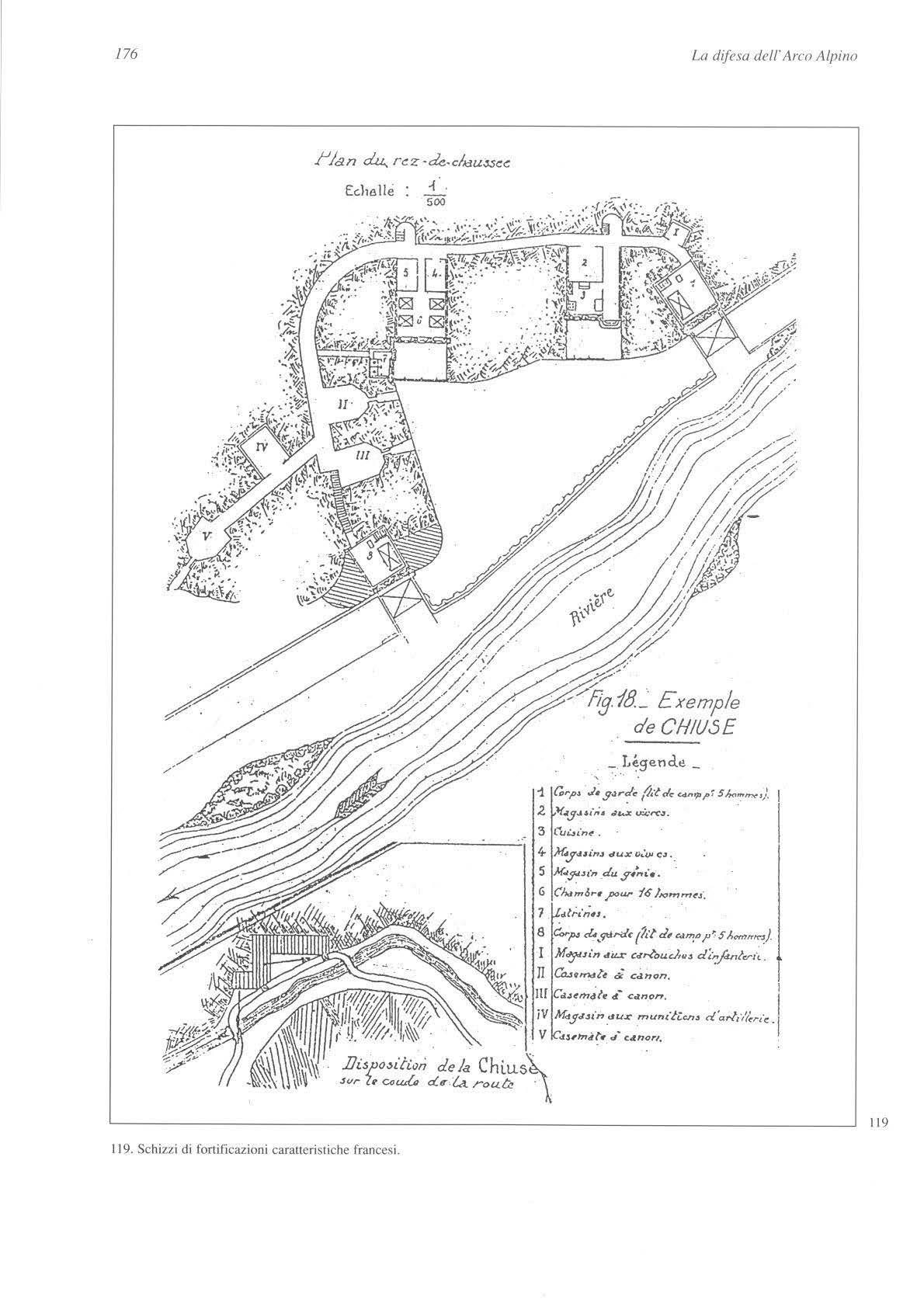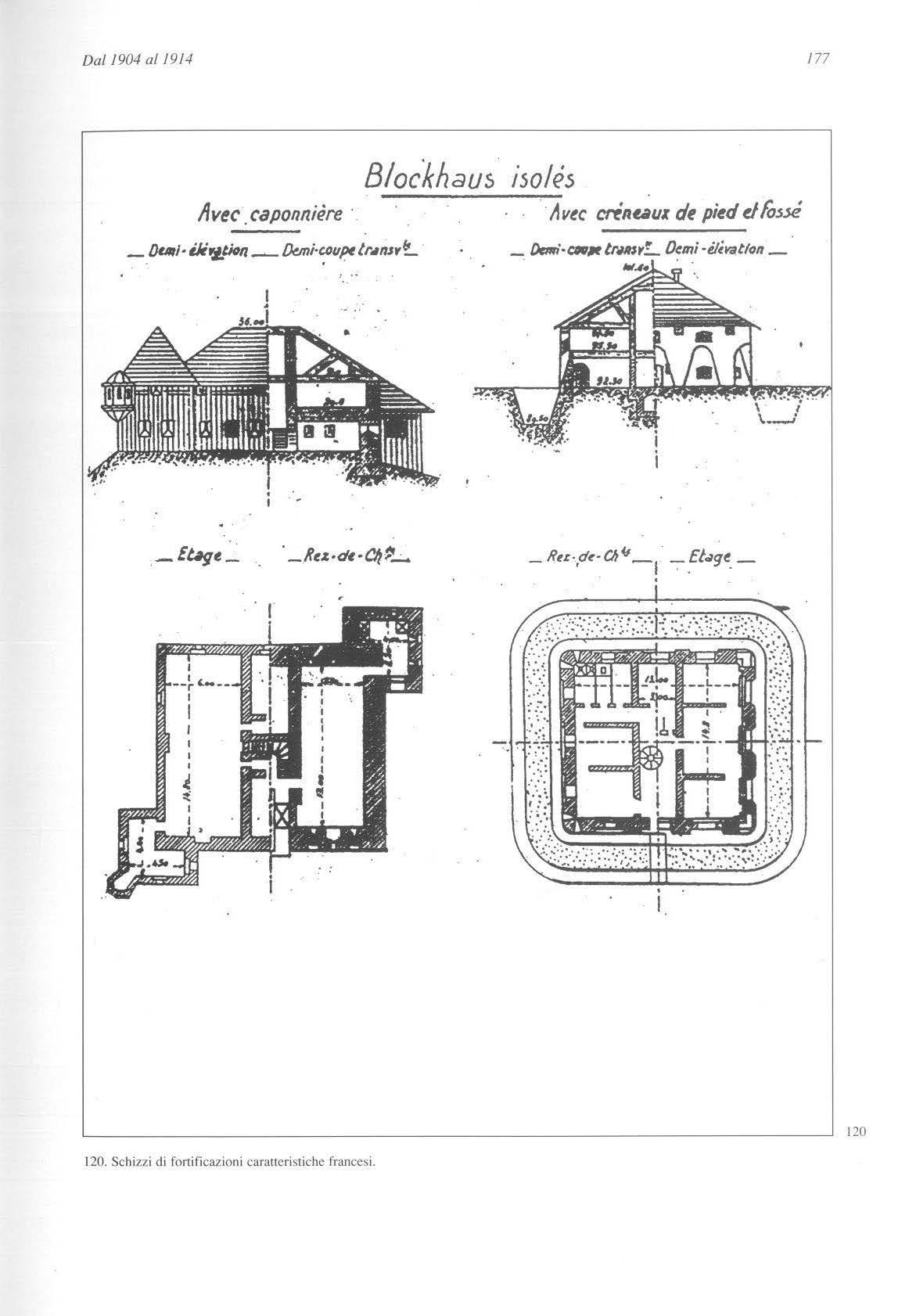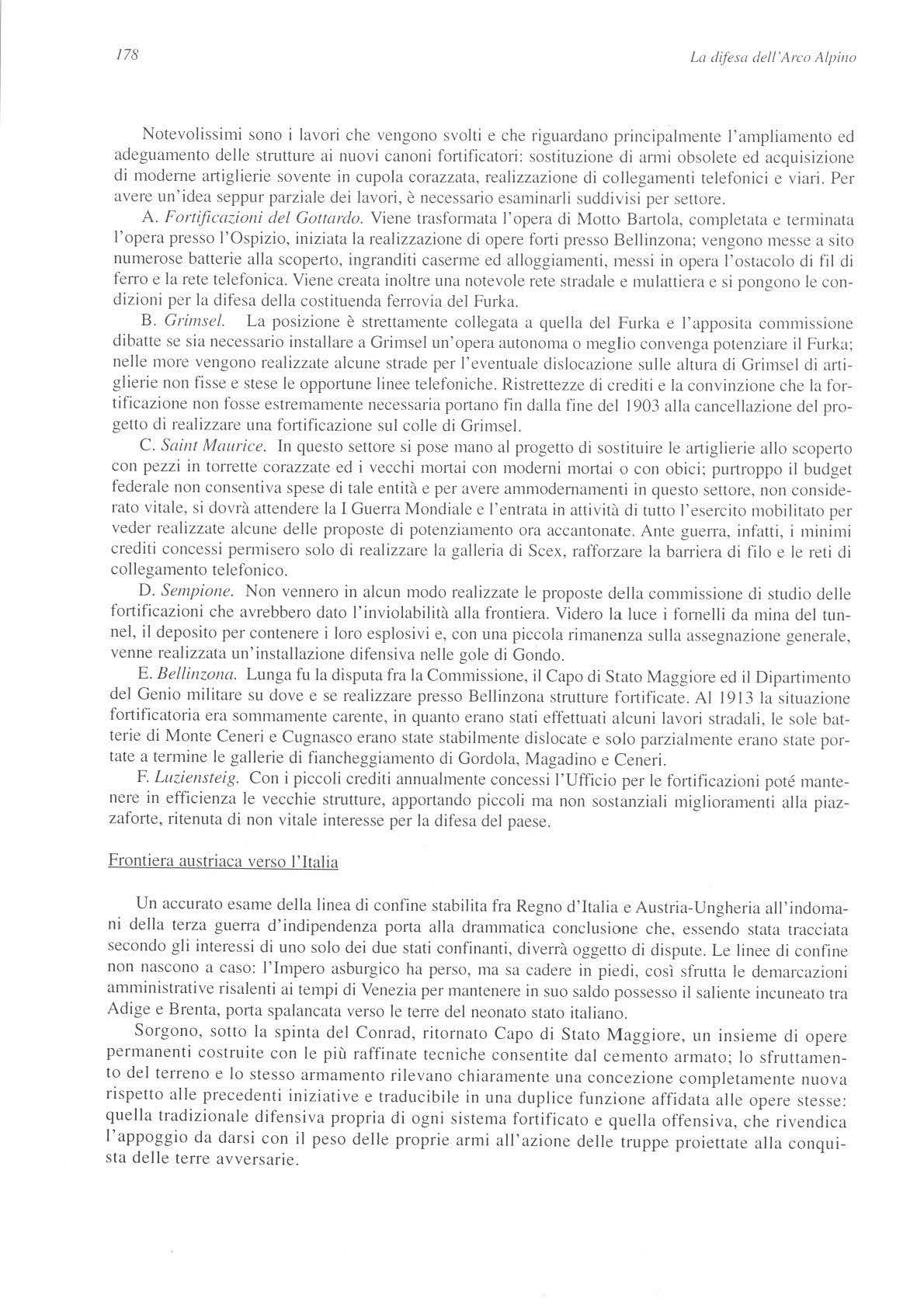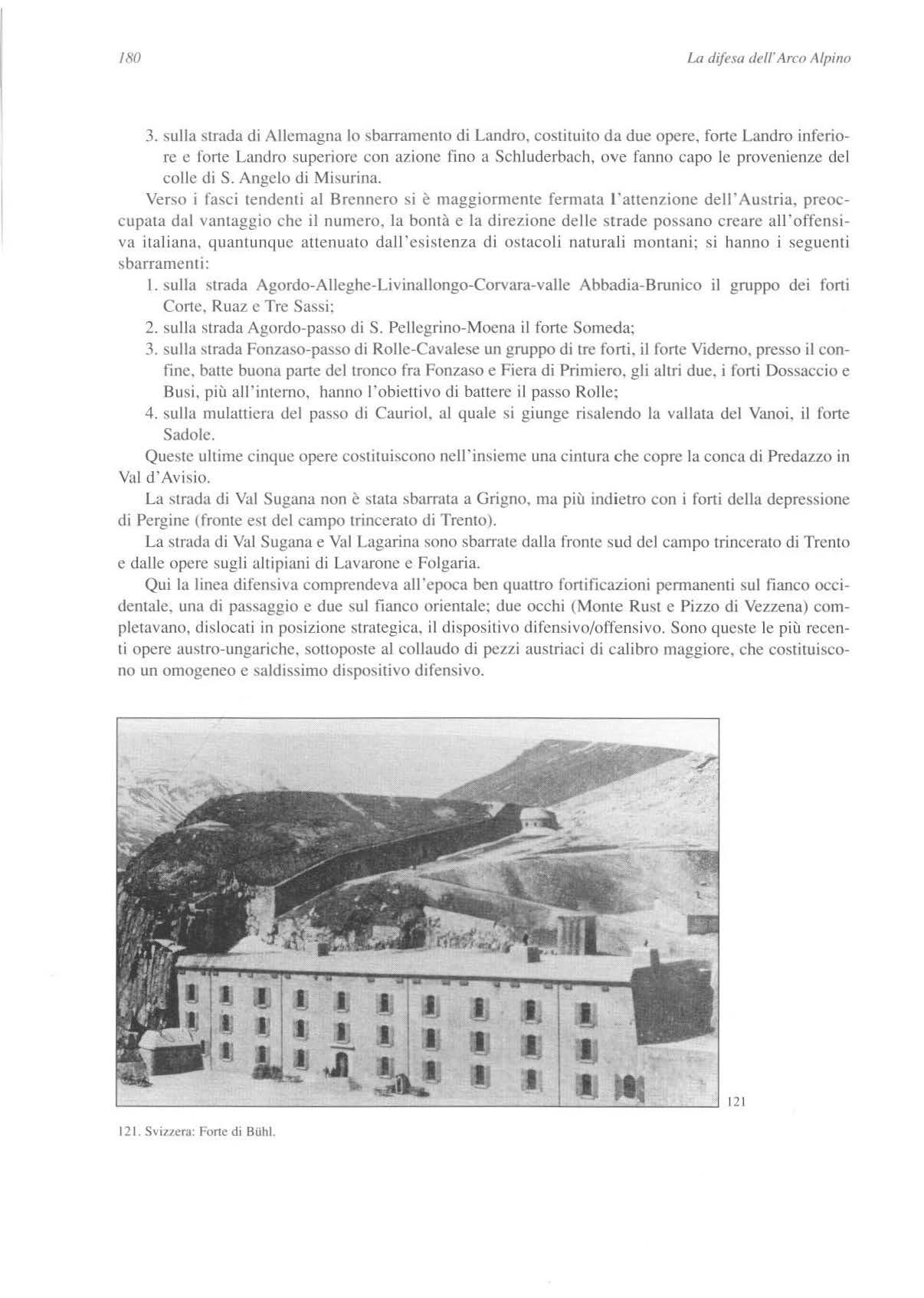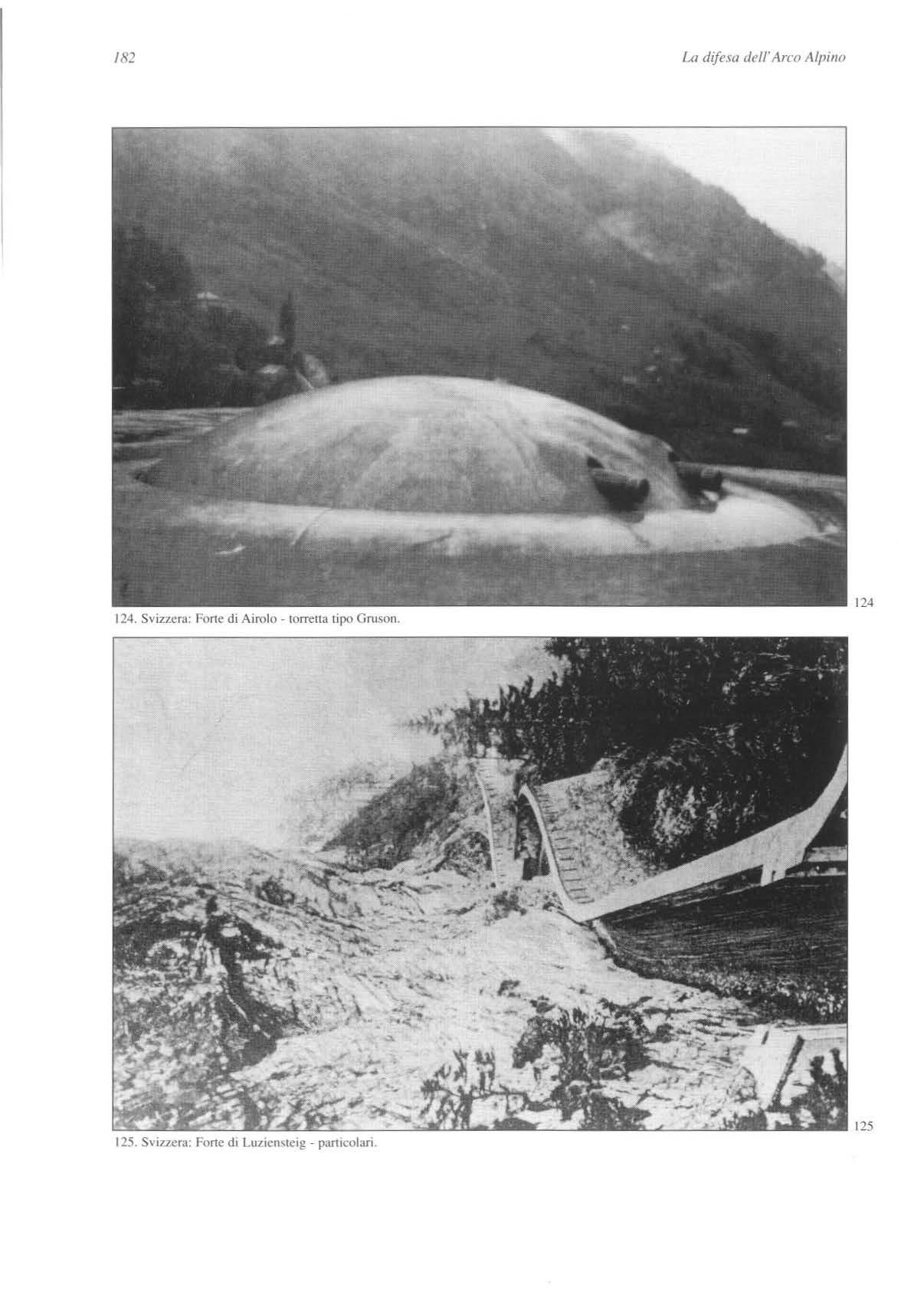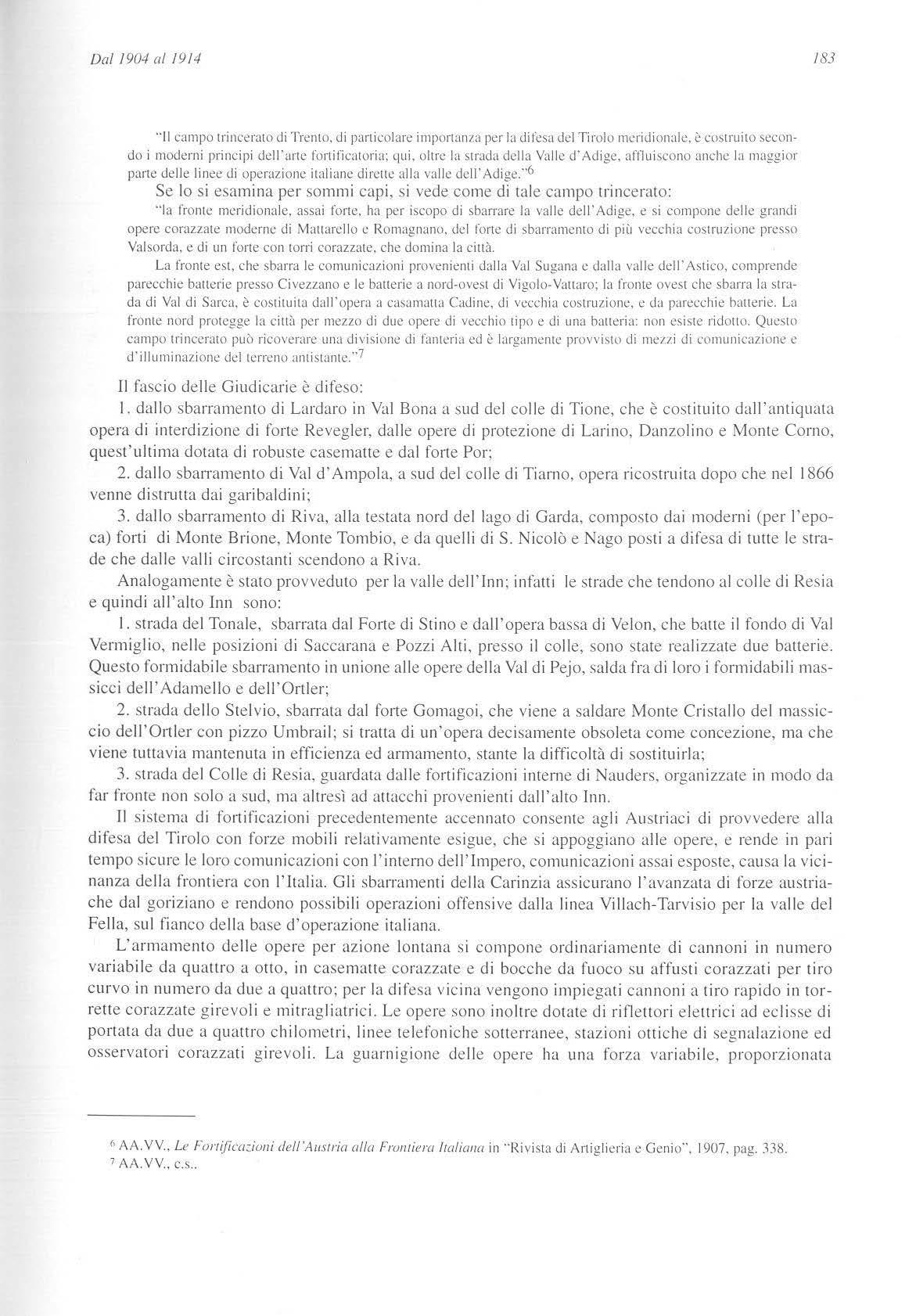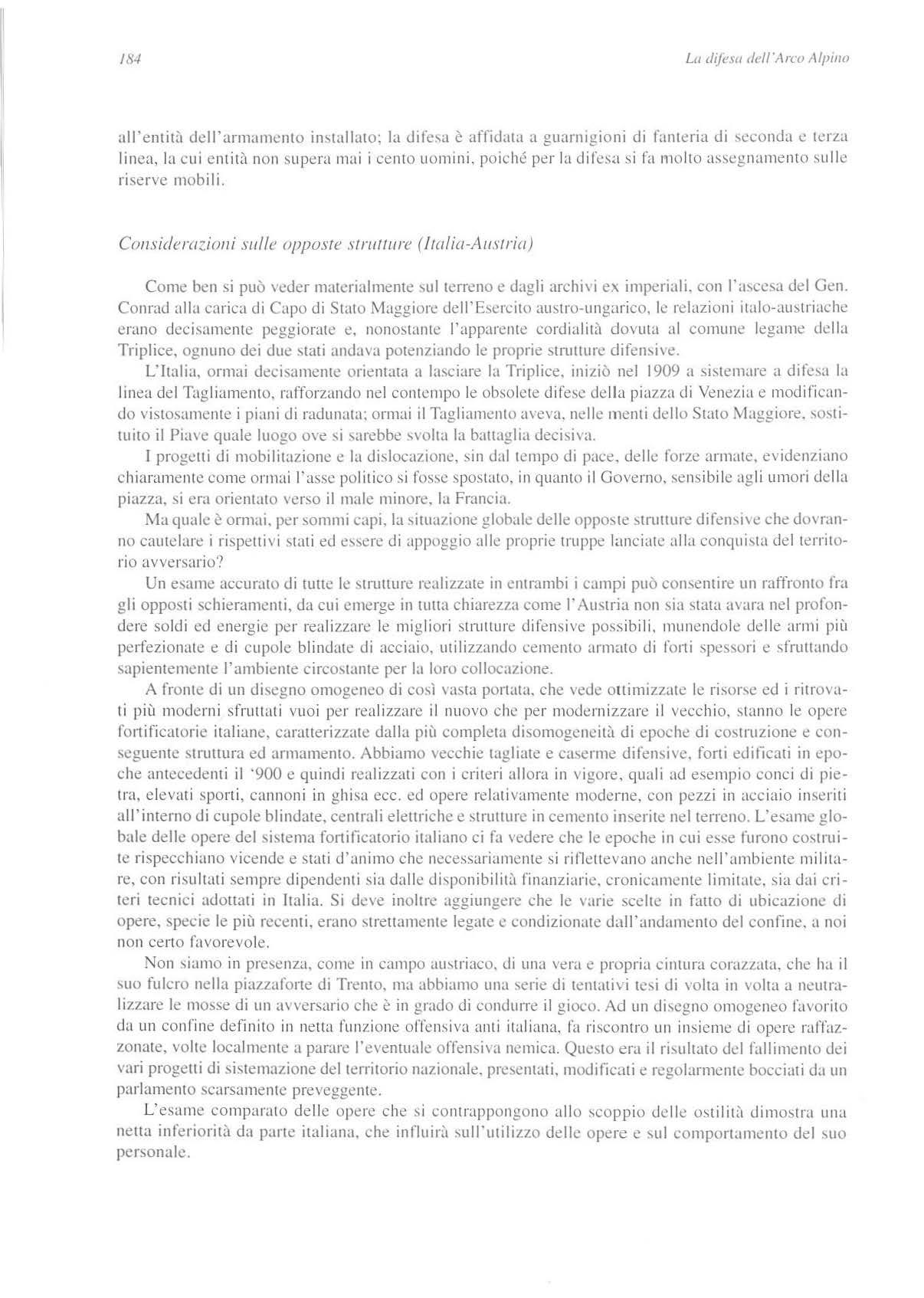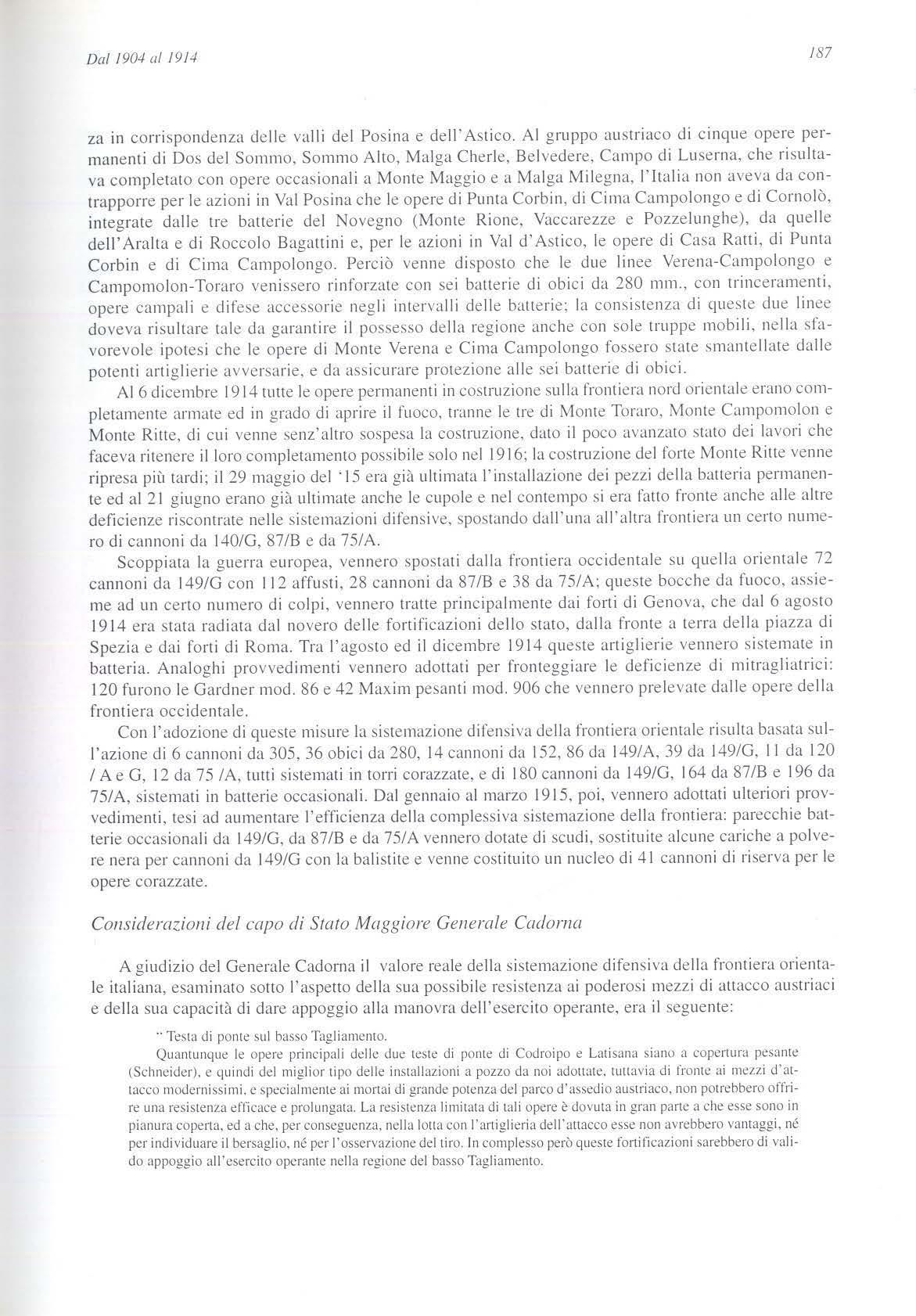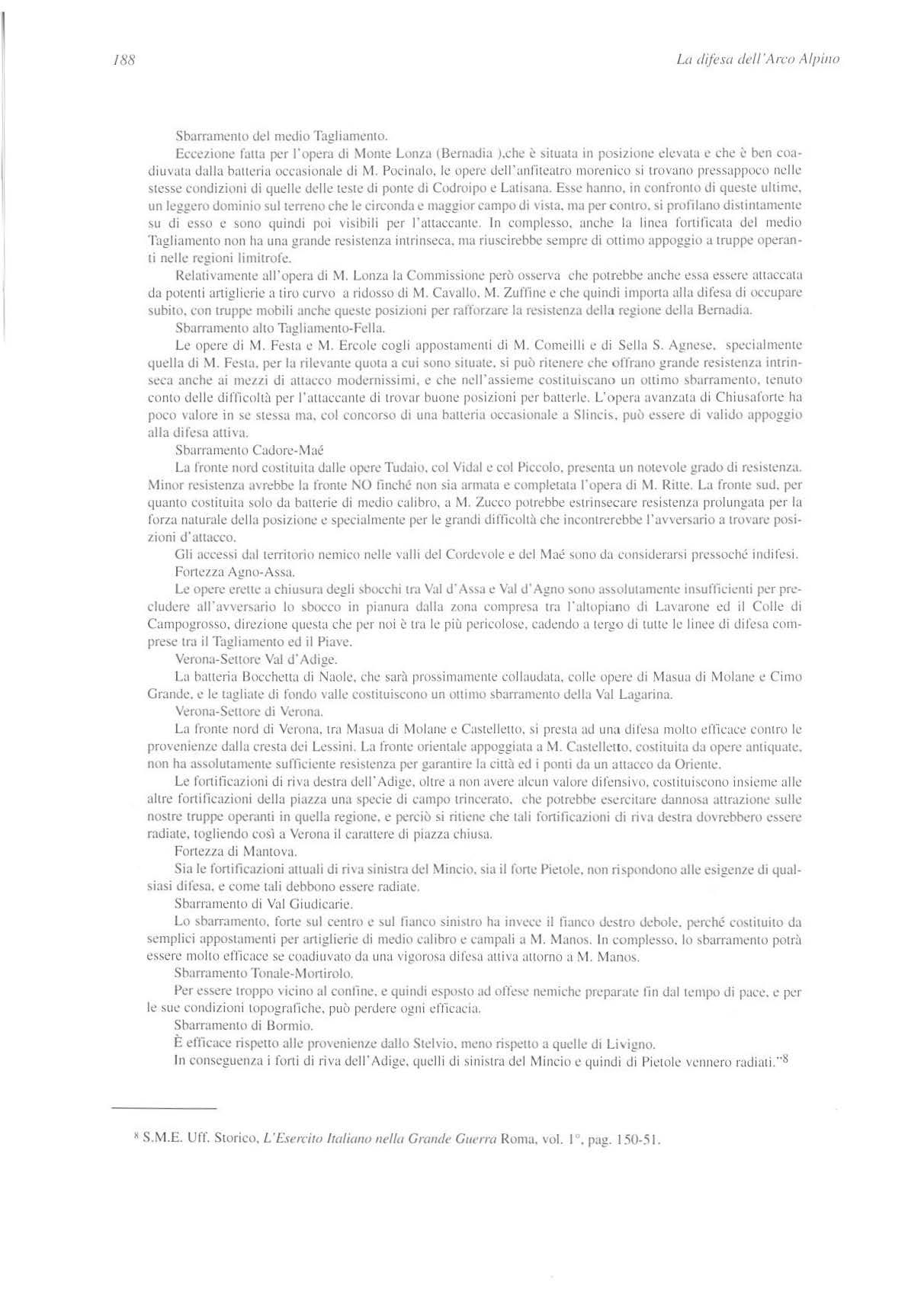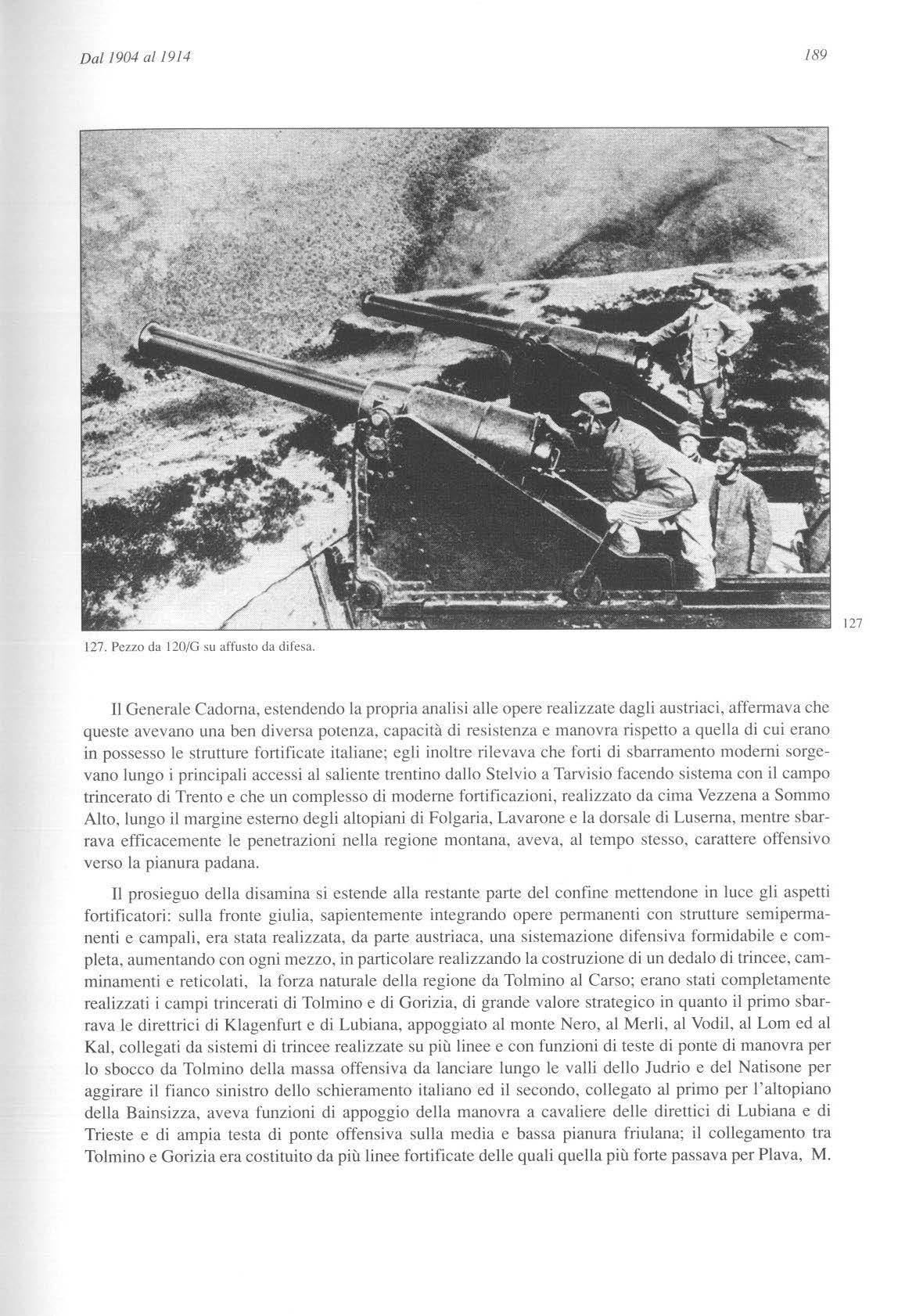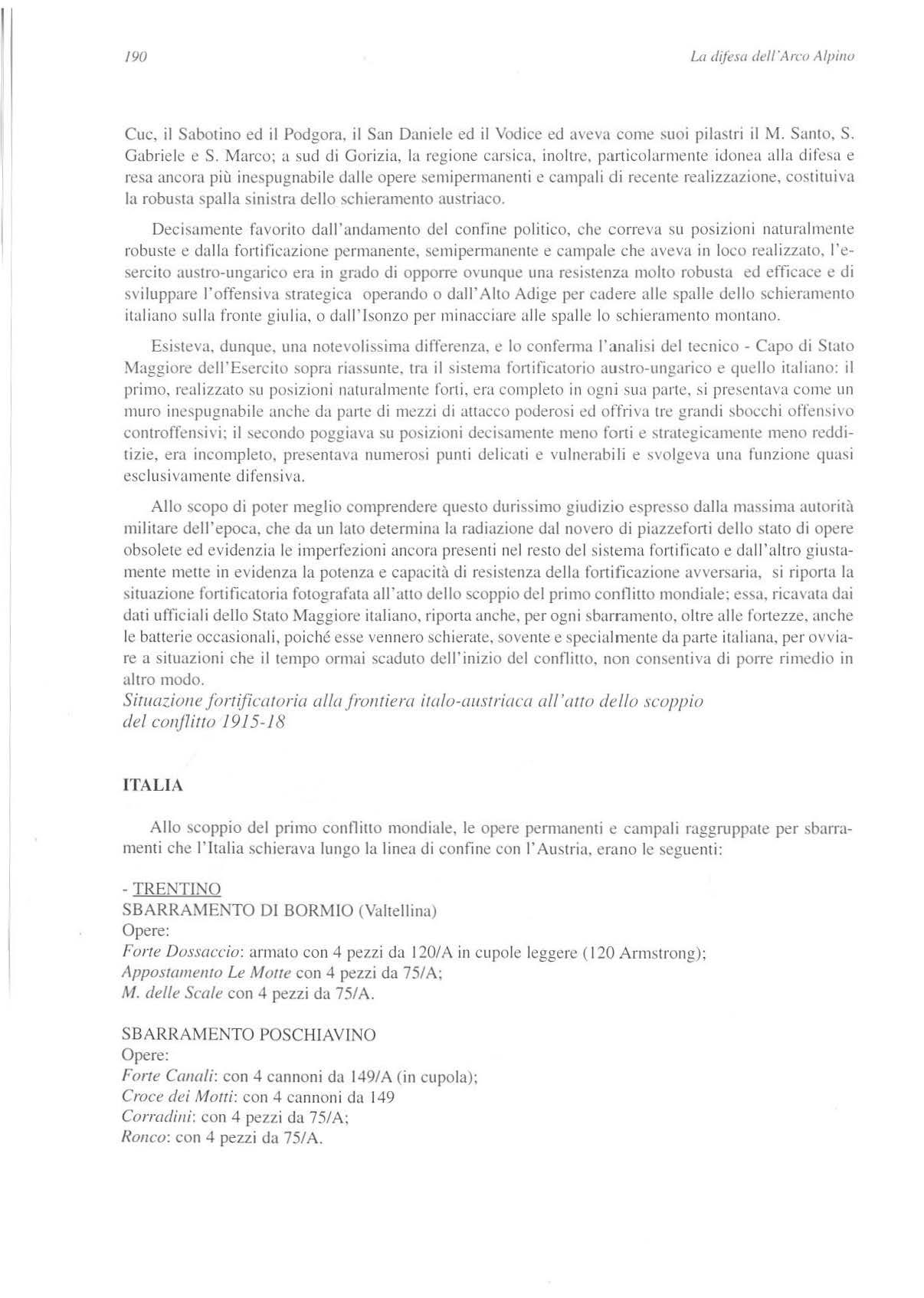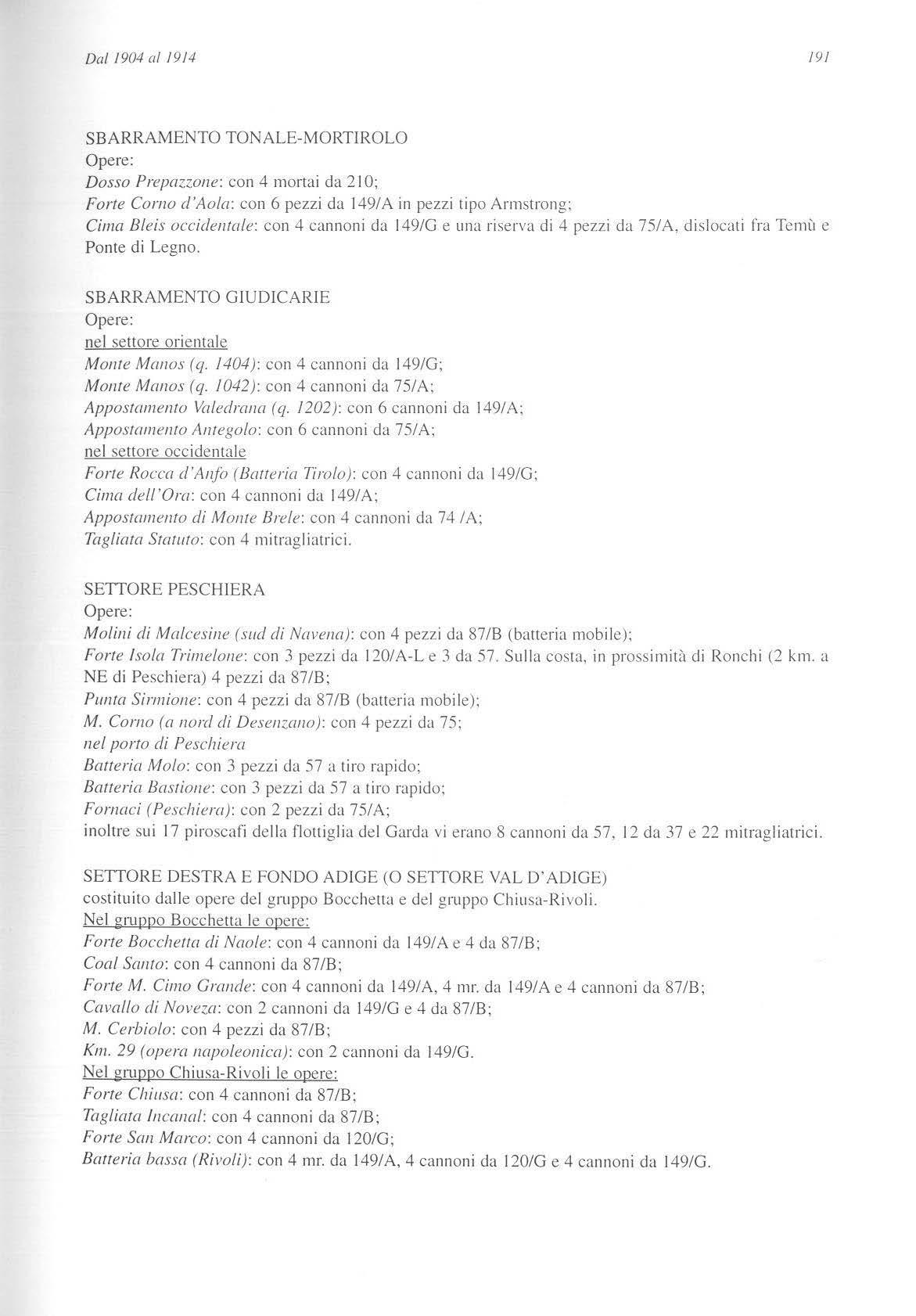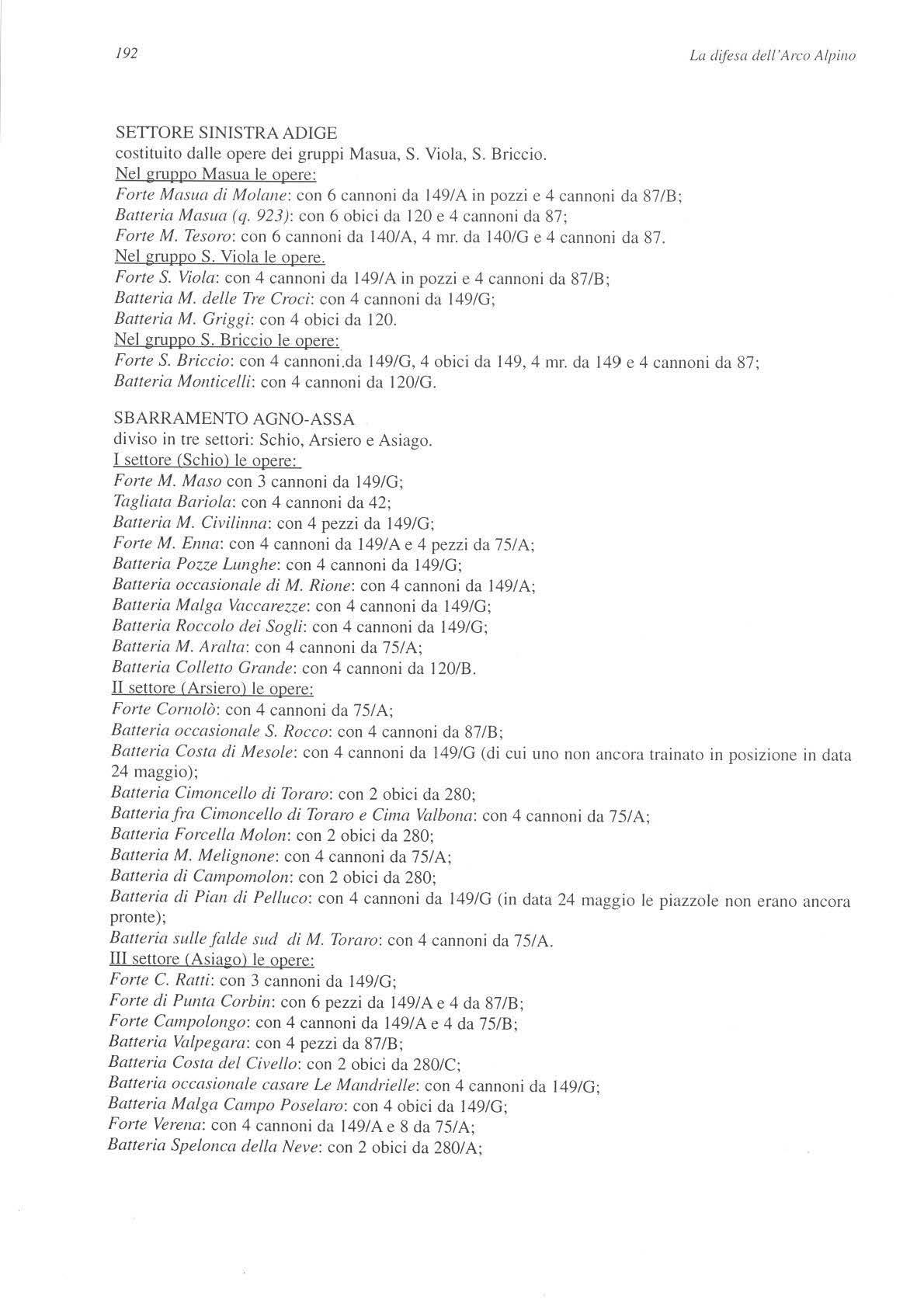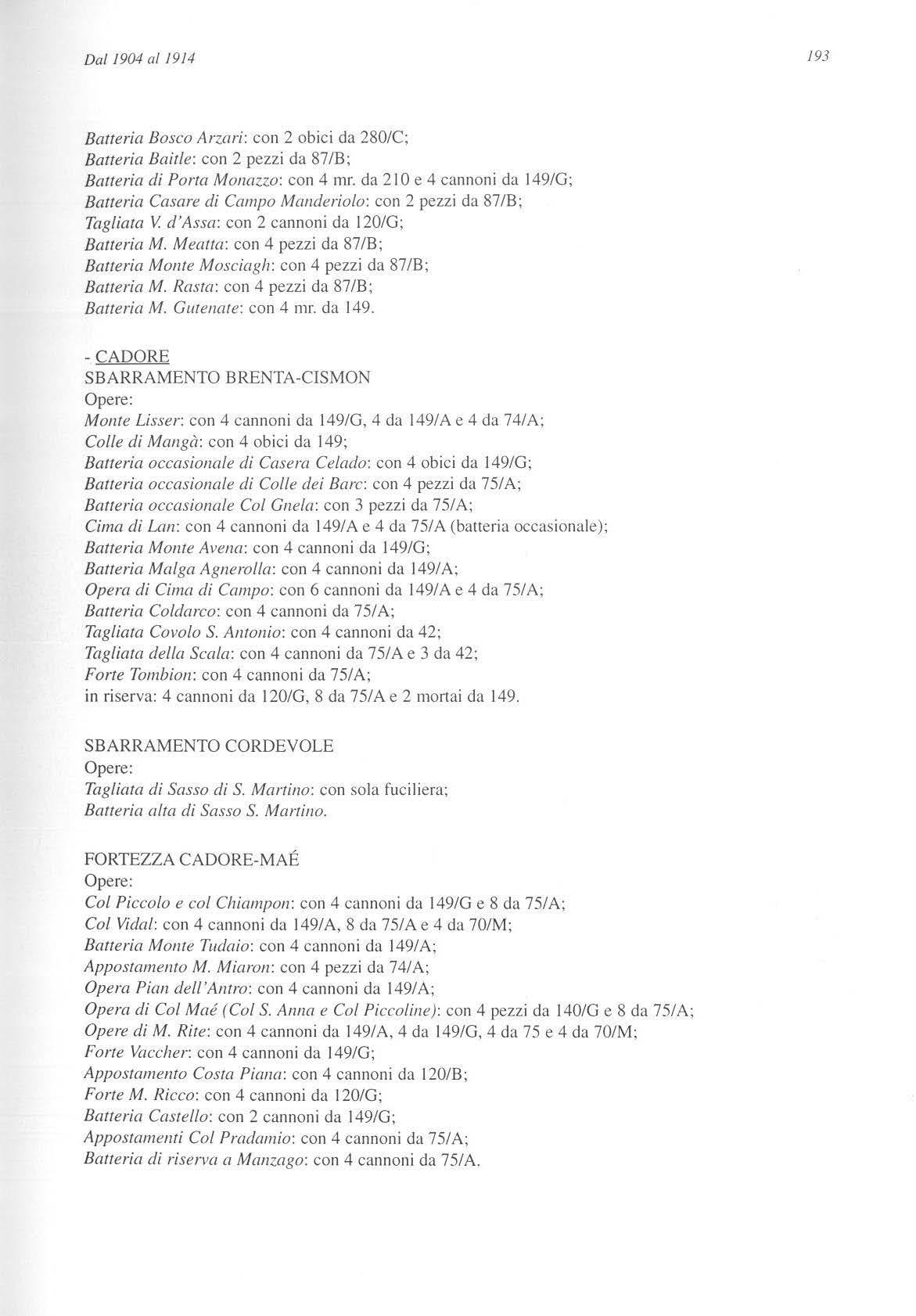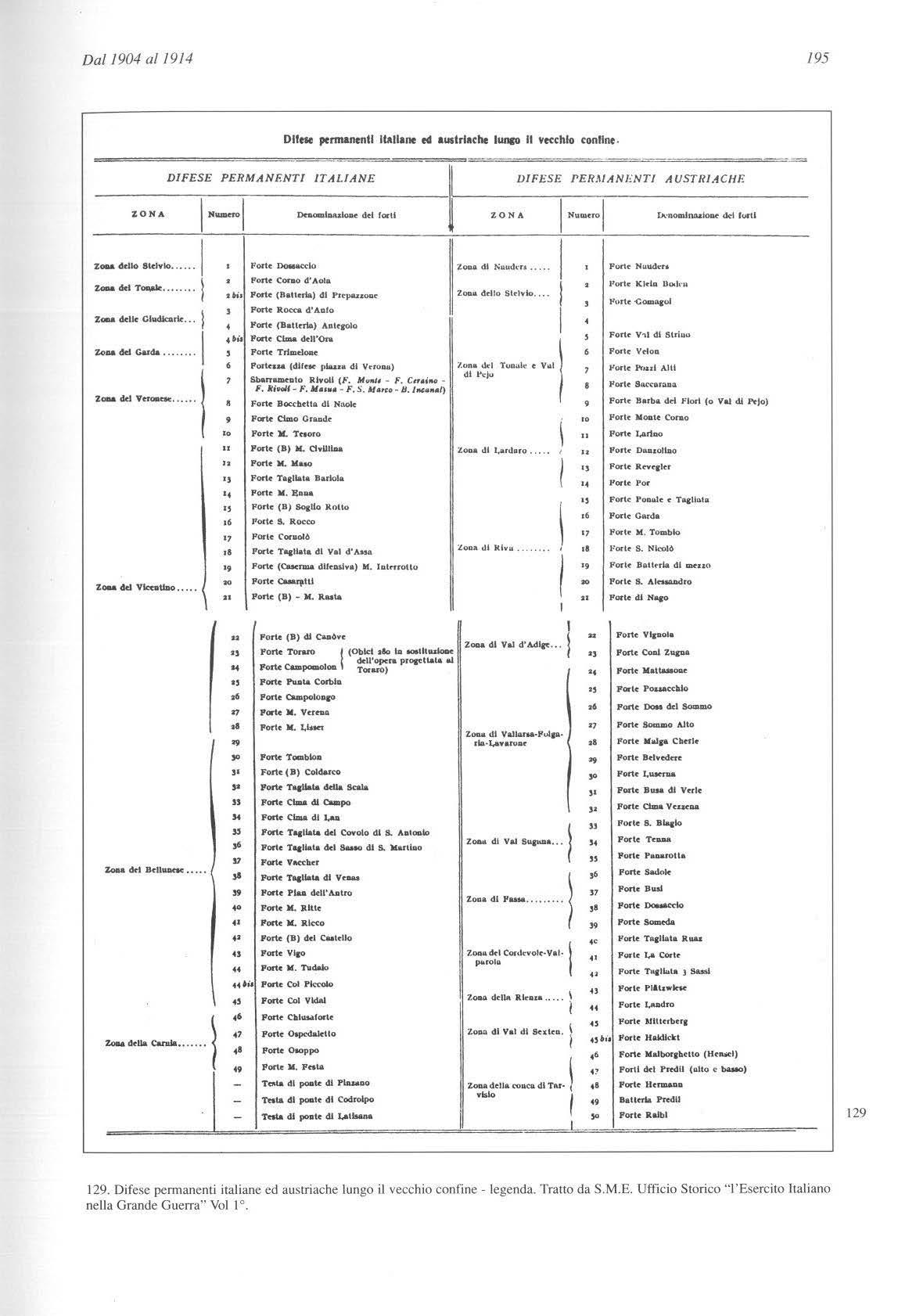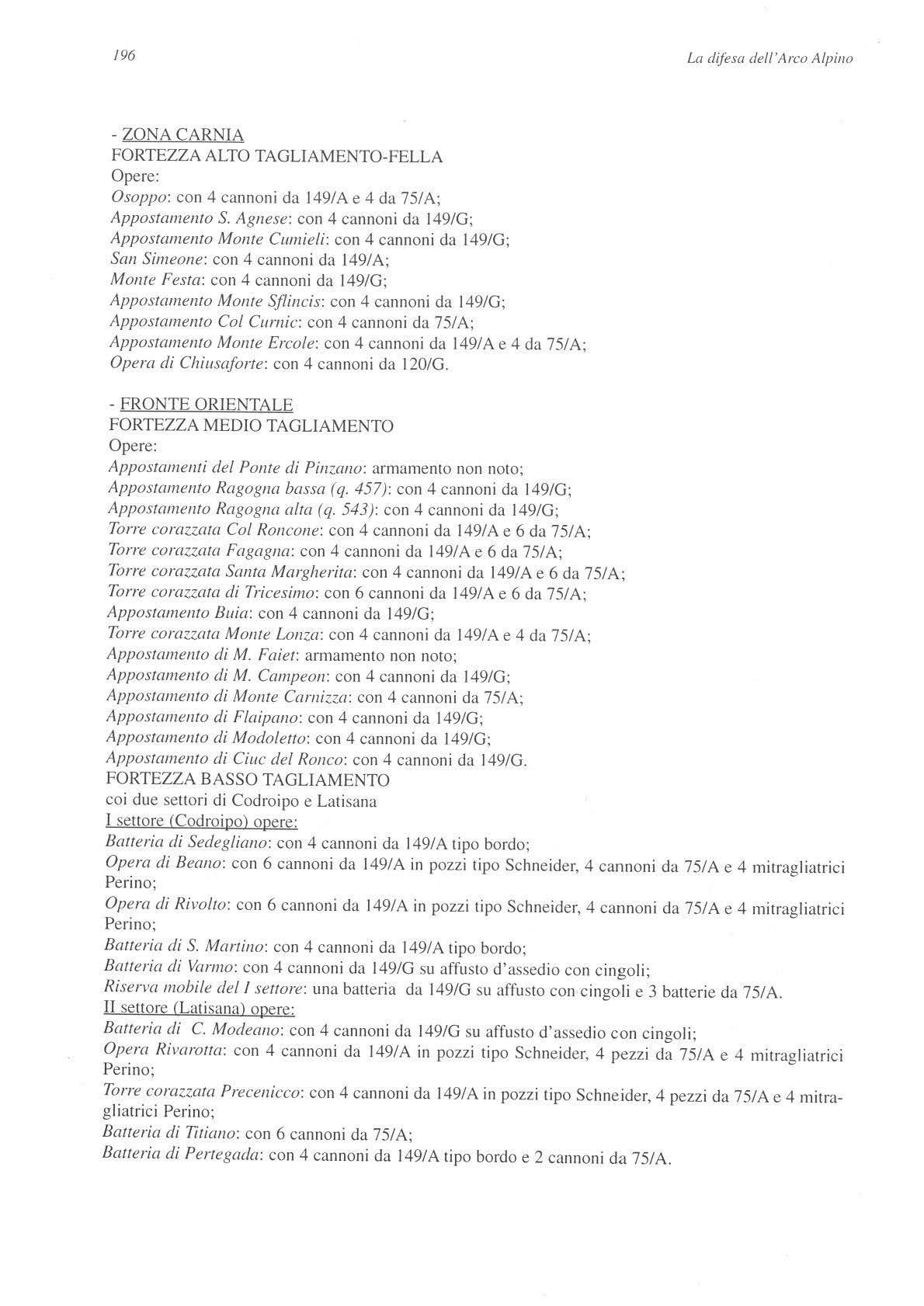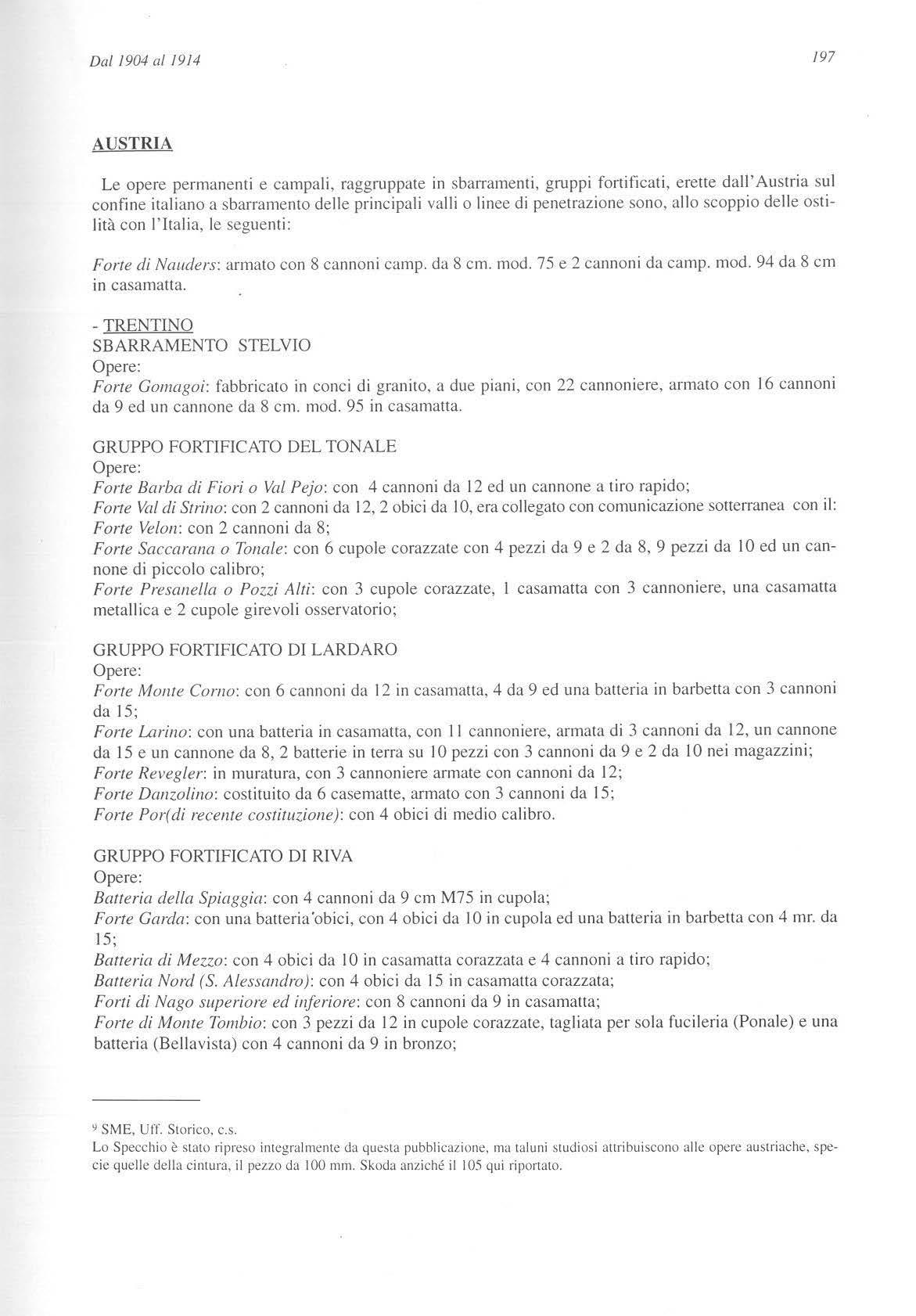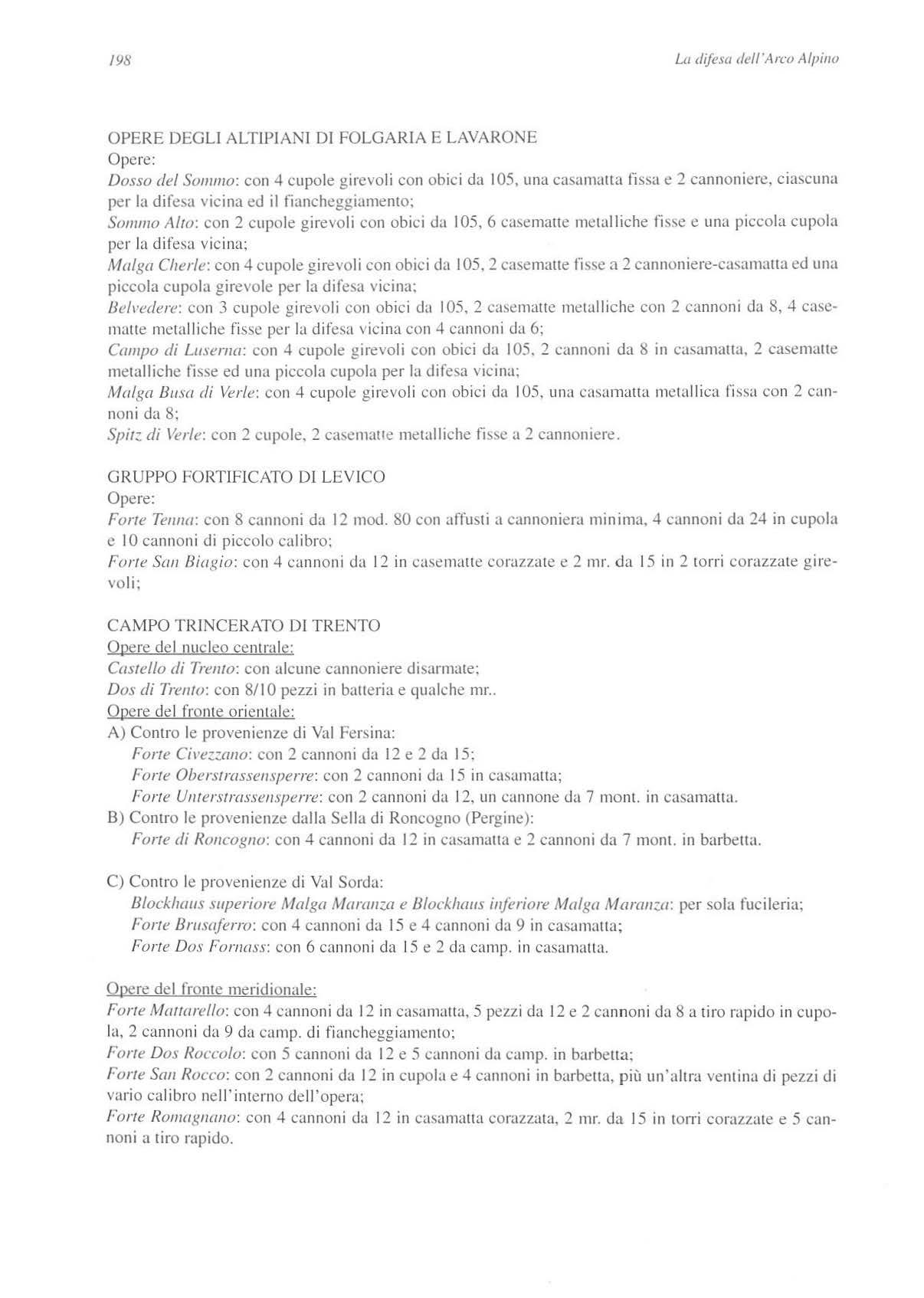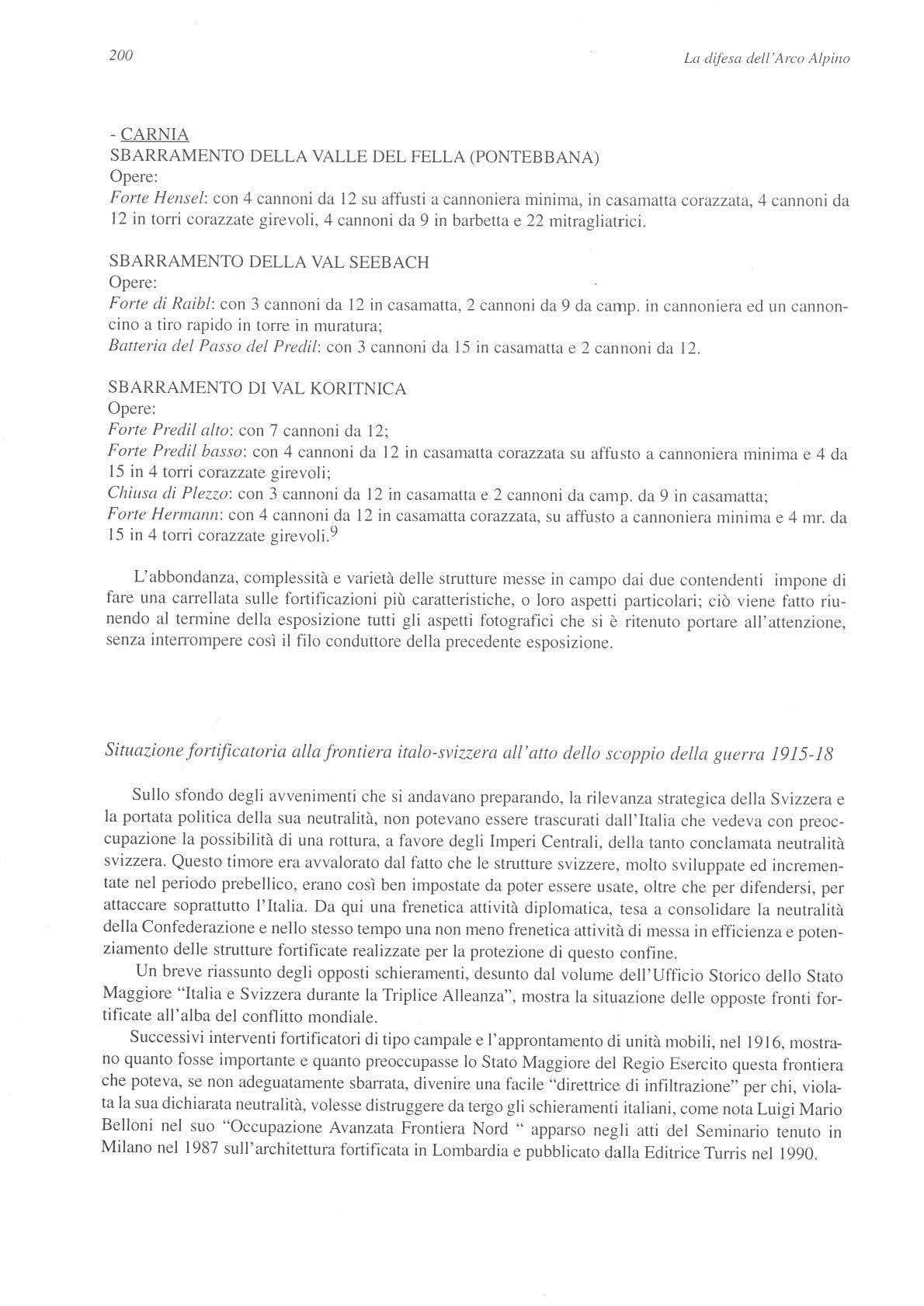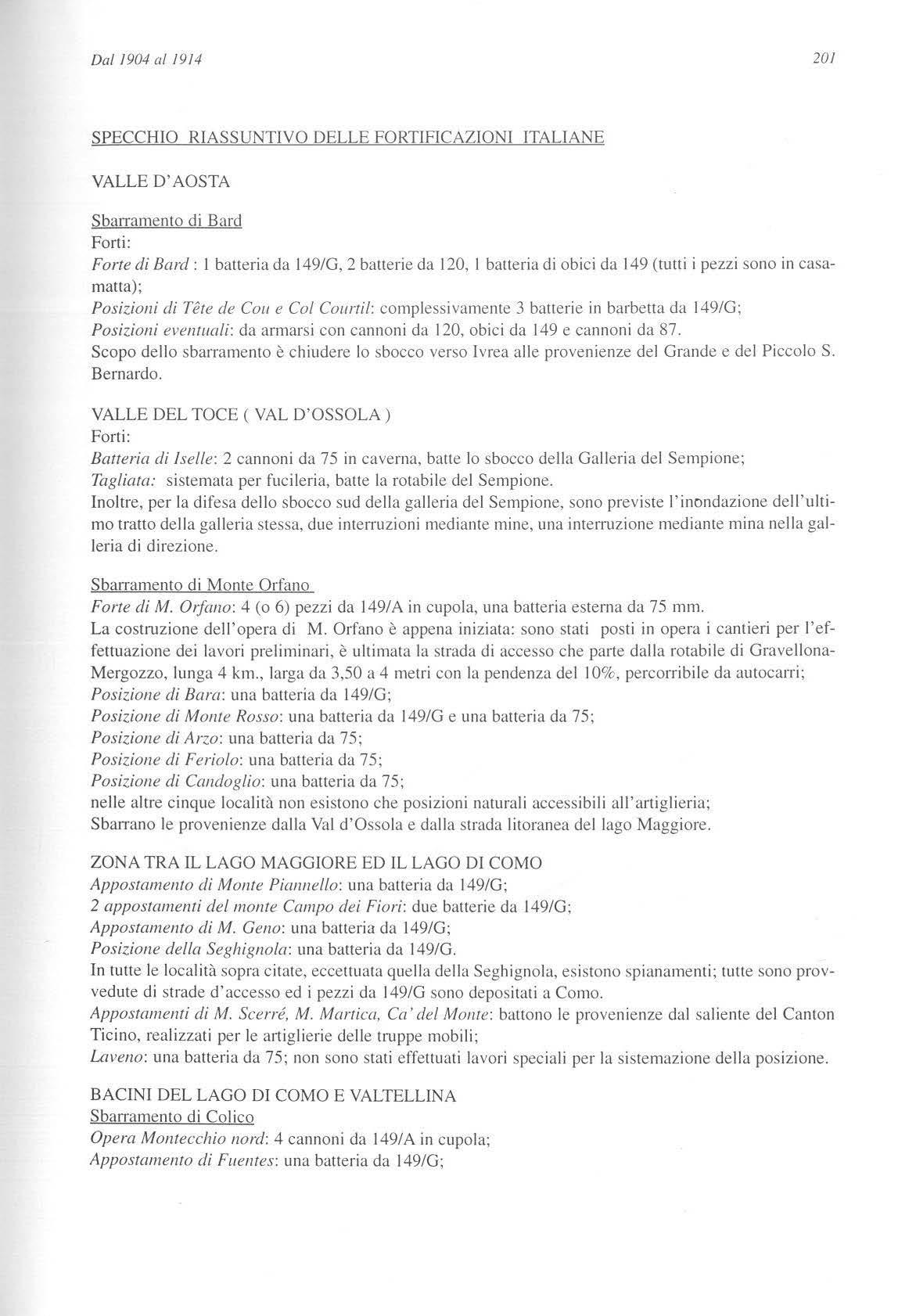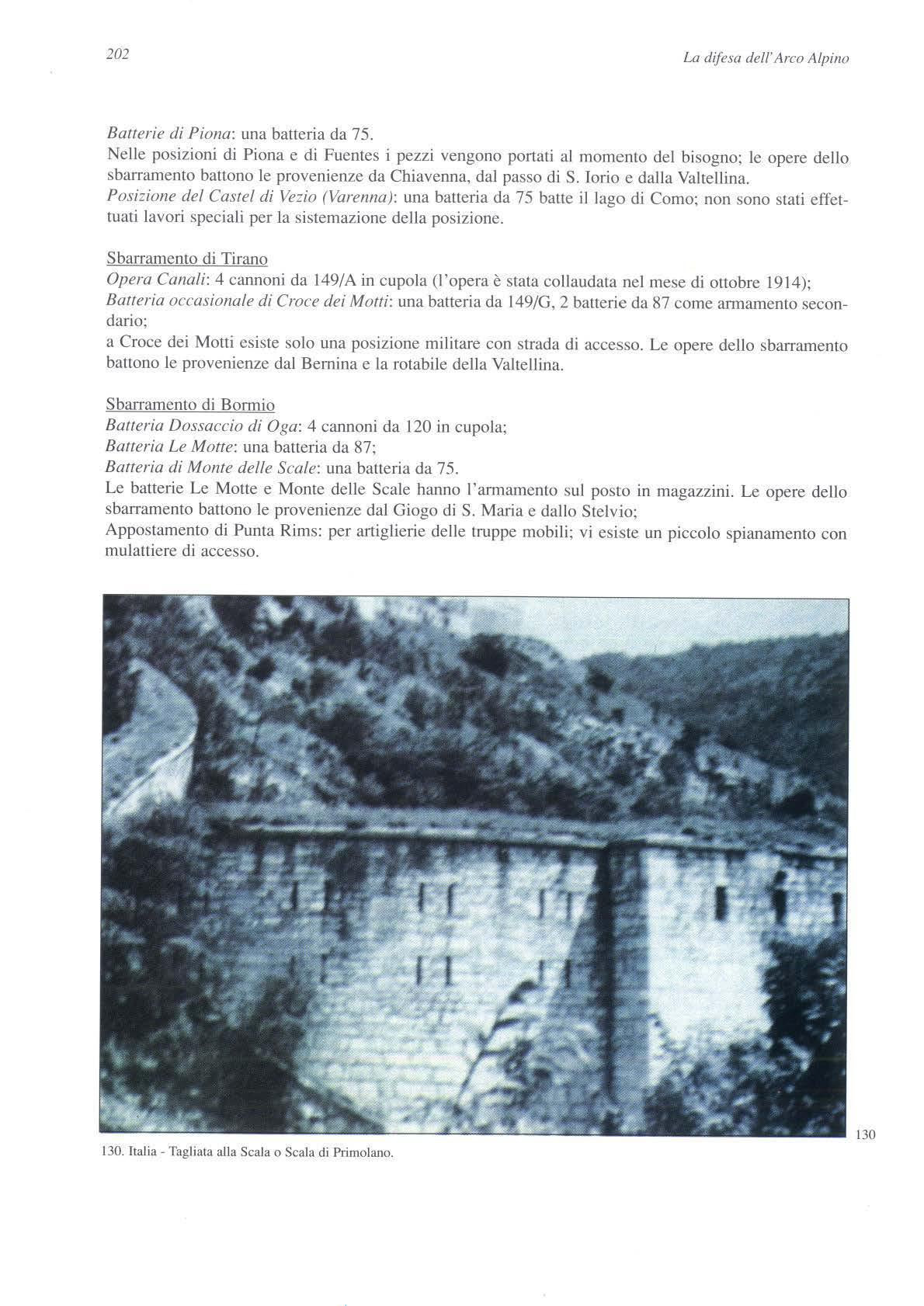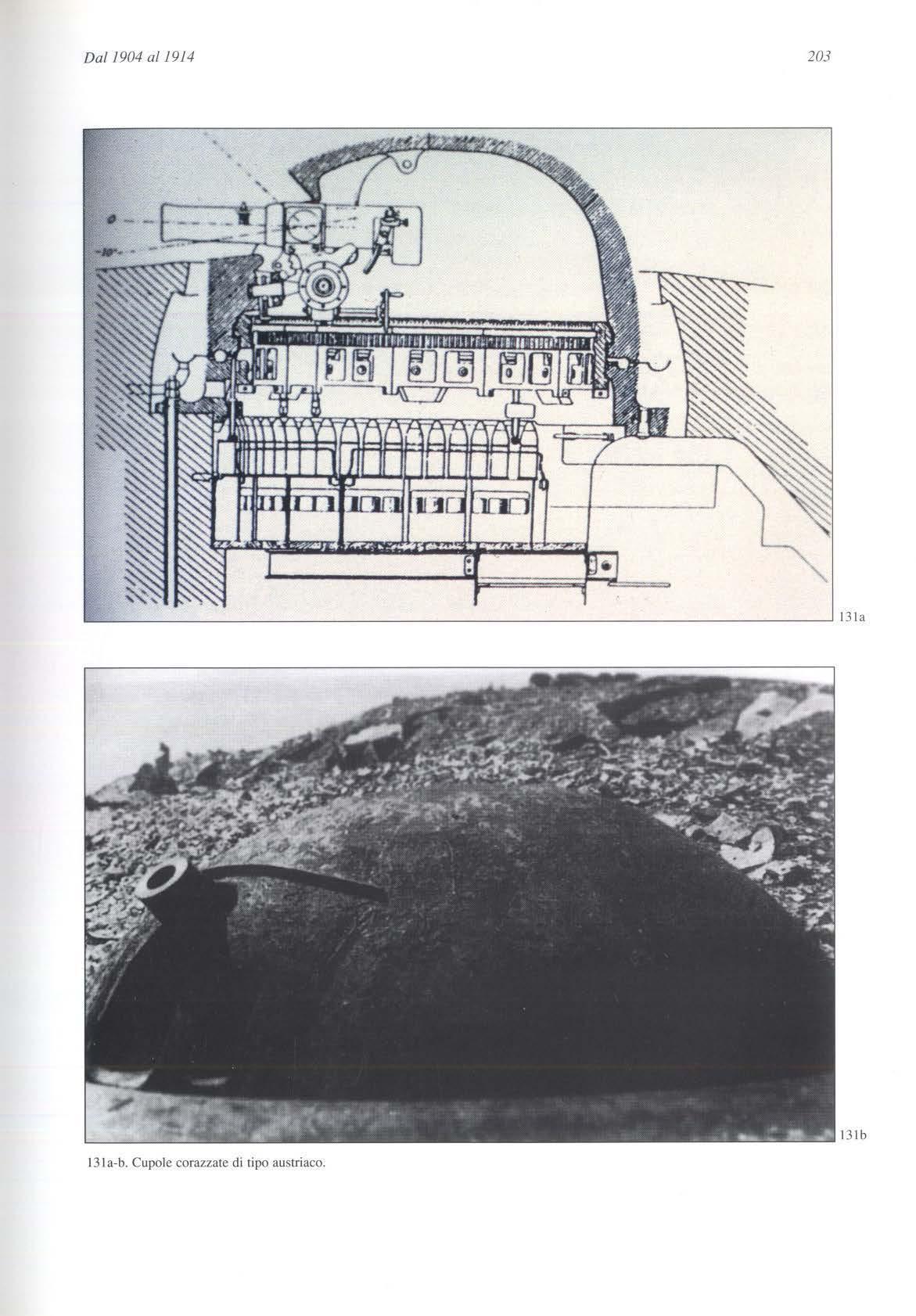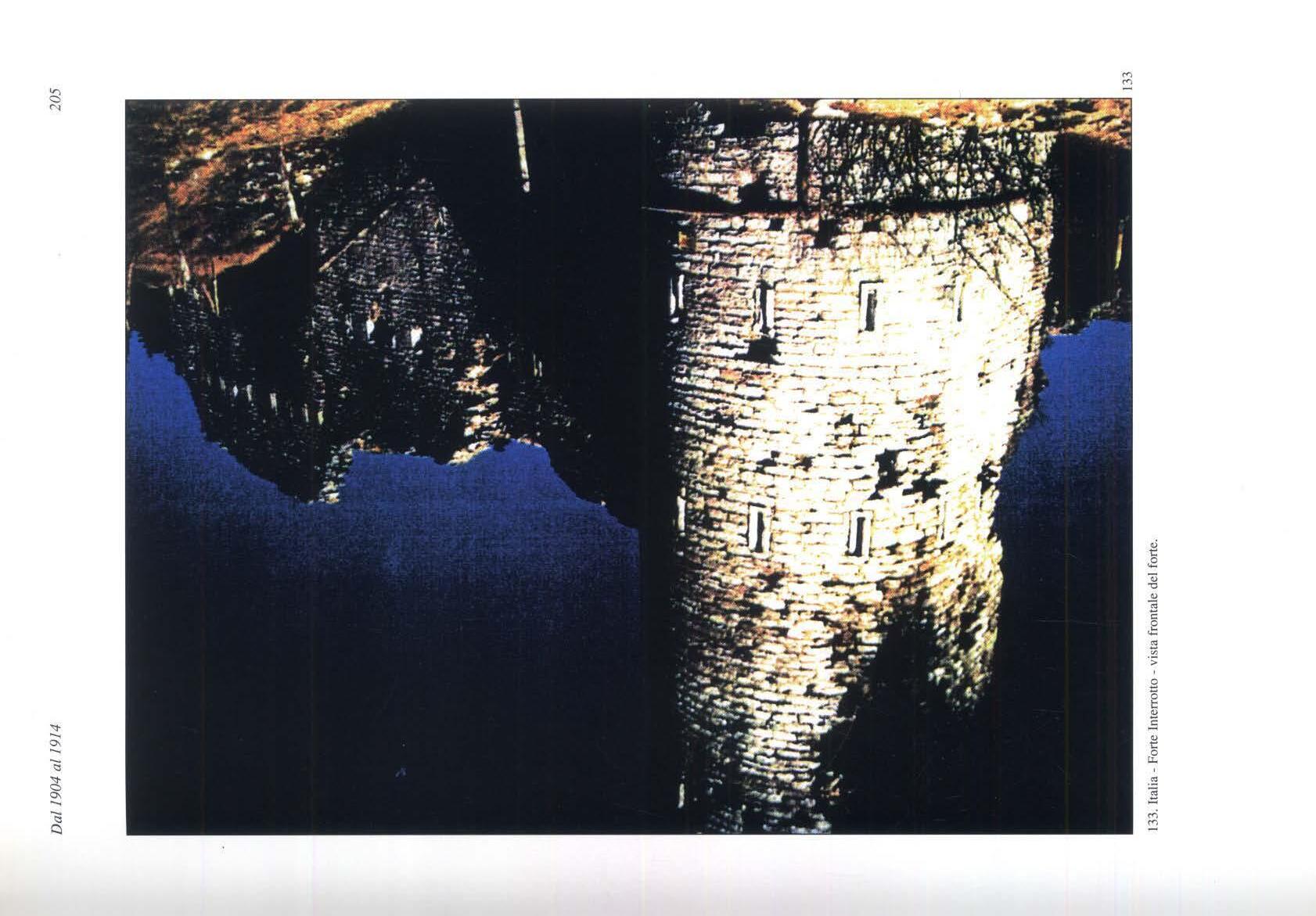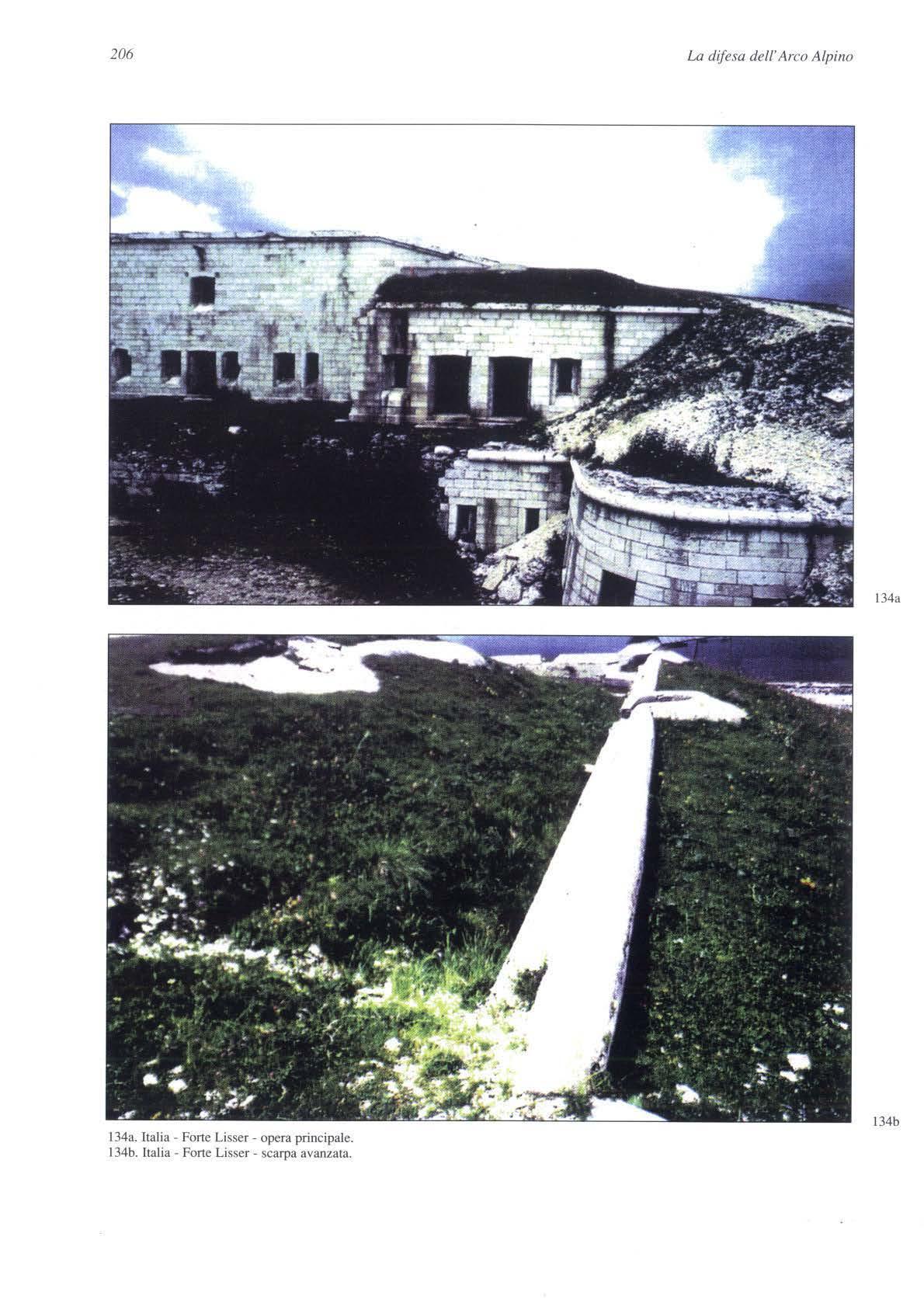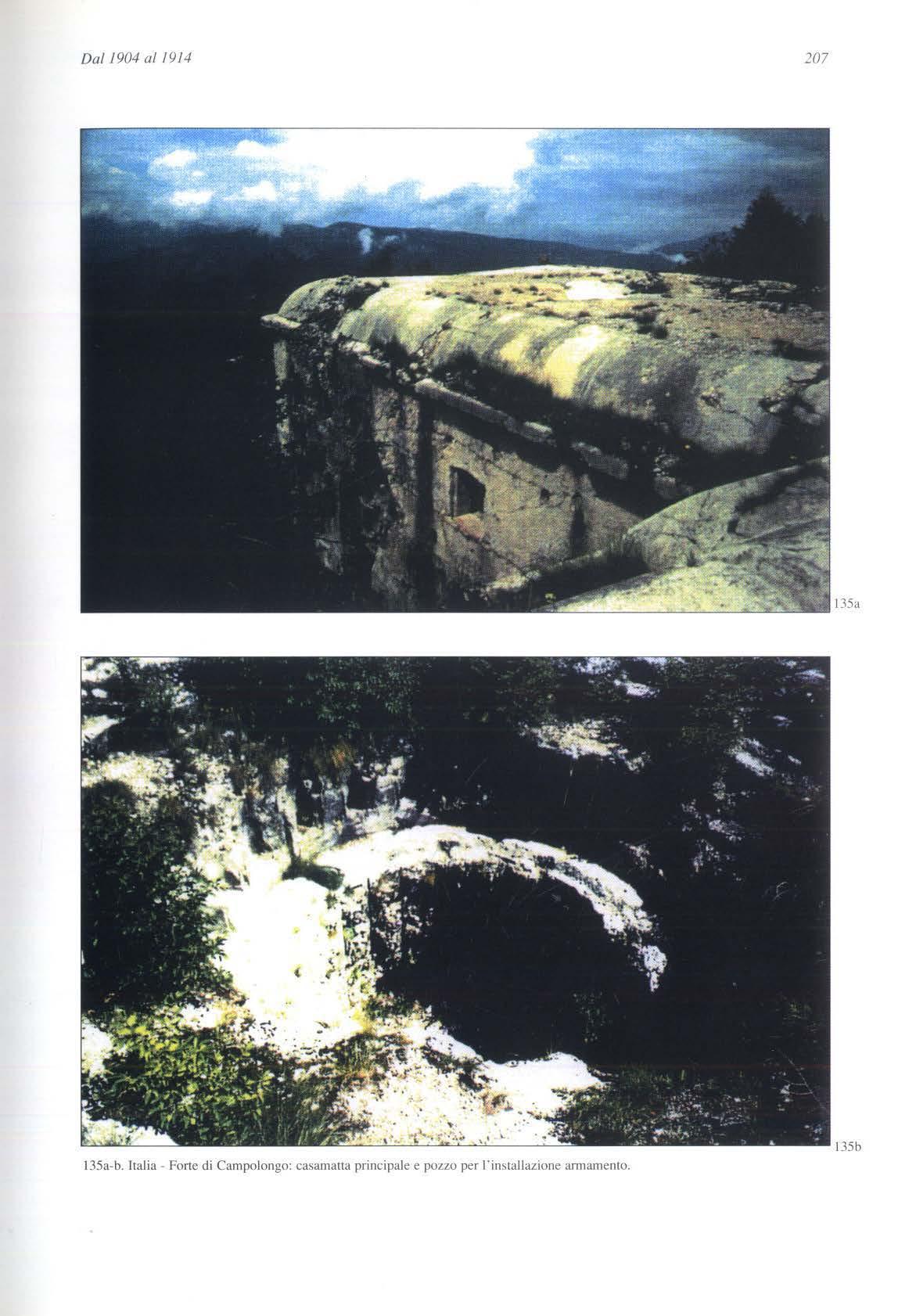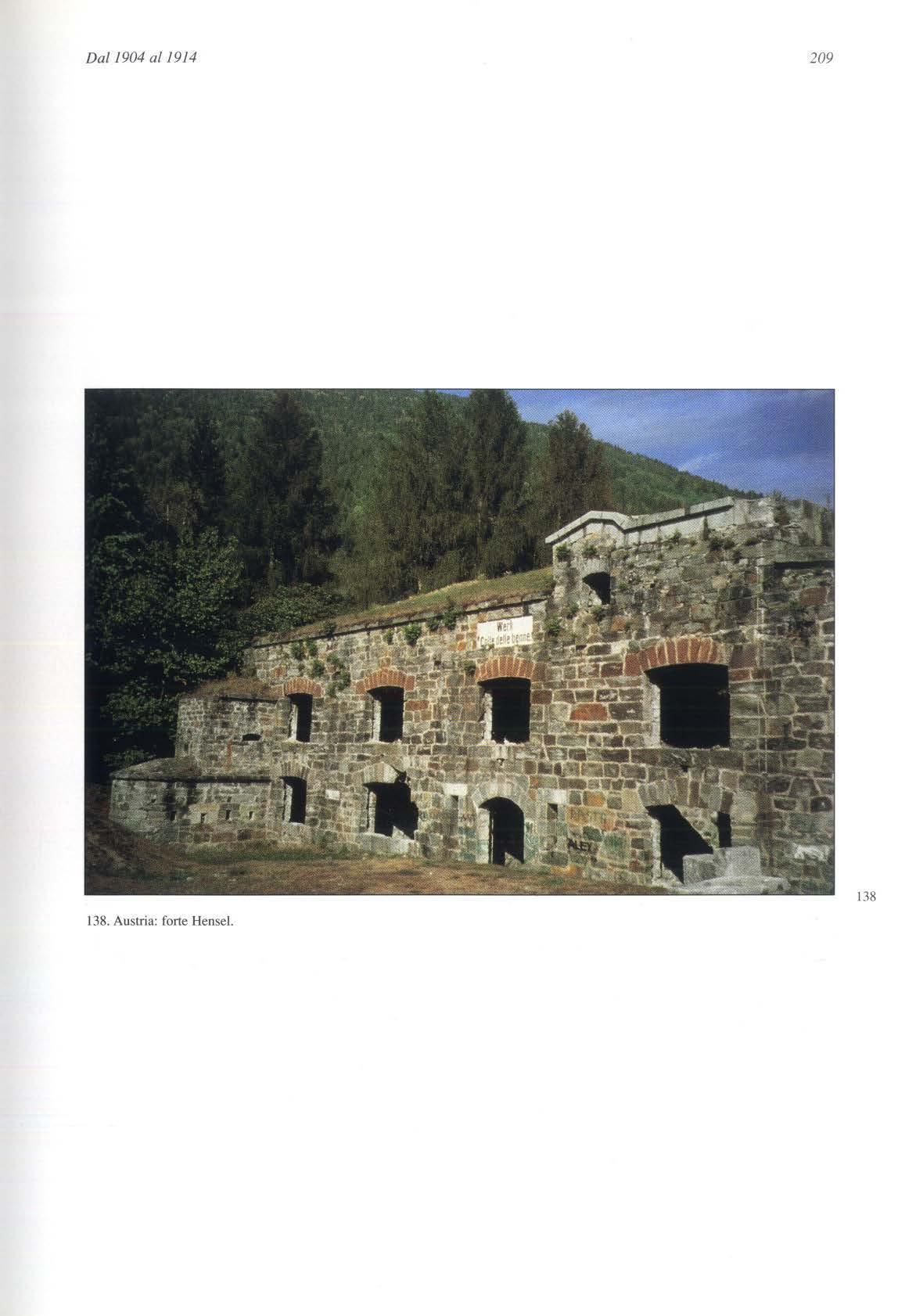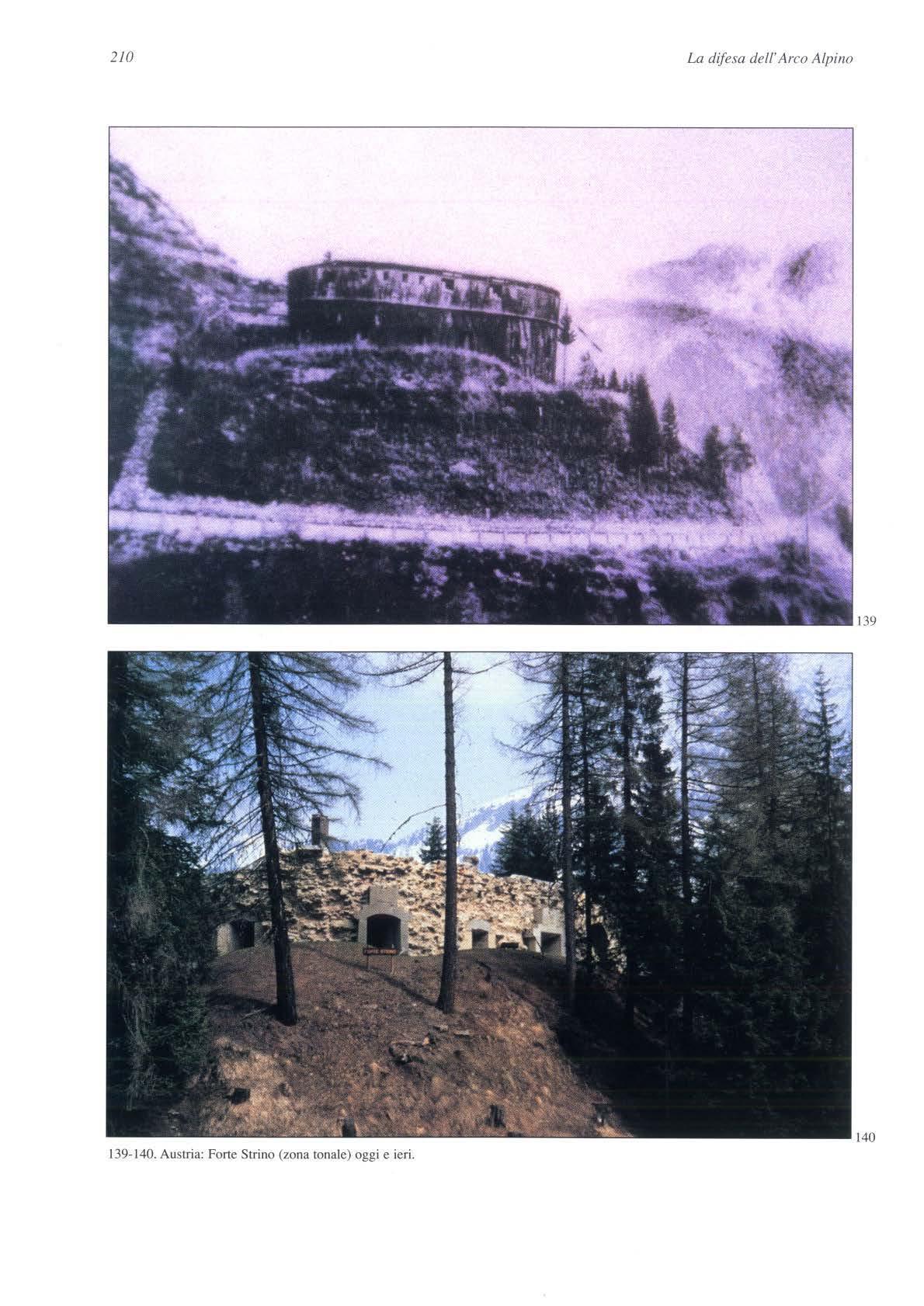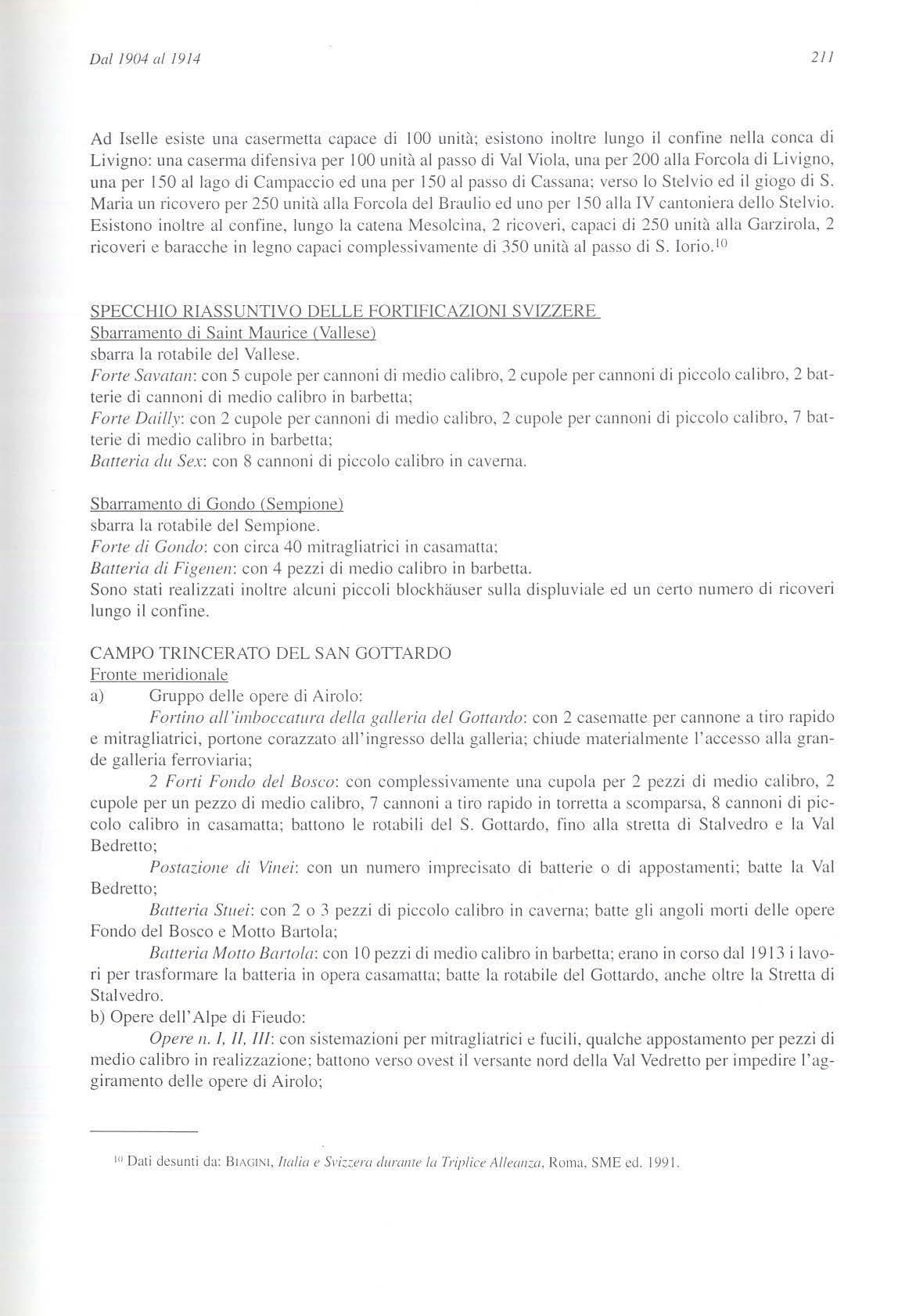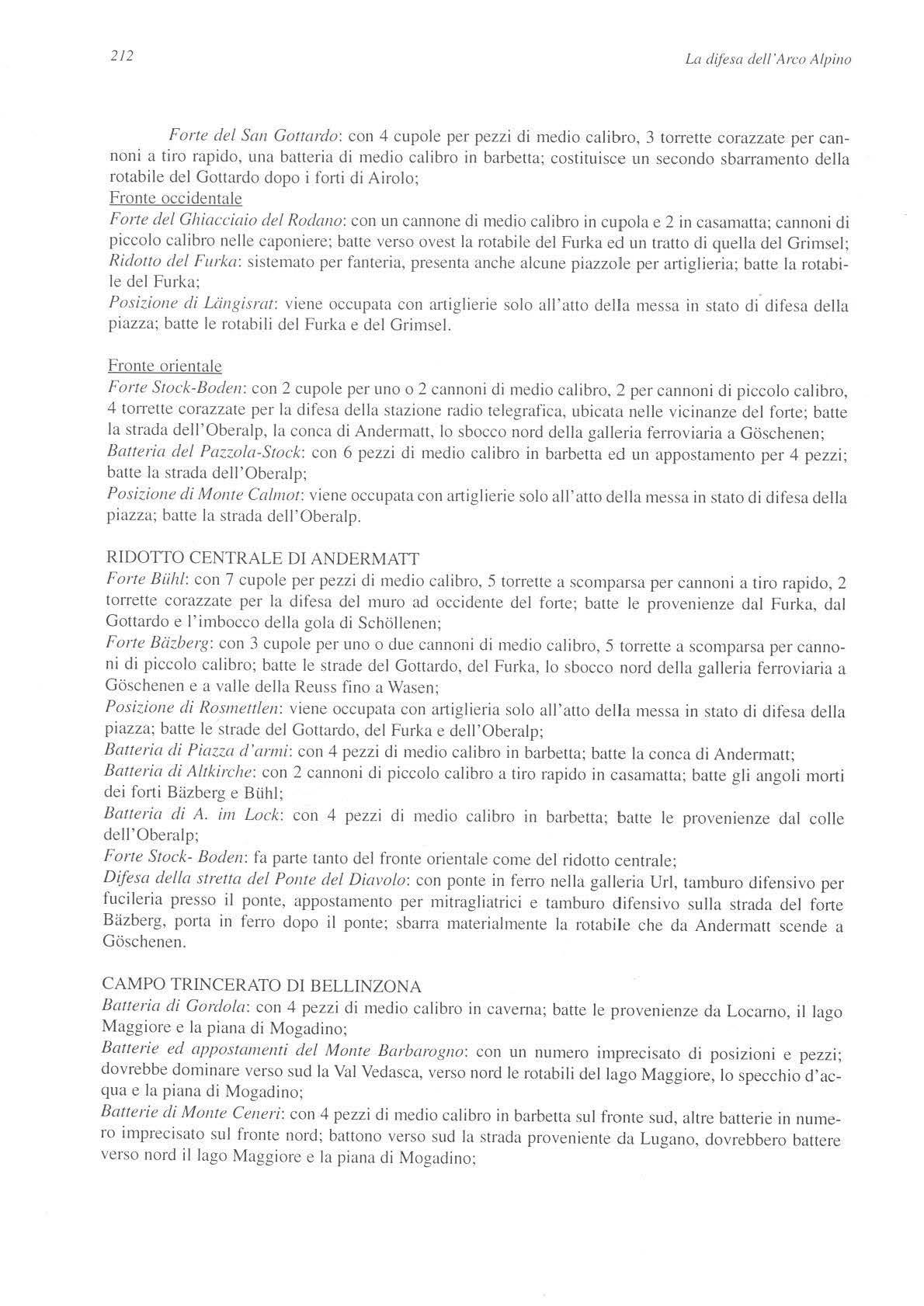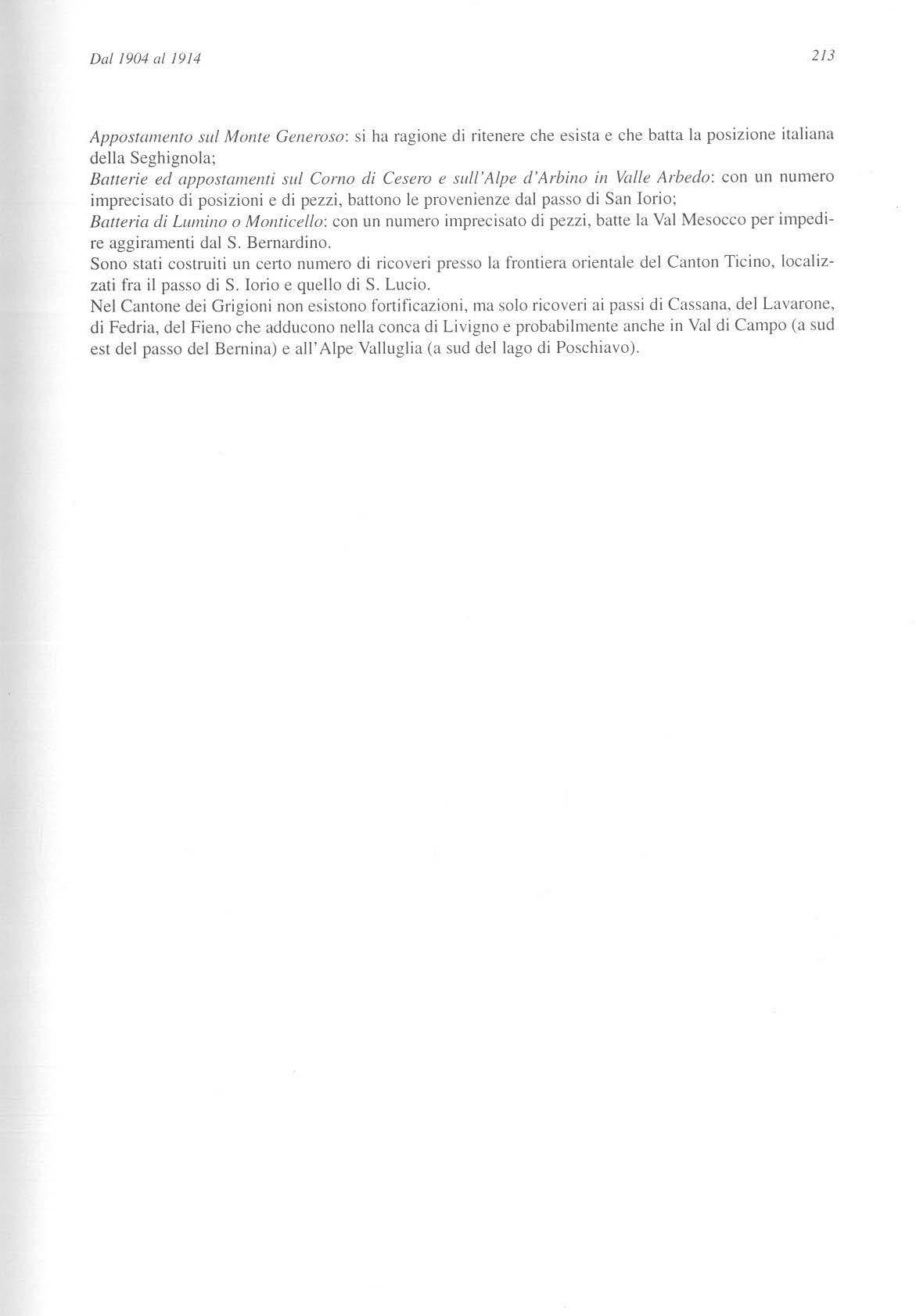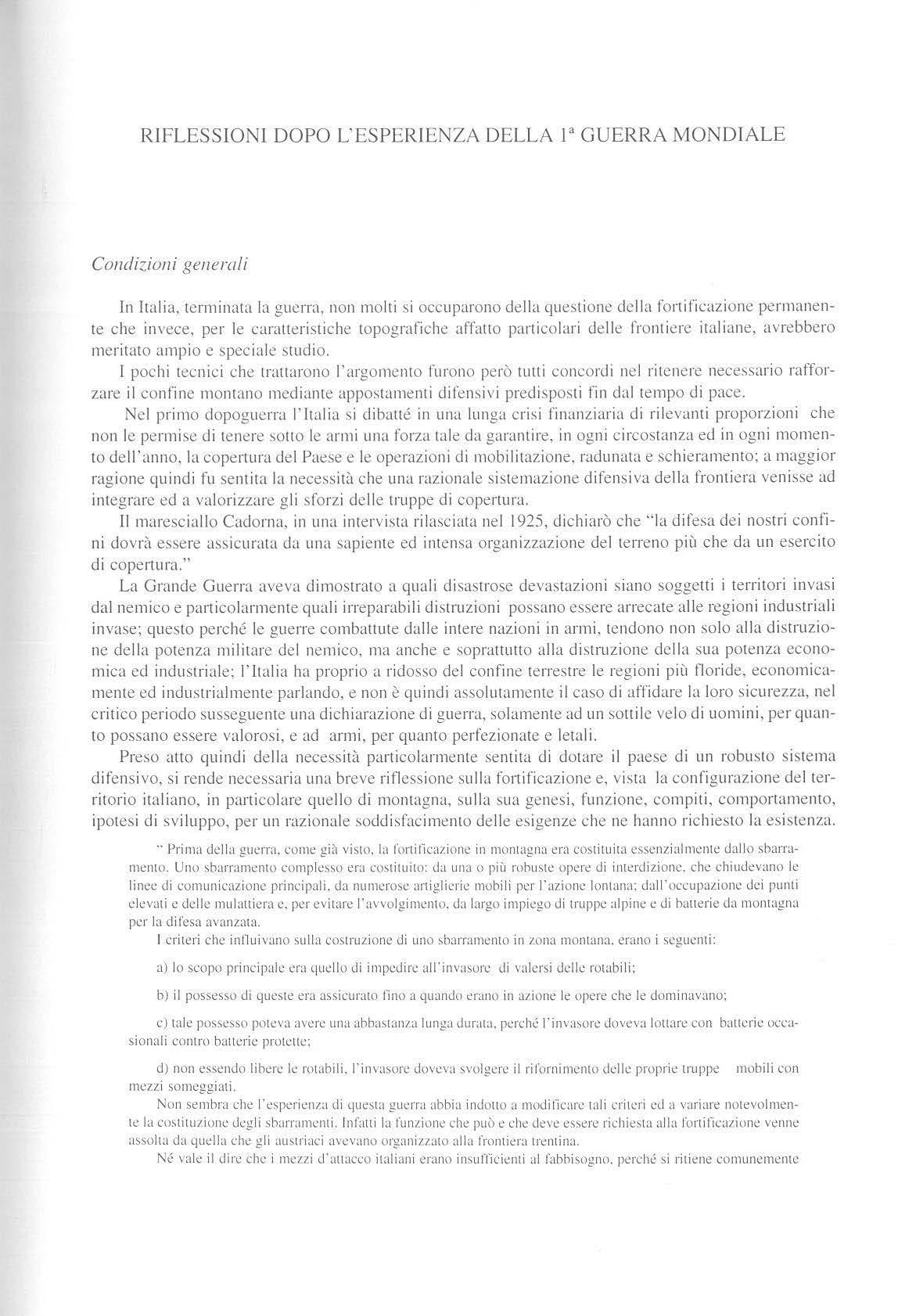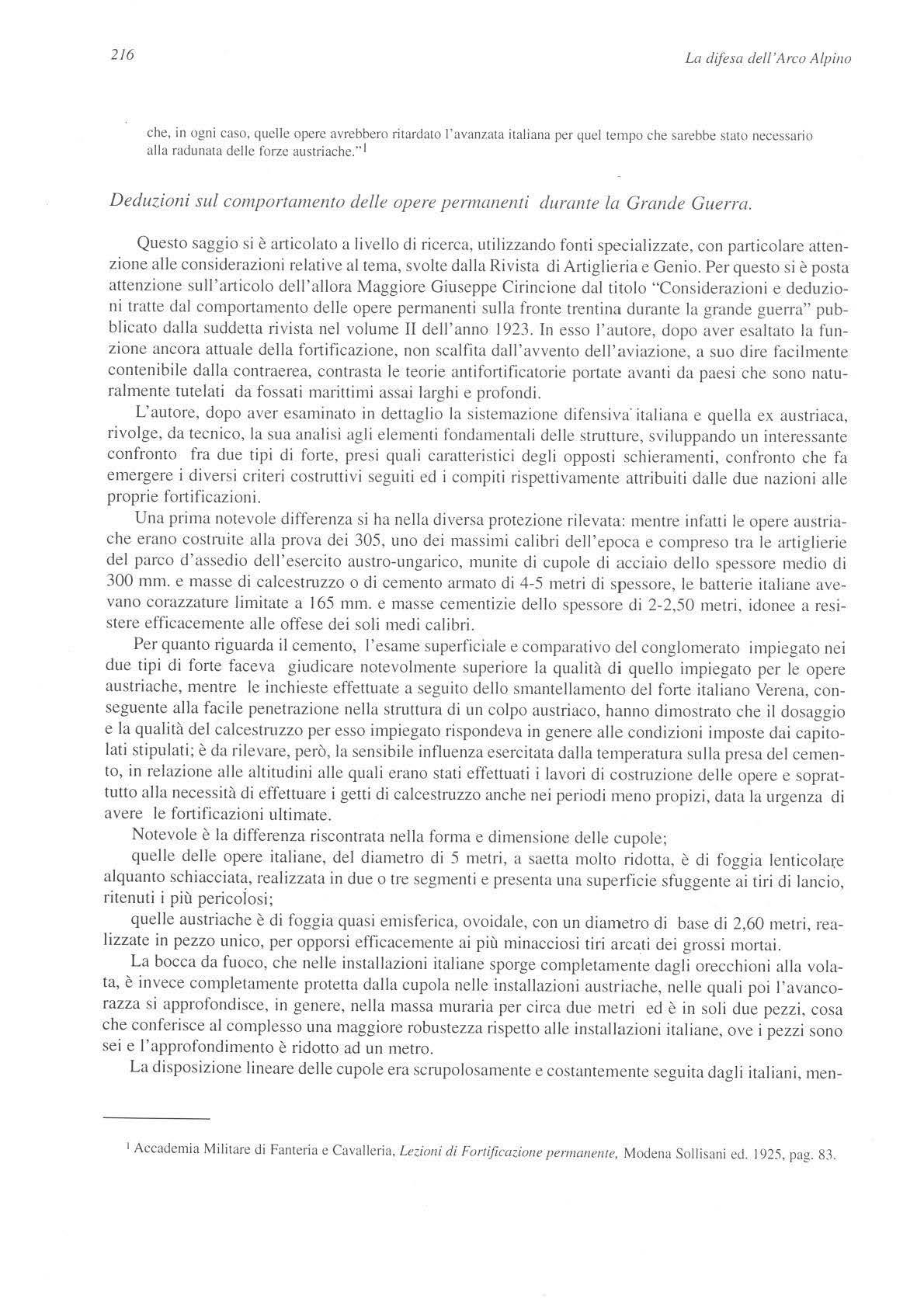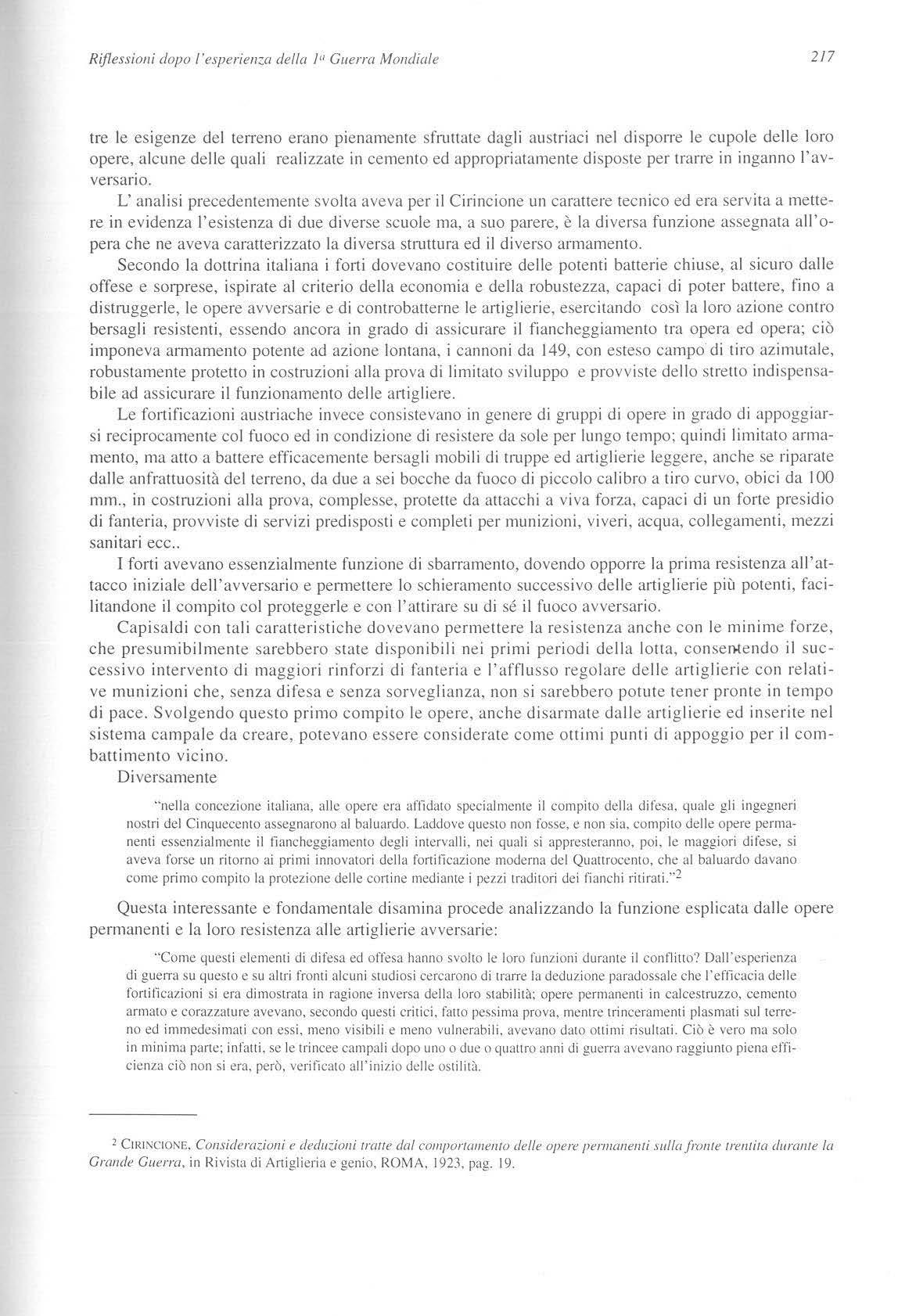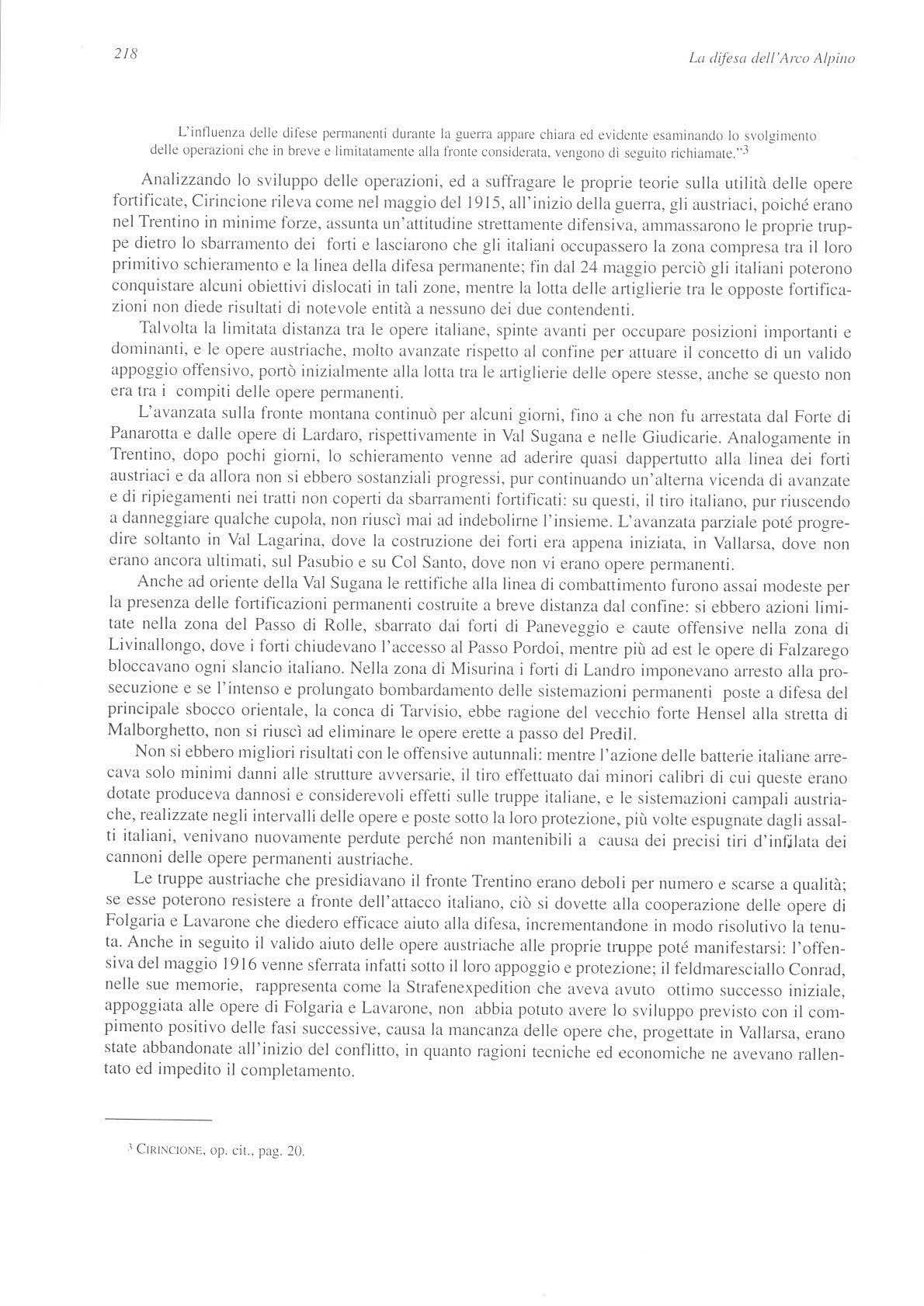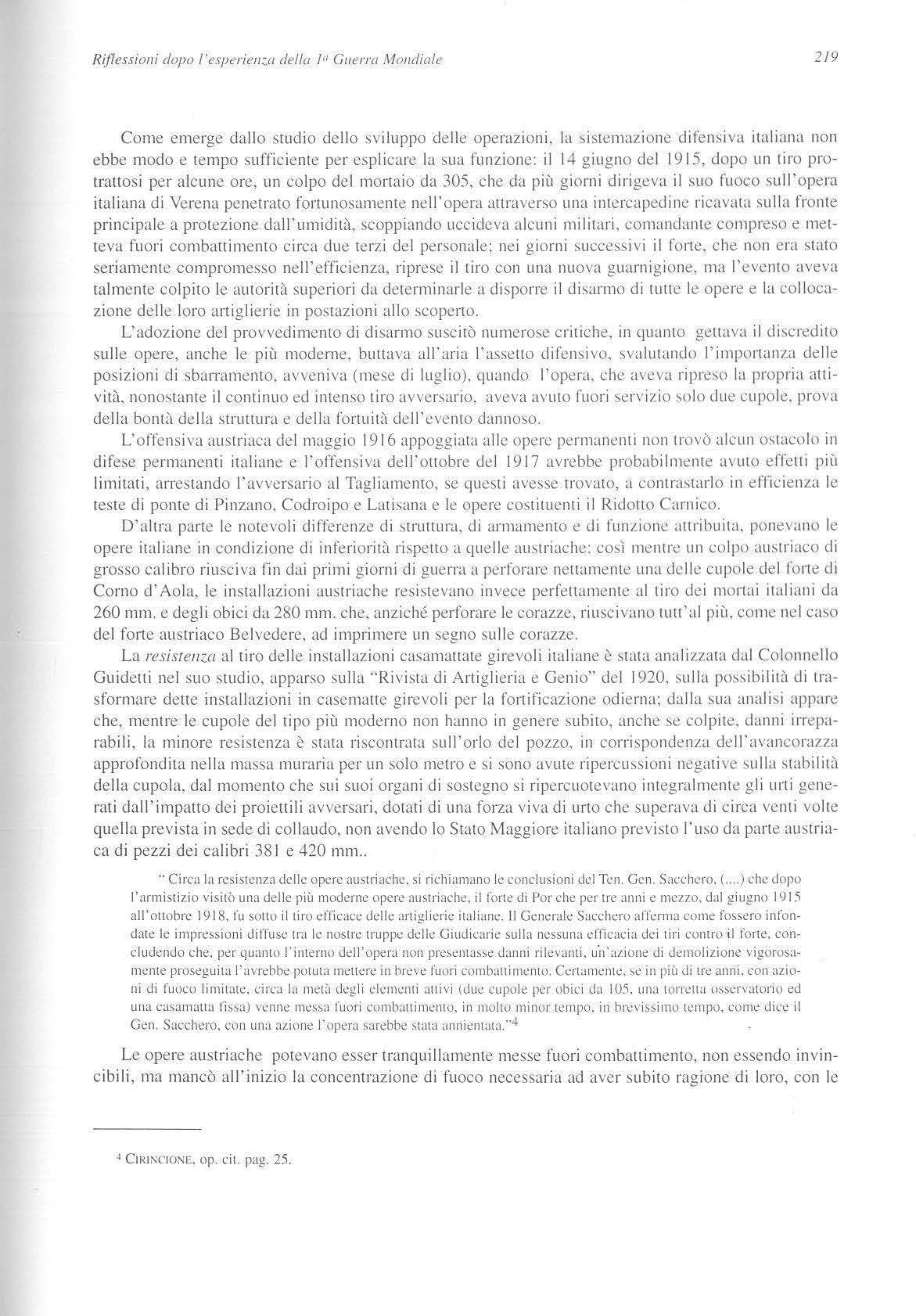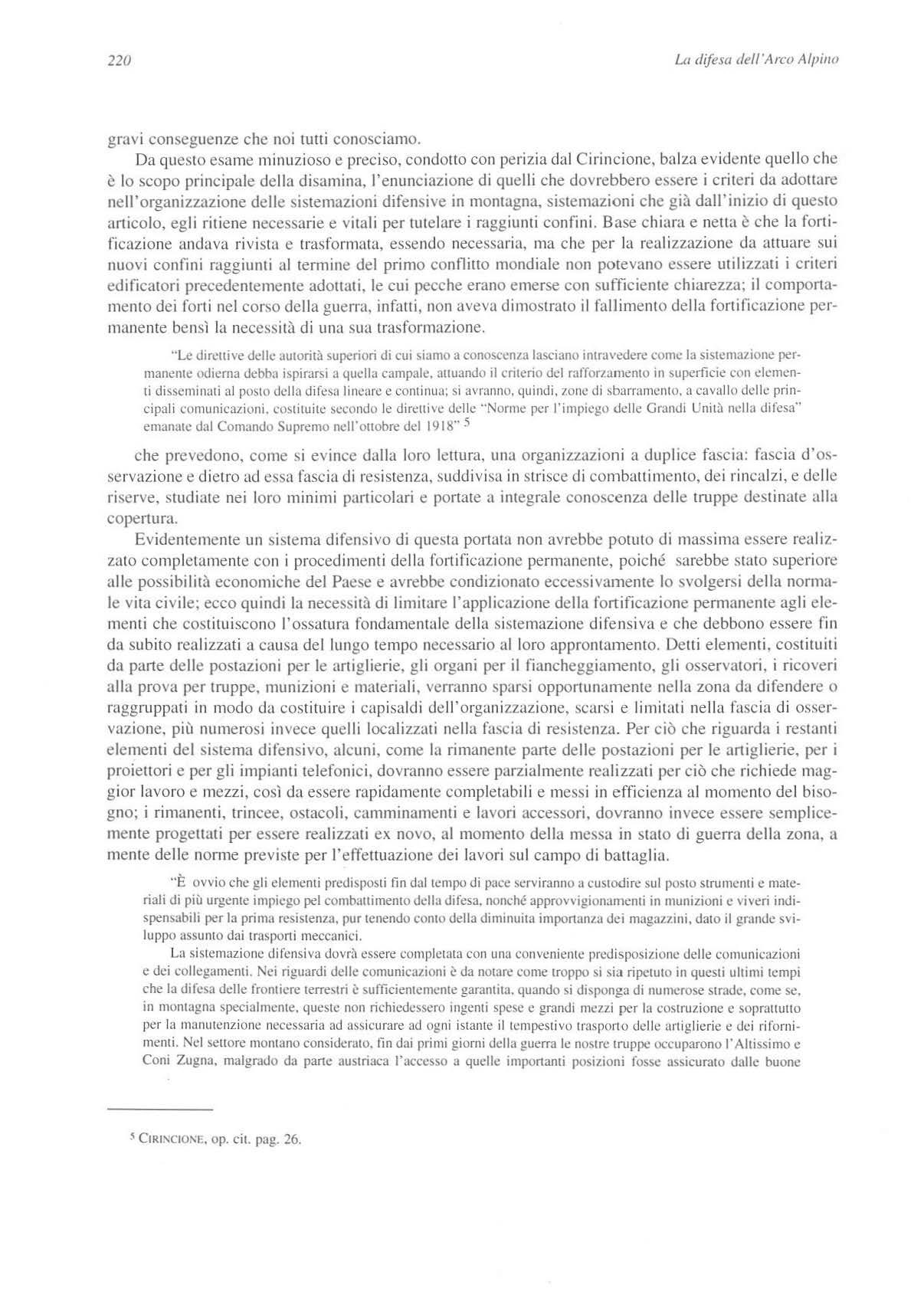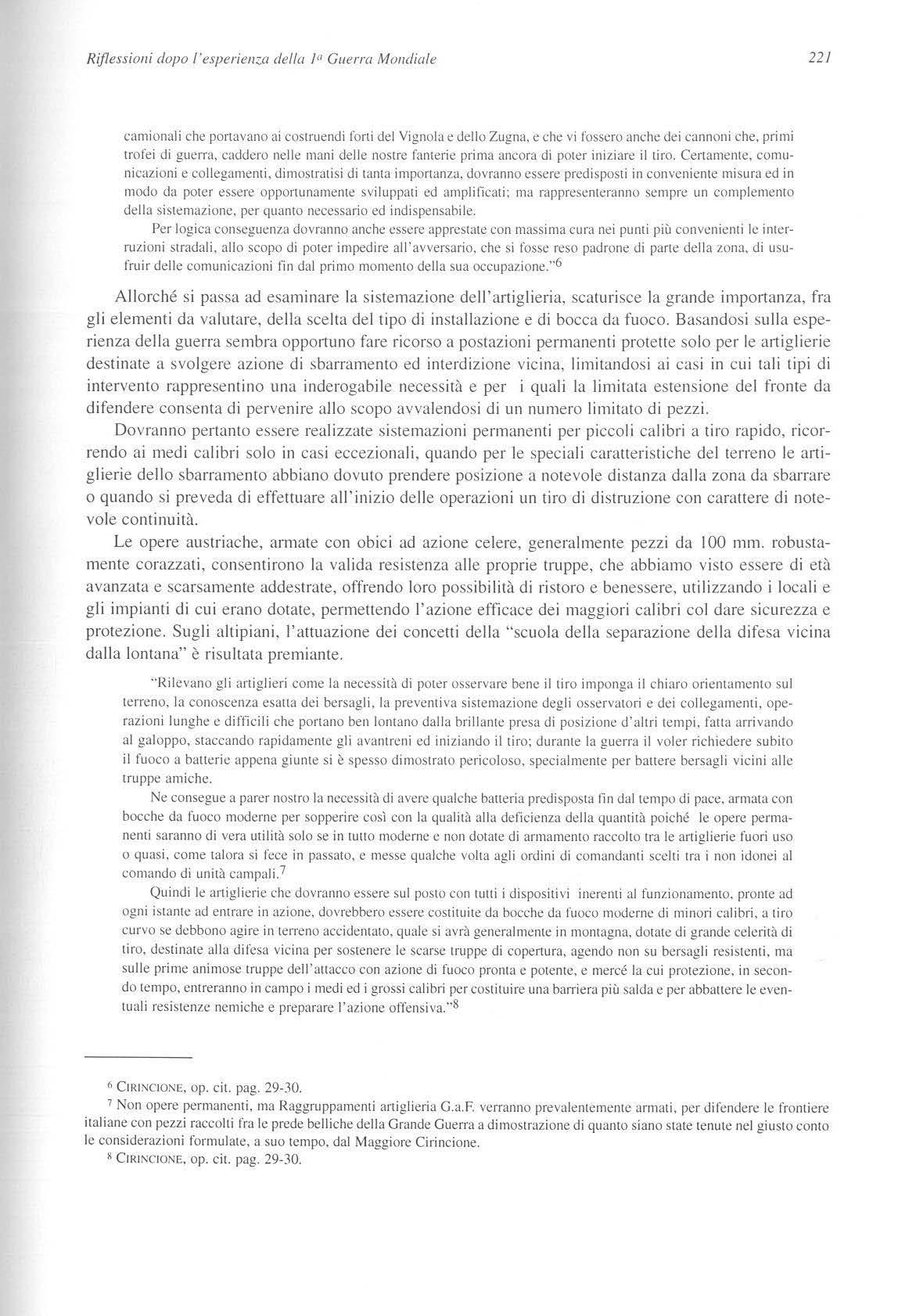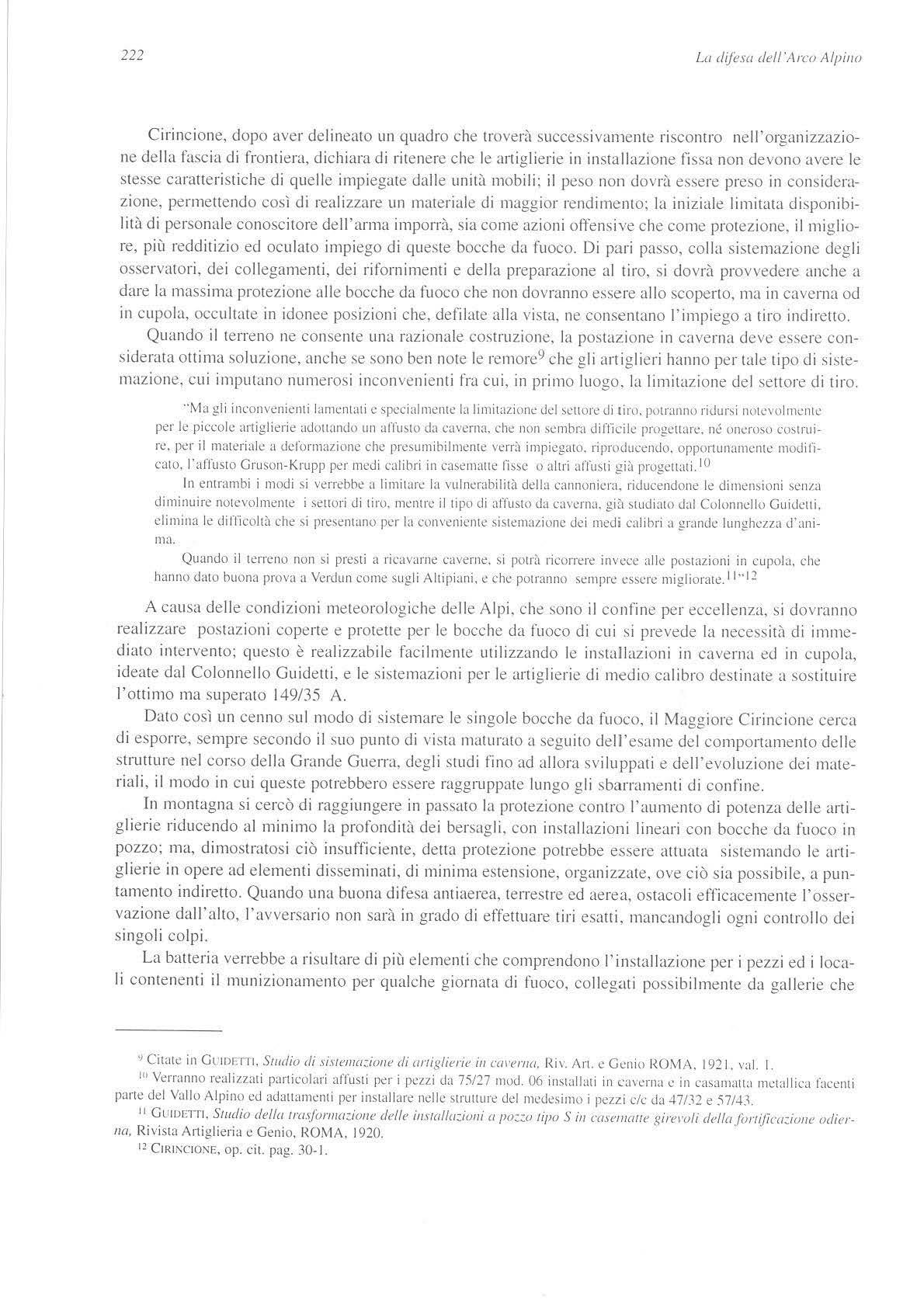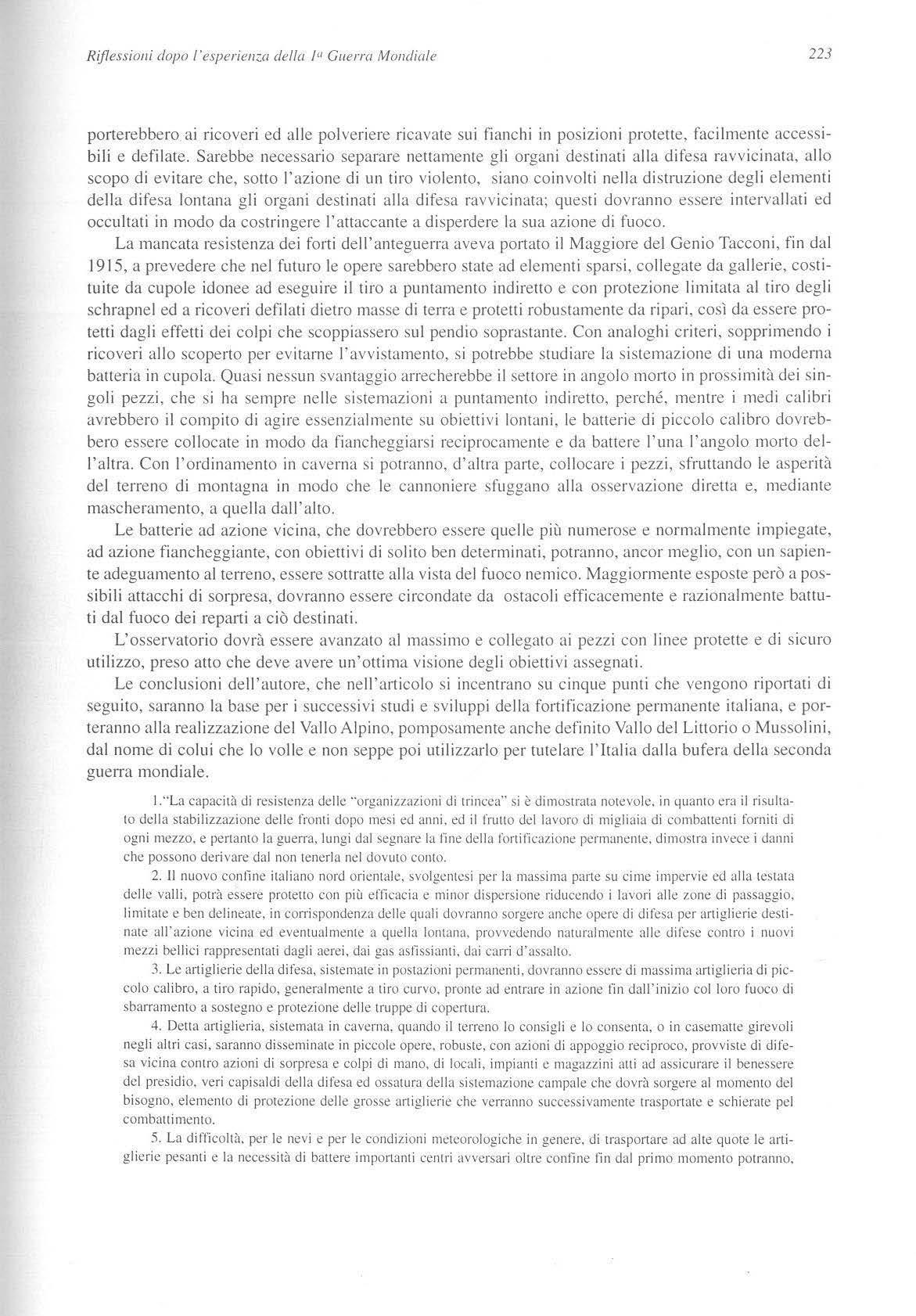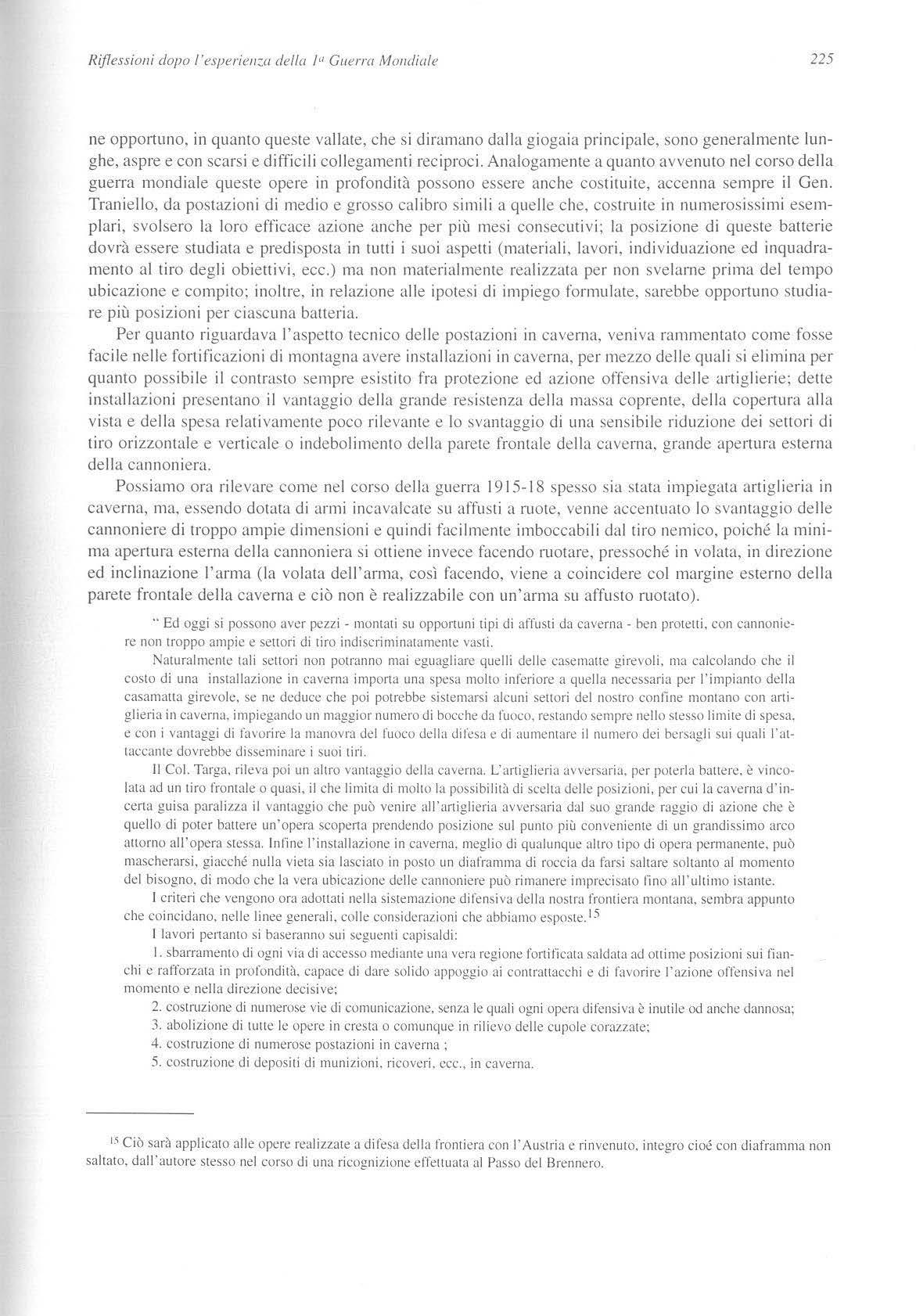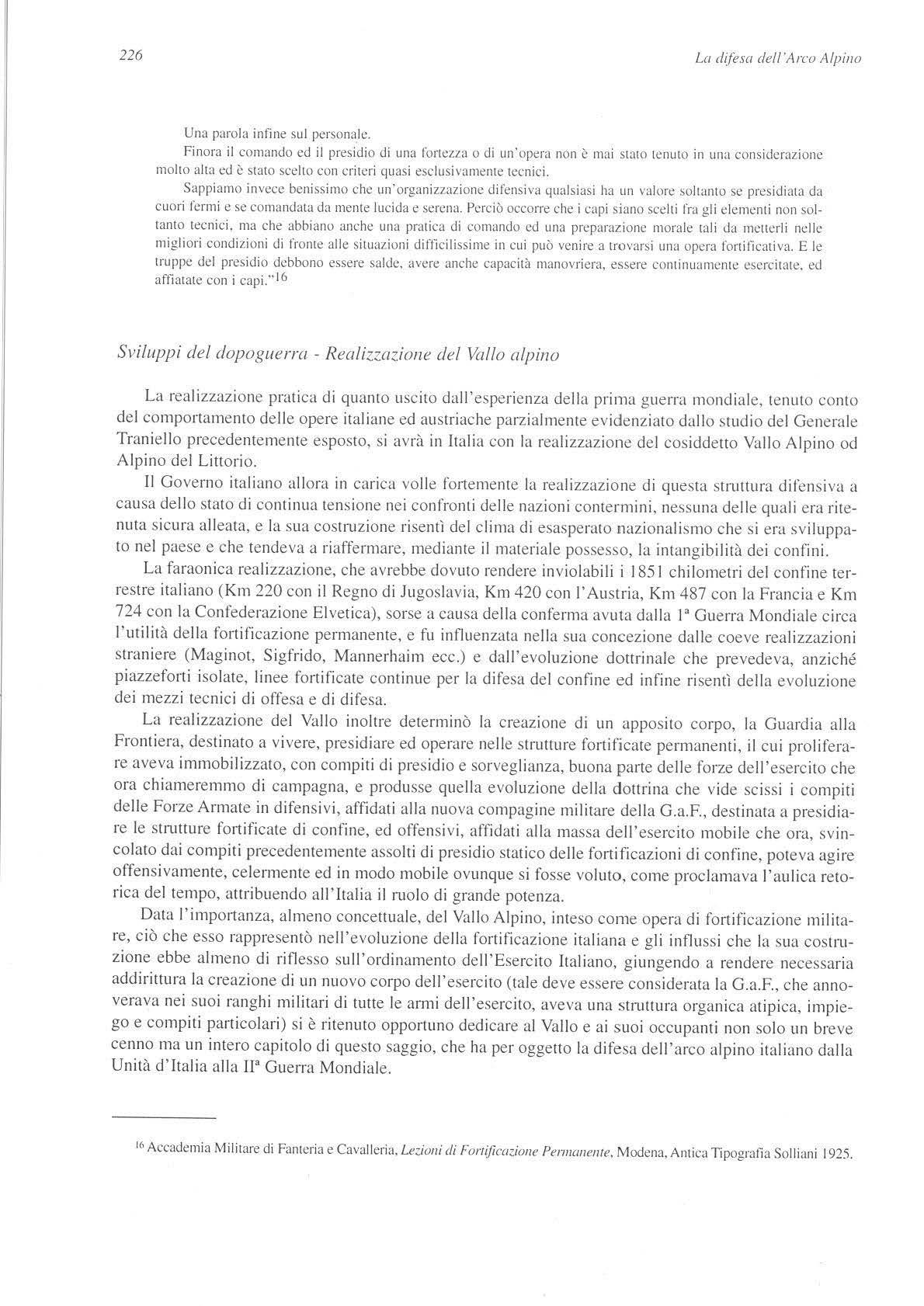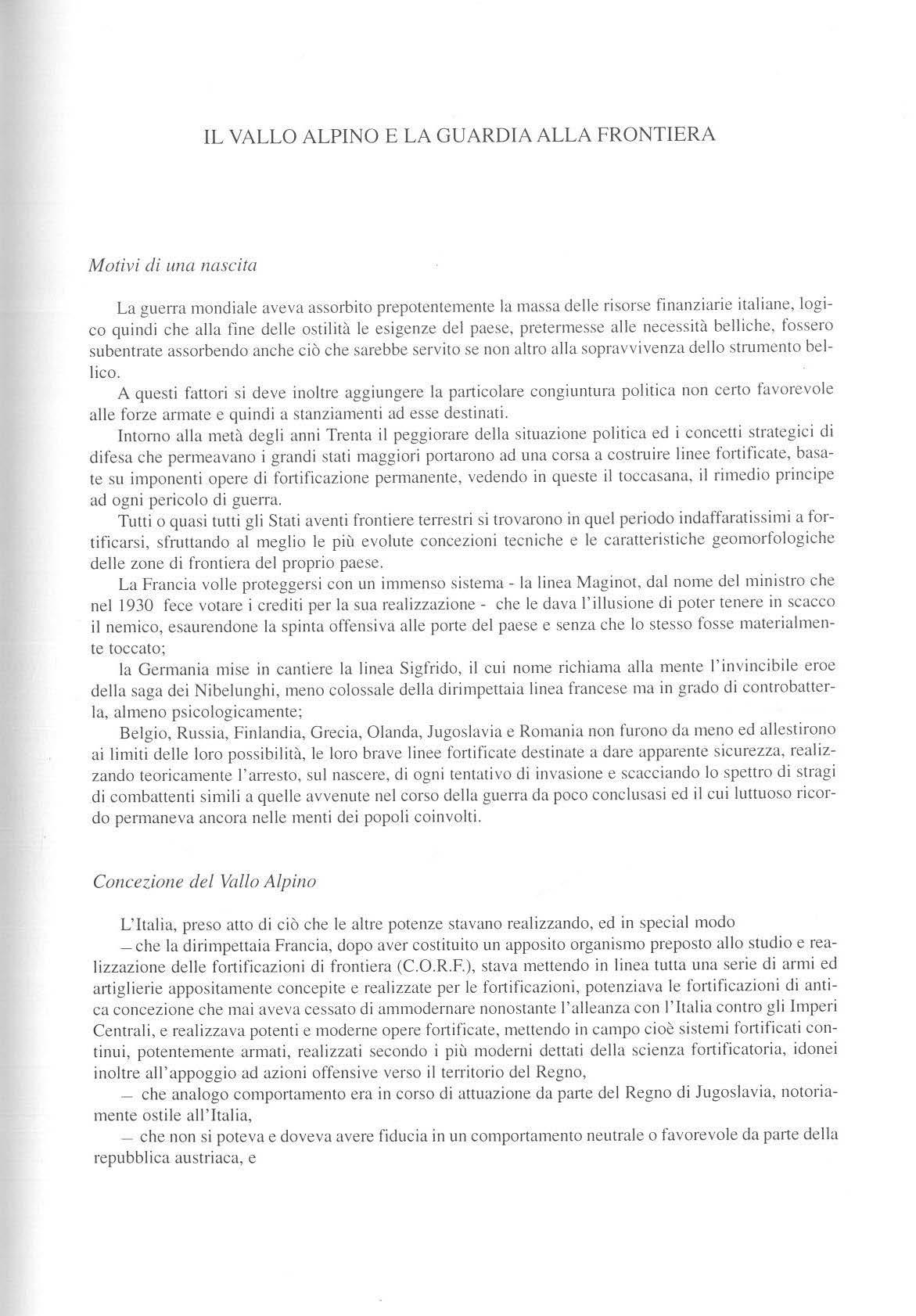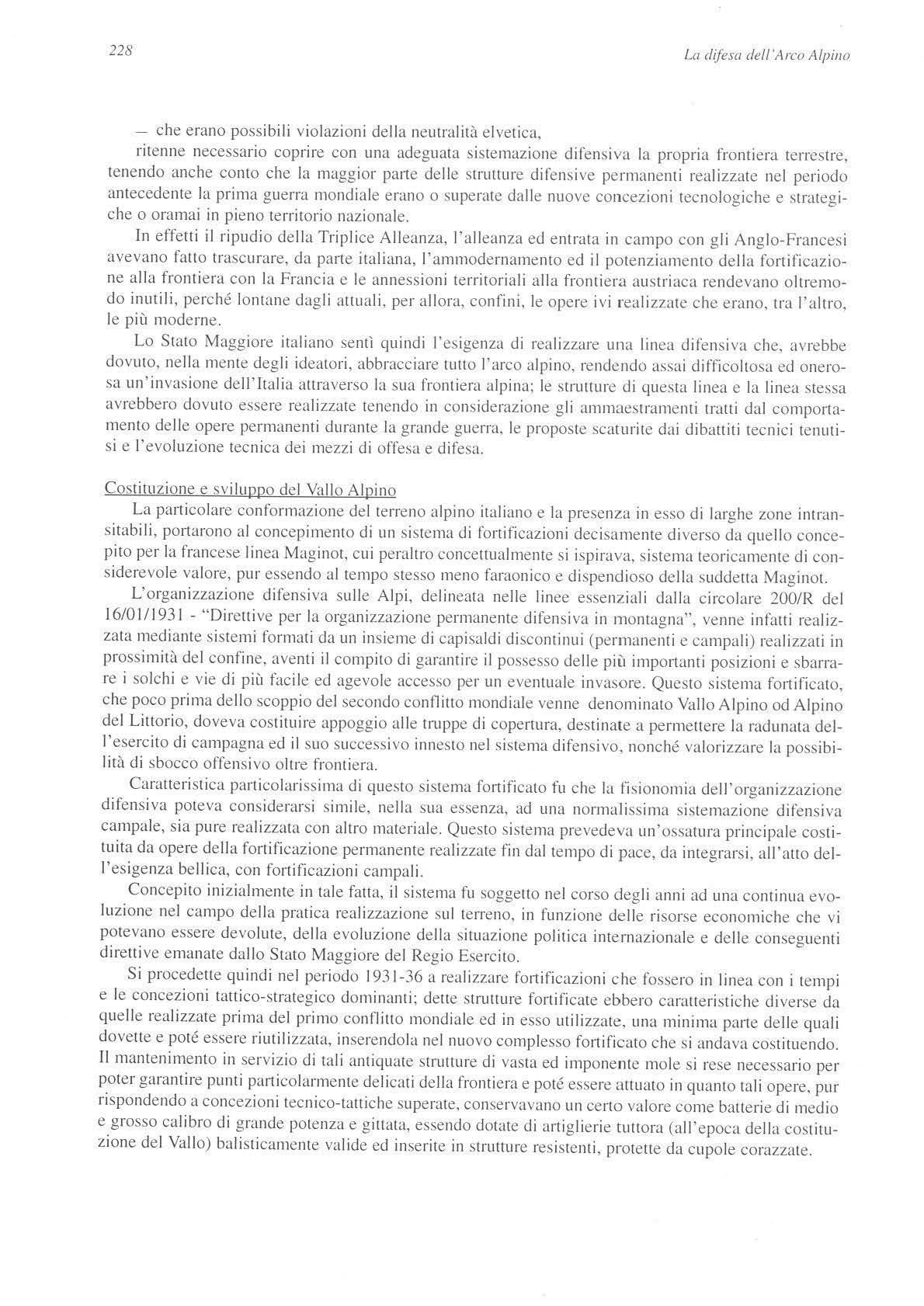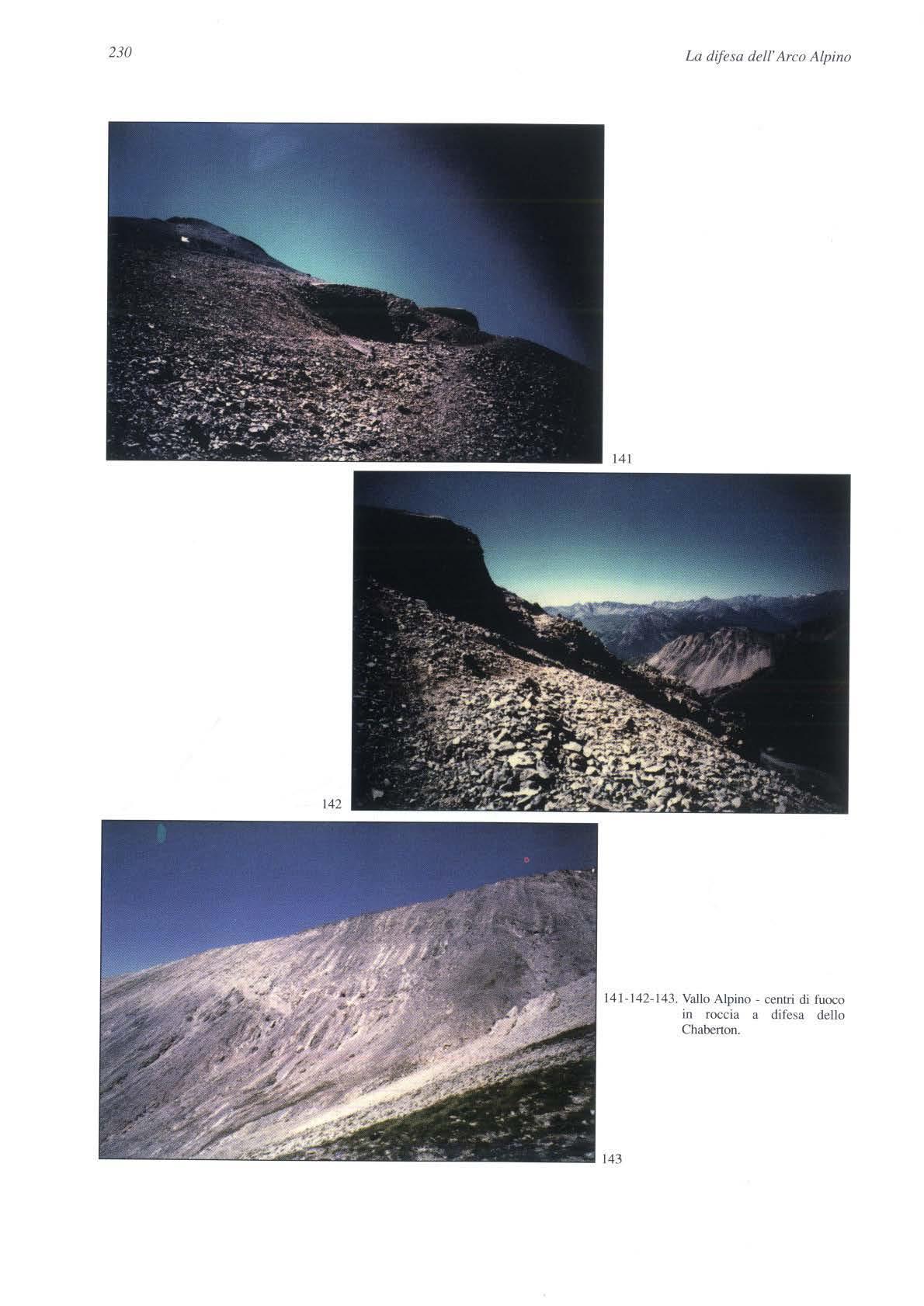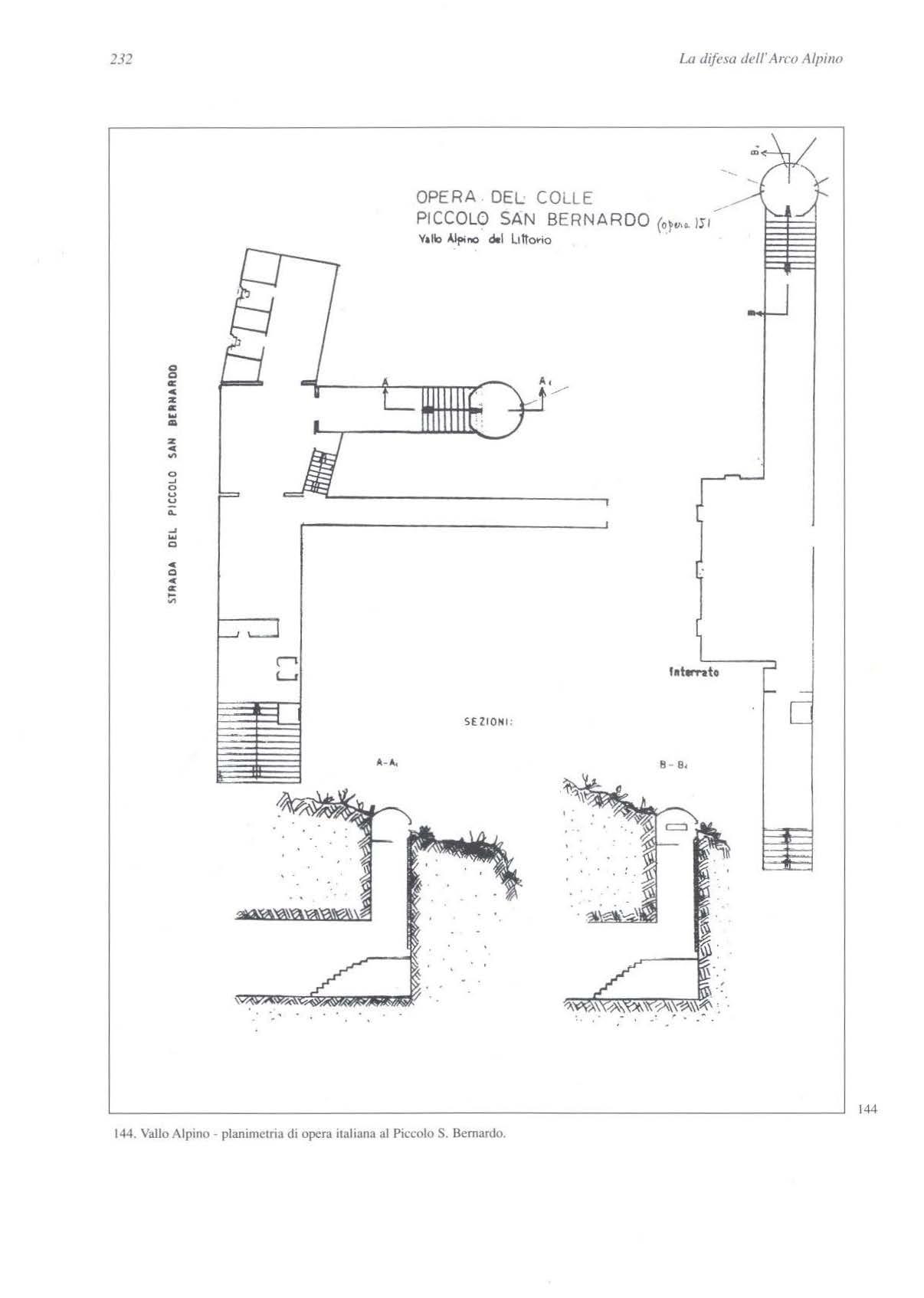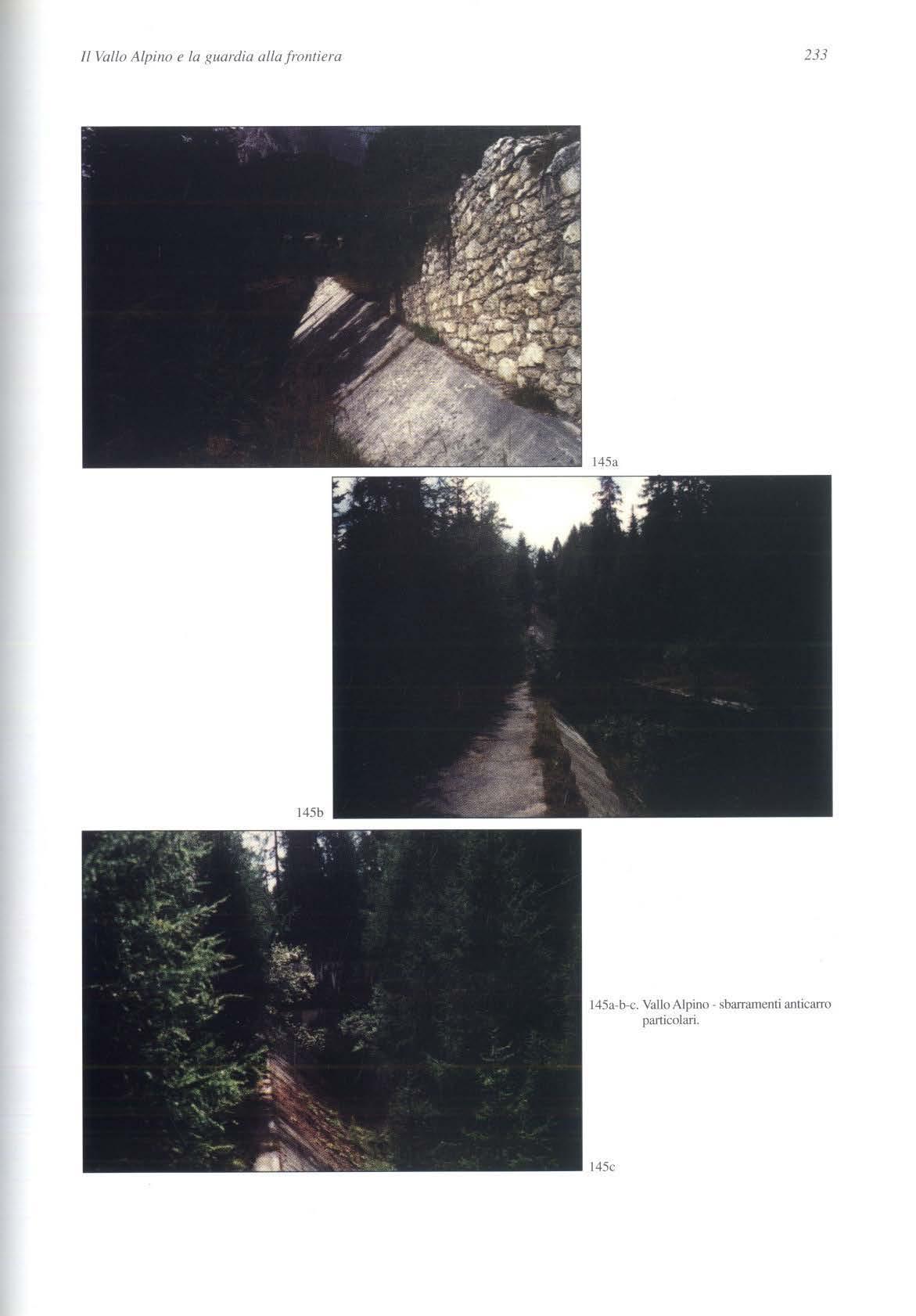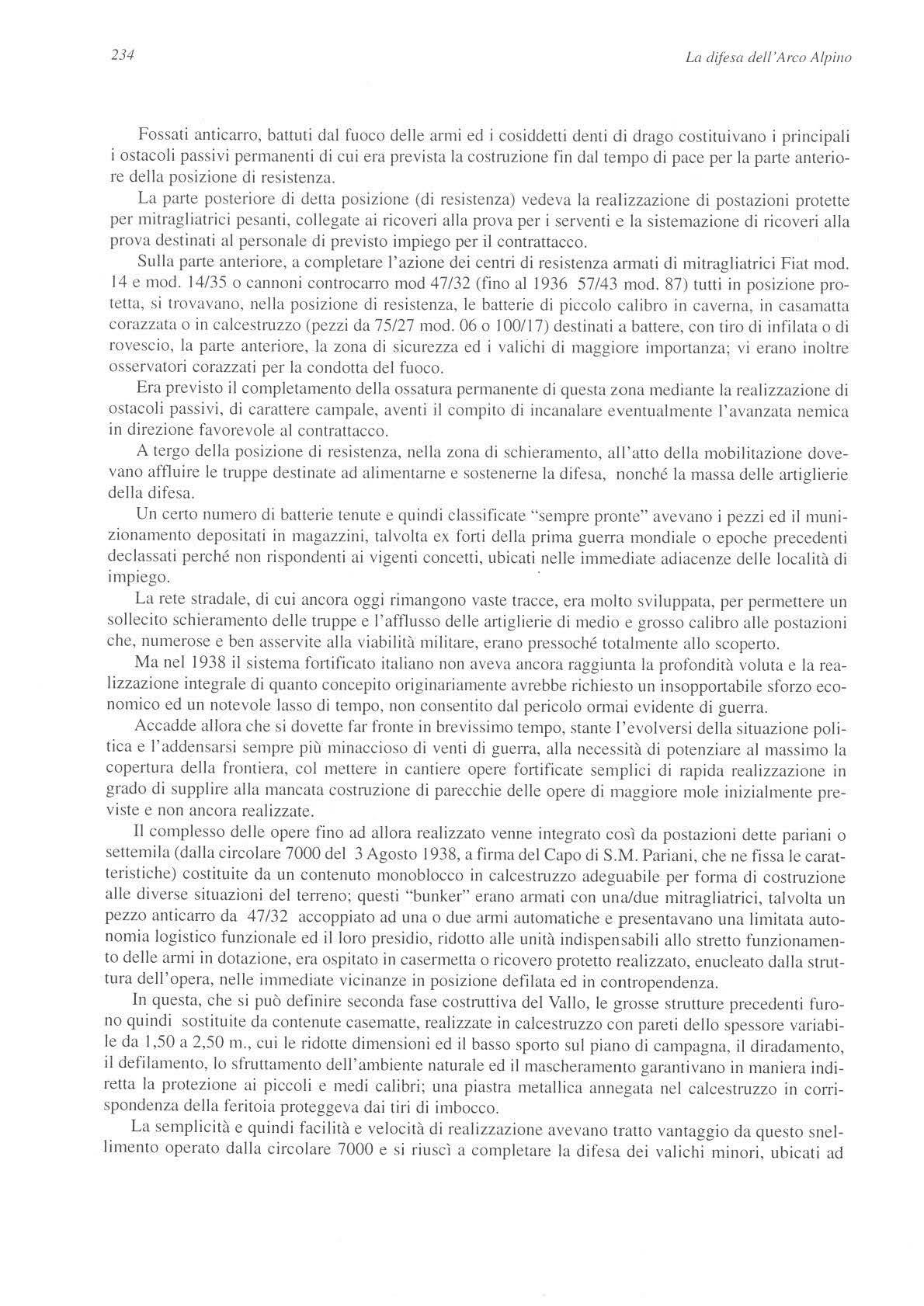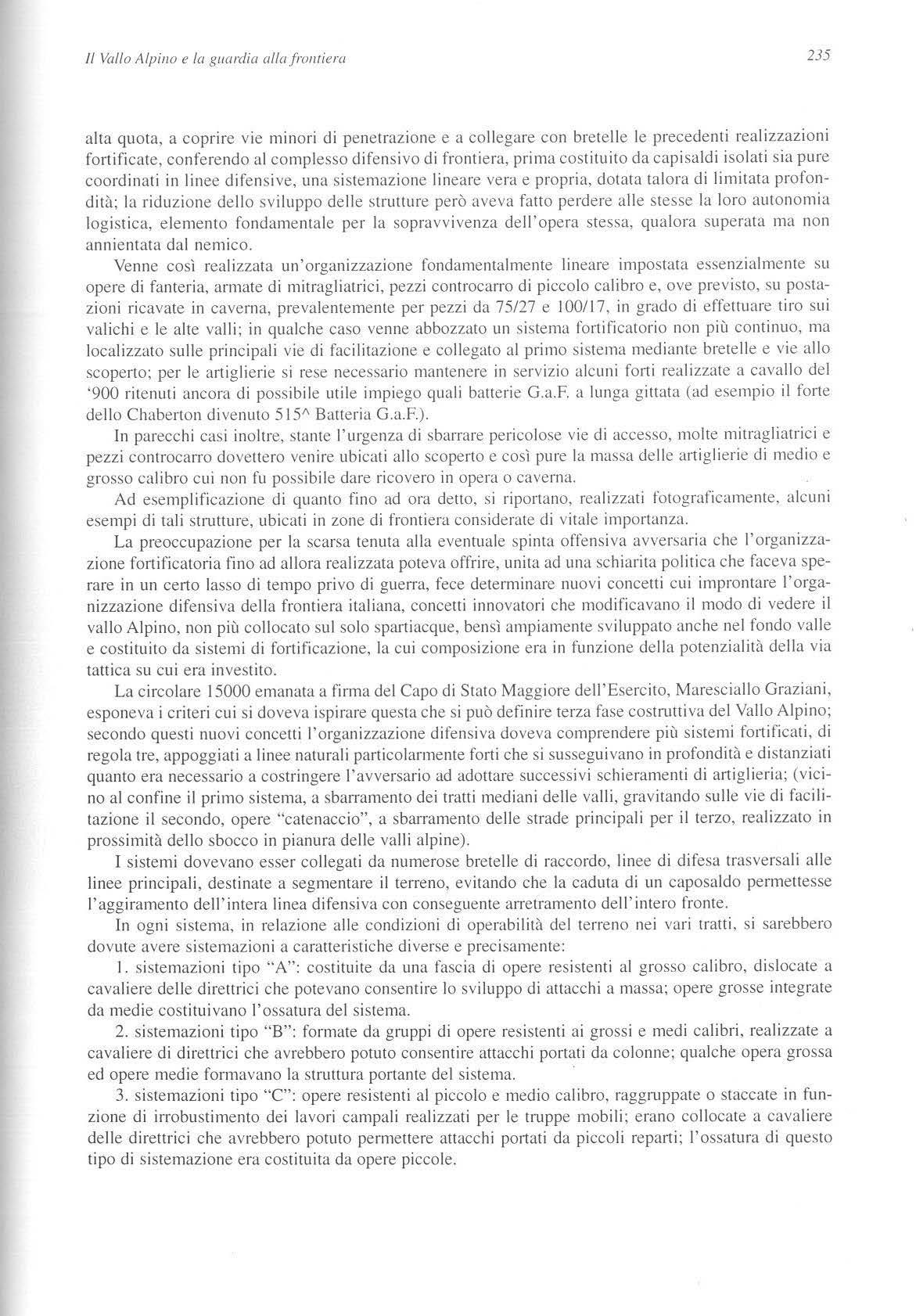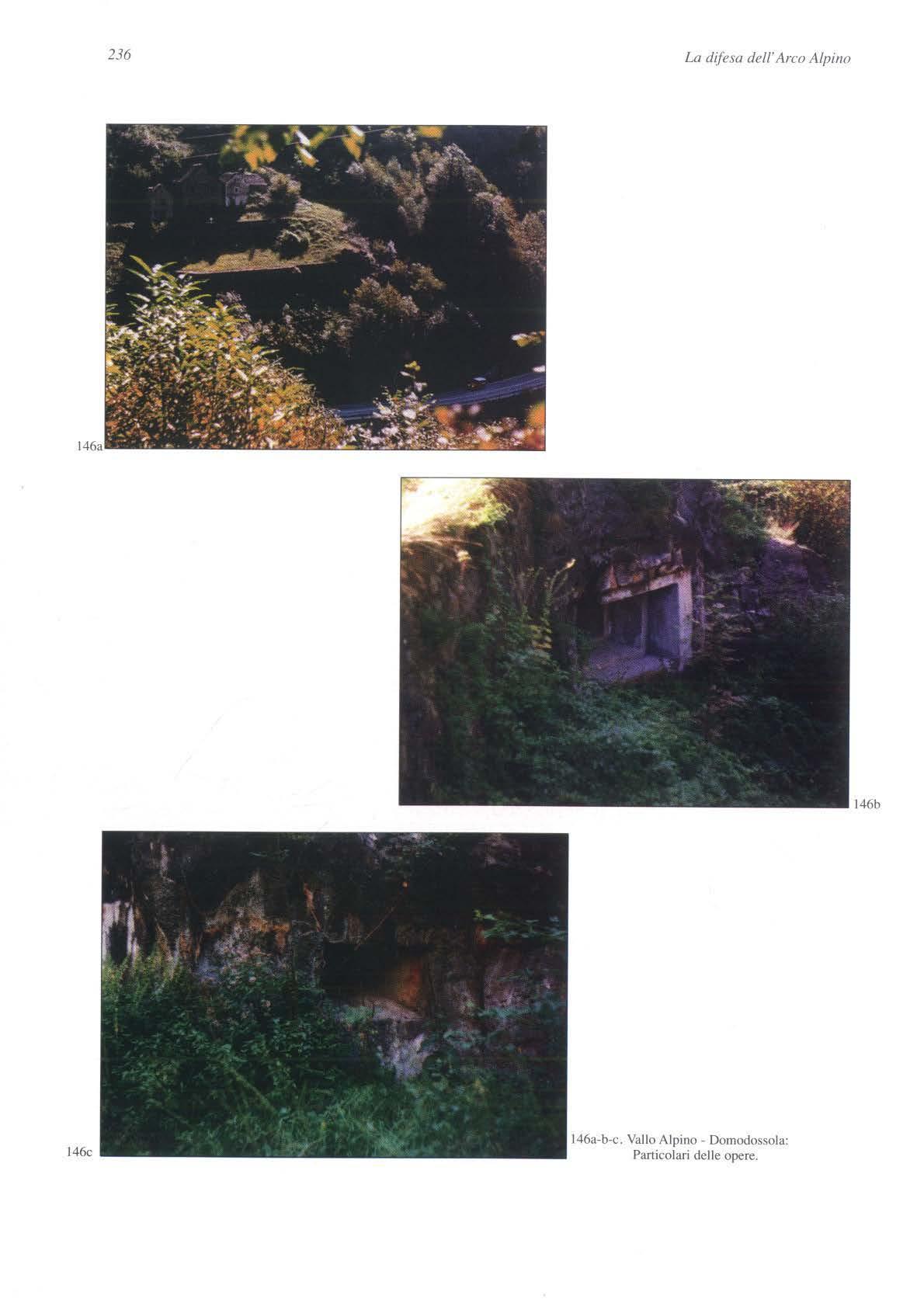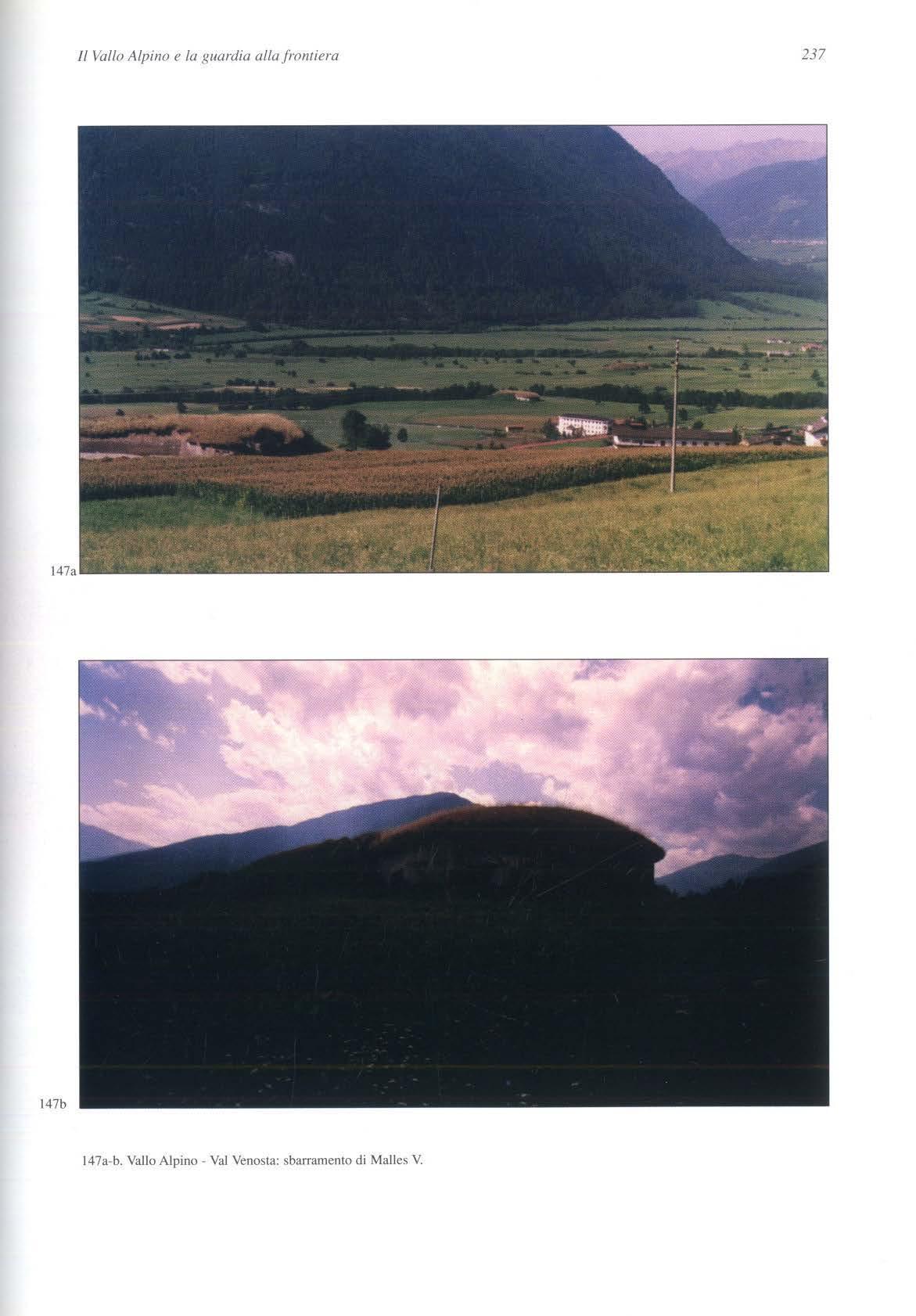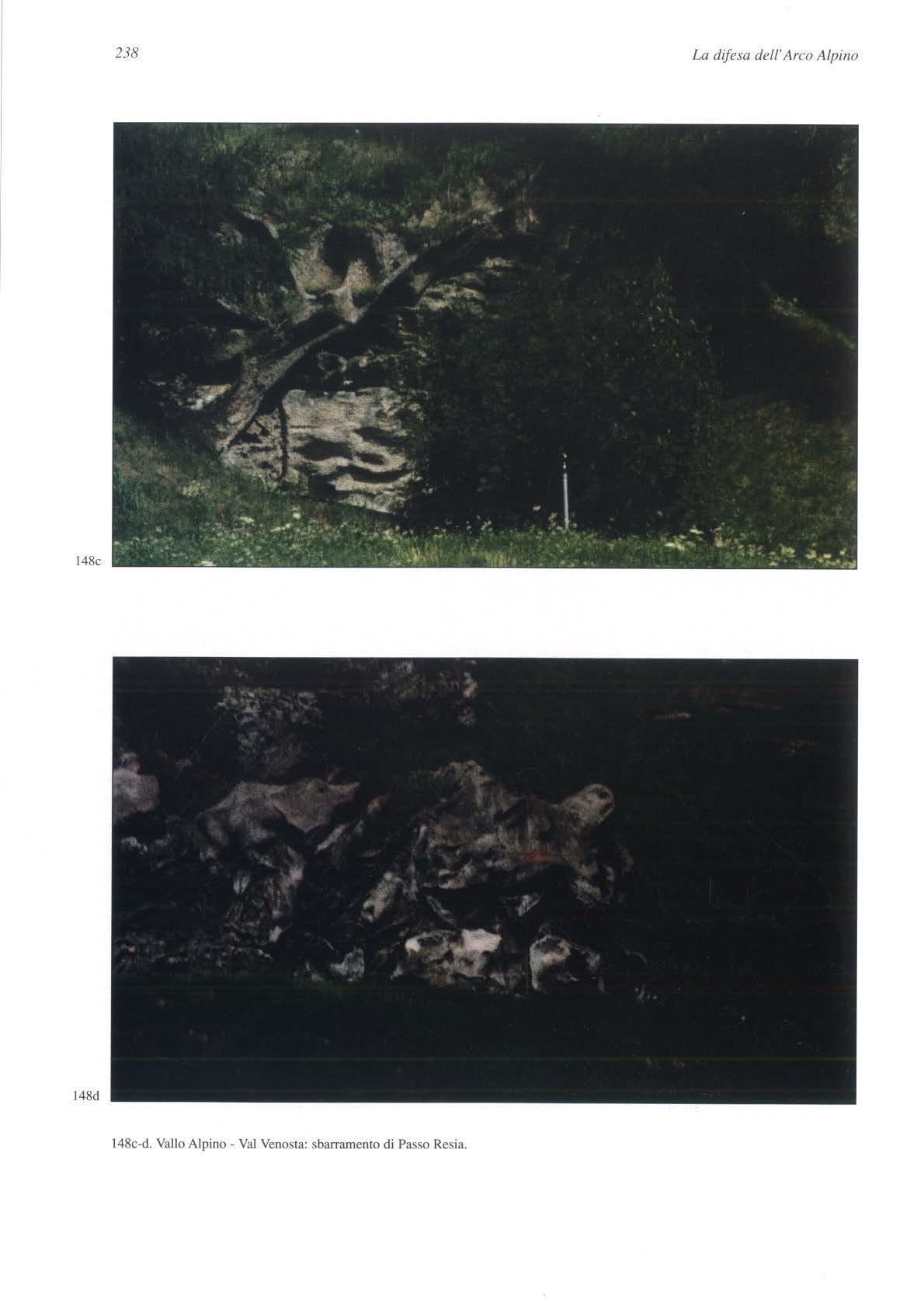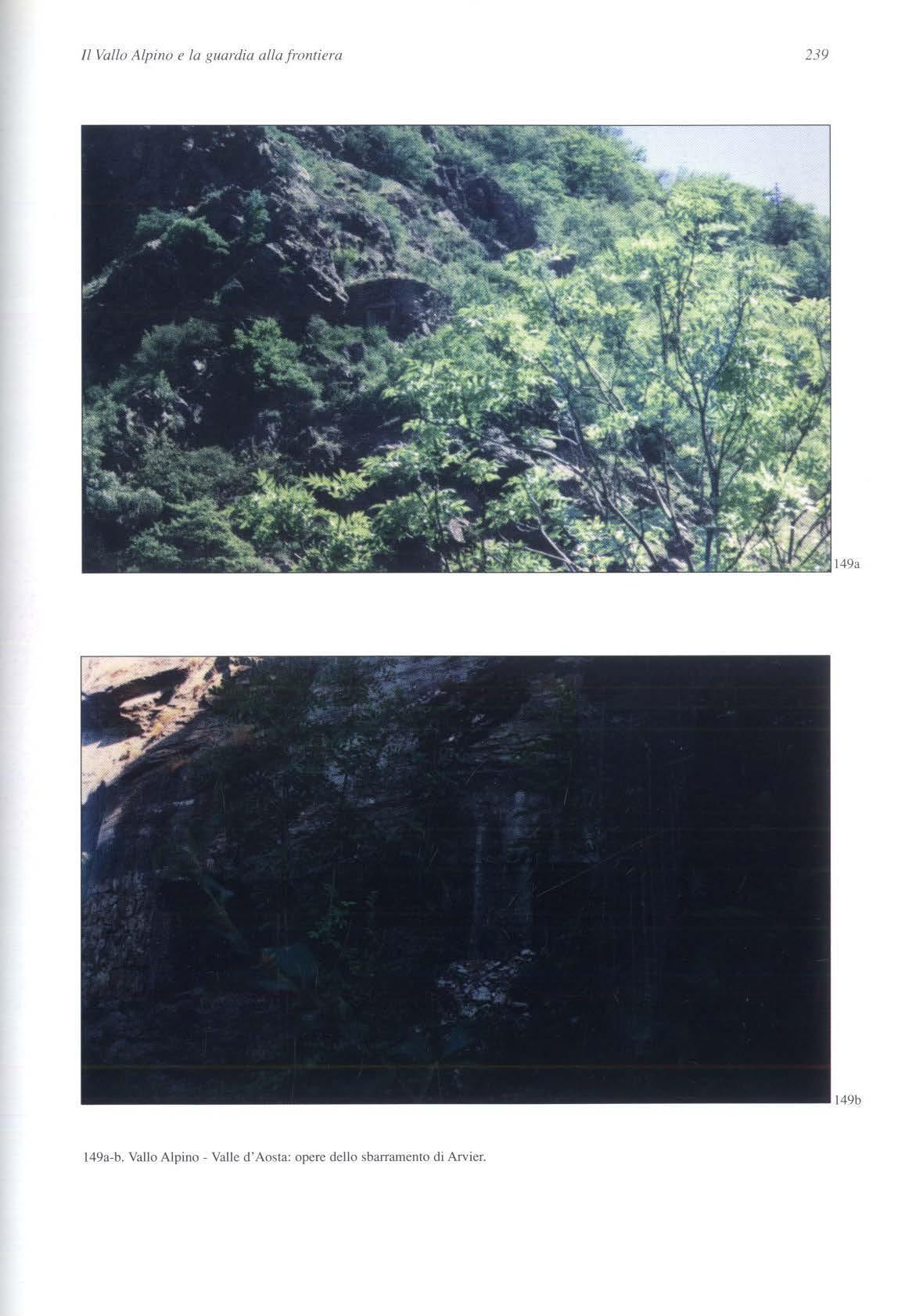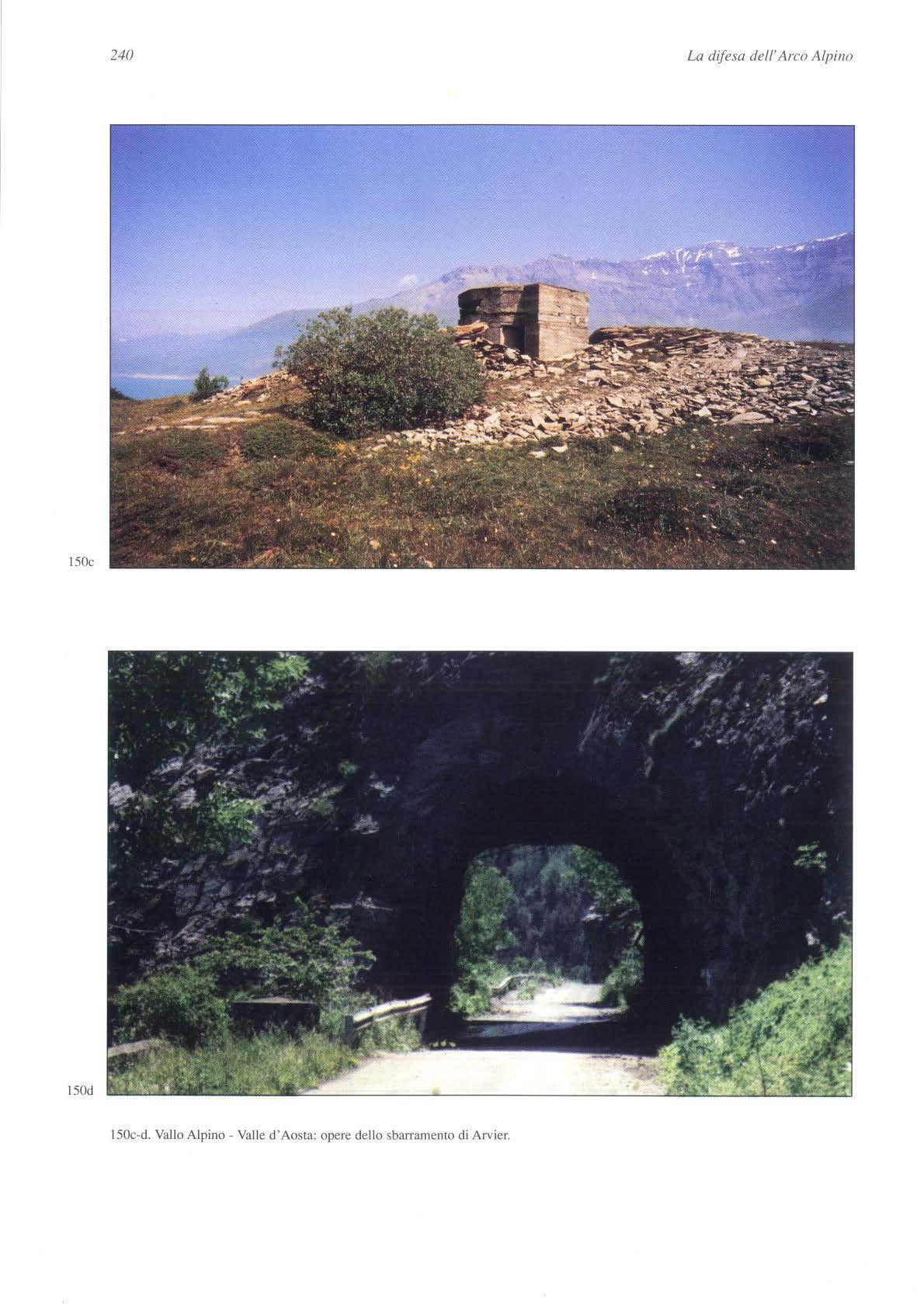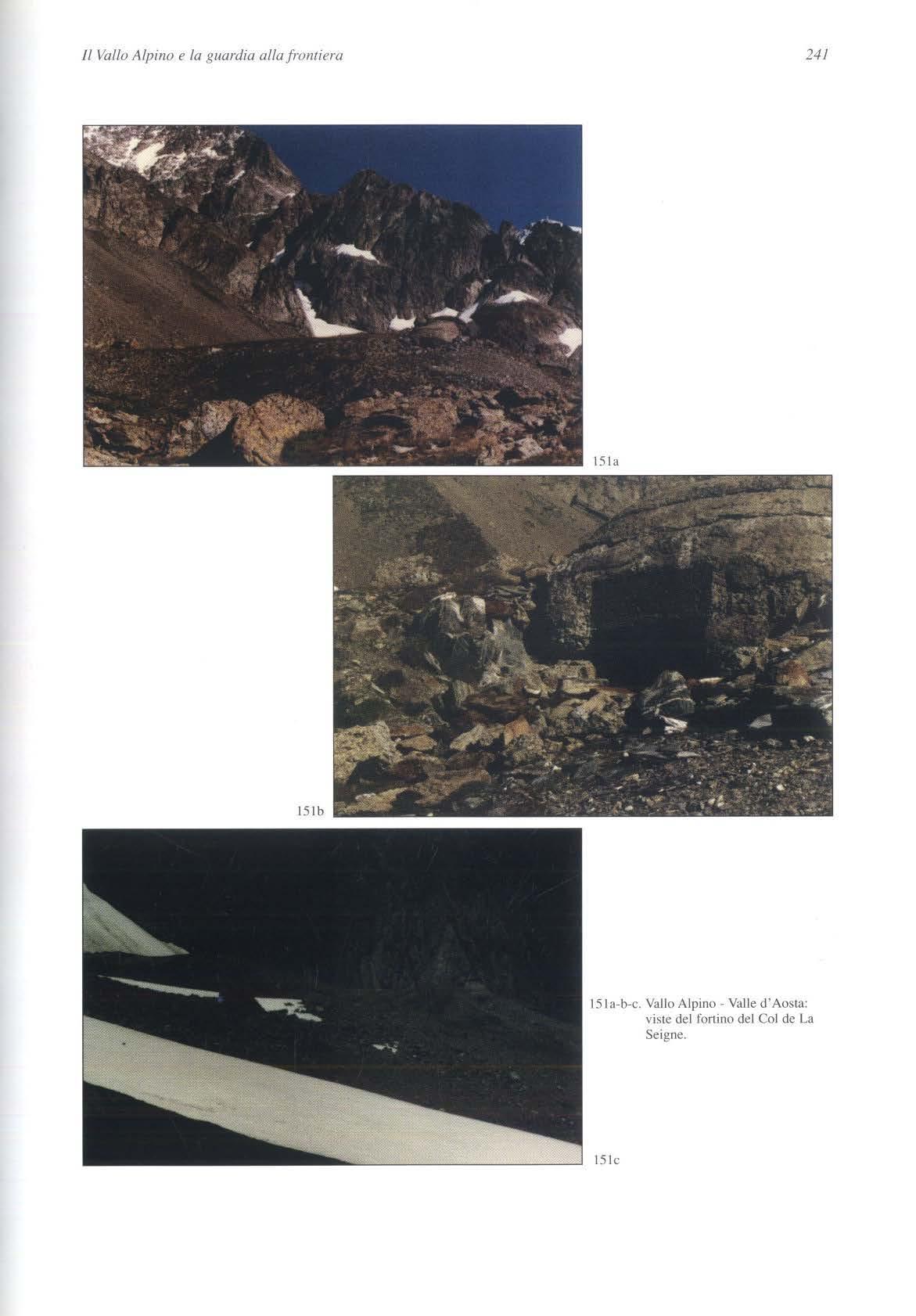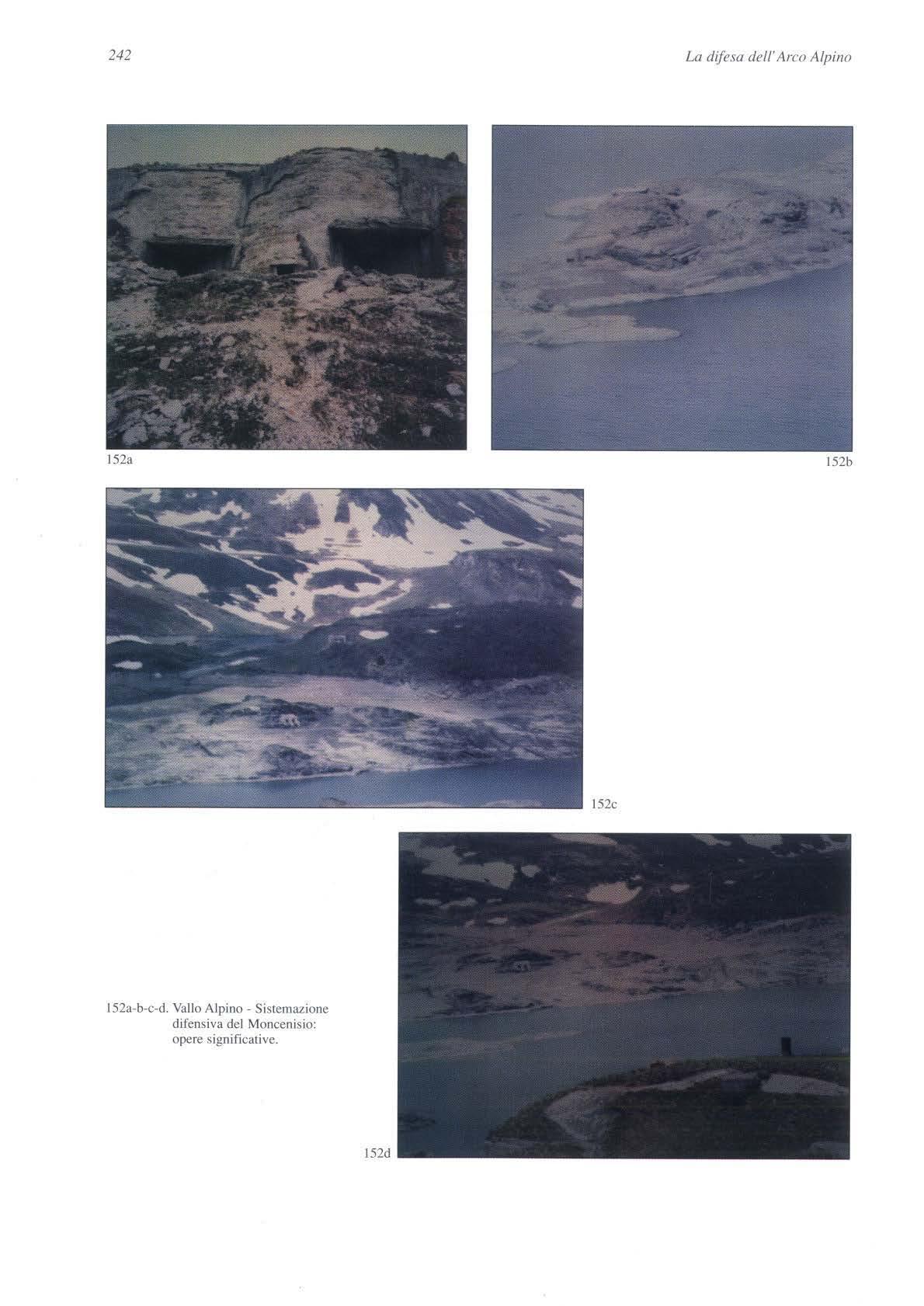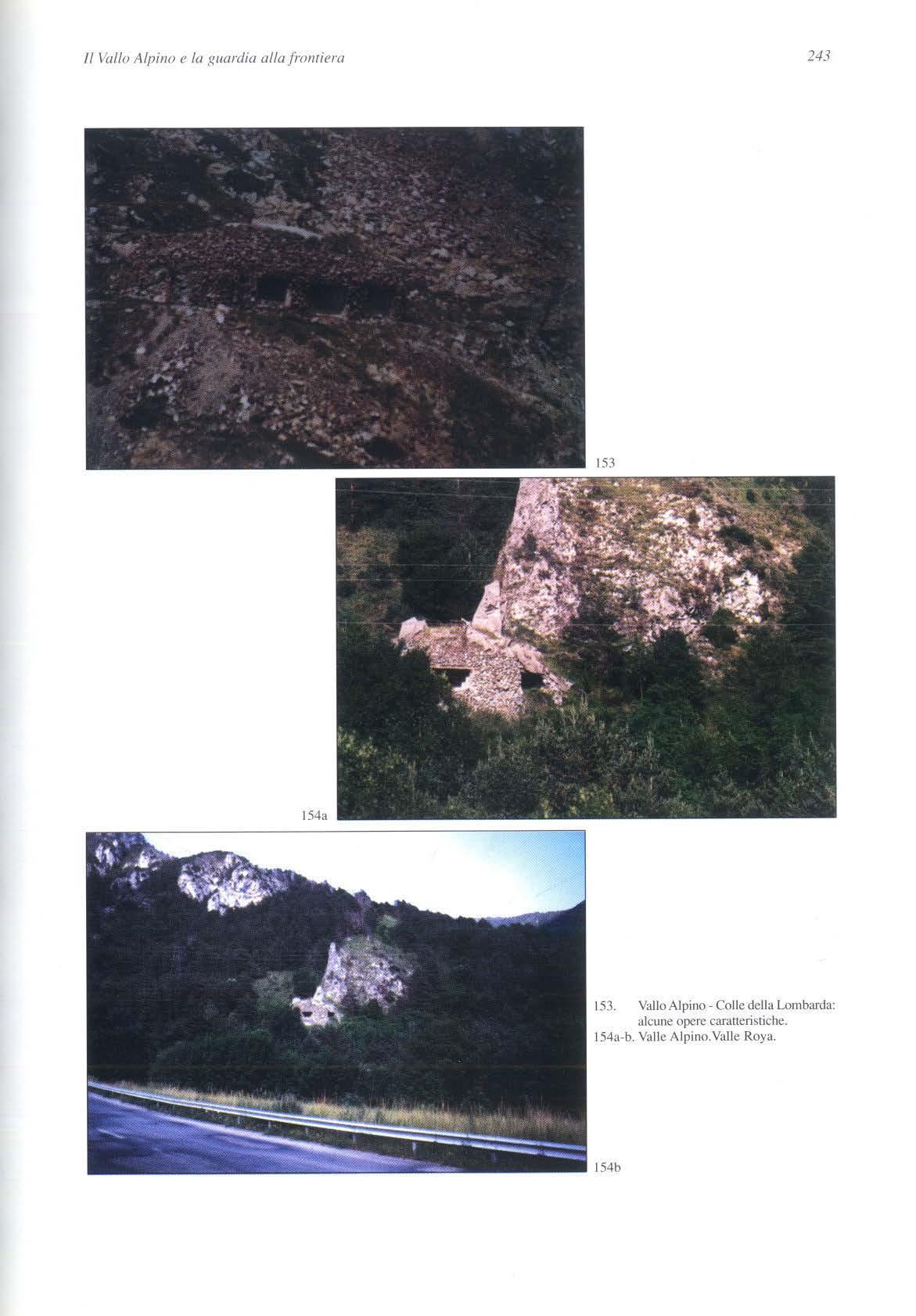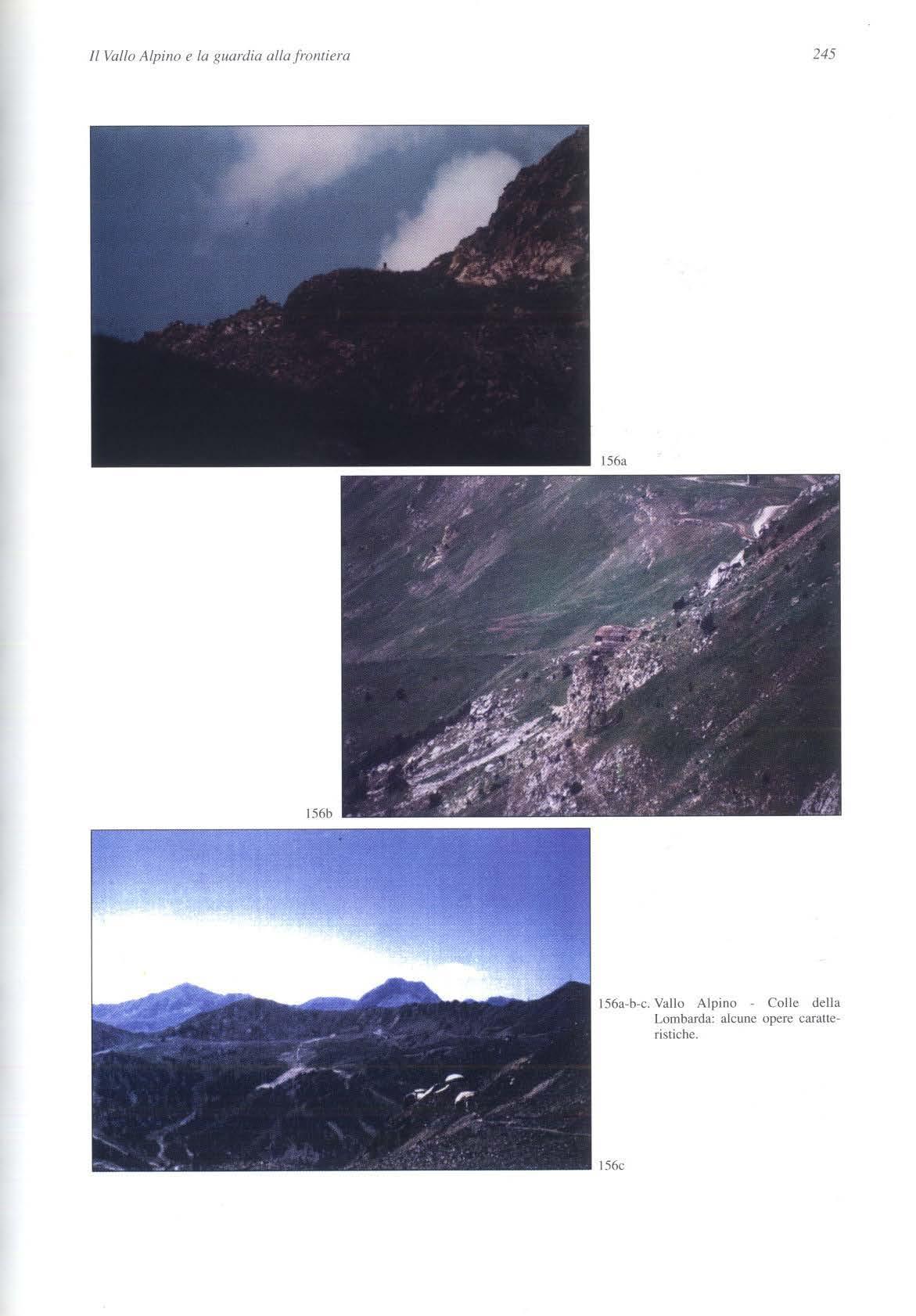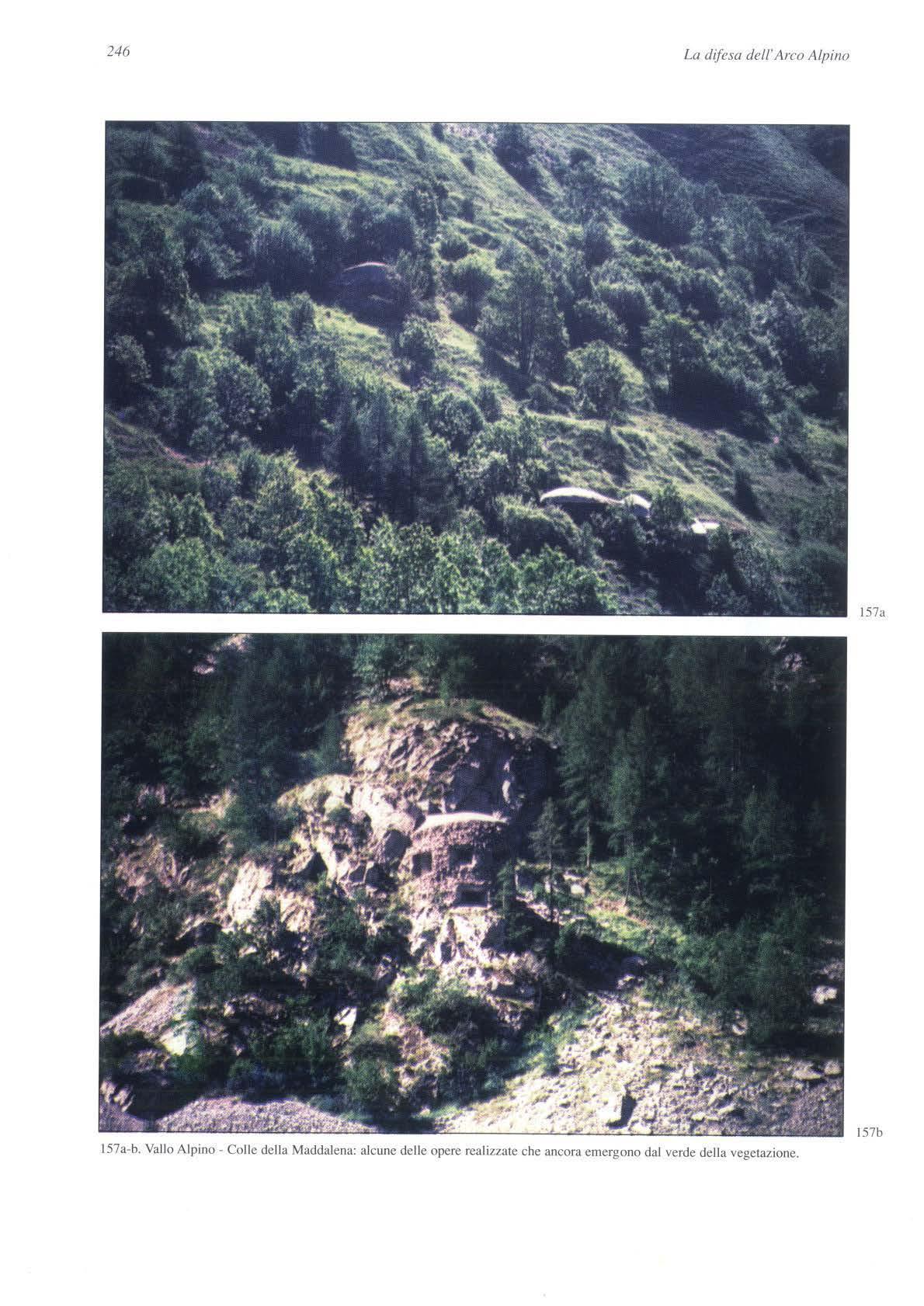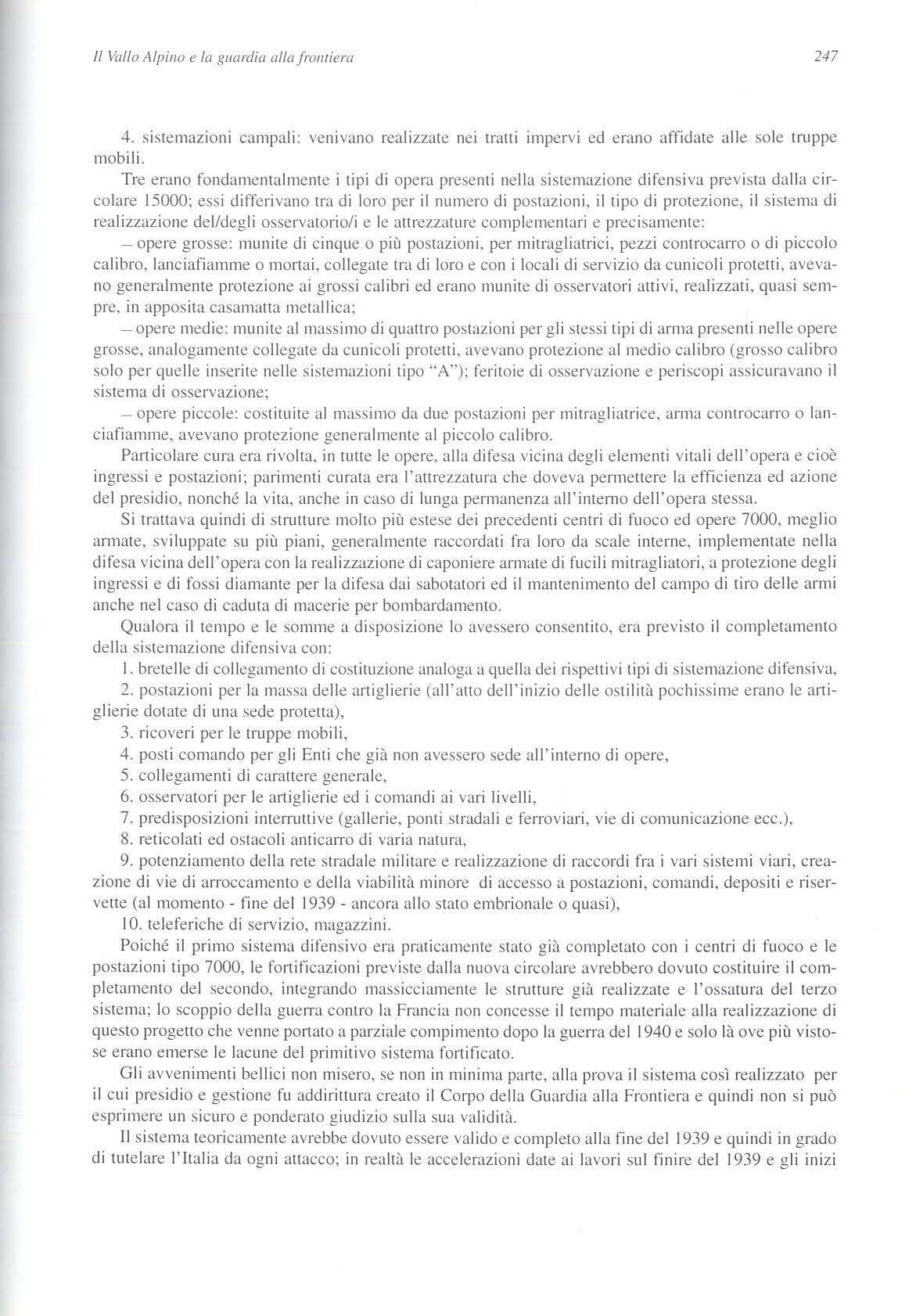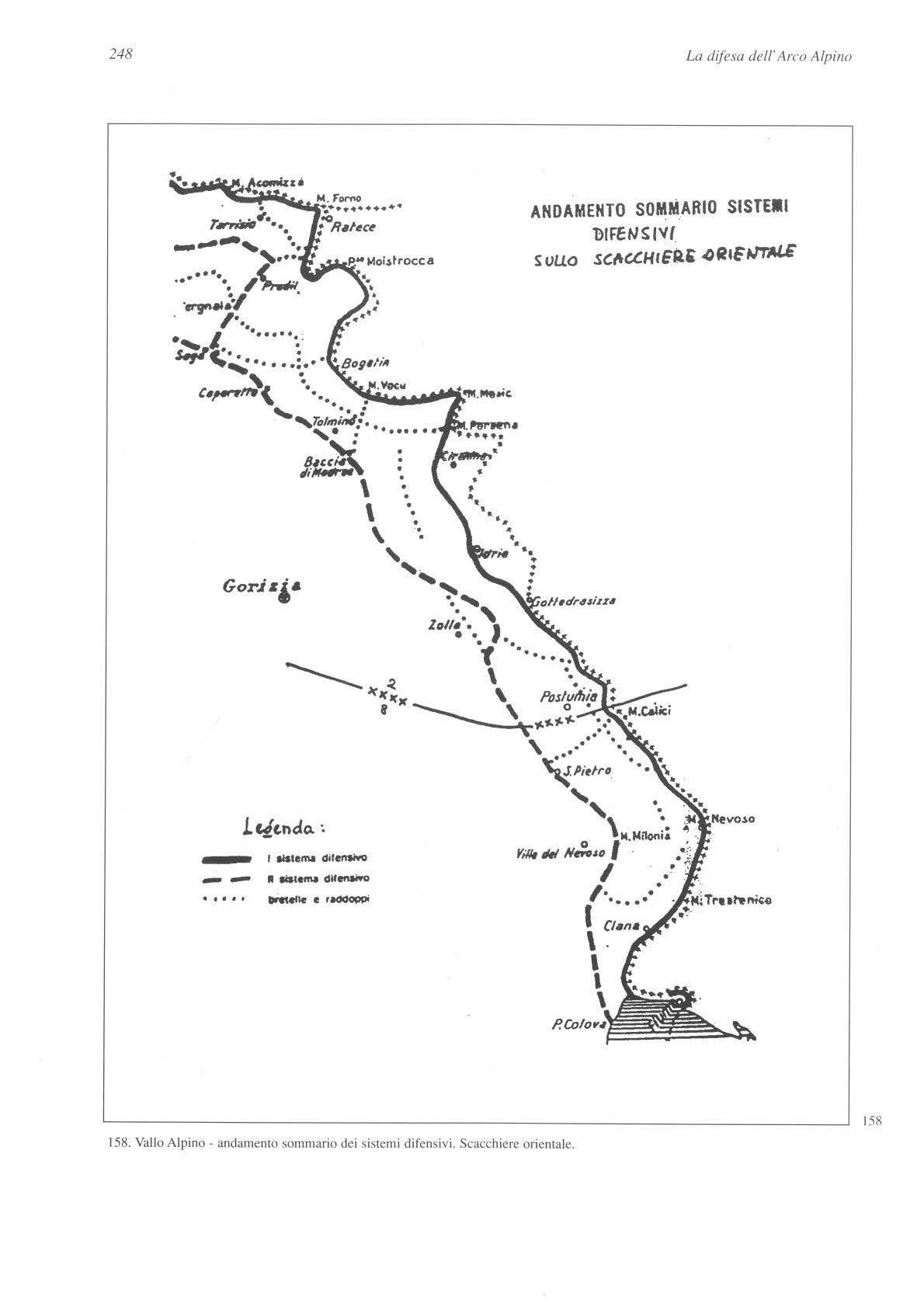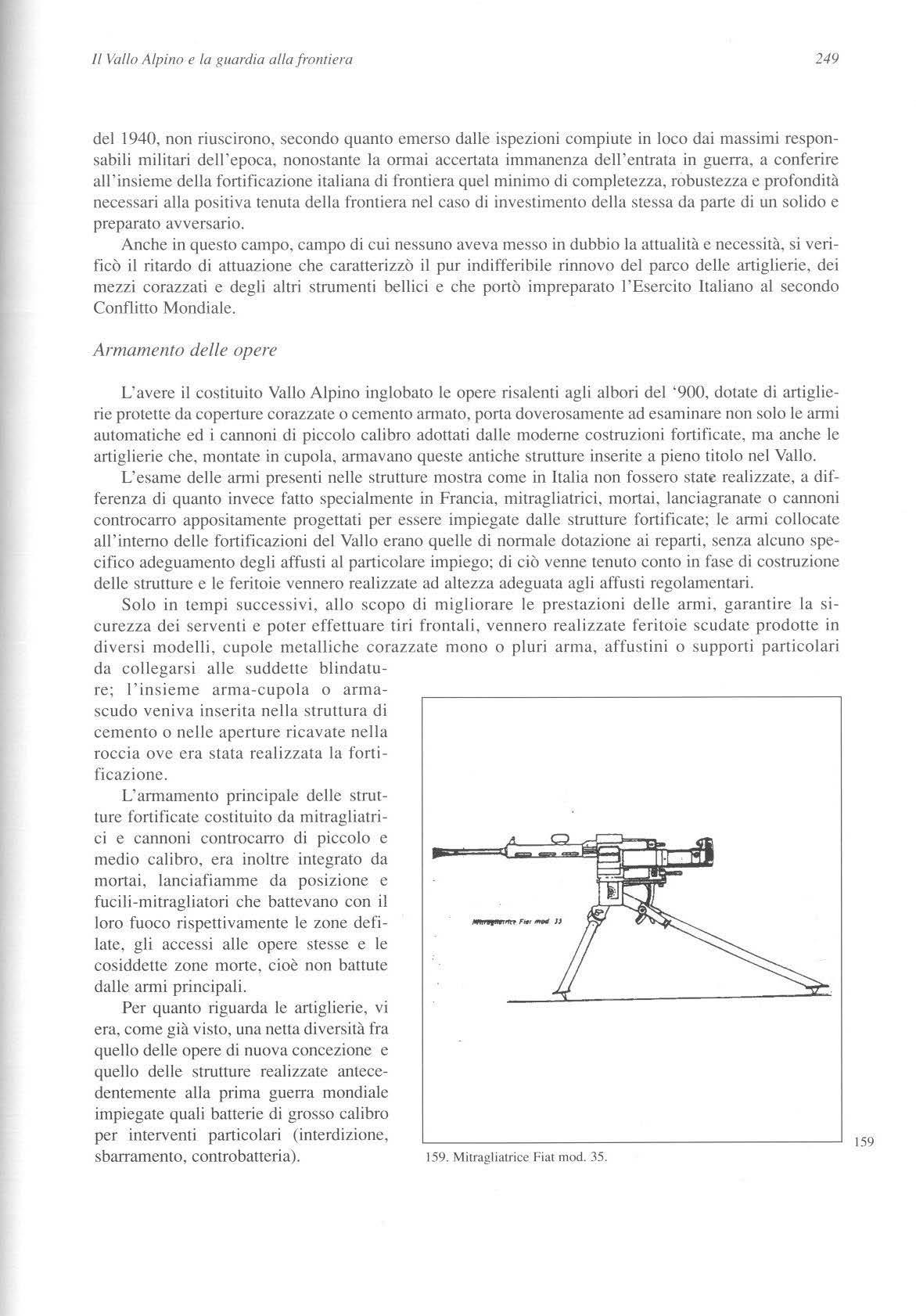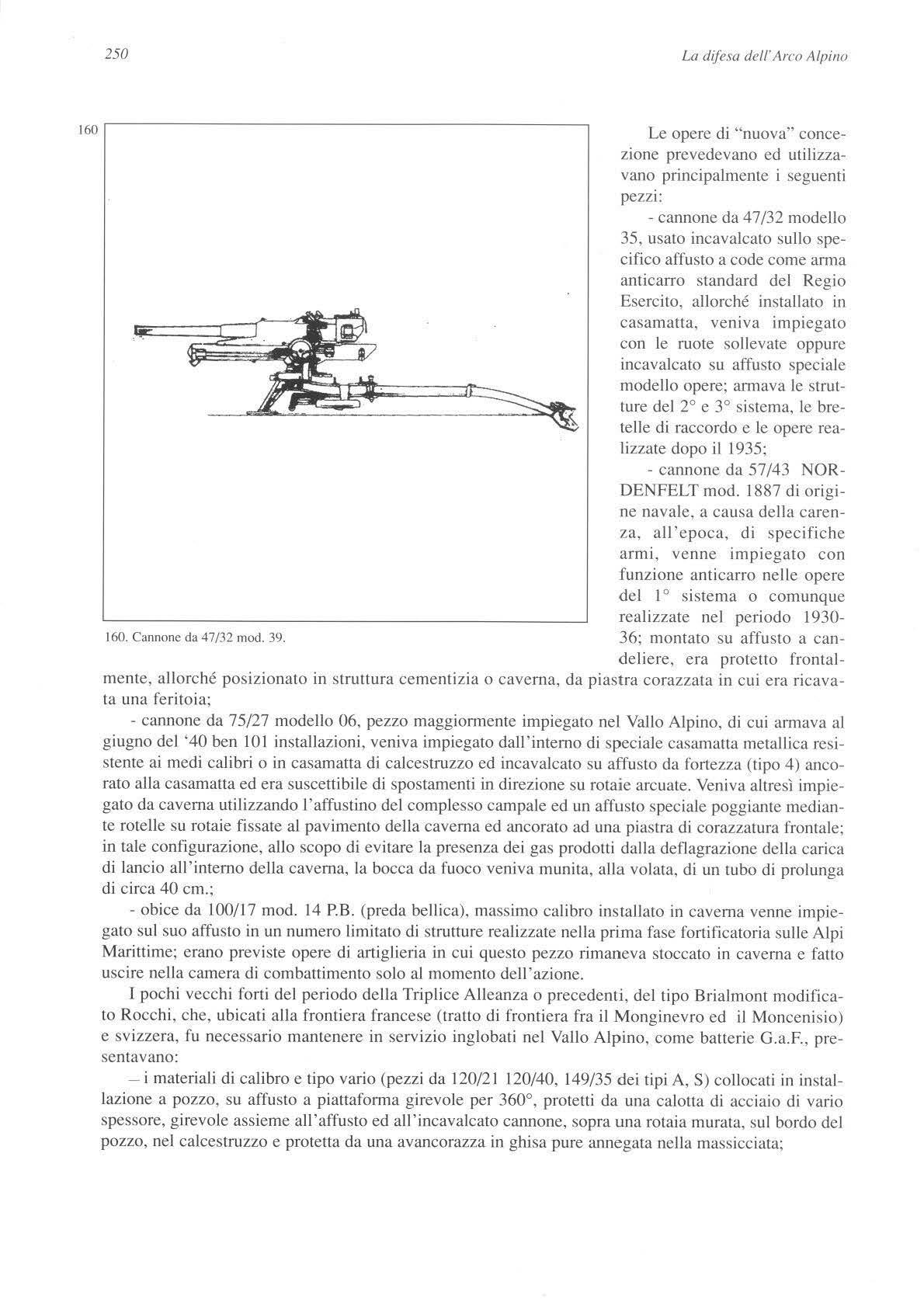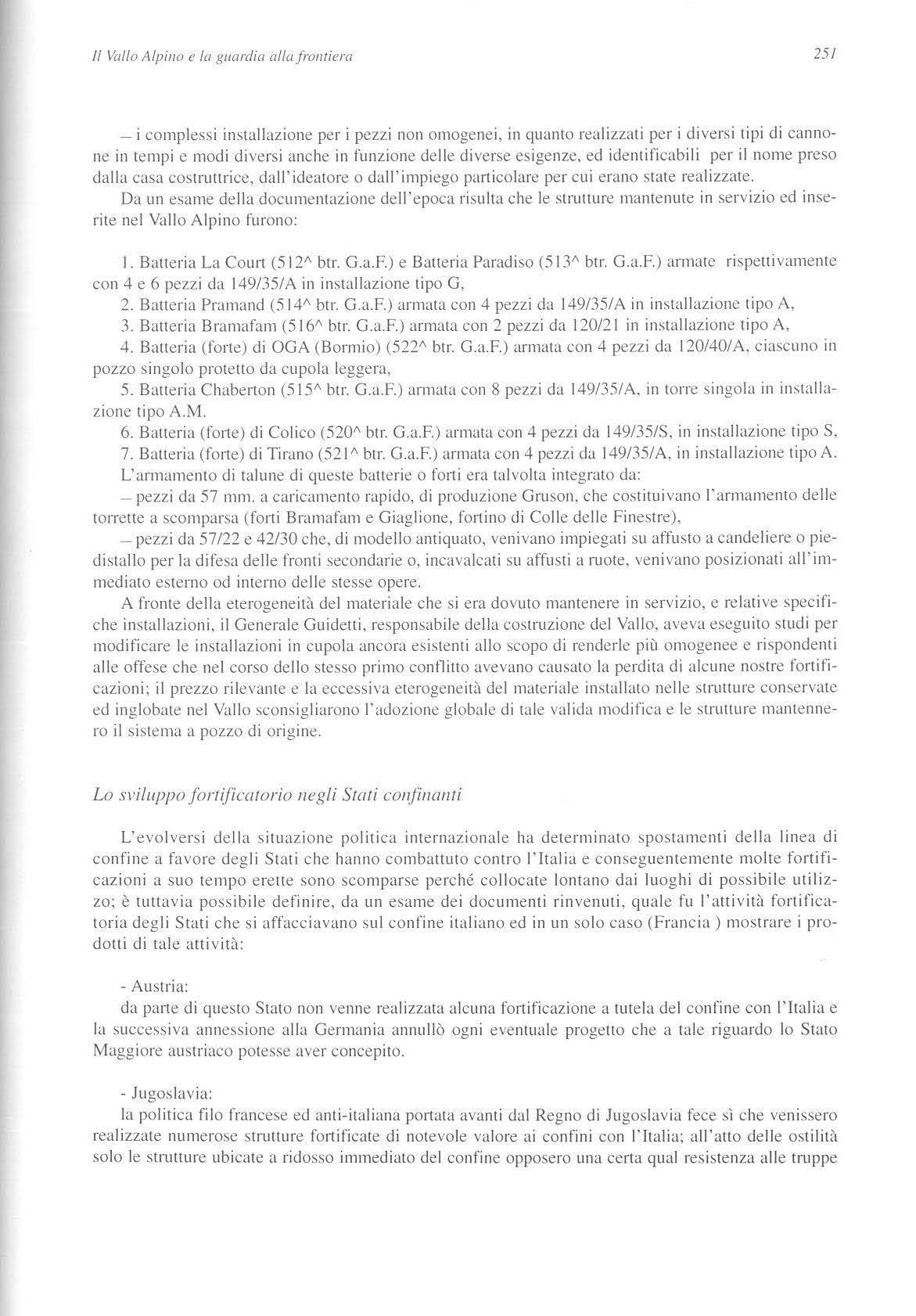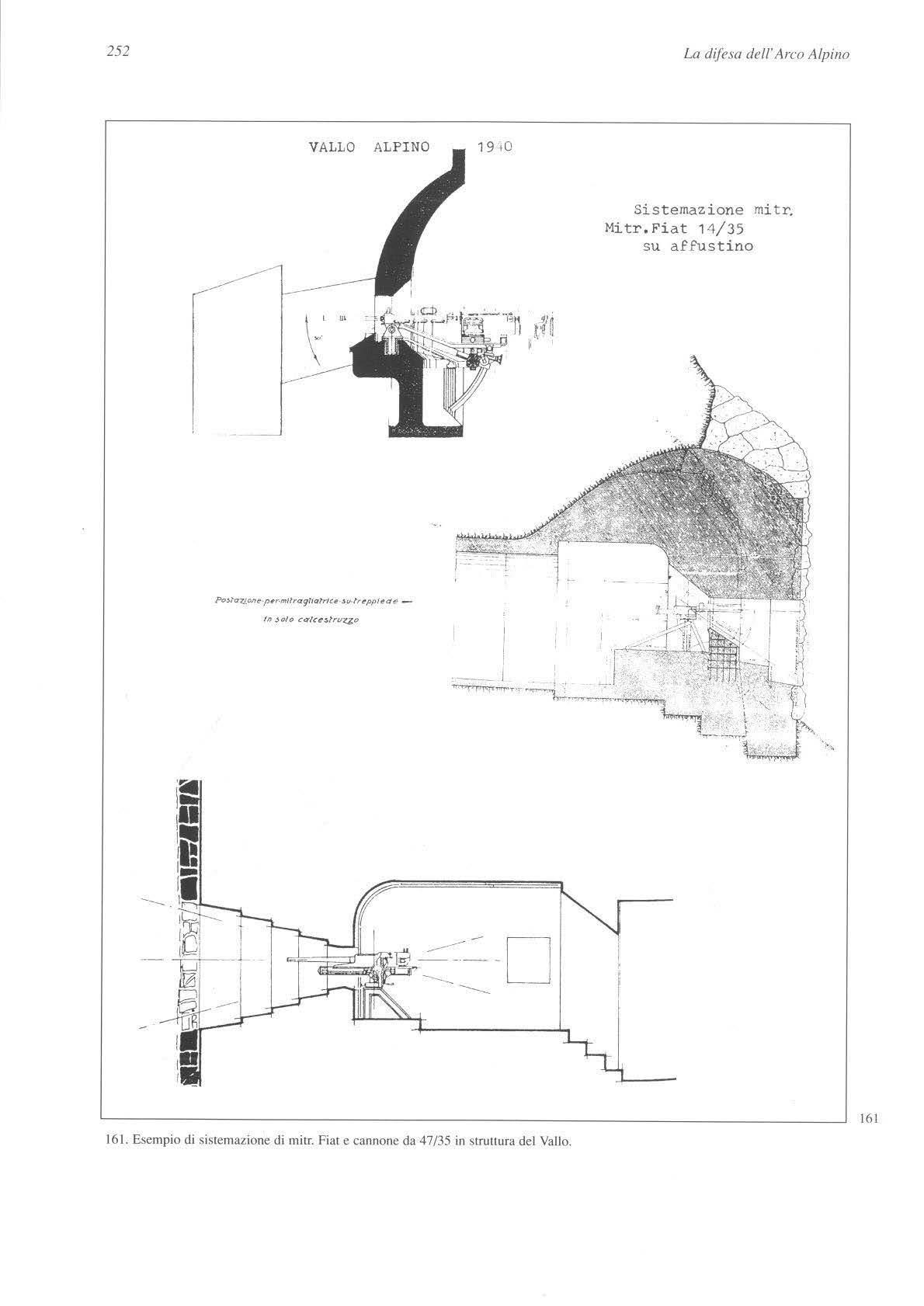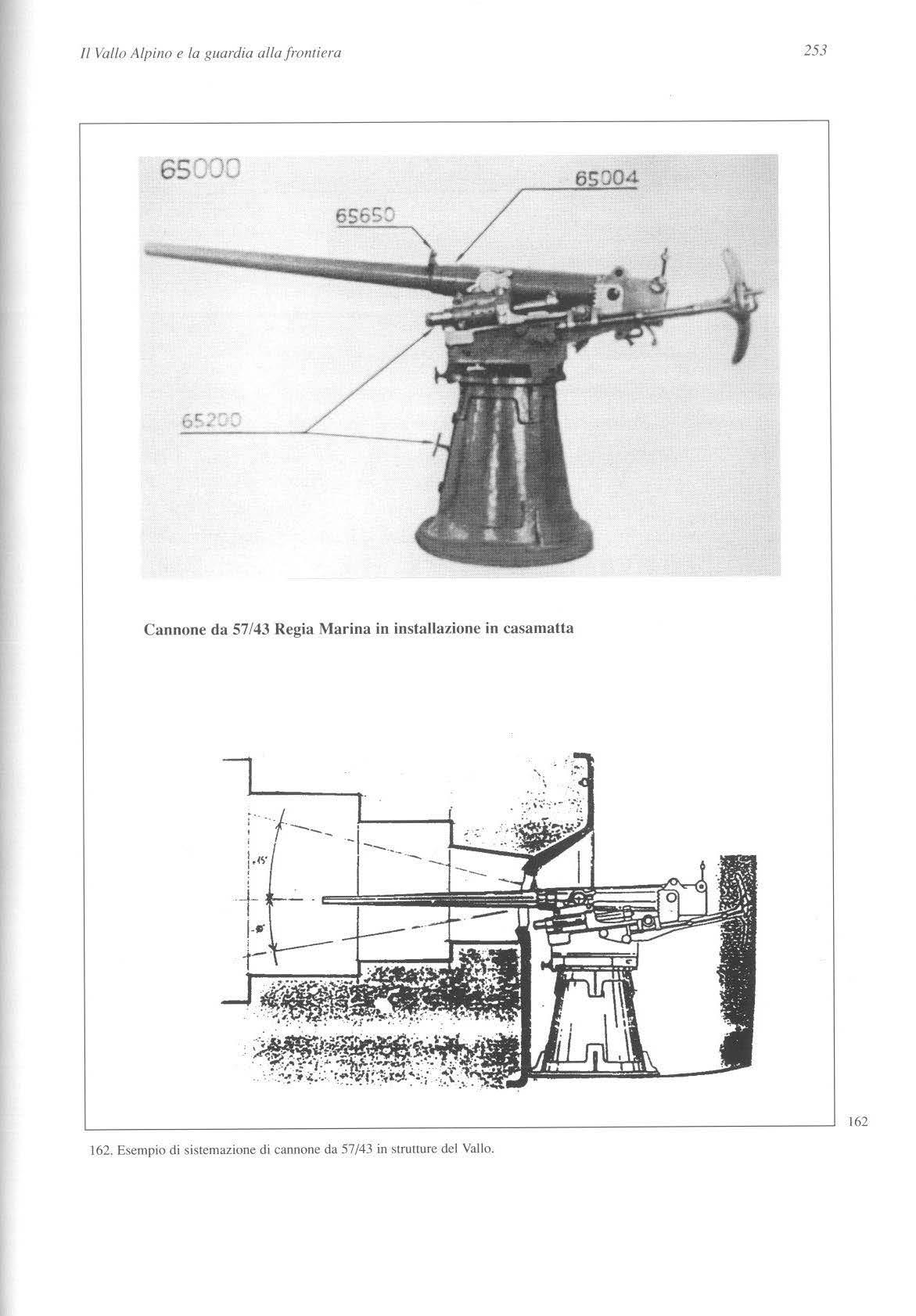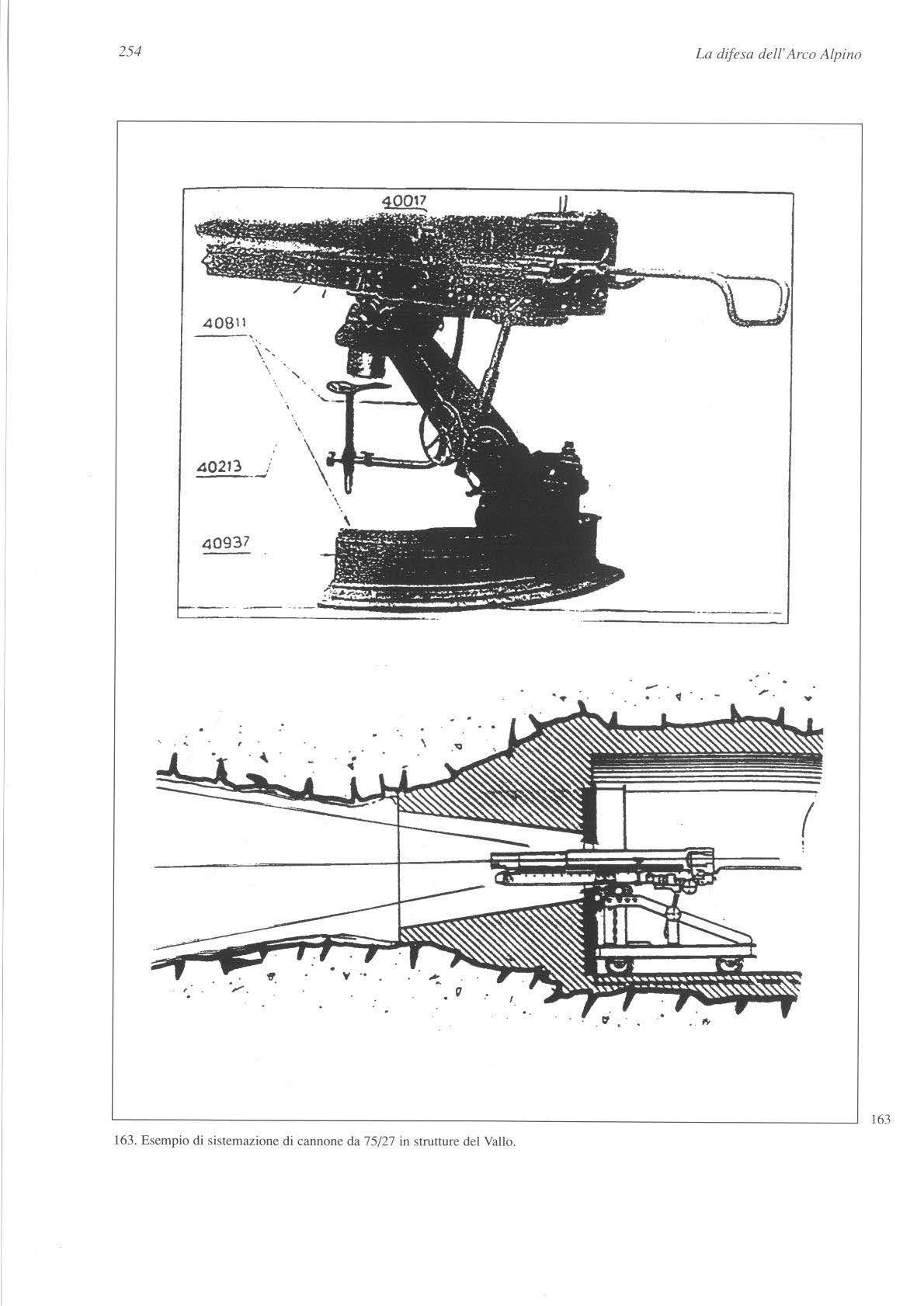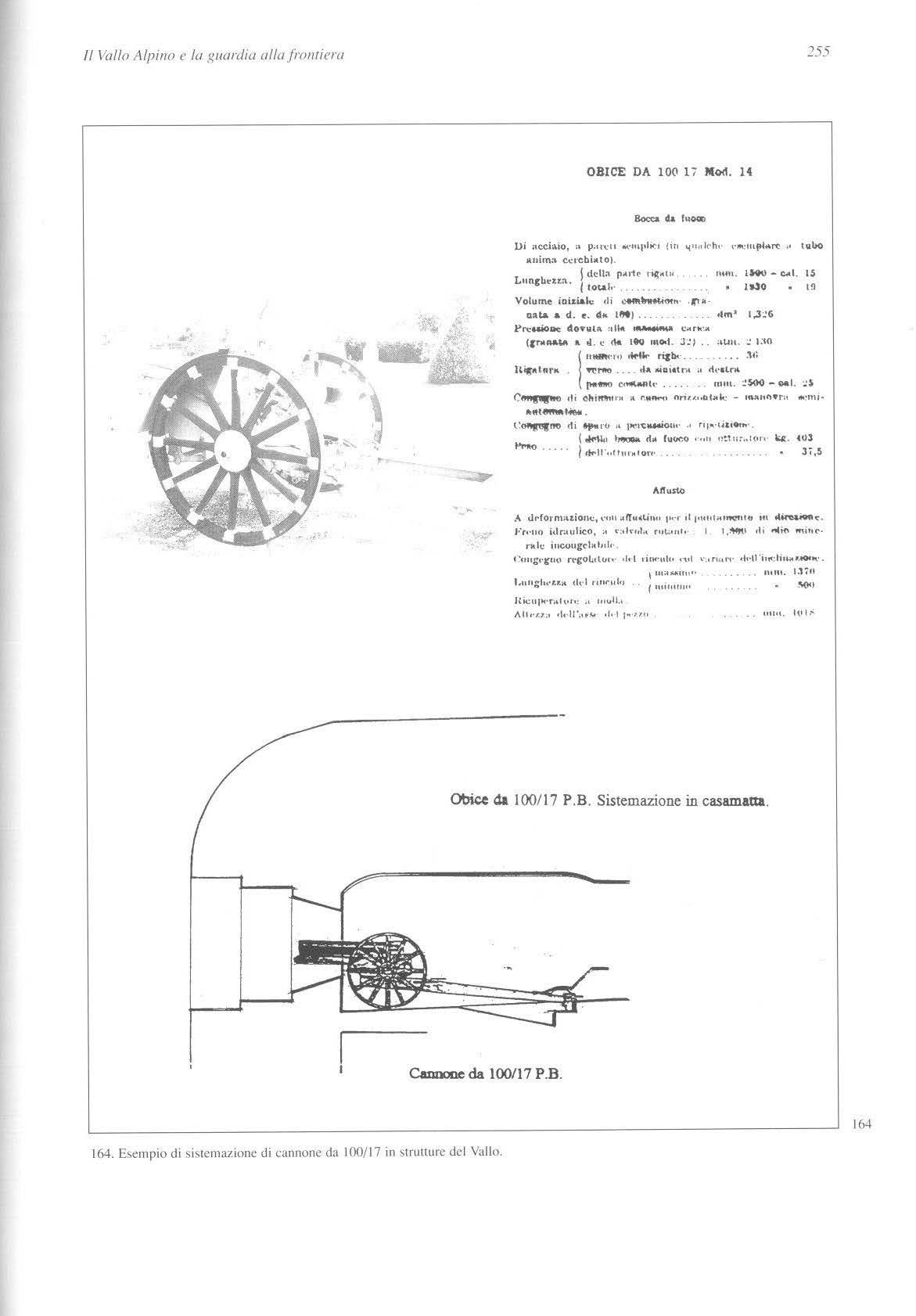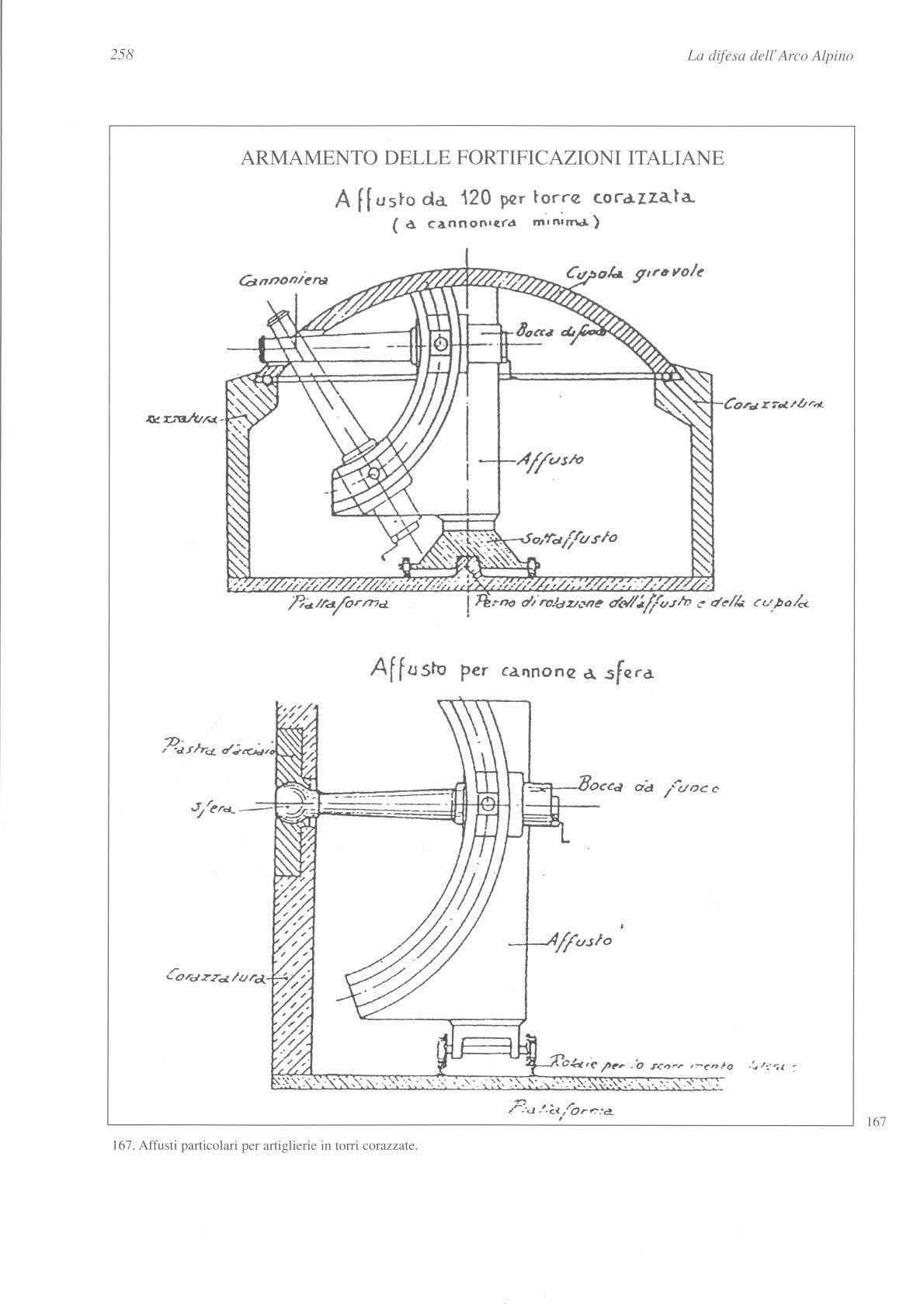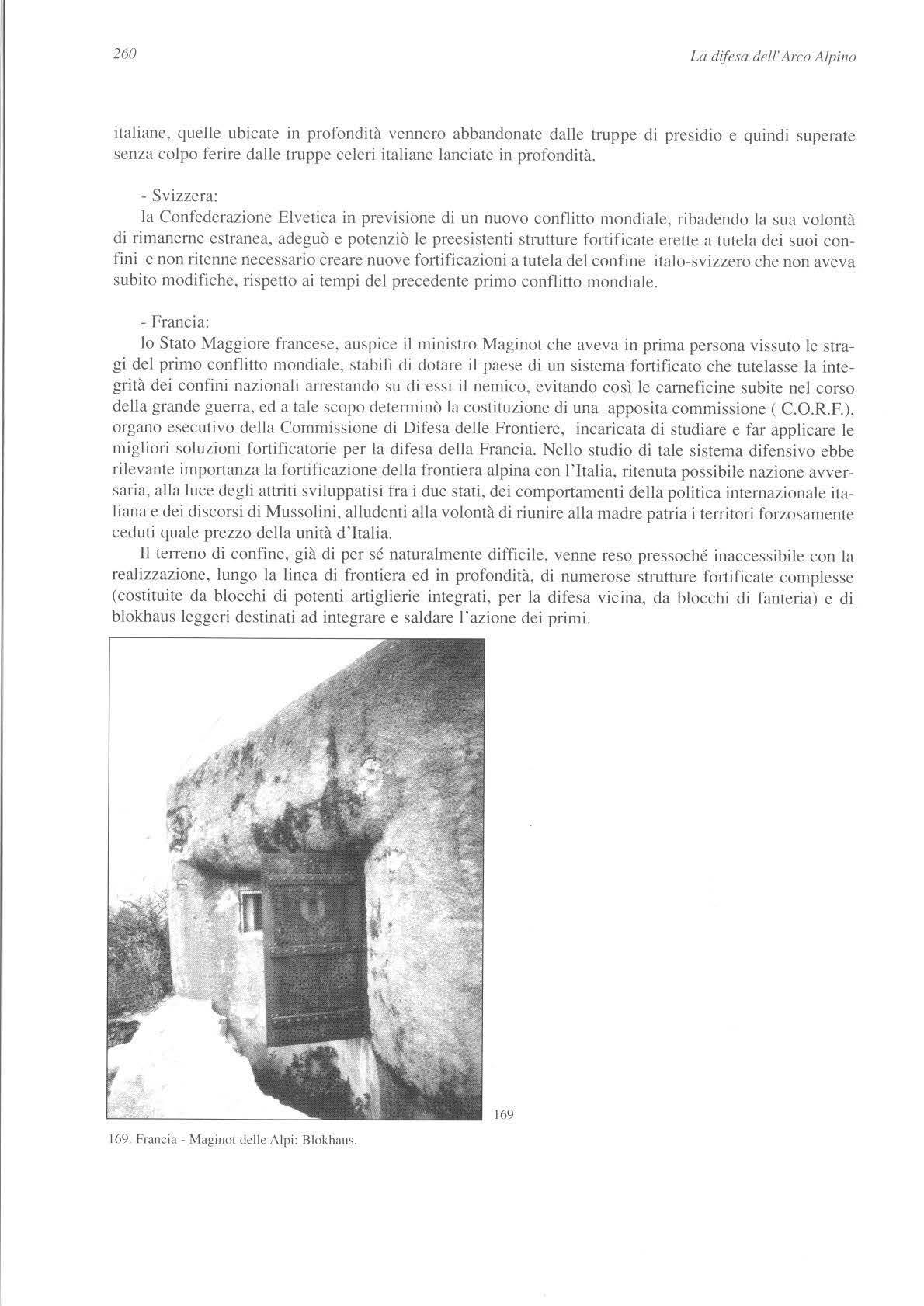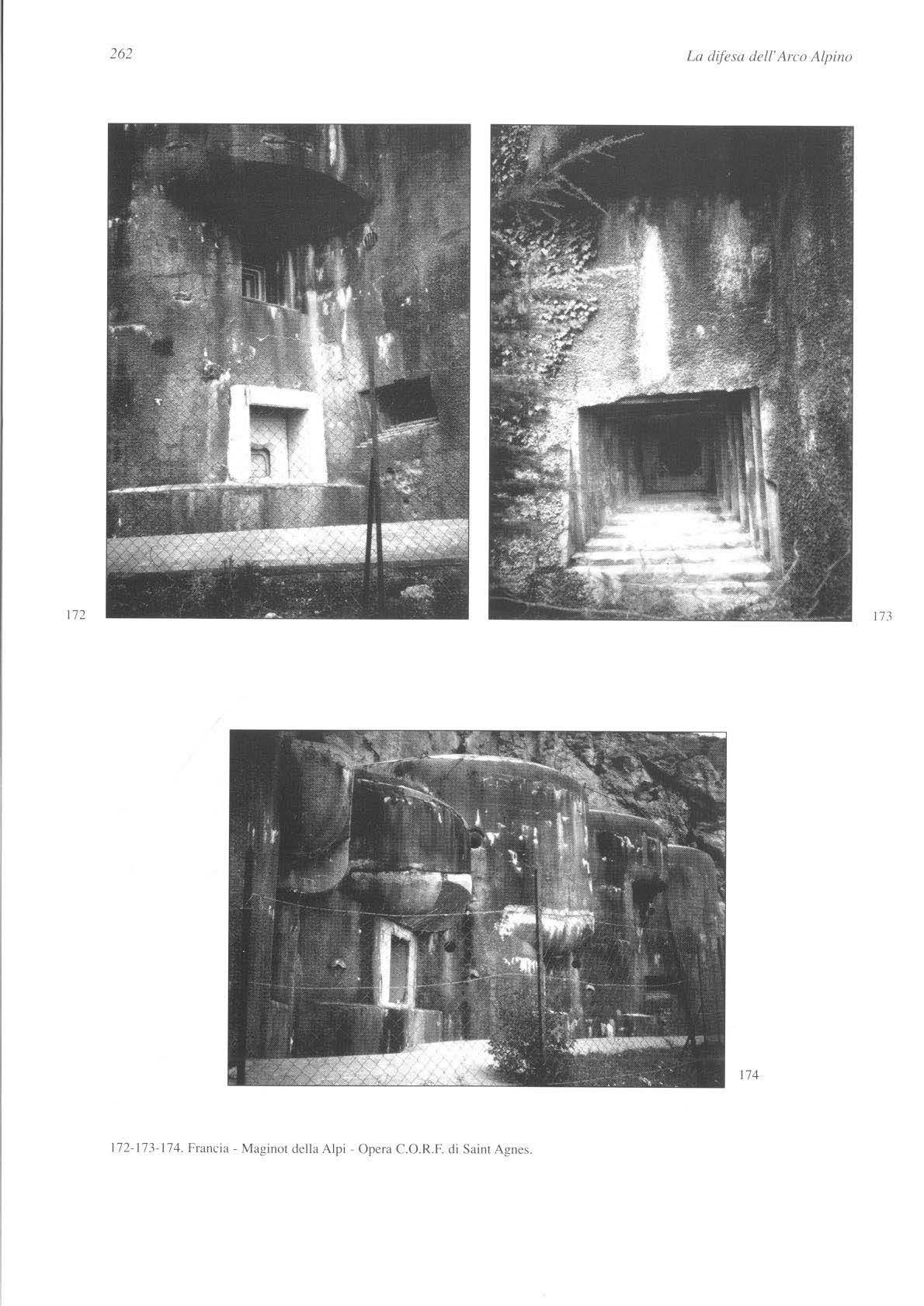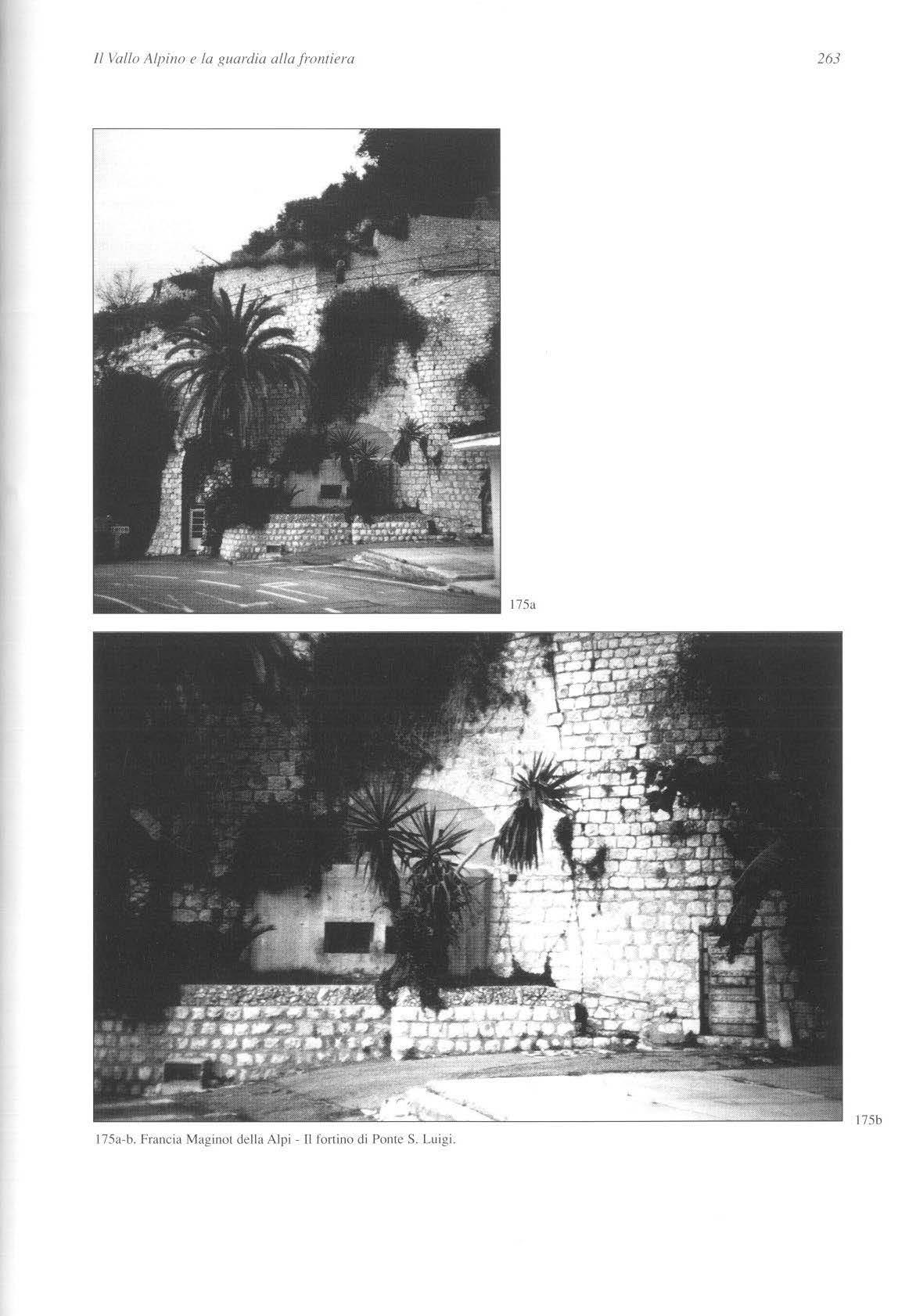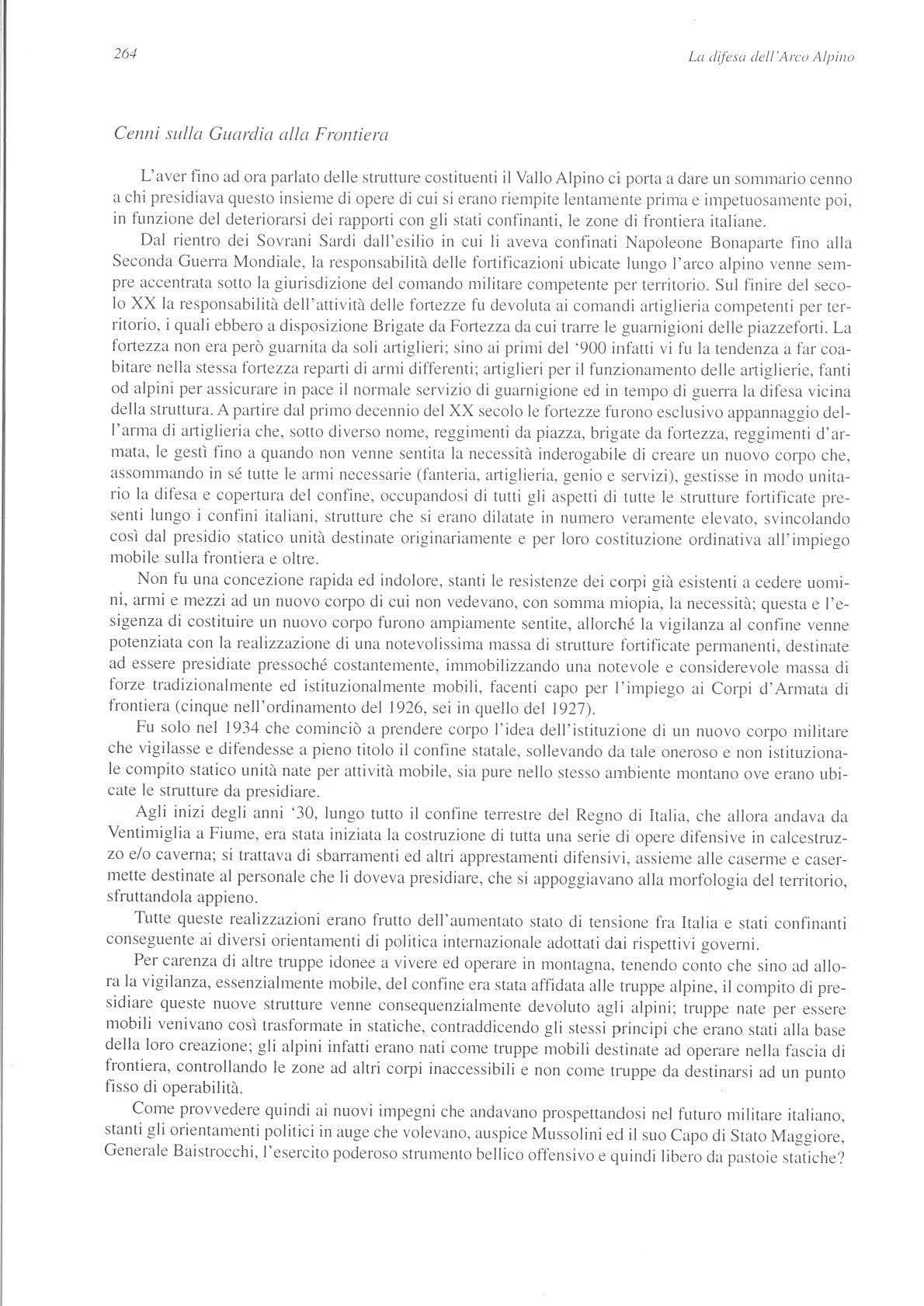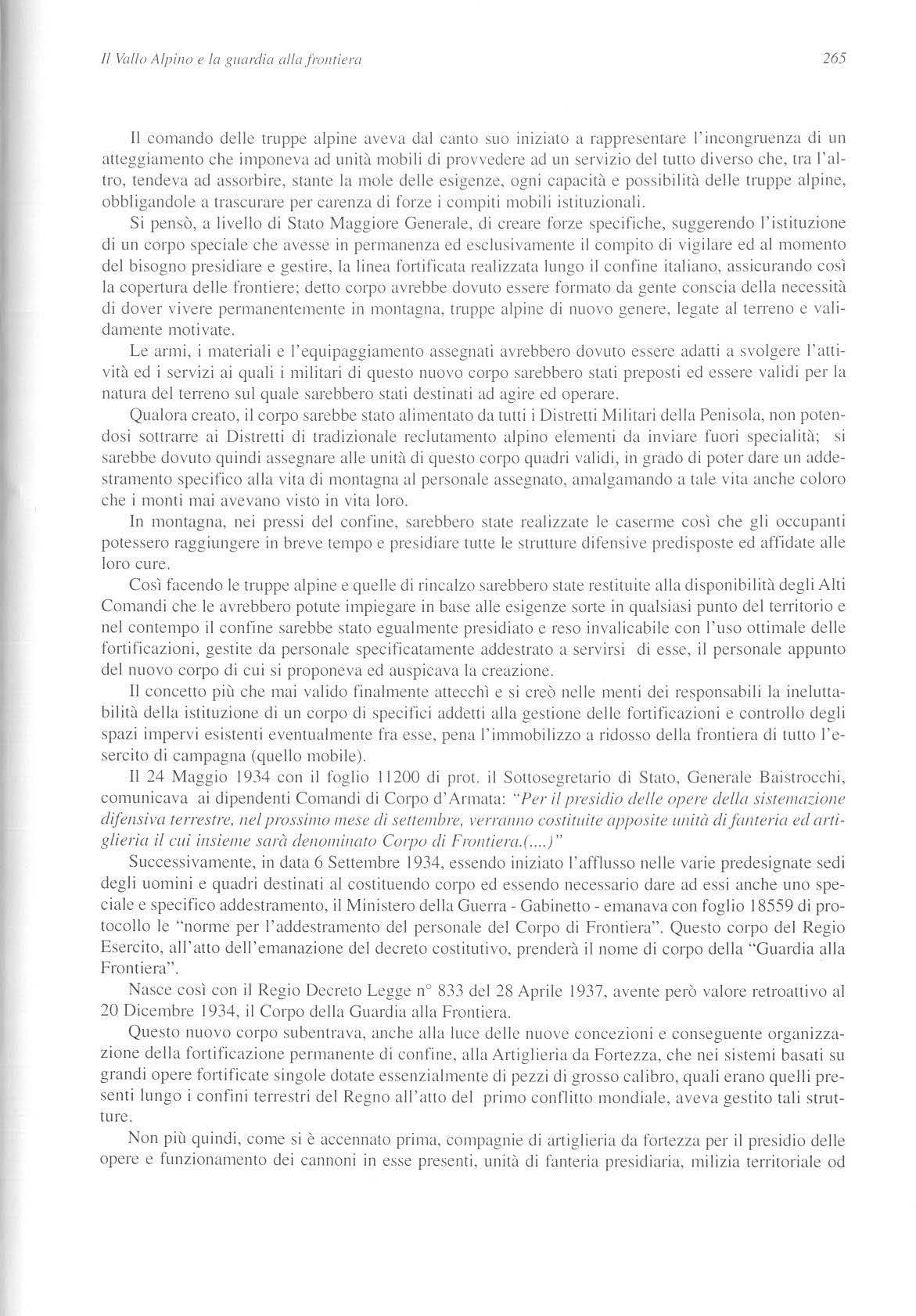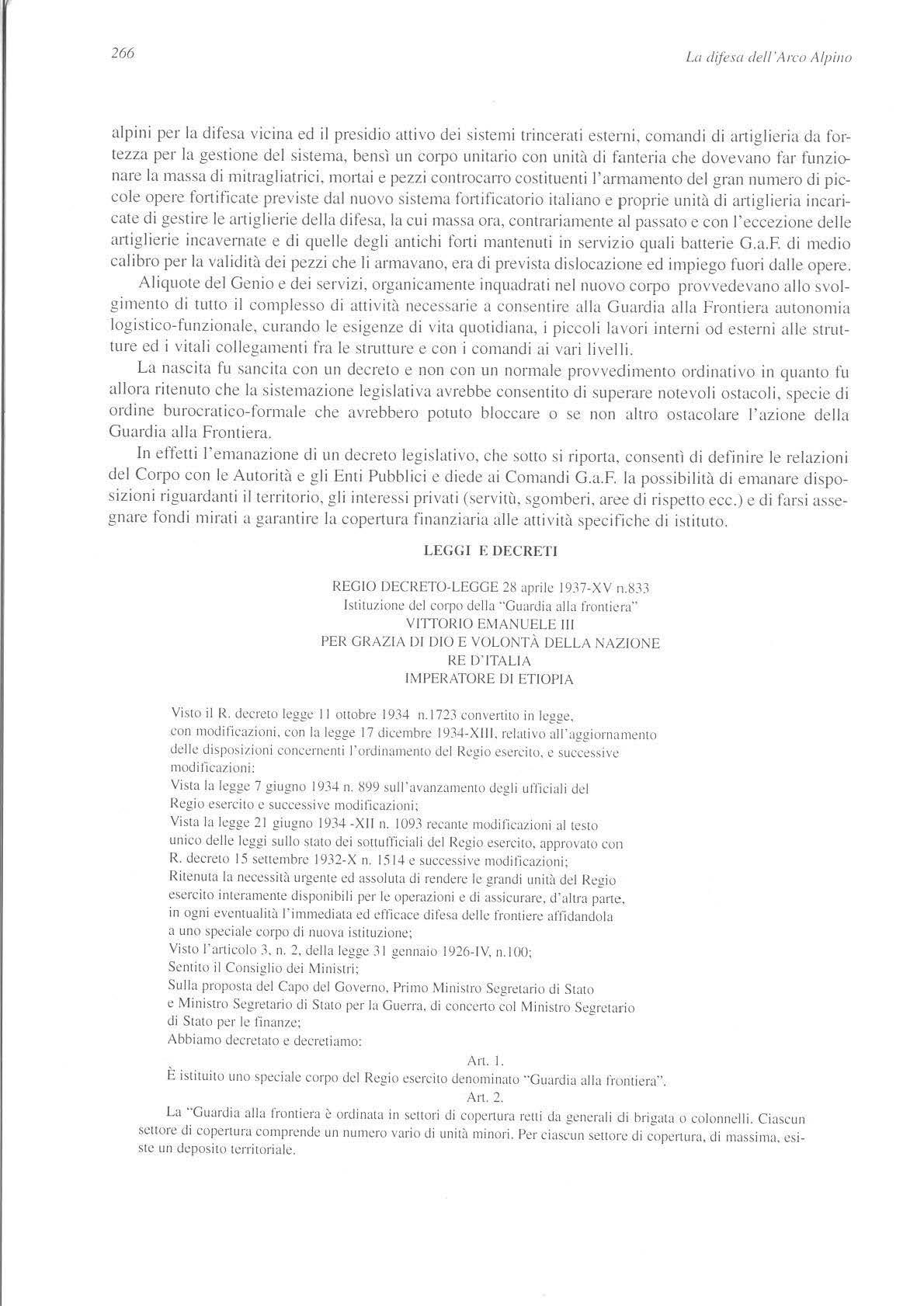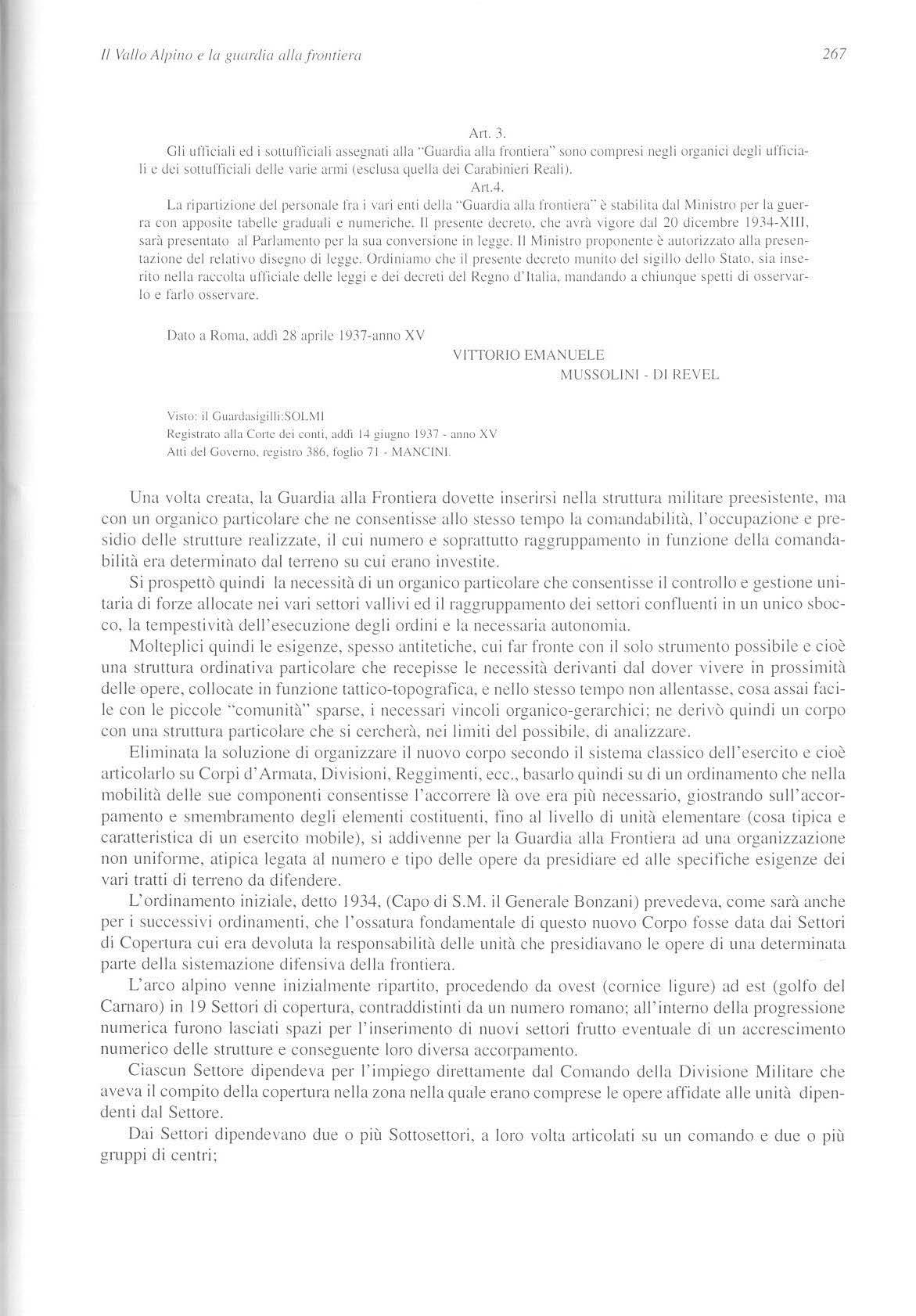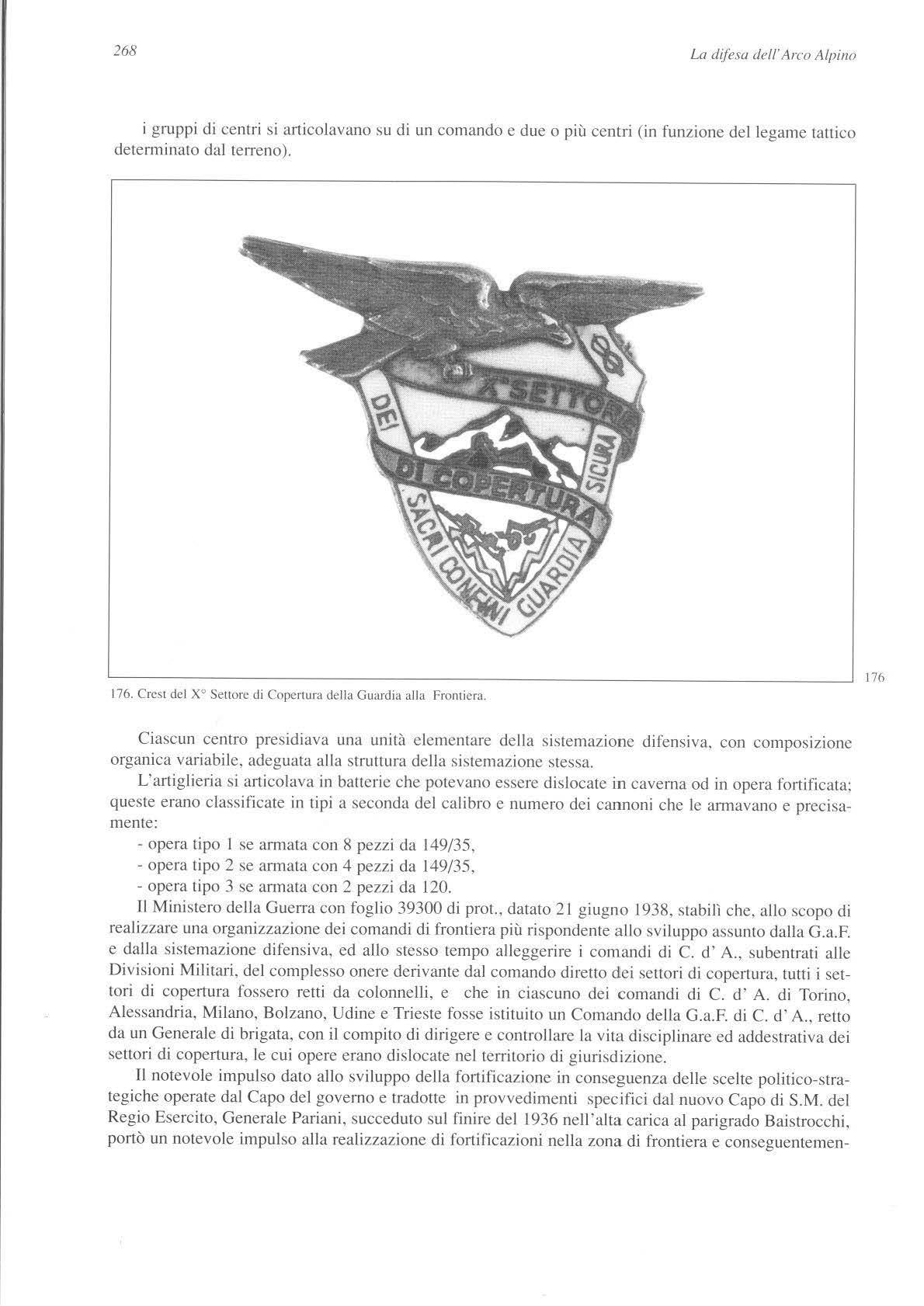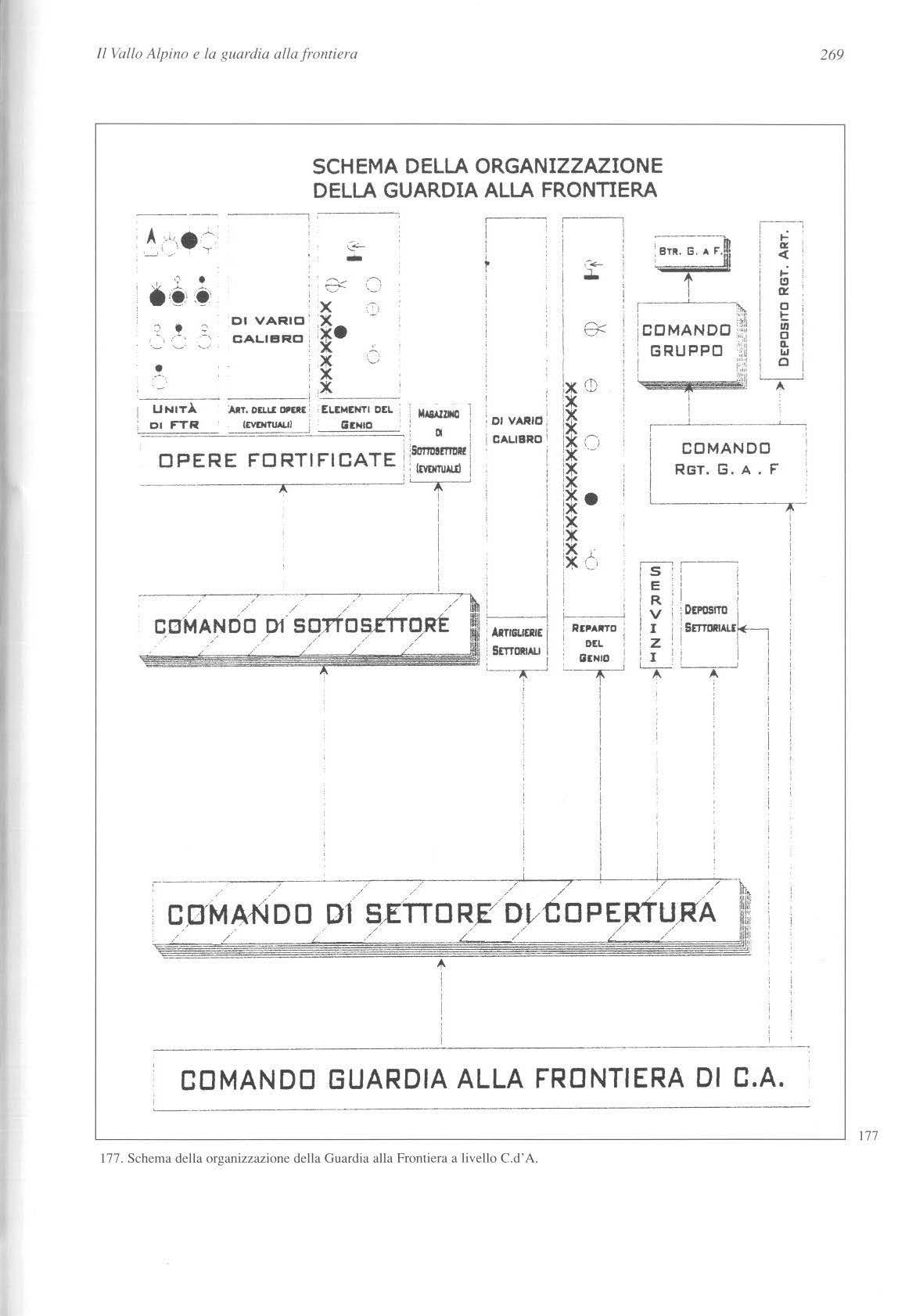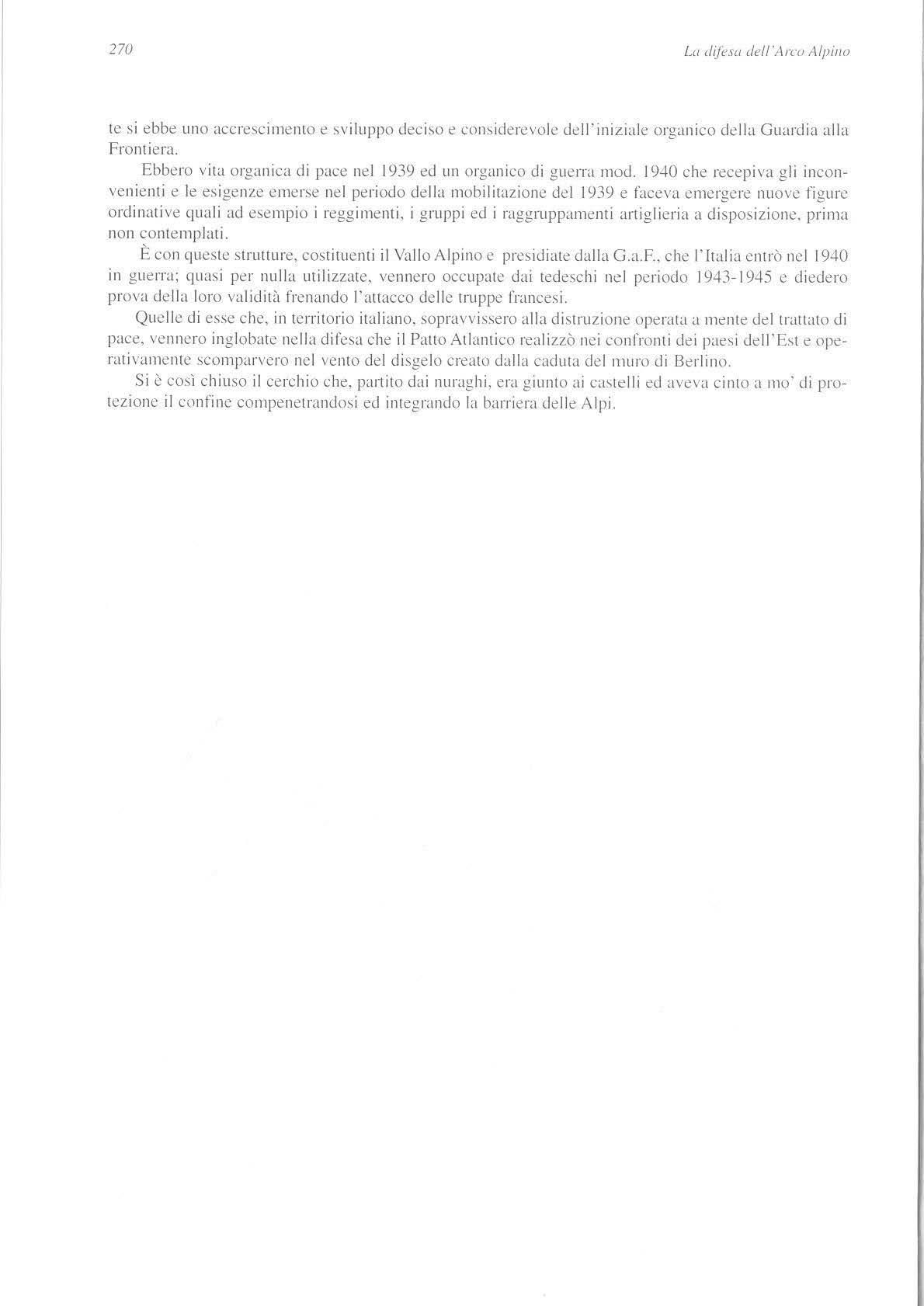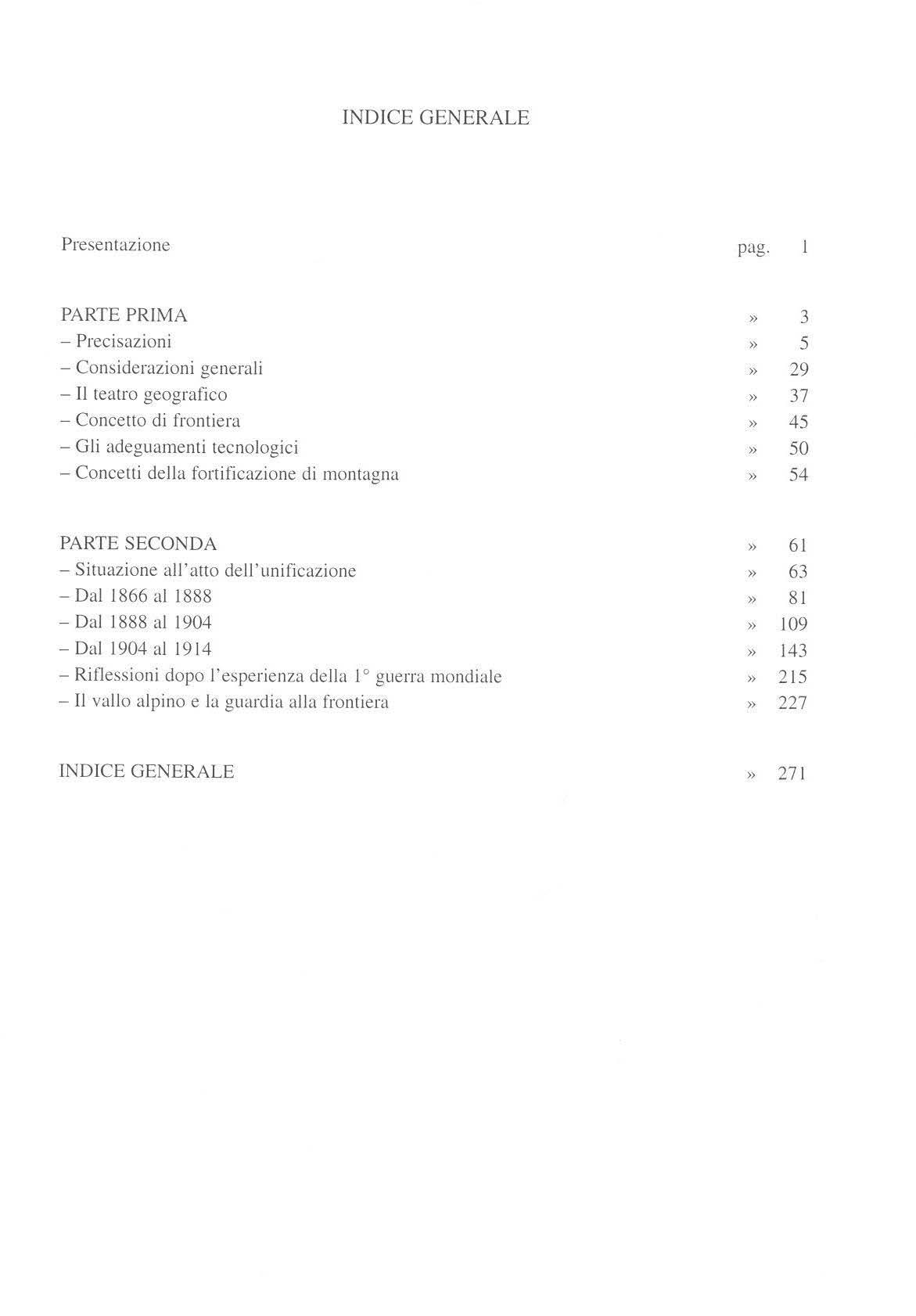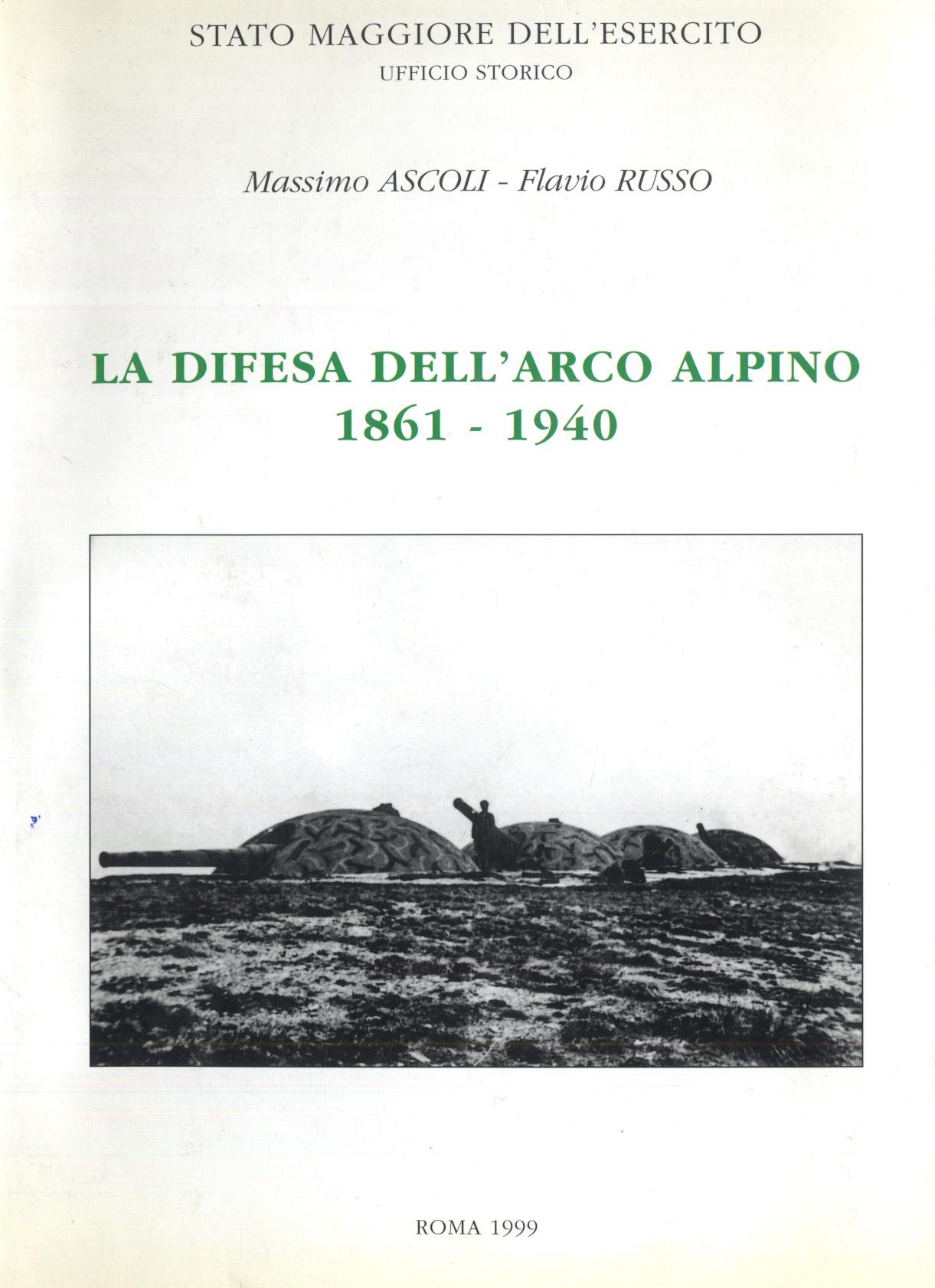

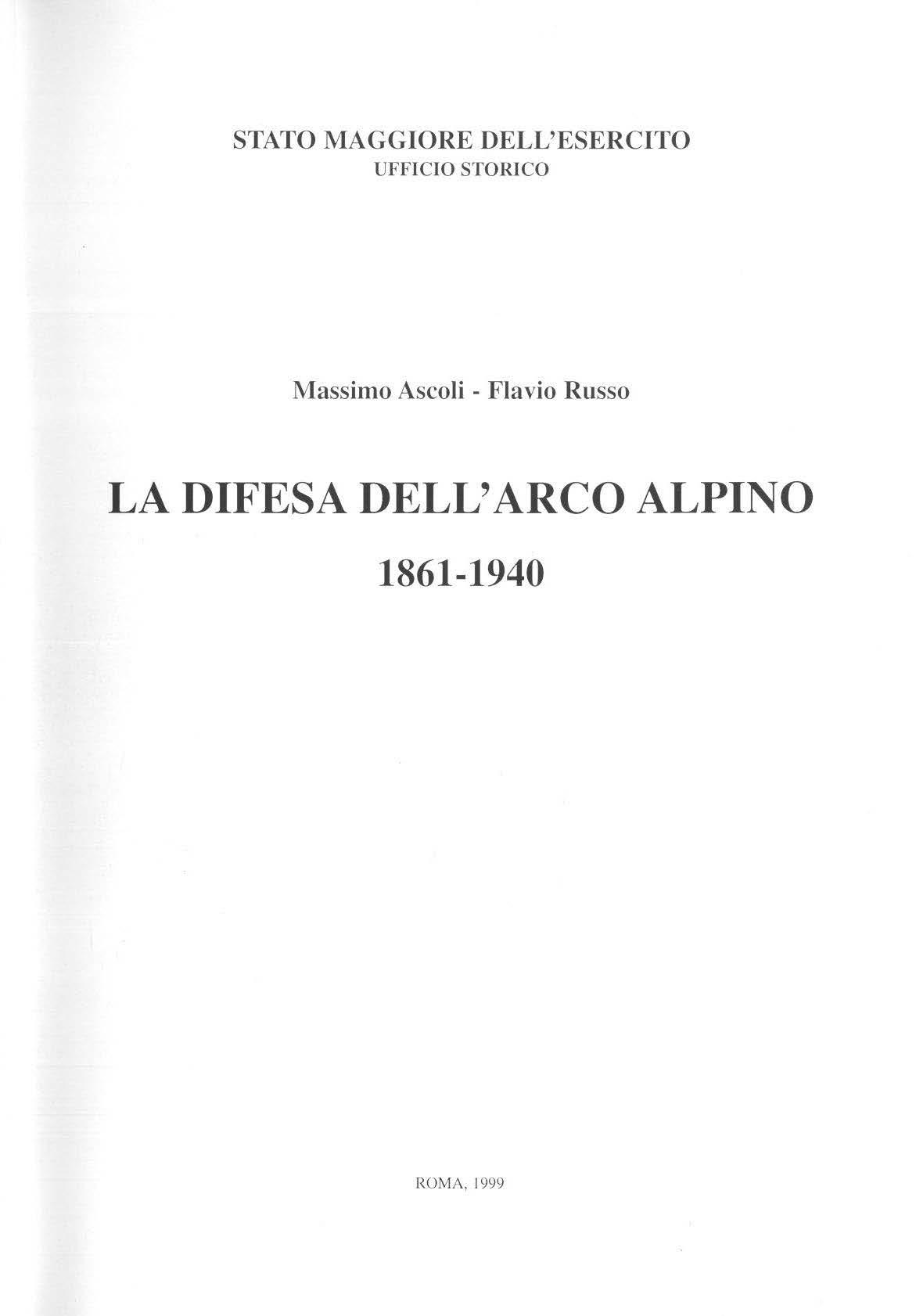
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO UFFICIO STORICO
1999
Massimo
Ascoli -
Flavio
Russo LA DIFESA DELL'ARCO ALPINO 1861-1940 ROMA,
PROPRIETÀ LETf'ERARIA

Tu11i i dirilli riser\'(/fi. Vit·ww lo ripmd11,io11e cmclie 1mrjalt• .w11:a <wlari::,::,a::,ione
C R) SME - Ufficio Swi1:o - Roma 1999
Finito th stampare nd mc~c di giugno 1999 dalla tipografia: ;\zicnd a Tipografica Ludo vici Sri 00 1..ilJ R0/\1 A - Via F. Pall,1vicini. 40 -1t:I. 06 55172141-49 - Fax 06 55172145
Negli ultimi anni è 11otevo/111e11te cresciuto l'interesse per l'architetfttra militare in genere, ed in particolare per le fortifico-::_ioni permanenti delle Alpi, motivo per rni ,wmerose opere, molto dettagliate ed in eccellenti vesti editoriali, sono state p11bblica1e sui mri asperri del/ 'w~omenfo. La riscoperfa del 1ema relativo all'arte fortificatoria, 1111 tempo riservata ai soli specialisti - ingegneri e 1e c nici del genio e d'artiglieria - è stata detta/Cl soprattutto dalle 1111me1vse vestigia di fortificazioni italiane, francesi, sviz-::.ere e austro-ungariche ancora presel1fi sull'arco alpino ed ormai divenute vere e proprie mete t11ris1iche.
L'Ufficio Storico, dopo alcune opere par::Jali s11/l'argome1110. ha inteso studiC1re compi11ta111e11te, col presente volume, la storia delle opere jònificme erette sulle Alpi dal Regio Esercito nel periodo compreso tra il 1860 e la fine della seconda g uerra 111011diale.
Dopo l'unifica z ione. I '/tedia ereditò dal Regno di Sardegna e dagli ex territori austro-ungarici del lombardo-Veneto vari forti e strutture permanenti, la maggior parte però oltremodo datate e di sc:arso valore bellico ed impeclitil'o. Si dove((e quindi ajfro111are il problema di rimodernare le poche opere ancora valide ed erigere 1111a nuova, imponente serie di forti a sbarramento delle principali vie di facilitazione alla pianura padana. La scarsità cli risorse economiche ed w1 piano fortijicawrio estremamente complesso, che doveva tener col1fo delle necessità difensive sia de/l'intero arco alpino. con i suoi 1.000 km di estensione, sia degli 8.000 km di coste e dei forti li protez.ione della Capitale, condi-::_ionarono pesantemente I 'intera produzione llrchitetfonica difensiva italiana degli 111fi111i decenni del/'800. Con /'odesio11e dell'lfalia alla Triplice Allecurw i maggiori sfor;,i edificatori ve1111ero indiriz-::_ati verso la profe-::_ione dei co,!fìni con la Francia, mentre dal 1910 in poi /'atte11-::_io11e principale fu 1frolta o/lo frull(iera con lo Monarchia Asburgica. Sebbene il rapido sviluppo ternologico delle artiglierie, con l'i11trod11zione della rigmura e delle polveri propellellfi i11jiu11i, avesse posto in serio dubbio le capacità di resistenza anche dei più 1111111iti forti alle potenziate offese balistiche degli obici e 111or1ai di grosso ca libro con affusto a dejòrmazione, il Regio Esercito continuò alacramente a costruire forti, da contrapporre a quelli aust,v -un gorici. fino allo vigilia della grande guerra. lo scarso impiego e re11di111e1110 delle fortificazioni permanenti durante il conflitto mondiale - la maggior parte dei forti 1 1 en11e disarmota e le artiglierie reimpiegate in .fun::,io11e campale - e l'acquisizione dei nuovi territori del Trentino Alto-Adige e Friuli Vene z ia Giulia, deter111i11arono nel dopoguerra il quasi totale abbandono delle sfrntfure permanenti, con l'ecce::Jone di pochi forti ai confini con la Francia e la Svizzera. Un 111101'0 impulso al/'al/estime11to di fortificazioni si registrò nel corso degli anni '30, in coincidenza con la costituzione del c01po del Rexio Eserci10 della Guardia alla Frontiera, preposto istituzionalmente al presidio delle opere campali e per111a11en1i di confine.
Il presente volume traccia in modo sintetico, ma esauriente, l'evolu-::,ione delle fortifiudoni alpine italiane 11ell'ulti1110 secolo, essenzialmente sotto /'aspelto tecnico. In particolare vengono eviden::Jati i principi ispiratori, i criteri costruttivi e di progettazione adottati, inizialmente, per la reolizzaz.ione dei cosiddetti forti cli sbarramento ad azione lontana - armati con artiglierie di medio calibro in torri corazzate, capaci di una reattività a giro d 'o riz::.onte e completamente m11ono111i dal punto di 1·ista tattico/logistico - e, successimmente, dei caposaldi in calcestruzzo o in caverna per armi m1tomatiche ed artiglierie leggere del cosiddetto Vallo Alpino, sono alla vixilia del secondo conflitto mondiale. lo sviluppo dell'arte fortificatoria italiana ed il suo adeguarsi ai bisogni sempre mufevoli della guerra, è stato inserito nel più ampio comesto del/ ·e\'0/11zio11e della politica estera e di difesa 11a-::_io11ale e degli ordinamenti del Regio Esercito, che i11fluenz(IJv110 i piani di apprestamento degli arricolati sistemi di opere pennanenti. /110/tre, le jòrtifico-::.ioni italiane sono siate, molto opportunamente, rqffrontate con le analoghe realizzazioni d'oltralpe, per evidenziore el'e11flto!i c1/fi11ità o divergenze costruttive e d'impiego.
L'Ufficio Storico ringrazia gli autori per l'impegnativo lm·oro prodotto, che consente 1111a maggiore conoscenza di questo particolare aspetto dell'organi::.zaz.ione dell'Esercito che, seppur tecnico, ha certamente contribuito in modo significativo alla vita ed all'el'oluz ione della Forza Armata.
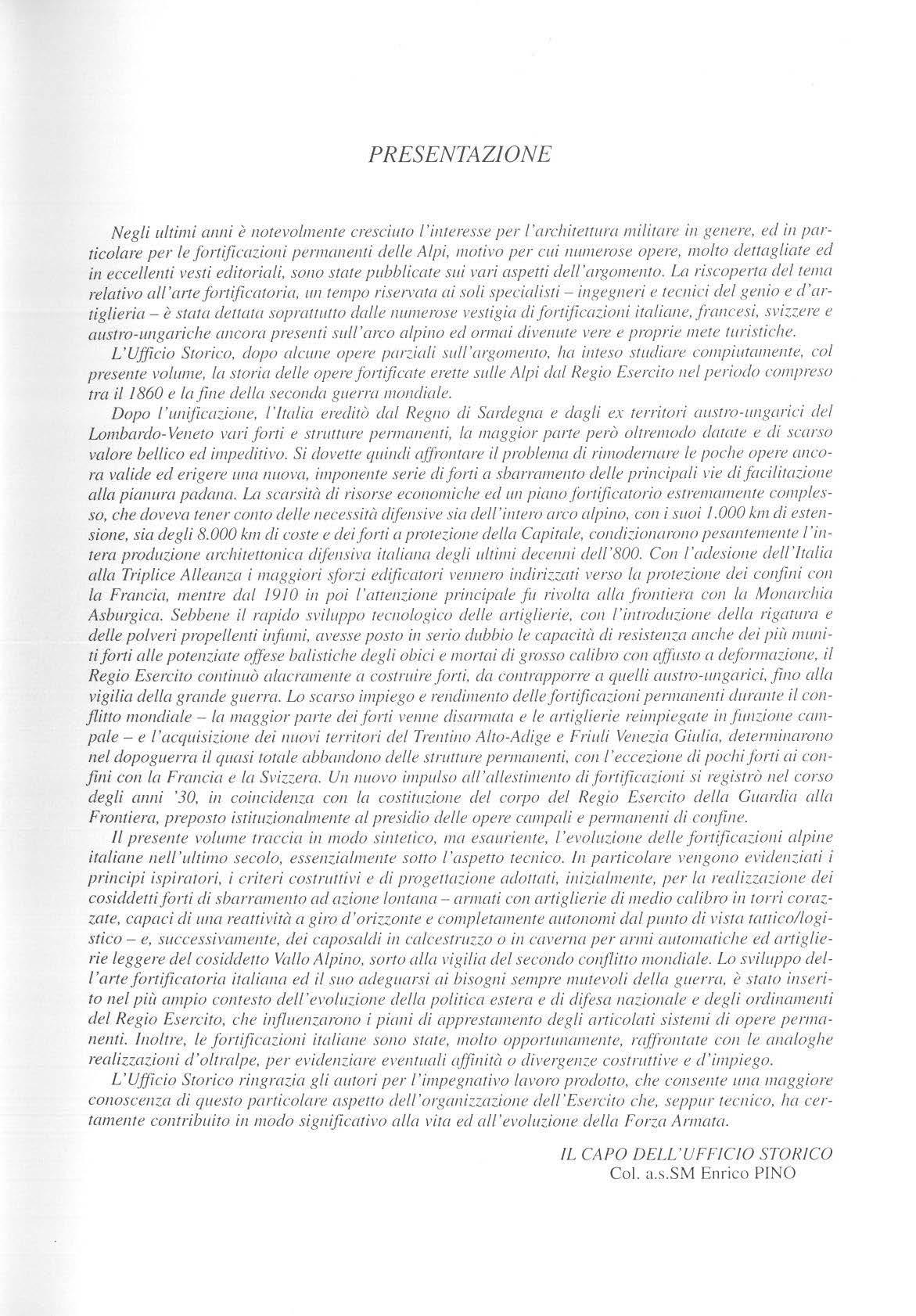
PRESENTAZIONE
IL CAPO DELL'UFFICIO STORICO Col. a.s .SM Enrico PINO

PARTE PRIMA
a cura di Flavio Russo
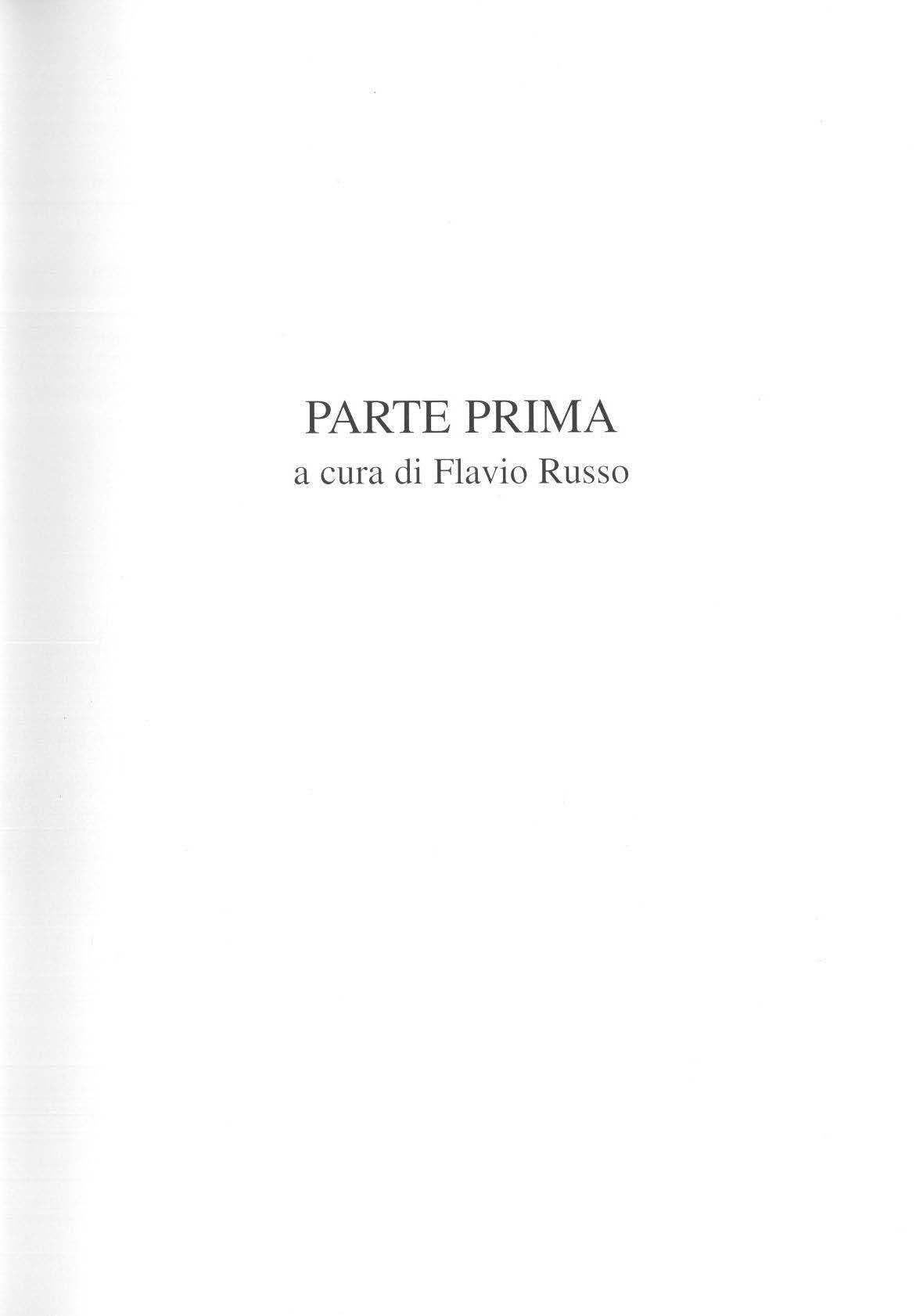

Precisazioni
Molto più del perimetro costiero, assurto dopo l'Unità d'Italia nella sua interezza a frontiera marittima, l'arco alpino, quand'anche non ancora completamente aggregato, limite terrestre naturale della Penisola, costituì la frontiera per antonomasia del neonato Regno. Indispensabile pertanto munirlo di un congruo impianto difensivo permanente, articolato su numerosi caposaldi fortificati di variabilissima consistenza e tipologia.
Recitava infatti il Piano Generale di Difesa dell'Italia:
1°-C he il territorio d'halia. considermo sollo il punto di vista gcog r al1 c.:o-111ili1an;, consta di due pan i essenzialmente d i s1in1e, delle quali l a prima. c i oè la continenta l e. conlìna verso terra con due potenze primarie d'Europa. e trovas i perciò espos1a allc invasioni più podcrose;la seconda, cioè la peninsulare, non 1rovas i in origim: esposia che ad allacchi per via di mare. i quali non possono in izia rsi che con un limi 1a10 numero di forzt; 1;
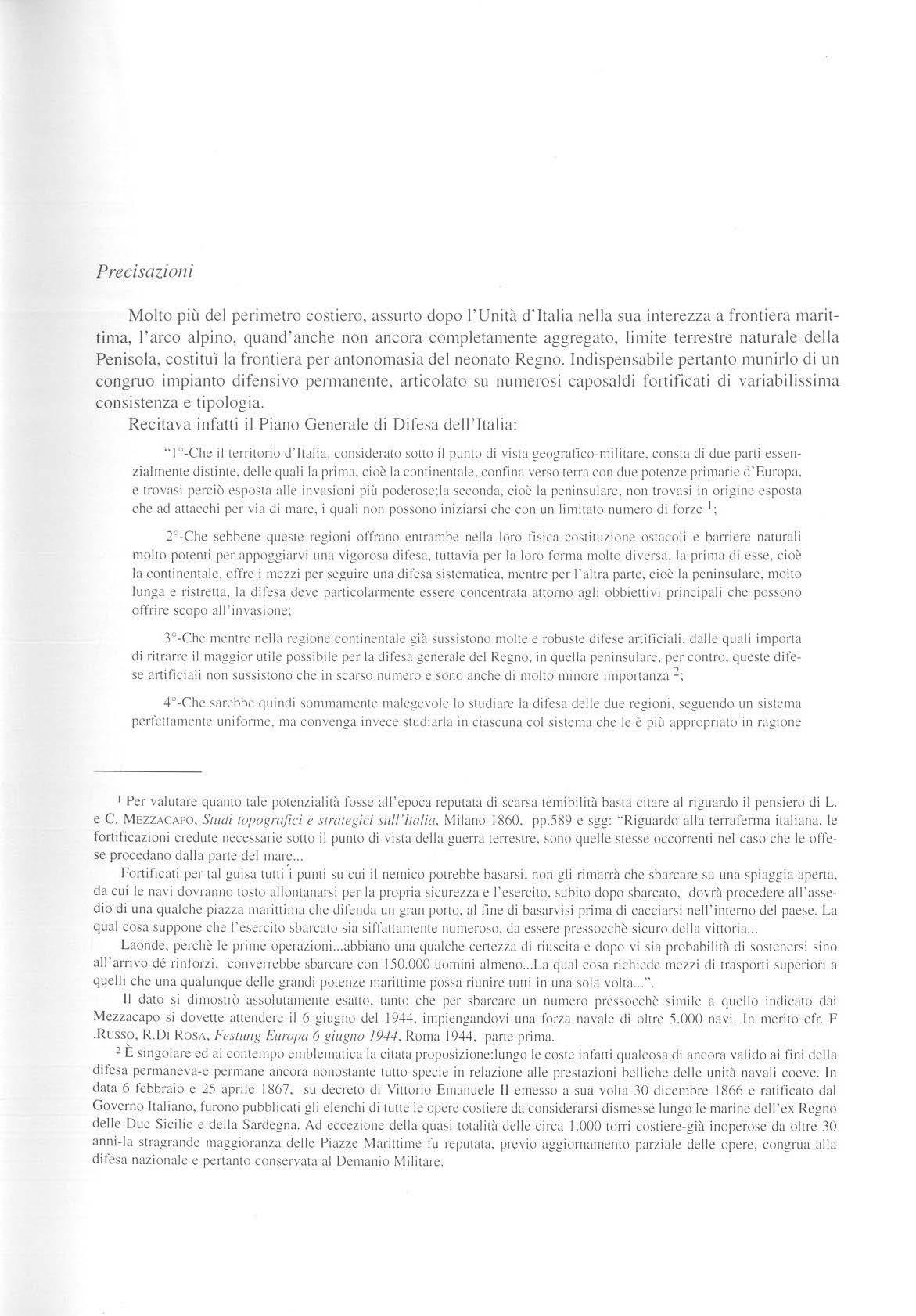
2° -Che sebbene queste regioni offrano en trambe nella loro fisica cos1i1ULione ostaco li e barriere naturali molto potenti per appoggiarvi una vigorosa difesa, tu llavia per la l oro forma molto diversa. la prima di esse, c i oè la continentale, offre i mezzi per segui re una difesa sis1e111atic.:a, mentre: per l'a lt ra pane, cioè la peninsulare, molto lunga e ristrella. la difesa deve panicolarmentc essere conccn1rata attorno agli obbielliv i principali che possono offrire scopo all'invasione;
1 ° -C hc mcn1rc nella regione continemale già sussistono molle e robus1e difese artiri ciali, dalle quali importa di ri1rarrc il maggior utile possibile per la dil'esa generale dd Rcgno. in quella peninsulare. per contro, queste difese artificia li non sussistono che in scarso numero e sono anche di mollo min o re i mportanza 2;
4° - Che sarebbe quindi ~ommamcnte malegev ok l o studiare la difesa delle due regioni. seguendo un sistema perfellamcnte uniforme. ma convenga in vece stud i arla in ciascuna col sistt.:ma cht.: le è più approp r iato in ragi one
1 Per valutare quanto 1ale potenzialità fosse all'epoca reputata di scarsa 1emib il i 1à basta citare al riguardo i l pensiero di L. e C. MEZZAC'APO, S111di 1opogmjìci e s1ra1eg i ci s11l/'/1ulia, Milano I 860, pp.589 e sgg: Riguardo al la terral'erma italiana, l e fonificazioni credute necessarie sollo i l punto di vista della guerra 1errestre, sono qudle stesse occo r re111i nel caso che le offese procedano da lla pane del mare
Fortificati per tal guisa tu lli ·i punti su cui i l nemico potrebbe ba~arsi, non g li rimarrà c he sbarcare su una spiagg i a aperta. da c ui le navi dovranno tosto allontanarsi per l a propria sicu reua e l 'esercito, sub ito dopo sbarca l o. dovrà procedere all'assedio di una qualche piazza marillima che difenda un gran porto, al fine di basa rvi si prima di caccia r si nell'interno del paese. La qual cosa suppone che l'esercito sbarcato sia siffa1tamente numeroso, da c:ssere pressocch~ sicu ro della villoria
Laonde, perchè le prime opcrazion i abbiano u na qualche: certezza di riuscita e dopo vi sia probabilità cli sostenersi sin o all'arrivo dé rinforzi. converrebbe sbarcare con 150.000 uomini almeno La qual cosa r ichi ede mezzi d i trasponi superior i a quelli c he una qua lu nque: delle grandi potenze mar ill ime possa r iunire tulli in una so la volta ".
Il dato si dimostrò asso lutam ente esallo, tanto c.:he per sbarcare un numero pressocchè simile a qu el l o indi cato dai Mczzacapo si dovelle allcndere il 6 gi ugno de l 1944. impiengandov i u na forza nava l e cli ol1re 5.000 navi. In merit o cfr. F .Russo, R Dt ROSA, Fes11111g /:'11mpa 6 giugno /9./4. Roma 194-l. parte prima.
2 È singo lare cd al co111empo emblema1ica la citata proposiLione:lungo le coste in falli qualcosa di ancora val ido ai fini della difesa permaneva-e permane ancora nonostante: tullo-spccie in relazione alle prcsiazioni bel liche delle unità navali coeve. In data 6 febbraio e 25 aprile 1867. su dec reto di Vi11orio Emanuele Il emesso a sua voha 30 dicembre 1866 e ratificato dal Governo Italia no, furono pubblicati gli elench i d i tu lle J..: opere costiere da considerarsi dismesse lungo le m ar ine del l 'ex Regno delle Due Sicilie e della Sardegna Ad eccezione della quasi totalità delle circa 1.000 torri costiere -gi à in operost: da olt re 30 anni -la stragrande m:iggioranLa delle.: Piazze :vlarillimc ru n::putata. previo aggiorn:imento par1, i a l e delle opere, congrua alla difesa nazionale e pertanto consl.!rvata al Demanio Militare.
della sua lisic:1 n>stituzionc c dei pcrkoh a cui trO\ :N esposta. in modo chc la resistcnla possa a, ,: r o, unque un·,:f. l'icaci a propo r z i o nat a ai vai b i sog ni ùcl l a J i!'csa " J
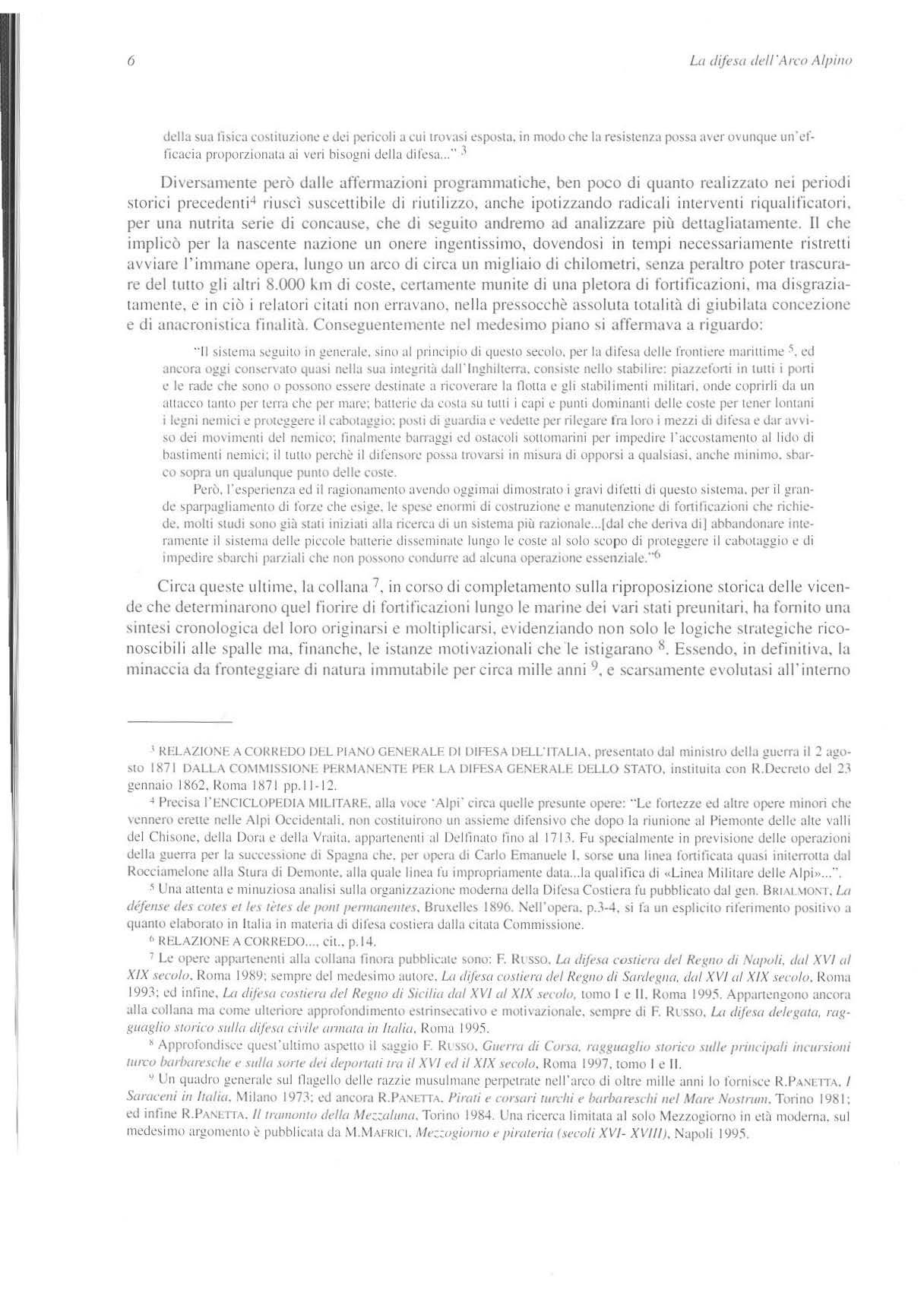
O i\'e r sa mente pe r ò da ll e affe rmazioni prog r ammati c he, ben poco di q uanto r ealiz za to ne i peri odi stori <.: i pre<.: ed enti 4 riu scì suscettibil e di riutili zzo , an <.: he ipo ti zzand o radi ca li interv e nti riqualifi cmo ri , per una nutrita se r ie d i co ncaw,e, che di segui to and re mo ad anali z zar e più d eu ag l iatament e. Il c he impli cò per la nasce nte na z i o ne un on er e in ge nti ss imo, d o vendos i in tempi neces sariam ente ri stretti a vv iare l'immane ope ra , lun go un ar co di c irca un mi g lia i o di c hil o m etri , se nza pe raltro po ter t rasc urar e d el tttlt o g li altri 8.000 l,_ m d i cos te, ce rt ament e munit e di un a pl eto ra di fo rtifi caz i o ni , ma di sg razi a1arnc n1 e, e in c iò i re l ato ri c itati no n erra vano. nell a p ressocc h~ asso luta to talità di g iubil ata concez i o ne e di anacroni, 1ica fina li tà. Conseguenrememe nel medesimo piano si afferm a\'a a r iguardo:
"Il i st ema seg ui to in gener ali: sin o al pr in c i pio d i q uesto secolo. per l a dit'esa de ll e frontie re m ar it ti m e 5. cd an<:ara oggi con~enato qua,i nella ,ua integrità dall' Jnghih,:rrn. consisti.! ncllo stabilire: piaucfoni in tulli i porti c le r ade che sono u possono essere Jes tina te a r i co,erarc la 11 0 11 a e g lt st abilimi;:nt i mi li t ar i on d e cop r irli da 11 11 all aeco ta nt o per ti.' r ra chi.' pi.' r ni an:; bat1<:r i i.' da costa , u tu ll i i cap i e pu m i d om in anti di.'ile co, te pcr te111:r lonta ni i legni 111.:mid e prutcggerc il cabotagg, o : posti di gu:m.lia e ,cdcltc J)\!r rilegare fra loro i mczzi di difesa e dar a,, iso dei 1110\lmenll Jc l nemico; finalme nt e barra ggi cd os i acolt sottoma r ini pi.:r i mp edire l 'accos t amc nlll al lid o d i ha,1 i men1 i nem i ci; il tu lio pcrc hè il d i fcm,ore possa trovarsi in mbura di oppt>rsi a qua l siasi. anche mi1111110. sbarco sopra un qualunque punt o delle coste.
Pcn). l'esperie nza ed i l rag i o namento ave ndo oggima i d im os tra to i gravi d i f etti di qucst o si s1<.:111 a per il gra nde sparpagliame nw d i for;e che es i ge. k spi.'sc enormi di cu,truz i oni.: e manutenzione di fortificazioni che rid11cdc. molti studi sono già stati iniziati ,llla riccrca di un sistcma più razionalc ldal che deriva d1 J abbandonar.: intC· rame nt.: il sis te m a d el le p i cco l e ba11erie d i ssc m ina te lu ngo Il: cos t e al solo sco p o di p rmc ggen.: i l cabot aggio e d i imped i re sba rchi par,iali c he non pos,0110 com.lurrc ad alcuna opcraL1011.: csse111iale."6
C irca qu es te ultim e, la co llana 7 , in co r so cli co mpktament o sulla ripro pos izi o ne stori <.: a dell e vicende c he dete r m inaro no q ue l fi o rire d i fo rtif icazioni l ungo le mar i ne dei \ ari sta ti pre unitar i, ha forni to un a sintes i cro no l og i ca lk l l o r o o ri g i na r si e mo llip licarsi. e, id enzian do no n so l o le l og i c he strat eg i chc ri conosci bi li all e spall e ma , fin anc he l e i stanze mo ti vaz io na li c he le i sti garan o 8. E sse ndo, i n defi n iti va la m in acc i a da fron teggia re di nawra i m mut ab i le pe r c i rca mill e an n i 9 , e sca r sa mente evo lut as i all'int ern o
'R l :L-\Z IOl\'t- A CORRl:.DO l>LL PI At\0 GF.Nt-RA L F. DI DIFF.S.-\ DELL'l rALI.-\. presentalo dal ministro dclla gm:rra il '.? agosto 1871 DALl.r\ CO:\IJ\IISSI0:--1: Pf- Rl\1 ,"l-:7'Tl PF:R LA DIFESA GF.t\ER,\Lf- DELLO STATO. inst illlita con R.Decn:to de l '.?3 gennaio 1862 R o m a I X7 I pp J J. I 2
-1 Prec i sa l'L:l\'C ICLOPF.DI ,\ J\IILI TARf-. all a "~x:c ·AJpi' circa quelle pro.:,1rn1e opere: " Lo: fonczze eJ altre opere minori che ,cnnero ereue nelle Alpi Oo.:cide111ali. non cos tituirono un .1,sicmc difensi\'O c he dopo la ri unio ne al Piemonte delle alt e vall i d el C h i \o ne , ddla D o ra e dell a V rai t a. appa rt ene nti al Oe llìnat o fin o al 17Lì. Fu spc cial111 e nt c in prC\ i sio111.: dell e: opcra , ioni della gucrra per la succC~!.iono.: di Spagn:1 che. per OJ)\!ra Ji Carlo Emanuele I. !.or,c u na linca fortificata qua,i initcrroua dal Rocciamclo nc alla St ura d i D emo me, alla q uale linea 1·11 1111p ropr i amcn te da t a .Ja l JU ali lìca di « Lin,: a Mi l i ta re d el le A lpi » .'
1 U na all e nta c minu1iosa a nalb i sul l a o rg an i11 az i ono.: mode rn a della D i fc , a C o~t i crn fu pubbl i cato d al gcn. B RL\I , 10:-. r / .c1 cléfe11sl' cles COI( ' \ et /es thes de po111 /1<' 1m1111e111(' \, Bruxdlcs 1896 :'\ell'ope r a. p.J-4. si fa un esplic110 rifcnmcnto po,itinl a q uant o e l aborato in Italia in materi a d i d ii'csa cos tio:ra dalla d ta ta Co mmi ~sione.
e, Rb L AZI ONF. A CO RI U:DO ci t.. p.14.
7 Le opere apparto.:ncnti alla collana finora pubblic11e !,Ollo: F. RL sso. La t!ife.111 costiero del RC'gllo di ,'V11poli, dal X\!/ al XIX se,·olo. R o m a I 989: ,e m pi-.:: d o.: I n1edi.:s i111 0 au tore. Lo d/j,,sa co.1 1ie m di' ! Reg no d i Sa rde.t1 11 a dal X VI al X IX secolo. R o m a I 991; o.:d infim.:. I.et dijì•.10 costil'm del RC'g11v di Sicilia dal XVI"' XIX secolo. tomo I e 11. Roma I 995. Appartengono ancora alla coll.111a ma come ulteriore approfond1mcnto c,trinsi.'catho e 11101ha1ionale. ~i.'lllpre dir. R LSSo. Lo d{li•.w dt'legaw . mgg uag lio swrico 111/la d(li•.10 cil'lle o m w ta 111 Italia. Rom a 199 5
Approfondiso.:c quest'u l timo a!,p,:11 0 il ,aggio F RL s,o. Gm•1n1 di Corsa. m1t1111aglio .\torico 1111/e pr111cip"li i11c11rsio11i 1111ro barbart'sc!te e . ,,tifa l()rte dei dt'pmwri tra ti X\II ed il X IX secolo . R oma I 997 tomo I c I I.
U n q uad ro g en erali.! sul il agc ll o de lh.: raZLi c mu sulma ne pcrpi.' trat e nell'a rco d i ol tre m i ll e an ni lo 1·orn i ,cc R P ~\/ErfA. I Saraceni i11 Italia. l\1ilano I 97>; ed ancora R.PA'l;l lT,\. l'imri e corsari turchi e barbareKlti 11el Mare Nostmm Torino 198 I; ~d infine R P,"t.lTA Il 11w1101110 della M,•::.::.aftt11<1. T o r ino 1984. U n:i r icerca li m i tata al so l o M ezzo l!iorn o in età 111 0J c rn a sul m ede si mo argomento~ pubb li ca ta da .\ll.:\1 AF Rl l'I /\1<'::.::.ugiomo e pirateria (secoli XV I- XV III ). N ap~>li 1995.
6 L ll difeso del/ 'Arco Alpino
de ll o stesso ampi o scorcio storico, fu possibi l e non so l o utilizzare conccnzioni arcaic he ma persino strutture antichissime 10 , limitand osi alla semplice manutenzione conservativa cd ad un progressivo infittìmento ubi cat i vo, con nuove opere di identica remota ideazione. Mai come in questo singo l are caso di stallo stori co è possibile riscontrare l a tante vo lte asserita peculiarità conservativa de l mare e delle dinamiche ad esso connesse 11
Fo rtun atamente l a conquista francese di A l geri 12 , determinando la drastica eliminazione dei corsari barbareschi e dei l oro incessanti ed innumerevoli insulti, rese possibile l'abbandono di quell'incred ibile si stema, schierato a protezione della menzionata frontiera marittima, e del l e sue o ltre mi ll e torri 13, ri co nduce nd o l 'es i genza difensiva alla sola coeva del mondo occidentale . Ed in ciò fu comunque un non insi gnifi cante soll ievo economico il potersi avva l ere de ll e piazze marittime migliori residue delle scomparse dinastie preunitarie. Infatti , precisava il piano citato:
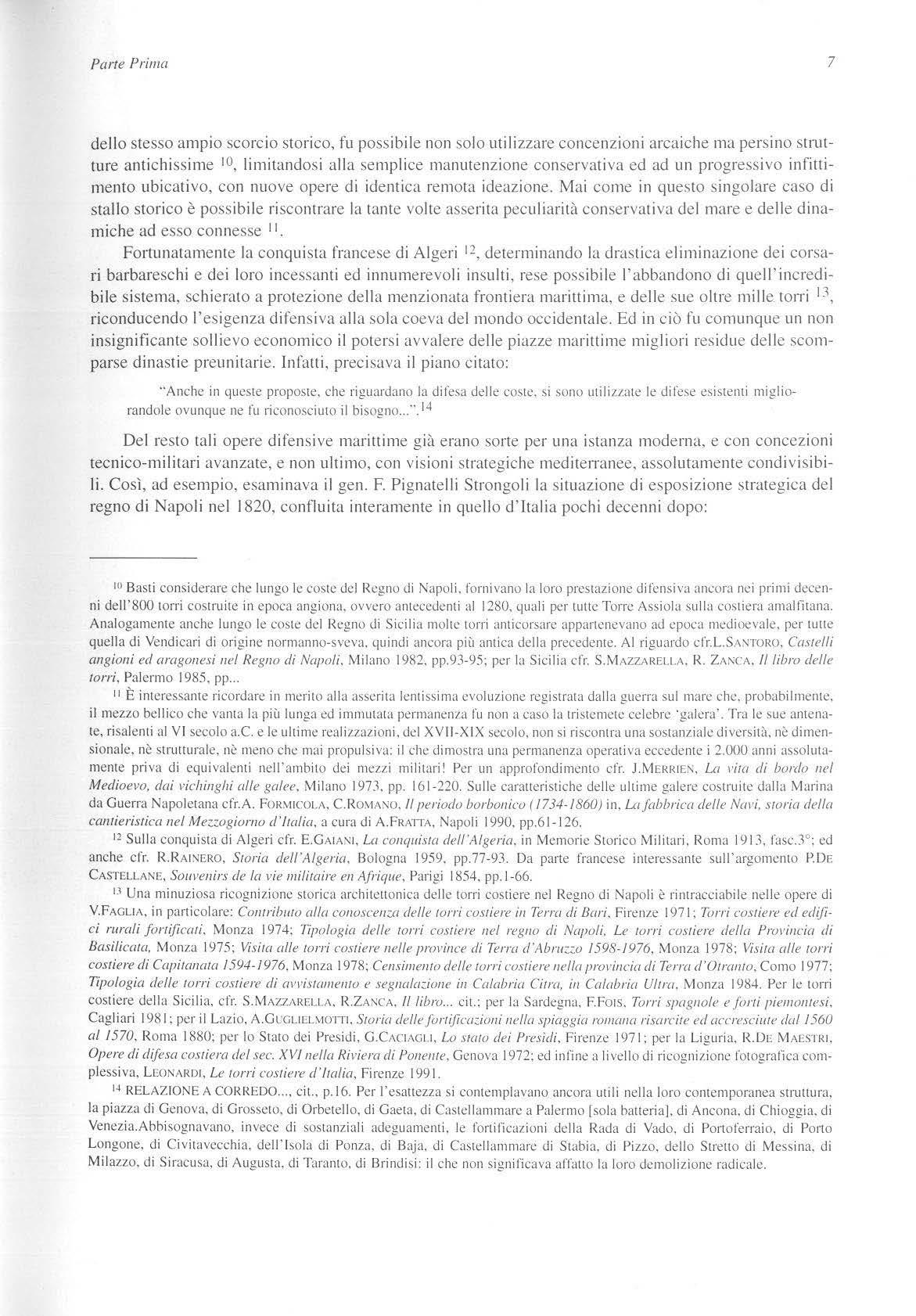
"Anche in queste p roposte, che riguard:rn o la difesa delle costt:. si sono util i .u.ate le difest: esistenti migliorandole ovunque ne fu riconosciuto i l bisogn o ". 14
Del resto tali opere difensive marittime già erano sorte per una i stanza moderna, e con concezioni tec ni co - militari ava nzate, e non ultimo, con visioni strategiche mediterranee, asso l utamente condivisibili. Così, ad esempio, esaminava il ge n. F. Pignatelli Strongoli l a situaz i one di esposizione strategica ciel r egno di Napo li nel 1820, co nfluita interamente in quello d'Italia poch i decenni dopo:
111 Basti co nsiderare che lungo le coste del Regno d i Napo li fornivano l a l oro prestazione difcnsi\'a anc.:ora nei primi decenni dell'800 torr i costru i te in epoca ang i o na, ovve ro ant t:cedt:nli al 1280. 4ua li per tulle Torre Assiola sulla costiera amalfitana. Analogamente anche l ungo l e coste del Regno d i Si c.:il iu molle torri anticorsare appartenevano ad epoca medioevale, per tulle 4uella di Vendi car i d i o r igine normanno-sveva. quind i ancora più antica della precedente. Al riguardo dr.L.SA 'ffORO, Casrefli angioni ed aragonesi nel Regno di Napoli, Milano 1982, pp.93-95; per l a Sicil i a cfr. S.MAZZARELLA. R. ZANCA, 1/ lib,v delle rorri , Pal er m o 1985, pp
11 È int eressante r icordare in merito al lu asserila lentissima evol uzione registrata da ll a guerra sul mare che, probab i lmente, il mezzo be ll ico che vanta la p i ù lunga ed immuta ta perma nen,a fu non a caso la tr i stemete celebre ·galera '. Tra l e sue ante nate, risalenti al VI seco l o a.e. e le ultime realizzazioni. del XVII-XIX seco l o, non si riscontra una sostanl i alc diversità, nè dimensionale, nè st rut turale, nè meno che mai propu l siva: il che dimostra una permanenza operat i va eccedente i 2.000 ann i assolutamente priva di equivalent i nell'amb it o dei mezzi milituri! Per un approfondimento cfr. J MERR IEN La vira di bordo nel Medioevo, dai vichinghi alle galee, Milano 1973, pp. 161 - 220 Sulle carat1eristiche delle ultime ga l ere costruite dalla Marina da Gu erra Napo l eta na cfr.A. FoRMICOLA C.Ro~1A:slO. Il periodo borbo11ico ( 1734 - /860) in, La fabbrica defle Nal'i, sroria defla can rierisrica nel Me::.wgionw d'/ralia. a cura di A.FRAHA, Napoli I 990. pp.61 -1 26.
12 Sulla conquista di A l geri cfr. E.GA IAN I, La conquis/(1 defl'Algeria, in Memo r ie Storico Militari , Roma 1913. fasc.3 ° ; ed anc he dr. R.RAl:-,JERO, Sroria defl 'Algeria. Bologna 1959. pp 77 - 93 Da parte francese interessante sull'argo m ento P.DE CASTELLANE, S011venirs de la vie miliraire en A}ì'ique. Parigi 1854, pp. 1-66.
u U na minuziosa r ic og nizi one stor i ca arch itett o nica de l le torri cost i ere nel Regno di Napo l i è r in tracciabile nelle opere di V.F AGLIA , i n partico l are: Conrriburo afla conoscen::.a defle rorri cosril!l'e in Term di Bari, FirenLe 1971 : Torri cos!il!l'e ed edifici rurali forrijìcari, Monza 1974; Tipologia delle Torri cosriere nel regno di Na110/i, Le Torri cosriere defla Pro1·ù1cia di Basilica/{/, Monza 1975; Vis ir a afle rorri costiere nefle prol'ince di Terra d'Abrll';,;;o I 598-1976. Monza 1978; Visira afle rorri costiere di Capirc111a/{/ 1594-1976. Monza 1978; Censimento defle IOrri cosriere nefla proi•ù1cia di Terra d'Otranto. Como 1977; Tip ologia defle ro rri costiere di avrista111emo e segnala;;ione in Calabria Citra, in Calabria Ulrra Monza 1984. Per l t: torri costiere del la Sicilia. cfr. S.MAZZARELLA. R.ZANC'A. li libro cit.; per l a Sardegna, F.Fo1s. Torri spagnole eJòrri piemonresi, Cag l iari 1981; per il Lazio, A .G L'GLIE L\10TTJ Storia defle for1ifirn;;io11i nefla spiaggia romana risarcite ed accresciwe dal 1560 al 1570. Roma 1880; per lo Stato dei Presidi, G.CACJ,\GU, Lo sfato dei Presidi. F irenze 1971: per la Liguria, R.DE MAESTRI, Opere d i difesa costiera del sec. XVI nella Ril·iem di Ponenre, Genova 1972: ed infine a l ivel lo di r icogni1. i one i'otografica complessiva, L EONARDI, Le torri costiere d'lralia, Firenze 1991.
14 RELA ZIO NE A CORREDO cil.. p.16. Per l'esattezza si contemplava no ancora utili nella loro contemporanea st ru ttura, la piazza d i Genova, di Grosseto, di Orbetello. di Gaeta, di Castellu mmarc a Palermo [so l a halleria], di Ancona, di Chioggia. di Venez ia.Abb i sognava no, invece d i sos tanzial i adegua ment i, l e fort i ficazion i della Rada di Vado, di Po rtoferraio. di Porto Lon gone di Civi tavecch ia , dell' I so l a d i Ponza, di Baja, di Caste l lammare di Stabia. di Pizzo, dello Stretlo di Messina, di Milazzo di Siracusa, di Aug usta, cl i T aranto. di Brindisi: i l che non sign i ficava affa u o la l oro demolizione radicale.
Parte Prima 7
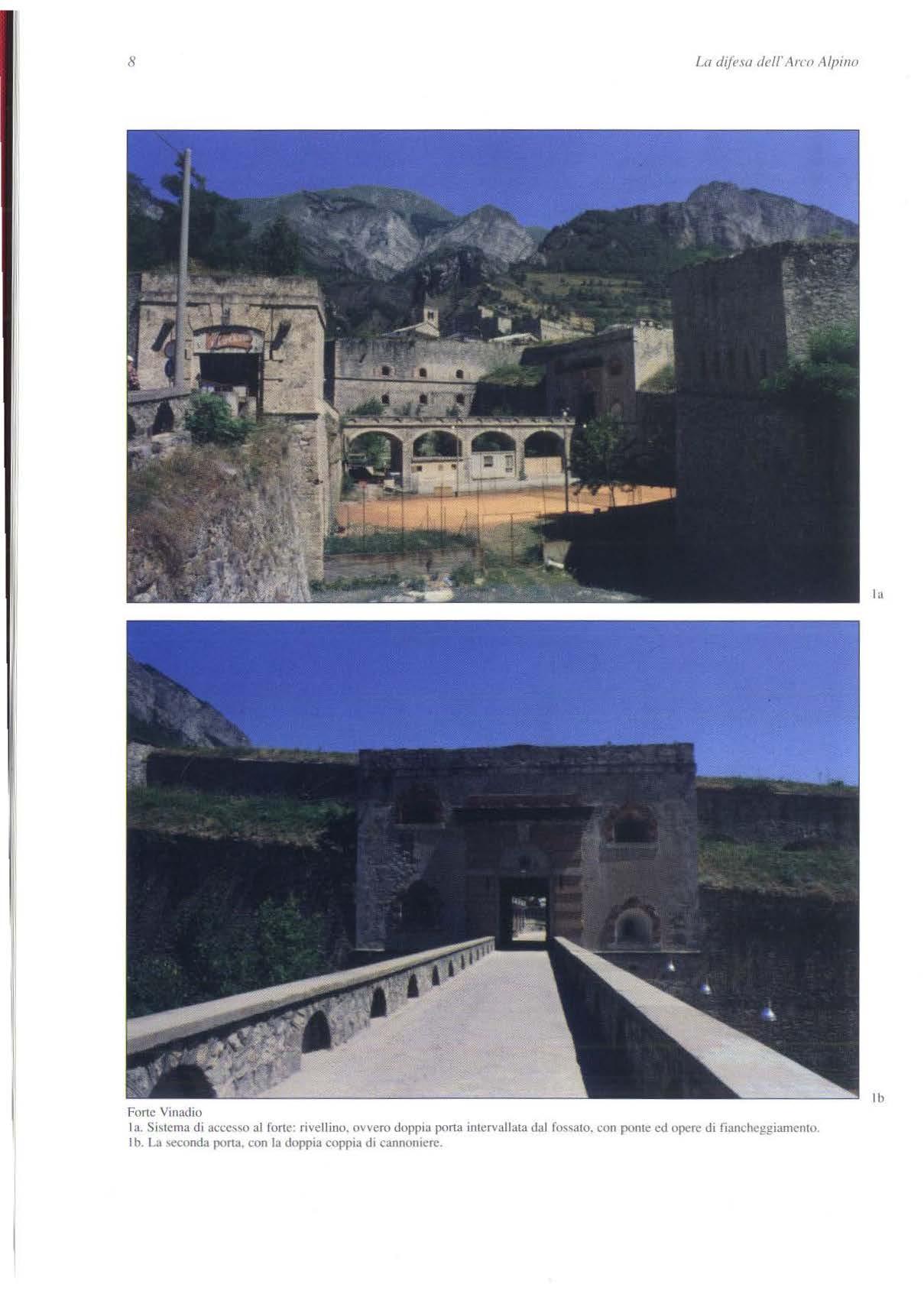
I I 8 La dife.,a del/'Arrn Alpino
Forte Vinadio la. Si~tcma di accc,~o al fone: rivellino. ovvero doppia porta intervallata dal fos,ato. c.:on ponte ed opere di fiancheggiamento. lb. l.;1 ,econda pona. con la doppia coppia e.li cannoniere.
lb
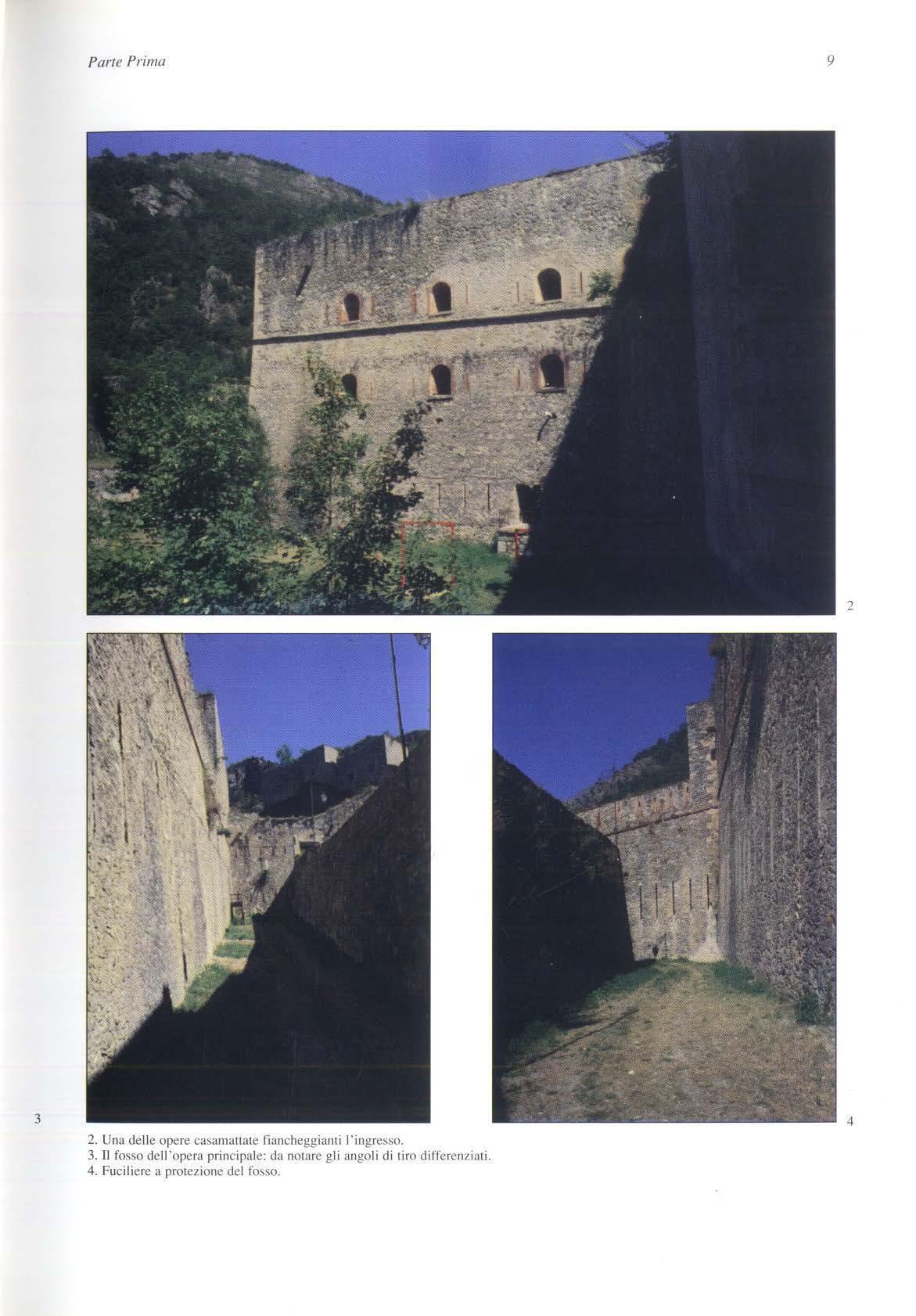
Parte Prima 9 2 3 4
2 Una delle opere casamatlate fiancheggianti l'ini..,rresso.
3. [I fosso dell'ope ra principale: da notare g li angoli d i 1iro differenz iati.
4 Fuciliere a protezione de l fosso.

10 La difesa Alpino i I 5 6
5. Dettaglio d i u n a cannoniera.
6. Una dell e opere sussidiarie poste sui fianchi delle alture che sovrastano il forte pr incipa le.
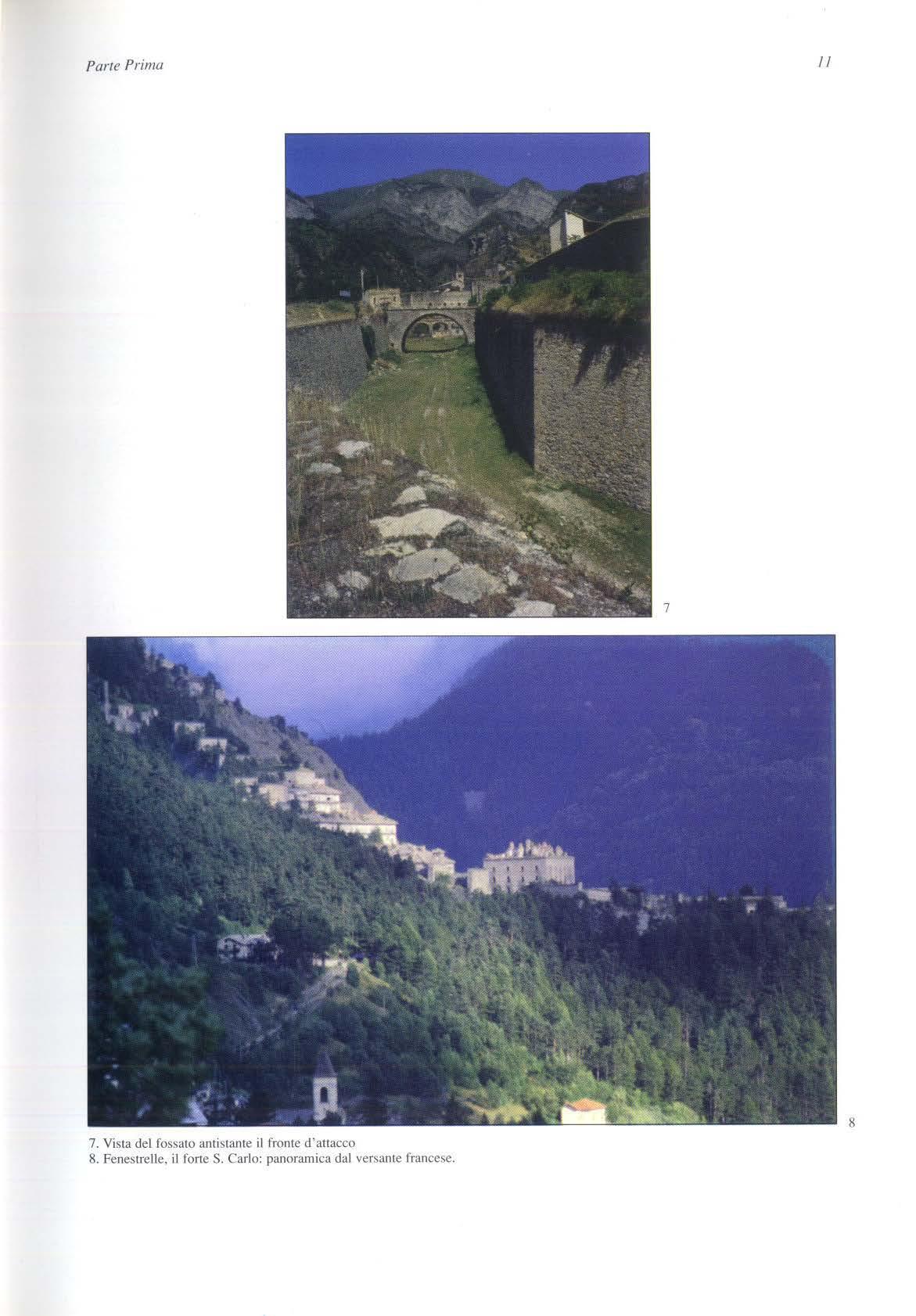
Parte Prima Il 7
7. Vista del fossato ant istante il fronte d'attacco
8. Fenestrelle. il forte S. Carlo: panoramica dal versante francese.
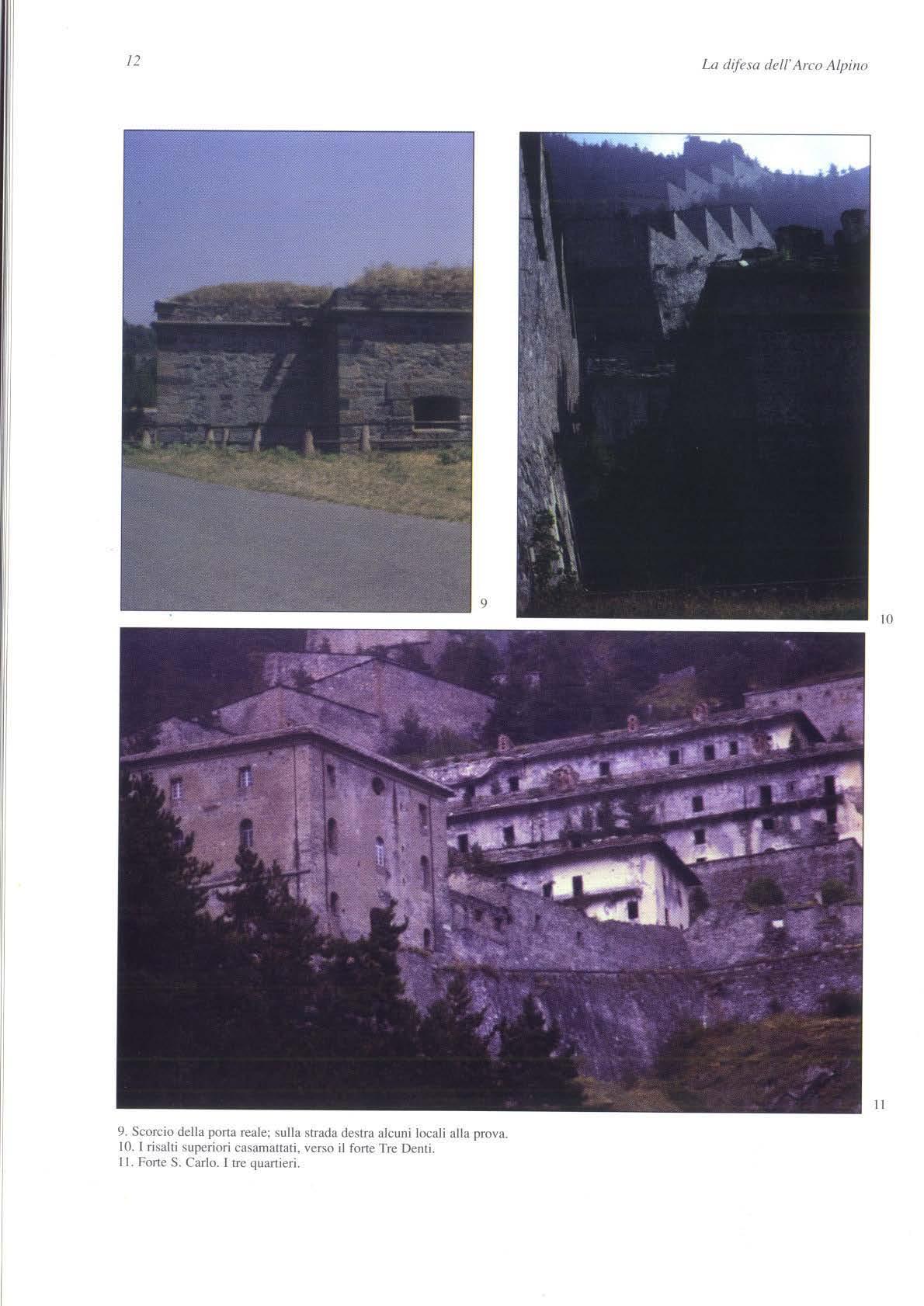
11 11 12
La difesa del/' Arco Alpino 10 li
9 . Scorcio della pona reale: sulla strada destra alcuni locali alla prova. IO. I risalti superiori casama1tari, verso iJ fone Tre Denti. I I. Forte S. Carlo. I tre quanieri.
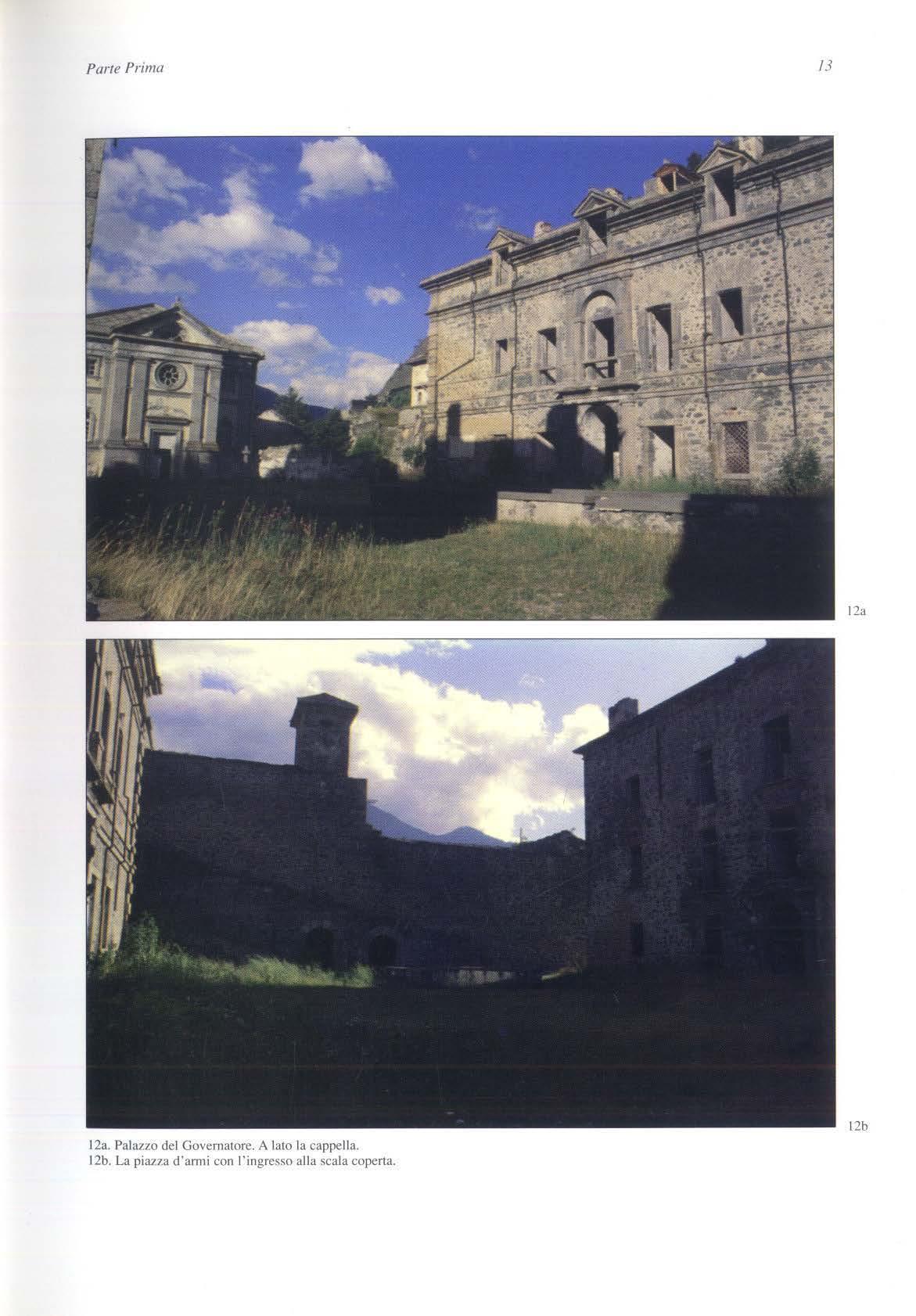
Parte Prima 13 12a l2b
12a. Palazzo del Governatore. A lato la cappella. J2b. La piazza d'am1i con l'ingresso alla scala coperta.
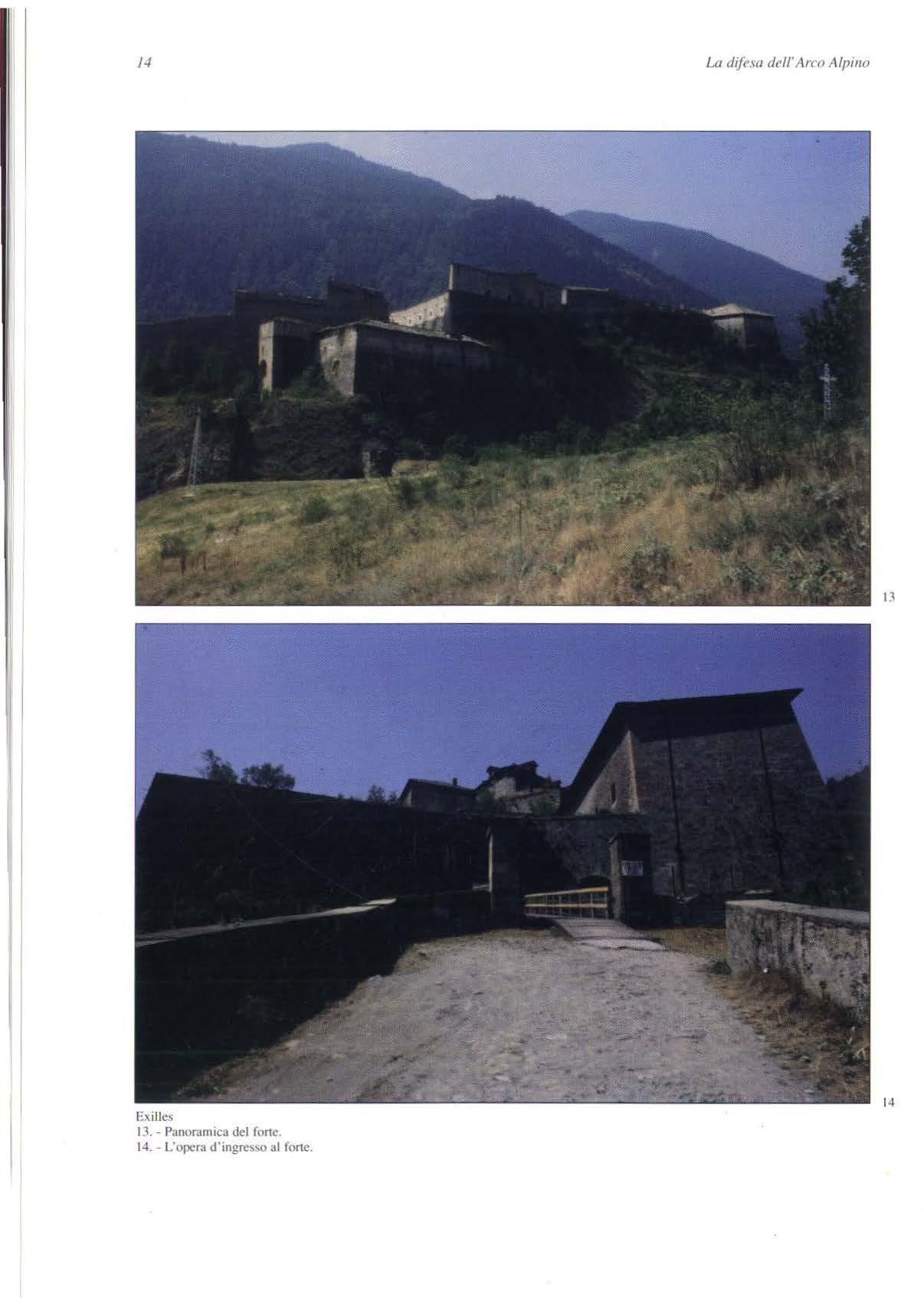
14 La difesa dell'Arco Alpino 14
Exilles
13. - Panoramica del fonc.
14. - L'opera d ' ingre~~o al fone.
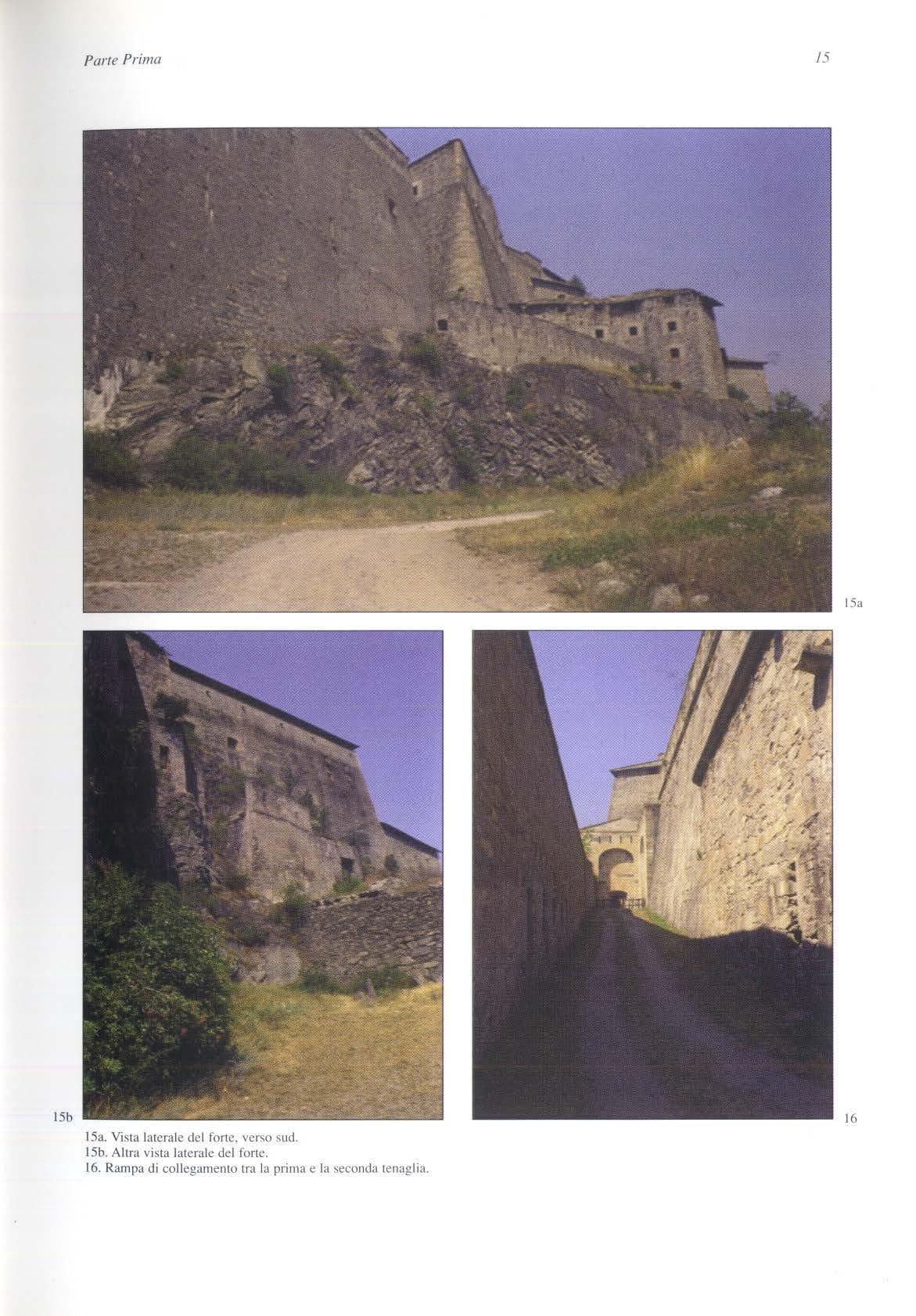
15b Parte Prima
15a. Vista latera le del forte, verso s ud.
15b. Allra vista laterale del forte.
15 15a 16
16. Rampa di collegamento tra la prima e la seco nda tenaglia.
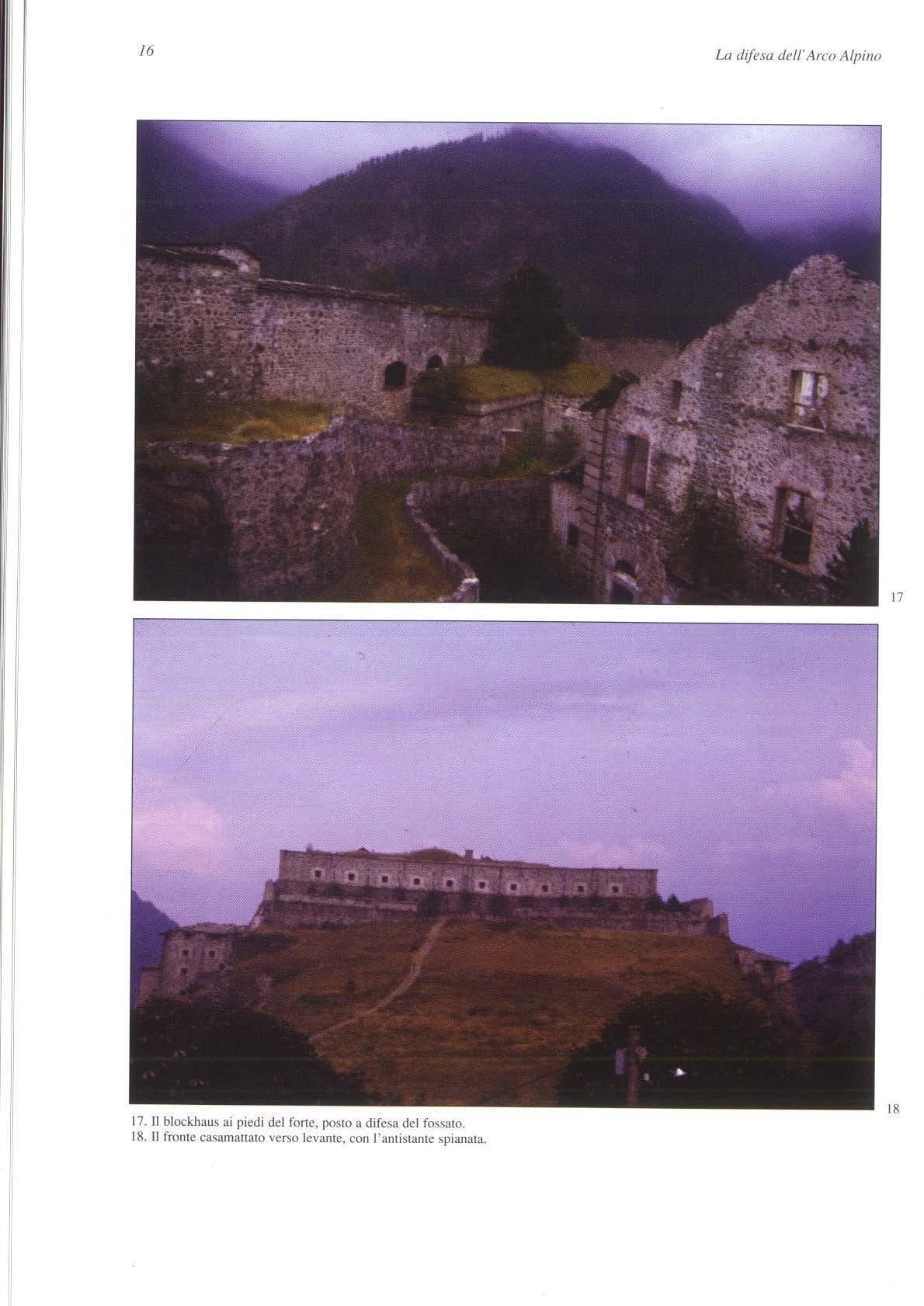
16 la difesa dell'Arco Alpino 17 18
17. li blockhaus ai piedi de l forte, posto a difesa de l fossato. 18. fl fronte casamanato verso levante , con l'an tistm11e spianata.
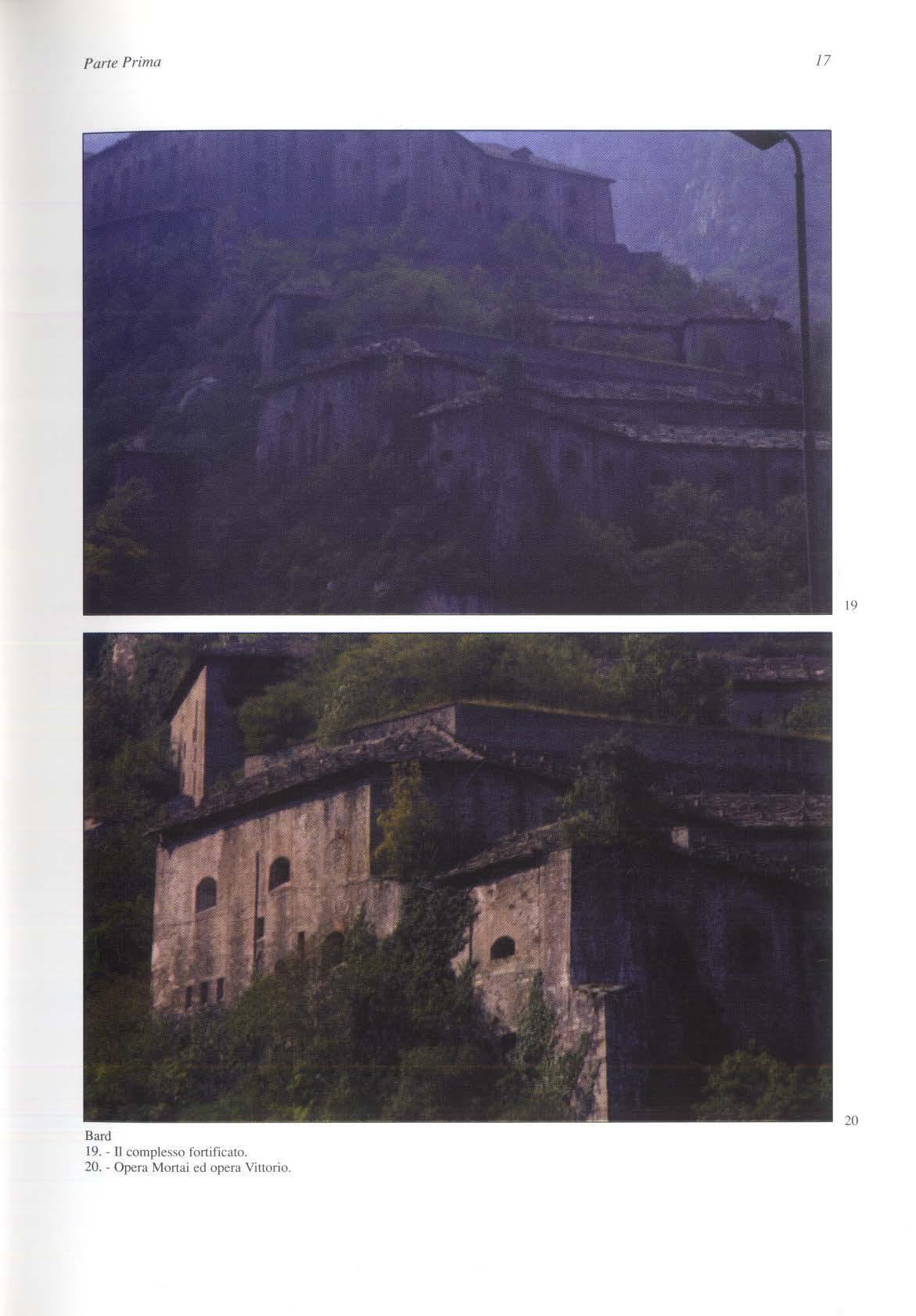
Parte Prima 17 19 20 Bard 19. - Il complesso fortificato 20. - Opera Monai ed opera Vittorio.
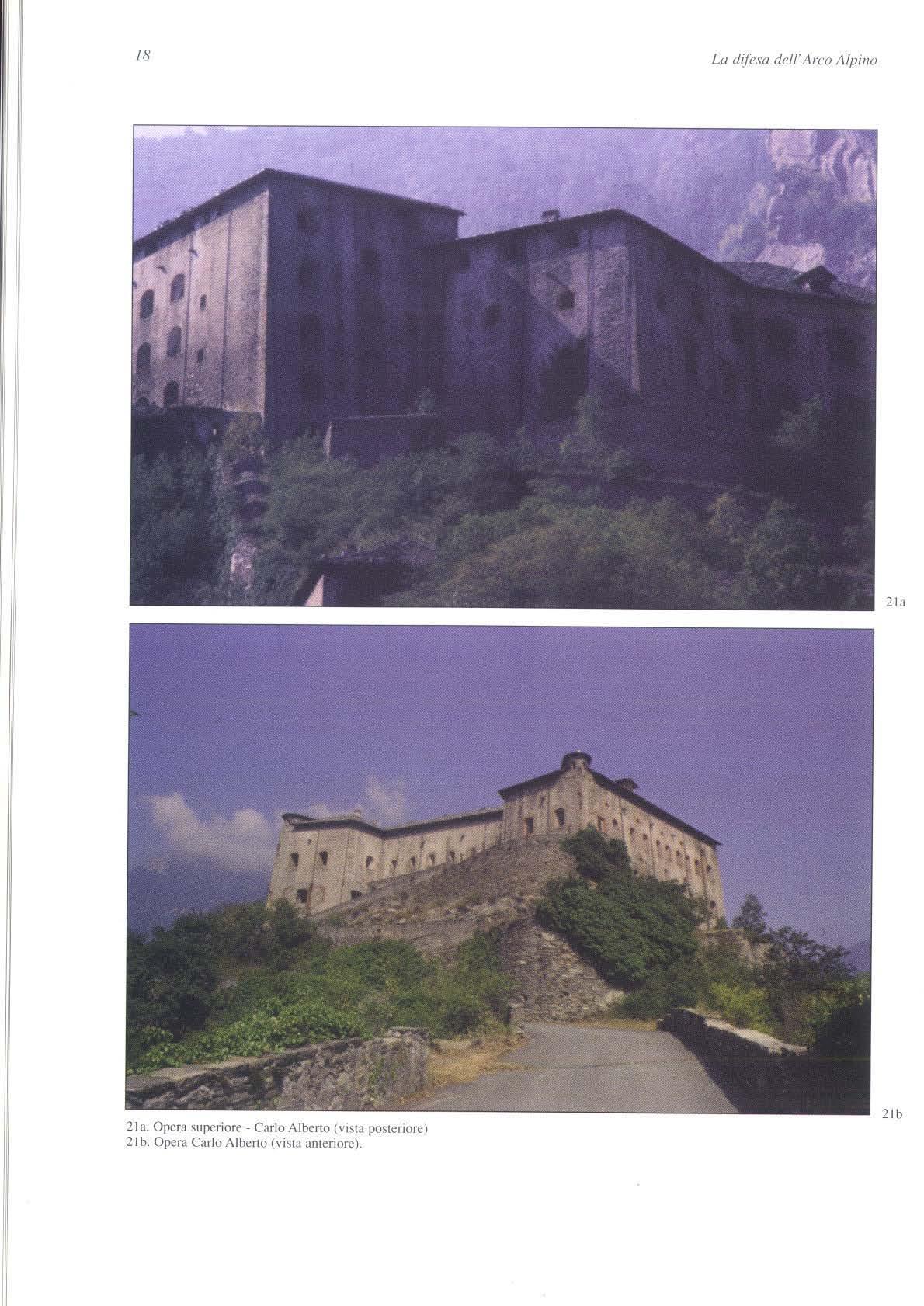
18
21 a. Opera superiore - Carlo Alberto (vista posteriore)
21 b. Opera Carlo Alberto (vbta anteriore). 21a 21b
La
difesa del/' Arco Alpino
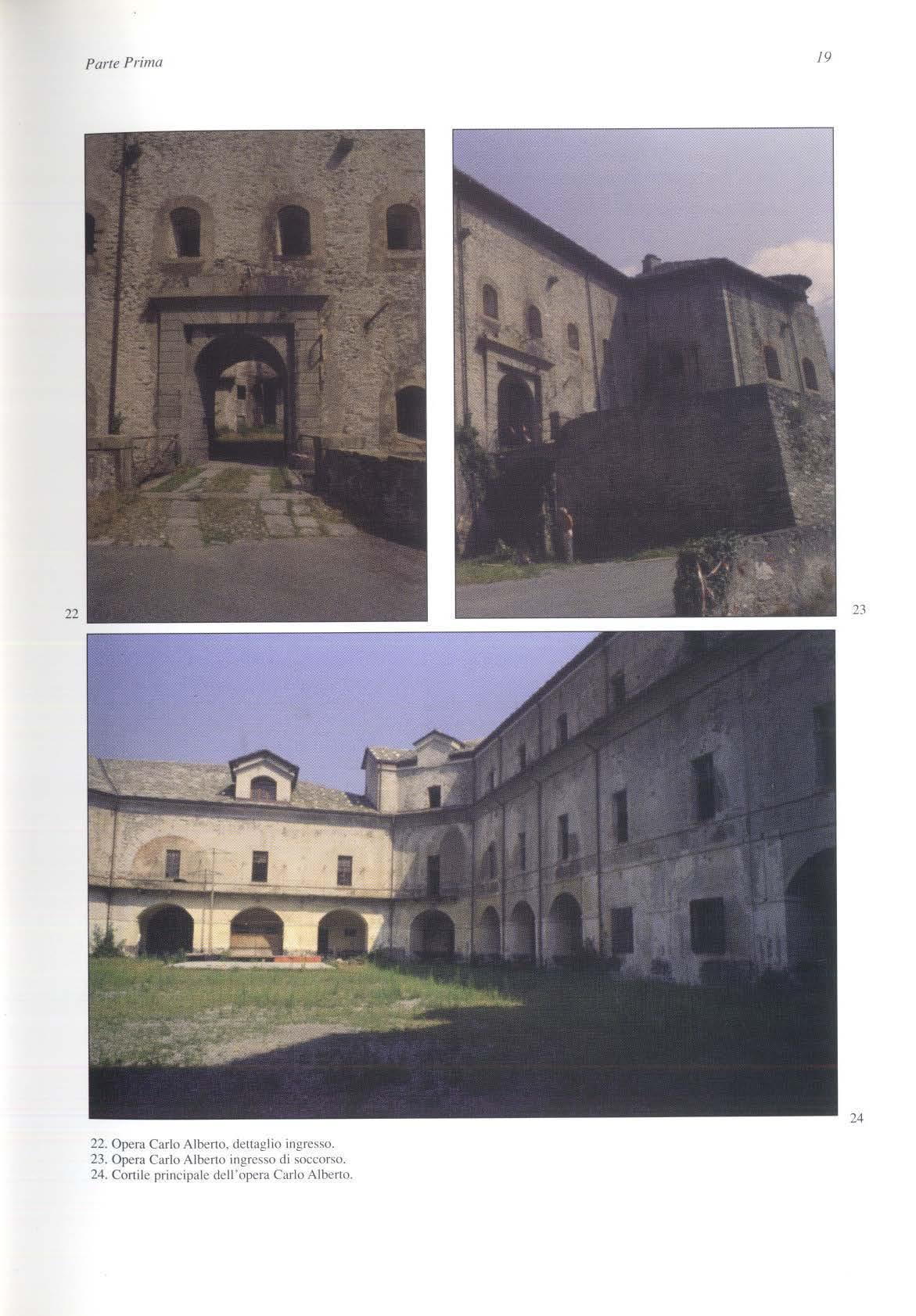
Parte Prima 19 22 23 24
22 Opera Carlo A lbeno. deuag lio ingresso.
23. Opera Carlo A lbeno ingresso di soccorso.
24. Coni le principa le dell'opera Carl o Alber10.
"11 soggello di questo Capitolo è vasi issi mo. e comprende tulle le cure di un Governo illuminato per assicurare l a difesa dello Siaw. La Lopogralia dc ' nostri due Regni 15 li n.:nde vulnerabili da per ogni dove ùa un nemico potente in mare. a causa ùella immensa estensione ùellc sue eosce Di falli se l'lnghiltem1 rosse governata da un ministero ambi1.ioso. potrebbe volere ac:quistare la Sicilia. onde con Gibilterra. Malta e Corfù avere nd Mediterraneo cama base di forza. da non pavemare la lcg::1 <.legl· Italiani co· France,i e Spagnuoli
Per terra noi risvegliamo la gelosi a della casa <.l'Austria 16 e non abbiamo allro prossimo al leato natura l e che il Piemonce. al l orchè egli imenderà bene il vero interesse del suo Stato. E se la politica unisce I' i\u~trin nll'lnghilterra. o al l a Russia, noi possinrno e,sere altaccati da due potenti Colossi, e dobbiamo resis tere iamo tempo che i nostri lont:tni naturali allc:1ti possan far <.li versione
Dalla pane del mare dunque il Rcgno delle due Sici l ie debbe esser considera t o come un :tnternurale dell'Europn e ~ì per terra, che per man.: come la parte Jell'Europa più ,ogge11, 1ad accrescere talml'nlC la l'orza di una delle Principali potenze da farla divenir dominante ~li llllte le al trc ". 17
E quanto le osservazioni dell'accorto analizzatore militare napoletano fossero attendibili lo dimostra quest'altro brano. di immediata interpretazione:

mentre noi siamo attaccati pcr !erra, un nemico più potente di noi in mare può ~bare.in: un Esercito in Puglia. e rendendosi padrone di qualche pian:a. marciare ~u la Capitali.:. ovvero può sbarcare a Sakrno. e portar~i a Napoli. ".18
Dal che ne conseguì se non la pronta realizzazione dei suggeri menti prospettati per stornare le infauste potenzialità evidenziate, l'adeguarsi progressivo delle piazze marittime del Regno delle Due Sicilie a siffatta ottica strategica, perfettamente co incide nte con quella del futuro Regno d'Italia.
Ecco allora che le precedenti ricerche non potevano esimersi, volendo riperco1Te le logiche ubicative dcJJe fortificazioni della fascia costiera peninsulare dalla ricostruzione di tali fasi, pena l 'incomprensione non so l o delle scel te successive ma finanche delle stesse piazze rnarillime, per lo più ulteriori potenziamenti delle preesistenti strutture delle qual i conservavano-e conservano -abbandanti pemianenze. Indi spensabile, pertanto, affrontare l'esposizione delle vicende evolutive di quel complesso sis tema e. quindi, in un lavoro di sintesi conclusiva, rimarcarne le acquisizio ni nella difesa costiera c.lell'Italia, fino al secondo connitto mondiale 19 II che giustifica la scelta di suddividere la ricerca in una prima serie di specifici studi spaziant i dall'avvento dell'età moderna, sino al momento della riunificazione nazionale, ed infine nella accennata sintesi delle altrettanto specifiche vicende relative però al periodo post-unitario.
15 Il Ri::gno di Napol i e quello di Sicilia. uniti ncll,1 com une definizione <.li Regno delle Due Sicilie in epoca nonmrnn:i. rimasero in seguito sempre d i stinti e separ:ui, anche quando appanennero :id un unito sovrano. Sol!an10 dopo la restituzione del R..:gno di Napoli, conclusasi la parentes i mura11iana nel 1815. Ferùina ndo IV <.li Borbone. per la Sicilia Ferdinando Ili. divenne re delle Due Sici li e Fcrdinan<.lo I. Per una ricost ru zione genernle dcl periodo cfr. H .A.L.FtSIIER. Sroria d'E11ro11a. Bergamo 196.J.. voi. li. pp.542 e sgg
11 ' Sembra confermare la fondatezza di tali;: int..:resse i l cle11ag l io che i rilievi esegu i ti per or<.line <.li Ferdinando I <.li Borbone di tulle l e fortificazioni costiere del Regno di Sicilia. operazionc affidall.l al Genio Militare austriaco. siano rima~ii fino ad oggi custoditi a Vienna! A l riguardo cfr. F.Rlsso, La difesa cosliem del Regno di Sicilia c ii. 101110 Il. pp.5 16--1-1.
17 F.PIGi\ATEI LI STRO~UOLI, Considem::.ioni s1ra1egic/1e sul sis1e111a di d(fesa del Regno di Napoli. Napol i 1820. pp.-11 e sgg ix l bi<.lern.
1 '1 Non è un caso chc la Seconda Guerra Mondiale in mmeria di au acchi navali vi<.le in particolare quello sferraw al la 1101ta i1ali an:i nncornta a Taranto I ' 11 novembre del 19.J.I, piazza navale per antonoma~ i a. di aragom:se matrice. e que l lo anfibio co111ro la piazza di Augusta. a sua vo lt a di impianto svevo. Per approfondimenti al riguardo cfr. G.C. SPEZIALI.:. S1oria 111ilùare di Tmwuo negli 111li111i cinque secoli. Bari 1930, pp.23- 105; circa le vicende costruttive originarie. e pp.207 - 259 nel l a veste moderna di p i azza navale italiana. Per Augusta e l e sue vicl.'nùc storiche cfr. L. D1 1FOL' R. Augusla da ci11à imperiule a ci11à 111iliwre, Palermo 1989. Circa inlìne le v i cende c:hc videro coinvoha Augusrn nell'ul1i 1110 co nlliu o cfr A. S,\i\'TONt. Le 01,em:.ioni i11 Sicilia e in Culabric1 l11glio-se11e111bre 19.:/3, Roma 1989, pp.171-220
I I 20 La difesa dell'Arco Alpino
Discorso, invece, del tutto diverso per l'arco alpino. Sebbene sorretto da una identica esigenza conosc itiva ed indagativa, non è possibi le percorrere un identico itinerario storico, mancando in generale le premesse, come pure le penmrnenze. E al riguardo significativo che lungo il settore occidentale, quello ritenuto di gran lunga più minacciato ed a rischio invasivo, quanto il neonato Regno:
·· ereditava nel 1861 per la difesa di questa delicata seLione di confim.: <.:ra rarpresentato ùal fone Exilles. dalla vicina Fortezza di F..:n<.:str<.:lle nel l 'alta Val Chison..:. e da l piccolo e vetusto Fon<.: Gatto al Monc..:ni~io 20:è da 4uesto poco che bisogna ponire. Già nel 1868, 4u.1ndo il problema principale della difesa del R<.:gno era ancora qudlo di cercare di coordinare le numerose difese regionali preesistenti in un disegno che avesse qualche parvenza di ra1.ionalità unitaria. si crn allacciata timidamente la necessità ùi dedicare qualche risorsa alla manutenzione, se non al rinnovamento. delle vecchie opere uella fronticrn alpina pur se la Francia poteva t:ssere considerata ancora. nonostante l a tensione p<:r i faui di Mentana, un vicino rt: l ativameme amichevole. Fu solo con il I 870-'7 I, vale a dire con la presa di Roma<.: con la mancata assistenza ita l iana a Parigi nella guerra franco-prussiana,<: con le nuove tensioni politiche che ne derivavano. che si ebbe il vero punto di svolta nelle relazioni tra le ·sorelle lat i ne ' Da una cauta diflidenza si passò gradatamente ad una vera e propria ostilità che si approfond1 nel corso del decennio successivo.
Come ai tempi di Carlo Emanuele I e di Viuorio Amedeo 11. come nel 1744. come nel 1792. la valle viene 11 uovamente a trovarsi in prima linea. Es<: a faccia a !'accia con una Frnncia divenuta osti l e non c'ern più da solo i l piccolo Piemonte, ma una ben più amp i a compagine naz.ionalt: dutata d i un ben più vasto territorio. il rroblerna della difèsa delle Alpi Occidenta l i non nt: usciva di molto sdrammatizzato. Fino al perlòionamento della Triplice Alleanza , che consentirà una maggiore (ma mai totale) tranquillitit alla frontiera nord-orientale. il neonato Regno d'Ital i a si trovava prossochè isolato <li rrome a due potenziali grandi nemici. Auwia e Francia. con infel i ci linee di frontiera ". 21
Più in generale le pe1manenze individuabili sull'intera frontiera alpina possono ridursi a:
Forte di Vin a dio
F o rtezz a di F e nes t re ll e
Fo rtez za di Ex ill es
Forte di B a rd
Fortezza di R occa d' Anfo
Fortifi c a z ioni di Ri vo li
di queste, in realtà, soltanto le quattro di Vinadìo, di Fenestrelle, di Exilles e di Bard di una qualche valenza. Il che però non significava affatto che potessero inserirsi semplicisticamente e senza adeguamenti nel nuovo schieramento, tant'è che nel 1874:
" vennero approvat i al cuni stanziamenti straordinari per I·adeguamento dcllt: opere di difesa Fu altresì possibi l e finanzi,ire interventi decisameme più modesti. qua l i l'ammodernamento delle vecchie fortezze di Exilles. Barù, Fenestrelle e Vinadio con l'adozione di artiglierie rigate e a retrocarica ". 22
Nonostante ciò non è esalto concludere che le stesse conservassero significativi resti di presistenze •i nteressa nti, poichè:
"Al l a fine del Settecento [I') imponente cimura di forti era di fatto comp l etata: dall'estremo nord lìno alle A l pi Mariuim<:. i l'oni di Bard, Brunetta. Exilles. Fenestn.: l le. Mirahouc. Demontc. Saorgio e Ceva. impedivano ogni sbocco nelle pianura del Po garantendo al Piemonte una certa sicurezza
20 Per un inquadramento stor i co-geogratico del l 'argomento dr. E. t L.PAlR tA, Castelfi eforte-;.::.e de/fa Val di Susa. Torino 1983, pp.44- 102. Per un approfonclirnemo sulle opcr<: fonilkat<: ereue dai Savo i a ed in partico l art: sui l oro proge t tis ti cfr. G.BELTRurr1, Le forte:,::.e dei Sarnia, Torino 1980. pp. 5 1 e sgg - In part i colare una accurata indagi ne storico-architcllonica e militare è stata pubblicata da D.GARIGLIO, M.MIKOLA, Le forte::.::.e delle Alpi occiden1ali, Cuneo 1994, voi I. pp. 11-TJ.
21 P.G.CORINO. P.GASTALOO. La 1110111ag11a fortijicaw, per i monti della mlfe di S11sa:daifor1i della triplice si110 alle opere in caverna del i 1a/fo alpino, Susa 1993, pp.2-3.
22 I bidem, p. 15.Per un approfondi memo su l l e caraueris tiche delle artiglierie da piuua di lì a breve adottate dr. E.CAs·t ELLANO, Evoluzione della Fonijica::.io11e Permanente sulle Alpi Occidenwli dall'Eporn Post-Napole011ica al Secondo Conflitto Mondiale, i n M<:morie St o r ico Militn ri 1983, Roma 1984, pp.578-582.
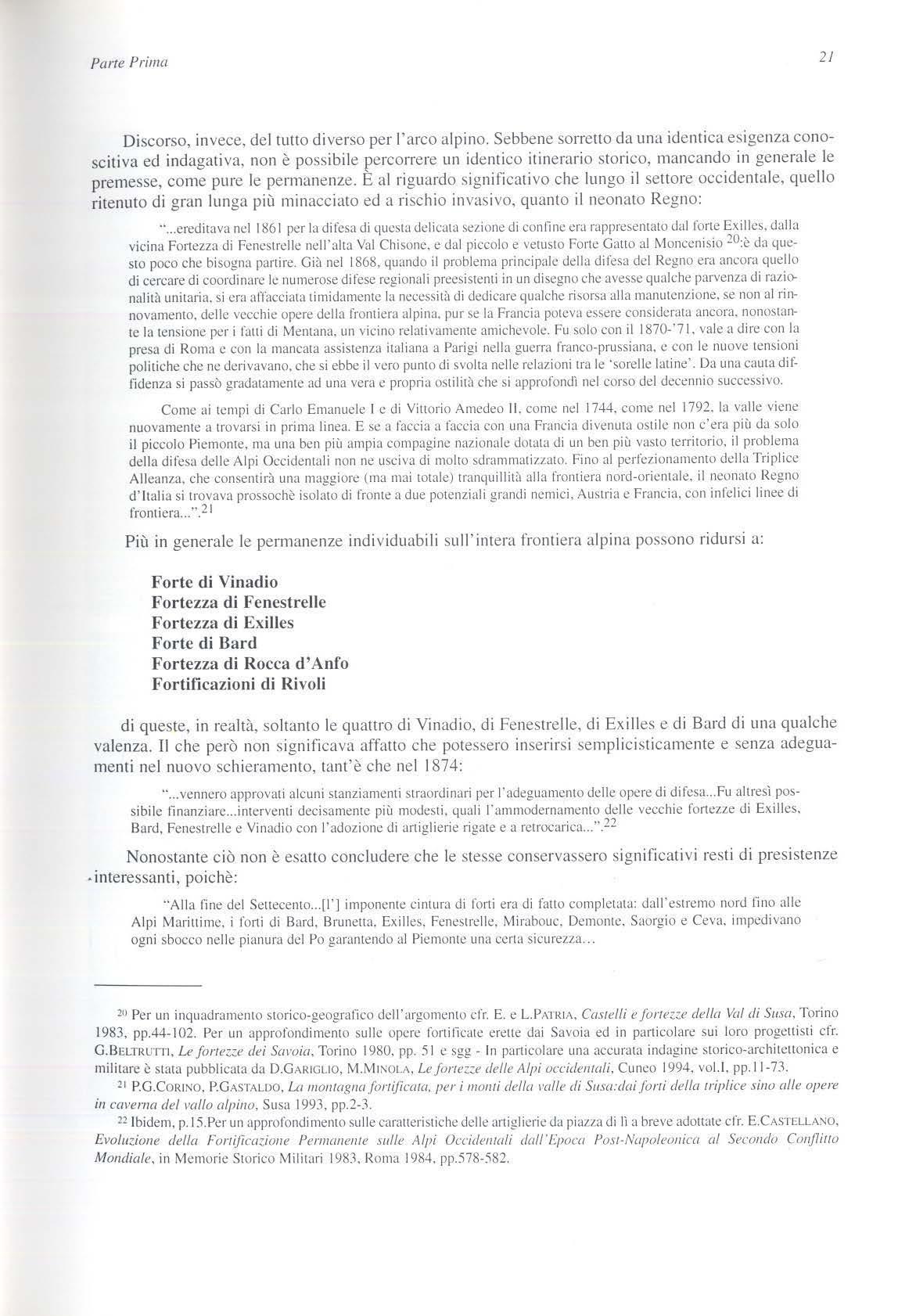
Parte Prima 21
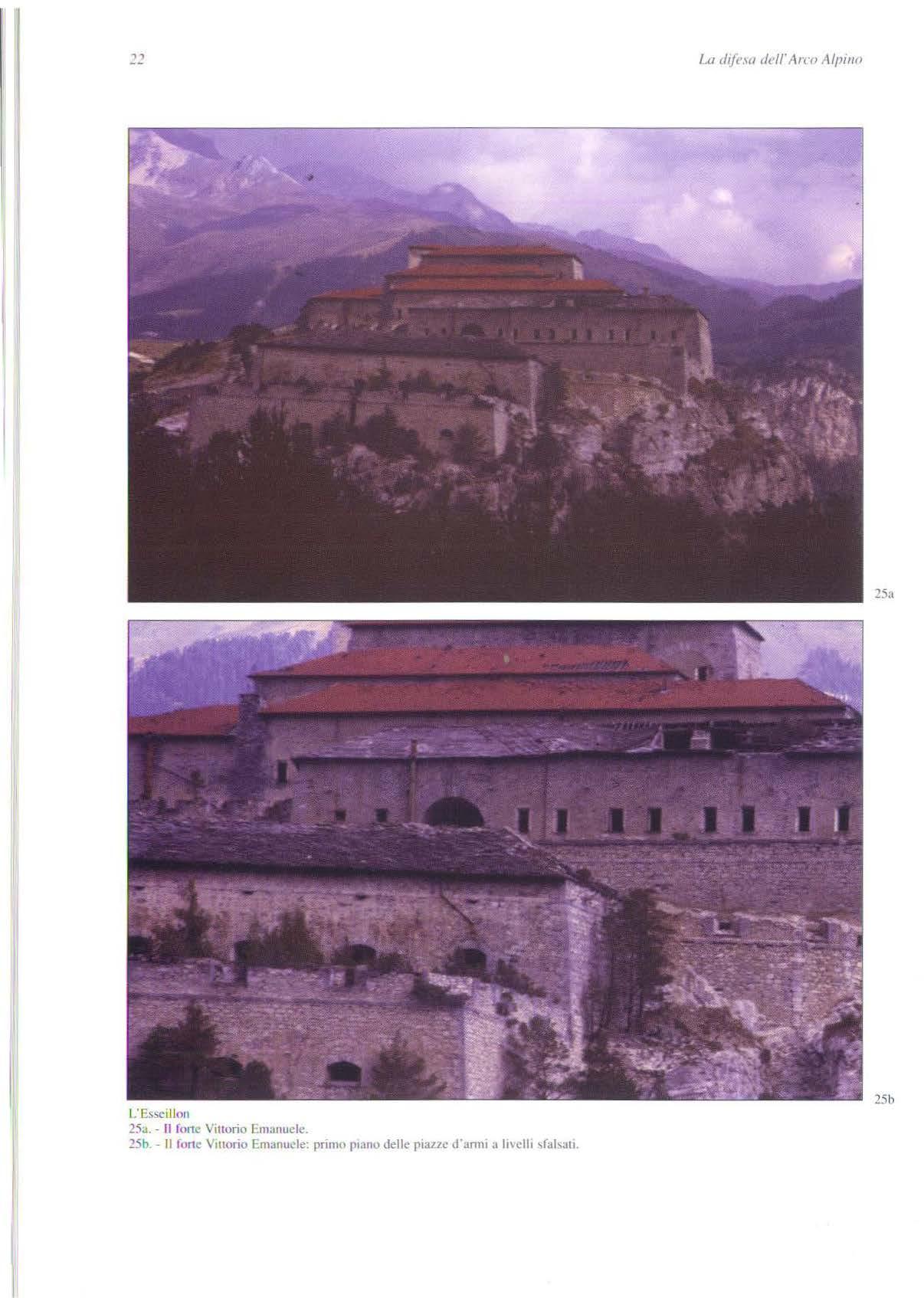
La d!f<'.111 dell'Arco Alpino 25a 25b L' fase 11lon 25 a. - Il fo nc Viuorio Emanude. 25 h - li Io ne Vmorio Emanuele: primo piano delle piane d'anni a 11,clli ,fabati
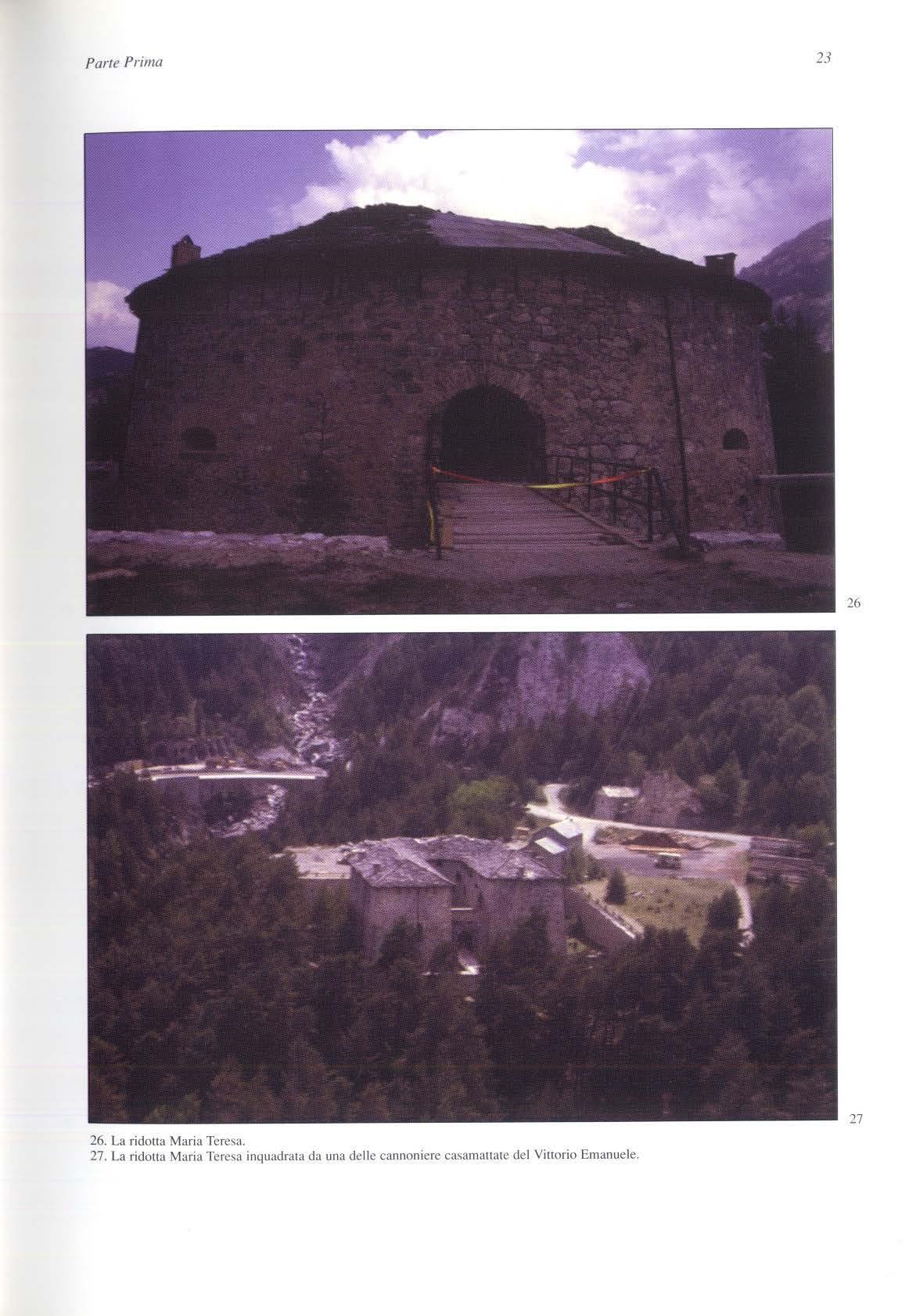
Parre Prima 23 26 27
26. La ridona Maria Teresa.
27. La ridotta Maria Teresa inquadrata da una de lle cannoniere casamawue del Vittorio Emanuele.
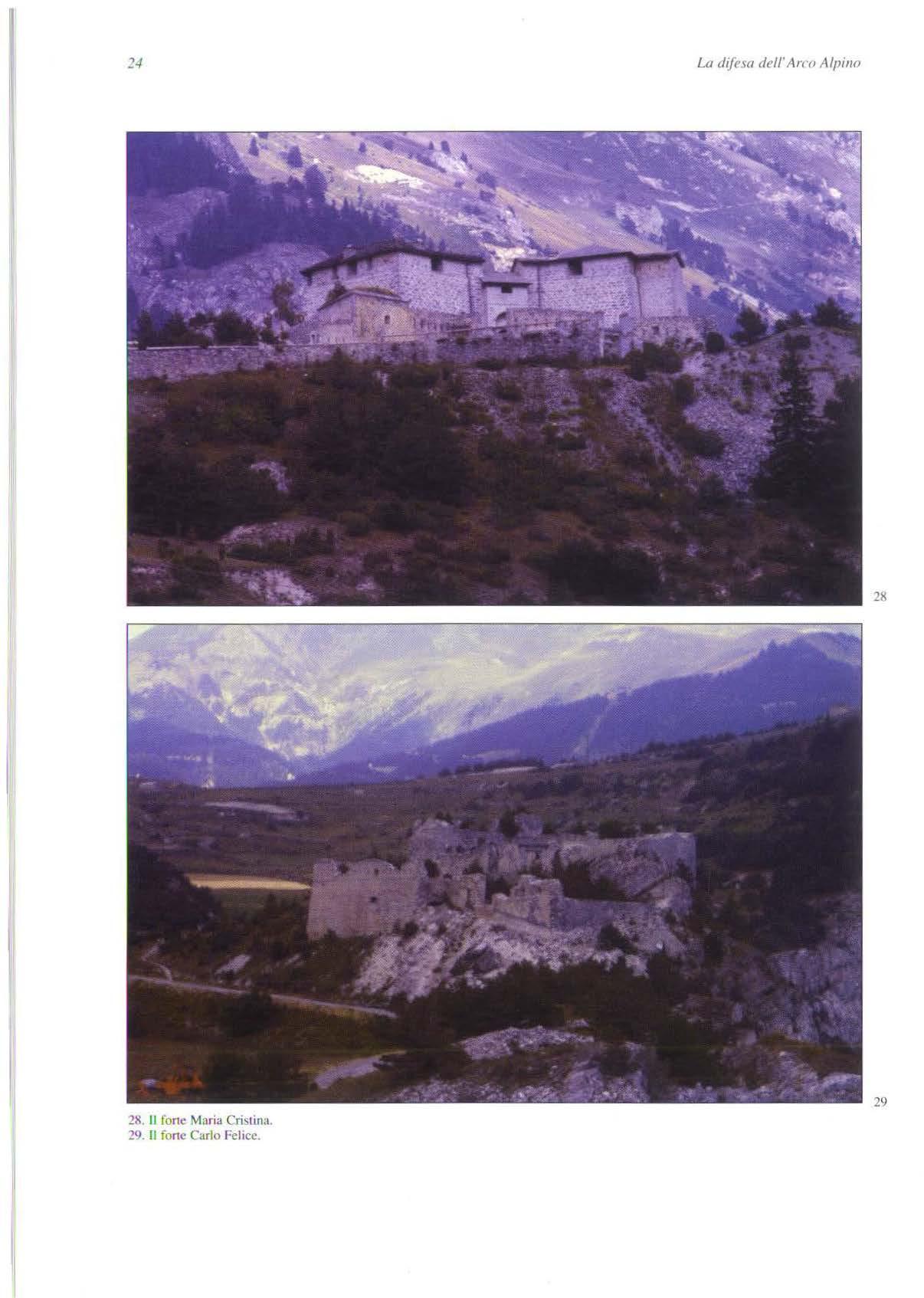
24
2&. Il fo rte Maria Cristina.
La difesa Alpino 28 29
29. n fo rte Carlo Felice.
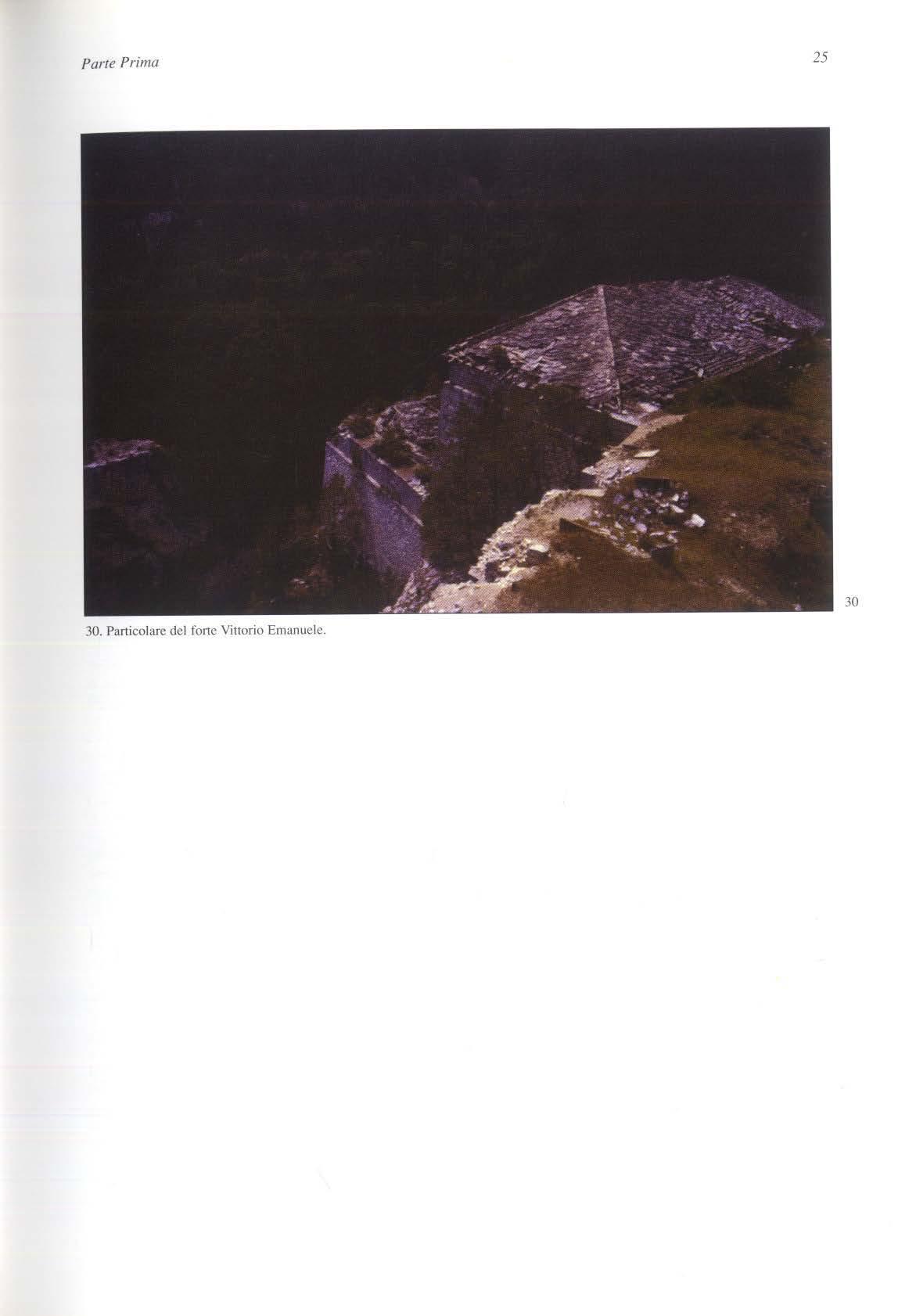
Parte Prima 25 30
30. Particolare del fo11c Vittorio Emanuele.
Con lo scontato rovescio sabaudo nella guerra contro la Prima Repubblica Francese, il Tnlltato cli Parigi del 15 maggio 1796 c il successivo dern:to dd primo console >lapolcone Bonaparte del 23 giugno 1800 imposero la demolizione c lo smantellamento cli tulle le forcezze alpine elci Pjemonte. Di tutto l'esteso complesso cli opere settecentesche si salvò solo il Forte di Fenestrelle, che trovò un razionale impiego come prigione di Stato
Negli anni 1830-38 vennc ricostruito il Force di Bard
Verso la metà del XIX secolo la vecchia cin1ura dei forti poteva dirsi tornlrnente ripristinata Bt:nchè più recenti di almeno un s<::colo. le opere di sbarramento non apparivano sostanziai mente dissimili dai forti ~eueccntcschi che le avevano pn::ccdute. dei quali condividevano il medesimo concetto ispiratore ". 2 3
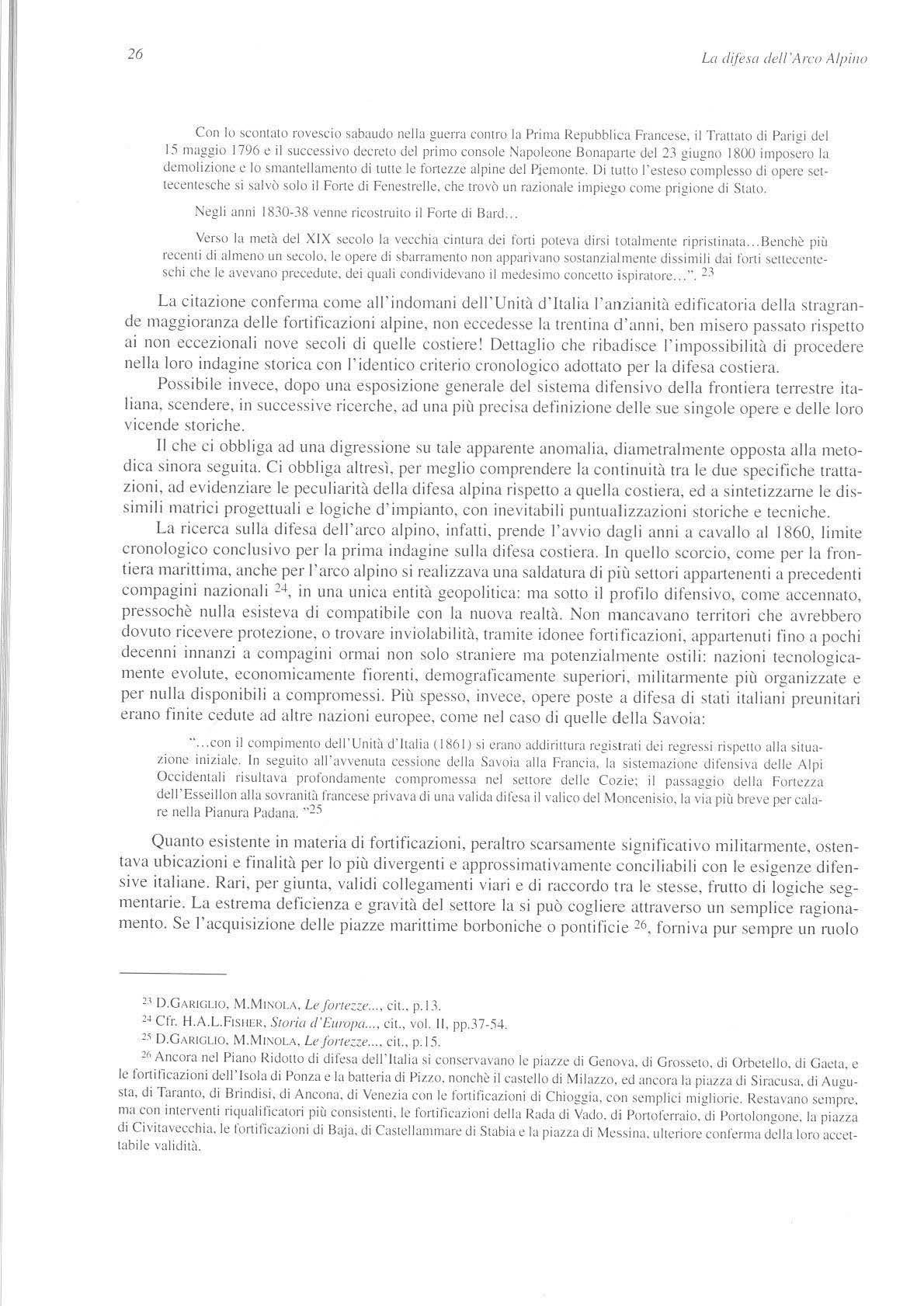
La citazione conferma come all'indomani dell'Unità cl' Italia l'anzianit~t edificatoria della stragrande maggioranza delle fortificazioni alpine, non eccedesse la trentina d'anni, ben misero passato rispetto ai non eccezionali nove secoli cli quelle costiere1 Dcuaglio che ribadisce l 'impossibilità di procedere nella loro indagine storica con l'identico criterio cronologico adottato per la difesa costiera.
Possibile invece, dopo una esposizione genera l e del sistema difensivo della frontiera ten-estre italiana, scendere, in successive ricerche, ad una più precisa definizione delle sue singole opere e delle loro vicende storiche.
TI che ci obb li ga ad una digressione su raie apparente anomalia, diametralmente opposta alla metodica sinora seguita. Ci obbliga altresì. per meglio comprendere la continuità tra le due specifiche trattazioni, ad evidenziare le peculiarità della difesa al pina rispetto a quella costiera, ed a sintetizzarne le dissimil i matrici progettuali e logiche d'impianto, con inevitabili puntualizzazioni storiche e tecniche.
La ricerca sulla difesa dell'arco alpino, infalli, prende l'avvio dagli anni a cavallo al 1860, limite cronologico conclusivo per la prima indagine sulla difesa costiera. ln quello scorcio, come per la frontiera marittima, anche per l'arco alpino si realizzava una sa ldatura di più settori appartenent i a precedenti compagini na zionali 24, in una unica entità geopo liti ca: ma sotto il profilo difensivo, come accennato, pressochè null a esisteva di compatibile con la nuova realtà. Non mancavano territori che avrebbero dovuto ricevere protezione, o trovare inviolabilità, tramite idonee fortificazioni, appa11enuti fino a pochi decenni innanzi a compagini orma i non solo straniere ma potenzialrneme osti li: nazioni tecnologicamente evolute, econom icamente fiorenti, demogratìcamenre superiori, militarmente più organizzate e per nulla disponibili a compromessi. Pii:"t spesso, invece. opere poste a difesa cli stati italiani preunitari erano finite cedute ad altre nazioni europee, come nel caso cli quelle della Savoia:
con il compimento <..lell' Unità cl' I talia ( 1861) ~i crano addirillurn registrati dei regressi rispcllo alla situnzionc inizialc. In seguito all'avvenuta cessione della Savoia al la Francia. la sistemaziom: difensiva delle Alpi Occidentali risultava profondamentt: compromessa nel sectore delle Cozie; i l passaggio ddla Fortezza dell'Esse i llon al la sovran i tà francese privava di una valida difesa il valico del Moncenisio. lo via più breve per calare nella Pianura Padana 25
Quanto esistente in materia di fortificazioni, peraltro scarsamente sig nifi cativo militarmente, ostentava ubic azion i e finalità per lo più divergenti e approssimativamente conciliabi li con le esigenze difensive italiane. Rari, per g iunta , validi collegamenti viari e cli raccordo tra le stesse, frutto di logiche segmentarie. La estrema deficienza e gravità del settore la si può cog li ere attraverso un semplice ragionamento. Se l'acquisizione delle piazze rnarinime borboniche o pontificie 26, forniva pur sempre un ruolo
D D GAR1c;uo, M.M1r-:01.,\, Le fone::.::.e cil p.13.
2-1 crr. H.A.L.F!SJJL'R. SIOrio d'Europa cir., vo i. Il. pp.37-54.
21 D.GARJGLJO, M.MINOLA, Le forte:;.e , cit.. p. 15.
26 Ancora nel Piano Ridouo di difesa dell'Italia si conservavano le piaLLe di Gernwa, di Gro~sew. di Orbetello. di Gaeta, e le fortilìcazioni dcli' I sola di Ponza e l a ba tt eria di Pin:o. nonchè il castel l o d i Milazzo, ed ancora l a piazza di Siracusa. di Augusta, d i Taranto, di Brindisi. di Ancona. di Venezia con 1c fonificnzioni di Chioggia, con semplici miglioric. Restavano sempre. ma con intcrven1i riqualificatori più consistcnti. le ronilkazioni della Rada di Vado. di Portoferraio. di Portolongone. la piazza di Civitavecchia, le fortitkazioni di Baja, d i Castel l amman:: di Stabia e la piazza d i .'Vlcssina, ulteriore conferma della loro acci.:ttabilc va lidit ì1.
26 La difesa dell'Arco Alpino
coerente ed utile ne ll 'ambito della nascente difesa marillima nazionale. essendo in defi niti va im mu t ata la loro ubicaz i one lun go la frontiera marittima e l a visione strategica mediterranea, no nc hè l'esposizione del territorio alle iniziative cli sbarco nemiche da esse comunque stornate, nulla di simile appar i va attribuibile al l e poche opere sparse sulle propaggini alpine assolutamente inadatte all e necessità difensive imposte dalla sa l vag uardia di un confine di recente tracciato, ed ancora in molti punti in attesa di una ulteriore e indi sc utibil e definizione. Nè peraltro os tentavano l a benchè minima utilità al riguardo le molteplici opere su l territorio italiano, un tempo d i sl ocate lungo l e linee di confine interne tra i sin go li stati preunitari. E non era purtroppo tutto. Proprio in quei medesimi anni l a tec no l ogia militare. e per essa in pat1icolare l 'artiglieria, manifesta un vistoso balzo in avanti che poneva fine alla sostanzia l e stasi evoluti va che l 'aveva contraddistinta dalla metà ciel '500 27. Il che ovviame nte trovò immediate rip ercussione sull 'intera produzione arc hitet to ni ca difensiva es i stente\ pateticamente inadatta a sostenere l e potenziate offese bal isti che, inimmaginabili nella loro vio lenza appena un decen ni o innanzi:
, n poc he dec in e d'an ni peri) le an iglieric compirono not..:vo li prog res~ i tecnici. I cannoni ad anima rig:ll;1, c he avçvano 1·auo l a compar~a nelle e:impagnc d' llalia dt.:I 1859-60. non l ardarono acl esseri.: g r adua l mentt.: adollati eia tutti gli es..:rciti curopc:i. Con la ri gat ura de ll e bocch..: eia fuoco si po tè abbandonare la tip i ca pa ll a !>l'erirn p..:r dare al proietto l a fo r ma ogiva l i.:. riuscendo così acl accresccrn..: il p..:so e l a l'o r ta i nizia l e e rcnclc ndone pit1 stabile e precisa l a traiettor i a. li ti ro, oltrç ad e~sere piti esauo ..:ci efficace. au mçnwva notevo l ment..: la stw g iu ata. co nsemendo di lx111ere le con i ne cl:l una di~ta n, a prat i came rll e Joppia d i que ll a fino ad allo ra possibik con lt: anigl i er i e ad ani m a l iscia.
L'aJo, i one <k ll a retrocarica. naturale co ns..:g ucnza de ll a rig:Hura e del perfezionami.:nto Jelle bocch..: da fuoco. aveva reso più edere l.1 cade nLa di tiro. In sostanza si potevano colpire. con una forza maggiore di quanto si faceva al tempo delle :irtig.lieri..: lisce. bersagli v i sibil i con t iri diretti od areati. rna si ouenevano anche Otti mi r isult::t ti col tiro inclireuo. quando il b..:rsag l io non era \'ÌSib il e perchè posto :1d u na notevo l e distanza dallo ~chierarnento de i p<!zz. i.
Era inev it ab il e che. alb luce de lle 11u0vc scoperti:. il \ecc il io sistema di fonilkaz i oni.: fo,se cornplctami:nti: da rivedere i.: da mig li ora re 28
Ed anche in questo caso, a differenza del fronte marittimo, se nza dubbio espos to alle artiglierie di analoga concezio ne, ma affe tt e al pari delle loro antenate dalle in sopp rimibili imprecisioni di punteria
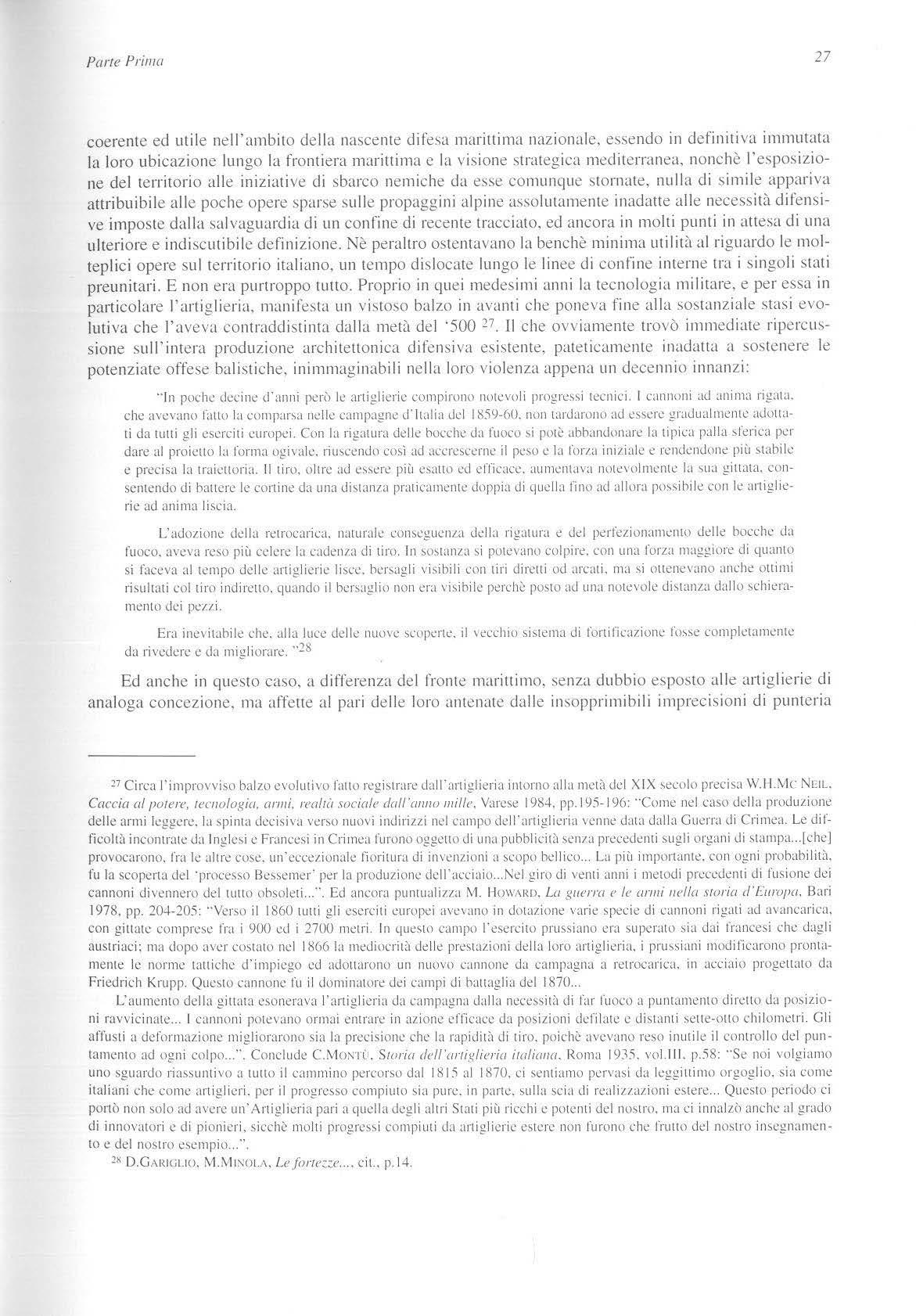
27 Circa l 'improvviso balzo evolutivo l'alto reg i,trare da ll ' an i glieri a intorno all a metà dd XI X ~eco lo precisa W.11.\!Jc NuL. Caccia (I/ potere, 1ec11ologia, armi, realuì sociale dal/ 'w1110 m ille. Varese 1984. pp.195- 196: Come nel caso della proci u, i oni.: delle arm i kggeri.:. l a sp int a di.:cisiva ver~o nu ovi indirizzi nel campo d..: ll' art i glicria venne data dalla Guerra d i Cr imea. Le d i fficollà incon trate da Inglesi ç Fra nc<.:si in Crim ea furo no oggetto cli una pubb l iciti1 scn,a p rt.:cedenti sugli o rga ni di stampa [che] p rovocarono. fra le ali re cose. u n 'ecceLionale fioritura d i in1 enzio ni a ~copo bellico La p iù i mponante. co n ogn i probabi l i t à. fu la scoperta del ·processo Bessemer' per la produzione ddl'acciaio Nel g i ro di vem i anni i me1odi pr.:cçdenli d i fusio ne di.:i ca nnoni divennero del tu lt o obsoleli ". Ed ancora pun tualiua M. HowARD, La guerm e le wmi nella sroria d't..'wvJJa Bari I 978, pp. 204 - 205 : Verso il 1860 tu lli gli es..:rciti ..:uropi.:i avel'ano in do t aL i one varie specie d i can noni rigat i ad avancarica. co n gillate comprese fra i 900 ..:d i 2700 rn çtr i. I n questo ca m po r eserc i to p ru ssiano era superato sia dai rrnncesi chi.: dagli aust ri ac i ; ma dopo aver costa to nd 1866 la medio cr i tà delle pres t:llion i della l oro artiglieria. i prussiani modificarono p r on tamente l e norme tatt i chi.: d'impiego cd ado 11arono un nuovo cannone d a campagna a retrocririca. i n acc i a i o p roge tt at o da Friedrich Krupp. Questo ca nnone f u i I dominatore dei campi d i ba t taglia del I 870
L'aumento della gittata eso nerava l' artig l ieria da campag na dall '1 ni.:cessitil di far ruoco a punrnmento dirt.:tto da pos i z i oni ravvic in ate I cannoni potevano o r mai emra re in az i one effi cac..: da posizioni ddi l aii.: i.: dis1an1i se ll e-0110 c hi l omel ri. Gli affusti a deform azio ne m igliorarono sia la p recisione eh..: l a rapidità d i tiro. poiché: avevano reso imrr i le il con trol l o dd puntamçnto ad ogn i colpo ". Concl ude C.Mot-:·1 r:1• S1oria del/ 0 (11'/ig/ieriu iwlimw. Roma 1935. 1·01.111. p.58: "Se noi vo l g iam o u no sguardo r i:is~ umivo a 1uuo il cam min o percorso dal I 8 I 5 al 1870. ci sentia m o p..:rvasi da l eggi uirn o orgoglio. sia co rn <.: i ta li ani chi.: co m e arti g l il.!ri. per il progresso co mpi u t o sia purt.:. in pani.: sulla sc i a di realiZ1.aL i on i esrere Questo per i odo ci portò non solo ad avere un · Artiglie r ia pari a qudla d..:g li alt ri Srati più r i cchi e poten ti del nos tro, 111a c i innalzò anc he a l grado di innovatori e d i pio nil.!ri. sicchè m o lt i progr..:ssi comp iu ti dn artig l ieri e es te ro; non ruro no c he fru t to del nostro in segnamc nlO e del nostro esempio .''. 2~ D.GAR1c;uo. M..\11:-:01.A, Lefor1e:;.:;.e c it. , p. 14
Parte Pri111a 27
prod o tte dal 111010 ondo so 29, le conseguenze appari va no not evo lmen te più stravolgenti. Una opera realizzata agli inizi dell'800, nella seco nda metà dello stesso secolo non offriva più alcuna seria garan,ia di re sis tenza ed alcun valore di deterrenza, trasformandosi perciò paradossalmente in una sorta di indicatore di co modo acces so. e in trappola mo rtale per i difensori. E se controbbatterc iI fu oco di bordata di una moderna nave da guerra riusciva ancora :,uscettibile di significati, i succe,.,i anche per batterie terrestri postate all'interno di forti superati. ,ia per l'ampiezza del bersaglio, sia per la sua intrinseca fragilità, il discorso si ribaltava completame nt e nel caso di forti a terra inv es titi da un cannoneggiamento effettuato con pezzi m ode rni. rigati e con proietti ogiva li La stessa ipotesi inrnsiva da mare. come accennato, non presentava ri spcno a l passato sostanzial i progressi, cos titu endo nonostante J'm vento dell e unità a vapore una procedura estremamente co mple ssa, rischio sa e comunque di sca rsa ril eva nza militare, ostata facilmente non so lo dagli apprestamt:nti difensivi, ma forse e !->Oprattutto dai fattori metereologici e climatici.
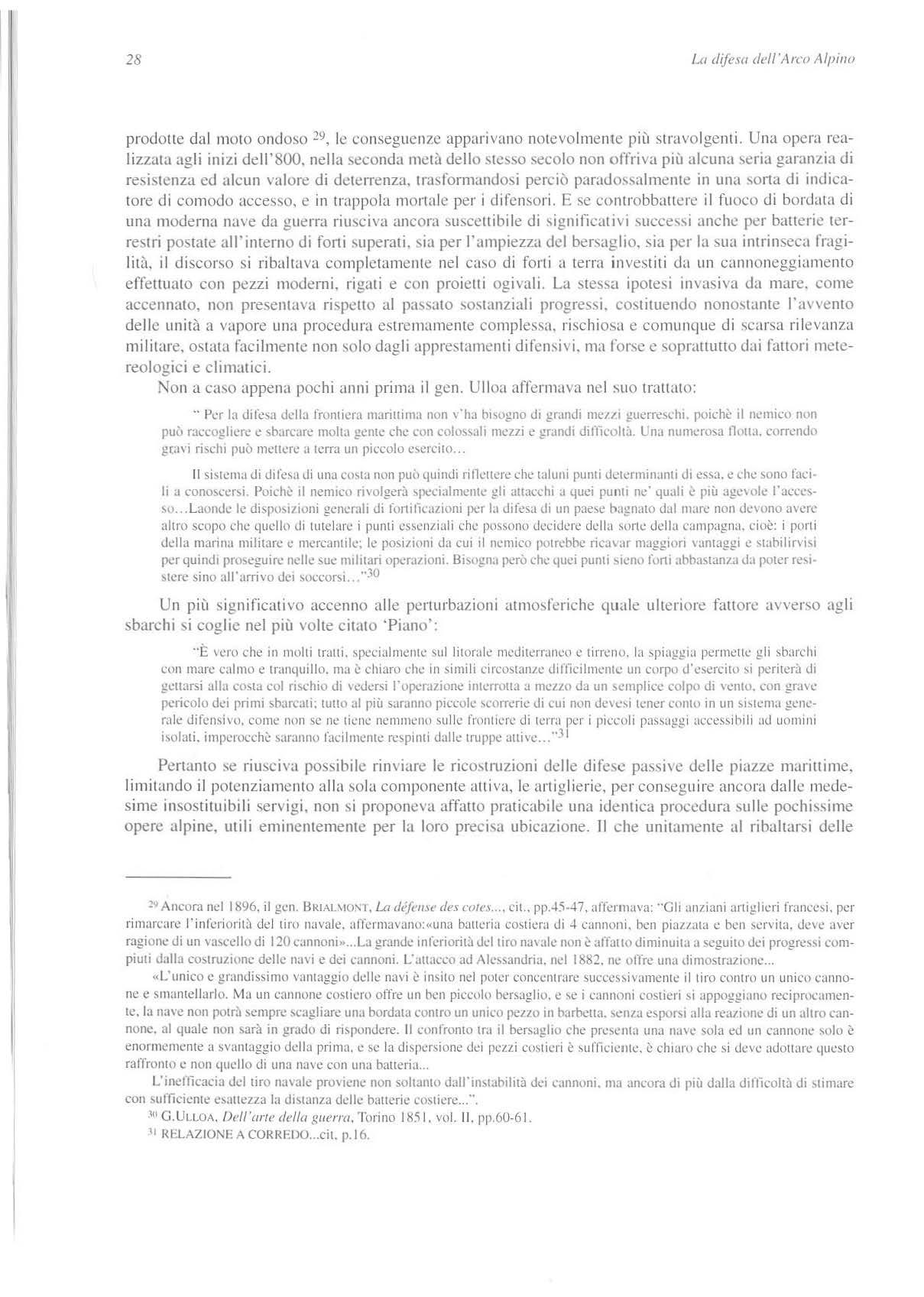
Non a caso appena pochi anni prima il ge n. Ulloa affermava ne l :suo trattato:
Pcr la difesa d..:lla fron1icra mariuima non , "ha hi,ogno d1 grandi me111 guem•sch1. poichè il nemico non può raccogliere e sbarcar..: molta geme che con colossali mezzi e grandi difficnlt/1. Una numerosa floua. correndo gr,a, i rischi può mene re a terra un piccolo esereiw
Il siMema di d ifes,t ùi un a cosi.I no n pUll quindi rillene rc c:he talun i punti dl..'terminanti ùi essa. e d1e sono fal·i · li ,l conoscer,i. Poichè il nemico rivolgerà ,pccialmente gli auacchi .i quei pu111i ne· quali i: più agevole l'accessll Laonde le dispos111oni generali di fortificazioni J>t:r la difesa d1 un paest: hagnato dal mare non de,ono a\'ere altro scopo c:he quello ùi tu te la re i punti esscn,iali c:he possono dccidc rt: dcll a sorte della l',H n pag na. cioè: i port i dclla marina militare e mercantilc; le posi11oni da cui il nemico p111rebbe rica\'ar maggiori ,antaggi c siabilir\'isi per quindi proseguire ncllè sue miliiari opcrationi. Bisogna però che quei punti ,ieno forti .ihhastan,a ùa poter n.'s1 stere sino a li ' arri,o dei so<.:corsi 3o
Un più s ig nificativ o accenno a lle perturbazioni atmo!->feriche quale ulteriore fattore avverso ag li sbarchi si cog li e nel più volte citato 'Piano':
"È \ero c he in mo lt i tra il i. specia lm ente su l litorak: me d iterraneo e t irreno. la :.pia ggia permellc gli sbarch i <.:(lll mare calmo e tra nquillo ma ì: chiaro che in sim il i circostann: diffici lment.: un corpo d'e~ercito si periterà ùi ge11arsi alla costa <.:ol mchio ùi ,eJersi l'opèrazione in1erro11a a meno da un semplice colpo di \enlo. con grave pericolo cle1 pnmi sbarcati; lllllo al più saranno p1<.:cole scorrerie ùi cui non de1cs1 tener conto in un 5btema generalè dife nsivo. come non se ne tiene ne mmeno sulle frontiere di terra pe r i piccoli pas sagg i acces sihili ad uom in i isolati, impcrocchì: saranno fac il mente n.:spinti dalle tru ppe auive " 1 1
Pertanto se riusciva possibile rin viare le ricos1111zioni delle difese passi, e delle piazze marittim e, limitando il potenziam e nto alla so la comp o nente attiva, le arti g lierie, per conseguire ancora dalle medesime in sos tituibili se r v ig i, non s i proponeva affatto praticabile una identica procedura su ll e pochissime opere alpine, utili em in e nt e ment e per la loro precisa ubicazione. Il che unitamente al ribaltarsi delle
2" An<.:0ra nel 1896, il gen. BRIAL\10:S. 1. La d~fi.·me des core.1 , cit.. ppA:\-47 affc n nava: "Gli anz iani a rt iglie ri franl'esi. per riman.:are l'in feriorità del Liro navale, afl'ermavano:«una baueria costiera ùi 4 cannoni. ben pia11,1w e ben servita. deve aver ragione ùi un vascello cli I :?O cannoni» La grande ini'eriorità <lei tiro na,ale non t: affollo diminuita a ~eguito <lei progre~si compiuti dalla co~tru1ione delle navi e dei cannoni. L' auacco ad ,\lc~~andria nel 188:?, ne offre una d1 mostrai ione
«L'unico e grandissimo vantaggio delle navi è in sito nel poter concemrnre successivarnenti.: i l tiro co ntro un uni co c.:a nnonc e smamellarlo. Ma un cannone costiero o ffre u n ben piccolo bersagl io. e se i cannùni cos ti eri si appoggiano reciproc:arne nte. la na,e non potrà sempre scagliare una bordata contro un unico pe7Zo in barbcua. sl.'nza espor~, alla rea11one di un altro cannone, al quale non sarà in grado cli rbponùere Il confronto tra il ber~agho cht: pre~ema una nave so la ed un cannone solo è enormemente a ~vantaggio della prima, e se la dispersione <lei pezzi costieri è sulTi ciellle. è chiaro c he si dcve adollarc que sto raffronto e non quello di u na na\'e con una ba ueria
L'inefficacia <lei tiro na, aie pronene non soltanto dall'instahilità dei l'annoni. ma an<.:0ra ùi più dalla ùillicohà ùi stimare con sufficiénte t:sancua la distanz.a delle batterie cos tiere...".
-'0 G.ULLOA. /)c/f 'ane della g 11erra. Torin o 185 1. voi. Il. pp.60-61.
11 Rl::LAZIONE A CORRF.DO cit. p. 16.
28 La ci(feso dell'Arco Alp ino
potenzialità invasive, non più supponibili da mare ma prioritariamente e motivatamente da ten-a, ovvero da nazioni europee tecnologicamente evolute, non consentiva alcun tentennamento nella edificazione ex no vo di un sistema difensivo continuo, con la atavica scarsità di mezzi disponibili.
La configurazione dell'arco alpino, solcato in senso meridiano da numerose valli, in prima approssimazione convergenti verso la pianura padana, lo rendeva pai1icolarmente idoneo ad un attacco con direttrice nord-sud, garantendo più imbocchi cd un finale concentramento delle forze. Improbo invece il contrario, ostaco l ato per giunta dalla maggiore ripidità dei contrafforti sul versante italiano: e la penalizzante connotazione si adattava mirabilmente alla logica degli eserciti nazionali 32 disponenti di immense masse cli armati divisi in altrettanti corpi di manovra:
Quasi tulle le comunicazioni stradali e ferroviarie convergono nel versame italiano verso centri di aurazione ben definiti. quali Torino. Milano. Verona. Udine e divergono per contro fortemente allra\'ersando le Alpi verso l'esterno. Questa circostanza. unita a quelle git, viste della differente profondità delle Juc zone sedimentarie e della scarsen:a dei solchi longitudinali nel versante interno. mentre essi sono rclativamcrue numerosi nel n:rsantc e~terno, conferiscono a caratterizzare le operazioni mi lit ari che si svolgono attraverso le Alpi nei due sensi: rapida convergenza di l ince di operai.ione e maggior facilità cli coordinare le operazioni stesse quando si svolgano ollcnsivameme dall'esterno verso l'interno. Le masse ddla difesa in qucslO caso si ~postano con maggior.: difficoltà. Per contro operazioni offensivi: proc.:dcnti dall' int erno verso l'esterno di\'ergono profondamente: la difesa ha buon gioco nella facilità degli spostamenti e nella succcssivitil di.:llc lince. ·<l:ì
In altri termini il teatro difensivo terrestre mostrava la sua assoluta dissimetria e la sua temibile inadeguatezza alla radicale rivoluzione tecnologica della seconda metà del XIX secolo, specie militare, generando la conclusione che nulla del poco esistente poteva utilizzarsi ulteriormente nella sua condiz ione originaria.
Adottare pertanto l'identico criterio indagativo proprio dei saggi sulla Difesa Costiera, in questo contesto appare non solo ozioso ma anche assurdo, essendo lo schieramento, scaturito dall'esigenza difensiva, sintesi di coeve concezioni e cli coeve strutture, o delle poche opere superstiti radicalmente trasformate. Nuova esigenza, nuova concezione, nuova ubicazione nella stragrande maggioranza dei casi quindi, e nessuna significativa permanenza. Il che ribadisce la necessità cli una limitazione cronologica assol utamente antitetica al l e precedenti ricerche relative alla difesa delle frontiere marittime. In dettaglio ci sembra possibile far rientrare le accennate divergenze di studio in due grossi ambiti teoretici: il primo inerente alla inesistenza cli preesistenze per motivi di matrice geopolitica, il secondo per la prioritaria necessità di aggiornamento tecnologico delle opere alpine. Il che comporta un successivo approfondimento sulla natura dinamica della frontiera alpina, e sulla radicale rivoluzione scientifica materializzatasi verso la metà del XIX secolo.
Per meglio cogliere tutte le accennate diversificazioni, e soprattutto per meglio cog li ere l e articolazioni strategiche che condussero alle scelte illustrate nel volume ci sembra indispensabile premettere ulteriori approfondimenti sulla peculiarità della difesa dell'arco alpino, in ogni sua parziale connotazione.
Considerazioni generali
La singolare anomalia geografica che caratterizza la penisola italiana è stata costantemente ribadita da tutti gli analizzatori geografici e politici. A nessuno di essi infatti è sfuggita la divaricante diversificazi o ne tra la componente continentale e quella peninsulare del suo territorio, origine di altrettante spe-
32 Su ll a genesi e sviluppo della coscrizione obb lig atoria, alle spalle degli immensi cs.:rciti nazionali. cfr, V.ILARI, Swria del servizio 111ililare i11 !wlia ( /506-1870), Roma 1989. vol.J, pp.195-209.
J i ENC ICLOPEDIA M ILI TARE. alla voce 'Alpi'. p.435.
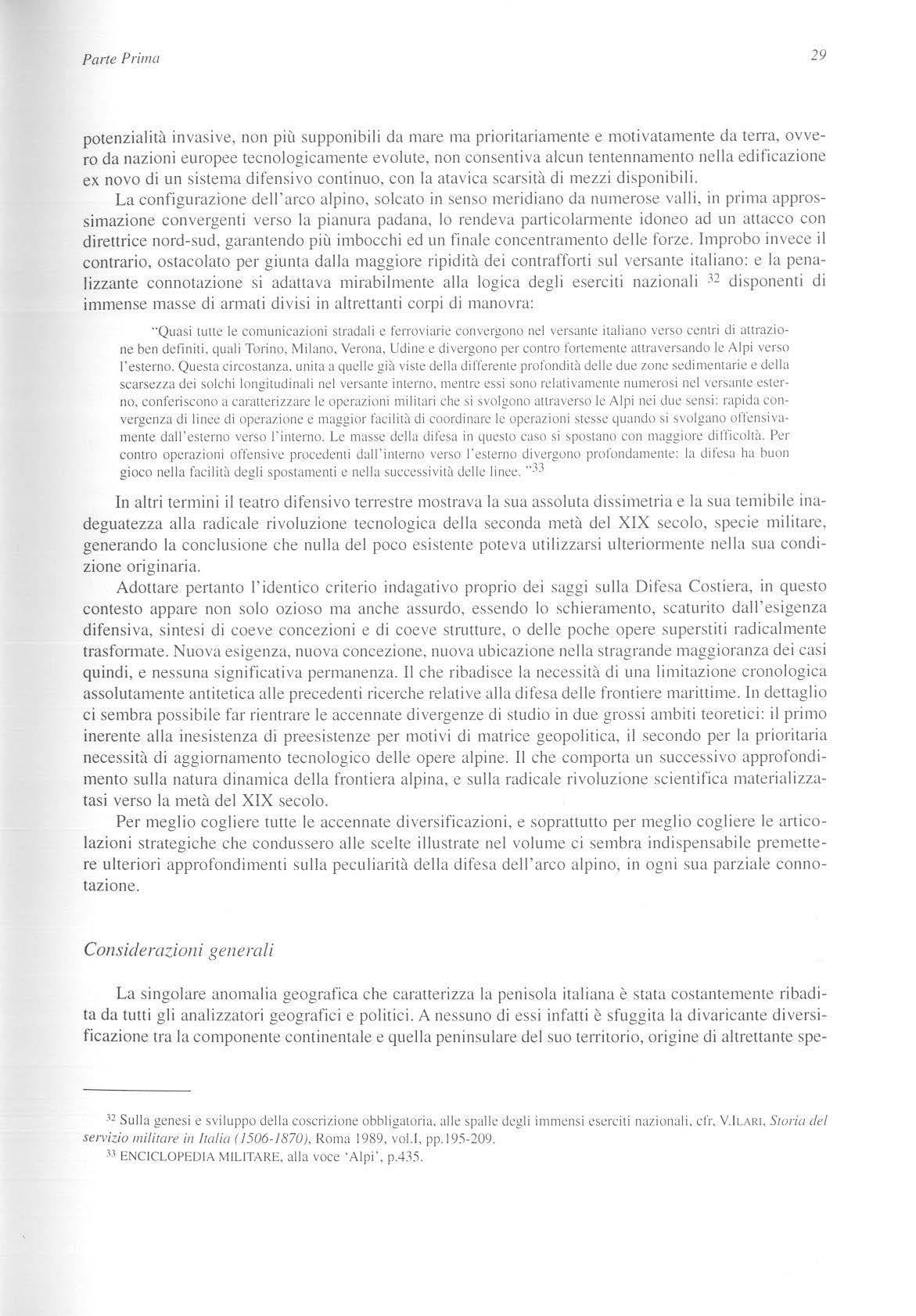
Parte Prima 29
c ifiche vocazi o ni integ r ati, ·e e difen~i\ l! <li im proba se no n i mpm,-, i b i le com posizio ne. Pe rt a nt o. la neocos titui ta naz i one:
" si tro\'Ù hèn pn:, tLl a fan: i conti c11 n una ,pccic Ji ma,·d1i:m:lli,mu geografico pt'rl'hi: il po,,ù,o Jci, aill'h1 alpini t' 1.klla pianura paJana [la) h:ga, :1110 al Ccmro-Etmipa. mcntrc Juèmila t'hiloml'lri Ji coste pcnin,ul:1ri ... l la ] c hi udcv:rno nd l\ lcJ it erranco.
Si trauì1 Ji Juè politiche bcn distinte. i:iasl'una l'Un proprie traJi,ioni ,corichi: L' con pr1 1pri.: ..:sig..:n,è strat..:gkh..:. La pnma s'idcnt1fKa,a con 4u..:lla Jc1 San11a. Lh..: per M:coli èrano ,Lati 1 ·nbtoùi' Jdk ,\lpi. cioi:' i nmt roll or i dcg li in g ress i alla pi a nu rn pada na d.i un lat o ..:d ,1lla va ll a t.i dd Roda no d a ll'a ltro : i l dlL· pe rrlli \L' loro scconJ11 una fras,: di non tr11ppo èl..:gant,' gu,to del Dul'a 1:.manu,:le Flibcrto. J1 111ang1ar,i poni :1 plll'O ·i1 c.,rciolu italiano·.
Dopo 1· Ll nit:t nlla d in.: tt riL·..: con t in,·ma le ' si a ll ia ndi q uel la 111..:dit..: rranca'. in izia lmc nt,: sta t ica pen:h~ il lkgno dei Borhoni t"ra n,,trctto tra 'I' ai:41w '-Inta e I' ;tc4ua sal:lla·. ci o.: tra lu Stat11 pon11flu11 t'J il mar.: in mano altrui. l\ l a con il taglio Jell' istn w d i Suc,, il l\kditc rr aneo dl\..:ntò u na d..: IJ...: prinl'ip:1li \'il' d i traffico rn o nd 1ak n: rso i l co ntin e me nfr il',111 0 e q ul'i lo asiat il:11. p,:r c ui la po, iLio 111.: mediter ranea a,·quistò gr:1nd<! J i11a111i,mo.
La probkmatica 1talinna d1,..:ntù sub1111 comple".1. La partl' ,è1tcntno1uk del pal'~è. quella che ,i .ippr..:,ta,a a d il..:n tar.: il lu tu ro tr i:1 11 go lo in dus tr ia le. M kg i> sem pre' J i p iù con le rl'g io ni cl'nt 1\H.' L1l'O )ll'..: l' rn n il loro tk'M inu politico. La pa re ,: merid ionale era d ir..:ttame ntl' inlluenLata dalle òplnraz ioni <.: dalk conquiste ,1lricanc e dai \'enti dell'impcnali~nw Anch..: la ,u:i rl'lau, a dl'prl's,ione .:cunomica la ,pingc,a ,cr,o tra!_!u,irdi ambi,itl\i cd ilh1sori.
Il dibaltito in \,:1w all'opinion,: pubblka ~ullc due Jircllrid comrappu~ll' e sull:1 politu.:a ,:~tera Ja sn:gli..:rl' a ~ccomla delle l'ircos tan,e. fu contin uo e serrato un;1 ,p..:ck di d1.1lc 11 ira pl' rm, rnt.'nt..:. che , iJ,· alfonna 1si l' 1111>rirc pa r..:c d1i m iti.
Uno dd più re~1,tt.'mi fu quello che a"..:gna,a all'ltah,1 il l'tHnp1t11 Ji ·pontl'' 1er~o le l'o,c..: afril'anè e ,..:r,o l' O rh: ntc è u rop,·o. do,.: la lì nl' dcl l'i mp.:ro 011 0111,111 0 p ro,pc11a,a g ran d i pn~s ib ilit i1,: s u~c 11 ava non me no g ra nd i a p pl'l it i ". :i-1
11 du ali smo deg li inte re ss i , co mp o rt a\'a sul pi ano del la sicurez La naz i o nale un altrett anto l ace rant e d ual ism o dife rn, i vo, e~.., en<lo ev id ente c he i l fam oso ·po nte' po te va riu scire ap petibik. o co munqu e minacc i ato, si a <la i \il ed i terraneo c he dalle Al pi . cd il crc,ce re del ru ol o , 1ra teg i co <l i po-, i 7ione obb li gava a ten e re nel debito co nt o enlrambe le potenzial i tù neg ati ve N o n a cm o anc o ra d o po il 188 0 ~e ne t ro va ampia tracc ia:
" La tl'll\lOnl' tra 1· Italia l' la rra ncia 111111 mo~ tr a1 a segn i dr alk nt amcnto per q u 11 Ho riguard a , a i piani m ilic.ir i e nc ll ' ap r il,: del J 880 sia C r isp i che Ni cotc ra ritcnl'\:1110 che la g ue rr a sar..:b be sco pp iat a ..: 11t ro due ,111 11 i al 111:1,simo , cl luglio 1881 fu riunita una commb,ion,: sollo la prc,idenza di Luigi .\ le11al·apo J1'.'r ,:saminaro: il probll'ma di una fortilìcaz ion,· dd l'Jt alia con tro l'a u.JCco lranct's.;: tra i , uo i memb ri \i ,:ra Enrico C'oso: n,. che d ol'..:"1 essc rc nom inato Ca po d i s tato magg io re ddl' ese rc it o di lì a poco. Bc 11 prcs to i dU l' uo min i ,i se o mraru no s ui p..:r icoli di u no sbarco francese. Il Cos..:nz creJ,:l'a chl' la mrnaccia più gr:l\,: sareh t>l' giunta da uno sbarco ,ulla m Il'· radi ponl'ntc. la quale ,t, rebbi: potuto :.iwr.: un inlluo:111a d irc u a , ull,: pri1wipali op..: raL ion i m ilitari. l i k/l al'apo ris pose che i pc rieo li pro vo:n ic 111 i da l m,irl' era no ma gg iori d i qua nw gcn,•ra ln11.: 11te si c re d..:ssl'- p..:r ..:scm pi o , OL'l'llpata la Sicil ia il nèmico a,rcbb,: potulO riun1ni una forrn di '.!00.l)(X) uomini e port,ir..: la guo:rra ndla peni,ola. Il Co,..:111 non cr:1 con, i1110:«II gencral,: Cos..: 11 1 os,en a che per 11p..:r:1rl' in q ues to mti J o il n..:m irn Jowebbe imricg a rc mo lto tc mpo a tu lt o va nt aggio del la d ifcsa».
11 .\ leuacapo continua,a a pom~ l'acl'..:nto sui pericoli di ,barchi a sud ll 111 ToSL·ana. ma il Cosl'n, ..:ra ,os l<.:nu io dal 13<.'rtoli:-V ialc il q ua le so tt nl incal'a il hi sog no di migl iora re le t ru p pe e di lese Al pini:. Il Pian i:1 1 rit e ll l' \' ;J e h,: la g uerr a 111: ll e zo nc n1o ntuosc al'r,:b h<.: d m·uto ,:,,,:re protratta il più a lun gt> possibile e mt'l t..:l'a in..:, id..:nza un'altra ragione per qucst,t ta1tica : «c11nn1rre a rl'nJo:r,: prekribile p..:r noi la lott:i ndla ,ona nlpì-
14 G .1\ ,flREOn I Lt1pu li1irn cs/erll dd!t1pri111 a Re pubb lica con 1111 r1 icolllt<' rig ua rdo al/ 'es / e11 m 1wo e al/· U11io 11 e So1· ie1ica, in Conferc nLC, Cen tro Al ti S tu di per la Difesa X LVI SeS\ i,Hl e 199..i- 1995 coni' n' VI I. Roma 1995.
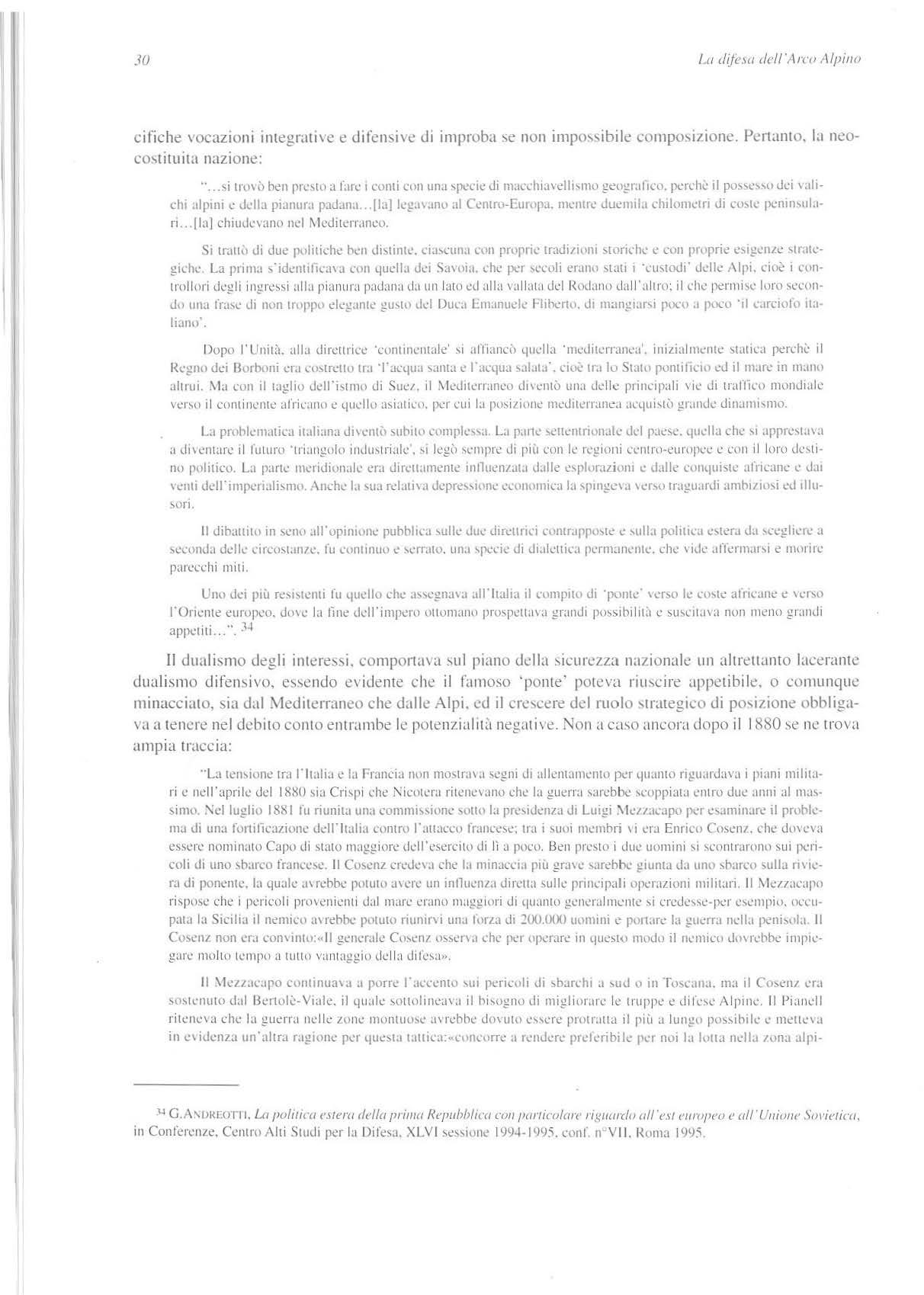
Il I 30 I.a d1feJC1 A lpin o
na il fatto che le particolari doti del nostro sold.ito lo rendono singolarmente appropriato alla guerra di montagna» ". 35
Ed ancora più in dettaglio circa i rischi di sbarchi:
"Poichè si riteneva che:: una rorLa di 60 o 70 mila francesi poteva sbarcare m.:gli ultimi giorni della mobilitazione italiana ed essere raggiunta entro otto o dieci giorni da una seconda forza di pari consistenza. il succ..:sso di tali operazioni si rivelava il pericolo maggiore che l"Italia pott:va correre in caso di gue::rra contro la Francia. pericolo più grande ancora di quello di uno sfondamt:nto delle difese :ilpine e continentali. in quanto tulle le dit't:sc preparate nella valle del Po sarebbt:ro state pres..: di ro\'escio e le comunic:izioni con la capitale ed il resto del paese tagliatt:.
Fortunatamente sbarchi di tali dimensioni potevano ..:ffettuarsi allora in uuc soli punti:la spiaggia di Viareggio ed il porlo e la spiaggia <li Livorno:la sistemazione difensi\a di qu..:sto tratto di l'rontiera marittima non si presentava perciò troppo ardua 36
Per quanto innanzi affermato, tuttavia, proprio grazie alla dissoluzione del!' impero ottomano e dei suoi satelli nord-africani, incrementandosi gli interessi, o forse i miraggi coloniali. scemò il rischio invasivo, almeno quello atavico, ampiamente trattato nei saggi sulla difesa costiera preunitaria. Il che unitamente ad una serie di altre considerazioni, prima fra tutte l'assoluta inadeguetezza difensiva dell'arco alpino, indusse a concentrare sulla riorganizzazione dello stesso la stragrande maggioranza delle scarse risorse.
E come il mare nel caso della protezione delle coste, anche l'impervio diaframma alpino impediva il diretto contatto tra le opposte nazioni. Ma sia l'uno che l'altro non potevano supporsi inviolabili, essendo innumerevoli, nel corso della storia, le invasioni del territorio peninsulare avviate dopo il loro superamento 37. Al massimo entrambi garantivano un vantaggioso ostacolo naturale, magari suscettibile di integrarsi con l'intervento ostativo dell'uomo al fine di conseguire la prefissata inviolabilità. Il che fu accuratamente prospettato.
Volendo ricorrere ad una immagine allegorica, l'opera di fortificazione progettata per proteggere l'intera nazione, se effettivamente realizzata nella sua massima proposizione, avrebbe dovuto consentire l'equiparazione dell'intero territorio ad una so11a di inattaccabile piazzafo11e marittima, con tre lati bagnati dal mare, dal quale poter ricevere costantemente merci e rinforzi in ogni traversia bellica ossidionale, e con il terzo saldamente ammorsato a terra, oppo11unità che, a sua volta, in caso cli blocco navale avrebbe garantito una insopprimibile identica funzione. Il concetto in sostanza fu perfettamente rece-
J~ J.Goorn. L'ltalio co111ro la Francia. i piani di guerra dìfensii·i ed ojfensil'i 1870-/914, in Memorie Storiche e Militari 1980, p. 160.

16 F.M1r-:NITI. // seco1ulo piww generale delle jill'l(fica~ioni studio e p1vget1i ( /880-1885), in Memorie Storiche..: Militari 1980. p. I 06.
J7 Riguardo alla l'in troppo agevole esposizione inva~iva del Piemonte. pr..:cisa :vi.VIGLINO I)' Av1Go. Forle::.::.e sulle Alpi, d(fese dei Scll'oia nella Valle S11tm di Ve1110111e, Cuneo I 989. p. I 5-17: "Ma è soprattutto nelle valli alpine del Piemonte che dall'inizio dell'ultimo decennio del XVI secolo il Ducato. sulla spinta degli avvenimenti bdlici, è costretto ad impe::gnarsi onde integrare ulteriormente il sistema difensivo territoriale con numerose nuove foneae.
Le truppe ugonotte avevano facile accesso dal Dellinato nella Valvaraita da dove::. altraverso S.impeyre alle terre del Ducato di Savoia non presentava più difficoltà di percorso
Anche la valle Scura risulta direttamente interessata da fatti di guerra, minacciata di invasione dal colle dcli' Argentera
Il problema della sicurezza rispetto alle invasioni ugonotte era grave anche nella valle di Susa, ove la fortezza di Exilles, in terra del Delfinato, costituiva la base per le incursioni nelle valli della Dora e del Chisonc
Solo l'intervento della Sp:igna, che teme l'instaurarsi di uno strapotere francese sulle terre ducali confinanti con i propri possedimenti- Franca Contea e Ducato di Milano-salvò lo Stato sabaudo dalla totale rovina ".
Parte Prima
31
pìto sin da ll' in i zio, e parzialmente anche perseguito 38 , ma la sua concretiZL.Ulione o~tenrava costi iperbo lic i ed asso lut amen te esul an ti da ll e effett i ve po tenzia li tà eco nomiche cie l Regno. Così l o st ig matizzavano alcuni attenti critici:
Riassumendo quanto dai mcno csigcnti in fauo di for111icaLione ~i crede indi!,pcn~abile noi vcdiamo che !,i vorrebbe:
I ° Chiuderc con forti tulle l e vie carretticrc che attraver~ano la barriera alpina cm,1i1ucntc il nostro conlinc con la Francia. colla Svizzera e coll'Impero Austro Ungarico. le quali. ,cnza contare altre di minor importanza. sono non meno di una ventina.
2 ° Ch i use çosì l e po n e delle A l pi si vorrcbbe favorire il libero manovrare sulle due rive de l Po rnll'assicurar~cne il passaggio in sei punti almeno e propriamente con 5 doppie h:ste di ponte a Chiavasco, Ca\alc. Vale111a. Borgoforte. Pontelagoscuro, e tre grossi campi trincerati ad Alcssandria. Piacenza. e Mantova.
3° Per rafforLare que;:sta base d'opcrazionc si vuole. verso Francia migliorare Genova 39 dal lato di terra e di mare. verso Austria perfezio nare Pesch i era. Verona, Legnano, e VencLia c costruire una testa di ponte a Boara sull'Adige al nord di Rovigo.
4 " Forzata la valle del Po s'intende che il nemico debba 1ro,ar chiu)i tuui i passi dcli' Appennino; epperò non solo si deve fortilkar Pisa o Spc1.ia ma pure 1u11i i 9 varchi appennini.
5° Per coprir Roma i più miti si con1cntano di un fone campo trincerato a roligno e tre l'oni Pialle a Ci,iiavecchia. Viterbo. cd Aquila 0
·'8 Viene affermato SULLA DIFESA GENERALE DEGLI STATI dell'Italia i1111,11·1icolare, esame del co111ropmge110 di difesa compi/mo dalla Gi1111ta della Camera dei DeJ1111a1i sollo la data del 2 aprile IH73, Roma 1873. p.90: A,11ichè dunque destare inq u ietudini cd apprensioni sulla possibi l e insunìdenza dei rrovvcd imellli di difesa chc si propongo no. le quali mi pare di avere dimostralo più sopra i n fo ndate. sarebbe a mio avviso preferibilc che l a Giu111a de ll a Camera dei deputali che ha studiato così a fondo la questione vedesse modo nella discuS\ionc di convincere il Parlamento ed il paese dell'urgcn,a dei prov,edimenti stessi. onde si disponesse a far uno sforzo straordinario e rronto per auuarc questo ~i,1ema difensi\O generale nel JX!riodo di tempo più breve possibile, acciò non avvenga che lo Stato si trovi esposto a qualche pcricolo prima di essere validamcnle preparato a superarlo.A tal lìne io ri terrei come mi~ura veramen te utile ed opportu n a c he alm..:no i forti di sbarramento nelle frontiere co111inentali. la piazza di Genova. ta1110 da terra che da mare. e le pia11e di manovra di Alessandria e quella nuova da erigersi nel Veneto al di là dcli' Adige. fossero complc1amcn1e sis1cma1e ed ult11na1c nel p.:no<lo di .i anni al più tardi : che le difese di Capua fossero compiute nei due anni successivi e 1u110 poi il sistema difensivo fossc completaw nd periodo totale di 8 anni.
In questo modo al tine del primo periodo di 4 anni lo Stato italiano sarebbe in grado di srn,tenerc una dilc\a acçanita e lunga sul teatro principale della vera guerra cioi! nella valle del Po Dopo sei anni avrebbe anche completamente riparato a qualsiasi auacco da mare. ed in 0110 anni avn.:bbe provvisto per sempre alla sua sicurezza cd indipendenza nel consor,io delle ro1cnzc europee ·•
39 U n auc nt o lavoro d i ri l eva m en to topografico della piaz,a d i Genova fu comp iut o tra il 1835 cd i l 18:18. senza dubbio motivalo dal l a crescente rilevanza che la stessa andava progre~sivameme acquistando nella nuov,1 visione strategica sabauda. Il grafico sarebbe stato ovviamente la base per successi,i studi di aggiornamento delle fortilìca,ioni. secondo una prassi ormai consolidata, ed avrebbe consentito la esaua de1ermina1ione delle potenzialità difensive delle artig l ierie da dislocarvi. Al riguardo cfr. A.FARA. u1 ct1r1a di lg11a:,io Po rm, canografia Jl<'I' l'archi1e 11 w·a mil i1are nella Ge11 01·a della prima me 1à de/l'011ocelllo, Roma 1986. pp .11 -15.
Jo I criteri ispiratori di una regione fortilicata momana nei pres~i dell'Aquila così ,·eni, ano si111e1i1.1a1i da A.GALLETII. Swdi sulla difesa 11a:.io11ale. Roma 1873. pp.17-18: ··A poco più di 60 chilometri da Roma in dirC?ione Nord-O\'es1-0ve~1 ~i trova l'Appennino che diviso in due rami, i più maestosi cd ahi di wua l a cate na, ricope rt e le c i me di neve per se n e mesi de l l'anno racc h i ude i n vasta co nca obl un ga l 'ah i pia no Aq ui l ano, lu ngo 93 ch il ome tr i e largo i n med i a 30. Il ramo orientale è p i ù e l evato dcli' altro. corre poco lungi dall'Adriatico ed è dominato dal Gran Sasso d'Italia alla sua volta signoreggiaw dal monte Corno elevato sul mare 2823 metri. Questo ramo è squarciato nel me110 dalla Pescara. la quale aprendosi un varco fra mo111e ~l arrone ha separato il Gran Sasso dalla Maiella dominata dal monte Amaro deva10 2707 rm:Lri. I l ramo occidentale è poco meno elevato dell'altro e i l monte Ve li no che l o si g noreggia non supera i 2428 me tri, ma ne co nserva l 'asprezza. L'alt i p i ano Aq uil ano è formato da ll e valli dcli' A terno e del Gi,io e da que ll a della Pest.:ara. che nata dalla conlluen1.a dei due primi è inguadabile cd ha l'aspeuo di un fiume. Queste valli sono generalme111e agresti e sclvagge le principali ciuà sono Aquila. Sulmona
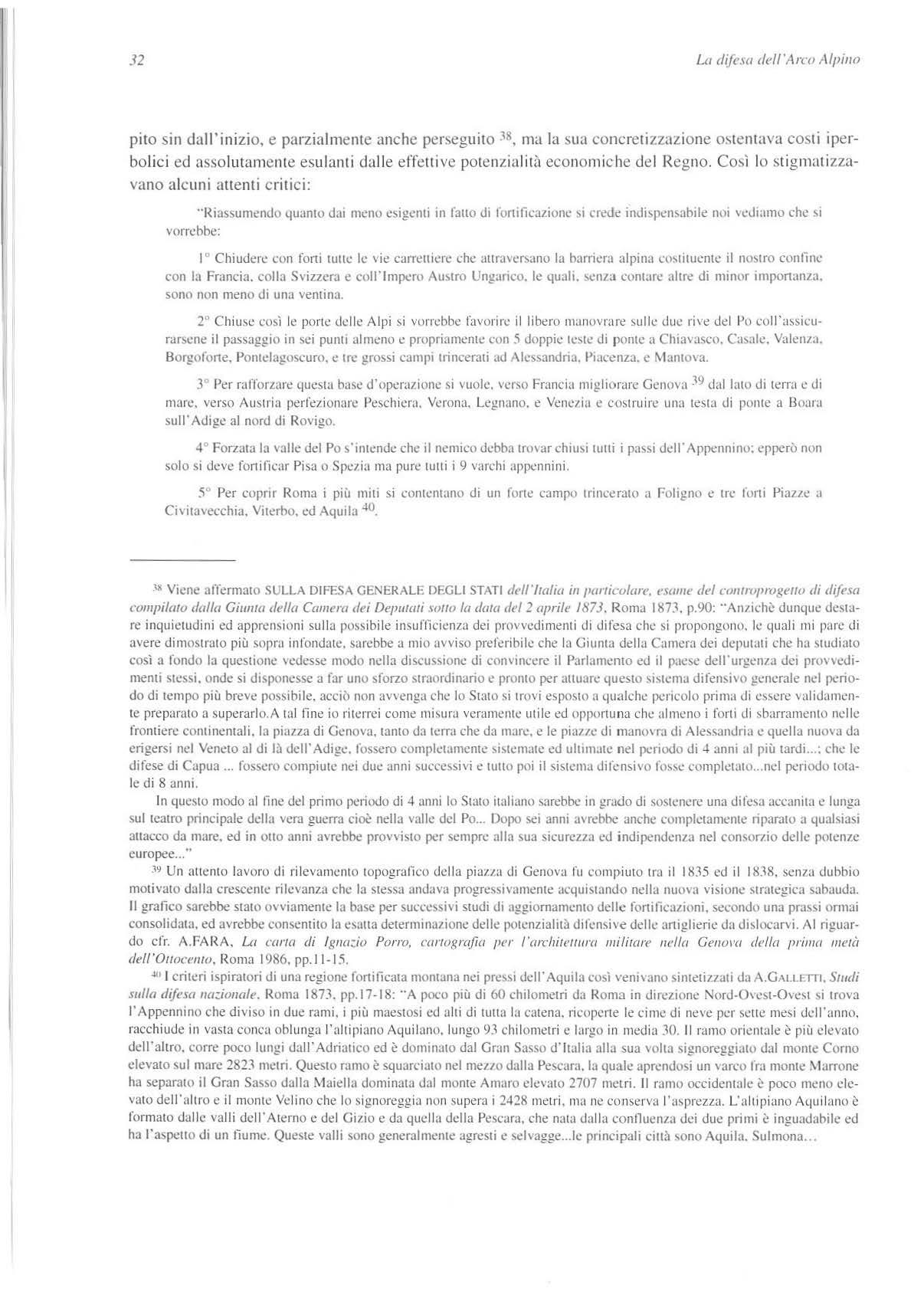
I 'I 32 La d(fe.1 t1 de,,.Arco Alpino
6° Finalmi.:nte Roma quale cap it ale deve esser messa al sicuro con t ro un bomba rdamento 41
7° Altamura dovrebbe diventare un gran campo trincerato.
8° Foggia ridoua pure a forte campo trincera to dovrebbe rannodare e proteggere tutte le vie de l versante orientale.
9° Mentre Eboli av rebbi.: la stessa azione sul versante occidentale.
I 0° Capua 42 resa pure a campo trincerato dovrebbe proteggere J\apoli al sud e chiudere !"adito a Roma al nemico ven i ente dal meZLodì.
11 ° Per tenere indissolubilmente la Sicilia unita al Contin<:!nte dovrebbe fort i ficarsi validamente lo stretto di Messina su l le due rive.
12° Infine per impedire. che le città marittime si ano danneggiate da fl otte nemiche. che i loro porti siano presi da esse e dim inuire alt resì i punti del li torale ove l a natura rende faci li g l i sbarch i si vorrebbe fortificare da l l ato di mare Genova. Spezia, Livorno, l o Stretto di Piombino. Civitavecch i a. Os tia, Gaern. Napoli nel Medi terraneo. Taranto nel Jon i o Brindis i ed Anco na 43 nel!' Adriatico; di p i ù Augu sta, Siracusa, Trapani in Si ci li a; Cagl i ari e Sassari in Sardegna ed altr i min o r i in tutto 16 Piazze almeno
Ma ci o nullameno è vano c ull arsi ne ll e il l usioni ". 44
Se quì al riparo d i q uès ti alt i e maestos i monti si riunissero gl i stabilimi.:nti e i g r an magazzi ni militari e in tempo cli guerra i depositi e il mate r ia l e ferroviario del l e provincie inva se; e se invece dispendere mo lt i e molti milioni a Piacenza-Stradella o Bologna la p i azza posizione di u ltimo rifugio si stabi li sse quì quale ce l'ha data l a na tu ra non potremmo r i tenere la dii'esa d'Italia assic urata e l a perd it a di Roma resa u m anamente impossibile?"
4 1 La fortificazione di Roma prese l'avvio progettuale a partire dal 1871. e concre to dopo l'emanazione d i una appos it a legge il 12 agosto 1877. A l riguardo A. I OKES, A.PIERGEKTILI, L'esercito nella tutela del patrimonio s1orico-ambie11Jale-For1e di Pietralata, Roma 1990. p.29: "Dirà M.Carcani nel l ibro «I forti di Roma» ( cdi7ione 1883):«ln un l asso di tempo d i soli .5 anni e con una spesa di circa 23 milioni. si è cost rui ta intorno a Roma una cinta di opere permanent i formate da 1.5 forti staccati. i quali metteranno al coperto l a Cap it al e da un bombardami.:nto e con un li mita to presid i o. in m assima pa rte composto da milizie mobili <:! 1erritoria li. permetteranno di oppors i ai tentativi che un corpo nemi co sbarcato nel prossimo litorale. potesse fare per impadronirsi de ll a città almeno fino all 'arrivo di un esercito d i soccorso Restava da dar loro un nome e lo fece il Regio I O novembre 1882 ovunque sorge u no dei nuov i rorti, ivi è un ric o rdo storico. un ce l ebri.: nome , cioè o della strada o della colli na, o del casa l e, o della tenuta dove sorgono»".
4 2 Circa la piazza di Capua, ancora ne l 1847 così vt!niva descritta da M.D ' AYALA, Napoli Militare. Napoli 1847 p.3 17: "Capua Popolazione 8 mila 68.5 anime. È pur nelle ordinanze cosiderata si ccome piazza d'armi di pr i mo ordine. con un uffizial generale quale governa tore. Assisa sull a sponda sin i stra del Volturno. vie n tagliata e circondata dal fiume. che dal l a facc i a sinistra del bastione Spero ne. l a bagna in sino all a faccia sin istra de l l o ntano baluardo sant' Ama lia da settentri one ad occidente e mezzogiorno, forma ndo come u n dodecagono E ll a avrebbe bisogno d i opere che la facessero affatto signora del fiume; nè la sua figura è la meglio acco modata allo svolgimento delle ope re forti; po i chè triango l are e v'è un cas tello di figurn quadrata, cretto da Car l o V nell'anno 1.5.52 Y' ha un arsenale d i r istauri con laboratorio di po l veristi Ancora oggi al suo int erno si trova l o Stabili m en to Pirotecnico Militare. C irca la sua ge nes i arch i te tt o nica cfr. L.SANTORO. Opere dife11sh 'e nel l'iceregno, in Napoli nel cinquecento e la Toscana dei Medici, Napoli 1984 pp.136-138.Ed ancora C.RoROTn, Una presell'::a rinascimentale a Capua: il forte di Carlo V sul Volwmo. in Quaderni n° 4. I st i tuto Nazionale d i Stud i su l Rinascimento Meridionale. Napol i 1987. pp 77 e sgg
4 J Circa il ru olo r i servato alla piazzafo rt e maritt im a di Ancona dopo l'Unità d'Italia. precisa G.LL'CCHF.Tr l, R.BELOGI, Ancona pia-:.:afor1e del Regno d"ftalia. in Studi St0rico M ilit ar i 1990, Roma 1993. pp..539 e sgg: " L a rico nosciu ta import anza militare dal punto d i vista tt!rrt!Stre-marittimo d i Anco na. dopo i l co mpletamento dcll'unilìcazione del territor i o naiiona l e, deriva dal fatto che oltre all'essere l'u nico po110 tra Venezia e Brindisi access ibile alle navi di grosso tonnellaggio. la città penn ette di cos ti tuire uno sbarramento delle comunicazio ni che costeggiano il litorale adriatico e di cop r ire lo shocco delle strade rotabili e dell a fe rrovia c he co n vergono su ll a li1oranea alla v icin a foce del fi um e Esi na. È anche la tesia dell a impo rt ante l inea di difesa aveQte l'altra estremi tà in Gaeta e c he av rà com unque i l massi mo peso ne ll e operazioni m il itari d i c ui. in entra mbi i versa nti appenninici. potesse o dovesse essere tea tr o
Le opere m ilit ari dec i se già nei g i orni della vi si ta di Vittorio Emanuel e Il. procedo no co n alacr i tà e di pa ri passo con quelle civ ili pressochè coincidenti. e già nel 1867 Ancona si presema nell a nu ova veste
L a Piazzaforte d i Ancona ha riconoscimento ufficial e dai 1861 al 1899 ".
44 M.MASSARI, Sulla d(fesa generale d'Italia. in Rivista Sicula. Palermo I 97 1. pp.5-6.

Parte Prima
33
Pe r cu i la vinuale fortezza Italia si ridu sse in breve ad una stri scia appena protetta da un ·fossato allagato ' e eia alquanti caposaldi lungo il suo confine terres tre.
Qu al ora i menzionati caposaldi fossero riu sci ti a stab ilire un li ve llo di deterrenza suffic iente a stornare iniziative aggressive da parte delle potenze europee, si sarebbe allora effettivamente assegnato al Regno un ruolo di tramite impre nsc indibil e ve r so il mo nd o mediterraneo , ru o l o paradossalmente perfettamente attuale, scaturente appunto dalla cessazione di minacce lun go Ja fronti era terrestre, mentre all'epoca:
"Ciò :nrebbc dO\UIO esser..: consegui10 :iumemando le lor,e mobili e foniticando Il.' frontiere.
Ma il nu ovo n.:gno aveva. in q uel momento. 1ali e 1a111i problemi eu u na situaz i om: l'in anz i ar i a <:o~ì d isas t ro· sa. <:hc non conse111ivano ceno l' erezione J i fortilicazioni. "-1 5
A contenere le spese della co l ossa l e opera di fortificazione dell'arco alpino contribuiva in maniera affa tto in si gn ificante il ru o lo, quand 'a nch e ambiguo, di neutralità della Svizzera. Non a ca:-.o ve niva fatto ril ev are c he:
" non es~endo il no~1ro Erario in tali nindi,ioni da eonicmplare ~pc,c per e,cnt11al11il lonianc. poiehi: 1ali almeno io repu10 quelle d"una guerra colla Svi11cra. Ben diversa Ì! la ques1ione dei ras~i d1c rne11ono nel Ti rolo -16
Anc ora più espressamente il medesimo relatore os'>er vava c he i passi:
che si aprono dopo la Chia,cnna , en,o lo Srulga e la Val Bregag.lia. quello di Pia11amala e qudlo di Val di Livigno. sarebbero o ra i passi indica l i a sceglie rsi am mes~o c he fin d'ora ~i volesse pens.irc: al caso di una guerra colla Sviaera. cosa eh..: panni <:osì l onta na. che forse il denaro speso pe r sim i l i spese po1 rebbe sembrare se no n spr..:<:al\l, al meno speso ~enza urgen1e necessiti1 "-1 7
Che il risparmio consegue nte al contenimento delle fonificaLioni lun go il co nfine sv izzero fosse tutt'altro c he insi gnifi ca nte l o dimostra l a no tevole es tensione di tal e fronti era. Essa infalli correva-e co rre con anda ment o immutato-lungo quasi 500 km, dei c irca 1. 200 dell'intera frontiera alpina. A rendere però comunque indispensabile un intervento difensivo. sia pure in t ono minore, non era t anto la poco credibi l e aggressività svizzera, quant o piuttosto l a sua v ulnerab ilità territ o rial e da parte di una delle altre potenze europee c he avrebbero potuto, approfittando della risaputa inconsistenza militare e l ve tica , vio l arne il territorio e penetrare da quelle indifese e co mode vie d'accesso, l e c ui est reme propaggini distavano appena 50 km da Milano. Non a caso l'ipotesi trovava una sua non marginale credibilità, in fa tti:
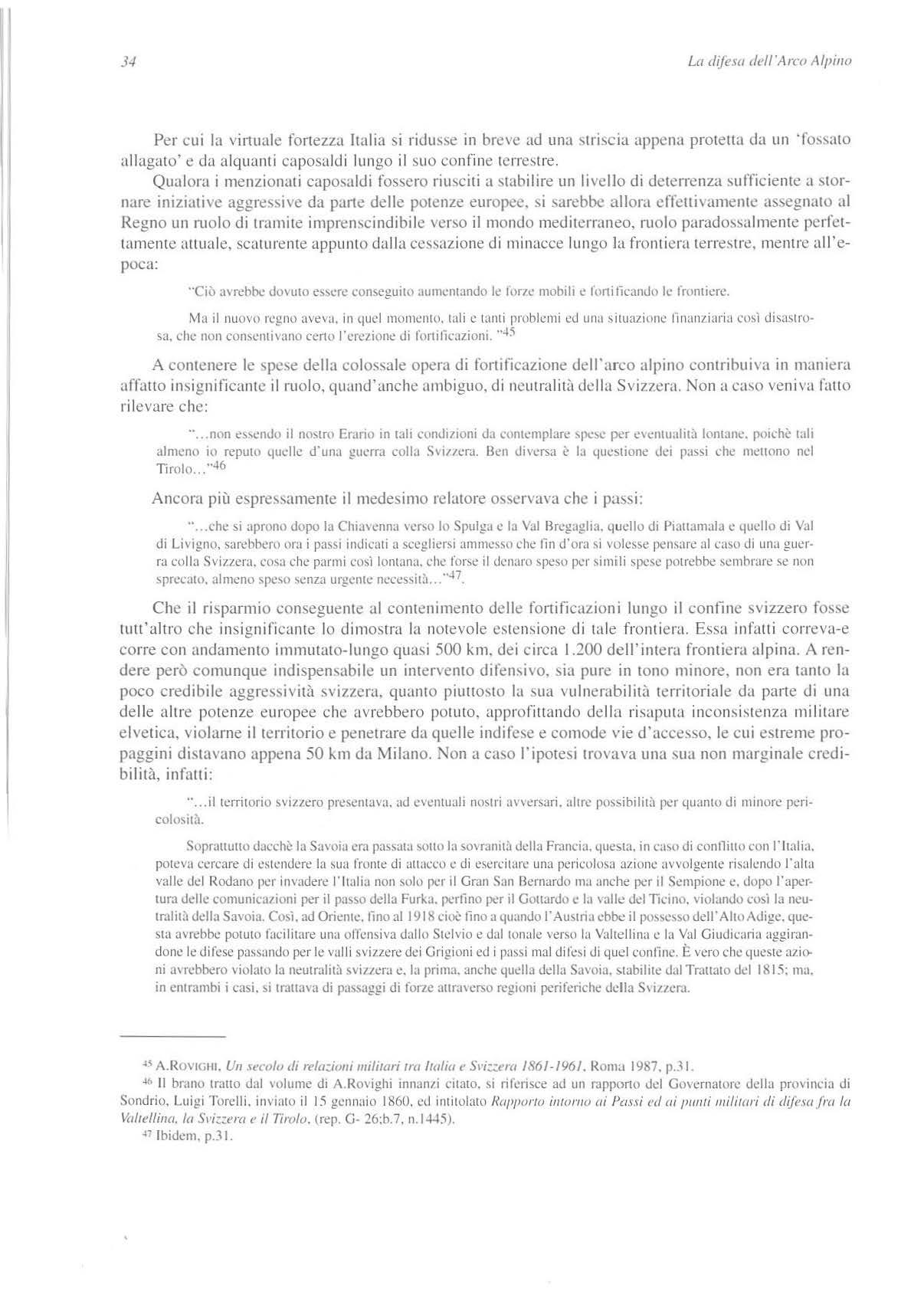
", il lerritorio sv iuero presc111ava. ad ..:ven tu ali nostri avversari. allrc possibili1il per quanto di minore rericolos11i\.
Sopra11u t1 0 dacchè la Savoia cm passaia sollo la S0\r:1n 1ti\ ù..:lla Francia. quesia, in c.1,0 d i co nllit1 0 con l' Italia. poteva <:creare di estendere la sua f'rome di allacco e di e~erciiare una reri colosa :izi one avvolg.enie r i sal..:ndo l'alta valle dl.'I R odano p..:r inv:idere l'llali a non so l o rer il Gran San Bernardo ma anche rer il Sempione c. doro l 'apertura dello.: comunic.uioni per il passo della Furka. perfino per il Got1ardo e l,t rnlle del lìrn10. , iolando così la neu1rali1à dell:1 Savoia. Così, ad Oricme. lino al I 918 citx: lino a quando I' Aus1ria ebbe il pi.i-sesso delJ' Allo Adige. ques1a aHebbe pollllo facilitare una offe nsi va dallo S1clvio e dal ionale ve r so l a Vallellina e l a Val Giudi<:aria aggirand o ne l e difese pa ssan do per l e valli svizze re de i Grigioni ed i pass i mal d i f..:si d i quel confine. È ve ro <:hl.' qu es te azioni avr..:bbero v i olato la ntutrnlità svi11era e. la prima. anche quella della Savoia. s1abili1e dal Tra11a10 del I 815: ma. in en1rambi i casi. si 1r:111ava di passaggi di forze aura,erso regioni periferiche dl.'lla S,i11erJ.
4~ A.R0\·1m11. Un secolo cli rela:iu111 militari tra Italia e S1 •1::<'m /86/ · 1961. Roma 1987. p.31. 41 li brano 1ra110 dal volume di A.Rovighi i nnan,1 ciiato. ~i rifcrisce ad un rappono ùcl Gtwernaiore della rrnvin<:ia di So ndrio. Luigi Torelli. invialo il 15 gen nai o 1860. cd intil ol ato Na1>1 w rto i11to m u ai Pass i ed o i p1111ti 111iliwri di difesa fm la Valtelli11a, la S1•i::em e il Tirolo. (rer. G- 26:b.7. 11 .1-1-15).
4 1 Ibidem. p.3 I.
3-1 La difesa dell'Arco Alpi110
Sicchè si potcva sempre temere c:he circostanze int erne cd cstcrne potessero impedirc alla Svizzera di impegnarsi a fondo per garantire la neutralità ed opporsi a qucstc vio l aLioni
Si era ben convinti, dunque, chc la neutralità sviLLera fosse a noi favorevole e c:he la sua osscrvanza fosse a noi con ven i eme: ma si p:iventava ogni possibilità che la Svizzera stessa non potesse garantirla 48
Dal canto suo la Svizzera osservava con crescente preoccupazione la situazione geopolitica che si andava strutturando intorno alle sue frontiere:
" L 'a nnée I 860 cos ti tua un tournant, et cela il plus d'un titrc
L'anno 1860 rappresenta una svolta sono molti aspelli. La S\'izzera vede compicrsi al ~uo intorno mutazioni politiche decisive. Una nuova grande potenza si profila a sud e la su:i insistenza a minacci:ire di aguuare il proprio appet it o su ll e nost re regioni di lingu:i ita l iana pose la Sviuera sulla difensiva per qualche decennio
Il vic in ato della Svizzera er:i diven ut o più c:omplesso. Si prospenava particolarmente important<.: sapere se si andava verso un equil ibr i o di forLe in Europa. Ma nè l a politica della Francia nè quella di Bismark, che più tardi comprendcrf1 anche quel l a dell a Russia, dell'Austria e ddl' halia. lasl·iavano grande spazio a speranze di pac:e.
Riproponiamo l a l en ura delle affermazioni chc l'cmissario bri t annico indirizzò al suo governo il 27 gcnnaio del 1862:«lo c:rcdo in nanzi tu uo, che ciò che dC\'C temcre la Svizzera, è una violazione della sua neutralità a causa di una marcia forzata auraverso i suoi territori: le ragioni d i paventare tale eventual it à superano per lci i timori di una invasione a fini annessionistici o di conquista» ··. 49
Ancora agli inizi del '900 quel particolare problema assillava i pianificatori italiani, tant'è che, commentava Saletta:
·· la necessità di dover provvedere alla difesa cli una estesa frontiera con mezzi limita ti. fece sembrare al Governo essere minor male trascurare quel tratto di essa confinante con una potenza la cui neut r alit à è imposta dai traltati. o con t er rit ori neutraliZLati come q uelli dcli' Alta Savo i a. Tuuavia il fidarsi t roppo della neutra lit à lii un paese c he lent ame nte, ma sicuramente, si è provveduto d·anni 50 ed ha rivolto verso di noi il nerbo maggiore delle sue difese. come se da noi spec i alme n1 c venisse minacciato. non sembra prudcntc co nsi gl i o ·•. 51
Dalle poche righ e citate emerge, ampiamente confermata, al di là della questione della frontiera svizzera, la penalizzante ristrettezza economica in cui si dovette dibattere il programma difensivo dell'arco alpino all'indomani dell'unità nazionale, e l'abnorme protrarsi della sua fortificazione supposta comunque impel l ente ed indispensabile per la sicurezza nazionale.
Tornando all'origine della assoluta inconsi stenza difensiva alpina, imputabile certamente alla frammentazione geopolitica della pai1e settentrionale della penisola, non è arbitrario cogliervi la maggiore conseguenza della menzionata divaricazione di interessi rispetto al mezzogiorno. L a riunione di quest'ultimo in una unica compagine nazionale già all'indomani dell'anno mille, trova forse proprio nella sua vocazione mediterranea, non inceppata da bruTiere naturali o da potenze concorrenti limitrofe insonnontabili ostacoli. 52 Il che
4 8 A.Rov1G111, U11 secolo di rel(l::,io11i cit., pp.41- 43.
49 H.RAPOLD, frolu1io11 desfor1ificatio11s e11 Suisse e111re 1815-1921, i n Fon e1forrijica1io11s 1m Suisse, Zurigo 1992, pp.29 -30
00 Sullc fortificazioni svizzere realizzate tra il 1860 ed 1945 cfr. G.D.REISS. For1ijirntio11 i11 S11'it:er/a11dji·o11 1860 10 19./5, in Fort, the i111ema1io11al joumal offonijica1io11 mul 111ili1wy archi1ec111re. voi. 21, 1993. pp.19-54.
A.BIAGINI, D.REICIIEL, Italia e S1•i:::,era durame la triplice allem1:a politica 111ilirnre e politica estera, Roma 1991. p.56. 52 Afferma G.GALASSO, Potere e is1iw::,io11i in Italia dalla rnd111a del/'/111pero romano ad oggi. Milano 19 76. p.46: Ben diversi da tu tti questi sono gli svi l uppi cht.: si hanno nel!' It ali a merid i o nal e e insularc. <love l a storia i stituzionale e sociale è accentrata int orno ad alcu ni grossi fa t t i poli ti c i. dai quali l a swr ia pos teri ore si svolge co n u na l ogica evide nte e. per molt i aspetti , serrata. Per il Mezzogiorno questi fatti si riassumono. in sostanza. nell'unificazione dclla massim a parte dcli' Italia meridionale sotto i signori normanni della Casa d'Altavilla. affluit i vi, con t anti altri l oro co m patr i o l i, nel la prima me t à del secolo Xl; nell'espulsione. dopo due secoli e mezzo, degli Arabi dalla Sic ili a. con la r idu z i one di questa a domin i o di un ramo cadetto degli stess i Altavilla tra il 1060 e il 1090;nell'u nifi caz i one dei domini mcr id i ona li e sici liani degli Altavilla nel 1127 -JO; nella nuova separazionc tra Continente c I so la per effetto dei Vespri nel 1282. cu i fa seguilo poi la l oro distinta vicenua come regni reciprocamente autonom i. bcnchè a l ungo unificati nella persona dello sl esso sovrano ".
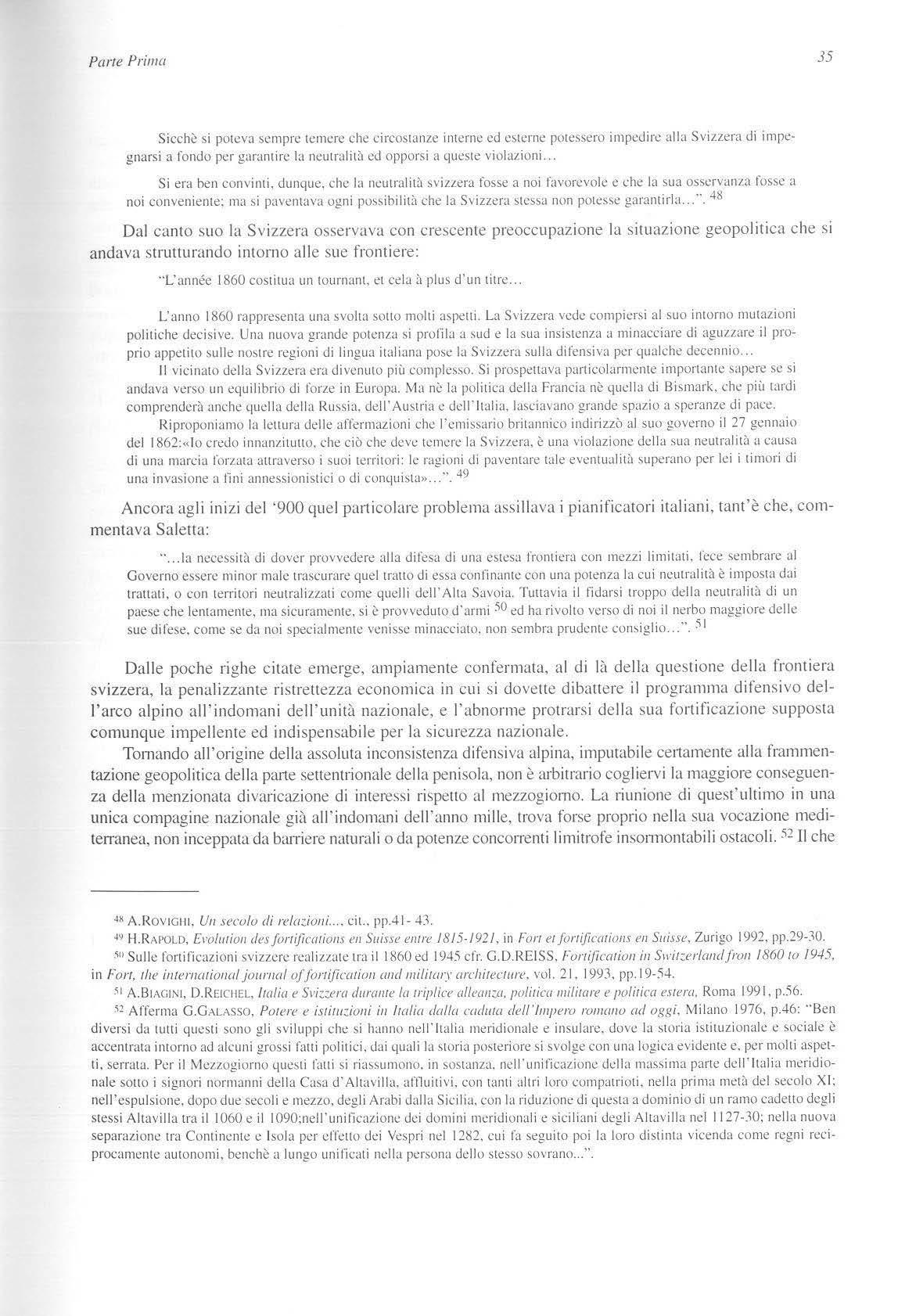
Parte Prima
35
,i
però lo rende nella sua interezza geopolitica preda ste::.sa delle potenze egemoni dell'epoca: nessuna frammentazione, quindi, ma inglobamento totale. 5J
La presenza del mare, infatti , nel passato molto più che in epoca contemporanea. agevole strada per antonomasia di ogni commercio e di ogni scambio, il vantaggio del ritrovarsi al cen1ro del Mediterraneo, come a dire dell'intero universo civile, e di disporre di innumerevoli ottimi scali marittimi lun go l e estesissime fasce cos tiere se cost ituì , da un lato una comoda opportunità cli arricchimento mercantile. dall'altro divenne la via maestra per le conquiste e le invasioni più disparate. E logicamente a quelle effimere si avvicendarono le meglio radicate e le più stabili, che proprio per storna re il noto destino delle precedenti cercarono di 'chiudere' il territorio appe na occupato ad identiche iniziative invasive. li che implicò innanzitutto l'assoluta padronanza di con fini naturali sicuri. o comunque non discrezionali. quali appunto la linea costiera. eliminando ogni enclave interna, o qualsiasi solu,ione di continuità nel possesso della fascia litoranea 5-1, unica garanzia di duratura permanenza dinastica, e di disponibilità di co ngrue ri sorse militari indispensabili per l 'iden tico fine. Ed il ra g ionamento si dimostrò vince nte , tant'è che per i successivi otto seco li la definizione geografica del mezzogiorno si confermò immutabile e stabilissima.
Abbastanza logico individuare nella relativa stret tezza della penisola una delle concause propiziatorie di siffatta dinami ca aggregativa, riu sce ndo estremante improbab il e politicamente e fortemente in stabile militarmente una compresenza di più compagini nazionali. La catena appenninica inoltre avrebbe reso ancora più aleatori e tali entità, costringendole a meri retroterra litoranei assolutamente e reciprocamente insufficienti ad una qualsiasi economia sociale, privi infine della indispensabile valenza militare autodifensiva. Non casuale, pertant o, che laddove la penisola, saldandosi all'Europa, ampia il suo territorio in maniera conside revole nel senso della latitudine, tornasse possibile tale frammentaLione. indubbiamente favorita dalle grandi potenze europee, ma non certo ostacolata, almeno fino al XIX seco lo, da una recepibile volontù unificatrice delle diverse compagini. gelosamente custodi della l oro individualità, quand'anche non indipendente.
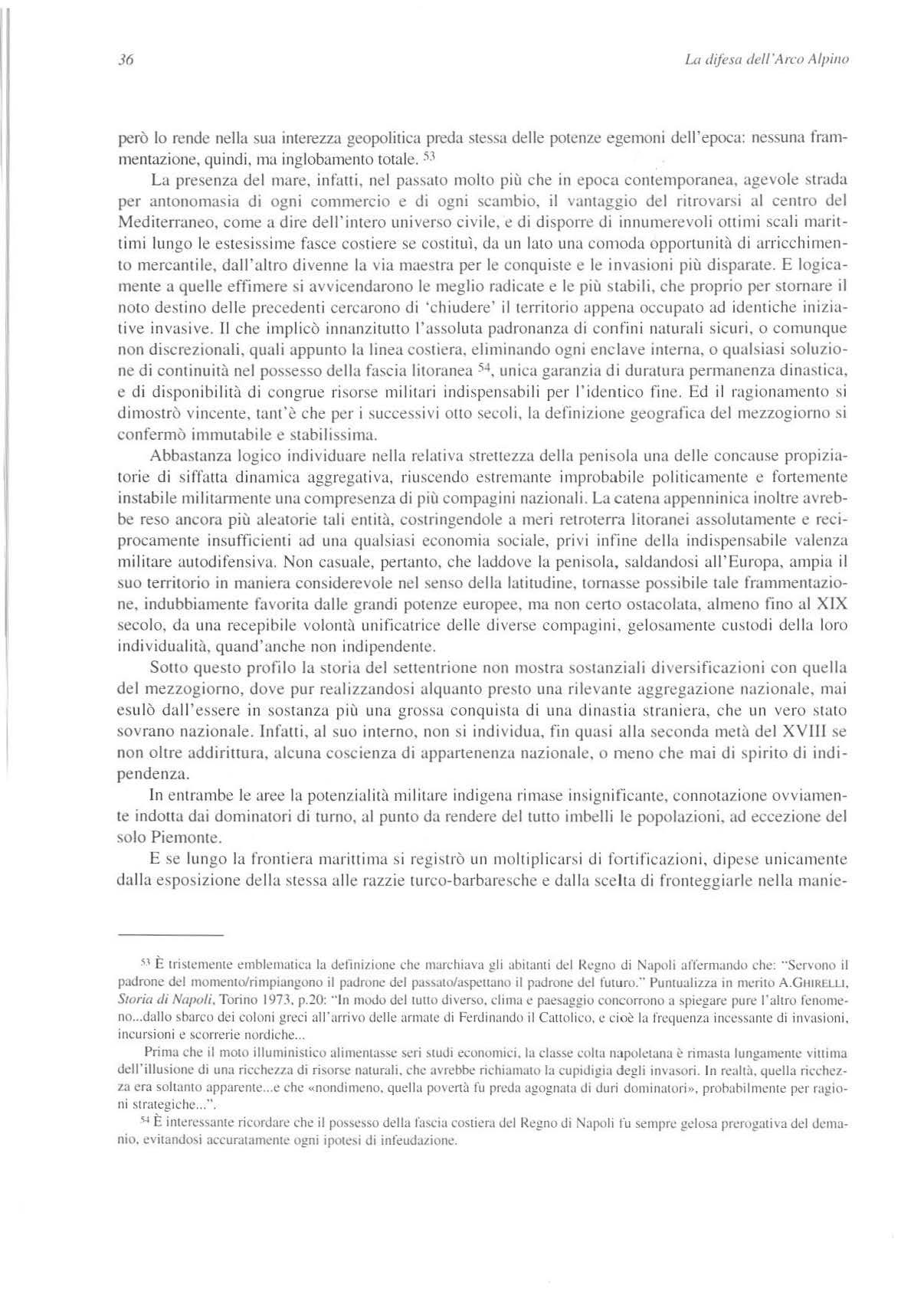
Sotto questo profilo la storia del settentrione non mostra sostanziali diversificazioni con quella del mezzogiorno, dove pur realizzandosi alquanto pres10 una rilevan1e aggregazione nazionale, mai es ulò dall 'esse re in sostanza più una grossa conquis1a di una dinastia straniera, che un vero stato sovra no nazionale. Infatti , al suo interno, non si individua, fin quasi alla seconda metà del XVIIJ se non oltre addirittura, alcuna coscienza di appanenenLa nazionale, o meno che mai di spirito di indipendenza.
In en1rambe le aree la potenziali1à militare indigena rimase insignificante, co nno1azi one ovviamente indotta dai dominatori di turno, al punto eia rendere del tutto imbelli le popolazioni. ad eccezione del solo Piemonte.
E se lun go la frontiera marittima s i registrò un moltiplicarsi di fortificazioni, dipese unicamente dalla esposizione della stessa alle razzie turc o -barbaresche e dalla sce lt a di fronteggiarle nella manie-
~, È tri)h.:mcme emblematica la delini1ione che marchiava gli abitami del Regno di Napoli affermando che: "Servono il padrone del momemo/rimp,angono il padrone del pa)'>ato/aspcuano il padrone del futuro." Pumualia.a in merito A.G111RELLI, Storia di Napoli, Torino 1973. p.20: " I n modo del tulio diverso. clima e paesaggio concorrono n ~piegan.: pure l'altro fcnomeno dallo sbarco dei coloni greci all'arrivo c.lellc armate e.li Ferdinando il Ca11olit:o. e cioè la fn:quenza in cc same di in vasio ni, incursioni e scorrer ie nordiche
Prima che il moto illuministico alimentasse seri studi economici, la classe colta napok1ana è rimasta lungamente vi11ima dcll'illusionc di una ricche/la di risorse naturali, che ,1uebbe richiamato la cupidigia degli imasori. In reah:1. quella ricchcz1.a era soltanto apparente t: che «none.li meno. quella povertà fu preda agognata e.li duri dominatori». probabilmcnte per rag.ioni stra l egiche ".
>-l È intercssante ricordare chc il possesso della fascia costiera del Regno di Napoli fu sempre gelo~a prt:rogativa del demanio. evitando\i accuratamcmc ogni ipoh!\I di infeuda,ione.
36 La difesa dell'Arco Alpino
ra meno coinvolgente possibile sotto il profilo militare. In assenza di quelle incessanti umiliazioni razziatorie 55, con un analogo spirito nazionale annientato non deve stupire l'assenza di credib ili opere difensive sia lungo l'arco alpino sia alle sue spalle. Le permanenze ereditate dall'Italia erano per lo più retaggi medievali, incastellamenti feudali, testimoni e compartecipi di contese intestine e non già strutture finalizzate alla sa l vaguardia di una sovranità territoriale propriamente detta, al pari dei tantissimi castelli interni al mezzogiorno privi di valenza difensiva collettiva, e concausa della permanenza feudale tanto dannosa e retrograda 56 Non a caso persino il Piemonte di cui abbiamo ricordato il maggior spirito militare:
·· viene generalmeme considerato un territorio geograficamente ed ernicamellle unitario. Ma questa presunta unità è un fallo recente. che poco riscomro ha nella storia della regione. assai frazionata soprallullo in epoca medievale, cioè quella più importante pa l'architeuura fortificata. ·•
Il teatro geografico
L'attaccatura continentale della penisola è vistosamente marcata dal maestoso co1Tugamento delle Alpi. Non molto antiche, geologicamente parlando, tradiscono tutte le asperità proprie dei rilievi giovani che ne costituiscono, per molti versi, altrettante peculiarità militari. In linea di larga massima possono dividersi in tre sezioni fondamentali, ovvero occidentali, centrali ed orientali.
Le caratteristiche morfologiche non risultano affatto assolutamente omogenee, dettaglio che influenzò non solo la dinamica storica che si svolse al loro riparo ma soprattutto la logica difensiva delle stesse. Sempre in generale, anche la pendenza degli opposti versanti appare notevolmente più ripida e scoscesa per quello interno italiano rispetto a quelli esterni, francesi, svizzeri ed austriaci, caratteristica che penalizzò l'opera cli trasformarle in possente spalto naturale.
La dimensione più facilmente recepibile, quella verticale, si innalza mediamente al di sopra dei 1.500 m., con punte non di rado eccedenti i 4.000, per l'esattezza ben 7 cime trapassano i 4.500 m., 24 i 4.200, 170 i 3.500. La distribuzione dei rilievi principali non è concentrata in un unico settore, cotrnotazione che ne esalta la portata strategica.
L' ampiezza trasversale, a differenza della altezza, è notevolmente variabile, oscillando fra i 30 ed i 360 km. Mediamente però si attesta intorno ai 200.
Tale estensione dà origine ad un sistema montuoso costituito, a sua volta, da un avvicendars i di catene, con andamento sostanzialmente parallelo e concentrico, degradante progressivamente verso le pianure basali. All'Italia ne toccò la frazione minoritaria, mai eccedente la terza parte, limitazione che ne compromise sensibi lm ente la facoltà di scelta sulle ubicazioni difensive da impiantarvi, e per con-
-'' Sulla frequenza e sulle modalità delle razzie turco-barbaresche cfr. F.Russo, Guerra di Corsa cil., tomo I.
56 È estremamente significat i vo il risvolto sociak involutivo stabi li tosi a seguito del pcrmanere di uno sterile feudales im o, in It al ia in genere e nel Mezzogiorno in particolare. Ricorda R.AJELLO. Sraro e feudalirà in Sicilia, economia e dirirro in 1111 dibauiro di fine seuece1110, Napoli 1992. pp. 132- 133: "In Italia l a condizione d i nobile-prosegue Palmieri-«si conserva con l 'esser di peso all a società; e si pc:rde quando si procura e si comincia ud esser l e utile». È, du nque, u n modo di graduare g l i o nori esattamente opposto a quell o che ragione vorn.:bbc:. La «opinione» trad i zionale, «che offcnde il bene pub blico, può e debbe esser corrella. Nessun nobile presso di noi farebbc il marinaio. l addove in Ingh ilt erra i figli di Lo rd fanno da mozzi. Si può dunque regolar l'opi ni one, secondo richiede l'util i tà pubb l ica». Le all i vi1à produ1tive mancano nel nostro pacse perchè sono inconciliabili con l'idea d i nobihà
La polemica contro l'aristocrazia di spada. l e accuse ad essa r i vo ll e d'esser inerte, di non contribuire a l benessere social e, di vivere solo di rendite certe, d i venir meno alle sue funzioni marzia l i era una lin ea interpretativa della stor i a del Mczzogiorno che si era diffusa già alla fine elci Sciccnto in torno ai terni del l 'economia, dcl commercio, della produllività materiale ".

Parte Prima 37
segue nza la validità complessiva della l oro protezione 57. Per l'identico motivo si realizzò una vistosa dissimetria tra le potenzialità di attacco godu te dall'Italia e quelle d ei !'luoi confinanti, ovviame nte a nos tro danno. E no n fu l 'u nica penalizzazione. ma forse so ltanto quel l a di natura geopo liti ca che so tt o l'aspetto morfologico una ben più grave e consequenziale esposizio ne è facile cogliervi anche ad un esame superficiale.
Osservando, infatti, l'impianto planimetrico dell'arco alpino sp i cca immediato il 1.,uo andamento curvilineo, assimilabile in prima approssimazione ad un settore di ellisse la cui concavi tà è rivolta ,erso la pianura padana Equiparandolo, per banalizzazion e del ra g ionamento , ad una co rtina continua è facil e scorgervi la principale connotazione avversa alla difesa: le numt:!rose vallate, disposte perpendicolarmente al suo andamento e converge nti verso l'interno. L e linee di frattura naturali, ampliate e modellate dai ghiacciai, si proponevano co me altrellanti poss ibili v i e di penet r azioni, 58 conse nten ti al l 'aggressore di incanalare le sue forze da direttrici diversificate e d i stanti , ma so1.,tanzialmente sboccanti in un m edes imo punto. ln altre parole sarebbe sta to improbo, in caso d'invasione, contenere l e forze ne miche avanzanti da così disparate direzioni. ed ancora più difficile im ped irn e la naturale riunificazione dopo l'a11raversamento della catena. Per contro un eventuale a11acco condotto dal versante italiano verso quello france se, per il medesimo motiv o trova va significativi ostaco li, tant'è che così il ge n. Mezzacapo sintet i zzavano l a dissimetria del settore occidentale. il più temuto:

l nohrc la pronuruiata convc,sllit ddlc Alp i verso la Francia. rende da 4ud law divergcntr. od almeno para llele l e \'alli per k : 4uali le rn l onne di un esercito italiano in\'asorc debbono operare. e però offrono una disposiLillnc poco favore\\>lc all"ollen~i\'a: do,e che la con\'Crgen,a delle \'alli del H'rsante rtalico rende mollo agevole la difensi\'a, a cagione della facilità con cui le riscne. po,tate al çemro del paese. po~sono accorrere ad impedire la congiunLiom: del l e co l on ne nemich e nel piano ". 59
La supposta valenza difensiva in realtà fu ben presto notevolmente ridimensionata, proponendosi nella sua esatta portata quanto innanzi affermato, tant 'è che lo stesso au to re, un Vl!ntennio dopo così preci sava:
La Commis\ione. fra i due \!sterni che ,i po~sono ado11an: p..:r la diksa della frontiera nord - o,est. quello cioì: d1 una resistenza ad oltranza nella zona montana. e quello dr una resbtcn,a nella d..:ua zo na avente unica 1111:n t e
~ , Precisa V.G,\I L"ARI, u• v1wra:.iu11i del gi11g11u /9./0 .rnlle Alpi uccide111ali. Roma 199-L p.12: ··Nel 19-40 il conlim: fra Ital i a e Fran cia era quell o st ab il ito nd 1860. al momento de ll a cessione della Sa\'oia e della Conti.:a di Ni11,1. Esso si c,tende,·a pi.:r -487 Km. correndo sempn.• lungo la lim:a di drsplu, io fra il bacino del Po e qudlo del Rodano. La frnntiera. quasi OHrnque ampiamente giuMilìcata da moti, i geografici cd t:t nici, cor reva perciò a~sa i l'icina a l limiti! es t delle A l pi occidi.:nta li. l asciando in Francia gran di ssima parte del sis te ma mont uoso e con ciò l a possibiliti1 di una difesa articolata in profondità. I n parole ~emplici. l'Italia era. dal pun10 di \' i\ta orografico. difesa da un solo muro quasi sempre comunt: alle due parti. mentre i muri paralleli cht: proteggevano la Francia erano due, t: in ce ni tratti addiri11ura tre. Solo le A l pi Mari11imc costituivano un a 7ona d i sostanL i ak equi li brio orogralico".
~x Precisa ancora V.GALu-.:ARI, Le opem::.io11i del cit.p.12: ··Naturalmente. il divario era altre11anto sen,ibile se il ragionamen10 veniva rowsciato ponendosi da un punto dr \ista offensivo. All'Italia t:ra necessario superare due o tre grandi bas1ioni naturali per giungl.!rC al R odano. alla Francia bastava va li carne un o per scl.! nd crl.! al P o.
Le amp i e vall i che rnnlluiscono. con maggiore o minore con,·crgen,a. ver~o la pianura piemllllll!~e. facilitano i mo\'imenti in direzione della linea di cresta principale. ma i contrafforti montuo~1 talvolta di grande mole. che le separano. n.:ndono assai rare l e vie di arro ccam en to a breve di su1111.1 dall a fro ntii.:ra l a manovra de ll e truppe è resa molto dilfo.:ile e le nta. v i sta la m:cessi t à di far 1.eendere i reparti lino all a pianura per poi risalire un·alt ra ,allata ogni rnlta che si \'Oglia far mas~a in un determinato trailo della frontit:ra.
L 'andamc nto parallelo al confi ne d i quasi 1u111: l e va l li d el versan te 1·rancese. co l legate fra l oro da va li chi non troppo diffic il i. favorisce invecc la manovra delle riser\'e ".
A sua volta E.C\STFLL.\:SO, Ervlu::.iv111• della For1ifica::.io11e Pem1w1e111e s11lll' Alpi Occide11wli cit.. p.562. puntuali, La al riguardo: In t al e prospeuiva di maggi o r vantagg i o per penctraLioni da Ovest verso Est :si è, pertanto. venu t o a co ll oca r e il probl ema del rafforzamento della fascia di front i era in funzione antifranci.:s..:. ad integra,ione del valore impcditi,o offerto dal baluardo alpino in corrisponckn,a delle grandi fratture d"intcrcssc strategico. Lungo q u esti solchi si sono addensate le ,ie di eomu nicaz i onc - allriment i dclii! linee d'opera?ionc o fasci d' in vasione-add uce nt i dal territorio fra ncese all a reg i one itali ana··.
w Le C.MEZZACAl'O, S11uli IOJWgmjid c it.. p. 17
Lo difesa Alpino
per iscopo di r i t ard are l a marcia dell' in vasore e perme tt ere po i alla difesa cl i manov r are in pia nura contro di esso, ha c redu t o d ovt.:rs i prefor ire i l p r imo, r it ene ndo asso l ut ame nte inopportu no i l secondo, la cui att uazio ne c i pr i verebbe d el vantaggio offe rt oci dalla ba rr iera al pina d i pote r lottare in favorevo li ss im e co nd i zio ni. con tro le l'orze nem ic he, le qua li , in que l t er re no, non po trebbero avva l ersi del l a propr i a superior i 1ì1 numer ica. De l resto. vista l a re l ativa ri strettezza e l a conformaz i o ne del teat ro di ope1wione dell'a l ta va ll e del Po. i l nostro esercito non potrebbe aspe t tare p1;: r en tra re: in azione che i l nem i co sbocc hi da tu tte Jç lin t.:e di i nvas i one nel pia no. senza corre re il r isch i o di trova r si in pos i zione avv i l uppata. Ne deriva qu in di la necessità d i arrt.:stare In m arc i a di t al une colo nne nem iche allraverso la zona m o ntana per g uadagnare spaz i o e te m po necessar i o a gettarsi co n tutte le fo rze d i sponi bi li co ntro k co l on ne c he fossero 1 i uscite a sboccare " 60
Il c he imp li cava, ovv i amen te u n ril anc i o de ll a necessi tà d i una :
«im m ed iata e ro bus t a occ upazio ne di q uel le pos i zion i fort iss im e che cos tituiscono l a ch i ave dei va r i scacch i er i m o ntani>, con forze mob il i. m a anc he u n imprevi sto sv il uppo delle for tifi cazioni es i stent i o già in cost ru 1.i one la c ui capacità d i resiste nza no n doveva essere più lim i tata a q ual che gio rn o. I forti cli montag na. progettati co me semplic i sba r ra m enti delle ro t ab i li, e post i q uin d i i n fondo alle va l li. avrebbero dovuto essere p rotett i da attacchi po rt ati dalle altu re ci rcosta nti e poi, là dove l e vie d' in vas i one erano pa rti colar m ent e i mportan ti essere ada t ta ti a scop i co ntroffe nsi vi ··61
L a di atrib a co n fe rma , in sos tanza, l a natu ra os ti le anc he in fun z i o ne di se m p li ce di fes a ciel ve r sante itali an o , per cui si rit enne ovv i amente p iù se mp li ce cost ruire ope re, sulla f al sa ri ga de l passa to, ne l fo ndovalle, piutt os to co me in vece se nsa to ed altri menti in d i scu ti b ile sui co ntraffo rti ei a c u i l e va llate t raeva no ori g ine. Il c he no n mancò d i pro durre mo ti vat e c riti c he negl i adde tti a i la vo ri:
lo sbarrnm1;: nt o efficace de ll e val li co ntro un nemico c he le d i sce nd a non può ave r si se non fo rt i fi ca ndo le o r igin i de ll e va ll i st esse. co l i! dove esiste i l passo m onta no più el evato c he attrave r sa In c resta dorsale della caiena. dove la nat ura ha accumulato i suo i ostaco li p i ù potem i che rest rin gono il passo e ne im ped i sco no l'aggiramento: e d ove inlìn e il cli m a p iù rig i do per la r ilevante el evaz i one sul livello del mare acc umula pu re alt r i ostacoli d i nevi e gh iacci e d i bassissima te m pe r atura, i quali im pedisco no al nemi co di st azionare e fer m ar si n lungo ed allo scope rt o nelle vic in anze del l e fo rt i lì caz i o ni c he quivi ve nissero ere t te
Ch i discende una va ll e ha cos t antemente il va nt aggio de l do m in i o sovra c hi la d i fcnde nel basso. o l u ngo i l suo percorso : perc hè fino da ll a orig ine d ella valle sti.:ssa. eg li può occ upare l e du e giogajc e percor rern e gradatamen t e l e c res te dis cendent i , a misu ra che si ava nza col g rosso nel fondo della val l e
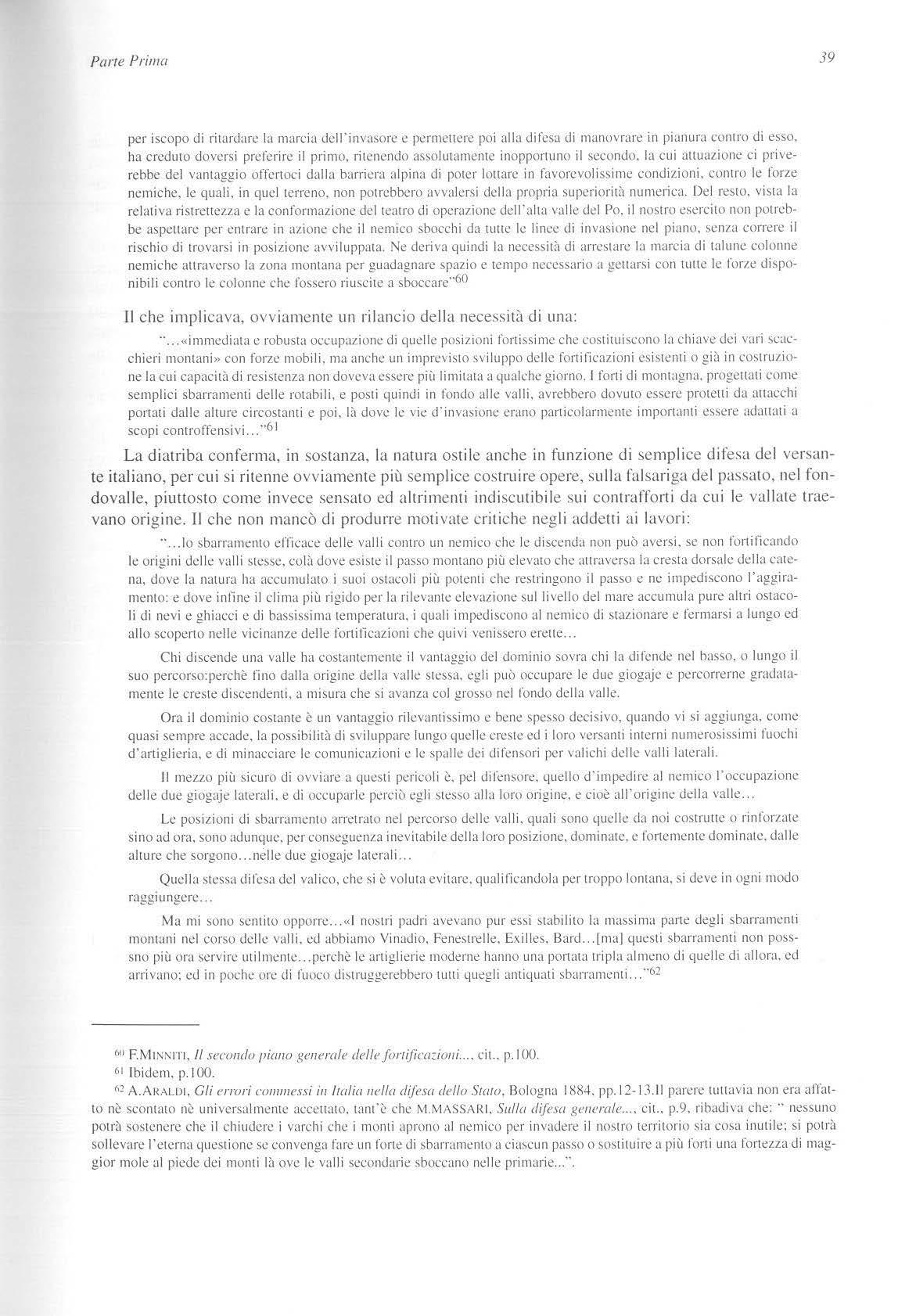
O ra il d o min io costa nte è u n vantaggio ri l evant i ssi mo e be ne spesso decisivo quan d o v i si aggiu nga. come q uasi semp re accade. l a possib i li t à d i svil u ppa re lun go qut.:lle c res te: ed i loro versant i i ntern i num erosiss im i fuochi d'artigl ie r ia, e d i m in acciare le co mu ni caz i on i e le spa ll e d ei d i fensori per va li c hi de ll e val li la teral i
Il mezzo p iù si c uro d i ovviare a qu es ti pe r ico li i::. pe l d i fensore. qu el lo d' i mped ire al ne m ico l 'occupazio ne dell e d ue gi ogaje l atera li , e di occupar l e pe rc i ò çg li st esso all a l oro ori gine. e c i oè all'o r igi ne del la va ll e .
L e pos i zio ni di sbarrame nt o ar retrato ne l pe rcorso delle va lli qua l i sono q ue ll e da noi cos tru ite o r in forLate sino ad ora, sono ad unqu e. per co nsegue n1.a inevi t ab i le de ll a loro pos i zio ne, d o m ina te, e fortemente dom in att.:, dal l e alture che so rgo no . nelle du e giogaje latera l i
Q uel l a stessa d ifesa del va l ico. c he si è vol uta ev itare. qual i fican do l a pe r troppo l onta na si deve in og ni m od o r aggi un gere
Ma m i sono se nti to oppo r re « I nos tri padr i avevano pur ess i stab i lito la mass im a pa rt e degl i sbarrame nt i m o nta n i nel co rso de l le valli. cd abbi .imo V in ad i o. Fe nestrelle, Exi lles, Bard [ m a) ques ti sbar rame nti non posssno più ora servire u ti l me nt e pe rchè l e art igl i er ie moderne hanno un a portata tr i pla al meno d i que ll e d i al l ora. ed arr i va no; c d in poc he on; d i f uoco d is t rugge rebbero tu u i qu egli an tiqua ti sbarramc nti "62
60 F.M tNNITI , // seco ndo JJimw gene mie delle Jo r1 ijìca:io11i. .. . c i t.. p I 00
61 Ibid em. p . I 00
<>2 A.ARA LU I , Cli errori co111111 ess i in / /(// ia ne llo d ifesa dello Sl(uo, B o l ogna 1884. pp 12- 13.11 pare re tu u avia no n era affa tto nè scontato nè un i ve rsa lm ente accwato tant ' è che M.MASSAR I Su /1(1 d ifesa generale ci t.. p.9. ribad i va che: " nessu no po trà sos te ner e che i l ch i udere i varch i c he i m o nti ap r o no al ne m ico pe r in va dere il nost ro terr itor i o sia cosa inu tile : si pot r à so l l eva re l'etern a que sti o ne se co nve nga fare un forte di sbar rame nt o a cias cu n passo o sos tituire a più fo rt i una fo rt ezza d i magg i or mole al pi ed e d ei monti H1 ov e le va lli seconda r ie sboccano nt.: ll e pr im ar i e ".
Pa rte Prima
39
La motivazione propositiva che si coglie alle spalle della questione si originava non ultima dalle eccezionali difficoltà, e quindi costi, che avrebbe richiesto l'erezione di opere difensive sulle sommità dei valichi, proprio per la notevolmente superiore impervietà del versante italiano rispetto a quello settentrionale, ed in particolare francese, ed al contempo per la ristrettezza relativa della frontiera alpina italiana, praticamente superata una volta scapolati i valichi.
Quanto sintetizzato conferisce alla catena delle Alpi una vistosa dissimetria difensiva, potendosi pe11anto paragonare idealmente ad uno spa lto mediante il quale i contendenti subiscono un rilevante incremento od un altrettanto rilevante decrernemo cli forze in funzione della sua articolazione. Per l'esattezza quelli favoriti dalla modesta pendenza dell'intradosso-appositamente realizzata- possono con notevo l e facilità raggiungere le posizioni elevate dei camminamenti offensivi, mentre quelli arrestati dalla vertica l ità del suo estradosso finiscono per sottostare ai tiri piombanti della difesa. Il versante itaforno nel nostro esempio disgraziatamente costi tu i va 1'estradosso!
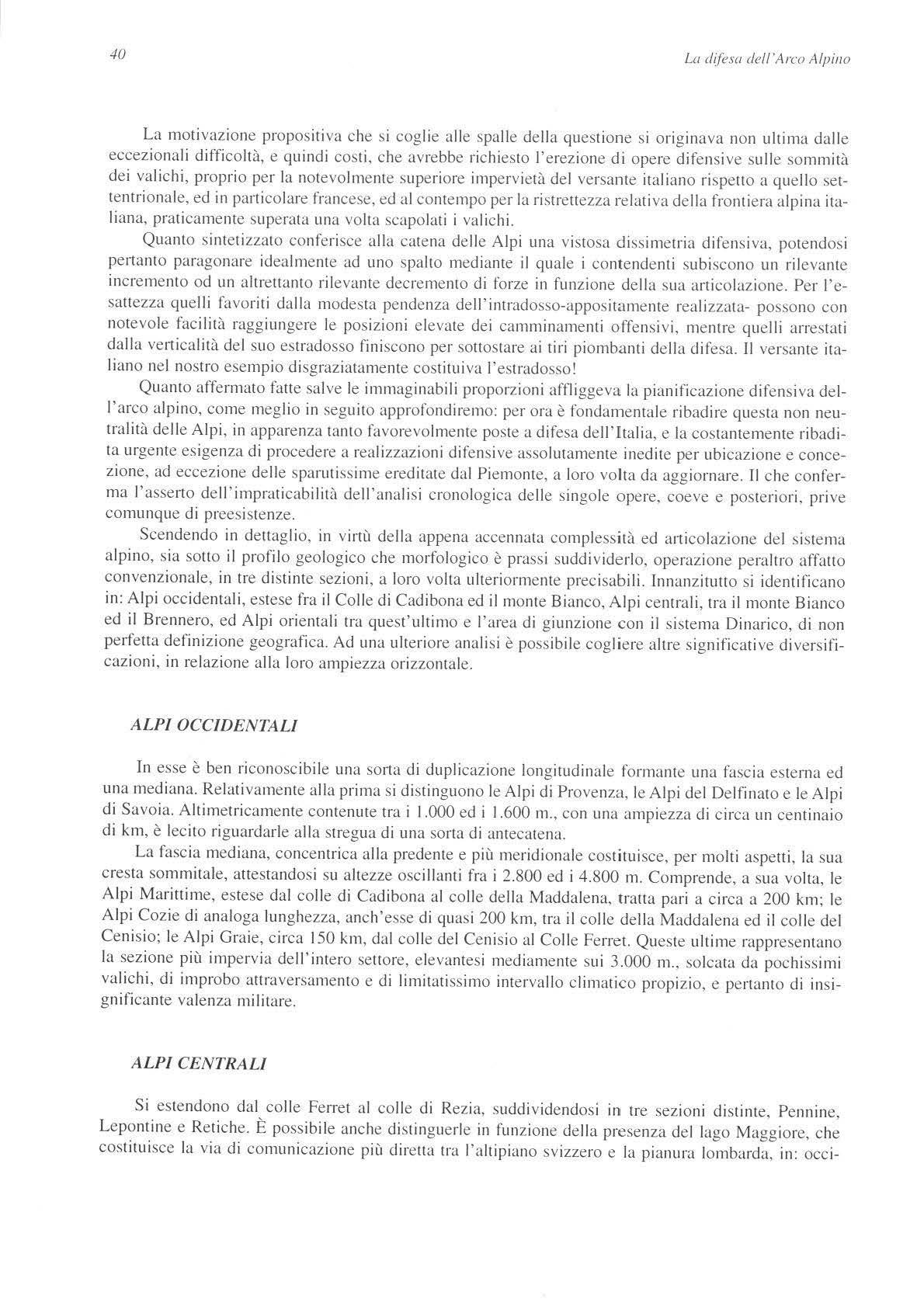
Quanto affermato fatte salve le immaginabili proporzioni affliggeva la pianificazione difensiva dell'arco alpino, come meglio in seguito approfondiremo: per ora è fondamentale ribadire questa non neutralità delle Alpi , in apparenza tanto favorevolmente poste a difesa cieli' halia, e la costantemente ribadita urgente esigenza di procedere a realizzazioni difensive assolutamente inedite per ubicazione e concezione, ad eccezione delle sparutissime ereditate dal Piemonte , a loro volta eia aggiornare. TI che conferma l'asserto dell'impraticabilità dell'analisi cronologica delle singole opere, coeve e posteriori, prive comunque di preesistenze.
Scendendo in dettaglio, in virtù della appena accennata complessità ed articolazione de l sistema alpino, sia sotto il profilo geologico che morfologico è prassi suddividerlo, operazione peraltro affatto convenzionale, in tre distinte sezioni, a loro volta ulteriormente precisabili Innanzitutto si identificano in: Alpi occidentali, estese fra il Colle di Cadibona ed il monte Bianco, Alpi centrali, tra il monte Bianco ed il Brennero, ed Alpi orientali tra quest'ultimo e l'area di giunzione con il sistema Dinarico, di non perfetta definizione geografica. Ad una ulteriore analisi è possibile cogliere altre significative diversificazioni, in relazione al l a loro ampiezza orizzontale.
ALPI OCCIDENTALI
In esse è ben riconoscibile una sorta di duplicazione longitudinale formante una fascia esterna ed una mediana. Relativamente alla prima si distinguono le Alpi di Provenza, le Alpi del Delfinato e le Alpi di Savoia. Altimetricamente contenute tra i 1.000 ed i 1.600 m., con una ampiezza di circa un centinaio di km, è lecito riguardarle alla stregua di una sorta di antecatena.
La fascia mediana, concentrica alla predente e più meridionale costituisce, per mo l ti aspetti, la sua cresta sommitale, attestandosi su altezze oscillanti fra i 2.800 ed i 4.800 m. Comprende, a sua volta, le Alpi Marittime, estese dal colle di Cadibona al colle della Maddalena. fratta pari a circa a 200 km; le Alpi Cozie cli analoga lunghezza, anch'esse di quasi 200 km, tra il colle della Maddalena ed il colle del Cenisio; le Alpi Graie, circa 150 km, dal colle del Cenisio al Colle Ferret. Queste ultime rappresentano la sezione più impervia dell'intero settore, elevantesi mediamente sui 3.000 m., solcata da pochiss i mi valichi, cli improbo attraversamento e cli limitatissimo intervallo c l imatico propizio, e pertanto di insignificante valenza militare.
A LPI CENTRALI
Si estendono dal colle Ferrei al colle di Rezia, suddividendosi in tre sezioni distinte, Pennine, Lepontine e Retiche. È possibile anche distinguerle in funzione della presenza del lago Maggiore, che costituisce la via di comunicazione più diretta tra l'altipiano svizzero e la pianura lombarda , in: occi-
40 La difesa del! 'Arco Alpino
dentali, formate dalle Pennine e dalle Lepontine, ed orientali, dalle Retiche. Al loro esterno non si riscontra una vera antecatena, ma una serie di formazioni quali le Alpi Bernesi, le Alpi dei 4 Cantoni e le Alpi del Reno. All'interno per contro si avvicendano le prealpi lombarde.
ALPI ORIENTALI
Costituiscono con la loro complessa morfologia lo spartiacque fra il mare Adriatico ed il mar Nero. La corrispondenza del confine geografico con quello politico lungo tale settore fu conseguita soltanto dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, limite che ne complicò ulteriormente la logica difensiva postunitaria. ln dettaglio possono individuarsi le Alpi Dolomitiche, le Alpi Carniche, le Alpi Noriche e le Alpi Giulie. Al loro esterno si avvicendano invece le Alpi Tirolesi ed Austriache, oltre ad un rilevante numero di minori massicci montuosi, comunque facenti parte del medesimo intricatissimo sistema, che non a caso attinge in zona la sua massima ampiezza trasversale.
Sempre con andamento concentrico, al loro interno si distinguono le Prealpi Venete e quelle Carniche, che contribuiscono sensibilmente alla impervietà dei siti.
Esaurita la schematica suddivisione longitudinale, è ancora impo11ante rilevare che a carico del versante meridionale, quello italiano, è possibile operare una ulteriore suddivisione in base alle diverse altimetrie. Una prima fascia si origina dalla quota di cresta e raggiunge l'attaccatura dei contrafforti. La sua ampiezza si attesta mediamente fra i 3.500 ed i 7.000 m.: è la più inaccessibile ed inospitale per antonomasia. Nessun tipo di vegetazione vi alberga, mentre invece abbondanti ed enormi appaiono i ghiacciai perenni.
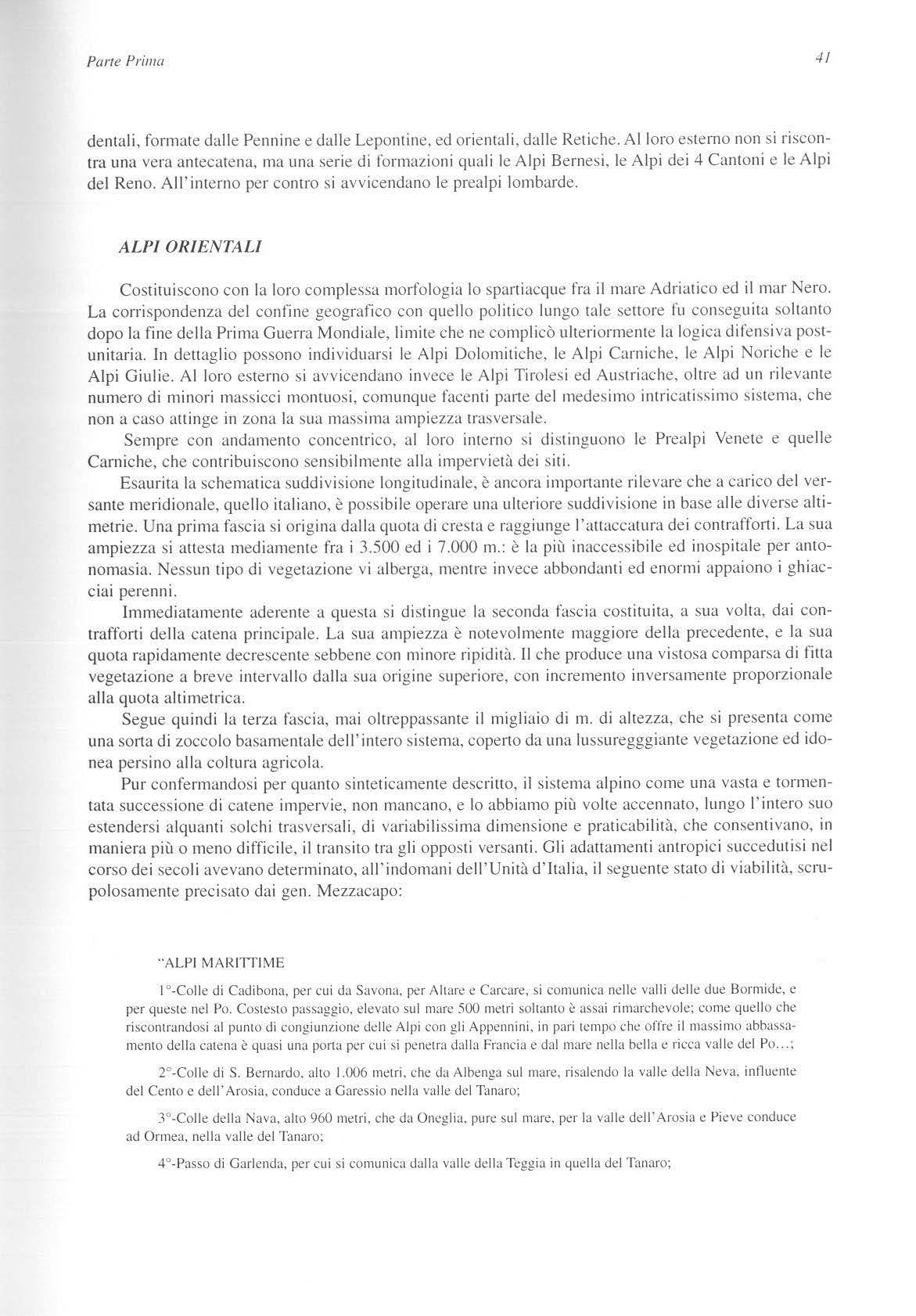
Immediatamente aderente a questa si distingue la seconda fascia costituita, a sua volta, dai contrafforti della catena principale. La sua ampiezza è notevolmente maggiore della precedente, e la sua quota rapidamente decrescente sebbene con minore ripidità. Il che produce una vistosa comparsa di fitta vegetazione a breve intervallo dalla sua origine superiore, con incremento inversamente proporzionale alla quota altimetrica.
Segue quindi la terza fascia, mai oltreppassante il migliaio di m. di altezza, che si presenta come una sorta di zoccolo basamentale del!' intero sistema, coperto da una lussuregggiante vegetazione ed idonea persino alla coltura agricola.
Pur confermandosi per quanto sinteticamente descritto, il sistema alpino come una vasta e tormentata successione di catene impervie, non mancano, e lo abbiamo più volte accennato, lungo l'intero suo estendersi alquanti solchi trasversali, di variabilissima dimensione e praticabilità, che consentivano, in maniera più o meno difficile, il transito tra gli opposti versanti. Gli adattamenti antropici succedutisi nel corso dei secoli avevano determinato, all'indomani dell'Unità d'Italia, il seguente stato di viabilità, scrupolosamente precisato dai gen. Mezzacapo:
"ALPI MARITTIME
I 0 -Colle di Cadi bona, per cui da Savona, per Ahare e Carcare. si comunica nelle valli delle due Bormide. e per queste nel Po. Cos1esw passaggio. elevato sul mare 500 metri soltanto è assai rimarchevole; come quello che riscontrandosi al pulllo di congiunzione delle Alpi con gli Appennini, in pari tempo che offre il massimo abbassamento della catena è quasi una porta per cui si penetra dalla Francia e dal mare nella bella e ricca valle ciel Po ;
2
° -Colle di S. Bernardo. alto 1.006 metri , c;he da Albenga sul mare, risalendo la valle della Neva, influente del Cento e dell' Arosia, conduce a Garessio nella val l e ciel Tanaro;
3
° -Colle della Nava. alto 960 metri, che eia Om:glia. pure sul mare. per la valle dell' Arosia e Pieve conduce ad Ormea. nella valle del Tanaro;
4° -Passo di Garlenda, per cui si comunica dalla valle della Teggia in quella del Tanaro;
Parte Prima 41
5 -Colli! di Tanarcllo. alto 2. 063 metri. il quali: conduce cfall' Abbazia di ,. Dal mauo. nella \'alle cklla Roja. per Briga in quella del Tanarello, inllul!nll! del Tanaro;
6 '-Colle della 'fbta di Ciauuon. chi! da Tenda. nella valli: della Roja. conduce in quella uc.:I Pc~io. intluente del Tanaro:
7°-Colle di Tend~1. alto I .900 llll!tri, che da Nizza. per Sospdlo, la \'alle della Roja, Saorgio e Tenda. conduce per Borgo San Dalmaao a C un l!o, nell:i va ll e <k lla Stura. inlluentc del Tanaro;
8 -Colle del Sabbione, alto 2.30-I metri. che dall'Abba11a S. Dalma110. nella ,alk: della Roja. conduce a Valdieri in qudla del Gesso. inlluentc della Stura;
9 "-Colle delle rines tre. alto 2.-190 metri. che da S. Martino Lantosca cond uc e nella valle del Gesso;
I 0 °-Collt: di Fn:rnamorta. alto 2.575 metri. che conduce ndla ,·alle della Tinca. inllucntl! del Varo. in quella del Ges,o;
I I 0 -Pa5so di Co lla Lunga. nito 2.573 metri. che da Iso la, nella valle dc.:lla Tinca. conduce a Vinadio in qu ella della Stura:
12 ' -Colle del!" Argentera o della Maddalena. alto 2.019 metri, pc;:r cu1 da Barc.::ellonetta. nella valle ddl'L'baye. inlluentc udla Durane\!. si giunge a Demontc nella valle della Stura:
I 3° -Co llc:: di Maurino. alto 2.982 mc::tri. che dalla valle dcll'Ubaye conducc in quella del la Maira. influente del Po;
1-t -Colle di Longet, alto 2.702 metri, che dalla valle dcli' Uhaye. per Ponti! Chiana le. conduce a Ca,teldeltino in quella ddla Varniia. influente del Po;
15 ° -Collc dell'Agne ll o. alto 2.796 mc::tri, che ùa Queyras nella valle del Guil. inlluente della Durance. conduce pure a Casteldellino 63
Intorn o al 1860, i passi elencati non rappresentavano altrellanti valichi stradali. Erano, infatti, attraversati da :, !rade rotabili so ltanto i colli di Cadibona, di S. Bernardo e di Neva. Una carrareccia, invece, scavalcava I' Argentera, ed un'altra il colle di Tenda. I restanti poi si proponevano semplicemente come itinerari mulattieri, pedonali o al massimo per bestie da soma. Per tutti, inoltre, il transito risultava possibile unicamente nel periodo non innevato, che oscillava da un ma ssimo di cinq ue mesi ad un minimo, in particolare a Finestre, di appena due: luglio ed agosto.
"ALPI COZIE
I ' -Colle delle Travcrsc11e. nito 2.995 melri, che da Quc::yras. rimontando In va ll e del Guil. conduce in quella del Po:
2 -Colle della Croce. alto 2.3'.!0 merri. che da Que)ra~ conduce nella ,alle del Clusone, intluente dd Po:
3° -Colle d' Abries nuovo, c:he da Queyra~. per Perrcrn e l'erosa, conduce nella va lle del Clusone. inllL1Cntc del Po;
4
° -Colle di Thurra. che da Queyras conduce alle:: sorgemi della Dora-Riparia. intluen1e dc.:I Po:
5 ' -Collc di :-.1ont-Gcnèvre. alto I .865 metri. che da Brian\'On. nella valle della Durance. conduce:: per Cesanne, Oulx ed Exi ll es a Susa. in q ue ll a ddlri Dora-Riparia. in flu ente de l Po;
6 ° -Colle del Monte-Cenisio. alto 2.06-t metri. che da ~lodane e Lanslehourg. nella ,alle dell'Arc. conduc:e a Susa in quella ddla Dora-Riparia:
7c.Colle dcli' Auraret, che dalla valle dcli' Are: co nduc e a Balme in qL11.:lla del la Stura di Lanni:
8u-Colle del Carro. chc dalle sorgenti del!' Are conduce nda \'alle:: de ll' Orrn ...... 6.J
6.1 L. e C.MLZZi\CAPO. S111di topografici cii.. pp. 19-21. t..i Ibidem. p.22.
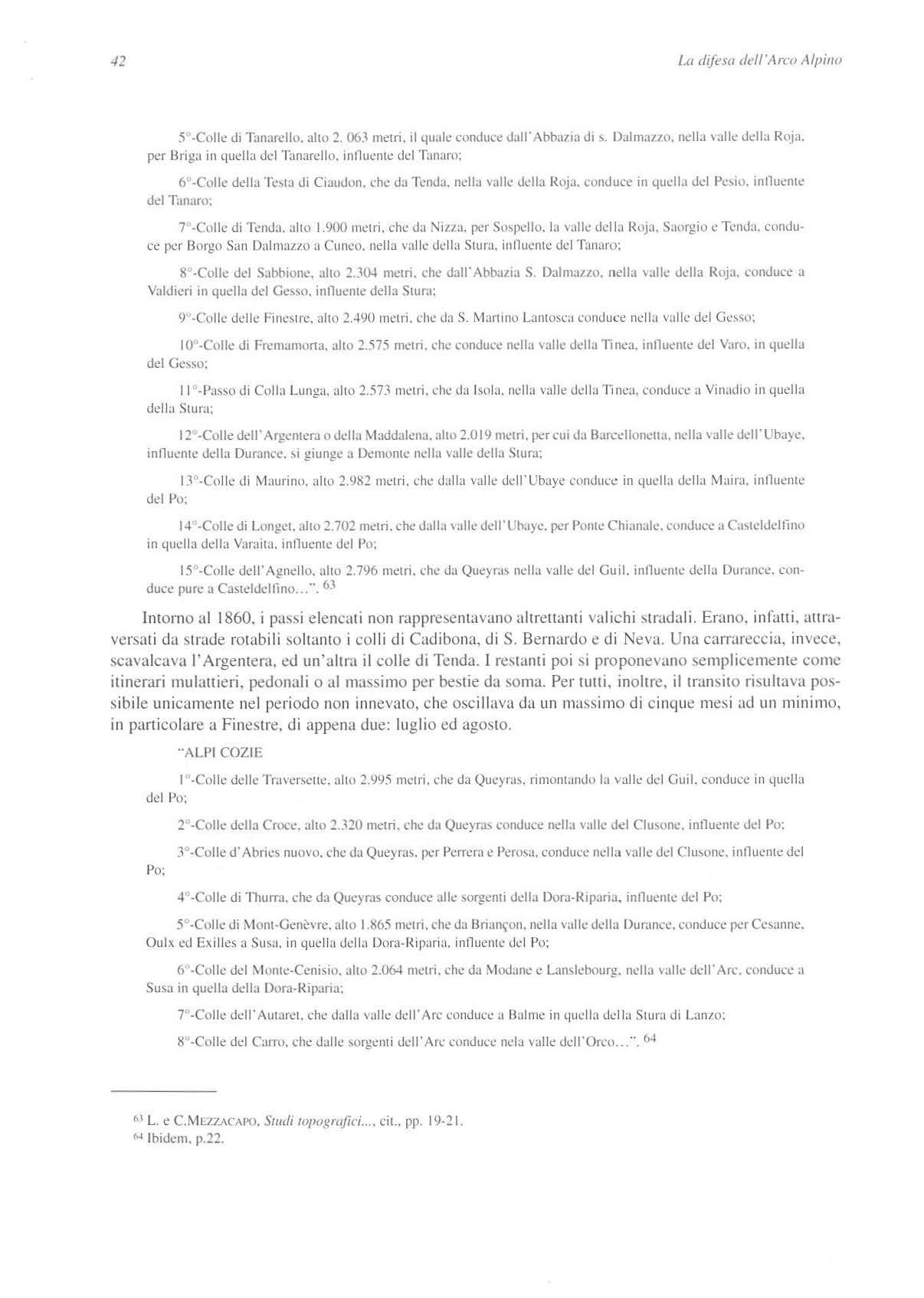
./2 La difesa dell'Arco Alpino
Al pari dei precedenti, soltanto il valico del colle di Mont-Genèvre era attraversato da una discreta strada rotabile. Una cattiva strada postale scavalcava, invece, il colle del Moncenisio, mentre per tutti i restanti il passaggio veniva consentito esclusivamente da tortuose ed impervie mulattiere. Circa la praticabilità stagionale si andava dall'innevamento perenne del valico del Autaret e del Carro all'intervallo massimo di tre mesi privo di nevi, per gli altri.
"ALPI GRAIE
I 0 -Colle del Piccolo S. Bernardo, alto 2.192 metri, il quale conduce da Moutiers, nella vnlle ddl' lsére, per Borgo Saint-Mauricc ad Aosta, nella valle della Dora-Bahea:
2 ° -Colle della Seigne. alto :!.462 metri, che da Borgo S. Maurice, costeggiando il monte Bianco. conduce nella valle della Dora -Bahea 65
Soltanto il primo era attraversato da una discreta strada rotabile, e risultava sgombro dalla neve da maggio a set1embre. 11 secondo transitabile solo pedonalmente, o con bestie da soma, restava sgombro luglio ed agosto.
"ALPI PENNINE
I 0 -Colle ciel Gigante. allo 2.49 I metri, che da Chamounix, nella valle cieli' Are. per disagevole sentiero non mai sgombro dalle nevi. costeggiando il monte Bianco conduce nella valle d'Aosta;
2 ° -Colle del Gran S. Bernardo, alto 2.491 metri il quale da Martigny, nella valle dell'alto Rodano, per SainlPierre e Saint -Remy conduce ad Aosta, nella valle della Dora-Baltea ·•. 66
Il primo itinerario era costituito da un approssimato sentiero ripido e disagevole. unicamente transitabile da pedoni e bestie eia soma, per giunta innevato l'intero anno. Il secondo, sebbene anch'esso impraticabile per i veicoli a ruote e sgombro da neve solo due mesi l'anno, luglio ed agosto, vantava il significativo precedente storico militare cli essere stato impiegato nel I 800 da Napoleone con l'intero corpo principale della sua armata, previo ovviamente lo smontaggio ed il someggiamento sia dei carriaggi che delle a11iglierie. Nel 1859 si lavorava a trasformare il percorso in strada rotabile operando un traforo presso Ménouve.
"ALPI LEPONTINE
1° -Colle del Sempione. alto 2.005 metri, che dalla valle del Toce. influente del Ticino, rimontando a sini stra la valle del Diveria. conduce in quella del Rodano, meuendo per tal modo in comunicazione Domodossola con Brigg;
2° -Col le del Gries, alto 2.383 metri. che risalendo la val I..: d..:I Toce, mena a S. Ulrichen. in 4uella del Rodano;
3° -Passo del Nufen, che dalle sorg..:nti del Ticino conduce a quelle del Rodano;
4 ° -Colle del S. Goliardo, alto 2.075 metri. per cui rimontando la valle del Ticino insino ad Airolo. si passa nel versante opposto ad Ospitale ed Altorf, nella valle del Reuss, uno degli influenti cieli' Aaar;
5° -Colle di S. Maria o del Lukmani..:r. alto 1.865 metri. cht: eia Airolo conduce alle sorgenti del Reno ". 67
La viabilità era costituita principalmente dall'ottima rotabile del Sempione, voluta da Napoleone nel I 8 I 2. Un'altra buona strada attraversava pure il S. Gottardo. Per i restanti valichi, invece, si trattava delle solite mulattiere. Il periodo sgombero dalla neve per le menzionate strade andava da maggio a settembre per la prima, e da giugno a settembre per la seconda, mentre le mulattiere restavano coperte l'intero anno.
6 5 lbidt:m, p.23.
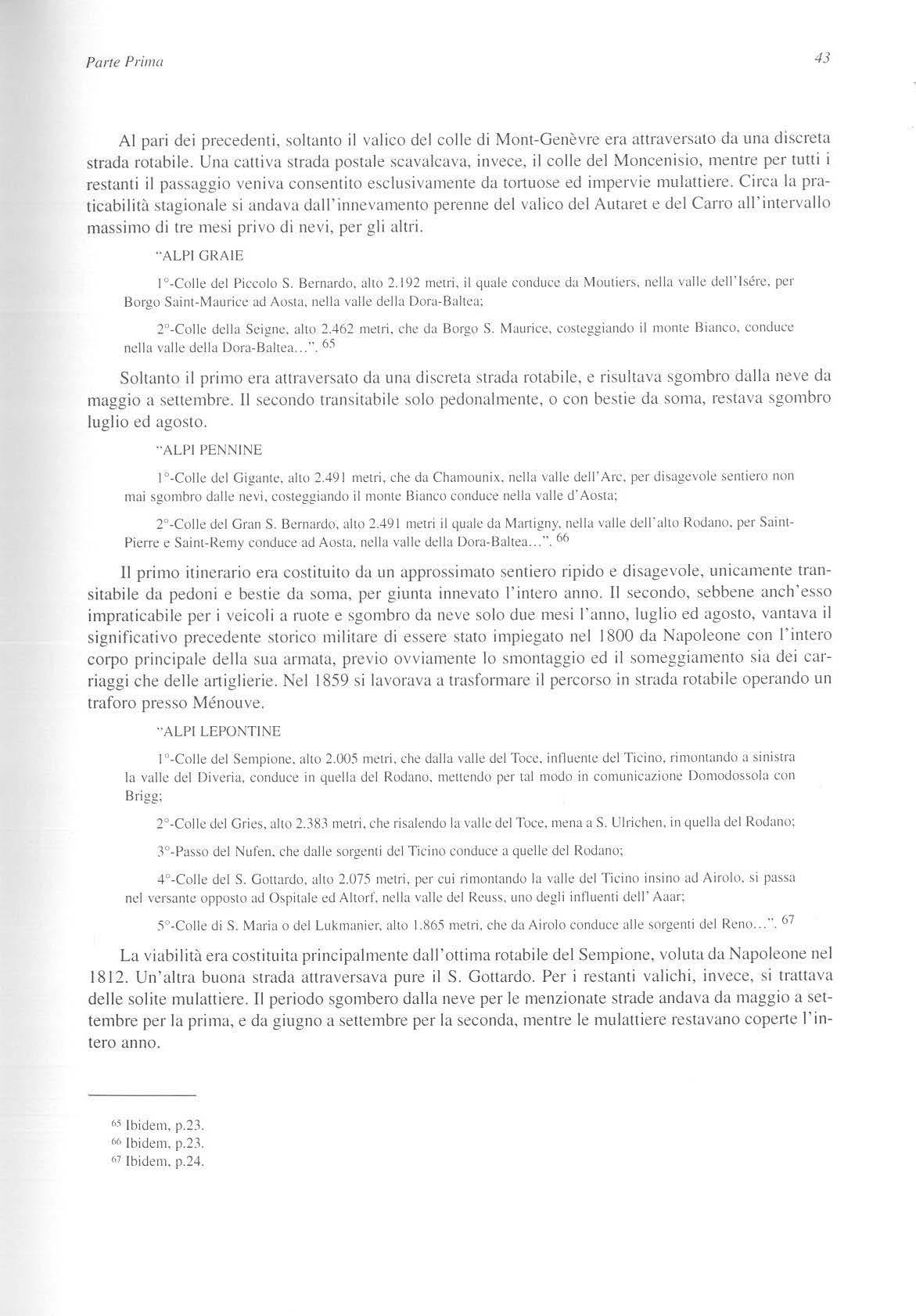
N > Ibidem. p.23.
6 7 Ibidem, p.24.
Parte Prima 43
'"ALPI RETICHE
1° -Co ll e del S. Bernardino. alt o 2.138 metri, che da Bellinzona, nella valle del T icino. risalendo a destra la Moesa. conduce a Spl ugen, nell'alta va ll e del Reno:
2° -Colle dello Sp lugen. o Sp lu ga. alt o 2. 115 metri. che da Chiavenna, nell a valle della Mera, conduce pure a Sp luge n e meue in co mu nicazione la val l e dell'Adda con quella del Reno;
3° -Colle c1· /\equa Frnggia. o della valle del Lei, al to 2.676 metri. che da Chiaven na cond uce ad Anders. nella valk dt:ll'a l to Reno;
4 ° -Colle del Monte Septim t:r o Seui mo. che da ll a so rgente della Mera co nduc.:e a Lenz. nella va ll e dcli' /\bual. influ ente del Reno;
5° -Collc cli Mal oia, o Maloggia, che dalla sorgente della Mera conduce a S. Moriz e Zcrnetz, nell'alta valle dell' l nn.
6
° -Colle d i Bernina, o Posso di Poschiavo. alto 2. 121 metri. che da Tirano, n dla va ll e cieli' Adda. co nduce in quell a del l' I nn, a S. Moriz:
7 ° -Collc di Tchirf, o di Tauffers. i l quale da G lu rns o Glorenza, nella va ll e Jdl' Adige. conduce a Zernetz in quella dcll'lnn;
8° -Colle di Fin i sce rre, di Reschcn. Rcsca. o Rascno. al to 1. 566 metr i che da G l ore nza cond uce a Nauders, nel l a valle dell'lnn;
9 ° -Collc di Nos tra -Signora l Unser-Frau) c he da Nn tu rn i. nella va ll e del!' Adige. conduce a Soldcn e di lì ad Ham in gen. nella valle dell' lnn.
I 0 ° -Colle, che d:1 Merano. nella vall..: dcl i' Adige. risalendo il Passeyr sino a S. Leonardo, cond uce a So ld en;
11° -C olle de l Brenner. alto 1.450 metri, che fa comunicare Botzen. o Bolzano, con l nnshru ck risalendo l a va ll e dell 'Eysack. o lsargo:
12° -Col l c, che da Stercz in g , sull'lsargo risalendo l a va ll e di S Giacomo ad orien te del Br..:nner. co nduce nella valle del Ziller, intl uent c dell'Inn . " 68
Le strade rotabili attraversavano il S. Bernardino, lo Splugen, il Mal oia, il Fincstcrre ed il Brennero, sgo mbre dalla neve tra giugno e settembre Il Settimo, in vece, disponeva di pessima strad a carrab il e e i restanti va li c hi solo di mulat1iere:i periodi cl imati ci non innevat i restavano identici.
"A LPI CARN I C HE
1° -Collc di Toblach. allo 1.266 metri. che mene in comu nicazione la va ll e dçll'Eysach, r isal endo il Rienz per Bruneckcn. con la va l le della Drava;
2
° -Collc di Kreutzberg, al to 1 105 metri. che da ll 'alta val l e de l Piave. r i sale ndo il Comelico, a greco d i Cado re conduce al l a sorge nte della Drava;
3 ° -C o l le del Monte-Croce. alt o 1.656 metri. che da Tolmezzo. nell a valle dd Tagliamemo. co nd uce in quella del l a Or ava, a Drauburg;
4 ° -Collc del Tarvis o di Saifnitz. al to 869 metr i , il quale pe r la va ll e della Fella. infl uente del Tagliamento. co nduce per Tarvis a Villach, sulla Drava;
5° -Colle d i Reclilò. al to 1.169 met r i, c he da Capo rett o, nella va ll e dell'Isonzo. per F l i tsch e l a Chiusa, co nduce a Tarvis ". 69
I colli di Tabl ach, di Tar v i s e di Predii ri su lta va no scava lcati da altrettante strade rotabili, mentre i restanti due da se mplici mulatti ere La loro percorribilità si limitava al per iodo compreso fra maggio e settembre per il primo e da giugno a se ttembre per il secondo. Costituivano il tramite principale fra l'Italia ed il cuore d ell ' impero austriaco.
M Ibidem. pp.25-26. r.9 Ibidem, pp.26-27.
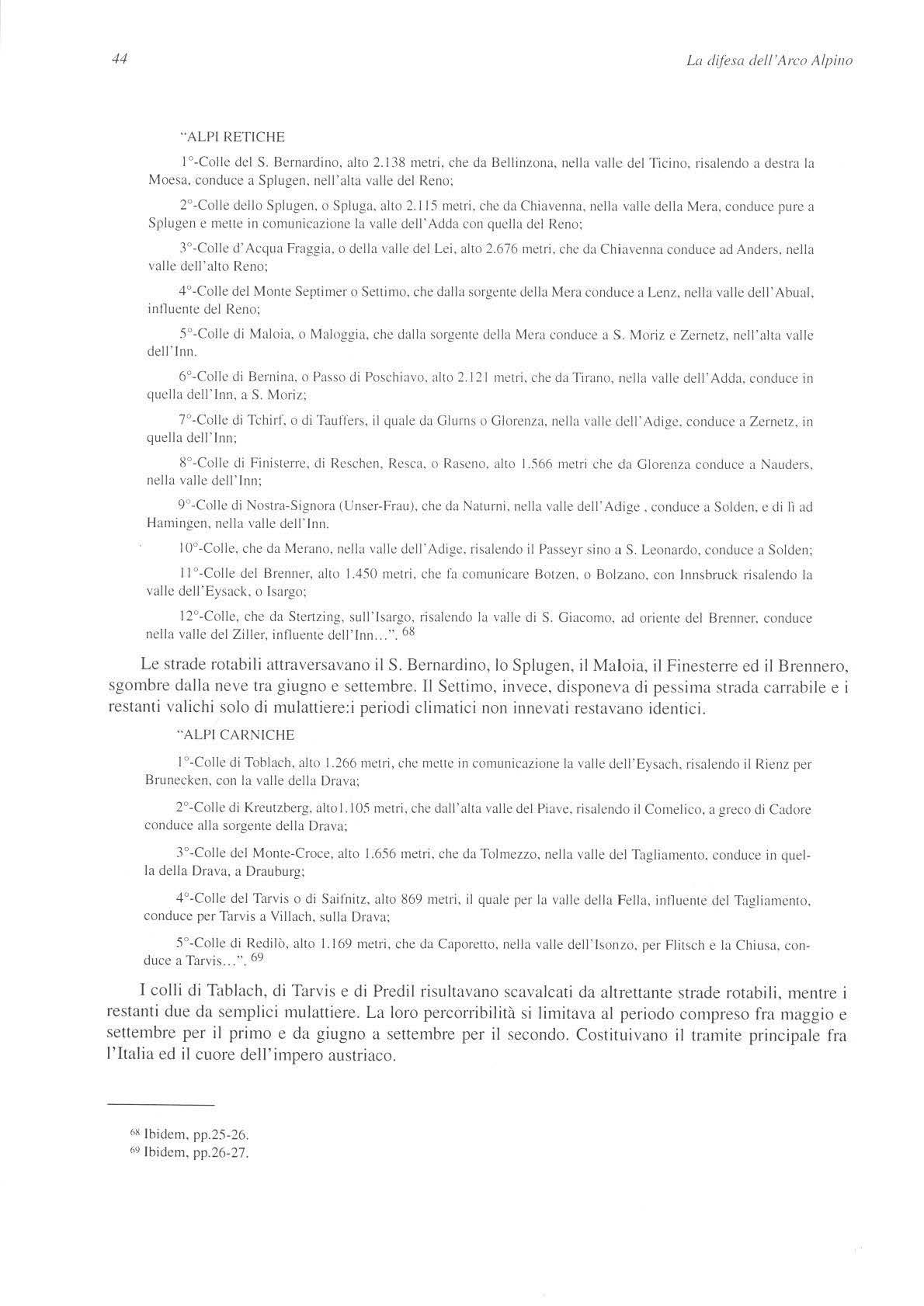
44 La difesa dell'Arco Alpino
··ALPI GIULIE
I 0 -Collc di Loitsch o cli Prcwald. che da Leybach, o Lubiana. conduce ad Adelsberg, e di lì a Monfalcone e Gorizia. sull'Isonzo;
2° -Colle. tra Lubiana e Zirknitz, ad oriente d' Adclsberg 70
Entrambi i colli disponevano di strade rotabili, di buona e discreta qualità, percorribili sgombre da neve da apri l e a novembre.
Ovviamente la maggioranza dei menzionati valichi e passi, in maniera certamente diversa ma sempre pericolosa, si riguardavano come possibili vie d'invasione, e pertanto si ritennero, almeno in prima istanza, da sbarrare con altrettante opere fortificate, tranne quelli logicamente situati nei settori ancora di dominio austriaco.
Concetto di Fontiera
Il concetto cli frontiera, nell'accezione romana della parola, stava ad indicare la fascia perimetrica conclusiva del mondo civile o civilizzato, al di fa della quale imperversava l'arretratezza barbara e l'assoluta mancanza cli sicurezza esistenziale 71 Non a caso la sua definizione, quando scandita da fortificazioni antinvasive-a lungo semplicemente antintrusive-, fu di /imes, vocabolo ancora presente nell'etimo di 'limite' 72 : ed il limite rappresenta appunto l'estremo di un insieme omogeneo, assolutamente distinto dal suo indefinito 'esterno', e perciò 'giusto' nella sua dimensione. ln poche parole era la conclusione del territorio imperiale.
Assolutamente divergente quindi dall'odierno significato, proprio per la sua evidente unilateralità. Il concetto moderno di frontiera, infatti, indica l a linea di separazione tra due stati autonomi e sovrani, soggetti cli pari dignità sociale e politica, sostanzialmente equivalenti e simili, sebbene di precipua aggregazione storica, istituzionale, ed etnica. È in quanto tale risultato di bilaterali convenzioni e trattazioni, magari non sempre pacifiche, ma costantemente confermate e rispettate reciprocamente.
Per meglio evidenziare la profonda divergenza proprositiva dei due concetti, basti osservare che quello romano a 'definizione unilaterale' si attag li a perfettamente anche al perimetro costiero-frontiera marittima-, molto più coerentemente ciel moderno, non potendosi, con la sua concezione a 'definizione bilaterale' ravvisare, a l di là del bagnasciuga, un concreto confinante. La superficie ciel mare, sotto questo profilo corrisponde perfettamente ad una sorta di territorio 'esterno', non abitato eia precise etnie stabilmente residentivi, ma percon·ibile in ogni rnomento, e da qualsiasi provenienza, da parte di formazioni cli barbari miranti alla penetrazione razziatoria all'interno della menzionata frontiera.

1n Ibidem, p.27.
7 1 Il termine "barbaro' indica infatti chi è stran i ero. ovvero chi risiede all'esterno dello stato. Ma clefiniscc al contempo chi è arretrato culturalmente di rozzi costumi, privo di qualsiasi c i viltà. E probabilmente l'accozzaglia indistinta di tribù esistenti all 'esterno dei confini imperiali trovò proprio nell'ostilità a Roma il suo cementante culturale. Aikrma M.MAZZA. Lolle sociali e res1(111ra~io11e (11//ori/(/ria nel lii sec. d.C.. Bari 1973. p.226: ·· la politica di frontiera che Roma condusse nei confront i delle popo l azioni contigue al limcs presentò aspclli decisamente vessatori; i quali in conclusionc contribuirono ad un i ficare le genti germaniche, in origine divise ccl in perpetua guerra tra l oro. nella comune opposizione alla po1enza romana Non potevano mancare in definitiva l e ragioni cli odio contro Roma tanto più [che]. con il miraggio cli un civ i ltà ricca e opulen1a essa stimolava le brame cl i popoli bellicosi che erano nati alla guerra e nella guerra avevano uno elci modi rondamentali per la risoluzione dei loro problemi economici .''.
72 Il termine ' l imes' al meno in izialmente non in dicava affatto un confine di t ip o perimetrico, ma semplicemente un itinerario di penetrazione nel 1erritorio non ancora assoggenato. È interessante quanto affermano R.FOLZ, A.Gl' ILLOU, L.MussET, D.SOURDEL, Origine e fon11t1~io11e del/'E11ropa 111edie11tile. Bari 1975. p.17: ··Dall'altra pane del Reno e del Danubio si estendeva il mondo germanico. Tra questo e l'Impero non si potrebbe parlare di una frontierra etnica A partire dalla fine del Il secolo s'inizia la pratica di reclutare dei prigionieri barbari per ripopolare e rivalorizzare le regioni devastate "
Parte Prima
45
Indiscutibile che in siffatta concezione la peculiarità certamente più specifica era insita nel presumere lo spazio esterno alla frontiera comunque e sempre ostile, saltuariamente attraversato da orde invariabilmente infide. Da lì ci si sarebbe dovuti attendere unicamente incursioni predatorie, nelle peggiori delle ipotesi anche invasive, ma mai l'istaurarsi di rapporti pacifici, con gli eventuali abitanti, supportati da una pari dignità culturale e materiale. Persino nei casi di accertato s.tabile soggiorno di organizzate e numerose popolazioni. il massimo riconoscimento reale di cui vennero gratificate fu la trasfonnazione in comodi 'cuscinetti' od in feroci guardiani della terra di nessuno n.
Posta in questi termini la detenni nazione del la frontiera appare non solo unilaterale e discrezionale, geograficamente e militarmente, ma, al pari della fascia del bagnasciuga, interposta addirittura tra due distinti stati d'aggregazione fisica, non omogenei tra loro.
La puntualizzazione non è affatto irrilevante, poichè ci consente di individuare alle spalle della odierna concezione di 'confine', termine quest'ultimo attualmente del tutto equivalente a quello di frontiera, intesa però nel suo globale dipanarsi, una lontana diversificazione, che soltanto lentamente si attenuò. Ma per moltissimi secoli a differenza del ·confine', che indicò appunto la linea di separazione-concordata o imposta-tra due proprietà, o aree-anche non necessariamente nazionali, come ad esempio agricole- la frontiera designò l'estremo limite difensivo, la fascia presidiata dalla compagine più evoluta, e più ricca, comunque la sola interessata alla sua definizione, e soprattutto alla sua inviolabilità, equiparandosi implicitamente l'eventuale penetrazione al saccheggio o alla razzia. piuttosto che alla conquista territoriale. Curiosamente dove la qualificazione di ·frontiera' permase più simile ed aderente all'orginale antico, ovvero nel caso di quella marittima, cadde prima in disuerudine, imponendosi, invece, nella designazione dei confini terrestri, ·frontiere' per antonomasia. Il che purtroppo implicò l'adozione di approssimate definizioni.
Il perimetro di frontiera, infatti, per l'accennata genesi storica. non poteva configurarsi in una nitida linea sorvegliata da entrambi i versanti con pari interesse, ma come, già accennato, con una fascia di variabilissima ampiezza, premessa del territorio ostile. In quanto tale non è assimilabile nemmeno alla ·terra di nessuno' poichè tale attribuzione suppone, implicitamente, una plurità di contendenti se non di pari dignità, almeno di pari aggressività. Era semplicemente il dissolversi territoriale dell'autorità civile e militare di un unico stato, in una sorta di deserto, come nell'accezione marittima, della terra nell'acqua.
La conferma dell'asserto può cogliersi nell'osservare che allorquando l'Impero Romano munì le sue frontiere più minacciate di articolate fortificazioni antintrusive, nulla del genere si realizzò sul versante opposto!7..t li che le equipara in ogni dettaglio, ovvero militarmente, concettualmente e persino foneticamente con le fortificazioni erette quasi 14 secoli dopo, lungo le coste peninsulari, finalizzate a loro volta a frustrare le scorrerie 'barbaresche', anch'esse prive-ovviamente-cli contrapposte opere difensive nemiche.

Inizia così a distinguersi un ruolo ed una tipologia di fortificazione di frontiera non genericamente difensiva, ma precipuamente ostativa, od antincursiva, tesa comunque ad interdire la penetrazione, anche e soprattutto temporanea, nel territorio posto alle sue spalle ai razziatori, unica concreta e temibile minaccia data la notevole disparità cli forze globali 75, imperante tra i due opposti settori.
71 Precisa A.H.M.JO:,JES. Il 1m11w1110 del mondo a111ico. Bari 1972. p.319: Al di là c.Jei confini, il governo romano aveva sempre cerca!O di mantenere uno schermo protettivo stabi l endo tranati con i capi barbari che vivevano nelle vicinanze. Questi ultimi si impegnavano a non razziare essi stessi le province romane e fornivano forze per la proti.:Lionc dclii.: stesse. Da pane romana \''era l'impegno di proteggere i barbari dai loro vicini "
7 ~ 11 fenomeno ricorda molto quello attuale dcll"immigrazione clandestina: anche in questo caso il ti.:rminc di l'rontiera presenta un solo imeressato al suo rispeno. essendo la pressione del llusso migratorio unidire,.ionalc.
7 ~ 11 fat!O che tra i due opposti schieramenti vigesse una notevole differenza ·globale' di forze. non significa allatto che non fossero possibili prevalenze locali invi::rse. situazioni.: tipica che si manifesta nel corso di una riuscita scorreria.
46 La difesa Alpino
ln a ltri termini, a differe nza della maggior pa11e delle fortificazioni che si prefigg eva no la protezione cli quanti al l oro interno raccolti, e pertanto effellivamente difensive, que ll e osta ti ve-od antintrusive, od ancora antinvasive e comunque di sbarramento - fungevano da mero supporto tattico per guarn i g i oni che, non di rado , avrebbero combattuto al momento opportuno al l oro esterno, intercettando possibili aggressori. Così un noto ana li sta militare si ntetizza la asser ita atipica valenza difen siva di tali opere:
1 Rom ani non ~ono in genere considerati un popolo irra z i ona l e o rndardo. tuna via l e open:: ;,tabi li di difesa da ess i costruite sono state spesso considcrntc sia inutili. sia corruttr i ci, come se l a semplke pn.:senza di queste difese i'i sse avesse polllto dar luogo ad una fatale mentalità da 'Line a Mag inot'. Quest i gi udizi r i ll ettono non solo la moderna consapevo l eaa de l crollo di tale sistema. av\'cnuto ncl 111 scc. d C., ma anche un p regi udii.i o C'iausewitzia no, apparentemente in estirpa bile, contro l e strategie e le costruzioni d ifens ive. un p regiudizio rnmunc sia i'ra gli storici che si occ upano d i Adriano e della sua po l itica. sia fra g l i espert i mi li tar i comempora nc i. chc d iscuwno sul le difosc miss il i~tiché odierne
Lt di rese di confine dt ll 'impero romano, nei setto r i provvi~ti di lincc di barr i era come mura. pal i t.Late, steccati o fo rt i l' i cazioni in te rra battuta. erano lin ce swdiatc per oppo rsi a pericoli d i bassa int ensit à. sopra tt utto infi ltrazioni di sconfinamento e incursioni periferiche. Tal i barric rc non avevano l o ~copo di fornirc una difesa as5oluta contro at tacch i su larga sca l a; al co ntrari o t'ntrambi i t ipi di l imcs. si a 4ue ll o ·aperto· che q ue l lo 'chiuso' (ciol! mun i to d barr i ere cont inue), servirnno come linee d i base pcr 1c J'or 1.é mobili d'attacco. chc ope r ,wano seg uend o una tattica di offesa. ma se mpre ne l conte~to di u na stra tegia dii'ensirn. contro g l i auacchi su la rga sca l a ". 76
Quanto affermato no n implicava affatto uno stato di guerra riconosciuta quanto piuuosto un a condizione di instabilità agg r essiva di popoli nomadi, o seminomadi, attratti dalle ri cchezze interne all'impero. Del resto lo sta to ufficiale di belligeranza avrebbe supposto un riconoscimento formale de ll e etnie estern e all a frontiera, mai in pratica nobilitate di si ffatta qua lifi ca, ma sempr e accomunate so tt o la generica etiche tt a di barbare o nomadi.
Ora esse nd o la minaccia delle scorrerie barbare-o delle incursioni da mare barbaresche-istigate dalla magg i ore ricchezza della compagi ne vitt i ma, o dalla sua più abbondante massa di potenziali prede, la vio lazi one delle frontiere diven ne subito sinonimo di saccheggio c he, trascurando le atroc ità e le deportazioni, ostentavano cos ti precisi per la co ll e1ti vità in termi ni di beni dis trutti o sottratti. Tale ammontare costituì in ultima ana li si il li mi te es tr emo di spesa sopportab il e per la difesa. Non sarebbe stato in altri termini sensato - e nemmeno a ll a l unga possibile-spe ndere I 00, per salvaguardare 50. ri cevendosi così il maggior danno propr i o dalla r ealizzazione e dalla gestione del sistema antincurs i vo li panicolarc vincolo in realtà, sia in epoca romana, lungo le frontiere europee. c he in epoca moderna lun go quelle marittime mediterranee, cost itu ì inevadibilmente un rigidissimo crite ri o per l e st r ategie difens i ve, costre tt e a divincolarsi con in significant i stan ziamenti. Le inc ursioni in fatt i, al di là della loro terroristica estrinsecazione ed efferata perpetrazione, qua nd 'anche notevolmente frequenti se computate nell'interezza economica dei danni arrecati si confe rm aro no se mpre non parti colarmente si gnificative in relazione ai bilanci g l obal i delle vittime-pur riu scendo devastanti i n relazione alle risorse locali-e q uindi non poteva no, proprio perchè non eccezio nalmente onerose -d etermin are l o storno di c ifre rilevanti per la frustrazione. Spiegabile così la preferenza accordata, sia dall'impero romano, che da quello spag nolo quindici secoli dopo, all'evacuazione dei territori la c ui difesa si preventivava eccess i va men te gravosa 77 Indispensabi l e allora adottare sis temi in grado di fornire la massima protezione co n la minima spesa, antiteti c he esige nze semp re difficilmente conciliab ili , e comunque solo nell'ambito di una va lenza complessiva ma mai assoluta.
Scendendo in dettagl i o quanto rimarcato impli cò il magg i o r ricorso all ' in ser imento nei trac ciat i difensivi degli ostacol i natural i, quali co rsi di fiumi, catene montane, e cos te marittime, altrettanti amplificatori dell'impianto fortificato contro ri sch i a bassa inte nsi tà ed a notevole frequenza, anc he a costo di
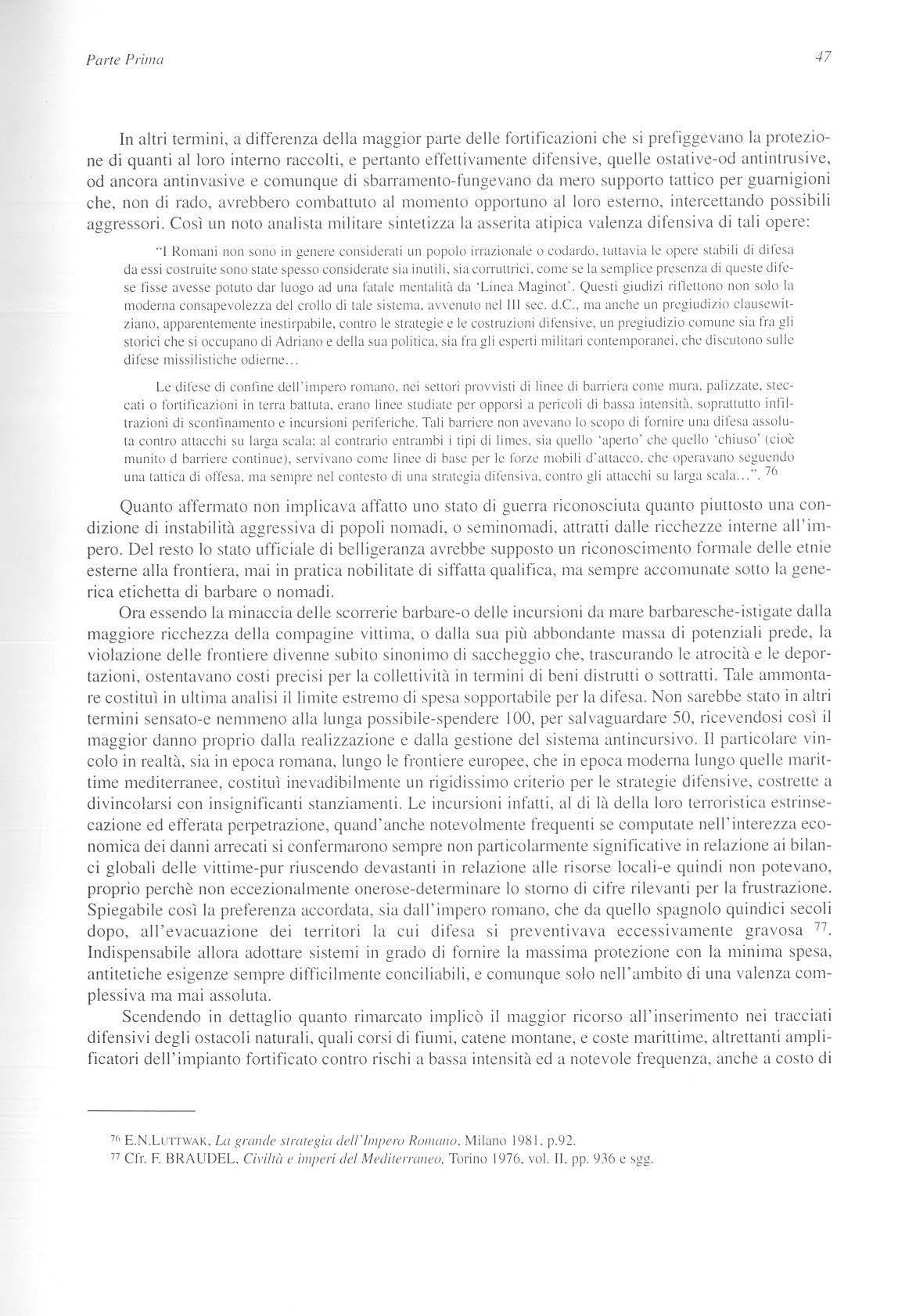
76 E.N.LUITWAK. La grnnde s1raregia del/ '/111pe,v Romanu. Milano 1981. p.92
C
Parre Pri111a 47
77
J'r. F. BRAUDEL. Ciri/1à e imperi del Medilermneu. Torino 1976. voi. Il. pp. 936 c sgg
far retrocedere la linea di frontiera. Più accortamente sarebbe preferibile parlare di 'disomogeneità' morfologiche naturali, piuttosto che di ostacoli, rivelandosi invai'iabilmente le predette i veri fattori di rallentamento e di diluizione degli attacchi incursivi. La perfetta padronanza difensiva di tal i connotazioni, ed il loro succedersi lungo una linea difensiva ostativa, produsse in definitiva, quella che è stata definita 'frontiera scientifica', ovvero un ponderato studio del tracciato della stessa ondè contenerne al minimo gli oneri difensivi, in uomini e suutture. Così il già citato analista:
"La politica di sicurezza imperiale iniziata dai Flavi aveva chiaramente subito un processo di maturazione. e la sua c aratteristica fondamentale era divenuta una scelta deliberata a favore di frontiere regionali ottimali. non solo in base alla loro co nvenienza tauica e topografica, ma anche in base a ragioni stretegichc in senso lato: in altre parole. delle fro ntiere che potremmo definire ·scientifiche'
questo tipo di confini ·scientifici' non ha lo scopo di racchiudere il massimo territorio possib i le, bensì la qu amità ottimale di territorio- cioè, in altre parole. l' area che è vamaggioso includere dal punto cli viStll politico. econ o mico e strategico. Il frame più breve non sarà quindi necessariamcntc il confine migliore. se questo racchiude u n terri to ri o diflkik:. abitato eia popolazioni difficili 78
L'integrazione delle disomogeneità naturali ali' interno della linea della 'frontiera scientifica'. ovvero il ripiegare su que ll e della frontiera, determina l a progressiva 'naturalizzazione' della medesima. Allorchè infatti, questa viene a co incidere, per l'intera sua estenzione, con tali barriere è abi tualm ente definita anche ·frontiera naturale'. A titolo di esemp lificazi one, premettendo che tra le 'discontinuità' ambientali non a caso la prioritaria è il limite tra l o stato so lid o e quello liquido, per tutti peraltro facilmente individuabile anche a livello puramente sensoriale, osserveremo che la frontiera marittima-equiparabile a quella innalzata lungo l a spoda di un fiume di indeterminata larghezza-coincidente per l'intera sua estenzione con il perimetro terrestre cost itui sce la frontiera naturale per antonomasia. Anche sotto questo profilo lo schieramento costiero differisce da quello montano, obbligato a non discostarsi dalle evoluzioni litoranee sensibi lmente.
La schematizzata concezione di frontiera, trovava la possibilità pratica di attuarsi proprio per la mancanza di interessi nemici coinvolti nell a sua definizione, o per la loro trascurabile reattività militare. Non sarebbe stata altrimenti così pacificamente conseguibile, lasciando suppo rre la sua progressiva fo11ificazione una altrettanto progressiva inviolabilità e quindi annu llam ento delle future iniziative militari 79 Il che pur non facendola assurgere ad imposizi one discrezionale elargiva ad un unico versante la sua validità difensiva.
Coinci dendo con evidenti disomogeneità naturali, la frontiera così attuata non necessita di alcuna operazione geodetica volta al l a sua esatta determinazione, nè peraltro me consente di successive per la sua modifica o rettifica, introducendoci perciò al requisito, se non più evidente, certamente più significat i vo sotto il profilo difensivo, quello della sua immutabilità. Ogni frontiera naturale, infatti, in quanto tale non è alterabile ed il suo molo di barriera si dimostra non modificabile a discrezione: il beneficio dei vantaggi difensivi da essa elargi ti è vincolato ali' immut abi lità del tracciato. Una frontiera naturale costante nel tempo, determina alle sue spa lle assetti stata li altrettanto stab ili: non a caso il Regno cli Napoli, ad onta della sua notoria inconsistenza militare, non subì mai per quasi un millennio mutilazioni territo1iali, a differenza degli altri stati peninsulari più o meno variab ili.
Se la disomogeneità mo1fologica accennata, è costituita da un amp i o sistema montuoso di notevole larghezza fornisce al suo interno molteplici potenziai i linee di 'frontiera natural e', prive però ovviamente del requisito di immutabilità obb ligata , essendo l'adozione dell'una piuttosto c he dell'altra influenzata da strategie politiche. E fu questo il caso appunto delle Alp i.
7 ~ E.N.L L1IT\~ AK. La grande s1rn1egia cit.. p.121.
7\1 Per l a verità l o schieramento delle torri costiere antincursive fu nella sua rase di iniziale realizzazione attiva111en1c osteggiat o d ai c o rsari barbareschi. con assalti ai can tieri, deportazioni in massa degli operai e distruzione radica l e dei manufatti.

48 La dijèsa Alpino
La frontiera alpina, infatti, mai godette di connotazione di immutabilità topografica, ad onta della sua estrema rilevanza orografica. Poteva però trasformarsi, con perfetta valutazione delle vie di accesso e delle loro diverse pericolosità, in una 'frontiera scientifica', pur confermandosi scarsamente 'naturale'.
È indispensabile aquesto punto precisare la seconda peculiarità militare della frontiera ·scientifica', deri van tele dal l'essere eminentemente ostati va: la sua inadeguatezza ali' impiego offensivo. Anzi potrebbe affermarsi che la sua definizione ostenta quale presupposto motore la rinuncia ad ulteriori acquisizioni territoriali, eccezion fatte per le pure manovre cli contrattacco. Ancora una volta simile impostazione è recepibile nelle opere di difesa costiera, antivasiva ed antincursiva, prive di va l enze agevolanti eventuali contrattacchi. Solo parzialmente, invece si individua nella fortificazione alpina.
Il pianificatore cioè della frontiera scientifica contemplando assolutamente insignificante il territorio al suo esterno, volontariamente vi rinunziava. Conseguenziale pertanto che linee ostative, supportate da forti cli 'sbarramento', si proponessero prive di finalizzazioni offensive, necessitanti di diverse logiche d'impianto e d'armamento. Allorquando in alcuni settori della frontiera alpina si volle agire in difformità da tale concezione si ricorse a particolari opere, non ascrivibili al repertorio tradizionale nè dell'architettura difensiva nè di quella ostativa. Un validissimo esempio si cog li e nel forte dello Chaberton, di cui è stato giustamente ricordato che:
secondo la visuale operaci va che andava affermandosi a fine ·soo. la funzione strategica ad esso attribuita era specificatamente offensiva o. quanto meno. comroffensiva; cioè. la nostra batteria veniva a collocarsi nella categoria delle opere fortilil:ate che la innovatrice do11rina bellica del tempo delìniva «opere autonome ad azione lontana».
Tali opere non costilllivano. come quelle di sbarramento. un el emento normale della fortificazione in montagna ma venivano costruite isolate su posizioni ekvate e prossime al confine. dominami una zona di importarua militare oltre frontiera
Rappresentavano, cioè , un corre11ivo al carn11ere strc11a111cnte difensivo d..:lle Conificazioni montane servendo da validi punti di appogg i o per le irruzioni nel territorio nemico e costituendo una pericolosa minacci:, controftènsiva nei riguardi dell"avversario che fosse riuscito a valicare la frontiera.
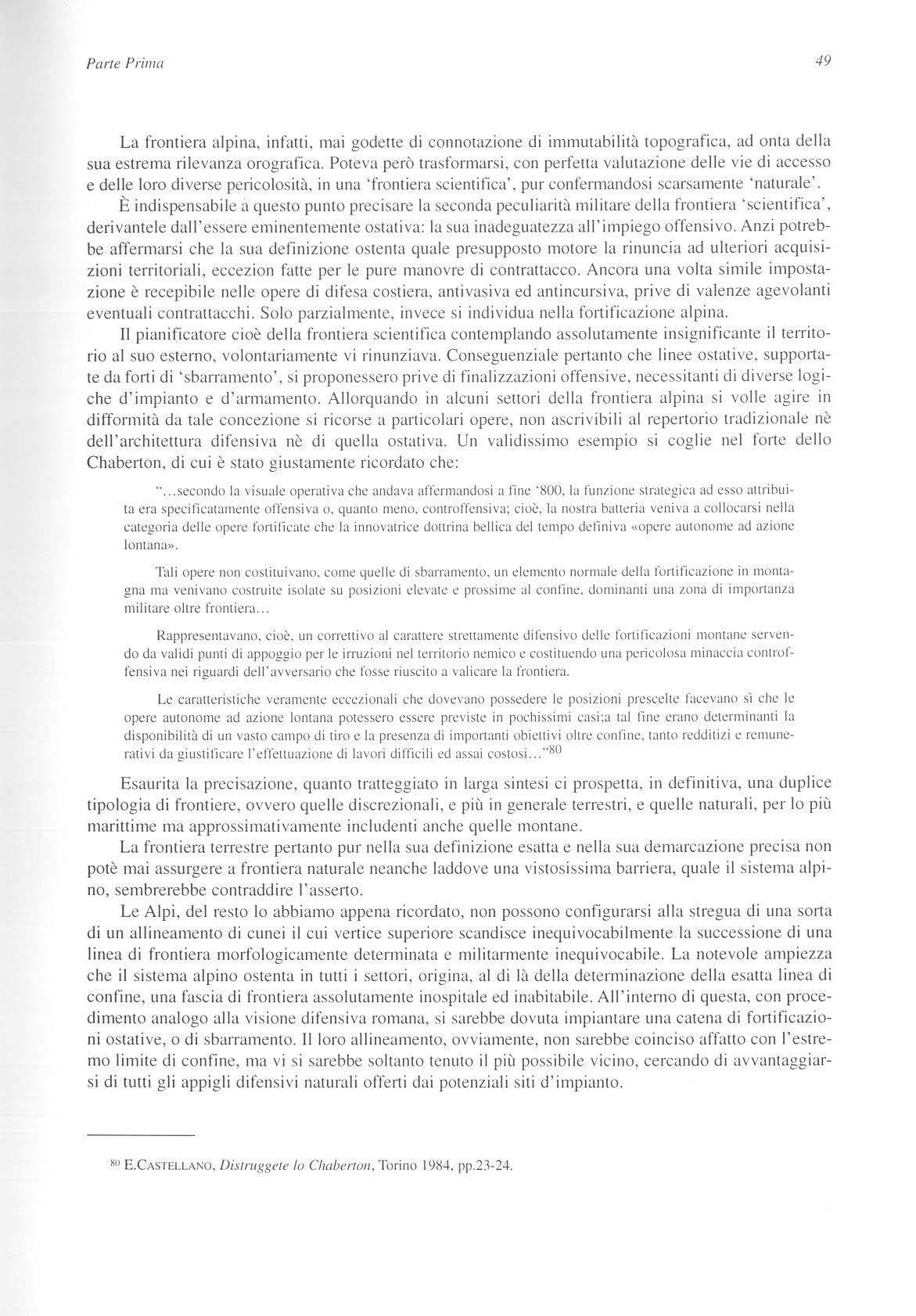
Le cara11eristichc veramente cccczionali che dovevano possedere le posizioni prescelte facevano sì che le opere autonome ad azione lontana potessero essere previste in pochissimi casi;a tal fine erano determinanti la d i sponibil it à di un vasto campo Ji tiro e la presenza cli importanti obiettivi oltre conl'ine, tamo redditizi e remunerativi da giusti lì care l'effettuazi o ne di lavori clifficil i ed ass:ii costosi go Esaurita la precisazione, quanto tratteggiato in l arga sintesi ci prospella, in definitiva, una duplice tipologia di frontiere, ovvero quelle discrezionali, e più in generale terrestri, e quelle naturali, per lo più marittime ma approssimativamente includenti anche quelle montane.
La frontiera terrestre pertanto pur nella sua definizione esatta e nella sua demarcazione precisa non potè mai ass urgere a frontiera naturale neanche laddove una vistosissima barriera, quale il sistema alpino , sembrerebbe contraddire l 'asserto.
Le Alpi, del resto l o abbiamo appena ricordato, non possono configurarsi alla stregua cli una sorta di un allin eamento cli cunei il cui vertice superiore scandisce inequivocabilmente la successione di una linea di frontiera morfologicamente determinata e militarmente inequivocabile. La notevole ampiezza che il sistema alpino ostenta in tutti i settori, origina, al di là della determinazione della esatta linea di confine, una fascia di frontiera assolutamente inospitale ed inabitabile. All'interno cli questa, con procedimento anal ogo alla visione difensiva roma na, si sa rebbe dovuta impiantare una catena di fortificazioni ostative, o di sbarramento. Il l oro allineamento, ovviamente, non sarebbe coinciso affatto con l'estremo limite di confine, ma vi si sarebbe so ltanto tenuto il più possibile vicino, cercando di avvantaggiarsi di tutti gli appigli difensivi naturali offe11i dai potenziali siti d'impianto.
Parte Pri111a 49
80
E CASTELLAKO, Distruggete lo Clwberton. Torino 1984. pp.23-24.
Il che costit ui va co munque un tracciato difens ivo di sc rez ionale.
Pert anto, assodato che la morfologia del territorio continenta l e ed il suo framm entarsi in singo li stati autonomi e rec iproca mente ricono scen tes i , condusse al concordato di pre c i se lin ee di frontiera , sembrerebbe i n prima approssimaz i one l ec ita la loro equiparazio ne di stu di o con l e lin ee di costa. Ma in realtà scaturendo da co nve nzio ni po liti che, da es iti militari. e da sce lte ubicati ve, per quanto affermato discrezionali. tutte al terabili nel tempo, sia tramite ulteriori trattativ e diplomatiche sia tramite nuovi eventi belli ci, sia ancora tramite diverse logiche difen sive, la loro rea le persisten za non può suppors i immutabil e al pari di quel l e marittim e
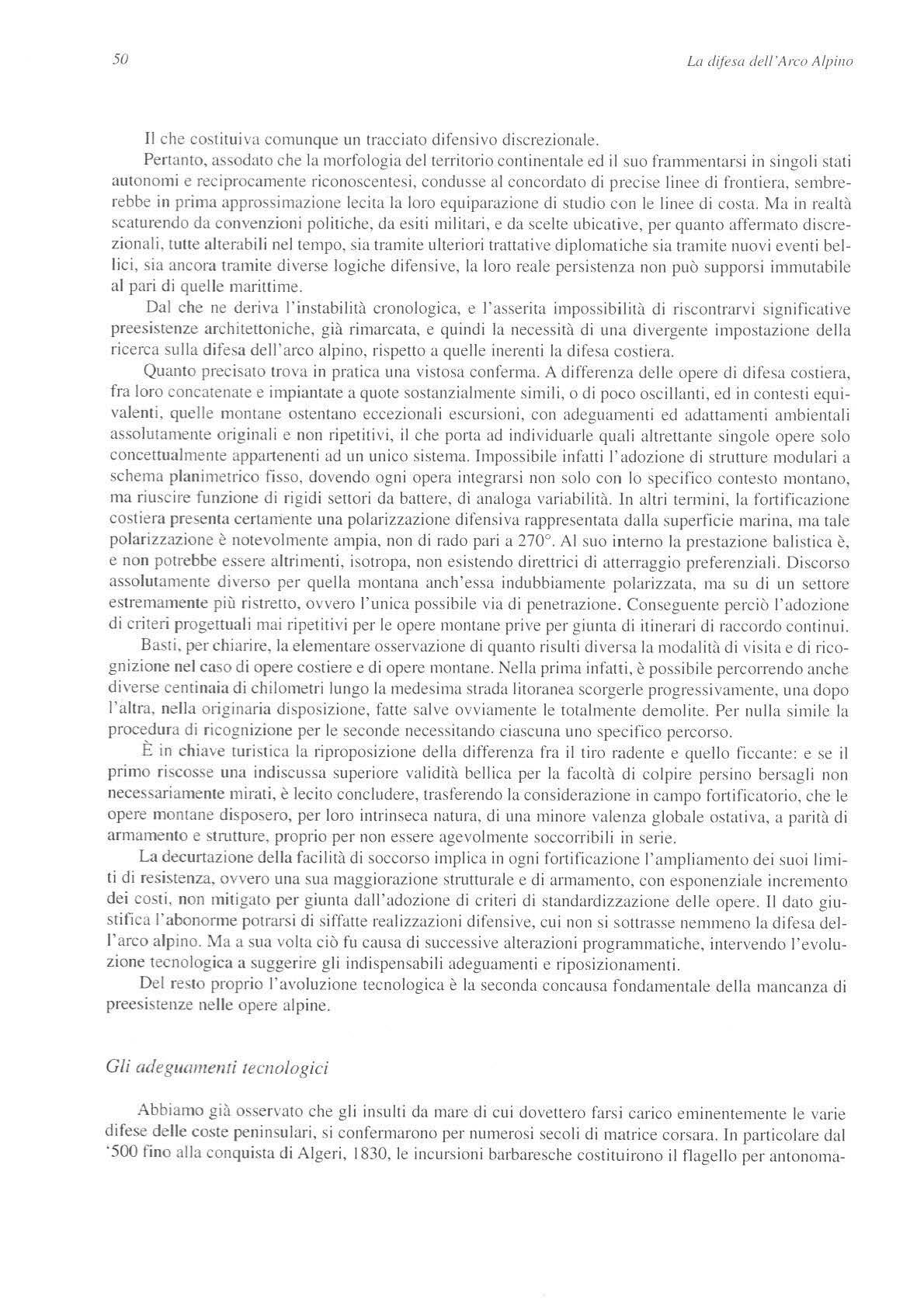
Dal c he ne deriva l' in stabilità cronologica, e l'asserita impo ss ibilità di ri scontrarvi significative preesi stenze architettoniche, già rimarcata, e quindi la necessità di una divergente impostazione della ricerca su ll a di fesa dell'arco alpino, rispetto a quelle in erenti la difesa costiera.
Qu an to prec i sato t rova in pratica una vistosa conferma. A differenza d elle opere cli difesa cost i era, fra loro concatenate e impiantate a quote sostanzia lmente simili, o di poco osci ll anti, ed in contesti equiva l ent i. quelle montane ostentano eccezionali esc ursioni , con adeguamenti ed adattamenti ambientali assolutameme orig in ali e non ripetitivi, il che porta ad individuarle quali altrettante singole opere so l o concettualme nte appa11ene nti ad un unico sistema. Impos sibile infatti l 'adozione cli strutture modulari a schema plani metrico fi sso, dovendo ogni opera integ rarsi non solo con lo specifico contesto montano, ma riuscire funzio ne di ri gi di settori eia battere, cli analoga variabilità. ln altri termini, la fortificazione costiera presema certamente una polarizzazione difensiva rappresentata dalla superficie marina, ma tale polar izzazione è notevolmente ampia, non di rado pari a 270°. Al suo interno la pre stazione bali stica è, e non po trebbe essere altrimenti, i so tropa, non esistendo direttrici di atterraggio preferenziali. Discorso assolutamente diverso per quel la montana anc h 'essa indubbi amente polariz za ta , ma su cli un se!lore estremamente p i ù ri strerto ovvero l'unica possibile via di penetrazione. Conseguente perciò l ' adozione di ctiteri progertuali mai ripetitivi per le opere montane prive per giunta cli itinerari di raccordo continui.
B asti. per chiarire, la el ementare osser vazione di quanto risulti di ve r sa la modalità di vis ita e cli ricognizione nel caso di opere costiere e di opere montane. Nella prima infaui , è possibile percorrendo anche diverse centi naia di chilo metri lungo la med es ima strada litoranea sco rg erle progres sivamente , una dopo l 'a ltra. nell a origina ria disposizione , fatte sa lve ovviamente le totalm ente demolite. Per nulla simil e la procedura di ricognizione per le seconde nece ss itando ciascuna uno specifico percorso.
È in c h iave turistica la riproposizione della differenza fra il tiro radent e e qu e llo ficcante: e se il prim o ri scosse una indiscussa superiore validità bellica per la facoltà cli co lpire persin o bersagli non necessariamente mirati, è lecito conc ludere, tra sferendo la considerazione in campo fortificatorio, che le opere montane di spose ro, per loro intrinseca natura, di una minore va le nza globale ostativa, a parità di arm amento e struttu re, proprio per non essere agevo lmente soccorribili in serie.
La decurtazione de lla facili tà cli soccorso implica in ogni fortificazione l'ampliamento dei suoi limiti di re si stenza, ovvero una sua maggiorazione strutturale e di armamento, con esponenziale incremento d ei costi, non mitigato per giunta dall'adozione di criteri di standardizzazione delle opere. Il dato giust ifi ca 1·abonorm e potrarsi di siffatte realizzazioni difensive, cui non si sottrasse nemmeno la difesa dell' arco alpino \ 1a a sua volta ciò fu causa di successive alterazioni programmatich e, intervendo l 'evol uzione tecnologica a suggerire gli indispensabili adeguamenti e riposizionamenti.
D el res to proprio l'avoluzione tecnologica è la seconda concausa fondamentale della mancanza cli preesistenze nelle opere a lpine.
Gli adeguamemi rerno l og ici
Ab biamo già osser va to c he gli in sulti da mare cli cui dovettero farsi carico emine ntemente le varie di fese d elle coste peni nsulari , s i confermarono per numerosi secoli di matrice corsara. In particolare dal '500 fin o alla conq uista di Algeri, I 830, le incursioni barbaresche costit uirono il flagello per antonoma-
50 La difesa dell'Arco Alpino
sia delle marine italiane ed, in maniera devastante, di quelle del suo mezzogiorno e delle isole. Prioritario per qualsiasi contesto dinastico avvicendatosi al governo dei singoli stati tentare di stornarle od almeno di decu11arne la virulenza, attivando idonee opere difensive. L 'aggressione tuttavia, per l'identico interminabile arco storico, lungi dallo scomparire, si confermò sostanzialmente immutabile sia nelle estrinsecazioni operative, sia nei mezzi navali specifici, obbligando gli apparati militari ad un paradossale, quanto anacronistico adeguamento ostativo. Non a caso il gen. Bartolomeo Forteguerri, comandante in capo della Marina da Guerra Napoletana, la principale forza navale italiana, in una sua acuta memoria della fine del '700 rimarcava quella avvilente costrizione, sia sul mare che lungo l e coste, affermando:
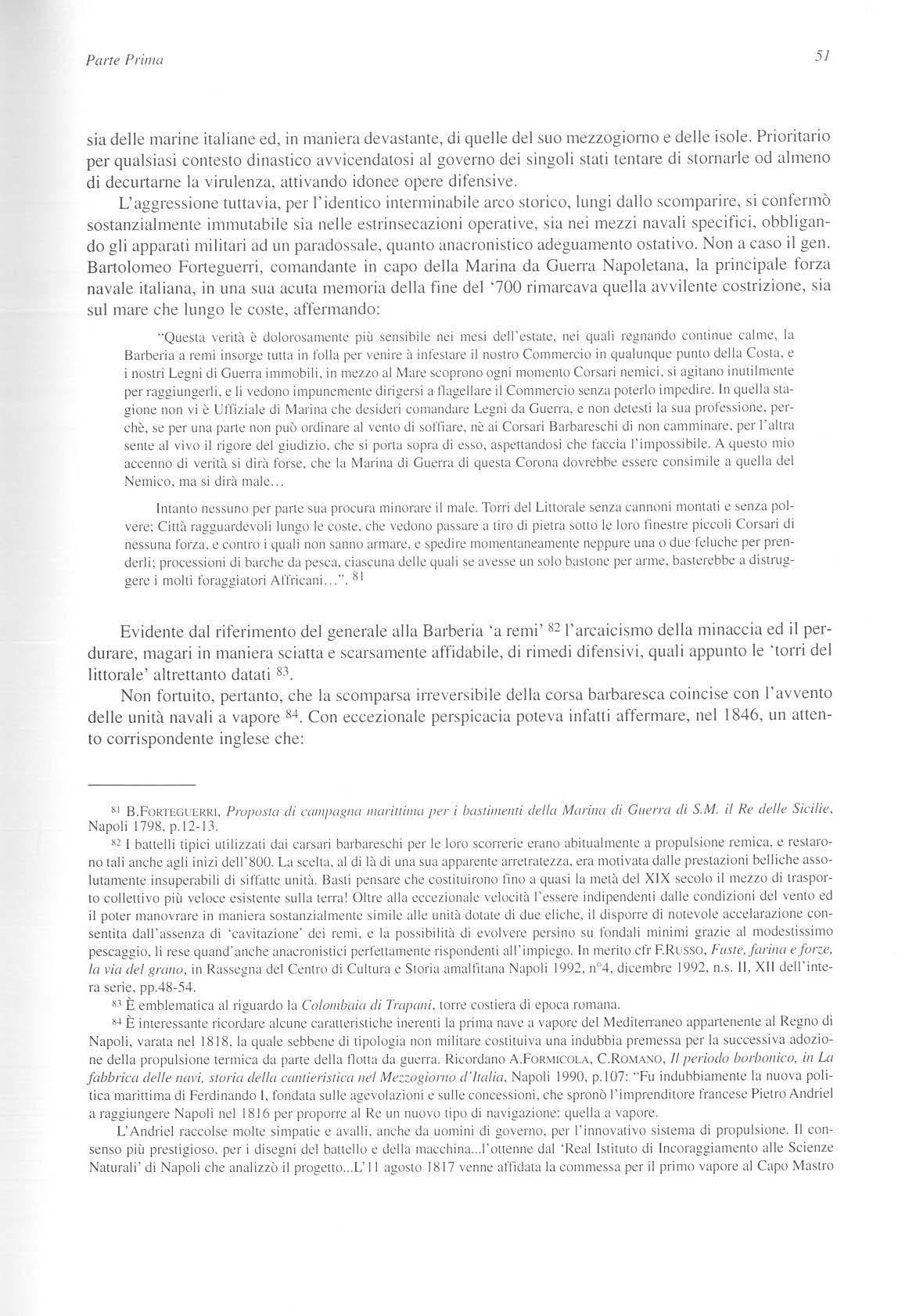
"Questa verità è dolorosamenh.: più sens ibil e nei mesi dell'estate. nei qua li regnando cont in ue calm..:. la Barberia a remi insorgi.: tulla in folla per venire à infestare il nostro Commercio in qualunque punto della Costa. e i nostri Legni di Guerra immobili. in meuo al Mare scoprono ogni momento Corsari nemici, si agitano inutilmente per raggiungerli, e li vedono impunemente dirigersi a llagellare il Commercio senta poterlo impedire. In quella stag i one non vi è UffiLiale <li Marin:i che desideri comandare Legni eia Guerra, e non detes ti la sua professione. perc hè, se per una parte non può ordinare al vento di soffiare, nè ai Corsari Barbareschi di non ca mm inare. per l'altra sente al vivo il rigore del giudizio. che si porta sopra di es~o. aspettandosi che taccia l' impossibi le. A ques to mio accenno di veri tà si dirà forse. che l a Marina <li Guerra di questa Corona dovrebbe essere consimilè a quella del Nemico, m:i si dirà male
Intanto nessuno p..:r partc sua procura minorare il male. Torri del Li11ornle senza cannon i montati e senLa polvere; Città ragguardevoli l ungo le coste, elle wdono passare a tiro <li pietra sono lc loro l'inestre piccoli Corsari di nessuna forza. e c:ontro i quali non sanno armare. e spedire momemanearnente neppure una o d ue feluche per prenderli; process i on i di barche da pesca. ciascuna delle quali se ave~se un solo bastone per arme, basterebbe a distruggere i molti foraggiator i A llrican i ". 8 1
Evidente dal riferimento del generale alla Barberia 'a remi' 82 l'arcaicismo della minaccia ed il perdurare, magari in maniera sciatta e scarsamente affidabile, di rimedi difensivi, quali appunto le 'torri del littorale' altrettanto datati 83
Non fortuito, pertanto, che la scomparsa irrè versibile della corsa barbaresca coincise con l'avvento delle unità navali a vapore 8-l. Con eccezionale perspicacia poteva infatti affermare, nel 1846 , un attento corrispondente inglese che:
1 B.Fo1ntGL'ERRJ. Pru11ost<1 di C<11111wg11a 111ari11i111a 11er i basri111e111i della Marina di C11erm di S.M. il Re delle Sicilie. Napoli 1798. p.12-13.
2 I ba11e ll i tipici ut i lizzati dai carsari barbareschi per l e loro scorrerie erano abitua lmente a propulsione remica, e restarono tali anche agli inizi dell'800. La scel ta. al d i là di una sua apJ)arente arre tra tezza, era motivata dalle prestazioni belliche assolutamente ins u perabi li di siffalle unità. Basti pensare ell e costilllirono lino a quasi la metà del XIX seco l o i l mezzo di tra spo rto collett i vo più ve l oce esistente sulla terra 1 Oltre alla eccezionalc ve l oci tà l'essere indipendenti dalle co ndi zio ni del vento ed il poter manovrare in maniera sostanzialmente simile al le uniti1 dotate di due eliche. i l disporre di notevo le accelaraz i one consentita dall'assenza d i ·cavitazione· dei r..:mi, e la possibilità di evolvere persino su fonda li m ini mi grazi e al modestissimo pescaggio. li rese quand'a nch e anacro nist i ci pert'euamente r ispo nd emi all' impiego In mer it o cfr F.Russo. Fus1e.farina efor:e, la via del gmno, in Rassegna del Cent ro cli Cultura e Storia ama l f itana Napoli 19 92 n" 4, dicembre 1992. n.s. Il, XII dell'intera serie. pp.48-54.
x.1 È e mbl emat ica al r i guardo la Colombaia di Tmpani. torre cos tiera di epoca romana.
4 È interessa nt e ricordare alcune ca rat terist ich e in eren ti la prima nave a vapore del Meclite1raneo appartenente al Regno di Napoli, varata nel 181 8, la quale sebbene d i ti pologia non militare costituiva un a indubbiu premessa per la suc:cess i va adozione della propulsione termica d:i pane della flotta da g uerra. Ric:ordano A.FORMICOLA. C.Ro:vtA:siO, Il periodo borbo11ico. in La fabbrica delle navi. sloria della ca111ierisrica nel Me::ogiomo d'/1alia. Napoli 1990, p. I 07: "Fu indubbiamente la nuova politica mariuima cli Ferdinando I. fondata sulle agevolaLioni e su ll e co ncession i. che sp ronò l'imprenditore francese Pietro Andriel a raggiungere Napoli nel I 816 per proporre al Re u n nuovo tipo di navigazione: quella a vapore.
L' Anclrie l raccolse molte si mpati..: e avalli. anc.:he da uomini cl i governo. per l'innovativo sistema d i propulsione. 11 consenso più prestigioso. per i disegni del ba11cllo e della mac:china 1'011enne dal 'Real lstilllto di Incoragg iam ento alle Scienze
Natura li' di Napoli che ana li zzò il progc 11 0 L' 11 agosto 1817 venne aflìclata l a commessa per il primo vapore al Capo Mastro
Pane Primo 51
·· I nteri eserciti Ji crocimi sono passati d i q ui e v i sono mort i, e le l oro stragi no n sono servite a n ull a. Per la civi ltà euro pea la fabbricazione di lance e di c::lm i fu un inutile sp rc::co d i metallo ment re q uella d i pi sto ni e degli stamufi si è ri 1,el:lla im:sist ihi l e: se ne dov rebbe trar re un ' all egor i a che d i mos tri la su per ior i tà de l co mmerc i o sulla ca1,aJle ria. e finisca con una grnm.k im ma11 i ne della meu:a lu na maomellana c he si es tin~uc ne ll a caldaia cl i Fu ltvn .' '. 8:i - - -
In praiica però, la ri co rdata in va rianz a dete rmin and o l a co ng rnit à de ll e fortifi c azi o ni cos ti ere cli i m postazione r i nascimenta le all e o ffese in c ursi ve, ne co nsentì l a sopra vv i ve nz a, ap pe na co n marg in a li adeguament i . L a loro v u lnerabi lità, in fatt i , non era minimamente sca lfita d all'agg ressi v ità barbaresca, ed i l ru o l o p recip uo d ell e stesse dive nne in breve, e si protra sse a lun go, qu ell o cli se mplice suppo rt o de ll e artigl ierie, anc h 'esse per ident ic i mo ti v i cli arcai c a co ncez ione 86 Il di scor so pu ò in de finiti va ampli arsi a t utte l e opere co~tie re ere tt e i n fun z i o ne anri co r sara.
È sign i fic ar ivo. del resto, c he persin o naz i o ni notevolm eme all' av an g uardia ne ll 'a mbit o d ella g uerra na va l e, co me rlng hi lterra, al m o me nto di pro ge ttare un a difes a cos ti era mirante ad interdire una po tenziale offesa i ncu rsiva-da parte della Fran c i a cli Napo leo ne nella fatti spe ci e- no n e laborarono ni ente di megl io c he l a r iproposiz i one seri ale cli un a vecc hia to rre di matric e ara gon ~se -t orre di Punt a d elle Mortellc in Cor si ca-ovvero de l X V seco l o addirillura , con l ' uni co adegu ament o a c ari co dell 'arm amento, 1ibanezzandol a con britannica suffic ie nza ' to rre Martell o' 87 È fo r se anco ra più si g nifi ca ti vo c he una idem ica st ruttu ra trovò i mpiego nel le fortific azi o ni de l Vall o Atl anti co 88 _
Qu anto appena accenna to di mos tra , in de finiti va, l a notevo lmente meno strin ge nt e es i genza cli aggi o rn amento che solleci tava no le fo 11ifi cazi o ni costi ere ri spett o a qu e ll e te rres tri , e non so ltanto ne ll a l ogi c a an t incurs i va. Anche le fo rtifi caz i o ni antin v asi ve, minacciate dalla ben più micidi al e pot enza d ev astatri ce delle anigl i erie nava l i d el le m oderne unità da batt ag li a, pur sulbendo una co stante e voluzi o ne, r iu scirono in genere a sopravv i ve re co n ampie riqu alificazioni ch e c omunqu e co nservaro no, mag ari a ru o l o di puro su pp orto strutl ura l e, l e anti c he opere rin as ciment ali. L e an a log i e op erative ed i limiti no n di fferivan o in maniera antitet ica co n l e l o ro antenate, tanto c he l' amm M ahan p otev a ironi cam ente afferm are, r ima rca ndo il perdure di q ue l lo stall o tec nol og ico :
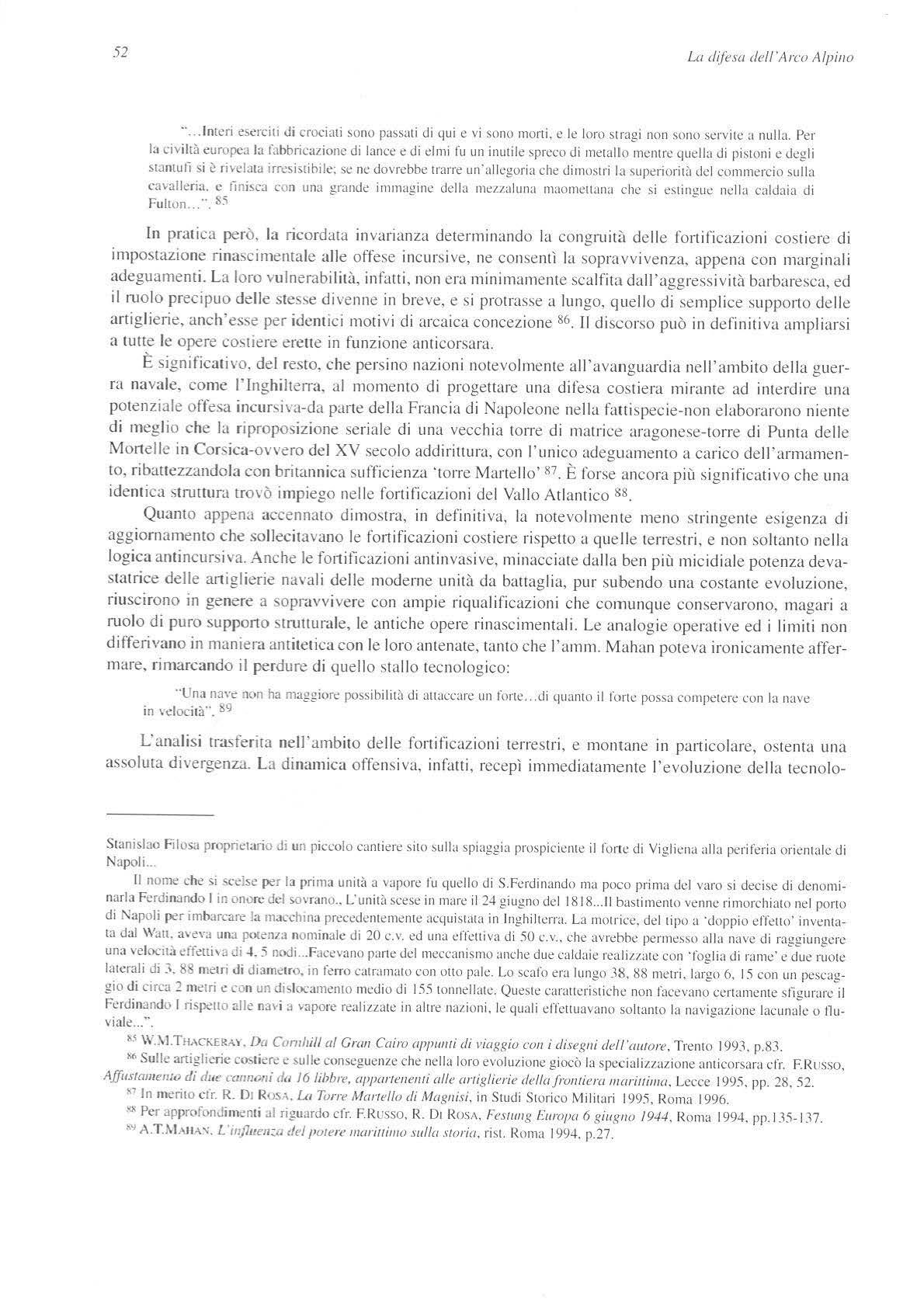
Una nave nt)fl ha mag giore possibi lit à d i auacca re u n forte d i qu ant o i l fo n c possa compe tere co n l a nave in \d OC i l à f,9
L'anali si trasfe r ita ne l l'ambito dell e fo rtifi caz i o ni terres tri , e mo m ane in parti c ol are, os tenta un a assoluta di\'ergenza. L a di namic a offensi va, infatti , recepì immedi atam e nte l 'evo lu z i o ne d ella tecn o lo -
Stan islao Fil osa proprietari o di un pic<.:olo ca nt ier e si to su ll a sp i agg i a pros pic i eme i l ro rt c d i Vi gl i ena a ll a per i fer i a o r ient al e di Napoli.
Il nome: c he si scd5c pe r l a prima un i tà a vapo re f u qudlo di S.Fe rcl inand o ma poco pr i ma del varo si dec ise d i dcno minarla Ferdi n.:ind o I in onor e del sovrano , L 'u ni tà scese in 111::m: il 24 gi ug no de l 18 18 11 bas ti mento ve nn e rim o rch i ato ne l po rto d i Napoli per imb arcare la m.icchin a pn:cedenteme nt e acqu i stata i n Ingh ilt erra. L a mo tri ce, del t i po a 'd o pp i o effe110 · in ve ntata dal Wan aveya una pocen,a nomi nale di 20 c. v. ed una eflclliva d i 50 c. v c he av rebbe pe rm esso all a nave cl i raggi ungere una ve l ocità df.!ni, a di -L 5 noJi Facev ano pa rt e del m ecca ni sm o anche du e ca l daie real i zzate con · fog l ia cl i rnm c ' e d ue ruote l aterali di >. 88 metri di diamet ro. in ferro rnt r am alO con o li o pJle. Lo scafo era l u ngo 38, 88 m etri. l argo 6 15 co n un pescaggio di circa 2 me tri e co n un d1~locamento me d io di 155 ton nellatc. Qu este ca raller ist i chi:: no n fa cevano c crt ame nt e s fi gu ra rc i l Ferdi nand o I rispeuo alle na v i .J vapore realizzat c in alrre na,,ion i l e quali dlc tl uava no so hamo l a nav i gaz i o ne la cun ale o fl uviale
85 W .\1.THACKERA\ Da Cvmhi/1 al Grnn Ca im app11111i di viaggio co n i d iseg ni d elf'awo re , Trento 1993. p 83.
~ 6 Sull e artiglierie co~t i t: rl! e sulle consegue nze che nella loro evol uz i o ne g i ocò la spe c ia l i zzaz i one anti co rsa ra crr. F.R1 1sso. Affustamenw di d ue cannoni du 16 libbre, a11p,1r1e11 e111i a (( e a rt ig lierie de{{ajìm lli era mari/l ima . L ecce 1995. p p 28 52
7 In mc:rit o cfr. R. 0 1 Ros-' u, Torre Martello di Magnis i, i n Studi Stor i co Militar i 1995 , Ro m a 1996.
;\I, Per ap pro fond i m.:nli al riguardo cfr. F. Russo. R D t RosA Fes11111g Euro pa 6 g iugno 19./4 Ro m a 1994 pp .1 35 -1 37.
~., A T. ,\ l.\ ll A"· L 'w;111e11 ::.a del 1101ere 111arit tù110 su ((a s toria r ist. Roma 1994. p .27
52 La di/esa dell'A rco Alpin o
g ia militare europea che proprio intorno alla metà del XIX secolo segnò una vistosa rivoluzione, co n es iti inimmaginabili. Un indi sc utibile esemp i o dell'affermato improvviso e stra vo l gente sa lto tecnologico l o si può cogliere nella effim era va lidità militare che contraddistinse le fo 11ifi cazioni occide ntali ri costruite, ex novo, nell'ambito del piano del 1815 mirante a ll a realizzazione della Lin ea fortificata delle Alpi, fra i I 1820 ed i I 183 1:
G l i arte l'i ci a cui va il merito della rea li zzazione del piano f u rono va l idissimi ingegneri del Co r po de l Genio piemontese. rivelatisi degni continuacori delle nobi li tradizioni degli arc hitelli militari italiani del XV I ~eco l o
Il complesso venne po rt alo a ter mine in un arco ventennale ( 1818- 1838) Sul finire del 1822 venne uhimato l ' Esseillon i111 orno al 1828 era pressocchè ultimato Exi ll es , Le opere del 13ard ric hi ese ro all'inc irca dieci anni. sino al 1838 ... [il) forte d i Vinadio, costruito fra i l 1830 ed il 1836... [le] fortificazioni d i Fenes trelle si concl usero solo ne l 1837
Per ciascuno dei fort i sumrn..:nz i onati i pea i di art i glie r ia raggiungevano le 40 -60 un i tà; si trattava di art iglierie ad anima liscia allogg i ate in case malle murari..:, c he avevano il compito di battere l a strada di fondovalle e la fascia di terreno ad essa immcdiatam..:nt e ad i acente, con ti r i di sba rra mento. Di qui l a denom in azione d i fo rt i di sbarra ment o che 1u1tora classifica. anche sollo il profilo storico tali cost ru zioni. Le differenziale quo te che costi1uemi l a fo n eua consem i va no di sovrapporre da pu111i dive rsi il fuoco delle arrn i su tra ili di strada so11ostan1i:la sca r sa è lli cac ia dei proieui çon1ro l e rob uste casematte e l a poca trasportabilità delle artig l ieri e de ll 'a1tacço, c he d i ffi d lm ent c potevano raggiungere posizioni dominami il forte. assicuravano a q ues to buone condiz i on i di resiste nza ". 9o
App ena pochi decenni dopo, i radicali perfezionamenti delle arti g lierie, ca nc ell ando quelle comode certezze, impon evano una reimpostazione dei fot1i, c he comunque non atti nsero più identici li velli cli credibilità. Le principali innovazioni tecnologiche dell'at1iglieria che consentirono il menzionato incremento offensivo possono essere individuate nell 'a dozio ne della retrocarica e della rigatura dell'anima:
"Vi ene spesso indicato. come rnassi mo ven ic e tecnico raggi u 1110 dall'O tt ocento ne l campo degli armamemi. l'adozio ne della retrocarica nelle armi da fuoco. I n realtà l' epoca v ide un' in novaz i one di ancor maggior valor..: tecnico e be ll ico: l 'adoz i one generalizzata della r igatura Le canne rigate permettevano una maggior g itt at a ed un a più grande precisione del co lpo; ma. cosa ancora più imponame. aprivano la strada a progressi nel munizionamenlO impensabi li fintanto che imperavano l e ar mi a can na li scia
i l proiello sparato da un'arrna rigata era slab iliualO dalla rotazione c he gli imprirneva la r i gatura e ciò conse nti va l 'adoz i one di pro i etti affusolac i , sparabili co n la sicurezza che dura nt e la tra i ettoria, essi avrebbero mantenuto i l 'naso· in ava mi , rnsì come uscivano dalla ca nna: ciò che a sua vo ha consent i va l 'adozione di spoleue in grado di fa r detonare i l pro i c tl o al mom..:nto dell' impallo, e non prima. La rigatura per metteva inoltre un'acc uratezza di tiro impossibile a ol\eners i con le an ni ad anima liscia, dal momento che l a traictlor i a dd proietto, giroscopicame nt e stabil i zzata. era assai pili v i cina a q ue ll a teoricamente ca l co l abi l e Era ora possibile concen trare addosso' al be rsagl i o una gran parte dei proietti sparal i ". 91
E non era tutto: il proietto c ilindro-og i va le infatti consentiva, per l a sua discrezionale lunghezza, un dimensionamento ponderale della carica es plo siva notevol mente ampio, in grado quindi di arrecare devastazioni assolutamente non confrontabili con quelle delle granate sferi che -pera ltro prive di penetrazione-senza co ntare ino ltre il considerevole incremen to cli g ittata consentito dall'effetto giroscopico men zio nato 92
'>(
1 E.CASTELLANO, Evolu~ione de/1(1 Fortifica:ione per111ane111e , ci l p. 567.
91 I.HOGG Stori(I delle fortijìcaz.ioni, Novara 1982. p 144
2 Sintetizzano R.FOFFAKO, D.LUGATO. D(/ M(lrgem a forte M(lrgliera. Venezia 1988, p. 80: "Il capitano p i emontese Giovann i Cavalli recacosi in Svezia nel 1846 presso le fo nde r ie Wahrendorff me tteva a punto un'idea çhe da tem po coh i vava Prima sper im entò la retrocar i ca con l'app li cazione della cu latt a alla bocca da fuoco, poi r icercò mediante l a r i gat ura della ca nn a la precisione di tiro e la stabi lit /1 del proie110. il quale ve niva ad assu mere una forma ci lin dro-con i ca per offr ire minor alt r ito all'ar i a Il 27 apr ile 1846 in Svezi a il Cavalli po rt ava a terrninc il suo esperime nt o I r isulta ti erano strab il ian ti : i l canno ne a ret rocarica con bocca da fuoco r iga ta di qua tuordici centimetri di ça libro e con proie u o cilindrico-conico otlc ne va un a g it -

Parre Prima 53
;'Jessuna fonificazione es istente risultava in grado di sopportare i cimenti bai istici così ampi ificati, tanto più che l'impatto. proprio per l'eccezionale lun ghezza della traiettoria , avveniva con un angol o pro ssimo alla verticale. O\'\'ero sulle protezioni orizzon tali , non pa11icolarmente resistenti in quanto fino ad al lora non pericolo!,amente esposte.
l i potenziamento in\ irtù della sua straord in ar i a rilevanza , consentì anche ai ca libri minori clell'artiglie1i a di conseguire esiti distnittivi assolutame nte inusitati, fino ad allora precip ui delle massime artiglierie d' assedio di improba movimentazione cd attivazione. Possibile, pertanto , condurre e postare su lle imper vie creste montane leggere bocche da fuoco in grado di sconvo l gere dall 'a lto le famose opere di 'sbarramento' protette principalm ente dal l oro dominio territoriale, stimato altimetricamcnte insuperabile. La conseguentè gravbsima e!:.posizione comportò oltre l'accennato radicale aggiornamento, anche l'impiant o di m10,·e opere addizionali destinate a frustrare la minaccia:

--si vidc. cio(!. la nc:,·è-s,ità Ji costruire imorn o al l' opera principale a lt n.: opere ~taccate - altrimen ti dcuc di prole7ione -da edilìcaro,i sulle allu rc laicral i ed an ti stanti. Mollepli,i erano i compili d1e la nuova dourina !altica aJ esse auribui,a:protaio nc dell'opera principa l e;perno di manovra a l'avt>rc delle J'orLè' mobil i ;più es1cso dominio sulle aniglierie écll'anacca111e:pres idio di posizio ni Jomina111i. in modo da suu r arle all'utilizzazione
Jcll':n 1-ersario
È così spie_g:.Jla l:J presenza delle: numerose opere minori che ancora oggi incon1riamo intorno ai vecc hi l'orli
Ji :.barramcll!o e che. fb{kllv a questi ult imi. rbuhano di più giovane e1à ··. 9 :,
Con<;iderando che gli adeguamenti tecnologici militari furono il risultato dell'evoluzione scientifica occidentale. e centro europea in particolare, è intuibik l 'effetto che produssero sulle fortificazioni alpine. A differenza infaui da quelle costiere tentate da razziatori primitivi, le opere lungo la frontiera terrestre del neonato Regno d'lcalia dovendo sbarrare una potenziale aggressione condotta da eserciti dorati di annamenti modemi!:.!,imi. non po tevano assolutamente contemplare una inadeguatezza strutturale, sinoni mo di rapido smantellamento o di vinuale assenza, anche a costo della totak riedificazione.
Quanto sinteticamente precisato ribadisce ulteriormente il perchè dell'inesistenza di s i gnificative permanenze nelle fo n ificazion i alpine e della conseguente non praticabilità della metodica cli ricerca fin qui seguita nell a co llana in materia di difesa costiera.
Ci semb ra a questo punro indispensabile prima cli affrontare la trattazione specifica fornire alcune nozi oni di base sulla fonificazione cli montagna e su ll e sue peculiarità evo luti ve e progettuali.
Conceui della Jonifica::.ione di mo11wg11a
La forrificazione si ~a lda, sin dal suo remotissimo avvento 9-1 nella storia dell'umanità, al concetto di inviolabilità. a sua volta sc re1tame nte connesso co n quello d'impervietà e di verticalità, suo limite estremo. Non a caso tra gli arcaici a!tributi della divinità, e quindi dei regnanti, spiccava no i termini di
im a di .n--1 me1ri. rnmro 1 20 16 J1 1m 111.:<lc~ imo calibro ad avancurica a palla ~l'erica e con l o sii.:sso angolo di 1iro. mi.:ntre g li cffe ni dirompemi c rJno quaun., ,olre maggiori." Vi ì: da aggiungen.: r iguardo alla riga tura ùdl'anima per i mprimere: ai proietl i l'effe no giro,c o p:co che d al pun1,1 <li vbtn teoretico non cosli!U i va affallO una novità eda1an1e.G i à oli re 2.000 ann i prima i gia, elloll i dei s:mniti venivano f.lm flllllare al momento del lancio meùian1e una apposiia correggia. co nseg uend o un v i stoso incrcmem o di giu,1rn, ~limato d:1 akuni s10rici dell'ordin e d\!I 50% ed ohrdn merito cfr.F.R1 sso. Dai Sanniti a/1'/;'sen·ito lralia110. la n-givne {urtifiwta ,Jt:I 11utese. Roma 1991. pp. 35-4-l
Y.1 E.C;ò fEIJ_A \O, Eruiu::.icm <' della For1{firn::.io11e f>er111,111rn1e c i i pp.569- 70.
\1-l Una i 111erc:~samissima s1r.t~;;i Jdk fortilìcaz ioni preistoriche è 1ra,cia1a da J.HARMAl\'D , L'arte dello guerra nel 111011do amico ,Jalfe àrrù-swru sumerhlie aJ/'1111pe1v di Roma. Roma 1978. Afferma l o stesso au!Ore: "Le or i gini orien lali. egiziane o asiatic he. della fonitìcnL i ,>ne m..:mano una particolare auenzionc. dato che in que i tern1)i furo no crc:ale lllllc le forme e l ementari di cui l'nrchiteuurJ militare,., sarebbe alime maw per ,inquem il a anni ".
54 La difesa Alpino
'a lti ssima' e di 'altezza', sinonimi indiscutibili d'intangibilità 95! Ovvio pertan t o che fortifi cazione e mont agna fossero imprenscinclibili componenti cl i una unica v i si one difensiva, mutuamente amplificantisi, senza l a cui complementarietà la ricercata si cu rezza non sembrava conseguib il e. Del resto già il semp li ce insediarsi su cucuzzol i irti e scosces i costituì la primaria e più econom i ca risorsa protettiva. Facilmente spiegab il e il perchè: investire ossidionalmente un villaggio apical e, anche non fortificato, si g nifi cava disperdere le forze e diluirle lungo strett i e inaggirabili sentieri obbligat i , perdendo in tal modo il van ta ggio del numero. Inoltre gli esiti del ti ro d i armi identiche, ma effettuato in posizione difensiva od offe nsiva, ovvero dall'alto verso il basso o viceve r sa, differivano vistosamente. ln prat ica gli aggressori si trovavano costrett i a sottostare alla gragno l a dei dardi scagliati d ai difensori senza poterne ricambiare l a v irul enza 96. Nè risultava ipot iz zabile alcuna permanenza all'es te rn o del perimetro nemico, coincidendo lo stesso con il bordo delle ripide falde dell'altura d'impianto. Senza co ntare, poi, il maggior campo visivo godu to dai resident i , grazie al quale riuscivano costantemen te in formati sugl i eventuali pericoli, restando peraltro scarsamente individuabili: il che conse nti va loro quale ultima ri sorsa di abbandon are l a posizione al profilarsi di un assal to particolarmente violento o reputato inconten ibile 97 E questo solo per ri corda re alcu ne delle innumerevoli agevolaz i on i forn ite dalle posizioni altirnetricam ente dominanti.
Non di rado, inoltre, la loro naturale impervietà fu notevolmente amplificata co n interventi um ani integrat ivi , ce t1am ente elementari, ma cli indubbia effi cacia interdittiva attuati g ià nella preistoria. Numerosi gl i esempi di epoca neolitica perfettamente pervenutici di ripid e colline il cu i piede, o l'estrema cus pid e, furono resi in accessibi li tramite lo scavo di un profondo fossato-a volte plurimo-il cu i materiale di risulta ammassa to su l bordo interno, al trim enti detto 'aggere' 98, formò un primo ostaco l o vertica l e, accentuato spesso da palizzata con tinua:
95 Precisa in proposito F.Rrsso. Daflo .1 w::o afla cimo bastionala, l'evol1do11e def/e difese peri111e1rali urbane ne/l 'Italia cen1ro-111eridio11ale. in L 'Universo, r iv. l.G .M I. n 0 4, 5, 6 I 98:ì, F irenze 1983, p. 609 : Occorre ancora tener presente chç co ntro queste ( forti ficazio ni preistoriche I (si tuazione c he rimarrà invariata pe r diverse m i g liaia di anni ancora) v i era l a sola forza um ana, nell'assenza totale di qualsiasi macchina, anche e l ementare, im plicamela mes sa in gioco di poten, e maggi ori di quelle erogate dal si ngolo indi viduo, e quind i la poss i bil i tà di sfo nd amemo era pra ticam ent e i nesistcn1t.:. Cil> sembrerebbe in palesç co ntraddiz i one con i l notevole spessore delle mura se non fosse per u na in dispensab i le prec i saz i one: i l consistcnt..: spessore delle m urag li e non veniva int eso. progettato ed eseg ui to come logica contrapposizion..: .ii tentat i v i .d i sfondame nt o ma esc lusivamen te in fu nz i one della r il eva nte altezza che dov..:vano nec ..:ssa riamente raggiungere per considerarsi inviolabi li ln falli l'ass..:d i o si rid uceva ad una seque l a di tenta tivi tesi a scavalca r..: l e mu ra d i c in ta med i ante delle grosse sca l e c1·assalto l arg he fino a quauro me tr i ".
96 Cos ì ricostrusce la sc:quen,a d 'a ll acco a fo n ilìcazion i sa nni te di sba rramento F.RLSS O Dai Sa1111i1i all'Eselt'Ìlo ... . cit.. p.39:
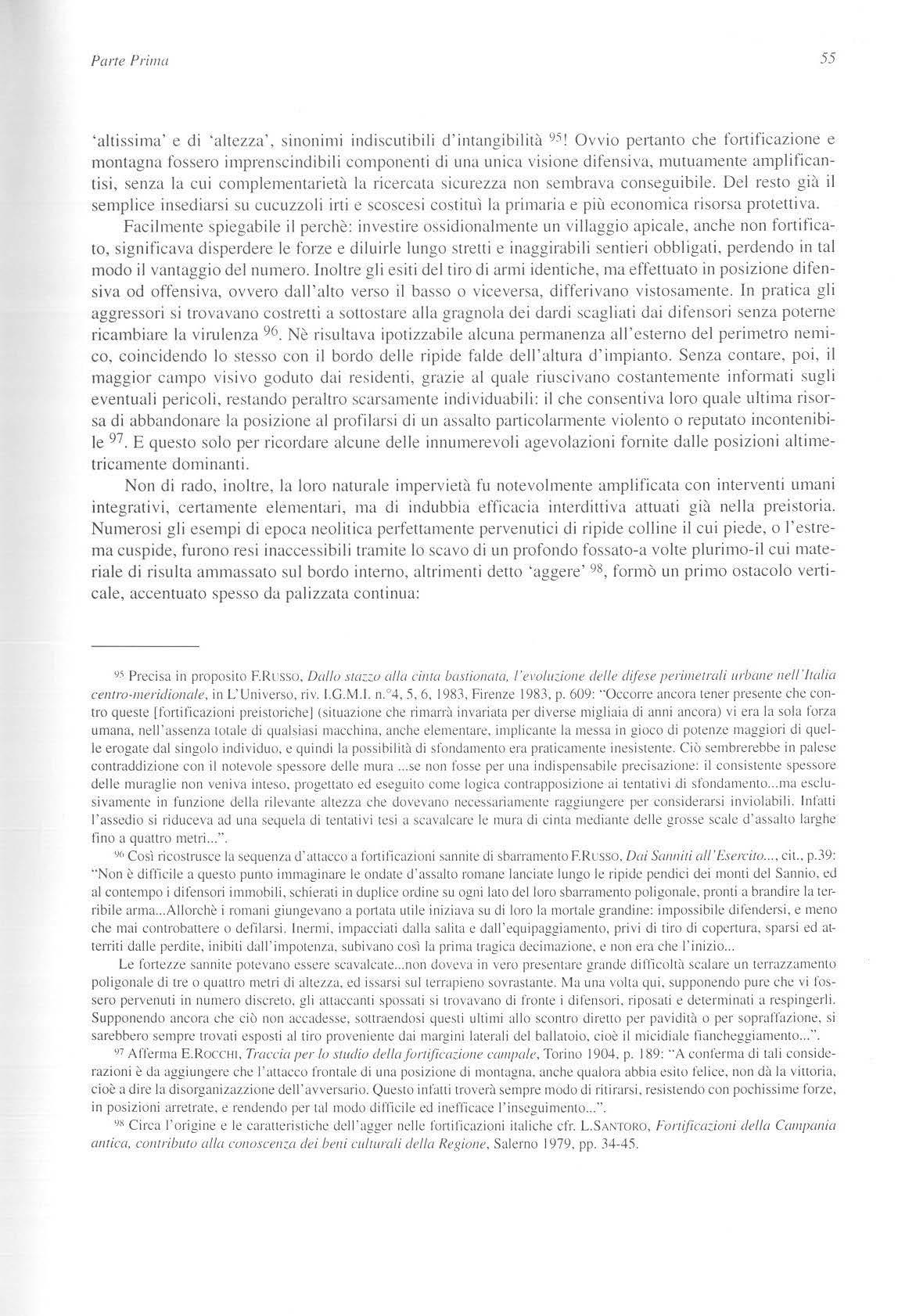
Non è d i ffi ci l e a questo pumo immaginare le ondate d'assaho romane lanciate l u ngo le ripid..: pendici de i monti del Sannio. t.:d al co nte mpo i difensori i mmobi li sc hierati in dupl ice o rd ine su og ni I mo del l oro sbarrame nt o poligonale. p ronti a bra nd ire l a terr ibile anna Allorchè i ro m an i giungevano a po rta ta utile iniziava su di loro l a morta l e grandine: i mp ossi bile d i fenders i. e meno che mai con troba lte re o defilarsi. I ne rm i. impacciat i da ll a sa lita e da ll 'eq ui paggia mento, privi d i t i ro di copçnura. spars i ed attel1'i ti dalle perdite. inibiti dall'impotenza. sub i vano così la pr ima tragica dt:cima,.ione. c: non era che l 'in izi o .
Le l'orten e san nit,;: potevano ..:ss.;rç scavalca tç non doveva in vero p resen tare grande difficolti1 scalare un tcrrazza mç nt o poligonale di tre o quauro metri d i aheua, ed issarsi sul 1errapit:no sovras tante. Ma un a vo lt a yui , supponendo pur.; chç vi 1·ossero pe r ve nuti i n nu m ero discreto. g li au accant i spossati si trovavan o di l'rome i d i renso r i, riposati e de term in at i a r,;:sp in gerli. Supponendo ancora che ciò non accadesse. sourae ndosi quest i ultim i allo sco nt ro direuo per pav id i tà o per sop raffazione. si sa rebbt: ro sç mpre trova ti ..:sposti al tiro proveniemc dai m arg in i l atera li del ba ll ato i o, cioè i l m i cid i ale fianchc:ggiamemo ".
97 Allerm,1 E .Rocn11 Traccio per lo s11ulio def!afortijìca;.io11e cw1111<ile, Torino 1904. p. I 89 : A co nferma di tali considt.: · razio ni è da agg iu ngere c hç l 'auacco fron tale di una posiz i one d i montag na. anc he qualora abbia ..:sito fe l ice non dà la v iu oria. c i oè a d ire la disorganiLaai one dcli' avve r sar i o Questo in raui troverà semp re modo di r it ira r si. resistendo co n pochissi 111..: forze. in posizioni arretrate. e ren dendo per tal modo d i fficile ed in e f ficace l ' in seg uimento ".
9 ~ Circa l'o ri g in e e l e caratler i stiche dell'agger nell e fort i ficazioni ita l iche cfr. L.SANTORO, Foni/iccdoni def/a Ca111pa11io antica co111ributo af!a conoscen::.a dei beni c11/111rali defla Regione. Salerno 1979. pp. 34 -45.
Parte Prima 55
"La p i ù pnmiti, a strun ura di fensiv..i in terra. i l recinto roni fi ca to, cons i ste in un fossato scava to tutt' in torno all a c, ma di u na col l in:1e c o rre me gro sso modo al la stessa quota. co sì d a r in serra re la so mmit à de l la coll in a stessa
L a terra r ica v at:.i dallo scav o era ,ll:cu mul ata all 'interno del fossato in modo eia fo r mare un terrapieno: genera lm e111 e la pendenza della fa cc i ata i ntt:rna de l fossato coinc id eva co n quella del l a facciata esterna del terrapieno c osì c he l'insi em e d ell e d ue o pere. qudla scava ta e quella cos tru it a. presentassero all'assal i t0re una su perfic ie uni ca " 99
Nelle arca i c he fortifi ca z i oni appena menzionate il vero fauore comune che si coglie tra fos sa ti, scarpate, ag geri , e paliZLal e, è appunto l 'impiego siste matic o, quale esped i en te os tativ o primario, della ve rti c al ità, o almen o della rilevante pendenza. Del res to anche nelle strutture difensive p os teriori il va lore interdittivo della veni ca lilà permane immutato, tanto che ancora nel seco lo XIX molte fonificazioni presentavano l 'unico acce sso ad o lt re 6 metri dal piano cli campagna 100 Ovvio allora che ogni formazione nalurale a sv i luppo vertica le co me dire og ni ripid a collina, e meg lio, ogni irta cresta montana si ri g uardò quale otti mo presupposto na turale per l ' insediamento di una fortificazione apical e. A l massimo necessari appena lievi adanamemi miranti ad esasperarn e l'imper v i età. Non a caso nei grossi sis temi montani v i ene individuara da mo lti storici, a fianco di una endemi c a mi se ria, a sua volta tes timonianza di scarsa prati cabilità razziatori a e co mm erci a le , una notev o le immunità offensiva fornita appunto dalla ostile morfologia dei luogh i :
" I l uoghi p iù ~t: \l~c cs1 furon o sempre l 'asi l o dell a liben il Durame i l viagg i o pt:r le cos te cli Siria s i vede il di ~po tism o !<l ei Turchi) è!> l<::ndc rsi u tuua l a LO na c arrcsta rsi, verso l e momagnc. al l a prim a roccia. a ll a prima gola facil men te difen d i bile
Ta l v olt a. sin o ai gi orn i no st ri q uelle libcrt11 montanare si so no co nst: r vat c , ancora ab basta nza vis ibili. vivaci. nono stant e il peso delle ammini straz i o ni moderne . " I OI
Il va l ore difen sivo offerto da ll a posizione arroccata fu talm ente recepito nel passato dalle popolazioni meno evo l ute d a indurle, in assenza di cim e, ad innalzare coniche collinette artificiali, ammassando il teITeno di r isult a da ll o scavo cli un ampio fo ssa to circolare, sulle quali impiantare l e loro se mplici fortificazioni. Il renn ine c he le designava era que llo di ' motta' , ciel tutto ines istente nella nostra lingua, anc he se t ra i fruit o ri di siffa tt e fo rtificazioni spiccano i normanni: un re ta gg io , in vero, ci è pervenuto ne ll a v oc e verbal e ·sm o tta re' c he indi ca, appunto, il franare di una collina.
Pe r millenni. q u i ndi . la fo rtifi cazione montana, se mpli ce e poco cos to sa, assolse un molo eminente mente, se non esclu sirnrnente protettivo, garantendo ai suoi occupanti, per lo più miserabili popolaz ioni anemie d alle scorrerie di pian ura o costiere, una sorta di accertabile tranquillità esistenziale. A scapito però di una magg io re c iviltà e di un magg i ore bene sse re, per non parlare della pura comodità.
Tra le pri me manifestaz i on i no n episo diche cli fonificazione di montagna in Italia, sia sulle pendici dell'arc o alp i no ch e sulle propaggini appenniniche, si rintracciano, con notevo le abbondanza, quelle ascri vib i li alle pop ol azioni indigene, a ltrimenti dette ' ca stelli eri' o 'recetti' 102. In larga sintesi possono ridurs i ad una sorta di c i rcu i1 0 murari o, eretto in opera megalitica, strettamente coincidente con l e circonvo lu z i oni del c igl io dell'altura d'impianto, definito in ingeg neria militare 'ciglio tattico'. Al di là
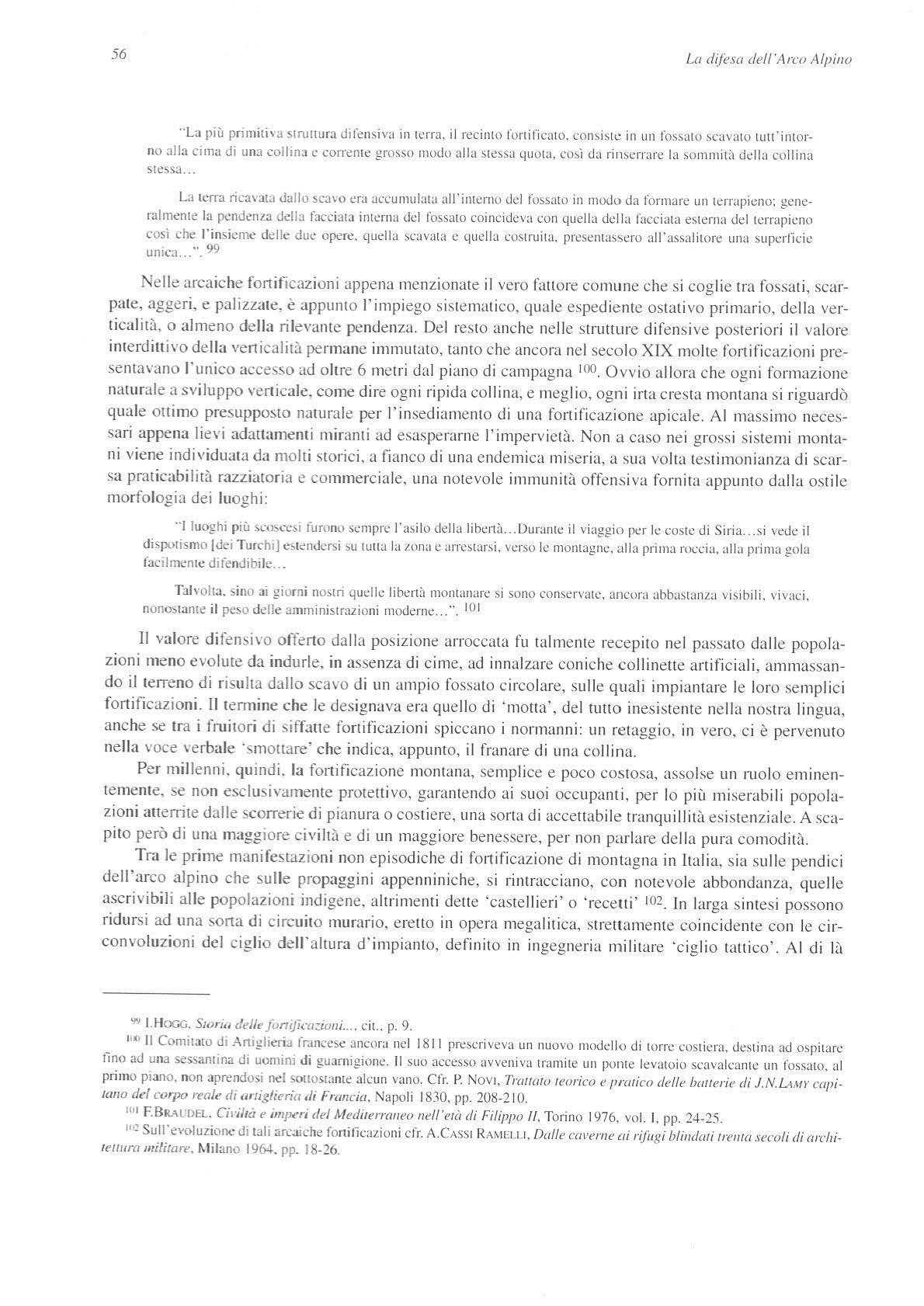
w I.H OGG S10rù , d e lle foriiJìca :io 11i cit p. 9.
h l> 11 Comit ato dt A rtigli eria frn nces e anc:ora nel 181 1 pre scr i veva un nu ovo mode l l o cli cor re costiera, cl t:s tin a ad ospi tare tino ad una sessantina d i uo min1 Ji gu arnigiont:. Il suo accesso avven iva tra mit e un porne levato i o scava l ca nt..: un fossato al prim o pi ano, n o n ap rendosi nel so uostame alc un vano Cfr. P. Novi, 1ì'({[taro teorico e prntico delle ba11erie di J.N. L4MY capilC/11 0 del corpo rea le di anig lieria t!i Francia. Napoli 1830. pp. 208-21 O.
11 ' 1 F.BRAL'DEL Ci1·iltit e imp eri del M e dilerra11eo nel/' e1à di Filippo I I. T o rin o 1976 , voi. I. pp. 24 -25
1t,J Sul l'evol uzi one di rah an:.iic he fo nificazìoni cfr. A.CASSt R AME I. U. Dalle cm •e me ai rifirgi blindati trent" secoli di archi1e1w m militare. t-.lil ano 196+ pp 18- 26
56 La difesa del/ 'Arco Alpino
della rozzezza della concezione e della realizzazione , attinsero spesso dimensioni ragguardevoli , lasciando immaginare l'immensa mole di lavoro necessario all'edificazione. Approfonditi ed accurati studi hanno dimostrato che la fase ini z iale di quelle grandiose opere contemplava, invariabilmente, lo spianamento della cima, spossante cimento che forniva al contempo la fondamentale superficie d'impianto per il villaggio ed i macigni neces sa ri per la sua cerchia megalitica. Via via che quelli si posizionavano, lungo il circuito sommitale delle pendici, venivano terrapienati alle spalle, ampliando così ulterionnente il pianoro apica l e, ed isolandolo, tramite l'estradosso verticale che progressivamente tal e enorme terrazzamento formava, da possibili tentativi di conquista.
All'interno di quelle primitive cittadelle convergevano al momento della minaccia le popolazioni limitrofe con le relative greggi, limitando si la difesa ad un compito puramente passivo, intervallato magari dal l ancio di ma ss i e di dardi sug li eventuali, e poco probabili, temerari aggressori, in genere tenuti a bada dalla sola visione di simili fortificazioni. L'abnorme diffonde rsi di analoghe strutture testimonia l'assoluta affidabilità difensiva da esse elargita, e giustifica gli immani sfo rzi sostenuti per erigerl e. Qualche dubbio invero permane, a prima vista, su ll a convenienza della tecnica poligonale I O\ unica modalità costruttiva adottata, che nel mutuo incastro di grossi conci, le cui facce este rne appaiono appunto altrettanti poligoni irregolari, risolse il problema della coesione dell'opera. L'evidentissima difficoltà insita nella procedura, la immaginabile l entezza imputabile al dover costruire concio per concio appositamente adattandolo con estrema precisione al suo contesto d'inserimento renderebbero, infatti, inspiegabile l'opzione ed, in definitiva, la sua eccezionale diffusione. Dall'Asia minore alla Gran Bratagna, dalla Grecia al Marocco, dalle Alpi ai Pirenei, ali' Appennino, persino sulla stessa Malta, ovunque si rintracciano strutture difensive apicali, si ritrova la medesima complicatissima metodologia.
Ma forse la spiegazione del mistero si ricava dal costatare che una identica maniera fu adottata anche in Giappone, e persino lungo le Ande 104, ovviamente da civiltà assolutamente distinte da quelle mediterranee, e ad esse accumunate da una unica terribile evenienza: la devastante quanto frequentissima sismicità. Ecco allora che nella resistenza delle mura poligonali alle sollecitazioni dinamiche , anche violentissime, quali quelle dei terremoti-o più raramente degli 'arieti' -si individua la accorta ragion d'essere, costituendo perciò siffatte arcaiche fortificazioni di montagna le prime costruzioni antisismiche dell'umanità.
li ricordato enorme numero delle opere pervenutici appai1enenti a quella tipologia, ad onta dei reiterati sconvolgenti insulti di una natura particolarmente ostile-e dell'uomo , spesso, ancora più radicalici dimostra la sensatezza delle scelta. Ci testimonia altresì l a pressante necessità, individuabile alle sue spalle, di preservare il va l ore difensivo delle fortificazioni anche all'indomani di eventi catastrofici, che altrimenti si sarebbero trasformati in altrettanti, recepibilissimi, inviti razziatori, giacendo sconvolta ogni difesa.
L'affidabilità complessiva delle opere così innalzate, e l a costatazio ne del notevole grado di interdizione che determinavano sui passaggi obbl igat i da esse presidiati, dovettero in breve consentire il conseguimento di un più ambizioso traguardo: la difesa di interi altipiani mediante la chiusura di ogni sin-
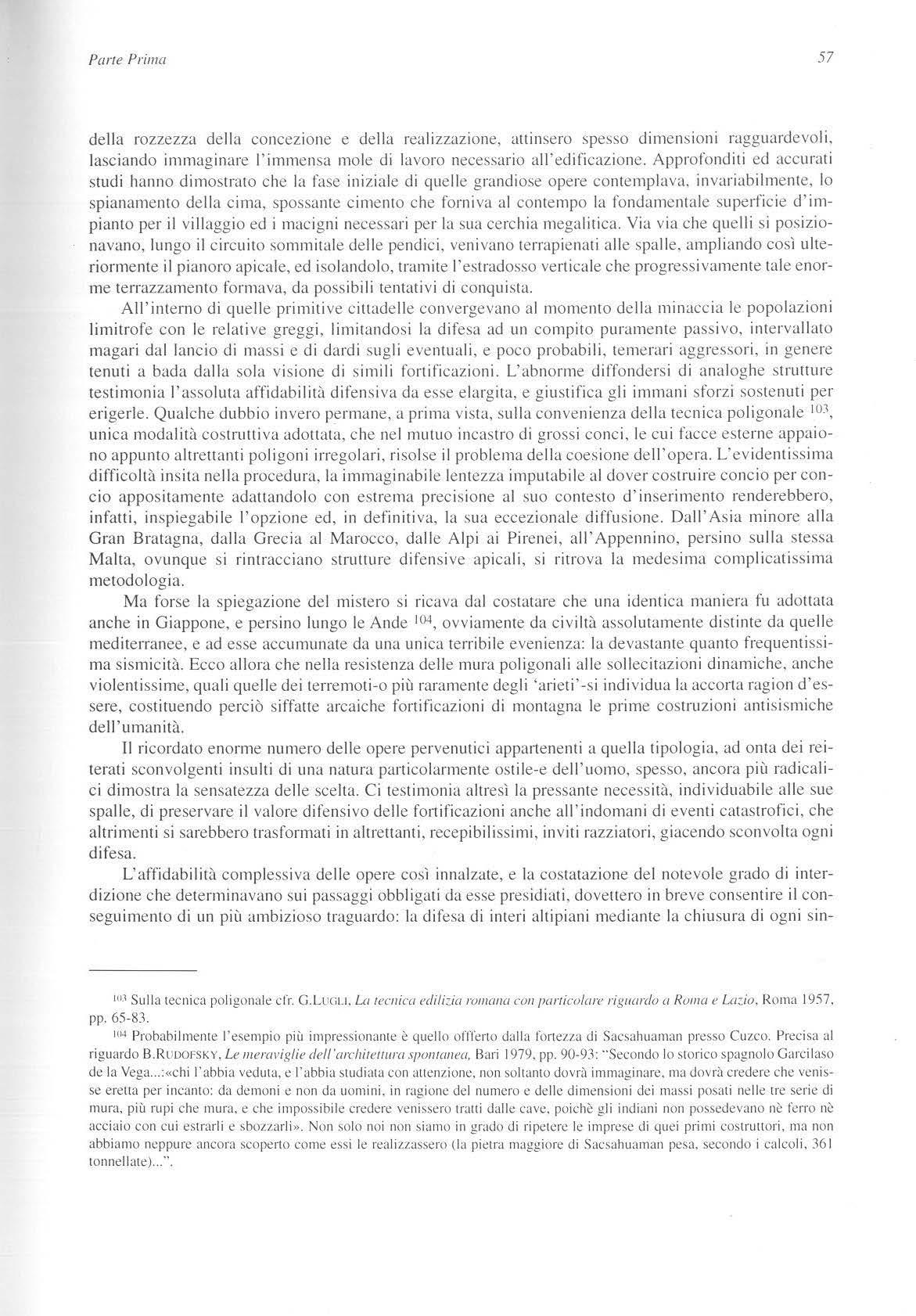
l!dili::.i(/ ro111(111a con p(lrticolarl! riguardo (I Roma e udo. Roma 19'57. pp. 6'5-83.
iu i Probabilmente l'esempi o più impressioname è quello offferto dalla Cortezza di Sacsahuaman presso Cuzco. Precisa a l riguardo B.R VI>OFSKY, Le 111er(ll'iglie dell'archi1t:1111ra spo11ta11e(I, Bari 1979. pp. 90-93: Secondo l o storico spag nolo Garci l aso dc la Yega :«chi l'ahbia veduta, e l 'abbia studiata co n au enzione, non soltanto dovrù immagina re, ma dovrà credere che venisse eretta per i ncanto: da demoni e non da uomini. in ragione del numero e delle dimen sioni elci massi posati nelle tre ser ie di mura, più rupi che mura , e che impossibile credere venissero tr a11 i dalle cave. poichè gli indiani non possedevano nè ferro nè acciaio con cui es trarli e sboaar li » Non solo noi non siamo in grado di r ipetere l e im prese di quei primi cos trutt ori, m a non abbiamo neppure ancora scoperto come essi l e realizzasse ro ( la pietra maggiore cli Sac.:sahuaman pesa. secondo i calcoli. 361 tonnellate)
Parie Prima 57
1u.1 Su lla tecnica poligon:lle cfr. G.Ll1c;u. L(/ tl!rnica
.''
go l o sentiero d ' acce sso con altrettan te piccole fo rtifi cazio ni , occupate esclusivamente da una guarnig i one mil i1 are. È una sorta di anticipazione della concezione del la 'reg i o ne fort ifi cata di montagna' di ottocen tesca fonn u lazione
Ai fini dell o studi o che se gue questo passaggio storico appare di e strema rilevanza, poichè si è di f ronte per la prima volta, ali' impiego concatena t o di pi ù opere montane finalizzate non alla protezione di sparut e pop o lazion i rinch iu se fra le l oro mura, ma a quella di un intc:ro vasto territor i o. Al suo inte rno una quantit à rilevante di abi t ant i, con i relat i vi villaggi e l e re lati ve masse arrnent izi e, potevano continuare in cot ale tranquillità l a l oro es i stenza, riu sce nd o preclusa l ' im missione di nemici dal ruolo di sbarr ame nto si ste matico am in trnsivo assolto da lle predette opere di ·sbarramento'.
La scala fu al massimo regionale, ma il concetto presumeva una va lidità statale, ed in quanto tale conobbe succe ss i ve riproposizioni, anche in studi modern i , non ultimo quello a suo tempo citato conte mpl ante i l concentramento nelle conc he aquilane delle maggiori risorse militari nazi o nali

In altre parole, una precisa branca della fortifi cazio ne di montagna iniziava a quel punto, ovvero intorno al I V-Hl se co l o a. C., l a sua precipua evo lu zione d'impiego, asso lutame nte divergente rispetto alla tradiziona le, in sostanza analoga a quella di pianura. La sua app li caz i o ne si proponeva compleme ntare dell a già quasi total e natura l e inviolabilità di molti areali montani, e quindi unicamente os tati va.
A ss odato infatti che le fo r tificazioni di montagna non potevano essere att accate con le medesime modal ità di quelle di pianura, ma so ltanto da una ben precisa ed ang usta direttrice; assodato c he l a l oro funz i o ne di sbar rame nto poteva con pochiss ime forze chiu dere irreversibilmente uno st rett o itinerario; assodat o che i l confrontarsi co n le stesse appariva indipendente dall'ent ità della compag ine attaccante, ma so lo funzione della morfolog i a delle g i oga ie, si ipotizzò da que lla data di impiega rl e per chiudere ogni acce sso a particolari alt ipi ani, trasformandoli in fortezze globali su scala regionale.
Senza dubbi o innovati va la concez i one, ma ancora di più quella del ru o l o di sba rram ento della fort ificazione di montagna appositamen te st rutturata. Ne evidenz i a il Rocchi le accennate peculiarità in un suo approfondito trattato:
"Le o pe razio ni preli mi nari c o mprendono l'avv i cinamento. l 'invest imento e l'occupazione elci terreno per
1•i mpi an10 delle batte r i e d ' att acc o.
Riguardo all'av v ici namemo ed all 'investime nt o. è faci l c anz itut to riconoscer..::
1° L a necess it à per le:! truppe d ' invasi one. d'incamm in arsi in val l ate gem:ralmente angust..:. in lunghi e stretti conidoi c he la d i fosa può facilmente sbarra re;
2 " L'i m possibi li tà dèg li spo stame nti nel!..: va ll ate prede tt e ;
3u La condi t:i o ne in ev itabik cli presen tarsi su d i una front..: ristretta ed in ord i ne profo ndo;
4 " L 'e~trem a cl i ni co lt à, se non pure l 'impossibi lit à, cli aggira re. dal p r i nc i pio dell'ope r a, i om:. k pos i zion i di d i te a. st ame il d if<.: tt o d i ~tradc lateral i. Gli agg ira menti per rnul:lttiere. o sent i eri, no n hann o grande importanza co ntro ope re pe rm anent i c hiu se.
In cons<.:gue nz:i. l' investimento di un ' ope ra di sbarramento non potrà venire ..:seguito, come per u na piazza o rdi nan a d1 pi anura da un marcia avvolg..: nt e delle colonne, m a solta nt o da un a marc i a concentrica delle co l on ne s te~se separm e d :i mas sicci spesso i mperv i. Generalment..: po i l 'invest im1.:n to non potrà <.:s~..: rç comp l eto, poichè no n riu:.ci rà al l 'agg resso re d'interceltare tu tti i passaggi seco ndar i . p rovvis ti di mul atti ere , o d i semplic i s..:ntieri. i q uali come gi à si d iss e. so no sempr..: assai numerosi in montagna
Da q uant o pr ecede è manifesto che dif'tìcilm1.:nte scopo di ta l e operazio ne p rel iminare, cont r o uno sba rr am ento. potrebbe essere il blo cco. Sen1.,1di re che co n quest o mezzo. il qua l e in olt re è in m assi m a da escl ud er si perchè non con forrnè all e r i c h ies te esigenze di ce l er i tà rara mente si potrebbe giungere a r i sult ati deci siv i. tr attandosi non di piaue popo l ose, m:i <.li semp l ici o pere mun i tç di r istre tt o presidio, e presumibilmente dotate cl i abbondanti app ro n 1gion;m1 enti. . " ( I 05)
i u, E.R o <THI. La fort ijica::. io n e in mo11ra11,11a. Roma I 898, p. 5.
58 La difesa Al1,il10
Ovviamente le precisazioni dell'illustre militare si riferivano allo scorso fine secolo, ma appaiono sostanzialmente valide anche per il periodo italico, ad eccezione ovviamente del dominio territoriale diretto, imposto dalla gittata delle armi specifiche.
Trascurando l'evoluzione dell'architettura delle fortificazioni in montagna, contraddistinta da fasi più o meno coincidenti con quelle registrate dalla generica architellura militare, falle salve le particolari esigenze imposte dalla natura dei siti d'impianto, il nostro breve approfondimento sulla genesi della fortificazione di 'sbarramento', per antonomasia montana, ne tratteggia esclusivamente le fasi salienti, fino alle estreme riproposizioni fruitive, argomento appunto del presente saggio.
Nelle pagine precedenti abbiamo appena accennato al ruolo di dominio esercitato dalla fortificazione di montagna, ricordando magari la maggiore virulenza del lancio di dardi e massi dall'alto verso il basso, fattore peraltro puramente tattico. In realtà, fino ali' avvento di efficaci artiglierie, una concreta azione di dominio territoriale non poteva avvenire molto discosta dalla verticale d'impianto della fortificazione, per cui il suo ambito operativo, e di dominio, non esulava dalle strette adiacenze, quali ad esempio i sentieri, o i va li chi che bloccava. Ma bastava allontanarsi cli poche decine cli metri, e ciò era possibile nel caso di itinerari cli fondovalle, che nessun intervento poteva estrinsecarsi eia quelle opere per mancanza cli armi congrue allo scopo: da cui la prassi di combattere all' esterno. In definitiva pur essendosi realizzato in pieno il compito di sbarramento, al cli là dell'interdizione di ristrettissimi passaggi-come i ricordati remoti accessi agli altipiani-riusciva impossibile accrescerne la portata.
L'adozione ciel l'artiglieria risolse la questione e restituì nuova credi bi I ità ostati va alle fortificazioni di sbarramento, ampliandone immediatamente il raggio cli dominio e d'interdizione. Anzi la posizione dominante ritrovò moltiplicate le sue potenzialità, poichè non diversamente dai dardi, la gittata delle artiglierie dall'alto verso il basso riusciva, non solo maggiore ma, notevolmente più devastante negli impatti ciel contrario. Le ballerie delle opere cli sbarramento videro pertanto istaurarsi la ottimale condizione di poter cannoneggiare restando praticamente fuori tiro. Persino quando le gi11ate si incrementarono gli esiti degli impatti sulle loro mura si rivelarono insignificanti, smorzati dalla forte obb liqui tà delle traiettorie e dalla perdita di energia delle palle decelerate dalla gravità.
La particolare condizione consentì la perpetuazione di canoni costruttivi ormai assolutamente superati a valle, ma perfettamente validi in montagna.
E mentre in pianura il bastione iniziava, insieme alla terrepianatura delle cortine ed all'allargamento dei fossati, la sua corsa evolutiva, in montagna si continuò ad erigere fortificazioni architettonicamente simili ad anacronistiche opere medievali, con l'unica distinzione di vistose teorie di cannoniere occhieggianti dalle massicce cortine. Il rilevante numero dei pezzi trovava una sua giustificazione nella necessità di concentrare un ingentissimo vo lume di fuoco sui tratti di viabi lit à sottostante, procedura che per la bassa cadenza cli tiro dell'epoca sarebbe risultata altrimenti impraticabile.
Nè presentava particolare valenza difensiva adattare perimetri bastionati alle creste d'impianto in quanto il bastione trovava significato nell'eliminare ogni settore defilato antistante mediante il fiancheggiamento e l'incrocio del fuoco con i corrispondenti: in asssenza però di un terreno piatto l a potenzialità si dimostrava inutilizzabile.
Possibile tull'al più nei contesti d'impianto su vaste spiana te articolare le mura a foggia di 'tenag li a' in modo da consentire una parvenza cli fiancheggiamento in caso d'investimento dirello del nemico, ma l'ipotesi stessa appariva più una e lucubrazi one accademica che una effettiva minaccia.
A sostituire il mutuo appoggio che le sin gole strutture componenti una fortificazione di pianura erano in g rad o di prestarsi mediante il reciproco fuoco, si provvide articolando una unica fortezz a in alqu ante opere staccate, ciascuna eretta ad un a diversa quota. Il che consentiva progressivamente all e più el evate cli poter tenere sotto tiro tutte le restanti: mancava certamente la reciprocità, ma la rilevante altezza riservata a quella sommita l e, ponendola a l riparo dal tiro nemico, fornì alla disposizione indiscussa valenza. Logicamente non esistevano i camminamenti sotterranei che raccorciavano le singole opere avanzate con il corpo principale della piazza, ma anche per quelle si adottò una funzionale variante costituita dall'adozione di rampe ricavate sui fianchi della montagna, serrate tra due massicci muri, debita-
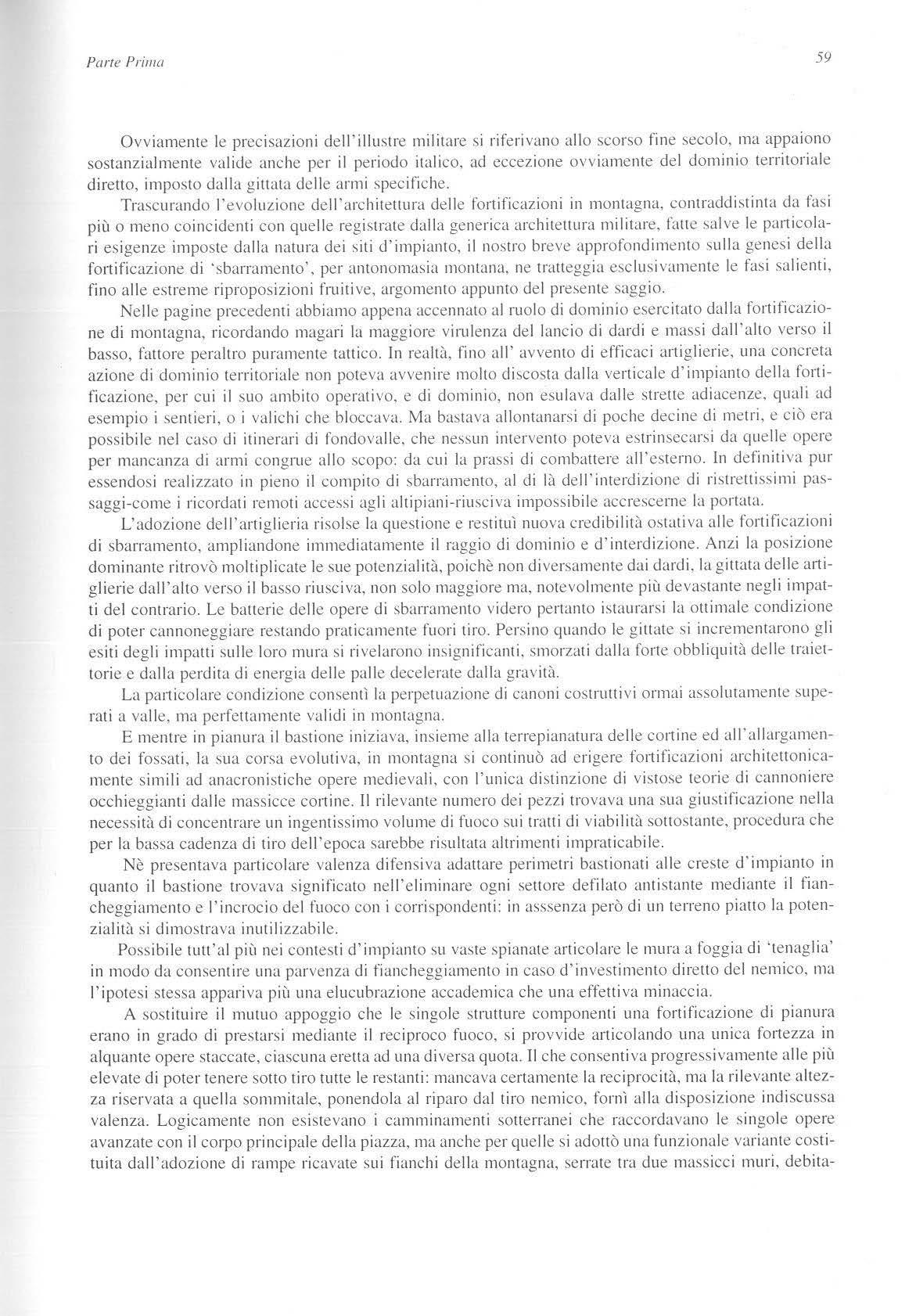
Parte Prima 59
mente coperti, in maniera di realizzare così una sorta di galleria artificiale alla prova, certamente più economi ca delle scavo in roccia, non di rado parzialmente impiegato.
I cri teri elementari esposti conservarono la loro validità anche dopo la comparsa dei proietti cilindro-ogivali, tranne per l'esigenza dell'impiego di strutture notevolmente più robuste e monolitiche, e della blindatura delle coperture. Le strutture orizzonatali infatti divennero rapidamente l e più vulnerabili e minacciate dai tiri delle moderne artig li erie capaci di ordinare fino ad allora inimmaginabili e quindi traiettorie discendenti prossime alla verticale.
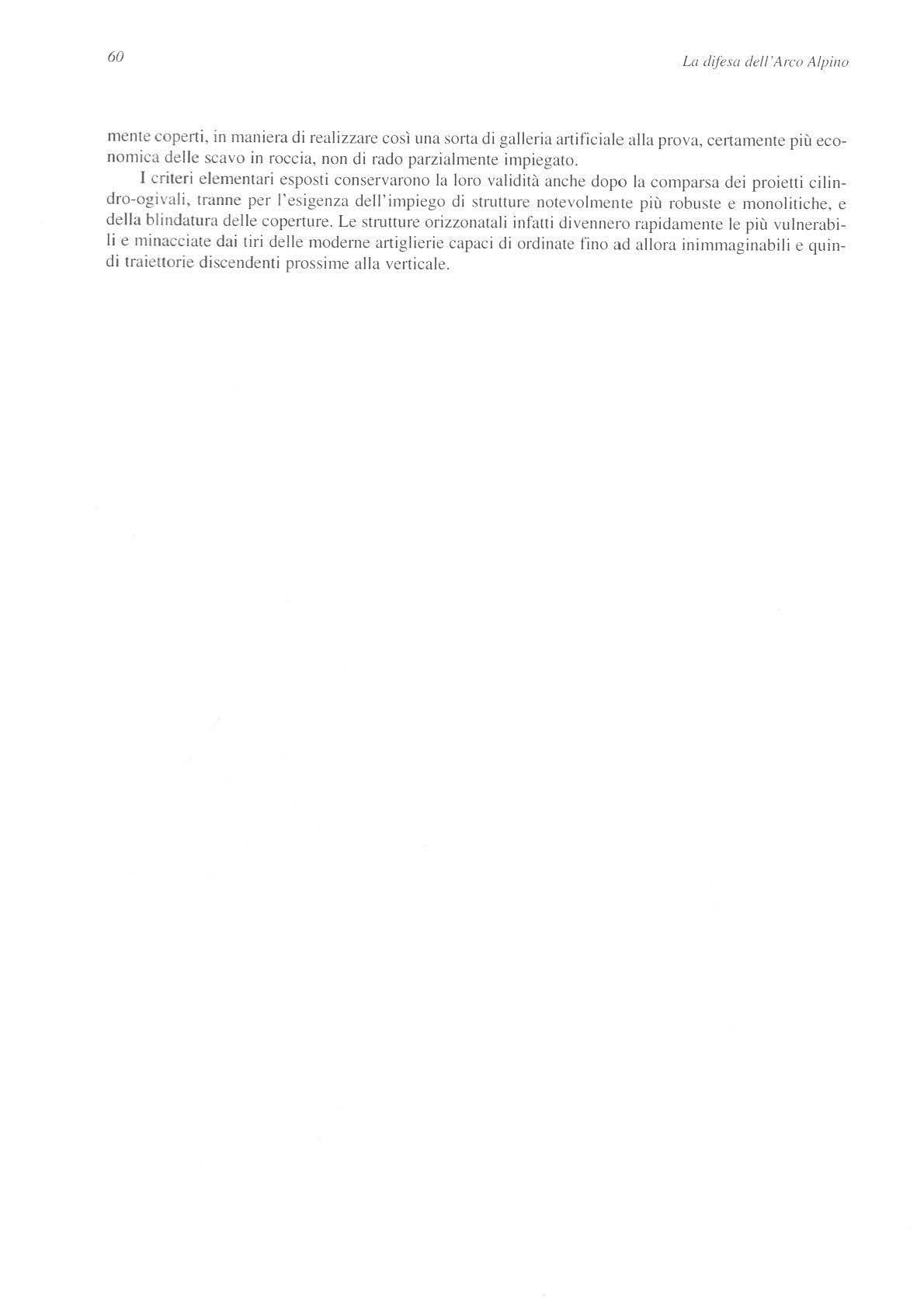
60 La difesa dell'Arco
Alpino
PARTE SECONDA
a cura di Massimo Ascoli
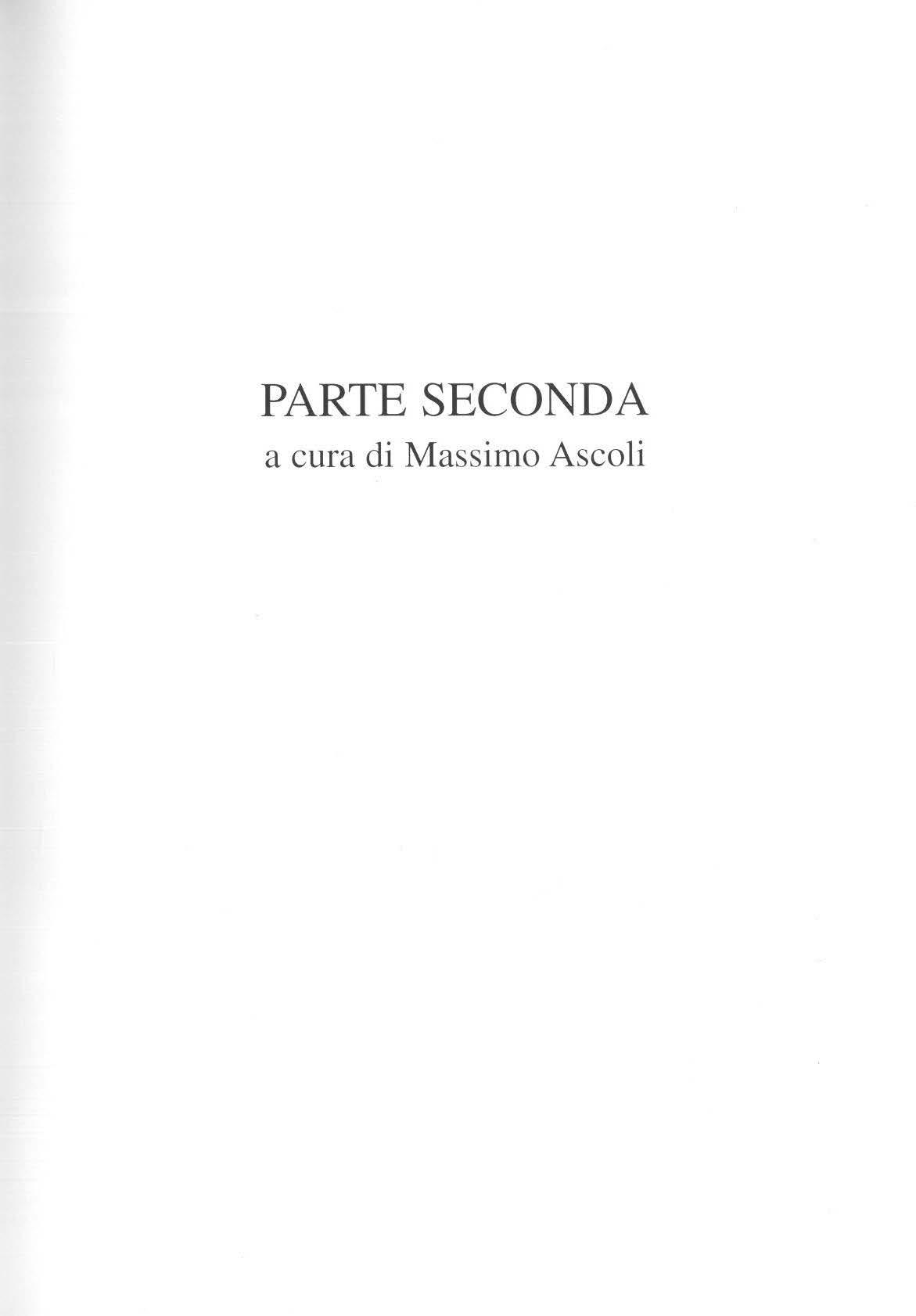

SITUAZIONE ALL'ATTO DELL'UNIFICAZION E
Situazione politica e motivazioni relative alla scelta del 1866 anziché 1861
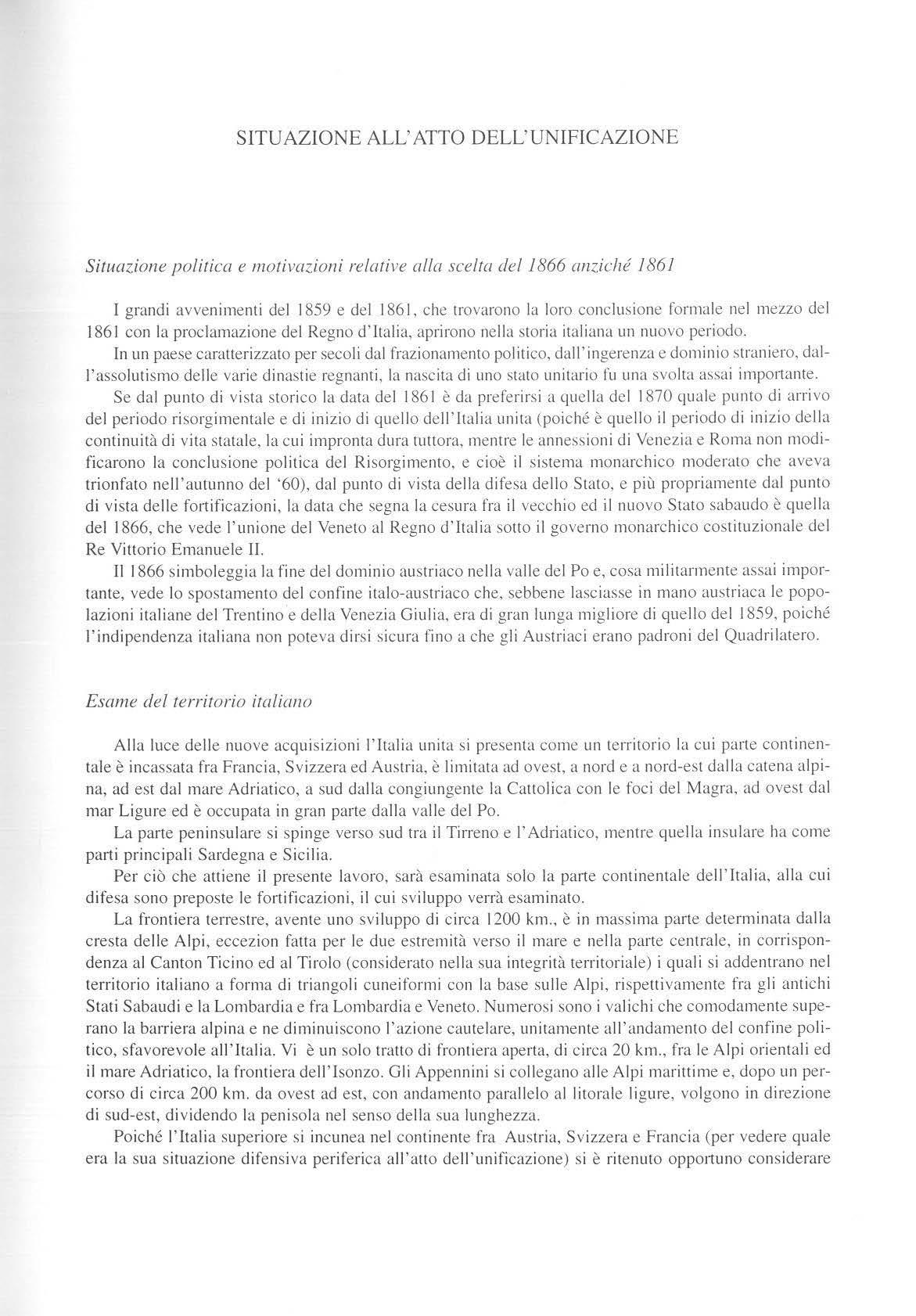
I grandi avvenimenti del I 859 e del I 86 I, che trovarono la loro conclusione formale nel mezzo del 1861 con la proclamazione del Regno d'Italia, aprirono nella storia italiana un nuovo periodo.
In un paese caratterizzato per secoli dal frazionamento politico, dall'ingerenza e dominio straniero, dall'assolutismo delle varie dinastie regnanti , la nascita di uno stato unitario fu una svo lta assai importante. Se dal punto di vista storico la data del 1861 è da preferirsi a quella del 1870 quale punto di arrivo del periodo risorgimentale e di inizio di quello dell'Italia unita (po iché è quello il periodo di inizio della continuità di vita statale, la cui impronta dura tuttora , mentre le annessioni di Venezia e Roma non modificarono la conclusione politica del Risorgimento , e cioè il sistema monarchico moderato che aveva trionfato nell'autunno de l '60), dal punto di vista della difesa dello Stato , e più propriamente dal punto di vista delle fortificazioni, la data che segna la cesura fra il vecchio ed il nuovo Stato sabaudo è quella del 1866, che vede l'uni one del Veneto al Regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.
Il 1866 simboleggia l a fine del dominio austriaco nella valle del Po e, cosa militarmente assai importante, vede lo spostamento del confine italo-austriaco che, sebbe ne lasciasse in mano austriaca le popolazioni italiane del Trentino e della Venezia Giulia, era di gran lunga migliore di quello del 1859, poiché l'indipendenza italiana non poteva dirsi sicura fino a che gli Austriaci erano padroni del Quadrilatero.
Esame del territorio italiano
Alla luce delle nuove acquisizioni l'Italia unita si presenta come un territorio la cui parte continentale è incassata fra Francia , Svizzera ed Austria , è limitata ad ovest, a nord e a nord-est dalla catena alpina, ad est dal mare Adriatico, a sud dalla congiungente la Cattolica con le foci del Magra, ad ovest dal mar Li gure ed è occupata in gran parte dalla valle del Po.
La parte peninsulare si spinge verso sud tra il Tirreno e l'Adriatico, mentre quella insulare ha come pat1i principali Sardegna e Sicilia.
Per ciò che attiene il presente lavoro, sarà esaminata solo l a parte continentale dell'Italia, alla cui difesa sono preposte l e fortificazioni, il cui sviluppo verrà esaminato.
La frontiera terrestre, avente uno sviluppo di circa 1200 km., è in massima parte determinata dalla cresta delle Alpi, eccezion fatta per le due estrem ità verso il mare e nella parte centrale, in corrispondenza al Canton Ticino ed al Tirolo (considerato nella sua integrità territoriale) i quali si addentrano nel territorio italiano a forma di triangoli cuneiformi con la base su ll e Alpi, ri spett i vamente fra gli antichi Stati Sabaudi e la Lombardia e fra Lombardia e Veneto. Numerosi sono i valichi che comodamente superano la barriera alpina e ne diminuiscono l'azione cautelare, unitamente all'andamento ciel confine politico, sfavorevole all'Italia. Vi è un solo tratto di frontiera aperta, di circa 20 km., fra le Alpi orientali ed il mare Adriatico, la frontiera dell ' Isonzo. Gli Appennini si col l egano alle Alpi marittime e, dopo un perco r so di circa 200 km. da ovest ad est, con andamento parallelo al litorale li gure, volgono in direzione di sud - est, dividendo la penisola nel senso della sua lunghezza.
Poiché l'Italia superiore si incunea nel conti nente fra Austria, Svizzera e Francia (per vedere quale era la sua situazione difensiva periferica all'atto dell'unificazione) si è ritenuto opportuno considerare
separatamente i tratti di frontiera verso ciascuno di questi sta ti , analizzando dapprima le lince stradali principali che attravers,m o ciascuno dei tre settori di frontiera in cui si è suddi visa la frontiera terrestre italiana, successivamente evidenziando le linee di invasione, lungo le quali ciascuno dei tre stati sopracitati potrebbe muovere per invadere l'Italia e i loro punti di convergenza.
a) Frontiera verso /'Austria
Le li nee stradali principali che attraversano questa frontiera sono:
I. Fa5cio di strade che attra versano la frontiera aperta dell'Isonzo, fra cui la ferrovia Gorizia Udine;
2. Strada del Natisone, che attraversa il co ll e di Starasella e mette nell'alta valle dell'Isonzo;
3. Strada ordinaria e ferrovia della Pontebba o di Tarvis, fra la valle del Fella (Tagliamento) e la valle del Gailitz (Gail-Drava);
4. Strada del Kreuzberg (o Monte Croce cli Comelico), fra la valle della Drava e quella del Piave e del Tagliamento;
5. Strada di A lernagna, fra la va lle della Rienz (Adige) e quella del Boite (Piave);
6. Strada di Valsugana, fra la valle del Brenta e quella dell'Adige;
7. Strada delle Fugazze, fra la va ll e del Leno (Ad i ge) e quella del Leogra (Timonchio -B acchig li one);
8. Linea di Val d" Adige o di Val Lagarina, composto di due strade ordinar i e e di una ferrovia;
9. Strada delle Giudicar ie, fra l a valle del Chiese o Val Sabbia e Val Bona (Sarca);
I O. Strada del Tonale, fra la Val camonica (Oglio) e Val cli Sole (Noce -Adi ge);
11. Strada dello Stelvio, fra la Valtellina (Adda) e la valle cieli' Adige;
12. Rimane inoltre la frontiera aperta dell'Isonzo, di limitato sviluppo ( 20 km.) che può consentire, se non opportunamen te sbarrata, l'in vasio ne del Friuli.
L'infelice linea di confine a forma di S, conseguente la guerra del 1866 e al relativo trattato di pace italo-austriaco firmato a Vienna, già divinata come infausta dal vecchio Garibaldi, assicurava, come è noto, un forte vantaggio ali' Austria Ungheria, assegnando ad essa il controllo clirello non solo della displ u viale della catena alpina, ma anche di parte dello stesso versante italiano. Essa dallo Stelvio piegava ve r \o sud in direzione ciel Passo Croce Domini, toccando il monte Adamello ed il monte Listino; superato poi il Garda, raggiungeva il monte Altissimo e l'orlo selle ntrionale dei Lessini e dell'altopiano dei Sette Comuni, incrociando il Brenta. Da qui, seguendo lo spart iacqu e fra Cismon e Mis e tra Cordevole ed Avisio, ragg iungeva la Marmolada per piegare quindi ad est, indirizzandosi ve r so il Boite, tagl iato tra Cortina d'Ampezzo e S. Vito. Dalle Tre Cime di Lavaredo si snodava poi seguendo lo spartiacque tra Piave e Drava e scendeva infine in Val Pontebbana, diretta allo Jof cli Montasio e alla clispluviale tra lsonzo e Tagli amento
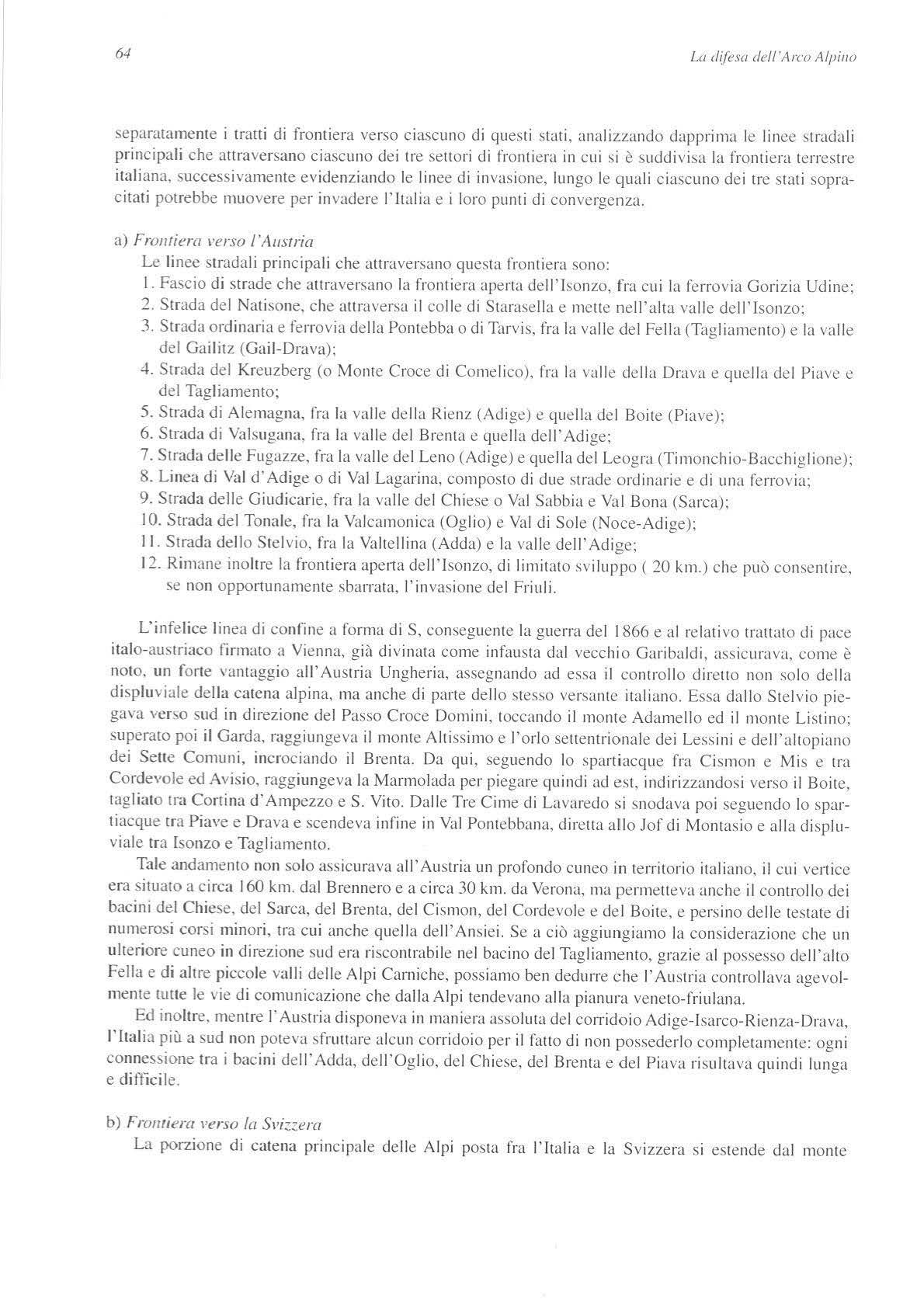
Tale andamento non so l o assicurava ali' Austria un profondo cuneo in territorio italiano, il cui vertice era situato a circa 160 km. dal Brennero e a circa 30 km. da Verona, ma permetteva anche il control l o dei bacini del Chiese, del Sarca, del Brenta, del Cismon, ciel Cordevole e del Baite, e persino delle testate cli numerosi corsi minori, tra cu i anche quella cieli' Ansiei. Se a ciò aggi ungiamo la co nsiderazione che un u lteriore cuneo in direzione sud era riscontrabile nel bacino ciel T ag liamento, graz i e al possesso dell'alto Fella e di altre piccol e va l li delle Alpi Carniche, possiamo ben dedurre che l'Au stria controllava agevolmente tutte le vie di comunicaz ione che dalla A l pi tendevano alla pianura veneto-friulana.
Ed inoltre. ment re l' Austria disponeva in maniera assoluta del corridoio Adige -I sarco-Ricnza -Dra va, l'Italia più a sud non poteva sfruttare alcun corridoio per il fallo di non possederlo completamente: ogni connessione tra i bacini dell'Adda, dell'Oglio, del Chiese, del Brenta e del Piava risultava quindi lunga e difficile.
b) Frontiera verso la 51'i::.::.era
La porzione di catena principale delle Alpi posta fra l 'Ita lia e la Svizzera si estende dal monte
64 La difesa dell'Arco Alpino
Grapillon, nel ma ss i ccio del Monte Bianco, allo Stelvio, nel massiccio del monte Braulio, cd è formato dalle Alpi Pennine, dalle L eponzie e da parte delle Retiche. La frontiera fra i due stati forma un gran sa lien te al di qua de ll e A lpi , per cui dalla parte dell'Italia essa resta comp l etamente aperta in co1Tisponde nza a quel salien te
La di sposizi one delle val l ate sui due versa nti è assai diversa:
su quello se tt en tri onale es i stono tre sole vallate, quelle del Reno, della Reuss e del Rodano, c he hanno difficili comunicazioni fra l oro: su quello meridionale, invece, si dipartono numerose vallate che sce nd ono nei bacini dell'Adda e del Ticino convergendo ve r so i laghi lombardi, e l e strade che l e percorrono si possono raggruppare in due fasc i , divisi fra l oro dalla catena Meso lci na o del Pi zzo Tambò, l a qua l e, unitamente ai l ag hi cli Como e cli Lugano, non permette fin pr esso l a pianura che difficili collegamenti.
Il fascio orienta le mette in comu nicazione fra cli loro i bacini montani ciel Reno e ciel l 'Adda, direttamente per lo Spluga e indirettamente attraverso l 'Engad in a (Va ll e clell' lnn ) per i va li chi delle Alpi ciel B ernin a e dei Grigioni. Le strade principali cli questo fascio sono tre, attraversanti rispettivamente i colli del Bernina, del Maloggia e dello Spluga.
L 'al t ro fasc i o, posto ad occide nte della catena Mcsolc in a, si compone della stra d a ordina ria del San Bernardino, delle v ie o rdinari a e ferrata del San Gottardo e dall a rota bil e del Sempione. Dal Sempio ne al Monte Grapillon la ca tena principale è attraversata ei a sole strade mulattiere, fra cu i merita menzione quella del Gran San Bernardo.
Partendo dal Monte Dolent (ad est del Monte Bianco) fino alla zona dello Ste l v i o (Piz zo Umbrai l fin o al 1918, ora al Piz Lat) il confine è lungo c irca 700 km. e corre per solo 220 km su ll a dorsale elevata e difficile delle Alpi Centrali (Penn in e e L epontine ad oves t, Retiche ad es t). Per la parte rim anente se ne distacca in più punii per c r ea r e sal i ent i che si svo l gono per ben 397 km. sul versan te italiano e per 92 km su l versante svizzero. T due sali enti it a li ani, del l e va lli di L ei e di Livig no, nelle A l pi Retiche, sono di minore interesse ai fini delle comu ni cazioni e di eventua li operazioni militari. Tutti i cinque sa li enti svizze ri, invece, in maggiore o minor mi sura, conferiscono rilevanti poss i b ili tà offe nsi ve verso i I nostro Paese:
il sa li ente d i Gondo o di Val cli Ycdro permette un co nt ro ll o assoluto del Passo elci Sempione e de ll'accesso alla va lle de ll 'Ossola (fiume Toce);
il grande sa l iente del Canton Ticino, spingendosi profondamente sul versante padano fra Lago Maggiore e Lago cli Corno e giungendo col Menclrisiotto a meno di 50 km da Milano, permette il con t rol l o indi sturbato di importanti passi alpini sull'a lto e m o ltiplic a su l basso la possibilità di passagg i della frontiera in terreni facili;
il sa lie nte della M era o di Val Bregaglia permette di scendere rapidamente a Chiavenna, tagliando l e comunicazioni con lo Spluga e di qui su Colico nell'alta valle del! ' Adda;
il sa li ente di Val Poschiavo co nse nte cli puntare a tagliare agevolmente, a Tirano , le comunicaz i o ni della Valte llin a tra Sondrio e Bormi o e di aprirsi i l passo ve r so il co ll e del l'Aprica e l a conca di Edo l o in Val Giudicaria;
infin e il sal i e nte di Val Monastero, per quanto min acc iato da quello italiano cli Val Livigno, perm ette aggiramenti a breve raggio delle difese (Giogo di Santa Maria e Pass o di Frach) dello Stelvio e di marciare , quindi, s ia ve rs o la Valt ellina , sia verso l a Va l Venosta.
Il confine, là dove co rre sull a dorsale o su con trafforti diffici lme nte perc o rribili, garanti sce sicu rezza, ma i numerosi sa li enti in favore della Svizzera m o ltiplica no i passi percorribi li , da con trollare per evitare l e semp re fiorenti att ività de l contrabbando, o da clifencl er e in caso di conflitto.
c) Frontiem verso la Fmncia
L a frontiera ital o-francese segue pressappoco l'andamento della cresta delle Alpi occidentali, e resta so lo aperta nel piccolo tratto posto fra l e Alpi marittime e i l mare.
Aspramente conteso e sogge tto a spos tamenti a segu ito deg li esiti delle gue rre, i I confine co rreva
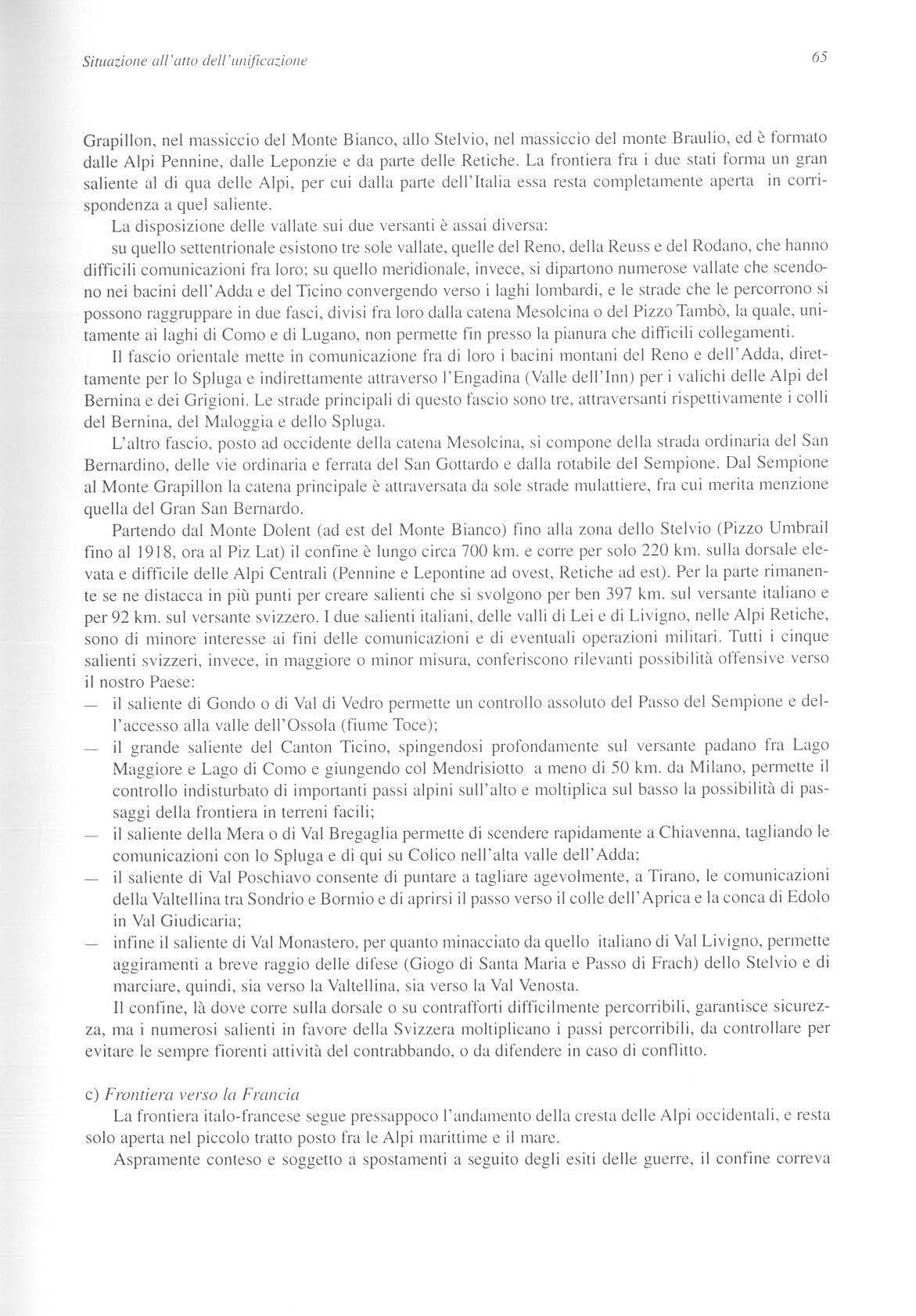
Situazione all'atto de/1'1111(/ica::.io11e 65
f ino al IS66 lu ng o la linea di displuvio, come anticamente a veva disposto il tratt ato di Utrec ht del 1713, eccez io ne fatta per la 7ona del Valico del Mo nginevro, ove il confine anelava a col locars i in corri s p o n<knt.a del ce ntro della piana.
Le linee pr in cipali che attra,en,ano questa frontiera sono:
I. La s t rada del Piccolo San Bernardo, fra la Vall e dell' l sère e la Va ll e d'Aosta ( Dora Baltea);
2. La lin e a del Cenisio. formata dalla s trada ordinaria del Colk del Ce nisi o e dalla fe rrovia del FréJU\. fra I' Are e la Dora Riparia;
3. La s trada del Mongine, ro. fra la Valle della Durance e quella della Dora Ripar ia, a ttrav ersando poi il Colle del Se., tri è re pe r e ntrare nt!lla Valla ciel Chiusone;
-L Strada cieli' Argentera o d e lla Maddal ena, fra l' Ubaje tte ( Ubaj e- Duranc e) e la Stura cli Vinadio;
5. La ,tra ci a del Co ll e di Tenda. che quanto prima ,arà seguita dalla ferrovia, fra la Roja e la Vermcnagna (Gc,.,,o-Stura);
6. La linea della Cornice. lun go il lit ora le ( Riviera cli Ponent e), co mp o:-.tn di un a strada ordina ria e di una ferro"ia. che congiungo no Ni ua co n Ventimig li a, Savona e Genova Siccome poi un corpo di in,a,ione france.,e, che a,anrnsse per la linea della Cornice. o sbarcasse in un punt o di es::.a, pot rebbe rimontare le va lli de l vc r!'.ante me ridional e delle Alpi Marittim e e de l!' Appennino Ligure per e ntrare ne l Piem o nte, così s i può con s id era re ciascuna dell e s trade percorrenti queste u ltime ,alli come con tinuazi one della lin ea della Cornice.
Le più irnp o rtan11 di queste .,trade sono sei: que ll a del Colk di ~ava, da Oneg lia a Ccva; quella d e l Colle Sa n Bernardo. pure da Oneg lia a Ceva; la strada o rdi naria. "eg uit a anche dalla ferro\'ia del Colle di Cadibona da Sa,·ona a Cairo, e quindi a Ce\-a o ad Acqui; quella d e l C olle di:!I G iovo, da Savona ad Acqui; quella del Colle del Turchino. da Vo leri acl Ovada. Come ,i \ède ,i tra tta. più che di semplici linee, di veri e propri val ichi in cui s i addensano le, ic di comu nicazi one altr i menri dette fasc i di in vasio ne, che adducono dal te1Tit o ri o franc ese alla regi o ne ita1ia na. Qu est i fasci di in\'as ione montani prese ntano a fallor comune (esclusa c hi aramente la linea del la Cornice) ,\-ìlupp i lungo ,a liat e brc\'i, ad andamento radiale e rettilin eo, con fo rti pendenze. La disposit.ione a raggiera dei contrafforti che si dipartono dal crinale alpino e la loro asprezza ha nn o cost re tt o le vie di 1rnn..,1to lungo il fo nd ov all e.
Ana logamente è -,iarn ostaco lata la creazione cli vie di arroccamento, che co nse nton o il co ll egamen10 in sen-.o rncridiano da \alle a valle.
In conseguenza della d ifferen te azio ne erosiva dei ghiacc iai e delle acque di sco 1Time nt o a seco nda ci e l di,er!>o grado di compattezza de i terreni attraversati, l'andamento della lin ea di di sp luvio ha dato lu ogo a num erosi salienti e r ientranti. Il sa li e nt e di ma gg io r forma ed es t e ns io ne , fra qu e lli cos ì formati, prende il nome di Bardonecchia. dalla località abitata più nota in esso racchiusa. È formato dalla testata delle alte val li d e l C h iso ne e della Dora Riparia che s i incunean o fra Delfinat o e Moriana, seguendo l'ampia c un a fom1ata dal I' Are nel suo corso. Si tratta de l saliente più pericoloso e criti co dal punt o di , ista di fen-,i\'O e come ta le parr ico larrnent e curat o dallo S tat o Magg iore sardo prima ed italiano p o i, c he lo hann o amcchito. per ev it arne una resezione alla base di un addensamento e conce ntrazio ne cli s trutture fornfo: at e che non t ro\'a riscontro in a ltre parti del co nfin e.
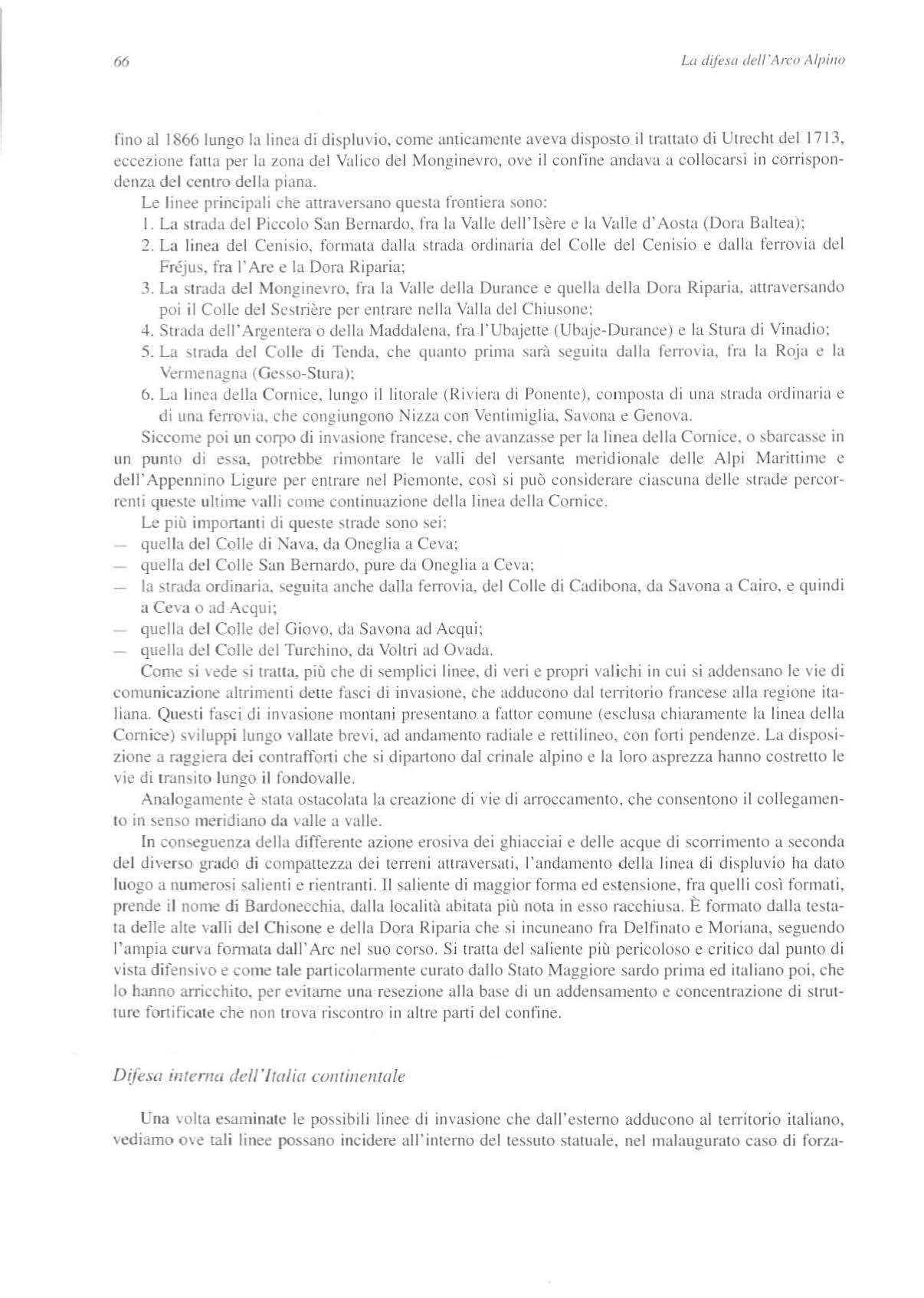
Dtfesa 111tenw dell' I talia co11ri11e11ta!e
Una \Olta esam inat e le possibili lin ee cli in vas ion e c he dall' es te rno adducono a l te rrit o rio italian o, vediamo o,e cal i linee pos~ano in c idere all'interno del tessuto s tatua le , ne l malaugurato caso di forza-
66 La difesa Alpino
mento delle difese cli confine ed invasione ciel territorio italiano.
"a) I potesi di una in vasio ne dalla fro nt ie ra aus tr i aca.
Le 11 linee principali che att raversano l a frollliera ita l o-austriaca si possono riunire in tn.: gruppi, costi tuenti altrc11an tc lince d i invasione cieli' Aus tria rispcllo all'Italia: il pr imo gruppo è formalo dalle prime cinq ul.! lin ce: i l secondo dalle l in ee 6•. 7" e 8": il terlO dalle ultime tre.
Le zone c he più probabilmente saranno segui te nell'invasione sono qu<.:lle corrispo ndenti al primo e al secondo gruppo: l a prima, perché comprende l a frontiera aperta dell'Isonzo; la seconda, perché i corpi d i inva~ione possono partire dal Tirolo I taliano. in possesso cieli' Austria, che si addentra a guisa di c uneo nel nostro territorio, e quindi. superata la fron tiera. essi trovan si quasi al c:cnlro dell'Italia c:o ntin.:n wle ed as~ai \icini a Bol og na. ove potrd1be esse re u tili.! stabi l ire un ridotto difensivo. lnvec:e, le l in c:e e.fa: cos tituiscono la terza zona cli invasiom: anziculto presentano maggiori clii'licoltà ag li sposcamenci cli gross i corpi di truppa, e poi sboc:c:ano nella p i anura lombarda a maggior distanza dal nostro supposto riclollo c:\!ntrale, sc:opo pri nc:ipale dell ·invasore.
Per la d i fesa interna di Sl.!co nd a linea delle prime due 1,ont: conn: 1i-ebbe ~wbilire una regione fonific:ata nel famoso quadrilatero Mantova - Peschiera-Verona-Legnago. come proponeva il Generale A raldi. Mantova dovrebbe esserne il perno di manovra, co n una testa di po nt e sul Po a Borgofone, e l e altre tre le piane di appoggio. Questa regione cos ti t uirebbe u n sec:o nd o sba r ramento della Val Lagarina e minaccerebbe l' invasore, che seguisse l e:: lin ee della prima zona e le prime due della seconda per dirigersi sul ridotto centrai..:. L..: fortiric:azioni verso te1Ta del l a piazza terrestre m ar itt im a di Vcnl.!zia cost i tuisc:ono u n 'a ltrn minac:c:ia sul l'ia nco opposw pc:r lo stesso invasore. il quale perciò non potrebbe passare oltre senza as~ediare regolarmence la regione fonifi ca ta I.! le p iazze predelle.
Come pe rn o di manovra rispello al la t<.:rza zona di invasione può servire: la piccola regione fortificata Piacenza-Cremona-Pizzigheuone. che conv i ene stabi lire per caso di un'inl'asione dal l a fro nti era svizzera. come cli remo tra poco" I.
Per completare la difesa interna verso l'Austria si dovrà, al momento cli una guerra, erigere teste cli ponte provvisorie sui principali fiumi che attraversano la pianura veneta, specia lmente su ll 'Ad i ge a Badia e a Boara, e sul Po a Santa Maria Maddalena, a nord di Ferrara.
"b) Ipotesi di un' invasion..: dalla frontiera sv i zzera.
A un nemico eh..: superasse questa fron tiera e volesse dirigt:rsi sopra il ridotto cemrak, converrebbe passare il Po a Piacenza..: a Crl.!mona. Quindi, per la difesa interna verso dl.!lla fron tiera è indicata l a posizione PiaccnzaCrcmona-Pizzighl.!ttone per stab i lirvi una rl.!gione i'o rt i i'i cata, c:on Piac:en1.a quale perno cli mano\rn, Crl.!monn e Pi zz igheu one quali piane di appogg i o.
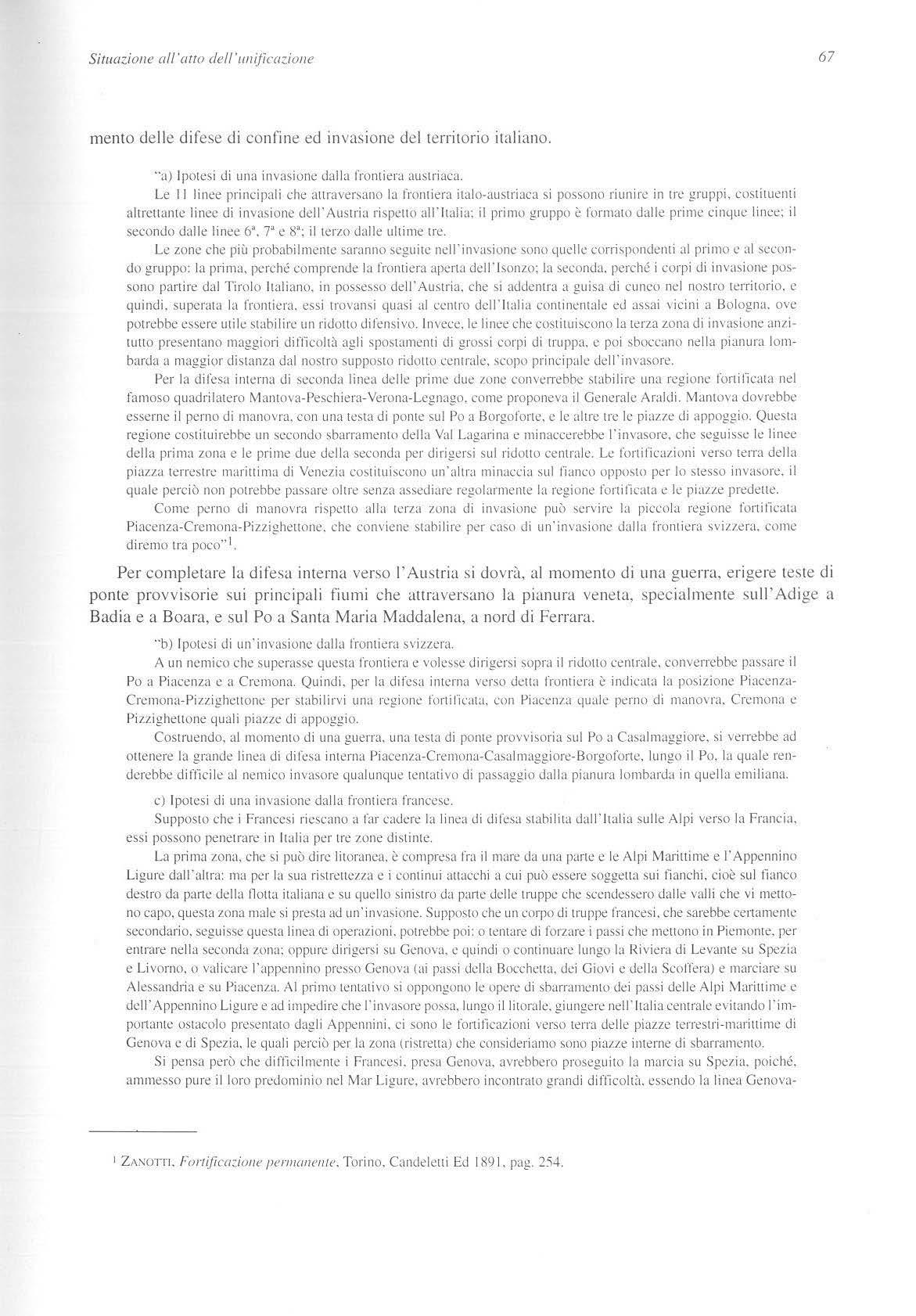
Coscruenclo, al momento di una guerra, una cesta cli ponte provvisoria sul Po a Casalmaggiore, si verrebbe ad ottene re la grande linea di difesa int erna Piacenza-Cremona -Casalmaggiore-Borgoforte, lungo i l Po, l a quale renderebbe difficile al nem ico in vasore qualunque tentativo di passaggio dalla pianura lombarda in que ll a emiliana.
e) Ipotesi di una invasione dalla frontiera francese.
Supposto che i Francesi ricsc:ano a i'ar cadere la lin ea di difesa stabi lita dall'Italia sull e Alpi verso la Franc:ia. essi possono penetrare i 11 I talia per tre zone d i stinte.
Ln prima zo na, c he si puti dire litoranea, è co mprt:sa fra il mare da una partt: e l e Alpi Marittime e l'Appenn in o Ligure dnll'nlcra: ma per l a sua r is trettezza e i l'Ontinui auacch i a c ui può essere sogge tta sui fi anchi, cioè sul fianco clescro da pane della notta italiana e su quell o sinis tro da parti.! delle tr uppe c:hl.! scendcsst: ro dalle valli che v i meuono capo, qu esta zona rnalt: si pres ta ad un'invasione. Supposto che un corpo di tru ppe frances i. che sarebbe certamente sec0ndar i o, seg ui sse questa li nea di operazion i. potrebbe po i: o cencare di forzare i passi che mc 11 ono in Piemonte:, per entrare nella seconda zona: opp u re dirigersi su Genova, e qu i nd i o c:oncinua rl.! l ungo la Riviera di Levame su Spezia e Li vorno, o valic:art: l'app enn in o presso Genova (ai pass i della Boc:c:h..:ua. tk i Gio\'i ç ddla Scolfera) e marciare su Alessandria e su Piacenza. Al primo tentativo si oppo ngono le opere di sbarrame nt o de i passi delle Alpi .Ylariuime e dc li ' Appennino Ligure e ad impedi re che l'invasore possa, lungo il litora le , giungere nel!' Itali a cencr:i le evitando J' i111por1antc ostac:olo prl.!senrnto dagli Appennini. ci sono le fonitìcazion i verso terra de ll e piazze terrest ri-m aritti me di Gt.:nova e cli Spezia, le quali perc i ò per la zona (ristrelta) che consideriamo sono piaLLe intern e di sbarra rn cnlO.
Si pensa però c he d i ffic: il me nte i Francesi. pr..:sa Genova. avrebbero proseguito la marc:ia su Spc7ia, poiché, ammesso pure il l oro prl.!dorninio ne l Mar Ligure, avrl.!bbcro incontrato gra ndi difficoltìt, essl.!ndo la l inea Genova -
Situa::,ione ali 'atto del/'1111ijìca::,io11e
67
1 ZA:s1(nT1, For1ijicrdo11e pem1wie111e, Torino. Candeletti Ed 189 1. pag. 254.
Spella htrada ordinaria e fcrro\'iaria) mollo malagcvok e facile ad es\ere interrnua. Più probabilmente dun4ue essi da Gt:nova avrebbew mosso s u /\h.:ssandria o su Pia ct: nza per riu n irsi al co1po d i inva s ione princ ipale c he già si trovas,e in Piemonte.
La ,econda lona. rhe si può ùcnominart: centrale. compre,a fra le Alpi \l.1ri ttirnc e r ApJJ<!nnino Ligurc da un lai, c 11 Po dall'altro (rllenuto pcrò quesw liumc come seno lhlacolo solt,11110 a \alle d1 Torino). è la più impor1:u111:. mettendo, i capo le princ ipa li vie pr0\e11ienti dirett amen te dalla Frnnl'ia. più que lle in di re lle che si Maccano dalla linea de ll a Cornire. e pcrch~. come vedn.:1110. l'invasore francese avrf1 co nv e ni en , a di dirigersi wr.,o di essa dalla 1cw1 zona.
La tena z o na ··scuemrionalc··i! compresa fra il Po e le ,\lp1 Cemrah. Le tmppe nemiche che a\e,scro mosso per questa 1011a s,irebbcro potute cmrare in Lombardia per numerose strade. m a inc ontrando success1\' i os tacoli neg h afflue nti di siniMra del Po. e poi. r,er av an 1ars i \'e rs o il r id otto centrah:. avrebbero dovuto s up erare il Po J:1 dm:e esso. ingro,sato ,Jagli afllucnti. d iventa u n ostaco lo ragguardevole.
\follo probabilmeme le truppe francesi. entrate in Italia per la terza 1.ona. si sarebbero ri\ersate nella ,ona centmle. ù1staccanJo soltamo qualche corpo secondario con l'incarico di occupare ) ;1 Lomban.lia"2
Ne l caso che la ma!'l sa dell'e se rcito fram;ese avc~sc deci so di invadere la zona centrale formata in g ran pan e dal basso Pi emonte . e di là diriger'>i per Alessandria e Pi ace nza sul rid o tt o centrale . a\' rebbe utilizzato la \ iab ili1 à csi~1e me e cioè le undici s trad e principali (da quell a del Cenisio a quella del Turch in o). Ma ques te s trade a11raverso cui in vadere l ' Italia co ntin e ntale co nvergono tulle verso Alessandria. do ve perciò sarebbe \lato va lid o c reare una reg ione fortificata per la dife sa int e rna verso la Francia. Quc'>ta regione awebbe dovuto avere per perno di mano, ra Alessandria e per piaae di appoggio Ast i, Casale e Valenza.
L'Appe1111i110 rosco-e111ilia110 e il ric/o((O centrale di difesa.
L' Appc!nnino. dalle sorge nti della Magra alla Catt olica, forma l'ultim a lin ea di difesa dell'Italia cont inenta le, qualunque sia la frontiera te rrestre da lla quale il nemic o provenga, poiché qu es ti sarà obb li gal o a supe rarl a co n la massa dell e sue forze p er penetrare nell'Italia ce ntrale.

"Quel tratto di appennino cos tituisce una grande barriera che si appoggia da una parte alle forti posi1ioni di Sm,Jdla. d1 Geno\a è di Spezia. e dall"altra dal ~lare Adriatico 111.:lla lunga stretta. facile a difendersi. che ,ta a sud di R1m1n1. rafforrnta dalla piazza teJTe,t rc manttima di Ancona ui cui dirt:mo in segu ito. L'invasore. non potendo per l,t natur..1 Ji questi ;1ppogg i d 'a ln g ira re l'os tacolo. sarì, costn.:110 a te ntarn e il va lico.
Le ,trade principali c he aurnversano l'Appe nnino 1osco-e111ilia no sono 0 11 0 ord in a rie. una t"èrro\'ia e,istente e dl!..: m l'o,truzione. che. dal pumo di \iSta delle operazioni direlte ualla \'alle del Po \er,o l'Italia centrale. pos~ono raggrupparsi in tre fasci. Il primo. sboccante m Val di /\1agra. è compo,w dalla strada della Cisa (da Parma a SanJna e a Spezia). che sa rà quant o prima seg uita dalla l"i: rrov ia e dalla s tra d a d i Cerreto o di Sassalto d a Reg g io a S.:1uana e Spe, ia. Il secon d o fascio. !>bocca nt c nella \'alle dc li 'O mbro ne è forma to Jalla \!rada dell'Abetone o lii Bos.. ,)ungo. attr.tvcrsantc.: gli altri due passi di San Marcello c dclii! Piastre (da ~1odena a Pistoia), dalla quale si i.tac.:aro parecchi.: altre strade secondarie . e dalle \trade ordinaria e ferrata della Porrcttana (da Bologna a Pistoia). 11 tem ra,cio, sboccante in Val d i Sieve, è co,1i1uito dalla s tra da della Fut a o delle Fill iga re (da Bol og na a Firenze) d3lla ,trac.la lmole~e (ua I mola a Firenze), dall a Mrada faentina (da FaenLa a f-irenze). che sa rà prest o seg uita dalla rerwvi.1. e dalla ~tralla forlivese (da Forlì a Firen1e).
È bene ossc~.1re come le Mralle ora accennate. mentre si raggruppano III fa,ci ver,o ,ud. divergono in\'ece nello sborcare, wr~o nuru. ne lla p ia nura emiliam1. r.inno ~alo eccezio ne qu elle de ll a Porre tt a e della F111a. le quali. suss1ù1a tc da que lle del terLo gruppo. costitu iscono l'un ico fascio o pponun o al la controffensiva da sud verso nord. e determinano con c1t) l'importanLa ,1ra1egica di Bologna. ove si ritiene comeniente di ,wbilire il ridono centrale di d1fe,a Jclr ltali.t contmentale. A Bologna quindi ,i ÙOHebbc cre;m.: una \ a,ta regione tonificata con due campi trinLer.1t1. l'uno di pi.mura. e l'altw di montagna. cs tendent i,i tino alla cre,ta ùèl l'Appe nnino e comprendcnte le , alli ucl Reno e d ella Sa ve na. Così cos titui ta qucl la reg io ne se rvi1\!bbe scnla dubb ie.i a conte ncn: 1ut10 il no,tro cst:rci to ch e in caso d i rowsci pat iti ne ll a Valle Padana.\ i ,i rit irasse. è, ricev uti iv i soccorsi dal resto Jell' Italia. pot reh-
- z. , ITTI. op. cit. pag. ::!.'i.'i Z.:;, ITII ,ip dt. pag '.!'i.'i-::!56.
68 La difern Alpino
be prepararsi a prendere la controffensiva. La sua azione poi si farebbe sentire sulle altre strade che attraversano l'Appennino tosco-emiliano. le quali perciò potrebbero essere difese anche da sole truppc mobili appoggiate ad opere passeggere. Infine, la regione fortiticata di Bologna servirebbe ad impedire che un corpo di truppe nemichc, riuscito a sbarcare sulle coste toscane. p-:nctrasse nella Valle Padana per congiungersi alla massa principale dell'invasore proveniente dalle frontiere tcrrcstri.'' 3
Strutture fortificate realizzate da Austria, Francia e Svizzera (motivazioni - rea/iz-:,azioni esistenti al 1866)
Lo studio fino ad ora realizzato consente di individuare quindi le linee cli attacco/invasione che possono essere utilizzate per invadere l'Italia o dall'Italia essere utilizzare contro gli stati contermini. Si procede quindi ad una disamina cli come nel 1866 tutti gli stati della zona abbiano provveduto a cautelarsi investendo sulle linee/vie cli possibile invasione, strutture fortificate. Lo studio prende in esame le strutrure difensive realizzate dagli stati confinanti per far fronte ad eventuali azioni italiane tese ad accrescere il territorio nazionale e successivamente la situazione difensiva italiana quale si presentava al termine della Terza Guerra di Indipendenza.
Austria
Privata dalla pace del 1866 delle formidabili fortificazioni della piazzaforte di Verona, l'Austria pone Trento, città di antiche tradizioni di comando, nel ruolo di fulcro dell'intero sistema fortificato meridionale dell'Impero e le fa assumere, a ripetizione più moderna cli un disegno gi~t realizzato nel passato, il rango cli vera e propria piazzaforte
Capolinea e sbocco da sempre di tutte le valli l:1terali nella spina dorsale cklla regione, in quella Val d'Adige cioè, che è l 'assc portante dd territorio
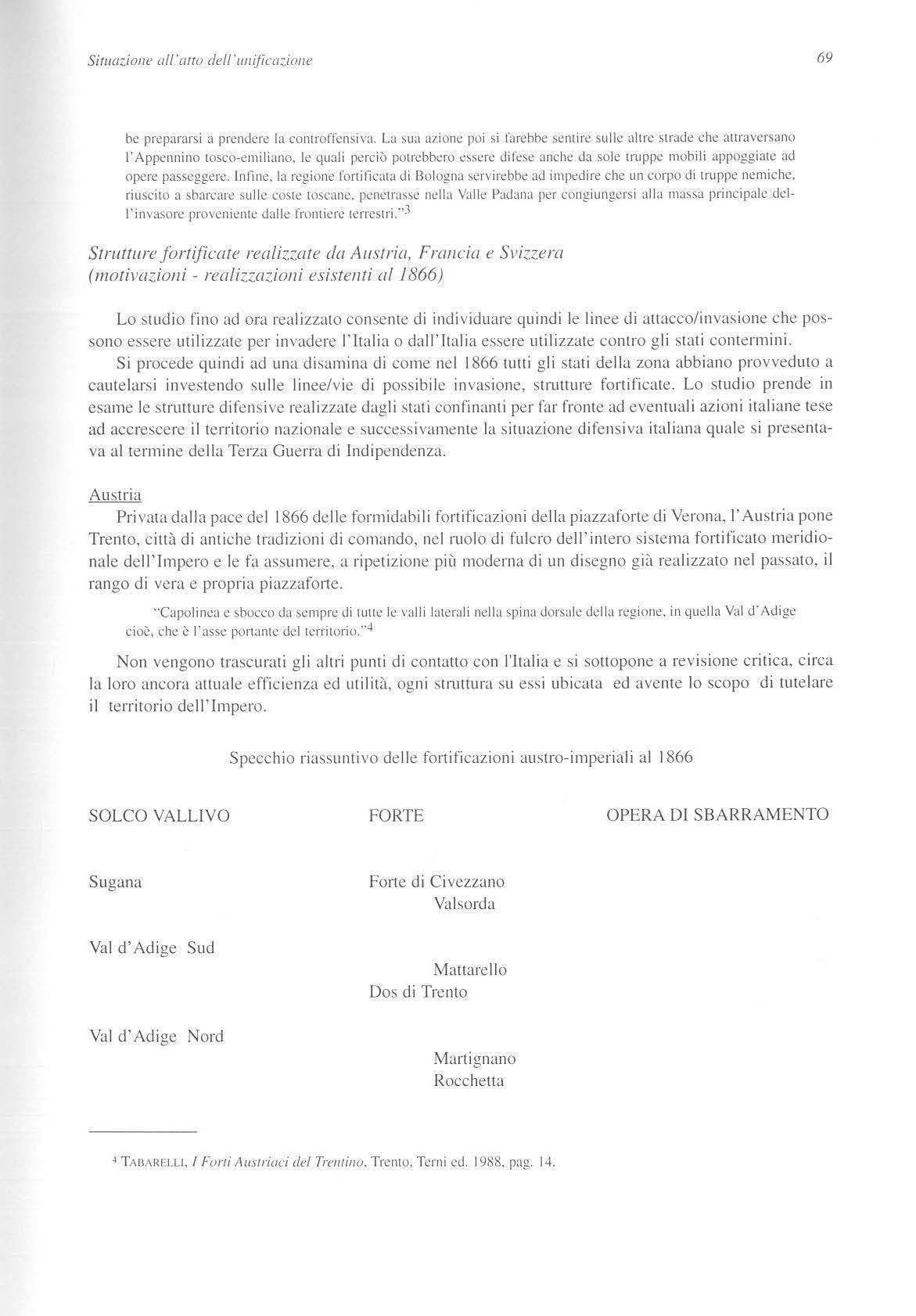
Non vengono trascurati gli altri punti di contatto con l'Italia e si sottopone a revisione critica, circa la loro ancora attuale dficienza ed utilità, ogni struttura su essi ubicata ed avente lo scopo di tutelare il territorio dell'Impero.
Specchio riassuntivo delle fortificazioni austro-imperiali al 1866
SOLCO VALLIVO
Sugana
Val d'Adige Sud
Val d'Adige Nord
Sit11a::,io11e
all'atto del/'1111ijica::,io11e
69
cli Civezzano Valsorcla
Dos di Trento
Rocchetta
FORTE Forte
Mattarello
Martignano
TABARELLI. / Forti ,~11s1riaci del Tre111ù10, Tn.:nto. Terni ccl. l 988. prig. 14.
OPERA DI SBARRAMENTO
Giudicarie e Val Chiese
Monte Brione
San Niccolò
Danzolino
Lari no
Revegler
Tonale
Stel\'iO Tarvisio e Val Canale
(sbarramen ti car in l iani )
Valle Isarco
Solco di Cadine
Garda Val di Sole
Val Rienza
Rocchetta
Gornagoi
Monte Ciavalac
Forte Lago Predii
Sbarramento di Passo Predii
Sbarramento di Malborghetto
Opera di Fortezza
Buco di Vela
Doss di Sponde
San Niccolb
Santo Alessandro
Nago
Vclon
Mero
Platzwiese
Svizzera
li problema ciel rafforzamento del le difese con un sis tema cli fortificazion i preoccupava eia anni le competenti autorit~t svizzere.
Nel 1831 la situazione politica divenne così tesa in Europa che si temette lo scopp i o di un connitto gene r ale. La dieta, riunita in sessione straordinaria a Berna, decise di far erigere provvisoriamente e rapidamente alcune fortificazioni sui punti più importanti della Confederazione.
Sorsero allora, costruite in maniera provvisoria, le fortificazioni di Anrberg, le opere delle Gole di Gondo, la testa di ponte di Saint Maurice e \'ennero migliorate e perfezionate! le opere costruite sul Passo di Luziensteig, risalenti alla Guerra dei Trent'Anni.
Allorché nel 1848 la situazion e po l iti ca in Europa divenne di nuovo critica, l a Confederazione dispose per il miglioramento delle opere fortificate di Saint Maurice e di Luziensteig e la realizzazione di opere forti presso Bellinzona. In questa citlft vennero realizzate le opere di difesa relativa alla linea fortificata ' ·intcrieure" ed "extérieure" causa il pericolo di eventuali azioni offensive portate dal governo
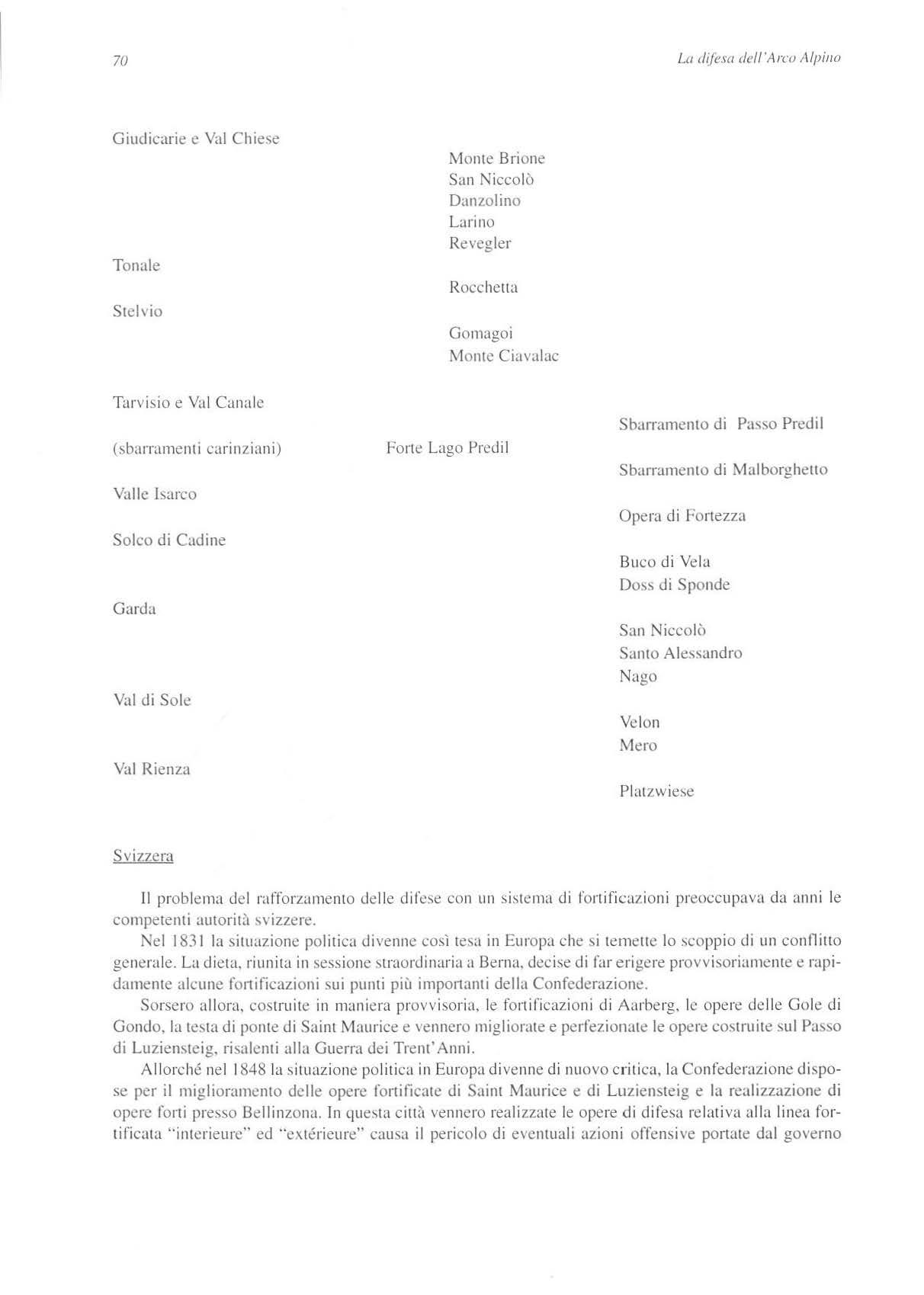
70
La difesa dell'Arco Alpino
austriaco in ritor s ione all'espulsione d a l Canton Ticino di re li g ios i capp uc c ini.
Qu es ta era la s ituazi o n e fortificata della Svizzera, re a lizzata in pieno travaglio conseg u ente al passaggio dell a re s p o nsab ilit à della difesa del paese dalle mani degli Stati a quelle della Confederazione.
L 'a nn essione della Savoia da parte della Fra n cia al termine del processo costitutivo della Nazione italiana prima e la nascita dello Stato tedesco poi portarono da due a quattro i v icini.
Le potenzi a li pretese dei vicini sul le regioni cli lin gua it al iana, così ritenevano g li ambienti della Confed erazio ne, furono causa di inquietudine in Svizzera e fecero propendere per un rafforzamento della s truttura difensiva a s ud.
La costituzione di un Re gno it a lian o st retta m e nte legato a ll a Francia infatti non in contrava il favore dell'opinion e pubblica, m en tre n e i can toni cattolici non riu sciva grad it o l'attacco perpetrato alla Santa Sede e la proclamazione di Roma cap ital e del Reg no d ' Italia.
Si temeva inoltre che la nas c ita, a l confine m er idi o nal e, di un o stato di vas te dimensioni e popolazione, ese rc ita sse attrazione culturale ed economica verso la regione ticin ese, comp li cando così i delicati equ ilibri int e rni della Svizzera stessa.

La cessione della Savoia, dovuta ai patti s tipul a ti con la Francia, o ltre a costituire un sacrific io penoso p er l 'I talia , doveva avere per la Confederazione s te ssa riperc ussio ni di carattere militare che più ava nti nel tempo s i sa rebber o vivacemente fatte se ntire.
Molto forte era la minaccia cos tituita dal saliente ticines e per l'int egr it à territoriale it al ia na, ma non era la sola, anche se forse la più pericolosa.
I nfatt i. sop r att ut to dacché la Savoia era passata sotto l a sovra nità della Francia. questa. in caso di contlitto con l'Ital i a poteva cercare di es tend ere la sua fro nte d i attacco e di esercitare una per i co l osa azio ne avvolgente risalendo l 'a lt a va ll e del Rodano per invadere l ' Itali a, non solo per il Gran San Bernardo, ma anc he per i l Sempio ne e, dopo l' apertu r a delle comu ni cazio ni per il Passo della Furka, perfino per il Gottardo e la valle del Tic in o violando così la neu tral i tà della Savoia.
Così ad oriente, fino al 19 18, c i oè tino a quando !"Aus tri a ebbe i l possesso dell'Alto Adige. questa avrebbe potuto facilitare un'offensiva dalla Stelvio e dal Tonale verso la Valtellina e l a Val Giudicaria aggira ndone le difese passando per l e val li sv i zze re dei G r ig i on i ed i passi ma l difesi di quel confine
È vero che queste azioni avrebbero v i olato la neutralità svizzera e, l a prima , anche quella del l a Savoia. stabilite dal tratt ato del 1815, m a in entrambe i cas i, si trattava d i passaggi d i forze att raverso regio ni periferiche della Svizzera.
Sicché si poteva se mpre temere c he c ircostanze intern e cd es terne potessero impedire alla Svizzera d i impegnars i a fondo per garantire la neutralità e opporsi a queste v i o l azio ni
È da dire che consimili passaggi attraverso zone perife rich e della Svizzera potranno apparire possibili. anc he alle autorità i ta li ane nel caso di event uali operazio ni offe nsi ve contro la Franc i a in comb inazi o ne con l a Genn ania all eata.
Notevoli le difficoltà dell'impresa sia per l e asperi tà de l terre no e successivamente anche per le d i fese predisposte da parte sv i zzera; era un 'i mpresa che si riteneva possibile esse nzi almente qualora l e pressioni interne cd esterne ese rcita bi li da parte tedesca avessero reso l a Rep ubb l ica Elvetica praticamente consenziente.
In q uesto caso l e possibilità di attraversamento dell a Svizzera av rebbero potu to co nse ntire due poss i bil ità:
-o di estende re le a7.ioni offe nsive (a uraverso il Moncenisio, il Piccol o San Bernardo. l a Tarantasia e la Moriana) ve r so il fronte Grenob l e-A l bertvill e co n altre avvo lgen ti per il Gran San B ernardo, il Sempione e l'alta valle del Roda no, in m odo da sboccare in forze nell a reg i one di Lione;
- oppure di avva lersi delle numerose l in ee d i penetrazione e d i ar roccame nto attraverso il ter r iwri o svizze ro per portarsi al con fin e nord occide nta l e della Svizzera ad invest ire, in combinazione con le annate tedesche all eate. l e posizioni del Giura Franco-Svizzero e tlell a famosa Troué dc 13clfort conco rre nd o alla batt aglia decisiva sul Reno.
Va deuo chiaramente, poi, che. nonostante le condiz i o ni topografiche del co nfin e così nega ti ve, l e p reoccupazio ni delle Autorità Militari ital i ane non erano destate tanto dalle minacce eserci tabil i da parte dell a Svizzera. sulla c ui vo l on tà e sul cui interesse a mantenere l a neutralità general men te;: si co nfid ava, quanto da qu elle eserci tabi li attrav erso il suo territ or i o dalle al tre gra ndi potenze confinanti.
Si è detto che generalmente si con fid ava nella volontà e nell'in teresse della Svizzera ad osserva re la neutralità; ma si tem eva che essa non potesse in ce rt e c ircosta nze garant irl a, opp ure c he il quadro politico es terno ovvero le stes se co mplcs siv ità della costituzione inte rn a della Co nfederazione potessero in durla a non con trappors i decisamente a violazioni per i fer iche del suo te r r i tO r io. che non fossero tali da minacc i are l a sua es i stenza o il grosso
Situazione del/'1111ifica:,io11e 71
delle sue l'orze arroccate nel rido u o <..lei Gonaruo o sull'altopiano S\'izzero.
Si era hen convinti, dunque, che la neutrulitf1 ~viZLera 1·osse favorernlc e che la sua osse r va n;;a fo~se conveni e!lle ali' I talia; ma si temeva che la Sv i zzera )>tes,a non po tesse garantirla.
Preoccup:wano po i tutti quei silllomi o qud le opinioni che. nell:i S\' i ue ra medesima. erano indicativi <..li u na minore volontà di OS)>t::rvarla.
Veniva riconosciuto che la polit i ca interna de ll a Svizzera era intluenzata essenzialmente dalle pressioni interne ed es terne de ll'ekmento tedesco e d i quello francese. mentre non mancavano. nt! ll a libera S\' i zzera. uomini e forze politiche or i entat i a vedere e a ch i edere politiche p iù att i ve d i quel l e ancoratè al mantenimento de ll a neutralità.
Di fatto nel p r imo ventenn i o <..lei XIX secolo. una nella pre\'ale1wt <..lell'demcnto tcuc,rn nella popolazione. nelle alli\' it à economiche. negli organi di informaziont' c. ,oprau utto. ndlc sfere militari. finirono per preoccupare le autorità po litiche e mi l itari irnliane pe r il caso d i un possibile !>chieramento della SvizLera al fianco di avversa r i ali' Italia, opp ure di un suo aueggiamento pitlltosto conse nziente ve r so l oro in iz i a ti ve." 5
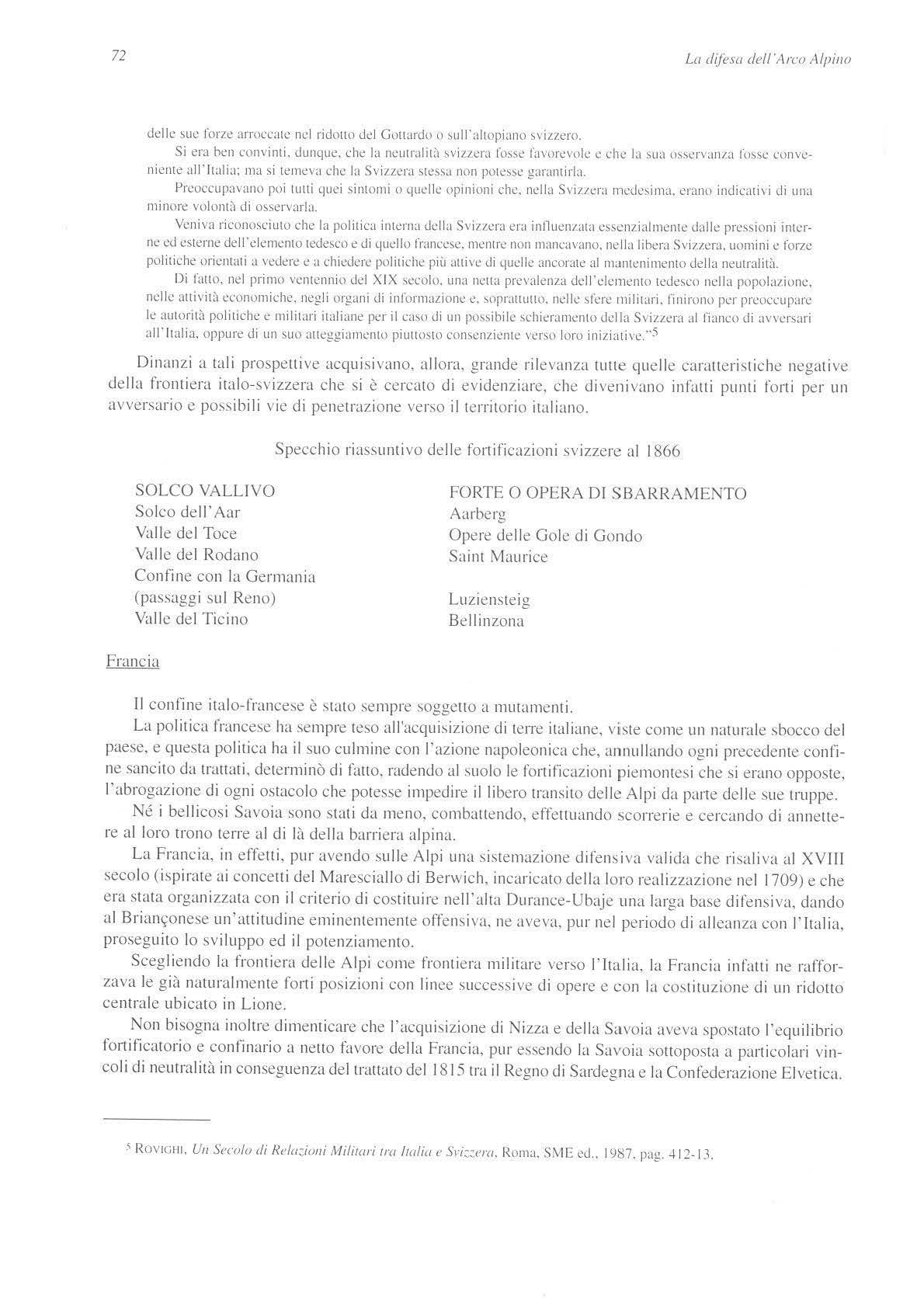
Dinan zi a tali prospcllive acquisivano, all ora, gra nde rilevanza tulle quelle carat teristiche nega ti ve della frontiera italo-svizzera che si è cercato di evidenziare, che divenivano in falli punii forti per un avversari o e possibili vie di penetrazione verso i l terr itorio ita l iano.
Specchio riassuntivo delle fortif icazioni svizzere al 1866
SOLCO VALLIVO
Solco del I' Aa r
Valle del Toce
Valle del Rodano
Confine co n la Germania (passaggi sul R eno)
Valle del Ticino
Francia
FORTE O OPERA DI SBARRAMENTO
Aarbc r g
Ope re delle Gole di Gondo
Saint Maurice
Luziens te i g
Bellinzona
Il co nfin e ital o -fr ancese è stato se mpre soggetto a mutamenti.
La politica fr ancese ha sempre teso all'acquisizione di terre italiane, vis te come un natural e sbocco del paese, e questa politica ha il suo culmine con l'azione napoleonica che, annulland o ogni precedente confine sa ncito da trattati, determinò di fatto, radendo al suolo le fortificazion i p iemon tesi che si era no opposte, l' abrogaz i one di og ni ostacolo c he potesse impedire il libero transito delle Alpi da parte delle sue truppe.
Né i bellicosi Savoia sono stati da meno, comballe ndo, effettuando scorrerie e cercando cli anne tter e al l oro trono te rre al cli là della barriera alpina.
La Francia, in effe tti, pur ave nd o su ll e Alp i una sis tema z i o ne difensiva va li da c he risaliva al XVIII seco l o (isp irate ai conce tti del M ar escia ll o di Berwich, in ca ri cato della l oro realizzazione nel 1709) e che e ra stata organizzata co n il c rit e rio di costituire nell'alta Durance-Ubaje una l arga base dife nsi va, dando al Briançoncse un 'attitudine e minentemente offensiva, ne aveva, pur ne l periodo di a ll eanza con l'Italia, proseguito l o sviluppo ed il potenziamento.
Scegliendo la fro nti era delle Alp i co me front iera militare verso l'Italia, la Francia infalli ne rafforzava le già naturalm ente forti posizioni con lin ce successive di oper e e con l a costilllz ion e di un rid o tt o centrale ubicato in Lion e.
Non bisogna inoltre dimenticare che l 'acqu i ::.izio ne di N i zza e della Savoia aveva spos tato l'equilibrio fortificatorio e con finari o a netto favore della Fra nci a, pur esse ndo l a Savoia sottopos ta a particolari v incoli cli neu tralità in conseguenza del tratt ato ciel 18 l 5 tra il Regno di Sardegna e l a Confederazione E lvetica
72 La difesa dell'Arco Alpino
5 Rov1ca11. Un SC'Colo di l-?ela::.io11i Miliwri tra /10/io e Sri::.::.em. Roma. SME ed., 1987. pag. -11 2 -1 3.
.t,n.,,,,. coiopr, ,.,. 4d ,,.,,..e,,. ,.,,. .,,, ,.,.., ,fuo
, e,..,..,.., Ai <.,....,.,,;.,,.,,~c•ru~•• I•) •el Cw,,~ltn, , <• •••"' • u r•rl<f•I• •J'•••• • (.I) t.•.- t,.:1cU11t ;,.,, un-,., '" . ,,_tfO ftJ •• llr+ •• • ,, • , ti • """ ·
3 I. La fonificazione attuale.
Situazione fortificatoria del neonato Regno d'Italia (1866)
Premessa
P1ima di procedere alla disamina di quelle che sono le strutture fortificate che il neonato stato italiano si trova a dover gestire, è necessario esaminare brevemente quelli che sono stati i concetti informatori che hanno determinato il loro sorgere .
" Nell ' ordinamento e dife sa di una frontiera costituita da una cate na di montagne s i possono seguire due partiti: pre se ntare una resistenza a oltranza nella zona montana, ovvero ritardare la marcia dell'invasore quanto basta per compiere la radunata delle truppe destinate a manovrare offensivamente contro le masse nemiche le quali s boccano dai monti."6
• ) Toni co,.o n ,:t.t ptr co11 •0,u: 4.o tt o 4• 14 fflft, f> I To""""' ti ,cr.Mpo,10 ,,,. "" CCUUIOIU U e) O,tirootorio coro:uco • proidt4>rt/ot.odcetdeo.
, A,(f•H(o r..,r,u:oto ptr ca111n)1tt ,ro 1 t CN f.'t(, : T"rN.tc(I 111 • co mp.zr,o p,t.r co1tfto11t cf& .s : "'"' ·
I Ou(Tt<UOri<'I corci::o.t, e prl'li tHort/l'lt"dd lncfl Scolo di 1 : ,uo
La piima teoria porta alla difesa a cordone del territorio (disseminato di opere in tutti i valichi e su più linee) con l'assorbimento della massa delle forze in compiti statici di presidio a detrimento della costituzione di una robusta massa mobile di manovra, la seconda prelude "ab origine" all'abbandono della difesa di una parte di territorio nazionale. In contrasto con la difesa a cordone adottata dai Piemontesi e pm volte bucata per sfondamento e'vJ aggiramento, si ha l'adozione del secondo partito teso a limitare lo sviluppo delle fortificazioni a quel grado che si reputava necessario per permettere lo sviluppo delle operazioni di mobilitazione, adunate e schieramento strategico agli sbocchi nella pianura dove sarebbero avvenuti i combattimenti risolutivi, e così si cadde nella esagerazione opposta.
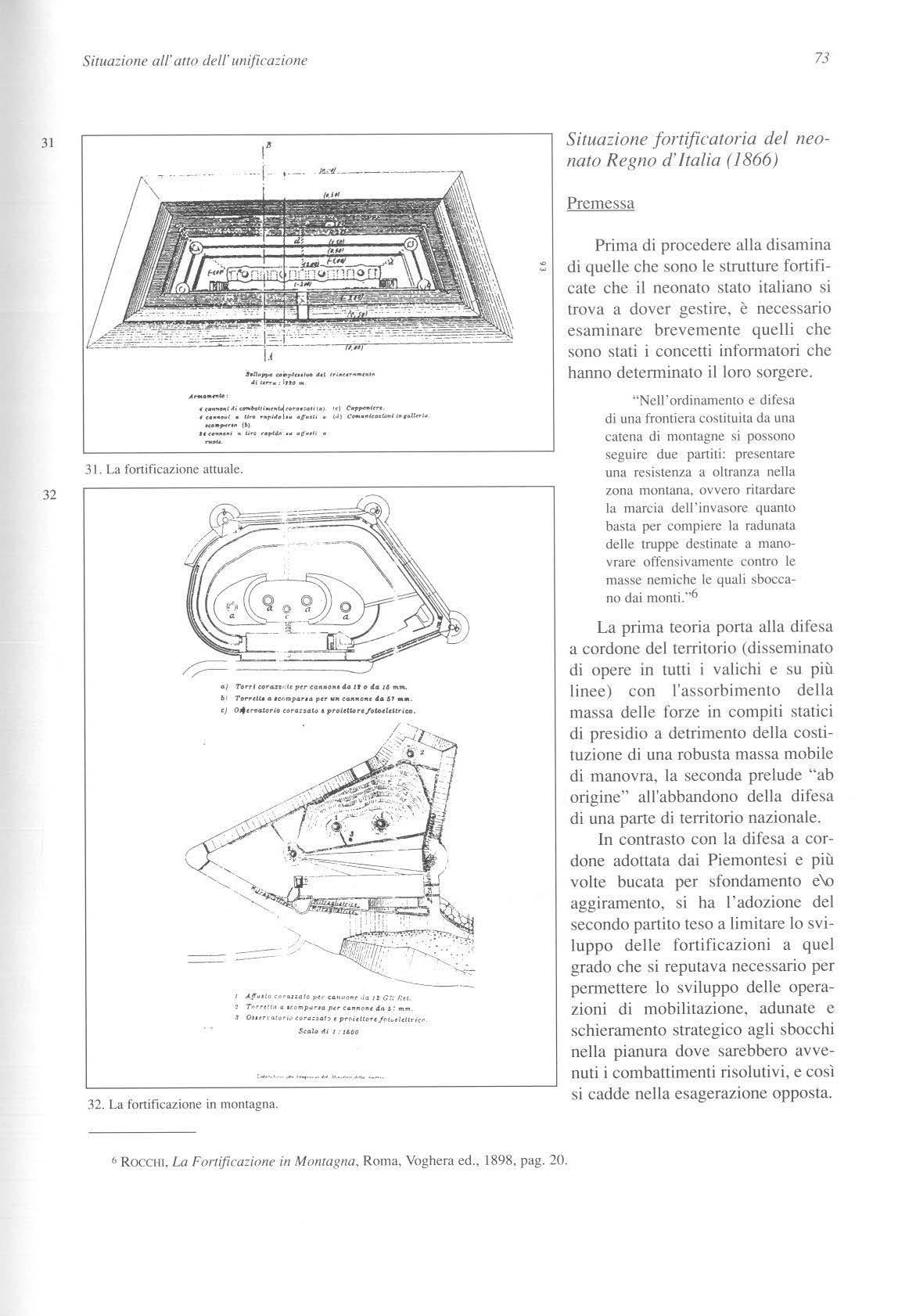
31 32 Situazione
ali' atto del/' unifìca:ione
- -·-
·""-'·fi- , .,., ,_ ,,. _ , ,.,.,
73
32. La fonificazione in montagna.
6 Roccin, La Fortificazione in Monta gna, Roma , Voghera ed., 1898, pag. 20.
Man mano che si perfezionava e portava a termine questo indirizzo difensivo, sorgeva in numerosi studiosi, p1i111i fra tutti i fratelli Mezzacapo. il Gen. Ricci ed il Perrucchetti, il concetto che la barriera delle Alpi fosse per l'Italia un dono di natura da sfruttare ''in toto" per trattenere l'avversario e che si dovesse sfruttare appieno la forza delle popolazioni delle valli al pine dando loro un completo ordinamento territoriale c he ne facesse valido elemenro di difesa.
Si profila quindi il conceuo di:
- sfruttare la forza difensiva delle Alpi, integrandola sapientemente con forti di sbarramento ed a ltri elementi difensivi statici e fondendo la loro azione con quella di truppe mobili (alpini),
- imporre non più un solo campo di arres to all'avversario per poter creare in piano masse mobili a seguito di mobilitazione, bensì un deciso arresto, se non annientamento, sulle posizioni iniziali di attacco, proporzionato alla va lidit à degli sbarramenti e forze mobili messi in campo.
Conseguente a q uesta evoluzione è la realizzazione del sistema dei forti di sbarramento a ll e frontiere e la costituzione delle compagnie alpine aue a svolgere la funzione mobile all'interno del balu ardo così creato.
Dalle opere ciel Rocchi "La Fortificazione in Montagna'' e "La Fortificazione Attuale" vengono tratte queste illustrazioni, esempio di opere di montagna con cui, secondo l 'autore, uno elci massimi studiosi dell'epoca, "afforzare" le difese in momagna.
Siruazione fortificatoria del Reirno
Le fortificazioni che lo stato unitario si trova a gestire sono parte eia distrugger e e parte da costruire. È necessario precisare il perché di questa affermazione che può sconcertare, specie in presenza cli una richiesta fortissima cli fo ndi per il piano fo rtific atorio.
L'Italia, all'atto della sua nascita come stato unitario. ebbe due principali eredità in fatto di fortificazioni, una dal Regno di Sardegna e l'altra clall' Austria.
"Ma 1:1 S,1rdegna specie nell'ultimo ù,xennio Jella su..i esistenza non ebbe rhe un nemico in \'i sta, qudlo che minacciava la sua frontiera Jell'cst e quindi quello che fece lo fece Jireuo verso qut:lla pane.
L'Austria dacché tenne il dominio in I talia non ehhe t' non poté ave re in \'ista che un nemico: quello provenicme dall'ovest e dal suJ. quindi si fortificò da quella pane.
L'Italia nella provincia dell'antico stato Sardo non ha da temere ché un nemico, il quale si trova alJ' ovest; nella ex provincia austriaca non ha pure a temere che un nemico, il quale si trova a nord e est. Come potrebbero quindi quelle fon ifi cazioni state cos truite per far fronte in senso opposto r ispondere alle esigenze difensive Jell'ltaliar7
Non è difficile capire come d'una piazza cons id erata i solatamen te si possano capovolge re l e difese e con le risorse dell'a1te fortificatoria farle ser vire ad uno scopo inverso a quello per cui fu costruita.
Questo capovolgimento cli schieramenti può ben soddisfare al concetto tecnico, ma non necessariamente a quello strategico, per cui è talvolta necessario distruggere e rifare altrove.
Alla fine di quanto precedentemente esposto si può rilevare come il neonato Regno d'Italia si sia trovato ad avere le sue frontiere difese da un insieme cli strutture fortificate, giit appartenenti alle precedenti compagini nazionali confluire nello Stato ed aventi diverse possibilità di reimpiego per co ll ocazione cd epoca cli rea l izzazione. Studiando queste fortificazio ni con lo stesso cr iterio adotta to nell'analisi ciel territorio, si cercherà di mettere in luce l'esistenza di queste strutture, raggnippandolc in tre settori, quanti sono quindi gl i stati che al I 866 si affacciavano a ll e frontiere italiane.
Poiché il tradizionale nemico era la Francia e l'Armata8, in caso di eventuale guerra contro cli essa, avrebbe ricevuto un n otevo l e incremento delle capacitù operative della fortificazione permanente, i re sabaudi, ed in particolare Carlo Alberto, vi dedicarono costante vigi l e cura. impegnandovi capitali ed energie, soprattutto al fine di potenziare gli sbarramemi naturali dei pussi alp ini e di provvedere alla cl ife-
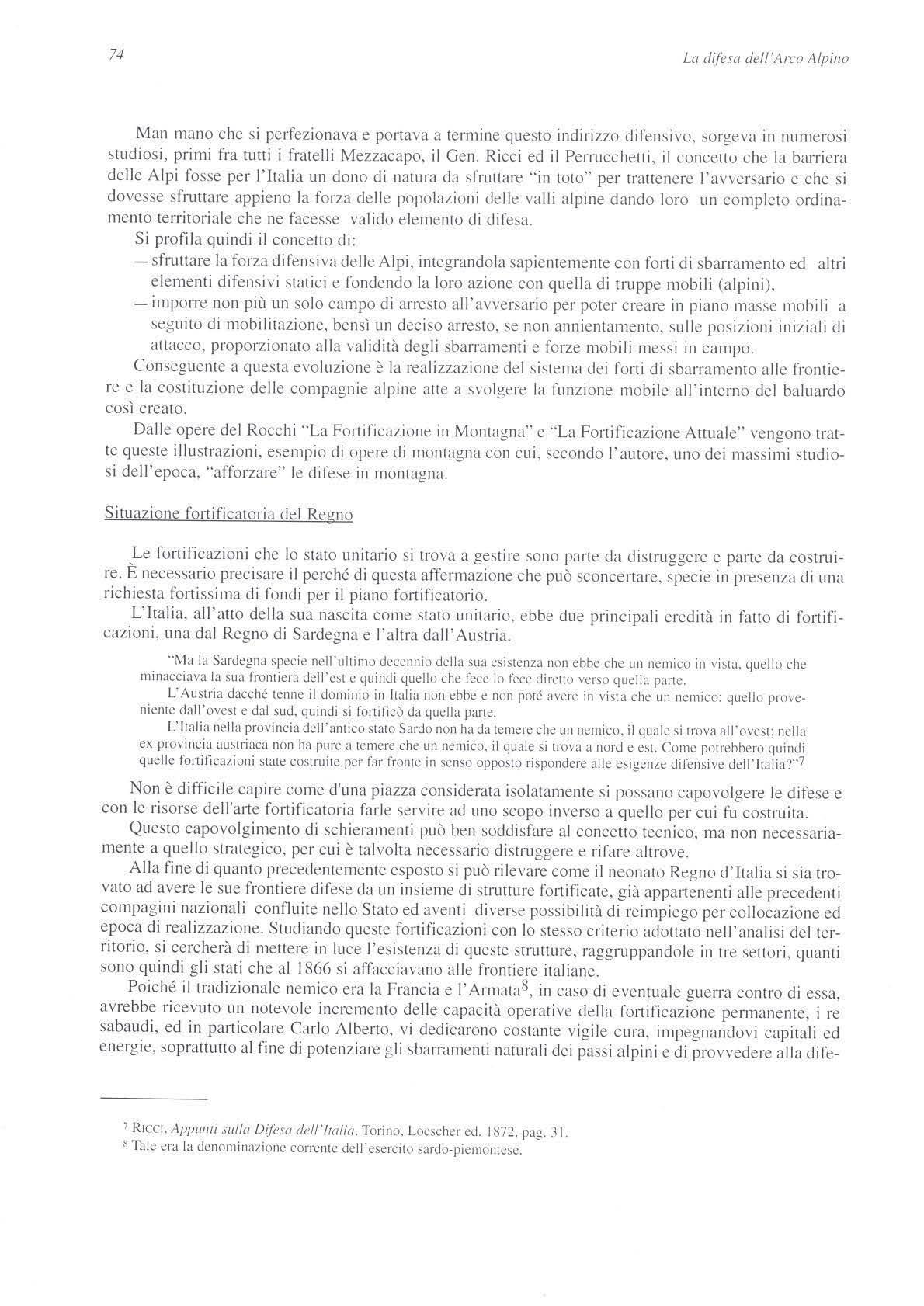
74 La difesa dell'Arco Alpino
7 R1cc1. App11111i sul/li Oi/'e 1a Torino. Lo~·schcr ed. 187:.. pag. 31. 'Tale era l a denominazione corrente dell'esercito ~ardo-piemontese.
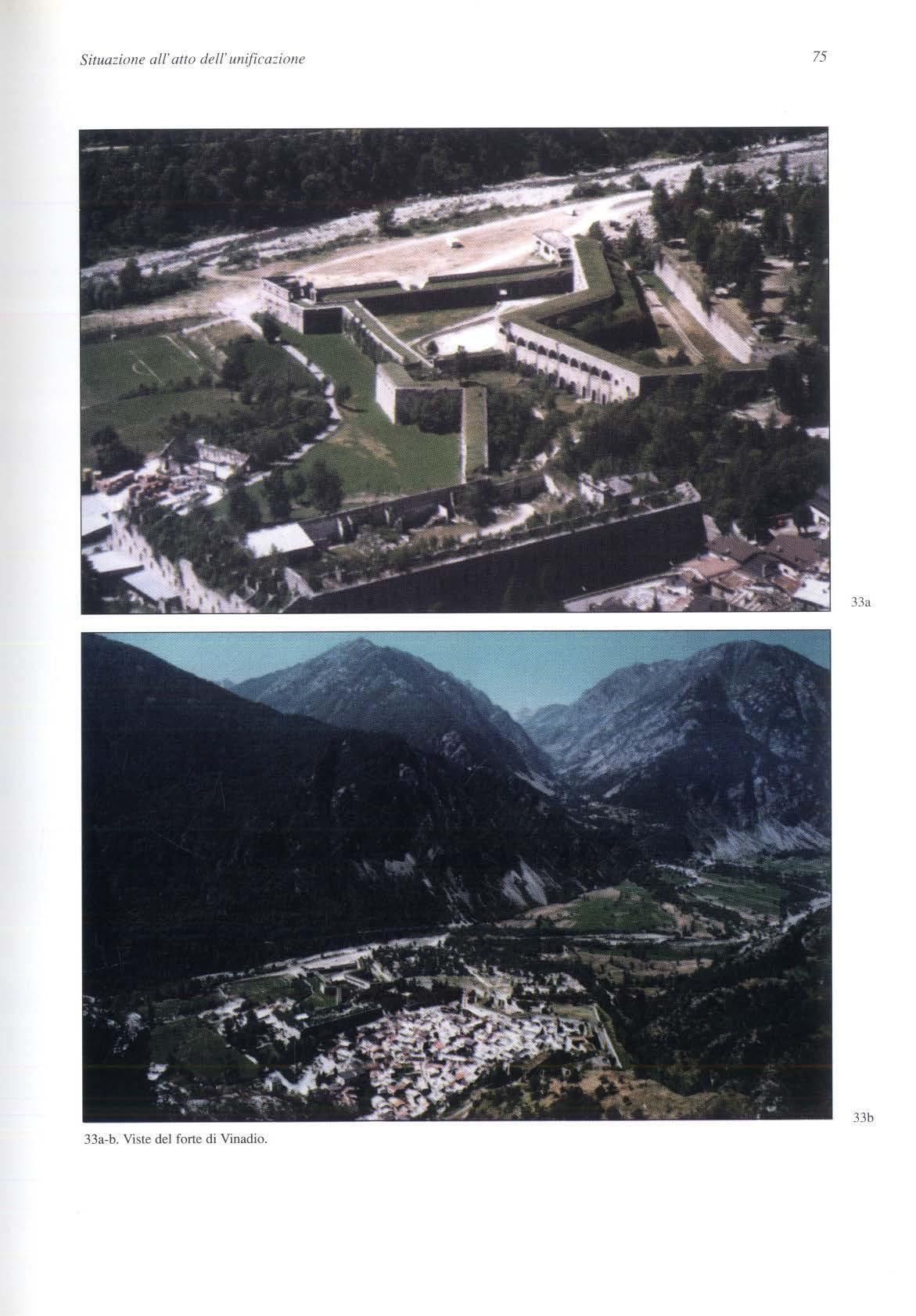
Situazione ali' atto del/' unifìra:ione 75
33a
33b
33a- b. Viste del forte di Vinadio.
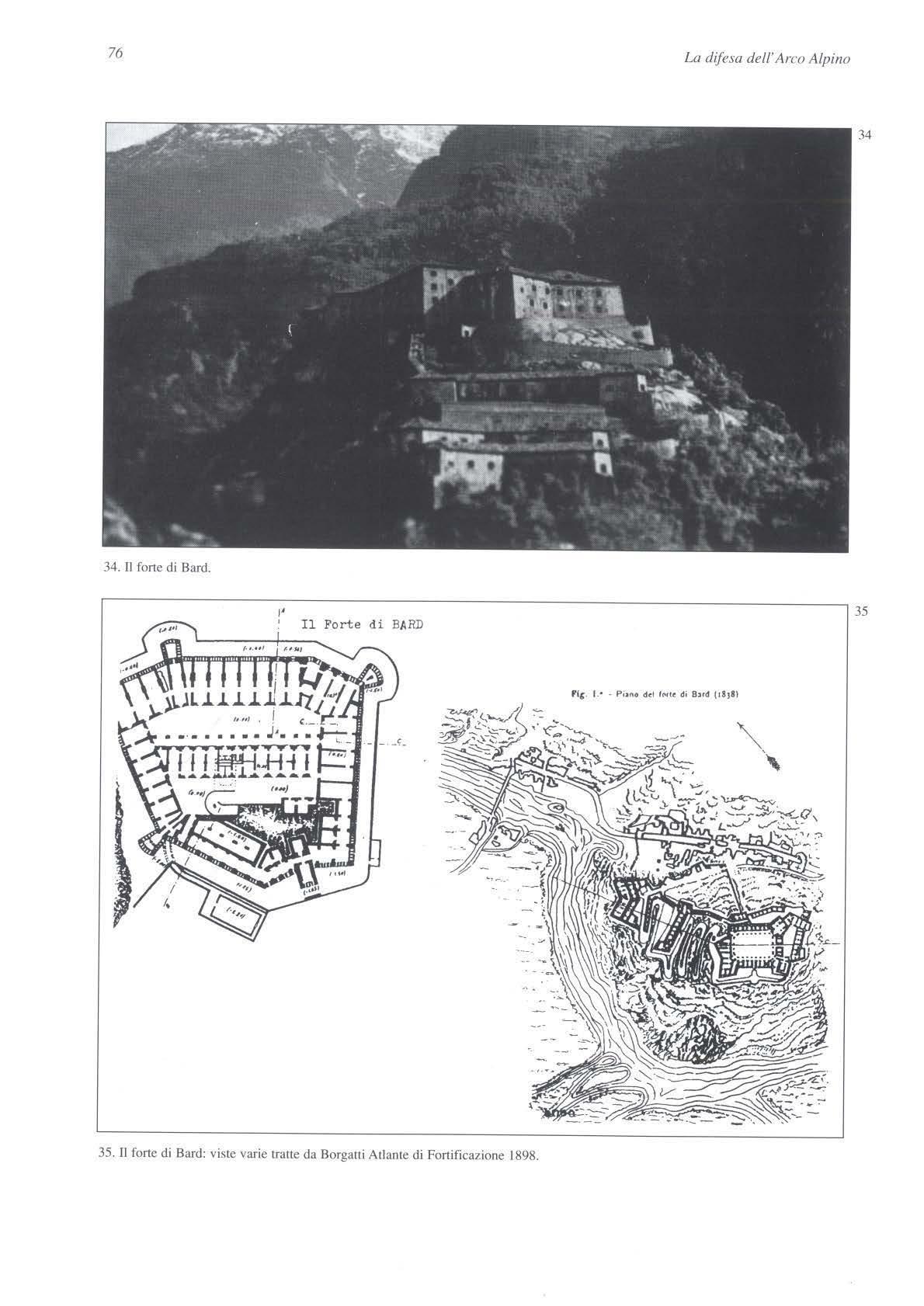
34 _ n forte di Bar~d- --::---- --~~:~ J' 11 Forte di BARD . · ne 1898. cr Fortif1caz10 B r a11i Aliante • tratte da o g d· viste varie 35 n forte d1 Bar La difesa e d Il' Arco Alpino P ,. 0 del INtt 1 , I. • - IJ,. d" B"d { 18 111 35
sa del fronte a mare della città di Genova.
Nel Regno sardo-piemontese infatti, unico stato rimasto indipendente, la fortificazione si mantenne in auge nella prima metà del XlX secolo.
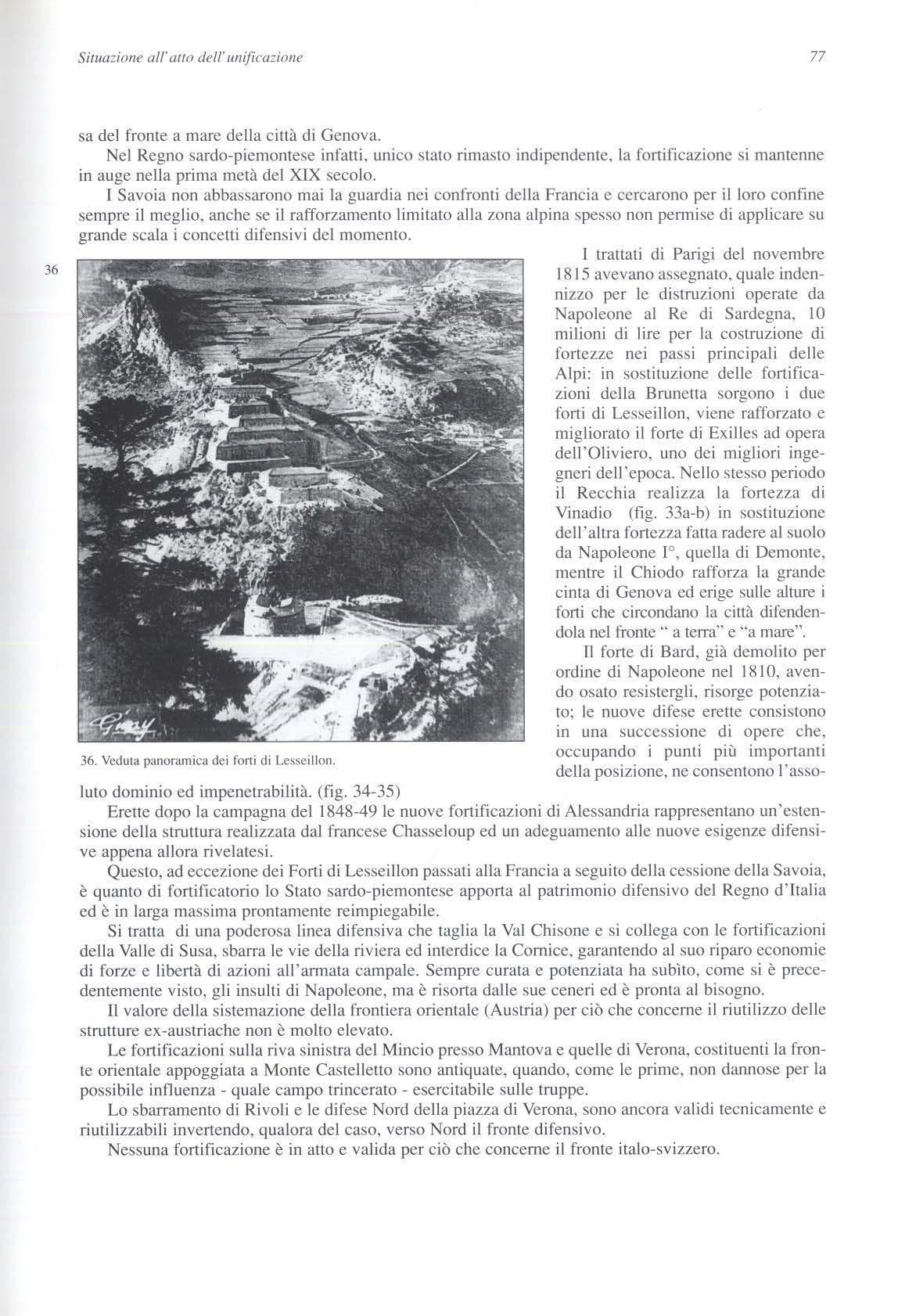
I Savoia non abbassarono mai la guardia nei confronti della Francia e cercarono per il loro confine sempre iJ meglio, anche se il rafforzamento limitato alla zona alpina spesso non pem1ise di applicare su grande scala i concetti difensivi del momento.
I trattati di Parigi del novembre 1815 avevano assegnato, quale indennizzo per le distruzioni operate da Napoleone al Re di Sardegna, 10 milioni di lire per la costruzione di fortezze nei passi principali delle Alpi: in sostituzione delle fonificaL.ioni della Brunetta sorgono i due forti di Lessei llon, viene rafforzato e migliorato il forte di Exilles ad opera dell'Oliviero, uno dei migliori ingegneri dell'epoca. Nello stesso periodo il Recchia realizza la fortezza di Vinadio (fig. 33a-b) in sostituzione dell'altra fortezza fatta radere al suolo da Napoleone 1°, quella di Dcmonte , mentre il Chiodo rafforza la grande cinta di Genova cd erige sulle alture i forti che circondano la città difendendola nel fronte" a terra'' e "a mare". n forte di Bard , già demolito per ordine di Napoleone nel 1810, avendo osato resistergli, risorge potenziato; le nuove difese erette consistono in una successione di opere che, occupando i punti più importanti della posizione, ne consentono l 'asso-
Erette dopo Ja campagna del 1848-49 le nuove fortificazioni di Alessandria rappresentano un' estensione della struttura realizzata dal francese Chasseloup ed un adeguamento alle nuove esigenze difensive appena allora rivelatesi.
Questo, ad eccezione dei Forti di Lesseillon passati alla Francia a seguito della cessione della Savoia, è quanto di fortificatorio lo Stato sardo-piemontese apporta al patrimonio difensivo del Regno d'Ttalia ed è in larga massima prontamente reimpiegabile.
Si tratta di una poderosa linea difensiva che taglia la Val Chisone e si collega con le fortificazioni della Valle di Susa, sbarra le vie della riviera cd interdice la Cornice, garantendo al suo riparo economie di forze e libertà di azioni all'armata campale. Sempre curata e potenziata ha subìto, come si è precedentemente visto, gli insulti di Napoleone, ma è risorta dalle sue ceneri ed è pronta al bisogno.
Il valore della sistemazione della frontiera orientale (Austria) per ciò che concerne il riutilizzo delle strutture ex-austriache non è molto elevato.
Le fortificazioni sulla riva sinistra del Mincio presso Mantova e quelle di Verona, costituenti la fronte orientale appoggiata a Monte Castelletto sono antiquate, quando, come le prime, non dannose per la possibile influenza - quale campo trincerato - esercitabile sulle truppe.
Lo sbarramento di Rivoli e le difese Nord della piazza di Verona, sono ancora validi tecnicamente e riutilizzabili invertendo, qualora del caso, verso Nord il fronte difensivo.
Nessuna fortificazione è in atto e valida per ciò che concerne il fronte italo-svizzero.
36 Situa:ione al/' atto del!' unificazione 77
36. Vedula panoramica dei foni di Lesseillon. luto dominio ed impenetrabilità. (fig. 34-35)

78 La. difesa Alpino 37 "':. ~ I !1 = 37. La fortezza
-
di Fenestrelle
veduta generale.
CONFINE
Specchio rias suntivo delle fortificazioni italiane al J 866
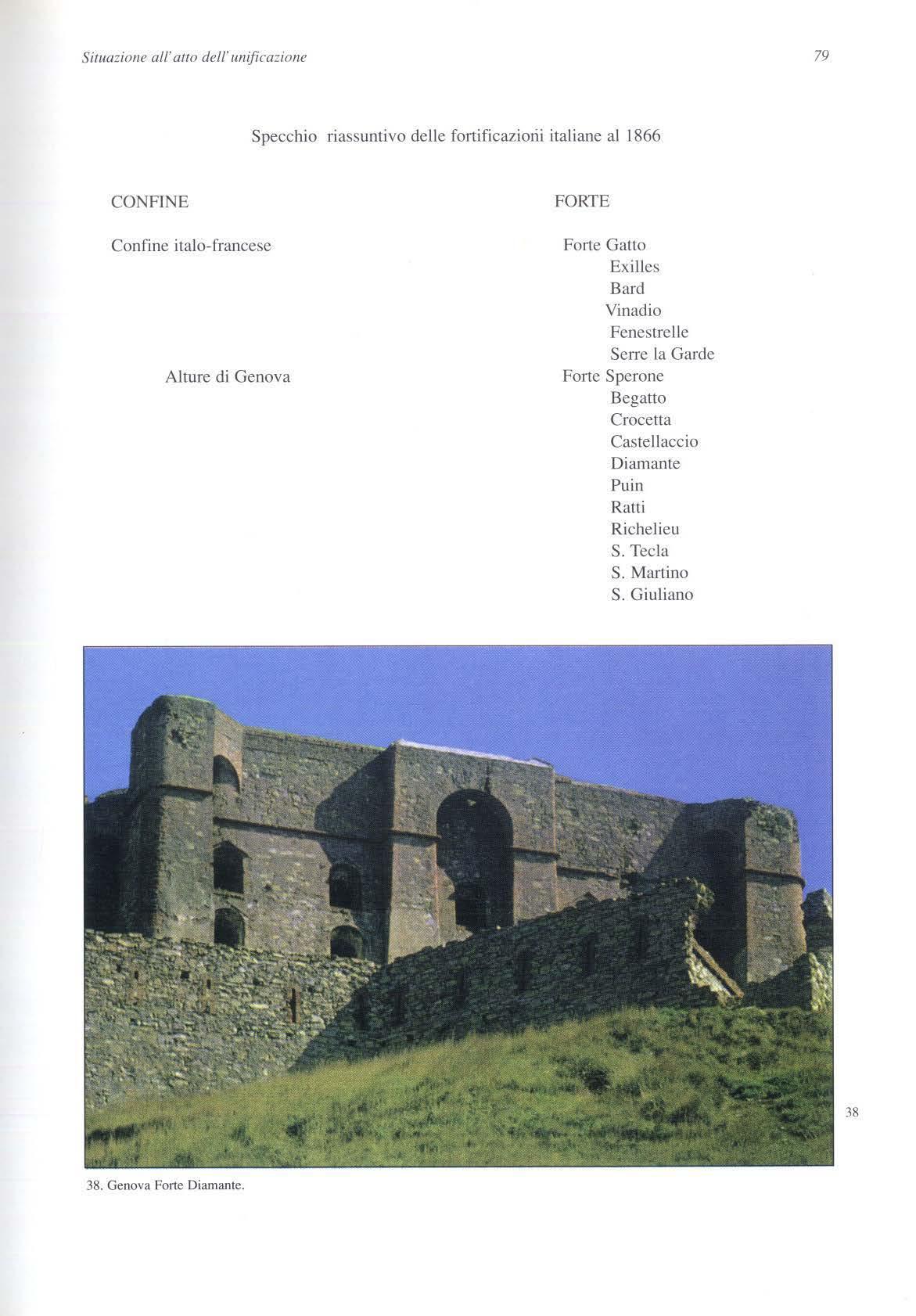
Confine ita lo-francese
Alture di Genova
FORTE
Forte Gallo
Exilles
Bard
Vinadio
Fenestrelle
Serre la Garde
Fo1te Sperone
Begatto
Crocetta
Castellaccio
Diamante
Puin
Ratti
Richelieu
S. Tecla
S. Martino
S. Giuliano
Situazione ali' atto del/' uniflca::ione
38. Genova Forte Diamante.
79 38
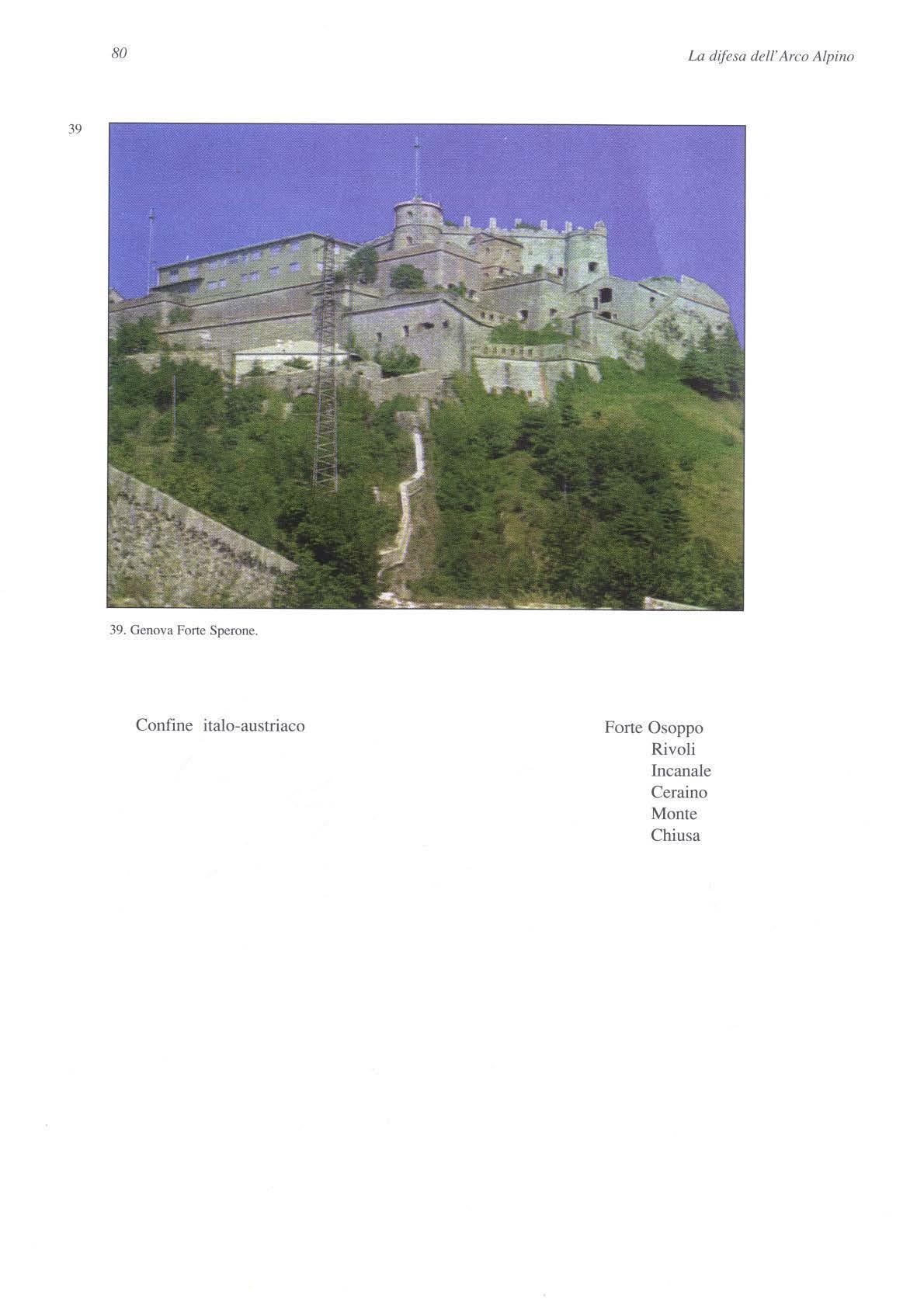
80 39
39. Genova Forte Sperone.
Confine italo-austriaco
La difesa del!' Arco Alpino
Forte Osoppo Rivoli lncanale Ceraino Monte Chiusa
Il primo pia110.fortificatorio
L' Italia, per la sua configurazione geografica, si trova in condizioni piuttosto sfavorevoli per ciò che riguarda la difesa, tanto territoriale guanto mobile, poiché la sua forma allungata non si presta né all'ordinamento concen lri co delle difese successive né al facile accon-cre delle forze mobili dalle parti centrali o periferiche dello stato ove si sono concentrate.
Assicurare il funzionamento delle forze mobili mediante un ben ordinato sistema di fortificazioni e comunicazioni, reso tanto più necessario quanto più la forma del territorio è meno favorevole a ll a rapidità della mobilitazione e dell'adunata nel punto minacciato , dovette essere e fu una delle prime preoccupazioni dei reggitori del nuovo stato.
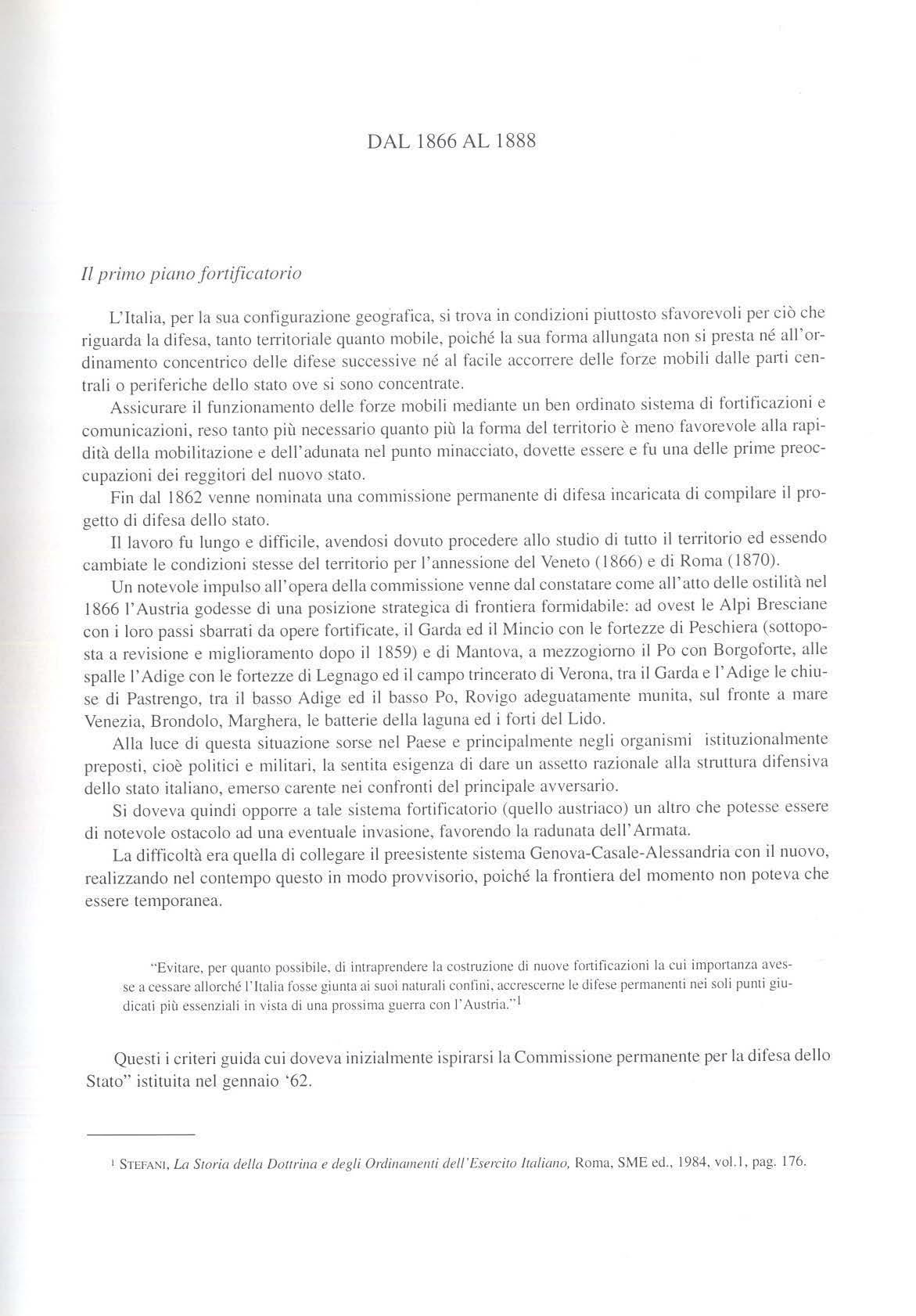
Fin dal 1862 venne nominata una commissione permanente di difesa incaricata di compi lare il progetto di difesa dello stato.
Il lavoro fu lungo e difficile, avendosi dovuto procedere allo studio di tutto il territorio ed essendo cambiate le condizioni stesse del territorio per l'annessione del Veneto ( 1866) e di Roma ( 1870).
Un notevole impulso all'opera della commissione venne dal constatare come all'atto delle ostilità nel 1866 l'Austria godesse di una posizione strategica di frontiera formidabile: ad ovest le Alpi Bresciane con i loro passi sbarrati da opere fortificate, il Garda ed il Mincio con le fortezze di Peschiera (sottoposta a revisione e miglioramento dopo il 1859) e di Mantova, a mezzogiorno il Po con Borgoforte, alle spalle l'Adige con le fortezze di Legnago ed il campo trincerato di Verona, tra il Garda e l'Adige le chiuse di Pastrengo, tra il basso Adige ed il basso Po, Rovigo adeguatamente munita. sul fronte a mare Venezia, Brondolo, Marghera, le batterie della laguna ed i forti del Lido.
Alla luce di questa situazione sorse nel Paese e principalmente negli organismi istituzionalmente preposti, cioè politici e militari, la sentita esigenza di dare un assetto razionale alla struttura difensiva dello stato italiano, emerso carente nei confronti del principale avversario.
Si doveva quindi opporre a tale sistema fort ifi catorio (quello austriaco) un altro che potesse essere di notevole ostaco l o ad una eventuale invasione, favorendo la radunata del l'Armata.
La difficoltà era quella di collegare il preesistente sistema Genova-Casale-Alessandria con il nuovo, realizzando nel contempo questo in modo provvisorio, poiché la frontiera del momento non poteva che essere temporanea .
Ev itare, per quanto possibile. ùi int raprendere la costruzione di nuove fonificazioni la cui importanza avesse a cessare allorché l'Italia fosse giunta ai s uoi naturali con lini. accrescerne le difese permanenti nei soli punti giudicai i più essenziali in vista di una prossima guerra con J'Austria." 1
Questi i criteri guida cui doveva inizialmente ispirarsi la Commissione permanente per la difesa dello Stato" istituita nel gennaio '62.
DAL 1866 AL
1888
1 STEt-ANI, La Sroria della D011ri11a e degli Ordi11ame111i del/ 'Eserciro ltalia110, Roma, SME ed., I 984. voi. I. pag. 176.
Dat e le premesse, gl i st udi furono lenti e difficoltosi, interrott i dal sopraggiungere della gue rra, ma ne l frattempo si era g ià dato co r so all'inizio di l avori, co n preminente funzione difensiva, q uasi un avancorpo di posizioni da difendere ad o ltran za o sull e quali ritirarsi in caso di event i sfavorevol i sul davanti.
Ciò fu rea l izza to dopo che la Commissione, riconfermando le proposte ciel gennaio 1864, presentò il p roge tto ge neral e definitivo della difesa dello stato .
T al e progetto pr evedeva:
I. l'ulter i ore po te nzi amento delle fo rt ezze di Piacenza e d i Bologna - per far del l a pri ma una grande p i azza da guerra co n campo trincerato permanente a gu i sa d i dorp i.i tcs ta di ponte sul Po (secondo il progelto del I 864) e della seconda u na gra nde riazza da guerra con dopp i o carnro t r ill(;erato. u no cioè nella pian u ra per la difesa della ciuà e l'al tro in collina (secondo il progetto del 1865). assegna ndo a Piacenza l ' u fficio d i appogg i are le orerazioni dell'esercito pe r l a difesa della Lombardia e de ll 'Emilia, e a Bologna quel l o di copr ire nel modo più efficace l e p r incipali comunicazioni tra la bassa va ll e del Po e la Tosca na, ed offrire un pu ru o d'appoggio alle truppe operanti sul basso Po-;
2. l a cos truzio ne a C remona d i una testa di pome (seco ndo un progetto già esistente) a ll o scopo cl i assicurare momentaneamente u n secondo passaggio su l Po riù a va ll e di Piacenza. al fine di agevola re un a d i fcs.i di f i anco del l a Lombardia atwccata dalla linea del Mincio. face ndo sistema con Pizzighettone e Piacenza;
3. i l rafforzamenw di Pizzighettone (secondo il progetto de l 1863) con l 'intento di estendere J'azionc cli Piacenza sull'Adda, assic ur ando un passaggio importame su ques to fiume all e t ru ppe operanti sul la riva sini stra del Po;
4. l a costr uzione d i un a n uova p i azza cli cara tt ere per manen te d i fensivo nella pane ce nt rale del l'Emil i a in quel si to che verrà scel to d i etro ult er i ori studi sul terre no (Guas tall a o Reggio) pe r collegare l e due piazze cli Pi acenza e di Bologna. cop r ire l e varie comu nicat.ioni dire tt e tra l a valle del Po e l a Toscana e particola r rncnte quel l e che provengono dai dis tre tti mant ovan i ;
5. la ch i usura. con opere di sbarrnme nlO di tu tt e le strade che att raversano l'Appenn in o tosco - emi l iano. al fine di accrescere valore all' appe nni no medesimo come lin ea difensiva;
6. la costruzione sol l ecita delle ferrov i e Spezia-Genova c Sa rzana-Parma, nonché l 'ape rt ura di rotabi l i di a rr occa mento sui g i oghi dell'appe nnin o pe r facili tare le comu nicazion i tra i fo rt i c he si dovrebbero erigere."2
TI progetto definitivo venne presentato in ritardo, inizialmente a causa della discorde valu taz ione su qual e fosse il mi glior punto intermedio cli raccordo tra Piacenza (punto natural e dì cope rtura ) e Bologna (d efinita fondamentale all'atto del trasfer imen to della capi tal e d'Italia dn Torino a Firenze), successivamente, co me prima accennato, la guerra e l a susseguente modifica dei confini imposero alla presentazione una ulteriore proroga te mp ora l e.
Solo nell'agosto 1871 la co mmi ssio ne presentò finalmente la relazi one a cor redo del pi ano generale di difesa dell'Italia, piano che, quasi ultimato nel 1866 dopo un'accurata indagine topografica e strateg ica del territ o rio nazionale, aveva do v uto obbli gatoria me nte essere rivi sto , aggiorna to e modificato a segu ito de ll 'annessione del Veneto prima e della presa di Roma poi.
Il pian o presentato dimostra va che l a commissione aveva l avorato con competenza ed oculatezza, ma non aveva dimostrato un sano realismo nei confronti delle ben note difficoltà dello Stato; esso infatti , te nendo conto de lle defici enze pal esates i , prevedeva, se nza eccez ioni , le misure fortificatorie ric onosc iute necessa rie per la difesa d ell o sta to a i confini, su ll e coste cd all ' interno , il tutto improntato ad una concezione marcatamente difensivi stica co n la prefigurazione cli due scacc hieri principali, costituiti rispettivam ente dalla zona continenta l e fino all 'appennino tosco-emiliano (da difendere siste matica-

82 La difesa dell'Arco Alpino
2 STEFANI, op. cit , pag. 177.
mente) e della parte peninsulare con difesa limitata ad alcuni capisaldi. Causa gli oneri elevatissimi che tale piano richiedeva, si dovette ripiegare su di un piano ridotto che puntasse al minimo indispensabile per far fronte ad un attacco esterno.
Il piano, sia nella versione integrale che in quella ridotta, ribadiva l'importanza cli fortificare le montagne, concepite come argine e margine di sicurezza; ecco dunque che bisognava cos truire forti su tutte le rotabili alpine, fortificare i porti e le rade, puntare su un unico arsena l e - Spezia - e sulla piazzaforte di Bologna, la cui esistenza e resistenza era vista come fondamentale,
"in quanto il possesso cli tale nodo nevralgico e l'afflusso cli uomini e mezzi dal sud garantivano se mpre lo svi l uppo di masse controffensive e la possibilità di un co mpleto re cupero strategico con relativa ric on qui sta dell'irnera pianura padana. ne l caso questa fosse già stata occupata dal rn.:mico." 3
Tre erano quindi le linee difensive:
- l a linea dei forti cli sbarramento in prossimità dei valichi alpini;
- l a linea del Po;
- la linea addossata alla catena dell'appennino, avente come perno il ridotto centrale difensivo cli Bologna.
Piazze dell'Italia continentale erano Genova, Alessandria, Piacenza, Legnago; teste di ponte a Borgoforte, Pavia , Pizzighettone, fortificazioni sul l 'asse Isonzo-Po-Ferrara.
La difesa "a capisa ldi " della parte peninsulare era affidata, tra le altre, al l e piazze di Ancona e Lucera, campi trincerati a Roma e Capua, porti fortificati a Livorno, Civitavecchia e Gaeta.
È un piano minuzioso, pedante e faraonico, c he si preoccupa cli garant ire innanzi tutto il Paese dal1 ' invasione e, temendo di commettere errori di valutazione, propone cli realizzare fortificazioni ovunque, immobilizzando per il l oro presidio forze che non saranno così disponibili per creare le grandi masse mobili previste per la manovra.
Il progetto originale prevedeva la disponibilitù di ben 97 piazze e la riduzione ne ha portato a 77 e poi a 65 il numero , ma il piano ridotto non modifica nulla del conceno strategico, e si ha solo una riduzione della spesa globale e la creazione di un a struttura goffa e disarmonica, frutto dei tagli apportati. Questo piano nelle sue due versioni ha estimatori cd avversari; questi ultimi in special modo non sono disposti ad accettare la perdita d i porzioni consistenti ciel territorio nazionale fin dagli inizi, ritenendo che l e Alpi non siano un elemento di frazionamento dell'impeto nemi co, bensì un potente ostacolo naturale da valorizza re.
Le critiche
Numerose e ben valide l e voci di coloro che ritengono il piano incompleto ed inad eguato e sovrastano quelle di coloro che gli sono favorevoli: il Yeroggio, il Ricci ed il Perruccheni si oppongono decisamente al piano proposto con scritte d'opcre in cui abilmente disquisiscono il l oro valido dissenso, cd il Perrucchetti addiri!tura dichiara:
La commissiom: per la dil'esa generale dello Stato nella sua relazione a corredo del p iuno d i clil'e sa presentat o a S.E. il Ministro della Guerra, dopo ave r affermato la conwnienza di sbarrare tulle le strade alp in e e fatte le sue
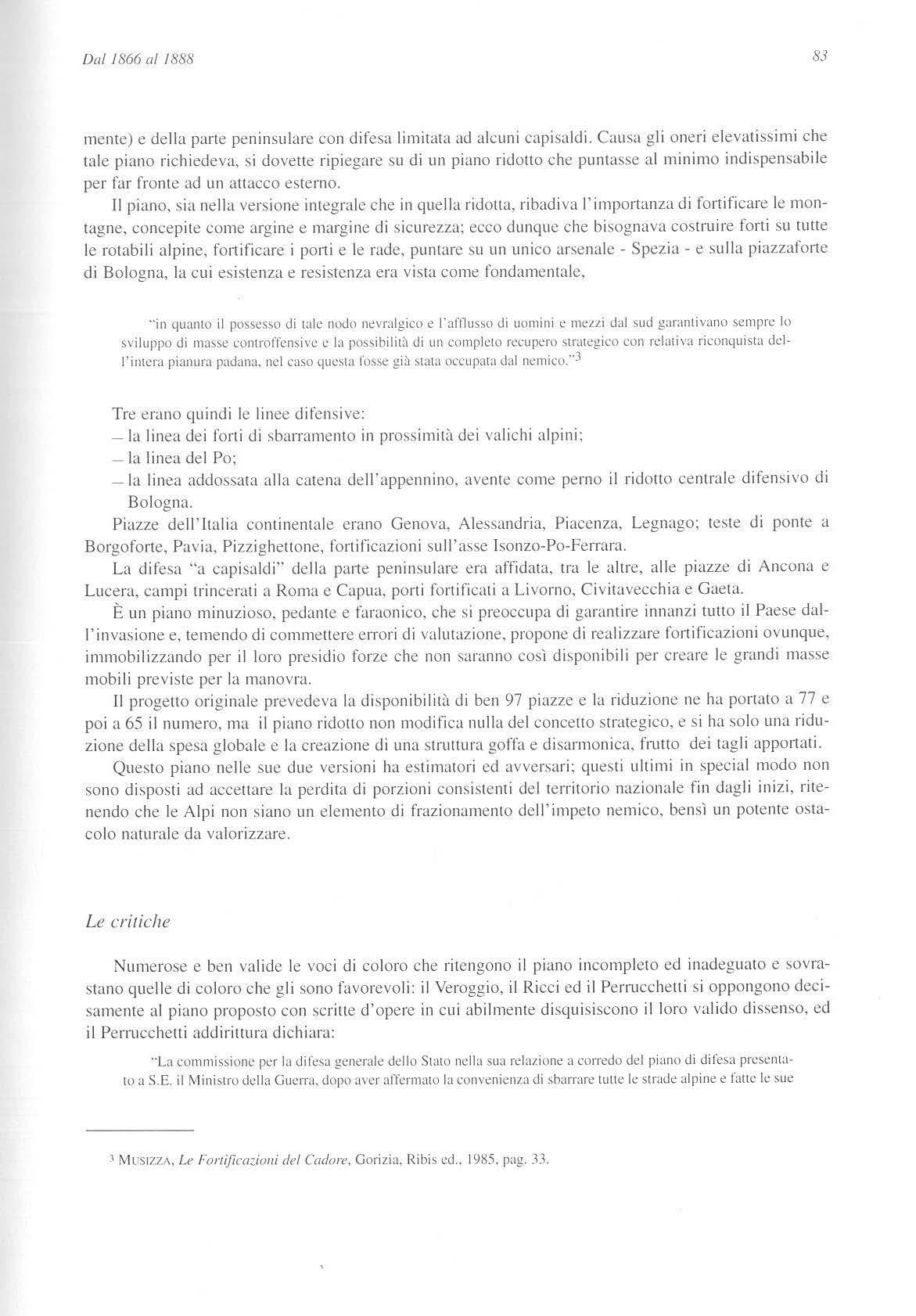
Dal 1866 al 1888 83
.1 MUSIZZA, Le Forti(ica::.ioni del Cadore, Gorizia, Ribis l!d 1985. pag. 33.
propos te , soggiungeva: "È vero che q uesto gran de scopo 11011 si è potuto rnggiu ngerc completamente perc hé sussistono iuttavia due lacune:
- una delle quali as~a1 bre, e \'erso la Sviucra, in cui s1 è tentato di riparani !'.>chb..:ne insufficientemente. con l a pia1.1.a di Varese:
- l'altra sull' I sonzo, dove fu for,w rinunziarvi assol ut amente. "
A far parere meno triste l a situazione creata nelle condizioni di difesa ùella frontiera ùalle suddette due lacune, la Commissione accennava da un a parte alla gara ntita neu tralit à della Sv i zzera, dall'altra alla lontanan za fra la fro nti era aperta dell'Isonzo cd il cuore del R egno.
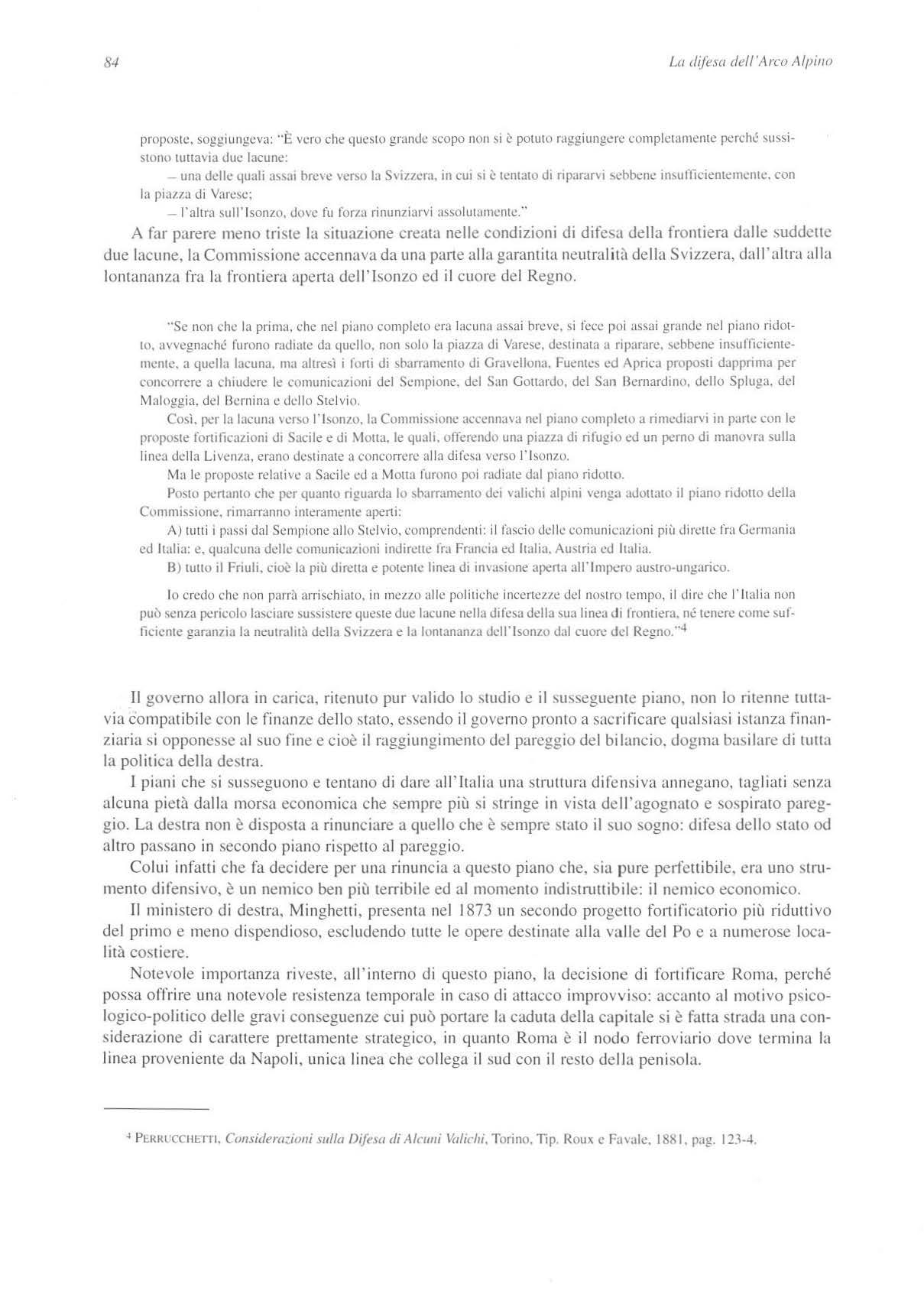
"Se non che l a prima, c he ne l piano completo era lacuna assai breve, si fece po i assai grande nel piano r ido tto. avveg nac hé furono radiate da quello. non so l o l a piazza di Varese. destinata a riparare. ~ebbene insufficientemente, a quella lacuna. ma altresì i foni di sbarramento di Gra,dlona. Fuentcs ed Aprica proposti dapprima per concorrere a chiudae le comunicazioni del Sl!mpione, del San Gottardo, del San Bernardino. dello Spluga, del M al oggia, de l B ern ina e d ell o Ste l vio.
Così, per la lacuna ,w~o I' hon,o. la Commbsionc accennava nd piano completo a rimediarvi in pane con le proposte fortificazioni di Sacile e di l otta. le quah. offeremlo una piaaa di rifugio cd un perno di manovra sulla lin ea dell a Li ve n1.a, erano dc~t inat e a co ncorre re alla d i fesa ve rso I ' l son1.o.
Ma l e proposte relati\'C a Sacile cd a M otta furono poi rad i ate dal piano ridotto.
Posto pertanto che per quanto riguarda lo ~barramento dei , afichi alpini \'eng~1 adottato il piano ridotto della Commissione. rimarranno i meramente apeni:
A) lutti i passi dal Sempione allo Stdvio, co111prenden1i: il fascio delle com un icazio ni più d irette fra Genmmia ed Italia: e. qualcuna delle comunica,ioni indirette fra Francia ed Italia. Austria cd I talia.
B) lutto il Friuli, cioè la più diretta e potente linea di invasione apena alrlmJX!ro austro-ungarico.
l o credo c he no n parrà arrischiato, in meuo al le politiche incerte11.c del nostro 1cmpo, il dire c he l ' Ital i a non può ~enza pericolo lasciare M1ssistere queste due lacune nella difesa della \Ua linea d1 frontiera. né tenere come sufficiente garanzia la neutralità della s, iLLera e la lontananLa dcli' lsonLo dal cuore del Regno. " 4
Il governo allora in carica, ritenuto pur valido lo studio e il susseguente piano, non l o rit e nne tuttavia compatibil e co n le finan ze dello stato, esse ndo il gove rno pronto a sac r ificare qualsiasi i stanza finanz iaria si op pon esse al suo fine e cioè il raggiungimento ù el pareggio d el bi lancio, dogma basi l are di tutta l a politica della destra.
I piani che si sussegu o no e tentano di dare all'Italia una struttura dife nsiva annegano, tagliati senza alcun a pietà dalla mor sa econo mica c he semp re più si string e in vis ta dell'agognato e sospirato paregg i o. La destra non è disposta a rinun cia r e a quello che è sempre stato il suo sogno: difesa dello stat o od altro pa ssa no in secondo piano risp etto al paregg io.
Colui infaui c he fa dec idere per una rinun c ia a questo pian o c he , sia pure perfettibile, era uno strnmento difensivo, è un nemico ben più terribile ed al momento indistruttibile: il nemico economico.
Il ministero di destra, Minghetti, present a nel 187 3 un secondo pro gclto fo1tifi ca torio più riduttivo del prim o e men o di spendio so, escludendo tutt e le oper e destinate alla valle del Po e a numerose l ocaIità costiere.
Notevole impo rtanza riv es te, all'interno di questo piano, la decisione di fortificare Roma, perc hé possa offrire una notevol e r es isten za temporal e in caso di attacco impro v vi so : accanto al m otivo psicol ogico-po litico delle gravi co nseguenze cui può portare l a cadut a della capi tal e si è fatta strada una considerazione di carattere prettamente strate g i co, in quanto Roma è il nodo ferroviario dove termina la linea proveniente da Napoli, unica lin ea ch e co ll ega il sud con il r es to de lla peni so la.
8./ Lll difesa A //JÙ10
P tRRL'CCIIETTI, Co11sidercdo11i sulla Difesa di Alcuni Valichi. Torino. Tip. Roux e Farnie. 1881. pag. 123--t
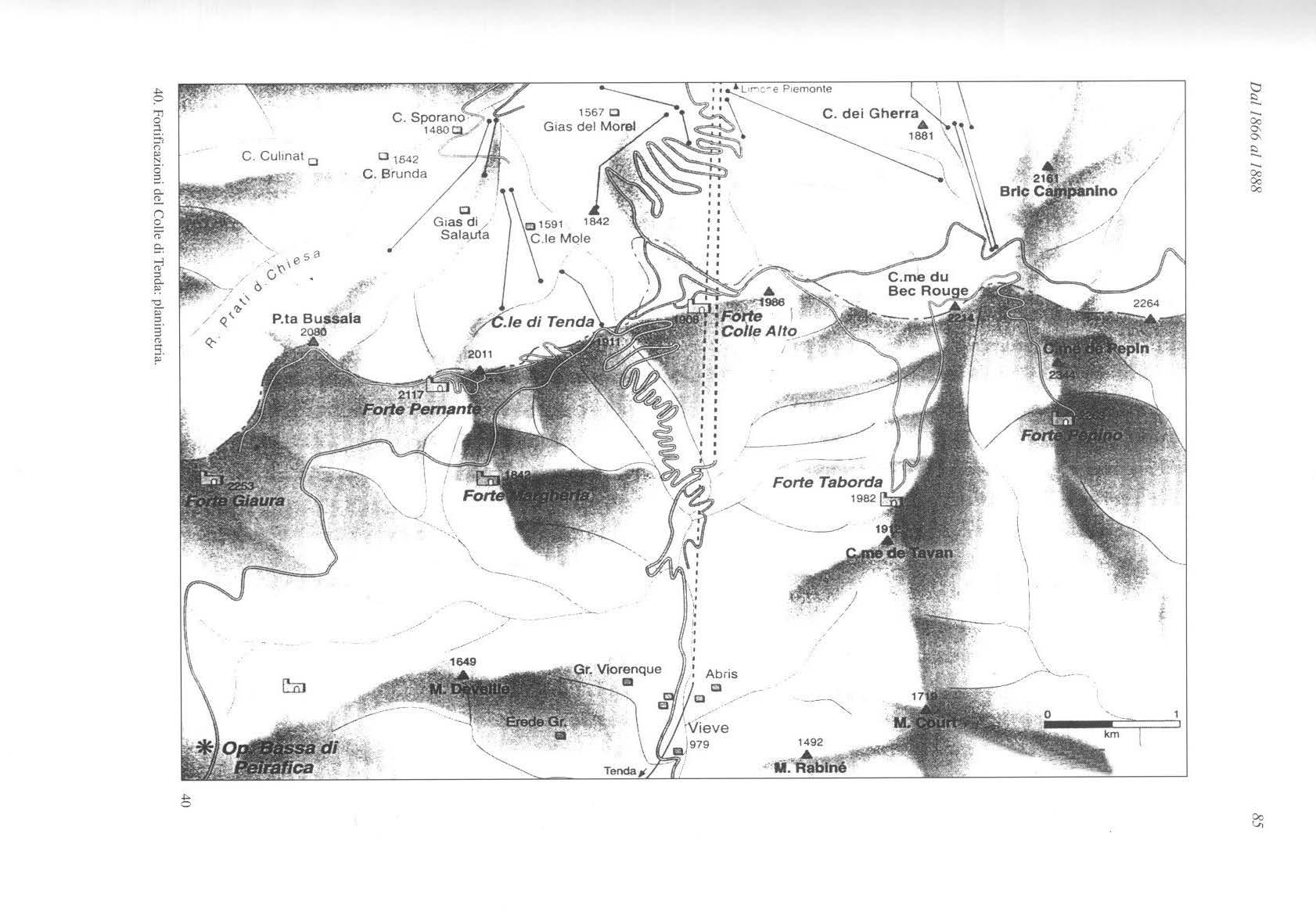
d :::\ 3-? r, o· =· Q. 2 i>' e, ;i :: Q. P. "O ii;" :: §' p· o c. Culina t 0 ,; ,e sa / 0'0 / ò · O 164 2 C. B runda -.,;._-. -..' l'S·v ., _,/ '• ~, :r \ .,, e G i asdi / Sala,,uta ',· , , \ '----·· -,.. ,,,,~··'' -., ', ' ·-·..:.,.__ --___ __.,,,, --~ f --,;. \ ,,,.--·,___ _ I I:::, e_Oo °' °' ._ Oc < ' "··--.::.
Il progetto, presentato e già dato per approvato, v i ene ritirato da l governo. po iché compromellerebbc l'agognato pareggio del bilancio.
Molti gli interventi successivi ed i vari progetli che, pur validi, cedono sempre di fronte al solito nemico: o la loro realizzazione o il pareggio del bilancio.
Cade infine senza grande rimpianto la Destra avendo, con il raggiungimento ciel pareggio del bi l ancio dello stato, ultimato il suo compito.
L'ascesa al potere della Sinistra nel 1876 non porta inizialmente grandi sovvertimenti nel campo fortificatorio: dal 1876 infatti si prosegue in i zialmente quasi per inerzia l o sviluppo di quelle attività forrificatorie che già in precedenza (e si parte anche dal periodo del Regno sardo -piemontese), si era ritenuto essenziale svi lu ppare: si ammodernano ta l uni materia li e si ce rca di migliorare il meccanismo della mob ilitazione, principalmente a ll o scopo cli organ i zzare la mi li zia territoriale, la cu i nascita avrebbe infaui consentito di svincolare dai compiti statici (sicurezza, vie di comunicazione ecc.) la milizia mobile che così diveniva l'immediato rinforzo dell'esercito.
Ad un periodo di transizione caratterizzato dal l 'azione protesa a portare a termine i progetti tracciati dal l a destra, suben tra una frenetica att i vità dovuta al perdurare della situazione internazionale che fa ritenere incompiute le opere portate avanti per risolvere la questione del l 'ordinamenro nazionale per la cl/fesa e rende urgente la necessità di adottare provvedimenti atti a sanarla .
È importante a questo punto rappresentare come, mentre la Con1missione disquisiva ed oculatamente proponeva, para l lelamente ed in modo assai opportuno, tenuto conto della pericolosità e de li catezza del settore di intervento, si procedeva alla sollecita realizzazione dello sba,rnmento della Va l Roja, intervento fortificatorio stabi lito già prima della unificazione.

In effetti lo Stato Maggiore piemontese già nel I 860, esaminando il pericoloso conf ine italo-francese, aveva deciso cli cautelarsi da i pericoli derivanti dal l a sinuosità della linea di confine che interrompeva per una ventina di ch il ometri il fondo della Valle Roja: venne così pianificato di fortificare le posizioni più e l evate che dominavano lo svil uppo della linea di confine, tenendo presente che le preoccupazion i erano pure rivolte alle necessità difensive della bassa Val Roja, all e spa ll e di Ventimiglia.
I lavori per la costruz i one dei forti, costituenti il campo trincerato di Tenda, ebbero inizio verso il 1880 e furono ultimati nell'arco di un decennio.
Sorgono così, realizzati secondo le caratteristiche Lecnico-fortificatorie dell'epoca, i forti Giaura, Pernante, Margheria, su ll a dorsale dell ' abisso, capaci baraccamenti logistici ed il forre Alto in corrispondenza del Colle di Tenda vero e proprio ed infine i forti Pepino e Taborcla sul contrafforte orientale.
Di tanto l avoro realizzato in un punto fondamentale per il controllo della frontiera (ora territorio francese), ciò che ancora resiste agli insulti del tempo e degli uomini si è cercato di evidenziare fotograficamente.
L'oc ul atezza della scelta dei punti su cui in vestire l e strutture fort ifi cate verrà confermata alle soglie del l a Seconda Guerra Mondiale allorché moderne st ru tture integreranno, disponendosi nelle adiacenze, le vecchie strutture e nel dopo guerra all orché la Francia pretenderà ed otrerrà come danni di guerra, mascherati da plebisciti, questi territori va lidi a cautelar l a, ma il c ui passaggio al l a Francia crea una potenziale minaccia per l'Italia.
Si ha così un'ultedore pratica dimostrazione di ciò che la ricerca storica ha con numerosi studi confermato e cioè che un punto fortificato, rispondente a precise esigenze del terreno, rimane il prescelto per lunghissimo periodo di tempo ( persistenza) ed esattamente sino a quando l'offesa resti simile e non emerga un nuovo modo di fare la gue1rn.
T p unti forti mutano solo se vi è un radicale mutamento nei modi di fare l a guerra.
86 La difesa dell'r\rrn Alpino

Dal 1866 al 1888 87 41 42 43 44 4142 -4344 I forti del
di
colle
Tenda oggi.
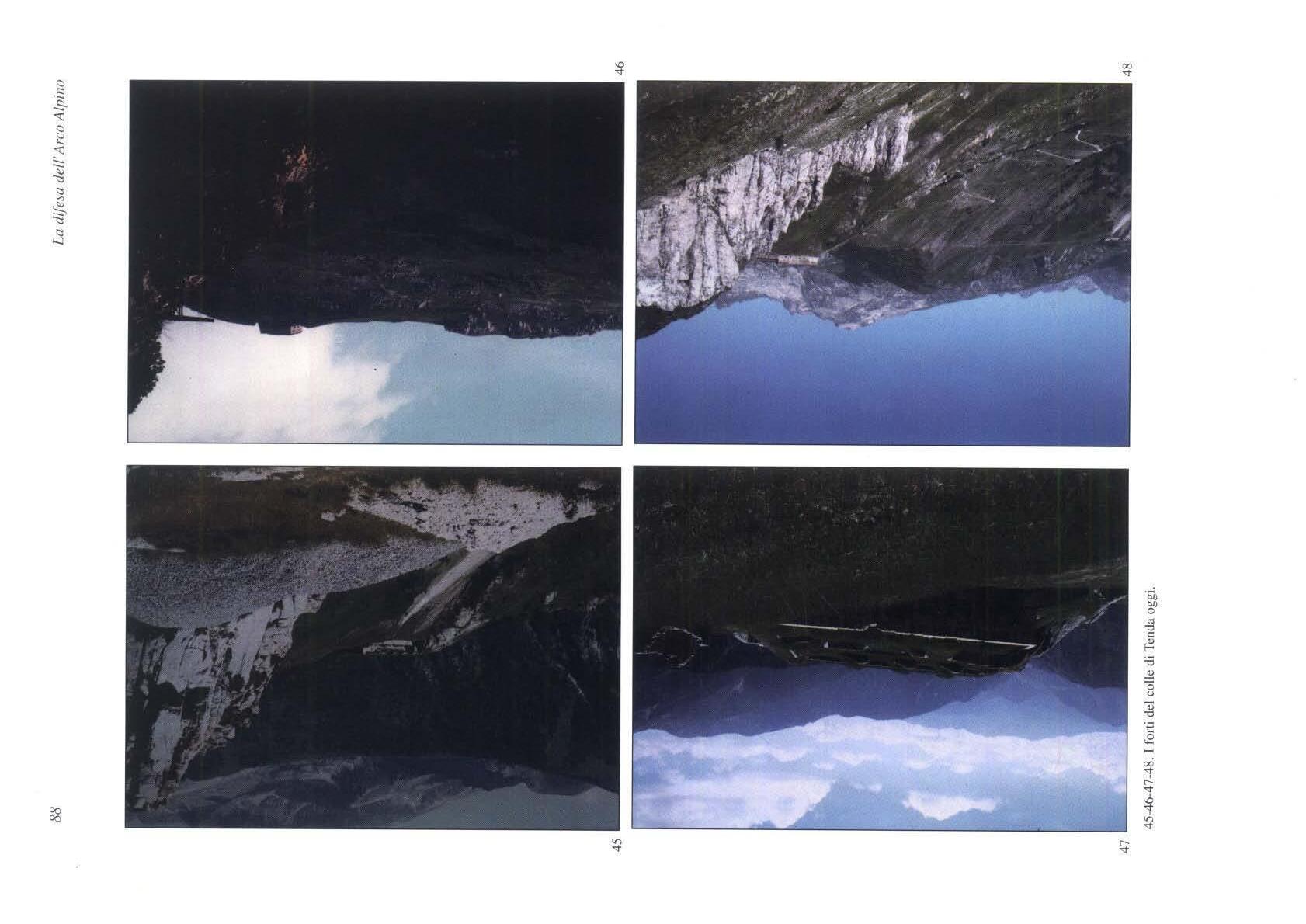
88 La difesa dell'Arco Alpino 46 48 4546-47-48. l
forti del colle di Tenda oggi .
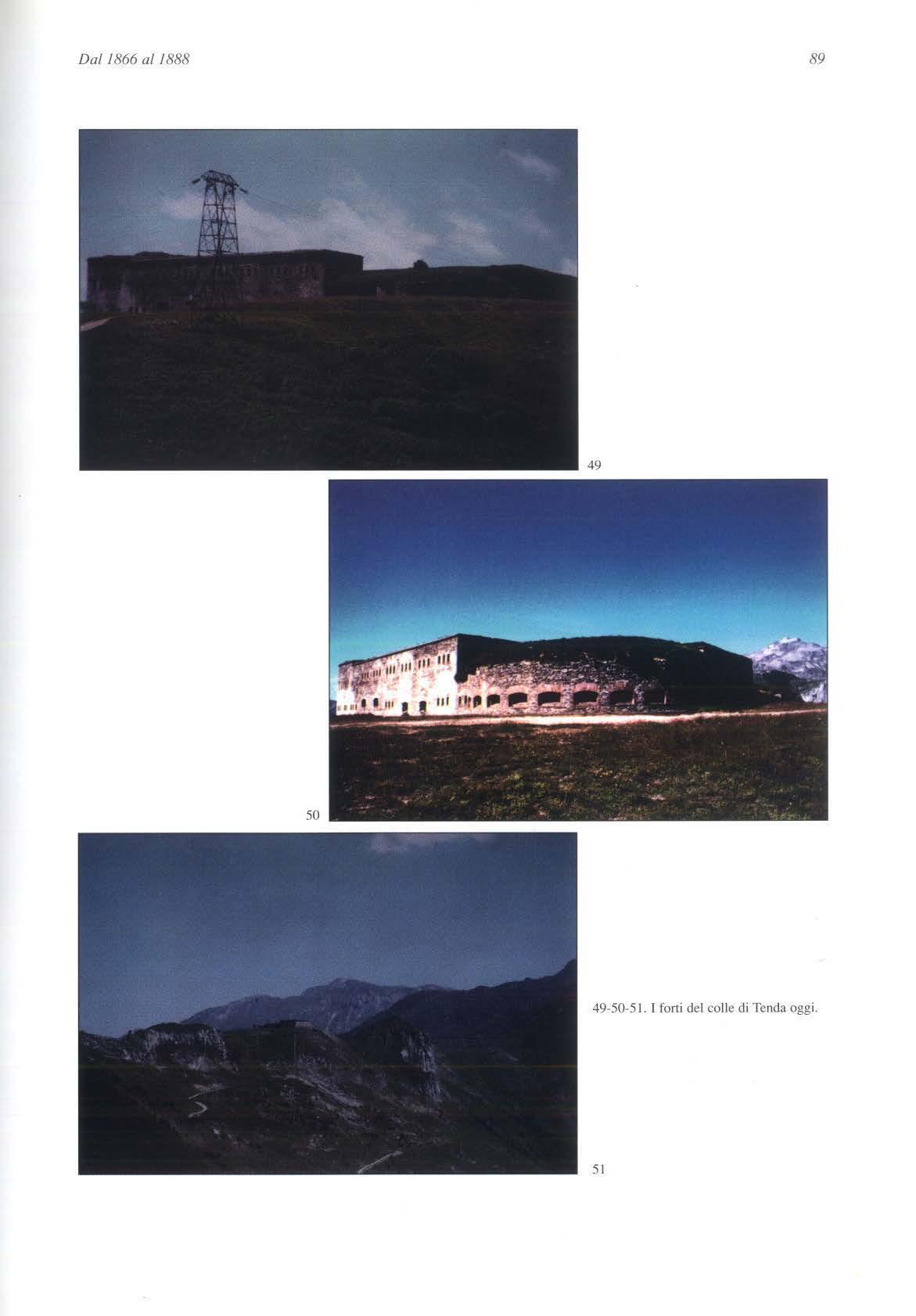
Dal 1866 al I 888 89
51
49-50-51. I forti del colle di lènda oggi.
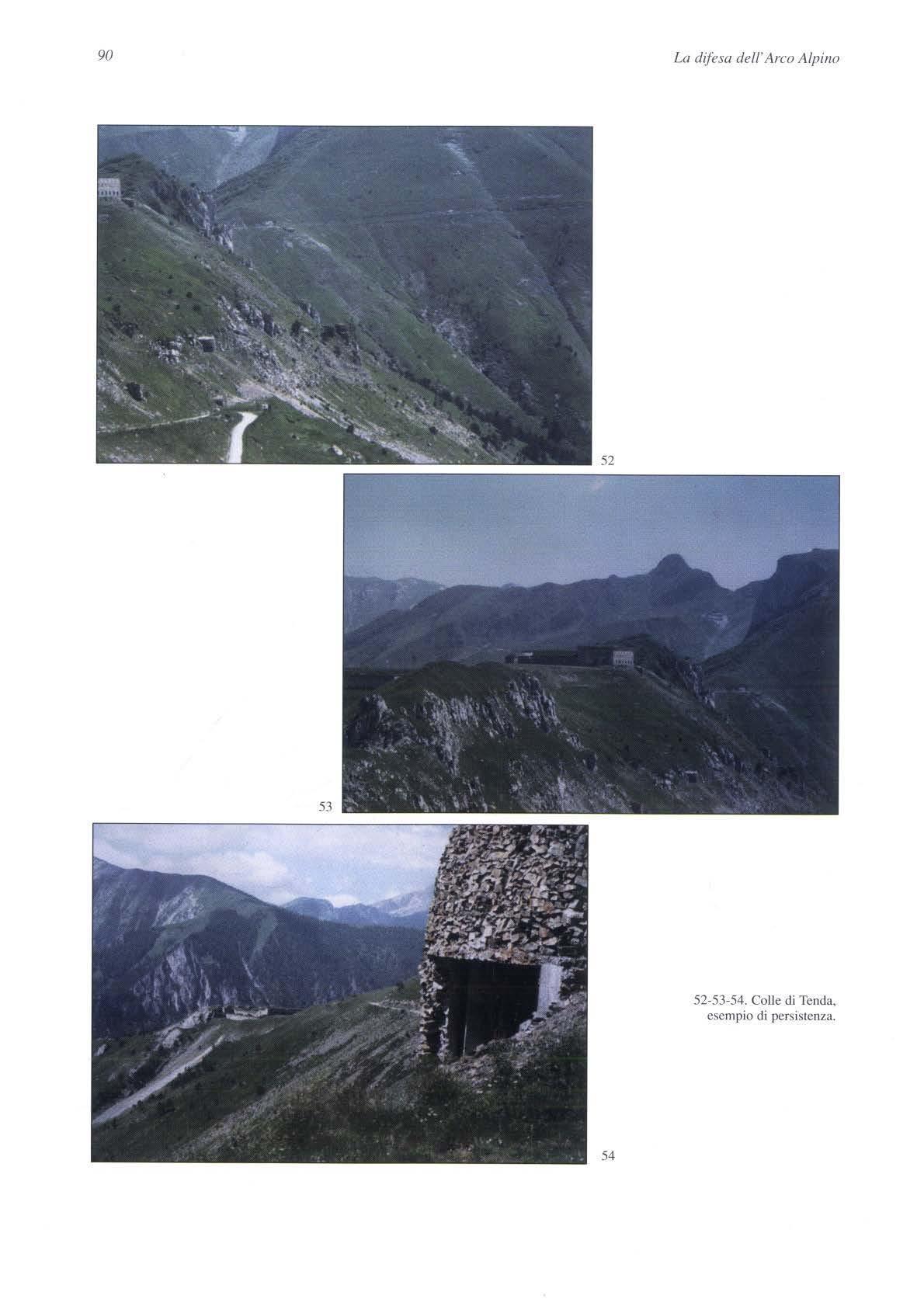
90 54 La difesa dell'Arco Alpino
52-5 3-54 CoUe di Tenda , esempio di persistenza.
L o sv ilupp o delle fortificazioni progettate dal Regno sardo -pi emontese alla Fonte francese
11 primo governo Deprelis segna una svolta nella realizzazione delle strutture fortificate destinate a dare sicurezza all o Stato; terminato il primo ann o di governo durante il quale v i ene dato corso a c i ò che e ra già stato programmato, in quanto rit enuto di imponanzn vitale, il Depretis forte de l consenso unanime di lutti i g ruppi della sini stra , imprim e un deciso impulso ai lavori già iniziati e si accinge ad un pr im o provvedimento o ri g inale: fortificare Roma cap it ale
A tale sco po a metà ma gg i o v i ene assegnato il coma ndo della Divisione militnre di Roma al Tenente General e Giovan Ballista Bruzzo, ingegnere militare, con il compito specifico di sovri nt endere a ll a proge tta z i one d e ll e opere di fortificazione e di avv i arne l'esecuzione il più rapidamente poss ibil e.
Si sto rn ano a questo scopo q uas i c inqu e milioni di lire dai tredici già stanz iati per i va li chi alpini e prima della fine del 1877 v i ene dato inizio ad un a serie di opere che rapprese ntan o un compromesso tra il gra nd e ca mp o trin cera to e gli apprestamenti per una difesa improvvisata, proprio per il preva l ere de l parere di Bruzzo su quello o ri ginari o di Mezzacapo.
Si decide dunque di costruire una coro na di quindici fortini staccati, ad un intervallo di ci rca 2 km. l 'uno dall'altro, affinché il corpo di piazza pos~a manovrare negli intervalli, appoggiato anche dall'artig li eria da campagna; l e opere sono destinale in maggior numero al l a riva si ni stra del Tevere, ma si preferi sce intanto ini z iare i l avori sulla ri va destra, p rimi fra Lutti quelli per il fo11e di Monte Mario.
Quali so no le ragioni de ll 'insol ita prassi seg uita e, in ultima ana li si, i motivi c he ne spiegano il cara ttere di urgenza? Come probabil e ipotesi si può porre un improvviso pericolo di sbarco, col l egato ad una min accia di guerra con la na z i o ne in grado di effettuarlo nelle dime nsioni o rm a i necessarie a questo tipo dì operazione, va l e a dire l a Franci a Infatti nel medesimo periodo l a situazi o ne po liti ca interna cli o lt ralpe è molto confusa; ca dut o il ministero Sirnon e succedutogl i il ministero De Broglie, l 'opinione pubblica ritien e che l a nu ova co mpag in e governativa abbia imenzioni minacciose verso l 'Italia.
An c he quando Mac Mahon il 25 maggio scioglie il parlamento i timori non cessano; e se dalle el ez ioni cli au tunno uscisse una Carnera reazionaria come quella del 1871?
Oltre a questo interrogativo g i oca a favore di tale ipotesi l'esperienza acquisita con Roma dalla Francia ne l 1849, anche se in altra situazione po litica e militare, e la necessitù, in caso di conflillo con l 'Ita lia, di impedirne la lunga res i ste nza, occupandone il ce ntro direttivo e così paralizzandola, magari a scapito di una forse più tatti ca me nte cor rella coord in azione dello sbarco con le operazion i terrestri sull e Alpi, conseguibile approdando su ll a costa ligure o toscana.
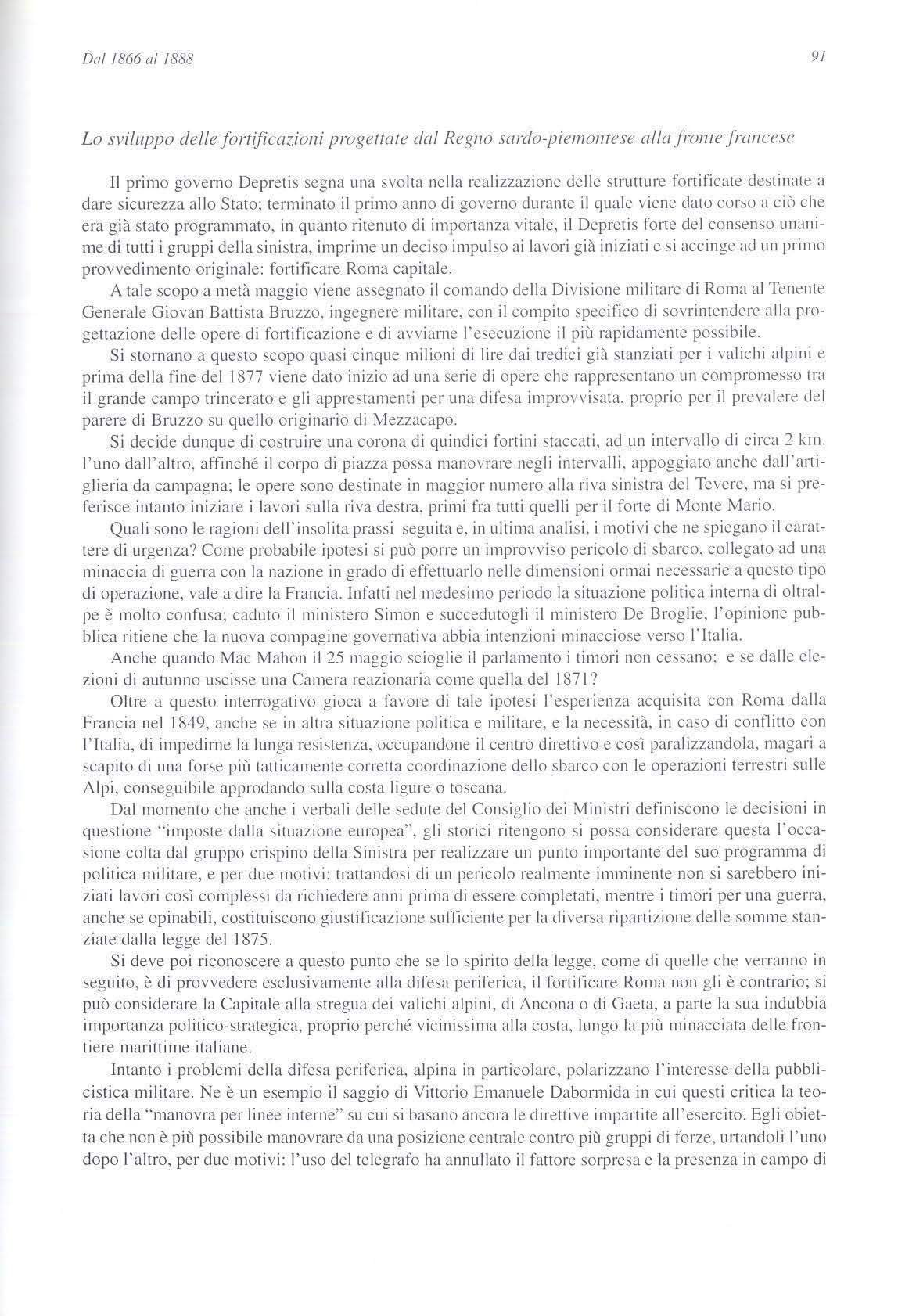
Dal momento che anche i ve rbali delle sedute del Consiglio dei Ministri definiscono le decisioni in questione ' impos te dalla si tuazi o ne europea··. gli storici ritengono si possa considerare questa I' occasio ne col t a dal gruppo crispino della Sinistra per realizzare un punto importante del suo programma di politica militare, e per due moti v i: traltando si cli un per icolo realmente immin ente non si sarebb ero iniziati l avori così comp l essi da ri c hiedere anni prima di essere completati, mentre i tim o ri per una guerra, anche se opinabili, costitu i sco no giustificazione sufficiente per la diversa riparti z i o ne dell e som me stanziate dalla l egge del 1875.
Si deve poi riconoscere a questo punto c he se l o spi rit o de l l a legge, come di quelle che ve rranno in seguito, è di provvedere esc lu si vame nte all a d ifesa periferica , il fortificare R o ma non g li è contrario; si può considerare la Capitale alla stregua dei va li c hi alpini, di Ancona o cli Gaeta, a parte la sua indubbia importanza politico-strategica, proprio perché vicinissima alla costa, lun go la più minacciata delle frontiere marittime italiane.
Intanto i problemi della difesa periferica, alpina in par1icolare, polarizzano l'interesse della pubblicistica militare. Ne è un esempio il sagg i o di Vittorio Emanue l e Dab o rmid a in cui questi c ritica la teoria del l a "ma no vra per linee int ern e" su cui si basano ancora le direttive impartite all'esercito. Egli ob i e tta che no n è più possibile mano vra re da una posizione ce ntrale contro più grupp i cli forze, u11and o li l ' un o dopo l'altro, per due motivi: l'u so ciel telegrafo ha annullato il fattore sorpre sa e la presenza in campo di
Dal 1866 al 1888 <)/
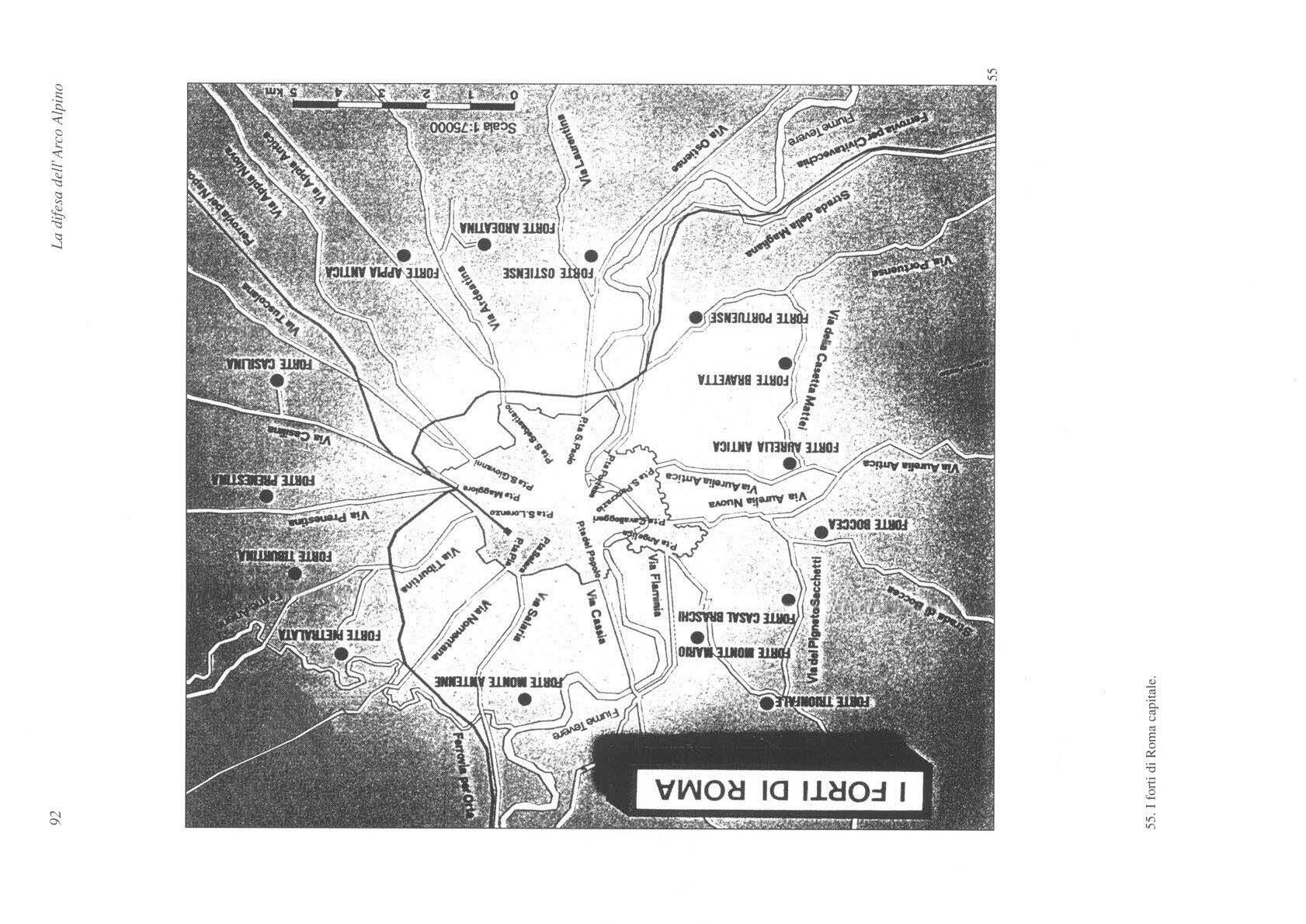
92 La difesa de/I' A . !CO Alpino 55. I forti d. R J
oma capitale.
eserciti di massa fa sì che l'attaccante possa essere facilmente avviluppato. Ostacoli nanirali e fortezze non riescono a mutare l'equilibrio delle forze; il fattore determinante è ormai la velocità di spostamento. Per questo è necessario il più a lungo possibile sulle Alpi, e con pochi, pochissimi uomini, in modo da conservare il grosso per lo scontro decisivo in pianura. Ma, soggiunge Dabormida, "4ualun4ue sia il concetto strategico del Comando Supremo italiano nel caso di una guerra impegnata da soli contro la Francia. l'unico risultato che potrà raggiungere sarì1 quello di arrestarne l'in\'a~ione. prolungando la lotta di tanto da indurre l'avversario a desistere o per stanchezza prodotta dal convincimento della durata dei suoi sforzi. o pcr l'intervento sia diplomatico sia armato delle allre potenze:·5
Molto più significative della precedente sono alcune pubblicazioni di Giuseppe Perrucchetti, destinate non alla normale diffusione ma riservate agli allievi della Scuola di Guerra, nelle quali il creatore della specialità alpina esamina sotto l'aspetto geografico militare tutti i teatri di guerra che possono interessare l'Italia, cioè le zone di frontiera austriaca, svizzera e francese; è un complesso di saggi assai interessanti, destinati ad influire in modo notevole sulla dislocazione e realizzazione delle fortificazioni italiane.
Ma l'accostamento tra le pubblicazioni del periodo 1878-1882 rivela alcuni elementi comuni. Fra questi spicca il condizionamento di una offensiva italiana sul fronte francese da pane di concomitanti operazioni tedesche sul Reno. Anzi, da quando, nel 1873, il ministro ha escluso dal progetto di difesa quella parte che si suole chiamare ''interna" (malgrado che di questa ci si continui ad occupare in articoli e saggi sino al 1875) scrittori come Gandolfi, Marselli, Daborrnida e Perrucchetti rivolgono la loro attenzione alle modalità per realizzare in concreto le ipotesi fino al momento formulate sul piano teorico.
Così alla capacità di resistenza nel tempo del sistema di difesa periferico continentale e costiero è affidata l'unica possibilità per l'esercito di mobilitare e concentrarsi prima che quello francese si sia saldamente attestato sul territorio nazionale. Che poi lo si affronti manovrando per linee interne a ridosso delle Alpi, con una colossale battaglia risolutiva in pianura o si tenti di attirarlo tra le giogaie dell'Appennino non ha importanza rilevare in questa sede. Lo sviluppo della capacità risolutrice del sistema militare italiano resta comunque legato al rafforzamento e all'agilità delle forze mobili, esercito e milizia.
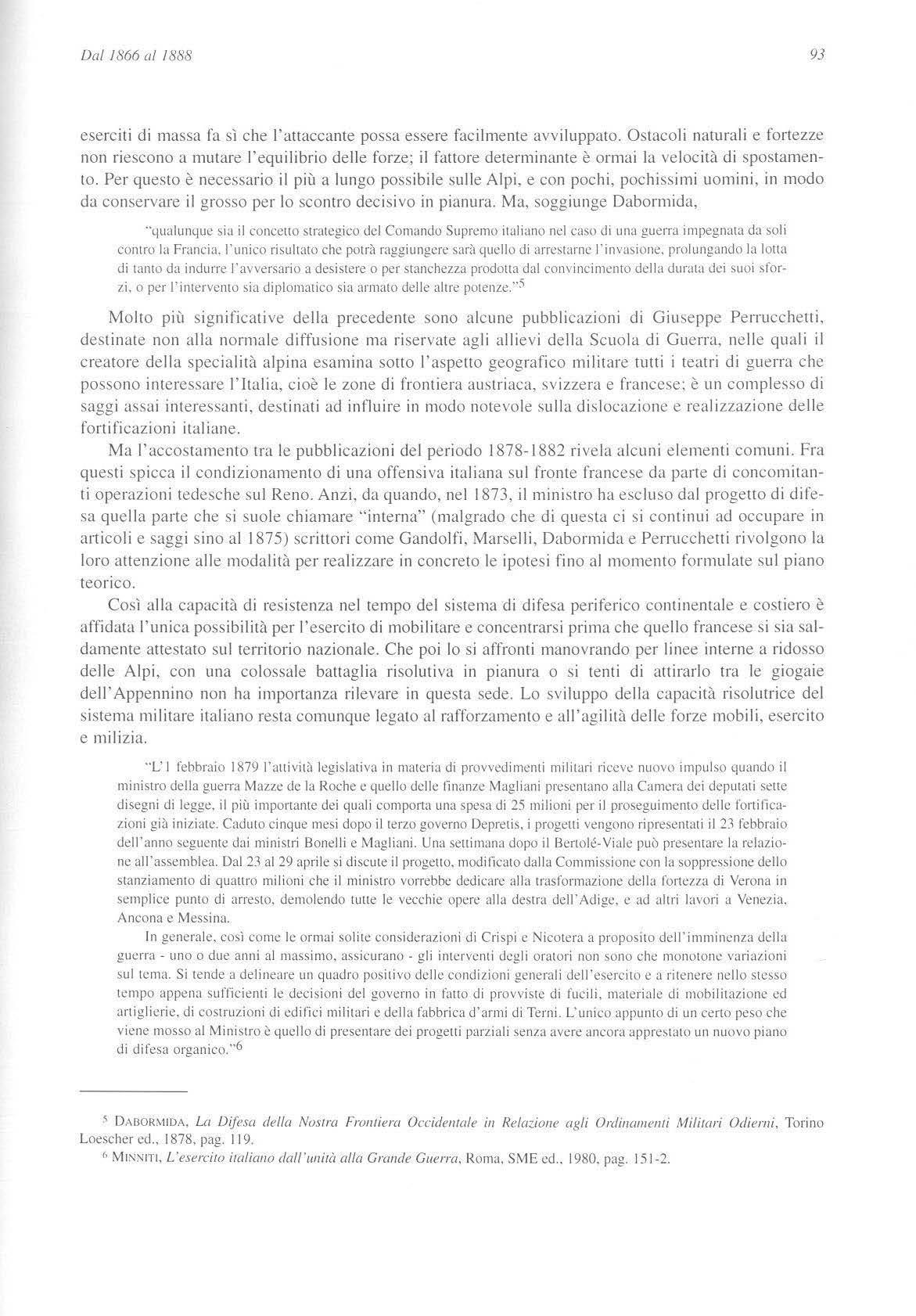
"L' I febbraio 1879 l'attività legislativa in materia di provvedimenti militari riceve nuovo impulso quando il ministro della guerra Mazze de la Roche e qudlo delle lìnanze Magliani presentano alla Camera dei deputati sette disegni di legge. il più importante dei quali comporta una spesa di 25 milioni per il proseguimento delle fortificazioni già iniziate. Caduto cinque mesi dopo il terzo governo Depretis, i progetti vengono ripresentati il 23 febbraio dell'anno seguente dai ministri Bonelli e Magliani. Una settimana dopo il Bertolé-Viale può presentare la relazione all'assemblea. Dal 23 al 29 aprile si discute il progetto, modificato dalla Commissione con la soppressione dello stanziamento di quattro milioni che il ministro vorrebbe dedicare alla trasformazione della fortezza di Verona in semplice punto di arresto, demolendo tutte le vecchie opere alla destra dell'Adige. e ad altri lavori a Venezia, Ancona e Messina.
In generale, così come le ormni solite considerazioni di Crispi e Nicotera a proposito dell'imminenza della guerra - uno o due anni al massimo, assicurano • gli intcrvcnti degli oratori non sono che monotone variazioni sul tema. Si tende a delineare un quadro positivo delle condizioni generali dell'esercito e a ritenere nello stesso tempo appena sufficienti le decisioni del governo in fatto di provviste di fucili, materiale di mobilitazione ed artiglierie, di costruzioni di edifici militari e della fabbrica d'armi di Terni. L'unico appunto di un certo peso che viene mosso al Ministro ç quello di presentare dei progetti parziali senza avere ancora apprc~talO un nuovo piano di difesa organico 6
; DADORMmA, La Difesa della Nosrra Fro111iem Occide11rale i11 l?e/a:io11e agli On/i11ame111i Militari Odiemi, Torino
Loescher cd., 1878. pag. 119.
<> MtNNITI, L'esercito italiano dall'1111irà alla Cm11de Cuerm, Roma, SME cd 1980, pag. 151-2.
Dal 1866 al 1888 93
Dei venticinque milioni stanziati per le fortificazioni (in totale si richiedono oltre ottanta milioni), tre vanno a Roma. quattro alla difesa delle coste e ben diciotto ai va li chi dalle Alpi Marittime e alla valle del Piave. La legge approvata passa quindi al l 'esame del Senato, ma il 2 maggio il governo induce il re a sciogliere il Parlamento e ad indire nuove elezioni
Non più di un mese dopo i deputati della nuova Camera approvano senza discussioni il nuovo progetto.
li secondo piano forrificatorio
Nell'ottobre del 1880 nasce la Commissione per l o studio della difesa dello Stato incaricata di redigere un piano delle fortificazioni
··nel quak avrebbero dovulO essere indicmc località ed opere \li cui basare la di resa pcrmaneme dello Staw.'·7
La Commissione l avorò dal 1880 al 1885 e ad essa va il merito di avere introdotto nell'impostazione delle strategie difensive della Nazione una nuova vis i one più redditizia e pratica, e soprattutto meno or ientata alle vel lei là manovriere di napoleonica memoria.
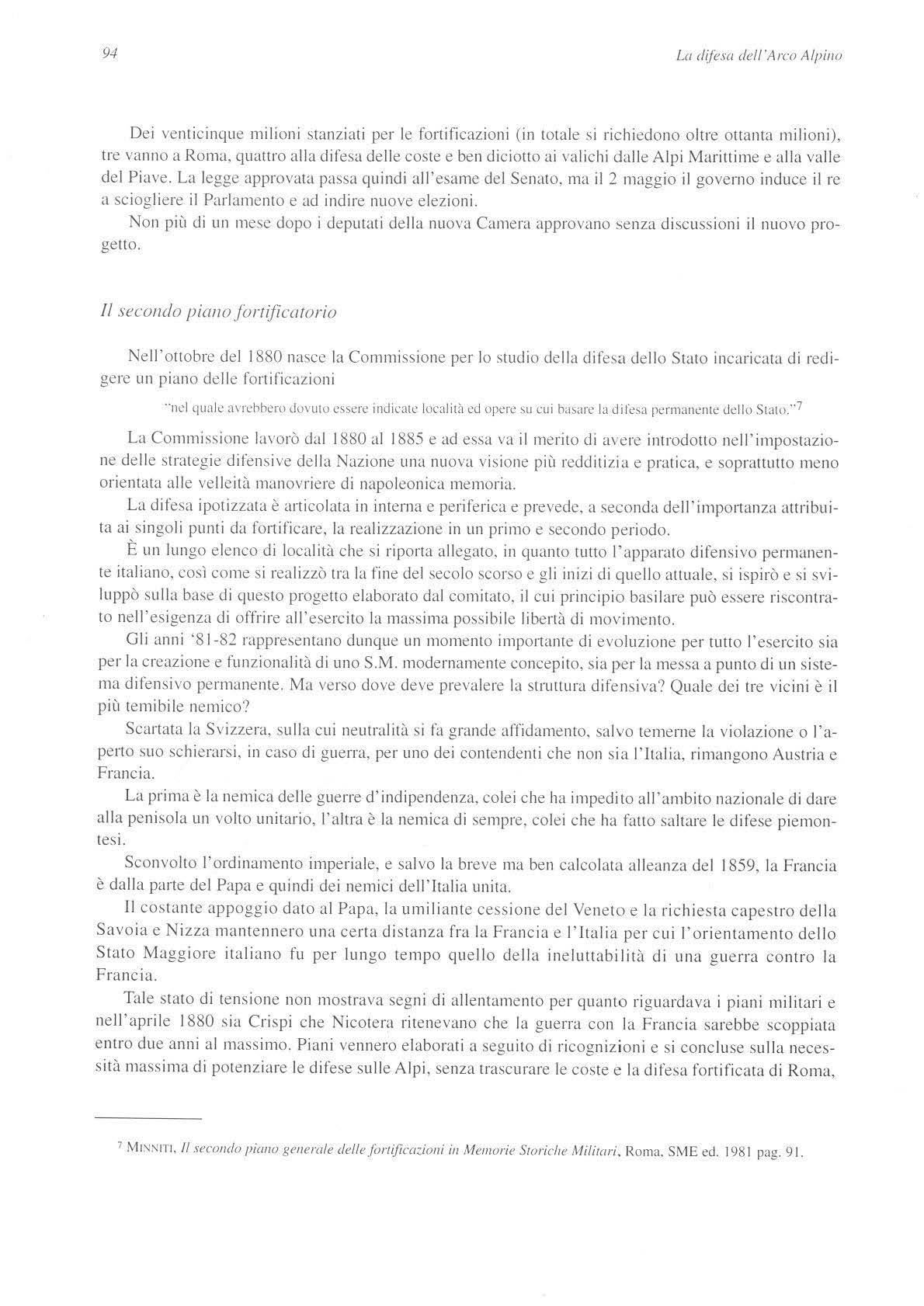
La difesa ipotizzala è articolata in interna e periferica e prevede, a seconda dell'impo11anza attribuita ai singoli punti da fo11ificare, la realizzazione in un primo e secondo periodo.
È un lun go elenco di località che si riporta allegato. in quanto tutto l 'apparato difensivo permanente italiano, così come si realizzò tra la fine del seco lo scorso e g li inizi di quello attuale, si ispirò e si sviluppò sulla base di questo progetto elaborato dal com itato, il cui principio basilare può essere riscontrato nell'esigenza cli offrire all'esercito la massima possibile libertà cli movimento.
Gli ann i '81 - 82 rappresentano dunque un momento impo11ante di evo luzi one per tutto l'esercito sia per l a creazione e funzionalità di uno S.M. modernamente concepito, sia per la messa a punto di un sistema difensivo permanente. Ma verso dove deve prevalere la struttura difensiva? Quale dei tre vicini è il più temibile nemico?
Scartata la Svizzera, sulla c ui neutralità si fa grande affidam ento, salvo temerne la violazio ne o l'aperto su o schierars i, in caso cli guerra, per uno dei contendenti che non sia l'Italia, rimangono Austria e Francia.
L a prima è la nemica delle g uerre d'indipendenza, co l ei che ha impedito all'ambito nazionale cli dare all a penisola un volto unitari o, l'altra è la nemica di sempre, colei che ha fatto saltare le difese piemontesi.
Sconvolto l 'ordin amento imperiale, e sa lvo la breve ma ben calcolata alleanza del 1859, la Francia è dalla parte del Papa e quindi dei nemici dell'Italia unita.
Il costante appoggio dato al Papa, la umiliante cessione del Veneto e l a richiesta capestro della Savoia e Nizza mantennero un a certa distanza fra la Francia e l'Italia per cui l'orientamento dello Stato Maggiore italiano fu per lun go tempo quello della in eluttabili t à di una guerra contro la Francia.
Tale st ato cli tensione non mostrava segn i di allentamento per quanto riguardava i piani militari e nell 'apri l e 1880 sia Crispi che Nicotera ritenevano che la guerra con la Francia sarebbe scoppiata entro due anni a l massimo. Piani ven nero elaborati a seguito di ricognizioni e si concluse su lla necessità massima di potenziare le difese su ll e Alpi, senza trascurare l e coste e la difesa fortificata cli Roma,
94 La d/f'esa ciel{ 'A reo A /pino
7 MINNITJ, Il secondo piano gener(l/e delle fortifirn::..ioni in Memorie Storiche Militari Roma. SME ed. I 98 I pag. 9 I.
per la cui realizzazione vennero stornati cinque dei tredici milioni destinati alle Alpi. Lo Stato Maggiore era pervaso della convinzione di un possibile aggiramento delle Alpi ~ffettuato con uno sbarco alle spalle delle difese a lpine e si regolava di conseguenza per tutelare il territorio ed in special modo la nuova capitale.
L'alleanza austro-tedesca del 1879 aveva reso sempre più palese l'isolamento dell'Italia; si imponeva quindi la ricerca di un alleato che non poteva essere che la Germania e, poiché la via di Berlino passava per Vienna, si dovette accantonare l'irredentismo e l'austrofobia e, lasciati i Balcani, dedicarsi al Mediterraneo, regione ove avversaria era la Francia.
La Triplice Alleanza
"L' Italia reagì ai primi c olpi vibratigli dall'imperiali smo francese no n so lo con la Triplice , ma anche con l 'a umento delle spese militari"; venne promossa dal Crispi ··una politica di espansione mediterranea antifrancese: 8
Tale politica non fu seguita dalle masse, che, nonostante le tensioni specie economiche esistenti fra Italia e Francia, vedevano nell'Austria il vero nemico. Il governo italiano, a fronte dei moti anti austriaci sorti in conseguenza dell'avvicinamento a questa nazione, temette per la sua sopravvivenza; aderì quindi alle pressioni dei moderati, imprimendo, previa repressione dei moti, un deciso miglioramento alle relazioni con l'Austria, miglioramento che, dopo alcuni alti e bassi, portò nel maggio del!' '82 alla stipula della Triplice Alleanza in chiarissima chiave antifrancese
La stipula dell'a ll eanza portò ad un rafforzamento delle m isure difensive nei confronti della Francia (ad es. la fo1tezza di Fenestrelle) non disgiunto, anche se può sembrare un paradosso, dall'adozione di misure di potenziamento del confine con l'Austria, ove questa, vista la deficienza di fortificazioni italiane di sbarramento sul saliente trentino, disponeva dell'assoluto controllo degli sbocchi attraverso cui far affluire verso l'Italia le sue concentrate forze.
L'ingresso dell'Italia nella Triplice provocò un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle difese del confine verso la Francia, non disgiunto ad un notevole interessamento per ciò che riguardava la deficitaria linea di confine con l'Austria.
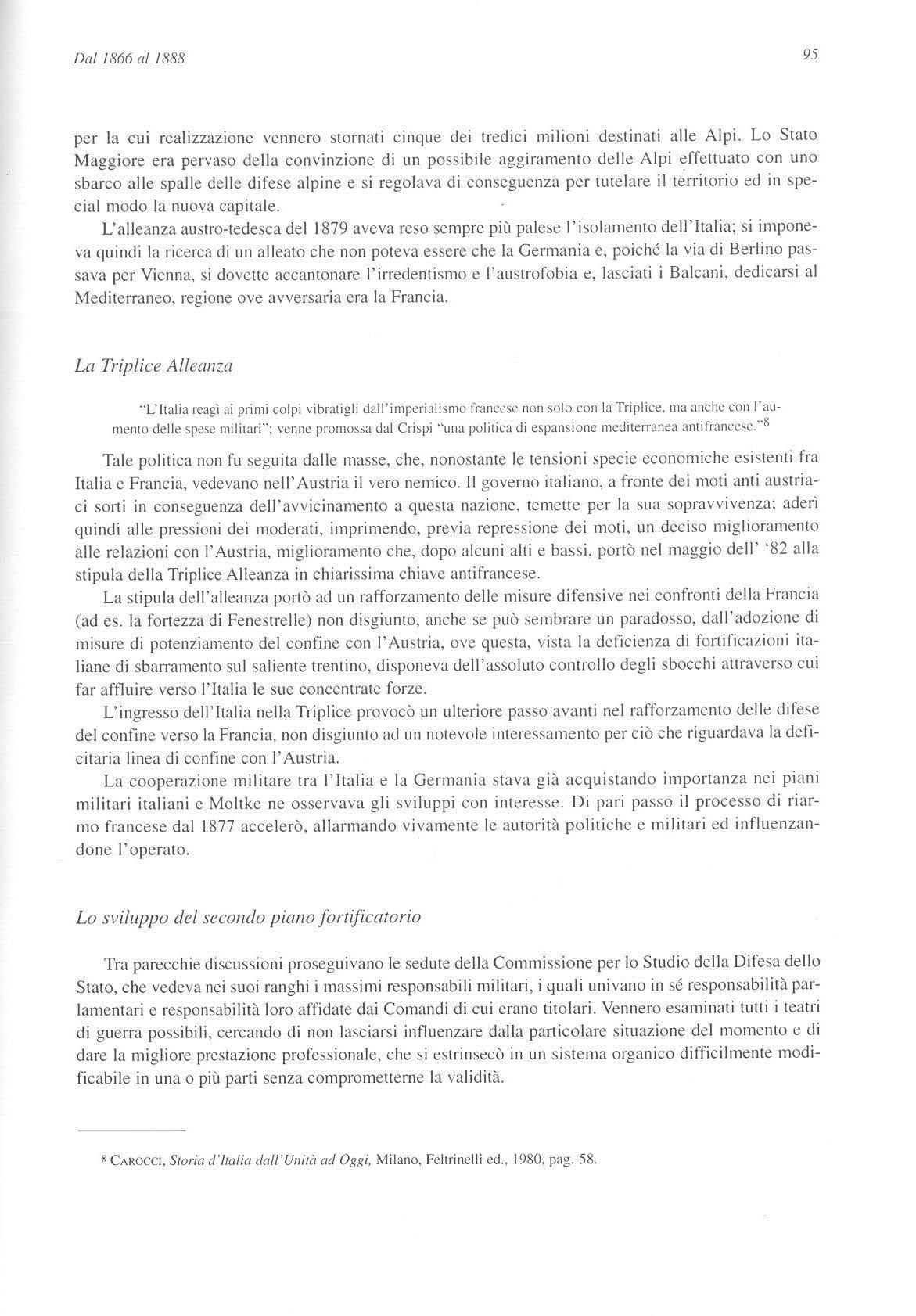
La cooperazione militare tra l'Italia e la Germania stava già acquistando importanza nei piani militari italiani e Moltke ne osservava gli sviluppi con interesse. Di pari passo il processo di riarmo francese dal 1877 accelerò, allarmando vivamente le autorità politiche e militari ed influenzandone l'operato.
Lo sviluppo del secondo piano fortificatorio
Tra parecchie discussioni proseguivano le sed ute della Commissione per lo Studio della Difesa dello Stato, che vedeva nei suoi ranghi i massimi responsabili militari, i quali univano in sé responsabilità parlamentari e responsabilità loro affidate dai Comandi di cui erano titolari. Vennero esaminati tutti i teatri cli guerra possibili, cercando di non lasciarsi influenzare dalla particolare situazione del momento e di dare la migliore prestazione professionale, che si estrinsecò in un s istema organ ico difficilmente modificabile in una o più parti senza comprometterne la validità.
Dal I 866 al 1888 95
8 CAROCC t , S10ria d'lralia da/l'U11Ìlà ad Oggi, Milano, Feltrinelli cd., 1980. pag. 58.
Pur tuttavia, a fronte di reiterate richieste di origine politica, la commissione, con forti riserve, elaborò un piano ridotto e. di più facile realizzazione, stante le- risorse economiche del Paese. Mezzacapo, una delle più illuminate menti militari presenti, si astenne dal votare tale realizzazione, ritenendo che solo i 1 piano completo elencasse le misure tecniche necessarie e che dovesse essere l'organo politico, a seconda delle esigenze della politica internazionale, a doverne determinare la priorità nel l'attuazione.
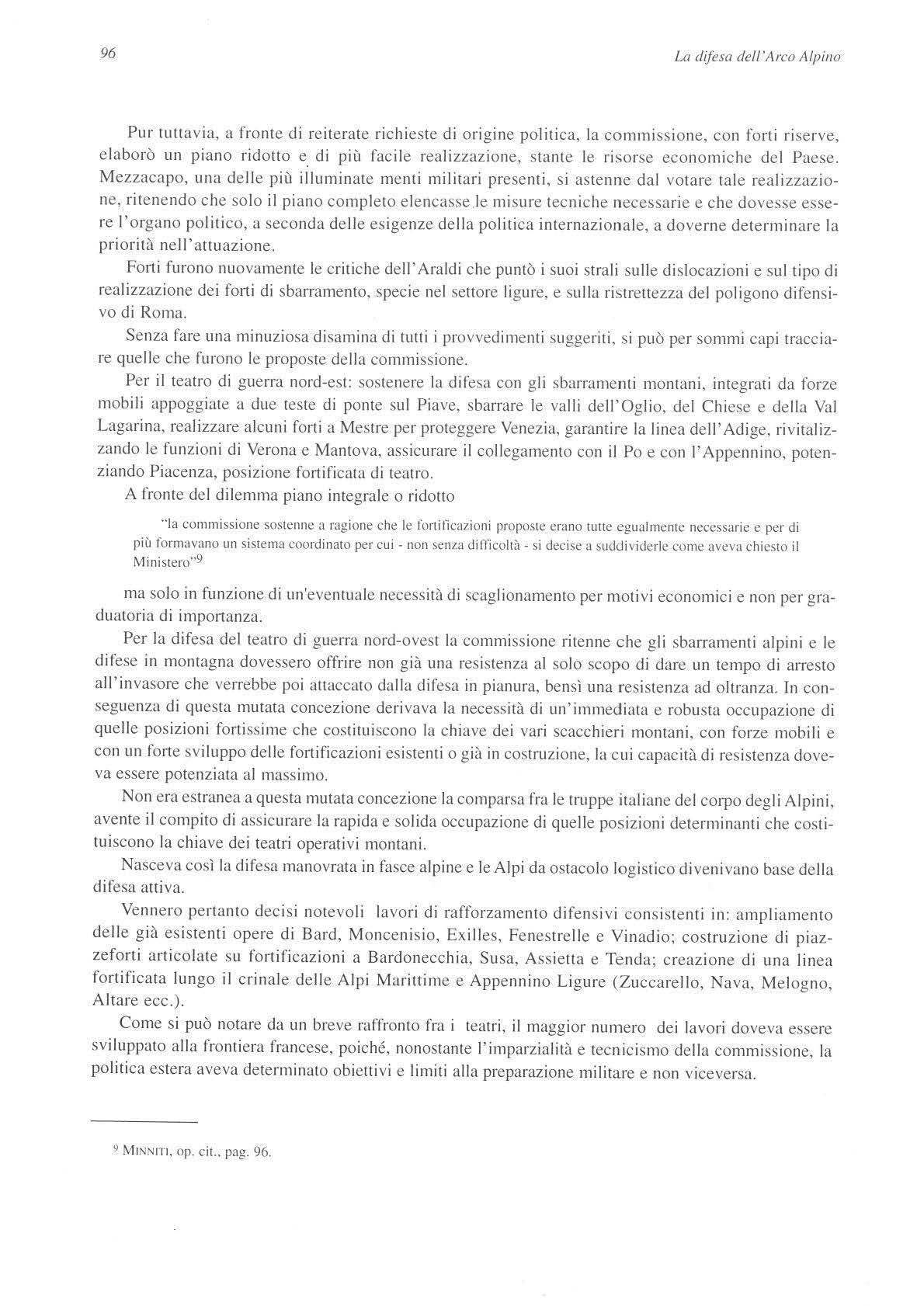
Forti furono nuovamente le critiche dell 'Araldi che puntò i suoi strali sulle dislocazioni e sul tipo di realizzazione dei forti di sbarramento, specie nel settore ligure, e sulla ristrettezza del poligono difensivo di Roma.
Senza fare una minuziosa disamina di tutti i provvedimenti suggeriti, si può per sommi capi tracciare quelle che furono le proposte della commissione.
Per il teatro di guerra nord-est: sostenere la difesa con gli sbarramenti montani, integrati da forze mobili appoggiate a due teste di ponte sul Piave, sbarrare le valli dell'Oglio, del Chiese e della Val Lagarina, realizzare alcuni forti a Mestre per proteggere Venezia, garantire la linea dell'Adige, rivitalizzando le funzioni di Verona e Mantova, assicurare il collegamento con il Po e con l'Appennino, potenziando Piacenza, posizione fortificata di teatro.
A fronte del dilemma piano integrale o ridotto
"la commissione sostenne a ragione che le fortificazioni proposte erano tutte egualmente necessarie e per di più formavano un sistema coordinato per cui - non senza difficoltà - si decise a suddividerle come aveva chiesto il Ministero··9
ma solo in funzione di un'eventuale necessità di scaglionamento per motivi economici e non per graduatoria di importanza.
Per la difesa del teatro di guerra nord-ovest la commissione ritenne che gli sbarramenti alpini e le difese in montagna dovessero offrire non già una resistenza al solo scopo di dare un tempo di arresto all'invasore che verrebbe poi attaccato dalla difesa in pianura, bensì una resistenza ad oltranza. In conseguenza di questa mutata concezione derivava la necessità di un'immediata e robusta occupazione di quelle posizioni fortissime che costituiscono la chiave dei vari scacchieri montani, con forze mobili e con un fot1e sviluppo delle fortificazioni esistenti o già in costruzione, la cui capacità di resistenza doveva essere potenziata al massimo.
Non era estranea a questa mutata concezione la comparsa fra le truppe italiane del corpo degli Alpini, avente il compito di assicurare la rapida e solida occupazione di quelle posizioni determinanti che costituiscono la chiave dei teatri operativi montani.
Nasceva così la difesa manovrata in fasce alpine e le Alpi da ostacolo logistico divenivano base della difesa attiva.
Vennero pertanto decisi notevoli lavori di rafforzamento difensivi consistenti in: ampliamento de l le già esistenti opere di Bard, Moncenisio, Exilles, Fenestrelle e Vinadio; costruzione di piazzeforti articolate su fortificazioni a Bardonecchia, Susa, Assietta e Tenda; creazione di una linea fortificata lungo il crinale delle Alpi Marittime e Appennino Ligure (Zuccarello, Nava, Melogno, Altare ecc.).
Come si può notare da un breve raffronto fra i teatri, il maggior numero dei lavori doveva essere sviluppato alla frontiera francese, poiché, nonostante l'imparzi alità e tecnicismo della commissione, la politica estera aveva determinato obiettivi e limiti alla preparazione militare e non viceversa.
96 La difesa dell'Arco Alpino
9 MINNITJ, op cit., pag. 96.
li secondo piano generale
Località e zone dove, secondo la Commissione per lo Studio della Difesa dello Stato, avrebbero dovuto essere costruite o rinforzate opere cli fortificazione. 10
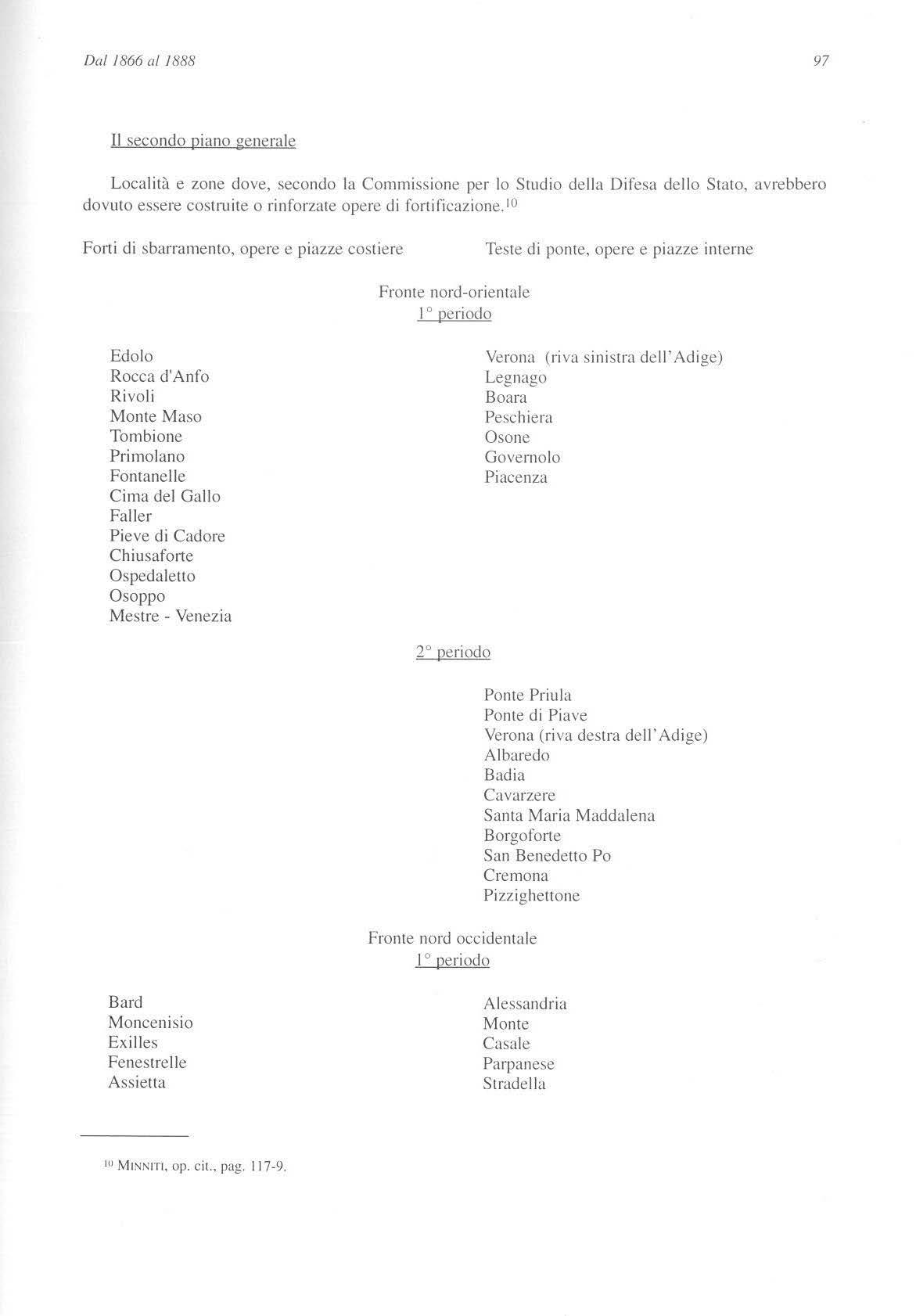
Forti cli sbarramento, opere e piazze costiere Teste di ponte, opere e piazze interne
Fronte nord-orientale I O periodo
Edolo
Rocca cl'Anfo
Rivoli
Monte Maso
Tombione
Primolano
Fontanelle
Cima del Gallo
Faller
Pieve di Cadore
Chiusaforte
Ospedaletto
Osoppo
Mestre - Venezia
Verona (riva sinistra dell'Adige)
Legnago
Boara
Peschiera
Osone
Governolo
Piacenza
Bard
Moncenisio
Exilles
Fenestrelle
Assietta
2 ° periodo
Ponte Priula
Ponte di Piave
Verona (riva destra cieli' Adige)
Albaredo Badia
Cavarzere
Santa Maria Maddalena
Borgofo11e
San Benedetto Po
Cremona
Pizzighettone
Fronte nord occidentale I O periodo
Alessandria
Monte
Casa le
Parpancse
Stradella
Dal 1866 al 1888 97
JO MINNITI, op. cit., pag. 117-9.
Susa
C o nca d i Bard onecc hi a
Sa mpe y re Vin ad io
Te nda
Zuccare l lo
Co lla Bass a - Cianea
S trad a tra Bar dinetto e Toirano
M e log no
A ltare - Mon te Giuro
Vad o
G io vo
T urc h in o
Ge nova
L a S pez ia
Mo nt e Bast io ne
S tra da de l Sempione
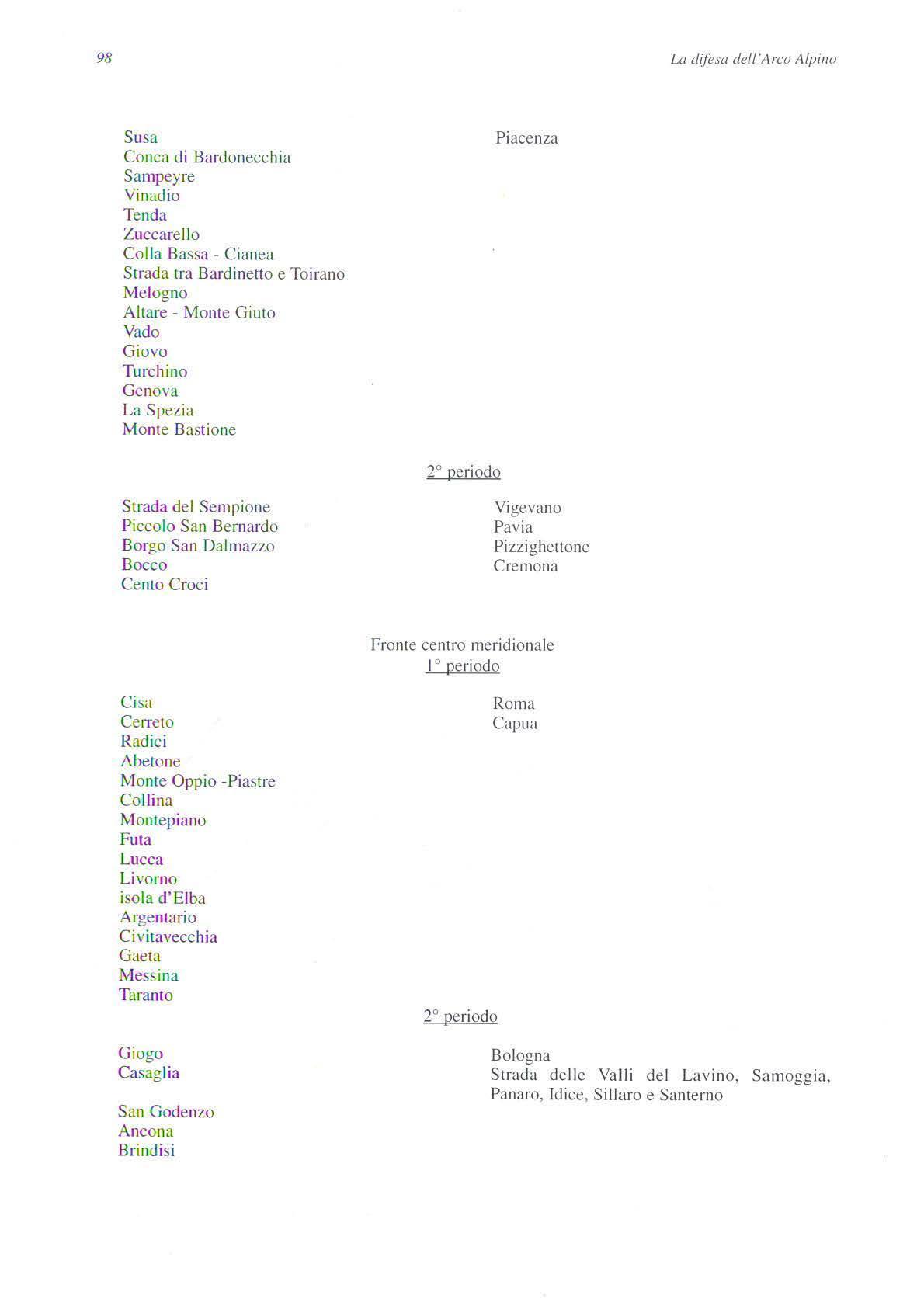
P icco lo S a n Be rrn:u-do
Borgo S a n Da lmazzo
Bocc o
Ce nto Croc i
C isa
Cerre to
Rad ic i
Abe to ne
Monte Opp io -P iastre
Co lli na
Mo nt ep i,m o
F uta
Lucca
Li vo rno
iso la d' E lba
A rge nt a rio
C i vitavecc hia
G ae ta
Me ss ina
Tara nto
G io go
Casag l ia
S a n Go den zo
A nc o na
B ri nd is i
? 0 periodo
Bologna
Strada de ll e Valli del Lavino, Samoggia, Panaro, Idice , Sillaro e Santerno
98
Vigevano Pavia Pizzighettone Cremona Fronte centro meridionale
periodo Roma Capua
Piacenza 2° periodo
1°
la
dife sa dell 'Arco Alpino
Mentre la Commissione per lo studio della difesa dello Stato elaborava i suoi piani, grosse innovazioni tecnologiche nel campo delle anni e delle strutture difensive rendevano necessarie modifiche fondamentali, vuoi come realizzazione che come collocazione; l'avvento delle granate torpedini cariche di esplosivo imponeva radicali mutamenti nelle strutture, prima fra tutte l'adozione di calcestruzzo e ferro.
Ma, procedendo a ritroso, si può dire che finché Je artiglierie rimasero lisce l'organizzazione difensiva permanente di una valle si limitava generalmente ad un'opera di sbarramento, avente il compito di battere la strada di fondo valle.
Si trattava di forti costruiti da ingenti masse in muratura che null'altro erano se non la tradizionale rocca o castello medioevale sopravvissuti in montagna attraverso i secoli proprio in virtù delle difficoltà opposte dal terreno ai mezzi di attacco.
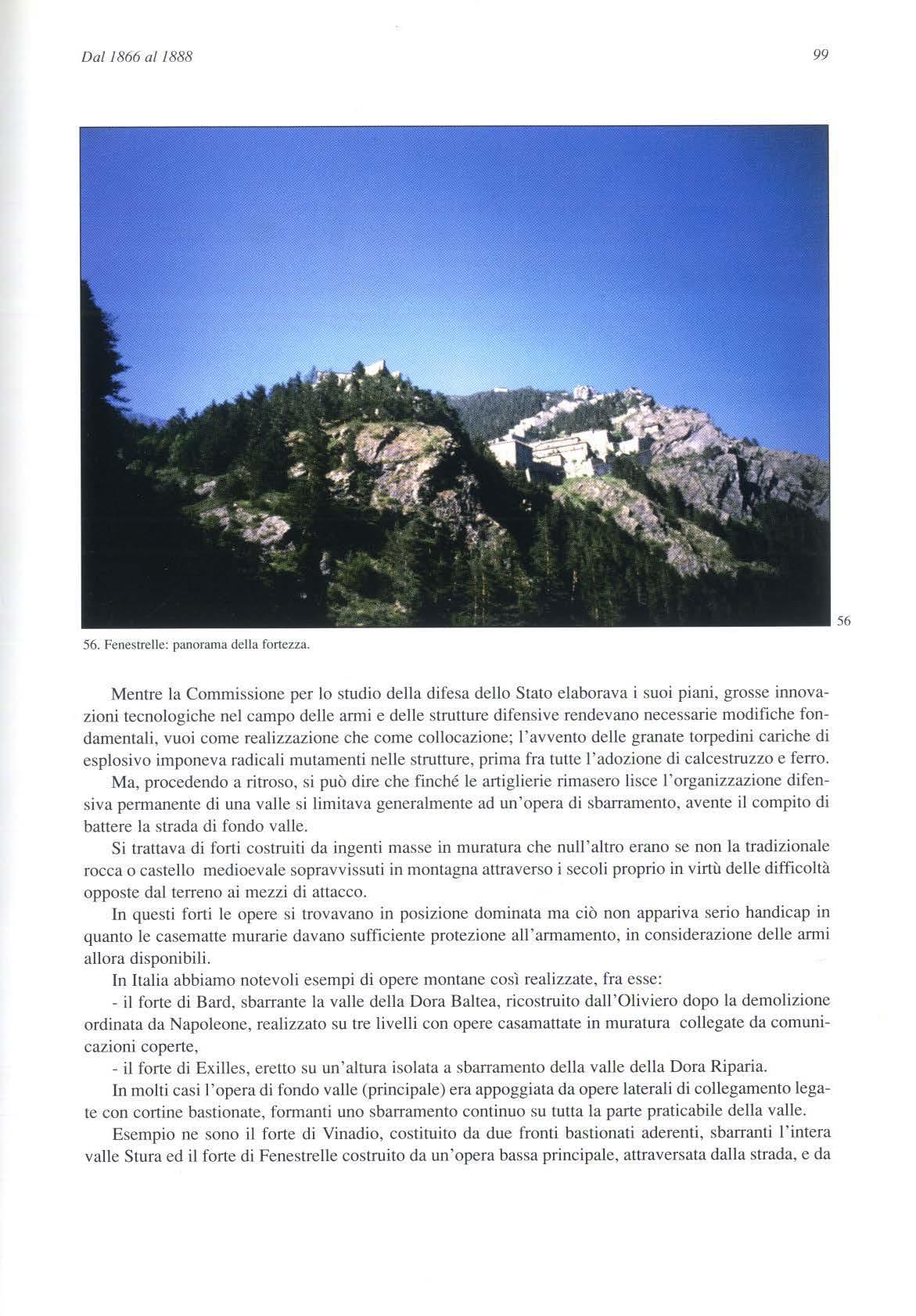
In questi forti le opere si trovavano in posizione dominata ma ciò non appariva serio handicap in quanto le casematte murarie davano sufficiente protezione all'armamento, in considerazione delle anni allora disponibili.
In Italia abbiamo notevoli esempi di opere montane così realizzate, fra esse:
- il forte di Bard, sbarrante la valle della Dora Baltea, ricostruito dall'Oliviero dopo la demolizione ordinata da Napoleone, realizzato su tre livelli con opere casamattate in muratura collegate da comunicazioni coperte,
- il forte di Exilles, eretto su un 'altura isolata a sbarramento della valle della Dora Riparia.
In molti casi l'opera di fondo valle (principale) era appoggiata da opere laterali di collegamento legate con cortine bastionate, formanti uno sbarramento continuo su tutta la parte praticabile della valle.
Esempio ne sono il forte di Vinadio, costituito da due fronti bastionati aderenti, sbarranti l'intera valle Stura ed il forte di Fenestrelle costruito da un'opera bassa principale, attraversata dalla strada, e da
Dal 1866 al 1888 99
56. Fenestrelle: panorama della fortezza.
56
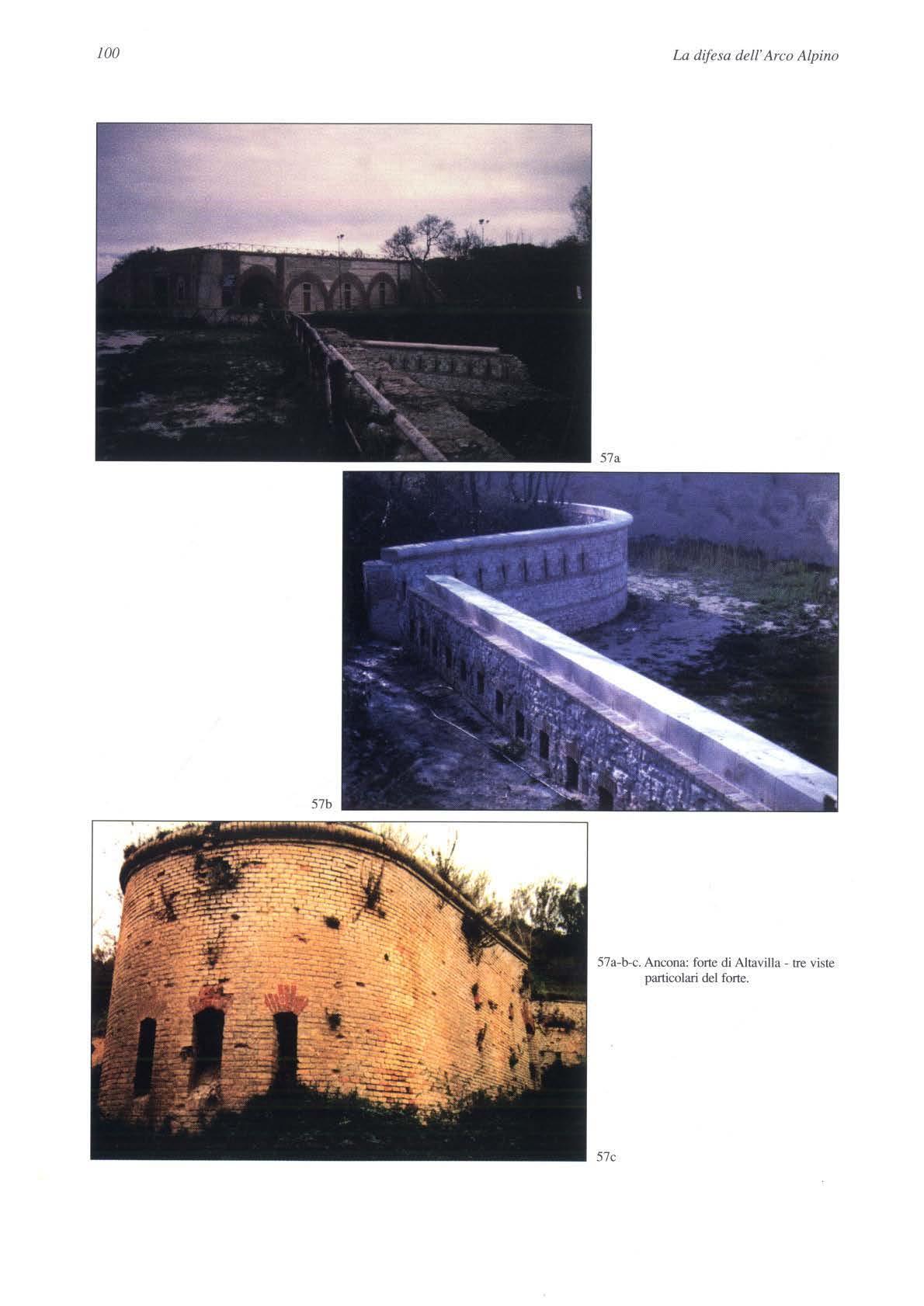
100 La difesa del/' Arco Alpino
57a-b-c. Ancona: forte di Altavilla - tre viste particolari del forte.
forti laterali collegati da trinceramenti permanenti e da muri con feritoie.
Aumentata l'efficacia delle bocche da fuoco per l'adozione della rigatura e di altri perfezionamenti, e raggiunta una maggior manovrabilità col perfezionarsi degli affusti, l'opera di fondo valle non fu più in grado di assolvere il suo compito, sia per insufficiente resistenza, sia perché battuta dall'alto dalle artiglieri e dell'attaccante.
Si cercò allora di aumentare la resistenza dell'opera con accorgimenti di carattere tecnico, quali la sostituzione delle casematte murarie con casematte corazzate a cannoniera minima o rinforzate da scudo metallico con cannone prigioniero; valido esempio di questa tecnica è rappresentato nel primo caso dall'opera di Fenil, nel secondo dallo sban-amento di Vinadio dove, intorno al 1880-1885, l'opera di fondo valle venne armata con una batteria a sfera da I 5 cm.
Simile ripiego non diede i risultati sperati, non fu quindi giudicato ulteriormente conveniente, in quanto "il gioco non valeva la candela", e non venne adottato per altre stmtture difensive; si optò per la realizzazione di opere minori dislocate sulle alture circostanti, da dove il fuoco avversario avrebbe potuto distruggere l'opera di sbarramento.
Sorgono pertanto gli sbarramenti o piazze militari costituiti da gruppi di opere relativamente vicine, concorrenti alla reciproca difesa del terreno assegnato: l'opera di fondo valle destinata a battere la strada ed opere laterali (o opere di protezione), costruite sulle alture circostanti, spesso assai elevate, a distanza anche notevole t'una dall'altra, con il compito di proteggere l'opera bassa che mantiene la funzione di interdire la rotabile per il cui sbarramento è stata realizzata.
Molteplici i compiti che la nuova dottrina attribuiva a queste nuove opere, oltre alla protezione dell'opera principale: perno di manovra a favore delle forze mobili, più esteso dominio sull'artiglieria dell'attaccante e presidio di posizioni dominanti, rese così inagibili all'avversario.
È così spiegata la presenza attorno ai vecchi forti di numerose nuove opere che chiaramente risultano di concezione più moderna.
Sorgono quindi, se si esamina il seltore nord -ovest:
- attorno al forte di Bard le opere della Cou e Macheby,
-davanti al forte di Exilles le fortificazioni staccate di Serre la Garde, Sapè,
- ai lati del forte di Vinadio l'opera delle Sources e le batterie Neghino e Serziera.
li forte di Varisello sorge ai lati dei preesistenti forti Roncia e la Cassa, costituendo la fortezza -sbarramento del Moncenisio.
Allo Zuccarello si aggiunsero le opere di Monte Arena, Rocca Livernò e Poggio Grande
··Però essendo probabile che l'avvcrsalio approfiuandu di speciali condizioni a lui favorevoli (none, nebbia ecc.) temasse di spingere nuclei di forze lungo la rotabile. speciali opere dette tagliate erano organizzate in guisa da poter battere con tiro di fucileria e artiglieria l'interruzione praticata sulla strada per impedire che essa potesse essere sollecitamente riattata dal nemico."' 11
Esempio di questo tipo di opera è la tagliata di Clavière (Cesana Torinese), ove una breve tagliata con ponte retrattile interrompeva la strada nazionale; tale in1em1zione era munita di corpi di guardia,alle due estremità del ponte, di postazioni in caverna per ,mmt di medio calibro e cli camere da mina pronte. Altro esempio che si ripona è la notissima tagliata della Scala (Primolano), ove l'opera controlla la strada.
Evoluzione della tecnica nel 1885
Verso il 1885, a causa dell'evoluzione dell'artiglieria, l'introduzione di obici e mortai a retrocarica,
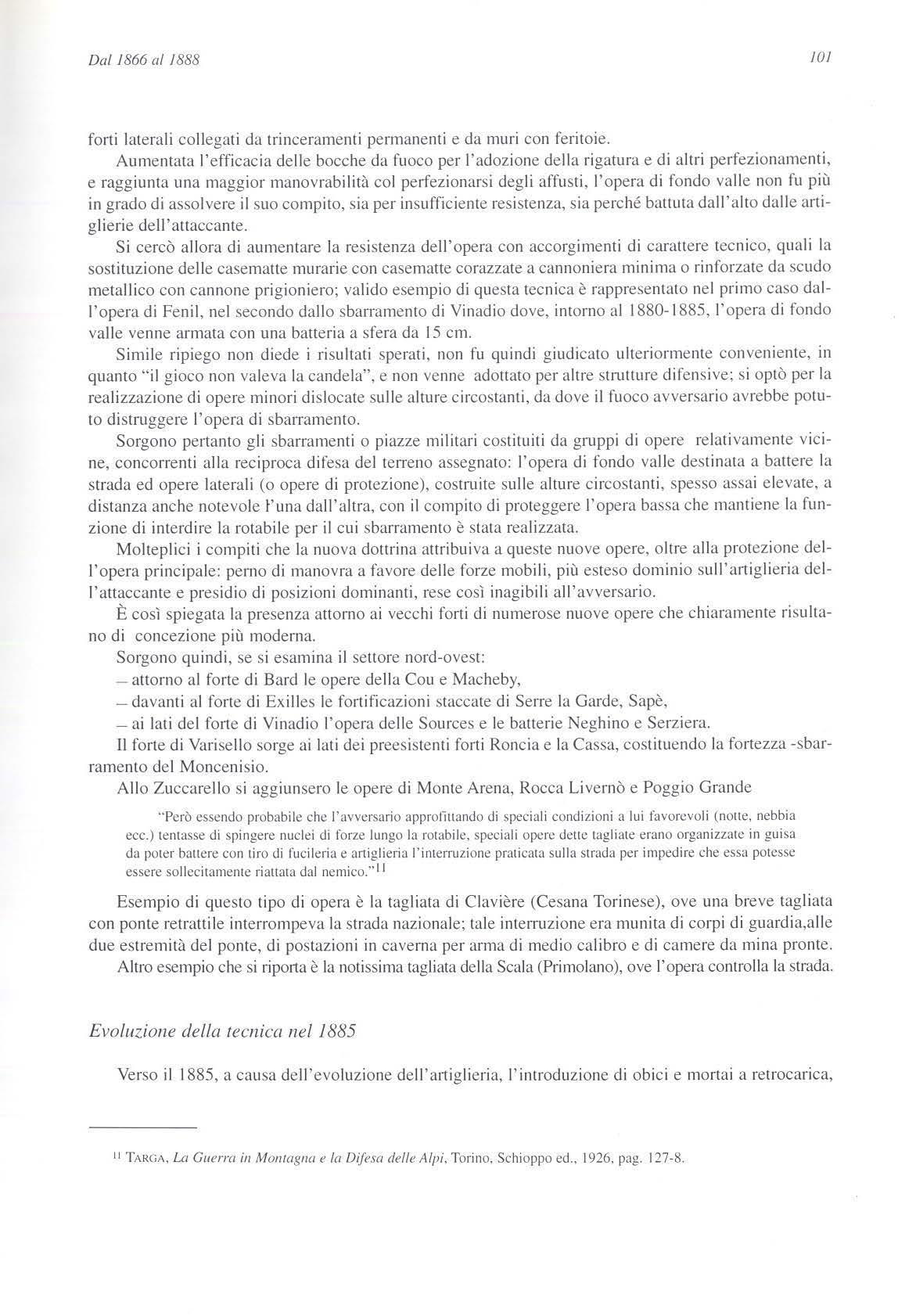
Dal 1866 al J888 IO!
11 TAR(iA. La Guerra i11 Mo111ag,w e la Difesa delle Alpi, Torino, Schioppo ed., 1926. pag. 127-8.
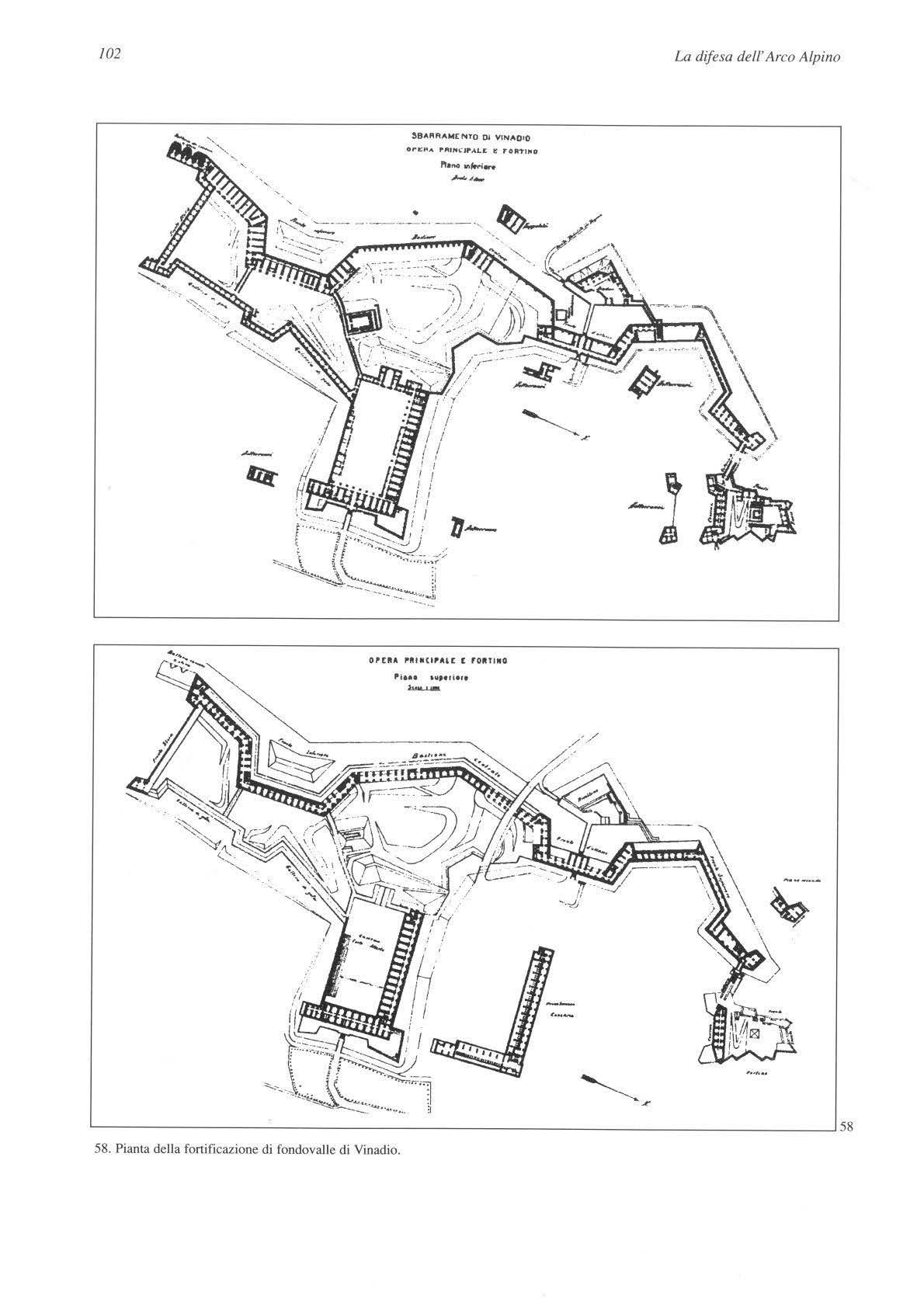
102 !B A AAA MC NTO Da VINAO IO ort:t4A PA.IN~IP,U.E ( roR'tlWO ft•no ltl'l(ff;..,..~ ,onu ,N1ot1,Alt t FOlttlNO ,1 ••, lù,., .. .. 1wu.,a la difesa de/l'Arco Alpino 58 - - ~. = d:v:a: ll e~~d~ i ;Y~in~a~d~io~.:_':_ ___ 58. Pianta de lla fortificaz10ne d1 on o
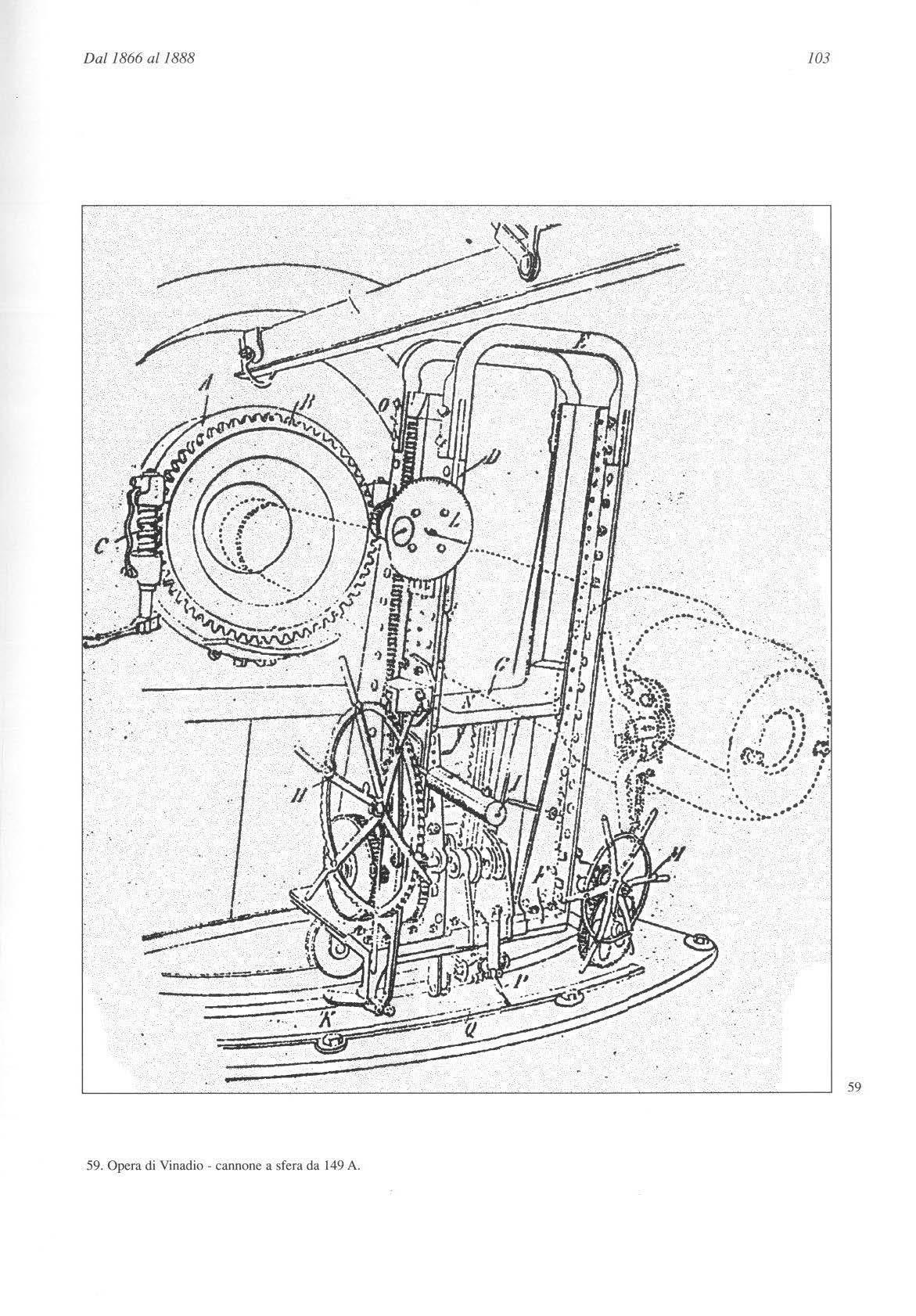
Dal 1866 al I 888 • d i Vinadio - can 59. Opera "era da 149 A. none a s, , 103 . •: •' · .. •, ... .. . ... '......... : .. 59
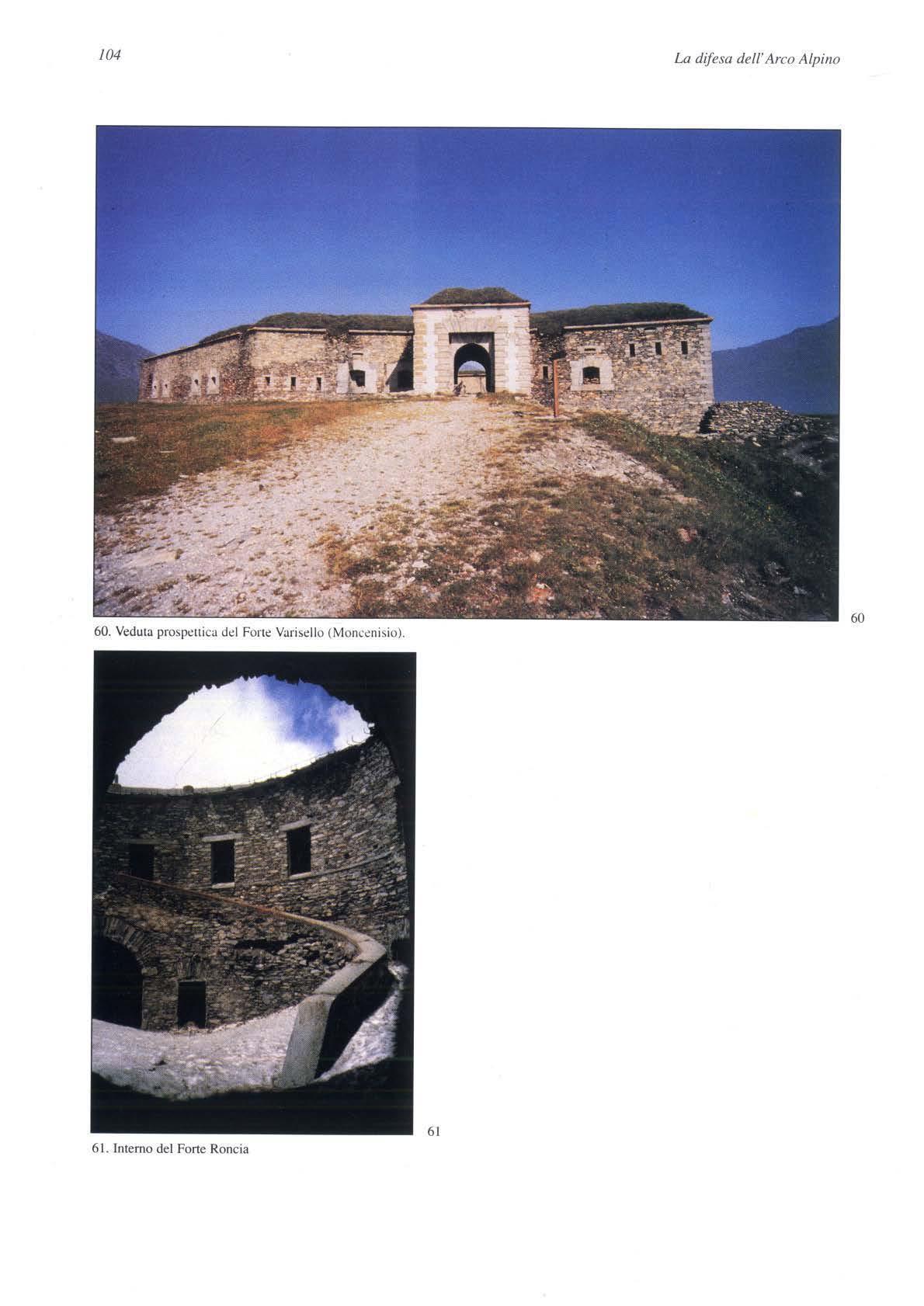
/04 La difesa dell'Arco Alpino 60
61
60. Veduta pro sp.: n ica dt:I Forte Varisdl o ( M oncè ni sio).
61. Interno del Forte Roncia
il perfezionamento del tiro a schrapnel e soprattutto l'introduzione in servizio degli esplosivi dirompenti e l'adozione di spoletta ad azione ritardata segnarono:
- la fine del periodo del campo trincerato, con forti in terra a muro ordinario, alti ed appariscenti rampari, ordinati a cielo scoperto, protezioni realizzate con volte ordinarie a terra;
- la sostituzione di tali materiali con il calcestruzzo, il ferro;
- l'adozione di casematte fisse o girevoli, metalliche per la protezione dei grossi pezzi, torrette a scomparsa o meno per i pezzi rapidi, caponiere metalliche.
Si rese quindi necessario introdurre nella fortificazione radicali trasformazioni che, oltre a.i materiali suaccennati, riguardarono gli elementi costitutivi e la forma complessiva. La trasformazione consi-
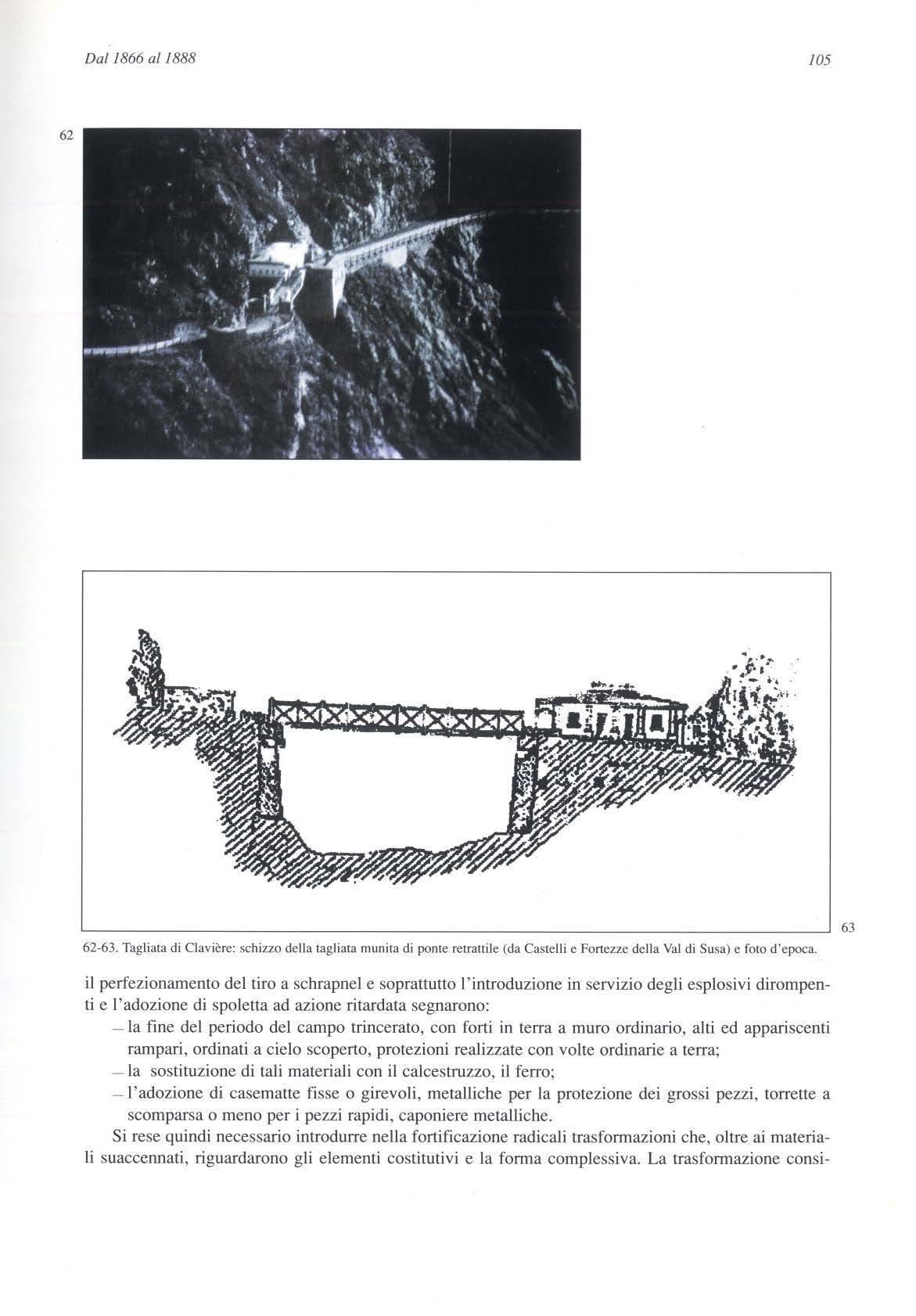
62 Dal 1866 al 1888 105
62-63. Tagliata di Clavière: schizzo della tagliata munita di ponre rettattile (da Castelli e Fortezze della Val di Susa) e foto d'epoca.
63
stette specialmente nel:
- aumentare lo spessore delle masse coprenti;
- adottare l'ordinamento casamattato per le batterie interne ai forti;
- abolire i rivestimenti murari esterni e sostitu irli con altri mezzi;
- accrescere l'estensione delle piazzeforti;
- sostituire i materiali da costruzione con le corazzature e con murature formate da calcestruzzo di cemento.

Non potendo lo Stato permettersi un lungo vuoto temporale nel campo della sicurezza né un esorbitante prelievo nel bilancio, si cercò, anziché di demolirle, di adeguare ai nuovi canoni le opere che fino ad allora erano state costruite o progettate secondo i vecchi sc h emi.
Le principali modifiche che si dovettero introdurre nelle vecchie opere furono:
- diminuire lo sporto s ul piano di campagna per renderle meno visi bili;
- aumentare la resistenza dei manufatti, accrescendo Io spessore dei parapetti;
- aumen tare la potenzialità dell'opera co n:
- l'impiego di torrette per armi a tiro rapido,
- il controllo con armi degli interspazi,
- la protezione delle grosse artiglierie con cupole o il trasporto in batterie esterne,
- la riduzione dei locali alla prova interni e la loro realizzazione fuori dall'opera.
Le operazioni svo lte n el settore nord-est (Verona) riguardarono la trasfo rmazione d ei forti di Ri vol i e Ceraino (cambio delle fronti difensive) e la costruzione ex novo dei forti San Marc o e Masua, delle batterie dal la tagliata d'Inca! e della batteria ba ssa di Ri voli. Sorsero inoltre sulle propaggini dei Lessini, a sbarrare la via agli Austriaci, i forti Monte Castelletto e San Briccio e la batteria Monticelli.
106 La difesa dell'Arco Alpino ,.· -· "" ··., .... -· ·- - -· ·.... , ........... - -· ....... ··•...... ;·· .... ·:·: ~":' .- ......... ""' "" .' .' t" :\ I '· O: ! ~• r.:- :- • ' :.,. ~· ';.,. ..... ' - ~·,,,. ' -~ .__ ______,J64
64. Tagliata alla Scala

Dal 1866 al 1888 107 / N · " ITALIA ,,.,...,. " ., ,,,. o.,. . ' •••• ,., ,,.". FORTE CEBAINO ,.,. "'"'"'~",o 1 • I -I•• c ,il• 1• C A ,_,.,...,••.,. t:•llllll•lll • •• ,, a11 ,:,,u ,., .,.._, ,. , . , .,_, • · ,, e,. ,........ ,. ..... IJGJ\ ,,. ,,. 111.•J • • ,1 •1 4 • 1$A ..-, •U et,,Alt • • • ""'""•1a,f• .. , C•"'"•"'' ..• 65 .roau llVOLI N t r , ,~ . "' ' ,,, o IttLli - Al\ft411. ucr,1ro ,., ., 4• •• G A ; '°' • e,.. f' l • , • ,. "'•"".. " • ,s r. nc.f't,, ' , ,_,_, " e " · r a• e e Ifa J -t - I *• tlC ttC ttu •·,_,,_,, ".. • e ,. "· ••C ft , AH. C' f ". o Il ,,.,.,_,, 66
65. Forte Ceraino: cambio della fronte difensiva. 66. Forte Rivoli: cambio della fronte difensiva.
L'impi ego su larga scala delle costruzioni corazzate nelle posizioni avanza te di frontiera corrisponde al concetto di agire sulle fortificazioni nemiche e di espugn,arte rap id amen te con l'azione cli potenti masse cli artiglieria validamellle proteue.
Quando invece g li sbarramenti non vengono informati al co nc euo strat eg ico dell'offensiva a fondo, l'impiego delle corazzature a protezione dell'armamento può venir limit ato a qualche nucleo o caposaldo della difesa so rgente in posizioni di speciale import anza cd alle opere di interdizione." 12
Stante la posizione dei fo11i di Verona rispetto la linea di confine ed alla loro possibilità di intervento a favore delle truppe italiane, anche a seguito delle polemiche sorte sulla convenienza o meno d e l loro utile mante nimento in servizio (vuoi nella fase di trasformazione di alcuni forti ex austriaci riutilizzabili, vuoi in quella di realizzazione ex novo di alcuni ritenuti indispensabili all'eventuale tenuta del fronte), ci si attenne ai nuovi principi fortificatori, attuando quelli so pra riportati, c he sono opera d e l Gen e rale Rocchi.
Non si ritenne infatti nec essa rio adottare per le artiglierie dei forti di Verona le corazzature previste, non essendo quest e destinate a dare un'impronta determinante all'espugnazione dei forti avversari, né sogge tte ai pericoli a causa d e i quali era conseguita questa rivolu z ione nell'arte fortificatoria.
Si rafforzarono le protezioni e lo spessore delle masse coprenti di terra, defilando l'opera al tiro avversario e proteggendo il personale co n vari rafforzamenti interni (traversoni e paradorsi) e camminamenti protetti, le casematte vennero realizzate solo e d esclusivamente ove ritenuto indi s pensabile.
In montagna si e ra costmito secondo gli stessi criteri adottati in pianura, pertanto le opere di montagna con casematte murarie sorte prima dell"85 si trovarono in condizioni di vulnerabilità analoghe a quelle in cui vennero a trovarsi i grossi forti di pianura con l 'o rdinamento a cielo scope 110, costmiti ne lla stessa epoca.
Si pensò quindi di rafforzare, analogamente a quanto previsto in pianura, le opere con il calcestruzzo, estendendo al massimo l ' uso di protezioni e corazzature metalliche, oppure di disporre in batteri e esterne delle bocche da fuoco da combattimento con pezzi tratti d a ll e opere stesse.
Con questa seconda soluzione si sarebbe venuti ad avere:
batterie collocate fin dai te mpi di pace in posizione dominante per battere con tiro diretto l'aggressore al suo primo apparire;
batterie collocate in posizione na scos ta per battere con il tiro indiretto l'aggressore che fosse riu scito a mettere in batteria proprie artiglierie; in tempo di pace si sarebbero realizzate solo opere murarie e viarie di accesso;
le vecchie opere di sbarramento trasformate in centri di rifornimento per batterie e punti di appoggio per forze mobili.
Ma anche tale soluzione, pur migliore della prima ipotizzata che avre bibe mantenuto le vecchie stmtture grosse e ben visibili, non era l'optimum e presentava numerosi inconvenienti.
Era necessario ispirare la fortificazione in montagna al nuovo concetto secondo cui l'azione di truppe mobili destinate alle operazioni attive e l'azione di quell e destinate alla dife sa d e lle opere avrebbero dovuto sommarsi e compensarsi a vicenda. Ciò sarebbe stato realizzato con l'ordinamento delle strutture fortificate determinato ne l XX secolo.
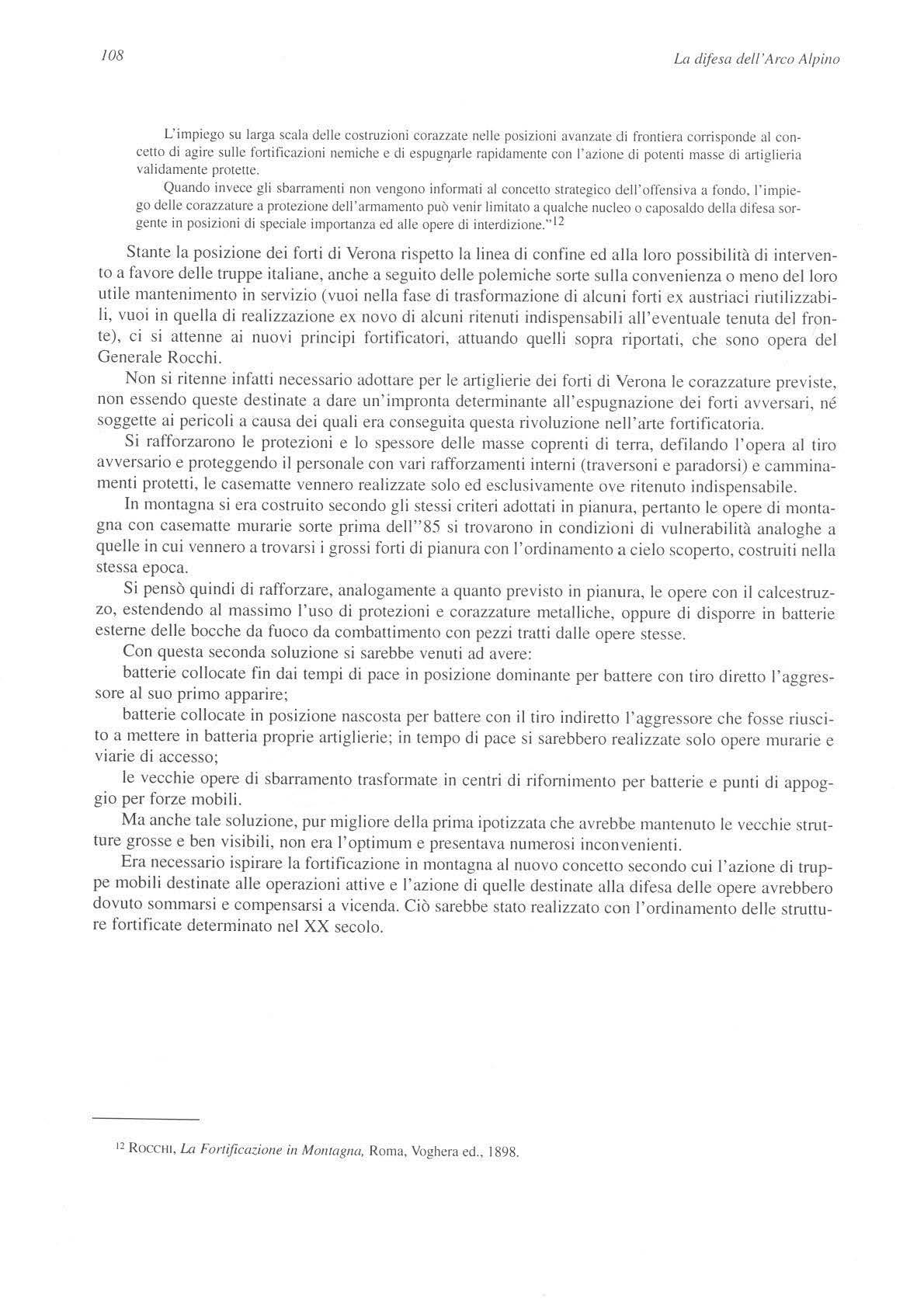
108 La difesa dell'Arco Alpino
12 R OCC HI, La Fortificazione in Mon tagna, Roma, Vogh era ed., 1898.
Tendenze fortificatorie dell'epoca (Tendenze prevalenti nelle organizzazioni difensive a cavai/o della 1• decade del 1900 con particolare riguardo al terreno montano, vista la conformazione del terreno del confine terrestre italiano)
Prende pieno sviluppo ora il concetto del reciproco compensarsi o sommarsi dell'azione delle truppe mobili e quella delle opere predisposte alla difesa.
Ali' inizio delle operazioni saranno le opere opportunamente collocate quelle che varranno a trattenere l'invasore, obb li gandolo a spiegare le proprie artiglierie, mentre eserciteranno su di esse un'azione prevalente sia per il dominio della posizione sia per la priorità de l loro fuoco. YeJTà così dato tempo alle truppe mobili di difesa di raccogliersi, riordinarsi e prendere al momento opportuno l'offensiva. Nel caso questa azione non vi sia e le opere non riescano a impedire l'invasore, entra in campo l'elemento passivo robusto, atto ad arrestare l'invasore e a dar tempo alla difesa di organizzarsi.
L'organizzazione difensiva viene così ad essere su due linee trasversali all'andamento della valle; più avanzate verso il confine le opere di carattere attivo, rappresentate prevalentemente da batterie di medio calibro dislocate in posizione tale da dominare le probabili batterie dell'assalitore (si farà ricorso ad installazioni protette nel caso rigidezza del clima o intemperie possano inficiarne eventualmente l'azione); più indietro, a distanza variabile, in funzione della conformazione del terreno e delle operazioni delle truppe mobili, le opere di sbarramen to o interdizione (elemen to passivo).
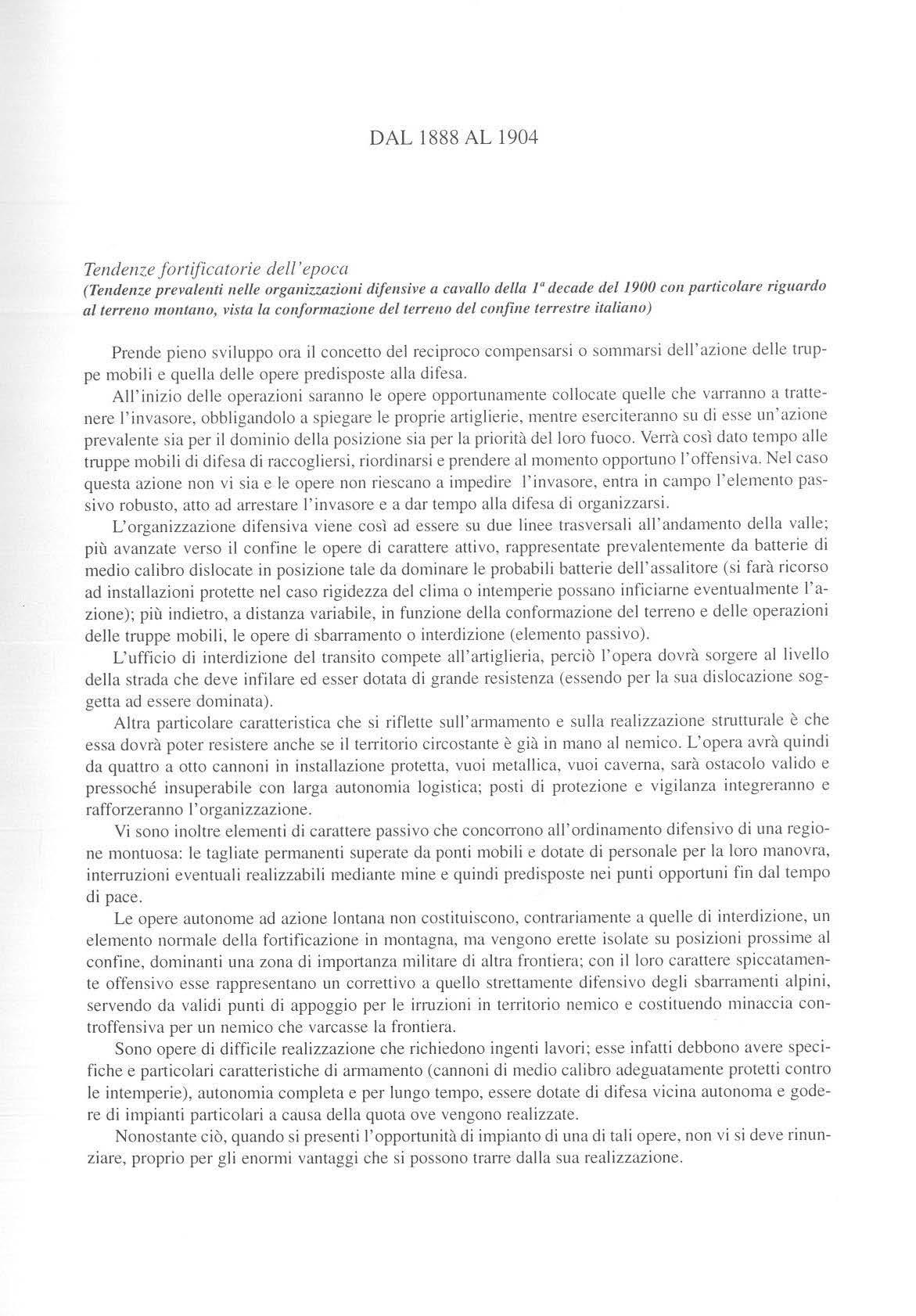
L'ufficio di interdizione del transito compete all'artiglieria , perciò l' opera dovrà sorgere al livello della strada che deve infilare ed esser dotata di grande resistenza (essendo per la sua dislocazione soggetta ad essere dominata).
Altra particolare caratteristica che si riflette su ll'armam ento e sulla realizzazione sttutturale è che essa dovrà poter resistere anche se il teITitorio circostante è già in mano al nemico. L'opera avrà quindi da quattro a otto cannoni in install azione protetta, vuoi metallica, vuoi caverna, sarà ostacolo valido e pressoché insuperabile con larga autonomia logistica; posti di protezione e vigilanza integreranno e rafforzeranno l'organizzazione.
Vi sono inoltre elementi di carattere passivo che concoITono all'ordinamento difensivo di una regione montuosa: le tagliate permanenti superate da ponti mobili e dotate di personale per la loro manovra, interruzioni eventuali realizzabili mediante mine e quindi predisposte nei punti opportuni fin dal tempo di pace.
Le ope re autonome ad azione lontana non cost itui scono, contrariamente a quelle di interdizione, un e lem ento normale della fortificazione in montagna, ma vengono erette isolate su posizioni prossime al confine, dominanti una zona di importanza militare di altra frontiera; con il loro carattere spiccatamente offensivo esse rappresentano un correttivo a quello strettamente difensivo degli sbarramenti alpini, servendo da validi punti di appoggio per le inuzioni in te rritorio nemico e costituendo minaccia controffensiva per un nemico che varcasse la frontiera.
Sono opere di difficile realizzazione che richiedono ingenti lavori ; esse infatti debbono avere specifiche e particolari caratteristiche di armamento (cannoni di medio calibro adeguatamente protetti contro le intemperie), autonomia completa e per lungo tempo, esse re dotate di difesa vicina autonoma e godere di impianti particolari a causa della quota ove vengono realizzate.
Nonostante ciò, quando si presenti l'opportunità di impianto di una di tali opere, non v i si deve rinunziare, proprio per g li enormi vantaggi che si possono trarre dalla sua realizzazione.
DAL 1888 AL 1904
Situazione fortijicatoria ai confini all'indomani dell'evoluzione tecnologica del 1885 (raffronto fra le opposte strutture)
Seguendo l'evoluzione dei tempi e quindi adottando tutti i ritrovati che la scienza fortificatoria offriva, l'Italia, fresca di unificazione, cercava di fare il punto allo scopo di poter realizzare un sistema fortificato difensivo che le cautelasse le frontiere nell'ambigua situazione politica del momento che la vedeva legata a Germania ed Austria con il trattato della Triplice, ma moralmente allineata con chi le faceva balenare la possibilità di raggiungere gli agognati confini naturali.
Questa attività fortificatoria italiana stimolava le nazioni contermini a dotarsi di analoghi sistemi difensivi atti ad impedire eventuali attività offensive italiane.
Facendo ampio ricorso ai lavori specializzati prodotti nell'ultima decade del XIX secolo possiamo avere un quadro sufficientemente esatto della situazione fortificatoria sui confini italo-francesi, italosvizzeri ed italo-austriaci.
A - Confine italo-francese
Se si esamina il grande libro della storia si può vedere come acuto sia sempre stato il contrasto tra la Francia ed il Regno sardo-piemontese. Temporanee alleanze di comodo non inficiarono tale continuo contrasto che vide il confine dei due stati alternativamente spostarsi su e giù per il Piemonte. Reintegrato il confine ai primordi con il trattato di Utrecht, la sistemazione territoriale venne sconvolta da Napoleone I, che sfogò il suo livore per la resistenza oppostagli, facendo saltare i forti di Bard, Demonte e della Brunetta. I risarcimenti imposti vedono la ricostruzione e il potenziamento delle strutture fortificate al confine con la Francia e se l'alleanza con Napoleone III ottenne l'astio, l'appoggio dato al Papa lo rinfocola.
Poiché il contesto di politica estera entro il quale si inseriscono i lavori della Commissione Suprema per la Difesa dello Stato italiano era inequivocabilmente delineato dall'entrata dell'Italia nella Triplice Alleanza e dall'assunzione da parte della Francia della veste di potenziale avversaria, questa non stette con le mani in mano a fronte dell'attività fortificatoria dello stato italiano.

Un addetto militare francese scriveva al suo governo:
"Dcpuis plus de vingt an s l'ltalie, pour ainsi dire hypnotisée par la presque eertitude d ' une guerre avec la Franc e. n 'a, quand il s' agissail d' armament sur terre et sur mer, jamai s, envisagé une aut re hypothése:· 1
Il logico sbocco in territorio francese di un'azione offensiva lungo il solco della Durance era Briançon, superata la quale si poteva giungere a Marsiglia, Grenoble ed aggirare il Monginevro, mentre quella lungo la Cornice era il nizzardo.
Venne quindi posta in essere un'attività di creazione e potenziamento delle strutture di sbarramento allo sbocco della Cornice e si potenziarono le strutture della piazzaforte di Briançon, nata per opera del Vauban agli inizi del 1700 e sempre potenziata.
Ed ecco per la penna di Giuseppe Fornasari, nobile von Yerce, riportata nella Rivista Artiglieria e Genio del 1890, la situazione fortificatoria alle frontiere francesi-italiane in un valido esame minuziosamente compiuto nel I 889 su entrambi i versanti:
"La fro111iera italo-francese è determinata pressappoco da quella pane della catena principale delle Alpi che dal Monte Bianco si protende verso il Mongincvro ..:d il Monviso ed arriva quindi fino alla costa ligure. Dal Monte Bianco fino a Mcntone sul mare vi sono 32 miglia geografiche in linea retta, ma lo sviluppo della frontiera era di circa 55 miglia. Pochi i punti di valico di queste aspre montagne.
Le cime più alte: al nord il Monte Bianco che si eleva di 4810 metri sul livello del Mediterraneo: al centro il
110 La difesa dell'Arco Alpino
1 GooCH, l ' lwlia c ontro la Francia 1870-1914, in ··Memorie Storiche Militari'', 1980 Roma, SME ed., 1981 :
Monte Tabor (3 I 75 me t r i ) cd i l Monviso (38 I 5 met r i): al sud la roc.:ca dcli' Arge nti era (3900 me tr i ) ed il Monte Clapicr p resso il Colle d i Tenda (3046 metr i ) i pun ti d i passaggio ai quali le strade m i lit ari conducono hanno altezze va r iabi li fra i 1900 ed i 3000 metri.
Dalla pa n e della Francia il terreno fra le Alpi ed il Rodano cos titu i sce una larga zona montuosa in c.:ui all e alte catene succedono quelle di media altezza e, poic hé le principa li vie di com un i caz i one seguono i l l un go e tortuoso co r so delle infrappos te vallate, ne consegue c he l e operaz i oni m i li ta r i per l 'invas i one del terri torio francese riescono diffic il i. t an t o p iù che, in mass im a, queste vallate sono divergenti. Occorrono non meno di sei o selle giorni per usc.:ire da questa zona montuosa
Molto p iù ristrella è invece l a zona montuosa nel territo r io ita li ano In molti punt i la tfotanza dalla frontiera al l a pianura de l Po è d i soli 30 km., e quind i con una so l a g i ornata di marcia si può scendere pe r ..:se111pio dal Monviso nella pian ura i ta li ana. D i p i ù, le vallate in c.:ui corrono l e vie prO\'en i ent i dai valic hi alpin i sono convergen ti verso l a pia nu ra del Po e per conseguenza resta faci lit ato il concentramento delk forzo; eh..: pe r invadere il ter rit o r io italiano riescono a passare la front i era in d i ver~ i pumi.
Mo lt o pi ù vantaggiose ernnu le co nd i zion i topogr;1 i1 c.:he p..:r l' I talia prima che i.:ssa cedesse nlla Francia J\izza e l a Savoia, dappoiché il concentramento ddle sue forze po teva !'arsi in posizion i molto più all'occidente, cioè al di lì1 di qu..:i pass i alp in i che ora ~o no in potere del l a Fra nc i a: ed in vero sul confine nord il concentrame nto poteva farsi ad 0110 miglia ti.i Lioni.:. in linea n;:ua, e sul c.:o nl1n..: sud-O\'CSt a dodici miglia da Lione e sedic i da Marsiglia.
Col l a Savoia J' I talia pi.: rd ellc il suo sbocco ni.:11' in tcrno della Francia; co n 1\iua I.i sua base per un 'operazione offe nsi va c.:o nt ro :vlarsiglia e le bocc he del Rodano. e con l a pe rdita cli entrambe queste prov in c i e è d i \'e nu ta m o lt o di rtk ile per l ' I talia una marcia strategica pi.:r raggiungi.: re il vi.:rsnnte occickncale de ll e A l pi, poiché il passnggio di questi monti dovrà farsi cl i viva forza. qual unque si a il punto della frontiera che sari1 sce lt o.
Ne consegue che l e operaz i oni offe nsive riescono multo pit1 diffici li ali' I talia che non alla Francia ..:d infalli fucendo astrazione tlalle fer111ate tlovute alla resbtenLa delle fort i ficaLion i e delle l'orL<:! 111obil i , l e t ru ppe francesi possono. dopo passata l a frontiera, superare in uno od al massimo in tlue g i orn i di marcia tulle le cl i fficoltf1 inerenti ai t er re ni montuosi, mentn.: che un es..:rc it o i t ali ano c he abbia oltr..:passatu l a front i..:ra. ~i troveril tlavanti uri'estesa zo na montuosa, attraversa r la quale occorri.: non mi.:no d i una scn i111 ana.
La Francia ha pure cos tru lla favorevolmeme la sua rete ferroviar i a pe r le operaz i on i militari.
Dal tronco Marsig li a-Maçon si staccano sei strade ferrate nella d ireL i one dei confin i. D u..: cli ..:ss,.; costillliscono l e principali art er i e c.:o m mcrciali e passano le front i ere, ci oè l a linea Lyon-Torino e qu ella lungo l a rh·icra Marseille-Genova, unn ter,a linea lungo l a va ll e dclla Durance rennina imm ed i.i t ame nt e ,ono la frontiera con la staz i one fort i licnta di Briançon. I noltre dalla lin ea Lyon-Torino si distacca presso Montmé li an u na diramaLione che co nduce ad A l ben ville sull' lshe Anche A Ibere ville è stata ro n i lk.i t a. trova ndosi ad un nodo cli vall i. F in al me nte trovasi in eo~t ru z i one u na diramazion..: della f'i.:rrovia Durane.:,.:, l a quale condurri, n..:lla va ll e ùell'Ubayc.
Meno favorevo li.: ~i presenta i l t r acciato delle ferro\'ie francesi che corrono parallelame nte al fronte a causa delk i mp o ne nti diramaz i on i al pine che si.:parano l'una dall'altra l e diverse vie le quali nella d irezionc ovi.:st - est co nducono ai confin i. Troviamo infa u i l a rerrovia Mnr$e il k-S i steron-Grenoble. l a p i ù p ro~sima alla from i era, chi.: ne d i sta dalle dod i c.:i all e quindici m i glia in l inc:a n.: ll a. sicc.:h.S mentre può r iuscire oppo rtun a p..:r la di ren~i va. ri m ane troppo l o ntana per le az i on i offensive
Nell'alta I tal ia vi sono quauro strade p rin c ipali c he cond ucono verso l a fron tiera. Due, già innanzi menzio nale, passano nel te r r it or i o rrancese, l'una che è la p i ù se tt entrionale, parte da Torino e trav..:rsa il Monceni~io, l 'al tra che è la più mer idionale, pane dn Genova e, costegg i ando il mare, t ravi.: rsa pa r imemi la rront i cra. Dalle su d de ue qu allro strad e p r incipali se n..: d i ra mano altre secondarie che cond ucono agli sbocch i del l e va lli di co nfine. In complesso la r ete ferroviaria dell'alta It ali a è molto fitta e malgrado l a direuosa cos truLio ne della maggior parte delle sta, ioni e delle molte linee ad un solo binario, perme1te u n rap id o conc.:entramenlo di forze verso il con fin e, e a tale scopo si presenta m o lt o opportu na l a l in ea I vrea-Tor in o-Cuneo.
In en trambi i te rriwri d i confinc k principali v i e di comu nicazione furono sbar rat e r iattando gl i anti ch i forti e specia l mente cos tru endo nu ove open;: di roniricazioni.:. e in ta le l avoro i francesi spiegano l a st essa grande attiY i t i1 dimostrata nel fon iric.: are i co nrin i w r so la Germania.
For1ifica::.io11i nel 1erriloriu del cv11jì11e .francese

Per r enders i conto delle fortilìcazio ni costrui te nel territorio fra ncese, sarà bene considerar le in re l az i on..: con le vie d i comun i cazione che esse debbono sba rra re o dom i na re: e pe r procedere co n me t odll, si proceder:1 con le st rade del Nord e m an mnno si procederà verso il sud, s..:nza tralasciar<.:, per u lt i mo, J'es::1111e dei pun ti fort i fica t i in seconda e terza lin ea.
Gruppo d i strade al nord
La pr in c ip al e strada d i questo g ru ppo è quella de l Piccolo S. Bernardo. che pane dalla piav:aforte di A l be rtvill e, ad or iente di Charnb..:ry: serpeggia nel l a tortuosn valle dell'Jsèn: (Tare nt ai se) ristr..:lla fra le al t e mon-
Dal 1888 al 1904
I Il
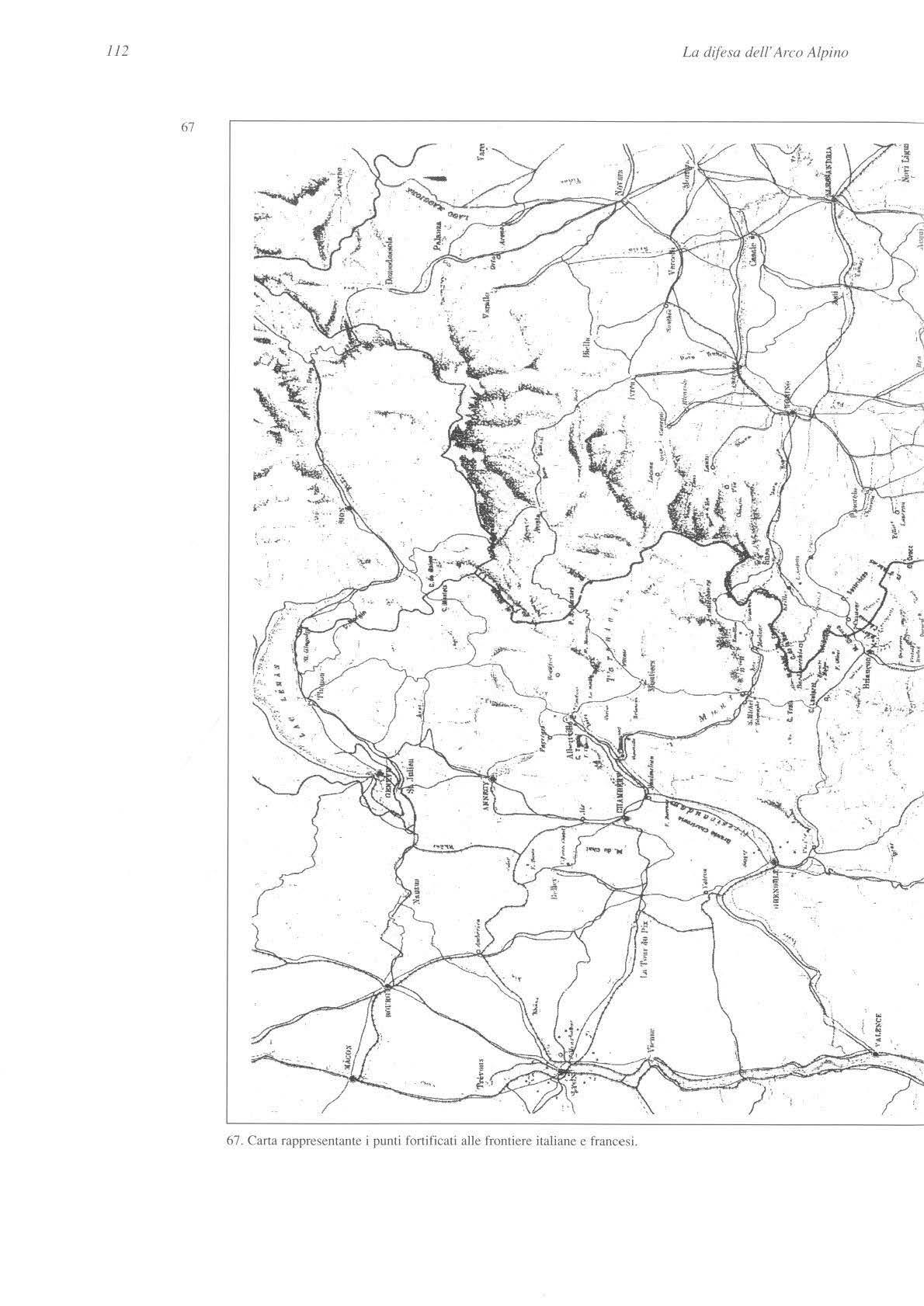
112 La difesa dell'Arco Alpino 67
67 . Carta rappresentante i punti rortificati alle frontiere italiane e francesi.
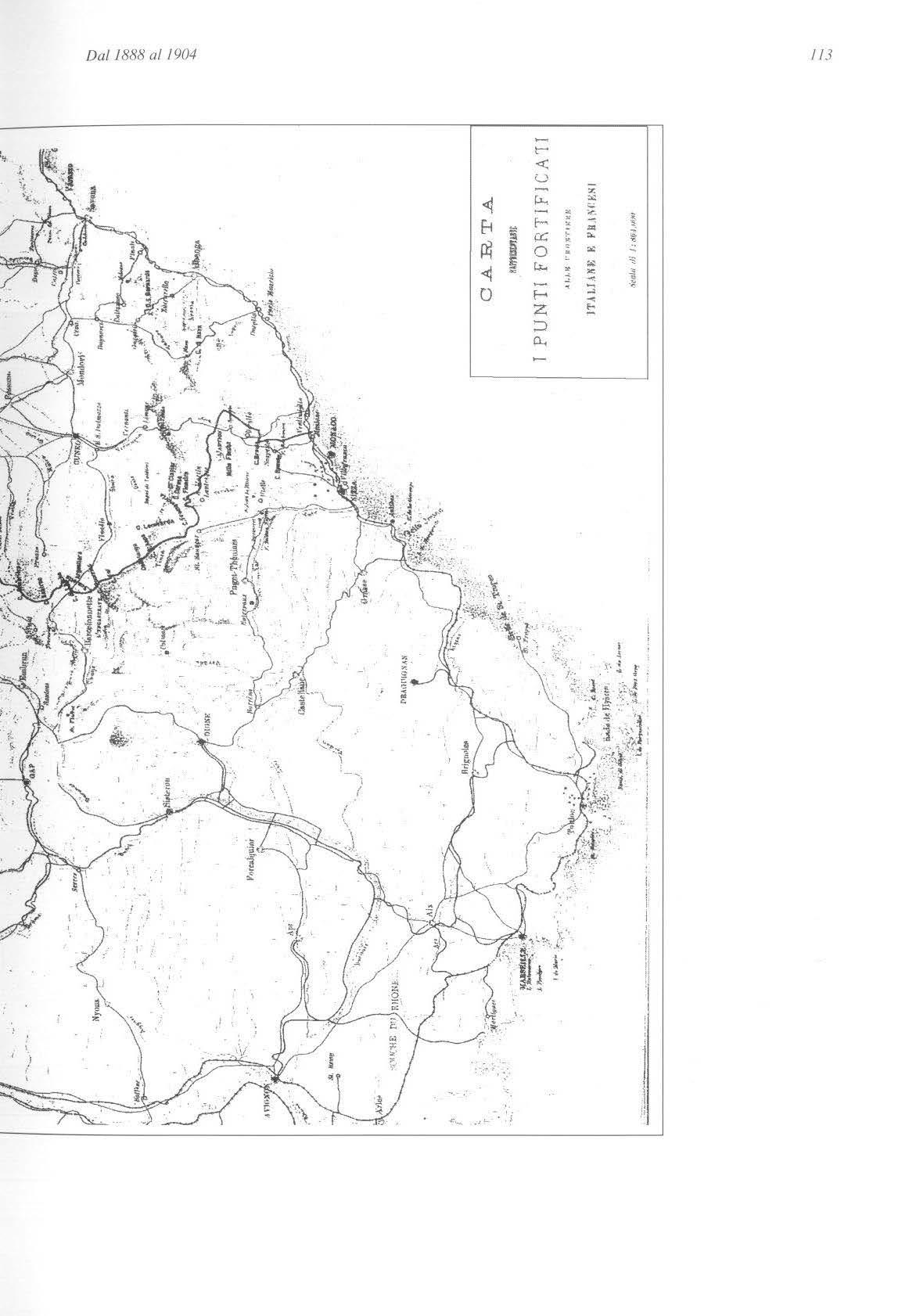
Dal 1888 al 1904 113i~ tl· o :,; µ... ,.,i 8 s E- "' çc ... JìÌ fi " o "" i c... <tj " >e . .. ..,, .i o . ·:r E- ... .., z t o..
tagne e cond uce al passo del Piccolo S. Berna rdo (2 192 metri). traversa qui nd i il confine e sboccn nella Va ll e d'Aosta. Presso questa via rotabile vi sono due strade mul att iere che da Saint Maurice vanno al di l à de l confine. l e quali però nelle part i più basse sono rotab i li. En trambi g i rano il p i cco l o S. Bernardo e conduco no parimenti nella va ll e d'Aosta. ed invero quell a p iù a nord co r re per le fa ld e mer idionali del Monte Bianco e riesce sul colle Seign e quella più al sud corre l ungo l e falde sette ntr i ona l i de l ghiacciaio Ruitor.
L'Osp i zio del piccolo S Bernardo, sebbene situ ato sul versante francese. è possedimento italiano Le condizioni topografic he del passo del piccolo S. Bernardo e della retrostante valle dell ' l sè re si prestano poco al l a difesa. La spia nata d i Vulmis presso Bourg Saint Maurice. la posizione presso Villette. quella del Pas-du-Ciel in v i cinanza di S. Marce!, i passi di Briançon, della Roche-Cevins, della Bathie. so no per loro stesse delle buone posiz i on i d i fe nsive: se nnonché l a configuraz i one a terraa i di en trambi i pend i i della valle, per i quali corrono vie parallele a quella principale, rendono possibi l e il domin i o su tutte le opere d i sbarrame nt o e di difesa che si potrebbero attu are.
Per conseg uenza so l o presso Contlans ove il fiume Arly sbocca nell'lsèrc. s'i ncon trano le p r ime opere fortificatorie.
I n questo terr it or i o, nell'anno 1815. i'u fatta l a difesa dello sbocco delle va ll i 1àrantaise e d i Beaufon sull a dest ra r i va del fiume Arly.
Le fortificaz i on i che si sono stabilite per avere il domin i o di questo nodo di va ll i, si possono dividere in tre g ru ppi, e cioè:
-l e opere p resso Conlla ns sull'altura compresa fra l e valli Tarantaise e Beauf'ort:
-l e opere sulle alture del Tali, all a des tra riva dell' A r ly;
• le opere al co ll e cli Tamié, per il quale passa una strada che cond uce a Faverges
Fra quesli tre gruppi è si tu ata la città cli Albcrtvi ll e. la quale. è congiun ta alla ferrovia del Moncenisio per mezzo di una d iramaz i one che passa per Cha mausset.
1° grnppo Alla riva si nistra delJ'Arly. sulla spianata dirimpell o ;id A l benvil l e. giace il vi ll aggio Contlans ed al margine orie ntale della medes i ma si trovano le tre batterie cie l Forte Vecc hio, de l Cas te l Rosso e del l a Spianata, l e qua li. insieme con un ridono retrostante. battono l a valle Tarentaise. A l nord di Conlla ns. su l le alwrc comp rese fra le val li Tarentaise e Beaufort. è situato il forte del Monte che, mentre assicura i l possesso delle alt ure stesse. dom ina le due vall i
2 ° gmppo. Sulle pendici se ttentrionali del Monte Tali v i sono: - i l forte di Lestal con una ba tte ria annessa: esso batte lo sbocco della valle di Arly e parte della valle stessa nonché la sinu os i tà della strada che da Ugncs mena a Queige e difende ez i andio la s trada che mena verso FavergesAnnecy. cioè verso la con trada più ricca della Savo i a; - la batteri a L ançon , al centro del si stema baue l o sbocco della va ll e di Beaufort: -l e tre ba tt erie della Grances ed i l forte Villard Dessous alle pe ndic i merid i ona li delle alture stesse, battono l o sbocco della va ll e T arentaise.
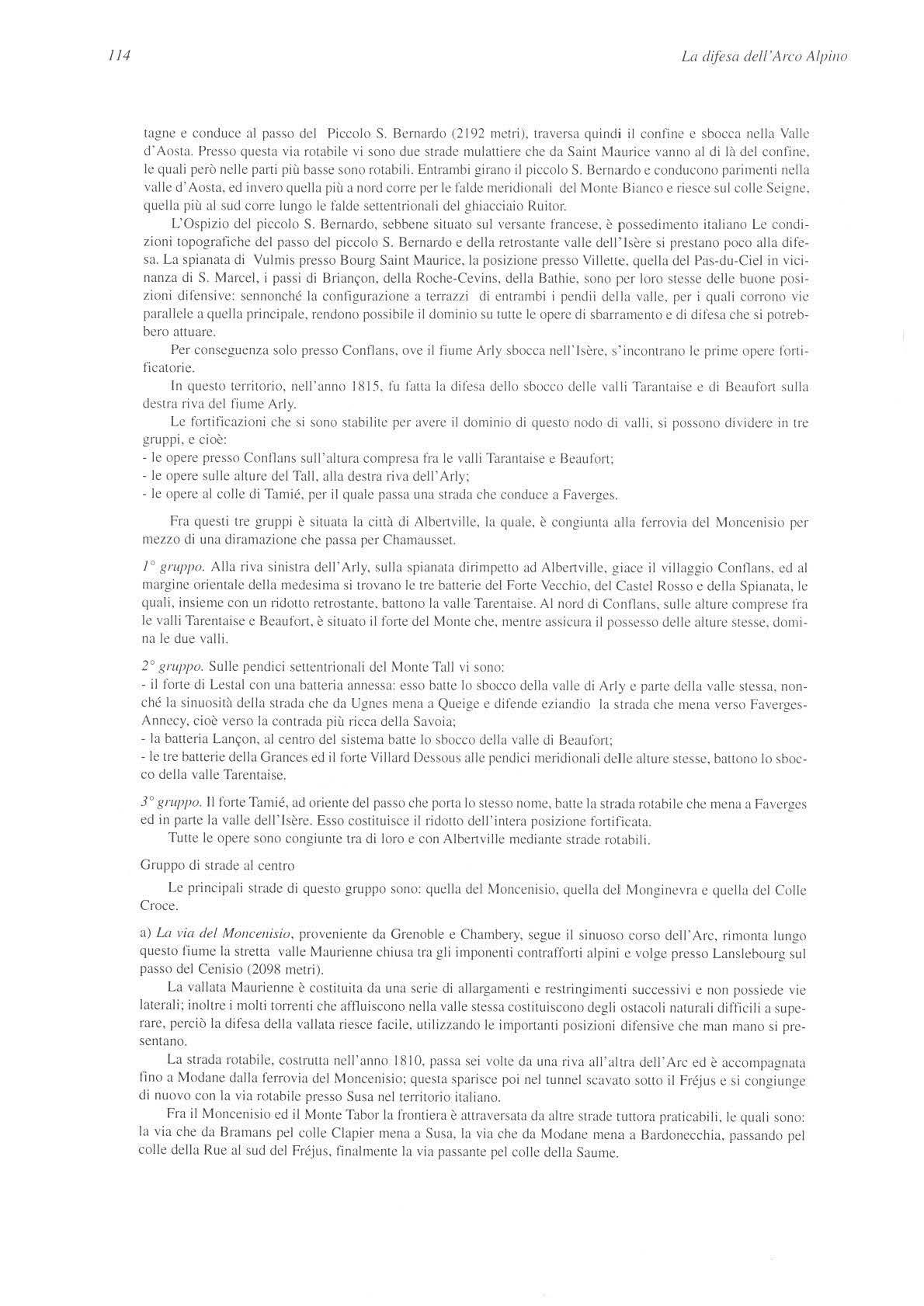
3 ° gruppo. Il forte Tamié. ad o r iente cie l passo c he porta l o stesso nome, batte la strada rotabile c he mena a Favcrges ed in parte l a valle dell'lsère. Esso costi tu i sce il r id otto del l 'i ntera posizio ne fort i fica ta.
Tu tte l e opere sono co ng iu nt e t ra di loro e con Albertville mediante strade rotabili. Gruppo d i strade al centro
Le principali strade cli questo gruppo so no: quella del Moncenisio. quella del Monginevra e que ll a del Co ll e Croce.
a) La via del Mo11ce11isio. proveniente da Grenoble e C hambery, segue i l sinuoso co r so dcli' Are. rimonta l ungo q ues to fiume la st retta valle Maurienne c hi usa tra g li i mponenti contrafforti alpini e volge presso L ans lebou rg sul passo del Cenisio (2098 metri).
La va llat a Maurienne è cos ti tui ta da una se r ie cl i allargament i e restr ing im enti success i v i e non possiede vie laterali; inoltre i molti to rren ti che afflui sco no nella va ll e stessa cos ti t uiscono degli ostacoli nalllral i d i ffi ci li a superare, perciò la d i fesa della vallata ri esce fac il e, utili zzando le imp o rt an ti posizioni difensive che man mano si prese nt ano.
La st rada r otabi l e, cos tru ua nell'an no 1810, passa se i volte da una r i va all 'altra deJl'Arc ed è accompag nata fin o a Modane dall a ferrovia del Moncenisio; questa spar i sce poi nel tunnel scavaw sotto il Fréj us e si congiunge di nuovo con la via rotabile presso Susa ne l territorio italiano.
Fra i l Moncenisio ed il Monte Tabor l a frontiera è attraversata da altre strade tu ll ora prat i cabi li. l e quali sono : la via che da Bramans pel colle Clapier mena a Susa, la via c he da Modane mena a Bardonecchia. passando pe l colle della Rue al sud del Fréjus. finalmente la via passante pe l co lle della Saumc.
114 La difesa dell'Arco Alpino
Per la difesa della valle Mauricnnt: vi sono tre gruppi di fortificaz i oni
I Il gruppo dell'Esseillon. Esso è costituito da opere antiche e recenti.
Le opere antiche costr uit e nell'anno I 815, per cura del governo sardo, si trovano alla riva destra dell' Are al nord-est d i Modane su di una spianata lunga 1500 metri, larga 100 metri, limitata all'ovest. sud cd est da rocce a p i cco. Essa chiude comp l etamente l a valle. l asciando libero per la strada so l o u no stretto spazio sulla riva sinistra dcli' Are. Queste opere sono congiunte con muri a ferito i e e fanno fronte verso la Francia contro cui vennero costruite. Esse sono:
- il fo rte Carlo Alberto posto nella pane più seuentrionale ed eleva ta della spianata ha una certa importanLa, perché da esso so l o si balle bene a monte della va ll e in d ire1. i one della l oca li tà denomin ata Aussois;
- il fo rt e Maria Cristina prossimo al precedente a li bero campo di t ir o verso i l tunnel del Fréjus;
il forte Carlo Felice più sotto dei precedenti , all 'orl o occidentale della spia nata fu in parte demolito;
- il fo rt e Yillorio Emanue l e per i suo i molti ricoveri a prova di bomba è il più i mportante ed è d i facile difesa. Esso batte bene la strada rotabile e le pani più basse della vallata, ma non ha azione sulle parti alte della medesima;
- la to rre Maria Teresa con annesse case m auc sbarra l a strada che conduce all a riva sinistra dell ' Are.
Con opponune modificazioni q ues te opere di sbarramen to potrebbero raggiungere grande importanza. poiché ostru i scono comp l eiame nte la vallata.
Le opere di recente costruzione sono :
- i l forte Replaton al nord di Modanc;
- i l forte Sappcy al nord di Fournca ux essi servono a di lcndcre l o sbocco del tu nnel.
2. li forte Rocher du Telegrap he situato sul l 'altura dello stesso nome, al sud -est di S. Miche ! sbarra la valle pr incipale e difende le due strade trasversali che si diramano da S. Mic he], l ' u na al nord che mena a Moutiers (ne l la valle Tare ntaise) passando pel co l l e des E ncombres, l'altra al sud che mena nella valle Romanche passa ndo pel colle des Trois Croix. col l e du Gablicr e colle du Lautarct.
3. Le fortificazion i d i Aiguibelle e C harnousset, si tu ate l à dove l a stre u a va ll e Maurienne sbocca nella la rga valle dell'lsère, difendono questa imponante posizione, l a quale viene anche ch i amata posiz i one fortificata di Chamo usset.
Le opere di questo g ru ppo g i acciono parte sull a riva destra, pane sull a riva sinistra cieli' Are. Le:: opere sulla riva destra si e l evano su quella cresta del monte A re, che dall a sua cima va dec l inando al sud - oves t verso la l ocalit à deno min ata Ai ton. Esse sono :
- batteria Aiton al sud di ques to villagg i o situa ta in basso e che infila lo sbocco della va l le, l a strada e la ferrovia;
- batteria de l a Téte Noire ad i acente al villaggio A i to n. batte l a valle e l e pendici fra Mongi l ibert e Aiguibelle;
- batteria di Frépertuis, cost rui ta a ten-azzi al sud-est della preceden te, è destinata ad operar,;: contro l e part i su perior i della va ll e; forte di Mont Perchet, c he ha maggior domini o. è destinaw. assieme all'opera denominata Crépa. ad assic urare il possesso dcJle alture cd ha pure azione dirt:tta co ntro i punti che hanno dominio sull e alture stesse;
- l'ope ra du Crepa ha la sua principale azione verso i l sud, domina la vaJJe al sud di Randens. prende di fianco l e posizioni che potrebbe occ u pare il nem i co all e falde sud-oves t del mont e Are e batte pure:: il pc:: nd i o occ i de nt al e delle alture del v i c in o gruppo c he non è ba llu to dagli altri fort i.
Le opere c he si trovano suJJa riva sinistra cieli' Are sono erette sulla cresta dell'altura c he trovas i a sud della l ocalità Mongilibert ed Aigue be ll e e si posso no dividere in due g ru ppi secondar i : quell o più avanzaw, sul l a cresta principale, è cos titu it o dalle opere cos id dell e di Tete-Lasse, le quali sono: l e batter i e del Foyatier, di S. Lucie, di Tele-Lasse, e d i Rochcbru nc. Esse batto no l a valle Maurienne e le sue va ll i seco ndari e.
Il secondo gruppo ad est del p recedente, diviso da q uesto da un'insellatura, comp re nd e i l forte di Mongilbert con hauerie annesse e l a batteria di Planchaux. L'ultima prende d'infilata lo spro ne mer idi onale deJJ'altura e batte i passagg i sui co l li del piccolo e grande C uc hero n Il fo rt e Mongilbert cost itui sce i l ridotto d i tutt o il g ru ppo; appoggia l'azione deJla batter i a; domin a in gran pane l 'altura ed insieme:: all a batteria imped isce d i gira re lo sbocco della st retta; sba r ra ndo la via che a fa r c i ò si dovrc::bbe perco r rere. perché essa via passa appu nto per l' in sel l atura su cui detto fone giace.
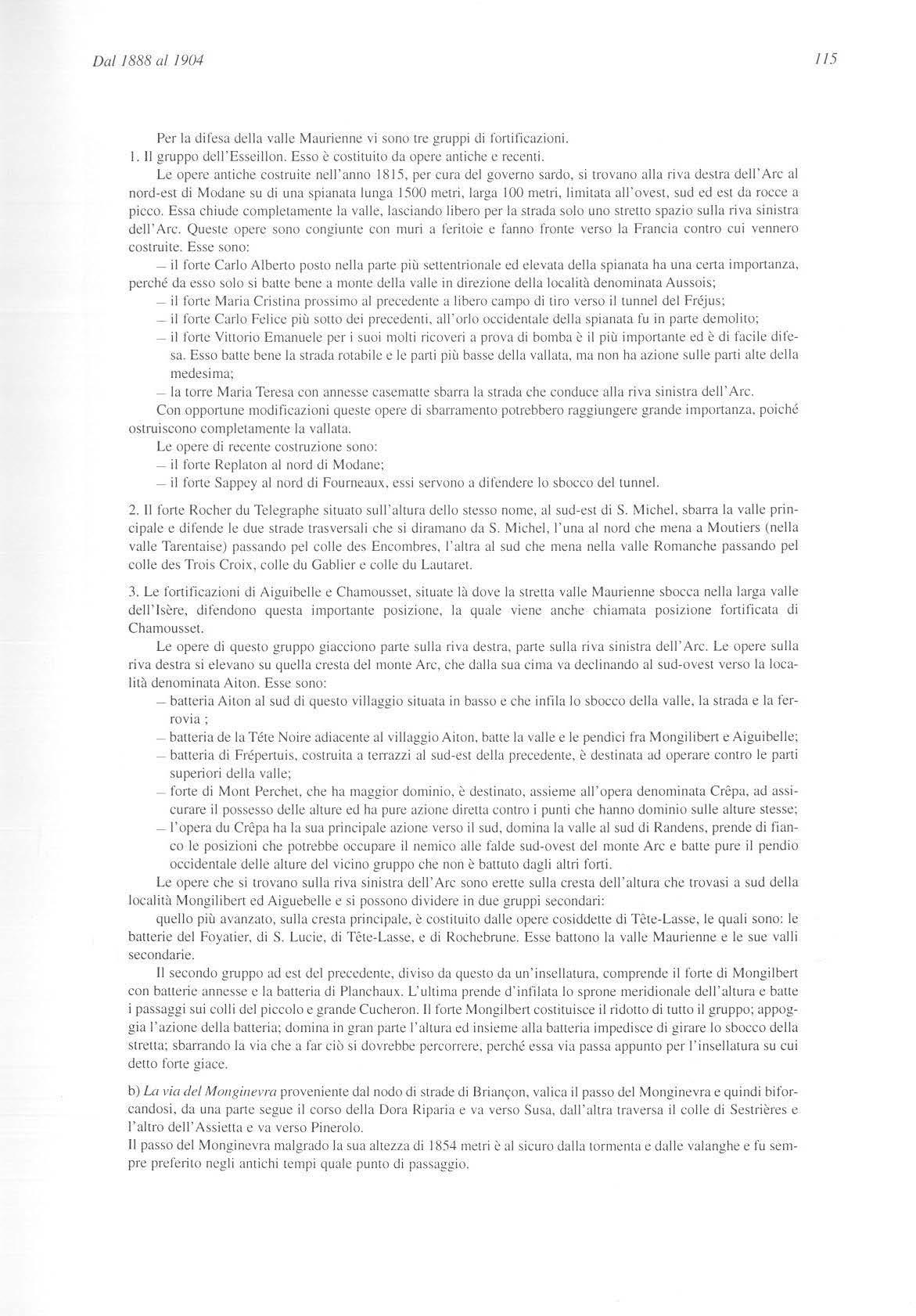
b) La via del Mongi11el'ra proven i ente da l nodo d i strade di Briançon, valica il passo del Monginevra e quindi b i forca ndosi, da una parte seg ue il corso del l a Dora Riparia e va verso Su~a, da ll 'a l tra traversa il colle d i Sestrières e l'altro del I ' Assietta e va verso Pinero l o.
Il passo del Mongincvra malgrado l a sua al tezza di 1854 metri è al sicuro dalla tor menta e dalle va l anghe e f u sempre preferito neg li ant i c hi tempi quale punto d i passagg i o.
Dal i 888 al 1904
-
J/5
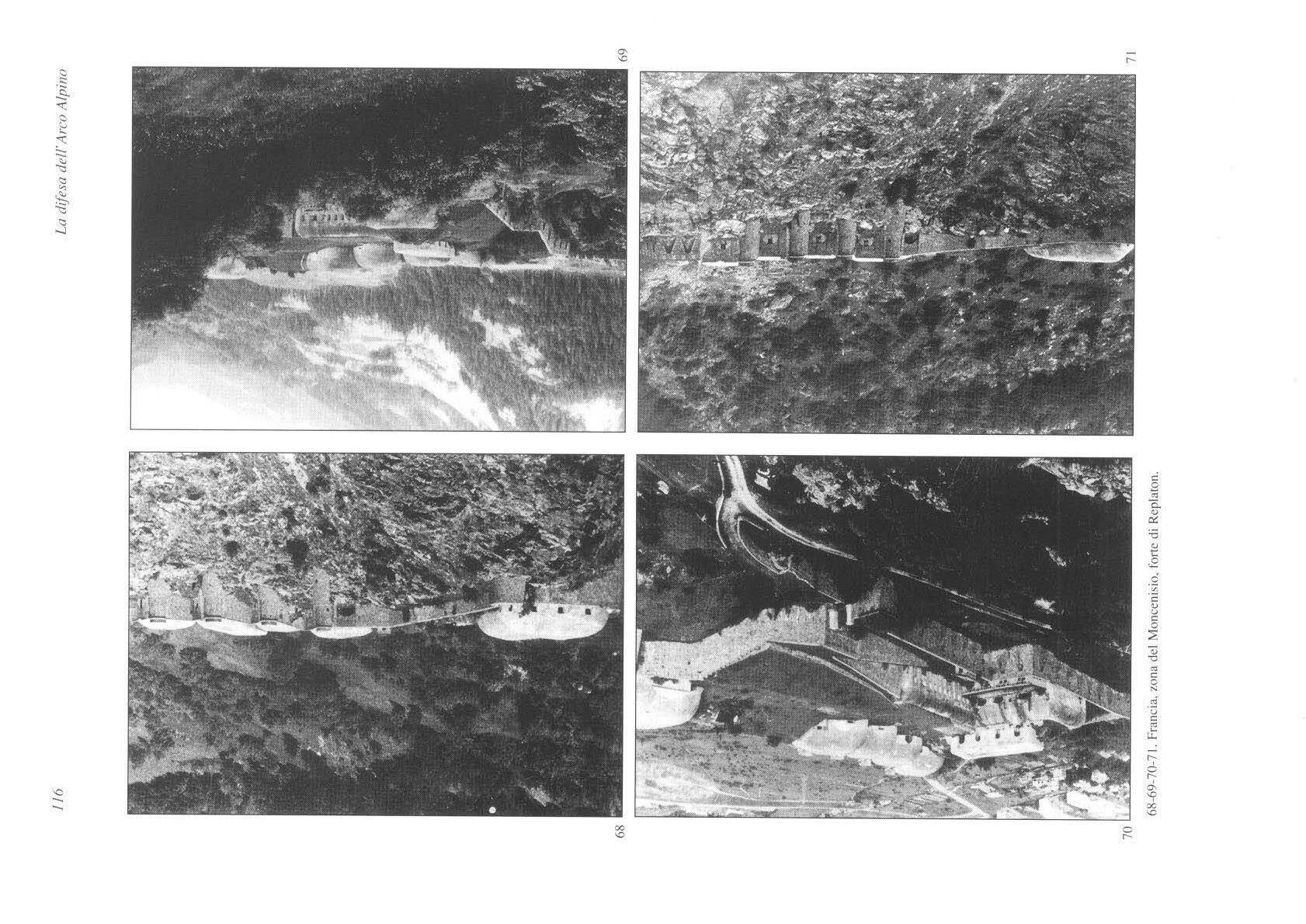
l/6 La difesa dell'Arco Alpino 68 69 70 71 68-69-
70-71.
Francia, zona del Moncenisio, forte di Rcplaton.
Presso il medesimo altri pas saggi secondari traversano la frontiera: due sono al sud provenienti dalla valle laterale della Cerveyrette passanti uno per colle Gimont. l'altro pel colle Bouson; ed entrambi possono essere resi praticabili pei carri. Altri sentieri s ono al nord e permettono passare dalle valli di Névache e Clarée nelle valli di Oulx e Bardonecchia, però la più importante di que ste comunicazioni è quella che passa pel colle de L'Echclle, che facilmente s i rende praticabile alle bestie da tiro e per mezzo di essa si giunge alla posizione Malpas. da cui si può vedere la stazione di Bardonecchia.
La via del Monginevra s i biforca nel territorio francese pres so Briançon. Il ramo nord, chiamato via del Lautaret. rimonta la valle della Guisane. sorpassa il colle del Lautarct, scende nella valle della Romanchc e va a Grenoble. li ramo sud percorre la valle della Durance, segue il corso di questo fiume. e fino a Savines è accompagnato dalla ferrovia che irmanzi si ebbe occasione di citare.
Nella valle della Durance si incontrano parecchie buone posizioni difensive, tra cui la stretta al sud di Briançon. il défilé di Pertuis - Rostan presso Queyrieres. la spianata di Réotier. la posizione presso Mont Dauphin, e molto più a valle la chiusa di Sisteron.
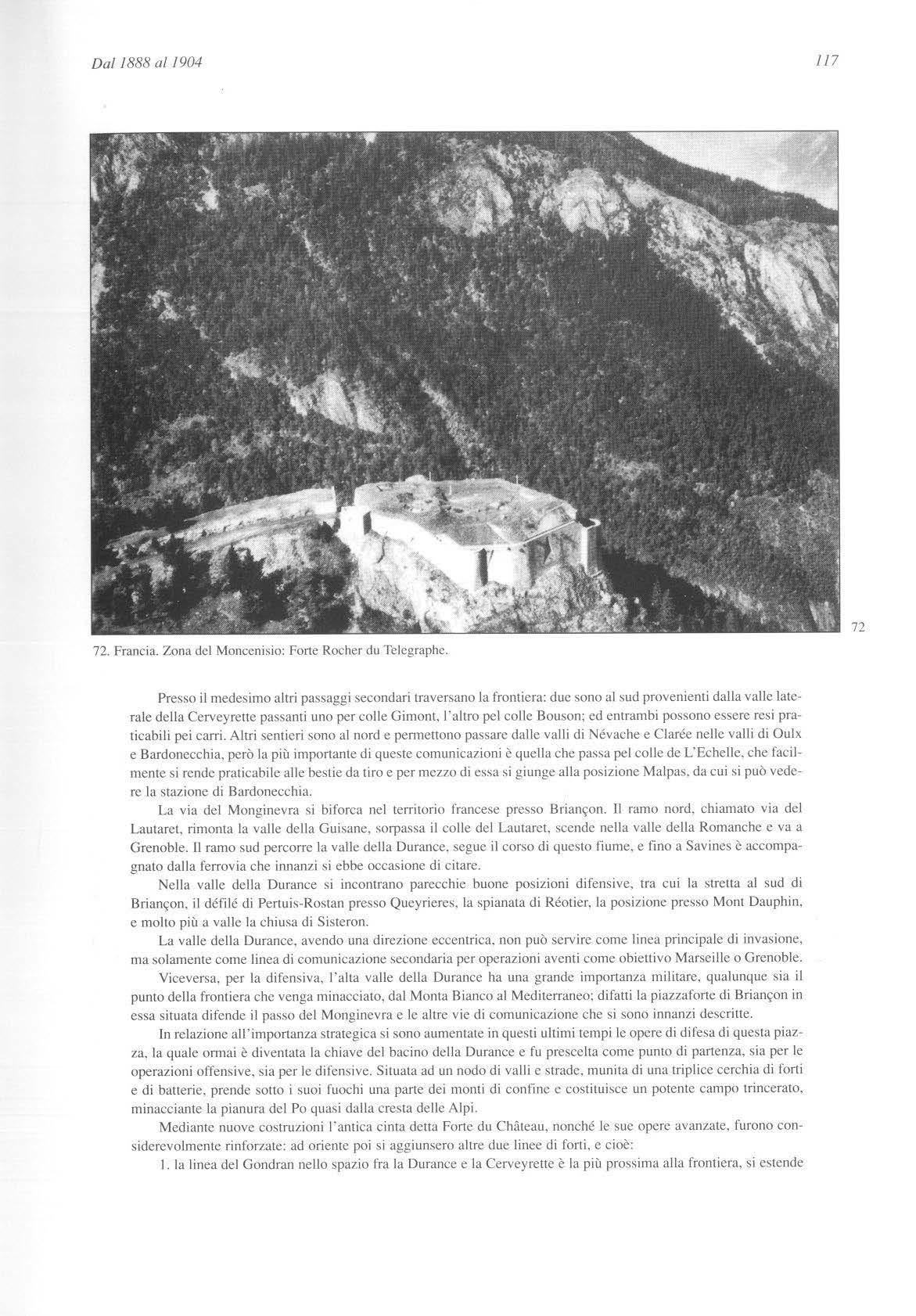
La valle della Durance, avendo una direzione eccentrica, non può servire come linea principale di invasione, ma solamente come linea di comunicazione secondaria per operazioni aventi come ohieuivo Marseille o Grenoble.
Viceversa. per la difensiva. l'alta valle della Durance ha una grande importanza militare, qualunque sia il punto della frontiera che venga minacciato, dal Monta Bianco al Mediterraneo; difatti la piazzaforte di Briançon in essa situata difende i l passo de l Monginevra e le altre vie di comunicazione che si sono innanzi descritte.
In relazione all'importanza s trategica s i sono aumentate in questi ultimi tempi le opere di difesa di questa piazza. la quale ormai è diventata la chiave del bacino della Durance e fu prescelta come punto di partenza, sia per le operazioni offensive. sia per le difensive. Situata ad un nodo di valli e strade, munita di una triplice cerchia di forti e di batterie, prende sotto i suoi fuochi una parte dei monti di confine e costituisce un potente campo trincerato. minacciante la pianura del Po quasi dalla cres ta delle Alpi.
Mediante nuove costruzioni l'antica cinta detta Fone du Chiìteau, nonché le sue opere avanzate. furono considerevolmente rinforzate: ad oriente poi si aggiunsero altre due linee di forti, e cioè:
I. la linea del Gondran nello spazio fra la Durance e la Cerveyrette è la più prossima alla frontiera, si estende
Dal /888 al 1904
72. Francia. Zona del Moncenisio: Forte Rocher du Telegraphe.
117 72
per tre chilometri lungo la stretta e scoscesa cresta rocciosa che unisce il monte Janus col monte Gondran. È costituita da nove batterie e tre ridotti riuniti da una retrostante strada coperta. Queste opere battono il passo del Monginevra, la sottostante cresta di confine, come pure le vie che dalla valla della Cerveyrette oltrepassano la frontiera;
2. la linea dell'Infcrnette, che corona una naturale scarpa rocciosa alta 50 metri, è situata dietro la precedente. Essa è costituita dal forte dell'Infemette situato al punto più alto e da un muro stacca to con feritoie che corona il ciglio della roccia, esso tennina a nord con lll1a batteria. Queste opere battono la torruosità della strada del Monginevra, nonché le valli della Clairée e Cerveyreue;
3. fmalmente vi è una terza linea dietro la precedente formata come segue: al nord la batteria della Croix de Toulose s iniata all'estremità meridionale dell'almea Peyrole; al centro Le antiche opere, ridotta des Sallettes, forte Dauphin, forte Trois Tète, fort Randuillet, forte d'Anjou; al sud la linea della Grande Maye, situata su di una scarpa rocciosa alta 700 metri costituita da sei batterie aventi per ridotto il forte Croix de Brctagne. Fanno parte di questa linea le batterie Gafouille, Cerveyrettc, Ayes, Chalet des Ayes. Verso occidente è in progetto La costruzione di un forte su li 'a ltura Notre Dame de Neiges.
Per difendere LI passaggio del Col de l'Echel le cd i sentieri che dalle vallate Névanche e Clarée conducono nelle valli di Ou lx e Bardonnéche fu costruito il forte staccato des Ol ives sul ramo nord della catena montuosa che si estende fra le vallate Clarée e Guisane.
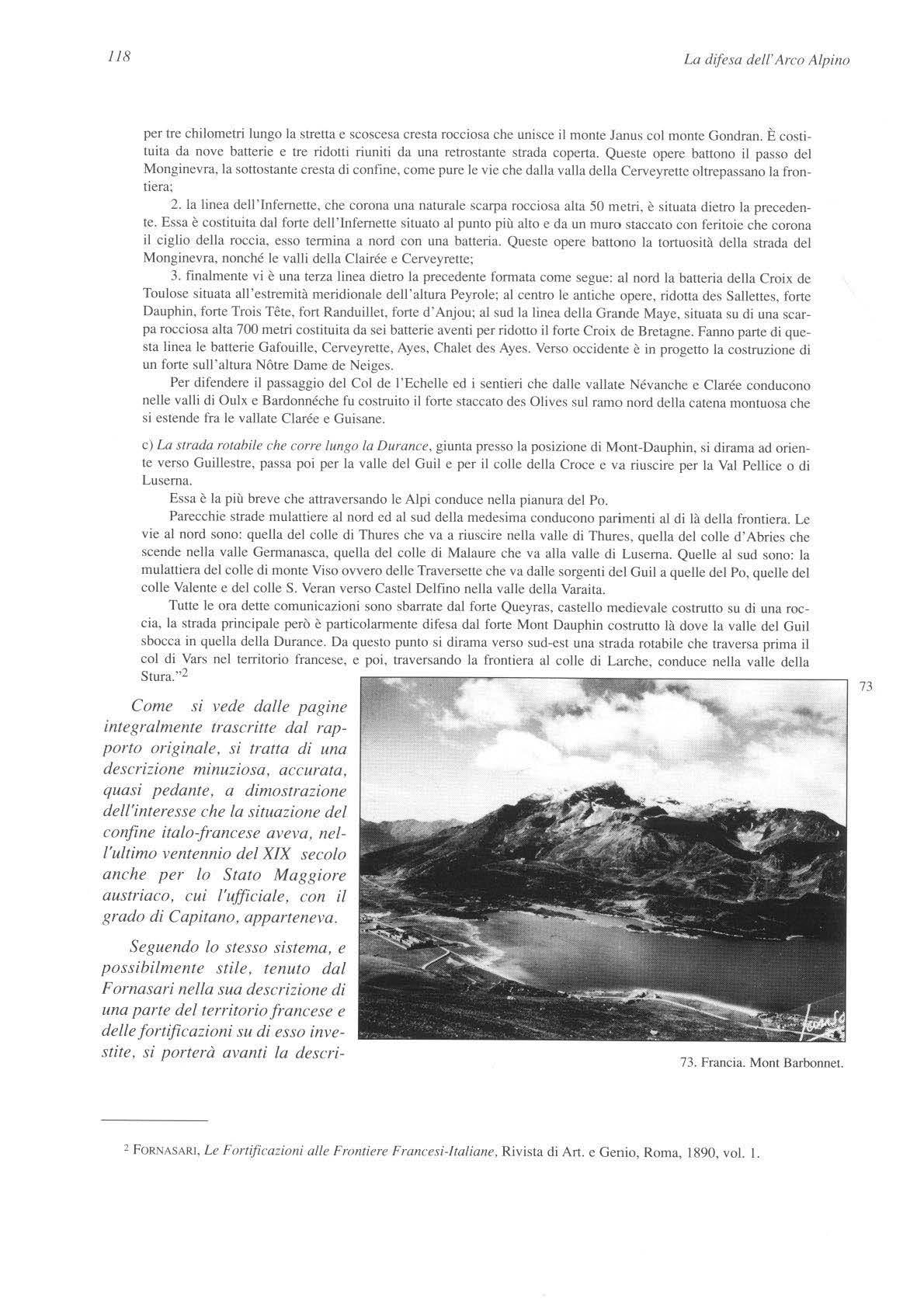
c) la strada rowhile che corre lungo la Durance, giunta presso la posizione di Mont-Dauphin, si dirama ad oriente verso Guillestre, passa poi per la valle del Guil e per il col le della Croce e va riuscire per la Val Pcllice o di Luserna.
Essa è la più breve che attraversando le Alpi conduce nella pianura del Po.
Parecchie strade mulattiere al nord ed al sud della medesima conducono pari menti al di là della frontiera. Le vie a l nord sono : quella de l colle di Thurcs che va a riuscire nel la valle di Thures, quella del colle d' Abries che scende nel la valle Gennanasca, quella del colle di Malaure che va alla valle di Luserna. Quelle al sud sono: la mulattiera del colle di monte Viso ovvero delle Traversette che va dalle sorgenti del Guil a quelle del Po, quelle del co ll e Valente e del colle S. Veran verso Castel Delfmo nella valle della Varaita.
Tutte le ora dette comunicazioni sono sbarrate dal forte Queyras , castello medievale costrntto su di una roccia, la strada principale però è particolarmente difesa da l forte Mont Dauphin costrutto là dove la valle del Guil sbocca in quella della Durance. Da questo punto si dirama verso sud-est una strada rotabile che traversa prima il col di Vars nel territorio francese, e po i, traversando la frontiera al colle di Larche, conduce nella valle della Stura."2
Come si vede dalle pagine integralmente trascritte dal rapporto originale, si tratta di una descrizione minuziosa, accurata, quasi pedante, a dimos1razione dell'interesse che la situazione del confine italo-francese aveva, nell'ultimo ventennio del XIX secolo anche per lo Stato Maggiore austriaco, cui l'ufficiale, con il irado di Capilano, apparteneva.
Seguendo lo s1esso sistema, e possibilmente stile, tenuto dal Fornasari nella sua descrizione di una parte del territorio francese e delle fortificazioni su di esso investite, si porterà avanti la descri-
118 La difesa dell'Arco Alpino
2 FORN ASA RJ, le Fortificazioni
Rivista di Art e Genio, Roma, 1890, vo i. I. 73
73. Francia. Mont Barbonnet.
alle Frontiere Francesi-Italiane.
zione dei rimanente territorio francese di confine e di queLLo italiano ad esso opposto poi. mantenendo il tempo presellle come se questa parte di descrizione facesse parte della relazione Fornasari del 1889.
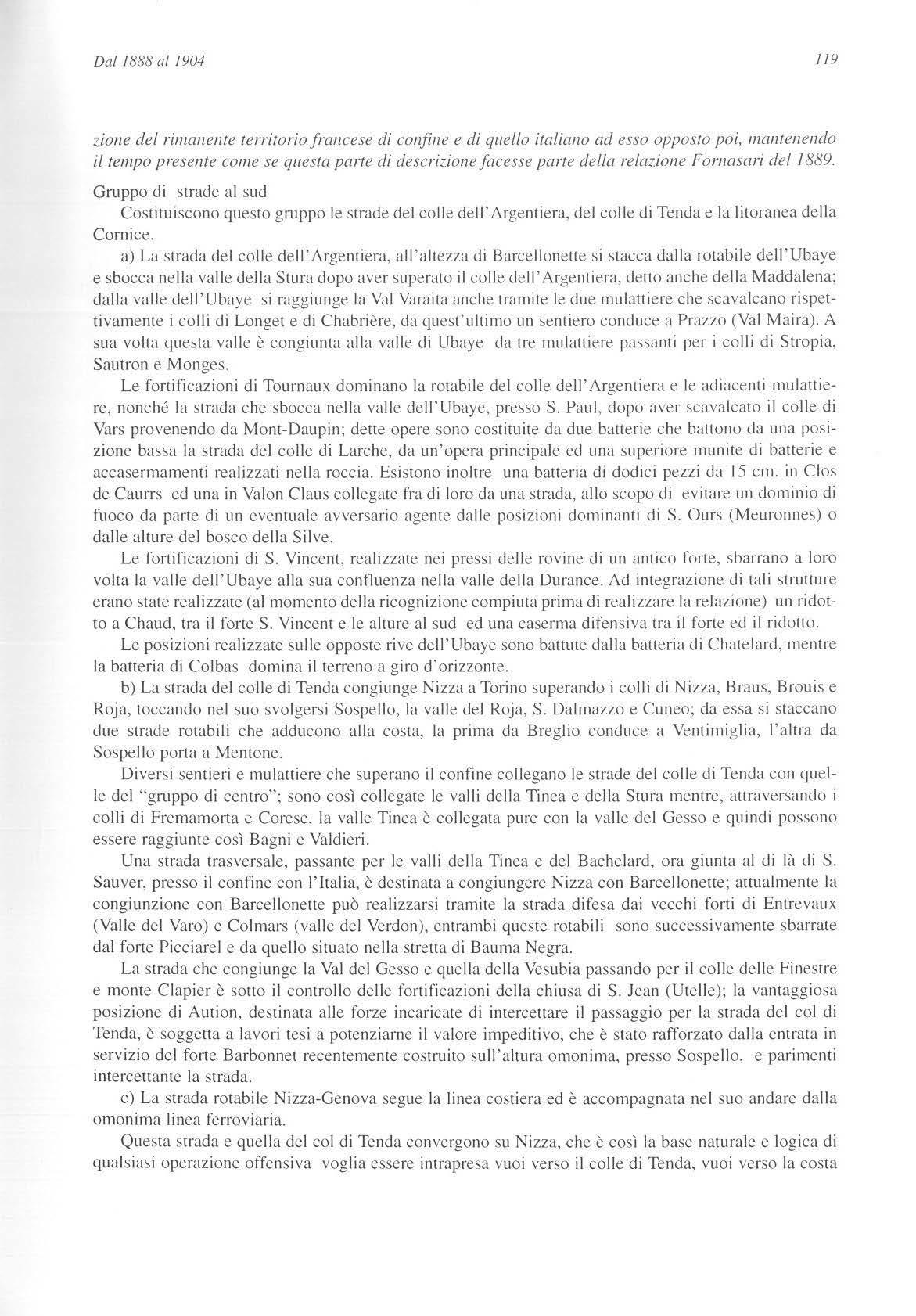
Gruppo di strade al sud
Costituiscono questo gruppo le strade del colle cieli' Argentiera, del colle di Tenda e la litoranea della Cornice.
a) La strada del colle cieli' Argentiera, all'altezza di Barcellonette si stacca dalla rotabile dell'Ubaye e sbocca nella valle della Stura dopo aver superato il colle dell'Argentiera, detto anche della Maddalena; dalla valle dell'Ubaye si raggiunge l a Val Varaita anche tramite le due mulattiere che scavalcano rispettivamente i colli di Longet e di Chabrière, da quest'ultimo un sentiero conduce a Prazzo (Val Maira). A sua volta questa valle è congiunta alla valle di Ubaye da tre mulattiere passanti per i colli di Stropia, Sautron e Monges.
Le fortificazioni di Tournaux dominano l a rotabile del colle del!' Argentiera e le adiacenti mulattiere, nonché la strada che sbocca nella valle dell'Ubaye, presso S. Paul, dopo aver scavalcato il colle di Vars provenendo da Mont-Daupin; dette opere sono costituite da due batterie che battono da una posizione bassa la strada del colle di Larche, da un'opera principale ed una superiore munite di batterie e accasermamenti realizzati nella roccia. Esistono inoltre una batteria di dodici pezzi da 15 cm. in Clos de Caurrs ed una in Valon Claus collegate fra di loro da una strada, allo scopo di evitare un dominio di fuoco da parte di un eventuale avversario agente dalle posizioni dominanti di S. Ours (Meuronnes) o dalle alture del bosco della Silve.
Le fortificazioni di S. Vincent, realizzate nei pressi delle rovine di un antico forte, sbarrano a loro volta l a valle dell'Ubaye alla sua confluenza nella valle della Durance. Ad integrazione di tali strutture erano state realizzate (al momento della ricognizione compiuta prima di realizzare la relazione) un ridotto a Chaud, tra il forte S. Vincent e le alture al sud ed una caserma difensiva tra il forte ed il ridotto.
Le posizioni realizzate sulle opposte rive dell'Ubaye sono battute dalla batteria di Chatelard, mentre la batteria di Colbas domina il terreno a giro d'orizzonte.
b) La strada del colle di Tenda congiunge Nizza a Torino superando i colli di Nizza, Braus, Brouis e Roja, toccando nel suo svolgersi Sospello, la valle del Roja, S. Dalmazzo e Cuneo; da essa si staccano due strade rotabili che adducono alla costa, la prima eia Breglio conduce a Ventimiglia, l'altra da Sospello porta a Mentone.
Diversi sentieri e mulattiere che superano il confine collegano le strade del colle di Tenda con quelle del "gruppo di centro"; sono così collegate le valli della Tinea e della Stura mentre, attraversando i colli di Fremamorta e Corese, la valle Tinea è collegata pure con la valle del Gesso e quindi possono essere raggiunte così Bagni e Va l dieri.
Una strada trasversa l e, passante per le valli della Tinea e del Bachelard, ora giunta al di là di S. Sauver, presso il confine con l'Italia, è destinata a congiungere Nizza con Barcellonette; attualmente la congiunzione con Barcellonette può realizzarsi tramite la strada difesa dai vecchi forti di Entrevaux (Valle ciel Varo) e Colmars (valle del Verdon), entrambi queste rotabili sono successivamente sbarrate dal forte Picciarel e da quello situato nella stretta di Bauma Negra.
La strada che congiunge la Va l ciel Gesso e quella della Vesubia passando per il colle delle Finestre e monte Clapier è sotto i l controllo del le fortificazioni della chiusa di S. Jean (Utelle); la vantaggiosa posizione di Aution, destinata alle forze incaricate di intercettare il passaggio per la strada del col di Tenda, è soggetta a lavori tesi a potenziarne il va l ore impeditivo, che è stato rafforzato dalla entrata in servizio del forte Barbonnet recentemente costruito sull'altura omonima, presso Sospello, e parimenti intercettante la strada.
c) La strada rotabile Nizza-Genova segue l a linea costiera ed è accompagnata nel suo andare dalla omonima linea ferroviaria.
Questa strada e quella del co l di Tenda convergono su Nizza, che è così la base naturale e logica cli quals i asi operazione offensiva voglia essere intrapresa vuoi verso i l colle cli Tenda, vuoi verso la costa
Dal 1888 al /904 119
ligure; analogamente, quindi, Nizza deve essere considerata il naturale ridotto per la difesa del tratto di frontiera più meridionale del la Francia.
Il piano generale di difesa adottato prevede che la via litoranea de l la Cornice e la ferrovia ad essa parallela siano sbarrati dalle fortificazioni di Nizza e Yillafranca e dai due forti della Turbie e (lèlla Chien, che possono agire anche rispettivamente su ll e alture di monte Age l e verso il mare. Per contro llare il terreno che si stende fra la via di Tenda e quella per Genova sono state realizzate, sulle alture ad oriente della Turbie, la batteria dei Feuillerins e della Drette, i forti della Revere e della Forna cd è prevista, a breve termine, la realizzazione di un forte su monte Agel.
li forte Montc-Chauve d' Aspremont e quello di Monte Chaurede Torrette dominano le alture nord ed è prevista la costruzione di fortificazioni a Mont Maccaron ed a Calomas, mentre la via di Tenda e quella che adduce a Tourette sono contro ll ate dal forte di Rirnières e dalla batteria de Brec. La costa ed il porto di Villafranca non sono stat i dimenticati dal piano di difesa francesi e alla loro tutela sono state preposte l e batterie di Solegal, Beaulieu, Cap-Ferrat, Mont-Boron, Rascassc e ciel Faro.
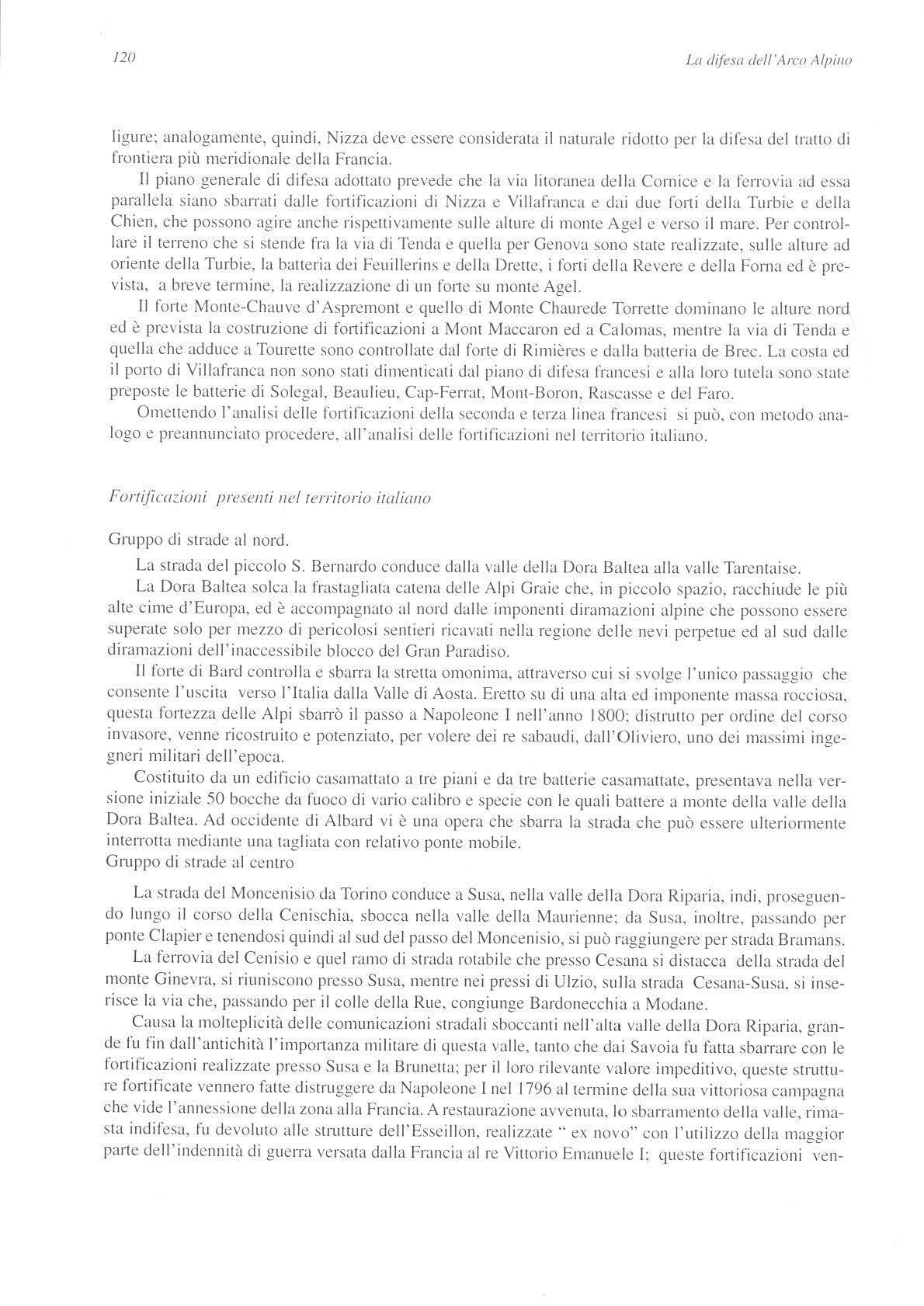
Omettendo l'analisi delle fortificazioni del l a seconda e terza linea francesi si può, con metodo analogo e prean nunciato procedere, all'analisi delle fortificazioni nel territorio italiano.
Fortificazioni presenti nel territorio italiano
Gruppo cli strade al nord.
La strada del piccolo S. Bernardo co nduce dalla val l e della Dora Baltea alla va ll e Tarentaise.
La Dora Baltea solca la frastagliata catena delle Alpi Graie che, in piccolo spazio, racchiude le più alte c ime d'Europa, ed è accompagnato al nord dalle impon enti diramazioni alpine che possono essere superate solo per mezzo cli pericolosi se nti eri ricavati nella regione del le nevi perpetue ed al sud dalle diramazioni dell'inaccessibile blocco del Gran Paradiso.
Il forte di Bard contro lla e sbaJTa la stretta omon ima, attraverso cui si svolge l'unico passaggio che consente l 'uscita verso l 'Ita li a dalla Valle di Aosta. Eretto su cli una alta ed imponente massa rocciosa, questa fortezza delle Alpi sbarrò il passo a Napoleone I nell'anno 1800; distrutto per ordine del corso in vasore, venne ricostruito e potenziato, per vo l ere dei re sabaudi, dall'Oliviero, uno elci massimi ingegneri militari dell'epoca.
Costituito da un edificio casarnattato a tre piani e da tre batterie casamattate, presentava nella versione iniziale 50 bocche da fuoco cli vario calibro e specie con le quali battere a monte del l a valle della Dora Baltea. Ad occidente di Albard vi è una opera che sbarra l a strada che può essere ulteriormente interrotta mediante una tagliata co n relativo ponte mobile.
Gruppo di strade al centro
La strada del Moncenisio da Torino conduce a Susa, nella valle della Dora Riparia, indi , proseguendo lungo il corso della Cenischia, sbocca nella val l e della Maurienne; da Susa, inoltre, passando per ponte Clapier e tenendosi quindi al sud del passo del Moncenisio, si può raggiungere per strada Bramans.
La ferrovia del Cenisio e quel ramo cli strada r otab ile che presso Cesana si distacca della strada del monte Ginevra, si riuniscono presso Susa, mentre ne i pressi di Ulzio, sul la strada Cesana-Susa, si inserisce la via che, passando per il colle della Rue, congiunge Bardonecchia a Modane.
Causa la molteplicità delle comunicazioni stradali sboccanti nell'alta valle della Dora Riparia, gra nde fu fin dall'antichità l'importanza militare di questa valle, tanto che dai Savoia fu fatta sbarrare con le fortificazioni realizzate presso Susa e la Brunetta; per il l oro ril eva nte va l ore impeditivo, queste strutture fortificate vennero fatte distruggere da Napoleone 1 nel 1796 a l termine del la sua vittor i osa campagna che vide l'annessione della zona al l a Francia. A r estaurazione avvenuta, lo sbarramento della valle, rimasta indifesa, fu devoluto a ll e strutture dell'Esseillon, realizzate" ex novo" con l 'ut ili zzo della maggior parte dell'indennit~t di guerra versata dalla Francia al re Vittorio Ema nu ele I; queste fortificazioni ven-
120 La difesa dell'Arco Alpino
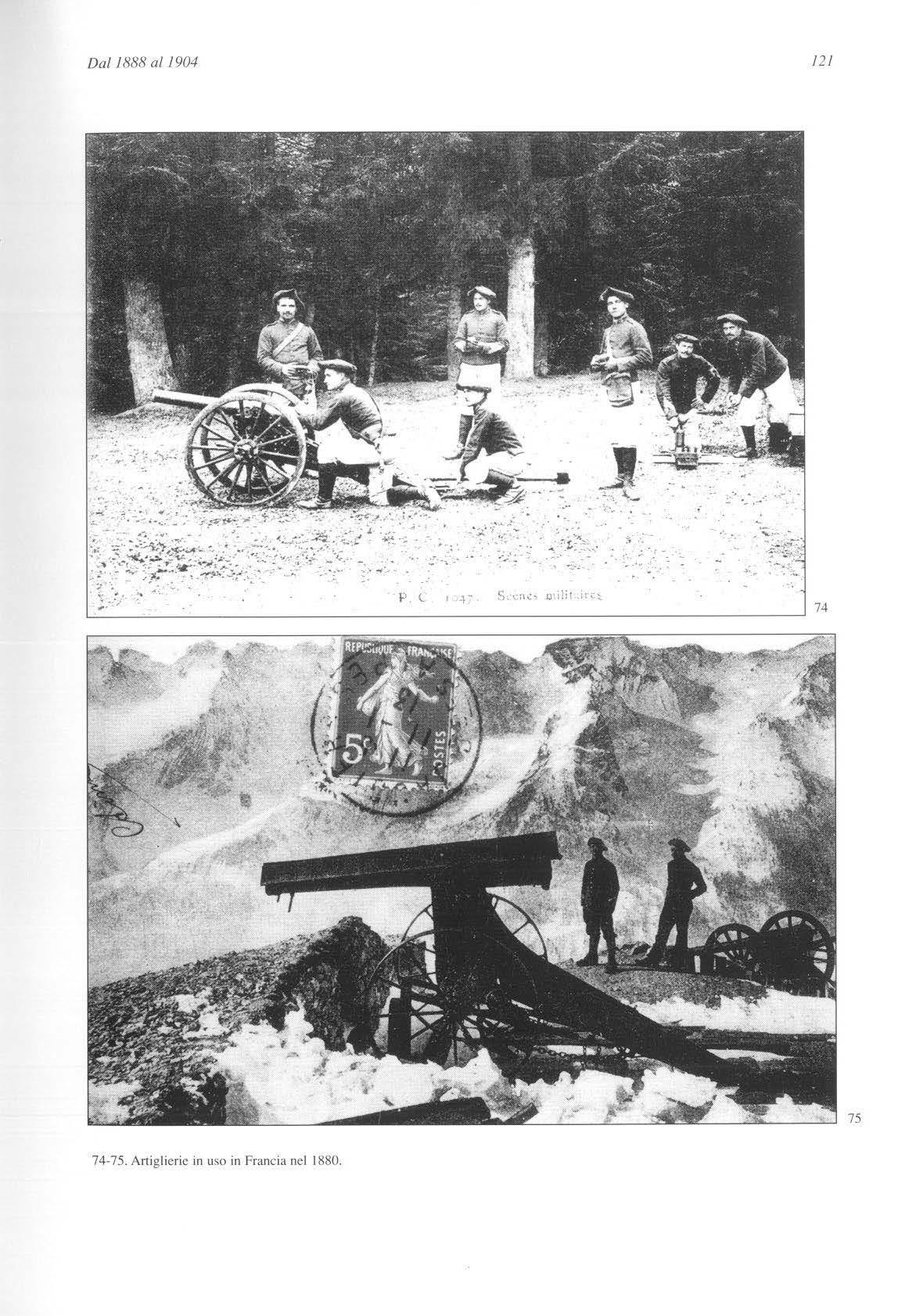
Dal 1888 al 1904 ~. :~... . ,. ·-~.. .. , '"..:.
i .: ,., ~ p (. 1 ·1 - · ,. ;.'' · - .:> • <· ....· :.. ·... .... .,., 121 74 75
·n Francia nel 1880.
74
-75. Artighenc in uso
nero rea li zzate no n solo per sbarra re la via del Moncenisio, ma anche per impedire che le fonificazio ni di s barram e nto, che ne l frattemp o s i e rano spinte fino ad Exi ll es, venissero g irat e.
La cess ione dell a Savoia a ll a Francia, al termine del processo risorgimentale, d eterminò la perdita delle fortificazioni dell'Esseillon e si rese necessario provvedere co n nuove strutture a sbarrare tale importantissima via di penetrazione.
Le nu ove o pere di sba rram e nt o rea li zza te al passo del Moncenisio, propri amen te su ll e alture della Gran Croce, hanno il domin io dell'esteso altopiano appartenente all'Italia e de ll a strada che lo attraversa; esse sono:
- forte della ta g liat a della Cassa
- forte Vari se ll o
- forte della C assa
- forte Rancia.
Al centro d e ll'alt o piano, a s ud -es t de l la go del Moncen is io, so rgeva in o ltre un antico blo c kh aus denominato Forte Gallo. il cui va lore, al momento cui si riferisce questa situazio ne, era bellicamcn te pressoché nullo.
La s trada del M o nginevro c he anra ve rsa il passo omo nimo si biforca e co n il ram o nord si inoltra ne ll a vall e della Dora Ripari a verso Su sa mentre con il ramo sud s i inoltra ne ll a valle de l Chisom: e, supera to il co ll e del Sestr ière, porta a Pinerolo; il ramo nord cd i passaggi secondari prossimi al Monginevro so no sbarrati dal fo11e di Exilles, mentre quello di Fenestrelle controlla il ramo sud ed i senti e ri che ad esso adducono o si d ipartono.
Il forte di Ex ille s è fo rmato da parecchie ope re a prova di bomba, disposte attorno ad un piazzale, ed è ar mato con tre ordini di cannoni in casamana; più avanti, \'erso Susa, vi sono due batte ri e, de ll e Tenaglie, mentre ve rso oves t, nella direzione di Exilles, v i è un a gra nd e batteria a tre o rdini di fuochi con tracc iato a te naglia. Un a s trada coperta intag liata nel mo nt e collega l 'o pera principale de l forte c o n l 'a ltura di S. Colombano.
l i forte Serre la Garde, costituito da una torre casamattara con piattaforma e da una ba tt eria cm,amattata di ca nnoni di grosso ca libro, difende la via che da Salbertrand conduce a Susa pa ssa ndo pe r Sa n Co lombano e Chiomonte; inoltre, in tempi più rec e nti , so no s tati rea li zza ti , più ava nti, su ll e du e ri ve della D ora Rip ari a, i forti di Fen il e di Sapé .
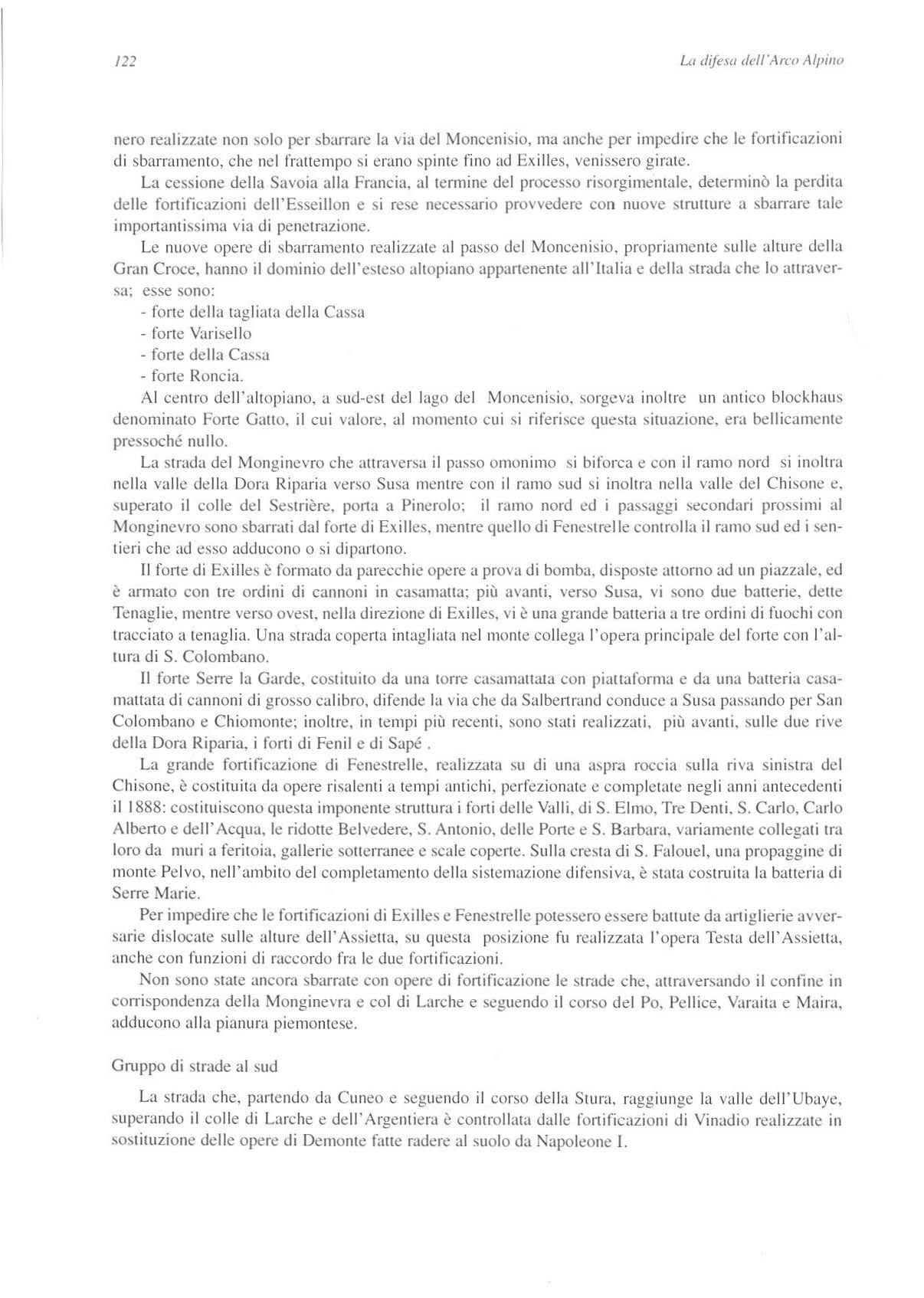
La grande fortificazione di Fenestrelle, realizzata su di un a aspra roccia su lla riva s ini stra del Chisone, è cos tituita eia opere ri sa le nti a tempi antichi, pe rfezionat e e co mpl eta te negli anni a nt ecedenti il 1888: cos titui sco no questa imp o ne me s truttura i forti delle Valli, di S. Elmo, Tre Denti, S. Carlo, Carlo Alberto e dell'Acqua, le ridotte Belvedere, S. Ant o ni o, delle Porte e S. B arbara, variamente collega ti tra loro da muri a feritoia, ga lleri e so tt e rran ee e sca le coperte. Sulla c resta di S. Fa louel, una propaggine di mo nte Pelv o, nell'ambit o del completamento de lla sistemazione dife nsiva, è s tara cos truita la batt e ria di Serre Marie.
Pe r impedire che le fortificazion i di Exilles e Fenestrelle potessero essere ballu te da artiglierie avve rsa ri e disl oca te s ul le a lture dell ' Assietta, s u qu es ta pos iz ione fu rea li zzata l'opera Testa dell' Assietta, anche con funzioni di raccordo fra le du e fortificazioni.
Non sono s tat e ancora sbarrate co n opere cli fortificazione le strade che, attraversando il confine in corr ispondenza della Monginevra e co l di Larche e seguendo il corso del Po, Pe llice , Yaraita e Maira, add uc ono a ll a pianura pi e monte se.
G,uppo di s trad e a l sud
La stra da che, part e ndo da Cuneo e seg uendo il corso della S wra , ra gg iun ge la valle dcll'Ubay e, s upera nd o il co ll e di Larche e dell'Argentiera è con trol lata dalle fo rtificazi o ni di Vinadio rea lizzat e in sos tituzi one delle opere di Demonte fatte radere al suo lo da Napolt!one I.
/22 La dife.1a A{flillo
Queste fortificazioni sono costituite da due opere a fronti bastionati, munite di casematte e difese da fossi, aventi due distinti ordini cli fuochi, uno per la fanteria e l'altro per le artiglierie; Vinadio giace letteralmente dietro questi forti ed è aperta dalla parte rivolta al territorio italiano essendo completamente dominata dal fuoco incrociato delle casematte. Rafforzano lo sbarramento le batterie di Neghino e Pratolungo, che realizzate sulle spalle, battono le contrapposte alture divise dal burrone in cui scorre il torrente Neirassa.
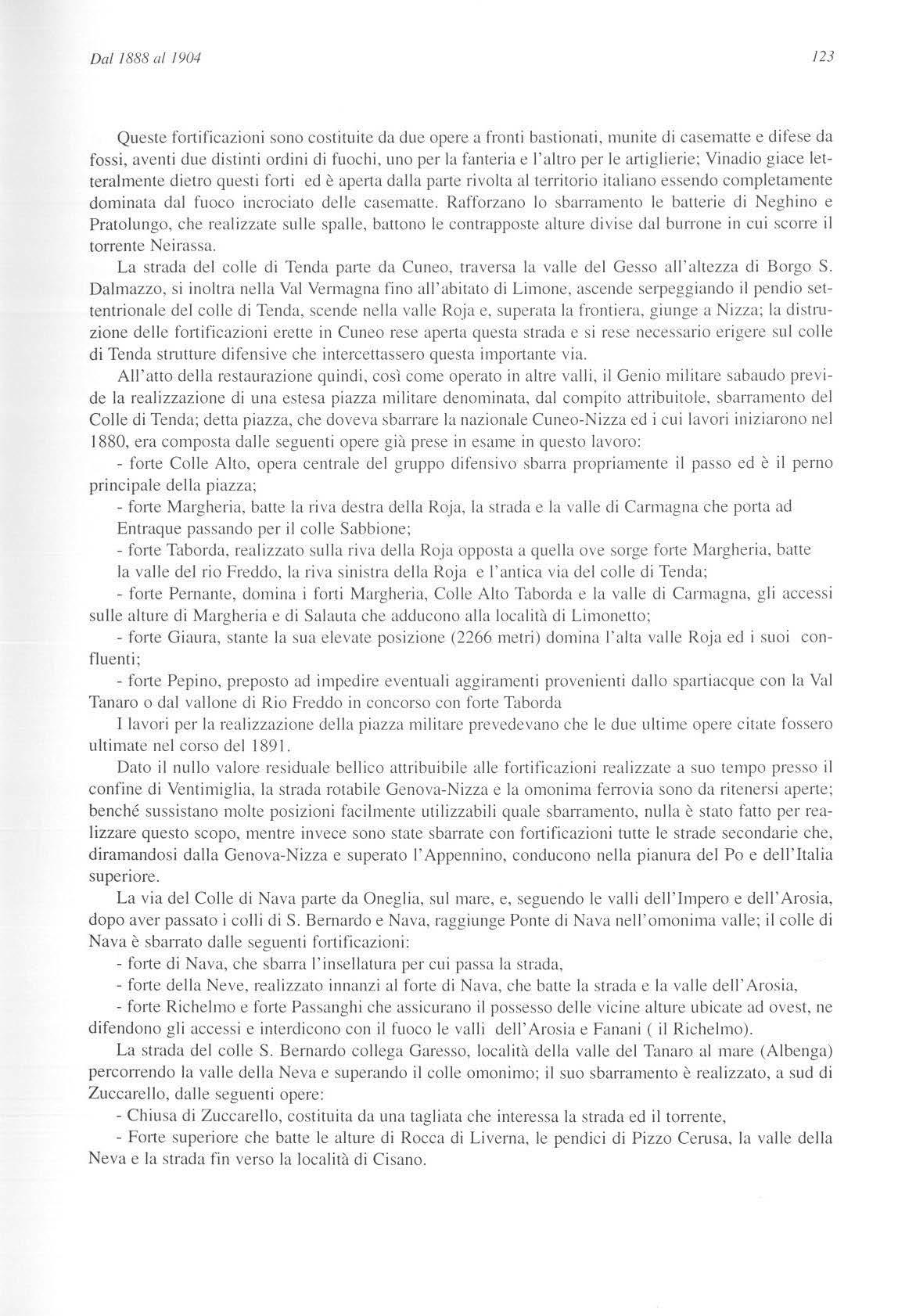
La strada ciel colle di Tenda patte da Cuneo, traversa la valle del Gesso all'altezza di Borgo S. Dalrnazzo, si inoltra nella Val Verrnagna fino all'abitato di Limone, ascende serpeggiando il pendio settentrionale del colle cli Tenda, scende nella valle Roja e , superata la frontiera, giunge a Nizza; la distruzione delle fortificazioni erette in Cuneo rese aperta questa strada e si rese necessario erigere sul colle di Tenda strutture difensive che intercettassero questa importante via.
All'atto della restaurazione quindi, così come operato in altre valli, il Genio militare sabaudo previde la realizzazione di una estesa piazza militare denominata, dal compito attribuitole, sbarramento del Colle di Tenda; detta piazza, che doveva sbarrare la nazionale Cuneo-Nizza ed i cui lavori iniziarono nel 1880, era composta dalle seguenti opere già prese in esame in questo lavoro:
- forte Colle Alto, opera centrale del gruppo difensivo sbarra propriamente il passo ed è il perno principale della piazza;
- forte Margheria, batte la riva destra della Roja, la strada e la valle di Carmagna che porta ad Entraque passando per il colle Sabbione;
- forte Taborcla, realizzato sulla riva della Roja opposta a quella ove sorge forte Margheria, batte la valle del rio Freddo, la riva sinistra della Roja e l'antica via ciel colle di Tenda;
- forte Pernante, domina i forti Margheria, Colle Alto Taborcla e la valle di Cannagna, gli accessi sulle alture di Margheria e di Salauta che adducono alla località cli Limonetto;
- forte Giaura, stante la sua elevate posizione (2266 metri) domina l'alta valle Roja ed i suoi confluenti;
- fotte Pepino, preposto ad impedire eventuali aggiramenti provenienti dallo spartiacque con la Val Tanaro o dal vallone di Rio Freddo in concorso con forte Taborda
I lavori per la realizzazione della piazza militare prevedevano che le due ultime opere citate fossero ultimate nel corso del 1891.
Dato il nullo valore residuale bellico attribuibile alle fortificazioni realizzate a suo tempo presso il confine di Ventimiglia, la strada rotabile Genova-Nizza e la omonima feITovia sono da ritenersi aperte; benché sussistano molte posizioni facilmente utilizzabili quale sbarramento, nulla è stato fatto per realizzare questo scopo, mentre invece sono state sbarrate con fortificazioni tutte le strade secondarie che, diramandosi dalla Genova - Nizza e superato l'Appennino, conducono nella pianura del Po e dell'Italia superiore.
La via del Colle di Nava pa11e da Oneglia, sul mare, e, seguendo le valli dell'Impero e clell'Arosia, dopo aver passato i colli di S. Bernardo e Nava, raggiunge Ponte di Nava nell'omonima valle; il colle di Nava è sbarrato dalle seguenti fortificazioni:
- fotte di Nava, che sbarra l'insellatura per cui passa la strada,
- forte della Neve, realizzato innanzi al forte di Nava, che batte la strada e la valle del!' Arosia,
- forte Richelmo e forte Passanghi che assicurano il possesso delle vicine alture ubicate ad ovest, ne difendono gli accessi e interdicono con il fuoco le valli dell' Arosia e Fammi ( il Richelmo).
La strada de l colle S. Bernardo collega Garesso, località della valle del Tanaro al mare (Albenga) percorrendo la valle della Neva e superando il colle omonimo; il suo sbarramento è realizzato, a sud cli Zuccarello, dalle seguenti opere:
- Chiusa cli Zuccarello, costituita da una tagliata che interessa la strada ed il torrente,
- Fo1te superiore che batte le alture di Rocca di Liverna, le pendici cli Pizzo Cerusa, la valle della Neva e la strada fin verso la località cli Cisano.
Dal 1888 al 1904 /23
La valle del Tanaro è pure raggiungibile da Finale tramite la strada che attraversa l'Appennino al colle di Melogno, sce nde successivame nt e verso Ca lizzan o di Bormida e scavalca il passo presso Bagnasco; le opere di sbarramen to realizzate al colle di Me logno sono:
- la batteria Tortag na e forte Meriggio sull'omonima altura,
- la Chiusa di Me logno, rea li zzata in corrispondenza de l passo stesso.
La strada de l co ll e di Cadibona collega Savona a Carcara su ll a Bormida or ie ntale; in questa locali t~t la st rada si biforca, da un a parte si collega a Millesimo, Ceva e Mondovì, dall'altra va a Cairo, Dcga ed Alessandria Parallelamente muove la ferrovia c he en tra in ga lleri a un po' a no rd di Cadibona e sbocca, dopo u n percorso di 24 c hil ometri di tunnel, in loca lità S. Giuseppe Bormida per diramarsi successivamente verso Torino cd Alessandr ia

La ev id ente importa nza di questa via di comun icazione portò a ll a recente realizzazione del forte d i Altare, e levato ad orien te della omonima località; il fo rte è costitui to d.1 due opere, pos te su due alture iso la te. cong iunte da una cinta com un e, a l d i sotto della qua le sco rre, in gal leria, la st rada
La strada del passo dei Giovi c he prov iene da Savona si co ngi un ge al nord cli Piazza co n la rotabi le proveniente da Varazze e, superato il passo, si di ri ge ad Acqui ed Aless an dr ia; poco prima del passo dei Giovi, dalla ro tab il e si stacca una diramazione d ire tt a a Pontivrea e Dego, entram bi localitù della Bormida o ri enta le; q ueste strade sono sba rrate dall'opera denominata Tagliata, dai forti Lodrino superiore ed inferiore, Bruciato. Scara no e Mogl ie. tutti realizzati sulle alture vici ni ori. Le u ltime tre opere sono armate con torri corazza te da 12 cm.
Non si ritiene opportuno, analogamente a qu a nto fatto per la frontiera francese, esaminare le fo rtificazioni cli seconda linea che non sono esame di q ues to st udi o.
SPECCHIO RIEPILOGATIVO DELLE FORTIFICAZ I ONI COSTITUENTI LE PIAZZEFORTI DI
PIAZZAFORTE
Ass ie rt a
OPERE
Gran Serin
Batteria d i Mouttas
Opera del la Gran Costa
Fo rt e Car lo Alberto
San Carlo
Tre Denti
Delle Valli
Serre Marie
Passo de lla Fines tra
Principa le
Sapé
Feni l Case Garde Serre la Gardc
XIX SECOLO)
ARMAMENTO
8 da 12 GRC/ret - 6 eia 15 AR/ret
4 da 15 GRC/ret -2 da 9 ARC/ret
4 da I 5 GRC/ret - 2 da 9 ARC/ret - 4 + 4 da 12 GRC/ret
so no presenti dal 1890 ol tre I 50 pezzi ( in postazione fissa o nei magazzini) dei tipi I 5GRC/rct, i 2G RC/rct, 9 ARC e m ortai da I 5 AR/ ret
6 da 15 GRC/ret - 4 da I 5 AR/ re t
2 da 9 ARC/ret in torretta a scornp .
IOda 12 ARC/ret
8 da 12 GRC/ret in barbetta
8 da 12 GRC/ret in batteria corazz.
4 ei a 149/G in barbetta
I eia I 5 GRC/re1 - 2 da 9 AR/ re 1 - 2 da 42 mm - 2 ei a 57 111111
cannoni d a 9 A R/rc t
24 eia 9 AR/ret
12-1 La d(fesa de/l'Arco Alpino
CON LA FRANC IA NEL SALIENTE
CONFINE
MONCENISIO-MONGINEVRO
Fenestrelle Ex ill es Moncenisio (FINE
Variscllo Cassa ANNO DI COSTR. 1897 1890 1892 1727/93 { 18 92 189 1 1874 1884 189 1 1898 1875 1877 1874
Malamot
Roncia
Tagliata della Cassa
Pattacrcu se
Bardonecchia f'oens
Jafferau
Bra111afarn
Ca se rma di Fréjus
Cesana
Champlas Scguin
Sbarr. di Claviére
Petil Valon
Chaberton
1897 4 111itr. Gardner
1877 6 da 9 AR/ret
1874
1889 24 GRC/ret - 4 da I 5 GRC/rèl
1898 4 da I 5 ARC/ret
1898 8 da 15 ARC/ret
1895 6 da 9 ARC/ret - 2 da 12 AR/rct in cupola
1874
1890 6 da I 5 GRC/rèl
1890 2 da 57 111111
6 eia 12 GRC/ret
1898 8 da l-+9/35 in torre
Susa
Pa111palù
Combe di Giaglione
Cas. dif. S . Chiara
Tavola di ragguaglio dei calibri delle artig li erie
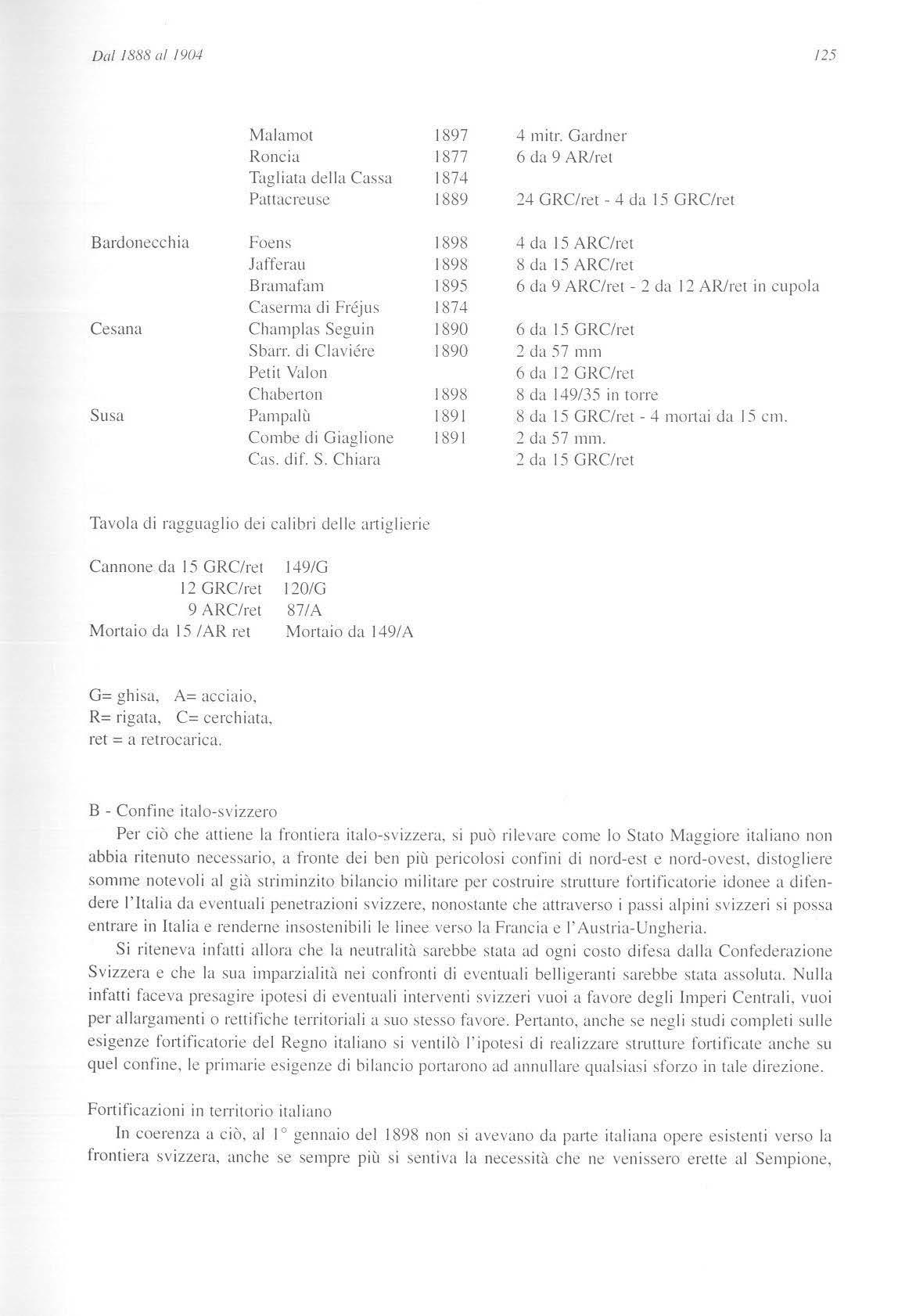
Cannone eia 15 GRC/ret
12 GRC/ret
9 ARC/ret
Mortaio da 15 / AR rei
G= ghisa, A= acciaio.
R= rigata, C= cerchiata , ret = a retrocarica.
149/G
120/G
87/A
\ttortaio da 149/A
1891 8 da I 5 GRC/ret - 4 mortai da 15 crn.
1891 2 eia 57 mm.
2 da 15 GRC/rct
B - Confine italo-sv izzero
Per ciò che attiene la frontiera italo-svizzera, si può rilevare come lo Stato Maggiore italiano non abbia ritenuto necessario, a fronte dei ben più pericolos i confini di nord-est e nord-ove st. di stog liere somme notevoli al già striminzi to bilancio militare per costruire strutture fortificatorie idonee a difendere l'Italia da eventua li penetrazioni svizzere, nonostante che attraverso i passi alpini svizzeri si possa entrare in Italia e renderne insostenibili le linee verso la Francia e l'Austria-Ungheria.
Si riteneva infatti allora che la neutralità sarebbe stata ad ogni costo difesa dalla Confederazione Svizzera e che la sua imparzialitù nei confronti di eventua li belligeranti sarebbe stata assoluta. Nulla infatti faceva presagire ipotesi di eventua li interventi svizzeri vuoi a favore degli Imperi Centrali, vuoi per allargamenti o rettifiche territoriali a suo stesso favore. Pertanto, anche se negli studi comp leti sulle esigenze fortificatorie del Regno italiano si venti l ò l'ipotes i di realizzare struttur e fo rtifi cate anche su quel confine, le primarie esigenze di bilancio portarono ad annullare qualsiasi sforzo in tale direzione.
Fortificazioni in territorio italiano
In coerenza a ciò, al I O genna io del 1898 non si avevano da parte itali ana opere esis tenti verso la frontiera svizzera, anche se sempre più si sentiva la necessità che ne venissero erette al Sempione.
Dal 1888 al 19U./
125
Gottardo ed a Fuentes, all'estremità nord del lago di Como.
Fortificazioni in territorio svizzero
La Svizzera, giunta alla fase confederale dopo lunghe e travagliate vicende che videro il suo territorio sottomesso al le scorrerie degli eserciti di alcuni Stati europei, non intendeva essere ulteriormente un campo di battaglia.
Dopo una prima fase di modesto sviluppo fo11ificatorio, che è stato già citato nella situazione delle frontiere all'atto della costituzione del Regno d'Italia, vi fu un periodo di stasi dovuto alla guerTa del '70. ''Nel 1883 il Consiglio federale - forse impensierito ùalla precarietà di tale protezione e dalla probabilità di un'invasione per parte di chi tendesse verso la Francia - stabilì di accrescere e migliorare le difese, cominciando dalla frontiera italiana sulla quale specialmente al nodo del Gottardo fece costruir..: il ridotto della sua difesa nazionale."3 inoltre decise di migliorare e conservare alcune vecchie fortificazioni sull' Aar.
Delle quattro fronti strategiche della Svizzera, prenderemo in esame quella meridionale, che corrisponde alla frontiera italiana e si estende dal Pizzo Umbrail fino al monte Dolent, dove concorrono i confini della Francia, dell'Jtalia e della Svizzera, e segue collo sviluppo di 658 km. solo per brevi tratti la linea di displuvio.
li Canton Ticino, che a guisa di cuneo si interna nel territorio italiano per 50 km., agevola alle forze federali la marcia su Milano, loro primo obiettivo.
La linea principale d'operazione, nel caso che gli italiani avessero voluto prendere l'offensiva, sarebbe stata quella del colle del Gottardo, poiché essa mette direttamente nell'altopiano svizzero, taglia la base Ma11igny-Coira ed evita le opere erette a difesa delle valli del Rodano e del Reno anteriore. Le rimanenti linee stradali che provengono dalla valle del Po sbucano appunto in queste due valli.
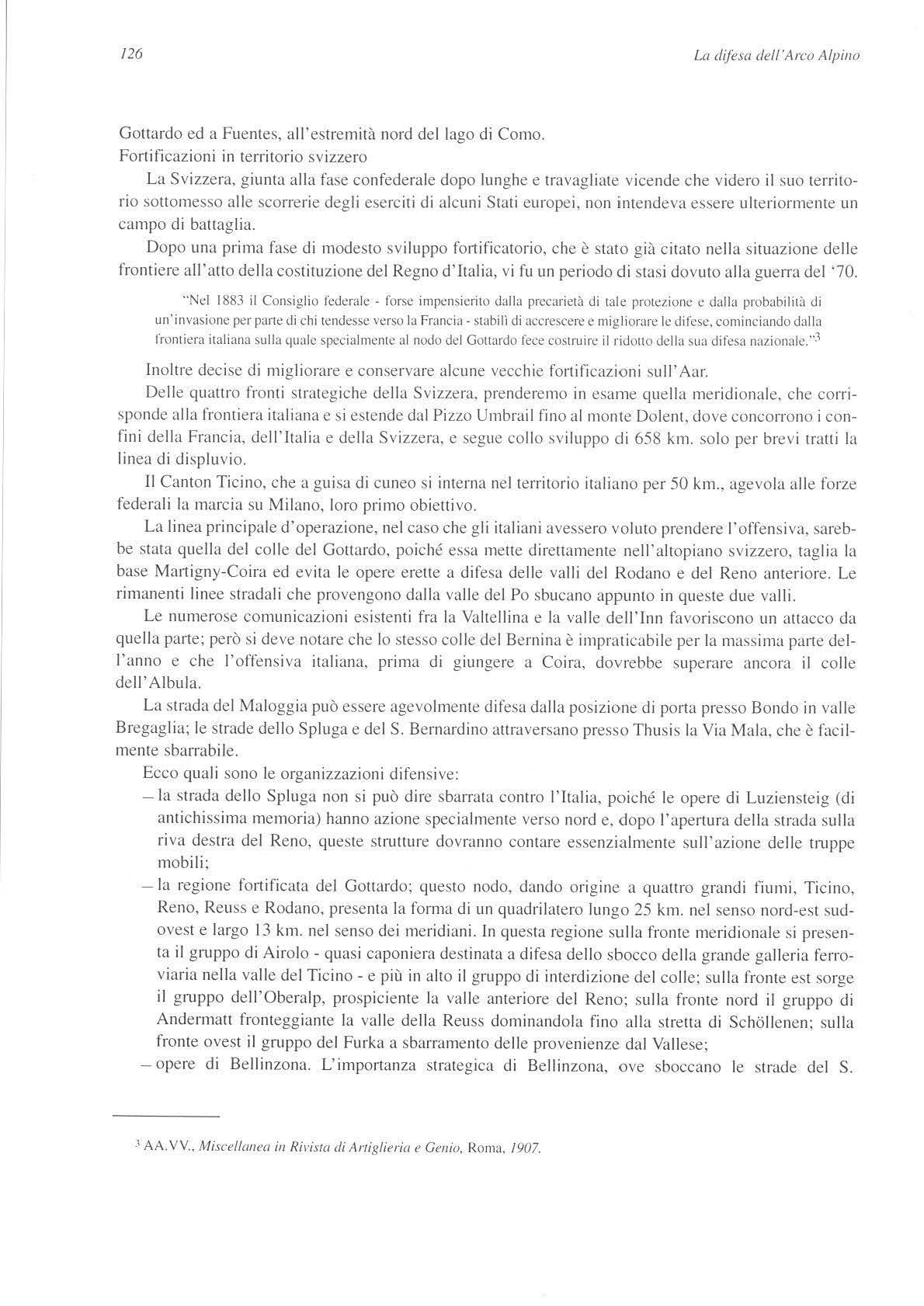
Le numerose comunicazioni esistenti fra la Valtellina e la valle dell'Inn favoriscono un attacco da quella parte; però si deve notare che lo stesso col le del Bernina è impraticabile per la massima parte del!'anno e che l'offensiva italiana, prima di giungere a Coira, dovrebbe superare ancora il colle cieli' Albula.
La strada del Maloggia può essere agevolmente difesa dalla posizione di porta presso Bondo in valle Bregaglia; le strade dello Spluga e del S. Bernardino attraversano presso Thusis la Via Mala, che è facilmente sbarrabile.
Ecco quali sono le organizzazioni difensive:
- la strada dello Spluga non si può dire sbarrata contro l'Italia, poiché le opere di Luziensteig (di antichissima memoria) hanno azione specialmente verso nord e, dopo l'apertura della strada sulla riva destra del Reno, queste strutture dovranno contare essenzialmente sull'azione delle truppe mobili;
- la regione fortificata ciel Gottardo; questo nodo, ciancio origine a quattro grandi fiumi, Ticino, Reno, Reuss e Rodano, presenta la forma di un quadrilatero lungo 25 km. nel senso nord-est sudovest e largo 13 km. nel senso dei meridiani. In questa regione sulla fronte meridionale si presenta il gruppo di Airo l o - quasi caponiera destinata a difesa dello sbocco della grande ga l leria ferroviaria nella valle ciel Ticino -e più in alto il gruppo di interdizione del colle; sulla fronte est sorge il gruppo cle l l'Oberalp, prospiciente la valle anteriore del Reno; su l la fronte nord il gruppo di Andermatt fronteggiante la valle della Reuss dominando l a fino alla stretta di Schollenen; sulla fronte ovest il gruppo del Furka a sbarramento delle provenienze dal Vallese;
- opere cli Bellinzona. L'importanza strategica di Bellinzona, ove sboccano le strade del S
126
La difesa Alpino
.l AA. VY Miscellanea in Ri,,isw di Ar1ig/ieria e Genio, Roma. /907.
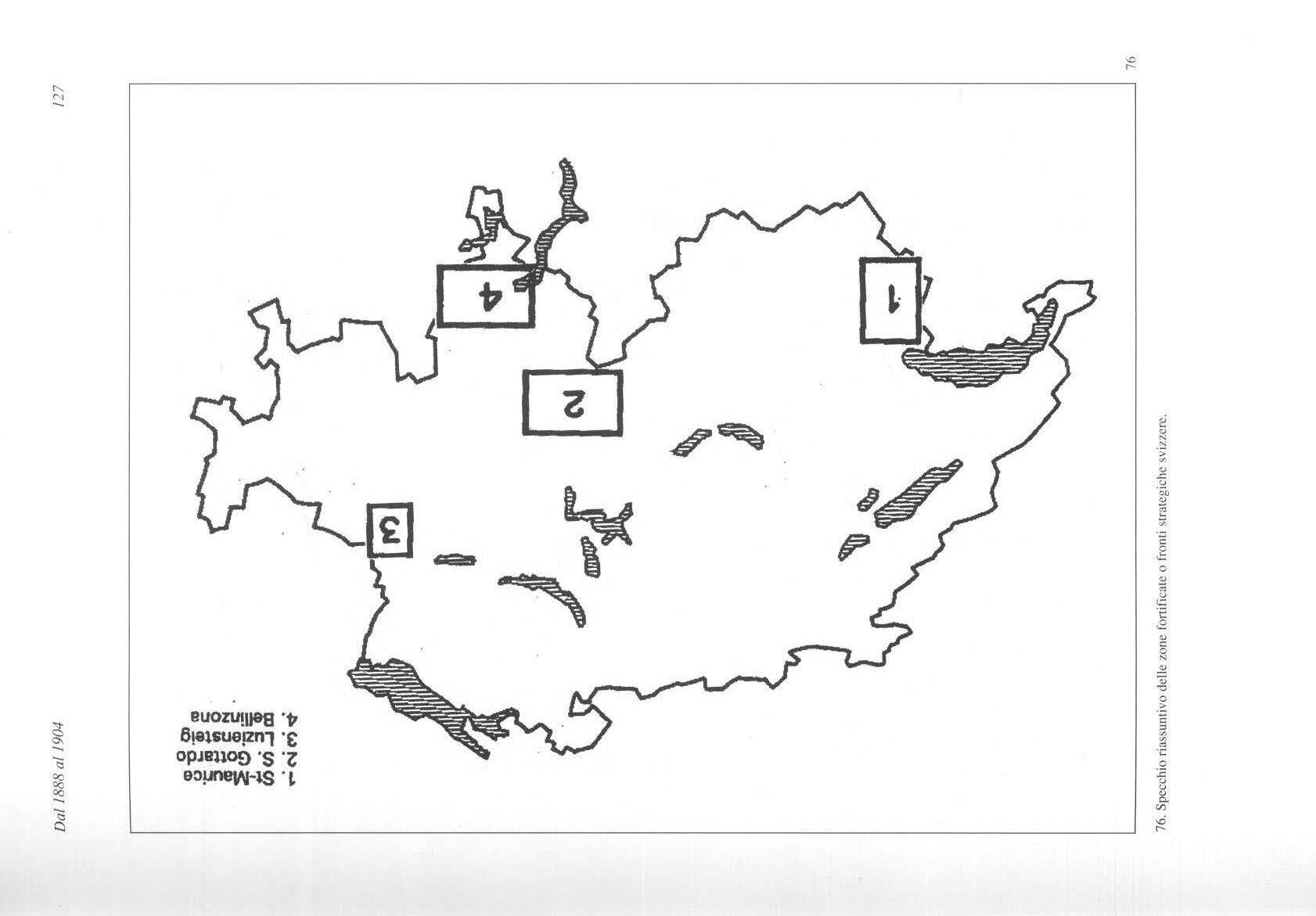
Dal 1888 al 1904 127 76 76. Specc h io r i assuntivo delle zone fortificate o front i stra egt i che svizzere.
Bernardino, ciel Lukrnanier e del Gottardo, dà ragione della sua scelta per costmirvi fortificazioni. Queste constavano di opere antiche (iniziate verso 1447) vicinissime alla piazza (500 metri) e precisamente: castel d'Uri, castello di Schwyz e castello di Unterwalden, e di una linea di difesa esterna iniziata dopo il 1859 a sbarramento della valle del Ticino presso Giubilasco, costituita sulla sinistra del fiume da cinque torTi tonde presso Camorino, la batteria e la lunetta Morobbia e sulla destra da un muro con feritoie e .dalla batteria e ridotta di Sementina.
Queste opere, benché non rispondessero alle esigenze tecniche moderne, costituivano una difesa avanzata ciel Gottardo e coprivano i due colli del Lukrnanier e del S. Bernardino.
La strada del colle del Sempione venne difesa nel versante sud solo da alcune batterie occasionali. da muri con feritoie a guardia dello sbocco della galleria di Gondo, lunga ben 222 metri, e della stretta omonima. Si previde cli difendere lo sbocco nord della galleria ferroviaria con una semplice caserma difensiva.
Lo sban-arnento di Saint Maurice sul Rodano difendeva le provenienze dalla valle del Rodano e dal colle del Gran San Bernardo. Le opere sull'altopiano svizzero consistevano sull'Aar, nelle località cli Aarberg ed Aarbourg in vecchie fortificazioni tenute in stato di buona conservazione.
C - Confine italo-austriaco
Nel 1848 nessun forte esisteva nel Trentino la cui posizione rispeno ai domini austriaci nella penisola era del tutto interna e quindi non sospetta di possibile invasione. Con la campagna del 1848 l'Austria si cautelò blandamente, realizzando gli sbam1111enti del!' Ampola e di Rivoli poi, sotto lo shock dello spostamento dei confini conseguente alla campagna del I 859, cOTse ai ripari, realizzando una serie di strutture fortificate. Sorgono immediatamente le opere di Val Strino, Val Giudicarie ed a Riva (Forti di S. Niccolò, S. Alessandro e Nago); Trento viene protetta con il forte di Martignano, la tagliata della Rocchetta e quella del Buco di Vela.
T lati deboli di questa struttura ancora agi i inizi sono messi in luce dalla campagna del I 866; il Generale Medici, infatti, nel corso della campagna, buca, come oggi si direbbe, la difesa austriaca e si presenta minaccioso a Ciré di Pergine, mentre Garibaldi stesso irrompe nella Val di Ledro.
Immediata la corsa ai ripari da parte dei responsabili austriaci; non essendo stata sufficiente la prima, si dà inizio alla seconda fase fortificatoria ('76-95) che vede riempirsi il Trentino, divenuto ormai l'estrema appendice meridionale dell'Impero, di fortificazioni.
Un'accurata analisi delle strade e possibili altre vie che adducono dal territorio austriaco a quello italiano porta alla realizzazione di tutta una serie di sbarramenti costituiti da opere, fortezze e tagliate risalenti ad epoche diverse, in pa11e modernizzate o potenziate con strutture di nuova generazione; si tratta di un lavoro di notevolissima entità, teso a rendere Trento un'imprendibile piazzaforte.
Ma l'opera austriaca non si limitò a Trento: esaminate le possibili vie di accesso che avrebbero potuto essere utilizzate dalle forze italiane, vennero sbarrate la moderna strada del Passo del Tonale, mediante opere la cui dislocazione interdicesse la stessa strada e quelle che ne avrebbero consentito l'aggiramento (Val Vermiglio, Val di Pejo. Val del Mome, Forcella di Montozzo) e la via delle Giudicarie con le fortezze di Larino, Danzolino, Corno e Revegler. Venne realizzata con sforzo imponente la cosiddetta fo11ezza di Riva che allineava un notevole complesso di opere permanenti e campali; dal Paneveggio a Sesto, alla Val d'Adige, le valli di Fassa, Parola, Badia e di Lanclro, il passo di Monte Croce Comelico furono interdetti all'eventuale penetrazione italiana con un sapiente dosaggio di strutture poste in corrispondenza dei valichi e dei passaggi naturali.
Ma per meglio evidenziare la solida e capace attività fortificatoria svolta, è necessario analizzare minuziosamente la frontiera cieli' Austria -Ungheria verso l'Italia a cavallo del 1885.

/28 La difesa dell'Areo Alpino
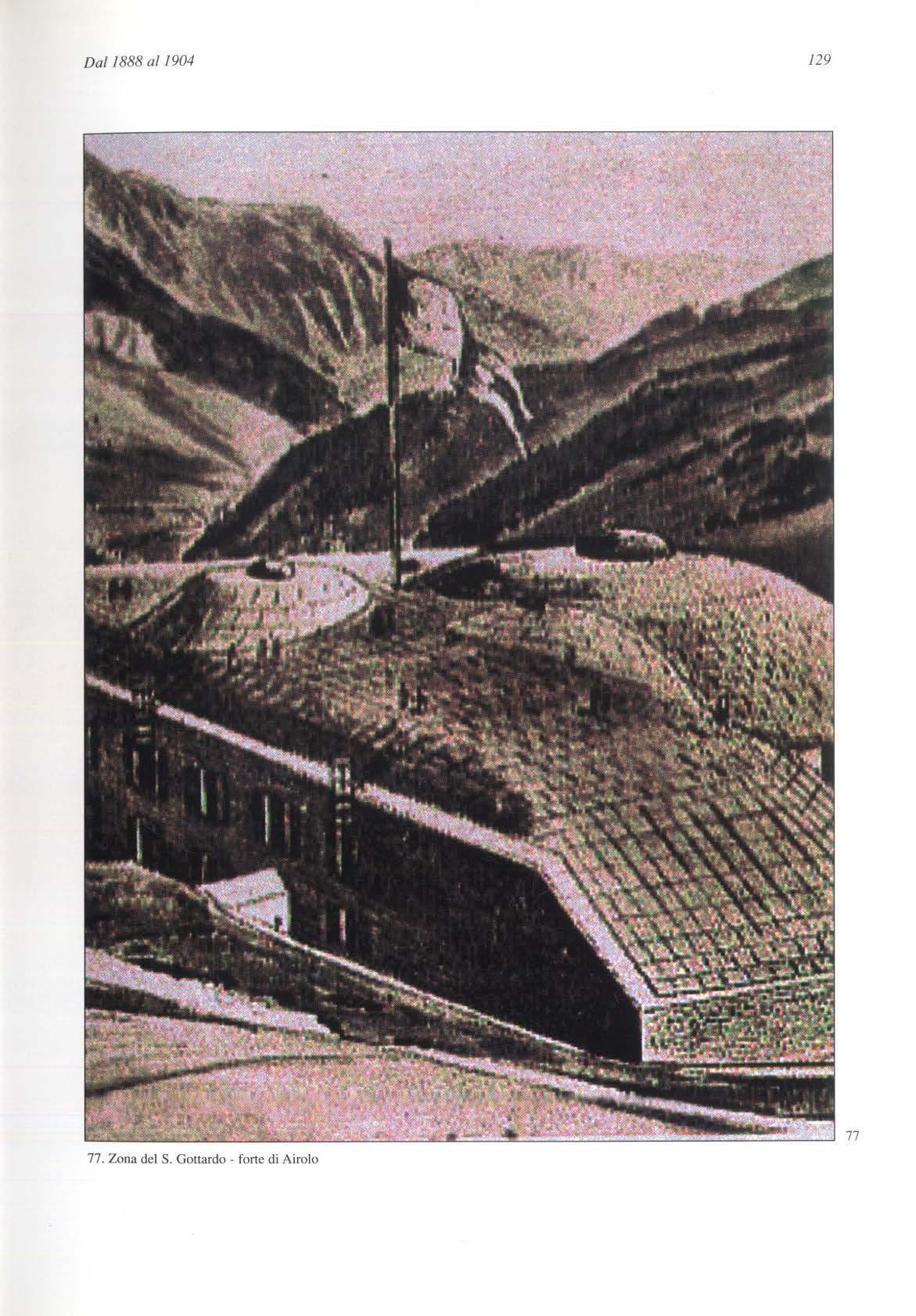
Dal 1888 al 1904 129 77
77. Zona del S. Gottardo - forte di Airolo
Dal colle dello Stelvio il confine fra l'Italia e l'Austria passa sulla creste del massiccio dell'011Ier e, per il colle del Tonale, a quella del!' Adamello, segue lo spa1tiacque, taglia la valle del Chiese a Ponte Caffaro, si dirige verso il lago di Garda che attraversa 5 Km a sud di Riva, raggiunge la catena del monte Baldo a Monte Altissimo, si volge a sud percorrendo la cresta della catena e discende in Val d'Adige e l'attraversa; dopo l'Adige sale sulla cresta dei monti Lessini, che segue sino alle sorgenti dell 'Astico, accompagna per breve tratto questo fiume, indi raggiunge la cresta dei monti che stanno tra Val Sugana e l'altopiano dei Sette Comuni. Esso poi discende e taglia il Brenta tra Primolano e le Tezze, sale sui monti a nord cli Primolano, taglia il Cismon a 15 Km a nord cli Fonzaso, quindi segue la cresta della diramazione del monte Cimon della Pala fino al mo1~te Marmolada; taglia quindi le alture del Cordevole, del Boite e raggiunge monte Cristallo sulle Alpi Carniche, segue lo spartiacque fino alle sorgenti del Pontebba, affluente ciel Fella, monta sul contrafforte del monte Canin, segue l'Idrio, piega ad ovest, taglia il Torre e segue il canale Ansa fino al suo sbocco in mare a porto Buso.
Da un esame della situazione fo1tificatoria al I O gennaio 1897, possiamo vedere come l'Austria abbia saputo sfntttare ed utilizzare al massimo il terreno offertole dagli ottimi confini che sapientemente aveva ottenuto al termine della guerra del 1866, avvalendosi abilmente cli vecchie demarcazioni territoriali risalenti ai tempi della Repubblica di Venezia.
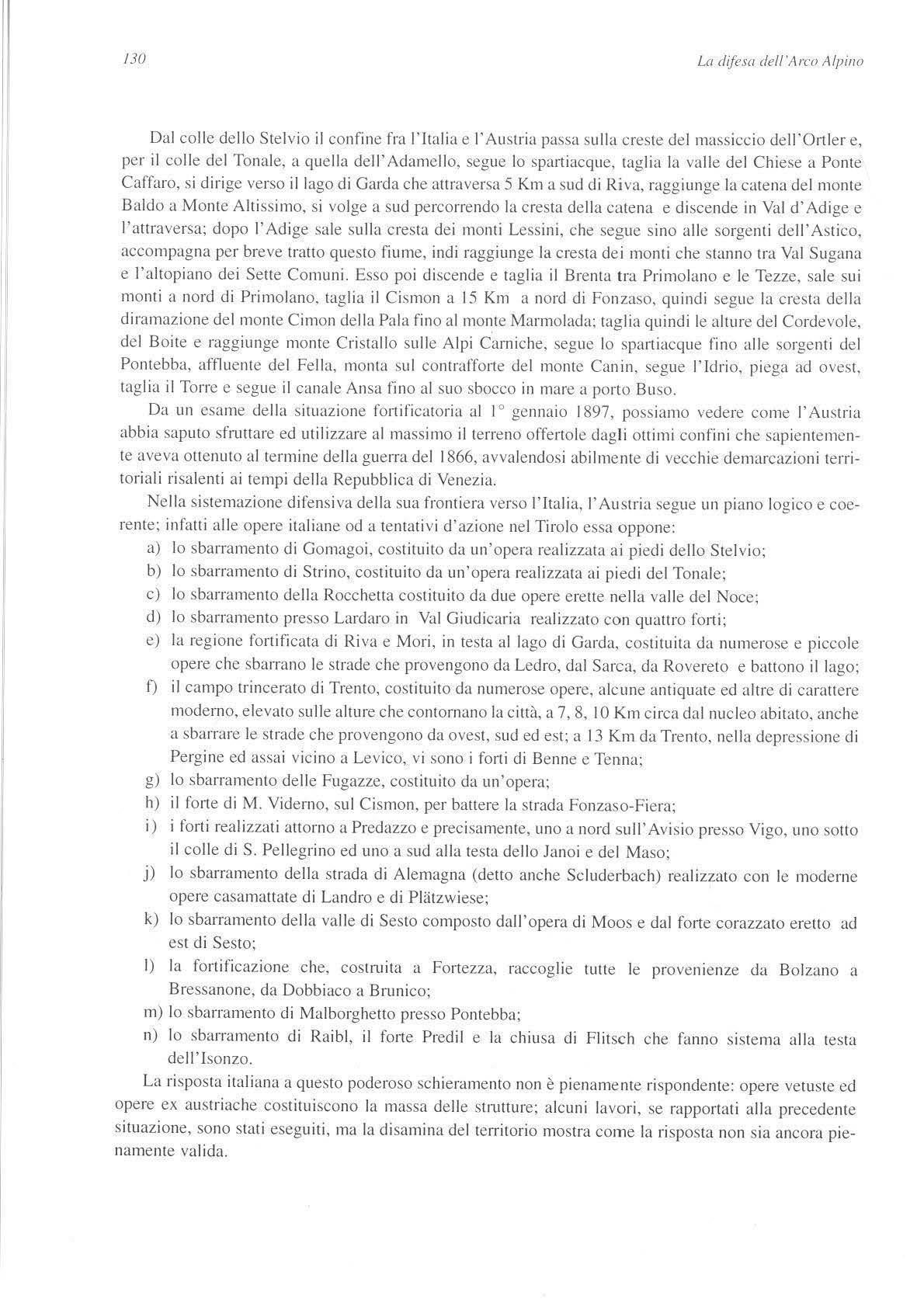
Nella sistemazione difensiva della sua frontiera verso l'Italia, l'Austria segue un piano logico e coerente; infatti all e opere italiane od a tentativi d'azione nel Tirolo essa oppone:
a) lo sbarramento di Gomagoi, costituito da un'opera realizzata ai piedi dello Stelvio;
b) lo sbarramento di Strino, costituito eia un'opera realizzata ai piedi del Tonale;
c) lo sbarramento della Rocchetta costituito eia due opere erette nella valle del Noce;
cl) lo sbarramento presso Larclaro in Val Giudicaria realizzato con quattro forti;
e) la regione fortificata di Riva e Mori, in testa al lago di Garda, costituita da numerose e piccole opere che sbarrano le strade che provengono da Leclro, dal Sarca, da Rovereto e battono il lago;
f) il campo trincerato di Trento, costituito da numerose opere, alcune antiquate ed altre di carattere moderno, elevato sulle alture che contornano l a città, a 7, 8, I O Km circa dal nucleo abitato, anche a sbarrare le strade che provengono da ovest, sud ed est; a 13 Km da Trento, nella depressione di Pergine ed assai vicino a Levico, vi sono i forti di Benne e Terrna;
g) lo sbarramento delle Fugazze, costituito da un'opera;
h) il forte cli M. Viderno, sul Cismon, per battere la strada Fonzaso -Fiera;
i) i forti realizzati attorno a Predazzo e precisamente, uno a nord sul!' Avisio presso Vigo, uno sotto il colle cli S. Pellegrino ed uno a sud all a testa dello Janoi e del Maso;
j) lo sbarramento della strada di Alemagna (detto anche Scluderbach) realizzato con le moderne opere casamattate di Landro e di Platzwiese;
k) Io sbarramento della valle di Sesto composto dall'opera di Moos e dal forte corazzato eretto ad est di Sesto;
I ) la fortificazione che, costruita a Fortezza, raccog li e tutte le provenienze da Bolzano a Bressanone, da Dobbiaco a Brunico;
m) Io sbarramento di Malborghetto presso Pontebba;
n) lo sbarramento di Raibl, il forte Predii e la chiusa cli Flitsch che fanno sistema alla testa dcli' Isonzo.
La risposta italiana a questo poderoso schieramento non è pienamente rispondente: opere vetuste ed opere ex austriache costituiscono la massa delle stiutture; alcuni lavori, se rapportati alla precedente situazione, sono stati eseg uiti, ma la disamina del territorio mostra come la risposta non sia ancora pienamente valida.
/30 La difesa Alpino
Nello stu dio dell'offensiva austr i aca bisog na cons i c.lc::ra re la fron tiera co m e divisa in due traili: l'uno abbracciante tuli o quan to il Tirolo Cisalpino o Trent in o. l'alt ro co rr ispo ndente al F r i uli e alla Venezia Giulia. Cotesti d ue t raili han no caralleri sos tanzia l ment e divt: rsi. e cib non solo sotto l'aspello geografico. ma anche. e più spec i alment e, sotto l 'aspetto m il i tare Il T rent ino comunica col resto dcli' Aus tr i a con due so l e strade indipendenti. è limitato da zone m o nt uose favorevo l i alla difensiva, per cu i nel suo co mplesso non potrebbe essere che sempl i ce teatro d i operazioni seconda ri e, e gli sbarramen ti delle vall i e l e tr u ppe che v i la scere mmo d i guardia c i garanti scono il fianco e l e spa lle d ura nte la radunata e l o schiera m ento ne l Friuli. ché certame nt e da questa parte verrebbe l' o rfesa principale. Le linee d i inv asio ne che l'Austria potrebbi.: si.:g uire at traverso tal e tratt o di frontiera pe r en trare in Italia so no, procedendo da no rd verso sud quella ddla Poruehha, de l Predii e de l basso I so nzo. Queste li nee sono separate da quelle del Trentino da una l arga, profonda ed imperv i a ma ssa montana. Corrono nientemeno che I 02 km. t r a Ospedaletto, sbo cco de l la linea della Pontebba e Vittorio, sbocco de ll a linea del Piaw, la pi ù or i entale cli que ll e del Trentino. Nessun co ll ega m en to aclunque, o almeno, co ll ega ment i assai d ifficili, e perciò in efficac i po trebbero siabi l irs i tra le operaz i o ni procedt:nti dai due traiti d i frontiera suclclcu i ."4
La sola linea del l a Pontebbana, lungo l a fronti era del Friuli, può esse re fac ilmente sbarrata ; l a lin ea del Predii e l e di ec i strad e che su un fronte di poco più d i diec i ch il ometri seg nano il corso del basso I sonzo attraversano inv ece u n terreno facile al mo v imento pressoché ovu nque, pri vo inoltre di rili ev i topografici, che po ssa no fornire buoni appigli tattici.
In questo tratt o di frontiera d ell 'Italia si ril evano l e ste sse co ndi z i oni in c ui versava la Francia nei confronti della Germania dopo il 1871; come l a Franc i a dovette crearsi una frontiera militare artificial e dietro a l confine politico, così ha dovuto fa re l'Italia, rea li zzando una linea di tes te di po nte sul Tagl i amento e rinforzando le zone att i gue ai tratti faci li all 'i nvas i one, in modo da poter impi ega re efficace mente l e trupp e mobili.
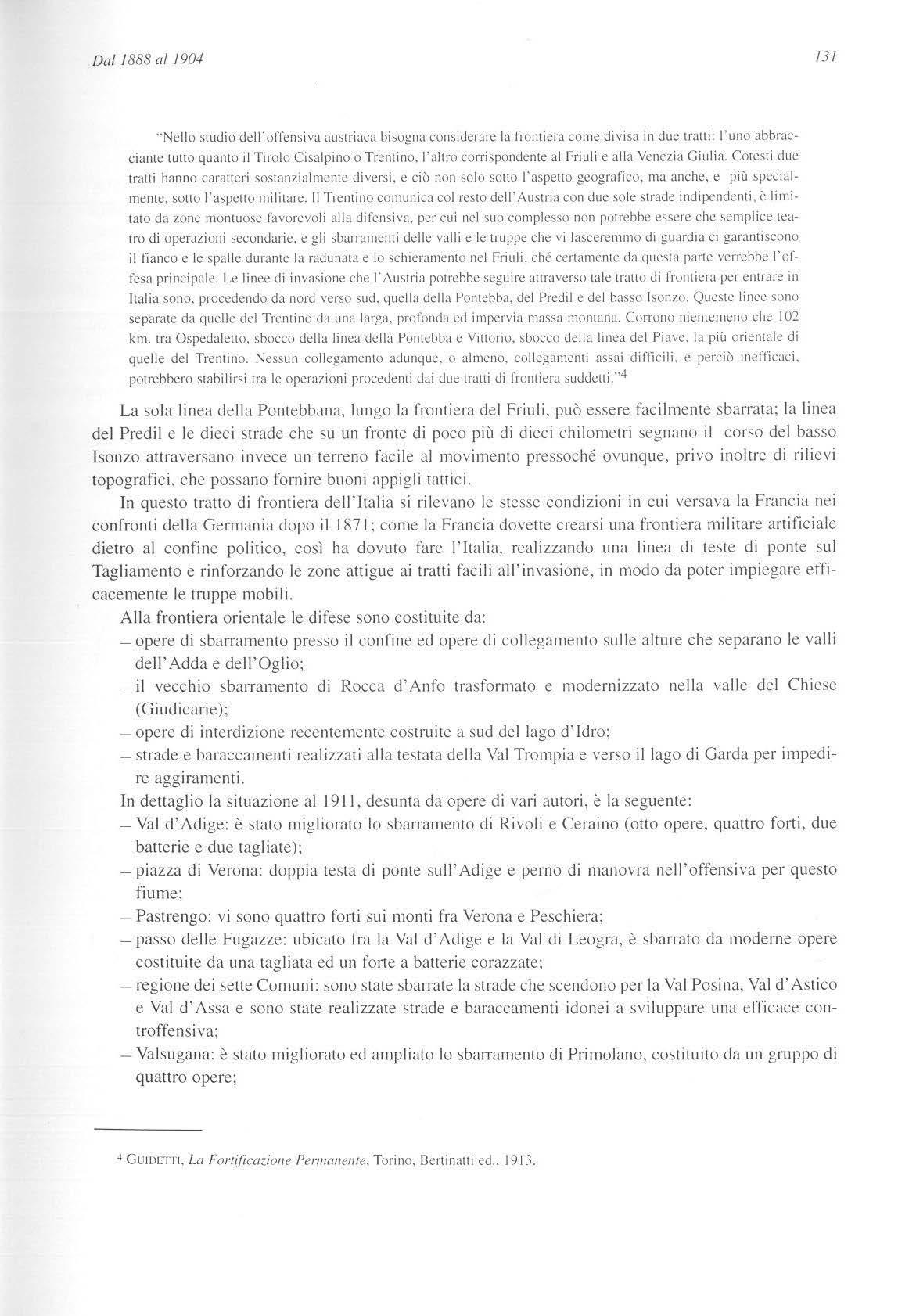
Alla frontiera oriental e l e difese sono cos tituit e da:
- opere di sbarram ento presso il confine ed ope re di collegamento sull e al t ure che separano le valli dell'Adda e dell'Oglio;
- il v ecc hi o sbarramento di Ro cca cl' Anfo tra sfo rmato e mod ernizzato ne ll a valle del Chiese (Giudica ri e);
- opere di interdi z ione recentemente costruite a sud del lago d ' ldro;
-strade e baraccamenti real i zza ti al l a testata del l a Val Trornpia e ve r so il lago di Garda per imped ire aggira ment i
In dettaglio la situazione al 19 I I , desunta da opere d i vari autori, è la seguente:
- Val d'Adige: è stato migliorato lo sbarramento di Rivoli e Cerai no (otto opere, quattro fo1ti, due batterie e due t agli ate);
- piazza di Verona: doppia te sta di ponte sull'Adige e perno cli mano vra nell'offensiva per ques to fiume;
- Pastrengo: vi so no quattro forti su i monti fra Verona e Peschi era;
- pa sso delle Fugazze: ubicato fra la Val d'Adige e la Val di Leogra, è sbarrat o eia moderne o pere co stituite da una tag l iata ed un fo11 e a batt eri e corazzate;
- region e dei se tte Comuni: sono state sbarrat e la strade c he scend o no per la Val Po sina, Val d' A sti co e Val cl' Assa e sono state realizzate strade e baraccamenti id o ne i a sviluppare un a efficace co ntr offensiva;
- Val sugana: è st ato mig l iorato ed a mpliato lo sbarramento di Primolano , cos tituit o da un gruppo di quattro opere;
Dal 1888 al / 904
131
4 G u1DEn1 , La Fortijica::.ione Pemw11e111e. Tori no, Bcrti nmti ed 19 13.
- le valli del Cismon e del Cordevol e sono stat e sbarrate rispettivamente presso Fonzaso con un'opera e presso Agordo con due opere;
- va lli Fe lla - Tag li amento: si hanno gli sbarramenti a Chiusaforte e presso Stazione per la Carnia;
- Val P iave: presso Pie,e <li Cadore è ,iato r eali zzato il r idotto cadorino, costituito da tre moderne opere corazza te c he , oltre a sba m1re l e strad e c he si riuni scono co là , servo no di appoggio alla co ntr offe nsiva e di protezione a lla linea <liretta di com unica zione fra il Cadore ed il Friuli che scava lca il passo di Mauria;
- esis te inoltre:
- il g rupp o fortificato di Osoppo, costituito dall e vecchie opere ubicate sulla storica a ltu ra di Osoppo e da numerose altre open.:: che sorgono a semicerchio sulle alture moreniche del Tagliamento e realizzano nel loro complesso un rafforzamento eccentrico rispetto alle principali linee di inva si one provenienti dal basso Ts onzo, in g rad o di crea r e un a ser ia min accia al fianco destro cli una eventuale offe nsiva austriaca;
- il complesso delle teste di ponte realizzate lungo il Tagliamento in grado di sbarrare durante il periodo necessario alla mobi litazione i principali fasci stradal i favorevoli ad una invasione.
Lll stasi dcJl'uta alla cris i eco110111 ica
D opo l 'u nion e di Roma, l ' uni ca preoccupazione militare dello Stato non poteva essere c he la semplice difesa ciel territ o rio nazi o nal e di front e a ll e grandi potenze con finanti.
Ma anche il semp lice atteggiamento difensi\'O richiedeva una notevole serie di provvedimenti riguardanti il reclutamento, l'addestramento, le scorte, la difesa delle coste, la costruzione di fo11ificazioni per c hiude re i passi alpini e la di spo nibilità di forze a ridosso de ll e frontiere, la si stemazione a difesa di l ocalit à intern e strat eg i c he, prima fra tutte la capi ta le . l 'a ll es timent o di navi , ecc., provvedimenti tutti c he richiedevano tempo e sopra11utto denaro.

In questo quadro il problema della fo11ificazione per la copertura delle frontiere terre.stri e marittime avev a un ' importanza e priorità notevo li ss ime anche in base ali' impo rtanza assunta dalla funzion e strategica d e ll a radunata.
Ora la contrazione degli spazi esistenti fra gli opposti schieramenti rendeva più probabile e temibile c he nel passato il pe ri co l o <li un 'aggressione o di una rapida in vasio ne e quindi impo rt ante ed urgente era il pro blema de lla fortificazione.
Ma molto, anzi t roppo se ne parlò e discusse senza decidersi a mettere mano al lavoro; il Ministro aveva a cuore il problema e lo dimostrò con la richiesta di un'assegnazione straordinari a per fortifica re La Spezia e c r ear e il co rpo d eg li A lpini , ma di pian o o rganico rea li zza t o nessu na tracc ia.
Dal '72 al i' '80 nessuno deg li stanziamenti straordinari prev id e spe se spec ifiche per la costruzione di opere fortificate di rilevante interesse e solo nel giugno del 1880 vennero stanzia ti 25 milioni, ripartibili in cinque anni, per la costruLione di opere di difesa a sbarramento delle valli alpine e per l avori cli difesa d ell e cos te. Gli anni Ouanla furono anni cli notevo li pos si bilitft finanziarie, durante i quali anc he il probl ema d ell a copertura ebbe su ffici ente sv ilupp o si a so tt o il profilo dell a cos truzi one delle opere permanenti che del l oro armamento ed equ ipaggiamento.
Po i tull o o quasi si fermò.5
Gli anni Novanta si apriron o co n una fort i ss ima crisi economi ca che p ose in drammatica evidenza il deficit del bilancio dello Stato. li primo obiettivo della po litica finanziaria di ogni governo che si rispetti, e qu elli di allora non furono eia meno, fu il ritorno al pareggio del b il ancio statale, che poteva esse re raggiunto so l o con un severo contenimento delle spese, non potendos i u lt eri orm ente grava re cli tributi le
132 La difesa dell'Arco Alpino
'S1u-,,,1. La Storia della Dottrina e degli (hr/i11a111emi de/l'L'sercito ltaluuw. Roma. SJ\11:. <!c.J .• \'OI. I. pag. :mo.
già tartassate classi popolari e non volendo quelle agiate compiere ulteriori sacrifici.
È chiaro che, essendo le spese militari una tra le più consistenti uscite statali, si tendesse nell'ambito del raggiungimento del pareggio ad una loro drastica riduzione. Nella lotta fra politici e militari prevalsero i primi e nell'ambito delle Forze Armate la Marina, che riuscì a mantenere quasi integri i suoi stanziamenti. Si ri corse ad una politica economica ridotta all'osso, necessaria per assicurare la pura sopravvivenza all'esercito senza sciogliere comandi e reparti. Si ricorse
"alla disperata ricerca di tagli di spesa da effenuare senza riguardo all'efficienza ed al morale dell'esercito, purché fossero salve l'intelaiatura di Comandi e Reparti e l'entità quantitativa del Corpo ufficiali."'6
Autore sagace di questa difesa ormai arroccata sulle ultime linee di resistenza fu il Gen. Pelloux, che cercò di tamponare le falle e di utilizzare ogni espediente che consentisse di sopravvivere
lìno a l giorno in cui l'aumento del bilancio non permenesse di tornare all'amico.'' 7
L'infelice giornata di Adua, maturata anche in segu ito a questo penoso quadro, acuirà la si tuazione e l'esercito vivrà anni di profonda insoddisfazione dovuti all'incremento zero dell'aumento della sua professionalità e capacità di difesa e ad un utilizzo in 0.P. e P.C. chiaramente non realizzanti.
L'infelice esito della campagna '95/96 in Eritrea e la grave posizione finanziaria derivatane allo Stato determinarono come conseguenza negli anni successivi una stasi pressoché total e nei lavori di fortificazione; questa fase di aITesto fu così vistosa che gli esperti austriaci, più che attenti osservatori delle vicende italiane, individuarono nel 1890 la fine del primo periodo di fortificazione del Regno d'Italia ed appena nel 1904 l'inizio del secondo.
Fo11unatamente per la difesa del Regno, ne l periodo '95/99 il viaggio di Stato Maggiore (istituito dal Capo di S.M.), preso atto della situazione fortificatoria del momento, rend eva note una serie di proposte che integralmente si allegano così come vennero esplicate nel 1900 e riportate dal Rovighi nella sua opera sulle relazioni italo-svizzere.

La relazione del viaggio evidenzia l'attività fo11ificatoria svolta da Francia e Austria e le preoccupazioni sorte nell'ambito dello S.M. a proposito del confine con la Confederazione El veti ca.
Le assegnazioni straordinarie che il Ministro della Guerra riuscì a strappare servirono al piccolo cabotaggio, destinando, per ciò che riguarda questo studio, alle opere militari ed alla fortificazione le somme necessarie a portare a compimento i lavori degli anni precedenti, piuttosto che ad iniziarne dei nuovi; era poco, ma serviva a tenere accesa la fiammella.
Sorge quindi, con lavori iniziati nel 1898, il fo11e dello Chabe11on, unica strn ttura di rilevanza di cui si ha notizia fino al 1904. L'opera si ispira ad eccezionale concezione tattica ed è rivolta a scopi spiccatamente offensivi. Si tratta del più alto fo11e d'Europa (quota 3135) ed è classificato opera autonoma ad azione lontana (di interdizione) con azione sulla lin ea di operazioni Durance-Dora e specialmente sulla conca di Briançon. È un'opera anomala nel paesaggio difensivo dell'epoca, ma prevista dalla vigente concezione fo11ificatoria e rappresenta, secondo la pubblicistica frances e del tempo artatamente gonfiata, un validissimo stmmento di minaccia nei confronti della Francia, schierando otto pezzi di medio calibro in torre con cupola a ridotta protezione tipo A.M., destinati a battere in profondità obiettivi nel paese nemico.
Concorrono alla difesa indiretta dell'opera, secondo le tendenze dell'epoca, gli apprestamenti difensivi sottostanti il forte, individuabili, sul versante nord, nel complesso di trinceramenti, opere in calcestruzzo ed in caverna, costituenti il caposaldo Chabe11on. Su l versante sud le provenienze avversarie sono intercettate dall'organizzazione approntata nelle località di Batteria bassa (quota 1909) e alta (quota 2195) del Petit Vallon; in località Porton (quota 2600) un'interrnzione a mine predisposte intercetta la mulattiera di accesso allo Chaberton.
6 ROCHAT, Breve Storia de/l'Esercito ltalia11 0, Torino, Einaudi ed. pag. 127.
7 ROCHAT, op. cil. pag 127
Dal 1888 al 1904 /33
Alla lu ce di quanto successivamente accaduto nel giugno I 940, allorché l'azione di mortai francesi distrusse sei delle otto ton-i, si può dire che una frettolosa e pedissequa applicazione della teoria in vigore aH'atto della costruzione. la paw-a che un eccessivo accumulo di neve a seguito di abbondanti precipitazioni, occludesse Je cannoniere di artiglierie poste in caverna o impedisse la rotazione di torrette realizzate a copertura di pozzi, l'inesistenza di offesa aerea o di mortai in grado di colpire il forte, portarono a scartare la soluzione caverna o pozzo e a realizzare invece un gigante n on dai piedi, ma dalla testa d'argilla, con i pezzi collocat i .in installazione metallica leggera, alla sommità di otto torri internamente cave, per l'inserimento del montacarichi per le munizioni, ed elevantesi dal piano d'appoggio di ben 7 metri.

Il complesso cannone -casamatta era stato studiato appositamente dalla ditta A1rnstrong per installare in opere realizzate in alta montagna il cannone italiano da 149/35, una volta scartata la soluzione inglese, che prevedeva l'utilizzo di un pezzo inglese da 152 mm.
La relazione riportata dal Rovighi evidenzia come lo stato dell ' economia nazionale abbia portato, o meglio, non abbia consentito una valida sistemazione alla frontiera, le cui vistose lacune ora emergono, premendo sui governanti che si vedono messi di fronte alla reale situazione; alcune note mettono in luce come una successiva commissione speciale, presieduta dall'erede al trono. abbia confennato, salvo quelle evidenziate eccezioni, la situazione messa in luce dalla relazione finale dei viaggi di Stato Maggiore e ne abbia concordato in linea di massima i provvedimenti.
Sotto questa press ion e qualcosa si mosse e. con il 1904. riprese con maggior lena e vigore la realizzazione delle strutture fortificate individuate come necessarie alla difesa dello Stato, attuando i nuovi moduli difensivi, fra i cui artefici l' It alia annovera il Gen. Ro cchi.
134 La difesa Alpino
8
7
78. Vista d ' insieme de ll e torrette del forte Ch aberton.
RELAZIONE FINALE DEL VIAGGIO DI STATO MAGGIORE AI CONFINJ DEL REGNO NEL 1900 PER LA RIORG ANIZZAZZIONE DELL'ASSETTO DIFENSIVO DELLA FRONTIERA
R elazione espressa sotto forma di ··considerazioni sintetiche sulla jì·ontiera terrestre dell' Italia" del viaggio di Stato Maggiore compiuto dagli alti vertici del Regio Esercito per rendersi conto della esaua situazione alle frontiere del Regno (riportata da Alberto Rovighi in "Un secolo di relazioni militari Ira Italia e Svizzera". R oma SME - Ujf Storico ed., pag. 306 -313).
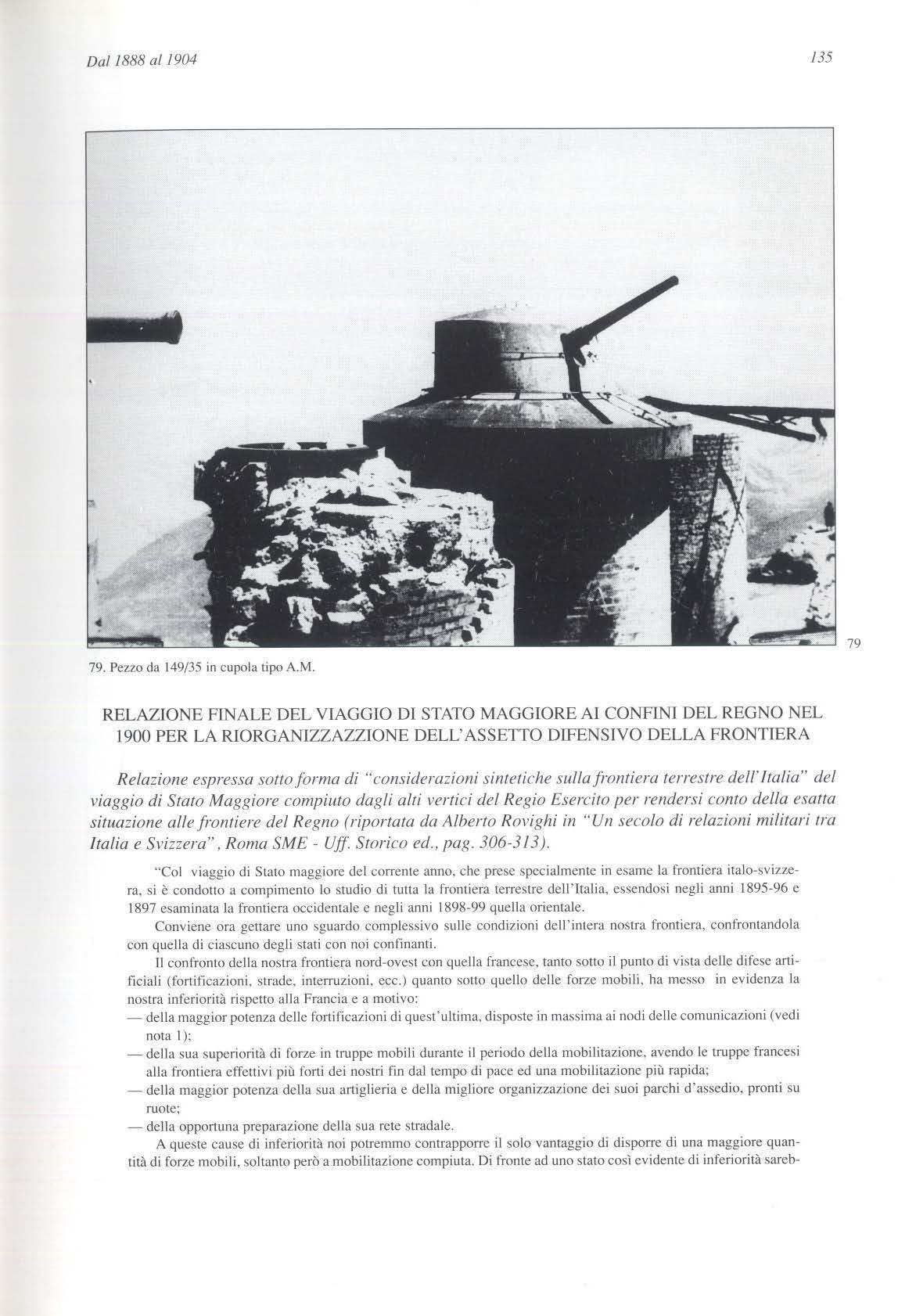
'·Col viagg io di S tato maggiore del corrente anno. che prese specialmente in esame la frontiera ital o -svizzera. si è condotto a compimen to lo studio di tutta l a front iera terrestre dell'Italia, essendos i negli anni 1895-96 e 1897 esaminata la frontiera occidentale e negli anni 1898 -99 quella orientale
Conv iene ora gett are uno sguardo complessivo su lle co nd izion i del l 'intera nostra frontiera, co nfrontandola co n quella di ciasc un o deg l i stati con n o i confinan t i.
Il confronto della nostra frontiera nord- oves t con quella francese, tanto sotto il punto di vista delle difese artificiali (fortificazioni, strade. interruzioni. ecc.) quanto sotto quello delle forze mobili. ha messo in evidenza la nost ra in feriorità rispetto alla Francia e a motivo:
- della maggior potenza delle fortificaz io ni di quest ' ultima, disposte in mass im a ai nod i delle comu ni caz io ni (vedi nota I):
- della sua superior ità di forze in truppe mobili durante il period o della mobilitazione. avendo le truppe fra nces i alla fron t iera effettivi più fo rti dei nostri fin dal tempo di pace ed una mobilitazione più rapida;
- della maggior potenza della sua art igl ieria e della migliore organizzazione dei s uo i parchi d'assedio, pronti su ruote;
- della opportuna preparazione della s ua rete stradale.
A queste cause di inferiorità noi potremmo contrapporre i l solo va n taggio di dispon·e di una maggiore quantità di forze mobili, so lt anto però a mobilitazione compi uta. Di fronte ad uno stat o così evidente di inferiorità sareb -
Dal 1888 al 1904 135 •
79. Pezzo da 149/35 in cupola tipo A.M.
79
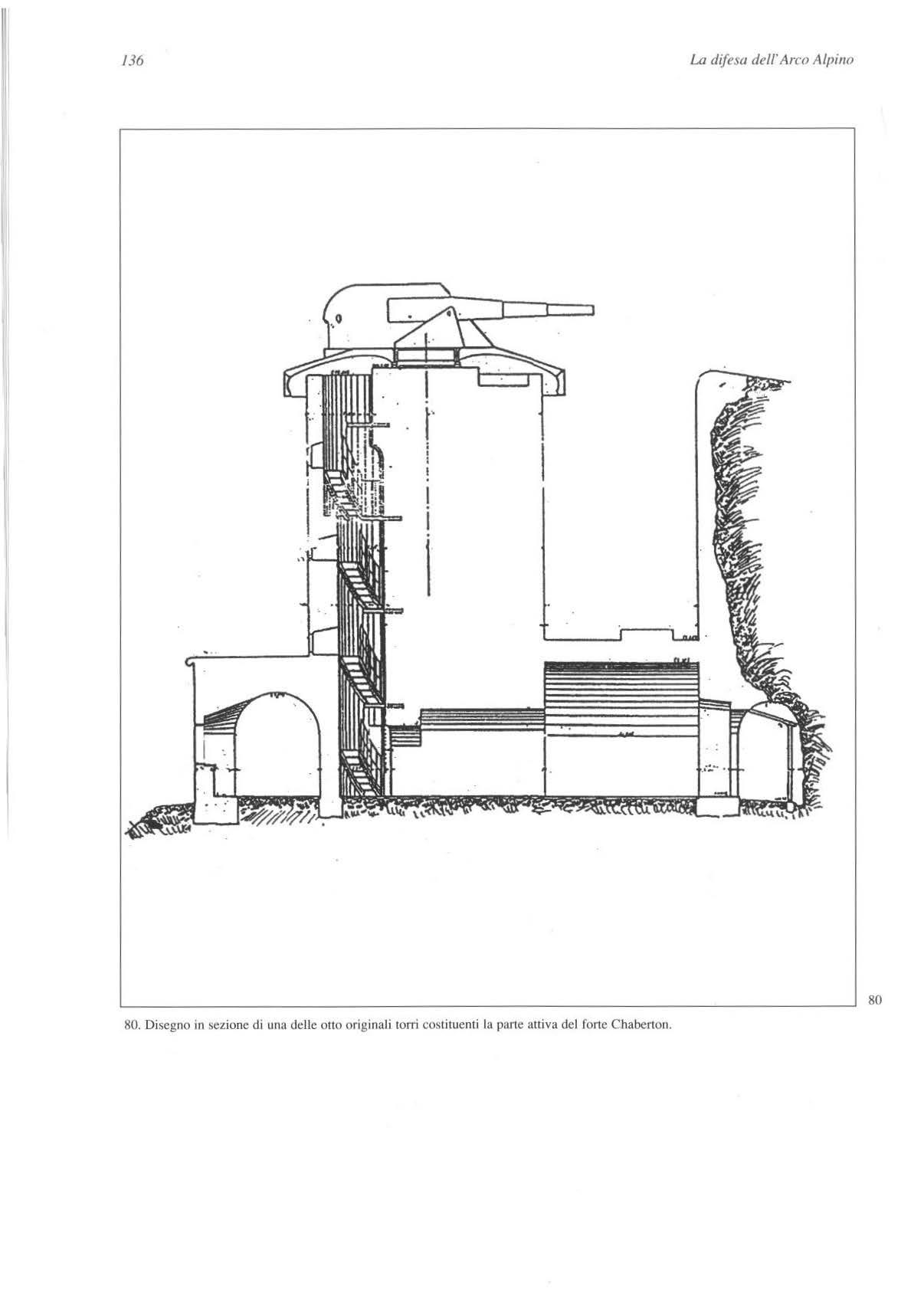
136 La difesa dell'Arco Alpino----------· 80
80. Disegno in sezione di una dell e otto originali torri costi tuenti la parte attiva del forte Chaberton.
be parso cosa naturale di tendere allo scopo di rafforzare siffattamcnte l ' asseno difensivo della nostra frontiera nord-ovest, da poter equi li brare i vantagg i che la Francia ha sopra d i noi.
Ma si co nobbe che i lavori per l'organizzazione difens i va d i quella frontiera. eseguiti in base a conceni i quali. per una serie di cause che qui non occorre indagare. andarono soggetti a variazioni sostanziali , erano tali e così avanzali, da non ammeuere un mutamento radicale se non con gravissimo dispendio ed a scadenza. e che conveniva perciò li mit ars i a rendere si cura la mob ilit az i one del nostro esercito. aumentando di tanto la forza di resistenza della front i era. c he bastassero a difenderla solo le truppe l eggere (a l pini. bersag li eri, art i gl ieri a da montagna) soste nu te, in date event ualità, da truppe di rincalzo.
A questo scopo tendevano appunto le proposte co nt enute nella Relazione del viaggio d i stato maggiore dell'ann o 1897 per la riorganizzazione dell'assetto d i fensivo del l a frontiera occidentale, le quali si possono riassumere come segue:
1° Valle d'Aosta. Costituzione dello sbarramento avanzato d i Pré S. Didier e rafforzamcnLO d i quello arretrato di Bard.
2
° Moncenisio. Rafforzamento dello sbarramento anuale, ricorrendo a corazzature cd a nuove opere.
3° Valli Dora-Chisone. Abbandono della linea avanzata di difesa a Cesana. conservazione della medesima a Bardonecchi:1. soppr i mendone però le opere di monte Gasparre a Tre Croci: raffor1;amento della l in ea arretrata, occupa nd o con opere della fortificazione permanente l a co nca dell'Oulx. rafforzando Exi ll es , I' Assietta e Fenes trelle.
4° Valli Varaita. Maira, Stura:
a) opere di sbarramen10 ne l la Val Varaita presso Sampeyre;
b) ope re di sbarramento della Val Moira presso Anso l eglio;
c) occupazione della Regione del Mulo con un a balleria permanente nel l a posizione del Pulpito;
d) occupazione con opere permanenti delle Barricate di Val Stura, del Colle della Cia ld o l et1a;
5° Valle del Gesso. Opera di sbarramento presso Valdieri.
6° Regione ira Roja e Nervia. Preparazione di u no sbocco offensivo verso la Francia e di balterie. al fine di precluderlo al nemico.
7° Appennino Ligure. Miglioramento degli sbarra111e111i di Nova e Zuccarello. Anche sull a frontiera nord - est. i; risultato che l e condizioni nostrt: sono in uno stato di no tevo l e inferiorità rispet10 a quelle del!' Austria a motivo:
- della insufficienza del nostro assetto difensivo, in pa ragone a quello assa i forte dell'Austria (vedi nota 2);
- delle condizioni per noi svantagg i ose nel teatro di operazioni ciel Ve neto or i entale. avvo lt o da tre lati dalla frontiera austriaca:
- dal l e sfavorevo l i condiz i o ni della nostra rete ferroviaria, l a quale. prolungandosi oltre il Piave con due sole li nce, rende impossibi l e la nostra radunata al confine orien tal e in tempo opportuno, in confronto a quella aus1riaca che può eseguirsi per sei lin ee fino a cuna prossimità della frontiera;
- delle maggiori d i fficoltì1 per noi, ove riuscissimo ad operare offens i vamente al di là della front i era dell'est. di procedere oltre, causa le strade sempre meno numerose, che non per l'Austria che varcato i l nostro confine, po trebbe avanzare nel nostro territorio per ben nove strade in dipendent i
Gli stud i fall i condussero a stabilire che, a toglier di mezzo le cause della nostra in feri or i tà ove le condizioni lìnanziarie co nse nt isser o di afTronta re il p roblema in 1ut1a la sua imerezza, i mezzi più adaui po trebbero consis tere:
I O nel c hiudere l a frontiera Nord e quella del Friuli;
2 ° nel migliorare la no stra rete ferrovia ri a prima ed o ltre il Piave;
3° nell'addensare i presidi ve rso la frontiera dell'est e nel portarvi fin da l tempo di pace il confine di due. anzic hé di u n so l o Corpo d'Armata;
ma che, tenendo presente lo stato delle nostre finanze. così dispendiosi provveclirne mi non po trebbero avere attu azione. onde. pur 1enendo di mira il fine ul tim o da raggi ungersi , conveniva limitarci a provvedimenti più urgenti, così concretati:
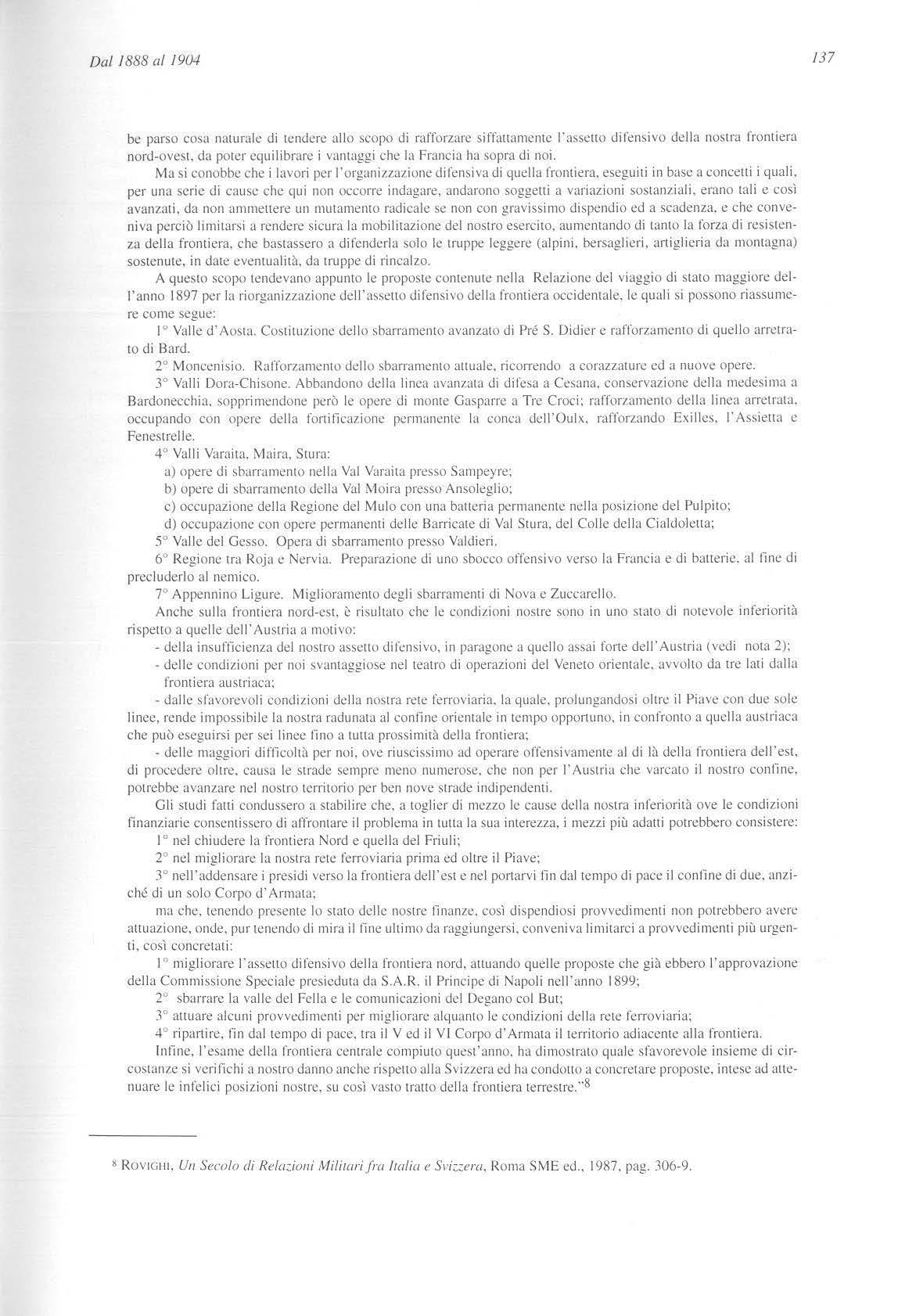
1° migliorare rasseuo difens i vo della frontiera nord, auua ndo quelle proposte che già ebbero l'approvazione della Comm i ss i one Speciale presieduta da S.A.R. il Principe di Napoli nell'anno 1899;
2 ° sba rrare l a valle del Fella e l e comunicazioni del Degano col But;
3° au uare alcuni provvedimenti per m i gl i o rare alqu ant o le co ndi z i on i della rete ferroviaria;
4 ° ripartire, fin dal te mpo di pace. tra il V ed il VI Corpo d'Armat a il terr it ori o adiacente alla frontiera.
I nfine, l 'esame della fromiera centrale co mpiuto quest'anno. ha dimostrato q ual e sfavorevole insieme cli circostanze si verifich i a nostro danno anche rispetto al la SviZLera ed ha condo t10 a concre tare p roposte, intese ad at1enua re l e infcl ic i posizioni nostre, su così vasto tratlo della frontiera 1erres1re."8
Dal 1888 al 1904
8
1987,
306-9 137
Rov1G111. Un Secolo di Rela::.io11i Militari.fra ltctlia e S,·i::.::.era. Roma SME ed.,
pag.
Il co nfin e italo-svi zze ro dev e esse re visto nella duplice o ttica di un attacco italiano alla Svizzera o di penetrazione svizzera in Italia. La prima ipotesi deriva dall'intesa allora stabilita con la Germania, nell'ambito della Triplice Alleanza, per rinforzare le truppe tedesche contro la Francia. La seconda è frutto dell'ipotesi della rottura della neutra lit à svizzera, dovuta certamente al prevalere degli c lementi tedescofili nell'ambito della Confederazione.
Esaminando accuratamente il confine alla luce delle due ipotesi prima formulate, si è portati a concludere come l'azione difensiva svizzera sia in condizioni più favorevoli della difensiva italiana, ai cui danni cospirano le condizioni geografiche dovute alla sfavorevole configurazione del terreno, le condizioni politiche, a causa del tracciato della frontiera assai svantaggioso, le condizioni militari, a causa dell'assetto difensivo e della minor ce lerità della mobilitazione attuabile dall'esercito italiano.
Molle dannose conseguenze derivanti da questo stato di inferiorità scomparirebbero o si attenuerebbero qualora la neutralità svizzera fosse rispettata, ma poiché non si poteva fare sicuro affidamen10 su tale assoluta neutralità, si rese necessario cautelarsi anche in questo settore della frontiera. Preceden ti commissioni avevano segnalato la necessità di lav or i fortificatori, ma il raffronto fra le fo1ti spese da sostenersi ed il possibile, larvato pericolo, avevano fatto optare per la soppressione, nell'edizione ridotta del piano fonificatorio nazionale, di tali lavori. Ma alle soglie del 1900 l'esigenza di realizzare i lavori precedentemente cassati s i ripropone in tutta la sua forza.
La relazione del viaggio di Stato Maggiore dell'anno 1900, oltre a sposare le conclusioni tratte dalle Commissione Speciale del I 898, per ciò che attiene le opere da realizzarsi a difesa dei passi del Sempione e Gran San Berna rdo, propone di far realizzare i segue nti lavor i:
Località
Valle del Toce
Lavori proposri
Valtellina
App os tamenti per arligl ieri e eia campagna a Ponte Maglio e Monte Cretese; Piccola opera in casamatta lungo la rotabile Olgia-Santa Maria Maggiore-Domodossola; Interruzioni strada li lungo la stessa rotabile; Piccola opera in casamatta presso Canobbio; Int erruz ioni stradali ne i pressi di Canobbio; Appostamenti per pezzi di artiglieria di medio calibro presso Colico;
Occupazione co n batterie permanenti di Le Motte di Oga (Bormio);
Occupazione con batterie permanenti della località I Corradini presso Tirano; Ridu zio ne a rotabile della strada che, auraverso il passo di Foscagno, congiunge Semogo con Livigno;
La loro attuazione non risolv e radicalmente il problema ma con essi si tende ad otte nere , con un minimo cli spesa, il massimo di sicurezza, compatibilmente con le condizioni finanziarie e con le richieste ritenute più impellenti di realizzazioni clifensive alle frontiere nord -ovest e nord-est.
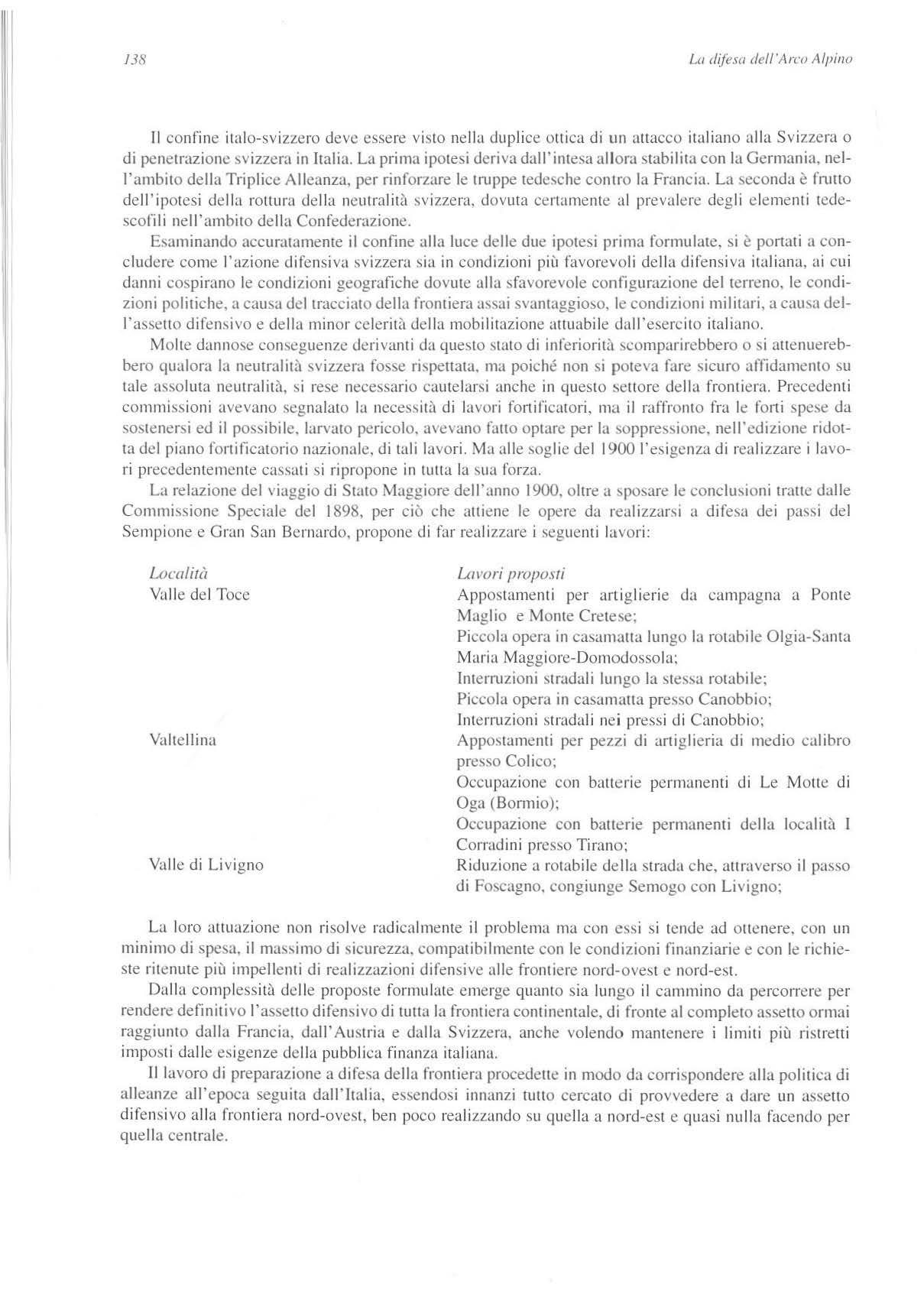
Dalla complessità de ll e prop os te formu late emerge quanto sia lu ngo il cammino da percol1'ere per rendere definitivo l'assetto difensivo di tutta la frontiera continentale, di fronte al completo assetto ormai raggiunto dalla Francia, dal!' Austria e dalla Svizzera, anche vo lend o mantenere i limiti più ristretti imp ost i dalle esige nze della pubblica finanza italiana.
Il lavoro di preparazione a difesa della frontiera procedette in modo da corrispondere alla politica di alleanze all'epoca seguita dall'Italia, essendosi innanzi tutto cercato di provvedere a dare un assetto difensivo alla fr o ntiera nord-ove st, ben poco realizzando s u quella a nord-est e quasi nulla facendo per quella centrale.
I I I I I 138 La difesa dell'Arco Alpino
Vall e di Livigno
La Commissione Speciale presieduta dal Principe di Napo li , fin dal 1898 si era pronunciata sul modo di ovv i ar e al le piL1 importanti lacune che ancora numerose esistevano sull a frontiera nord-ovest. È da tenere presente però che anche alcuni provvedimenti che si riferiscono all a frontiera svizzera dovevano essere considerati come indispensabili, poiché servivano a completare le difese verso la Francia; tal i eran o le opere già progettate per il Gran San Bernardo e il Sempione e lo sban-amento, solo allora proposto, delle a ltre linee di accesso alla vallata del T oce. A quel momento le proposte relative alla frontiera no rd -est non rivestivano carattere di urgenza immediata, ma l o sarebbero divenute man mano che aumentava la possibilità di un diverso orientamento de ll a politica italiana. Po i ché era pressoché impossibile sperare che si potesse provvedere, anche affronta ndo gravi sacrifici, alla l oro realizzazione al momento del bisogno, all o scopo di evitare di essere co lti impreparati, era indispensabile fin dall'inizio dar mano ai lavori c he, ritenuti necessari, erano stati definiti i n ordine di p ri orità dal l a Comm i ssione de l 1899.
Il relatore del viagg i o, esaminando l a frontiera nord o centrale, ri levava inoltre come le proposte falle richiedessero una spesa molto limit ata, se posta in raffronto al grande vantagg i o che se ne sarebbe tratto ed auspicava che esse ve ni ssero realizzate in un avvenire non troppo l ontano; la relazione si concludeva con l a seguente asserzione:
··Quando un siffauo as~etto difensivo di rn u a l a rrontit.:ra tt:rre~1re possa dirsi raggiunto. e ~ia staio comp l etaIO anche quello delle piazze mar ittime e specialmente di Genova. non soltanto l'avvenire polit i co potrà essei\: guardato con tranquillità e sicurezza. ma l a nostra po lit ica non più vincolata da preoccupazioni d'ordine militare sulla forza di res i stenza dell'u na p iuttosto c he dell'altra frontiera. sarà li bera di seguire q uell'ind irizzo eh..: sa r à per mos trarsi più rispo ndente agli interessi del Paese."9
La relazione del v iagg i o è integrata da due note, che si riportano integralmente, poiché in esse viene ev idenzi at a, e direi quasi fotografata, la situ azione difensiva d i Francia ed Austria alle rispettive frontier e co n l ' Itali a. No ta l
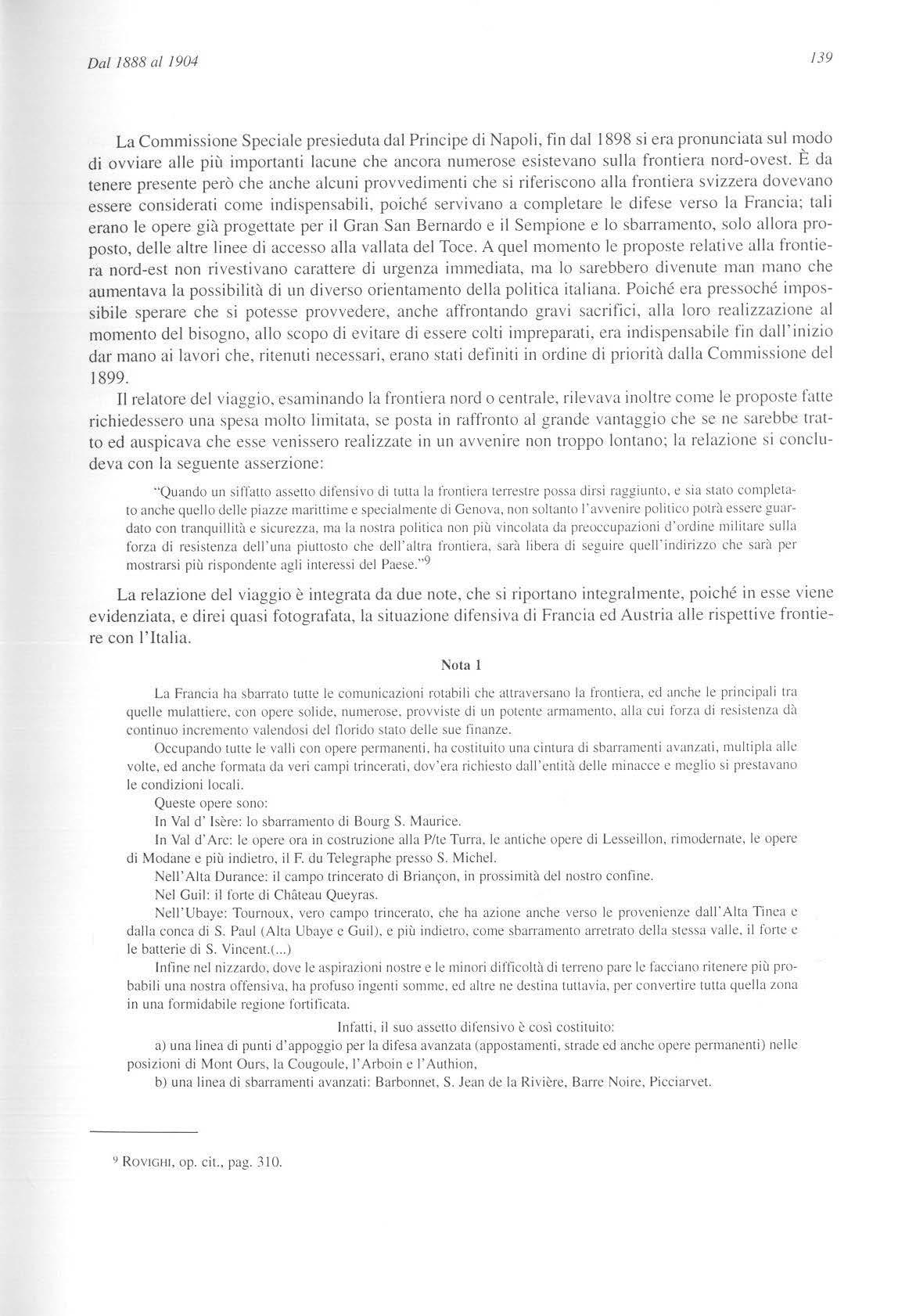
La Francia ha sbarrato tulle le comunicazioni rotabi li che auravt:rsano la frontiera. cd anche l e principali tra que ll e mulattiere. con opere sol id t:, numerose. provviste di un potente armamento. all a cui forza di resistenza dà continuo incremento valendosi del il orido stato delle sue finanze.
Occupando tutte le val li con opere permanen ti. ha costi tuito una cimura di sbarramenti avan1.a1i, multipla alle volte, ed anche formata da veri campi trincerati. dov'era richics!O da ll 'entità del l e minacce e mt.:gli o si prestavano le condiz i oni loca li.
Queste opere sono:
I n Va l d' l sère: l o sbarramento di Bourg S. Maurice.
I n Val d' A re: le ope rt: ora in costruzione alla Pile Turni. le ant i che opert: di Lesseillon, rimodernate, le opere di Modane e pi ù indietro, il F. du T c l egraphe presso S. Michel.
Nell'A lt a Durance: il campo trincerato di Briançon, in prossim it à del nost ro confi ne.
Nel Guil: il forte di Chàteau Queyras.
Nell'Ubaye : Tournoux. ve ro ca mpo trin cerato che ha azione anc he verso l e provenienze da ll 'A lt a Tinca e dalla conca d i S Paul (Alta Ubaye e Guil). e più indietro, come sbarrame nt o arretralo della stessa val l e. i l forte e l e batter i e di S Vincem ( )
lnlìn e nel n i zzardo. dove k asp ira zioni nos tre e le minori d iffico lt à di te r re no pare l e facc i ano ritenere più probabil i una nostra offensiva, ha profuso ingenti somme. cd altre ne d.:s tina tu ttavia, per conve n ire tu tta quella zo na in una formidabile regione fo rtilìc aca.
In fatti i l suo assello d i fensivo è così costitu it o:
a) una l inea di punti d'appoggi o per la difesa ava nzata (appos tament i . strade ed anche ope re permanem i ) nelle posizioni di Monl Ours, l a Cougoulc. I' A rb o in e I ' Aut hion.
b) una linea di sbar ra men ti avanza ti : Barbonnet. S. Jean de la Rivière, Barre Noi re. Picciarvet.
Dal 1888 al /904 /39
9 R OVIGII I op. cit., pag. J ] O.
c) una c in tura di opere stacca te a Mont Age l , Mont Maccaron, Mont Chauve, Mont Colmars. d) un nucleo centrale, costituito dalle opere che, da Capo d'Aggio. per la Turbi e. la Révère, Mont Gros e Mont Alban, coronano le alture ad est di Nizza; e dal fronte a mare.
Di più la Francia ha con cura costante aumentato, a favore degli interessi militari. la sua già ricca rete ferroviaria verso la nostra frontiera ed ha ridono quella ordinar i a in condizione di servire ottimamente a tulli gli spostamenti di truppe, sia verso il confine, sia per trasferirsi dall'uno all'altro scacchiere.
Notn 2
L'Austria ha assicurato l o sbarramento di tutte le strade dul Tonale a l canale di Brenta, col trasformare il Trentino in una vern regione fortificaw, nella quale sorgono quattro grupp i di opere: a Strino (due esistenti e due in progetto). a L arduro. a Riva ed a Lcvico. ed un po1eme nucleo centra l e a Trento. Ha poi sbarrato. con opere (per la maggior parte or ora 1errninate, men tre a l cune sono in cos1ruzione) potentememe casumattate o sotto corazza, ed armale secondo i più recenli sistemi. tulle le s1rade rimanenti. che c:onducono nel Tirolo e nel Pusterthal e quella che danno accesso alla conca cli Tarvis. E c:ioè:
l a strada del Cismone e quella di Val San Pellegrino, coi foni dl.!i Dossac:c:io , dei Busi e di Someda; la strada del Cordevole e di Val Abbad i a. c.:oi forti di Corte. Ruaz e Tra i Sassi; la strada d' Allemagna e la sua sussidiaria per PlatLwiese, c:olle open: di Landro e di Platzwiese. mentre è in p roge t to una n uova opera a Podestagno sulla via cl' Allcmagna. che prec:luderà anche la sussidiaria mulattiera per Federa Yed l a:
l a s1rada di Monte Croce di Comelico coi fon i di Sexten: la linea della Ponwbba. colle opere d i Malborgheno: la strada per la Sella di Ncvea, colle opere pn::sso Raibl; l a li nea del Predii, con quelle d i Predi i , di Fli1 sc:h e co l fone Hermann; infine, è in progetto un ' opera per chiudere l a strada del Pulfero.
Con ciò, I · Aus1ria sta per dare compi mento ad un vasto programma. la cui auuazione è frutto specialmcnlc del l 'indefesso lavoro di questi uhimi anni.
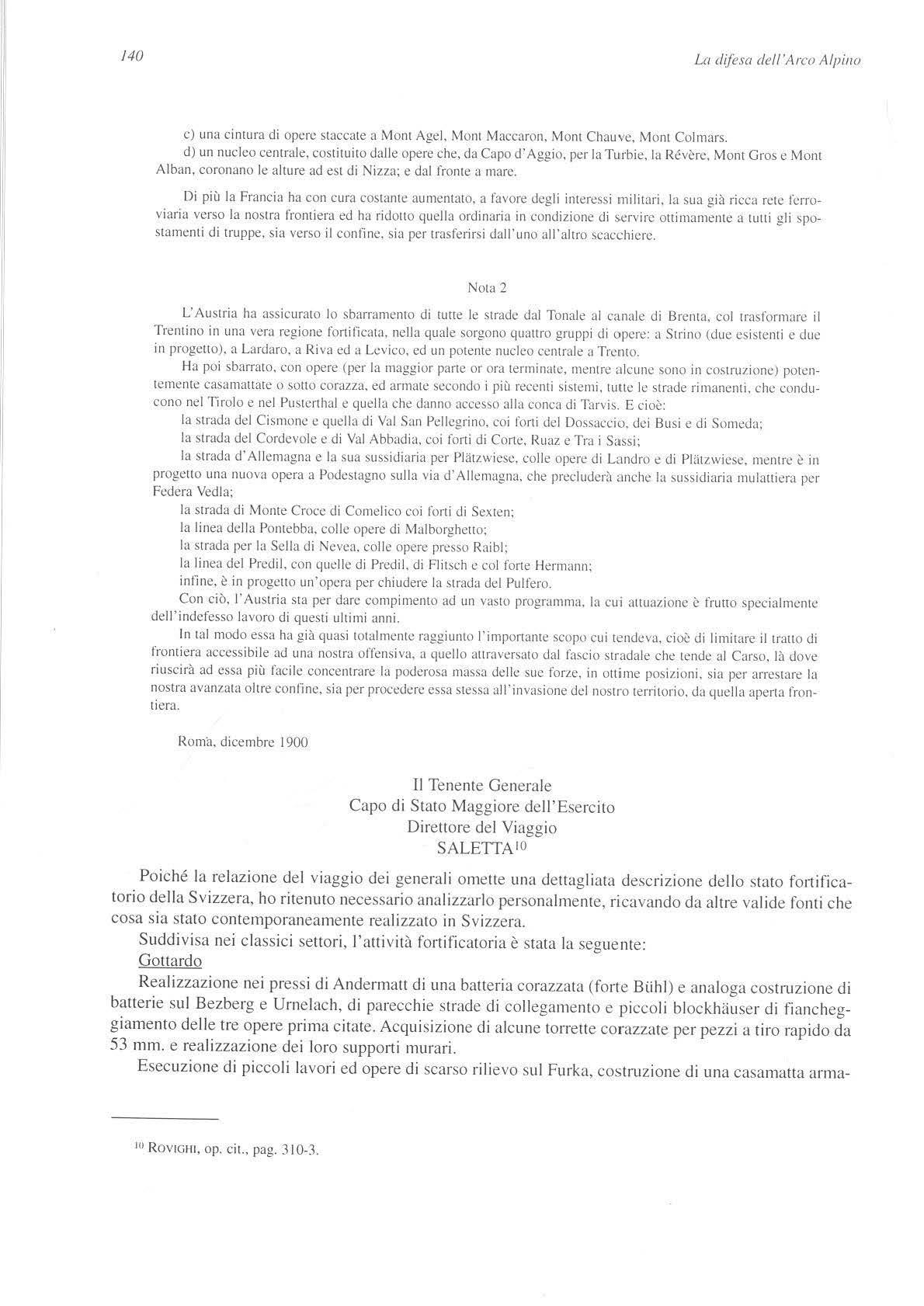
In lai modo essa ha già quasi lOta l mcnte raggi umo l'importante sco po cui tendeva, cioè di limitare il 1ra1to di front i era accessibile acl una nos1ra offensiva, a quello aurave r sato dal fasc:io strada l e che tende al Carso, là dove riuscirà ad essa più facile concentrare la poderosa massa delle sue forze, in ouime posizioni , si a per arrestare la nostra avanzala oltre confine, si a per procedere essa s1essa all'invasione del nostro 1erri1or i o. da quella apena frontiera.
Roma. dicembre 1900
Il Tenente Generale
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Direttore del Viaggio SALEITA 10
Poiché la relazione del viaggio dei ge nerali omette una dettagliata descrizione dello stato fortificatorio della Svizzera, ho ritenuto ne cessario analizzarlo personalmente, ricavando da altre va lid e fonti che cosa sia stato co ntemporan eamente realizzato in Svizzera.
Suddivisa nei c lassic i settori, l'attività fortificatoria è stata la segue nt e:
Gottardo
Realizzazion e nei pressi di Andermatt di una batteria corazzata (forte Bi.ihl) e ana loga costruzione di batterie su l Bezberg e Urnelach, di parecchie strade di co llegame nto e piccoli blockhauser di fiancheggiamento delle tre opere prima citate. Acquisizione di alcune torrette corazzate per pezzi a tiro rapido eia 53 mm. e realizzazione dei loro support i murari.
Esecuzione cli piccoli lavori ed opere di sca rso rilievo su l Furka, costruzione cli una casamatta arma-
140 La difesa dell'Arco Alpino
IO R OV IGHI, op. Cii.. pag. 310-3.
ta di cannoni sul colle del Gottardo per la sicurezza del colle stesso e dei collegamenti Andermatt-Airolo ed infine costruzione di un blockhaus ad Oberalp.
Grimsel
Non è stato realizzato alcuno sbarramento alla strada di Grimsel nell'attesa cli conoscere, da parte di una commissione appositamente nominata, se fosse opportuno realizzare tale sbarramento o piuttosto potenziare le opere viciniori, rendendo efficace il loro intervento su Grirnsel.
Saint Maurice
La posizione è molto importante ed il suo rafforzamento è fonte di animate discussioni fra la Commissione ed il Dipartimento Militare, nonché l'ufficio di Stato Maggiore delle Forze Confederali. Stanti i forti contrasti emersi, venne decisa l'immediata realizzazione di opere solo là ove concordi erano i pareri e precisamente:
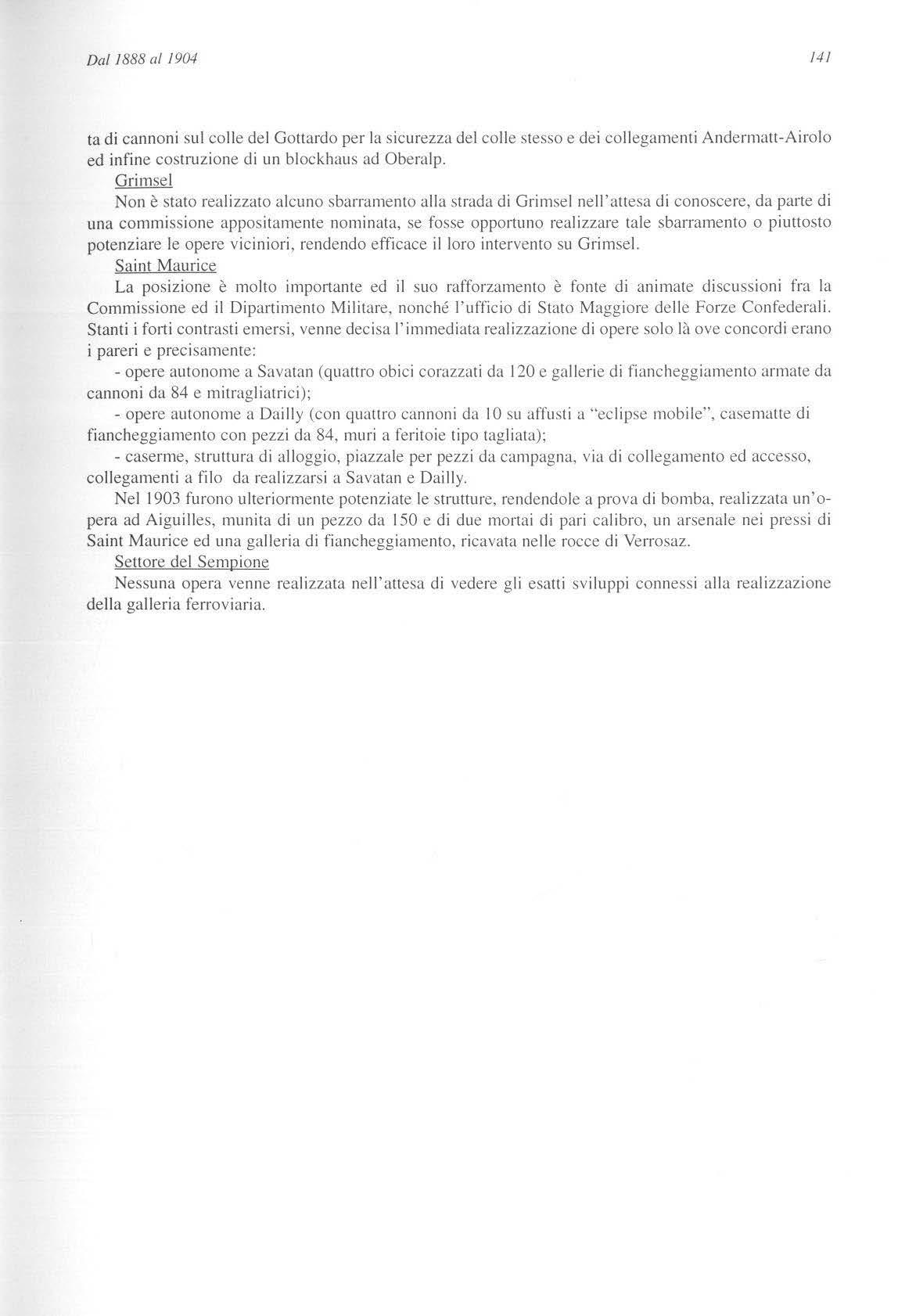
- opere autonome a Savatan (quattro obici corazzati da l 20 e gallerie di fiancheggiamento armate eia cannoni da 84 e mitragliatrici);
- opere autonome a Dailly (con quatlro cannoni da 1O su affusti a "eclipse mobile", casematte di fiancheggiamento con pezzi da 84, muri a feritoie tipo tagliata);
- caserme, struttura di alloggio, piazzale per pezzi da campagna, via di collegamento ed accesso, collegamenti a filo da realizzarsi a Savatan e Dailly.
Nel 1903 furono ulteriormente potenziate le strutture, rendendole a prova di bomba, realizzata un' opera ad Aiguilles, munita di un pezzo da 150 e di due mortai di pari calibro, un arsenale nei pressi di Saint Maurice ed una galleria di fiancheggiamento, ricavata nelle rocce di Verrosaz.
Settore ciel Sempione
Nessuna opera venne realizzata nell'attesa di vedere gli esatti sviluppi connessi alla realizzazione della galleria ferroviaria.
Dal 1888 al 1904 141

Premessa
'Tuili i particolari d'ordinamento di costruzione e di armamento delle opere di difesa, divisate ed erette negli ultimi decenni del secolo XIX sono informati al principio della massa" 1 allorché nuovi e più potenti mezzi di distribuzione sono venuti a perturbare l'equilibrio fra difesa ed attacco, si è provalo a ristabilirlo con l 'aumentare la robustezza dei r i pari. Come nel XV secolo si provvide al colossa l e ingrossamento delle muraglie per renderle atte a resistere al tiro delle artiglierie, così nel XIX seco l o si è ricorsi alle enormi masse di calcestruzzo cementizio per neutralizzare l'azione dei grossi proietti
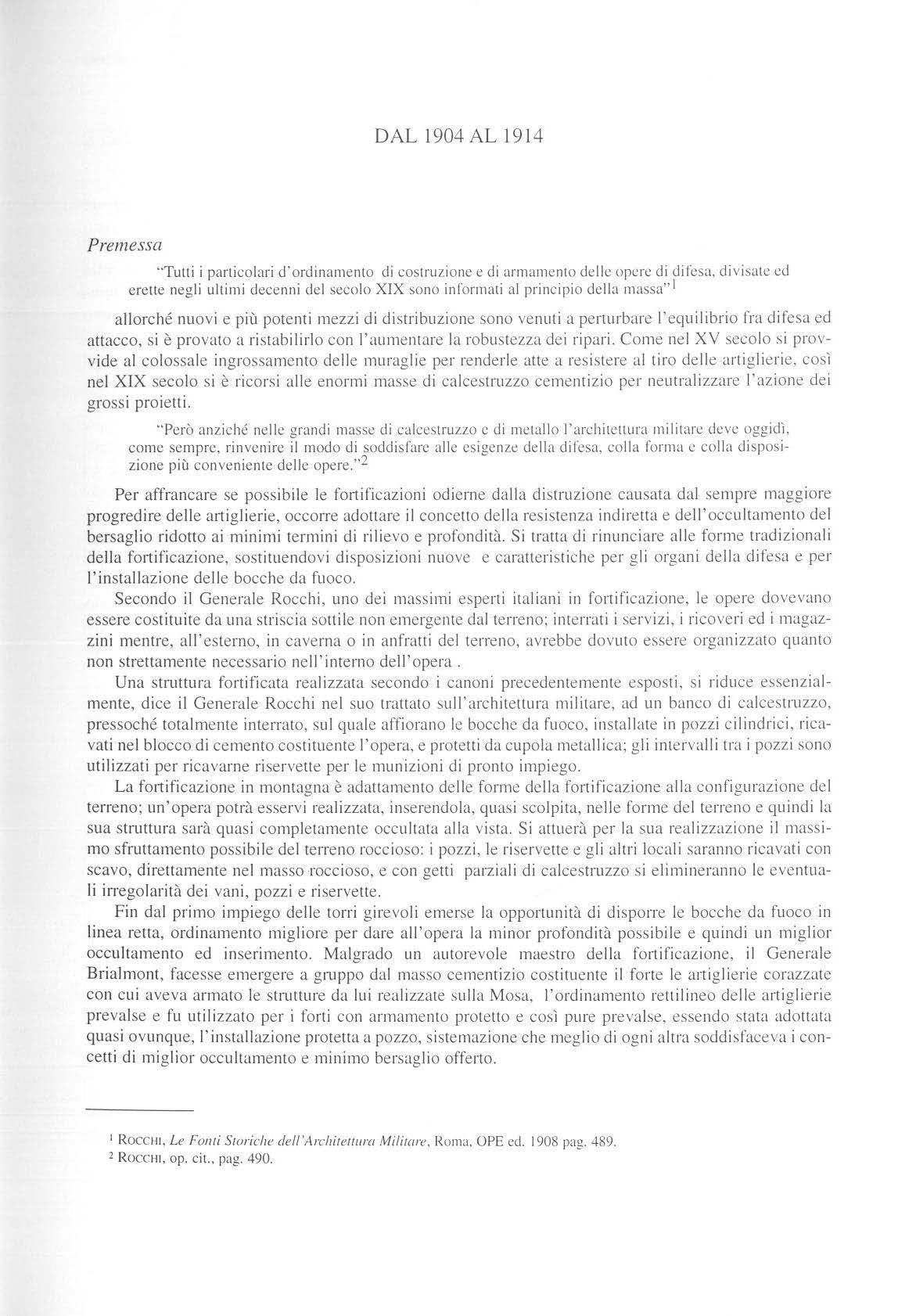
Però anziché nelle grandi masse di calcestruao e di meta ll o l ' architellura militare deve oggidì, come sempre, rinvenire il modo cli soclclisl'arc alle esigenze della cliCesa, colla forma e colla disposizione più conveniente delle opere." 2
Per affrancare se possibile l e fortificazioni odierne da ll a distruzione causata dal sempre maggiore progredire delle artiglierie, occorre adottare il concetto del l a resistenza indiretta e dell'occultamento del bersaglio ridotto ai minimi termini di rilievo e profondità. Si tratta di rinunciare al l e forme tradizionali de ll a fortificazione, sostituendovi disposizioni nuove e carat1eristichc per gli organi della difesa e per I' i nstal !azione del le bocche da fuoco.
Secondo il Genera le Rocchi, uno dei massimi esperti ital iani in fortificazione, k opere dovevano essere cost it uite da una str iscia sottile non emergente dal terreno; interrati i servizi, i ricoveri ed i magazzini mentre, all'esterno, in caverna o in anfratti del terreno, avrebbe dovuto essere organizzato quanto non strettamente necessario nell'interno del l 'opera.
Una struttura fortificata realizzata secondo i canoni precedentemente esposti, si riduce essenzialmente, dice il Generale Rocchi nel suo trattato sull'architettura militare, ad un banco di calcestruzzo, pressoché totalmente interrato, sul quale affiorano le bocche da fuoco, installate in pozzi cilindrici, ricavati nel blocco d i cemento costituen te l'opera, e protetti da cupo l a metallica; g l i intervalli tra i pozzi sono utilizzati per ricavarne riservette per le munizioni di pronto impiego
L a fort ificazione in montagna è adattamento delle forme della fortificazione alla configurazione del terreno; un'opera potrà esservi realizzata, inserendola, quasi sco l pita, ne ll e forme del terreno e quindi la sua struttu ra sarà quasi completamente occultata alla vista. Si attuerà per la sua realizzazione il massimo sfruttamento possibile de l terreno roccioso: i pozzi, le riservette e gli altri locali saranno ricavati con scavo, direttamente nel masso roccioso, e con getti parziali di calcestruzzo si eli mineranno le eventuali irregolarità dei van i, pozzi e riservetle.
F in dal primo impiego delle torri girevoli emerse l a opportu nità di dispone le bocche da fuoco in linea retta, ordi namento migliore per dare all'opera l a minor profondi t à poss ibi le e q u indi un miglior occultamento ed in serimento. Malgrado un autorevole maestro della fo rtificazione, il Generale Brialrnont, facesse emergere a gruppo dal masso cementizio costituente il forte l e artiglier ie corazzate con cu i aveva armato le st rutture eia lui realizzate sul la Mosa, l 'ordinamen to ret1ilineo del le artiglierie prevalse e fu uti li zzato per i fort i con ar mamen to pro1e110 e così p ure prevalse, essendo stata adottata quasi ovunque, l'installazione protetta a pozzo, si stemazione che meglio cli ogn i altra soddisfaceva i concetti di miglior occ ult ament o e minimo bersag l io offerto.
DAL
1904 AL 1914
1 ROCCHI, Le Fonli S1uriche dell'Archi1e1111m Miliwre, Roma. OPE cd. I 908 pag. 489.
2 ROCCHI, op. cit. , pag. 490.
Lo sviluppo a ridosso della Prima Guerra Mondiale. Generalità e criteri di base della 11um 1a fortificazione ( il secondo periodo furtificatorio del Regno)
Come già visto, il maggiore esperto italiano in fortificazioni, il Generale Rocchi, era fautore cli un tip o di struttura ben diverso eia quello fin ad allora utilizzato e che poteva irriverentemente esser visto come una evol uzi one della struttura castellana, e ciò influì in modo fondamentale sulla realizzazione delle fortificazioni italiane. L'evoluzione fortificatoria non investì solamente il campo strutturale della fortificazione ma coinvolse anche quello della installazione delle armi nelle fo1tificazioni, quindi principalmente gli affusti, dovendosi adeguare le strutture difensive al notevole progresso tecnico raggiunto dai mezzi di offesa.
Facendo un breve passo indietro nel tempo, allorché l'adozione delle spolette a tempo e degli schrapne l misero in evidenza la assoluta incapacità cli r esistenza delle murature ordinarie, la inutilità della presenza di parapetti e coperture in terra, emerse chiaramente come fosse sempre piì:t pericoloso mantenere allo scoperto le artiglierie delle fortificazioni; sino ad allora infaui i pezzi delle stru tture fortificate si prese ntavano schiera ti in barbetta su piazzola, incavalcati su affusti da posizione fissi, o, per quelli installati nel le batterie dislocate ad alta quota, su affusto da difesa a ruote, che ne permetteva lo spostamento e la rimozione per l' immagazinamento durante la stag ione invernale. Si r ese pertanto necessario adottare diverse sistemazion i che co nsenti ssero un va lid o utilizzo delle strutture fortificate, adeguandole ai progressi avvenuti. Dopo l e esperienze del 188 I, si cercò di aumentare la resistenza delle vecchie strutture con espedienti di ordine tecnico che culminarono con l 'installazi one nel forte cli Vinadio di affusti a sfera per la batteria omonima, e l'adozione, per talune vecchie strntture dislocate in posizioni fondamentali, di casematte corazzate a cannoniera minima; successivame nte, a seguito dell'uso generalizzato del calcestruzzo, ferro e derivati, vennero adottare le torrette a scomparsa, costruite con lo scopo di tenere i pezzi esposti per il solo tempo indispensabile allo sparo, e le batterie con affusto corazza to in in stalla zione a pozzo protetto da cupola corazzata Gruson.
In dette installazioni, sul fondo del pozzo, ricavato nella massa cementizia dell'opera o scavato nella roccia, era collocato l'affusto disposto sopra una piattaforma girevole; una cupola metallica collocata su ll'orlo del pozzo e resa mobile eia un comp l esso di in granaggi trasc i nava nel suo movimento di rotazione canno ne, affu sto e piattaforma girevole; nella cupola che poteva essere pesante o leggera era ricavata la ca nnoniera attraverso cui fuoriusciva la bocca da fuoco. L'accesso ai pozzi avveniva attraverso corridoi ricavati nella massa dell'opera e comunicava con una galleria interna parallela alla fronte.
L'adozione nel I 905 del nuovissimo pezzo eia 149/35/A, fece sì che nel periodo dal 1904 al 1914, i I Regio Esercito utilizzasse diversi tipi di installazione per i cannoni più comunemente in uso nelJe sue opere e precisamente:
- installazione tipo Ispettorato per cannoni eia I 20/G
- installazione tipo Armstrong per canno ni eia 149/A,
- installazione tipo Grillo per cannoni eia 149/A.
- installazione tipo Ispettorato per cannoni da I 49/G
- installazione tipo Schneider per cannoni eia 149/S;
- installazione in pozzo per cannoni da I 20/40;
Venne inoltre adottato per il solo forte Chabe11on, collocato ad alta quota e non ritenuto possibile soggetto acl offese provenienti dall'alto, una particolare cupola a corazzatura leggera denominata - installazione tipo Armstrong-Montagna per cannone da I 49/A.
In due tavole, rielaborate dalle "Istruzioni su l serv i zio delle artiglierie d'assedio - installazioni a pozzo" edito dal Ministero del kt Guerra in Roma nel 19 I 2, si cercherà, v i sta la loro imp o1tanza nel!'ambito delle strutture fortificate presenti ai confin i italiani, di dare una panoramica di tali installazioni.

144 La difesa dell'Arco Alpino
LE CUPOLE CORAZZATE PIÙ DIFFUSE IN ITALIA ALL'INIZIO DEL '900
a) Installazione tipo AM (Armstro ng per opere i montagna), per canno ne da 149 A.
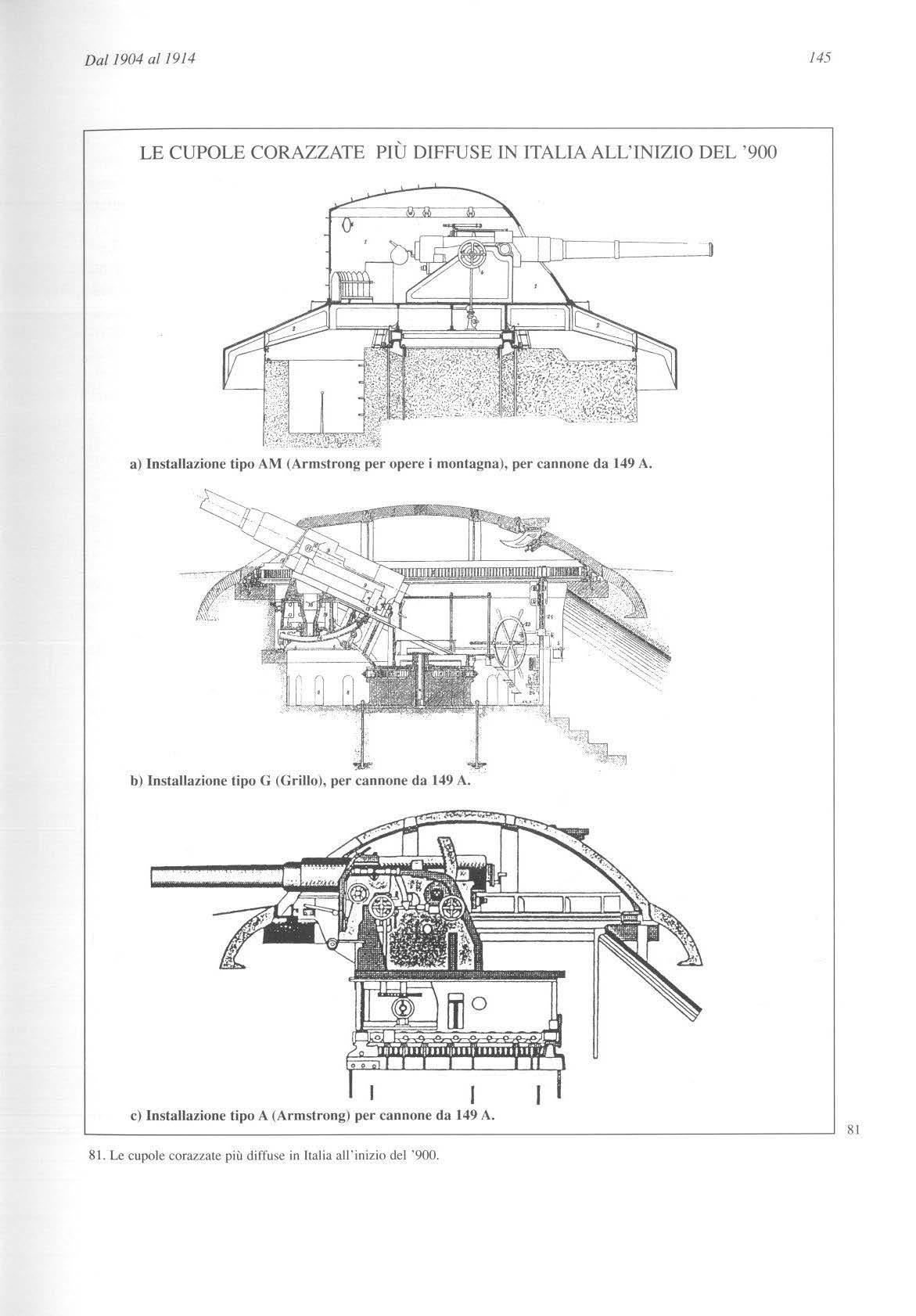
b) Installazione tipo G (Grillo), per ca nnon e da 149 A.
Installazione tipo A (Armstrong ) per cannone da 149 A.
Dal 1904 al 1914 145
81
e)
81. Le cupole corazzate più diffuse in Italia all'inizio del '900.
a) Ins tallazione tipo A (A rm s trong) per cannone da 120/ 40
b) In stallazione tipo I ( Is pettorato) per cannone da 120 G
c) In s tallazione tipo S (Sc hneider ) pe r ca nnon e da 149/35 S
82. Le cupo le corazza te più diffuse in Italia all'inizio del '900.

/46 La difesa dell'Arco Alpino
82
Opere con questo tipo di installazioni e rispondenti ai canoni del Gen. Rocchi fiorirono un po' dovunque sull e Alpi, all orché l'Italia di Giolitt i , non più condizionata da remore finanziarie, vo ll e impegnarsi in un inu si t ato sforzo cli rafforzame nto militare che mirava tra l 'a ltro ad aum entare, nell 'ambito della Triplice, il peso militare italiano.
Tra il 1904 ed il 1915 si co ll oca quindi il Il periodo di fortificazione del Regno d'Italia, periodo che vede l o sboc c iare alle frontiere di nuove opere, l'adeguamento delle vecchie, l a riesumazione di q uei progetti di fortificazione che, diligentemen te preparati da ll a Commissione Suprema per la difesa dello Stato, erano stat i fino ad allora se non totalmente almeno per una buona parte disattesi.
Si opinò che la cos t1u zione cli opere fortificate in corrispondenza ciel confine orientale avrebbe potuto sollevare ob i ezioni da parte dell'A ustri a, nostra alleata nella Triplice, ma il vero motivo della mancata fortificazione fu l'indisponibilità finanziaria, tanto è vero che, un a vo lta che questa venne meno, si diede tranquillam ente co r so all'attività fortificatoria proprio su quel confi ne, anche se si stava rinnovando i I trattato di all eanza.
Se vi fu una stasi nella fort ifi cazione questa non intral ciò lo svi l uppo delle truppe alpine che, create con compito di cope1tura nell'ambito di una politica st rellarnente difens i va, ebbero uno svi luppo progressivo assa i rapido.
li problema della copertura fu quindi vivamente sentito ma bisognò attendere l'ascesa del Gen. Pollio a capo di Stato Maggiore per avere della cope11t1ra stessa una idea chiara e c i oè che essa era l'el emento primo e fondamentale della manovra genera l e e non una fase difens i va a sé stan te passiva e protetti va.
L 'evol vers i dei progetti di radunata e l'impossibi lit à di contrarre i tempi della mobilitazione affermaron o l'esigenza di destinare maggiori forze alla cope rtura , rendendo più organ i ca ed efficace la difesa su tutt e e tre l e fronti da dove potevano provenire le minacce all 'integrità dello Stato.
L'ordin ament o strategico italiano andava ass umendo caratterist iche ben definite, sottendendo una sp ec ifi ca az ione difensiva controffensiva.
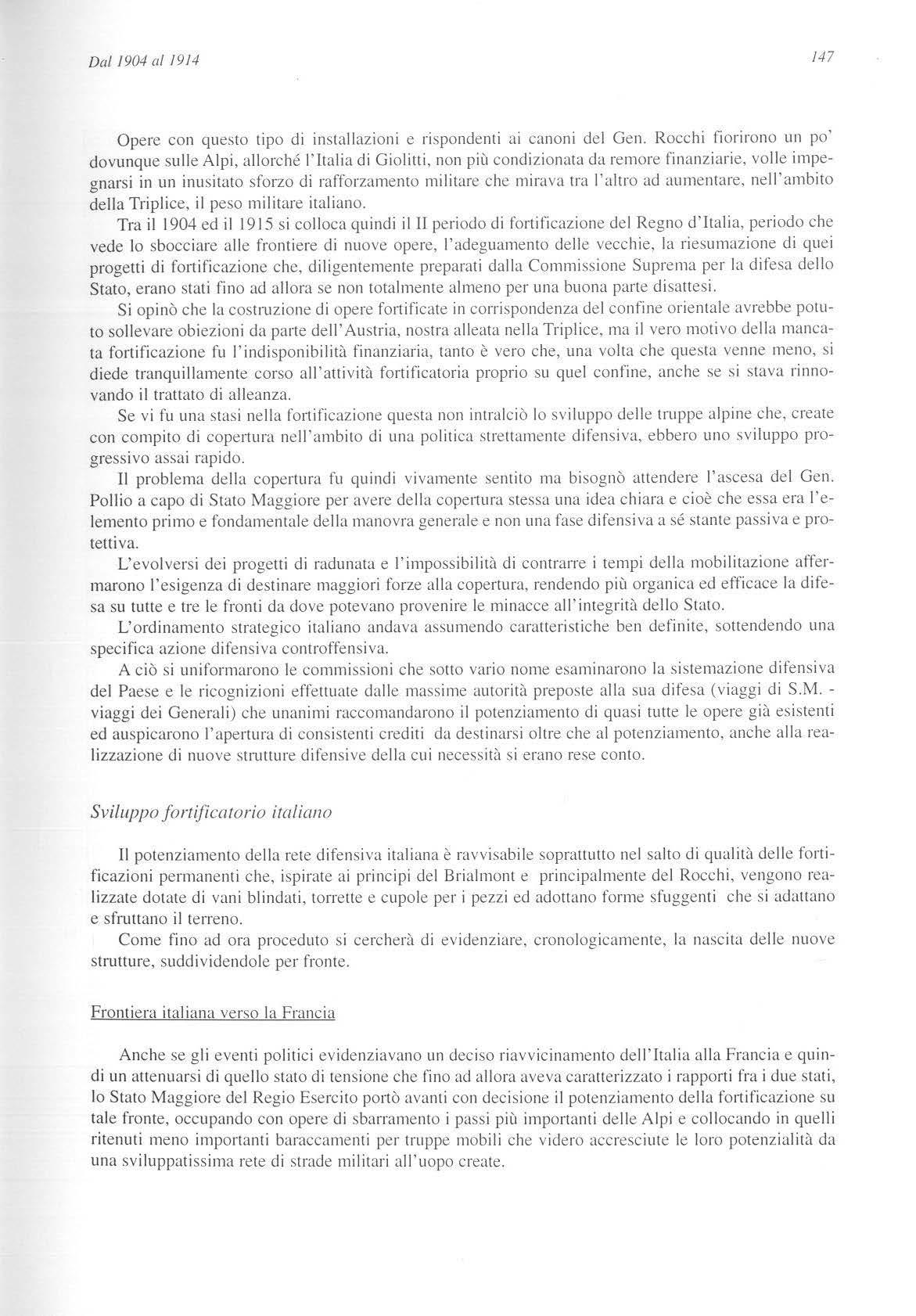
A ciò si uniformarono le commissioni che sot to va ri o nome esaminarono l a sistemazione difensiva del Paese e l e ri cog ni zion i effett uate dalle massime autor ità preposte alla sua difesa (viaggi di S.M.viaggi dei Generali) che unanimi raccomandarono il potenziamento di quasi tutte l e opere g i à es i stenti ed auspicarono l' ape rtura di co nsis tenti crediti da destinarsi olt re che al potenziame nto, anche alla realizzazi one di nu ove strutture difensive della cui necessità si erano rese conto.
Sviluppo for tifi ca torio italiano
Il potenziamento della rete difensiva ital ian a è ravvisabile sopratt utt o nel sa lto di qualità delle fo rtific az i on i permanenti c he, ispirate ai principi del Brialmont e principalmente del R occh i , ve ngono realizzat e dotate di va ni blindati, torrette e cupo l e per i pezzi ed adottano fo rm e sfuggenti c he si adattan o e sfruttano il terreno.
Come fino ad ora proceduto si ce rc herà di ev idenz iare, crono l ogicamente, la nascita delle nuove strutture, suddi videnclole per fronte.
Fronti era italiana ve r so l a Francia
Anch e se gli eve nti politici evidenziavano un deciso riavvicinamento dell'Italia alla Franc i a e quindi un attenuarsi di quello stato cli tension e che fino ad all ora aveva cara tt eri zza to i rapporti fra i due stati , lo St ato Maggiore del Regio Ese rcito portò avan ti con decisione il potenziamento della fortificazione su tal e fro nte, occupando co n ope re di sbarramen to i passi più importanti delle Alp i e collocando in quelli ritenuti meno impo rt an ti baraccamen ti per truppe mobi li che v idero accresciute l e l oro potenzialità da una sv iluppati ss ima rete cli strad e militari all' u opo crea te.
Dal 1904 al 1914 147
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che ali' epoca eravamo strettamente legati alla Triplice alleanza e che inoltre, nonostante il calo della tensione, la Francia era un nemico atavico; in tale ottica si ha un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della difesa del confine verso la Francia che coincide con un più moderno ricorso a strutture realizzate con calcestruzzo e protezioni metalliche, aventi scarsissimo rilievo sul piano di campagna, minima profondità e notevole adattabilità aM!e preesistenti forme del terreno.
Nel corso del primo decennio del XX secolo fanno la loro apparizione le batterie da 149/35 a cupola corazzata del Moncenisio (fo1ti Paradiso e La Court), il forte del Pramand, armato di quattro cannoni ad affusto speciale con cupole di acciaio ruotanti a 360°, inserito nella nuova piazzaforte di Bardonecchia assieme al forte Bramafam, che disponeva, tra L'altro, di due torri girevoli corazzate per cannoni da 120 mm. nonché di quattro pezzi da 57 mm. a caricamento rapido in torrette a scomparsa.
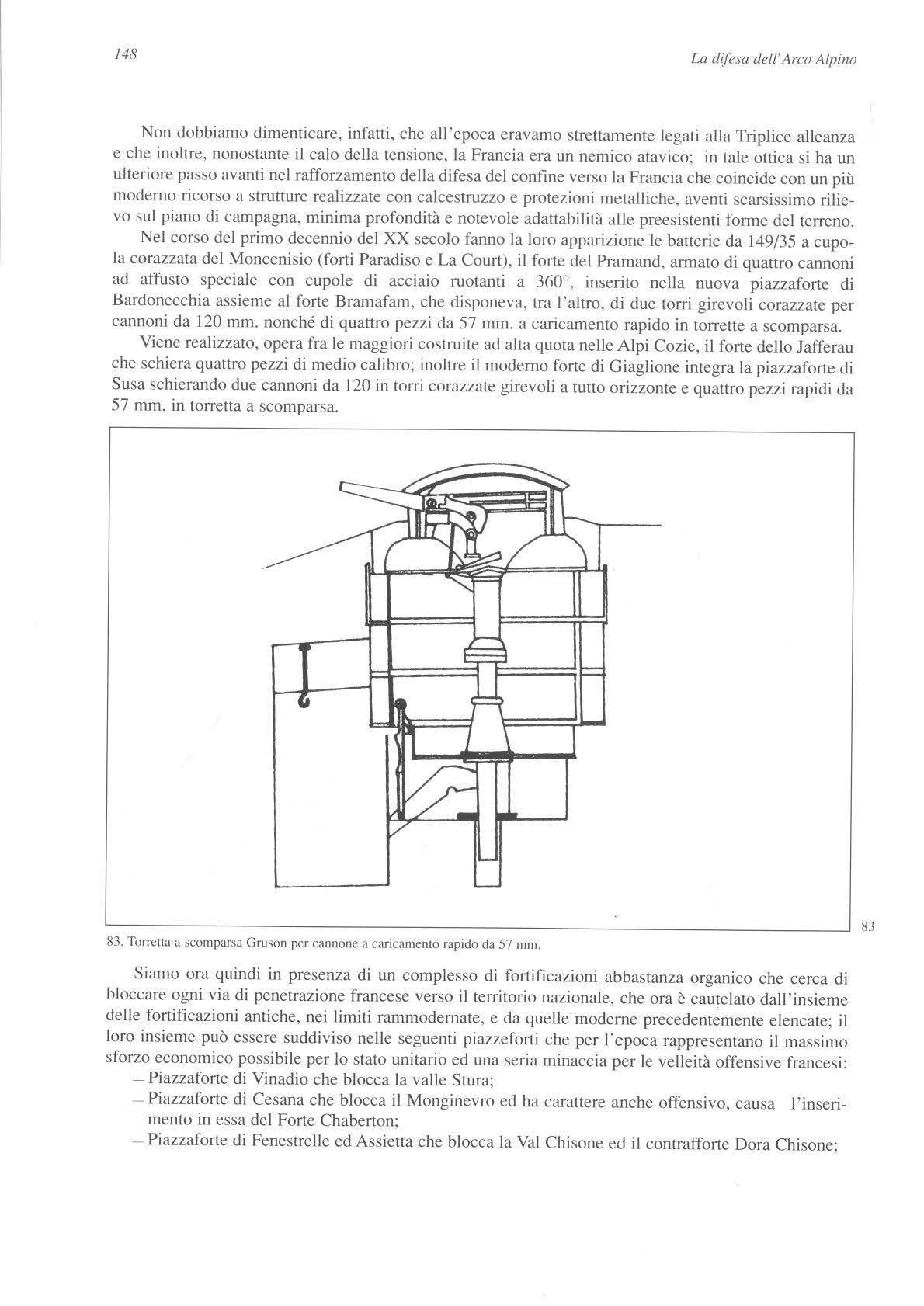
Viene realizzato, opera fra le maggiori costruite ad alta quota nelle Alpi Cozie, il forte dello Jafferau che schiera quattro pezzi di medio calibro; inoltre il moderno forte di Giaglione integra la piazzaforte di Susa schierando due cannoni da 120 in torri corazzate girevoli a tutto orizzonte e quattro pezzi rapidi da 57 mm . in torretta a scomparsa.
83. Torretta a scomparsa Gruson per cannone a caricamento rapido da 57 mm.
Siamo ora quind i in presenza di un comp lesso di fortificazioni abbastanza organico che ce rca di bloccare ogni via di penetrazione francese verso i I territorio nazionale, che ora è cautelato dall'i nsieme delle fortificazioni antiche, nei limiti rammodernate, e da q uelle moderne precedentemente e lencate; il lor o insieme può essere suddiviso nelle seguenti piazzeforti che per l'epoca rappresentano i l massimo sforzo economico possibi le per lo stato unitario ed una seria minaccia per le velleità offensive francesi:
- P iazzaforte di Vinadio che blocca la valle Stura;
- Piazzaforte di Cesana che blocca il Monginevro ed ha carattere anche offensivo, causa 1'inserimento in essa del Forte Chaberton;
- P iazzafo1te di Fenestrelle ed Assietta che blocca la Val Chisone ed il contrafforte D ora Chisone;
148 La difesa dell'Arco Alpino
83

Dal /904 al 1914 149 84a 84b
84a-b. Piazzaforte di Bardonecchia, forte del Pramand, la mimetica è della 2° G.M.
- Piazzaforte di Bardonecchia, realizzata per la difesa dell'omonima conca;
- Piazzaforte di Exilles, 2 ° sba rram ento della valle Dora;
- Piazzaforte del Moncenisio, già iniziata ed in corso di realizzazione;
- Piazzaforte di Susa, realizzata alla confluenza delle valli Dora e Cenischia;
- Piazzaforte del Col delle Finestre - di antica storica memoria - che sban-a l e valli tra Susa e Fenestrelle;
- Piazzafo11e di Bard, che blocca lo sbocco della valle della Dora Baltea (blocco della Val d'Aosta prima di Ivrea).
La particolare delicatezza ciel salie nte, comprendente le Valli cli Susa e del Chisone comportò l 'effettuazione di imponenti lavori di fortificazione, a sbarramento delle due linee di invasione adducenti a Torino. In questo schizzo, realizzato su base fornita da una carta del TCJ, è emblematicamente indicalo l'addensamento in tale settore di ben sette piazzeforti: Bardonecchia, Cesana, Exilles, Assietta, Fenestrelle, Moncenisio e Susa; tutte dipendevano dal I ° Corpo d'Armata cli Torino.
Tutta questa attività fortificatoria italiana viene accuratamente controllata dalla Francia che, nonostante il riavvicinamento, continua a tenere la frontiera sotto la sorveglianza dei suoi organi cli spionaggio, come evidenziano questi schizzi, opera di un uomo dei "servizi " francesi, che si allegano nella veste o rigin ale e nonostante la mole, a dimostrazione delle tip ologie ed ificatorie adottate e ciel live llo raggiunto dalle fortificazioni italiane su tale linea cli co nfine
Frontiera italiana verso l a Svizzera
Molto complessa e travagliata è la realizzazione di strutt ure fortificate al confine italo-svizzero. La complessità dei problemi alla frontiera nord-est e nord-ovest del paese avevano portato a sopravalutare la neutralità svizzera posticipando od annullando i la vori ritenuti necessari dalle varie commissioni incaric ate di esamina re l a sicu rezza alla frontiera succedutes i nell'arco di tempo intercorso fra l'unità ed il I 9 I O.
L'attenuarsi sempre più evidenziato dei legami con l'Austria e la Germania e la presa di coscienza dei sent imenti germanofili delle alte sfere militari svizzere portano ad un ripensamento da parte del governo italiano, che si vede costretto ad occuparsi seriamente anche dell'eventuale possibilità di una penetrazione avversaria da tale fronte; seg no evidente di tal i ripensamenti è l'interessamento che il corpo di S.M. del Regio Esercito dimostra facendo svolgere ricognizioni ed utilizzando monografie del se ttor e ed il moltiplicarsi di richieste di rapporti sulla situazione delle forze e fortificaz ioni elvetiche che vengon o inviate ai nostri addetti militari.
Già il secondo piano generale delle fortificazioni aveva previsto nel 1871 la necessità di fortificare alcuni punti del confine, come emerge dall'allegato estratt o della
RELAZIONE A CORREDO DEL PJANO GENERALE DI DIFESA DELL'ITALIA
presentata al Ministro della Guerra il 2/08/1871 dalla Commissione Permanente per l a Difesa Gt:nerale dello S1ato istitui ta con R.D. dt:I 23 Gennaio 1862 - da arch i vio SME Uff. Storico -
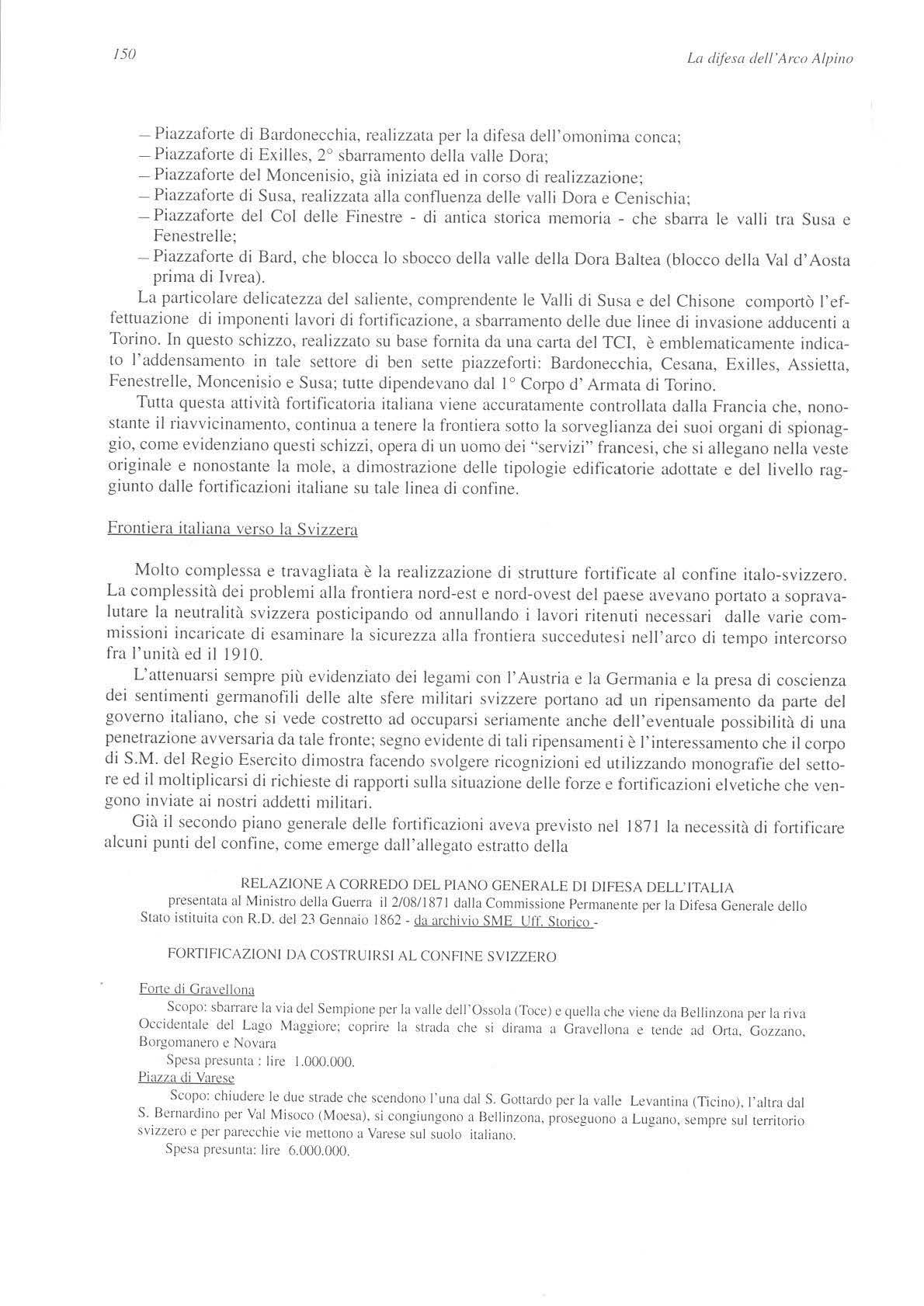
FORTIFICAZIONI DA COSTRUIRSI AL CONFINE SVIZZERO
Fone d i Gravellona
Scopo: sbarrare la via dt:I Sempione pe r la va ll e dell'Ossola (foce) e quella chi:! viene da Bellinzona per la riva Oc.:ciden1alt: dd Lago Maggiore: coprire l a strada che si dirama a Gravellona e tende ad Orta, Gozzano, Borgomanero e Novara
Spesa presunta : lire 1.000.000.
Piazza di Varese
Scopo: chiudere le due strade che scendono l'una dal S. Gottard o per l a valle Levantina (Ticino). l'altra dal S. Bernardino pt:r Val Misoco (Moesa). si congiungono a Bellinzona, proseguono a Lugano. sempre sul territorio svizzero e per parc:c.:chie vie meuono a Varese su l suo l o italiano.
Spesa presunta: lire 6.000.000
150 La difesa dell'Arco Alpi110
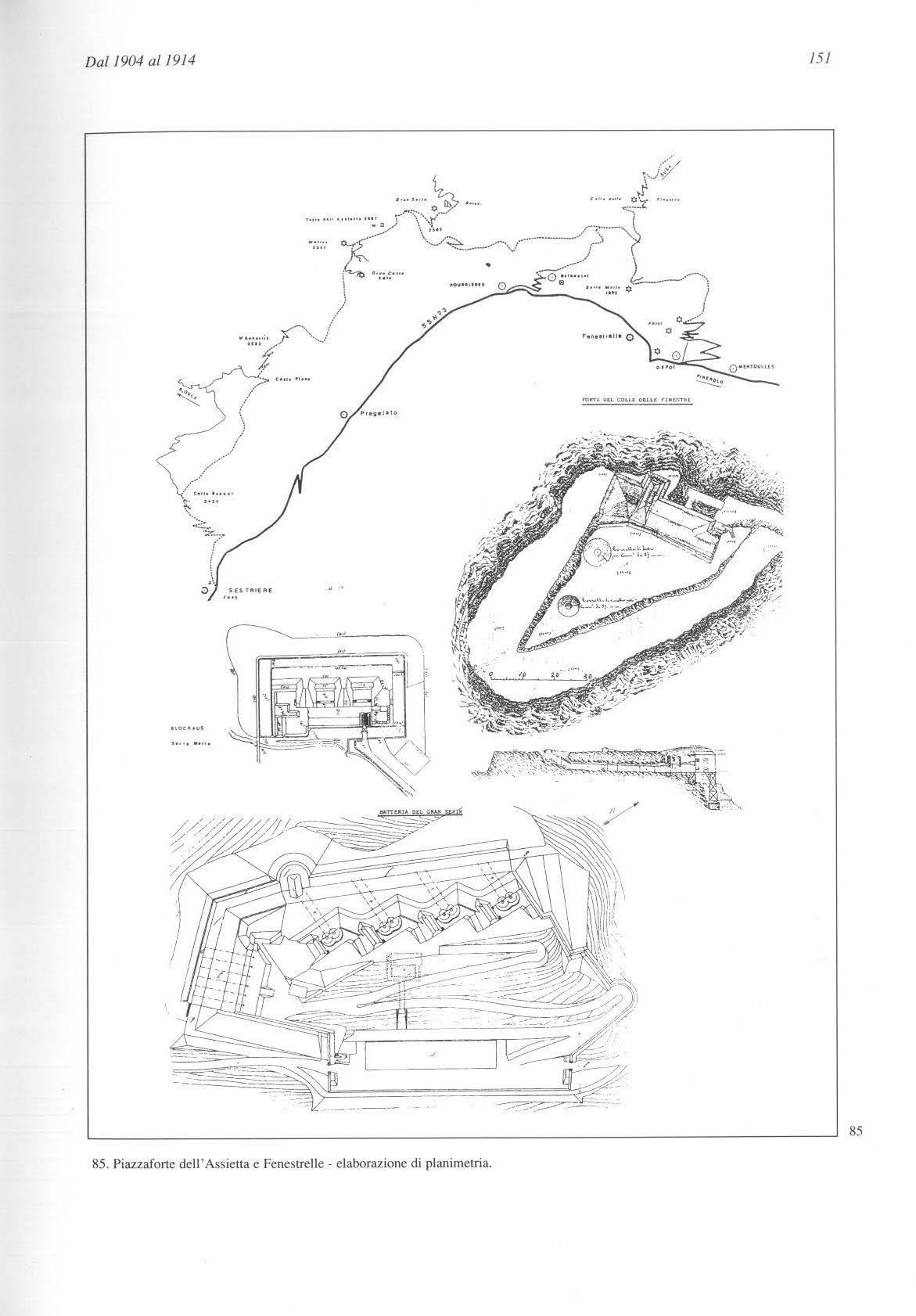
Dal 1904 al 1914 151 85
85 Piazzaforte dell 'Assietta e Fenestrelle - elaboraz ione di planimetria.
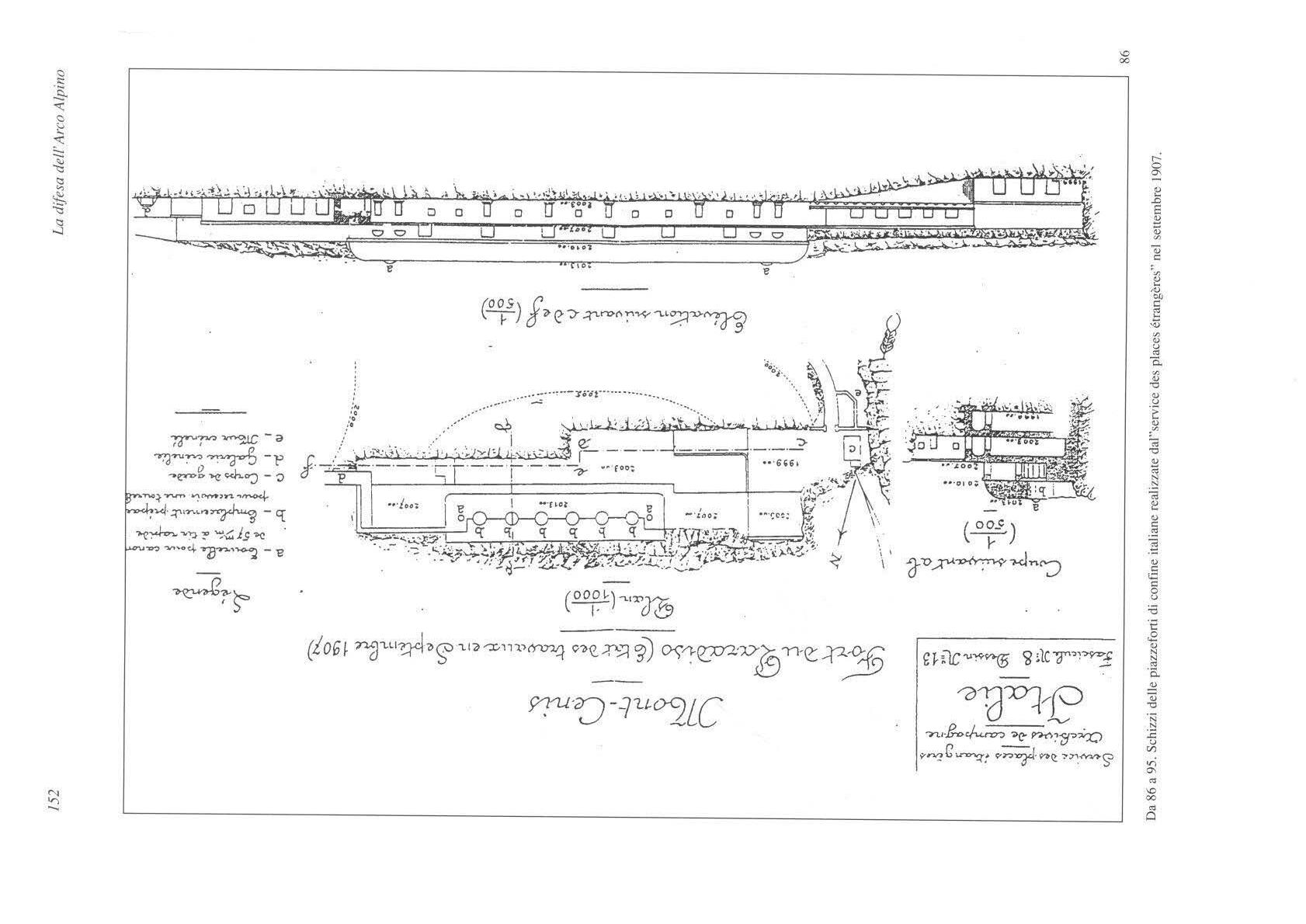
152 La difesa del/' Arco Alpino 86 Da 86 a 95. Schizzi delle piazzeforti di confine italian e realizzate dal"service des places é tran gèrcs" nel settembre 1907.
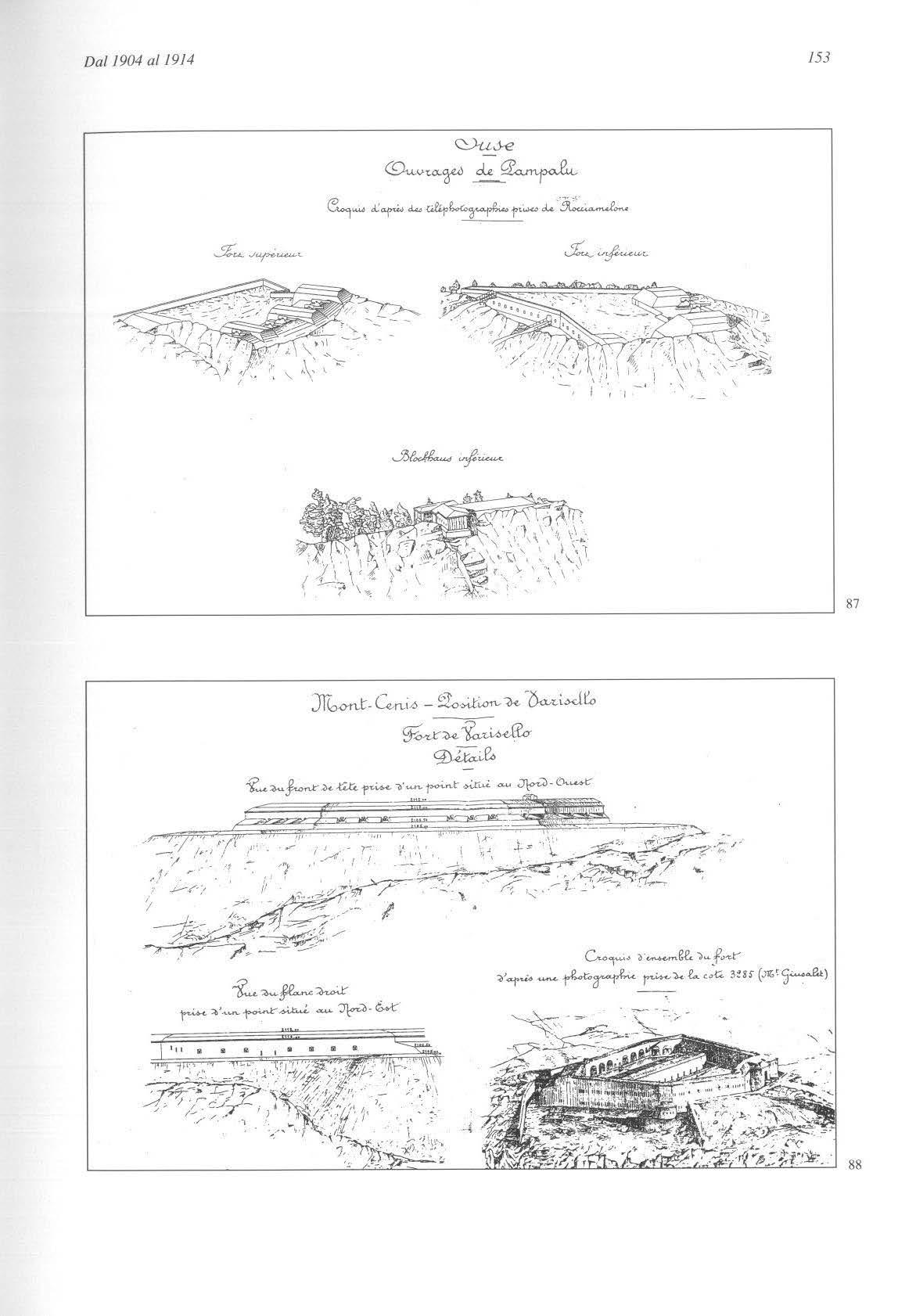
Dal 1904 al 1914 0LLJ-e ©u_vux-~ ,i.;"1'...., d..c. •.-~ ~..,.. Jr<o-O'r\,t- G-n.i.o - s!o-,.J:~ # -&x,t.i~l'.o ~,a-:u ¼,t,i/4& ~e.i .. .ta.. f"~ ""b·....,.,Fnr :;._" ""' ~-l'k......t:' -· r I · 153 _, ' G.,,..,;. ~--"'e.e.,~ f.,,.,t"' ~·4,...:......,.... ~rt'.e,.;,. r.,.,.,.,~ e... ,.:.i:._ m, (Jlb~5~..ili> ~·-,=~~ """'~-~ '" ' 87 88
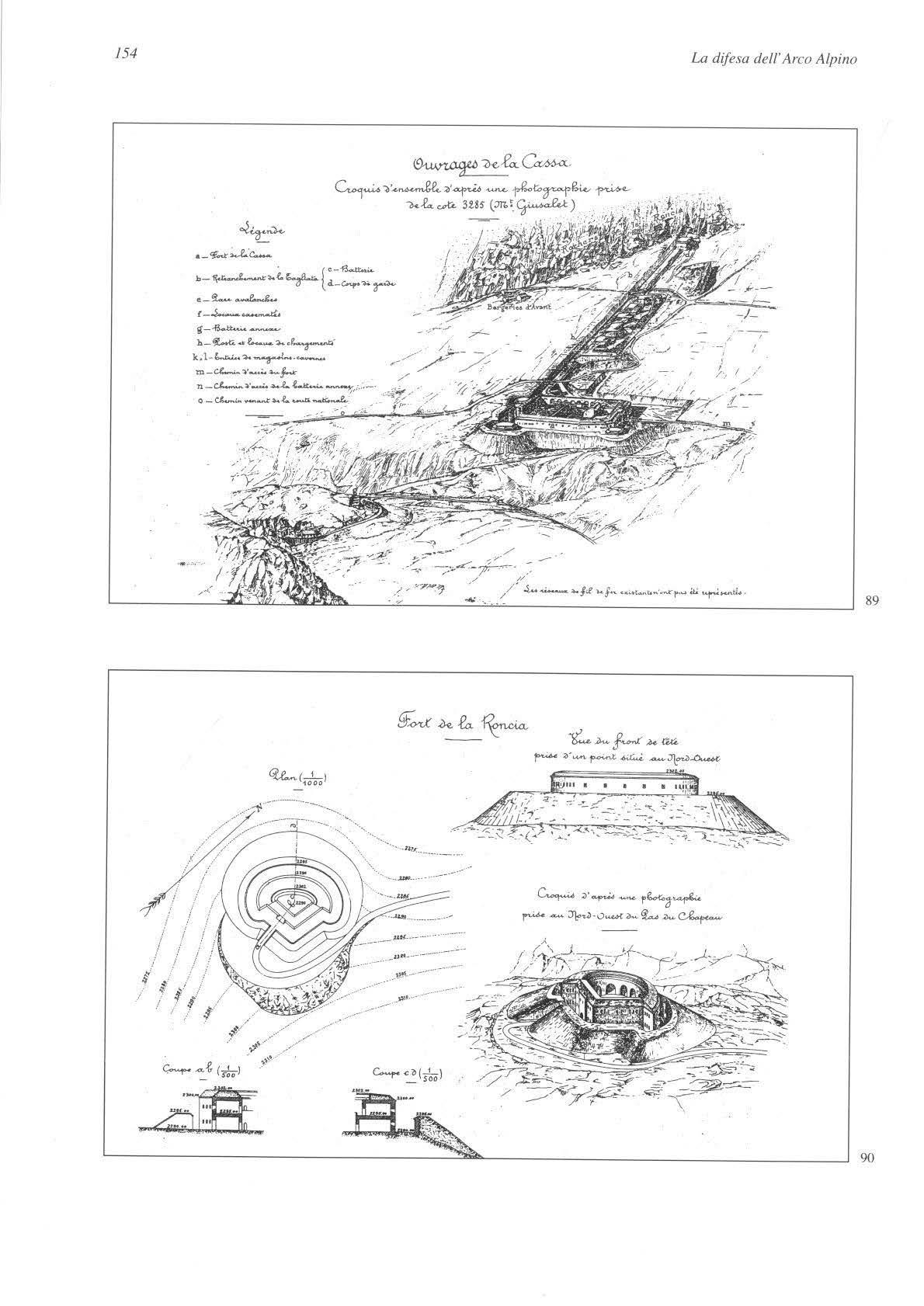
154 ! I --~~·c.-. b-~......,.. r.~t'--'--(:~:;~r..., ·-!t-~ / La difesa dell'Arco Alpino / / g:~~.ex.~ ~;}....f..-r.a.a<i / / / ,,,.._ - ··---~····-,.,,.. f>"- ..,--~ -Jtow~ ~..>·"1"""- r~3~ ~-~·v.-t-~~~ 89 90
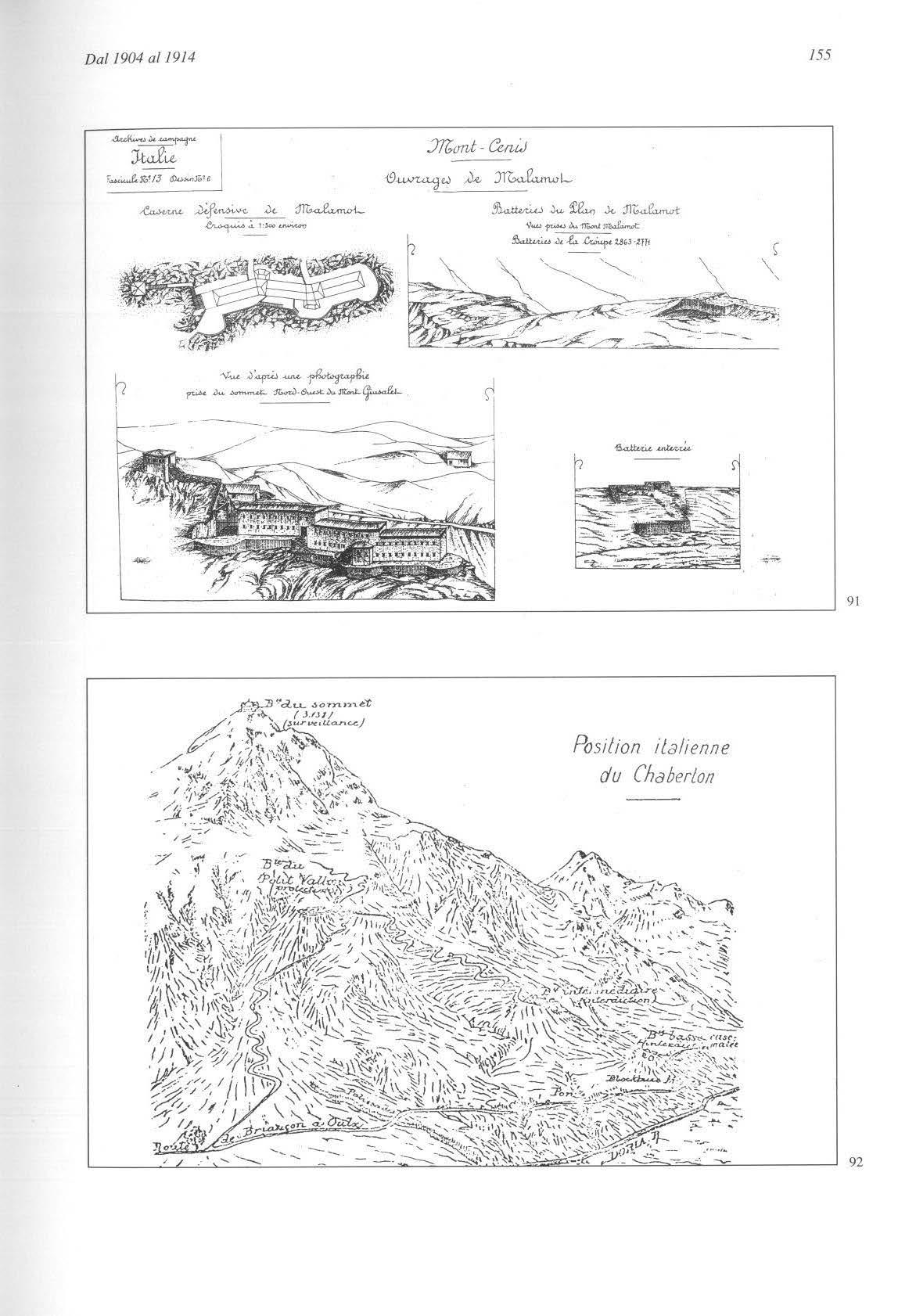
Dal 1904 al 1914 r ~f~- .J<. 11~ ~~~!Hio~ JT?;,ont - <:erz,iJ {9~f..) ,V~ Jr<.=e.u.wl., 3ktw-...«J .}...., J<, :11~ v..,,~.i..,1r_,~ ~.>...fi~UGJ llTI Position iéalienne du Chaber/017 ç \ ' 155 91 92
--. -. -
A . e_,....f...f"""""'"-'-'H.., .... ...
B __ ~· __ ~~.8..,~$R
C . ~ .....
o.e, .,.. ~-~~ -u-.., [.E'....,,. h
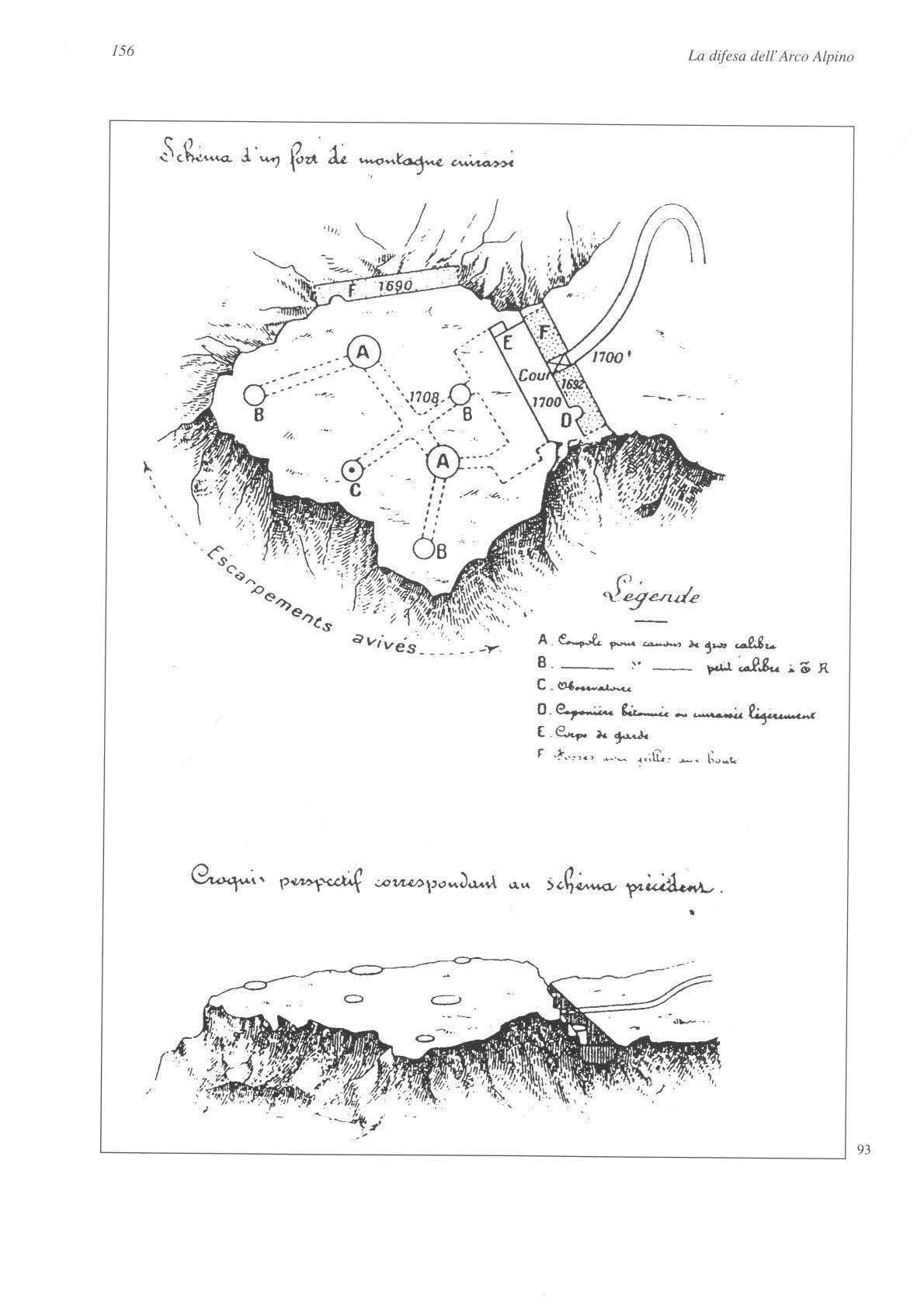
156 •1 ,,. La difesa Alpino
• 93
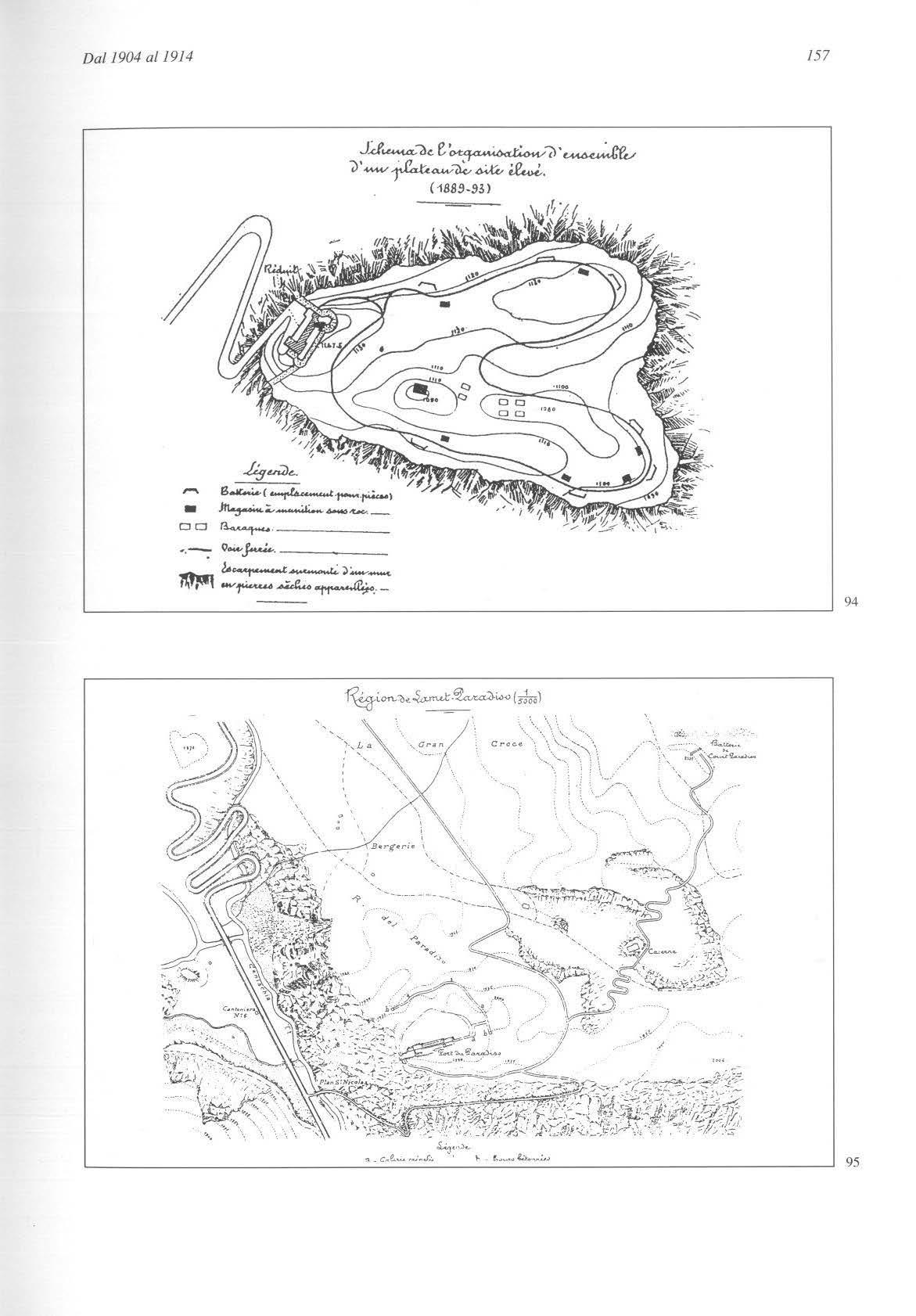
Dal 1904 al 191400 JdU&4(.<X,oee~"è)·~ ~·....,..,.~(U</~~ ~. (188.9-93) I {fif'I /, 6~( """l'fau,_,t ,1-.,...,_1 .tn..,-....:...~------ - ---Q...,j-u, - - -\~~z· .: ,1., ....,.• ..,,. r--.:C: ;i:....,_ -.,..-.u '"1'1' ,t;...157 94 95
Forte di Fuentes
Scopo: intercettare la strada dello Spluga per la valle di S. Giacomo (Liro), quella per Val Bregaglia (Mera) sbocca a Chiavenna sulla precedente. e l'altra dello Stelvio che scende per la Val.tellina (Adda)
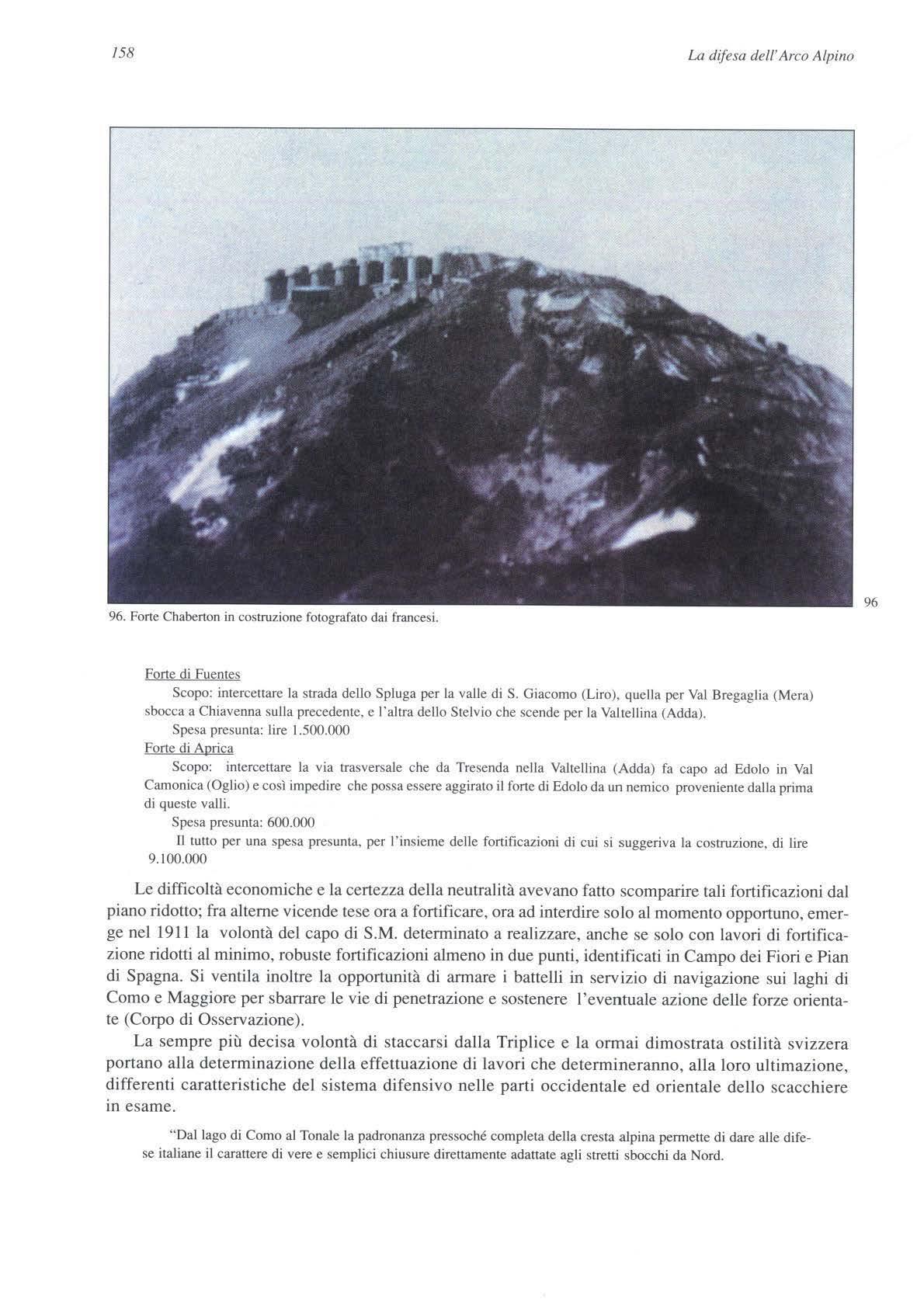
Spesa presunta: lire 1.500.000
Forte di Aprica
Scopo: intercettare la via trasversale che da Tresenda nella Valtellina ( Adda) fa capo ad Edolo in Val Camonica (Oglio) e così impedire che possa essere aggirato il forte di Edolo da un nemico proveniente dalla prima di queste valli.
Spesa presunta: 600.000 n tutto per una spesa presunta , per l'insieme delle fortificazioni di cui si suggeriva la costruzione, di lire 9.100.000
Le difficoltà economiche e la certezza della neutralità avevano fatto scomparire tali fortificazioni dal piano ridotto; fra alterne vicende tese ora a fortificare, ora ad interdire solo al momento opportuno, emerge nel 1911 la volontà del capo di S.M. determinato a realizzare, anche se solo con lavori di fortificazione ridotti al minimo, robuste fortificazioni almeno in due punti, identificati in Campo dei Fiori e Pian di Spagna. Si ventila inoltre la opportunità di armare i battelli in servizio di navigazione sui laghi di Como e Maggiore per sbarrare le vie di penetrazione e sostenere l'eventuale azione delle forze orientate (Corpo di Osservazione).
La sempre più decisa volontà di staccarsi dalla Triplice e la ormai dimostrata ostilità svizzera portano alla determinazione della effettuazione di lavori che determineranno, alla loro ultimazione, differenti caratteristiche del sistema difensivo nelle parti occidentale ed orientale dello scacchiere in esame.
"Dal lago di Como al Tonale la padronanza pressoché completa della cresta alpina permette di dare alle difese italiane il carattere dj vere e semplici chiusure direttamente adattate agli stretti sbocchl da Nord.
158 La difesa del!' Arco Alpino
96. Forte Chaberton in costruzione fotografato dai francesi.
96
Abbiamo così gli sbarramenti di Colico, dci Corradini (Tirano), del Dossaccio (B0r11110J, e ui Corno d'Aol:l (Tonale); cd il tcrrcno ha favorito la costruzione Ji una piazza J'armi cemrale al Mortirolo. rispclto a questa chiusura del Bernina-Poschiavo. dello Stelvio e del Tonale.
Verso le Giudicarie h: nostre d i fese non sono co,ì salde. as~unw110 infalli il carattere Ji appoggi di nrnnovr,1; come è il complcsso Croce Dornini-Maniva e come sarebbe l'altro complesso Rocca J' Anl'o. di garibaldina memoria, Yclcdrana-Mome Manos se l e foni dife~e austri:iche del Chiese 11011 llbbligassero a rc~tringerc :i ~empi ice sbarramento anche il compito di questa estrema difesa oriemale.··:>
Questo complesso di opere, data la sua specifica collocazione, può essere opportunamente indirizzato, come poi sarà per azioni di fuoco anche ve r so l'Austria.
Sbarramento di Colico
Nel pri mo decennio del secolo lo Stato .\1aggiore dell'facrc;itn deciùcva Ji rinforLare le rronticrc c;on opere permanenti. A sbarramento ùclla dire11rice Mera ed Adda fu ipllli11arn I.i cos1ru1:io11t' Ji un'opcra a Pian di Spagna. Le ricognizioni cffc tlll,Hc sulle rnllina ùcl fonc di rucmes (rl~aliZLalo ùagli Spagnoli) portarono a scartarn..: l 'utilizzazionc p..:r la ~u:i posizi0nc 1roppo avanza1a rispc 110 alla , ali..: dcll'AdJa chi: l'avrebbe fo ll o facile bersaglio al 1iro dire110 di anig.lierie piauate a nord di Morbegno e 1roppo sc;opc11a rispetto alla va ll e del Mera.
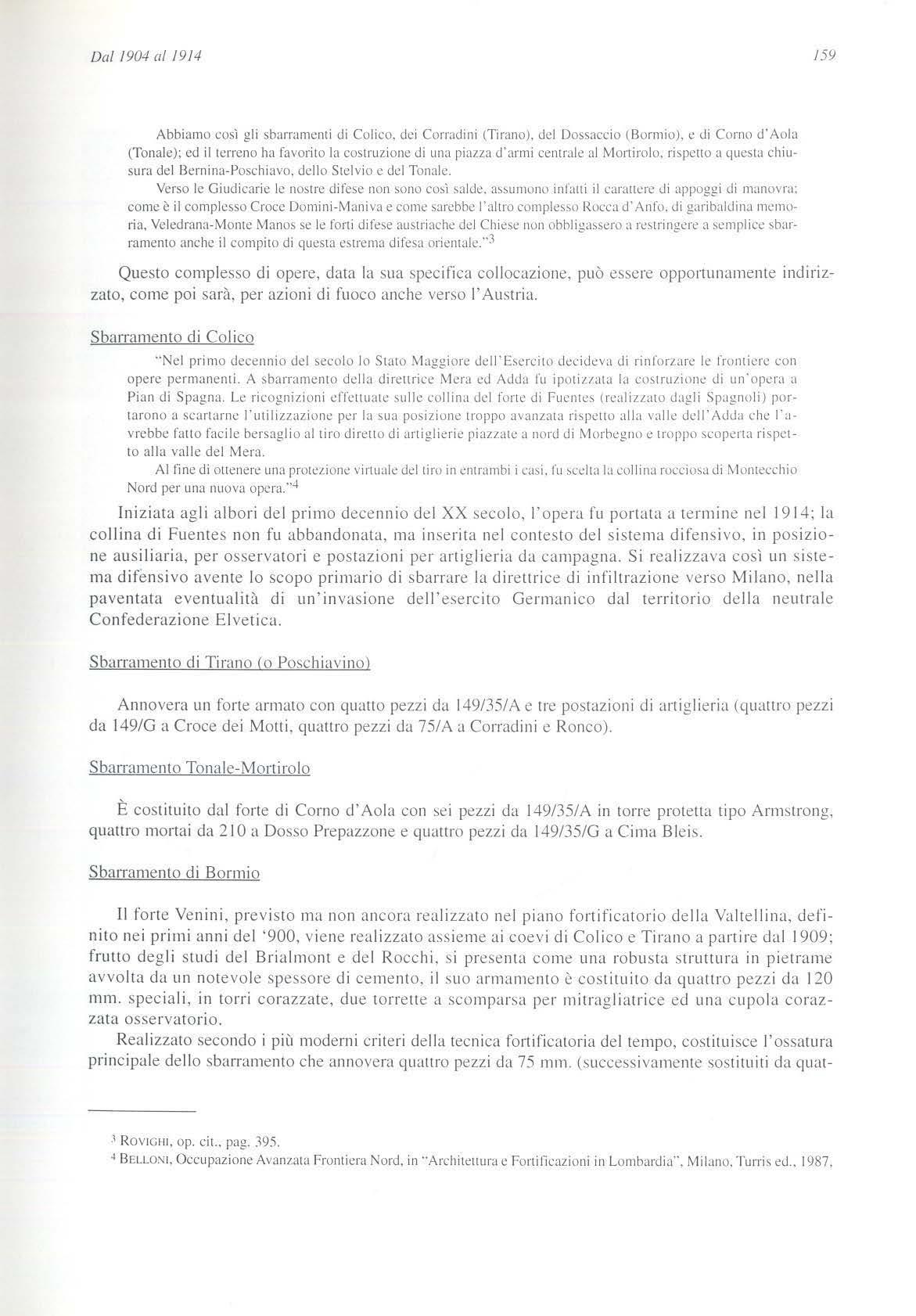
Al fine di 011ene re una p ru1ctione virtuale dt:I liro in entrambi i ,a~i. fu ~,clw la ..:ollinu roc·cio~.1 ùi f\' l ùntel'cilio Nord per una nuova opc r a."-1
Iniziata agli albori elci primo decennio elci XX secolo. l'opèra fu portata a tern1inc nel 1914; la collina di Fuentes non fu abbandonala, ma inserita nel contesto del sistema difensivo, in posizione ausiliaria, per osservatori e postazioni per art i glieria da campagna. Si realizzava così un sistema difensivo avente lo scopo primario cli sbarrare la direttrice di infiltrazione verso Milano. nella paventata eventualità di un'invasione dell'esercito Germanico dal territorio della neutrale Confederazione Elvetica.
Sbarramento di T iran o (o Poschiavino)
Annovera un Corte armato con quatto pezzi da 149/35/A e tre postazioni di artiglieria (quattro pezzi da 149/G a Croce dei Motti. quattro pezzi da 75/A a Corradini e Ronco).
Sbairnmenlo Tonale-Mortirolo
È costituito dal forte cli Corno d'Aola con sei pezzi <..la 14 9/35/A in torre prolelta tip o Arrnstrong, quattro mortai da 21 O a Dosso Prepazzone e quattro pezzi da 149/35/G a Cima Blcis.
Sba1rnmento di Bormio
JJ forte Venini, previsto ma non ancora r ea lizzal o nel piano fortificatorio della Valtellina, definito nei primi anni del '900, viene realizzato assieme ai coevi di Colico e Tirano a partire dal 1909: frutto degli srudi ciel Brialmont e del Rocchi. si presenta come una robusta struttu ra in pietrame avvolta eia un notevole spesso r e di cemento. il suo armamento è costituito eia quattro pezzi da 120 mm. spec iali, in torri corazzate, due torrette a scomparsa per mitragliatrice ccl una cupola corazzata osservatorio.
Reali zza to secondo i più moderni c riteri della tec nica fortificatoria del tempo , costituisce l 'ossatura principale dello sbarramento che annovera quattro pezzi da 75 mm. (successivamente sostitu iti da quat-
3 ROVIGHI, op. cii.. pag. J95.
4 BELL0'.\11. Occupazione Avan1:ala Frontiera Nord. in "Archite1tura e Fonilìcazioni in Lombarùin'', Milano. Turris ed 1987,
Dal !904 al /914
15<)

160 , , ,. -. . ' . . . l ••••••••• • , , ~·•.....\ "",...,,,..•I '' 97. M o nt ecch io di ColicoSchizzo planimetrico del fone Lusardi. La difesa dell'Arco Alpino r ( . o "'"' ... .. ... ... w .. <I. ... >4 e , , o..· 97
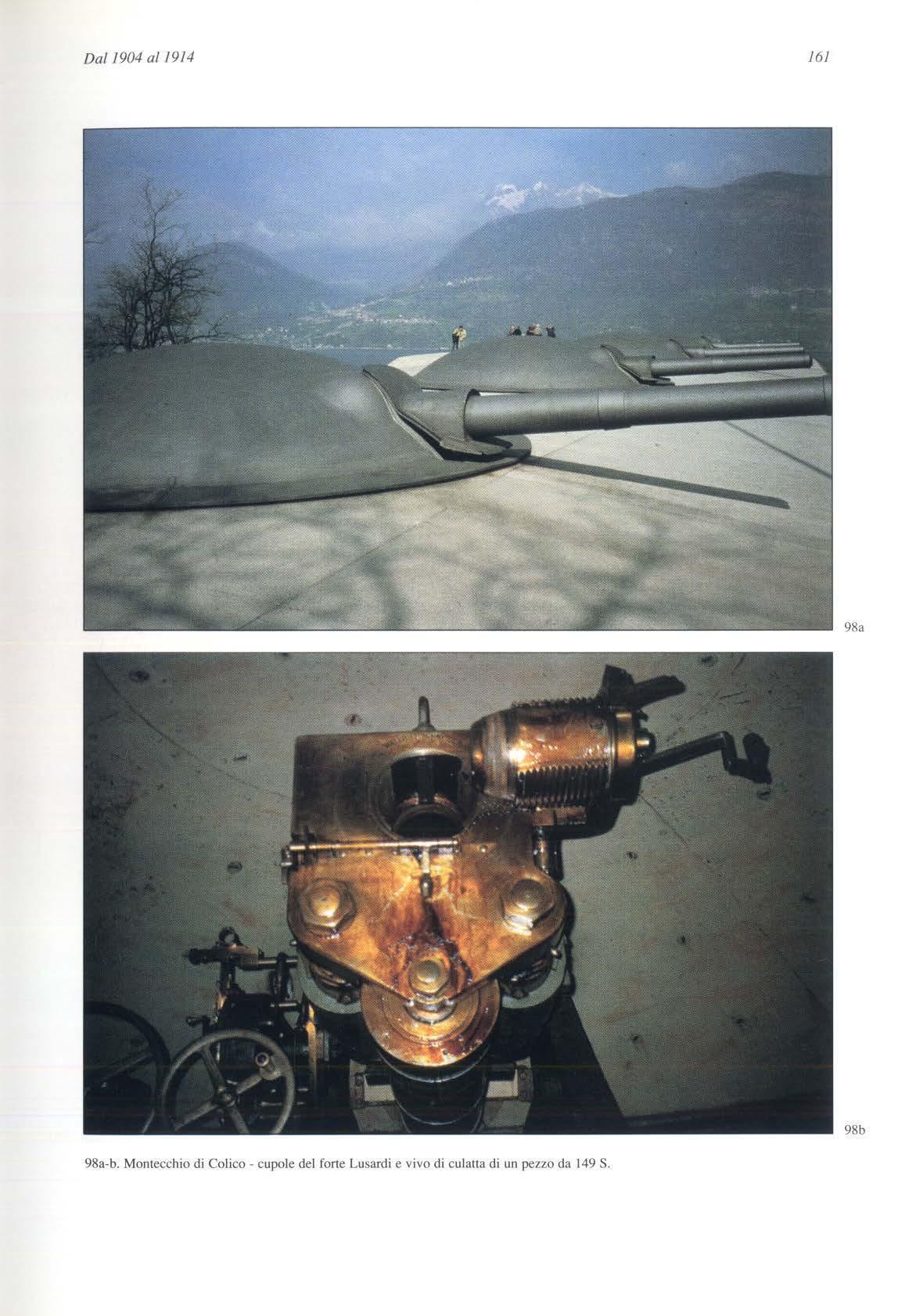
Dal 1904 al 1974 161 98a 98b
98a-b. Montecchio di Colico - cupole del forte Lusardi e vivo di culatta di un pezzo da 149 S
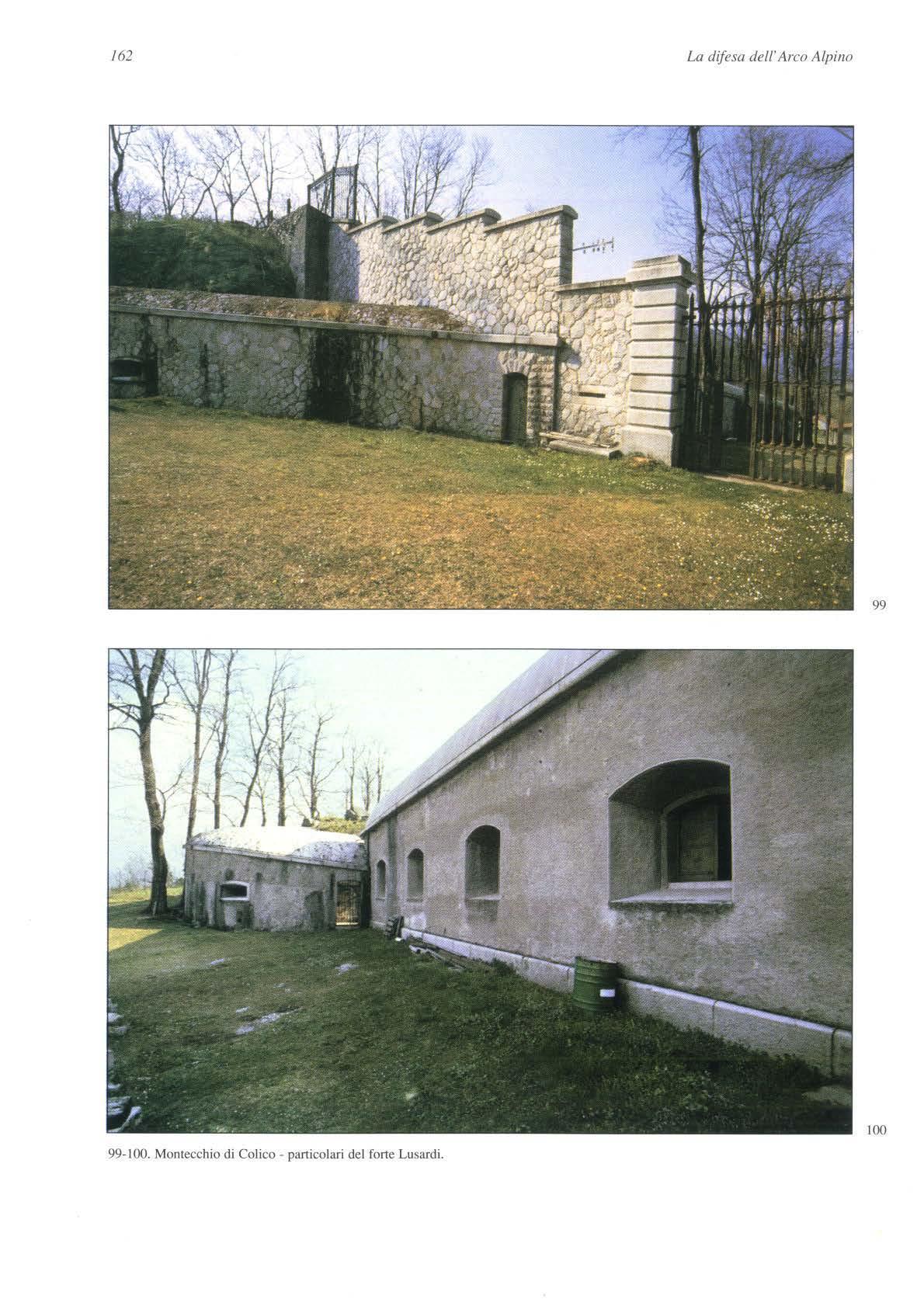
/62 La difesa dell'Arco Alpino 99 100
99 - l 00. Montecchio di Colico - panicolari de l forte Lu sardi.
tro pezzi da 149/35/G) dis l ocati in piazzole ricavat e assieme a ricoveri protetti, su ll a vetta del Monte Scala, quattro pezzi eia 75 mm in località le Molle ed altrettanti a Monte Masucco.
Frontiera italiana verso l 'Austria
L 'ascesa alla carica di Capo di Stato Maggiore del Gen. Poli io seg na profondamente l o sviluppo fortificat o delle frontiere.
Viene alla lu ce nel 1909 un nuovo piano di mobilitazione e radunata, impostato su di un arco di 23 g i orni, c he ha il suo principale riferim ento in pianura ne l Piave.
Vi sono nel periodo notevoli stanz i ament i destinati al potenziamento e completamento dell e difese alla frontiera e viene data a l piano del 1909 un'impronta più marca tamente offensiva.
L'orientamento strategico italiano andava assumendo caratteristiche ben definite, sottendendo una spec ifica azio ne difensiva-controffensiva. Era previs t o c he allo scoppio delle ostil i tà le truppe di cope rtura occupassero posizioni chiave o ltre confi ne ed ostacolassero non so l o l 'avanzata ma la radunata stessa del nemico.
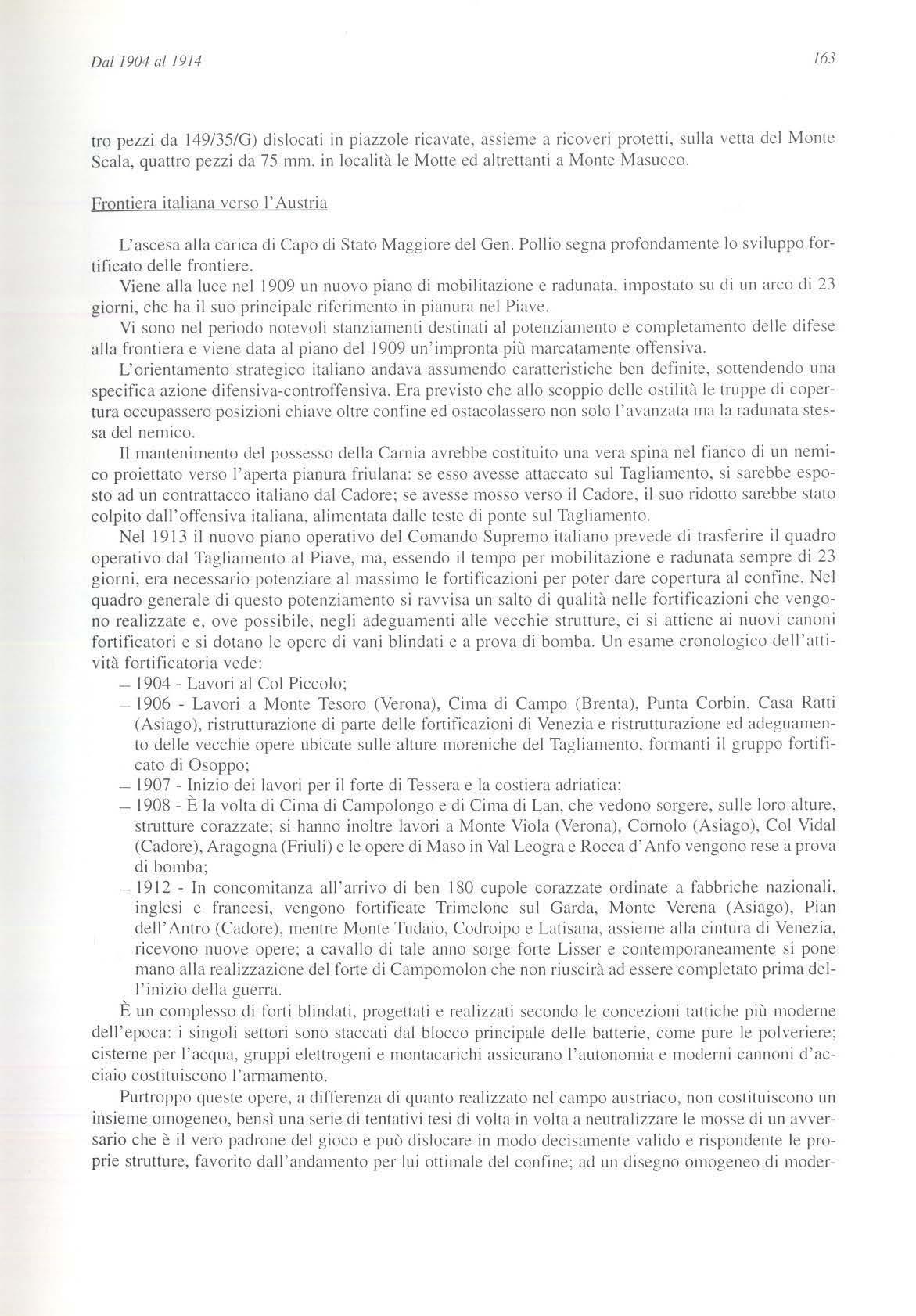
li 1mmtenimento del possesso della Carnia avrebbe costitui to una vera sp in a nel fianco di un nemico proi ett ato ve r so l 'aperta pianura f1iu l ana: se esso avesse attaccato sul Tagliamento. si sarebbe esposto ad un contrattacco italiano dal Cadore; se avesse mos::;o verso il Cadore. il suo ridotto sarebbe stato colpito dall'offensiva italiana, a limentata dalle teste di ponte su l Tag li amento.
Nel 19 13 il nuovo piano operativo del Comando Supremo italiano prevede di trasferire il quadro operativo dal Tagliamento al Piave, ma, essendo il tempo per mobilitazione e rad un at a sempre ùi 23 giorni, era necessa ri o potenziare al massimo le fortificazioni per poter dare cope rtura al confine. Nel quadro generale di questo potenziamento si ra vvisa un salto <li qualità nelle fortificazion i che vengono realizzate e, ove possibile. negli adeguamenti alle vecc hi e stru tture, ci si attiene ai nuovi cano ni fortificatori e si dotano le opere di va ni blindati e a prova di bomba. Un esame crono l ogico dell'attività fortificatoria vede:
- 1904 - Lavori al Col Piccolo:
- 1906 - Lavori a Monte Tesoro (Vero na), Cima di Campo (Brenta), Punta Corbi n, Ca::;a Ratti (Asiago), ristrutturazione cli parre de lle fortificazioni di Venezia e ristrutturazione ed adeguamento delle vecchie opere ubicate su ll e al ture moreniche del Tagliamento. fo rm ant i il g rup po fortificato di Osoppo:
- 1907 - Ini zio dei l avor i per il forte di Tessera e la cos ti era adriatica;
- I 908 - È la volta di Cima di Carnpolongo e di Cima di Lan , che vedono sorgere, su ll e loro alture, strutture corazzate; si hanno inoltre lavori a Monte Viola (Verona) Co rn olo (Asiago), Col Vidal (Cadore), Aragogna (Friuli ) e l e opere di Maso in Val L eogra e Rocca d' Anfo vengono rese a prova di bomba;
- 1912 - In concomi tan za all'arrivo di ben 180 cu p o le corazzate o rdinat e a fabbriche nazi o nali , inglesi e franc es i, vengono fort ifi ca te Trim e l one su I Garda, Monte Verena (As iago), Pian cieli' Antro (Cadore), mentre Monte Tudaio, Codroipo e La ti sa na, assieme alla c intura di Venezia. ric evo no nuove ope re; a cava llo di tale anno so rge forte Li sser e contemporaneamente si pone man o a lla rea lizza z i one ciel fo rt e di Campomolon c he no n riu sc irà ad essere co m pletato prima del!' ini z io della g uerra.
È un comp lesso di forti blindati, progettati e realizzati secondo le concezio ni tatti c he più moderne dell'epoca: i singo li se tt o ri sono staccaci dal blocco p1incipale del l e batterie. come pure l e polveriere; ci stern e per l'acq ua, g ruppi e lettrogeni e montacarichi ass i curano l 'au tonom i a e moderni ca nnoni d'acciaio costituiscono l 'armament o.
Purtropp o queste opere. a differenza di quanto rea lizzato nel campo austriaco, non cos titui scono un insieme omogeneo, bensì una seri e di tentativi tesi di vo lt a in volta a neutrali zza re le mosse di un avversario che è il vero padrone del gioco e può dislocare in modo decisamente val ido e rispondente l e propri e strutture, favorito dall'andamento per lui ott imale del co nfine; ad un disegno omogeneo di modcr-
Dal 1904 al 1914 163
Il
12

I) l!>H<W'4W\.W
ti. l.'.,.,.t,t.,~
1) p..,i:.,., u.11:.A!
164 ( 114 O/ O 00 O 0 I tUO) /,, ,.,, J<,a}.,. /: {O<JO pi',n1lu J~/1~ "'"ralure J,..,(.., I: hJuv ·,; : :: .' : ,,. ·.~ . ·I S :: 101 Tirano - schizzo planimetrico del forte Sertoli. La difesa Alpino OP E 'J ('I ((ll'1flL I Leggendo ~o.,.;..L,ou, 2 'i'ou• lf.,,C\.Yt.U:.. 1 d él~1·~,""-'!._....., ~l~'J~w -~t...,,.....A', t!..-.........:~ l'"'l ,... '"""-~~..)lt J,;.....\MI ':l"""\'l'j ,;l,. ll , :! \'W<l!N J.;. \Ml~ l,vv. -
.a.....-t'.......to.;
10
.;r,""'i'"'t'.:,
PV4-<lk.
101
f~•11.o ~l\{e rÌ-o r t
i Corrtd.oto
2 /'oni.,
3 Rlstrvctt.
-4 Ma9ttn11i
!S Ca11tuilt~
6 Cu.ci.,,..

7 Ittfertl'.,ar~, a /'fo,.tdca,.Hft.i.
S Ahog,,Lo Uff~ti.ali.
10 Ma,c./,,.r1,1r~
11 C •po11 ~ ,
12 Locai~ carL,u11•1\to 1'5 Corpo ,u q111rJ.i.,
14 C11mera co1,unc:io e. Osserv,tor~o
Dal 1904 al 1914
• - :-,;"':", y..-.._• ~-::,, \;H, ,.. ,, • 1 \ "f 1\t '~,,'~; '
102 Bormio - forte Yenini di Oga - planimetria.
scala 1:500
165
102
SGala 1: tOOO
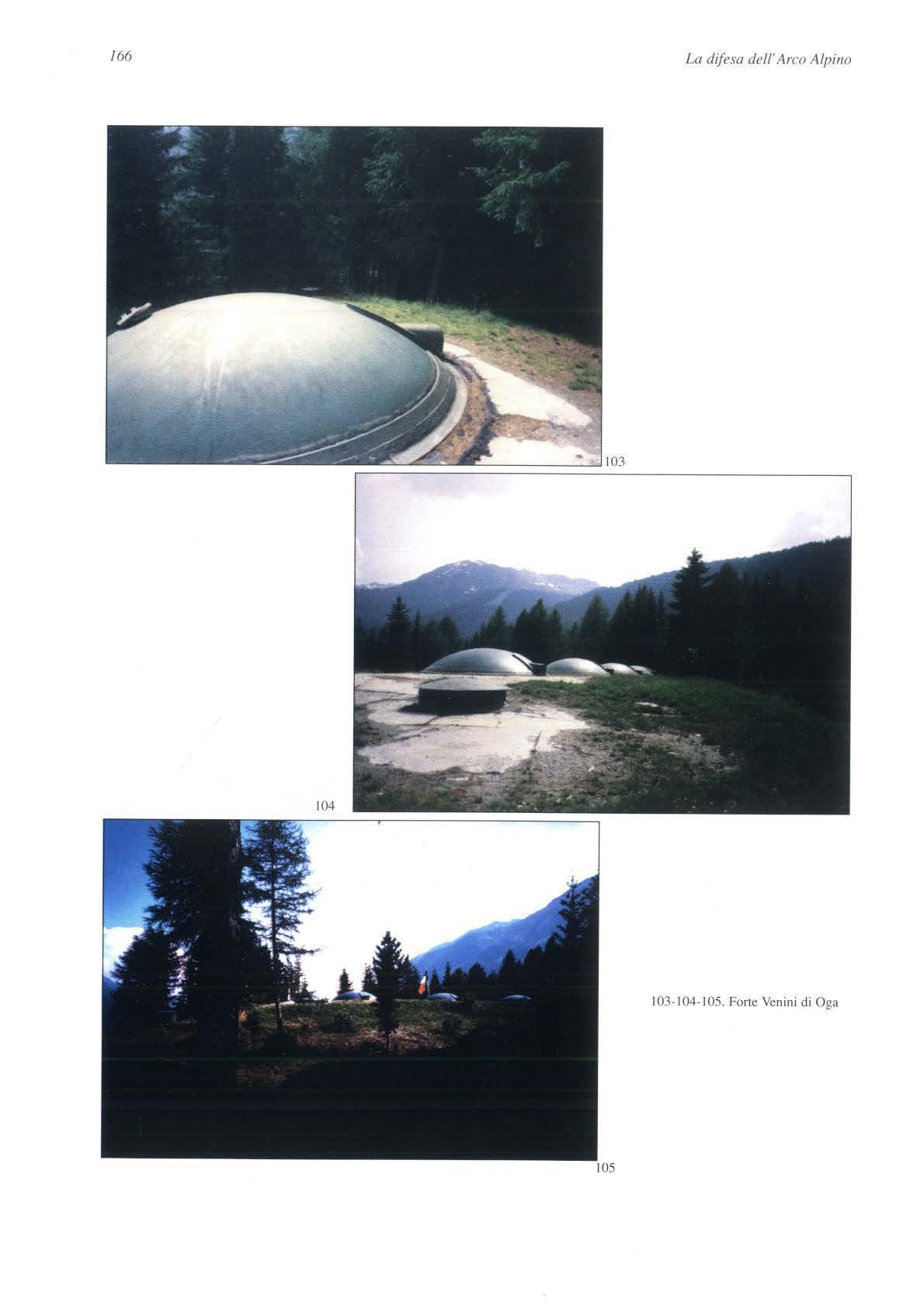
166 La difesa dell'Arco Alpino
105
103- 104-105. Forte Yenini di Oga
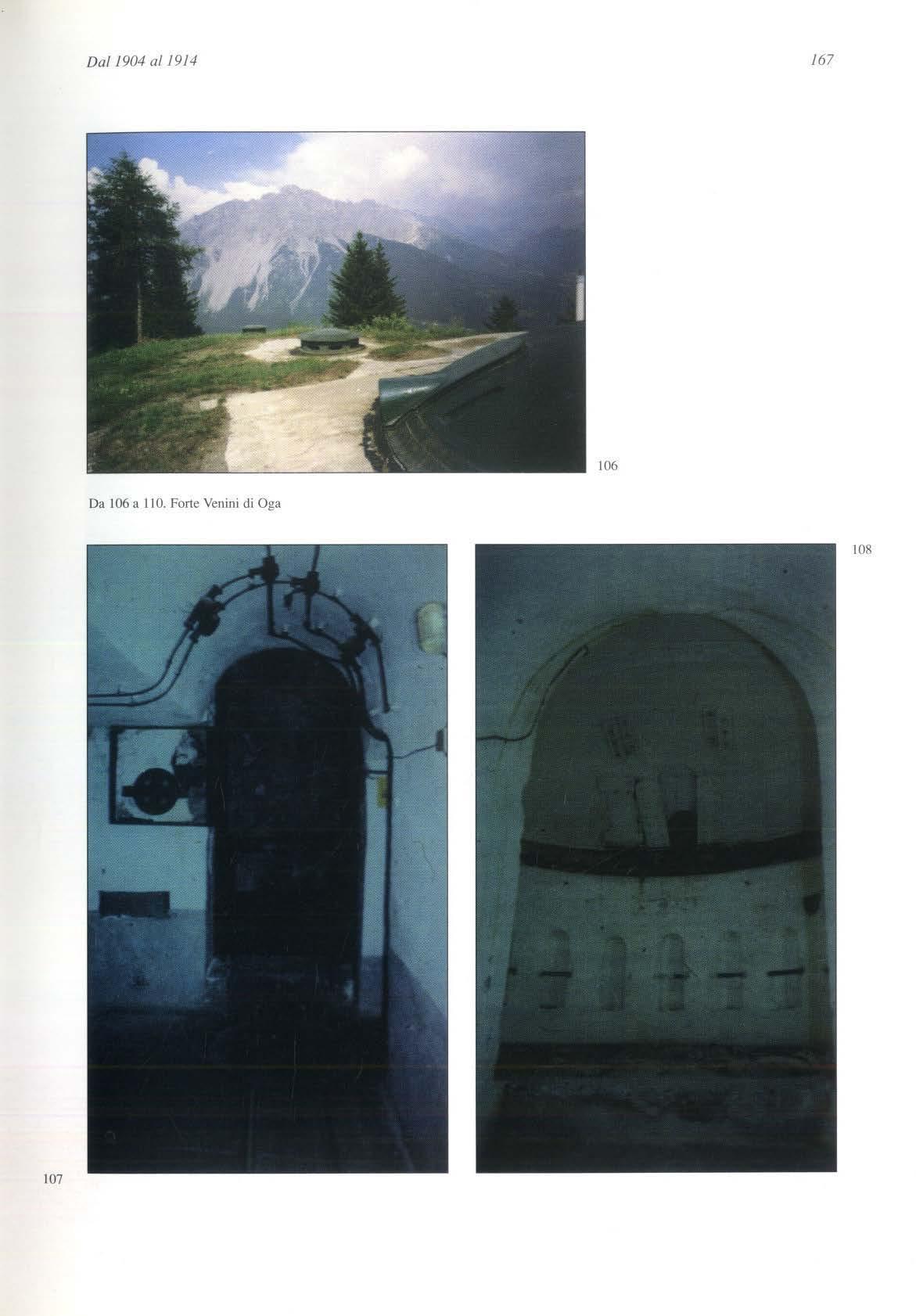
Dal 1904 al 1914 167
I06
108 107
Da I06 a 110. Forte Venini di Oga

168 La difesa dell'Arco Alpino
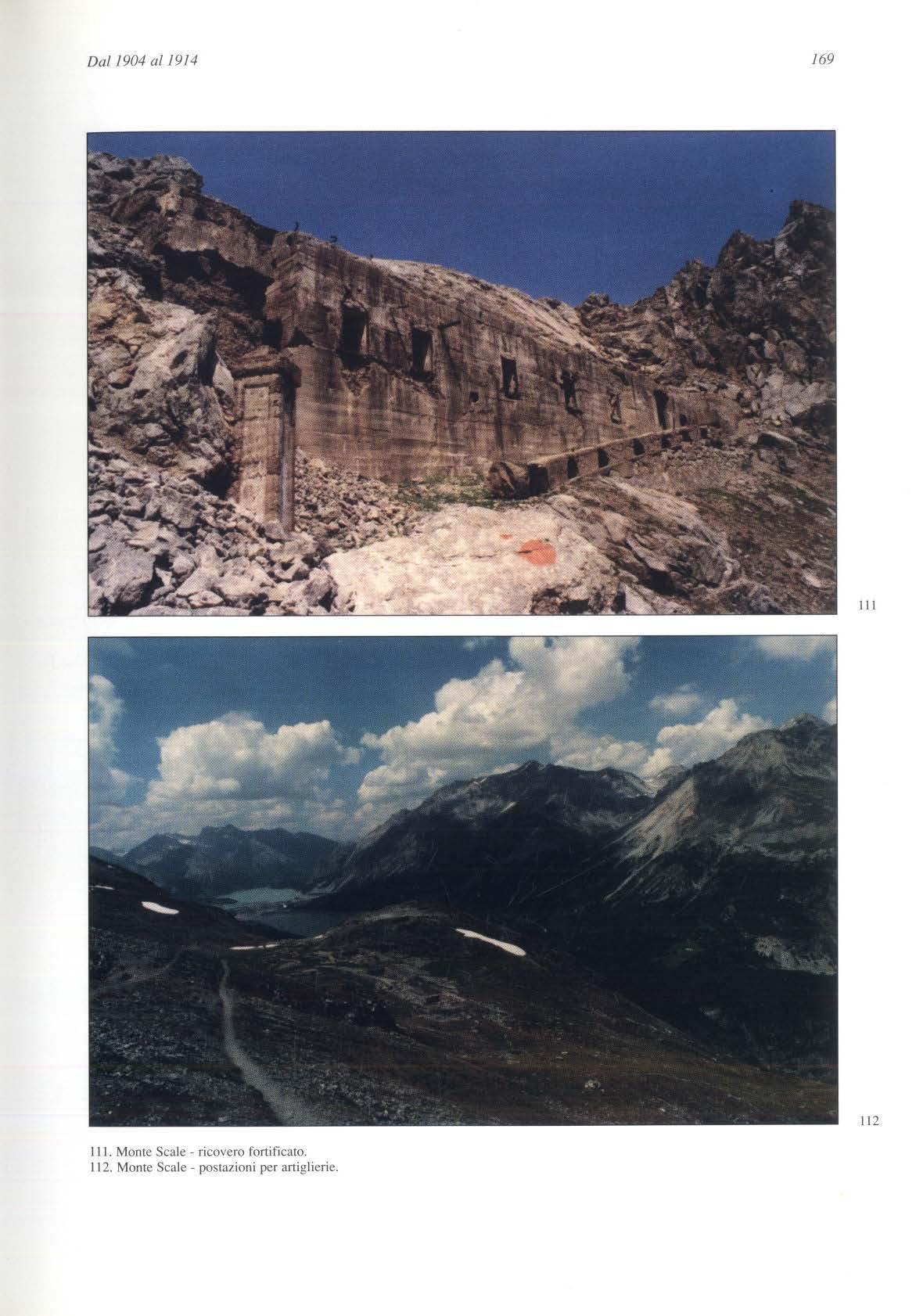
Dal 1904 al 1914 169 111 112
11 l. Monte Sca le - ricovero fo rt ificato.
I 12. Mon te Scale - postazio n i per anig lierie.
ne strutture, come realiLZato in campo austriaco, fa riscontro un rafforzamento od un singolo inserimento cli nu ove stru tture fortificate, volte localmente a chiudere "buc hi '' rivelatisi a seguito di più accurate ricognizioni e studi.
Questo era il frutto di una sistemazione difensiva del territorio nazionak razionalmente studiata dagli addetti ai lavori, ma bocciato da un parlamento scarsamente preveggente che lima all'osso le spese militari, concedendo fondi atti so lo ad interv enti se ttoriali e limit ati. Gli sviluppi fortifica tori francesi, svi::;;,ero ed austriaco
Quali sono gli s1·il11ppi fortijìcotori nei Poesi che Fedono alle loro frontiere opposte il sorgere di moderne opere forti e 111110 1111 miglioramento ed adeguamento delle l'ecchie stm1111re difensil•e confinarie?
Situazione fortilìcato ri a francese (Frontiere della Francia verso l'It alia)
Benché chiaramente ormai il Regno d'ilalia si stt!sse a, viando all'abbandono della Triplice per schierarsi con gli anglo-francesi, la Francia non solo manteneva, ma anzi adeguava e raffittiva le strutture fortificntc co ntro l'Italia.
L'allegata fig. 13 (si è vo lut amente mantenuta la numerazione originale della figura, che è tratta, come le seguenti 14 e 15 dal volume del Prof. Montigny "Les Alpes Françaises. Les réalizations françaiscs sur !es Alpes en 1914") mostra schematicamente l'insieme di tali suutture agli inizi del 19 14. Il ruolo di ciascun g ruppo di opere è chiaramente evidenzia to dalla figura stessa e dall'eventuale esame delle strade e ferrovie presenti nella zona. Si riportano inoltre, a titolo di esempio circa il livello di organizzazione raggiunta, lo schema di ordinamento di due importanti piaaeforti, quella di Nizza e quella di Briançon.
Nizza, infatti, era un obiettivo di primaria importanza per un eventuale nemico intenzionato ad invadere la Francia, mentre Briançon è la più tipica delle piazzeforti francesi dislocate in montagna a ridosso dei confini con il Regno d'Italia. Se la si esamina, si può notare come essa sia collocata a soli 9 km. dalla frontiera italiana del 1900 all'incrocio delle valli della Durance, Guisanne e Cerveyrette, accessibili facilmente dall'Italia. Questo punto, riconosciuto strategico fin dall'antichità, ha visto il suo territorio guarnirsi di fortificazioni romane più volte rimaneggiate ed arricchite dall'epoca di costruzione a tutto il 1700. Sotto la spinta rinnovatrice si hanno continui adeguamenti e nel 1900 la città, dal punto di vista fo11ificatorio, vede la contemporanea presenza delle strutture rea lizzate nel 1750 per ispirazione del Vauban, quelle concepite nel 1875 e le strutture realizzate ex novo nel 1885 (epoca della transizione delle strutture), anche se nella montagna francese l'impatto con questa evoluzione fu assai limitato. Un esame effettuato al l 'epoca infatti vede il rafforzamento e miglioramento del vecchio Fort du Chateau, la cos tru zione di una prima line a più esterna lun ga 3 km. realizzata lungo la cresta che congiunge Monte Janus al Monte Gondran. Una linea successiva è costituita dal forte dell' lnfernet e dalle batterie Lamie collegati da un muro con feritoie. La terza linea è formata a nord dalla batteria della Croix de Toulose, al cen tro dalla Redoute des Salettes, dai forti Dauphin, Trois Tetes e Randouillet, a sud dalla Grande Mayc, la cui opera di maggiore importanza è il for te Croix de Bretagne. Un forte a Nòtre Dam e de Nièges ed il forte de l'Olive sulla destra della Clarée comple tano il quadro strutturale di questa piazzaforte.
A titol o di pura esemplificazione, sempre tratte dal medesimo vo lume francese, s i all ega no gli sc hi zzi del forte cli Barbonnet e di alcune strutture caratte ri stiche adottate dai Francesi prima e dopo il 1885.
Frontiera svizzera verso l'Italia
Il periodo in esame, 1904 -14, co incide circa co n il terzo o quarto periodo di costruzione delle opere fortificate svizzere, come cita Julius Rebord nella sua "Histoire dc la consrrnction des ouvragès fortifiés federaux 1831- 1921" da cui sono tratte alcune foto inserite in questo lavoro.
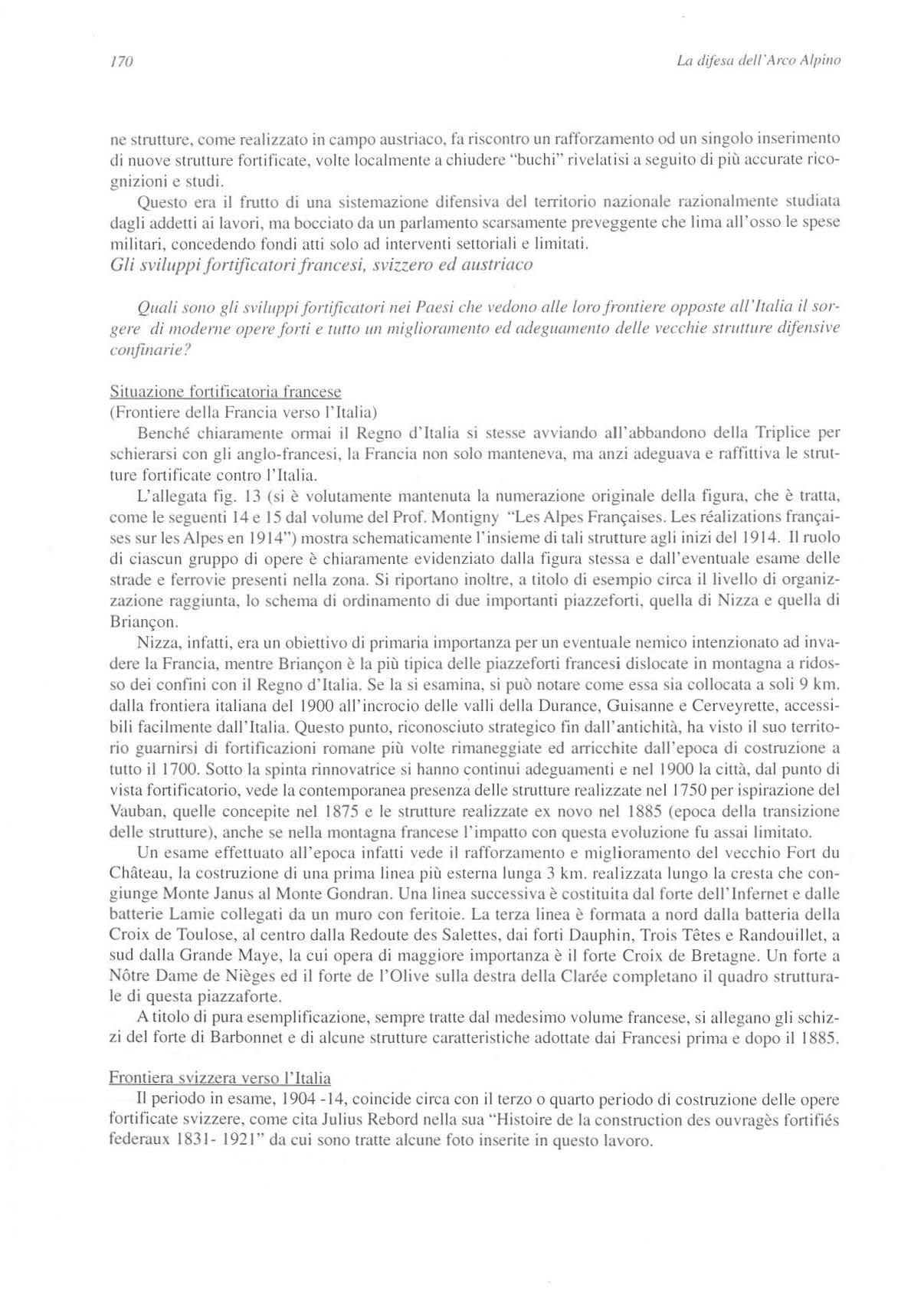
170 La difesa Afpi110
a l represenlent du • Jgroupements dovvr4ges Lo ouvr.190 «de couverlure·»
11' ~nl p.>s repristnlb
On n·., p.u figuri lts fort,,',cdtions ,ta/iennu
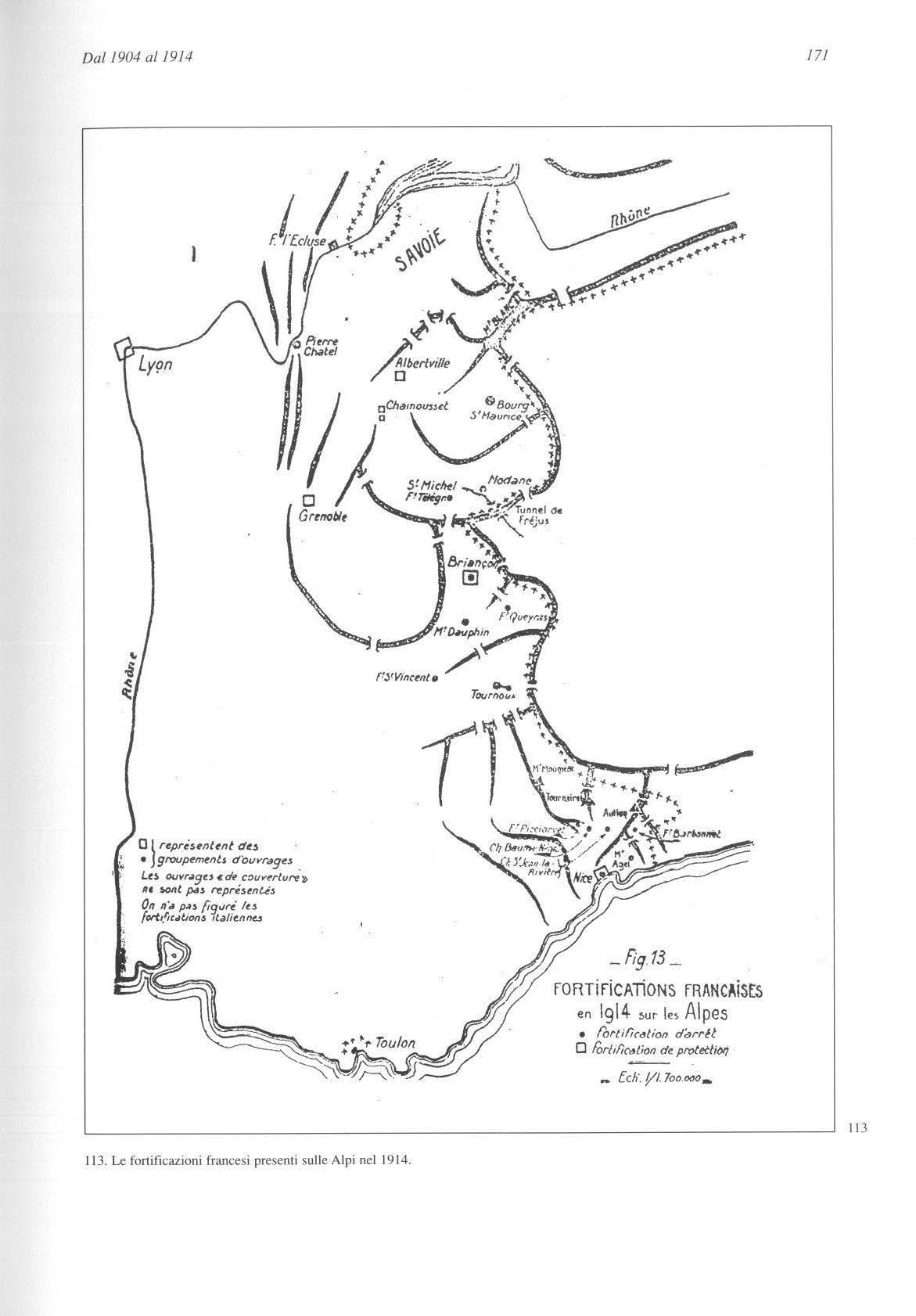
Dal 1904 al 1914
171 11
11 3
113. Le fortificazioni francesi present i sulle Alpi nel I 914.
_ [eh·. f"l looooo -.
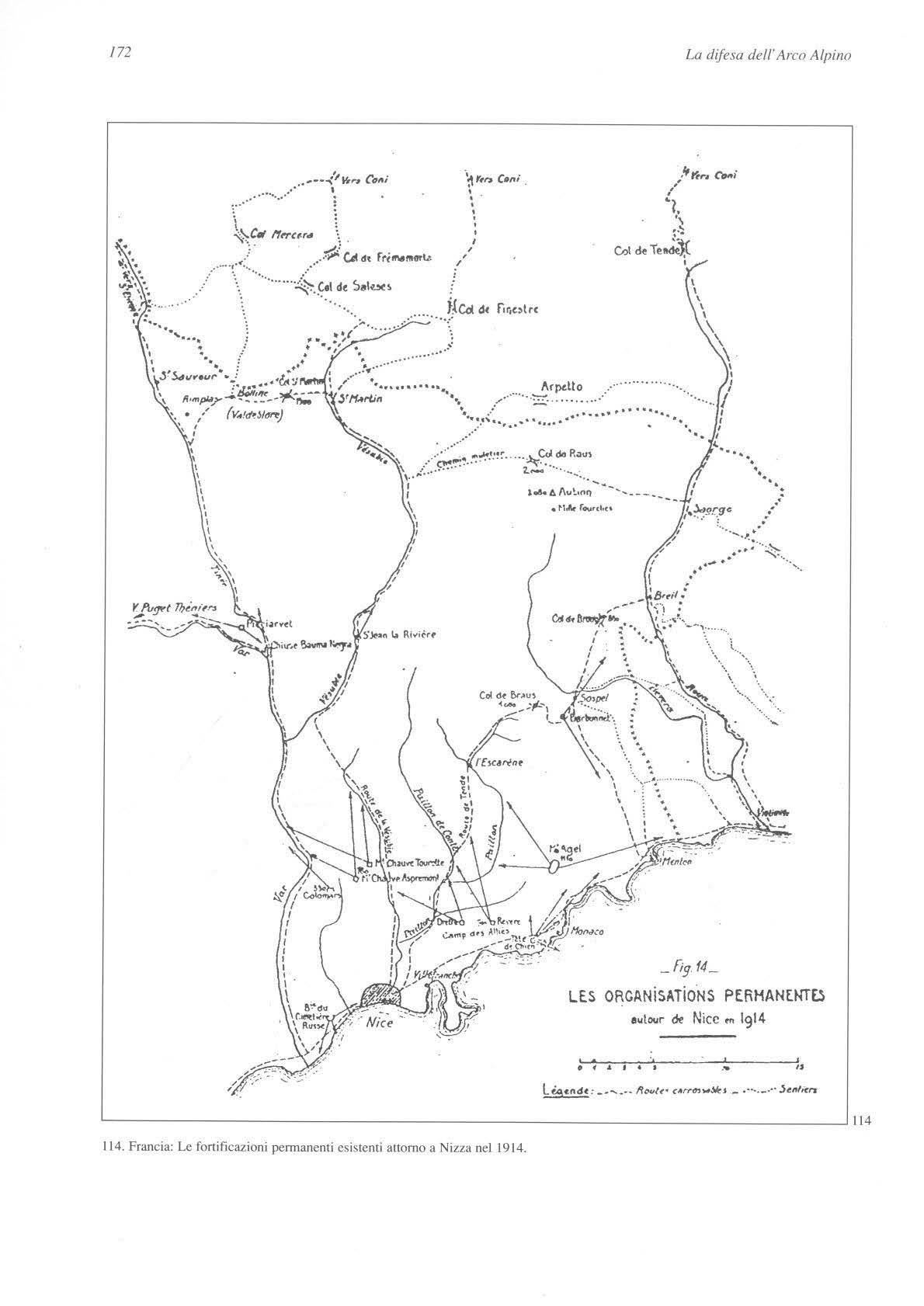
172 La difesa dell'Arco Alpino ,··"'~y,.'7 Co11i ~ ,,,. ,.,.; ' ··· ' .. • ·. ..: . 1 • : • ' , -. : ... 1,.J· .S.,vr•ur • .: ••&e,, ;"' fi;;;,::C ....1.:\ A•mf"J,r'-·----·T'n.. , • / (V,.f<P.JI""') • I 'I ,I . '''' 'I I , / }~Cd d« fìr,t)lrc .·········:· ........:-· .. .. Arpdto ·············· .,,.·········~············· .. ...... . ·•~.•'••r •• • •••• • ••• •• ••• •. • • • ~.... ··· ... ,, • .-..."- ~ _ .. ·· • ~.'.'!~ ~Cd.do R,1,n • \ 2:·:..~-~ -···· 1.~··· , - -~< I '~ I le&• A Aut,nt) ',, \ I I I I I I _ fig f4_ .. . .. ~--., ......• .. .. ·..... LE.S ORCANiSATiO.NS PERHAN[NTES autour de Nicc m 1914 • f .& f • I IJ Li:gendt: __ ,_•• //~le• (ArrO,wM,s - ·····-···s~nlicri 114. Francia:
114
Le fortificazioni pennanenti esistenti attorno a Nizza nel 1914.
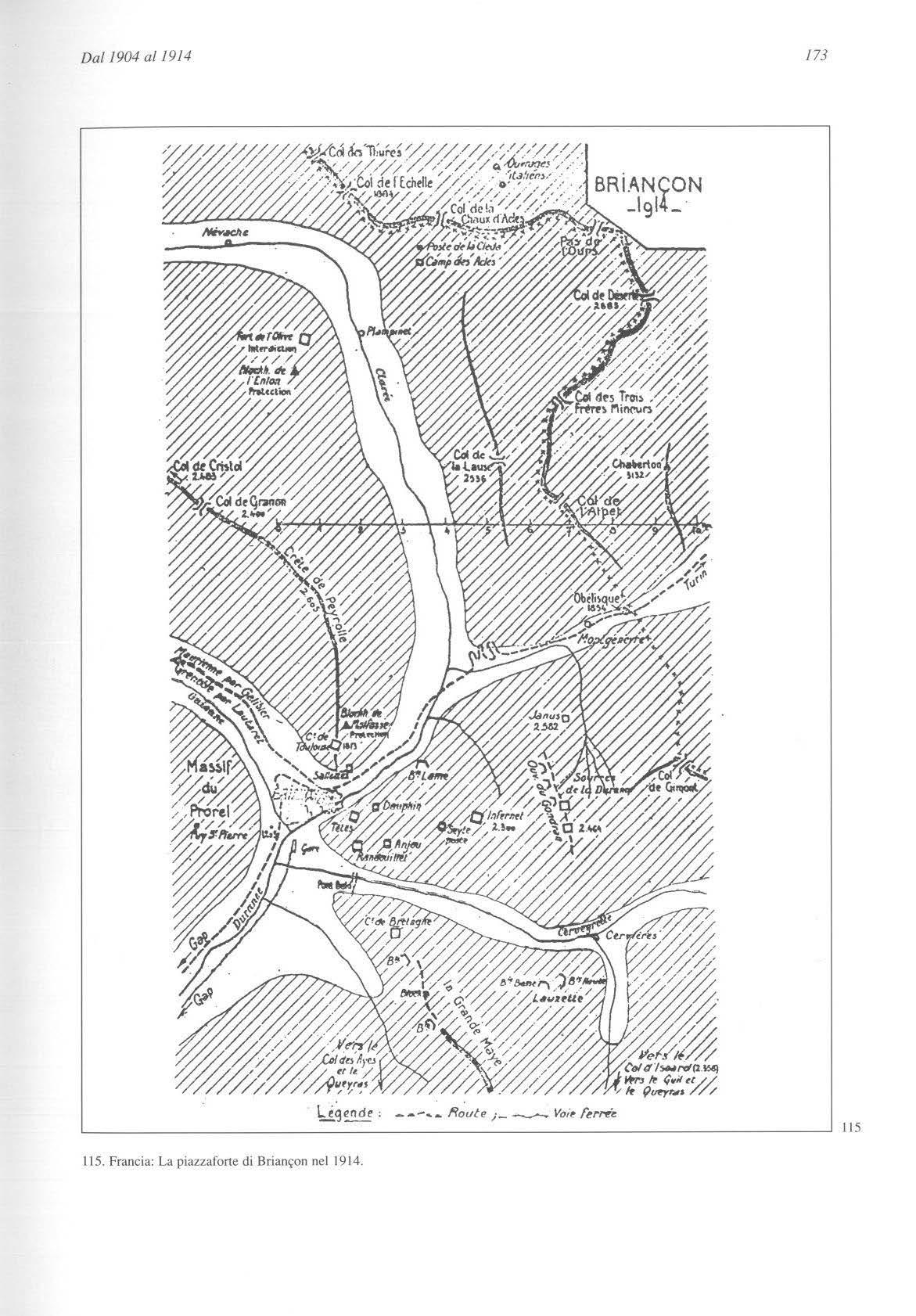
Dal 1904 al 1914 173 '-------- --' 115
115. Francia: La piazzaforte di Briançon ne l 1914.
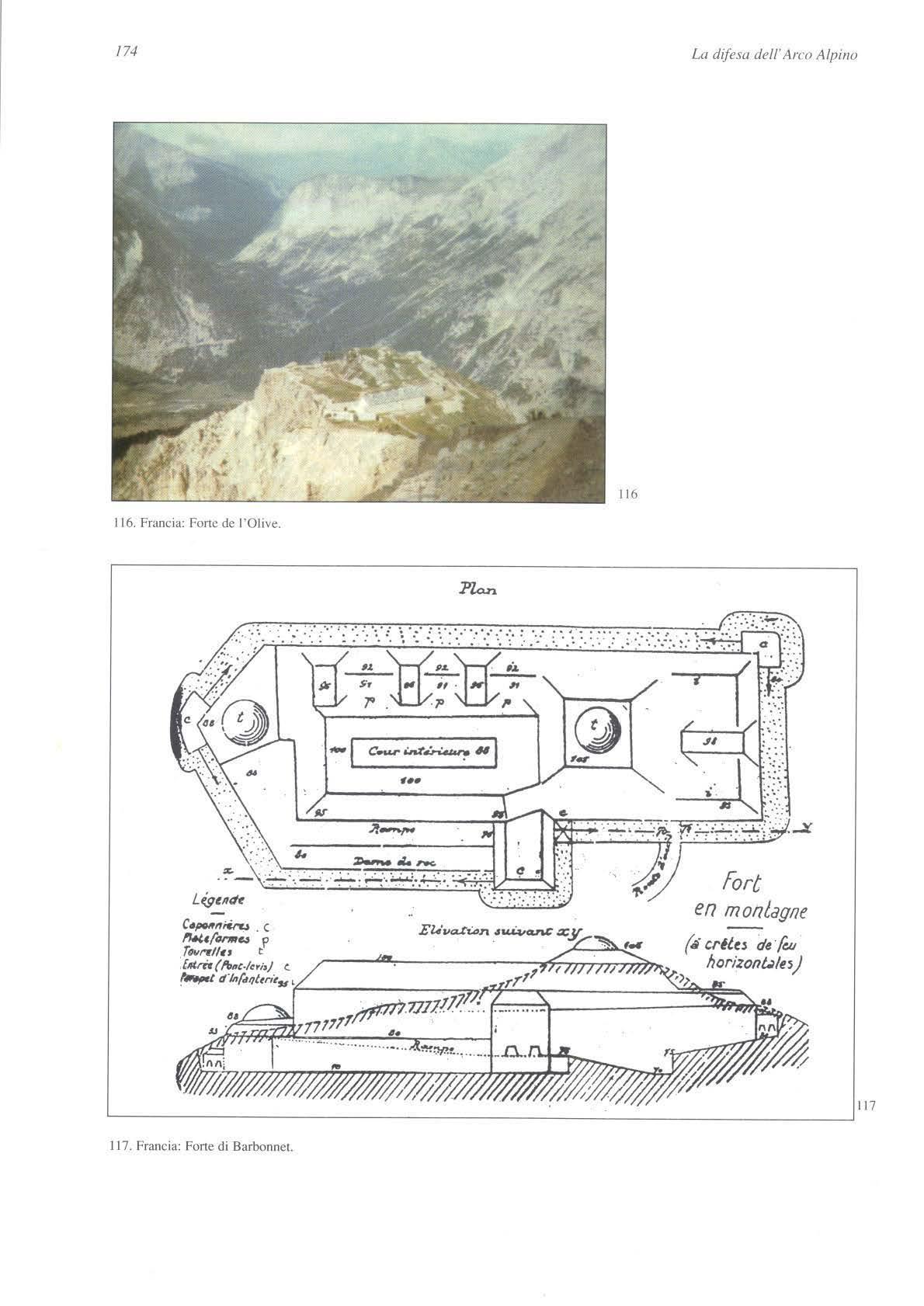
174 La difesa dell'Arco Alp ino 116
-j c~wJ~NI .,..
116 Franc ia: Forte de l ' Olivt:.
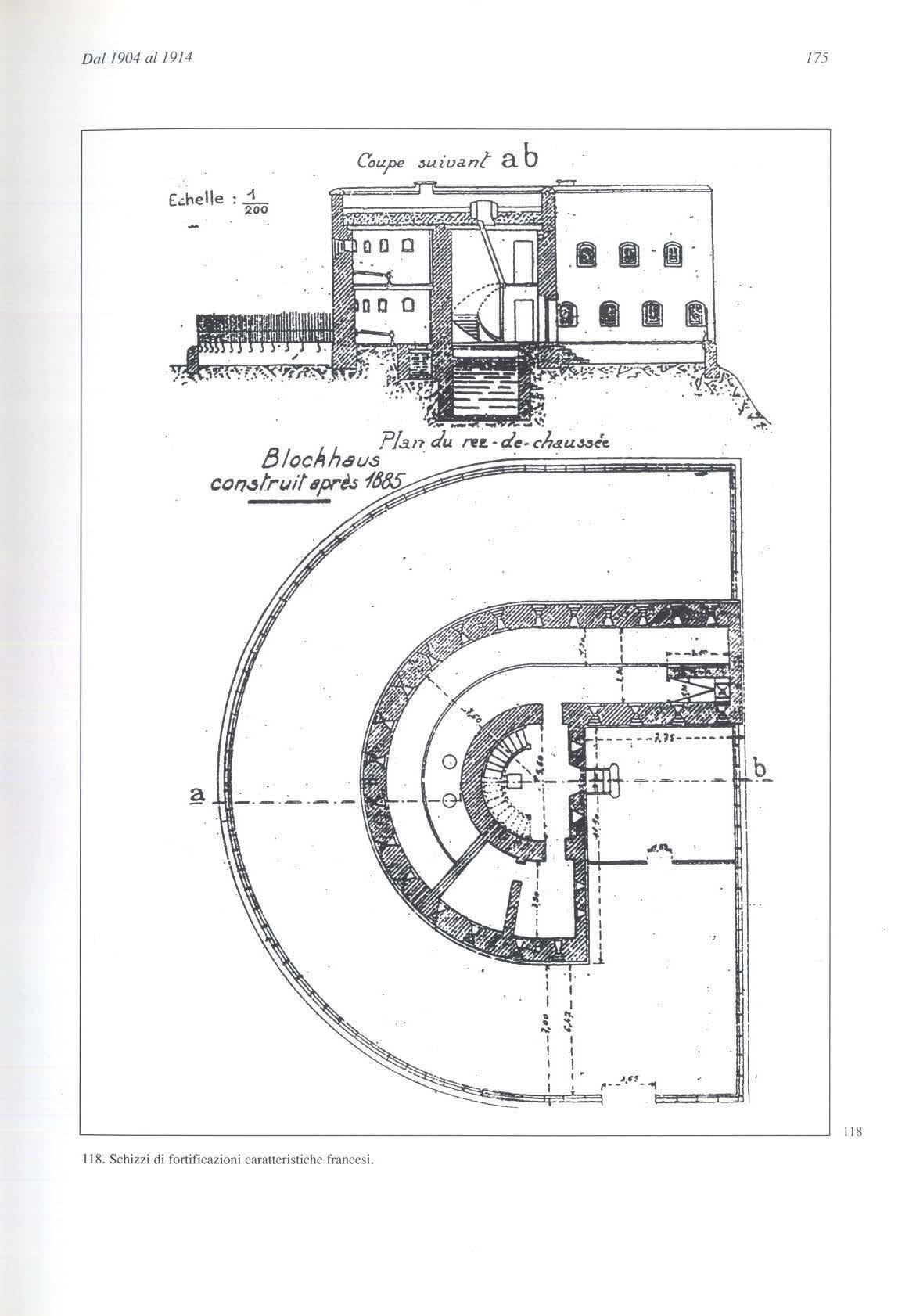
Dal 1904 al 1914 E.:helle · -1 200
.,. I I ..... I I I 1 l I Il ' . .,~ ,.. - • - 11 175 11 8
ll8. Schizzi di fortificazioni caraueristiche francesi.
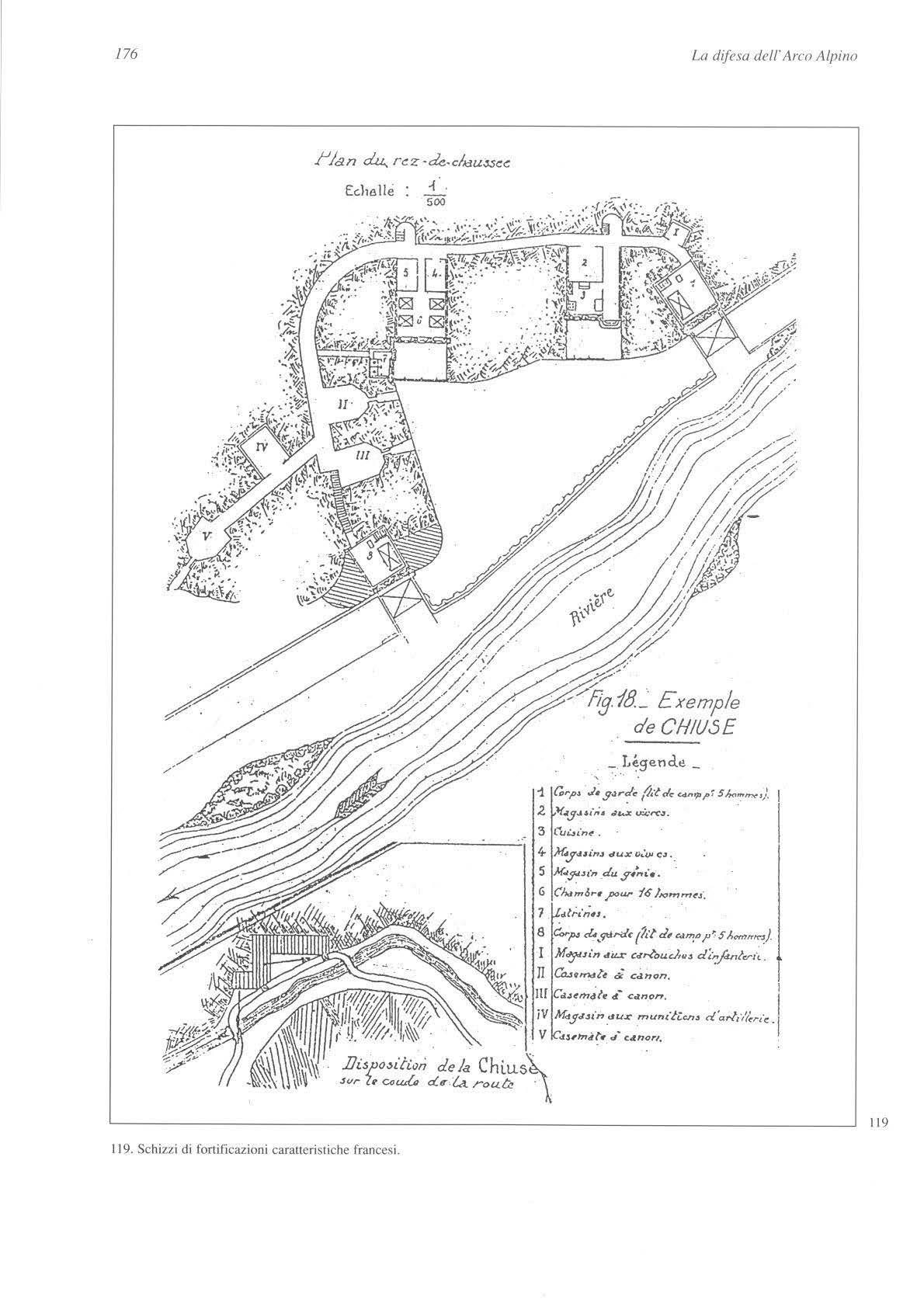
176 La difesa de/l'A reo Alpino
119. Schizzi ct· f , ortif1cazioni caratteristiche frances1.
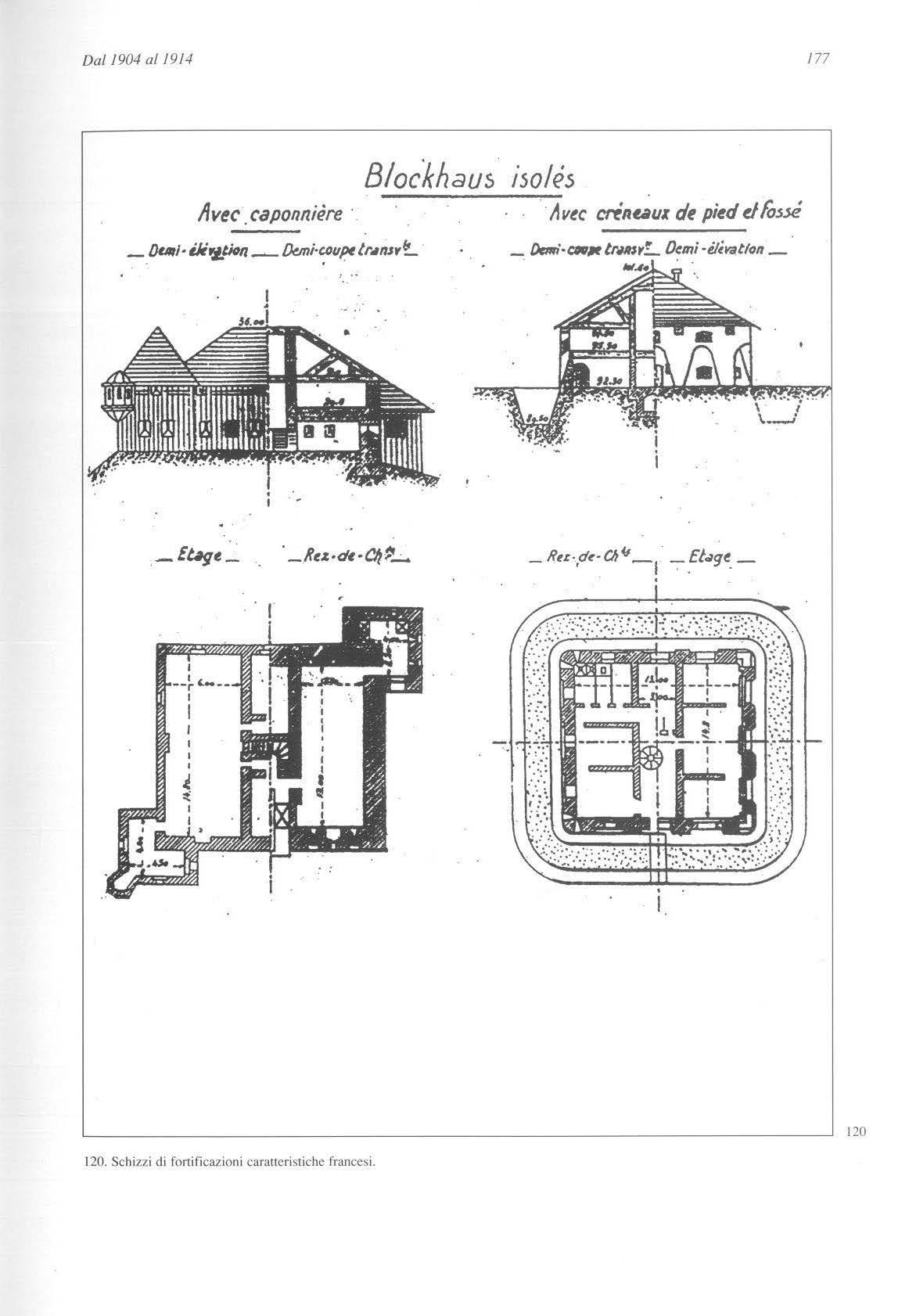
Dal 1904 al 1914 177 8/ockhaus isolés Ave('. (aponnière ·. · · ··Avtc crinuu1 de pitd d fosJé _ Duti• iliFl}ion -- lkmi·'!upt lrt1ns,'!_ I ,,...1 . ../.!.:}.'·\::j:/i':.::·~j~:~::.:·:?>;~::\\/.:, . ... 120
120. Schizzi di fortificazioni caratter istiche francesi.
Notevolissimi sono i lavori che vengono svolti e che riguardano principalmente l'ampliamento ed adeguamento delle strutture ai nuovi canoni fortificatori: sostituzione di armi obsolete cd acquisizione di moderne artiglierie sovente in cupola corazzata, realizzazione di collegamenti telefonici e viari. Per avere un'idea seppur parziale dei lavori, è necessario esaminarli suddivisi per settore.
A. Fortificazioni del Cot1ardo. Viene trasformata l'opera di Motto Bartola, completata e terminata l'opera presso l'Ospizio, iniziata la realizzazione di opere forti presso Bellinzona; vengono messe a sito numerose balterie alla scoperto, ingranditi caserme ed alloggiamenti, messi in opera l 'ostacolo di fil di ferro e la rete telefonica. Viene creata inoltre una notevole rete stradale e mulattiera e si pongono le condizioni per la difesa della costituenda ferrovia del Furka.
B. Crimsel. La posizione è strettamente collegata a quella del Furka e l'apposita commissione dibatte se sia necessario installare a Grimse l un'opera autonoma o meglio convenga potenziare il Furka; nelle more vengono realizzate alcune strade per l'eventuale d i slocazione sul le altura di Grimsel cli artig li erie non fisse e stese le opportune I inee telefoniche. Ristrettezze di crediti e la convinzione che la fortificazione non fosse estremamente necessaria portano fin dalla fine del 1903 alla cancellazione del progetto di realizzare un a fortificazione sul colle di Grimsel.
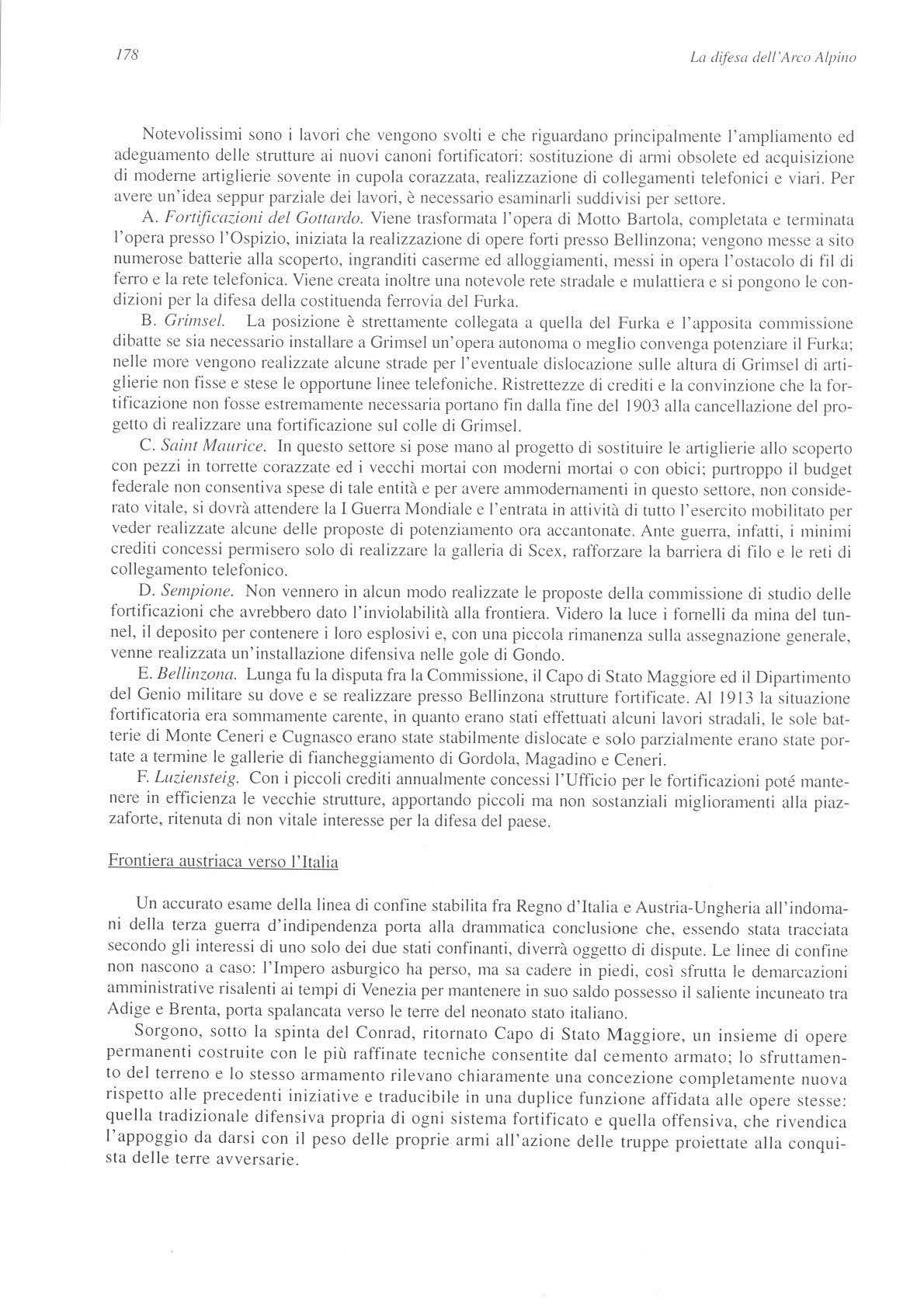
C. Saint Maurice. In questo settore si pose mano al progetto di sostituire l e artiglierie allo scoperto con pezzi in torrette corazzate ed i vecchi mortai con moderni monai o con obici; purtroppo il budget federale non consentiva spese di tale entità e per avere ammodernamenti in questo settore, non considerato vitale, si dovrà attendere la I Guerra Mondiale e l'entrata in attività cli tutto l'esercito mobilitato per veder realizzate alcune delle proposte di potenziamento ora accantonate. Ante guerra, infatti, i minimi crediti concessi permisero so l o di realizzare la galleria di Scex, rafforzare la barriera di filo e le reti di collegamento telefonico.
D. Sempione. Non vennero in alcun modo realizzate le proposte della commissione cli studio delle fortificazioni che avrebbero dato l'inviolabilità al l a frontiera. Videro la lu ce i fornelli da mina ciel tunnel, il deposito per contenere i loro esp l osivi e, con una piccola rimanenza sulla assegnazione generale, venne realizzata un 'installazione difensiva nelle gole cli Gondo.
E. Bel/inzona. Lunga fu la disputa fra la Commissione, il Capo cli Stato Maggiore ed il Dipartimento del Genio militare su dove e se realizzare presso Bellinzona strutture fort ificate. Al 1913 la situazione fortificatoria era sommamente carente, in quanto erano stati effettuati alcuni lavori stradali, le so l e batterie di Monte Ceneri e Cug na sco era no state stabilme nte dislocate e solo parzialmente erano state portate a termine le gallerie di fiancheggiamento di Gorclola, Magaclino e Ceneri.
F. Luziensteig. Con i piccoli crediti annualmente concessi l 'Ufficio per le fortificazioni poté mantenere in efficienza l e vecchie strutture, apport ando piccoli ma non sostanzia li miglioramenti alla piazzaforte, ritenuta cli non vitale interesse per la difesa ciel paese.
Frontiera austriaca verso l'Italia
Un accurato esame della linea di confine stabilita fra Regno d'Italia e Austria - Ungheria all'indomani della terza guen-a d'indipendenza porta alla drammatica conclusione che, essendo stata tracciata secondo gli interessi di uno solo dei due stati confinanti, diverrà oggetto di dispute. Le linee di confine non nascono a caso: l 'Impero asburgico ha perso, ma sa cadere in piedi, così sfrutta l e demarcazioni amministrative risalenti ai tempi di Venezia per mantenere in suo saldo possesso il saliente incuneato tra Adige e Brenta, porta spalancata verso le te1Te ciel neonato stato italiano.
Sorgono, sotto la sp inta del Conracl, ritornato Capo di Stato Maggiore, un insieme di opere permanenti costruite con le più raffinate tecniche consentite dal cemento armato; lo sfruttamento ciel terreno e lo stesso armamento rilevano chiaramente una concezione completamente nuova rispetto alle precedenti iniziative e traducibile in un a duplice funzione affidata alle opere stesse: quella tradizionale difensiva propria di ogni sistema fortificato e quella offens i va, che rivendica l'app oggio da darsi co n il peso delle proprie armi all'azione delle truppe proiettate alla conquista delle terre avversarie.
178 La difesa dell'Arco Alpino
Un accurato esame del terreno ci mostra come sia stata sfruttata in modo ottimale la morfologia del terreno, inserendovi come strutture il meglio che potesse essere concepito e prodotto all'epoca, con un uso spregiudicato di vero cemento armato, cupole blindate di acciaio di forti spessori e potente armamento.
Infatti l 'A ustria, nella sis temazione difensiva della sua frontiera verso l'Italia, ha seguito dal 1897 in poi un piano l ogicamente preordinato, la cui attuazione può dirsi compiuta alle soglie del conflitto mondiale. Criterio fondamentale cli tale sistemazione difensiva fu di avvalersi dell'arte fortificatoria l à dove il terreno montano le viene in aiuto e di provvedere con truppe mobili per qu e l tratto di frontiera che corrisponde al l a regione di pianura; appunto in base a tale concetto essa ha sbarrato con forti dotati cli grande autonomia tutte le rotabili che dall'Italia mettono nel Tirolo, Pusterthal, Carinzia e Carnio la , ha creato un grande campo trincerato nel saliente ciel Tirolo (che può anc he servire di base ad operazioni controffensive ed anche offensive) e su lla sua ben sistemata rete ferroviaria fa valido affidamento per far affluire rapidamente a l basso Isonzo il numero di forze mobili rit en ut o necessario.
Nella considerazione che gli obiettivi da raggiungersi da parte dell'Italia dovrebbero essere Budapest o Vienna, il cuore della monarchia austro-ungarica, che per tale scopo i fasci strada! i CoclroipoPalmanova-Graclisca-Gorizia e Portogruaro-Latisana-Cervignano che attraversano la frontiera aperta risulterebbero eccentri ci ri spetto alla direzione genera l e, si deve trovare la ragione della mancanza quasi generale di fo11ificazioni austriache nella parte meridionale delle Alp i Giulie.
Nella parte settentriona l e invece, a sbarramento de l fascio di Pontebba, troviamo un comp l esso di opere realizzate nei pressi cli Tarvisio c he hanno lo scopo cli arrestare un'irruzione dell'Italia attraverso l e Alpi Carniche e di servi re d'appoggio per l'eventuale avanzata di truppe austriache e di rinforzi
Tarvis, posto di fron1e al sal iente che l a fron1icra i taliana fa su l Fella. è un importante nodo di comunicazione Per Tarvis passano infatti la s1rada e la ferrovia proveniemi dal medio Tagliamemo e da Udine , l e quali attraversano la valle del Fella. conducono a Villach nella va lle della Drava e cost ituiscono la più breve linea di comuni cazione con Vienna: fa inoltre capo nella valle del Fella l'altra s1rada che, per il passo del Predii. conduce in Val d'Isonzo ed a Gorizia. oppure a Wurze n ed a Lubi:rna nella valle delln Sava, costi1uenuo una minncc i a sui fianchi ed a tergo di forze austriache co ncentrate in quelle regioni."5

Le fortificazioni erette dagli austriaci presso Tarvisio, con il compito di interdire fra l'altro le strade Udine-Cividale-Starasella-Tarvisio e Osoppo-Stazione per la Carnia-Tarvisio-Villach, risultano costituite, come appare da un artico lo appa r so sul giornale Militar Wochenblatt del 1907, dagli sbarramenti di carattere permanente Flitsch, Raibl e Forte Hensel; si tratta di strutture in gran parte realizzate dopo il 1900 secondo i moderni principi della fo rtifi cazione e comprendono opere per la difesa lontana, ciascuna armata con diversi cannoni corazzati, e sbarramenti stradali. Lo sbarramento Flitsch si compone cie l Forte Hermann per l'azion e lontana, dello sbarramento stradale Flitscher Klause e del vecchio Forte Predii; lo sbarramento Raibl comprende l a batteria per la difesa lontana Prcdilsatter e l 'opera di sbarramento Raible See èd il Forte Hensel sbarra l a strad a e l a ferrovia nella va ll e del Fclla. Nessuna opera ri su lta realizzata per sbarrare la strada di monte Carnico.
Sul fascio stradal e della valle del Piave troviamo maggiormente sv iluppato il sistema difensivo, esistendovi opere a sbarramento delle tre strad e principali sul l a direttrice Longarone-Dobbiaco:
I su lla strada cli Monte Croce Cornelico (Va l Parola) il grup po di Sesto (Sexten) coi forti Mittelberg e Haideck a sbarramento della strada e a difesa cli alcune mu l attiere che fanno capo alla conca Moos-Sexten;
2. sulla strada di S. Angelo di Misurina (Val Anziei) il forte Platzwiese in Val di Prags;
Dal 1904 al 1914 179
-'
AA. VV., Le For1ifico~io11i dell'A11s1rio alla Fro111iem ilo/i(llw in Rivista di Artiglieria e Genio··. 1907. pag. :rn .
3. sulla st rada di Allemagna lo sbarramento di Landro, costituito da due opere, forte Landro inferiore e forte Landro s uperiore con azione fino a Schluderbach, ove fanno capo le provenienze del colle di S. Angelo di Misurina.
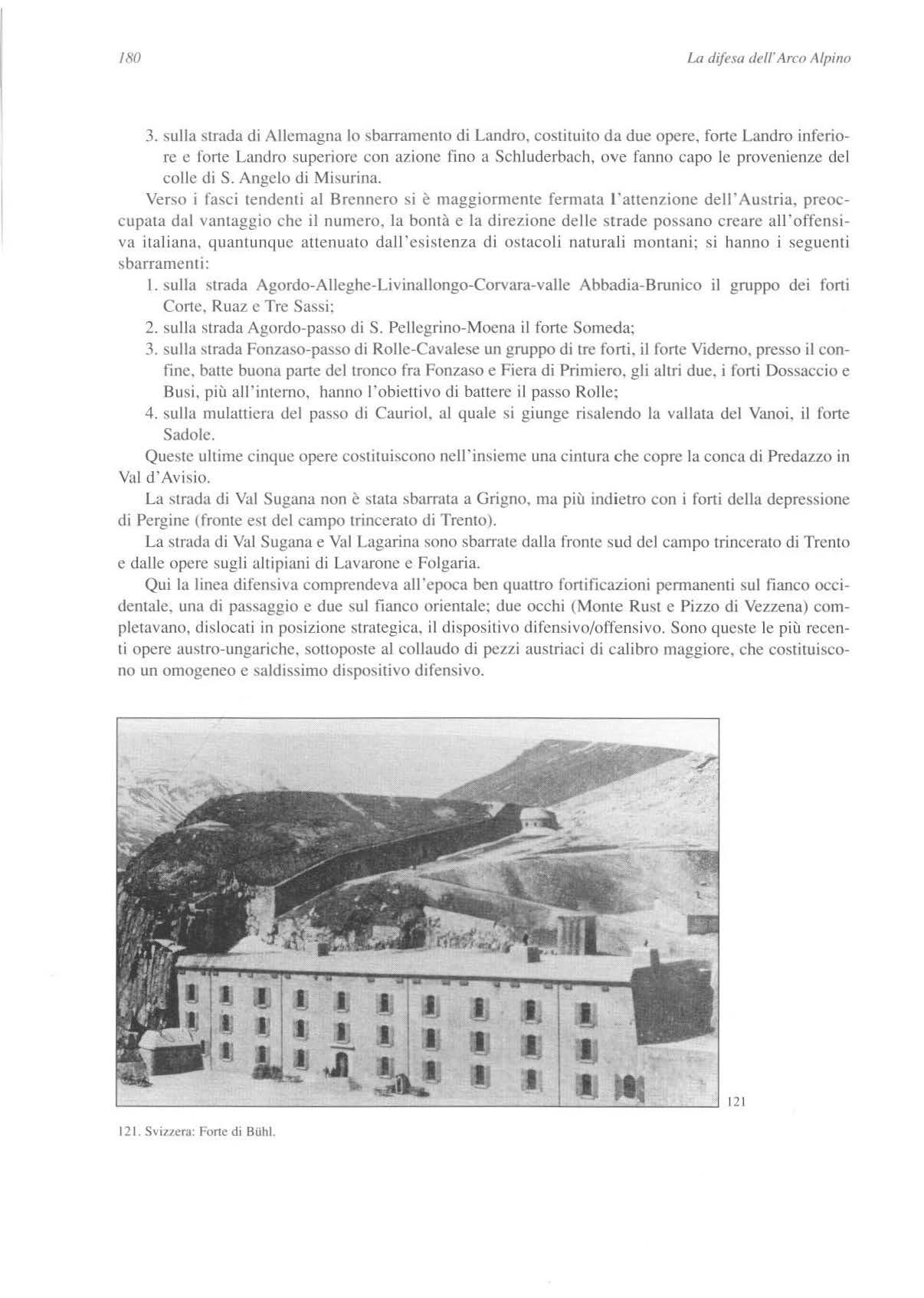
Verso i fasci tendenti al Brennero si è maggiormente fermata l"attemion e dell'Austria, preoccupata dal vantaggio che il numero, la bontà e la direzione delle stra de possano creare all'offensiva italiana, quantunque auenuato dall'esistenza di ostacoli naturali montani; si hanno i seguenti sbarramenti:
l. sulla strada Agordo-Alleghe-Livinallongo-Corvara-valle Abbadia-Brunico il gruppo dei forti Corte, Rua z e Tre Sassi;
2. sulla strada Agordo-passo di S. Pelle gri no-Moena il forte Someda;
3. sulla strada Fonzaso-passo di Rolle -Cavalese un gruppo di tre forti, il forte Videmo, presso il confine, batte buona parte del tronco fra Fonzaso e Fiera di Primiero, gli altri due, i foni Dos saccio e Bu si, più all'interno, hanno l'obiettivo di battere il passo Rolle;
4. sulla mulattiera del passo di Cauriol. al quale si gi unge risalendo la vallata del Vanoi, il forte Sadolc.
Que ste ultime cinque opere costituiscono nell'insieme una cintura che copre la conca di Predazzo in Val d'Avisio.
La strada di Val Sugana non è stata sbarrata a Grigno, ma più indietro con i forti della depressione di Pergine (fronte est del campo trincerato di Trento).
La strada di Val Sugana e Val Lagarina sono sbarrate dalla fronte sud del ca mpo trincerato di Trento e dalle opere sugli altipiani di Lavaronc e Folgaria.
Qui la linea difensiva comprendeva all'epoca ben quattro fortificazioni permanenti sul fianco occidentale, una di passaggio e due sul fianco orientale; due occhi ( Monte R ust e Pizzo di Yezzena) completavano, dislocati in posizione strategica, il dispositivo difensivo/offens ivo. Sono queste le più recenti opere austro-ungariche, sottoposte al collaudo di pcai austriaci di calibro maggiore, che costituiscono un omogeneo e saldissimo dispositivo difensivo.
180 La difesa dell'Arco Alpino
121. Svi11era: Forte di Biihl.

Dal 1904 al /914 181 122 123
122. Svizzera: Zona di Saint Mauricc - ridotto di fiancheggiamento di Savatan
123. Svizzera: Forte A lpino S. Gottardo - Torretta osservatorio.
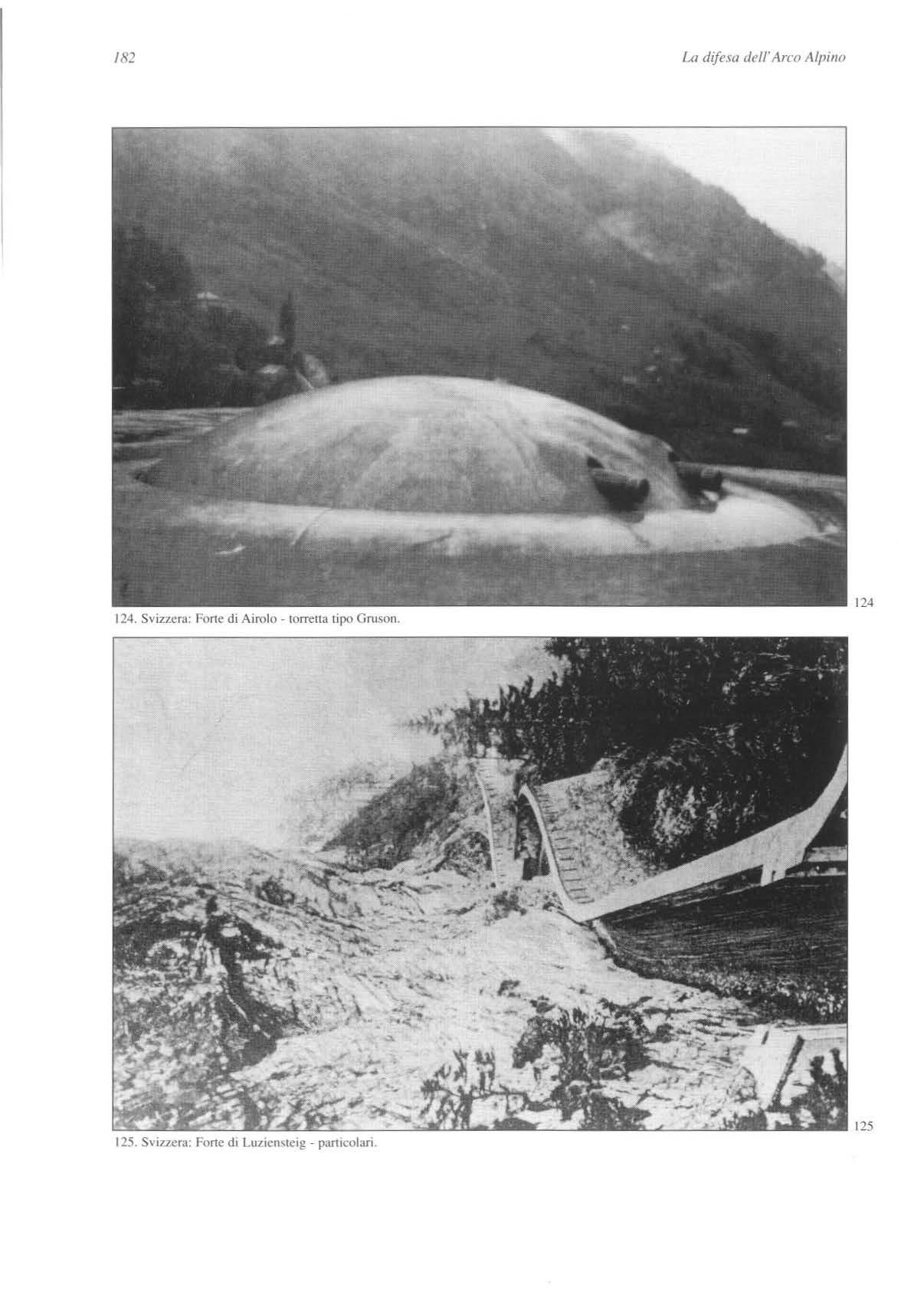
IR2 La difesa dell'Arco Alpino 124
125
124. Svizzera: Fone di Airolo - torretta tipo Gruson.
125. Svi77era: Fonc di LuLicn~tcig - particolari.
"Il campo trincerato di T rento, di part icolare importanza pala difesa del T irolo mt:rid i onalc. cosLruilO secondo i moderni princip i ddl'arte fortificutoria; qui, oltre la strada della Valle d'Ad i ge, affluiscono ancht: la maggior parte delle l in ee di opt:razione italiane d irette alla va ll e cieli' Ad i ge:·6
Se lo si esam ina per sommi cap i , si vede come di tale campo trincerato:
"la fronte meridional e, assai forte. ha per iscopo di sb:.irrare la va ll e del l 'Ad ige, e si compone delle grandi opere corazzate moderne di Mauarello e Romagnano. dt: I forte d i sbarramento di più vecch i a costruzione presso Valsorda, e di un forte con torri corazzate, che do mina l a ciuà.
La fronte est, che sba rra le l'Ornunicazioni proven i enti dalla Val Sugana e dalla valle dcli' Astico, comprende parecchie batterie presso Civezza no e le bauer ie a nord-ovest di Vigolo-Va ttaro; la fronte ovest che sbarra l a strada di Val di Sarca, è cost i tuita dall'opera a casamaua Cadine. di vcçch i a cos tru zione. e da parecc;hie hauerie. La fronte no rd protegge la ciuà per mezzo di due opere d i vecchio tipo e d i una batteria: non esiste ridouo. Qut:sto campo trincerato può r ic overare una d i visione di fanteria ed è largamente provvisto di me1.1. i di comunic:12ione e d'illuminazione dd terrt: no antisLantc." 7
li fascio delle Giudicarie è difeso:
I. dallo sbarramento di Lardaro in Val Bona a sud de l colle di Tione, che è costituito dall'antiquata opera di interdizione di forte Revegler, dalle opere di protezione di Larin o, Danzolino e Monte Corno, quest'ultima d otata di robuste casematte e dal forte Por;
2. dallo sban-amento di Val d' Arnpola, a sud del colle di T i amo, opera ricostruita dopo che nel 1866 venne distruua dai garibaldini;
3. dallo sba rram en to di Riva, alla testata nord del lago di Garda, composto dai moderni (per l'epoca) forti di Monte Brione, Monte Tombio, e da quelli di S. Nicolò e Nago posti a difesa cli tutt e le strade che dalle valli c ircostanti scendono a Riva
Analogamente è sta to provveduto per la valle dell'Inn; infatti le strade che tendono al colle cli Resia e quindi all'alto Inn sono :
I. strada del Tonale, sbarrata dal Forte di Stino e dall'opera bassa di Velon, che batte il fondo di Val Vermiglio, nelle posizioni di Saccarana e Pozzi Alti, presso il colle, so no sta te realizzate due batterie. Questo formidabile sbarram ento in unione alle opere della Val di Pejo, salda fra di loro i formidabili massicci cieli' Adamello e dell'Ortler;
2. st rada dello Stelvio, sbamua dal fo ,te Gomagoi, che v i ene a saldare Monte Cristallo del massiccio dell'Ortler con pizzo Umbrail ; si tratta di un'opera dec i sa mente obsoleta come co ncezione, ma che viene tutt av ia mantenuta in efficienza ed armamento, stante l a difficoltà di sostituir l a;
3. strada del Colle di Resia, guardata dalle fortificazioni interne di Nauders, organizzate in modo da far fronte non solo a sud, ma altresì ad attacchi provenienti dall'alto Inn.
11 sis tema di fortificazioni precedentemente accennato consen te ag li Austriaci di provvedere all a difesa del Tiro lo con forze m ob ili relati va mente es i gue, c he si appoggian o alle opere, e rende in pari tempo sicure le l oro comunicazioni con l ' intern o dell'Impero, comunicazioni assai esposte, causa lavicinanza della fronti era con l'Italia. Gli sbarramenti della Carinzia assicurano l 'avanzata di forze austriache dal goriziano e rendono possibili operazioni offensive dall a linea Villach-Tarvisio per la valle del Fella, sul fianco della ba se cl' operazione italiana.
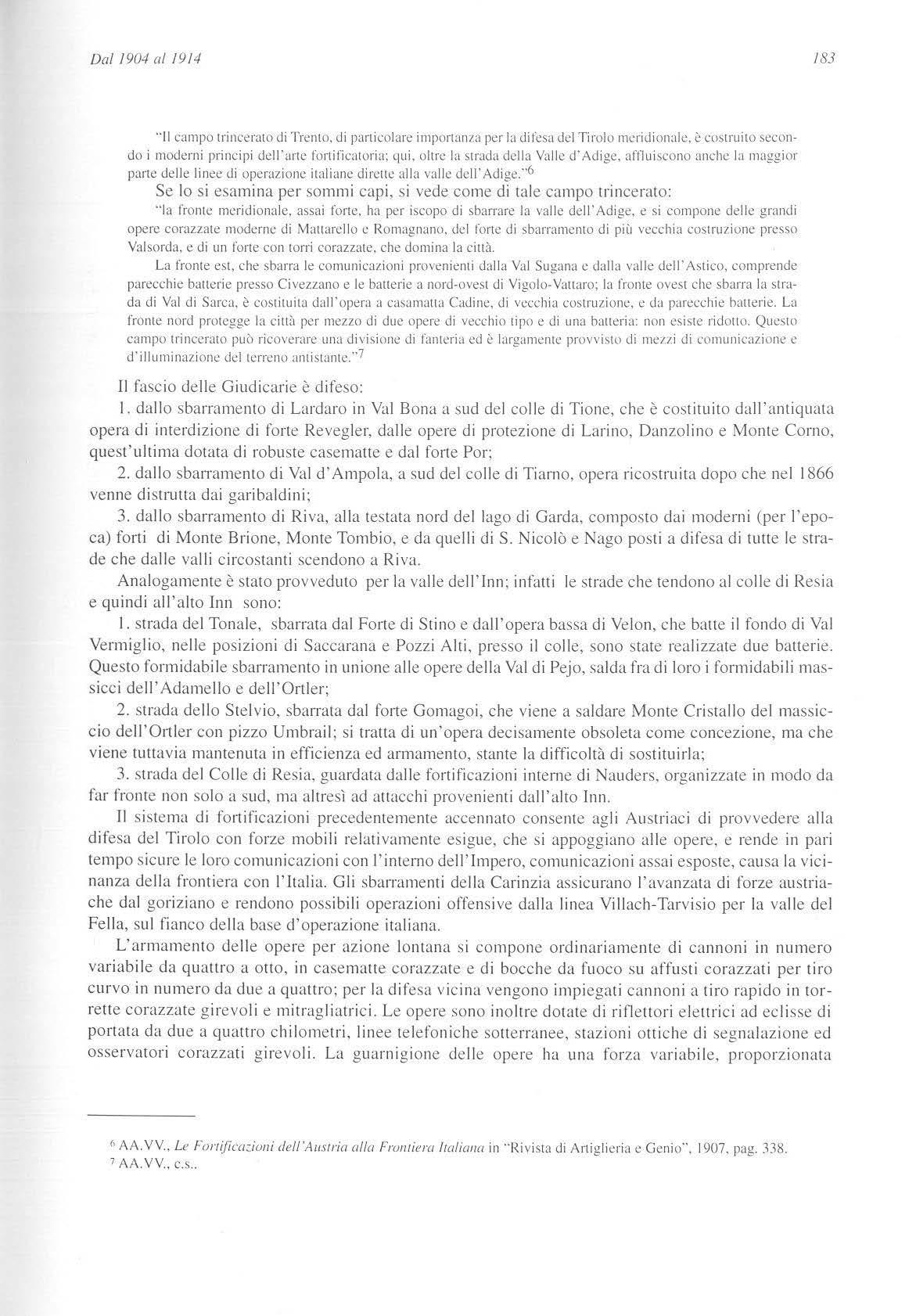
L'armamento de lle opere per azione lontana si compone ordinariamente cli cannoni in numero variabile da quattro a otto, in casematte corazzate e cli bocche da fuoco su affusti corazzati per tiro curvo in numero da due a quattro; per l a difesa vicina vengono impiegati cannoni a tiro rapido in torrett e corazzate g irevo li e mitragliatrici. Le opere sono inoltre dotate cli riOettori e leuri ci ad ec li sse di portata da du e a quattro chilometri, linee telefoniche so tt e rranee, stazioni ottiche di segnalazione ed osservatori corazzati g irevo li. La guarnigione delle opere ha una forza va riabil e, proporzionata
6 AA. VV., le For1ijica~io11i dell'A11s1ria alla Frmlliera /1alic111c1 in "Rivista di A rt ig li er i a e Genio" . 1907, pag 338.
7 AA VV., c s
Dal 1904 al 1914
183
all'entità dell'armamento installato; la <life,a è affidata a guarnigioni di fanteria <li seconda e terza linea, la cui entità non supera mai i cento uo111ini, poiché per l a difesa si fa molto assegnamento sulle riserve mobili.
Considerazioni sulle opposte strutture (Italia -Austri a)
Come ben si può \e<ler 111aterialmente sul terreno e dagli archivi ex imperiali. con l'as.cesa del Gen. Conrad alla carica di Capo e.li Stato Maggiore dell'Esercito austro-ungurico, le relazioni italo-aw,triacht.! erano decisamente peggiorate e, nonostante l'apparente cordialità dovuta al comune legame della Triplice, ognuno dei due stati andarn potenziando le proprie strntture difensin::.
L'Italia, ormai tkcisamente orientata a lasciare la Triplice, iniziò nel 1909 a sistemare a difesa la linea del Tagliamento. rafforzando nel co ntcrnpo le obsolete difese della piazza cli Venezia e modificando vistosamente i piani e.li radunata; ormai il Tagliamento aveva. nelle menti dello Stato Ylaggiore. ,ostituito il Pia\e quale luogo O\'e si ,arebbe svoha la ba11aglia decisi\a.
r progcui di mobilitazione e la dislocazione, sin dal tempo di pace, delle forze armate, evidenziano c hiaram ente co me ormai l'asse politico si fosse spostalo, in quanto il Governo, sensibile agli umori della piazza, si era orientato verso il male minore, la Francia.
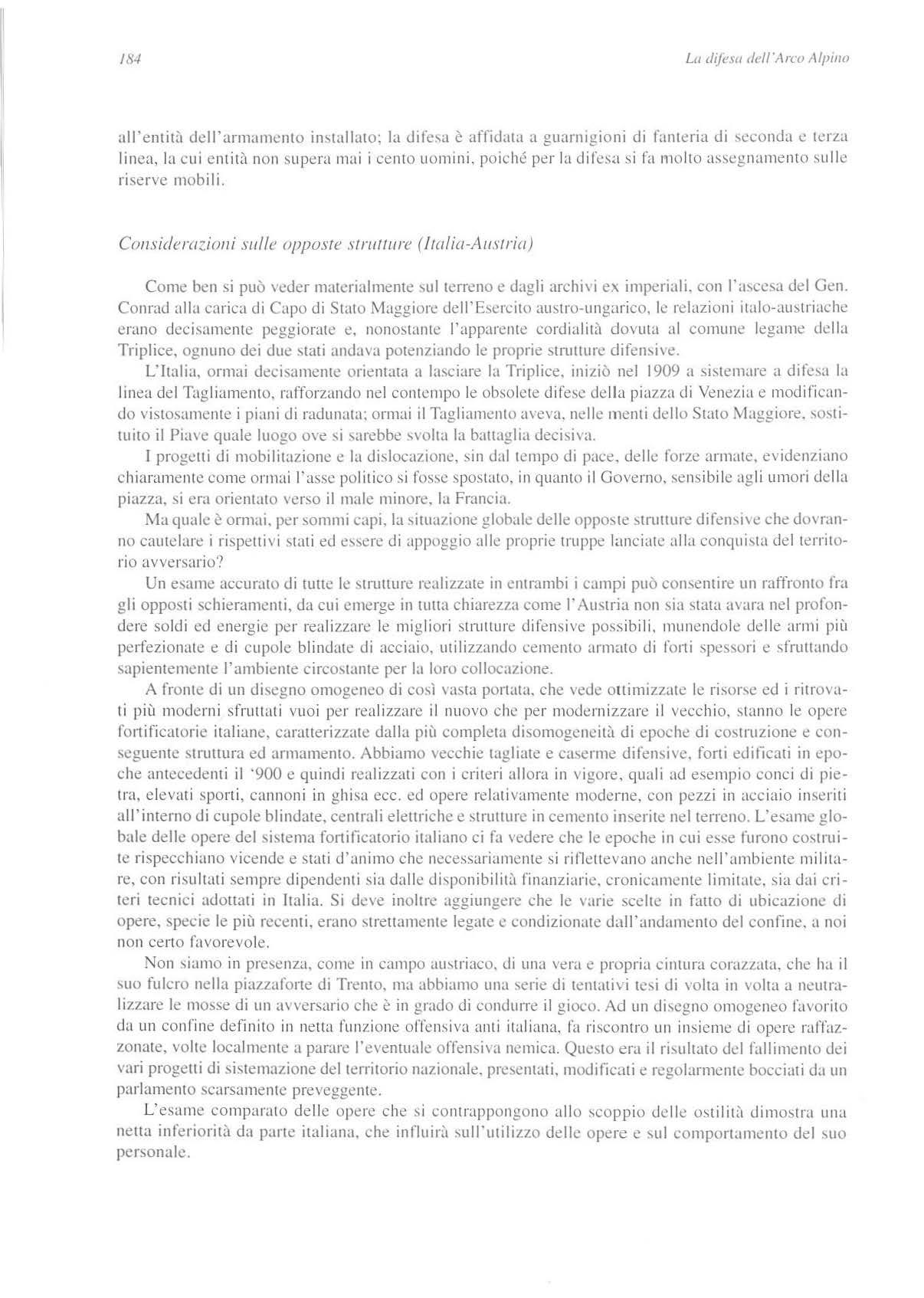
Ma quale è ormai. per sommi capi, la situazione globale delle oppo~te strullure difens.i\'e che do\ ranno cautelare i rispettivi stati ed essere di appoggio all e proprie truppe lanciate alla conquista ciel territorio avversario?
Un esame accurato di tutte le strutture realizzate in entrambi i campi può consentire un raffronto fra gli opposti schieramenti, da cui emerge in tulla chiarena come l'Austria non sia stata avara nel profondere soldi cd energie per realizzare le migliori st rullure difensive possibili. muncnclok delle armi più pc1fezionate e di cupole blindate di acciaio, utilizzando cemento armato di forti spessori e sfrullando sapientemente l'ambiente circostante per la loro collocazione.
A fronte di un disegno omogeneo di così vasta portata, che vede ollimizzate le risor,e ed i ritrovati più moderni sfruttati vuo i per realizzare il nuovo c he per modernizzare il vecchio, stanno le opere fortificatorie italiane, caratterizzate dalla più completa disomogeneità di epoche di costruzione e conseguente struttura ed armamento. Abbiamo vecchie tagliate e C,N:rme difensive. forti edificati in epoche antecedenti il '900 e quindi realizzati con i criteri allora in vigore, quali ad esempio conci di pietra, elevati sporti, cannoni in ghisa ecc. ccl opere relativamente moderne, con pezzi in acciaio inseriti all 'interno di cupole blindate. centrali elettriche e strnllure in cemento inserite nel terreno. L'esame globale delle opere del sistema fortificatorio italiano ci fa ,edere che le epoche in cui esse furono costruite rispecchiano vicende e stati d'animo che necessariamente si rillettevano anche nell'ambiente militare, co n risultati semprt! dipendenti sia dalle disponibili1~1 finanziarie. cronicamente limitate, sia <lai criteri tecnici adottati in Italia. Si deve inoltre aggiungere che le varie scelte in fatto cli ubicazione di opere, specie le più recenti, erano strettamente legate e condizionate dall'an<lamento del confine. a noi non certo favorevole.
Non siamo in presenza, come in campo austriaco. di una vera e propria cintura cora1za1a, che ha il suo fulcro nella piazzaforte di Trento, ma abbiamo una serie di temativi tesi di volta in \Olta a neutralizzare le mosse di un avversario che è in grado di condurre il gioco. Ad un disegno omogeneo favorito da un confine definito in netta funzione offensiva anti itali ana, fa riscontro un insieme di opere raffazzonate, volle localmente a parare l'eventuale offensiH1 nemica. Questo era il ri-.ultato dd fallimento dei vari progetti di sistemaLionc del territorio na7ionale, prcsemati, modificati e regolarmente bocciati da un parlamento scarsamente preveggente.
L 'esame comparato delle opere che s i contrappongono allo scoppio delle ostilit~, dimostra una netta inferiorità da parte italiana. che influir(1 sull'utilizzo delle opere e sul componamemo <lei ,uo personale.
/8./ La d(lesa dl'lf"Arco Alpino
L'avvento del calcestruzzo armat o, dapprima mescolato all a pietra e poi utilizzato da solo, soprattutto nelle parti più esposte alla minaccia o, addirittura, all'offesa diretta del nemico, è pienamente sfruttato dal l'Austria nel la realizzazione dei suoi moderni forti del l'Altopiano; robuste coperture di calcestruzzo di notevole spessore, in c ui vengono affogate con profusione incredibile putre ll e di ferro di 50 cm. di altezza, proteggono i difensori; le cupole che accolgono e proteggono i pezzi, generalmente obici, sono di acciaio con spessori variabili dai 250 ai 500 mm Scherni distributivi liberi seguono l'andamento del terreno con l a linea del fuoco, la più avanzata, naturalmente, verso il nemico ed i servizi sono posti subito dietro, ri vol ti verso le lince arniche; una linea di difesa, genera lmente affidata a mitragliatrici, fucilieri e pezzi cli piccolo calibro, se non addirittura fortini staccati dal resto del complesso, i traditor, cautela da poss ibili aggiramenti.
Tecnologicamente inferiori, le opere italiane presentano un eccessivo uso della pietra che, se pur esteticamente più gradevole, è decisamente inferiore al cemento come compattezza e solidità; là ove invece, nelle opere più moderne, viene impiegato il cemento, le tecniche delle gettate, la carenza di armature meta li i che e l 'uso di materiai i Iignei rendono le st rutture più sensibil i ali' azione distruttiva de l1'artiglieria di quanto non lo siano quelle avversarie. Corpi più ampi e diluiti e minore adeguamento al terreno rendono le strutture più visibili e v uln erabi li , mentre la superiori tà nel calibro dell'armamento. pur se non adeguato alle masse coprenti dei forti avversari, richiede l'adozione di particolari strutture, le polveriere, atte a contenere ed assemblare i colpi.
La disamina sino ad ora condotta ha evidenziato gli aspelti tecnici ed i procedimenti seguiti nei due opposti schieramenti; ma come si era g iunti a questa si tu azione alla frontiera orientale, situazione che provocherà un duro intervento del Gen. Cadorna, assunto alla carica di Capo cli Stato Maggiore, succedendo al Gen. Pollio improvvisamente deceduto?

Il programma di sis temazi one difensiva della frontiera orienta l e, stilato nel 1909-1 Oe completato nel 1911, con l' o rganizzazione della zona corrispondente alle sorgent i del Torre e del Natisene, subì nel 1913 un ulteriore perfezionamento e potenziamento; nel maggio di eletto anno la Commissione Suprema Mista per la Difesa dello Stato, incaricata di definire un nuovo limitato programma che colmasse le deficienze ancora esistenti nella nostra organizzaz ione difensiva in base ai bisogni immediati e più impell enti, si pronunciava per il completamento urgente dell'assetto ciel Cadore che, già sbarrato in corrispondenza delle rotabili di Monte Croce di Comelico e di va ll e Anziei, non l o era invece, se non in modo in sufficiente, nelle va lli ciel Cordevole e del Maé. Scartata, a causa delle cond izioni economiche del Paese, la possibilità cli affrontare la spesa di quattro milioni necessari a realizzare l e opere corazzate prev i ste, si deliberò di limitarsi, con una spesa complessivamente molto inferiore, all a costrnzione di strade ed a qualche altro lavoro per l'eventuale occupazione cli alcune posizioni.
Allo scoppio della guerra, tredici delle opere corazzate progettate sulla frontiera orientale erano ancora incomplete. Di esse, quella destinata a sorgere su ll a posizione del Toraro, tra Val Posina e Val d' Astico, era ancora a ll o st ato di progetto; quelle di Bocchetta di Naole, in Val cl' Adige, di Campomolon, tra Val Posina e Val cl' Astico, e di Monte Ritte in Cadore erano in corso di costruzione, quelle di Cornolò in Val cl' Astico e di Colclarco tra Val Brenta e Val Cismon non erano ancora armate; erano ancora in corso cli armam ento le ope re cli Montecchio nord in valle Mera-Adda, dei Canali in Val Poschiavina, cli Cima dell'Ora in Val Giudicarie, di Monte Enna in Val Leogra, di Monte Verena in Val cl' Assa, di Monte Li sser in Val Brenta e di Monte Tudaio in Cadore. Di più, anche nelle opere già ultimate, s i lamentavano numerose, seppur non gravi, deficienze, soprattutto in fatto di armamento secondario, munizi o namento , materiali per la difesa vicina, quali mitragliatrici, reticolati ecc ., batterie occasionali, batterie di riserva mobile, mezzi di comunicazione, di osservazione del tiro e proiettori. In un primo tempo venne perciò disposto che, nell'attesa che le ope re fosse ro completate, le deficienze ne l loro armamen to venissero compensate con la sistemazione provvisoria, in vicinanza delle opere stesse, di un adeguato numero cli batterie cli cannoni di medio calibro e di cannoni campali.
Speciali provvedimenti vennero adottati per fronteggiare la mancanza delle opere di Campomolon e del Toraro, per cui il sis tema difensivo italiano risentiva di una particolare debolez-
Dal 1904 al 1914 185

186
126a. Austria: Il forte di Gomagoi dopo il taglio in corrispondenza dell'asse s tradal e.
La difesa Alpino
126b. Austria: Vista da una feritoia del forte di Gomagoi.
126a
126b
za in corrispondenza de l le va l li de l Posina e del!' Astico. Al gruppo austriaco di cinque opere perma nenti di Dos del Sommo. Sommo Alto, Ma l ga Cherl e. Belvedere, Campo cli Luserna, che risultava comp l etato con opere occasionali a Monte Maggio e a Malga Milegna, l'Italia non aveva eia contrapporre per le azioni in Val Posina che le opere di Punta Corbin, di Cima Carnpolongo e di Cornolò, integrate dal l e tre ballerie del Novegno (Monte Rione. Vaccarezze e Pozze l unghe), da quelle del!' Aralla e di Roccolo Bagattini e, per le azioni in Va l d' Astico, le opere di Casa Ratti, di Punta Corbin e di Cima Campolongo. Perciò venne disposto che l e due linee Yerena-Campolongo e Campomolon-Toraro venissero rinforzate con sei batterie di obici da 280 mm., con trinceramenti, opere campali e difese accessorie negli intervalli delle batterie; la consistenza di queste due linee doveva risultare tale da garantire il possesso della regione anche con solè truppe mobili, nella sfavorevole ipotesi che le opere di Monte Verena e Cima Campolongo fossero state srnanlcl l ate dalle potent i artiglierie avversarie, e da assicurare prolezione a l le sei ballerie di obici.
A l 6 dicembre 19 14 tlltte le opere permanenti in coslruzione sulla frontiera nord orientale! erano completamente armate ed in grado di aprire il fuoco, tranne le tre di Monte Toraro, Monte Campomolon e Monte Ritte, di cui venne senz'altro sospesa l a costruzione, dato il poco avanzato stato dei lavori che faceva ritenere il loro completamento possib i le so l o nel 1916; la costruzione del forte Monte Ritte venne ripresa più tardi; il 29 maggio de l · 15 era già ultimata l'installazione dei pezzi de ll a batteria pennanente ed a l 2 I giugno erano già ultimate anche le cupole e nel contempo si era fatto fronte anche al le altre deficienze riscontrate nel l e sistemazioni difensive, spostando dall'una al l 'altra rrontiera un certo numero di cannoni da 140/G, 87/8 e eia 75/A.
Scoppiata la guerra europea, vennero spostati da l la frontiera occidentale su quella orientale 72 cannoni da 149/G con 112 affusti, 28 cannoni da 87 /B e 38 da 75/ A; queste bocche da fuoco, assieme ad un ceno numero di colpi, vennero tratte principalmente dai fort i di Ge nova, che dal 6 agosto 1914 era stata radiata dal novero delle fortificazioni dello stato, dalla fronte a terra del l a piazza di Spezia e dai forti cli Roma. Tra l'agosto ed i l dicembre 1914 queste aniglierie vennero sistemate in batteria. Analoghi provvedimenti vennero adottati per fronteggiare le deficienze di mitrag l iatrici: 120 furono le Gardner mocl. 86 e 42 Maxim pesanti mod. 906 che vennero prelevate dal l e opere della frontiera occidentale.
Con l'adozione di queste misure la sistemazione difensiva della frontiera oriemale risulta basata sull'azione di 6 cannoni da 305, 36 obici da 280, 14 cannoni da 152, 86 da 149/A, 39 da 149/G, 11 eia 120
I A e G, 12 da 75 I A, tutti sistemati in torri corazzate, e di 180 cannoni da I 49/G, 164 eia 87 /B e 196 eia 75/ A, sistemat i in batterie occasional i. Dal gennaio al marzo I 915. poi. vennero adottati ulteriori provvedimenti. tesi ad aumentare l 'efficienza della complessiva sistemazione della frontiera: parecchie batterie occasionali da 149/G, da 87/B e da 75/A vennero dotate di scudi, sost i tuite alcune cariche a polvere nera per cannoni da 149/G con l a ba l istite e ve nne costituito un nucleo di 4 1 cannoni cli riserva per l e opere corazzate.
Considerazioni del capo di Stato Maggiore Generale Caclorna
A giudizio de l Generale Cadorna il va l ore reale della sistemazione difensiva della frontiera oriental e i taliana, esaminato sotto l'aspetto de l la sua possibile res i stenza ai poderosi mezzi di attacco austriaci e della sua capaci l à di dare appoggio all a manovra de ll 'esercito operante, era il seguente:
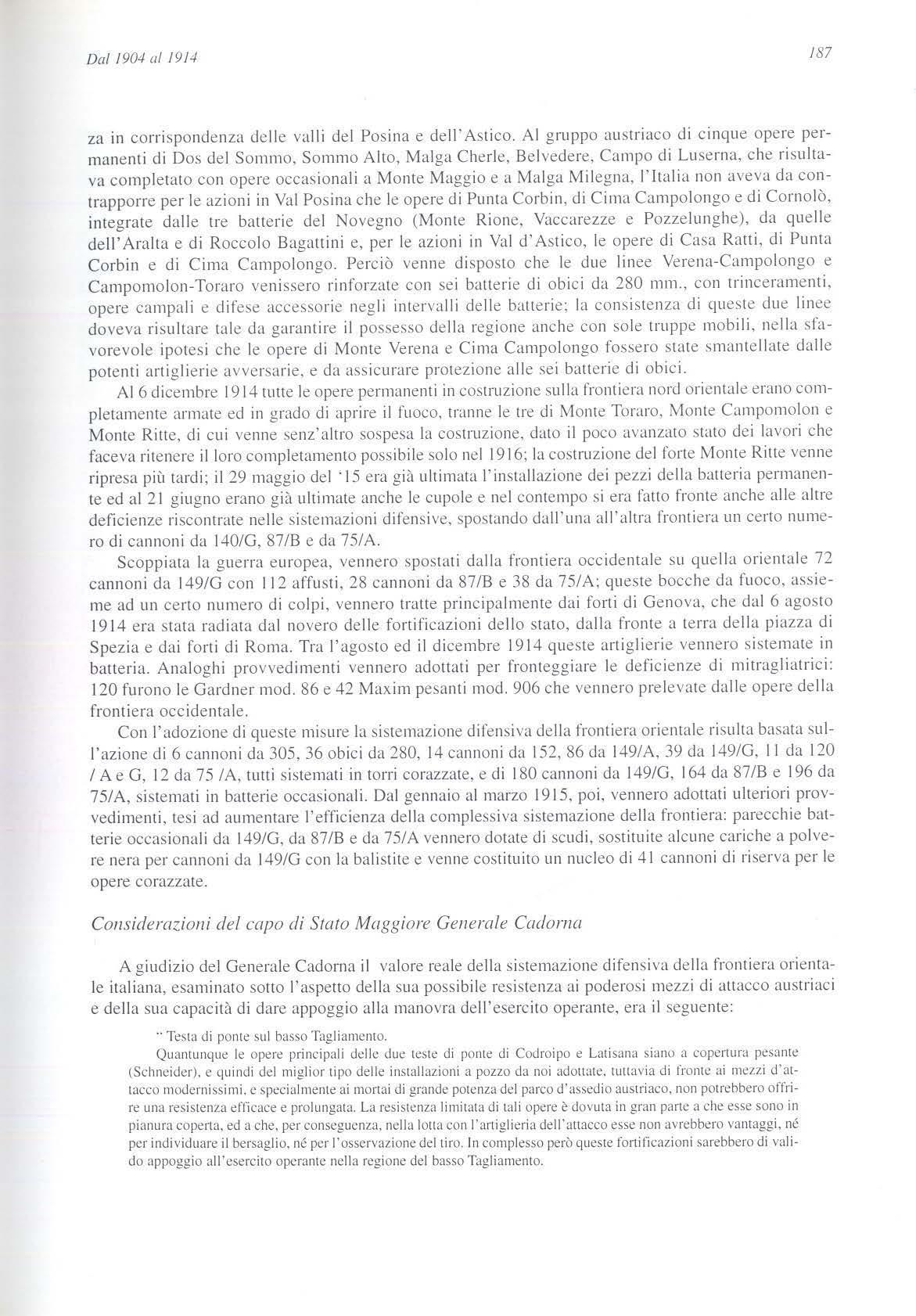
·· Testa d i ponte su l basso Tagliamento.
Quamunque le opere principali delle due tcsw di ponte di Codroipo e Latisana siano a copertura pesante (Schncidcr). e quindi del miglior tipo delle installazioni a pozzo da noi adollah.: tuttavia di fronte ai mt'.I.Zi J ' attacl'O 1110<..lernissimi. e specia l mente ai mortai di grande potenza del parco d' asset.lio austriaco, non po trebbero offrire una resistenza eflìcace e prolungata. La resistcnza limitata di tali Opt'. re è dovuta in gran parte a che esse sono in pianura coperta. ed a che, per conseguenza, nella lotta con l'art igl ieria dell'attacco esse non avrebbero vantaggi, n6 per individuare il bersaglio. n6 per l'osserva1.iom: del tiro. In complesso però queste fortificazioni sarebbero di valido appoggio all'esercito operante nella regione del basso Tagliamento.
Dal 1904 al 1914 187
Sbarrame1110 tlel mi.:dio Tag liami.:1110.
Eccc,ioni.: falla ()l.!r l\lpèra d1 \tome Lon,a (Bernadi,1 ).che.: silllal,1 in posimrnc dè\,1\,1 e che.: bcn coadiuvata <falla ba11cria oc,a~ionale di M. Poci11,llo. k opere tlell'anfi1ea1ro morenico s i trovano pressappm:o ndk stesse contlizioni tli quelle tli.:lle teste tli ponte tli Cotlroipo e Latisana. fasi.: hanno, in confronto tli queste ultimi.:. un leggero domi mo sul 1errcno che le drconda e maggior campo d1 nsia. ma per con1ru. si profilano dislintameme su di es~o e sono quindi poi visibili pt:r l'a11accan1c. In complesso, anche la linea fortificata cie l medi o Tagliamen10 non ha una gr:rnde resis1e11La i111 rinseca. ma riuscirebbe sempr..: di onimo appoggio a lruppè operanti nelle regioni limitrofe.
Rela1iva111eme all'op1:ra di M. Lonza la Conunission..: però osserva che po1rehhi.: anche essa essen: a 11 acca1a da potenti artiglii.:ric a tiro c urvo a r itl osso d i M. Cavallo. :V1. Zuffine e c he quinùi importa alla tl ifesa <li occuparc subito. con 1rup()I.! mobili anche queste posiLioni per raffor1are la resiste11La tiella regiont: della Bemad1a.
Sbarramenltl alto Tagliamemo-Fclla.
Le ope re tli M. Fes1a e .\11. Ercole cog li appos 1a111e 111i di M. Co meilli è di Sella S. Agnese. spi.:cialmente quella di ~I. Festa. per la rile\·ame quota a cui sono situate. si può ritenere che offrano grantle resisten!.1 intrinsl!ca anche ai me11i di allacco mod1:rnissimi. e che nell'assieme costit11bca1ll) un ollimo sbarramento. 1enuto c.:onto delle difficoltà per l'a ltat:cantc tli 1rovar buone posiz ioni per bm1crl1:. L'opt:rn avanzala tli Chiusal'urll.: ha poco rnlore in se stessa ma. col concor,o tli una balleria occasionale a Slincis. pul> essere di valitlo appoggio alla ùifesa alli\a.
Sbarramt:nto Caùore-i\ la6
La fronte nortl cos1i1uita tlalle opere Tudaio. col Vitlal e col l'kcolo. prt:,1:nta un nolC\'Ole grado di resistenL.1. :\linor rcsisten,a anebbe la fronte NO lìnch6 non sia armata e completata l'op.!ra ù1 i\l. Ritte. I.a frollle suù. per q ua nt o rns ti1uita solo tla bauerie <li medio calibro. a M. Zuct:0 polrebbe eslrinsecare res is te nLa prolungata per la forza naturale dell:1 posizione e specia l111 en 1e pèr le granùi ùifficohà L'he inconirerebbc l'a\'\'ersario a tmvarc posiLioni d'auacco.
Glr accessi dal territorio nt:mko nellt: Yalli tlel Cordc\·ole è d..: I l\1né sol1Ll tla con,,derarsi pr1:ssoch..: indifesi.
Fonezzri Agno-Assa.
Le opere erette a chiusura degli st>occhi tra \'al ti' As,a e \'al ti' Agno ,unu assolutamente insufficienti per precludere all'anersario lo sbocco in pianura tlalla zona L'Ompres.i tra l'altopiano tli Lavarnne cd 11 Colle d i Campogrosso. direi.ione qu1:sta che pa no i ì: trn lè più p1:ricolos1:. t:aùendo a 1e rgo di lllllc k lince di difesa co111prest: tra il Tagliamemo etl Il Pia\'e.
Verona -S euor..: Val d' Aùige.
La balleria lfocchclla di Naole, che sarà prossi111aml.'111e collauduta. co lle opè re d i Masua tli Molane e C im o Granùe. e le tagliate <li fontlo \ alle rnstituiscono un ottimo sbarramento tlell.1 \'al Lagarina.
Verona-Sellore <li Verona.
La l'rume nord tli Veron:i. ira J\1asua <li Molane e Castelletto. s i pn:sw ad u na dif1:sa molt tl efl'ica<.:e <.:o nt ro le provenien,e dalla cresta dei Lcssini. La frontè orientale ,1ppoggiata a i\l. Ca,telletto. rnstituita tl:1 O()l.!re antiquate. non ha ,1,solutamentc sufli1:1ente res1stenzri per garantm! la citù t'd , ponti <la un anacco <la Oriente.
Le fort ili ca,ion i di rha tlcstra dell'Adig..:. o ltre a no n avert: akun valore dii'ensi\'O, cosl illli s<.:o no in,i e m..: alle allrc fort ifi cazion i della piaaa un a specie <li <.:ampo 1rineerato. t·he potrebbe esercitare dannosa auraLionc sulle nm,tre trup()I.! operanti in qu1:lla regione. e perciò si ritiene che tali fortilica,ioni d1 ma destra dm rcbhero e!:>scre raùiate. togliendo così a Verona il cara tt ere <li piazza chiu!:>a.
Fortcna di Mantova.
Sia le fortilica1ioni alluali tli rh a sinistra del t\1incio. \1a il forte Pietok. non rispontlono alle esigcrue <li qualsiasi ùifèsa. e comè tali tlehbono esM:r.: radiale.
Sbarramento di Val Giudicarie.
Lo sbarramento. forte sul centro e sul lianco sinistro ha imece il lianrn tlescro tlebole. p..:rch..: costilllito da ~ernplic, appostamenti per artiglierie tli medio <.:alibro e campali a :\I. Manos. In complesso. lo sba rrnnh:nto potrà esser.: mo lto eflicnce se coaùiuvato da un:i vigorosu dif1:sa a1ti\'a a ll o rn o a M. Man o~.
Sbarramento 'lìrnale-t\ lortirolo.
Per e!:>sere troppo\ icino al conlinc. e quindi espmltl aù offe,e nemiche preparale lin tlal tempo <li pace. e per le s ue contliz ioni topogra fk hè può perdere ogn i el'i'icada.
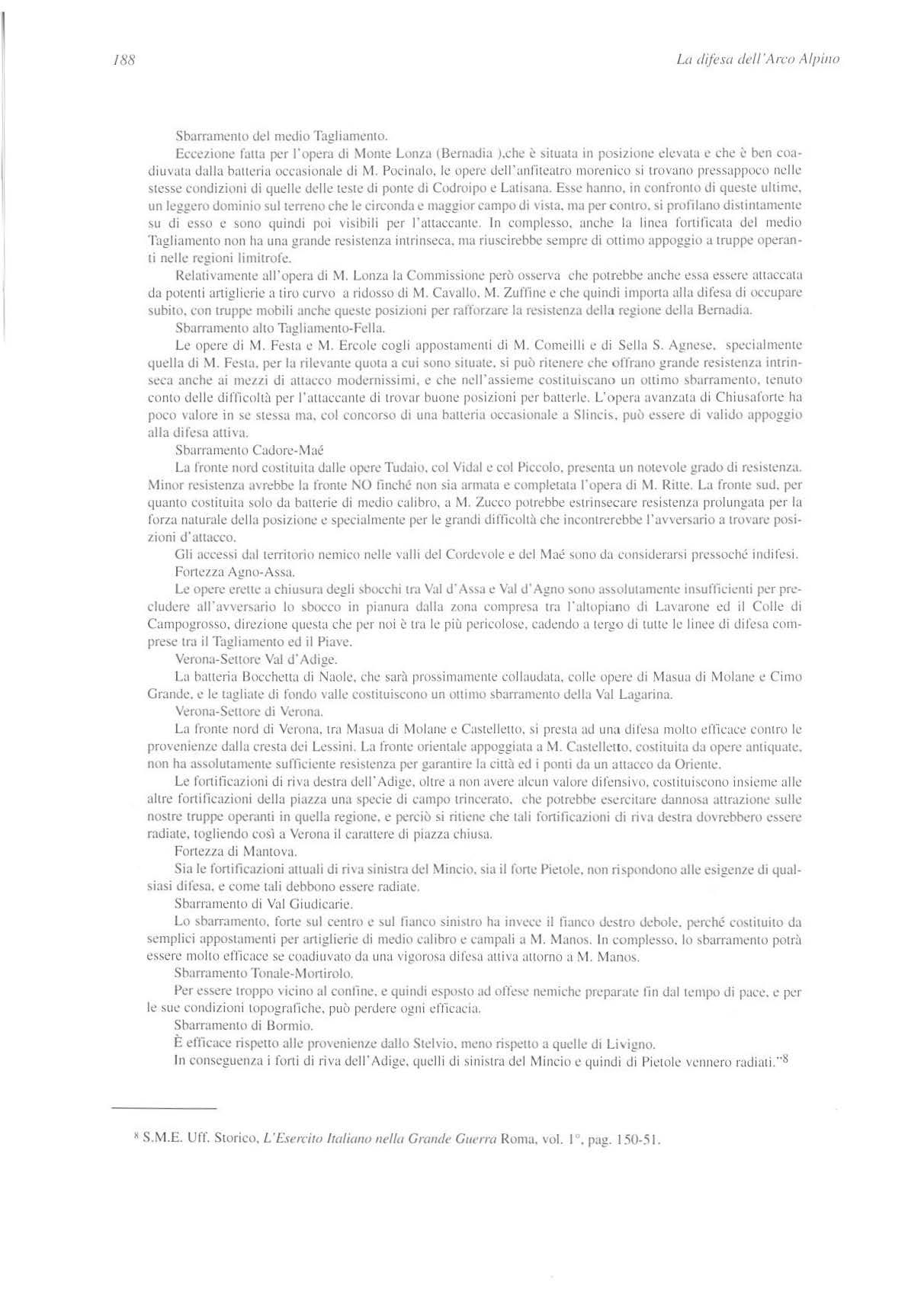
Sbarramenlo tli Bormio.
È dlicace mpetto alle prm enicrue dallo Stelvio. meno rbpello a quelle di LÌ\ igno.
In conseguenLa i forti tli riva dcl i' Adige, quelli di sinbtra de l Mincio e quindi di Pietole vennero rntlia1i."8
/88 la difesa dell'Arco Alpino
x S.M.E. UIT. Storico. L ·Est!rcito /t(l/ia110 111!1/a Grwule G111•rra Roma. YOI. I ·. pag. 1.50-51.
Il Generale Cadorna, estendendo la propria analisi alle opere realizzate dagli austriaci, affermava che queste avevano una ben diversa potenza, capacità di resistenza e manovra rispetto a quella di cui erano in possesso le strutture fottificate italiane; egli inoltre rilevava che forti di sbarramento moderni sorgevano lungo i principali accessi al saliente trentino dallo Stelvio a Tarvisio facendo sistema con il campo trincerato di Trento e che un complesso cli moderne fortificazioni, realizzato eia cima Vezzena a Sommo Alto, lungo il margine esterno degli altopiani di Folgaria, Lavarone e la dorsale di Luserna, mentre sbarrava efficacemente le penetrazioni nella regione montana , aveva, al tempo stesso, carattere offensivo verso la pianura padana.
Il prosieguo della disamina si estende alla restante parte del confine mettendone in luce gli aspetti fortificatori: sulla fronte giulia, sapientemente integrando opere permanenti con strutture semipennanenti e campali, era stata realizzata, da parte austriaca, una sistemazione difensiva formidabile e completa, aumentando con ogni mezzo, in particolare realizzando la costruzione di un dedalo di trincee, camminamenti e reticolati, la forza naturale della regione da Tolmino al Carso; erano stati completamente realizzati i campi trincerati di Tolmino e di Gorizia, di grande valore strategico in quanto il primo sbarrava le direttrici di Klagenfurt e di Lubiana, appoggiato al monte Nero, al Merli, al Vocii!, al Lom ed al Kal, collegati da sistemi di trincee realizzate su più linee e con funzioni di teste di ponte di manovra per lo sbocco da Tolmino della massa offensiva da lanciare lungo le valli dello Judrio e del Natisone per aggirare il fianco sinistro dello schieramento italiano ed il secondo, collegato al primo per l'altopiano della Bainsizza, aveva funzioni di appoggio della manovra a cavaliere delle direttici di Lubiana e di Trieste e di ampia testa di ponte offensiva sulla media e bassa pianura friulana; il collegamento tra Tolmino e Gorizia era costituito da più linee fortificate delle quali quella più forte passava per Plava, M.
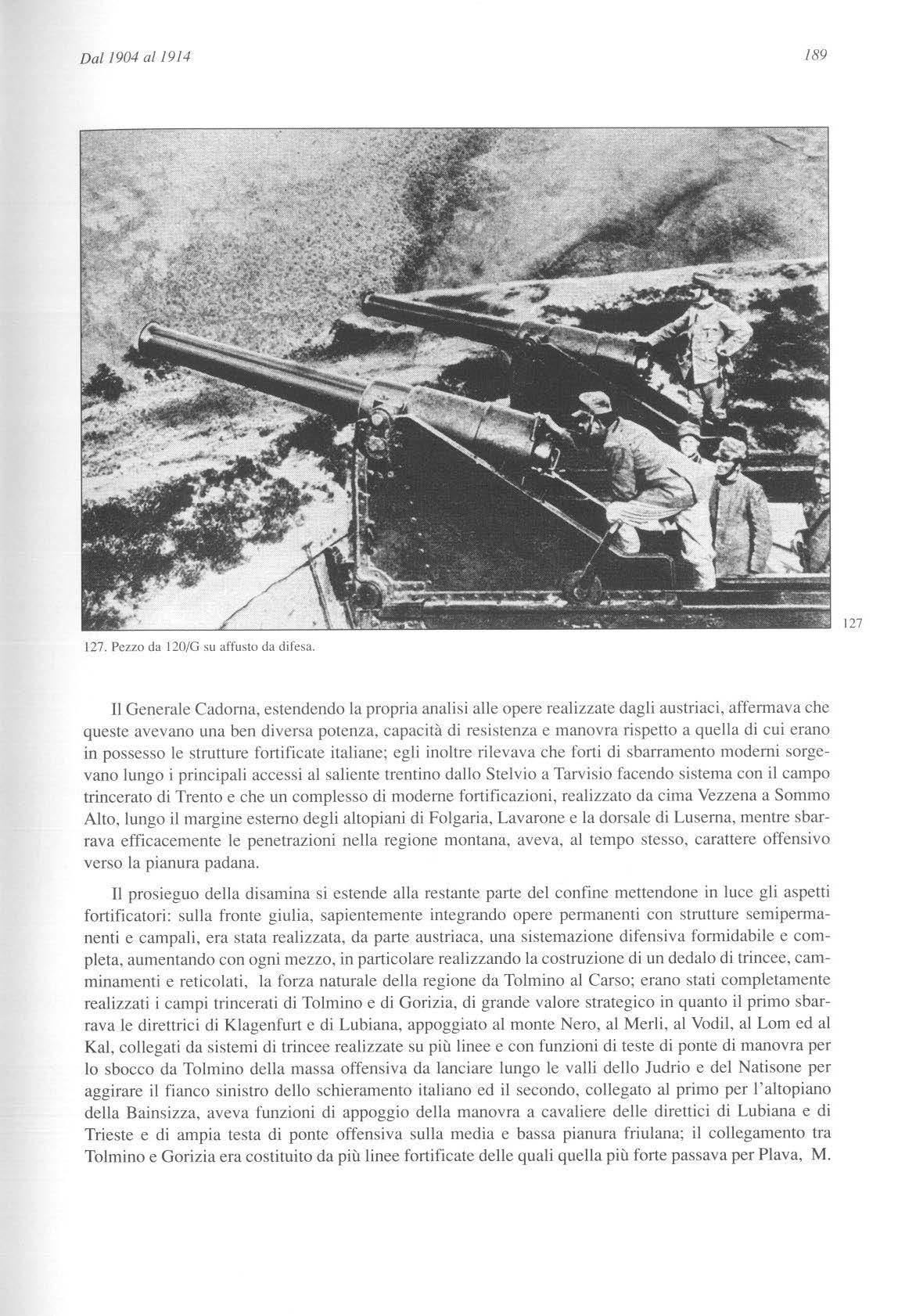
Dal /904 al 1914 189
l 27. Pezzo da I 20/G su affusto <la difesa.
127
Cuc, il Sabotino ed il Podgora.
il
San Daniele ed il Vodice ed aveva come suoi pilastri il M. Santo, S. Gabriele e S. Marco; a sud di Gorizia, la regione carsica, inoltre, particolarmente idon ea alla difesa e resa ancora più ine spugnabi le dalle opere scmipem1anenti e campali cli recent e realizzazione, costituiva la robusta c;palla sinistra dello schieramento austriaco.
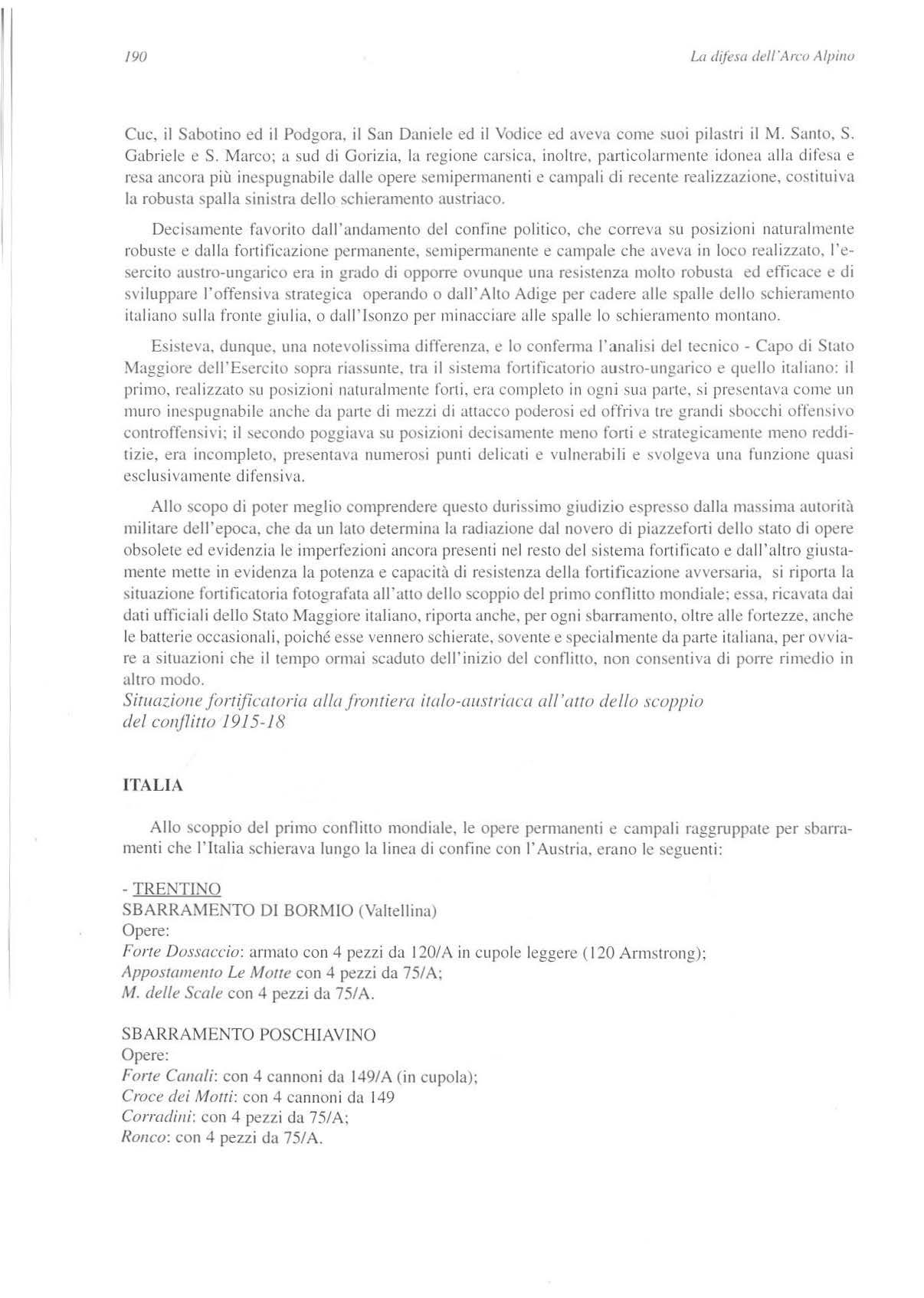
Decisamente favorito dall'andamento elci confine politico, c he correva su posizioni naturalmente robuste e dalla fortificazione permanente, sern iperman en te e campale che aveva in loco realizzato, l' esercito am,tro-ungarico era in grado di opporre ovunque una resistenza molto robusta ed efficace e di S\'iluppare l'offensiva strategica operando o dal l'Alto Adige per cadere alle spalle dello schieramento italiano su lla fronte giu lia. o dall'Isonzo per minacciare alle spalle lo schieramento montano.
Esisteva. dunque. una notevolissima differenza. e lo conferma l'analisi del tecnico - Capo di Stato Maggiore dell'Esercito sopra riassume. tra il sistema fonificatorio austro-ungarico e quello italiano: il primo, real izzato su posizioni naturalment e forti, era completo in ogni sua parte, si prescnrnva come un muro inespugnabile anche eia parte di mezzi cli attacco poderosi ed offriva tre g randi !->bocchi offen~ivo controffensivi; il secondo poggiava su po!>izioni decisamente meno forti e !>trategicamente meno redditizie, era incompleto, presentava numerosi punti delicati e vulnerabili e S\'Olgeva una funzione quasi escl u sivamente difen s iva.
Allo scopo di poter meglio comprendere questo durissimo giuuizio espresso dalla massima autorità militare dell'epoca, che da un lato determina la radiazi one dal novero di piazzefo11i dello stato di ope re obsolete ed evidenzia le imperfezion i ancora presenti nel resto del s istema fortificato e dall'altro giustamente mette in evidenza la potenza e capacità cli re sis tenza della fortificazione avversaria, si riporta la situazione fortificatoria fotografata all'atto dello scoppio del primo conflitto mondiale; essa, rica\ ata dai dati uffi cia li dello Stmo Maggiore italiano, riporta anche, per ogni !->barrarnento, oltre alle fortezze, anche le batterie occasionai i, poiché esse vennero sc hierate. sove nte e spec ialment e da parte italiana, per ovviare a situazioni che il tempo ormai scaduto dell'inizio del conflitto. non consentiva di porre rimedio in altro modo.
Situazione jòrrifirntoria alla ji-ontiera iwlo-ausrriaca al/'auo dello scoppio del co11J7i110 1915-18
ITA LI A
Allo scoppio del primo conflitto mondiale, le opere permanenti e campali raggruppate per sbarramenti che l'Italia schierava lungo la linea di confine con l'Austria, erano le seg uenti:
-TRENTINO
SBARRAMENTO DI BORMIO (Valte llina )
Opere:
Forte Dossaccio: armato con 4 pezzi da I 20/ A in cupole leggere ( 120 Armstrong);
Apposta111e11to Le Molte con 4 pezzi da 75/A;
M. delle Scale con 4 pezzi da 75/A.
SBARRAMENTO POSCHIAVJNO
Opere:
Fone Canali: con 4 cannoni da 149/A (in cupola);
Croce dei Motti: con 4 cannoni da 149
Corradini: con 4 pe zz i da 75/A;
Ron co: con 4 pezzi da 75/ A.
190 La difern del/ 'Arco At1,i110
SBARRAMENTO TONALE-MORTIROLO
Opere:
Dosso Prepazwne: con 4 mortai da 21 O;
Forte Como d'Aola: con 6 pezzi da 149/A in pezzi tipo Annstrong;
Cima Bleis occidentale: con 4 cannoni da 149/G e una ri serva di 4 pezzi da 75/A, dislocati fra Temù e Ponte di Legno.
SBARRAMENTO GIUDICARIE
Opere:
nel settore orientale
Monte Manos (q. /404): con 4 cannoni da 149/G;
Monte Manos (q. 1042): con 4 cannoni da 75/A;
Appostamento Valedrana (q. 1202): con 6 cannoni da 149/A;
Appostamento Antegolo: con 6 cannoni da 75/A; nel settore occidentale
Forte Rocca d'Anfo (Barteria Tirolo): con 4 cannoni da 149/G;
Cima del/'Om: con 4 cannoni da 149/A;
Appostamento di Monle Brele: con 4 cannoni da 74 /A;
Tagliata Statuto: con 4 mitragliatrici.
SEITORE PESCHIERA
Opere:
Molini di Malcesine (sud di Navena): co n 4 pezzi da 87/B (ba tteria mobile);
Forte Isola Trimelone: con 3 pezzi da 120/A-L e 3 da 57. Sulla costa, in prossimiti'1 d i Ronchi (2 km. a NE di Peschiera) 4 pezzi da 87/B;
Punta Sirmione: con 4 pezzi eia 87/B (batteria mobile);
M. Corno (a nord cli Desen::,ano): con 4 pezzi da 75; nel porto di Peschiem
Batteria Molo: con 3 pezzi da 57 a tiro rapido;
Batteria Bas1ione: con 3 pezzi da 57 a tiro rapido;
Fornaci (Peschiera): con 2 pezzi da 75/A; inoltre sui 17 piroscafi della flottiglia del Garda vi erano 8 cannoni da 57, 12 da 37 e 22 mitragliatrici.
SETTORE DESTRA E FONDO ADIGE (0 SETTORE VAL D'ADIGE)
costituito dalle opere del gruppo Bocchetta e del gruppo Chiusa-Rivoli.
Nel gruppo Bocchetta le opere:
Forte Bocchetta di Naole: con 4 cannoni eia 149/A e 4 eia 87/B;
Coal San 10: con 4 cannoni eia 87 /B;
Forte M. Cimo Grande: con 4 cannoni eia 149/A, 4 mr. da 149/A e 4 cannoni da 87/B;
Cavallo di Noveza: con 2 cannoni da 149/G e 4 da 87/8;
M. Cerbiolo: con 4 pezzi da 87/B;
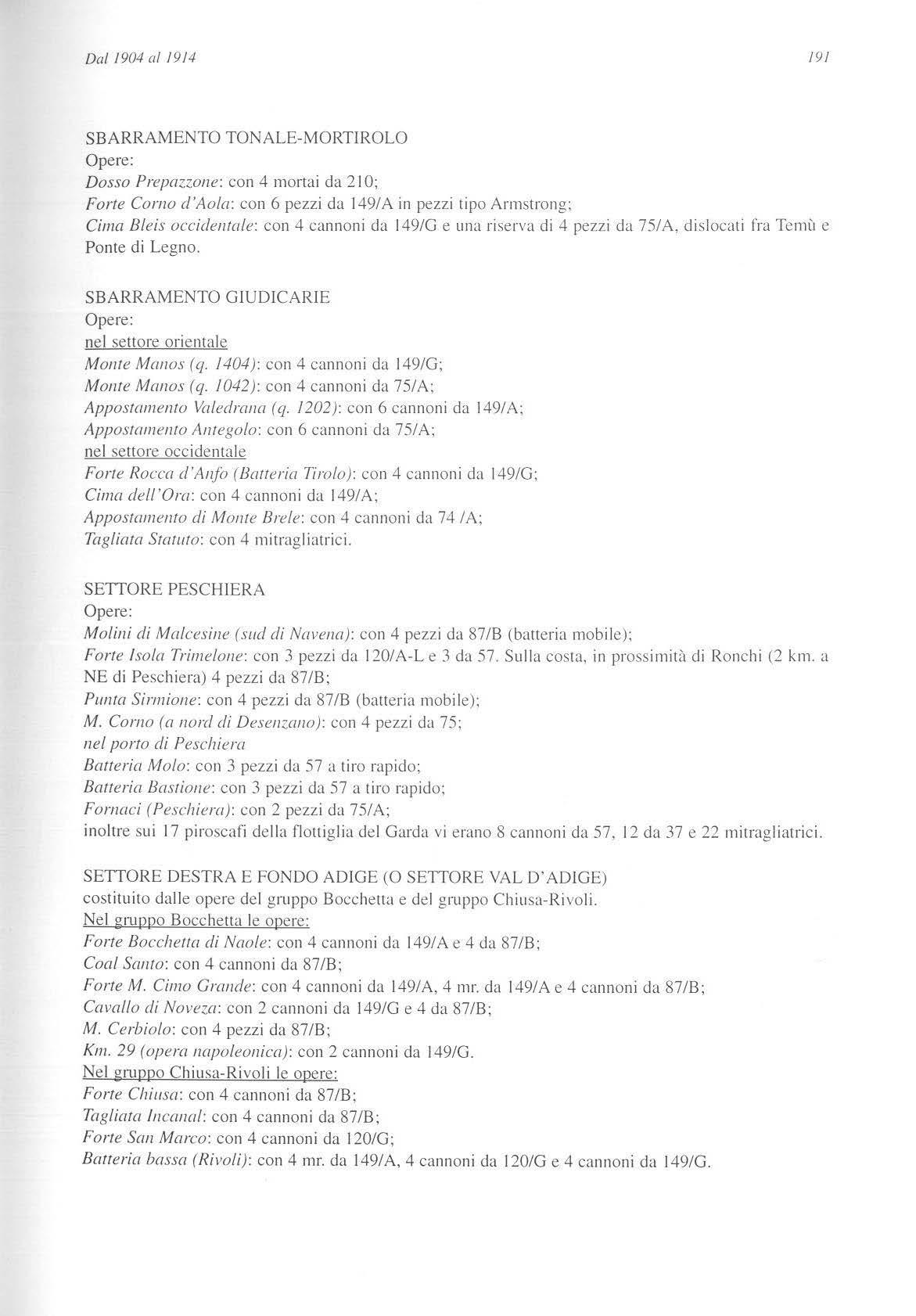
Km. 29 (opera napoleonica): con 2 cannoni da 149/G.
Nel gruppo Chiusa-Rivoli le opere:
Forte Chiusa: con 4 cannoni da 87/B;
Tagliata lncanal: con 4 cannoni da 87 /B;
Forte San Marco: con 4 cannoni da 120/G;
Batteria bassa (Rivoli): con 4 mr. eia 149/A, 4 cannoni da 120/G e 4 cannoni eia 149/G.
Dal /904 al /9/4
/91
SEITORE SINISTRA ADIGE
costituito dalle opere dei gruppi Masua, S. Viola, S. Briccio.
Nel gruppo Masua le opere:
Forte Masua di Molane: con 6 cannoni da 149/A in pozzi e 4 cannoni da 87/B;
Batteria Masua (q. 923): con 6 obici da 120 e 4 cannoni da 87;
Forte M. Tesoro: con 6 cannoni da 140/A, 4 mr. da 140/G e 4 cannoni da 87.
Nel gruppo S. Viola le opere.
Forte S. Viola: con 4 cannoni da 149/A in pozzi e 4 cannoni da 87/B;
Batteria M. delle Tre Croci: con 4 cannoni da 149/G;
Batteria M. Griggi: con 4 obici da 120.
Nel gruppo S. Briccio le opere:
Forte S. Briccio: con 4 cannoni.da 149/G, 4 obici da 149, 4 mr. da 149 e 4 cannoni da 87;
Batteria Monticelli: con 4 cannoni da 120/G.
SBARRAMENTO AGNO-ASSA
diviso in tre settori: Schio, Arsiero e Asiago.
I settore (Schio) le opere:
Forte M. Maso con 3 cannoni da 149/G;
Tagliata Bario/a: con 4 cannoni da 42;
Batteria M. Civilimza: con 4 pezzi da 149/G;
Forte M. Enna: con 4 cannoni da 149/A e 4 pezzi da 75/A;
Batteria Pozze Lunghe: con 4 cannoni da 149/G;
Batteria occasionale di M. Rione: con 4 cannoni da 149/A;
Batteria Malga Vaccarezze: con 4 cannoni da 149/G;
Batteria Roccolo dei Sogli: con 4 cannoni da 149/G;
Batteria M. Aralta: con 4 cannoni da 75/A;
Batteria Col/etio Grande: con 4 cannoni da 120/B.
II settore {Arsiero) le opere:
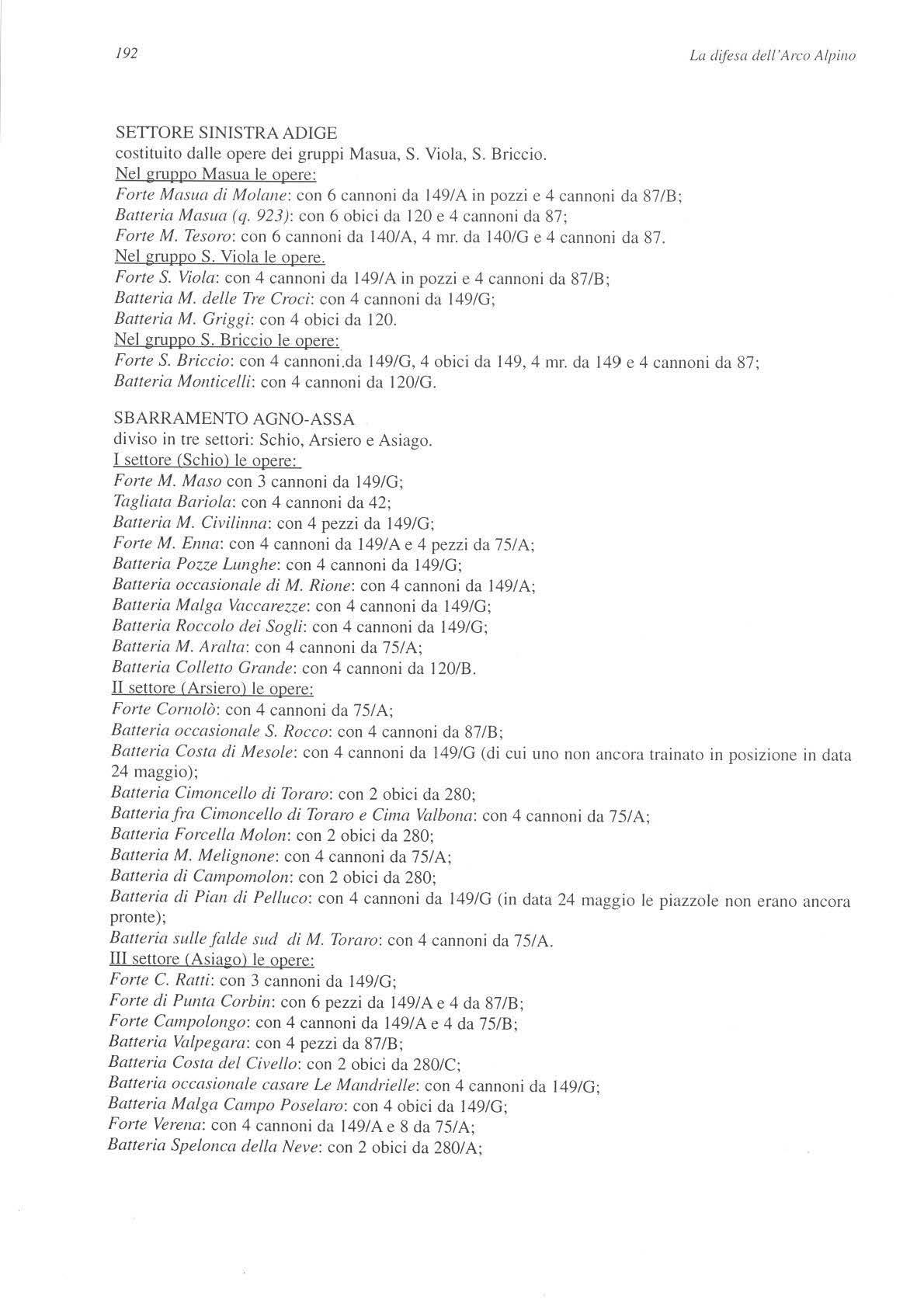
Forte Cornolò: con 4 cannoni da 75/A;
Batteria occasionale S. Rocco: con 4 cannoni da 87/B;
Batteria Costa di Mesole: con 4 cannoni da 149/G (di cui uno non ancora trainato in posizione in data 24 maggio);
Batteria Cimoncello di Toraro: con 2 obici da 280;
Batteria fra Cimoncello di Toraro e Cima Va/bona: con 4 cannoni da 75/A;
Batteria Forcella Mo/on: con 2 obici da 280;
Batteria M. Melignone: con 4 cannoni da 75/A;
Batteria di Campomolon: con 2 obici da 280;
Batteria di Pian di Pelluco: con 4 cannoni da 149/G (in data 24 maggio le piazzole non erano ancora pronte);
Batteria sulle falde sud di M. Toraro: con 4 cannoni da 75/A.
III settore {Asiago) le opere:
Forte C. Ratti: con 3 cannoni da 149/G;
Forte di Punta Corbin: con 6 pezzi da 149/A e 4 da 87/B;
Forte Campolongo: con 4 cannoni da 149/A e 4 da 75/B;
Batteria Va!pegara: con 4 pezzi da 87/B;
Batteria Costa del Civello: con 2 obici da 280/C;
Batteria occasionale casare Le Mandrie/le: con 4 cannoni da 149/G;
Batteria Malga Campo Pose/aro: con 4 obici da 149/G;
Forte Verena: con 4 cannoni da 149/A e 8 da 75/A;
Batteria Spelonca della Neve: con 2 obici da 280/A;
192
La difesa d ell'Arco Alpino
Batteria Bosco Arzari: con 2 obici da 280/C;
Batteria Baitle: con 2 pezzi da 87/B;
Batteria di Porta Mo,wzzo: con 4 mr. da 21 Oe 4 cannoni da 149/G;
Batteria Casare di Campo Manderiolo: con 2 pezzi da 87/B;
Tagliata V. d 'Assa: con 2 cannoni da 120/G;
Batteria M. Meatta: con 4 pezzi da 87/B;
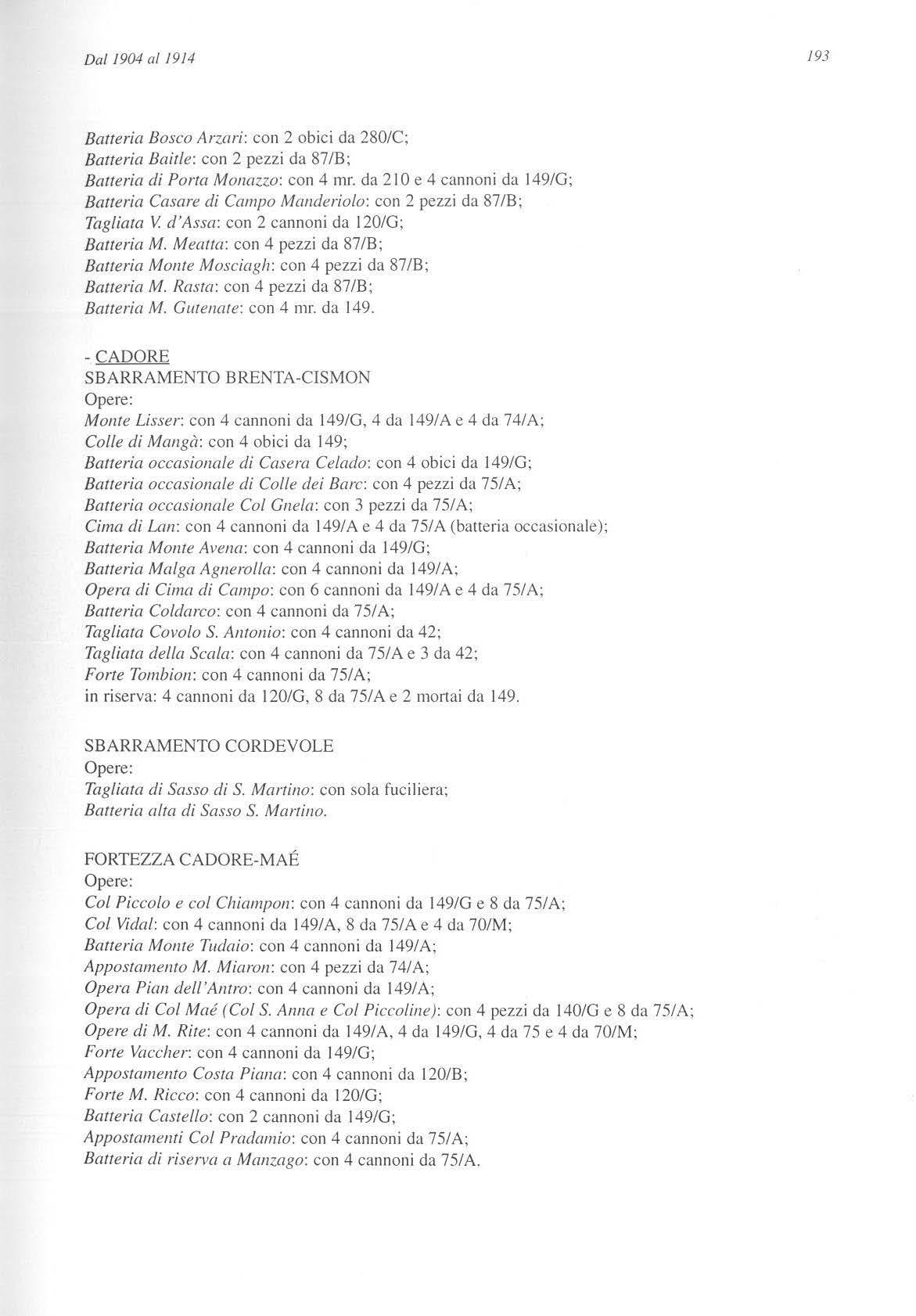
Batteria Monte Mosciagh: con 4 pezzi da 87/B;
Batteria M. Rasta: con 4 pezzi da 87/B;
Batteria M. Gutenate: con 4 mr. da 149.
-CADORE
SBARRAMENTO BRENTA-CISMON
Opere:
Monte Lisser: con 4 cannoni da 149/G, 4 da 149/A e 4 da 74/A;
Colle di Mangà: con 4 obici da 149;
Batteria occasionale di Casera Celado: con 4 obici da 149/G;
Batteria occasionale di Colle dei Bare : con 4 pezzi da 75/A;
Batteria occasionale Col Gnela: con 3 pezzi da 75/A;
Cima di Lan: con 4 cannoni da 149/A e 4 da 75/A (batteria occasionale);
Batteria Monte Avena: con 4 cannoni da 149/G;
Batteria Malga Agnerolla: con 4 cannoni da 149/A;
Opera di Cima di Campo: con 6 cannoni da 149/A e 4 da 75/A;
Batteria Co/darco: con 4 cannoni da 75/A;
Tagliata Covo/o S. Antonio: con 4 cannoni da 42;
Tagliata della Scala: con 4 cannoni da 75/ A e 3 eia 42;
Forte Tombion: con 4 cannoni da 75/A; in riserva: 4 cannoni da 120/G, 8 eia 75/Ae 2 mortai da 149.
SBARRAMENTO CORDEVOLE
Opere:
Tagliata di Sasso di S. Martin o: con so la fuciliera; Batteria alta di Sasso S. Martino.
FORTEZZA CADORE-MAÉ
Opere:
Col Piccolo e col Chiampon: con 4 cannoni da 149/G e 8 da 75/A; Col Vidal: con 4 cannoni da 149/A, 8 eia 75/A e 4 da 70/M;
Batteria Monte Tudaio: con 4 cannoni da 149/A;
Appostamento M. Miaron: con 4 pezzi da 74/A;
Opera Pian dell'Antro: con 4 cannoni da J49/ A;
Opera di Col Maé (Co l S. Anna e Col Piccoline): con 4 pezzi da 140/G e 8 da 75/A;
Opere di M. Rite: con 4 cannoni da 149/A, 4 da 149/G, 4 eia 75 e 4 da 70/M;
Forte Vaccher: con 4 cannoni da 149/G;
Appostamento Costa Piana: con 4 cannoni eia 120/B;
Forte M. Ricco: con 4 cannoni da 120/G;
Batteria Castello: con 2 cannoni da 149/G ;
Appostamenti Col Pradamio: con 4 cannoni da 75/A;
Batteria di riserva a Manzago: con 4 cannoni da 75/A.
Dal 1904 al 1914
193

194 La difesa dell'Arco Alpino~ i ·i :Iii~ Cl> .r:::~~ e .;:: + o • e + o + o • (.) .. o • + + o • . 2 ..c: (.) (.) CD > G) -e "' CD e j!! ::, 1/J CD ..e: (.) ..."' - 1/J :::, al "'O CD CD e "' . "t! .;: e CD e "'E ... CD Q. CD 1/J .! o 12 8 128. Difese pennanenti italiane ed austriache lungo il vecchio confine. SME Ufficio Storico.
zou ddlo 8lclvlo•..•.•
z..a del TOIUII< •.••...• l
z dcli• Cl\1dlcorlc. • •
Zou citi Garda • • . . . •
Zoaa dd Vnoaeac:,
Dlltse permanenti 1111.llane Cii austriache IIUIIO Il VKchlo conllnt.
Forte Dolll~lo
Portt COC'DO d' Aola
t ._-s Porte (Ratluia) di Pr,:-panou,:
Fort< Ro«a d' Aolo
l'ort• (Ball<rla) ADl<l()IO •
Porte Cima dell'Ora
Pont Trimdoa.c
Porto.I& (dUNit pbt.u• di Vt-roaa)
Sbarramtoto Rivoli (Jo', Mu-..11 F. c,,.aitt0
F. 1liPOII - 1• M•••• F. S. M•rto- Il. IM•,.•I)
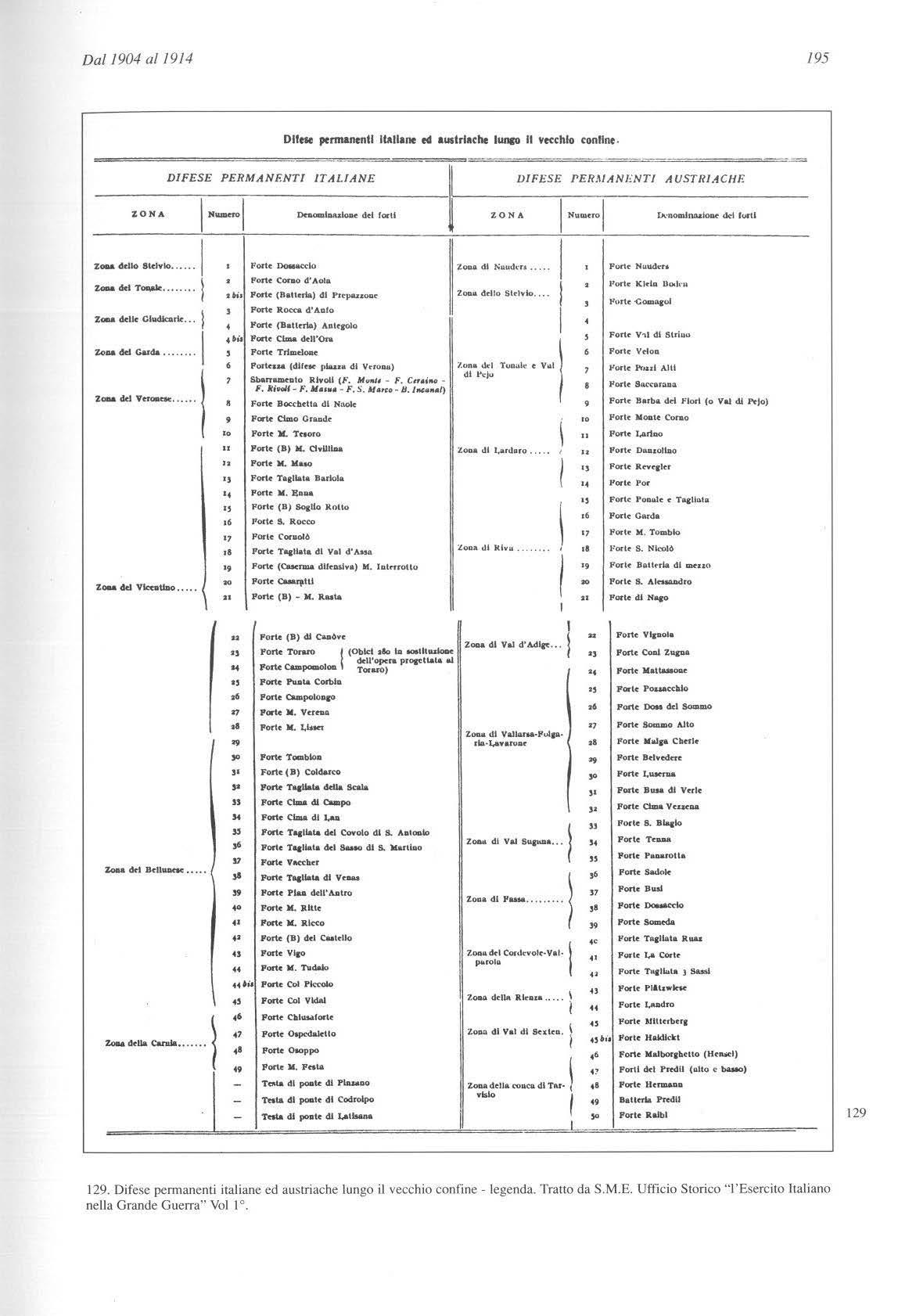
Fortt 8QC('hdtQ di NOOI(
Partt Cimo Gra.ad"
Portt ll. Trsoro
Porle (8) IL Chlllla&
Porte 1K. Mt.lO
Poru: Ta111a1a Barlola
Porte M, Eau
Porle (B) 5o1Uo Rollo
Portc S. Rocco
Porte Cora.ollt
Porte Tacllata di Val d' AuA
Porte (Cucrma dlfc.oslv•) M. lalnrotlo
Porte eua,.tU
Porte (B) - 1K. Ratta
Forte (B) di Caa6vc
Porte TOrvo I (Obici do la
dell'opera proe<llata ol
Porte ùm_.lOG T«uo)
Port< Pwala COfbla
Porte ùmpotoa,o
Porte K. Vun.o.
Fort• M. I,i,,a
Porte T-bloa
Forte ( B) Colduoo
Port< Tqllata ddla Sc:8la
Porte Cima di Campo
Port• Cima di l,aa
Porte Tacllata citi C<WolO di s. Aaloolo
Porte Tacitala del S...ao di s. 'M•rtloo
Forte: VA«hirr
toa a dl ?o:audn, , . , . Zoo.a ddlo Sttlvlo , ••.
Zona del Tu~h: e V.al di l'•lu
IA•nom!DA&loa< dei furti
Purte Nuudt'U
Porte: Kldn U01ku
Forte V'll d1 Striuu
Forte Vc-loa
Jlorlc Pi',ul Alll
Jlortt 8a«Of3D.l
Forte Barba dd Flo,I (o Vai di PtJo)
Porte Moatt Cor.o
zoo.a di l,a.rJaro •. • • < Zooa di Jtivot.
ZOGO di Val d'Adlc< • ··
Zoa• di va11a11a-Jlvlp· da-I.avaroat z dJ Val Su,p. )
Zolla
Port• Tacllata di v,
Porte Plu ddl' Aatro
Portt X. Jlltte
Porte lii'. lllc<o
Porte (B) del Cutello
Porte Vl,o
Porte M. Tlulolo
446i• Porte Col Pl«'Olo
Port• Col Vldal
Porte Cllha•tort.c'
Porte Otp,dakllo
Port< Ot0ppo
Porte Il. Fata
49
Tcola di pc,,,tc di Pta...Ao
Tetta di pc,,,t• di Codroipo
1'<11& di poat• di 1.atlMna
7.ona.dtl Cortlcvotc-Val-1 pi.rola
7-ooa dellK Rlir-ua
Zoa.Q di Va.I dl Sulc11.
Zoaa ddla COD<a di TA,. \ 1o I I
•• Il " ,, 14 ., 16 17 ,a 19 .. .. .. ., •• ,, •6 •1 ,a ., )O )I ,. " ,. S) s6 '7 ,a )9 •• 41 ,, n f4 4)
Forte: o,uuoJlAo
flortir ltn~lu
Porte Por
Forte PoaWc e Taallola
Porte Gt\rda
Porlt M. Tombto
l'a<lt s. l<lc:ol6
Porle Dottnla di meno
P0tlt 8. AIC'UO.Odro
Porle di Na,o
Porte Vlsoola
Porte Coal Z-
Porte lilattaNODe
Porle Pouacc;bJo
Forto Ooal dd Sorlrm<>
Porte Som.mo Alto
f'orte Ibla• Cbcrlt
Porte Btlvcdnt
Porte l.uttnaa
Forte Bma dJ Verlc
Fotte Cima Vuicaa
Porto !I. Blaalo
Porte Te&11a
Porte Paouoll•
Forte Sadolc
Port• BIUI
Portt ~lo
Forto S-<da
Porte TacUala Ru&&
Porle t.a Corte
Porte btlt..ta l s...i
P<Wte PJIUwlc~
Porte L,utdro
Forte lfllterbcra .,
Porto Haldlcl<t
46 Forte 'Malbor1bo110 (H,....,I)
Porti del Pttdll (•Ilo e -) ,e
Porte Hcrmua
49 Ball<rla Ptodll
)O Porlo llalbl
Dal 1904 al /914 195
---,----:---------
DIFESE l'ERMANENTI AUSTRIACHE
I"_,.,I
del fo,tl Z O Il A Il<um•ro I
DIFESE PERMANENTI ITALIANE I
D<G..,.IAIUlo11<
ZONA
l
I
.1
•. zoaa citi vi.:..u..o
,
• I
drl BdlllOaC •• , ,
•;,
9 IO Il .. is 14 I) 16 17 ia 19 ao .. .. ., .. ., a6 .,. •• ., )O ,. ,. " ,. " s6 )7 ,. )9 •o 41 •• o 44
-tlt-
\
l I i I I
l
.;.
·~
129
129. Difese permanenti italiane ed austriache lungo il vecchio confine - legenda. Tratto da S.M.E. Ufficio Storico "l'Esercito Italiano nella Grande Guerra" Voi 1°
- ZONA CARNIA
FORTEZZA ALTO TAGLIAMENTO-FELLA
Opere:
Osoppo: con 4 cannoni da 149/A e 4 da 75/A;
Appostamento S. Agnese: con 4 cannoni da 149/G;
Appostamento Monte Cumieli: con 4 cannoni da 149/G; San Simeone: con 4 cannoni da 149/A; Monte Festa: con 4 cannoni da 149/G;
Apposwmento Monte Sflincis: con 4 cannoni da 149/G;
Appostamento Col Cumic: con 4 cannoni da 75/A;
Appostamento Monte Ercole: con 4 cannoni da 149/A e 4 da 75/A;
Opera di Chiusaforte: con 4 cannoni da 120/G.
- FRONTE ORIENTALE FORTEZZA MEDIO TAGLIAMENTO
Opere:
Appostamemi del Ponte di Pinzano: armamento non noto;
Appostamento Ragogna bassa (q. 457): con 4 cannoni da 149/G;
Appostamento Ragogna alta (q. 543): con 4 cannoni da 149/G;
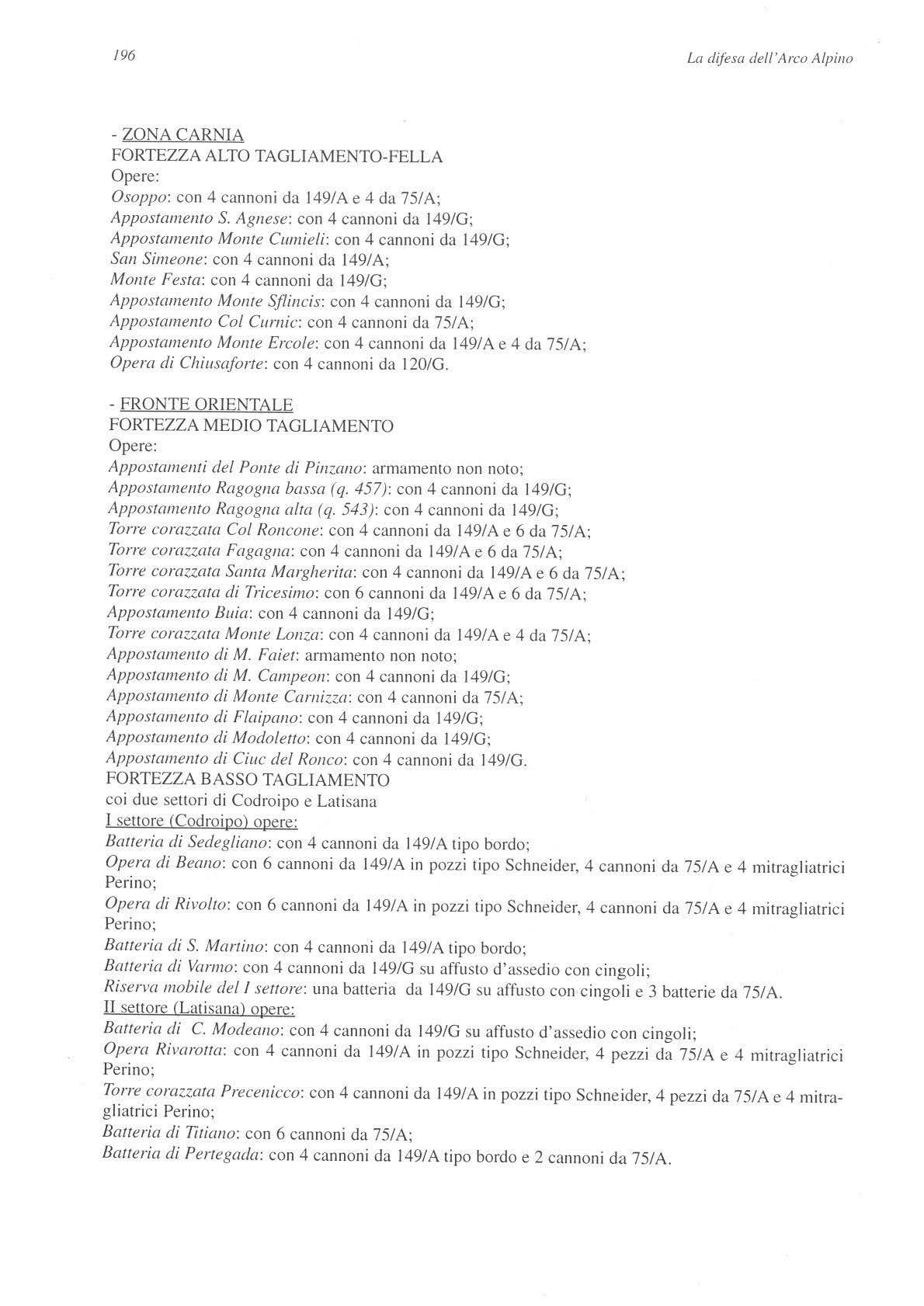
Torre corazzata Col Roncone: con 4 cannoni da 149/A e 6 da 75/A;
Torre corazzata Fagagna: con 4 cannoni da 149/A e 6 da 75/A;
Torre corazzata Santa Margherita: con 4 cannoni da 149/Ae 6 da 75/A;
Torre corazzata di Tricesimo: con 6 cannoni da 149/A e 6 da 75/A;
Appostamento Buia: con 4 cannoni da 149/G;
Torre corazzata Mo111e Lonza: con 4 cannoni da 149/A e 4 da 75/A;
Appostamemo di M. Faiet: armamento non noto;
Appostamento di M. Campeon: con 4 cannoni da 149/G;
Appostamento di Monte Canzizza: con 4 cannoni da 75/A;
Appostamemo di Flaipano: con 4 cannoni da 149/G;
Appostamenlo di Modo/etto: con 4 cannoni da 149/G;
Appostamento di Ciuc del Ronco: con 4 cannoni da 149/G.
FORTEZZA BASSO TAGLIAMENTO
coi due settori di Codroipo e Latisana
I settore (Codroipo) opere:
Batteria di Sedegliano: con 4 cannoni da 149/A tipo bordo;
Opera di Beano: con 6 cannoni da 149/A in pozzi tipo Schneider, 4 cannoni da 75/A e 4 mitragliatrici Perino;
Opera di Rivolto: con 6 cannoni da 149/A in pozzi tipo Schneider, 4 cannoni da 75/A e 4 mitragliatrici Pe,ino;
Batteria di S. Mar1ino: con 4 cannoni da 149/A tipo bordo;
Batteria di Vanno: con 4 cannoni da 149/G su affusto d'assedio con cingoli;
Riserva mobile del I settore: una batteria da 149/G su affusto con cingoli e 3 batterie da 75/ A.
II settore (Latisana) opere:
Batteria di C. Modeano: con 4 cannoni da 149/G su affusto d'assedio con c in go li ;
Opera Rivarotta: con 4 cannoni da 149/A in pozzi tipo Schneider, 4 pezzi da 75/A e 4 mitragliatrici Perino;
Torre corazzata Precenicco: con 4 cannoni da 149/A in pozzi tipo Schneider, 4 pezzi da 75/A e 4 mitrag li atrici Perino;
Batteria di Tttiano: con 6 cannoni da 75/A;
Batteria di Pertegada: con 4 cannon i da 149/A tipo bordo e 2 cannoni da 75/A.
196
La difesa dell 'Arco Alpino
AUSTRIA
Le opere permanenti e campali, raggruppate in sbainmenti, gruppi fortificati, erette dall'Austria sul confine italiano a sbarram e nto delle principali valli o linee di penetrazione sono , allo scoppio delle ostilità con l ' Italia, le seguenti:
Forte di Nauders: armato con 8 cannoni camp. da 8 cm. mod. 75 e 2 cannoni da camp. mod. 94 da 8 cm in casamatta.
-TRENTINO
SBARRAMENTO STELVIO
Opere:
Forte Gomagoi: fabbricato in conci di granito, a due piani, con 22 cannoniere, armato con 16 cannoni da 9 ed un cannone da 8 cm. mod. 95 in casamatta.
GRUPPO FORTIFICATO DEL TONALE
Opere:
Forte Barba di Fiori o Val Pejo: con 4 cannoni da 12 ed un cannone a tiro rapido;
Forte Val di Strino: con 2 cannoni da 12, 2 obici da I O, era collegato con comunicazione sotterranea con il:
Forte Velon: con 2 cannoni da 8;
Forte Saccarana o Tonale: con 6 cupole corazzate con 4 pezzi da 9 e 2 da 8, 9 pezzi da 10 ed un cannone di piccolo calibro;
Forte Presanella o Pozzi Alti: con 3 cupole corazzate, l casamatta con 3 cannoniere, una casamatta metallica e 2 cupole girevoli osservatorio;
GRUPPO FORTIFICATO DI LARDARO
Opere:
Forte Monte Como: con 6 cannoni da 12 in casamatta, 4 da 9 ed una batteria in barbetta con 3 cannoni da 15;
Forte Larino: con una batteria in casamatta, con 11 cannoniere, armata di 3 cannoni da 12, un cannone da 15 e un cannone da 8, 2 batterie in terra su 10 pezzi con 3 cannoni da 9 e 2 da IO nei magazzini;
Forte Revegler: in muratura, con 3 cannoniere armate con cannoni da 12;
Forte Danzalino: costituito da 6 casematte, armato con 3 cannoni da 15;
Forte Por(di recente costituzione): con 4 obici di medio calibro.
GRUPPO FORTIFICATO DI RIVA
Opere:
Batteria della Spiaggia: con 4 cannoni da 9 cm M75 in cupola;
Forte Garda: con una batteria'obici, con 4 obici da 10 in cupola ed una batteria in barbetta con 4 mr. da 15;
Batteria di Mezzo: con 4 obici da IO in casamatta corazzata e 4 cannoni a tiro rapido;
Batteria Nord (S. Alessandro): con 4 obici da I 5 in casamatta corazzata;
Forti di Nago superiore ed inferiore: con 8 cannoni da 9 in casamatta;
Forte di Monte Tombio: con 3 pezzi da 12 in cupole corazzate, tagliata per sola fucileria (Ponale) e una batteria (Bellavista) con 4 cannoni da 9 in bronzo;
9 SME, Uff. Storico, c.s.
Lo Specchio è stat o ripre so integralmente da qut:st a pubblica:cione. ma taluni studiosi attribuiscono alle opi.:rc austriache, specie quell e della cintura , il pezzo da 100 mm. Skoda anziché il I 05 qui riportato.
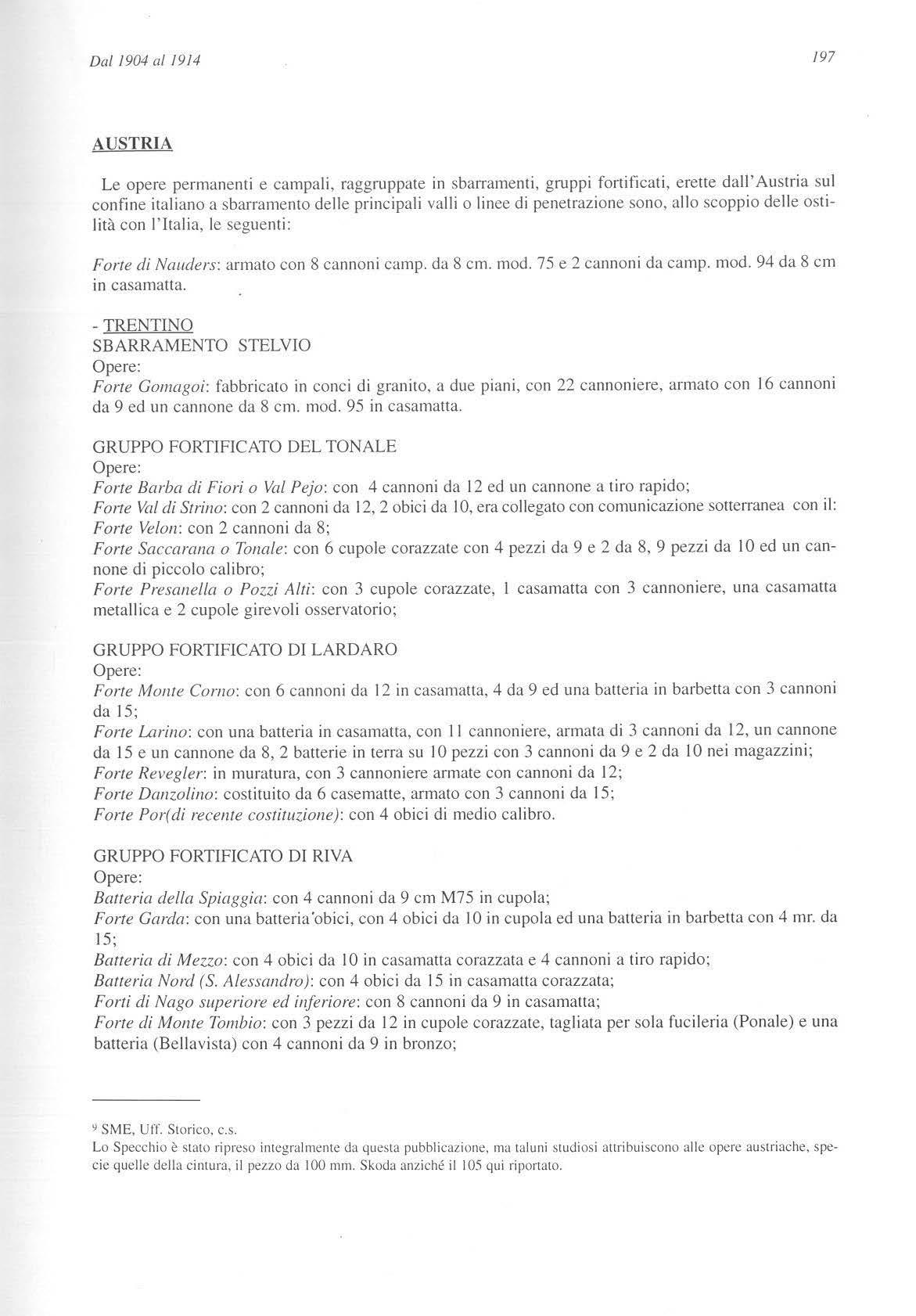
Dal /904 al 1914 197
OPERE DEGLI ALTIPIANI DI FOLGARIA E LAVARONE
Opere:
Dosso del Sommo: con 4 cupole girevoli con obici da I 05, una casamatLa fissa e 2 cannoniere, ciascuna per la difesa vicina ed il fiancheggiamento;
Sommo Alto: con 2 cupole girevoli con obici da I 05, 6 casematte metalliche fisse e una piccola cupola per la difesa vicina;
Malga Che rie: con 4 cupole girevoli con obici da I 05, 2 casematte fisse a 2 cannoniere-casamatta ed una piccola cupola girevole per la difesa vicina;
Belvedere: con 3 cupole! girevoli con obici da 105, 2 casematte metalliche con 2 cannoni da 8, 4 casematte metalliche fisse per la difesa vicina con 4 cannoni da 6;
Campo di Luserna: con 4 cupole girevoli con obici da 105, 2 cannoni da 8 in casamatta, 2 casematte metalliche risse ed una piccola cupola per la difesa vicina;
Malga Busa di Verte: con 4 cupole girevoli con obici da 105, una casamatta metallica fissa co n 2 cannoni da 8:
Spir: di \lerle: con 2 cupole, 2 cascma11e metalliche fisse a 2 cannoniere.
GRUPPO FORTIFICATO DI LEVICO
Opere:
Forte Te1111{1: con 8 cannoni da 12 mod. 80 con affusti a cannoniera minima, 4 cannoni da 24 in cupola e I O cannoni di piccolo calibro;
Forre San Biagio: con 4 cannon i da 12 in casematte corazzate e 2 mr. da 15 in 2 torri corazzate girevoli;
CAMPO TRINCERATO 01 TRENTO
Opere del nucleo centrale:
Castello di 1ì·ento: con alcune cannoniere disarmate;
Dos di Tremo: con 8/1 Opezzi in batteria e qualche mr..
Opere de l fronte orientale:
A) Contro le provenienze di Val Fersina:
Forte Cfre::ano: con 2 cannoni da 12 e 2 da 15:
Forte Obersrrassensperre: con 2 cannoni da 15 in casamatta;
Forre U11rerstmsse11sperre: con 2 cannoni da 12, un cannone da 7 mont. in casamatta.
B) Contro le provenienze dalla Sella di Roncogno (Pergine):
Forte di Ro11cog110: con 4 cannoni da 12 in casamatta e 2 cannoni da 7 mont. in barbetta.
C) Contro l e provenienze di Val Sorda:
Block/1(111S superiore Malga Moran:a e Blockhaus inferiore Malga Maran:(/: per sola fucileria;
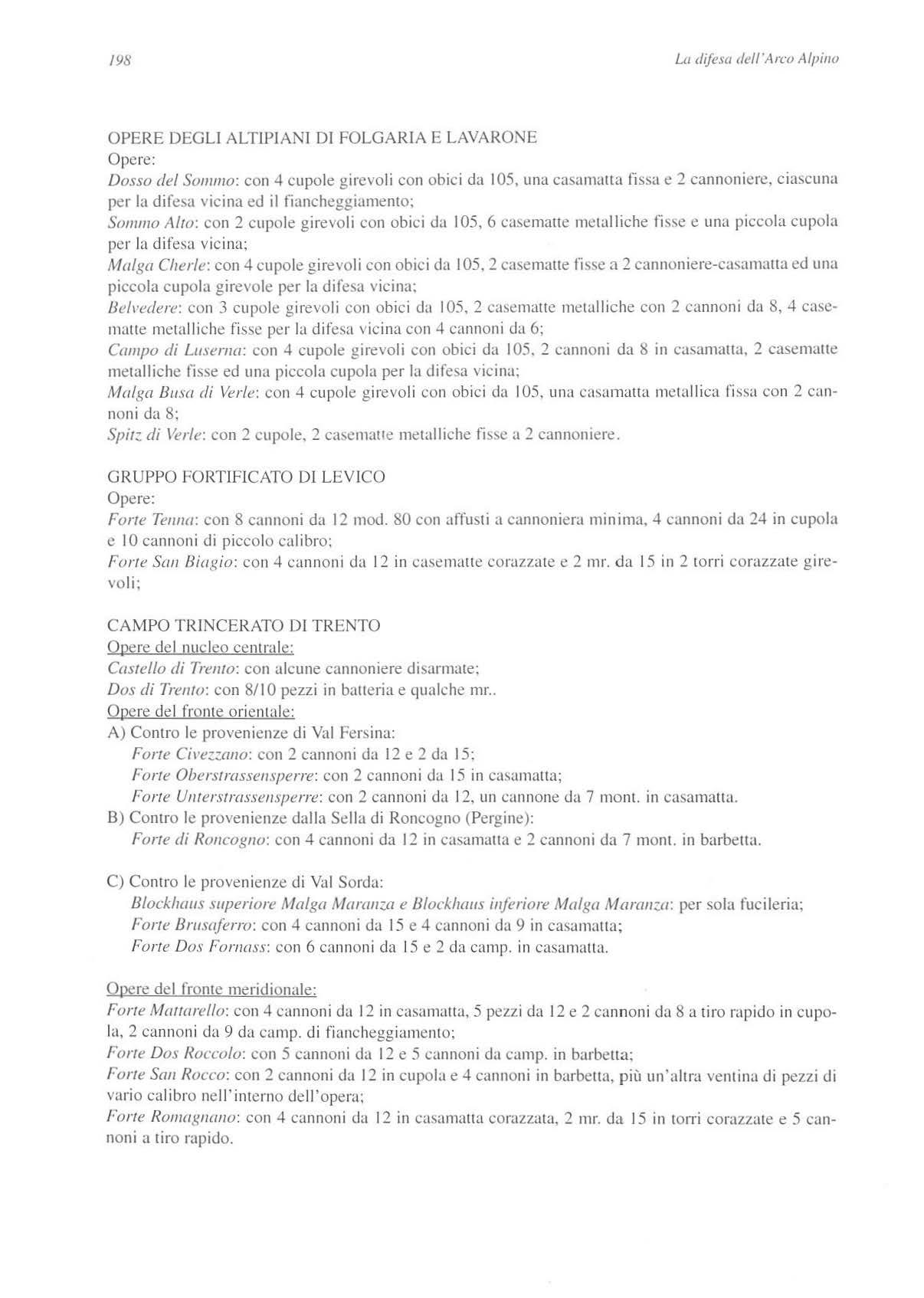
Forre Bmsaferro: con 4 cannoni da 15 e 4 cannoni da 9 in casamacta;
Forte Dos Fornass: con 6 cannoni da 15 e 2 da camp. in casamatta.
Opere del fronte meridionale:
Forre Mano rei/o: con 4 can noni da 12 in casamatta, 5 pezzi da 12 e 2 can n oni da 8 a tiro rapido in cupola , 2 ca nn oni eia 9 eia camp. di fiancheggiamento;
Forre Dos Roccolo: con 5 cannoni da 12 e 5 cannoni da camp. in barbetta;
Forre San Rocco: con 2 cannoni da 12 in cupola e-+ cannoni in barbetta, più un'altra ventina di pezzi di vario calibro nell'interno dell'opera;
Forre Romognano: con 4 cannoni da I 2 in casamatta corazzata, 2 mr. da 15 in torri corazzate e 5 cannoni a tiro rapido.
/98
La difesa dell'Arco Alpino
Opere del fronte settentrionale:
Forte Martignana: con 3 cannoni da 8 camp. in casamatta e 3 cannoni da 7 rnont.;
Forte Ca/isberg: con 2 cannoni da 15 ed uno da I 2 in casamatta.
Opere del fronte occidentale:
A) Contro la conca di Sopramonte: Blockhaus Mondo/in: con un cannone da 15 e 2 da 12 in cannoniere; Batterie Candriai: con 8 cannoni eia 8 in barbetta;
B) Contro le provenienza da Val Buco di Vela:
Forte superiore Buco di Vela: con 2 cannoni eia 12 in casamatta; Forte inferiore Buco di Velo: con 3 cannoni da I Oda camp. ad avancarica.
-CADORE
SBARRAMENTO LINEADELCISMON E DI TRAVIGNOLO
Opere:
Forte Dossaccio: con 4 cannoni da 12 in casamatta corazzata e 4 rnr. da 15 in torri corazzate girevoli; Fortino Busi: con 4 cannoni eia 12 in cannoniere.
SBARRAMENTO DI VALLE SAN PELLEGRINO
Opere:
Forte Someda: con 2 cannoni da 12 in casamatta, su affusto a cannoniera minima, 3 mr. eia 15 in torri corazzate girevoli e 6 cannoni a tiro rapido (4 in casamatta e 2 in tOtTi corazzate girevoli).
SBARRAMENTO DI VAL CORDEVOLE
Opere:
Forte La Corte: con 4 cannoni da 12 in casamatta corazzata, 5 mr. da I 5 in torre corazzata girevole, 6 cannoni a tiro rapido;

Tagliata Rum,: con 2 cannoni di piccolo calibro e 4 mitragliatrici.
SBARRAMENTO DI VALCOSTEANA
Opere:
Tagliata Tre Sassi ed una caserma difensivo: con armamento complessivo costituito da 2 cannoni eia 6 cm. mod. 98 in casamatta e 2 cannoni eia 8/M 98.
SBARRAMENTO DELLA VAL RIENZA (STRADA DI ALEMAGNA)
Opere:
Forte Plèitzwiese: con 2 cannoni da 12 in casamatta corazzata, 2 mr. da 15 in torri blindate e 2 cannoni da 9;
Forte Lmulro basso: con 3 obici da IO in torri corazzate e 4 cannoni da 9;
Forte Landro alto: con 3 cannoni da 12 in casamatta corazzata e 2 cannoni da 9.
- POSTERIA
SBARRAMENTO SEXTEN
Contro le provenienze dal Passo di Monte Croce di Comelico:
Opere:
Forte Mitterberg: con 3 cannoni eia 12 in casamatta corazzata, 3 rnr. da 15 in torri corazzate e alcuni cannoni di piccolo calibro;
Forre Haidickt: con 2 cannoni da 12 in casamatta corazzata, 3 mr. da 15 in torri corazzate e alcuni cannoni da camp
Dal 1904 al 1914
199
- CARNIA
SBARRAMENTO DELLA VALLE DEL FELLA (PONTEBBANA)
Opere:
Forte Hensel: con 4 cannoni da 12 su affusti a cannoniera minima, in casamatta corazzata, 4 cannoni da 12 in torri corazzate girevoli, 4 cannoni da 9 in barbetta e 22 mitragliatrici.
SBARRAMENTO DELLA VAL SEEBACH
Opere:
Forte di Raibl: con 3 cannoni da 12 in casamatta, 2 cannoni da 9 da camp. in cannoniera ed un cannoncino a tiro rapido in torre in muratura;
Batteria del Passo del Predii: con 3 cannoni da 15 in casamatta e 2 cannoni da l 2.
SBARRAMENTO DI VAL KORITNICA
Opere:
Forte Predii alto: con 7 cannoni da 12;
Forte Predii basso: con 4 cannoni da 12 in casamatta corazzata su affusto a cannoniera minima e 4 da I 5 in 4 torri corazzate girevoli;
Chiusa di P/ezzo: con 3 cannoni da 12 in casamatta e 2 cannoni da camp. da 9 in casamatta;
Forte Hermann: con 4 cannoni da 12 in casamatta corazzata, su affusto a cannoniera minima e 4 mr. da 15 in 4 torri corazzate girevoli.9
L'abbondanza, complessità e varietà delle strutture messe in campo dai due contendenti impone di fare una carrellata sulle fortificazioni più caratteristiche, o loro aspetti particolari; ciò viene fatto riunendo al termine della esposizione tutti gli aspeui fotografici che si è ritenuto portare all'attenzione, senza interrompere così il filo conduttore della precedente esposizione.
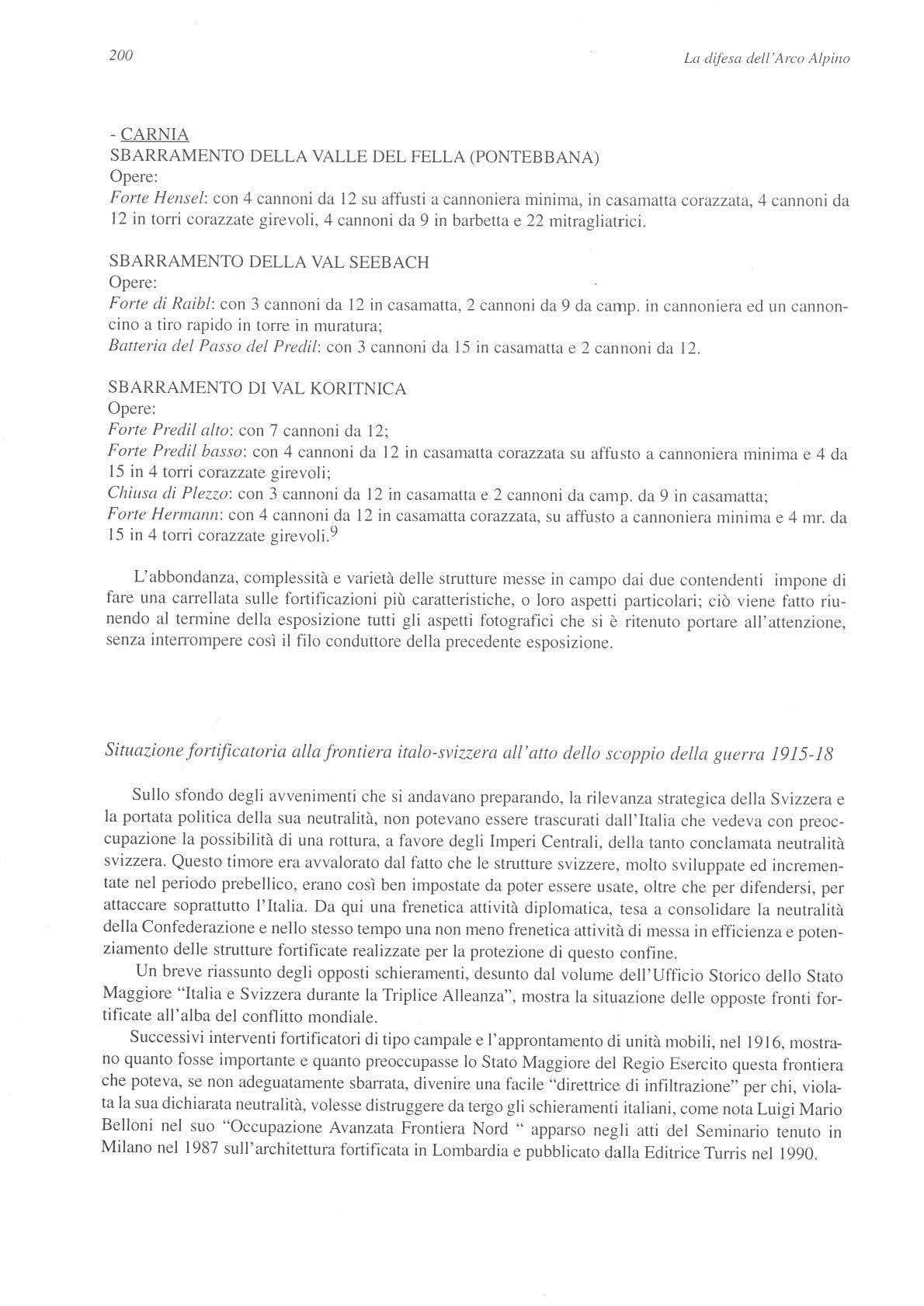
Situazione fortificatoria alla frontiera italo-svizzera ali' atto dello scoppio della guerra I 9 I 5-18
Sullo sfondo degli avvenimenti che si andavano preparando, la rilevanza strategica della Svizzera e la po1tata politica della sua neutralità, non potevano essere trascurati dall'Italia che vedeva con preoccupazione la possibilità di una rottura, a favore degli Imperi Centrali, della tanto conclamata neutralità svizzera. Questo timore era avvalorato dal fatto che le strutture svizzere, molto sviluppate ed incrementate nel periodo prebellico, erano così ben impostate da poter essere usate, oltre che per difendersi, per attaccare soprattutto l'Italia. Da qui una frenetica attività diplomatica, tesa a consolidare la neutralità della Confederazione e nello stesso tempo una non meno frenetica attività di messa in efficienza e potenziamento delle strutture fortificate realizzate per la protezione di questo confine.
Un breve riassunto degli opposti schieramenti, desunto dal volume dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore " Italia e Svizzera durante la Triplice Alleanza", mostra la situazione delle opposte fronti fortificate all'alba del conflitto mondiale.
Successivi interventi fortificatori di tipo campale e l'approntamento dn unità mobili, nel 1916, mostrano quanto fosse impo1tante e quanto preoccupasse lo Stato Maggiore del Regio Esercito questa frontiera che poteva, se non adeguatamente sbarrata, divenire una facile "direttrice di infiltrazione" per chi, violata la sua dichiarata neutralità, vo lesse distruggere da tergo gli schieramenti italiani, come nota Luigi Mario Belloni nel suo "Occupazione Avanzata Frontiera Nord " apparso negli atti del Seminario tenuto 111 Milano nel 1987 sull'architettura fortificata in Lombardia e pubblicato dalla Editrice Turris nel I 990
200
La difesa dell'Arco Alpino
SPECCHIO RIASSUNTIVO DELLE FORTIFICAZIONI ITALIANE
VALLE D ' AOSTA
SbatTam e nto di Bard
Forti:
Forte di Bard : I batteria da 149/G, 2 batt e ri e da 120, I batt er ia di obici da 149 (tutti i pezzi sono in casamatta);
Posizioni di Tete de Cou e Col Courtil: compless ivam ente 3 batter ie in barbetta da 149/G; Posizioni eventuali: da armarsi con cannoni da 120, obici da 149 e cannoni da 87.
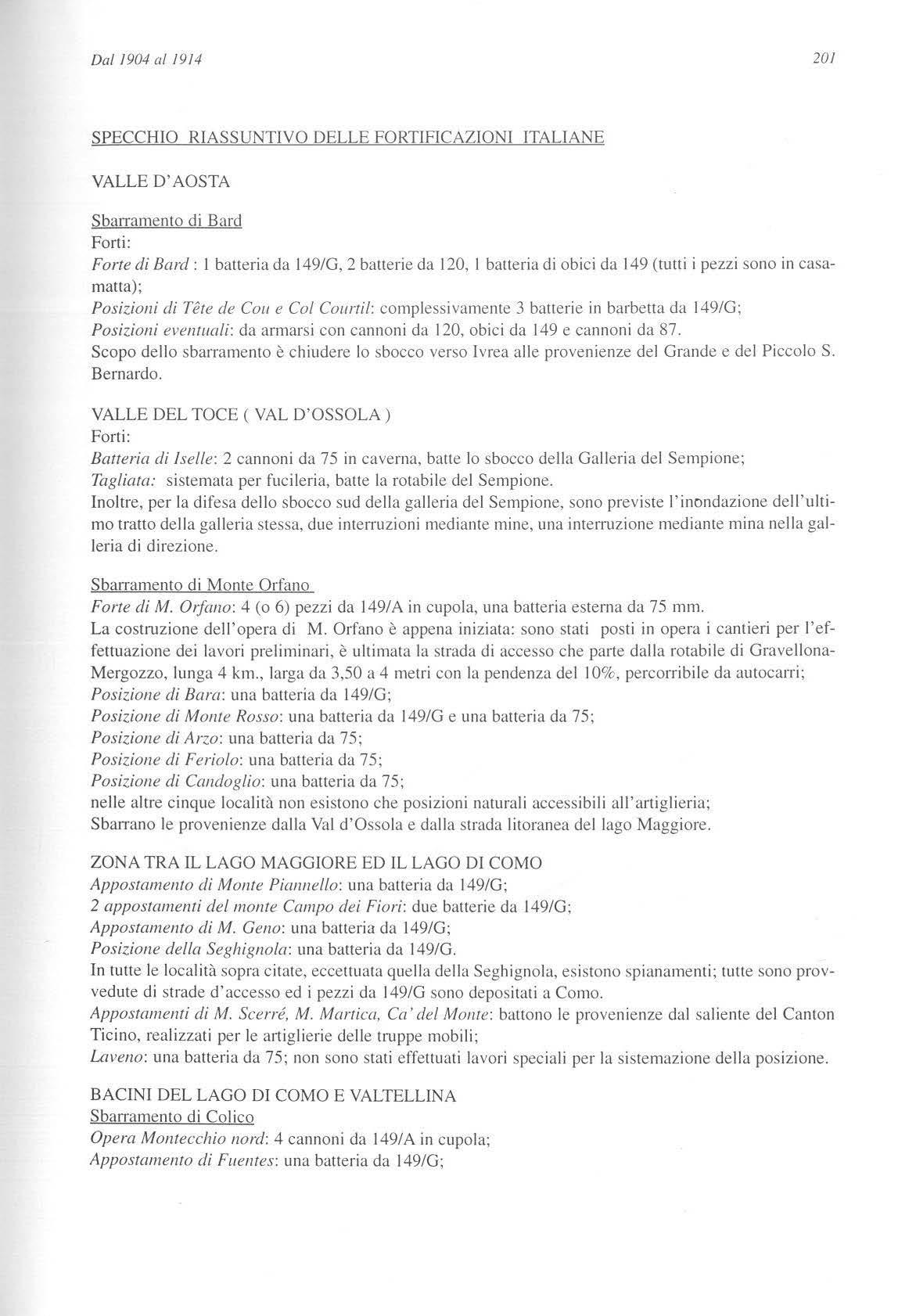
Scopo dello sbarramento è chiudere lo sbocco verso Ivrea alle provenienze del Grande e del Piccolo S. Bernardo.
VALLE DEL TOCE ( VAL D'OSSOLA)
Forti:
Batteria di /selle: 2 cannoni da 75 in caverna, batte lo sbocco della Galleria del Sempione;
Tagliata: sistemata per fucileria, batte la rotabile del Sempione.
Inoltre, per la difesa dello sbocco sud de lla galleria del Sempione, sono previste l'inondazione dell'ultimo tratto della galleria stessa, due inte1TUzioni me diante mine, una inte rruzione mediante mina nella galleria di direzione.
Sbarramento di Mont e Orfano
Forte di M. Orfano: 4 (o 6) pezzi da 149/A in cupola, una batteria esterna da 75 mm.
La costruzione dell'opera di M. Orfano è appena iniziata: sono stati posti in opera i cantieri p e r l'effettuazione dei lavori preliminari, è ultimata la strada di accesso che parte dalla rotabile di GravellonaMergozzo, lunga 4 km., larga da 3,50 a 4 metri con la pendenza del I 0 % , percorribile da autocarri;
Posizione di Bara: una batteria da 149/G;
Posizione di Monte Rosso: una batteria da 149/G e una batteria da 75;
Posizione di Arzo: una batteria da 75;
Posizione di Feriolo: una batteria da 75;
Posizione di Candoglio: una batteria da 75; nelle altre cinque località non esistono che posizioni naturali accessibili all'artiglieria;
Sba,rnno le provenienze dalla Val d'Ossola e dalla strada litoranea del lago Maggiore
ZONA TRA IL LAGO MAGGIORE ED IL LAGO DI COMO
Appostamento di Monte Pia1111ello: una batteria da 149/G;
2 appostamenti del monte Campo dei Fiori: due batterie da 149/G;
Appostamento di M. Ceno: una batteria da 149/G;
Posizione della Seghignola: una batteria da 149/G.
In tutte le località sopra citate, eccettuata quella della Seghignola, esistono spianamenti; tutte sono provvedute di strade d'accesso ed i pezzi da 149/G sono depositati a Como.
Appostamenti di M. Scerré, M. Martica, Ca ' del Monte: battono le provenienze dal sa li ente del Canton
Ticino, realizzati per le artiglierie delle truppe mobili;
laveno: una batteria da 75; non sono stati effettuati lavori specia li per la s istemazione della posizione.
BACINI DEL LAGO DI COMO E VALTELLINA
Sbarramento di Colico
Opera Montecchio nord: 4 cannoni da 149/A in cupola;
Appostamemo di Fuentes: una batteria da 149/G;
Dal 1904 al /91 4
201
Batterie di Piona: una batteria da 75.
Nelle posizioni di Piona e di Fuentes i pezzi vengono portati al momento del bisogno; le opere dello sbarramento battono le provenienze da Chiavenna, dal passo di S. Torio e dalla Valtellina.
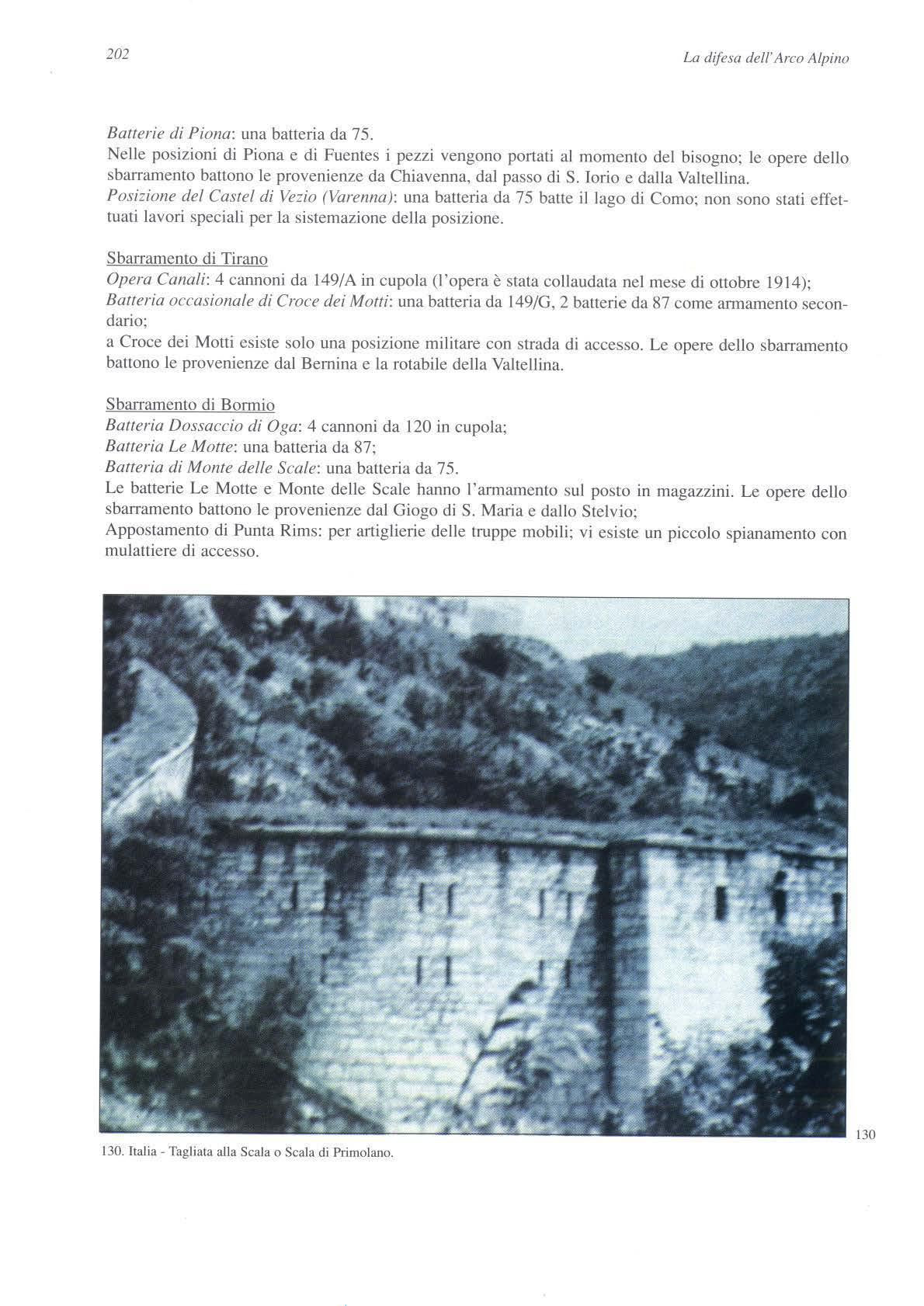
Posizione del Castel di Ve:io (Varenna): una batteria da 75 batte il lago di Como; non sono stati effettuati lavori speciali per la sistemazione della posizione.
Sbarramento di Tirano
Opera Canali: 4 cannoni da 149/A in cupola (l'opera è stata collaudata nel mese di ottobre 1914);
Batteria occasionale di Croce dei Motti: una batteria da 149/G, 2 batterie da 87 come armamento secondario;
a Croce dei Motti esiste solo una posizione militare con strada di accesso. Le opere dello sban·amento battono le provenienze dal Bernina e la rotabile della Valtellina.
Sbarramento di Bormio
Batteria Dossaccio di Oga: 4 cannoni da 120 in cupola;
Batteria Le Motte: una batteria da 87;
Batteria di Monte delle Scale: una batteria da 75.
Le batterie Le Motte e Monte delle Scale hanno l'annamento sul posto in magazzini. Le opere dello sbarramento battono le provenienze dal Giogo di S. Maria e dallo Stelvio;
Appostamento di Punta Rims: per artiglierie delle truppe mobili; vi esiste un piccolo spianamento con mulattiere di accesso.
202 La difesa dell'Arco Alpino
130
130. Ita lia - Tagliata alla Scala o Scala di Primolano.
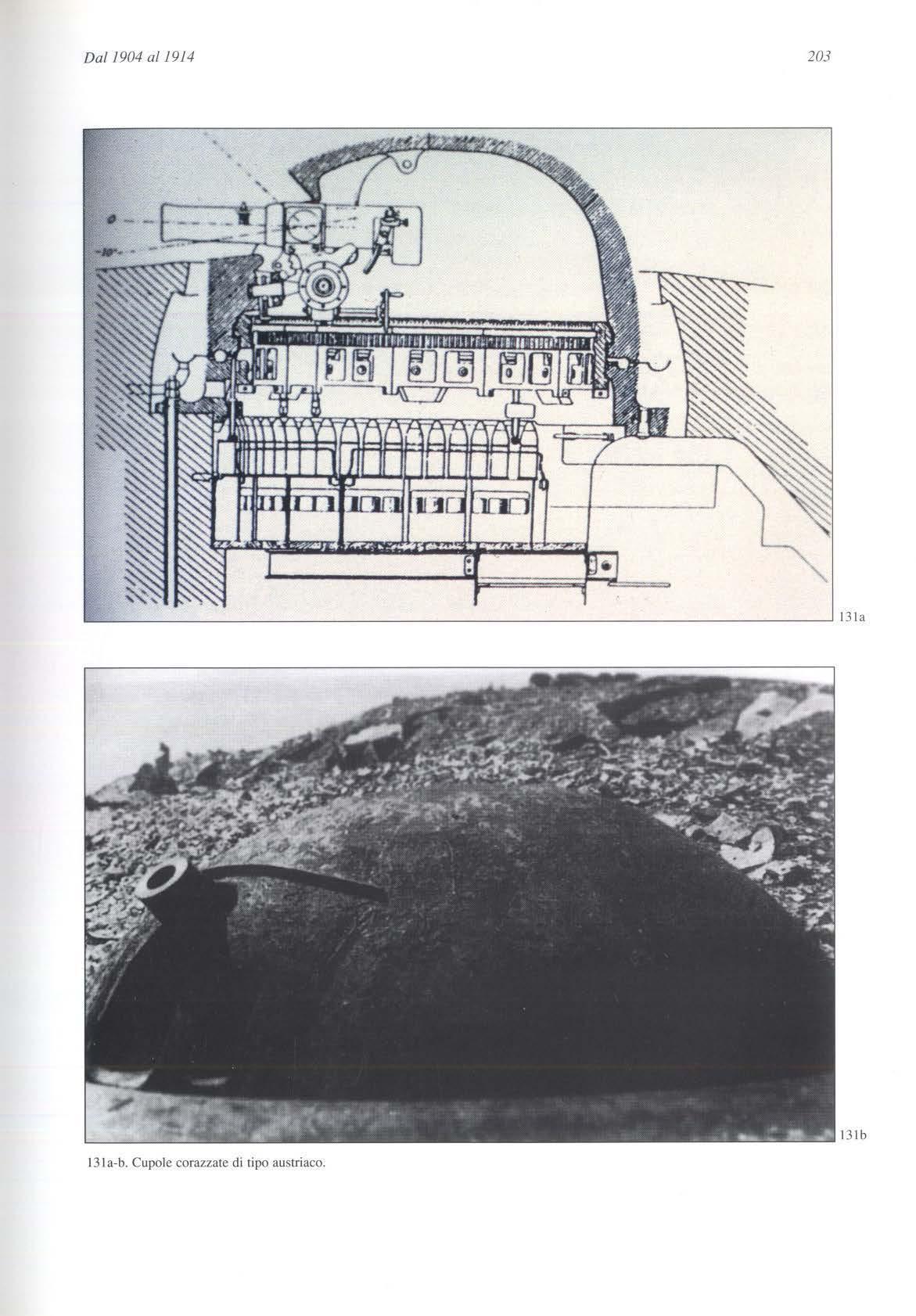
Dal 1904 al 1914 203 13lb
13 1a-b. Cupole corazzate di tipo austriaco.

204
132a. Austria - Forte Belvedere - cofano di controscarpa.
La difesa de/l'Arco Alpino
132b. Austria - Forte Belvedere - particolari de l cofano.
l32a 132b
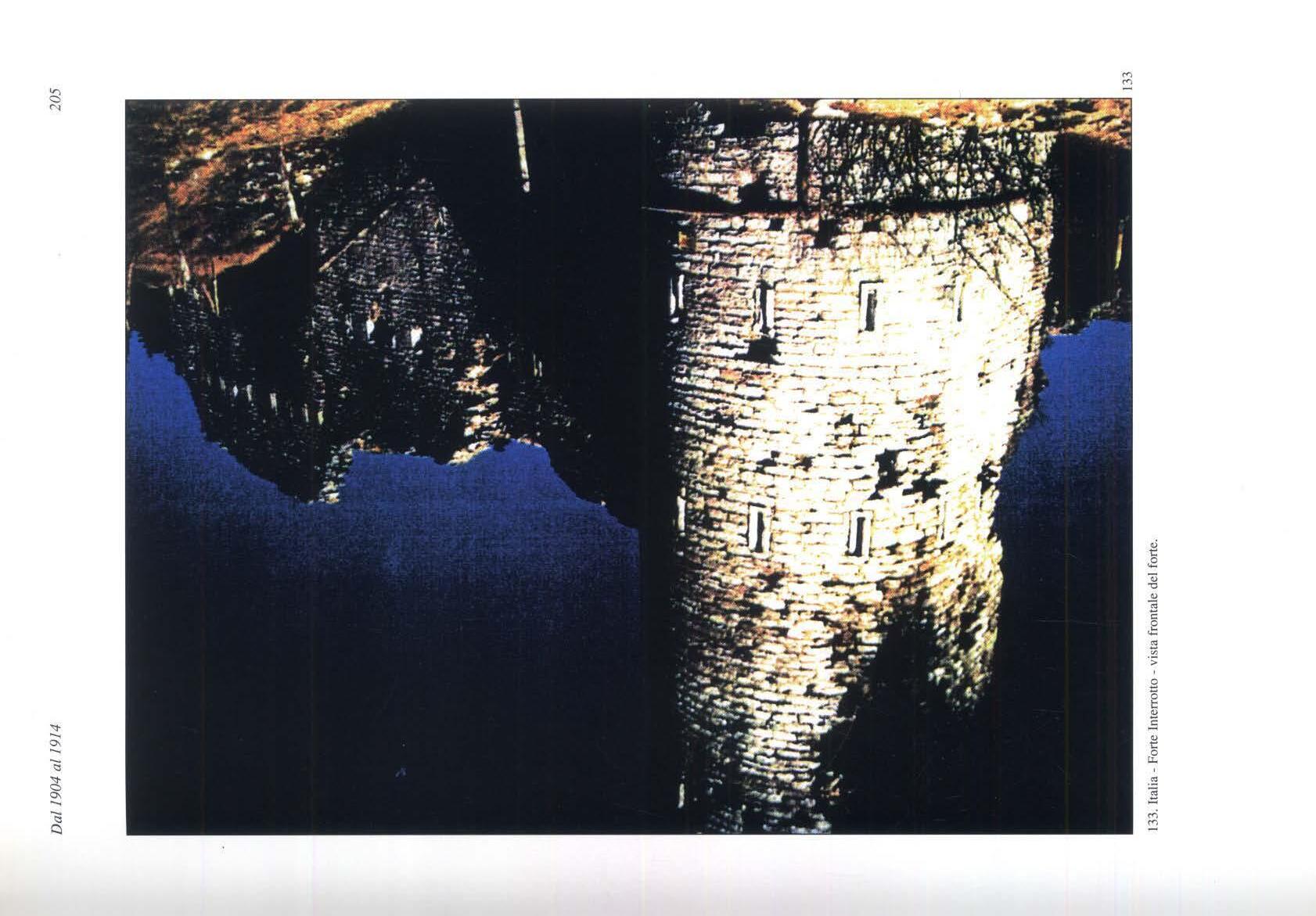
Dal 1904 al 1914 205 133 I 33.
-
Italia
Forte Jnterrottovista frontale del forte.
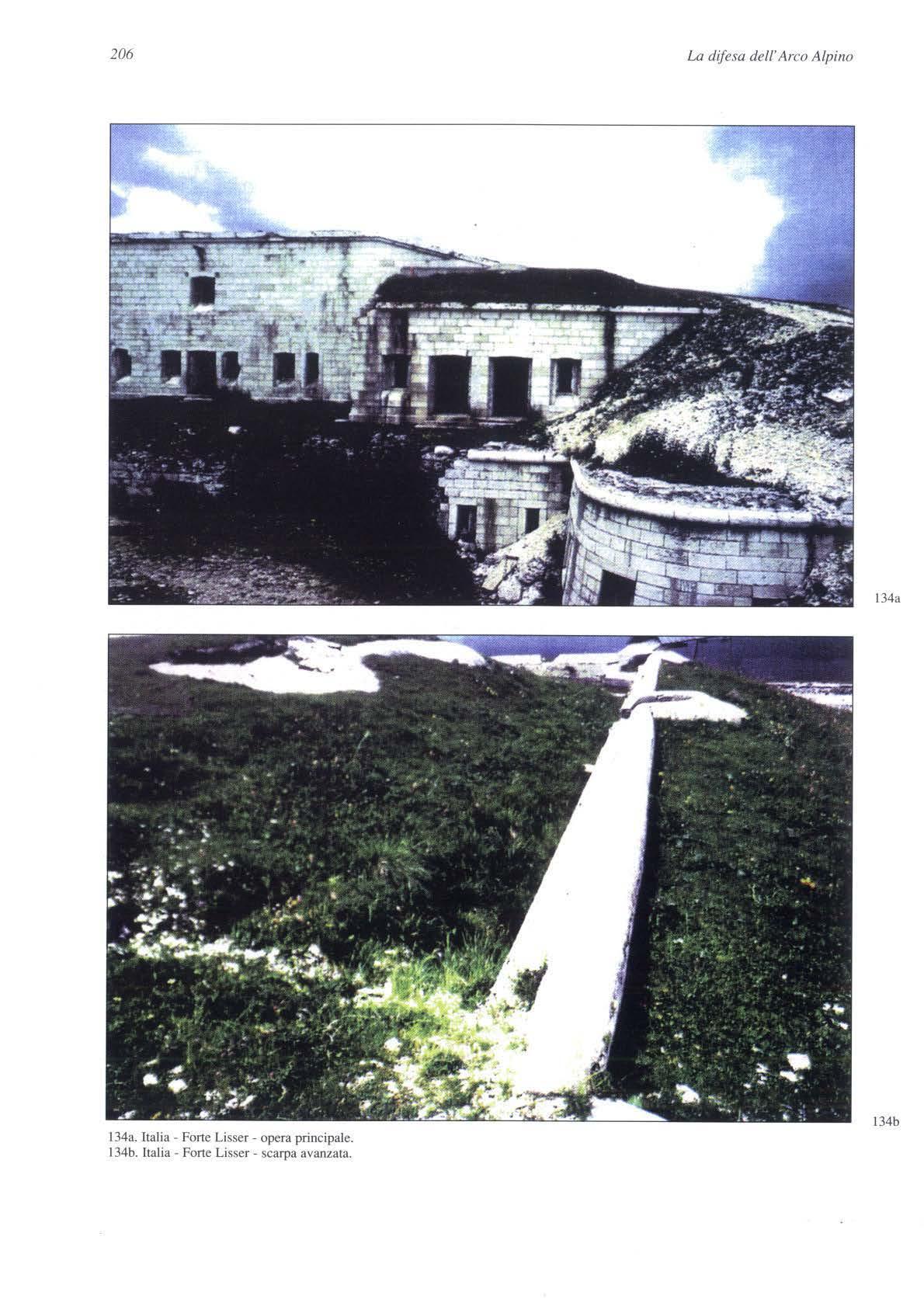
206
134a. Italia - Forte Lisser - opera principale.
La difesa del/' Arco Alpino
134b. ltalia - Forte Lisser - scarpa avanzata.
134a 134b
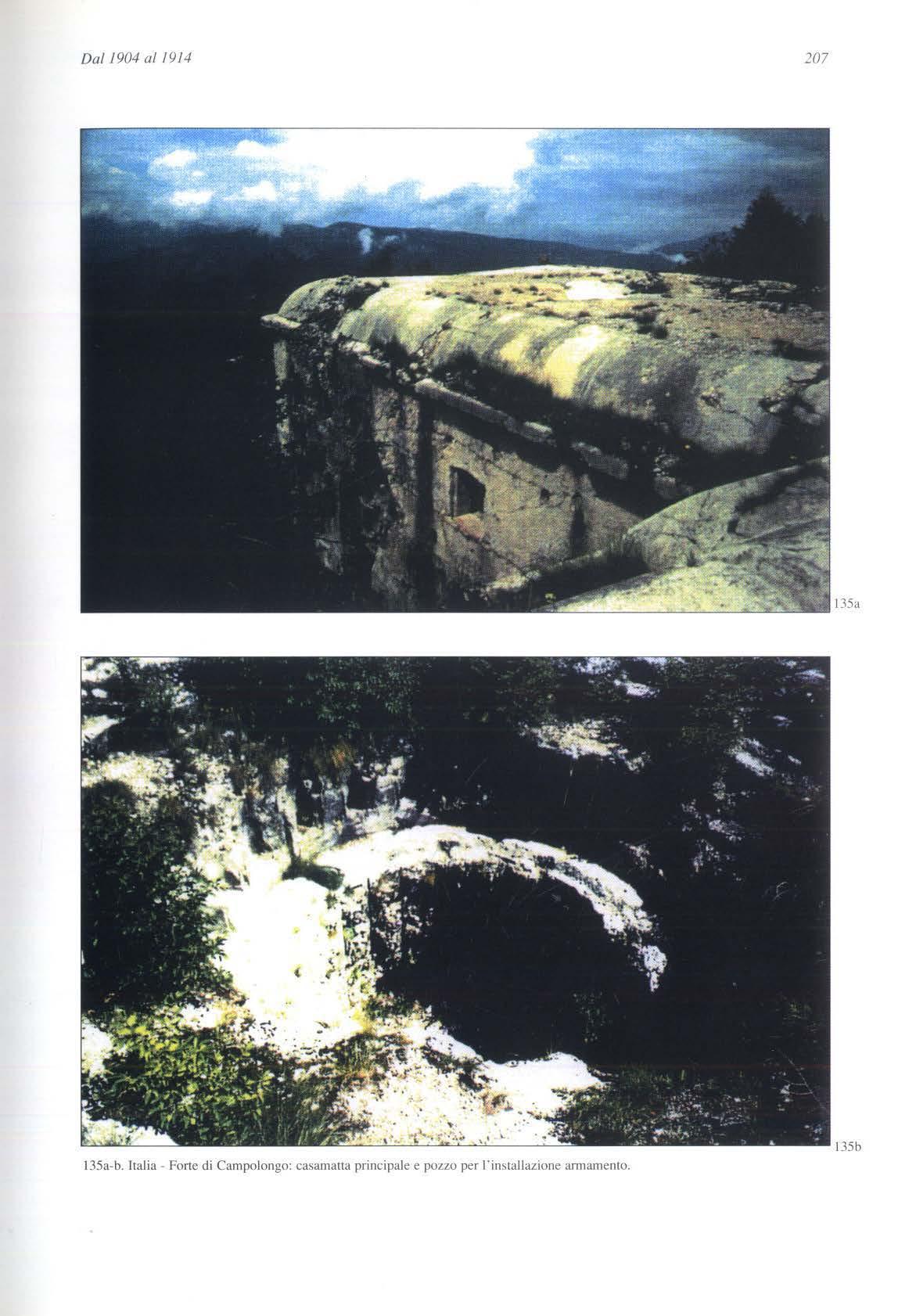
Dal 1904 al 1914 207 135a 135b
135a-b. Italia - Forte di Campolongo: casamana principale e pozzo per l'installazione armamento.

208
ò
/7J.75'CJ Pi,;n i"' e/e,/ /..,ùm o
136. Il diverso utilizz.o degli spazi: pianta del forte Verena (It).
SU(Jenore La difesa dell'Arco Alpino ,,,.__,,,,; - --...,.. , \ 136 137
137 Il djverso utilizzo degli spazi: pianta del forte S. Sebas tiano (Au).
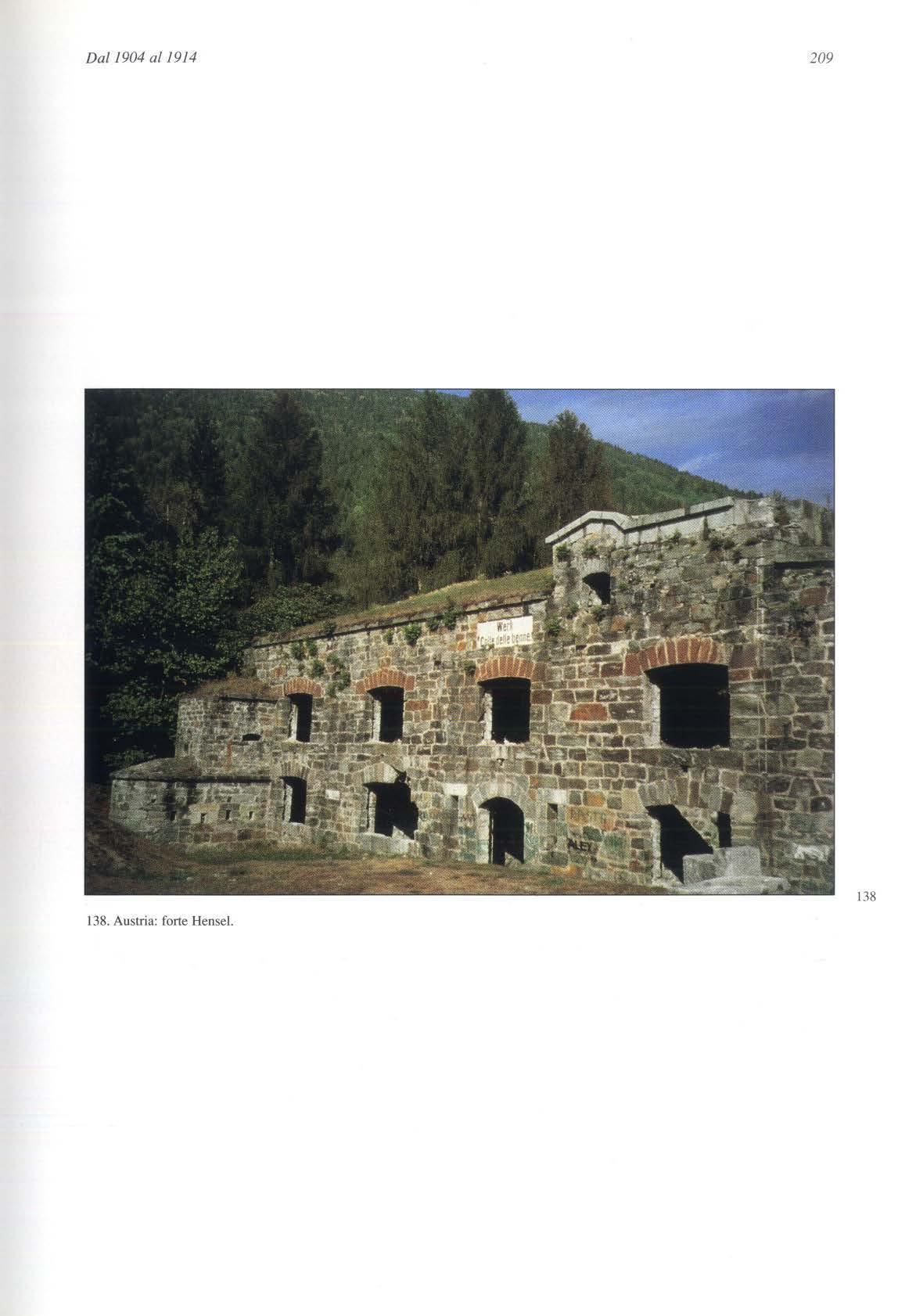
Dal 1904 al 1914 209 138
I 38. Austria: fone Hensel.
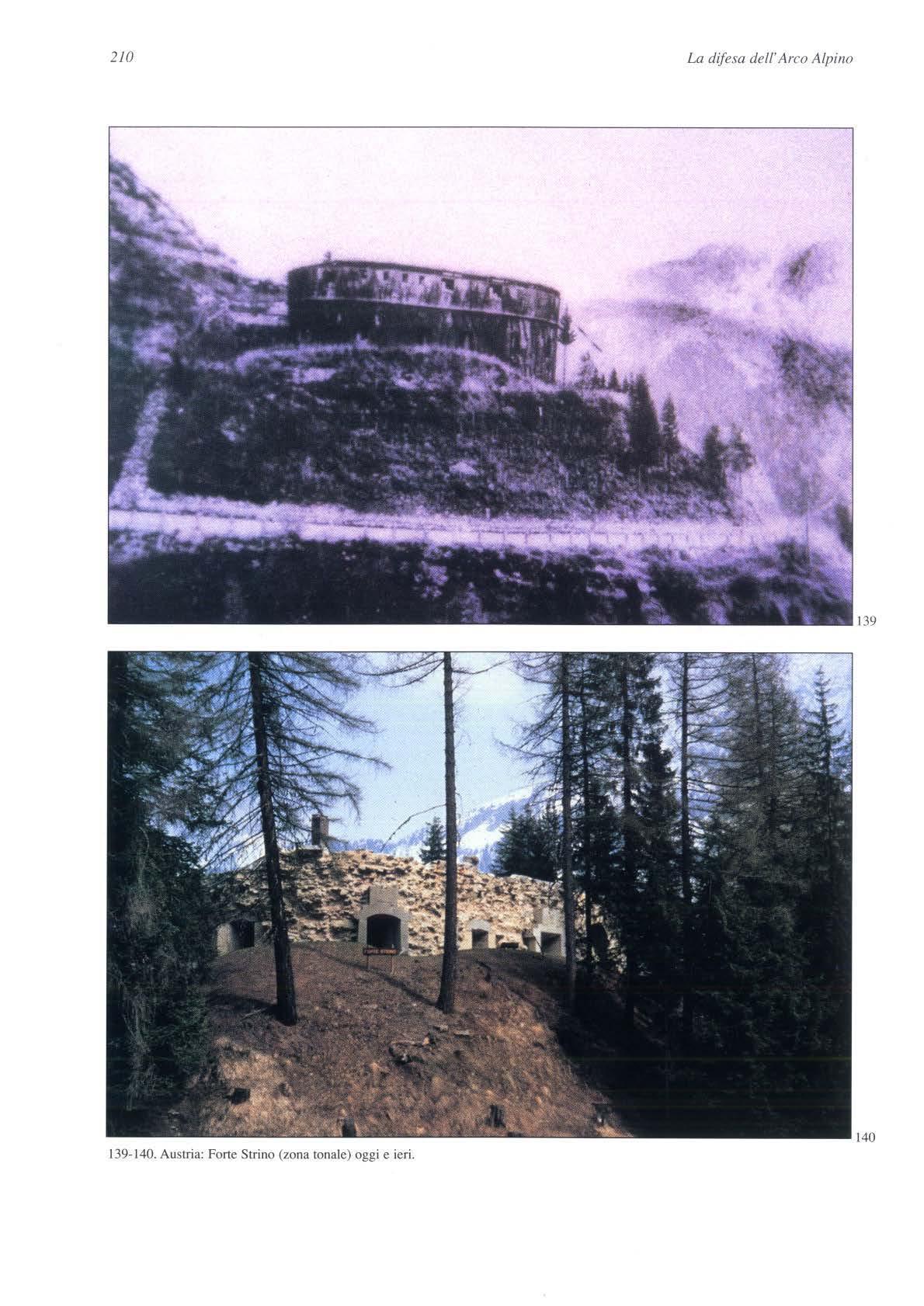
210 La difesa Alpino 139 140
139-1 40. Austria: Forte Str in o (zona ton a le) ogg i e ieri.
Ad !selle esiste una casermetta capace di 100 unità; esistono inoltre lungo il confine nella conca di Livigno: una caserma difensiva per 100 unità al passo di Val Viola, una per 200 alla Forcola di Livigno, una per 150 al lago di Campaccio ed una per 150 al passo di Cassana: verso lo Stelvio ed il giogo di S. Maria un ricovero per 250 unità all a Forcola del Braulio ed uno per 150 alla TV cantoniera dello Stelvio. Esistono inoltre al confine. lun go l a catena Mesolcina, 2 ricoveri. capaci di 250 unità alla Garzirola, 2 ricoveri e baracche in legno capaci complessivamente di 350 unità al passo di S. Iorio. 10
SPECCHIO RIASSUNTIVO DELLE FORTIFICAZIONI SVIZZERE
Sbarramento di Saint Maurice {Vallese)
sbarra la rotabile del Vallese.
Forte Sovaton: con 5 cupole per cannoni di medio ca lib ro, 2 cupo l e per cannoni di piccolo calibro, 2 batterie di cannoni di medio calibro in barbetta;
Forte Dailly: con 2 cupok per cannoni di medio calibro, 2 cupole per cannoni di piccolo calibro, 7 batterie di medio calibro in barbetta;
Batterio du Sex: con 8 cannoni di piccolo calibro in caverna.
Sbarnmento di Gondo (Sempione)
sbarra la rotabile del Sempione.
Fone di Condo: con ci rca 40 mitragliatrici in casamatta:
Batteria di Figenen: con 4 pezzi di medio calibro in barbetta.
Sono stati realizzati inoltre alcuni piccoli blockhauser su ll a displuviale ed un certo numero di ricoveri lungo il confine.
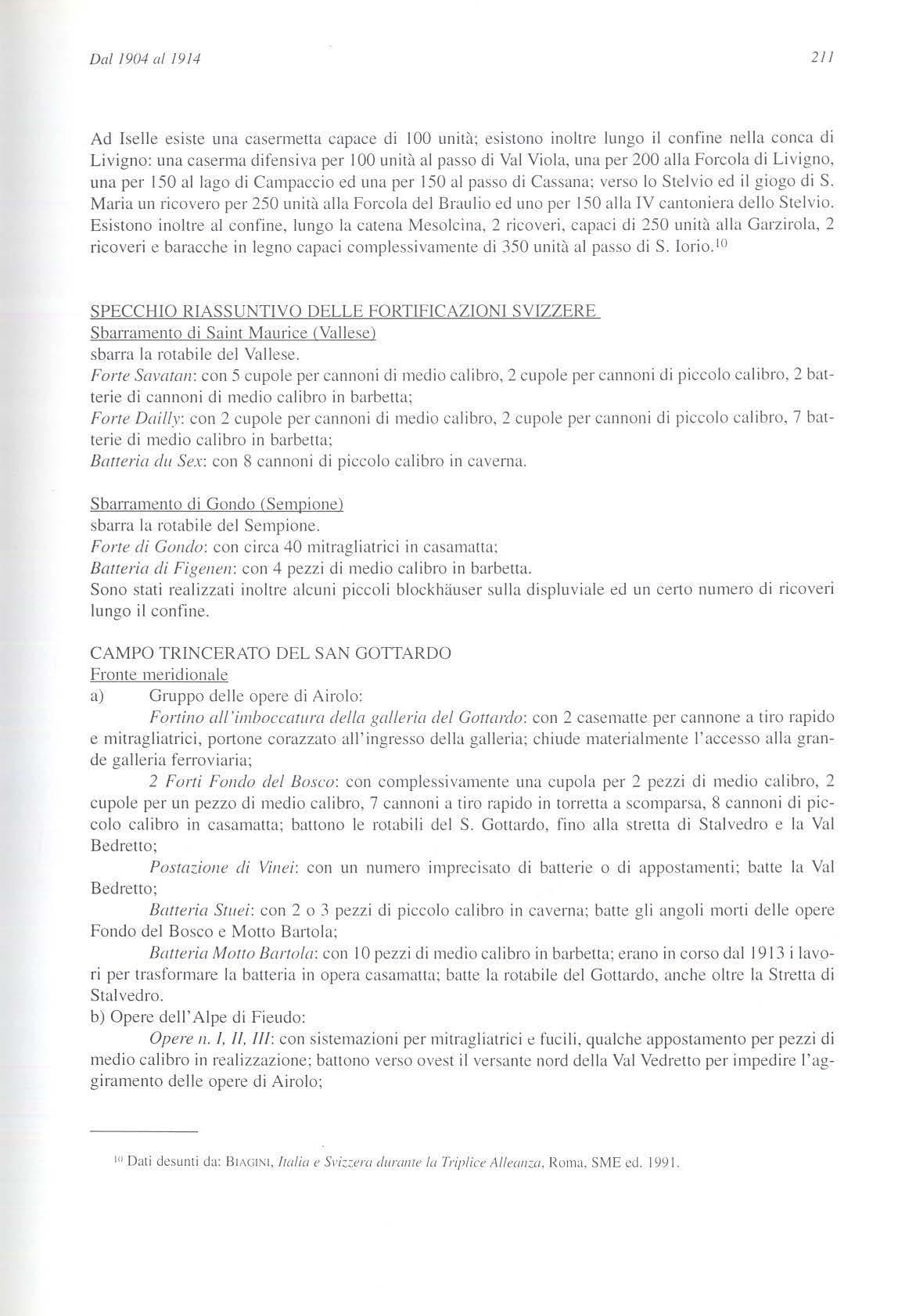
CAMPO TRINCERATO DEL SAN GOTTARDO
Fronte meridionale
a) Gruppo delle opere di Airolo:
Forrino al/'i111boccat11ra dello galleria del Gottardo: con 2 casemane per cannone a tiro rapido e mitragliatrici, portone corazzato all'ingresso della galleria; chiude materialmente l 'accesso alla grande gall eria ferroviaria;
2 Forti Fondo del Bosco: con complessivamente una cupo l a per 2 pezzi di medio calibro, 2 cupole per un pezzo di medio calibro, 7 cannoni a tiro rapido in torretta a scomparsa, 8 cannoni di piccolo calibro i n casamatta; battono le rotabili del S Goliardo, fino alla strerta di Stalvedro e la Val Bedretto;
Postazione di Vinei: con un numero imprecisato cli batterie o di appostamenti; balle la Val Bedretro;
Batteria Stuei: con 2 o J pezzi di piccolo calibro in caverna; batte gli angoli morti delle opere Fondo del Bosco e Motto Bartola;
Batteria Molfo Bartolo: con IOpezzi di medio calibro in barbetta; erano in corso dal 1913 i lavori per trasformare la batteria in opera casamatta; batte la rotabile del Gottardo, anche o ltre la Stretta di Stalvedro.
b) Opere dell'Alpe di Fieudo:
Opere 11. I, Il. Ili: con sisternazioni per mitragliatrici e: fucili, qualche appostamento per pezzi di medio calibro in realizzazione; battono ve r so ovest il versante nord della Val Vedretto per impedire l'aggiramen to delle opere di Airolo;
Dal 1904 al /9/4 211
w Dati des unti da : BIAGINI. /1alia e !fri::.::,ern durame la 7ì·1jJlice Allean::,a, Roma. SME cd. 199 I.
Forte del San Gottardo: con 4 cupole per pezzi di medio calibro, 3 torrette corazzate per cannoni a tiro rapido, una batteria di medio calibro in barbetta; costituisce un secondo sbarramento della rotabile del Gottardo dopo i forti di Airolo;
Fronte occidentale
Forte del Ghiacciaio del Rodano: con un cannone di medio calibro in cupola e 2 in casamatta; cannoni di piccolo calibro nelle caponiere; batte verso ovest la rotabile del Furka ed un tratto di quella del Grimsel; Ridotto del Furka: sistemato per fanter i a, presenta anche alcune piazzole per artiglieria; batte la rotabile del Furka;
Posi zione di Uingisrat: viene occupata con artiglierie solo all'atto della messa in stato di difesa della piazza; batte le rotabili del Furka e del Grimsel.
Fronte orientale
Forte Stock-Boden: con 2 cupole per uno o 2 cannoni di medio calibro, 2 per cannoni di piccolo calibro, 4 torrette corazzate per la difesa della stazione radio telegrafica, ubicata nelle vicinanze del forte; batte la strada dell'Oberalp, la conca cli Andermatt, lo sbocco nord della galleria ferroviaria a Goschenen; Batteria del Pa-::.zola-Stock: con 6 pezzi cli medio calibro in barbetta ed un appostamento per 4 pezzi; batte la strada dell'Oberalp;
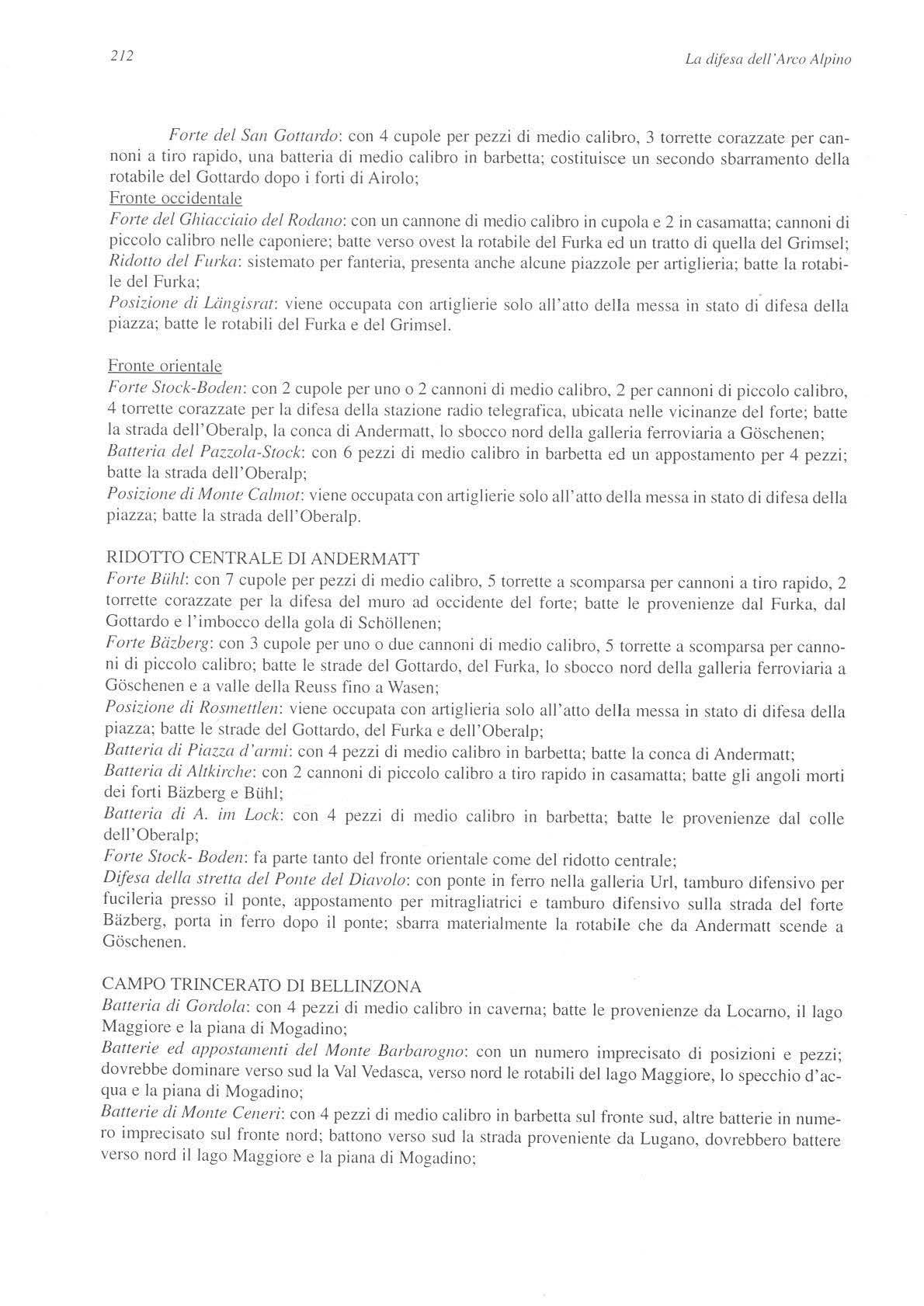
Posizione di Monre Ca/11101: viene occupata con aniglierie sol o all'atto della messa in stato di difesa della piazza; batte la strada dell'Oberalp.
RIDOTTO CENTRALE DI ANDERMAIT
Forte BiihL: con 7 cupole per pezzi di medio calibro, 5 torrette a scomparsa per cannoni a tiro rapido, 2 torrette corazzate per l a difesa del muro ad occidente del fone; batte le provenienze dal Furka, dal Gottardo e l'imbocco della gola cli Schol l enen;
Forte Béizberg: con 3 cupole per uno o due cannoni di medio calibro, 5 torrette a scomparsa per cannoni di piccolo calibro; batte le strade del Gottardo, ciel Furka, lo sbocco nord della galleria ferroviaria a Goschenen e a valle della Reuss fino a Wasen;
Posizione di Rosmettlen: viene occupata con artig li eria solo all'atto della messa in stato cli difesa della piazza; batte le strade del Gottardo, del Furka e dell'Oberalp;
Batteria di Piazza d'armi: con 4 pezzi di medio calibro in barbetta; batte la conca di Andermatt;
Batteria di Altkirche: con 2 cannoni cli piccolo calibro a tiro rapido in casamatta; batte gli angoli morti dei forti Bazberg e Btihl;
Batteria di A. im Lock: con 4 pezzi di medio ca l ibro in barbetta; batte le provenienze dal colle cieli' Oberai p;
FoJ'le Stock- Boden: fa parte tanto del fronte oriental e come del ridotto centrale;
Difesa della stretta del Ponre del Diavolo: con ponte in fe1TO nella galleria Uri, tamburo difensivo per fucileria presso il ponte, appostamento per mitragliatrici e tamburo difensivo sulla strada ciel forte Bazberg, porta in ferro dopo il ponte; sbarra materialmente la rotabi l e che eia Andermatt scende a Goschenen.
CAMPO TRINCERATO DI BELLINZONA
Baueria di Gore/o/a: con 4 pezzi cli medio calibro in caverna; batte le provenienze da Locarno, il lago
Maggiore e la piana di Mogadino;
Batrerie ed appostamemi del Monte Barbcuvgno: con un numero imprecisato cli posizioni e pezzi; dovrebbe dominare verso sud la Val Yedasca, verso nord le rotabili ciel l ago Maggiore, lo specch i o cl' acqua e la piana cli Mogadino;
Batterie di Monte Ceneri: con 4 pezzi di medio calibro in barbetta sul fronte sud, altre batterie in numero imprecisato sul fronte nord; battono verso sud l a strada proveniente da Luga no, dovrebbero battere verso nord il l ago Maggiore e l a piana di Mogadino;
212 La difesa dell'Arco Alpino
Appostamento sul Monte Generoso: si ha ragione di ritenere che esista e che batta la posizione italiana della Seghignola; Batterie ed appostamenri sul Corno di Cesero e sull'Alpe d'Arbino in Valle Arbedo: con un numero imprecisato di posizioni e di pezzi, battono le provenienze dal passo di San Iorio;
Baueria di Lumino o Monticello: con un numero imprecisato di pezzi, batte la Val Mesocco per impedire aggiramenti dal S. Bernardino.
Sono stati costruiti un ce,10 numero di ricoveri presso la frontiera orientale del Canton Ticino, localizzati fra il passo di S. Iorio e quello di S. Lucio.
Nel Cantone dei Grigioni non esistono fortificazioni, ma solo ricoveri ai passi di Cassana, del Lavarone, di Fedria, del Fieno che adducono nella conca di Livigno e probabilmente anche in Val di Campo (a sud est del passo del Bernina) e all'Alpe Valluglia (a sud del lago di Poschiavo).
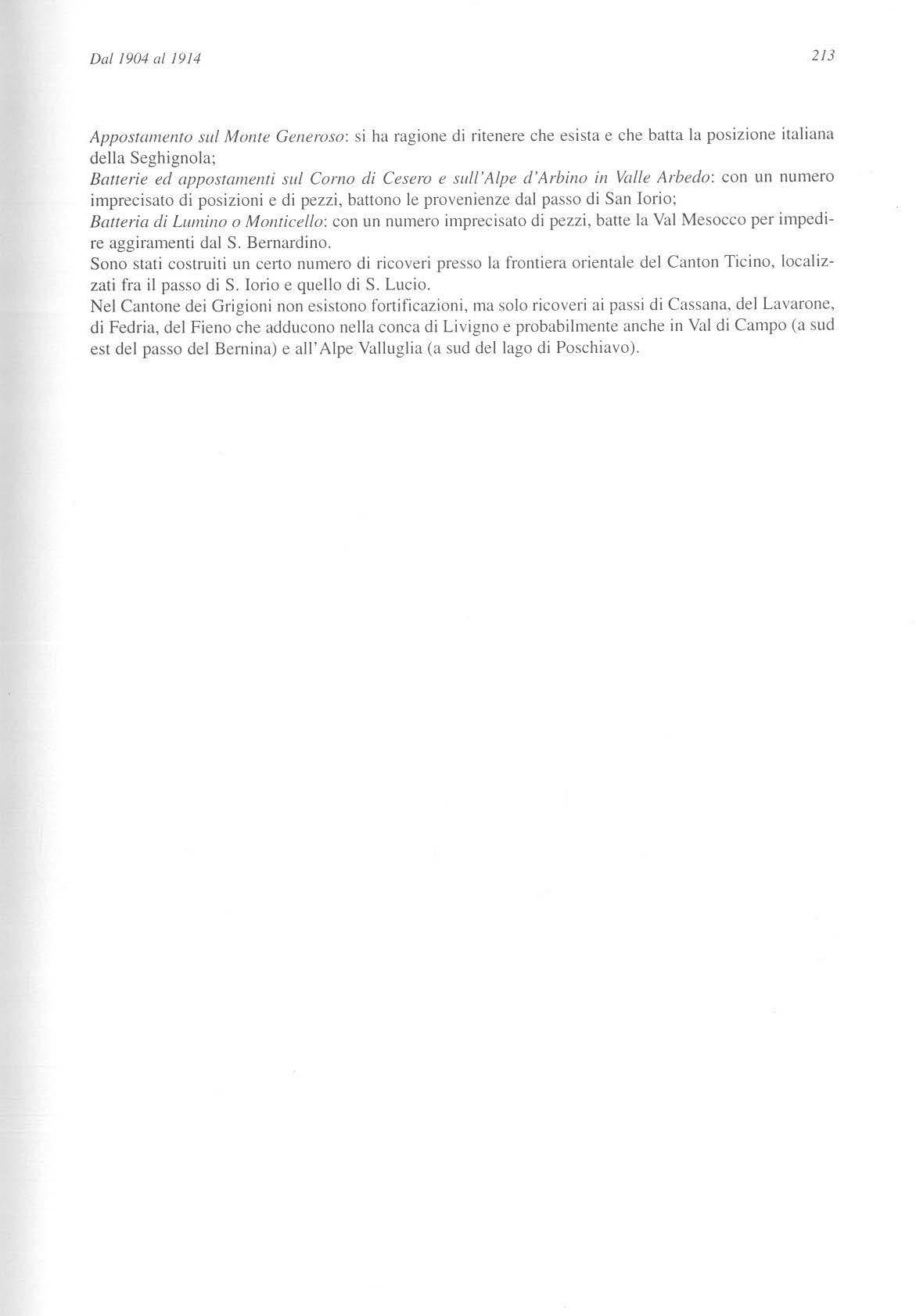
Dal 1904 al 1914 2/3

RIFLESSIONI DOPO L'ESPER I ENZA DELLA la GUERRA MONDIALE
Condizioni generali
In Italia, terminata la guerra, non molti si occuparo no della questione della fo r tificazione permanente che invece, per le ca r atteristiche topografiche affatto particola r i delle fr ontiere i ta l iane, avrebbero meritato ampio e specia le studio.
l poch i tecnici c he tratt arono l'argome nto fu r ono però tutti conco rdi ne l ritenere necessario rafforzare il co nfine montano mediante appostamenti difensivi predisposti fin dal tempo di pace.
Nel primo dopoguerra l 'Ita li a si diba tt é in u na lun ga cris i finanziaria di rilevanti proporzioni che non le permise di tenere sollo le arm i una forza tale da ga rantir e, in og ni circostanza ed in ogni mome nto dell'anno, la cope rtura de l Paese e le operaz i on i cli mob ilita zione, radunata e schieramen to; a maggior ragione quindi fu sen tita l a necess ità che una razionale sistemaz i one difensiva della fr on ti era venisse ad integrare ed a valorizza r e g li sforzi del l e tru ppe di cope r tu ra.
Il maresciallo Cadorna, in una intervis ta rilasciata ne l I925 , dichiarò che ·'l a difesa dei nostr i confini dovrà esse r e ass icurata da una sap i ente ed intensa organizzaz i o ne del terreno più che da un esercito di copertura. "
La Grande Guerra aveva dimostrato a quali disastrose devastazioni siano sogget ti i te rrit or i in vasi dal nem ico e particolarmente quali irrep arabili distruzioni possano essere arrecate alle reg i oni industriali in vase; questo perché le guerre comba ttut e dalle intere nazioni in armi , tendono non so l o all a distruzione della potenza militare del nemico, ma anche e soprattutto alla distruzione della sua potenza economica cd industriale; I' llalia ha prop ri o a ri dosso del confi ne terrestre le regioni più floride, economicamente ed industrialmente parlando, e non è q uindi assolutamente i l caso di affidare la loro si curezza, ne l c ritic o periodo susseguente u na d i c hi ara zione di gue rra, solame nte ad un so ttil e ve l o di u omini, per quanto possano essere valorosi, e ad armi, per quanto perfezionate e letali.
Preso atto quindi della necessitt1 pa rti colarmente se ntita di dotare il paese di un robusto sis tema difensivo, sì rende necessari a un a breve riflessione sulla fo rti f icazio ne e, v i sta la configurazio ne del territorio italiano, in partico lare q ue ll o di montagna, sull a sua genes i, funzione, comp iti , comporta mento, ipotesi cli svi lu ppo, per un razionale sodd is facimento delle esigenze c he ne hanno richiesto la esistenza.
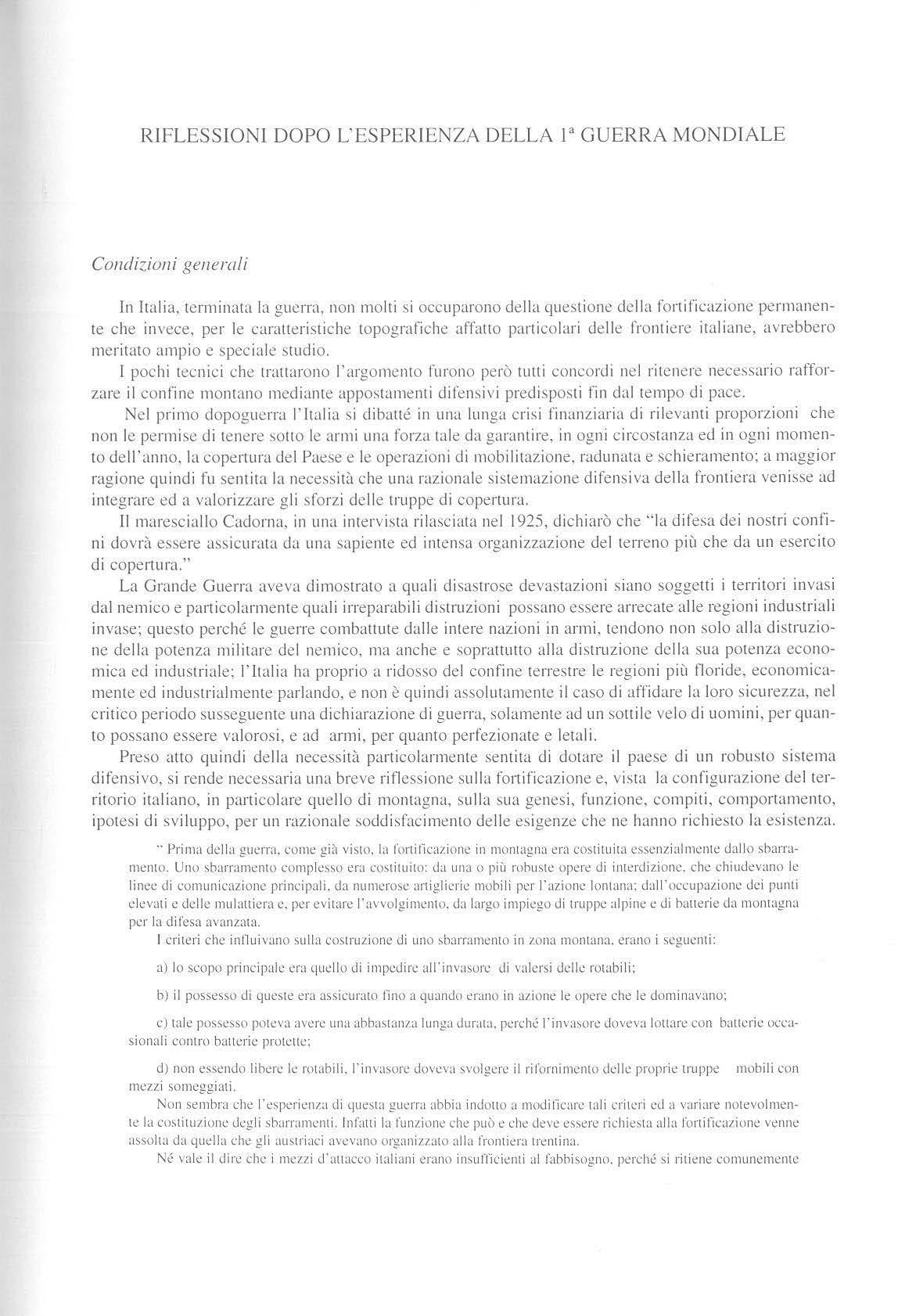
·· P1ima de ll a guerr a. come già visto, la fonifica1. i o ne in mom ag na era costituita esscnzialmentc da ll o sbar r amemo. Uno sbarram..:1110 comp l esso era cost i tuiw: da una o pi ù robuste ope re d i int erd i zio ne c he c hiudevano le lin..:e d i comun i cazione principali. da numerose art i glieri..: mobi li pe r l 'azio ne lontana; dall'nccupaLione dei punti ..:h.:vati e delle mul atti era c. per evitare l 'avvo l gimen t o, da l argo impiego di truppe alpine e di bauerie eia m on t agna pe r la d i fesa avanzata.
I crite r i che iniluivano su lla costruz i o ne di uno sb:i rr ame nt o in zo na m ontana. era no i segu..:nti:
a) l o scopo pri ncipale era qu..:llo di impedire all'in\'asor..: di vale rsi delle r otabi li;
b} i l possesso di queste era assicurato fino a quando erano i n a, i one l e opere che le do min avano;
e} t al e possesso po teva avere una abbastanza lunga <lurat.i p..:rc: hc; l ·inva~or..: doveva l onare con ba t ter i e occusionali contro bancric prote t te;
d} non essendo liben:: le ro t abili. l'invasore doveva svolgere i l rifornimento delle proprk truppe mobili co n m..:zz i someggiat i.
No n sembra che l 'esper i enza d i quo;:s t a gue r ra abbia in dotto a modificare t ali cr it eri ccl a 1·ar ia re notevolmente b co~ti tu1.ion..: d..:gli sbarram..:nti I nfa t t i la funzione eh..: può e c l1e deve essere r ic hiesw alla fo rt ificazio ne venne assolta da q udla eh..: g li aus tr i aci nvernno organ i zz:no alla fron tiera tre nt inn.
Né va l e i l dir..: che i mezzi d'a11acro iwlian i era no in suffi cienti al fabbisog no. perché si ritiene comun..:m..:nt..:
che, in ogni caso. quelle opere avrebbero ritardato l'avanzata italiana per quel tempo che sarebbe stato necessario alla radunata delle forze austriache." 1
Deduzioni sul comportamento delle opere permanenti durante la Grande Guerra.
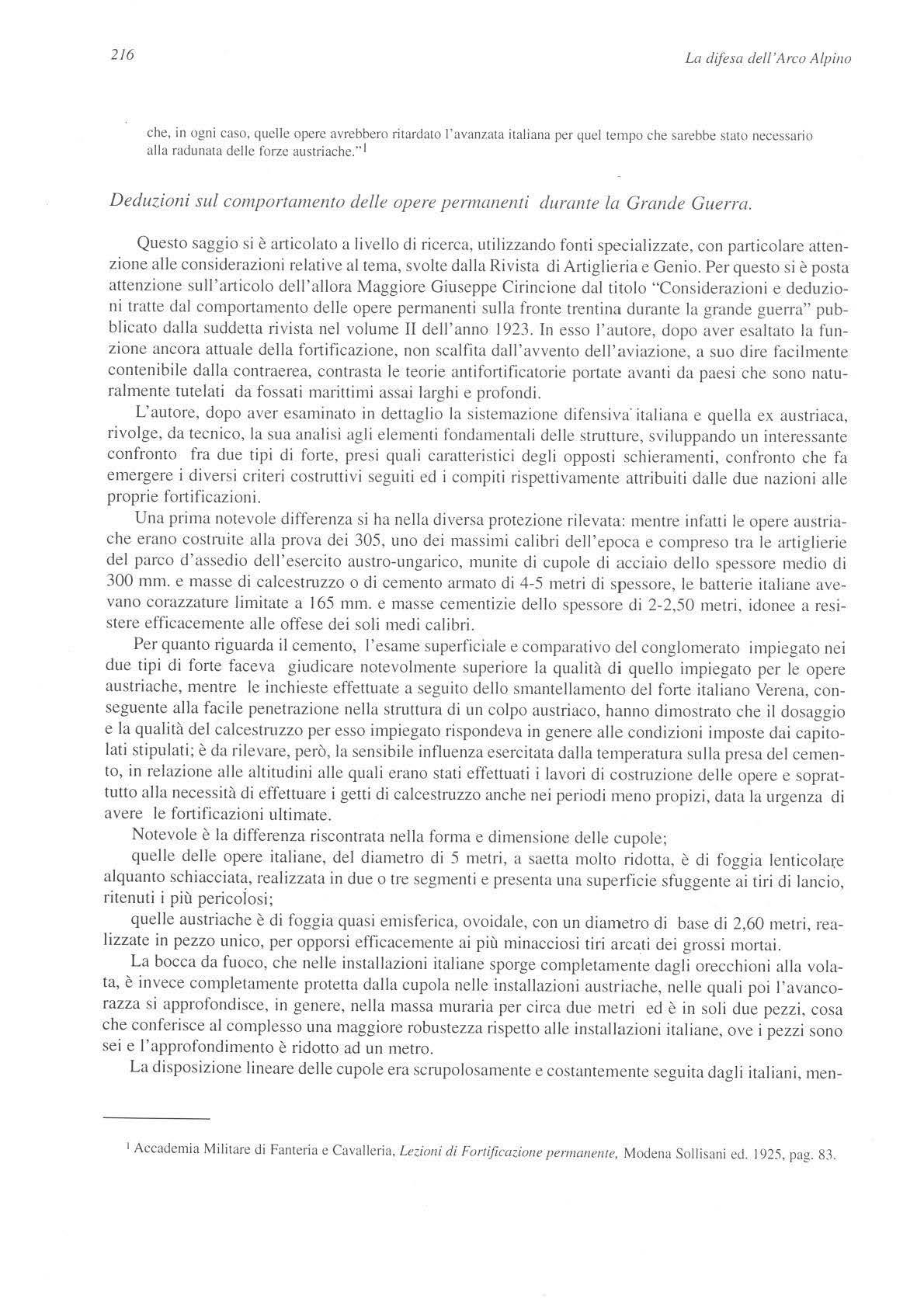
Questo saggio si è articolato a livello di ricerca, utilizzando fonti specializzate, con particolare attenzione alle considerazioni relative al tema, svolte dalla Rivista di Artiglieria e Genio. Per questo si è posta attenzione sull'articolo dell'allora Maggiore Giuseppe Cirincione dal titolo "Considerazioni e deduzioni tratte dal comportamento delle opere permanenti sulla fronte trentina durante la grande guerra" pubblicato dalla suddetta 1ivista nel volume II dell'anno 1923. In esso l'autore, dopo aver esaltato la funzione ancora attuale della fortificazione, non scalfita dall'avvento dell'aviazione, a suo dire facilmente contenibile dalla contraerea, contrasta le teorie antifortificatorie portate avanti da paesi che sono naturalmente tutelati da fossati maiittimi assai larghi e profondi.
L'autore, dopo aver esaminato in dettaglio la sistemazione difensiva· italiana e quella ex austriaca, rivolge, da tecnico, la sua analisi agli elementi fondamentali delle strutture, sviluppando un interessante confronto fra due tipi di forte, presi quali caratteristici degli opposti schieramenti, confronto che fa emergere i diversi criteri costruttivi seguiti ed i compiti rispettivamente attribuiti dalle due nazioni alle proprie fo1tificazioni.
Una prima notevole differenza si ha nella diversa protezione rilevata: mentre infatti le opere austriache erano costruite alla prova dei 305, uno dei massimi calibri dell'epoca e compreso tra le artiglierie del parco d'assedio dell'esercito austro-ungarico, munite di cupole di acciaio dello spessore medio di 300 mm. e masse di calcestruzzo o di cemento armato di 4-5 metri cli spessore, le batterie italiane avevano corazzature limitate a I 65 mm. e masse cementizie dello spessore cli 2-2,50 metri, idonee a resistere efficacemente alle offese dei soli medi calibri.
Per quanto riguarda il cemento, l'esame superficiale e comparativo del conglomerato impiegato nei due tipi di forte faceva giudicare notevolmente superiore la qualità di quello impiegato per le opere austriache, mentre le inchieste effettuate a seguito dello smantellamento ciel forte italiano Verena, conseguente alla facile penetrazione nella struttura di un colpo austriaco, hanno dimostrato che il dosaggio e la qualità del calcestruzzo per esso impiegato rispondeva in genere alle condizioni imposte dai capitolati stipulati; è da rilevare, però, la sensibile influenza esercitata dalla temperatura sulla presa del cemento, in relazione alle altitudini alle quali erano stati effettuati i lavori cli costruzione delle opere e soprattutto alla necessità di effettuare i getti di calcestruzzo anche nei periodi meno propizi , data la urgenza di avere le fortificazioni ultimate.
Notevole è la differenza riscontrata nella forma e dimensione delle cupole;
quelle delle opere italiane, ciel diametro di 5 metri, a saetta molto ridotta, è di foggia lenticola(e alquanto schiacc i ata, realizzata in due o tre segmenti e presenta una superficie sfuggente ai tiri di lancio, ritenuti i più pericoiosi;
quelle austriache è di foggia quasi emisferica, ovoidale, con un diametro di base di 2,60 metri, realizzate in pezzo unico, per opporsi efficacemente ai più minacciosi tiri areati dei grossi mortai.
La bocca da fuoco, che nelle installazioni italiane sporge completamente dagli orecchioni alla volata, è invece completamente protetta dalla cupola nelle instal lazioni austriache, nelle quali poi l'avancorazza si approfondisce, in genere, nella massa muraria per circa due metri ed è in soli due pezzi, cosa che conferisce al complesso una maggiore robustezza rispetto alle installazioni italiane, ove i pezzi sono sei e l'approfondimento è ridotto ad un metro.
La disposizione lineare delle cupole era scrupolosamente e costantemente seguita dagli italiani, men-
216 La difesa dell'Arco Alpino
1 Accademia Militare di Fanteria e Cavalleria, Le-:,ioni di For1ijicazione pen11a11e111e. Modena Sollisani ed l 925, pag. 83.
tre le esigenze del terreno erano pienamente sfruttate dagli austriaci nel disporre l e cupole delle loro opere, alcune delle quali realizzate in cemento ed appropriatamente disposte per trarre in inganno l'avversario.
L'analisi precedentemente svolta aveva per il Cirincione un carattere tecnico ed era servita a mettere in evidenza l 'esistenza di d ue diverse scuol e ma, a suo parere, è la diversa funzione assegnata all'opera che ne aveva caratterizzato la diversa struttura ed il diverso armamento.
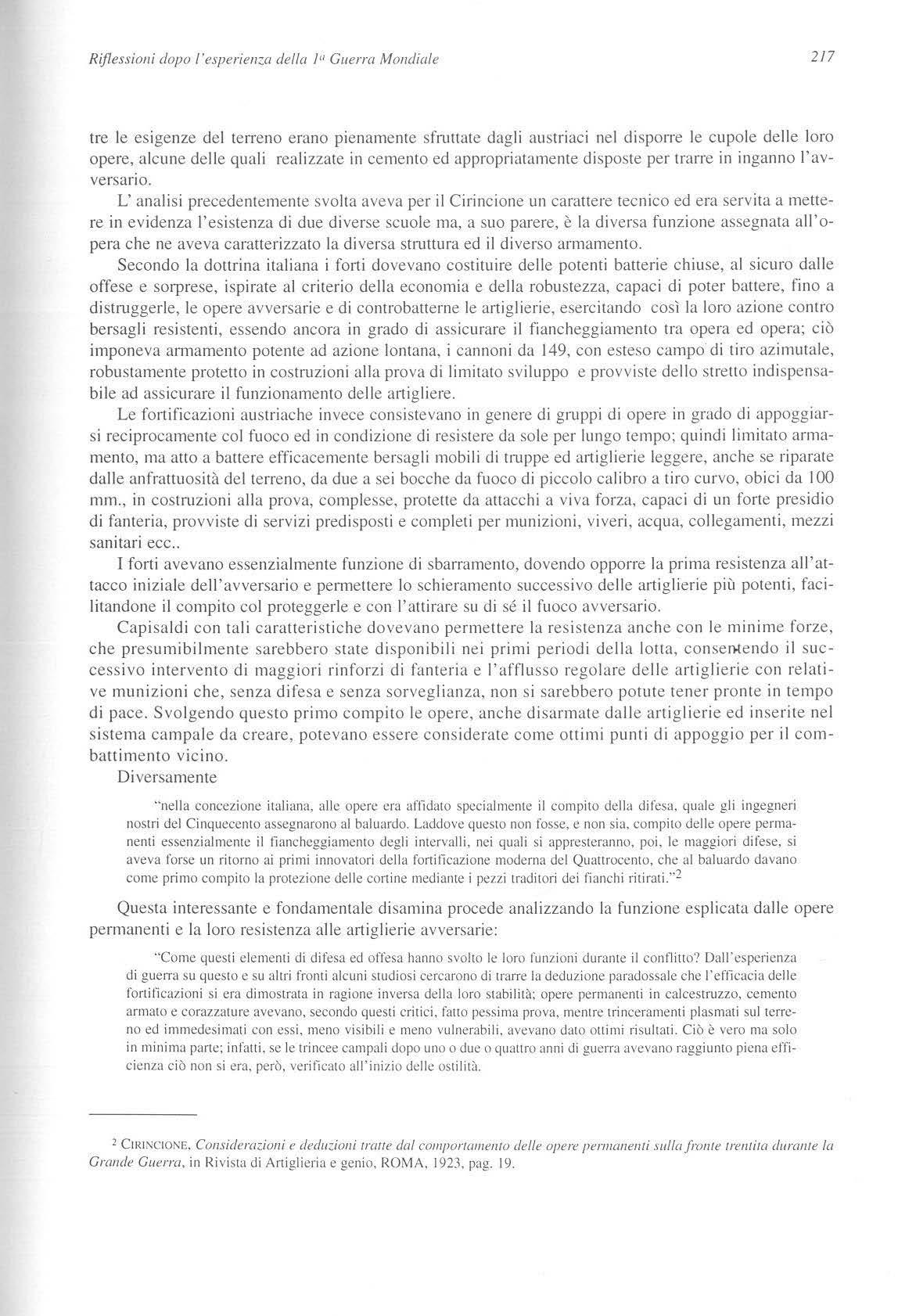
Secondo la dottrina italiana i forti dovevano costituire delle potenti batterie chiuse, al sicuro dalle offese e sorprese, i spirate al criterio della econom i a e della robustezza, capaci di poter battere, fino a distruggerle, le opere avversarie e di controbatterne le artiglierie, esercitando così la loro azione contro bersagli resistenti, essendo ancora in grado di assicurare il fiancheggiamento tra opera ed opera; ciò imponeva annamento potente ad azione lontana, i cannoni da 149, con esteso campo cli tiro azimuta le, robustamente protetto in costruzioni alla prova di limitato svi luppo e provviste dello stretto indispensabile ad assicurare il funzionamento delle ai1igliere.
Le fortificazioni austriache invece consistevano in genere di grnppi di opere in grado cli appoggiarsi reciprocamente col fuoco ed in condizione cli resistere eia sole per lungo tempo; quindi limitato armamento, ma atto a battere efficacemente bersagli mobili di truppe ed a11iglierie l eggere, anche se riparate dalle anfrattuosità del terreno, da due a sei bocche da fuoco di piccolo calibro a tiro curvo, obici da I 00 mm., in costruzioni all a prova, complesse, protette eia attacchi a viva forza, capaci di un forte presidio cli fanteria, provviste di serv izi predisposti e completi per munizioni, viveri, acqua, collegamenti, mezzi sanitari ecc
I forti avevano essenzialmente funzione di sbarramento, dovendo opporre la prima resistenza all'attacco iniziale dell'avversario e pennettere lo schieramento successivo delle artiglierie più potenti, facilitandone il compito col proteggerle e con l'attirare su cli sé il fuoco avversario.
Capisaldi con tali caratteristiche dovevano permettere la resistenza anche con le minime forze, che presumibilmente sarebbero state disponibili nei primi periodi della lotta, consentendo il successivo intervento di maggiori rinforzi di fanteria e l'afflusso regolare delle artiglierie con relative munizioni che, senza difesa e senza sorveglianza, non si sarebbero potute tener pronte in tempo di pace. Svolgendo questo primo compito l e opere, anche disarmate dalle artiglierie ed inserite nel sistema campale da creare, potevano essere considerate come ottimi punti di appoggio per il combattimento v icin o.
Diversamente
·'nella concezione italiana, alle opere era affidato specialmente il compito della difesa. qua l e gli ingegneri nostri del Cinquecento assegnarono al baluardo. Laddove questo non fosse, e non sia , compito delle opere pennanenti essenzialmente il fiancheggiamento degli intervalli, nei quali si appresteranno, poi, le maggiori difese, si aveva forse un ritorno ai primi innovatori della fonificazione moderna del Quattrocento, che al baluardo davano come primo compito l a protezione delle cortine mediante i pezzi traditori dei fianchi ritirati.'·2
Questa interessante e fondamentale disamina procede anal iz zando la funzione esplicata dalle opere permanenti e la loro resistenza alle a11iglierie avversarie:
"Come questi elementi di difesa ed offesa hanno svolto le loro funz i oni durante il conflitto? Dall ' esperienza di guena su questo e su altri fronti alcuni studiosi cercarono di trarre la deduzione paradossale che l'efficacia del l e fortilìcazioni si era dimostrata in ragione inversa de lla l oro stabi lit à; opere permanenti in ca l cestruzzo, cemento armato e corazzature avevano, secondo questi critici, fatto pess im a prova, mentre trinceramenti plasmati sul terreno ed immedesimati con essi, meno visibili e meno vulnerabi l i, avevano dato ottimi risultati. Ciò è vero ma so l o in minima parte; infatti. se le trincee campali dopo un o o due o quattro anni di guerra avevano raggiunto piena eflìcienza ciò non si era, però. ver i ficat o all'in i zio dt!lle osti lit à.
Riflessioni dopo l'esperienza della i" Guerra Mondiale 217
2 CiRINCIONE, Co11siderazio11i e ded11zio11i trcllle dal co111portame1110 delle opere pen11a11e111i sulla fmnle 1re11tila d11ra111e la Grande Guerra, in Rivista di Artiglieria e genio, ROMA. 1923, pag. 19.
L'influenLa delle difese permanenti durnme la guerra appare chiara ed e\'idente esaminando lo svolgimento delle operazioni che in breve e limitatamente alfa frome considerata, vengono di seguilo richiamate."3
Analizzando lo svi lu ppo delle operazioni, ed a suffragare le proprie teorie sulla utilità del l e opere fortificate, Cirincione rileva come nel maggio del I 9 I 5, ali' inizio della guerra, gli austriaci, poiché erano nel Trentino in minime forze, assunta un'attitudine strettamente difensiva, ammassarono le proprie truppe dietro lo sbarramento dei forti e l asciarono che gli italiani occupassero la zona compresa tra il loro primitivo schieramento e la linea della difesa permanente; fin dal 24 maggio perciò gli italiani poterono conquistare alcuni obiettivi dislocati in tali zone, mentre la lotta delle a11iglierie tra le opposte fortificazioni non diede risultati di notevole entità a nessuno dei due contendenti.
Talvolta la limitata distanza tra l e opere italiane, spinte avanti per occupare posizioni importanti e dominanti, e le opere austriache, molto avanzate rispetto al conf in e per artuare il concetto di un valido appoggio offensivo, po11ò ini zia lmente alla lotta tra le artiglierie delle opere stesse, anche se questo non era tra i compiti delle opere permanenti.
L'avanzata sulla fronte montana continuò per alcuni giorni, fino a che non fu arrestata dal Forte cli Panarotta e dalle opere di Larclaro, rispettivamente in Val Sugana e nelle Giudicarie. Analogamente in Trentino, dopo pochi giorni, l o schieramento venne ad aderire quasi dappertutto alla linea dei forti austria c i e da allora non si ebbero sostanzia li progressi, pur continuando un'alterna vicenda di avanzate e di ripiegamenti nei tratti non coperti da sbarramenti fortificati: su questi, il tiro italiano, pur riuscendo a danneggiare qualche cupola, non riuscì mai ad indebolirne l'insieme. L'avanzata parziale poté progredire soltanto in Val Lagarina, dove la costruzione dei forti era appena iniziata, in Vallarsa, dove non erano ancora ultimati, sul Pasubio e su Col Santo , dove non vi erano opere permanenti.
Anche ad oriente della Val Sugana l e rettifiche alla linea cli combattimento furono assai modeste per l a presenza delle fort ificazioni permanenti costruite a breve distanza dal confine: si ebbero azioni limitate nella zona del Passo di Rolle, sbarrato dai fo11i di Paneveggio e caute offensive nella zona cli Livinallongo, dove i forti chiudevano l'accesso al Passo Pordoi, mentre più ad est le opere cli Falzarego bloccavano ogn i slancio italiano. Nella zona di Misurina i forti di Landro imponevano arres t o alla prosecuz i one e se l'intenso e prolungato bombardamento de ll e sistemazioni permanenti poste a difesa del principale sbocco orientale, la conca di Tarvisio, ebbe ragione del vecchio forte Hensel all a stretta di Malborghetto, non si riuscì ad eliminare le opere eretle a passo ciel Predii.
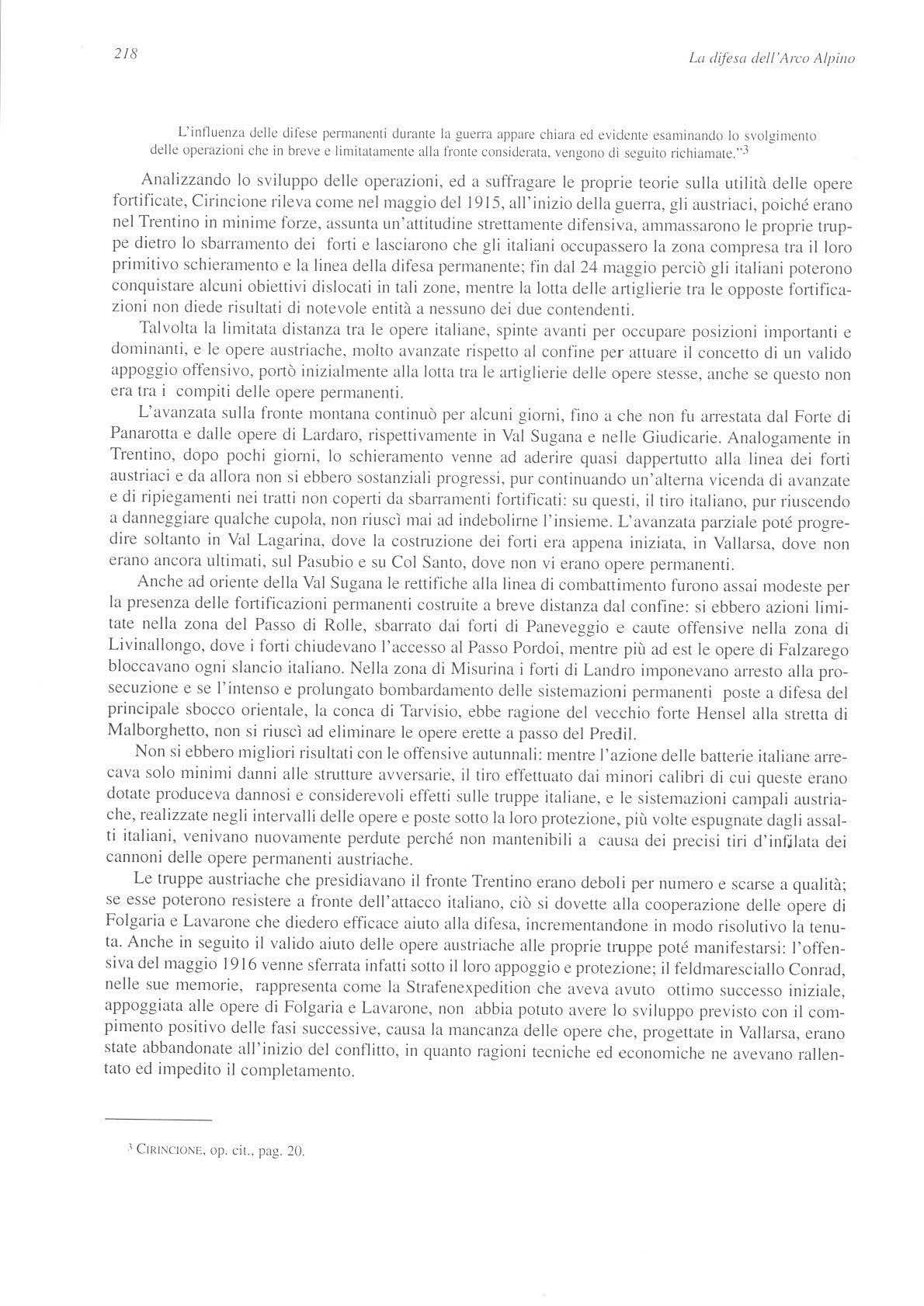
Non si ebbero migliori risultati con le offensive autunnali: mentre l'azione delle batterie italiane arrecava solo minimi danni alle strutture avversar ie, il tiro effettuato dai minori calibri di cui queste erano dotate produceva dannosi e considerevoli effetti sulle truppe italiane, e le sistemazioni campa li austriac he, realizzate negli intervalli delle opere e poste sotto la l oro protezione, più volte espugnate dagli assalti italiani, venivano nuovamente perdute perché non mantenibili a causa dei precisi tiri cl'infjlata dei canno ni delle opere permanenti austriache.
Le truppe austriache che presidiavano il fronte Trentino erano deboli per numero e scarse a qualità; se esse poterono resistere a fronte dell'attacco italiano, ciò si dovette a ll a cooperazione delle opere cli Fo lgari a e Lavarone che diedero efficace aiuto alla di fesa, incrementandone in modo risolutivo la tenuta. Anche in seguito il val id o aiuto delle opere aust ri ache alle proprie truppe poté manifestarsi: l'offensiva del maggio 19 I 6 venne sferrata in falli sotto il l oro appoggio e protezione; il feldmaresciallo Con rad, nelle sue memorie, rappresenta come la Strafenexpedition che aveva avuto ottimo successo iniziale, appoggiata alle opere di Folga ri a e Lavarone, non abbia potuto avere l o sviluppo previsto con il compimento positivo delle fasi success ive, causa la mancanza delle opere che, progettate in Vallarsa, erano sta te abba ndonate al l ' inizi o del confl itto, in quanto ragioni tecniche ed economiche ne avevano rallentato ed impedito il completamento.
218 La difesa dell'Arco Alpino
CmrNcrorsr:. op. cii.. pag. 20.
'
Come emerge dallo studio de ll o sviluppo delle operazioni, l a sistemazione difens i va italiana non ebb e modo e tempo sufficiente per esplicare la sua funzione: il 14 giugno del 1915, dopo un tiro protrattosi per alcune ore, un colpo del mortaio da 305, che da più giorni dirigeva il suo fuoco sull'opera italiana di Verena penetra to fortu nosamente nell'opera attrave rso una intercapedine r icavata sulla fronte principale a protezione dall'umidità, scopp i ando uccideva alcuni mi li tari, coma ndante compreso e metteva fuori combattimento c irca due terzi del personale; nei g i orni success i v i i I forte, che non era stato seri amente compromesso nell'efficienza, riprese il tiro con una nuova guarnig i one, ma l'evento aveva talmente colpito le autorità superiori da determ in arl e a d i sporre i l disarmo di tutte le opere e l a col l ocaz i one de lle l oro artiglierie in postazioni allo scopert o.
L'adozione de l provvedimento di disarmo suscitò numerose cr i tiche, in quanto gettava il disc redito sull e opere, a nche le p i ù moderne, buttava al l'ar ia l 'asse ll o difens i vo, svalutando l ' im portanza delle pos i zion i di sbarramen to, avveniva (mese di luglio), quando l'opera, che aveva ripreso l a propria attività, nonostante il con tinu o ed intenso tiro avversario, aveva avu to fuori serv i zio solo d ue cupole. prova della bontà del l a struttura e della fo r tu ità dell'evento dannoso.
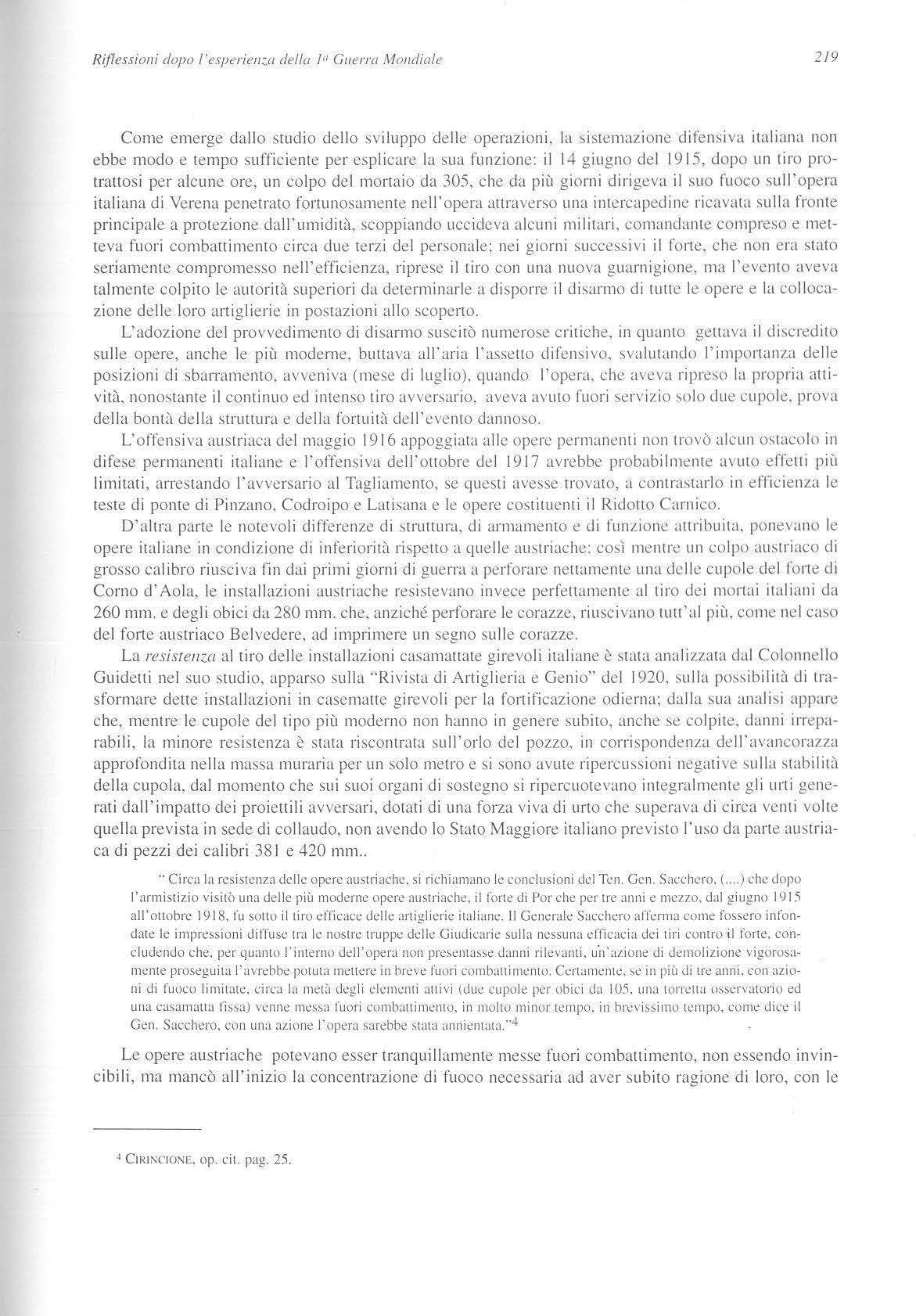
L'offens i va austr i aca del magg i o I 916 appoggiata a ll e opere perma nent i non trovò alcun ostacolo in difese permane nti ita li ane e l' offe nsiva de ll 'o tt o bre del I 917 avrebbe probab ilmen te avu to effetti più limitat i, arrestando l'avversario al Tagliamento, se ques ti avesse trovato, a contrastarlo in effici enza le teste di p onte di Pinzano, Codroipo e L at i sana e le ope re cos titu en ti il Ridotto Carnico.
D'altra parte l e notevo li diffe renze di strut tura, di armamento e di funzione attribuita, ponevano le opere italiane in cond i zio ne di inferioritl1 ri spe tt o a quelle aus tr iache: così mentre un co l po austriaco di grosso calibro riusciva fin dai primi giorn i cli guerra a perforare netta mente una delle cupole del forte di Corno d' Aola, le in stalla zioni austriache resistevano in vece perfettamente al tiro dei mortai italiani da 260 mm. e degli obic i da 280 mm. che, anz i ché perforare le corazze, riuscivano tu tt'al pi ù , come ne l caso del forte austr i aco Belvedere, ad imprimere un segno su ll e corazze.
L a resistenza al tiro del l e in stal l azioni casamattate girevoli itali ane è stata anal i zzata dal Colonnello Guidetti ne l su o stud i o, apparso sulla "R i vista di Artiglieria e Genio" del 1920, su ll a possibilità cli trasformare dette installazioni in casematte girevo li per l a fortificaz i o ne odierna; dalla sua anal i si appa re c he, mentre le cupo l e del tipo più moderno non hanno in genere subit o, anche se colpi te, dan ni irreparabi li , l a minore resistenza è sta ta riscontrata sull'orlo del pozzo, in corrisponde nza dell'avancorazza approfo ndila nella massa muraria per un solo metro e si sono avu te ripercussioni negative sulla stab ilit à della cupola, dal momento che sui suoi organi di sostegno si ripercuotevano integralmente g li urti generat i dall'impatto dei proiettili avversari, do ta ti di una forza viva di urto che superava di c irca ven ti volte quella prevista in sede di co l laudo, non avendo lo Stato Maggiore italiano previsto l 'uso da pa rt e au striaca di pezzi dei calibri 381 e 420 mm
· Circa la res i ste nza delle opere aus triache. si richiama no l e co nc lusio ni dd Tcn. Gen. Sacc he ro ( ) che dopo l'armistizio v i sitò una del l e più moderne opere austr i ache, il forte d i Por che per ire an ni e mezzo dal g iu g no 191.'i all'ouobre 1918. fu so t to il t iro effi cace delle artig li er ie ita li ane. I l Genera l e Sacchero alTt!rma come fossero in fonda te le i m p ressio ni diffuse Ira l e nosln.: truppe delle Gi ud i carii.: su l la nessuna effi cac i a elci ti r i contro i l forte, conc.:l uclcnclo che. per quamo l'imerno dell'opera non p rese nt asse dann i r ilevant i. u·n aL i one d i demol i zione vigorosamente proseguita l' av rehhe po tu rn mi.:ll ere in breve fuori comba11imc nt o. Certa me nt e, se in più ùi ire anni. co n azioni di f uoco li m it ali.:. circa la mctì, degli clcmcnl i :i11iv i (due cupo l e per obici da I O.'i. un:i 101Tclla osse r vator i o ed un a casa m all.t fi ss.i) venne messa fuor i comba 11 i111e nto. in molto minor tem po. in brevissimo tem po. come dice i l Gen Sacchero. co n una aLio ne l' opera sarebbe staia annien taia."
Le opere austriache potevano esser tranquillam ente messe fuori combattimento, non essendo in vi ncibili, ma mancò al !' inizi o la concentrazione di fuoco necessari a ad ave r sub ito ragione di loro, con l e
Riflessioni dopo I ·esperie11::,a della I" Guerra Mondiale 2/9
4
4 CIRIKCIO~E. op ci i. pag. 25.
gravi conseguenze che noi tutti conosciamo.
Da questo esame minuzioso e preciso, condotto con perizia dal Cirincione, ba lza evidente quello che è lo scopo principale della disamina, l'enunciazione di quelli che dovrebbero essere i criteri da adottare nell'organiuazione delle sistemazioni difensive in montagna, sistemazioni che già dall'inizio di questo articolo, egli ritiene necessarie e vitali per tutelare i raggiunti confini. Base chiara e netta è che la fortificazio ne andava rivista e trasformata, essendo necessaria, ma che per la realizzaz ione da attuare sui nuovi confini raggiunti al termine del primo conflitto mondiale non potevano c~sere utilizzati i criteri edificatori precedentemence adottati, le cui pecche erano emerse con sufficiente chiarezza; il comportamento dei forti nel corso della guerra, infatti, non aveva dimostrato il fallimento della fortificazione permanente bensì la necessità d i una sua trasformazione .
Le direttive delle autorità superiori di cui siamo a conoscen,a lasciano 1ntra\'edere come la sistemazione permanente odierna debba ispirarsi a quella campale, attuando il criterio del rafforz:imento in superficie con dementi dis~eminati al posto della dife~a lineare e continua; si avranno. quindi, zone di sbarramento. a cavallo delle principali comunicazioni. costituite secondo le direuive delle Norme per l'impiego uelle Grandi Unità nella difesa'' emanate dal Comando Supremo nell'ottobre del 1918" 5
che prevedono, come si evince dalla loro lettura, una organizzazioni a duplice fascia: fascia d'osservaz ione e dietro ad essa fascia di resistenza, suddivisa in strisce di combattimento, dei rincalzi, e delle riserve, studiate nei loro minimi particolari e portate a integrale conoscenza delle truppe destinate alla copertura.
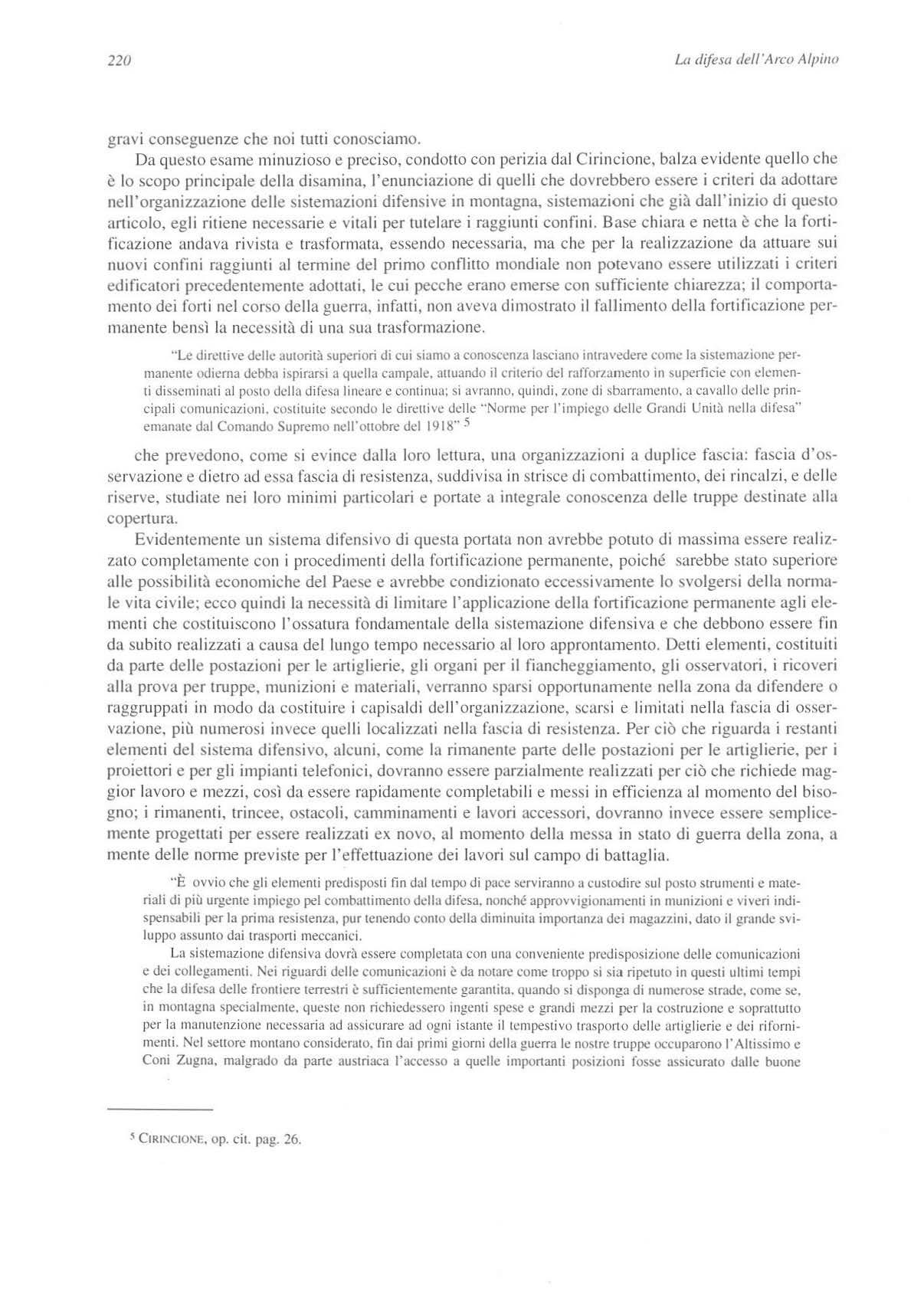
Evidentemente un sistema difensivo di questa portata non avrebbe potuto di massima essere realizzato comp letamente con i procedimenti della fortificazione permanente, poiché sarebbe stato superiore alle possibilità economiche del Paese e avrebbe condizionato eccessivamente lo svolgersi della normale vita civile; ecco quindi la necessi1à di limitare l'applicazione della fortificazione permanente agli elementi che costituiscono l'ossatura fondamentale della sistemazione difensiva e che debbono essere fin da subito realizzat i a causa del lungo tempo necessario al loro approntamento. Detti elementi, costituiti da parte delle postazioni per le artiglierie, gli organi per il fiancheggiamento, gli osservatori, i ricoveri alla prova per 1ruppe, munizioni e ma teriali, verranno sparsi opportunamente nella zona da difendere o raggruppati in modo da costituire i capisaldi dell'organizzazione, scarsi e limitati ne ll a fascia cli osservazione, più numerosi invece quelli localizzati nella fascia di resistenza. Per ciò che riguarda i restami elementi del sistema difensivo, alcuni, come la rimanente par1e delle postazioni per le artiglierie, per i proiettori e per gli impianti 1elefonici, dovranno essere parzia lmente realizzati per ciò che richiede magg ior lavoro e mezzi, così da essere rapidamente completabi li e messi in efficienza al momento de l bisogno; i rimanenti, trincee, ostacoli, camminamenti e lavori accessori, dovranno invece essere semplicemente progettati per essere realizzali ex novo, al momento della messa in stato di guerra della zona, a mente delle norme previste per l'effettuaz ione dei lavori sul campo di battaglia.
"È ovvio che gli elementi predisposti fin dal tempo di pace M:rviranno a custodire sul posto strumenti e materiali di più urgente impiego pel combattimento della difesa. nonché approvvigionamenti in munizioni e , i veri indispensabili per la prima resisten:rn. pur tenendo conto della diminuirn imponanla dei magauini, dato il gr:111de sviluppo assunto dai trasponi meccanici.
La sistemazione difensiva dovrà essere compleiata con una conveniente predisposizione delle comunicazioni e dei collegamenti. Nei riguardi delle comunicalioni è da notare come troppo si sia ripetuto in questi ultimi tempi che la difesa delle frontiere terrestri è sufficientemente garantita, quando si dbponga di numerose strade, come se, in montagna specialmente, que::ste non richiedessero ingenti spese e grandi mezzi per la costruzione e soprattutto per la manutenzione necessaria ad assicurare ad ogni is tante il tempest ivo trasporto delle artigl ierie e dei rifornimenti. Nel settore montano considerato, fin dai primi giorni della guerra le nostre truppe occuparono l'Altissimo e Coni Zugna, malgrado da pane austriaca l'accesso a quelle imponanti posizioni fosse assicurato dalle buone
220 La difesa dell'Arco Alpino
CIR1-.:c10/I.C,
op. cit. pag. 26.
Riflessioni dopo l'esperienza della Ja Guerra Mondiale
cam i onali che portavano ai costruendi forti del Vignota e e.letto Zugna. e che vi fossero anche e.lei cannoni che, primi trofei di guerra, caddero nelle mani delle nostre fanterie prima ancora di poter iniziare i l tiro. Certamente, comunicazioni e collegamenti, dimostratisi di tanta importanza, dovranno essere predisposti in conveniente misura ed in modo da poter essere opportunameme svi l uppati ed amplificati; ma rappresenteranno sempre un complemento delta sistemazione, per quanto necessario ed indispensabile.
Per logica conseguenza dovranno anche essere apprestate con massima cura nei punti più convenienti le int<::rruzioni stradali, alto scopo di poter imped ire all'avversario. che si fosse reso padrone di parre de tt a zona, di usufruir delle comunicazioni fin da l primo momento della sua occupazione:·6
Allorché si passa ad esam in are la sistemazione dell'artiglieria, scaturisce la grande importanza, fra gli elementi da valutare, della scelta del tipo di installazione e di bocca da fuoco. Basandosi s ull a esperienza della g uerra sembra opportuno fare ricorso a postazioni permanenti protette solo per le artigl ierie destinate a svolgere azione di sbarramento ed interdizione vicina, limitandosi ai casi in cui tali tipi di int ervento rappresentino una inderogabile necessità e per i quali la limitata estensione del fronte da difendere consenta di pervenire allo scopo avva lendosi di un numero limitato di pezzi.
Dovranno pertanto essere realizzate sistemazio ni permanenti per piccoli ca li bri a tiro rapido, ricorrendo ai medi ca libri solo in casi eccezionali, quando per le speciali caratteristiche del terreno le artiglier ie dello sbarramento abbiano dovuto prendere posizione a notevole distanza dalla zona da sbarrare o quando si preveda di effettuare all'inizio delle operazioni un tiro di distrnzione con carattere di notevole continuità .
L e ope re austriache, armate con obic i ad azione ce lere, generalmente pezzi da I 00 mm. robustamente corazzati, consentirono la valida resistenza a ll e proprie truppe, che abbiamo visto essere di età avanzata e scarsamente addestrate, offrendo loro possibilità di ristoro e benessere, utilizzando i locali e g li impianti di cui erano dotate, permettendo l'azione efficace dei maggiori calib ri col dare sicurezza e protezione. Sugli altipiani, l' attuazione dei concetti della "scuo la della separazione della difesa vicina dalla lontana" è risultata premiante.
"Rilevano gli anig l ieri come la necessità di poter osservare bene il tiro imponga il chiaro orientamento sul terreno, l a conoscenza esatta de i bersagli, la prevent i va sistemazione degli osservatori e dei co l legamenti, operazion i lung he e diffici l i che portano ben lontano dalla bri l lan tt: presa di posizione d'altri tempi, fatta arrivando al galoppo, staccando rap id amente g li avantreni cd iniziando il tiro; durante la g uerra i l vo l er richiedere subito il fuoco a batterie appena giu nte si è spesso d i mostrato pericoloso, specialmente per battere bersagli vicini alte truppe amiche.
Ne consegue a parer nostro l a necessi tà di avere qualche batteria predisposta fin dal tempo di pace, arma ta con bocche da fuoco moderne per sopper ire così con l a qualità atta deficienza delta quan tità poiché l e opere pennanenti saranno di vera u ti lità solo se in tu tt o moderne e non dota te di ar mam ento racco l to tra l e artig li erie fuori uso o quasi, come talora si fece in passato, e messe q ual che vo lt a ag l i ordi ni di comandanti scelti tra i non idonei al coma ndo d i unità campali.?
Q ui nd i le art i glierie c he dovranno esser;;: sul posto co n tu tti i dispositivi in erent i al funzionamento, pronte ad ogni istante ad entrare in azione, dovrebbero ..:sserc cost itu ite da bocche da fuoco moderne di minori calibri, a tiro c urvo se debbono agire in terreno accidentato, q uale si avrà gener almente in montagna, dotate di grande celeri tà di t iro, dest in ate atta difesa vic in a per sostenere le sca rse truppe d i copertura, agendo non su bersagli resistenti, ma sulle p rim e an im ose truppe dell'attacco con azione di fuoco pronta e potente, e mercé la c ui protezio ne, in secondo tempo, entrera nno in ca mpo i medi ed i grossi ca l ibri per cos ti tuire una barriera più sa l da e per abbattere le eventuali resistenze nemic he e preparare l' azione offens i va: &
6 CiRINCJONE, op. cit. pag. 29-30.
7 Non opere permanenti, ma Raggruppamenti art igli eria G.a.F. verranno prevalentemen tt: armati, per c.lifenderc l e frontiere italiane co n pezzi raccolti fra l e prede belliche della Grande Guerra a dimostrazione di quanto siano state tenute nel giusto con to le considerazion i form ulate, a suo tempo, dal Maggiore Cirincione
8 CIRINCtONE, op ci t. pag. 29-30.
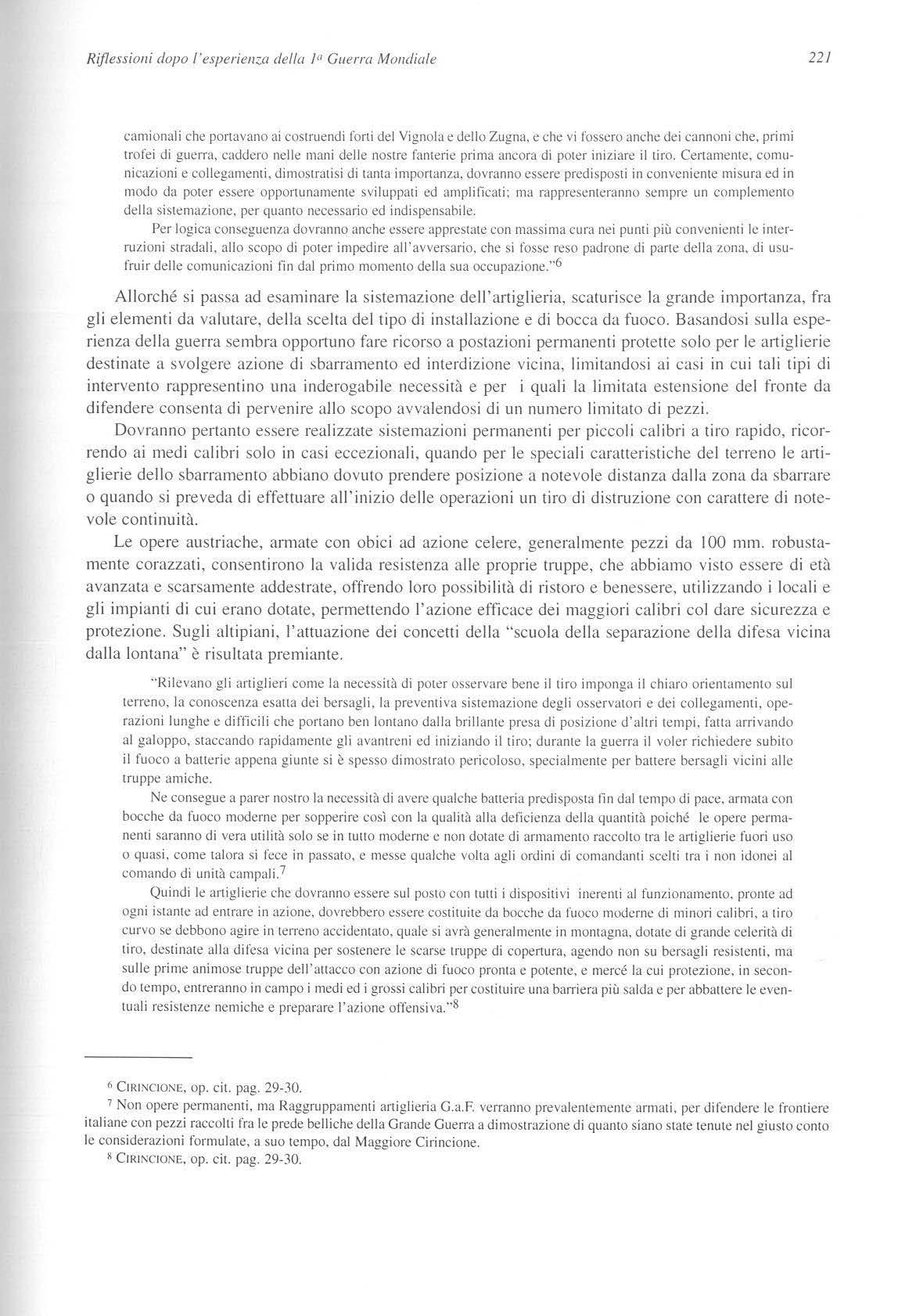
221
Cirincione, dopo aver delineato un quadro che troverà successivamente riscontro nell'organizzazione della fascia di frontiera, dichiara di ritenere che le artiglierie in installazione fissa non devono avere le stesse caratteristiche di quelle impiegate dalle unità mobili; il peso non dovrà essere preso in considerazione, permettendo così di realizzare un materiale cli maggior rendimento; la iniziale limitata disponibilità di personale conoscitore dell'arma imporrà, sia come azioni offensive che come protezione, il migliore, più redditizio ed oculato impiego di queste bocche da fuoco. Di pari passo, colla sistemazione deg li osservatori, dei collegament i , dei rifornimenti e della preparazione al tiro, si dovrà provvedere anche a dare l a massima protezion e alle bocche da fuoco che non dovranno essere allo scoperto, ma in caverna od in cupola, occultate in idonee posizioni che, defilate alla vista, ne consentano l 'impiego a tiro indiretto. Quando il terreno ne consente una razionale costruzione. la postazione in caverna deve essere co nsiderata ottima soluzione, anche se sono ben note le remore 9 che gli artiglieri hanno per ta l e tip o di sistemazione, cui imputano numerosi in convenienti fra cui, in primo luogo . l a limitazione del sertore di tiro.
"Ma gli inconvenienti l.imo;:ntu t i e spec ialme nt e la li mita zione del ~cuore d i tiro. potranno r idurs i no tevo lm ent e per le piccol e artigl i erie .idottando u n affusto da caverna, che non sc mbrn difficile proge u are. né oneroso rnstruire. per il ma teriale a ddo rm azione che presumibilmente ve rri't impiegato. riproducendo. opportunament e mod i ficato, l'affus to Grnson -K rupp per mcd i cali bri in ca$emaue f is se o altri affus ti giì1 progcllati. 10
In emrambi i modi si verrebbe a lim it ar..: J,1 v uln erabilità della cannoniera. r iduce nd o ne le dimensioni se nza diminuire no tevo lm eme i se u o ri di tiro, ment re i l tipo cli affusto da caverna. già stu d iat o dal Colonnel l o Gu i c.lclli, elimina l e d i ffic oltà che si p rese ntano per la conveniente siste mali o nc clei medi calibri a grande lunghezza cl'anima.
Qua ndo il terre no non si pres ti a r icavarn e caverne, si potrà ricorrere invece all e postazioni in cupola. c l1 e hann o clato buona prova a Vcrclun come sugli Altip i ani. e che potranno semp re esse re migliorate. 11 " 12
A causa delle condizioni meteorologiche de ll e A lpi , che sono il confine per eccellenza, si dovranno realizzare postazioni coperte e pro tette per le bocche da fuoco di cui si prevede la necessi tà di immediato intervento; questo è realizzabile facilmente utilizzando l e insta l l azioni in cav e rna ed in c upo l a, ideate dal Co l onnello Guicleiti, e le sistemazioni per l e ar tig li erie cli medio calibro des tinat e a sostituire l'ottimo ma superato 149/35 A.
Dato così un ce nn o su l modo cli sistemare l e singole bocch e eia fuoco, il Maggiore Cirincione cerca di esporre, sempre secondo il suo punto di vista maturato a seguito dell'esame ci el comportamento delle strutture nel corso della Grande Guerra, deg li studi fino ad allora sviluppati e dell'evoluzione dei materiali , il modo in cui queste potrebbero essere raggruppate lungo g li sbarramenti di confine.
In montagna si cercò di raggiungere in passato la protezio ne cont r o l'aumento di potenza delle artig li erie riducendo al minimo l a profondità dei bersagli, con installazioni linea ri con bocch e eia fuoco in pozzo; ma, dimostratosi ciò insufficiente , detta protezione potrebbe essere attuata sistemando le artigl i e ri e in opere ad elementi disseminati, cli minima estensione, organizzate, ove ciò sia possibile, a puntam ento indirerto. Quando una buona difesa antiaerea, terrestre ed aerea, ostacoli efficacemente l'osservazio ne dall'alto, l 'avve r sari o non sarà in grado di effe ttu are tiri esatt i , mancandogli ogn i controllo dei si ngoli colp i
La batteria ver rebbe a risultare di più el ementi c he comprendono l'installazione per i pezzi ed i locali contenenti il munizionamento per qualche giorna ta cli fuoco, collegati poss ibilmente da gallerie che
9 Cita te in Gt' JDETII, Studio di siste11w~io11e di aniglierie in cm·er11<1 Ri,. /\n. e Genio ROM A. 192 1, va l. I.
10 Ve r ranno real izzat i par1 icolari affust i per i p..:zzi eia 75/27 mo d. 06 inst al lat i in e,,·erna e in ca~amau:1 met all ica facenti pa rte ciel Va l lo A l pino cd adallament i per ins tall are ndlc.: stru llure del me desimo i pezzi e/e da :on:. e .",7/-B
11 Gu10F.Trl. Studio della trasfon11a:io11e delle Ìl1stalla:io11i a po:::.:::.o lipo S i11 rnse111a11e girffoli della ji)f'(ijica:io11e odierna, Rivista Artig l ieria e Genio. ROMA. I 920.
12 CIRIKCJO.'JE. op. Ci i. pag. 30- I.
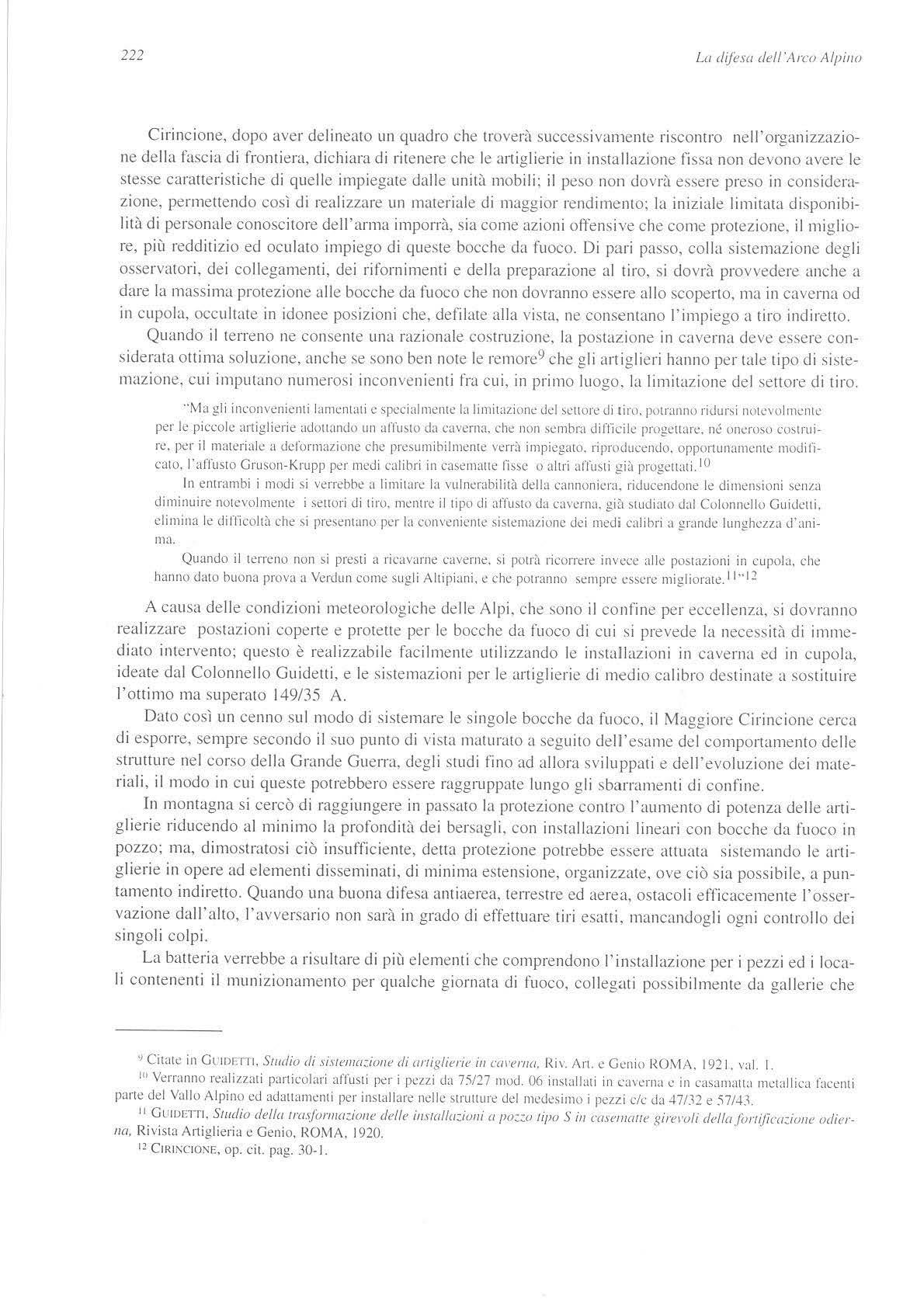
222 La t!{/esa Alpi,w
porterebbero ai ricoveri ed alle polveriere ricavate sui fianchi in posizioni protette, facilmente access ibili e defilate. Sarebbe necessario separare nettamente gli organi destinati al la difesa ravvicinata, all o scopo di evi tare che, sotto l'azione di un tiro v i olento, siano coinvolt i nella distruzione degli elementi della difesa lontana gli organi destinati a ll a difesa ravvic inata; questi dovranno essere intervallati ed occultati in modo da cost rin gere l 'attaccante a disperdere la sua azione di fuoco
La mancata resistenza dei forti dell'anteguerra aveva portato il Maggiore del Genio Tacco ni , fin dal 1915 , a prevedere c he nel futuro l e opere sarebbero state ad elementi sparsi, co ll egate da ga ll erie, cost ituit e d a cupo l e id o nee ad eseguire il tiro a puntamento indiretto e con protezione limit ata al tiro degli schrapne l ed a ricoveri defilati dietro masse di terra e protetti robustamente da ripari , cos ì da essere protetti dagli effett i dei co lpi che scoppiassero sul pendio soprastante. Con ana l oghi cri teri, sopprim endo i ric overi allo scoperto per ev itarne l' avvistamento, si potrebbe st udiare la si stemazione di una moderna batteria in cupola. Quasi nessun sva ntaggio arrecherebbe il settore in ango l o morto in prossimità dei singo li pezzi, che si ha sempre nelle sis temazi on i a pu nt amento indiretto, perché, mentre i medi calibri av rebbe ro il comp ito di agire essenzia lmente su ob iett i vi l ontani, l e batt eri e di piccolo calibro dovrebbero essere co ll ocal e in modo da fiancheggiarsi reciprocamente e da battere l'una l'angolo morto de ll 'a ltra. Con l'ordinamento in caverna si potranno, d 'a ltra parte, col l ocare i pezzi, sfruttando l e asperità del terreno di mo ntagna in modo che le can noniere sfuggano all a osservazione diretta e, mediante masc heramento, a quella dall'alto.
L e batterie ad az i one vicina, che dovrebbero essere quelle più numerose e normalmen te impiegate, ad azione fiancheggiante, con obiettivi di so lito ben determinati, potranno, ancor meglio, con un sapi ente adeguamento al terreno, essere sottratte al la vis ta del fuoco nemico. Maggiormente esposte però a possibili attacchi di so rpresa, dovranno essere circondate da ostacoli efficaceme nte e razionalmente battuti dal fuoco d ei reparti a ciò destinati
L'osservatorio dovrà essere avanzato al massimo e co llegato a i pezzi con linee protette e di sicuro utilizzo, preso atto c he deve avere un' ottima v i sione degli obietti vi asseg nat i
Le concl u sioni dell'autore, che nell'ar1icolo si incentrano su ci nque punti che vengono riportati di segu it o, sarann o la base per i successivi studi e svi luppi della fortificaz ione permanente italiana, e portera nn o alla realizzazione del Vallo Alpino, pomposamente anche definito Vallo del Litt orio o Mussolini, dal nome di co lui che lo vo ll e e non seppe poi utilizzarlo per tutelare l'Italia dalla bufera della seconda guerra mondial e.
l. " L a capaci tà di resistenz.i delle organ i zzazion i di trincea" si è dimostrata no tevo l e. in 4 uant0 era il risultato della stabilizzazione delle fronti dopo mes i ed anni, ed il frutto del lavoro di mi gliaia d i combattenti forniti di ogni mezzo. e perta mo la guerra lungi dal segnar e la tìne del l a fo rti ficaz i one per manente. dimostra in vece i da nn i c he possono derivare dal non tener l a ne l dov ut o conto.
2. Il nuovo co ntìn e italiano nord orientale, svo l gentesi per la massima pa rte su cime i mpervie c d a ll a testata delle va lli , potrà esse re protetto con p i ù efficacia e minor dispe rsione r idu cendo i l avor i all e zo ne di passaggio, limitate e ben delineate, in corr i spondenza delle quali dov ranno sorgere anche opere di d i fesa per arti glierie destinate all'azio ne v icina ed event ualm ente a quella l o ntana, provvedendo natural mente al l e difese contro i nu ov i mezzi be lli c i rapprese nta ti dagl i aere i, dai gas asfissianti dai carri d'assalto.
3 Le artiglier i e della difesa, si stemate in postazioni permanenti, dovran no essere d i massima art i glieri a di piccolo ca libro, a t iro ra p i do, generalme nte a t iro cu r vo. pronte ad entrare in az i o ne fin dall'inizio col loro fuoco di sbar r amen to a sostegno e protezione delle truppe di copertura.
4. Detta artiglieria, sistemata in cave rn a, quand o il terreno lo consigli e l o co nse nt a, o in casema tt e girevoli negli alt ri casi, saranno dis sem in ate in piccole opere, rob uste, con azioni d i appoggio r ec iproco, provviste di difesa vici na contro az i on i cli sorpresa e co lpi di mano, cli locali, im p i anti e magazzini atti ad ass i curare i l benessere d el presidio, ve r i capisa l di della d ifesa ed ossatura della sistemazione campale che dovrà so rgere al mom ent o del bisogno, eleme nt o d i protezione delle grosse art i glieri e che vcmrnno successiva mente trasportate e sc h ierate pel comballimento.
5. La d i fficoltà, per le ne v i e per le condiz i o ni meteorologiche in gene re, di traspo r tare ad alle quote l e artigl i eri e pesanti e la necess ità cli battere importanti c:enlri avversari oltre confine fin dal pr i mo mo ment o potranno,
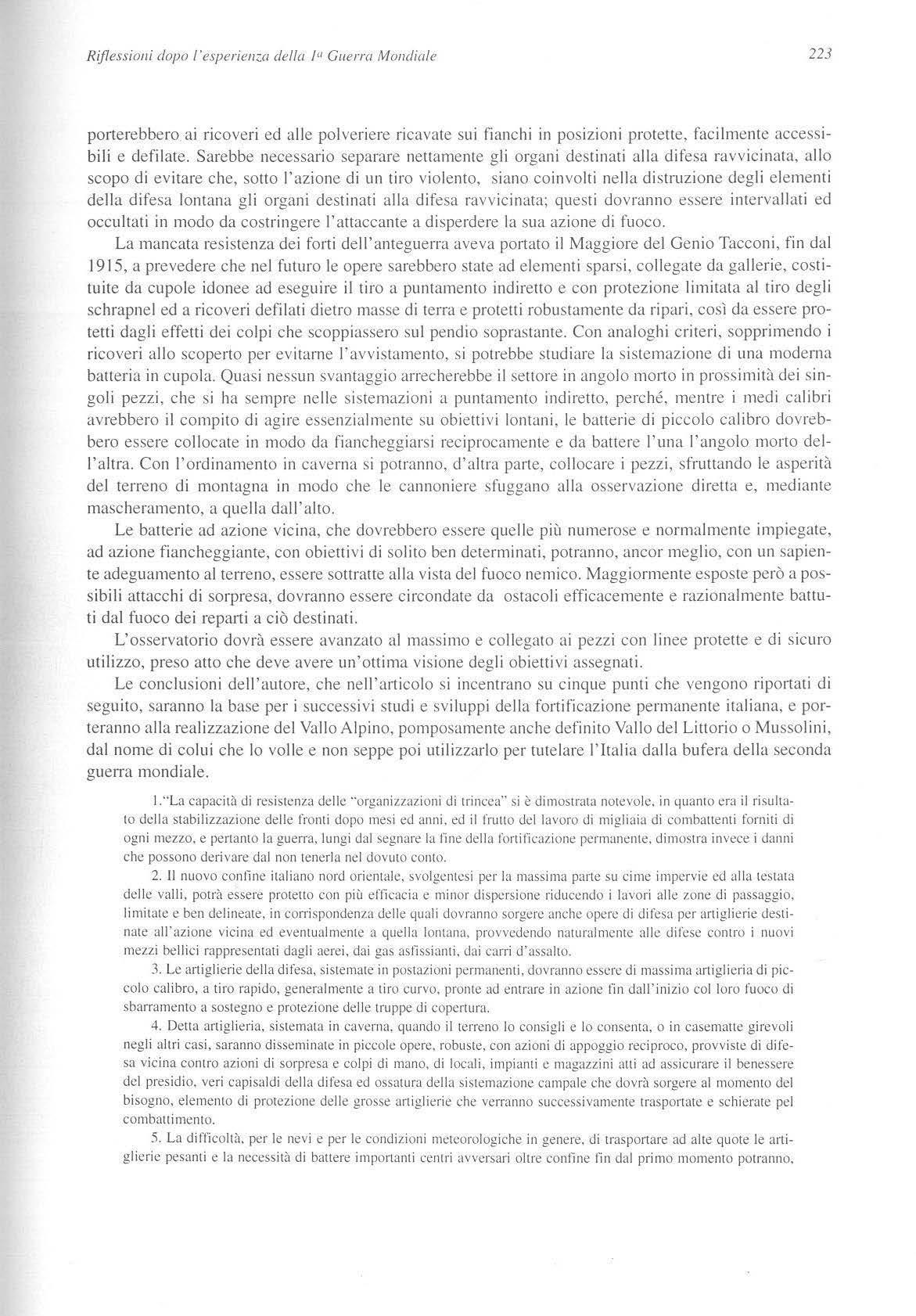
Rifiessioni dopo f'esperienza della i" Guerra Mo ndiale 223
in casi speciali, consigliare la sistemazione permanente. organizzata con gli stessi cri1eri, di aniglicric dçi maggiori calibri." 13
Ipotesi per i/futuro ( post 1918)
Le considerazioni e deduzioni precedentemente riponate ebbero un notevole impatto sugli ambienti tecnici preposti alle strutture fortificate e di riflesso anche sulla manualistica specializzata: è opportuno perciò accennare a quanto veniva insegnato a proposito della fortificazione in montagna nel 1925 agli allievi ufficiali del!' Accademia Militare di Modena, e che rispecchia ciò che venne realmente attuato nel campo fortificatorio italiano.
Circa le "modificazioni cli indole tecnica" da introdurre nelle fortificazioni, la manualistica rammentava come l'ingegnere, visto nella veste cli progettista delle nuove strutture fortificate, avrebbe dovuto tener conto che (siamo nel 1925) la potenza delle artiglierie era, rispetto a prima della guerra, aumentata, erano apparsi sulla scena bellica i carri d'assalto, l'arma chimica e l'aviazione con le sue azioni di bombardamento e conseguentemente qualunque opera realizzata avrebbe dovuto, al presente, avere una forma complessiva tale eia offrire la minima possibilità di essere colpita e la massima resistenza, qualunque fosse la direzione del tiro avversario. Per indurre il nemico, capace di radunare in breve tempo un rilevante quantitativo cli artiglieria pesante, a disseminare il fuoco dei suoi pezzi su una ampia zona, anziché concentrarlo su cli un unico ristretto obiettivo, le dimensioni dei singoli elementi delle sistemazioni difensive avrebbero dovuto essere, rispetto alle strutture utilizzate nel corso del conflitto appena terminato e già più contenute rispetto a quelle realizzate nel XVIII secolo, ancora più piccole, il loro mascheramento ed adattamento al terreno più che mai accurato.
Dalla lettura delle '·note ed appunti circa la difesa del nuovo confine montano"l 4 emerge come l'autore, Generale Traniello, ritenga sia necessario per la sistemazione della frontiera italiana tenere presenti alcuni fondamentali postulati che così possono essere riassunti: per interdire le linee di invasione importanti è necessario realizzare piccole opere, possibi l mente in caverna e con i servizi realizzati all'esterno in posizione coperta, robustissime, di limitato ma potente armamento (2 pezzi) che si appoggino reciprocamente; queste, vera ossatura dello sbarramento, costituiranno i nuclei base delle altre artiglierie che affluiranno in linea al momento opportuno; dette opere dovrebbero essere integrate da molte postazioni blindate per mitrag l iatrici, realizzate in posizioni avanzate, ma tali da non esser soggette a distruzione (posizioni traditrici con azione di fianco e di rovescio) e protette contro eventuali colpi di mano.

Per elette opere e postazioni, costituenti sbarrnrnento di interdizione, si dovranno inoltre realizzare due o tre fasce di reticolato per la loro sicurezza da vicino, interruzioni stradali, multiple e successive, a distanza tale da poter essere battute dalle armi dello sbarramento, caserme difensive nascoste al tiro per controllare i passi secondari, molti osservatori disposti in posizione coperta e fuori dalle opere, strade di arroccamento, di manovra ed accesso numerose e comode; dovrà inoltre essere predisposto abbondante munizionamento, faci l mente traspo11abi le in batteria e previste le predisposizioni necessarie per consentire alla truppa di frontiera di vivere in pieno inverno.
A l la luce de l loro limitato costo, queste opere possono essere moltiplicate in profonditi1, per controllare le vallate lungo le quali si svolge la l inea di invasione intercettata dallo sbarramento; lo si ritie-
13 CIRINCIONE, op. cit pag. 34-5.
14 TRAN IELLO. Note ed App11111i circa la difesa del nuol'o confine montano riportate in LeLioni di Fonificazione Permaneme - Accademia M il itare - Modena 1925.
224 La difesa dell'Arco Alpino
ne opportuno, in quanto queste vallate, che si diramano dalla giogaia principale, sono generalmente lunghe, aspre e con scarsi e difficili collegamenti reciproci. Analogamente a quanto avvenuto nel corso della gue,i-a mondiale queste opere in profondità possono essere anche costituite, accenna sempre il Gen. Traniello, da postazioni di medio e grosso calibro simili a quelle che, costruite in numerosissimi esemplari, svolsero la loro efficace azione anche per più mesi consecutivi; la posizione di queste batterie dovrà essere studiata e predisposta in tutti i suoi aspetti (materiali, lavori, individuazione ed inquadramento al tiro degli obiettivi, ecc.) ma non materialmente realizzata per non svelarne prima del tempo ubicazione e compito; inoltre, in relazione alle ipotesi di impiego formulate, sarebbe opportuno studiare più posizioni per ciascuna batteria.
Per quanto riguardava l'aspetto tecnico delle postazioni in caverna, veniva rammentato come fosse facile nelle fortificazioni di montagna avere installazioni in caverna, per mezzo delle quali si elimina per quanto possibile il contrasto sempre esistito fra protezione ed azione offensiva delle artiglierie; elette installazioni presentano il vantaggio della grande resistenza della massa coprente, della copertura alla vista e della spesa relativamente poco rilevante e lo svantaggio di una sensibile riduzione dei settori di tiro orizzontale e verticale o indebolimento della parete frontale della caverna, grande apertura esterna della cannoniera.
Possiamo ora rilevare come nel corso della guerra 1915-18 spesso sia stata impiegata artiglieria in caverna, ma, essendo dotata di armi incavalcate su affusti a ruote, venne accentuato lo svantaggio delle cannoniere di troppo ampie dimensioni e quindi facilmente imboccabili dal tiro nemico, poiché la minima apertura esterna della cannoniera si ottiene invece facendo ruotare. pressoché in volata, in direzione ed inclinazione l'arma (la volata dell'arma, così facendo, viene a coincidere col margine esterno della parete frontale della caverna e ciò non è realizzabile con un'arma su affusto ruotato)
Ed oggi si possono aver pezzi - monta ti su opportuni tipi di affusti da caverna - ben protetti , con cannoniere:: non troppo ampie e senori di tiro indiscriminatamente vasti.
Naruralmcntc tali settori non potranno mai eguagliare quelli delle casematte girevoli, ma calcolando che il costo di una installazione in caverna imp o rt a una spesa mult o inferiore a quella necessaria per l'impianw della casamaua girevole, se m.: deduce che poi potrebbe siste marsi alcuni settori del nosrro confine montano con artiglieria in <.:averna. impiegando un maggior numero di bocche da fuo<.:o , resrando semp re nell o stesso limite di spesa, e:: con i vantaggi di favorire la manovra del fuoco ddla difesa e d i aumentare il num ero dei bersagli sui q uali l'attaccante dovrebbe disseminare i suoi tiri.
Il Col. Targa. rilev a poi un altro vantnggio della caverna L'artiglieri a avv;;:rsa,ù, per poterla battere, è vincolata ad un tiro frontale o quasi, il che limita di molto la pussibili1i1 di sce lta delle posizioni, per cui la caverna d'incerta guisa paralizza il vantaggio che può venire all'artiglieria avversaria dal suo grande raggio di azione che è quello di poter ba1tere un'opera scoperta prendendo posizione sul punto più conveniente di un grandissimo arco auorno all'opera stessa. lnrine l'installazione in caverna, meglio di qualunque altro tipo di opera permaneme, può mascherarsi, giacché nulla vieta sia lasciato in posto un diaframma di roccia da farsi saltare soltamo al momento del bisogno, di modo che la vera ubicazione delle cannoniere può rimanere impre<.:isato fino all'ultirno istante.
I criteri che vengono ora adollati nella sistemazione diìensiva della nostra frontiera momana. sembra appunto che coincidano. nelle linee generali. colle considerazioni che abbiamo esposte. 15
I lavori pertanto si baseranno sui seguenti capisaldi:
I. sbarramento di ogni via di accesso mediante una vera regione fortificata saldata ad on ime posizioni sui fianchi e rafforzata in profondità. capace di dare solido appoggio ai comrattacchi e di favorire l'azione offensiva nel momento e nella direzione decisive;
2. costruzione di numerose vie:: di comunicazione, senza le quali ogni opera difensiva è inutile od anche dannosa;
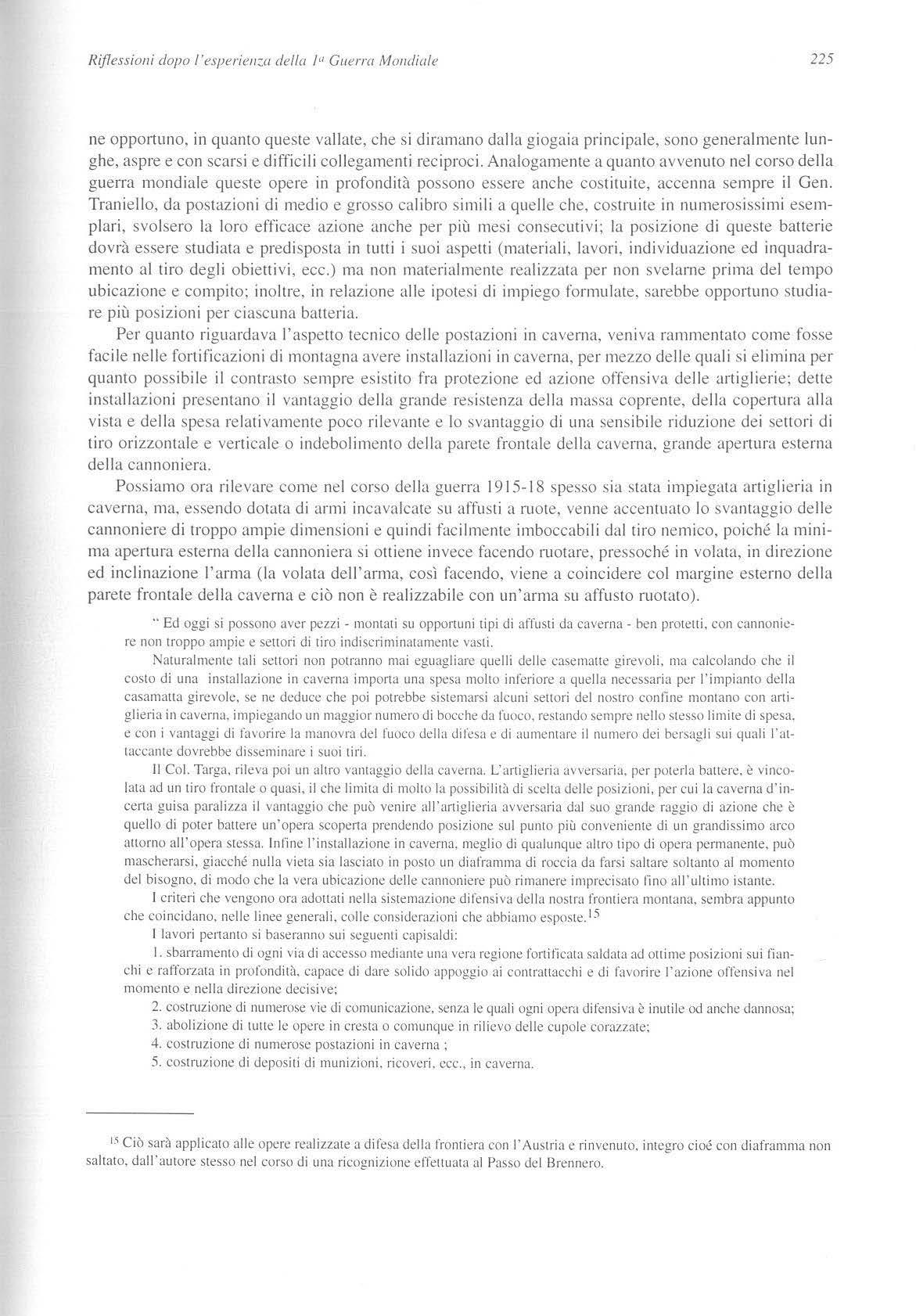
3. abolizione di tulle:: le opere in cresta o comunque in rilievo delle cupole corazzate;
4. costruzione di numerose postazioni in caverna :
5. costruzione di depositi di munizioni, ricoveri. ccc., in caverna.
15 Ciò sarà applicato alle opere realizzate a difesa della frontiera con l'Austria e:: rinvenuto, integro ciué con diaframma non saltato, dall'autore stesso nel corso di una ricognizione effettuata al Passo del Brennero.
Riflessioni dopo /' esperien::.a della /c1 Guerra Mondiale 225
Una parola infine sul personale
Finora il comando ed il pres id io di una fortezza o di un'opera non è mai staio tenuto in una considcrnzionc molto alt a ed è stato scelto con criteri quasi esclusivamente tecnici. Sappiamo invece benissimo che un'organizzazione difensiva qualsiasi ha un valore sollanto se presidiata da cuori fermi e se comandata da mente lucida e serena. Perciò occorre che i capi siano scelti fra gli e l emcnti non soltanto tecnici. ma che abbiano anche una pratica di comando cd una preparazione morale tali da metterli nelle migliori condizioni di fronte alle situazioni difficilissime in cui può venire a trovarsi unu opera fortificati va. E le truppt: del pres idio dcbbono essere salde. avcre anche capacità manovriera, essere continuamente esercitate. ed affiatate con i capi." 16
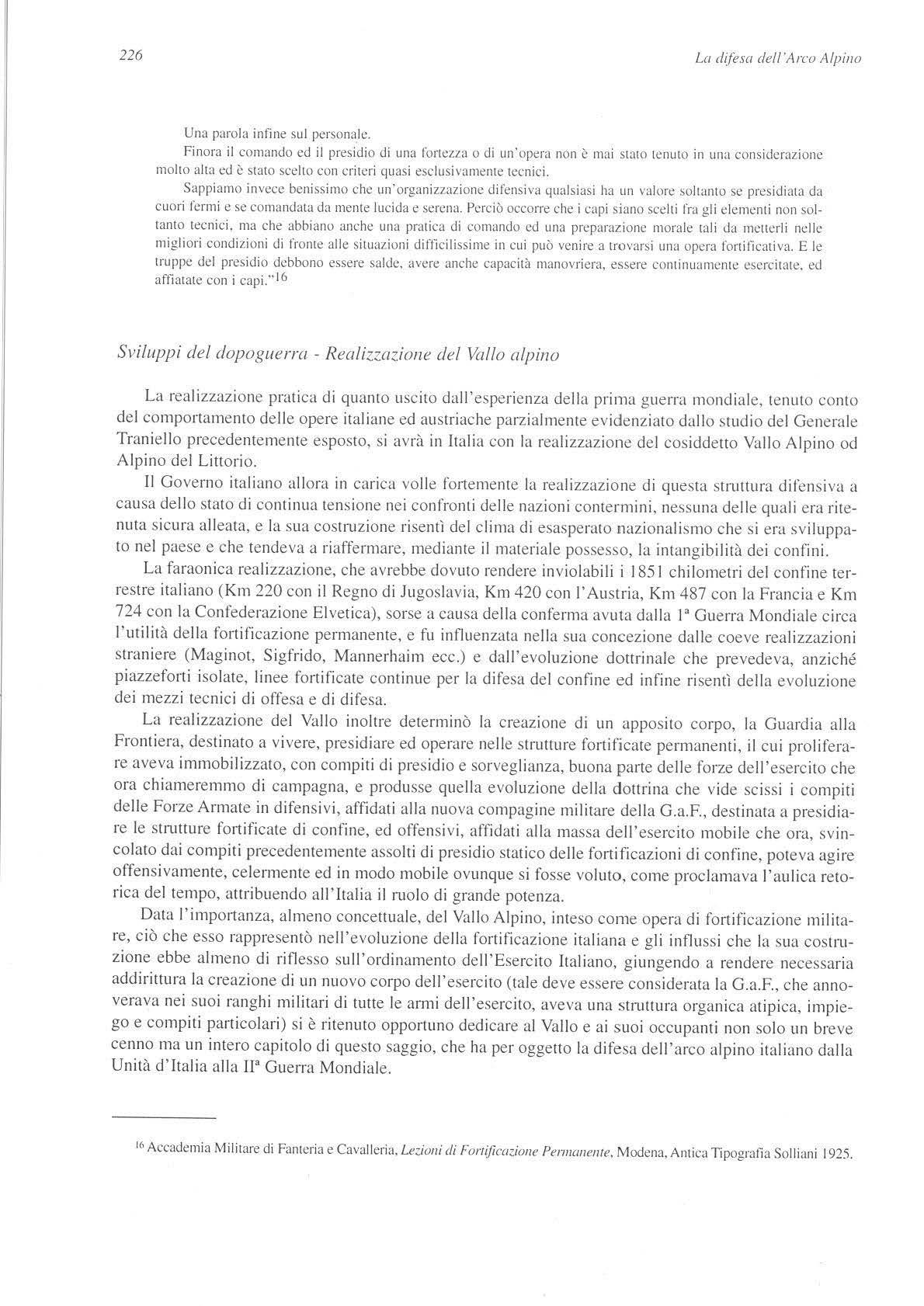
Sviluppi del dopoguerra - Realizzazione del Vallo alpino
La realizzazione pratica di quanto uscito dall'esperienza della prima guerra mondiale, tenuto conto del comportamento delle opere italiane ed austriache parzialmente evidenziato dallo studio del Generale Traniello precedentemente esposto, si avrà in Italia con la realizzazione del cosiddetto Vallo Alpino od Alpino del Littorio.
Il Governo italiano allora in carica volle fo1temente la realizzazione di questa struttura difensiva a causa dello stato di continua tensione nei confronti delle nazioni contermini, nessuna delle quali era ritenuta sicura alleata, e la sua costruzione ri sentì del clima di esasperato nazionalismo che si era svi luppato nel paese e che tendeva a riaffermare, mediante il materiale possesso, la intangibilità dei confini.
La faraonica realizzazione, che avrebbe dovuto rendere in violabi li i 185 I chilometri del confine terrestre italiano (Km 220 co n il Regno di Jugoslavia, Km 420 con l'Austria, Km 487 con la Francia e Km 724 con l a Confederazione Elvetica), sorse a causa della conferma avuta dalla 1• Guerra Mondiale circa l'utilità della fortificazione permanente, e fu influenzata nella sua concezione dalle coeve realizzazioni straniere (Maginot, Sigfrido, Mannerhairn ecc.) e dall'evoluzione dottrinale che prevedeva, anziché piazzeforti i solate, linee fortificate co ntinu e per la difesa del confine ed infine risentì della evoluzione dei mezzi tecnici di offesa e cli difesa.
La realizzazione ciel Vallo inoltre determinò la creazione di un apposito corpo, la Guardia alla Frontiera, destinato a vivere, presidiare ed operare nelle strutture fortifkate permanenti, il cui proliferare aveva immobilizzato, con compiti di presidio e sorveglianza, buona parte delle forze dell'esercito che ora chiameremmo cli campagna, e produsse quella evo lu zione della dottrina che vide scissi i compiti delle Forze Armate in difensivi, affidati all a nuova compagine militare della G.a.F., destinata a presidiare le strutture fortificate di confine, ed offensivi, affidati all a massa dell'esercito mobile che ora, svincolato dai compiti precedentemente assolti di presidio statico delle fortificazioni di confine, poteva agire offensivamente, celermente ed in modo mobile ovunque si fosse voluto, come proclamava l'aulica retorica del tempo, attribuendo alt 'Ita lia il ruolo di grande potenza.
Data l'impo1tanza, almeno concettuale, ciel Vallo Alpino, inteso come opera di fortificazione militare, ciò che esso rappresentò nell'evoluzione della fortificazione italiana e gli influssi che la sua costruzione ebbe almeno di riflesso sull'ordinamento dell'Esercito Italiano, giungendo a rendere necessaria addirittura la creazione di un nuovo corpo dell'esercito (ta le deve essere considerata la G.a.F., che annoverava nei suoi ranghi militari di tutte l e armi dell'esercito, aveva una struttura organica atip ica, impiego e comp iti particolari) si è ritenuto opportuno dedicare al Vallo e ai suoi occupanti non solo un breve cenno ma un intero capitolo di questo saggio, che ha per oggetto la difesa dell'arco alpino italiano dalla Unità d'Italia alla na Guerra Mondiale.
226 La difesa dell'Arco Alpino
16 Accademia Militare di Fanteria e Cavalleria, Le;:.ioni di Fortijica;:.ione Per111a11e111e. Modena, Antica Tipografia Solliani 1925.
IL VALLO ALPINO E LA GUARDIA ALLA FRONTIERA
Motivi di una nascita
La guerra mondiale aveva assorbito prepotentemente la massa delle risorse finanziarie italiane, logico quindi che alla fine delle ostilità le esigenze del paese, pretermesse alle necessità belliche, fossero subentrate assorbendo anche ciò che sarebbe servi t o se non altro alla sopravvivenza dello strumento bellico.
A questi fattori si deve inoltre aggiungere la particolare congiuntura politica non certo favorevole alle forze armate e quindi a stanziamenti ad esse destinati.
Intorno al la metà degli anni Trenta i I peggiorare della situazione politica ed i concetti strategici di difesa che permeavano i grandi stati maggiori portarono ad una corsa a costruire linee fortificate, basate su imponenti opere di fortificazione permanente, vedendo in queste il toccasana, il rimedio principe ad ogni pericolo di guerra.
Tutti o quasi tutti gl i Stati aventi frontiere terrestri si trovarono in quel periodo indaffaratissimi a fortificarsi, sfruttando al meglio le più evolute concezioni tecniche e le caratteristiche geomorfologiche delle zone di frontiera del proprio paese.
La Francia volle proteggersi con un immenso sistema - la linea Maginot, dal nome del ministro che nel 1930 fece votare i crediti per la sua realizzazione - che le dava l'illusione di poter tenere in scacco il nemico, esaurendone la spinta offensiva alle porte del paese e senza che lo stesso fosse materialmente toccato;
la Germania mise in cantiere la linea Sigfrido, il cui nome richiama alla mente l'invincibile eroe della saga dei Nibelunghi, meno colossale della dirimpettaia linea francese ma in grado di controbatterla, almeno psicologicamente;
Belgio, Russia, Finlandia, Grecia, Olanda, Jugoslavia e Romania non furono da meno ed allestirono ai limiti delle loro possibilità, le loro brave linee fortificate destinate a dare apparente sicurezza, realizzando teoricamente l'arresto, sul nascere, di ogni tentativo di invasione e scacciando lo spettro di stragi di combattenti simili a quelle avvenute nel corso della guerra da poco co nclu sasi ed il cui luttuoso ricordo permaneva ancora nelle menti dei popoli coinvolti.
Concezione del Vallo Alpino
L'Italia, preso atto di ciò che le altre potenze stavano realizzando, ed in specia l modo -che la dirimpettaia Francia, dopo aver costituito un apposito organismo preposto allo studio e realizzazione delle fortificazioni di frontiera (C.O.R.F.), stava mettendo in linea tutta una serie di armi ed artiglierie appositamente concepite e realizzate per le fo11ificazioni, potenziava le fortificazioni di antica concezione che mai aveva cessato di ammodernare nonostante l'alleanza con l'Itali a contro gli Imp eri Centrali, e realizzava potenti e moderne opere fo11ifica te, mettendo in campo cioè s istem i fort ific ati continui, potentemente armati, realizzati secondo i più moderni dettati della scienza fo11ificatoria, idonei inoltre all'appoggio ad azioni offensive verso il territ orio del Regno,
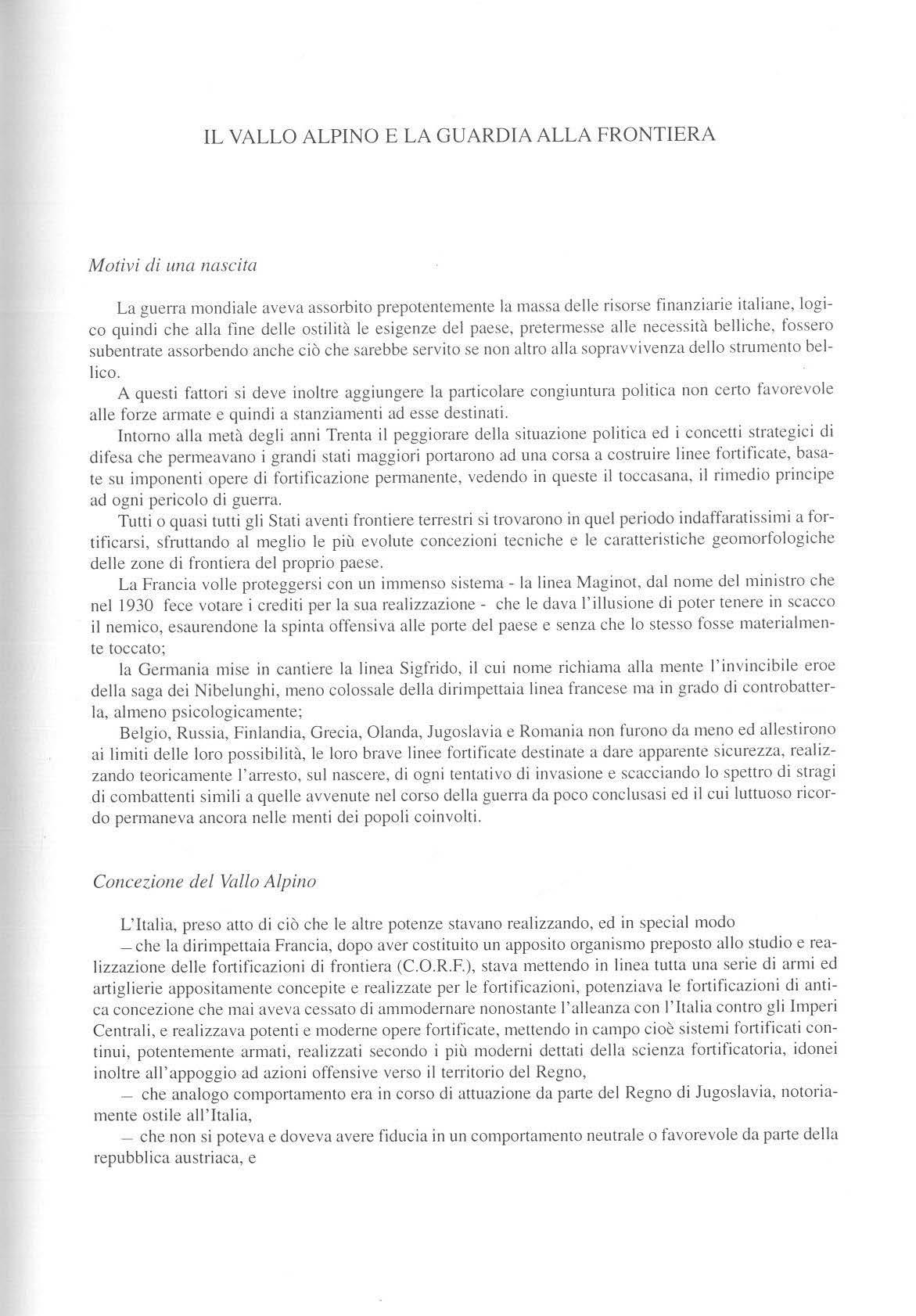
- che analogo comportamento era in corso di attuazione da parte del Regno di Jugoslavia, notoriamente ostile all'Italia,
- che non si poteva e doveva avere fiducia in un comportamento neutrale o favorevole da parte della repubblica austriaca, e
- che erano possibili violazioni della neutralità elvetica, ritenne necessario coprire con una adeguata sistemazione difensiva la propria frontiera terrestre, tenendo anche conto che la maggior parte delle strutture difensive permanenti realizzate nel periodo antecedente la prima guerra mondiale erano o superate dalle nuove concezioni tecnologiche e strategiche o oramai in pieno territorio nazionale.
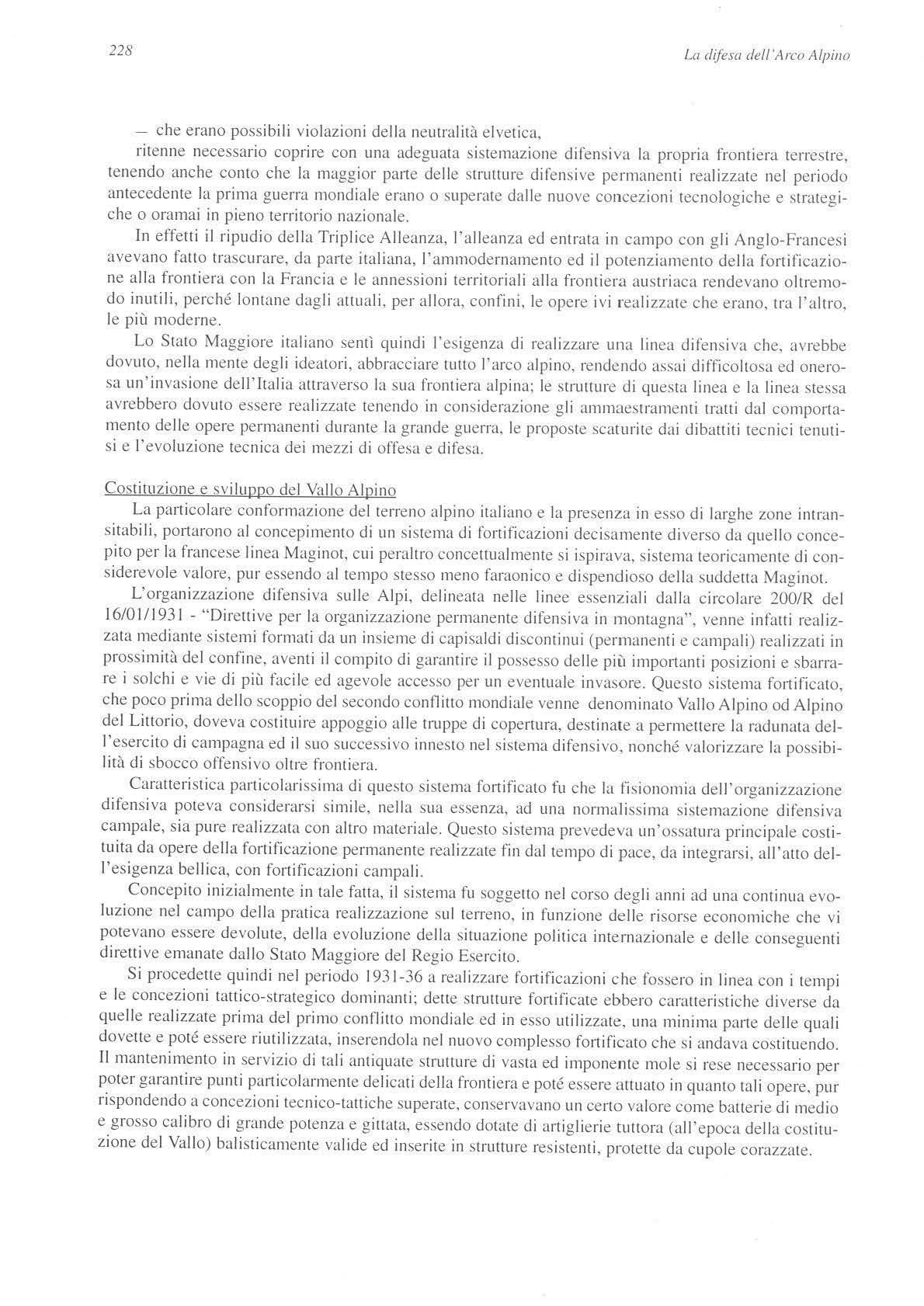
In effetti il ripudio della Triplice Alleanza, l'alleanza ed entrata in campo con gli Anglo-Francesi avevano fallo trascurare, da parte italiana, l'ammodernamento ed il potenziamento della fortificazione alla frontiera con la Francia e le annessioni territoriali alla frontiera austriaca rendevano oltremodo inutili , perché lontane dagli attuali, per allora, confini, le opere ivi realizzate che erano, tra l'altro, le più moderne.
Lo Stato Maggiore italiano sentì quindi l'esigenza di realizzare una linea difensiva che, avrebbe dovuto, nella mente degli ideatori, abbracciare tulio l'arco alpino, rendendo assai difficoltosa ed onerosa un'invasione dell'Italia attraverso l a sua frontiera alpina; le strutture cli questa linea e la linea stessa avrebbero dovuto essere realizzate tenendo in considerazione gli ammaestramenti traili dal comportamento delle opere permanenti durante la grande guerra, le proposte scaturite dai dibattiti tecnici tenutisi e l'evoluzione tecnica dei mezzi cli offesa e difesa.
Costituzione e svi luppo del Vallo A lpin o
La particolare conformazione del terreno alpino italiano e la presenza in esso di larghe zone intransitabili , po11arono al concepimento di un sistema di fortificazioni decisamente diverso da quello concepito per la francese I inca Maginot, cui peraltro concettualmente si ispirava, sistema teoricamente di considerevole valore, pur essend o al tempo stesso meno faraonico e dispendioso della suddetta Maginot.
L'organizzazione difensiva sulle Alpi, delineata nelle linee essenziali dalla circolare 200/R del 16/01/1931 - "Direttive per la organizzazione permanente difensiva in montagna", venne infatti realizzata mediante sistemi formati da un insieme di capisa ldi discontinui (permanenti e campa li ) realizzati in prossimità del confine, aventi il compito di garantire il possesso delle più importanti posizioni e sbarrare i solchi e vie di più facile ed agevo le accesso per un eventuale invasore. Questo sistema fortificato, che poco prima dello scoppio ciel secondo conflitto mondiale venne denominato Vallo Alpino od Alpino del Littorio, doveva costit uire appoggio alle truppe di copertura, destinate a permettere la radunata dell'esercito di campagna ed il suo successivo innesto nel sistema difensivo, nonché valorizzare la possibilità di sbocco offensivo oltre frontiera.
Caratteristica particolarissima di questo sistema fo11ificato fu che la fisionomia dell'organizzazione difensiva poteva considerarsi simi l e, nella sua essenza, ad una normalissima sistemazione difensiva campale, sia pure realizzata con altro materiale. Questo sistema prevedeva un'ossatura principale costituita da opere della fortificazione permanente realizzate fin dal tempo di pace, da integrarsi, all'atto dell'esigenza bellica, con fortificazioni campali.
Concepito inizialmente in tale fatta, il sistema fu soggetto nel corso degli anni ad una continua evoluzione nel campo della pratica realizzazione sul terreno, in funzione delle risorse economiche che vi potevano essere devolute, della evo luzi o ne della situazione poi itica internazionale e delle conseguenti direttive emanate dallo Stato Maggiore del Regio Esercito.
Si procedette quindi nel periodo 1931-36 a realizzare fortificazioni che fossero in linea con i tempi e le co ncezion i tattico-strategico dominanti; dette strutture fortificate ebbero caratteristiche diverse da quelle realizzate prima del primo confl itt o mondiale cd in esso utili zzate, una minima parte delle quali dovette e poté essere riutili zzata, in serendola ne l nuovo complesso fortificato che si andava costituendo. TI mantenimento in servizi o di tali ant iquate strutture di vasta ed imponente mole si rese necessario per poter garantire punti particolarmente delicati della frontiera e poté essere a ttu ato in quanto tali opere, pur rispondendo a concezioni tecnico-lattiche superate, conservavano un certo valore come bauerie di medio e grosso ca libro di grande potenza e giuata, essendo dotate cli artig li erie tuttora (all'epoca della costituzione del Vallo) balisticamente va lide ed inserite in strutture resistenti, protette da cupo l e corazzate.
228 La difesa dell'Arco Alpino
Mole compatta e raccolta, cannoni di piccolo e medio calibro, mitragliatrici e fucili mitragliatori, cura quasi maniacale dell'inserimento della struttura nel paesaggio, uso spregiudicato di acciaio e cemento armato caratterizzavano le nuove fortificazioni destinate a costituire l'ossatura del Vallo Alpino e le differenziavano dai forti di precedente concezione. Con queste nuove strntture si cercava e tendeva ad ottenere un elevato volume di fuoco entro breve raggio piuttosto che un tiro di maggior gittata, ma più lento e metodico.
Sono elementi caratteristici e fondamentali di questa prima fase costruttiva che si sviluppa nel periodo compreso fra il 1931 e il 1936 il centro di resistenza e la batteria in caverna:
il centro di resistenza era un'opera complessa fortemente protetta, caratterizzata dalla impenetrabilità e reattivitù a giro di orizzonte, contenente nel suo interno tutti i mezzi di vita e di azione necessari a consentire al suo presidio di vivere e combattere, anche se circondata e superata dal nemico. Armato principalmente di mitragliatrici, era destinato ad agire col proprio fuoco prioritariamente sul fianco ed il rovescio; per la copertura delle zone ove era prevedibile un eventuale sfondamento operato da mezzi corazzati avversari e ad integrazione e fiancheggiamento dei fossati anticarro successivamente realizzati, presentava casematte di calcestruzzo armate con pezzi da 57/43 R.M. (opere del primo sistema realizzate fino al 1935) e da 47/32 (opere ciel 2 ° e 3° sistema, bretelle cli raccordo, opere post 1935). Il centro si articolava in nuclei in numero e specie corrispondenti al numero e specie delle armi in dotazione; era la fortificazione moderna italiana cli maggior dimensione in grado di resistere ai proietti allora in servizio; la sua struttura generalmente si sviluppava all'interno della massa rocciosa ed aveva i malloppi, o postazioni, destinati a ricevere mitragliatrici e/o pezzi anticarro, ricavati nella roccia o parzialmente all'esterno sfruttando la protezione offerta dalle notevoli masse di calcestruzzo impiegate nella realizzazione della struttura; ogni malloppo comunque terminava verso l'esterno con un blocco di cemento armato in cui era ricavata la feritoia strombata a gradoni.
La circolare 300 del gennaio 1932, contenente le aggiunte e varianti alla precedente circolare emanata nel gennaio I 931 prescrisse, tra l'altro che:
- le strntture di nuova generazione e quelle in precedenza realizzate in pa11icolari punti del terreno fossero internamente rinforzate da una piastra di metallo, realizzata in vari tipi, che recava solidale l'affustino speciale destinato al I' incavalcamento dell'arma;
- oltre alle strutture in roccia venissero realizzate casematte cementizie o metalliche che, opportunamente inserite nel paesaggio mediante annegamento nel cemento e ten-a, lasciassero fuoriuscire le cupole metalliche delle torrette e le feritoie delle armi in dotazione.
Le batterie in caverna, armate principalmente con il pezzo da 75/27 mod. 06 e di previsto impiego sui valichi di maggiore importanza, nonché di concorso all'azione dei centri di fuoco sul margine anteriore della posizione di resistenza e sulla zona di sicurezza, avevano i pezzi in strutture analoghe a quelle dei centri di fuoco, realizzate però con vani di dimensioni adeguate alla mole dei pezzi che le costituivano. Queste strutture 'erano ricavate direttamente nella roccia oppure costituite da casematte in cemento armato o metalliche, annegate nel cemento, idoneamente inserite nel paesaggio; ampie cannoniere strombate esternamente a gradoni in calcestruzzo con spigoli a volte rinforzati da metallo, proporzionate al calibro dell'arma ed al brandeggio richiesto, erano ricavate direttamente nella struttura o copertura cementizia oppure nel blocco che chiudeva verso l'esterno i vani rocciosi destinati a contenere i singoli pezzi; talvolta erano riquadrature ricavate nella roccia, semplici o rinforzate - all'interno - da piastra metallica con feritoia.
Cunicoli alla prova di diversa dimensione e spesso interrotti da scale collegavano i malloppi, le caverne o strutture metalliche alla galleria principale o centrale su cui si aprivano i vani destinati a ricovero, posto comando, locali per le comunicazioni e servizi; uno o due malloppi in cemento armato generalmente costituivano l'uscita, il cui vano era materialmente chiuso da porte in ferro di tipo attivo; spesso il vano-dormitorio, spartanamente arredato, era costituito da parte della galleria stessa.
Opere complesse, veri e propri fortilizi resistenti ai medi calibri, avrebbero dovuto successivamente essere collocate a sbarramento, anche in profondità delle principali vie di penetrazione; con specifico

li Vallo Alpino e la guardia alla fromiera 229
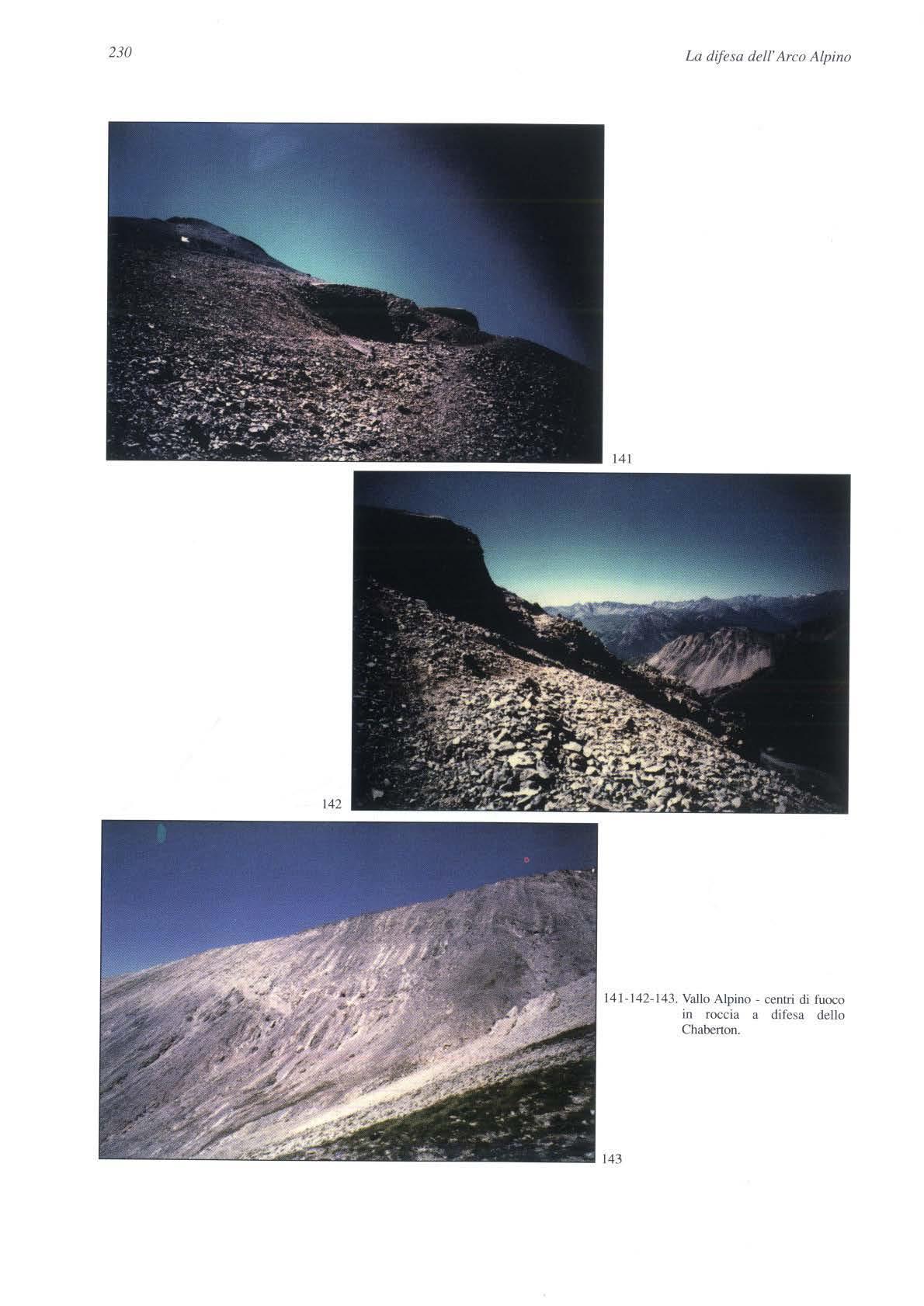
230 la difesa dell ' Arco Alpino
l 41 - 142-143. Yéùlo Alpino - centri di fuoco in roccia a di fesa dello Chaberton
compito anti fanteria e con armamento limitato alle sole mitragliatrici, erano previste opere semplici, dotate al massimo di tre mitragliatrici, a guisa di difesa ravvicinala e a corona delle opere complesse collegate almeno parzialmente alle suddette opere da camminamenti e cunicoli.
Questa fortificazione avrebbe dovuto costituire perno di appoggio e manovra per lo schieramento delle grandi unità mobili agenti negli spazi interni.
Qualora quindi le disponibilità finanziarie ed il tempo a disposizione lo avessero consentito, anche l'Italia avrebbe potuto essere difesa da un sistema fo1iificatorio profondo e raffinato, largamente ispirato alle coeve linee Maginot e Sigfrido, su linee successive, potentemente armato e quindi in grado di garantire la inviolabilità del territorio nazionale.
Un'analisi più approfondita e dettagliata mostra come questo sistema fortificalo, alla cui concezione e realizzazione fu tecnicamente preposto il Gen. Angelo Guidetti, prevedesse:
- una Zona di Sicurezza avente lo scopo di impedire la sorpresa, rallentando e logorando nel contempo l'attacco;
- una Posizione cli Resistenza appoggiata sui fianchi a zone di percorribilità assai difficile.
La parte anteriore di detta posizione di resistenza era previsto fosse battuta dal fuoco organizzato cli tutte le armi della difesa ed in particolare modo dai tiri incrociati delle anni installate nelle opere presenti nella zona, i cui operatori si avvalevano della perfetta conoscenza ciel terreno antistante per batterne, in qualsiasi condizione, ogni piega o recondita asperità.
Il sistema difensivo quindi:
1. si basava su postazioni per am1i della fanteria (centri di fuoco), per pezzi cli artiglieria (batterie in caverna) ricavate in caverna, in strutture in calcestruzzo o metalliche, inserite nell'ambiente mediante acconcio mascheramento di te1rn e cemento (falsa roccia);
2. presentava pai1icolari accorgimenti adollati per consentire un ottimale funzionamento della strutture realizzate; infatti. allo scopo di sollrarre le feritoie ai tiri di imbocco avversari, ampio sviluppo era stato dato ai tiri di fianco e rovescio, in grado di offendere l'avversario meno svelando l'origine del proprio fuoco; Era stato anche previsto che:

a) qualora necessario utilizzare il tiro frontale, le postazioni per le mitragliatrici e/o cannoni di piccolo calibro impiegate per tale tipo cli tiro fossero realizzate mediante casamatta metallica (struttura a pozzo costituita da anelli metallici che rivestivano le p,u-eti del pozzo scavato nella roccia munita in superficie di cupola monoferitoia - per mitragliatrice - annegata nel calcestruzzo e terreno, o struttura metallica realizzata in più parti - per il trasporto - e messa in opera annegando gli clementi nel calcestruzzo e mantenendo visibile la sola feritoia ricavata nella piastra frontale).
b) nelle zone di previsto comballimento ravvicinato, causa la mancanza di passaggi fissi, le postazioni a casamatta fossero di dimensioni lievemente maggiori di quelle prima descritte e munite cli torretta a quattro feritoie con quattro conchiglie po1ta arma anziché di cupolctta mono arma,
c) i malloppi in calcestruzzo fossero rinforzati con piastra metallica frontale (ne esistevano diversi tipi), che presentava feritoia di dimensioni oltremodo contenute, tale da richme notevolmente il rischio del colpo di imbocco,
d) le strutture fossero realizzate con spessori di calcestruzzo oscillanti fra i 3,50 ed i 4 metri, tali da dare una notevole protezione contro i colpi anche dei grossi calibri.
Le attrezzarure interne delle strutture, inoltre, erano state concepite in modo eia consentire una lunga autonomia ai presidi delle opere anche nel caso le opere fossero state superate ed aggirate; si erano previsti quindi magazzini per i viveri e le munizioni, impianti di illuminazione, ventilazione, filtraggio e rigenerazione dell'aria interna, nonché impianti di protezione antigas.
Stazioni radio, impianti telefonici e fotofonici (tipo particolare di apparato che collega punti mutuamente visibili ed allineati, trasformando in trasmissione il segnale acustico in un fascio luminoso e convertendo in ricezione il segnale ouico in acustico ricevibile in cuffia) assicuravano i collegamenti interni alle opere, fra le opere ed i comandi superiori, mentre impianti sanitari ed igienici protetti ed ubicati all'interno evitavano la necessità cli uscire, per la bisogna, dalla struttura protetta.
Il Vallo Alpino e la g11Mdia alla jiw1riera 231
OPE RA , DE L COLLE PI CCO LO SAN BERNARDO (o~"'o.1 r ,va11o Alpino dal l1lt<>+'io
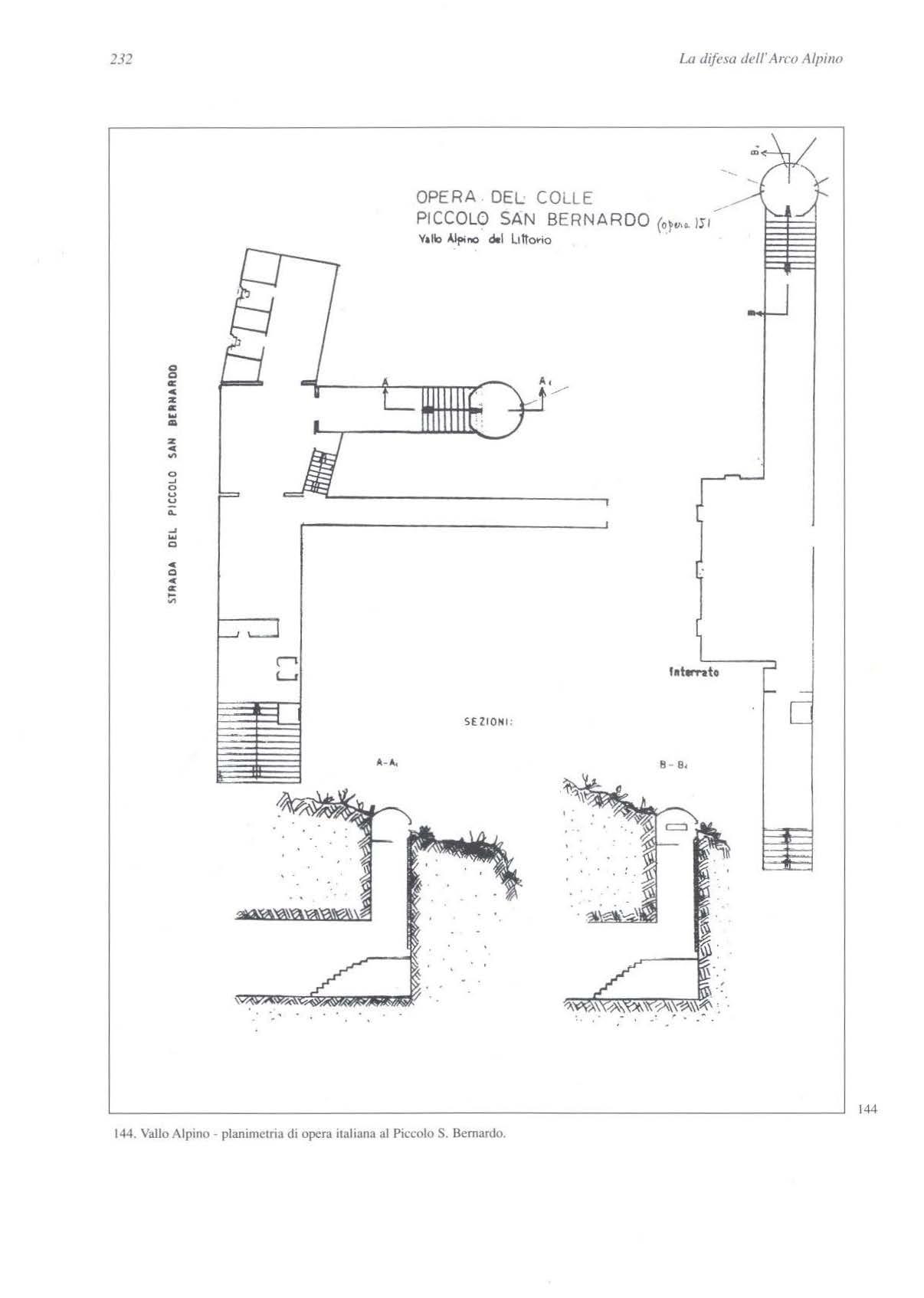
232 o Q a: e z a: .., e % e "' o .J o .., .., CL .J ... e e Q e "' :;; La difesa dell'A rco Alpino
faterrat o SEZIO N I : 8 8,
144
144. VaUo A l pino - planimetria di opera italiana al P iccolo S. Bernardo.
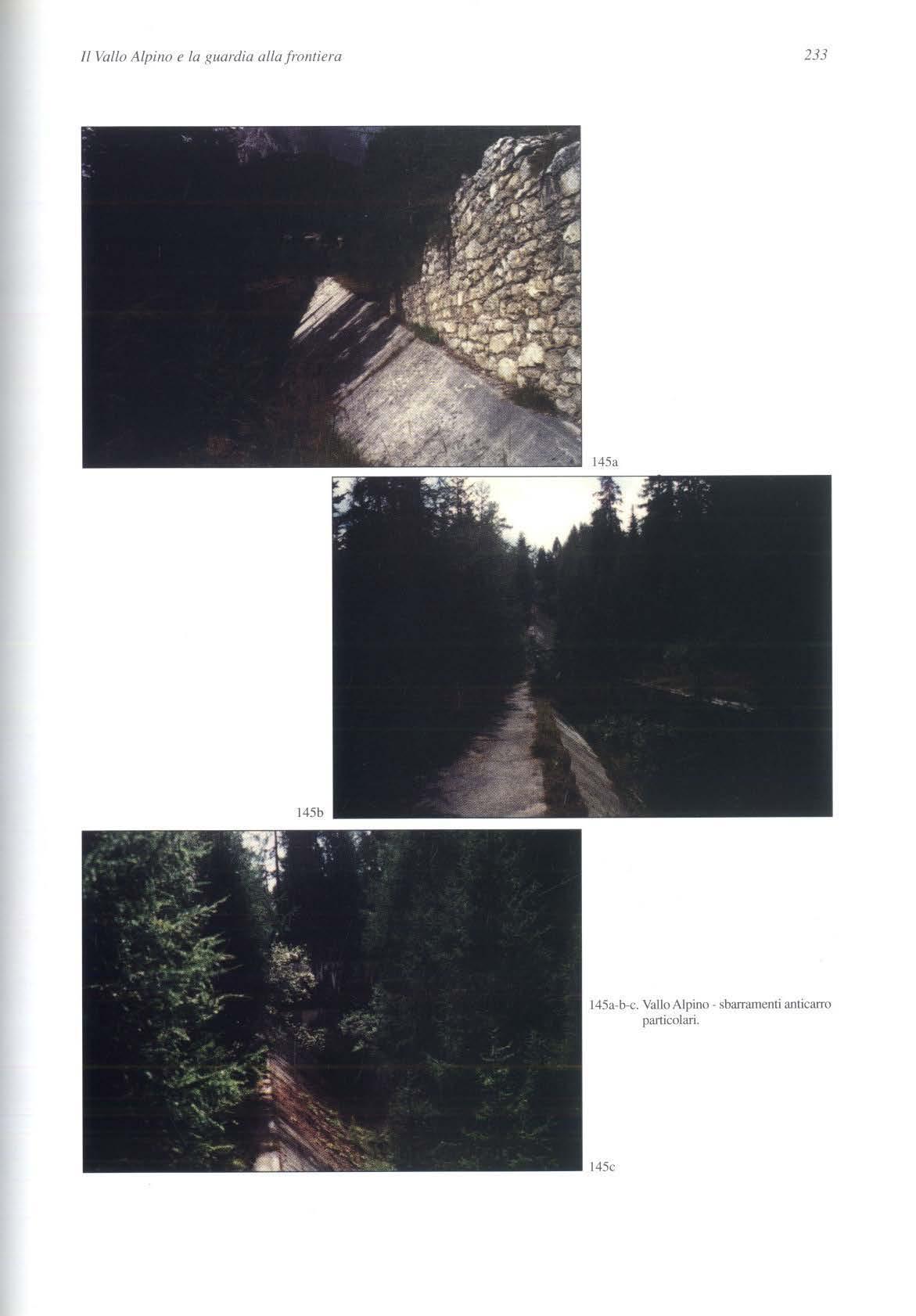
Il Vallo Alpùw e la guardia alla frontiera 233
145a-b--c. Vallo Alpino · sbarramemi anticarro particolari.
Fossati anticarro, battuti dal fuoco delle armi ed i cosiddetti denti di drago costituivano i principali i ostacoli passivi permanenti di cui era prevista la costruzione fin dal tempo di pace per la parte anteriore della posizione di resistenza.
La parte posteriore di detta posizione (di resistenza) vedeva la realizzaz i one di postazioni protette per mitragliatrici pesanti, collegate ai ricoveri alla prova per i serventi e la sistemazione di ricoveri alla prova destinati al personale di previsto impiego per il contrattacco.
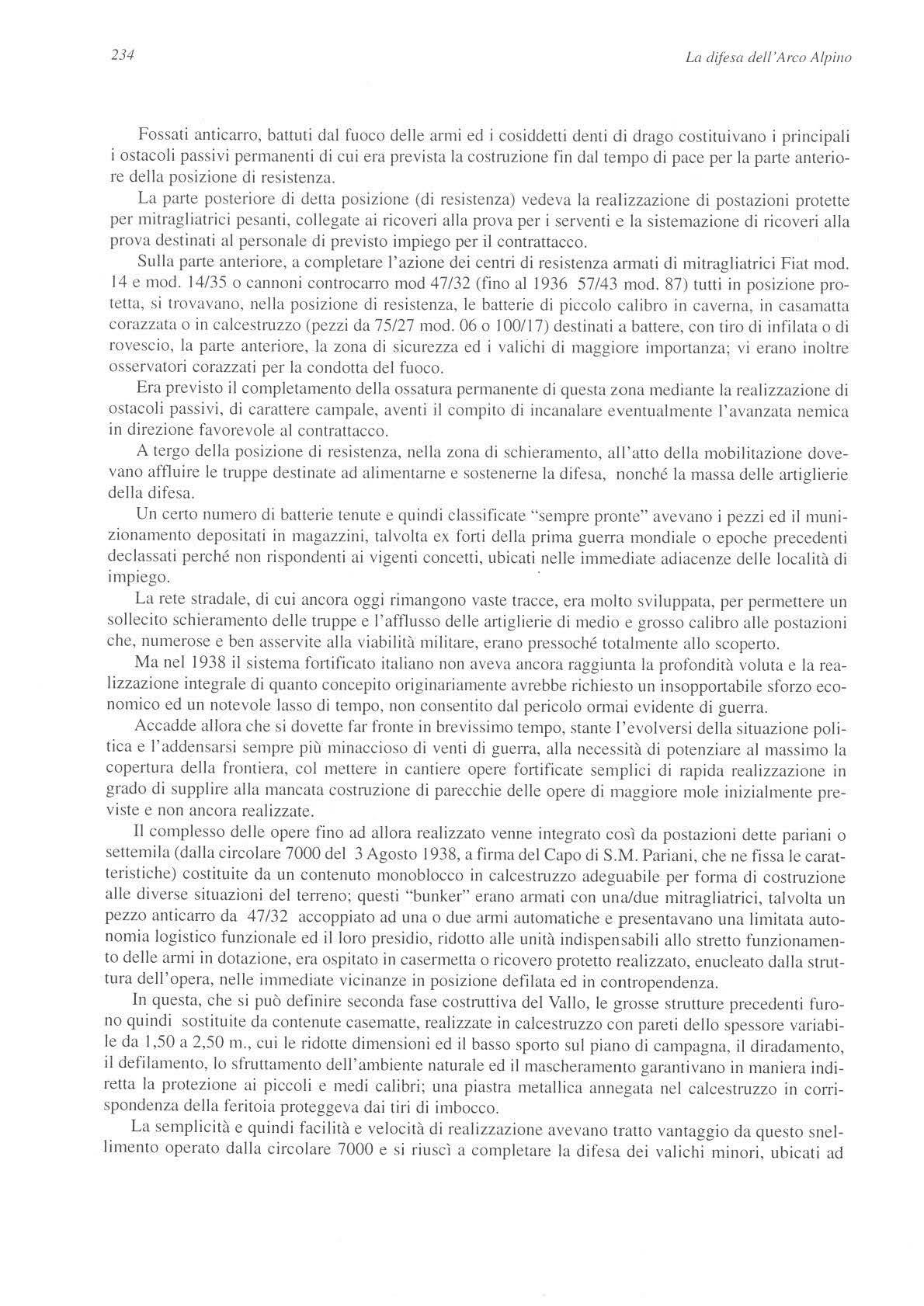
Sulla pa11e anteriore, a completare l'azione dei centri di resistenza armati di mitragliatrici Fiat mod. l 4 e mod. 14/35 o cannoni controcarro mod 47/32 (fino al 1936 57/43 mod. 87) tutti in posizione protetta, si trovavano, nella posizione di resistenza, le batterie di piccolo calibro in caverna, in casamatta corazzata o in calcestruzzo (pezzi da 75/27 mod. 06 o I 00/17) destinati a battere, con tiro di infilata o di rovescio, la parte anteriore, la zona di sicurezza ed i valichi di maggiore importanza; vi erano inoltre osservatori corazzati per la condotta del fuoco.
Era previsto il completamento della ossatura permanente di questa zona mediante la realizzazione di ostacoli passivi, di carattere campale, aventi il compilo di incanalare eventualmente l'avanzata nemica in direzione favorevole al contrattacco.
A tergo della posizione di resistenza, nella zona di schieramento, all'atto della mobilitazione dovevano affluire le truppe destinate ad alimentarne e sostenerne la difesa, nonché la massa delle artiglierie della difesa.
Un certo numero di batterie tenute e quindi c l assificate "sempre pronte" avevano i pezzi ed il munizionamento depositati in magazzini, talvolta ex forti della prima guem:1 mondiale o epoche precedenti declassati perché non rispondenti ai vigenti concetti, ubicati nelle immediate adiacenze delle località di impiego.
La rete stradale, di cui ancora oggi rimangono vaste tracce, era molto svil upp ata, per permettere un sollecito schieramento delle truppe e l'afflusso delle artiglierie di medio e grosso calibro alle postazioni che, numerose e ben asservite alla viabi lità militare, erano pressoché totalmente allo scoperto.
Ma nel 1938 il sistema fortificato italiano non aveva ancora raggiunta l a profondità voluta e la reali zzazione integrale di quanto concepito originariamente avrebbe richiesto un insopportabile sforzo economico ed un notevole lasso di tempo, non consentito dal pericolo ormai evidente di guem1.
Accadde al Iora che si dovette far fronte in brevissimo tempo, stante l'evolversi della situazi one poi itica e l'addensarsi sempre più minaccioso di venti di guem1, alla necessità di potenziare al massimo la copertura della frontiera, col mettere in cantiere opere fortificate semplici di rapida realizzazione in grado cli supplire all a mancata costruzione di parecchie delle opere di maggiore mole inizialmente previste e non ancora realizzate.
li complesso delle opere fino ad all ora realizzato venne integrato così da postazioni dette pariani o settemila (dalla circolare 7000 del 3 Agosto 1938, a firma del Capo di S.M. Pariani, che ne fissa le caratteristiche) costituite da un contenuto monoblocco in calcest ruzz o adeguabi l e per forma di costruzione alle diverse situazioni del terreno; questi "bunker" erano annati con una/due mitragliatrici, talvolta un pezzo anticarro da 47/32 accoppiato ad una o due anni automatiche e presentavano una limitata autonomia logistico funzionale ed il l oro presidio, ridotto alle unità indispensabili allo stretto funzionamento delle anni in dotazione, era ospitato in casermetta o ricovero protetto realizzato, enucleato dalla st ruttura dell'opera, nelle immediate vic inan ze in posizione defilata ed in contropendenza.
In questa, che si può definire seconda fase costruttiva del Vallo, le grosse strutture precedenti furono quindi sostitu ite da conte nute casematte, realizzate in calcestruzzo con pareti dello spessore variabile da 1,50 a 2,50 m., cui le ridotte dimensioni ed il basso spo110 su l piano di campagna, il diradamento, il defilamento, lo sfruttamento dell'ambiente naturale ed il mascheramento garantivano in maniera indiretta l a protezione ai piccoli e medi calibri; una piastra metallica annegata nel calcestruzzo in corrispondenza della feritoia proteggeva dai tiri di imbocco.
La semplicità e quindi facilità e velocità di realizzazione avevano tratto vantaggio da questo snellimento operato dalla c ircolare 7000 e si riuscì a completare la difesa dei valich i minori, ubicati ad
234 La dijèsa dell'Arco Alpino
alta quota, a coprire vie minori di penetrazione e a collegare con bretelle le precedenti realizzazioni fortificate , conferendo al complesso difensivo di frontiera, prima costituito da capisaldi isolati sia pure coordinati in linee difensive, una sistemazione I ineare vera e propria, dotata talora di limitata profondità; la riduzione dello sviluppo delle strutture però aveva fatto perdere alle stesse la loro autonomia logistica, elemento fondamentale per la sopravvivenza dell'opera stessa, qualora superata ma non annientata dal nemico.
Venne così realizzata un'organizzazione fondamentalmente lineare impostata essenzialmente su opere di fanteria, armate di mitragliatrici, pezzi controcarro di piccolo calibro e, ove previsto, su postazioni ricavate in caverna, prevalentemente per pezzi da 75/27 e I 00/ 17 , in grado di effettuare tiro sui valichi e le alte valli; in qualche caso venne abbozzato un sistema fortificatorio non più continuo, ma localizzato sulle principali vie di facilitazione e collegato al primo sistema mediante bretelle e vie allo scoperto; per le artiglierie si rese necessario mantenere in servizio alcuni forti realizzate a cavallo del '900 ritenuti ancora di possibile utile impiego quali batterie G.a.F. a lunga gittata (ad esempio il forte dello Chaberton divenuto SIY' Batteria G.a.F.).
In parecchi casi inoltre, stante l'urgenza di sbarrare pericolose vie di accesso, molte mitragliatrici e pezzi controcarro dovettero venire ubicati allo scoperto e così pure la massa delle artiglierie di medio e grosso calibro cui non fu possibile dare ricovero in opera o caverna.
Ad esemplificazione di quanto fino ad ora detto, si riportano, realizzati fotograficamente, alcuni esempi di tali strutture, ubicati in zone di frontiera considerate di vitale importanza.
La preoccupazione per la scarsa tenuta alla eventuale spinta offensiva avversaria che l'organizzazione fortificatoria fino ad allora realizzata poteva offrire, unita ad una schiarita politica che faceva sperare in un certo lasso di tempo privo di guerra, fece determinare nuovi concetti cui improntare l'organizzazione difensiva della frontiera italiana, concetti innovatori che modificavano il modo di vedere il vallo Alpino, non più collocato sul solo spartiacque, bensì ampiamente sviluppato anche nel fondo valle e costituito da sistemi di fortificazione, la cui composizione era in funzione della potenzialità della via tattica su cui era investito.
La circolare I 5000 emanata a firma del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Maresciallo Graziani, esponeva i criteri cui si doveva ispirare questa che si può definire terza fase costruttiva del Vallo Alpino; secondo questi nuovi concetti l'organizzazione difensiva doveva comprendere più sistemi fortificati, di regola tre, appoggiati a linee naturali particolarmente forti che si susseguivano in profondità e distanziati quanto era necessario a costringere l'avversario ad adottare successivi schieramenti cli a1tiglieria; (vicino al confine il primo sistema, a sbarramento dei tratti mediani delle valli, gravitando sulle vie di facilitazione il secondo, opere "catenaccio", a sbarramento delle strade principali per il terzo, realizzato in prossimità dello sbocco in pianura delle valli alpine).
I sistemi dovevano esser collegati da numerose bretelle di raccordo, linee di difesa trasversali alle linee principali, destinate a segmentare il terreno, evitando che la caduta di un caposaldo permettesse l'aggiramento dell'intera linea difensiva con conseguente a1Tetramento dell'intero fronte.
In ogni sistema, in relazione alle condizioni di operabilità del terreno nei vari tratti, si sarebbero dovute avere sistemazioni a caratteristiche diverse e precisamente:
1. sistemazioni tipo "A": costituite da una fascia di opere resistenti al grosso calibro, dislocate a cavaliere delle direttrici che potevano consentire lo sviluppo di attacchi a massa; opere grosse integrate da medie costi tu i vano l'ossatura del sistema.
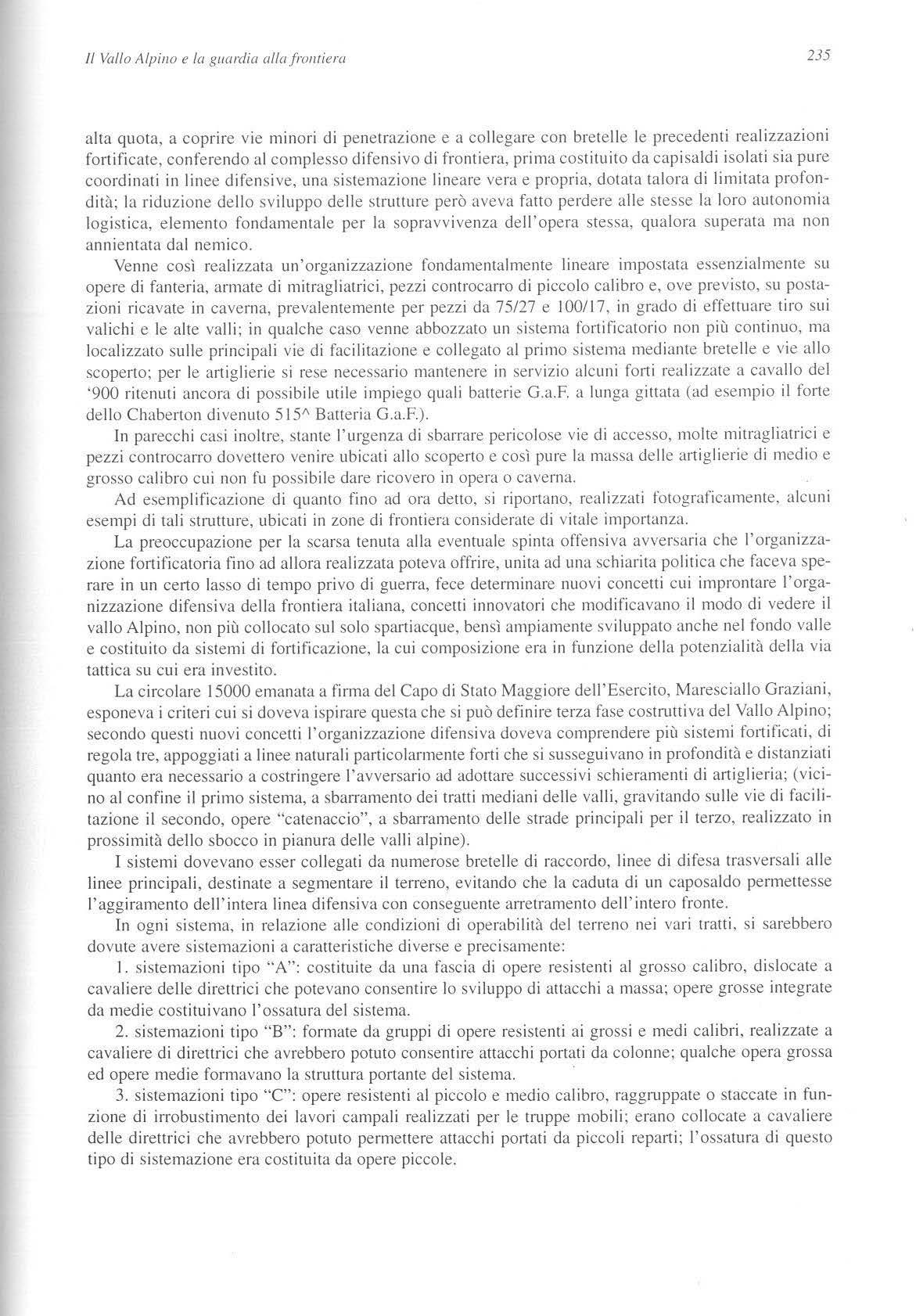
2. sistemazioni tipo "B": formate da gruppi di opere resistenti ai grossi e medi calibri, realizzate a cavaliere di direttrici che avrebbero potuto consentire attacchi portati da colonne; qualche opera grossa ed opere medie formavano la struttura portante del sistema. ·
3. sistemazioni tipo "C": opere resistenti al piccolo e medio calibro, raggruppate o staccate in funzione di irrobustimento dei lavori campali realizzati per le truppe mobili; erano collocate a cavaliere delle direttrici che avrebbero potuto permettere attacchi portati da piccoli reparti; l'ossatura di questo tipo di sistemazione era costituita da opere piccole.
Il Vallo Alpino e fa guardia alla fronriera 235
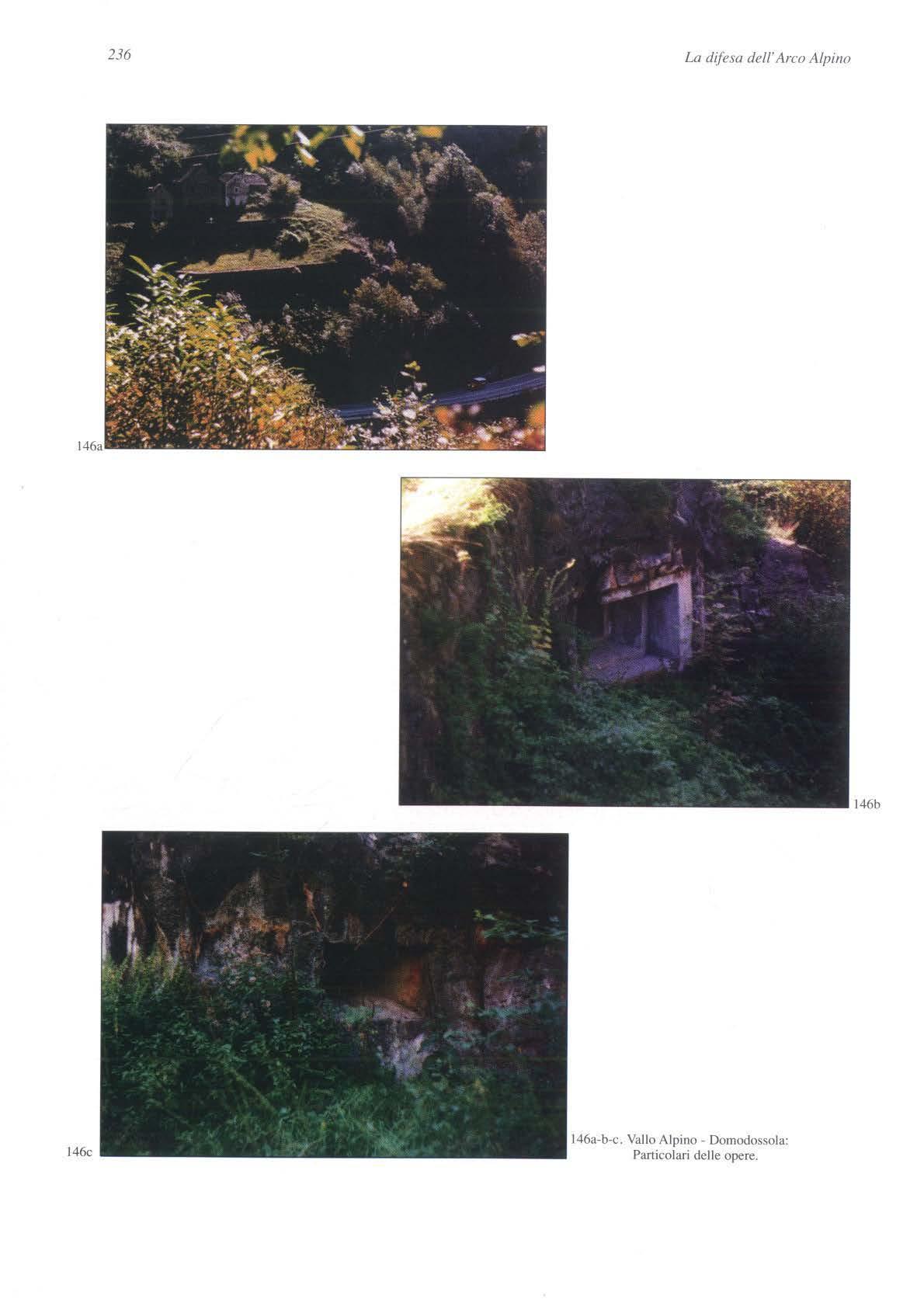
236 La difesa del/' Arco Alpino
146b
146c
l 46a-b-c. Vallo Alpino - Domodosso la: Partico lari delle opere.
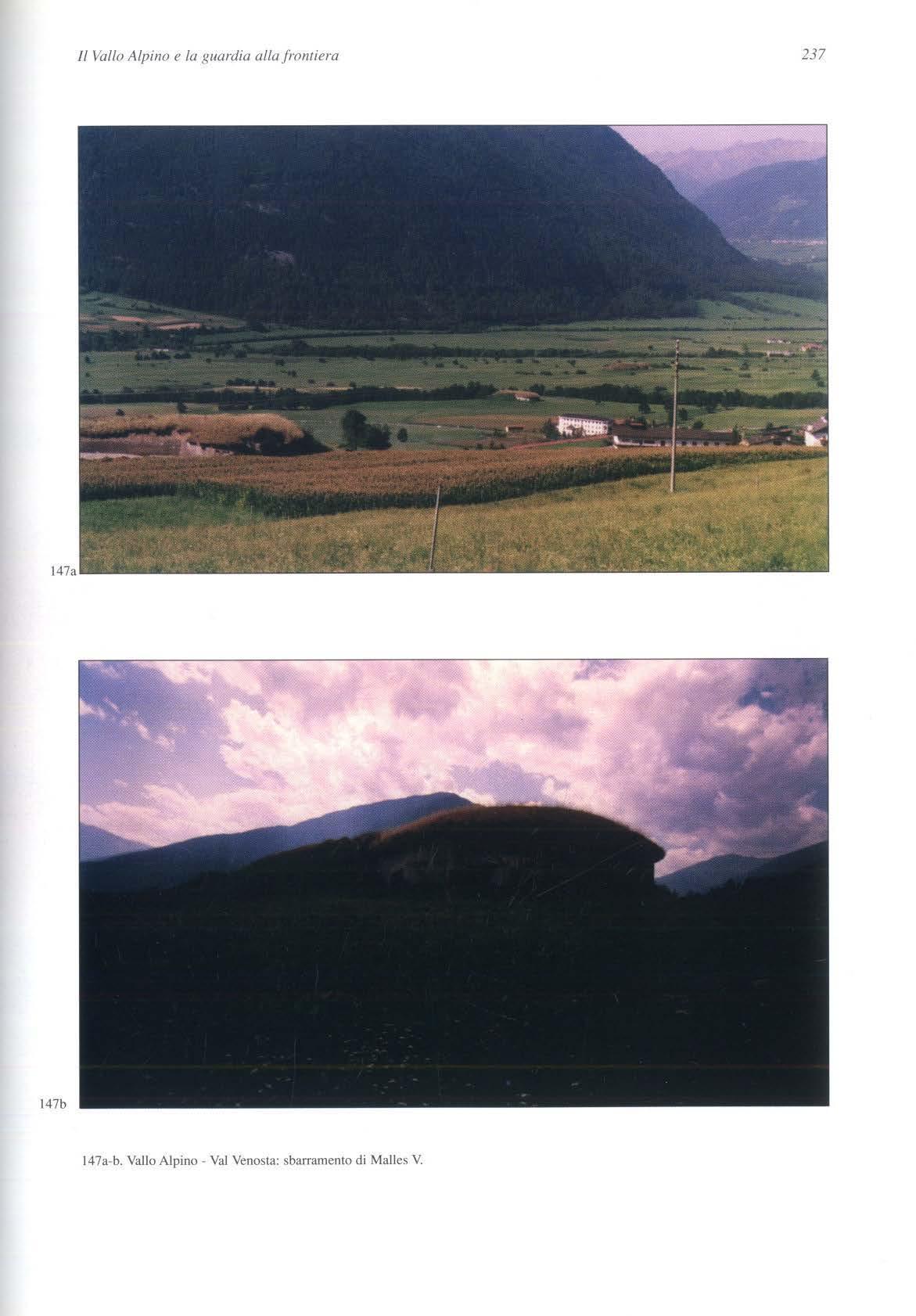
li Vallo Alpino e la guardia alla fromiera 237 l47b
I 47a- b. VaJJo Alpino - Val Venosta: sbarramento di MaJlcs V.
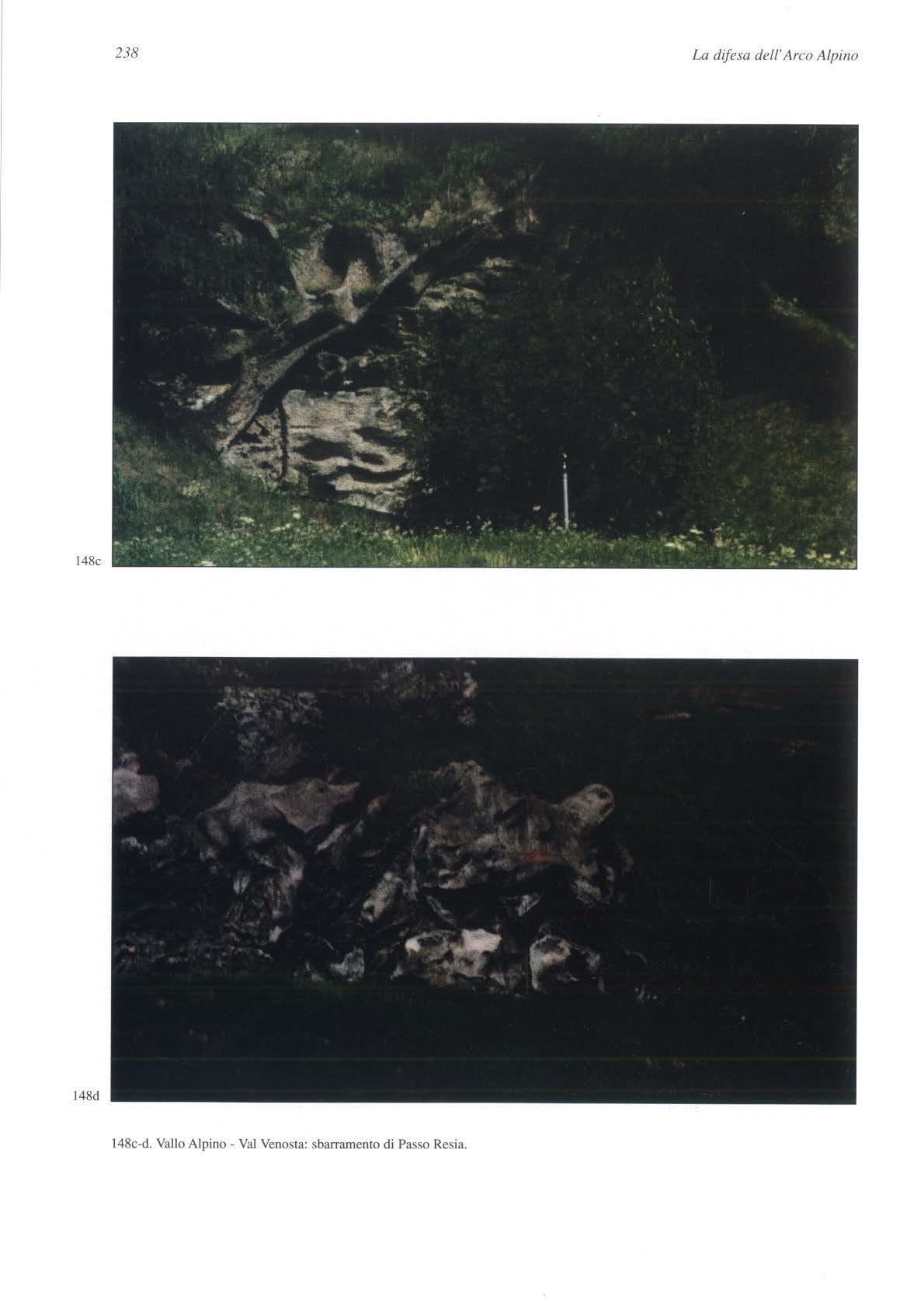
238 La difesa Alpino 148c 148d
148c-d. Vallo Alpino - Val Venosta: sbarramento di Passo Resia.
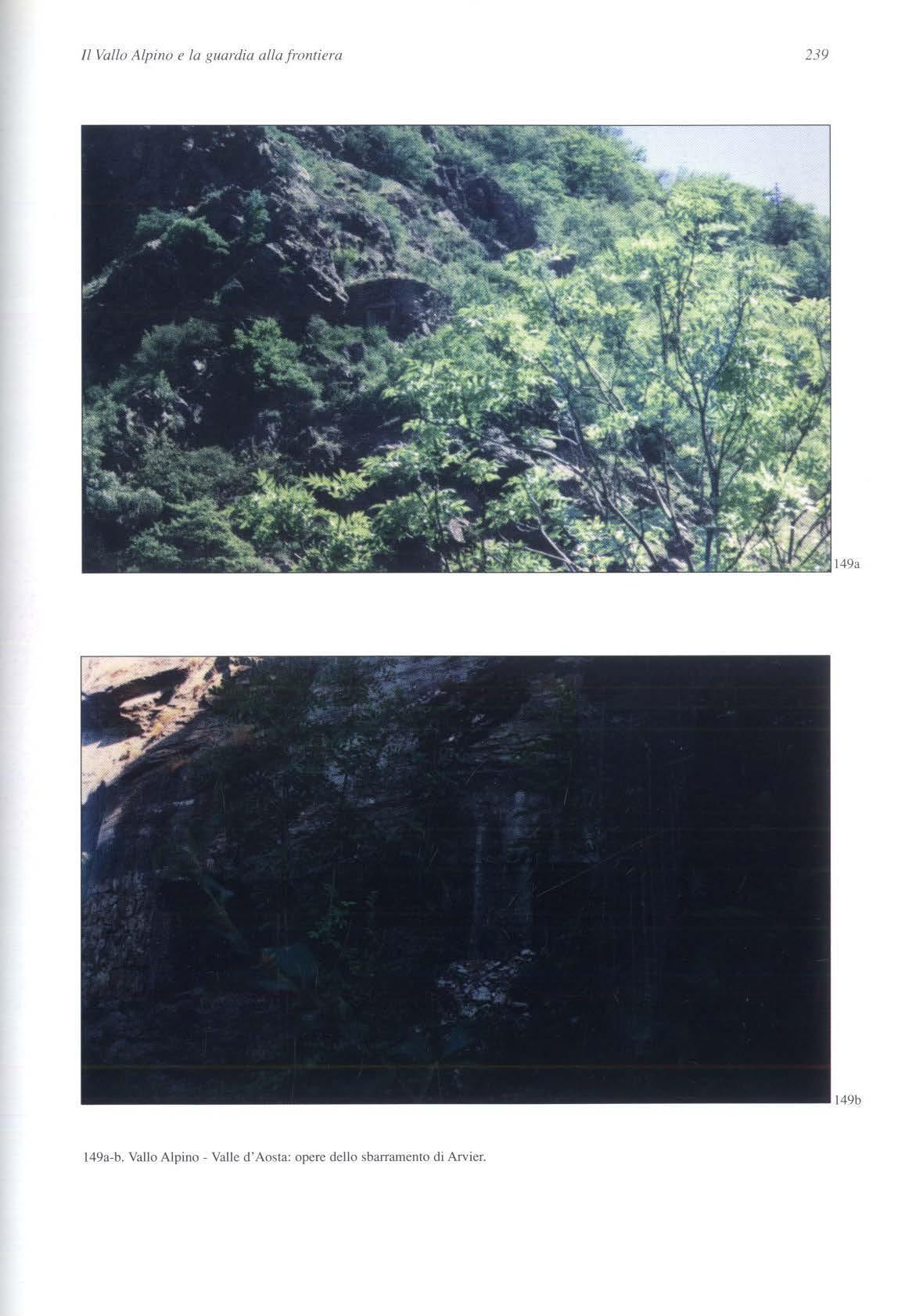
li Vallo Alpino e la guardia alla frontiera 239
149b
149a-b Vallo Alpino - Valle d'Aosta: opere dell o sbarramento d i Arvier
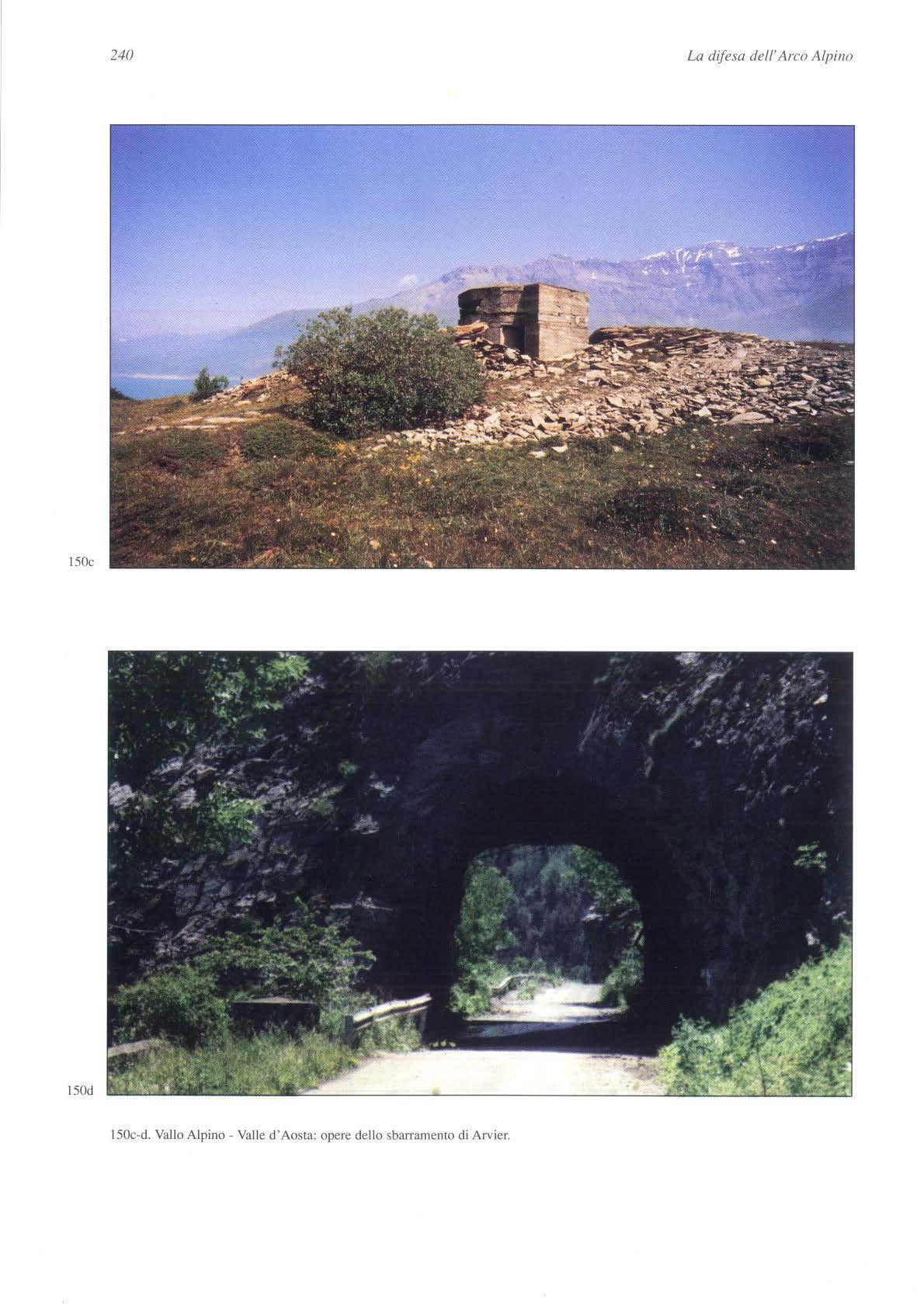
240 La difesa Alpino 150c 150d
LSOc -d Vallo Alpino - Va ll e d'Aosta: opere dello sbarramento di Arvier.
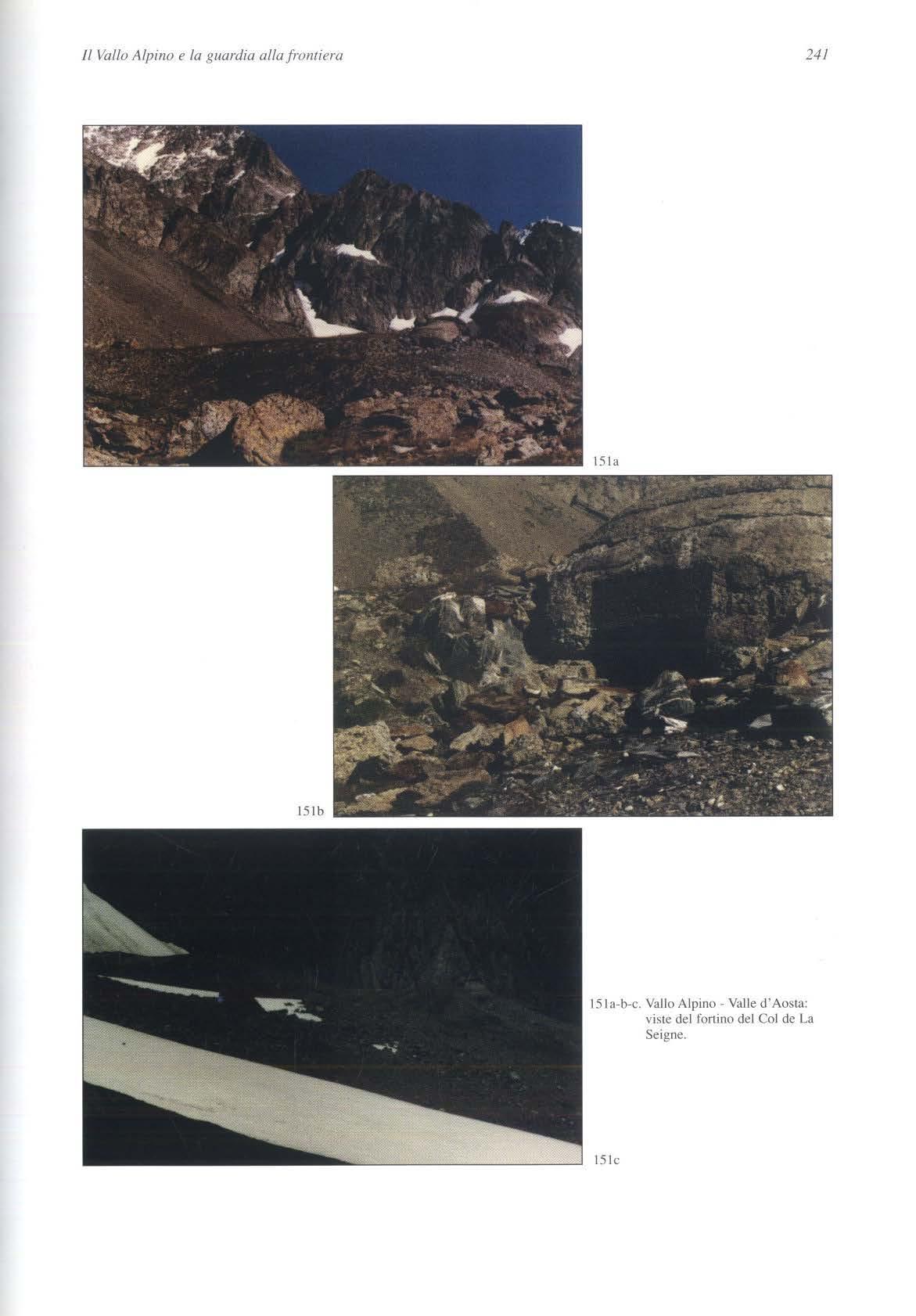
il Vallo Alpino e la guardia alla frontiera 241
151a-b-c. Vallo Alpino - Valle<l'Aosta: viste <lei fonino del Col de La Seigne.
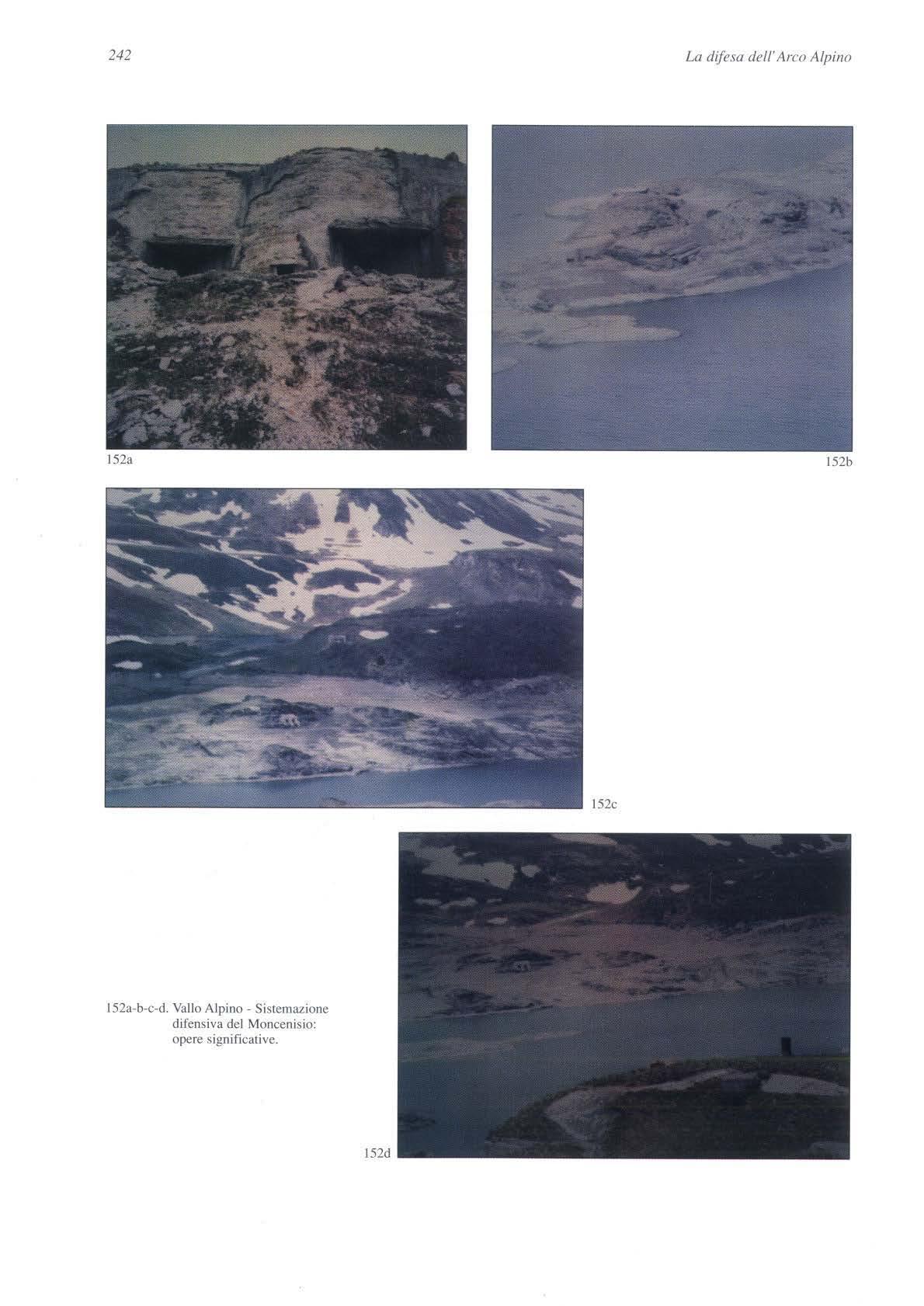
242
152a
l52a-b-c-d Vallo A lp ino - Sistemazione d ife n.siva del Mo ncenis io: opere sign ificative.
La difesa def/' Arco Alpino
152d
152b
152c
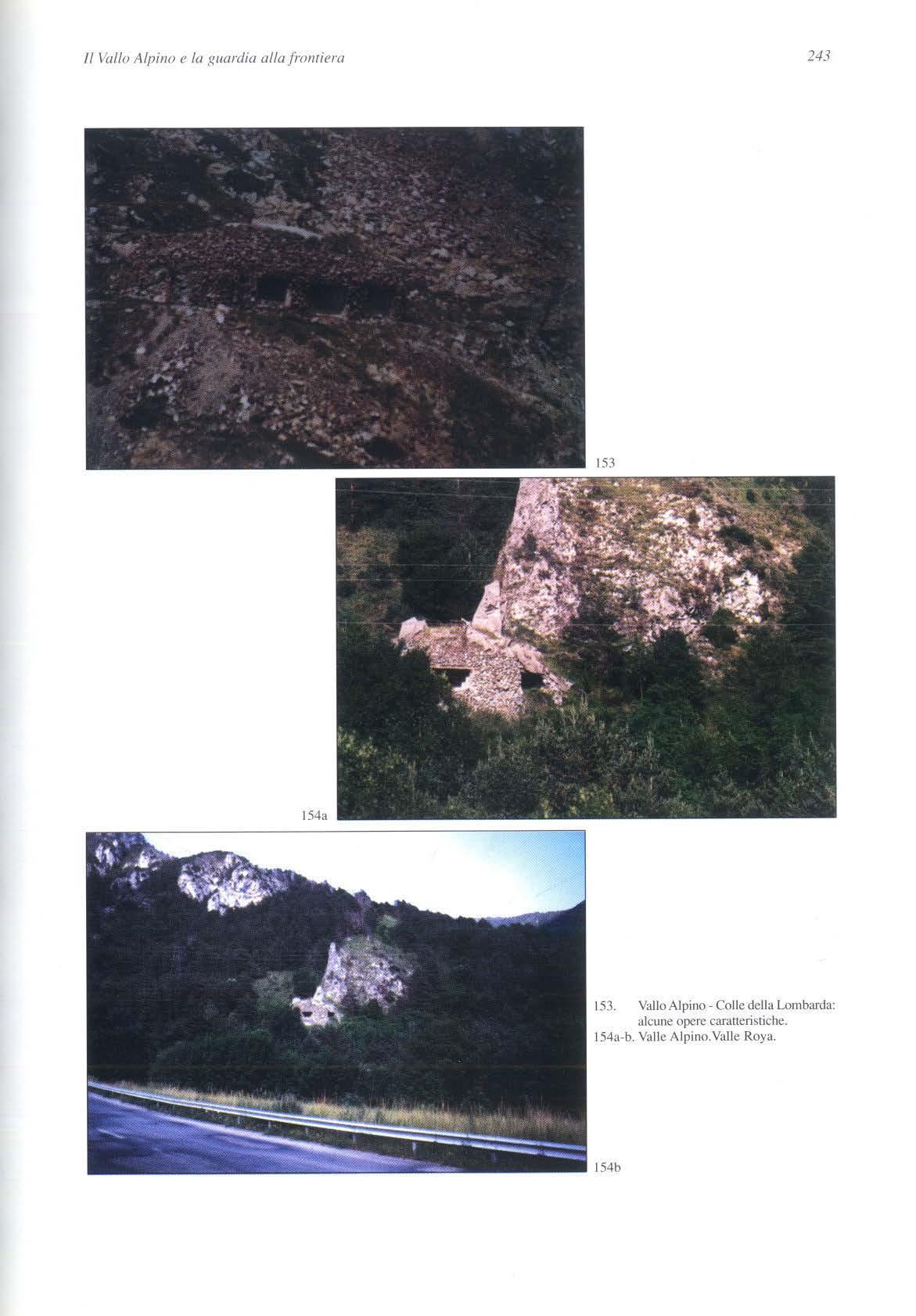
li Vallo Alpino e la guardia alla .fromiera 243
153. Vallo Alpino - Colle della Lombarda: alcune opere caratteristiche. J 54a-b. Valle Alpi no. Va ll e Roya.
]54b

244 La difesa dell'Arco Alpino
155a- b-c. Vallo Alpino - Colle della Lombarda: alcune opere caratteristiche.
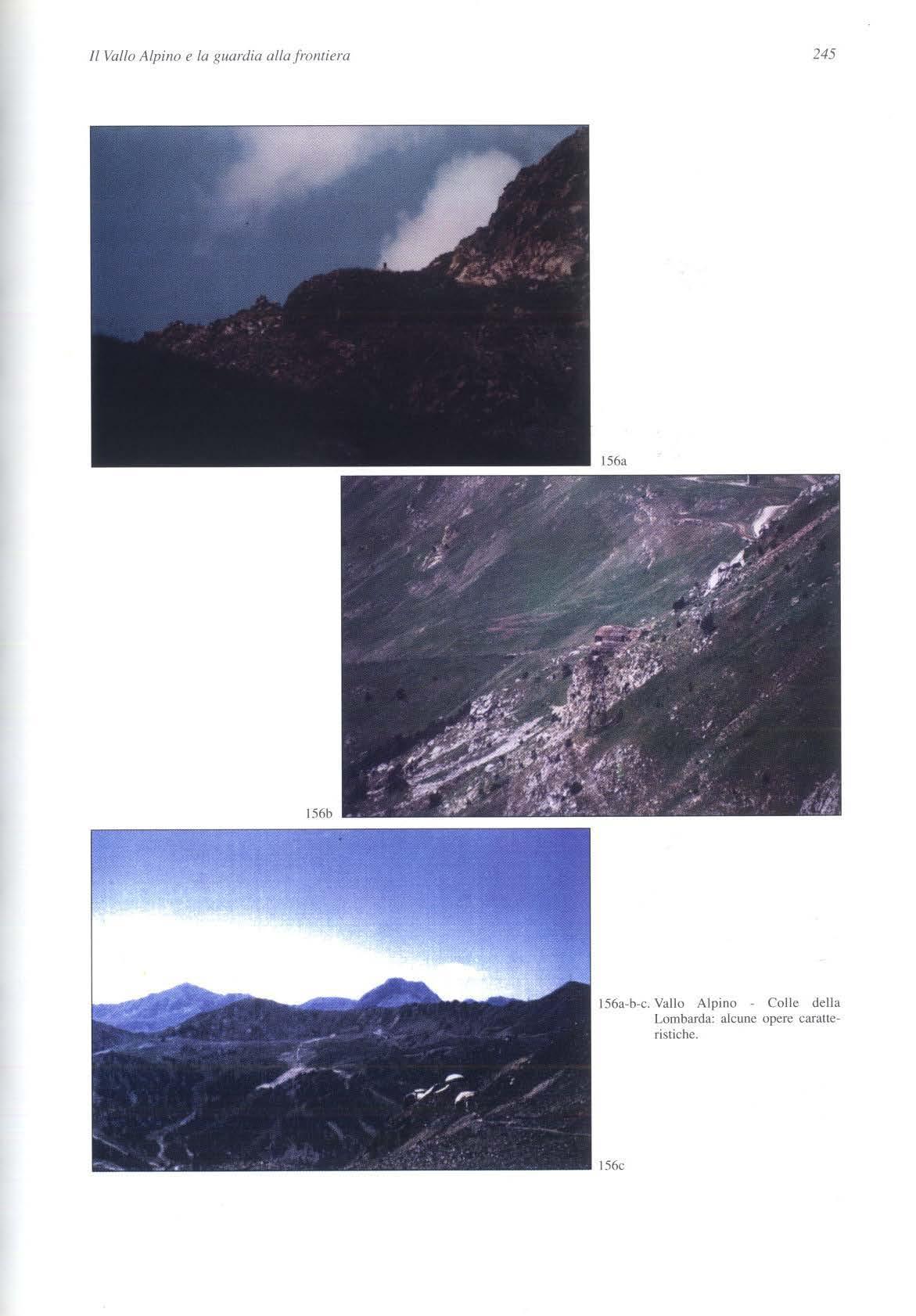
Il Vallo Alpino e la guardia alla frontiera 245
I56a-b-c. Vallo Alpino - Co lle della Lombarda: alcune opere caraueristichc.
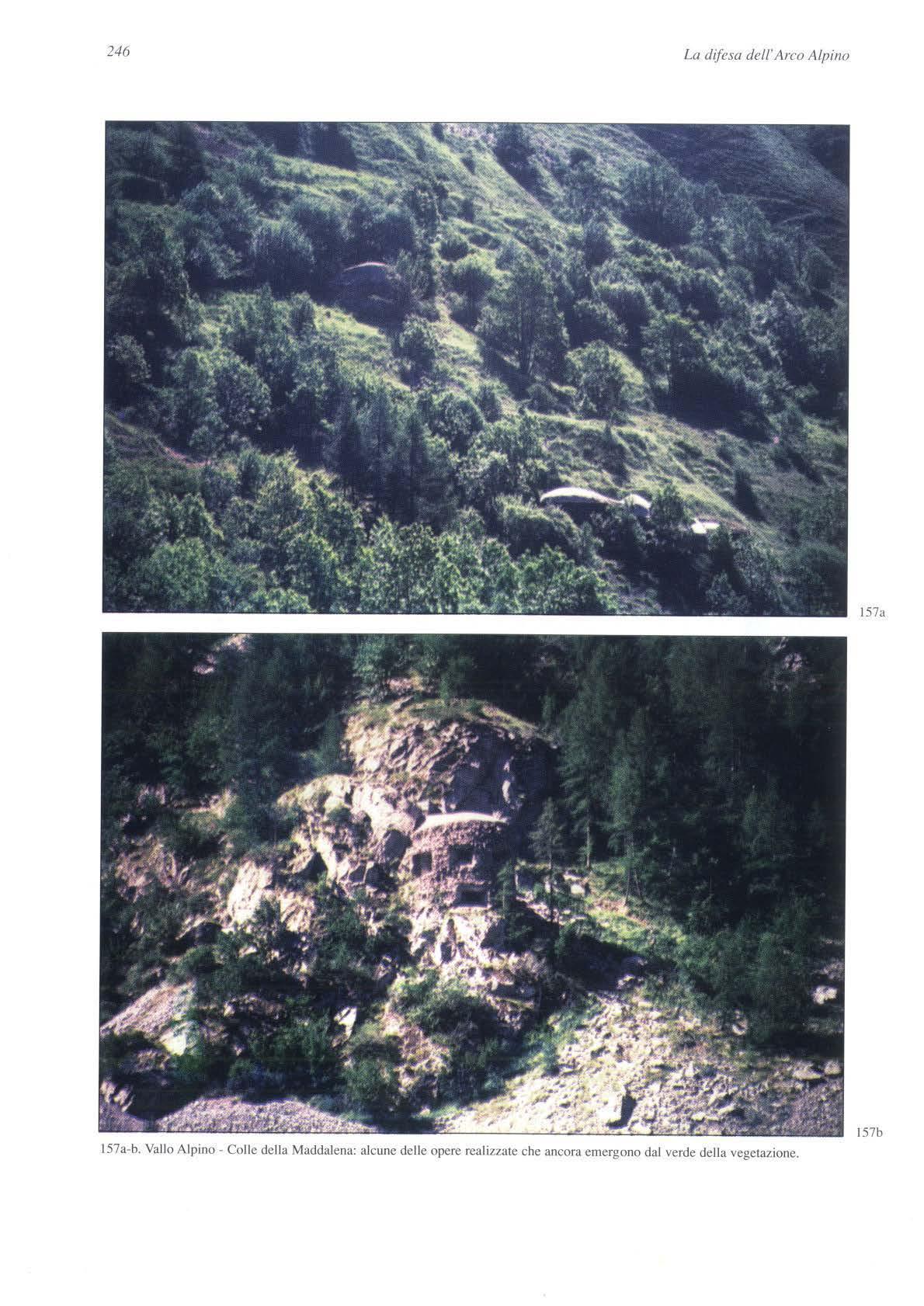
246 La difesa dell'Arco Alpino
157a
157b
157a- b. Va llo Alpino - Colle de ll a Maddalena: alcune delle opere realizzate che ancora emergono dal verde della vegetazione.
4. sistemazioni campali: venivano realizzate nei tratti impervi ed erano affidate alle sole truppe mobili.
Tre erano fondamentalmente i tipi di opera presenti nella sistemazione difensiva prevista dalla circolare 15000; essi differivano tra di loro per il numero di postazioni, il tipo di protezione, il sistema di realizzazione del/degli osservatorio/i e le attrezzature complementari e precisamente:
- opere grosse: munite di cinque o più postazioni, per mitragliatrici, pezzi controcarro o di piccolo calibro , lanciafiamme o mortai, collegate tra di loro e con i locali di servizio da cunicoli protetti, avevano generalmente protezione ai grossi ca li bri ed erano munite di osservatori attivi, realizzati, quasi sempre, in apposita casamatta metallica:
- opere medie: munite al massimo di quattro postazioni per gli stessi tipi di arma presenti nelle opere grosse, analogamente collegate da cunicoli protetti, avevano protezione al medio calibro (grosso calibro solo per quelle inserite nelle sistemazioni tipo ''A"); feritoie di osservazione e periscopi assicuravano il sistema di osservazione;
- opere piccole: costituite al massimo da due postazioni per mitragliatrice. arma controcarro o lanciafiamme, avevano protezione generalmente al piccolo calibro.
Particolare cura era rivolta, in tutte le opere, alla difesa vicina degli clementi vitali dell'opera e cioè ingressi e postazioni; parimenti curata era l'attrezzatura che doveva permettere la efficienza ed azione del presidio, nonché la vita, anche in caso di lunga permanenza all'interno dell'opera stessa.
Si trattava quindi di strutture molto più estese dei precedenti centri di fuoco ed opere 7000, meglio annate, sviluppate su più piani, generalmente raccordati fra loro da scale interne, implementate nella difesa vicina dell'opera con la realizzazione di caponiere armate di fucili mitragliatori, a protezione degli ingressi e di fossi diamante per la difesa dai sabotatori ed il mantenimento del campo di tiro delle armi anche nel caso cli caduta di macerie per bombardamento.
Qualora il tempo e le somme a disposizione lo avessero consentito, era previsto il completamento della sistemazione difensiva con:
I. bretelle di collegamento cli costituzione analoga a quella dei rispettivi tipi di sistemazione difensiva,
2. postazioni per la massa delle artiglierie (all'atto dell'inizio delle ostilità pochissime erano le artiglierie dotate di una sede protetta),
3. ricoveri per le truppe mobili,
4. posti comando per gli Enti che già non avessero sede all'interno di opere,
5. collegamenti di carattere generale,
6. osservatori per le a1iiglierie cd i comandi ai vari livelli,
7. predisposizioni interruttive (gallerie, ponti stradali e ferroviari, vie di comunicazione ecc.),
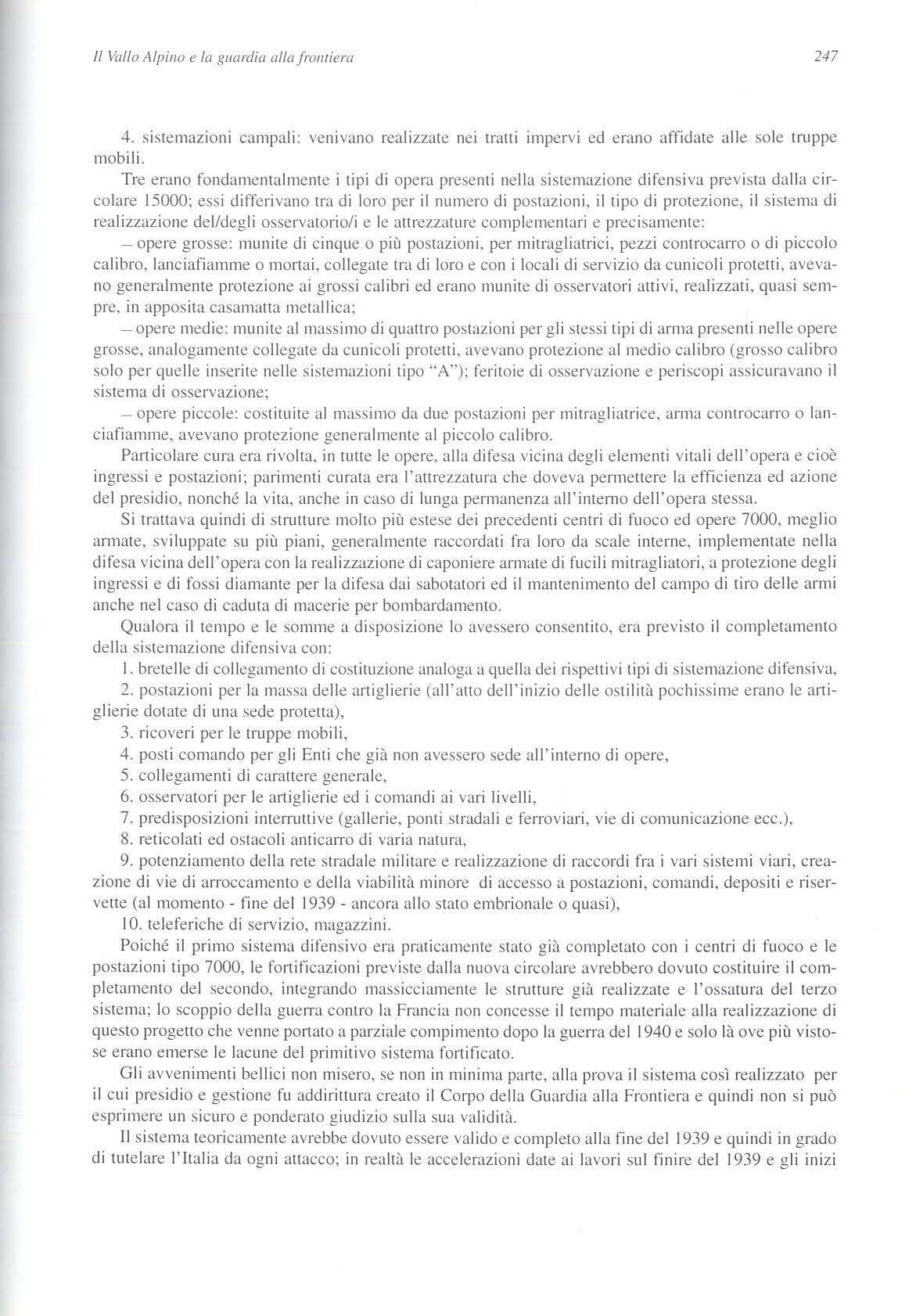
8. reticolati ed ostacoli anticarro di varia natura,
9. potenziamento della rete stradale militare e realizzazione di raccordi fra i vari sistemi viari, creazione di vie di arroccamento e del la viabilità minore di accesso a postazioni, comandi, depositi e riservette (al momento - fine del 1939 - ancora al lo stato embrionale o quasi),
l O. teleferiche di servizio, magazzini.
Poiché il primo sistema difensivo era praticamente stato già completato con i centri di fuoco e le postazioni tipo 7000, le fortificazioni previste dalla nuova circolare avrebbero dovuto costituire il completamento del secondo, integrando massicciamente le strutture già realizzate e l'ossatura del terzo sistema; lo scoppio della guena contro la Fra ncia non concesse il tempo materiale alla realizzazione di questo progetto che venne portato a parziale compimento dopo la guerra del 1940 e solo là ove più vistose erano emerse le lacune del primitivo sistema fortificato.
Gli avvenimenti be lli ci non misero, se non in minima parte, alla prova il sistema così realizzato per il cui presidio e gestione fu addirittura creato il Corpo della Guardia alla Frontiera e quindi non si può esprimere un sicuro e ponderato giudizio sulla sua validità .
li sistema teoricamente avrebbe dovuto essere valido e completo alla fine del 1939 e quindi in grado di tutelare l'Italia da ogni allacco; in realtà le accelerazioni date ai lavori sul fin ire del 1939 e gli inizi
Il Vallo Alpino e fa guardia afta jiw11iera 247
ANDAMENTO
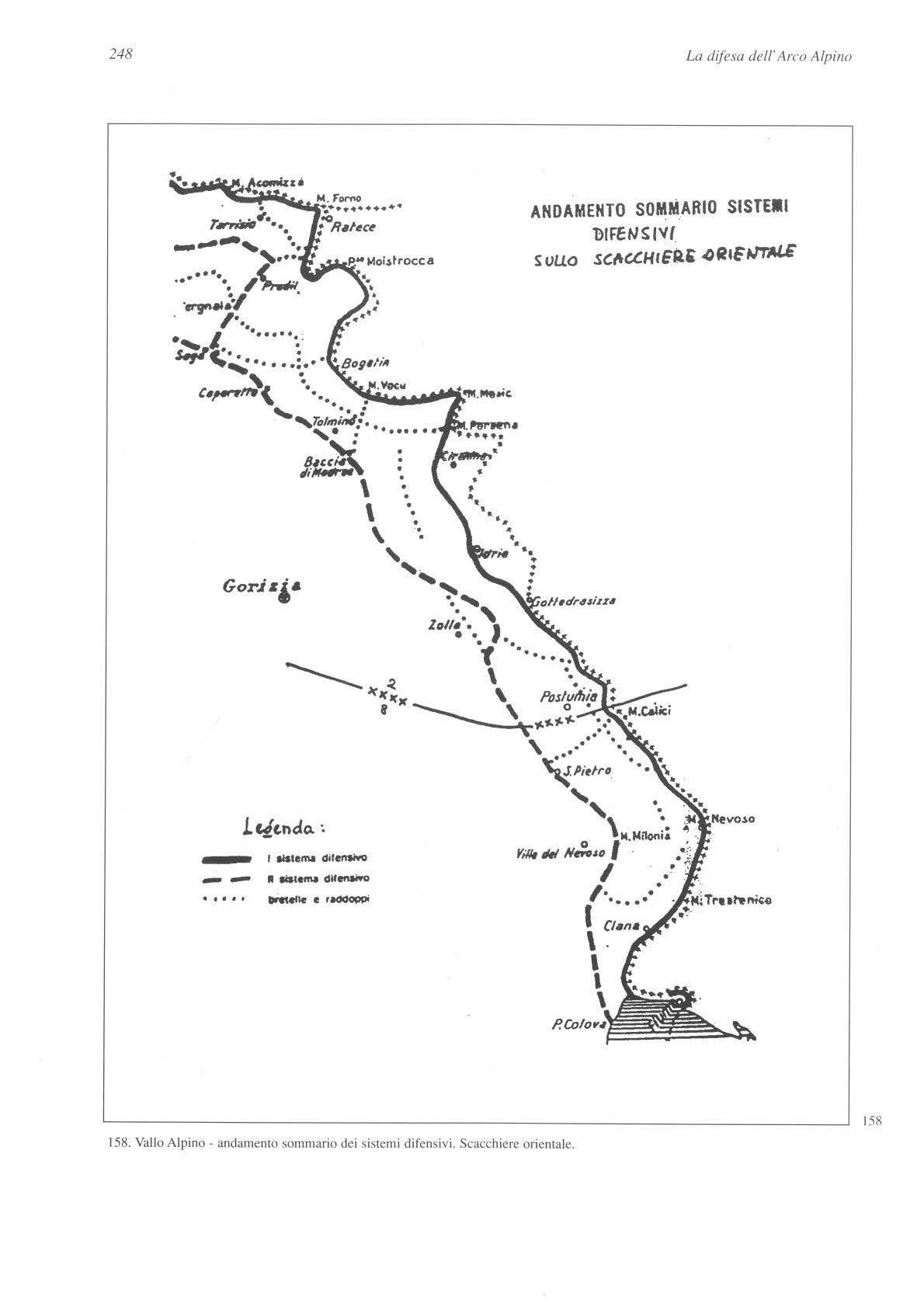
248 7rrillio;.• • • _....., · .. , ... •••• L... ·. ,~ ..,.,,.-':., . ,... ' ....... . ., .. ~~,..... : . ~, ........ . C11~I ••••• ' • ""l.l"li ~"' ' ... ,rolmin4:. '. : ....... . J~ \ \ \ . • . • .. . •" ... w .. .. ,. •• ,,. ,, -..:---, Zoll•. J • • • .., •. La difesa dell'Arco Alpino
SOMM ARIO SISTE•l l)lfENSIVI s ouo .SCr\CCH1fQ.• 4itF,JT'AL.E •• • •• . • \ ,e IC ,ex , Poslv,;,ia ! i o• •M.c.iici I Siltem& difentM> -..... -,.1-1-1> ••• • • .. .. . ' .• . . . . Pi11'ro _ • • • \,. ', . ~.. • • \ \ ICeV0.)0 M.Milon•• Yilll t/,1 N.:O~o f I . I· .....• I a11n• 158. Va ll o Alpi no - andamen
i
iv i Scacc
orien
158
to sommario dei sistem
difens
h ie re
ta le.
del 1940, non riuscirono, secondo quanto emerso dalle ispezioni compiute in loco dai massimi responsabili militari dell'epoca , nonostante la ormai accertata immanenza dell'entrata in guerra , a conferire all'insieme della fortificazione italiana di frontiera quel minimo di completezza, robustezza e profondità necessari alla positiva tenuta della frontiera nel caso di investimento della stessa da parte di un solido e preparato avversario.
Anche in questo campo, campo di cui nessuno aveva messo in dubbio la attualità e necessità, si verificò il ritardo di attuazione che caratterizzò il pur indifferibile rinnovo del parco delle artiglierie, dei mezzi corazzati e degli altri strumenti bellici e che portò impreparato l'Esercito llaliano al secondo Conflitto Mondiale.
Armamento delle opere
L'avere il costituito Vallo Alpino inglobato le opere risalenti agli albori del '900, dotate di artiglierie protette da coperture corazzate o cemento armato , porta doverosamente ad esaminare non solo le anni automatiche ed i cannoni di piccolo calibro adottati dalle moderne costruzioni fortificate, ma anche le artiglierie che, montate in cupola, armavano queste antiche strutture inserite a pieno titolo nel Vallo.
L'esmne delle anni presenti nelle strutture mostra come in Italia non fossero state realizzate, a differenza di quanto invece fatto specialmente in Francia, mitragliatrici, mortai, lanciagranate o cannoni controcarro appositamente progettati per essere impiegate dalle strutture fortificate; le a.imi collocate all'interno delle fortificazioni del Vallo erano quelle di normale dotazione ai reparti, senza alcuno specifico adeguamento degli affusti al particolare impiego; di ciò venne tenuto conto in fase di costruzione delle strutture e le feritoie vennero realizzate ad altezza adeguata agli affusti regolamentari.
Solo in tempi successivi, allo scopo di migliorare le prestazioni delle armi, garantire la sicurezza dei serventi e poter effettuare tiri frontali , vennero realizzate feritoie scudatc prodotte in diversi modelli, cupole metalliche corazzate mono o pluri arma, affustini o supporti particolari da collegarsi alle suddette blindature; l'insieme arma-cupola o armascudo veniva inserita nella struttura di cemento o nelle aperture ricavate nella roccia ove era stata realizzata la fortificazione.
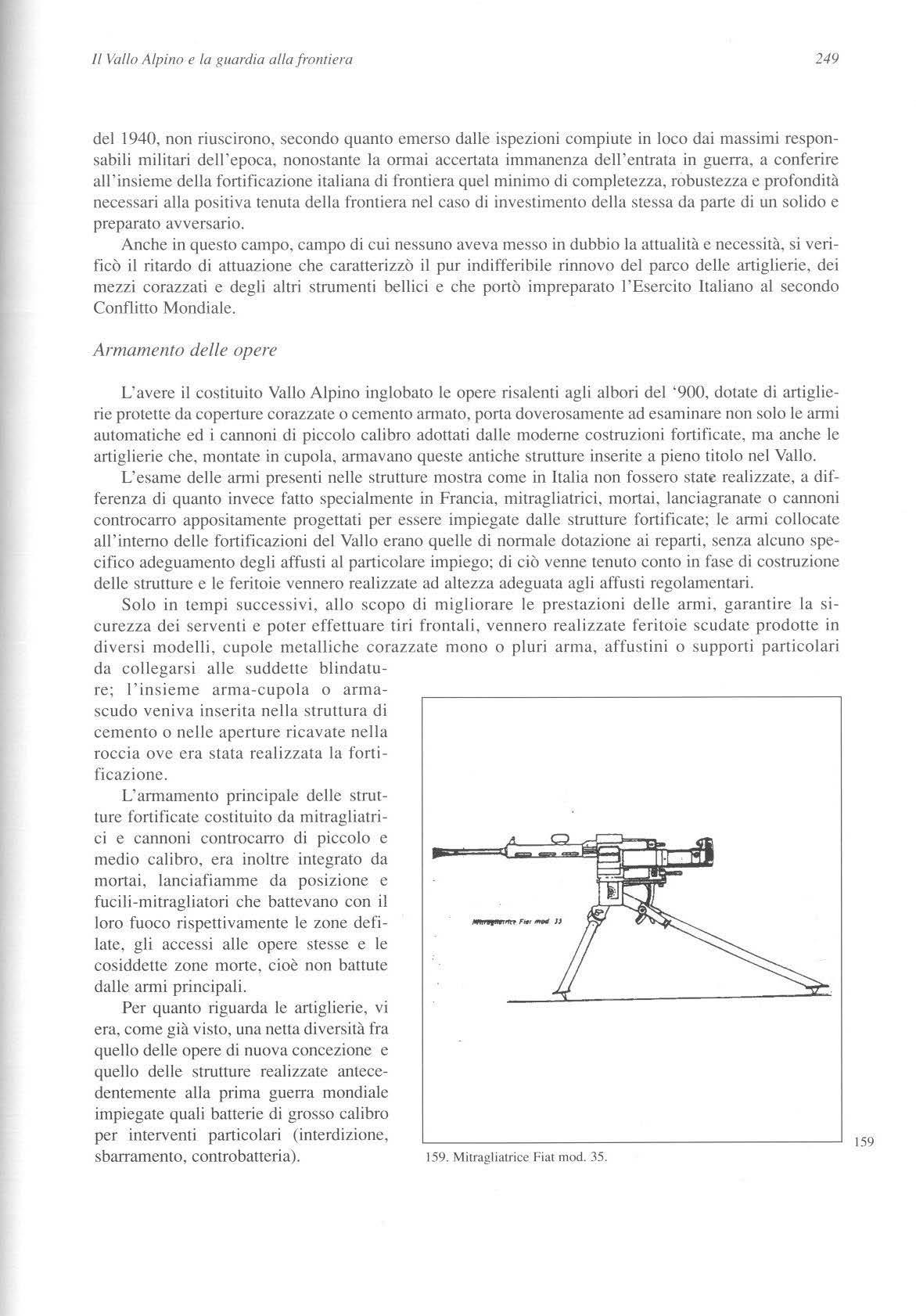
L'armamento principale delle strutture fortificate costituito da mitragliatrici e cannoni controcarro di piccolo e medio calibro, era inoltre integrato da mortai, lanciafiamme da posizione e fucili-mitragliatori che battevano con il loro fuoco rispettivamente le zone defilate, gli accessi alle opere stesse e le cosiddette zone morte, cioè non battute dalle armi principali.
Per quanto riguarda le artiglierie, vi era, come già visto, una netta diversità fra quello delle opere di nuova concezione e quello delle strutture realizzate antecedentemente alla prima guerra mondiale impiegate quali batterie di grosso calibro per interventi particolari (interdizione, sbarramento, controbatteria).
Il Vallo Alpino e la g uardia alla frontiera 249
159
159. Mitrag liatri ce Fiat mod. 35.
Le opere di "nuova" concezione prevedevano ed utilizzavano principalmente i seguenti pezzi:
- cannone da 47/32 modello 35, usato incavalcato sullo specifico affusto a code come arma anticarro standard del Regio Esercito, allorché installato in casamatta, veniva impiegato con le ruote sollevate oppure incavalcato su affusto speciale modello opere; armava le strutture del 2° e 3° sistema, le bretelle di raccordo e le opere realizzate dopo il 1935;
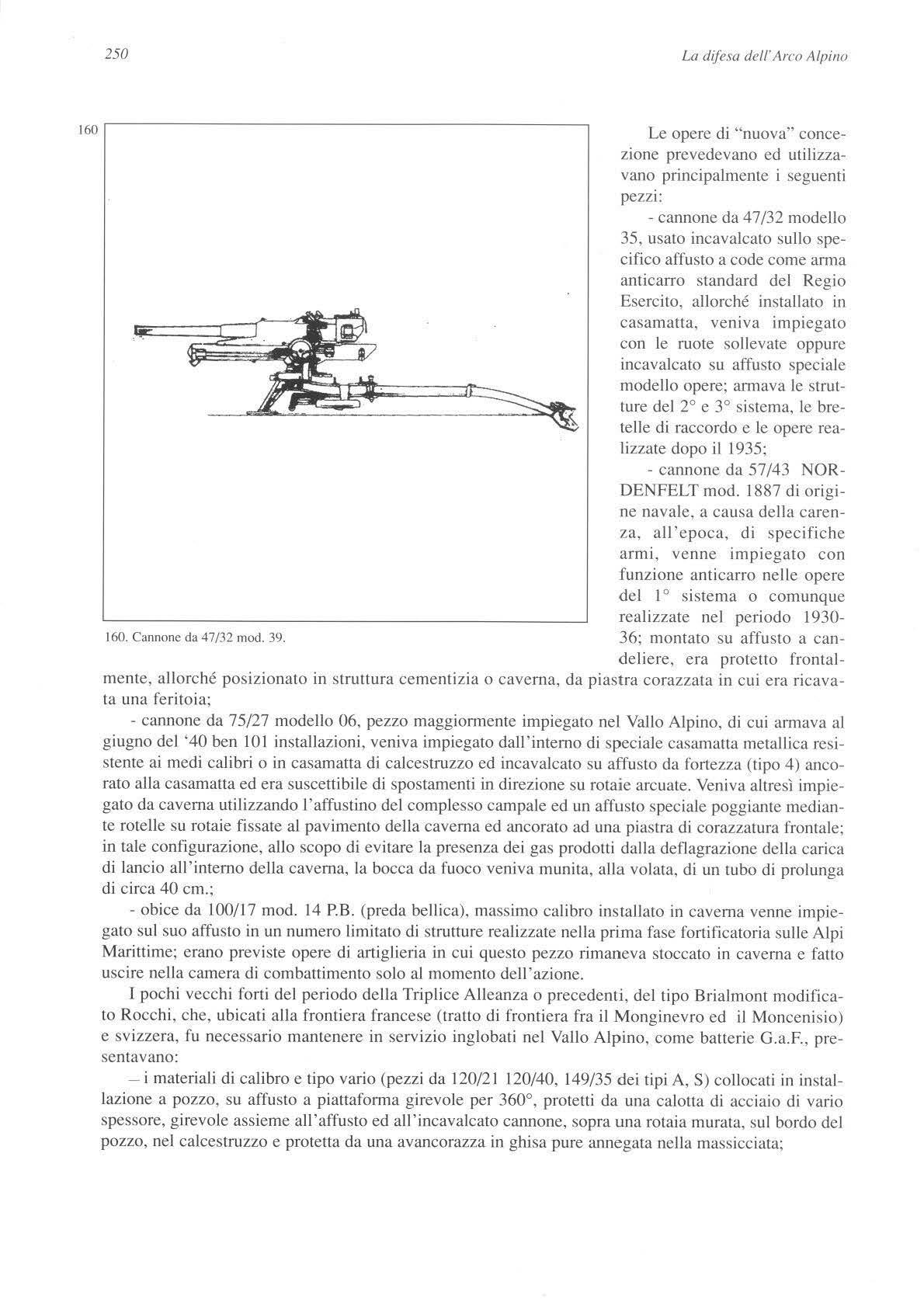
- cannone da 57 /43 NORDENFELT mod. 1887 di origine navale, a causa della carenza, all'epoca, di specifiche armi, venne impiegato con funzione anticarro nelle opere del 1° sistema o comunque realizzate nel periodo 1930160. Cannone da 47/32 mod. 39. 36; montato su affusto a candeliere, era protetto frontalmente, allorché posizionato in struttura cementizia o caverna, da piastra corazzata in cui era ricavata una feritoia;
- cannone da 75/27 modello 06, pezzo maggiormente impiegato nel Vallo Alpino, di cui armava al giugno del '40 ben 101 installazioni , veniva impiegato dall'interno di speciale casamat ta metallica resistente ai medi calibri o in casamatta di calcestruzzo ed incavalcato su affusto da fortezza (tipo 4) ancorato alla casamatta ed era suscettibile di spostamenti in direzione su rotaie arcuate. Veniva altresì impiegato da caverna utilizzando l'affustino del complesso campale ed un affusto speciale poggiante mediante rotelle su rotaie fissate al pavimento della caverna ed ancorato ad una piastra di corazzatura frontale; in tale configurazione, allo scopo di evitare la presenza dei gas prodotti dalla deflagrazione della carica di lancio all'interno della caverna, la bocca da fuoco veniva munita, alla volata, di un tubo di prolunga di circa 40 cm.;
- obice da 100/17 mod. 14 P.B. (preda bellica), massimo calibro installato in caverna venne impiegato sul suo affusto in un numero limitato di s trutture realizzate nella prima fase fortificatoria sulle Alpi Marittime; erano previste opere di artiglieria in cui questo pezzo rimaneva stoccato in caverna e fatto uscire nella camera di combattimento solo al momento dell'azione.
I pochi vecchi forti del periodo della Triplice Alleanza o precedenti, del tipo Brialmont modificato Rocchi, che, ubicati alla frontiera francese (tratto di frontiera fra il Monginevro ed il Moncenisio) e svizzera, fu necessario mantenere in servizio inglobati nel Vallo Alpino, come batterie G.a.F., presentavano :
- i materiali di calibro e tipo vario (pezzi da 120/21 120/40, 149/35 dei tipi A, S) collocati in installazione a pozzo, su affusto a piattaforma girevole per 360°, protetti da una calotta di acciaio di vario spessore, girevole assieme all'affusto ed ali 'incavalcato cannone, sop ra una rotaia murata, sul bordo del pozzo, nel calcestruzzo e protetta da una avancorazza in ghisa pure annegata nella massicciata;
160 250 La difesa del/' Arro Alpino
- i complessi installazione per i pezzi non omogenei, in quanto realizzati per i diversi tipi di cannone in tempi e modi diversi anche in funzione delle diverse esigenze, ed identificabili per il nome preso dalla casa costruttrice, dall'ideatore o dall'impiego particolare per cui erano state realizzate. Da un esame della documentazione dell'epoca risulta che le strutture mantenute in servizio ed inserite nel Vallo Alpino furono:
I. Batteria La Cou11 (5 1211 btr. G.a.F.) e Batteria Paradiso (51311 btr. G.a.F.) armate rispettivamente con 4 e 6 pezzi da 149/35/A in installazione tipo G,
2. Batteria Pramancl (51411 btr. G.a.F.) armata con 4 pezzi eia 149/35/A in installazione tipo A,
3. Batteria Bramafam (51611 btr. G.a.F.) armata con 2 pezzi da 120/21 in installazione tipo A,
4. Batt eria (forte) cli OGA (Borm i o) (52211 btr. G.a.F.) armata con 4 pezzi da 120/40/A, ciascuno in pozzo singolo protello da cupo l a leggera ,
5. Batteria Chaberton (5 1511 btr. G.a.F. ) armata con 8 pezzi da 149/35/A, in torre singola in installazione tipo A.M.
6. Batteria (forte) di Colico (52011 btr. G.a.F.) armata con 4 pezzi eia 149/35/S, in installazione tipo S,
7 Batteria (forte) di Tirano (521 11 btr. G .a.F.) armata con 4 pezzi da 149/35/A, in installazione tipo A.
L'armamento di talune di queste batterie o forti era talvolta integrato da:
- pezzi da 57 mrn. a caricamento rapido, di produzione Gruson, che costituivano l'armamento delle torrette a scomparsa (forti Bramafam e Giaglione, fortino di Colle delle Finestre),
- pezzi eia 57/22 e 42/30 che, cli modello antiquato, venivano impi egati su affusto a candeliere o piedistallo per l a difesa delle fronti secondari e o, incavalcati su affusti a ruote, venivano posizionati all'immediato esterno od interno delle stesse opere.
A fronte della eterogeneità del materiale che si era dovuto mantenere in servizio, e relative specifiche installazioni, il Generale Guicletti, responsabile della cos tru zione elci Va ll o, aveva eseguito studi per modificare l e installazioni in cupola ancora esistenti allo scopo di renderle più omogenee e rispondenti al le offese che nel corso dello stesso primo conflitto avevano causato la perdita di alcune nostre fortificazioni; il prezzo rilevante e la eccessiva eterogeneità del materiale installato nelle strutture conservate ed inglobate nel Vallo sconsig li arono l'adozione globale cli tale valida modifica e le strutture mantennero il sistema a pozzo di origine .
Lo sviluppo jòrtificatorio negli Stati confinanti
L'evolversi della situazione po liti ca internazionale ha determinato spostamenti della linea di confine a favore degli Stati che hanno combattu t o contro l'Italia e conseguentemente molte fort ificazioni a suo tempo erette sono scomparse perché col loca t e lontano dai luoghi di possibile utilizzo; è tuttavia possibile definire, da un esame dei documenti rinvenuti, quale fu l'attività fortificatoria degli Stati che si affacciavano su l confi ne italiano ed in un solo caso (Francia) mostrare i prodotti di tale attività:
- Austria:
eia parte di questo Stato non ve nne realizzata alcuna fortificazione a tutela del confine con l'Italia e la successiva annessione alla Germania annullò ogni eventual e progetto c he a tale riguardo lo Stato Maggiore austriaco potesse aver concepito.
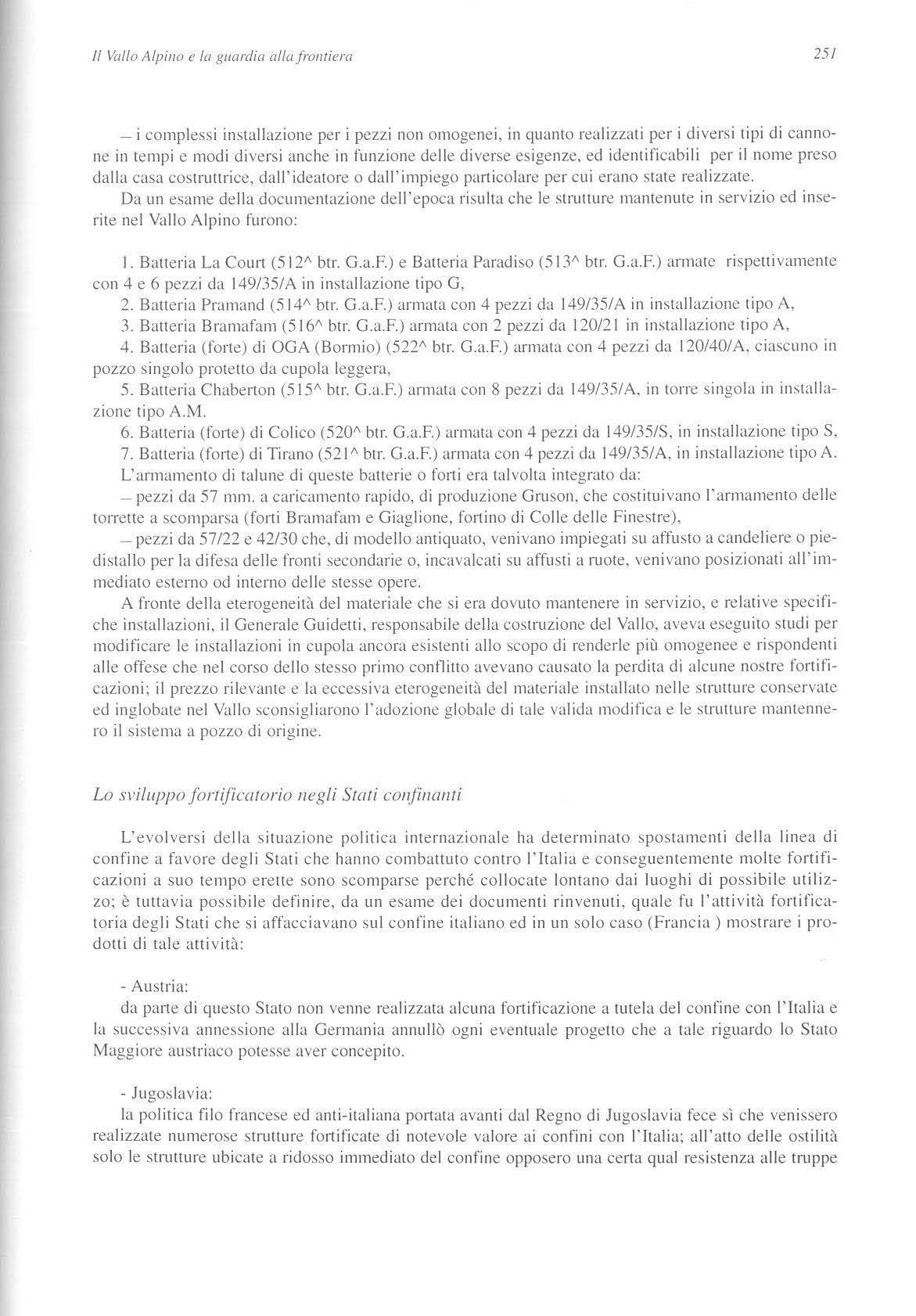
- Jugoslavia:
la politica filo francese ed anti-italiana po11ata avanti dal Regno di Jugoslavia fece sì che venissero realizzate numerose strutture fortificate cli notevole valore ai confini con l'Italia; all'atto delle ostilità solo le strutture ubicate a ridosso immediato del confine opposero una certa qual resistenza alle truppe
li Vallo Alpino e la guardia alfa fro11tiera 251
VALLO ALPINO
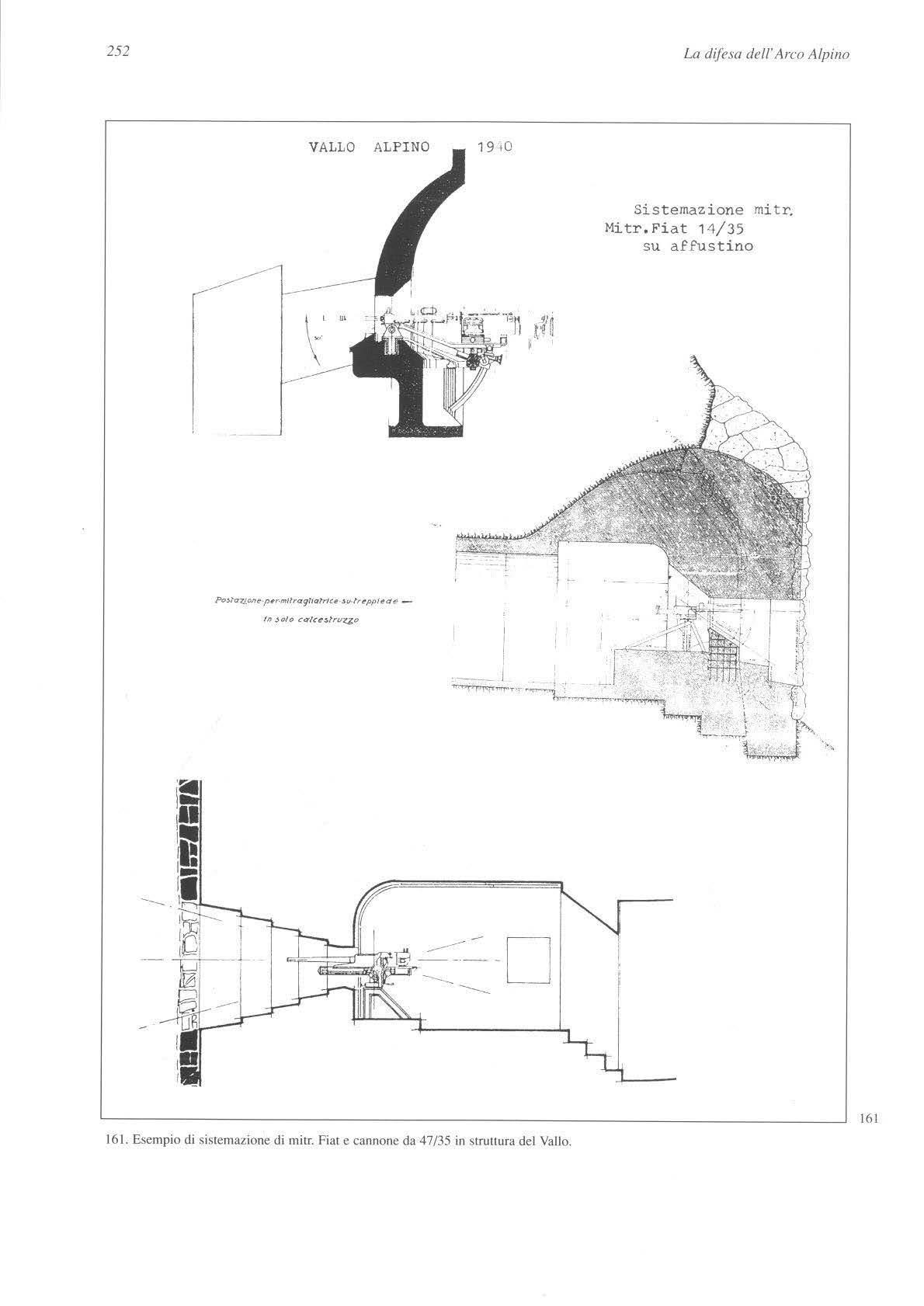
252
:--l
La difesa dell'Arco Alpino
161 . Esempio di s istemazione di mitr. Fiat e cann one da 47/35 in strutlura de l Vallo.
161
Sistemaz i one mit~ Mitr . Fiat 14/35 su affustino
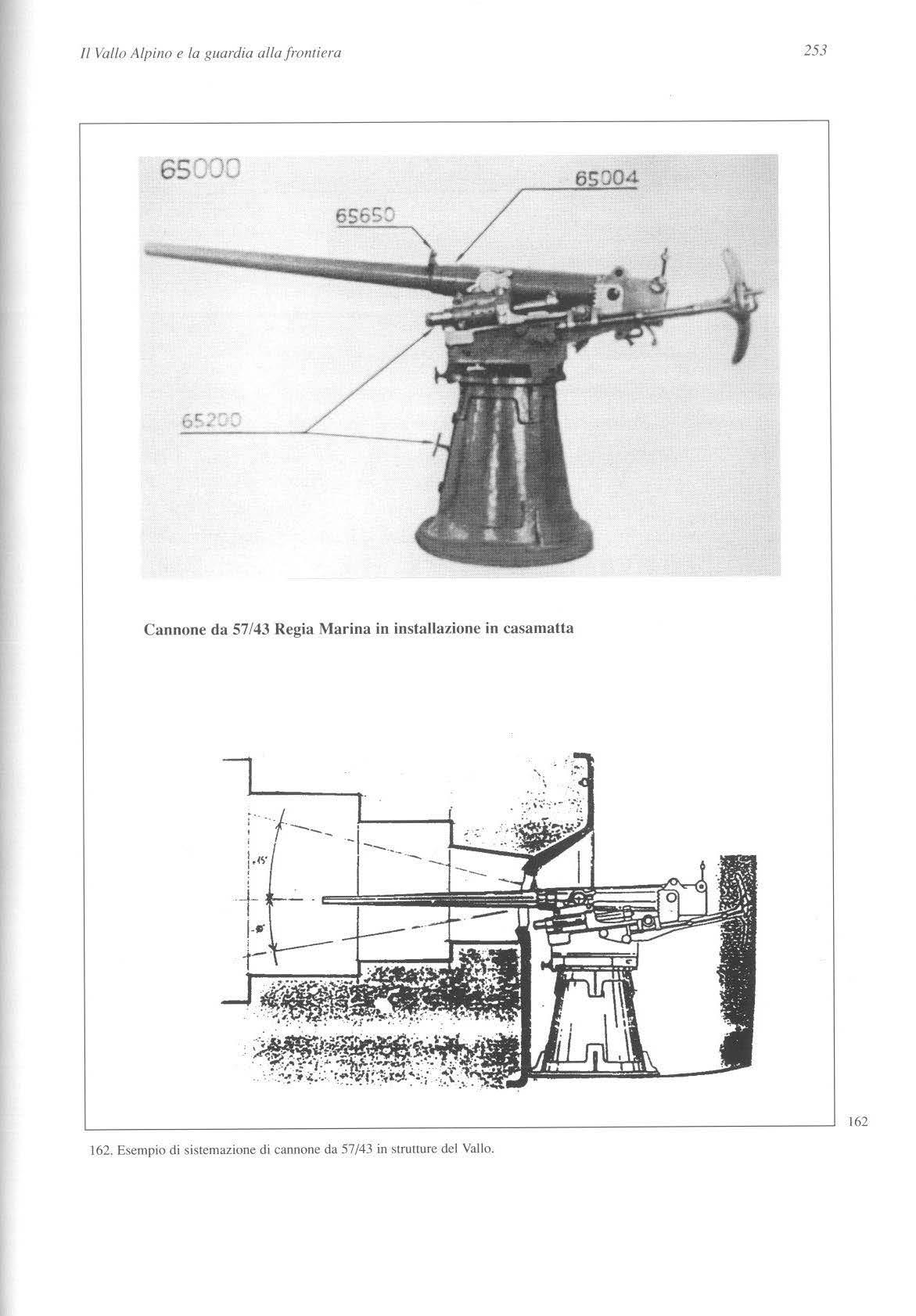
li Vallo Alpino e la guardia alla fronriera 253 65 000 65004 65 650
:·· / - 1· ~.' i i ,.. .• _ -- .--_;;.::: ,.,, -' --'_j _ I 1 .f- · 162
Cannone da 57 /43 Re gia Marina in in stalla z ion e in casamatta
162. Esemp io di sistemazio ne d i cannone da 57/43 in struuu re del Va ll o.
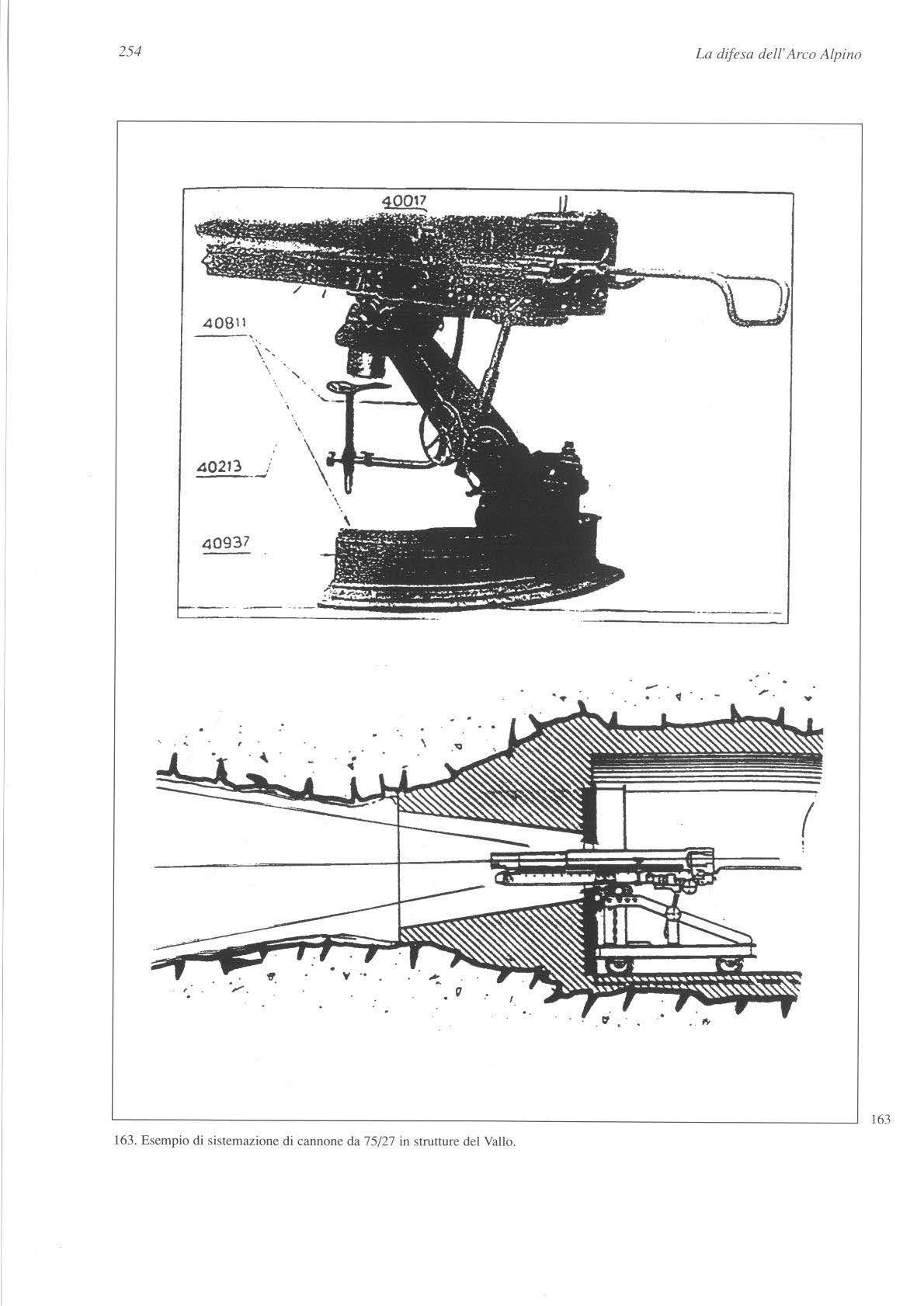
254 La difesa dell'Arco Alpino 40811 \. ', ' ' 40213 -' 40937 - -·--·163
163. Esemp io di sistemazione di cannone da 75/27 in s trutture del Vallo.
OBICE DA 10(1 li Mo<I. 14
Bocca dA luoao
l.>i ;,cciaio, a pan:u "'-'mt•lfC;1 (in ~u.dC"'h,· t·1".:mp.l~rc .1 tubo auim:\ ci.:rcbi•tO).
L b ! dcli!\ p,u1, 1·>1;•l".
ung .zta. I tota!,·
Volume iai&iak di ,_'°'"""'"'
aat.a a d. •· 41,. 14")
Prc&UODC do•ulA alhl. c~r 11f:.,4.
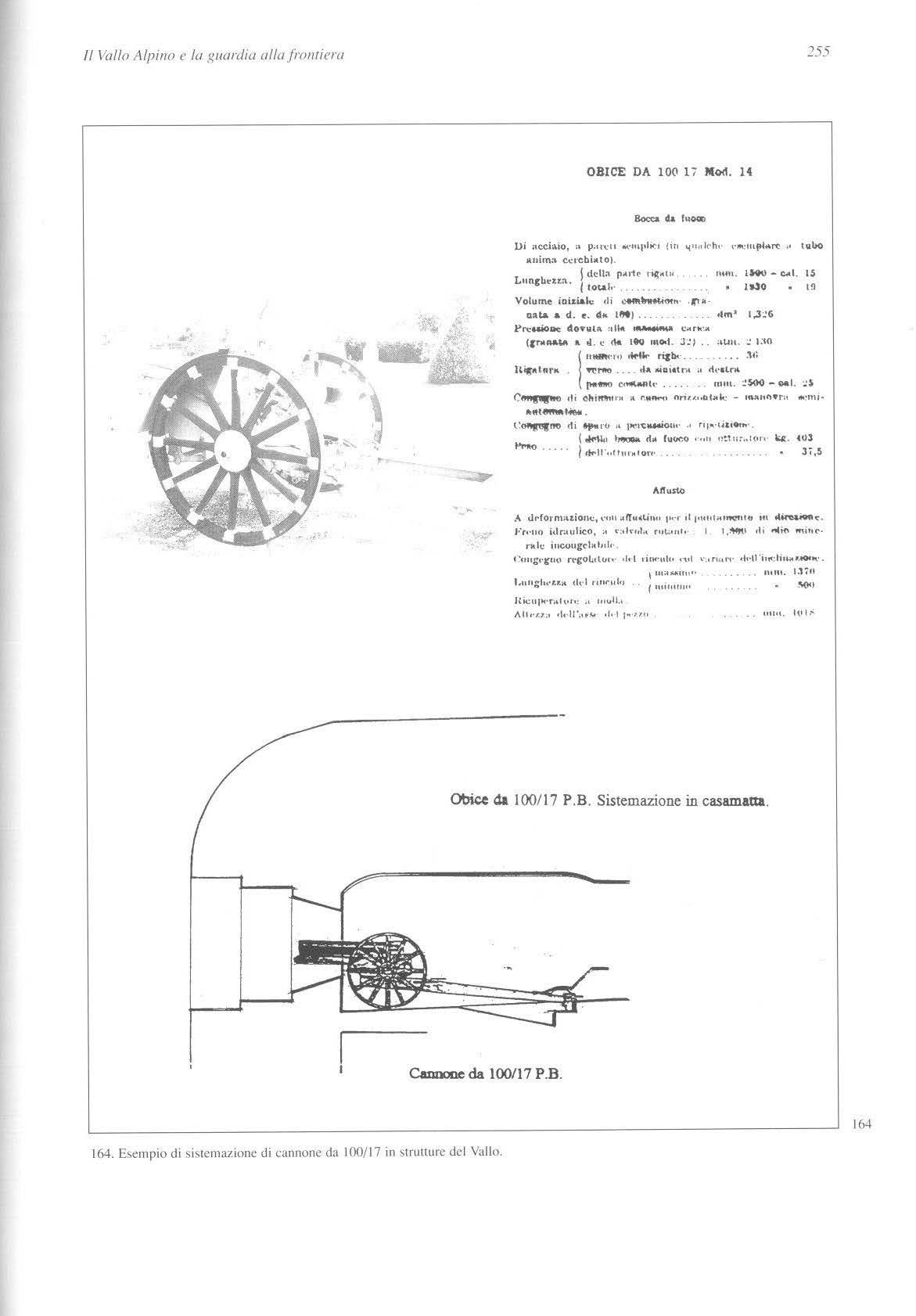
l\lfll. 119\1-c.ol. 11'l0
C'I•·
f(ffl 1 1,J:6 (I"',.."' ., .i. e <\e. lto mo.I J: j u11 : 1:10
1'i(Att1rK .-CrtltO •.•. ,la. Maittr,1 a ,tt,alrM.
1$ l~ l,,_,..., ,14-11,, n,b< ·. ~«:
p,t11110 c,_l\' mm - oal. ~$
e~ tli chitftttnt il , n,;,.,.,.U(Jolk: - 111:u,..,.r., - ~m,- ..,tt-~ .
C°"f'Ol'fffl di ..,_r<, a lllt"l'C.....,;Olu· r,1~·1.ii&tc.t" ·· { tk41,t, dà [u<.,<:o , 11 o-:.tu~.~l<trt · ka: 4.0.J t-Mlo ' · · · · J 4f-truttur"ton• , li ,5
Affusto
A Jc·fOl'nlatioau.:, 1,.·011 :.tf'f«c.t..inu p,·r ,t .,,u1(Mf~1tc, tu 4wc&ioth: " .t:." J,'r,·110 i<lr.wlico, :1 ~:,h·11t" r,,t.:rn•,· 1,:,,,,C,• ,H ,..i-<" ..,i,1<'• n.lc iucougcl-tfulc· f'm1;,·ru<, n•gol.tlot1· ,Id 1i1w-ul<1 '"'I ,·.• r,01'<· ddl"iHdin~,.40ft\',
'ntifllllHI
H:icUJ)t•raJ(•r ,: ,1 111vll.t Ah•·r.7:, d, H'.,t~ ,t.11 ,.,<•
mm. llfo !\OC! mtu l(1l:"
Obice
Il Vallo Alpino e la Ritardia alla jì'Of1tiera . ... 255
4a 100/17 P.B. Sistemazione in casamaaa.
Cannone da 100/17 P.B.
164
164. Esempio di ~i~iernazione di cannone da 100/17 in strutture del Vallo.
PRINCIPALI ARTIGLIERIE INSTALLATE NELLE OPERE DEL VALLO -Strutture di antica concezione-
CANNONE DA 120/'0
DI ICCl>lo al Gicll.U., OOmpo&V., - - lii ,art. •
t,o. ùlla pa,lo rtc,.t& • . mm 0111et - ool. 31
t,,a.t,ci. l1oi..i. • • , uu,,, u,t
VoJw.m• 4J oocaba1U.O.
(l"onob • pollotlo 4o 110)•••. dm' f,UO
Preulooodon&a.U. maaalmo cuiu
(,,....lo • ,.U.llo da 110) , •= 2'00
B.tpt.a,. Mo d• c1a1tn • tl.aMlil•
..,..,..,., dello rlpt se pMIO 001&aote .••••. mm SIOO - ool. SO
OOIIC'C"• 41 ohlaJV.ra ·• riloot olllJld,o troooO ootlloo, -
....UOpla.liloo.
~oo 41 ,p,,,o •,.,.....ione,• rfp.t.ulon1.
p- 4o1la - 4o - (con oer<>hlo porlo &a dal ltoDI)
q '"'·
tA,i&llulooe
lii po-, oon oopcri..r. metolllea 11ff.,,._ IOltoDGl,I ID4lpm•
d -lo dall'al!ulo • ooo qllOO&a t!N•or.: al!a1lo od llloal 10 plal,tal • -bVO pATole; o,,llo O moD!oollo
OOD lrMa J4nalloo O ,ioupert.loTO I moli,,. ()oal1CJlb 4I
olen.rJo0,t O d llon, OOD dllpoclll\'O 41 lll&l>Offa topldo por lllr4 la4.tpoa4ente. 0oq..., 41 ~.
tra p!MWonlla ct,w,ol• • b..- to.
aou.c-1o tlMlleo Ira c..,..i. 41 ooperm• • al!v.no.
PnllO l4nalloo dal Ila-. od 1WCII di olloU6
•llri&bU. ...U'lolomo 4tl cllusdto td embolo - O-In;
CANNONE DA 120/21
DI aoclolo LII ·1ooo o&wr.t.or• • ~..... .,lo ,o,a -..i.
.- ,. , lftO-oal.~ 'l'olun1lal.slaledl-l>utlou (lnua
• pell&l:lo 4o U0/11) •lm' sµt
doftlo olla(lrt,na.16 • p~te da 1:I0/'1) .•.• •""- UH
Blcolva ...,.. 4a 4olln • eblllln linmvo doli• rl(h1. H
,- _....,te mm. - - ..i. lSO
Oo- 41 elllunn • rilo111 Sparo mtldlolllo -atllo • lrlllooo o oollN1lO dl -.!00,t
• poreu&lo111 ,..... ...l 4.u:
q. 1'22

! 4111 1011<1.tt.~n t oporlollo,. : 6,
•) .4.Jtnl.to da d.UaH, pt.r b-..uerl& • C&AD011.Mr1. 'IIUDJm•
•> UQ.lt.o por t.otn ooru1&W..
<) AtrUlo da d.UCM jg OUut..Ct.L
256 La difesa Alpino
r:: ::
_ .. _
!
_ .. _
Pt-
:=i:..~.~-~~
165
165. Vallo Alpino - artiglier ia ad i ns tallazione fissa - cannone da 120/40.

Il Vallo Alpino e la guardia alla frontiera 257
J
t.')
O'>
'1
"O
<t <.) <l O) -..:] "" D w z o z z <l u 166 166. Vallo Alpinoartiglieria ad installazione fissacannone <la 149/35.
o N N o Q_ z
N <i _J _J <i I'- 1,/) z <t a, a, ';i ,o 'O w w z z q o z z z
z <i <t u
u
-
w z o z
ARMAMENTO DELLE FORT IFICAZIONI ITALIANE
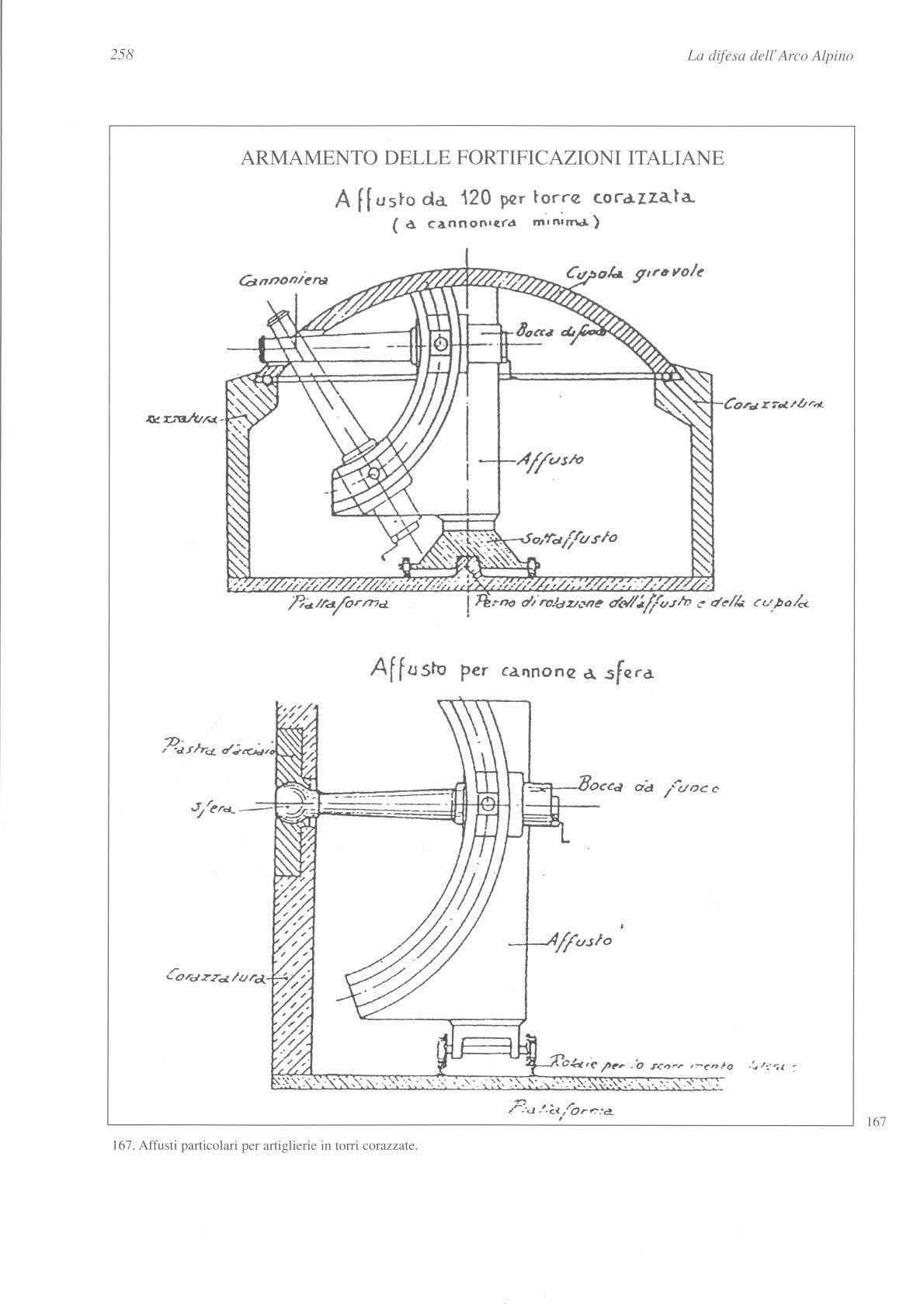
A ff usto da 120 ~r torr<i e.o razzata.. ( d ca.nnof\•~l'"d m·,n;md.}
Affusto per cannone d. .sf'lrd.
258 La difesa del!' Arco Alpino
167
167. Affusti particolari per artiglierie in torri corazzate.

italiane, quelle ubicate in profondità vennero abbandonate dalle truppe di presidio e quindi superate senza colpo ferire dalle truppe celeri italiane lanciate in profondità.
- Svizzera:
la Confederazione Elvetica in previsione di un nuovo conflitto mondiale, ribadendo la sua volontà di rimanerne estranea, adeguò e potenziò le preesistenti strutture fortificate erette a tutela dei suoi confini e non ritenne necessario creare nuove fortificazioni a tutela del confine italo-svizzero che non aveva subito modifiche, rispetto ai tempi del precedente primo conflitto mondiale.
- Francia:
lo Stato Maggiore francese, auspice il ministro Maginot che aveva in prima persona vissuto le stragi del primo conflitto mondiale, stabilì di dotare il paese di un sistema fortificato che tutelasse la integrità dei confini nazionali anestando su di essi il nemico, evitando così le carneficine subite nel corso della grande guerra, ed a tale scopo detenninò la costituzione di una apposita commissione ( C.O.R.F.), organo esecutivo della Commissione di Difesa delle Frontiere, incaricata di studiare e far applicare le migliori soluzioni fortificatorie per la difesa della Francia. Nello studio di tale sistema difensivo ebbe rilevante importanza la fortificazione della frontiera alpina con l'Italia, ritenuta possibile nazione avversaria, alla luce degli allriti sviluppatisi fra i due stati, dei comportamenti della politica internazionale italiana e dei discorsi di Mussolini, alludenti alla volontà di riunire alla madre patria i territori forzosamente ceduti quale prezzo della unità d'Italia.
TI terreno di confine, già di per sé naturalmente difficile, venne reso pressoché inaccessibile con la realizzazione, lungo la linea di frontiera ed in profondità, di numerose strutture fortificate complesse (costituite da blocchi di potenti artiglierie integrati, per la difesa vicina, da blocchi di fanteria) e di blokhaus leggeri destinati ad integrare e saldare l'azione dei primi.
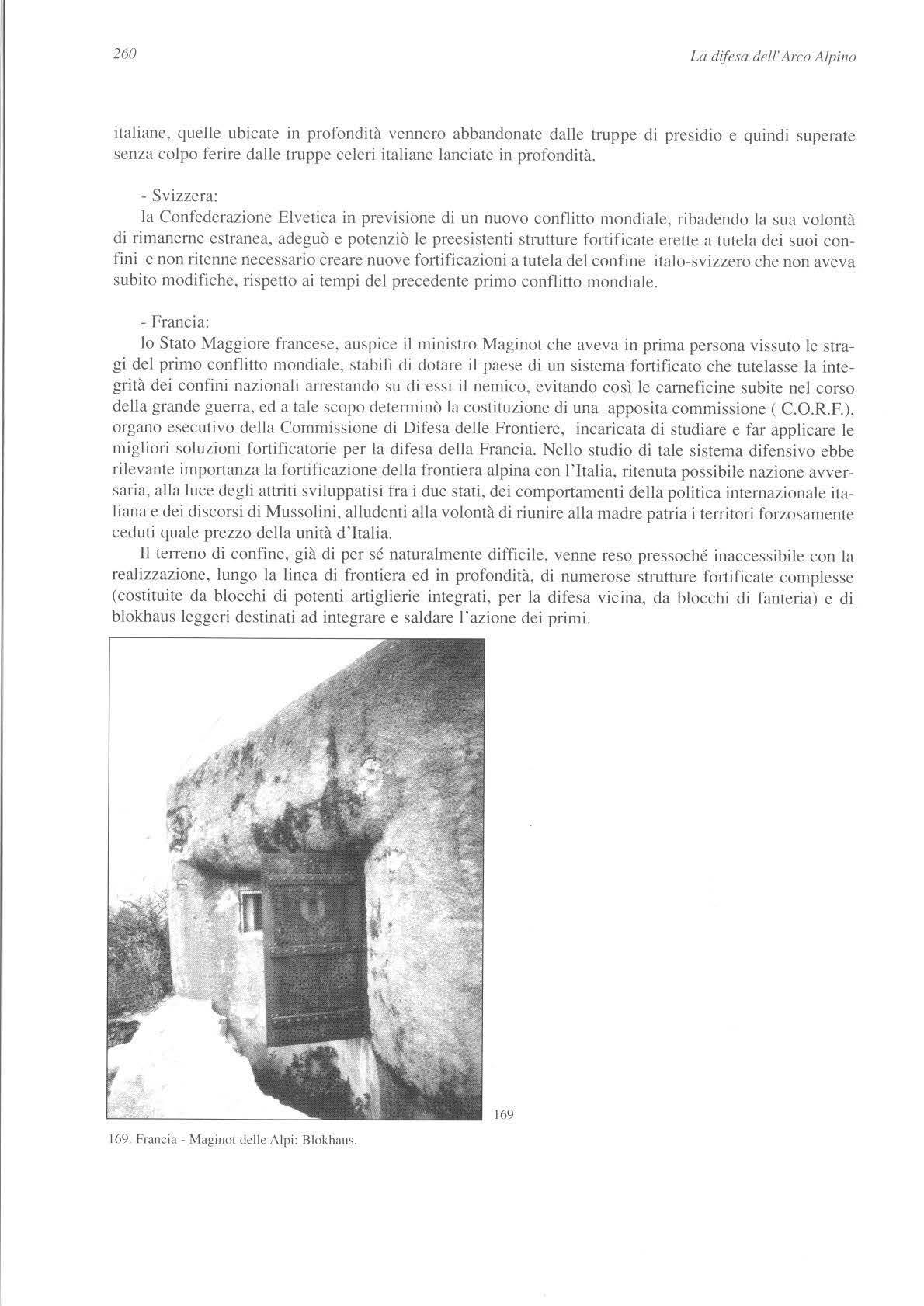
260 La difesa Alpino
169
169 Francia - Mag:inot delle A l pi: Blokhaus.

Il Vallo Alpino e fa guardia affa .fi"o111iera 261 170
171
170. Francia - Maginot delle Alpi: Blokhaus.
J 71. Francia - Maginot della A lpi - Opera C.O.R.F. cli Saint Agnes.
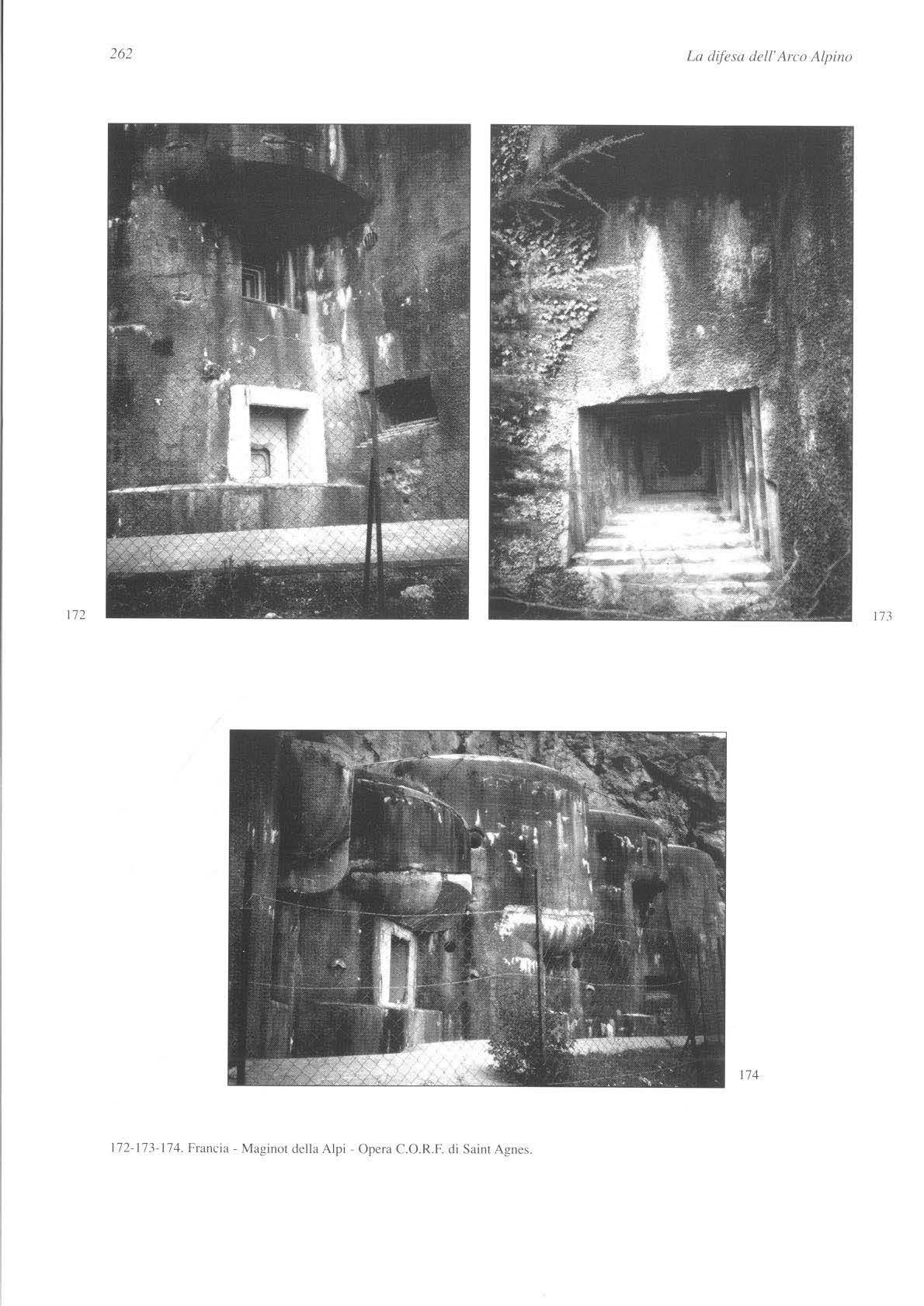
262 La difesa defl' Arco Alpino 172 173 174
172-173-174. Francia - Maginot della A lpi - Opera C.0.R.E d i Saint Agnes.
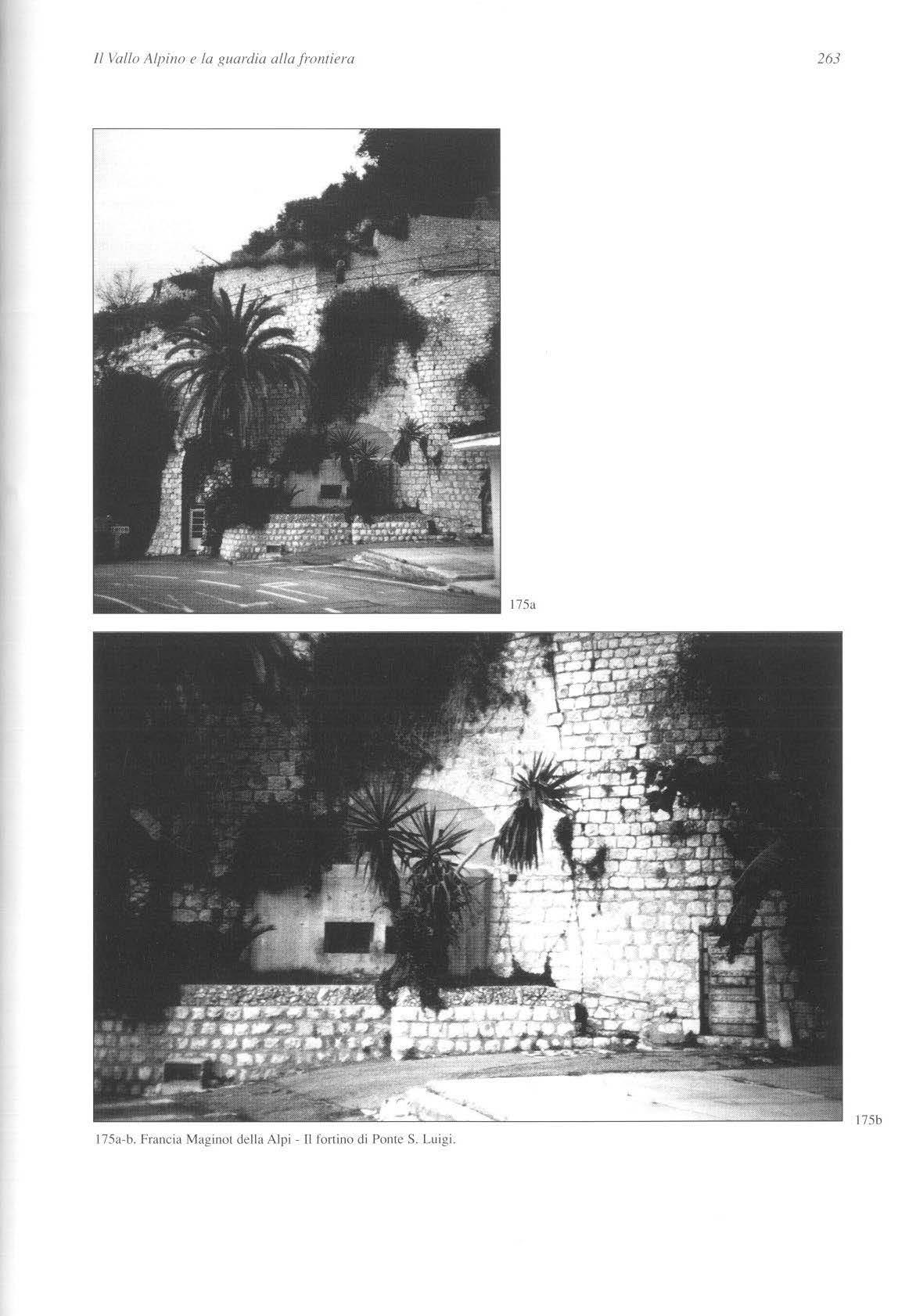
li Vallo Alpino e la guardia alla frontiera 263
175a
175b
175a-b. Francia Maginot della Alpi - ll fortino di Ponte S. Luigi.
Cenni sulla Guardia alla Frontiera
L'aver fino ad ora parlato delle strutture costituenti il Vallo Alpino ci porta a dare un sommario cenno a chi presidiava questo insieme di opere cli cui si erano riempite lentamente prima e impetuosamente poi, in funzione del deteriorarsi dei rapporti con gli stati confinanti, le zone di frontiera italiane.
Dal rientro dei Sovrani Sardi dall'esil i o in cui li aveva confinati Napoleone Bonaparte fino alla Seconda Guerra Mondiale, la responsabilità delle fortificazioni ubicate lungo l'arco alpino venne sempre accentrata sotto la giurisdizione del comando militare competente per territorio. Su l finire del secolo XX la responsabilità dell'attività delle fortezze fu devoluta ai comandi artig li eria competenti per territorio, i quali ebbero a disposizione Brigate da Fortezza da cui trarre le guarnigioni delle piazzeforti. La fortezza non era però guarnita eia soli artiglieri; sino ai primi del '900 infatti vi fu la tendenza a far coabitare nella stessa fortezza reparti di armi differenti; artiglieri per i I funzionamento delle artiglierie, fanti od alpini per assicurare in pace il normale serv i zio di g uarn i gione ed in tempo di gue1Ta la difesa v icina della struttura . A partire dal primo decennio del XX secolo le fortezze furono esclusivo appannaggio dell'arma di artiglieria che, sotto diverso nome, reggiment i da piazza, brigate eia fortezza, reggimenti d'armata, le gestì fino a quando no n venne sent ita l a necessità inderogabile di creare un nuovo corpo che, assommando in sé tutte le armi necessarie (fanteria, aniglieria, ge ni o e servizi ), gestisse in modo unitario la difesa e copertura del confine, occupandos i di tulli gli aspetti cli tutte le strutture fortificate presenti lun go i confi ni italiani, strutture che si erano dilatate in numero veramente elevato, svincolando così dal presidio statico unità destinate originariame nte e per loro costituzione ordinativa al!' impiego mobile su lla frontiera e o ltre.
Non fu una concezione rapida ed indolore, stanti l e resistenze dei corpi già esistenti a cedere uomini, armi e mezzi ad un nuovo co rpo di cui non vedeva no, con somma miopia, la necessità; questa e l'esige nza di costituire un nuovo corpo furono ampiamente sentite, allorché la vigilanza al confine venne potenziata con la realizzazione di una notevolissima massa di strutture fortificate permanenti, destinate ad essere presidiate pressoché costa ntemen te, immobilizzando una notevole e considerevole massa cli forze tradizionalmente ed istituzionalmente mobili, facenti capo per l 'impiego ai Corpi cl' Armata di frontiera (cinque nell'ordinamento del 1926, sei in quello del 1927).
Fu so lo nel 1934 che cominciò a prendere co rpo l 'idea dell'istituzione di un nuovo corpo militare che v igilasse e difendesse a pieno titolo il confìne statale, sollevando eia tale oneroso e non istituzionale compito statico unità nate per attività mobile, sia pure nello stesso ambiente montano ove era no ubicate l e strutture da presidiare.
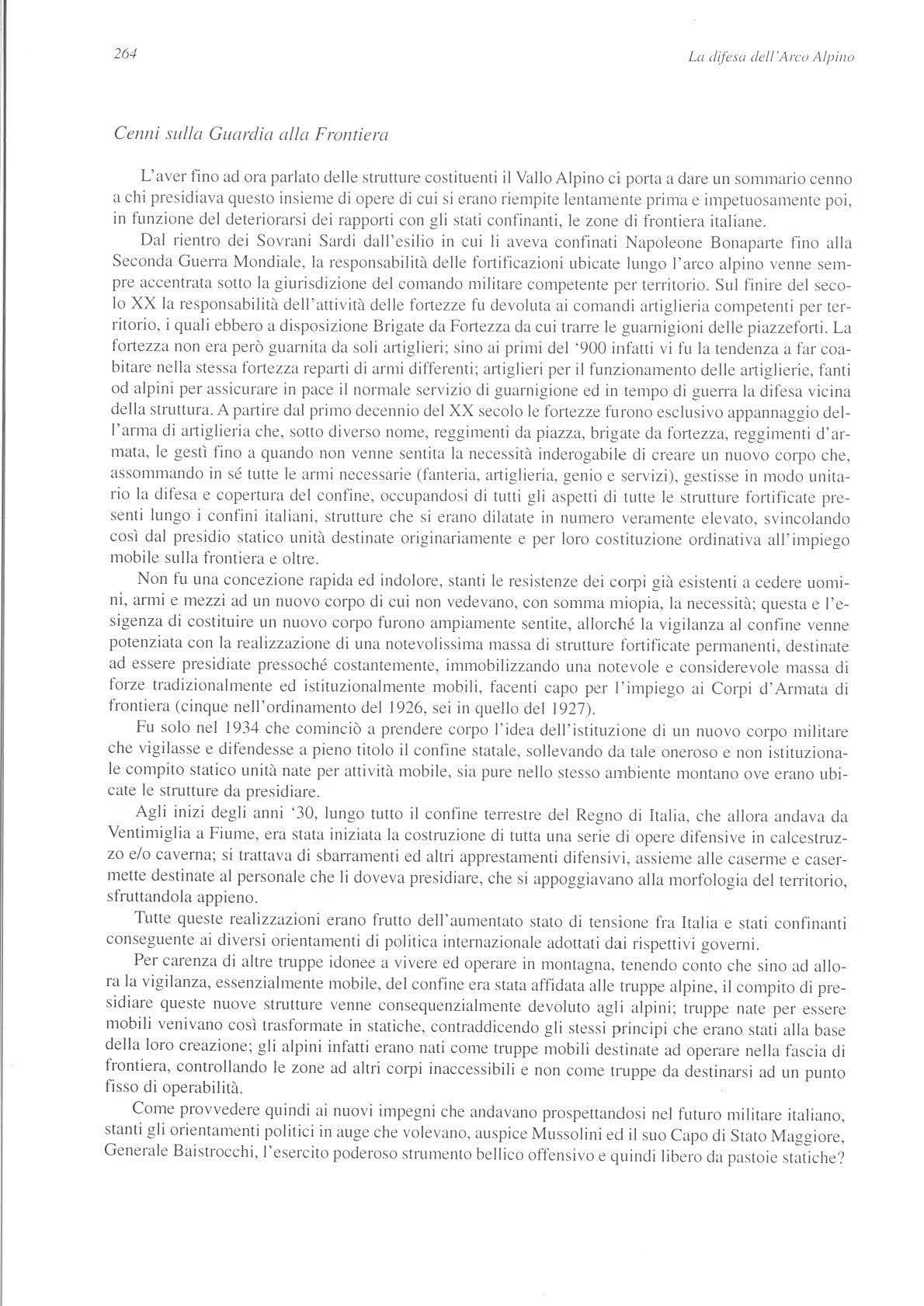
Agli ini zi degli anni '30, lungo tutto il confine terrestre del Regno di Ital i a, che allora andava da Ventimiglia a Fiume, era stata iniziata la costruzione cli tutta una serie di opere difensive in calcestruzzo e/o caverna; si trattava di sbam1menti ed altri apprestamenti difensivi, assieme alle caserme e casermette destinate al personale c he li doveva presidiare, che si appoggiavano alla morfologia ciel territorio, sfruttandola appieno.
Tutte queste realizzazioni erano frullo dell'aumentato sta to di tensione fra Italia e stari confi nanti conseguente ai diversi orientamenti di politica internazionale adotta ti dai rispettivi governi.
Per carenza di altre truppe idonee a v i vere ed operare in montagna, tenendo conto che sino ad allora la vigilanza, essenzialmente mobile, del co nfine era stata affidata alle truppe alpine, il compito di presidiare queste nuove strutture venne consequenzialmente devoluto agi i alpini; truppe nate per essere mobili venivano così trasformate in statiche, contraddicendo g li stessi principi che erano sta ti alla base della loro creazione; gli alpini infatti erano nati come truppe mobili destinate ad operare nella fascia cli frontiera, controllando l e zone ad altri corp i inaccessibili e non come truppe da destinarsi ad un punto fisso di operabilità.
Come provvedere quindi ai nu ovi impegni c he andavano prospettandosi ne l futuro militare italiano, stan ti gl i orientamenti politici in auge che volevano, auspice Mussolini ed il suo Capo di Stato Maggiore, Generale Baistrocchi, l'esercito poderoso strumento bellico offensivo e quindi libero eia pastoie sta ti c he?
264 La dif'e.rn def/ 'Arco Alpino
Il comando delle !ruppe alpine aveva dal canto suo iniziato a rappresentare l'incongruenza di un atteggiamento che imponeva ad unità mobili di provvedere ad un servizio de l tutto diverso che, tra l'allro, tendeva ad assorbire, stante la mole delle esigenze, ogni capacità e possibilità delle !ruppe alpine, obbligandole a trascurare per carenza di forze i compiti mobili istituzionali.
Si pensò, a livello di Stato Maggiore Generale, di creare forze specifiche, suggerendo l'istituzione di un corpo speciale che avesse in permanenza ccl esclusivamente il compito di vigi l are ed al momento ciel b i sogno presidiare e gestire, la linea fortificata realizzata lungo il confine italiano, assicurando così la copertura delle frontiere; detto corpo avrebbe dovuto essere formato da gente conscia della necessità di dover vivere permanentemente in montagna, truppe alpine di nuovo genere, legate al terreno e validamente moti vate.
Le armi, i materiali e l'equipaggiamento assegnali avrebbero dovuto essere adatti a svolgere l'attività ed i servizi ai quali i militari di questo nuovo corpo sarebbero stati preposti cd essere validi per la natura del terreno sul quale sarebbero stati destinati ad agire ed operare.
Qualora creato, il corpo sarebbe stato alimentato da tulti i Distretti Militari della Penisola, non potendosi sottrarre ai Distretti di tradizionale reclutamento alpino elementi da inviare fuori specia lità ; si sarebbe dovuto quindi assegnare alle unitit di questo corpo quadri validi, in grado cli poter dare un addestramento specifico alla vita di montagna al personale assegnato, amalgamando a tale vita anche coloro che i monti mai avevano visto in vi ta loro.
In montagna, nei pressi del confine, sarebbero state realizzate le caserme così che gli occupanti potessero raggiungere in breve tempo e presidiare lutle le strutture difensive predisposte ed affidate alle l oro cure.
Così facendo le truppe alpine e quelle di rincalzo sarebbero siate restituite alla disponibilità degli Alti Comandi che le avrebbero potute impiegare in base alle esige nze sorte in qualsia~i punto del territorio e nel contempo il confine sarebbe stato egua lmente presidiato e reso invalicabile con l'u so ottimale delle fortificazioni, gestite da personale specificatamente addestrato a servirsi di esse, i I personale appunto del nuovo corpo di cui si proponeva cd auspicava la creazione.
li co ncetto più che mai valido finalmente attecchì e si creò nelle menti dei responsabili la ineluttabilità della istituzione di un corpo di specific i addetti alla gestione delle fortificazioni e controllo degli spazi impervi esis tenti eventualmente fra esse, pena l'immobilizzo a ridosso della frontiera cli tulto l'esercito di campagna (quello mobile).
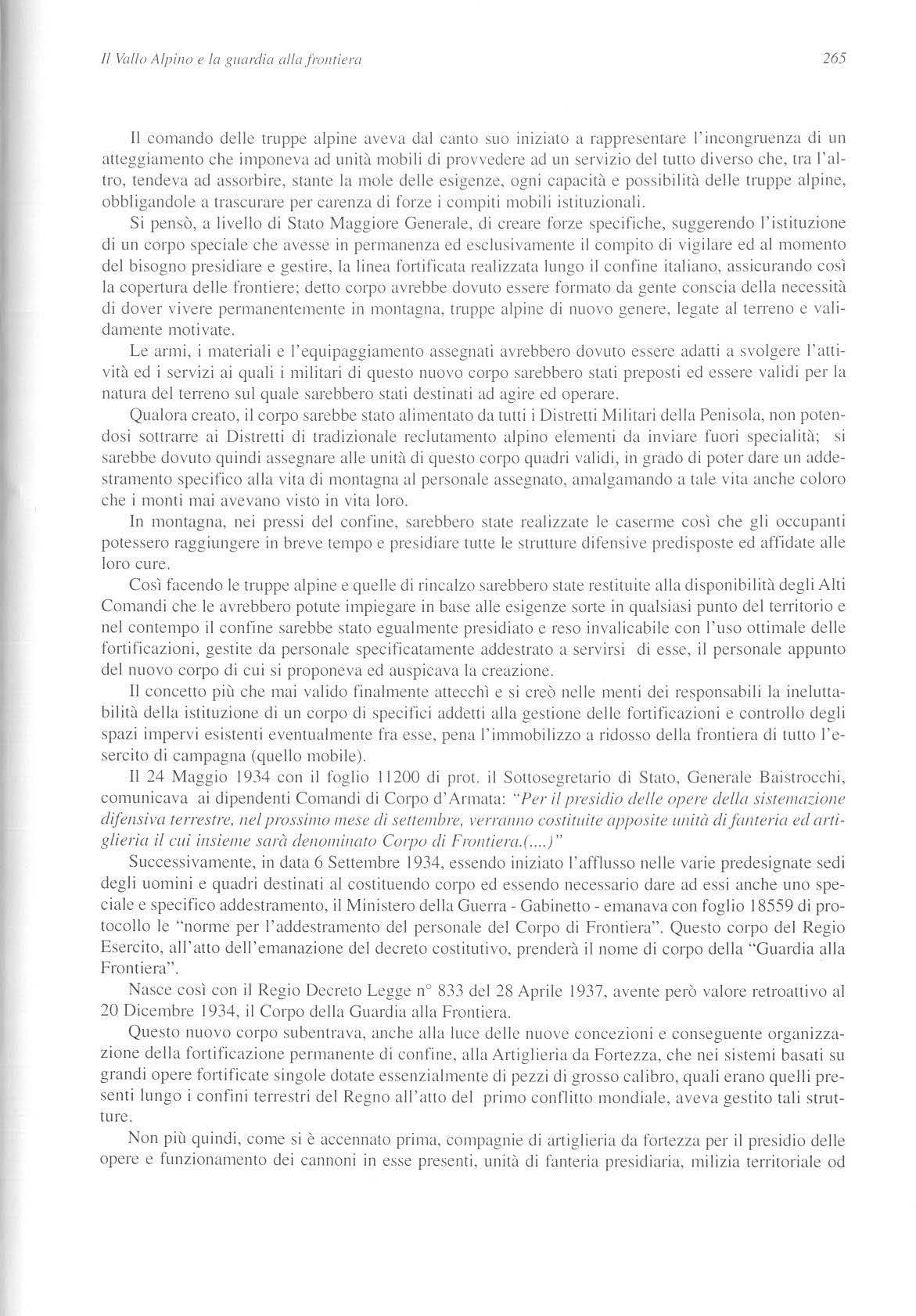
Il 24 Maggio 1934 con il foglio 11 200 di prot. il Sottosegretario di Stato, Generale Baistrocchi, comunicava ai dipendenti Comandi di Corpo d'Armata: "Per il presidio delle opere dello sistemcòone difensiva terrestre, nel prossimo mese di se11e111bre, 1•ermn110 costituite apposite unità di fanteria ed artiglieria il cui insieme sarà denominato Co,po di Frontiem.( )"
Successivamente, in data 6 Settembre 1934, essendo ini ziato l'afflusso nelle varie predesignate sedi degli uomini e quadri destinati al costituendo corpo ed esse ndo necessario dare ad essi anche uno speciale e specifico addestramento, il Ministero della Guerra - Gabinetto - emanava con foglio 18559 di protocollo l e "norme per l'addestramento del personale del Corpo di Frontiera". Questo corpo del Regio Esercito, all'atto dell'emanazione del decreto cost ituti vo, prenderà il nome di corpo della "Guardia alla Frontiera".
Nasce così con il Regio Decreto Legge n° 833 del 28 Aprile 1937, avente però valore retroattivo al 20 Dicembre 1934, il Corpo della Guardia alla Frontiera.
Questo nuovo corpo suben tra va, anche alla lu ce delle nuove concezioni e conseguente organizzazione della fortificazione permanente di confine, alla Artiglieria da Fortezza, che nei sistemi basati su grandi opere fortificate singo l e dotate essenzialmente di pezzi di grosso cal ibro, quali erano quelli presenti lungo i confini terrestri del Regno all'atto del primo conflitto mondiale, aveva gestito tali strutture.
Non più quindi, come si è accennato prima, compagnie di artiglieria da fortezza per il presidio delle opere e funzionamento dei cannoni in esse presenti, unitù cli fanteria presidiaria, milizia territorial e od
Il Vallo Alpino e fa guardia alfa Jim1tiera 265
alpini per la difesa v i c ina ed il presidio attivo dei sistemi trincerati esterni, comandi di artig li eria da fortezza per la gestione del sistema, bensì un corpo unitario con unità di fanteria che dovevano far funzionare la massa di mitragliatrici, mortai e pezzi controcar ro costituenti l'armamento del gran numero di piccole opere fo11ificatc previste da l nuovo sistema fort ifi catorio italiano e proprie unità di artiglieria incarica te di gestire le artiglierie della difesa, la cui massa ora, contrariamente al passato e con l'eccezione delle aiiiglieric incavernate e di quelle degli antic hi forti mantenuti in servizio quali batterie G.a.F. cli medio calibro per la va lidità dei pezzi che li armavano, era di prevista dislocazione ed impiego fuori dalle opere.
A li quote del Genio e dei servizi, organicamente inquadrati nel nuovo corpo provvedevano allo svo lg im ento di tutto il complesso di attività necessarie a consentire alla Guardia alla Frontièra autonomia logistico-funzionale, cura nd o le esigenze di v ita quotidiana, i piccoli lavori intern i od esterni alle strutture ed i vital i collegamen ti fra le struttu r e e con i comandi ai var i livèlli.
La nascita fu sancita con un decreto e non con un normale provvedimento ordinativo in quanto fu allora ritenuto che la sis temazione l egis l ativa avrebbe consentito di superare notevoli ostacoli, spec i e cli ordine burocratico-formale che avrebbero potuto bloccare o se non altro ostacolare l 'azione della Guardia alla Frontiera.
In effetti l'emanazione di un decreto legislativo, che sotto si riporta, co nsent ì cli definire le relazioni del Corpo con le Autorità e gli Enti Pubblici e diede ai Comandi G.a.F. l a possibilità di emanare disposizion i riguardanti i l territorio, gli interessi privati (servi tù. sgomberi, aree di ri spetto ccc ) e cli farsi asseg nare fondi mirati a garantire la copertura finanziaria alle attivitù spec ifi che cli istituto.
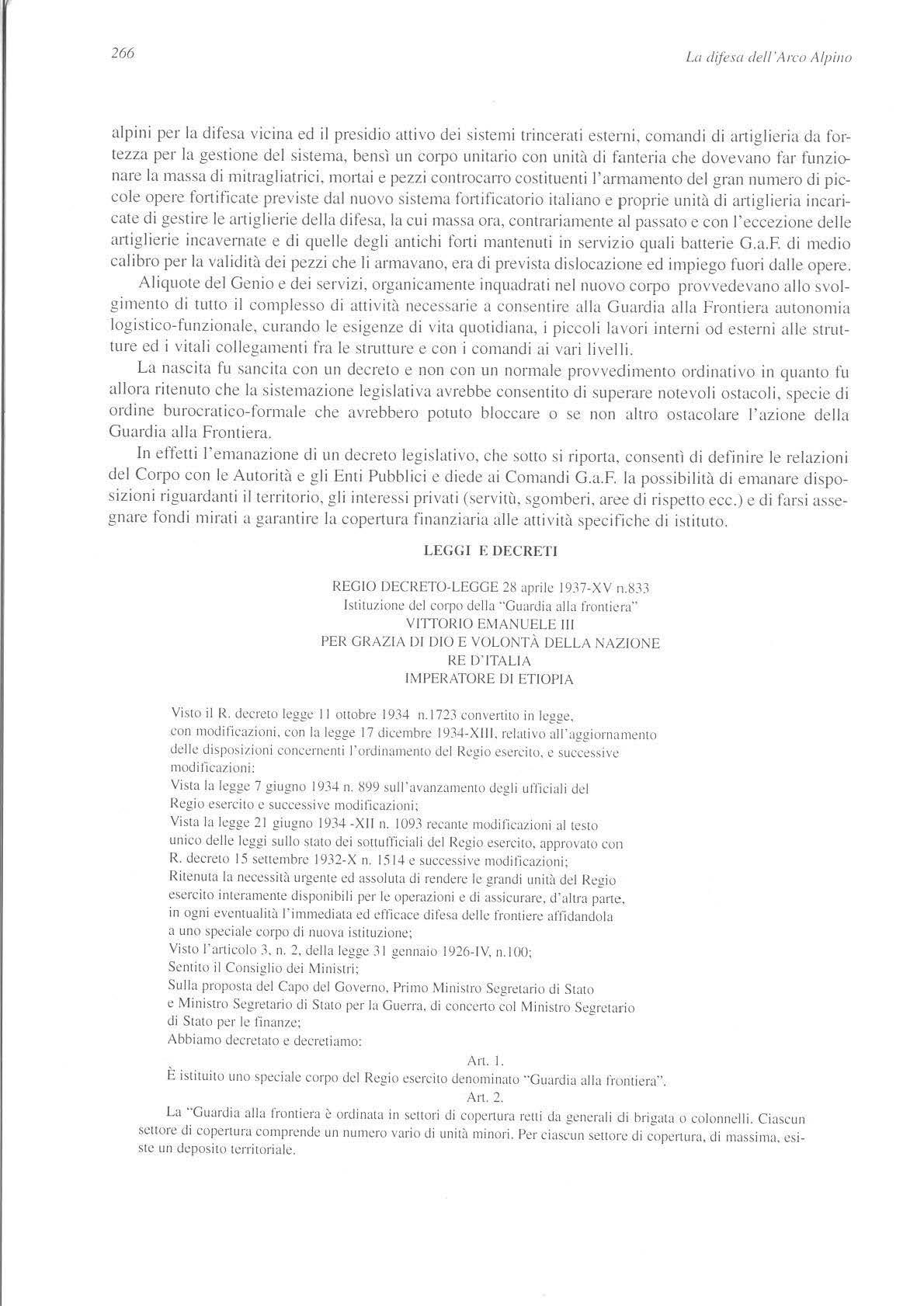
LEGGI E DECRETI
REGIO DECRETO-LEGGE 2tl aprik 1937-XV n.833 Istituzione dd corpo della Guardia alla frontiera"
V JTTORIO E:vlANUELE lii
PER GRAZI/\ DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE DI ETIOPIA
Visto il R. decreto legge 11 ottobre 1934 n. 1723 converti to in legge. <.:on modiricazinni, con la legge 17 dit·ernbre 193..f-XIII. r..:lativo all'aggiornamemo tielle dispo~izioni concernenti l'orJinamento del Regio esercito. c succe$sivc modi fic,wioni:
Vista la legge 7 gi ugno 1934 n. 899 sull'avanzamento degli ulTic:iali del Regio esercito e successive 111odilìcaLioni:
Vista l a kgge 21 gi ugno 1934 -Xli n. 1093 recante modificazioni al testo uni co delle kggi sullo stato dei souufficia li de l Regio esercito. approvato <.:011
R. decreto 15 seuemb re 1932-X n. I 514 e successive modilìcazioni;
Ritenuta la necessitÌI urgeme ed asso lut a di rende r e le grand i unità del Regio esercito in!cram ente disponibili per l e operazion i e di assicurare, d'altra pane. in ogn i event uali tà l'immediata ed efficace di resa de ll e frontiere affidando la a uno speciale corpo cl i nuova i stituz i o ne;
Visto l'a rti co l o 3, n. 2, del la legge 3 1 genna i o 1926- IV, 11. I 00:
Sentito il Consiglio dei Minis1ri:
Su ll a proposta de l Capo del Governo. Primo M in istro Segretario di Staw e Ministro Segretario di Stato per la Guerra. di co ncerto col Ministro S,;;grctario cli Stato per le finanze;
Abbiamo clecrctato e decre(iamo: Art. I.
È istilllito uno spec i ale corpo del Regio esercito denom in ato "Guardia al la frontiera Art. 2.
La "Guardia alla fro nti era è ordinata in settori d i copert ura reu i da generali di brigata o co l onnelli. Ciascun settore di copertura comprende un numero vario di unità minori. Per c i ascun seuore d i copert ura. di massima. csisie u n depos it o terri toriale.
266 La d(fesa Alpino
Art. 3.
Gli ufficia li l'd i souufficia l i as~t:gnati alla Guardia alla frontie r a sono compn~~i negli organid dcgli ufficiali c dci sottufficia li (klle varie armi (esc lu sa quella ùci Carabinieri Reali).
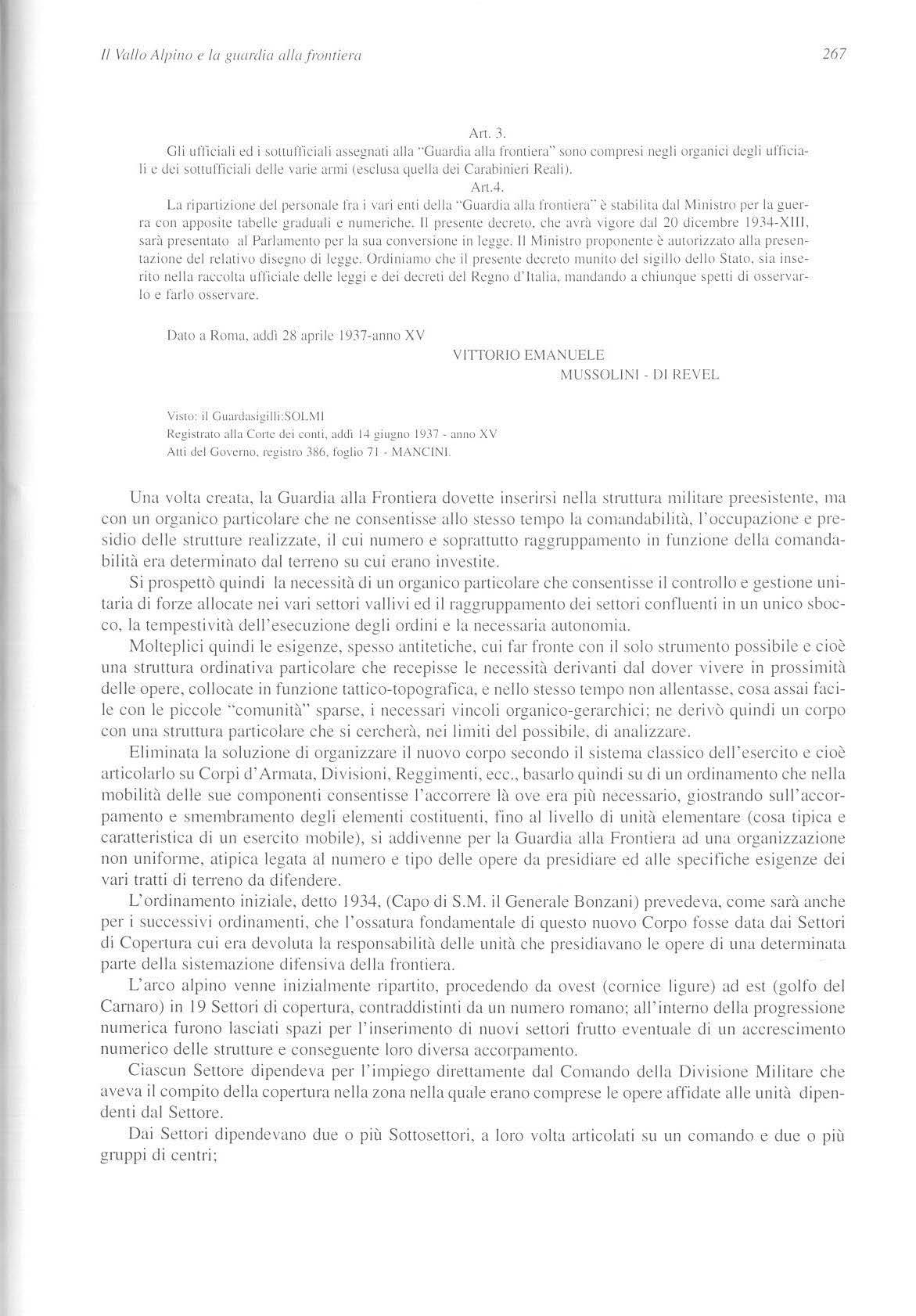
Art.4.
La ripartizione ùel personale fra i vari cnti della Guardia alla frontkra è stabilita dal .\ilinis tro per la guerra con apposite tabelk graduali e numt:richc. Il pn.:scntc dccreto. chc a\'l'i1 vigorc <lai 20 dicembre 193-1-XIII. sarà p resentato a l Par l amento per la sua conl'ersionc in legge. Il Ministro proponente è autoriaato alla prescnta1. i om: del n.:lativo disegno di leggc. O rdin i amo che il presente dccrcto munito del sigillo <lello Stato, ~ia ins..:rito nella raccolta u llicia le delle leggi e de i decr..:ti del Regno d ' Italia, manda ndo a chiunqul? ~petti di osscrvarlo e l'arlo osservarc.
D,ìlO a Ro111;1, addì 28 aprile 1937-anno XV
Y ITIOR IO E.'vlA~UELE
Vis10 : il Guar<la,igil l i:SOU, tl
Regis1r:uo alla Conc <lei com i, addì 1-1 giugno 1937 - anno XV
Atti del Gm,:rno. regi,tro 386. foglio 7 1 • [\'l,\NCINI.
Una volta creata, l a G uardia a lla Frontiera dovette inserirsi ne l la struttura militare preesistente. ma con un o rganico particolare che ne consent i sse allo stesso tempo la coma ndabi litù, l'occupazione e presid i o de ll e strutture realizzate, il cui numero e soprattutto raggruppamento in funzione della coma nclabilità era determinato dal terreno su cu i era no investite.
Si p r ospe tt ò qu indi l a necessità di un organ i co particolare che consen ti sse i l co ntro ll o e gestione unitaria di forze all oca te nei vari settori vallivi ed i l raggruppamento dei settori confluen ti in un unico sbocco, l a tempestività dell'esecuzione dègli ordini e l a necessaria au tonom i a.
Moltep l ici quindi lè èsige nze, spesso antitetiche, cu i far fronte con il so l o strumento possibile e cioè una slrull ura ordi nativa particolare c he recepisse l e necessità derivanti dal dove r vivere in prossimità de lle opere, co ll ocate in funzione ta t tico- topografica, e nello stesso tempo non allentasse. cosa assai facil e con le piccole "comunità" sparse. i necessar i vincoli organico -gerarchici; ne derivò quindi un co rpo con una st ru ttura particolare che si cercherà, nei l imit i cie l possibile, cli anali zzare.
Elimi nata la soluzione cli organi zza re il nuovo corpo secondo il sistema c lassico dell'esercito e cioè articolarlo su Corp i d'Armata, Di vis i oni, Reggimenti, ecc basar lo quindi su cli un o r dinamento che ne ll a mobilità delle sue compo nenti consen ti sse l 'accorrere là ove era più necessario, giostrando sull'accorpamento e smembramento degli elementi costi tu e nti , fino al livello di unità elementare (cosa tipica e caralleristica di u n esercito mobile), si addiven ne per l a Guard i a alla Frontiera ad una organ i zzazione non uni forme, atipica l egata al numero e tipo delle oper e eia presidiare ed alle spec ifi c he es i genze dei var i tratti di terreno ei a difendere.
L 'ordinam ento iniziale, de tt o I 934 , (Capo di S.M. il Generale Bonzani) prevedeva. come sa rù anche per i successiv i ord inamen ti, che l 'ossat ura fo nd amenta l e di ques to nuovo Corpo fosse data dai Settori di Copertura cui era devoluta la responsab ilit ù dellè uniti'1 c he p res idi avano le opere di una determinata parte della si stemazio ne difens i va della frontiera.
L'a r co alpino ve nn e ini zia lmente ripartito, prOcèdendo da ovest (corn i ce ligure) ad es t (golfo del Carnaro) in 19 Settori di cope rtura , contraddistinti da un numero romano; a ll'interno della progressione numeri ca furon o lasciati spazi per l'in ser imento di nuovi se tt o ri frutto eventua l e di un accrescimento numerico delle strutture e co nseguente l oro diversa accorpamento.
C i ascun Setto r e dipendeva per l'impiego direttamente da l Conrnndo della Divisione Militare che aveva il comp ito della copertura ne ll a zona nella q ual e eran o comprese le opere affid ate a ll e un it à dipendenti da l Settore.
Dai Settori dipendevano due o più Sottosettori, a loro vo lta arti colati su un co mand o e due o più gruppi di ce ntri ;
Il Vallo Alpino e la 311wdia alla fromiera
267
MUSSOLINI - DI REYEL.
i gruppi di centri si articolavano su di un comando e due o più centri (in funzione del legame tattico determinato dal terreno).
Ciascun centro presidiava una unità elementare della sistemazione difensiva, con composizione organica variabile, adeguata alla struttura della sistemazione stessa.
L'artiglieria si articolava in batterie che potevano essere dislocate in caverna od in opera fortificata; queste erano classificate in tipi a seconda del calibro e numero dei cannoni che le am1avano e precisamente:
- opera tipo 1 se armata con 8 pezzi da 149/35 ,
- opera tipo 2 se armata con 4 pezzi da 149/35,
- opera tipo 3 se armata con 2 pezzi da 120.
Il Ministero della Guerra con foglio 39300 di prot., datato 21 giugno 1938, stabilì che, allo scopo di realizzare una organizzazione dei comandi di frontiera più rispondente allo sviluppo assunto dalla G.a.F. e dalla sistemazione difensiva , ed allo stesso tempo alleggerire i comandi di C. d ' A, subentrati alle Divisioni Militari, del complesso onere derivante dal comando diretto dlci settori di copertura, tutti i settori di copertura fossero retti da colonnelli, e che in ciascuno dei comandi di C. d' A di Torino, Alessandria, Milano, Bolzano, Udine e Trieste fosse istituito un Comando della G.a.F. di C. d' A, retto da un Generale di brigata, con il compito di dirigere e controllare la vita disciplinare ed addestrativa dei settori di copertura, le cui opere erano dislocate nel territorio di giurisdizione.
Il notevole impulso dato allo sviluppo della fortificazione in conseguenza delle scelte politico-strategiche operate dal Capo del governo e tradotte in provvedimenti specifici dal nuovo Capo di S.M. del Regio Esercito, Generale Pariani, succeduto sul finire del 1936 nell'alta carica al parigrado Baistrocchi, portò un notevole impulso alla realizzazione di fortificazioni nella zona di frontiera e conscguentemen-
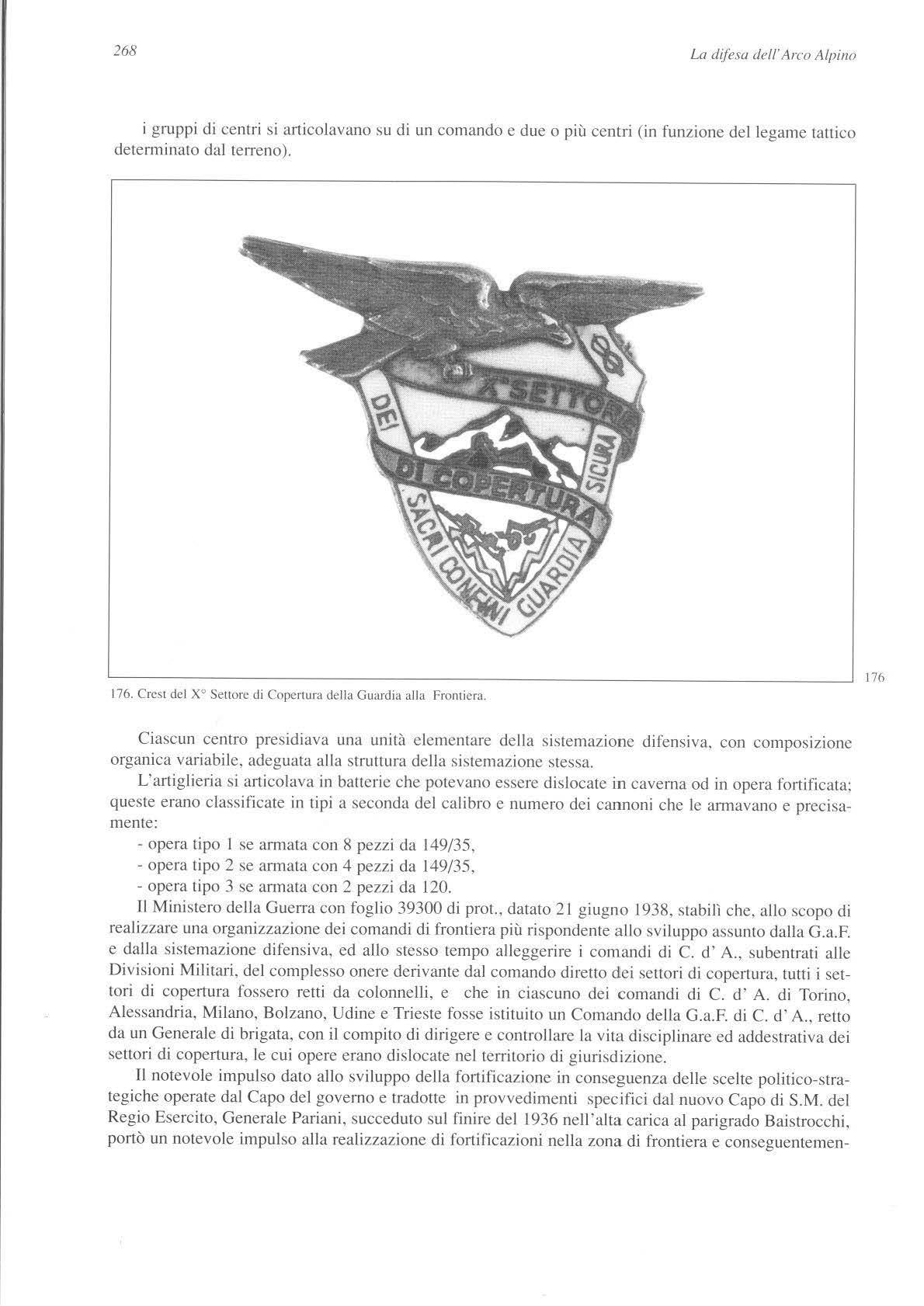
268 La difesa dell'Arco Alpino
l 76. Crcsr del X0 Settore di Copertura della Guardia alla Frontiera
176
COMANDO GUARDIA ALLA
DI C.A.
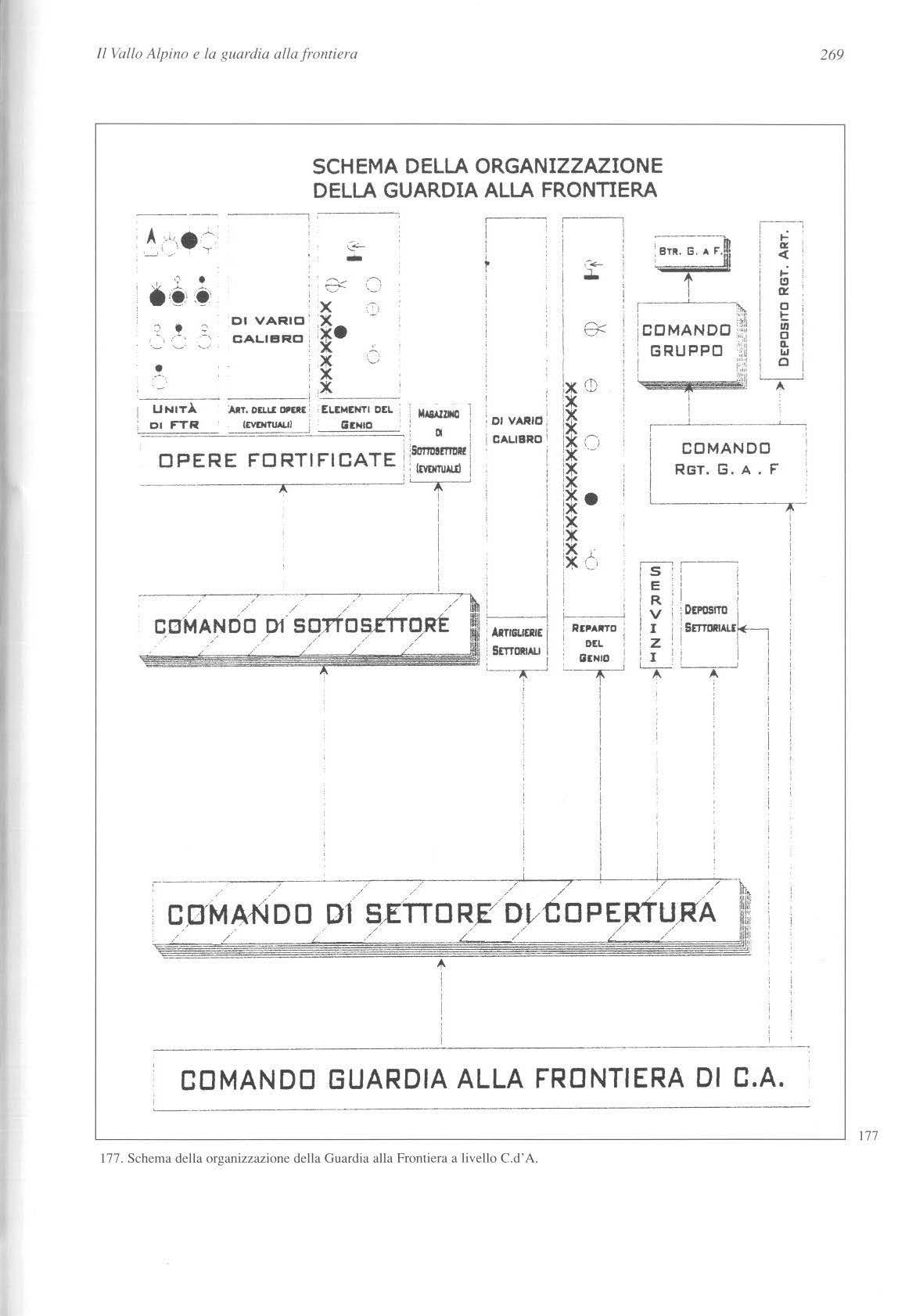
Il Vallo Alpino e la guardia afla frontiera SCHEMA DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA GUARDIA ALLA FRONTIERA ---·-- ---~ e~.. .....__ ,....,_ '. ·.._ : X ;~i f ::' 01 VARIO ' :x. ·~' ·:__, :~ CALll!RO ! J ,. : X ::J i x _-_______ ; :)I(___ I UNITÀ MT, DELLE IJIIEU ; · [LEMDIT I DEL ; : MJWZINC l DI FTR tcvD1TUAUJ i GtN 10 : : a I iSormsmtllf i op ERE FORTIFICATE : (tvonUJ.Ul I ! I i I I r ; i I : 0 1 VAAld : Ì CALIBRO I I I i l c,ai:tA_ tl é; 9(s9:rfa~~- Ù.-TIGUERIE 1 1 ' / ' ., SmDRtAU ! + ! ' i ' I I I i I .-..,_ .. ,,...__ C7' DtL GINIO t ! I I I I ! I ,-., ---~m i ix , E "··w i < t - i ; I ! O:: I I g 1CDMANDO ;.~~ j GRUPPO :i,; I :!i F:~ ! 0 I ""===~===iJIJJ '!i~ + r1 i ' I COMANDO RGT G A. F I r-:-' 5 'I I : I I ~ ;i I I V i IDEPOSITO I I I i r &mDIIIAl1 ~ 1 : z ! I I ! 1 ! 1 I ! ~ , I A A ! J ! i ' '
FRONTIERA
269 177
177. Schema della o rganizzaz ione de ll a Guard ia alla Frontiera a livello c.d·A.
te si ebbe uno accrescimento e sviluppo deciso e considerevole dell'iniziale organico della Guardia alla Frontiera.
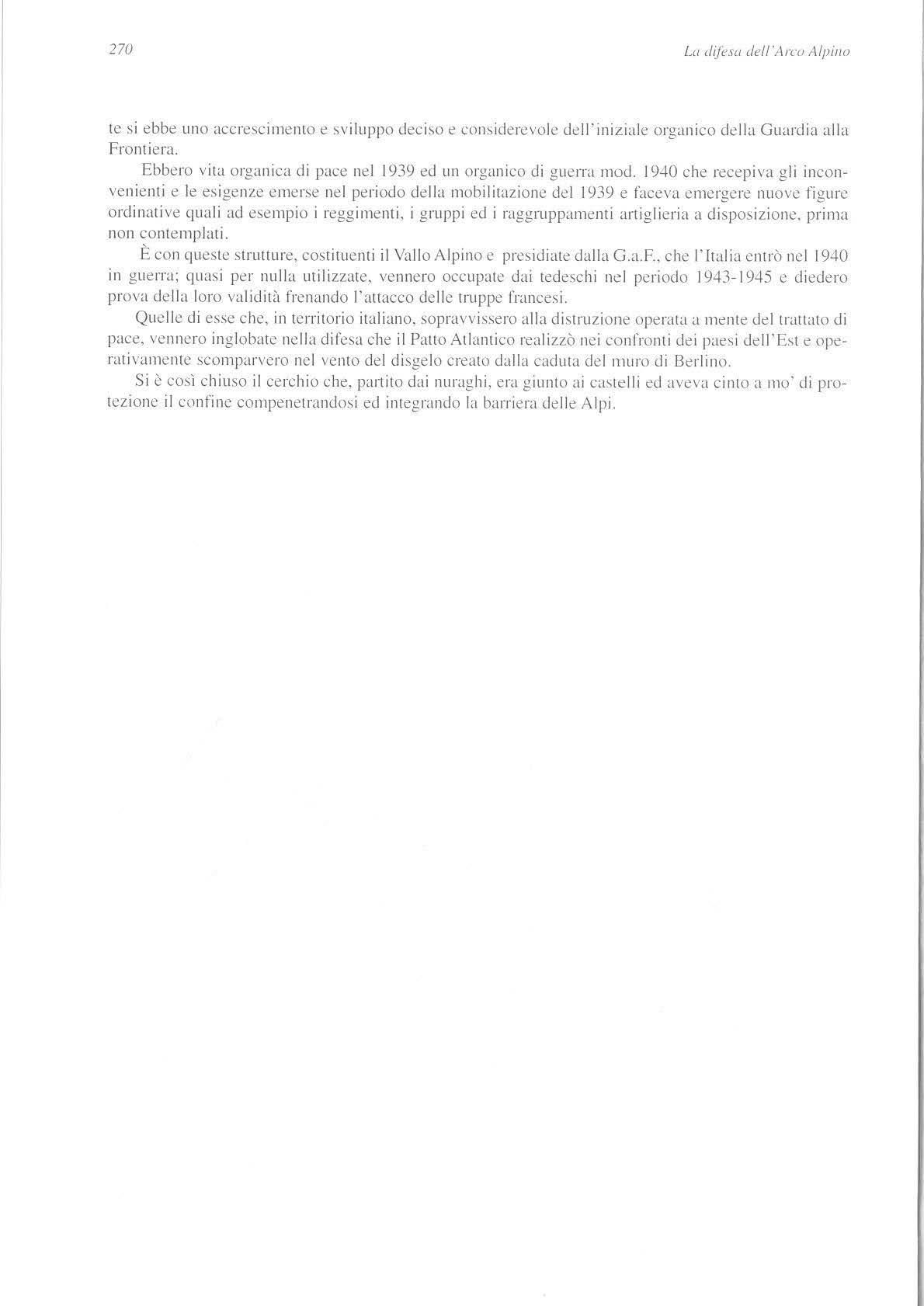
Ebbero vita organica di pace nel 1939 ed un organico di gucm1 mml. 1940 che recepiva gli inconvenienti e le esigenze emerse nel periodo della mobilitazione ciel 1939 e faceva emergere nuove figure ordinative quali ad esempio i reggimenti, i gruppi ed i raggruppamenti artiglieria a disposizione, prima non contemplati.
È con queste strutture, costituenti il Vallo Alpino e presidiate dalla G.a.F., che l ' Italia entrò nel 19-W in guerra; quasi per nulla utilizzate, vennero occupate dai tedeschi nel periodo 1943-1945 e diedero prova della loro validiti't frenando l'attacco delle truppe francesi.
Quelle di esse che, in territorio italiano, sopravvissero alla distruzione operata a mente del trattato di pace, vennero inglobate nella difesa che il Patto Atlantico realizzò nei confronti c.lc:i paesi dell'Est e operativamente scomparvero nel vento ciel disgelo creato dalla caduta del muro di Berlino.
Si è così chiuso il cerchio che, partito dai nuraghi, era giunto ai castelli ed aveva cinto a rno' cli protezione il confine compenetrandosi ed integrando la barriera delle Alpi.
270 Lo difeso de/f',\rco Alpino
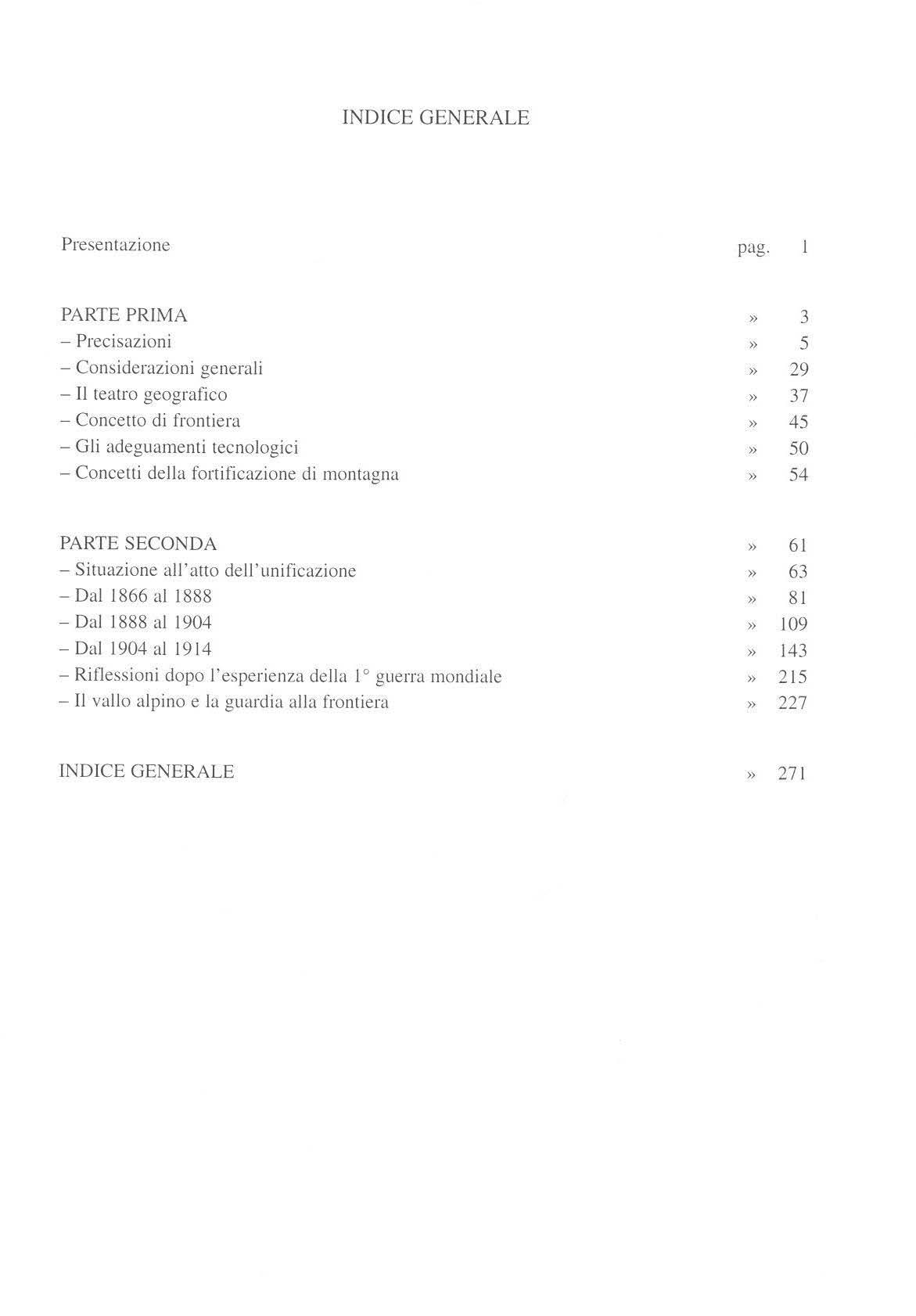
INDICE GENERALE Presentazione pag. PARTE PRIMA » 3 - Precisazioni » 5 - Considerazioni generali » 29 - Il teatro geografico >> 37 - Concetto di frontiera » 45 - Gli adeguamenti tecnologici » 50 - Concetti della fortificazione di montagna » 54 PARTE SECONDA » 61 - Situazione a li ' atto dell'unificazione » 63 - Dal 1866al 1888 » 81 - Dal I 888 al 1904 >> 109 - Dal 1904 al 19 I 4 » 143 - Riflessioni dopo l'esperienza della l O guerra mondiale » 215 - Il vallo alpino e la guardia alla frontiera » 227 INDICE GENERALE » 271