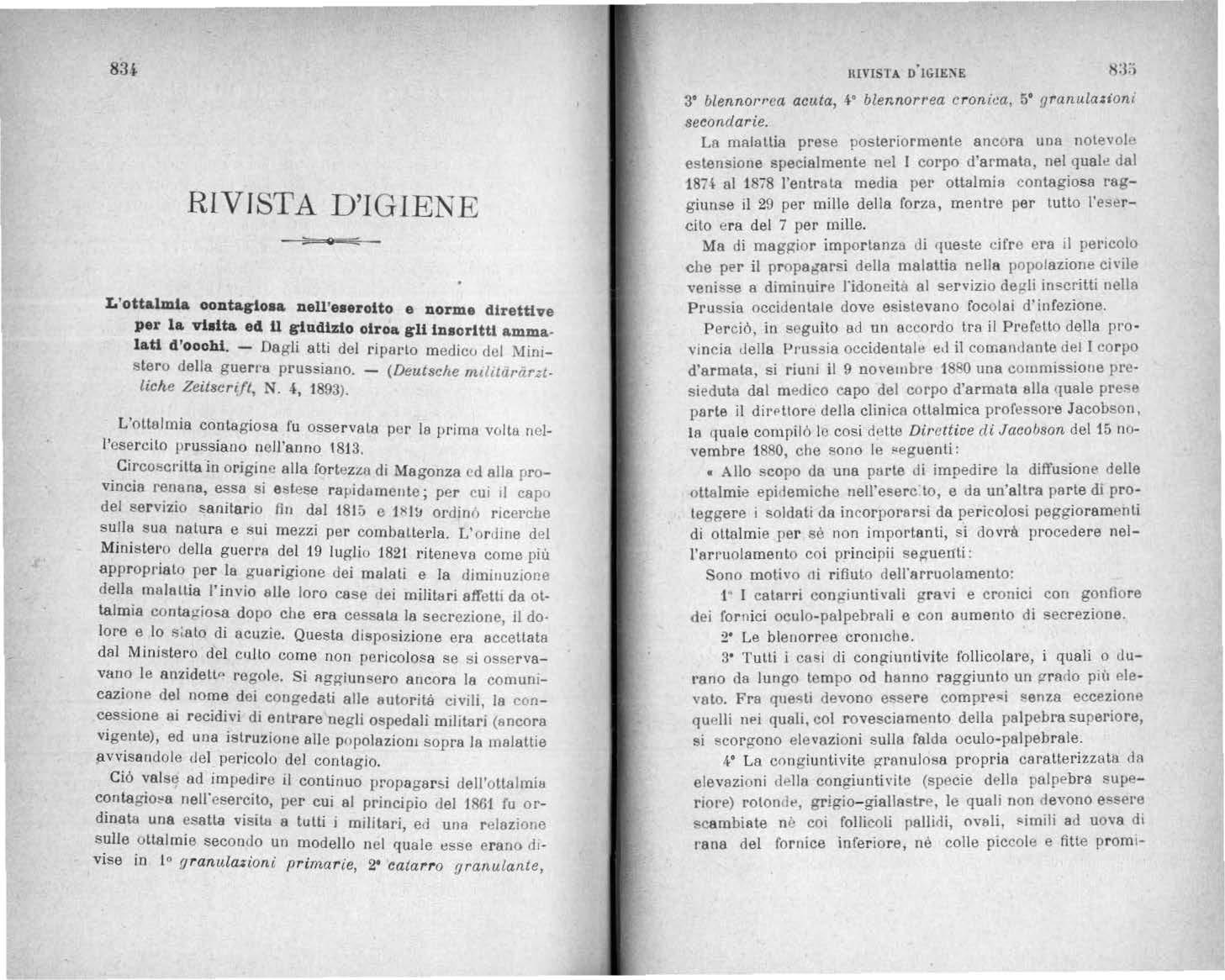
27 minute read
RIVISTA D'IGIENE
L 'ottalmla oontagloaa nell'eaerolto e norme direttive per la vlalta e4 U gludlzlo olroa gli lnaorltti ammalati d 'occhi. - Dagli atti del rip!lt·to medicCJ del l\1in 1stero della guerr·11 prussiano. - (Deutsclte mtliwrnr:;c. liche N. 4, 1893).
L 'ollolmia contagiosa fu osservata por la pl'ima volla nell'esercito prussia no nell'anno 18 13.
Advertisement
io origin e alla forteza1 di Ma gonza l d alla provincia renana, essa si est ese ra pidumeute; per cu1 d capo del ser vizio sanitario lìu dal 181 5 e H-111 ordino rtcercue sulla sua natu r a e sui mezzi per cornballet·la. L' o rdJIIe del Mi nis tero della guet•t•a del 19 luglio 1821 riteneva come piu appropr·iato per la gua rigi one dei malati e la dimiuuzìone della malatlia l'invio alle loro case dei miJitari affetti da oltalmia do po che era cessata la sect·ezione, il do· loro e lo si ato di acuzic. Questa dispos izione era accettata dal Mini s tero del cullo come non pericolosa se si v&.no le anzidettn rogolo. Si Aggiunsero ancora la comunlcazinnP del nome dei congedali alle sutorita CIVI li , la concessione ai recidivi di entrare negli ospedali militari (11nco ra vigente), ed una istruzione a!Je popolazioni sopra la malattie avvisand ole del pericolo del contagio.
Ciò valse ad impec.liro 11 continuo p:-opagar5i contagio..:a nell"esercito, per cui al principio del 1861 fu ordinata una esatta visita a tulli 1 m11itari, ed una r P-Iazione sulle uttalm ie secondo un modello n el quale ess e e ra no divise in 1° q ran ula:ioni prima r ie, 2' Catar r o
IUVJSTA D'IGIENE
a· blennorrea acuta, i-• blennorrea 5' yranula:ioni secorularie.
La malattia prese pos teriormente anco ra una notevol•• estensiOne specialmente n el l corpo d'armata, nel qual<' ùal al 18ì8 l'entrata media per ottaJmia con tagiosa t•aggiunse il 2U per mille della forza, mentre per lutto l'e::;t>rcito e ra del 7 per mille.
Ma di maggior importanza ùi que:;te cifro e ra Il pe1•icol'> che per il della malattia nella Ci\'ile a diminuire ridon eilit al servizio de!!li inscrilti nella Pru ssia occidentale dove esistevano focolai d'infezione.
Perciò, in srguilo ad un accordo tra il Pr·efello della pt·o· vmcia della Pr·us:;ia occidentali' t!cl il comandante del I eo r po d'armata, si riunr il 9 no,·elnbt•e una commissione presieduta dal medico capo del corpo d'armnta alla quale pre"e parte il dir·Pllore della clinica ollalmica profcssol'e Jacobson, l a quale compilò le cosi Dir cttioe di Jacobson del15 novembre 18RO, che sono le !<t>guenli:
• Allo scopo da una porte c.li impedire la diffusione delle ottalmie epi !emiche nell'eserc to, e da un'altra pa rte di p r oteggere i soldati da incorporarsi da per icolosi peggioramt:mti di ottalmie per sè non importanti, si dovrà procedere nell'arl'uolamenlo co i ppincipii segue ati:
Sono motivo Ili rifiuto rlell'arruolamento: q.• La congi untivite I(J'anulosa propria caratterizzata dn elevazioni della congiunti,·ite (specie dello palpebra riOJ'e) rolon dt>, grigio- giallastri', le quali non devono e"sere scam biate n e co1 follicoli pallirli, ovali , "im1li ad uova rli l'ana del fornice inferiore, né colle piccole e tìtle p r omt- nenze della congiuntiva esterna, le quali sono affatto senza importanza.
1• I catarri g ra vi e cronici con gonfiore d e i forn ici oculo - palpebrali e con aumento di secre zi one.
2• Le blenorrre cron1che.
3• Tutti i cas i di congiuntivite follicolare, i quali o durano da lun go tempo od hanno ra ggiunto un ,arfldo p1i1 Plevalo. Fra quec;tJ devono essere comprP"'i senza eccPZione quelli nei quali, col rovesciamento della palpebra superiOre, si c;co rgono elevazioni sulla falda oculo -palpebrale.
No n sono moLivo di rifiuto: t • I catar-ri acuii e cronici poco perché e!<"i guarire mediante breve cura, o spogliarsi dd lot·o carattere
:2• Le dPlte granulazioni p1·irnarie, cioè i fllllicoli linfatici i8olati senza ec·cezione. Esse, pet· sè sol e, nou hanno importanza. Se, per f'ccezione, sono i primi segni della congiUntivite granulot>a, si può, più tordi congedat•e i malati abbastanza iu tempo.
3• l casi di congiUntivite follicolare colla falda oculopolpebrale superic,l·e normale ».
Oltracciò nel1883 furono e manate dai Ministri della guerra e dell'mterno norme per combatte re le otlalmie contagio"•' nelle provincie della P russia occidentale.
Si ebbf' too;to nna notevole diminuziono della oLLalm1A coutagiosa negli in,.ct•itti e fr a la popolazione civile. Non si \'CriRcarouo più veri focolai morbosi, ed tl numero degli in · scritti riformati per ottalmia contagiosa. che nelr81 era di 663, discese uell'83 a 311 e nell'87 a 153.
Contemporaneamente i corpi di truppa dall'ottalmla contagiosa erano sorvegliati e v1 si eseguivano <''181tamente le r ego le igieniche precedentemente ordinate, e v 1 si ùavauo nuove p r escrizioni intese ad impedire l'ulteriot·e diffusione o..lell'ottalmia, e ad ollenerne una più rapida guarigione: come mino r e affollamento nelle caserme e nelle infermerie per ottal m ic1, tlislribrnJont: dt uo catino inùivìJuale a lulli, segregazione degli otlalmici od agli ospedali, od in camerate e caset·me apposite.
Queste misure non tarda r ono a da t·e buoni risultati: prima gli ospedali et·anc1 pieni di oltalmici, cci in Kòni g'-'berg !>i dovette aprire pet' essi un ospedale succursale, dopo la applicazione delle an1.idelte direttive il numero delle ollalmie coulagiose nel l COl'pO d'armala diminuì nolevolmeule. nel periodo di 8 annt dal 1• aprile 75 al l " aprile 33 questo numero fu d1 ·i83t, c n el success1vo pel'iodo di 8 anni fu solamente di 2505 .
Mentre, •:ontinuando nelle norme ll!Ì.-niche e·J 8•10pcra1Hlo 1 nwtod1 di cu ra più adatti, queste favorevoli condiziCini si mantenevano e progred1 vano finn a l presente fra i mtlilari. inveèe, fin dall"88, si nelln popolazione ch·ilc di alcuni distretti un aumtnlo df·lle oltalmie conlagio!'e. che richiP8e nuove ed enendche IDIS\lre. In questa ctrcostanza si rinnoY Ò la qu.,,..tione che era gta -;lata fatta anl,.ceclenle: mente, se non ,.:i do,•esse •Hlre alle co q i delle d ir etti vP d 1 Jacobson un altro indtrizzo in rela1.ione alle nuove ve lute scientifiche sul la natura della otlahnia con tagio!>a. tracciat·e quel'lte direttive nel 1R80 si erano !:'eguite le t lee contenute nell'l/anclbueh der gesflmmten Augenher/l,unde ron unr{ e,( in qu»ll"epoca generalmente accettale: secon•lo Saemisch nelle congiuntiviti con formazione dt p:ranulaztoni sì do vevano con5>tderar e due forme fra IOI'O distmte. Nella pr1ma, la congiuntivite ollicolare, le gt•anulazioni avev&;no il significato di follicoli, il processo morboso era capace di una guarigione com · pleta; nella seconda, la congiuntivite g r anulosa, le zioni co>'lituivano neo·formazioni, e davano luogo al rag· grinzamento della
In base alle osservazioni m1croscoptche si è fallo a poco a poco una reazione con tro 11uesto mod o di considet·are le gl'anulaziNti, secondo la letteratura medica degli ultimi 8 anni, non s 1 òisting"ore Jue gt'upoi dt malattia - nna congiuntivite follicolare, e1l una ;!ranu losa -mo comprenderli solto un solo nome di congiunltvite f.)llicolore o {.!ranulosa.

Fin ché l'opinione òi Saemi<1eh per i rn edtc i visttanti era sempre diiTicile di riferite le piuttosto all'uno che all'altro g-ruppo di mslallia, menLre al pt•esrnte si potevano ùat·e regol è' più semplici per decidere quali casi permettano e quali no li arruolamPnli. .
Perci ò d1 comune a ccordo del Ministero della guerra e d1 quello de1 culti fu invitato il prof. V. Ri ppel. successore Jacobson, arJ espt'ttnere il suo pa1·erl', se si soslttuire le dirtltli ve del J acob!"on con altre corrispon1lenti allo
RIVISTA stato attuali' della e nello ::.Lesso tempo l'u incari cato della queslroul' l'utlìcio r-anitario del I corpo d'armata.
Il risullntu flnale fu la prescrizione dr nuove norme da "ed'ot•a innanzi nel git!Liizio circa gli rnscrrtti ammalati d'occht non nel I corpo d'armata, ma in generale anche negli altri corpi dove l'otU!Imia contagiosa ò meno diffusa. La differenza essenz1a1e tra queste prescrizioni e le Rla in cio che si è abbandonata la di· visione tra malattie follicvlart e granulose (p recedentemente come tracoma), ag:.riungendo alla designazione granulare la pat•ola (ollicolare tra parentesi, perché circa la ulililà di una anziché dell'altra designazione le opinioni sono ancora divise. Le nuove direttive sono le seguenti: Non imperiiSCnnn l'arr·uoiAmenlo: l' I catarri con{:l'iuntivali acuti. l cutflrri cong1un tivali flittenular i.
2• l catarri congiunlivali cronici leggieri; con secrezione moderaLP, o notevole gonfio r e della l'alda oculo-palpebrule.
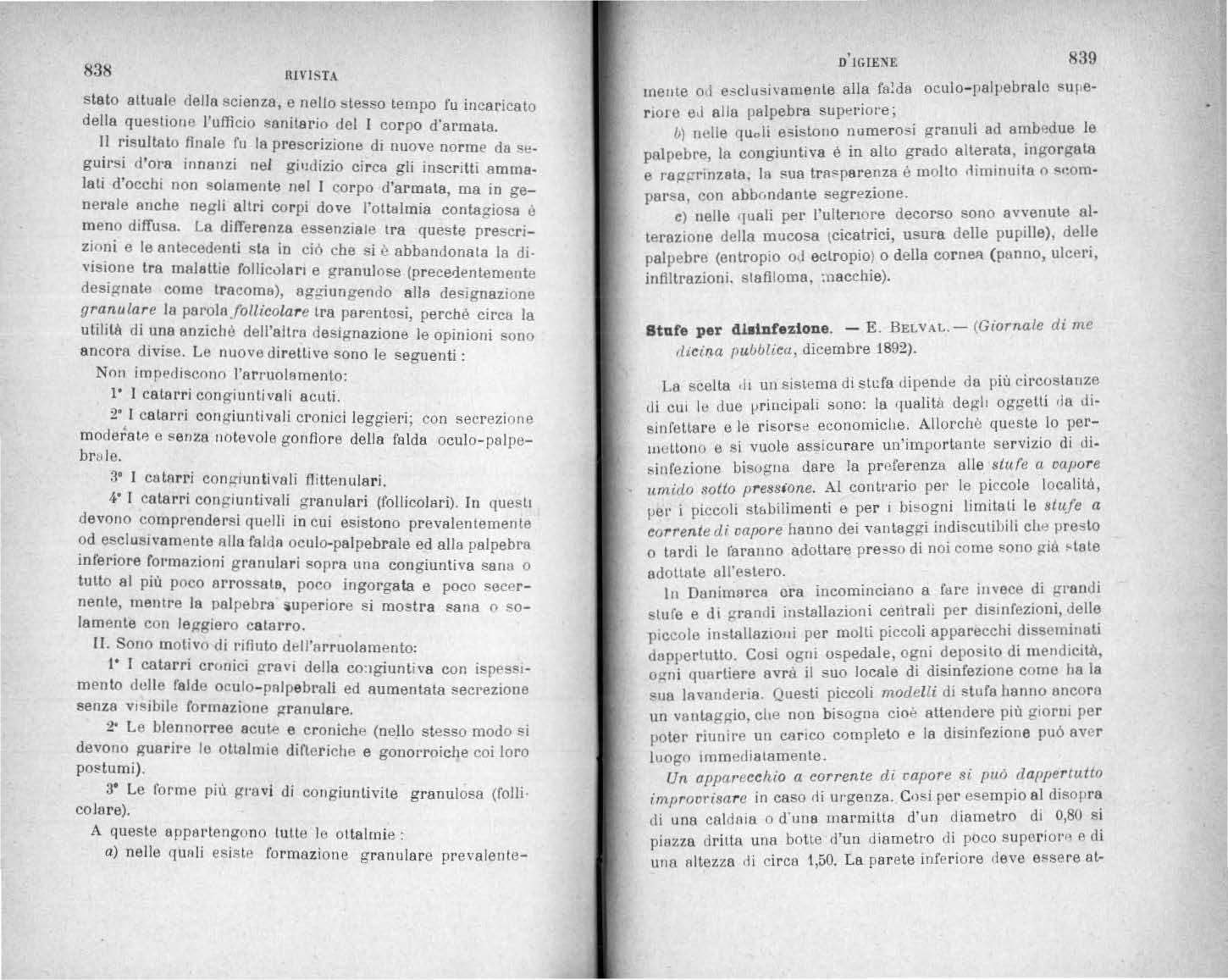
4' I catarri cong-1untivali granulari (follicolari) In queRll devono compt·endersi quelli in cui esistono prevalentemente od esclustvamAnte Alla faldA oc ulo-palpebrale ed aUa palpebra inferiore fot·maz.ioni granulari sopra una congiuntiva sano o tutto al più poco arrossata, poco ingorgata e poco l"Oct>rnente, mentre la palpebra iuperiore si mostra sana o c;olamente con leggiero catarro.
II. Sono motivo di J'lliulo dt'll'nrruolamento: t• I catarri cronici gravi della co:1giuntiva con tSpf'S"'Im en to delle l'alde orulo - pAipebrali ed aumentata secrezwne senza VJ"'Jbile formazionf'
2• L e blennot·ree acute e cronichf' (nello stesso modo si devono guarire le ottalmie difteriche e gonorroicl1e coi loro postumi).
3" L e forme più t:n·avi di congiuntivite granulosa (folli· colare).
A queste appartengono tutte le ottalmie: a) nelle CjUAii esil'l lr formazione granula r e pre\·alente- mente od esclus1\amente alla fa!da oculo- palpebralo l"UJ'er ior e e. l alla palpebr•a sup>!t'ior·e; v) uelle rruolr e;;islono numerosi ad le palpebre, la congiuntiva é in allo grado •. tng-o r gata e (o c;ua trRo:parenza Ò molto rilmtnUJia O ron abbr.ndante segrezione. e) nelle ,1uali per l'ultenore decorso sono avvenute alterazione della mucosa !Cicatrici, usura delle pupille), dell_e palpebre (entropio o 1 eclropio) o deUa cornei\ {punno, ulcer1, infiltrazioni. stafiloma, :nacchi e). stufe per dl•ln f ezlone. - E. BELVA!•. - (Giornale (h me f/ 1eina p uiJ/;ltea, dicembre 1892).
La scelt.a ,J, uu c;Jslema dt slda da più ùi cu 1 le due t•riucipalt sono: la 'lualitil deglr og;.retl1 ri o dtsinfellare e le risors<! economiche. Allorchi• uH•Ltono a si vuole assicu r are un'importante serVIZIO d1 dthinfezione bisogna dare la prt>ferenza alle stufe a umido J•ressi one. Al contr·ario pet• le piccole località, pe 1 · i piccoli e per 1 le stufe_ a corrente di oapore hanno dei vantaggi lndtscullblll eh.. pre....to 0 tardi le t'aranno adottare pre,.su di noi come l'Ono !-late ad ollote ull'estero.
In Dunima1·ca ora incominciano a fare invecP di re e d 1 installazioni centrali per dtsrnfezioni, piccola in-.t.allaziOui per molti piccoli dappertutto. Cosi ogn1 ospedale, _d_eposllO dt me nti1C1tà, quartiere avrà il suo locale dr dtsmfez1one come ha la JavnnùPJ'ta. Questi piccoli modelli d1 hanno ancora un che non bisog;na ciot> altenùel'e p1ù gtorui per poter riunir•e un cartco completo e la disinfezione può avc>r 1rnm!.!dìalameote.
Un apparecchio a corrente dt !è(fflOre può _d appe r tatlo improorisa re in caso rli u,·genza. C•>sì por esemp10 al li una calrln 1a o d'una marmitta d'un diametro d1 0,80 SI l r piazza dritta una bolle d'un diametro di poco RupcrJOI'' 1 r < • una Allozza di rircR 1,50. L a parete inferi ore 1leve al-
IHV!SlA tr a ve r ">a la da numerosi fo ri per dar• passaggio Al vapor·e: oppure il può esset•e eia ur.a rete di Ct>rde. L a par·ele superiot·e è futla la un rovercbio mobile, che cùiudt', pe r rtua uto è po!>sibile, esattam ente. Nel centro tale cove r chio è forato col tr apano, l'orìflcro è chiur;o da un ta ppo, all ra n,•t•so si rr ual" pa"sa un termometro da un tubo asc:ar lar zo, ap t! rlo alle due e"trermlà e che devo> dat•e passug-gio al È meglio che tale tubo st allo esterno del loC'ale. Pet· evitare che il vapore sfugge tra la ca ldaia e la hottt', si chiude l'interstizio con con o r"n feltt·o bagnali.
L a lòpesa pel primo impianto ammonta a 20 lìt·e al massimo, il costo del cai'I..H)IIO può esset·e valu tato a 75 centesimi pet• di<:infez10ne
All'ospeda le militare rli Gtessen si e ,i n.-:tallato un appare cc hi o di tal ::rener e Il focolare è in muralura, 11 calderone in rame; la camer·a di disinfezione rappresentata da una botte di querc ia dì m. 1,20 Jr allezza s u eli m. 1 di diamett·o alla base e m 0,1}{) alla parte superiore; é cerchtata 111 ferro ed i cet·chi sono raccomandati a ,·iti. Il cnlJe roue porta uu livello ad acqua.
Il l'o colaio f> sormontato da uua lamie r a fornila d'nna c:canalatur·a Ci rcolare che si t•iempie d'acl'jua, e nella tJUale s·mtrodu t' B il bordo inferiorE> dt>lla Lotte.
Il cowrc h10 t> a chiusum ermetica mercè u11 nndln òi cauccrù.
B i,.ogna attenJ t> re ua·ora e mezzo pe t chè il vapot·e seg11r 1041° al t... rmometro nel dalla stufa. A par·tire da !fUf''> lO l•·mpo biqog-na altt>ndet'P un'ora perclw la di...:lnf,.,zione sia t' olln!Jleta. Sono 1recesgori 18 kg. di cat•bone . lutte le $\ufe di tal gent>r·e lt anno un pr ezzn che var1a da t-00 a 600 lil·e.
La ,;tura co'ltruita a Golliuga, cou indicazione di Flììa-ge è de l medesimo con camera di disinfezione in la tta. e CO<:luta 45(1 !tre t•d ha dali l'IC:Ultati Sr•ddisfacenti
Ove c:i oli uu g:.. uet'alore di vapore, ,., fn ci le impiantnre una eh queste :-;tufe. Si fa al'l'tvare il vapor·e pe r uu tubo ,Ji 15 millimetl'i , li dllllll··lt'•' in una a doppio fondo.
D'lli tENR 84. 1
11 fonJ o inferim·o è pieno; a cen timetri di distanza. è di<:po:::ln il fondo s uperiord. fo ralo per lasciar pas"at·e 1\ vapore. 11 covercbio non deve combaciare erm eticamente: lo si carica con gros!:'e pietre. In seguilo si fa passare la correute di vapore, il q uale deve pe r lo meno avere nel ratore unn tensione d'una m e zza atmosfera. Un I'Ublllello permette di reg:olarne l'arrivo. Dopo 5-10 rnrnuli il e"'Cf' dalla parte superiore dello botte alla temperatura di 100• cd a partire cla 1\}esto mome:1Lo, è necesl'larJO cloe , ' . ti'8<:corrn un'ot•a perchè l'operazione l'in compiUta.
G.
Prof. dolL. A. GA K'l'NER . - Sulla ereditarietà della tuberoolos l . _ (Zdlsch r iflfur unrl I nlectionakra nkheilen, Vol. Xlll, fas cicolo 2", febb r ato 1893).
Di quest' 1mporlantissimo la voro ci limitiam o a rift.•ril'e le conclusioni generali. . . . . ... 5; i. L'uomo non appartiene alle pm dt alla tube r colosi, pt> r ciò n e s"gue di necess1ta che debba_eSIslere una disposi1.ioue indivitluole, s •·oza la quale n o n lrebbor•> spiegar e le di!Te!'enze t'elalive al d<·eorso e ali esrto della malaUia. a. La disposizione è basala· Ja un lato, !:Ulle d' ind•·bnlimcnto dell'orgarusmo, dall'altt•o Ialo. sulle va rtet.à della !'lUI\ struttur a analomtcu e del ::;uo l:l. LR tubercolosi primaria r... tale dellr• f(lanùole hnfatiche po<:.c:ibilc: sulla r·elati va ft·equenza di non si può pel momento dari' alcuna r Pgola Cl.'rla. sembr·u impossibile che i bacilli tubercolosi dal sangue pO!'I!'Iano penetrare nelle lacune linfaliche e nelle glando le linfaticbe.
'> L'infezione naturale, che st manifesta nell'uor.w molto · frerruenlemento che nelle c lassi anim1111 più disposte, ccforse il bue, si spiega eon la grande malutlia, con la inteusita dell' con t nuno r i mezzi di protezione dell'organ isrno umano e col decors o più lungo della malullia, in una ptu·ola, cnn l a più lunga durAla del pe r iColo d'infezione. . . .
4. No 11 par,., c he le val'ielà nella della laltia rwll'uomo dipendano dal dive r so grado bacilli . Quand'aut· fosse l'attenuaziOne del bncillo della tuhl' r colosi, Jì n ora non f;i nell orga ni smu l'azio n o dei bacilli allonu att naturalmente.
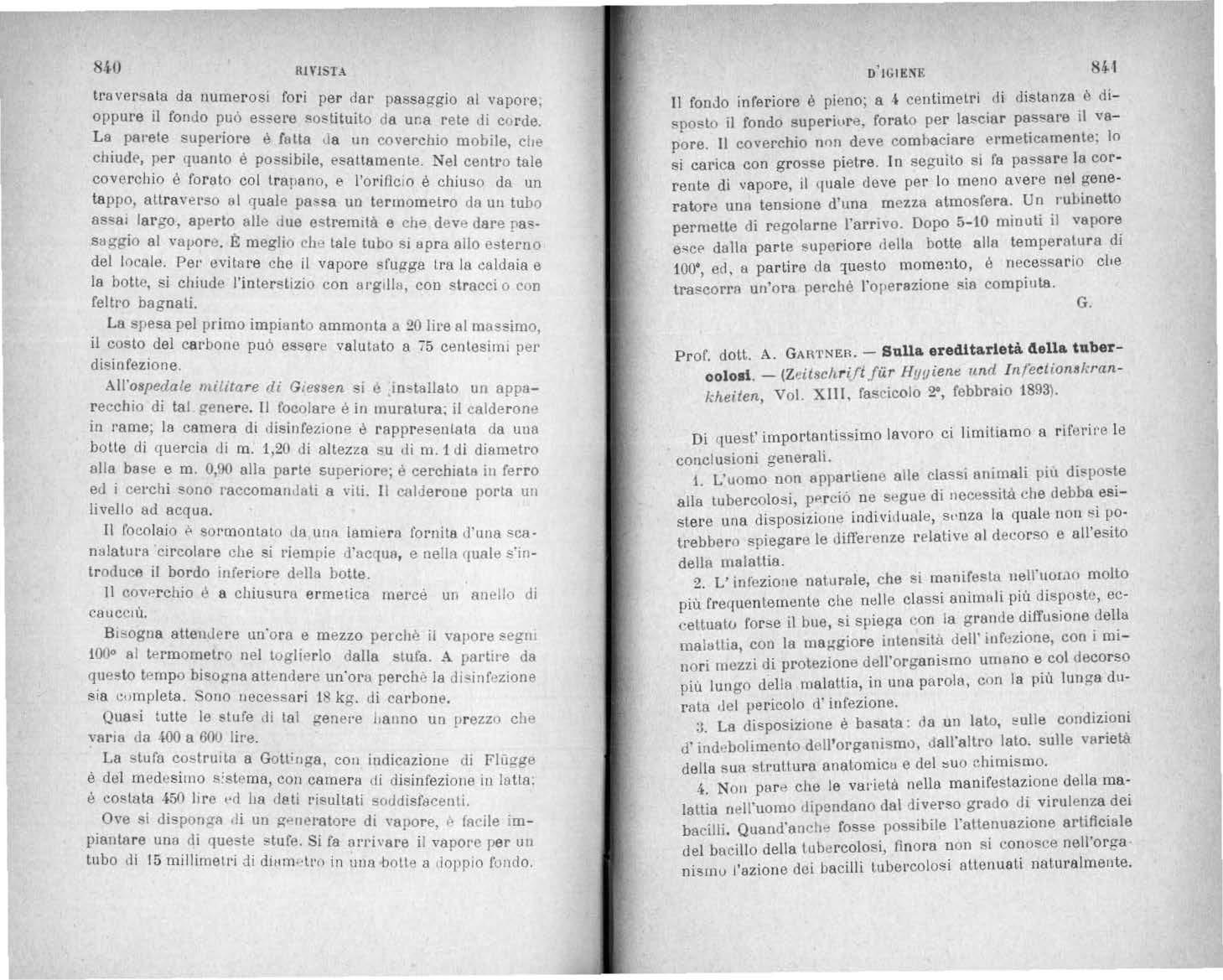
5. Lu tubercolo:;i l'eta!,,, cioA In malalLia già sviluppata alla nascita, i· mollo rar\1; In prt>«enza di uacilli tuburcolnl<i m un r.. to umano, appa1•entemenle è stata dimo«trala !'O· lamenta due volte; ancltP. le della prima età che poo;sano ascriversi con sicureua alla vita fetale, sono sime.
Le poche us"er·vaz1oni pe; 6 ba,.tano p.,r dim()strure che e t•nssibile una trasmissione di bacilli tubercolosi dai all'erubrione.
6. La in.,egna clte i b11mbini nel prrmo anno di vita sono 111 allo grado colpili ùa tubercolosi. La mortalitA. nella !'leconda metà del prrmo anno di vita, é maggiore che nella primu. La rnortaliLa minima per· tubercolosi si ossèrva l'ra il 6• e il 16° anno. Da que!<to ultimo tempo comincia di nu(lvo l'aumento clw, secondo alcuni statisti, !<i prolunga "ino alla J>ÌÙ tarda età. altri si tiene allo da 20 a 30 annr, per di,.cendere n per salire dr nuovo.
7. Lu f'levala morlaliltì della (H' ima eta può ascriver"i ad un pnr regolar•e allecchirnento di bacilli congiunto acl un più rapido decorso della malattia uei fanciulli, anziché negli adulti o a 1 un' mfezione più 1·apida av,enuta o pl'ima o dopo la nascltn, o ati una combinaziol!e d i rJuesli due momenli C8US81i.
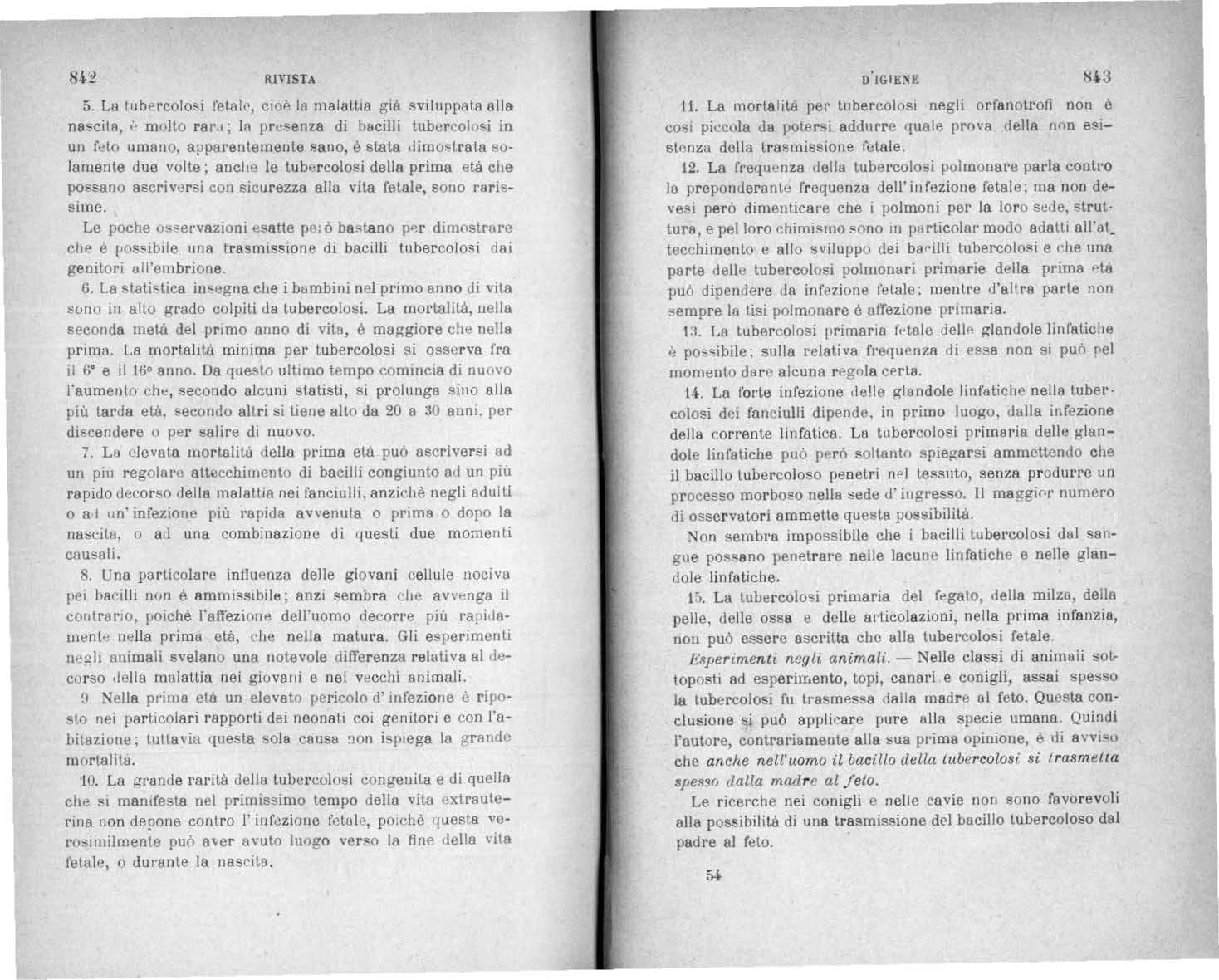
8. Una particolart> infJuPnza delle giovani cellule nocivo pei b1willi nc11l è amntissrbila; anzi sembra l'ile avn·nga il contrarro, po1chè l'affezione dell'uomo decorre più rapitlo11\ent•· ndla prima età, <·he nella matura. Gli esperimurrti ll<'!!h animali svelano una notevole differenza reialì va al •le· curso .!ella mnlaitia nei giova11i e nei vecchi animali.
11 Xella pr·ima eté un elevato pericolo d' 111fezion e è riposto nei particolari l'appor·ti dei rreonati coi genitori e con l'abitazione; tutta via questa sol a causa •w n ispiega la mnrtalita.
LO. La gr·antle rarità della tubercolosi congenita e di quello eh<! s1 rnamCesta nel primissimo tempo della vita Pxtrauterma rron depone contro l' t'eta lP, pOIC'hé que!<ta vopuò a"'er avuto luogo lA Rne clelia 'rta tetalP., o durante la nascite.
11. La mortalila pe1· tubercolosi negli orfanotrofi non é cosi piccola da poter:-;1 addurre quale prova cleli a oon esrsLnnza della trasmissione fetale.
12. La rrei(IH'UZa della tubercolosi polmona1'6 parla COOti'O la preporrderanle frequenzt1 dell' iu fezione fetale; ma non de· però dimenlical'e che i polmoni per la loro sede, «trul· tura, e pelloro ehimi«mo sono in parlicolor· modo adatti all'al_ tccchimonto e allo sviluppo ùei badili lubercolol'li e l'Ire una parte cieli•• polmonari prima rie della prima Ptà può dipendere eia inft>7ione fetale: mentre d'ali ra parte non 8empre In Lisi polmonare é affezione primaria.
14. La for·te infezione delle glandole nella tuber· colosi di'i fanciulli dipPnde, in primo luogo, dulia infezione della co rrente linfatica. La primaria delle glandole linl'atiche può però soltauto spiega r!'i ammettendo che il bacillo tubercoloso penetri nel tessuto, senza proùurl'e un processo morboc:o nella sede d' ingr·es!'lo. Il maegi0r numc1'0 ù1 osservatori ammette questa possibilità.
La tubercolosi primaria del fegato, della milza, della pelle, delle ossa e delle aJ'l.icolazioni, nella pl'ima infanzia, nou può essere ascritta che alla tubercolosi fetale
!!.:'sperimenti negli animali.- Nelle classi di sottoposti ad esperimento, topi, canat·i e conigli, assai spesso la tubercolosi fu trasmes!'la dalla madrt> al feto. Questa conclusione si può applil'are pure alla specie umana. Quindi l'autore, contrnr·iamenle alla sua pr·ima opinione, è dr avvrst> che anche nell'uomo il bacillo della tub ercolosi si trasmetta spesso dalla mad r P al feto.
Le r1cerchc nei conigli e nelle cavie non sono favorevoli alla possibilité di una trasmissione del bacillo lubercoloso dal padre al feto.
Se 1 bac1Lh tubercolosi e r ano numeros1 nello sperma, non ne segui l' infezior1e del feto, ma quella della madre .
P er ·Lanto si può conchi uùere che la tubercolosi omana non è tra!"messa dal pAdre al feto dm•ante l'allo della zioue.
C. S
Doll. P. I'H.oscu.- Bulla d.Ufuatone de l b&olllo della difterite neloorpo dell'uomo .- (Zeitschri(t.fur ll!IIJ' ene nn cl Infectionst.rankheilen, Vol. X l Il, fascicolo 1°, Frnora et•a ammesso che i bacilli della difterite si trovassero in quelle parli del corpo, rn cui danno orrgine ulle membrane ,·aralteristirhe. Solamente pùchi os"ervator• dissentivano dalla comune opinione.
Le osset·vaziot'll dell'autore si l'ife ri st·ono a 15 casi dr vera difterite, confermata tla ricer che balleriologiche, tel'minati con la m o rte o'IGIE!\E
In 5 de1 casi non si trovarono bacilli difterici negli organi, ma i nspeLlivi maiali o morirono assai presto, o infeziom di altra natura complicarono ed aggravaron o la di fterite.
Negli altri 10 casi l'autore tr ovò 1 bac11li caratteristi ci nel sangue e negli organi. Dal sangue degli essudali, quando esistevano, e dal s u cco degli o r gani l'autore ottenne colture nell'agar, e noi tr asporti, coltu r e pure, di cui sper imentò l'azione negli animali.
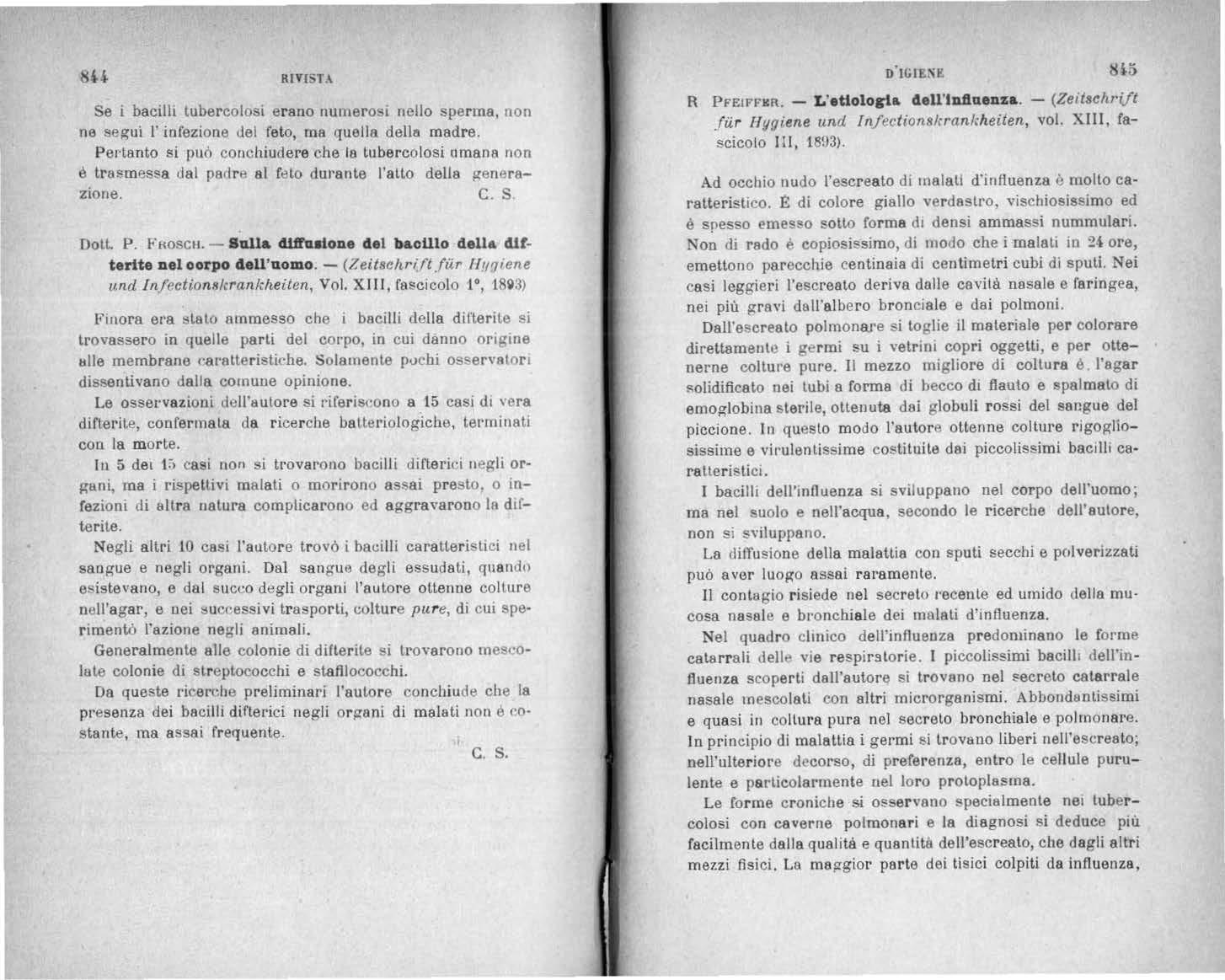
Generalmente alle colonie di diCte r ile si troYarono late colonie di slr eplococchi e sl.afilococchi.
Da queste r·irer·rhe preliminari l'autore conch iude che la presenza dei bacilli difteeici negli or ga ni di malati non è r•ostante, ma assai frequente.
R PFEIFFKR. - L'etlologb. dell'ID1luenza . - (Zedscltrift jur Hvuiene tmd Infec tionskrankheiten, vol. Xlii, fascico lo III, 18!J3).
Ad occhio nudo l'escreato di maiali d'influenza r' mollo caratteristrco. f: di colore ve r dasll•o, visch iosissimo ed è spesso emestoo sotto forma dr densi ammassi nummulari. Non di rado copiosissimo, di modo che i malalr in 24 ore, emettono parecchie centinaia dì cen tim etri cubi di sputi. Nei casi Ieggieri l'escreato deriva dalle cavità nasale e faringea, nei più gravi dall'albero bronciale e dai polmoni.
Dall'escreato polrnonw·e si il materiale per colorare direttamente i g<! rmi su i vetrini copri oggetti, e per ottenerne colture pure. Il mezzo migliore di coltu ra è l'agar solidificato nei tubi a forma di becco d1 flauto e spalmato di emoglobina sterile, ottenuta dai globul i r ossi del sangue del piccione. In questo modo l'autore ottenne coltut·e rigogliosissime e vir·ulenlissime costituila dai piccolissimi bacrll1 caralleristicr.
1 bacilli dell'mflueoza si sviluppano nel corpo dell'uomo; ma nel suolo e nell'acqua, secondo le ricerche dell'autore, non si S\'iluppano.
La diffusione della malatLia con sputi secchi e pCilverizzati può aver luogo assai raramente.
Il contagio ri siede nel secrelo r·ecenle ed umido della mu· cosa nasale e b1·onchiale dei molati d'rnfluenza. Nel quad r o clrnico dell'influenza predominano le f01·rne catarr ali delle vre respirator ie. l piccolissimi bacill r dell'influenza scoperti dall'autore si trovano nel secrcto catarrale nasale mescolati con altri rnicrorganismi. Abbondantissimi e quasi ir1 collura pura nel secreto bronchiale e polmonare. l o principio di malattia i germi si trovano liberi nell'escreato; nell'ulteriore decorso, di preferenza, entro le cellule purolente e par ticolarmente nel loro proloplasma.
Le fo r me c r oniche si osservano specialmente ner tube rcolosi con caverne polmonari e la diagnosi !'li deduce più. facilm ente dalla qualità e quantità dell'escreato, che dagli altri mezzi fisici. La maf(gior parte dei lisici colpiti da influenza, muoiono e quelli che supera no la malattia, pegg1orano pel processo tubercoloso. nrcalar ro si diffonde per contagio dalla mucosa alla laringe, ai bronchi e al polmone. ll bacillas coli communis, descritto da Eschcrich sollo il nome di bacterium coli comnwne, identico Ili bacillo delle fe ci descritto da e al bacillus neapolitanus di Emmerich. Esso si trova in abbondanzll nelle dejezioni del· ruomo e m qu e lle degli anim»il. È dunque naturali" che se l'acquA potabilo è infetta dalle feci contenenti bacilli del tifo, lo sarà contemporaneamente da l bacillus coli communis, che nell'acqua si sviluppa meglio di quello del tifo .
Secondo le osservazioni dell'autore, i micrvrganismi dell'influenza non penetrano che raramente e in iscarso numero nel torrente cir colatorio sanguigno, ove non si :sviluppano.
Perciò nell'influenza non si tratta di un'infeziOne del sangue, come nella febbre rico r rente, ma di un avvelenamento per riassorbirnento di Loxine da influenza.
Si osservano nei cadaveri di mdiv1dui morli pe1· intluen za polmoniti lobulari, con zaffi alveolari centrali di colore grigio-giallastri. della grandezza di una testa di spillo a quella di un pisello, distinti chiaramente dal tessuto rosso cupo che li c•rconda.
Quc<>li zafO sono costituiti da numerosis simi bacilli dell'influenza, che r iempiono il protoplasma delle cellule purulente. Nel secr eto dei grandi bronchi, della laringe e della nasale i dell'influenza sono uniti ad altri nu· meros1 microrganismi come streptococchi, diplococchi di Friinkel ed altri.
Nei grandi bronchi l'epitelio vJbrlltile spesso é distrutto ed i• soslitUJLo da r•esidui epiteliali o da cellule purulente. Talo ra le cellule purulente penetr ano fra le vibratili e si avanzano nello strato cilindrico colmando tutte le lacune lasciate da elementi distrutti. piccoli bronchi ne r iempiono Jel tutto 11 loro lume.
Piccoli al"cessi formatisi talor·a ne• lobuli polmonari gli danno aspetto poroso.
Contr o le cellu le epiteliali dei bronchi !'i veggono nume· r·osissimi bacilli car atteristici. Il processo e schiettamente catarrale e ricorda la gono r rea della mucosa e congiuntivale.
La polmonite lobulareJ dell'influenza si differenzia dal processo della polmonite cruposa per la mc.ncanza di fibrina coagulaLa.
La malattia può terminare co n la gua r1g:ione completa. in risoluzion f" parzrale, ed altre volte con esce:;sohni miliari· formi, con indurameuto c caseificnzione tlel le!'lsuto polmonllre.
Haro è l'esito in gangrena polmooare. Allre CC)lnplicoz•oni più r·are sono la otite media e la cerebrale. Nelle é riprodurre in parte la mulaltia; ma tanto in questi animali, quanto nei conigli gli effetti più sicurr si ottengono cou inoculazioni di toxine elai.Jorat" dai "ermi clell'influenza nelle colture.
,.., - Nelle jlrandi riunioni di uomini, specialm ente nelle caserme, giovano l'isolamento dei primi malati e le disinfezioni.
Terapta. - Nei catarri •ncrpienti delle cavità nasali, la cura antisettica puo fAr... abClrtim la malattia; nei catarri della larmge e dei grùn li bronchi "'ono utili le inalazionr antisetticht>; nella bronchite capilla re e nella bronco-poi· monile la te r apia non produre a lcun effetto. c.
O. - Btc ero he sul bacUlo del tifo e sal baotl· las ooli oommunia . - (Zeitschrift fùr Hygéene und lnj'ectionskranklwiten, vol. 12'. fase. 4°).
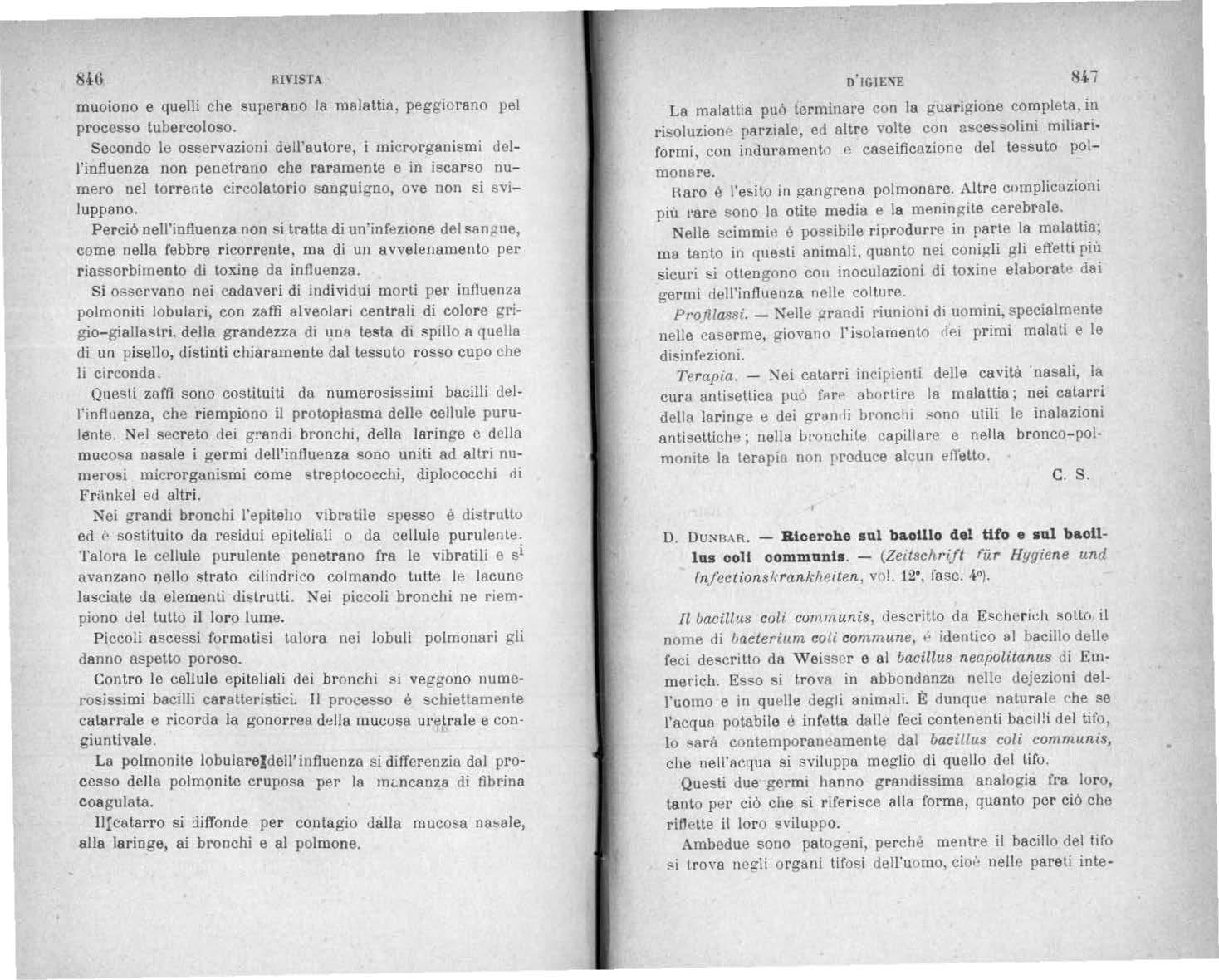
Questi due gormi hanno grandissima fra lo r o, l.anto pet' ciò che si riferisce alla forma, quanto per ciò che il loro sviluppo.
Ambedue sono patogeni , percha ment1·e il bacillo rlel tifo
!':i tro,·a neio'(li o rgani tifosi delruomo. cioì• nelle pareti inte· glandole mesenteriche, nella milza, nel fegato e ne 1 rent, !l coli commune, in coltura pura, è trovato m parecchi processi infiammatori a d es. in un ascess? l'e s tirpazio n e di un gozzo, nell'infiammazione della CisL•fellea e dei conùotti biliari ; dopo il cholera nostras tutta gli nel pus della menangite, peri ton ite, pleurite e negh ac;cessi del fegato, ecc. l. latte il bacillo del tiro '>i s vifuppa rigogliosamente, Pl'oduce picrolo grado d1 acidità e non dà m 11 i lungo a coagulaziOne;
Due sono le ditTe r enze carattPri<:tiche di 'fUeSll gePmi nei 111ezzi nutritivi di sviluppo.
1! &aclerium coli commune invece, nello stesso m c>zzo nutrihvo, forma acidi m abbondanza e l alla temperatura di 37• C. congula il latte in 2-i-48 ore.
I l. Il bacillo del tifo nelle co tture non dà mai luo<ro a sviluppo d i gas; menl•·e il bacteriurn coli commune clti lu ogo <'Oslanleroente a sviluppo di g-as tanto nella e nelrruanlo nel brodo. In quest' ultimo si sv 1Juppano grandi quaotiiA di gas, alla temperatura di :r;o c. rre :1 e J2 ore.
.' che formano nel brodo sono coslltuili, in parte mm1ma, da ac1do carbonico, per c•i rca s;, di tutto il gas, da 1dr•ogeno P da una minima parte dr azoto o metano.
Frronea era tlunq ue l'idea di molti osservatori che il bucillo del tifo e il bacteriwn coli commune fossero identici; err one1 erano pur·e i positioi, ottenuti nelle ricerchr. del bacillo del tifo nell'a cqua potabile.
S1ccome i car atleri della del latte e sviluppo di gas nellP colture in brodo non erano stati presi fin0 1'a in esame per la ricei' Ca di ffe r enziale, così i due aermi, che negli inquinamenti di acque potabili per le di tifosi trovan si s empre insie me, furono cvideotementP cnnfusi fra loro.
Vari Eta
In diver"e occa!"ioni è c;;tato enunciato l"avvi!"O che un m ezzo polenlac;;!'lirno per far d1rninuire la rabb1a sarebbe quello di mettere una forte sui cani; mn :1essuno per quanto si sappia, ha espresso il concetto che questa imposta dovesse governativa.
Una imposta gooe r na.tica avrebbe per effetto immediato d1 far· reg1slrare i canr e eli metterli sotto l'attiva sor,-e!!lianza d1 Lutt1 gli governativi (agenti delle impoii<le, pretori, carabinieri, ecc.) eppercio anche uoa forte delle :;tuardie municipali le quali, come la pratica ci chn1oslr•a, sono assai più atLive quando tr a.ttasi di un a sorvPRiianza governativa, di quando traltasi di uno semplice l"orveglianza porlata dai locali regolamenti municipali. Ciò stabilito ta1·ebbe poi sommamente facile l' ollencre che tutti i cani indistintamente t'o!"c:er•o muniti di una mu'>eruola falla secondo un modello unico realmente efficace, il eh•· ci condurrebbe in pnl'hi anni alla totale rlella rabbia.
Cre.lia mo utile di r iportart> togliendola dalJa Ras:scona di scien•e mediche, anno VI l, n. 9) la ci rcol a re emanata dal laboratoriO Jel Collegio di Francia, n ella quale é indicato il moùo col •1ualc chiun1ue può procur·ars1 con lulla farilità il succo testicolar,. ed ad adoperarlo con chtArrzza e con tulti i pa r ticolal't ocr·orrenti.
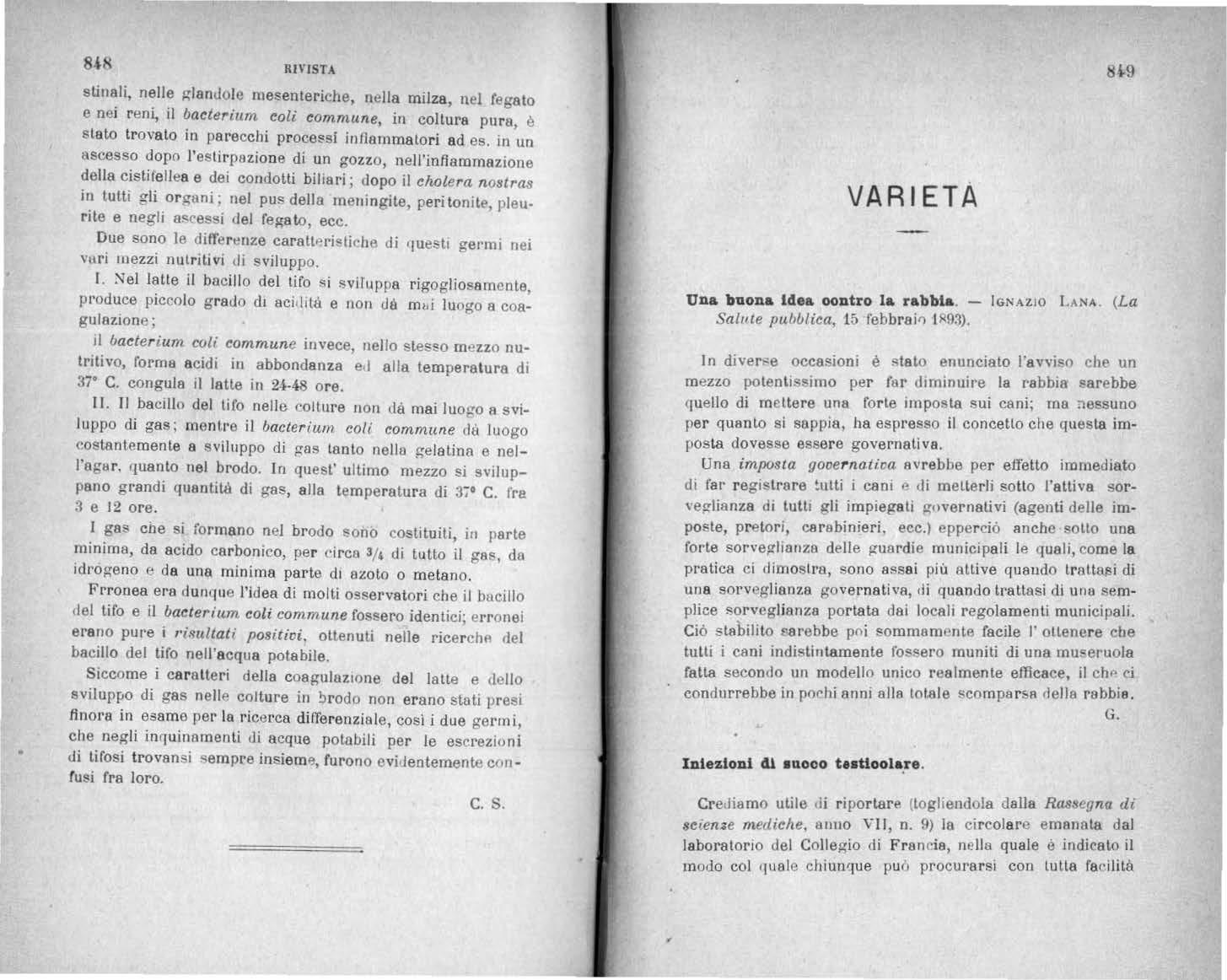
• Noi non rnanrfiamo ti liqutdo Lesticolare se non dietro domanda di un medico che accom pagnata daUa sua carla di vi.,ita e dalla storta rlell'ammalato che si ,.uol :;,ottoporre all11 cura.
• Il liquido lo mandtllllHI gratUitamen te, :>alvo le spe:;e cii posta e d'invio, por le quali il rìchi.,dente dovrà unire due fra ncobollt dn n centestmi.
« Le domande si riv olgono semplicemente au Laboratoire de médeclfi.C, n. 12. R11e Clawlt Bf•r nard, Paris.
• Il me lico che ahbia eseguilo una cura e che riun ovi la domanda del liqutdo, Jovt•à mandare insieme una t•elazione dei J'i"ullAli ottenuti dal principio della cura. senza dt che non ;;i dare risposta alla domandu
."v/orlo rli adoperare organico. - jo fJu t'sto liquido vien<· sped ito gratuitamente e non si può vendet·e.
2• Si deve se mpre pe1· 111iezione ipodermica. a· si dove lllt ettAI' puro. Si carichi col lirtuirlo puro soltanto mezza la si rin ga di Pt·avaz e 'li finisca di riempirla con acrtua sltlla la bollilA dì fresco.
4• Tutlt 1 recipienti adoperali (la ::oiringa, l'ago) Ja pelle, dt•vnno lavati dilt,!:Cillt>menle con ac11ua fenicata all't per :l(}!).
5o Si devono mìellare du 2 ad X grammi del lif{uido allungato come é detto. in fJUf.lnle punhtrP occorrono, almeno due volle per sethrnana.
6o È inutile conllnuare 111 cura !'e non si ollìene un mi!.dio· ramPnto al termine dt tl'e !lellimane.
. ;o L'iniPzione dev•' e«"Pt'e fatta al ventre, 0 neUa r egione mterl'capolare o nblle nattche: l'ago deve esser e introdotto lullo fìno al calcio e in parallela alla super ficie dPils pelle.
8• Se la cura é diretta cont r o la fiacchezza senile, deve essere continuata per almeno tre mesi e ripeesa poi per uguale pet·iodo eli tempo, tutte le volte che il soggetto nt" avrà hiMgno.
9• Il vaso del liquido deve essere tenuto ril.(oro"amente chtuso ed in un luogo fresco. È necessario non introdurre mai acrrua nel liquido: non serve pi(t quando s'inlorbida no· t•volm en
10• Se l' iniezione i> dolorosa (il che avviene assai di rad o) s'allunghi il li•tuido con due volumi d'acqua, anziclu'• con uno solo come R'è indicato di sopra. G.
Hivista Biblioghafi Ca
Tralté de chirurgie de guer re , par E. DELORME
Il dott. Delo rme, professore alla scuola d'applicazione di medicina militare di Val-de-Grace, ha ora completato il suo impor·tante Trattato di chirurgia di f!Uer r a, di cui é compat·so già tla qualche anno il primo vol ume che contiene la Storia della chi r u r gia militare f r ancese e !o studio delle jertle rla arma da jao co delle parti molli (l) .
Il tomo seconù0, che ora termina l'opera, fot•ma un volume di piu di 1000 pag:1ne con 39i incisioni ne l Le!>.lO e 3 tavole fuo r i le!<lO, lulte disegnate dall'autore m base ad esper ienze o a ca"i notevoli. Esso l r allA d elle lesioni delle ossa per arma da .fuoco, delle (eritf' nelle carie regioni e del se r nizio sanitario in campanna.
Lo l'l tudìo delle lesioni de lle ossa per armi da guerra é forse il più impol'tante nella chirurgia militare. La frel(uenza con cui si o"Mrvano queste fe!'ite, il loro carattere pat•ticolare, la lol'o g ravitA, la moltiplicilà e l'importanza tn· terv enli che esse reclamano, la durata e la diflicol!A della loro cUt·a·. eù mtìne la parte considerevole deYoluta al chir urgo nei successi ottenuti obbl ig an o ti medesimo a po rtare su di osse un'attenzione pa rti colare. Mercé numerose espe·
(l ) F. Alcan editore, un vo l. gr. in s• !6 fr.: Il t• vol. si ven1l9 oeparat.amente al 11rezzo 11i rr. 16.
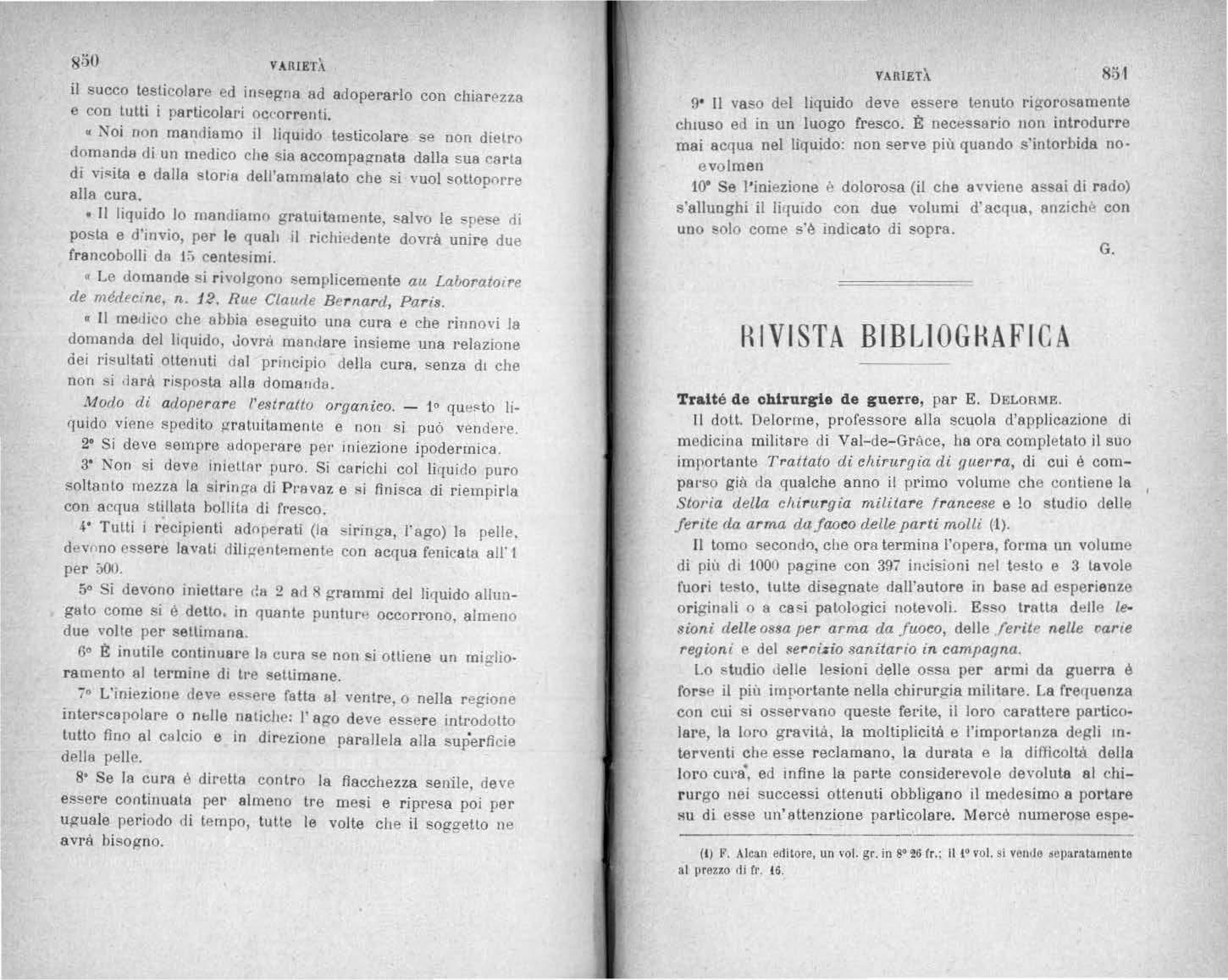
Rivista Bibl Iografica
rienze l'autore ha potuto fissa r e, meglio che non s1 fosl:>e fallo pr ima di lui il ca r attere anetomo patologico delle principali di 11n este lesioni: se le trasfot'mnz1oni recenti delle armi hanno rnodifical0 il loro carattere, il metodo antisettico cambiandone il decorso ha affatto mutato c1ò che una lu nga osc,ervazione aveva loro pronostico, sul loro trattamento e sugli accidenti cu1 esse po!:<sono dar luogo. Dell e nurneroc:;e allrlbttzioni del servizio in campagna tl pror. Oelorme non tratta che ' luelle relative alle prime cur·e da darsi ai feriti sui campi di battaglia; alla scella melodica dei fer•iti; al lrAllamento i11 sito dei feriti IPggieri o d1 quelli che m rag ione della loro non possono evacuati; 1·apida all'indietro d1 tutti gli altri ferili: all'inizialiva da prendersi per la creazione o estensioni-l dì ospHalieri nella madre patria, ed a1 soccorsi da darc;i ai ferili durante gli a ssedi. In rag10ne delle trasformazioni conti nue degli a1·mament i nei d1ver·si paes1, l'autor•e ha dovuto i11 nn ultimo capitolo mettere sotto forma di aggiunte o appenùic1 le questioni piu importanti che potevano sollevare ultimi progrec,si compiuti. G.
Lehrbuoh 4e• Krie g •ohirurgte (T1·atlato di chir·ursda da guet• ra) del O. KARL SEvoeL STABSARZT nell'esercito bavarese. - Stuttgard, Enk t>, 1R!l3.
ll manuale tli chirul'l·da d1 :!el dott. Seydl:ll, che c1 fu gonlllme nte fa,·o,·ito, fa parte della B ibltoteea del medieo edita da Enke di Stuttgard. L'autore, che •\ insegnante di oper&7.10ni del corso por i med1c1 milita r i, e docente alla univet•::ità di Mo naco, ha tralasc1ato come dice egli ogni 1h storia, di stali"lica e di casuistica, e vi ha compreso sola111ente quanto è indispensabile a sapersi dal medic.1 mililare per poter portare un'efficace soccorso sul campo di battaglia.
L ' ope1'a é divisa in due partì: una generale e d una specia le. La par te generale contiene una breve descrizione delle armi moderne, l'azione tlei proiettili sulle d1verse pal'l1 e sui varil tessu t i d el corpo, la c ura ferite in generale, l'uso degli antisettici in guerra, le malattie delle ferite, i mezzi di ricovero dei feriti sul teatro della guer r a (tende, baracche,
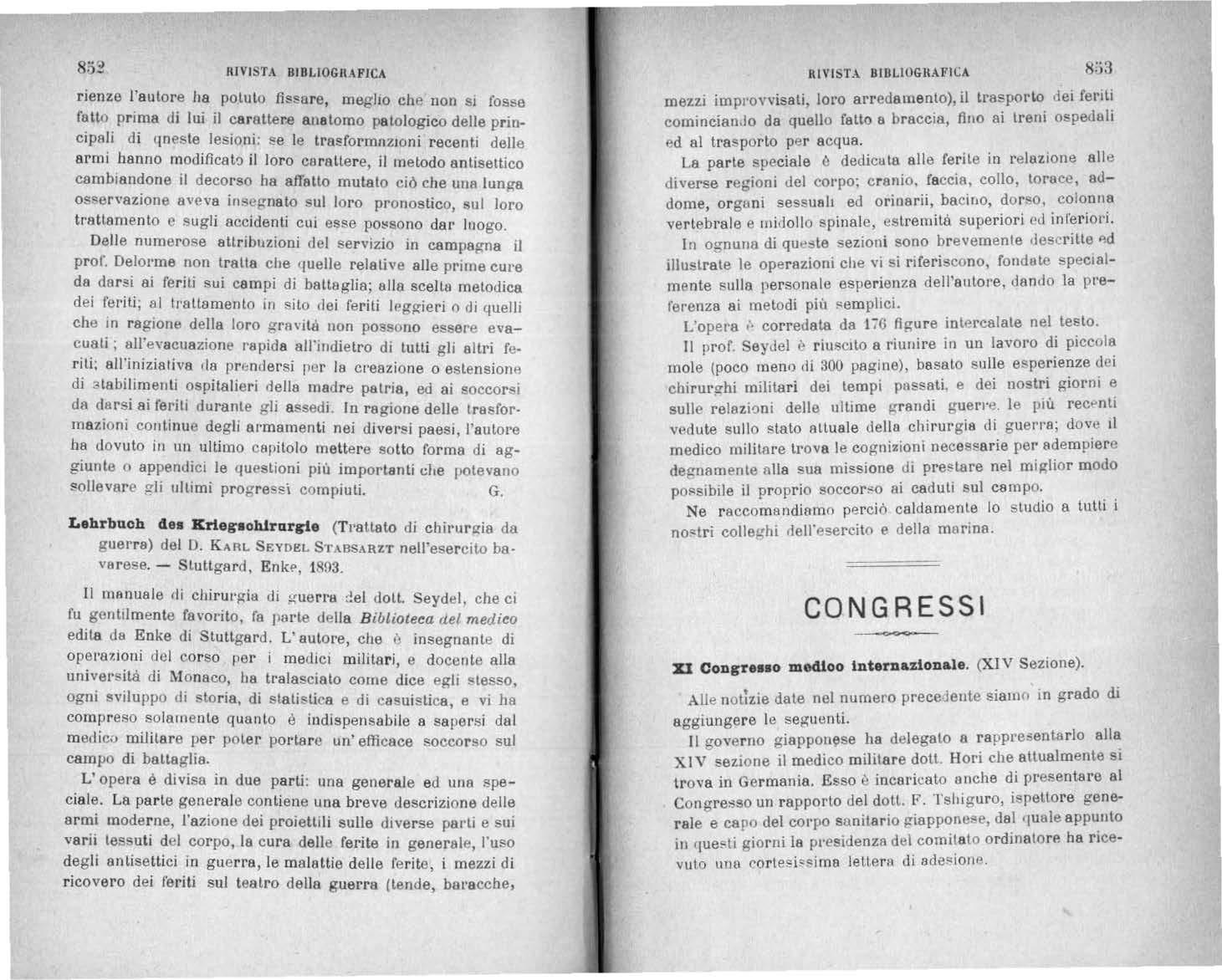
RIV ISTA BIBLlOGRAFICA
mezzi impr·ovvisati, lot'O a1·redamento), il trasporto .lei fer1l1 comincian,lo da quell o fallo a hracc1a, fluo ai treni ospeJuli ed al trasporto P"r acqua.
La parte speciale ù deùicula alle ferile in t'elazione all e diverse r egioni del co1·po; c rani o, faccia, collo, torace, addome, orguni sessuah ed orinarii, bacillo, dor"o, colonna vertt>brale e midollo spinal e, estremità superiori l'd inferiori.
In ognuua di qu,..::;le .;:ezioni sono brevemente .Jec;crille Ad illustrate le operazioni che v1 si riferiscono, fondate ::;peclalmenle sulla personale esperienza dell'auto1'e, dando la pt·ererenza ai metodi più semplici.
L'oper·a ,·. corredata da 176 figure iotPrcalate nel
11 prof. SeyJel ,> riuc;c1Lo a riunire in un lavoro di piccola mole (poco meno di 300 pagine), basalo sulle esperienze dci chirur!!hi militari dei tempi passati. e dei nostri giorn1 e sulll' relaz.i')ni delle ultime le più rec..nti vedute su llo slato attuale della chirurgia di guer·1·a; dove Il medico militare trova le cognizioni per adempiert' def!namenle alla sua missione Ji pre!"tare nel miglior modo il p r oprio soccor"o ai caduti sul campo.
Ne ra ccomandiamo perciò caldamente lo studio a Lutti i no"-tri colle!:hi rleli'Psercito e della
Congressi
XI CoDgre••o modioo internazionale . (XIV Sezione).
Alle noLÌz1e dale nel numero preceJeute siamo in grado di aggiunge r e le seguenti.
11 govP rno ha delegalo a rapp1·e.sentarlo alla
XIV sezione il medico militare dolt Hori che attualmente SI trova in Germania. Esso è incaricato onche di presentare al Congre8SO un rappot·lo del dotl. fo. Tshiguro, i'-'pello re generale e capo del cor·po suo ilario dal •1uale appunto in que:-ti giorni la presidenza del comitato ordinatore ha ricevuto una lellera di ade"-iOIIP.
Il della marina ha ufficialmente dele· gato al Congresso il dott. Fernandez Caro sotto-ispettore dì sanità e c::enatore dP.I regno; quell(l della marina il dott. John Macdonald, genet•aJe degli ospedali l•'ra le numeros(adesioni ostet't> giil arrivate notiamo pure (juella del dott. Wenzel, ge:1erAlat'7.L, col grado di contrumrniraglio, della marina tedesca, quella del doli. Mackinnon, l'illustre capo del corpo sanitario dell'esercito e quella del pro f. A ugerer, capitano medico d la .'liti{,•, threttore della po· liclinica <'hir·urgica dell'uni\'ersità rli Mona<'O.
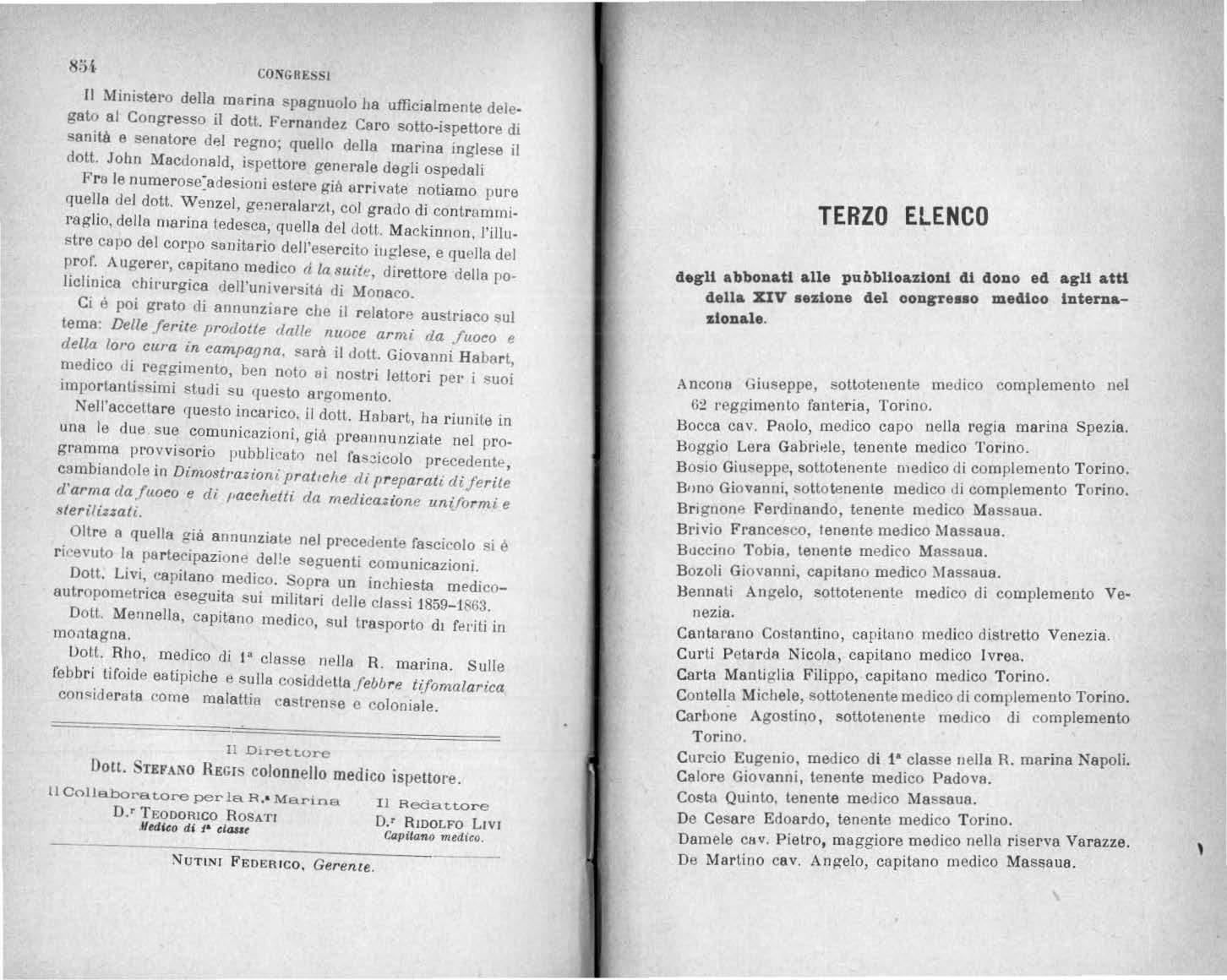
Ct è poi grato rli annunziare cfte il r elatore austriaco sul tema Delle ferile prodotte r/allt• nuoce armi rla fuoco e della loro cura in campa!Jn.a, c::arà ti dott. Giovanni. Ha ha r t medico di ben noto ui nostri lettori per· i c::uoi importanti"simi studi 8U r1uesto
Nell'accettare 'Juesfo incal'ico, il doti. Hobart, ha riunile tn una le flue sue comunicazioni, gia preannunziat.e nel progrnmma provvisorio pubhlwat•1 nel fa"::!icolo pre:cedentP, csmbinndole in ioni prattche di preparat1 di ferite d'arma da.fnoco e di J•acchetli da medica;ion.e uniformi e !lterili:uatt.
Oltre n quella Q'ià an nunziale nel pr•cce.lente fascicolo è ri •·evuto la partecipazione del!e "Oguenti comunicazioni.
Dolt. Livi, capitano medico. Sopra un inchiesta medicoautropometr·ica eseguita sui militari delle J859-l f<11:3.
Doli. Mennelta, capitano medico, trasporto d1 fe1·iti in mo.1tagna.
Uoll. Rho, medico di t• classe nella R. marina. Sulle l'ebbri lifoitlt> eatipiehe e sulla cosidde lta .febb re conc:itlerota f'Orne malattiu c a.,trenge c roloniale.
Il Dtrett.orc
Dotl. STEFANO Rxcr:, colonnello medico ispettore.
Il Collaboratore perla R.• Me.ru'l &
D.• TEODORICO ROSA n lltd l eo d i t • elll$1t
NuTt NI F EDER ICO, Gerente.
Terzo
degli abbonati alle pubbltoaztont di don o ed agli atti de ll a XIV ••zi on e d el o ongre ••o m e dico ln ternastonale .
A n cona niuseppe, sottotenenle medrco complemento nel 6:? I'cggimenlo fanteria, Tonn o
Bocca cav. Paolo, medico capo nella r·eg1a marma Spezta.
B oggio Lera tenente medico Torino. .
B osiO Giuseppe, sottotenente medico di complemento Tormo.
B•mo Giovanni, sottotenente medico dr complemento Torino.
Bri gnonP Fer·dinando, tenente m edico Massaua.
Brivio Francesco, lenente medico ì\lassaua.
Buccino Tobia. tenente medi<'o
B ozoli Giovanni, capitano medico
Bennalt sottotenentc medico di complemento Ve· nezia.
Canlar aJJO Costantino, capila1t0 medico distr·ello V e nezia.
Curli P ela rdA Nicola, capitano medico Iv r ea.
Carta Filippo, capitano medico T orino.
Contella Michele, sottotenente medico di romplemenlo Torino.
Carbone Agostino, sottolenenle medJC'o di complemento T orino.
Curcio Eugenio, medico di t • classe nella R. marina Napoli.
Calore Giovanni, tenente medico Padova.
Il ROO.a.t.t.ore
D.• RIDOLF'O LJVI Cupitano mtdico.
Costa Quinto, tenente medico Massaua .
De Cesare Edoardo, tenente medico T orino.
Damele c11v. Pietro, maggiore medico nella riserva Varazze. De Martino cav. A n gelo, capitano medico Massaua.










