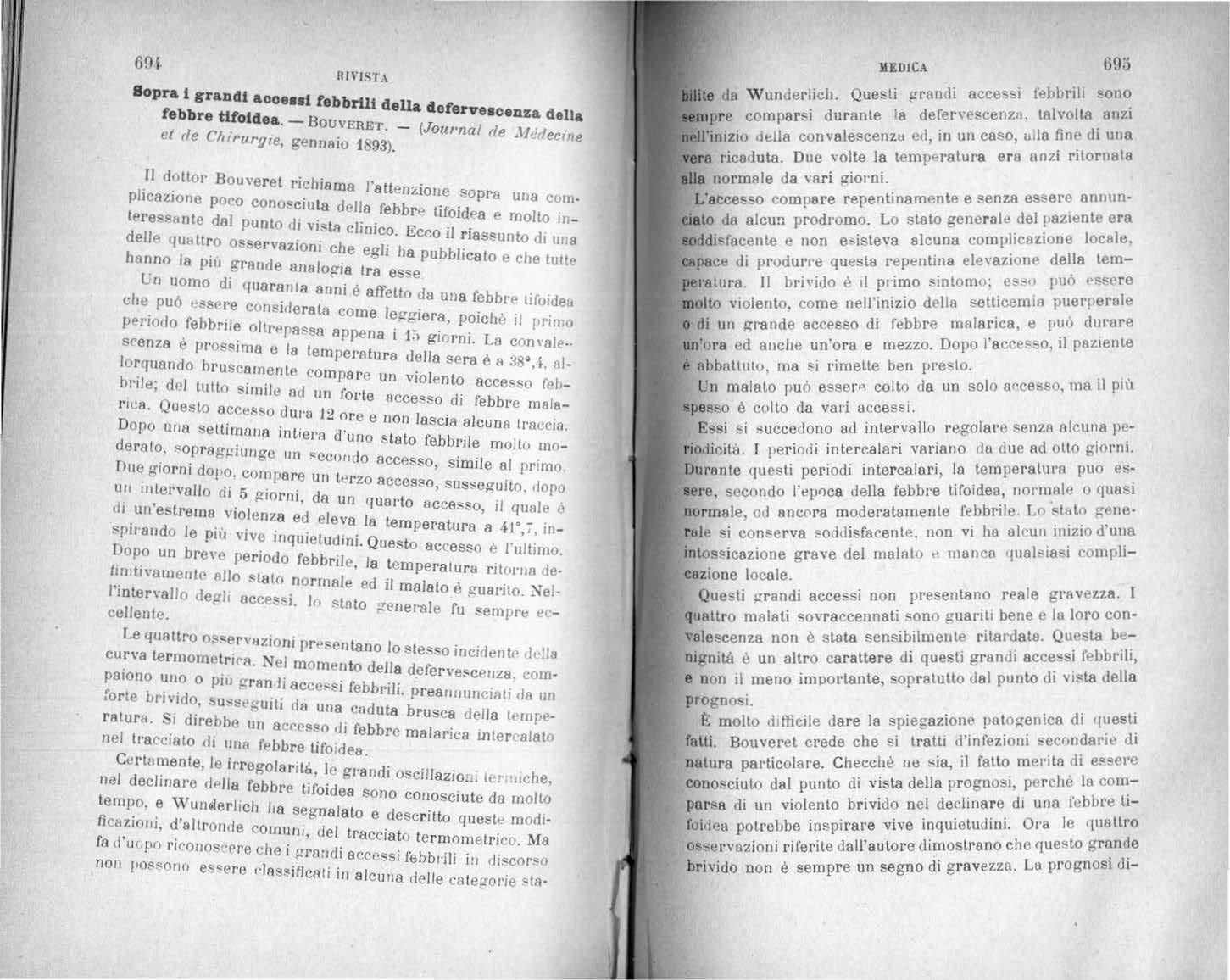
126 minute read
I'HH RIVISlA
S opra 1 grandi aooe..t tebbriU d febbre titolde B ella deferveaoenza de lla l'l rle C/, . & - OU.Vf::RET. - (JOctl'na/ de ,lf,·declne llrllrg,e, genuato 1893).
Il dollot• Bou"eret ri chiama l'alt . .
Advertisement
plicAZione poro conu ciuta d >IJ • .l"opra una comtere!l!':unte dal punto l -···t c ,.a _lebbr... lifotdPa e molto Ilic l VI'< 8 C IOICO E ·1 · delJP rptH liro O'-"er\-"" . . 1 · eco t riassu nto dt una n-.1001 c 18 egl l bb hanno la piu <l'J'Aude l l Ja pu ltcato e che tutte
• t- an11 op-ta tra es:--e
Ln uomo dt •Jua rarlla an · · chu puo • ,;sc•r·e con..,iderat e affetto una lebbl'l" ritorcleu
. · a come Je""'Jera · 1 . .1 . fil' l'rodo febbrile olt
,..!':'- potc 1e r pr•tn;u rPpa"Sfl Rppena i r · · srenza (> 1 1 '1 grr11'nr. La con,ale.. lorquando empel'fltura della se ra è A :{8",1-. Ilil · · ' co mpar·e un violento
>l'ile; d<'l lttlto simile ad un fori . feh- l'l l!a. Questo lu 12 e Accesso dJ febbr•e mala' t 1'<1 ore e 10 1 ·
Dopo UIIS !:'eltirnAua intieJ'fl d'un J n ascta traccia. derato. sopro..,.roiun..,. o stato febbrJie moltiJ mn-
"'" oe un >'Ccoodo acces · -1 flue g-rorni dof•O. cnmrtare u 1 l sunJ e al primo 1 erzo acces"O sn ·t 1 un rntervnllo di 5 ,... 0 , . d · ssegut o. , opu ,..r 1 nr, a un quar·to a ·1 dr un'estremi! violenza ed l ccesso, l qualt> è RfiÌI'aiJdo le più vive el eva. la temperatura a ·il",:-, rnIIICJUIC Udcnr Questo ' Dopo un brc\ c . d · accesso è. l ulhmo. parto o febbrtle la t lin.tt,·unterrtt• "Ilo blat • emperatura rJl rll'llA de· " " Cl normale ed ·1 1 l'intervallo cle·•Jr acr"' . 1 . 1 ma alo è guarito.
<" .cS,_I, 0 <>loto •ene J ( ccllenle. ra e u sempre;
Le quattro >r,...,e La . curva lermometrJra N l l n no lo stesso rncitft>nlt> •lt·lla
· • e rnomerrto della d li paiono uno 0 ., 10 " 8 1 e com,. -r n r acce ...«t febb il' forte Lr i\ icl n "' . · . . · 1' 1 • prearumucruti dA IHI lP it·re olarJt' l l . "' "• gJ·artr!t O<tcillaz· 1 1 ne declrnal'e clt>lla bb, . . rou o.. .. re 1e, e 'e tllotùea sono c terupo e Wunflerl · 1 1 onoscrute da molto · re 1 ta segnalato e d · 1, ficuziorli d'altro 1 escr1 •O queslt' morii' 111 e couJ un,, del tracciato t · fa ci'U<,pn rir·olloc;r·rr .1 . . ermometrtco. Ma nor. I•O«'-'ortc• e Cile' a cc,•ssi febbr·iJj iu di:::corso ' t' Asc;: f/ t'. f eH 1 111 a cuna delle C:A ie{!or·ie 'lìl-
• .,u.,::H•g-uttJ du una d t b raturH . Sr direhbP · . cn u a rusca clelia lt·rupe1111 dJ febbre m l . . nel trar·ciato dr IIJtH ,. bb . a artca mter•·alato •P re trfordea.
llEDICA
bJiile da W unJerlic.:h. Quesli f!ratHli acce... ,i t'ehl!rilt .. ono te m pr e compart=i durante la defervescenzu, lah·olta lliiZi nell'i nizio con valescer12a et!, in un ca<t o, ulla fine di una vera ricaduta. Due volte la temp1-ratura era an:t.i ritornata alla normale da \'ari gioJ·oi.
L'a ccesso ro m pare r·epentinamente e senza e«sere armunciato da alcun prodromo. Lo stato generalt' del pazrenlc era so ddi<.facente e non e ...isteva alcuna complicazione locHle• Cllpa ce di pt•odur·r·e questa repentina ele\azione della tempe r'B'ura Il b ri vido è rl primo sintomo; es:-u puo P'-!'t>re mol to vrolento, come uell'inizio della --etllcemin puel'l arale o d1 lllt gr·ande accesso di febbre malarica, e pul• rlul'are un' nra ed anche un'ora e mezzo. Dopo l'acces.._o, il pal.tenle " nhbatluto, ma si r·imetLe ben fH'e-;lo.
L'n malato può colto da un solo af·ces"'\ ma il prù é collo da val'i Hccessi.
!'i :.uccetlono ati intervall o regolal'C "enzA alcuna per iodicil<ì. l periodi intercalari variano da due ad ollo gtOI'ni. Uuranle questi periodi intercalari, la lemperaturfl puo P><serP, l'ep()Ca della febbr·e tifoidea, rlor•rnf!h• o qua::;i no r male, o.J anc0ra moderatamente febbrile. Lo :.wne· r ult> si conserva !=Oddisfacenlc>, non vi ha alc·un ini?.io d'una in toss icazione grave del maiolo r maneo 'Jnabia;;;i c·omplicnziooe locale.
Que:;ti 1!randi acce!'!';i non presentano reale gt•avPI.za. l q uattro malati sovraccennati !';ODO guat•rta bene c la loro convale"cenza non è stata sensibilmente rita•·data. Que:;la nignrlà è un altro carattere eli questi granJ1 acce... l't>bb!'lli, e nou il meno impot·tante, sopratulto dal punto di vt!':la della pr ogno"' ·
1<: mollo drfficile Jare In spiegazionP patogeuica di questi fa lli. Bouverel crede che si lrallt d'infezioni "'ecnndar·ic •li na tura pat·ticolare. Checché ne ><ia, il fallo mer·tta di e!,...et·e c o no!"ciuto dal punto di vista della progno:;i, pt'rchè la compa r sa di un violento brivido nel de(·linare da una ft•bl>l'e tipolreiJbe inspirare vive inquietudini. Or·a le r[UALl r•o Of\>.;c> r vazioni riferite dall'autore dimoslJ•ano cho que"lo g rnru.le bri vido non é sempre un segno di gravezza. Lo prognosi di-
Me Di Ca 691
pende t•videnlernente rlalla diasrnosi. È facile eliminare l a lebbre intermillcnlE', la ptotmta, una cornplic&zione locale di natura infettiva o suppu raliv n. La dia?(nO!Oi presenta ma.r· gtort dtfficoltit co11 la selliccmia, almeno durante ed immediatamente dopo il pt·imo ncces:.o. Pi ù tar·di si hanno comE' elementt dt diagnosi dtfferenziale: l'tnte,(Zrilà dello stato generale, la mancauza di complicaziont locali, l'andamento l'egolare della temperaluea ft•a due Accessi, lo maucanza delle localizzazioni e pleut·aliJ della c;etlicemia. e di lesion e della cute che po!5!01l essere stata lu porta d'ingnc;so di una infezione secondarta. Procedendo m tal modo per vta dt eliulitoazionf'. !OÌ é nece!O!O&riamente portati ad attribuire que!Oli grundi acc:es-.t ft>bbrth ltfoiclea s-tessa.
Do po la pubblicaziOne del lavoro di Bouveret, il Frenkt>l di Lione ha pubblicato un analogo, ma tmpot·tanle sopratutto per d numero accessi che furono da 18 a 20 e molto violenti. Frenkel ed il professore Tec;c:ier· c r edono che si trattava verisimilmenle in questo caso di malaria-tifo, valo a dire, del risveglio di unA intossicazione malarica prodotta dalla febbre tifoidea. Tessit!r cr·eùe che questi l'etti uon siano rari: egli stesso ne avrebbe o::;;Pnali un certo numero specialmente nei malati che avevan n pre· cedeotemente sog:::-io rn ato in paesi malarici.
Le nevritt oervlco-braoohiall nella tubercolosi - DELAV.\U. - (Journal de Médecine el de Chirurgie, !!'ennaio 18!l3).
Le ne"rili cervico- braccbiali compa iono peneralmente in un'epoca assai avanzala della malattia. Il più esse sono uniluterali; lA l volta pero, quando la tubercolosi si S\'OlKe successivamente nei due polmotoi, esse pos!"ooo esserr· bilaterali .
Qualunque siA l'epoca della malatl1a in cui e"'!Oe competono, sieno unilaterali o bilaterali, queste nevralgiE' locnlizzatt:: ai plessi del membro superiore si presentano IJUasi semp re con gh 1deutici caratteri che possono essere riassunti nella se-
• maniera: dolo r i ,·iolenlt e conlinut, inlorpidtmenlo clt 11 1n embro ditficollé di effettuare i movimenti che sono d'>lorost, della moliltta, disturbi della sensibiliU.., atrofia muscolat'f' ed allerazioni troflche cutanee. Tal volla fenomeni, unili dapprincapio, si localizzano in seguito ad un delerminHLO ner•vo, che il più è all'l ra ilner·.vo cubita le. sovenli, esiste una vera paresi rhe si t>sph<'a con u na diminuzione della forzn dinamomelrica ed è dovuta ad un grado dt amiot r ofia più o meno pronunciato, mollo sove nt1 si pure lo zona che deve e!:'sere constderalo come un disturbo Lrofico in l'at'pOl'tO c.o n la nevrtle. Qu el"te nevralaie, mfatti, dipendono da alterazioni nervi peri tèrrci, ì quali sono all'<'tti vet•isimilmenle. 1!A .rarenc hìmatn!Oa. la quale 6 la con.,eguenza, sta ùt un u·rtlaztone di vrcinanza subrta dal tronco nervoso in corrtspondenza ùel focolaio tubercoloso, sia di una rompressione esercitata sul nervo da un lubercolo pleurale aderente, sia infine tlell'tnfezione tubercolosa.
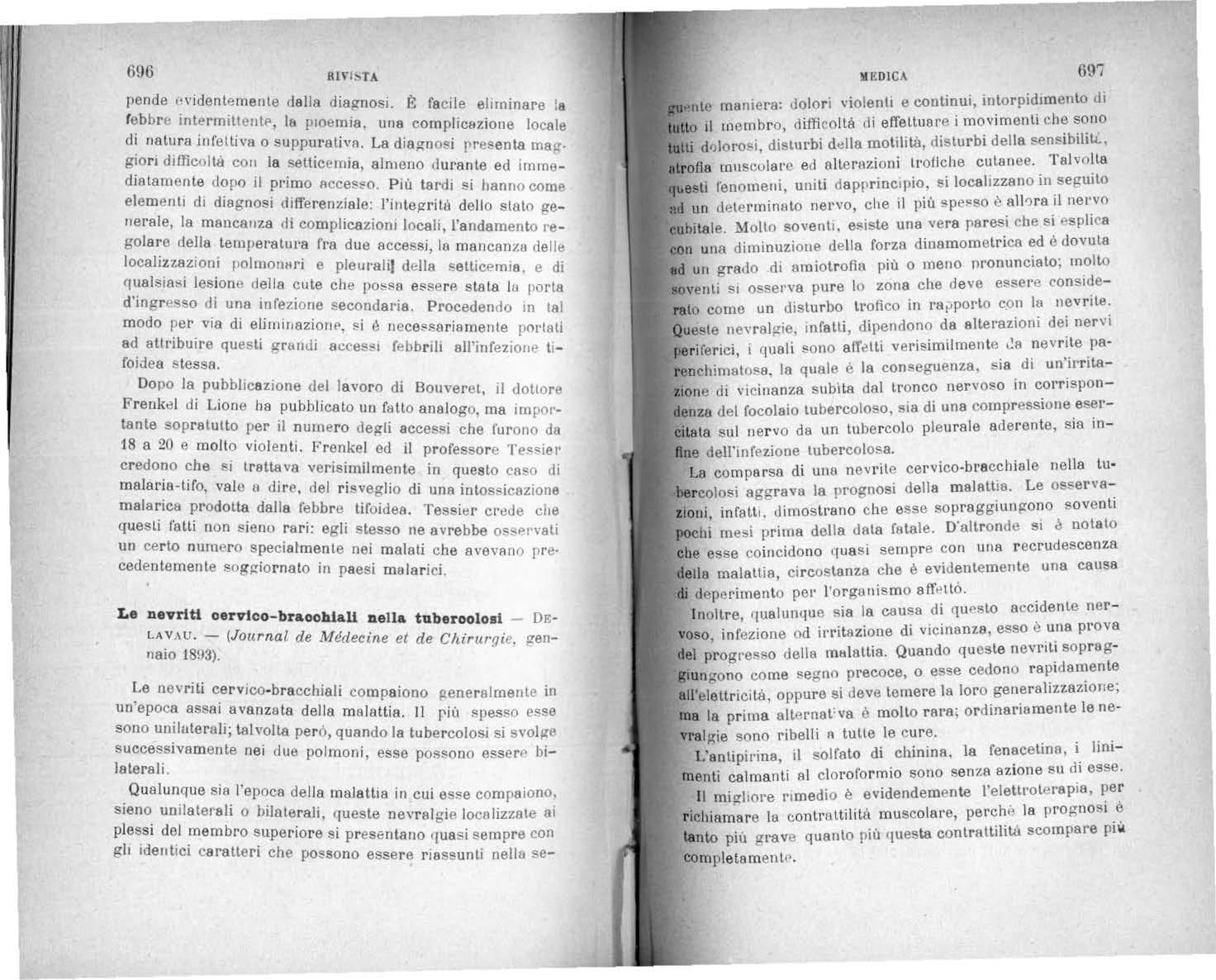
La comparsa di una nevrile cet•vi co-bra ccbiale nella tu · bercolosi aggrava la pt•ognosi della malall ta. Le ztoui , infatl t, climostt•ano che esse sovE>nlJ pochi prima della dala fslale. o·alt r ondè SI è notato che esse <'Oincidono tru a si sempre con una r ecru descenza della malattia, circostanza che é eviùenlemenle una causa di J eperimenlo pet• .
Inoltre, qualunque sia la causa di flUPsto acCidente nervoso infezione nd ir-ritazione di vicinanza, esso è una prova del della mttlatlia. Quando queste nevrili sopraggmngono come segno pr·ecoce, o es"'e cedono all'eleLtrictLà, opp ure si deve temere la loro ma la pr ima allernal:va è mollo rara; ordmarramente le ne· sono ribelli n tulle le cure. . . . .
L'anlipi l'ina, il solfato di chinina. la •. hmmenti calmanti Al clorofo rmio sono senza az tone su d1 esse.
Il miglio re r·•medio è evidendemente ri chiamare la contrnlti litti. mu scolare, per·ch.:. la prognO!OI tanto piu llrave quanto più questa conlrAllilit.U scompar·e Pl lil comple tamt>nlc>.
Fn \:-1K L. OAY - Panoreatite emorragica - ( The Bo.'! ton Jlerltca! and Suruical Jo11rnal. dic. Ji·ln:!).
Un medico òi \!) anni, eli lt>mr1erarnento net'voso. eon stomaco sempre delicato, soggetto ad aveva nei!lì ultimi anni ma:;rgiormenle sofl'erto per la mancanza dr son no ed ieregolariia dPi pasli, a causn dei molli all'ari pr·or nali, P si era r·idollo a mal partito, es!'endo costretto n nutrtrsi molto scar:<arnente t·on lall•• t>d amilarei.
Tre anni innanzi, via:.rgìando all'este r o, aveva sofferto una siucope dopo la quale r·imase per• 12 ore 111 parziale collasso, P si rirnist> dalla debolezza in seg111to a più settiwane d1 cura. Dopo d'allora si el'a asso,!!'ge ltalo ud una cur·a carnea pe•· "'ei me!:ii, iudi aveva inlJ'IlpJ·eso Ullll die ta mista con poca carne, dol'miva p11cO e si conciliava il ...onno c·on "Ol'tauze !:illmolanll. ebbe per più mes1 una :<eo,..az!One dolorosa Rll'epigasl r io che calmava con s l rofinazionì lneali di clnrof'nrrnio, r> talvolta con inalazioni. p r irna '"era Ilei 11-1!1:? era molto spoc::!'ato, non tira•·" innanzi '-enza stimolanti, qurndi sr a lasciAI' l'eset·cizio della ed a conce!lersi un necr•s!'a rio ripo c::o. Comindò allora u sotfri1· di vomito incoer•·rb•le, emetten,lo cihi, lrqutdo ,·o•·dastro e scuro, na1 c::enza l"angue. L 'epigaslf'io dh·enne maggtorrnen t e dolentH specialmente alla pressione, eJ il dolore si estendeva all' ipocondrJO destro. sulle ultime> de«tre in corrisp mdenza d••l lllar· gioe epatrco, onde tluiJitò di una periepatite.
Ui gioJ'rto iu gromo divenne sempre più debole, lìsiramente o mentalmeute, et•a spesso u \'eva >-111copi frertutmli, poi!'O debole o frequente, la tempt•ratura ;.i elevava rara mente, e non so rpassava 1 38, 5, IB intestina e t•an sempre costipale da ricltieclet·e l'uE=o frequentP d• rnloMe· lano, pu •·ganlt l'almi e clistP ri, e le feccie erano a ,·olla "colo rat e, a volta mostravano poca bilt>.
MBDlCA d'..ùl ora polé rilenl' r e b1 odo, lallP diluilo e ras rlti atura di eer nP. uur·anto In prima metà di ma ggio t•iacquislò Je forz e, e polé al 19 sopporlal'e J'H-;lirpazione dal cavo de'<tro d• una ma«sa suppurata, segu•ta da prortlA cicatrizzazione. Nelle u!Lt•e due sellimane mtgliorò sempre, ebbe appena qualche vomi to , ma non fu rnai da fJUel dolore dell' ch' egli chiamava agon ia, e che all&vrava ron le inalazioni di clor·oformro; fu sempre slillico, e nella prima settimana dr grugno, forRe per l'ab us o del clorofonnio, ridivenne debole.
11 !dor no 11 giugno, Jopo un vomito ct>ll d(•J d olo r e all'epigaslrìo , carl<le in colla sso, pet·dè i sensi, pallido, cov rì di pr·ofuso «uùo re, Pbbe le milà fredde; il pol"o a 120, una t<>mperalura suLnormaiP, la re &:ion e epigastri<'& era dolenlissima alla prec::sione, Il collasso divenne semp r e più profondo e LG l/2 ore dopo il vomito del mattino, il paziente morì.
18 ore dopo lu mor·te fu eseguita l'uutopc::ia, non rivel ò null1:1 tl'auo rm o te al capo, <'uo re, polmoni, rlcu r e, milza, fegulo e reni, intestina e Lo stomaco e ra dilata li), ('d uveva le pareti lieve mente ìniellato, e spa lmate di muco aderente; la cistifellea couteneva una p•c· cola cou creziorw di bile ispessita c Jue altr·e concrezioni sunili e 1·ano uell'eslremìtà .J uode oale del dallo coledoco, e ne riem pivano qua!'i il lume
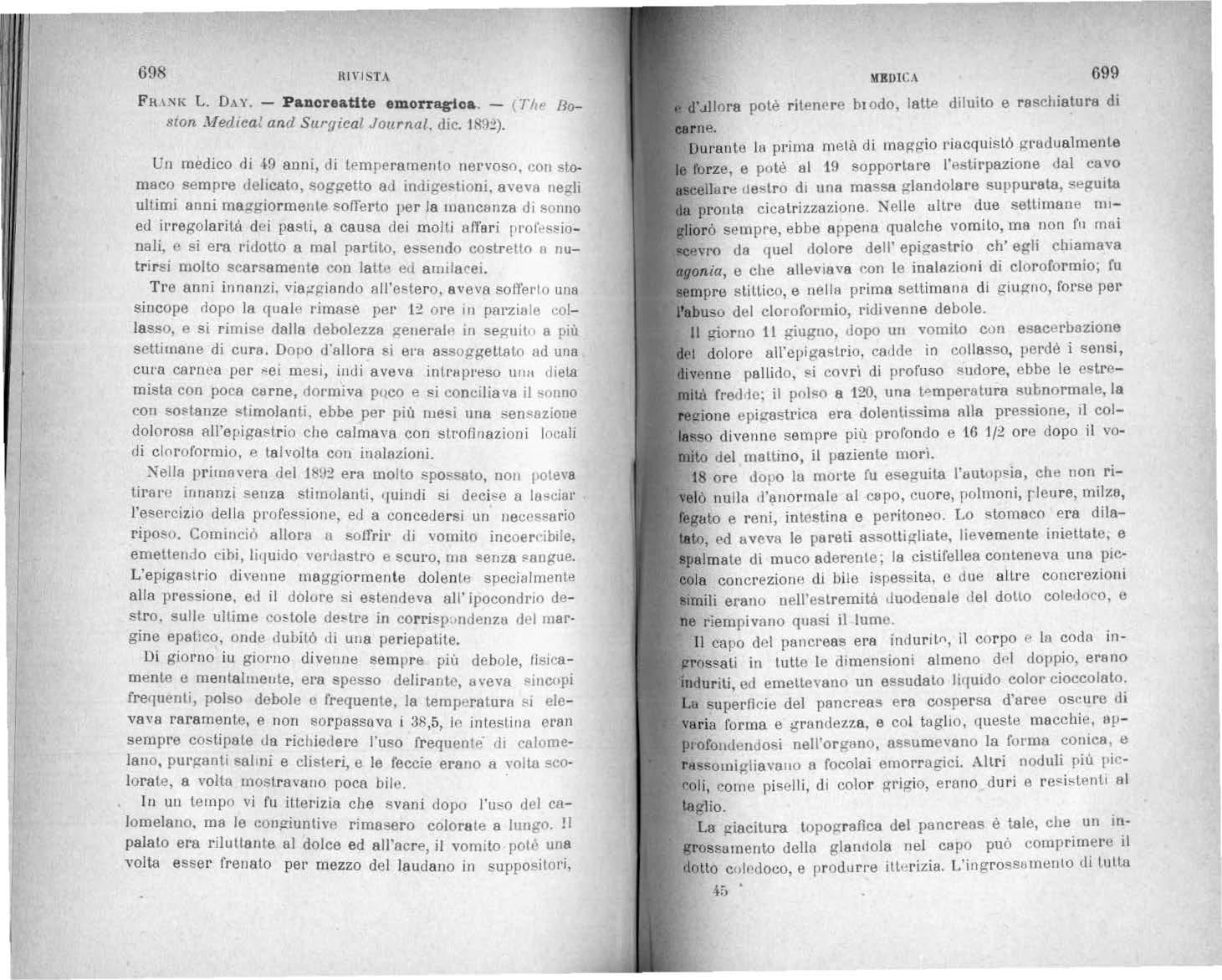
Il capo dPI pancr·eas era il corpo P In cado rnin lutle le dimensioni almeno di'l doppio, erano induriti ed emettevano un e5<sudato lirJu•do colo•· cioccolato. Lu del pancreas e ra cospersa d'arco .li varia l'orma e e col taglto, macch1e, upJ.Ir ofo udenùosi nell'orgnno, as>:urnevano la !'OJ·ma conica, c a rocolai emorr agici. Altri noduli piu pwroli, rome dr colo r e1·ano duri e r ec::isLenl1 al la :.d»nrlol a puo pr<'B8ionP c:;uJl'aorta, lA c•tn1 iuf1•• rtore, i vus1 rn..--. •• ntet•ici !;uperiori ed 'il ples11o !-'olare . .\1 davAnti dr>l pancrt>&'> 8la li ventJ'Jcolo ed il lobo ,..iuistro del fe;{alo che pure po..,.,.ono esser compressi, onde pos>;ono 8\ ur dl'iturbi della <11:-:e!'!lione, della ctrcolaztone, cd P mi alle eslremitu tnferiori, "·c·.
45 .
Il ,..ucco h n lrP funzioni principali- la com·ersione dPII'amido P iu alucosio. J'f'> mul ..ionamento dt>' gresc;i, ti completarnentn della albnm 1noidi in concorr enza c• d !-lUcro Ma appuuto 1,..,. questa fuuzJone CO'<I CfJutplessa che troYa au:-tlio e snslttuzirmo iu quella rli allr1 lA diag:no;;J d,...IJa mala!tta dPI pancr·en« non (• facile.
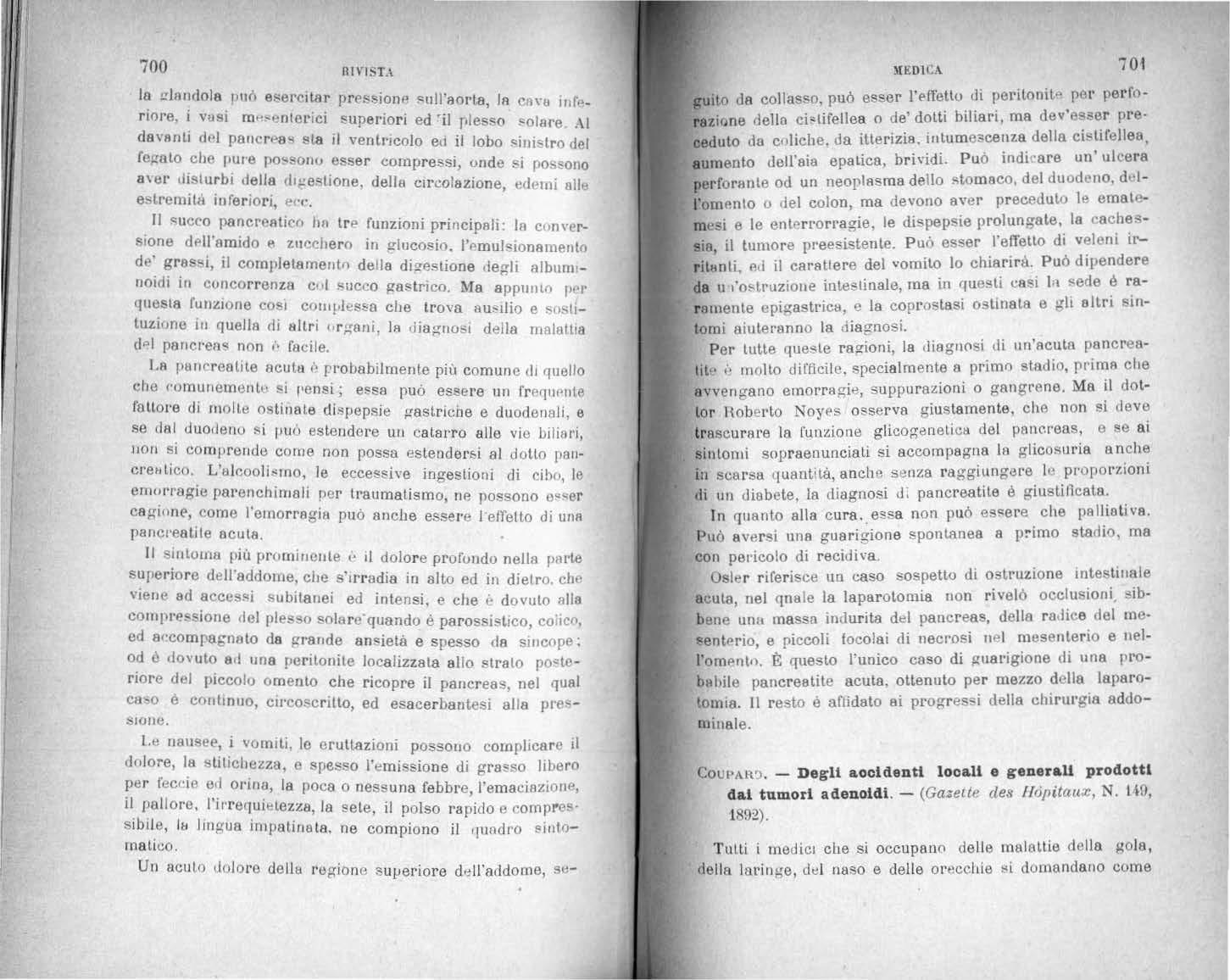
La panrreatlle ncuta i• pt·obabilm enle più comun e dt f!Uello cito t·umunement.. <>i J'6nsi; essA può essere un fr PrJIIPllle fatlor·e di mo lle ostinata di,pepsie gaslr•che e duoden a li , e se dal duodeno si puo estendet·e un c atarro alle vie bllitH'i, IICHI si comprendo cou1e non possa al Jotlo panCt'eHlico. L'ulcoolt-<tno, le ingeslioni di ribn, le oruot•ragie parenchimali per lt•aumalismo, nfl possono o-.-,er cagione, come l'ernorrAgitt può ancbe esser e l effetto di una pancr·ealtle acuta.
Il sinloum piu prorn111enle t'· il dolo r e profondo nella ptll'le superiore dell'addollle, clte s'•rr odia iu alto cd in dietro. clw vieul! ad !-i ubitanei ed intensi, e che i> d ovuto alla del ,..olare quando e parossislico, coiicn, ed 81'Compagnnto da frrande an,..ieta e spesso da sincope: od è dovuto ad una perllonile localizzata ello strato po'-'tedel piccoi!J omeuto che ricopre il paucreas, nel rJUal ca..,o é contmuo, ed esacerbantesi alla pre,.SJO(I(), l.t> nau.,ee, i vomiti. le eruttazioni possouo compltcarc il d(Jiore, la stitichezza, e spesso di grasso liLero per ed ot·wu, la poca o nessuna febbre, l'emaciAztorw, il pallore, l'ir·requidezza, la sete, il polso rapido t> compre!' lingua Hnpalinala. ne compiono il quodt·o !'intomalico.
Un aculo dolore delhi r egione s u)Jeriore ddl'addome, 'W - da può esser l'effetto dt pertlonil pet• perroraz ifme rlello ci"Lirellea o de' dotti biliari, ma dev'ec:;i'\er preceduto rla coliche. da itterizia. della cislirellea. aum ento dell'aia epatica, brividi. Può un'ulcera pe t•forRnle od un neoplasma dello stomaco. del duodeno, dt>ll'otnP-nlo o del colon, ma devono aver preceduto le emalem ,.si e le le di5pepsìe prolungate, la t•acbes8io, il tumore pt•eesistenle. Puo esser l'effetto di veleni it·rit Hnli. A.! il car11t1ere del vomito lo chiarirà. Può dipendere da u t'o!->truzioue inte;:.tiuale, ma in questi casi la serle è rar amente e la copt•,,c:;tasi oslmata e glt altrt smtom t aiuterann o la diagnosi.
P er tutte queste ragioni, la diagnosi di un'Acuta pancreaht.. ,, mollo dit'licile, specialm ente a primo stadio, pt•tmA che a vven gano suppurazioni o gangrene. Ma il dottor l{obe rlo osserva giustamente, che n o n !-li devo tr ascurat'e la l'untione glicoganetictt del pancweas, o se ai sintomi sopraenunciali si accompagna 1t1 glicosul'ia anche in quantità, anche senza ra ggiungor·e )!" pt·opot•ziom di un diabete, la diagnosi ù, pancreatile è giustiflcata.
I n quauto alla c ura . .essa non può es,..ere che pallioLiva.
Pu ò aversi una guarigione spontanea A p:-imo starl io , ma co n pet·icolo di recidiva Osler riferisce un caso sospetto di ostruzione tnlestinale a cuta, nel qnale la laparolomia non rivelò occlusioni :>ibIJc•ne una massa indurita dd pancreas, della r a.lice del mc<>enll'rio, e piccoli focolai di necf'Osi mesenterio e uelÈ f]uesto l'unico caso di guarigione di una probtthile pancreatite acuta. ottenuto per met.zo d e lla laparotomia. Il resto é aftidato ai pt•ogres-i della chìrut·g•a a ddom male.
CoUJ>At\') , - Degli aocldentt looaU e generaU prodottl da.l tumori adenoidi.- (Ga;:;elte de.<; !ftjpittw :r, N. 1R92).
T ulli i medicr elle si occupano rle lle malallie della gola, della lari11g-e, dd naso e delle o!'ecchie domandano come mai un'tlll'ezione cosi frerruente ab br·a l po ulo restare per tanto tempo sconosciuta.
Quest'affeziOnA si os<>erva sopratullo nei fanciulli· ma q· constala pure fiSsai so venti nei giovani, negli adulti' eJ che nelle persone allempate.
Nella maggio r parte der casi, i sintomi obiettivi sono talmente cara te rbtici c!Je é ' mpossibile non racono,.cerli. aspetto speciale: ed agitato, male di ecc.: sono fenomeru 1 pm orchnari scorso, il dottor Mar·tha, basauùosi sulle osserco municatPgli dall'aulure. sehrnalava la nece!;;:ila dellablazi ont• d"i lum l)ri adenoidi nf'i fAnciulli operati ùt tracheolomia l' che non potevano, molti mesi dopo l'f)peraz ione
. A serie di dasturbi, l'autore aggiunge gli a rce,.s i da stnùult!';rno, mdicandone la patoge nia.
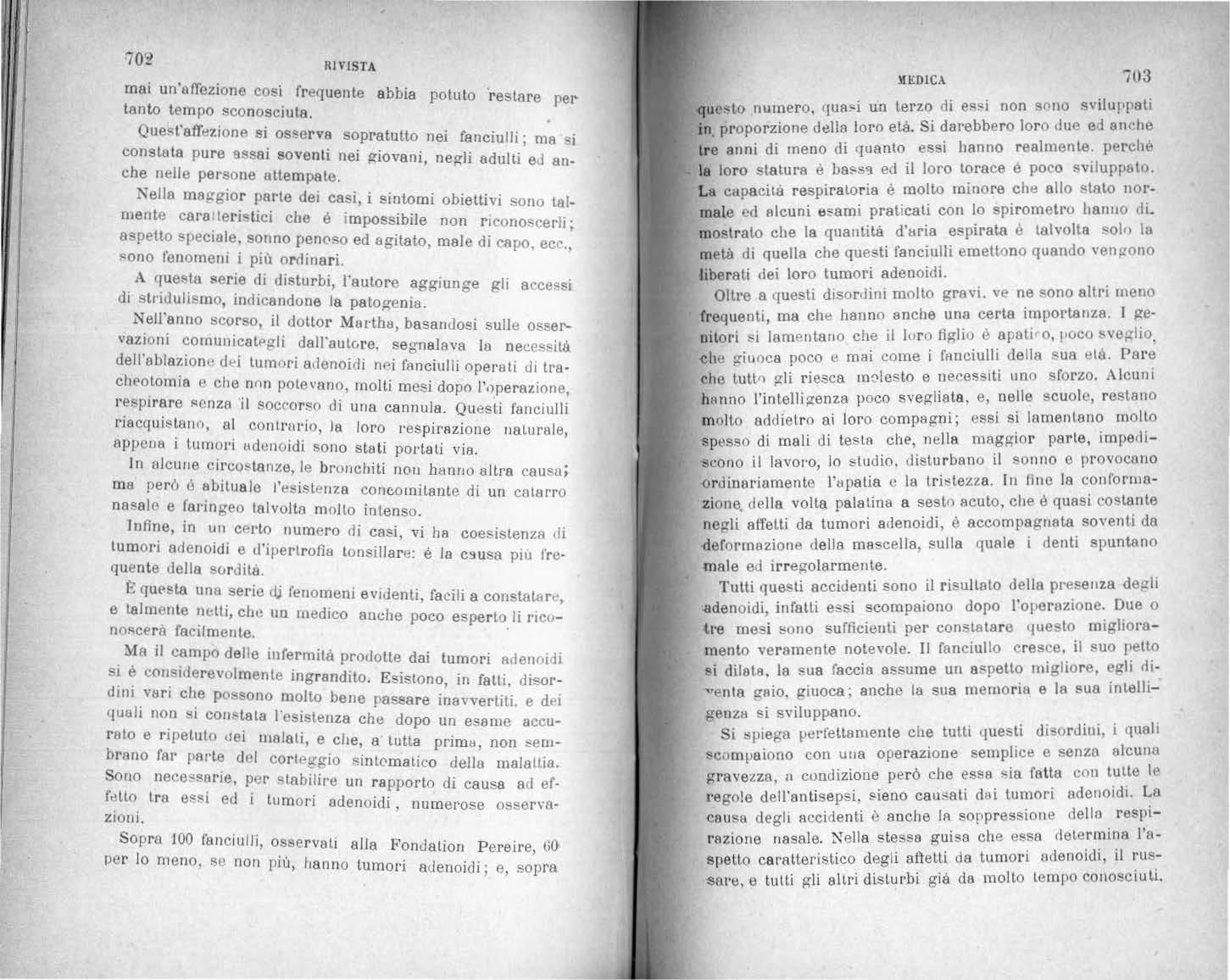
ROnza il soctor!;o di una cannula. Ques ti fan ciu lll rJacqut><lano al conlt'•"tt•1'o la 1 • • • ' , oro l'eSptrllzlOne ualurale appoua i lumol'i Hdunvidi sono sta ti portali via. ' in un CPl'lO numPro di casi, vi hA coesistenzA di lumorl ad enoidi e d'iperlrofia lonsillar e : é la cgusa piu fr equente ùella
In ulcuu.e cii'CO><lanze, le bro LJchiti non banno altJ·a causu ; ma però o auituale J'es isle uza con comitante di un colarro nasale e fal·ingeo talvolta m olto intenso.
È questa sel'ie dj renomeni evidenti, facili a e che un medico poco esperto li ric unnAcera facilmente. ·
. Ma il delle mfermila prorlolle dai tumori è COIIRiderevol menle ingrandito. Esistono in fatti dkorÙIIIl ''ar1 che p 1 ' • ''"'Sono m o lo bene passare inaYvertiti. e du cruult non si resistenza cha ·'opo . "' u un esame accurato e rapelulo dei maiali, e c la e, a Lutla non ::>embrano far· pal'le del coriP!.{gio f'inlC'maLico della malallia.
Sono per· un rapporl0 di causa ad ef· ftJllo tra e::<f't ed i tum or·i adenot'dl. ZtOnJ. , nume1'ose osser,·a-
Sopra 100 l'anciulli, osservati alla FonJalion P ereire tiO per lo meno se non piu 1 • ' • , 1anno tumo1'1 aùenoicli; e, sopra lf!WICA qu e..,to numero, tJUA"i un terzo òi esl'i non sono sviluppati in p1•op orzione della loro elà. Si darebbero loro due ed an(•he tr e anni di meno di cruanlo essi hanno realmente . la lo r o statura e eù il lor·o torace é poco sviluppato. La capacità respiratoria é molto minore allo qlalo normale cd alcuni pratacati con lo spiromell•o hanno di. mostrato che la f(Uantità. d'ttria espirata c talvolta solo In metà di quella che questi fanciulli emettono quando "en !!nno li berati dei loro tumori aden oid i.
Oltru a questi dasorùinì mollo grtwi. ne qono altt•i meno frequenti, ma hanno anche una certa impot•tanza. l mlori lamentano che il loro figli<) è apnti • o, poco sve;..lio. clw poco e mAi come i fAnciulli della s ua eta. Pare ch e lutl, gli riesca m::>le»to e ueres;;;iti uno sforzo. Alcuni l111nn o l'intelligenza poco svegliata, e, nelle scuole, restano molto addielro ai loro compagni; essi si lamentano molto spesso di mali di te>:la che, nella maggior parte, impediscon o il Javo1·o, lo studio, disturbano il sonno e provocano o r dinariamente l'upalia c la tri,.leua. In fine la conformazione. della volta palalina a sest0 acuto, che é quasi costante negli affetti da tumori a tlenoidi , é soventi da derormazione della mascella, sulla I'!Uflle i denti spuntano male ed Irregolarmente.
Tutti questi accidenti sono il risultato della pt·esenza degli adenoidi, infaUi essi scompaiono dopo l'operaztooe. Due o tre mesi surticienli per constatare crueslo miglioram ento veramente notevole. Il fanc1ullo rresce. il suo petto <>i dilatA, la $Ua faccia assume un a-.petlo migliore, eglt tli"Pnta a:Hio, giuoca; anche la sua e la sua inlellisi sviluppano.
Si sptega. pel·t'eUamente cue tutti IJUesti dis o rdini, i quali l:'c.tmpaiono con uua opet·azione semplice e senza alcunu gravezza, n condizione però che essa "ia faLla con lulle te t·egole dell'antisepsi. sieno causali dai tumo 1·i adenotdi. La causa deglc accidenti è anche la ùelln respira zione nasale. Nella stessa guisa che essa determina l'aspello car·atteristico degli aftetti da tumori adenoidi, il sm·e, e Lutti gli allri dislul'bi g ia da molto tempo conosciuti.
'iO i. J\IV!S1A e,.,.a c pure ca ù 1 che l'ar·a l eg l arcJdenli SO\'ra ril'elili. E naturale e pa!'sa le .vie respiratorie. sf'nza es< una quanllta d1 "'ermi r· . mPandro derle nasali )P q li o o c lmpuriià nel arw arriva ll'oppo b•·uscamente nei o . ' spasmo, il quale disturba la fu . p lmom, delerou nH . . ozwue normale dd pell 1 l suo• rno\·imenti respiratori L' l• e . ' . ar·1a res1duale non è tr cu•ntemente ec:pul"a l'flria 0""'. t <:u tciente nbbonfla nza 'l'amato a non &!'"orbita in sulfìner·ale se• ne rise t' 1 SI a male, la nutrizione "t.ln e e O S\'tluppo delle e 1\ l'itacdato. ossa e dei muscoli
L'outote Cl·ede che, se tulti i me <.J' . \'Ìnt! dei l'elic' . l . ICI potessero cont , •• .,u taLI che da l'ab! . . n oid· 'l . . . azwne ùe1 lumo1·i ndel, l num Pro det deboli d' . . . proporzione. lll1tnulrebbe m notevole
Un oa•o di atruma. lutratora.oloa. \ ' ntatt ./" . h . . - :\ JESMANN. - tror'" se wetzer Aer.zte N. 1 1893)
Uu uomo di ;)G anni che era d . . ber!.!:n dP' "Ove · · H a 40 annt ospite Jell'alr rl m erJ!"au a veva solt ·t d' . Ma ru presentato al dolt y·er i) l t.ll'lturbi r mesi prima de l la s · tesmann l:'nlo alcun• ffiOI'le. percbè . . di . tori e r an<:i a•YtTravat 1 fì d' 1 suoi sturb1 respira- no a 1ve m re ,. · . . z•one Una v ert access1 d1 sotfnca· · e ra anam11es1 11on p t· "' "enza a•·ticolure e·' . d 0 sere raccolta, parla\'& u 111 mo o qua"'J affi U .
A\·eva una e"ces . _,. a o HJCompren!-'ibiie.
!'lVII utspnea Len r in avanti la pa t . ' eva .ortemenle i11clinata r e del cor l a •JU6"ta posizion L po e a testa, poH:lu' "olo tl po eva r . era stortorosa COli di l' l "'1 arta; la respu·nzione s Hl o rumor e d 1 · hreviss1mo· un nod t . 1 5 enos1. Il colli) era ' o s rumos o d· durezz l 'd •1uunto una noce s'ed · a ap1 e!l, grosso ' e'•a a desll'a l l r eva che 11011 fo S"t:l . ::s:oo a arwge, ma paN ,· l . , •n rupporto con la dispnea. r l po morii •' nel ruo r e Il lA peJ'Cll "'l'-ini rO flPI d' nn a SI l'Il' cont r ò di nolf'\'OIC; . ·' ·o rmoslr6 u l · .
SI f'St-lndeva in basso "' b 118 o tusJta che dal giugulo ollusìtà cat·diaca e si r amd o i _la t i dello sterno nno alla mill!LA
• 11 ' 011 !)Va Immediatamente con e.&stl.
Il \\'ic>Sll11ltln , lando'-'i di un "''mile uella elinira del prof. Krònlein' fece la dì slruma ìntra· tora cica, fondandosi sulla lunga durata de1 disturbi turi. "'ulla figu r a dPila ottusità e sull'alto g rad o dì tracbeale. Al malato furono somministrate larglw clo<:i d1 ioduro dJ potasl>io e applicata la Vl"scìca di ghiaccio sul pt!llo, ton chP i più aculi disturbi respiratori mighorat·ono a!(JUtlnlu. In ulti mo tempo o::opeavvenne anche lo ùif<fagia, ed il rnalulo mori di marasmo per rleficiente nutrizione. Allo l'f'zinnP trov ò il mediaslino anteriore rtempito eia un tumore .Iella grandezza di due pugni chiusi, che f<i estendeva dal ,f!IU· gulo fino alla biforcazione della trachea e stava per coslrlirP a CtJ.vallo r.1. queslu e Hl pe1·icardio. Er·a costt lUllO ùu unu struma ovorde in parte d·•gr!nc• rata in cisti. A de><lra, acco"l'> alla. una <:tr uma gr•ns!la quanto una no"e romllh•tamente ca lcificata, che col grosso tumo•·e non aveva lutamenlealcun t'apporto parenchimaloso. La trachea <:cbtHC• clULA per la pt·essiolle girava come un na><tro inlo l·no una fe!<:su•·a del tumore a desLI'a di aveva quindi un rilevante ìncUI' vamento scoliotico. Circa la metà della st1'uma slava in tt <:ini"'h'a, l'altra m elà p0<:teriormenle a sini<:Lra •Iella h·achea.
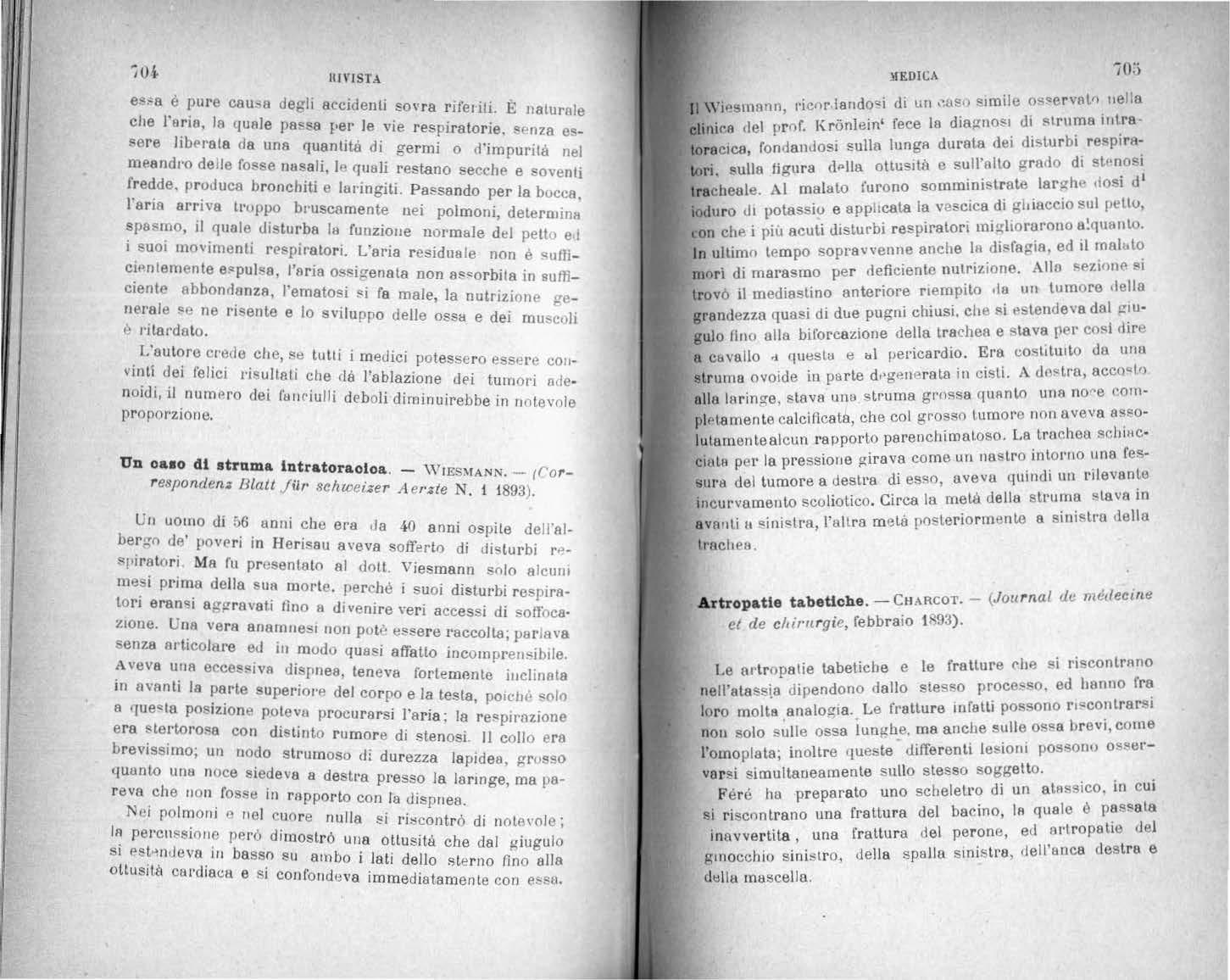
Artropatie ta.betlche . - CHARCOl'. - (Jou rnal dc ulédectne et de c!tim r giP, febbraio i R9:3).
Le at·tropalie tabetiche e le fratture rhe riscontrAno nell'alass\a dipendono dallo stesso proce"<:O, ed hanno fra loro molta .analo!!ta. Le ft·allur e mfalli possono r•"contrars1 non 11010 ossa lunl!he, ma anche sulle osc:a brevi, come l'omoplata; in oltre •1ueste ùiiTe r onli le»ior11 pos.:;onC) O'<'<ervarsi simultaneamente sullo stesso sogget to.
F é r é ha preparato uno schelett·o di u n altlssico, in cui si ri <:cnnlrano una frattura de l barino, lA qua le é pas!"ala inavvertita , una fratt u r a del per one, ed al'lropatio del g-mocchi<> s inistr o, dell a spalla srnistJ'a, dell'anca dest ra e m a!:icella.
Nelle artropatie le parLi tendìnee, i legamenti subtbcono pure alteraziooi, ed il più l'alfezione assume 111 forma a trofica, ma vi sono casi in cui si for·mano vegetazioni, come nelle artriti secche, ciò che indica l'esistenza di una certa r eazione; forse questa si produce quando i malati cont111uano a camminare e cagiOnano cosi un'irritazione dell'arlicolllzione. Quanto al meccanismo intimo di 'Iueste fr atture e di queste nrtrop•llie, esso ci è an co ra quasi sconosciuto e noi supponiamo Mllanto cl1e abbiano crnlrale.
J casi pr·esentano d'altronde un clinico molto variabile. Una donna del ripar·to di Cha r cot, per egempio, offre la pa1 ticolarlla che la la be, dopo esstJre r esh•tu 111 lei con decorso benigno pe1· J6 anni, si è falla im pr••' mente molto più g-rave.
Si o!lser·vano, infatti, talvolta malati, i quali arr1van o ad un'eta avanzata senza aver mui avvertito che dolo1·i fulgor anti o disturb1 oculari, senza aver mollo sofferto della loro a ffeziOne. NelltJ malata iu la tabe è !>tatH precoce, esseuclo sopt•aggiuuta a :$ anni; questo fatto si ne· gli individui che presentano un'l're lllà nervosa s •intA ad un allo grado stessa, dell 'età pre..:entemente eli i-5 anni, avendo condott <l un'esistenza mollo infelice e numerosi eccessi venerei, ha cominciato nella tabe con dolori fuJ go ra nl 1 , susseg uiti beo p1·esto d1:1 ipereslesia della pelle in alcuni punti. Pet• la durata di 16 anni circu, visse con questa forma benigna troppo so/Trirno, I(UanJo, tre anni or flono, portando un pesante carico, uno !';Cro..cio nel ginocchio, po!<cia una specie di !';po"llamento nel membro che l'obbligò a fermat•si. Sopra ggiUnse a tutta p r ima una tumelazione consider·evole; due mesi dopo il lato destro ru pul'o colpilo come il sinistro. E ssa coulinua però a camminare senzn avverti re molla difficoltà.
:\fa le due ;,liunture sono tumr•fallP in modo da 111dicar•e che in t[Uesle parli esiste una violenta reazione.
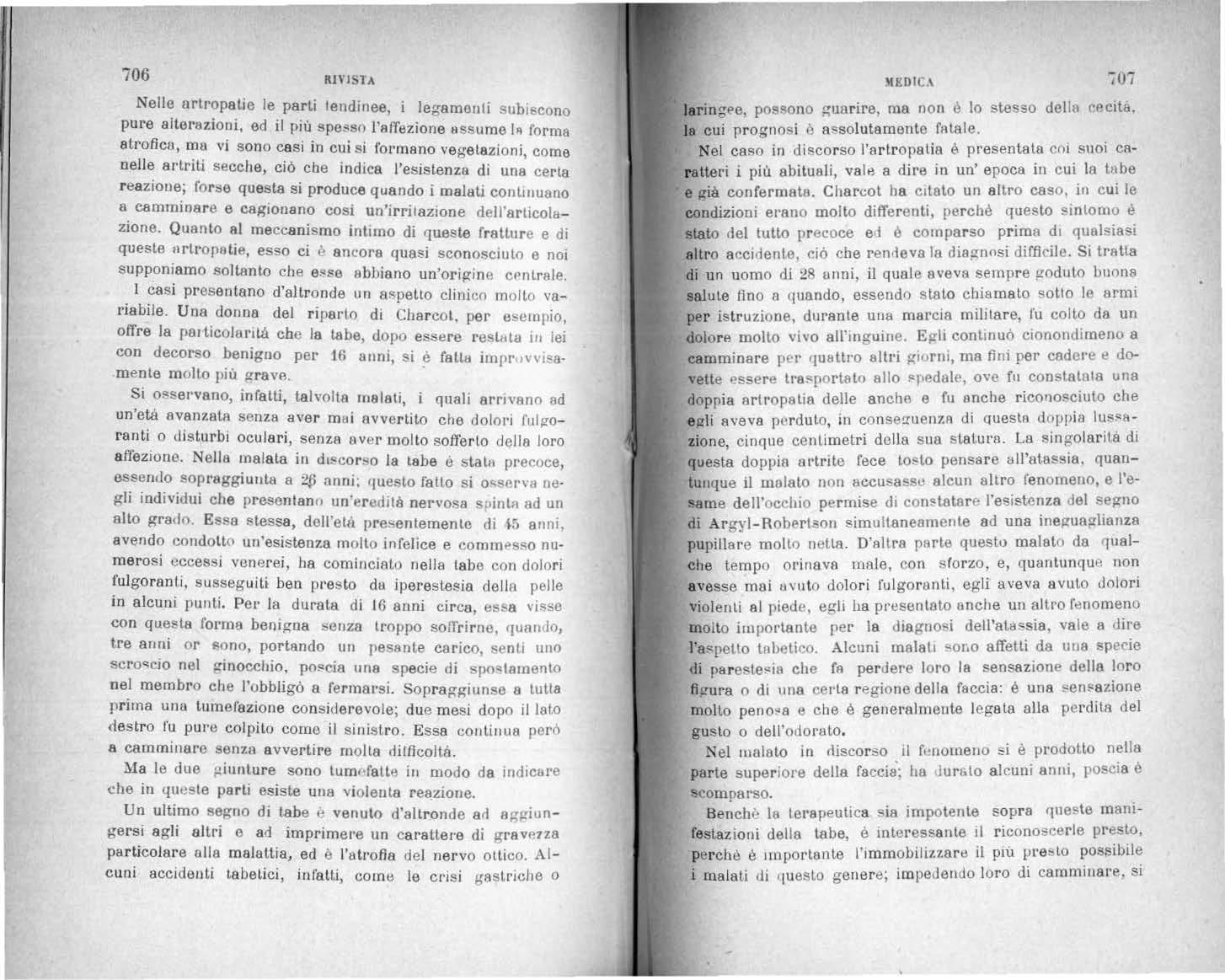
Un ultimo segno di tabe ,. venuto d'all r ond e an gersi agli alil'i e ad imprimet·e un caraltet·e di particolare alla malatLia, ed è del nervo ottico. Alcuni accidenti tabetici, infatti, come le ct·•si gastr•che o
'I.I!DIC \ "iO i Jarin gee, guarire, ma non è lo stesso dellu <'P.Cita, la cui pr ognosi f.! actsolutamente fAtale.
N e l cMo in disco r so l'artropatia è presentata co1 Stloi car atte ri i più abituali, a dire in un' epoca in cui la e confermata. Charcot ha c1lato un artro caso, in cui le condizioni et·anu molto differenti, perché questo sintomo è stato del tutto e l è cornparso prima d1 qual!"iasi altro acc1rlenle, riò cbe ren•ieva la diag:nnsi difficile. S1 tratta di un uomo di 28 anni, il quale sempre rtoduto buona salute fino a quando, essendn s tato chiamato sotto le armi per istruzione, durante uua marCII\ militare, fu colto da un d olore mollo vivo all'inguin e. Eg-lr cont1nuo cionondimeno a camminare per rtuattro altri g1"rnì, ma fim per· cadc•·e e dove tte allo !<pedalt•, ove fu una doppia artropal1a delle anche e fu snche riconosciuto che egli aveva in di questa doppia lus'<azion e, cinque centimetri della sna statura. La singolarilli di questa doppia artrite fece tosto pensare all'atassia, quantu nque il molato non accusasse alcun altro fenomeno, e l'e· same dell'occluo permise d1 conc:tatar P l'esistenza del segno di A rgyl-RobE'rlson simultaneamente ad una pu pillare mollo netta. D'altra questo malato da 'lualche tempo Ol'inava male, r.on s forzo, e, quantunqutJ non a vesse mai tl\ lllO dolo ri fulgoronli, egli aveva avuto tlolor1 violenti al pied P, egli Ila pr·t!sentato anche un alt•·o f,momeno mo•lo itnpot•lanle per la diagno..;i dell'alu"sia, vale a dire l'a!"petto tohelico. Alcuni malalt ..,or.o affetti da una specie di pa r esle->ra che fo perdere loro la sensazione della loro fì!!ura o di una ce1·La regione della faccia: é una mol to peno..,a e che é genet·almente legata alla perditA del gusto o dell'odo•·nto.
Nel malato in rliscor"o il ft•nomeHO si e prodotto nella parte superior·e della faccia: ha lu rt.lo al cuni anni, poscia é ,
Benchì• la tcJ•apeulica l<ia impotente sopra 'Iueste mamfestazioni della tabe, é mte ressante tl ricono sce rle presto, per ché è nnpo••Lanle l'Immobilizzar e il pm pos:;ibile i mal ati di ,1uesto impedendo loro di camminare, si
'IEOIC \ evita di aggeavare cyue:.-le artropatie che, dalla forma btmigna, Allora al la for•ma t,;owA:-o - Glioma del corpo atrlato ( nuoleo lentloolare) oon alntoml di molanoolla , e terminazione tn oon vulaioni untlateraU oon lperptressla . -(The Lancet, dicembre tx!1:3). casi d'alienazion,.. mentale per tumori cerebrali 11011 sono comum; Clouston li calcola al :!M p. tO'J, Tuke, Bristowe e Gr·ier.inger ne rrporlano ben pochi, Sfl''lll.!e dice cha è raro trovar pazzie rlirt>llamPnlP dipendenti da tumori endocl'anici; fra le •liverse 111igliaiu di malti accolti in Belhlem, una sola csosto;:.i sifilitica si è trovata all'autopsia, Andrai e Ourand Fa r del &Sl:iel'iscono che raramente 1 tumori cerPbrali producono mentali, Cahneil t>d altri dicono che trova ap pena quell'h • forma d'alienazrone mentald in un terzo od in u na m .. til do' tumori cerebi•alr; nell'asilo di Lanca!lhire negli ullimi anni pochissimi tumori han prodotto alterazioni mentali. appena 8 stt 1+,96!> mulali.
Sulla braohloardla. - H AMI'Et.N. - meri. WocltPnselt. e Cent ra/b. /ìi. r die medie. \Vissenscll., 5.
L 'autore di!!lrnguc: A) la brachtrordia fìsiologlCa, eh c rtscontrasi nei e nel puet·pel'io, e deve considerala o come un sintomo della !:tanchezza (Traube) o come un atto di compeol"azione del cuore, in certo modo come un sintomo della guarigrone H) la brachicardia patologica, <·he t\ volta si divide tn l) brllchicardta -.intomati ·a e simpatica (nelle malatlie tiPI e della midolla spinAle, talora nelle malattie dallo c::tomaco e inlc'ìtini, nella Plmintiasi ecc. ; 2) la forma to"c::ica (nella ademia e ul'emia, dopo l'uso smodato dell'alcole e del tubacco per lo più pe r irt·itazione diretta o rifltlssa dt>lle fib t•e intbilrici del 3) la brachicardia come nevrosi centrale primaria del cuore: l'abbassamento che può osservarsi m tali cttsi della frecyuenza dei battili cardiaci a 40-50 avviene isolutnmenle o come fenomeno concomilantP di nevros i :;.renorali, for ma conlrRsto con l'abiluale lRchicardia nervosa e dllriva pr obabilmente da un romorato l'ltato di irr•tazione dd centro motorio cardiaco; 4) la t'o t·ma JH'IIIctpale 6 la brachicardia d<'i malati di cuore. In que'-'la può il più basso numero d i pulsazioni (20 e anche al minuto), talora con gravi accidenti parlico!Rrmentr I\Cces!5i epilettiformi. Si incontra nei vizi valvolari (particoll\rm enle nella slenos i dell'ol'ltio aortico) e nelle m a laUie del muscolo cm·diuco (mioca rdite ca ll osa e degenerazione uèl cuore), e per lo più è la di uua tlllerazioue di molo compeusatrice p ro cedente dal centro tnolorio del cuore Mu più fr·el]uentemenle l'lì verifica nella coronaria e ... embra e-.sere delPrmiuata da alteraz10ni mater iali della sostanza de l cuo r e. Spesso la braclricat•dia è l'unico rilevante, ma non necessario, sin tomo della !iclerosi co r on ale.
Un d1 nt>gozio di 26 l'Inni <>nt1·ò au·ospedale il 20 nov embrtl 189!, nou aveva ma1 ..,offerto sifilide, era sempt·e l'Lato bene, non aveva anamnestici in famiglra.
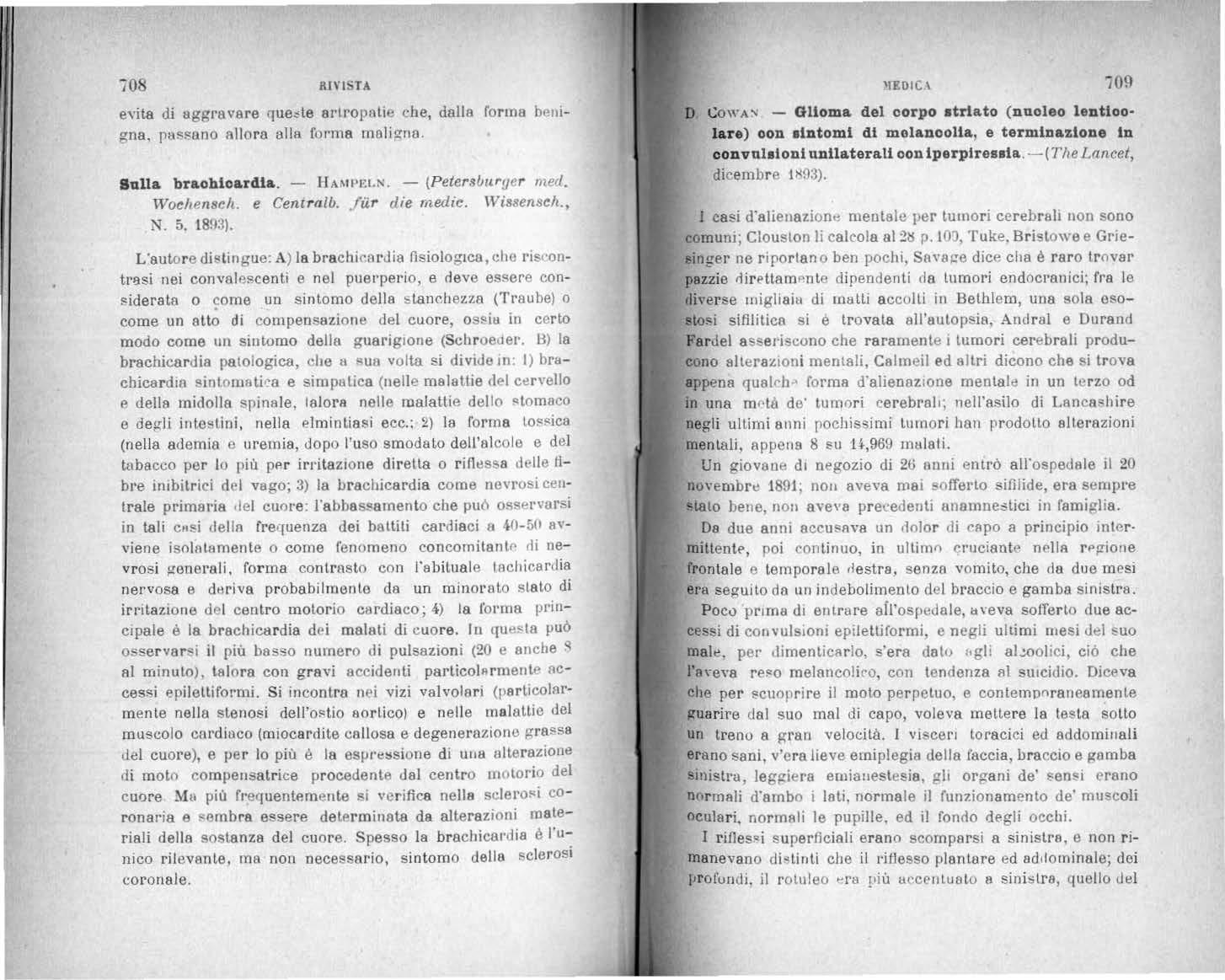
Da due anni accusava un tlolor 1li rApo a principio inter· m itten te, poi rontinuo, in ullimn cruciant1• nrllR rPI!ioue front ale e temporale destra, senza vomito, che da due mesi era segu ito da un indebolimento del braccio e gamba sinistra.
Poc0 pr1ma dt entrare ail'ospt:òale, tt\eva sofferto due accessi di cotrvulsioni epileLtiformi, c negli ultimi oresi ùell>uo mal d, per· ,limenlicArlo, s'era daliJ :ogli al.!oolici, ciò che l'a\·eva re"O melancoliro, con tendenza al stucidio. Diceva che per "cuoprire il molo perpetuo, e contempnraneamente j;marire dal suo mal di capo, voleva mette r e la lesta sotto un treno a gran velocità. l v1scer• toracici ed addominali erano sani, v'era lieve emiplegia della faccia, braccto e gamba l<in islra, eruianeslesia, gli organi de' sen"t erano norma li d'ambo i Iati, normale il funzionamento de' muscoli ocula r i, normali le pupille, ed il fondo dt>gli occhi. I r ifles"i superfìciali erano scomparsi a sinistra, e non rimane vano di-<linti che il t·iilesso !Jianlare ed addominale; dei lJrofuuùi, il rotuleCJ ... ra più IH'C<'rttuato a sinistra, quello dd bicipite bronchiale A sinistra si otteneva farilmente non vi erA clono. ' i'l"on avendo l'infe rm o perduta la facoltà di inghiottire, ;::h furono amministratr 6 gr·ammi di cloralio in due volle con l'intervallo di 40 minuti, in seguito di che gli accessi diven · nero più brevi e piu rari fino a scomparire. 1 riflessi tendrnei del Ialo sinistr o l'llnasero aboliti per (]ualche tempo, la paralisi non auroentò .
La parola era inceppata ed esitante, le facoltà menta h ottuse e deprt>f<Se, clueueva piela per la sua vita, e sosteneva che a Natale lo avrebbero amrllazzato. La memoria era deficiente circa gli eventi t•e renti, talché non s apeva dar r·adi M <>te<>so.
1128 novemhre ebbe movimenti co nvulsivi clonici al braccro sinistro, e perde interamente la coscienza per· pochi minuti; quando rinvenne si lagnò del dolor· di capo. due mesi rimase nel rnode!ìimo stato, con l"e::;pressione di dolore nel volto, ammrccando le palpebr·e. PresP tre volle al giorno due grammt e mezzo dr bromu r·o di potas!'lio, e ioduro di potassio per tempo, ma senza effetto.
Nella sera del 3 febbraio 1892 ebbe l 7 acce!'lsi epilettiformi in due ore, cadendo per· terra privo di coscienza, con forte deviazione coniugata degli occhi e del capo verso sinistra, contrazioni toniche del lato sinislr·o della faccia, braccio e gamba sinistra, della durala di pochi secondi. terminanti con convulsioni cloniche dello stesso Ialo. Ogni attacco du rava circa 4 minuti, ed era segu ito da un i ntervallo di 2 minuti.

La temperatura si elevò gradatamente nel ternf!o degli accessi, fino a raggiungt! re il massimo di 39" verso la fine, la coscienza non to r nò mai negl'intervalli, il r ifle sso congiuuti· vale r im&!"G abolito per qualche tempo dopo gli accessi.
Il giorno fl giugno l'infermo ebbe una convulsrone simile alle precedenti, il 14 lugli o ebbe un'allra serie di 12 convulsioni consecutive a sinistra. la temperatura sali rapidam ente a u·, il polso a t20, la respirazione 11 10, fu rip etuta l'aro-
11EOICA 7 11 li cloralio, fu del whisky pel retto, ma la temperatura cresceva ancora, l'inft>r·mo er·a comatoso, il vollo cianotico, il p r ofuso sudor·e scorreva a rrvi pel corpo, le pu pille si dilatavano, i riflessi d'ogni genero e rano aboliti, furono iniziate le inalazioni di clot•ot'ormio, e finalmente, do po due ore, finirono gli accessi.
Al le 10 anl. del 15 luglio la temperatura era scesa a 39,o, il p olso a 120 era molle e piccolo, la respirazione a r)G era stertorosa e fischiante, v'ora completa emiplegia motol'ia u !'Casoria a sinistra, mrdriasi, scomparsa de' riflessi superficiali e pro fondi , nella noLte aveva do rmilo appena brevi momenti, era conscio benché mollo ottuso di mente. si lagnava ancora del dolore al lato destro del capo, non av eva avuto vo mito, poteva inghiottire a piccoli sorsi, aveva pe rduto le feccia nel letto. Alle 5 poro. l'rnfel'tnO dh•iene pallido, debole, ha il r espiro affannoso dt Gi- nlli al minuto, è soporoso ad inte r valli, a volle si agita nel letto pel forte dolor di capo, si fa nno senapizzazioni pel col'po ma senza frutto, il polso drv rene impercellrb•lc, le est•·emità si raffr eddano, lo stupore aumenta, eJ alle 11,15 pom. avviene la rnOI'Le.
L 'autop:;ia rilev ò i dati seguenti:
L a dura mad•·e la pia e l' tH'acuoide erano normali, all'apertura scor-ero <'irca 100 g ram111i di liqu•do traslucido, i c;Pni era no ripieni di scuro e liqu1d0, la supedlcre del cer vello aveva una moderata congestione venosa, la corteccia a ppa ri va nor•male, per consistenza e forma delle circon voluz iOni, eccPttoché nel lobo Lernporo-<>ft>noidale dest ro, ct.e era raggri nzato e ramrn olltto, e nelle pa rli adracenti a lla circonvoluziune ascendente et! alla terza frontale che era no pure im p icc rolile e flaccide.
Nel c;eparare queste CÌl'COnvoluzioni ...d aprire la !!<t'is!"ura di Sil•·io, sr vrde una mas!'a lucente che occupava l' insttlrt di Rei! a destra, e che e ra evidentemente la cAgione d el r•ammollim ento tlelle dette ci1·convoluzioui. Continu and o la dissezioni', si rni!le allo !"<'Operto tutto il neoplac;mo che era di forma OYnl ... occupante le circonvoluziom
IU\'ISU 'IEOI C.\ involvenle il la lf"rza parte del nucleo lenllcolarl', e spo<>lunl"' 111 clenlro la capsula inlet·na senza addentrarvi ..i.
Il cerebrale all'intorno del tumore era pdllido e gtalliccio; il tumore era soffice all'esterno e qua!"i diffluente nel centro, di apparenza non conteneva focolai emorragici antichi o recenti. Fu indurito, e le sezioni rivelarono un glioma a ca ratteri tipici, con degenerazione gra"'"a nel cl'nlro, senzA cristalli rl! emat•,iclina. Le sezioni della " 0"lAnza cerebrale de' dintorni mostrarono l'estensione del ttrrnore fino alla metà del nucleo lenticolare, ma nulla nella capsula interna e nel lobo ft•ontale e
Hivista Chihuhgi Ca
\V - Sulla oauslsttoa della setttooemta orittogenetloa. - (rnur111b. (iir f'/tir N 27,. ll<92 ,
L'aulo r P, che sino 1R8L ti ve,·a già pubbhcati 1!1 ca"• tl1 seltiroemta crittngenelica osservati all'ospet!ale Ji Lipsia, ebhc in opportun i tà di osservarne e di :'ludiarne ancora un cr rto numero, de' rruali ulltml ei!ll tratto est<>sll!nente in un suo odierrao lavoro. Dalle stQrie dt quei singolt sì pos>;ono de d ut•re le "egueuli coustderaziulli.
In un CS!\n l'infeL.ione piemica ebbe Il suo punto Ji p!lllenzo da una ferila a l un dito, datante da 6 sr>ttima11e •'d 111
RtVlSTA CBIRURCIC.\ appar r>nzo di nP!'<s un a entità . In un altro caso la -.eltirof'rnia ,.i attribui, con !!ra.nde probabthtà atl una lestnne sotlocuta nea dell'anca riporlllla due mesi e mezzo inclielt·o. In un ter.to caso ad un ascesso .·;ubfreniro non cliagnostiealo duraule la vita. In all r 1 casi ad allezioui t>Ù articora1·1 non bene dclermtnale. l n quattro altri pazienti il primilivo fo colaio dal quale si sviluppò renclocarJilc ulcero"a e l'i nfezione gene rale non polf> essere dimostralo l n un <'8'-0 to !'Clli coemia fu il seguito di un'angina in appare nza ma che all'anlopsiA si fece conoscere pet• un a cesso; in un all!·o il punto di partenza clell' fu u 11 8 rcc<>nte con perforazione dell'appendice 'errm fo1·m e, e nell'ultima delle osservaz ioni rip ortate furouo epatici rausati da cairoli biliari, bencltt'- il non nvesse mai manifestato sintomi dell'ora clella a0e7.10IH'.
N e ll a grande maggioranza deUe sue osservazioni Wagner ebbe a nntare la pr·esenza di numerosi tllicrococclti d<>l pus, precisamente ùel genere stafìlococcu piogene Rpecialrnente 11e:Je supp urazioni limilate, menll'C Lt•ovò f1111 abbondanti gli streptococchi piogcni nei flemmoni di !fuAi.
Collu pioemiR criptogenetica si scambiiH'C Altre ma tal lt e come il tifo addominale, )A tubercolo!:'i milia•·e acuta, e"a otemt, febbre malarica, mt>ningite ctwellre-spinalc, t·euntaat•licolare acuto, ecc. La pt·escnza dei mtct•ococclu nel sangue e nel sudort'! !'arà il fatto ,.;u cui qi ba>'erà la dia:.tuosi d tfTt'renziaJe. Il Ff'OOOSliCO P qua"i "<'mpre infauc;tl'.
R oc;E,WACH. - Una osservazione sulla teontoa dell'opeTazlone dell' emplema e della punztone esplorativa . - (Central. fu r Chi rury., N. '!.7, 1892).
Ro;;:embaclt crede che ne! rasi t'ecenti dt <'mpiem11 l>tll. del tutto l"ufficieute un semplice taglio del con l'inlt'Oduzìone di due gran•li tubi a a l"t'osc;e pareti, o che la r esezioue di costa sia nt>ccssaria so lo uei cac;ì lllVelerat1; ma c·.he in que sto caso si debba poi fare uuu r e: sezione estesa, una specie di Lora copla sLica, allo scopo dt
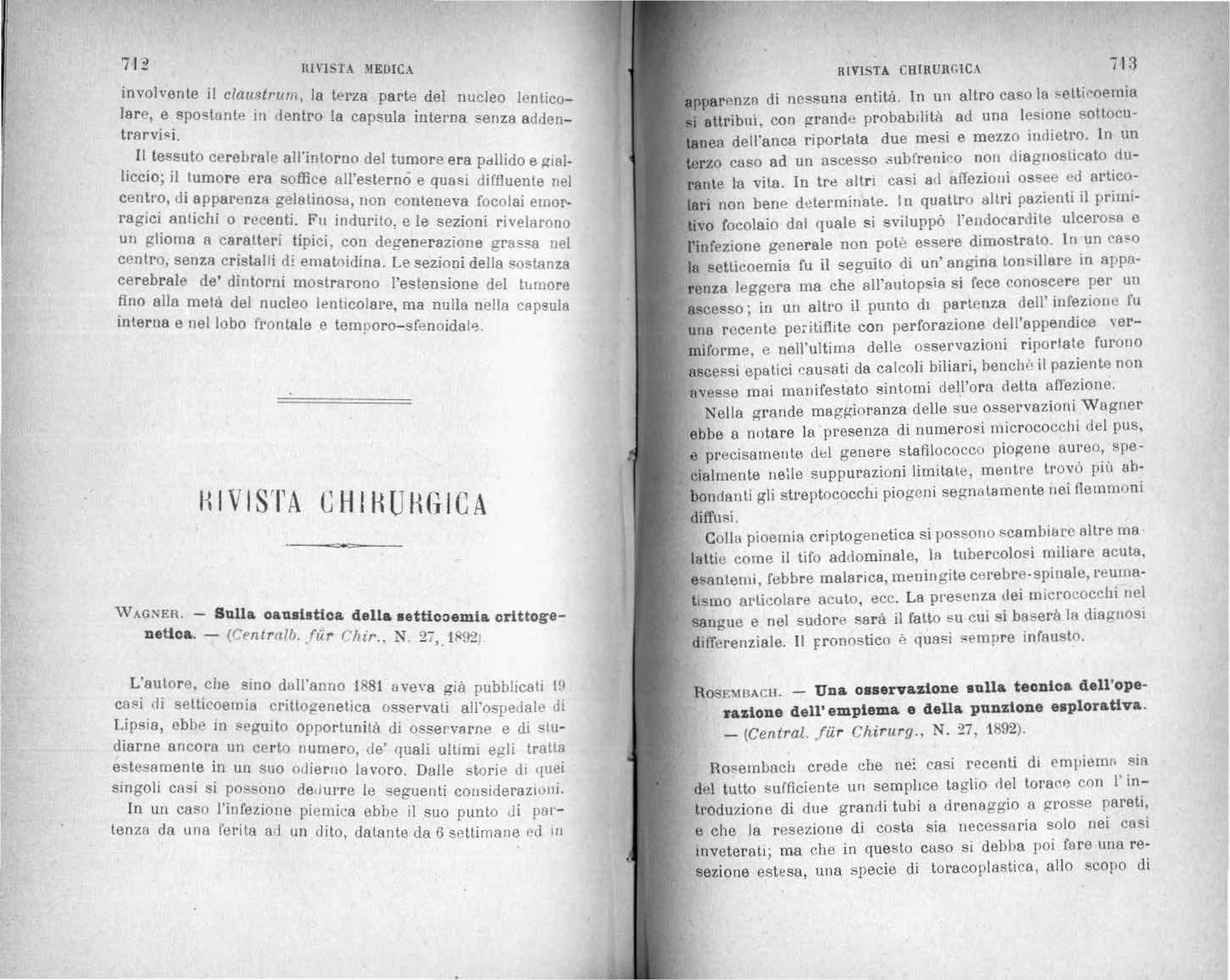
ClllRCRG l CA p rovocarP la chiusu ra d ella ltrl'lllde c avità a pa r t>ti ri:ri.le. Relativamente a questo secondo punto l'autore ci inùiC'a l)
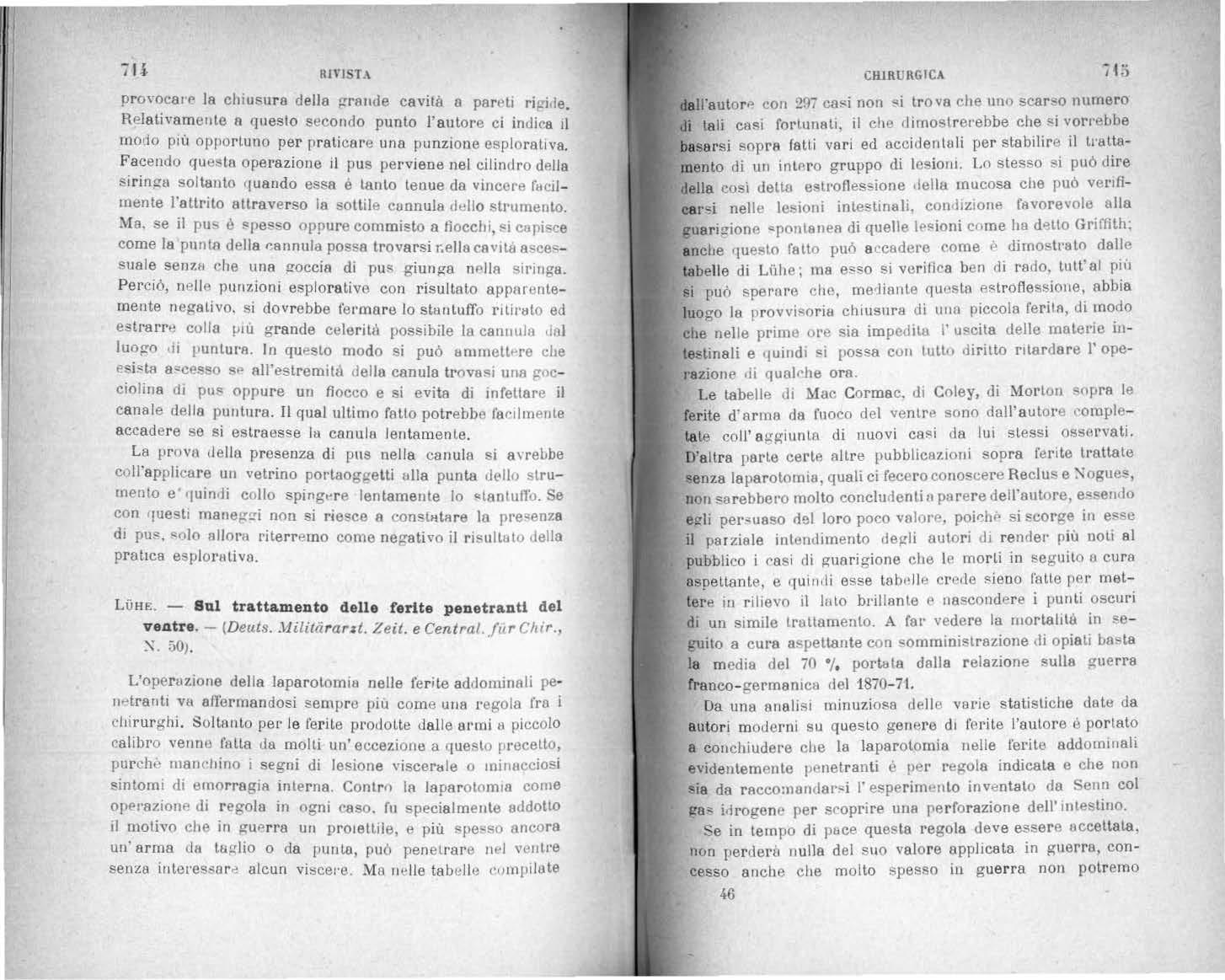
•nodo più opportuno per pralicat•e una punzioue esplorativa. Facendo ope razione il pus per viene nel cilindro della si ri nga soltanto rruando essa è tanto tenue da vincere ftttilll1ente l'allr ito attrave r so la soUiJP cuonula ,lt Jio stt•umento. Ma. se il pu-. è <:pe<:so oppure com misto a fiocch1, si cnpi..,ce come la pnnln della rannula po<:<:a trovarsi r.ella cav1ttt
<:uale senz11 l'Ile una a-occia di pu<: nrlla siriuga. Perc •ò, nt>ll•' punzioni esploraLiV(' con risultato apparentemen te negativo, si dovrebbe fc1·mare lo stantuffo ed estl'arrt> colla fJIÙ gran de celerilu possibile la cannulu tta l luoa-n dt puntut·a. In qu sto modo <:i può H.rumcll re che esi-.ta a--cefl<>o SP all'estrem1tu dell a canula trova<: i una gocciolina d1 pu<: oppure un fiocco e si evita di mfellare il canale della puntura. Il qual ultimo fallo potr ebbP accad e r e se si estra esse la canula len tamente
La pr·ovu de lla presenza di pus nella canula si aHeLbe coll'ap plkore uu vetrino portaoggetti ulla punta dello .;;trurnenlo e •[Uindi collo spingo• r e lentamente lo "tanlufli>. Se con quest1 maneg-.:i non si rie<:ce a con"LH.lflre la f>1'6"enza dr pu". '-'olo nllor11 r·iterr Pmo come negati•m il r1sult uto della p r atica esploruti va.
Lii HE. - Sul trattamento d elle ferite penetranti del ve.atre.- (Deuls. Jdilitiirar.:t. Zeit. e Central.fllr Cllir., :\. :JOJ
L'ope r uzioue della la p arotomta nelle ferite addommalt pe· u•·trant1 va all'armandosi sempr e piu come uua r egola fra i chirurghi . Soltanto pet• le f'e rite pt•odo tte dalle at•mi 11 piccolo calibro venno fulla da molli un'eccezione u q uesto procetto, purchi· mandnno i segni di le!'ione o miuuccio!'i sintomi di emorrag1a in te r na. Conlrn la laparotom1a come OpPt'8ZIOJJP dr r egola in ogni raso. ru 8pecia lmenle addotto
Il motivo elle in uu proteltile, e più "Jlesso ancora un· arma dtt taulio o da puuta, può penetrare nt·l vrnt•·e 8enza inlol'es;;ar.-! alcun viscere Ma n elle tabe lle c•umpilute da ll'auto r<> con :W7 ca-:i non "-i Lr o va che uuo scar,..o numero Ji tali casi rot•tnnati, il clw d irnosl r erebbe che "l bas arsi sop ra falli va r1 ed acciden ta li per il tl·ati.B.men to di un intr r o gru ppo di lcsio111. Lo stes!'o "i può di re <Iella cosi dell(J eslt·oftes,-ione dulia mucosa che può verlficar"i nell e le!SJOIIi intestmah. con ltzione favorevoli) alla !!'U&rJa-Jooe "ponlanea di quelle Je<;ioni come ha Griflilh: anclre 1 uesto ratto può a •·cadei'C come i> dalle ta belle di Lfthc; ma es:so si vorilira ben di rado, tutt'al più j;i pu ò sper•a1'e ti•P, me,liante qu<•sta estrotlessioue,_ abbia luogo la p r ovvio.;oria chiusura d i 111111 piccola ferita, dt modo che nelle prime ore sia impeditu l' u<:cita delle matel'ie intestinali e quindi "'l possa con tutto diritto r1tardare l' operazione oli qualrhe ora.
Le tabelle dt Mac Corma c. ùt Coley, ùi Mortou «npra le ferite d'arma da fnoro del ventrt> sono dall'autore co mpl{'lale coll' a ggiunta di nuovi casi da lUI stessi ossArva.ti. D'altra parte certe Altre pubblicazioni sopra fer•te L1·attate laparolomw, quali ci fecero co noseere Re clu" ogues, non <:arebbet·o mollo conclurlenti n parere dell'autnre, e""61Hio egl i per..,uaso rlel lo r o poco valorr. poit:ht> si scorge in es<:e il parziale 1nlundim en lo degli autori dJ rende1· più noli al pubblico i c-asi di gua r igione elle le mo r ti in segUitO a cu r a aspettante, e qU111di esse talwiiP crf'cle sieoo l'atl.e per mettere in rilievo ti lulo bt·illanle r na!'condere i punLi oscuri di un simile trullarnento. A fa•· vedere la mortalità in <:ea cura con '-Ommrnislrazione dJ opiati btbla la m edia ciel 70 •;. porllita dalla rela1Jone sulla :;tue rra franco-german•ca del 1870 -71.
Da un 11 analisi minuzioRa dellt> varie statistiche data da autor1 m oderni su questo ge nere d1 fpr ile l'autore è po r tato a con chiude1·e che la laparotomia nelle t'erite addotninali evidentemente JlPnetran ti c pPt' indicata o rhe non "ia da raccomandar...i r espe ri nwnlo inv;.ntato da Scnn col idrogen e per una pe r rorazione dell'intestino.
Se io tempo di puce quef'la regola deve essere nccetla la, non perderà nulla del suo valo r e applicata in guer r a, con· cesso ancllP che molto spesso in g uerra non potremo
CR l RURGICA 711
oltenere tutte le condizioui favor ... voli a questa operazione. e più di tutto non potr emo disporre del tempo a co111pire questo allo oper·ativo. Dicasi lo s tesso per la necessaria antisepst , c he non !:iempr e si può in modo perfallo attuare, e flll!.a anch(' a;.trazwne dalla ::rrt•nde 11 bitiùi chirurgica che richiede allo operatn·o E que-.te condizioni tanto più facilment(• c i m8ncheranno quanto piu urgente sarà l' inòicazione di operar e. che può prcsPnlat"'Ì già fin sul posto di medicazione; n1a, se queste !"O li O elrcnche possono mellere acl operare in !"ingoli cast, var·ranno mai a distrugg-ere la regola gene1·ale, talv?lta ct sarà perwesso, srecialmente se ci manca 11 d1 tìs>;ar•e un'an:::a iuteslrnale fe r 1ta alle parel1 addominali e pratrcare un ano prelernnturall'.
Alla .lapnrotomia deve far una isp»zione di tulta la cavrla, e, secondo i casi, il lampou amento la neft·ectomia, ecc. con irrigazion e di tulla la cavita U:ediante soluzione cloruro-sodica fisiolog'ica. ln casi gravissirn 1 si raccomandA Il drenaggiO secondo Mi lhulick mediAnte !!arzll iodoformizzata. Sar·à da evilat'l'ìi rl trasporto defrlt opt•t·ati almeno nei p rimi :;riorni.
MANLEY - Note didatttohe e ollnioh e aull' oateogene•t e •ulla oateopla.sttoa. - (Centrrtl . .fiir Cflir., N. 27).
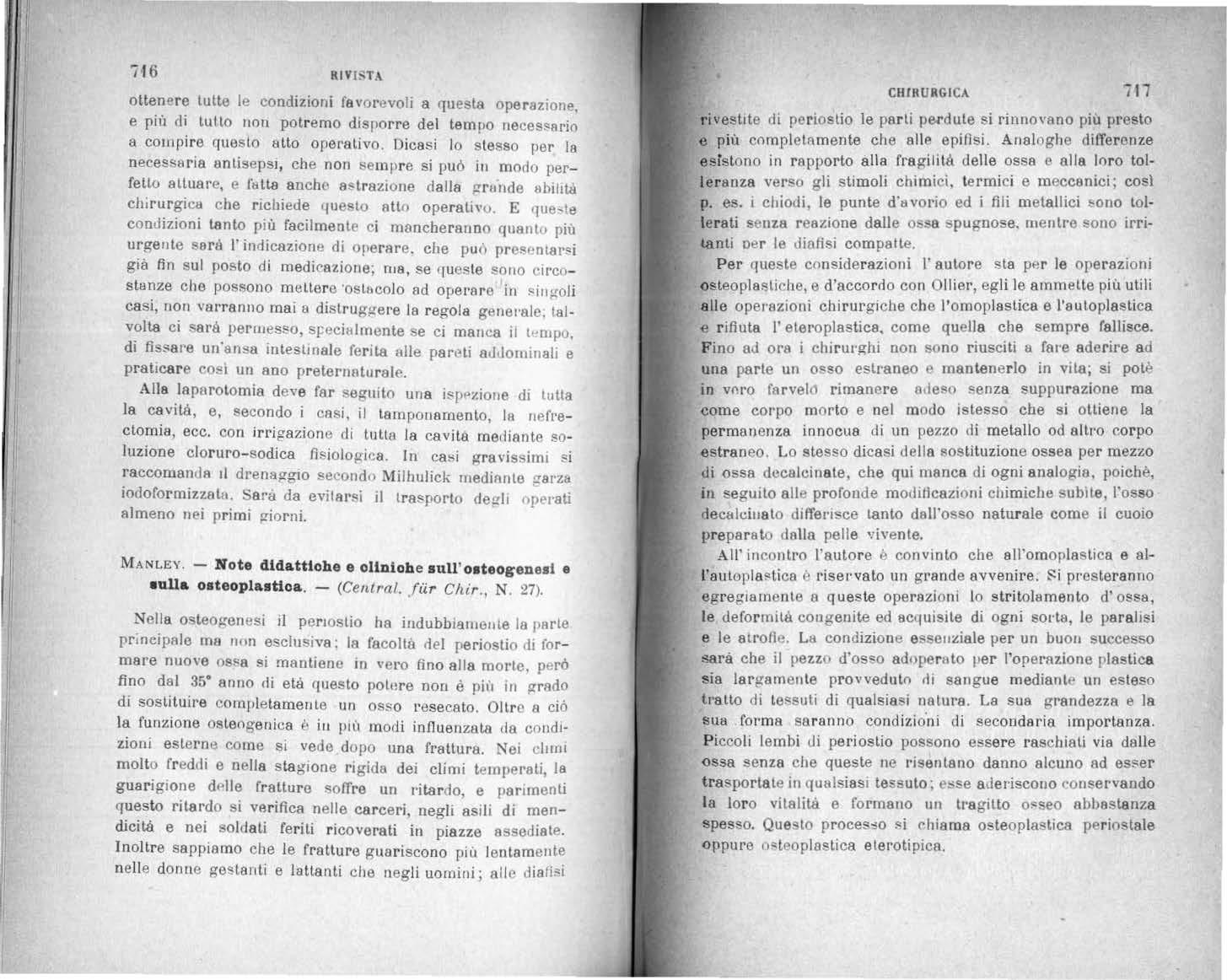
Nella li pertostio ha indubbranreute la parte prmcipAie ma non esclusiva: la facoltà rlel periostio di formare nuove si mantiene m ''Cl'O fino alla morte, pt:rò fino dal 35• anno rli età questo pOtHre non è pin in jXrado di sostituir·e completamente un t•esecato. Ollrc a ciò la funzione osteogenica i· in pnì modi influenzata da cond rziour esterne co me sr vede dopo una frattura. Nei clunt molto freddi e nPila stagione rtgida dei climi temperati, la guarigione dPIIe fratture soffre un r·itardo, e parrmenli questo ritardo si verifica nelle carceri, negli asili di mendicita e nei soldati feriti r tcovet·ati in piazze assediate. Inoltre sapptamo che le fratture guariscono più lentamente nelle donn e gec::ta11ti e lattanti che n egli uornini ; alle diall"r riv estrte dt pc r iostio le pa r li si rinnovano piu presto e pi ù cnmplelnmente che alle epifìsi. A.nal ng lre diffe r enze esis tono in rapporto alla fragilila delle ossa c alla lnro tolleranza verM gli stimoli chimici, termi c i e meccanici; cosl p. es. r chiodi, le punte d'ttvorio ed i fili m etallici tollera ti senza reazione dalle :opugnose. mentt·e sono irrita nti oer le dinlisi compalle.
P er queste conside r azioni l'au tore sta pPr le operazioni o steoplastirhe, e d'accordo con Ollier, egli le ammette più utili all e opet·azioni chirurgiChe che l'omoplaslica e l'auloplastica f! r ifiuta l' elet•oplastica. come quella che sempre fallisce. F ino ad ora i chi rut•gh• non sono rmsciti tt fa•·e aderire ad un a parte un oc;so eslraneo e mantene r lo in vita; si poti> in vl'ro I'Arvel11 rimanere senza suppurazione ma come corpo morto e nel m odo istesso che si ottiene la permanenza innocua di un pezzo di metallo od altt•o corpo e str aneo Lo stesso dicasi della sostituzione ossea per mezzo <Ji ossa dccalcinate, che qui manca di ogni i n seguito alle profoude m odttlcaw)lli chimiche subtte, l'osso rlecalciualo differ·rsce tanto dall'osso natu r ale come il cuoio p r eparato dalla pelle vivente.
All' inconl!·o l'autore è convi nto che all'omoplas tica e alt' a utopla!"tica i• riset·vato un gt·ande avvenire. pr·esteranno egt egramcnte a ques te operazioni lo stritolamento d' osstt, le deformità congenite ed acquistle di ogni sor·ta, le paraltsi e le atrofl o>. L11 condizione e!'!seuziale per un buou successo sarà che il pezzo d'osc::o adoperato per l'operazione plastica s ia lat•gam en te provveduto tlr sangue medianti' un esteso tr·atto rli di qualsiasi natura. La sua grandezza la s utt forma saranno condizio'ni ùi secondaria importanza. P iccoli lembi di periostio possono esser e raschiati via dalle o ssa senza che queste ne r·tseulano danno alcuno ad esser trasportate in quulsiast tessuto; aderiscono rons ervando la loro vitalita e formano un lt·agrlto O"seo abbastanza spesso. Questo proces::;o !>i rhiama osteoplastrca perim1tale o ppure o"t<>oplaslica eterotipica.
La poalzione rettiUnea nell' anoblloal del gomito dal punto d1 vtata profenlonale . - ABEL MARTII\. - li dollot• Abel Martin osser' a che, lì n da l ppocrate, i chiraccomanclano per i cast in cui é necessario decider·si per l' anchiiosi dol gomtto, di porre il membt•o nella posizione l'emi - Ressa, come la più favorevole e la meno incomoda. L'autore nota per ò che r anchrlosi r ettrlinea non dovrebbe essPrt' abbundonala completamente, pet·ch ·. dal p1111Lo ci1 ''ISLA prat1co, può t•enrlere utili ui mal»ti, che non compense r ebbP nulla la pos1zionP. angolare. È necessar·io, infatti, prima di poppe 11 membro nella pol'lizione che deve sempre conservare, consultare il malato sulla sua p1 ofe«s1one e "'Ludiare la posizione dei :;uoi membri nei loro principali lavori giot•nttlicori. Per esempro, per i collivatol'i, che cMltluiscono l'immensa maggioranza dei malati della la posizione> rettilinea, ftps«a, é infinitamente preferibil l:' alla poc.:izione angola r e Tulli 1 lavori tlella len·a. 10 questa posiziOne, "ono pos.,ibili ed ancbP facili, e per i wovimenti neces!Suri per piccoli b1sogni, come eli portare la mouo alla alla bocca, er-e., l'altro membro resta disponibile . cita molli cac;i uei quali questa stessa pos1zìone ha dalo buoni ri.,ullali (fa rm aer«li, pianisti, cocclueri, ecc. ). Fa 'llllndi d' uopo tenPI' gr·an conto delle ci r costanze e non obbedJre ìn un m odo 8"soluto al precetto che pt·escrive di situart• il membeo, in tutti i casi, nella posizione Ang-ollire.
(Journal rle .\IMerin.e et de C'hi ,. 11rgie, e:Pnnato 189:ll.
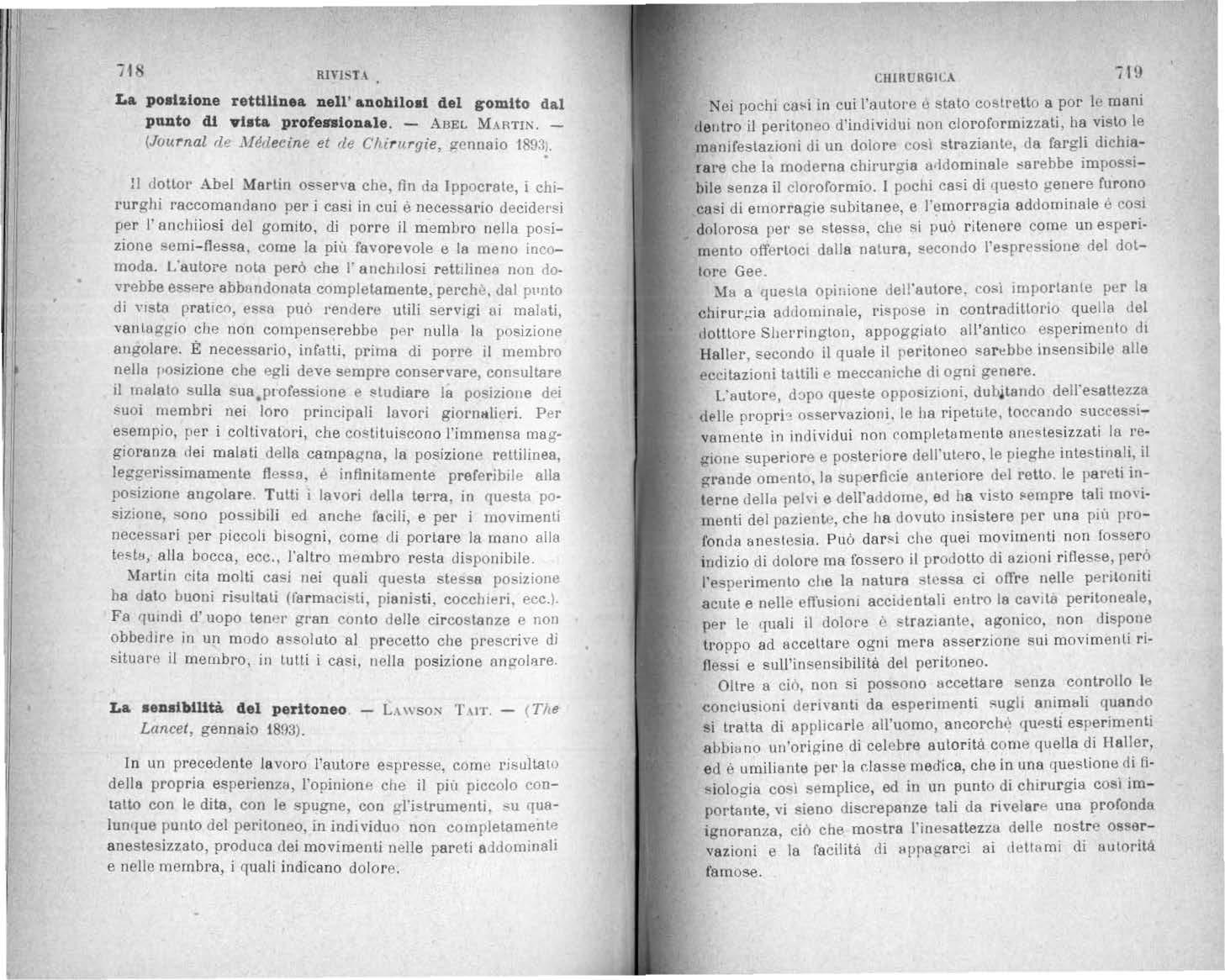
La ••n•lbWtà. del perttoneo - T\IT - (Tite Lan.cet, gennaio i893).
In un preceden te lavoro l'auto re espre;::.se, e.ornt• l'r:;uiLalo della propria esperien:w, l'opiuionP che il più piccolo contatto con le dita, con le spugne, con ::l'islrumentì. ,..u qualuo rlue punto del peritoneo, ìn individuo non a neste!".izzalo, produca dei movim enti nelle pareti addommali e nello membra, i quali indicano dolo r P.
CIURURGILA li H
Ne1 pochi cal'i in cui l'auto1·e t.i :;tato coslrellfl a por i l' mani dentro il periton eo d'individui non cloroformizzali. ha visto le m anifestazioni di un dolor•e strazianlr:, da fargli dichiara re che la moderna addominale ,..arebbe impos,..ibi le senza il cloroform io. l pochi casi di tJUesto genere furono casi di em o rra g1e subitanee, e l'amorra:;da addominale e ro::;1 dolorosa per· SP stessa. che si può ritenere comf' un esperim ento offertoc1 dalla natura, secondo l'espressioue rlel dollorc Gee.
a que'-la opinione dell'autore. cosi ìmportanltl pt!r la ch 1r ur;.:ia uddou11nale, !'ispose in contradillot'IO quella clal dot tlore Sher·ringlon, appoggialo all'antiCO esperim ento th Haller, secondo il qua le il peritoneo !<Orl!bbo msensibile alle eccitazioni lutlili e meccaniche d1 ogni genere.
l.'autorP, d.>po que::;le opposiziOni, delle propri·' osse rvazioni . le ha ripetute, toe.rando vam e;1te in individui non comp lt•lame nle la t·eJZ!One super10re e posteriore dell'ult>ro.le pieghe il gt·aude omenlo, la superfi cie antet•iore del retto. le pat·ch "': terne della pelvi e dell'addome, ed ha Yi<;:to !-8lllpre tah monm enti del paz1entt·, che ha do,•ulo insistere per una p111 (H'ofonrla anestesia. Può darsi cho quei movimenti non fossero i ndizio di dolore ma fossero il p r odotto di az1oni r iflesse, perii l'es perimento che la natura ;;tessa ci offr e nelle pel'itonill a cute e nelle ell'usioni acci ùenlah entro la cav1ta peritoneale, le quali il dolore i• st raz 1ante, agonico, non. tr oppo ad accettare ogni m Pra asserzione Rui mov1m en L1 rifl essi e sull'insensibilità del periloneo.
Oltre 8 cio, non si possono sen za controllo le conclus iOni deri,·ant• da esperimenti l'Ugh alllmttli quando si tratta di applicarle all'uomo, ancorch t' rrw>sli esperimenti abbiano un'origine di celeb re autor ità come quella di Tlaller, ed t> umiliante pee la r.lasse rnect·ica, che in una questione cii lìcos1 semplice, ed in un punto di chrrurgia cos1 importante, vi sieno discrepanze tali da r1velare una profonda ignoranza, ci<> che mostra l'inesattezza delle nostre osse rvazi oni e la facilità ch 11ppagar!.!i ai detlami di autor•it.A fam ose.
A la questione, l'autor•e l1a una circolAr•e a r cl11rurg.hi della Gran Bretlag-na e dell'Irlanda; ma rnol.tl non han rrsposto alla sua circolar·e, e le risposte dPgh altrr .non sono c orne r;i vedra in seguito, del l au.tore non sr rneravrg!Ja, poi c hé dei suoi due assist enti • fr·atel11 Martin, l'uno è d'accordo con l'autore l'liltro t' dr contrar•io avviso '
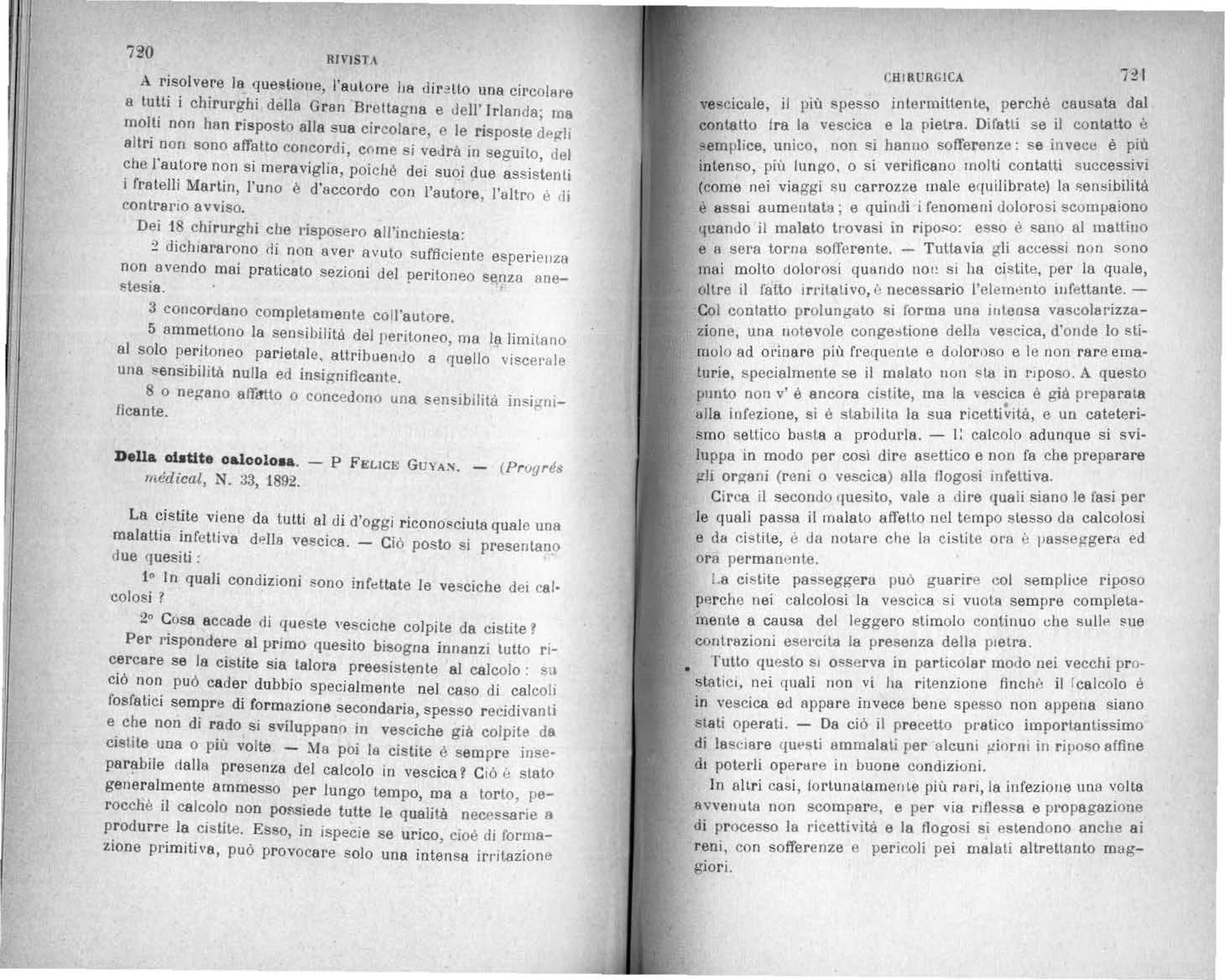
Dei 18 chirurghi che t·isposer·o all'm chiesta :
2 dichiarar·ono eli n on aver· avuto s uffi c ie nte e speriellza non avendo mai praticato sezioni del peritoneo senza Ane-
3 concordano completamente coll'au to re.
5 la sensibilità del peritoneo, ma la limittHIO al solo parielAle. attribuendo a r1uell o una nulla ed insignificante.
8 o negano alftttto o concedor1o b una sens1 ilita in:::iuniJìcante. · veo:;cicale, il più spesso inlermittente, perché dal contatto Ira la vescica e la pietra Difatti se ti contatto è .:ern plice, un ico, non si hanno so fferenz e: s e invece é più inten so, più lungo , o si verificano rnolti contatti successivi (come nei viaggi l"U carrozze male equilibrate) lA é aumentala; e quindi i fenomeni dolor osi scompaiono •ll!anùo il malato t rov asi in ri poso: ec;so sano al mattino e a sera to rn o soffe rente. - Tuttavia gli accessi non sono mai molt.o dolol'osi quAnùo si ha ch•LiLe, per· la quale, C•llre il fa(lo Jrr·itath·o, ,.. n ecessario l'elllln•!nlo wfettante.Col contatto p r olungato SI forma una wleosa vascolarizzazion e, una n otevole conge::.tJOne della vescica, d'onde lo !"timol o ad ot·inare più f'requ t>nle e d olorclso e le non rar e ema· lurie , specialm ente se il malato uon ;.J.a in r1poso. A questo punto non v' è an cora cisti te, ma la -.escica è g:iè preparata alla infezione, si è slabi litn la sua r icettiv1ta, e un cateterismo s ettico bu sta a produt•la. - l: calcolo adunque si svi· luppa in m odo per cosi dire asettico e non fa che preparare organi ( r eni o vescica ) Alla flogosi mfelliva.
La cistite viene da lutti al di d'oggi qual e una malattia della - Ci ò posto si presentano llue ques1l1 : l n quali condizioni sono le ve sciche dei ca l· colosr ?
2o accade eli queste vesciche colpile da cistite?
Per r·tspondere al primo quesito bisogna innaoz1 tutto rise la cistite sia talora preesistenle al calcolo "• Ciò non può cader dubbio specialmente nel caso di calcolr fosfatici sempre di form a · d z1one secoo ar1a, spess o re cid1vant1 8 cbe non d1 rado si sviluppano in vesciche giè colpite da CIStite una o pi ù volte '" · 1 · • • - .ua POI a Cistite é sempre mse · parabile clalla presenza del calcolo in C1 ò i· stato generalmente ammesso per lungo tempo ma a torto per occhè il calcolo non poMiede tutte le a p.rodurre la c rs tite . Esso, io ispecie se urico cioe d1 formaZIOO ·· ' t• ' ' e Pllrnr 1va, puo provocare solo una intensa irritazione l .a cistite paslleggera può gua rirè col semplice riposo pa r che nei calcolosi la vescica si vuola sempre co mpleta· meu t.e a causa del leggero stimolo co ntinuo c he s ullt> contrazi oni eset'Cita la pr esenza della pretra .
Circa il secondo quesito, vale a Ji re qua li siano le fasi per le quali passa il malato afl'ello nel te mpo s tesso da calcolosi e dn r.i::;tile, è da n o ta t'e che lA cistite ora ù ed or11 permao,.nle.
Tutto questo SI io parlicolar mod o nei vecch i prostat ìct, nei r1uali non vi ha r itenzione finch b il ! calcolo é in vescica ed Appare invece bene spesso non appena siano stati o perati. - Da ciò 11 pre cetto pr·atico importantissimo di la<>c1 are qut>s t i ammalali per alc un i l! im'n i in affine d1 poterli operlit'f>' 111 buone condizion i.
In all ri casi, lortunatame11te più rar1, la infezione una volta avveuulll n on scom pare, e per via e p1·opagazi ooe ùi processo la ricettivita e la flogo :::i si estendono anche a i reni , con sofferenze e per icoli pei malat i altrettan to maggiori
Fincb cistite c possibile la fortnazr, 111 e h calcoli s?pratulto fosfatici, perchè questi sali pr·ecrprlano sotto la mflueuza della vita degli che modificano le ur111e.
Allorquando sr t•rteneva il calt·olo cau"a efficiente olella cistite la maggioranza dei era alien 11 dllll'o pt>r·,.re !!lì ammalali in tali conùrzioui. Ma n,.!giolì, lata ,.,_ conosciuta la natura infeltiva della d<=lite dei calcolo-.i ntlatto indipPndeote dalla semplice azione di contatto del calcolo, l'operazinne c· diveuuta obbligator•ra. E in vero per mt•zzo suo, purchti eseguila con tuLlf' le r·egole asettirhe ed alltied in modo da a;;portar·c il più piccolo frammento di calcolo. «i vrene a logli..r·e ulla vescica lo stato di irrrtazione e di ric·ettiYita prodntt.a dall'aziOne dt de lla pietra e <JUirtdr «e ne rende la curn locale molto più rap idtt ed efllca('c.
Le cistiti adunque dei calcolOSI roulla fJI'esenLauo l'Ili? le distingua dalle tdlre ci'5liti. Lo sviluppo del calcoln uvviene in .modo asettico, ed es:;o, non uveudo potere infettant.e, 11011 da !-olo produrre ci"mtl. - La dr ultrma non contrornolica la oper·aztone, la consrdia anz i, pe rché solo con tale mezzo si l'lf·sce ttd ottenere unA <:i•·ura e rapida g:uariginne.
Un oaao di avvelenamento a&tnrnino per una palla rimasta confitta nelle oaaa.- e LEwrN - (Arh. fù.r klul Ch1 r . e Cent r alb, (iirdie meri. W1ssensch, N. 9. 1893).
Un uomo di 30 anni ebbe un cn l!JO d'arma da fuoco nel gi·:occlJiO, la pnl\a (liHJCtl'6 dal lato esterno, 1'8l:>t'Ol8 la cArtila gine articolut·e, nella te::,la della tibia, ma non fece alcuna Apertura d'uscita. La ferita gual'i, il malato rrma!<e, ron una legsriPra limitazione det movimenti del ginocchio, 17 111 anni sano. Dopo questo temp l eominciò una set• re oli 8iotomi che si t'iconobbe r o a ppllt'tenere a un avvelenamento cronico di piombo, cioè anemia salurnina con gran ueno- lezza , coliclw, di,..appelenza, costipazioni", vite e slo1natiie, leggrero tremito delle mani, nella orma fu dimostralo il piombt•, non a lblllllina; del nes,-una alterazio ne del polso, nessuna paralisi.
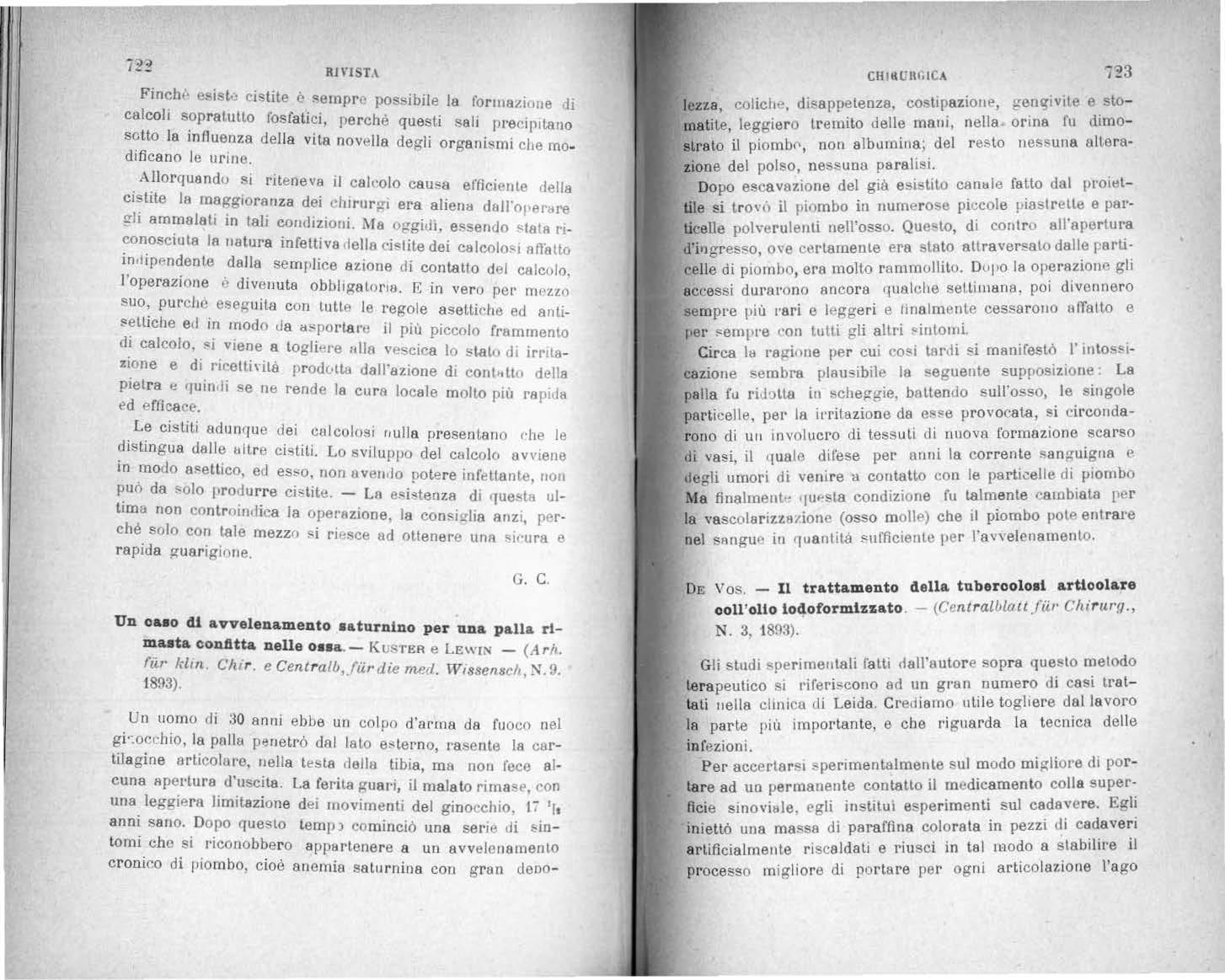
Do po escavazione del già canale falto dal pt·orettile si trovo il piombo in numl:lro-.e piccole piastrelle e pat·ticelle polverulenti nell'osso. Que'<lO, dì contro all'apertura tl'iolgres"'o, o ve c.:\•rtarneule era altra versato dalle rartirelle di pwrnbo, era mollo rammollito. OoJ'O la orerazionP gli accessi durat·ono ancora 'tualt'he settim an a, poi divennero !; Orn pt·e piu rari e Jt..ggeri e finalmente cessarono ulfallo e pet• !"empt·e ('011 lutti alll'i <>intomi.
Circa lu t·agione per cui tar-li «i manifestò l' intossicazio ne "'embr'8 plausibilt> la "eguente supposizione : La pa lla fu rio! >li a in battendo sull'osso, le singole particelle, pet' la irTilaziooe da provocata, si l'ircorrdaron o dì ur• involucro di tessuti di nuova formazione scarso di vasi, il quale difese per anni la corrente e tle<Yli umori di venire a contatto con le parti.::elle dì prombo . Ma tìnalmeul condizione fu talmente ratnbrala )'er la vascolarizzazione (osso molle) che rl piombo poiP entrat·e nel in •1uantìtà ><uftìctenlo per l'an·elenamento.
DE Vos. - Il trattamento della tubercolosi articolare coll 'olio lodoformizzato . (Ccnt ra lblo tt fiir· Clti rur·g., N. 3, 18!l!i).
Gli studi sperrmentali l'alt• dall'autore sopra metodo terapeutìco sr t•iferì,.cono ad un gr·an numero di casi trattati nella clrnrcu di Leìda. Crediarno utile togl•ere dal lavoro la parte piu importan te, e che r·iguarda la tecnica delle infezioni.
P et• sul modo miglior·e dì po rtare ad un permanente contatto il medicamento colla superfici e sinovitl!e, egli inslitui esperimenti sul cadavere. Egli ìn iett6 una massa dì paraffina colorala in pezzi dì cadaveri ar tificialmente riscaldalr e riusci in tal modo a stabi\ u·e il pt·ocesso migliore di portare per ogni articolazione l'ago della si ringa ir1 'fuel punto dul quale il lìqui.lo può distribuirsi facilmente rn tullft la cavità articolare r> polé rilevare inoltre l'ìnfiuenza del massa ggio e dei movimenti passivi unrforme penetraz rone e diffusione della materia inf'ettata.
I n base a queste ri cerche !"autore indica comf' più appro· prrati ì seguenti punti per ogni singola articolazi oue:
P e r l'articolazione della spalla, col braccio in abduzione mentre !"a vambraccio piellato ad retto giace un centimetr·o al dì d ietro e al dì sotto dell'acromio.
Per l'ar·ticolazirme del gomrto un pun to allatn destro del· J"(IJccrano; la punta dell'ago deve pent-trare trt1 l'eminenza capitale dell"omero ed il capitello del radio .·
P er l'articolazione della mano, al lato radiale l'angolo della tabacchiera analolUJca, al fato ufnare un punto al limite supet·iore dell'osso pisiforme.
P er l'articolazione dell'anca l'a utore ra ccom a nda il seguente p1·ocesso che di sua invenzione:
Egli stttbil isce dapprrma un punto situato un pollice all"es_te rn u di _una linea che congiu n ge la spina ante ri ore superiOre .ed rl del pul>e. A partire da questo punto che ali mte rno e sop ra il capo del femor·e vien tirata una lmea fi n o alla pat·te esternA tfel gr·anrfe e linea si diviJe in quattro parti; nel luogo d'unione tra fJuarto esteruo ed t t r e quarti rnterni di qu,.sta ltnea sta ti punto dove l'i deve infiggP. r e l'ago. Lo c;t rurnent o deve P_enetr ore in modo che diretto flll't>slerno della 1111 ea sopra rtcordata vada ad u r·tare contro mentre l'•1rto aiace in estensione e il ma r gine inter no del pie i e sta in dire;ione verticale.
Q uP::.ta regola \'&le pP.t· la posizione del trocantere nella linea dt Roser-Néfaton, ma se da questa il l!•ncanlere è spostato deve deviai'(' il punto esterno della linea di direzione nello ;; tesso verso come si fosse spostato il capo del femorP.
Pe r l'articol azione del gino cchio l'autore stabili sce un punto nell'angolo che si trova tra il m argine superiore della tibia ed ti legamento proprio della r otola .
P er l'at·licolazirme del piede indica un punto alla parte
Chirurgica
del piede imrnedralamente sul davanti del malleolo a questo nuovo coucello, il chÌI'UI'go può rrvol;:reee tutta la sua attenzione ed il suo lavoro ul trattamento della stessa le:Jione ce r eb rale e questo tral_già sempliflcato dal modo di cornprend•·r·e le co ndrz wnr della pPessione co r•ebrale sar ebbe oramai nellariete r minalo e r•egolato da normP, qualol'a !'!ulla rnorlalltà della c ura non l'eguasse la questione tuttora l-<8 le ferite del cervello debbano essere t ra ttate 1·ornc le lesiOni ui qualsra"i altro o r gano o riehiedano quulche proces"o.
10 ; si con tro l'astra g alo, si tr Pne l'ago un poco indietro per poi la pun ta tra la puleggta dell'a stragal o ed il malleolo. .
A ·'om pletare !'ic;tr·uzione sul lecnicisruo di que,..tll terapta l'a utore raccomanda di l'intezione Assoi lentamente per es 10 :zr amuti in cinque mi nuti.
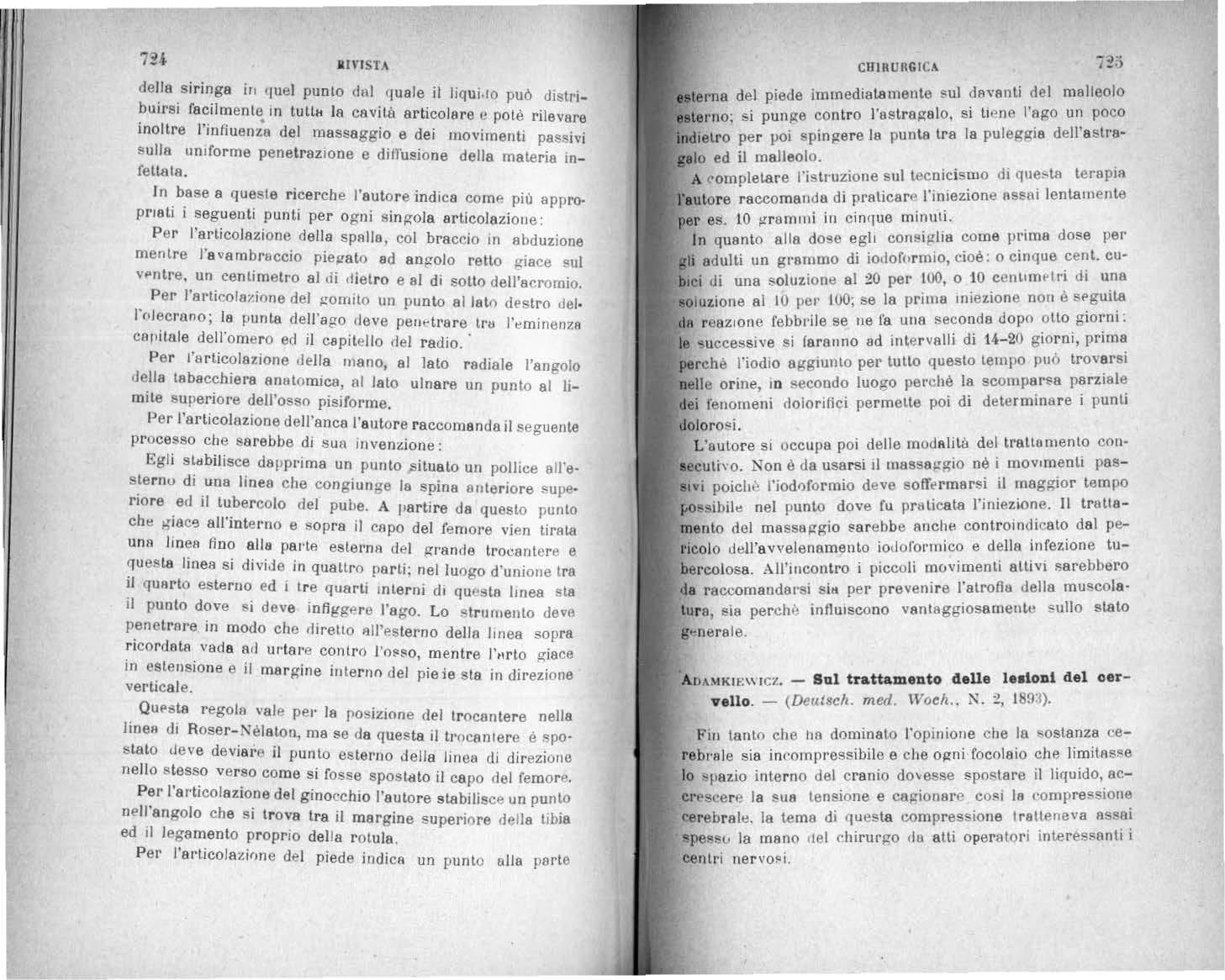
In quanto alla dose eglt consij!lia come pt•tma dose per gli adu lti un grammo di iodoformtO, cioé: o cinque cent. cubrci di una soluzione al 20 per tOO, o 10 centun.-tt•i Jr una sotuzione al IO p1w 100; se la prrma rniezione nou é sPgUita dA r eazrono febbr•ile se ne fa una seconda dopo ullo giol'ni. le .,uccessive si faranno ad intervalli di 14-20 gio rni, prima perché l'iodro aggiunto per tullo questo tempo può trov a rsi nell e o ri ne, m '-;ecoudo luogo pet·ché la scomparsa parziale dei fenomeni clolorifici permette poi di determinare i punti dolorosi.
L 'autore si occupa poi delle modalità del trattamento conaecu ti,o. Non è ùa usarsi ti né i movcmenli pas@tvi poichc• l'iodl)formio deve soffe rmarsi il magg10 r tempo nel punto dove fu praticata l'iniPzione. Il traUame nto del massaj:!gio sareb b e anche contr o endicato da l per icolo Jell'a vvelenamento iodol"ormico e della infezione tubercolosa . All'incontro i piccoli movimenti allivt l'arebbei'O da s itt per prevenire l'atrofia della muscolatur a, t:ia perchP infturscono vantaggiosamente -.ullo stato g.. nera le.
'A o .\ MKI E\\ rcz.. - Sul tTattamento delle lealonl de l oervell o . - (Deutsch. med. Woch .• N. 2, t S!l"l).
Fut tanto elle IlA dominato l'opinione che fa c;osta nza c·erebr·Aie sia inC'ompr·essibile e eire focolaio che lo ... pazio inte r no del c rani o do"esse spo!'\tare il liquido, acCI'P"re r e la sua tensione e cagionarf' cosi la c·ompressione C'erebra le. la tema di questa compressione lralteneva assai «pe st• la mano c!Pl chirurgo eia alti operatori inLeres!':a nti i cenL1·i nervo!Oi.
Pe_rcin èominava in prima lmea il pensiero della fem-wue del hquulo cerebr?·<>pir!al", in secondo luogo il chirurgo door·cupar:-r th allontauar•e il focolaio c·he limitavn lo spazro necessario Quando por tt lediante trapanaztonP ··d elevazione Ri era a 'luesta necessità , l'attenzrnue era al lora sol tanto riv<> lla alla sLessa lesione cerebralr• c procede'a alla dalersione ed alla medieazione d111la ferrla colle norme che dalla !:-lcienza e l'esperienLa erano slat•· rieonosciute opporluue per· la cura delle ferite in gen r·ale. E beu naturale c·he cowpletamente mutata ta curn dellr• lesioni cerebralr, ora eire si sa non essert> la del C»l'\'ello ni', rl hquor cerebrale suscelltbtle dr forte ter.sione, e per dr pru e accertato che o •ni foc·olaio inlra c..-aniale cnmpenetru la fosse di cera ed al hrtuido spo>ila to da una r·ornpr·css rone anche minima !"<i e•tuilibr·a enlranJo rrelle ,ene dd c r anio.
Ora i chiru1·ghi nou leliJono nò la compressione corf'br!lle nè consider·ano il focolaio urtracrauico quale del!; compressione ruu lo l'i gua r dano unicamente , ome corpo estranee> Ir ritA la Rost.unza cerebr•ale, oppu re m causa del suo volume l'isYe;:rlra rwlla sensib1le mas:::a del <'en-e'lo i cosi detti fenomem di compr essione.
I tanto noi sappra m o t'he, non soltanto per tu delicalei.Za della sua istolo;:rictt, il tessuto nervoso occupn uo fra i va r r tessuti, ma anche per t'all(1 grado d1 ll'ltta bll1ltl fì:;:io logi1·a inlluenze esler·ne, ed 1111 [l!'in-
CB IRURC.II:A
ciptn f'lementare di fisiologia e' come il les'-ulo nervoso sio in special modo eccitato da chinu<:i.
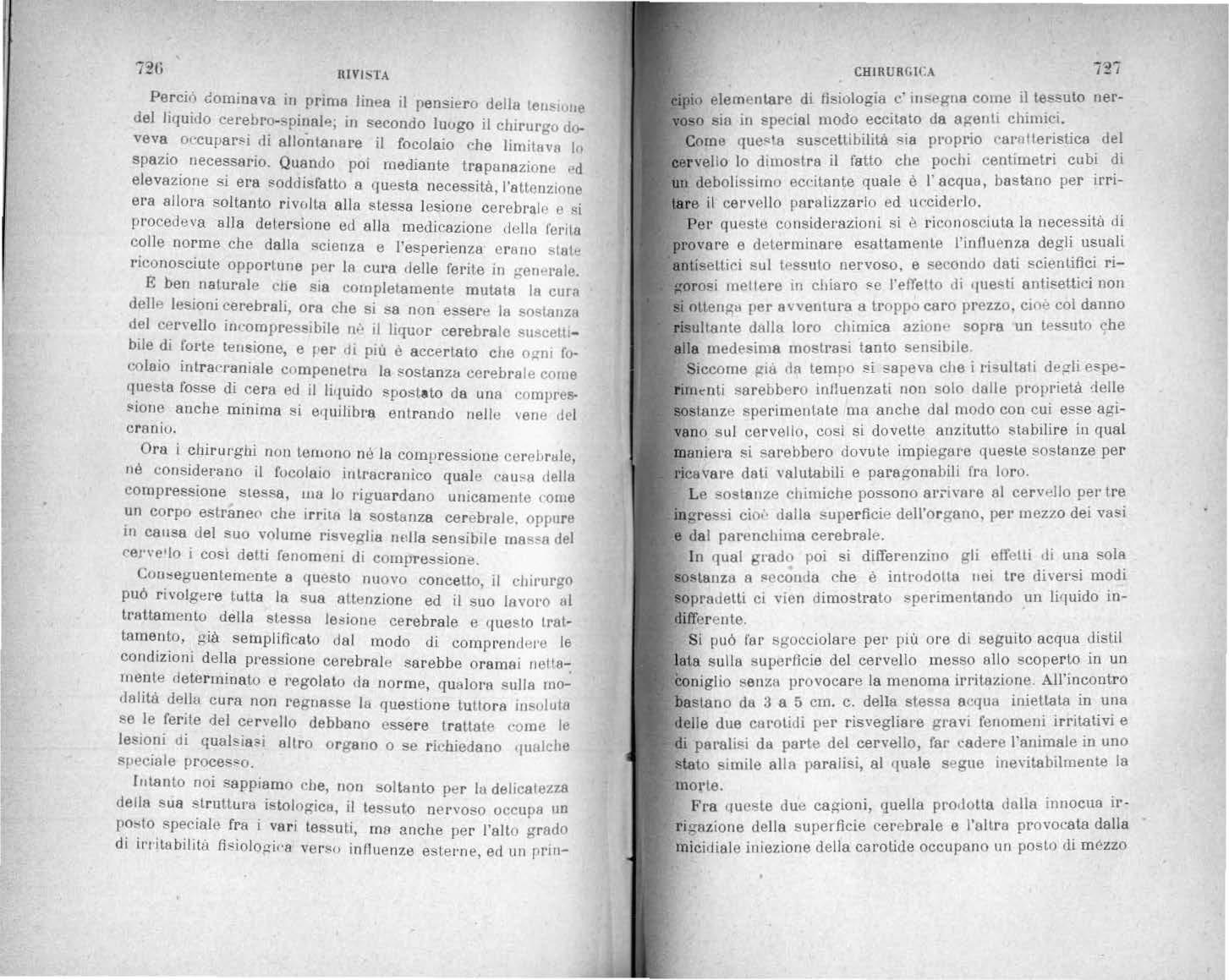
Com e que-.ta suscettibilità pt'oprio c·ar·•llleristica del c er vello lo il fatto che pochi cenltmetri cubi di Ull eccitante quale 6 l'acqua, bastano per irritare il cel'vPllo paralizzarlo ed urcidcdo.
P er' quesLa considerazioni si riconOS<'tut.a la necessil<'l di ppovat·e e determiuaee esattamente l'rnlhrf'nza degli usuali an tiseU1ci sul lt>ssulo nervoso, e t=:erondo dali ri1-{oro"i mf'ltere 111 chiaro !"e l'eiTetto ,J, que!';ti antisettici non !!i otteng11 per 8' vemur·a a troppo caro ctnl:' col danno r isu ltante dulia loro chunrca azron•• sopra un che a lla medesima moslrasi tanto sens1blle.
Srccome rln tempo si sapeva che t r·i"'ullati degli Psper irn .-nti :-;arebb('ro inJ!uenzalr non dalle pr'OJH'ietà rfelle sostanzt-J sperimoulale ma anche dal modo con cui esse agiva n o sul cerve llo, cosi si dovette anzitutto stabrlire in qual m anie r·a sarebbero dovute impiegur·e queste ><ostanze per r icavare datr valutabili e paragona!Jili fl'u lnro.
L e clnmrche possono ar:-1vor·e al cerv••llo pet· tre cio•· dalla super ficit> dell'organo, per· mezzo dei e da l par«•nchuna cerebrale.
In qual grado por si differenzino gli oflelli oh una sola so!"<la nztl a !"<l'COn la che è int1·odotta 1101 tre di veesi modi sop radelll ci vien dimos tra to !,opertmentando un li'tuido jndifft·r ente.
S i può far sgocciolare per· piu ore di segutto acqua disLil lata sulla sup(•rfìcie del cervello messo allo l:iCOperto in un oo niglio senza provocare la menoma irr·itazione All'incontro b a stano da 3 a 5 cm . c. della stessa a<·qua inietlala in una •Ielle due CIU'Olldi per risveglia1·e fenomeni irrilalivi e di par'Sii!"<r da parte del cervello, far· t·adere l'animale ill uno sunile alla paralisi, al quale s•'gue ine"ilabilroente la m ot·te.
F ra «JUl'1'1te tluu cagroni, tjuella pt•odolta dalla mnocua irr ii!AZiOIIe della superficie cerrbrale e l'allra provoca ta dalla micidia le iniezione della carotide occupano un posto di mézzo
RIVI" fA
.. neui delle uJit>zioni falle colla sle!:'sa nel pArcnchima del c·ervello
Se si pratica una iniezione, introduccu lo J"ago ii una di Pravatz direllamente nel cervello dell'animalP . . SI rmunfestauo f,•uomeni più o meno vivi di irritazione rerebrale, tra i quali cpecialmenle nbtagmo,mio:;i,contrattureecc. che poi si lasciando l'Animale m condizioni nc•rmah
Per·tanlo, SICcnu.e razione delle sul parenchima cerebr·ale i-- interamenlP specifiCfl, e ogni f•·rita del cervello non é allr·o che una soluzione di continuo del purenrllitna , e per·c·iò la disinl't'ziuiH' delle ft!l'ile del cervello corrJc::prHHie all'azione delle applicate sul pur·enchima po-to a nudo, coc::r influenza <IPi dic:infellanll sul ciel cervello avremo dati poc::1tiv1 soltautn da quell'espe r ienza che stabilirà nel modo il più c:icuro le proprirtà di quelle sostanze per• diretto contatto delle ste"se col parenchrma cerebrale.
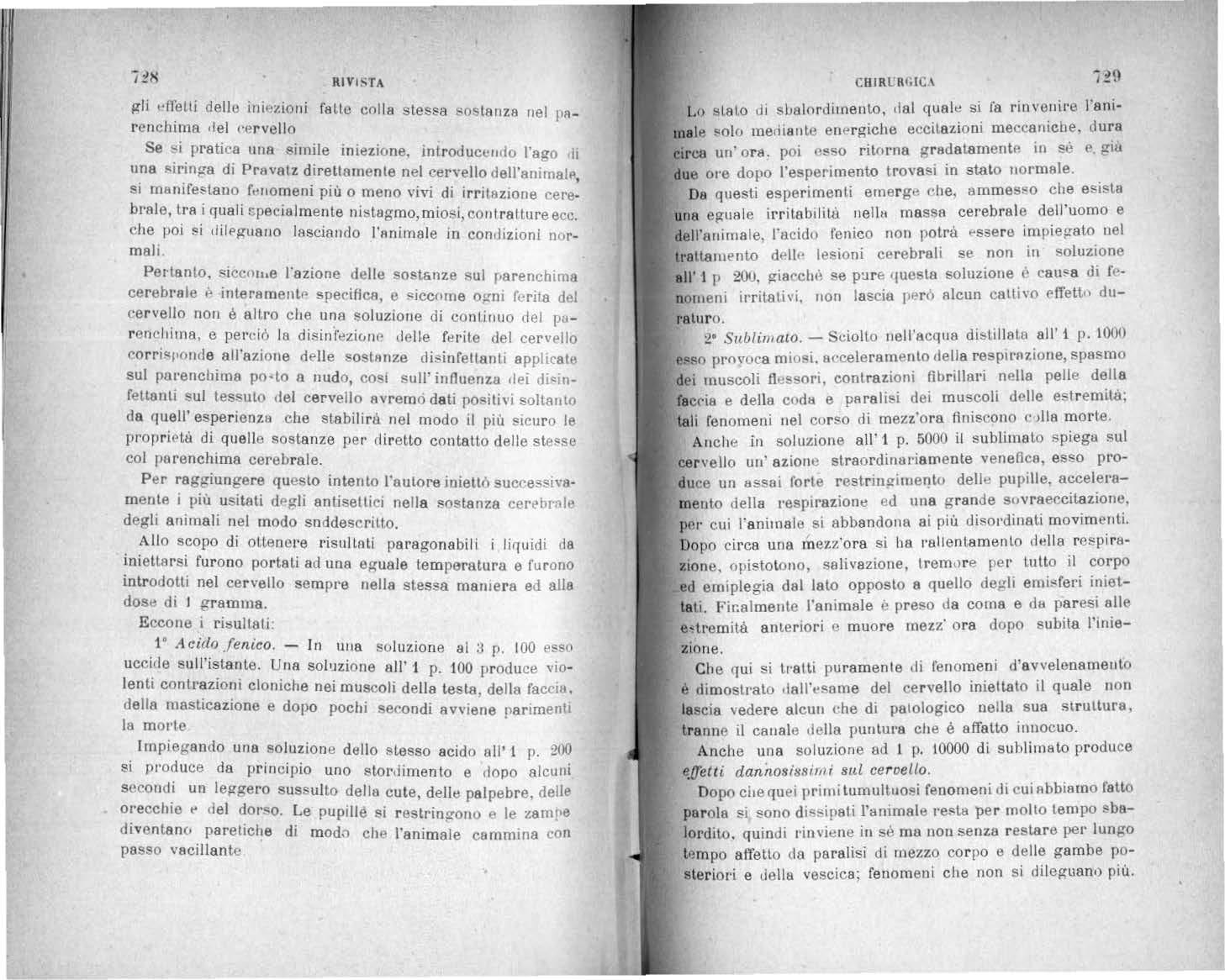
P er raggiungere questo intento l'autore iniello mente 1 piu usitati antisettici nella l"nstanza cert?hnle degl1 animali nel modo snddescr1tto.
Allo scopo di otLenol'e r•isullati paragona bi l i i l irruidi t la iniettarsi furono portali ad una eguale temperatura e furono introdolli nel cervello sempr·e nella stessa ma1uera ed alla dostl di l gramUla.
Eccone i ri:mllal1
1• A ciclo .fenico. - In u11a soluzione al :i p. 100 esso uccide sull'istante. Una sol1Jzione all' 1 p. 100 produce viOlenti contrazioni cloniche nei muscoli della testa , della faccw, della masL1cazione e dopo pochi serondi av\'lene parimenti la mor·te
Impiegando una soluzione dello Rlesso acido all' 1 p. 200 si p1·oduce da principio uno stoP.!imenlo e dopo alcuui secondi un leJ{gero sussulto della cute, palpebre, delle or•ecchie e de l dorc::o. Le puprlle si restrin!!ou o " le zamr•e diventane. paretiche di modn cht> l'animale cammina con passo vacillante t• Sz,blimaco. - Sdollo uell'acqua di&llllalu all'i p. 1000 e;o!'lo provoca min'H. af'celeramPnto della respn·Azione, spAsmo dr i muscoli tlt'!!!:IOrr, cont razionr Cibrillari nella pelle della fa cria e della e paralisi dei muscoli delle estremrlà; tal i fenomeni nel corM di mezz'ora finiscono <' 1lla morte . An che tn soluzione all' 1 p. 5000 il sublimalo spiega sul cer ,·ello uu' slraordinar·iamenle veneflca, esso prod uce un assai forte restriuaimento dellP pupille, acceleram ento della •·espirazione una grande sovraeccitazione, pr1· cui l'animale si abbandona ai più disor•dinali movimenti. Dopo circa uoa mezz'ora si ha r·allentamento d..-lla respirazione. opistolono, c;alivazione, lrem,) r e per· lutto il corpo ed em iplegia dal Ialo opposto a quello de:.:li inletta lr. Fi1:a lmenle l'animale ..- preso d a coma e da paresi alle e·lremilà anteriori c muore mezz' ora dopo subita l'iniezio ne.
Lo stAto ùJ sbalordimenlo, dal quale si l'a rinvenire l'animal e med1anlc> energiche meccanicue. dura circa un· o r a. poi I'S<;o rit()(•na gradatamenlP 111 sè P giu due ol'e dopo l'esperimento trovasi in stato normale. Da questi esperimenti emerg"' dte, che esista un a irritabilità nelltt massa cerebrale dell'uomo e de ll'anirna le, l'enico non polra tosse re impieg-ato nel tra llam enlo dPIIP lesioni cerebrali se non in soluzione all' 1 p 20U, Se p:.rre I(UCSla SOluzione t'• cau"a di fo •· no utenl n·ritati' i, non lascia pPrl) alcun cattivo rffetto duratur o.
Cho qui si t•·atti puramente di feuomeni d'avvelenameuto e dimostralo olall't>Mme del cervello iniettato il quale non lascia ,edere alcun l'he d i patologico nella sua slrutlura, tra nne il cauala della punlu•·a che é affatto innocuo.
A nche una soluzione ad L p. 10000 di suhlimalo produce e,(fetti danr10sissi Ili i sal ceroello.
Dopo che qut.>i pri1ui lumulluo<>i fenomeni di cui Abbiamo ratto parola si sono d1 <.;:-ipati l'ammala l'el"la per molto tempo sbalo r dito. quiod1 •·in viene in se ma non senza restare pe1· lungo lo> m po all'ello da paralisi di mezzo corpo e delle gambe poste r ior·i e ùella vescica; fenomeni che non si dilcguaM più.
L'esame clPI cervello non ci ;.;omministra al cun dHto lllaleJ'iale pP.!' lo che anche per queste deve ammPlter•e l'azione del sublitnato.
QueRti esperimenti c'insegnano che il subltmato. anche in soluz1one attenuata all' 1 p JOnOO. danneggia mollo 1 t:er\'t>llo: quindi il suo impiego nel trattamento delle lesiom c ...reb•·ali é da ri!:!'ettarsi.
:3" Acido bortco. - Per il trattamento delle ferite •lei cervello 11 lt·rzo da mettersi in r1uestione è l'acido boriro.
Le ìni•·zion1 d'acido bor1ro nel ce rvell o ci banno fatln , edere che la di questa sostanza alla p1·oporz1one normale del 3 p. 100 non altera per nulla il se si ec<'ell un f)nalrhe fenomeno iJ•ritati vo, nessun fotto abnorme si man1festa in seguito ad iniezione di acitlo borico; l'animale tollera queste iniezioni senza risentirn c il benché minimo danno il risultato dei suddetti sperimt>nli abbittmo che pe1· la disinfezione delle ferite cerebrali l'acido l't>nico e più t\IICo r a ti sublimato !,Ono da J'ifìutarsi. All'in rontt·" l'acido borico al :l p. 100 può essere usato ::;enza alcun pe1 icolo. Sulln rruestion•· altri mezzi antisettici pe1· d cervello H Mpr·a qucJI) chr potrebbe èlire CfJuirttlente cerebrale di mezz1, equivalente che sPmbra variar'•' da uu antrst'!lico un altro, l'autore non si pronuncia in merito pt'rrhé e <>a questione non potrà e>osere r1<>oltu che con allr1 e!';perimentì da nella maniera -uddescrilla.
1 futlll·i spermtenti in ogni dimostreranno come ri hanno dimostralo quelli giu fatti. che J'antiseps1 del cen-ello richiede norme, e che se queste >'i tra<:curano !li fa correre Al malato 1 ['ili gravi pericoli. E l tnberooll •otto - outanel dolorosi.- PAOL Ro'. -(Journal de MMecine et de Chirurgi.:, gennaio 1893).
Si dà il nome di lubercoli sotto-cutanei dolorosi a piccoli tumori, mobili, clastici, risiedenti nel tessuto cellulare sotto· cuta neo, e caratter iz zati ad una cer·ta epoca della loro e voluzio nt• da dolori la cui intensità aumenta coll'età del neopla s ma. Ma tanLa é la diversità dei giudizi emessi sulla str uttura islologica di questi tumori che si pos!louo distingu e rt1 ben otto opinioui ben nette su questo sol-{getto e che s ono le seguenti. l solto-cutanei dolorosi sono:
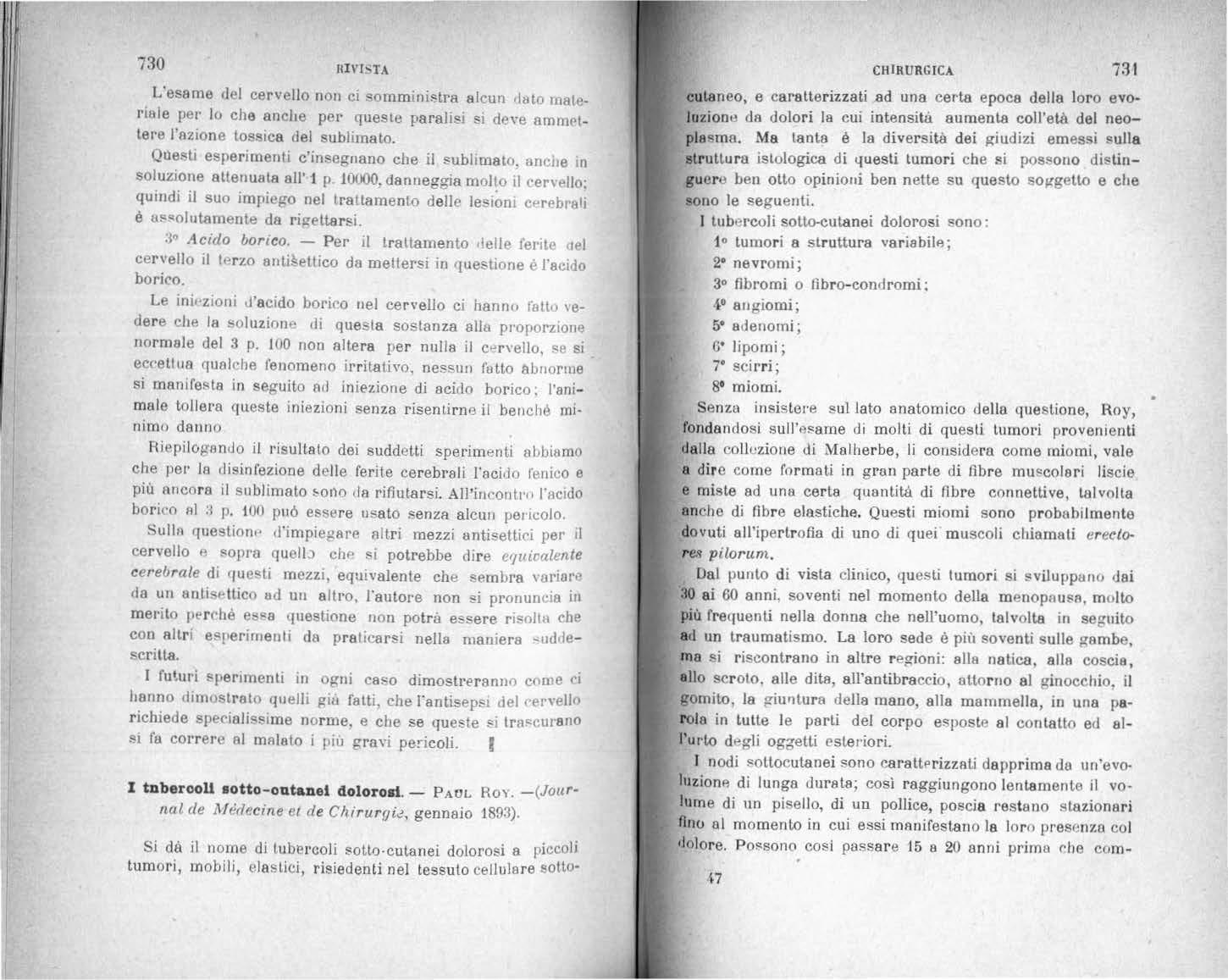
1° tumo r i a str uttura variabiiA;
2• nevromi;
3° fibromi o fibro - condromi; i-0 augiomi; s· adenomi;
(i• lipomi;
7" scirr i; l nodi soltocutaoei sono caratlPrizzati dapp r ima do un'evoluzionA di lunga durata; così raggiungono lentamente il volum e di un pisello, di un pollice, poscia r•es tano fino a l moment.o in cui essi mAnifestano la loro presenza co l •l olo r e. PoRsono cosi passare 15 a 20 anni prima rhe comi-7 paia il dolorP. lwnrhé questo il piu spt>""o molto menr, lungo. l caratteri del dolore !>c,no mollo variabili; o r a è un formicolio, ora è un pr urito; al cu ni malati pat•agonarono le loro solferenzc a quelle che t•isultuno da una puntura, da un colpo di lancelta .
8° miomi.
S enza insiste1·e sul lato anatomico della questione, Roy, fonda ndosi di molti di questi tumot·i provenienti dalla colluzione ùi Malhe r be, li cousidera come miomi, vale a di r e come formati in gran parte tli fibre muc:colari liscie e miste ad una cer ta quantità di fibre connettive, talvolta anche di fibre elasticha. Questi miomi sono pr obabi lmente do vuti all'ipert r ofia di uno di quei muscoli chiamati ereciore.' pilorum.
Dal punto di vista clinico, questi tumori si gviluppono dai :10 ai 60 anni, soventi nel momento della meoopnusn, m olto più frequenti nella donna che nell'uomo, talvolta in seguito ad un traumatismo. La loro sede é piu soventi sulle (.tambe, ma si riscontrano in altre regioni: alla natica, alla coscia, allo sc r oto, alle dita, all'aotibraccio, attorno al ginocchio. il g-omito , la :ziu•llura della mano, alla mammella, in una parol a in tutte le parti del corpo e!';postP al contatto ed all'ur·to dt>gli oggetti ester·iori.
Il dolo r e si pt con caratteri spectali. Esso non si p r esenta pet• cosi di r e mat con Lulla l'acutezzà che sovenlt in seguito. :'l!on il dolot·e d ell inizio e sopporlabilo, ma oc ;or re, per manifestarsi, che subisca, in I(Ualche modo, unA provocaztone per pat·le di ester10ri. Quando il é tn riposo, qu ando il tubercolo è al rtparo da qualunque urlo, da pre,sione, tllubercolo non e doloroso; ma se sopral!giungo:: un cambiamento nello dd malato, se il lumot·e viene a subire una cotnlH'e!'sione in seguito aù un colpo, a l uno sfr·egumento. dovuto ud un tnovimeuto del malulo, il st mantfe..,ta. So1amentè in "f\f(Uit, il tumo r e diviene sponlauearnenle.
Il piu spesso que!>lo dolor·e si presenta sotto forma di lrafìllure chr. compaiono ad inte rvalli irregolari. Queste lratìl · dol o ros e !:>Ono d'ordinario vaghe, poco accentuale nell'nllz tu. possono raggtungere m segu1to uu p-rado di acutezza cile ù iventa lolvolla tntollerabile. In certi casi pel'ò il lolore é di prima g iunta <'ccessivamenle violento.
Le ir r lldtaztuni d olo r ..tse sono il ptù spe:;so trrc_olart, ti l-<i ra attorno al lubel'colo in una zona mal ct r cosr: r tlla. Ciò costituisce uno dei segui che permeltonu Ii distinguere ti lubereo lo so lto- cuta neo dal ueVI'oma.
La du rata degli accessi e molto irregolare: e::>sa varta da diect minuti a due ore. Gli accessi, dapprima ad intervalli lunghi, aumentano di frequenza iu seguito. l prtmi dolO ti dapp r ima aJ epoche indeterminate, po:-cia
Lutti i l-'{w r rri, più volte al giorno; finalmente gli a ccesst .'hveulatu• cosi frequenti che il dolo r e sembt·a continuo. Ftnché !-('li acc;essi sono lontani gli uni dagli altri, la s alute 1-!en e l·ale non é inle t•essat.a: ma quando essi so:w quasi continui il malato pet·de l'appetito, il Mnno, ca de nell'abbellimento e n ell a trisl<>zza, ec:l il suo sta to gener·ale finisce per f.tl' avementP compromesso
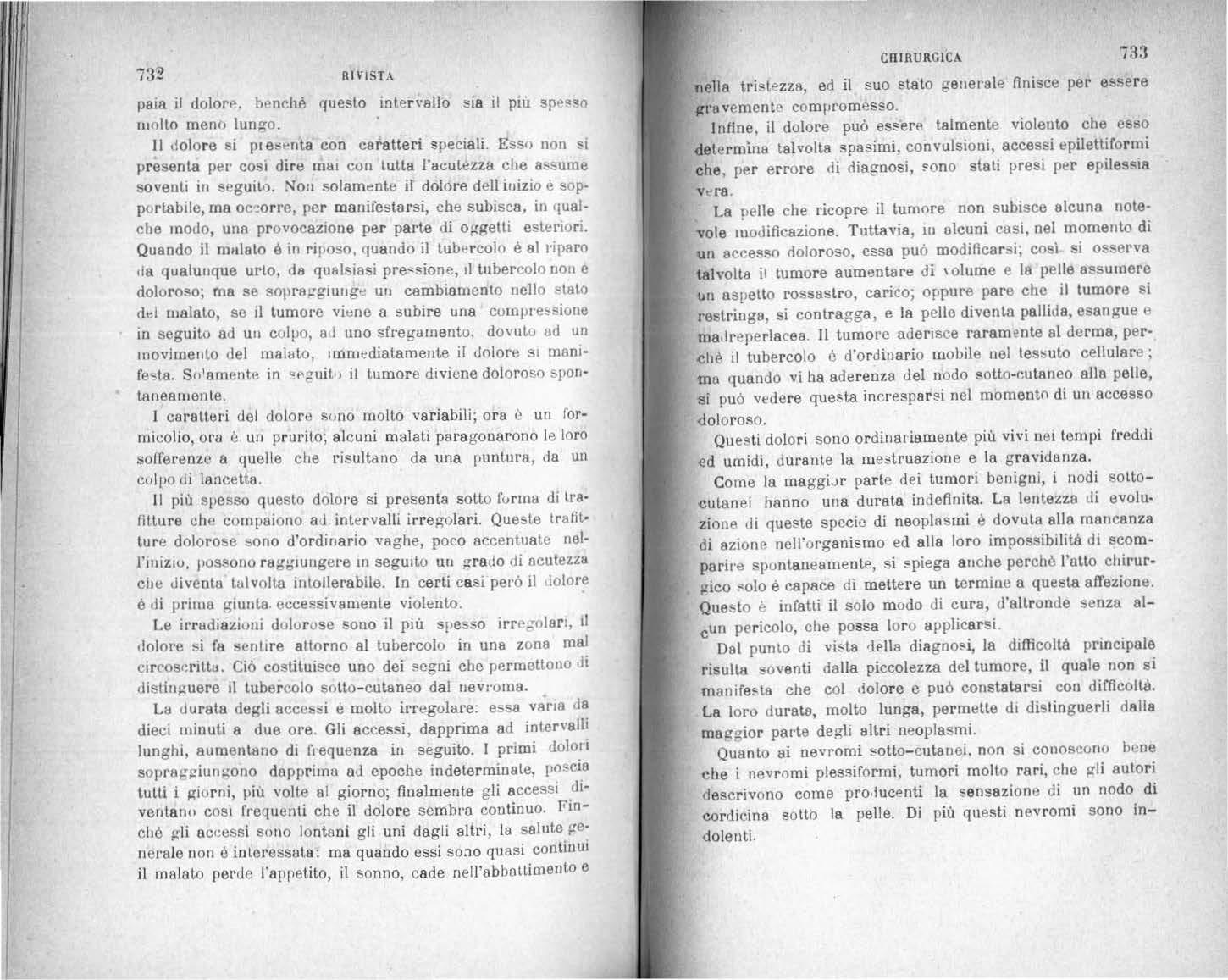
1ntine, il dolore può essere talmente violeuto che esso de termina tal volla spasimi, con vulstout , accessi t!piletlifo r mi c he, per e r rore di diagnosi, slalt presi per epilessta V•·ra.
La pelle che ricopre il Lumore non subisce alcuna notev ole modificazione. Tuttavia, in alcuni cusi, nel momento di u n arcesso doloroso, essa può co!'lì si talvolta il tumore aumentare di ' olume e la pelle assutoere ùll as petto rossastro, carico; oppure pare che il tumore l'estrioga , si contragga, e la pelle diventa pallida, esangue P ma.lrepe rla cea. Il lumo1·e aderrsce raramwle al derma, perdtè il tubercolo è d'ordinario nel cellulare ; mu quando vi ha aderenza del n odo sotto-cutan eo alla pelle, sì può vedere questa inc1·espar !:!i nel momentn di un accesso
Que!';ti dolori sono ordinai iamente più vivi n e1 tompi freddi ed umidi, ùuranle la mestruazione e la g r avidanza.
Come la maggiJr parte dei tumot•i benigni, i nodi solloeulanei hanno una durata inòeflnita. LR lentezza di evoluzione di queste specie di neoplAsmi è dovuta alla mancanza di azionA nell'organismo ed alla lo r o impossibilitA di scomparire spontaneamente, si spiega anche perchè l'otto chirure capace di mettere un termine a quesla affezione. e infatti il solo m odo Ji cura, d'a ltr onde :se nza aleun pe r icolo, che possa lo r o a pplicar si
Dal punto di vista •Iella la diffico ltà princtpale r isulta soventi dalla piccolezza del tumore, il quale non si manrfesla che col dolore e può constatarsi con difficoltà. La lo r o durata, molto lunga, permette dt distinguerli dalla mag gior pa1·te de gli altri neoplasmi.
Quanto ai nevromi solto- cutan ei. no n si conoscono bene che i nevromi plessiformi, tumori molto rari, che autori desc r ivono come pro.!ucenti la sensazione di un nodo di cordicina sotto la pelle. Di più questi nevromi sono indolenti.
Sì os•er vano lungo i cordoni nervosi t um ori che possonoel'lserP molLo dolorosi, ma questi tumori, denominali altre volte oevromi, non sono punto costituiti di tessuto nervoso n eo fo rmalo . Essi sono tumo ri di connett ivale, nati a spese della guaina e non a spese dei tubi ner vosi. Si tratta in rea lta di fib r om i. di mixl)mi, o di qarcomi di :nervi. La parola nevroma é assolutame n te impropria per designare ora questi tumori.
Delle perlol•UU· - NOE L HAL LE. - (Jou r nal de M hlectneet de Chiru r nie, febbraio 1893).
Il doUor !\'oél Hall é ha studiato sotto questo titolo i rutti d'infiamma zione perivel'lcirale che egli ha potuti) osser\·are in questi uliimi anni alla clinica dell'ospedalE'
Que.. ti cast di perioslite si dividono in due gruppi : nel pt•imo la vescica è il punto di purtenza della leqiooe; la cistile vtene complicHla da pet•icisLite. Si tratta allora d• pericistite cera, d'origine vescica le. Nel $eco ndo gruppo l'intestino o qualche organo pc! vico é stato la sede della malaltta: aderenze, focolaio purulento, encislite, tumo r e, per forazione vesckale, lutto ciò si può risconlt·are ai!COt'a in quest" pericistitifalse d'o r igine intestinale o genitale.
Le pericistiti vere possono presen tarsi so lto varie forme: la prima é la ro ..ma cronica se1nplice, scler os•(o sclero-adrposa. B uno lesione fr eq uente, comune c1uasi nelle sue fot·me attenuale; poche cistiti croniche non ne sono accompagn ate a •1ualch e g rad o; tra il periloneo e la vescica, invecr del tessuti) cellulare normale, esiste un o strato di tessuto libroodiposo, il cui spessore può raggiunge r e un centimetro e che contiene sovenli \ene voluminose.
Que sta produzione altorPo alla vescica non è un fallo I!'Oiato, é un caratter e a 1tatomico g•• ncraledelle lesioni c r oniche nell'apparato urinario ed è frequente attorno al pielo-n efriti antiche. Questo tessuto può fo r mare con la sua ma ssa veri tumori peri-vescrcali , alla parte super iore od anterio r e dello vescica, o sulle parti poslero-laterali, alla sua base, atto rn o all'u r etere
CHIRURGI CA /35
<> alle vescicole seminali. Queste masse potrebbero conl'tat a le clinicR m en te e fo r se son o gtt\ state consit:erate com e iperlrotìe o neoplasmi della prostata o vescicoliti rronicbe . Però queste di peri cist1te no·n sono esclusrve all'uomo; si pos"ono pure riscontrare nella donna affetta da cistite cronica.

Le lesioni di per icir,.tile c ronica sono so venti co mpli cale da suppurazione; si co ns tatano a llor a uno o più fopurulenll encioo;tici in mezto ul tessuto sclero- adiposo ed tlde renze pet·i-vescicali Essi r isiedono in diversi punti de lla r egione perivescicale; il lo r o contenuto è o ra inodor·o, ora di orlo re fetido, "enM che per c iò vi sia comunicazione con la vescica. Dell'evoluzione di questi ascessi nulla s i può dire di pr·eciso, pet·chè essi il più sovente non venguno const.ulali che all'au topsia.
La per i<'istite suppu rato con perforazione costitu isce un secondo g ruppo che si distingue dal precedente per un car•atterc impor tan te. L'ascesso peri-vescicale, voluminoso, è tn ampia comunicazione con la vescica. Un lavorìo ci peritonile è avven uto all'intornodella perforazione; molte porzioni inte tinali sono ade •·cnti in ques to punto. Esse formano la parete de lla ca vita dell'ascesso e c ostituiscono con lui una massa più o meno voluminosa , tu mo re perivescicale solido, soventi percellibrle colla pa lpazione addominale. Pare cbe la fis tol a vescico - intestinale non succeda spesso a r1ueste lesioni d'ori.gin e vescicale; e cel to al contr ario che il più spesso la comunicazione flstolos a è il ris ultato di una lesione intestinale primith·a interesl'lante secondariamen te la parete vescicale. perfor·azioni pato log iche della vescica sono di natura d ifferente: le une avvengono in corrispondenza di una cellul ll vescicale, le altre s uc ced ono a ciò che si chiama l' ulcera per fo r ante semplice, analoga all'ulce ra de llo stomaco. Qualun r1ue sia la causa ùella per forazione, essa produce ordinariamente, eccello il caso di pe rito oile acutissi ma genera lizzala , una per itoni te c ircoscritta ad esi va.
La pericistite pu ò anche avere un'origine tubercolosa P. n eoplastica. Come le infiammazioni semplici, la degene razio ne tubet·colosa della vesctca é complicata da leswni peri- nella c1stite lubercolosa si osserva p ù sov. ·nte l& pericistile flbro - lipomato:::a; essa é c o stante n elle forme lente ed antiche: la vescica, distrutta dali"ulcerazio ne nelle sue parLi interne si rinforza con uno strato flbro- g ra l'soso peritoneale. gruppo d'infiammazioni peri-vescicali si po ngono le peri-cistiti d'origine intestinale o genital e. In questi casr il puulo di partenza della lesione, la sua s ede principale. sono all'infuor·i dell'apparato urinario, nell'inlesliM o negli organi genitali interni : ti cieco, l'appe ndice cecale sopra t utto. l'S iliaco, gli annessi uterini nella donna, sono i pun ti più frequenti della lesione.
Questa per1-ciilite pu6 d'altra SUN u1·are ed essere con!'O " iata a perforazione.
Lo pericislite puo risconlrarsi egualme nte nel cancro Mila vescica e presentare lesioni mollo a •1u elle o r& indicate.
Anatomicamente. si può costatare in vicin a nza della vescica un tumore solido ad e renttl, un focolaio rii $ùppurazione encislico o comunicante; lesione è più sov enti di natura neoplasica e termina frequentemente con una fi s tol a vesrico-intestinale.
Clinicamente, si consta!,ano sintomi di cistite più o meno accen t uata, talvolta ematurie o una piouria mtermi ltente, l'evacuazione di fr·ammeuti n t:> op!asici con le orine. in vicinauza della un tumore pelvico accessibil e a lla palpazione addominale, alla I'ettale o vaginale. :"'ella serre dei sintomi nulla di r egolare, nulla di sistematico, e ciò é causa di difficoltà di d1agnosi soventi considerevoli. St é riscontrato anche una voluminosa raccolta sanguigna anteuterina enci<>tica aperta nella vescica e simulante un neoplasma voluminoso od ancoi'ft l'ova r io suppurato comunica nte contempor aoeamertte coll"intestino e colla ves cica.
Ciiirurgica
Ba lla d1&gno•l d!t!erenzlale delle malattie dell'oreoohlo medio e del l&berlnto. - SANKAU, - (Are/t. fùr Ohrenheik. e Cent r alo. fùr die medie . N. 2, 18!13).
11 Sankau rac comanda un metodo per distinguere lo mu· Jat tie delrore cc hio medro Ja ()Uelle dell'interno, che afTt! rllla <.icuro. c11 nsiste nell'applicare le due estremita di duP. otoai condotti udit0ri esterni della persona da mentre un diapason in vibrazione ò posto sul vert1ce del cran io di quella. L'esaminatore ascolta, flnchè il dia?ason per mezzo dellP due estremità anteriori del dopp10 otoscop10: I J'i!'lulluti ottenuti dal Sankau con questo metodo sono 1 !'eguenli. .
Esaminando pet'snnf\ con l'udito no r male si percep1sce egual tono da ambo i lati cior'• si crerle di seotir•e u.n solo. Nelle malattie dell'apparecchio rondullore del suont l'esaminatore raccoglìe dal lato dell'orecchio ma lato un tono più forte . se la toalallia è bilaterale il tono del lato maggiormente malato i> più l'orte. Nelle malattie clell'apparecchio senziente il tono del làto molato i· più debolf', nel!? malottie de i due lati (• più debole dal lato rhe è malato PIU gravemente. Se, avendo l'esame con lo specchio dimostrala l'esistenza di una roalatlia dell'apparato conduttore, l'esamtl cor due otoscopi indi ca invece un tono mino1·e dal Jato malato, c1ò vuoi dire che il Jaberinto é già attaccato. P er decidere nncora se in quell'orecchio che presenta una malattia r!Pll'apparecchio conduttore ne pure una l'appare r chio senziente, il Sankau pone in ad del Lucae, la prova della di,·ersa percez10lie ()UanLilaltva degli Hllì e bassi toni.
MAURICE RICHAROSON. - Stntomt &cuti addomlnaU dentllmmedl&ta. operazione .- (T/te Boston Medtcal and Suryical Journal, gennaio 189:j),
In quali circostanze è necessa r ia l'i mmeditt ta Quali 80110 i sintomi che appat·si subituneamanlo 1n persona

CIIIRUU!;[CA
precedentemente sano indicano lesioni '}Uasi :-.cmprP fatali senza il soccorso chi rur gico?
Prim a di rispondere a queste domande l'autore osserva che nel 18!)1 di 300 operati, il maggior numero di morti avvenne per peritonile, e nel 11:192 si può calcolare un morto per tuU1 i generi di operazioni , su tr·o morti per pe1•itonite, esdu!>i 1 casi di peritoniti che non potevano assolutamente guarire con l'operazione. In questo lavoro invece, egli prende a conside rar e solo quei casi nei qualt non v'era alcun indiziO pl'ecedenle di malattia addominale, e nei 'IUali i l<intornt allarmanti sono comparsi senza cagione apparente, in persone• antecedentemente sane, che potevano guarrre con l'mter vento chirur·gico , escludendo i casi di fer·ite d'ar·ma da fuoco e d'a rma da punta, sui quali non v'è più divergeuzfl rl'oplnioni intorno alla necessita cruna lapraolomia e!'lplor·ativa, ed iuchJuendo i colpi ed allri che non la::.ciano traccia di violenza este r na.
Le patologiche che pr oducono sintomi allarmanti, sono secondo l'autore, in or·Jinc di frequenza. lo stravaso, l'emor ragia , e le ostruzioni acute. Lo str avaso per perforazione dell'appendice vermifol'rne é quello che eccede !'li lutti gli Al tr r prasi insieme, gia cche le torl'lioni, gl'invaginamenti, gli per nastr·ini ligamentosi, non ragguagliano il uumero delle appendiciti suppu ra te Le e morragie per gr·aviùanz e t>Slrauterine, ulcerazioni intestinali , lesioni violentr, danno pur·e sintomi pericolosi, come li da J'estravaRO settico per ulceri e pe r rottura cielltt cislifelle !l e
Qualunque sia la cagioce, nello s travaso settico la vrla e m pericolo imminente, e le o re, anzi i minuti sono prPziosi. È difficile fare una preci:sa diagn•>si differenziale fra la peritonite sellica e l'a s ettica, uel pl'imo princtpio, ma ilruedico non deve pet·.fersi io di'>cussioni iu quei m omenti, dovendo badare a quei sintom i che fanno ric onoscere la necessità dell'esplorazione, ed attendere da essa la prima diagnosi, poiché la perilonile settica è quella che ha prodotto il100 o;. dr morti. Le occlusioni d'ogni genere sono quasi sempre mortali se il socco rso non giunge in tP.mpo.
Il sintomo iniziale •' semprd il dolore, generale a pt'lll • cipio, più tardi localizzato, o localizzato fin dal primo istante, spesso esacerbantesi alla pressione. Nel maggior numerò dei casi non manca il vomito che si manifesta o al prrncipio del dolol'e, o subito •lopo, e spesso sino alla fiue; l'assenza del vomito però non dev'esser presa come buon augur io.
Quando la natura tendP a stabilire una perilonite locale• posson o av ers i sintomi locali mollo imporwnti, ma quando l'infezione è estesa, non sr osser"a altro che la tensrone e la d olo r•abil ità addominale, mentre che lo stravaso manifesta con l'otlustlà alla percussione, specialmente ar lati della pelvr.
La limp11nite è pre<'occ nella perilonite diffuf'a, appare fin dall o prime ore, ed é sintomo di grande importanza. S e a questi segni si aggiunge la coproslasi, la dìagn<•si th \'iene evidente, la prognost tnfau<;la. Le alte raz ioni della temperatu ra e del polso non sono costanti quantunque ft•equeuti; il polso acceleraLo è sinl<Jmo pii.l grave della temperatura ele· vata , entrambi servonc a d indicar\! le condizioni settiche, ma spargono poca luce sulla diagnosi. Le perforazioni settiche si annunziano con dolor•e, vomito, timpanite, coprostasi e sintomr le occlusioni si manifestano con li stessi segni meno i gene rali , nelle emorragie v'è dolore ('d esaurimento.
11 primo e pitl importante sintomo f. il dolore, ed il suo carattere di subitaneita, persislenza, acuzie, l'essere difluso a pl'incip to e locAlizzato piu tardi, l'essere n.m 11imile ad un c. ampo iotesti011le o ad una colica, ma d t tal natura che non inganna né il malato nè il medico, questo è dolor e tale, che se è accompagnalo dal vomito o da un principio di collasso, l'ichiede imperiosamente la laparotom ia.
Dall e statistiche delle ovariotomie normali e di awHti simili rhmlta che la mortalità è ID1110re ladùove non si deve far altro cht> 11prire l'addome. Spesso non é ne cessaria una molto estesa esplorazione, ma basta un piccolo taglto per vedere se esiste una lesione seria; l't!ruorragia, la fuoruscrta i.l.O RIHSTA di feccie, gli allorcigliomenti inlestinali, l'intuc;suscezione, lo strangola mento, in :uce immediatamente, onde se v'era una 1·agione di esplot•a r e, l'operazione s at•à giustificata. allrirn ••nti, il danno dell'operazio ne s arA lievP Malgrado ciò, l'autore è d'avviso che Ria no da C•)lldannare le laparotomie inutili e frettolose, e c!1e l'esplo raz ione addominale non sia esente da p C' ricolo, ma che il pericolo sia nelle mani di un o spe1·imentato operatore, il quale reslrin· gera ai minimi termini il num Pro delle esplorazion: inutili.

L'autore ammelle che in mol t i casi i sint(Jmi allarmanti possono p r esto calmar·si, ma d'altra parte, se sr deve allen· dere dall'ulter1or·e corso de l m ale l'indicazione dell'ope ra· zionP, o se assolutam ... nle p rima de ll'oper·a zione st vuoi far la diagnos1, si può rinunciare alla c ura chi t• urgica nel maggior numer·o dei c asi. Su 100 infe rmi di peritonile acuta con dolore localizzato, vomito , e collasso, il mal o> ca· g ionato dalla la porotomia esplorati va sar à infinitamente piccolo, par•agonato al gran bene che essa può produrre nelle pl'ime 12 ore in cu i t sin tomi allurmnnli si s.ono mani·

:U. BRIGG. - L& oura degli a•oe..t oerrioalt • e nza ol · oatrioe . - (The Bo11ton. Medicai arul Sw·uica l Journal, ISH:l)
Un g iovane di 2(i a nn i, con una voluminosa ghawdola lin· fa tica suJla regi one cer vicale s uperiore, dolente, fluttuante, con pelle arrossibt, era stato cura to per un mese ron iodur·o di potassio "' mercurio Mnza giovamento Altrf' J:!lan· dole alla base del collo s i avviavan o alla suppurazio11P.
L'auLo r e fece u11a pi ccola ttpe rtur a nell'ascesso, fol'bi la cavità ascessual e con un piccolo r·aschiatoio, la lavò con si ri n ghe di creolina, e la tamponò con gat·za al sublimato.
Dopo un mese le alt re glandole e ran o suppura te, e l'autore incise i d ue punti di pe ll o più e dopo l'usci ta di grande quantilà di pus, r ilevò con lo spPcillo che dalla base del collo tln dietro l'orecchio v'era una gran c&vilil a scessuale. Ripetè le siringhe di creolina, imbottì il
f UII:URGICA 'iii
(·a,·o con garza a '-Uhliu in 1ueslo moJo a med i,·ar ginrnalmt'nle il pazi .. nte, e "d nfZnì mPJic'azione 1·i· mossP col ras chialoio de'i 1·iccoli rezzi di ll'anglio, iìno a che dopo un altro mese il r n!:'chiatoio non trovò più c;ostanza g landolosa da estrarre.
Intanto la cavità ascessuale suppurava :::empre, e Io specillo a cce1•tava un lungo seno che dalla sommita del collo scen · cl e \'A flno allo sterno La cavitil in sef::uilo divenne sempre più il seno fu ra schiato, lfi\'Alo, e percm·so cla un dren aggio in altre due sr chiuse, lasciando tr·e p1ccole cicatrici stellate.
Un giovane di 28 anni aveva u11 eno r me asc esso nella regi one anlt>riore del collo, che r·1empiva tutto lo spazio com· preso rr·a In mAscell!t inferiore destra f' la clavi cola.
L'a utore ec:e,zm una piccola puntu ra in linea di una de l collo, ne usci gran de quantità di pus. 111di lavò il cavo con d1 creolina, della garza al sublimulo, e dopo alcune setLtmane di quec:ta semplice curu, l'ascesso si chiuse lasciando una ctcatrice visibile.
Lna ragazza ùi a anui aveva un g r osso tumore infiammat o ri o nella nu ca, molto dolen te, e con cute ar·r ossi ta, ma !-enza fluttuazione . P er alcuni ,ziorni ru curata con catapla smi. e q u ando IH !luppur·azirme divenne evidente, l'auto r·e re ce una ptccola puntura allimtte del cuoio capelluto, m olto pus, lavò la cttv ttà ascessuaie gio rnalmente con c r•eolina , pose nell'apertura della garza al sublimato, ed in bruv e ottenne la guarigrone con piccola cicatrice .
Come si vede, la cuea consiste oel far rfelle pt ccole aperture tlella lunghezza di un centim etr o o poco più, e nel rascruare ove occorra, e lavare !ìpesso la cavità ascessuale. Qua ndo res 1duauo de' seni di piccolo cahb t•o che non danno lioer·o scolo alla marcia, si pos::oono dilatare gradatamente con catele1·i di guttaperca, indr irrigar e con si ringhe oli creolina.
Sir JosF.PH - Sulla medicazione antiaettto a delle fer1te . - ( The Lancet, gennaio e febbr·aio 18931.
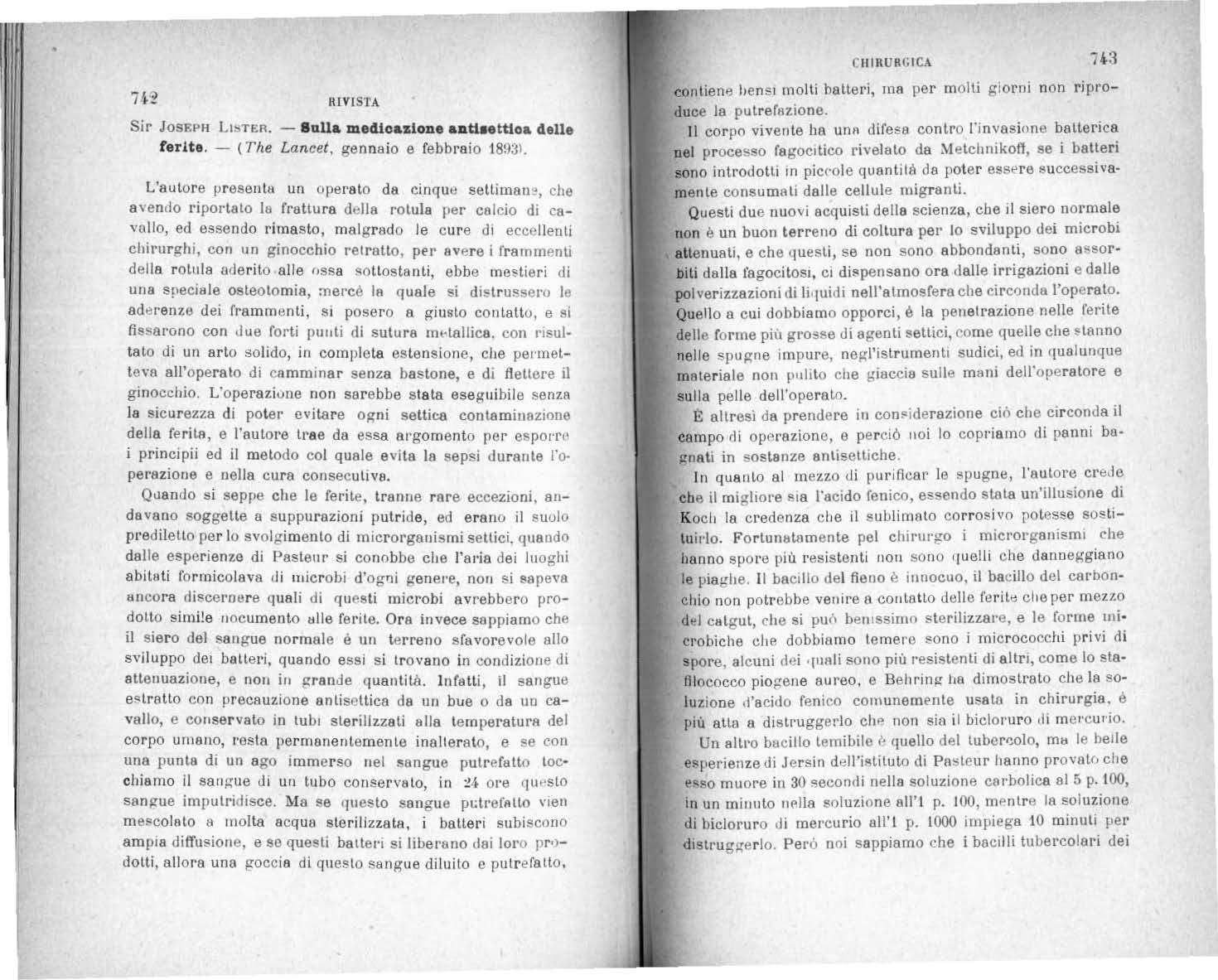
L'autore pr esenta un upe rato da cinqul:l seltimao ", che a'endo ri portato lo frattura della rotula per calcio di cavallo, ed essendo rimasto, malgrad o le cure dr eccellenti chirurghi, con un ginocchio retrallo. per avere i frammenti della rotula aderito alle ossa ebbe di una speciale osleotomia, :ner'cè la CJuaJe si drs-tr usset•o le ad ..renze dei frammenti, si posero a giusto contatto, e si fisc;arono con due forti puuti di sutura mt-lallica. con l'isultato di un arto solido, in completa estensione, che pe1 •metteva all'operato di ca mm ina r senza bastone, e di flettere il ginocchio. L'operazione non sarebbe st ata esegu i bile senza la sicurezza di poter evitare ogni settica contaminazione della ferita, e l'autore trae da essa al'gomento per espor·rt• i principii ed il metodo col quale evita la sepsi durante l'o· perazione e nella cura consecutiva
Q11ando si seppe che le ferite, tranne rare eccezioni, andavano soggette a suppu razioni putride, ed erano il suolu pt•edilello per lo svolgimento di microt•gauismi settici. CJUaodo dall e esperienze di Pasteur· si conobbe cl1e l'a1·ia dei luoghi abitati form icolava di microbi d'ogrti genel'e, no11 si l!lapeva ancora discet·oere quali ùi questi microbi avrebbero prodotto simile nocumento ttlle ferile. Ora invece sappiamo che il sier o del sangue no rmale è un terreno sfavorevole allo sviluppo det balleri, quando essi si trovano i n condizione t.h attenuazione, e nou in g rande quantità. I nfatti, il sangue e!'lralto con )Jrecauzione antisettica da un bue o da un cavallo, e conservalo in tub1 sterilizzati alla temperaturA del corpo umano, t·esta perm anentemente inalterato, e se con una punta di un ago immerso nel sangue putrefatto toc· chiamo li ù1 un tubo conservato, in :.?4 ot·e quroslo imputridisce. Ma se 'lueslo sangue pt.:l!•efAtto ' '1en a molta acqua sterilizzata. i batteri subiscono ampia diffusione, e se questi battet·t si liùerano dai loro pr•1dolti, allora una gocci a di questo sangue diluito e putr efatto,
CII IRURC;JCA
henst molli batteri, ma per molli giorni non riproduce la putrefAzione.
Il corpo vivente ha unA difesa contro l'invasione batterica nel processo fagoc1tico r i velato da Metchnikoff, se i batteri son o introdoltr 111 pic<·ole quantità da poter essere successiv amente consu mali dalle cellul e migr anti.
Questi due nuovi acquisti della scienza, che il siero no1·male non è un buon terreM di collura pe1' lo sviluppo dei micr obi attenuati, e che questi, se non sono abbondanti , sono a;;;sorbili dalla fagoci tosi, ct dil!lpensaoo ora dalle irrigazioni e dalle pol verizzazioni di liquidi nell'atmosfera che circonda l'operato. Quello a cui dobbiamo oppo rci , è la penetrazione nelle fel'ite delle forme più gro5se di agenti settici, C'ome quelle che nell e impure, negl'istrument1 sudici, ed in qualunque mater iale non che sulle mAni dell'operatore e sul la pelle dell'operato.
E allres1 da prendere in con!'1derazione ctò che circonda il ca mpo eli operazione, e perciò noi lo copt·iamo di pannr baJ;matt in sostanze antisettiche.
I n quanto al mezzo Ji purificar le spugne, J'autot·e crede che il migltot·e !'Ila l'acido fenico, essendo stata un'illusione di K oclt la ct·edenza che il subl imoto co rrosivo potesse sos titu il'io. pel i microt·ganisml che hann o spore più r esisten ti non so11o r[uelli c he danneggiano le piaghe. li bacillo del fieno è innocuo, il baci llo del carbonchio non potr ebbe venire a contatto delle ferilo::: che per mezzo di'l calgut, che si può ben essimo slerilizzal'e, e le forme micr·obiche che dobbiamo temel'e sono i micr ococchi pr ivi di spore, alcuni dei •(mlli sono più resistenti di altri, come lo slafllococco piof{ene aut•eo, e B eh ring lta dimoslt•ato che la luzione .t'acido fenico comunemente usata in ch irurgia, è {H Ù attll a disLmgger·lo chP non sia il biclor·uro di me1·curio. Un aiLt>o bacillo Lemibile i> quello del luberl!olo, le belle e!'lp erienze di Jersin di Pa!lleur hanno provatr, che e"so muore in 30 seconòi nella soluzione carbolica al 5 p. 100, in un minuto n«>lla snluzione all' l p. 100, mPnlre la soluz ione di bicloru r o di mer•curio all'l p. 1000 impiega 10 minuti per dr str•uggerlo. Però noi sappiamo che i bac1lli tubercolat•i dei
CIHlWRGICA
tubi cultura hanno minor l'esistenza di quelli che sono contenuLI nello sputo, onde l'autore ha prPgato il suo collega _a delle. investi).!azi oni in propoRito. e questi, con tnoculaz10n1 m di sputi precedentementP tPouti per varro tem po _nella soluziOne d'acido c arb oliC'o al 5 p. 1011, ha pr·o,·ato che tl con tatto d ell'acido carbollco per un minul••, attenua grandemente il pott>re d i atLecchimeoto dei bacilli tubercolari n ell'orgAnism o delle cav1c. che il contatto d1 un'ora lo diStrugge completamente.
l n _di cio, l'autore la ,.a le spup-ne con sa po· nata, p01 con <:oluzJOne di soda, poi con acqua, le la<:c1a ac;ciu· gare, indi le immerge in una sul uzione ac•1uosa d' a cido cur· bt•iico a 15 p. 100, e ve le fino al momenti> di adoperarle
Quando _Je ha usate una volla, lt lascia pul!·pfai' nell'acqua, la putrefaz10ne stacca l'albumina coagulata nei po ri della spugna, la quale è poi lovata finché non da più a lcun colo r e all'ac•1ua e conservala nella soluzione carbollca.
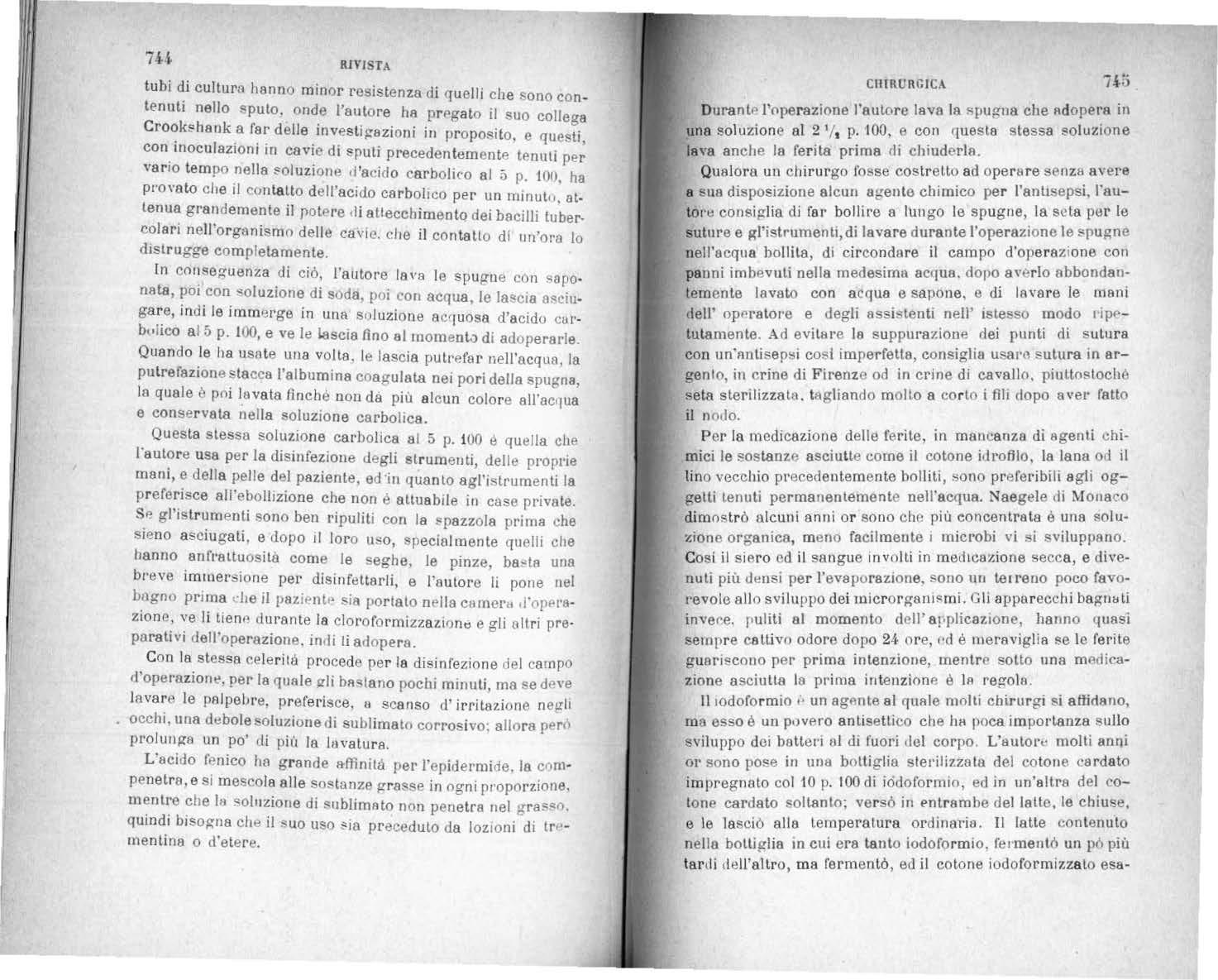
. Questa stessa soluzione cai•holica al 5 p. iOO e quella cbe l usa per la disinfezione degli strumeuti, delle p1·oprie man1, e della pelle del paziente, ed ·in quanto agl'i strumenti la preferisce all'ebollizione che non è attuabile in case private.
Rono ben ripuliti con la prima che Siena as cmgali, e clopo Il loro uso, specia lmente quelli che banno anft·altuosità come le seghe, le pinze, ba,..ta una br·eve immersione per disinftlllarli, e l'autore li pone nel l>ngno pr1ma ·he il pazJPill•' .:;ia portato nt•lla Cllmei'd .ropf'I'8· zionr: :e li tienr• durante la cloroformi.:zawm"' e gli ult r i pre· parahvr dell'operazione, indi li adopera.
Con la stessa celerità procede per la disinfezione dPl campo d'ope1·azioue. per la quale !lli bAc;lano pochi minuti, ma se dt>ve lavare le pa l pel>I·e. preferisce. n scanso d' irr•itazione occh1, una dt!bole l::!Oluzione di sublimato corrosh·o. allora per11 un po' rli più la lavatura.
L'acido ft>nico ha grande affinità per l'epidei•mirle. la cnm · penetra, e si mescola alle MR tanze graRse in ogni pr·oporzione. che !11 c;ol nzione di RnblimAtO non penetra nel gras-:n. qumd1 b1sogna ci!H il ;;;uo uso prdceduto da lozwm di tr ,·· mentina o d'etere.
DuranlP l'ope r azione l'autore lava la "[lltgna che Adopera in una soluzione a l 2 1/ 1 p. '100, E' con questa stessa soluzione la va anche la ferita prima di chiuderla.
Qualora un chirurgo fo sse costretto ad operare senza ave r e a sua disposizione alcun agente chimico per l'antJsepsi, rauto nJ di l'ai' bollire a lungo le spugne, la seta per le suture e gl'istrumentt, di lavare durante l'operazion e le spugne n ell'acqua bollita , di circondare il campo d'operazione con panni imbevuti nella medesima acqua. dopo av t> rlo abbondantemente lavato con acqua e sapone, e di lavare le mani «lell' opN·atm·e e degli nell' 1stesso m odo tu ta mente. Ad evi tat·e la suppu1·azione dei punti di sutura cnn un'anliRep!:!i imperfetta, consiglia usa1·n su tura lll argento, in crine di Firenze od in c rine di cavallo. piuttnstochè seta ster ilizzata. molto a co r to i fili dopo 8\'ei' fatto il ll O«IO.
P er la medicazione delle ferite, in manl'anza di Agenti chi· m iei le sostanze asciutte come il cotone idrofllo, la lana od il li no Yecchio precedentemente bolliti, :,;ono prt!fei·ibill agt1 oggetti tenuti permanentemente nell'acqua. Naegel e .ti Monaco di most r ò alcuni anni or sono c he più eoncentrata è una zione organica, meno facilmente 1 mici'Obi "i si c;viluppano. Cosi il siero cd il sangue in volLi in medtcazione secca, e divenuti più densi per l'evaporazi on e. sono \Ili te r reno poco fav oJ'evole allo sviluppo dei IOic r orgallll'mi. Gli apptlrecchi inve re. puliti al m omento dell' a! ·plicaz10ne , hanno quasi sempre cattivo odo1•e dopo 24 o re, l'd é meraviglia se le ferite g uarr!"cono per prima intenzione, mentrl' sotto una mPcl iraz ione a sciu lla la prima è lR 1•egola. ll 1odoformio ,, un agPr1Le al quale molli chirurgi si affidano, ma esso é un P•Jvero antise ttico che h» poca importanza s ullo sviluppo dei batter·• al dt tuor·i .te! corpo . L'auto!'<' molti anni ot' sono po!"e in una bottiglia stel'ilizzata del co ton e ca rdato im pregno lo col lO p. 100 di iòdot'orm10, ed in un'altra del rotonf' cardato soltanto; ve r sò in E>nl r ambe del latte, le chiuse, e le lasciò alla temperatura ordinaria. Il latte con tenuto n ella in cui era tanto iodoformio, fer·menlò un pò più tar1li dell'altro, m a fermentò, eù il cotone ioùoforrnizza to esa·
CHilWBGlCA
nato a.l mostr ò il latte di cu i era imbevuto brulicante d1 batler·t dJ d tversa speci e AJcun i hanno · •. · assertto che se s Introduce de ll a polvere di iodot'o · · . ' . . rmJO m un tubo dt culSI s.vduppano dei mict•organismi che si annidan o nel tod o formw stesso .
ciò, il ioc!oformio esercita una potente inJiuenza anttsettica su ll e ferite agendo secondo B h · . ' ' e rt ng, non ùtrettamente su llo sviluppo de' batLeri rna ch'm · t • • 1 JCamen e sut loro p r odotti tossici, aJ.te ra ndone le tossine, e innocue. gb esperimenti di Behring e di do Ruyler h.t ptomama si .ottiene dai micrococchi piogeni, iniet: tata cavtt.à perttoneale di un topo, lo uccide in 12 ore ma aff' tt · ' . . a o mnoc ua se é mescolata a piccola quantità dt todolormio .. Una piccola quantità di pus putrefatto , inocu lata nel perttoneo di un topo riesce fatale, ma non reca nessun .se mista a iodofo r mio, quautunque queuccida.. ' m;crococchi p iogeni . Privi de' loro prodott.i I ba tterli sono poco uocivi, e probabilmente sono distrutt i Jalla fagocitosi.
Tutto ciò ci spieO'a come 1 1 d' · . . o a po ver e 1 1odofo rrnw sul le fertte possa ave 1 . . . r e un g r an va or e ant rsetltco, !:'pecialse rJ rr.anga per molto tempo fra i tessu ti non asso.rbrto, senza irritarli. Larldove è impossibile escludere gli. a genl! settici, come nella bocca o nel l'etto, o quando seni pu rul enti, il iodoforrnio riesce prezioso e l'autore prtma d' 1· 1 b ' spp IC8r o , a gna la superficie c ru enta con soluziOne dt cloruro di zinco all'8 %, onde rita r da r e lo sviluppo dJ a gent i se tti ci. Il iod<'formio è ancora il miglior sg:nte sul campo ùi ba ttagl ia, n elle fratture complicale a fertle delle pat·ti moli ' · • • 1 • ma se SI opera s ulla pelle sana, e SI ::;pazto all'intorno per adaUarvi una buona fasctalura , e st hanno a d isposizione alt · l' ·d· . ,. . . n 1qut r per conset va r la fe11ta asett1ca 11 iod otorm 10 non è · · d b'l 1 . ' p1u rac coman· a '.e, per e le puo servir di mezzo ai micr obii es temi onde farst fino a lla fer't È 'ù . . . . . 1a. • p1 commendevole la prallca d.I VJeona, riservare il iodoformio per l'interno delle fet·tle, e covru·le poi d i cotone assorbente, a nzicllé quella che consigli<• 1'11!"0 del coto ne e della gai'Za iodoformizzata.
Ogni materiale e sclusiva mente asettico, come il cotone e la garza s te1 ilizzata al calore, che non abbia a contatto nessun a gente aLlo ad impedire lo svolgimeuto dei mt crobii, può perrnette1·e ai germi esteriori il pa ssaggio sino alla ferita , se il san gue od il sier o lo impregnano e raggiungono la s up e rfi cie ester·na della medica tura. Gli appa r eccbi di ster ilizzazione al calore non si possono aver dovunque, ed un mate rial e puramente a s ettico, senza n ull a che ne impedisca l'a ccidental e contaminazione, richiede infini te cure, e l'autore che lo ba visto in uso presso abilissimi chirurghi, non è soddisfatto dei ri sullati.
Una buona medicatura antisettica deve contene re un sicuro agente a ntiset tico, commisto in modo cile non si possa dissipare Cl'mpleta mente prima che la merlicazione !'ia ri nnova ta, deve esse1' capa ce di a ssorbir prontame11te il sangue ed il siero che possa scor r e r e dalla fe rrla , e non deve riesch•e irt•itanle.
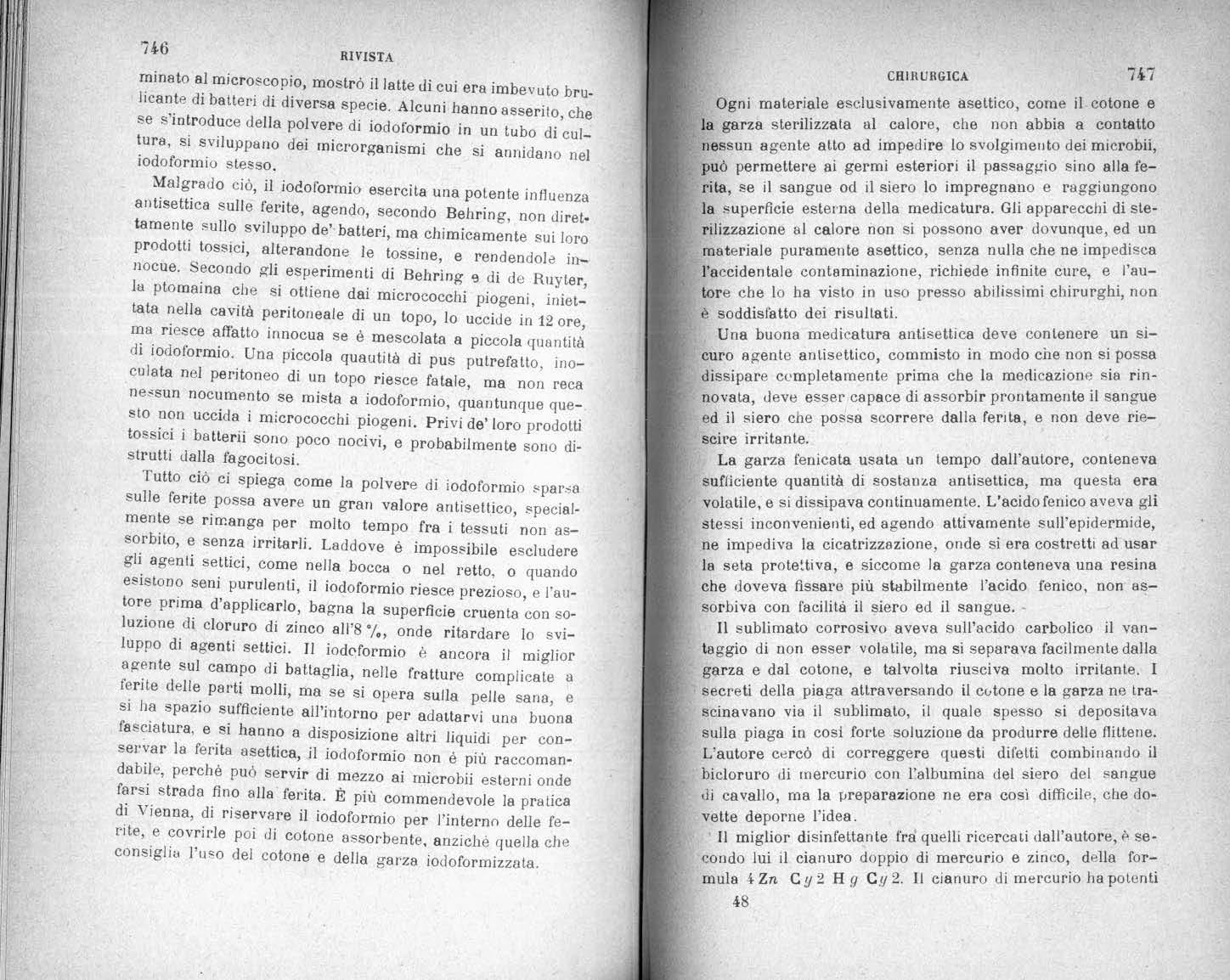
La garza fenicata usata 1.1n tempo daJI'auLore, conteneva s ufficiente quan tità di sostanza antisettica, ma questa era volatile, e si dissipava continuamente. L'acido fenico aveva gli stessi inconvenienti, ed agendo attivamente sull'epidermide, ne im pediva la cicatrizza zi one, onde si e ra cos tl'e tt i ad usar la seta pr otettiva, e s iccome la ga rz a conteneva una resina che doveva fissare più stabilmente l'acido fenico, non assorbiva con facilità il siero ed il sangue .
Il subli mato co rros ivo aveva sull'acid o carbolico il vanta ggio di non esser volutile, ma si sepa rava facilmente da lla garza e dal cotone, e talvolta riusciva mo llo irritante. I secreti della pia ga attraversando il cvtone e la ne lrascinavano via il sublimato, il quale spesso s i depositava sulla piaga iu cosi forte soluzione da produrre delle flittene. L'autore cercò d i correggere ques t i difetti cornbiuaaùo il biclo ruro ùi mercurio con l'albumina del siero del sangue J i cavallo, ma la preparazion e ne er a così difficil E>, che dovette deporne l'i dea.
Il miglior di si nfettan te l'ra quelli ricercati dall'auto r e, t. secondo lui il c ia nu r o doppio di mercurio e zi nco, della formula 4 Zn C y2 Hg C y2. JJ cianuro di mtn·curio ha potenti qunlilà antisettic he, mollo ;oolubtle, rna fortemente ir· r1tante; la su11 combmaz1one col induro di zinco lo rendP meno solubile, e punto ll'l'itante. Il cianu1·o di mercurio e zJn co si scioglie appenB in 3000 l'arti di del quindi basta una piccola quunlila di sa le per mantener chius11 la ferita per 1nollo la quale, senza sublrP irritazione, cicatrizza ad i:nm ediato contatto del farmaco.
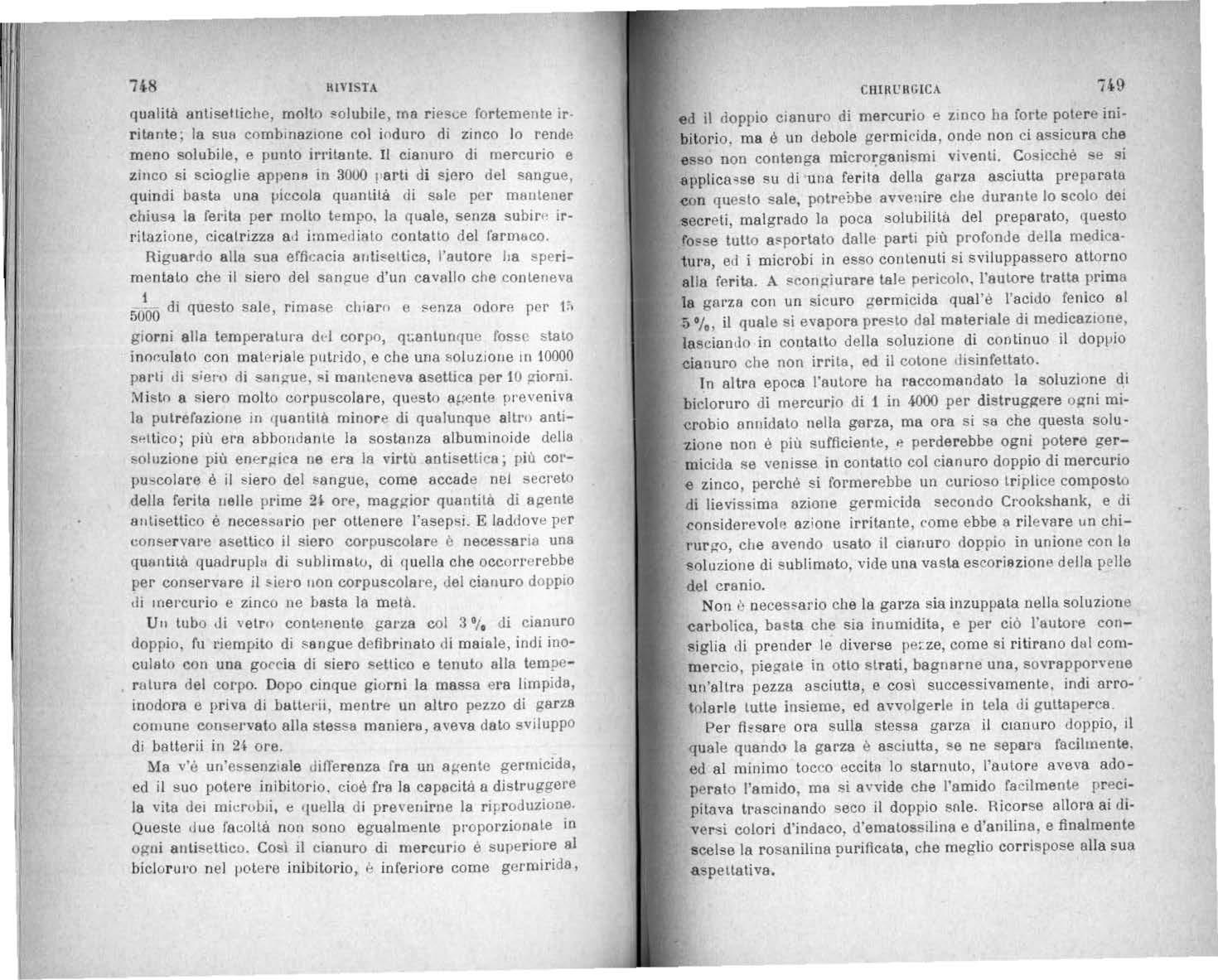
Ri gu ardo alla sua eflkAcia auli$eltica, l'autore ha )o;p erime ntalo che il sie1·o del sanguP d'un cav tlllo che conteneva
50 1 0ò d1 questo sale, rimase cl11aro <J odor e per 1.1 g1orni alla temperalu1·a dtl cor po, foss!' s tato inMulato con mat Pr1a le putrido, e che una 1r1 10000 par•li tli !'iem rli '-Ì man teneva a settica per 10
!\l a !'i ero mollo corpuscolare, questo ag.eote pl'evenivA la puLrefazione 111 •Juaulllà minore di qualunque a lll·o antiRPllico; più er·a abhondante la sostanza albuminoide della soluzione più entrgica ne era la virtu antisettica; più cot•pu-.;colat•e è il "ie r o del Rangue, come accade nel sec1·eto della ferila uelle prime orr, quantità di a(:tente antisettico è ncceRstuio per ollenere l'asepsi. E laddove per conserva1·e a!:tettico il siero corpuscolare è necessarlll una quflllLilà quadruplti di subii ma tu, di quella che occort·r•rebbe per conset•vare il c.iero non corpuscolare, del cia11uro d o pp10 d1 rne1·curio e zinco ne basta la metà .
Un lubo di 'etro gar·za col 3 °/, di cianuro doppio, ru l'iempito dì s angu e tli maiale, indi ino· culalo con una gor<'ia di siero !'ellico e tenuto alla tempPr utu ra del co 1·po. Dopo cinque giorni la massa Pra lnnpida, inodora e prtva di ballerii, mentre un altro pezzo di garza comune alla maniera , aveva dalo sviluppo d1 ballerii in o r·e.
Ma v'e un'<'!-.Senziale rhtTe reoza fra un agente gernucida, ed il suo potere ioibitori o. cioè fra la capacità a distr·uggere la vita de1 mJcl•obli, e •Juella d i preveuirne la rir,r oduzione. Queste due facolla non sono egualmente p1·oporzionale in ugui anLisellico. Cosi il cianut·o di mercur1o è supe r 10re al biclor u1·o nel potere inibit01·io , iofet•iore come gcmmida • e d il doppio cianuro di mercurio e zrnco ha forte potere inib ilorio. ma é un debole germicida, onde non ci Q!'!sicura che e s"o non contenga vl\·enti. Cosiccltè si su di una ferita della garza asciutta prPparata c on questo sale, potreobe avvenire che durante lo scolo de1 -secr eli, malgrado la poca solubililà del preparato, questo ro.:se tullo a !'portalo dalle part1 più profonde della medicatu ra ed i microbi in esso contenuti si sviluppassero attorno ' . a lla ferita. A tale pericolo, l'autore tt·alla prima l a gn1·za con un sicuro ;::ermicida qual'è l'acido fenico al 5 Ofo , il qual e si evapora pr e!'to dal mater1ale di medicazione, lascian tlo in con tatto della soluzione di continuo il doppio c ianuro che non irrita, ed il cotone chsin fettato.
In altra epoca l'autore ha raccomandato la soluzione di bicloruro di mercurio ùi 1 in 4000 per dist r uggere ogni microbio annidalo nella gerza, ma ora si sa che questa soluzione non è più sufficiente, ,. perderebbe ogni poter e germ icitla se venisse in contatto col cianu ro doppio di mercurio e zinco , perché si formerebbe un c urioso triplice composto di lievissima azione germicida secondo Crookshaok, e di considerevolr az ione irritante, rome e bbe a rileva re un chir·ursro, che avendo usato il cianuro doppio in union<' con lo di su blimato, vide una vasta escoriaziont> della pelle del cranio.
Non ... neces<>ario che la garza sia inzuppata nella soluzione carbolica, basta che sia inumidita, e pet· ciò rauto1·e cons iglia di prender le diverse perze, come si ritirano dul comm ercio , pie gate in o tto strati, bagnarn e una, sovrapporveue un'altra pezza asciutta, e così successivamente, indi arrotolarle tutte insiem e, ed avvolgerle in tela di g uttaper ca Per ora s ulla stessa ga rza il c1o.uuro doppio, Il 1ual e quando la g arza è asciutta, se n e separa facihnenle. ed al minimo LOCI'O eccitA lo starnuto, l'autore aveva ado· pt>rato l'amido, ma c:i aHide che l'amido facilmente prPCi· pitava tJ•ascmando seco il doppio sole. Ricorse allora ai diveNi colori d'indaco, d'ematos!'!ilina e d'anilina, e finalmente s celse la rosunilina purificata, che corrispose alla sua a spettativa.
Chirurgica 75 1
Questa r·osanil ina, alla dose del 1/ 1 o;. sulla quantità di cianuro doppio, si ver:S& sulla soluzione del cianuro ripetutamente lavato per ribe ra rlo dall'eccesso di ciAnuro di mersi rimescola più volte, indi s1 attende il precipitato che e fallo dal sale, il quale s i è appropriato il colore della rosanilina. Si filtra quindi, e s i lascia asciuga r e a moder ato caJOt·e.
.La polvere colorata di cianuro doppio si stempera 10 m ortaiO nella soluzione carbolica al 5 o;o, nella propo1·zione di 2 in iud1 si versa 10 un cAtino, c vi si immerge la assor·benLe !Jiegata ad otto falde, agitando sempre il hquu.Jo non s i form1 precipitato. Si spreme poi la e SI appende perché si a sciughi alla temperatura ordtnal'la. La soluzione è da prefe1·irsi aJI'ac•1ua ru preparazione, perch•:. in essa il sale si diffonde e per:chè distru[tge qualunC(ue ge 1·mc che la del co mmerciO CI)Oleuere. la che de ve servirgli nella pratica privata per un 1nte ro aa11o, e fa pre· parare dagl'infermieri quella che Adopera nell'ospedale, r1uesta per·ò non la lasciu asciugare co mpletame nte all'aria, ma la fa involgere in tela di gullaper.:a ancora umida, per non doverla inurnidire quando si deve adoper·ort>.
Un metodo rapid o di preparazioni', quando al m om eulo dell'operazione non si abbia della garza prepar·ata, é 11 sesi p•ega la ga rza iu otto fald e, si immerge nella su luzrone Càrbolicu, si spreme, si stende su di un panno s empre P•egata in o tto falJe, si spolve r a sul foglio supe r ficialt: la polvere fiuissima del sale con uno spolverino da pepe. si 8t'l'olola la s• spreme e s1 maneggra per un minuto o due onde aver•e una completa d1ffusioue dei sale allrala massa della gaeza, rndi si avvolge in un altro ro.,.lio ascrullo L'inferuuere può cominciar que!>la prepa r·azi:ue quant!IJ :si i11comincia la cloroformizzazrone, e la ga1·za sarà pronta pel momPnto dell'operazione. Cinque mett·i e mezzo di gart.a, cosi weparAta, basto11o per r1 ualunque O!JeruZIOue.
La quantita del salo impiegato per ogni n metri e mezzo di garza ummonta a gr. u, il prezzo tlel c1anuro tloppio é d'
L 50 al k1l., ogni medicazione importa 0,30 del r imedio, mn o on è necessario adoperare tanta quantità di sale, se· condo l'autore la metà, onde la spesa si eiclu r rebbe a 0,15. I n manc anza di garza, s1 possono adoperAre gli sLracci di lino clt e sono mollo llSSo1·benti, i panni lini vecchi e gli asciugamani, e nello stesrso m odo si possono rendere antisett iche le fascie che devono and a re a conlatlo della pelle Un altro m odo d'impiegare il sale, é il farne una poiLi,dia con la soluzione ra rbolica, e spalmarla con ua pennellino .di vaio sulla ferito che si vuoi proteggere da un rom1le v•· cino rl'infezione, come nelle vicinanze nell'ano e del pube. Nel ca mbio delle medica tu r e, l'autore lavo sempre le piaghe con soluzione car bolica al 2 1/ 1 •t , o quando lava l» par·ti cii'• -costanti, protegge la piaga d all o sco lo del liquido di lava · tura . Per r imuove la prima medicaLura dopo 24 ore, se la medicatura c'• bagnata; se ò asciutta, la lAscia alcuni gi o rni .
Qualli'O anni di esperienza con vincono l'nutore della suo nuovo metodo.
L'autor·e inflne la sua nel vedere come la speranza che con cepiva al congresso inle:-nazionale di Londl'a 11 anni o r sonn, si va realizzando, e che l'uso della med icazione anLisellica si va diffondendo per tutto il mond o. Solo gli rin cresce elle alcuni spe:,;so si affatichino i ntorno a cose !>Upe rnue, trasc urando l'essenziale, e con le migliori mtenzioni, non ottengano i mi glio ri risultati. Spera però che inclirizzo r iesca utile ai colleghi, e diriga la loro attenzione alle condizioni del d I
3:ulezlo1Ll • ottooutauee eU alcool llella oura delle erule rlduolblll. - t R eoist a de Sanidad militar, t• àe marzo de 1893).
Il dottor Sleffen ha sperime ntato dur·ante tre anni questo metodo di trattamento radicale dell'ernia e propone alcune modificazionl nella tecnica dell'operazione ide11ta da Schwalbe. R imp1azz.a la s irin g a di Pravaz con una siringa più gr·ande la cannula più lunga P più FtrOS!"A.
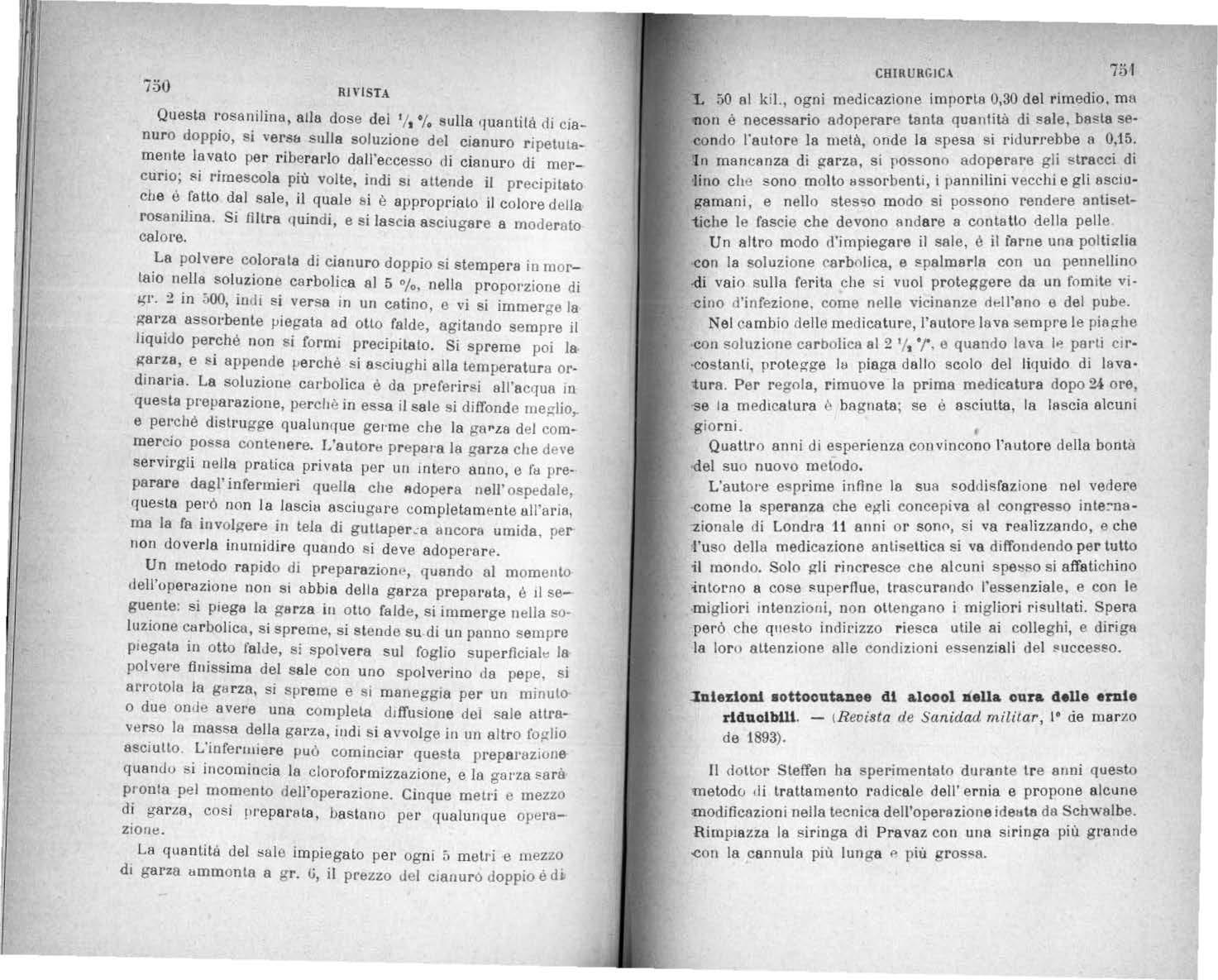
Rivista Chirurgica
RI idotla l'ernia, procede il dottor Steffen alla intro luzion& e a cannula formando pr· é applicabile a lulte le varietà di er•nie e -03 casi trattati dal dottor Schwalbe solo in 25 è r·
• dell'orificio . . Ima una piega colla pelle A livE-llo ermarJO: se trascorsi alcuni minuti (da uno a dieCI) osservA emorragia, inietta lentamente 50 cena iff, ritira un poc(] la cannula e la fa cambiai e dJ dJrt'ZIOne pel' iniettare altri 50 t' . al"ool . l' cen JgrammJ d• • e ripete oper•az tone fino a disseminare nell .. dell'erma do due . e vJcmanze r-\ot! facend . . quattro grammi del medPsimo lirJuid o. d l PIU r e una puntura nella pelle ries cono poro o orose le rniez1ooi p·· ·d ' . , lu ra pi e e con meno pericolo di in•eZIOne.
In princip1o si prat . · . . lcano unu o due IOiezioui per settimana po\t' f• IÙ di l'aJ'O e si continua il trattamento perme .en o allmfeJ'fllO di non porta r e il cinto dopo due o tre mes1.
" l'unico accidente che si verificò fu il rn uno degli operat1.
RIVISTA DI OCULJSTlCA
•••ara deU 'aouità vblva _ H • t · lui GNON.o a Val de-Gr(lce. "
. In r.er stabili re l'attitudme al ser vizio militare ì diSOrdiOt VI!'IIVI Si appre· d l . · . ztano a la m1sura dell'acuità visiva
E Idoneo al ser,·izio armato l'indivJ'duo l . . la . . .. n a CW VIS on. scende a meno di •; , per un occh io ed 'l to per l'allro. tener ronto delle condizioni est r inseche caPACI .d' raJ• i risultati della misura del poter visivo
Las.cJando m !hspnrte l'i nfluenza della intensità dell'ìlluminazJOne, della t(Uale ognuno couosce J'J'mport l anza e a neces-
RIVISTA DI OCUI.ISTICA
!'llÙ di nnpedire all'r>c::nminalo d1 pt·emet·e l'ot•chio primo della lettura di non farlo Jpggere dopo ave1·lo sottoposto ad uu ec;ame obbiettivo prott·allo, resta A valutare an ro ra l'ioflu,..nza potissi111a della formo di !'egni lracciat1 !'\ulle scale tipografiche.
Nell e clin1che otla lmologiche s'usano in genere due *'ca l.,-, l'una di lettere, l'altra con det segni quadraLi, mancanti però d'un Ialo : la p ri u1a serve per chi sa legger·e, l'alt ro per gli analfa beti.
Ma la misura dP-1 visus non riesce la stessa f'On l'una o l'a ltra scula .. Di rt>gola coi J'e!'arrunato tma linea supe1·iore o quella che discerne colle lettere ... ciò accad e spel'ialmenle negli astigmatici e sovrutu lt<' Cof!ll tpe•·melropi astigmatici; é facile a compren d erne la E lu difl'erenza va da 1/, (colle od 1ft (coi quadr·ati incompleti).
Ben meglio sarebbe quindi usare della scalo a quadrati ...
È .:erto c h e si r ea lizza una condizionP d1 misura in r elAzione alle esigenze militari. Ollerremo al poslutto un più "icuro accordo dei giudizi.
A questo breve dello scritto del Mignon da noi riportato, la redazione degli Archioes de M édecine et rle Pharmaci e militaires fa se::ruire la segueute noLA: È op" porluno misurare possibilmente l'acuità vis1va a ffii'ZZO
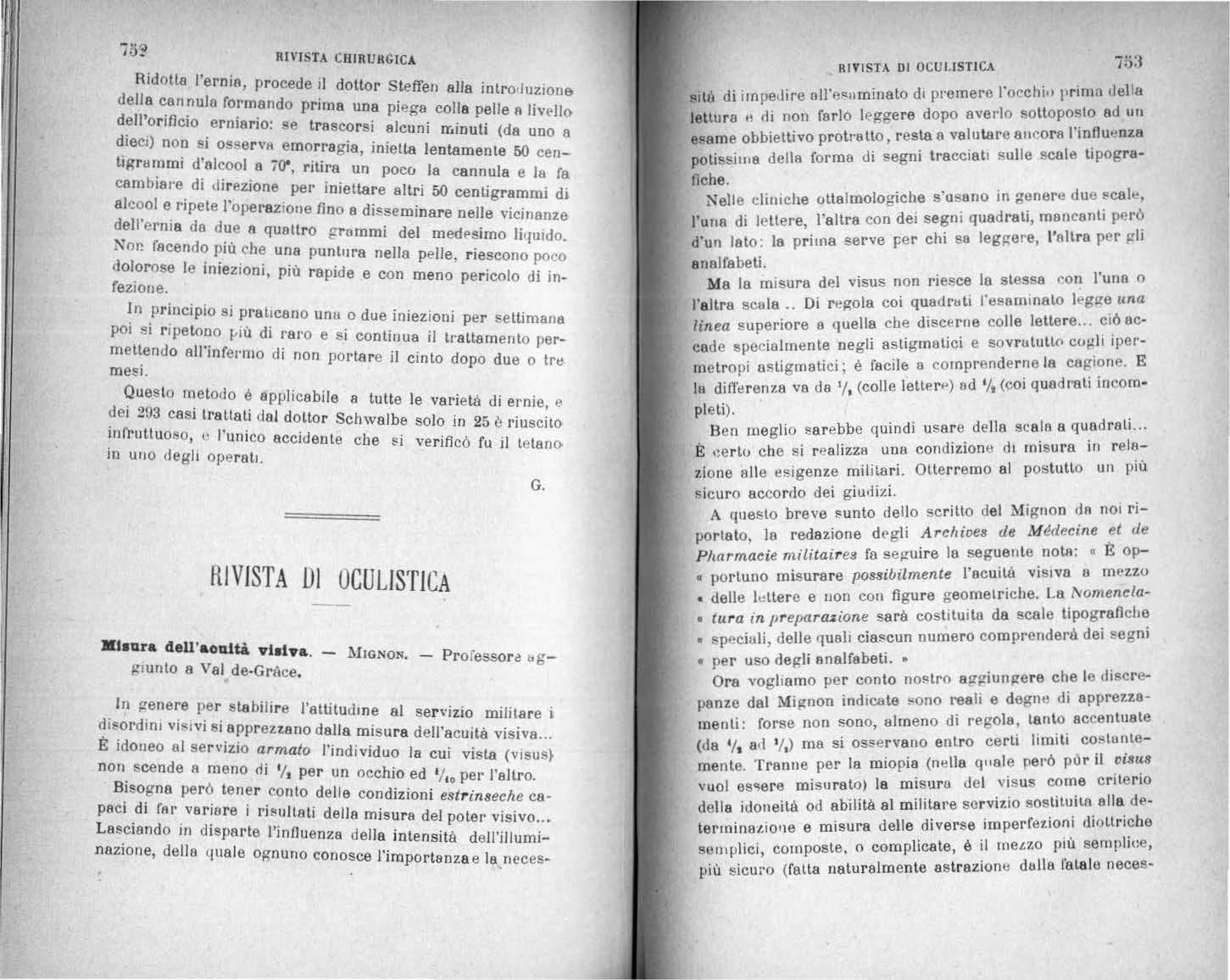
• delle ldlere e uon con figure geometriche. La !Vomencla-
• tura in preparasione sarà cosl 1lui la da scale tipografiche
• c;pPciali, delle quah ciascun numero comprenderà dei segni
• per uso analfabeti. •
Ora vogl1amo per conto nof'tro a:;rgiunjle r e che le di!'lcrepanze dal Mignon indicate >-ono reah e degni' di apprezzamenti: forse non s:ono, almeno di •·egola, tanto accentuate (da •; , ad 1/ ) ma si osservano entro certi lìrn1t1 menle Tranne per la miopia (nella qnale però pur il oisua vuoi os"lere misurato) la misura del vis us come criterio della idoneità od abilità al milita1•e sorvi7.io sostitu ita alla ciP· terminatione e misura delle diverse imperfezioni diottriche seruplici, composle, o complicate, è il me.t.zo più sernplh:e, più !:;icuro (falla naturalmente astrazione dalla l'alale neces-
RI\"JSTA silà di r icorrere ad un me zzo d'indole soggeltt va ) per istabilire quei giudizi. Ciò prsto nessun a llro mezzo d'esame può a quelli praticati colle scale murali (all'uopo, be n inteso, col concors o delle lenti).
Ora i• indiscutibilmente ve r o che le scale di ca r LLtl eri necessitano un visus meno imperfello, di quello che basta, in identiche condizioni per quelle di seg-ni geometrici. È egualmente vero che In vista, calcolala sulle esigenze del servizio militare (portata pn:t che finezza ed esaltezza), polrebbesa meglio praticamente d eterminare con dea segni geometricJ c figure semplici, anziché colle fo rm e ptù complicale delle lettere ottometriche. l segni semplicemc11t" g1·ometraci
P•ll si prestano ben meglio per un sufjiciente pratico riRconlro coi segni pieni (quad r ati e dischi o punti come s i usano in Ingh ilterra ) naturalmentP tenuto calcolo pea· questi uiLimi d1 Ila proporz ionale r iduzione della superfi cie per gli s tessi diametri.
Saremo ben lieti da vedere come cost ituila I'Rnounzialo nomenclatu r a in prepara3ione. Ma siam fin da ora cunvinli che il pr incipio dal Migno n annunzi ato è ltmto giusto e pratico da no n poter essere messo fuori Iii questione, come militare da qualunl}un meglio inte!'a scala ottotipica B.
'Trattamento del tTaoom& - T ANNRR. febbraio 1893. (Medica l record,
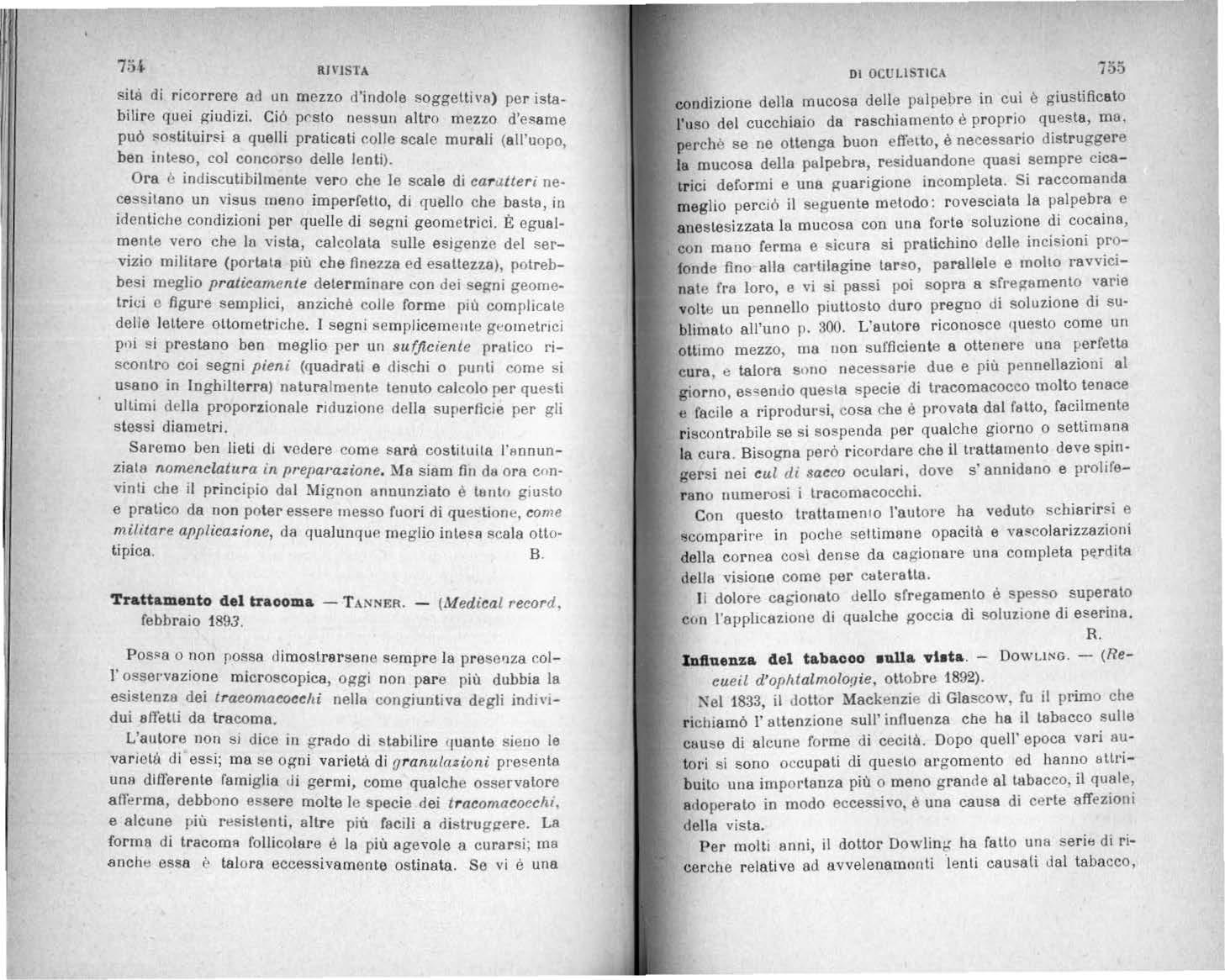
P os>:a o non possa dimostrarsene semp r e la p r esO'lza coll' microscopica, oggi non pare più dubbia la esistenza dei tracomacocehi nella congiun t iva degli indi\'Jdui affeUi da tracoma.
L'au tore non si dice in g rAdo di s tabilire quante sieuo le var10là di ma se ogn i varieta di pa·esenta un a ditre re nte fa miglia di ge rm i, come qualch e osservator e afTèrma , debbono esser e molte le specie dei t r acomacocch1, e alcune piu resistenti, alt r e più facili a La forma di t racomA follicolare é la più agevole a cura r si; ma essa ,:- talo r a eccessivamente ostinata. Se vi è una
DI OCULISTIC.\
cond izione della mucosa delle palpebre in cui è giustificato l' us o del cucchiaio da ras chiameoto è proprio questa , ma. pea·chè se ne o ttenga buon effN to, è necessario la mucosa della palpebra, residuandone quasa sempre cacatr ici defù r mi e una guarigione incompleta. Si raccomanda m eglio perciò il seguente metodo: r ovesciata la e ane stesizzata la mu cosa con una forte soluzione da cocama, con mano ferma e sicura si pratichino de ll e incisioni profo nde fino alla cartilagine tar:to, parallele e molto natc fra loro e vi si passi poi sopra a sfres:camenlo var te volte un piuttosto duro pregno di soluzion e di subli mato all'un o p. aoo. L'autore riconosce questo come un ott1mo mezzo ma non surtlcieo te a ottenea·e una perfetta cura , e talora' snno n ecessarie due e più pennellaziooi al gior no, es'5endo questa specie di tracomacocco mollo. tenace e fa cile a r iprodua·si, cosa che è provata dal f11tto, factlmenle riscontrnbile se si per qualche giorno o settimana la cura. Bisogna però ri cordare che il tealta mento deve gers i oei cu i clt sa cco oculari, dove s· annidano e prolifer ano uume1·usi i lracomacocchi.
Con questo traltaanenao l'autore ha veduto !'\Chi arirsi e '!comparii·e in poche sellimane opacità e dell a co r nea cosl dense da cagiona a·e una co mpleta perrlata dell a visione come per Cl:lleJ·atla.
11 dolore cagionato dello sfrègamento è superato con l'apphcaztonc di quulche goccia di soluz.aone di eserina.
R.
1D1luenz& del tabacoo •ull& vl•ta . - OowL.tNG . - (Recueil d'oplltalmologie, ottobre 1892).
18.33 , ti dotto r Macke nzie di Glascow, fu il pa•imo che r icluamò l'a ttenzione sull'influenza che ha il tabacco sulle cuu be di al cune forme di cecità. Dopo quell'epoca vari autol'i si s ono occupati di q u esto argomento ed hanno allJ•ibuito una impoa·tanza più o meno g ran de al il quale, a rloperato io modo eccessi,·o, è una causa di certe della vista.
P e r molla anni, il dottor Oowling ha fallo una ser i{j dt rtc e r c h e r e lative ad avveleoamonli lenti causali dal tabacco,
Di Oculistica
e recentemenl·J ha molti individui addetti alle principali manifatture eli tabacco nella citta di Cincinnati.
Il numero totale .!egli impiegati in quelle manifatture era di 3000, di cui 1fl00 uomini ed il rimanente d1 donne, principalmt•nte di giOVIllettt>. Fra i 1:)00 uomini, l'autore ha "'Ceilo 150 dr quel11 che erano più vecchi e conosciuti anche come i più grandi consumatori di tabacco. Egli fece l!n e same mollo a cc urato del loro o r gano della \'ista.
Ecco un l'lunto dellt• sue ricerc he. - Sopra l]uei l f>O uomint, ve n' Pra no il 90 p. 1011 che facevano uso di tabacco sotto una J'or•ma o Mtto un' allra. Circa 20 p. 100 mas ticavano tabacco, oltre la p1pa od il sigar o clte fum a van o in abbondanza. Compa1·at1vamente pochi di fJUelli esamiuali bevevauo eccf'!il'lh·amenle. e 'JUelli che ciò facevan o b e vevano quMi lutti In birr a.
Molli impio>ga ti avevano i muscoli flosci e sofTI'ivan o piu o me11o d i anemia, pnrtirolarmente le donne.
Gh uomini estuninati avevano da 30 a 60 anni.
Nella pr·ima serie Ji esami lo lista conteneva alcune
Uuo sola fu in modo evrdente avvelenata dal tabacco , avveleuamento che si era manifestato nelle affezioni della vista. Si trattava di una donna di 40 anni, la quale tava un caso claRsico di ambliopia. Essa confondeva il ed il ve1·de della carta col nero. il bianco col grigio carico Essa aveva pure notato una dimjnuzwne notevole della s ua v1sta, sopratutto negli uiLimi due anni. Essa lavo ravu n el da crn ,1ue anni, ma non ne ave,·a mai fallo uso <:o tto I]Ualsiasi forma.
T r a i 150 uomini sollopo sti alr esame, 45 erano in modo più o men o e vidente affetti Ja ambliopia da tabacco. Alc uni ne erauo leggermente t11fdli; in 30 la malattia era ben accentuato, pe r ché prendevano distintamente il rosso per il nero o per il br·uno ed il verde per un azzurro pallido o aranciato. l colori in ta l modo confusi non l' erauo che per la visione centrale, perrhè distinguevano senza difficoltà la perifer ia.
La maggior parte der 150 uo m ini avevano le pupille più o meno e ciò 10 un gra n 11umer·o ili casi io cui no n ' i ertt altra di a"' dal Ma •1uesr.a contrazione era p1·onunciatn P per·SISteva in tutti quelli che prl',.enlavauo altri eintom1 accentua ti dell'infezione da tabacco
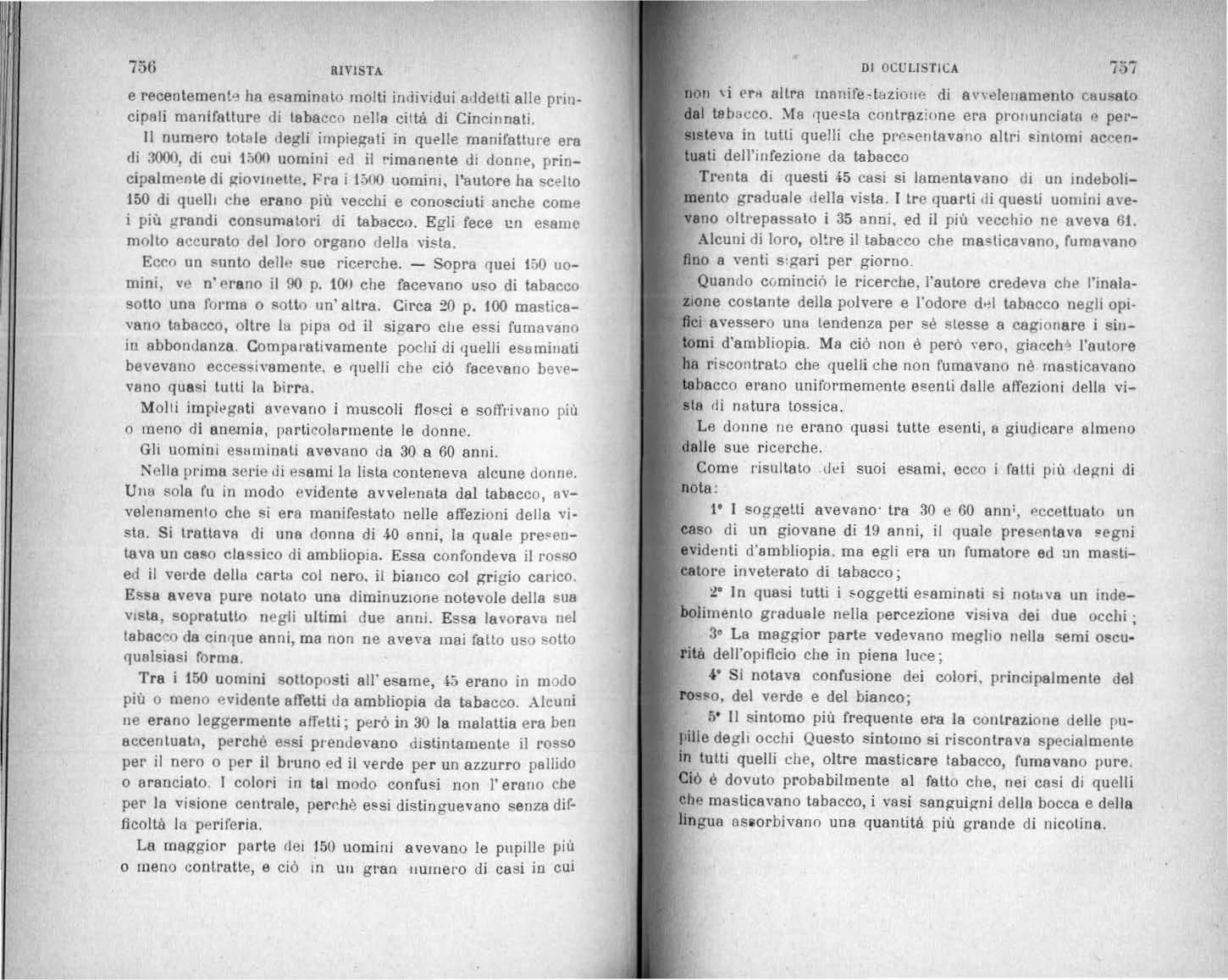
T renta di questi 45 si lamentavano d1 un rndebolimento graduale della vista. I tre quarti di questi uomini aveva no oltr•epassato i 35 anni. ed il più vecchio nP aveva 61.
Alcuni di loro, oltre il tabacco che mac:;ticavano, fumavano fin o a venti s :gari per giorno
Quando C(J minciò le rice r che, l'autore credPvo che l'inalaZione costante della polvere e l'odore d ...l tabacco negli opifi CI avessero una tendenza per sè stesse a cag1 o nare i sintom i d'ambliopia. Ma ciò non è però "ero, l'autore ha riscontrato che quelli che non fumavano né ta ba cco erano uniformemente esenti dalle affezioni della vista di notura tossica.
L e donne no erano quasi tutte esenti, a giudicare almeno dalle sue ricerche.
Co m e risultato uei suoi esami, ecco i l'atti più di nota:
1' I soggetti avevano· tra 30 e 60 ann;, Pccetluato un easo di un giovane di 19 anni, il quale presentava oegni d'ambliopia. ma egli era un fumatore ed un mac;ticatore inveterato di tabacco;
I n quasi tutti i si notuva un indebolimento graduale nella percezione dei due occhi·
3• La maggior parte vedevano meglio nella !-!emi oscu: rita dell'opificio che in piena luce;
4• Si notava con fusione de i colori. principalmente del r o«!<o, del verde e del bianco;
5' Il sintomo piu frequente era la <:ontrazione delle pupill e deglr occhi Questo sintomo si r·iscontr ava specialmente in tu tti quelli che, oltre mastica re tabacco, fumavano pure. Ci ò é dovuto probabilmente al fallo che, ner casi di quelli ch e masticavano tabacco, i vasi della bocca e della lin g ua asaorbivano una q uantita più grande di nicotina.
Studi 1ull' accomodazione dell' occhio degli ucc elli .Ttl. Bf:ER. - ( Pflugers Areh. e Centralb. medie marzo 1893
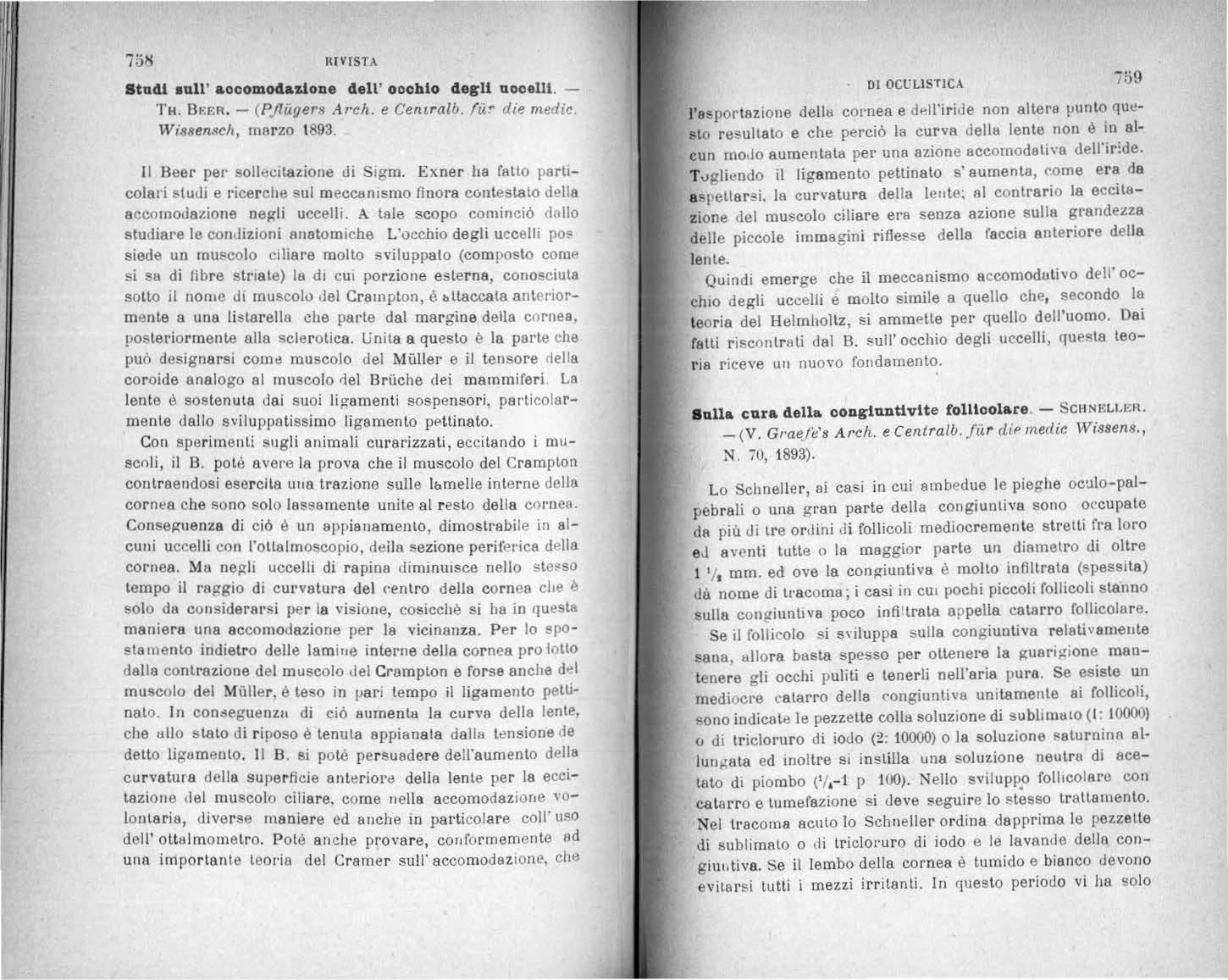
11 Beer per· sollecitazione di Sigm. Exner ha fatto particolari stuùr e ricerche "'UI meccanrsmo finora contestato della accomodazione uccelli. A tale scopo cominciò rlHIIo studiar•e le conJizioni anatomiche L'occhio degli uccellr po.siede un crliare molto sviluppato (co m posto si su di fibre strrate) la dr cu1 porzione esterna, conosciuta sotto rl nome d1 muscolo del Crampton, è anlenormen te a una listarella che par•te dal margine della cornea, postet·iormente alla scle r otica. Unita a questo è la parte che può designarsi come muscolo del Miiller e il tensore della coroide analogo al muscolo tlel Briiche dei mammiferi La lente e sostenuta dai suoi ligamenti sospensori, par·ticolarmeote dallo sviluppatissimo ligamenlo pPLtinato.
Con sperimenti sugli animali curarizzati, eccitando i muscoli, il B. potè aver·e la prova che il muscolo del Cram pton contraendosi esercita uua trazione sulle h,melle interne della cornt>a che so no solo lassamente unite al r esto della cnr·oen.
Conseguenza di ciò é un appianamento, dimostrabile in alcuni uccelli con l'otlalmoscopio, clelia sezione p erifPt·ica della cornea. Ma neglt uccelli di rapina dim muisce nello tempo il t'aggio di curvatur•a del rentro della cornea clae è so lo da con siderars i per la visione, cosicché si ha in questa maniera una accomodazione per la vicinanza. P e r lo spostarnento indietro delle lamiue interne della cornea pro lotto dalla contrazione del mu scolo del Crampton e forse anche d"l muscolo del Mull e r , é teso in var r te mpo il ligamento pellinato. In conseguenzu di ciò aumenta la curva della lente, che ullo stato d i riposo é tenuta appianata dalla tensione fie detto ligu mento. 11 B . si potè persuadere dell'aumento della cu r vatura della superficie anteriore della lente per la eccitaziou e del muscolo ciliare, come nella accomodazrone volontaria, diverse maniere cd anche in particolare coll' ul'lo dell' ottalrnometro. Potè anche provar e, couforrnemente ad una importante teor·ia del Cramer sull'accomodazione, che
01 OCt.;LlST1CA
l'aspol'la zioue cor·nea e Jpll'i ri de non allerti punto C'Jlh!re.,ullato e che perciò la curva della lente non è m alcun modo aumentata per una azione accomodati va dell'ir!de. T ..,gtiendo il liga mento pettinato s'aumenta, come da a "pellarsi. la curvatura della leute; al contrario la eccitaz ione del muscolo ciliare er·a senza azione sulla gr·andezza dell e piccole immagini riflesse della raccia anteriore della le nte.
Quindi e merge che il meccanismo accomodotivo dell' occhro degli uccelli e molto simile a quello che, Mcondo teoria del Helmhollz , si ammette per quello dell'uomo. Dat falli dal B. sull'occhio degli uccelli, teor ra riceve un nuovo l'ondarnento.
S ulla cura della ooDgluntivlte folltoolare . - SCII _(V. Graefe's A.rch. e Centralb. jt'tr cliP medie Wissens., N . iO, 1893).
Lo Schneller, oi casi in cui ambedue le pieghe oc:.rlo-palpebrali o una gran parte della congiuntiva sono da piil di tre orJini ll i follicoli mediocremente strettr fra loro eJ a venti tutte o la maggior pa rte un diametro di oltre 1 '/, mm. ed ove la è mollo ioflltrata (spes!'lr ta) ua nome di lracoma; i casi in CUI pochi piCCOli follicoli StannO sulla conai unllva poco infi ' trata appella catarro follicolore.
Se 11 follicolo si sviluppa ::.ulla congi untiva relati vamente sana, allo ra basta spesso per ottenere la mantenere <>li occhi p ul iti e tenerli nell'aria pura . Se esiste un catarro della rongiunliva umtamente ai follicoli, .::ono indicate le pezzeLte colla soluzione di subli mato (1: 10000) o dr tricloruro di ioùo (2: 10000) o la soluzione aled moltre st instilla una soluzione neutra di acetato dr piombo (1/ 4-1 p 100). Nello svilupp_o follrcolare con catarro e tumefazione si ùeve seguire lo stesso tratlamenlo. Nel tracoma acuto lo Schnelle t• ordina dapprima le pezzette Ji sublimalo o di tricloruro di iodo e le lavande della congiu11tiva. Se il lembo della cornea è tumido e bianco devono evitarsi tutti i mezzi irritanti. In questo periodo vi ha solo un mezzo che 5ti può u arP senza peri colo e co n s icu ra spt>ranza di rapido miglio r ame nto o guarigione ed è la esci..inoe della piega NP1 casi di tracoma acuto 10 cui la cornea è malata non si deve mai indugiare Nel tracoma cronico in c u1 è malal11 solo la piega oculopalpebr ale e fa cornt>a è sanu, lo Schneller e scide solo le pieghe malate in tutta la lo1•o lunghezza e particolarmente lr granulazioni esistenti agli angoli. Partecipand ovi la cornea é riA seguirsi lo s te..so trattamento. Allora si dissipano benché molto lentamen te anche gli intorbidamenti della corneA. Se il lracoma della piega oculo palpebrale ba ancha la congiun tiva con o senza affe zioni della cornea la cura ' medica non ba alcuno scopo, devesi invece prontamente opera r e asportando la piega ocul o palpebral e insieme co n una parte della congiuntiva, e talora con una parte della cartilagine. Se esiste panno cr&sso, può per furio riso l vere rapida me nte, la circoncisione della cornea. N el raggrinzamentodella congiuntiva per tracoma con o senzu la esistenza anco 1·a di folli coli è pure indicato il ll'&llamento operativo.
RlVISTA DI OCULISTICA.
RIVISTA DI ANATOlliA E FISIOLOGI A
Normale E Patologica
e del doll Sawt!:'chenko ( 1). Si d1 r 1ferirt> le proprie o9servazion1, citando dei lavort prec<>denli ;;olo ctò che conferma il suo moòo di "edere N o la però che, negl1 ultimi du e anni mollo è ::stato scrtllo sull'argomento che lo occupa : ciouonostaute abbiamo au co ra, egli dice, u11 matertale informo, non essendovi Cra 1 singoli fatti conosciuti alcun ne-.Ro. Un a coRa e accertata ,.d è che nei tumori carcinomalosi noi abbiamo da fa 1·e con un para ... s tta animale ; ma se vi sia di es;so una sola forma o più fo rme, e se queRte siano le diverse fa si di !'vil u ppo tli un organi<>mo non ancora conosciulo, o tuUe forme morfologica mente mature nou s1 Sll ancora. Dalle O>"servazionl dt Kos8inskg, Sudakewitsclt, Sawtsehenko, Vedeler ed altri l'A teoricamente, viene alla che la forma perfetta mente sviluppata del parassita non è ancora conosciuta, e questo suo m odo di v eder e egli dice che é perfettamente confermato dalla pt·atica.
Le s u e os-serva zioni riguardano un carcinoma de l labb1·o. Ha fallo ri cer che anche su altr1 carcinomi (!ello mammella ecc.) e, costantemen te, ha trovato le sles!'e f•>rm e di parassita. Fa eccezione 'Oio un csrcinoma celloirie, il q uale, probabilmente, avrà un paras ita specific·o.
KoROTNEFr . - Il • Bhopalooephalus oarolnomatosu• • (Para••Ua del oanoro). - lC'entralblatt fur Baet. unrl Paras ite nk, 23 marzo 1893). ·
L'autore comincia col che non ha lo scopo d1 fare la critica di tulto ciò che è stato Rc ritto sul carcinoma.
Rimanda quindi chi avesse vaghezza di conoscere la letteratura d 1 questo tumore al trattato del pror. Pouwi ssozk1
L'autore cha le figut·e e le de ..ct·iziooi date da altri osservatori, che hanno fallo ri cerche :.apra w1 gran numero di carcinomi, con cordan o p t; rfeltamenle con le sue. appM!i qualche cosa che egli non a.bbia visto. La forma adulta, elle, pe1· le s ue qual ità morfologicbe, l"A. indica col nome di Rhopalocephalr1s ca r einomatosu!l, 6 naS<lriform e, potrei di r e simile ad un l'eslode, ed ha u na testa, che si continua co n un corvo allungato . N ella vi è un nucleo senza con torni determinati, n ou vesc1cohu·e, fatto da uu plasma g r anuloso, a g r oss1 granuli , cht> "l colora in rosso mattone col colore di Biondt men lt·e il re-.to del corpo si colora tn arancio.
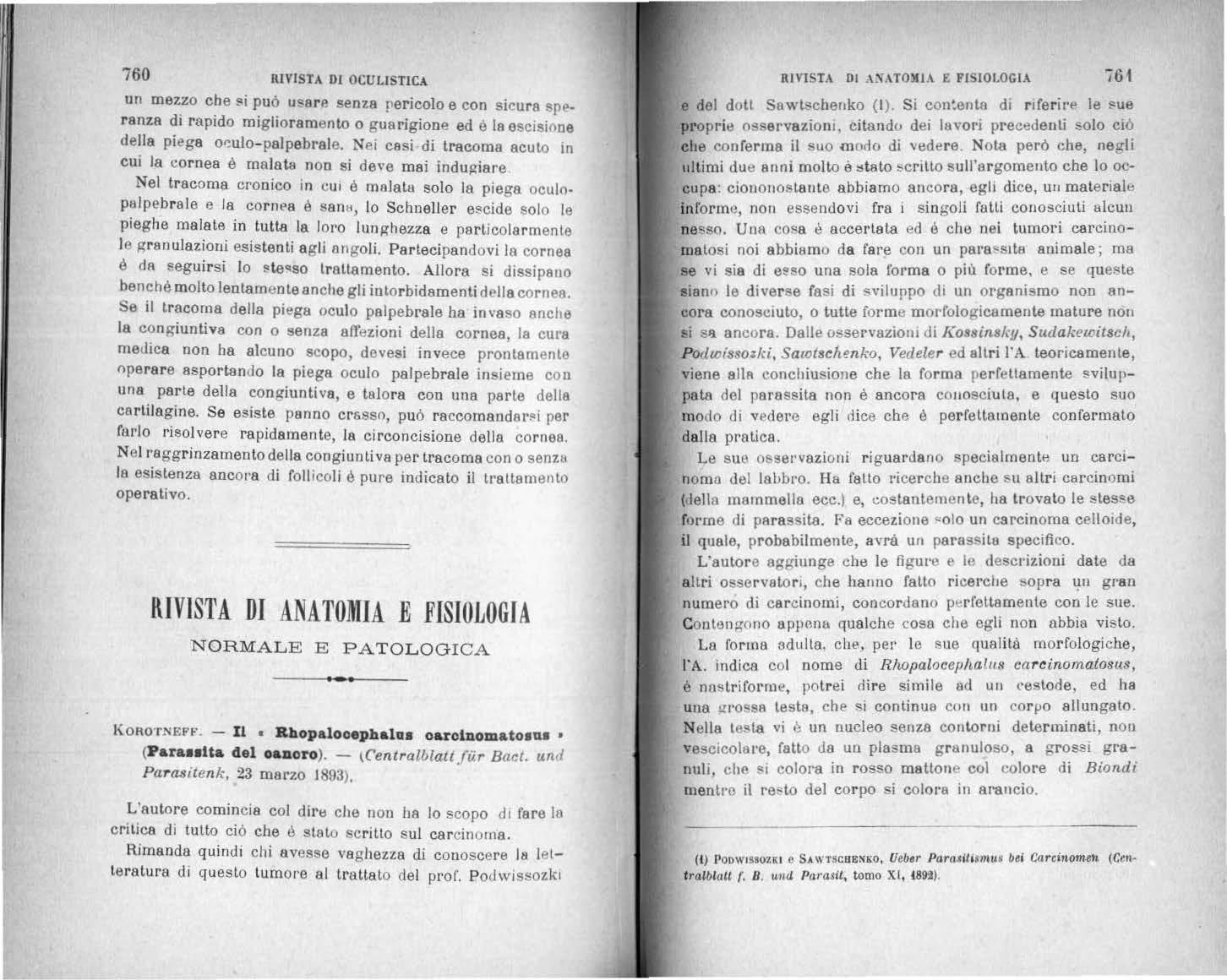
Il corpo del Rhopaloceplzalus e stretto, non fornito di pseudopodii, ed é fallo da un plasma pu1·amente L'aspetto del parassita 6 quello di un organismo della "perie delle gregarioe. Attorno alla forma adulta s1 trovano un gran numero di giovan i parassiti, che han forma ellittica, cJa,•ata, che contengono nell'inll'rno il loro nucleo di gro""i e sono rinchiusi in una cellula cancerig-na; ma, crec:cendo, escono d111la cellula e ne sorpassano i lim1ti. La cPllula chP- contiene il parassita, divenuta più grosl'a e sfer1co, esercita un'azione meccanica sugli elementt epiteliali che la circondano, i quali, costretti da una parte duliA cellule che contE'ngono il parassita, e dall'altra dai te.,suti sani, 'appiattiscono, acquistano forma di fa'ce e circoudano in giro le prime. Arrivati a questo punto, i parassiti sono m grado d i molliplicttrsi per scissione, sicché aumentando la pressione con gli elementi vicini, c r esce 11 numero dellP cellule falciforrni e si originano l e cosl dette perle del carcinoma. Nel centro di ciascuna perla si trovano o uno <1 più parassiti in scissione. Come effetto di questi fat.ti le cellule contrali delle perle cadono io sfacelo, r esirluanrlone un df'lrilus, in cui spE'sso nuotano forme di gregarine. Questo delriLus sta, senza dubbio, in stretta relazione con l'infezione df'll'organi!'mo ammalalo. La forma di gregarina in un periodo più giovanl:j di svìluppo era slala già menzionola .!al doll. Sawtschenko e da Vecleler (l ) ti ciclo di sviluppo del Rhopalocephalus. Non tutti i giovani parassiti si trasformano come è dello ùi sopra. Alcuni, dopo che si é in essi formato un piccolo nucleo, <>i circondano di un a capsula che rif1·ange fortementl' la luce. Un cosi diverso sv1luppo sta probabilmente in relazione con la nutrizione del parassita. Se la nutrizione è abbondante. que.,to se invece è "C8l'"a, si incista. La forma 111capsulata diventa presto simile alle Ct')ccidiP: è l"tala giil descritti! da Kes..insky c Su la kewitsch. EssA é sft>r·rca, h n
( l ) der Carcinome (Centralblalt r. B. ulld
DI A'UTOllL\ E FISIOL<IGI
\
i()3
la parete a doppio routorno, e contiene la VP"c:irhella 11ul• · cireondala da una sostanza finamentc g-l·unulo-.a. Questa form a di coccidia si deve considerar·e come il punto dr pai'· tenza di tutte le fasi di sviluppo del Rlwpalocephalw<J suo mterno banno origine olelle larvf', Hlle 'Jll8h l'A. ha dalo il nome di •onidi. Quec:tr, u"cendo dal cor•po mater•nn, '-'Ì inlroduconn nell• c rroc:tanti cellule conrerigne, e ,·j : ""il•1ppano prnducendo organt--mì <>rmili ulle
Ci h zooi•ll c:i formano in parte a "P''"6 della ve,.cirhetta gcrmrnal•• (Kermbla':'"hen) ed in parte a !Opec:e del plasma dellt> r.c>f'Cicllt>. E..;:-1 "'Ono dei corpi ovali c punluli..Ma woidi non sono gli uniri d1sc•·ndenli t!f•lla roccidia. forma fondamentale ne ha ancora altri. Gli
K6rper di Biitschli. corpi 1'81CIIOI'tni di Balbi anr) F-Ono corpi della forma di un fagiu•)Jo fatti dll una cic;ti .ialina, la quale conlienP un accumulo di sent.a nucleo colol'abile. Questo accumulo di plaRmn é come separato dalla cisti, ùi cui l'orma l'as"e centrale, eù è 1nantenuto a posto mediante tre ligamenl1 jalini fic:"ali nl!a parPle della cisti. Si pu0 ùir·e che Io sporozoide r· un znn1de rincbm«o iu una cic:ti. Non vi è allr·a d11ferenza fra le due forme. La coccidia in dt>lerminali periodi del suo luppo contiene od un L:O(•ide fJ!l uno r.:J.mrozoirl», rnni le due fQI'rllr> inc:reme.
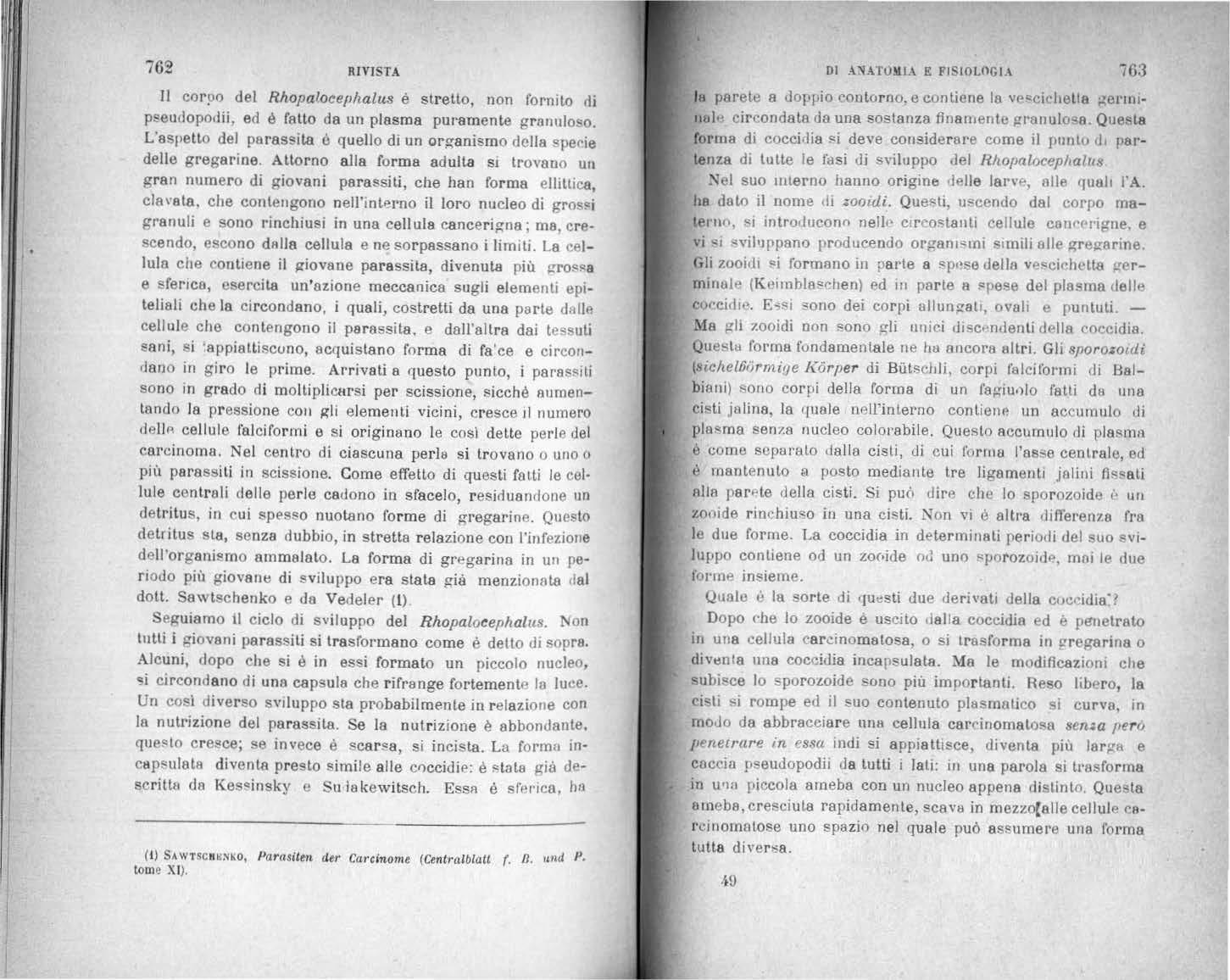
Quale 1\ la sorte eli ùue ùerivatr della cocc•idia:?
Dopo c·be lo zooide è usc1to clalla coccidia ed l• penetrato 111 una cellula <'ar.;inomalosa, o si lrac;forma in !!'regarina o una cocciùia incapsulala. Ma le modificazioni che subi!'lce lo "porowide c:ono pii! impo r tanti. Reso ltbPro, la ci"ti si rompe ecl il suo contenuto plasmatico si curva, 1n rnoJo da abbraccia r e una cellula car·rinomalor.:a sen:a pe r o in essa mdi si apprattrsce, diventa pru e cuccia pseudopodii da tutti 1 lati: in una parola si tt·asforma in u•w piccola ameba con un nucleo appena distinto. Questa amPba, cresciuta rapidamente, scava in mezzo[alle celluJP rl!t' t:momatose uno spazio nel quale può as!'umer·e una forma lulta di
Il clell'ameba di::.lingue a colpo tl'orc·hio dai nuclei delle cellule carc1110malo"e· Il numer·o delle amelJu all e volle è grandissimo. Il carcinoma del labbr·o sul quaJe l'A. ha falLo specialmente le sue r·icerche Ol'li pieno zeppo dr emrbe dr diverse Perché questa par·llco. larité. tanto importante del tum o r·t• carcinomnto"o a::tli osservatori facilmente considerando i cliverl'li metodi usali per r pezzi ed il lr'atlamento a cui sono stati sottoposti prima di far·e i tAgli. L'immc r !'lione nella soluzionP di subhmato ed i a mano libera aveJ'P in precedenza imparallinati i pe1.zi mettono in evulenza le amebe. Le amebe del carcinomA non si arresta n o c:;lrali epiteliali, ma penet1·ano ner tes ..utr circostanti: anti l'A. c rede che esse si diffondano mollo luugi nc.>ll'organismo dell'ammalalo, r!arrdo luogo in tal modo alla cachessia raralleristica del cancr o (1).
L'am eba del ca rcinoma ba le seguenti particolat·rtà. Quando lo spazio inter·cellulore nel quale esso si è situAta c:\ divenuto grande, si mostra un a dte non circonda il sJta. ma tapezza il detto spazio danrlo,!!li non una forma rotonda, ma una fo rma irregolare. L'ameba è attacca ti\ alla capsula mediante numerosi pseudopodii. Come n elle forme di coccidìe CO!'<I n ell' interno delle si -forman o zooali e sporozoidi ; ma l'<iccoroe la mttssa dell'ameba è piit g ran Je di quella della rot:ctd ia, cosi le stesse formazioni pMsono esser·e più numeros,. nellA pt•ima che nella seconda. Puh andw avw•nire che nella stes!'a ameba lr.:>vino riuniti zooidi e <:porozorr!i. Per ciò che t•iguarda l'ulteri o re sviluppo, g l i zooidi !'<i trac;fot•mano m coccrdie, gli sporozoidi l"Oio P c:;emprP in am ebt·.
Spesso si tr·ovano delle forulttzioni s peciali in mezzo alle cellule carcinoma lose, che sembrano un'agglomera zione r!i alveoli con pnr·eti rifrang-enti fortemente la luce Il contenuto rlegli al \'eoli è mur.11lagginoso e si colora deb olmente.
(l) 1 prodoLU a'otatl del parassita possono da soli rortarr l'inLouirazione dell'organismo, mn t'ameba, rormando n11ovl rocolai di carcinomn, 1la nll n cn· chessia uo caratLere intens1vo e specillco.
DI A-'\ATO'IIA E FIS I OLOGIA /65

S ono ci::.tr vuote di sporozoidr, in cui, uscito il plasma, si sono ra ccollP cellule linfatrch e. L'A. trova insostenibile l'opinion e recentemente ua Huffer e Walker (l) che siano dei parassiti morti.
Da ciò che pt•ecede d ob biamo co nchi udet·e che il lfhopalocepltalu., l> un o r ga nismo nel qu ale si trovan o unite insieme te proprietà dt due dive rsr gt·uppi dt organismi infer iOri , le coccrdie e le gregarine. Da una parte le due fasi di sviluppo alternantisi, nna libera, arneba, e l'altra rncapsula ta, fann o pensat·e alla corcidia; dall'altra le proprieta m o rt'ologi che del Rhopalocephalus sviluppato lo avvicinano alle gregari ne. 1 :: nolo che nelle cocctdie il numero degli sporo· zoidi ., minrm o an zi, alcune vo lle, non ne esiste che unoeosa che l'autore ha sempre osser·vato nel Rlwp aloceph a l us m a, a g iudi ca r e dalla descrizione di Saw\schenko si deve ammettere che g li sporozoiò i possono esse1·e anche molto numet•osi. Oro questo faLLo s i uelle gregar•ine. Con pieno diritto dunque possiam o co nsiderare il Rhopalocephalus c;ome una forma intermedia ft·a le cocctdie e le gt'egarine. .
Ma in che t·elazione sta Il parassita con l'etiologta del can c r o A. r1sol vere la qui:,;lionc ci servira di j:(llida .l'influenza c he esso esercita sulle cellule in mezzo a cur si tr·ova.
L'auto r e ha messo in chiaro che la cellula abitala dal para c:sita diventa solo più grande, senza moltiplican•i (2). Il carcinoma I]Uindi non cresce sotto l'infiuenza del parasstla; anzi l'A. dice che le cellule cao ce rigne si moltiplicano prop rio in 'J Uei punti tn cui il parac:;sita non esiste. Cionon ost!lnle
( l ) On #Ofllt pamrilic protozo a (ound In ca11ctrous tu1norJ (Tht JoumaL o( Pa t. a llll . Bai., l!;9i ottobre).
Vi 8 una •omlgllanza col MyxO>POrldlum oryosoìdu tumor s con la d11Terenza che in questo il dalla cellula agisce 10 mOllO che il nucleo subito si segroenta senza carloenl&SI e la cellull.l si trasrllrmn In un plasroolilo , mentre che la cellula caneerlgna conserva i raratteri morro logici di una vera cellula. Solo aumenta di volume.
!P alter•azioni che le cellul" subic;rono per effetto d1 sono considerevoli.
È positivo che il periodo r•·gresstvo ùel cauao " clovuto al Rhopalocepltalus, che inuuce la necros1 delle celluiP cancerigne, donde 1 funesti efft>tli della neol'or·mazioue !<U l'organismo. L'A dice: teoricamente un carcinoma parassiti non hA alcuna che è confermata dall a pratica o, pt>r meglio dire dalla clinica perché i tumor1 di questa natura non producono tutti stessi pfl'atli sull'or·f.(anii'mo ammalale). Alcun e vollt- la malall1a hn una l'orma latente, ed, a •1uanto anermano molle autorità, inco11trano. nei vecchi, for·me di carcinoma, che non eser citano nlcutHl azione '<ulle linfatiche , le quali sono perfettamente sane. L'.-\. dice che queste forme non infettive. innocue, molto p t•obabllmente non contengono paras:>iti. Sicché allora il f'UI'cinoma non t> che una semplici' neoformazione epidermoidale, s imile a tante altl·e (capelli, cor·na, uugh1e, calli). Ma dove e lo stimolo per cruesla anorm a le fol'mazione epidermoi<Jale? Anche qui la clrnica ci 1lice rh e, nel maggior numero dei esso è r·app res enlalo da. un'azione traumallca, che altera ti tlella p arte colpllA
E, 111erlico d i 1"
MET::lCHN KOFF. - Patologia. oomparata. dell'ln fia.mma.zione . ( De11tsch . meri. Wochens c., J,
Il nolo fondato1•e della teor1a della fagocito<>i pubblicando or·a in una serie li lf'zion1 i risultati <ll·i ltn·ori già in parte conosciuti e rhe gli servirono a crea1·c la. nuova dottrina, lenta di applicare i concclli allo biologico dell'infiammazione. Egli qu1 non occupa rrua'-'1 affatto del problema della immunità, ma invece 8i pretlgge lo !';ropo di dimosll·are che l'infiammazio ne non è alt1·o che una lotta per l'esistenza roaoifeslantesi negli infimi grad1 degli essen viventi, lotta che si decide nell'inldl'no deli P cellule c che quindi cons1ste in una fagocitosi.
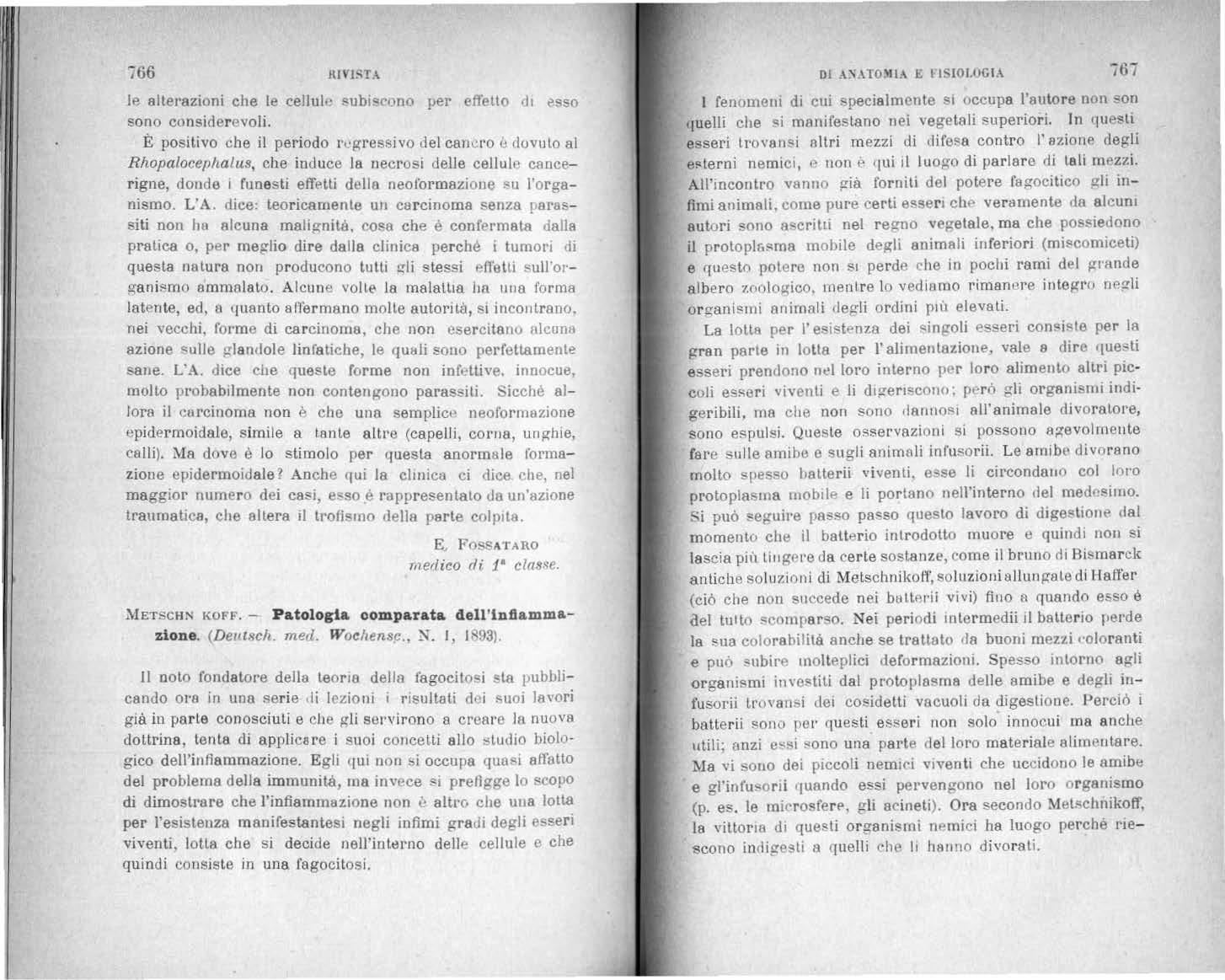
01 l:. llo;;lOI.IlGI.\ i67
fen omeni d1 cui c;pecialmcnte <•ccupa l'autore non <:on q uelli che manifestano nei vegetali i'uperiori. In quE>sli esseri lro ,·anl'i Altri mezzi di contro l' a1.ione degli e!'lerni uemic1, " non t> qui li luogo di parlare di tali mE>zzi. All'iocontt·o vanno f!ià fornili del polPre gli infimi animali , come pure r erti 8!''!er1 chP veramente tla al cun1 autori 80no a-.crilti nel re gno vefotelale, ma che il prolopi&Rma mobile dep;li animali inferiori (miscomiceti) e fJuestn potere non s1 perdP rhe in pochi l'ami del A'l'flnde albero 7.ool ogico, 1nenlre lo vediamo l'imanPJ'e integro IH't.di animnli degli ordini p1u elevali.
La lotta per l' C!'li't.. nza dei "ingoli Psseri per lfl ,:tra n parte in lo tta per l' alimenlalione, vale e dire !(Uesti esseri prendono loro interno per loro alimento aiLri picc oli esReri ''i venti e li p1·rò gli organismi mdigeribili, ma che non sono danllORI aU'animale divol'atot•e, sono espulsi. QueRle osservazioni si possono a;;\'evolmente fare sulle e c;ugli animali inl'uRorii. Le am1bt• divorano mollo hallerii viventi, esse li circondauo col lol'o protoplasma mobtl.- e li portano nell'interno del med"sitno. Si può passo pa<>so questo lavoro di digesttont' clal momento che il baltt>rio introdotto muo!'e e quindi non si la scia più ltnge1•e da certe sostanze, come il bruno di antiche soltmoni di Metschnikoff, soluzioni di l latl'et· (ciò che non succede nei vivi) fino a quando esso è òel tutto sl'otnpar<Jo. Nei periodi 1ntermedii il baLto r 1o per·de la i'Ua colorabilitil anche se ll'atlalo tla buoni mPzzi I'Olo ranti e può "llbirP molteplici deformAzioni. Sp es::>o intorno organismi iJne!'tili dal pl'Otoplasma delle amibe e degli infusorii LJ'o,·ansi tle1 cosid ettì vacuoh da cligeslioue. Pe1·ciò 1 batterii !'Ono pe 1· ()Uesli non solo innocui ma anche 11lili ; onzi u;;Hi '-'Ono una pat'll' del lot•o materiale alimf'ntare. Ma vi :sono dei piccoli nem1ci Vl\'enti che le amibe e gl'int'usorii quando essi pervengono nel loro o rganismo (p. es. le microst'erE>, :?li acineti). Ora secondo Met::;ch nikoff, la viltor1a d1 organismi nt->m1c1 ha luogo perché I'Jescono incliA"esti a quelli rlw 11 hanno divorali.
RIVlSTA
Tutti questi micr·obi sono m obili e questa loro mobilitA eostituisce per essi un mezzo di contro i nemici, perm t>tlendo loro ai fuggire e di essere espulsi per chemotassi negativa.
I fennmeu1 della chem o tass i possono nel modo piu ch1aro OS!'< ervarl"i iu f!Uei g r ossi coagu li eli p r otopla sma che rapprt>lo stad io eli plasmod ie det In cJuegli appnlllO fu studiato per la pruna volla da Stahl ltt L 'l dott rina delle chemo tassi é ampiamente svolta e da Metschnikotf, e di essa egli distingue tt·e specie, ,·aie a dtre positiva (ctoè attrattone dt mu lerie chimiche ver::Jo ot·ganisml mobtli), chemotass• negall\'1.1 (rlpulsJnml, eliminaziOlle), chemotass1 inùiffe•·enle (mancanza di ogn• movimento). Qu*'sle tre specie di r.hemotassi egli potè disltrtguere osser\'anùo tanto t miscomiceli pure altri ot'llEI· oiqmi mobili.
La chemolassi o egat1 va s i r e n de p al ese nei mi scomiceti anc h e sull e pa rti d i un solo ot·ganismo. Se ad esempio si cauteri zza una pa r te di esso, que!'ta " iene eliminata mentre il resto uel cor po da essa si ritra e.
Uagli organismi uoicellulari ai policellulal·i, a i meta zo1 ,..j osserva un g1·an salto nella filog-enia. Vi sono invero at(imali (p. es. i protospongi) i r1uali constano di una colon1a di cellule che s1 differ enziano m olto fra di loro inquanto dte le cell ul e estern e se rvo no alla locomozione> le in ter ne tHtrllboi di ) funztonatJo da ot·gani di nut••iziouo. Ma in questi animali non avviene atH:o ra uno ePparazione funzi onale definitiv a. LI' in tern e cellule amiboiòi possono in t••1opo trasfo,·morsi in estet·ne non am iboid t e viceversa, ml?rtlre negli infimi gradini dei veri melazoi ò già visib il e una ueUa divisione, almen0 in due fogli germinativi, uno eslet·no e l'altro interno, cioè io ettod erma ed entoderm a . hiparllzione si ve rifica nelle spouge embrionali nel loro stad•o di g ast1·ule . Nella ulleJ•tore e vo luzione individuale d•·lla spugna s i stacca dal fogliello iuler·no il foglietto germinativo medio o mesode rma .
L e spugne hanno qui una speciale imporl8nza perclw M e lschnikoff per la pt•ima volta osserv ò su di esl'e In dig-P- stione inlracellulare operanlesi nelle ce llul e mesodermiche. Yet•amente aoclw qui co me negli organ1smi le cellule enl{)derDllche ùiget·iscono par imenti, ma anche qu e!';te ultim e hanno ancora uua diges tione int r acellul art' com e le amib n ecc. Le ce llule del rnf'sode r ma, che so11o quelle elle d'ora in pot c'inlet•esseranno essenzial m entt', !'ono confo rmate come le amibe, sono n11)hili e <>ono inJ1uen1.ale dalla chem otassi.
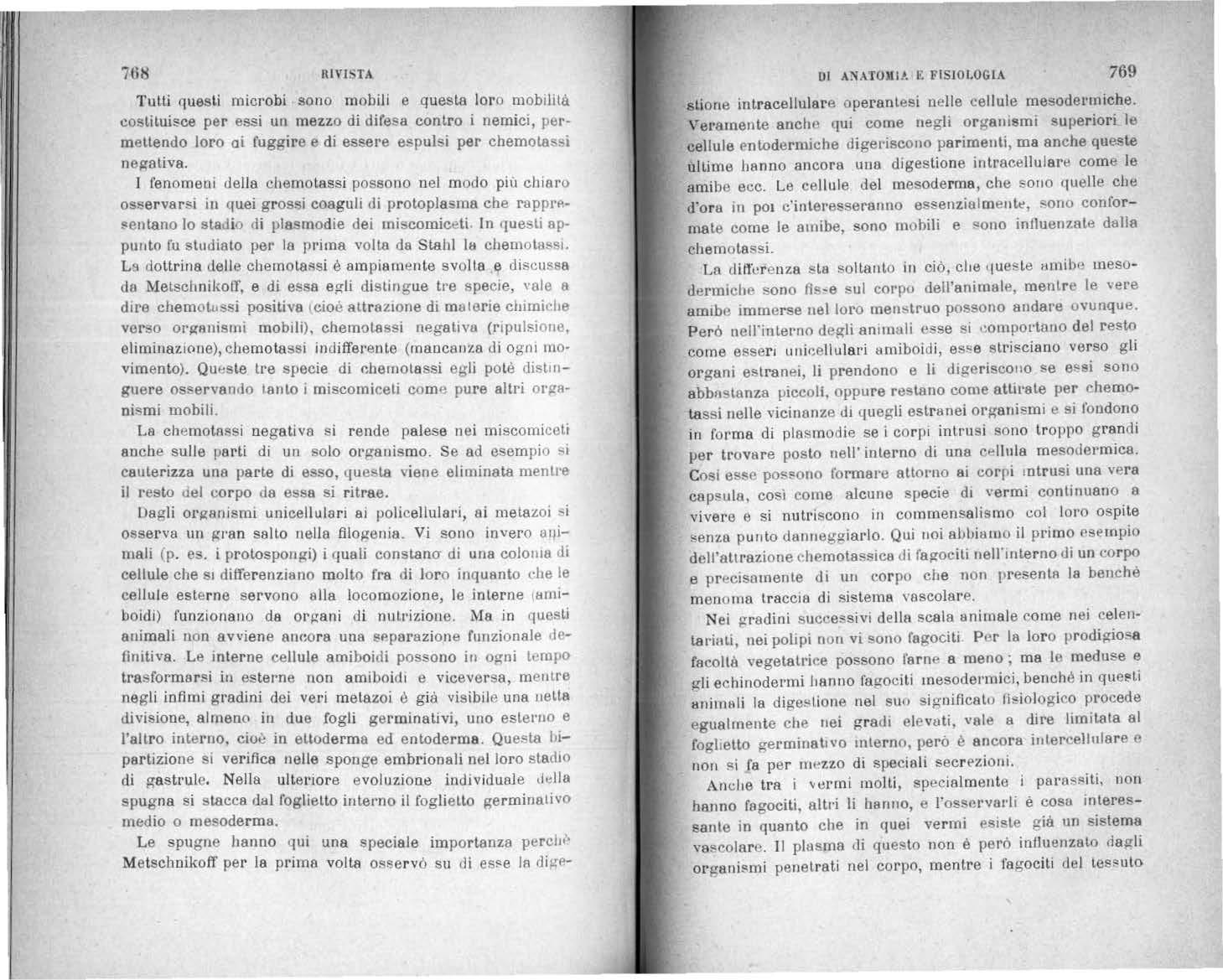
L a difl'er e oza s ta t>ol tanlo in ciò, cita •tueste mesodermi che sono li!'- e sul corpo dell'animalP, mentre le 'ere am1 bP tmme r se nel loro menostruo possono andare ovunque . P er ò nell'interno degli an11nuli esse SI ··ompot·Lnuo d el resto come esserr unic:ellulari amiboiui, stri!'ciaoo verso gli orga ni e!'<tranei, li prendono e li digeriscono l'e sono abb llstanza oppure rec;tano come atli1·ale per che motassi nelle vicinanze dt quegli estr anei organi ;::ml c si fon dono in ro 1·ma di plas morlie se i co r p i intrusi sono tr oppo g randi ver trovare posto nell'interno di una c... llula mesoùel'mica. Cosi esse pos!'ono format·e att('lrno ai cor pi 10lrusi una vera ca psula, così come alcune spe cie dt ,·ermi contmuano a vivere e si nutriscono in commensali smo col loro ospi te sem.a p u nto danneggiarlo. Qui noi aLbiumo il primo rsernpio d ell'attraz ione du•mo tassica tli nell'Inte rn o di un cor po e prt>cisamente d 1 un C'O r po ch e non presentA la ben c h è m enoma tracc1a di sistema vascola r• e.
N e i successivi della scala animale come nei C'elen1.8•·i»li, nei pohpi non vi sono fagocil1 PPr la loro fa collà vegetatt·ire possono farne a meno ; ma le meduse e gli echinodermi !tenno fagociti mesodet·mici, ben eh è in quettli "nintt1li la dige!-llione nel suo significato H;::iologico procede egualmente cht> uei gradi elevuti, vale a dire limil8ta al fogltetto germinat1vo mterno, però è ancora inlercellulare <' non si fa per trwzzo di specia li secr ez ioni.
Anc lte tra i "erm i molli, spec ialmente i non banno fagociti, alt1·i li banno, e l'ossPrval'li è cosa mte re!'sante m quanto che in quei ve rmi es1'1le già un va!';rolarc. I l plusma di que!'!lo non é però in11uenzalo organ i!:>mi penetrati nel corpo, mentre i fagociti del
RIVI'iT.-\ me«oderrn1<·o In funz1on • del le:-:sulo mede:-.uno. Quci<lo fallo può con:;:lalare perch.:. il pla«rnr. del «angue t• colorato e quindi l'u5'cila del medP.<-tmo 1!11 i va'i "'l fa pale:-e. l vcrmj che non han no fagociti -.i ùlfeudai lorn rwmsct pltJ grandi che penetrano in t':-o,i. llté· diante la di una ln mbrana prolell1"a di i<mna lal,·olta 8""0i biuar·r·a.
NeA"It ouimnli 1iell' ordiue segu..nte, uei m• llu"chr e .l nrlropo•ll ,..i vedono :.ria lt•ucocill nd sangue (solo unmuclearì) ma Slccc.rrw i 'll"'i sonzui,:mi t"Omunicano t"olla ca\'llli oiPI ro1·po meùtllnle lacune aperte, cos1 non è pos!"ibiiP una ci;,ll t1·11 1l8goc1t1 mesoderm1ci che abbiamo a'ia cono!'ICiuti P quelli (leucociti) che proveng011o dal 'l ra vi t1 .una specie <'lw una g'I'IWde imprwtanza per la :o-lot·ia della teoria del fagocilismo, eù qul•lla delle dal'nH• o clet piccoli gTanchi aquatici. Melschnikolf fece lo SUt' prirn<' OSt;l•rvat.ÌOIIÌ SU animali !>.ludiaiiÙOVi la lollA dei fagociti e dei m ict•orgaoismi patogeni. Accade p. C!". d1 veder·u clte uua spt•rrale for·mn di ferment ln<Jttospora bir·u!<pidata, da ll'intestino fa passaggio nelle l'avrta del corpo. Mel!<Chmkoff polc'' os,.Prvar'" (l e dal'nie souo C0'-1 p1ccolt> e truspar·enli che !-Ì pos!3ono :-<tudiare per intero al 111JCrO'-'COpio) eire le <lpore dr que;;;to fermento nella canl» del corpo vengono Losl•l assalttP da e dt voralr·. l t modo d'azione di'l fal.{oritr "'' esplica come una speciale Hl· flnPnza òclle spore d1 fronte alle conrl!ziour de,.rli umot'J del corpo e cio spt>CIAimeonte a' v1eue quando una spora -.oJp parzialmente :>'imbatte in 1111 faQ:o,.ilo. All ora !11 parte di che trova nel vien •(Ut>lla part•• eire spcH·:z·· libera nel liquido amb1ente resta intatta Se le ,..pore pPrrelr·ate souo in uutnel'O cosi gt·ande che le cellule divoratr-ici no11 poc:;«ono impadrouir·st di lULto, allora le "l'"re risparmiate veg.·lano 111 rorltln di lievito e queste non Yeut:rono digerite, ma alltt lot•o volla med iante la lor11 secrezione, i fagociti ed ucci dono l'ani male..\nche altrt mi· cr organismi \saprolegni) che Yenendo dal di fuor1 veg-elnno nel r.ol'po delle dat'nie ucc1dono i fagociti.
Ora facciamo un gran salto e portiamo ci a cou!"ide r·ar•e 1 l vcrlehrali, com•' si portano nel "angue parecchie f ol'tll(l rlt ft•UCOCi ti, lra i ()Ualt :\letschn1koff ITibllZIOil8 t ltJU· cociu polinucleari (leucocili prop1•iamtmte detti, corpuscoli pm·ulen ti microfal{i), le piccolt> fonnn uninucleat•i (linforltt , lP g1•an•li l'nrme mononucleari r-hiamate da Metschn 1koll l eucocili mononucleart, macr•orHg-i o gli eosinofìli. Soltanto t polinucleari e le graudi cellult> ad un sol nuclPO A!:(iscono come l'uç{ocili, i linl'ocili e lo t•ellule eosinotlle non spit>${auo qne«ta azione; pur lutlavia MPLscbniktJJT crede eh(' i linfoctli r·uppt•e>tt•nlano le l'orme giovflni che si possono lt'asf(lt'rnar<> in altre di lt>u cocili fagocilici. opina 'co rrlt'«r tamenlP alla maggi or parte deg-li O!"«f'rvaloi'Ì) che i leucociti pol'IMIIO cau1hiarsi in cellule di teossnlo congiuntivo. sn· r ebbcr·o però suscettibili di questa lrasfot'mazione 1 corpu;;coh purulenti tip1c1 lleucociti polinuclear·li, ma b<•nsi 1hnfoc1li .. 1 leucot"iti mononncl,..ari. Egh cr ede anzi cht> le forrnt> po· li nucl••ar·1 po sano ritot•nare di nuovo mouonuc!t>ari.
DI A"UTO,II.\ E 7i l verlebrah di cui l'ultimo e pià ba;;so g-radiuu t'occupato dallo A nfloxu« c:he non ha fagociti. I n certe parli delle lorvt' d1 al cuni nllri vertebrati mferiori esistono invero copio«i fogo· erti. ma 1 fao;o<'Ìll del c,angue cioè i leucoclll nou "piegano in es:;i alcuna allrvita poiché i vasi sanguigui in que'-te «pt>cie non in lutti gli animali adulti di caleErOt•ia e specialmente in tuili gli altri ,·ertebr·atl i lt•tH'ncili ùel hanno una parll' importante !"C nnn fagO<'ÌlOSI.
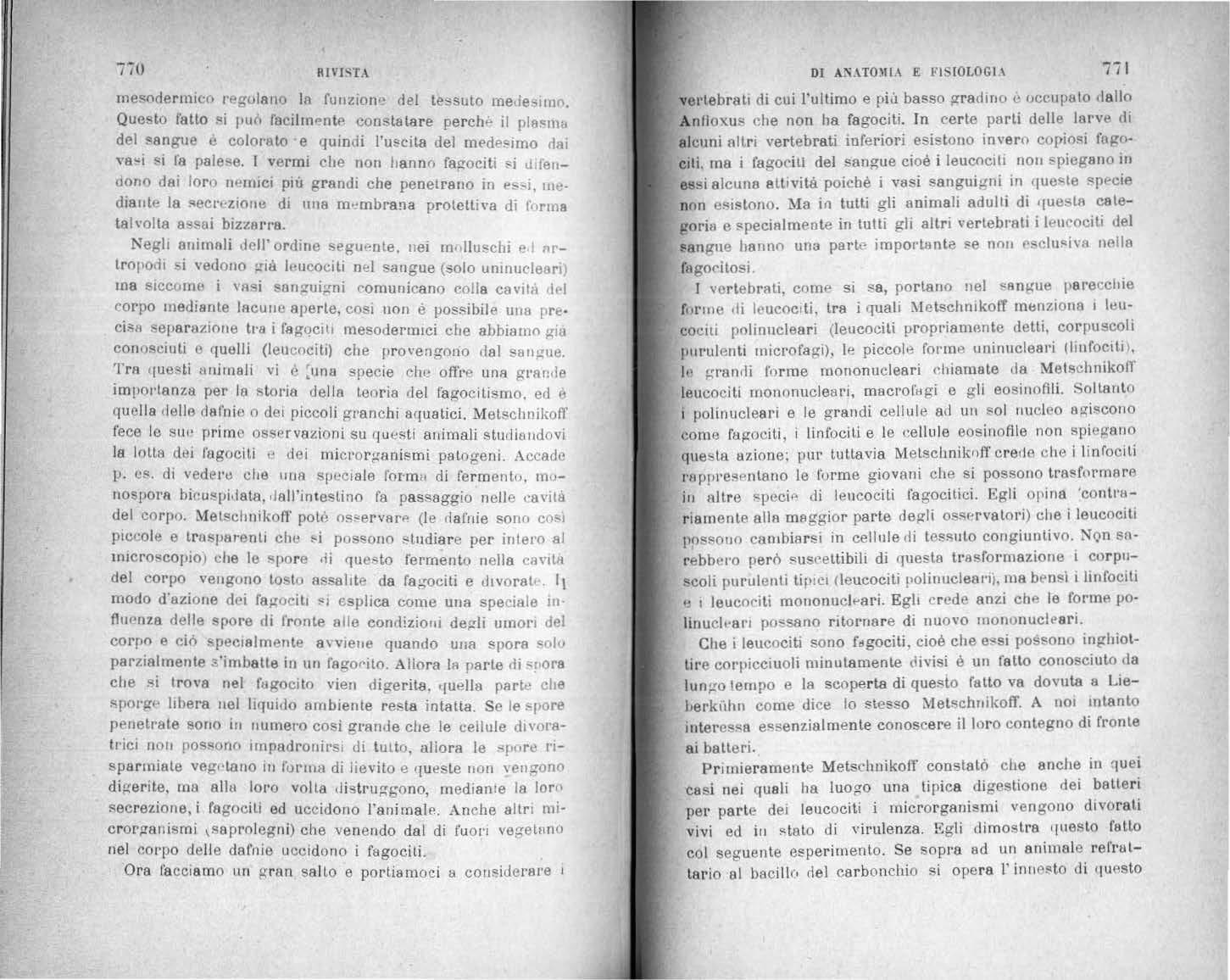
Che i Jeucocit1 sono r,gociti. croè che C"'Si possono lllfthiolLire cor'picciuoli minutamente divisi è un fatto conosciuto tla lun;..:o tempo P la scoper ta di que«to fallo va dovuta a Ltelterki"lhn come dice lo stesso Metschuikoff. A noi mtanto 1ntere!<!<a conoscere il loro co ntPgno di fronte a1 batter·i.
Pr1mieramente Metschnikolf constatò che anche in ' tuei casi nei (Juali ha una tipica digestione òei batte r i per parte dei leucociti i microrganismi vengono d1vorali v ivi eù ir 1 !>Lato di virulenza. Egli dimostra queRlo fatto col seguente esperimento. Se sopr•a ad un animale rerraltario al bacilln tlel carbonchio si oper a l' ùi quPsto bacrllo wd•amo accumulat·si e t·accogliersi i leuroc1li, i quali divorano i bacilli inoculati, di modo dopo breve tempo non si trova più nessun bacillo Hbet·o. Se poi tra questi leucociti contenenti bac111i ne pr endiamo ']Ualcuno e questo si provv ede di sostanza nutriti va, si possono vedere i batteri impt•igionati nei leucociti uscire dui medesimi. Questi bacilli cresciuti poi di nuovo nel terreno nutritivo sono virulenti rome è stato dimostralo con inoculazioni sopra animali; spesso anz1 si sono mostrati più virulenti di quantlo furono atloperali per la prima inoculazione. Più tardi naturalmente, quanuo la potenza digerente tlei fagociti si <'· completAmente spiegata i bacilli sono pL'riti, ma siccome essi prima et'ano non pUI·e vivr, ma anzt velenosi, questo deperimento, s ec ondo Metschntkoff può tl1pendere solo attività dei leurorili cioè da una digt!st10ne intt·acellula r e. l leucociLi di un comune coniglio non sono attirati dal bacillo Yelenoso del carbonchio e nemmeno lo mangiano. Ma i IJacill i non velenosi del carbonchio (vaccino) attraggono i leucoc1Li per cflemotass1: veugono da questi ingoiati e )JOi dige1·iti. Lo stesso dicasi dei bucilli velenos1 del carbon chio ri!:'pello ai conigli vaccinati; vale a dire a conigli ver t rel'l'altari. Anche m questo caso l bacilli vengono annientati pet· Jagocitosi.
Ma i leucociti non si comportano mica ugualmente verso tu W i batlet•i. Intanto essi leucociti non si appropr•iano lutlt 1 batter1.
É notarsi inoltt•e che ba Lteri tl tversi sono assorbiti da forme diverse di leucociti; cosi g-li streptococchi, i gonococchi, ecc, son presi soiLanlo dai microfagi (leucocili polinuclea ri ); i bacilli clelia lebra solo dai microfagi (grandi leucociti mononuclea r i) ecl ' altri sono d ivorati da e::trambe le specie di leucociti.
Devesi da ultimo osservare che la sola assimila zione del bacillo pec pariA de l Jeucocito, non basta per proteggere l'org anismo da una infezione. Se i fagociti non riescono a dige rire tutti i batteri che si sono appPopriati, l'animale muore; così anche come é noto, nella setticoemta dei topi, nella tubercolosi, ecc.
DI ANATOliB E FISIOLOGIA ii3
In a lcuni casi però, anche nella circostanza ora menzionata, i leucocili sondi qualche giovamento in rruanto che essi meltollo ostacolo allo sviluppo delle spore. Questo noi vediamo nell e r ane che si sono inoculate con bacillo del carbonchio. Nelle ordinarie condizioni le raue sono immuni dal carbonchio e cosi le spore vengono Jacilmente prese fagociti, n on sono però distrutte, ma ne é impedita la loro proliferaztOne. Ma se si mettono le rane sotto alla temperatura. le spore (che sono ancora vitali) germogl iano perchè, secondo l'opini one di Metschnikon·, nelle alle temperature i fagociti r•·stano o uccisi oppure indeboliti in modo da non poter spiegru·e piu la loro a zione pro telti va.
I n tu W i casi in cui 1 batteri Rono assot•bili dai f'agoci l i fa duopo;che quelli spieghino su quPsli la cLemotassi positiva. Se manca l'attrazione chemotatlica non puo aver luogo l'aggregazione dei battert nel corpo dP.i leucociti.
Questa chemotassi può avvenire fuori del sarebbe questa la infiammazione tipica, ma può anche farsi nel !"angue stesso quan.Jo cioè i batteri .;i trovano nel circolo sanguigno.
I n questo caso av viene un aumento di leucociti, cioè una leucocitosi ehe, secondo Metschnikoff, s arebbe del tutto analoga alla infiammazione ti pica.
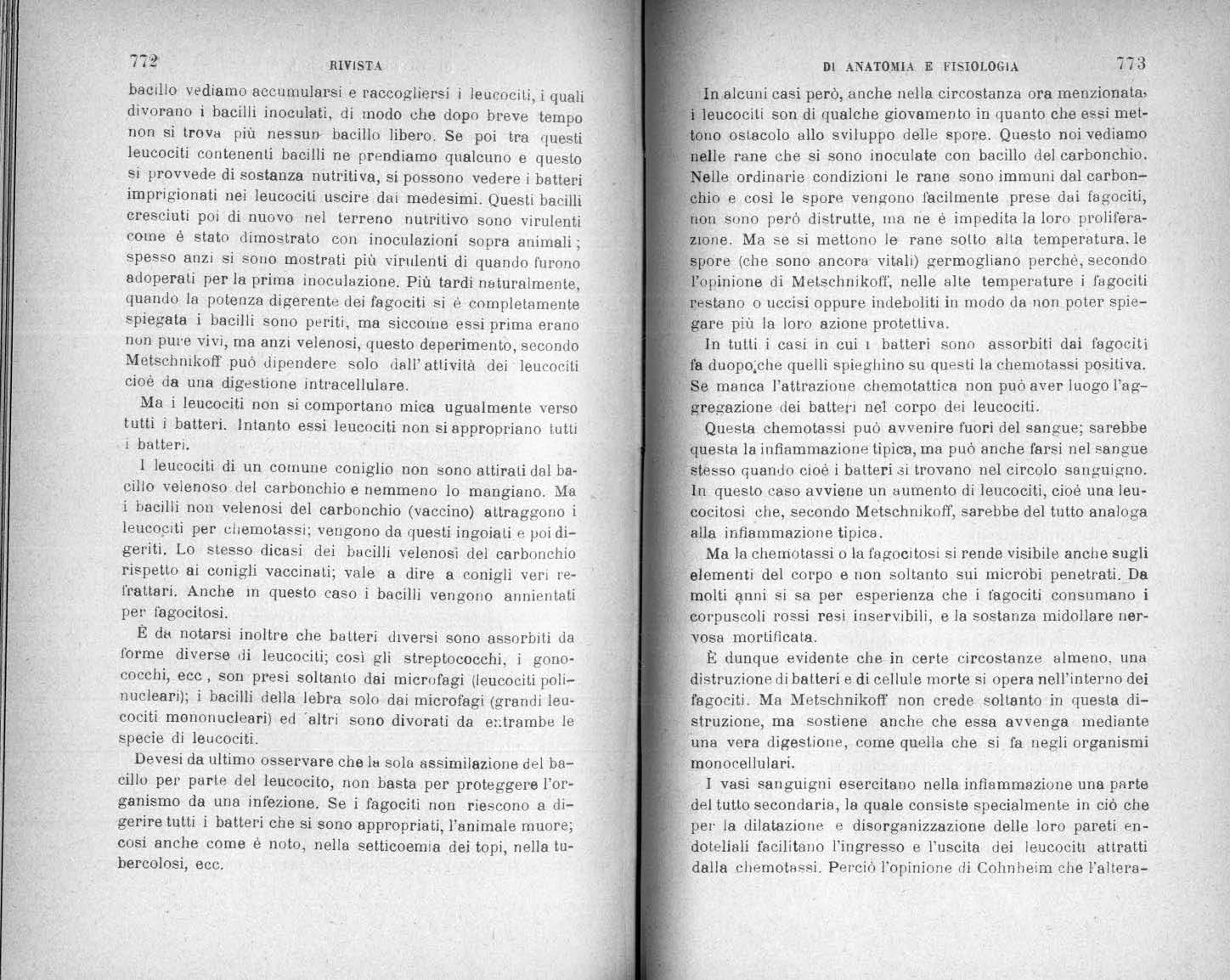
Ma la chernotassi o la fsgo c1tOs1 si rende visibile anche sugli el ementi del corpo e non soltanto sui microbi penetrati. Da m olli Q,nni si sa per esperienza che i fagociti consumano i co,·puscoli t•ossi resi inservibili, e la sostanza midollare nervosa mortificata.
È dunque evidente che in certe ci r costanze almeno, una di stl'uzione di batteri e di cellule morte si opera nell'inteJ'no de i fa gociti. Ma Metscbnikofl' non crede soltanto it1 questa distruzione, ma !"Ostiene anche che essa avvenga mediante una vera digestione, come quella che si fa negli organismi mon oce llulari.
I vasi sanguigni esercitano nella iofìammaziune una pArte del tullo secondaria, la quale consiste ::pecialmenle in ciò che pel' la dilaLazione e disorganizzazione delle loro pat·eti endo teliali facilitano J'ingtesso e l'uscita dei leucocilt attratti dalla clternotA!"Ri. P PI'ciò l'opinione di Cohnl1eim che l'altPra - llf\IS1A zione delle pari' li vnc.ali costituisca l"el:!seuza della mfìarn111.t· zion e da rigellar:-i; ir.fslti, dice rautore , nei cas1 iu cui ha luogo una irrilaz10ne della parete ,·asale dall'mterno all'esterno non vcd1amo lt•apelare alrestPrn o i leucoci!J. Per nt·lla febbre J'iconente nella quale innumet•eyoJi spirilli ,·anno ad irritat•c ro i lor·o mo,·imenti e coi loro prod otti le parett dei vasi, non si fa infìammazioue nel -=en,n proprio di Cohnheim l leucocrlr aclnn'Jue sar...bbero bensì i principali, ma non glt t'Sclusivr fnttor·r liPIIa protezione fagocil ica di nn o r f!nni!'mu, perché tll Ct>t·te rircostanze ultri elementi me:-;olel' mrr1, COOlP "Jit'I'Jalmeule p-li endotelii vasal i della milza d•·l fegato, P<·t., possnnn as!'umerP la funzione di ceUul P fA!.!O· citit·ho.
Rlpr• es;•ntando IR nota sua leor1a delle tubercolosi l'autore . ' , sernp1·e che r macrofagi debbano riguar·darsi quali prolellOt'J fagocitici del corpo contro i bacilli tl
C'he lt> cellule giganti in g1·an p'al'le non altrn che il pt•odotlo di un ru rnmollrmenlo di m ac1·ofa{!i.
Anclw le C'<' llule della lept·a devono, secondo Met!> chnikolr. eserciLarH un'flzione fa gocitica ed i vacu oii che si wdono formarsi in '(Ueste CPilulP ùa lui considerati fJu&li vacuolt rla •li:;te;:tJ o ne come quel11 delle amibe e cle!d1 infn!::'uri.
Ftualrnente egli crede anche che gli accumuli cellulari delle crnrdche ejlaliti. nefriti, PCC., non siano allro che accumuli di ftgot'ilJ. 1 'JUI'lli '<ono cle<-ti nali assorbire e digPrit·e le ct>llule che f ut·ono in precedenza .l an lw2g-ialt>
L'autore si Clcrupa delle infiammazioni nelle 'lualt compt•ende le sier·o- fìbrinose dPJle meml>rauc il curatter·e di 1111este fl ogosi, dai cui prodnlti non rtcavano Alcuno o •1uasi alcuno fagocita, sarebbe di m1a ce rta utihlà per l'organrsmo In ri g uarù o ai batteri stessi ... dat J s if"t·osi l'i comportano l bacilli del carhonchio e dellu tubercolo"'i cl'escono ben poco neg li essHdali siel'liSi, hl'lll'llé prodotti, l'unri del cnrpo, forni:::cono a1 buclllt 1111 appt'OJli'ÌIIlO rrut l·in1r.nto..\lrin r ontrn il vilwion e di
01 AN.\TO MIA E flSIOLOC.JA
cresce mollo rigoglt0so neglr esc::uclAli. Ila ciò n •· viene che rutilila deg-li fssudati «1eros1 non può cousi!'lere m una ut:cisione di inoltre ammellere clte gli essudati sieros1 opet'tn o Ulltl d i-.Lruzione od un'attenuazione dei prodotti V•'neflri dei batteri. come si è potuto per ti si ero tlel nel tetano e nella difterite.
A nelle 111 quei cast in eu t !"l sia constatalo sul vetro uua proprieta baltertcida del siero del sangue di alcuni anirn!lll, que"'la p ropri età fa difetto nel siero nel cor po vivente, co"''• per es mpio, il siero del sangue ùe1 topi l buctllo del carbonch io.
DA ult11no euli passu a studiare tlell'intlammaZIOIIP , ti cu1 carattere principale egli defltusce una t'l.'azroue Ji fnt.:ocili contro agenti nocivi. Perchè si fa ccia quesla l'eazione è necess:aria un'attrazione cltemotatlica, e questa atLt•azlone uegli an i mali superiori sarebbe pPopi·ia di qut•i leucociti i qualt, per scisswne e fra1muenlazione dei loro nuclt•i, clivenlano alli a Lr·apelare dalle pareti dei vasi. un<'he a llr1 fagocitt pot1·ebbero eventualmenlP entrare 111 attivitu. Anzi gli stessi vasi sanguigni sa rebb e r o attratti chemotatlicamenle verso il punto miuaecialo e di c i() abbiamo lA pr0\'8 nPlla formazione dt>l panno corneale.
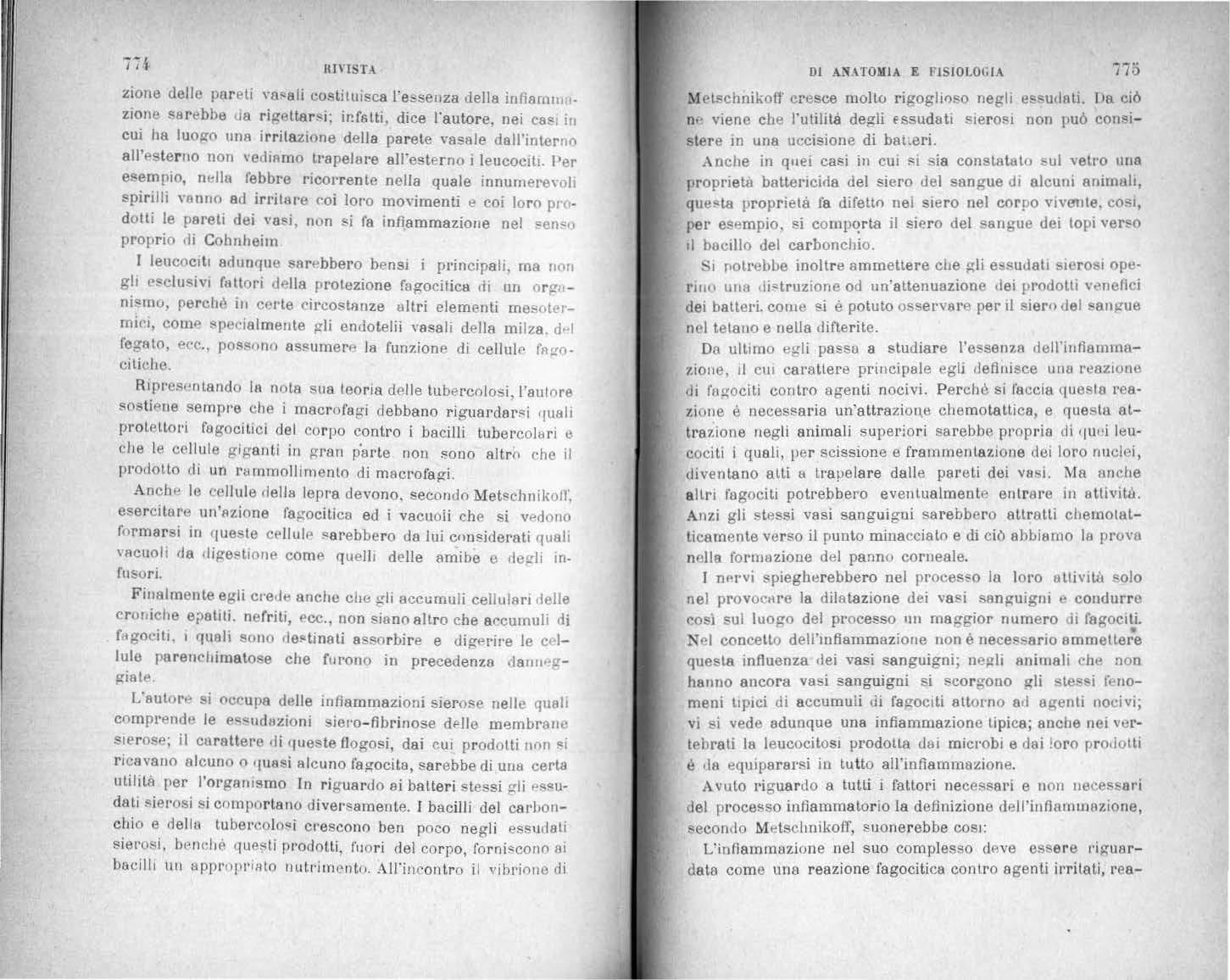
1 nrrvi spiegherebbero nel pt•oces"o la IMO alli,·ità c::olo nel provoe11 re la dilalazione dei vasi condurre r.osi !';UI luogo del pt•ocesso nn numero Jt fagoctli. N PI concetto dell'mfiammazione uon é ammettere questa mfluenza dei vasi sanguigni; negli animali che non hanno ancora vasi sanguigni si scorgono stessi t't' IlOmeni trptci di a ccumuli di fagocrti atton10 s ol nocivi; vi si vede adunque una infiammazione tipica; anche ne1 \t!rtPhrati la Jeucocitos1 pt•odotta mic1·obJ e dai !oro protlutti è rla equrpa rarsi in tutto all'mfìammazione.
A vulo t•i guar do a lutti i fatlori necessari e non ;lei processo infiammatorio la definizione dell'iufllunmAzione, :;econdo Mdsc.lmikofl', suoner ebbe cosr:
L"iufìatnmazione nel suo comples!>o dave es!lere riguardata come una reazione fagocitica cont•·o agenti il'rilali, rea- zione che ;:.i cornpie Ol'a per mezzo di soli fagociti mobili, ora col co ncMso anche dei f'agoc 1ti vasali e dell'influenza
Sulla. pQ rm eabi lltà. della pelle . - Si gno ra !'luUBE-MeNGARINI. - (A r chio . /ilr Anat. und Ph!Jsiol. e Centralo. (ii r cliP medi e .. !'. 10; 1893)..
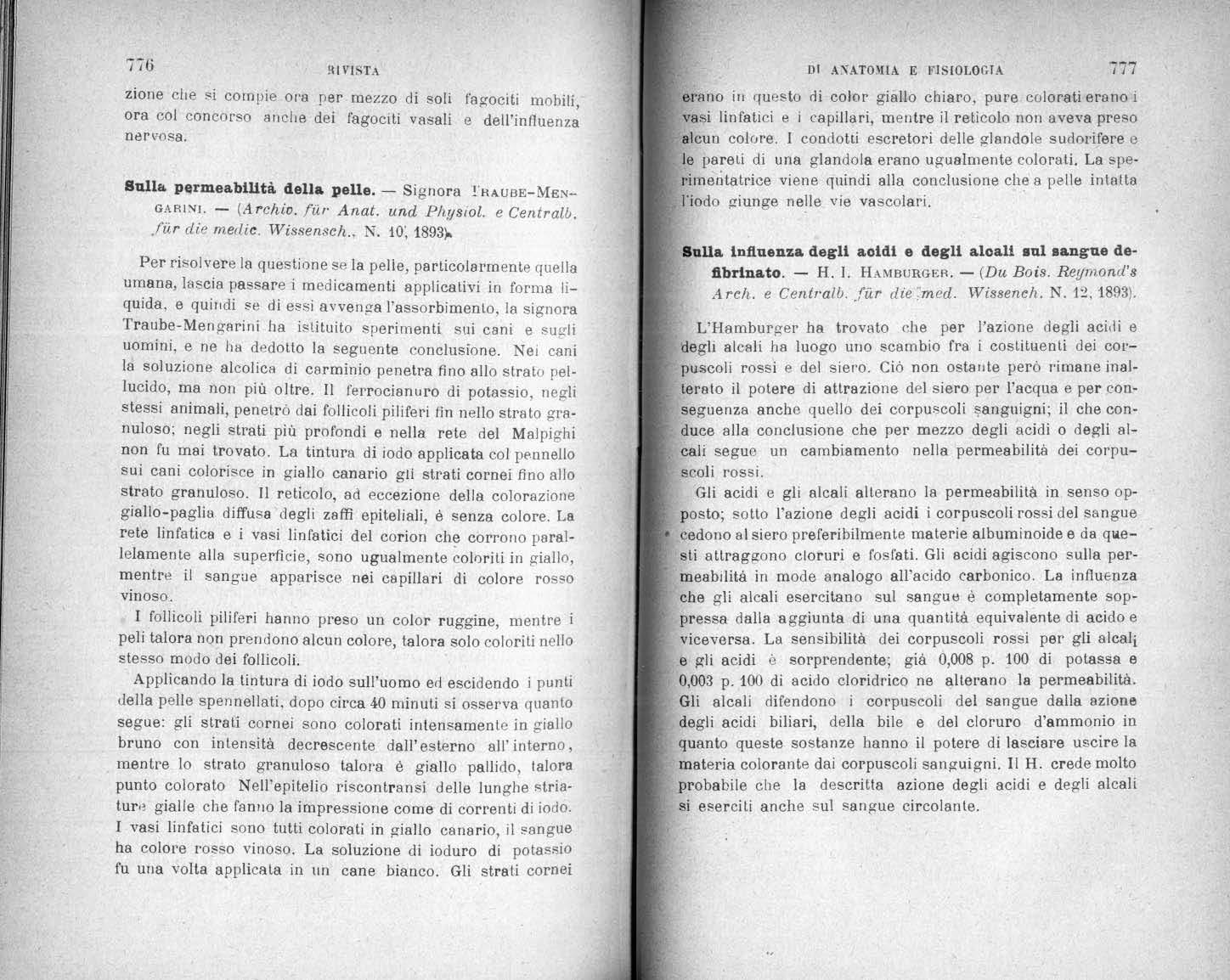
P er risolvere la questione se la pelle, particolarmente quella umana, lascia passare i medicamen ti applicativi in forma liquida , e qui11<li se di ess i avvenf,!a l'assorbimento, la signora Traube- Menga ri n i ha istituito sper imenti sui cani e su!.!ll uomi ni, e ne lt<t dedotto la seguen te conclusione. Nei cani la soluzione alcolica di carminio penetra fino allo slraln perlucido, ma non pi ù o !tre. Il f'er r ocian uro di potassi o, negli stessi animali, penetrò dai follicoli piliferi fin ne llo strato grRnuloso: negli strati più profondi e nella rete del M alpighi non fu mai trovato. L a tintura di iodo applicata col pennello sui cani colorisce in giallo canario gti stl'ati cornei fino allo s trato granuloso. Il r eticolo, ad eccezion e della colorazioue giallo-paglia diffusa ùegli zaffi epiteliali, é sen za colore. La r e te linfalica e i vasi linfatici del cori on che corron o parallelamente a lla s u pe rfi cie, ugualmente co lo r iti in giallo, mentre il san g ue apparisce nei capillari di colore rosso vi n oso.
I follicoli pilife ri hanno preso un color ruggi n e, mentre i peli talora non pt·endono alcun colore, talora solo coloriti nello stesso modo dei follicoli.
A ppl ican do la tintur-a di iodo s ull'uomo ed escidendo i punti de lla pelle spennellati, dopo cit•ca 40 minuti s i osserva quanto segue: gli strati co rnei sono colorati int ensam ente in giallo bruno con intensità decrescente dall' estern o all'interno, mentt•e lo s lralo g ranuloso talo•·a é g iall o p alli do, talo ra punto colorato N e ll'epite li o riscont r ansi delle lunghe Rtriatur.• g ial le che fanno la impressioue come di correnti di iodo. l vasi linfali ci sono tutti colorali in giallo cana ri o, il Mngue ha co lot•e r osso vinoso . La soluzione di ioduro di potassio fu uua volta applicata in un cane bianco. Gli strati cornei et'AilO in questo rli color giallo c hiaro, pure colo rati erano i va si li n tat1 ci e 1 capillari , meutre il reti colo nou aveva preso al cun colur·e. I condo tli esc retori delle :;dandole sudorifere o le pareti di una g landol a e ran o ugualmente colora ti. La sperim entatrice viene quindi alla conc lusione che a pelle in lotta J'iodo ::ri un ge nelle vie vascolari.
Bu lla i nfluenza degll aoidt e degli &lo ali 1ul aang u e deflbrin&to . - H. l. HAMBURGER. - (Du Bois. Re!Jmond's .4 re/t. e Ceniralb . .fur die ,m ed. Wisseneh. N. 1893).
L'Hamburger ha trovato rhe per l'azione degli acidi e degh alcali ha luogo uno scambio fra i costituenti dei cot'puscoli rossi e de l sie•·o. Ciò non però rimane inalterat o il potere di attra z io ne de l sier o per l'acqua e per cons eguenza anch e quello dei corpuscoli il che conduce alla conclus ione che per me zzo de g li acidi o d e gl i alcali segue un cambiamento nella permeabilità dei corpuscoli rossi.
Gli acidi e gli alcali alte ra no la perrneabililà in senso opp osto; sotto l'a ziooe deg li ac idi i corpusco li rossi del sangue
• cedono a l s iero preferibilmenle materie album ino ide e da sli atlrag!lono cloruri e fosfati. Gli acidi agiscon o sull a perm eabllità in mode analogo all'acido ca r bonico. La inlluénza c he g li alcali esercitano s ul è co mpletam en te soppressa da lla aggiunta di una quan ti là equivalente di acido e viceversa. La sens ibilità de i corpuscoli rossi per gli a lcali e gli a cidi è sorprend ente; già 0,008 p . 100 di potassa e 0,003 p. 100 di acido cloridrico ne altet·ano la permeabilità. Gli alcali di fendono i corpuscoli del sangue dalla azione d egli acidi biliari, de lla bile e del cloruro d'ammonio in qu anto queste sosta nze han no il potere di las ciare u scir e la m ateria colorante dai corpuscoli sang ui gni. Il H. crede molto proba bile che la d escritta azione degli acidi e degli alcali si e ser ci ti anche s ul c ircolante .
Azione del prlnolpil attivi della noce kola sulla contrazione musoolare . - Esperienze del pr·or. UGOLINO Mosso. - (Estratto ,tagli Atti dei/a R. Acr:arlemia delle Scien.;e di Torino, arlunanza ;; marzo '1893).
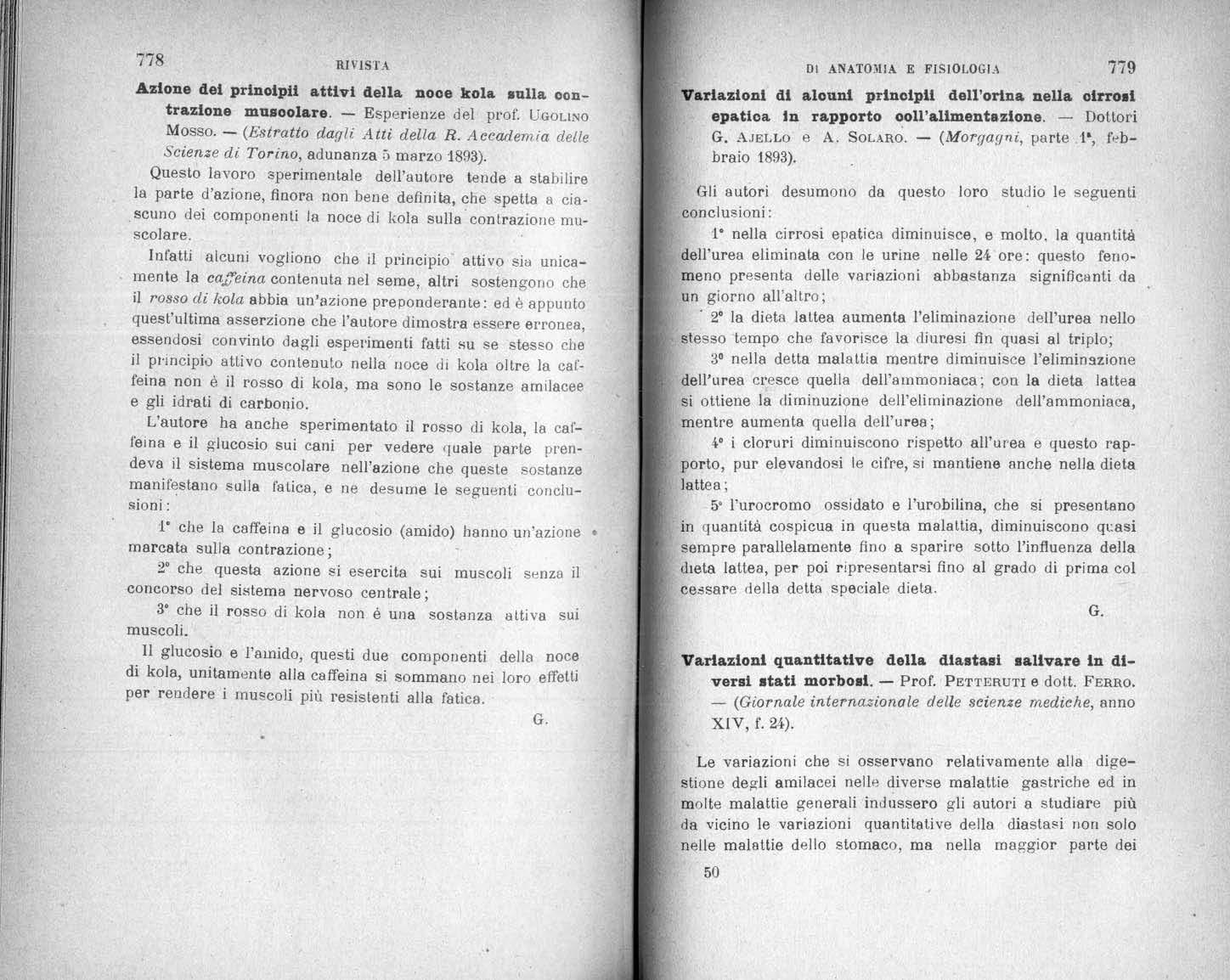
Questo lavoro sperimentale dell'autore tende a slahilire la parte d'azione, finora non bene definila, che spetta a ciascuno tlei componenti la noce di kola sulla ·contrazione muscolare.
InfalLi alcuni vogliono che d pl'incipio attivo sia unicamente la caffeina contenuta nel seme, altri sostengou o che il T'OSso di kola abbia un'azione preponderante: ed è appuuto quest'ultima asse r zione che l'autore dimostra essere erronea, essendosi convinto dagli espel'irnenti fatti su se stesso cile il pa·ancipiù attivo contenuto nella uoce tli kola oiLre la carfeina non è il rosso di kola, ma sono le sostanze amilacee e gli idrati di carboni o.
L'auto r e ha anche sperimentato il rosso di kola la cat'f'ema e il g-lucosio sui cani per vedere quale pl'endeva il siste ma muscolare nell'a zione che queste sostanze sulla faLica, e ne desume le seguenti conclusioni: l" che la caffeina e il glucosio (amido) hanno un 'azione • marcata sulla contrazione;
2• che questa azione si esercita sui muscoli senza il concorso del sistema ner voso centrale; ll glucosio e l'amido, questi due componenti della noce di ko la, unitamente alla caffeina si sommano nei loro effetti per r endere i mu!'coli piu resistenti alla fatica.
3" che il rosso di kola non è una sostanza a tt iva sui muscoli.
G.
Varl a.zlonl di alouni prlnolpll dell'orina nella olrroal epatica. In rapporto ooll'allmentazlone. - Dollari G. AJELLO e A. SOLARO. - ( M orgagni, parte 'l', r... bbraio 1893).
Gli autori desumono da questo loro studio le seguenti conclusioni: t• nella cirrosi epatica diminuisce, e molto, la quantità dell'urea eliminala con le urine nelle 24 ore: queslo feuom eno presenta delle variazioni abbastanza significanti da un giorno all'altro;
· 2• la dieta lattea aumenta l'eliminazione clell'urea nello stesso tempo che favorisce la diuresi fin quasi al triplo;
3° nella detta malattia mentre diminuisce l'eliminszione dell'urea cresce quella dell'ammoniaca; con la dieta lattea si ottiene la diminuzione dell'eliminazione dell'ammoniaca, m entre aumenta quella dell'u rea;
1• i cloruri diminuiscono rispetto aU'urea e questo rapporto , pur elevandosi le cifre, si mantiene anche nella dieta lattea;
5• l'urocromo ossidato e l'urobilina, che si presentano in quantità cospicua in questa malallia, diminuiscono ql:asi sempre parallelamente fino a sparire solto l'influenza della weta !allea, per poi r ipresentarsi fino al g ra do d i prima col cessare della delta spe ciale dieta.
G.
V arlaztonl quantltatlve della diastasi aaltvare In diversi atatl morboal. - Prof. P ETTERUTI e dott. FERRO. - (Giornale internazionale delle scienze mediche, anno XIV, f. 24).
Le va riazio n i che si osse rvan o r elativamente alla digestione de,gli amilacei nella dive r·se malattie gastriche ed in mo lte ma lattie generali inJusse ro gl i auto r i a studiare più da vicino le variazioni quantitative della uou so lo nelle mal a ttie dello stomaco, ma nella mag-gior parte dei cas1 (·he ebbero occe<.ioue di oc:ser va re nel co r !:lo •lÌ un anno nella t• sala doune nell'o«peda le Incura bili.
Nella lelle rat urn medi f'A non s i trovano rhe porhissimi dat1 in e l'le ne l!' o!'.se rvazioni del Samuel sulla diminuzione della dlllsta!li !-<alivare (-<ostanza rhe produce la digestione degli a mi lacei). nelle febbri e nelle dispep;;ie in ge nere, come auche 1 dati g e ne r ici sulla dm1inuzione 1li questa s o stanza nelle am•m1e e nelle Cllchec:c:1e, non si trova nient1· altro di pl'eciso.
Dalla somma dell e i3 osse1'V82in ui di <; tu ali au tort pr es entano il r esoconto, si possnno dedur• r e lo seguenti conclusiom:
1• P er· a lla diasta"i vi <;ono due fo rm e dr catarro gaslt·ico. rn una forma la d1 a c:tas1 e diminuila ed in un'altra aumenta. La m uggio r parLP dei Jistu rbi gast r o enterici produe.. la d1minuzinne nella quantità della ptialina , mentre in pochi questo aumeata uote volme nte.
Qu este diminuzioni ed aumenti n on sernpt·e possono scop r·ir si j.lei soli fenomeni che accompagnano questi dic:Lurbi, ma r· necessar·ia la r ice r ca analitica la 4ua e ha una Yasta applical.ion e nelle cure diete t iche di queste fo rm e morbose.
2° L 'anemia, la Lcmperalu1·a febb r ile e la tube r colosi indu conn una d1 minu zione quan ti laL1va n e lla dias tasi sa livare. Questa diminu z ione è ms!lsirna negli febb1·ilr, mentre non é poi tanto r 1levante nelle alt r e due condizioni.
:J• Il ptialismo mercur iale è associalo a diminuzione pr obabilmente !->Oio relativa dl'l la diastasi saliva r e , mentre il pllalismo pa raliti co ne aumenta la quantità a ssoluta.
4' La leuce mia induce aumento n ella diastasi suflvare.
DI AXATOlll \E FISIOLOGIA i81
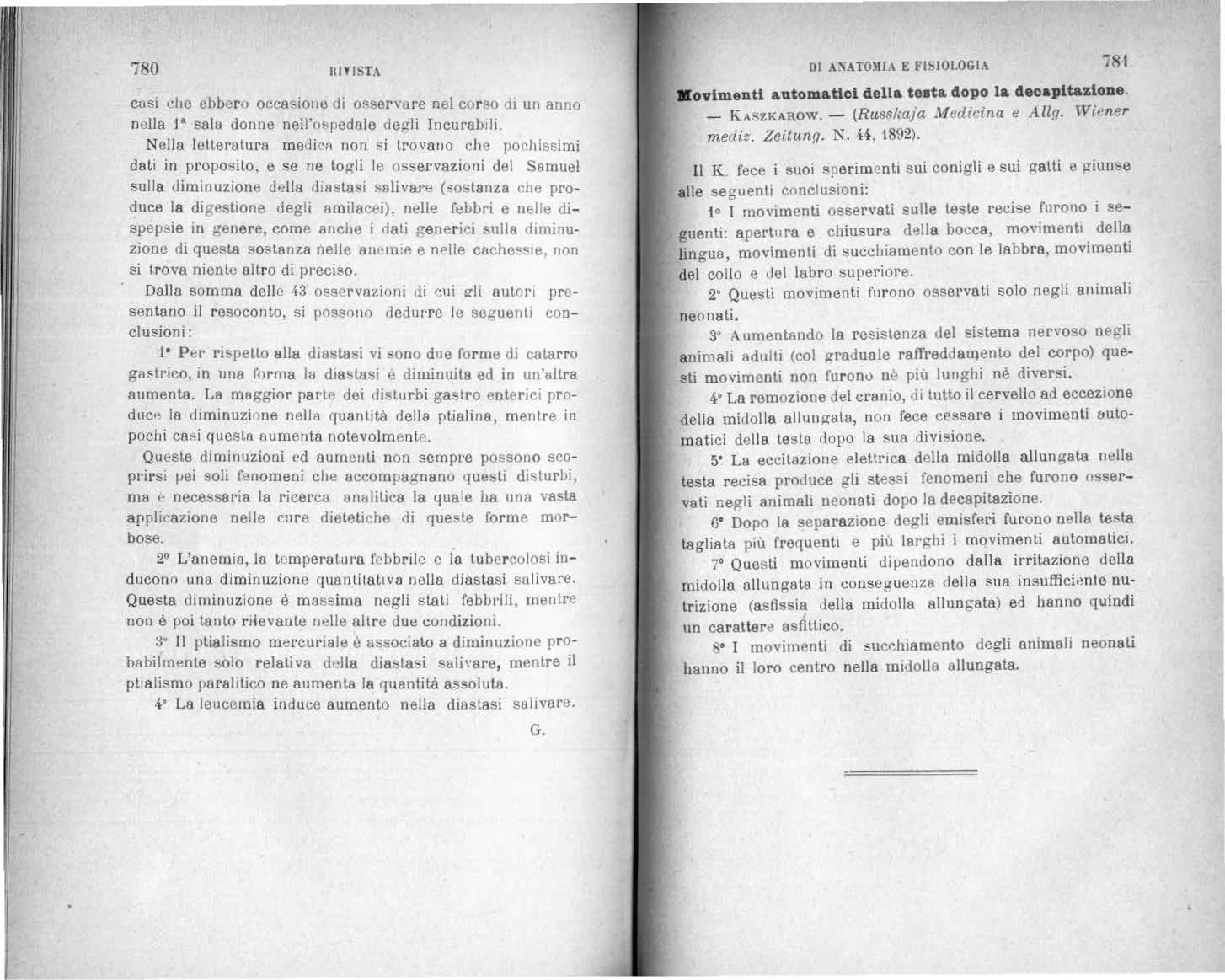
•o vimentl automatici della te•t a do po l& decapitazione.
- KA I':ZK AI:\OW. - (Ru!;skaja .\1edtcina e tlllg. Witmer Zeitung. N. 4-i, 1892).
Il K fece i suo1 s ui co ni gli e sui g alli e ,ziunse a lle seguenti conclusioni: f o I mo,·imenti osservati c:ulle teste r ecise furono i segue nti: a pertura e chiusura dell a bocca, mo,·imenlt. lin g ua, movimenti di succhiamento con le labbra, movunenb del collo e del labro superiore. a• Aumentando la resistenza del sistema nervoso negli an imali adulti (<.'ol gra du a le raffreddall)ento del cor po) questi movimenti non fu r ono nf> piu lunghi né div e r si. s• Do po la separaz ione degli e misferi furon o oella tec:ta ta gliata p1ù fre()uenll e piu i movimenti automatici. s• I m ovimenti di degli an ima lr neonati hanno il lo ro centr o n ella midolla all ungata.
2• Questi movimenti furono solo negli a11imal i neonati.
4• La r emozione del cranio, di lutto il cervello ad eccezione della mirlolla allun gata, non fece cessa re i movimen ti automatici de lla testa riopo la sua divic:ione.
5• La eccitazione eletlrtca d Alla midolla nella testa re cisa produce gli stesl'i fenomeni che furono osservati negli aniroah neonati dopo la decapitazione.
7" Ques ti movimenti dipendono dalla irritazione Jella midolla allungata in consegueoza de lla s ua insufficitlnle nutrizione (a sfissia Jella m idolla allun g ata ) ed hanno q uindi un car aUer<' asfittico.










