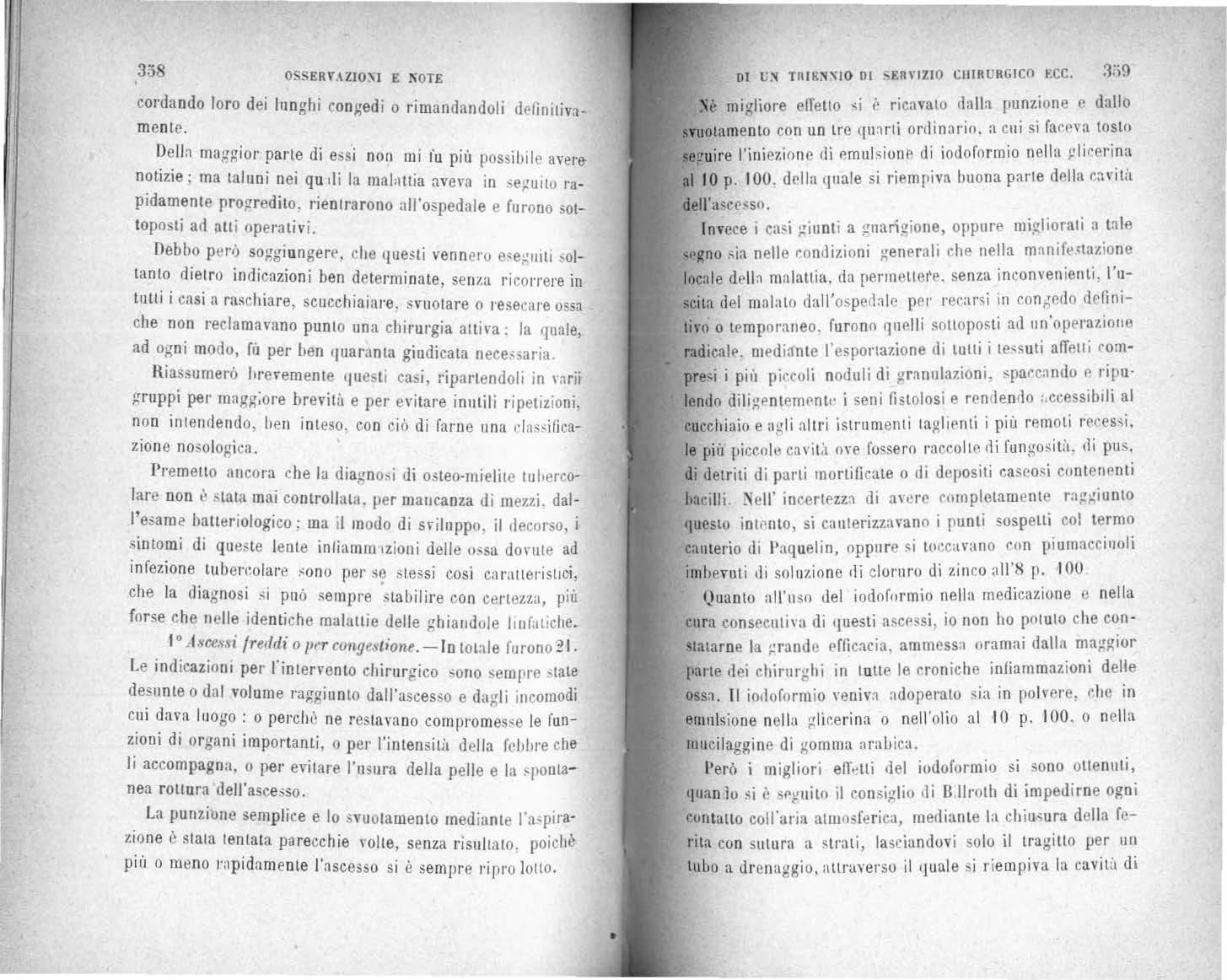
56 minute read
E l'i
OTE corda ndo loro dei lunghi o riman dandoli ment e. definitiva- lweremente •IUI!st i casi, ripartendolt in ':1rii per mngg;ore breviti1 e per evitare inutili ripetizioni. non intendeudo. llen inteso. con ciò di farne una dns,ificazione no.sologica.
Dell a maggior parte di essi non mi fu più avere notizie: ma tal uni nei qu di la malatlia aveva in rapidamente pro)!redito. rientrarono alrospedale e furono sottoposti ad nui operati vi.
Advertisement
Debbo Pl'l't) soggi u nger<', d1e questi vennero e.;egmll ,ortanto dietro indicazioni ben determinate, senza ricorrere in tutti i casi a 1'as1:hiare , scucchiaiare. svuotare o reseeare ossa che non reclamavano punto una chirurgia alti va: la ,1uale, ad Orini modo, fil per hen •Juaranta giudicata nece:-saria.
P r-emeno ancora rhe la dia;.:no"i di osLeo-mielitr tubercolare non i.• stata mai contro ll ata. per mancanza di meui. dall'esame batteriologico: ma il modo di sviluppo. il ,]ecorso, i sintomi di queste lente inliamrn1zioni delle o:-sa dontte aù infezione tuber•:olare per se stessi cosi cnr·atlerist1oi, che la diagnosi "i pnò sempre :Habilire con certt•ua, più forse che nelle idenLi rhe malallie delle ghiaudule IIIJfatiche . l 0 fsce.\wi freddi o pt•r cungt•stione. - l n tot:tle furono zl. Le indicazioni per· l'iOLervento chirurgico sempre .-tale desnnte o dal volume raggiunto dall'asces:;o e da;.rli inromodi cu i dava luogo: o perchè ne restavano compromesse le funzioni di organi importanLi, o per l'intensitit ùt>lla f«•hltre rbe li accompagna, o per e\Titare della pelle e la nea rouura miuliore efl'ello si i• ricavaw llalla punzione C' dallo o svnotam ento l'OD un tre qu:Jrti or1linnrio. acni si fai'PYa tosto l'ini ezionC' di di iodoformio nella J.! IÌ rt>rina al IO p. 100 . dC'IIa «Jnale si riPmpiva huona parte di'Ila ravilit
La punziune semplice e lo svuotamento mediante l'a-pirazione è stata tenta ta parecchie \'Oite, senza r·isultato. poichè piil o meno rapidame nte l'asc c3so si è sempre ripro lollo.
I nvece i ca.;i J.!ll! Dl i a J.!nari!?ione, oppurP migliorati a tale .;pgno :o. ia nelle rontl izioni genl'rali rh P nella man ife ;tazione lllcnle d1•ll :1 malattia. da permPllCI'E'. senza inconvenienti. l'nòel malato dall'ospe rl:IIP pPr rel':mi in con;irllo ÒC'rìnitinl o tPmporaneo. furono qnelli sottoposti atl nn 'oppr·a1.ionn rad rcaiP . mPdiante l'esportazione di tuili i afTeui rornpre,-i i più pi,·culi noduli di P ripu· lenti o dilig PnternC'nL«· i se n i fistolosi P renllen rlo :.cressibdi al cucchi aio e ag li alt ri istrumenti tagl1l'nti i più rPmoLi 1wes.;i, le più piccolt• ea,it:l O\'e fos:;ero rarroltr. <li di pus. di tletriti di parti mortificate o di drposili casco-<i runLenPnti ha··illi. incertezz1 di a\ére ru1npletamente ra)!;.:iu nto •ruesto intl'nto, si cauterizzavano i punti sospeui col tPrmo cau terio di Paq uelin, oppu r e si ltH'cavano ron p1Umarciuoli imlt evo ti tli soluzi one eli cloruro di zinro :1l1'8 p. l 00
Quanto all'uso del iodoformio nella <' nella t'nra consecutiva di ttnes t i ascP,si. io non ho potuto che conla ;1rand<· eflìcacia. amrness:t llramai dalla maggior· parte Ilei chirurghi in lulle le croniche inliammazioni delle oss1. li io•loformio adoperalo sia io polvrrl'. rhe in emnlsione nellu glìr:erina o nell'olio al IO p. 100, o nr lla ruu cilagginr di gomma arabica.
Però i mialiori etl'...ui 1Ìel iodofol'mio si sono ollennti, !')
•ruan lo si ì• il con siglio tli 13 llroth di impedirne ogni
•·unLat to coll'ana alm11sferica, me<liante la chiu.;ura della fprita con sut ura a strati, !a sciandovi solo il tragitto per un tuu o a dr ena ggio. attraverso il quale riempiva luca vita di emubwr.o ùt todofonnio o che veniva dopo tolto per applicare in suo luogo l'ultimo punto dt i' Uiu ra: o co ll a partiale e col tampouam cnto di tnlla la ca\'t là t• on mus,;ola irnpre;.{ nata della !>Oi uztone, e seguita dall'applicazione di una medi cazio ne fatta con tlen.;t 'lratt dt co tone idrofilo fortemente compressi.
Come giit ' i a1·cennato, ascessi freddi per che l'lltlenento t•hirur::ico furono npartiti : f.f della toracicn da carie di una u piit t'n!>tolc. drlla davicola, dello stemo: o da periconùrite l'un )!usa tleiiP rarLilagini di prolun;.tameoto.
In 7 rli questi nt 'Ì, dopo aver esportalo, colle pareti dell'asces..;u. tutte le parti molli iulillrate di pus o ùi e talvolta anchu semplicement e iperplasti che. si li· tnitò l'o perazione al ra ;-;dt iameltLO e allo svuotamento par· zia le delle ossa e tIelle cari ilagini co l c ucchiaio tagliente. l n ;_; altri easi si ri co rse alla re sezione di interi pe1.z1 ti t una o più co,tolt•: iu 1111 sesto a quella pat'Ziale dello sterno, e nel seuuno alla resezione di e della dente t'stremllit della clavij·uld t;li e"i ti furono i seguentt : complete X: guariinromplet(l. ciOl' eon vermanenza di seni fi:.tolosi tut· tol'a aperti e s1•rernenti 6. Tuili gli operati, arl eccezione di uno (,;old. C. \ . deii'X.t0 fanteria), ell e venne :-uhito rimandato al corpo. e di 1111 altro conl;edato per fin e di ferma, furono alla di :\Toncalieri o inviatt in li ce nza di convale:;cenza da due a tre mesi.
Di re cidi,·e venuti a mia conoscenza soltanto 1 io duo dei quali, rientrati nell'ospedale di Torino, si do,•e tte prot·et.lcre ad ur1 sccontlo atto operativo pilt esteso e piu grave del primo. che però non va lse ad ottenere fa g uarì ·
DJ Ui\ Tllll.'lt:'iiO n t :-.El\\ IZIO C HlRUitt.lt :O ! t t:. :Hi1 aione . cosicchè gl'i nd ividui furono delìntli\'amente con!.!edati in "egrtito a di rimando. l'n terzo, notevolmente migliorato io licenza di con ,·ale:;cenza, fu ohllligaw di ri coverare in seguito nell'ospedale militare di Firenze. dOH' venoP sottoposto a delìuitivHmente inabil<' al servizio: e l'ultimo fùr·iformato al corpo.
La dill'usione del processo toher·colare ni polm c..ni c --tat1 una sola ,·olta. in cui l'osteomielite a'e'a intaccato prrma l'estremit1t acromiale òella da\lcola e poscta il manubri o dello "terno .
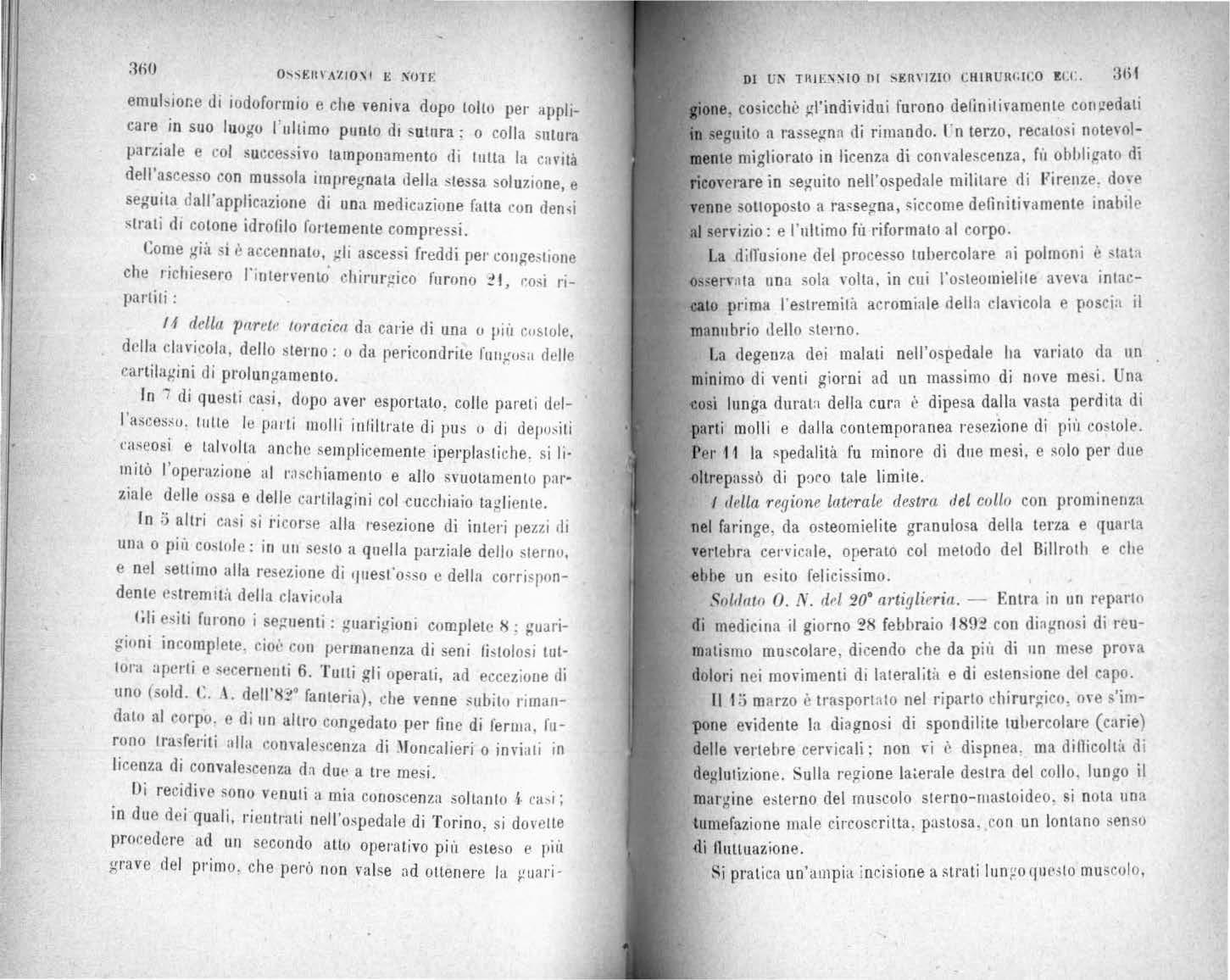
La clegen1.a dei malati nell'ospedale ha variato da nn minimo di venti giorni ad un massimo di nove mesi. Una 1:osi lun ga durata della cura è dipesa dalla vasta perdita ùi part i molli e dalla contemporanea resezione di più
Pe1· H la fu minore di due mC'si, e solo per due oltrepassi> di poro tale limite.
1 rlrlla regione latrrate destm del collo con prominenz:t nel fat·inge. da osteomielite granulosa della terza e quarta ve rtebra cen•icltle, operato col metodo dt>l Billroth e che ehhe un felicissimo.
Sold11t n O. N. rlrl 20" al'tiglù•ritt. - Entra in un reparto di medicina il giorno febhraio con di reuma tismo muscolare, di cendo che da più di nn rne:.e prora dolori nei morimenti di lateralitit e di del capo.
[( l :; marzo è trasportato nel riparto chiroq.!Ì C<I. o,·e s'impone evidente la diagnosi di spoodilite tol•erco lare (carie) delle vertebre cervica li; non ç-i (• dispnea . ma dillicoltit d t rleglu tizione. Sulla la•erale destra del collo. lungo il margine C$lerno del muscolo sterno-mastoideo. si nota una tu mefazione male rirrosrritta. pa stosa, ron un lontano sen:;o di fluLL uazione.
Si prat ica un 'ampia incisione a gtrati que.; lo mu sco lo,
OSqR\'.UIOi\1 'W lE si svuota e rip uli sce la c;m tit, rascl ti •t ndo le apofisi tr·asverse delln terza e quarta verte!Jra ce rvi cale: iudi si fa una o; utut·a di tutti i res.;u ti n'ci;;i, 'i riemp;e la r;nitit di emu lsio ne di iodoformio io g-ltt·erina e con nn ultimo pun to si com pl etamente la fenta. lo ca po ad otto ginr ni ;;i cons ta ta 1111:. co111 ple ta riunwne di tutta la ferita: i movimenti del capo sonu l ibe ri . lrbet a pure la deglutinazil)nr. cos icc hè l' indi' i1luo viene inviato in licellza di convalescenza di giorni ehbi p111 di ri ceverne notizie.
1 di'l dorso tlt osteomielite :! ranulu-a dell'olla\a e nona vertebra
Soldato Il. E. di'l i2° {'mlt' ntt. - l ntli\'iùuu marilento e ron febbr e che alla sern oltrep<h:>:l\a i :Hl ' h. gradi. Prattcata un'am pia in cisio11 e a tutto della mnssa mu seo lnra sacro- lomba r e rli s inistra, se;.;uila 1lalla re,eztone tlell'apulbi trasver-;a di •Juel lato della ottava e nona verteb ra " tlalla delle lami ne VPr tehrall t'u l'ri5po nde n ti. s1 d11u le parzialmente con punti di sutum la lnrga bre cc ia, tanto da pot er tamponare con mnssolu impreg nata di emu lsione di iodoformi o Lulta la ca vità , ind i medicazione or·cl n-;iva. (:uarigi11ne co mp leta dopo venti !'Il i : l' ind i,. id uo. dt'Il' ult ima di le\'<1. c ro n)!edato definili 1 amante pt>r !.!nu:ihtà. Entrato !) febbraio 1892, uscito i aprile flum·dia eli .'11. E. della fo.Ha ilincu da lll t.. 'l TRif.:\ 'ìlO DI ._Eli\ JZJO ClllRt;IIGICO Rl C. osteomit'lit·· dt'll'os.w omommo. Operato due volte, la sf'conùa delle quali ro n inri;;ione delle pare ti addominali tulla la luu ;.:bezza uell'arcn ta dt'l Pop:irzio; IO allo del perio:->ti o. incisione dell':tpo neu rosi loggia vasalc e I'Jsc b iamen lo di parer chi pu nt1 deli dt npulita I'Ompletamente la ca v rià dell'a$•'esso. sutura e z1ooe al iodoforln to seco ndo il metodo di Billroth . Guangtoor compl eta, cos icc hè il pnò. dopo due di li r: nza, riprend 1•re tutl•J il servizio. La malattia datavrt (\ a cmque mes1.
:J dt'lla (ossa ilia ca. dei qunli <lue da carie ,·ertebral e, ope 1·nti co l taglio di Ooe lliu ge r al di ;;opra d el lega!flento t1el P oparzio, s nbito a live llo dt•lla spi na iliaca an teriore superiore. uno morto nell'ospedal e per tuùercolo:;i polmona re, l'a ltro. un ullicial e del di P inerolo. andato 10 li ce nza d: co nval escenza e morto co la pure per la co mplicanza; ed un o da os teomi ellte dello s tesso iliaco.
1 della filssa sarru - reltalr t la carie del S olcl. C. l' . del 7'1° Jimlt'/'111.- Entrato l i- fehhraio da un reparto medico. Coll'espl ornzione r eualo ,;j nHer t c un tum ore ohlun "o, llul!u a nte, dte occupa llllla l'incavatura del v1 i• fe hbre se rotin a. In ,) impo::sihile. s vu ota l'ascesso coll'aspiratorE' del e s'rn ieuano circa GO grammi d1 emu lsio ne di iotloformiO m ••licerin a. l:cs:-.ano la febbre e 1 dolor i, e si rerHle po,;siuile la funz ione detl'aho. L' a,;ces;;o però dopo dieci giorni l'i duce,. IIHl in proporzioni assai miu or i, tanto clte di l'Ui soll'riva il malato si ritlnrono a mi nime proporziOni. H ,.: ior no :?0 marzo lascia l'uspeJale per recarsi in congedo di rimand o .
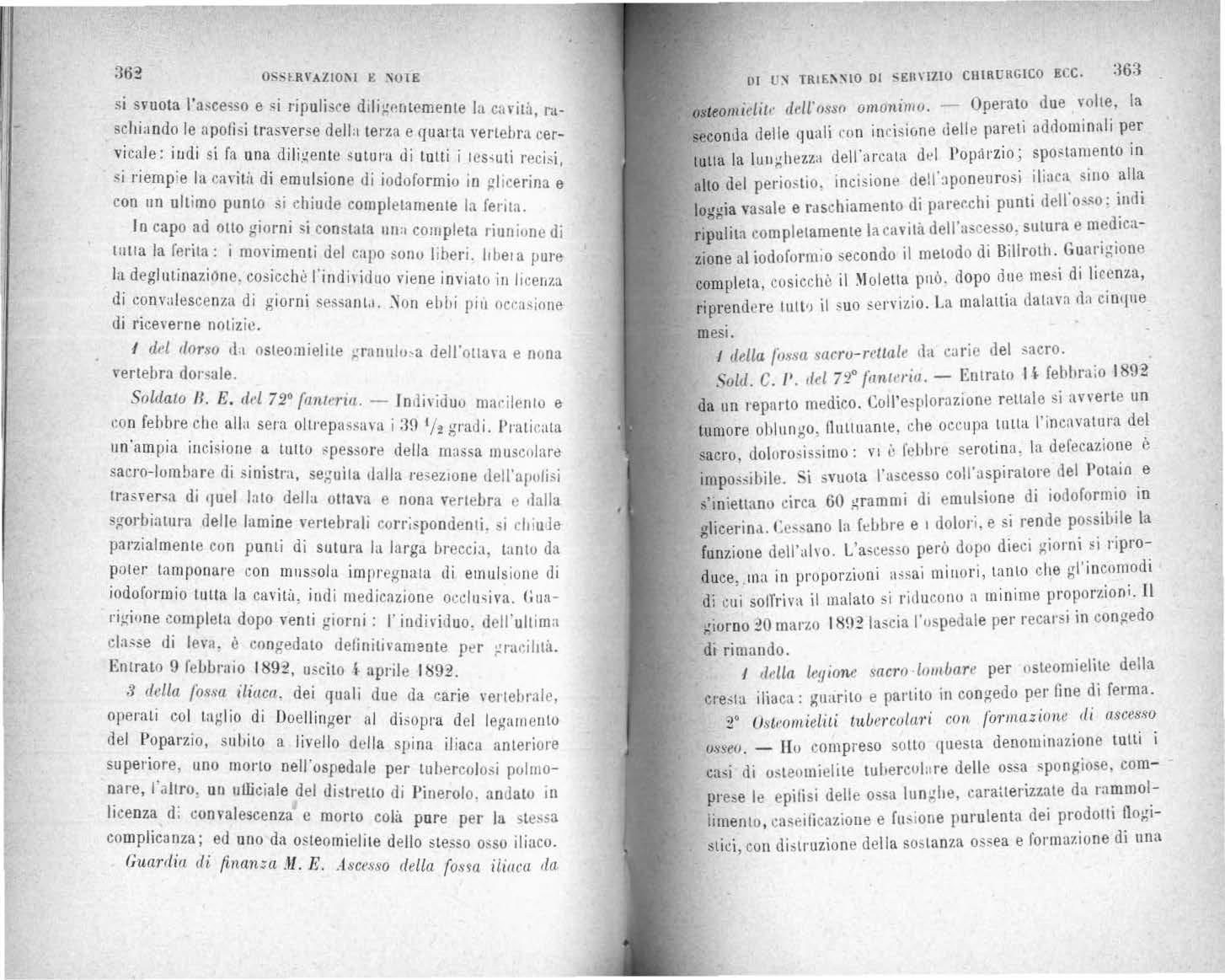
1 ,f1·lla leyione sac1'11 l11111ilare per osteomielite della cre:.ta iliaca: guarito e partito in co ngedo per fine di ferma.
3° (M t'OIIlieliti tub er co ltt1'Ì con fo7'11tet.::icme di usyeo. - Ho rom preso s{ltlO ' lu esra denominazione Lulli i ca"i di u:;teomielite tuiJercul are delle ossa compl'ese le epifisi delle ossa t·araaerizzate da lnnen to , casf.ilicazioue e fu :-1011e puru leota dei proùot11 Ooglstit:ì co u distruzione della so:.tanza e formazione di una ' cavitit a'cessuafe nell'interno dell'osso. Sono i casi p111 numero5i che ahhiano rinterreoto chirurgico.
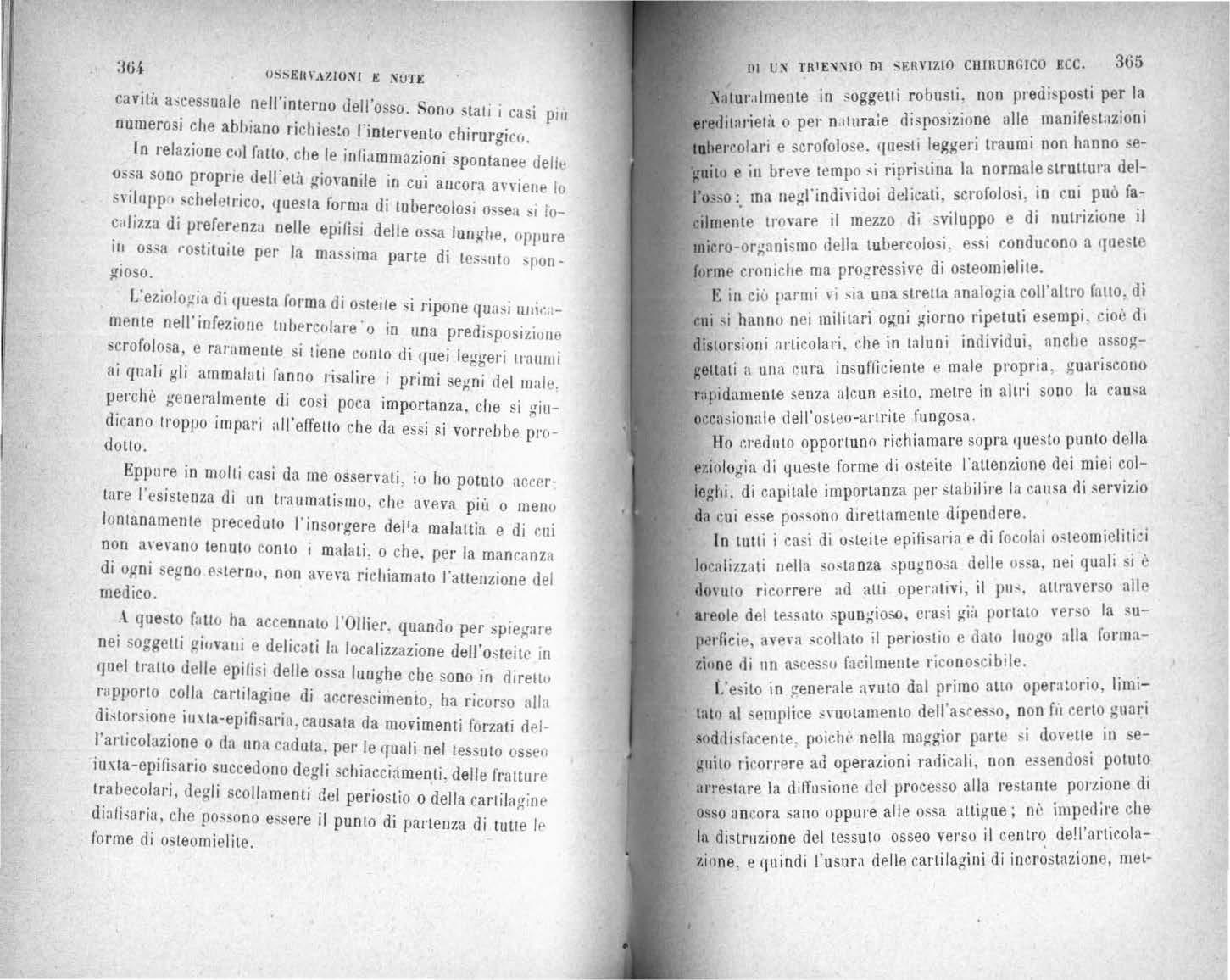
In relazione C•>l fauo. che le infi,t mmazio ni spontanee dellt:' sono propne de l l'età gio,·aoife in cu i ancora a' vieut' lo :-\ ilupp' . clteiPtrico, tfu esta forma di tubercolosi o,;sea s1 foCillizza di J..lrefere oza nelle epifi ·i delle ossa lunghe, oppure i11 os'a ,·ostiluJte per la ma ssi ma parte di te;;,utu :-pongioso.
L'eziologia di que. ta forma di osteite :<i ripone quasi ..mente nell'infezi ouP tubercolare o in una predispos1z.iunP scrofolo·a, e raramente si tiene conto tli 'JLtei le"'.,er i lr:uuui no ai qnnl1 gli ammalati fanno risalire i primi se;.:-ni del male. p erchè generalmeuLe ùi cosi poca importanza. c.lte si ::iudicauo troppo impan nll'elfetto che da es.,;i $i vorrehbe prodolio.
Eppure in molli casi da me osservati. io ho potuto accertare l'esistenza di un traumatis111o, che areva più o meno lontanament e prece duto l'insorgere del'a malattia e di ,•ui non a\e\·ano tenuto ronLo i malati. o che , per la mancanza di ogni seg no e:-tern.t, non aveva rid1iamato l'alleuzioue def medico.
\ fallo ha acce nua tu I'OIIier. quand o per spie;:are nei t:i,,vaui e delicati la loca l izzazione dell'os teit e rn IJUel tratto delle epifisi delle os a lunghe che in cllrellu rapporto colla cartilagine di accrescimento, ha ri co r$0 alla di-;tor:'ione iu\ta-epifi:-aria. causata da movimenti forzati dell'articolazione o (Ja una ca duta. per le cruali nel tes;;nto osseo iuxta-epifbario succedono degli schiacciamenLi. delle fratturP tra ùecolar·i, degli scollumenti del periostio o della car·tihrgiuf' diali.;aria, the po..;so no il punto di partenza di tutte lP forme di osteomie lite.
:\ atur.,lmente in ;;oggetti robu sri . non e retiit ari eti• o per n ltllraie disposizione alle_ to her•·ofari e scrofolose. qne:;ii leggeri traumi non hnnno . . l .. re,·e t·'rDJlO 'i ripri.-tina la normale slruttum dei- J!Illlll e n u " · • . , l. . ·o. ma ne.,l'indi,-idoi delica ti, scrofolost. IO CUI puo fao'" . n l • · 1· - ·1 0 p di nutnzrone 1 ··ilmente trovare Il mezzo ul ,vt upp mir ro-or •anismo della tuùercolo5i. e'si conducono a fur ml' ma proaressive di osLeomielite . .
E Ili Cio parmi n sia una s Lrella nnalogia f•H.to: ùr rui ,i hanno nei militari og_ni giorno ripetuti esempi. CIOè d• disl orsioni nrtirolari. che in individui. anche
. f · · le p1·opria " Ulli'ISCOIIO gellati n una rura lnsu ll cl ente P ma . . ,.. . r;1p1Ùamente :.enza al cun e;;ito. metre in altn sono la ca u:-oa orcasionnle dell'oslPo-arrrite fungosa.
Ilo r.•·ednl o opport uno richiamare sopra questo . l ,· rl ' 41Lesle l'orme di O!\teite l'attenzione r1e t IDICI col- f' i. ro o.,1a 1 ò' .. di capitale importanza per stabilire In causa t nneslat·e la diiTnsione del alla restante pol'l.lone dt Il alli.,ne · nì· impetlire che osso :.rncora ,;ano llppure a e ossa • ., , .
''UI esse direuamente dipendere . . ... l . . ,· d' O'let'le epifisarin e di focr,lni O'teOffil elrt ICI n tut11 t ca:-1 1 ' • • loralizzati uella so:-La nza ,;p ugno-a delle ossa. nei quali :\1 l' . · .. t. · ·1 JHh auraverso aliP tlo\lt to ru·orrere ad alLI oper.l lVI, ' . • al eole del s pungio:;o, giil portat o ver"o la :;uavp,·a 'colla.to il periostio e luogo a lla format.iune di un a:.ces'o facilmente r ico noscibile. . .. i n avuiO dal primo altn tal '' al :o.emplil'e ,, uotamento dell'a scesso, n.on fil ,·erto_ gua n sndr]io;facente. po ic he nella mnggior parte ,, tn se. · . l' ·al· non e;:.se ndosl potuto gu ilo ril'orrere ad operazron 1 rat 1c. 1. · . .
In del tes sut o osseo verso il de!l'arllcola. . d' l'u · url delle car tila•.,ini di incros Lazi onP, met- Wlne. e qu'n 1 :> • n tessP l'al'licolazione ,.tessa in diretto co ntall u col fo<·olaJo pu. ro le nto.
Pu 1· tr oppo in queste malattie. q uando si co nstata a l ciel perw·tio. l'os-,o i· ;.:ià così profondamente intaccato che rimaugono poche proiJabilitit dì guari!.!iooe con alli opera tiri parziali. In vece nei primi . tadi dt•lla malania. prima rhe la dt>generazione e il rammollunento dei prodotti e dei depositi caseosi si potrebbe mediante l'ahlazionP totale dell'osso o la resezione di tutta la pat·te ammalata, rinscirr a rimuovere completam ente il focolai() d'infezwne ed impedire l'ulteriore diffusione ciel proma nei C<1SÌ che presentati. non mi è mai occor»o tli sorp t·endere la mai;Jllia in questo suo primo stadio.
Sof,l. Al. 11 • fi 0 Osteomielite cro'fl,ica dell'estres upM·iv1'1' dt•l primo osso ntetafaneo sinistro.o, tant e la l'esezio ne totale di il p r ocesso di osLeite fn ngo;;a s i estendr alle ossa del t:m;o. co5icchè il ;> l 1'!88 si procedi• disart icolazio ne sollostra;.ralea dt• l pie1le col processo drl Ro11\ a lembo piantare iu terno. Gu ari:.:ione per prima ·enza accorciamento Esce ti 24- ;.;1u::rno 1 88, mun ito di un buon apparecl'hio pr(lt eiro. rhe _gli pt>rmette la ùeamlwlazione coll'ai uto ù1 un has lon e .
Sold. n. l . .ur lanlt•ritt. Ostromitlitt• rrnnica di'[ r llssO con diftwwme all' a1·ticola::wne falmtyu '''''taummt. Di sarticolazione del primo tue1ata1 so col metodo n lembo 111terno. ùel Guerin. Guarito in condi rimando.
Soltl. /J . r . l . SrUrJ/(( rli Cat'tdlt•ria Carie cmtralt' di'l colra!Jno dt•stt'" da ostt•nmù•lttt• {tmgosa. - L'ammalatn fa tbtare la mnltlllJa d;t nn colpo ricevuto con una pala ò.1 :-cudPria. Si av1•crto un ascesso sottocutaneo s ulla superfici e posteriOI'C del calcag no: Il giut: no 1888 inc isione dell'asce sso pinz 1 a sequestri della porzione sporgente dell acrom ton 111teramen le staccata. e del marg in e della spina òella scap<tla 1·olla piuza-sgorbia di Luer. L'articolazione della spa ll a c intatta. Entrat o :.> settembre l 88R; uscito 30 oltoh r P 1888 in l icenza di con val rsce nza di giorni nova nta. L'individuo :$ l è duvuto io se,:ui to riformare. poiché si era riaperta la ferita 1'oll a formazione òi un sen o fi._to loso. çnltl. Jf. L t.t artiglit>ria. tfli{tsaria di'il' 1'.\ ltrm it 1i s11 paim·r d1•l eu bito destto. - Si oper.1 due voi te: la prinn ùi :-emplice s vuotamento del\'olecrano. la di parzial e de l gomito !\e nza alcu n ri:;111lnto. p<wlw si deYe in fine procede1·e all 'a mputazione rlrl hra cc io. Gual'il o in co n rredo di ri mando .
DI UN 1RIE'lNIO DI SE RVIZIO CH IR URGICO ECC. 367 e n•sezi une della metà posteriore del calcagno co lla fol·mazio or di nn lemho tr ian golare supe r ior anteriorP. 11 morho,; o non si arresta: quindi il 30 agoi>Lo stesc:.o anno st proced e alla disarticolazione so ttoastragalea del pi ede _col metodo del R oux. r.u nri!!in ne per prima >e nza accorciamento dell'arto 1\e in co ngedo di r imando per riforma mun110 di app.1recchin proteiro. cnm minando coll'aiuto di un semplice ha:;lone.
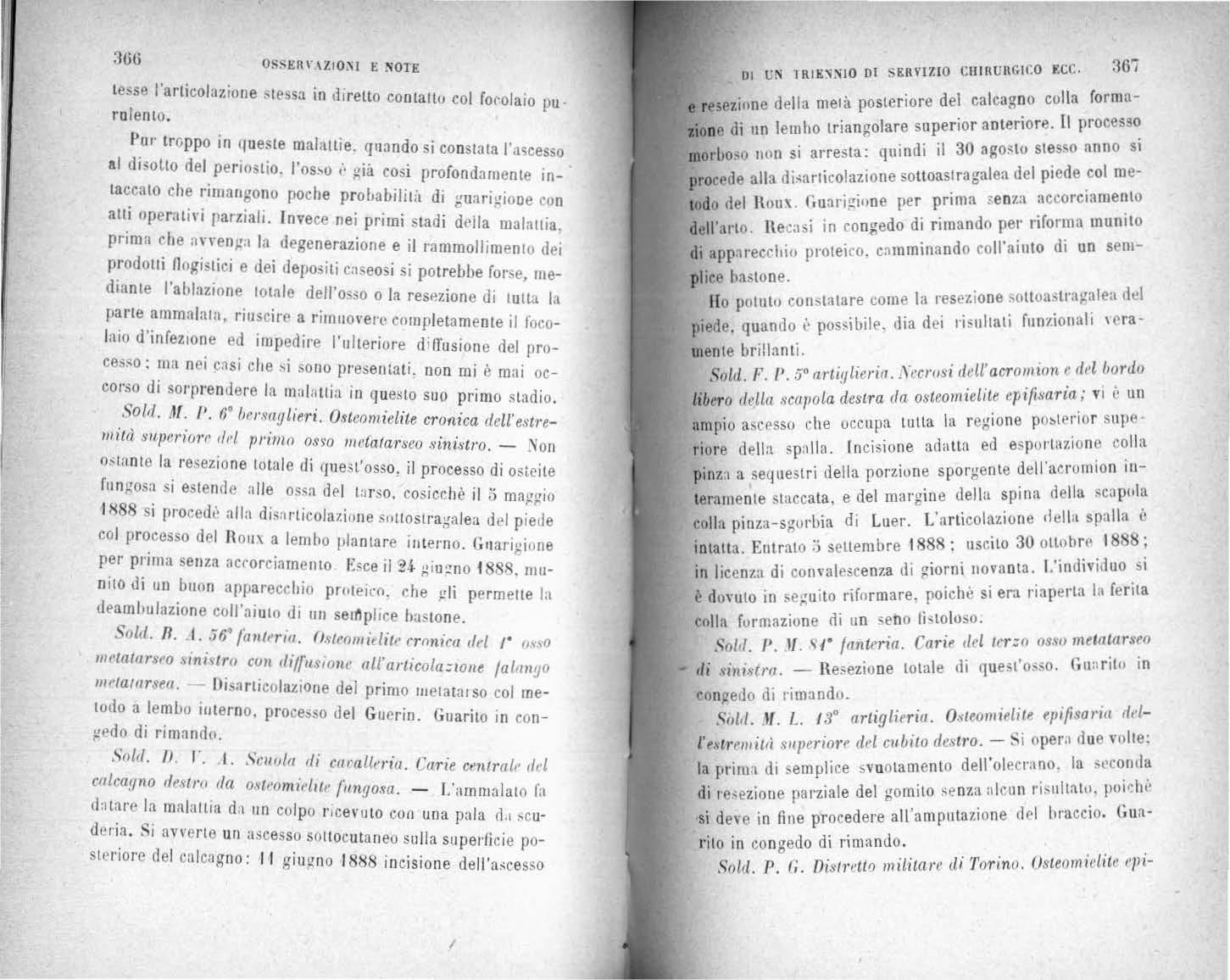
Ho potuto t:ome la resezione 1lel pied e, quaoùo i· pos:;ibile. dia dei ri:Htltati funzionali 'eramente hrillant i.
S old. F. t> . 5o nrtiylirrio ..Yt·crosi drll' acromwn r dellio1·do liber o della sc0710la destra da osteomielite VI i• un ampi o ascPsso l'he occupa tulla la r eg ione s upe riore della :>palla. Incisione ada tltl ed e:-;put.'lliZ JOil ?
S ol d. p. l f. \ r fn.ntn·in. Carie a,,L tcr ::11 nsso metatarsen dì sinP>fl'o. - Resezio ne totale di in di rimandu.
Snld. P. 0 n. Disf1·t·tto militare d i Torino. t•71i-
OSSEII\ AZIONI R '\O T& fisal'ia drll'r:il?"t•lllità. infrriorr dello tihia sinistm.- \1 i• tumefazione molle, pastos.t. fluttuante:; centimetri al di-opra dell'ioterlinea al·ticulare. l nci:.ione e sv uotam ento ùi un ptccolo ascesso osseo dopo esportati collo scalpello gli corticali della tibia. Guarigion e. L'indi' iùno, insc t·i tto di leva, si ma nda rivedihile. mi l· stato d i arerne ulteriori notizie.
Sotd. F. L. (jo ber.vaylit•l'i. E.'iiti di usteilt' 1•pi{isaria della dPll'onti'Ttl de.vtro - \i ì• un largll a:,cesso ehe occupa buona parte della regione deltoidea. I ncisione lungo il "olw delloideo anteriore: tutto il mttsco lo è s taccato dalla testa dell'omero. Colla sgor iJia e collo scal pello si esportano le due tuhPI'Osita e si svuota tj uasi tuuo il capo articolare senza penetrare nell 'articolazione. Entrato mar1.0 l esc ù aprile l H89 per re ca rsi in li cenza di co nval escenza di giorni n o,anta. Viene in seguito congedato per incompiNa fu nzionalità dell'artirolazione tiella spalla destra, ma la guarigwue ,-i manti ene.
S1Jlil . .Il . G. yrniu. ().)· ft'Ìlv t·pifi.<;arin dt>l l' estumita m{e-rwrl' tlell' omero con ust:t•sso t'?llloarticolare da tadltltt sul qomilo. - Spa ceatura e :wnotameutu ll ell'ai;cesso, svuotamento del condilo esterno colla sg-orhia e col ctu•cltiaio di rolkmann: entml'l 23 mart.o 1890 · uscito 10 ma""ÌO 1890 ' nn pe r io lic<'nza di co nvalescenza. f n seg uito ì· inriatu in t·ongedo per riforma, in di rimas ta rigiditl clell'articolnzione del ;.:omito, ma la mantiene :--t .thile.
Sold. li . f'. JJ 0 jant•·ria. Esiti di oslt•omit·litl' epifi.wma tl•·ll'Mtrt'lllitll inj'erior1• delji ·111ore si•ti.\t1·n (co ndilo e:"terno) ,.,m vasto p,.riarticolare: l'articolazione ùel ginocchio i• inlalta. l ncisio ne dell'ascesso e svuota mento del coudilo esterno. Il proce•'o di o,teomielitec••ntinua in alto. cosit·,·hi·
Jop u quattro mesi si deve proretlere della coscia al terzo medio. Guarito. In congedo tll ntorma. S old. o. Il . .1. 62" (anferia. tubm·olme tlell'tsmmtitò suprriore dt• lla tibùt sinistra. L'individuo accusa un le"'•ero trauma riportato in servizio . c; iit cura to inutil. men te coll'ignipuntun1: cltè anzi la. malallia lta ampmmente invasa l'arLtcol.tzion e. Artrectomia estesa ro n svuot amento dell a testa della tihia: nes.su n ri::;ultnto, cosicch è un tnei'e dop o si pror.eò e all'amputaztone della coscia terzo medio. in co n).:edo per nforma.
S old. B. G. 7/ 0 f'anterill. Esiti di tnlm·cnlarr tfttl l'estn•miuì infe ri ore de!t'omt'I'O destro. l'ritt operato nel mese di maggio 189 1 di un piccolo asces ·o osseo in punto, non guarito. 11 2:> olloù re stesso anno dell' estremitil inferiore dell' omero. Guarito in congedo d t rimando.
Sold. B. ('. fi 1o fimtrria. J .vces:iO :iOttoperiosteù del maltrolo esumo tltt osteomiehte. I ncision e adatta e raschiahlonto.
Gu arito, e inviato al ùepo:,ito di conva lesce nza di e 4uindi al co rp o . .
Sold. D. L. A . 62° {nnteria. Ascesso ossro nella 1·eg10ne w 11er iore es tt•rna dPlla yamlia sinistra da osteomielite della l t's t a del peront•. Spaccatura dell'ascesso e svuotamenlo dell' est remi tà superioredel peronegia este5a mente intaccata dal processo di os teite fnngosa. L'operazione si deve un 'altra volla , ma in!ine si ottiene una buona 1-{uar lgtO ne. L'i ndh iduo vi r oe congeda to tla l se n izio.
3 '' Ostriti rare/(tcenti (ostt•opurosi) sen.:a {orma.:iom di e tli infiltra::iorti caseose.- Casi due. Uno della prima falan ge del polli ce destro, operato di amputazione del capo arti colare tlel primo osso melacarpeo; l'altro della ,.;econda fa- del della mano destra, operato di disarllt'olazionc fahwgo -meLacarpea. b) Carie e necrosi esiti di osteiti e periostiti traumatiche. - Ad eccezio ne di un caso in r.ui la malauia risieileva nel primo osso metalarseo destro, si lulle nella Libia, in seguito a frallura o a fe rita lacero-rontusa ro n scopertura e contusione de ll 'osso.
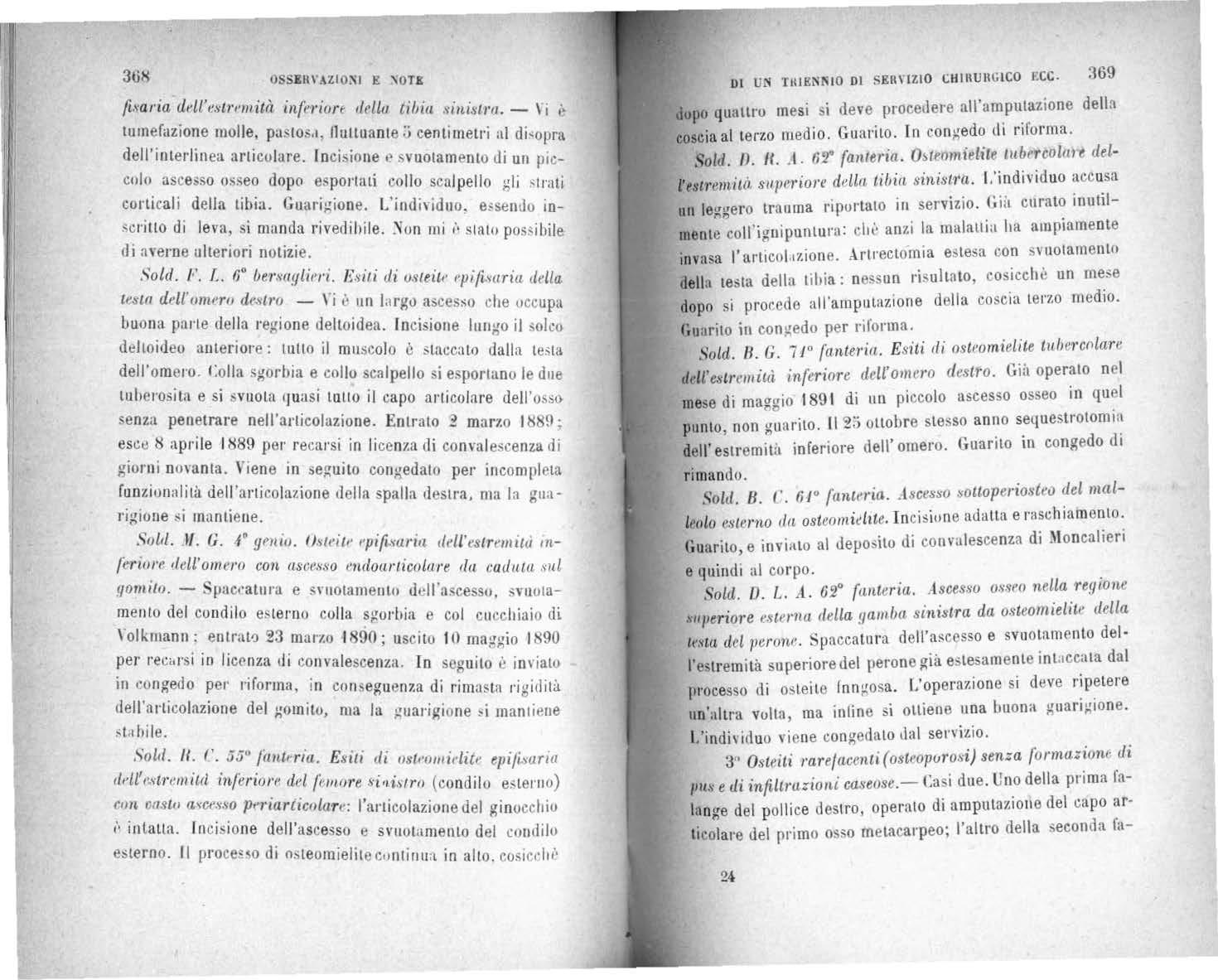
T re Yolte si è trattato di necrosi e quattro di carie. solo negli esiti di necro:-i, in cu1 la formazione e il del sequestro era confermata, oltrechì• dalla data della le:-oione anche dall ' esame deii.L parle, si è prurPduto senza indut!ÌO a\1(1. -seqnestrotom 1a, ma auche nella St'mp lice rar ie , rp1anùo al disotto del periostio ed in li ltralo di suppurazione si è trovata la sostanza corticale dell'os:>o aspra, porosa. rammolli t.\, si è r·ieorso allo svu otamcnL•I col cucrhiaio e wlla sgorbia sino 1 che il tessuto o:.seo :.ano. giun,:eudo qoan <IO è stato necessa rio al ca nale midollare. che vonira rai>-rhmlo il :raltu in cui il midollo ,-i pre:-:enuwa intaccato 1lal flog is tico. lufalli. in du e la ru completa in un me;;e, in tlll terzo. in C]Uarantacinque giorni. e in lJUarLo in tlne mesi, e gl'indiyidui potevano recar:-:1 in licenza di convalescenza per rip1·endere dopo il senizio.
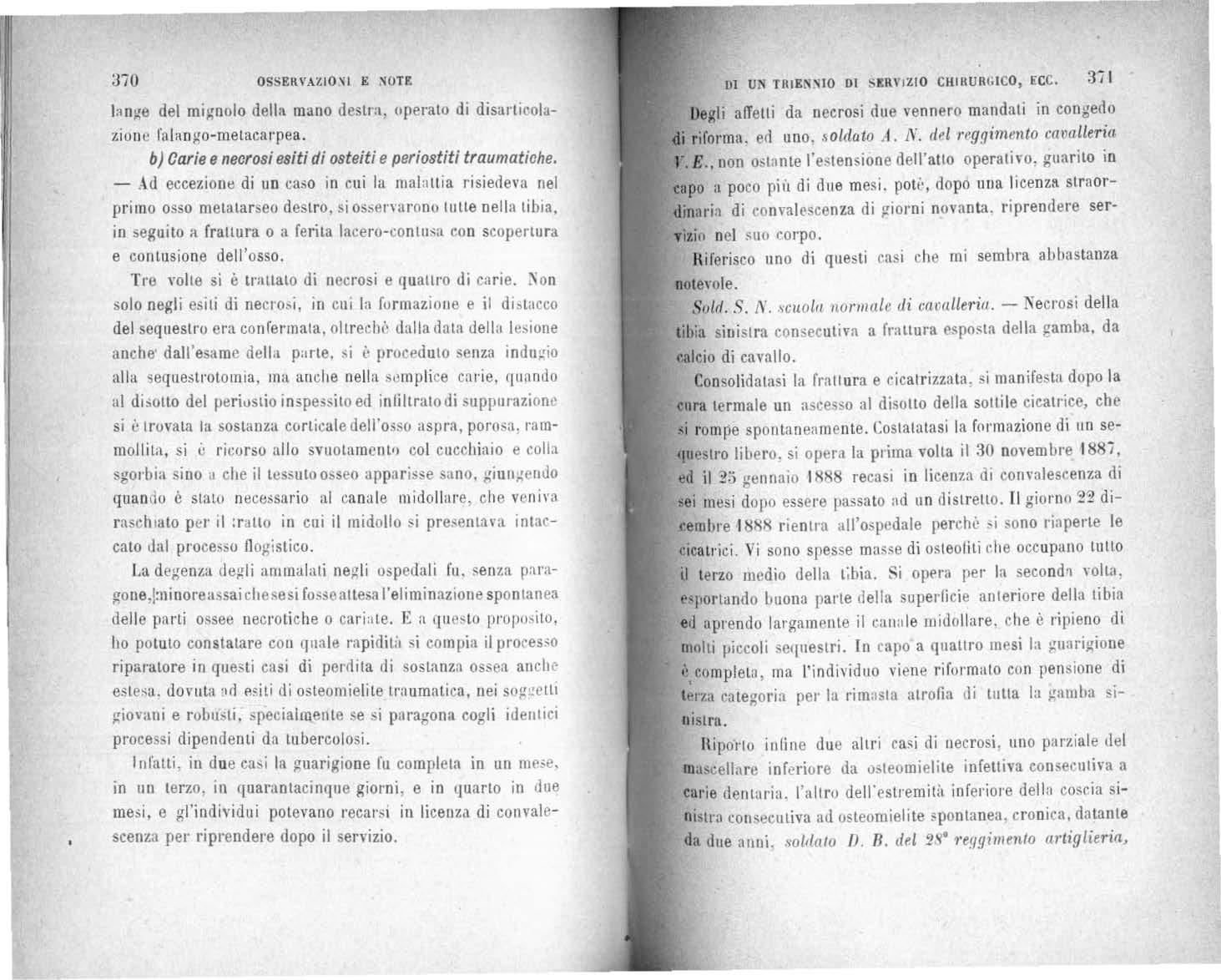
La degenza degli ammalati ospedali fu. paraj!One.!:ninoreassai che fosse at tesa l'eliminazione spontan ea delle parti ossee necroticbe o cariaLe. E a tJUt'' to proposito, ho potuto constatare con quale r·apiditit -.i compia il proces.;o riparatore in tfu e,.,ti casi di pcrtlita di sostanza ossea anclJ e es te;.;a.. dovuta ·l(J tli osleomielite traumatica, nei an1 e rohn,ti. :.pecialmente si paragona cogli identi ci processi dipendenti da tttbercolosi.
[)egliafTeui da nccrosi due ve nn ero mandati in congedo di riforma. etl uno . .\oldCJto .i . 1Y. dPlrPg!]imrnto cm,alleria r. E .' non OSL'lnte r e,:tensione dell'atto operati vo. guarilo in topo a poco più di due mesi. pot è, tlopo una licenza straord inaria di ronnll'sccnza di nov an ta. riprendere serTizio nel :-ono corpo.
Riferisco uno di questi casi che mi semhra abbastanza notevole.
Solrf. S. JY. swolrt IWI'IIIItlt• di cftvalleria. - Necrosi de ll a tibia consecutiva a frallura della j!amba, da di cavallo.
Conso lidatasi la fratt ura e l'icatrizzata. si manifesta dopo la (n ra termale un ascesso al disotto della solli le cicatrice, che si rompe spontaneamente. Costatatasi la formazione di un se4JII>' Slro libero. si oper.1 la prima volla il 30 novembre 188i, il 25 :;ennaw I XH8 recas1 in licenzn d1 convalescenza di :;ei mes i dopo essere passato ad un clistretto. TI giorno 22 direruh re l SXX rie ntra peuhè ,.i );ono riaperte le t'icatri ci. Vi sono spesse masse di osteofiti che occupano lolio il terzo medio della t;bia. Si opera per la seco nd1 volta. e'JtOr lando uuona parle della superficie anteriore della tibia ed aprendo largamPnle il canale miùollare. che è ripieno di rnnlt1 piccoli sequestri. Tn capo a quallro mesi la i• compl eta, ma l'indi,·iduo ,·iene riformato con pens1one di l >'IZa t'ategoria per la r·imas ta atrofia <li tulla la ga!llha sinistra.
Hiporl o infine ùuc allri di necrosi. uno del inferiore da o::.teomielite infettiva consecutiva a carie l'altro deiJ'estremitil inferiore delln coscia sinistt·a con:'eculiva ad osteomielite cro ni ca, datante da due anni. solrluto D. B. di'l 21/" reygimmto artiglierin, per la quale l'indìvirluo aveva giit snhito una pt·ima operazione avanti il suo arr uolamento.
Nel primo t:i procedelle all'estrazione di un largo setjuestro della porzione orizzonLale del mascellare inferiore; guat·ito e recatosi in licenza di convalescenza, l'individuo venne dopo riformato per recidiva della malattia.
Nel seco nd o, dopo un 'estesa sequestrotomia , il soldato potè riprendere ancora ii servizio nel suo corpo.
{Continna).
Rivis Ta Di Giornali Italian I Ed Ester I Rivista Medica
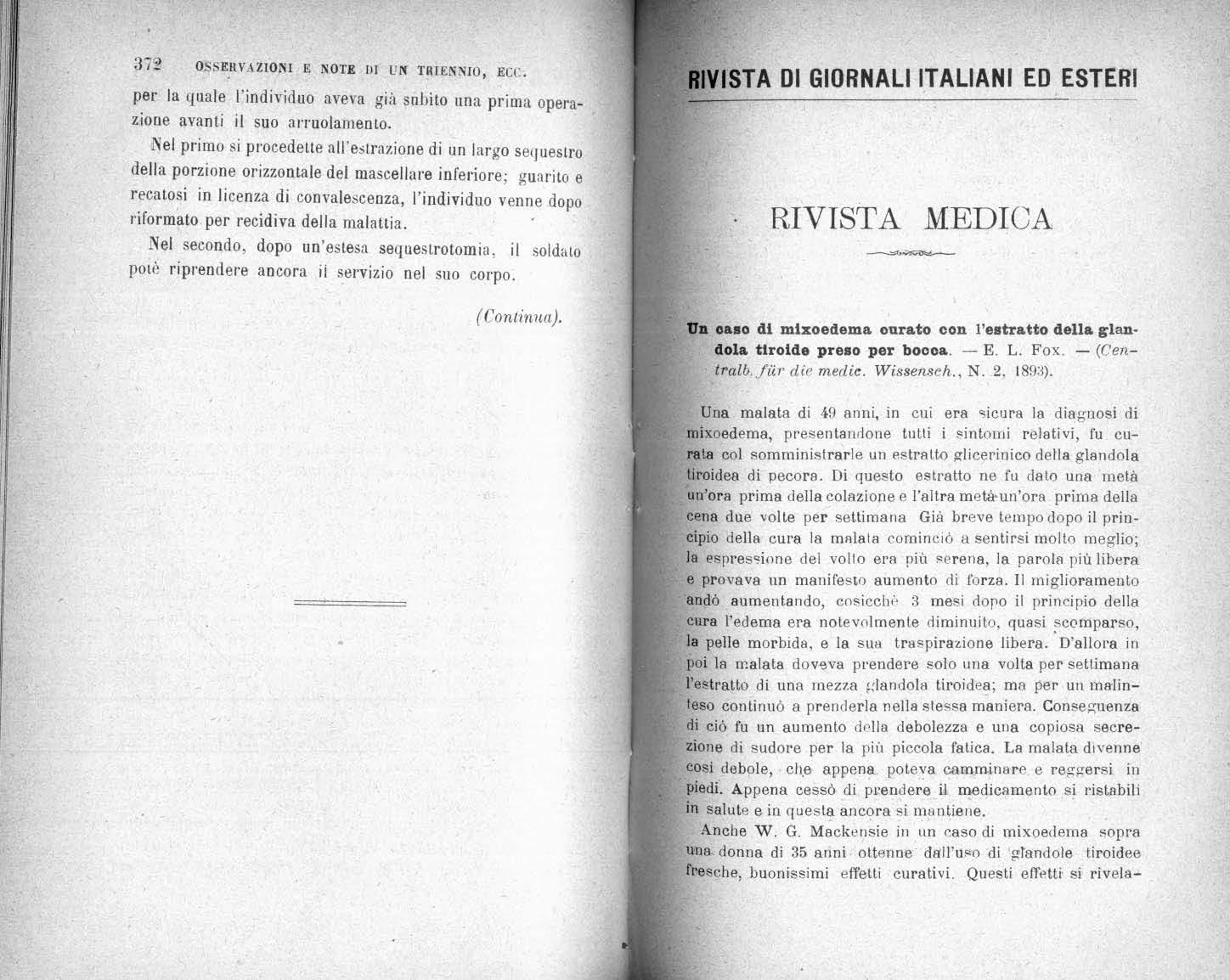
Un oa1o dl mlxoedema ourato con l'e1tratto della glan· dol a tiroide preso per boooa. - E . L. Fox . - (Centralb .fi.i l' die medie. Wissenseh., N. 2.
Una malata di 4!) anni, in cui era o;;icura la diagnosi di mi xoedema, presenla11rlone tnlti i E'intonai r e lativi, ru curala col !'lomminislrarle un estrRlto glicerinico della glandola tiroi dea di pecora. Di questo estr·atto ne fu dato una metà un 'o r a prima della colazione e l'altra m età-un'ora prima della cena due volte pe r settimana Già breve tempo dopo il principio della cura la mAlata comi nciò a sentirsi molto meglio; la espres<>ione del volto era più ,ere na, la parolA più Jihera e pro vava un manil'e sto aumento di l'o rz a. Il miglioramento andò aumenta ndo, :i mesi doro il principio della cura l'edema era nolev nlrnenle diminuilo, quasi sc0 mparso, la pelle morbida, e la sua traspiral.ione libera. · D'allor·a ir1 poi la rr.alata pt'endere solo una volta per settimana l'es tra tto di una mez1.a Liroidea; ma per un malinteso continu ò a prentlerla nella stessa maniera. Conseguenza di ciò fu un aumento drlla debolezza e una copiosa secrezione di sudore per la pii• piccola fatica. La malata d1venne cosi debole, ch.e appena poteva camminare e reg-g-ersi in piedi. A ppena cessò di prendere il medicamento s i ristabilì in salute e in ques ta ancora si monLiene.
Anc he W. G. Mackensie in un caso di mixoetlema sopra una donna di 35 anni ottenne di gtandole tiroidee fre sche, buonissimi effetti curativi. Qu es ti efTt>tti si riv e la- rono con un'a cceleramento rlel polso è l aumento di temperatu r a corrispondente alla quantità del me<licarnenlo PI'''"O, ed inoltre con una gene1·ale diminuzione della tumelat.ione e con un miglioramen to di tulti i fenomeni mor·bosi elle accompagnano Il mixoedema. dell'auto1·e •' quello di altri dimostrano che la ris ipola, sebbPne malattia infettiva locale, qualche ,olia può pro lu•·re pu r e uu'infezione geperale.
Un oa1o d 'toteztone generale per streptooooohi in •egoito .. rl1lpola cutanea . - PFUHL.fci. r 1/ygiene und ln.fectionskran!.1tetlen, vol. 12o, lthC. 4•, 1892).
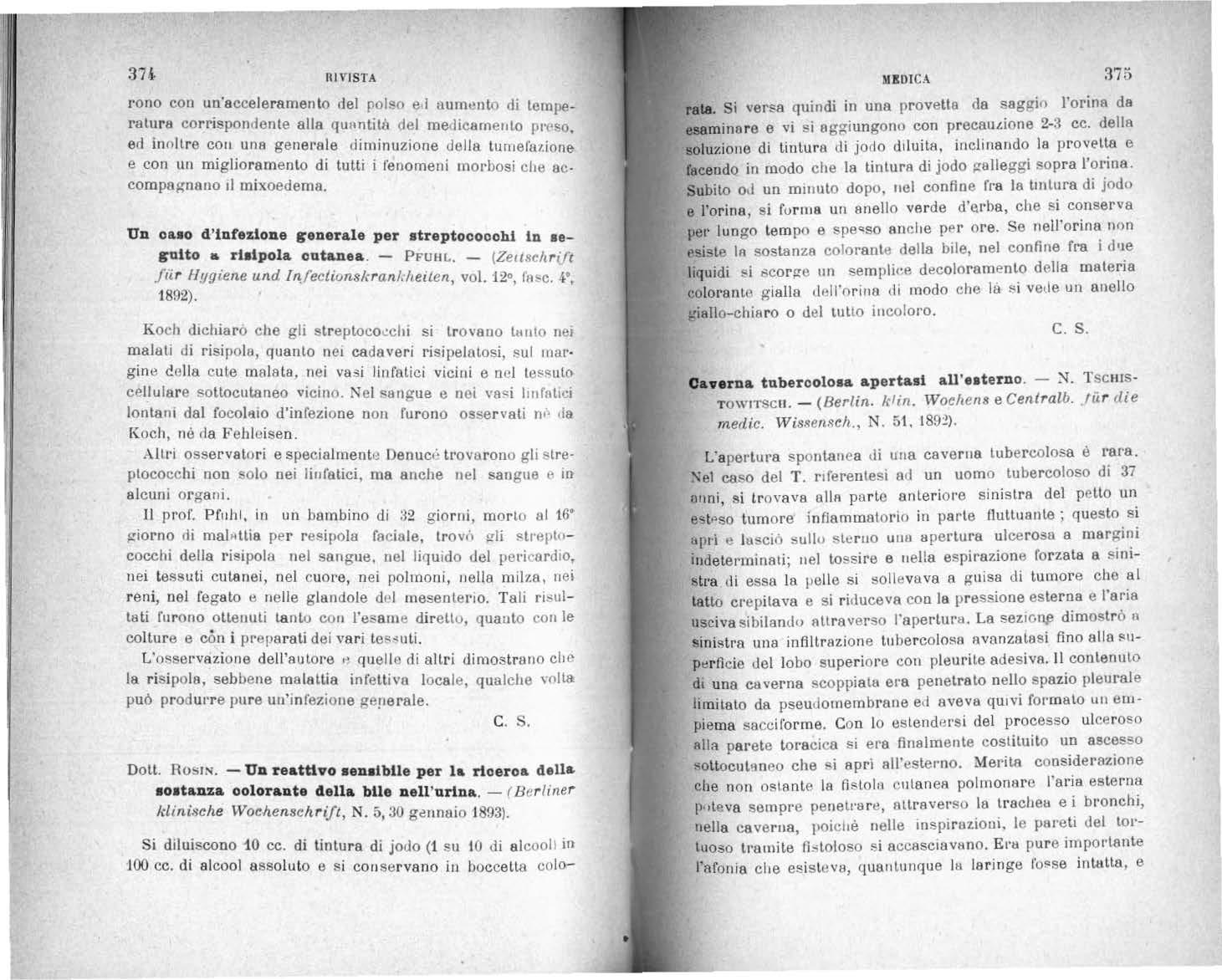
Koch ùtchiarò che gli streptoco..:chi si trovano tttnlo ner mahill di risipola, quanto net cadaveri risipelatosi, sul lllal'· ginè c!ella cute Infilata, nei vasi linfatici vicini e nel tef'c:;ulo cellular e sottoculaneo vicino. Nel <::angue e noi va«i hnfnt1ct lontan1 dal focol'iiO d'infe:lione non furono osser vati n•· <la Koc h, ne òa Fehluisen.
Alli'Ì osserv ato ri e specialmente Oenuet'· trovarono gli c:;tre· ptococchi non solo nei linfatici, ma anche nel sangue P m alcuni organi.
11 prol'. Pfuhl, in un bambino di :12 gio rni , morlu al 16• eli per resipola fariale, tron\ J?li st•·eptococchi della risipola nel sangue, uel liqUido del pe!'it'ard1o, nei tessuti cutanei, nel c uore, nei pol moni, 11 ella milt.a, nei ren i, nel fegato e nelle glandole dPI rnesenler•io. Tali r,,.,ultati furono ottenuti la nlo con l'esame dirello, quanto con le colture e con i p•·epar ati dei vari te«..:uti.
Do tt. RosiN. -Un reattlvo sen1lblle per la rioeroa della. 101tanza colorante della bUe nell'urina. - r Berliner klin.ische Wo chensch r ift, N. 5, 30 gènnaio 1893).
Si d1luiscono 1.0 cc. di tintu r a di j oùo (1 sn tu di al cooll irl 100 cc. di alcool assoluto e s i conS!;lrvano in boccetta colo-
M!OICA
rata. Si ''ersa quindi i n una provetta da saggin l'orina da esamin are e vi si aggiungono con precaut.ione 2-:J cc. della soluzione di tintura di jodo diluila, inclinando la provella e tacendo in modo che la tintura di jodo sopra l'orina. Subito o J un mmuto dopo, uel confine fr·a la tmtura di jodo e l'orina , s i fu r n1a un anello ve r de d'e1•ba, che conserva pe•· lu ngo tempo e spe'"SO anche pt>r ore. Se nell'o r ina non t>siste lA sostanza coloranlt• della bile, nel confine fra i d•1e l iquidi si un sempliC'e decoloramento dt>lla materia co lo r·anll' gialla t(,.ll'oriml di modo che là si vetle un anello ::iall o-chiaro o del tullo incoloi'O.
C. S.
Caverna tuber oolo•a apertali all' eaterno . - TsctHS· TOWtTSco. - (Berlin. klin. Wocltens e Centralb. tù r di e merlic. N. 51, 1892).
L'a pertur·a spontanea ùi una caverna Lubercolosa è r_ara. :'\el caso del T . r1ferentesi ad un uomo tubercoloso d1 37 11rmi si trovava olia po r te anle r ior·e smislra del petto un ' . tum ore inflammatorw in parte fluttuante; questo s t upl'i e Jusciò sullo slt: r uo unu apertura ulcerosa a indeter·minari; nel tossire e nella espirazione forzata a smrstt·a tli essa la pelle si sollev ava a guisa di tuu rore cho al tat to crepitava e si r iduceva con la pressione esterna e l'aria attraverso l'apertura. La dimoc;Lrò n smis tr a una infiltrazione avnnzatasì fino alla Slldel lobo superi o r e con pleurite adesiva. Il contenuto d1 un a caverna scoppiata era penetrato nello spazio pleurale hmitato da pseudomembrane ed aveva qu1vi for•malo uu empiema saccifo rrne. Co n lo es lerrder·si de l processo ulce r oso pa rete to1•acica si era finalmente costituito un ascesso "oltocul•111eo che c;i aprì all'ester·no. Mel'ita considerazione che n on os lanlo la (ìstoln cutanea polmonarc l'aria esterna p.. teva sempr·e penell'are, all rav ersc> la t r acheu e i br·onchi, nella caverna, poicllè nelle msptrazioui, le ptHeli del tOt·tu oso t1•arnite fbtoloso si E1·u pu r e impo1·Lanle l'afonia cile esis l t•va, quantunque la laringe fO!"se inW.lla , e
llEDICA
que!"lO sr spieg-fl co me nei fllla tl'aclleolomia poichè, <i cagionA del seno fistol oso, l'nt'ia espil'ala alll'avPr'so la r ima glolliclea non aveva suf'fir.ienle tensione per mettere in m0to le CO I'de vo cali.
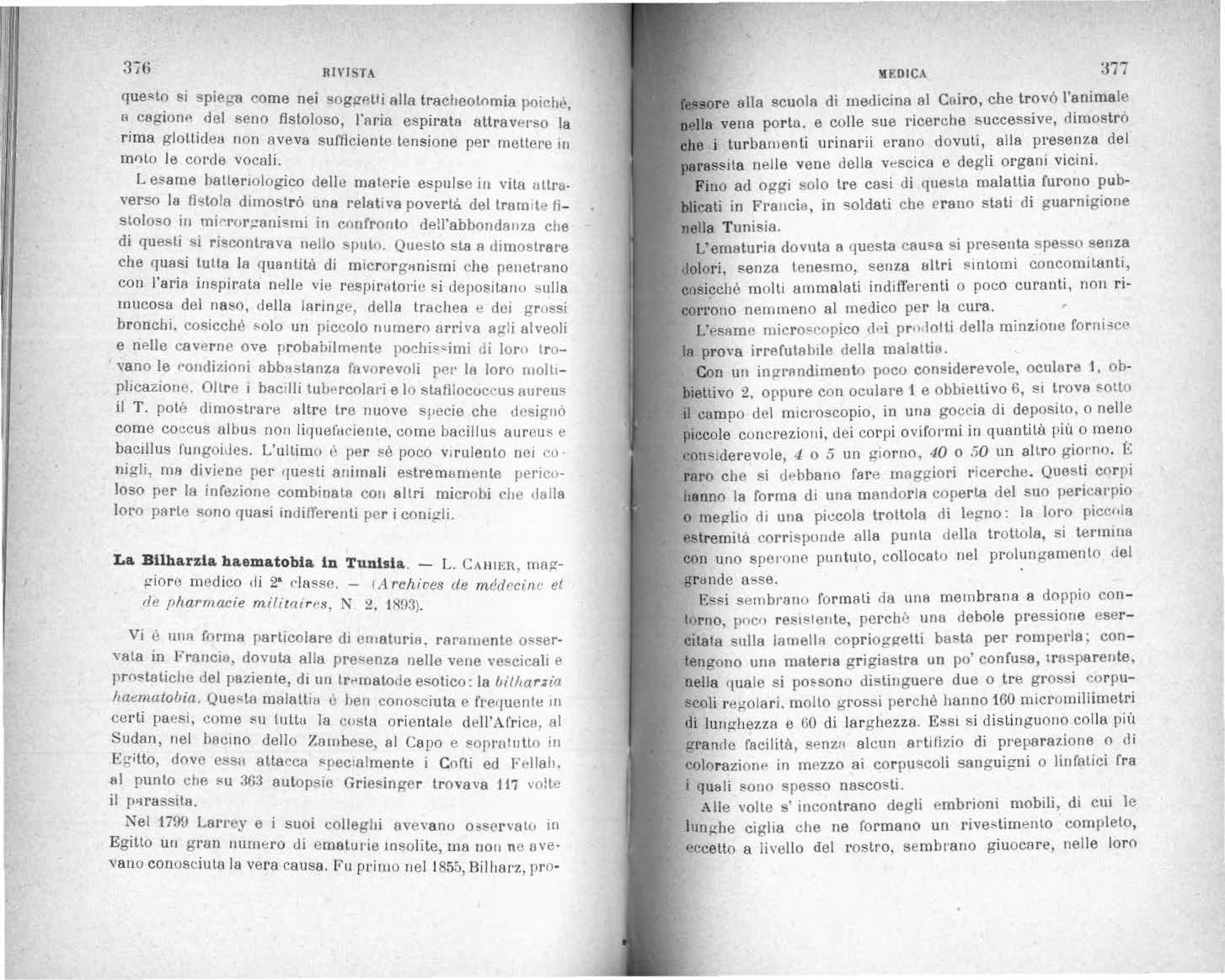
L esame ballerrologico delle rnatPrie espulse in vita verso la fi"lola dimostrò una r·elativa poveri&. del tram ,l•• fistoloso in mi 'l'or ::ani!"mr in confronto dell'abbondAIIza che di !'li nello Questo sta A tlrmostrare che quasi lulla la quanlila di m1crorg>tnismi <·he penetr-ano con l'ariA inspil'alA nelle vie respii'HlOI'i C si deposita11o sulla rnucosa del naso, della lAringe, della tracheA "' dci grussi bronchi. cosicchè ur1 piccolo numero arri\·a alveoli e nelle cavt> rn r ove p roba bilmt>nle pocbi!",imi di loro trovano le rondizioni Abba<>tanza liworevoli per la loro ruoltrp!Jcazione. Oltre i bAcilli tulwrcola1·i e lo slafilococ•·us il T. pol!" dimostrare altre tre nuove specie che designò com e coc<.:us al bus non come bacillus aureus e bacillus fungoides. L'uiLimo è per "ò poco v•rulento noi •. t, nigli , ma diviene per· •(UC$ti animali eslremanwnte fH'rJ Citloso per la in fezione combinala con altri micl'nbi chl• dalla lorn parli' Mno quasi inditfer·enli p<' r i
La Bilha.rzla h a. ema.tobia. In Tunisia. . - L. CA Bi ci\, ntagmedico di 2• c·las::<e. - 1A rehioes de médre,:n'' et de Jl/tat•mrxrie mifitntrr•s, N ::!. JH!)3 )
Vi e lillA fnrrna particolare dr t>ruatul'iR . rar amente vata in FrallCitl, dm ula alla pl'O"'enza nelle vene "e"cicah e prMtaliciiO del paziente, di un tr,.rnalode esotico: la lnlharzia haemaloiJia. Que-.La u ben COllosciu ta e fr·e•JUOII!t! 111 cel'li come l>U lullu la costa orientale dPII'Afri ca, al Sudan, nel bacmo dello Zambeso, al Capo e l'Oprntnlln in dove Ol''>il attacca !=>pcc•almenle i Cofti ed F'f'llah. al punto che an:l aulopl:HC Griesinger lrova\·a 117 \'Olte il
Nel 170!.1 Lat't't:Y e i suoi colleghi avevano rn Egilto u11 grau numè ro di emalur·•e rnsolite, ma uo•• n e uvevano couosciulH la vera causa. (i'u pt•imo uel 1855, Rilhar·z, prn· re!lsor e alla scuola di medicina al Cui l'o, che trovo l'animale OPlla v ena pol' tu. e colle sue r·icerche successive, climostri> che i turbnr11euLi urinarii erano dovuti, alla pl'esenza de l parassita nelle vene della vescica o degli organi vicini.
Fi no ad oj:!gi tre casi di malattia furono pubblica ti io Fr•a Jtcia, in c::oldali che e ran o stati di guarnigione nella T unisia .
L'ematuria dovuta a questa si pre>'enla senza .lolor i, !'enza tenesmo, senza l'rntomi conco nutanl1, cnsicchc molti ammalati indil'l'cl'enti o poco cUl'anti, non ricorl' ono nemm eno al medico per la cura. micro ...ropico rlr>i prn.lolli della miozione
111 pr o"a irrefutAinle della malattia.
Con un inj:!I'Andimento poco considerevole, oculare l. obbiettivo 2. oppure con oculare l e obbreLtivo 6, sr lr'OVA !'Oltll il èampo del rrllCI'oscopio, in una gocria dt deposito , o nelle pi ccole concr·eziolli, u e i corpi ovifo1·mi in quantità o sembrano formali ria tll\A membrana a doppio co nt11r no, pncll pcrcb•'> un a debole pressione ese rci tata sulla lamellA busta per romp e!'la; contengono uno mfllerJa grigiastra un po' confusa, nella r 1uale s i pM-sono ùislinguer·e due o tre grossi •:orpuscoli mollo grossi perché hanno 160 micromillimetri •li lu nghezza e GO di larghezza . E!'lsr si distinguono colla piLt facilità, senzH alcun ar·tdì zio di pr·eparazione o di color azioni' in m<'zzo ai corpuscoli o linfatici rra i quali sono spesso nascosti.
•·on;.:derevole, .J o 5 un !'iorno, lO o 50 uo allro g •o•·no. E roro ch e si dt>bbano faN rn aggiori ricerche. Questi corpi ha nno la forma d• una m ando r la coperta del suo perkar'pio o me!!'lio clr una piècola trottola di le::tno: la lor·o piccola t>s lremità corr isponde alla punta Jella trottola, !'i lcrmwa con uno spCI'OIII' puntulo, collocal•> nel prolungamento del asse.
A Ile volte s' incontrano degli embrioni mobili , d• cui le l un:.rhe cigl1a c.;he ne formano un r'ive:-tim ento completo, Pecetto a livello del rostro, semb1·ano giuocare, nelle loro
l!P:OI CA
ondulazioni, cogli element: flgurati del sangue clte vengono t\d urtadi.
Qualche volla 11:1 malattia non decorre coi semplici sintomi mu soLLo l' iuflucoza della irrrtazioue vescica 'e lliretta o rifl essa, deteJ·mirrata dalla 0\U e degli embrion i nelle pareti del serbatoio ur•ina r io f' dei suoi annessi, può venirne una urctrite o unu cislHe del collo , quando non ne viene addh·rtlura una crstite fuogo-:a con grande ispessimento delle paretr e forte r rduzione della cavità.
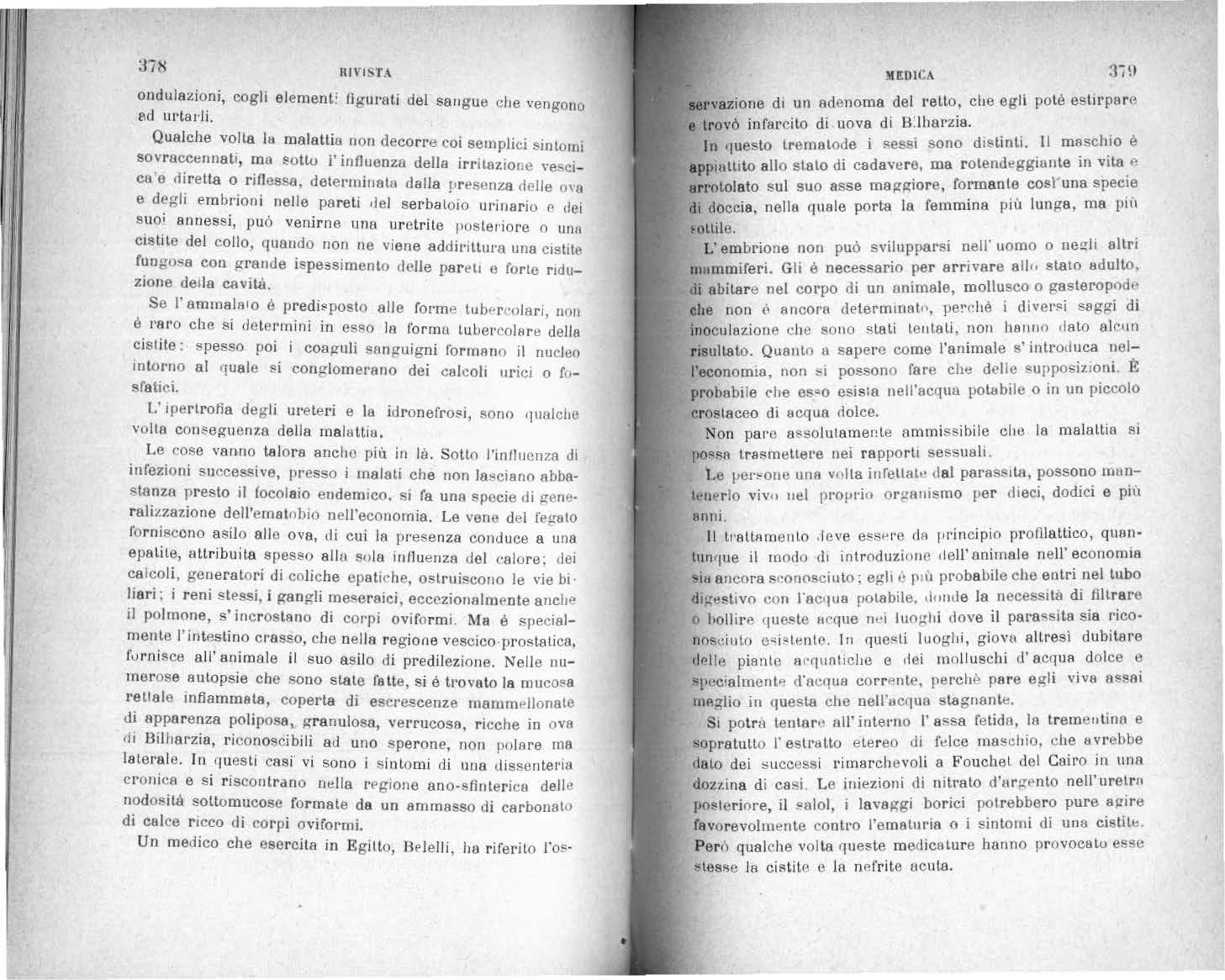
Se l'ammalar o è preditoposto alle forme tubr>rco lar1 non é l'ar·o che si detcJ•rnini in es!'IO la forma tul.rercolar e 'della cistite: spesso poi i coaguli sa nguigni formAno il nucleo intorno al qual e si conglomer•ano dei calcoh uricr o fosfatici.
L' rpertrolìa degli ur·eteri e la idronefrosi, qualclro volta con seguenza della mal a ttiu.
Le cose vanno talora anch e più in là. Sotto l'inllucnza di infezi oni successive, presso i malati che non Ja-.;ciano abba«tanza presto il focolaio endemrco. si ra una !Opccie di generalizzazione dcll'ematobro nell'economia Le vene del fe!rato forniscono asilo all e ova, di cui la rwese nza conduce a una epatite, attribuita spesso alla sola inlluenza del c·alore; dei calcoli, gene ratori di co li che epa ti1·he, ostruiscono le \'ie br liari; i reni ste-ssi, i gangli eccezionalmente anclrP il polmone, s'incrostano di cor·pi oviform i. Ma é specialmente l'intestino crasso, eire nella r egione vescico prostatica, fvrnisce all'animale il suo asilo di predilezione. Nelle numeros e autopsie che sono state falle, si é LJ·ovato la muco!'a reUal e mtìammata, coperta di escr·escenze rnammt>llonate di apparenza poliposa, granulosa, verrucosa, ri cche io ova di Dillrarzia, r iconoscibili ad uno spe r one, non polAre ma laterale. In questi casi' vi sono i sintomi di una dissenteria cr·onica e si r iscont ran o nella r Pgrone an o-sfìnteri ca delle nodosità so ttomucose formate da un ammasso di carbon ato di calce ri cco di corpi ovifor·mi.
Un medico che esercita in E gitto, BPlelli, Ira riferito l'os- servazi one dr un adenoma del retto, eire egli poté esti rpar e e trovò infarcito di uova di l:Uhar•zia.
I n questo trematocle i sessi so no distinti. Il maschio è appmllrto allo slalo di cadavere, ma rolend t!ggiante in vita .'' arrotolato sul suo asse majlgiore, formante cosi una spec1e dr doccia, nella quale porta la femmina più lunga, ma piil
L' embrione non può svilupparsi nell' uomo o negli allri mrunroiferi. Gli è necessario per arrivare ali•• stato adulto. ,Ji abitare nel co rpo di un rrnimale, mollu sco o che non o ancora determ malo, pe!'<' lré i d i versi saggi di inoculazione ell e sono terrtali, non har111o dato alr•w risultato. Quanto a saper·e co me l'animale s' introduca ncll'econoffila, non si possono fare che dello «upposizroni. È probabile rhe cs"o esisla nell'a cqua pol.llbile o in un piccolo rrostaceo di acqua nolce.
Non par·o amm issibile che la malattia si trasmelteJ'e nei ra pporti se:;suali .
Le per·!-ouo una volla inrellal<J tlal parassrta, possono manh•rwrlo vivo trel pt'O!Jr·io or ganismo per dr eci, dodici e piu i.
Il lr·attArnenlo .leve dA pt·incipio pronlatlico, quan· tunque il modo dr introduzione dell'anima le nell'economia "ili ancora sconCisciuto; egli (• pri1 probabile che entri nel tubo co n rac•tua potabile. dnrrtl e la necess1to di filtrare o loollirP questo Hrque nt>i dove il sia r·icoII ORt.:iulo In que!"ti luoghi, giovtt altresì dubitare riPile piante tl!'quntrclre e rlei molluschi cl' acquA dolce t} '-'Jil'C ialmentP d'nci']UB perclrè pa r e egli viva asl>ai lllAA'Iio iu questa che nell'aequo stagnanlt:.
Sr potrà tenta r •• nll' inlel'nO l'aRsa fetida, In treroeutina e sopratutto l' eslr'l:llto ete r eo di felce masch io, che avrellbe dato dei successi rimarchevoli a Fouchet del Cair•o in una dou.ina di casi L e iniezioni di nitrato nell' urelrn pMt eriore, i l oaJol, i lava ggi bor ici potrebbero pure favorevolmente co ntro l'emaltll'ia o i sintomi di una cistilt-.. Però qualche vol ta queste roedicature hanno pr ovocato ei"S!; -.tess e la ciRLiltl c In nefrile ucuta
Le hibite diuretiche rammalalo.
I n casi più complicali un interven to sara giustificalo; si dovrà ricorrer·e alla litolrisia o alla crstotomia, che ha reso già al :Wacbie.
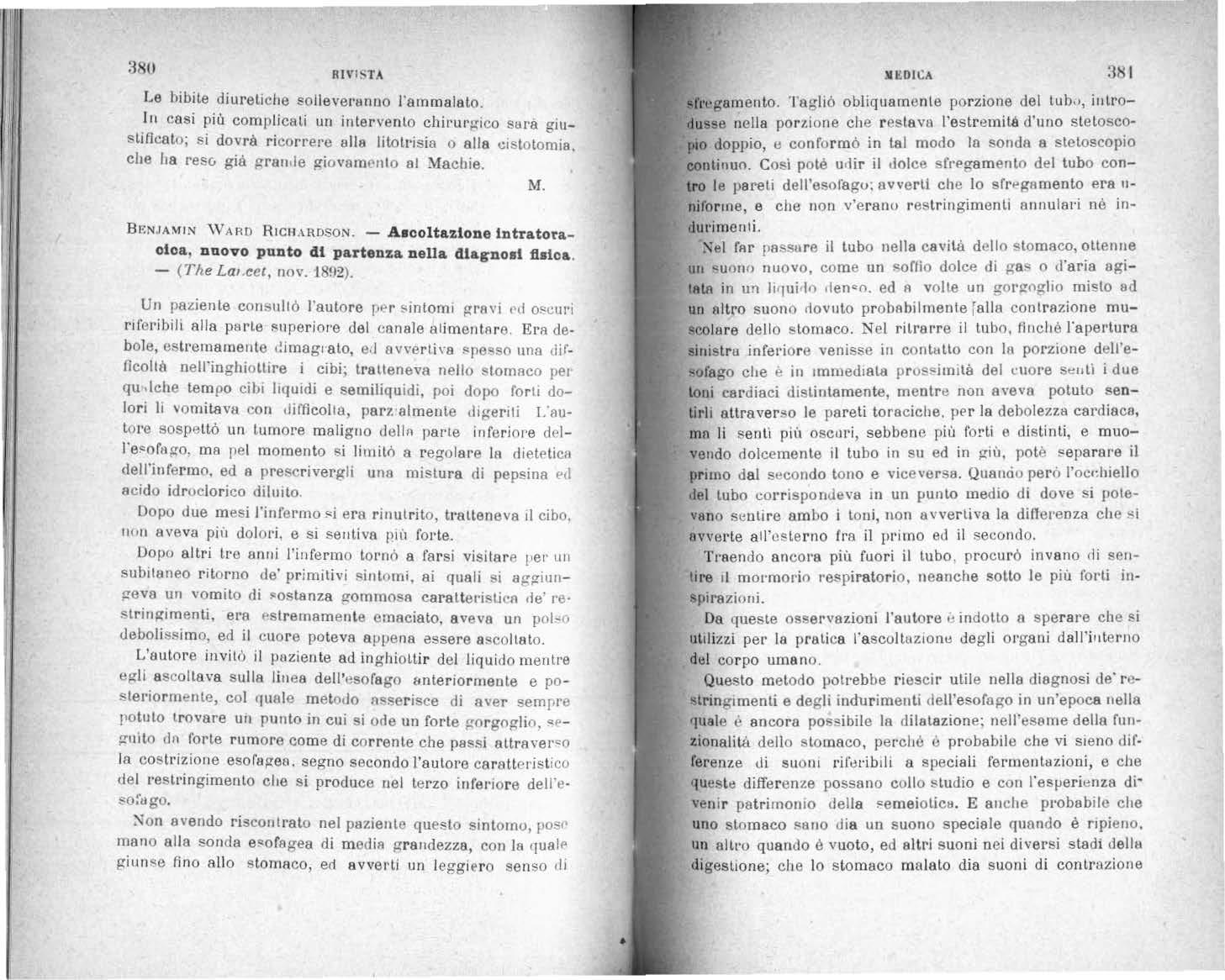
M.
BEN.IA MtN \VARO RrcH.\RDSON. - Ascoltazione lntratol'aoioa , nuovo punto di partenza nella diagno si 11sioa . - (The La1.ect, nm•. 18!l2).
Un pa;::iente l'autore pPr grtn-i t•d oscurr rrfc.wibili alla par·te !'lllperiore del c.:anale alim entAre. Era debole, dimagralo, e. l a ,.,·erti,·a "Pec;;so una ùirflcoltà nell'inghionire i cibi; tratteneva nello l'tomaco pet qu .tche tempo crhr lrqurdi e semiliquidi, poi ùopo fortr dolori li vomitava con o!iftìcolta, parz almenle drgeriti !.'autore sospP-Llò un !umore malign o delln par·te inforior·e dell'e"ofug-o. ma pel momento si limitò a r egolare l a dieteticA nell'infermo, ed a una mistura di pepsina Ptl acido idroclorico dilurto
Dopo due mesi l'infer·mo >:i era rrnutrilo, tralleneva il cibo. non aveva piit dolol'i, e si sentiva prll for·te.
Dopo a l tri Lr•o anni l'infermo tor·nò a farsi visitarE' per Lllr subitaneo ritorno ùe' primitivi !'lintumi, ai quali l'li geva un vomito di "Ostanza eommMA de' r·e· Rtrin,:trmenti, erR PStrernamen t e emaciato, aveva un ùeboli);l'imo. ed il cuore poteva appena essere a!'lcollato.
L'autore invitò i l paziente ad inghiotti r del liquido mentre egli ascoltava sulla liuea deii'Psofago &nterior menle e poster·iormPnle, col quRie metodo ns!"erisce di aver sem1·re potuto trovar·e un punto in cui si orle un forte c: pgnrto dn forte r umor•e come di corrente che pas!'li altrflvei'"O la segno secondo J'auto•·e ca r attcristicP tlel clte si produce nel terzo infer·ror e dell'e-
:'\on avendo riscontrato nel paziente questo sintorno, mano alla sonda e"Ofllgea di medin g randezza, con la qualr giun«e fino allo stomaco, ect avver•tì un leggiero senso dr li
Eoi
CA sfn•gam ento. Taglr6 obliquamen te p()rzione del tub,,, intt·oriusse nella po r zione clte r E-slava l'estremil.8 d'uuo stelol:;COpto doppio, conformò in tal modo la sonda a stetoscopio continuo. Così potè udir il dolce sfr·egamento del tubo contro l e paeetr dell'esofago, avverti che lo sfr .,p;AmenLo era nniforrn e, e che non v'e ran o restringimenti annulat·i nè indul'iment i . fAr pa!<sure il tubo nella cavila dello ottenne 1111 suono nuovo, come un >:oflio dolce di ga>< o d'aria agilillA in un li!Jui•lo den"'o. ed A volle un misto ad un Altro suono r!ovnto probabilmente raliR contrazione mu!':COiare ùello stomaco. Nel titrarre il tubo, finché l'apertura siuistru infet·iore venisse in conL!illO con ltl porzione dell'e"''Jtago che è in unmedrata pru!l'c:imità del cuol'e seHli i due ton i caL·diaci ùisLintamen te, mentre non aveva potuto sentirl i allraverso le pareti toraciche, per la debolezza cardiaca, mn li sentì pi1'1 oscnl'i, sebbene più fo!'li e distinti, e muovendo r!olcemenle il tubo in su ed in potè ;.:epar are il primo dal st-condo tono e viceversa. Quauciu però l'ocl:l1iello
,Jel tubo corr isponùe,·a rn un punto medio di dove si pote\'80 0 sentire ambo i toni, uon avvertiva la difler·enza eh!' nvv et•le all'este rno fr·a il p1·imo ed il sec:ondo.
Tr·aendo an cora pill fuori il tubo, procurò invano di sPntrre Il m ot·mor·io r·espiratorio. neanche sotto le più for·ti in!'J) ìrazioui.
Da queste osservazioni rautore ,. indotto a sperare che si ultlizzi per· la pratica degli or gan i dall'i nterno dul co r po umano.
Questo metorlo potrebbe riescir utile nella diagnosi de' rrstringrmenti e degli indurimenti dell'esofago in un'epoca uella ']Uale l' an co ra possibile la dilatazione ; della runzionalita dello stomaco, per·clrò ò probabile che vi siena diffe!'enze Ji suonr a specia li fer·mentuzioni, e che differenze possano collo studio e con l'esJ.Ierienza divenr r palrimonro deiJa "emeiotictt E anche pr·obabilc che uno stomaco stwo di a un suono speciale quando é ripieno. un altr·o quando é vuoto, ed allri suoni nei diversi stadi dellu di gestione; che lo stomaco malato dia suoni di contrazione
Ca 383
diversi da quelli del sano, r-pecialmente se la malatt111 risiede nelle puret1.
Con un buono «>teloscopio esofageo introdotto nello stomaco, si potr!l certumentf' sentire un rumore di aneurJ!'Ima che all'esterno e spes!':o impossioile udire, si potranno s e ntir lllegllo i l'urnor·1 del cuore ueUe estr eme debolezze nel collasso, e co11 lo stesso mezzo si potrà calda nello stomaco, o una corrente farari 1ca sul <'UOI'e per r iatlival'lle le contrazioni.
. Gli polrnonari, i bronchi, il laringe, J'artt> ri11 lnuommatll, le succlav1e e le Cfii'Oltdl, la trachea stessa, po!'!':On? e-.sere ascoltati con uno stetoscopio esofageo .
Rt«ogna JlBI'O ricordarsi che la son .1a esofagea n o n t' :;;cmprP tollerata, che molle volle si puù giungere Renz a di ad una diagnosi pr ecisa, e quindi essa sarà rontroindlcatA non ò necessaria e se uon ,._. tolle r ata, e quandn UMre rlovrà essere perfezionata, a r ricchita di più lort, e rPM poco tlessibi le.
PJ•of. l. M. DACOS rA.- L e r elazioni de ll'a l bum inuria c on l'ecceaaiva aeore z i one d 'ac i do urloo, e con l 'o aaaluri a. - (The !Joslon. Medicai and Surgical Journal, ùic 1:->!l:l).
V'è un gruppo distinto di albuminuria, la cui patologia non " cluHrnmonte •nlesa, ma che ha ca1•atteri distinti b Pn dtscernihilt da quelli della forma della malattia rena .e . come ne ,; l'origine, il cor so e la terminazion e. don.r ... la nece ssilù di sturliarlo dal punto rli vista pato lo!!'ico e terapeulico.
L.:u uomo eli età :-;otfet·ente di albummuria con emisiow• di cilindri ia 1111i eptleltalt, nveva disord 111 ata la d i""slione \'tt IIALUIOIIZ8, COStipazioni, depres<>ioui di spu 7to, nenos1smt, una cou ù izioue si1uile a quPila che si ri., ciJnt rA n Pila ltlernia. L'or1nn del mattino deposita va at·enella uri r·u. il _d' <'S,0:}1 veniva da l02:i a 1032; v'era pic <:o la •/ll8nt1tà d olbummu, cr·cesso d'acido urico ed urati. Con a1 •· propriata si mig liorarono le condizioni diaest1ve, il paziento v1aggiò l'Europtt e f1·uì ùi diverse celebri ucqu c min ti l'ali , to r r1ò in Ame r ica guarilo, e da t r e anni l'albumina uon è pi ù r 1compat•sa nelro r i11a .
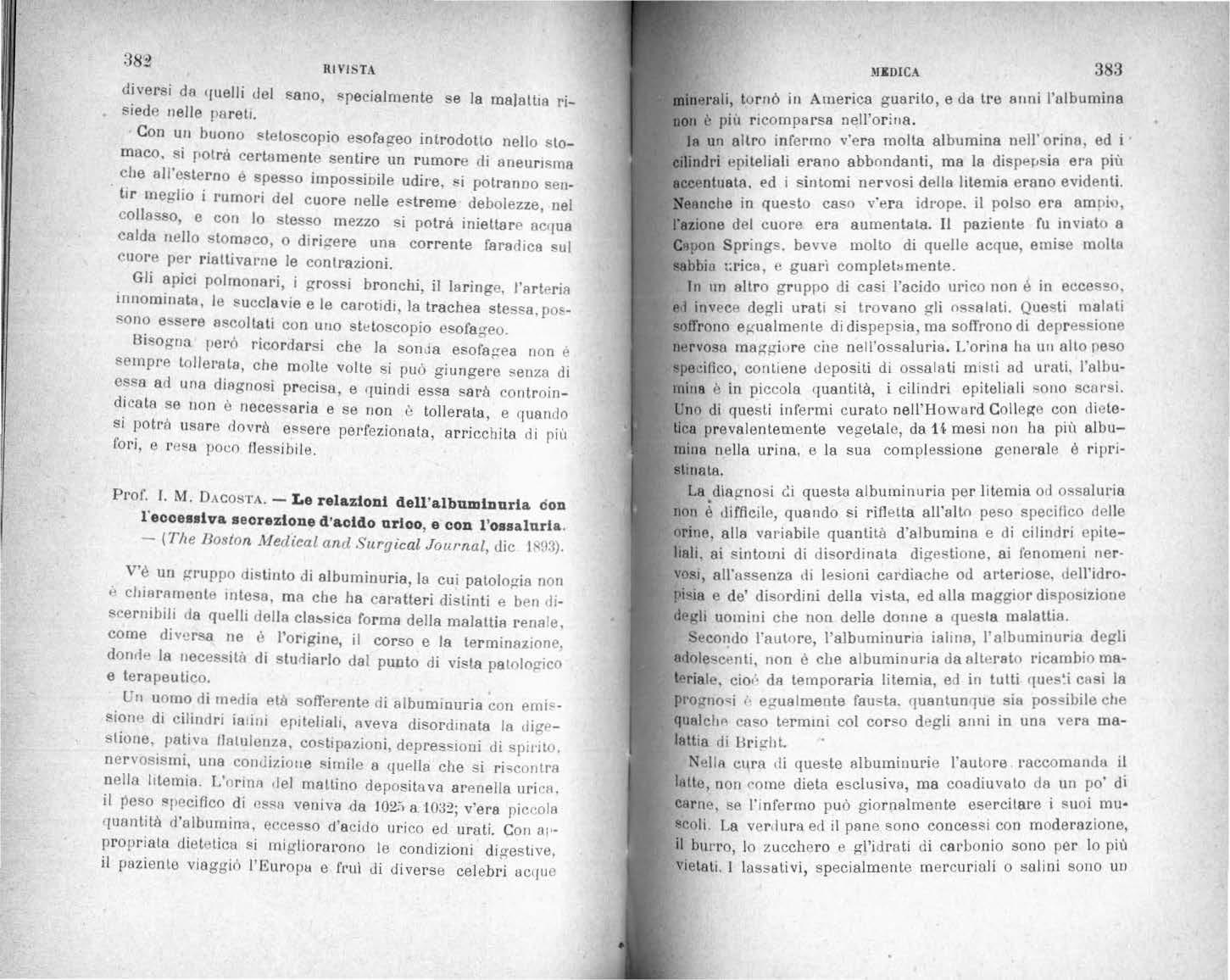
111 u n a ltro infermo v'era molta albumina nell'orina, ed i cilindri •'pitelia li erano abbondanti, ma la dispE'!'Jsia erA più accentua ta . ed i sinlomi nervosi della lilemia e r ano evidE>nli. Nennche 10 questo caso ''t>ra id1·ope. il polso era amni,,, ra zion e del cuo1·e et·a aumentala. Il paziente fu rnvialo a C"'pon S pring8. bev,·e molto di quellu acque, emise molla 1!8bbw •• gua1·i complelnmenle .
I n un altro gruppo di casi l'acido urico non é in eccec;c:n, e l degli uralt si trovano gli Quec;ti mal ah egualmente di dispep8ia, ma sotl"rono di depressione nt>rvosa ri1e nell"ossaluria . L'orina ha 1111 allo peso cont1ene depositi di ossalali mtsli ad ut•ati, l'albumina è in piccola. r1uaotità, i cilindri epiteliali .;;ono sc;n·si. Cn n di questi infe1·mi curato neli'Howsrd con dièletir.a pre valentemente vegetale, da 14 mesi non ha più albumina n e lla urina, e la sua complessione goneJ•alc è ripriBl lllata
La diaj:fnosi C.:i questa albuminuria per litemia od oo;;sal ut·ia non é d iffic1lc, quaudo si rifletta all'alto peso specifico ne lle ori ne, alla va1·iabile quantità d"albumina e di cilindri rpiteltAii ai sintomi di dig estione, ai renomen1 ner· vos1 , all'tl!>Senza di lesioni ca1·diache od arteriose, dell'idroe d e' disordini della vi,la, ed alla magg10r disposizione uomini che non delle douue a qu e sla malattia. raulo re, l'albuminuria ialina, l'albuminuria degli lltlole"'Ct>ntJ, non è che albuminuria da alte rato ricambio rnacio" da temporaria lilemia, ei in Lutti I(U!'"'i c11si la progno--i • . e:::rualmente raul"ta. r1uantun <JU8 sia pos...ibile chf' qtJAicltn ro«>o Lermtni col cor:;:o d t•gli anni in una ve ra malAttia d i Uril!h L
Nella cura di queste albuminurie !"autore t·accomatHlu il IHlle, non l'Ome dieta esclusiva, ma coadiuvato ùa un po' di carnt>, se l'infermo può giornalmente i !luoi mu · La verdura ed il pane coocess1 con moderazione, il bttt' I'O, lo zucchPro e ùi ca!'I.Jonio sono per lo più VI eta ti. l lassativi, specialmente mercu r 1ali o salini SCJIIO uu
» EOlCA pu r lalo di untica esperienza, Il citrato e racelalo d1 potassa VIetano il degli epiteli 1·enuli come fa11no lù ah l'e acque m iner ali. n'importanza capitale l'e!lor cizio muscolttl'(> Sl"lt>mAtico, perché que!IL' albuminu r ia lilemica s1 é "l"la piu ,·olte ricomparit•e dietro l'iniezione cle' pazienti, eu in un ci'albumtllUI'ia eia oso:alur•a da tempo gual'lltt, l'albu•nin!l ricompa r ve nell'ot'ina in dc• gli ossalat1, pet· a' P1· l'Infermo masticato il rabarbaro.
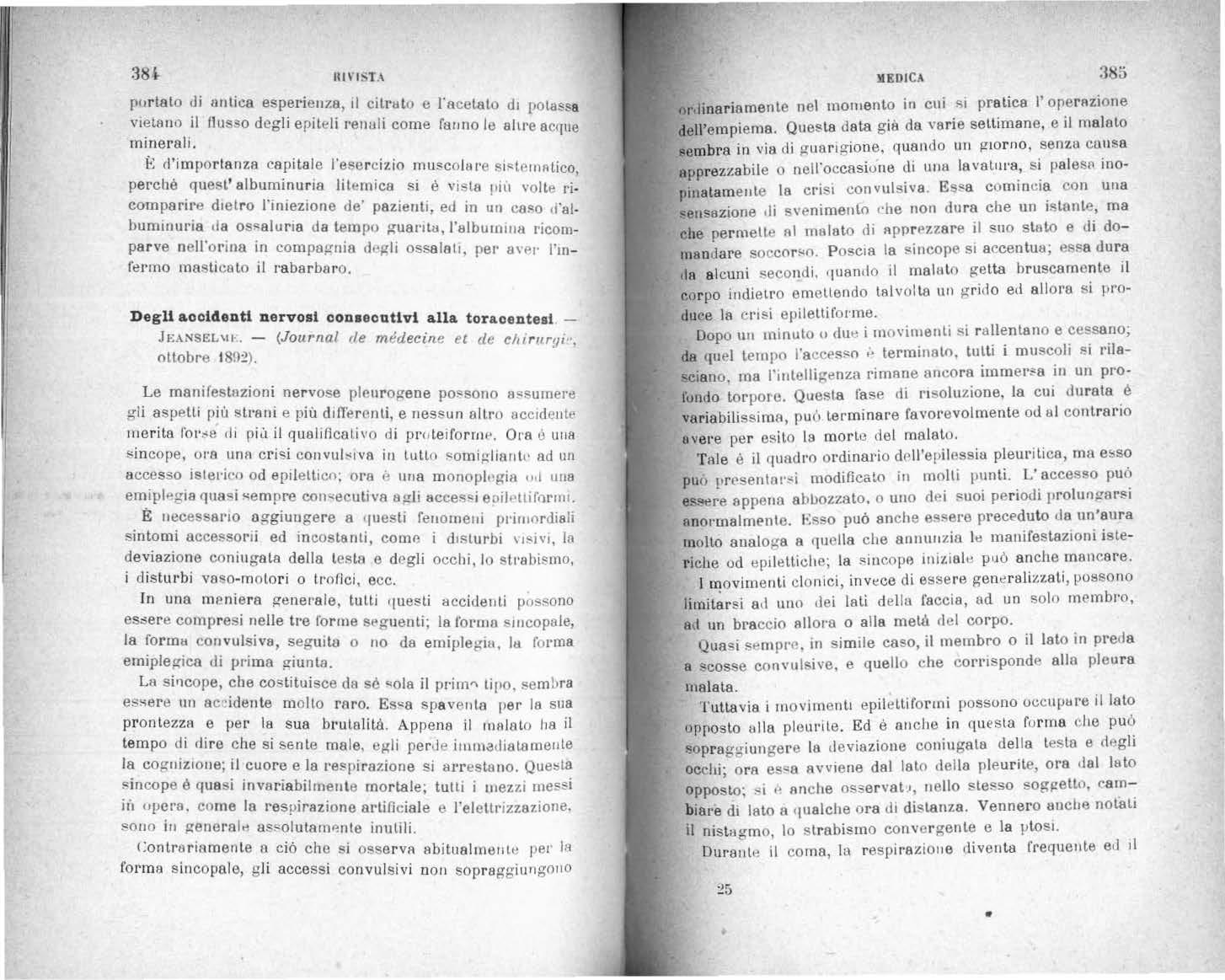
D egU aooldenti nervosi oonseoutlvl alla torao e nt e slJEANSEL\11. - (Journa/ de médecine ec cle chirur!l' . oltohrt> 18!12).
Le manifeslozioni ner vose poo:sono gli aspPlli più f-ltrani e più dill'ercnti, e nessun allro ttcc•denlt> mer ita fOl':<e d1 più il qualificalivo r! i pi'<Jleifornw. Ot·a ò Ul lll :>incope, orA unA crisi convub1va in lutto f'Omigliantc• ad un acces.;;o islet·ierl od epilelt1cn: 01'8 i• una monoplc•A"ia nd una c.;ernpr·e con ...ecutiva acces'-i eoilt•t1ift1rrru.
È necessat'IO aggiungere a 'IIIOsli feuomeui p••iu1ordiali sintomi accessor•1i ed incoslanli, comP, i d1!'ìLurbi , la deviazione coniugata della Lesta e d<'gli occhi, lo i disturbi o lrofìci, ecc.
I n una nwnie r a gener'ale, tutti questi acciùe11ti pos>:ono es::;ere comp r esi nelle tre forme seguenti; la formo "lllcopale, la convulsiva, segu•lo o 110 da emiplegJo, ltt forma emiplegica di prima giunla.
La sincope, che costituisce dA sè «ola il pr·irn" tipo, sembra e::-;'ler e un ac·•iden l.e molto raro. Es..,a spa vPnla per la sna pr on tezzA e pe r la sua br utali tà. Appena il mA lato ha il tempo di di r e che si senle male, egli perdP imn•atliatameule la cogniz10ne; il cuore e la t'espirazione si ttl'restano. Questa
!<i ncope é quasi m va r iabilmen te mortale; lutti i tlleZI.I messi in opera, cnme la res11irazione artificiale e relell•'izzazione.
!<ono in g-enerai,.. inutili.
Controriamente n ciò cho si osser vA abitua l ment<• per 11-1 form a sincopale, gli accessi convu lsiv i 0 011 sopr aggiungo110 or.linariamente nel mon•ento in cui :'Il pratica l'oper Azione dell'empiema. Questa data già da \'a r ie settim ane, e il maiolo 11 embra i n via di quando un {ottorn o, senza causa apprezzabile o nell'occasione di unti la vat111·a.' pal es11 inopinalam eule la crist convulsiva. Es!la con una "en sazione .li S\ pnimento c·he non dura che un JstanlP, ma rhe per mette Al malato di Appr Pzzare il suo stato e di domandare soccor;;o. Poscia la s:-incope s• accentua, dura eia al cuni !'econdi. quando il mala to getta bruscamente i l r,orp o indiell'O emcllendo lalvult.a un grido ed allora si produre la c·risi opileltil'ol'me. l'ulta via i IIIOvimont• epiii:!Lliformi possono occupure il lato opposto alla plout·i le. Ed é anche i n questa for ma cile sopraggiungere la deviazione coniugala della lt><;La e dPgh occhi; ora es"'a Avv1ene dal Ialo <Iella pleu r ite, ora tlal Ialo opposto: "i ,. Anche osserva t,, nello stesso ram-: bia re dt Ialo a •1ualche ora d1 distanza. Venn ero anche nolal1 il nist agmo, lo str abi8mo conve r gente e la ptos1. il coma, l a r espir&ZIOne dive11La frequente ed 1l polso mollo celere; la ternpe •·atura, che l> bal"S:I'l al momentr, dell'a cculenle, può sali•·e 111 seguito a 41 °. Sovente, quando il coma comincia a gcomparire, si constAla che uua tlelh:1 del corpo è parailzzatu. Que!>lll emipleg1a può essere completa; ma e ra1·o che l' impoltmzu funzio11ale f'lia Al"soluta; la parel"i è più f•·er[ueute deliA pat•alisi; frequ••nte1nente, d'altr-ondl', si I1A ....ollaolo unn ulOnCIpl<'gia brachiale p1ù o m eno RC"entualn ; di pil1. 'l"''sla com plicazione r1sit>de quasi semp1·e dAllo s l e!'so lato dello empiema. Deve!'li notar,.. ancora che la nnu oceu1•u sempre il lato in cu1 le convulsioni S!JIIO state pl"edo miiiAnll . lu 1111 numet•o di Clisi mollo p ù lnnilall remipl <'gill pll'Ur tlica lta per· c arallt're di sopraggiu11gel'P eli pr1ma giunlll sPnza essPr P pre<'edutH dll unA ct•i"i P <h ntllt 1•sseee 1\ccolllpagnata da di conoMenzH. Anche in questo caso. lu cttusa provocalt·ice può esst r e un'iniez:rorw.
Dopo tul minuto o <lue i lllovimenli rallentano e cessano; da tempo ;.. terminato, Lutti i muscoli si t•ila" ciano, ma r•imane unc:ora immet'«a in un profondo torpore. Questa fase eli l'rsoluzione, la cui du r ata .è publermi nare favor'evolmente od al contr arlo avel'e per esito ls morte de l malato.
Tal e è il quadro ordinario drll'epilessia pleuritica, mn e!iso puo prt>sentnr"'i modificato in molli punti. L'accesso eS!>I"re appena abl.lozzato. o uno dd suoi per iodi Anor·malmenlo. t·:!'iso può anche preceduto tla un'aura molto analoga a <tuella che aonuuzia manifestaz•oni isteriche od la sincope tniziale può anche mancare. 1 movimenti clo nici, di esse r e gene r alizzati, posso no ad uno clei lati della faccia, ad un solo mt>mbro, al un braccio AI!OI'a o alla metà del corpo.
Quasi sempl'<', in simile caso, il membro o il Ialo rn preda a :.>cosse convulsive, e quello che corrispondi> allo pleu r a Inalala.
A questi motori pos!<ono asso (" i...trSI, siu Ùtlrunle gli accessi, c,ia durante la fac,e paralil,ca, a l1tul o ,h ep1fe11 ,. mrni, molti dislui"IH 1ncn«La11L•, rill ... llollli l'ideazione. l' m·ti<'OIAzlone d e lle parolo>, lA l"ensibilllà o speciale. 1 centri vaso·molor·i o t!'otict. Questi diqlurbl si f'Spllcann coll'ebetismo, col delirio, coll'eccitaziww maniaca, coll'al'a8ttl, coll'ambliopia. coll"alllau r osi. ecc.
Nt>l momento in cu1 il liquido panelt'tl nelht pleura, il malato avverte un mollo vivo e d uu i11til·rzzimenlo doi nwmbt•r sopralullo dal lato <·orrispontlenle all"em('iema Que"-tu "ensAziorw si di ...sipA a poco a poco, ma irnmanlinonl1 o qnak •P {!tOrno dopo il malato SI acco r·gc che uno dei l'uoi lati, nt•,ltnnriamente quello delhi plenr·ile. é indebolito. L' emipiP!!tll puo cornpar·n·e an c he più insidiosamente, senza alcun dolurc. nò formicolii 1·•·ecedeuti.
La prognl)si di lutll questi acculenlt net'\ osr è gra ma, poir.hé la rnortr> è !lOpraf!g tullta Jfl volle l'tU 3!l casi. Il dottor de CPren,•tlle come segni precur·sor•i clte po!':"onn rat• [H'evedere la compa1·sa prossima degli accidrnti: l'ineguaf!"ltanza pupillare, l'ipereslesra pleur o·cutanea e la Psistenza di d1slurbi \"aso- motori e specialmente la compar!'H dol sanguf' nello secrezioni della pleura. Quanto alla cau-.u dr r1ue.,lt accidenti eso;;a é ancora osc ura. Sta _però il. _fallo che n e ll a m8!':'<ima pat•le dei cnsi si Lr·atlava tlt pleut•tll pur ulen te, tec volle sollanlo fJU esLi accidenll si sono prot_lotlr nei c a "'i di pleut·ite Aggiungasi che 'luanlunque stati c tlali alcuni fatl t di accidenti pare che rl trau rnatismo prodotto dalla puntur·a o dallt> lavature ne sra stato rn la C'a u<>n dt•lèrminante. .
Ma ru d ' uopo ummettere anche una causa ora , tutte le cause dc!'ri menll. la miseria , la null·lztone m!'urli ciente. la le mulotlie lunghe e pro· du cono un o stato d1 debflir>7ZR irr·itablle e talvolta un r a J.iOnP delle funzioni eccilo-m o tr·kt del tni<i.ollo mollo proprzta alla comparsa delle mauifestozioni ne r vose.
T uHi qu e:-;li fattori di gravezza si riscontrano all'ortf!inc o u el corso d<'lle pur·ulentf'. A 'lllel"le cause che produ cono la depressiOne del si!' ma nervoso, si deve a a;: c:i ungere gecondo .1 ean!lelme, il riac:sorb tme n to lento de t !H't HIOlll settici conteuuli nt!lla pleura, parchi• nella grande tll CJue.sli casi si trova il contPnulo della plt>u r a mn nifo•stamente put·ulento o gangt·enoso.
Dnl punto rli visln prolilalli c o, dovrA quindi raddoppia r e d i prt><"auz -<f' il malato ,. o cardiaco; tn Prl icozi oni dtwono essere fatlt> con tulti i più rr -
I-!' 1Rrd1 ,, s1 eviter•à sopratulto la proiezione di'l li({uulo con l' uTig11 tor" È ,.perabile che que-.li ternibili a ecid,.. nti divenpi11 rori. ;.:t•azil' ai pt•ogre;.si del mt\loJo Rnlr:-etlr co eh..- permette d1 guarire rupi.lomente e soventP a nche c:enza ri co t••·erP alle In\ a tu l'C le mf\lalt:t' prodolle tl l\l l'en.piema.
E rltrom e la.l g ia. . - SE--:ATtll\. - ( RP r l. kli11. \l'ocher.schr. 7 novt>ml!re i8fl2).
C on 'iuello pl'esenlalo da Gerltar.Jl, queRlo òell' t' il !'Cr·l)nrlc> Cll"'O dr >'iffalta malattia esposto alla Socreta mediCA d i BPI'lin o L'n uomo di H anni, pl'ima affatto c,ano, da un ann o e me7.7.0 fu t·olpilo da dolor·i nevralgict, da d('bolezze n elle bt•accia e posc1a nelle Po co dopo apparve, ot·a
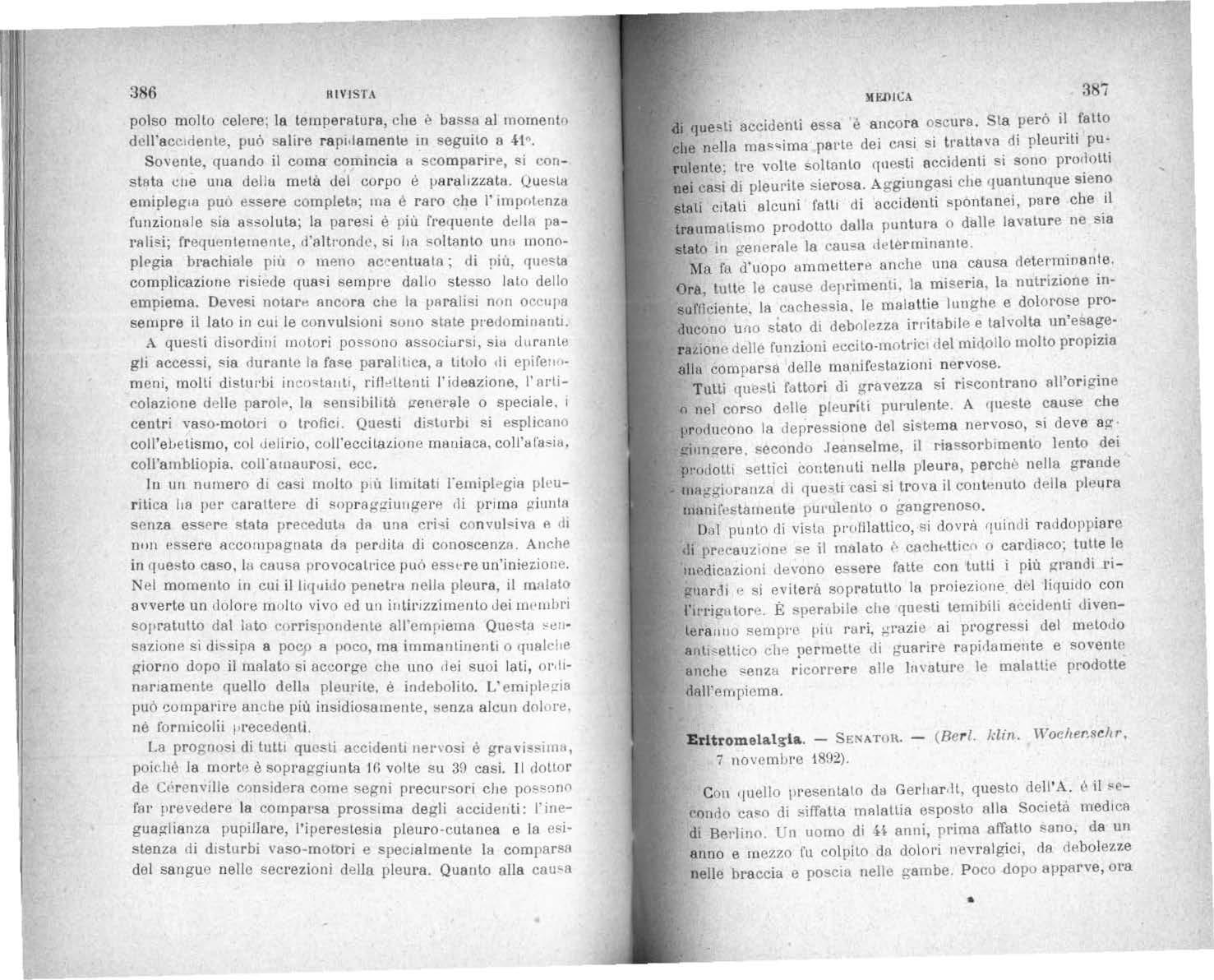
Medica
maggio t·e ed 01·n minore. un si mmet1·ico dolle pnrti
Al primo apparire esso e1·o di un l'Osso inteu-<o. cliP -;comalla pres«iont>, sopra la l'l'gw ne met.acarpo-f'alan zea ,.. pr1me articolazioni falangee di entrambi le mani, e anrltc 11ello regioni cubitali.
Qualche arrossamento si presentavR pure ROpra i malleoli sul dorso dei piedi e nella regione del #-!inocchio sinistro' L'arrossamento var1ava di intenc:;ità essendo pitt accentu ato nell'estate. ma "enza dolore alcuno. Dei noduli si presentavano nelle parti arroslìate sul dOt'Sù delle rnani. riman enrlo le ossa e le articolazioni e sen?.a che sop 1·a\venl ssero d1sturbi viscerali. Passaudo col dito sopra la pelle del braccio e del torace si produce,·a una str·iscia simile a quella cile si scorge nell'orticaria. Fra le altre osser·vaz1o111, I'Aulot·e dico rlw questa malallia differisce dall'Erytema rrrlorieum pet• ave1'1' allaccato i pie ;i e ri;;parnlialo le mani, pel' gli acces!:'i d1 dolori p1·ecedeuti l'arroc:;sameulo e per la sua p rsistenza da pru annr. E probabile che alcuni dei rt';.?ISlrAtr com e t> r1tema abiLU11lc for se dovrebber o meglio qualitìca t'"'' come eritromclalgùt. T.a malattia sarebbe neurosi. A ri gHat'd<' c!c! noduli si c·onosce chi' i disturbi dei vaso-motori sono accompagnali da anomalie ùi iperlrofì» e au·otia, ma pare che •r uesti noduli non sieno "'lati 8ino ad ora chia ramente de!:<c rilli nella er,fromelalgia.
Il mlllalo si della eletlrot.•r!ipia, ma non fn notato un deciso mig lior•arnento delle alt e1·azioni. L'antif,•hrina rispose assai bene 11el calmare i Jolori.
Bernhardt pur(' e!';pose un cac:;o srmile in una donna di 50 ann i. Cintrue anni prima esi a ebbe dolo r e mani e nei piedi tla arrossimento e gonfiore, l e superfici palmad e dorsali delle mani SI presentavano alftltlo , l'arrosM· mento no11 era unrfot•me e le alterazioni l'li liruitavauo dalla delrarticolu?.ion e radio-uluo-earpea. 11 r ,c:;sor·e era ac· compnt:"nato eta gonfio r e pastoso rfelle parti con dolori nei m ov unenlr altiYi, però le ar ticolazi oni no:r erano attaccale I ner•vi ed i muscoli delle braccia erano pu re sensibili alla pressione'. ConlrH r iamente agli altri casi l'infe1·ma risentiva pe:.rgioramenti col freddo. La sensazione tattile delle dita era RVver•Lila come attraverso ad un rivestimento di esse, pe1·ù non risvegliava dolori. L 'alterazione dei piedi migliorò mollo tanto che la mala\8 potè oltene1·e di passeggi are ai•Juanto bene.
Dala la forma ra1·a Ji que!';ta malattia, sulla quale t•ecrnli gli sludii e le osservazioni come enlitit a crediamo oppor·tuno illu.,trare il caso con alcune notizte storiche e descrittive della importante lesione
Il pl'tmo a de;;criverla fu il Weir nrl 1872 e 18iX, per propri1:1 os«crvazionr che pèr altri casi offertigli dn altri.
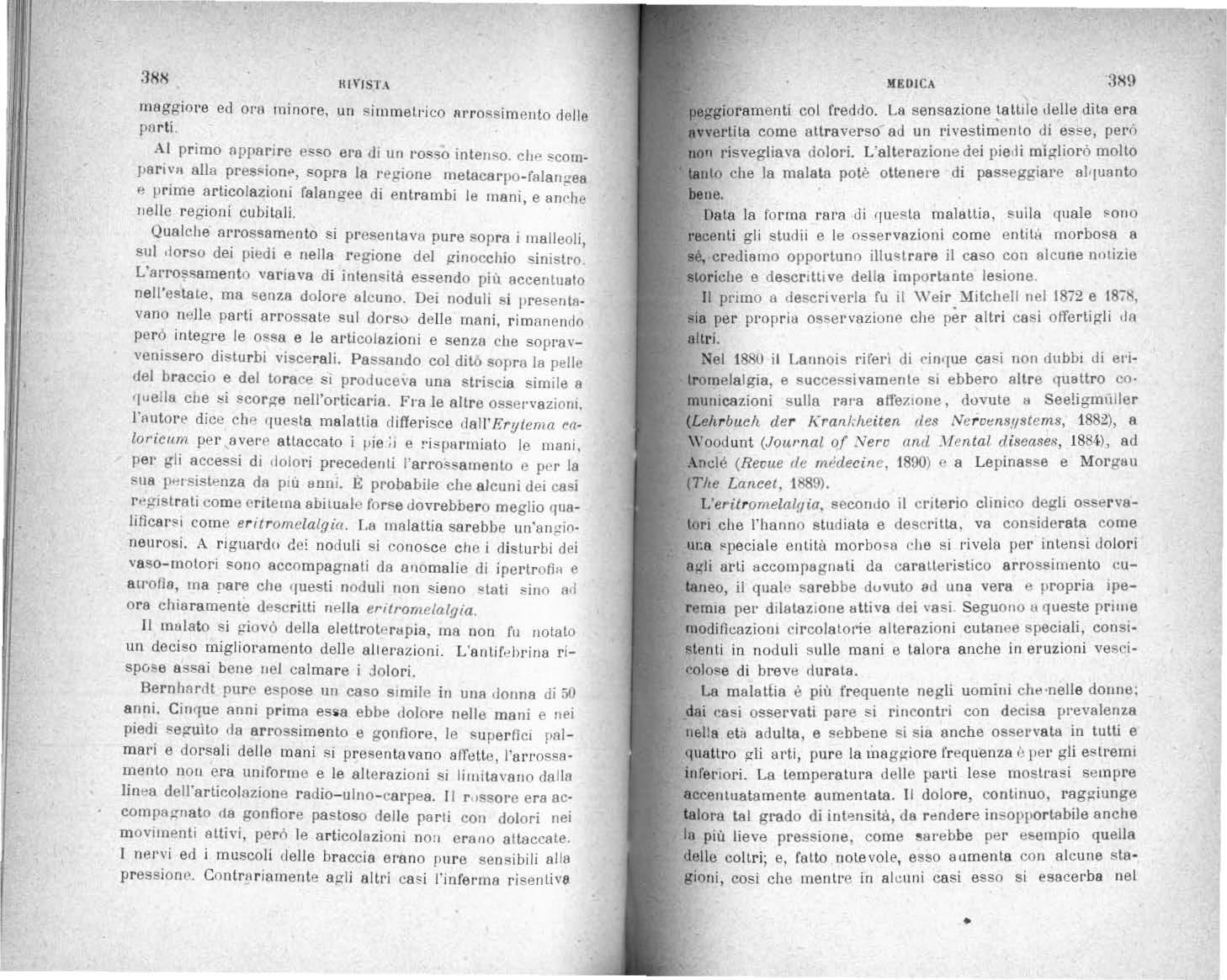
Nel 1880 il I.annois riferì di rinr[ue caRi non dubl..>i Ji el·itromelalgia, e sr ebbero al tre e1uattr o CO· murucazioni sulla rar·a al'l'e;. rone, a See!igmuller (Lehrbuch de r J.:ranl.heiten rles 1882), a \\' oodunt (Joumal of :Vero rutd .V en tal rliseases, 1884), ad Anclé (Reoue de rnt'decine, 1890) " a Lepinasse e Morg1:1u (The Laneet, L.'erit r omelalyia, secondo il cr1 terio cltn1co degli osservatcm che l'hanno studiata e descl'itta. va considerata come l:lpeciale entità morbo"a c•he lSi l'ivela per inttmsi Jolori ag:li accompagrH1li da caratteristico arrossimento tan eo, il quale sarebbe dovuto ad una vera e propria ipert>rnla pe1· drlatazione attiva dei "asi Seguon o niJueste pr11ne modi lìcazionJ rircolator·ie allerazioni cutanee speciali, consiRLenti in noduli sulle mani e talora anche in eruzioni vescic•olose di breve rluraLa.
La malattia e più frequente negli uomini cht>·nelle donne; dai rasi osservati pare si riucontri con dec1sa pl'evalenza uelta età arlulla, e sebbene !';i sia anche osset•vata in tutti e <{Uilllro j:rli 81'li 1 pur e la maggiore frequenza l· per gli inl'el'rori. La temparaLUI'R delle parLi lese most1·asi sempre accentuatamrnle aumentata. Il dolore, continuo, raggiunge tal o1·a tal grado di da in soppor tabiJe anche la p1ù lieve pressiOne, come !I:II'E>bbe pet• esempio quella dello coltri; e, fatto notevole, esso aumenta co n alcune stagiOu i, cosi che menl!•e in ak:uni casi esso si esacerba nel
)I&IHCA 3H I verno, in altri aumenta nella state, pero in gene r·aiP il fredclo gli è più favorevole, ed anzi qualche mfermo .. adrlirittura giO\'alo rlel bag-no freddo locale a permanenzA.
L e ultime pubblicazioni, fra le •Juali quella del Senatorriferita di SOJll'&, confermano non solo questi fatti clinici, rna danno nuovi particola r i, i quali concedono u)eglio di r·itenere la malattia come entità mcrbo<>a speciale e di rli iTerenzitll'l& da Altre che per 'JIIAiche punto ad es;.A famigliare.
Così, oiLr•e i sintornr !'ilevati dal Serrator nel dn lui ossPr·vato e che gia per• sé sorro suftìcienti ad 1snlare la erilrornelalgia dag-li er·!Lerui in !..'ener•... , allr·i ve no:> hA deltag-lllclamPnte esposti dal Gerh ardt alla seduta del giugno alla Società medica di Berlino, i quali confermano "Pmpr" piil la natura speciale dell a ma .attia.
Di fatto, 11enza riferire per intero la storiA del caso presentato riai r.e .. barclt, cr piace ripor•ta re qui la descri7.ione che egli fa delle alterazioni, essendo Pssa importante per il criLPrio clinico.
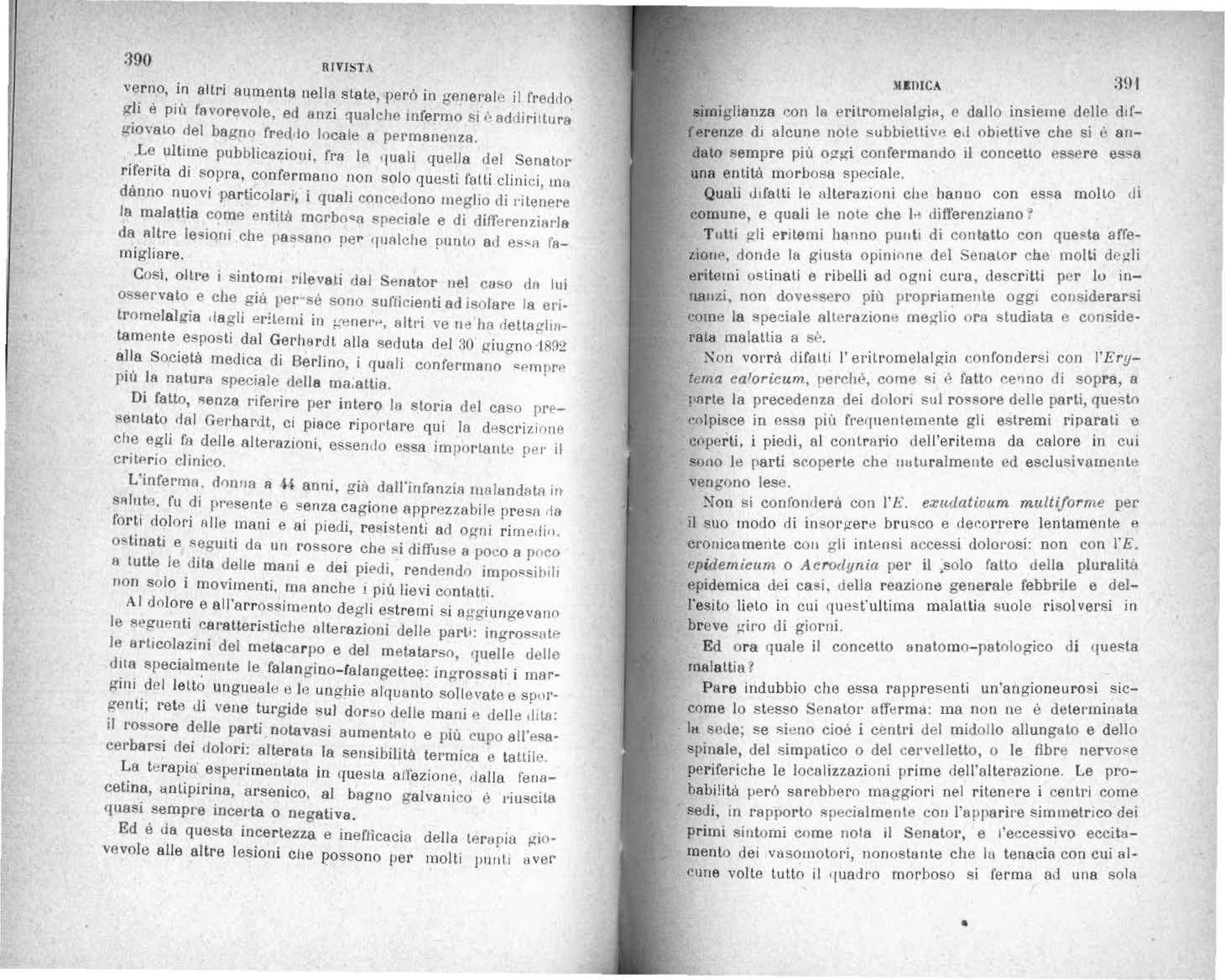
L'infermn . rlnnna a -H anni, giil dall"infanzia molandaln•n salute. fu di pr·esente s "enza cagione apprezzabile presn da l'orti dolol'i alle mani e ai piedi, resi"lenti ad ogrri ri merlln. oo;;tioalJ e seguiti da un r•ossore che "i diffuse a poeo a pnco a tuLte le dita delle mani e dei piedr, rendendo non solo i movimenti, ma anche 1 più lievi contatti.
Al dolore e all'arr ossinwnto degli es tremi si le seguenti cat•atteristi che alterazioni delle parl•: ingros<>att> le arllcolazini del metaca r po e del metatarso, I]Uelle dalle dna specialmeute le falangioo-falangettee: ingrossati i mar· gin1 del leltÒ ungueal a e l o unghie alquanto sollevate e spnl'· g-enti; rete di ven e turgide :iul delle mani r- delle d1t.a: il delle parli notavasi aumenlftto e pi ù cup o all"esacer·barsi dei clol ori: alter ata la sensibilità termica e talli ll • .
La espet•i mentata in questa atl"ezione, dalla l'errHcetina, é.\Otipirìna, arsenico. aJ bagno galvanico è l'iuscita quasi sempr•e incer·ta o negativa.
Ed è da que:.ta incertezza e ineftìcaciu della terapia gin· vevole alle altre lesion i che possono per molti IHlll\1 !lvet• sirni gliauza con la erilromelal!l'iH, e dallo dP.Jie d•fr o>renze dr alcune nole subbieltive e.J obretlrve che SI è andato sempre più confet·mando 11 concetto Pssere es<:a una entità morbosa specinle.
Quali drfatti le nllerazwni elle hanno con essa mollo dt comun e, e quali lP nole che 1..-
T utti er •temi hanno purrtr di contatto con arre: t.ionr, donde la giusta opininne del SeuaLo r mol li de.gh eriterni oslinali e ribeUi ad ogni cuJ'a, descrr t t1 pt> r. lo rn-:nanl.i, non più pl'Opriamente oggi t·orne la speciale alleraziont! meglio ora studiata e considerala malattia a st'- si confonderà con e;cudatioum multiforme per il suo modo eli brusco e decol'l•ere lentamente. fl cr•onicamente co11 gl i intensi accessi dolo1·osi: non con l.E. f'p idemicum 0 Acrodgnia per il ,solo fatto plural1ta epidemica dei cao;;i, della reazione gen.e rale febb.rJie e l'esito in cui quest"u l tima malattia suole rrsolversr 1n breve •·iJ'O ùi giorni.
Non vo 1·ra JifaiLi l' confonder si :ou l'Erytcma caloricum, perch1,\, come ._i t> fatln d1 a pnrte la precedenza dei dolorr sul delle ('olpisce in essa pit"1 frequentemente gli estrem1 r•pa:at1 e coperti, i piedi, al contr ario dell'eritema da calor.e m cur souo le parti scoperte che uuturalmenle ed esclusivamente vengono lese.
Ed ; ra IJUale il concelto analo mo-patologico di IJUe!'la ma lattia 7 . .
P are indub bio che essa ra ppresenti un'angioneurosr . SICcome lo stesso Scnalol' at'f't>rma: ma non ne è deler·mtuata 111. sede; se sieno cioè i cenlt·i del midollo allungalo e dello spinale, del simpatico o del ce,·velletto, o le . fibre nervo"e periferiche le localizzazioni prime probabi lità però sarebbero maggiori nel rilen.e re cenLI'r in rapporto specialmenlt> cou l'apparu·e srm.metr Jco. de1 Pri mi sintomi come nota il Senatot•, e l'eccessivo eccttal mento dei vasomotori, nonostante che lu tenacta con cura<'une volle tutto il ')Uadro mOI'boso si ferma aJ una sola
Rl\' ISTA tii1WICA parte possa deporre anche favo revolm ente per' LR: seconJa suppo.,izione.
La eritr .:>melalgia sa r ebbe intìu e l'op pos to d ella mal attia di R egnauJ o ga ng rena simmetrica del:e estremita , in cui è causa efficiente un car'alleristico restrin g imento uei vasi seguito dai r elativi fatti di ischemia, e con quefilO jJi special e, che menli'e predomina lo stato di eccessiva eccitabilità net'vosa, nella ma lattia di J'allerazione ha s ede nei nervi dilatatori, ma s i m anifesta s olto forma di vera e p r opt·ia parali si.
T . R.
Apoplessi a del pancreas attribuita al mal dt mar e . -
(T Lancet, 14 ge nnaio i 893).
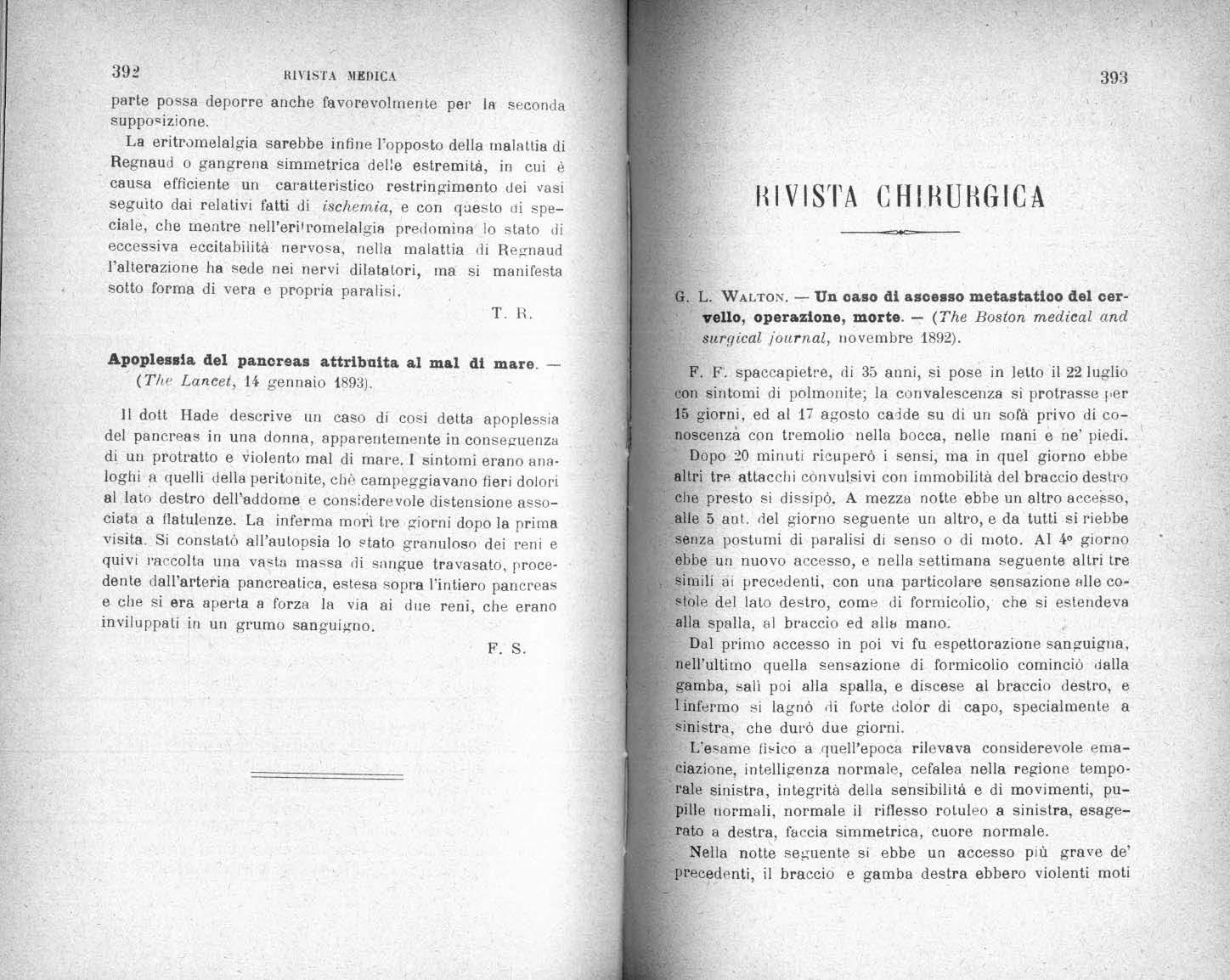
I l dolt Rade descrive llll ca so di cosi del ta apoplessia del pan c r'ea s in una donna, apparentemen te i n di uu proh'atlo e violento mal d i mare. I si nto mi erano ano· loghi fl quelli della pet'itonite, chf> carnpeggiavauo Jieri dolori al la to dest r o dell'addome e cons:derevole distensione associata a flatulenze. La inferma m nrì lt'e giorni dopo la pr ima visita . Si constatò all'autopsia lo g-ran ul oso dei reni e quivi r·accolta una va"ta massa rl i s angue tra vasato, p r oce· dente dall'arte ria pancreatica, estesa sopr'a l'intiero pancreas e che si e ra aperta a forz a la via ai due r en i, che erano invi luppali in uu grumo sanguil-{no.
HIVIS 'I'A CHIHUHGICA
G. L . W ALTO N - Un o aao dt a s cesso m e ta.statloo d e l c e rv ello , operazione , morte . - (Th e Boston. me dical a n d surrtical jou r n al , uovcmbre '1892).
F . F. spaccapietr·e, ùi 35 anni , s i pose in JeLto il 22 lu.glio con sintomi di polmonite; la convalescenza si protrasse 1•er 15 g ior ni, ed al 17 a gosto ca dde su di un sofà privo di cnnos cenza co n tr·emolio nella bocca, nelle mani e ne' piedi.
Dopo :W minuti r ic up erò i sensi, ma in quel giorno ebbe al tr i tr A attacchi convulsivi co n immobilità del braccio des l t·o c he pr esto si dissipò. A mezzti nolle ebbe un altro a ccesso, alle 5 aol. ciel gio rno seguente un altr-o, e da lutti s i l'iebbe sen za postumi di pa ralisi di senso o di moto. Al 4° giorno ebbe un nuovo accesso, e nella settimana seguente allri tre sim ili a i precedent i, con una particolare sensazione Alle co!< lole d e l lato destro, come di formicol io, che s i estend e va all a spalla, t1l br1:1ccio ed mauo.
Da l pr'imo accesso in poi vi fu espettorazion e sangui g na, u ell ' ullimo quella sensazione di formicolio cominciò dalla g amba, salì poi alla spalla, e discese al braccio destro, e l in fermo ,;i laguò oli forte Jo lo r di ca po, specialmente a si n ist ra , che dur·ò due g iorni .
L'e "am 0 li!-ico a .(juell'epoca ril evava considerevole emaciaz ione, i nle lligenza normale, cefalea nella r egione te mpo· rale s i nistra, iuteg r•it.a della sensibilità e di movimenti, pupill e n or m a li, normale il riflesso rotu leo a sinistr a , esagerato a destra, faccia simmetrica, cuore normale.
Nella notte si ebbe un a cc esso p i ù grave de' precedPn ti , il braccio e gamba destr a ebbero violenti moli
Chjrurgica
convulsiv i senza perdita di etl nna rnotor ia de l braccio dur·ò poche ore. Quindi si pensò ùi fa r r•i coverare l'iuferrno all'ospedale in attesa di un'operazionE>, essendo sicu ra la diag-nosi di ascesso cert·braiP.
Enlrò il 2 settembre, il po lso era peno, e segnava ballult•, il te r mometro 38", la menlfd erfl limpida, v'eran pr·o· fu si sudo ri, dolor•e temporale ed occip i"pecialmente a sini stra, le pupille erano contratte' ma sen,;ibllr alla luce, r1 r otuleo era esagera to a destra, con tendenza al clooo del piede, nor·male a i movirn.•nti della gamba destra alquanto atassici senza parali<>i di alcun muscol o: atassici er·ano Anche i mov m enti della rna11o destra, la er·a normale ad amho i lati.
L'e<>ame degli organi respit•atori mostrò respn·azione ><Upor fkrale a deslr·a, con l'antoli m111uli all'apicE', ottusità nel resto ùel polmoue dMlro pri vo ùi murrnure e tlr t·iRt:Onanza toraci ca nella lin ea ai"cellare, a causa d'un vrrsameHlO pl euri co. Polrn une sinistro e cuore norma li, normali le orin e, se n•· eccettui una traccia di albumina, poche cellule dell'epi telio degenerato in e pClchi leucocrti.
l<'u appli cala la vescica di g hia ccio sulla testa, l'acqua ca lda ai piedi, fu nutrito l'infermo con dieta ru amministrato mezzo centigrammo di stricnina rrualtro Y:Jite al giorno. un g r ammo di bromu r o di sodio e m ezzCl grammo rli fènacetina nelle ore pomeridianE', e si ebbt> il ripo<>o nella notte segue:1te. Al pomeriggio dell 'indoman i comincio il vomito, l'intensa cefalea, il pr ofuso su dore, la discesa del polso a 30 battiti, ma due centigrammi di morfina calmarono que<>ti sintomi, e rialzarono il polso a 60.
Alle 9 di sera r icominciaron o il dolor di capo Hl il vomito, che continuarono tutta la notte, e si calmarono iufìne con ini Pz ioni ùi un ce uti g r Am rna l'urrn di rnorftna, e con l'ammioisL rozione di mezzo g r ammo di fenacetina. L'ostrnala costipazi one venlrale che durava da più giorni, l'insensibilila e l'apatia della n olle, il polso che oscrll ava da 50 a 60,1a temperatura che variava poco dai 38' , l'immobilità del bracdo destr o, la leggiera deviazione del labbro, la depl'essione della pinna nasale destro richiedevano urgentcml'llle I'OpPr azione ehe fu eseguila dal dott Conant sollevando un lembo in co r·della circonvoluzione prerolaudica, scoll ando il per roslio, ed applicando uoa treflna del dia m etro di un pollice. N on vi fu emorraj:!ia, la duramadre era tesa c spot·:..:enle, scur a e non pul::;ante. Fu incisa a sernicercbio nel 11egmenlo infel'iore dell'aper·Lur·a cranica, e "O IIevata. avvenne I'Prnia della sostanza cerebr·ale, non pul"anle, e Jluttante. nolle seguente la r espir·azror•e r idi venne rl vollo pallido, i ocular·i si vo!gevano in alto, l'infet·mo vomitò più volle, v er•so il mattino nnùò sempre peggiorando, ritorn ò lo stupor e; i r ipetuti clisteri pr·odu11<>4'rO uo' evacuazion e di materie fecali all' 1 pom., dopo di che l 'rnfer mo par eva m rgliorasse, ma p1ù tardi il respr r o diwnne irrcgolar e rl volto cian otico, ti coma divenne più pr·nfondo, ed aiiP 1 pom . avvenne la mor·Le. fu intr·odolto un drlo nella ferila,
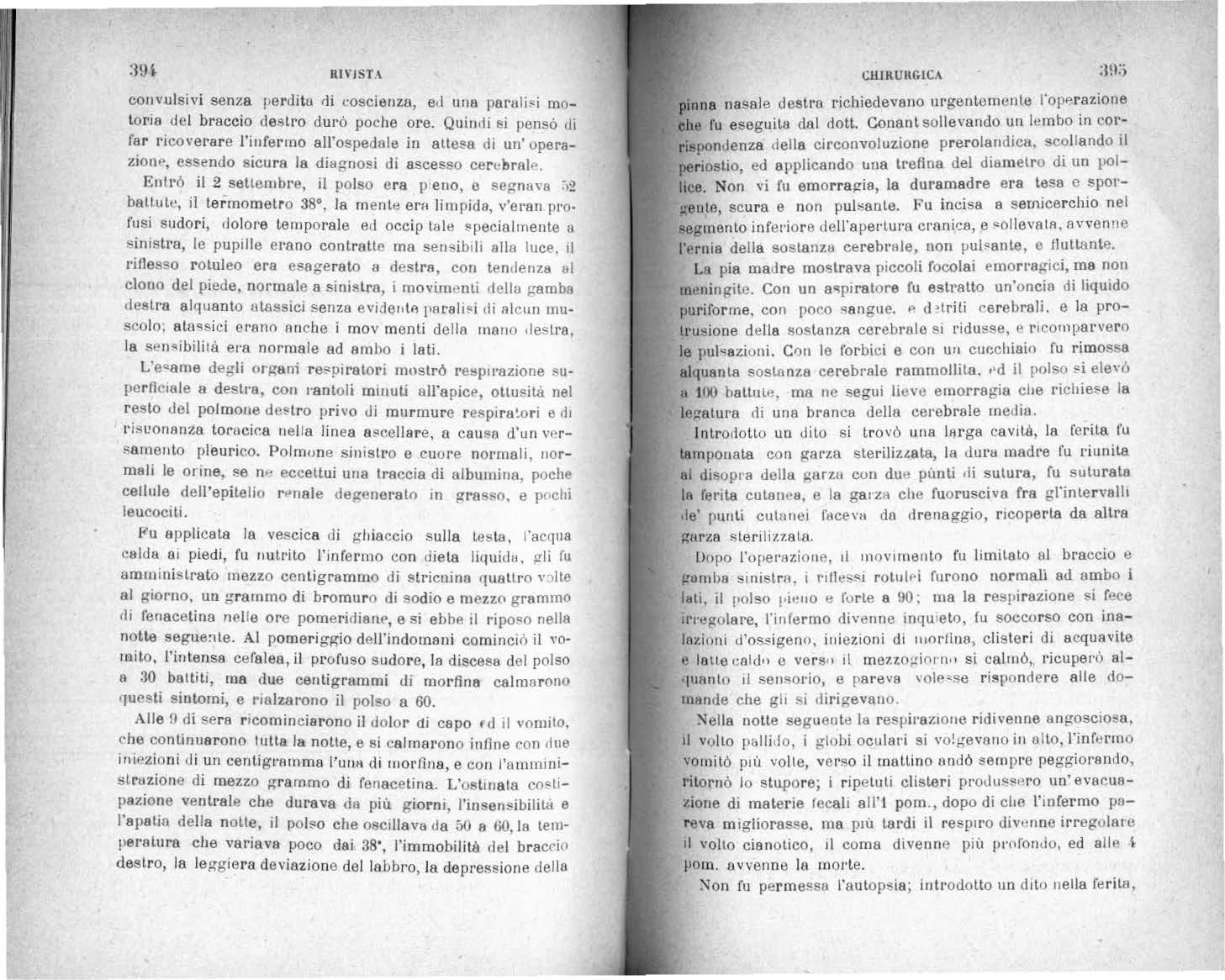
La pia madre mostrava piccoli focolai t>mo rr·a,:r•ci, ma non ul••nin gite. Con un a'\piratore fu estratto un'oncia di liquido puri forme. con poro c;angue, P d >!.riti C'er ebra li. e la prolt•usione della sostanza cerebr·ale si P r•compat•vero le pul-.azioni. Con le forbici e con un fu alquan ta sostanza cerebrale rammollita. ··d il polo:;o "i ele"ò H 100 batlulP, ma ne segUJ lieve emorragia che richiese la òi una branca della cer·ebrale rneùia.
I ntrodotto uo dito si t r ovò una larga cavrta, la ferita fu I..Ampouata con gar'za sLeriliuata, la madt•e fu r i unita ol disopr·a della garza con dUt• pùnti di sutura, fu sutu rata Ili rer·ita e la garza che fuorusci va fra gl'inte r valli ·le' punti cutonei faceYu da drenaggio, ricoperta da altra ste ri lizzata.
Dopo l'oper·Azione, rl rnovrmento fu limitato al braccio e p:um ba srnistru, i t••flessi roLulf•i furono no r mali ad ambo i latr, il polso l'w no e forte a 90, ma la r espi razione fete ir•regol ar·e, 1'111lerrno divenne inf(uieto, fu socco r so con inaù'oo:;sigeno, ini ezioni di ruOI'tina> cliste r i di acquavite P !all e e versn tl mezzop:irll'n•• si calmò, ricuper·ò al•(ttAnlo rl sensor·io, e pa re va r ispondere alle dollllln de che glr «i dirigevano.
KlVI'il A I.RIRURf: IC\ nltre all'ascesso aperto, Sl' ne costatò un allr(l paù in Rllf•, verso la lanea mediana. pa·e!'>so la circonvoluzione frontale ascendente, e la cavità da questo secondo era lonto vasLa, cbA l'indice 111 trodoLto ne tocca,•a appena le pareti.
La l etteratura degli ascessi metastatici Jel cet'Yello l· !lecondo l'sutor e t!lOilo scarsa; egli cr·ede che sia il pr·irnn cal"o di diagnosi ac<'ertata dall'efficace vuotauaento, poicht'· la mela cer·<'brali i· dovuta secondo Bergmaun a processi suppurativi del cranio pet• malattia dell'oreccllto medio, un· allra g-ran parte ai traumi, ed una alla tubercolosa eù aa processi rnetastatici. Questi rur·onn cltmoc;trata ;>rima da V tr l'itow a polmomonare, poi ùa Biermer in seguito a broncbtf•cta«ie. •• do Niilher che parlr. rli ascessi polmonara, polmoniti, pf,.urat. Pd empiema, per i quali in otto casi l'autopl'<ia rtle"A l'ascesso cerebr ale.
Bergmann sostiene cho gli ascessi metastàlici del cervello sieno sempre mnltipli, Niilh er fra i suoi otto casi ta·ow'l una sola volta l'ascesso solitario, e la speranza di tr·ovar1:1 almeno una volLa su otto quec;ta condizione, deter·m11tn l'au· tore alla tr apanazione del Cl'lmto, Yist.a la progno8i dic:perata degli as<'essi cerebrali.
La diagno8i di ascoss(l c r eb1·ale si fonda m olto dato etiolobico che qui era evidente, ma un tumore cerebrnlt· avr·ebbe dalo gli stes!li sintomi. In favo re dell'ascesso antll· lava pero l'anormale tr> mp eralura, e l'assenza di ll'"lfllll atrotlche del nervo ottico. Non era certamente determinabile la granclezz a dell'ascesso, ma s1 poteva pen!lare ari un ascesso ampio, può r aggiungere considerevoli dintPn· s1oni prima della localizzazione de' anche quando occupa la zona motr·ice, od è situato nelle sue vicinauz
Senator ha riportato un caso simile al presente. prec,eòuto pea· sei mesi da malattia polmonare, con parafio..;t dtll br·accio destro, epilettiforme, paresi del ramo facc·iale inferiore deslt'O, intii della !(amba destr a, E'd Rl J:l• orno afasia aLassica, e morte al J 7• giorno, con rep èl'tO anatomico di focolai irnflammato r i nel polmone, ed a,.;cesso nell'emisfero sinistt•o contenente 50 grammi di pus
RIVISTA DELLE MALATTIEVENEREE EDELLA -PELLE
Prof. NEt'-"ER. - Cura della blenorragia.- médical, N. :!:1R,
I n un rapporto letto al con!{resso anternazionale di derlllatologia e fiilìlo:;.tra fia lenuto in Ytenna nel seltemùre 1892 , il pr of. a•iassunse uel mod o i principii <'11rAtivi fondamentali della blenorragia:
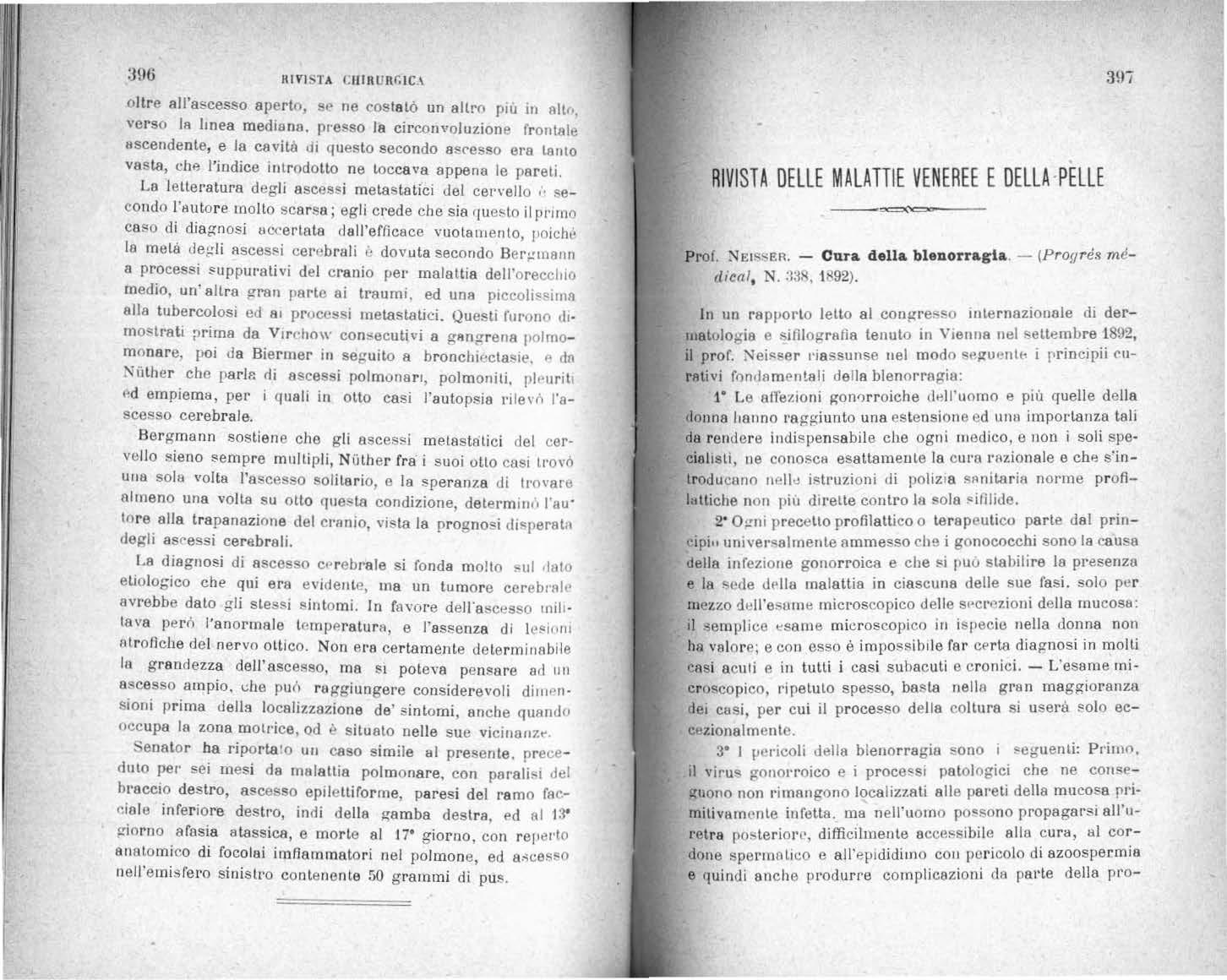
1" Le alfezaoni gon0rroiche ciP-II'uomo e più quelle della donna hanno raggiunto una estensione ed una importanza tali cla r endere indi spensabile che ogni medico , e non i soli specia listi, ne conosca esalLamente la cut·n l'flzionale e s'introducano nPih: il'\lruzioni eli polizaa Mnita riR nonne pr otìlattiche non piu dirette conlro la c:iftliùe .
2' O!!ni prect>lto profìlaltico o terap euLico parte dal priul'ipiu univea·c:afmente ammesso che i gonococchi sono la caU88 della infezione gonorroica e che si puu stahilì re la pl'e!:'enza e la <;cde ùPIIa malattia in ciascuna delle sue fasi. solo per mezzo dt>ll'esnme micl'oscopico delle SI'CI'r>zioni della mu cosa: 11 t1same microscopi co in ispecio nella donna non ha val ore; e con esso é impossibtle far CE- rta diagnosi in molli caf;i acuii o iu tulti i casi subacuti e cronici. -L'esame micr oscopico, l'ipelulo spesso, nell a gl'an maggioranza rl ea casi, per cui il processo della coltura si userit eolo ecc·•zionalmcnlc.
3" l vericoli della blenorragia sono i "cguenti: Pa·imo, il gonOI'I'oico e i proce!'St patologica che ne consenon 1·irnangono localizzati all e par·eli della mucosa pl'imiti varn <.>nte infetta. ma nell'uomo poc:Mno propagarsi all'nr etra posleriOJ'L', difficilmente alla cura, al cordone spermolaco e all'ep ididimo co11 pericolo di azoospermia e f]Uindi anch e pt·odurre complicazioni do pat•le della pa·o-
IUVlS'fA stata, della ve:>ci..:R nellu donnll poi possono partec1• p11t·e all'aiTt>ziorw, l'utem, le lrnmbe, le ovaie ed anche il peritonc o ''t!';<'"t8lt>. - 81'• on.to, il vi r us blenor ragtco nelle fAc:i ulteri o ri invade !.!li pl"ol'ondi dell'epitelio. P er rui dn questo suo doppio m super·tìcie e pr·ofondilù ne che puo mantenersi pet· mesi ed auni in punti pocu o pun to c cioe finisce per costitui re una sorgente d'infezion e cromca. QumJt é nelle prime rasi dellu ma· laltia che il vir us st limita m punti accessibili t uretra ante· ri orc nPII'u omo, urt>lrH e collo nella donna) e sopra strati epiteliali abbastanza si che ne può riuscir fnt>ile e lu cu r11, In quale JevB a vere per iscopo d t impe· ùit··· che una llt'elrite antt:H'iore si lrusformt i n uretrite po •n gouotTea cronica. P e r ciò deve essere intrapresa 5,ubilo tlopo la infezioue e colle seguenti not·me. l medicamenti d11 usarsi avct·e la pPoprielà di ll ccitlcre i di aumentare quanto meno è pos!';iblle lA infiAmmaztonP e di non ledere !a mucosa. A tali esi· gpuzu ri!'ìpondono rl nitrato di a r gento nella prvpurzionu di l per· :201)0 o pc t· 1000: il !'olfo illiolato òi ammoniat:a all'l per· 100, il sublirnALO l : 20000 -1 : 30000: le debolt di Bnll er (prive eli acido fen•co e eli s ublimato ) 1 in :!800 .:i acqm1. - Controindicali invece sono i rimedi pttrAm•·nte astring-enti, per· il r·ischio di tr·aspot·lare col mezzo clelia iu· ieziorte i g-onococchi nelle parli piu interne, le soluztoui rnu · stiche mollo I'Oucenlrate per il pericol o della formazione di I'eSLI'IIl!.!llllenli, ed 111 fine qun<o.i tulli i processi di cura mec..:arm•a, quali l'en .IO '<copia, la inll'oduzione di candele! le C'CC'.
I l nreto,Jo nugliore di cura (precoce, anlrbaLtet•icH ) cnn·
Ìll ll'l'il:wziont rr·equentr clell'uretra in modo tla l'aggrun·

!.:'er·ne Lutlu le della muco!';a nelle ::;ue numer·ost> ni gltl•.
- p<'r c:nrnDclilil. pt·attcH, le it·t•i.:.:aziout sltlUILe riA inil•ztnrti ae,·urale falle cou una gros:;:a ::.ir·rng11 ben co--lr·utla. 1\clltt 1louna, ollr" le irl'iguzioni c le si pralichorù l'AHciugAilH'nto de!l'urelra ,, del collo . - Ln t'\ll'tt ò affflllo inHlil<'. L<' igie11ici1A e dietotidie. e i topici anttllogislici sono ulrli e tlovrauno essece usftli JWl' quanto l'• posl:;ibtlt'.
DELLE MALATTIE K DILLA !•BLLB
Il' In tutti i casi subacuti quando già esistu unu uretrile posteriore deve ripetersi l'esame vedere nelvi sono gonococchi, perché solo m tale evenrenza dovrà llp plicar·si la cm·a locale Anche a queslll ul'elt•ite pos!Prio r e precoce.
7 La dur·ata del!a cu ra n on deve dtpendere dal l'isultatu momentaneo, spesso rapi diss imo : cl'o rtlinario con· \in ual'la a lungo, però fo r ma ruollo più attenuALA. Cin im pot·la non è la ra p!dita, ma lo certezza tlell'estlo.
s• P er la cur·a della gonorrea CI'nn icll, sia nell'uomo nello ùonna, é indispensabile innanzi lutto di !=;apere ._.. c:i lr·atlt di una vera mfezione blenor·ragica, vale a dire purul enlo.
!)' Nell'uomo, quando esiste vH·us gonorroico noll'essu · dato Jell'urelrtt anterio r e o posteriol'e, lo si deve disl t·uggere C<JII e irt•i gazioni o colle istillaziorti d i Guyon. Se non es is tono più gonococchi, l a cut•a varia a seconda dello stato anatorno· patol ogico della mucosa e del tess uto sottornucoso. Nella ma g-giot·anza dei casi si tratta di processi talm en te in!'ligni · ll••anli l'A. sconsiglia ogni altra cu!'a all'mfuori di it·r·ij.!azioni od isttllazioni sempltci. Le allerazioni più profonde dell a mucosa devono essere localizzal l3 in modo (>l'eciso en doscopia) e richiedono una cur·a I'OI ma.,.saggio, In cauterizzazi one. la dilatazione ecc.
to• Nella donna la cura del!a blenol'ragia è molto piìt tlifli ctle e non •' possibile render!-i conto dei rr sullalt lerapeulici ,.enza t•ipetel'e ronltnuamenle l'esame micro,copico dell'essudlllo. La blenorra gia deU'urelra e del collo deve 6!'1'-Cl' <'Ur ata colla ma!';"irna prontezza e l energia per impe(lire l'he In int'ezt one "i pr·opaglri all'utero , alle trombe, al perrtoneo, nl'l qual caso la lerapta diventa di uu ""'i lo mollo dubbto e spesso richiede operazioni di molla gravita.
u• La frec1uenza e la cur•a della blenorragta r·eLtale tne· rttn no mollo maggiot•e attenzione di quella c lt e flnm·a !'· sla tu ad es!; e concei'!';fl. imperocehè IR in fazione gonor·t·oica del r e t to sembra essere il punto di partenz11 di molti pt·ocessi ul ce1•osi ct'onici. G. C.










