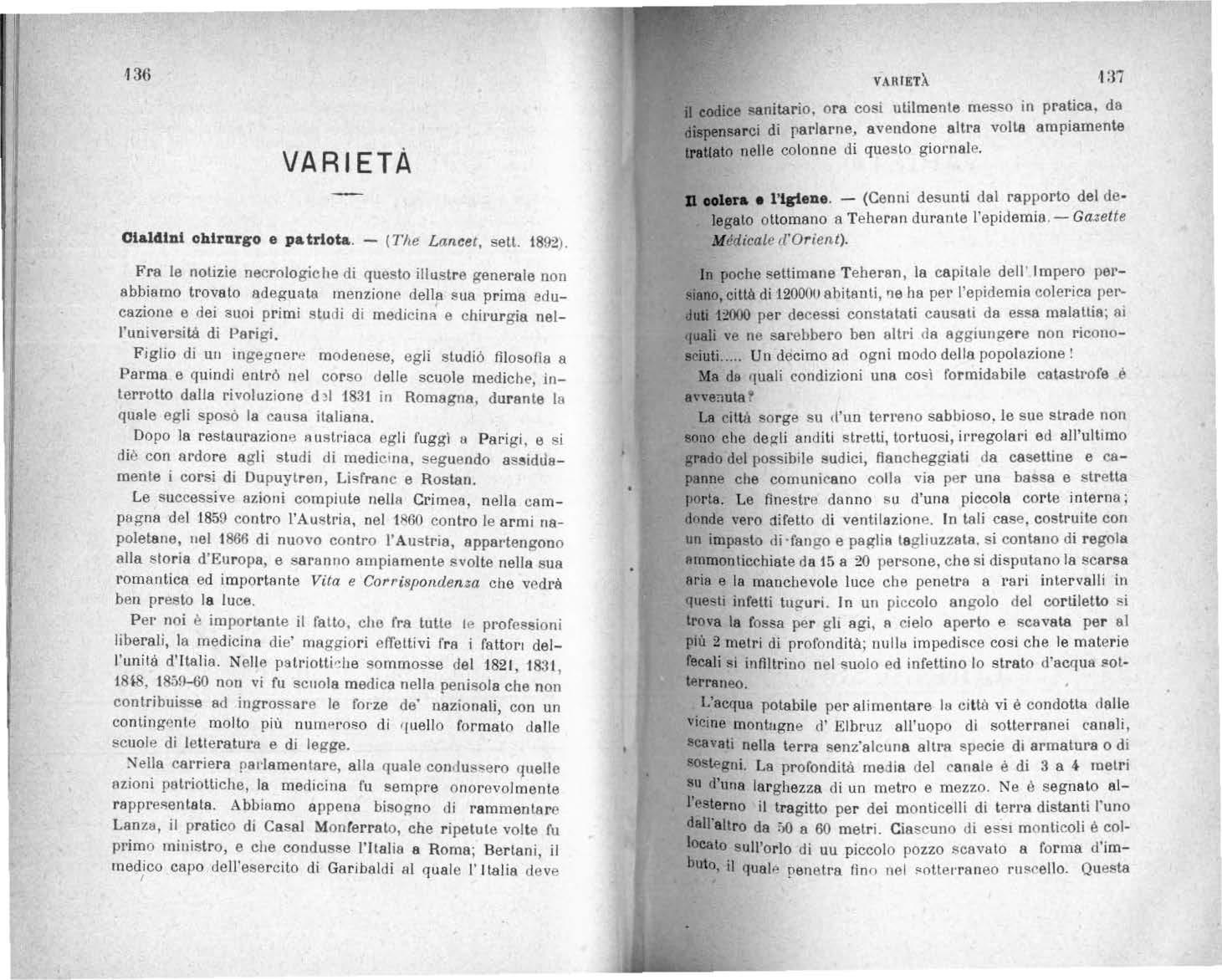
210 minute read
VARIETÀ
Oial4tnl ohlrurg o e patrlot&. - (Tite Lrtncet, setl. 1892).
Fra le notizie necrologiche di questo illuslre generale non abbiamo trovato adeguata menzioni' della sua prima educazione e liei suoi primi studi di medicina e chirurgia nell'un iversita di Parigi.
Advertisement
Figlio di uu ingegnerP modenese, ogli studiò filosofia a Parma e quindi entrò nel cors o delle scuole mediche, interrotto dalla rivoluzione d 1831 in Romagna, durante la quale egli sposò la causa italiana.
Dopo la restaurazion e a ustr•iaca egli fuggi u Pari gi. e si con ardore agli studi di medictna, segu endo a s!idùamente i corsi di Ou puytren, Lisfran c e Rostan.
Le successive azioni compiute nella Crim ea, nella campagna del 1859 con tro l'Austria, nel 1H60 contro le armi napoletane, nel 1866 di nuovo con tro l'Austria, appat·tengono alla s toria d'Europa, e s aranno au1piamente !'volte nella sua romantica e d importante Vita e Corrisponderua che vPdrà bf'n presto la lu ce.
P er noi i> importante il fallo, che fra tuLle 11• pt•ofessioni liberali, la medicina die' maggiori elfeltivi fr a i fattorr dell'unità d'Italia. Ne lle so mmosse de l 182 1, 18:ll, 18i8 , l S:l!l-60 non vi fu scuola medica nella penisola che n on contribuisse ad ingrossare le for-ze de' nazionali, con un conlingonte molto più di quello formato dalle scuole di lett eratura e di legge.
carri e ra par·lamenlare, a lla quale quelle Rzioni patriottiche, la merlr cina fu sempre onor evol mente rappresen tata. Abbiamo appena bisogno eli rammenlarl' Lan za, il p ratico di Casal Mon fe r ra to, che ripetute volte fu prim o ministro, e che condusse l'Italia a Roma · Berlani il ' ' med) co capo dell'esercito di Garibaldi al quale l' 1talia deve il eodice c::a nitario, ora co!'t utilmente m esso in pratica, da dispensarc r di parlarne, av endo ne altra volla ampiamente traUato nell e colonne di questo giornalE'.
D eolera • l 'Igiene . - (Cenni desunti dal rapporto del de · legato o tto mano f\ T eheran duranle l'epidemia . - Ga::e t te M tldicall' d'Orient).
In poche settimane T eber an, la capitale dell Impe ro pel's iano, città di 12000u abitanti, rre ha per l'epidemia coler ica pet'duti t :lOIJO per de<'essi constatali cau!!ali da es!'a malallia; ar quali ve ne sat'ebbero ben altri da aggiUngere non ri conoar iuti ..... Un decimo ad ogni modo della popolazione t Ma da quali condizioni una così formidabile catastrofe è 8V\'8:1U la t
La cilti.l sorge c::u d'un t erreno sabbioso. le sue strade non sono ch e degU anditi stretti, tortuos i, ir't'egolari ed all'ultimo grado del possibile sudici, fianchegg iali da casettine e capanne che comuni <'ano co ll a via per una bassa e stretta porta. L e fìnestl' e danno s u d'una piccol a corte interna; donde vero difetto di ventilazi one. In tali case, costruite con un eli e paglia tagliuzzata. si contan o di regola Ammon ticchia te da 15 a 20 poesone, che si disputano la scarsa aria e la manchevo le luce che penetra a rari intervalli in que " tr infetti In un piccolo angolo del cortiletto si trova la fossa pe r gh agi, A delo aperto e scava ta per al p1ù 2 metri di profondità; uullt1 impedisce cosi che le materie fecali !l i mflllrino nel •molo ed infettino lo strato d' acqua !IOl· terra neo.
L'acqua pota bile per alimentare la c rltà vi é condotta dalle vi eme monlllgn e d' Elbruz all'uopo di sotterranei canali, !!ca va li n ella terra senz'alcuna altra specie d• armatura o d i La profondità. media del <'anal e è di 3 a 4 roetri su d'una larg hezza di un m etr o e mezzo. Ne ò s egnato all't>sterno il tragitto per dei monticelli di Lerra distanti l'uno dall'altro da r,o a 60 metr r. Ciascuno di esst monlicoli é collocato s ull'or lo di uu piccolo pozzo scavato a forma d'imbuto, il pen etra fino ne l ;.otter ran eo rusrello. Questa
Congressi
specie di sono per potere d'un tratto riscontrare in caso di sprofontlamenti il punto ove si prodotti. Va da se c h e le dl)nne del p opolo vi accorrono in per Javarvi i panni, ed anche spesso vi praticano la toleUa dei loro bambini La popola2.ione è assolutamente m· ddTe1·enLe a tali dettagli e continua ad attingere quell'acr1ua per· gli usi s u oi domestici.
Nessuna praticasi a T eheran per ciò che concerne i mondeZ7.ai e la polizia medica Il sapone ordinat·1o t• pe1· la parte della popolazione un oggetto di lu,;;!.'o; fin o il semplice nome di municipalità vi è sconosciuto.
Fino a poco tempo fa i seppellimenti praticavansi l'uor1 della città. benché a non molla distanza. Ma la bisogna et'· sendo ct·esciuta conside r evolmente si credette bene tornar•· alla vecchia pratica, e le inumazioni si praticarono ancora in diversi luoghi nel bel mezzo della città. E v• ha di mPgli o; bisogna ricordare su l propos!lo il costume persiano per cui i morti s i colloca no pr·oprio a fior di terra, lasciando ancor·a una bella apertu1•a in co r·rispondenza della testa l .. Sarà l'acile compr ender e come l'aria deve essere viziAta in consPguenza d ella decomposizione dei cadaveri, senza pariare dt>l triste spettacolo dei diseppelltmenti dei cadaveri operati dagli sciacalli!!
Congressi
XI Oongre..o me41oo internazionale . - Roma, 18\1:3.
Jllavorod1 pr eparazione del congresso è ormai entrato in un l'ase di piena attività . La propaga nda in favore del Congresso, tanto all'estero che a ll 'inte rn o, dà già frutti superiori alla aspe ttativa ; ed il favore con. cui il Governo e il pubblico
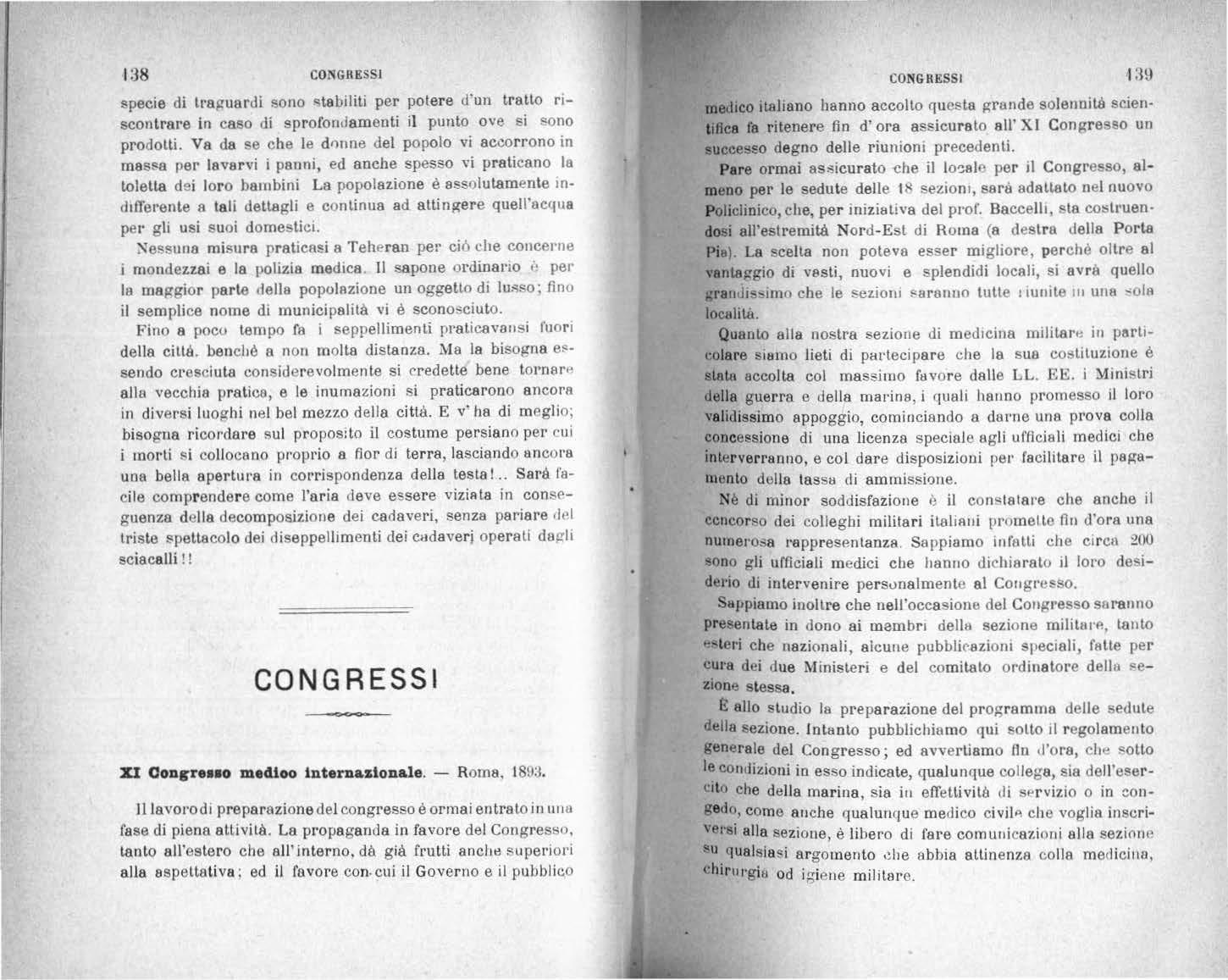
Cong Ressi
medico italiano hanno accollo questa grande solenuitil scien· &ifica fa ritenere tìn d'ora assicuralo all' Xl Congresso un successo degno delle riu nioni precedenti.
Pare ormai as,:;icurato che il per ti Congresso, almeno per le sedute delle I l'! sezton1, sarà adattato nel nuovo P oliclinico, elle, per iniziativa del p1·of. Baccelli, sta costt·uen· dosi all'estremità Nord-Est di Roma (a destra della Porta Pia). La scelta non poteva esser migliore, perché oltre al di vesti, nuovi e splendidi locali, si avrà quello gral u.lt.,-..tmo che le sezi0111 !'8ranuo tutte tlUillle 111 una -..ohi allo studio la preparazione del programma delle sedute della sezione. Intanto pubblichiamo qui solto rl regolamento generale del Congresso; ed avvertiamo fin d'ora, ch" c:otto le condizioni in esso indicate, qualunque collega, sia dell'ese r· cil11 che della ma r ina, sia iu effettività di s,.. rviz1 o o in ::onged o, como an che (Jualunque medico c ivil P che voglia inscri\'t'I'Si alla sezione, è Jiber·o d i fat•e comunicazioni alla sezio rw s u 'l Ualsiac;i argomento •!lte abbia allin e nza colla. medicina, od i,qieue militaJ•e.
Qua nto alla nostra sezione di medtcina militar<' in part•colare si amo lieti di p<trtecipare che la sua costituzione é s tata accolla col massimo favore dalle LL. EE. i Ministri della gue r ra o della marina, i quali hanno promesso il IOI'O val idissim o appoggio, cominciando a dame una prova colla concessione di una licenza speciale agli ufficiali medict che interverra nno, e col dare disposizioni pe1· facilttare il pagamento della tass11 di ammissione.
Nè di minor soddisfazione è il com;tatar·e che anche il ccncor!'o dei coll eghi militari italiaui prometto fln d'ora una nurnero,;a t·appresentanza . Sappiamo inl'atti che ci r cn 200 sono gli urtìciali m edici cbe hanno dichiarato il lOI'O de.,iderio di intervenire pers0nalmente al Congc·esso.
Sttppiamo inoltre che nell'occasione del Congresso saranno presentate in dono ai mambr1 della sezione militar-P., lauto .. " leri che nazionali , alcune pubblicaziom spectali, falle per cura dei due Ministeri e del comitato or·dinalore dellu l<ezione s tessa.
Congressi
Ri,olgiamo anzi un caldo invito a tutti i voiPnterosi t: a tutti coloro che si sono dedicali allo studio di par·tir.olare que!"tione scientifi ca e p1·atica della nostra specialità, affinché ne p1·eparino qualche comunicazione per la prossima riun ione. S ara la migliore occasione per far onore 11 l'lé steqsi, al corpo inter•o, ed ai stranieri che a vremo 18ono r e rli
Reqolamento Generale del
ArL. 1. Il decimo primo Confrresso medico internazionale sarà inaugurato in Roma il 24 Mllembre 1893 e chiuso il 1• ottobt•e suecessivo.
Art. 2. Sono amm essi a prendere parte ai lavoJ•i del Cong resso i medici che, avendo soddisfatto agli obblighi della iscrizione, abbiano ottenu to la tossera di ric onoscimento.
Art. 3. Le persone a ddotlo ralP in altre scien ze, che s'inte•·essino pe r i lo r o s ludii spe ciali ai lavori del Congresso, potranno e:c>servi i:ocritte coi medesimi doveri e dir1Lti dei Congressisti laureati in m ed icina, compr·esa la facolta di prende•·e parte attrva ai lavori, sia con comunicazioni, come pa rte cipando alle discussioni.
Art. 4. La quota eli amm issione per i membri del Congresso resta fissata in lire venticinque: essa dà diriLLo ad una copia degli alti de l la quale sort\ loro sredi ta !'!ubilo la pubblicazione
Art. 5 Lo scopo del Cong•·esso è esclusivamente scientifico.
Art. H. I lavori del Congresso ve rra nno divisi fra l8 t'>er.ioHi: ogn i aderente al Congresso è pregato d'indicare, all'alto della i!lcrizione, a quale sezione voglia paJ•tecipa r e.
Art. 7. Il Comita to pl'ovvisorio p r omuoverà nella seduta d• aperlul'a la nomina della p r esuienza definitiva, che saNI composta di: uu presidente; tre vice pr·esidenti; un numero indete rminato di pr..,sidenli onorarii L' di segretari.
CONGRESSI l il sezione, organizzando le sedute. il pl'O(Jrio pre· siùente ed un cer to numero di presidenti ooo r a r ii, 1 IJUali dirigono alte rnativ amente le sed ute.
Parte de' segr etaJ'i viene scelta fra i m embri stra nieri per compilare i ve rb ali delle comunicazioni e delle discussiOn i nelle dive•·se lin gue.
Art. 8. Le r iunioni del Congresso vengono tenute ogni giorno, sia per sedute generali, sia pe1' i lavori ùellè sezioni L·orario, il numero delle sedute generali ed il loro ordine del grorno sono flssati dalla presidenza del Congresso .
Art. 9. Le sedute plenarie dest inale: a) All e d•scussioni •·elative ai lavori e agli geno>rali del Cong r csc:;o. l1) All e confer enze e parteripazioni d'iuteresse generale.
AI'L 10. Le conferenze nelle sedute plena ri e e ne ll e eventuali sedute s traorJinarie sono rise r vate ai membr1 p r escelti dal Comitato o rdinatore.
Art. 11. L t> comunicazioni da farsi al Congresso devono eMer annun ciale non più tardi del 30 giugno 1893.
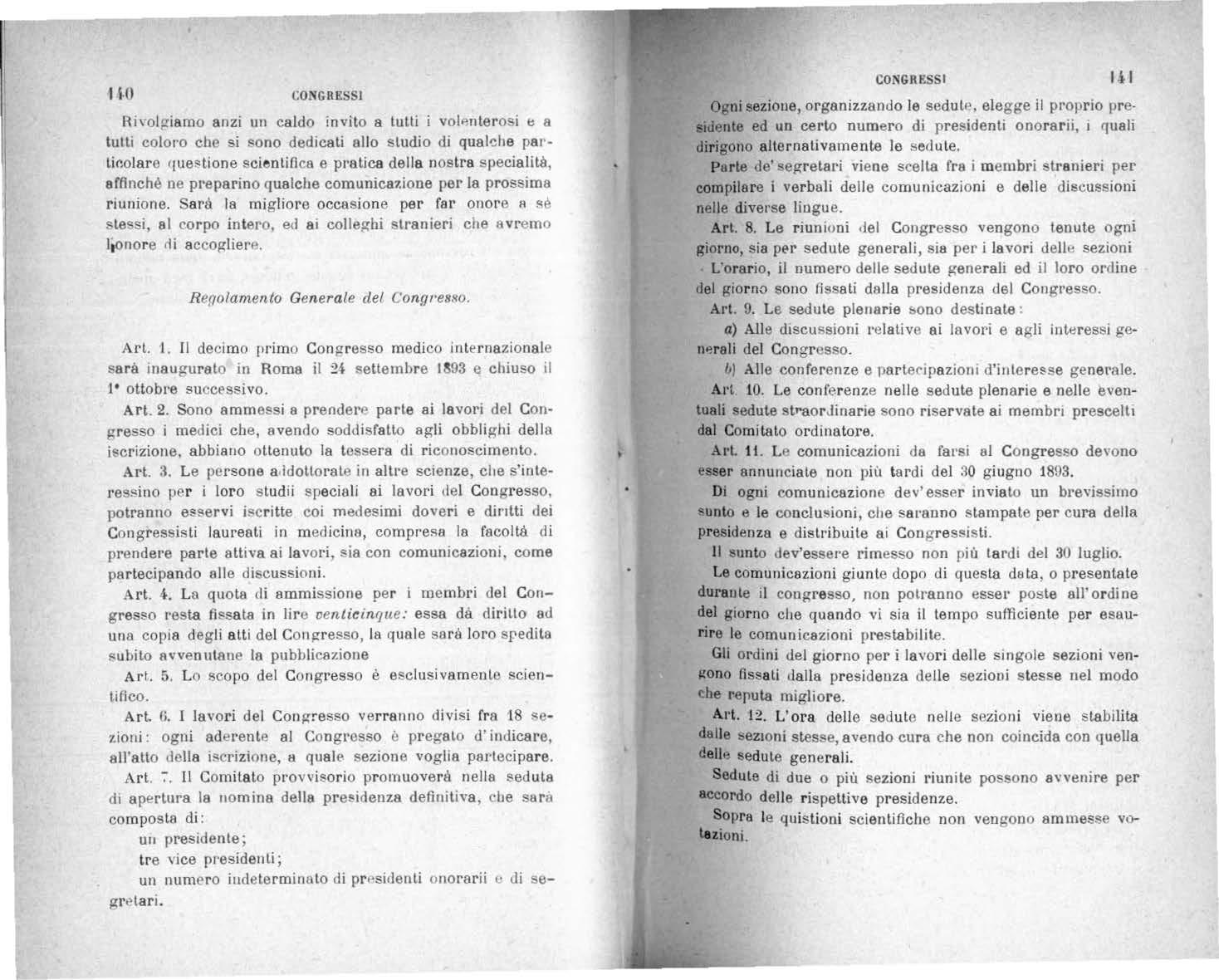
Di ogni romunicazione dev ' esst>r invia to un brevissimo "Unto e le conclusioni, che sal·anno s tampate per c ura della presid enza e distribuite ai
Il sunto dev'essere rimesso non più la rdr del 30 luglio.
Le comuni cazioni gi un te dopo di questa dala, o presenta te duraute •l congre sso, non pot•·anno essei' poste all'o r dine del giorno che quando vi sia il tempo sufficiente per esaurire le comunicazioni prestabilite.
Gli ordini del giorno per i lavo ri delle singole sezioni venllOno fissa li dalla pr esidenza delle seziooi s tesse nel modo the reputa migliore.
A1·t. l2. L' ora de ll e seJ ule nelle sezion i viene stabilita dalle ::,eZJoni stesse, avendo cura che non coincida con quella sedute genera li.
Sedute di due o più sezioni riunite possono avvenire per accordo delle rispettive presidenze.
Sopra le qu istioni scienti fiche non vengono ammesse votazioni.
A.rt. 13. Il tempo S.S!'le:;tnato por cia'>cuna comunicazione è di quindici minuti.

Gli oratori che prendono par'Le alla discus;;ionP potranno parlare una sola volla e per cinque minuti.
Suno concessi all'auto r o della comunicazione, esaurila la discussione, non più di dieci minuti per risponde r·e comples· siva menle a tutte le obbiezioni fatte.
Sarà data facoltà ai lH'esidenLi pPr l'impo r tanza dell'sego· mento, sentito il pat·cre f'avtwevole della sezione, di accordare agli a•1tori delle comuorcazion i, in via eccezionale, un determinalo tempo maggiore.
Art. 14. Il testo <li le conferenze e partecipazioni, falle tanto nelle seòute plenarie lJUanto nelle deve esser r·imesso a' segr'elari prima della chiusura della relativa seduta. Uno speciale comitato di redazione , nominato dalla Presidenza, decide se ed in qn1:1lo misura i sudclelLi alli pos· sano pubblicati n e l resoconto del Congresso.
I memb r i che pat'tedpann alle discussioni sono p re gati di r'imetlere nella stessa giornata a' se:;rretari un l'iasc:unto delle fatte da loro.
In tultP le sedute l t> ufficiali sono: l'italiano, il francese, il tedesco e l'inglese.
Gli statuti, i programmi e gli ordini de l giorno si pubblicano in tutte e quattro le suddette lingue.
:-.Ielle sedute é tuttavia pe1'messo di servirsi, per brevrssime OS8er vazioni, ùi qualche allra lingua, purché uno c'ei membri presenti 8i dichia1'i pronto a tradurl e in una delle lin gue ufficiali.
Al'L.16. Il pr esidente la discussione secondo le norme parlamentari generalmente ammesse in a dunanze congeneri.
Art ii. L e persone non contemplate nell'art. :l che s'in· teressano a· lavori di qualche determinata sezione possono veuirvi ammesse per della presidenza del congresso.
I n tal caso ·esse sar anno munite di tesse ra speciale e do· vranno pagare una tassa d'ammissione pari a qutlila slabi1ite per i congr essisti, con dieillo ad una copia degli atti del Con gresso.
Le al rn virtù d i di· 111po11izroni non possono pr endere la parola né nelle sooute gene rali né in quelle delle sezioni alle quali non sono iscritte. Art. tH Gli s tu denti i n medicina poteanno essere invitati od autorr:tzell dal presidente ad assistere alle sedute, ma come "emplici udito l'Ì. dovranno essere muniti di una carta speciale di am· eht> potranno ottenere Mn:tll paga r e tassa alcuna
Necrologi A
CHoaoobiDo ll&mnJ , medico di 2a classe nella R.• marina.
Una nobile esistenza, devota all11 umanità, sacra alla si è spenta nel fiore degli anni, nel delle oneste s peranze, al crepuscolo mattutino del Natale, in Gioacr.!.mo Mazzini, medico nella mal'ina r eale. E g li alla nobilrssrma a rt e sanitaria attinse pl'ofonda la dollrina, ma con la do tlt'ina succhiò fìero il veleno della morte, che, pur dilan ialo da lu nghe a teoci sofferenze, fr ontAggiò seren o nella coscienza ùe l m orbo letale, con indomito coraggio, con filosotlco !ilo icismo. Cbè la fatale infermità, che gli rose la giovan e vita il dott. Mazzini t r asse dal duro, periglioso tirocinr o negli aggravalo d alla mancanza del neces!:'ario conforto e da dolorosi sac•'ifkii.
A •Juesta no,•ella vittima del dovere, c he segna un'aUra nell ' infimto mal'tirologio d ei medici, le meritate onoranze addolorati colleghi, le benedizioni dei poverelli di Castell o, che in lui trovavano ;;e mpre il medico benefatt o r e 1
Cor r isponden:a.
Il Capt tano medico della milizia mobile dott. Giuva, r esidente a S. Giovanni Rotondo, a proposito dl un a r ticolo r ipo r ta to nel Formula r io del fascicolo di dice m br e (pag. 1643) sulla cura del coler a colr jodofor mio, ci scrtve che egli pure questo medicamento nel co· !era flno dal 1886, ritracndone grandi van ta ggi. Dalla memoria che egli ci ha con tempor aneame nte fa vo r iLo (L'epidemia coler ica occor sa in S. Giovanni R otondo Napoli 1887ti pogr. fra telli Orfeo), ed alla quale r imandiamo p e r maggio l'i dettagli, ri leviamo che la dose più com u n emente da lui pr escri tta è s tata di trenta centigr ammi al gio r nCl, divisi in tre ca r tin e.
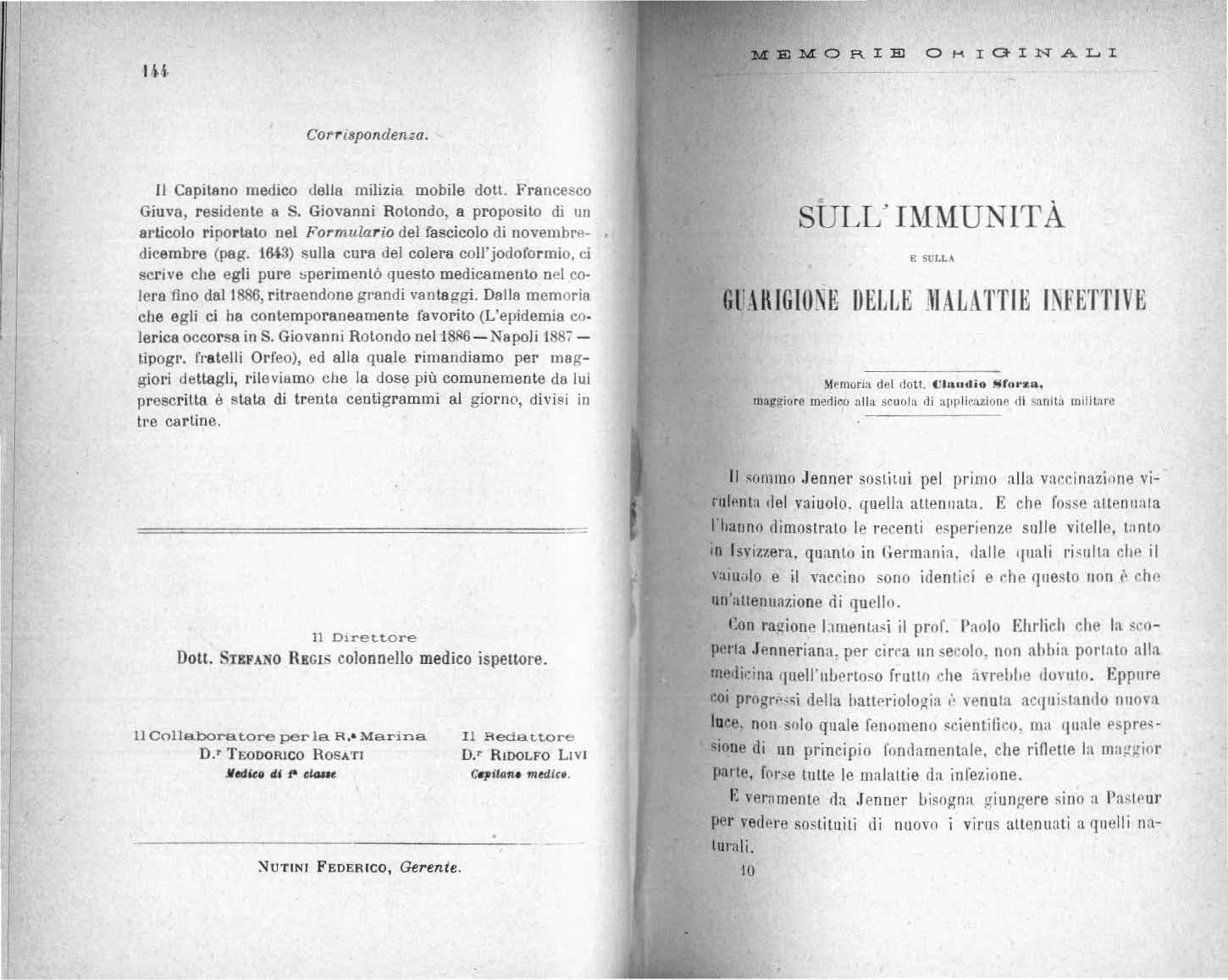
del <loti. CJJuudio Nforzu, medico alla scuola di app llo-azinnA di sanitu
Il sommo .lenn er sostiwi pel primo all a vnrcina1.ione virult•nta del vo iuo lo. quella atLennaLa. E che fossi' altrn nata l'hanno dimostrato le r·ecenti sulle vitell(', tanto in l:;v iue ra. q uan to in li-ermania, dalle 'l'tali ri.-ulta t.hl' il \:tiu ,, lo e il varrino sono iden tici e I'IH' questo non 1\ t'hr un 'allenH nzio ne òi quello.
11 Di re t. t.ore
Dott. S rBPANO RRGIS col onn ello medico ispettore.
11 Collaboratore per la. R .• Ma.r1na
D.• T EO DORl CO R OSATI .lltdko di l" etoue
Il Reda.t.t.ore
D.• RtDOL F O LtV I Cq ìtan • medict.
Con ra!!ione l:tmenta'i il proi'. Paolo Ehrlich r.he la Jit•r·ta .IPnn er iana. per cirt'a un non ahhia por·tnto alla uu•tli •·tna frutto rhe avrehht> 1lo' uln. Eppm·p •·oi progrP•;;i della hattl'riologia i• venuta nuo\ a luce. non solo quale fenomeno l't'ientifìco. ma quali' .;ione dr nn !Jrincipio fondamentale, che riflette la Jl:lt le, fnr·,e tntle le mrdatLie da infezione .
E ver·amen te cla J enuer I.Jisngna giungere .;ino a JWr vet!Pro sostituiti di nuovo i viruo: attenuati a quelli natur·!lli.
:'i!UTI NI FEDERICO, Gerente .
L'immunitit è di liue:;p,.r.ie. natur.deeartilicide. Ou est'ul· Lirna può ronferir:-i con proces:'i 'nriatì,;simi, r1oè ron inr•· cnlaz;oni sottoc ltla nPe, o pe ritone ali di I'Oiture ' ive ma attenuatE>. ron colture morte l) rHtrale, o co n i loro prodotti rh1111ici, con t·niL11ro trana te c·on (Hou\), co n rhrrniche. ad e.;empio lridnrnro di imlo mp.;rolatn a quelli' dr •lrfterilP o di tetano ( Behrin;,). 1'1111 colturf' lll"''·olate aò infuso di lt lno o in esso ( Brirgrr. l\ itn ...ato e W assermann) ed anche run minuue quantitit di roltnre viruleutP inornlale sotto l<1 pelle.
Con tali proces'i "' i• otteuuta l'tllllllnnirà artificiale ronlru il rolera dei polli, il tifo. la polmonitt>. il tetano, la difterite , il ,:o lera il carhonl'lrio. il mal r·o.;so dei suini t>rl altre.
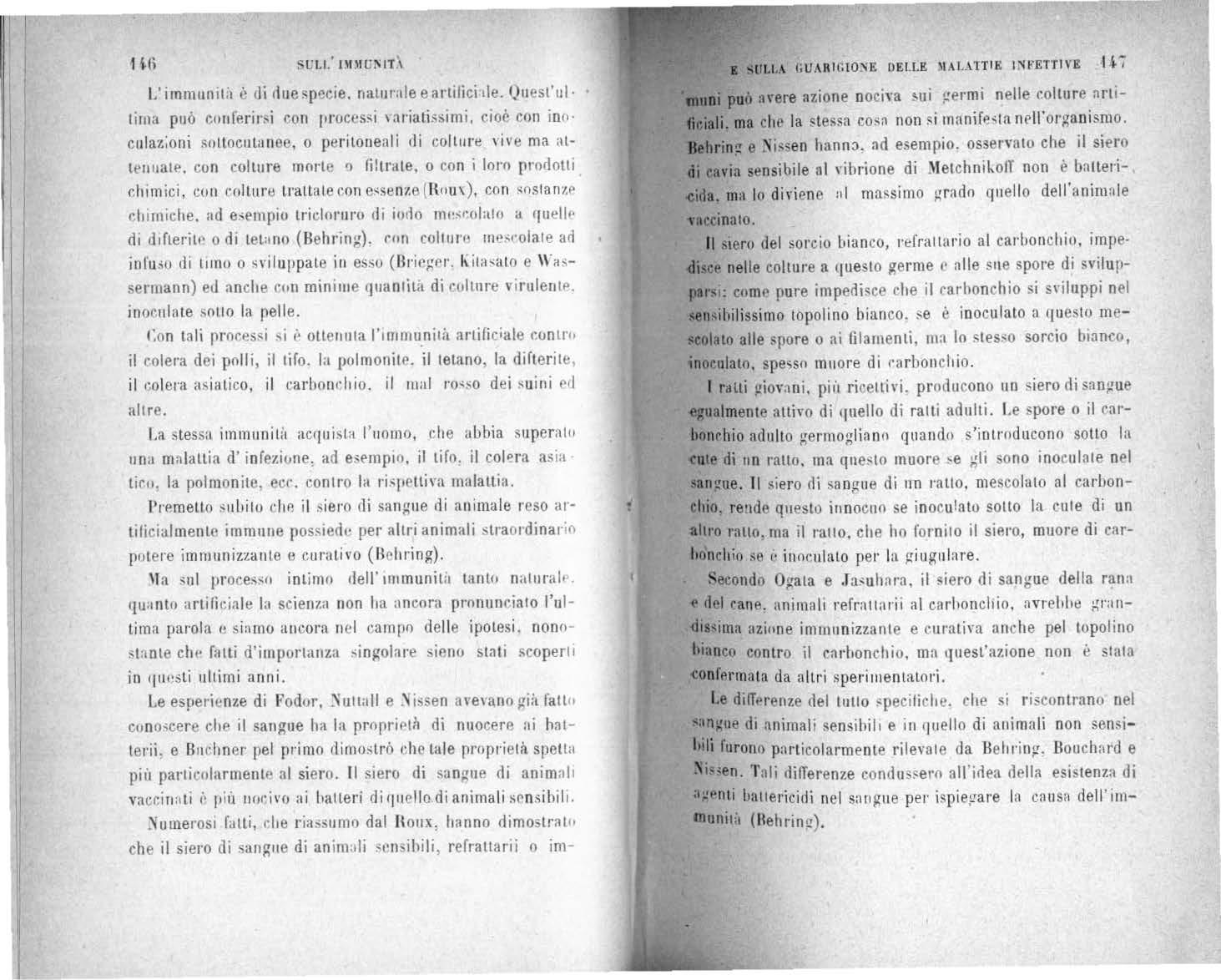
La immunitir ac!]uisla l'uo111o, c:he abbia lì llpera to una malallia d' infeziune, acl esemp111, il tifo. il coiPra asi.t tiro. la polmonite. ecr. contro la ri.;petlim malattia.
Premello ;;ulrilo rhr. il .;ie ro !li sa ngue di animale reso artilicml menl<• immune possierlt• per altri animali :;traordi na r io potere immunizzaule c curativo ( Bchring).
\l a l in Lim o dell' rmmunitir tanlo natura h qu.t nto artilit·iale la scien7.a non ha ancora pro n uoriato l'ultima parola 1· s iamo ancora nel campo delle ipotesi. non o"tante chi' falli d'importanz.t .;ingoiare =-ienu stati scoperti in quP.:>Li ultimi a nni.
Le esperienze di FodiJr, e a,·eH111o già fati" ehe il sangue ha la propri1•th di nuocerr ai hatterii. e Burhncr pel primo rlimo>'lrò c·ho tale proprietà spetta più partirolarmenlr al siero. Il siero di di animatr i• più IIO I' ivo ai batteri di q11rllo di anima li se nsibili. fatti, rlte riassumo dal Houx, hanno rlimostr11to che il siero di sangue di anim·di st'lbihili. refrallarri o im- l L l S (ILI A (;UA RI GlO:'IE DELLE )IAI,.\1TIE t- l ralti l!iovaoi , pil1 ri cetth·i. producono un siero di attivo di ' tnello eli ratti adulti. Le spore o il rarbonr hi o adulto qua ndo s'introducono solto la aue di nn ratto. ma qne...to muore :,:li sono inoculnte nel san ;me. Il giero òi sa ngue di nn rallo, mescolato al carbonchio. re·tde qu esh.> iuoocno se inocula to solto la cute di un ahro ratt o, ma il ratto, che ho fornito il siero, muore di cnrltonchio :;e !' in ondato per la giug ul are. l nsegna l\ocl1 che un organismo d iv iene immu ne contro un dato microrganismo se questo non può svilupparsi pii1 nel co rp o dell'animale. Se l'organismo i• immune, 11·ionferà dei germ i patogeni, anche se questi penetriuo tt•rnporaneam ente ne l co rp o e ne ri em piano e capillari e te.;'uti (carbo nchio, de' topi).
GUDÌ può :1çere azione oocin <.ui :.:ermi nelle rolture artrfl cial i. ma che la cosn non nell'organi smo. Behrin!! e hann:>. ad esempio. osservato che il siero .cJi eavi a st>nsibile al ,•ibrione di Metchnikoll' non t> ba tteT'ima lo divi Pnc :ti massimo grado que ll o dell'anim fde necinato.
Il srero del sorcio bian co, r·efrat tar'io al carhonclrio, impe· nelle co ltur·e a questo germe l' nlle sne spore di svilup.pars r: com r pure rhe il rarhonchio si s,·iluppi nel sensibilissimo topolino bian co. ::;e è inocu lato a questo mealle :-pore o ai fìlarl\enti, ma lo stes.:o sorcio bianco, ;nor.ulato, speisn mu ore di t'arboncltio.
Secondo e il di sangue della ran a i' Ilei rane. animnlt refrattarii al carbonchio, avreltlte granazi11oe immunizzante e curali ,'a anche pel topolino bia nco contro il rarltonchio, ma quest'azione non è stata confermata da nltr·i speriu re ntatori.
Le dìiTt>renze del tutto specil iclte. rhe si riscontrano nel dt animali sensibilt e in quello di anima li non sensibiti furon o particolarme nte rilevate da Behrinl!'. Bouch:.rd e Nil'•en. Tali clifTerenze all'irlt>a drlln esistenza di bauericidi ne l per ispieifare In causf1 dell ' immun itir ( Hehrin !.!).
.;arehhe.stato più semp lice e più l'hia ro cht' la teori•• dell' immunitit se si fosse co nfe rmato clte nel sangue di un animale fossero uccisi quel germi, pei quali e immune, e ··he quelli, i quali. inoculati produ cevano la morte dell'animalt>, fossero stati in grado di crescere l' mollipli ca rsi nel )l a non essenòo costante, per •1 nesta via nN• possihlle di giungere alla soluzione dell 'i ntricato problema.
:XeiJ 'oqw nismo. oltre le p1·oprietà del sa nf:ue di uccid ere hat!erii devono e,;istere altri di schermo t·onlro gli agenti morhosi cile producono i batteri stessi.
Altri germi patog,eni (tetnno, clifterite) cile non abbandonano nell'organi ,-mo le loro sedi p1·eùileue. lo inondano ron veleni di ma:>simo potere tliiTusivo. Contr·o mici'Organismi può protello l'animale in due modi: o impedendo ai germi morbosi la continuaz iont' della •itn. o protepgen •ln l'animale co nrro i veleni da essi clabo:·ati.
. e 1·esi!<te routro il ' 'eleno. il ge r·rne diYiene pt•r· esso quas i innocuo. anche se continua a vivere ed a svilu p·
Però :'\lJJneut:r ndo la dose del ve leno e no o rinforzand n rontemporaneame nte 1.1 tlell'or).(anismo. si giungeril al punto , in l'ni rapidamente la morte (Br·if'ger. 1\ ita:;n to e
Hon\ \ ersin per· la difterite, 1\ itasato pel Letnno. nell è ri.;p ett ive co lture tli bauerii. bann o dimostrato la esislenta di velen1 tanto potenli. da Ca!!ion:u·e la morte. elle i non al•handonino la lnro sede d'inoculazion• ·· j tratta :111un qoe di nna vera intossrcazion e. Qne;;Li veleui, «e bhene di a?.i one pote nte. so no di u n'estrema lahilitir. Nella rura adumlne d i queste malallie sarebbe utile 1l1 volgere lA proprie forze co ntro il veleno prodollo dai batteri i. Behring riuscì a guarire, con divero;i rimedii, animali infeui da difterite . se nza uccidere i bacilli ··orrispondenti e lo risultato onenne Kitasato pel tetan o. Per lu scopo pratico meglio il siero di di animali rt>,;i artiflcralmento> im muni. contro il tetano, nel quale Behring e l tlnsato r iconobbero nno strao rdinar iO potere antito ssico. l1er sill:'ltti eccellenti ri,;ultali, i dflli autori ritennero per rermo ch e la causa della immunità acquisita co ntro il telano rip os ta nel sa ngne e siccom e gli stessi effeLLi si ollennero anche col siero di 1•osi conclusero che riposta nel si ero.
Il siero di sa ngue di Lali animali spiega grand e \'irtu immunizzante e curati va.
Questi risllltati furono •·onfermati in pir'tluoglti e per varie malallie ùa infezione.
1.' immun ilit acquisita ..;i trasmelle dalle madri alla prole ttelrntero col sa n6ue e d rlle nutri··i ai hamiJini col latte.
Qne:-ìt'ultima scoperta, giit ('onfermatn, i• tlovuta alla mente -eletta del prof. Paolo Ehrlich. il quale, in uno studio important iss imo sull 'immnnitit delle cavie contro il ricino o l'a brina, dimo , t1·ù che il latte della nutri ce immune può produrre nei latta nti un allo grado d'immunità. Da ciò può anche deQnt·si come l'allattamento artiliciale non s in mai da an_teporsi a quello natu rale tanto della e. in rirc ostanze eccez;onali, di nut r ice .
Hanl.ing e riu:;cito ad e,;tral'l'e sostanze chimi che prot ettive tanto dal corpo di animali naturali, quanto da 4uello d1 .animali ed ha de no!'!linato tali sostanze filaxine e soxine El le ha in e to:\olilaxin e, ruicosozine e LO\O 'ozi ne, secondo n;.;iscon•J co ntro i micro· organismi o i loro veleni.

Que·te ·ostan7.e appartengono alb uminoidi e r.ts::.ousigliano ai fermenti od enzimi. organi vegetativi degli uomini e degli auimali ha n no luogo tali azioni complesse da poter neu tralizzare i p1ò potenti \eleni.
Ga u tier, ll auchard eù altn hanno dimo strato rhe nell'organismo. per tru:.formazioni thimil:he, si forman" prodotLi ser.ondari o fermenti, i quali posseggono Azioni eminentemente 'Alenose. sostanze circolano per un certo tesnpo nel corr-oo, lìn chè ,i hrnciano e si convertono in prodotti lin uli. Brieger, Kitasato e Wasse1·mann sono di a\'\ iso che nun avveleniuo l'organismo, perchè in questo esi:>tono sostanze ha aknn immuniz?.an te o cnrativ•J inoculato nel di altri anitllali ..\nzi 1\itasato, pr·ima da olo. po1 io co mpagni a ùi Br·ieger o Wasse rmann sos teneva quel ;;ieru non anJui=-ta:;se tali propr1eti1, neppure dopo l 7.iun c ùel pol lo con colturo di teta no , m:1 Vaillard potelte ·ll1· most ra rP a h itasato, che il di sangue del pollo artpus ta t.11i ,·irri1, pnrchr le inocnlnzioni di tetan o sieno eseguilA nel peritoOI'O e ron 'luantitit snflicienti di materiale. .
•·apaci di neutralizzare l'azione dei prodoLLi veleoo:>i iutermedii, provenienti dalla tlecomposi7-ione dcii'Alhumina normale. e ritengono che tali sostanze si tr(lvino nel corpo prutopla·matico delle cellule, lo :.troma ùe:.:li orgnni e che L'Set·citino pure un'azione su i veleni dei batLeri. il potere protellivo specifìco e nelle cell ule dei ballerl stessi. cellule che contengono molto fosforo e l'azione dell e chi mi che dell'orga nismo normal e non farebhe altro che 1110dilìc:Jrc il loro potere tossico. Gli autori sop rncitati estras:wro tali sosta nze dalle cell ule di veccbje col ture di tifo e ne sperimenta rono la lor·o grande azione tossica t' immunizzanre la dose impiega ta.
.\'el corpo degli uomini e degli animali di,•enuti immuni ha dunq ue luogo un cambiamento di natura chim ica e camb:amento, seco ndo ll ehring, si e:,plicherebhe nt•lle parti del sangue, prive di eleme nti vitali.
Il l'iero di sa ngue di animali che sono immuni per natura. ad esempio, quello del pollo domesti co co ntro il tetano. non.
La terapia del siero di :>angne, inaugurala da Belll'tn:r, trovasi i n aperta oppo,.;izione con la terapia <'(lllulare r itn-i) in·m:,(nrata da e so:::tenuta \alidamente da lui e tla i suoi seguaci. <)uesl'llltirna teoria va acquistando di i n giur no nuova imporran?.a.
Jlopo le prime !iulle claJnil', l'a ul<lr e ha esteso le sue r irerche alle prinripali malattie d'infezione ed ha dimusrralo , ari esempio, che nel coni glio sensibile al caruoncbio, i IJ:II'ill i :.:er mogliano, tliO'ondono in ttatto l'organismo ecl lll'l'illono l'animal e: invece nel coniglio immunizzato i citi distruggono i rispcuivi microrganismi. t:aui vit:\ rlei fal(oc•i ti i· gra ndissima tanto nell'animal o rcfrallal'io, quanto in tjtwll o immu nizzato: essi tli gel'isco no i corpi che inglobAno, non e'elusi i microrgani ,.,mi virulenti (rarhon•·hio;, mentre nell'animale ,;ensillile digeri:. co no i microrgnnismi atLenuali. l germi de l mal rosso dei suini e della tubercolosi sono pure .-la essi in globati, ma non digeriti. t.:on nume rosissi rni espe· rim l' nti ta nto l'autore. quanto i suoi segunt'i hanno dimoche i fagociti inglobano i parassiti vivi e virulenti .
Fra le altre prove, Rou>. adduce le seguenti. Nella seui"" lll ia •Ielle rane, prodotta da hacilli mobilissimi, questi, in.. hati dai fagociti, co nser·vnno ancora il loro movimento. l l tarilli rarbonrltio:-.i del ronig\il) vnccinato. imp;igionati d ai fagociti . si svi luppano al microsr.opio :.o tlo J'ocrh1o dell' ossen a tore.
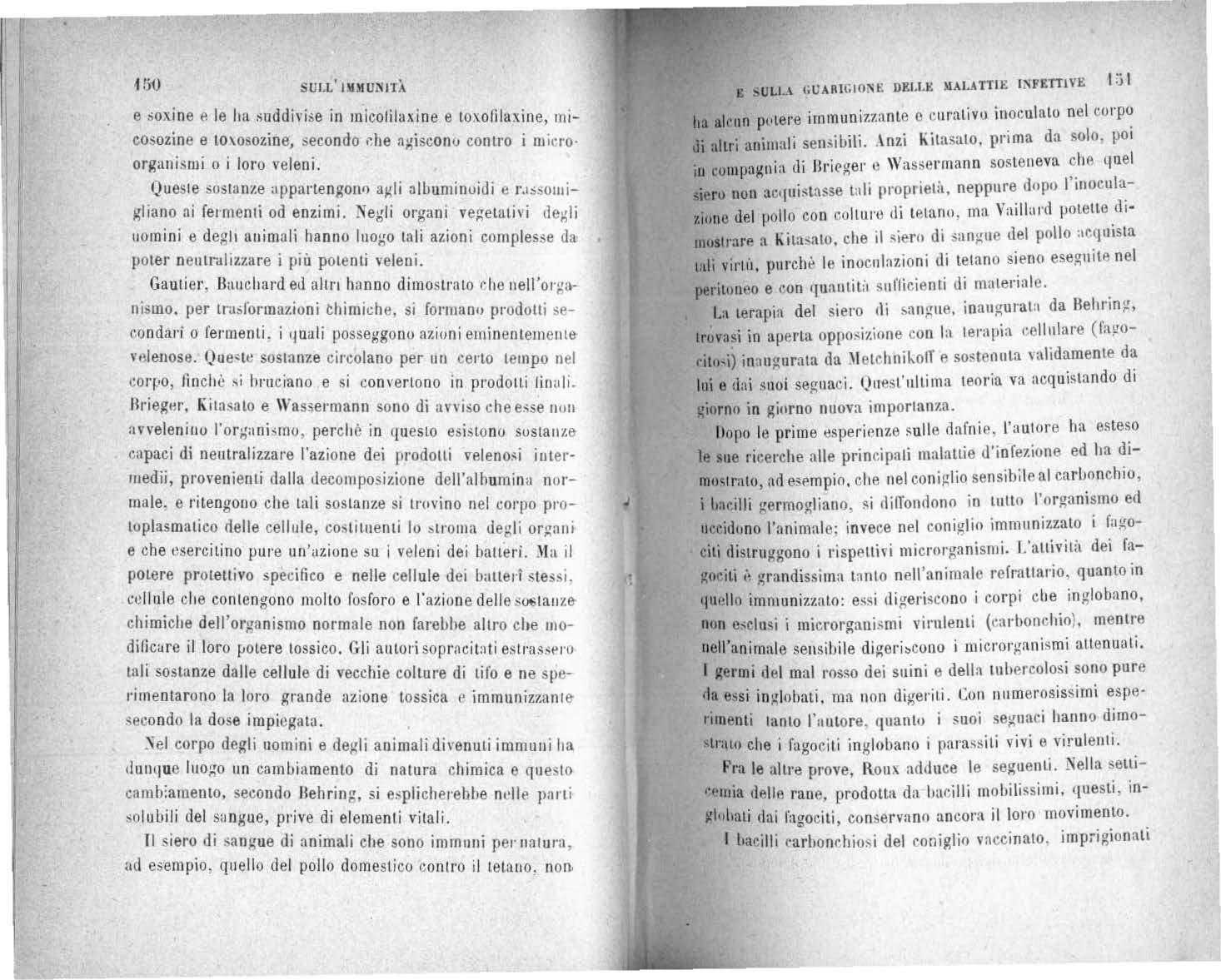
Metcbnikolf isolò un fagocita che conteneva un ba ci ll o carbonchioso e con esso otten ne nna coltura virulenta di carbonchio.
Altri argomenti in favore della fagocitosi : l halleri fuori dell'azione dPi fagociti;
Il carbonchio. ad e:-:empio, si :;Yiluppa nella ramera an· leriore dell 'occhio, anche del cnn1glio \accinato:
Il carbonchio deholi,simo del primo vacci no l'a sleur cresce facilmente nell'umor ac1Jueo del co ni glio ,accinato: l \' accini invece attira no i fago citi. L'azione di quest1 ,. gr.l nllis!>ima in princ1pio: se tarda, il veleuo uccide i fagot'itl .
Le spore di carl>o nchio sotto la ru te di un coniglio vaccinato. riparate con carta da liltro o batufi'oli di ovatta dai fagociti e noo dai liquidi, ::.i svilup pano.
Questa grande aziouc dei fagoc1ti negli animali vac1:ina11 dipende da ciò che essi so no allralli dalle sostanze elahoratr da microbi, le quali dào no l'imn111nitit. Al cune di 4ueste :;osta nze hanno azione attrattiva. altre ripul siva. Vel eno mi t·l· dialissimo ripulsivo, ad esempio, i• quello del colera.
L'acido lattico, elle Ila IH'gativa, la morlr dei fllgociti.
Il siero di sangue di auimali refralta1·i ritarda lo sviluppo delle spore e attiva i fagot·iti, i quali sono pure allraUi tanto dalle proteine dei 111icroui morti, 'tuanto da quelle de1 viv1.
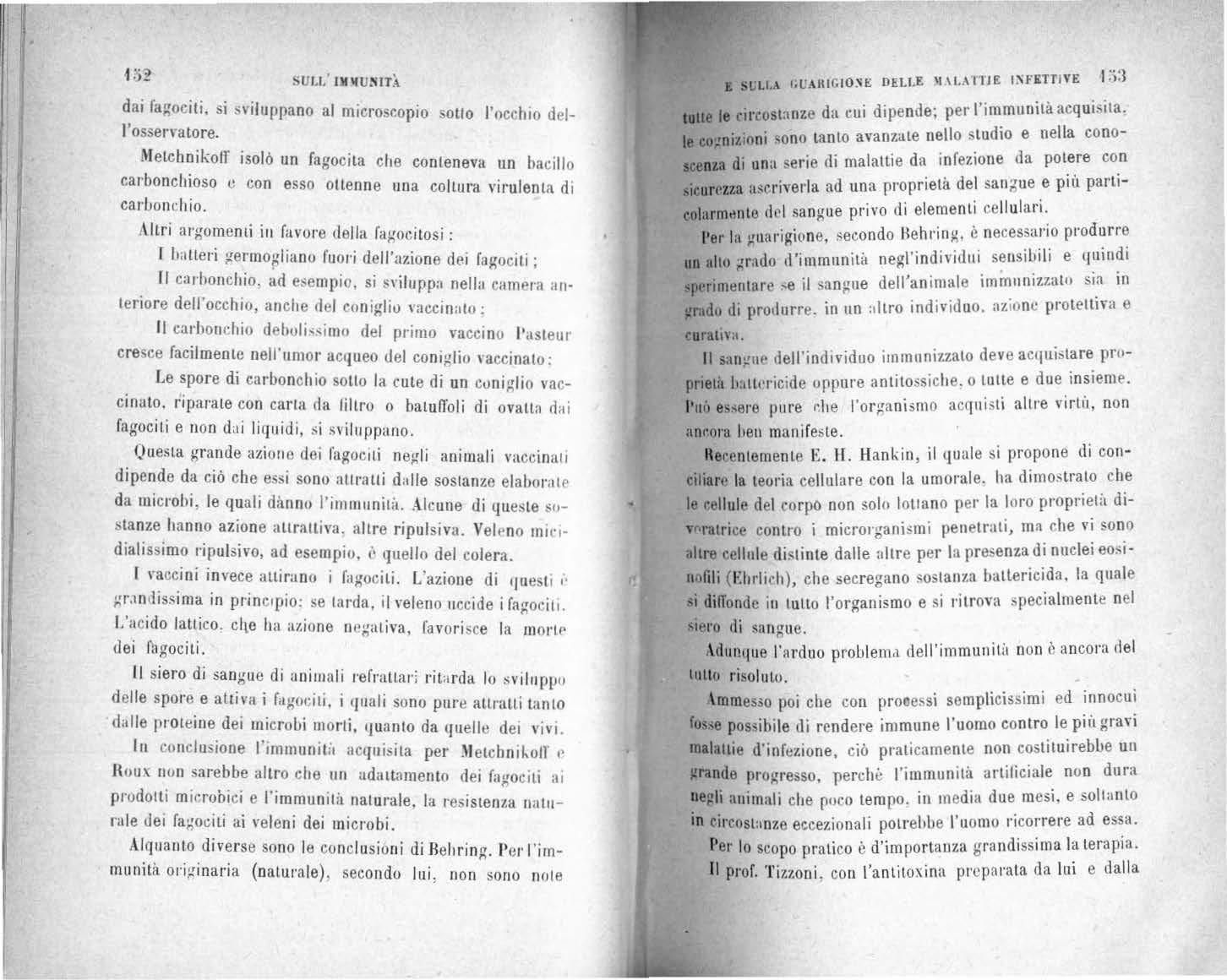
In t:(IIIClusione l'immuuitit acquisita per •• Houx nun ·arebbe altro che un adat tamento dei fagoc iti a1 prodotti mi.:robici e l'immunitit naturale. la resistenza naturale ùei fagociti ai veleni dei microbi.
Alquanto diverse sono le conc lusi oni di Rehring. Per l'immunità ori(!inaria {naturale) , seco ndo lui , non sono not e tulle le t·1rwstanze da cui dipende; per l'immunità acqui:-ita. le co;nizioni "ono tanto avanzate nello studio e nella coooscenu di una serie di malattie da infezione da potere co n 11ic urrzza ad una proprietà del sangue e pitt parlicolarmnnte clt•l sangue privo di elementi ce llulari . l'er la ).(tH\I'igion e, seco ndo Behrinj! , è ne!'es;;ario produrr·e un alln ,.:r;ulo tl'immnnità negl'individui se nsibili e (JUindi spt•rimentare ,e il .-;angue dell'animale immnnizzatn sia in Jlradu ti1 produrre. io un :dtro individuo. az·onc protettiva e curati, ...
Il s•HI!!Ut' clell'individuo immunizzato deve acq uistare proprietit lt:;llt'l'icide oppure an titossiche. o tutte e due insieme. l' uil essere pure rlte acquisti altre virLil, non nnrora ben mani feste.
Re,·rntemente E. H. Rankin, il quale si propone ùi conciliar•• la teoria cellul are con la umorale. ha dimostrato che le rellule del corpo non solo louano per la loro pro prietit divr• ratrice contro i microrganismi penetr·ati, ma che vi sono altre cellule di . tinte dalle altre per la pre5enza di nuclei eo:-.i · nofili (Ehrlieh), che secregano sos1an1.a battericida, la quale si diffond e in tutto l'organismo e si ritrova specialmente nel di . •\d unque l'ardu o pr·oulem cl clell'immunilit non t'ancora del lutto riso lut u.
\ mmes3o poi che con prooessi semplici:;simi ed innocui fo5se possi bile di rendere immune l'uomo contro le più gravi malallie d'infezione , ciò non costituirebbe uu Jlrande progresso, percbc l'immunità artiliciale non dura animali che poco tempo. in media due mesi, e solta nt o in circostanze eccezionali potrehhe l'uomo ricorrere ad essa. Per lo scopo pratico c d'importanza gra ndi ss ima la terapia.
Il prof. Ti zzoni. co n l'antitoxina preparata da lui e dalla douoressa signorina Cauani dal siero di :-a ngue ùi ca ne e dr co niglio re:; i artili cialm ente immuni. ha già ottenuto noYe :Hrar·igioni di tetano nell'uomo.
Tali ris ult ati ti debbono recare molto piacere, anclte se f''i to egnale non otten nero Baginscky e in una hamhrrr,j tetanica co l siero di sa ngue di co nigl io immunizzat o e Henon in du e casi di tetano eu rati nell a clin ica del pro/'. Dieulafo.' co l siero di di im mun izzato da Yaill ard e Hou\.
1\ itasato. nei topolini bianchi e nell e cavie, inoc ulati c·on ischegge 1li leg no, imbratta te di spore di tetano e cur.tti, ri -;pe ltivam ente , dop o 12 ore e :H ore, con inoculaz ioni nel peri toneo di si ero di :;angue tli animale i mm uni zzato, a far· loro su perat·e la malattia. Però Lazarus ha r·ecen· temente dimostrato che il siero di sangue di uomini, i quali hanno da poco tempo superato il colera asiatico, mentre i• attivissimo per co nfer·ire l'i mmunitit. non ha r he poca azione. se In mal atti a i· comi nciata e la tempe ratura t\ divenuta considE>revolm en te e che, a colera manift'sto , non è più bile a lcuna guari gio ne.
Ch antemes e e \\'i dal , io un re cen te ed importanti:-simCI studio sull'infezi ou e tifosa speriment a le , co nchiudon o che il eli a ni mali im mun izzati possiede azi one immunizzante e curativa e che il si ero di sangue dell'uomo, çhe Ira il tifo. tanto nella co nva! e•;c·enza, t{Uicnto dopo la (clopo 1- ·ettim ane. i. anni. 2? a nn i l po,;siede virtir immu ni?. · zanti e terape uti che.
In somma la buona via è aperta e '>peria mo che in venire la c'i nseg ni il modo di poter curare , al prim o loro le malatti e da infezio ne con rimedi piu eftirari di quelli che abitiamo usato fino ra.
Hi gennaio 189:{.
Contributo
QUIS TIONE DELLA SORDlTA' VERBALE
11er il dott. l uic:i 8earaao t toteneotP medico
La della sord it à verbale non ha una sturia molto remota. i toglie nn fuggevole accen no fntto nel l G3 da Baillarger d'indi vidui che passavano per e dementi. ma non erano nè gli uni ni· gli altri, non niTe tti che da una specie di afasia, il vero per·iodo dell'osservazione comin cia co l Broadbent nel 1873 seguito subito dal Wernirke e dal 1\ usm aull. F: fu prima clinico e fisiologico e poi l'anatomo patol og ico. quello che gui dò i primi pa :;si nella menziona ta ricerca. co me si .;;a, tali mezzi di indagine quell i che han preso il sopravvento sullo nell o studio delle malattie nervose.
Ila quell'epoca si no a che lo Charcot mcttera fuori il c• elehrA stu dio delle afasie nell'anno 1883 ·84 si ehbero parecchi e puh blicazioni, parte di casi clinici soltanto. parle corredati dal r eparto necro scopico. Sicchi• l'i llu stre ·cienziato pole tte rar ce nn o di 15 casi di sordi tà Hrbale J,:i:'t pubLli cati , dj cui 1O sel(ui ti dall' auto psia. F: basandosi :-u di essi. giacchù man cava ngli osservazioni proprie : inc'u ·e la
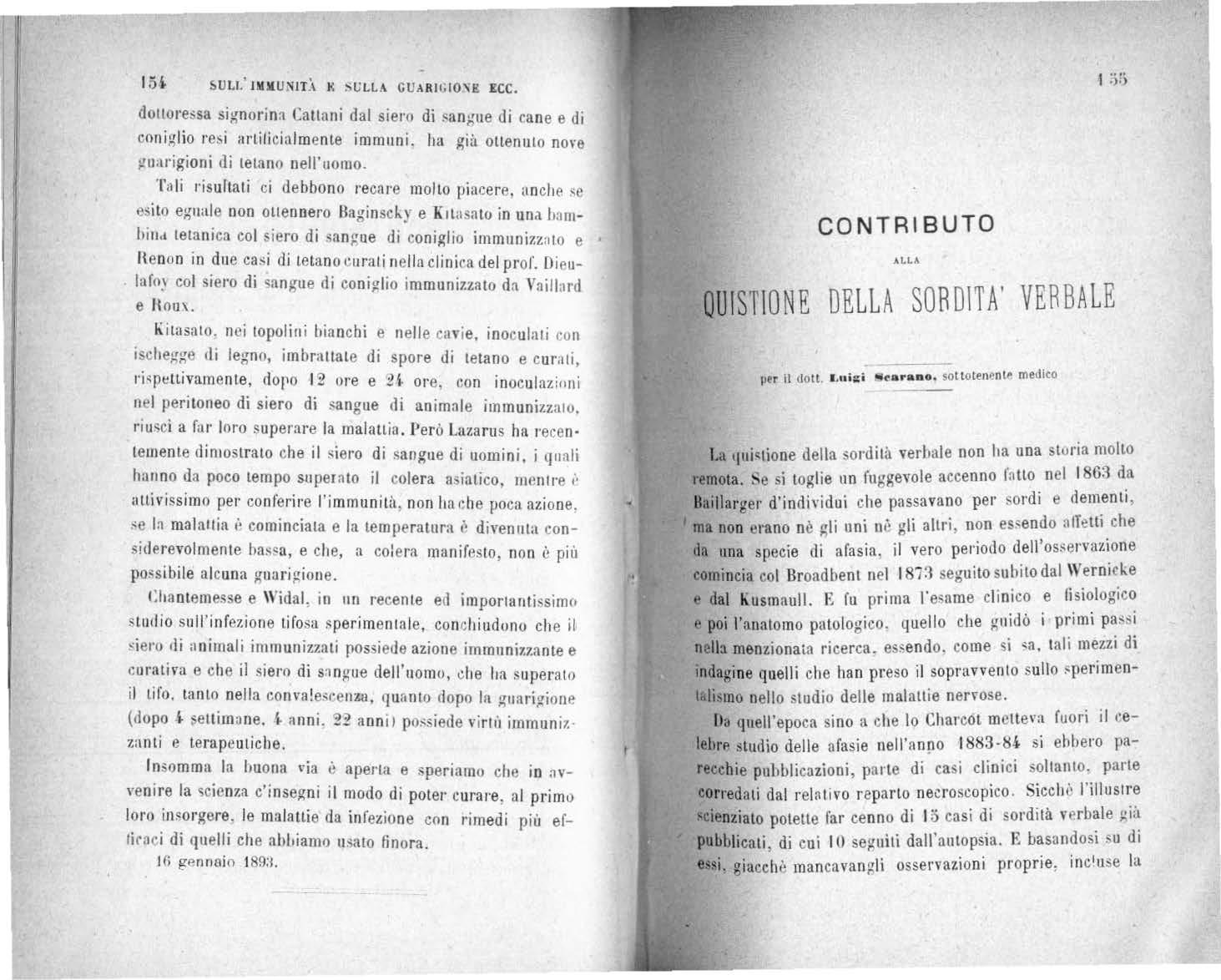
:>ordilit verJ,ale. come una specie tulla a sè di afa in, fra le nllre alterazioni del già nole.
I n L_nl.e studio fu a breve intervallo dal Sepf•illi m•r/l(lle. aui l r fre niatico iraliano 1Rts3. e l ilmta t! i {1·eniatria fascicolo 1o e 2° anno 1 ). l.u cranr e Mppdll ([orali::;a:;ioni fun::ionali del <'n-rt'//t1
F l HSJ l. dal nostro illustr·e professore Bra nc/ 11 (L Xapoli 1885). Tulli vi appor·tarono il loro
,·alevolls rmo conlrihuto di ossPrvazioni nuove e di trlter· . d d . . 1011 e 1 uzr.onr sulla stregua dei falli coscienziosamente anzi, per essere stata richiamata sull'argo mento J'nttenzron e degli studiosi dagli illustri aulori menziona ti 1 s ul riguardo din•nnero relativamente più merose, ne mnucarouo osservazioni contrarie o tali soltl in alle deduzioni nmmesse dai precedenti o;;srr,.<Horr . casi mi diedi cura di rintracciare nell'occasione eire dr nell'ospedale militar·e pri nci p 'lle della di' rsrone Napoli un reperto net'l'oscopiro, che può recare un ro nlrrbuto non s prezzauile alla quistio ne. li n occorre richiamare nella storia dell'inferm o. li Boens f{ta a l suo entrare n ell'os pedale prese ntava otile secretiva croni ca a dEstra. mnlallia che sofTrivn giit d·t Yari anni . a ttnnntn assicurava lui stesso: l o ,:colo rlell'orecchio a quel tempo era ben poca I'O'a. otosco pico praticato a varie riprese collo spec ulo del ToHr l•ee e lo specchio del Trollsrh. ollre ad alte razioni di poco rilre' o del condotto, faceva rilevare perforazione estesa della membrana del timpano. Tale le!'.ione n sua volta veconrermala esperimenti tlel e del PolilzPt' . al microscopio la secreziOne tenne, che colan tlall'orecdJio. allo scopo di la IJalur·a del prore.;su, non mi rius c1 mai di risrontrarvi il hac;Jio di h.och.
. r ero da quell'epoca sin ogf(i la questione non ha cessalo dr essere argomento di studi e talvolta anrhe di con1raversia, coerentemente a quanto avel'a asserito lo Charcol. che drceva essere la sorditit verbale la forma di afas ia m-eno studiata e più dillici le ad analizzare.
Higuarda''•l il ,·ice brigadiere dei RR car·ab· . . Il . . · rnren oerrLurgi della.lt•gione d i Torino iri decesso per tubercnlosi poi· dragnosi deuitaml'mte con fermata in '"i ta coll'esame deglr e:>pettorati.
Con tulla proballililit era ,lat.'\ essa il punto di partenza della t ubercolosi nel sno crganismo.
La ra collit uditiva ).:enerira dell'orecchio afTeuo se mbrava d<' l lullo nho lit a . Dico in quanto che i• risapuLO, eumr tlillirile provare l'udito nei casi in eui uno solo or·gnni e nll'etto e l':l111·o è normale. anche ricorrendo ,,J sollerfu or io consi" liato drll Oennerl. Clte però la causa n n · della fo sse di natura organica pr t· alterazione òell'orecclrio interno, lo rlimostravn l'esame co l diaplta:;o11, dr eu i il pazienle non avvertiva l e vihrnziooi, quando veniva situnto alla :ìOmmilit della te,;la. o '\n ll'apolisi mnsloide eli di'stra.
1:rò pure è spiegtt.ilt'. nolo qnanlo sia diffirile rin,.,.n ri o nell e secrezio ni ri'Oniche aperte mentrP la tliftÌt'()ll.a ct>ssa nei ca.;i tli acuzie o suhacuzie.
LI Bezold. infatti. riferiser al r·1gllitr'tlo nel :;uo archivio di l'linica merlica un hel caso rli otite meòin suppurntiva maiu un intli,·i.Joo tuhercolntico l' intluenza
1lella lin fa di Kock, in coi si notnrono ahhontlnnti bacilli Lnhcrr()lari. Colla secrezio ne avendo tentato qunkhe cultura in :,i&ro di ebbi cogta otemente negati\';.
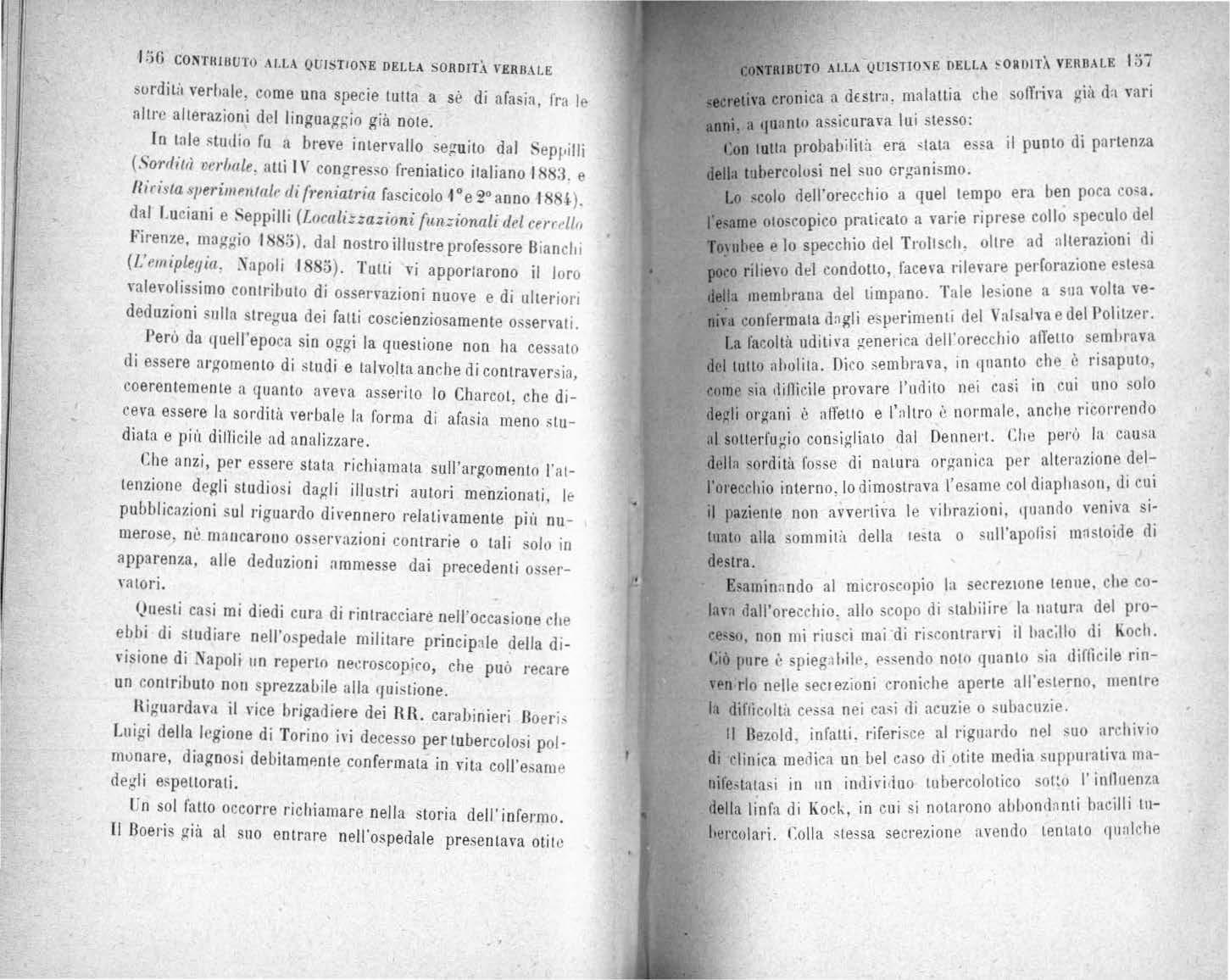
Ad O)lni modo il Boeris, oltre la perdita giit della facoltà ndit i,·a generica all'orecchio de·tro (sord1ta ltrnta deii'Ar naud) non prE>senta,·n ne5suna alterazione che si riferisse n pel delle parole (sordila verbale).
La vista era pure uormnle e l'esame oftalmos('opico del fondo dell'occhio riusci Sormali pure erano le diver"e estrinsecaz1on1 somnliclte e di relazione alla dipendenza del cervello.
.\ Ila necro,copia, di cui io fui incaricato. oltre alle alterazioni dell 'a pparato respirnlorio proprie delln tuhercolo <i aYanznla, :-i riscontrarono le . ejluenti della cavit.t cra uica e delf'o1·ecchio. Pallore dellu dura madre, che prPsentavasi ili.; cre tamente te!'a e del tullo normale alla !' ua superlìcie interna: meningi interne pure pallide ed edemato't> ::.oprat utto in corri;;po nden?.a del lo ho tempoJ'ale di rlrstra, ore la pia madre si abbas ·ara in una perdita di !' Ostanza sottostaote; vasi ba::ali senza alterazioni npprezzabili, circonvoluzioni cerebrali pallide, edematose. di consistenza dimirwita; al lobo temporale destro un focolaio di rammollimento di colore di molle e diflluente, il 'JIIale inteJ·dssava la mal{gior parte della 1• . e circonvoluzione e che iniziandosi io a' ·a nti poco pit't indietro della scissura di Silvio e rasentando in alto quasi il limite di misum,·ada aranti indietro nn due ce ntimetri. dal· l'alto in has!'o un centimetro e mezzo con u na profond1tà ineguale o.;cillante tr·a mezzo ed un ce ntimetro: aller,t?.iooe dPIIa sowtnza ce rehrale nei diversi tagli e nemmeno fal'c ia esterna delle meningi: ependima questi prepHali a discreto ingrandimento, " vede sub lo sr.omparsa In normale strutturn della cerehrale e al suo po!>to le cellule ner..-o"e alcuue pnve di prolungamen ti, granulose o ridoue in piccoli granuli, altre rigonlie e pa ll ide ron prolun gamenti e ialini: le lole della neYro.,lia t·ariche di line goccioline di gra-. o; po1 r . . cor pi arroton tliti e opachi per le successiYe trasmormnz10n1 dt>l gr.ts5o; <li mi elina forma di picco li gloh1 liberi e l'•Jrpt amilacei.
·... dell ' on'cchio medio con distruzione della membrana ... del timpano c grave alterazione della catena degli rli 11oa tale alLPrnr.ione cerebrale. che in \ila non s'era annun ziata con nlrun stntomo apprezzabile. rarc ol,; i il pe1.zo. che tenni ad ind urire in m;soluto. feci di,·er si preparati. cc• lotandone alcuiH l'eosina. altri alla picrooigrMina del ed uno con colornione dopp ia all'eosina e nll'ematossilioa.
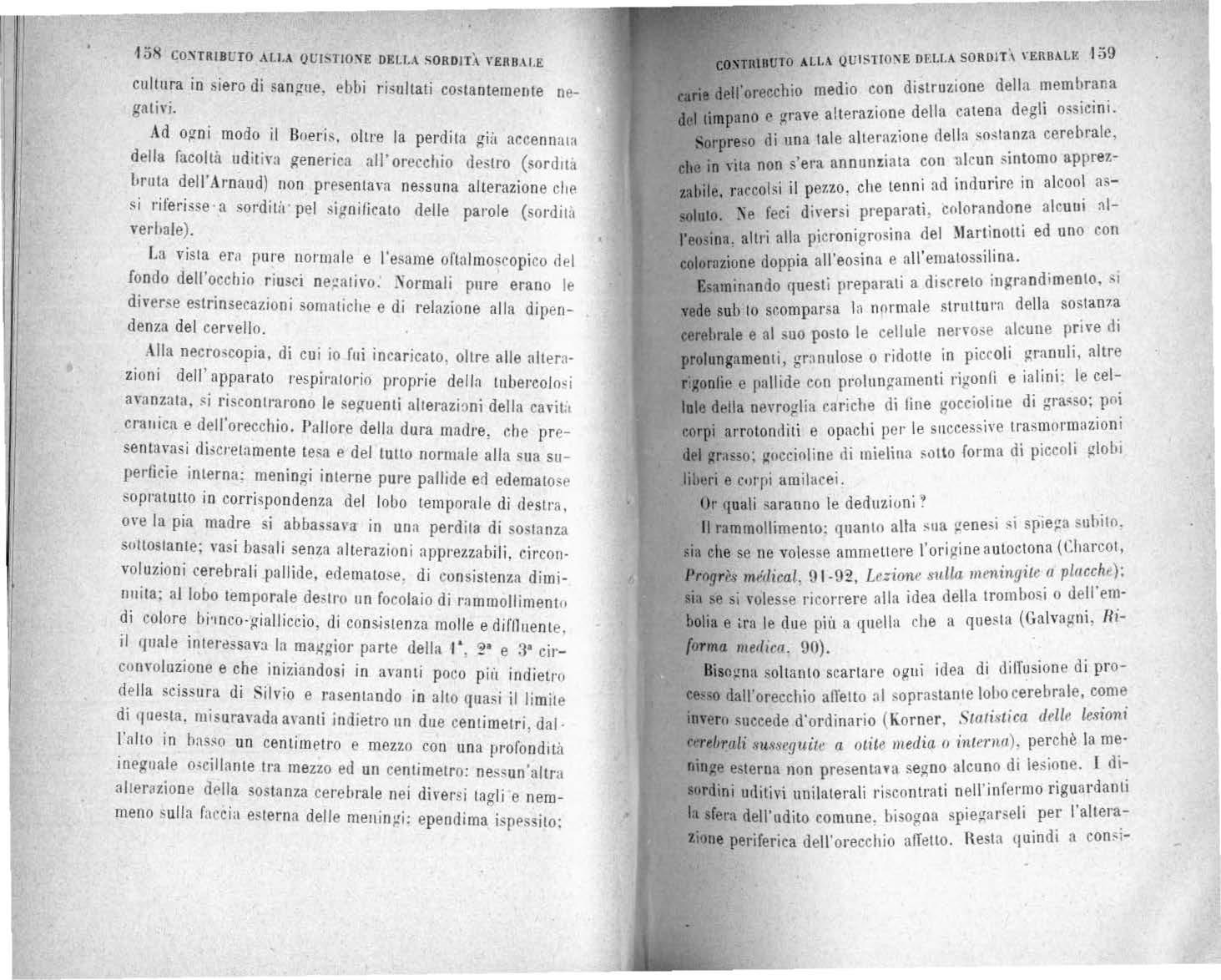
Or quali sa ranno le deduzion;?
Il rammollimento: quanto alla :-ua si :ouhito. a che se ne ammett ere l' ne autoctona (Charcol, Prn9 rì>s mltliral. Lr:ionl' stttla meningite _a plarc.h 1 ); si., :-e:;; \ Oiesse ricorrere alla idea della tromhost o del! embolia e i.rn le due più a l[UCibl che a queslll (Galvagni. Riforma medtcn. 90}.
Biso)!n R so ltan to scartare ogui idea di ùilfusione di proùal l'oreccltio alletto al :;oprnstante lobo cerebra le, come inveru succede d'ordinario ( 1\.orner, Scati.stica dell1' lesioni ri'Ttilrnli .vussrgtti/1• a otitl' media o inll'nw). perchè la esterna non presentava segno alcun o di lesione. l surdin1 uditiv i unilaterali ri sco ntrati nell'infermo riguardantt h lìfe1·a dell 'udito comune. bisogna per l'allerazi,lne periferica dell'orecchio afTetto. Resta quindi a con-1- derare il foco laio di rammollimento per le possibilt influenze inere nti alla s ua sede speo:a le. t:., nlinnartclu lllOILre l'esa1nf' ,..or to il rappotlo eli lt>sione riguarclantP parli colrll'lnente il loho temporo,;fpnc1itlale di de,tr.a, cwrorr·e notare rhe nnnloi(amenle al mio. ce ne t> qualche altro riportato Mila IPIIf'mlura. seuza 1'111> mai si ;t\Ul n a dPplorare apprezzabili. S<'mbrereblte ant. i chf' la chirurgia. falla audace da tale considerazione. non :we..;sp risparmiato un tal campo, rhe si (H'P,tn,·a rosi hPIIf' per lr anlit r cunquiste. Ciò pnò rile\'rtrsi dai lu•i !':hi >'Oiltlltll!'ttti dal Bt•r·gut;trt (Sucie/IÌ 11/l'rlictt eli /lerlhw) f' dal Uuch\\ell tf;illl'llttft• ull'llim amt•rir.autt}. Utt• pt'rò il luho tt•lnporu.;fenoidale di dt>,tra fo.;;;p di 1111pnttaut..t relati,·amente tlla funzione dell' udrt.ium• c t'OIIlf' furniune gt>nt>ral e dell'n di lo P c·ome fnnt.imtt' la paro la signilica tn, n<Jtt pare. l.n si vrdt> all'!•r·malo da tuili gli autori e lo prova l'osspnra;:inuP d te uppnrtunartr rnLe fa il ih• Ho--s i ( lf o,walt• di utointrifl, ltom;!) rit wl uta dal Lucia n i su due in.Ji, idui. r.inc\ dte nPi •nr.lomuti a'· P\ iùentt' la dPii••it>uza ciP Ilo :-;viluppo rlei h•ntpurali iu rortl'r'canto alle altre r.q.!IUflt e che <rnaldrP \'oli:l, "'11111' 111 urt o dt>i casi del l.tr c• inni, il lola n tli " ini stra Arn an>'Bra pier tlelidenlr> tiri dt:>stt·n.
I n linea ge nera le occone ri corJnre che t·ilevnnti distruzioni sostanza cerebrale possono essere rompatiLili colla vtla ed anche non annunziarsi co n alc u n sintomo. c1 ,i hellissirni se ne nl riguardo nella Relazione pubblicata a cura del nostro l spellorato di sanità militare guer ra clr america na e s u quella franro-tedesca ul tim a. :'1i· manr.a a spiegarr silfatt i casi la parola della sc ienza tr oria dello svil uppo di centr·i s11ppleto 1·ii r drlle funzioni dorandosi considerare la corteccia cerebrale t'0111t• non di r.enLri e ··ircost·r·itLi. ma ,uJo di 1'81111'1 dr intensita fu nzionale. r:ome lesione particolarmente localizzata al lo ho temporo- ::;fenoida lc. non poteva ave re inOuenza hen chiara sulla l'n.:ol lil genera le tlell'udizione. liiit il Nohtnagel avevn all'armato che soprutuLlo i ùini uditi\ i di tllr sol lato, a pre..;rmder e ra)!ionevolrneole eia nna diretta dt'll'acu.;llro nei proressi ha:-.ilari . rari.;.;imt nei focolai E a;!g1ungHa chP oun Pra no st rlli puh hl ica ti reprrt i nenoscopici i IJ tw !l dimos lra.;set·o che i focolai ::it rntt i pir·t verso la co rte ccin avessero proclotlo la :"orditù. Migliore fnrtuna non lranno avuto gli :>Lttdi posteriot·i int,.,i a scoprire nell'uomo il decorso. intran·anit·o delle origint delle libr·e dell'acustico, quando anrhe il .\l e) neri dovelle nhhandonare l'idea rhe fossero in c'oli n r·ot della l'ossa di Silvio. E ancor;l piu tardi il Lur iani e co nronlt' ron lni il Ferr ier an·errnauo lo clelia sorditil propriamente della in rapporto allt> le->ioni r•ot·licali. rimanendo aùcltr'tllura nell' omhra quello che an11nali i• noto, cioì•. il rapp orto di hilatrralità della cort eccia cerehrale dei due c•olla ,fera ttd•tiva pt>r·rfrric·a clf'i due lali dPI c·orpo.
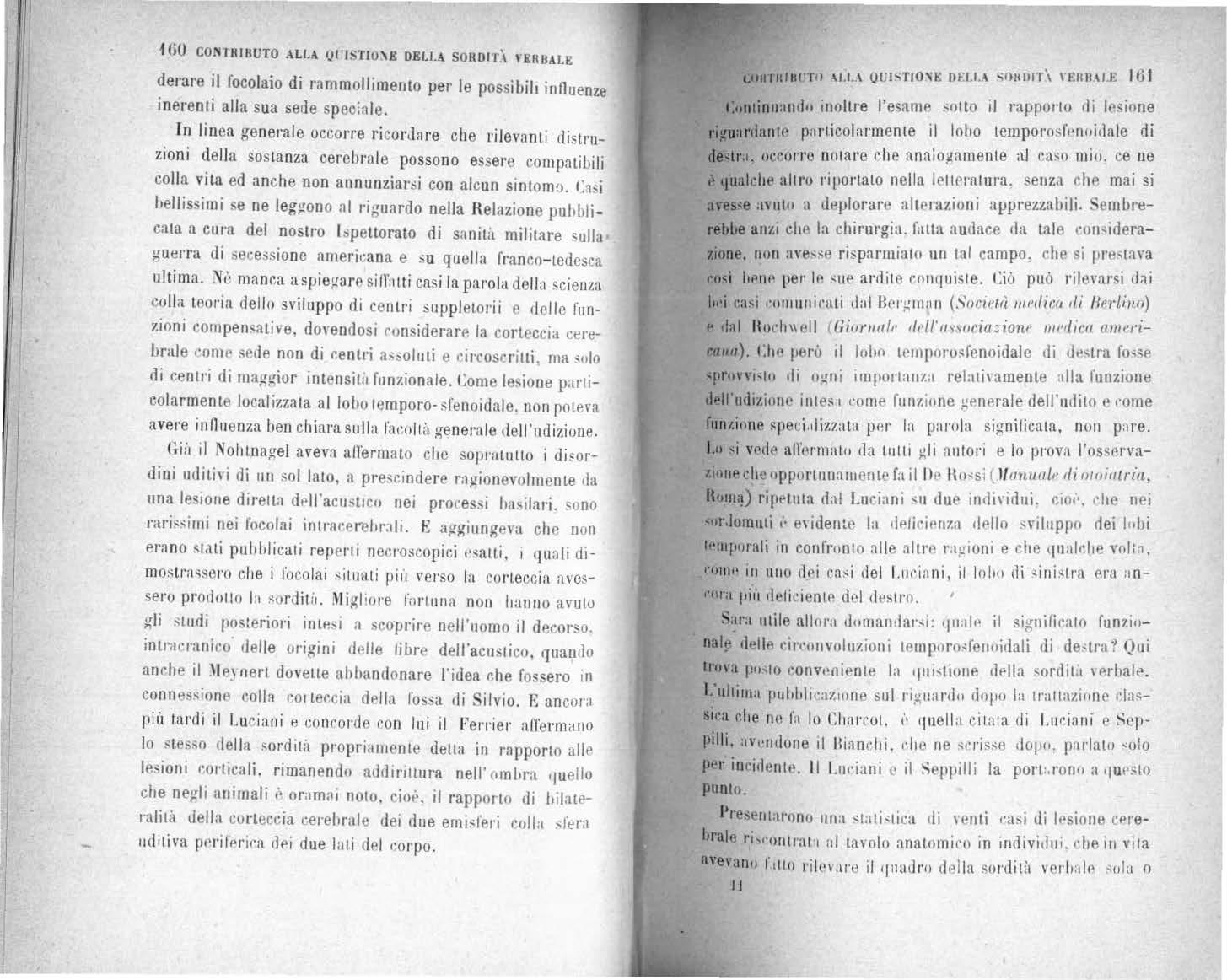
Sara util e allora clonraudaN: qtr.tiP il signific-ai o fu n7. iona lf. •lellf' I'Ìf'I'<Htvolul.ioni trmpurcHfertoielali tli de . <tra ·t IJui ltu\·a po -lo ··onv.. nienle la IJIII'lwne ùPIIa ...ordita 'rrlrale. l.' ulltlll•r pul•l•l u·:tl.lltrte sul clopu la lratlal.ic•rH' sira rlrp 1111 fa In t:ltnrcot. ,·. quell a ci lala el i l.n ria ni f' pilli. :rVl'tHlone ti ll innl'111. ··!te Ili' dopo. parlato P" t inc·rclent e. Il Lnr ian i t' il Seppi Il i la poJ'l:, rono a qur•;:to punto .
Jir·esellt:u·ono trna .;rari-tie·a clt 't>llli •·a:'i 1li le>sione rrrebrale al taYolo nnatnmi,·o in individui. dte in' ila ave\'anu ftllo il qnaù r·n della so rJilit vcrla:ale• n accompaguata ad altre alterationi Si1Tau 1 in cui era no comp resi otto de1 dieci casi annunziati dallo Ch:trcol, era no lutti q uelli, che ri s ultavano puhiJiicati prima dell'epoc.t della loro Hisogneril. per :nere la :-tatisllra completa. <l).(l!innge1 ne uuo del Franrl-el di Be1lino e l'altro del Chaulfard ch'essi avt•\auo ome:N>. 11a ro,;i 1111 to tale d1 :!.:1 di :.urùita puhhlicali pr11ua del ' in cui t·r•.,tantcmcnte la lc,.iono riscunlrala al taroln analomH;o riguarda il loho temporale ùi si 111 slra, wer·1s.tmtmte la prima parte della seconda ein·onvol uzi one.
Dall'X:; 11 1 poi trovn cl11' sono pubhlirali 1 -.eguenli a ltr·r :-.empre l o Pe m• t (Ospedale della Crore R11:ha a Li oue anno 1886). Caso di donna aleromasit'ét. che eLite apoplessia crrehrale co n indel,olim eulo degli arti del lato inde· holimento che scomparve: la sord ità \'Orh,tle. All ,1 auto i a SI rhcuntrò ram muli imento dei • , posteriori dd le due pmnt• clr<ouvolnzioni temporali di sini srra.
"J• Professore Leona rd o Bntn chi. Cerbone t;iovanni di anui 6 1 •·ico1e rfllo nel nwni romio provin cia le di Napolt: presenta ra sunl ili t vt=;riJal e, para fasi a. paresi del la faccia ,, destra estesa arti omonim1 . .\ ll'autopsia s1 riscontr11 ranunollilllPOlo della metit posterwre della l' ri rcrJOroluzione temporale di sinislr.t a parte della temporale
:1• Cornunicazione dol Netter alla societit eli hiolouia di Parigi. Una donna che in ,,eguito ad a ttacco eli pre senla 1a emip legia a destr:t o sord itil verbale . nonostan te e:.isles:.e inte;.:ritit clrlle alln• conosccm·e. L'aulops 1a 1·iseontr11 di lulla la pl'lma tempora lr d t stnhlr 1 oltre lo• a so-.lt guo
/.1) c o d o
•· Jullltllllcat.wuJ el lh•Jerine alla .sle;sa st,<'ICliL So;.:gello co lpit o ùa t:er. itit e sunlitit \t;rbalt; comJJINa co n urlito prfettamentt• ,·onsen·ato. Alla necrO:'t'opia ,;i rinven ne una fiulra j!ialla di ram mollimento oect tpante la circomoluzionr .parietale inrert o•·e e la parte della prima e dell a aeeonda tetnp orai EI. non ché della seco nda occipitale. Il rammollimento si approfondi,·a nellt sostanza hianca sino alla parete n•ntri rr,lare.
:}• del Serll't l\ alla stessa societit. l ndiTidtto con cecitit psi!'hi t·a e verbale, sorcìilfl wrhale e a(!rnfìa. \ ll'nnlopsi n gi notavano lesioni simmetriche -della curva e a sinistra una molto limitata ùella regione retro-i n-ulare e della JH'Illl:l temporale. La mant an za -di le:'ione della seconda frontale, che avesse spiegata la si spie;ta stato l'ammalato rieco per le lettere.
6 " "ill s (l'nir. med. mnrta::., noremiJre l Hfl l ). Donna morta in st'I·Wito a ripetutt nttacrhi di interamente iu ultimo di ,ua vit<,. Al tl\\olo anatomieo fn ri- contt·ata atrolia della l" circonroluzione teruporal .. •li sini,tra nei suoi • 3 pOl-leriori co n depressione !lpiccata co rrtspnndentt> nl trnal'lo posteriore della set·onlla temporal e eLI all a scii'-surn parallela.
'i" Comtln irat.ione dello autore alla ao;gnciazione flevrol o;.:t ca nmel'icana o di le:;ione della l' e z ' t•irronvoluzione tempor.tle tli in indiYiduo, cilt' in ,·ita aveva presentato ::or·ditil per le parole in "eguito ari allarco .apopl ettico (frirmvlle wyiPsr• rli mr•dicino). f ndi1 iduu r rn''" t·atu nel rnanil'Omio di \\' t·st al'asiro in :1. ript>tull nervosi con perdita di cosl'ienza (eptle:;sia?) s..,rin lin tlall'adole:SI'enza e in rni :;ei settimane prim:1 ÒPII'nlrimo l'udito era IOI'fli\10. rn'Sf' ll l:lntlo perO l'f'o'i tit ... :;nr,hta verbale . mostrò rammollinwlllll <lelle circonvo luzioni tewporalt di sini,lra, del 1.dru e tlell'insula. sinistt·a atlravrrso le> s1 ..,·urgeva una lerevnle depressione a lirello d ella patte p'lsteriorr del lobo frontale e dei '/3 inferiori delle c:ir·convolnzioni eentrali. da una ltu: una. che fra le altre par·ti ;n e'a ,]istruito In 1n cireonvolu7.ione temporal e di :;i nist rn eia terza ,·irconvoluzioue frontale dello ,..te;;so lato. intanto 1'ompreso nel campo dist r ullo Il ,·rntro dei movimenli volontari dP II'nr'lo il pazienle fu obbligato a senir=-t della nww per ,·ui divrntnto a poro a po co man cin o, prrsentava l'emi.;fero cle,..tro p1l1 luppato rlel e in vita nou cliede segno nè di ni· di ,;on l i là ve rh ale.
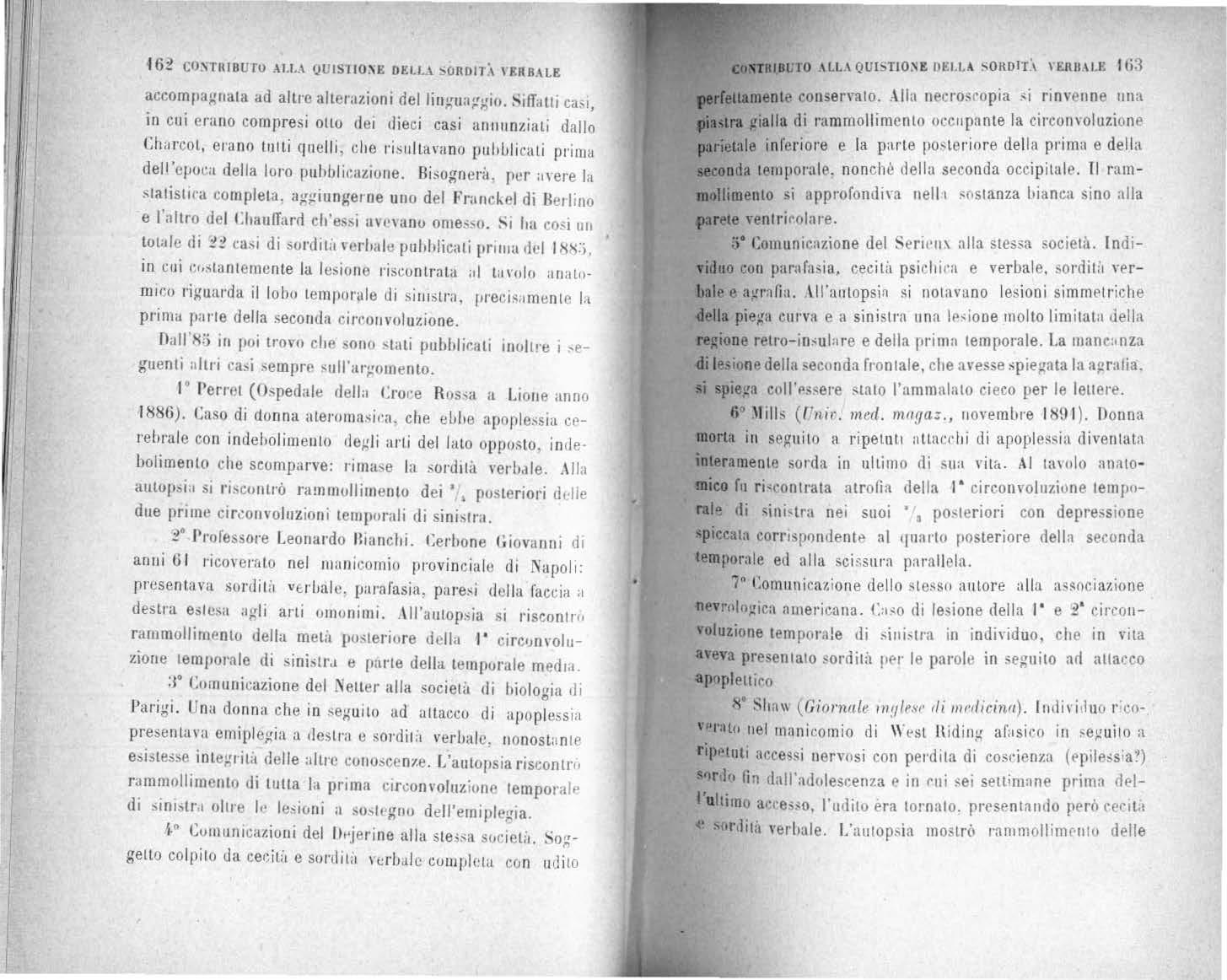
Coi ca:;i che sono andalo raccoglienllù. In statistica tlel Lucia ni sale da tO n 30 casi di sordità 'erhale tuui heu to nfermati •la! relativo reperto nocro,;copico.
PPrò ris ro ntt·ando la lelll'l'atura. qual chP altra ,· .. -a :>i riesce a trovare degno di nota.
Il riferis ce di un uomo mancino sin dalla gioventu all'etto da emi-epileo:sia destra. con ,;uc,·e.:,;i'a non complica ta ad alcun disturbo ùellin)o!uaggio, ni· a :\OI'IIila verbale.
La necroscopia fe ce ri5co ntt·are un tumo1·e che a\ eva completamente distr·uuo le ci rconvoluzioni tl3 utporali dt :' ini.:tr·a.
Ed ultimnnwn te ( 1/11'1/ico lum · f,artln. l R911, riferisce di un reperto an a Lomieo tl'individuo in etti la metit .;ini.,tra del ,·.. n ·ello meno ''ilu ppata della destra.
1:1 troviamo quindi innanzi a ll'l' or.lini di fatti; dn 11 11 11 prte 30 ca:;i di circonvoluziont d, sinistra con ft>n omeni 11l vrta tll sor.ltta verbale accompagnata -o no da altre alterazioni da uu 'al tra parre due c.1si di le:>iom delle stesse parli senza fatti di soròit ir 'erhale. però in individu i manci ni; dall'altra il caso ed al:ri .analoghi di lesi oni del lobo temporale destro, :-;ra spontanee, -che IH'O\"ocate chirurgicam ente alcuno di altt'razione al'asica. Qu anto alla !'Ordltit verbale le nllrriori osten'aziunt che si vanno ra cc ogliendo dinwstrano sempre P"' che un1 tale alterazione del ud1to de,esi con sicurezza auriuuirc a lesione del cett rr o per l'udizione della parol1. ti quale risiede nella prima e parte della ri rcon-voluzione tem poro;t!e di come zona di difl'erenzi amento sulla vasta area corticale della funzione per l'tllltlizl<llle 4renerale.
()aJl'oss el·vazione però dei t'.n!ìi riferiti sin tjlli e ancl1e da -quelli parecc h i riportati dall'All eo-Star, dal Bennet. dal Ba!lian, ilal Ball et e dal Uernarcl l' non riferiti qui. percht:· non acco111pag nati dal reperto nec r·o,copico, ri su lta, rho la pl't'iale indirata col nome di verbal e r.,ramente ,;i manifesta sola. Lo l:ltarco t infatti dei dieci casi di r•li dispoue,·a. potelle pre,;en tarn e !'o lo dne di :'\Orditit vel'l•ale senz1 complicanze di allra alterazione del 38 rifet•iti in que3to studio. ve ne ha ben Hl in cni la sortlità per le parole risulla s tata accompagnata da cecità ,·ert.ale. o da ngra1i.1. o da afasia nrticola re. l quattro centri per gli atti elementari del lin guaggio. d ue se nsoriali {i centri della uditiva e vi·m a). due motori (i ce ntri della m·Pmori a dell'arti colazio ne dei molli e della memoria gr.t tira). mmiLi fra loro da comme:;sure, per cni operano Si!lternnti ·amente come un vero apparecchio e colla proprietit co mpen sativa de ll'un cenlro per l';l ltro, tanlo che lo Charcot tale compen:.o ha oleratCJ a ri so rsa terapeuti ca. Or potendo lesi i cen t ri e le e le lesioni di quesle es,ere meno appariscenli delle pr·ime, :;j spiegano facilmt>nte i casi di del linguaggio seoztt lesio ne anatomica apparente e vicrver·sa: si spiega no le parafasie e le lesion i dr 1111 cenlm con alterazione della rispelliva funziont> 1ncon quella di altro cent ro alme no 111 apparenza rnlegro. In conseguenza i casi rifcrili sotto lali r1 guarùi dallo (wm uni cnzio ne de l gi ugno 1889 alla sot·ielà ne\ rolo;..ica americana) non potranno essere invocati a detrimento della localizzat.ione dei vari centri dellrn)! uagg:io. È da notare altresi che. fuori del co mpen"o in allo esi::-tente fra i Hri centri elementari cle l lingu :1gg io, un allro compenso JJiwgna ammettere iu via votenzialtl dell'emisfero destro su• sini:-lro. noto il fenomcuo del destrismo cerebrale, per r.ui la preminenza dell'emisfero sini:.tro sul oestro in fallo del linnei man ci ni Lrovasi essere invece dell'emisfuo srtl sinistro. LI inoltre che in casi di lesioni antiche e croniche =s i rende possioile la cornpeu;:atione per soslitutione fnm:ionalc di alt r e parli in tJuelli. dte vanno a diventare mancini. E se ne ha una prova nel dJ. me riporlato del (Tatti, il cui infermo era pian piauo diventato man cino e presenLava l'emisfero destro piu sviluppato del sini.;l ro. l n dipendenze. di tali co nsiderazioni, mentre si sp iega. percbe nel caso del Weslpltal e in 11 nello
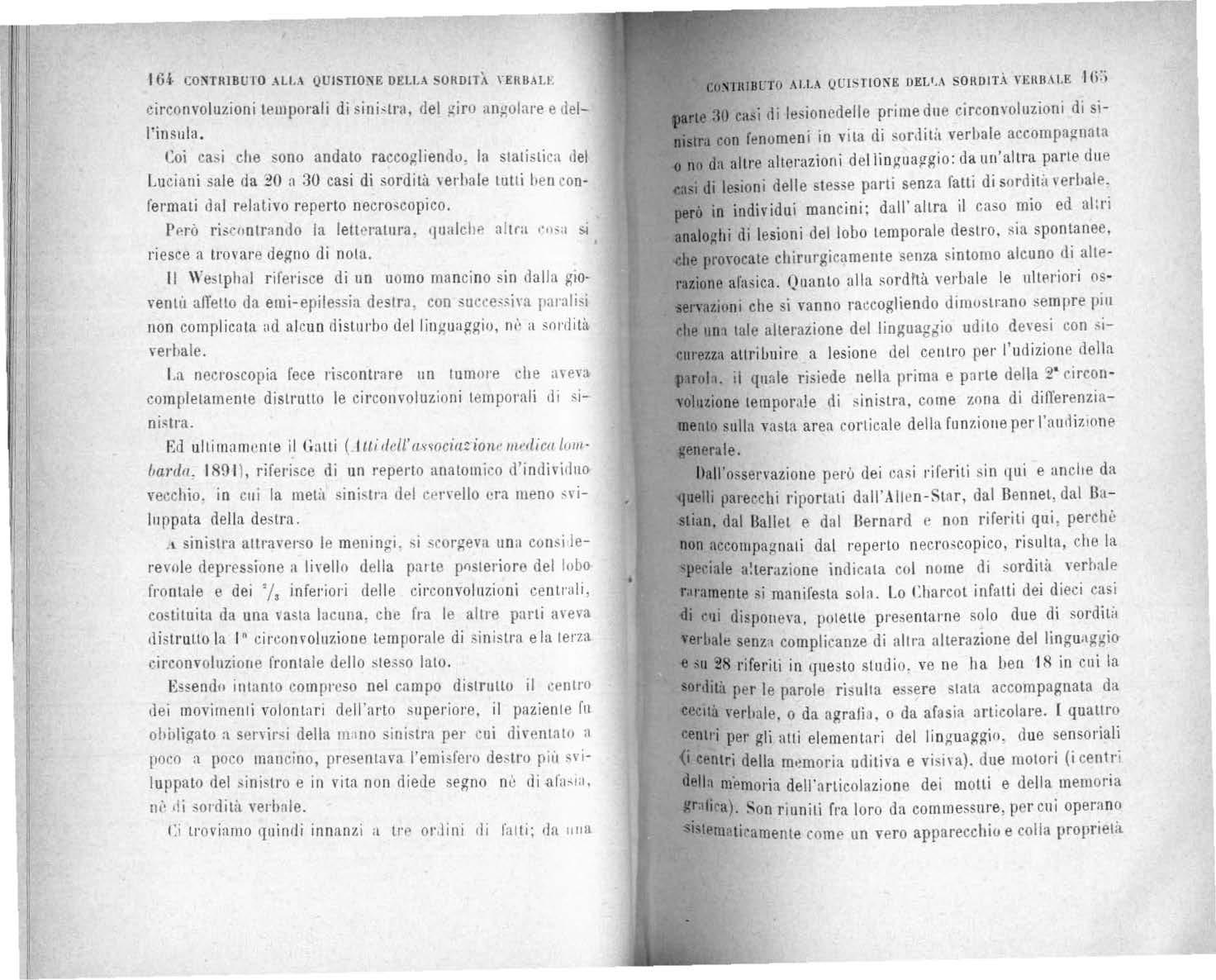
Gatti le lesioni , abbenchè vaste del tolto temporal e :;i111:\li'O non dovevano dar alcuna alterazione rlel linuua •,••iu n 'n,., ' in quet:li individui solo perchè ma ncim. preminente l'emisfero destro sol sinistro, scaturisce inoltre chiaro il funzionale del loho tempora le de:;tro. 11 yuale va t'ttenuto so lo potenzialmenle egua le nl s inhmo nel sno- eòmpilu funzion ale (' potere potenziale diventa reale oei manrini . Le le:;ioni quindi di esso solo in tal caso potranno a,·erP lo stesso ;:ignilicaLCJ che hanno nei destri mani le analoghe lesioni del lobo tempomle si nistro. che in ca o ro ntrnri•l, come in q nello descritlo ùa me, mnnr.herit ogni altt>razione ri ferì Ili le al l' arasin :;enc;nriale o -;o rd iti1 verLale. t.,so 'i n'i cnYt.:'E 01 FERITA n' · ELt: t un 11 Santin1 pra di medi ucrP co-,tituzione, p.u uo,to denulnlu. pallido, in preda a w-and e agitazione e depre!\sio n c morale. Dopo aver l' nntise1"1 dt t•tllo l'arto. esami n.•i la lesione.
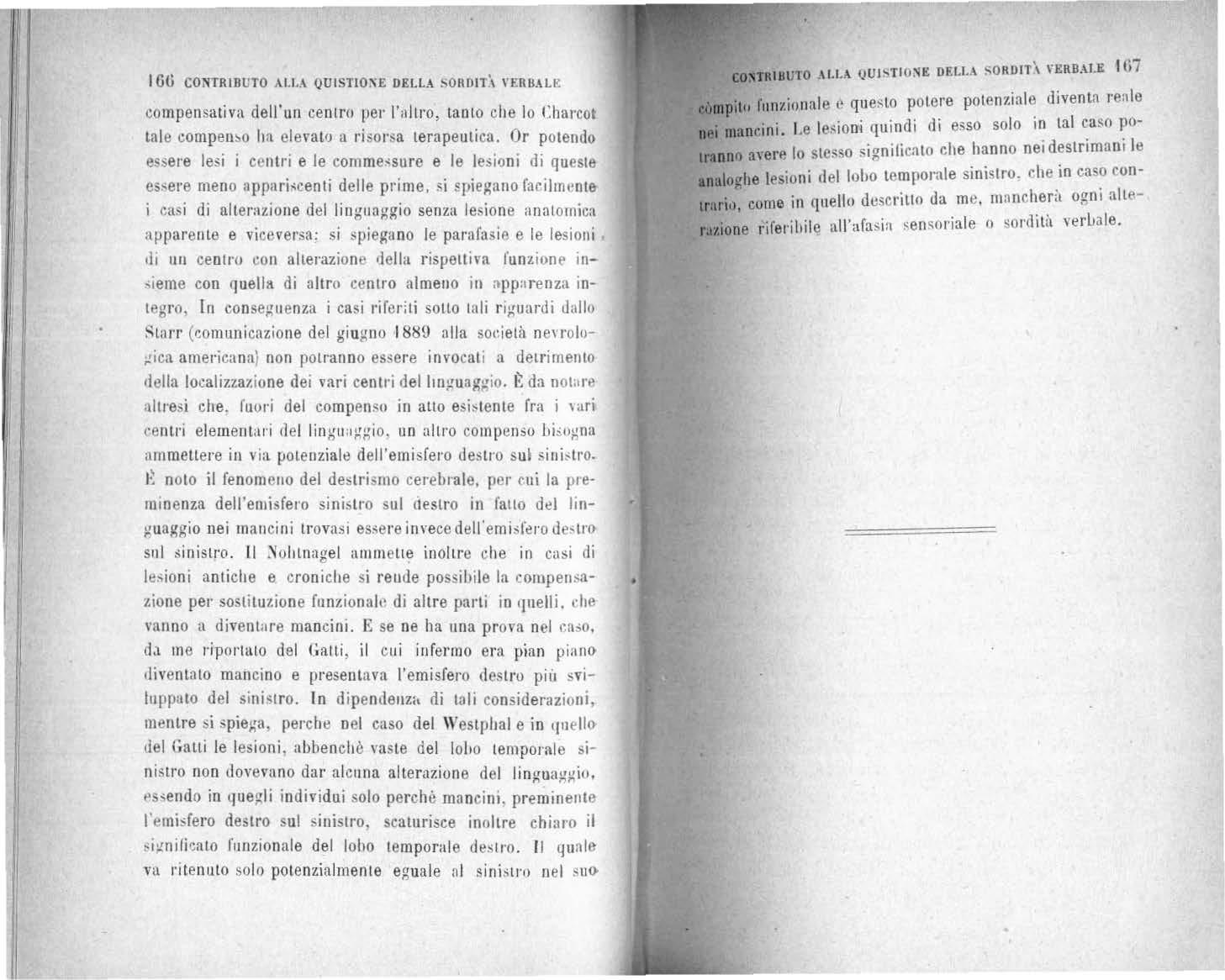
Un Caso Non Comune
CARlCA'J'O <,\RTCCCL\. A A
ConlllnÌI"<Utont• d ••l cap1tnno med1cu r •. B e rnardo, letta IIP.IIu rotlft•r••nza sclo11ti0ca nell'owetla!e militare pnncirtale rlt Bologna 11 u rticl'mhrr
San lini n el l O fa nter1 a della cla:-.se l R!io (ricl1iamatol, prende' a parte alla ese rcitazio ne di co mbattimento il agosto scorso . Per orrore. e;.:ll ed il suo , ·icino eli liln, una cari iiCI'ia a nei loro fuci li , ed eutrambi. co ll' arma t·ar·ica. sedettero so pra un mucchio di ghiaia durante un intervallo di riposo. La bocca del fuci le del compagno toccava la ;.(amha si nis tra del Sanlini: iu uu mome nto, non s1 :;a per colpa di chi, dal s utltletlu schioppu partr un colpo; il nominato solda1 o fu rovescialo e :.; i ma nifestò s uhito un ' abho rHiante emorTagia. chl' fu arrestata da un ufliciale, Il quale 'triose forte ment e un fazzole11o 1ntorrw alla coscia ferita . li capitano medi co dott. De· Robe rto accor:-e. medicò prO\ visoname n te il d!sg raziato. rhe fu tosto tras portato alla ,ezio n e di sa nita da mn coma ndata .
Nel quinto superior·e della l'accia della r:amba sinlnistra. nello ... pazi o n l ti centimetri sullo la t e-t1 del perouc, s i notav n 1111 nrilizio rotondo del diametro di cenlimelri l e' . a hord1 irregolari, t:ontu.;! . con lieve gr.nio di astione. Premendo sopra i eontorni della fer1ta venne fuori an:t notevole quanlil a di ).!rllllli di san!!ue. di detrito muscolare e di framm ent i ò1 ,top pa e gi a''erti,·a nella parte stanle un \' Uotn dell'ampi ezza di uua melu di medioc re !!'ra rldexza: evidPnlem ente le p1rt1 molli souocutanee. t•,i:;tenti fra le tlue os.;;a, 111 quel punto era no ' L'olio il fazzoletto eol quale era stata fatta l'emostasi a. dalla ferita <;angtw d1 color ros.; u vivo, in abbo ndanza. in fretla e "enza getto: l'emorragia si ar rcst:wa co l rinnonre 1'
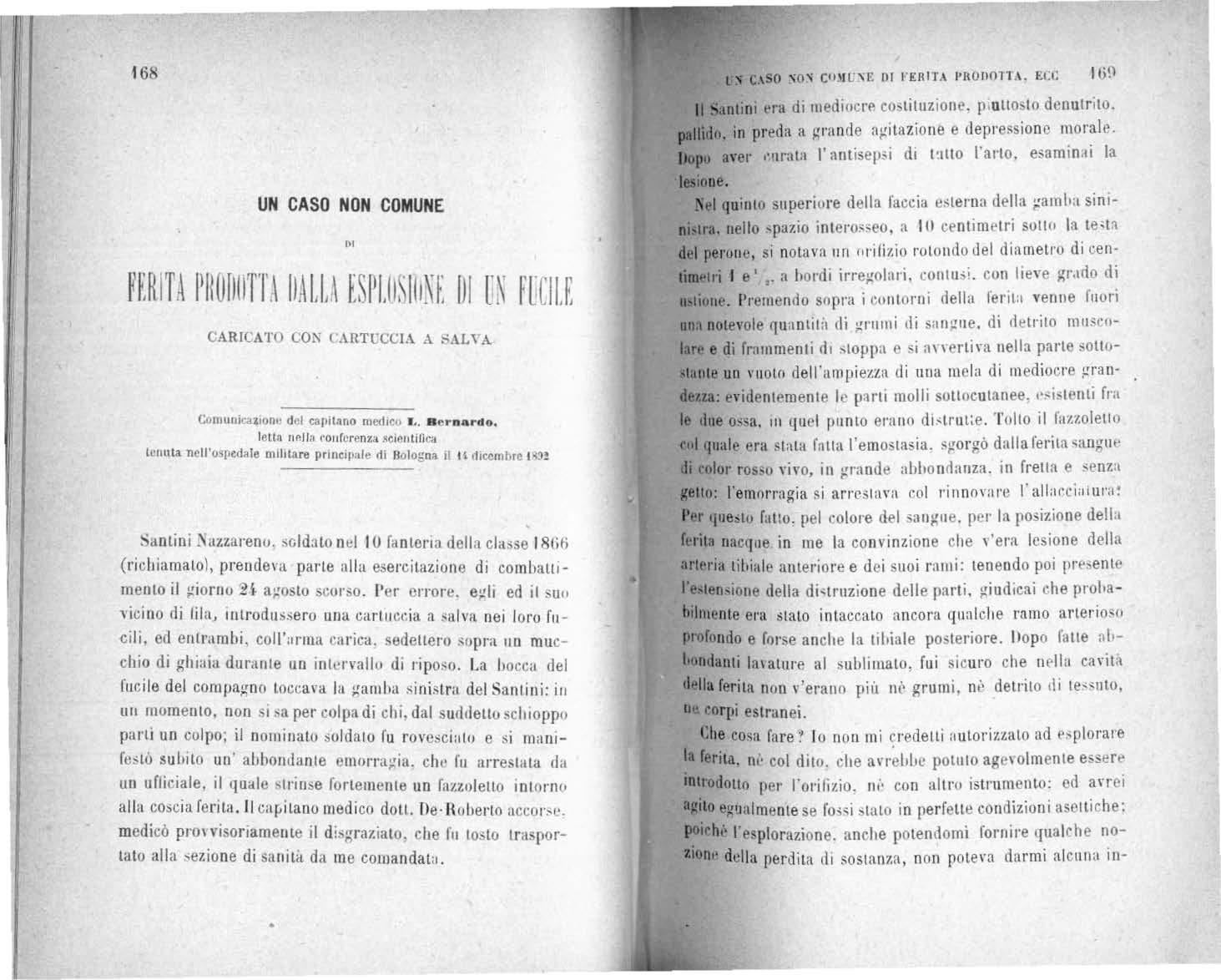
Per fallo. pel •·olore ùel 1wr la posizio ne della ferita na cqtl e in me la co n vinzione che ''em lesione della aNeria tiltial e anter·iore e dei suoi rami: ten end o poi della di-;truziooe delle parti . giudtcai che proltabilmente era stato intaccato ancora qual che ramo arterioso profondo e ft>r '. e anche la tihiale po,teriore. Ilopo falle abbondanti la\ ature al sublimato, fui sicuro che nt> Ila ca ,·ita della ferila non v'eran o più ni• grumi, ne detrito di Dii corpi estranei.
Che cosa fare ? l u non mi nedelli auloriualo ad p.;plorare la ferita. ui· col dil u. d1e potnlo age,olmenle essert' introdotto per l'orifizio. n\· co n alt ro istnunenlo: cd avre1 agito eJ.Piltlmente se fo .;.; i stato in perfette condizioni asNtiche; poichi• l'espl orazione . anche potendomi fomi1·e qualrhe nozion t• della p&rdita 1ii sostanza, non poteva darmi alcuna in- dicazione circa-il da nppre,.,tnre al momento: (avP. \n gi:'1 accertato che le o::sa non errlll o fra ltU I'Ole) . lo creclettì elle fosse impossìhilt> di allacr.iare in sito i \'l'i sangui nanti, per t'a ngustia dello spazio interosseo in alto, e pc·r la pmhahìlitil di dover legare od il tronco p1·incipale ùella tihiale. o la femorale nel suo quarto inferiore.
Snpeodo co me in casi consi mili l'emo rragia sì a1'1'esti so lo con una adalla compressione, mi decisi nri applicare no tampone. Colle compresse di garza antisettica, prnna ìmruer,;e 10 una soluzio ne dì suh limato e poi coperte di poco iodoform ìo, mi rìusl'i eli riempire la cavìtù della ferita; fe ci qui nd i un a f;l. sctal ura romp r essin1. to lsi il fazzolello costri t tore de ll'atto; l'emorragia non ·i riprodusse e poi l'infermo venne lra!'pnrtato civile di Lugo.
Colit. die t1·o mia insiste nza, la ferila venne riesa minata «' la\ata di n uovo, e si vide che sgorgava s;:ogue di color sr.uro e non ve rm ig li o come io pr·ima ave vo scorto. Solo a "copo diagnostico, per valutare l'esteozionP della perdita di sos tanza, co n un o sp ecillo di vetro :-;teri lìzzato, vPnne accertato rlte, olt re al la distruzio ne delle parti molli, v'era lacerat.ione dell'apone urosi profonda e scopertUI'<I della tibia e del pc rone . Essen do di min uita la quant it il di sang ue rhe usciva clalla ferita e per,ister.ùo in qtwstf) il colore rosso·srnro. s1 rredè clt e assieme ai tess u ti molli lesi vi fos;;e lesio ne delle vene . A ness uno ri uscì st• ntire il polso della prdidia; però l'a r to colpito era meno caldo dell';d t ro. i decise di aspeltare gl i even ti: la fe rita ve nne occ lusa co n medica tura !'te rili zzatn al calore, dopo avervi introdotto poca ga rza all'iocioformio a scopo di dre naggio.
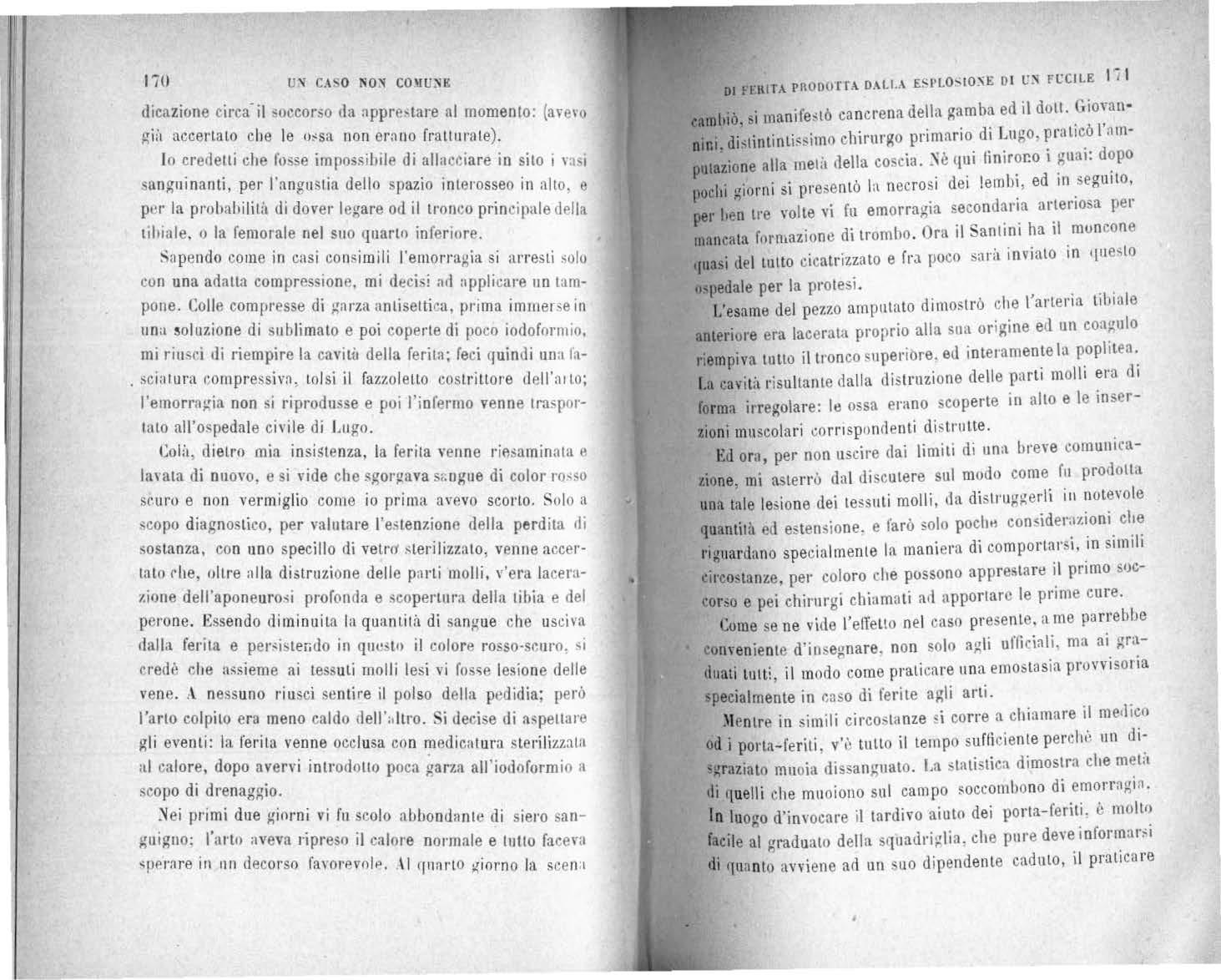
:-i ei prim i due giomi vi fn srolo abbonùnnte di siero :;anguigno: l'arto aveva ripr·eso il calore normale e tutto fareva SJlf' l'nre in nn decorso fa, ot·PvoiP. \l cpnH·to giomo la eamhiò, mani fe,-tò ca ncrena della. gamba ed il doli.
DIGI chi r urgo primario di Lugo. l amall a meta llella coscia. :'\è 'lui l pochi si prese ntò la nccrosi dei ed lO _seguitO, per lteo tre volte ,.i fu emorragia ar.tei'IOsa per mancata furmazione di trornho. Ora Il SantiDl ha Il moncone (luasi del tutto cica trizzato e fra poco saril in viato in o pedale per la protesi . .
L'esame del pezzo amputato dimostrò che l'artena tilHale anteriore era lacerata proprio alla -;ua origine ed un riempiva tutto il tronco ed p_oplitea: La cavi tiLris ul tante dalla dis tr uzione delle par LI mollt era tlt forma irregolare: le ossa erano in alto e le inserzioni mu scol ari comspo nclenti .
Ed ora, per non uscire dai limiti di nOi\ hre• e comuulrnzione, mi aste rr ò da l discutere sul modo come fu prodolla una tale dei tessuti molli, da dist ruggerli in notevo le quantit (LPd estensione. e farò solo pochti con$iderazioni elle · d' ompoi'tat"i io simi li r ig uardan o specialmente la ma n1 e1·a 1 c , :. • per coloro che possono appresta r l:l i_l primo s•>Ccorso e pei chirurgi chiamati ad apporlarc le pnme cure.
Come ne vide l'eiTe t to ne l caso presente. a mc pa rreh!Je con•en ien te d'iusej:(nare. non solo agli ufltriali. ma ai_ dua ti tutti , il modo come praticare una emostasia provvlSO JI3. specialmente in r.nso di ferite agli arti.
)l entre in simili circostanze co r re a. chiamare il me•lico od i porta- re r iti , v't'• tutto il tempo suffic·iente perchi• u n sgraziato muoia dissanguato. La dimost ra elle meta di •tuelli che mu oiono su l campo !'Occombo no di cmorrngia. In luogo d'i n, ocare il tardivo aiuto dei è faci le al grad uato della che pure deve di <(u nn to avviene ad un suo dipendente cad uto, il prattcore l'emo5 1n sia pro' ,.;,o ria coll'allacriatura dell'arto med ia ntP un semp lice hzzolello . Certnm enlc che ro.- ì non si salverehltl•ro lutti coloro che offrono ferite del !i i,tema nscolare (poirlli· i :.ti grossi va ;;t non danno quasi tempo nlsoct'orso) . ma wduhhtarnenle \' 1 s, trehhe nn minor· num ero di ade.;so poi coll'u,o del fucile a p ic•·olo calibro. an che prevedPmlo 1111 au ment o delle emor•·agie per la ;;;t 1 ettezza del tra).:Ìllo della ferita. nn-i en e mf'no rapidam ente e la compressio ne ,·in ce facilmente dl'lle emoranrh e di tron c. hi importanti. di ce da molti che se i graduati. duraute il fuoco. si occupa,.ser·o dei feriti. avrchhe disordine nelle file e la fila n· Lropia ma schererebbe la pusillauimità di paren:lti, i quali eviterehll et'o è i comhalte t·e colla di soccorrere il compagno. modo di vrder·e non ha :;erio valore: è ben diffi cile un. ::o ld alo. non ventra :;occorso dai compagni v1 c1 nt: del dtsonltue "e ne se mpre: non (• megli o for ;;e che r ir.evn un co nv en ienle aiuto da un gradua to pr ima htru1to . ::tll7. 1Cill' da soldati tgncm•nti t \l a. r·ipeto. qui non :;t tralla d'in segnare ai graduati tutta la tecni ca dei primi :>oct•orsi, ma so lo q uella C'lte rignarJa l'emostasia provvisoria: in termini il graduato dovrebbe soccorre re il ferito, quando s at·corgessl' che qtJ es Li perde poirht' ,., ri.;aputo che ferile d'ar ma da fuoco. le quali non intet·ess an o v:.l si importan t i. generalme nt<· non danno sang tte. :-i creda che, per il ;.!ran numero d i feriti. i quali emonagie. molti grad uali sat·el.Jit et·o tolt i dal coml1allere . La -.lall slica delle d1· g uet·re che le ferite dei vasi delle ( le so le. forse . che do' rehlle t·o a rt·e-.tare i detti grad uati ), sono al la media del 3 o o d ei feriti tttlti { l ). Il nu mero tlei
• l ll Il calcolo ritato sì t'lfe rt ice alle Jlll''ato• ::uerre: fQr'e in :n,enari' rul· l tleì morterni ful'ili n piccot n t" tlihro, pl 11 clc\ll ta In nwrlic. ',J,•IIc dd \iiSÌ ol••e!l j ·trh colpiti di 1111 re'.!gtm emo romhaUP nle puil o,cillare fra i 100 1 gli 800 : 'i .;arelll1ero arlutHiue da :i a ferile tli Mterie periferi che: turn erebue di gra n danJIO che allreua nti J!ratluati si disto!.!li e>sero per pochi 11111111ti e façessero un 'ada tta co mpre.;slont> arre:;ta ntlu l'emor raJ.(ia ...:011 melzi \ me pare tÌI no: del resto parPI'Chi chirurghi pensano allo modo. e I' Es march voleva tlare una hertella elastira eh emo·la,ia ad ol.!ni caporale. l' t> t' lo la ,;mania di fu re la ù tng no:>i c.;atta delle le:;ioni , untle tle ·cr'IV erle c.oo spinge,·a. il chi rur go a e rif rngare uelle fertte. \ un oceorre dire quanti dann i ahbia appnrlalll pt·atit'.t. Inutile qnt"'-1 ,emprè .
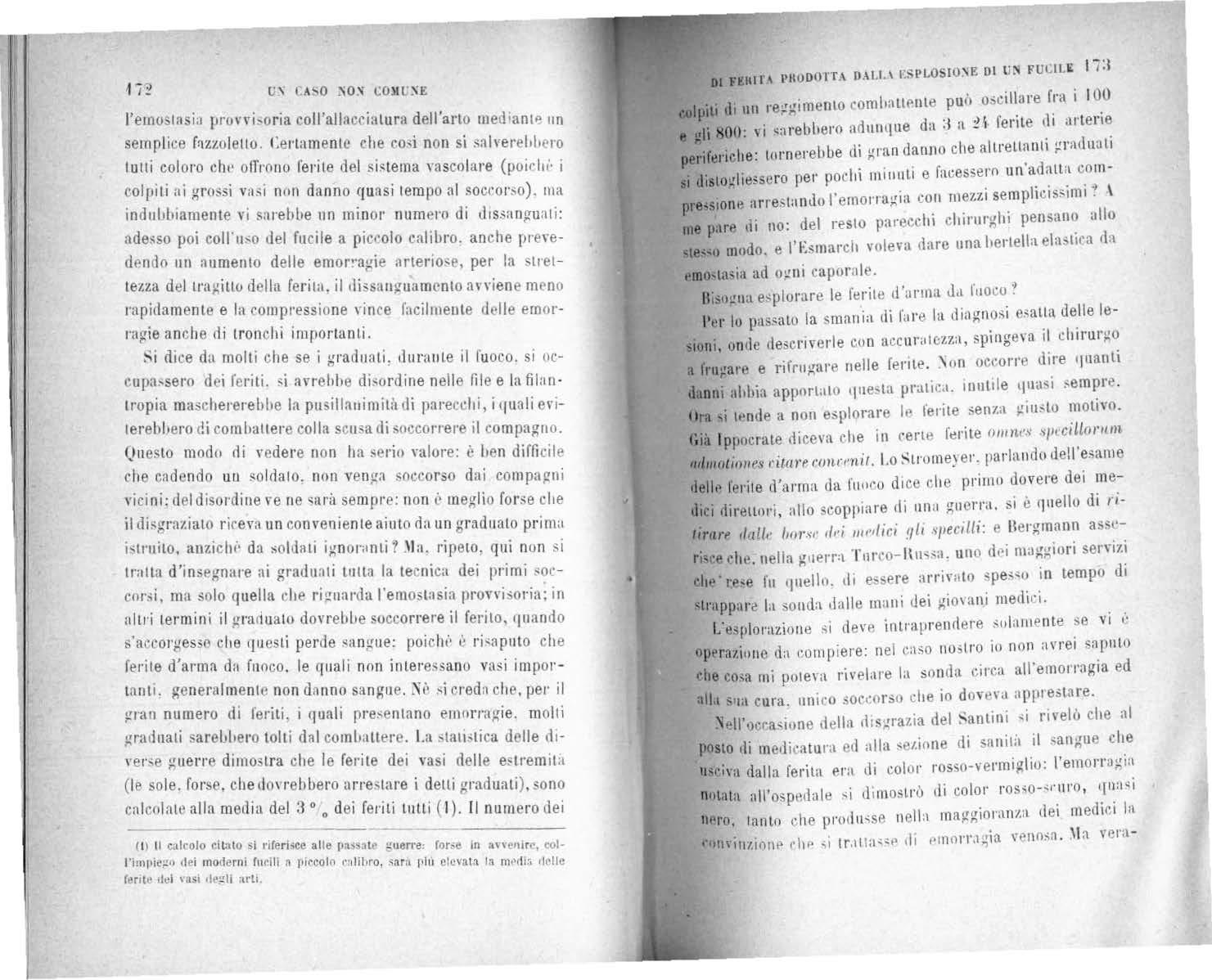
8iSII'.!IHI \e ferile Ù'al'llltl J,l fuOt:O?
Ura ,j tttnd e a non esplot·are lt• ferile senza motivo. fìià l ppocrate diceva t• he in t 61'lt> ferite otuws cillontm t' Ì/111'1' f'mtrmit. Lo pa rla udo tlel l'e:>ame tlellt> fet ·ite d'arma da lunro d1ce r ll e primo dovere dei medi ci •lirettor i, nllo st.:oppiare di 1111 <1 gue rra. si quell o di ri · lircuP ,t,,l/t· lmr·s, · rf,•i tu, •tl ici !flt e Uergmann as:wgnerr:\ un o do•i nwggio ri servizi ch" · rP•e fu quel\ n. d i arrirnto in tempo ùi lot sonùa dal le mani dei gio,ani rnedi··i.
L'esplorazione .;i deve intmprendere ,;e vi ,·. opt>rat.ÌIIII <' tb rom piere: nel (':\SO io non a Hai rhe cosa mi po1era rivel.•re la sonda cin·,a all'emorragia ed al1.1 :;•1a cura. nniro :>OC1:01'sn che io dowHI appt e5Lare. ..ll' oet·a-.iune tlella del Santini -.i r1reliJ cht> al posto •li etl alla .;f't.ione rli ;;,nnitit il .-angue che us,·ira tlall a ferita era lli coltll' rosso-vermiglio: nntata nll 'ospmlale ,..i di co lor ro s·;o-"r' UI'O, nl'ro. ta nto che nell a tOa;.!gioranz;t dei 111edil'i In dtP ,, oli o•mnrr.qia \'t>nosa . 'la vrm - men1e il colore del sangue ri ;con tralo a ll' ospedale era multo pril cupo di rJnello che abitualm en te il venos '· tale alterazione crom 1ti ca si deh!ta allril 111 re ali 10doform10 spar·sn in auhondanza nella ferila c nell e rompr·esse de l lampone. lo mi perrnetto rile\i1re un tal fnltu
P 'rchè in potrPhlte di1J·,i un caso consimile e drlerun certo imbarazzo flre non soccorrano altri da1 1 per la natur·a dell'l•morragia.
Come si manifestò lo cancrena '1
. È ehe nell 'a llacciatura dt!lla poplitea. il circolo , 1 l'l:itablltsce mediante r arteria articolare superliriale (ramp della femor·nle) la quale sbocra nella rete ar'liro lare. in cui m:ue rapo l'estrema dir 11uazione della della t1hi1, prrmo ramo dell<l tihiale anteriore: on ero dirattamente per· mezzo delle arlerie ar1icolari e la r ico rrente: od nnche, più rarnmenle. per mezzo del ramo della circonlh>s, 1 estema. la rete articolare e la ricr1rreu1e. i\el no;;tro ca,0 la tibiale era distrullu in cJuel trauo rhe co mpren 1lt· fil sna. e la dir·amazione del/n ricorTt'Dte: il sangu e del Cll'colo periferico non avreltl•e ma 1 potuto imito. _ f'ar.e ''. dei!J riltiale anteriore: ed il trombo che dnll'.ll·lt•rnl LrbJale estende,·a si nu a 11111 a fa poplitea c:;L inse totalmentt• il circolo del !'angue. E1'..t inP\ itahile la rancren 1 : t!t'l l't'.'tn, i." condizioni fav orHoli nell'alhcciatura della }1 11· e lri11aiJ. l.a morte dell'arto i· per la diflic·olt i.' ad int•' {fl'lllll del ci rcolo per me1.zo dJ ramr r'osJ p1crnli.
La canaena 'i nnnifestò solo ,tf 'Jnnrlo giorno perch(· il lroml w poco a poco la poplitt>a e la Cl rcolazrune st estinse gr;ldottamente.
Le emorragie secon iarie per m:lllcata lurmazionp cii lromltJ che ,·erificar·on · · · 0 111 s1 dt>bh ono
DI t'ERI T.\ PRO !lOTTA D \I.T.A DI UN' FuCILE ti :S alla denutrizion e e deb olezza generale del Saotin i: nè dovette essere una profonda depre:.sione morale. cau·ata in lei dalpetBiero di poter morire e moglie nella piit miser·ia essa era stata sposa to. !iOio col rito reli;.:io·w). Il PirogofT h:1 notato che le emorr·agie secondarie per mancanza di avvengono facilmente indi,·itfn, indeboliti e negli anemici.
Era rnnicata l'amputazione l a diminuita. ma non indicava elle lacir·tolnlJOne si f.tceva. fJttanlnnque stenlalamenle, e !\i poteva sperare in ltna suffi cien te pr·ogt·essi,,a irrigazione
Del resto si era sempre in tempo ad amputat·e al primo indizio di estinzi one del circolo: non si credeue perciò necessaria l'amputazione primari:t e tullo un lale procedimento; pu1· tro ppo il consecutivo non <'onfermò le che si erano formaLe in principio.
Il Cibo che 'i ho narnllo. f'}!rcgi •;ollcghi. non t- sen1.a importanza, e lot sto ri o della to cca ta al San tini (i l'or:;c moltu p'ù tslrutlh•n rli molti trio nfi clte racroutnre.
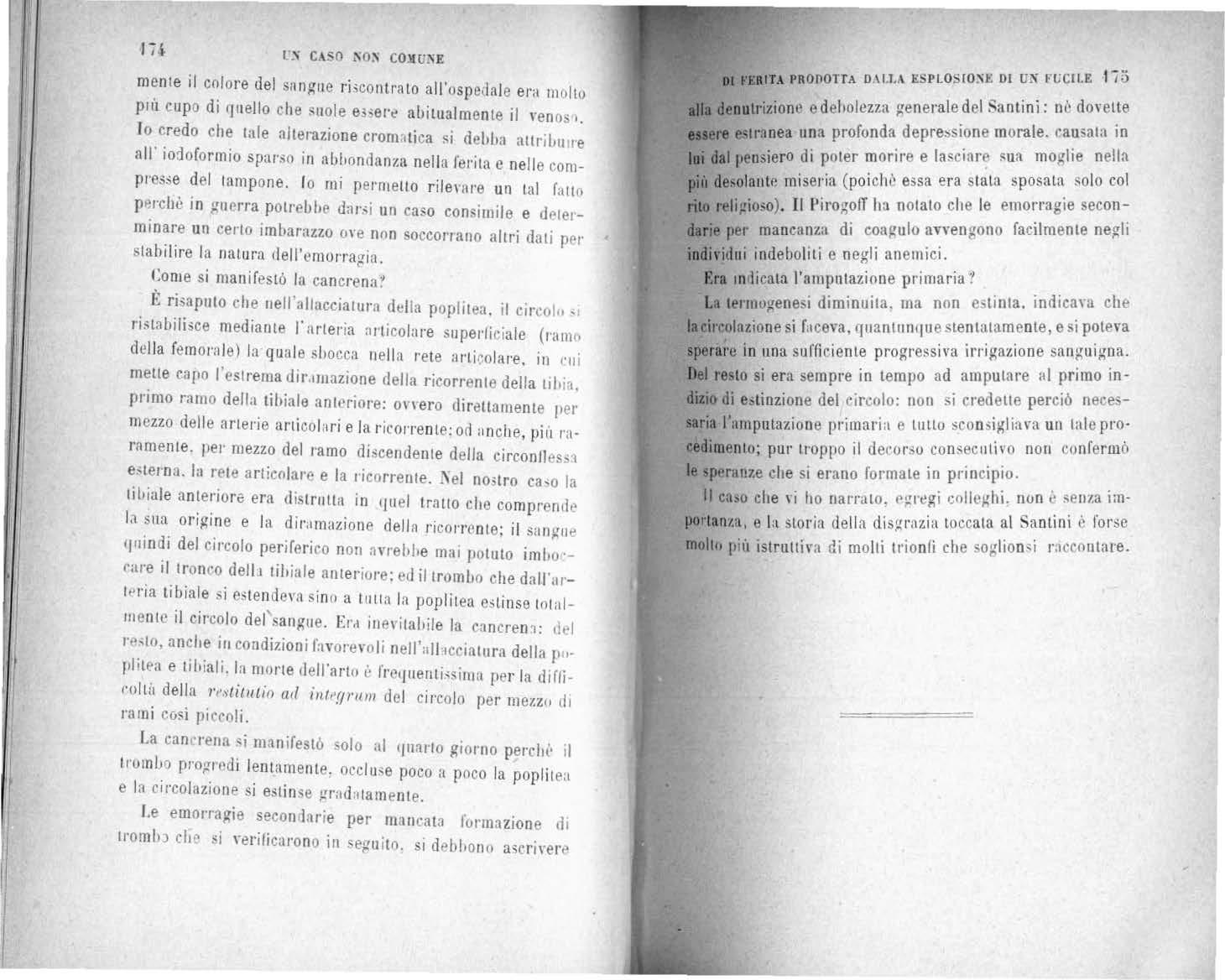
SCIENTIFICA KR[SK-PASQUHL PER LO STliDIO
UE LIJ\ DJSSENTE IU OEPATI CO IN BCITTO
Rd;o/.100" pro>lirninare tlo•l ololt. A te a n dro Mo><ltco ·Il t • d. R. Ya.rma, Pr nr. r..::.• r l:tiPne nPIIJ n l'ru•. rlr :'1 1oh possibile tl.u·e nn l'<tppurlo parLkobtreg!! i.Hn "ulla t·ennala spt>diz10ne. mi limlle r t'l tJIII appre.,.:o arl .;nr'cinlamentc il mrHio ,·ome fu organiaata. in .·om•nl'iando dallr sue origini. lr t'il·roslanze in cui $i ell"t>tlul} il e i risnlt.a l. i pii• impo•·rnn li dw cliede .
È nopo innanzi lrJltori iPvan•. dtel'iniziat i' n de ll'intrapresa fu tull'all";lllu pri1·ata. e ·II'IPsi ari nn r·umulo ùi rirco:>tanzP r tl'ore' oli se poti• "''et· portata <ttl eiTt•llo. e '"' i ri,ultatt della t'oni,po,ern in co> r to qual 111orlu al piano pre.:lahiltlo. l. 'r:;se r mi ll OI' uto io w t·upnn' lin da l IHH!) di'I li o stutlio etio louir•u c clinit:o de ll e lllnlallie l'ehhrili dominanti a \ la.;saHn I l ) mi ref' e il •lf•stderill òi studiare anche pill
Il v. i l! n••• l;n·ur i: ,\ ota Jll'er·rtthNI (tbbri d• lf•H•'""'· ne l medico •lei Il ru.-cilo e Ile/La Il. mm·i11a, " l'altro: .St1H11 Jtr••;r u :a d t larct
•li dillrn llt'll'intc.itiiiO di lllctmi (cbtn •icilall li a rtl'l fìi•Jrtaul• irttn·· t/l'Ilo• uio n;e ruutn \Il i , li•' ili pa 111i . secondo Mdi ni rice1 llli. il l sette mitre I S!lO: l i ) V. 1 m t••J la•orr: Studio thot gico Hlitlic<l tltllt malallit JIIU m,.,'' lffU "t ua, t• l'.tllro: 'ul b{u n fiamma · studio cliluco ed ossrr11a;iQni IIGittriolog l cl• c, rll'l Giornale nttà ic u del Il eurcilo t dell11 Il mrn•ifW, l t\91. (l ) V Il min lal'oro: /licerclte b!lllerlologlrhe sttt colera a .1/aunow e corm· dtra: 1 1onf ay iPIIiclle, 111•1lo fì ionwle, :! e lo b1tteriolo,zico accurato che ne feci. lrattando:;i eli un caso \'erarnente :-ono snrcintaruentr nferiiJ nrl mio ultin1o lavoro sug li Strcptorocr.hi (1).
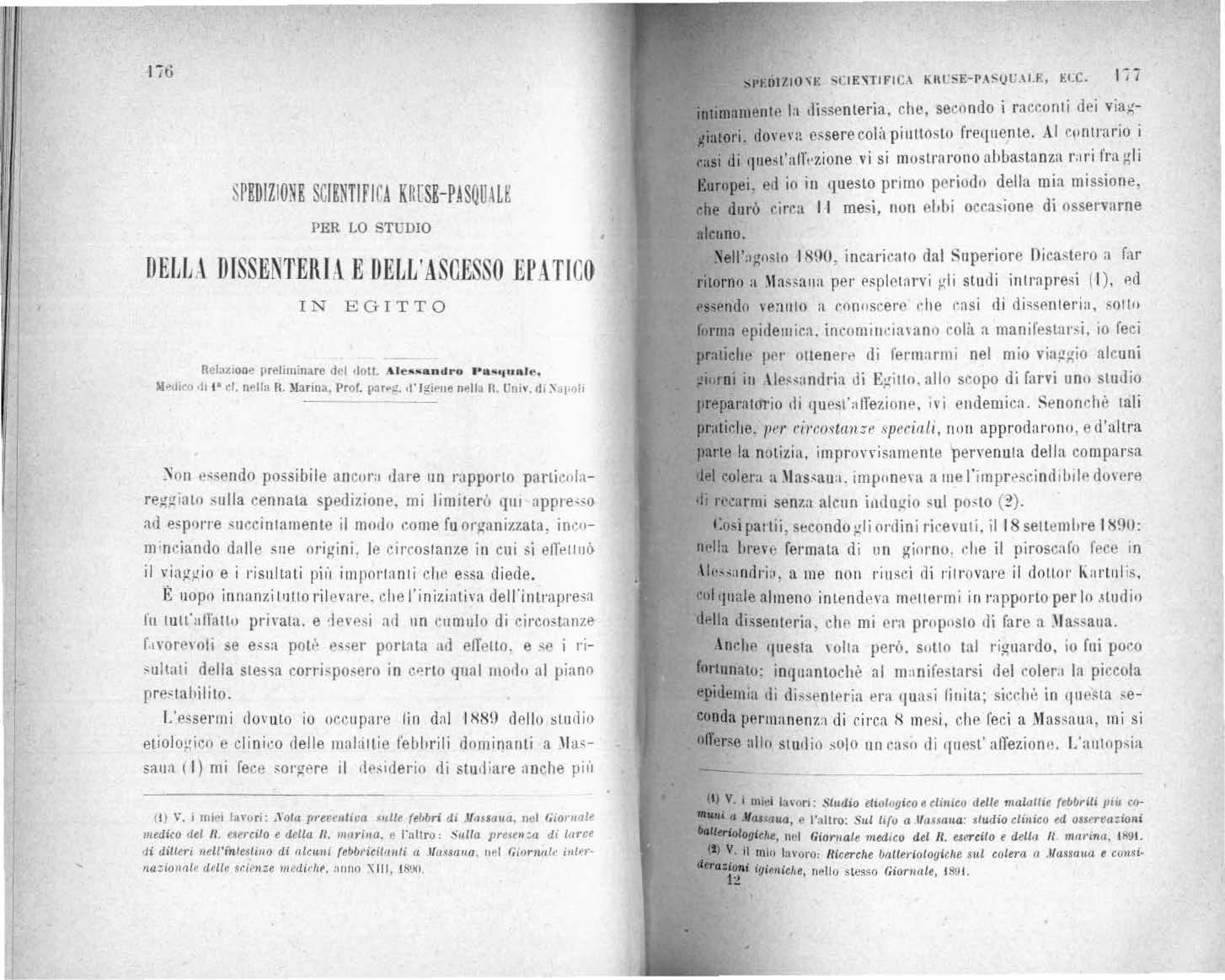
'ol.I E'ìTI FIC.\ 1\ lll 1-:t.C. 1";/ intimaltll' ll lr h i rac.c.onl i t! ei l(iatori . dovl'l' 1 \ r:; sere colli freq ue nto. Al rpn tra ri o i rasi di qu e..;t'all't·zione vi si mostra r ono nhoasto nza ,.,, ,.i fra gli Europei. et! io in questo pruno pN iodu della mia missione, r he dnr ò ri rra I l mesi, 110 11 di osservarne alettno . l X!lO . incaricalo dal Superiore Oica·Mro a far ritorno a \ln:'>rlll a per r:-pll'l:Jrvi gli st uùi in trapresi ( l ), Pd ve:111 10 a ('Ml ost·err l'ht> t•nsi d i .;oll" lur mn epitlen11r:1. incomin cia1ano t•o lit a 10 fe ci praticlt .. pt•t· one nt>r... eli fermarmi nel mio alruni ,w. rn i 111 \ lt>,.:a nù1·in ùi Egilln . allo sropo di farvi unn stullio preparalol·io tl 1 queilì'alreziotH', ''i enùemit'a. Se nonrhè lali prali r he. JWI' nun a pprodn r ono. c d'a lt ra parte la notizi a, imp r orr isamP nle lJen' e nu la de ll a co mpa rsa 1..1 r:olera a ) Jas.; au :t. unpn nera n ntt> l'impr<'scindtlttiP dnH'I'S •lt n •.:a r·n11 se nza alcun itlÙu!.(io .;ul po,to ( ?) .
1\l•llit hre 1·c· fe t·mata di un gitll'no. d 1e il piroseafo fpcc 10 a me non r iusd tl i ril l'ovare il dollCJ I' I\ HI'Lul s, •·ul aJtt ale alme no inte nde ' a nwl term i in rapp orto pe r lo .1L11Ò io !l.. lla ùissent r ri a, dlf' mi rra prnposlo tli far e a \ l as:;aua. \ nrltr qu esla 'olia però. solto tal riguardo, io fui pOt' O fclrlnn :tlo : inqna ntochè al ma nifestnrsi ùel t•olet.,, la pircola epide n11a tl i e ra tjUihi linita; sio·hì• in ,;econda di circa H chr fec i a mi s i allo st utl iu :.lllll nn t':t:->o di tftH'sL' aiTezionl'. L':tnlop:-.in.
Co<i la cose. ed io :n·rra quasi perduto ogni r·aoza di poter alluarr il mio propon11nento, qnaod•1 nel ln;.:lio 189 1 fui dal dottor Kr·nsP.allorn Capo della M'ZJnne hatterio!ogira della :;tat.ione zoologica d1 :\ apoll , do' 'io lavorava. per conoscerr quan lo e dove in Egi11o putes,..e esseni la migliore occasione per· attuare 1111o stud;o sulla dissenteria e .;ull'a,-r.esso epatico. Le notizie ricliieslemi mi furono gPntilmente fornile dall'egrPgio amiro
"collega dollor Torella . rlele;.:ato italiano al con:>ig lio tfnaran· tunario internazional,.. di .\l e,-;andria; per mezzo suo fu mollo esibilo al douor 1\ ruse, come laboratorio di la· YOt'IJ. l' Osprdalr 91't•co di Alt·ssa ndri a. che. a suo te mpu. fu ulilizzato anrhe dalla rommissJO ne tedesra inviata pt'r In gtudio del colera, la guida di Rohr,rto Koch.
Però \'Olle il ca:;o ('he. all'epoca più opportuna in tpwll'anno per lo -.tudio della dissenteria e clrll'ascesso epatico 111
Egillo , il dottor Kruse fosse occupato in altri lavori , che piu tarcli vid ero la In re, i quali l'ohhli;wrono a rimettere a tPmpo il pntgellalo ' iar!gio. Que,to differimenlo mi ofTn t'n,·· casinnr, per mo mo llo favorevole, di un irmi a lu i nella suaccennala ,;pedizio ne. E ciò io feci ueo \Oie n tieri. in qunutu che il dewleno. che anch'io da lungo tempo ili s1 11 diare più inLimamenle la e l'asc esso epatiru dl•i climi caldi, ::.i an :a\a finalmente ad una pratica auna zione. Dal )J inislero ili ma n na olle nn i l' aulorizzazìool' th ncarmi in .\ lessandri a d' E;.:illo per farvi questo :;t udio e di r•maoeni anche oltre la durala della mia licenza ord inarin: però le che per mi ;l part e ammonlurono a ci rca L. · 1600 , dovettero essere sopportate pe rsonalmen te da me. Pe 1· alt ro, deb bo 'Jni aggiungere. che, in rigu:u·,io all'ohhie uivo della nostra spedizion t>, non potevano coincidere condizioni piu f&Jort>r oli. 'pecialmenl e pel fallo che, come ho dello, il dollo r lrnse giil da parecchio, occupandosi dei prolozoi patogeni ( l ). andava prep:-trandosi per qnPslo :audio, ed aven un piano già (JUa.,j e, come Capo dell.aboratorw della SLaz inne zoologrca di :'iapoli, era r iuscilo ad olteoere le tna;:l(iori a;.revolazioni.
PE R 1.0 STUDIO OEI.I.A ECC.
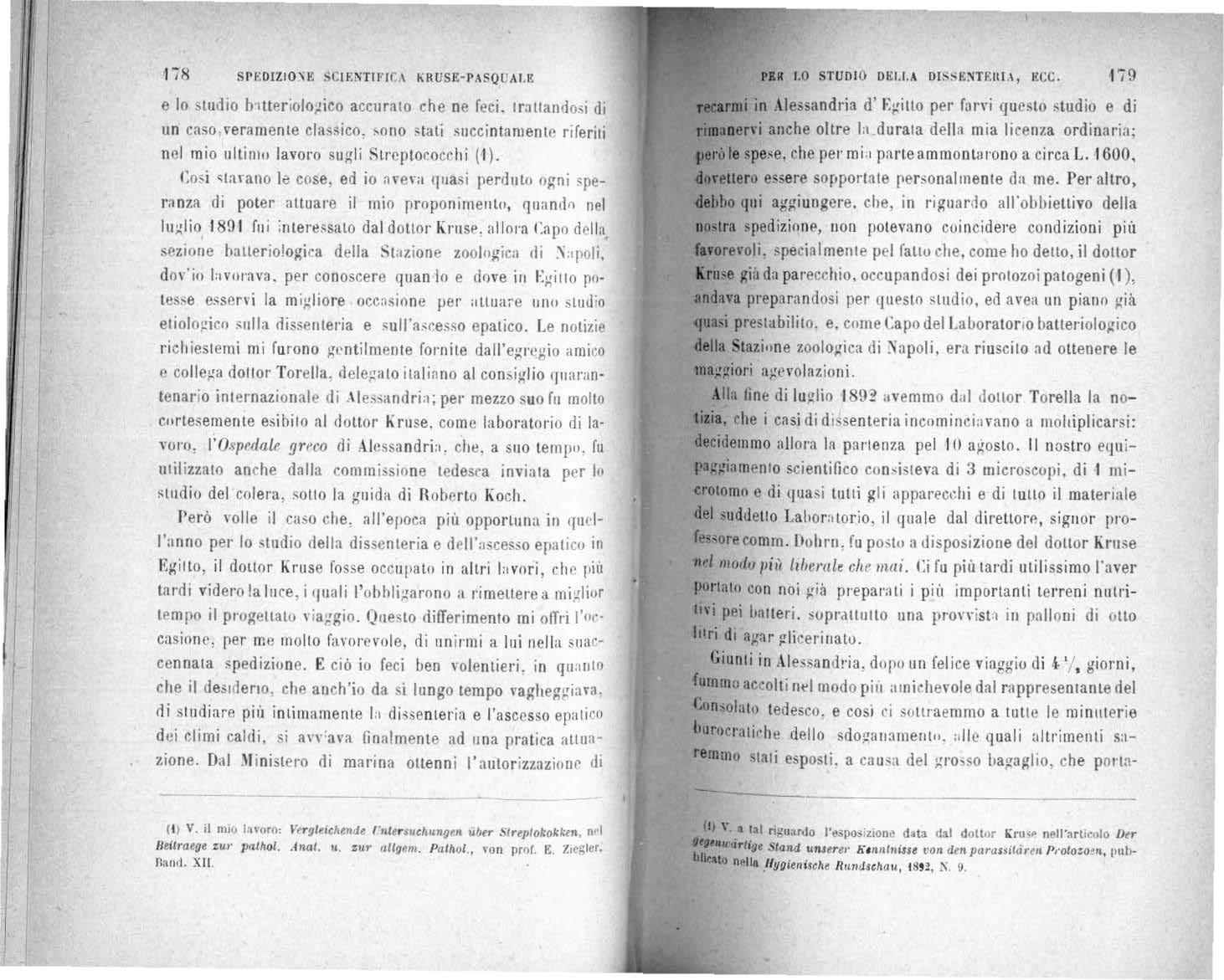
( Il V. il mìu f;l\'fJrll: f"nlr r .mchungm ubtr Slrtplokokktn , n l Beilraeqe zut· pnlho!. Atlal. "· zur tlli(Jr.m. Palhvl., ,on pror. E z,c::;ler. lland. Xli vamo cou noi. Anche co t·di alissima e premurosa fu l'ac,·oche n cerammo dal dottor 'l'Mella, cosicchè. senza sottostare ad alcuna noia. potemmo. sbarcando. andar·e stabilmente ad occupare l'allo)Zgio , già per noi. il quale era posto silo che più conveniva a l noslt'O scopo. Dall' egregio collega fummo poi inLro<loLti lo ).!iorno nell'ospedale greco, il direllore del I[Ua le, sil{IIOr dottor l!mcaro l. e l'ispeLtore, si).( nOI' t:ripp ari. posero a no stra disposizione molli locali, adaltati rccellentemente pei nostri lavori e muniti di ruhi di gas e di acqua. Quivi potemmo in l,reve tempo impmnrarci un laboratorio , che rispond eva a l ulte le '' ;.Ìgenze. Dohhiamo parimenti all'incessante gentilezza rlel dottorZancarol e degli allri medici dell'ospeda le, signori dottori ) foscatos. P etrides o del farmacisla -.ignur Felire. !'e. ne l corso delle noslre ricerche, non ci mancò mai nulla. specie in riguardo ngli animalr ne,·essari ai nostri esperimenti, i rJuali non si po:;:;o no poi colà lanlo f,,cilm ente procacciare. P er ciò che concerne il materiale d'esarne , le condizioni endemiche, oei mesi di setlemhre ed ottobre dello scorso nnno non furono abb:lstnnza fav orevoli. per coi la 1·ifra dei casi e dei rleces,;i pe1· dissenteria ed ascesso epntico restò decisameute infer iore alla media. Ciò mnlgrado potemmo pit'l di :jQ casr di di:'seoter ia e 1:,; ascessi epatici con 14 ;lutop.;;ie in Più della meti1 di rasi proYeniva dall'ospedale greco. l rimanent i furono a nostra disposizione. grazie alla gt> ntilezza altri col leghi iu Alessa ndrin , e fra quesli so no da citare in prima linea il direllon• dell'ospedal e arabo, il ùoltorc e il coad iutore do ttor· non r hè il drrettore dell'ospedale dottor · il dollor· direttore dell'ospedale israelilico. il tl nt - f) ua nto alla già pei lavori di Loesch e sopratullu di n. 1\och e poi di Kartnli._, essa poteva es,ere att ribui ta con 'loalche moli,·o fondato agli animali tl'o1·dine inhmo. alle ameb e. An che in que!'!to campo vi •·rano importanti qnitlio ni da ri solrersi. Ohbit>zioni contro l'entità delle amehe i!rano state so lle vate da autori. che in molli casi di dis:;enteria
Alla line di lu l.!lio 18D? avemmo d,JI dottor Torella la notizia, the 1 casi di dJ,senteria incominciavano a ru oltip licarsi: decidemmo all ora In partenza pel l o agoslo. Il nos tr o etJttiscientifico co o,i 51eva d1 3 microscopi, di 1 microtonro e di quasi tu ili gli apparecd1i e di tullo il mater1ale del •udùeuo Lab oratorio. il quale dal direttorP-, signor profes,ore com m. llohrn. fu po,tu n disposi zione del ilotlor Kr u:;e 71iù lthrrale citi' Jnl(i. Ci fu più tardi utilissimo l'aver purtalo con noi preparali i più importanti terreni nutriti\'i pei baneri. .;upr,ltlutto una pronisl1 in palloni di uuo lr!ri di agar in dopo un felice viaggio di 4 ' l , giorni, fummo ac ·ohi nel modo piu a mid1evole dal rappresenlante del ted esco. e cos1 t'l a tolle le mi n ute r ie huriiCt'alich e dello sdoj.!an:nneutfl. ;dlc quali altrimenti saremm o stali esposti. a causa del hagagiJO, che pollaIli \' lal ril(uarolo ziont' d tta rf al d tlttvr KrthP IJtr ltgenu ••rlia• "'t d • • 1 • "' an unsere•· lì1n nhuue von dtn purautfarm J>,·oto:o•n, pnhllirat<l Rtl111l&chau, tSU , l\. u.
1'!1\ 1.0 STUUIO DEI.I.A ECC. tore Mas<a, dir·etlore dell'ospedale europeo; gli altri ca'i provenivano d;tlla prati ca privata di una serie di rollegh i.
Fa d'uvpo an cora notare d1e nell'ospedale e sopra ttollo nell 'uraho avemmo occasione di fare molte altre autopsie di persone, che aveva no soiTerto e rispetLi vamente erano morte di lepra, malaria, distomi, tifo addomina le ecc. Di tifoide bitiosa ne ossrn'ammo pochi casi intra ritam, ma non all'a utupsia. Potemmo eziandio stndi ·•1·e sopra ammalati direrse forme di eonginntivite , tanto ddlnsa 111 Eg1t10, noncllè l'elefantiasi ecc.
Don le a\'eHno trO\' at e , ment r e d'altro lato aYevaoo "Yato parassiti anal oghi in casi di afTezioni ooo dig5entcriche il nei I nollre v'erano divergenze fra le de3crizioni dei :siD)(oli ri eercat ori circa il volume ed altre proprietà rlelle aml'l.e. l ri sultlli degli esperimenti s ugli anima li non erano pnnto sotldisfacenti, e le indicazioni di esp erimenti di cultura riusciti. nel modo co me erano date, potevano far sorgere odubhi seri. )lanca\'a pure la r icerca aoatomo· dell a dissenteria ca rntlerizzata dnl le amebe, e dal punto di 'i sta hntleri ologico era nece:;sario rifarne accuratamente lo studio. soprallnllo perche da certi autori erano tlate date io dir.azioni preci"e circa l!atteri :-pecilìci della di;;senteria.
Erauo prin cipa lmente i quesiti, che attende\·ano una dall e nostre ri cerche. Ecco in hrere quali furu no i ri snltamenti di queste:
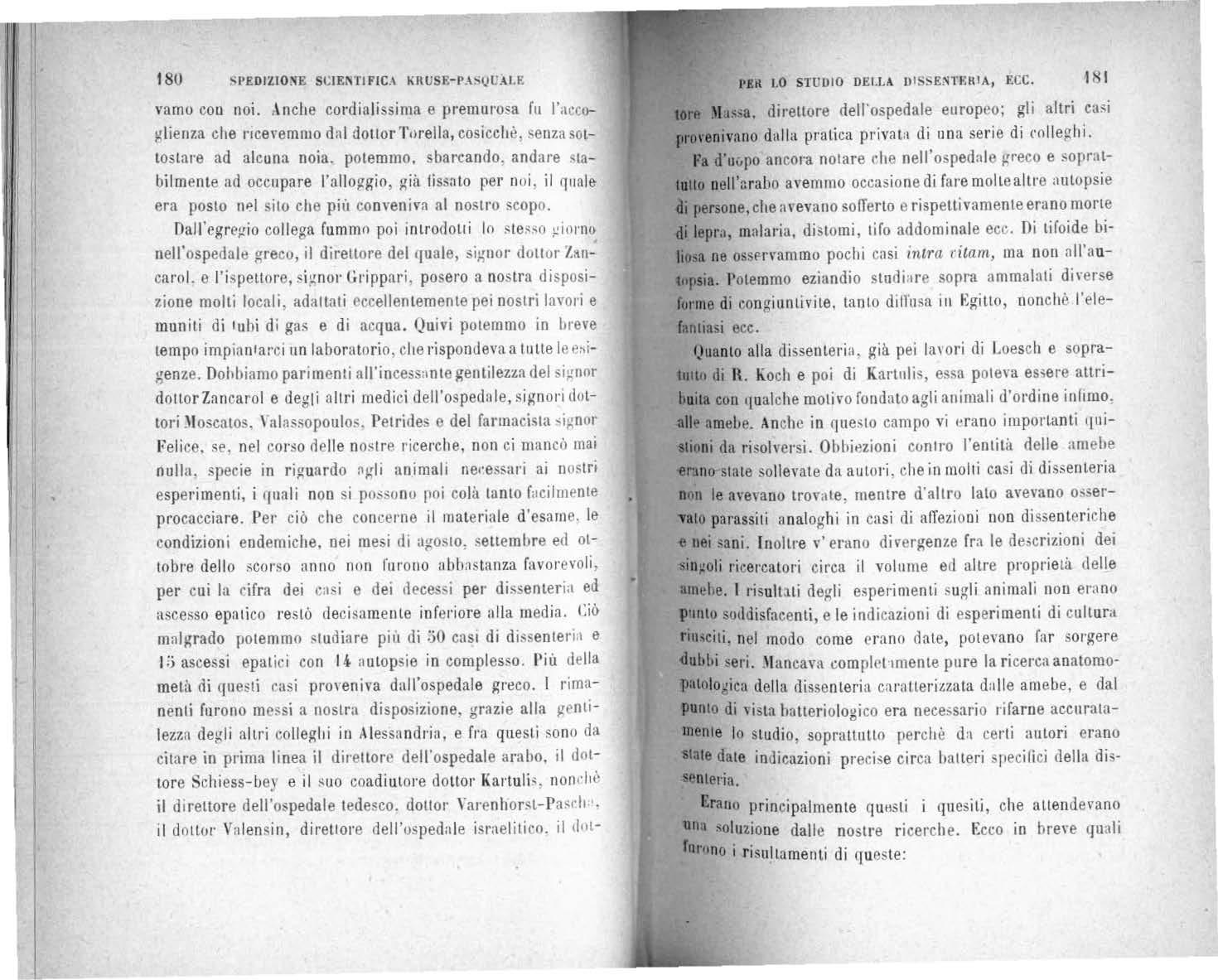
SP&DIZIO...K SCIE'iTa'ICA
ro eravamo ancora io -"apoli, avevamo incomiuciato ricerche di controllo sulla presenza di amebe in norm oli. Già le prime indagini fur ono co ronate da successo . li dottor Kruso trovò anziltltto costantemente le nelle 'U e feci , e poi spE>sso an ch'io nelle mi e. Lo reper to r imase cos tante tluranle il nos tro sof!giorno i n l) uivi potemmo cons tdare che qtt!'ste tWtPiw, unwt'tll Oii flili di!l canale inttwtinalr, non .vi distinguono morfi)/o!fit·amellt•• da qu rllr della di.vsmteritl . .\ l contrari o, se ai s'iniellano nel retto feci normali co ntenenti amebe. I{U Cs te nou '1 moltipli ca uo, oè provocano di 5turlri di speti <1 qnal.;ia -i. Codesto fatto , ciot' che le amebe ddl t• (!•ci normali 1wn sono /I(Lfii[Jrllr pei gatti, co me vedremo, per di,ti nguerl e dalle ameb e dell a d che vi sono racch iusi e sopra tt ullo per g li er itro··iti: qnJ iche volta vi si trovan o io tal e quanlitit, che l'a meba ras-
L'osservazione ùn noi fatta. su ll a presenza de ll e armlrt> nei nostri intestini. co nferma l'asserzioni! di Gra!',- i. rlte in I talia qu e.; ti p rntot.oi sono fret{U enti parassiti dell'uomo . Nell e persone dimoranti in Egitto uoì eccezio nalm entt' nvemmo occasione di co n.;latare ana log hi re peri i, tullochè a re.;simo fa llo un gran num ero di r icerche. Si cchè la diffi;stlllll' clt•ll' imtocltt' aml'bl' CfJ /11 1' parassiti inces linali ,, rllria :ioni locali.
2" Per contr·o, nelll' deit•zioni degli ammalar i di tfi.,srt•ta ia t'fJÌ:iaca s i trorano ordùteu·iam ent P am ebr. Il loro vo·lum e va ri a fra l 0 -!> 0 JJ. ; il lot·o corpo, nell o stad io di mob ilità , mostra per lo piti una divisione in e ntopla ...lfla ed ectoplasmd. L'ento ,. la sma , che rifra nge abba<:ta nta fortemente ln lu ce, è qu ;ts i omogen eo . ovvero c piti o meno granuloso: spesso conti ene vacuo li, e può esserne quasi t•o mpletamenle ri empito. Lo ste·so dicasi pE'i corpi str.wie ri.
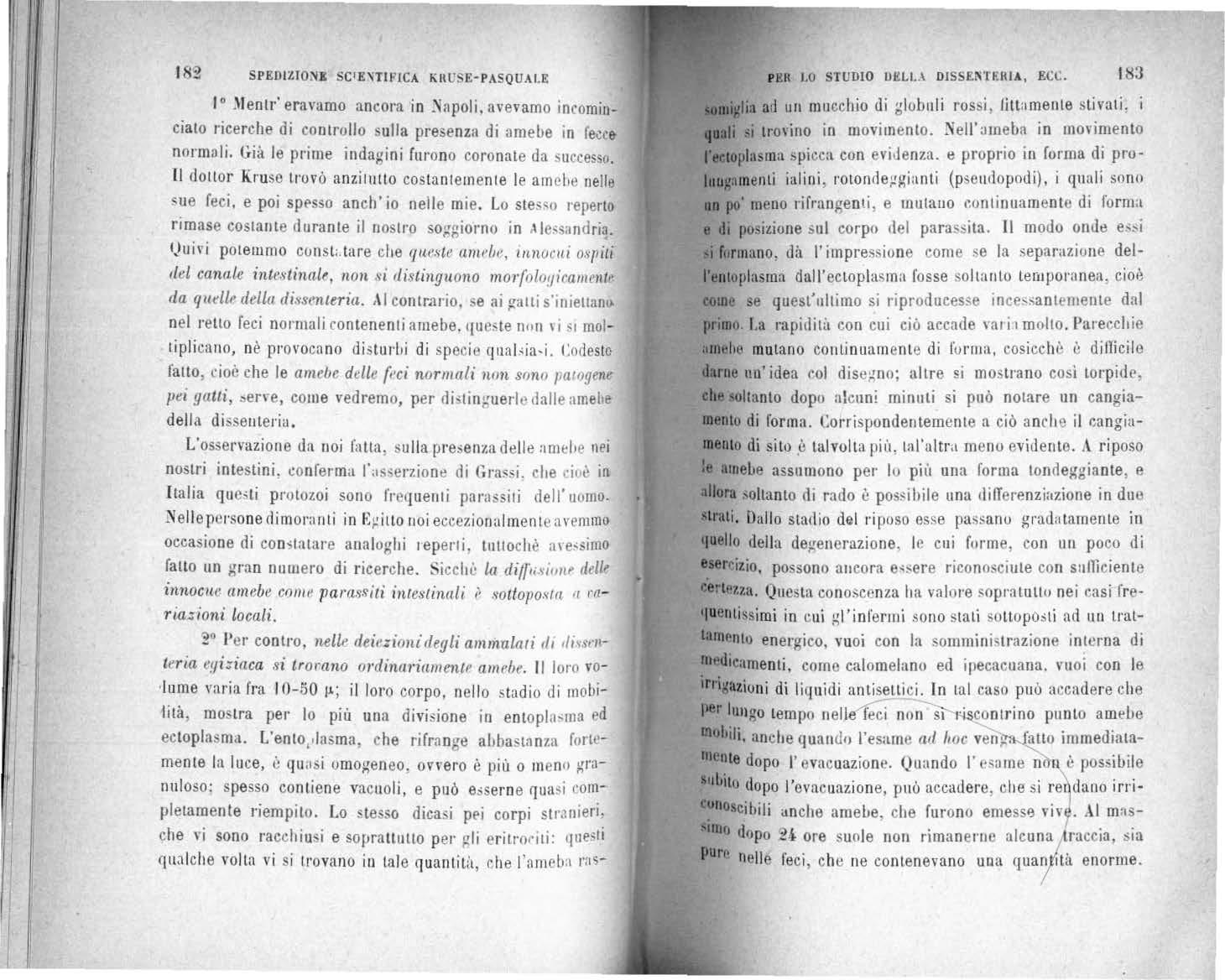
PER LO STUDIO UtLL \ OJSSENU:IH A, Et: l..
aomiglia ad 1111 mucchio di ;;loùnli rossi. litt :1 mente stivali. i qaali trorino in movim ento. Neii' :Hne ba in lllO\' imen to l'ectoplasma con eviJenza. e propr io in forma di proluugamenti ialini. roton ,le ;tgianti (pse utlopoùi), i quuli so no un po' meno rifran ge nt i, e ul ulauo r.on tinuam entc• di fo rma e di pusili one su l cor po del parassita. Il modo onùe es:-i furlllano. ùil l'i mpressio ne come la sepa razi one dell'entoplasrn a dall' ectopl asma fos se so ltauto leru porrmea. cioè come se qu est'ultimo si riproducesse ince,.sa n temente dal primo l.a rap idità con cui ciò accade \ al i t mnlto . Pa rerclti<' .tmelw mutano co ulinuam ente di forma, cosicchè i• diflicilo darne nn' idea t'O I dis e;.( no; altre si mostrano cosi Lorpid<' , che soltanto dop o a lcu ni minuti si p uò notare un ca ngiamento di forma . Corri spondeuteme nt e a ciò anche il cangiamento di sito .è talvolta più. tal'altra meno evidente. A rip oso le amebe assu mono per lu più un a forma tonrl eggiante. e allora 'oltanto dt rado è una clifTerenz i:tzione in due lllrati. Dall o s tadio del rip oso esse passano gradatam ente in quello dell a de generazione, le cui form e, co n un poco di posso no ancora e.;$ere riconosciu te co n suJTiciente eertpzza. Ques ta co noscr nza ha valore !'Opratullu nei rasi fre•JUell tissimi in cui gl'i nfer mi stati ad uu u·atlamPnto energico, vuoi con la sommini ... trazion e interna di medicamen ti, come calomelano ed ipecacnana. vuoi con le irrigazioni di liq ui di antisetti ci. l n tal caso può acc adere che per lungo tem po non s1 pu nto amt>Le mol•ili. anche q ua ndo l'e samt> ati !tac ven;:r:wa llo immediatamente dopo l'e vacuaz io ne. Qu ando l' (•:ìatneri"on ,·. possibile 1 ' 1Litu dopo l'evacuazio ne, p uò accadere , che si irrianche ameue. che fur ono emess43 vi\'e. Al m:.ss&mr1 ùupo 24 ore suo le non riman ei'II C alc una traccia, si a pur,, nelle fe ci , che ne cont eneva no una quai'til enorme .
Per ciò che r.oorer ne la tem perat u ra alla l]uale hisog na fare le os;;ervaz ioni. per In rice rca de ll e <lmei.Je c ut ili ssimo il ser· virs1 del microscopio a risca ldamento, oppure del LaYolo oggettivo riscaldato pet· accelerare il movimento ameboide; però ciò non i· us.;o lulamente per In diagnosi. soprattu tto po i se la temperatura del la came ra non è troppo hassa.
LP col orazio ni, con o .;enza pn'via del prepa1-.1to fres co, riescono :;i. ma facilitano lu•n poco •l delle amebe . TuLIU\' ia i.· il colorarle per wegli n dimost rare un carauerc pnncipal e peculiare deluosti'O para:-sita, cioè il sn11 n11cleo. c/11' I''ICO colorabil1. Il nucleo sem pre; però specialmente nelle forme mobili pe1 · lo più non è 'isibile, a nche quando il co r po dell' ameua s ia complt> Lamenle trasparente por mancanza di picco le gm nul nzioni. \' acuoli o corpi stran ier1. Quando l'ameba e morta. mediant i' l'aggi u nta d1 rea uivi, risalta a!Jhastaoza chiaramente 1111 nudco vescicola re, relativamente pir colo, che, :;ol tnoto cl1 rado, co n tiene co r·picciuoli nucleari.
:1• Cosi come nello feci de;.!li inl'twmi, an che :.pessu i· dillicile potPr con:.tatare le a111ebe. Soltanto di rado i si lro,anu in gran 11Ja $:;a nel muco, che tappezza la mucosa intesti nal(•, l'Ome pure nel co nte nuto dell e ul cerazioo i. Per ò, anr he quando man ca1w qui. si riesr c ancora a constatarle nri lo!fli t/elle Jlftl'li ttlCI'I'ale. Le amelw ri:.teùono a preferenza, se non est:l usJvamenll', nella )oonumut·osa limitrof;t alla perd ita di sosta nza . l'er il loro ricoo ose imon to si adatta no sop ratu tlo lll lissa zi onc in alcoo l e l<' co n ed eosina, oppure con :-o luzionP di bleu di metllcne. È imporr ante notare, che le amebe nel tes suto ordina riamen te ap pari:;cono più picco le di quelle. che v h ono liberame n te ne ll'in tes tino. - l,)uant unqu e avessimo fatto un numero ronsider d i esperimenti (in cl uso gli anima l i di co ntroll o fu sperime nta to 'Il circa 40 gatti ), giammai vedemmo l' ul cerazione approroutlarsi al punto come suole a,·venire nella dissenteria uman a. Che le amebe abbiano una parte essenziale in que sto si pu ò desumerlo con prohabi liti1 I!Ìit da l fallo . rho e;se si moltipli ca no io modo sor prende nte ne ll'i ntes tino dei rratti e 'i i ri:-coutra no in massa nell' iorestino in- ' rermo, soprauuuo nelle glandole della mucosa . Di li1 dalla mu wsa, nell a so ttomucosa. a risu lta dalle oo:>tre l'icerche, sembra che non penetri no truasi ma i. Una pruova anche più evidente cirra l'entità speci{ica delle amebe della dissentel'ia è rostituila dal "e;.!uente nostro e·perimen to: col pus di un ascesso e patico. prodottosi dopo disse n teria, il quale conteneva mollo amebe viven ti , però pu nto halleri, come potemmo acce r ta rci median te prep arati e cul tnr «', a noi riuscì pa r ime nti produrre il testti descritto processo nell'intestino crasso dei gatti. Quest' espPrimenlo arri'VVP qua.\1 lo rnlore, come sP l'in{l•zione degli 11nimuli da I'S]Je1"Ìmmto fosse stalrt ottenuta con una ctdtm·a pu?·a di amebl'. :)• Ad ogni. modo sarehhe sta to imp or ta ute di ndihire per gli esperimenti anche cu lture di amebe. Sventuratamente in più di ce nto singoli esperimenti - i q uali furono variati per riò che concerne il materiale clelia semina, eome l• qu al ità del terreno nutritivo - no n fummo mai tanto fortunati da ollenere lv sviluppo e la moltiplil•azione oellP amebe della dissenteria. Bencltc nel corso delle nostre nt'arche ci fossimo t rovati di accordo con Kartuli • . s u questo p unto importan te noi non possiamo confermare i ri-
.f.' Se già il rep er to costa n te, ed in Egillo quasi escluaiYo. delle am c• he della disseo téria, che ivi è endemica, c.ome pare la loro penelrazio ne nei tessuti viventi della parete in\8Stioale, depongono per la loro import anza etiologica in questa infezi one, motivi anche più potenti per ammettere tal cosa ri>ultano dall ' esperimmtn Slt[jli animali. L'ani male da esperimento, elle più si adatta per la riproduzion e rlella di ssenteria. e il l nieuanclo material e che ro nten;.n ameh e della dissent eria. p. es., fecce dissenteriche. nel retto del gatto, si pu ò prod urre co n certez7.a nell· ultimo tratto dell ' in testinn di questi animali un pror.esso. che, pel 110 carallere anatomico, non perfeuameote alla di,.senleria dell'uom o, ma pcrmcrtc indubbiamente un paragone con ultima. Es so p uò essere delioito come un ca tarro emorragico, che si nd ulcerazioni. per lo piit e o; up er fici ali. raramente estese. e, ne i JCiovani g .1 ll i. può determinare l:l morte .
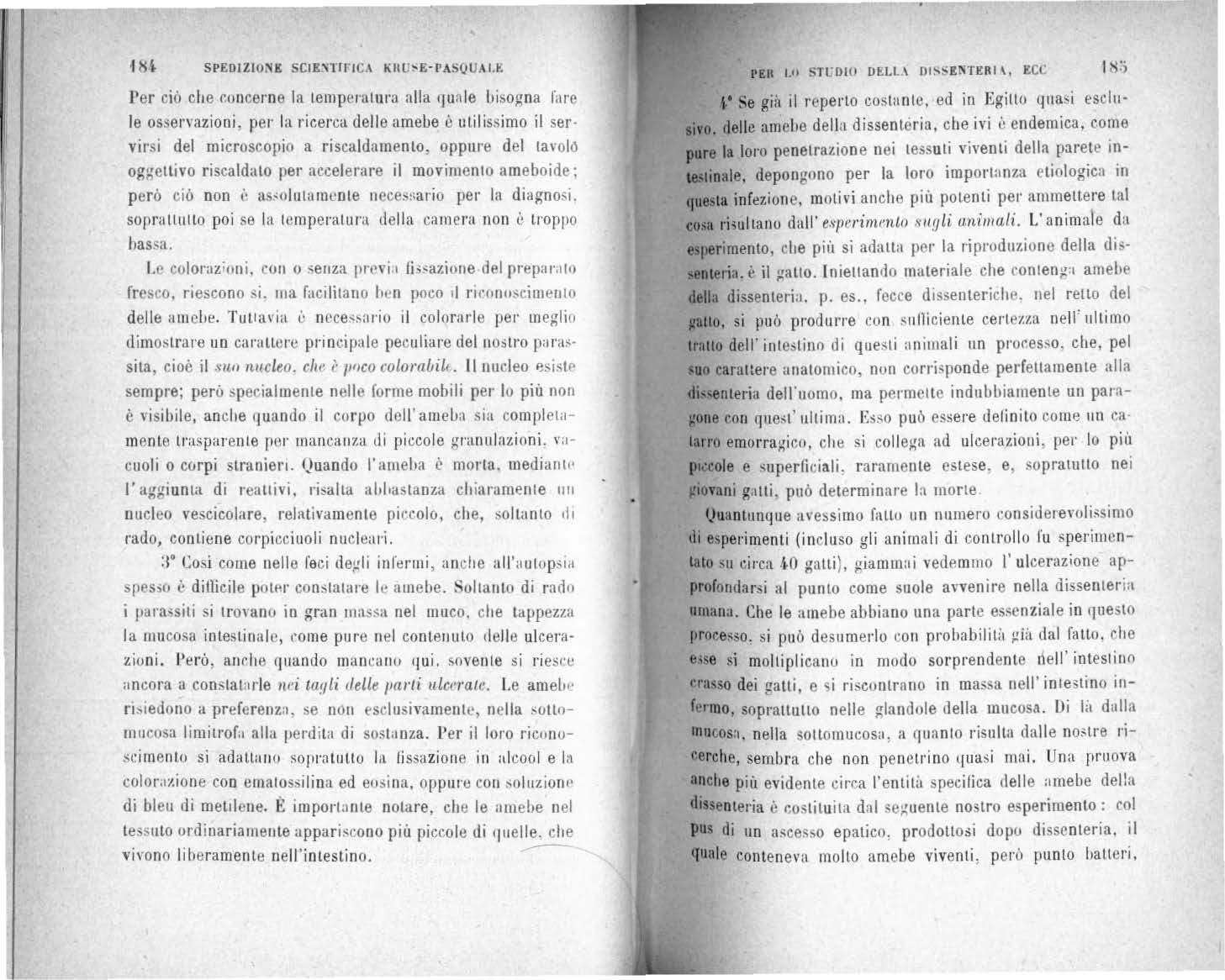
!<u ltat i di q uesto t•icercatore: la cultura dellt• aml'bt• dPlla dissenter ia PI'J" ura resta ancora un postulato dt•lla scit
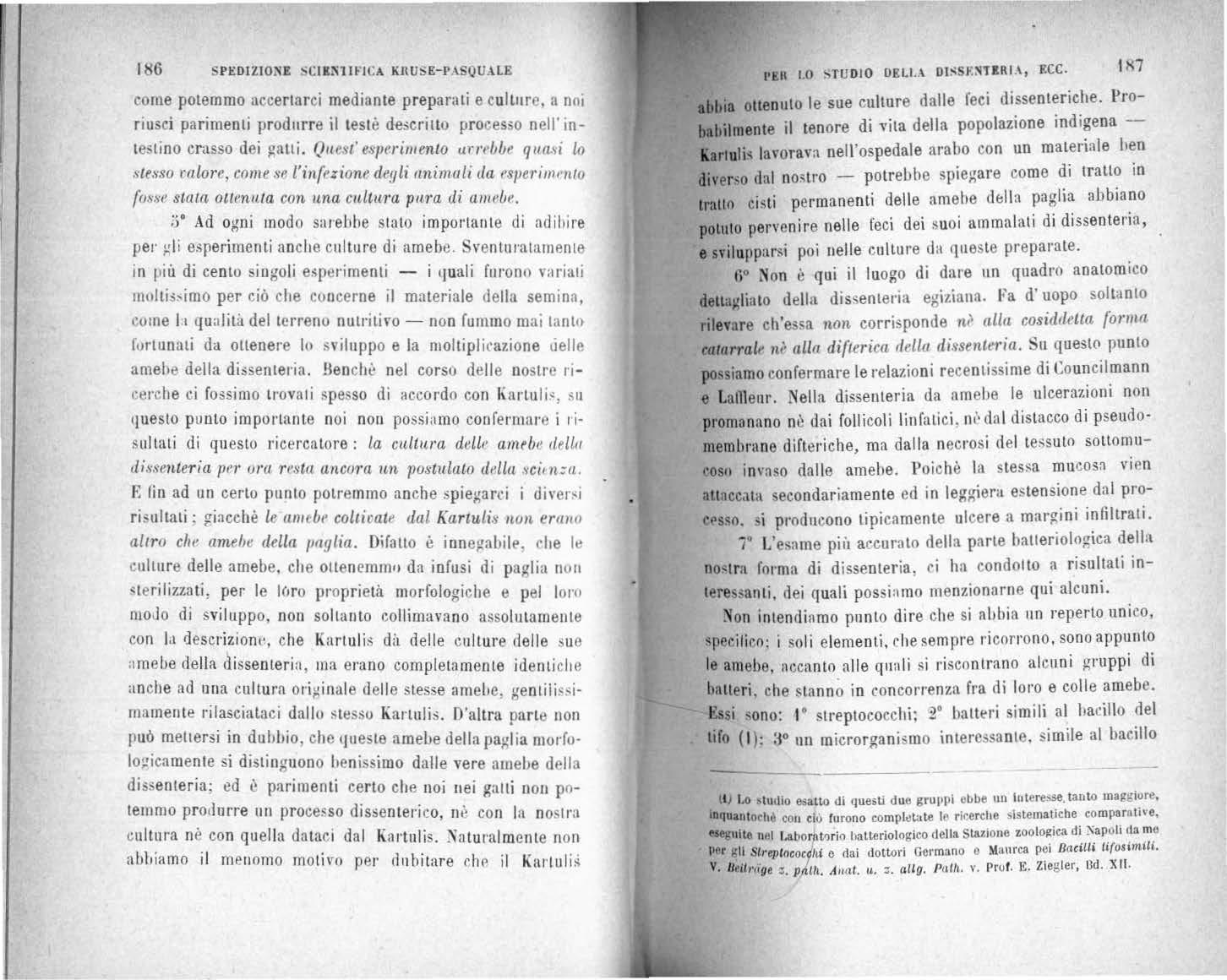
E lin ad un certo pu nto potremmo ancbe spiegard i òi,·er... , ri :>u Ilati : le amt Vt' coltiratl' dal non erano altro chi' amebe della tmglia. Dirauo è i oncgauile , d1e le ..:ulture delle amebe, che ottenemm" da infusi di paglia nuu per le IMo proprie tà morfologiche e pel loro mo tlo di sviluppo, non so lt anto col limava no assolu tamente con l•t desc ri ziont·, che Kart ul i:; dit delle culture delle s ue amebe de ll a d issen te r ia, ma era no completamente iden ticlte anche ad una cultura originale delle stesse amebe, mameu te rilasciataci dallo stesso Kartnli:;. D'altra par te non può mettersi in dubuio. che tjueste ameue della paglia morrolo::icame nt e si distinguono heni:; im o dalle vere amebe della ed è parimenti cer to che noi uei galli oon potemmo produrre nn processo dissen terico, nt'• con la cu ltura nè con quel la da taci dal K:utul is. non ab biamo il meuomo mo tÌ\' 0 pPt' dnb it nr e r.hr il t•t:lt 1.0 :-<T UDIO DELLA OI SS t NTBRI \, RCC. tbb ia ottenuto le s ue cult ure dalle feci disse nter ic he. Probabilmente il ten ore di vita della popo lazio ne indige na lavorav a nell'osp edale arabo con un materiale hen diverso dal - po trebbe spiegar e come di tr auo in tralt o dsti permanenti delle amebe dblla paglia abb iano potuto pervenire nelle fec i dei suoi amma la ti di dissente ria, e poi nelle culture da ques te preparate.
1)0 Non è qu i il luogo di dare un quadro anatomico dell a. dissenteria egiziana. Fa d'uopo soltanto rilevare ch'e-sa corri:;ponùe 11ì• alliL cosiddettct fonnrl ratar rall' alla diftericct rlellet dissenteria. Su qoesl(\ pun to possiamo con fermare le relazio n i re centissime di Councilmann e Lalllem·. Nella. dissenteria da nmel1e le ulce razioni non promannno nti dai foll icol i li nfatici. tH' da l ùis tacco di pseudo· membrane dift er·iche, ma da ll a n cc ros i de l tessuto so ttomu,•oso invago dalle amehe. Poichè la virn attaccata seco nd ariamente ed in leggiera da l prot'Psso. ' i pro ducono tipicamente ull'ere a margi ni in filt rati. j • L'esnme più accu•·nto della pnrte batteriologica della form a di disse nteria, ri ha condotto a r isultati indei quali menzionarne qui alcu ni. intendi amo pu nto di re che si ahb ia 11n reperto un ico, sper,ilir.o; i li elem en ti, r he se mpr e r icorro no, so no appun to le amebe, accanto alle qn nli si risco n tra no a lcu n i gru ppi di haueri. che s tnn n o in concorrenza fra òi loro e colle a me be . Essi ,ono : 1° streptoc occhi; .2° bat t l'ri simili al ha,·ill o de l tifo ( l ): :io nn microrganismo simile al bacillo il ) l..o , httlio di questi duo grupJli ebbe un lutere,se. tanto majlgiore, mquantor hé con ciò rurono lP r irerche ,istematìche comparative, M I halteriolo!(lco della StaT.ione di <la mo JWr Slreplococ91ti o dai dottori Germano o Manrca poi Bacill i lì{os •mill. della difteria, che noi alluiamo denominato /Ja cilltu claraw s: ed in ultima linea .r..o alcuni bacilli fondenti la gelatina. t:u · desti baueri :-i nnveonero non sol tanto nel sang ue degl 'i ndividui morti pet· dissenteria. ma si potè anrhe con:-tatare ch'essi parteciparano ùireuamente ai processi ulcerativi tlell'intestiuo Le amebe penetrate nel tessuto si acco mnaturalment e a balleri, e spesso ne era no fi nanche sopraiJa tte. Siccht'· in lJnesta fornHl di dissenteria trallasi dt una infe::ione tipicnmentt• mista. Come r1sultn da!fl' twpenmeuti sui gatti, lt• amt•lie potrl'bht'1'o costltnir·t• il fattore primrwio: soll11 l11 lorv influen.:n - {a ll' uopo inrocar r il traspm·to meccanico - taluni luttl eri si srilul'prmo ed est• reitano mt'a :ione noci w.
V. lltitrrige :::. p!{u1• Auat. u. ::. ali g. Puth. v. Pro f. E. Z1egler, Bd. X11.
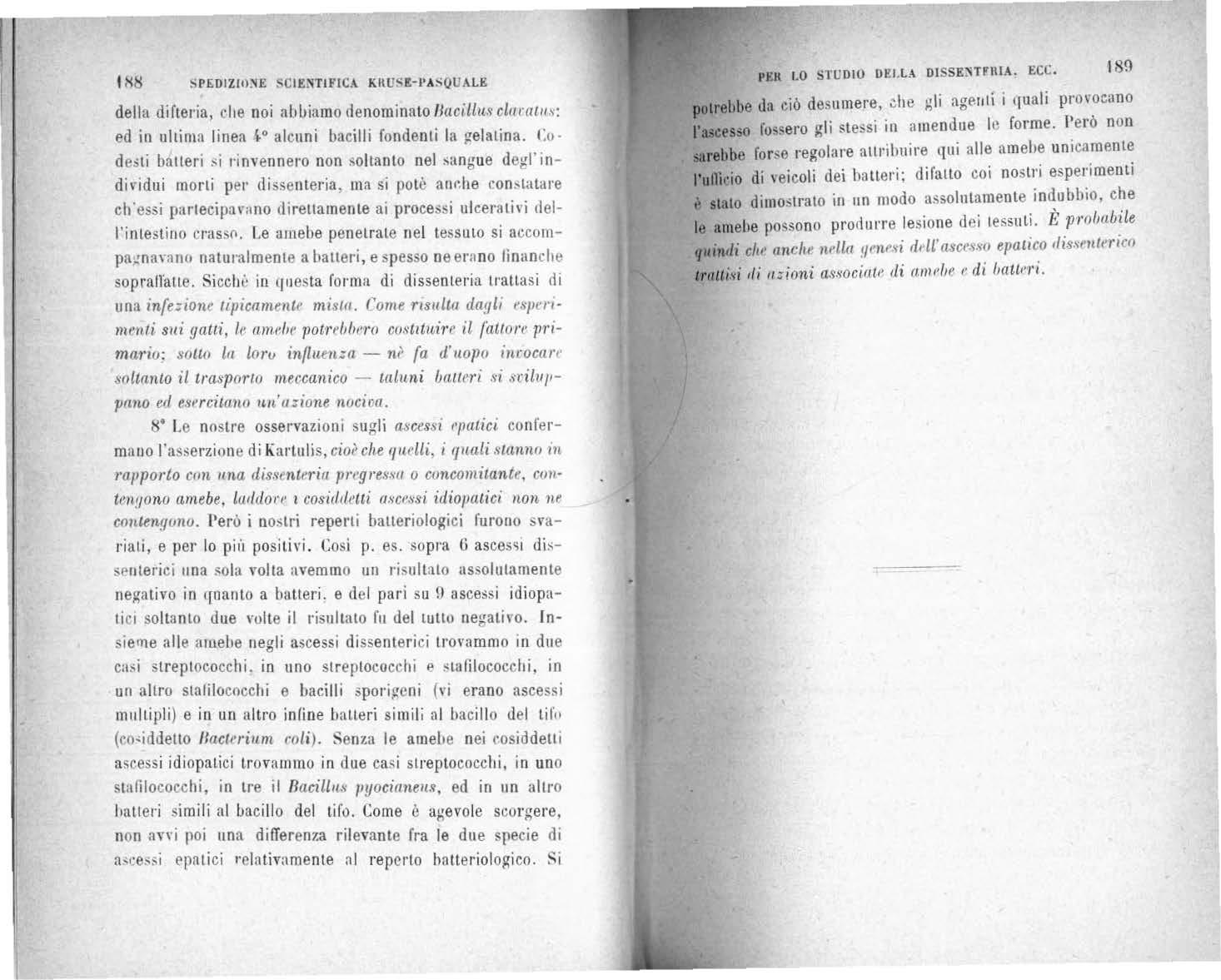
• Le nostre osservazioni sugli ascessi t•patici conferma no l' d i Kartulis, ciot\ che qul'lli. i quali sumno in ra,,porto ron, nna !lissentt'ria prt•gressa u concomitante, cmJtmyono amebe, laddort' t cosùlrletti asct•ssi idiopatici non nr contengono. Però i no:-tri reperti batteriologici furono svariati, e per lo piir positivi. Così p. es. sopra 6 di:-.sruterici una volta avemmo un risultato assolutamente negativo in troanto a batteri. e del pari su H asces:;i idiopati cr soltanto due \'Oite il ri·nl tato fu del tutto oegatÌ\o. I nsieme alle amehe negli ascessi dissenteri ci trovammo m due ca:;i streptococchi. in uno streptococchi P "talilococcbi, in un altro stalilococc hi c bacilli sporigcni (vi erano ascessi multipli) e in un altro infine halleri simili al bacillo del til'o (ro•iddetto 1Jact1·rinm r()li). Senza le amebe nei t•osiddell i ascessi idiopatici trovammo in due casi st reptococchi, in uno stalìlococchi, io tre il 11yocimums, ed io un altro hntt eri sim ili al bacillo del tifo. Come è a<•evole scorrrere r> ' non ani poi una differenza rilevante fra le due specie di epatici :Il rep erto bntleriologi co. Si poLrebbe da ciò de:;umere, gli agenti i quali pr'nvocano
J'asees:;o gli ste:)si in amendue l1• forme. Però non sarebbe fo rse reg olare allrihuire qui alle amehe untcamente l'ullkio di " eicoli dei haueri; difatto coi nostri esperimenti è stato dimost rato in nn modo assolutamente indubhio, che le amebe possono prorlurre lesione df'i tessuti. È ptobabile clw anclu nl'lla tldl' ascesso epauco dis81'1tlt'I'Ù:o ,fj 11:ioni associrrlt' di tt/lli'IIP ,, di lmtt,•ri.
Laveran (1), nel suo importantis-imo la\·oro sull'infezi one riassume i principali pro ces:;i di colorazione, propo,ti per l'e5ame dei parassiti nel sangue .
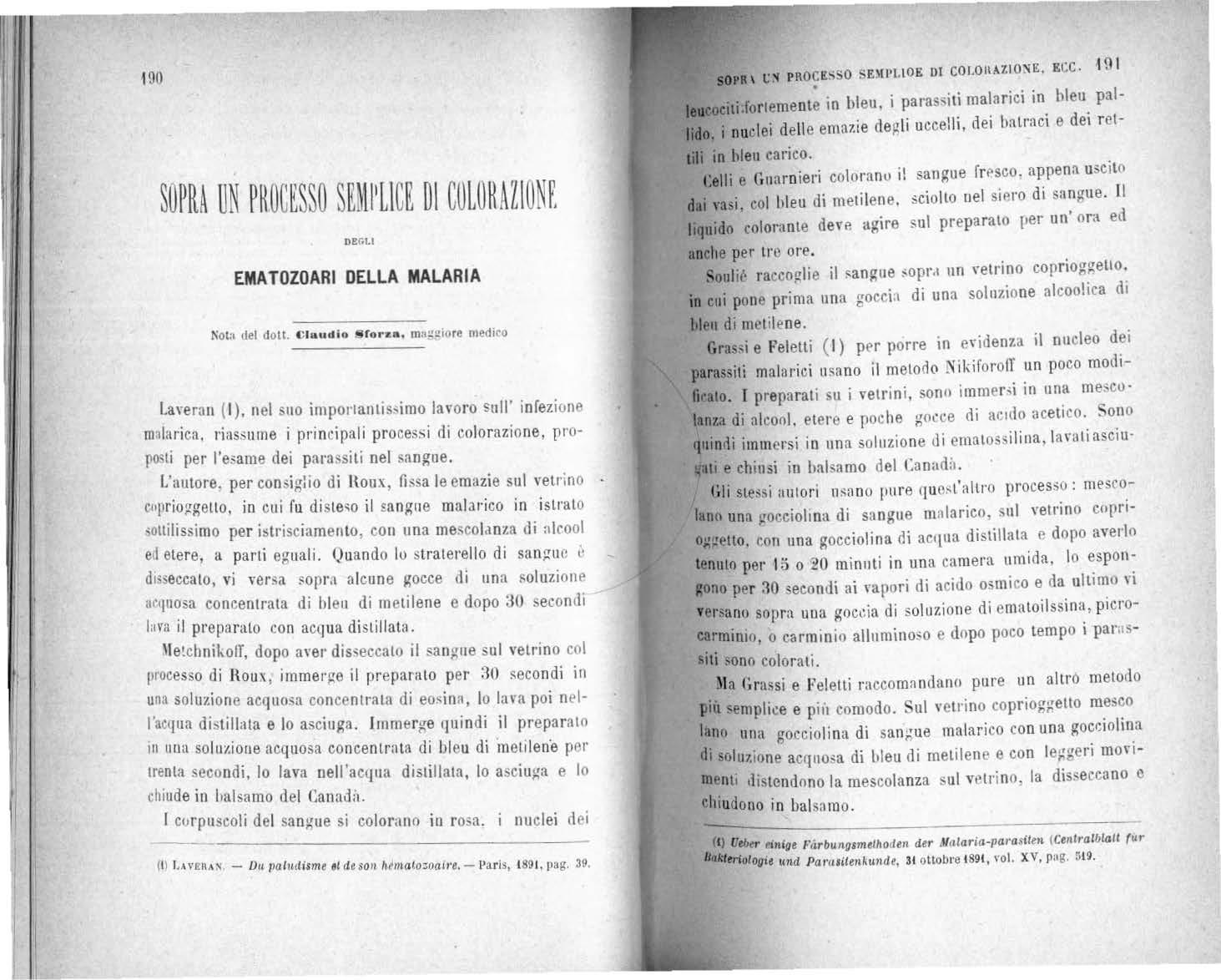
L'autore. per con:>ig:io di ltoux, fì:;sa le emazie sul vetrino CHpriogge llo, in cui fu diste'o il malarico in istrato .;ollilissimo per islrisciamen to, con una mescolanza ùi alrool e.J eter e, a parti egua li. Quando lo strat erello di sa n rrue è di;seccato, vi versa . opr.1 alcune gocce di una !'OI;zion e a··•1nosa concentrata di bleu di mE'lilene e dopo secondi lavA il preparato con acqua distillata.
\le!chnikoiT, dopo aver il sangue sul vetrino co l processo di Houx, immerge il preparato per secondi in una soluzione acquo'a concentrata di eosina, lo la\ a poi neldbtillata e lo a:;ciuga. quindi il preparato Hl uua acquosa concentrnta di bleu di metllen·e per trenta secondi, lo lava nell'a ct{lta distillata, lo asciuua e lo chiude in halsamo del Canad it. " l corpuscoli del san).{ue si coloran o io ro,a. i nuclei rl ei lellCociti.fortemente in bleu. i paras-;i ti malarici in bleu pallido . i nud ei dell e emazie uccelli, dei hntraci e dei r ettili in bleu t•arico. t:elli e colorano il sangue frrsco. appena uscito dai ,·asi, col hl eu di metilene. sciolto nel sirro di sangue. 11 hqnido colorante devP. agire sul preparato per un' ora ed anche per tl'l' ore. e Felelli ( l) per porre in eYidenza il nucleo dei parassiti mal arici ulla no il metodo un poco moditirato. I preparati su i vetrini, sono immer,i in una me=-co · lanza di nkool. etero e poche go\·ce di at'llio acetico. Sono quin ,ìi imm ersi in una soluzione di emaws,;ilina, lan(iasciu· lìli sle5si autori 11:\ano pure quc,;t'altro processo: mesrolanll un a di sangue malarico, sul vetrino copriron una gocciolina di ac1pHl distillala <' dopo averlo tenuto per 15 o 20 minnli in una ramera umida, lo espongono pt>r 30 secondi ai ,·apori di acido osmi co e rla ultimo' i sopra una goc\:ia di soluzi one di emntoi ls sina, pierocarmini o, o carmmio alluminoso e ùopo poco tempo i parassiti :.ono colorati. ll a l;rassi e Feletti pure un altr6 metodo più -.emplke e pilt comodo. Sul vetrino copriog)!elto mesco lan o una gocciolina di malarico co n una gocc;iolina di di hleu di metilene e con le;:geri morimeni • •li,lendono la mescolanza sul vetrino , la disseccano e chiudon o in balsamo. ---------- sOPH' r:; l'liOCKsso DI Ecc. l detti preparati, disseccati, so no quindi immersi per t+ ore ed alla temperatura di !'17° C. (termo:Hato ', nella seguente
Sonl ir il . angue ::opr.• nn vetrino in cui pont> prima una gocci.• di una soluzione alcoolica d1 bleu di mctilene.
J(all e chiusi in del Canarli•.
Il (l ) CeiJtr !'lnige f'àrbt.mg&melhO<I en aer M11laria·porosllen ( Celllratblall (ur al."ttriotogte und PartHIItllkund t, 3l o LLobro !891, l'Ol. XV, png 519.
Io sono riuscito ad ottenere sempre buoni risultati e doppia colorazione I.Jen definita seguendo il processo nsa Lo prima da Caooo ( l ) per la colorazione nel sangue dei bacilli dell' influenza e quindi da Ca non e P ielicke ('2) per In colo razitme nel sa ng- ue dei bacilli morbillosi.
TI sangue malarico, disteso per istrisciamento in istrati sol· tili ss imi sui vetrini copr·roggetti, è lìs5alo con l'immersione pt·r :j, IO minuti nelralcool as oluto.
Soluzione acquosa concentraLa di bleu di rnetilene cc. W.
• " 0 di soluzione di èOsina in 70 "lo di aknul re. 20.
ArtJna distillata cc . &.o.
Ilo po H ore i '' eli·in i sono es trallr d.rlla soluzione colora ote, lavati in nequa distillata, disseccati e clri usi in balsamo del C:mntlit.
Come nel processo di .\l etchnikolf. i glolmli rosi>i sono eo lonui in ro sa. i nuclei dei leucoci li in uleu ca ri co, gli emain ttualunq ue lot·o 'itadio di svi luppo, in hleu paJii.jo. Conservo preparati di :;a n).(n8 mnlarico del 36 aprile 18\U, in cui si anche distintamente. i parassiti dell a fellhre terzana, rnolt i dei quali allo stadio di sporu· !azione.
Con lo stesso processo si ottengono pure oelli preparati di gonococchi nel pu s blenorTagico, a doppia colo razi one.
H ft>bl)l'atO 18!1:t
( t ) l eber flne11 1/if;,·o•·oanismua iln Brute tJO n l n(lum:aliranl:m (()NlWh. Metl. Worh. 1892, Il •' 111 ). tt ) c PtELICK&. - tilltn IJ•Jcillus in1 /Jiul '- ron 1/a <tl'•l/:rank·,,, (llerhn. klm Wor.h. 189!. :>.. tG.
POLVERIFlf:IO DI LIRI
'l••ni•llia INt;t •ti 1:1 •·onrt•rt lflt.;l .;rwn t•ll• ·n dPWO'PIItlttl•• •Il Ilo ma oPI mesi' ;li st·ll•'lllllre 1892
[) , co ntro al picNJio pat>se di Font:wa Liri, wmune del ·ircondario d i Sot·a. posto so p m 11 n r.ollina, a :r10 mell'i ·li elevawme, trm asr al "ud IlO monle denominalo Jp ce ,-e .
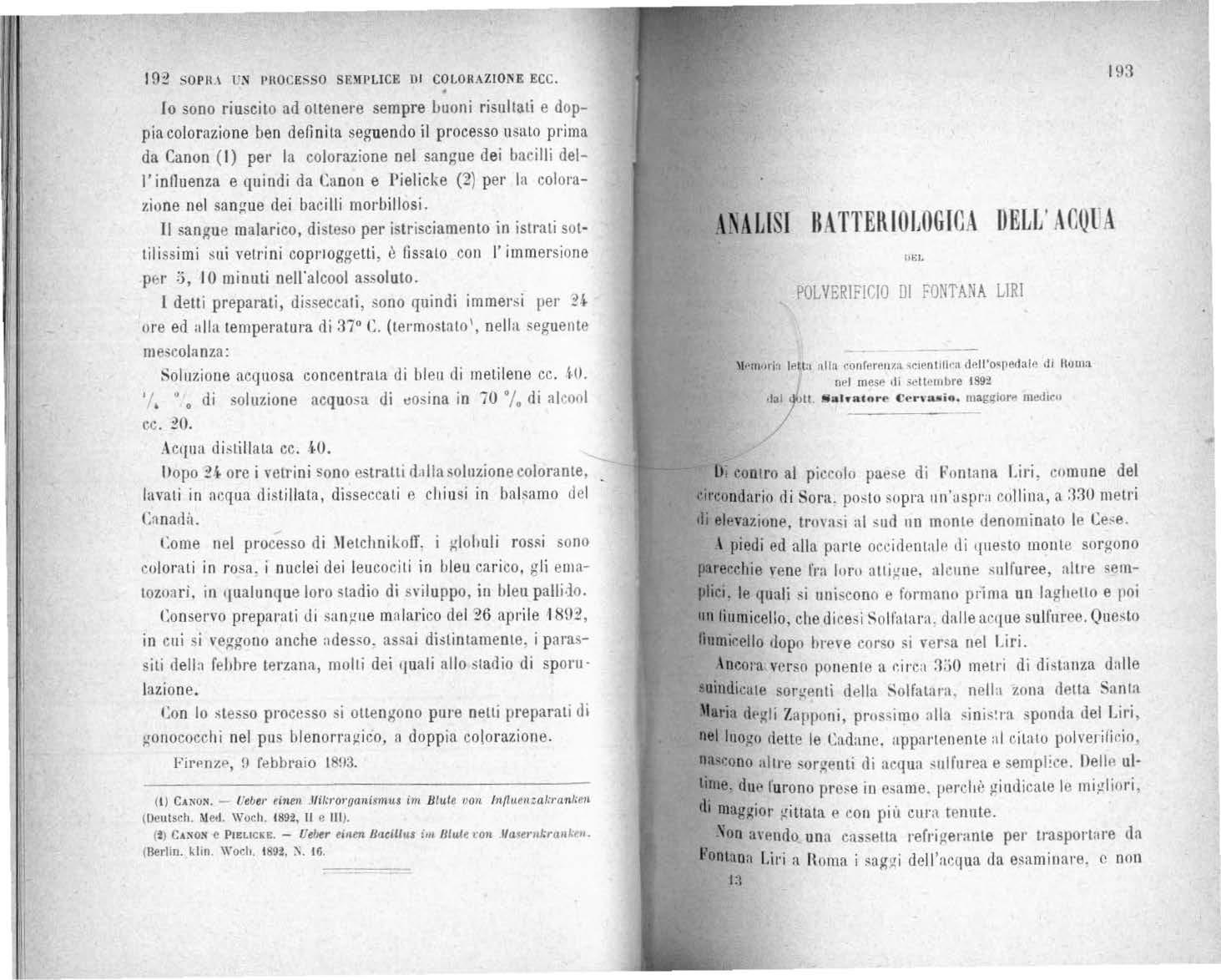
\ piedi ed alla parte ocl'idPntaiP •li t[uesto moult> so rgono parerchie \'POe fra lllru ;lltune sulfuree, aJu·e sPmplicr. le <tual i si uniscono e forman(l prima un laglr<'llo e poi un liumi cello, cltedit·e· i Soll'at:ua . dall8tH'tlUe s ulfttr N'. Questo liumirell o dopo hrt>\8 sr ve N\ nel l.iri.
\ ncom vPrso pont n lu a !l;)() metri di dalle soindi l:ate sor!.{rnti dt>lla Solfalara . nclh zona 1letta Snntn n a' rtulo un a cassetta t·efrigerante per trasportare !In
Maria Zapponi, prns.;rmo :1lln sponda del Liri, nel lnogo elette le Caclane. appar·t<'nente al t·itaLo po lve1 ili,·io. allr·e di arqua 'nlfnrea e sempl!ce. llellt> ultime. 1lut> fur ono prr,-e in (1-;ame. pen:lri• 1-(intlicate lr migliori , di maglo(ior !!Ìllata t> t'Oli più cura trnute.
•' ontao a Liri n Homa i dell 'arq ua da 8samiuare. o non 1:1 potendo in nessun altro modo conserraziooe di es,e acque, durante Lutto tltrill{lllo. nel ;.:hiaccio. credei oece:;sario d1 praticai e le cu ll u re. uutnerare et! isolare le colonie su l posto. per continuare qui a lldmn le ull('riori ricercl1e. P c't'ciò raccolsi l'acqtm tla esami nar}. I'Oil le I'Oiute cautele, in bottigl ie di Er le nmeyer della ca a1·.itit di circa ;jl) ,.• t:., pre v iamen te hen la 1 ate, La ppa Le co cotonu t' rese slenli alla Lempemltii'U di oltre e suhiL dopo la pre·n dell'ac,rua pratu:;u nllture a p allo 10 di Pt·tn pure sterilizzate l o ctuesto temp(), giurnu per ;.domo, feci l c>numcrazione delle colonie e oe anda1o noutndo le diiierenti pPr :,;w !arie l'uua d.dl'allra l'Oli in studiai purr, ronw meglio se ppi, l.t dal late' lopogra fic;o e racco lsi ljltall:e piu informazioni potei comlizioni sanitarie !orali. In quanto alle conclizioui locali p11tei. bene a1·rertarn11. che. eccelluati por·hi dt fehhri malarirhe, d1 formP. nuu gravi rlurante I'P,;t·1tr e l'autun no, e pod1i ammalati d1 polmonite e pleuru-polmonite nella sta l! io ne in1 ernalc a preftrenza. non s1 malattie inretuve a furmeepideniiChe. non tiro. non od altre forme morbose ).!rn1i dell'apparecchio ùigcreJJle.
Di Ul'fJU<I reci quallru coJ(ure, rioi· con l t 1'. c.. cun 1 b di 1·. 1· •• con 1 10 e '/,. di c. r .. adoperando per terreno di nutrizione gelatina al l t per cento: perciò 1111 ur.nnreva un apparecc hio che potei fa1·.ilmente uncon una vasca da la1raggio di fotogra fie, clte si lmvava in UOà stanza a pian terreno, a mezzano! Le, l'lte cortesemente mi rn ceduta con l'ambiente dal sig. comandante IJUel poherifi,·io per 1 sette ;.:iorni clt mi.t permanenza cola.
Per tJuaoto alla località come gii1 ho dello, le sor- lJIL l'OLI" ER I FICIO DI Lll\1 H genli d'ac•1ua in esame sono a poea distanza dal fiume Lsri . C,}u t'sln lìnm e a di un chilometro a monte si trcna ad una quota di lh·ello di parecchi metri superiore a quelltl delle delle
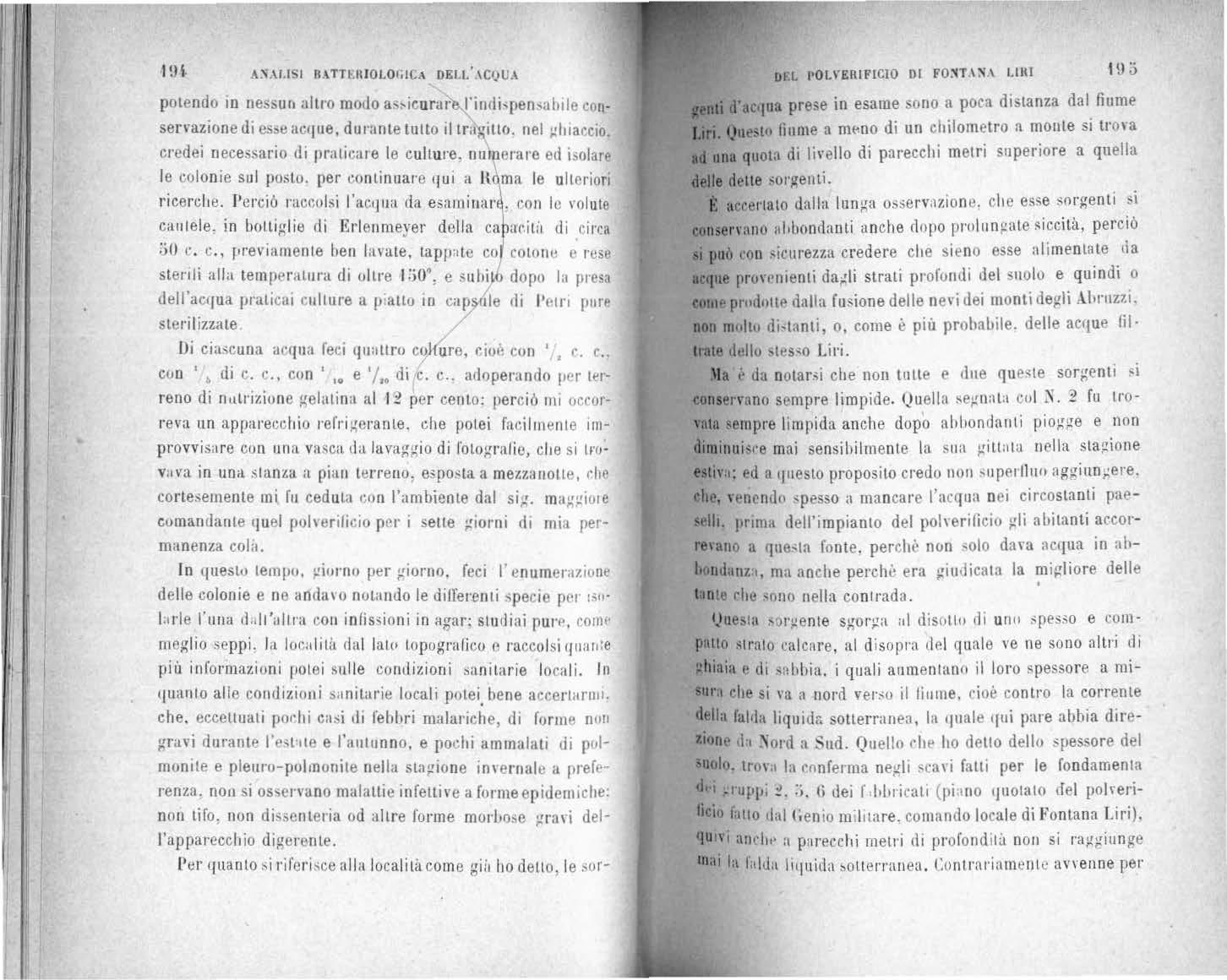
È dalln l unga osservnione. che esse sorgenti si consenano ahh onclanti anche dopo perciò si può ··on , icu rezza credere che sieno esse alimenwte da aeque prOII' Ilt enti da;!li strati profondi ùel suolo e quindi o c:ome proll nllc> dalla fusione delle neri dei monti !llruai. non mult u di,lanti, o. come è piu prohal>ile. delle acque Iii· i· Ja che non tulle e 1lne sorgenlt -.i consen·ano semp re li mpide. ljuella col t fu trovnta limpida a nche dopo aiJI1ondnn ti piog!!e e non diminuisr·e mai se nsibi lmente la sua giunta nella "li\'a; ed a questo proposito credo non ,uperllno agginnJ,:ere. che, \PO l' ntln ,, ma ncare l'acqua n l'i circostanti paeselh. pr ima dell'impianto del poherilicio gli a bi tanti accorre, ano a fonte. perchr non --oto dava actJua in abbonùan7. •, ma anche perchè era la delle &.1011• r ht.' ' ono nella co n trada. '
Ira te •lellu Liri.
:-.o r ).!e nte sgoq!a al dis1•tlo dt u n11 :;pes3o e compntto slml o l'a lcnre, al disopra del quale ve ne sono altri d t
P d1 i qua li aumentano il loro a misur,, rhe si va a noni. ver:;o il liume, c•ioè contro la corTente della fahl a liquiùr. sotterranea, la quale '[ni pare abbia direzione l• " onl a Sttd. Quello dii:' ho detto dellu .;pessore del &Uolu. tro 1 l:lt•onferma neglt 1i falli per le fo ndamenta Ùt•l .l UJ'[ II :L . :) . (i Ùei r hluicall (pi 1!10 IJUOlfiiO Ife} [>Oiferilicio tatt o m;lttare. comando locale di Fon tana Liri), qull"l arwft ,. a pa recchi metri di profonditi! nou si ra){>!iun).{e tn.ti h lalda ltqu itla Conlrariameute avvenne per gli scavi falli in vicinanza di altre sor·l.(en ti 7. IS El !1. dnv& alla pr'ofonùitiL di metri di humus e ghiaia si vava acqua.
<)uesto dato per se stesso ha certamente un ).!ra>e 'alore per far giudicare facile l'inquinamento delle accp1e di queste ultime sorgenti per· la loro alle acque pinvarw. non completameute filtrate: vi è da aggiungere t'lte tlue,lt' IWt) lavore,·oli co ndiz ioni del suolo furono peggiorate dai molti 'Ca' i per la costruzione dei faiJI11·icati .
.\l i sia lecito far cen no delle qnalitit organolettidte de lle actrue in parola e d•Jpo riferirù sullito del loro e;;arne nwro"r'opico e haueriologico.
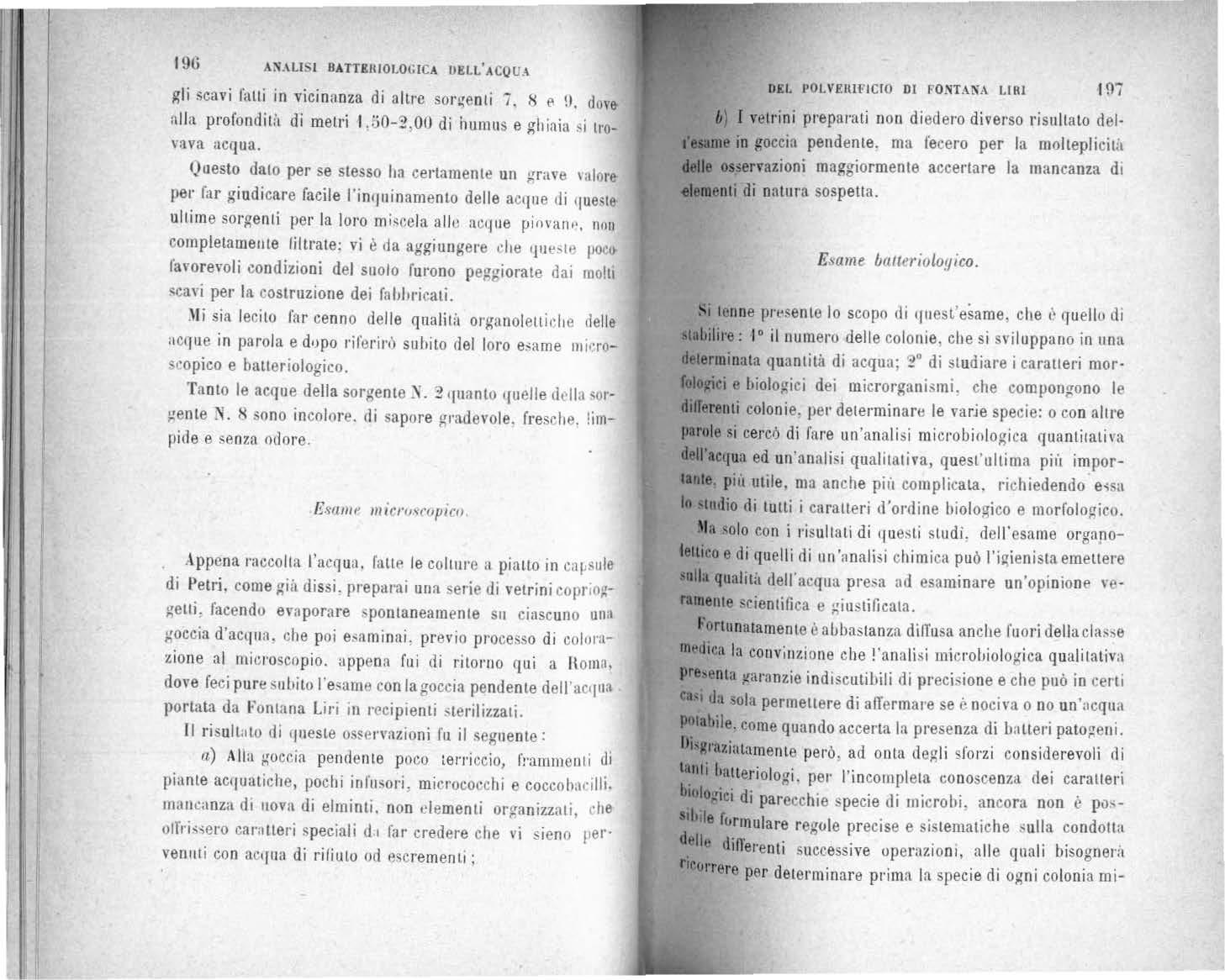
Tanto le acque della sorgente X. :? tJUanto t[uelle dd la ge nte N. 8 so no incolore. di sapore gradevole. fresd1e. limpide e se nza odore.
DEL I'OLV EIUFIC!O 01 LIRl l \)/
b) 1 vetr·ini preparati non diedero diverso risultato del· t esame in goccra pendente. ma fecero per la molteplicita delle 053ervazioni maggior mente accertare la mancanza dr 41femenl i di natura sospetta. Esame botterioloyico.
Appena ra ccolta l'acqua, fattP le colture a piallo in di Petri. come già dissi. preparai una serie di vetrini copno;:geui. facendo evaporare "pontaneamente sn ciascuno una goccia d'aCCjllil, dte poi e:;aminai. previo processo di colorazione al appena fui di ritoruo qui a Homa, dove feci purt: .;nl•ito ron lagoct'ia pendente deiJ'ac'1ua portata da Fontana Liri m recipienti 'terilizzati.
TI di queste os5rrvazioni fu il seguente: n) AIla goccia pend ente teniccio> f!·ammenti di piante acquaticlte, pochi infu"or·i. mirrococchi e coccoharilli. uHuwmza dr uova di elmintr. non dementi oqmnizzatr, r he carotlteri !\peciali d' far credere che vi sieno per· venttri con a(·qua di rifiuto od e'rr'ementi;
Si ten ne prl'sente lo scopo di cruest'esa me , che t' (Juello eli stabili t·e: 1° il numero delle colonie. che si S\'iluppano in una determi nata t) uantitit di acqua; ?0 di studiare i caraueri mor· fologici p ltiol ogici dei microrganismi. che compongono le d11Tere nti colon ie. per determinarè le vade specie: o co n alt t'e parole cercò di fare un 'anali si mi crouiologi ca quantitati,·a dell'ac'( na ed un 'anali si qualitativa, quest'ultima più imporllnle. più utile, ma anche pilt complicata. r·ichiedendo lo tntlio rlr tulli i ca ralteri d'ordine biologico e morfolo::rico. Ma con i risultati di questi sludì . dell'esame organoteuico e di qu el li di nn':lnalisi chimica può l'igienista emettere sulla qualitit dell'acqua presa ad esami nare un' opi ni one "eramente t:cientifi ca e
Fortu natamente è abbastanza diffusa anche fuori della ml'dica la couv inzione che !'analisi qualitativa pre:,enta di pr·ecisione e che può in t'ertr ca,i da sola permeLLere di affermare se è nociva o no un 'ucqu. t potabile. come quando accerta la presenza di bnLLeri patogeni. per'ò. ad onta degli sfo rzi co nsiderevoli di lanl i hatteriolog i. per· l'i ncompleta co nosce nza dei ca ratteri di parwchie specie di rnicrohi. anco ra non è pù:-.- le fcmnulare regole precise e sistematiche sulla condolla delle differenti successive operazioni, alle quali bisogneri1 ricorre re per determinare prima la specie di ogni co loni a mi-
DELL'ALI.)t:A
croui ca. t] uindi l'ufficio vero, che nel l' a.·qua e umano. Per alcune specie di batteri :-i hanno vere di loro s i co nosce non solo la forma. colla •1ual e si ma nifestano per i ùill'erenli mezzi di •·oltura. ma ànror·;l i lor·o modi diver-.i di rea gi re con n;.:enti fi:;ici: ealore, luce, elettri citit, o •·oi chim ici : ferment•lzioni varie . fenome ni di idratazion e, di :;cloppiam ento. di .;otn nl.e tns:;iche ecc.
.\la sono po co numer·o.;e. uè le ncquiwnoscen ze si possono facilmente generalizzare per le altrP e per :->tahilir e nn ul ctoclo tecnico di anali.; i.
Pe rciò un'esam e uauer-iologico dell'acqua con lo co mpleto delle colo nie hatlericlre da essa :;viluppatesi, avrehhe ri chiesto mollo temp o e molto sapere e quindi io mi sono limitato allo studio comparativo dei caraller·i delle co loni e bat· teriche delle acque esaminate co n quelli dei haueri patogeni dell'uomo, che possono trovarsi nell'acqua e dei •1uali i_· hene co no:;ci uta la biologia: e qui dehbo dire ch e in ciò fare mi ·on fallo guidare da prn clenza e cautela, onde nei tluLbiosi risultati delle mie osservazioni avrei chiesto l'apprezzato parere ùel professure At'hille Sciavo, che ebhi a maestro nel •·or--o di batteriologia, fatto quest'anno alla Scuola ò'il!iene. i! quale e per la sua squisita cortesia e per l'amidzia di cui mi onora mi fu prodigo di mezzi ; l ) ed anche òi o.:o usigli.
Le co ltnre fatte a Pontnna Liri furono 1cnute alla temperalllra di 20°-23 c. La numemzione dell e co loni e la feei il gior no 7" dalla preparazione delle coltu re, e nell e acque della torgen tP t ne troYai ron c·alcolu appro.,simativo l per ogni centimetro cubi co di ar.c! U'I impiegata e per la sorgente 8 un num ero assai magl-(iorc. f)u esLP l'ifre pl'r acque di "o rgPnti rerlamente elevate ed è uenP rirorclare, che ( p r. ulture furono falle o;ul dopo podti minuti dalla rarcolta clelle acque per prevenire appunto In protliginsa e rapicla molliplirazione dei IHllteri, bene arr.rrtala da gli di Cramer. di Boltou e cl i altri.
Tolgo lini lavoro di Lustig (Dia:,:no:.lira cl ei battPri drll'acqna) la "f.'VUPIIIP tabella pPr la climo ;;t razi one drll'arrrnnata rapida moltipl u·azinne òei batteri.
Su mero rlellP colonie in. 1 centimetro cubico cl' acr1ua.
T••roJWrntura olell':untJienLo• (ilO
\'a notato clte varie prove halleriologiche di una stessa ac 4ua dit nn o delle osr.illazioni ril evanti del valore numerico dei rni i. il che i• co nfe1·mato dalla delle anartuì npprcsso riportate. praticate dall'illustre ij:(ienista ll icp1el. dirc>llore della sezione balleriolo)!ÌI':l dell'o%ervator·i muni pa lo• eli )l ousl)oris.
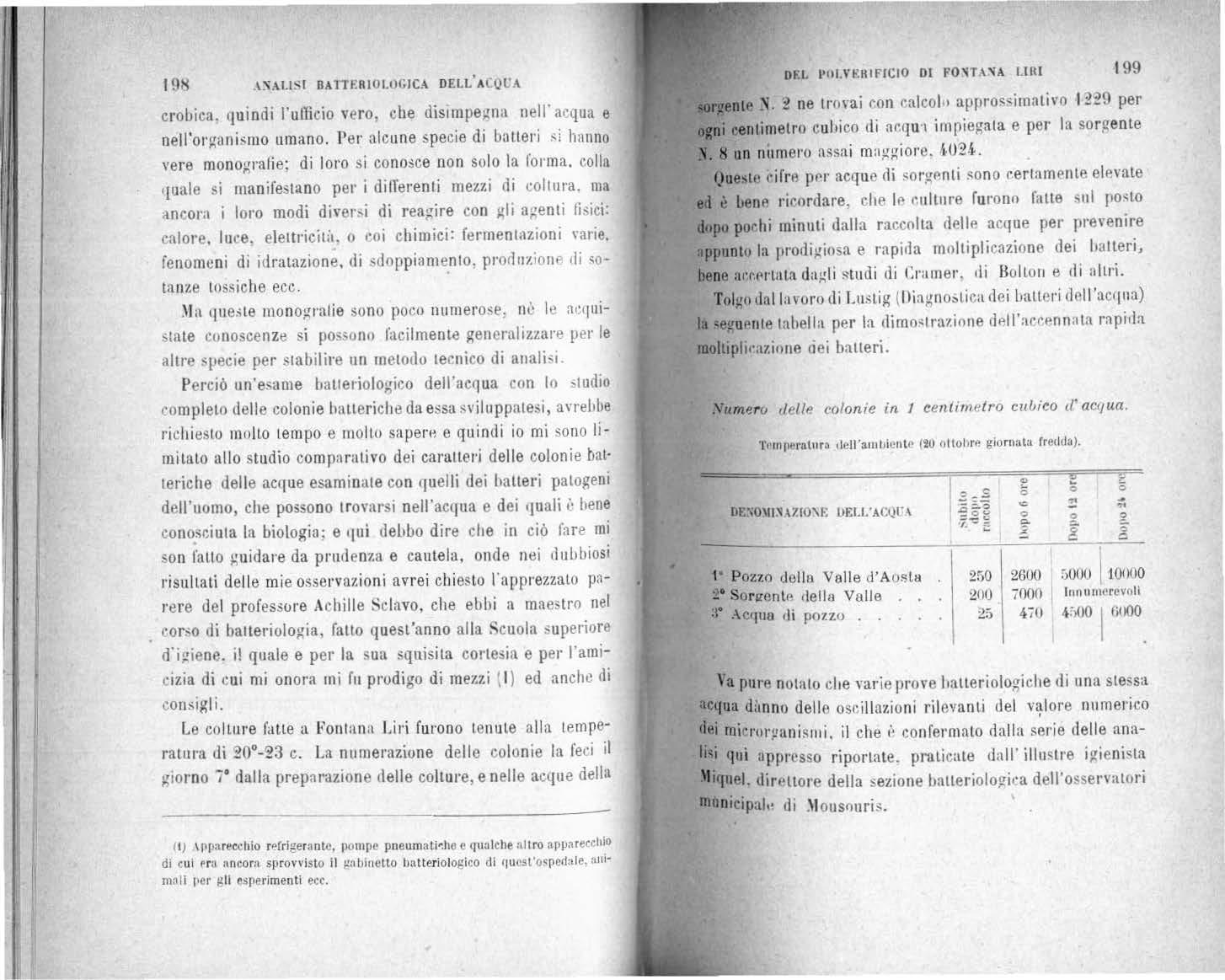
H) pumpc c qualche alt ro n(tparerchìo di cui fr{L nncorn sprovvloto Il ;tn Imo etto b(Ltteriologlco di IJUt•st'ospcd;tle, n11i· mnll per ftll r spe rimenlì
.\'('IO 18U0 ( \MiNE. Al \ TO JO DI 'l OXTROI!Gt: •
R11 !teTi ]lei' l'entÙIH'tr i eu/nei rl' acqna. jnalisi del 2\1 luglio l RHO. :)o
>• )) 9:1 fehbra1o » 100
)• )i :?:3 maggio Il :;oo
)) » G ;.:ingno )\ 10011 li )l x lugli(1 )) :;o oo
» » l. :1)!11:.111 )'
11.0011 llattrri pt'l' 11/t cenliluet!'o mliico fi' li C'Ili Il. del 1!1 111agg10 I K!lO
18!HI (. EWH, Al.l." Ofl'lLI'iE o' h ·a, ).
1.000
» » :!, giugno )l 1:2000
)) )) :l marzo » i-00011
)t >• 6 \!enna io )ò ltRfiCIII
Come dunque :-.1 vede. la quarrlita di hatlen di ù variabile. sia vcrdrè da un ' acqua potabile a q.uella che non la (• pi11 le cifrf' C(llonie micml1iche possono oscillare lra ;.:randr limiti. Il giudizio fondato su llll esame baUe1·iolngico quanlitativo dere avere un valore molto relativo. TulLav h una sr.ala dell'o1·a nom inati) igieni :;La francese, con la IJUale i: intlicato in moclo apprussimali\'O •Juale dere essere la dei lmllerr delle categorie di ncqna, mi autorizza a quella del poi veri liri o di Fontana Liri rome mediocre. Et·co la ind rcata scala:
IlEI 1'0 !.\EIHFICIO III Lllll
Balleri per OJ.(ni cen timetro cuhico di acqua
Ac•tua ecce:;:.ivamenle pura O a l O
,.
1O a l 00
» pura . '' 00 a 1 000
» mediocre impura .
1000 a 10000 10000 a 10000 0
,. molto impura 100000 a piu.
In •1uesti nll imi anni importanza si i· (lata al aomero dell e spel'le direr,..e di colonie. che si tro1anu in an centimetr·o cuhi co di ar.qua. 'ligula, tlislirrto batteriologo di Cadsr·uhe di ce che :\e in un cenL. cul1i co di acqua i trovano più di dieci ,;pecie di coloni e. si del'e ammettere che quest'acqua è piir o meno inquinata da sostanze organiche ed impure ed in questo caso i halleri clelia pulrefazioue predominano.
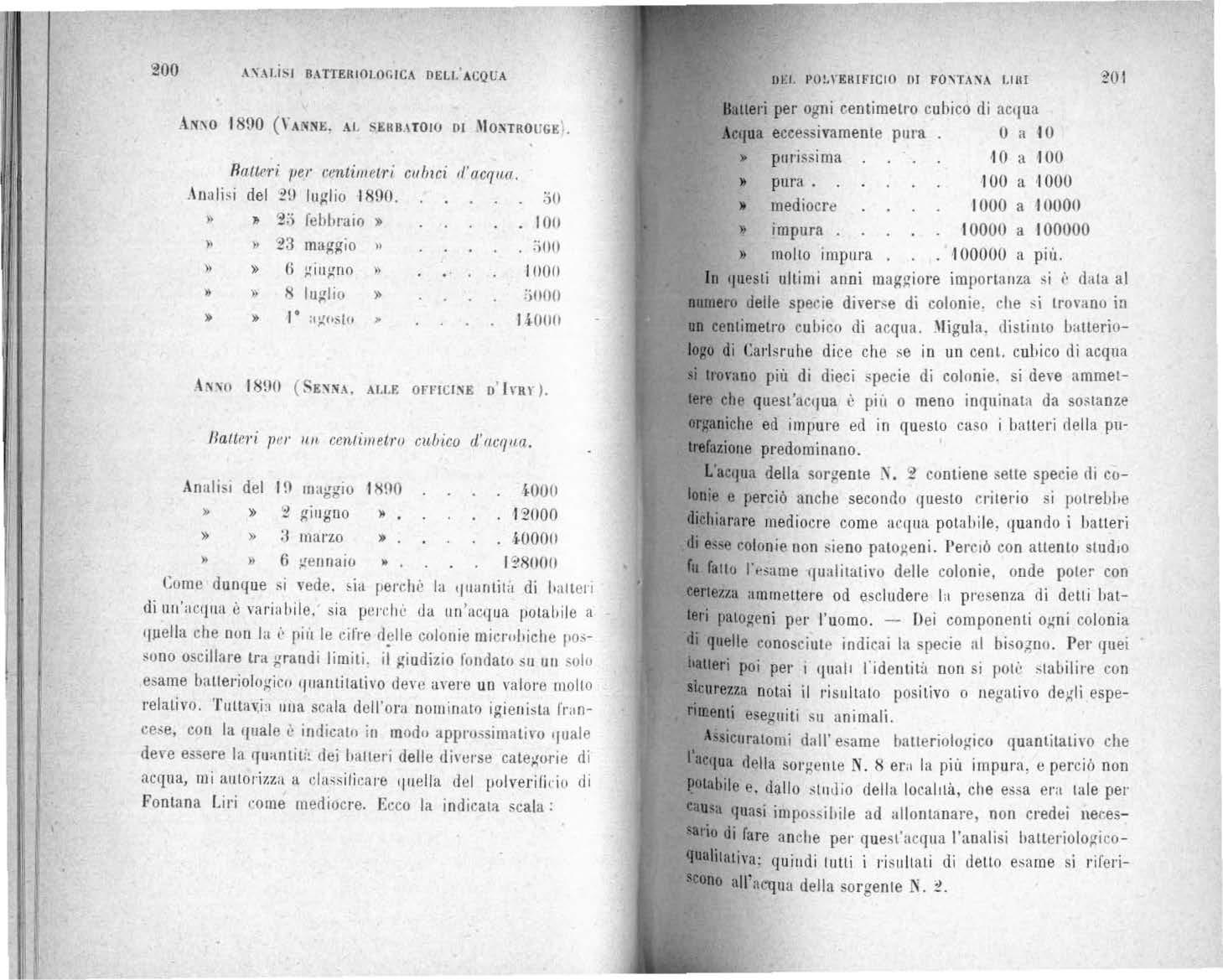
L'acttua della .\. contiene selle speciP dr colonie e perciò anche secondo questo rriterio si potreJrl,e di chiarare medi ocre co me arqua polallile, lj uand o i haueri di t'OII)nie non sieno patogeni. Percrò con aLte nLo studro ru fallo l't•same qualitativo delle colonie, onde poter con eertezza amrnellere od escludere la òi detti batteri patogcni per l'uomo. - Il ei componenti ogni colonia di quell e conosciult> indicai la specie al bi"Oi!Hl. Per ttuei haueri poi per r qualr J'idenlittt non si pOlL' :-tabi lire con sl.curezza notai il ri su llalo positivo o negativo degli esperimenti :;u animali.
As icura tomi dall'esame batterioto:.:ico quanlitatilo che l'ac•tua tlrlla sorgente N. S la pi(t impura, e perciò non I?«Jlabil(' e. dallo ;;t udio della local rtà , che essa era tale per eausa •tunsi impo,..,.il1ile ad allo ntanare, non credei neressario di rare anche per q uest'ac4ua l'analisi hatteriologiwqualitutiva ; quindi tulli i ri su lt ati di dello e;;a me si r iferiscono alr:H:t[ua della sorgente N. :! .
(Juaclro tndicanle 1 ri sullalt d••i ualferi, df'iio studto r/p/le culwre a deylt espe rimenti fatti IW{]lt an.imali, imJiie!lando c ulture 1'/cacate tlalla so r {;ente S. 2 de l polverijìcio rh t -;.. Jt'o1llana Liri.
:\uulcrn· Lione delle cu liuri) GAIU'ITERI l!OIIPOLOt:JCI r: GU LTUII .\1.1
Cull . t•. l Picco li coccln agg ruppali in ammas!-li irre go lari. Le su piasLJ·o di gelatina appn 1ono r otonde, di un bianco d1 por cellana non r iiPvate, e con piccolo ingrandimento s1 mostrano tn tll'ifo rm e con trnta giallastra. B atterio immobile non fluidifica la geiAt ma che tardamente e lentamente.
Cull. 2 l M1 cr ococchi spesso unili due a due non Cttpsul ati. Lo colonie in g-elotma :-;ono di tlll coloi'ILO r osso -maltone. Dopo cinque giot·ni hann o un d1amdro di 0 ,5 mm., nei gio rni co nsecutivi le co lonie acquistarono un rolorilo sempre ptù da accostarsi a quello del cin!lb1·o. A debole ing-randimento le co lonie che sono profonde nella massa appaiono r osso - brun e. Ballerio immobile: non fluidifica la gelatina.
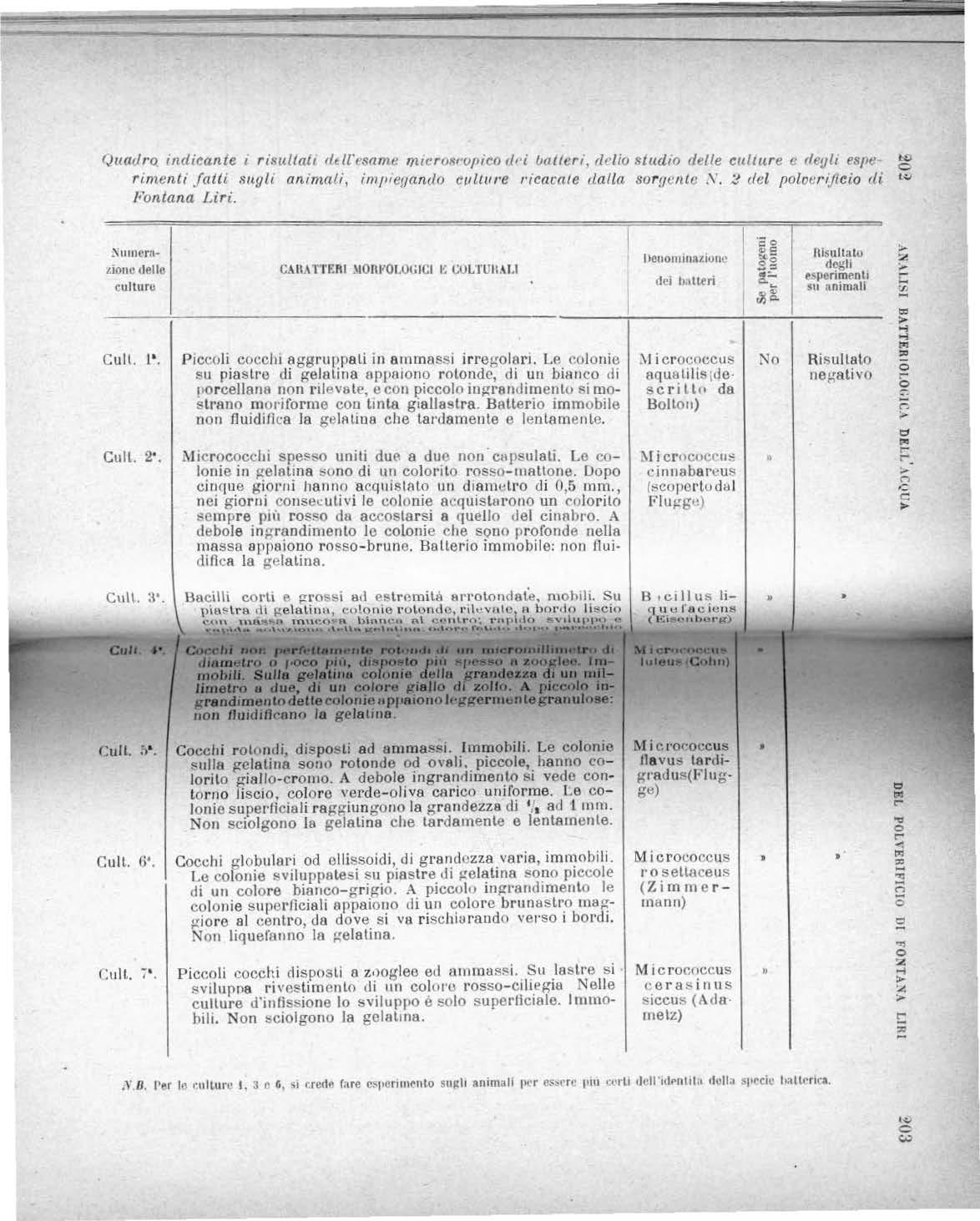
Cu\1. :\'. l 1:3actlli corti e g r ossi ad 1'!\lr Pm ila arl'Otondate, mohtli. Su d t r olnnd<•, t•ilevnll' 1 n b01·clo Ji,..cio \"OH f \ b ì ont'tt. f\\ I"Hitl·'O ll61lOllllll3/.lùllt' tlei batteri .\1 i Ct'OCCJCCUS aqualilis tù esc r ill•• da Bollon)
Culi. :1• l Cocch i r oto ndi, di!'pos l i ad I m mobili L e col on ie sulla g-elatina sono r oto nde od ovali, piccol e, hanno colo r ito g-iallo-cr omo. A debole ingrandim ento si vedo contor no Jisc10, color o verde- oliva cal'ico unifor me Le colonie super·tlciali r ag-giungono la grandezza di 1,'1 ad 1 mm. Non sciolgono la gelati na che tardamenle e lentamente.
Cull. 6'. l Cocchi globulal'i od ell issoi di , di gl'andozza varia, immob ili. L e colonie svilu ppa lesi su pi astre di sono picco le di un colo re biauco-g r igio. A piccol o le co loni e superficiali appaiono di un colo r e brunastro al ce ntro, tla dove si va rischl orand o verso i bot•di. on liquefanno la gelatina.
Cull. i • . l Piccoli cocchi disposti a z•logleo ed Su lastre si · riv es tim rnto di nn coloro rosso-ciliegia Nelle cul ture d'inCìssione lo sviluppo e solo superlìciale. l mmohill. Non sciolgono la gelal1na.
\f i crococcus cinnabat·eus (sco por tu da l
·a o <>S llhullalo l e<. o 2:o Ilegli t'Perimeoh SII animali No Ri!>ullato negativo
M i c I'Ot'OCCUS lla vus la r òige)
M i c r ococcus l'o s eltaceus (Zimme rma nn)
M 1c rococcus (Ada-
RATTERIOI.Ot.ICA UELL'ACQUA
Accertalo l'inquinamento dell'acqua in esame, era neL·t·ssario cercarne le Per la sorgen te N. la ripeto, ·ta nel poco spessore del snolo sopra. tante alla l'alda liquicla: per cui con questa si vanno a me::-colare act1ue pio\'ane non compleramenre filtrate. Ma le stes,;e acque prolou rle di quesla :.orgente non si possono con sicurezza ri tenerr non inquinate. mancando a monte della falda liquida :;ollerranea una zona di protezione non coltivata e non abilata.
Accanto alla strada provinciale, nel tratto elle poro è lonlano da questa fonre. a monte. si trovano olrre i fablll'icnli del poh·erilicio (quello dell'ar.iùo nitrico. della denitrificazione degli acidi riguadagnali dalla nitro-glicel'inr:. delle offici ne di maestranza, della r.aser ma ed infermeria) anc1 1e in numero discreto fabhl'icati di proprietà di privati ed un por.zo con actJUa guas ta 1ra le case di proprietà di Ma cioccio e Ama- · turo; quindi . eccell uato l'impianto di adatti fillri. elle for,;e riuscireiJIJe difficile, nessun altro provvedimento. a mio parere. potrebbe render·e potabile quest'acqua.
Per l'acqua clelia sor·gente l. invece le conrlizion i :;ono meno sfa ' ore1 oli; del suo lo soprasra nte alla falda 1iquida !.!i•L ne parini; pochi so no i fabl1ricati e nessuno di essi òe,•e srr' ire per abitazio ne: dal fahhricato per il miscuglio de[.!li acicl1 e da q uello dell e caldaie al casello del guardiano del t·anale. zona, non vi é altro faiJI.Jricato ..\ nclre al ùi la del muro di ci nta del poherilicio. accanto a IJUesta wna. non Yi sono abitazio ni di pr ivati. È pnr vero però che in vicinanza eli qne.;L·t sorgente N. :2 sta il fabbricalo per la nilrazinne del coro ne, ma io credo che SI possa provvedere senza grande d ifficollà o che il suolo non resti inquinaro dai liquidi d1 rilìuto.
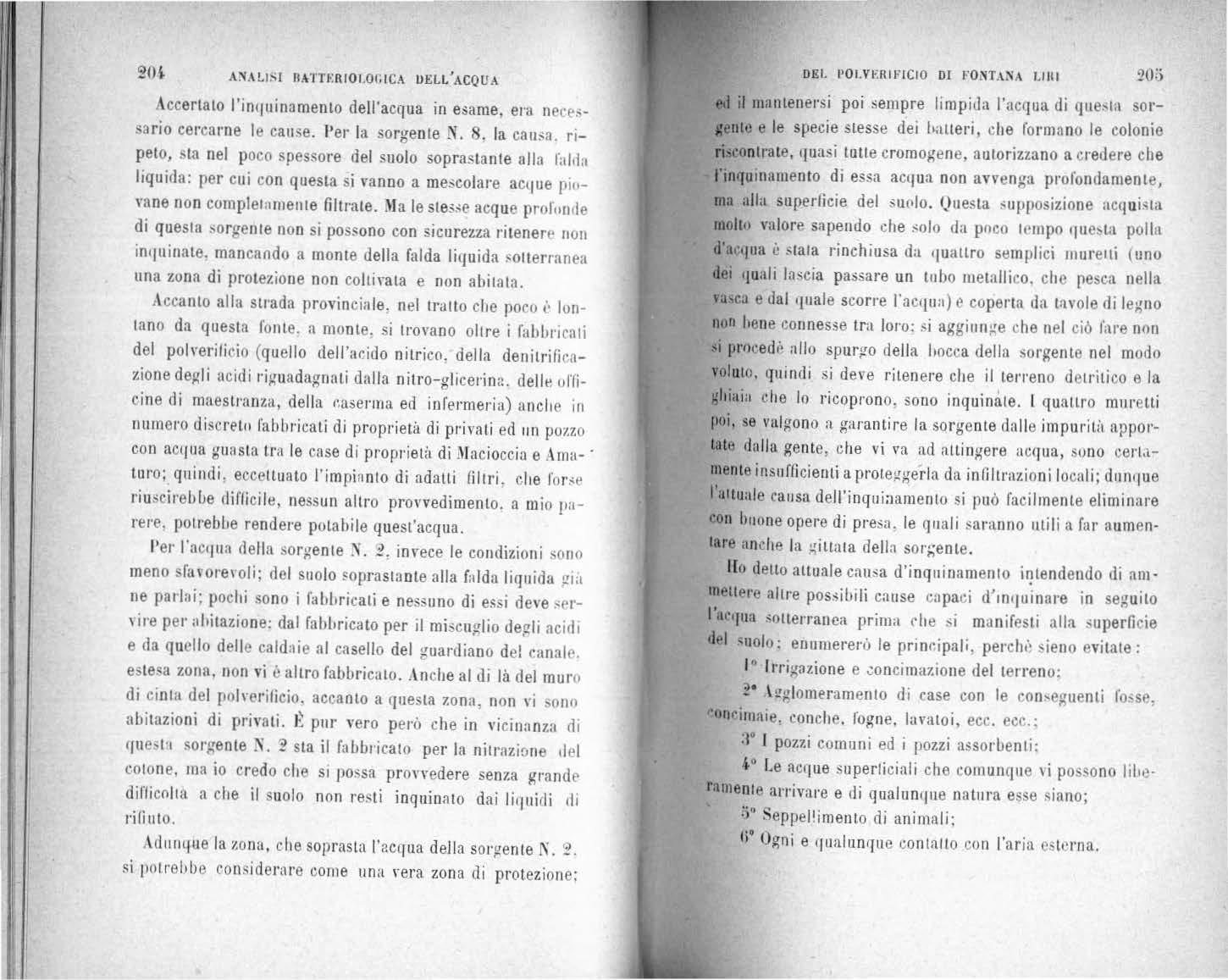
Adunqu e la r.ona, che sop rasta l'acqua della N. 'l. si porr ebbe considerare come una rera zona di protezione: ll u deuo attuale causa d'i nqu iuamenlo inte nd endo Ji ammett l'r'c altre possibili cause d'rnquinare in seguito l'at•qua prima dte :-.i manifesti alla superficie di'l '110in: enumer·erù le prin1•ipali. perchi• evitale: l n l rrigazione e .:o ncimar.ione del terreno: h •g Jome ramento di case con le " 0 11 L'imare. t•onche, fogne. lavatoi, ecc .
DEL I•Or.n:RIF ICI O DI FONT.\NA 1.1111 2():) etl ilmanten er·i poi sempre limpida l'acqua di tJUC:-Ia so t·gento e le specie stesse dei hatteri, d1e fo r·ma no le colonie ri!>contr·ate, quasi tutte cromogene, outorizzano a credere che l'in,]um amento di essa ac11ua non avve nga profondamente, ma alla superlìcie del 'U<'Io. Questa :;upposizione acq ui.,ta rnolt u Ya lore sapendo che :;olo da pnco lt•mpo que:-.Ul polla d'M•Jn a è :;lata rinchiusa da 'tuallro semplici murerti (uno dei ' Juall lascia passare un tubo metallico. che pesca nella e dal 'tuale scone l'ac'tua) e copel'la da t:wole rli legno non hene ro nnesse tra loro: aggiunt.re che nel ciò far·e non pr1wed t\ spur)!o della hocca della sorgente nel modo voluto. quind i si deve r·itenere che il terreno d etritico e la ghiaia ehe lo ricoprono, sono inquinate. L quallro mnr·ctli poi, se 1•algo no a garantire la so rge nte da lle impuritit appor·tate dall a gente, c he vi va ad at tin ge re acqua, uno cerl.lin suffi cienti a pr·oteggerla da inlìllrazioni loca li; dunque l attual e ransa dell'inqu i;t ame nl o si può facilmente eliminare con hnone opere di presa. le quali :>aranno utili a far au menant'lte la ,:ittala delln sorhente.
:1• l pozr.i comuni ed i pozzi assoruenti:
4ò Le acque superticiali eh o comunque 'i possono liltt'· ramenr e a tTivare e di qualunque natnra esse siano;
:;o Seppel!imento di animali; l o non dir ei ce t Lamenta all'in;e,:nere. per tema di oll'euche il serbatoio non dt•\e perrnellere perd1ta di a•·qua. rw inli!Lrazione e ueppure l'entrata in e:-:so ad nnimali. 1'11e
H" Ogni e qnalunrru e contallo con l'aria C':Mt·na.
Occorrendo d i fan· cl ei si io 'icioanz·t dei fabl,ncati. che sono nella zona. rlte lto !'hiamato di prf1tezione . si dPbhono evitare le fi,,e. I'O!IIUnque co:-lroite, e deve tlare In preferllnza alle mobili. perché meno !JPt'irolose per l'inquinamento del ·Hwlu. minori devono es.;ere i riguardi e le cau t ele nPil'imp antn dellf' condotlure. cJonlora. come t'• progettato. ,i \'oglia l'acq11a dalla :-or:.tt'llll' ai serhatoi. La condottura. anche •tu ella in cnt l'arqna !i•·orrf· per semplice itazione. drH"ra e,-,pre chiusa. ad nn a t'l'l'la profonditit e ron materiale rmpe rm eaui le. on1ie l':wq1w ,ia prot ella dn ogni contami nazwnr 1lall'e ·terno e da sfarnn'\nh mocWìraz ion i 1lella te mpera tnra l st' l'lmtol. da ùo, e l'actjliU verrà co n maf'cltine elevata e in dtstriltnt.io ne ed il ser batoio , elle si l'Hr·ebl•e a mP.z.t.n cos ta de l monte le Crse per· ri ceve re l'acqua su per flua ai l.isogn i de llo imento per· essere poi :1doperata a ll 'ort·orl't:>Ozu, spintavi dulie slesstl ma cclti ne. vnooo costillliti c·on precelli d'ingegner·ia sa nitaria .
J.liiS ono cont.1mi nare l'acqua: non )!li dtrei eire la 111 ùue scompartimenti è sempre IJÌIL opportuna, perdu• si as icura rl ,ervizio, qualora ahhi,o;ui r ipulrtura o riparazione: ue che il material1• di co.;;truz.one òeH• es...er tale da non altetare 1'.1cqua. nè t'ome clovranuo dis!Jo:tl i due tubi dt entrata e di n:;cita: ma l(J pregherei per una !lnuna copertu ra. allo :;copo ùi l'acqua da illiJUinanH•uti e togli erla anche all'inlluenza della locP. raccomanderei un snfli cie nle spe!lsore de ll e pareti. copertura di es:'e con ClH'pi. che siano t'llltivi rondu tlori del calore, eLI uua ventilazion e dl'll'ambiente. pt'rCirL' sia m:111tenutn all'acqua
DEL POl.\ KRIFICIO DI FONT\ \A tiRI -t o: eon,enien te temperalll ra: ed a ljnesiO scopu ' 'o rrei. t•he tabo dt>l 5erhatoi o fosse coperto da un :.Lrato di lena. Pen ... u 1'11e qual che leuore potrebbe incolp:mni eli ll&to troppo per un a simile relazrone. ed ro percrò debbo 3;.!:-!iunger·e che alcuni ri c'ordi e risultati di altri «.>sami bauerio)!rafici di acq ne dati da eminen ti iJ,!irrr isti, furonu a bello studio da me citati . onde mettere in guardia ctun lehe eolleJ.:a con11·o la troppa ùuuna fede o tendenza che Cj.: lr po,sa avere a1l :ll'rurdare un "nlor·e a r·ert1 dr esami lta lleriologici delle nrr1ue. per riò dre ... i ... pecialmen te al rrn mero dei hattE:ri per ogni c·enL1m e tro rui>ICo di aeqna. r nw·lllsiuni. l.e acque del poherilicio di Fontana Liri pre:-e ad na re furono qu ell e sorgen:i r ico nosci ut e da i num l' ri X.
•:ntmrnh e hanno vre:;eutato un numer·o di halll'ri '"P·r ore di mollo a t} nello che ordinariamente hanno le huunc a •tue di IleIle due :oOI'J.!enLi la IJÌÙ iuquinata t' quella de l ;\. S t· la rau-.1 clt·ll'inquinamento è di diflicrle. per non dire impo,,,_ bile . rf'mozi ont>, perchè dipende da inromplela liiLra1.lun•· delle Ul'que piova ne. che pe rcin impure vanno a mescolar'i con le at:que :-ollerranee, che : limentan o della so r,: enLe. La incomplt>ta liltra;.ione llipende dal poro s pe:;sore del Ma ,.i ,. pure la pos,;ibilitit. c he l'a cq u :t di que... ta ... veng.1 giit du lonlauo inquinata e ciò per il pot.zo co r1 l'acqua guasta. che si trora tra le case di proprie tit \l al'iocria e1l Ama111r n. non i· prudente l'ar ia adoprare rome •c•t ua potn bil e.
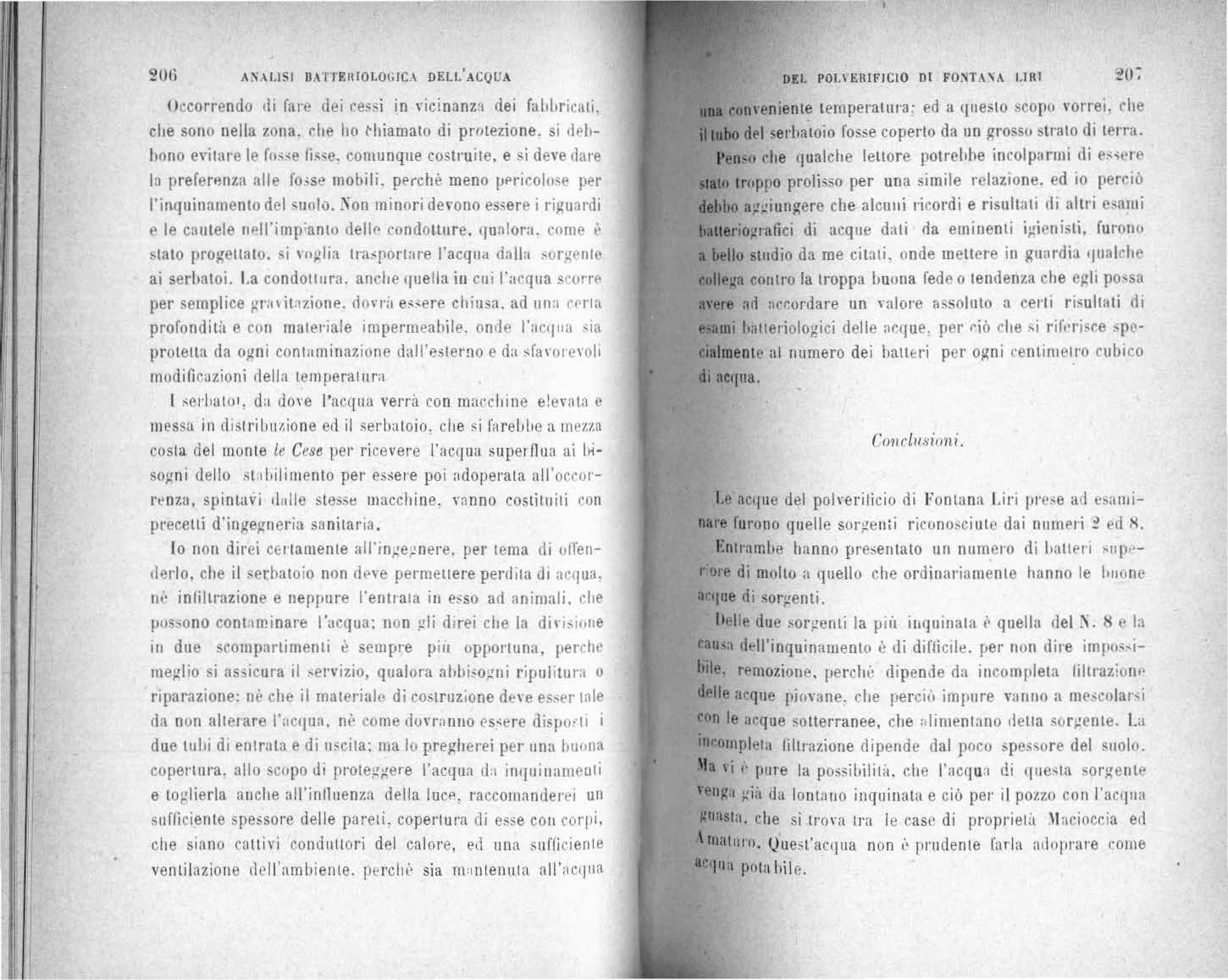
L'acqua (}ell.t :;orge nte N. ancora potabile invece, si puù aedet·e che venga inquinata alla sorgente stessn pe1· 1,1 manca nza di un 'app ropriata opera di presa, la tt ualc• opera . ollrec hi' renderebbe pura l'acqua, aumenterebbe an che la :.:iu.a ta della sorgente.
Si mcromanda di tener presente le cause 'opra c·ttate. che po.,so no routn mm are lb acq ue sollena nee per eYilaJi e e pren· tlere nella voluta considerazicme i preceLti igienici acc ennali Jlt:'l' l,t eli una hnona ··onllollnra e .;er hatoi .
Ista Di Giornali Italiani Ed Esteri Rivist A Medi Ca
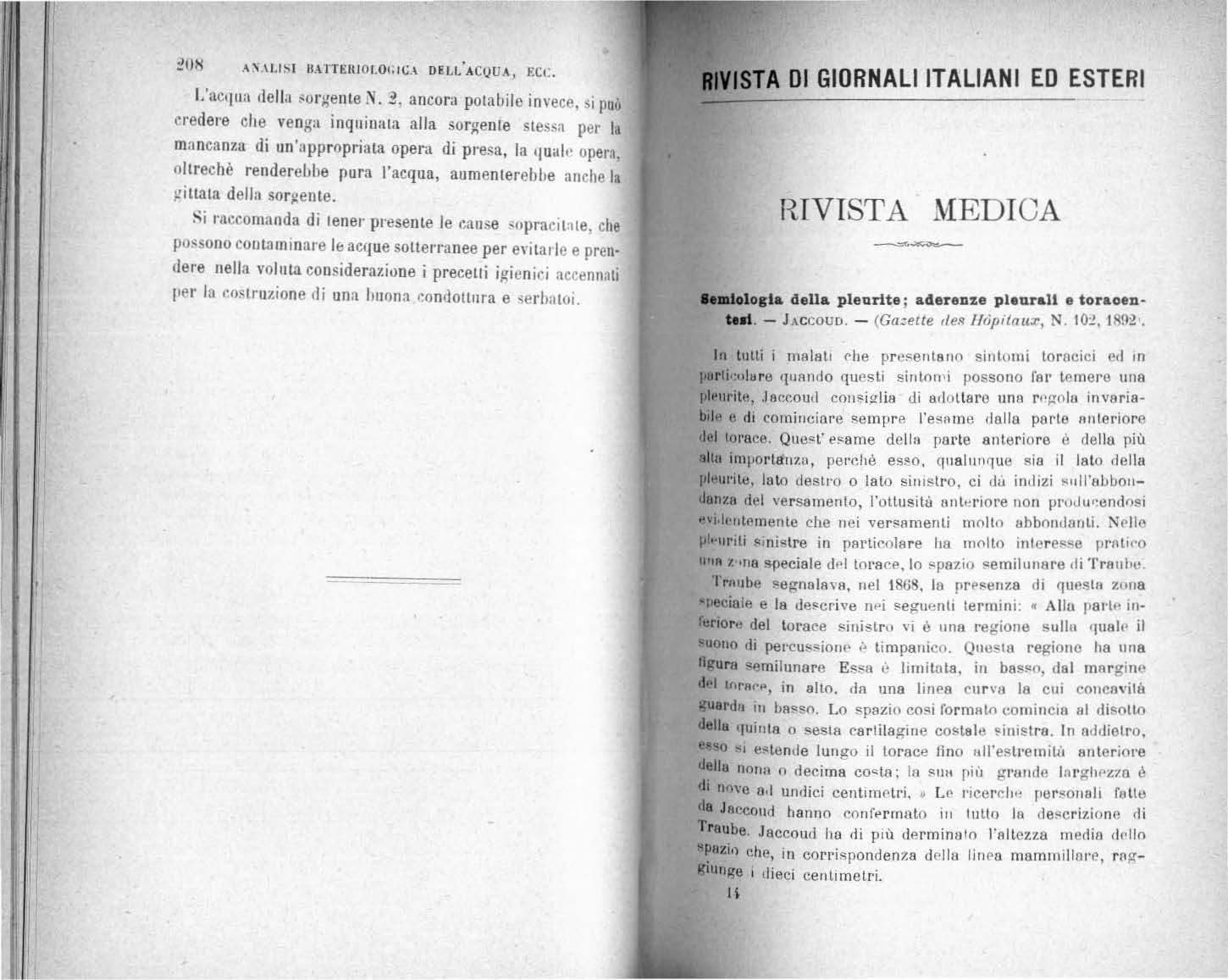
lealologla. della. pleurite ; aderenze pleurali e toraoenteat . - hccouo. - (Gazette des !lòpilauJ', N. 18fl2.
In tulli i malalt rhe sintomi lorocici <•d m Jlarlic:olure qcHrntlo questi possono far lrmel'(l una !Jll'lll'ite , .l 8('r.oud ùi ado t lar e unll r t•golu in variab•lt• e di cominciare sempre dalla par'le nnteriorE' tlel IOJ•ace. Qu ec:.t' eS<ame deliA pa t•le anteriore ù della più allu impor·tan7.n, pe t·ché es!'o, fJua l unrtue sia il lato de lla lato Jest r·o o lato siru:;:tro, ci dù indizi sull'abbonclanza del versamen to, l'otlusiltl nult'riore non pt•odu 1'endl')si "'i·lt•rilf'mente che nei ver sAmenti molto ahborulnnli. Nrllr pl••ur•ti i n pArlirnla r e ha rnolto prnlir•o 11••11 1 •Ila speciale dt>l Lm·arP. lo spazio c:.emilunare eli Trauhe Truubp nel 1868 la dr fJUI'Stn zuna e la descrive nPi seg:uenlt termini . " All a par·tc> inf"rior.· del torace sinisLN ,.i e una r·egione sullu qual!• il "uono rli pet·cu«sion<> , limpanieo. Qno.,.la t•egiono ha una llgura ,..,.milunarc E ssa t• llmi lola. in bassn, da l mnrgìrw dPI lnr'll<'t>, in allo. da una linPa ru r ,•a la cui coucn "ilà guardn 111 IJAc:.so. Lo spaziP cosi for mAto t•ominc•a al 1lisouo delh1 quiuta o sesta ca r tilagine costale "in•stra. In addietro, "' e!':lenJe luugo il torace fino all'eslJ'etnilu anlerim·e della nonn n decima coc:.ta; hl :;:nH piu graudP l:lrglwaa è di nnvo 8•1 undici cen t imrtri. • L r r·iceJ•rh" rtl llo da Jnc·court hanno ronrt>rmnto ili lutto la de!:'crizinnf' di Traube. .Jaccoud hn rii più derm inato l'nllezza meclin clr•llo che, in corr·isponden7.a drlla littf'a mamm illo t·r, r fl!rglunge t dieci ce ntun etri.
:t
Il lilnpem,.mo rli rrue,.lo !';flfl7.io t> F< peciale; è un suo nr, vuolo, ncldommaiP , nculf). cliffPt•ente dalla sonor 1là pi11 grA vr pn1 pi e na ciel polmone. Si ò che in fall•, q uesto pun to, il non è r :e mpilo dal polmoue
La varde coslnle, la pleura co ,., lale o d•a frammalJCa, il d1a· l'rRnnnH sol l.n to :,;0110 ntlerpo!';li tra il diln ,. l'addome . La trova que ....to punto la •h·ll" :"tornaco e del CO II) II ,
A fiAnr·o d1 I( Ul'!\lo limpanisrno, JtH:COUII l1n duP alli'C parlico iM •lA: t• c:•·ll•• \'t hri:IZIOni V(ICl:llt; 2• del UltlrUlOI'IO V6:S('ICOiare, che co11 J'IJ!>;::;.-nza stessa del polmoni'. Le "ilmlzlu ui vocali devon o PS!<(' r e ri Cf' I'CStc coll'e,..lremilà dolie tllllt, r e•·che la mano a pplicata a piallo oll•·epas"er eube i l1rn1ti delln Rpazio e si verrebb H dalle vib1·nzioni oll'll•• pH rli v1cine. !\ella guio::a per il mormorio l'o· r ecchio non deve lasciarsi ingunnare dal mormo1·io lonta no di progagazione.
L 'oltus ilil, sostitue ndo questo limpani s m o no rm ale, p res enta un inlc r es«e di primo ordine. Questa ottusità s1 ri,;contra in tre P'randi condizioni l versamenti plcu rilici possono pr od urre una soppr esstono> totale. Ora é il fatto eli un versam e nto pl('urale abbondHnte, condiz1one che, come la precedente, e ra !;Lata ficgnalala du Traube; or1:1 é 11 fatto d1 una pleurite pa•·zialo.
La prima rll fJU esle ro nd1zloo1 r estringe talvolta drlla meliJ, ma senza mai l"•lpprimerlo completamente, il campo sonor o dello spazio di Traube . (!: la polmonite della pRrte anterio re del lobo inft> l'iore del polmone sm islro. Vi ha nella r e!..10ne o llusa al soff1o, la h r oncofonia. Benché l'alfoz10nè saa rara, la di a gnosi (t quindi facil e .
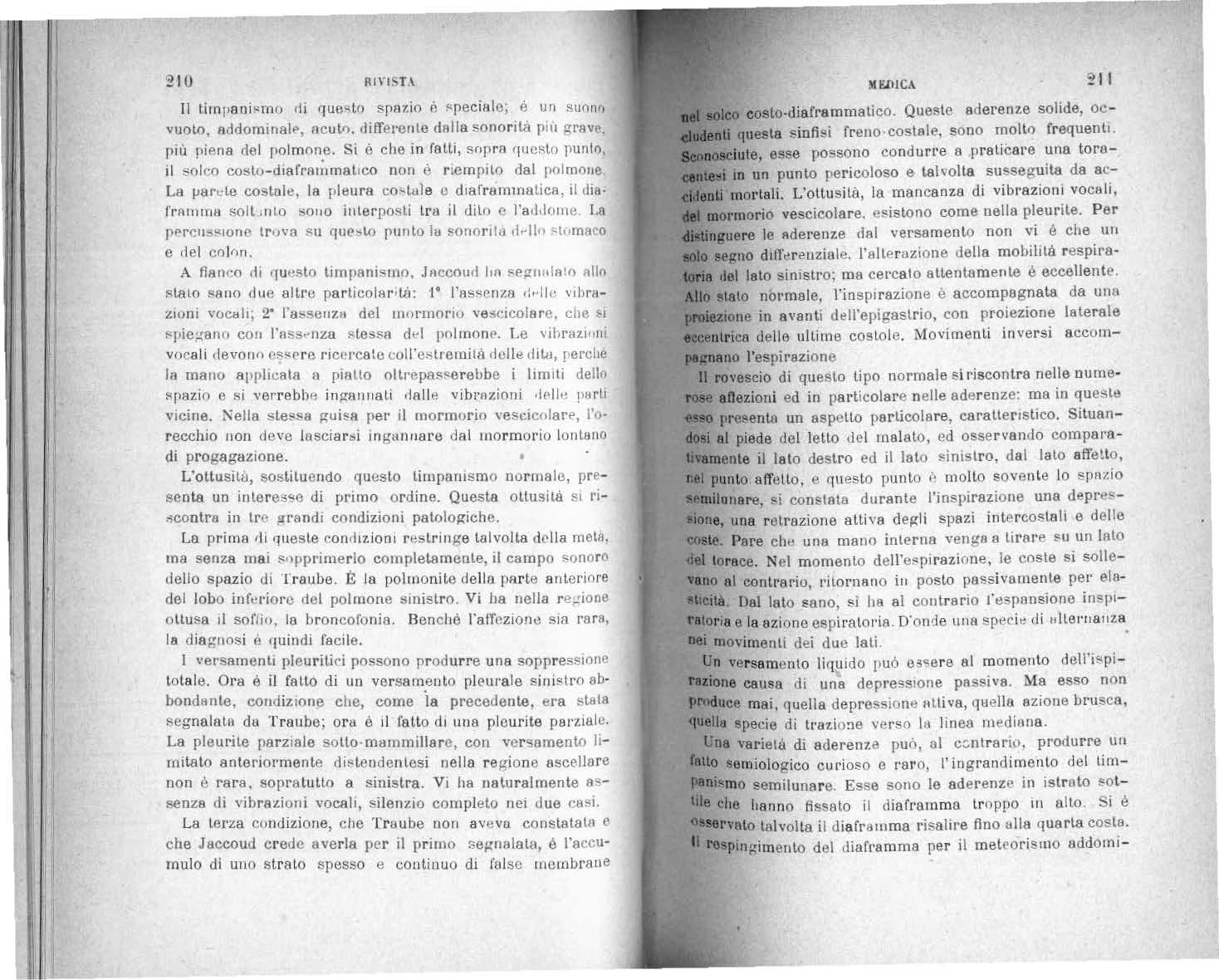
La pleurite pa rz ia le cou liJOitalQ aoteri01·mente nella r egione a scellar e non è rara, sopra tutlo a sin is tra. v, ha natu ralm ente a..,di vibrazioni vocali, s ilenzio completo ne1 d ue c;a:;i.
MFJHCA
Il rovescio di qu e!'.lo lipo normale s i t•i s conlra nelle nu me· roee aftezioni ed in particolare n e lle ade r enze: ma in qu e"Le -MilO un parti cola re, caraller•sti co. Siluan4oei al piede del !eLlo del malato, e d osservando compa•·ahmenle il Ialo destro ed il lato dal lato all'etto, nel punto affetto, e questo punto ,., mollo s o venLe lo spnzio 'leiiÙlonare, c:ti constala durante l'inspirazione una -.one, una r elrazione atti va def(li spazi inte r coslali e delle «Mite. Pare chP un a ma no inte r na v enga a Lirat•e s u un Ialo ilei tora ce. N el momento le coste si sollea l coutt·ario, 1·ito rnan o in posto passivame nte pe1· elas&ieilà Dal Ialo san o, si ha al conlrar•o t'esplln sione insptl'llor ia e la azi one esp it·atOI'ia. o ·ontie una c::.per ie d i ttl lei'IISi tZ a Dei movimenti dei due lati
Un versam•'nlo liqui do può esc::.er e al m o m e nto razione causa di una dep t•essiOne pa s!liva Ma esso non produce mai, quella depressioni' Hlliva, azion e brusca, quella specie di t•·azio:1e verso 111 linea mediana .
Una varietù di aderenze può, al ccntrar1o, produrre llll fatto se miologico c uri oso e rar o, l'i ng ran di mento del Limfllnì"'mo semilunare. E sse sono le ade renze in istra to tlle che hanno fissato il diafl'amma tr oppo 111 a lto . S i é Ollervalo talvolta il di a framma ris a lire fino alla quarta coc:tla. Il d el diaft•amma per il meleo rislllo add om i- naie aumenterebbe egualmente la zona sonora. Ma questi l'alti sono me11o importauti. l falli del primo aruppo hanno. al contrario, per la diag nosi delle ader·enze e della :;:intìsi freno costale, una importanza estrema Queste aderenze sono freq uenti. L a possibilihi. deve sempre essere causa di preoccupazro 11e n elle plcurni nel momento in cui fa d'uopo pr aticar e la torucentesi. Se non sr ricono sconQ iJUeste aderenze, cur·re rl pericolo Ji punger·e troppo basso, l<i ove il liquido, per 'fuan lo abbondan te sia, non può discendere, e!':c:endo la cavità pleurica soppressa dall' acco llarnenlo dei Non vi sono punti dt elezione per· la toracentesi. Se si su p-. pone, a fo rt io r i, se si é r rr.onosci utu la di adel'enze, ù necessario punger·e mo ' lo in alto. Se rro si corr e il per i· di attraver sa r·e col lrequarli lo slrato uni co rormato dalla par·ete, dalla pleura costale e diaframmatica rusr, dal diaframma. senzs trovare il liquido e rli penetrare nell'addome.
Condizioni patogeolohe della cistite. - GuvoN. - (Jou r· nal de M étlecine et de Chirurgie, dicembre L892).
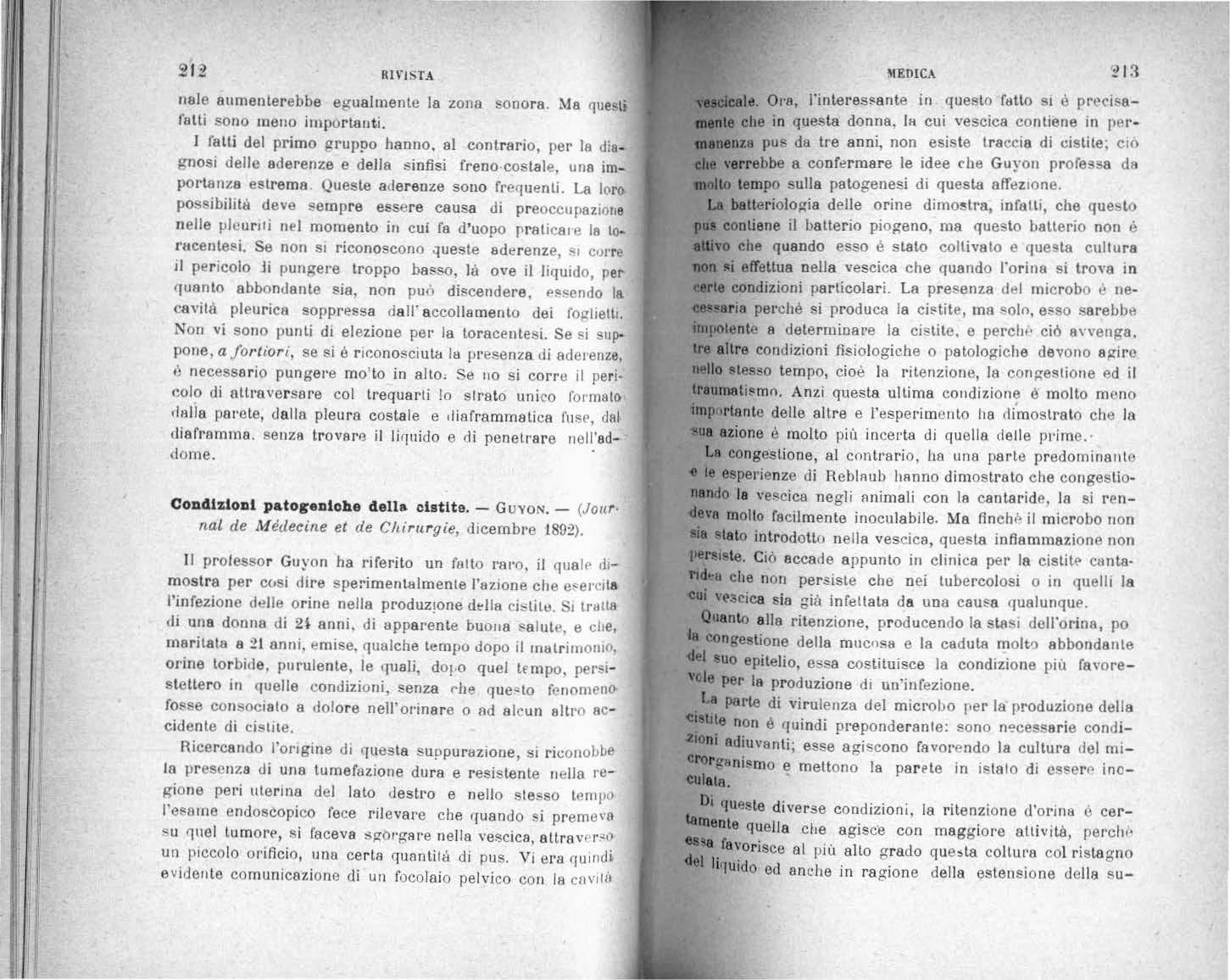
Il prolesso r Guyon ha riferito un fallo rar·o, il qualt• drmostra per· CCJSi di re spe rimentalm ente l'azr one che e-:ercrla l'infezione dt>lle o rine nella produz!one dt-lla ci:::.tito. S• Lr111ta dt una donna di lH anni , di apparente buoua salute, e che, mari tata a 21 ann i, t>mise, qualche tempo dopo il matrim onio, orine torbide, purulente, le quali, do, o que l tempo, per"tstetler o in quelle condizioni, senza rhe que -.lo fPuomenofosse co nsocialo a dolore nell'or-inare o Ad alcu n altro accidente di cistite.
Ricercando l'or·•gine dr questa suppurazione, sr ri conoutJe la presenza di una tumefazione dura e resistente nella r'Ogione pef'i uterrna del Ialo ùestt·o e nello stesso tempo l'esa me endoscopico fece ril evar·e ch e 11uando si preme\'& »u l'fllel tumot'E', si faceva sgo r·gare nella vescica, un_ prccolo o r·iflcio, una certa quanli lit di pus. Vi era qu •ndi evrdente co municazione di un foco lai o pelvico co n la cn,·rlù ta Dt queste di verse condizioni, la ritenzione d'orina r cerlllente quella che agisce con magg ior·e allivilà pe r·clw •ea fav · ., ' 4el OrJsce al ptu alto g rado que:.ta coltura col r ista g no hrturdo ed anche in ragione della estensione della su- perfl cie d'assorbi na ento, la mucosa Lulla ìntiera es>:enù() alterala, mentre che in caso dì lraumalistno, la lesione é m o llo meno estesa.
Ora , rinteres>:ante in questo fatto s t è ehe in questa donna, In cui vescica co ntiene m pe rpu s da t re anni, non esis te traccia di cistite; crò • verrebbe a confermare le idee rhe Gu yon profe3sa ds eolto tempo sulla patogenesi di questa alfezrone.
La batteriologia delle orine infatti, che questo fU contiene ll batterio pìogeno, ma queslo Lalterìo non è e&li•o che quando esso è s tato coltiva to e questa cultu ra 'DOn Ili effettua nella vescica che quando l'orina si trova i n certe condizioni particolari. La presenza dt>l microbo c ne._saria pet•ché si produca la cisti te, ma solo, esso sarebbe ùnpotente a determinare la cistite, e perch•• ciò avvenga. tre allre condizioni fis iol ogiche o devono nello tempo, cioè la ritenzione, la congeslione ed il tl'lumatil" mo. Anzi questa ultima co ndizi one é mollo mt'no 'liDportante delle altre e l'espet·ìmento ha cJ(moslt'ato che la 1108 azione è molto più in cer·ta ùi qu el la delle pl'ime. La congestione, al contr·ario, ha una parte predom inant e le espel' ie nze di R eb lnub l11mno dim os tralo che co ngestionando la ' 'escica neg l i Animali con la cantaride, la si r en-deva mollo fa cilmen te inoculabile. Ma il microbo non lia stato introdotto n ell a vescica, questa intìammaziont> non peretste. Ct ò accade a ppunto in clini ca pet' la cis ti te cunta1'1dt-u che non per.siste ch e n ei tubercolosi o in l'fUCili la -cui Vt>arica sia già infettata da una cau sa qualunque. Quanto alla ritenzrone, pr od ucend o la stasi dell'o rin a, po ta congestione della m ucosa e la cad uta molt'l abbonda nte -del suo epitelio, essa costituisce la condizione piu fa vore'YOie per la pr oduzione di un'infezione.
. La parte dì virulenza del micro bo per la produz ione della non é (fuindi preponderanle: sono necessarie cond i.ZIOni adiuvanti ; esse agiscono favorendo la cultura del mtCI'Orga ni!Orno e mettono la pa r ete in rstal o di esse r ,.. ino-culata.
Queste condiztonì appunto mancavano nella malata in di sco 1·so; il mtct•obo arrivato acciùentalme11le nella vrsctca non ha potuto esservi coltivato, e ciò spie-ga l'assenza di cistite. ·
Guyon ha osservato molli falli n •1uello rife r ito ed ha in parLi0olare dlato un caso nel quali' il co nta tto del pus con la vescica ha duralo tr·enta lltHti senza cagionare cistite St trattava di un uomo d i 31 atHtt, da una pionefr ile calcolosa, che, dal succes"t v o ad una "JH?rHzione fH tLa pet' evacuar e il pus, rresenlavn orint> limpide. O ra , malato, dopo il suP primo arm o di villl, aveva s em pre emesse orine torbide. Non vi era s tnla ruai cisti te, per ché subito dopo l'operazione le o rine erano •liventate chi11re.
Si può osset•vare nella stessa guisa la comu nicazio11e della vescica con l'intesti11o senza che si abbia cistiti:! e lu pe· netrazione del coli-bacillo è insufficiente da sè solo pel'" produrla.
Insomma, perché si produca la cistite, è necesslll'io che il terreno sia adatto per la modificazione tlell'epitt>ltn "della circolazio n i"! .
Delle pseudo- coxalgie . - DuPLAY. - (Gazette Il6pit a u:t. 100, 1802).
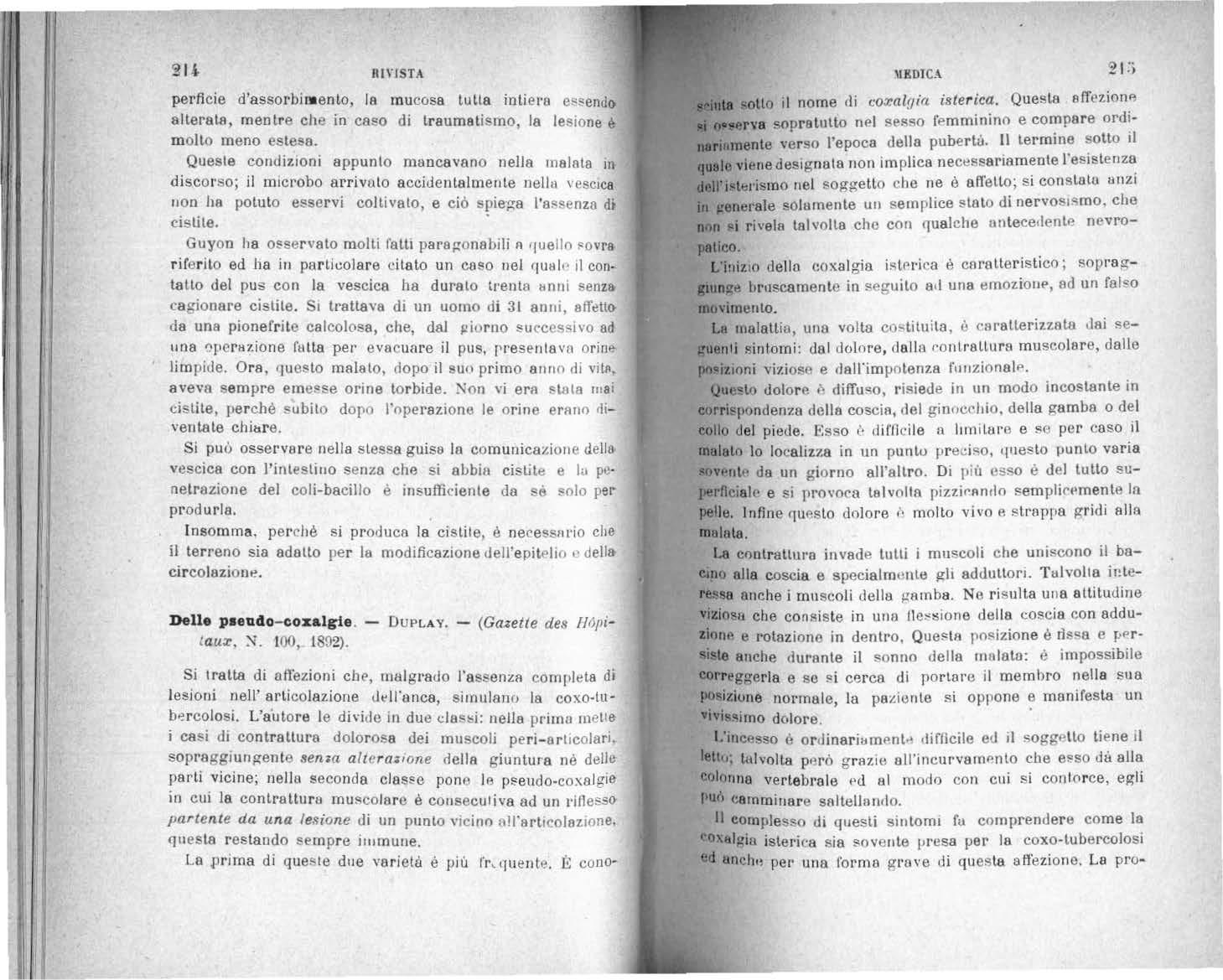
Si tratta di aflezioni chP, malg t·a.do l'assenza di lesio ui nell'articolazione Jdl'anca , simulano la coxo-luL'au to re le divide in due clast-i: nella primo metre i casi ùt contra ttura dolorosa dei mu scoli pe r i- articolari. sopr aggi u ngente seMa alt er az,one della giuntura né delle parti vicine; nella seconda classe ponr le psendo-coxalgte in cui la contra ttura musco lare é conseculiva ad un rifless() partente da u n a lesione di un pu nto v1cino n!l'artwolaz10ne, questa r esta ndo se mpre irumune.
La p r ima di due va ri etu è pi u È cono-
\lEDI CA
110Uo il nome di co:tal[Jirt iste r ica. Questa O'eerva sopratullo nPI fpmminino e compare ordiJIIriomente ver!'O l'epoca della pubert.U. Il ter min e sotlo ti quele vi eue desr g nala non implica nec t!ss a.rtameote nel sogge tto che ne é affetto ; si consta ta u nzt in ttenel'ale solamente un semplice sta to di nervossc;mo. che non ,.j rivela tal vo lta cho con qu a lche an tececlenlP nevropalieo.
L'i!tiZIO dello coxa lgia. is lrt·ira é cnrnlleristico; Mp t•a gbruscamente in seguito a•l una aù un fal"o movimento.
La malalli u, una vo lla co-;tiluita. •' co•·atlerizzata ,Jai seguenli sintomi : òal dolore , dalla ronl rall u r a muscolare, dalla po•iztoni viziosr• e dall'impotenza funzionalP. dolor i' diffuso, ri $ieùe in un modo incostante in corrispondenza della coscia, del ginocdlio, della gamba o del collo del piede. l!:sso r> diffici le a llm tLa l'e e F<C per caso il malato lo localizza in un punto p r eciso, q11esto punto varia IOVPnt•• da un g io r no all'altr o. Dt p tu esso è del lutto supertlcial<' e si provoca talvolta pizzironrlo semplirt•m eote la pelle. Infine quP-slo dolore ,., molLo vivo e strappa gridi alli\ malata.
La cootr altut·a i nvade lulti i muscoli che uniscono il baemo alla coscia e specialm l'nle gli adduttori. T ulvolta it!leressa anche i mn scoli della Ne ri s ulta una attitudine viziMu che consiste in unn lle,..sione della coscia con adduziont> e rotazi one in dentro, QuestA posizione è rls"a c pPrsiste anche durante il sonno della molato: è impossibile COI'I't>ggerla e se s i cer ca di portare il membro nella sua po11izione normale , la paztonle si oppone e manifesta un dolore . · l.'mc••sso è o r dioa r i11 mPnt... difficile ed 11 soggP llO ti ene 11 lett••; talvolta pt>rò g r azte all'incurvamPnto che e10so da alla colonna verlebrale al modo co n cu i si con iMce, egli (luo camminare sallellanrlo.
Il comple sso di questi s111tom t fa co mprendere come la isteri ca sia soveule presa per la coxo-lub e t'colosi ed anchH per· una forma g 1·uve di qu es ta a ffeziono. La gnosi t' la cura !'\Ono pero mo l to dill'erenLi nell'un o e nell'altro caso.
Ora, la diagnos' ,. quas1 pos!>ibile, e sovente facile. Come già SI d1::>:se, l'iniziO é brusco Pd i ùistu1·bi funzionali compaiono r-;ubito, come in seguito ad una E :;si raggiungon o f[uasi semp1·e dopo nlcuue ore il lo ro d'intensit.a. Nella coxo-Lubercolosi invece, per molle per molli mesi, non vi ba che un po' di dolore, un po' di moleRLia nel ginocchio e nell ' anca, un lic\'e zoppicare che la presenta in seguito ad una ratwn o ad uua marcia. I \'Cri ""iutomi, dolore, conlraUure e pnstztom viziose, non compaiono che ptn tat·di.
I l rlolorc é eguallnente diffePonte secondo che si tJ·alla rlt coxalgia isterica o òi coxo-tubeJ•colosi. Nel primo caso, t> diffu so, difficile, o i impossibile a locallzzat·e, camh1a d1 sito da un friorno all'altro; nel secondo , C!>SO sop•·a;tgiuu!!u durante la marcia o quaudo lo si ricet'CI\ esercitando uua pressione nelle esL•·em1tà os;.ec: inoltre f(Uesto dolore. H può provocare, sia con un colpo sul calca!!no o sul gran sia direllamentc col dito in diett·o ciel gran trocanLere, o in a vanti sulla tesla del ferr.oro .
Di più la po8is io1te lliziosa nell'individuo non t'• la stes:<tt net due casi. Nella coxalgia isterica s1 con!.'tala, fin ,Jall"inizw, rotazione 111 dentro e fless ione; me·ntre che nella coxo-tube•·colosi lu CO!"CI8 è dapprimu in r olaztOIIB a. ll 'iufuo t•i e i11 abduzione
Benche'• i rnooimenti sembr1no abolili 111 ambedue 1 CBSI, è possibile constatare (hfferenze nella loro estensione e trarue un nuovo elemento diagnostico. !:<'atto !Oiluare l'mdividuo nel decubito si app lica la man o sinistra spina iliacu anteriore e superiore per sor,egl i arne i rninitni spostarncnli, e coll a mano si imprtmono alla co,..c•a leggiei'J ruovimenti. Se si tratta di una coxalgia il bacino semb r a sa l dato al fe1no•·e e lo !:'CflUC esallamcntr; se si tratta di uua coxo-tubercolosi si può produrre 1111 IPggiero oscillameoto della lesta nella cavilil cotiloidea.
L'esame locale della r egione ro xo- femorall;) dà egualmente preziOSI indizi, almeno in un periòdo un po' avanzalo della tielaU1a coxo - Lubet·colosi si constatano atrofia muaeolare, llOa pastosi tà profonda che denota la presenza MAle 1ungos1tà.
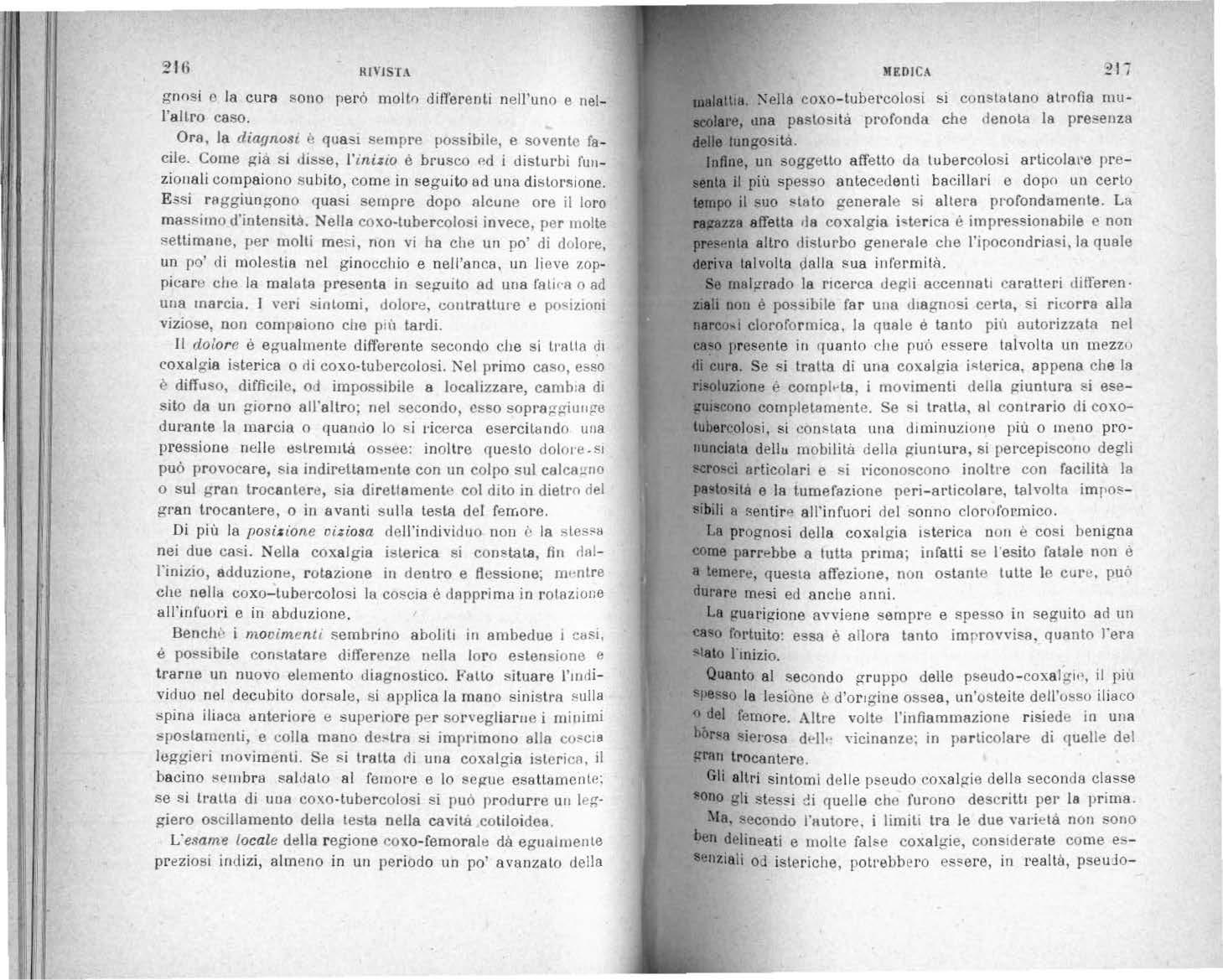
Joftne, un soggutLo affetto da tuber colosi arlicolat·e preDta il più spesso antecedenti bacillol·i e dopo un certo tempo il suo "Ialo generale si altera pr·ofondamente. La Nlf&ZZ& affetta da coxalgia i<:ter ica è impressionabile e non pres"nta al tro tli<:;turbo generale che l'ipocondriasi, la quale deriva tall'olla da lla sua fnfermitil.
Se mal !!J'ado la rtcet•ca ùeflli accennali caralleri · uli no11 è posstbile far una ù1 aguosi ce rta, <:i ricorra alla nareo J clorofor m1ca, la qualo e tanto piìr au torizzala n el caso presente in quanto elle puo essere talvolta un mezzo di cura. Se si Lralta di una i<:;terica. appena che la neoluzione e compl.- la, i movimenti della giuntura si esegwscono completamente. Se lralld, al contrario di coxotubercol osi, si constala una più o meno PI'O· nunciala dellu mobilita della giuntura, si pet·cepiscono degli l'CI'Osci art icolari e «i inolll·e con facilità la pasto,.ita e la tumefazione pcri-articola1·e, Lalvolta imposai bili a sentirP all'infuori nel so nno cloroformico.
La prognosi della coxalgia isterica non é cosi bemgna come parrebbe a lulta pr1ma; infatti se l'esito fatale non e a questa affezione, non ostanle tutte le cuJ'c, puo durare mesi ed ancbe anni.
La a\'viene sempre e spesso in seguito ad un caso fortuito: essa è allora lento imrrovvisa, qu11nto rera fllato lmizio.
Quanto al secondo gruppo delle pseudo - coxalgte•, ti piu spesso la lesione u d'or1gine ossea, un'osteite dell'osso iliaco li!tno r e. Altre volte l'mfiammazione r isiede in una bol'tla sierosa dt>ll•· ,·icinanze; in particolare di quelle del gran lrocan tere
Gli altri sintomi delle pseudo <'Oxal:;rie de liA seconda classe tOno gl i stessi di quelle che furono descritti per la prima.
Ma, "econdo i limit1 tra le due non sono ben delineati e lllolle coxal gie, co nside t·ate come e::-.aenziali oJ isteriche, essere, in realtà, pseuJo- coxalgie r iflesse . In una giova ne di d iciotto anni , rhe presenta va Lu tt i i di uoa coxalgia isterica , l'autore ha potuto constatar e u n dolore ed una pastosità che pet·siste tl.etlero molto tempo io della c r es ta-tli aca e sopr a un punto molto limita to co r rispondeolB all'apofisi ma r· g inale dell'osso iliaco, diguisaché egli venn e nel la supposi· zione che la contrattura muscola r e fosse prodotta cln una Jeggie t•a osteile apofìsa r ia dell'osso coxale. Questa diagnos i fu confermata in sellui lo, perch é, diciotto .mesi dopo, la malata guarì nello stesso tempo che i fenomeni locali cla parte dell'osso coxale scompar,•ero.
La cura diffet·isce, secondo che l!·atta dell"una o dell'a llra varielà. Se si tra tta di una p"eudo-coxalgia sintom at;ca, si dovrà guarire In lel'iOnP che ha prodotto l'aflPzione, ed allo r a il m embr o ricupet·era le sue funzioni nonnnli. Se la coxalgia é isterica, il più sovente fJU&I siasi cul'a medica o chi r urgica sarà impo ten t e. La malata gua r isce me nte senza alcuna cu1•a e senza cb,.. s possa pt·evt>dere l'epoca e la causa di q u esta gua r igione. Tuttavia , non lob · bia mo a stPnsrci da quall'iasi inte r vento terapf'ulic,, p•·rchi> fr equen temente esso rende a lla malata reali benelìrì.
Fra i mezzi medicamen tosi, vennero p1•econizzati l'oppio, il b r omuro di potassio, ma essi non art•ecano alcun giovam en to. L'autore crO>lde che in alcuni casi la suggestiontt possa r iusci r e util e.
A lcuni han n o consigliato il massaggio, l'ele ttl'icità, i movi m enti forzati; ma l'autor e non li consi glia.
Per l'autore, l'unico tra tta mPnto radical e co nsiste nel co rr egger e e nel man tenel'e l'arto nell a sua posizione normale Alcuni medici, Cl la!•col in particolare, consigLiano di abban· dona r e la mala ta n sè ste ssa, r itenendo che i vi zi di posizione scompaiono spontanea mente d opo la guarigione. L'auto r e. non è di questo avvi!'>o. Infatti, in una malata affetta cla coxa lgi a iste l'ica ed alla qua le egl i avova r addrizzato il memb r o sot to il clo r ofo r mio, egli ha p r odotto degli mollo forli indicanti la rol lul'a di bri g lie tlbrose e di r e trazioui muscolari. Dopo che la coscia sera r tcondot ta ad una no r male, si melter à la mala ta in una doc cia di di Bonnet. Si po trebbe praticare l'es tensione continua nei asi in cui !>i ha tendenza a lla riproduzione dell'attitudine viziosa. Ma, se si adopera quel'to mezzo, fa d'uopo non che u na debole tr azione, del resto si corr e il pericol o di r isv egliare. e d i accrescere i dolori e le contrattu r e.
Yet&Do l.ntermlttente d ' origine gaatrloa. - BouvERET e DEVJC. - (Journal de ,,lédeeine et Chirur[Jie, ottobre 1892).
11 tetano in te r miltente d 'origine gastr•ca non si osserva che nei casi d i dilatazione del ventricolo con gastrica. Si de vono contr appor r e questi ('8SÌ ben l'ludiati da Reich mann e alle dilata:t.ioni atoniche ed anocloridril'he, quelle per esempio del secondi) g rado dell'atonia mteslinale nelle quali le crisi gastralgiche ed i vomiti man ca no.
Tra le 23 osset'vazioni riuutte da Bouver e t e Oevic. l 2 furono seguite da a utopsi a , ed è interessante notare che in tutte si é constatalo s ia ulceri in attività, sia cicat r ici di anti che ulcel'i. In u n caso l' ul cera e r a conl'ociata ad un cancro clP.I pilo ro.
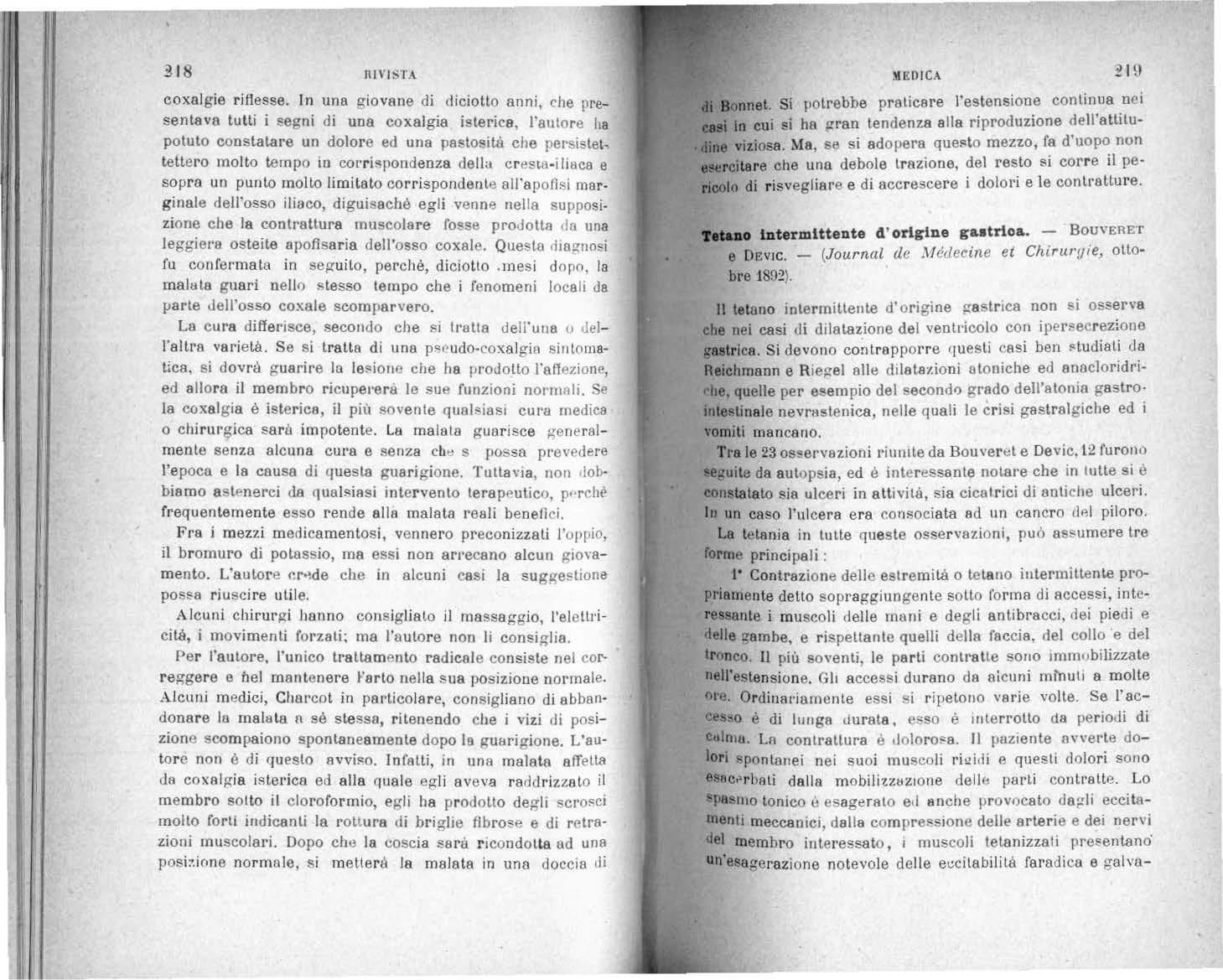
La tclania in tutte qu e ste osser vazioni, può tre rormt• princi pali :
J• Contrazione dell e estremilil o teta no intermittenle pl'opriamente de llo sopra ggiungente sotto forma di accessi, interessante i muscoli delle mani e deg li anlibracci, dei piedi fl rlelle ::cam b e , e r ispeltanle quelli d ella t'accia, del collo e del tron co. Il più soventi, le pa r li contr·alle sono tmmobilizzate nell'estensi on e Glt accessi du r ano da aicuni ml'nul1 a molte 0 1'e. Ordina•·iamenle essi "i ripetono varie volte. Se l' acé di lunga Jurata. è •nle rrolto da periodi di culmu. Ln cont1·attura è .toloro"a. Il paz1ente an·erte dolori spon tanei nei suoi riuitli e questi dolori sono dall a mobilitzaz•one parti contr·alte. Lo
SJl8!<1lJO tonico è esageralo ed anche p r ovocato da:,rli eccitamentt mecca nici, dalla compressione delle arte r ie e dei nervi ùel membro inte1•essato, i muscoli tetanizzati prel'entanò u n'esageraz ione no tevole delle faradica e galva- nica. La !'>ensibi lità general e resta intalla : !':'i é n otato talvolla uu certo grado d' iper estesia. pr i ma forma è la pit't comune.
2• piu o meno Rap presenta ab· baslunza bene l'immagine di un accesso di tetano . La contra l· tura invado dapprima Jr estremità, poi si estende ai muscoli di'Ila faccia, del collo e tlel tronco. St hanno anche mom enti di calma. dut·anle i rruali la conll'aUut·a ce;;sa od abbandona ti tmnco t> la TAlvol ta i memht•i <'O ntratli sono scos..i dall o convulsioni cianich e Questa fo•·ma é l:t'ave: la contt•allura prolun:;r11ta det mu scoli può determinare l'asftssi a.
Convulsinni toniche e cloniche generalizzale, con perdilli di conoscenza, dfl un per iodo di coma e che rammentano del tutto le co nvulsio ni di un accesso epilellico.
La contrattura è il s1ntom o dominante, ma non l'unico sin· tomo, e ciò è uoo dei punti più interessanti della questione. Cosi in quasi lutti i casi i vomtti diventano pii• frequenti e piu abbondanti prima e dut·ante la crisi.
La dispnea ò un sintomo comunissimo sop ratullo nelle forme .generalizzate; il polso è SOVf'Uti rt'equenle e debole.
L e pupille sono ordinAl'iamente, se il cac;o è grave, ristrette e poco c::ensib1 l 1 alla luce. Fu ptù volte conslatalo l'aumento della temperatura centrale dut'ante e dopo !!li accessi inten<:i.
L'intelligenza ,·. talvolta disturbala, la m emo ria offuscata, la vi,ota conrusa, ltl paeol a diffi cil e; il delirio e l'agitazione sono snttomi gr•avi che precedono ordinar·iamente il coma e la mol'le. L'albuuunu ria è t;lala constata ta varie volte, come pure la cefalal gia e l'aum ento dt> l r-;udor·e.

Tu lli questi di:;turbi sono paragonabth, ma non simili tt qurlli che si constataao in certe inLoss icazioni, nell' uremitt pe1· esempio. Pare che siasi prodotta una materia nel ventricolo dilatalo grazie alla ritenzione ingesta; e!ò<:A enlra nella circolazioue e pr·oduce così fenomeni convulsivi.
La natura di questa sostanza tossica è un sogF(ello di con· tt·over-sia . Essa del'iva verisimilmente dal distUI·bo stesso del chimismo stomacale. Essa per ò non è costituita dalla pepto· tO!-l" ii11L Questo, secondo Bouver·et e Devic, si produrrebb e ael cnr.;;o delle operazioni deli'E>st razion e a non esisterebbe nella cavità stomacale allo stato normale. Ma P'lil la ,Joman dfl essa non ;.i fot'mi nelle condizioni anormalt della di gestione di uno ;.tornaco iper secretore e dilatato.. Gli autori sono t•iuscili a prepal'are un estratto alcooltco molto con vulsivante e\aporando i liquidi di digestione t> le sol uzi ont alcoolich e alla ;;tufa a 39•. Con una tli un mese ,.1 possono determinare con iniezione intrav cnosa ver·e t'OD\'UI<: ioni telaniche. La natura Ji questa c::ostanza convul" i vanle non é an cnra stAtfl determinata; P pero probabile che !li tr atti dt una !tictonina a cui l'alcool dà nuov,. pr·opri eta; un odot•e vi 1·o;;o, la tossicila ed il potere co• tvul<:ivante. È lleeettsar io •tninùi completamente l'alcool m Lutti i CliSi di permsnente e in quelli che !lODO da ritenzione ge"lt•icA. QnAndo è cnmpar sn la tetania , il migliot• consic::te nell ' evacunre e nel lavarf"l lo "tomac..> con la "ondtl.
La morte improvvis a nell'obultà.. - (Jo urllal de M Meci ne t-t de Chirurgie, ottob r e, 1802).
T ra i numerosi accidenti ai quali c::ono i poli8arcici e cbe lor o impedi::;cono per la maggior pnrle di tt rr•i,•are ad un'eta avanlala, devesi annovt>r·ar e la mot'Le improvvisa, irnt•rtwed ula, senza che nulla po;;!'a fil l'la pre"aBench<' essa sia segnalata fin da t tempi piùr•emoti, non c::i è ma 1 potuto nettamente In palogeUia Tra tuttP le cause invocaLP, pare C'ho le nlteraztoni ùlll muscolo eardtaco abbiano avuto la pat·te più importante. perchè, 19 ca;;i di morte nell'oLesila, dHll e autopsie prali· cale da t'· venuto a t•bn llare che 1:! volle la causa del dece!'sO era stato un edema polmonare acuto consecuti' o alla P&t·ali!'li del miocardio ani poso, li volle vi et·a simultaneamente una notevole dell'aorta, 6 ,·olte la mol'le era stata cau · •la una cor ebrsle , conseg uenza dell'arteria· ed una volla c::oltanto f'ra stala p1·odolln dall'l t'nllll r a del cnorr.
Pl' r parli" >-ua, Ki<:ch e;npra 12 autopsie di ob•·<:r· che soccotnbellero con !P apparenze di uua sAlute eccellen te e m entre attendevano alle loro occupazioni abituali , trovò t vo lte edema acuto del polmone, 7 volle emorr agia cereh1·ale ed una volla rottura del cuore. Uno d i questi soggetti , l'elil d• 33 anni, SI e r a dato al coito immediatamente dopo la colazione e cadde morto nel recarsi dal letto al canape. Al · l'autopsia furon o constatati come causa della mo r te una degen ei•azione del cuo r e e depositi ateromatosi nell'aorta.
L a morte improvvisa nell'obesità non è cosa rara , ma essa avviene io un modo fulminaute ed ioopinato non per la famigli a , ma anche per il medico.
1 parenti non tengono conto dei feno m eni subiellivi, come l'atranno, la e:tanchezza che indicano cbe il cuore non i> piu m grado di vincere g li ostacoli, ed è sollu l'imminenza di un deliquio. Il medico non possiede solto questo rapp orto alcun segno di diagnosi cel'la. Secondo le osservazioni di Ki sch, il polso e notevolmente rallentato. la com parsa de ll'angina di petto, cos titui scono i di morte improvvi SA n egli obesi. Ma questo genero di morte può anche verificarc:i senza questi segni precurso ri, ed essa si deve soprat ullo temere r1u aodo l'alcoolismo cronico o l'arterio-scle rosi compii· ca no l'ad i posi Fa d'uopo anche tener couto detell antecedenti ereditari o collaterali che costituiscono $OllO questo rapporto una r eale predisposizione. Ma tutte que'<te c1rcostanze non costituis cono elementi di una progno:; i certa, perc!Jè' furono spesso r·isconlrati riuniti nei soggetti che non l"occombettero ìmrwovvisamente.
La. atoma.tlte a.fto.a epidemica.- StEGEL. - (Jot1rnal de .\lédecine et de C!ti rt1rgie, c., tlobre 18!)2).
La febbre dei bovini e tra.,missibile alr uomo; lt> vacche &o no particolarmen te pericolose quando !" eruzione si pl'esenta all' dei capezzoli e si deve allora r·ac· comandare ai proprietar i di far bollire il latle che si consuma. L'epide mia di febbre aflosa che dom inava da più anni a Britz, loca lité nell o virinanze di Berlino, è s tata il pu nto d i parten:ta
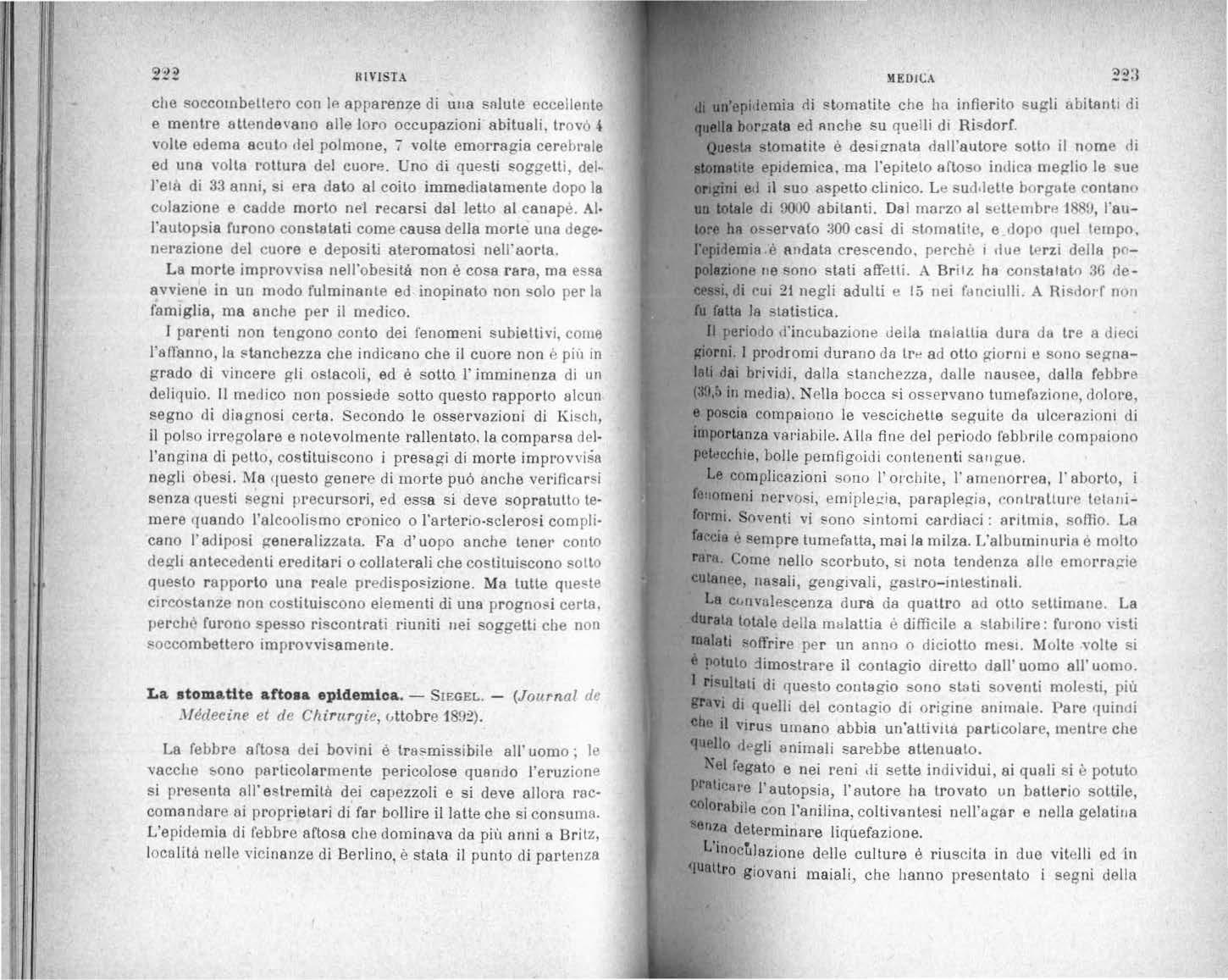
Meoi Ca
t'mia eli s tomatile che ho inrìerilo s ugli abitant• di ed 11nche su f!Uelli d• Ri.,dorf.
Questa stomatile é desì!!nata clall'autore soLto il nom e eli jltomabte epidemica , ma l'epileto afloso indi ca mejllio le sue ..gioi e.l 11 suo 8SpeLlo clinico. L e swldelle borgule contano 111 &otale d1 00:10 abitanti. Dal marzo al scltPmbrP JRR!I, l'aulore ha o-.-.erva[o casi di "Lomatite, e dopo rruel tempo. l'epidemia P. a ndata c r escendo. perl'hf> 1 cluP della pPpOJezione ue <>ono stati alfelli. A Brilt. h11 cous talalll :j6 tleCfl8i, di I'Ui :21negli adulti e 15 nei lilnciU!li. A non tu fatta la statistica.
Il perio lo d' i ncubazione della mRiallia dura tre a dwci ,Porni. l prodr omi du r ano da Lr·.. ad ollo e sono se[.tnatati dai brividi , dalla stanchezza, dalle nausee, dalla (39,b in media). N ella bocca l'i osservano tumefazion<>, dolor·e. e poscia compai ono le v escicheLLe seguito da ulcerazioni di importanza var·iabile. All11 fine de l periodo febbrile compaiono peldcch•e. bolle pemfigoid •
Le complicazioni sono l'orchi te, l' amcnorr·ea, l'aborto, i teuomeni ne1·vosi, emiple !!ia, parapleg-ia, Ponli·attu•·r• tChlllilormi. SovPnli vi sono o-inlomi car·diaci: ar1tmia, Mllio. La taccia è sempre lum efatta, mai la milza. L'albuminui·ia é molto rara. Come nello scor•buto, sì nola tendenza alle cutanee, nasali , geng•vali, g-ast r o - intestinali.
La cc.n,·ulP.scenza du ra da quat tro ad otto settimane. La durata totale della mulallia è difficile a stabilire: ru ono ,·ic:ti malati pe r un anno o diciotto mes1. Molte YOILe si • potuto jimostrare il contagio dir·etto dall' uomo all'uomo. l risultati di rJuec:;Lo contagio sono stati soventi moiPsti, piu travi dr quel1 1 del contagio d1 o r•l!in e animale. Pare tJUlndi ebe il ' 't ru s u ma n o abbia un'allivila particolare, me n tr·e che quello rl<>gli animali sarebbe attenualo.
Nel fegato e nei r·eni di sette individui, ai quali si è potuto l'auto psia, l'autore ha trovato un batter io sottile, COlorabi le con l'anilina, coltivantesi nell'agar e nella gelatiua ""za determin are liquefazione.
L'i nocfllazione dt>lle culture é rius cita in due vitel li ed in quattro giovani maiali, che han n o pr esentato i segni della sl01118lite anosa. Ill'égatO eJ j rent ui questi tlllimaJt !'Ontenevano i batteri specifici dispo"ti come nell'uomo. L'inocule.zione delle culture ha falhto al contrario "lli '!O· nirdi, snl cane, sui topi, sui porcellini d' lnrl iA. r1crrrhe ,·acche affelle da febbre aflol>a non banno •lati ris-ultati positt vi. dà questo nome Ad un'anomalia congenita, per d• in rlt•lla quale il velo del pnlato, d'apparenza no r male, intatto e mobile, divit>ne troppo corto eJ il suo margin e libero 11011 puc'l in nessun momento rombaciaee con la parete poslet·iore della faringe. 'l ulta\la ,1uesta b r e,·ilà dt>l velo non è che apparente; l'accorciflm.-nto iu let·es!>a soltanto la volta ossea palatina: la lesione e. al 1alalo, ed il sintomo i nvece al velo, perché questo, f!ven.lo la sua inserztone po•·tata indiell'O, non può Laslart>, ']U811tunque le sue dimensioni abituali, a chiudere uno r imasto troppe> gt·ande. l disturbi funzionali consislotw qua"i esdu!"ivllmeult! nei della parola; i disturbi della non esi· co:tono quasi mai. Ma la voce è alternta pet• modo tn certi Cfll"i, vien falla la d1agnos1 di paralisi del velo palatmo Quec;:lt di;;ttwbi sono però molto vat·iabili nello IOt'O intensivi, e mo>ntre alcuni maiali pa1•lano in una maniera qu ast inintel· Jigibile, allri rtescono A fa r si capire mollo bene. Ch ecché l'i&, tulli i malati parlano col senza eccezione; lf' '·oralt lll'endono tulle ti timb r o nasale; lf' consonanti sono IO<'• h· firatr: 1 malati non fisch iare e soffiano difticilmente.
Dell' lnlufflclenz& velo- p&l&tln&. - (Juu rnal de M Mecine et de Chirurgie, ottobre 18!12).
Quest'aftez1one, benché t·ara, i• pr ol.Jalti lmenlc più frequente di •tuanto !:'i cr ede, perchè non puc'l t-!>co:ere •·iconoscinta che eia un accu•·ato La sintomalolof:(ia ,.. però abbAstanza chi ara.
Infine, la l'espirazione fonetica 1\ clislurhatA; lta luogo pe•· l» via faringo-nasale, incesc::anlemente bPantP, uno fuga pPt' ltt quale sfugge l\1ria, pe1· modo che il tnalalo pa rl audo r• nh· li!WIC.:A btip ln dt t·iprPIHler e fiato a r iascun ic::tunlo', e, lllnltn•. durante gli ,:fol'zi ch e essi fanno pe r fursi comprendPt'e, i moluli esep:uisrono cont razi oni smo r flost> rlel naso e del lAbbro !-4U · JWI'ÌOr l', a cui parlt>ripano i mu"lcoli zigomalici. Il eli sintomt può ri sconlrar si in un CPI'lO numl' ro di 11 lte r s-:ioni palaline. Per• lure la d'inflnf· llclenu velo-pa laLina, è nec('c;sat·io l'Psame direlto. L'c•c::plo· raziou" d1gitol u ùel palato fa allora riconoscere che la volla ossea nnn rìnormAie e, invPr·(' dt lc•rminart• tu.lietr·" 1'0II 1111 mor'!!lne l1c::cin e un r1 lll'nfondu inf'nvuluru ll'inn golorr•. Quesla irwisura di'l mat·!!itH! c1 .. 1 pi11110 OS!':eo che ha lu ror·m11 dr un V, la. cui punta ,. pt>>lhl tn fl\fHill, e"ic;te in tutlt i n1 lull• 1 cast unt'lrt!, l'ugoln è IJifidu; ma la vc.lla dc•! palato nou pt·e,.enta all'nlln <llterazione.
L'evulnzr nr1e di yjzio!'u coufo rma:l.ioue del pal ato e velo·pAlalimr clte ]'t>"plicn non
19 II'JO dt>i min or t lrA lli <'Ili nlleri.::lici clelia stortA. Ec::c;R 'rongeuita; L11ll1 i e:-an rinaLt tllcil lat·ano di ave r St!llllll'e 1111rhuo In alcuui, il difetto di pnHiuncia ruanleuulo imnHtlabìle per lnLla lu vtla; tdl ri hanno con!'\lulalo t:olfnu,lat•r degli anni un sensii.Jilt' nt-1 loro ]ln-
Dal P1HllO d1 vi;:tll della cuea, l'educazione or tnf'nnica può 1\ nr oclitìc.•r" seu sibtlmentc· questa in fe•·rnità etl a nmdet·t• rntelltJ;{iiJilc In paro!u. Gli upJ.lart!cchi prolettci
*:M
1'l"'"'Pr13 utili in ulcuni rttsi, quantunque di un'apmollo dtrtlde. alle operuz1oni chil'llrgtche pnre che esse noli ollengano dte t·i!-4nltuli OcJenli, "!' 11 011 noce vi hUa Jertoar4lte tubercoloaa. - JAccouo. (Joumal de .\J,:df!cùl" et de Clu r urqie,
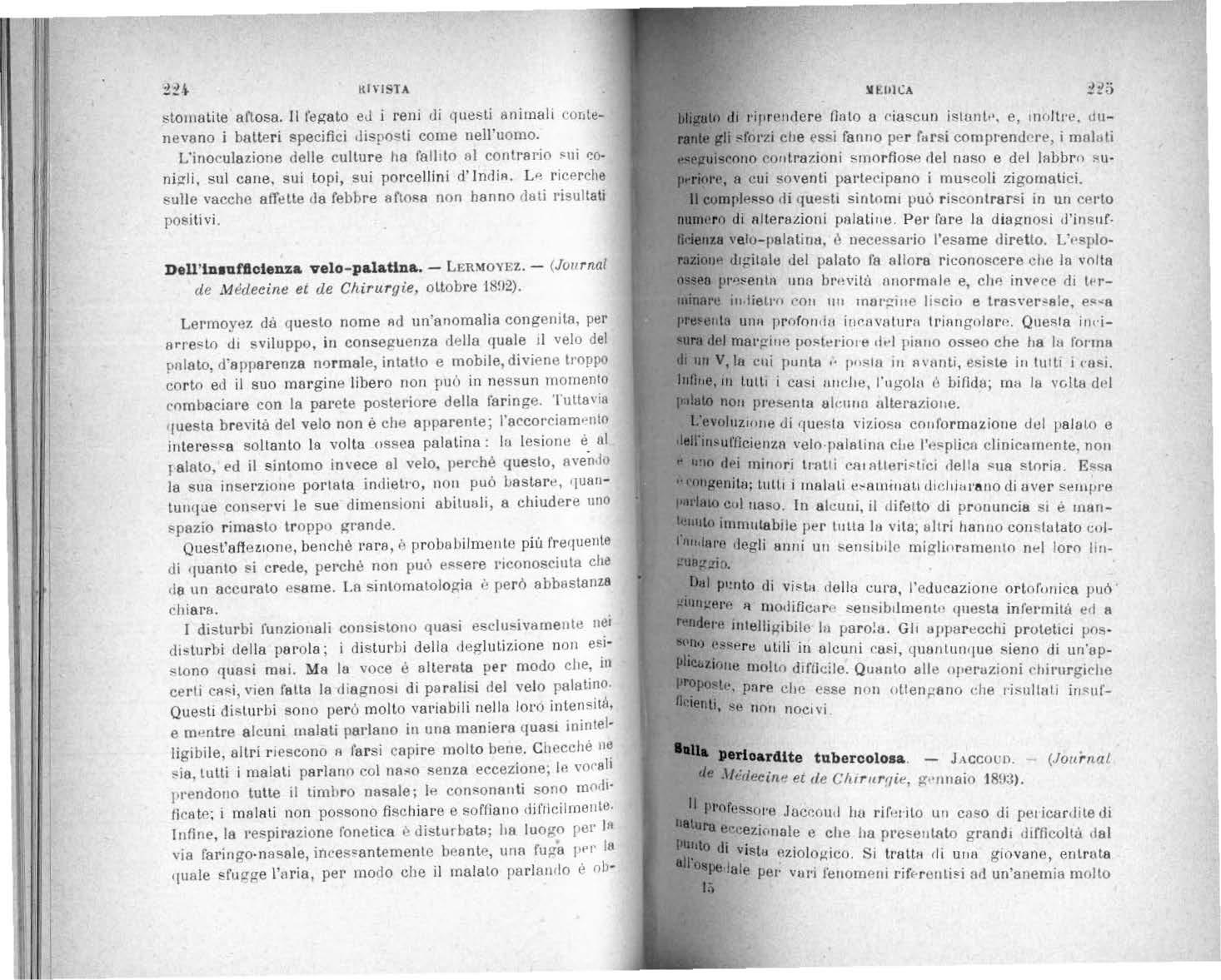
Il profe'lsot·e Jacr.nnd Jw ril"•!t·ito Llll Cl1"0 di pet icarclile di llalura e•·cezic•Hale e che ha p••e:;e11tato dtffìcoltà .!al di vi st11 nziol ogico. Si lralttt dt Ullfl g1ovane, entruta
08P6 lale pet· ' 'Il l't l'enomt>ni ad un'anemia mollo t;:, gra,·e, che aveva pt·rl) ollenuto un m1gltora1ucnto iu c:apo di tre sellimane d1 sogg1o1·no allo spedale, ma che fu coltn bruscamente un g-1orno da malessere, brividi e t'e1tn !.trado dì oppt'e!>sione; gli acctdenti s1 Bt-rJ.!rll \'a r ono n d g1orno succe:;sivu, c fiu d1:1 qnesl<) morneulo si perce1•ironr> alla punta del cuo r e sl'regam<•nli pE' t'icarJtci, i f(Uali e!-\LP::<rro t'!llridamentc, c !'i potè quindi far tliag-nosi di utlfl pcril'ardite RCUlA. Si potuto pPnsare ad un Arlìc·oJare inizianLesi cnr• una pericardite, corne -.i tRIma ìn questo caso 1 dolort artic,...lar• «oprH::!)!IUill-(ono dopo due o tre giol'lli, e questo non si è 'cl'lfìcato nella malata in parola.
La pet•icar.lrte fec·e t•apidi progressi, senza cl1e ,., nè versamN1to, ne' f'udocar.li te; glt sfregamPnli !'i ltzzarono, ma ben scomparvero :;rradtlltlrnrnte in uno Rpazio di cinrJne giornt cir·ca. Ora . ciò è un sog'lo molLo im· portante, pcwchè questa rapida scom pars1:1 degli st'r el-'{amenti , quAndo essa rwn è m rapporto con la produzione dr uu ver· sa mento, i· un r-egno quasr ce rlo dell'adPrenza geuPrale del pericardio Quando s;i é potuto seguire il m11lalo fin dal l'inizio. si può con-;iolerare l'{uesto fallo comP il piu sicu ro di questa ader enza.
La pri ma cii questa pericarolile veniva in tal mnclo a !;volgersi senza cne si potesse dire co n cert(·zza fJUal» ne fo::se la nalur·a. La pericardiLe primitiva, infulli, é mollo ra ra e non è proclolla che da due cause, il lraumatismo ed il raffreddamento.
La pr ima si può f'RcilmentE' constatare ; quanto alla <:ecnnda, essa non può ammelte r si che dopo una r icerca minu zrosa. la quale abbta permesso di eliminare tutte le altre cause.
La pericardile secondari a, oltre che nel reumatismo, rr· ::;con tra nella polmonite, nella pleu r Jte, nella malattia di Brighi, in l•1Lle le ma l att1e infettive, cau<:e tutte che potevano, nella malata in discorso, facilmente da parte.
Tre cause posso no anrora dar luogo alle pericanl1ti rhe sop raggiun gono bruscamente: la tub ercolùsi, il cancro o il sarcoma.
Yedica
perr car ltte lubercolosa si fa sernpre per estensione oli h tut-ercolosi precedente C:i cui non si trovava alcuna nellA malata. E però vero che furono segnalati due ase in cui la tubercolosi pericardica esisteva sola all'infuori -cJt qualsia"i altra lesione di questa natura. Ma questo fatto eccezional e cne non era il caso di tenet'ne conto La perirnrdile cancerosa succell e sempr e ad un'altra localizzazione rlello stesso genet•e.
Ouan to alla peri ·ardi te sarcomalosa, essa i> quasi sempre in casn di IXeneralizzazione del sa r com11. Da una statistica falla da Jaccoud. si t•ileva che sopra 13 osservazioni dJ dtft'utolon e <:arromatosa. 10 \'Olle il era stato interessato.
Ma nel ra'-'O in par ola le conùtzioni erano ben differenti e, per esclu!;ione, si el'a porto ti ad amme ttere una pericar · dt te acuta a frign re, essendo stata la malata so ttop osta all'azione di un raffreddamento, un po' pl'imu della compar>'a dei primi accidenti.
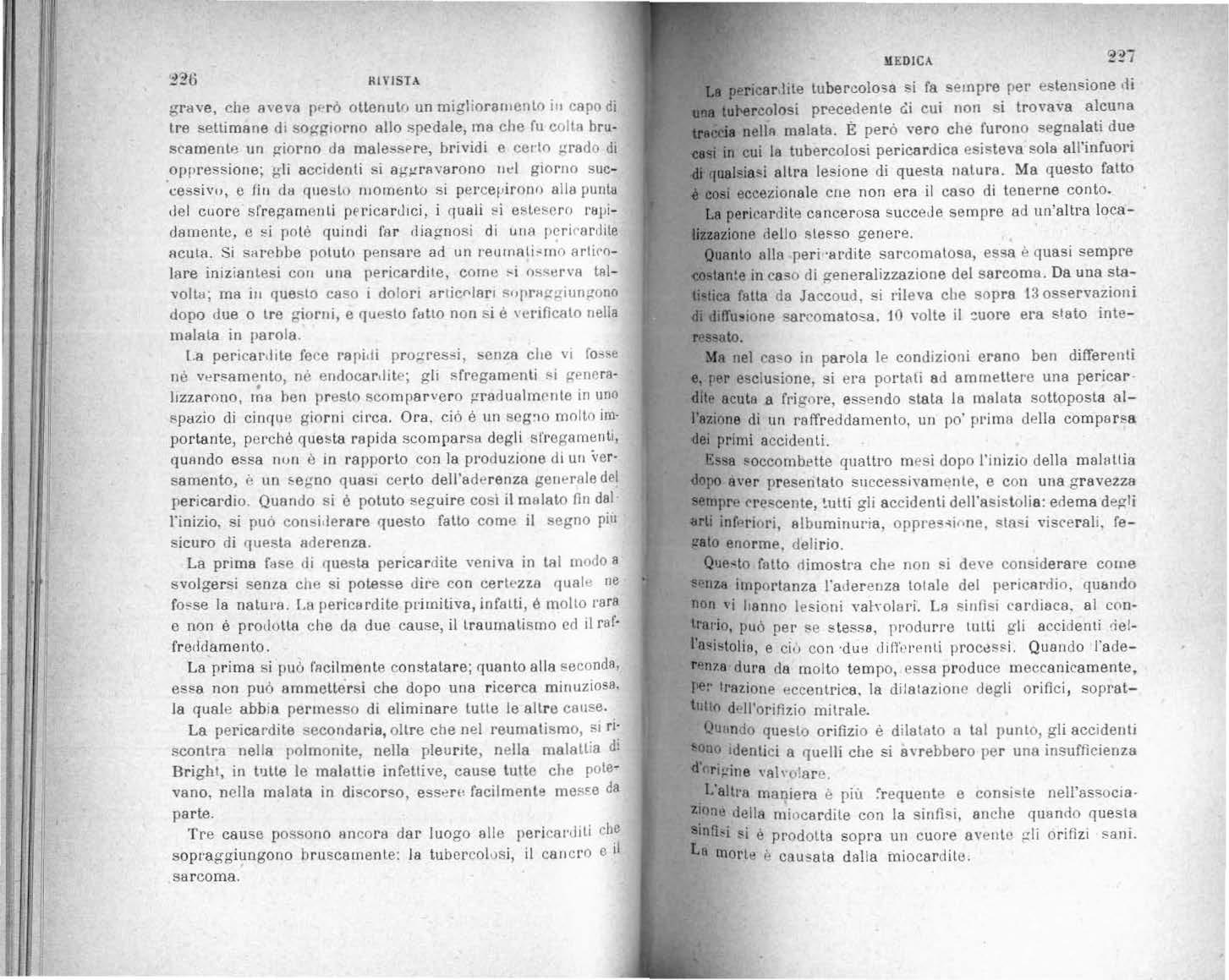
Essa !'Occombette quallt·o m<>si ùopo l'inizio della mahtltia dopo aver pr esentato succE>ssi,•am ente, e cou una gra vezza sempre r r e!"cente, gli accidenti dell'asi::;toli a: eclema farli inf•'rH•ri, albuminur·ia, visce r ali. fegato enorme , deli rio
Q•Je to follo òi mostra che non si deYE' considerar·e come 1!enza importanza l'aderenza totale del pericArrlio, quando non ,.i hanno lesioni Yarvolari. L a "infbr canliaca. al cCi ntrar·io, puo per se ste ssa, pt•odu rr·e tutti gli accidenti riell'alliKtolta, e citt con ·due clifl't•l'<'llli Quando l'adedura da mo l to tempo, essa pr oduce m eccanicamente, f'e:' trazion e PCCeulrica . la dilatazione uegli Orifici , SOpt•a tt utto dr:ll 'or iti:do rnilrale.
Qu undo questo orifizio è dilattltO a tal punto. gli accidenti tOno •dentici a l'{uelli che si avrebbero per una insufficienza d'ortl!ille \'Aho'a r P l 'allt·a maniera è più e cons1«te nell'assocra· della minca rd ile con la sinfi"i, anche fJUando questa ainfi.j è p t·odolta sopra u11 cuore avenll' !!li o r itì zi !"ani.
La morlt> causala dalla
Nei casi in cu1 la flintìsi cat·Jiaca non manif'eiìla cu11 aceidellli g •·avi e pe1·mell e al malato di sop•·avvive•·e per molto tem po, e neces!<'ario t e ner a m ente che 1 malati sono esposti stessi pericoli ed alle preca uzioni dei cardiaci. Vi La una condizione delle pii1 !'pia · cavoli che non esiste nei casi di a de r e n za parzi Hle.
L 'auLupSlA di lJUesla malaln ha dimos trAlo che "" In diagnosi et·a pe1· la fo r ma d t tale pericardite e pe1· le !'ue consPgut:nze, non l'era per la sua natura, perclu> "i trattava dì u11a pericardile tubercolosa, ma soprazginnla in rondizioni tali che i tube•·coli erllOO inapprezztlbdi pt> r i nostri mezz1 d'esplo razione l 11falli, la <iintìsi e r R totale e co;oliluila da un tessuto r esistente fOI'marllc uu'ad e renzu ttelle più so lide; esisteva una miocat·dile iotet·:-ltiziale <:onf'talala d all 'esame microscopico ed infln,.. tutt i gli ùr itìzi tardiaci, tranne l'orifizio polrnona r e, ave,·ano sub1lo un pl'ir;ci pio <i i dilatazione. Ri sulta da qu"slo Pf'ame chP se la malatA non fos se soccombuta alla s ua m1ocar.tite, e;;sa sa rebb f' morta piu tardi per uua in s uffi ci en za o mitrale
Tu tti i gAngli sotto-bronchiali .Iella parte infe1•iort> dPI OOPdiastino erano tubercolosi; non !;i ri !'con lra vano lu bel'coli che in quel punto, e là era l'origine delltJ. perirardil••. gangli. che la loro posizione reHdeva compiPtamente latenli, erano, per la maggior parte. ed vano dete rrnmalo unA mediastinile H ''eva la fusione d1 tutti i tessuti di questa re gione. PPrò il polmonare era Mno.
Lo sl.llto dei gangli, d'altronde. ùimost r·ava che la loro lesione er•a mollo più vecchia della pericar.lite ; to r s·anche ris aliva all'infanzia, pt>rcht'> si vedo no sove nlì q ueste adenupatie rimanere latenti pe1· molto tempo.
Da questa \'icinanza e du questa conliguitil delle Jesiuui non ne "egue che vi dPbbano esse r e lubercoll nel JJerrcardw; la JJei'ica rdite potr·ebbe e!'se r e semplice m ente dov.uta ad una irr·1tazione di vicinanza; pe r ò, n el caso in discorso, ec:am i mullipli hanno dimostralo che esi!'tevano nel pe r icardi o amma:>:;l di noduli anche bAcilli , i r1uali non potevano 'a»ciai'C dubbio sulla dell'elemento tub e r colo!>o.
Mf:OICA
È degnn d1 nota nella !<loria di questa pericardite il fallo che essa "i o!'serva quasi co:..tantemenle al disotto dell'eta di 30 anni. R isultn anche dalle osse r vazioni felto e lle essa 4 raram eute consociata a lubercoli pol munari. ' Lu tul Jercolosi che la produce è soprattutto pleurale o gaogliouare. È pur raro chl' sia consocia ta ad un vertoamento notevole .
llllatadoa e 4el v•ntrlcolo 41 origine nervon -lJFN'IIART. - (Journal de .\létlecine et deCitircu·gte, gennato
Il dotto r H ennarl ha cercalo di riE" olvet·e sperimentalmentP la lJUe!lli ù ne se in certe condizioni la dilatazione del ventriOllo nM abbia pe r ori::tine Ulll\ azione t•iflessa proveniente da un'irrita zion e nervosa più o meno lontana. Ora l'aspet'lenza negli anim tdi ba dimos tralo che l'eccitamen t o dell'es tremità central e di un nervo sensibile, come lo sciatico, detennina per via r1flessa un rilassa mento del venlricolo Pd un dei suoi movimenti ritmici.
Il professore W e r tlleimer hA espresso l'opi nione che certi Cllli di d1ln t azi one pote,·ano rssere ri feriti a questa teoria. Quando la dilatazione sopraggi un ge, per esempio, sotto l'mlluenza di u11 l raumat i"mo violento ( Dupl ay), di una fl ui d o r so (E 1·J ma nn ), d i colpi violenti sulla •·egione il r avv icina m ento s'impone con la EOineope che si produce n ..lle identiche condizioni. N ei du<> casi, li rlla!lciamento e l'11rresto dei movimenti Mno dovuti ad un riflesso inib1tori o, ad una az i o 11 e anli- tonica ave n te il suo pu nto di parte nza nei ne r vi sensibili. l n vece di par ti r e dalla il rifl e""O può avere la s ua o ri gine nei cen tr i. È 10 moclo che in un malato di cui parla Ouplay, la dila -
Caztone a vvenne in seguito ad una sincope c a g ionala da un spavento te meccanismo SI applica a diversi c a si di dilazione in ra pporto co.i fen o meni n ervosi ed in part1colare
Oln dilata7 ioni sop ra ggiunte nel cor so Jella nevralgia telahr.a. ll enuart ne cita due casi, dei (ruali uno in un
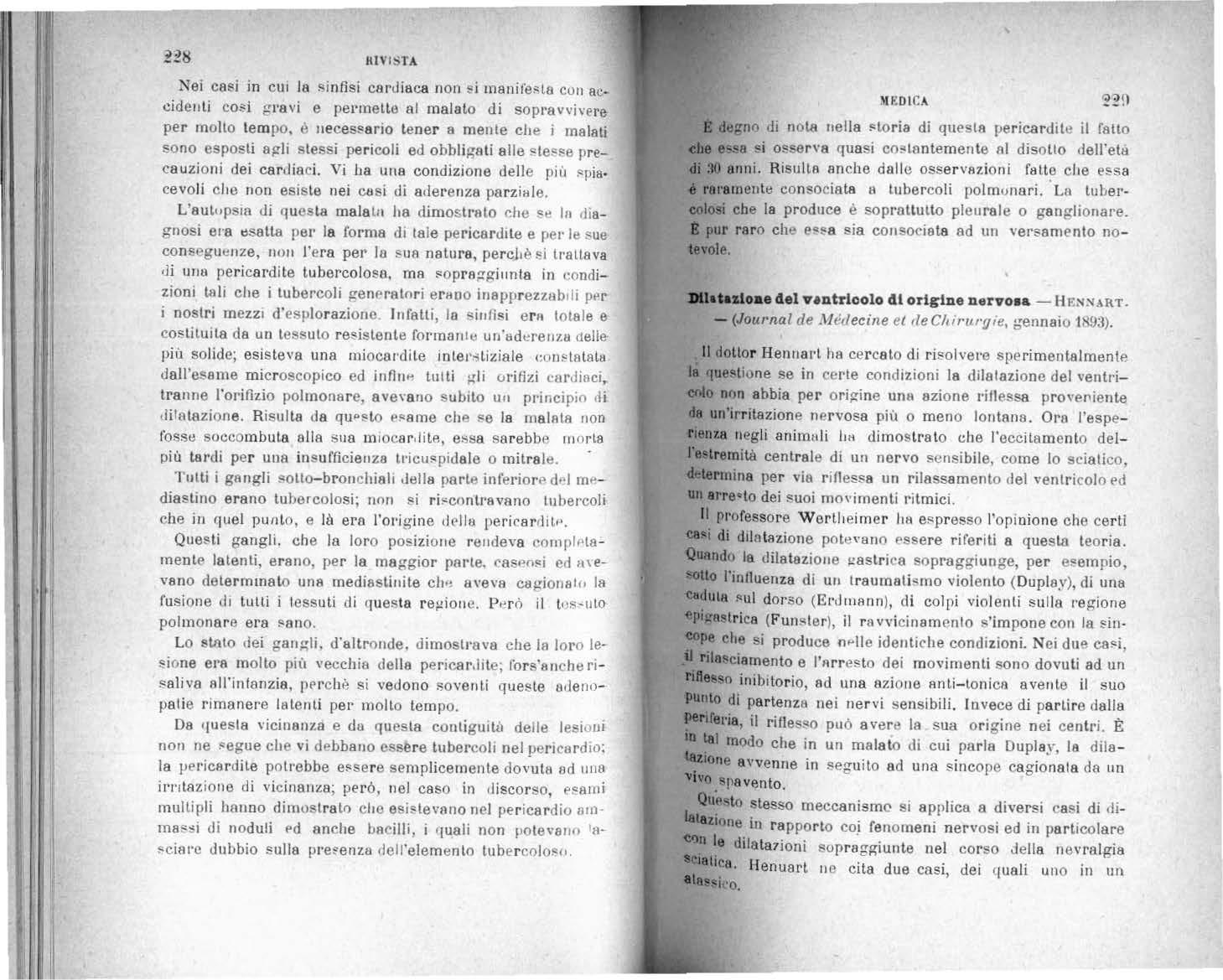
Qu esta teo1·ia della dilatazione del vPntricolo riflessa 1otrebbe forsf' anche essere applicala alla ddalazione che l'O· prag:<iunl-!e frequentemente clorotici e nef.!li anemici, i quali sono soventi affetti da nevralgie intercostHii.
Per la ricerca dl baoUll tubercolari.- V. K ETH. - (.:1 1'Ch• .fii. r Hyyiene e Cenl ra lu. fi't r dte medtc. :\. 2. 1893).
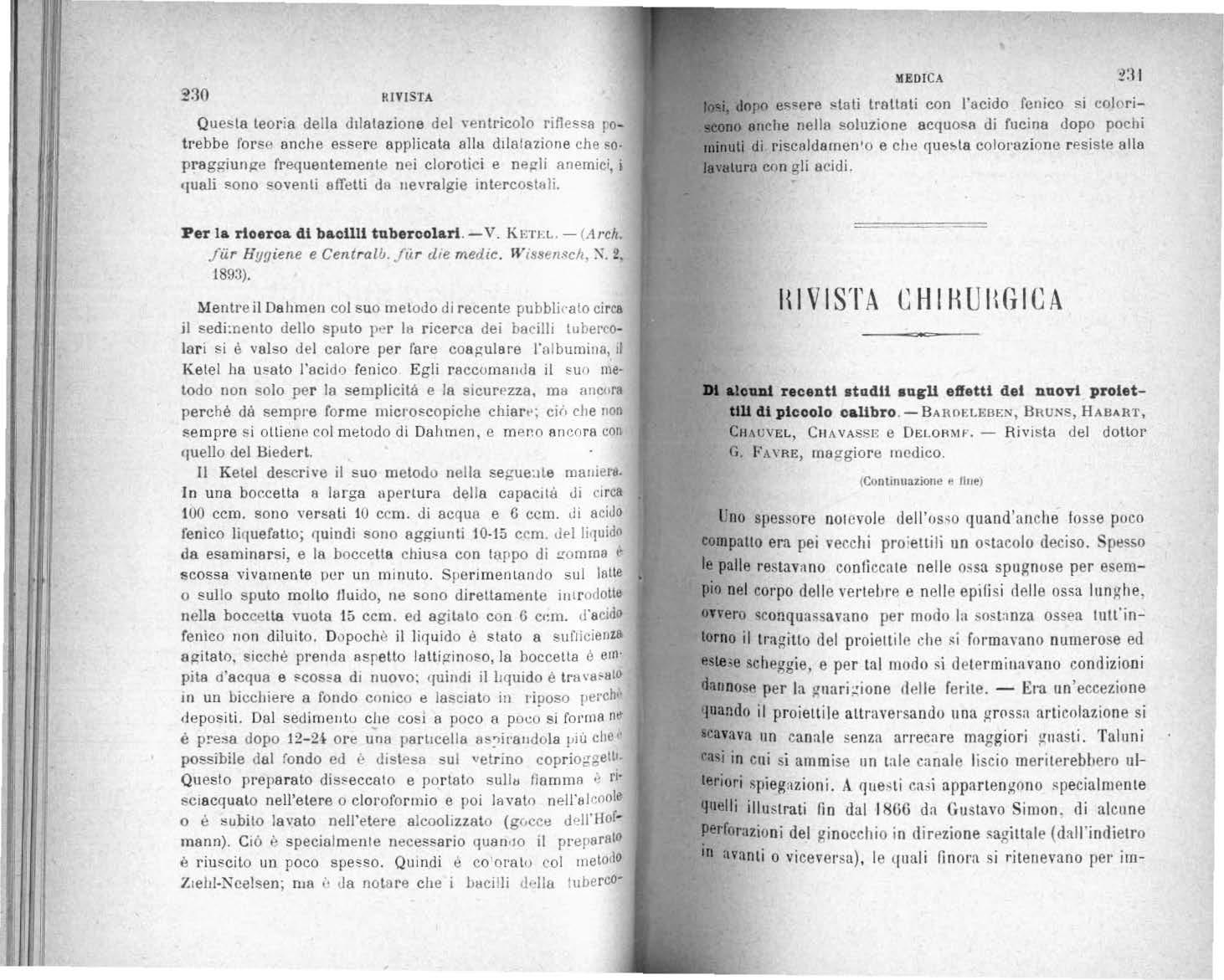
Ment1·eil Dahmen col suo metodo di recente pubbJi,·ato circa il sedi:nento dello sputo 1wr !1:1 ricerca dei barJ!I1 tubel·rolari si è valso Jel calore per fa1•e coagulare l'albumina, 11 Ketel ha usato l'acido fenico Egli raccomau.la 1l suo metodo non solo per la semplicitA e la stcurPzza, rna anco ra perché dà semp1·e forme mic1·oscopiche chiart•; cii• che uon sempre si ottienf\ col metodo di Dahm en, c mPr.o an co ra con •1uello del Biedert.
Il Ke tel descrive il suo metodo nella segue.1te mauit!rd. In una a larga della capac1tà Ji c1rca tUO ccm. sono versati 10 ccm. Ji acqua e G ccm. di aciJo fenico liquefatto; quindi sono aggiunti 10-15 ccm. JPI lì'Juido da esaminarsi, e la boccetta chiu:::a con tappo di !!Omma r scossa vivamen te ucr un m1nuto. Sporimentanun sul ln lle • o sullo sputo molto lluido, ne sono di reltamentc iulroolotlll nella boccetta vuota 15 ccm. ed agttato con G cc:m. cl'actdo fenic o non diluito. DllpochtJ il liquido è stuto a suf1icieu zs agitato, s•cchf. prenda aspetto latti ,trinoso . la boccetta è e10· pila d'acqua e a dt nuovo; quindt il liquido é tru \1:1:-ato 1n un bicclliere a fondo cnntco e lasc1ato m J·iposo perch depositi. Dal sedimento che cosi a poco a pol!o si fot'll18 nt;> è p!'esa dopo l 2-2i ore una part1cella a;-:->it'audola l'Ili che possibile dal fo ndo eù e distesa sul vetrino Qu esto preparato e portato sulltJ fìamrnn •' rl· nell'etere o clot·oformio e poi lavato nell'al roo le o è subito la,·ato ncll'etet'e alcoolizzato mann). C•ò è specialmente necessario quan••o il preparllt0 è rim:cilo un poco spe:;so . Qumdi c co oralo col 111etoclo Z•ehl-:Ncalsen; n.a i· da notare che i L8cilli tl•·llu tube rco-
Medica
IO!Ii, dopo es"ere "Lati trattati con l'acido fonico colPriaeono a1whe nelhl soluzione acqu o«a di fucma dopo pochi ro inuli di J'iscaldamen•o e che• colo•·aziooo resislP alla lava tura cnn !;li acidi.
Hivista Chihuhgica
DI &lo1Ull re centi atadlt augU effetti del nuovi prolettiU d1 plcoolo calibro . - BRUNS, HABART, CIIA tJVE r.. , C II A V ASSE e - Rivtsta del dottor tCon tmuaz•one llue) l! no spessore no1cvole dell'os-;o quand'anche fosse po co compatto era pei vecchi pro ;euili un deciso. Spt!sso le palle restavano con fi ccate nell e ossa spugnose per est>mpio nel cor·po delle verteiJrP e n ell e epifjsi òt> lle os::;a lunghe , onero <;conqua c;.,avano per modo la ossea tutt'intorno il tragitto del proieltill' l'11e ,;i formavano n umerose ed este'e '>cheggie, e per tal modo clt>termiuavano conilizio.ni per la gnari ..:ione dPile ferite . - Era un'eccezione 'Juando il proiellile attraversa ndo una gr(lssn articolazione si acavava nn canale senza arrecare maggiori guasti. Taluni ìn cui si ammise un tale canale liscio meriterebbero ulteriori s pieg azioni. A que:iti r.a-;i appartengono specialmente qnelli illu st rat i fìn dal I H6G da Gu stavo Simon . di alcune del in direzione sagillale (dall'i ndiet i'o 10 avanti o viceversa), le quali fìnora si ritenevano per im- po:-;sibili senza lesione ossea. Infatti p1'!'Ò le vecrht c pallA di piomho allungate pote\IUHI beni-;simt> attra ,ersa rf' l'articolazione del ginocchio se nza ledere alcun osso. ovvero un 50 io; purchc l'articolazione si trovasse in mezza tle::.stone r iut· a gradi. - Jl nuovo proiellil o può i queste ed altre simili \'ie anche più relle. e con foro d'ingre sso ed uscita an· che più piccolo. Ma anche attraverso os!'a 5pugnost • e rompalle. per r1uan to siano, secnndo le ,·edutt> tt·orirhe del Bardeleb eu, deve far si st rad a come un tronco d'nlhero. E di tal pcrfora;,ione netta di u11 gros,;o thso spugnoso, l'autore l'ese mpio di una ferit.t completa del ginocchio dal di dietro in a,·anti, con perforazion e del condilo esterno del femore e sclteggialura d 'u n pezzo della rotula. guarito in nove sellimant> cnn altitudine dell ' atto al mo\1mento.
G. F A\ ' RE, •ncùico.
Secondo le osservazion i fatte dal Buooe n· Hivere . nmhe nella del Chili si sa rehher o avuti parecchi casi di decorsi altreLL:1n1o fav orevoli di fe1it e ossee pr<'dotte dal nu oro fucile; ed anehe nelle diafi s i delle ossa cave le ferite perfnnnti erano di relwlu. La sostanza dura compatta delle (lrTre in raso una sena resiste nza al uuovo proiellilP . P co mprende che nrà maggio;e per quanlo più J'o:;,o 1'
Quanto in proposito ::'t' in allri tempi o:;scrvalo dr timhalz•l di deriazione clei!IL palla. appare alfano inverosimrle co lla grande ve locitit e colla piccola superficie d'urto de l n uo,·o pro ie ttile.
Qualo però nei singoli ral>i . rioè da parlc dei singoli os... i.
1 LJUalr possiedono una sostanza cortrrale più o meno rompatta e spessa, sia In resistenzH . ed in IJUal modo. vale a dll't' C'Jn quale effetto sulle ossa, la medesima ' 'i nta ;o; fum •e al ' N'' ca lcolo pcrchè le nostre eonosce nze sulla cedevoJezza ed elasticità delle singole ossa sono ancora molto rn-
CHIRL:RI,JCA per potere dare in merito un fondato giudizio. li Ba rdeleben per spiegare r1uesta chiama io un terzo fa tto re, cioè l'dasticità delle parti t•olpite e ù1ce: Un filo di caucciù con una trazione a poco a poco aumen tata si lascia distendere !i n dieci volte la sua lunghezza e fo r;:.e pi ù. Se per co ntro viene disteso d'11n tratto con forza egua le di trazione, si straccia. Qualche co a di simile sembra succedere anche per le ossa colpite da una p:dln.
• il caso di di re: la prati ca val più della grammatica, o mepo l'esperimento deve aprire la via allo studio.
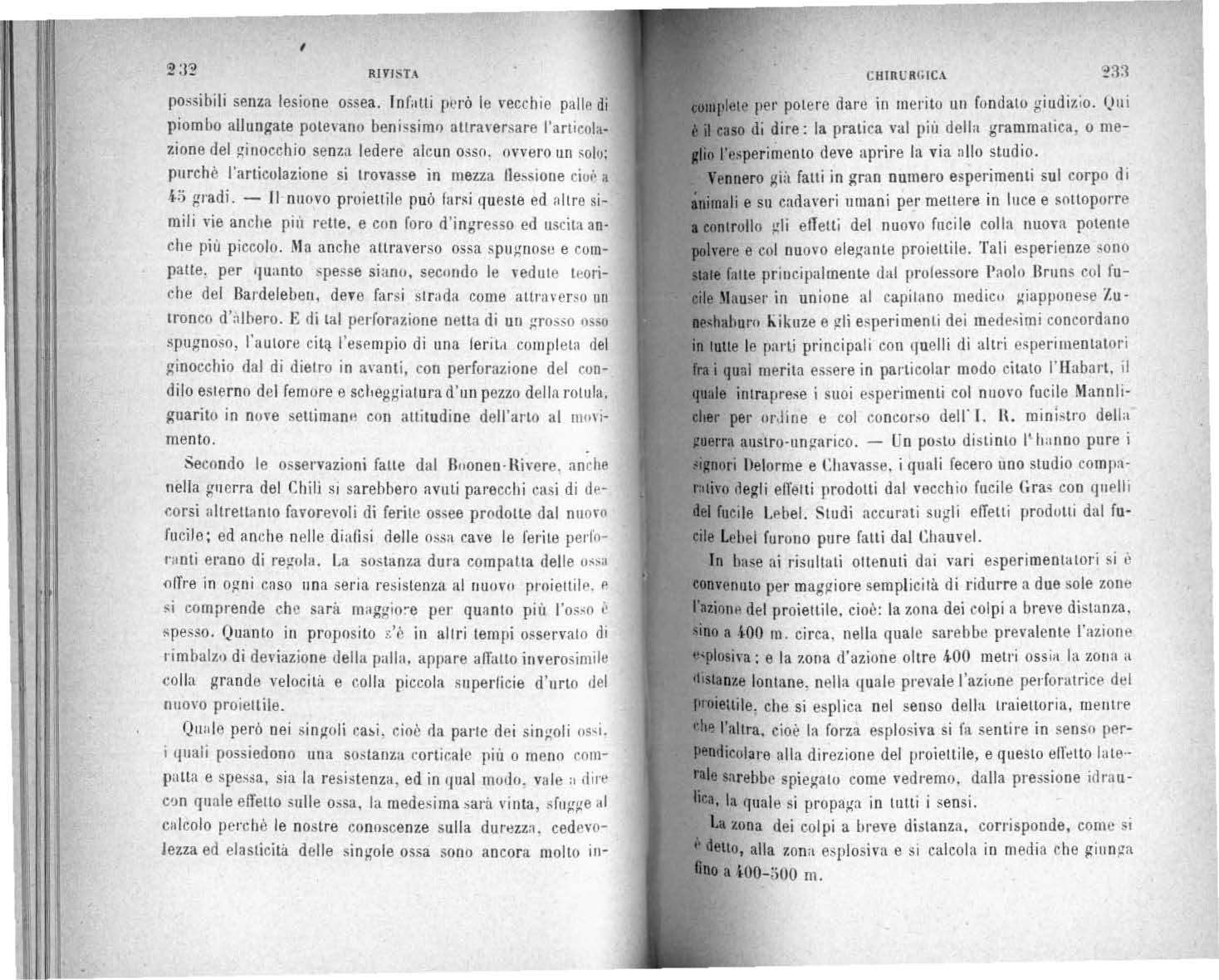
Vennero fatti in gran nu mero e sperimenti sul corpo di ioimali e sn carlaveri umani per mettere in luce e sotloporrt' a controllo :.:li effetti del nuovo fnci le colla nuova potenle polveri' e col nuovo elegante proieuile. Tali esper ienze sono stale fatte prin cipalmente dal prolessore Paolo Brnn<; col fucile in un ione al capitano medico giappone:.e Zu · e gli esperimenti dei rn ede,;imi con cordano in lotte le parti prin cipali con !Juelli di al tri fra i qu al merita essere in parti colar modo citato I' Habart, il quale intra pre,;e i suoi espe rim enti col nuovo fucile Mannli· eher pe r ur.line e col t·oncor,o dell'l. IL mini,tro della jloerra - Un posto distinto l'hanno pure i ttgnori llelorme e Chavasse, i quali fecer·o uno studio co mpal'lllivo •legli ell'elli prodotti dal vecchio fucile con quelli del fu rt le LPbel. • tndi nccuroti sugli erTeui prodotti dal fucile Ll' hel fur ono pure fatti dal Chauvel.
In base ai risultati oltenuli dai vari esperimentatori sr ,, eonvenu to per magl!iore sempl icità di ridurre n due sole zone l'aziont> del proieLLile, cioè: la zona dei colpi a breve distanza. sino a m. circa. nella quale sarebbe prevalente l'azrone e la zona d'azione oltre 400 metri ossia la zona a 11tsta oze lontane. nella quale pr·eyale l'azione perforatrict> del pr'Oieuile. che si esplica nel senso della traiettoria, mentre ehe l'altra. cioè la forza esplosiva si fa sen tire in se nsn perpendirolare alla direzione del woieltile, e questo efl'tltto late .. rate sn rebbl' spiegalo come vedremo, dalla pressione idraulica, la qual e si propaga in tutti i sensi.
La zona dei colpi a ureve dislanza, co rr isponde, come "i f. deuo, alla zona esplo:,i\'a e si calcola in media che giunga 6no a •oo- :)()0 m.
Le ferite di questa zona sono le più ora,-i di tutte poicl1•• • l') c 11 proieuile. penetrando nel corpo umano colla velot:itit, non c_o n_cede_ ai liqu idi co nte nuti nei tessuti di sfuggire p1ccolr fori e istanti in esl=i, co,-icchè le particelle IH.JU ide l\pmte violentemen te verso la periferia della cavi tà scnvata dal proiettile ne fanno scoppiare per pres:oione idrostatica le pareti. l i llruns. mentre ammette che per le del cranio l'azione esplosiva sia do vuta es e nzialmentc alla pressione della massa cerehrale sulla calloua cranica, 0 ,.. ,ena che nelle ossa lunghe l'eiTNto e"plosivo è lo sia che la cavitit midollare sia piena o vuota.
La \'elocitiL con cui il proiettile colpisce non permeue all'eladell'osso di esplicarsi, e così la parte colpi ta si sche!!gta. Se la ve locità è mino re, o di tan to dimin uita che l'elastidel tessuto non vengn subito ed interamente superata al pl'lmo ur to, allora la comunicazio ne del movimento resta limi tata alle parti prossi me alla superfìc ie d' urto; il punto tlell'osso colpito di1·ettamente viene frantumato e portato \'in palla, in pa rte fo rs'n uche ridotto in polvere, m'\ nella YH; manza no n si pr oduce a/Tatto o soltanto in un )!rado insignifìcn nte. - Le esperienze hanno dimostrato però che coi piccoli proi elli li gli e/leui esplosivi sono minori di quelli prodl)tlt da proiettili ùi maggiore calibro almente se di piombo e non rives titi di ca micia resistente. g tluesta diminuzio ne di azione esplosh·a con notevole anmenw
CH II\ URf:lCA
penetrazione del nuovo proiettile è dovuta alla maggiore velocità, eù alla minore superfi cie d'urto del mPdesimo in co nfronto dei vecchi proie ui li.
l'er il proieuilc del fucile Lebl'l il limite della zona esplosiva non oltrepasserebbe, secondo le esperienze del r.haurel, i 21111 m. , per q nello del sarebbe secondo Bru ns a 300m . Invece nelle esperienze col fucile di 8 mm . la zo na determinata daii' Hahart arriverebbe sino a 500 m. Non è però possibile stabilire uno stt'ello limite di fra una zona e l'altra, sia per la diversitil dei tessuti colp iti , come delle accidentali che possono veri fi carsi. - La zona dei colpi a grandi distanze spazia fra •oo e 1200 ed anche a 1800 m. ed abbraccia la pilt grau parte dell' es 1ensio ne come eflìcar.e per il fnoeo della fanteria.- Le ferite prodolle a tnli distanze. in cui non entra più in campo l'iiZione esplosiva del proiettile ma poss iede ancora gran parte della sua forza viva. si avvicinano per i caralleri a quelle causate da arma tagliente e sarann o le men o gravi pt·esentundo le condizioni più favorevoli per la guarigione. Quanto alle lesioni prodoue corpo umano così il Bardeleben riassume gli effetti dei nuovi pro· iettili di pi ccolo calibro: semplici tragitti carnei. piccoli fori cl' ingre•so meno lar,2;ht del d iametro del p roiellile io conseguenza dell'ela'ticr tit della pell e. t ra gitto de l proiettile li=-cio nei muscoli, pie· colo fnro d' uscita rotondo o sfrangiato e ferita lacera pilt gra nde so ll anto allot·achè il ro lpo \ie ne più da vicino, va le a dire da una distanza minore di :500 m•. o se le ossa so no lunl!o il trauitto della ferila. e le sue sclreauie v r ponate vi a dal pro iettile, o fi nalmente se il proiettile fermato prim a della 'ua pP.netrazione.
Pra le lesioni ossee, rtuelle specialmente che inLeressano il cranio ronfermano la teoria emessa e discus$a dal mnl:medico Ern esto Reger sulla importanza della idraulira. contro la IJUale. in riguardo alle lesioni della scatula cmnit•a. non si elevano più giorno che alcune 'UCI isolate. Le scheggiature della scatola sono tanto più nnm ero,;e quanto piu [Jiccola i.• la distanza da cui si spara e mancano solo in quei casi in cui la distanza supera gli 00 rn. r·isultati dimostrano che il nuovo proiellile segnalato per ma):!gior· durezza. per mi nor diametro e per maggi or velocità esercita per grado e quantitit un' ;1zione scheggiantr minore dell'antico proiettile di piombo. il quale areva un moto meno velnce e un diamelro più grande, e che essen do compo,to di piombo soggetto a nel colpire lt>
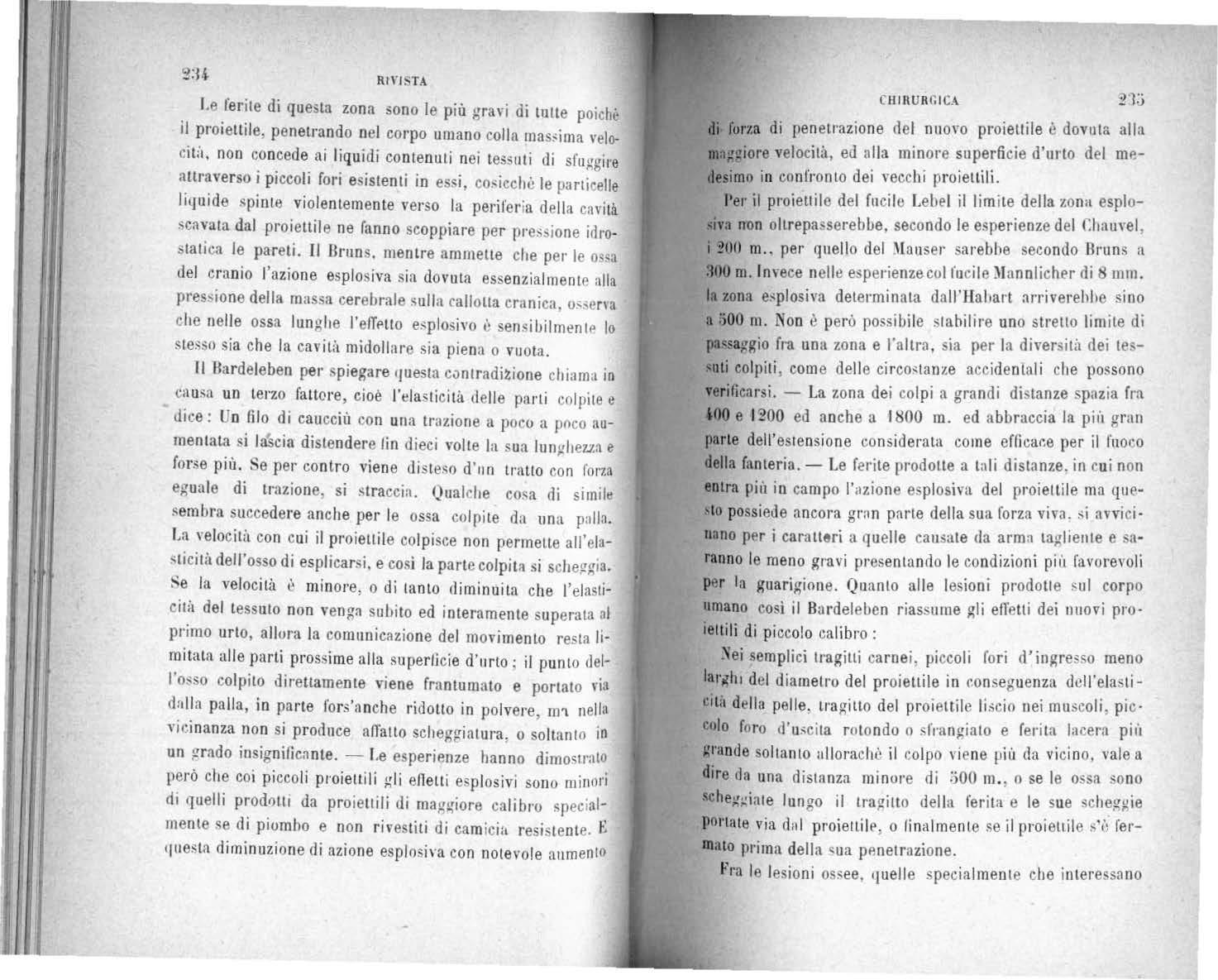
L' epifisi delle o:.sa lun ghe, :o e il colpo parte da una d i:;tant..t minore di -t-00 m., sofTI·ono quasi senzn eccezione noteroli scheggiature, mentre a distanze maggiol'i presentano di /'('gola un canale liscio.
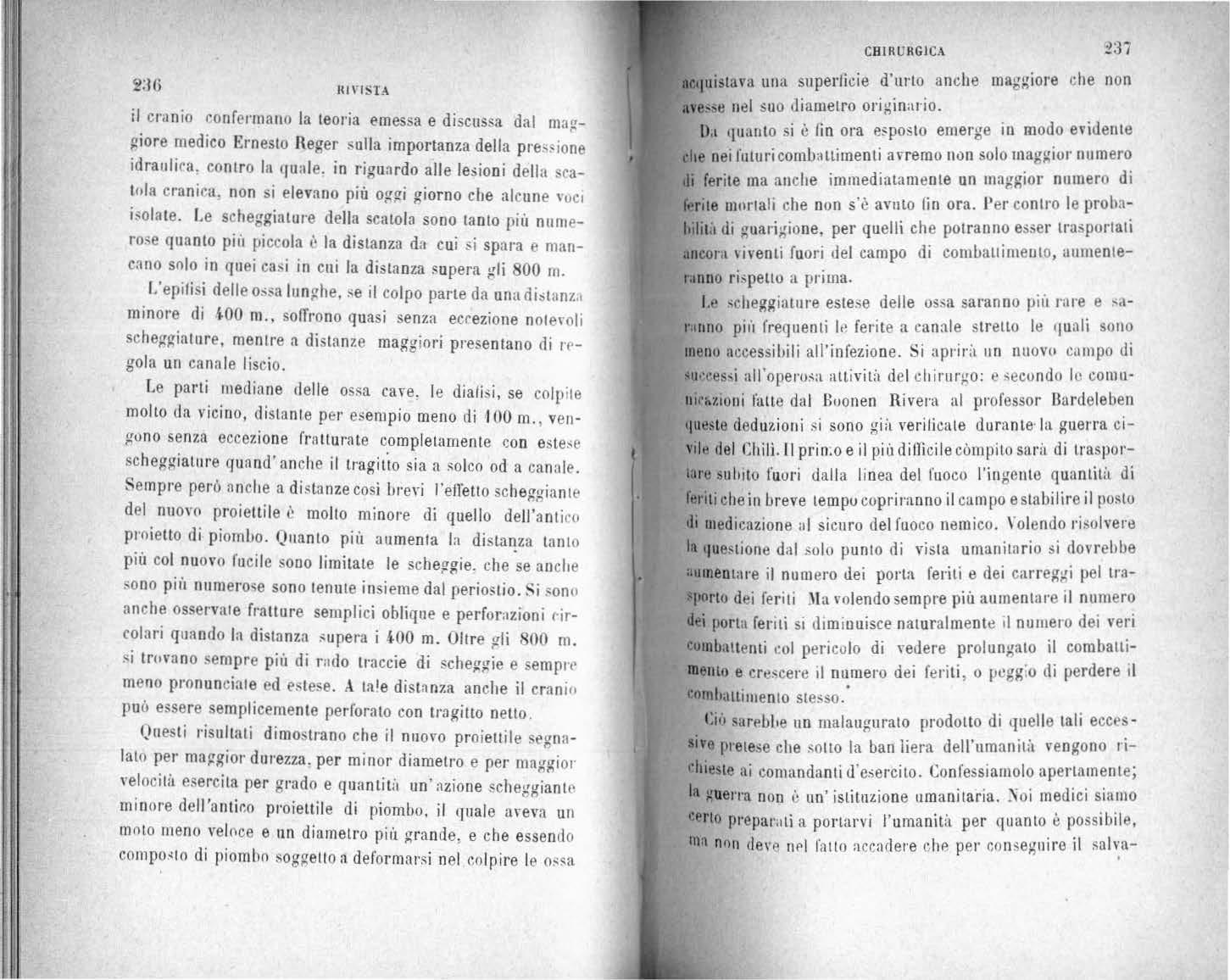
Le par·ti mediane delle ossa care, le dialisi, se colpite molto da vicino, distante per esem pio meno di 100m. , vengtl no sem:a eccezione frallurnte comp le tamente co n qunnd' nn('he il tragitto sia a so lco od a canale. Sempr·e però anche a cosi Lrerì l'efl'etto sch eggiante del nnoYo proiettile è molto minore di quello dell'anti co proietto di piomùo. Quanto più au menta la tanto più col nuo\'O fucile sono limitate le scheggia. che se an che :.ono piil sono tenute insieme dal periostio. Si anche osservare fratture semplici oblique e perforazioni c·ircolari quando la di tanza ,-upera i 400 m. Oltre ;.di 800 m. si tn•vano sempre più di rado traccie di e .empn' meno pronunciate cd e:>tese. A ta!e anche il cranin può essere semplicemen te perforato con tragitto netto .
CHIRl:RGICA
uistava una d'urto ant;lle maggiore d1e non nel suo diametro origina t io .
o,1 quauto si è lìn ora emerge in modo evidente che nei futuri comblltlimenti avremo non solo rnag:,:ior numero di fer ite ma anche immediatamente un numero di ferite mnrtali che non s'è avnto li n ora. Per contro le prohabililit di guarigione, per quelli che potranno trasportati ancor.&, iventi fuori del campo di comuauimeuto, uurnenteranno ri .-petto a prima.
l.t> estese delle ossa sar·anno più rare e :-.,1r.a nno pilt rrequenti lt• ferit e a ca nale streuo le quali men o accessibili all'infezione. Si apririt 110 nuovv c.unpo ùt all'opero:\a atLivilit del chirurgo: e le comu· nirbzloni falLe dal Boonen Rivera al professor Bardeleben queste deduzioni :ìi sono giit verilieate durante· la guerra civile del Chili. l.l prin.o e il piu difficile còmpilo saril di trasportare snhtlo r,wri dalla linea del l'uoco l'ingente di feriti che in breve te mpo coprira nn o il campo e stabi lire il posto di medi cazione al sicuro del fuoco nemico. Yolendo risolvere la dal so lo punto di vista umanitario si dovrehue uumemare il num ero ùei porta feriti e dei carreggi pel traJIOrtiJ dei feriti )l a \'o lendo sempre più aumentare li numero dei porta feriti si ùtmiouisce naturalme nte ti numero dei veri combattenti wl peric olo di vedere prolungato il comballimento e cre,cere il numero dei feriti , o !Jt'gg:o di perdere ti comhalltlllen to · l :iit !larrblte un malaugurato prodotto d i q nelle tal i ecct>saive tnetese che ,;ollo la bao liera dell'umani ti\ vengono r ichieste ai comandanti d 'esercito. Confessiamolo apertamente; la non i· un'istituzione umanitaria. :\oi medici siamo
Cl'rto p1·epat·;1ti a portarvi l'umanità per quanto è possibilr, ma non de,·r ll f' l ratto nrraclere chP per conseguire il salva- mento ancora sempre dubbio5o della vita d' u n uomo , se ne sacrifichino molte a ltre e venga in l'esito de l combattimento. l n og ni caso Il nostro còmpito prin cipa le sara di tra:>portare i feriti all'infu ori del fuo co nemico, e po ssibilmente sul campo di battaglia fermare le emc>rragie peri colose, ed imped ire con apparecchi immob ilizzati la lacerazione delle parti molli dalle ossa frant umate.
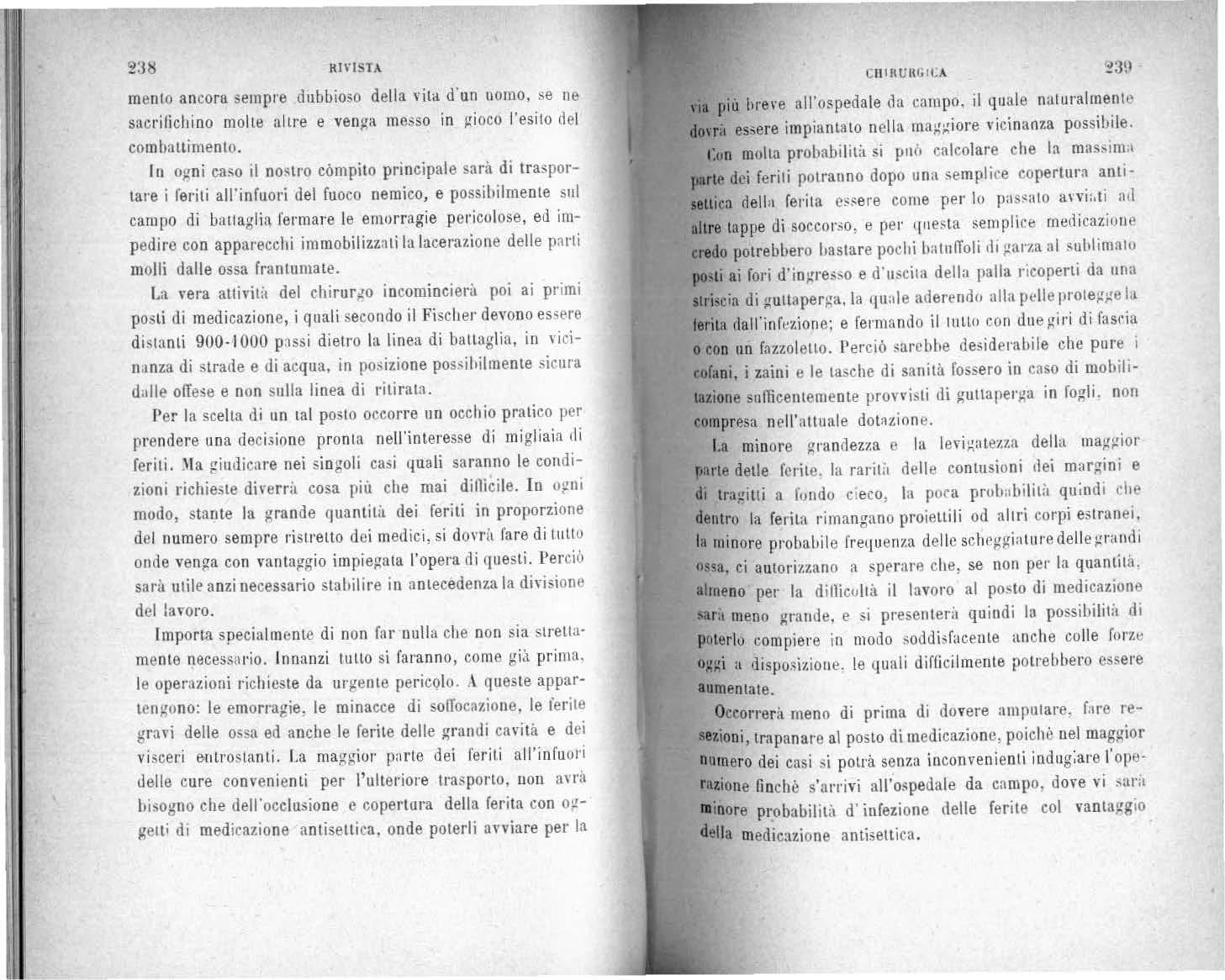
La vera auivitit del chir ur incomin cierit poi ai primi pos ti di medi cazione, i quali secondo il Fi sc ber devono es sere di .; tanti 900-1000 p:.ssi dietro la linea di ba ttag li a, in vi cin,t nza d i strade e ùi acqua, in posizione pos=-ihilmente :'>icnra dalle offese e non linea di ritirata.
Per la scel ta di un tal pos to orcorre un occhio prati co per pr end ere una dec i.>ion e pront a nell ' interesse di migliaia di feriti. \l a giudicare nei sin goli casi quali sa ranno le condizioni ri chieste diverrit cosa piu che mai dilli ci le. I n o!! ni modo, stante la gran de quantitit dei feriti in del numero sempre ri stretto dci med ici, si doH iL fare di tullo onde con vanta)!gio impiegata l'opera di questi . Perciù sal'i1 util e a nzi necessario stabili r e in an tecedenza la di,·isiont' del lavoro.
Importa specialmente di non far null a ell e non sia st retta· mente necessn r io. Innanzi tutto si faranno , come già. prima, le operazioni ri chi es te da urgente pericolo ..\ queste appartengo no: le emorragie . le minacce di soiiocazio ne, le fe rite gravi delle os5a ed anche le ferite delle grandi ca\'i tà e dei vi sce ri enlros tanti. La maggior pn rle dei feri ti all' in fuori delle cure co nv enie nti per l'ulteriore trasporto, non avrit bisog no che dell' occlusio ne e cope rtura della ferita con o!!getti di medicazione anti selli ca, onde polerli arv iare per la
Crt lliUIItotL A via piu hre re all'ospedale da t:n mpo. il qu ale nat uralmentt• dovrit impiantaLo nella vi cinanza possibi le. C:on multa prohabi lilit si pnò ralcolare che la ma s:.m1.1 parti' dci feri ti potranno do po una :;e mplire copertu ra anttsell ica della ferit a essere come pe r lo a' vi;. ti ati al tre tappe di soccor,:;o, e per ({tl esta :;empl ire medi cazione cred o potrebbero bastare pochi hatu!Toli tlt).!UI'Za al sublimato ai fori e della palla ncoperti da una stri>cia di la tju ale aderendo alla pelle l.t ferita dal l" infl'zione; e ferma ndo il tutto con du e•• iri di fasl'ia ,.. o con un fazz oletto. Perciò :;arebhe desi derabi le che pnre t cofani, i zaini e le tasche di sanita fossero in caso di mobilita zione snfficent eme nte provvi:.Li di in fogli. non compresa nC' II' allnale l.a minore e la lev i!.!fl lt?zza della maor rrior '" ,..,. parte detle feri te. la rarita rlelle co ntusioni dei marrrini e . ,.. dt tra!!tlti a fondo cieco, la po ca proh ahi lita qu ind t che de nt ro la ferit a rim angano proi eui li od altri corpi estranei, la min ore prohahi le freq uenza delle de ll e ci autori zzano a spe rare che, se non per la quanLit iL almeno per la clillicolrà il lavoro al posto di medicazione sara meno grande, e si presenterit quindi In possibi litit di poter l0 compier e in modo :-;oJd isface nte anche co lle forzt: o;;;.:i a nispo sizione. le qu al i diffi cilm ente pot reb bero aumentate.
Occorrer/t meno di prima di do vere amputare. f<t re resezio ni, trap ana re al posto di medicazio ne. poichè nel maggior num ero dei casi ::.i potrà. senza in co nvenienti iadna;are l'op e· . o raztone fì nchè s'arrivi da cam po. dove vi ,ar;"t ll inore probabilitit d' infezione delle ferile col della medicazi one antisettica .
Cou tali l'el'lte a canale stretto, levigato, tl uaoù'aoche stano Il? 'e ossa profonde. l'infezione nt:lle prime ore dopo la fenta, si verilica di t·ado, come ri ,nlta da alc un e ossef'\'azioui fatte da il quale ehLe opport un itil. d1 esaminare nn certo numrro ti' indiridui stati feriti i n un' ins u rrezion t' a Biala co n proiellili del nu o' o fucile Maonli cher. Al giit ritnto esempio di perforazio ne del ro ndilo esterno tlel femore e della articolazione del gi nocchio, il Bardelellec nt> un altro. nel tluale appena cinquanta ann1 fa "arehhe •·oosiùerato come nn errore chimrgico l'omm is · me dell'amputazione: anche in questo ferito i di cui ahiti Prano di cel'lo poco asellici. co me non lo sono fJ.llelli di un soldato ferilo in co mbattim ento , si riu scì a prevenire l' in fezione henchè l'individuo venisse cu rato so ltanto un'ora e mezza dnpo In ferita. Si deve perciò altamen te conrlan· nare la mania d'operare Ji certi giova ni e co,ì pure rendo no catLiv issimi serv izi i frettolosi cerca tori Iii proietti! i Di rado i nuovi proi eiLi l i rei\te r.tnn o couliccati nell.1 ferita A tril!'\r.ineranno nt'l loro lragiuo ht·andelli tlt
.\n t'tl r piit lit rado tlt p!'lma av rà motivo di frugarvi dt>nu·o t'l/Il lu speci llo e rarissimame nl e poi un tale prnidldt' nel colp1re 1111 si ùeforrneril come av"iene quando '' ttra ro ntro un Qualche Yolla si poll·anno tnuavia thsen.tl't' tali ,·nmhinmenti di forma ed anche .;.minu namenli, :>e il pro iet ti! P t·olpi prima qualche rorpo t! nrn e rim halzau<lo sia pen etra to già alterato di form:t nel corpo nmanu comt• ehhr ot:casiorw di ,·edet·c BogJaoik a Biala . .\ liMa non solo srag li c tlell'involucrn srrantumato, 111a andtr pea;i appitllliti rlel no•·ciolo di piomho, i quali cagiona no di .-;Lt·nztoni pt' neLrandf) in formn e gra ndez1.e cJi,"erse nei vari tes!' uti e spec ialme nte poi ne ll e ossa, posso no l'imanervi co11- tieta ti. Uovrem o a vere in rneole pn,siiHiil:'t allorrhè ll'llllasi dt I'O mu:ll timenti fr·a case, muri, od in ram p a!!n e rocc io•e . t:o ntrariamente all'opinione di qnelli che han nn accnlt() ro n il lltt Ovo proiettile di pi.·t·nlo raliiJro. ill t'amit:iato
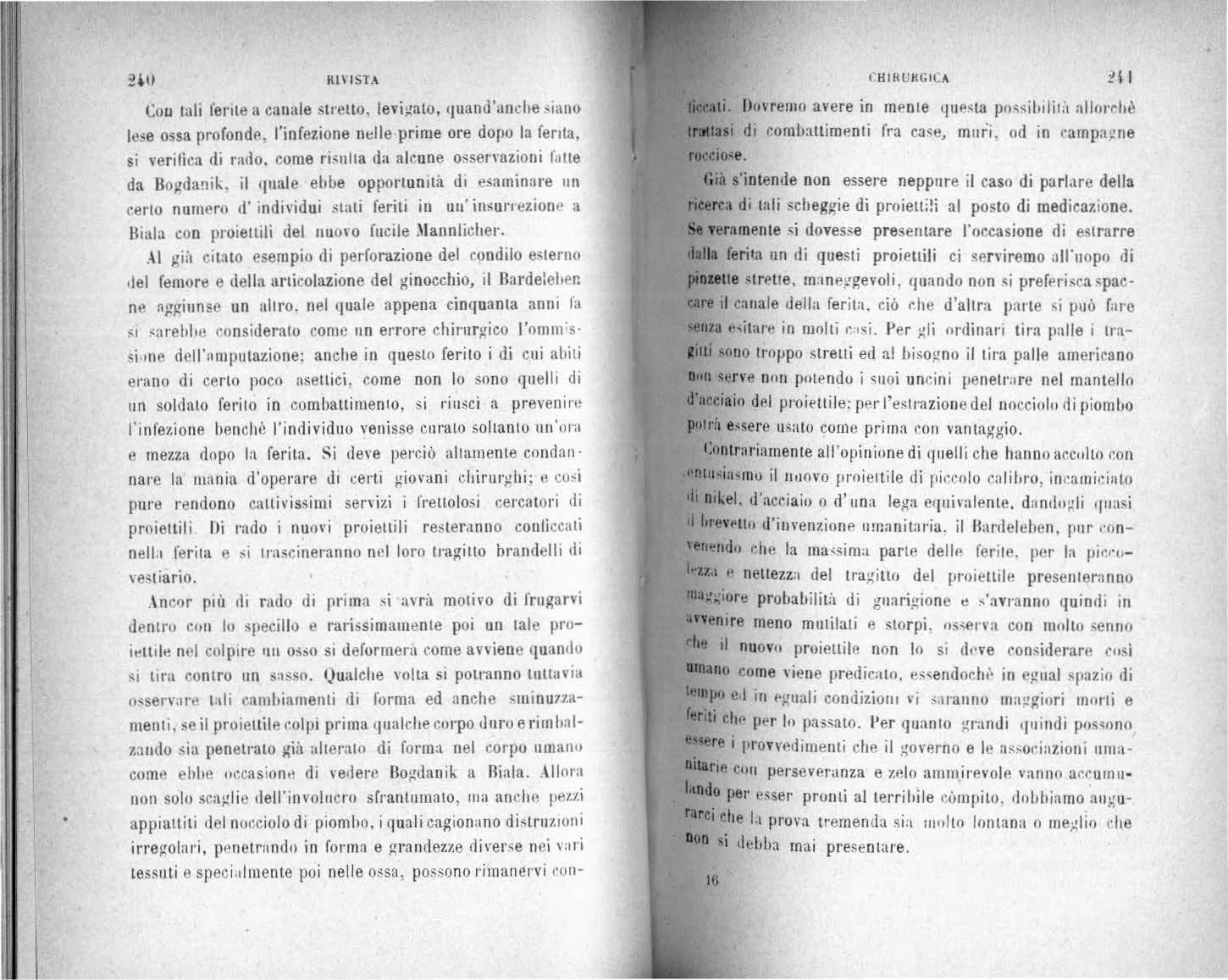
Già s'i ntende non essere neppure il caso di parl.1re della ricerca d1 tali scheggie di proieu:!i al posto di medicazione. Se ' eramente ;;i dovesse presenta re l'occasione di est rarre da lla feri ta nn di questi proi ettili ci serviremo ,1ll'uopo di piozelle streue, man e::gevoli. quando non si preferisca spaccare d ··aua le della ferita. riò rhe d'a ltra parte ,i può fat·e senza "''itat·l' in molti Per gli nrdinat'l tira palle i tra«ill i ,ono tt·nvpo streui ed al hisogno il tira palle america no Oun nnn pot endo i un t·ini penetrare nel man tello d'nccia in del pt·oiellile: per l'estrazione del nocciolo rl i piombo pulria U'lnto come prima t'Oli van taggio.
•li tl 'acriai o o d'una lega er[uimle11Le. dandog li quasi d lt re vl' tto umanitaria. il Hardelehen, pur ··on\ eru.• ndo dte la ma.;sima parte delll1 ferilf'. prr la pi,•,·ut.·zz.a " nettezza del del proieuile presenrernnno llla;!.,ion: probab ili til di guarigione ., -.'avra n no quindi in n venire meno murilati P storpi . n:;.;en·n con molto senno rlae ti nu ovo proielliiP non lo si cl1•ve ron, id erar f' t'os i 1lmanu 1'0 ffi e \iene predicaLO, e".;enùorlll'o in f'J.!llal spazio di tetn ..,, e 1 in . 1. ù" · . . . . r l'gua 1 con IZtOIII vt .;aranno tna!!gwrt morii e fe t lti rhc• pt' t" lu passato. Per quanto •111i nùi l pron edimemi che il governo e le as-.o•·iaztoni uma· ouartf' con perseveranza e zelo nmmirrvoiP vanllt\ arc'utnu · '"odo per esser pronti al terrihile cùmp iw . dobhinmo an••utarci rhe l.t prO\':l tremenda sia 111111to lontana o meg li r1 nncH \[lfl. - Lealoni p r odotte dalla dinamite e loro trattamen t o - (r a:elle HòJ•ilfJ.LIJ:, d1cembre
Don si debba mai p resentare .
:v ! Pc co nnmw dr.lil' ll'siuni l' r otlolle dalla 1/tnanut, -
T ;:a:t ctneb'31 dnlln dPl la din atrt il<' 111o11 prw du•·nno urlo <':!llllle 111 Lutti 1 l:'.ell'>Ì dt1 rnnllt :-1 <·rerlc. l.)a Alcune prAticate nei laboralt>t'l plrtolet•lll•:Ì
::;t>mhra provatn che i ohb di!<nHtO sile
Lo ..,forzo msg;!iore ,..1 opt•t'a :-ul piauo •Il ro:... i- t·iit appUillfl itllpa!'lt!<CC al ;.!"88 il rù:·Jilirlahill' :-\111 [l o- ler e.
(Jg"lll (llalvolLH 1111 t'lorpo oli f!UC"lli nelura ... coppt8 all'aria lt het 1:1 esso duppr1ma :::;ulla •·lte In
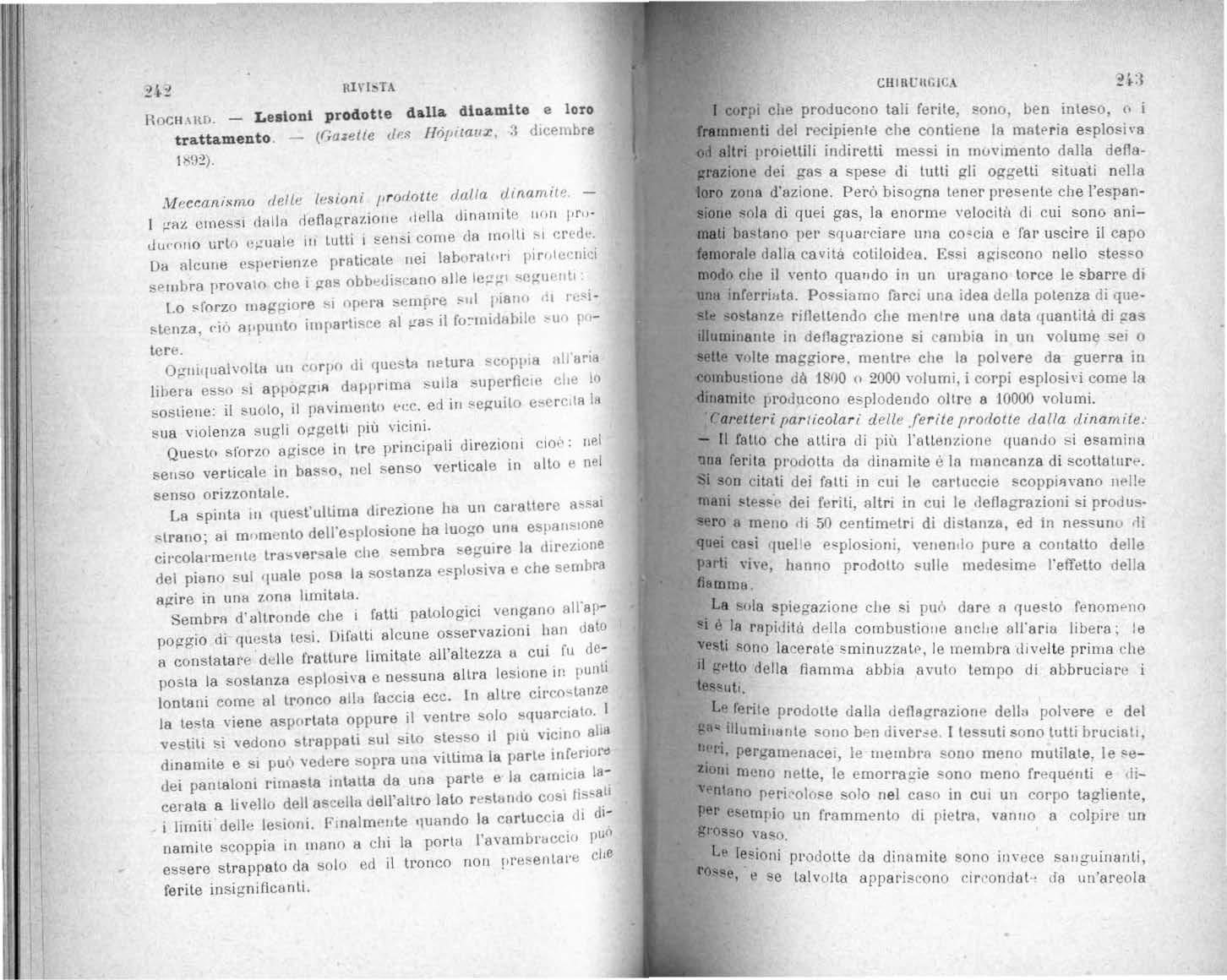
::;ostieue: il t<uolo, i l l·t:c ed in "ef.(uilo c crctiA l11
:>\la VIOl en zA Sllg" li op-ge lll (11Ù vic1nÌ.
Queslo s ror zo ag-isco in t r e pri ncipali di r ezioni <' ÌO•': ufll
!"Cuso ver tica l e in basc.o, nel se nso verticale in Hlto t> nf'l senso or i zzontale.
L a spinla tn quest'ultima direzione ha un carattere a,..:-al strano; al momo•ulo dell·e... plosi one ha un11 espAu ... IQna tra:-var,..ale che ::,embra !:-egUtre la direzione del pia no sul quale posA 111 :-<o"lanzH .. e che sembra a(!i r e in umt zo n11 hmilatA.
Sem br A d'altr onde che t fAlli patol ogici vcnga1w nl\"ap- d i ques ta tesi. llifallt alc une osser vazioni htut dalo a cons lata r·e dP il e fr attur e !i m itale all 'altezza 11 cui fu po.::.la la sostan za Pspl osi\ a c ne!'suna allr·a lesione w punlt lonta ni come al tronco alla fuccia ecc. I n oltre cil·c·o-.;lf1111.C la testa viene aspo rtata oppu r e il ventre solo !:'f!U8r<'ialo. l vestilt si vedono &ll'appali sul s1to ti ptu ' ictno alta òtn amile e :;t può vcdt! r e ,-opra una vittima la. parlt! l 8 ladei palllalom t·imas.l a utbHla da una perle e u camrct ceral a a livello dell dell'altr o I alo rt>stullliO cosr ll,.,,Au 1 li tni ll dell1· F1nalmc•ule quando la car tuccia t11 dinami te scoppia 111 a chi la po r tu l'aYa nlhrucCiiJ pu" essere strappato da ::;ol!J ed il tronco no 11 cl 1 e fer il e i nsi gn incantr. l curjll che prod ucono tali ferile, sono, beo inteso, ,, i frammen ti <lei r ecipienle che con t iPIIe la matP r ia esplosi\'8 ()l allri pro iettil i indirelli mt!ssi in muvrmento òRila defta,:razioue dei gas a spese di tulli txli oggetti s.iluati nella toro zona d'Azio ne. Per ò bisogna lt>ner peege11te che l'espantlioue >'ola di fJu ei gas, la enor mf' vo locilil eli cui son o animati baf<lan o per squ a..cia r e una co•cia e fat· uscire il capo femoral e dallA rav ìta cotiloidea ES!\1 af:rscono ne llo stes,.o morl •l che il ' 'ento quando in un ut·ag-uno tor ce le sbarre di unH inrcrdu ta. P ossiamo farct una 1dea J,.lla potenza di tTUI>.. ,oc.ll!nzP r iflettendo che tn>'nl r e una dala 'luanlilà di zas dluwi uante in detlageazione si cambia tn u11 volume se1 o sette volle ma ggio r e. mentrt> che la polver e da guerra in eotnbu!\tion e dà l 8<)0 o 2000 volumi, i corpi esplosivi come la ilinamitr producono e>;pJodelldO oll r c a 10000 vol umi ('aretleri par ticola r i dP/le .fe r ite prorfolle (/al/a r{irtamite.
- Il rallo che attira di più l'at lenziom• qna nJo !;i esamiua nna fet·ita p1·odolta ùa dinam i te è la mancanza di sco llat ur P. Si l'itati dei ratti in cui le COI'lUCCIC !\COppii!Yano llPllf.' mani <.lt>!l" l' dei fe r ili, altr i in cui le deflagrazioni si pr odu:;· u m euo di 50 centimPtr l di ed in nes"unv tli que i CO"Ì quel.e venendo pure a coBlalto delle p.nti vive , h11nno pr odollo medel'lime l'effello della tlamm u.
. sola spiegazione clJe l'li pun dare A fenom... llo " 1 la rApi ditù t!Plla combustione ancl1e l i be r·a le !\Ono lace r ate ::: m inuzza l P, le me m b1·a divelle prima.c he 11 della fi Amntd abbia avuto tempo ùi abb ru ci at'<• i
L··. ft>r·il e pr odo tte dalla ùeflagt•nziOnt> dellu poh·ere e del .gn"_ 11lumi"ll ttte so11o l leS!'U l i sono lutti brucialr, ucr·t !Jer , 1 . · b8Hwuacet, e membt•u !:iOno meno mutil ate. l e c:e21 11111 meno nelle, le emorragie ,.ono meno f r equenti e di""0111110 pe r i ·olose solo nel co!'o in CUI un cot•po per c;.eml •i o un frammento dt pietra, vanno a colpìt·e un
LP. le'<ioui pt•ouol l e ùa di nam i te :::ono inYcce sansruinanLi ro e • · • t> se lal volla app at'isc:o no ri r t•oncl ot · da un'areola
2h Rivista
nPI'a qu•'"ta non b che retfetto rli una con tusione. Esse ferite po"sono ofl'r•ire !"ezioni nette e pr esentano la forma di quelle pr odottP. da tagli o. . . .
Sono b Pn!' i talvolta frastagliate m a le !"oluztom tlt cont muo sono tutt.avta men o conLuse di qu elle p1·nùoUe dA !'tru· menti ollu"• e semht·ano tenere all a lnro forma un rlt tuezzo Lra le ferile contuse propt•iamenle ,J .. lle e quelle eta Le emo rr ilgie sono immedi.ate.. mettono in per 1co lo la vi l& e spesso l'a pphraz10ne. fasrin d'l!:sm 111·ch. Cosi a v, enne appunto in una dell e Vllltm e della vi a che fu po t·tala a ii' H òtel Dit>n e che non st potè !'al v are ùell a cosc1 a . .
Le fer ite dt cui nrn ci occupiAmo <'ono per regola llmttale
11 d una 1·egionc che ha sopporta to tullo In sfo rzo dP))A causa vulnerante. Qu elle prodotte òalla pnlvere pi ri ca o dal illuminante !"nno spesso m olto vi si osservano tull1
1 di e son o di !'Oven te da ll A com· bu l'ltinne delle ve s ti. 1 capelli, le sono abbrucia li rnenl r P che colla dtnamite lt> pa rti provv iste di peli "ono ' ' lA 'luosi sampre proletle, esse pO<'<'ono anche · dr btanco costituilo .ti s ilice I g ra nelli. dt penetr o11 o aurhe nel le!"l'IULO cellul are producendon det rrc· coli l"COIIarnenli e po!>;;:ono incllstrarst nel derma come • .!l'Il · n PIli di poi vere.
Le lei'\ioni p1•odotte ùalla dinamite non !'OllO tlolo r o,.l' al pa 1·i eli 11uelle deila polvere, la quale pe t• il ;:almlr o che t:"n· ti enP t' causa di un dolore sovente a ::i:ai peno-.o, tardano o prPRtano ,Jiffictlm enle a lla in ctw"nde-;li "COIIl\menti P della comp re i'\,.ioue dei tesi'luli, però guaren•IO lascian o cicatr ici tleformi r etralte; fìna 'mente non ran.no temer l:l fJuelle 2 r 1w i co m plicazioni gastt·o fllcih a dopo le vaste :-cottalure, proJolle dalla poher<' e d al gai'\ illuminale.
1 ca 1·atleri ora de!'crilli non son privi d'imp ortanza : dll»ll l aii'''"Pello !!'Oio del ferito ;;i potrebbe ric onoscere l'e"plo· ''IOil•} è òovutn Hl gos illuminante opp ure arl all r a <·ome !a dinami te od altt•i composti analoghi. In un
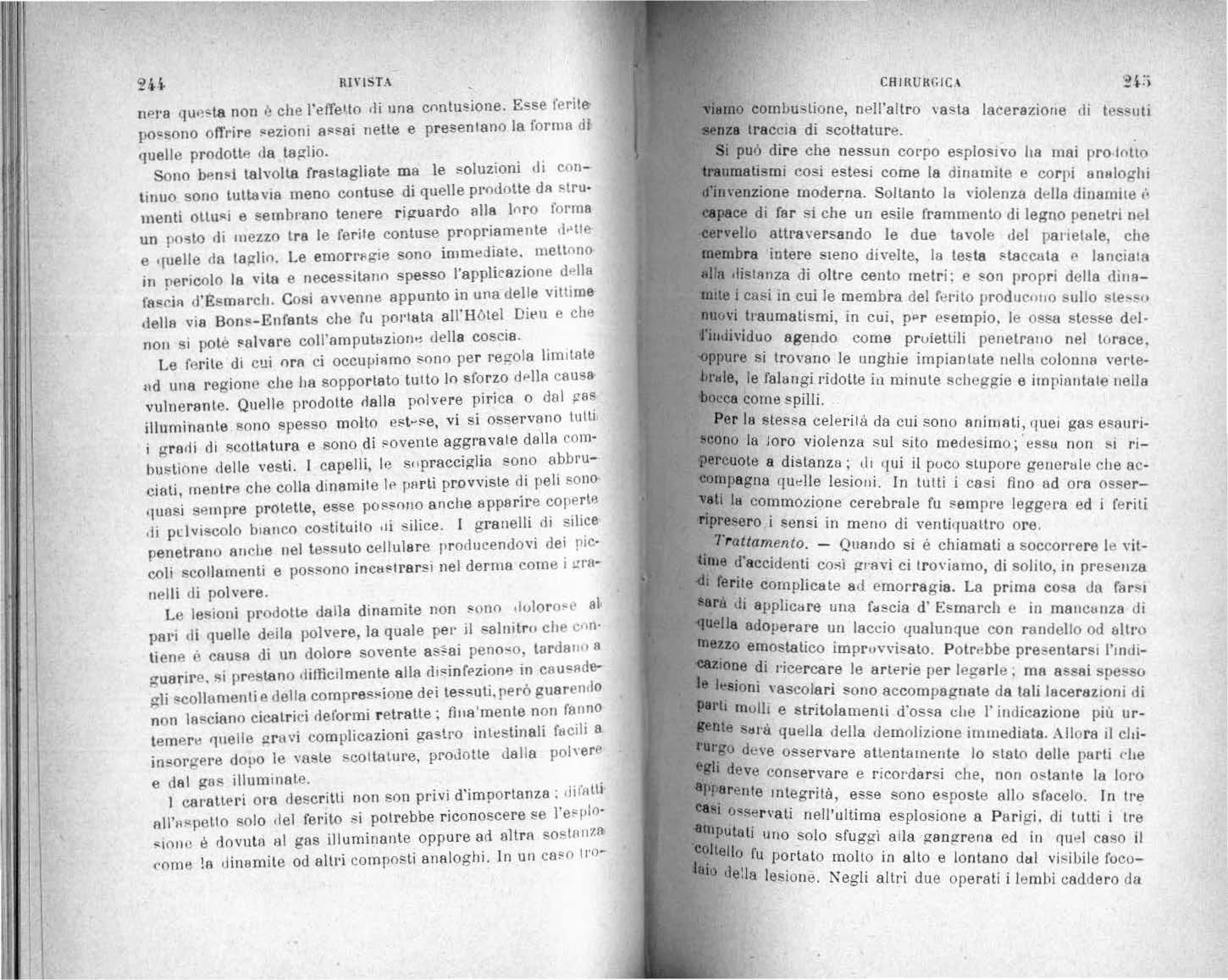
CfllllURt:IC .\
-.i11mo com!Ju-, tione, nPIJ'alt r o \&i'\la lacerazione tli senza tra ccta di scoLlature.
S i può dire che nessun corpo esplostvo ha mai pro tntto tra umatismt cosi estesi co m e la dinam1te e cor pi anttloghì d'in,·eozione moder na. Soll&nlo Ili ''iolenza ddla dinamue l· capace di far si che un esile frammento di legno penetri nel attrave r s an do le due tavole del pa1 1etale, che mem bra intere steno divelle, la testa P lancrata alla di oltre cento metr i; e n prop r 1 della dinamtte 1 ca:>i m cui le membra del fer·ilo producu11o >-ullo !'lt''-"" nuo,•i l!·aumatismi, in c ui, le ossa stesr:oe d el· fiudividu o agendo come pruiettili penetrano nel torace, si trovano le unghie impiantate nellu colonna verlele fallln gi r·iùolte ia minute scbeggie e irnpiautale nella -bocca come spilli.
P er la ste!'sa celerità da cui sono anin1ati , quei gas e!'auriscono la Joro vi olenza s ul sito medesi mo; ·essu non l't r ipercuote a dista nz a; LI• qui il poco stupo r·c gene1·ule c he accom pa gna quelle lesioni. In tuili i casi fino ad or·a os!'ierv.att la commozione cerebrale fu s empr·e legger•a ed i feriti Mprei'\ero i sensi in meno di ventiqualt r o or e.
- Quando si è chia mati a socco r·r·ere lt' \'ittime d' accidenti così :navi ci tr o,·iamo, di solito, in presenza -dr ferite complicate a d emorragia. La prima coi'\a da fa r <: t eara di una d' Esmarch e in man cllnza di -quella adoperare un laccio qualunque con r andello od altro mezzo emos ta tico imp r uY\'isato. P o lr t>bbe l' rndr•·icer car e le ar teJ•ie per Jegsrle. ma a ssai spe::-sCI le II'Siom ' ·ascolari sono a cco m pagnate da tali lacera z10ni el i partt lll ulll e slr iLolameoti che r ind icazione più «ente scmi. quella della demolizione im111ediata . .\llor a rl chirurgo J,. , .e osservare aUentamtnle lo sta to delle parti dte egli deve conser va r e e r icor·dsrsi che, non ostante la lor·o mtegrilà, esse sono esposte allo sfacelo. In tt·e eas• 0 "fle r ,·ati nell'ultima esplosione a P arigi. dt tutti i t r·e .am putali uno solo sfuggì alla Ran g r en a ed i tt qu,..J caso il ru porta to mollo in allo e lo ntan o dal vi !'ib ile fo co&t•l de:ta lesione. Negli alll'i du e operati i le mhi caddero da
,, pur lullav1a ru notato in essi i lt>mbi tl esli n Ati a corwi re il moncono c> r ano pe r feltamenl•• ,:ani. Si compr ende acciden te am me tte n do rhe i vengano rolp1li da stupore nel anehe da m orte a breve l"t·aclema l"ollo l'influsso di una tu nl o formidabile lnoll1 e 'i & un'allru che ri impone di ampulu1•e "'" "ul clt>ll'arto s1luato al ÙI"Opra della lesione, sia "ullo stesso spesso si s0no n"se r vale l'el' i l e ;;ve t'Hl li"8i me tttnumer•pvol i , e molltplic1là di lesioni vien e a complicare lo stato del ferilo fnvoreudo una quant1til g1·ande ,J'iuo· colazioni settiche. Gli "collamenti l'ono purè molto fre•1uent collie pure le anfr attuol'ilit. In s' incoutnwo co rp1 e<:lranet, ed in lati contl1zioni rnnti8ep!"1 di tullP le ::<urt>rfici sanguinanti può f'S<;Hre mollo difficile. Pertonto il chir ur go non dov r à omellere ùi rlisiuf'etta t•e rerilu, s•a piccola s•u g ran de, e ùi app licarv i una sotto pt>na di vede r u e qualcuna ùivenlurt> il punto di partenza d'nr.rtdenti infelli' i.
11 più lontano che pos<>iLile dAlla ferita, la pellP pUi'l essere rimasta 111ta.lla, le parli molli possmn apparire ma nell' inle1·no de l memb•·o si t1·ovaur, drlle l't>udi l ur•• dei c1mali inl'und•buliformi protlolt1 gas. dlllla <ollice o da qnalclw altro eorpo stranirro. !_!Ut>Slt' ar>el'llll't' permPtlono Alle conlu ... ioni di estencleJ•::-i sop1a nn& SII! e di ando1·r a produrrP p1·oi'Pwlameula dei rocolai cl'inft>zione.
I.A romrnoz•one CPI'ehrale o i> leg!!era o non e"1ste. e Mlrn_,-.euza di'l fenomeni 1'8rt>brali 14r8Yi si polrA Il clo r oformiO nel cttso !-l uoves;;,e :nterventrt' r•or. Clpern:done
U na les ione che, scnw par er e mollo !.\'1'8''", tuuavia tl piU grande intere;<"e del d11 r nrgo CUrllt'IO e il lrau!l18liSIIIO oculare. Questo "i manifesta as<=ai spe""O rnn unll c do' ula all'espansione dei !!8t; carid1i .li malerta c;ilicea, ma tah·olta 1 guasti non "ono co"-i t! v1 puo e•sere l ussaztOilt' del cristallln", dt<>lacco r etin1co, penelraz i one di corpi .. !:-LI'anei nel bulbo, .
Il dollOI' Hochard nella lel"i illu-"li'Rli\'U dPJ l'ecen l t
C8"1 di !"ulla necessitò di un e<>ame arr.uJ'II l O deiJ'orclllo fe1 ito. E:!lr clire rlle rn t{UE'! raRi la cauMln dalla e talvol ta inten--u . acrn m par:nala da enorme c·hemosi chP ma,.thcru tutta la co r 1wa c può far ternPre una p•·rfornzion<.' del hulbo Sogche la perrot·azione può farsi l'fletti "onreult" eomP JHl r •• il c·l'r<>tallino puc\ eo..:sl'r•• lu<><>alo. :\fa heon IZ'li emollir•nli t'ief<cono a cloma r e rinfìammazinne
'U ie. 1n c·l1Pmosi spar·isce, ed in r:apo a tre si !'Or· pr·esi al vPder P. l'occhio ri lr·r·rwto alle c.ne normali. l J.!rBni ù1 silire si trovuuo rn ··d1cazione or due angoli lelrnrl'hi o. l nr«i di Parigi han11n •l11nn<>[l•nto lu n••rec::c:it;'r cl i fare •mn i spez1one minuziosa d«·Jtli orrlu feriti E', '" les10n i , pac:... are prontamente 11d 111111 enPrgica trraoia. Lo '-l d•cn<:i rig-uard•• a_gl1 "''ccrhì. i 'JUali la violenza t.J Jic, scop pio l'ipor'BIIO spesso la rottu r a cnmpll'la della membrunn del LimpHlHl.
Quando state p1•ese lullc que!-'l•· Jll'ecauzioni l'd il l'el'Ilo l O<><>n superarP rl pericolo tJaurnalieo, se non muore di !'hl)l'k, <: hA 'J lli i• più violento chE' 111 altt·P le!':ioni, es"o ent1·u nel nurne r·(J dei traumatiri ordtm1r1 l' non hu du t1•rncre J?l i aeriùenti !';Oiitl u vPnire in !"t>WIIlO alle p<:p\o<:ionl accompa.lrnu te da <:cotl atur·e.
P.
Delle flatolo del mento - - (Journal de J led tct n.t· et de Chirurr;ie, t!H'Pillb!'e I X9t).
L e li!'lole delle mascelle non co"litrii"COno n11'allezione rara l ' ' 1 on u1rn eno le fistole dt>l nwnlo, che sono J'ull r onde le tn Hno ù i tut te, ;.o no talvolta di di/Ticile, a ÙPll U diffìc(,lltJ <'hP si ha nf'l ricono<:cere In lor o ur1::1 ne.
! . 1 :8 fìstole d,..J menln <'auo;ate •JU8"i sempre da una t "•onF> de• denti e prinripalrnente degli incisivi; lu d1llicollit l•r on ene do ò c11e, 111 ct·r tt ra<:r, Il dente 11on semb r a pre,.,.nt!i r t> ulc t I l · . ma a eraz 10uc>, oppu r e cost piccolo oltr.oru zione che non 1 Lt 'b . l "' c r e1 e a r r u1re a CSU!;O ad es8a eJ agire quind i dr sovenli allora si riferil:'ce la fistola ad una lestn rHI Msea e lube r·colosa e lntli i di curi\ che ::.r mel· tono rn opera, l'""za toccare il dente, non modifi can o l'Affeziona.
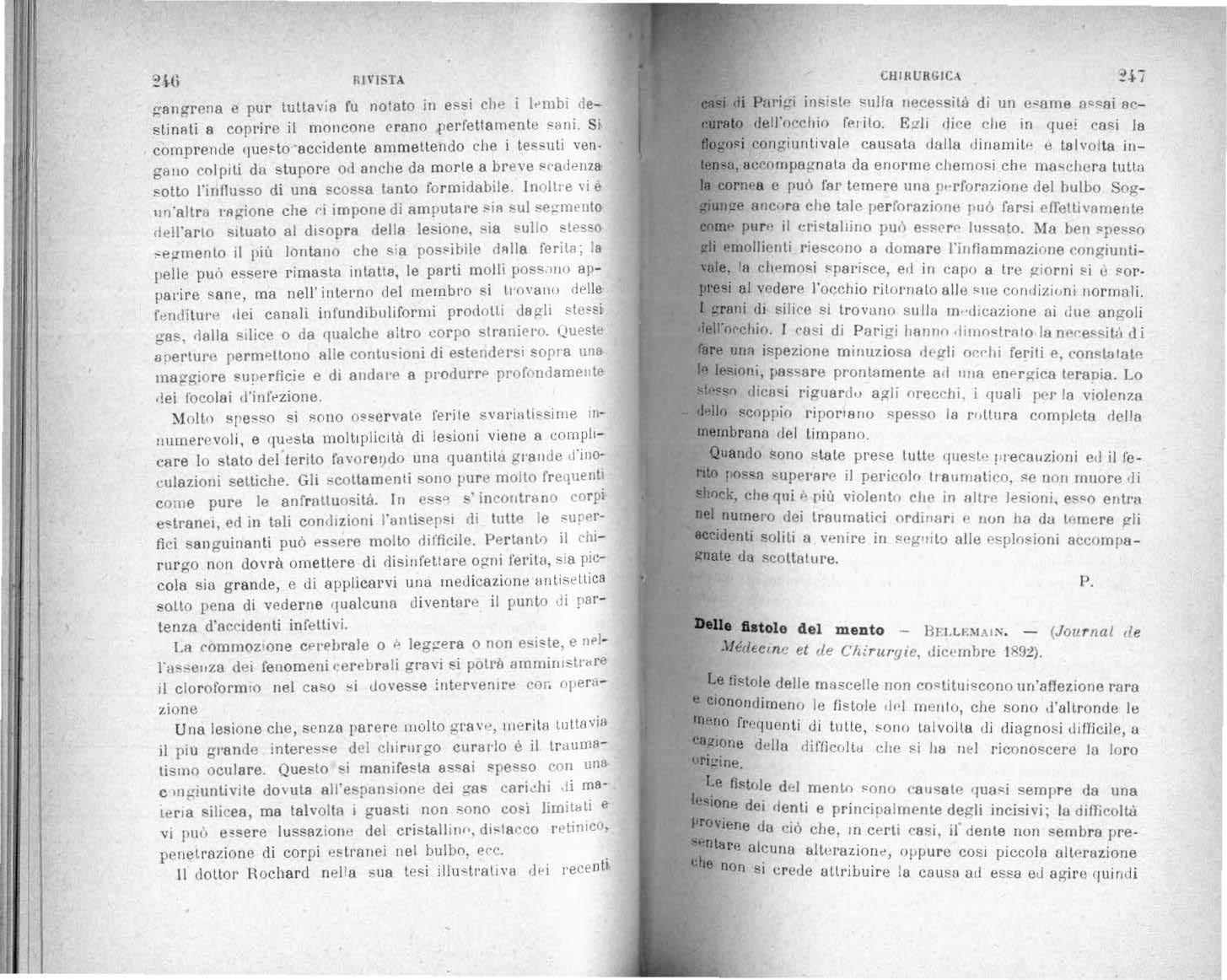
La causa pt·rma è infatti una per iostite o ptullol>t.o, dello uu'a r lrrle alveolo-denlat·ia. Il perio::.tio e l'Collfl l<J dal pu,.., la raùrce è denudata, Il mascellare e carialo, rna la puo al coll<'llo del denlc. mod o rhr lfll''"lo può parere !' anC\
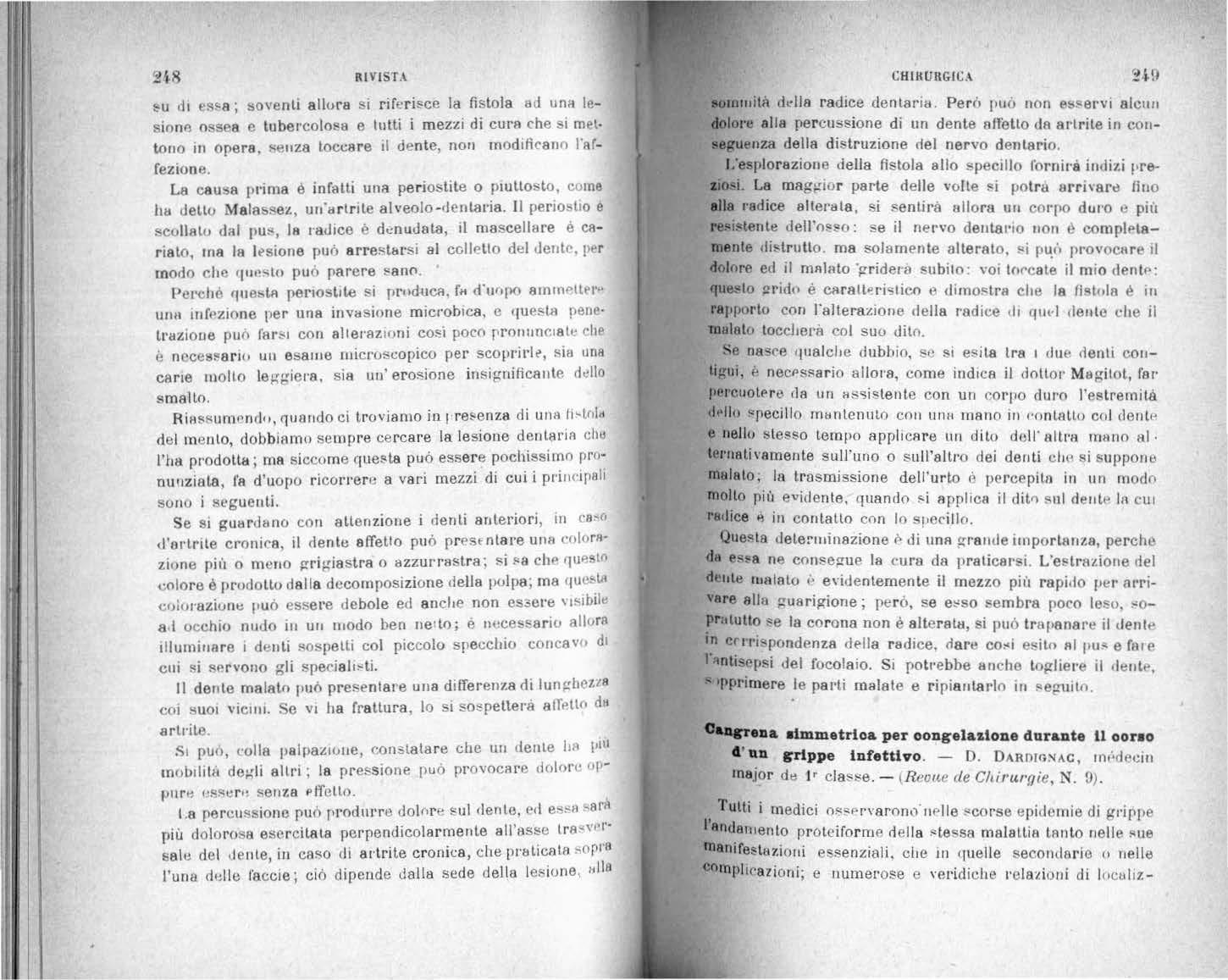
P er·ché perroslrte si produca, fM d'uopo unn 111frzrone per una invasione microbica, a pene· pu t1 far:>r cou alrerazroni cosi poco pronunc1ate r he è nC'ces:o:a r ro uu esar11e micr-oscopico per scop t•it'l<', sia una carre mollo si a un'erosione in siguificaute ddlo sm alln.
Ria!"sunwndo, CJlHIIIdo ci troviamo in 1·re!'enza di una lr .. Lnl rl òEl l m en to, dobbi amo semp re cerca r e la l esione denlat•iA chij l'ba prodotta ; ma si ccom e questa può essere pochissimo pr()· nunzial.a, t'a d'uopo ri corr·er,. a var1 mezzi di cui i pr·irH'ipalr sono i segue nti.
Se si con allenzione i denti anteriori , in \l'ar·lrile cronica, il clen l e afTello può ntare un11 colnrllzione più o m euo o l'8 che é proùollo dalla decomposizione della polpa; ma qucf-ltt
I'UÒ debole ed anclte non es3et·e a l occhio nudo 111 u11 1110do ben ne•lo; e allor!l 1llumi11are 1 d•·nti sospetti col picco lo specchio concavo dr cu1 -.i sperialr>-li.
Il dente malato può pre se ntare una drfferenza d1 COl sUOI viCIIII. Se VI h a frallura, IO SI so,;pelterà affe>tlO dii artr·itP
Sr puo, <·olia palpazrune, constata r e elle un dente lr<l pru m ()brlitli. degli allrr; la pt•essione puo pt·ovocare dol()rc up - r•s.. senza Pffcllo. t.a percu!'<siono puo produrre dol()rf< sul dente, Pti es,.n " ari\ più dolor·osa esercitala por-pendicolarmenle all 'asse tra --v•• r· salo del dE'lite, in caso di a1 lri te cr onica, che pr!lticata ,o pra l 'una delle faccie; ciò dipendo dalla sede della l el'ione, Hlla
l: HlltUUGlC.\
tiO UHuitil ddla radice dentaricr. Per ò può non el:!l'-er·vr alcun dolor·e alla percussione di un dente affetto da artrite in COIItleg uenza della distruzione del nervo dentario
L 'esploraz ione della fistola allo specillo t'ornil'à indizi preziosi. L a parte delle volle l"i potra arrt,ard fiuo ell a r·adice allel'ala, si sentir·à allora u11 cor·po dur·o l, più le tleii'Msn: se il ner·,·o denl.ar·ro 110n t> compiPlamen te tlil'trutto ma solamen te alterato, !'i pr·ovoc11re rl dol ore ed il mniAlo su bito: \'Oi tol'cale il mio <lente>· quel'IO :1rid<1 é Cl'lrall.,ri-slico e che la é in t8 J1prwlo con l'alterazione clelia radice dr fJtH I den te che il m alato tocclteea col suo dito.
Se qualche dubbio, se s1 esita tra 1 duP clenti cont- necPSRa r io allol'a, come indrca il dollOI' M agitot, far· pPr·cuolPre eia un con un co rpo dur·o l'es tremità •l••llo "'reci l lo rnllnlenulo co11 urH• mano in t'IJOlallo col <lerrlP e nello stesso tempo appli care un dito del l' altt·a mano al. ter·nalivamente su ll' uuo o sull'a!Lr·o dei denti <;Ili' si suppou e ma lato, la tr asmissione dell'urto f> pe r cepila in un modo molto piu evidente, quandC\ applica il dit0 !'1 111 denlt' In CUI radice in contatto con lo specillo.
QueRla dele:-minazione l> di una g-ra11de itnporlallt&, perche da essa ne consegue la da pralicar·si. L'eslr lltiorre del deute maln to " e,·identemente il mezzo piir rapid o per nrriva r e Allu pe r ò, se sembr a poco leso, "0<:e la cor ona non é si può tr apanar·e il uenlt> rn cr dE'Ila rad ice, òare co:< i esito Al pu, e far r r tn tisepsi ùel focolaio. Si poLI'ebbe anche il rleutP, "•ppri m ere le pat•li maiale e ripiautar·lo in "eguiln.
Oaacren a almmetrlo a per oonge laztone durt.nt e t1 oorao 4 ' u u grtppe infettivo . - D DAROrG:-<AC, major 1• ( Reone cle Chirurgie, N. U) .
, Tu ili i m edici
$Corse epidemie di gr·ippe
111ndar11ento proteifor me dell a m alattia lAnto 11elle !'<Ue mau ireslaziolli es<:enzia li, eir e 111 quelle seconda r io o uelle complrrazioni; e numet·ose e "et•idi che t·ela ti•JIIi di lotalrz-
LII!Rl!Ritl( \ zazioni tllver;;e dPlla int'ezione 1'peciale rPne. lu ,.e"cica. il polmone, la pleura, il cuore, ririùe, il cervello, ecc stoLa attua le delle nostt'l' conoscenze non ;;i "8 ancol·a l?e r1uesLe polmoniti, oliti, nefrili, endocar.liti, ecc. cb e qualificano pet• grippali d•pcndano unicamenlt> da 'lliP!' lo ;:peciale av,elenamento, il che pnrl3 poco [H'nhallile, o in •1uale rnndo e misura tali' at:ente infettivo, ad altt•i microbi patogeni comuni e conosciuti. abbi11 potuto determinare tali complicazioni più lemibili della gril'pe medesima; ma !'i ammellB chr vi allora del!L• eon.dizioni (ar:ore oli, se non alla gene'-i, alla vilalilil dei pa lo!!;eru, e qurrvii pro luzione di quegli ::;conr·erli .,ecou,hl'i <'Oil<'OJnlblnli di cni si fanno dei fenomeni grrppali, non si "arPbbrro probabilmf'nle manife;;tati ;;e l'ol·!!ani«mo non rosse stato prevenli vamente impre;;sionato in totali tu dall'attacco di g rippe.
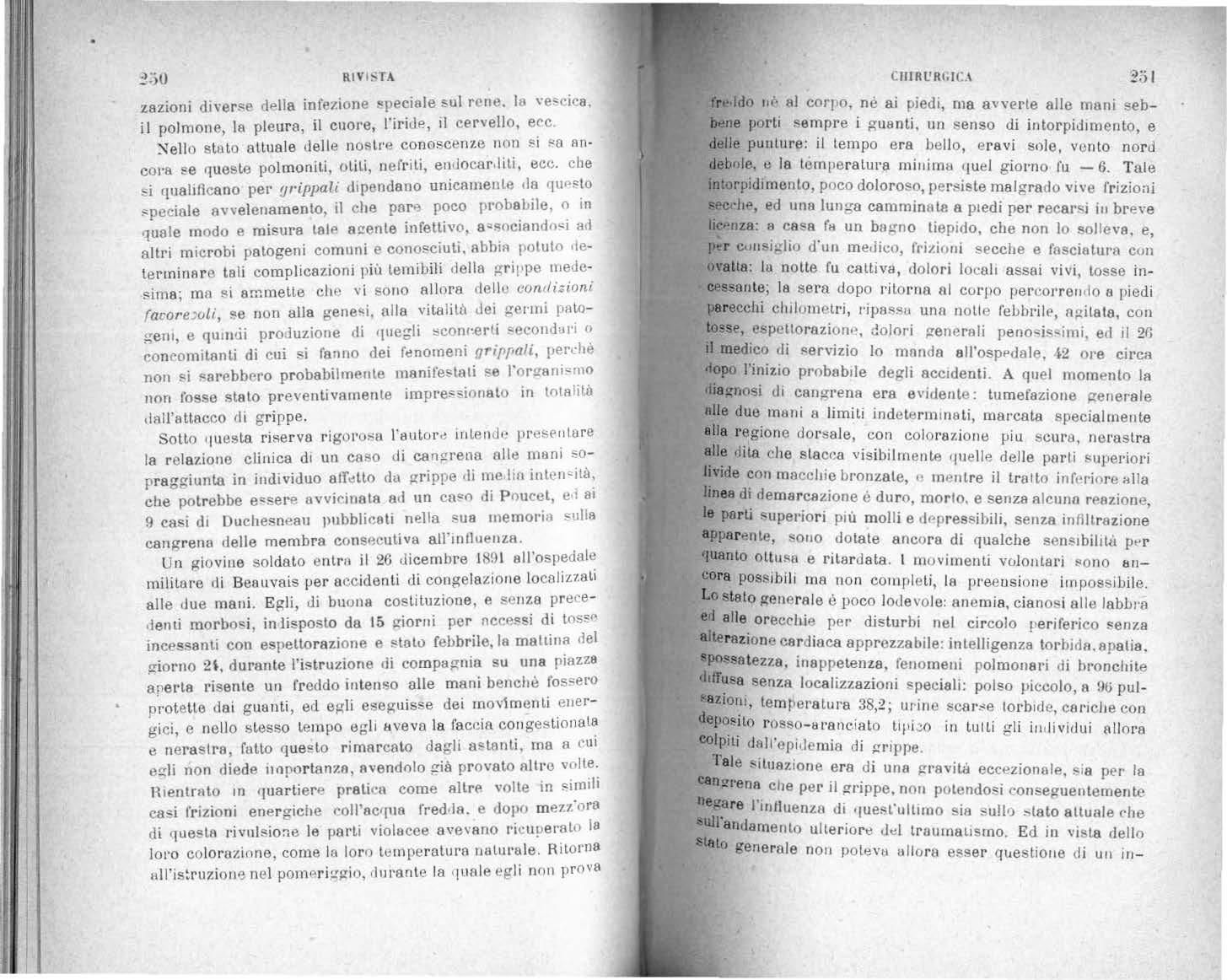
Sello 'lllCSla rh.;erva rigoro:<n rautortl i tiLPndf' fJl'l'!:iE'III8re la relazione clinica d t un Cf\ HO d i ca n ali t! ma ni !;0p rag giunt.a in individuo ùn grippe •li me !in in!Pn'ilà, che potrebbe e"sere avvirinatfl ati un ca<>n di P o u cel, e·t ar 9 casi d• Ouchesneau pubblicati nella sua tnemot·iA delle membra consP.cutiva all'tntluenlA. un so ldato entrn il 26 dicembre 11:\HI all'ospedale mililat•e rli Beauvais per accidenti di congelazione localizzati alle due mani. Egli , di buona costituzione, e Sl'nza precedenti morbo"- i , in.lisposto da 15 sz:iorni per nc<'t>!"Si di incessanti con espettorazione e ;;toll) febbrile, la matlina del giorno 2 i , durante l'istruzione di compagnia su una piazza t·iseuto un freddo intenso alle mani benchi} fos"ero p·r·olelle dai guauli, ed egli eselo(u isse dei mov1menLi elle rgici, e nello stesso tempo egl• &veva la fact·ia e nera'llra, foLto questo r imarca lo dagli tl"tanli, ma a r ut non diedP no1po r lanzA, avendolo provato altre volle Rientrnto tn quartierP prati<'O come Altre volle in ;;imili ca<;i frizioni enP r giche <'OII'Ac•p ta rred lA. e tlopn mezz'o ra di questa t•ivul sio:-:e le parLi violacee avevano ricuperat n la Jot•o colorazione, come lo loro ll!mperatura naturale. Ritorna nel .\ut•ante la qunle el!li nnn prova fre !do tti' al coqoo, né ai p1ed1, ma avwrte alle mani sebbene po1·t• <.empre i guanti, un senso di intorpiJtmento, e de!Je punture : il tempo era bollo, e ravi Mie, vento no r d deuole, e la lernpe r alm·a minimn quel gi01·no fu - 6. Tale intorptdtm enlo, poco doloroso, p e r;:iste malgrado vtve frizioni ed una lunga cammin11te a ptedi per r ecar"i in bre>e lir,nza : a <'asa f11 un tiepulo, che non lo solleva. e, JH:r c.m ;;t;.:lw d'un medico, ft•it.ioni secche e fnscialur·a con ovatta: lu nelle fu cattiva, dolori locali assai vivi, tosse inCPssnute; la sera dopo t'ilo1·na al corpo pereorrenclo a piedi parecchi cltilwnrtri, t·ipas!'u una noltP rebb1·ile, ngita ta, con espeltorazion,• , dolOI'i peno.:;i"---illli, ed 11 21ì il medico di servizio lo manlla. all'ospPdale, i2 ot·e circa òopo l'inizio probabtle degli accrdenti. A quel momento lfl dr can!-{rena era evidente: tumefazione generale 11lle due a limiti indetermmati, ma.r·cata specialmente alla re gione do t·;sale, con colo1·azi one piu scu1·a, net'ustt·a dita r·he stacr:a visibilmente quelle delle parli superiot'i hvtde cnn ma cchie bmnzale, ,. m•mtre il tratto inf1•t·inre alla linea di demarc11zione è duro, morlo. e senza alcuno rPazione , le parti "UP6l'iori p1u molli e dPpressibili, senza inflltrazione appar t>nle, "-Ono ùotate ancoro di qualche sen;;tbilttù p..r 'JUanto ottu!;u e rila r ùata. l movimenti volontari !>OliO cora POS!;ibili ma non completi, la preeusione imp osstbi le. Lo stato genl'rale è poco lode,·ole : anemia, cianosi alle labbt·a e l alle oreccbiP per disturbi nel circolo periferico a lte razion i' cardiaca a p prezza bile: intelligenza torbidA. apatia. spo;;sotezza. inappetenza, fenomeni polmonat•i tli br·onchite senza localizzazioni ;;peciali: polso piccolo, a 96 pul"8Zior! ' • tcmreratura 38,2; ur itre torbide, car·icll e depO!'llO l'OS$CJ-81'811Cialo trpi .;() in tuili o·li illdivicJui allor·a colpiti dall'opitlemia di g-rippe. "'
Tale i-1tuaz1one era di una eccezionale, Joo;ta per· la canS!rena che per il !!r·ippe, non potendosi conseauentemenle l'lrtllucnla di •1uest'ulluno :-;ull0 alluale rhe :ull anda mento ulteriort! tld traumaL•smo. Ed in vi11ta dello lato generale non polevu ullora esser questione di un 111- tervanlo qual siasi, essendo ancora precisare ..ione dei de!lo sfacelo i m mediato o rimoto. Con un prono;;lico riservato, si i stituì un trattamento lo· 111co e 1·ipa1·atore, gl i ncciùenti bronchiali e wippali con analge5:in a e solfato ch intco, le parli cangrenat... in bagno di solllzione debole di Lt sl er dtmezzala a 50 centir.cr. per 4 ore al g iorno , indi do\(' ad una verA imbalsamazione con polveri jodoformio, canforK, acido bor ico, mantenute denso l'Lralo di ovatltl, trattamento che favùri la delfWStone delle supel'flcie, la t'or maztooe del Ro lco d'eliminazione e (Jl't::' PII o"ni co mplicazto ne : e sollC' l'azione di esso il rtr:aslo stazionario pe r 10 giot·ni, cominciò poi a m igli01·are 1·apidamente, tanto che LO ((iorni più tat•di lo !'I alo gPnPr.a•IC' er a lA bt•onchtle scomparsa ed era possibtle, .,.ollo qualche ri ;;erva, di fa r e un p1·onostico favorevole c1rca la parzial e conservazioue delle mau1 111 vi8la del mantenimento da più giot·ni nettamente stabilito t1 conservalo ùel solco di deli m itazione. due mnni la faccia palmare i· rtdivenuta quasi normAle, quella invece presenta nelle parli più alle, el tlisopra del S('l \co predetto una gonflf'Z7.8 t>dematosa, nl8 con sensibilitù, co lorito, circolazione normale: al disotto qu ...sta hnea le parti cangrenale d1vise in due zone, la ptu altn seùe Ji un 1n•ocesso can)!r·enoso umido, !>Il quasi la lolalt tà di ogni tlito una cangrena secca, col mum mifìrali, in escara ind<•lente, F<o not•a alla percussione formata da tullP le paeli molli net'P, sct·ep'llate P applicale alle ossa necrosate: non vi era traccia di umida sulle ùue faccie palmat•t
Mentre in pemcipio sarebbe stato imprudcnlt::, e prematuro, dccidet·si ad una amputazione pr·imiti,-a , ortt d 1po 35 ùi aspellativA armata, collo stato generale !lh'Pnuto eccellente, col solco ùi delimitazione che fi-.sa'A e<>.ellamentO l'estensione del dPficil delle parli moll i e n••lle os:-a, divenuta inutile una prù lunga aspettath' a si decist> l'a1nputnzionP parziale delle mani, o megliu la regolori zza-
CHIRt tii: Jt:A
_ tione tnPtodica dl'lle pa r ti sfNcelate, che "''nne esegu i ta 111 f!uP ad ottu sriorni d"inlf'r,·alfo.
Il risultato fu, nelle mano si nistra, 1'11mputazio ne dE>lle lre O!lF<a metacarpee intermt!dle del pollice conservando la meta della pruna e del 111ignolo conservando i due ter zi pure dell a pr ima fdlan gcl e guar-igiouu per pr ima intenzione; nella mano destt·n esportazione di'Ile 4 ultime dita diNrlirolando le articolaziom fahm#{ee, conser\'lm do 11 pollice , e r icoprendo la vn:::ta perdila d<'i tP!!umenti dorMii con lembo fot·mato dai tegumenti della regtnne palmat·e delle dtla riruasti vivi, suturati fra loeo e for·m,rtli un su l'llciente le: ubo che pur·e a•le1·l co mpletam ente per prima ml" llzion e P senzA ioctd enti
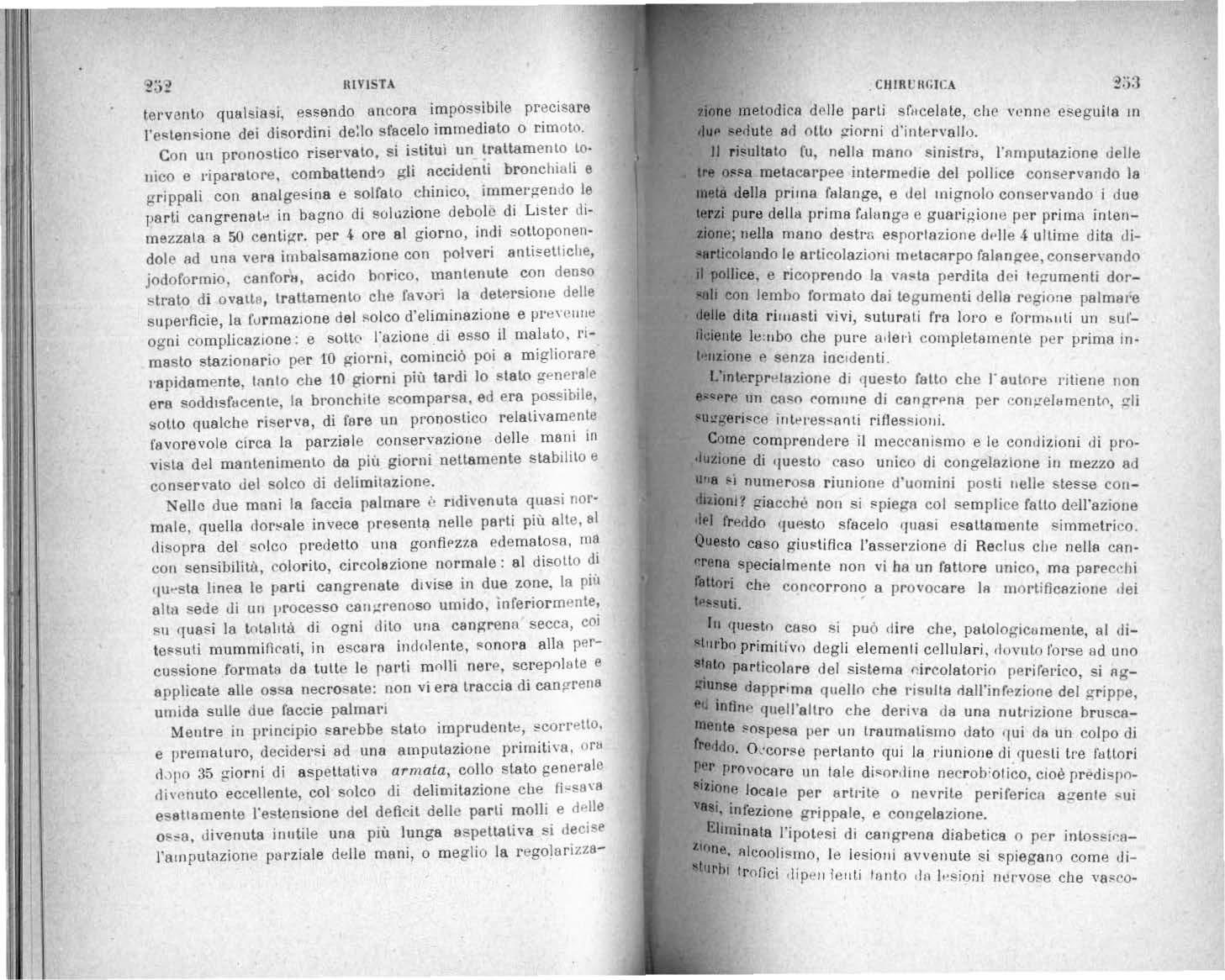
L'mter p r ... lazion e dt questo fatto che r autore ritiene non 8Jl"PrP nn <'Omnne di per <:On!!ellllnenln, !!l i lltlt't·es..;aoti riflesl'liO tti.
Come com prend ere il m eccanis mo e le condi zroni di pt·o•luzione di que sto caso unico di congelazione in mezzo ad uroa "'' riuni one d'uomini posti uelle stesse condiziont ( giacché non si spiegA col se mpli ce fallo dell'azione •lt>l frt>dd o questo sfacelo quasi esattamente "immet ri ro. Questo caso l 'asser zione di Rec lus che nella canspecialmPnle non vi ha un fattor e unico, ma parect•hi ratlot·i che concorrono a prO\'Ocare la mortificazione ole i lu qu es to ca so si può dire che, palologicomente, al dilllllrbo prim iti vo degli elementi cellula r i, dovuto l'ot·se ad uno 81.Rlo partico lnre del sistema <'i r colatorio pt>rifel"ico, si ngdappr ima quello che l'Ì'Illll& nalJ'inft>zione del n-r ippe eu intln •• quell'altro che det'l''a da una nutl'ìzione meute per un Lraumali smo dato •tui da un colpo di ftoe,lifo. Q,COI'I'O pertanto flUÌ la I'ÌUflÌOlle di f(Ueslì lt' e l'allo r i r e nn la le di:::ordrne necrob:olico, c1oé
81210111'! locale per artr·ile o nevrite periferi cn a!!ent e '-UÌ •asi. infezione grippale, e
Elnnina ta l'ipotE-si di cangr·ena diabetica o per zurne. ll lcooli:::tno, le lesio ui avvenute si spiegan'> come dilllltrh1 l r orìci olipt>ll 1crtli lnuto oln \.•sioni ch e ''8»<'0- lar•: n c:ono fennuwn1 uel corso della malattia che dcpon.!ono 1n favo•·e di arnlwdue 11ueste c rigini, per cui si pun per ro8"'"Umere, cht> vi furono in questo caso disturbi trotici a<-'-OCiali ad alterazioni vascolaei per arlerio-5:cler·oc:i acuta. sovralullo dei capilla ri, e come !'<i osser vano in seguito ad 111fo>zioni che eHetli locali di lali processi, riuniti.;i, conversero ad uno sle5so scopo, la morte delle pa rli, e che essi furono tanto più rapidi percltè agirono su un orga111smo pn•dispO!'<lO per idiosincNISJa par ticolare, 10 stato dt decadtmento per malattia iu allo, ed attivali anco r a dall'tnbt·utale tlel frPddn che agì come un ve r o lranmali!'mO. l'e;:sudalo che si !'<panùe n ei te;;.E-ult, J'uurnenlo ùt cellule g:toHtni, il rammollimento e la fu-done delle flbrllle t·ongiunllvali e la fo rm azione di vasi Vl.ll'iano cta'ìcuno variantlo cosi l'a8pelto anatomico dell'inlìanllnA· zionP . - La flogo!'i può essere sie t·osa per lungo tempo. come e:'sudali pleut•ici, neg li igromi; i fatti provano clte può e,;ser t.ule anc)te nPl cellu lat·e e• l allo1'8 e!'iste d'or· piccnla cavità l"i['ie!Ja di li•]Utùo clw e un \'ero a., cesJo si eros f). che la leucocth•"i cnl!a tt•t•ilnZJtml} li>t· m& li\ a •le l tn Hlollo osseo, Jo,·uto .acl 1111 'cle11n pt·ndullo ete..<>o IR un micrl)ho che .iH pRr·te c:ua tlt>lermlltll !' 111 tì 11 n 1 maz toue locale, si comprende che, in d11li CA"'i, j' 11 zi11ne , 111 m•lollo o Pn !'<ia meno vi,·a, la leur·o·· tn"'1 menn abhnudant•·. u l'l''"''udalo esclusn·flluent·· -.tero;;o, auzicht> !>ierùpurulen lo.
I due or·diui di ,-asi, arterie e veue, furono pt'ouabilmente oblitet·ati, determinando cosi le due fu r me clin iche ed lllllllomo dP I proces!':'o necr·obiolico.
Degli aaoeul aleroal, - E. NJCAISE - (Revue (le citi t rtrf7itJ, K (i, 1R9:l).
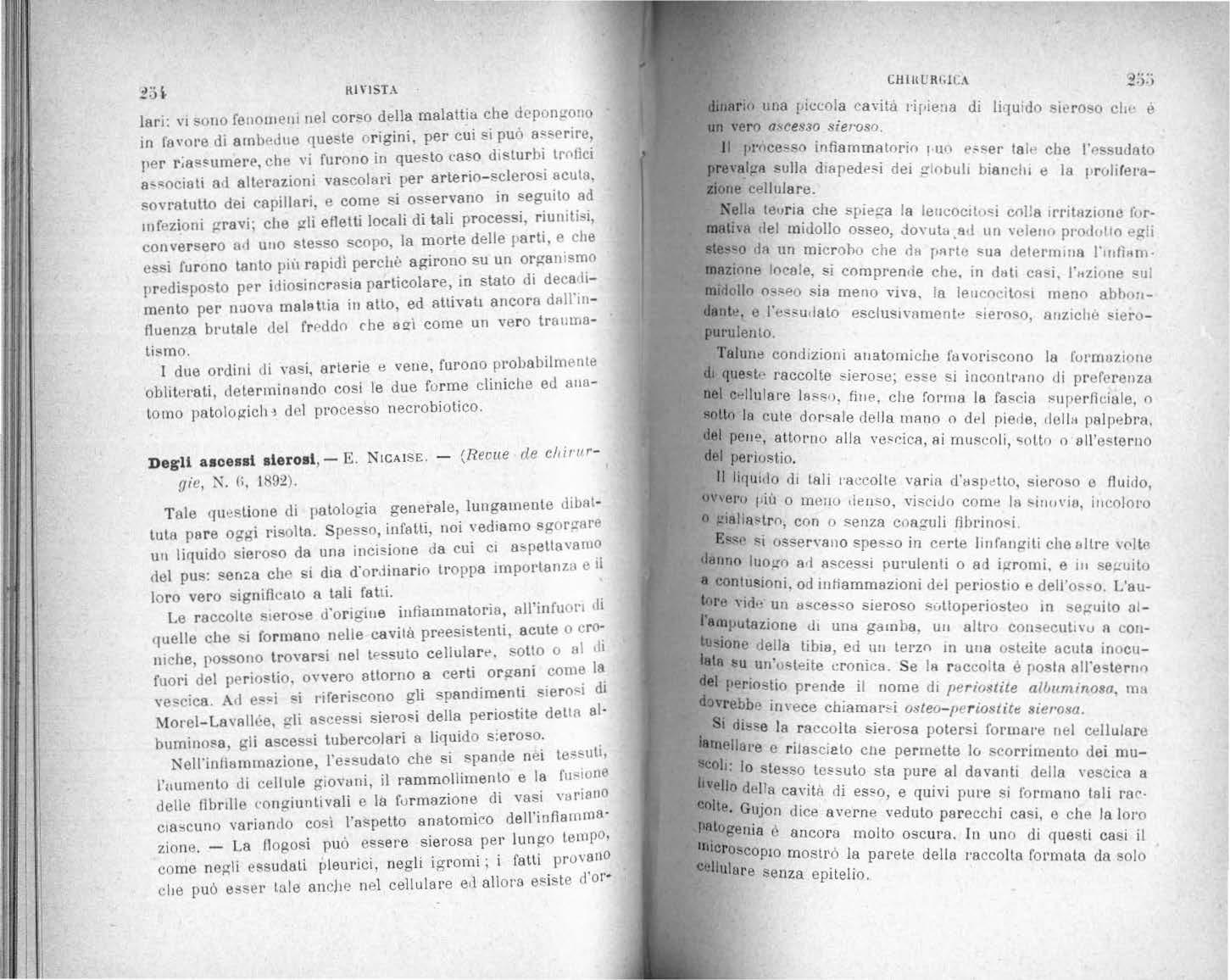
T ale tjlli'!'lione di genet•ale, lunga111ente dibattuta pa r e og-gi risolta. Spesso, infalli, noi ''ediamo un liquido sie1·o<:o da una da cui et a:.pettavanto tlel ser.za chE' s1 dta d'ordinario tt•oppa 1mporlanzn e ti loro vero :signilkato a tali falti.
Le ra ccolte s er·o...e d"o r 1gine infiammatoria, Rll'infuort oli quelle che si fo r mano nelle cavità prc>esislenli, acute o eromelle, possono lrovarsi nel tessuto cellulart'. solto o al tli fuori del periostio, ovvero attorno a certi or!!ani come la_ ve"cica. Acl e"'-i "i riferiscono gli spandimenti stero"i d• Morcl-LavRllée, :xli ascessi siero<:i della pe r iostite della al· buminosa, gli ascessi tubercolari a li'!uido s:eroso.
Il )ll'"ce..:so infiammatoJ'ir, 111n 1'"-«er talP che <:ulla dtapedt>:<i dei !!lobult bian cl11 e la prolt fet·azioue c"llulare.
Taluntl comilzioni auatomiche f11 vot·iscono la l'ot•mo 11011 p dt qu e!>t•· raccolte ·e - - · - "'' ro:oe, es:;e s t lnCn11lt'llrto d1 preft>renzR nel c.. llu la•·e che fo t•ma la fasr ia n snll.o la dor"ale della m!Hlo o di'l p iede, doli" plllpeb;'l'l, del PC11 !', a_tlot•no alla ve!'cica, ai must·oli, c.nLto o all'e!'<te r no del per·wst1o.
Il l1CJUr tlo dJ lal 1 •·accolte ' 'a r iu d'Hspl'lto, Rtero>-o o fluido O\''et·o (•iu o me1t· 1 - ·-. J -. ' O • 0 l t'll:-0, VJ,Cl O COrllt' )Il '--11111\'10, 1111'0101'0 con o "enza cnag"u li fìiH'inosi
E!<"" "t ossen·Auo spec:;:;o in CPrle linf"Angili che \C'Ilr. llatmo luoun ad ac:cessi purulenti o ad if.'romi. e 111 se:.uilo 8 contusiOni. od inHammazioni tiel pe t•iosttO e dell'o,..,o. L'autore \"tri•· un a'<ce-"0 st"e o LI • · , .,_ r so "" 1n ,..e ..uito ull c.h uua gamba. u11 allt·u A condella tibJtl, ed 1111 le1·zn tn una osleile acuta inocu8 a f!U un' •c:l ·t . S l d .. _c '"'l e cromca. e A r uccolla é postA all'e., ternn d el perto:olto prende il nome dt pt>rio3lite aliJIImlllosa 11111 ovrebb" i n, h- . . • . ecc c •amat·::-t
81 dls'"e la r a Il · · la eco a s1erosa poters1 roru1ar·e rtt:l cdlula rc rnellat·e c r ilasc•elo c11e perttlelle l'· · v dei mullcolt; lo ste . l l l l :sso ess.·u o sta pure al davanti della YcscicH a IVe IO tlella ·"t· J' .. COlte _ ca' 1 a 1 1 es,.o, e qun•1 put•e formano tali rar. Gujon d1ce averne veduto parecchi casi e c hi" la lo1·o P&logenia n ' 111. · aucora molto oscura. In un o di queslt casi il ICr O!>COplO ffi OSt 'Ò 1 d c 11 1 1 a parete ella t·accolla fo1•mala da solo e u ar e senza epitelio.
<Jli crarwwciei di sierosità ùel
..:econdo lui dalt do sierosita dR rotln r·a Ùl't ''8"t arterioc;i, veno"i linfalici e dalla lt>lle tll'eole dt>l tes;;ulo Sarebbe come una t>ruoral tra::;udamento dj una non prù "811!!Utnanle, o 111la srero!'rtà r o;,!'aslra t·bo! rrnhe'e il priuoo uppat·eccluo nelle amputazioni: qu i però nuu salo !'colamento dall'apertura di vasi lacerati raprd&.tnt!nte llllut•ati eta ma bensì un es;outlato di natura rrritaltva.
Nella pru pnrle di tali spauolimenlt sier·oRi co nse cultvi n si !'egnala l'e"iRtent.a di nn orlo (born·rl>/el) nlln perifct·in, tnrlt7.•n evidente dell'infìammaziont> dellP pRrt!li dt•lla cavila.
Le rnccolle dello ()('t'io!Jtite albuminosa apparlen)!uno pure a questi a'lce<;!lt sier·ost. - O lie•· definisce 'luesta
Ull8 fOI'mS RperiAIG di perio"'ltle ctu•atlerizzala rlalracCUIIIUlO ..,nlto r1 e negli stt•ati po:•r toslei t..li un lic1uid o "ifllant... , aluuminnit!e, lraspAI'ente, analogo alla sll tO'ia.
T alora il liquido 11011 è fllanlP, la cnnsistPnza pure"" ,. vtlJ'rabile: e In vis•·idiln e la con;;iRLenza non in ruppo rlo C·JIIn Jll'l'"en.w tlell'alburnina che tHii raccolte conlP!l-
1(0110 n della IOUC1118 rhe t.ah·nJta
L '»ntOI'e rifet·ic:,cl' llll numero di c;ue e di nlll't r ifer.htli a t'Il"' acuti . Ptl a casi C'l'Onici: uiLIInt 'iOIIII per· In ptil vi!'chinsr. L'd arcompaf!lll'llln 1 lumm·i hinn ·In e le oo;teiti luberc•ola r i. c;ono rrt>'fUenli ed entr11110 nelln dej:!li asces!'i fre.lù a: il loi'O procel'SO t•o mpletamenle da quello degli ascessi aculr della in· linmmat.ione di tali è rnlt>t't'"·
!-Unte perchP. mo<.tra l'asc·esso extrapef'in-:teo, ;:enza lt!;:io'lt> del u1n con o"sea profond a che non rfl;tla faccia profonda del pt>t·io;:tio.
'I'Ainni, tr11 cui Lannelongue e Le Denlu, non Rtntnellnlln dre il liquido tli tnli asce::si sier osi sia"i I"OI'Iltalo pr imilt'nmentP, ma sta invece In lrasft)rmazione di ua1 fi"'Ce--;:o frpoldO COlHUilO, la o•ui t•e llulo• rurono r ia sso r bite, 11011 Ja;:(·inwlo clt6 la :>H·t•nsilù più n me11 0 Talt> ..:te-
Chirurgica
'1'088 ciegli ll'""e"c;i fr·eddt non St puù negar·e, ma é tJbbaalanzn rora. La secrt>zione primitiva tlel liquiùo >l Olflli invecf\ constatata, e di Stocohna, ammette che J101811 !lia per la debole intensità dt>ll'mfezione misia per una relativa immunità contro 1 batter• pioliDI dovuta ad una oslette puruleota anterior e. Dali•• considerazroni suesposte risulta dun que che P ' f!!l!<i !'Ì•·ro!>J e!'istono, che es!'li in.,orgono m condizioni d vene, so11o acuti o cronici. e che la loro causa prMs1ma ImmediAta non è ancora ben dt>fìnitA 1\ una I)Ue<>lione di ancnrA allo studio.
Gli 8'-'Ce c:osi !':Ìet·osi d'l)r·iginll furono os..,ervalt m !<Cgwto aol una amputazi one, ad una conlusio11e tlell'o"so Oll t>ite !'O\'ra-Ppilìsraria, alla o-;leo -mielile. N l'W tube.rcolare, la varieta cronica di tali ascessi costiluiRce tll collocati fuori del periol'llio.
Rivi Sta Di Anatomi A E Fiswlogja
NORMALE E PATOLOGICA nervi pertfertol nella oaobeaala Ureoprlva -: l u. LA NGIIA(.;S. - .-tre/t. Cent r ai&. (ti r "'e 1 1 , 1/ic . N. t , 1892). ·
In Lr e d. "" l t· - 1 c •essta 1reopr1 va 1! Langhous osservo )P leRUenlt altera·· · · · . . . . Cllpi.II . ZIOllt ne1 nervr per1fertc1: spe!'l'>rmrnlo tlei 1 art e de ll e vt•ne, allargamento dell" lacune lillfatit'l 1e Perm ev r io e nell 'endone\'rio e rompR l'SO di sotlilic;:sirne longi•t d" r . . c.lli . • 1 tnA 1 e t1·asvel•::alt, dt fo rm e solide fusiformì e U e delle cosidelle cellulr a vescica nelle lacunA niCIIltch 1• 'l' l l . · u e queste alteraziOni hanuo il lot•o punlo di t7
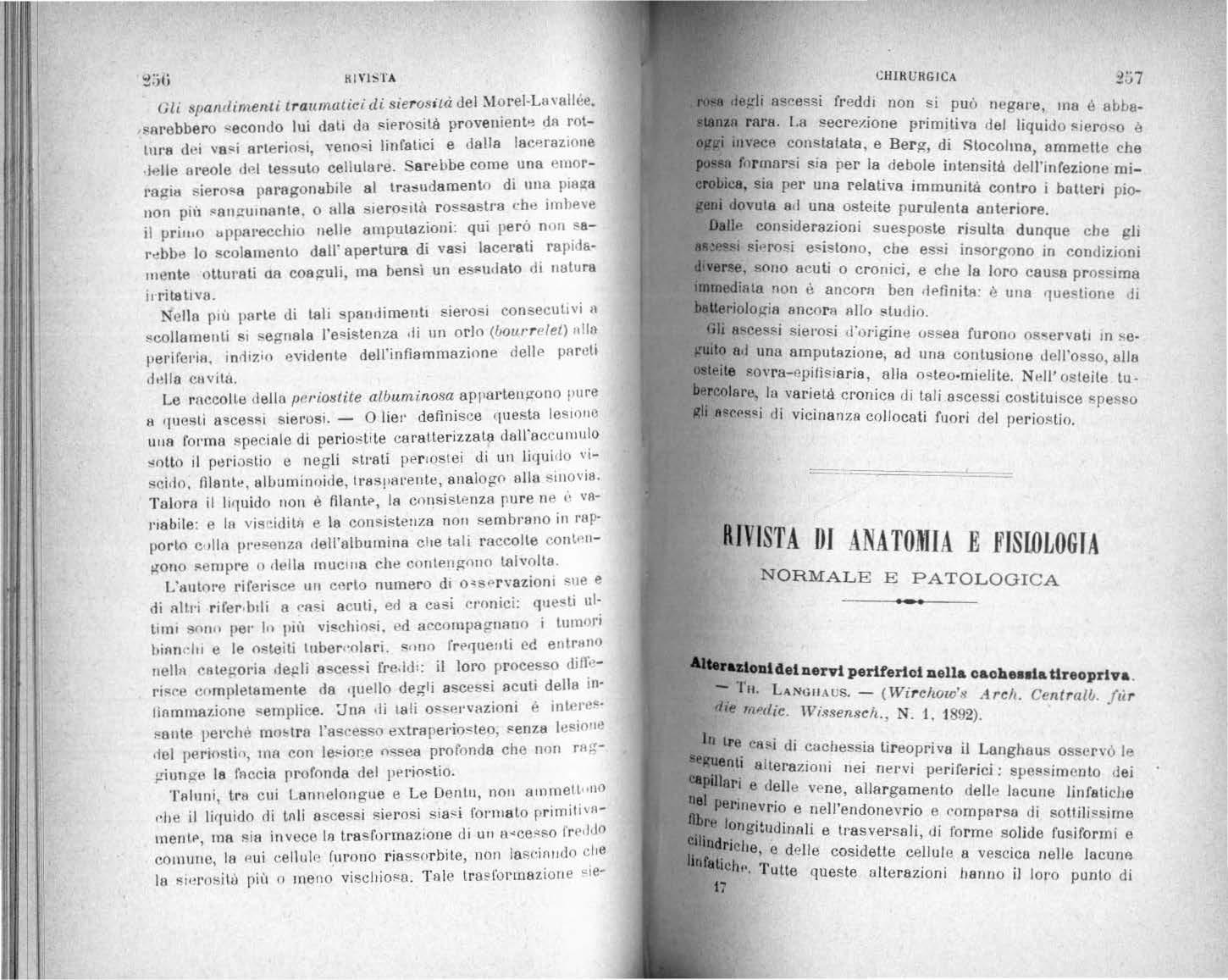
01·igiiH' nel pPrlltuvr·&o. l :e:::AluC del M::;temo nen·n<.o r.r:utra.le fu negati,·c·.
1.'Hller·ar&onP delle pa reti dei va"i ,:anfrutgnl nell'endon "\flll t': n<'l pr·rinev&'IO nelln drlla Jlfii'Ple n per ma:.:-::i•ll' ,.,.1luppn dello endotelico ticll'enrlo•wvrtn n del pcrlfle\Tio o per la formazione d1 u11u lllalcr&a l"'ro•uogcne11 nou ;.!l'ttnulosa o d1 lumr!le CIJIICPiltr1c1110,.111!> strat•licate &ntmediatamenle sottc, l'cudotl:lio L'1n· gr<r-<'-&menlo ,-. talora co"i da ra.::_: tllll!!IWt' fllln Il doppio del lume llr·l va«o. Alla malerta ntno;:tf'IWR •·hr ,Jcbollnente col c-arminio e con la C0!-:1118 s1 uulsco•w mnllo uurhe akune linee 1'(1Jt g:ranuluz10ni ov11lt che f.cmLrano piuttosto fiurillc che lamella. Sulle arleric Il L. non ha potuto osRervarc con !-1!-ill'l·tllc allcrazioui.
Le c!'lllll" A ve!'<t:ÌCU cOII"'islOIIO 111 fo r me conl,.nonLi due CJ t r e grunuli div1se da Rolldi pareti 1u più separate. Esse sono r olondcggianli.O i 1-regola r t quasi !'.empr e un poco appianate. La p1u supt>rllcte <' addossa t a al periuevrio, il dJ&melro è pa1·allolo all'asse del fascio nervoso. Le camere sono pi Ene, nno ad esserne apparentemente rh un Jirrui,Jo aC(jUO!'o. l scp1menli chl'l dividono le camet'P cnnello stPs!'O modo C'Iella membrana cellulare. In virinar,za 1lelle granulazioni si ''ede nei cani una piccola zona di p r otoplaRmll.. Il contenuto delle camere non e certamente muco, r1corda la mat.er1a colloide dello slroma tlcll!l ll r o1dea. Le forme gio\·ani di •1uesle cellult: a ve· !<CÌCA Lrov11usi costantemente spaz1 liofalic• ed hanno una camer a. Nei cam osservans1 !!ia 11 i• • giot·no dopo la operazione, dopo il settimo giorno la l'o r utc complete. Il L. crede che queste cellule a ' ... ;,;c1ca 81 e 1w cellule endot.-liali liscie del pet·•uevt·io t r asformate.
Le fo1·me solide Cilindriche e fusiformi hanno un omogene<J povero di gra nulazioni e una periferia coslllUtlll da un lasso concentricamente striato. 1 lim1t1 fru l'uno e l'altra ROno o r dina r iamente da una linea det:tsll. che talol't\ sembra ave r e un doppio contorno, nella quale
DI A.XATOlW. E fiSIOLOt;! \ :nH granulazioni ovali. Talora anche nel centro GIIIOgeneo vi sono delle j:tranulazioni. Tutti i corp1 soltdi tono c1rconùal1 da sll'ali di fibre concentl·icamente dic;poslP -e aurnver<;a te da abbondanti granulazioni. dP1 qu··"ti corpi c::oli.ii stanno immedialamenlP c::otto il (11'fmevri o. Il L. conf"idera i corpi solidi come eme n ti di c )!l· netli\'O t ra 'lformati. ma il ::c-i!rnlfìcato della dt>generRziont.> non e ben chial'o; probabilmeuh' le cellule a w<:cica ;:tanno eon I{Ue li corpi in un determinalo t'apporto.
La d 1latazione delle cellule linfaltche non altera la forma carcolare delle sezioni del perine,•rio . Le cellule a ,.e.. cira rsie lonu f'empre negli spazi ltnfallc• dilataLL MenL1·e ne1 tfi'O""'Ì fa sci net•vosi parlicolarmente nei ti'Onchi n<:'rvos1 rnnlutle le menlovale allerazioni, nei piccoli l'a'-CI nervo..i pa rti colar·menle ne1 nervi '<Olo t•iscontrnsi la d•latazi o ne degli spazi Jinfatici cou o senza la cllmparc::a delle ct>llul e a vescica e proliferazion..- dell'endonevrJo. Simili altPraz ioni si ll•ovano anche ne l crelinic::mo.
Il L par·la anche di simili !'parc::r· uella letteratura in m a lallie (nella atrofia mus ·olat•e progreHsiva, tubu, -eirmgomielitt . ueu1·ite mull1pla infettiva, twunte cou-..ecutiYa al tifo o alla tubercolosi con parah!'li) rhe non hann o alcun l'appo r to con le til'ltld"e: e·l ag2'iunge che pure nel gozzo ot•.liual'io incontransi pt'OC"<:<:i, quando tt·attao:i di lumor1 solidi. Que-.to fatto fa nao:rere l'i ]Pa chP e<;io:ta un eerto ue ,n cau>:alt' fra 8 de.. alterazi•lni nern1.,.e e la formazione rlel gozw.
•oeroh e aperlmen t all sulla lnnervazione dello atomaoo . - L. o.. ert. - (Zeil!Ph- fiir 1.-ltn. .'dN[ , e rentrnlb. fw · clie ''wd. H'issenselr., 511, le i1n po r tanti ricerche deii'O"'er rigu/IJ'Jano la illlll'l'\'80116 rl ..- 1 piloJ•o e qu.,lla rlello !>lomaco. In quanto a t pioro l'n. stabili1·e cou nuo,·i spe1·imentt cl1P il \lt"O , l' LI d l . ,... ,.,. o e rtloro, menll·e lo splactJrco lo rlilala, .avuto_ nel I_8R't. Noi q t li ril'et•ire degl! f'pet·trnenll . Pel pllnm 1 -.:rguenti _ to Jl tono dd p1loro e in alcuni c asi mollo allo, !'upera il valore di unu pre::<sJOno di 200 millimell'i di mel'cu_rio, in alll•i ca 8 i é quasi nullo, vale a di re che lo s tomaco c;1 ''uota p er la minima so!'lanza che vi cada dentro. .
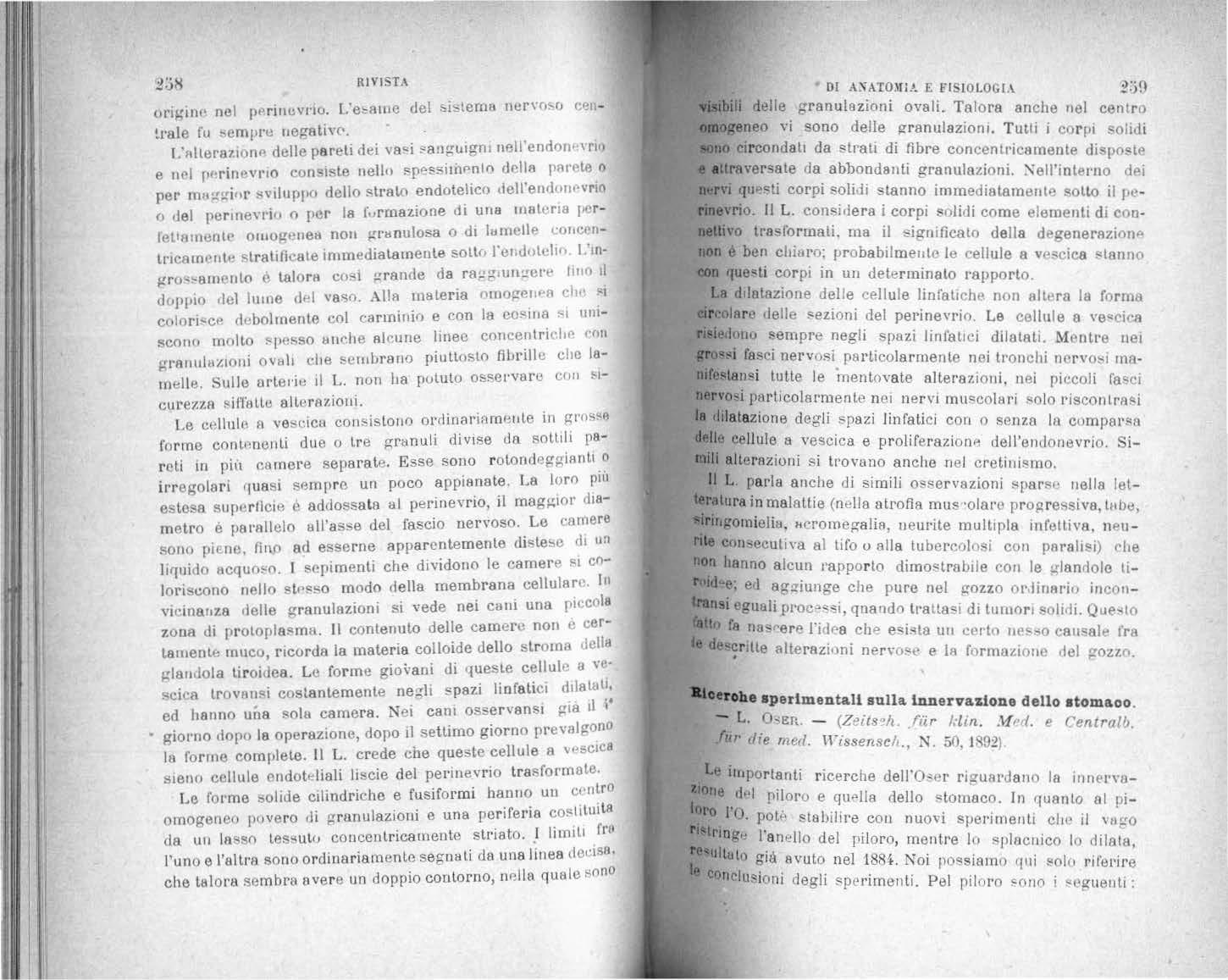
:2• Per regol a il tono del piloro corr isponde allo pressiOne di 10-2tJ mm. ù i me1·curio, c ioù si apre quando lo Rtomaco è pieno corri sponden temente a quèsla Il piloro può nel corso di uno Rpe r irn !' nto varJSre 111 gm83 l'he un tono molto allo dappr1ma si ca m bia in uno mollo basM.
3o L'avvicendarsi della con'1·az1one e del r ilascwmeul() ossia del ristrmgimento o della dllataz1011e del piloro !"UCcede tanto quando i nervi sono 1ntat t i, quanto allorché
1 t f>o Lo splacnico puo in del+>t·miuati cas1 apru·e Il p1loro chauso o dihttare il r ast r eLlo.
4o 11 , 8 go può in determin ati ca8i l'hiuder!' comp e amente il piloro aperto. . . . .
R ispello alla innenrazaone dPilo !'l •rna co ricordiamo J !'e· resultali:
•
1o 1 movime n ti spor. lane1 dello stomaco persistono tanto coi nel'vi intatti quanto coi nervi 1·ecisi, affatto irr!'golari e "en za ritmo Jeterminato. l neonlransi talora animali il cui Rtomaco rimane in co mpleto ri poso.
2• La irrrlazione del vago dete r mma una forte cuutr·azione che non dura mollo dopo la irl'llazione ed alla quale s egue la che per s is te breve t.;mpo. La del vago non arreslll la perislalsi dello sto1naro che eslp r ima di essa. ·
3' L a irr itazione cJ Jlo splacn1co dello ;;tornaco pro. una con tra zione molto debole, ed una s uccessiv a dello stoma co che pt!rilisle lungamente dopo l'll'l'llaZI?ne.
1 movimenti spontanei rhe esisteYano p1·ima della JrntaC le secnnzioue dello splacnico sono a!'l'estalL ome az101 li l · opravvien e spP"'"0 da 1•ia della irrilazionP do o sp aco1co s una viva peristalsi, mollo piu viva che prima della 1rr zione. Questa aumen tala per istelsi co me eff'elto secondar 11 > n! ANATO MI A g FI S IOLOGI.\ 261 dello spla cnico può e"serP a r restalo rla nuo"a irritaz 10ne dello s tesso ne r "o.
-i 0 Per• la Ìl'l itazione simultanea del vago e dello splacnic" si ha dapprima l'effet to motorio della il'rilaziorre del vago: ma nel cor3o ulteriore nou è r ambiata la mauit'rll rli agire dl'lla irr ita.don e dello splscnico. il riposo dello stnmoco cagion alo dal la irritazione dello !=<placnico, l'irritlizione del è più o meno inalli\'8, ma aumenta l'eff'etlo di qu••Qta più tardi quando quello dPlla irr•rlllzione del \'81J:O -è 1'8"!>8la .
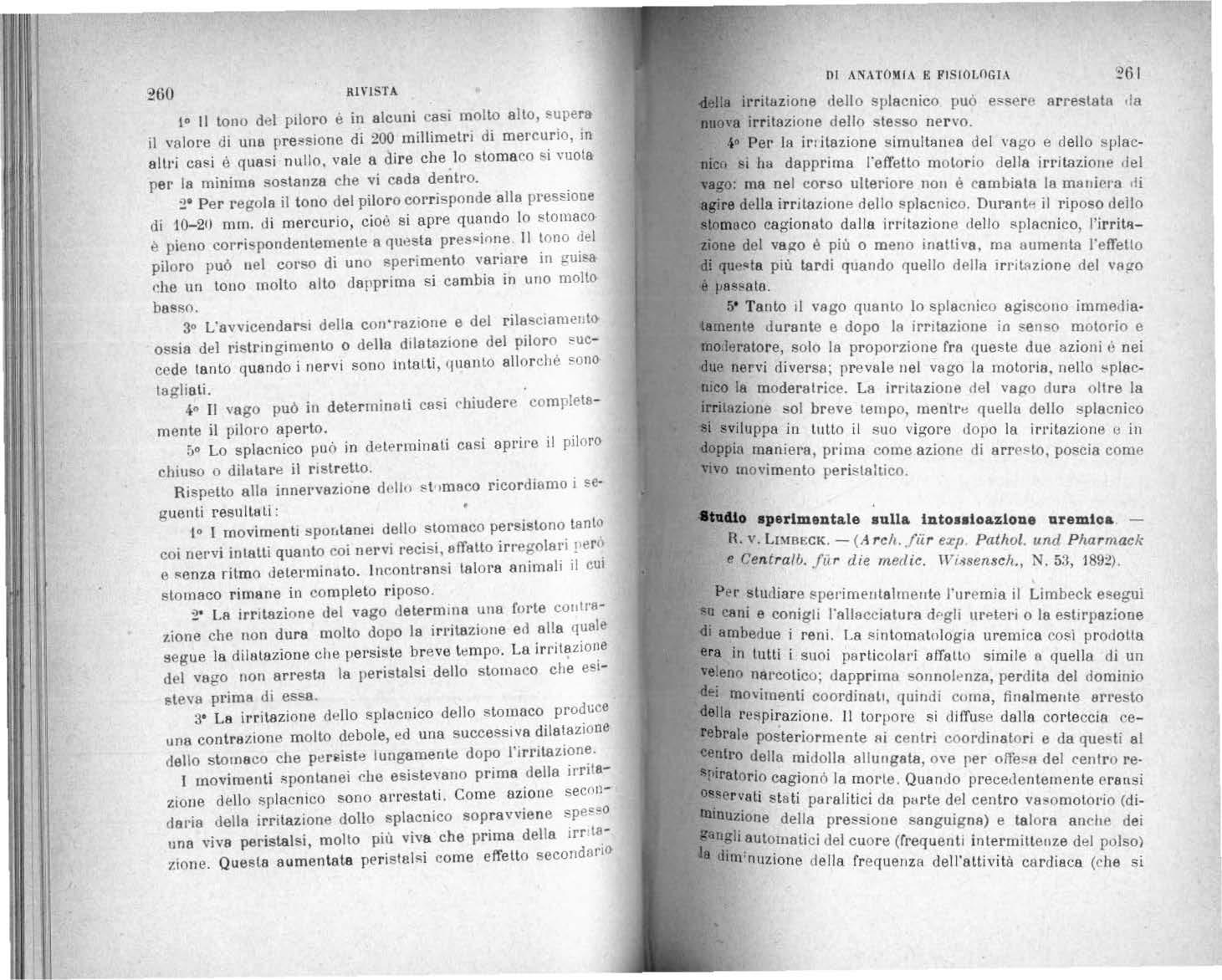
5' Tanto d vago quanto lo splacrrico agiscono irnmetiia· temente d urante e dopo la Irritazione in motorio e mo leratore , solo la p r opoa·zione fr a queste due azioni ù nei due:> nervi diver•sa ; p r evale nel vago la motol'ia. nello n iCO la modera trice. La irr·rtazione de l vago rlu r a oll re la irritazione sol breve tempo, quellu dello splacnico si sviluppa in lutto il suo vigore dopo la ir1·itazione c in doppia man ie!'a, pl'Ìilla come azioni' di a r r r"-to, poscia come VIVO movi mento
&ta41o aperlmenta.le aulla. into..toazlone nremto& -
R. v. LI:ItBf:CK.- (/t r e/i .fii r e.cp Path ol. u.n.d P ha r mack e Ce n. t r a/lJ. ju r die medie. \\'r.isensch., N. 5:1, 189:!).
P er studiare sperimentalmeu te l'ur!'mia il Limb eck liU cani e conigli l'allacciatura dç.gli o la eslirpa1.!ooe di ambedue i re ni. l.a u remica rosl prodotta e ra in lutti i suoi pa r licolal'i affatto simile n quella di un veleno nar•cotico; ùapprimu sonnolt>nza, perdita del dominio dt-i mo"imenti coordioalr, quindi cmna, tìnalmerrte arr·esto della r tlspirazione . Il torpore si diffuse dalla corte ccia cerebral e posterio rmente Ai centri coor·dinatori e da que"ti al centro della m idolla allungala, ove per offe--a del cent r o re· 11!•irato ri o ca gion ò la morte. Quando precedentemente e ran si s tati p o ralitici da purle de l centro vasomotol'io (di· rninu zione della pressione sanguigna) e talora anclr t> dei Rarrg-h automatici ciel cuore (frequenti inte rm ilterrze del polso) !a dirn·nll7.ione della fr eq uenza de ll'attività car diaca (che si
Hl\1STA Dl A:'\ATO'IJIA E FISIOLOGIA
l'a con la sezione bilaterale dci Ynglii indica una ll'l'iluzione centr a le del vago; ma quec:to l' un fenomeno ordina ri o facente parte della della oorcoc:i centrale. l Lentati,·i fatti dal L. di t•inlt•a,·riAre 11el :::angue m·emici il principio tossic.o uon fut·ono lrut· tuoc:i ; nt• l'a' "eiPnamento alcalino da alcuni, .te In per Hei.Ji "llppoo:to <la ollri furono da iui c"n lerrnnt
Rivista Delle Malattie Veneree Edella Pelle
Sulla l nfiuenza delle alterazioni della pelle e dl alo unl medicamenti osati esternamente sulla densità d el sangue e del aiero sanguigno .- \ \l'irchotc's A rch. e ('l ntrallJ. ft'ir die medie. \l'issensclt., i7, 1R!I2).
La tle l l:' an gue e del siet·o sanguigno fu detertninatu col metodo di I! arnmer::chlag. l risultati dellu\'•11'0 che comprende più di 1200 O!:ser,azioni su circa 200 per::;on•· ..:oilll i i'>'!!Uentt: l Jlnlfltcie del/a P"lle.- Su 11 casi di pemfìl!•J la :-ilu del sanKue et·a as::olut11mPnte un poco au•n,..ntatu ul Jt olella normn ( 1,05V-1 ,06!J negli uomini, 1,05i- l ,Ofi0 nelle don ne), o almeno st manteneva alta in rupportn ùurata della mal attia n all'a::; pello del malato. In l utti 1 ca"1 di ustione mortale la tlenl'ilù del sangue fu trovata noLe"ol m t.! n le aumentata (l ,065 1,073). aumento ili denc:itù fu oli regola osservato bolo dura nte le prime ore dopo la le::JOne, aumentò anche in alcuni l'asi du r ante le altre c. nc••,•f; · :,.i,•e 12 o r e pe r nd cor so del se::n111lo gint•no. LO Scld. non può IJUindi ae<"ellare la opinion•J del T oppeiner, secondo cui l'aum ento di densttà de l cau!'A d1 morte . l ti mloro blo •peoUlco dell'ulcera molle . - B. KRF:fiiNC. - (.4 rclt.fii r Der m. una Srtplt. e Centralb (lir r/·p mrrlrc. \\' .• N. il, 18fJ2). d 11 KrPt'Lm g L•·ovò nella mar·cia delle pustole provenienti 6110 innec;L() della secrezione ùell'u leera molle regolal'rn<' nle e, Per lo più esclu sivamenLP, bacilli luoghi 1,5- 1f.1. co11 e;:olre- mita arrotondate e :spesso una nel mezzo, pa rl•' r iUniti in gruppi, isolati. i quali stavano nel protoplasma delle cellule e !o;carsamente anche fra cal· lule. S1 color iSCOno facilmente con una ;;oluzione di azz.urro d1 metilene con aggmnla d1 borace. ma non, al contl·arlo, col metodo ciel G1·am, r si facil mente con l alcool o l'ac.clo acet ico diluito. Anche uella marcia di un bubooe virulento furono ric;contrAti questi bacilli, mentre non !-;i tro· vernno ma1 nei bubom non virulenti. come uf\ppurc nel!•• pustole d1e ernno -<latr prodotte dall'innesto del "rcretn eh uua prirna1·ia affezione s1fililica. La. collura dei mict•ohi, pro· babdmenle idr.nlit:i a ctuelli deo;crilli dal Da ct•ey nel lflnO. uon polé mai »ulle ord111a rie sostan z e nutrit1ve.
Gli I'CZP'lli acul• poss()no produrre uu pa!"sPggwro e piccolo aumeulo clelia dPnsità del sant:euP. Gh eczemi urnitli che ohu·ann da lungo tempo aumentano gPnPr·alrnPnle il p!•c:n specifico del "'angue cou qualche eccr•ziorJt•, in r tu ,. 0""ennla una diminuzione clelia densità ciel !'iero sanguigno. l l. Rrlf•porto frfl la del x t ero e i lù1wd, datr dallrt !lttper/teie cutanea.- Gli e>'<:UÒilli urlle maiMLie ..... SQno in generalr Jni)ILn ri f'chi rli albumina (rlt alto peso "Jlt)rtfico) ('Onll·ariamente agli essurhtll l'he cl•••·• vano dai eavdlari d'aHre parti del corpo. Nelle aiTI•zioni vec;cicolose 8 bollo"(', il ll •tn ido conlrnuto nella vc>scicn ha ordmat·iams>nte miuor J en!':1lu del siero !<anguig11o, 11111 in a lcuni fH'oce s" '• nou d peso specifico del c:ict•o l• raggiunto, mA ollt't>passato, come nell' Zoster. Fra le rauc:e più im portan t i elle influ iscono sul peso specifieo dt-l l'e:-:Ruùa lo, !'O liO: da una la natura ùel p r oce;;;so e lo in tr n!'ila dE'Ila irt·ilflziouP mn f'Ui rtue sto ope r·a su ll a pelle; dall'altra, le speCia li t:•111ùiz ioui dl-llla pressione Rl:lll:!uigna e della ctrcolnZiow• dei vasi da cui l'essndalo trapela.
Ili In fluenza dei medicamenti sull a den.•ittt dd l' rlel siero. - Il c:ul>lnnato 111 rombinnzione fn cihuente solubile- iniPzioui t! i sublunato - pur'1 in brP.,·u tempo Cl'lgiona re un aurnP11lo di denc:itù clt>l sungue con "UCt'l'"" lvo l'itorno alla nor10a. i•l alc·uni giorni, o anche o:ollo 8 Questa alter azione ùel sangue non e accompagnata dii unportan ti fenomeni ge11erali; per ò le t·icercbe de ll ' 0berma .,·et· sulla orina hanno dunostrato in es!'a un a umento d,.lllt uuchm a lbumina.
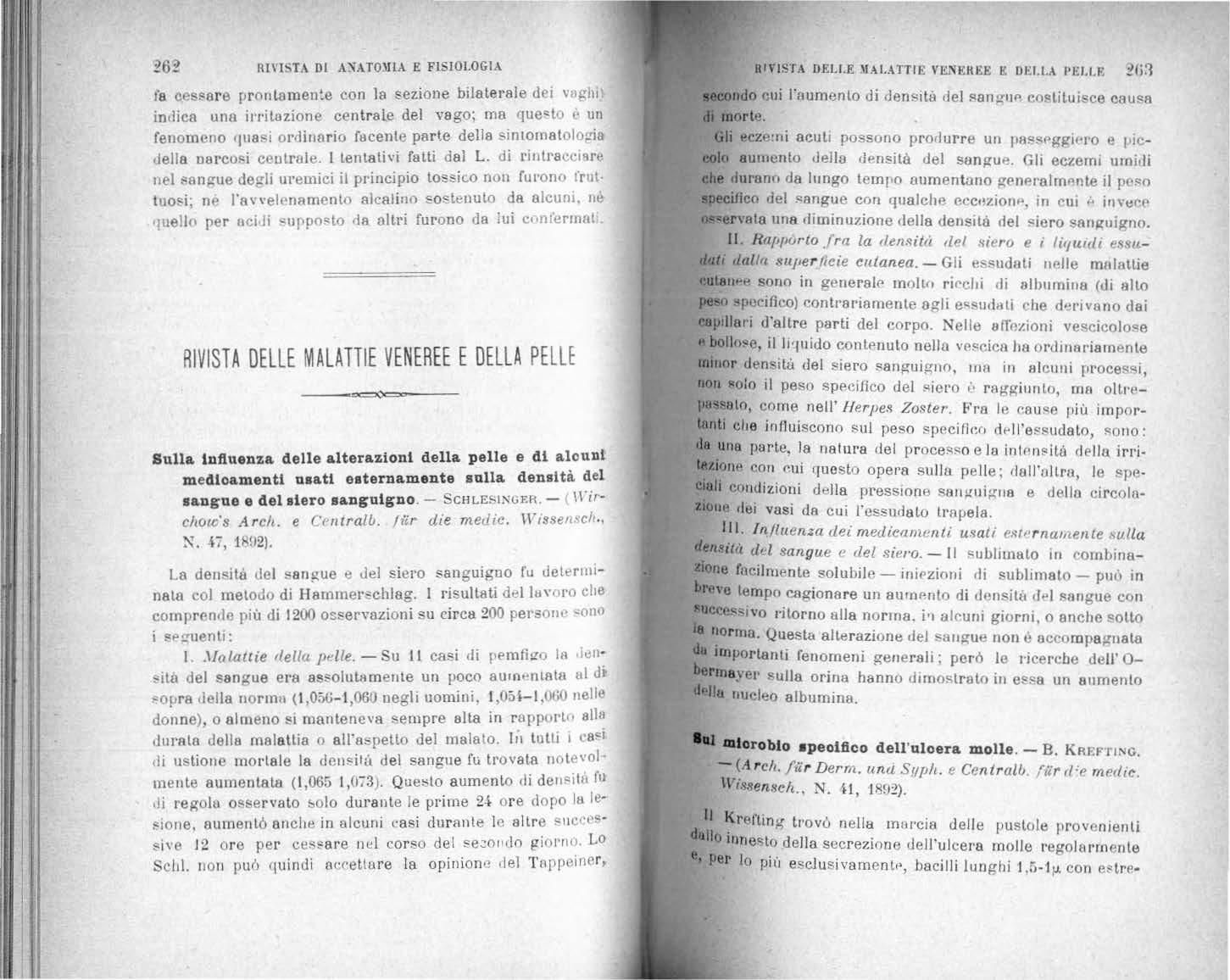
D l TECNil:A t SERV IliO MIUTAil[
Oroo• Ro81a italiana . - B olletttno dell' thrernb r ·· 1fl!l 2)
Qur,.ta pre:::ievolc pubblirazioot' p r ova a I'JUAie or<lmamenlo c orll•RJ giunta la benemer1la i!'lituzione eta nnl' f' forma il mtgl w r e e des1derevole elogio drlla Alli\'ÌW e capacita cl1 chi la presiede e dei me111bri la dlngiJllO
Vt !'l nH·colgono 1 completi dali clrllu stato HH1l'll\C'. arnmin1slrallvo ecl ùella asl':ociazioue coi rc>'- 0 " conti e de l colllilalo centrale e dei rrgionah, nonchf> do1 to-cornilali, dell'Unione delle dame della Croce Ro :-sa. ('CII bilancio consuntivo dello scorso anno ed il prevellli \'O pel corl'entc r·edalti con s emp licità e ch1arezza veramente ar·
RIVI SL>\. 0 1 E SEH VIZIO ME DICO MIL IIA I\E
F.,.,_77" " "'e. U n elenco g-ener ale d ei corupouenti s ione , c de ll a assegnazione del per sonale e 8Upc•riortl ed Inferiore clegli spedali, treni , rnagazzeni, ecc. da una conforidea della possibile s ua allività. Cosliluisce cosi la più e lorJuente prova del valore della ist1luzione.
!\la ha ancora una irnpo1·tanza ,·eramenle eccez1onole, giacc hé ollre 11 ra!'sicurarci sul florido »lato della as,.ociaz!one. ci assicura tlelle pratiche e quìudi f1·uttifere idee di ehi In di r ige: fornisc e in vero dei prezio»i dali sugli men ti falli col c;uo materiAle f' rol per.,onale addelto a!.th apedali, ai treni- spedali.
Ed essi e"perimeuli furono numerosi, t·Jpctull e coJtdolli con Abile conoscenza delle questioni che poterono valere a I'ISo h ere.
Furon o a tluuti co n ben 6 ospedali di 50 letti, tla montagna; con 5 ospeduli di guerTa cla 700 letti , eon 4 (1\lll , X , X III , e quel lo di Sicil1a), o se ne polPro no Lt·arrc} prezios e motivanti pl'Oposte praticissime eli modlfìcazioni, Ria di mezzi e mate1·iale ù1 trasporto, sia anche di cruello operatorio, di meclicazionP c famHtceulico, o11de perfezionarli e render li m eglio pratici e bicu r•i... Oi alcune di essa osser·vazioni e proposte potrà anche l'es erci to, t.Pnendone conto pel miglioramento rlPII'analogo aozi ben puo ùirsi identico, m a let·iale del quale é È ,;olo col metlerlo invero alla prova che si puo e'>,..ere ratt i "ÌCu r i Jella bonta di esso mater1ale, e tr·arre le iudicaz ion i necessarie per co rreggerlo se del caso.
Facc ia mo seJZ:uire un o specchio indicante lo stnto ciel personale a lla fine del 1892.
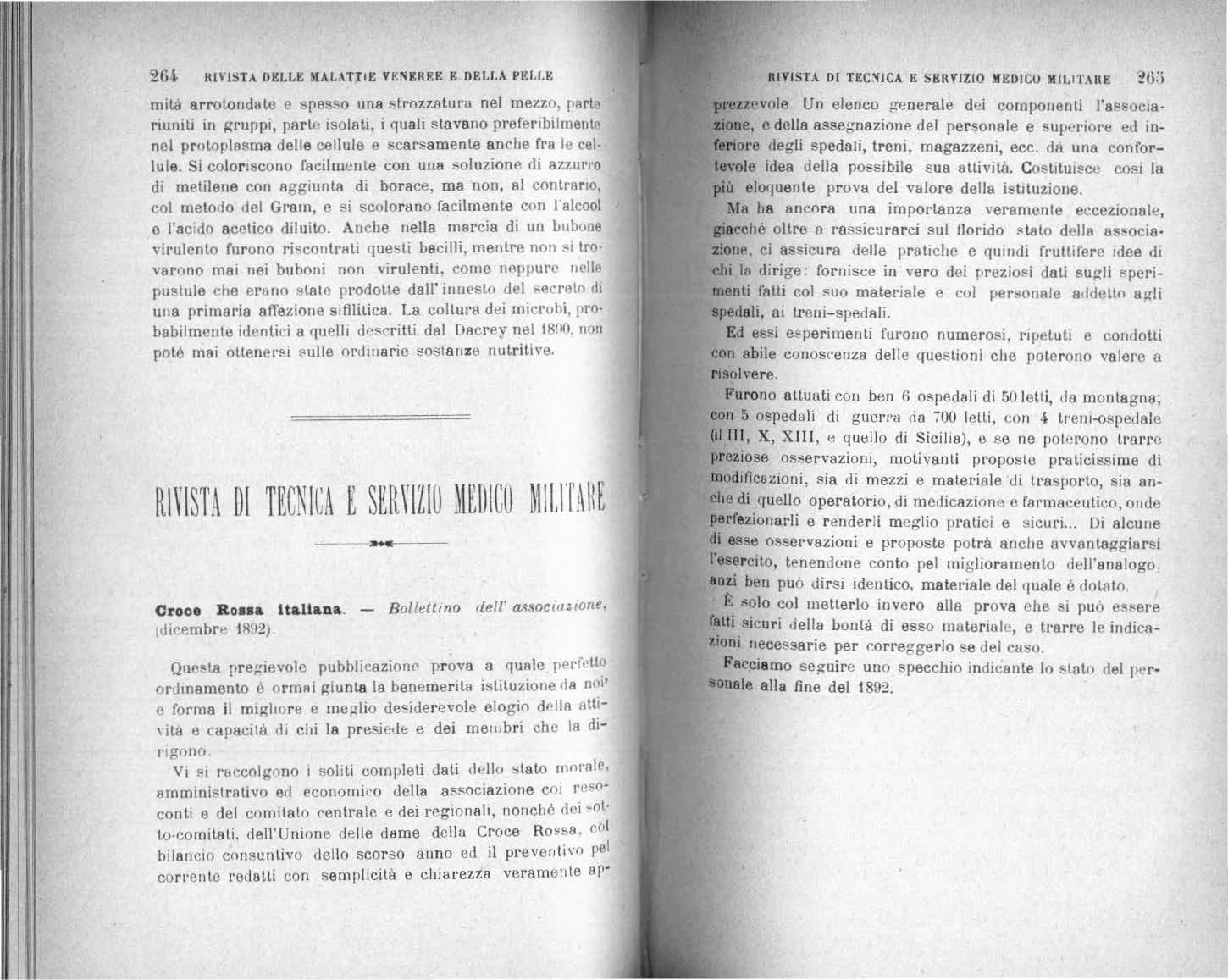
Delegali generali . . .
Commissari delegali (co· lonnelli, alle armatf'} .
Jc::pellori med1ci (lenenti colonnelli) . . . . . 3 ì\IPdici direttori (mai!!Ziorl) . . . . . . .
Jc::r cuori amministrativi (lPIICnli colonnelli) . .
Jo.;petlon ammu11slrali vi di classe (maggiori) 1
Dirt,Llori rli treno oc;pe.lflle . . . 13 l\ I Pd1ci cnpi di tl'eno (capitani ) . . . il
Jc::peLtori farmacisti . .
1\ledlci capi eli riparto (capitani) . . . . . 5!>
Comm issari arnminisl!·alivi d 1 i" dasl"e (capi L.) 19
Contabili (capil.)
Farmacisti capi (id.) .
Cappellani (id .) . 5·
:\l e1IIC1 ass1:olenti d1 1' cl. Lenenti) . . . 91
Commissari ll\'1 cli2' classe (tenenti) 21
Conl8b1li di t• clas,.e (iù.} 52
Farmac1sli di 1" classe ( tenf'nt i) 19
Medic1 assistenti di 2• cl. {sollolcnenti). 108
Comm1s!c'ari di 3" classe (sotlotenPnli). 29
Con la bili di 2• classe sot· totenenli) 4G
Farmucist1 di 2• classe (soltOIPIIPnli) 3i
Tota le. . . ti88
Personale à1 assil$ten:a .
Assistenti amministrativi (marescialli)
Capi sorveglianti di l' (furieri maggiori}.
Capi sorvegHanli di 2' (furieri )
Sor Yeglianti d1 1• (ca-l porali
Sorvegl1auti di 2 • (caporali.
In t'erm ieri l
Cuochi \ solrlali l nser·vien li ljl)
Variet
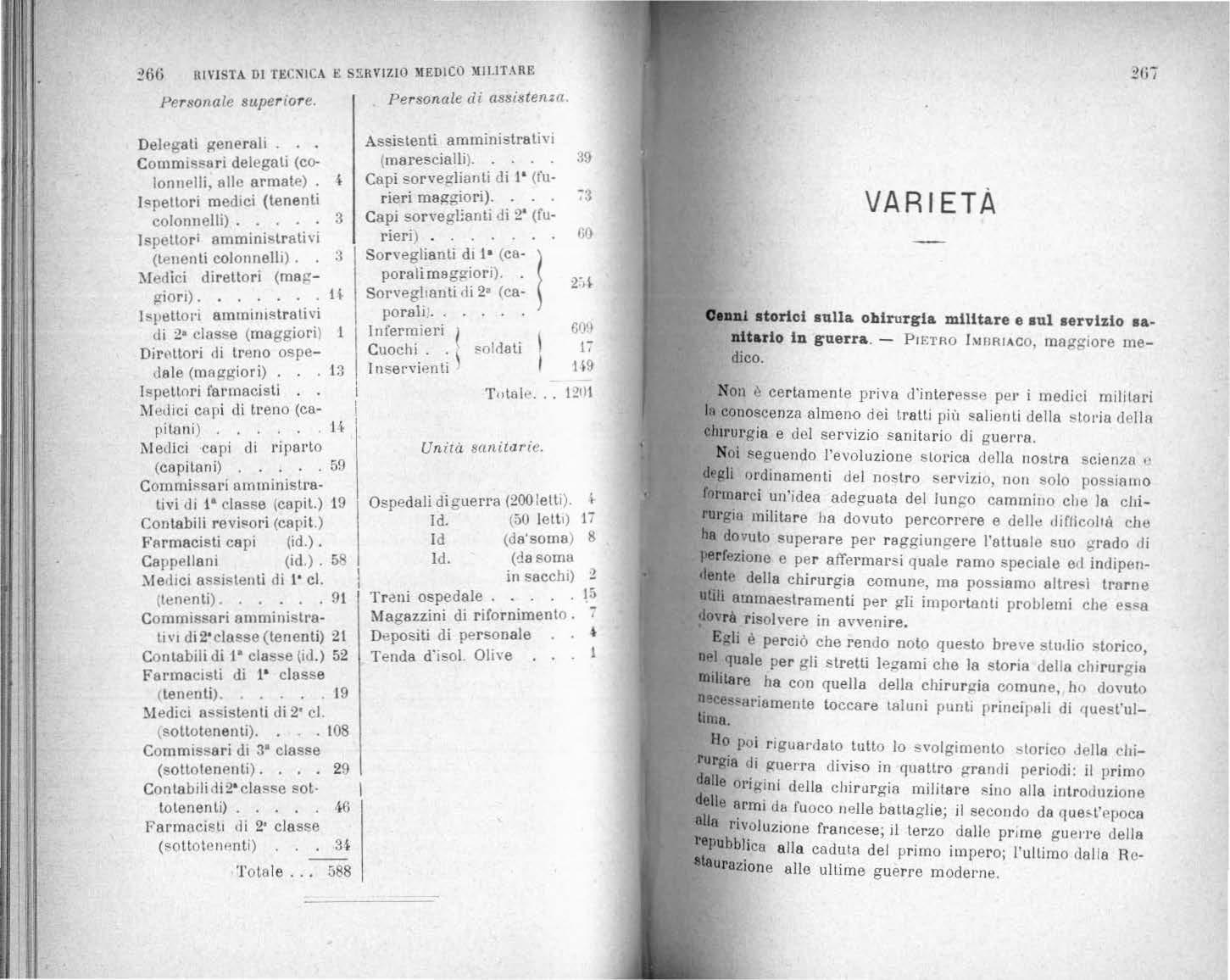
lj()l) 17 U9
TtllOit•. o o !Zill
OeDnl atorioi aull& ohlrurgl& mlllt&re e s u l servizio uDltado ID - PrF:TRO hJORIACO, maggiore medi c o.
Non r. cer tamente priva per i medici militari la conoscenza almeno dei lratti più salienti della l-<tOI'ia dellA chJrurgia e del servizio sanitario di guer1·a.
Ospedali di guerra lell1 ). l ld. lett1) li
Id (da'soma ) 8
Id. (da soma in sacch i) l
Trani ospedale . . . . Magazzini di rifornimento . • di personale 4
Tenda d'1sol OliYe l l. . ( primnrdi 1iella chirurgia militare, al pari dt quelli delh1 chirur!.{ia comune e della medicina, sonoE difllc1le. e.l anche ozioso. il SE' l'uomo pr111Hli,·o pt•ima lh malalo sia fer i to e quindi se vento dei manuali sviluppato prima la pratica chi1·ut•gica e poi quella m edica. - mollo "erM1mile però che la chiru1·gia s1a oata come traumatica ed om:i co1ne chil'u r gia traumatica di guerra; dapp oich&, al pari delle donne giù madri che !'occot·revano le primipare, i ).tuerrieri più intelli)Zenli c più p r atic i dovette t•o preRt are ass1sleuza e soccorso a i loro compagni fer iti.- cO"Ì che l'origine della chirurgia milita r e è antica quanto l'umaua sociela, quanto la gue rra, che nacque non appena l'unmr, pr imitivn si uni in rapporti sociali con alt r i uomini.
Noi l'evoluzione storica della nostra scienza .. dt>Ftli 'JI'dioamenli del nostro scrvizw, non solo rormarc i un'idea adeguata del lungo cammino che la chirur(.!ul m ili ta r e ha dovuto percorr·ere e dell\j rliflicolul ha do vuto superare pee raggiungere l'attuale suo g'l'ado di perfezio n e e pe r affermarsi quale ramo speciale ed indipeu•lente dell a chirurgia comune, ma poss1amo altrec;i tl'llrne Utili ammaestramenti per :.rli impo1·tanll problemi che es;.a dovrà risoh·ere in a'·venire.
Edi é per c1ò che rendo nolo questo br·e, e stnrl1o co, nel qual e per gli ;.tretti leg:ami che la storia della chìrurg10 Dlllitare ha con quella della cnmune, ho dovuto toccare taluni punti princi pali di ' luesl'ultuna.
Ho po i r iguar·dato tutto lo svolgimento "'lorico Jella chirurgia di g-uerTa divi;.o in quattro pPriodi: il primo dalle o ri g1ni della chirurgia milita1·e alla introduzione dellll ar·mi da fuoco 11elle ballaglie; il secoudo da quer-l'Ppoca alla r·ivo lu zione francese; rl terzo da ll o prune gUPI'I'e ùella repubblica a lla caduta del pr imo impero; l'ultimo dalla Rcat.aurazion e alle ultime gue r re modeme.
Quando la società co m inciò ad organizza t•si e si formar ono le caste e le J:te r archie, la casta sacer dolale s'impadl·oni della medicina, e questa fu ese1·citala ne1 temp ii, abbrtwciando specialmente la part.e ig1enica e la p a rto doi m orhi inte1•ni, che !<pecie sotto forma epi,JemicA r.olpl, ·ano lo trihu. La ch i rur!<ia come me.licin a nej:tlt accampamPnti delle tribù guerriere, da cui penelra''ll pot nelle ritlà. ed iv1 i maiali ,·enivano espo!'ti sulle pubbliche v1e perché foss e ro curati.
Ma tanto la rnedtcma che la cluru r gia, svolgent1si, come dice il Puccinotti, J'uua ::;otto fo r ma ierat1ca, l'allra ,ottu forma demotica o popolAre rirnaset•o pe1' lungo tem po a"solutamente empil'iche, dominale dalla superstizione f' dal mtticismo; e ciù p1·esRo i popoli pilt civili, l'indiano e i' Pgi!. i"
Il pt•imn libro in cui si fa cemlo della cu r a dei fertli in guerra è d poema sanscl'ito il Rama1; a n.a nel I'JUale !'l clte i fe1•iti veniva110 allontanati da l c a mpo di baltftglia 8 trasportati solto una tenda, ove si medicavAno con elii e vegdali.
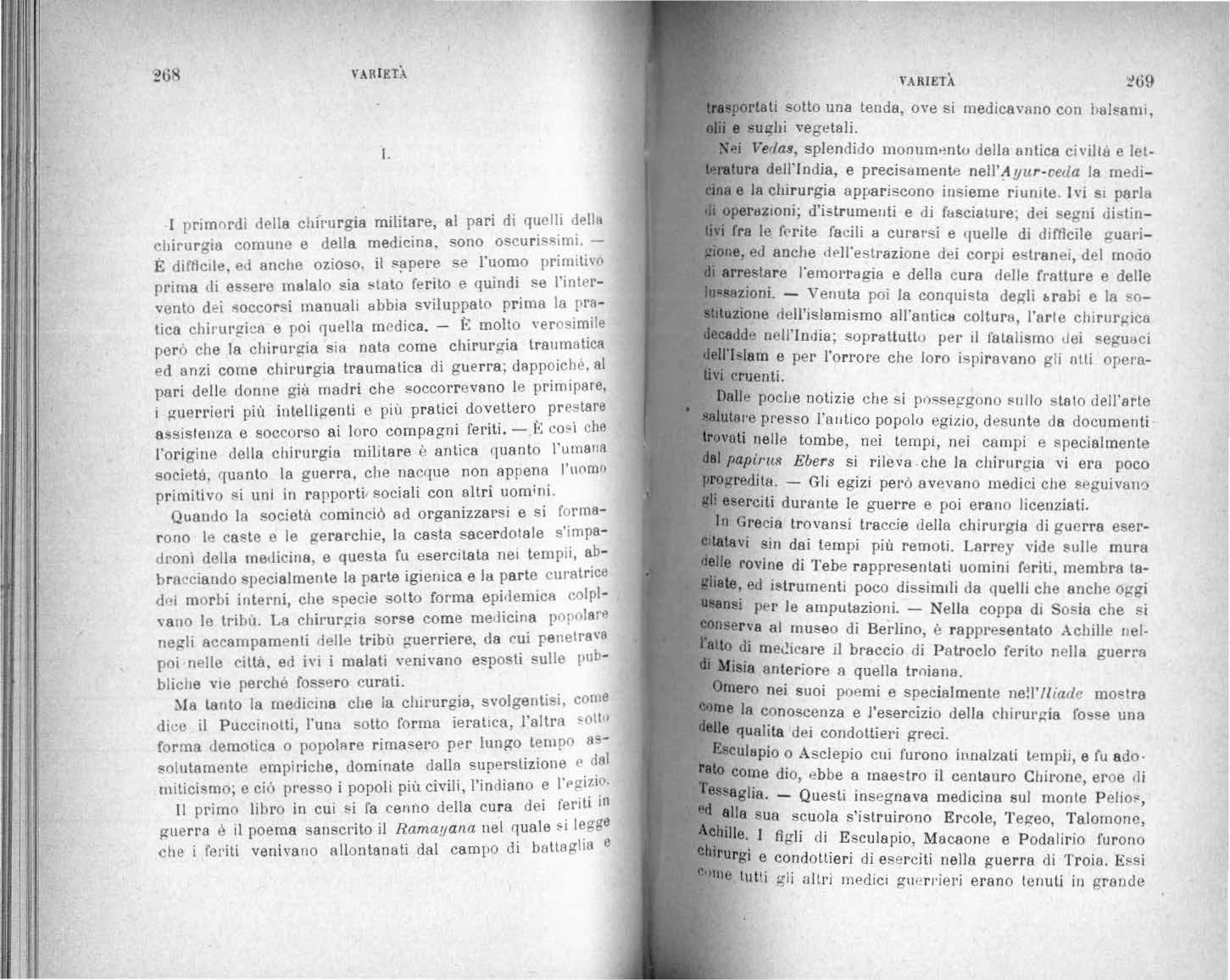
NPi {,·e,fas , splendido della antica ci,·iltù e Jet· &e1'8tura del l'I ndia, e nell'Ayur- cetla la mediana e la ch ir u r gia appa r iscono insieme riu 111 te lvi s 1 parJ11 .• d'istr umenti e di d e i segni di--tintivt fra le f••rìte fa cili a cur·ar·si e quelle di dirtìcile ,raoue, ed anche dPII'esLJ•azione dei corpi estt·aneì, del rnofiO dt l'emoJ• r agia e della c ura delle frallure e delle
- Yenula poi la conquista degli e la all tuz tone all'antica coltura, l'arie cluruq.:ica nelJ I ndta; soprattutto per 11 fatalismo de i seguuci del.l blam e per l'o r rore che loro i<;piravano gli ntti oper·atlvt cruenti.
• Dall e poche notizie che si r•>!"S8!!gono !"llllo iltalo dell'arte pre!:'SO l'aulico popoltJ eg1zio, desunte d a ùocumenti lrovah nell e tom be, nei tempi, nei campi e l'lpecialmenle dal papi:·u s Ebers s i rileva che la vi e r a poco - Gli egizi pel'ò avevano medici che sPguivtJll':> gh eserc1tr d ut·anle le guer r e e poi era no licenziati.
In Gre cia trovansi traccia della chiru1·gia di guerra eserCtlalevt sin dai tempi piu remoti. Larrey vide llulle mura rovine di Tebe r appresentati uominl feriti, taghate: ed ì!:l tr umenll poco dissimtli da quelli che anch e uaans1 p1• r le amputazioni. - Nella coppa d1 Sosia che !'i a l museo di B erlino, è r appresentato Achille uel· d.iatto_ 11 braccio di P atroclo ferilo n e lla guerra Mlsla a nter10re a quella tr niana.
Omero n e· · . . 1 suo1 poemt e spec1almente ne!l'/lmdl' mocotra :me la c_onoscenza e l'ese r cizio della fos!'e una le qua h ta de i condottieri greci.
Esculapi o o Asclepio cui furono innalzati lemJ)il e fu a do· ra&o com d. bb . ' T e 10, " e a maecotro 1! cen tauro Chirone eroe di essa glia Q r · ' ed · - ues 1 msegnava medicina sul monte P elio"
A. b alla s ua !;Cuo ia s'istr uirono Erco le T egeo T a lornonc' c ili l fì o eh· 8 ·. 1gl! d 1 E scu lapio, M acaone e P odalirio fu r ono Jrurgl e c o rl lt' . d' .. n o 1en 1 e se r crtt ne lla gue rr a (Ji T r oia J;<:cosi <l•llne lutt' r J o o l !:{ 1 u lr 1 medici e r ano tenuti in graude sl irna e vcncrnzione. Macaone fet·tlo fu fallo salire -.ul cat-ro dJ il quale lo tras:-e !ung-i dalla pugna nella Rua tenda, ·1olomeo, ce di Crt>la, gli disse: • abbt cura delret·oe che non ha ptwi nel medtcare, e la sua vita val e wille v1le. • medicò la ferila d i Men elao e Palroclo l!'lruito du Achille la ferila di Euripilo, pet· estrarne la freccia e1·an intlitta.
Pet·ò anclte in Gt•eci a \'enire !Orno aù lppocr ale perchc la chirurgia e la medicina assumesset·o forme tlfìche. P. veramente nel secolo ili Pericle in cui la g:1·eca si iiJuc;travu dei nomi di Pilagora. di Arisloltle P d1 Platone; in cui ti Pat•tenone aveva consacrata la i!IOI'I8 1li Fidia, si rapprt>senta vano l e tragedie di Sofocle, e Tucidide sct·iveva lo !';IOl'Ìa della pesto di Atene, et·a tempo che anche per la medicina un uomo di genio il pandola al cieco empirismo, la ponesse sulla retla via dP l scuo la di Coo la medicina e la chirurgia formtl\arlo una scienza Rola dominata ùa quello spirito a cuto di oF.,.er· vazione pe1• cui le opere ippocratiche destano anche o;:ad, dopo 2a la più grande ammit·azione.
!'cien lifl co.
La doU1·ina delle leòiioni e specialmente delle lu"· ..,azioni e delle fratlut·e molto in quel tempo. ,.,.1 quale davasi impot•tanza uUa Lellezza delle forme, c indietro la pr·alica delle amputazioni. poichè i g rèCi morivano piutl04lo cbe r·eslar e mutilati.
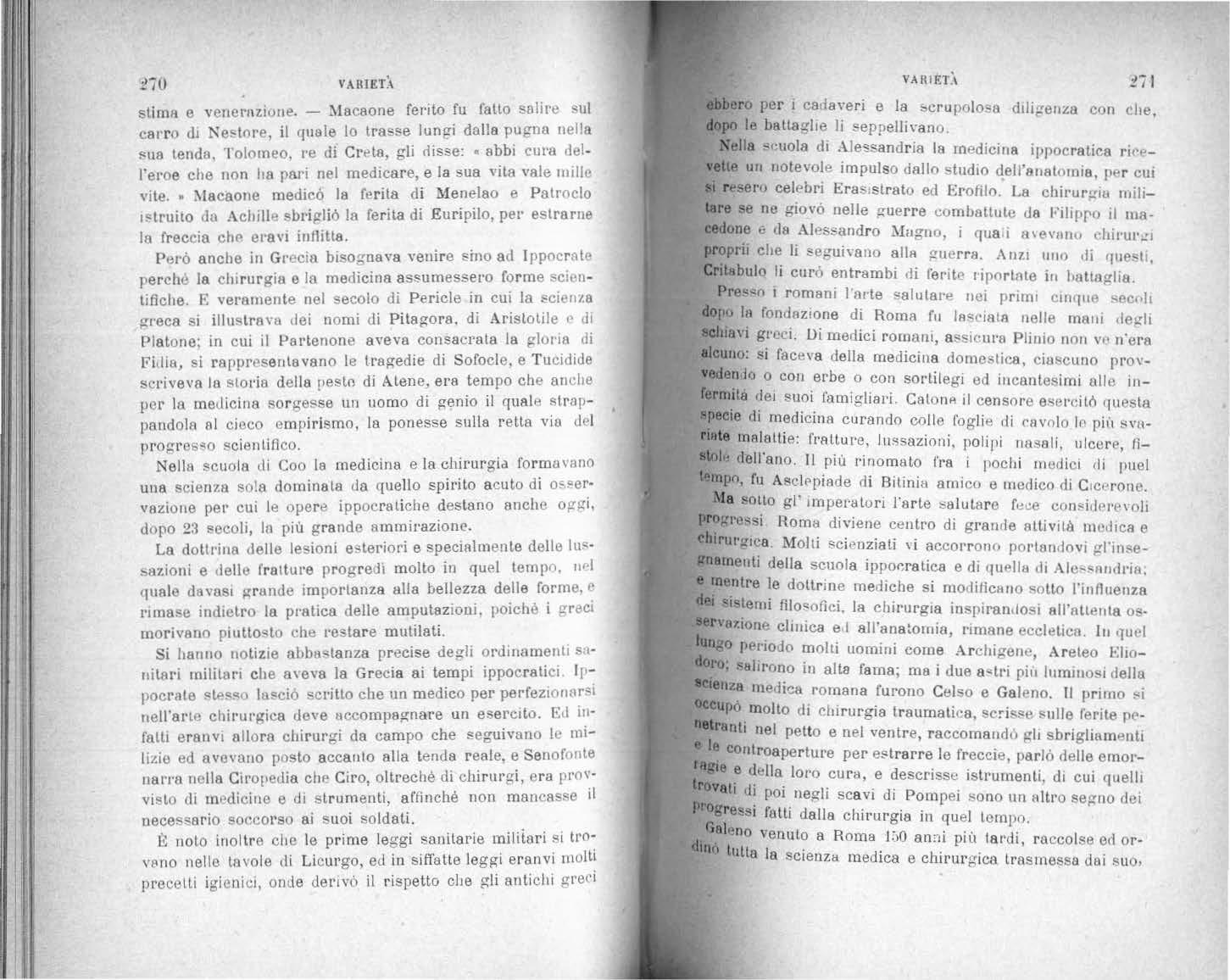
Si hanno notizie nbbtt-;lanza p rec ise deglt ordinamenti sn· u1lflr1 militari che n'eva la Grecia ai lempi ippocralic1 1(1pocrnle luc:ciò c;crillo che un medico per nell'ar•tf' chirut•gica deve nccompag-nare un eserc1to. E tl in· falli eranvt allora chirurgi da campo che seguivano le milizie ed ave' ano posto a cca11to alla tenùa reale, e Seno fonte nat'l'a nella Cn·opetlia che Ciro, oltt·eché di era Jli'O\'· dt tn<' dicine e d1 strum enti, affinché non mancasse il nece.,..,ario soccorso ai suoi soldat i.
È nolo inoltre che le p r ime leggi sanitarie militari s1 troP no nelle ta, ole eli Lic ur·go, ed in siffalle leggi eranvt molli IH'ecctli igieniei, onde derivù il rispetto che gli anliclt1 gt·ec'i ebbero per i catlaYeri e la !>crupolo.-a dtli.,renta con che. dopo le battaglie li seppel11\·ano. d •al...no venuto a Roma t:>O anni più lar•di ra ccolse etl orrno tutta l . . . ' a serenza medrca e chtruPgica trasmessa dai !tUO, predeces!'or•i e richiamò in vigor·e i prin cipi della .:cuoia
Nella scuola d1 Alessand r ia la medic111a ippocratica rll'• _ veliP. u11 110te,·ole impulso dallo !<lud1o dell'auatnm1a, pt'r cui In rt',..ero celt>br1 ed Erolilo. La chii'Ur;.!IU 111 '1ttare se ne gi0\'0 nelle guerr e combattute da Ftlippo il macedone c da Ales:::and r o :\Iugno, 1 qua. i ti\ e,·1111 o 1·11i 1·ut·.: 1 proprii li seguiYano aliA !!uerrll. A rm uno di que«tl, Crthtbulo 1t curo entrambi di fer1le r ipnrlnte iu huttaglia. Pre""'n t romani l'al'le «aluta1·e nei prt1n1 CI IHJIU' :-;f'coh dopo lu fondflzlone di Roma fu lac;r1a1a nelle rnan1 tle!.!'lt aclua\'i gr·eci. Vi medici romani, a ss1cut·u Plinio nou w n'era a lcuno: si fac eva della mediciua dome,;tica, cia!>icuno provveden io o cou erbe o con sortitegr ed incantesimi ullo inferm.ila dt>i 8uoi t'amigliar·i. CatonP il censor•e e..;t•r·,·ilò que::;lR di m edicina curando colle foglit> tli <'avolo il' piì1 HVH· r rAte rnal ollie: fratture, polipi IIH'lali, ulcure fìat.nJ,, dell'ano Il p'1u' · t l' · · · · · ' . r 1noma o ra 1 poclt 1 rnl'diCI d1 puel letnpn, fu Asclrriade d i Bilinitt amico e medico di C rc rouc. Ma sotto gl' ltnpet·e.lori l'arte ::;a iuta r e fo· .;e con:<iclri'P\oli Homa diviene ceutro di grande nttiv1là med1ca e chlrut'"I Ca M 11· · · 1· · " o t "iCIPilZia t 't acco1'rono pot•landovi !lnamenlì della scuola erli qurllu tl1 e rne.ntre le dottrine mediche si rno<iificHno «otto l'influenza de1 " 1"lemi filoc:ofìci, la chirurgia inspirantlo!'\i 0 .,.. clruica e l all'anatomra, r1mane cccletica. lu •llll'l fiP t'IOJCl molti uomiui come .-\rchigeue, Areteo Elto010· s11l 1rono 111 alla fama; ma i due a,tt•i piu lttminos1 clelia ICieuza meoiica romana furono Celso e GalPno. Il pruno :-i 0CCUI10 m ollo l J . . t . . c t c ururgta raumaltca, "C!"t!tl"e ferite pPnetra ntl nel petto e nel ventre, raccomaudù oJ1 sbri glittm..,nlt e le co t "" n roa perlut•e per e$lrarre le freccie, parlò delle emortragle e ùdla loro e descrisse.: istrumenti d1 cui quellr rova ti di poi l' . cl' P . ' neg 1 sca v1 1 ompet sono un 11ltro dui falli ùalla chii·u,·gia in quel tempo.
Do po Galeno la chirur·gia a R oma progredi poco o punto, e st> non st.ato per A nlillo, Ale:-sanùro di Tralles e Pa olo d'Egina, gli ultuni lempi tletrrmpero romano sarebbero rrmastì, ri spetto all'arte chirurgica, nella prù 111'0· fonda dimentu·anza.
:-.letrepoca della repubbli ca i romani ebbero medici e pra· ticanti la chrrurgia che i condottieri nellt> ed erano compensati con una parte della preda bellica. Non avevano pt>rò ambulanze, né un servizio qualsiasi di 1'icnvero d>'i maiali e feriti. i quali er11no lasciati nei campi alla preui tlei cnmmilitnnt e degli abitanti rlel paese.
Oopo la !lf'Concla guerra punica riconos ci uta l'importan1.11 del !'lanitario in g:uena, le J•omanP furono p rovviste di cltir·ur gi detti oulnerarii. - Questi oulnl'rari l'ese r o così g r·andi servigi alle tr•uppe, clre Augusto loro il diritto di cittadinanza, la dignità equt>slre e l'e<;euzi one dall"' llil'l"-tl e dai pubblici pe::;i. F urono i us t •luilì medici di corte. Arcbialt•i palatini col lttolo di perrectissimi e di e'JUitl's o COI•lltes archiatro r wn.
P er• i ft• r itr "i organizzarono solto Get•manico e Ti br•rio mezzi speciali di Lt•n <;po r lo: leUighP t> cat·ri pc·ovvist1 dr oggt>lti tli m edil'azrone e t•·ascinttli da buoi . Sorser o quindi l'Ui campi di 1 cosi delli ortfetudiMri pet' i ferili e 1 melati p;t•a vi.
Caduta Roma e l'impel'O ùi Bisanzio, la ùecadt>nza dr tolle le !-\nPnze ed at·ti, l'e non portò con sé anche quella delle mediche, si de,·e agli arabi, i qualt con · servut•ono la me•licma ippocratica coi suoi succel'l'ivr per·rezioua m enli " la Lral'mtsero di nuovo in Europa. Le l'runle di Salerno t> d i Cor·dnva coarlinvarono efficacemente lo scuoln araba
:'-lou per·tanto, la chir·urgia ne'l medio evo si ridusse •rrùlt•le pr etlamente manuale, e::;er citala da m onaci, da bat·bit>r• e citu•latan i. Solo pet· eccezione qualche in s ig ne medico , sperte iu Itolia non t rascur ando lo studio delle molaltin ef'ter·nt!, val,.e a 'lonPI'e an cora in ono1·e la pratica e la scienzn chi ·
VAJIIET.-\ rurg ica. N omint> fra gli altri Gug:Iielmo da Saliceto, 1 ro oln Parma, da .Milano, Guido di Clranliac che lu •al ul.l!lo 111 Ft•ancia come rrformator·e della r.hirut•gia.
Colln r·c,, ina ùelle istituzioni civili venne put· quella de,.li Ol'tlinunr ••nli militari De• medici o piuttosto frati
I&IIUOII O uncnrn le "Chicre guer r ec:che, ma addetlr pru ehe ul servizio delle milizie, aUe perROIIP dei re (' df>i pr111pr dre ne hann n il Car1o il Temet·at•io l.lt•l lranne il rollegio dei chirur·gi di s fon· a Partgi da Giovanni Pitard archiAtro dt LX, la militAre rimao:;e senza o rdino menti pi'OIH'i sino alln tslltuwme degli eset·cili p"lrmanenti nell'epoca del Hirla"CImt>nln. Il. lul!tu tn, la comparsa delle 8l'llli da fuoco campi di tne nl1·e induco• profonde lra sformaztonr nell'at·le del guerru ..r..riure, unprime Ull indirizzo nuovo alla durut•g:ta miblarl· cd lifrt>lla uno stabile e.l adeg:ualo ordiuatu('nlo del ""11.18 S l'· l d · . · " r rro. e 1ueuP a 11la dell'ul\ ••nzrone della poi· vere "111 lu llot·a mcerta, " geueralmeute ammesso che le •rrnr d·r f • 1· 1 ·
O!!ltllll di Borgogna un servizio clrirurgico per e tru ppe. a ssegnando un chir·urgo aù ogni compag:nia di lauce, corril'ponùenli atl 8()(1 uomini.
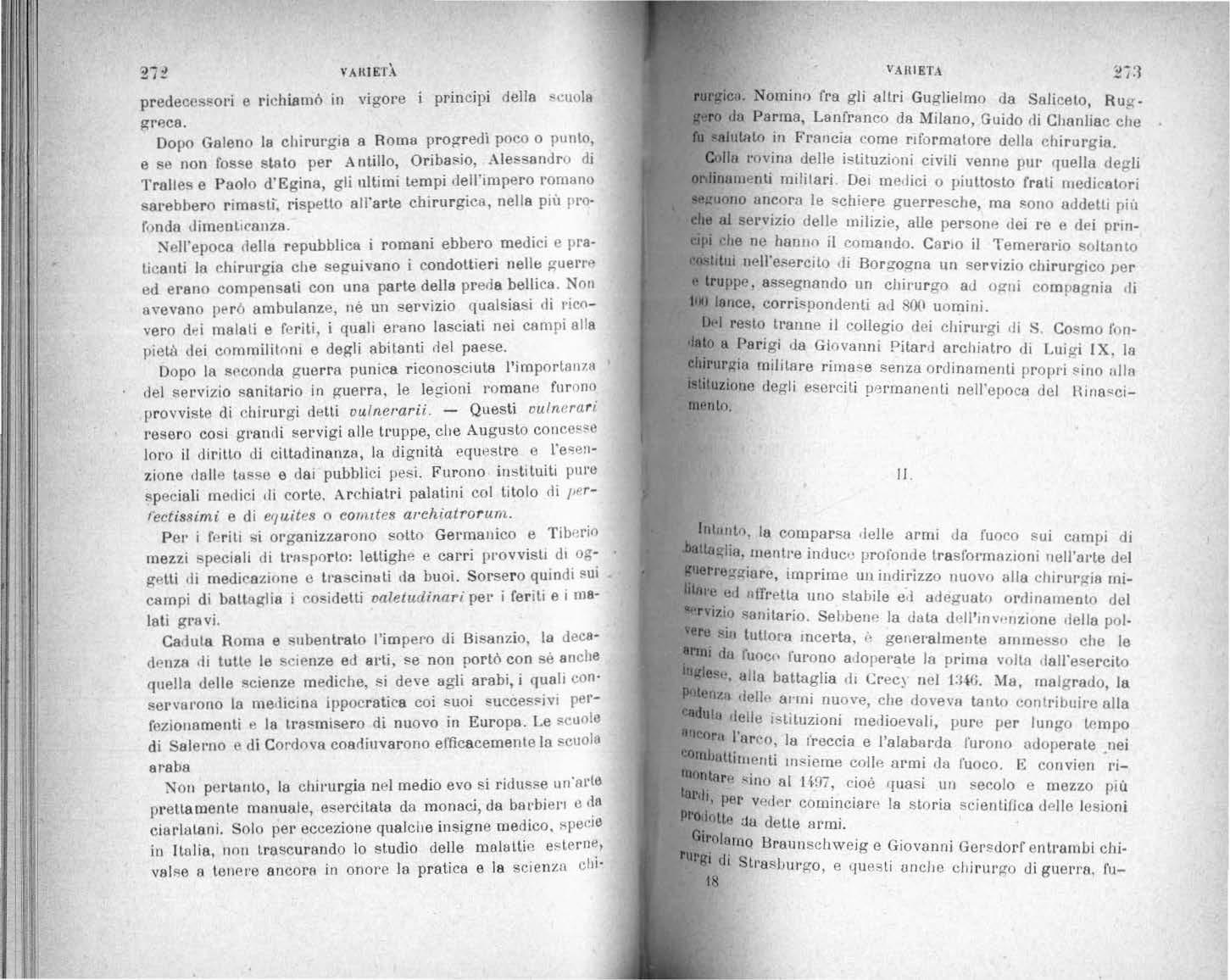
• uoct• m·ono a oper·aLe la pruna volln dall'el'e r cito a lla IJaLLaglia tlt CrèC) n t'l J:l41i. Ma, tllalgraùo, la Pt lenz 1 dPIIo• 81'1Ui nuove, che dove\u tanto eonlrìbuit·c alla cadutu dello ·l·l · ·
1. 1. " '" t uzronr met roevu t, pure por lungo lf'mpo • l'nr ·o l l' l b ' • a treccra e a a ar·da i.\Ùuperate nei C:OtnlJUttiul c>rrli cu,..i eme colle ul'mi t!a fuoco. E convien ·t·illlontar.. --ino al J<<j- • • • lar.
•· '• rroe '[Ual"r tllJ sel'olo c mezzo p1ù h, per cominciarc> la storia scienlilìca lesion i PI'O.I Il lt•• :Ju delle tll'mi
Girotnmo ' · '
1 · . G' . rur . orau nsc nve1g e rovannr Gerl>dorr l:'llll'a m!Ji chi· gr di Stt·asbu J•go, e quPsli Ollchc clii rut'"O ùi guet•t·a fuIX ,., ' rono i pt'ÌI•lÌ a "'Ti ''et·e ferile d'arma da fuoco; ll!·auu.weig nel 1i!J7 c Ger:-dnrl' n<'l 15:r:. E:<SI raecol-(llf'llflo ;:li Cl'rori dei loro c:nnlemponwei riguardat'ono fPr1le come .. La !'.lc.<<l'a idea e l anche •llCIIa della 11'-'ltCJIIC cieli·· parli furono l<O"Ienule da Gio"anni da che nPl o pet·cin •[uesli con:;;iglia"a una vl't'll tlternpta an · t!eln;; bt·ucinre !t· l'ente c11l ferro ur r o"entalo o •·on olio lou.· lt•nte. Alfnnso Ferr1 tla Vaenza, chirurqo di P••pa Paol o 111 tratto anclt1• delle ferilo d' at·ma tla fuoco, di\ itlcn.io l·· dHIII·ine dt>l Vi!!o; invcnl•\ rure un rcr l't•'lrn/.11 111c dello pAlio e dc..;crisse in modo arnmirubile i :<int"uu t' !.(li accid•·••t• d1 stli'Htle ferii-'. Prrn i lamr1 più "'lf"dallll !-U f'!IIO!<lo furono rJuellt d1 Barlo lollteo \ln:..::.:i t' d1 .\mbrogio Pot'<>n.
Gtù "''' dHlla lino tlel ::;ecolo antecedente Cn111n11n eh il'lll 'g'O clo•ll'armaLH dei wneziani, dop() la battaglia di Fornovn (lei 1't!l5 avevn dALe nol1zie delle f'er1Lo du aJ•tnH dA fuoco n eli•• HUC 1111110lnzioni alla chit·ut•giu di Pi dJ'O A rl{e· lnlo, non l'Ome avvelenate, c H••rengnl'IO du Ca1·pi nel put·e aveva cmeo.;so qualche tlubbin nn turu ,.peci/l ca di tali feJ•tle. Ma il mer1lo ùi uve t'(' Vt•rumellttl la qucsL1011e e di a v!'rd dimostralo luminosl'tlltAnl11 che le fei'ÌL•· d'at'm'l du fuuc11 non nè avvt'leunlt' w usli' ma sollanlo "P' al Bart ,Jnnlll" :\l».!'!!i ,, a l Amhru:.:1u Pareo, i quali quasi Cl'nl"mJJOI'I\111!!1· nwul•· ,. forse senza supere l'uno clt•ll'alli'O, puh· blu"trono i t'l"llllalt dei loro slurli e delle loro O'-'ser\'cll.JOIII. Il ulf•ritn ,), Pareo non è ccrtume.1l·• liu1ital11 a •Juu-.lo se()pPt'ln. La fama d1 lui é alle lunglm loti•• rho s')-.IOIIIIH lu Fruncia ::;ollo il regno ùi F1·anl"esco l, :-111° ad Enr1co l V. Chii'Ul'!!O dt :.:ento, sebbene venuto dallu1nile co1uliztOIH.' rlt bal'l11ere. egli pal'ln in seatnto all'espt •rir•ll /.8 aerJUI"la.La "Il migliaia di ferili •·urali iu tante batlngli• ·. Ep· fOrÒ lli'IJ•• 111)1'1'6, pur rispettando C giOYfllldO»I del ('011" sigli tli l ppnet'nlt< ,. 111 <Taleno appoggia le sue idee cd 1 pt·ecl'lti ,..u Jin !' •·opt·ia pL'aLica pBt'sonale. E g li »erissc divt• t'"1 lfl\"tll'l, ma il 111it llliJlOI'lt\llle è quello sulle f'oril P ri'AI'I'IH· IHigio, O\'(} si li'OVHIIO ul il i ammaesLramenti specie :-ul la dtu· posliea dt tali fel'ite e sul modo di e8egui1•e l'cc.;trazione dei protelliit .
Oltre a •l •lefinitivamente ahballnta l'erronea crt>denza eh•• le ferite di arma da fuoco a,•,·elenate, propu znn l'a llacciatura immediata delle artertt• e eonlribui eoi111 -,uo autorità ati un pm stabtle c più raziona e d .:lt t•nltnamenll sanitari di !!UCI'ra. AmbrOgio Pareo :;;i elevò a tanta allezza da salutAto <'Ome ti primo chirur:: o del c.;uo lPmpo ed tl padre della chtrul·gia militure trall cc.,e.
N"• due "ecoh :-ucce"'ivi. CIOè òul teml'o clt Pareo. alla r&voluz tone in Franc1a le ::;cienze merltchP, e !'Opraltulto la chirurg1a , un alto gl'A• io di perf't>zioue. Cnllu scopP.rla recente tlella stampo. eol StJI'get•e e t'lordlna1·,.,i <li unm:rs ttù, istituti, accademie, ilmoviii\C'nln scianti fico diventa assi! t e feconùo in Allalomin e flsiolo a, f(ualt le ::;coperte SJ ;;urcedono t> l>i mnlliplicntJo ron 8lll!l'••lare ft' Cf(ltenza. Harvey scopre la t: il'COlazione deJt.;angue; i vttsi Pt!'(uett1·ova il connucn tc romu 11A det cbilifèrl e se,:ue il canale lorac!co /ìuo allo vena suc·lav1a. Stenone ricoiH>SC•' la nalni'H dei vnRI linfultci; Maltokhi gellu le basi dell'annt m11R Lnewcnltne<'k porta 11 m icroscvpio da lui sk:;so fab!Jricato twl campo va<:to ed tuespl ot·ato dell'anatomia dei Le"suli a du la pt•imn deri !i one dei globuli del sangue; tnfìne il f'oudu palolog1ca.
La clururgia protitlù più che 1a med•rina di '<tfl'allc lnnoe sropeJ•le perrhi· i chirnr..:i "laccatJ"L di dai lu 'l'ICi e d b a1 at'IJtert, non av.'vano avuto il tempo tll rtenlu·e l'tnfiuenLa de1 sistemi li osofic1; e pel',·i•J 111 Italia, i p1u gl'andi analomiri fu1·ono pure i JliU valenti elJtrurgt.
Ln rltirurgia militare il movimento e rifulse dt viva :uce, mn ssimam ente in Fran cia, ove le coulinue rd ucca11tle ofrt•trono alla Ll'aumatologia ùi guerra mu).{giOI'O oppot·di Ps,..rcilarsi e di prop-t·ed•re. G. L Peli!, Ledran.
Louis-Rnvalfln sono da BllllOvt>rar·si t't·a i p111 illtts lri c:aruptoni della ch irurgia mi litare l't ancese in tal n pe1•iodo·
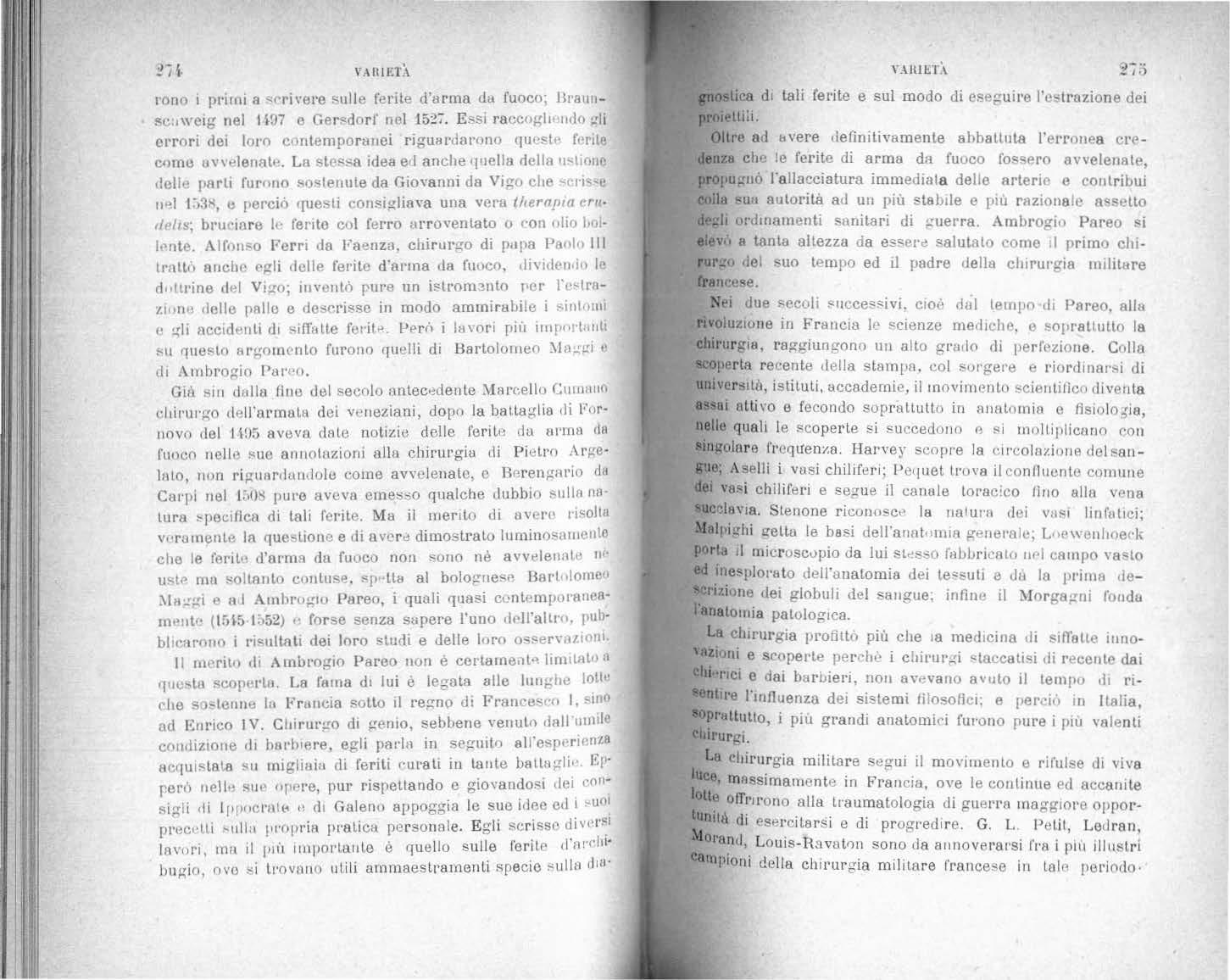
L'Ilalia non av,•nùo p1'e"o pal'te diretta alle vicPnde ;.ruerr esciH.\ 11011 conta in quesl'epocu chirurgi militari di grido Furonvi pe1•il molti che !'li occuparono di lesioni e di'Ile ferile d'arma da fuo•·o, e rra •ruesli si distinsero Nnnnoui, Pietro Moscati, Pallella, Monteggia. rra lutti. mei'Ita dì in porticoltu· n1odo rammentato Ce:::nre :\Ind •tuah> nella opern rle ra ra medication e ott.lnt: rlttl, pr1mo m;;egno a semplificai'e la cura delle rerile e al ab· handonare l'H!'IO delle stuelli e degli unguenti.
Allri paesi, !'lÌ eleva sopralulli Heistero Il quale ru rneùicn mtliluro m Olanda all'epocn delle guerl'e combullnle colù da LHigi Xl\', t' scrts;;:e un'ope1·a che racchiudo tutte le ,:ognizlOni di rruel tempo, ::oll'aggiunlR d1 uumero:w W<!'lenazioni pl'OPI'ie e di precetti or iginalt n""Hi
Tieislero fu uno dei p1·incipali restauratori delln chn'III'gitl 111 Gel'll18ntll Sono pUI'e degui di menzione SchUtnucket·, Thedou e Bilgttet• medici in capo dell'armata è:li Fed•>rico tl grande. Il Bilguer el evandosi crmtro l'abuso delle amputa. ;doni ù stato un 1werursore <iella chirurgia nella pt·otica militare.
Dt non poca i 111J'Orlanza furono le innovazioni apporlllC negli ordinamenlt satHlari e segnatamente nel mato>rin l• · .ti mediralui'a e dt trasporto dei fet·iti.
$otto Ent'ico l V <:orgono le prime ambulanzt:' ed i pr tni ospPdali da campo. Gtà <>in dai tempi di Pa1·eo er·nn, i guìlo delle at·mate, cassont eontenenli mezzi di soc<!orsn , mR t'u il Sully rhe creò le Jll'tme ambulanze e ho di Ami,..II" nel J;>97 organiuò il primo ospedale ambulaule. Solto Luigi X Ili e (H'Opriamente nel 1630, durante la campa{{nli 1l'ltalta, Richelieu l'niLivando l'idea di Sully l'a "tabilit·o ambulanze ed ospedali ambulanti in CIJntle!'-:,iouP 1'0!!ti 03pedalt pet·manenli; ogni è provvisto di un citi · rurt:o; .;;i l'ondono ospedali milttari pet'manenLt, a capo dèi qut1lì sla un chirm·go col titolo di chirui·go maggiore tli armala. Sotto Luigt XIV il si aumenta dt un muggio•• tlUtHero tli chirurgi alle amburanze e dei chirurgi aiulonli magg-tori nt reggimenti. Si instiluiscono put·O
VAHIKJÀ 2i'ì f elrir·urgi consulenti. Solto il r egno ùt L uigt X Y i nOne e propriam entE' nel secolo X VIII, l'ùrganiaazione !'-anilarin mihtare france"e r11ggiunse il maj:\'gior di per·fezinnamentu. Si allarga il quadro dei chiruJ•gr maggio1•i e si dà loro una po,izione stabiiP: s'instituiscono pure :,rli ispettori, .et un comitato com:ulli,•o pres"o tl mini!';t.•I o della !!Ut'ri'a. Si fondauo ciiHjue anfiteatri o scuole pPr glt nllìe\'i chirurgt, nelle piazze militari piu impnrtar.LI. E l'ac.qJ.,mi a di chit•urgia acco:;di,.. nelle snP file 1}11 numerlJ d1 chirul'gi ùell'eset•cito, si intzia nel 17()7 la pubèlicazi one di un giornale dt medicina milìlart•, che !>11!\Sì!'lll' •ncora la. di questi due uomini, cl1e furouo a capo del 8thizt n <>a 'l · 1. . · nt at·to neg 1 esercttl napoleonici, deslu più ammirazi one ed é piena di utili iusep-namontt pet• il ltco lllililare
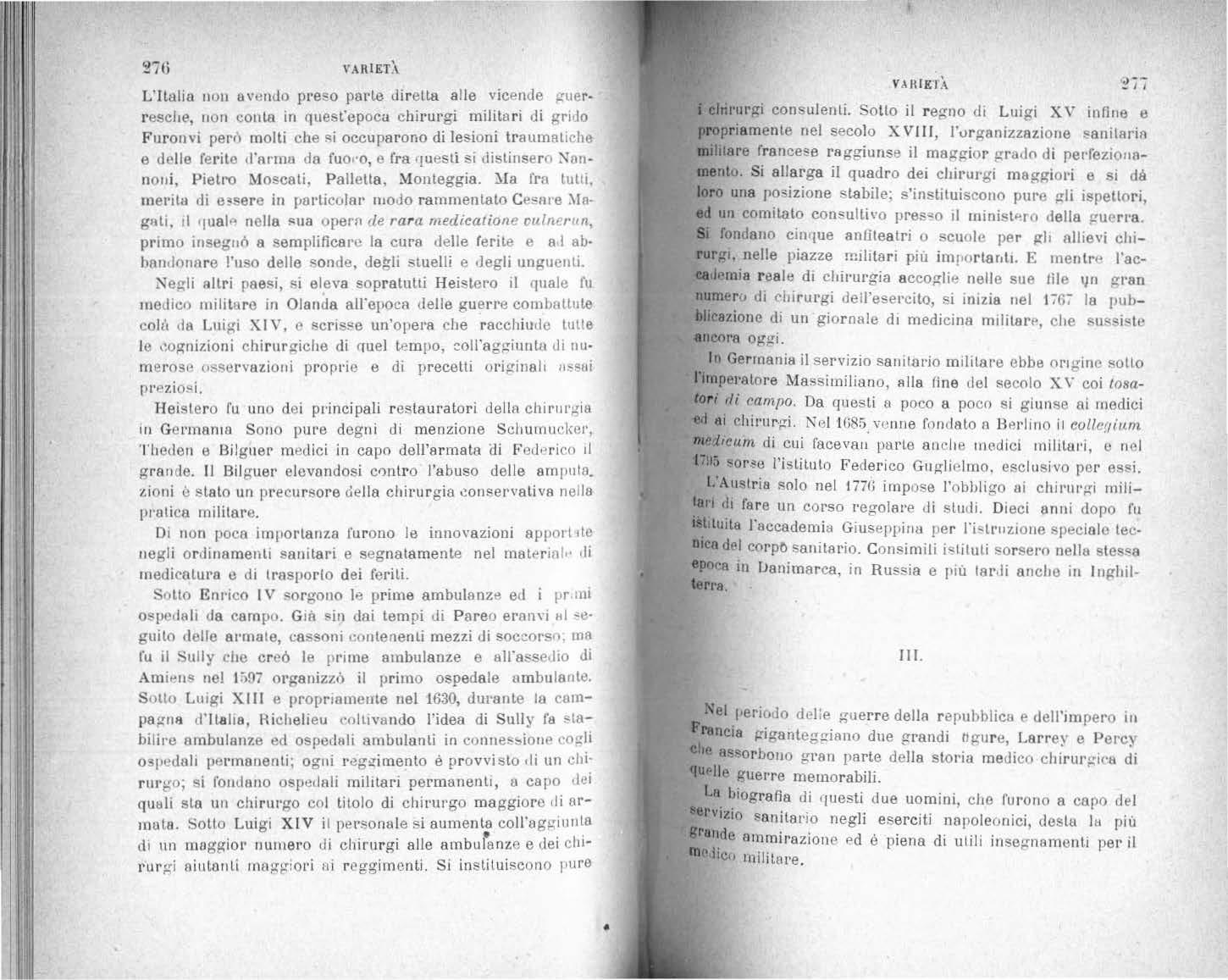
, I n Ger tnania il servizio santlat·io mililat·e ebbe nrtgtnP llmpet•atore Massimiliano, Alla fine Jel secolo X.\' coi {()Salo r i di rampo. Da questi a poco a poco l'li giunse ai medici -ed ai chii'Ur;!i. r\l'l1(i85. ,·enne fondalo A Bt>t'llltO il cofle!{inm rtu!dr crun di cui facevan pat•le ancltP IIHidici mililat·i, c nel 17115 l F d · G l' l · · ·· ,. 1 u o •e ertco ug w mo. esclustvo per ess1. l.'Au<:tria solo nel 1771i impose ai milidt fare un c01·so regola1·e di studi. Dieci anui dopo fu iàltluita l'ttccade · G"' · • l" · · . m1a IUSepp11ta per t'li'IIZtOlle spt!ctalc lecDrca del corpo "ani lario. i«liluli l>Or!'lci'O nella stes!"a epocn 111 IJanimarca, in Russia e più tat•di anche in Inghilterra. Ili.
Nel · per1odo delle guerre della repubblica e deii'Imppro in .Pran · · · eta A't!.tanle;::f!Iano due g1•andi Ngure, Larre' e Pei'C' ehe IIS;;.;orbouo gt•an parte della slo1·ia medicn clti,rui·git·ll di guerre memorabili.
Leggenùolo, non si sa se ammira1·e in loro più lu poteuza dell'iu);!egno o la vasLila tldla dottrina: la ,·alentia di'l f'iuo l'ohilità clell'Ol'gtl.mzzalore; l'alliYilù, lo devozwne.. il m ''ero la di::lciplina, il valore·, tu noncuJ·anzn del pericolo.
Sarebbe troppo il dire di tutti i perfezionnlllt'llli e di tutte l t> innO\ azioni portate dfl Domenico Lflrr!'y nel campo <Iella chiru rgia milit.are. - Accen no <:olo we t•.!lì fu degli shrigliamcnti e della e"--l'azwne iuuncdrata dt•l C01'pi ,..ll'tlllieri dalle ferite; 1·accomandù pure l'ili erlUl'tl dt>l pCl'icardio nt•gil spandi•nenti traumatici t11 t.:"·0 e tletermino con Il luogo di elez1one di tull' utt., operot1vo. - Si occupò delle l'••t·il• tle la vesc1ca, di c111 raccomandava li ta::rlio precoce pt•r 1'••-.ll'Azione tli palle di !'ltlteggie. - Esegui più volte la ,]i,.urllc.:oluzione dell'anca ton un suo !'lpeciale proc.'sso; o per· qwlln tlelln spalla il a racchella tlel Lal't'PY è ancor·a molto l'flCCOillAIHiuLo oggi giorno.- !tJfine fu caldo pa•·tig-iurw dt'llil Rmou1nzloni primut•ie, tlellc qnal< io u11 sol giorno dnpn In hutta:-din dt'lln Mo<:C0\\'8. ue e«ef!ui 200.
Larrey h11 lac::ciato Humet•oe:e pubblicaziom ma 1., ;•in i lllportanti ;:ono l•' sue memorie e la clinica c !t in t r:1 ictt, quali ha I'Onse::rnato i ri"'ullalì di un·e,.perie11za ac·qni'-'lata nei cnmpi di sec::--antn cran•li battaaliP e nellt• ambu1An7.•' e negli osp••duli dal liU2 ul 18W
P ier Francesco l'ere\, compagno ed t>mulo di Llll'ri!y uon In--ci!\ molli sc1·itti. - La principale sua m ouo!! rntia e •111•'118
-.ui corp1 "'tr•anrerì, pubblicata nel 11!12 11 titolo di Jlanualt dl!l chirur,,o d'armrttu, e l poi tli 1111t1 e -
··ouda purtP
Egli fl ... ;:r'l 111 1110 lo esatto le indicazioni dea-li .,briçluHucnlì imm ..clial• o c::econdal'i tlt>lle ferite. come pu1·e dolio 8111!'111tl·
.1.10111 Ct:!t'canùo eli l1m•tm•o l'uc::o e l'abuso che cl• que..,l t' t'a-
,..... va la dJirut•,.rìa militare d'allora. I nspirandosi ai
Moreau 1'-Ì l't>ce SO"'lenitot•e de ll e resezioni e ne e .. c:.:ur
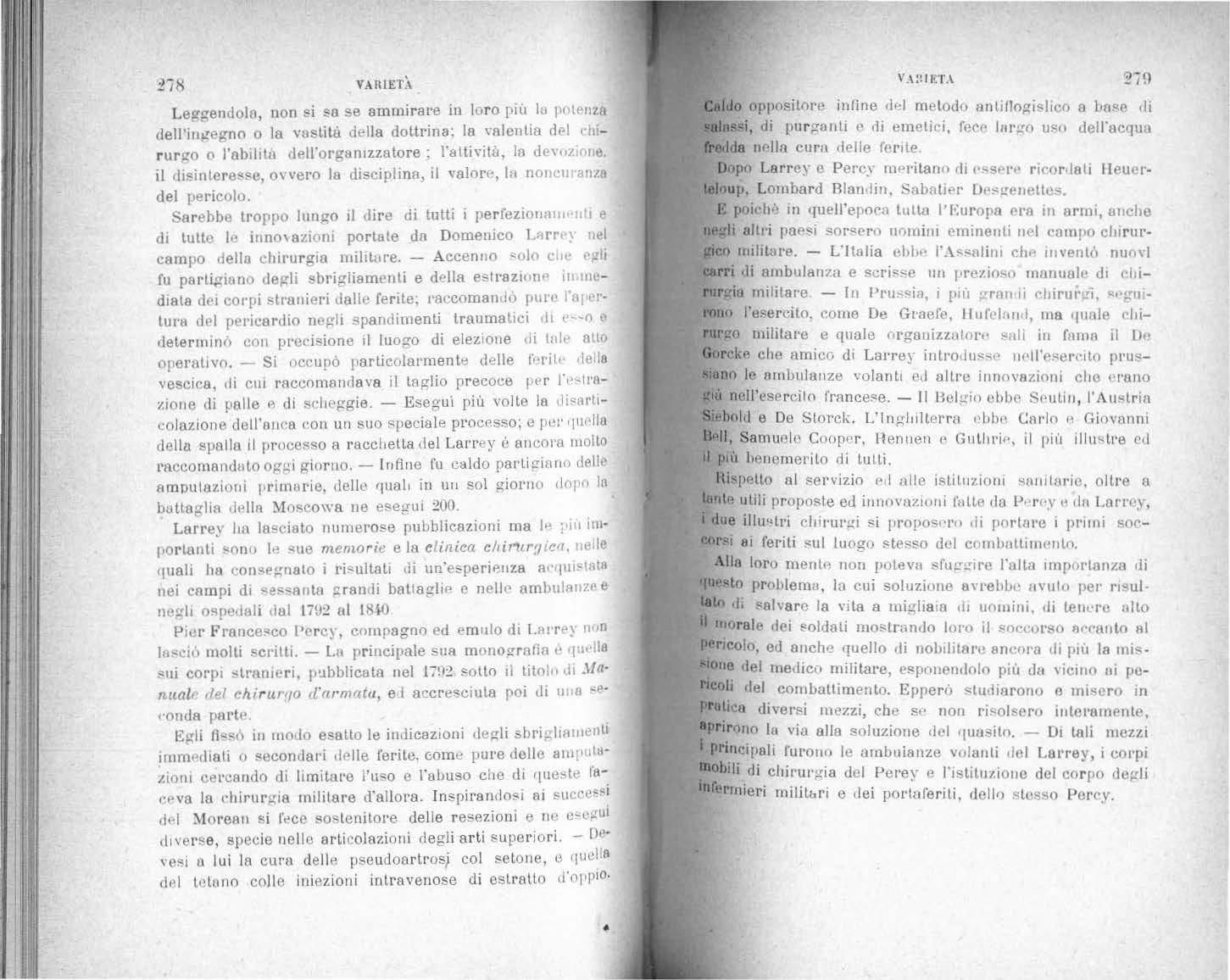
!11' er-c::e , specie nelle arti c o l azioni degl i a rt i s u periori. - D•'· oppositm•p inlìne dt·l metodo a hose dt , J i p ur ganti e di emeti ci , ferp l11r:ro u;;o freclda ru ·lln cura delle fc rr le r•_u_cr pa li ful'onu le ambuianze volanti del Lat·rey, r cor•pi
"e"' o l ui la curo dell<-' pseudoart r osj col sc loue, c quel A tlt>l ti'LOl lO colle iniezioni i nl r avenose di csl r allo d'oppio.
Dopo Larrey c Pere_,. Hwr·itano dì ricordati llt'Ul'l'· teloup, Lorubar d Rlan ·lin, SAbnlit>r Ue,.:!!t'IH'tle-..
E poil'i 1è in •ruell'epora lullt1 e1·a rn armi, aucho negh alt t• ì pa•'"i :-:or"'el'•l nominr t"lllinenti n<'l campo chi r ul'· gJco mi li l nt·e. - L'Italia ehh·· J'.\,..snliru eh•• iu\'entc'l nuo\'l carri di ambulanza e scric:::-:e un prezioso rnunuult• tlr dlirurgin lllililat·e - In Pl'll"'"in, 1 p1f1 • rnu 1i chirui·,:ì. "''E!Ill· ron" l'esa r c·ito. t•ome De G1·aefe, lluft'laud, ma qnnle rhim ilita1·e o quale i rgaui1.wlol'" ,..ali iu fnlll!l il Ll•l Gor<'kP clr(l amier, di ll<'li'Pr-<Cr<·ltn 8 ano lo nr nbulanze ,ofant• t>J altre inno\·aziollì eh o t•r·uno g<u rwJI' ese J•cilo fmnce,e. - Il Belgio eh be SPuLi n, l'All'li riu Sa·ho ld e Dc Slot'ck . L' l ngl11lterra ••bbl' Cari n ,. Giovanni &Il, Samuc le Coopcr, llennen t' Gutltr•i,., il più illu«tr·e c<l ti p1ù h Pn c m erito di Lutti.
RispPlto a l !':ervizio c>d nlle istituzioni oltre fl leJ1tc ulì h p r opoRle eù innovazwni ftllL<' do P· ·rc•\ "dn LO l'l'l') i due illu ••ll'Ì chir·ur!!i si propoc;••J'n di pnriiii'O, i prirni ai ferili luogo "tesso di' l cotti hall i 1111'11 tn.
AliA lo r o menti' 11011 P•Jlevu :,;t'uuzrre l'alla unpm·Lnnza di JUe,.tn prohlenH, In cui soluzione 8\' l'ehi.Jt• uYulo pe1· ri:mlteto 1h la v ita a mi!:dra•a .li uou1ini. di ten••r'<' allo Il 1111Jral e dei soldati mo,.trnndo Jm·n il ;.ncTot•so III'I'Hnto Rl per,rolo, ed anche '1uello tli nobilitar·c ancor·o di prù la misrle l m ed1co militare, e"ponentlolo più ùu 'icrno ui pericoli •le i combattimento. Eppero «tuciiarono o misero in pr atica mezzr, che s•· non l'isolscJ'O inlel'&rnPntf' l u via alla soluzione del •fllU"'ilo. - Dt tali meu: l p . .
Dlobrh di del Pe1·ey P l'i"ltituzione del corpo clegli tnferrn1 · ·1·1 · 1 · crr mr t or• e ' e1 pnr·laferili, tleii'J !'l tc<;so PorC'y.
IV.
Dopo il trattato del 1815 l'Europa depone le urmi e viene un lun go periodo di tregua, uel quale l e istituzioni m ilitari , nonchè progredire, fanno dei passi indietro.- Nondimeno in FNmcia, dopo la J'eslaurazioue ruro no riorganizzati gli anfiteatri d'istruzione, fu ripresa la puhbticaziou•• interrotta durante le gu ene napoleoniche, rlel Giornale rlt medici n a militare e nel 1824- fn fondata la seuola di pet•fezionamenlo del Val-de-Grace.
Avvengono pure nella stessa Feancia a cominciar·P dal 18Zll rr equen ti episodi e spedizioni mtlilari che valgono a teue1·e desta chi t'LLI'gica nel corp0 uttario dell'esercito.
Ma dalla seconda metà del secolo xtx s' inizin lJlll lumin osa e più reconda per la chi rur gia militare. un't•ra nella qua le vengono apf'lOI'lali radi ca li mutamenti nellP istituzioni sanitarie non solo, ma s'imprime un indiri zzo dP l tuLlo nuovo alla prali ca chiru r g ica t! i guerr'a. E ciò a v'i eu e per due ordini diver·si di caus e: per· la profonda lr·as rornlll · zione delle artui e delta e tattica mililar·e. e più a11cora per i pr·ogressi. ;,orpr•endenli dalla chirurgia nel nostro secolo, m grazifl de l metodo spPrirnen· tale rigorosameuLe applicalo alle scienze biologiche, e dell'r,:<sen·azionc cl tnica non turbata da p1·econcelti 5:istema llci. -lo non ho bisogno di fermHrmi su tale ar·f!omenlo nè dr rammentare gl t uomini insi gn ì ch e a quei llauno legato il loro nome.- Rico rdo Ml lanto l'an estesia generale introdolla in cltiJ•urgia n el 18-1-!J dopo i prirni tentativi falli ùa Morto n e dal Simpso11; l'emo!> taRia preventiva mrdiante la dt'ligaziouc elastica Si i vcsli'I-Esmarch c gli allri nwzzt successivame nte inventati; e la merlica rura llnliseLlica acqui· stata alla pr-atica ehiru1·gica per to e1·i lo di Giuseppe Lic:te r; fiuesla lriade g loriosa e benefica che ha s tenuinalRmcrtl.e la sfe ra d'azione della terapia c hir•ut•gica moder·na
HlUETÀ :?81
e che ha g ià eseecilato e piit ancora dovt•à ese rcitare in av venire, una grande intluenza sulla cura dei fer·iLi in guPrra. v...u gon o intanto le prime g 1·andi guert·e, di C1·imea ut'!
ù d' I talia nel 1859, e queste guerre, delle tre gt'flndi scoperte suaccennate non ne trovano cl1e una di assai fre sca dala , !"a nestes ia. D'altra parte la cl tii'UI'gia rnililat·e e ra allora troppo legata alle anliehe tradizioni ed ancora troppo oppressa dal giogo pt·epotente de l ramo amministrativo, per pole t·s i al lontanat•e di mollo dai vecchi sistemi e dare risultati migliot'i ùi ryuelli delle an tecedenti. - Epperò: fe riti lasciati senza soccorso su l campo di battaglia o soccor s i male e tardivamente; mezzi di trasporto insufficienti e rlisaù a tti al pronto e J'egol81'e serv izio di sgombe ro e di dissem in amento ; malatlio infetti ve cile cagionano maggio l'i perdite del fer1·o e del fuoco nemico: ecco t precipui sconci ch e on c lte nelle g tte rr e di cu i leniamo dil'corso, non furono eli minati.
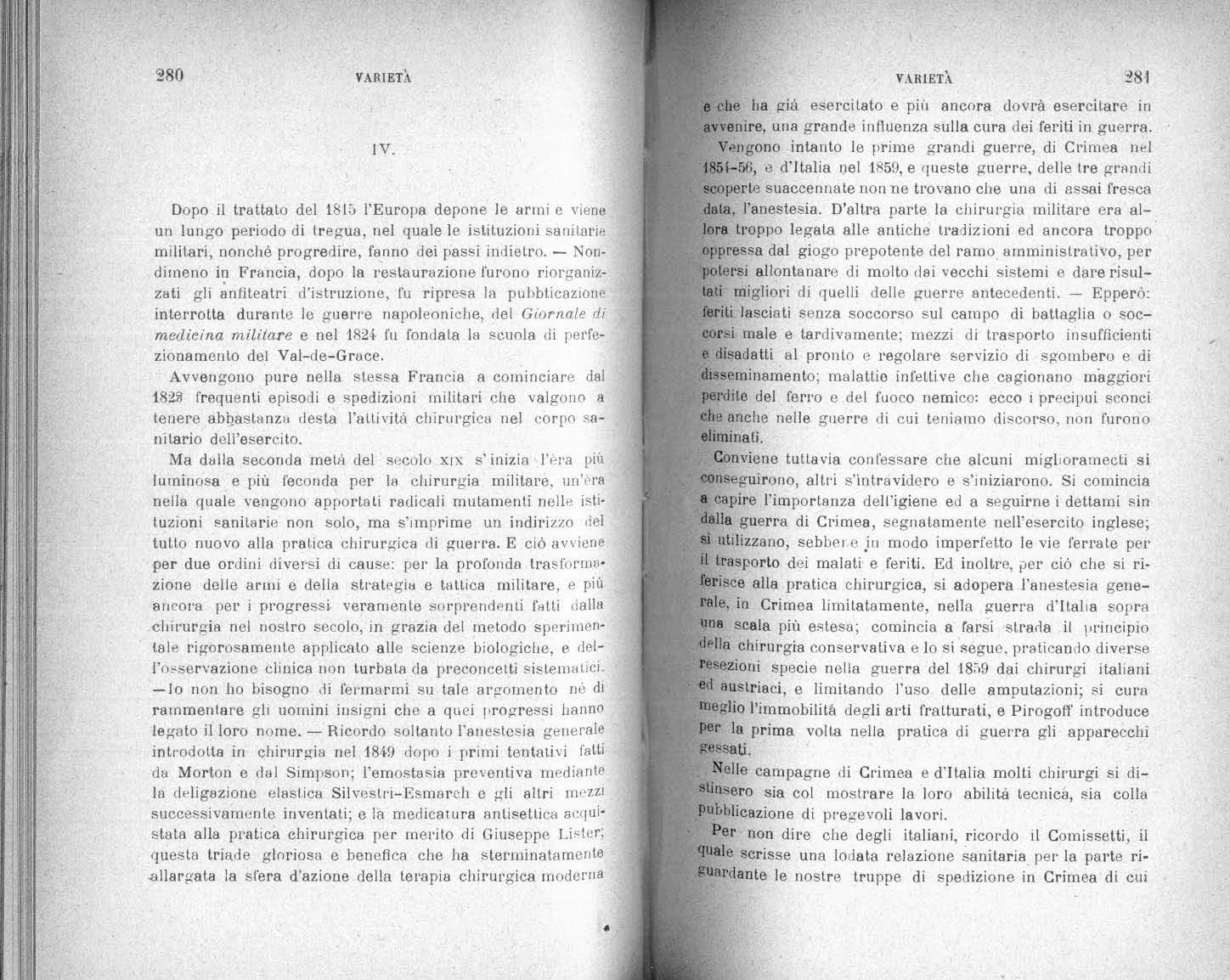
Conviene tuttavia conl'essare cile migl to ramecti si conseguir ono, altri s'ìulravidcro e s'iniziarono. Si com incia a ca pire l'i mportanza dell'igiene ed a seguirne i dettami sin dalla g uer ra dl Crimea , segnatamenle uell'esercito inglese; si utllizzano, sebbe t r .iu modo imperfetto le vie ferrate per il tr as por to dei ma lati e feriti. Ed iuollre, ciò che si rifer isce alla pratica chi rur g ica, si adopera l'anestesia generale, in Cri mea limitatamente. nella d'Italta sopra una sca la più e;;tesa; comincia a farsi strarla il pr·iucipio dPlla c hir u r gia conseJ'valiva e Io si seguo, p1·aticantlo diverRe r e!>ezi oni specie nolla guerra del 18::.9 dai chirurgi italtani e tl au!'Lriaci, e limitando l'uso delle amputazioni; Ri eu1'a meglio l'immobilità degli arti l'J•atturati, e Pirogolf introduce per la pri m a volta nella pratica di guerra gli apparecchi A"el->Sati.
Nolle campagne di Ct'imea e d'Italia molti chirurgi si diSlin, ero s ia col mostrare la loro abilità tecnica, sia colla Pubblicazione di pr·egevoli la vori.
P er non dire elle degli iLaliani, ricor·ùo il ComisseLti, il qu al e scrisse una lodata relazion e sanitaria pe1· la parte ri · gunt·dante le nostre truppe di spedizione in Crimea di cui
PJ'f'l Il tne.lico t•apo, il CI>J'te:::e, che ùopo le catnpa!!un dtll c del 181i0 scri""C dtver"i Ja,·ori. l't·a cui pregialt,..<:ima 11011 iu llhlia, me nn,.Jt, furwi. la Guirla leoncoprncira del Ttterlico 111ilitare in. camftfl(JTW: il H.u·nff!o, Phe pubblic,', unn llleutot·ia uJie ferilt> ,rarma Ù>l l'uocn, nuoruln
.Ici premio Rtberi.
Ili han l i 1 itnportanti in'le:marnenli fu RPI•'lrtnlrw e l11 tli rli Alllt!l'ica, del L':ntl o tH•Jn ÌH d,• l <'Ot·po snnitnrìo e lo spicito inlr•aprenrlenle e t! ard ito d •::h amtli'ÌI'Rni dùuuo r·a!!roue dei falli dnlla t•hirnr:.:'a rnilitar•· in quello guer·ra. :"'e enumet·o i p1ù nnlcYoli: furono p et· In pt·tma volla '-'pet•JJtwntali i Lrl'nl - 0"1 •c dali p•·r· il tnt"!'' l't.J a a-rnn•li dr"'lauze t'l lo s,!!omb!'ro lRt'!!O P "ollei' Jin dei mnlnli 1• l'cr·ili, Qi u--arono e c:ott "'llt;r·csso le te11de e lt> bararche per il t·ieovero di si '-'vrluppn in nna mn ttiern fl!';!'ai sa e praltca il ><istemo dei ,_OCC'OI'SI privttll.
Nò 1118110 l'ilevf\nli furono i progrec;;.i uel ea ru po
- St fJI'alirnrottrt :m,8G:3 operaztoni.- Da cir) si pu6 'luanti illsP!.(Ilntnenli ><iano dovuti rleri,·at·e rJu 1111 mate J•ialc ;.;cienlilic-o CO'-' Le"'Lt'!-<r>, abilmente c;frullato ùw migliori cltirtii'.!L rli AmL•t·i,·n, diA ct·uno lutti al ::-;!'rvizio ùell'e-;el'cito - La slot•ta medtco-chirur•grca di quella !!Uert·a rei.lalla dul Bar·ne" e dnii'Olt", e 111 cui noi posseJiamo un pregew•le contf"' lldro per npt>ra rltll :.rener·Hit> medico Ba r ortìo e del ma:!!!'ioro u1e lico Sforza,,·. u11 vero monumento di chinrrg:ia ruililRI'U
Alla guerrn di Ameril'a segui quella au,.lro - pru-."tflll 1 t>•l au:-lr•>-iluliana tlel 18!)1;,
In <JIIec;tn gu.. l'l'8 I'P"ercito JW;.;lJ•o ebbe soltanto In g:inruntu <'HIItpn.e de'l :!i- a Cuc;loza e poi a ltri ptecolt t' liut ilRIÌ romha•lnneuti. Tutta\ ill il corpo i'Anitario militare rim·dinalo, per· tuer·r tn "l·ecialmente ti el Riber·i. seppe mo--trat·e uon ;.;o lo
In sua devozione ecl il suo zelo, ma anche la "Ila Rlulil!Ì ehir·ur gicn.
:-\ello fur0no sperimentnle
In pei tna volla in Europa e sn vasta "Cala at·mi a tiro · rapido; ed il fuci li' ad ngo prussiano fu quello che deci-;•· le -.orti rl··ll a :.:uer•·a sui Cllffi( IÌ di Sadowa.
V.\RIET\ lJ•'IIa guet•ra franco·gerrnanica fu pubblrcala una r·elazione 88ntlat·ia. che o.> un'o!Jera gra ndiosa e pieua di ultli rn enti ai pari della ::loria meùieo-chil'llr!!'ica 1lclla f.\'UL'l' l'U d'Amer·lca e della quale pure possediamo uu pregevolr sunto pubbli cato per Cllra del Giornale medico del R. Nrercilo e della R. mari n a.
<tuesti fot·midobili islr'urmmli di il i'rmci pio contemporant>arnente irl\'al"n nt'Ì principali eee•·ctli <11 Eul'o pa della obbligatorietà al !':en:izio rntli ture di tutti i domnt abili alle ormi. furono cauc:n di pt•ol'ctnole modilicazioni nell'arte del Per tal modo uelle guerr·o m oderne >'Cendono sul campo di haltaa-lin tniliuni di uominr ar·mati d'istrurnenti di !!ucrt•a ,Jpr•minatori. e cosi le campagne si son l'e-=e p iu brevi, mu nello etesso tempo più sangurno-=e.
Nella guerra franco-get•manica olt>l 1:'\70-71, gli acceunali principii lJ'Ovarono per la prima \'olta la loro AmpiA upplicazione. Ep per ò quella g-uerra t·bbe UIIA !<pectalu itoportanzu miliwre non "olo, ma n•' ehbP ptH'C mo!Lic:t"tmA. la chil'Orgia tli campagna, tanto più clrt> 'IUe'<tll pol1\ L!'art·e partito da tutte le nuove conrruisle della Rrtt>IIZR e del lo pratica l'ltirurg ica e sperimenl:-u'P. la con venzioue d i GlllcVl'a rle l con In IJual e fu ::ancila la neutrali Là dei muiALi ,. l'cri t i a rlel loro per;;onale e mtllcriale di soccorso.
La chir·urg ia militare te. lesca col !"UO materiale hl'll" nl'lnato e ben e adallo, a tutti i ('01 'nlido aruto elte le prPsLarouo le soctelà dt l'occor·so, P c•ll conror.;o dei più illustri pro fessori delle universilù ati ollenet•e un'i!.{ie nt> rt!!Orosa: J'a""''"lenza dei feritt ['OI'lttta !';ÌO aul cnmpo d t balla:,;lra. un si.:;tema di ancl11• A luughis....im e ùi--tanze in treni O<:pednli comodr e bt!ne urt•cùnlr 11d il pi ù p r onto c piu P'>lec:o "parpagltamento dei mnlali e ferili.
In tal prevenuta la tn:-:org:enza clelia sctlkoernia, della pioemia e ùi tutte le allr·e malattie ol'inft>zione '<l poterono ottenere risultati senza e:-:empio, P quasi inspcn1li, dalla cbrrurgia conservatiYa.
N Jtl ho là Llo pa r ola tlella chi r·ui• g ia mililm•o t'r·Euterc:o, da p- poiche' que$1'1, pur a \'endo nel suo seno uomini eh mer·rto, ma dominata nncor« daalt anlichi ordinamenti, non ottenne gran da quelli delle guerr·e dt Crtmt!a e d'ltaliu lo mi Iaoilo a citare l'ra le più recenti le ope r e ùi Fi<- ·•ltf'r, R Legouesl, Esmarch. .Mose Lig-ì\foo r·lwf, D elor111e, Cl.au, el e 'luelle ilalrane ùel maggiort' medico ll.an done e Jei tenPnli colonnelli medici Sc>gr·e P Prelli, clw hanno P"r noi un pA r licolarP interesse ( l 1. l) 1/antllmc/o d•t Ar•egscluru•·llit, d1 H. f'I'CHER. ChirurQir tltl Sclwuoertelzungen in 1\ri•·oe. E. lltcuTen. Bre>lau. IS'>", f'ratlt df CIIÌI'CII'(Jit tl'lll'lllrt, l. L !!flOt'E, r, Pari>, 181:! lllltetWlf 111 rlt i !'ll!'!}ìa dt tenente colonnullo F Set111L, M· J•url, rtl88.
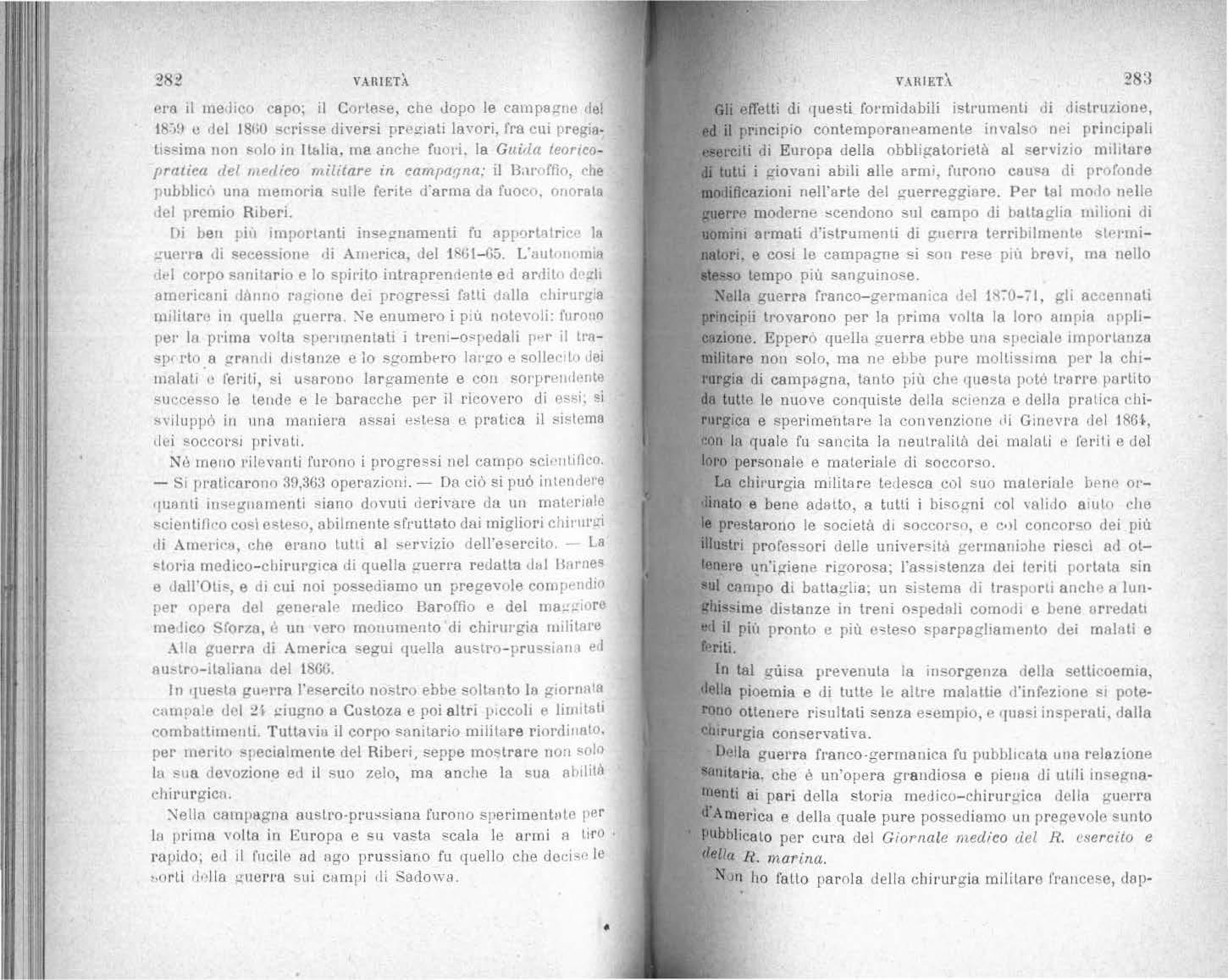
4 lla guerra del 1870-71 J>uccesser·o la I!Uerra ru!:'s o -lurc:a òcl 18i8 c quella serbo-bulf!ara del 1885. Queste dr mollo minor·t> 1mportanza. specie l'ultima, delh· guerre ant eriori, hanno avuto ìl merito di confermare l'allo Yalore dt>lla m edica lura anlil"ellica; perciocché, la do,·e pt>r le rnani di Pit'O/.{OIT, eli di Moselig -Moorhof essa fu beuc applicalA Si otlennero risultati eccellenti; quando lllYece ru si videro comparit'e la infezione settica e pur·u· lenta, la risipola e le altre malallie infellive clte fur·ono la preoccupazione ed il tormento degli antichi chirurgi militar1.
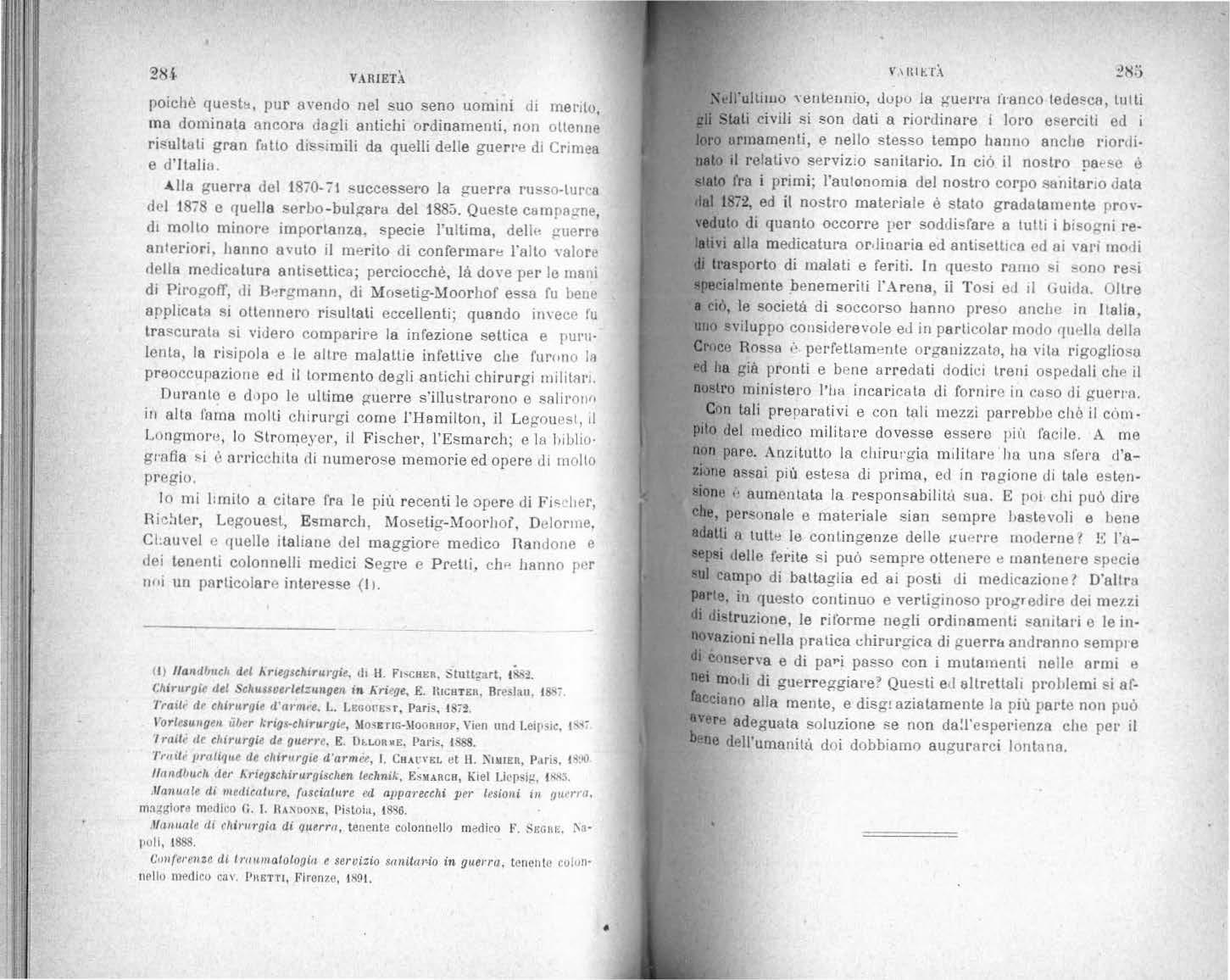
Ouranto e d •>po le ultime g-uerre s'illustr·arouo e salrr•on" i11 alta f'nma molli chiru1·gi come l'Hamilton, il LegouPst, cl I.ong-mor·P, lo Stromeyer•, il Fi scber, l'Esmarch; c> l a l11hlru· gmfìa l'i !'• Ut'l'icchrtu dr numer•ose memorie ed oper·e dt rnoltn pregio.
\ 'o rlfluiiQtll tibtr krl(lo-ch&rur(li•, lJo.;z \'ien ,,,/ l'Ili/t• tlr chtrttrgle dt !}IIUI't', E. •E. l'ari.;, 1888.
,.,.,,,,. Jll'llltqllt dt cllirurgie d'a•·mù, l. ut n. P.!ris, lltltldlmr/1 tltr Arit(liChirurolsc/ten techmk. EswAncu, K1el LkpstJ!, ,!lmwule 111 metlirature. (rl&cialtll't l'd npporecchi ]Jtr lesioni w !JIIt'l'l'll, nw rlko 1:. l. 1\A\ DOL\E, Pistoia, tS36.
C:o!!(Ct'!'IIZC dt lrrull/tCJIOIO!)in r servizio sanUm··io in gue1·ra, tcnent<• colun· tnN1it·o ,.n,. I'JC&TTI, Plrcnzl', ll<9L
Ndl'ultuu o , eul.ezmio, do!Ju ltt t'I!Ul co leùescu, Lu l Li gU Stati civ1li si son dali a rior·dinare i Jor·o e!'ercitt ed . i loro urmamenli , e nello stesso tempo hanno anche I'IOI'<h· uto il re lali ''O serviz1o sanitario. I n ciò il nostro !)a.,c.o ò stato fro i primi; l'aulonomia del nostr·o corpo s!lnitarto data dal 18i2, ed il nost1·o materiale è stato gradatamente provveduto ùt q uanto occorre per a tull1 i t·elativi alla m eùicatur·a oroliuar•ia ed antiselt1ca cd ui ''ar·i modi di di malati e feriti. In questo rnmo -.1 ,..ono res1 epecialmente benemeri ti l'Arena, il e.J ti Oltre a crù, le società di soccorso banno preso anclw in l lalra, uno l'Vilup po considerevole ed 111 parltcolar modo IJII»llu della CrocH Rossa l• perfellamPnte organizznla, ha vita rigogliOl-iU ed ha :;tià pronLi e bPne arredali dodici treni ospf'dali chP il nostr o mini stero l'lu-1 incaricala ùi forn1r c• in cuso eli guerrn. Clln tali pre par•ativi e con tnlr mezzi parrebho chò il cònl· prlo del 1uedico milital'e dovesse assero pit'l l'at:ile. A me no n paro..\ nzilutto la chirurgia militm•e ha unA l'\ l'e1'a d'azi.lne più estesa di prima, et! in ragione ui tale esteulione " aumenta ta la r e sponsabililti sua. E pot chi può dire che, pcr;;nnalo e mate r·iale sian sempre bastevoli e hene adatti n tulle le contingenze delle moclcrne t !•: I'nlepsi olelle l'erile l'\i può sempre ollenere e u1antencl'e sul campo di battaglia ed ai posli di medicazione t D'allru parte, i11 questo continuo e pi'o,;reùit•e <lei meat di distruzione, le riforme ne!;(li ordinament: :<anital'i o le innovazioni nPlla pratica (;hirurfrica di gue rr& andranno !'empi e dr e di pari passo con i mutamenti nelle armi e Dei m od1 di Que:::;ti e.lellrellall problemi si af.. lacciuuo alla mente, e disgt azialamente la più parlo non puu aver.. adeguala soluzione ::e non da!l'esper·irnza che per ti bene ùP.ll'uma nilù doi dobbìaml) augurat·ci lonltHin.
Role du Médec lu -che f de la d ivi sto n p e ndan t le combat, pa1· G\YOY, llll' tecin pt•mripal de 2< clu.... se. Du tra n s po rt d e blesaéa sur v oi es fe rr ées, pa1· le rnnJOr Lolit's FROt·.HLtCH, me.lecm-.:hef tle la rJéren!'e du Gothar l.
•\miamr, megl10 una colpevolt> pe r tn-err• tanto ad annunziare queste inLPt'••"-
!;AnlissimP puhhli<'azioui, piuttosto che l'a..::-:iuo ignoruto du i coll••gla.
Il libro del !la per iscopo di dimoc:;trnrt> •111Aie '-t8 l'opera ultlissima de l medico di rettore d'una divisiortr', in nell'nt'l.l tlel combattime nto . E vi riesce in mndn ,.,. • t·amottte convincente, !:!empt•e tenendosi sul ter r eno det l'nlti.
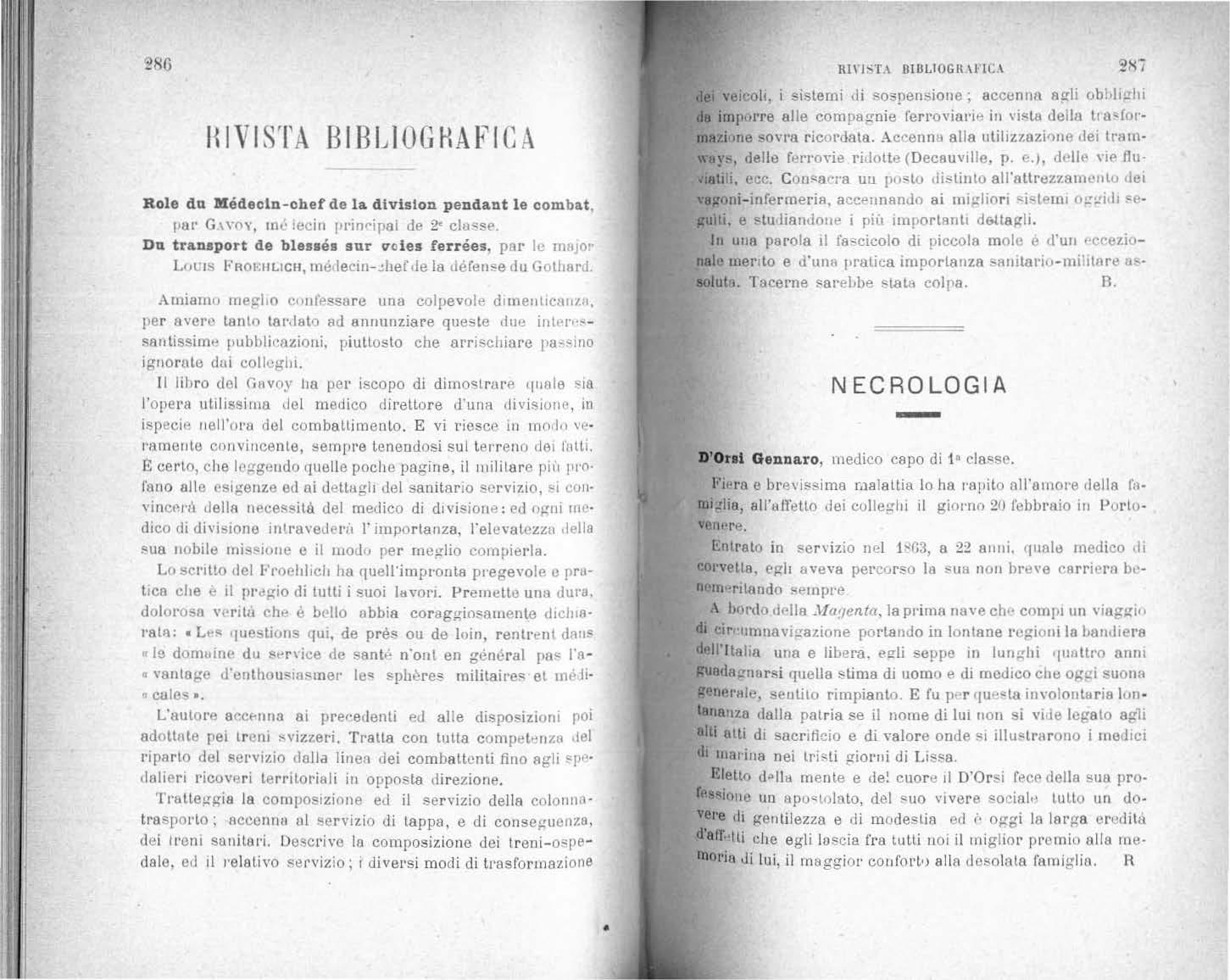
!'!:certo, C' !t e lr;.rgcudo I]UOIIc poche po.gine, il ntililare pìit pt'n· fano alle cs 1genze ed ai ùPllt:lglt tlel sanitariO servizio, -:i c.:utt· ' incl'dt .Iella n+'ces,ila del medico di dì <>tl oHtll tm·· dico di d ivisiOne inlt ·avedt:'l'11 J' importanza, deJia nubile tnb..:toue e il wo.f,, pe r me1-.dio cnu1pierla.
Lo o.;cJ'tllo elci Ft·oellliclt ha quell'impronta p1·ege,·ole o praltca elle •· il di lutti i suot l« YOI't. Premette una dut•a, dolot'O!:!Il YPritù eh... e bl'IIO ubbia coragg-io<::amenle dtclua- l'SIA: • •ruesliuns qu1, de prés ou de loin, re ntr.-nt dmt" «le domutn<> du o.; nice dc n'onl en gènéral puc:; l'a -
• \'Snlagt• ù'enthuusmsmet' le« milìlait•e« et mè liculcs •.
L'autorP ai pre,•edenti ed alle disposizioni poi adollnle pei lrl'ni :-viuert Tt·atla con lulla compt>t'"IIZH del rtpnrlo ùel SCI'\'lZIO tlalla linen Je i combattenti fino Agli srwdalil'rt t• icovP ri LPrrilot•iali in opposta direzione . la compOSIZione ed il servi zio della co lonlt.1· lra spo t•lo; Accen nu ul serviz io di tappa, e di conseguenza, dei l t• cnt !:lun ìlat·i. Desc!'ive la composizione dci treni-o;;;pedale, cd ti J•e lalivo se rviz io; i diversi modi d i lt•as form aziane
BlBLlOGI\UIC\ er \'Pt colt. i sistemi di "ospensione; acce nna Adi oht•lt!!hi da irnp.wre all e compa!('nie fert•oviat·t.., in vista delln l1 a ... fot·· rna zi t!le s0\' 1'8 r ic•ll'data. alla utilizzuzi0ne •lei tram· \\tly>-, delle ft>t'I'OYie ri,Jotte (Decau"dle, p. ••.), ,J..llt> \'lP llu· ••alt i, ccc·. C•m"ac·t·a uu po"'lo distinto all'atlrczzalttl'nlo t!ct \&goni - inferm e r ia, accennAndo ai mi!!liOrt ll!:!!i !t 'C· e <>lu liantlout" i più imporlRnll d&Has:cli.
In uua parola ti fa,cicolo di piccola moll' t' d'un •·ccezillnale mer.lo e ù'una pmlica importanza amtat•to -m ilitnrl' ,,... solut 1, lucerne stalH colpa. B .
NECROLOGI A -
D'Oul G enn aro , medico capo di 1• claF:s('.
F il' rll e r.1alatlia lo ha rupilo nll'anJot·e della f'anu ,..d ia , all'ufTetto dei 11 ginl'no 20 febbraio in P r•r loven• •re.
Enl !'alo in !"enizio nel 1-<G3, a :22 anni. qunll) medico di corvetta, e;:tlt HVe Ya pe1·corsn la "'Utt non breve r.Arriern ben 10 'ritnndo !'t>tnpt·e
\ bnt•do d•'lla Jfa,,enta, la pl'ima nave clt'· cmnpt un ,·ia:;gio di ctr portando in lontane regioni la bandtera dell'I tAlia u ua e liLera. e!!li seppe in lunghi •tunllr·o anni guadft..!nar;;i quella !'lima di uomo e dt medico chtl ogd suona llCitP.t•nfe. :;Pulito rimpianto. E fu p··r l(ll''-'ta in,·olouturìa lontanan za dalla patr ia se ti nollle di lut non si vi le legato agli alti a tti di sacrttìcio e di Yalorc onde ;<i i rned1ci dt ttt al'ina nei di Lrs!>a.
Elettr, mente e de! ti D'Or:>i rt>c.f' clelia :-;ua prort'!!«i onc un npu«tolato, del :;;uo \'tvere «o•'ia l" lullo un dovet·e d1 gentilezz a e d i modestia ed ;. oa•ri la lar rra e r l•ù ita d' l"O t"
811' •lli clte egli ]a !>CÌa fra tu tti 1101 il rni gl iOI' pt'Otnio alla ll1 tltno l'ia Ji lu i, il rn aggiM conforl•) alla desolata famiglia. R
Monarl oav Oreate, lenente cc•lonnello m edico.
Il gPnnaio cessava di vivere il ùoU. cav. Orf'ste ì\lonar1, diJ·eUore di'Ilo spedale mil ilare di Brescia'.
Nato o Ra,·enna nel 1836, cominciò di buon o ra la c11rriera nwdi co mllilat•e, arruolando-.i nel giugno tra i volon ta1·i bolo.!nt!"l Pre::-e parte alla campagna dt>l 185!1 e del txr.G. Era riPIIo spedale di Brescia nel giu!!no
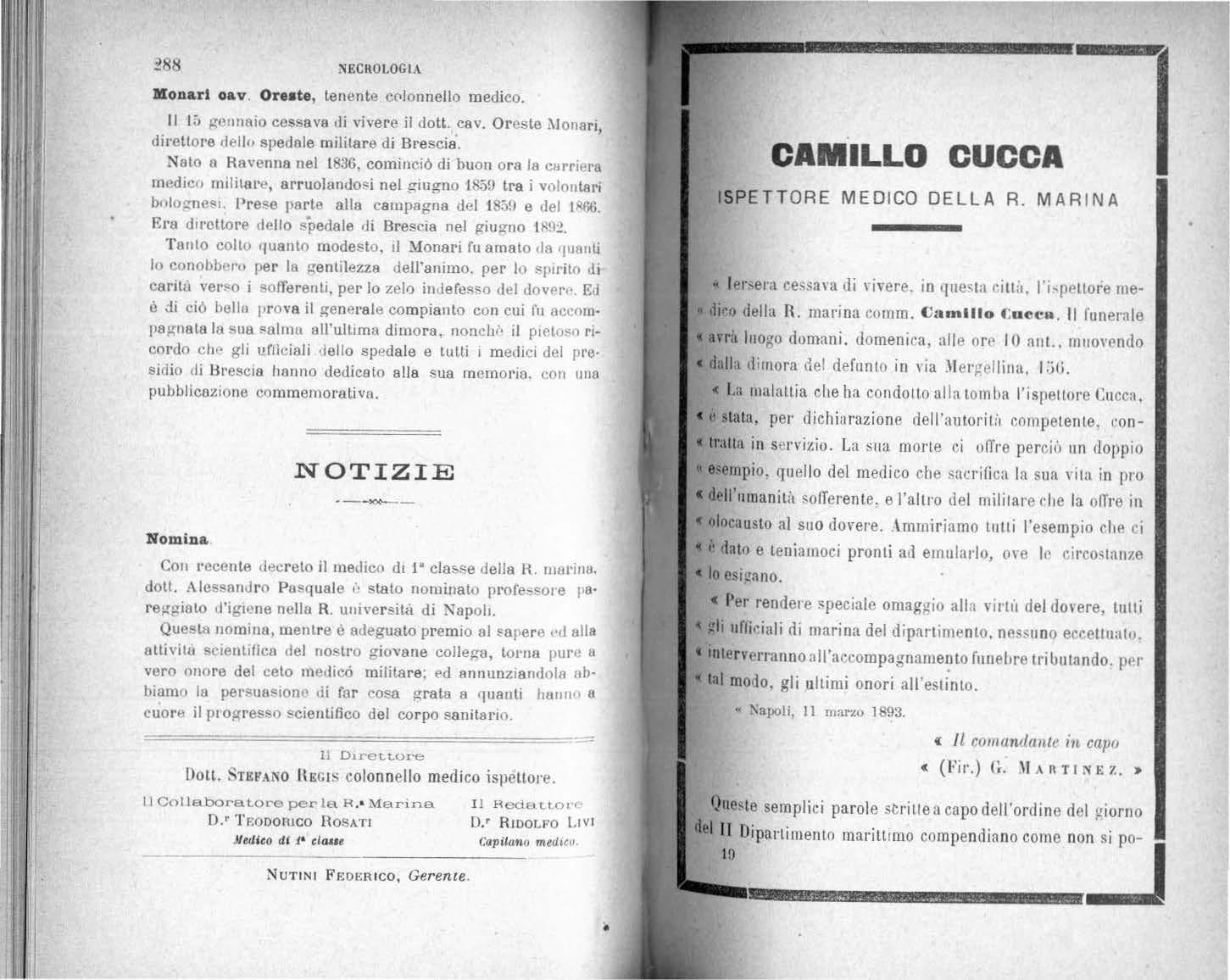
T onto collo 'Juanlo modesto, il Monari ru amato da 'flllln ti lo conohbe1'o pe r la. gentilezza tlell'animo. per lo Ji caritu verso i "offerenti, per lo zelo in del dovf'r l'. E.J ò ,li ciò helln prova il generale com pianto con cui ru accomsua all'ultJma dimora, nonchi• il rtcordo ch" gli uflìciali dello spPdale e tutti 1 m edic t ùel pro· siùio di l:kescia hanno dedicato alla merno1•ia, t'Oli ttrto pubblicazione cQm m emorativa.
Notizie
Nomin a.
Con t•eccute decreto il medico dt 1• clas:<e della H. lluu·iua. doli. Pa squale •· stato nominato 1•a · tl'igwne nella R. uui,·er sitil di Xapolr.
Questll nornma, adeguato pr emio al ere o•d alla alli\'itu scientifica del nostro giovane collega, tor·na pure u vero onore del celo medico militare; t'd annunz •and ola ub· bramo la tii far <'osa a 'lUanti haun•> a il pr ogres$n "Cienlifico del co rpo sanilarro.
L. D1ret.t.ore lJ Co Ila bo t'a t.OI:'O per la R • Marina
Dott. STEliANO HEGt s colonn ello medi co ispellore.
D.• TP.oooRJco RoSATI
Medico di 1• claut
FE DER ICO, Gerente.
Ca Millo Cucca
I SPETT ORE MEDICO DELLA R . MARINA
.. ressa\a di' ivere. in que , ta t'ill:'•· l'i-.pPtlore me•li··o clelia B. marina eom m. Carn ll l o Il funerale c avr;'t luogo domani. ùomenira, allr ore l O an t .. lllltOYf'ndo c dall a dimora del defunto in ,·i a 31 er·gel liua. l :;o.
« La malaLtia che ha condotto alla tomha l'ispettor·e Cucca, c t' stata, per dichiarazione rlell'autorilii competente, conc lralta in SHvizio. La sua morte ci olTre perciù un doppio l' quello del medico chP -;acrilica la sua 't la in pro c dell ' uma nitit !'Offerente. e l'altro del mililare diC la oll'l·e m «oloca usto al suo dovere . ..tmmi r iamo tutti l'esempio cliP t·i
« i• tlato e teniamoci pronti ad emularlo, <n-e h• cir·co,tanze c lo
« Per rendere :-peciale omaggio alla rinù del ùorere, tuili c f!l i uffì.-iali di marina del dipart ime nto, nc<;suno ecrellnato. • inten m-anno fnneltre tri uuta ndo. pel'
« tal mo1lo. gli u ltimi onori all'estinto.
« Il mar-Lo 1893.
« l l romandanlt• i n cap11
« (Fir.) \I ARTINEZ. »
IJ
D.• RlOOLF O LtV I Capitano meduo sempliri parole sc ritlea capo dell'onlino dol giorno del Il Dipartimento maritt 1mo compendiano come non s i poI!) tt·eobe meglio la stima alussima, universale che godeva C.' amlllo C:::ueca , il profondo lutto che la morte di lui ha sparso in tulli i corpi della marina. l. · · r essn
Raro esempio d'uòrno in tempi impuri, può senza sospetto dirsi di lui ch'egli possedera tutta la j!r·ande virtit dell't'-.-.ert> se nza la mistificazioue del parere.
F. gli alli della sua Yita di studioso. colto, mode!-lO, di lavoratore infat icabile e meùico paternamente sono incancellabili nella memor·ia di quanti lo elthrro coed ebbero ricorso al suo in telligente e sapiente t•o nsig lio.
!)'indo le mite, di mente etJ Uilibrata e di carattere ,;aldo, eg li fu il tipo del medico e ùe l militare. .
Addottoratosi in medi cina e chirurgia nel classico Ateneo napol etano. entrò. chirurgo requisito, nel 1859 a far parte di !JUCI corpo sa nitario della marina che ha lasciato tanto nome di sè per valore d'uomini alla scienza. .
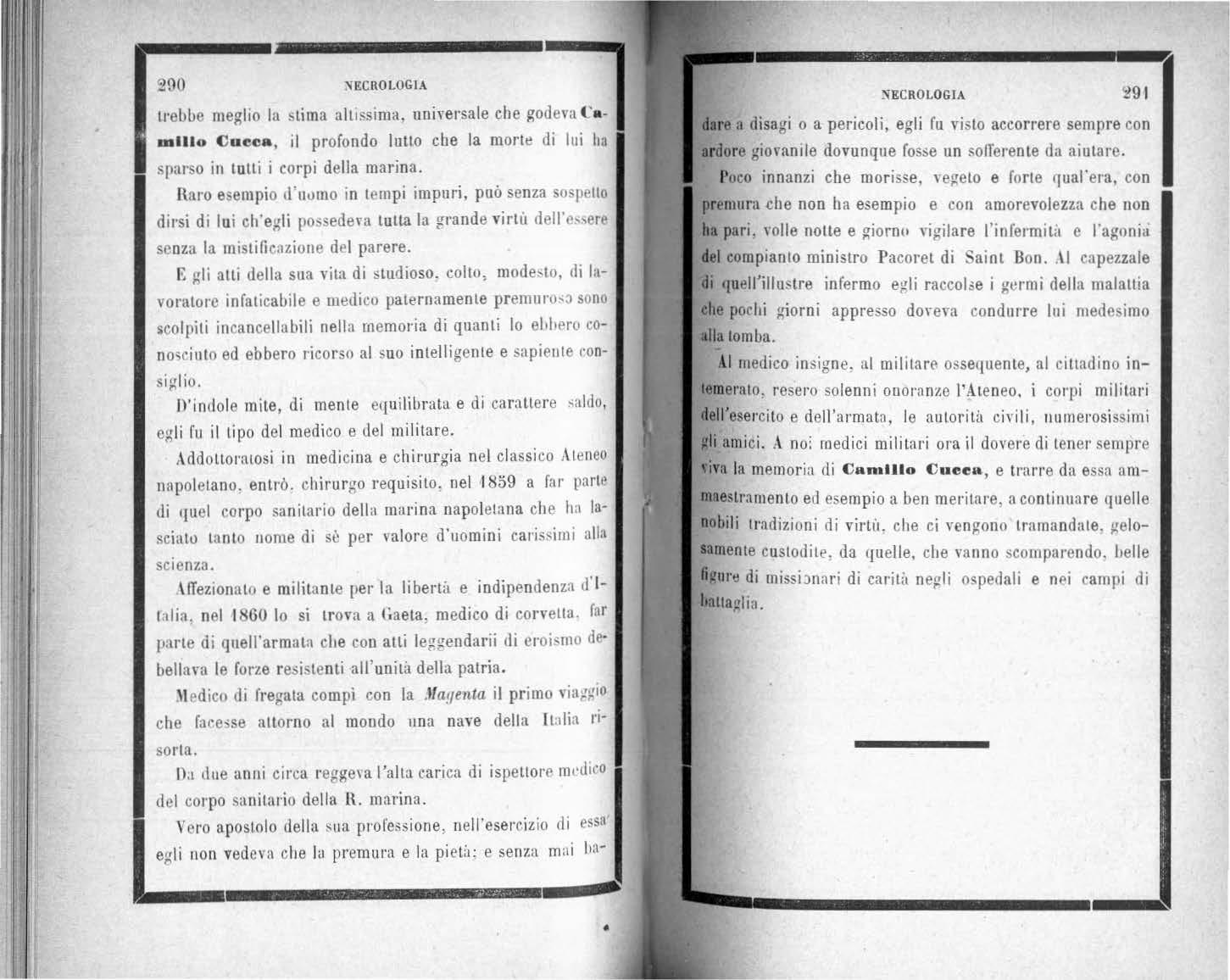
\ fTezion aw e militante per la libertà e indipendenza d ll d in. nel 1 60 lo si t rova a medico di co rv ella. far parte à i quell'ar mata che con alli leggendari i di de· bella va le forze r esi ·ten ti all ' un ità della patria.
\l edico di fregata compi con la Jl a!fenta il primo via;t!Ì.0 che farcsse attorno al mondo una nave della ltalia nsorta.
Ila due ann i ci rca regge\ a l'a l la carica di ispettore nwtlu·o del co rpo sa nitario de ll a H.. marina.
\' ero apostolo della sua nel eserciZIO c 1 errli non vedeva che la pr emura e la pieLil: e senza mni dare a disagi o a pericoli, egli fu visto acco rr ere sempre co n ardore giovanile dovunque fosse un sofTerente ùa aiu tare . l'oco innanzi cbe morisse, e forte qual' era, co n prem ura cbe non ha esempio e con amorevolezza che non ha pari. rolle notte e giorni• vigilare l'infermita c l'agonia del compian to ministro Pacoret di Saint Bon . .\ 1 capezzale di 'luell 'illusLre infermo raccol3e i germi della malallia che pochi h>iorni appresso dorera co ndurre lni medesimo alla tomb a.
Al medi co insigne. al militare ossequente, al cittad in o intemerato. resero sol enni onoranze l'Ateneo. i corpi militari dell'eserci to e dell'armatn, le autorità civili, uumerosi ss imi gli ami ci. A no: 1aedici militari ora il dovere di tener sempre \"ÌVa la mem oria di Camillo c:::u.,ea , e t1·arre da essa ammaestramento etl esempio a ben meritare , a continuare q uelle nobili tl'a dizi oni di virtù. che ci vengono trama nd ate. ge losamente custodite. ùa quelle, che vanno scomparendo. belle di missbnar i di caritit ne;di ospedali e nPi campi di batta,::! w.
Resezi One Total E
Lettura fatta :tlla confcronzn ,cicntiUcu. •lrl !l !(ennaio 1893 nello spc•lnlc mililnro fil Firl'llZl' cl al dott•>r Gio v .4.nlonio P e ra ,.;. capllltnu nw•llro frattura complicnta ùell'astragalo, la cni diagno,;i di solitu •· patente. la •Jue=-tione che snbito s'nfTaccia è quella del l'amp ulazione o della resezione, secondo la gravitit ùet ru asti delle pani molli, e l'estensione dello sche;.rgiamento dei r.api articolari. l m·ero colla resezione sotto-capsulo-periosl('a. applicando le nurme ni un severo metodo antisettico, -i oltenHt' una erie di felici risultamenti .. tanto che si disse che con tale operazi,)ne l'infermo non compera la vita al prezzo di u na lllutila zione ma essa vie ne conservnta assieme ulteriore de ll ' ur to reseca to. Ed il Koenig . do po aver aeccnnato ehe ezianù io nelle fra ll ure complicate e lesioni per an na d<t fuoco del piede, la resezione dar'à migli ori risultati che nef passato, mediante l'uso della medicazione anti5ettica, aggiunge che questa medicazione in una guerra futura farà diminuire di molto l' importanza della resezi one stessa.
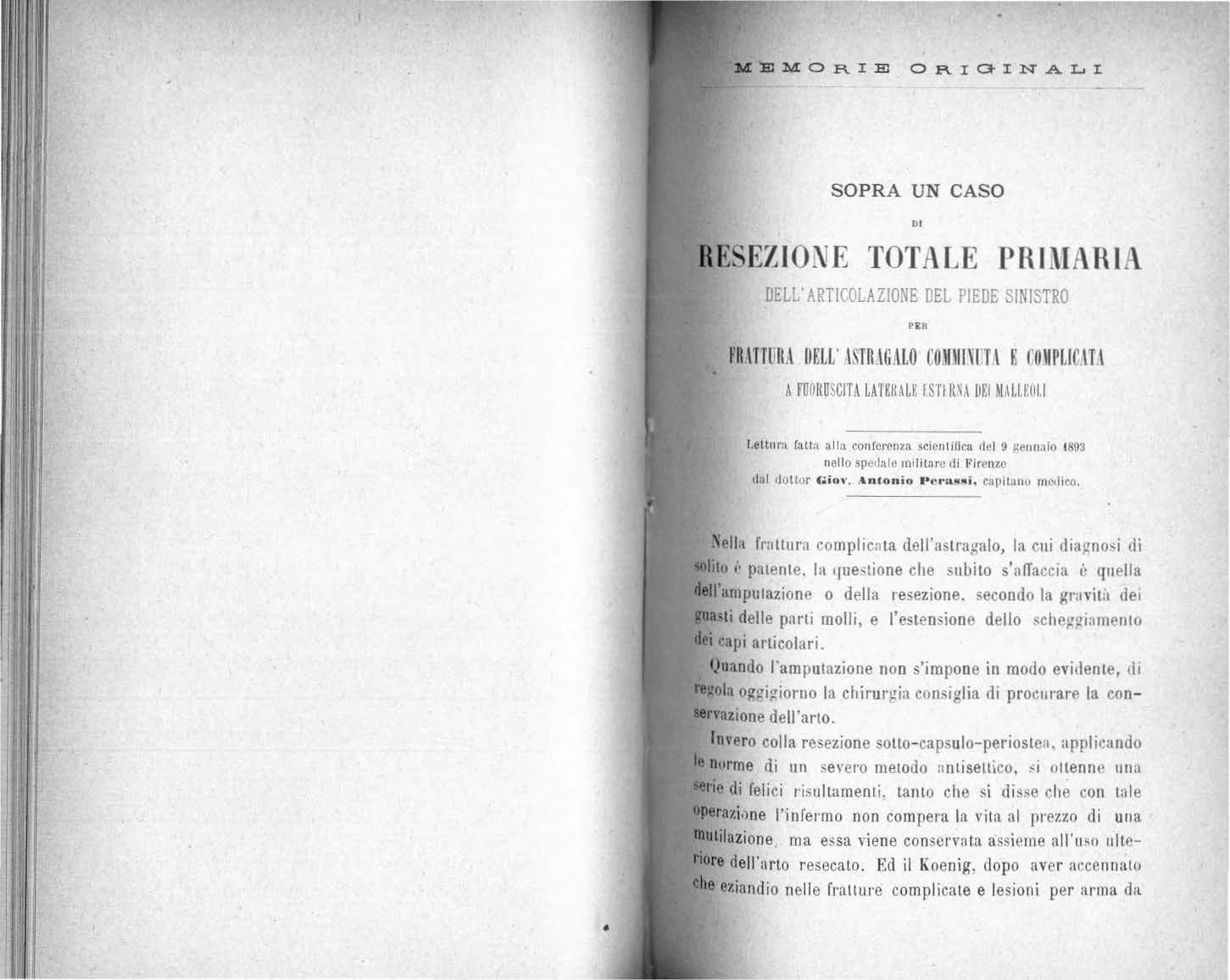
IJuando l'amputazione no n s'impone in modo evidente, tli feJ!o la la chirurgia con,.iglia òi procurare la conaervaztone dell'ar·to.
Limitando la questione ai soli lraumatismi nei quali si protlusgero ferite penetranti nell 'at"licolaz ione del piede ron frattura dell'ast ragalo , dirò che in due casi di tali lesioni. precedentemente osservati nella pratica chimrgicn militare, io consegnrnza di cadute da cavallo. la cura seuza resezione. nonostante le cautele riuscì lullaria infruttuc.sa , e s i dovette in secondo tempo pratica re l'amputazione della Negli accennati casi si co nstatò che la guarigione non fu conseguit a. l'astr·agalo fralluraLo c disgiunto in gran parte dai propn mezzi legamentosi e nutritizi. era stato co lpito da rarie ne· crotira.
Qu e-;te antecedenti O'Senazioni infl uirono utilmente a deterininare l'indiriLzo operativo nel ca 'O, di cui :,'intrapr·ende nna -; ucr inta relazione.
L'appuntalo Feliziani Au l-(o lo del reggime nto cavalleria Mont e bello , in età d'anni 3-i., ... dotato di robusta costi tuzi one organi ca . co n temperamento e malallie pregresse de).!ne di nota.
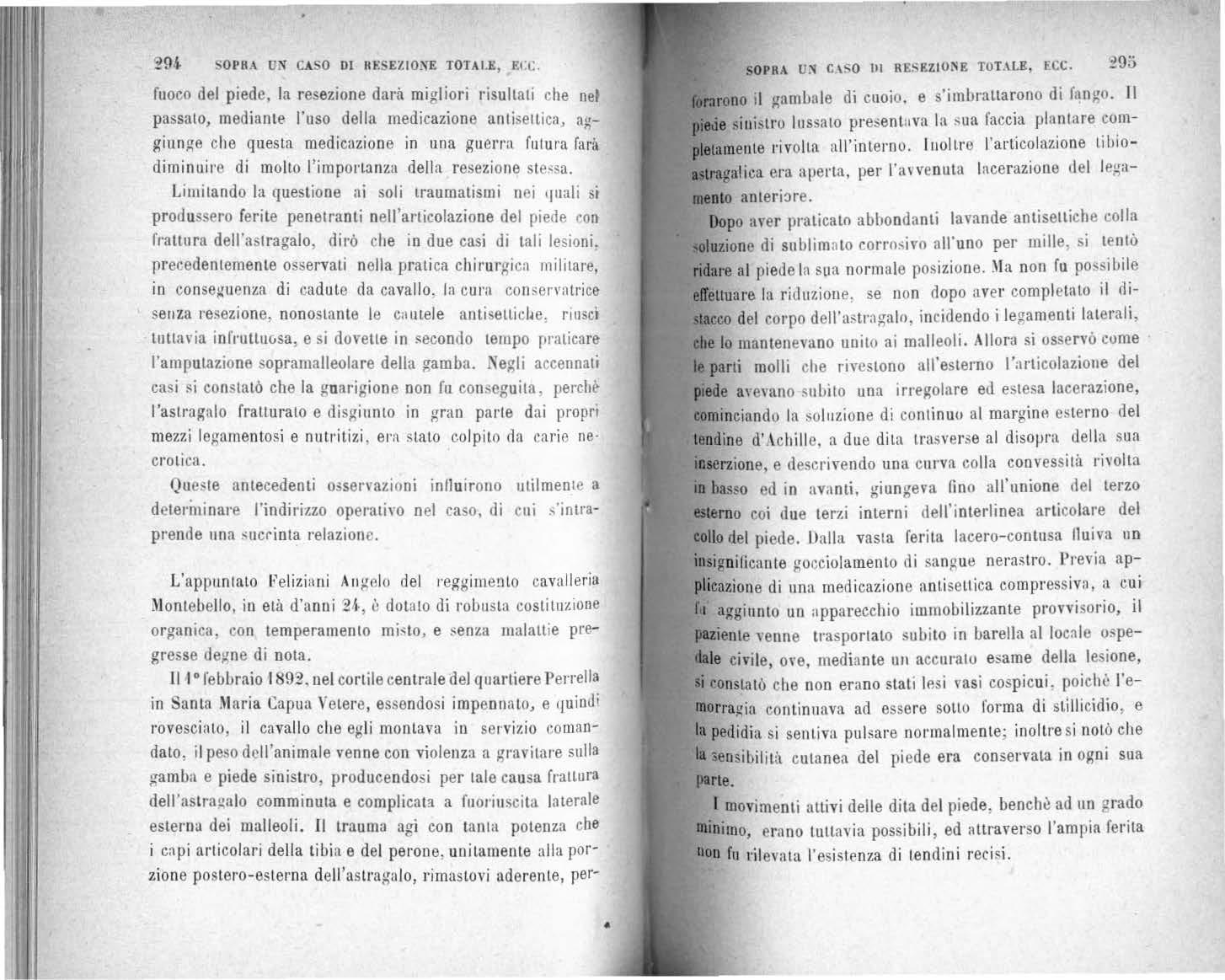
Ili o feburnio 189:2, nel co rtil e centrale del quartiere Perrella in Santo Maria Capua Vetere , e ssendosi impenn a to, e quindi rovesciato, il cavallo elle eg li montava in se rvir.io co mandato, il peso d ell ' animale venne con vi olenza a gravitare sulla gamba e piede sinistro, producendosi per taio ca usa frattura dell'as t ra!.ta lo comminuta e com pli cata a fuoriuscita laterale esterna dei malleoli. Il trauma agi co n tanta potenza che i cnpi ar·ticolari della tibia e del perone , unitamente alla porzione postero-esterna dell 'astragalo, rimastovi aderente, per- l movim enti attivi delle dita del piede, ben chè ad un j!rado minim o, rrano tuttavia possibili, ed attraverso l'ampia ferita non fu ril evata l'esistenza di tendini f risullati cl eli'esame dircltt•, roo val itinti dal cri tet·to riH• tt·;tltavasi di rnhu:->to. in eta giovane, e nt!lla pie· npua dei poteri 'i tali. portarono alla ronclu.,ioue rhe in primo tempo fo..;s e indicato agire coi tuew ,Jall l'it irurgia con:-;ervatrice. Senta indugio il pazt en te fu dlll'o lor·mizzato. e dopo a\·er pmticulo l'emo.-aasia prHettttva ti dlirnrgo primario dott. l'a olin o rnlla coctpetat.iontdcllo :>crivente. procedeue alla re,;ezione sottoperios'l'a dt't malleoli e dell'an•u mallaolar·<'. n poco pitt Ili un rt>ntnnetru al della su:t su perlic·ie articolare. Furono quiudi ri· le scheggia dt'il'astragalo aderenti ultur._o, e. non qualche clillii'OitiL -.i riu sd colle furLici ri ,·un e J't' !.!Qiar izzare la '-II!Jerlicil' di frallura del frammento an tero- interno, riulilsto sol id :mten te nn ito al gno P allo scafoide. in spp,·ial wodo per mezzo del le).!a merlln intertarsico. Ce.-hata la comp ression e elastica circolare. d• 'ettero allacciare tlue sottili arterie sottoruta nce: e s1 pruapplicando. nella prolondit;t del c:ampo operatof'Ìt. un ' ansa di tuLo :1 drenaggio, le cui t•stremitit sporgr\;1111) agli angoli della ferila c·utauea. la qu ale \COlle :;uturala. In ultimo l'arto fu aM.giato "opm un 'emicanale eli filo metallwo. provvi.;to di pedale ad an!!olo rello, co llo scopo d'im· nHJhilizzat·e il piede in posizione all a gamha. 1:o0però :1 tal fine l'u:-.o tlelln rnedicazwne nntiseLtica cumpressi\a.
0 11 gambale di cuoio. e s' imbrattarono di fango. Il piede siuistro lussa to presentava la :;u a fa cci.a fJia.ntare pletamenle riv oltrt all'interno. Inoltre tdiiOutragali ca era aperta , per l'aHeouta laceraztone del legamento anteriore.
Dopo aver prati ca to abbo ndanti lavande antisettiche rolla soluzi one di snblim nto connsivo all' uno per mille. si tentò ridare al piede In sua normal e posizione. 'f a non fu possiuile effeuuare la riduzione. se non dopo aver completalo il distacco del corpo incidendo i lat erali, cbe lo manten eYano unito ai malleoli. Allora si osservò co me le parti molli che ri\'estono all'esterno l'articolazione del ptede a\ cvano ;;nbito una rrregolare eù estesa la cerazione, cominciando la so luzione di co ntinu<t al margino esterno del tendin e d' \ chili c, n du e dita trasver se al disoJJr·a della s ua ilserz io ne, e descrivendo una curva co lla con,•essittl rivolta ID basso ed in ava nti , giu nge va fino all'unione del terzo estern o coi due terzi interni delf'i nte rlinea ar ti colare del collo del piede. Dalla vas ta ferita lacero - contu sa fluiva un gocciolamento di sangue nerastro. Previa applicar.ione di nna medicazion e antise ttica compressivn, a cui h aggiunto un apparecchio immobilizzante pr·ovvisorio, il paziente 'enn e traspo rtato sul.Ji to in barella al loca le o:>pedale civ ile, O\'e, mediante llll accurato esame della lesione, si rons tatò che non erano stati les i vasi cospicui. poi chè l' emorragia continuava ad essere souo forma di stillicidio, e la pedidi a si sentiva pulsare normalmente; inoltre si notò che la :;ensibil itit cutanea del piede era conservata in ogni sua parte.
Il decorso e l' «htlo ùell ' operaziCine fu f. a ' ' ore' oli. ne Hrificaron:Si complicanze di rilievo. primo 't'Lleunriu insorse una rear.ionl' fehbrilo a t1po continuo remillent\'. tlon mai superiore a 39 gradi e mezzo. nel settt·nario la temperatura pin alta fu cii 38,:1'', poscia si elthe completa. La vasw soluzione di comi n uo cicalrizr.il in gran parte per prima intenzione. eccezione fatm un tratto ver:;o il centro. ove era stata l'al· ne dell e ossa lus.;ate parti molli: quivi comparn gau;.:renosa. avente le tlimen•iuni di una moneta da die ri centesimi. e per tal t•au'a fu r'tardata alquanto l.t parigi one. ollenutasi colla formazi one di una cicatrice uen consolidata , dop o ottanta tlalla prati ca ta reser.ione. In st';.:nito !ii perm ise all'operaio tli graduali e progrt>ssiçi e:.ercizi, prirua col .;u,sidio tlede e poscw di un bastone. per al•itual'e l'arto re3ecato a sosteaere il del corpo. Erano lrascorsi tr t> mesi e mezzo. quand o fu abbandonato ogni sostegno, erl uni ,·amente coll'u:>o dJ u na s,•ttrpa speciaiP che compensa, co n Ull tacco piu alto. il racco1·ciamenlo dell'arto leso. e sostiene lateralmente il collo del ptede, (m ediante una staffa di lamiera), la deambnlaziooe polt\ efTt>lluarsi abbastanza speditament e. ma con claudir.azione.
Tale disturb o funzionale era pro\'Ocato in particolar modo da nn!l sensazione dolorosa di :;tiramento, rhe insorgeva in corr ispond enza della parte mediana clell.t ricatnce, ore la presentava.;;i retraua, infossata ed aderente allo achc>lelrn sottostante. Per modificare effetti dell'ad erenza cicatriziale, si giutlicù opponuno sperimentare l'applicazione delle fangature. e snccessi1•amen te alla curn term:1le, prati cata nello stn l1ilimento halneo-milit:H·e d'lschin, doraute la quinta muta, ::;i manifestò uo notevole e progt'Ps•ivo mi;.dioramenlo. poichi• la parte retratta della cicalrice »i rese meno aderente, la locomozione divenne sc mprC' piìt libera, e meno vistosa In claudicaz ion e. t 'esame diretto dell'arto resecato, dieci mesi dopo l'av· venuto tr. umathmo, fa ricollo5cere un rac corciameuto non superiore a dne centimetri. La circ·ooferenza del polpaccio sin istro rlill'erisce in meno cla quella del destro di ap- pena un ce ntimetro. rl piede non è alterato nella sua forma. nè fta subìto diminuzione alcuna nella sua larghezza: pero vie ne appoggiato al suolo alquanto in P malgrado l'esiste nza di limitati movimenti e pas:;in, che ,-i e!Tett uano pressochè io modo in corrispondenza dell'articolazione resecata, tutLavia il piede no11 ra,!!,!!iunge l'anjZolo rello esallamente. La motilita delle dita sOl'I\A vN CA O DI IIESEZIO'IE fOf\LE , ECC. 29t) alla 1ecrione dorsale del piede: invece si produre a l. l'altezza di du e briglie cicatriziali, situate l'nna al davantr 1 l' altra all'i ndiet ro del malleolo esterno resecato . un assai lieYe t' circoscr·itto edema cutaneo, \'Pt·osimil mt•nte suscet· tihile di scomparire col tempo. è co nserv nta ad un grado quasi normal e . An che quando la stazi one ere lla è prolungata, non 5i osserva tra ccia alcuna d'i nlìltr·azione edematosa alla metà interna della ,amba e

19g SO PRA UN CASO DI RESEZIONE TOTALE, ECC.
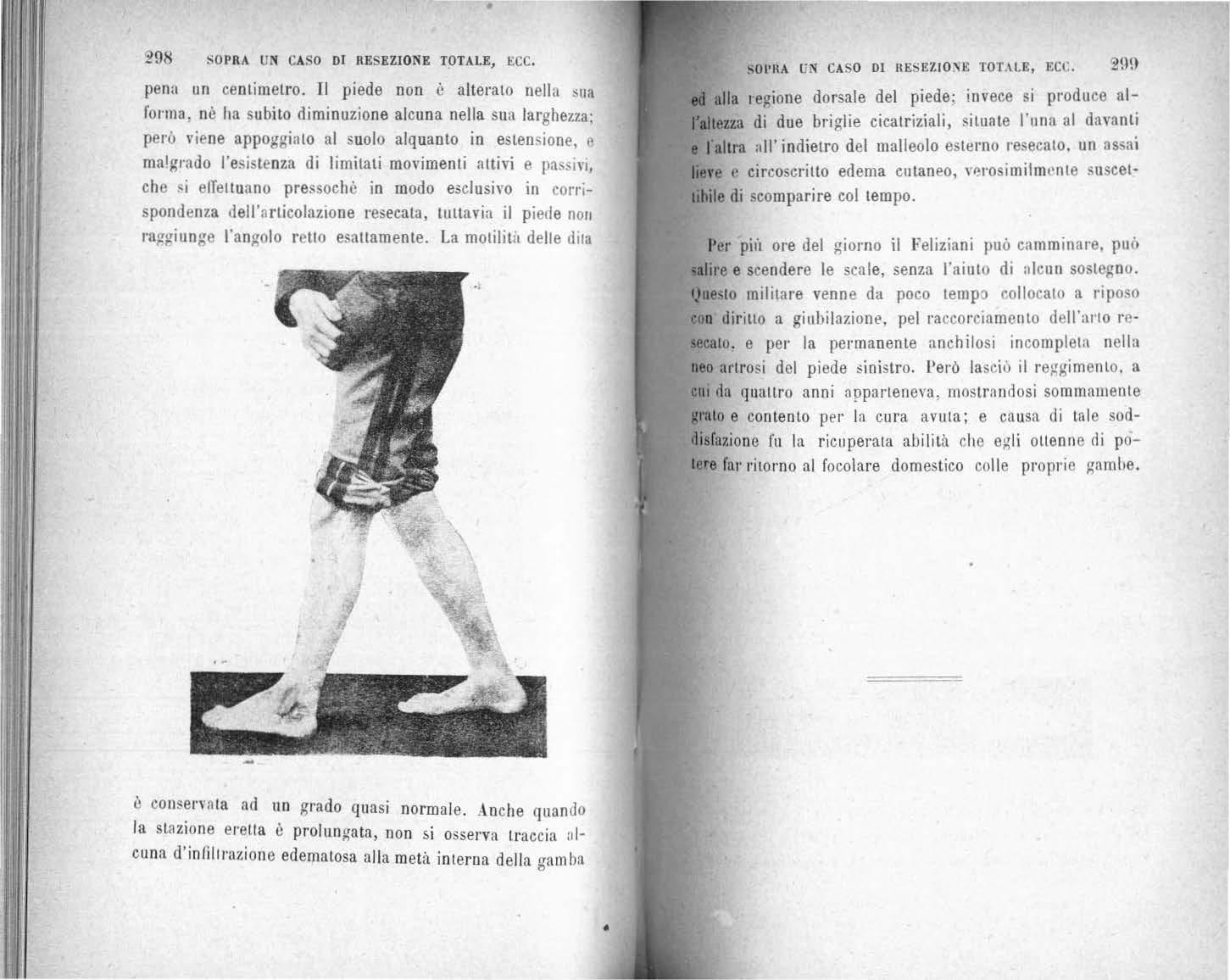
Pt>r più ore del giorno il Feliziani può camminare, può salire e scendere le scal e, senza l'aiuto di alcun sostegno. Questo militare venne da poco temp:> collocato a riposo coo diritto a giubilazione, pel raccorriamcnto dell'arto resecatu. o per la permanente anchi losi incompleta nella neo del piede sinistro . l 'arò lasciò il re).:gimento. a cut tla quallro anni nppartene\'a. mostr:mtlosi so mm amente grato e co ntento per la cu r a avuta; e causa di tale soddisfazi one fn la ri cup erata abilità che egli ollennc di potere far ritomo al focolare domestico colle proprio gamhe .










