







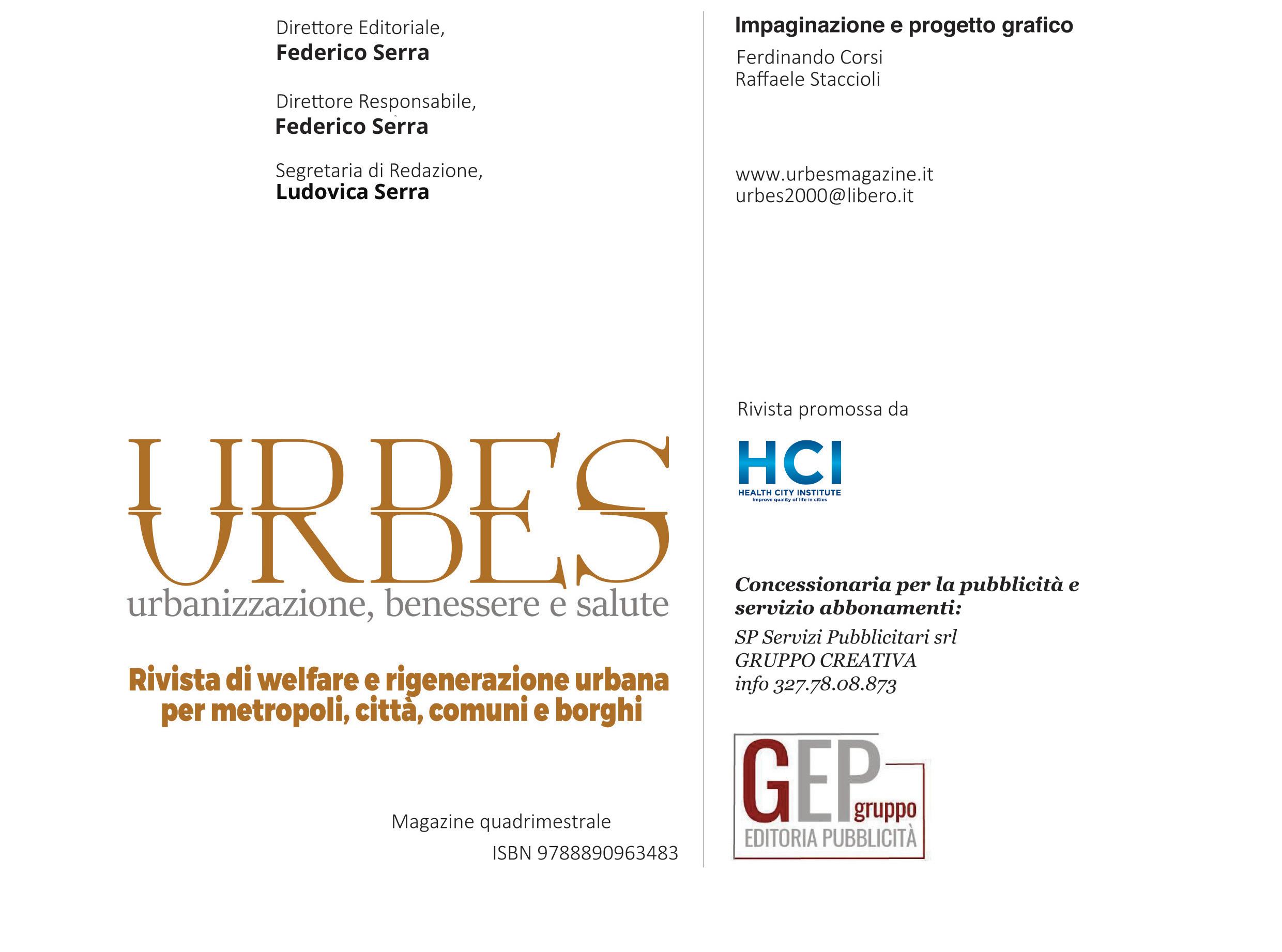
Promosso da: https://www.urbesmagazine.it/ https://healthcityinstitute.com/


di Federico Serra
Viviamo in un’epoca in cui la velocità delle trasformazioni economiche, tecnologiche e culturali sembra superare la nostra capacità di comprenderle. In questo vortice di cambiamento, il concetto di bene comune rischia di essere relegato a un’astrazione nobile, ma distante. Eppure, esso rappresenta una delle idee più antiche e, allo stesso tempo, più rivoluzionarie della convivenza umana: l’idea che esistano risorse, valori e diritti che appartengono a tutti e che, proprio per questo, devono essere custoditi e tramandati.
Il bene comune non è semplicemente la somma dei beni individuali, né coincide con l’interesse della maggioranza del momento. È piuttosto ciò che rende possibile la vita in comune: l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, il patrimonio naturale e culturale che ereditiamo, ma anche il sistema sanitario, la scuola pubblica, la giustizia, la sicurezza sociale. Non si tratta solo di cose, ma di condizioni: l’equità, la coesione sociale, la pace civile.
Un tratto distintivo del bene comune è la sua intrinseca fragilità. A differenza della proprietà privata, che può essere difesa dal singolo, il bene comune è vulnerabile perché dipende dalla cura condivisa. Senza attenzione e partecipazione, si degrada. La sua tutela esige una logica opposta a quella del consumo immediato: richiede visione, lungimiranza, e soprattutto la capacità di rinunciare a qualcosa oggi per garantire a tutti, domani, le stesse possibilità.
Troppo spesso, però, assistiamo a una distorsione pericolosa: la riduzione del bene comune a slogan politico o a strumento retorico. In realtà, esso è un concetto esigente: obbliga a mettere in discussione vantaggi personali se questi danneggiano il tessuto collettivo; impone scelte politiche e amministrative che vadano
oltre l’orizzonte elettorale; sollecita i cittadini a non considerarsi semplici utenti di servizi, ma co-proprietari di un patrimonio comune.
Il bene comune è anche memoria viva. Ogni città, ogni comunità lo incarna in luoghi, tradizioni, storie che ci raccontano chi siamo e come siamo arrivati fin qui. Abbandonare queste radici significa impoverire non solo il paesaggio urbano o naturale, ma anche il nostro immaginario e la nostra identità.
In un tempo in cui il linguaggio della competizione sembra dominare, il bene comune ci ricorda che la cooperazione non è una scelta opzionale, ma la condizione stessa della sopravvivenza e del progresso. Proteggere un parco cittadino, ridurre le disuguaglianze sanitarie, difendere la libertà di stampa o garantire l’accesso universale alla conoscenza non sono atti di generosità: sono investimenti sulla qualità della nostra vita collettiva.
Il bene comune, dunque, non è un concetto statico. È un processo in divenire, che si costruisce ogni giorno attraverso le decisioni delle istituzioni e i comportamenti dei cittadini. Non basta proclamarlo: bisogna praticarlo. Significa informarsi prima di votare, ridurre il proprio impatto ambientale, partecipare a un’assemblea di quartiere, vigilare sull’uso delle risorse pubbliche.
In definitiva, il bene comune è la casa di tutti: possiamo abitarla solo se impariamo a prendercene cura insieme. Se non lo facciamo, non solo la casa cadrà in rovina, ma ci ritroveremo ciascuno fuori dalla porta, soli, a rimpiangere ciò che avremmo potuto proteggere.
EDITORIALE
AGORÀ
ZIBALDONE
IN PUNTA DI PENNA
CITTADINI
FOCUS ON SOCRATIC DIALOGUE
SPIGOLATURE
CURARE E PRENDERSI CURA
IL VASO DI PANDORA
RECENSIONI
TAKE AWAY
PENSIONATI ITALIANI
RAINBOW VILLAGE
LE REGGE
VIA FRANCIGENA
NEW YORK SKY
CITTÀ PIÙ STRANE AL MONDO
LA CASA DEL POSTINO
CITTÀ DOVE SI MANGIA MEGLIO
ISOLA SELVAGGIA
10.9 ST MICHAELS
CITIES +
11 ESPANSIONE URBANA
SCIENCE FOR CITIES
LA SCIENZA COME VEICOLO DI SAPERE NEI CONTESTI URBANI
URBES DIALOGUE

15 ANNI DI “ECONOMY FOR THE COMMON GOOD” — UN TRAGUARDO E UNO SLANCIO
VERSO UN MODELLO ITALIANO DI “HEALTH FOR THE COMMON GOOD”
METABOLISMO URBANO
YMCA BENE COMUNE
YMCA GIOVANI

AREE INTERNE
MANIFESTO AREE INTERNE
SONDAGGIO
APPELLO DEI VESCOVI
AMERICA RURALE
VIAGGIO TRA I BORGHI
CITTÀ
WORLD CITY DAY E GIORNATA DU SENSIBILIZZAZIONE
MANIFESTO SALUTE NELLE CITTÀ
CATANIA
BOLOGNA
MILANO SUPERICCHI
NEW YORK FIRE ESCAPE
APPUNTI DI VIAGGIO
TORONTO E NIAGARA
BOSTON
WASHINGTON
TURKS & CAICOS
MIAMI
NEW YORK
ARTICOLI
CONGRESSO EHA 2025
LEGGE OBESITÀ
RAPPORTO ISTAT
L’ACQUA CHE RIVELA L’ANIMA DI UN’EPOCA
IL CONTRIBUTO QUALITATIVO DELL’HEALTH CITY MANAGER
CITTADINI PROTAGONISTI DEL BENESSERE COLLETTIVO
DA ARISTOTELE ALLA COSTITUZIONE
MILANO E HINTERLAND, LA NUOVA FRONTIERA DELLA LONGEVITÀ
ADVERTISING
MULTIPLA
REGIA CONGRESSI
LAST MILE
SIDEA
STREAMLIVEEVENTS
Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri

La storia del nostro Paese è segnata da una straordinaria capacità di coniugare creatività e ingegno, bellezza e innovazione. La celebre definizione dell’Italia come “popolo di santi, poeti e navigatori” ha accompagnato nei secoli la rappresentazione della nostra identità culturale e civile. Oggi, nel XXI secolo, a questa immagine occorre aggiungere con convinzione un nuovo pilastro: l’Italia come popolo di ricercatori.
La ricerca scientifica rappresenta infatti la condizione necessaria per il progresso economico, sociale e sanitario di una nazione. Essa non è più un ambito specialistico riservato agli addetti ai lavori, ma un patrimonio strategico che tocca la vita quotidiana dei cittadini: dalla salute alla transizione ecologica, dall’innovazione tecnologica alla sicurezza alimentare, fino alla sostenibilità dei sistemi di welfare.
Il contributo delle ricercatrici e dei ricercatori italiani è riconosciuto a livello internazionale: nonostante risorse limitate e un contesto spesso sfavorevole, l’Italia continua a esprimere punte di eccellenza che si collocano ai vertici della comunità scientifica mondiale. Un capitale umano e intellettuale che costituisce una delle più importanti ricchezze del Paese, al pari del patrimonio artistico, storico e culturale.
È dunque doveroso ribadire che la ricerca non rappresenta un costo accessorio, ma un investimento strategico sul futuro. Senza ricerca non vi è innovazione, non vi è competitività, non vi è crescita. E, soprattutto, senza ricerca non vi è salute né equità sociale.
In questo senso, la responsabilità delle istituzioni è
chiara: garantire stabilità e continuità ai finanziamenti, rafforzare le carriere dei giovani, sostenere il rientro dei talenti formatisi all’estero, favorire la collaborazione tra pubblico e privato. La sfida che ci attende è quella di costruire un ecosistema della conoscenza che sia capace di valorizzare il merito, di promuovere l’interdisciplinarità e di consolidare il ruolo dell’Italia nello scenario scientifico globale.
Se l’Italia è stata e continua a essere patria di santi, poeti e navigatori, oggi essa deve diventare, con pari dignità, patria di ricercatori. Solo così potremo consegnare alle future generazioni un Paese non soltanto custode del proprio passato, ma anche protagonista del proprio futuro.

di Frederick Greenhouse
“La città non è un luogo, è un modo di essere insieme.”
Lewis Mumford, The Culture of Cities (1938)
Le città sono nate come comunità prima ancora che come infrastrutture. Erano luoghi di scambio, di incontro, di mutuo riconoscimento. Oggi, nel pieno della crisi ecologica e sociale del XXI secolo, riscoprire il valore della comunità come bene comune non è un atto di nostalgia, ma un’urgenza politica e morale.
Negli ultimi decenni, l’urbanizzazione ha generato benessere e innovazione, ma anche solitudini nuove e disuguaglianze più profonde. Abbiamo costruito quartieri iperconnessi, ma spesso scollegati dalle persone che li abitano. Lo spazio urbano, che dovrebbe essere il luogo del “noi”, si è fatto dominio del “mio”: il condominio al posto del vicinato, il consumo al posto della condivisione.
Rimettere al centro il bene comune significa invertire questa deriva. Significa riconoscere che la città non appartiene a chi la possiede, ma a chi la vive, la attraversa, la custodisce. È un’idea antica, che risuona nelle parole di Aristotele, quando definiva la polis come “comunità di liberi uguali che vivono per un bene comune”. Ed è un’idea che oggi ritrova nuova forza nei movimenti urbani di cittadinanza attiva: nei patti di collaborazione di Bologna, che hanno trasformato giardini abbandonati in spazi condivisi; nei bilanci partecipativi di Milano e Torino, dove i cittadini decidono come destinare parte delle risorse comunali; nei laboratori di quartiere di Barcellona, che sperimentano una governance cooperativa tra abitanti e istituzioni.
“Il bene comune non è ciò che resta quando tutti hanno preso la loro parte, ma ciò che cresce quando tutti partecipano.”
Elinor Ostrom, Premio Nobel per l’Economia 2009
L’economista americana ci ha insegnato che i beni comuni — l’acqua, i parchi, l’informazione, la salute — non si proteggono con la proprietà privata né con l’amministrazione centralizzata, ma con la partecipazione condivisa. È una lezione che le città devono tornare a imparare. Ogni volta che un gruppo di cittadini decide di rigenerare una biblioteca, piantare un orto urbano o condividere energie rinnovabili di quartiere, costruisce un frammento di futuro.
Pensiamo a Parigi, dove la “Cité du Réemploi” pro-

muove il riuso creativo dei materiali urbani; o a Vienna, che da decenni investe sull’edilizia pubblica come garanzia di dignità e coesione; o ancora a Napoli, dove il recupero dell’ex Asilo Filangieri come bene comune urbano ha dato vita a un modello di autogestione culturale riconosciuto dal Comune. In ciascun caso, la comunità è diventata soggetto attivo, non spettatore delle decisioni altrui.
Il bene comune, infatti, non è un concetto astratto: è un’esperienza quotidiana. È il marciapiede percorribile, l’aria respirabile, il parco accessibile, la scuola aperta. È la capacità di una città di generare prossimità, fiducia e cooperazione. Come scriveva Italo Calvino nelle Città invisibili, “la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano”. Ecco: il bene comune è la linea che unisce passato e futuro nella mano della città.
Tutto questo non significa idealizzare la comunità, ma governarla con intelligenza. Il bene comune richiede politiche pubbliche che favoriscano il dialogo tra istituzioni, cittadini, imprese e terzo settore. Richiede una nuova forma di leadership urbana, fondata non sul comando ma sulla cura. Perché prendersi cura di ciò che è comune — dall’ambiente alla salute, dal patrimonio alla conoscenza — è l’unico modo per rendere sostenibile anche ciò che è individuale.
“L’umanità non abita la terra, ma la sua capacità di stare insieme.”
Hannah Arendt
Oggi più che mai, la sfida delle città è riscoprire questa capacità. Non sarà la tecnologia a salvarci, se non sapremo usarla per costruire relazioni. Non sarà la ricchezza a renderci prosperi, se non sarà condivisa. Non sarà la modernità a renderci felici, se perderemo il senso dell’appartenenza.
Le città che riusciranno a farlo — e molte lo stanno già facendo — saranno quelle che avranno il coraggio di dire noi, in un mondo che continua a pronunciare io.
di Fabio Mazzeo Giornalista e divulgatore scientifico
“Ma chi l’ha detto?”.
“La televisione”. “Il giornale”.
Ci siamo relazionati così per decenni, pesando col credito della testata il fondamento della notizia.
Poi, nel 2008 è cambiato tutto. Cos’è accaduto nel 2008? La risposta ce l’avete in tasca, o sul tavolo. E non farete a meno di guardarlo non appena la soglia d’attenzione per questo articolo si abbasserà. L’avvento sul mercato dello smartphone ha impartito l’ultima accelerazione alla rivoluzione digitale cominciata con il debutto del web e che ha travolto non solo il modo in cui comunichiamo, ma la struttura profonda del pensiero collettivo. Lo psicologo americano Jonathan Haidt la definisce “la più fulminea riconfigurazione della coscienza e delle relazioni umane della storia”, un’accelerazione antropologica che investe la nostra capacità di discernere, comprendere e giudicare.
L’uomo, che la mattina acquistava in edicola il quotidiano, e ne sfogliava le pagine orientandosi all’interno di un percorso prestabilito, oggi si misura in una condizione in cui, ogni minuto, sul web si inviano 56 milioni di messaggi e si visualizzano più di 4 milioni di video.
Ogni minuto, impressionante no?!
Peraltro, si tratta di informazione digitale, per sua natura liquida: può essere copiata, modificata, estratta dal contesto. Questo la rende estremamente flessibile, ma anche vulnerabile a manipolazioni. Nel mondo dove le notizie potevano già essere ricombinate e collassate dentro opinioni, con la tecnologia sono arrivate le deepfake video in cui volti, parole e gesti vengono riprodotti artificialmente, ma con effetti di alta verosimiglianza cambiando il concetto stesso di verità visiva. “Vedere per credere”, si diceva. Non è più così.
Siamo arrivati a tutto questo dopo anni in cui c’è stato chi ha pensato fosse utile distruggere l’autorevolezza dei media tradizionali, percepiti come manipolatori, e
diffondere la credenza ingenua che tutto ciò che circola in rete sia autentico per definizione, liberando la parola in uno vale uno, dove ogni opinione ha lo stesso peso, indipendentemente dalla sua fondatezza. In questo paesaggio mutevole, è urgente ripensare il senso dell’informazione come bene comune, essenziale alla vita democratica. Perché senza un’etica della parola, senza uno sguardo critico sul mondo che ci viene raccontato – e che noi stessi contribuiamo a raccontare – la libertà si svuota e la verità si dissolve in una nebbia di percezioni.
In questo quadro, il giornalismo cambia per tornare alle sue radici più profonde: non è più soltanto un mestiere, ma una funzione civica che coinvolge chi scrive e chi legge. Ogni parola è un atto di responsabilità, ogni condivisione è una scelta politica.
Accuratezza delle fonti e rigore contro gli algoritmi che regolano la visibilità dei contenuti premiando ciò che emoziona, indigna o diverte indipendentemente dalla sua veridicità.
Certo, il giornalismo ha meno armi: non esiste un “algoritmo della verità” mentre i nemici dell’informazione imparziale hanno buoni alleati negli algoritmi dell’attenzione, dell’engagement, della polarizzazione. La posta in palio è altissima, è in gioco la sopravvivenza della democrazia per come la conosciamo perché le informazioni false producono effetti reali: influenzano le elezioni, minano la fiducia nelle istituzioni, alimentano odio sociale. In questo scenario, la verità diventa un effetto collaterale, non un fondamento. Ciò che conta non è se un fatto sia vero, ma se funziona, se fa presa, se orienta i comportamenti.
Oggi il giornalismo si trova davanti a un bivio: continuare a inseguire la visibilità facile, riproducendo le dinamiche dei social – fatte di rumorosità, ironia artefatta, polarizzazione e falsificazione – oppure recuperare il proprio ruolo di presidio critico e civico, sottraendosi alla dittatura dell’algoritmo. Troppo spesso

l’informazione autorevole si è piegata alla logica del clickbait: titoli gridati, contenuti svuotati di senso, narrazioni ridotte a slogan emozionali. Non c’è testata che oggi non rincorra i trend social, lisciando il pelo agli urlatori digitali, amplificando i personaggi del giorno, facendo da megafono a chi grida più forte. Ma in questo modo, la credibilità si dissolve e con essa la funzione democratica del giornalismo.
In un’epoca segnata dalla sovrabbondanza, il vero problema non è più reperire le notizie, ma orientarsi nel caos. Il disorientamento non è un’anomalia, ma una conseguenza strutturale del sistema. Per questo servono nuove forme di alfabetizzazione critica: non solo comprensione del testo, ma capacità di riconoscere le fonti, decifrare le intenzioni, valutarne la coerenza e collocarle nel giusto contesto. È una competenza lenta, esigente, indispensabile.
Piccoli suggerimenti di uno innamorato del mestiere:
• occorre opporsi alla dittatura dell’istantaneità. Solo il giornalismo che si prende il tempo per verificare, contestualizzare e interrogare i fatti può generare conoscenza. Educare alla lentezza è oggi una forma di resistenza culturale;
• è urgente superare la logica della performance permanente per promuovere una comunicazione più consapevole, che non confonda visibilità con valore. I giornalisti devono custodire la propria integrità come garanzia per i lettori, offrendo narrazioni fondate e non spettacolarizzate;
• serve ribadire con forza che condividere una notizia è un atto politico, un impegno civico. In un ecosistema dove gli algoritmi premiano l’emozione, è indispensabile ripristinare la centralità del dato, della verifica, della competenza.
Solo un giornalismo che non si limiti a spettatore può risultare architetto di senso, costruttore di fiducia e garante del bene comune. Solo così potrà tornare a essere, come l’aria e l’acqua, una risorsa vitale per la democrazia.

Negli ultimi anni abbiamo imparato a considerare la salute come un bene comune, un concetto che si è evoluto profondamente e che oggi assume un significato più ampio e complesso. Non è più soltanto un’espressione retorica, ma una chiave interpretativa del nostro vivere collettivo, capace di raccontare le trasformazioni sociali, economiche e politiche del Paese.
Dalla consapevolezza collettiva all’esperienza quotidiana
L’esperienza della pandemia ha rappresentato una cesura storica. Ha reso evidente quanto la salute non possa essere considerata un ambito settoriale, ma un valore fondativo della coesione sociale. La consapevolezza diffusa dell’importanza della prevenzione, della ricerca, dell’accesso equo alle cure è diventata parte della vita quotidiana dei cittadini, ma anche del linguaggio politico e istituzionale.
Oggi, tuttavia, parlare di salute come bene comune significa riconoscere che permangono profonde disuguaglianze: tra Nord e Sud, tra città e aree interne, tra chi ha accesso a servizi efficienti e chi no. Disuguaglianze che rischiano di tradursi in una sorta di “geografia sanitaria” del Paese, dove il codice di avviamento postale finisce per determinare diritti e opportunità.
Il valore della salute come interesse generale
Dal 1978, con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale, la salute è stata riconosciuta come un diritto universale e come strumento di uguaglianza sostanziale. Ma oggi quel principio fondativo rischia di essere messo in discussione se non si riesce a garantirne l’attuazione concreta.
Rendere effettivo il concetto di salute come bene co-
mune significa riportare la salute al centro dell’interesse generale, intesa come valore che accomuna tutti e che, al tempo stesso, si declina in modo differente per ciascuno: dal bisogno di personalizzazione delle cure alla necessità di contrastare le disuguaglianze territoriali e sociali.
Serve una visione sistemica, capace di superare approcci frammentati e “a canne d’organo”, in cui ogni settore agisce isolatamente. Le sfide attuali – dall’invecchiamento della popolazione alla gestione delle cronicità, fino all’inclusione delle nuove tecnologie –richiedono una governance integrata, in grado di connettere competenze, dati e responsabilità.
Aree interne e prossimità: la sfida dell’equità
In Italia circa 11 milioni di persone vivono nelle aree interne, territori ricchi di storia, cultura e capitale umano, ma spesso penalizzati nell’accesso ai servizi essenziali. Garantire la salute come bene comune significa anche sostenere il diritto di queste comunità a rimanere vive, attraverso servizi di prossimità e modelli organizzativi innovativi.
Le tecnologie digitali, la telemedicina, le reti territoriali possono essere strumenti determinanti, ma solo se accompagnati da politiche di valorizzazione dei professionisti che vivono e lavorano in quei contesti – medici di famiglia, farmacisti, operatori sanitari – e che devono essere messi nelle condizioni di scegliere di restare, non per eroismo, ma per legittima volontà di contribuire alla crescita delle proprie comunità.
Dalla prevenzione all’innovazione: un patto per l’equità

Il concetto di bene comune si misura anche nella capacità di garantire pari accesso all’innovazione. Ciò vale per i farmaci e i dispositivi medici, ma anche per la diagnostica e la prevenzione. È emblematico il caso degli screening oncologici che, pur essendo inclusi nei LEA, presentano ancora differenze significative in termini di copertura e adesione tra le diverse regioni italiane.
Queste disuguaglianze non sono semplici dati statistici: rappresentano, in molti casi, la differenza tra la vita e la morte. Ecco perché la prevenzione deve essere considerata non un costo, ma un investimento di civiltà, un pilastro per garantire equità e sostenibilità al sistema sanitario.
Salute, sostenibilità e futuro
La riforma del Titolo V della Costituzione ha riconosciuto la salute come livello essenziale della vita collettiva, da garantire attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza. Ma perché questo principio sia effettivo, i tempi della politica e dell’amministrazione devono sapersi adattare ai ritmi dell’innovazione scientifica e dei bisogni reali delle persone.
Investire in salute significa investire nel futuro del Paese. Significa orientare le scelte pubbliche non solo guardando alla prossima elezione, ma guardando alla prossima generazione.
Solo così potremo trasformare la salute da “valore dichiarato” a “bene comune realizzato”, capace di unire, includere e generare sviluppo.
di Ludovica Serra
C’è una parola che la Generazione Z aver rimesso al centro del vocabolario del nostro tempo: responsabilità. Non quella imposta, ma quella scelta, costruita giorno dopo giorno, attraverso gesti, linguaggi e battaglie che nascono online e si traducono in azioni concrete. I giovani nati tra la fine degli anni Novanta e la metà degli anni Duemila non chiedono soltanto un mondo migliore: pretendono di essere parte attiva del cambiamento. E lo fanno in modo nuovo, globale, interconnesso.
È una generazione che non crede nei confini. Cresciuta con la rete come spazio naturale, ha imparato presto che ogni scelta locale ha una conseguenza globale. Le loro città sono digitali e fisiche insieme: piazze virtuali che si affollano di discussioni sui diritti civili, sul clima, sulla salute mentale, sulla giustizia sociale. La Generazione Z parla di bene comunein una lingua diversa da quella dei loro genitori — più fluida, più collettiva, meno ideologica. Per loro, il bene comune non è un principio astratto, ma qualcosa che si tocca, che si misura nei comportamenti quotidiani: nel riciclo, nel voto consapevole, nell’attivismo gentile, nella cura del pianeta e degli altri.
Non è un caso che il loro senso di cittadinanza sia, più che nazionale, planetario. Si sentono cittadini del mondo, ma non per questo meno legati ai luoghi che abitano. Anzi, c’è un ritorno alla prossimità: la voglia di rigenerare quartieri, di partecipare a progetti di volontariato urbano, di costruire comunità sostenibili. Le nuove forme di impegno nascono spesso da piccole azioni — una campagna su Instagram, una raccolta firme, un gruppo di acquisto solidale — ma rivelano una maturità politica e sociale sorprendente.
Dietro lo schermo c’è una generazione che studia, si informa, si mobilita. Che rifiuta le disuguaglianze
come inevitabili, che non accetta che la salute sia un privilegio, che considera la diversità una ricchezza e non un rischio. È la generazione che ha imparato a vivere in un mondo instabile — tra pandemie, guerre, crisi climatiche — e che, proprio per questo, ha fatto della resilienza un valore condiviso.
Il bene comune, per loro, è un orizzonte inclusivo: non solo l’ambiente o la giustizia sociale, ma anche la salute mentale, il diritto alla felicità, la possibilità di costruire relazioni sane e comunità empatiche. È una nuova forma di umanesimo digitale, dove la tecnologia non divide, ma connette; dove la cittadinanza si esercita con un click, ma si misura nei comportamenti quotidiani.
Guardare la Generazione Z significa, forse, tornare a credere nella possibilità di un futuro più giusto. Un futuro dove “bene comune” non è più un tema da convegno, ma una pratica di vita. Dove il “noi” conta più dell’“io”. Dove ogni ragazzo e ragazza si scopre parte di qualcosa di più grande: una rete globale di cittadini che non vogliono essere spettatori, ma protagonisti del cambiamento.
E se il mondo, oggi, sembra un luogo fragile, loro lo abitano con la leggerezza di chi non ha paura di ricominciare. Con la convinzione che la cura del pianeta, delle città, delle persone — in una parola, del bene comune — non sia un’eredità da ricevere, ma una responsabilità da esercitare. Insieme, ogni giorno.
Come scriveva Italo Calvino, “prendere la vita con leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, senza macigni sul cuore”. È così che la Generazione Z guarda al futuro: con il cuore leggero e lo sguardo alto, come cittadini del mondo che non cercano solo un posto da abitare, ma un mondo da custodire.
Viviamo dentro un paradosso. I numeri ci raccontano di crescita economica, aumento delle esportazioni, bilanci in ordine. Ma fuori dalle tabelle, la realtà è fatta di paesi svuotati, famiglie che arrancano, giovani che non vedono futuro e genitori che si arrangiano tra due lavori precari. Qualcosa si è rotto. E non si può più far finta di niente.
Il mercato – ci è stato detto per anni – avrebbe portato benessere diffuso, se solo fosse stato lasciato libero di agire. In parte è stato vero. Ma oggi, dobbiamo ammettere che un mercato senza direzione, senza vincoli e senza responsabilità, ha smesso di servire le persone. E ha cominciato a servirsi di esse.
L’impresa che chiude e il paese che muore
Pensiamo a una fabbrica che delocalizza. Per l’azienda, è una scelta razionale: meno costi, più profitto. Per il paese che la ospitava, è l’inizio di un collasso. Chiudono i bar, la scuola perde iscritti, i figli partono, i genitori restano soli. È accaduto a Termini Imerese, è accaduto a Gela, accade ogni giorno in decine di comuni italiani. Il capitale vola, ma le persone restano a terra.
Questo modello ha favorito una concentrazione di ricchezza mai vista. Nel 2024, il 10% più ricco della popolazione italiana possedeva quasi il 60% della ricchezza nazionale. Ma una società non tiene se il profitto è scollegato dal destino dei territori, se la rendita finanziaria conta più del lavoro produttivo, se l’innovazione serve a tagliare posti di lavoro e non a crearne di nuovi.
Un nuovo orizzonte: capitalismo del bene comune
Non si tratta di essere “contro” il mercato. Si tratta di decidere a chi il mercato deve rispondere. Un capitalismo orientato al bene comune significa rimettere al centro il lavoro, le comunità locali, la coesione sociale. Significa fare in modo che le scelte economiche pro-
ducano valore non solo per chi investe, ma per chi lavora, vive, costruisce futuro.
Vuol dire, per esempio:
• incentivare fiscalmente le imprese che investono nel territorio, assumono stabilmente, formano giovani;
• tassare in modo più deciso le multinazionali che estraggono valore senza restituirlo;
• legare i fondi pubblici a impegni precisi in termini di occupazione e impatto sociale;
• promuovere cooperative di comunità, imprese sociali, filiere locali come motori di sviluppo;
• rendere il lavoro dignitoso, stabile, ben retribuito, una priorità nazionale.
Lavoro non come costo, ma come fondamento
Se il lavoro viene visto solo come un costo da tagliare, l’Italia non ha futuro. Le imprese che innovano e reinvestono – come quelle dell’automotive a Torino, della ceramica a Sassuolo, dell’agroalimentare di qualità in Emilia o in Puglia – dimostrano che è possibile crescere senza impoverire. Ma serve una visione. E serve uno Stato che non si limiti a registrare, ma che indirizzi.
Uno Stato capace di fare politica industriale, di accompagnare la transizione ecologica, di difendere settori strategici. Che premi le imprese che guardano al lungo termine e che proteggano non le rendite, ma la fatica onesta.
Lo Stato come regia, non come stampella
Il ritorno dello Stato non deve essere un ritorno assistenzialista. Al contrario: uno Stato moderno deve indirizzare gli investimenti, costruire reti di innovazione pubblico-private, attivare i territori. Le ZES, le aree

interne, i fondi PNRR, sono tutte occasioni per sperimentare un modello economico nuovo, fondato sulla corresponsabilità tra mercato e comunità.
La domanda è semplice: vogliamo continuare a essere spettatori passivi della “mano invisibile” che premia solo pochi? O vogliamo costruire un’economia che serva le persone, anziché chiedere alle persone di servire l’economia?
Una sfida che riguarda tutti
Questa non è una battaglia ideologica. È una questione di sopravvivenza democratica. Le disuguaglianze non sono solo un problema economico: sono un rischio politico. Alimentano sfiducia, rabbia, populismo. Quando il mercato non si cura del bene comune, finisce per logorare la democrazia.
Per questo serve un cambio di passo. Non con slogan, ma con riforme concrete. Non contro le imprese, ma al fianco di quelle che scelgono di essere parte della soluzione. Non contro la globalizzazione, ma per una globalizzazione che rispetti i territori e le persone.
L’appello
Il tempo delle analisi è finito. Il tempo della politica è ora. Bisogna scegliere se essere amministratori di un declino o costruttori di un nuovo modello. Un modello in cui il lavoro sia di qualità, le imprese siano radicate, la crescita sia inclusiva.
Rimettere al centro il bene comune non è nostalgia: è lungimiranza. È l’unica strada per un capitalismo che duri. E per una democrazia che tenga.
C’è stato un tempo in cui le città italiane si accontentavano di essere città. Con i loro pregi e i loro difetti: un teatro comunale che cadeva a pezzi ma con un’anima, un mercato rionale rumoroso, qualche monumento trascurato e un’osteria che resisteva al tempo. Poi, improvvisamente, è arrivata la febbre. Una febbre che sale lenta, inarrestabile, e colpisce senza pietà sindaci, assessori e uffici stampa: la “capitolite acuta”, la necessità viscerale di fregiarsi di un titolo che cominci con “Capitale di…”.
Non importa di cosa. Basta che sia “di qualcosa”: Capitale della Cultura, Capitale Europea dello Sport, Capitale del Libro, Capitale della Gentilezza, Capitale del Verde, Capitale dell’Arte Contemporanea, Capitale della Rigenerazione Urbana Sostenibile, Capitale della Creatività Digitale Inclusiva, e via delirando. È la nuova moneta simbolica del potere locale: un’etichetta da mettere sul sito del Comune, un logo da stampare su ogni cartellone, un motivo per convocare una conferenza stampa con sfondo istituzionale blu e frasi tipo “la nostra città guarda al futuro con entusiasmo e visione”.
Nel frattempo, la città vera resta lì: con l’autobus che passa ogni quarantacinque minuti, la buca che festeggia il suo quinto anniversario e il parco giochi abbandonato che fa da parcheggio abusivo. Ma non importa: è tutto “in transizione”.
Il bello è che ormai non si candida più una città, ma un’idea di sé. Ogni comune presenta dossier chilometrici, pieni di parole chiave: “resilienza”, “inclusione”, “innovazione sociale”, “partecipazione civica”, “nuove centralità culturali”. Tutti i progetti, però, sembrano scritti dallo stesso algoritmo: un po’ di street art, qualche laboratorio di cittadinanza attiva, un festival green, e via verso la gloria.
La retorica è sempre la stessa: “vogliamo restituire la città ai cittadini”. Come se qualcuno l’avesse rapita e servisse un concorso ministeriale per ritrovarla.
E così, a colpi di candidature, si è creata una Repub-
blica delle Capitali Temporanee, dove ogni settimana un sindaco annuncia con fierezza: “siamo in corsa per diventare capitale di…”. Nessuno sa esattamente cosa comporti vincere, ma il comunicato stampa è già pronto, corredato di hashtag e di immagine panoramica al tramonto.
Intendiamoci: la competizione non è un male. L’idea di premiare città che investono in cultura, sport o sostenibilità è nobile. Ma il problema è che, in Italia, tutto diventa spettacolo autocelebrativo. Il titolo serve più a chi amministra che a chi ci vive. Le città vincono, festeggiano, spendono (poco), comunicano (molto) e dopo un anno archiviano tutto in un faldone con su scritto “esperienza straordinaria di crescita condivisa”. Poi ricomincia il tran tran: bilanci in rosso, piani regolatori fermi, piste ciclabili che finiscono nel nulla, eventi che sopravvivono solo sulla carta.
La verità è che “capitale” è diventata una parola-specchietto. Serve per nascondere le fatiche quotidiane di città che arrancano. Invece di aggiustare ciò che non va, si preferisce creare una “narrazione positiva”: un’operazione di marketing territoriale che promette rinascita e identità condivisa. Ma dietro i loghi, restano i problemi strutturali di sempre.
Ci sono città che si proclamano “capitale del verde” e non hanno un piano di manutenzione per gli alberi; altre che si autodefiniscono “capitale della cultura” ma chiudono le biblioteche la domenica; altre ancora “capitale dello sport” con piscine comunali chiuse per lavori da dieci anni. Però fa curriculum.
Nel frattempo, l’Italia dei piccoli centri, dei quartieri dimenticati, delle periferie che non hanno nemmeno un marciapiede decente, assiste in silenzio. Forse anche loro, un giorno, si candideranno. “Borgo di 312 abitanti, Capitale dell’Equilibrio Mentale”. Potrebbe funzionare.
Il paradosso è che più ci moltiplichiamo in capitali, meno capitale vero produciamo: umano, sociale, economico. Ogni titolo è effimero, ogni riconoscimento


ha la durata di una stagione turistica. La retorica si gonfia, la realtà si sgonfia.
Eppure, basterebbe poco per restituire senso a tutto questo: una scuola aperta anche il pomeriggio, un centro civico che funzioni davvero, un piano di mobilità coerente, un investimento serio nella cultura di base. Non serve essere “capitale” per farlo: basta essere coerenti, competenti, presenti.
Ma in Italia la normalità non è più medaglia: è sospetto. Dire che una città “funziona” sembra quasi banale. Meglio un titolo, una candidatura, una visione “strategica”. Così ci sentiamo parte di qualcosa di grande, anche se non sappiamo bene cosa.
Forse un giorno ci sarà un nuovo concorso nazionale: “Capitale italiana della Normalità”.
Vincerà la città che non ha dossier patinati, ma autobus puntuali, verde curato, servizi pubblici efficienti, cittadini informati e un sindaco che parla poco e lavora molto.
Ma è una prospettiva troppo rivoluzionaria, quasi pericolosa: non si può mettere su un manifesto elettorale. Nel frattempo, avanti con le candidature. Tra poco, probabilmente, verrà istituito anche il bando per la “Capitale Italiana del Buonsenso”. Ma attenzione: verrà annullato subito dopo per mancanza di partecipanti.
Il medico di famiglia è, da sempre, la figura più prossima alla vita quotidiana delle persone. È il primo volto della sanità pubblica che incontriamo, il primo ascolto quando la salute vacilla, il primo sguardo che cerca di leggere nella complessità dei sintomi la storia di un corpo e di una comunità. In un tempo in cui la medicina rischia di diventare frammentata, tecnologica, distante, il medico di famiglia rappresenta l’ultimo presidio umano del sistema, la soglia tra la persona e le istituzioni, tra il bisogno individuale e la risposta collettiva.
In questo senso, la medicina generale non è solo una funzione sanitaria: è una forma di cittadinanza attiva, una responsabilità sociale che parte dalla cura ma arriva fino alla costruzione del bene comune.
La salute come responsabilità condivisa
La pandemia ci ha insegnato che la salute non è mai un fatto individuale, ma un equilibrio collettivo. Le reti di prossimità, l’attenzione ai fragili, la fiducia nei comportamenti di prevenzione: tutto ciò che ha funzionato nei momenti più difficili è nato dove il medico di famiglia è stato riconosciuto come punto di riferimento, come guida capace di unire la competenza clinica con la conoscenza profonda delle persone e dei territori.
Il bene comune, in sanità, si costruisce ogni giorno nell’incontro tra medico e cittadino, nel rispetto reciproco, nella consapevolezza che la salute è un diritto universale ma anche una responsabilità condivisa.
Il medico di famiglia, con il suo ruolo di continuità, è colui che tiene insieme prevenzione, diagnosi e accompagnamento terapeutico, ma anche educazione sanitaria, alfabetizzazione, orientamento nei percorsi. È colui che, prima ancora della cura, promuove salute.
Il territorio come spazio di relazione
Il territorio è oggi la frontiera più importante del Servizio Sanitario Nazionale. Qui si gioca la possibilità di rendere la sanità più equa, sostenibile e vicina. Le Case della Comunità, le Centrali Operative Territoriali, la
telemedicina e i team multiprofessionali non sono solo nuove infrastrutture o strumenti organizzativi: sono l’occasione per costruire una medicina del futuro che mantenga il valore umano dell’ascolto e della relazione. Il medico di famiglia deve poter restare il perno di questa rete, con una funzione rinnovata e riconosciuta. Non un semplice erogatore di prestazioni, ma un regista di salute pubblica, capace di integrare saperi, professioni e risorse.
La prossimità, in questa prospettiva, non è solo geografica, ma etica: significa farsi carico, comprendere, accompagnare. Significa riconoscere che la salute di un quartiere, di una città o di una regione dipende anche dalla coesione sociale, dall’ambiente, dall’istruzione, dal lavoro.
La sfida della complessità
Viviamo un’epoca segnata dall’aumento delle cronicità, dall’invecchiamento della popolazione, dalle nuove povertà sanitarie e digitali. In questo scenario, il medico di famiglia non è soltanto colui che “cura” ma chi coordina, interpreta, integra.
Deve saper dialogare con la medicina specialistica, con l’ospedale, con i servizi sociali, ma anche con la scuola, il volontariato, l’associazionismo.
Il suo sguardo olistico diventa la chiave per leggere la salute come un ecosistema, dove corpo, mente, ambiente e relazioni si influenzano reciprocamente.
Per questo la formazione del medico di famiglia deve essere sempre più orientata alla complessità: competenze cliniche solide, ma anche capacità di comunicazione, leadership territoriale, lettura dei determinanti sociali di salute.
Un nuovo patto con i cittadini
Ricostruire la fiducia tra cittadini e sanità è una delle grandi sfide del nostro tempo. La Medicina Generale può e deve essere il motore di questa ricostruzione. Serve un nuovo patto tra medico e cittadino, fondato sulla trasparenza, sull’ascolto e sulla corresponsabilità.

di Alessandro Rossi
Presidente SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie)
Serve una politica sanitaria che riconosca il valore strategico della prossimità, non come retorica ma come modello di governance.
Ogni investimento nella medicina territoriale, ogni progetto di riforma delle cure primarie, è un investimento nel bene comune.
Perché il bene comune non è un concetto astratto: è la somma dei volti che il medico incontra ogni giorno nel suo ambulatorio, delle storie di chi non può permettersi di essere lasciato solo, delle famiglie che chiedono di essere ascoltate.
È la salute intesa come bene relazionale, come diritto che si realizza solo nella comunità.
Conclusione
Essere medico di famiglia, oggi, significa restare umani in un mondo che rischia di dimenticare la misura dell’uomo.
Significa fare della medicina un atto di cittadinanza, un ponte tra individuo e collettività, tra presente e futuro.
Nel prendersi cura della persona, il medico di famiglia si prende cura della città, della comunità, della società intera.
E così, silenziosamente, ogni giorno, contribuisce a costruire quel bene comune che è la più alta forma di salute possibile: la salute condivisa.

Nel marzo del 1968, durante un intervento all’Università del Kansas, il candidato democratico alle presidenziali Robert F. Kennedy pronunciò il famoso discorso sul PIL. In un passaggio divenuto celebre, Kennedy metteva in discussione la “tirannia” del prodotto interno lordo, quel metro che “misura tutto quanto, tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta. E sull’America ci può dire tutto, tranne perché siamo orgogliosi di essere americani”.
Quello di Kennedy era un appello a ritrovare una visione etica della politica e a riconoscere ciò che realmente determina il senso di appartenenza a una comunità: il bene comune. Del resto, proprio la costituzione degli Stati Uniti aveva per prima riconosciuto la felicità (pursuit of happiness) come orizzonte ultimo della polis. Nella Dichiarazione d’Indipendenza del 4 luglio 1776, Benjamin Franklin aveva inserito la massima: “tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità”. Pochi anni dopo, la Dichiarazione francese sui diritti dell’uomo proclamava che il fine delle istituzioni pubbliche è rappresentato dalla “felicità di tutti”.
Il discorso di Robert Kennedy poggiava, quindi, sulla tradizione del costituzionalismo moderno che tiene insieme etica e politica. E, se siamo disposti ad andare alla sua radice, potremo facilmente riconoscere in quel discorso l’archè del pensiero politico occidentale: l’idea che la politica è il mezzo per realizzare il bene comune e che la polis è il luogo deputato alla sua realizzazione. Questo collegamento è esplicito già nei pensatori greci. Per Aristotele, l’uomo è autenticamente uomo solo nella polis, nel suo “essere con gli altri”. E il grande filosofo aggiungeva, nell’Etica, che le virtù dell’uomo, se ben guidate, possono condurre al loro fine supremo: la felicità. La sintesi è che nella polis l’uomo trova una guida per realizzare il bene comune e una vita virtuosa, secondo le leggi della natura e della giustizia. Nel Medioevo, la dottrina aristotelica è ripresa e rielaborata da Tommaso d’Aquino. Anche per il teologo medievale, il bene comune ha un fondamento antropologico. È una tendenza naturale dell’uomo in quanto essere sociale. La visione tomista aggiunge al concetto di bene comune un valore escatologico: non si esaurisce nel benessere terreno, ma trova il suo pieno compi-

di Margherita Iuzzolino
mento nella vita eterna. Chi è chiamato a promuovere il bene comune, deve quindi preoccuparsi non solo delle condizioni materiali, ma del destino spirituale degli uomini.
Il collegamento tra polis e bene comune è presente anche in Machiavelli e Hobbes. Questi pensatori, seppur all’interno di una concezione mondana e pessimistica dell’esistenza, vedono nella polis l’unico luogo in cui è possibile sopravvivere, trovare sicurezza, vincere la paura.
Oggi possiamo ancora riconoscere nella dimensione politica dell’esistenza, scoperta dai greci, la determinazione fondamentale dell’uomo? E che il fine ultimo della polis è il raggiungimento del bene comune?
Per provare a rispondere a queste domande, dobbiamo considerare che nelle società contemporanee la politica è trasfigurata dal dominio tecnico-economico. I segni di questa grande trasformazione erano ben visibili già nel corso del ‘900, quando alcuni lucidi pensatori, come Emanuele Severino, avevano descritto che la tecnica, da mezzo per raggiungere scopi specifici, era diventata il fine supremo, sostituendosi alla politica.
Le conseguenze di questa trasformazione sono sotto gli occhi di tutti: calo della partecipazione pubblica, crisi delle istituzioni, neutralizzazione e depoliticizzazione della società, affermarsi di quello che i sociologi chiamano “io minimo” o “io narcisista”. In pratica, il contrario di quello che le tradizioni politiche ci hanno trasmesso, cioè che solo nella polis può realizzarsi pienamente l’umanità dell’uomo.
Il concetto di bene comune rischia così di diventare anacronistico. Ma si tratta soltanto di un’apparenza. La politeia, l’essere “l’uno con l’altro”, resta la determinazione fondamentale dell'essere umano anche nel moderno paesaggio urbano. Lo dimostrano le mobilitazioni di massa contro le guerre, contro il cambiamento climatico o la violenza sulle donne Ma lo dimostrano anche i gesti individuali più semplici e silenziosi come quello dell’anziano che, sfidando i li-

miti dell’età, si piega a raccogliere i resti di una sigaretta sul marciapiede sotto casa. Questi atti testimoniano l’esistenza di una comunità politica di cui l’uomo non può rinunciare a esser parte.
Guidare oggi la polis significa allora comprendere che la connessione tra etica e politica non può essere cancellata da alcuna trasformazione tecnologica e che il bene comune resta l’orizzonte dell’azione politica. Non è il progresso tecnico ma il bene comune lo scopo della polis.
Ma quali sono i beni comuni ai quali deve guardare l’agenda politica? Sono di due tipi. In primo luogo, quelli che gli economisti definiscono beni convergenti, come la sicurezza, il decoro urbano, i trasporti, la rete. Sono i beni destinati all’uso collettivo, ma che soddisfano interessi dell’individuo uti singuli. Questi beni coprono solo in parte il fine della polis. Accanto a essi, vi sono altri beni, prodotti dalla condivisione e dalle relazioni umane. Un esempio di questo secondo tipo di beni è il linguaggio, la comunicazione. La parola che
si esprime nella lingua fonda il rapporto essenziale tra il “noi” e l'io", tra l’uomo e il gruppo, la collettività in cui vive. Charles Taylor definiva la conversazione non come la somma di due monologhi, ma come il risultato di un’interazione nella quale i partecipanti si influenzano reciprocamente. Per questo, il primo bene comune che la polis deve assicurare è un bene immateriale, la cultura, che più degli altri beni rafforza il tessuto connettivo della comunità, la fiducia e infine lo stesso benessere.
Occorre quindi ripartire dalla parola comunità nel suo significato originario. La koinonía pone in evidenza “ciò che è comune”, ma anche “comunico con”. Questo concetto, che è all’origine della civiltà della polis, ci dice che ciò che è essenziale al gruppo, ciò che consente a esso di costituirsi e di perpetuarsi, è il fatto che i singoli “comunicando tra loro” producono cultura. Il comunicare, il dialogo, la parola, la cultura continueranno a essere il fondamento della polis.
24
Le nuove frontiere della salute urbana
Tra il 2024 e il 2025, la letteratura internazionale sulla salute urbana ha conosciuto un’espansione senza precedenti. Organizzazioni internazionali, case editrici accademiche e autori indipendenti hanno contribuito a delineare una visione sempre più integrata del rapporto tra città, salute e sviluppo sostenibile.
Dalle linee guida dell’OMS ai volumi di ricerca di Elsevier, dalle riflessioni economiche sulla healthonomics alle indagini territoriali condotte in Germania, emerge una convinzione condivisa: la salute delle città è la nuova frontiera della salute pubblica globale. Le opere pubblicate tra il 2024 e il 2025 rappresentano una svolta: la salute urbana non è più un tema di nicchia, ma una chiave di lettura del nostro tempo.
Dalla pianificazione urbana alla politica economica, dall’innovazione istituzionale alla cultura organizzativa, emerge una visione condivisa: le città sane sono quelle che sanno cooperare, innovare e includere.
Questi libri, nella loro diversità, offrono una bussola per orientarsi nel futuro della salute pubblica globale — un futuro che, come insegnano gli autori, comincia nelle nostre città.
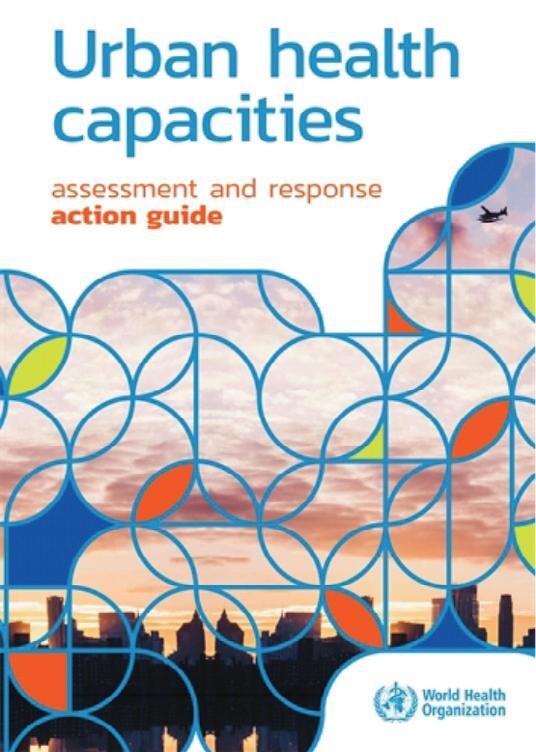
Urban Health Capacities: Assessment and Response Action Guide (2024)
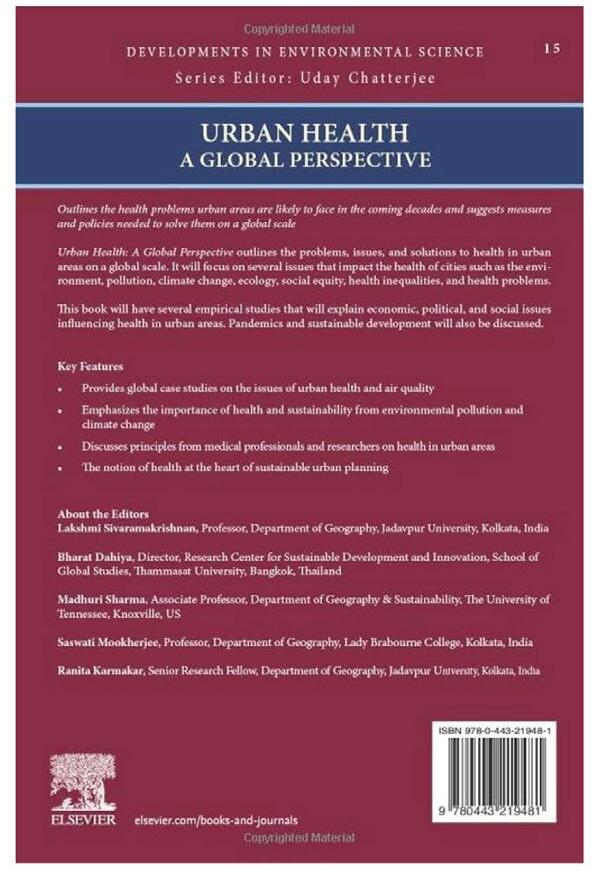
Urban Health, Volume 15 (2024)
Pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, questa guida rappresenta un riferimento essenziale per le amministrazioni locali e i professionisti della salute pubblica
Il testo spiega come rafforzare le connective capacities, ovvero le capacità di collaborazione tra diversi settori della governance urbana — salute, trasporti, ambiente, pianificazione — per costruire città più sane e resilienti. Parte di un kit formativo più ampio, corredato da video e strumenti operativi, la guida concretizza l’approccio “Health in All Policies”, traducendo la teoria in azione.
Pubblicato da Elsevier, questo quindicesimo volume offre una visione globale della salute urbana. Le città vengono analizzate come ecosistemi complessi, in cui i determinanti sociali, ambientali e infrastrutturali si intrecciano con le disuguaglianze e le opportunità. L’opera si distingue per il suo approccio comparativo, includendo contributi di esperti da Asia, Africa, Europa e Americhe. Il volume sottolinea come lo sviluppo urbano sostenibile sia oggi inseparabile dalla salute collettiva, proponendo politiche e buone pratiche replicabili.
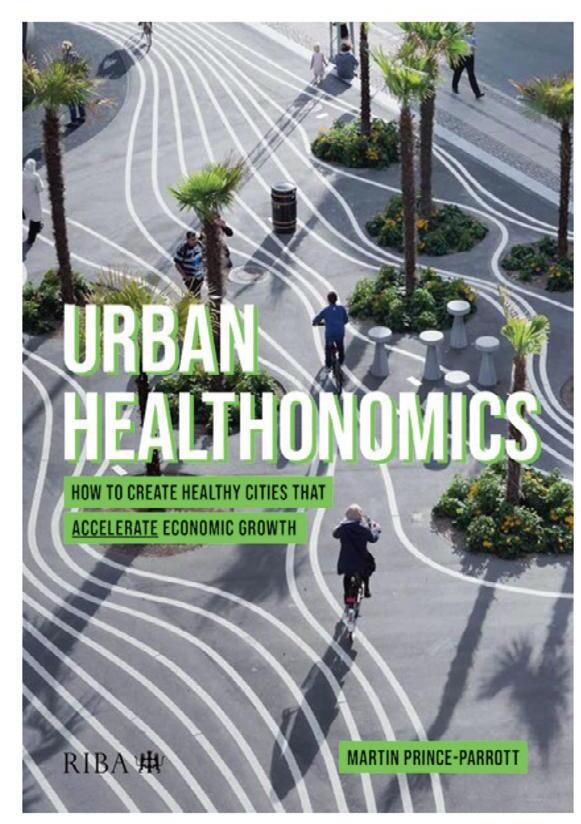
Urban Healthonomics: How to create healthy cities that accelerate economic growth (2025)
In uscita per RIBA Books, questo volume introduce un concetto innovativo: la healthonomics, ovvero l’economia della salute urbana. L’autore sostiene che una città sana non solo favorisce il benessere dei cittadini, ma anche la crescita economica, l’attrattività turistica e la produttività.
Attraverso casi di studio, modelli quantitativi e comparazioni tra città globali, il libro propone una visione strategica: investire nella salute urbana significa investire nel futuro economico delle metropoli.
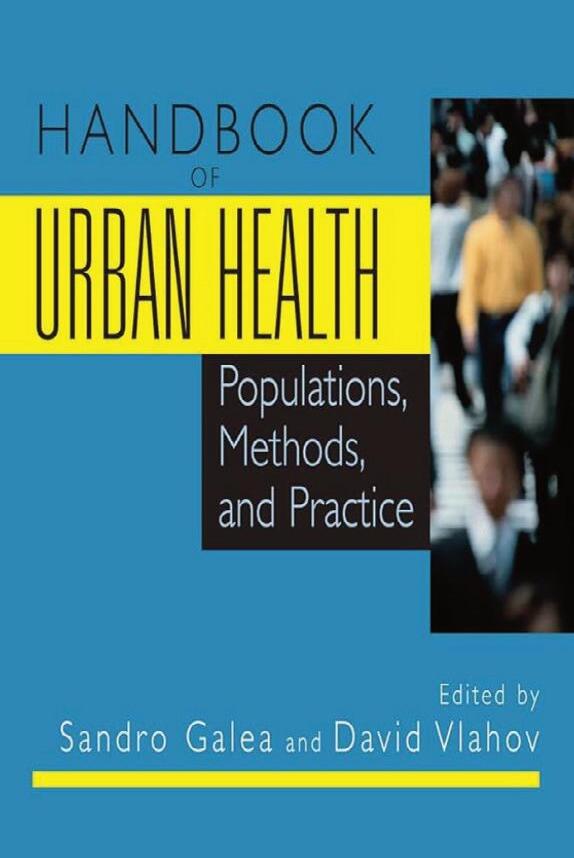
The Health of the Populace (2025)
Scritto da Pasquale De Marco e autopubblicato, questo volume sorprende per rigore e completezza. Analizza le più recenti ricerche su inquinamento atmosferico e acustico, determinanti sociali della salute, salute mentale e resilienza delle comunità urbane.
De Marco adotta un linguaggio accessibile ma scientificamente solido, rendendo il testo utile sia per esperti sia per lettori interessati alle trasformazioni della vita urbana contemporanea. È un contributo prezioso alla democratizzazione della conoscenza sulla salute pubblica.
Innovation for Urban Health: Policy Brief (2024)
In questo policy brief l’OMS delinea le strategie per integrare innovazione sociale, tecnologica e istituzionale nei sistemi urbani di salute.
Il documento è sintetico ma denso, e propone raccomandazioni concrete per amministrazioni e governi.
L’obiettivo è chiaro: promuovere città intelligenti e inclusive, capaci di tradurre l’innovazione in benessere collettivo e in maggiore equità sociale.
Urban Health in the Ruhr Area I. Current Situation and Perspectives (2024)
Pubblicato in lingua tedesca da Urban-Health.de, questo volume open access esamina la salute nell’area metropolitana della Ruhr, una delle regioni più industrializzate e densamente popolate d’Europa. Il testo combina analisi epidemiologiche, valutazioni ambientali e prospettive di pianificazione urbana, offrendo un modello di ricerca territoriale replicabile in altri contesti. È un contributo accademico ma anche operativo, che mostra come la salute possa diventare un indicatore di rigenerazione post-industriale.

Health literacy of urban organizations. A practiceoriented handbook (2024)
Anch’esso pubblicato da Urban-Health.de, questo manuale pratico affronta la health literacy delle organizzazioni urbane, cioè la loro capacità di comprendere, comunicare e agire in modo coerente con i principi della promozione della salute.
Il volume fornisce strumenti concreti — schede operative, esempi e checklist — per trasformare enti pubblici, scuole e aziende in veri e propri attori di salute. Un testo tecnico ma profondamente orientato all’azione e alla formazione.
Le opere pubblicate tra il 2024 e il 2025 rappresentano una svolta: la salute urbana non è più un tema di nicchia, ma una chiave di lettura del nostro tempo. Dalla pianificazione urbana alla politica economica, dall’innovazione istituzionale alla cultura organizzativa, emerge una visione condivisa: le città sane sono quelle che sanno cooperare, innovare e includere. Questi libri, nella loro diversità, offrono una bussola per orientarsi nel futuro della salute pubblica globale — un futuro che, come insegnano gli autori, comincia nelle nostre città.


Negli ultimi anni un fenomeno silenzioso ma in crescita sta ridisegnando il volto della pensione in Italia: molti anziani, liberi dagli impegni lavorativi, scelgono di trasferirsi all’estero. Non è solo desiderio di avventura o fuga dal grigio: dietro queste scelte ci sono incentivi fiscali, qualità della vita più accessibile, clima favorevole e comunità internazionali già radicate. Ma quali sono le mete più gettonate? E cosa occorre sapere prima di partire?
Un esodo che cresce: numeri e dinamiche
Secondo dati recenti, i pensionati italiani residenti stabilmente all’estero sono oltre 228.000. Di questi, circa 38.000 hanno trascorso tutta la loro vita lavorativa in Italia e sono partiti solo dopo il pensionamento. Il peso relativo di questa migrazione pensionistica è aumentato notevolmente: se nel 2010 i trasferimenti riguardavano 10 ogni 100.000 pensionati, oggi si stimano 33 ogni 100.000.
È un fenomeno che non riguarda soltanto i migranti di lungo corso: il trend interessa anche chi decide di lasciare il Paese dopo il pensionamento, trasformando l’esodo in scelta strategica.
Pochissimi tornano: ogni anno si registrano tra le 40 e le 80 riammissioni, segno che chi parte tende a restarci.
Le motivazioni alla base del trasferimento
Perché molti pensionati scelgono di vivere lontano dall’Italia? Le ragioni sono varie e si intrecciano:
• Riduzione del costo della vita: molte destinazioni hanno spese quotidiane, immobili e servizi sensibilmente più accessibili.
• Vantaggi fiscali: diversi Paesi offrono regimi agevolati o addirittura esenzioni sulle pensioni estere.
• Clima e ambiente: luoghi con sole, paesaggi e • stagioni miti sono particolarmente attrattivi.
• Servizi sanitari e qualità della vita: Paesi con un buon sistema sanitario pubblico, infrastrutture e reti sanitarie spesso convincono chi ha bisogno di assistenza.
• Presenza di comunità italiane: trasferirsi dove già ci sono connazionali rende l’integrazione culturale e sociale più semplice.
In sintesi: non è solo una questione economica, ma una decisione che combina stile di vita, benessere e progettualità.
Le mete preferite: geografie della pensione
Ecco alcune delle destinazioni più scelte dai pensionati italiani e cosa le rende attraenti:•
• Spagna: rimane la meta più ambita. Clima mediterraneo, sanità competitiva, comunità italiana consolidata. Zone come la Costa del Sol o le Isole Canarie sono particolarmente richieste.
• Portogallo: per anni considerato paradiso fiscale, oggi con condizioni forse meno vantaggiose, ma ancora apprezzato per stile di vita e costo contenuto.
• Francia: scelta da chi cerca vicinanza geografica, connessioni familiari e un sistema sanitario efficiente.
• Tunisia: per i pensionati autosufficienti, attira per il regime fiscale (7 % su solo il 20 % della pensione), clima, costo contenuto.
• Albania: meta emergente soprattutto per chi proviene dal Sud Italia. Nessuna tassazione sulla pensione e spese molto basse.
• Grecia, Romania, Bulgaria e Croazia: destinazioni dell’Est Europa in forte crescita. Con meno di 500 €/mese si può vivere decorosamente in alcune aree.
• Cipro e Malta: per chi cerca clima mediterraneo

stabile, stabilità politica e sistemi fiscali vantaggiosi.
• Slovacchia, Montenegro: meno note, ma con particolarità interessanti: in Slovacchia, ad esempio, la pensione italiana può essere esentasse.
Molte di queste mete offrono aliquote fisse (es. Grecia 10 % per dieci anni) o esenzioni totali (Albania, Slovacchia).
Aspetti pratici da non trascurare
Trasferirsi non è soltanto cambiare indirizzo: serve pianificazione. Ecco le cose fondamentali da valutare:
• Iscrizione all’AIRE: chi diventa residente estero deve iscriversi all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
• Residenza fiscale: occorre dimostrare di trascorrere almeno 183 giorni (o regole equivalenti) nel nuovo Paese.
• Convenzioni e doppia imposizione: bisogna verificare se esistono accordi tra l’Italia e il Paese ospitante per evitare di pagare due volte le impo ste.
• Pensioni pubbliche: alcune pensioni, in particolare quelle del settore pubblico, possono restare tassate in Italia nonostante il trasferimento.
• Assistenza sanitaria e farmaci: controllare che il sistema sanitario locale supporti le proprie esigenze o sottoscrivere una polizza privata.
• Trasferimenti “fittizi”: l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su chi dichiara residenze all’estero senza prove reali di trasferimento.
Una scelta ben pianificata può trasformarsi in una nuova fase della vita serena. Una mal preparata può generare problemi legali, sanitari o fiscali.
Riflessi sul Paese e prospettive
Questo fenomeno non è neutro per l’Italia. L’uscita di una parte della popolazione anziana può ridurre la domanda di servizi locali, alterare l’equilibrio demografico e la struttura fiscale. Al contempo, molti pensionati mantengono rapporti con il Paese d’origine: proprietà, famiglia, viaggi, portando capitali e relazioni tra le frontiere.
Guardando avanti, due possibili scenari:
• Consolidamento del fenomeno: se le condizioni interne (fisco, servizi, vivibilità) non migliorano, sempre più pensionati potrebbero guardare oltre confine.
• Inversione attrattiva: l’Italia potrebbe rendersi più competitiva offrendo politiche fiscali dedicate, servizi sanitari, incentivi alla residenza in aree meno centrali.
Vi sono caffè, piccoli stand e souvenir legati alle opere del villaggio.
È consigliabile informarsi sugli orari di apertura e chiusura, perché in passato il borgo è stato chiuso per restauri.
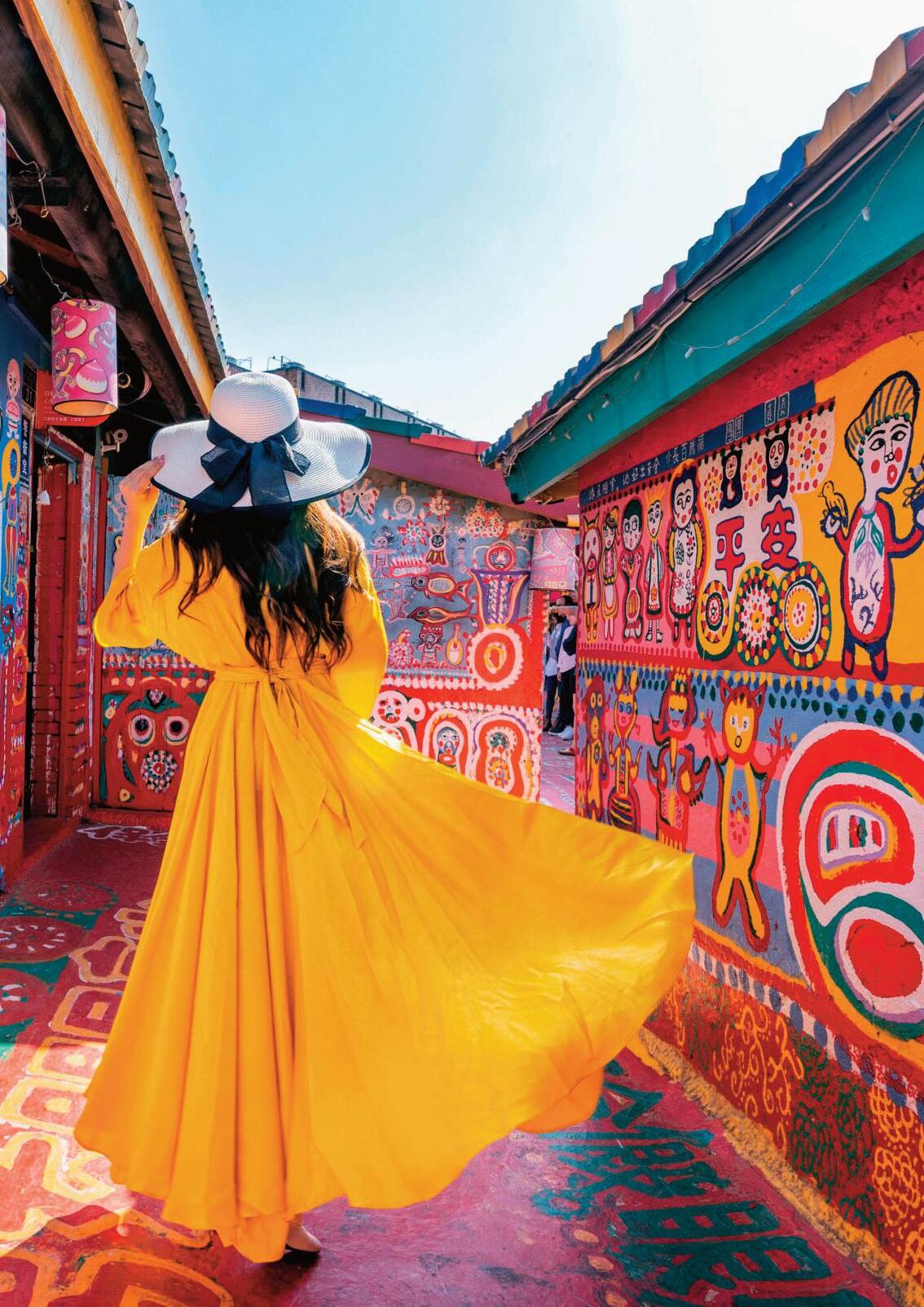
Nell’isola di Taiwan, nella città di Taichung, si trova il Rainbow Village — un minuscolo villaggio che oggi è divenuto meta turistica e simbolo di resilienza. Quattordici anni fa, quel borgo rischiava di essere demolito. Ma un ex militare di 84 anni ha deciso di reagire non con la protesta, ma con un pennello: ha dipinto ogni muro, ogni porta, ogni angolo con colori vivaci, figure e motivi fantasiosi. Quell’atto creativo ha trasformato il villaggio in un’opera d’arte urbana, facendolo sopravvivere alla cancellazione architettonica. Il suo autore, Huang Yong-fu, è divenuto noto con l’appellativo affettuoso di “Nonno Rainbow”. Con il passare degli anni il suo progetto ha attirato l’attenzione di studenti universitari, comitati di cittadini e autorità locali, che hanno contribuito a preservare e valorizzare il sito.
Dalle abitazioni militari in disuso all’arte urbana
Originariamente, il villaggio faceva parte di un complesso di alloggi destinati a soldati e loro famiglie — strutture erette per far fronte alle necessità abitative legate ai dipendenti militari. Col tempo molti di questi insediamenti sono stati abbandonati o destinati a essere demoliti con l’espansione urbana.
Quando l’amministrazione locale decise di abbattere le case, Huang rimaneva uno degli ultimi abitanti rimasti. Rifiutando l’idea di partire, iniziò a dipingere la sua casa e poi progressivamente quelle limitrofe, dando vita a un’esplosione di colori: animali, figure umane, elementi surreali, motivi decorativi e piccoli racconti visivi.
Da questo gesto personale, l’opera si è gradualmente “espansa” grazie al sostegno collettivo: studenti universitari, appassionati d’arte e cittadini hanno lanciato la campagna Save Rainbow Village, che ha convinto le autorità cittadine a tutelare il borgo, trasformandolo in parco pubblico e attrazione culturale.
Un luogo celebre e controverso
Negli ultimi anni il Rainbow Village ha accolto migliaia di visitatori all’anno. La sua notorietà globale lo ha reso uno dei luoghi “instagrammabili” più citati in Taiwan.
Ma la trasformazione non è stata priva di tensioni. Nel 2022 è emerso un episodio controverso: alcuni operatori incaricati di gestire il sito furono accusati di aver coperto con nuovi strati di vernice alcune delle opere originali, alterando o danneggiando parti del patrimonio artistico. Le autorità locali presero provvedimenti e avviarono indagini.
Il villaggio fu temporaneamente chiuso per restauri e ora è riaperto al pubblico, anche se molti osservatori segnalano che una parte delle opere originarie non è più visibile o è stata alterata.
Significati simbolici: memoria, resistenza, creatività
Il Rainbow Village non è solo un luogo colorato da visitare: incarna alcune idee forti:
• Resistenza culturale e memoria: l’azione di Huang è una forma di resistenza — contro l’oblio urbano, contro le ruspe. La pittura diventa un modo per dire “io ero qui”, “questa casa è mia, non la cancellerete senza combattere”.
• Arte come rigenerazione urbana: un borgo altrimenti destinato all’abbattimento si trasforma in un’attrazione culturale, portatore di flussi turistici, identità distintiva e opportunità economiche per il quartiere.
• Tensioni tra gestione e autenticità: la gestione del patrimonio artistico, il turismo di massa, le pressioni commerciali possono entrare in conflitto con la conservazione dell’autenticità originale.
• Il ruolo dell’individuo che agisce: Huang non era un artista professionista — la sua azione nasce da una motivazione personale, quasi intimistica — eppure ha avuto un impatto collettivo enorme.
Visitare il Rainbow Village oggi
Per chi desidera visitarlo:
• Il villaggio si trova nel distretto Nantun di Tai• chung, non lontano dal centro città.
• È piccolo: solo alcune case rimangono, ma ciascuna è stata oggetto di cura e intervento decorativo.
• L’esperienza richiede poco tempo (10-15 minuti per un giro veloce), ma è consigliabile prendersela con calma per osservare i dettagli, gli angoli nascosti e le decorazioni minuziose.
• Vi sono caffè, piccoli stand e souvenir legati alle opere del villaggio.
È consigliabile informarsi sugli orari di apertura e chiusura, perché in passato il borgo è stato chiuso per restauri.
Le grandi residenze reali sono espressioni monumentali del potere, del gusto artistico e della storia dei popoli. Spazi concepiti per stupire, affreschi che raccontano imprese, giardini che incarnano simboli di dominio: visitarle è come percorrere un museo vivo. Ecco dieci regge reali da mettere assolutamente in agenda, ognuna con la propria storia e il proprio fascino.
1. Versailles (Francia)
Simbolo per eccellenza del potere assoluto, la Reggia di Versailles è un capolavoro del barocco francese. Fu trasformata sotto Luigi XIV da una residenza di caccia a una corte magnifica e continentale. I suoi viali geometrici, la Sala degli Specchi, gli appartamenti del re e della regina e i giardini immensi raccontano l’ambizione di una monarchia che voleva imporsi come modello europeo.
2. Reggia di Caserta (Italia)
Spesso definita la “Versailles italiana”, la Reggia di Caserta è il gioiello del Regno delle Due Sicilie. Opera di Luigi Vanvitelli, con i suoi immensi parchi, fontane, scalinate, sale decorate e le porcellane pregiate, testimonia il desiderio borbonico di uguagliare – anzi, superare – gli splendori delle corti europee.
3. Castello di Schönbrunn (Austria)
Residenza estiva degli Asburgo a Vienna, il Castello di Schönbrunn è caro anche per i legami con l’imperatrice Elisabetta, la celebre “principessa Sissi”. Il palazzo e i suoi giardini (proclamati Patrimonio UNESCO) sono un esempio raffinato di architettura barocca e classicista: ogni stanza, ogni decorazione è pensata per stupire e sedurre.
4. Palazzo Reale di Madrid (Spagna)
Con oltre 135.000 metri quadrati e migliaia di stanze, il Palazzo Reale di Madrid è il più grande palazzo reale dell’Europa occidentale in termini di ampiezza. Originariamente voluto sulla scia del vecchio Alcázar, oggi ospita collezioni d’arte notevoli e offre un’immersione nella storia spagnola attraverso gli arredi, le stanze di rappresentanza e gli splendidi saloni reali.
5. Palazzo da Pena (Portogallo)
Una delle regge più eclettiche e colorate del mondo è il Palácio da Pena, situato a Sintra, vicino a Lisbona. In stile romantico-neogotico, con torrette variopinte, facciate decorative, elementi moreschi e vista panoramica, è una sorta di fiaba architettonica che unisce stili e civiltà.
6. Buckingham Palace (Regno Unito)
Il Buckingham Palace è diventato icona della monarchia britannica: residenza ufficiale della regina, sede cerimoniale e simbolo nazionale. Nei mesi estivi è visitabile da dentro, permettendo al pubblico di esplorare sale di Stato, collezioni d’arte e ambienti storici che fondono classicismo e elementi decorativi britannici e francesi.
7. Palazzo di Sanssouci (Germania)
Situato a Potsdam, nel brandeburgo, il Palazzo di Sanssouci fu progettato come dimora estiva dal re Federico il Grande. Più che una struttura massiccia, è un’opera elegante e sobria, con giardini terrazzati, padiglioni ornamentali e motivi rococò. Un rifugio reale che riflette la volontà di equilibrio tra natura e architettura.
8. Palazzo Topkapi (Turchia)
Al cuore dell’antico impero ottomano, Topkapi regna su Istanbul, affacciato sul Bosforo. Non è un palazzo unico, bensì un complesso di cortili, padiglioni, fontane, sale del tesoro e dell’Harem, ambienti segreti e ricchezza simbolica. Ogni sultano portava la propria impronta: il risultato è un mosaico di stili architettonici, influenze islamiche, decorazioni orientali e splendore materiale.

9. Peterhof (Russia)
A pochi chilometri da San Pietroburgo, Peterhof è definito “la Versailles russa”. È celebre per le sue fontane monumentali — alcune funzionanti senza pompe grazie a giochi idraulici ingegnosi —, i giardini all’italiana e l’uso diffuso di oro e decorazioni sontuose. Distrutto e ricostruito durante la Seconda guerra mondiale, oggi è uno dei simboli del recupero storico russo.
10. Palazzo Reale di Bangkok (Tailandia)
Il Grand Palace di Bangkok è una fusione di sacro e regale: all’interno ospita il Buddha di Smeraldo, una delle immagini buddiste più venerate al mondo. Il complesso, con le sue guglie dorate e tetti policromi, è un caleidoscopio di stili thailandesi tradizionali. Anche se i re oggi vivono altrove, il palazzo resta fulcro cerimoniale, spirituale e culturale.
Perché meritano una visita
1) Testimonianza storica vivente
Le regge non sono solo monumenti: hanno ospitato decisioni, intrighi, fasti e sconfitte. Attraversarle significa avvicinarsi al potere in forma tangibile.
2) Fusione di arte, architettura e paesaggio
Non si tratta solo di edifici: i giardini, i boschi, le fontane e gli spazi esterni completano il discorso estetico, creando ambienti immersivi.
3) Sfida di conservazione
Molte regge hanno affrontato guerre, rinnovamenti, trasformazioni. Il loro stato attuale è il risultato di restauri, scelte politiche e visioni culturali.
4) Diversità stilistica globale Dal barocco europeo al rococò tedesco, dall’architettura ottomana al complesso reale tailandese: è un viaggio che insegna come il concetto di “dimora reale” si adatti alle culture e ai climi locali.
Consigli per il viaggiatore curioso
• Guarda oltre le stanze più famose: spesso le sale minori, i saloni di servizio, i cortili interni offrono spunti più autentici.
• Prenota con anticipo nelle stagioni turistiche alte: molte regge richiedono ingresso program• mato.
• Visite guidate o audioguide regalano contesto storico, leggende e dettagli architettonici che altrimenti passerebbero inosservati.
• Vestiario e regole culturali: alcuni palazzi (es. Thailandia, Turchia) richiedono abbigliamento contenuto o rispettoso.
Orari speciali e zone chiuse: alcune sale o giardini sono accessibili solo in certi giorni o sezioni delle regge possono essere chiuse per restauri.

La Via Francigena è un antico percorso di pellegrinaggio che unisce il Regno Unito all’Italia, passando per Francia e Svizzera, fino a Roma. Il primo tracciato noto fu registrato dall’arcivescovo inglese Sigerico, nel 990 d.C., che annotò le tappe del suo viaggio da Canterbury a Roma e ritorno.
Oggi la Via Francigena è riconosciuta come Itinerario Culturale Europeo (dal 1994) ed è percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo in molte sue sezioni.
Lungo il suo percorso si incontrano città, borghi e luoghi che offrono testimonianze storiche, culturali e paesaggistiche straordinarie. Vediamo alcune delle città principali attraversate.
Città e tappe principali sulla Via Francigena
Ecco una selezione di città e località significative lungo il cammino:
In Inghilterra e Francia
• Canterbury (Inghilterra) – punto di partenza del cammino di Sigerico.
• Calais (Francia) – una delle città costiere francesi attraversate.
• Reims (Francia) – città con grande patrimonio gotico e storico lungo il percorso.
• Besançon (Francia) – un’altra delle tappe note nel tratto francese della Via Francigena.
In Svizzera e al confine con l’Italia
• Lausanne (Svizzera) – attraversata durante il cammino verso l’Italia.
In Italia: città lungo la Via Francigena
Una volta entrata in Italia, la Via Francigena passa per numerose città e borghi significativi. Ecco alcune tappe toscane e laziali degne di nota:
• Ponte d’Arbia (Toscana) – località nei pressi di Siena, che originariamente fu una tappa (“Submansio Arbia”) documentata da Sigerico.
• Siena – nel tratto senese la Via attraversa il
territorio provinciale e offre scorci medievali caratteristici.
• Viterbo – città del Lazio attraversata dal percorso; nel suo centro storico si conserva il quartiere medievale di San Pellegrino, che ha evidenti legami con l’antico cammino.
Oltre a queste, lungo la Via Francigena si incontrano molti altri comuni, borghi e centri minori che arricchiscono l’esperienza del cammino, rendendola una traversata variegata tra natura, arte e spiritualità.
Perché visitare le città lungo la Via Francigena
• Storia viva
Le città sul percorso custodiscono chiese, mura, palazzi medievali e tracce delle comunità antiche che ospitavano i pellegrini.
• Esperienza a tappe Ogni città è un traguardo e insieme un punto di partenza: pernottare, esplorare, ripartire.
• Diversità paesaggistica
Dalle Alpi alla campagna toscana, fino alle colline del Lazio, il cammino offre paesaggi sempre diversi.
• Cultura locale
Ogni tappa è occasione di conoscere tradizioni, cucina, artigianato e talenti locali.

Nel quartiere di Tribeca, a Lower Manhattan, si erge un edificio che rompe con tutti gli schemi del panorama urbano di New York: 33 Thomas Street, noto anche come l’AT&T Long Lines Building. È celebre per una caratteristica insolita — oppure potremmo dire «inutile» —: non ha (quasi) finestre.
Architettura “blindata”
Progettato dall’architetto John Carl Warnecke e completato nel 1974, 33 Thomas Street è un esempio di architettura brutalista portata all’estremo. Le pareti esterne sono rivestite con pannelli prefabbricati in cemento rivestiti di granito svedese, senza aperture trasparenti (salvo l’ingresso a livello stradale).
Le uniche “aperture” visibili sono grandi condotti di ventilazione e le prese d’aria, necessarie per far respirare l’edificio.
Ma perché un edificio così “chiuso”?
Funzione, sicurezza e simbolismi
Motivi tecnici e funzionali
L’edificio è pensato per ospitare apparecchiature di telecomunicazione — centraline, switch, infrastrutture che non richiedono luce naturale. Una finestra avrebbe generato problemi di surriscaldamento o inefficienze termiche.
Inoltre, l’assenza di finestre è anche una misura di sicurezza: protezione contro intrusione, danni esterni o attacchi. L’edificio è concepito come una “fortezza” che può funzionare in modo autonomo.
Simbolismo e teorie della sorveglianza
Alcuni studiosi e osservatori hanno associato 33 Thomas Street al mondo della sorveglianza e del controllo statale. In documenti e analisi è stato indicato come un hub di telecomunicazioni potenzialmente coinvolto in operazioni di intercettazione o intelligence.
Nel saggio “Apocalypse-Proof”, l’edificio è descritto come “un grattacielo abitato dalle macchine” — un’architettura che incarna paranoia, riservatezza e la simbiosi tra tecnologia e potere.
Si dice che possa operare in modo autosufficiente per
settimane grazie a generatori interni, rifornimenti idrici e sistemi protetti.
Impatto visivo e percezione pubblica
L’aspetto monolitico e privo di finestre lo rende alieno rispetto allo skyline circostante. Camminando per le strade, appare come un blocco impenetrabile, spesso definito “misterioso” o “impervio”.
Alcuni architetti lo apprezzano per la coerenza progettuale e per l’assetto radicale; altri lo criticano come simbolo estremo di un’architettura inchiodata al potere e alla segretezza.
Negli ultimi decenni l’edificio ha suscitato interesse mediatico e teorico: è entrato in storie su spionaggio, teorie della sorveglianza e architettura urbana “oscura”.
Alcuni numeri interessanti
• Altezza: circa 550 piedi (≈ 170 metri)
• Piani: 29 piani utili
• Il carico per piano è più consistente di un grattacielo standard, per supportare apparecchiature pesanti.
• È stato progettato per resistere anche a eventi estremi e offrire rifugio in condizioni estreme.
Riflessioni finali
33 Thomas Street è un caso affascinante di architettura estrema, per il quale i tradizionali criteri di “bellezza”, “trasparenza” o “uso abitativo” diventano secondari rispetto alla funzione tecnologica e alla protezione dell’informazione. È un monumento alla materialità del potere e un monito sull’interazione tra tecnologia e città.
Il mondo è pieno di città “ordinarie”, con grattacieli, mercati, traffico e quartieri residenziali. Ma ci sono anche realtà che sembrano uscite da un sogno surreale, in cui la ragione lascia spazio all’insolito, al paradosso, all’estremo. Dalle città interamente dipinte ai borghi costruiti in grotte, passando per comunità quasi deserte: queste 13 località mostrano quanto la diversità urbana possa essere spettacolare.
Le 13 città più strane (una panoramica)
Ecco alcune delle città e località più curiose, secondo la classifica:
1. Thames Town, Cina
Replica in miniatura di un villaggio inglese: cabine telefoniche rosse, architettura vittoriana, strade acciottolate. È parte di un piano residenziale vicino a Shanghai.
2. Setenil de las Bodegas, Spagna
Un borgo dove le case sono letteralmente incassate nella roccia: pareti naturali e muri artificiali si combinano in una architettura unica.
3. Longyearbyen, Norvegia
La città abitata più a nord del mondo. Per quattro mesi l’anno il sole non sorge: una peculiarità estrema del ciclo giorno-notte artico.
4. Consonno, Italia
Un tempo borgo agricolo, trasformato negli anni ’60 in “città dei balocchi” e poi abbandonato dopo una frana. Oggi è un paese fantasma con un passato visionario.
5. Isola di Miyake-jima, Giappone
Isola vulcanica dove gli abitanti sono obbligati a portare una maschera antigas perché il suolo emette gas tossici.
6. Slab City, USA
Conosciuta anche come “l’ultima città libera d’America”: comunità che vive in camper o autobus, senza elettricità, acqua o servizi pubblici ufficiali.
7. Coober Pedy, Australia
In un paesaggio desertico, la popolazione vive quasi interamente sotto terra, per sfuggire al caldo estremo. Le case, i negozi e persino chiese sono scavati nel terreno.
8. Chefchaouen, Marocco
Il “villaggio blu” del Marocco: gli edifici sono dipinti in tonalità azzurre, una scelta estetica e simbolica che ha profondi legami culturali.
9. Monowi, USA
Un paese con un solo abitante: Elsie Eiler, che gestisce il bar e la biblioteca. È anche sindaca. La popolazione una volta era maggiore, ma si è gradualmente ridotta.
10. Kampung Pelangi, Indonesia
Una baraccopoli che è diventata un villaggio arcobaleno: ogni edificio è stato dipinto con colori vivaci per creare un’attrazione turistica.
11. Dwarf Village, Cina
Un villaggio abitato esclusivamente da persone con nanismo, che si esibiscono in spettacoli di musica, danza e teatro.
12. Elista, Russia
Città famosa per gli scacchi: spazi urbani dedicati al gioco, scacchiere giganti e una identità culturale legata a questa disciplina.
13. Battleship Island (Hashima), Giappone
Isola industriale abbandonata che ricorda una corazzata. Un tempo densamente popolata, oggi è un simbolo spettrale di declino.
Che cosa rende “strana” una città?
Le ragioni che spingono una città nel “territorio dell’insolito” sono molteplici:
• Condizioni estreme: clima, ubicazione remota, elementi naturali (vulcani, deserti, artico).
• Scelte architettoniche radicali: case in grotta, edifici ipercolorati, replica di stili lontani.

• Declino demografico: città simboliche con popolazioni ridotte al minimo.
• Trasformazioni urbane incompiute: progetti ambiziosi abortiti che lasciano tracce utopiche.
• Progetti artistici e rigenerazione collettiva: quando una comunità reinterpreta il proprio spazio con interventi colorati o insoliti.
Per il viaggiatore curioso
• La visita a queste città offre più di uno scatto fotografico: è un’esperienza che spinge a riflettere su identità, memoria e paesaggi liminali.
• Alcune località sono facili da raggiungere (Chefchaouen, Setenil de las Bodegas), altre richiedono logistica adeguata (Monowi, Slab City, Battleship Island).
• Il carattere “strano” può mutare: ad esempio, progetti di restauro, turismo di massa o politiche urbane possono trasformare radicalmente queste comunità.
La “Casa del Postino” di Salina è salva: il tribunale la dichiara non abusiva


La celebre villetta sull’isola di Salina, resa immortale dal film Il Postino con Massimo Troisi, non verrà abbattuta: il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha riconosciuto che non è abusiva, accogliendo il ricorso del proprietario. Questo pronunciamento mette fine a un contenzioso iniziato con una segnalazione secondo cui l’immobile avrebbe subito ampliamenti non autorizzati durante ristrutturazioni.
Il luogo, il film, il peso simbolico
La villetta si trova a Pollara, nella contrada Punta del Comune di Malfa, sull’isola di Salina, nelle Eolie Nel film, è il rifugio del poeta Pablo Neruda (interpretato da Philippe Noiret) che instaura un legame poetico con il protagonista Mario, il postino interpretato da Troisi.
La casa è immersa in ulivi, ibiscus, oleandri e si inserisce nella morfologia tipica eoliana: l’architettura locale è parte integrante del valore che ha avuto nel film e nel paesaggio attorno.
Motivazioni della sentenza
I giudici – il relatore Nino Caleca e il presidente Ermanno de Francisco – hanno ritenuto fondato il ricorso del proprietario, il signor Giuseppe Cafarella, e hanno annullato il provvedimento del Comune che dichiarava parzialmente abusiva la casa.
Le motivazioni indicate includono:
• l’esistenza di titoli edilizi validi (in particolare una concessione del 1985) che legittimano le dimensioni attuali dell’immobile;
• la compatibilità delle modifiche con tali titoli;
• il riconoscimento del valore artistico, paesaggistico e pubblico del bene: la casa è legata al film, al patrimonio culturale e alla memoria collettiva.
• il fatto che l’immobile fosse già inserito nella LIM (Carta dei luoghi dell’identità e della memoria) della Regione Siciliana, in relazione al riconoscimento delle Isole Eolie come sito UNESCO.
In sostanza, il tribunale ha stabilito che la casa non è
abusiva e che il tentativo di demolizione non poteva essere mantenuto.
Che cosa succede adesso
Con questa sentenza, la “Casa del Postino” resta in piedi e può essere preservata come bene d’interesse culturale e paesaggistico.
Il proprietario spera che si apra l’iter per il vincolo ufficiale che riconosca e tuteli permanentemente l’immobile, includendolo in circuiti culturali e turistici formalizzati.
Tuttavia, l’accesso al pubblico non è garantito: la casa non è gestita come museo né aperta su base ordinaria, e non è chiaro quando o se lo sarà.
Significato culturale e simbolico•
Questa vicenda mostra come il diritto e la cultura possano intersecarsi:
• Un luogo cinematografico – parte della memoria collettiva – è stato messo in pericolo da questioni edilizie, e salvato grazie alle sue valenze simboliche.
• Il riconoscimento del “valore pubblico” può giocare un ruolo decisivo nei contenziosi urbanistici.
• L’architettura locale (in questo caso, eoliana) e il paesaggio circostante sono considerati elementi essenziali per valutare la compatibilità di un edificio con il suo contesto.
• La tutela non è sempre automatica: richiede iniziativa, ricorsi e visione che vada oltre la mera proprietà privata.
Napoli prima al mondo, seguita da Milano, Bologna, Firenze, Roma e Torino. Un trionfo del made in Italy della tavola, tra tradizione e identità territoriale
Nel mondo globalizzato dei sapori, dove ogni metropoli rivendica un piatto iconico e un rito culinario, l’Italia resta imbattibile. L’ultima classifica internazionale di TasteAtlas – la piattaforma che raccoglie milioni di recensioni sui piatti e le cucine tradizionali di tutto il mondo – incorona il nostro Paese come la culla gastronomica più amata del pianeta: sei città italiane figurano nella top ten mondiale 2025 delle città dove “si mangia meglio al mondo”.
Un primato che non è solo statistico ma culturale: in un panorama dominato da street food asiatico e fusion metropolitane, l’Italia si distingue per continuità, identità e memoria. Dalla pizza napoletana alla bistecca fiorentina, dai tajarin torinesi al risotto milanese, la cucina italiana resta – nelle parole di TasteAtlas – «una forma d’arte collettiva capace di emozionare più di ogni altra».
La classifica 2025: ecco le dieci capitali del gusto secondo TasteAtlas
Posizione
(Fonte: TasteAtlas, Best Food Cities 2025)
Un dominio italiano che racconta una storia
Osservando la classifica, la prima impressione è evidente: l’Italia non ha rivali. Sei città su dieci appartengono alla stessa nazione, e ciascuna rappresenta un diverso modo di intendere la tavola.
Napoli, in vetta, è l’archetipo del gusto popolare che diventa universale: la pizza è ormai patrimonio dell’umanità, ma solo sotto il Vesuvio conserva la perfezione originaria, fatta di lievito madre, pomodoro San Marzano e forno a legna. La cucina napoletana è identità, rito collettivo e teatro di strada.
Subito dopo c’è Milano, che incarna la modernità gastronomica: capitale della creatività culinaria contemporanea, ma ancora legata ai suoi classici come il risotto allo zafferano e l’ossobuco. È la città che ha saputo trasformare la cucina lombarda in un linguaggio internazionale, tra sostenibilità, design e sapori del territorio.
Bologna, terza, rappresenta la sostanza: qui si mangia “di gusto e di pancia”. Il ragù bolognese e le lasagne verdiraccontano una cultura familiare e inclusiva, che ha fatto della convivialità un simbolo di civiltà. È la città dove il cibo è ancora artigianato puro, tra tortellini fatti a mano e mercati che profumano di burro e salvia.
Firenze, al quarto posto, esprime la semplicità della materia prima trasformata in eccellenza: la bistecca alla fiorentina, i crostini ai fegatini, la ribollita e il lampredotto sono il manifesto di una cucina che celebra il rispetto per il prodotto e il gesto essenziale del cucinare.
Roma, sesta, è la città dell’istinto gastronomico. I piatti simbolo – carbonara, amatriciana, cacio e pepe – sono ormai parte dell’immaginario mondiale. Qui il cibo è racconto popolare, improvvisazione, arte di arrangiarsi: la “romanità” si

esprime anche a tavola, tra osterie e trattorie che resistono al tempo.
Infine Torino, nona, regina del Nord-Ovest, rappresenta l’eleganza sabauda del gusto: i tajarin, gli agnolotti, il vitello tonnato, ma anche il gianduiotto e il bicerin, testimoniano una cucina che unisce la tradizione contadina all’eredità aristocratica. È il gusto della misura, del dettaglio, della lentezza consapevole.
Le altre protagoniste: un mondo che si confronta con l’Italia
Fuori dai confini italiani, solo quattro città resistono all’assalto del made in Italy: Mumbai, Parigi, Vienna e Osaka.
Mumbai porta nella classifica il fascino speziato dell’India urbana: street food, fusion, sapori decisi. Il suo simbolo, il vada pav, è il “panino del popolo”, sintesi perfetta tra tradizione e contemporaneità.
Parigi resta icona di raffinatezza: la crème brûlée e la pasticceria francese continuano a esercitare il loro fascino, anche se la capitale francese sembra oggi più influenzata dalle mode globali che dalle proprie radici regionali.
Vienna, ottava, difende la tradizione mitteleuropea: i piatti di carne, la pasticceria imperiale, il culto del caffè.
Osaka, decima, è la rappresentante dell’Estremo Oriente e capitale dello street food giapponese, con i celebri takoyaki – polpette di polpo e pastella che incarnano la convivialità nipponica.
Un segnale culturale: il cibo come identità
La supremazia italiana nella classifica Taste
Atlas non è un caso. L’Italia non è solo un Paese che “mangia bene”, ma un Paese che vive attraverso il cibo
In ogni città, la gastronomia diventa linguaggio identitario, memoria collettiva, espressione estetica e sociale.
Napoli e Roma raccontano la passione; Bologna e Firenze la solidità della tradizione; Milano e Torino la capacità di innovare senza perdere le radici.
È un mosaico di culture culinarie che, unite, rappresentano la più potente diplomazia culturale italiana nel mondo.
La sfida, ora, sarà quella di non trasformare questo successo in retorica.
La globalizzazione, il turismo di massa e l’omologazione dei sapori rischiano di banalizzare ciò che l’Italia ha di più prezioso: la sua autenticità gastronomica.
Ma se la classifica TasteAtlas ci insegna qualcosa, è che la forza del gusto italiano sta nella verità dei suoi piatti, nel legame tra cibo e territorio, tra mani e memoria.
E finché in una trattoria di Napoli verrà servita una pizza margherita come quella di cento anni fa, o a Bologna un ragù che profuma di domenica, o a Torino un bicchiere di vermouth versato lentamente, l’Italia continuerà a sedersi in cima alla tavola del mondo.

In un mondo sempre più connesso e affollato, l’idea di vivere per alcuni mesi su un’isola isolata può suonare da sogno. E questa occasione sta diventando realtà: l’isola di Handa, al largo della costa nord-occidentale della Scovezia, ha aperto le candidature per un guardiano stagionale che riceverà alloggio gratuito e uno stipendio di circa 30.000 € per sei mesi di servizio.
Dove si trova Handa e qual è il suo valore naturale
Handa è un’isola remota, prevalentemente composta di arenaria, circondata da scogliere che si innalzano fino a 100 metri.
È nota soprattutto per la ricca fauna selvatica: colonie di uccelli marini (come le urie, le gazze marine e gli stercorari maggiori) nidificano sulle scogliere, e le acque circostanti sono talvolta frequentate da balene, delfini o squali elefante.
L’isola non ha residenti permanenti e il silenzio domina il paesaggio, interrotto solo dagli elementi naturali e dai richiami degli animali.
L’offerta: cosa prevede il ruolo di guardiano
Il contratto ha durata stagionale: sei mesi, da marzo a settembre 2025.
La retribuzione promessa è intorno a 30.000 € e comprende l’alloggio sull’isola.
Mansioni principali
Tra i compiti del guardiano:
• cura e supervisione delle attività dell’isola (manutenzione, gestione della fauna)
• coordinamento e supervisione dei volontari che possono collaborare nelle attività di conservazione
• accoglienza e gestione dei visitatori — ogni anno l’isola riceve migliaia di persone che la visitano
• gestione dei programmi di lavoro e rotazione delle attività nell’arco della stagione Requisiti richiesti
Non sono richieste qualifiche specifiche, ma:
• è preferibile avere una conoscenza della flora e fauna locali (sia terrestre che marina)
• serve una patente di guida valida e un mezzo per gli spostamenti verso la terraferma (verso il villaggio di Scourie) per compiti logistici (spesa, lavanderia, etc.)
• spirito di adattamento, autonomia e propensione a vivere in un ambiente isolato e con risorse limitate
Vita sull’isola: tra sfide e fascino naturale
Vivere a Handa significa abbracciare una vita essenziale. L’unico collegamento regolare con la terraferma avviene una volta alla settimana, per consentire al guardiano di adempiere alle necessità pratiche.
L’isolamento, la mancanza di infrastrutture urbane e la convivenza quotidiana con natura selvaggia possono risultare impegnativi, ma anche straordinariamente gratificanti. Per chi ama il birdwatching, il silenzio, la distanza dal caos moderno, l’esperienza è unica.
Per chi è adatta questa opportunità
Questa offerta è ideale per:
• persone che cercano un’esperienza fuori dagli schemi, immersi nella natura
• chi ha conoscenze o passione per la fauna e l’ecologia
• coppie (l’alloggio è “spazioso” abbastanza da ospitare due persone)
• chi sa convivere con l’isolamento, le condizioni spartane e un ritmo di vita differente
Tra i paesaggi più suggestivi d’Inghilterra c’è un isolotto che emerge dalle acque costiere, legato alla terraferma da un sentiero che appare e scompare al ritmo delle maree: St Michael’s Mount. Questo luogo affascinante fonde storia, mito, architettura e natura, offrendo al visitatore un’esperienza che sembra sospesa tra leggenda e realtà.
Un “gemello” inglese del Mont Saint-Michel
St Michael’s Mount è un isolotto mareale situato nella baia di Mount’s Bay, in Cornovaglia (Inghilterra), nei pressi del villaggio di Marazion.
È collegato alla terraferma tramite una calzada di pietra acciottolata visibile durante la bassa marea. Quando la marea è alta, invece, l’isolotto è raggiungibile solo in barca.
Storicamente, St Michael’s Mount è spesso citato come “la controparte inglese” del Mont Saint-Michel in Normandia, per la somiglianza nell’impostazione: un’isola mareale con un edificio sacro / fortificato sulla sommità.
Tuttavia, pur richiamandone il modello e condividendo alcune funzioni monastiche nel Medioevo, non vi è identità diretta: le storie si intrecciano, ma sono specifiche per ciascuno dei due luoghi.
Storia, architettura e proprietari
Le radici monastiche e il passaggio a castello
Le prime tracce umane sull’isolotto risalgono al Neolitico, e nel corso dei secoli è stato probabilmente un punto di culto o rifugio in epoca antica.
Nel Medioevo, sull’isolotto fu eretto un priorato benedettino, e la sommità ospitava chiesa e edifici religiosi.
Dopo la Dissoluzione dei monasteri sotto Enrico VIII, le funzioni religiose recedettero, e l’isolotto si trasformò in fortezza e residenza difensiva.
A partire dal XVII secolo, la famiglia St Aubyn acquistò il sito e da allora lo gestisce. Ad oggi, l’isola è gestita insieme al National Trust, con la famiglia che mantiene un contratto in diritto di occupazione per il castello.
Struttura e funzione
In cima all’isolotto sorge un castello / palazzo fortificato, con terrazze, mura, giardini pensili e parti architettoniche stratificate che riflettono secoli di cambiamenti stilistici e funzionali.
Alla sommità si trova anche la Chiesa di San Michele & tutti gli angeli (St Michael & All Angels), che continua a essere un luogo di culto oggi.
Parte dell’isolotto è stata classificata come Site of Special Scientific Interest (SSSI) per il valore geologico: le rocce granitiche, le intrusioni e la loro esposizione sono oggetto di studio geologico.
Visitare St Michael’s Mount
Come arrivarci e quando
• È consigliato prenotare in anticipo l’ingresso al castello e ai giardini tramite il sito ufficiale.
• Durante la bassa marea, è possibile attraversare a piedi il causeway (la calzada) che collega l’isolotto a Marazion.
• Altrimenti, nei momenti di alta marea, si utilizzano barche di collegamento dal porto vicino.
• Le aperture per i visitatori possono variare, e ci sono parti dell’isolotto meno accessibili (percorsi ripidi, gradinate) che richiedono un minimo di mobilità. Cosa vedere
• Il castello e le sale storiche, con arredi antichi, collezioni e panorami sul mare
• I giardini terrazzati, con piante adattate al clima marino e viste spettacolari
• La chiesa di San Michele, ancora in uso

• Il villaggio portuale che sorge alla base dell’isolotto: negozietti, strutture ricettive, carattaristici spazi costieri
• Percorsi panoramici, scorci marini, stazioni panoramiche e piccoli dettagli architettonici nascosti
Miti e leggende
Attorno a St Michael’s Mount si intrecciano narrazioni leggendarie, come per molti luoghi costieri:
• Si dice che l’arcangelo Michele apparve ai pescatori nel V secolo sull’isolotto, da cui deriva il nome sacro.
• Alcune leggende collegano l’isolotto a miti di giganti, di maree che sommergono terre perdute e di passaggi misteriosi tra terra e mare.
• Come altri luoghi mareali sacri, è stato meta di
pellegrinaggi o itinerari spirituali (es. il “St Michael’s Way” in Cornovaglia, percorso a piedi che conduce all’isolotto).
Un territorio vulnerabile
Tra le sfide del luogo:
• L’erosione costiera e l’innalzamento del livello del mare possono mettere a rischio il collegamento causa-mare e alcune superfici basse del sito
• La manutenzione del castello, delle strutture storiche e dei giardini richiede risorse continue
• La gestione del turismo: dare accesso e conservare il sito significa trovare un equilibrio tra flussi di visitatori e protezione del patrimonio
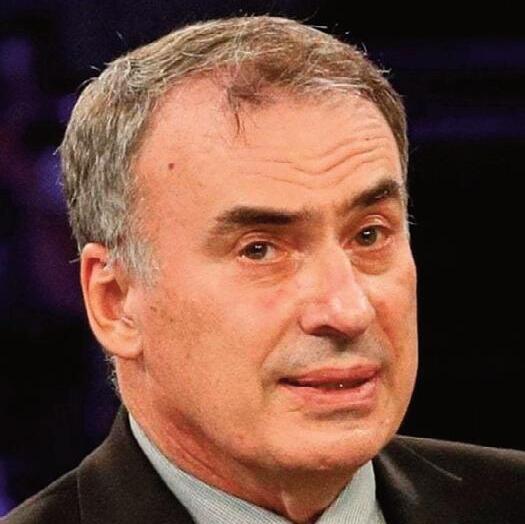

Negli ultimi decenni l’Italia, come gran parte dell’Europa, ha conosciuto una trasformazione profonda nella distribuzione della popolazione: da un lato le città si sono progressivamente espanse, inglobando periferie e territori circostanti; dall’altro le aree rurali, interne e montane hanno subito un costante processo di spopolamento. Si tratta di un fenomeno non nuovo, radicato nelle grandi migrazioni del Novecento e nell’industrializzazione che ha attratto milioni di persone dalle campagne ai poli urbani, ma che oggi assume caratteristiche inedite a causa della globalizzazione, della digitalizzazione e del cambiamento climatico.
Queste dinamiche non riguardano solo la geografia della popolazione, ma incidono sulla qualità della vita, sulla coesione sociale e sull’equilibrio ambientale. Le città, sovraccariche di pressioni abitative, di traffico e di inquinamento, rischiano di diventare organismi ingovernabili, mentre i territori rurali vedono indebolirsi il tessuto economico e sociale, con la perdita di servizi essenziali e competenze.
Espansione urbana e spopolamento delle aree rurali non sono dunque due tendenze separate, ma parti di un medesimo processo che ridisegna il rapporto tra uomo, comunità e territorio. Analizzarne le implicazioni significa riflettere sul modello di sviluppo che vogliamo costruire per il futuro, cercando nuove forme di equilibrio tra città vitali e campagne abitate, capaci di produrre benessere, identità e sostenibilità.
Le dinamiche dell’espansione urbana
Le città esercitano una forza attrattiva crescente: la concentrazione di servizi, opportunità lavorative, infrastrutture sanitarie ed educative, oltre all’accesso a reti di trasporto e comunicazione, spinge individui e famiglie a spostarsi dai contesti rurali a quelli urbani. Tuttavia, l’espansione urbana non sempre avviene in maniera equilibrata.
In molte realtà si assiste a fenomeni di urban sprawl, ovvero a un’espansione diffusa e poco pianificata che consuma suolo agricolo e naturale, frammenta gli ecosistemi, aumenta l’inquinamento e rende più difficile
la gestione dei servizi pubblici. Le periferie si dilatano, spesso senza un disegno organico, generando insediamenti residenziali privi di coesione sociale e di accessibilità adeguata.
Le città, pur continuando ad attrarre risorse e capitale umano, rischiano così di diventare spazi congestionati, segnati da disuguaglianze, marginalità e vulnerabilità ambientale.
Lo spopolamento delle aree rurali
Parallelamente, le aree rurali e interne soffrono di un progressivo spopolamento. Giovani e famiglie in cerca di lavoro, istruzione e opportunità abbandonano i piccoli centri, che si ritrovano con una popolazione sempre più anziana, connessa a reti deboli di servizi e infrastrutture. Questo processo produce una spirale di declino: meno residenti significano meno servizi, meno investimenti e minore attrattività, accentuando così la fuga verso le città.
Le conseguenze sono molteplici:
• perdita di attività economiche legate all’agricoltura e all’artigianato;
• degrado del patrimonio edilizio e culturale;
• riduzione della biodiversità colturale;
• aumento del rischio di dissesto idrogeologico per l’abbandono dei terreni agricoli e forestali.
Inoltre, lo spopolamento accentua le disuguaglianze territoriali: mentre le aree urbane diventano poli dinamici, le aree rurali r ischiano di trasformarsi in spazi marginali, con pochi residenti e scarse prospettive.
Le interconnessioni tra città e aree rurali
Espansione urbana e spopolamento rurale non possono essere analizzati separatamente: le due dinamiche sono strettamente collegate. L’attrazione delle città cresce
nella misura in cui i territori rurali non offrono servizi, opportunità e qualità della vita adeguati. Viceversa, il declino delle aree interne alimenta la pressione demografica ed edilizia sulle aree metropolitane.
Eppure, le città dipendono dai territori rurali per risorse fondamentali: acqua, cibo, aria pulita, energia, paesaggi naturali. Il loro destino è dunque interdipendente.
Riconoscere questa interconnessione è il primo passo per immaginare un futuro nel quale urbano e rurale non siano realtà in competizione, ma partner in un sistema territoriale equilibrato e sostenibile.
Implicazioni di policy
Affrontare questa sfida richiede politiche integrate e multilivello, capaci di ridurre gli squilibri tra aree urbane e rurali. Alcuni assi di intervento fondamentali:
1. Rafforzare i servizi nelle aree interne: sanità, scuola, mobilità e connettività digitale devono essere garantiti come diritti essenziali.
2. Valorizzare l’economia rurale: sostenere agricoltura sostenibile, produzioni tipiche, filiere corte e turismo responsabile.
3. Pianificazione urbana sostenibile: limitare il consumo di suolo, promuovere città compatte e policentriche, recuperare aree dismesse anziché espandersi in maniera incontrollata.
4. Governance territoriale integrata: costruire alleanze tra città e aree rurali, rafforzando la cooperazione intercomunale e interregionale.
5. Promozione di nuove forme di abitare: favorire il ritorno alle aree rurali attraverso incentivi fiscali, coworking diffusi, smart working e progetti di rigenerazione comunitaria.
Conclusioni
L’espansione urbana e lo spopolamento delle aree rurali sono processi che minacciano l’equilibrio dei territori e la coesione sociale. Affrontarli non significa arrestare la crescita delle città né forzare un ritorno idealizzato alla campagna, ma costruire un nuovo patto tra urbano e rurale, basato su reciprocità e sostenibilità.
Solo se le città sapranno riconoscere il valore strategico delle aree interne e se i territori rurali saranno resi luoghi vivibili, connessi e produttivi, sarà possibile garantire uno sviluppo equilibrato e inclusivo. La sfida del futuro sarà dunque quella di immaginare un’Italia — e più in generale un’Europa — in cui città e campagne non siano mondi opposti, ma parti complementari di un unico ecosistema sociale, economico e ambientale.



Le città sono da sempre luoghi privilegiati di incontro, di scambio e di produzione culturale. Nelle aree urbane si concentrano università, centri di ricerca, biblioteche, musei, ospedali, teatri, laboratori tecnologici e spazi di divulgazione. In questo ecosistema complesso, la scienza non rappresenta soltanto un insieme di saperi specialistici, ma diventa un veicolo di conoscenza condivisa, capace di orientare le politiche, migliorare la qualità della vita e rafforzare la coesione sociale. In un’epoca segnata da crisi globali — sanitarie, ambientali, energetiche — il ruolo della scienza nelle città non è più confinato ai laboratori o agli atenei, ma permea la vita quotidiana dei cittadini, influenzando le scelte individuali e collettive.
Le città moderne si configurano come veri e propri laboratori sociali, nei quali la scienza trova spazio per sperimentare e applicare conoscenze a beneficio della collettività. Dalla gestione dei trasporti alla pianificazione urbanistica, dalla salute pubblica al contrasto dell’inquinamento, le soluzioni scientifiche diventano strumenti operativi per affrontare sfide complesse.
La scienza, nei contesti urbani, non è solo produzione accademica, ma anche innovazione tecnologica e trasferimento di conoscenze. Startup, incubatori, reti di innovazione e comunità digitali contribuiscono a trasformare la città in un ecosistema dinamico, dove la ricerca dialoga con l’economia e con le esigenze sociali.
Scienza e cittadinanza attiva
Un aspetto cruciale riguarda la democratizzazione del sapere scientifico. Le città sono spazi privilegiati per la diffusione della cultura scientifica: festival, mostre in-
terattive, musei della scienza, iniziative di citizen science permettono ai cittadini di partecipare attivamente alla produzione e alla condivisione delle conoscenze.
Questo processo rafforza la cittadinanza scientifica, intesa come capacità dei cittadini di comprendere, valutare e utilizzare le informazioni scientifiche nelle decisioni quotidiane. In tal senso, la scienza diventa veicolo di empowerment sociale, riducendo le disuguaglianze culturali e contrastando fenomeni di disinformazione e sfiducia nelle istituzioni.
Scienza per la salute urbana
La pandemia di COVID-19 ha mostrato con chiarezza quanto la scienza sia fondamentale per la resilienza delle città. Le decisioni legate a mobilità, spazi pubblici, campagne vaccinali e modelli di prevenzione sono state guidate dalla ricerca scientifica e dall’evidenza epidemiologica.
Ma oltre alle emergenze, la scienza contribuisce ogni giorno al miglioramento della salute urbana: studi sull’inquinamento, sull’alimentazione, sulla salute mentale, sugli stili di vita attivi orientano le politiche pubbliche e le scelte individuali. In questo senso, la città diventa un campo di applicazione per la scienza della complessità, che analizza le interazioni tra ambiente, società e salute.
Per valorizzare il ruolo della scienza come veicolo di sapere nei contesti urbani, è necessario rafforzare alcune linee di intervento:
• Investire in infrastrutture culturali e scientifiche, accessibili e diffuse in tutto il tessuto urbano.

• Promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi scientifici, attraverso iniziative di cocreazione e citizen science.
• Integrare la scienza nelle politiche urbane, adottando un approccio evidence-based nella pianificazione e nella governance.
• Ridurre le disuguaglianze nell’accesso al sapere, garantendo che la divulgazione scientifica raggiunga anche i quartieri periferici e le comunità marginali.
• Creare alleanze tra università, enti locali, imprese e società civile, per trasformare la conoscenza in innovazione concreta e condivisa.
La scienza, nei contesti urbani, non è un sapere astratto né riservato agli addetti ai lavori: è uno strumento di emancipazione collettiva e di innovazione sociale. Le città che sanno mettere la scienza al centro dei propri processi decisionali diventano più resilienti, inclusive e sostenibili.
Riconoscere la scienza come bene comune urbano significa rafforzare la capacità delle comunità di affrontare sfide globali e locali, costruendo ponti tra sapere e società. In definitiva, la scienza non è solo conoscenza: è energia civile, veicolo di consapevolezza e motore di futuro per le città e per i cittadini che le abitano.

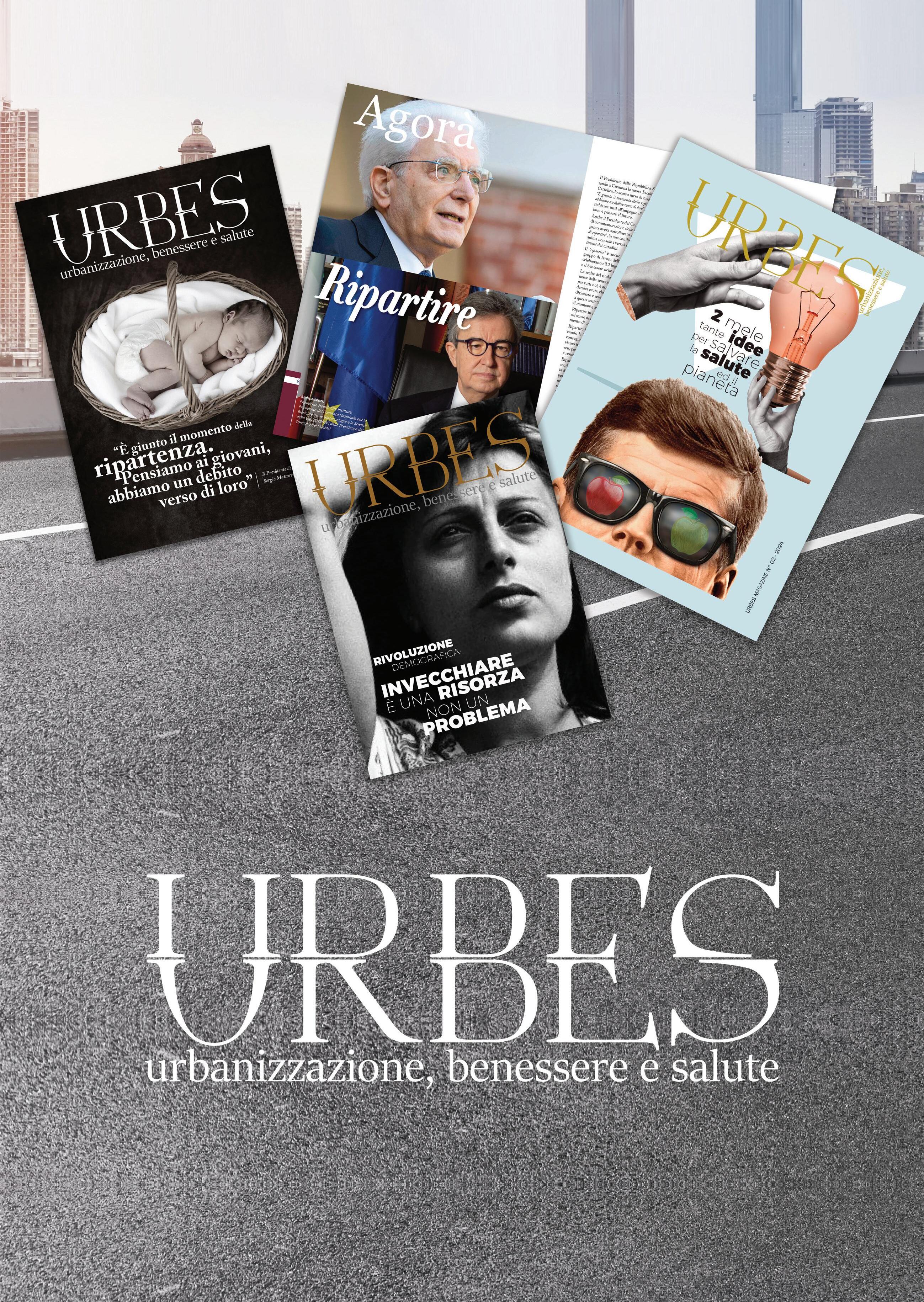
HTTPS://WWW.URBESMAGAZINE.IT/

Il 6 ottobre 2025 l’iniziativa “Economy for the Common Good” (ECG, da qualche tempo operante come ECOnGOOD) ha celebrato il suo quindicesimo anniversario, segnando un momento importante nella vita di un movimento che ambisce a trasformare il paradigma economico dominante.
Fondata nel 2010 in Austria, Baviera e Alto Adige su impulso del pensatore e attivista Christian Felber, l’iniziativa ha come obiettivo primario quello di rendere il bene comune — piuttosto che il profitto individuale — il fine centrale dell’attività economica.
Nel corso di questi anni, ECG/ECOnGOOD è cresciuta non solo come movimento culturale e teorico, ma ha anche dato vita a strumenti concreti di misurazione, certificazione e applicazione di principi etici nelle organizzazioni: aziende, enti pubblici, istituzioni educative.
Alcuni numeri e risultati salienti
Nel comunicato per i 15 anni, si citano i seguenti dati (aggiornati al momento della celebrazione):
• Oltre 1.400 organizzazioni che hanno redatto un bilancio del bene comune (Common Good Balance Sheet)
• Quasi 50 città e municipi che hanno applicato il modello ECG
• Più di 200 università coinvolte nell’insegnamento, nella ricerca o nella diffusione della visione ECG
• Circa 11.000 sostenitori nel mondo, 5.000 membri attivi in oltre 170 gruppi locali, 35 associazioni nazionali
• L’adozione, nel 2015, di un parere interno al Comitato Economico e Sociale Europeo (EESC) favorevole a ECG, con una maggioranza dell’86 %
Secondo Christian Felber, un modello economico radicato nelle convinzioni etiche e democratiche ha bisogno di “150 anni per maturare pacificamente e attuarsi democraticamente” — eppure nei primi 15 anni “siamo arrivati sorprendentemente lontano.”
Tra i progressi tangibili menzionati:
• Lo sviluppo di strumenti come il conto del bene comune pubblico (Common Good Account), il Business Canvas ECG, l’etichetta ECOnGOOD Label per prodotti che riflettono il bilancio del bene comune.
• L’attività accademica: cattedre, programmi universitari e conferenze internazionali (già tre conferenze internazionali ECG realizzate fino al 2025)
• L’estensione geografica: da Austria / Germania / Italia verso l’Argentina, il Giappone e altri paesi, con associazioni ECG attive su diversi continenti.
L’articolo festeggia non solo il passato ma guarda al futuro, con l’evento ECOnGOOD International Conference (ECGIC 2026) a tema “Transforming towards a fair and sustainable economy” che si terrà ad Amberg, in Germania. Economy for the common good+1
Che cos’è il modello ECG / ECOnGOOD?
Per comprendere il significato di questo anniversario, è utile riassumere in cosa consiste il modello ECG:
• ECG è un modello economico alternativo che pone come obiettivo primario il bene comune, ossia una vita buona per tutte le persone in equilibrio con il pianeta.
• I valori fondanti sono: dignità umana, solidarietà e giustizia sociale, sostenibilità ambientale, trasparenza e co-determinazione (partecipazione
• Il fulcro operativo per le organizzazioni è il bilancio del bene comune (Common Good Balance Sheet), che si basa su una matrice composta da 20 temi che valutano come l’ente — azienda, municipio, scuola, … — contribuisce al bene comune.
• Sulla base del risultato del bilancio, un’organizzazione può ottenere un’etichetta (ECOnGOOD Label), che segnala al pubblico il suo impegno concreto verso criteri sociali, etici e ambientali.
• Non si limita al livello micro (aziendale) ma propone interventi anche a livello politico: incentivi, fiscalità favorevole alle imprese ECG, politiche pubbliche, appalti preferenziali, ecc.
• Il modello non si limita all’Europa: ECG sostiene che i principi siano universali, in grado di dialogare con contesti diversi, culture e sistemi economici. In sintesi: ECG tenta di dare forma concreta a un’idea che spesso rimane astratta — che l’economia serva le persone e non viceversa — integrando etica, misurazione, partecipazione e cambiamento istituzionale.
Forze, sfide e prospettive
Forze e punti di forza
1. Strumento concreto
Non si tratta solo di un manifesto: il bilancio del bene comune rappresenta un metodo operabile per misurare ciò che nell’economia tradizionale è spesso ignorato (valore sociale, impatto ambientale, qualità della governance).
2. Vocazione democratica e inclusiva
La co-determinazione e la trasparenza come valori centrali offrono una modalità di governo delle imprese e degli enti che rompe con il modello “top-down”.
3. Rete internazionale
La diffusione in più paesi, le associazioni, le conferenze internazionali, l’attività accademica: tutto contribuisce a rafforzare la credibilità e la legittimità del modello.
4. Sinergia con gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDG)
Le imprese e i municipi che adottano il bilancio del bene comune possono usarlo come leva per allinearsi agli SDG dell’ONU.
Sfide e limiti
1. Scalabilità e diffusione
Pur con oltre 1.400 organizzazioni coinvolte, il mondo economico rimane in gran parte estraneo al modello. Passare da “nicchia” a “massa critica” è una sfida non da poco.
2. Competitività economica nel contesto corrente
La transizione verso modelli etici può scontrarsi con logiche di mercato che premiano costi più bassi, economie di scala aggressive, concorrenza senza vincoli.
3. Standardizzazione vs contesto locale
Applicare gli stessi criteri etici e ambientali in Paesi con differenze culturali, normative, economiche richiede flessibilità e adattamento del modello.
4. Incentivi politici e istituzionali
Perché il modello ECG possa esprimere tutto il suo potenziale serve che vi siano politiche di supporto: fiscalità, appalti pubblici favorevoli, regolamentazioni che riconoscano il valore del “bene comune”.
5. Riconoscimento legale e normativo
In molti ordinamenti giuridici, il concetto di “bilancio sociale” o “bilancio del bene comune” non ha ancora un valore vincolante. Occorre costruire ponti tra la teoria ECG e le leggi vigenti.
Prospettive per i prossimi 15 anni
• Politiche pubbliche integrate
Se alcuni Paesi o regioni decidessero di integrare il modello ECG nelle politiche fiscali, negli appalti pubblici o nei criteri di finanziamento, si potrebbe ottenere un salto di scala.
• Educazione e cultura
Intensificare l’inserimento del modello ECG nei curricula universitari e nelle scuole (cosa che già accade in diversi casi) può formare generazioni più consapevoli.
• Collaborazioni con altre economie alternative ECG può dialogare con modelli come l’economia circolare, il movimento B Corp, le imprese sociali, l’economia della condivisione, per costruire sinergie e integrazioni.
• Tecnologia e digitalizzazione
Strumenti digitali per la raccolta dati, la rendicontazione, la tracciabilità, l’open data possono rendere il bilancio del bene comune più agile, accessibile, verificabile.
• Espansione globale
L’attenzione verso Africa, America Latina e Asia
dovrà crescere, adattando il modello alle realtà locali, valorizzando culture e partenariati locali.
• Ricerca e validazione empirica
Occorre continuare a verificare con studi empirici l’efficacia del modello: impatto ambientale, qualità della vita, vantaggi competitivi per le imprese aderenti.
Il quindicesimo anniversario di ECG / ECOnGOOD è un’occasione per guardare indietro e riconoscere quanto è stato fatto — ma anche per focalizzare lo sguardo sul compito ancora grande che si pone avanti.
Questo movimento dimostra che non è solo possibile pensare un’economia diversa, ma anche cominciare a viverla concretamente. Il bilancio del bene comune, l’etichetta ECOnGOOD, l’applicazione nei comuni e nelle università sono passi concreti verso un’economia che metta il valore sociale e ambientale al centro.

A cura dell’Health City Institute
L’esperienza dei 15 anni di Economy for the Common Good dimostra che è possibile tradurre principi etici e di sostenibilità in strumenti concreti di governance. L’Health City Institute, che da anni promuove la salute urbana come diritto e responsabilità condivisa, è oggi nella posizione ideale per costruire un modello analogo: un “Bilancio del Bene Comune della Salute Urbana”, capace di misurare, valorizzare e guidare le politiche delle città verso il benessere collettivo.
1. Dalla teoria del bene comune alla pratica della salute comune
Come ECG ha ridefinito il significato di “economia”, l’Health City Institute può ridefinire quello di “salute”, spostando l’attenzione dal paradigma sanitario (ospedali, cure, spesa) a quello urbano, sociale e partecipativo.
Il punto di partenza è semplice ma radicale: la salute non è solo un obiettivo, ma un bene comune, prodotto e mantenuto da fattori ambientali, sociali, economici e culturali condivisi.
Un modello italiano di “Health for the Common Good” potrebbe dunque tradurre i determinanti di salute urbana — aria, verde, mobilità, abitare, inclusione, partecipazione — in indicatori di valore pubblico, sul modello del Bilancio ECG.
2. Strumenti: il Bilancio della Salute Urbana
L’Health City Institute potrebbe sviluppare una Matrice della Salute Comune, analoga a quella ECG, articolata in aree tematiche e indicatori misurabili, da applicare a città, enti locali, aziende sanitarie o imprese socialmente responsabili.
Esempio di possibili assi tematici:
• Equità e inclusione: accesso ai servizi sanitari e sociali, contrasto alle disuguaglianze urbane, coinvolgimento delle comunità vulnerabili.
• Ambiente e vivibilità: qualità dell’aria, mobilità sostenibile, spazi verdi, resilienza climatica.
• Governance e partecipazione: presenza di piani
Urban Health, tavoli multisettoriali, processi decisionali aperti.
• Innovazione e digitalizzazione per la salute: uso etico dei dati, piattaforme di monitoraggio urbano, alfabetizzazione digitale.
• Benessere e stili di vita sani: promozione dell’attività fisica, sport di prossimità, alimentazione sana, salute mentale.
Questo Bilancio della Salute Urbana potrebbe diventare uno strumento di rendicontazione trasparente per i Comuni e per le aziende partner, al pari del “Common Good Balance Sheet”.
3. Governance: reti locali e figura dell’Health City Manager
Il modello dovrebbe poggiare su una rete multilivello: Comuni, Regioni, Università, ASL, imprese, cittadini. Una figura chiave — l’Health City Manager, già proposta dall’Health City Institute — assumerebbe il ruolo di facilitatore del bene comune urbano, coordinando politiche e attori sul territorio.
Come i “gruppi locali” dell’ECG, anche in Italia si potrebbero istituire Laboratori del Bene Comune Urbano, con funzione di monitoraggio, progettazione partecipata e valutazione d’impatto, in collaborazione con università e centri di ricerca.
4. Etichetta e riconoscimento: il marchio “City for the Common Good”
Sul modello dell’etichetta ECOnGOOD, l’Health City Institute potrebbe promuovere un marchio di riconoscimento per le città e le organizzazioni virtuose, denominato ad esempio “City for the Common Good” o “Città per la Salute Comune”.
Questo marchio segnalerebbe l’impegno concreto nel promuovere salute, sostenibilità e inclusione urbana, incentivando la concorrenza positiva tra territori e amministrazioni.
Tale riconoscimento potrebbe diventare anche una leva

di policy, integrata nei bandi e nelle premialità previste dai fondi PNRR, dal Green Deal europeo o dal Piano Nazionale di Prevenzione.
5. Educazione e cultura della salute urbana
Come ECG ha collaborato con oltre 200 università, l’Health City Institute potrebbe attivare un network accademico italiano della Salute Comune, coinvolgendo atenei, scuole e istituti professionali nella formazione di figure esperte in urban health, governance partecipata e sostenibilità sociale.
Potrebbero nascere:
• corsi universitari di “Health and Common Good Management”;
• summer school dedicate alla valutazione del benessere urbano;
• progetti di citizen science per coinvolgere i cittadini nel monitoraggio della salute nelle città.
6. Indicatori, dati e trasparenza
L’ECG ha costruito la sua credibilità sulla misurabilità. Anche l’Health City Institute dovrebbe investire in piattaforme digitali di data sharing urbano, integrando:
• dati ambientali (ISPRA, ARPA);
• indicatori sociali e sanitari (ISTAT, Ministero della Salute, ISS);
• dati di percezione della salute (survey, osservatori locali);
• indicatori di prossimità urbana (trasporti, verde, servizi).
L’obiettivo sarebbe costruire una dashboard nazionale del Bene Comune della Salute, accessibile e comparabile tra città.
7. Una cornice internazionale e istituzionale
Il modello italiano potrebbe dialogare con le esperienze europee, l’OMS e le reti globali delle Healthy Cities, integrando i principi della Carta di Roma di Science for Cities (2025), promossa proprio da Health City Institute e ANCI.
La Carta già riconosce la salute come bene comune e definisce le basi per una governance urbana fondata sulla scienza, l’inclusione e la giustizia sociale — valori pienamente coerenti con l’approccio ECG.
8. Conclusione: dal bene comune economico al bene comune della salute
Il percorso di Economy for the Common Good insegna che il cambiamento sistemico nasce da piccole sperimentazioni locali capaci di contaminare la politica e la cultura.
Allo stesso modo, l’Health City Institute può fare dell’Italia un laboratorio per una nuova stagione di “Urban Health for the Common Good”, dove città, cittadini e istituzioni co-producono benessere, in modo misurabile, trasparente e partecipativo.
La visione di fondo è chiara:
“Come l’economia può servire il bene comune, anche la città può servire la salute comune.”
di Andrea Lenzi
Il concetto di metabolismo urbano rappresenta una chiave interpretativa innovativa per leggere, comprendere e governare le dinamiche delle città contemporanee. Così come il metabolismo biologico consente al corpo umano di trasformare le risorse in energia, di smaltire le scorie e di mantenere l’equilibrio vitale, il metabolismo urbano descrive i flussi di materia, energia, informazioni e relazioni che attraversano le città, determinandone la sostenibilità, la resilienza e, in ultima analisi, la salute dei cittadini.
Oggi, più che mai, le città sono chiamate a misurarsi con sfide complesse: l’aumento della popolazione urbana, il cambiamento climatico, l’inquinamento atmosferico e acustico, la produzione e gestione dei rifiuti, l’accesso equo a servizi sanitari e sociali, la diffusione di stili di vita sedentari e poco salutari. Tutti questi fattori incidono direttamente sul metabolismo urbano, generando squilibri che si traducono in conseguenze tangibili per la salute individuale e collettiva. Una città che consuma in modo eccessivo e non restituisce in termini di qualità ambientale e sociale è una città che, inevitabilmente, “si ammala”.
Le città in salute sono, invece, quelle capaci di orientare il proprio metabolismo verso modelli sostenibili, circolari e inclusivi. Ciò significa saper utilizzare le risorse in modo efficiente, ridurre gli sprechi, integrare sistemi energetici rinnovabili, progettare reti di mobilità attiva e condivisa, promuovere spazi verdi fruibili e sicuri, sviluppare servizi di prossimità che rafforzino la coesione sociale e contrastino le disuguaglianze. In questo quadro, salute e sostenibilità diventano due facce della stessa medaglia: non può esistere città sostenibile che non sia anche promotrice di salute, così come non può esistere città in salute che non si fondi su un uso equo e responsabile delle risorse.
Il metabolismo urbano deve essere letto e governato attraverso strumenti di monitoraggio integrato: indicatori ambientali, dati epidemiologici, analisi socio-economiche, valutazioni di impatto sanitario. Solo una governance multilivello, partecipata e fondata sull’evidenza scientifica, può guidare processi di trasformazione urbana che abbiano come obiettivo il benessere collettivo. In questo senso, il concetto di Health in All Policies trova nel metabolismo urbano un campo di applicazione concreto: la pianificazione urbanistica, le politiche di mobilità, la gestione energetica, l’organizzazione dei
servizi sociali e sanitari devono essere pensati come elementi interdipendenti di un unico sistema.
Non va dimenticato, infatti, che il metabolismo urbano non riguarda soltanto le infrastrutture materiali, ma anche le dinamiche immateriali: le relazioni tra i cittadini, la cultura della salute, la fiducia nelle istituzioni, la capacità di costruire comunità inclusive e solidali. Una città che facilita l’incontro, la socialità, la partecipazione civica e il senso di appartenenza è una città che rigenera costantemente il proprio tessuto sociale e che, di conseguenza, rafforza la salute dei suoi abitanti.
Per costruire città in salute occorre dunque un approccio integrato, capace di connettere dimensione ambientale, sanitaria, economica e sociale. Ciò implica politiche urbane attente alla qualità dell’aria e alla riduzione del rumore, alla gestione circolare dei rifiuti e alla sicurezza alimentare, ma anche al contrasto delle fragilità, al supporto delle persone anziane, alla promozione della salute mentale e al superamento delle disuguaglianze territoriali. In questa prospettiva, la città non è soltanto un luogo fisico, ma un vero e proprio ecosistema di salute, in cui la prevenzione delle malattie e la promozione di stili di vita sani diventano parte integrante delle strategie di sviluppo urbano.
Il futuro del metabolismo urbano sarà definito dalla capacità delle istituzioni, delle comunità e degli attori economici di costruire alleanze strategiche. La transizione ecologica, la digitalizzazione, le nuove politiche sociali e sanitarie devono convergere verso un unico obiettivo: garantire città più vivibili, più resilienti e più giuste. Solo così il metabolismo urbano potrà trasformarsi da fattore di rischio a motore di benessere, restituendo ai cittadini spazi e tempi di vita che favoriscano la salute, l’equità e la qualità della convivenza.
In definitiva, parlare di metabolismo urbano significa parlare di una nuova visione delle città come beni comuni: luoghi che non appartengono solo a chi li governa, ma a chi li abita e li vive quotidianamente. Città in salute sono città che non lasciano indietro nessuno, che sanno bilanciare consumo e rigenerazione, che producono non solo sviluppo economico ma anche capitale sociale, ambientale e umano. In esse si gioca la grande sfida del nostro tempo: dimostrare che è possibile crescere senza consumare, innovare senza escludere, abitare senza ammalarsi.

di Federico Serra
L’urbanizzazione è uno dei megatrend più rilevanti del XXI secolo. Oggi oltre la metà della popolazione mondiale vive in aree urbane e le proiezioni indicano che entro il 2050 questa quota supererà il 70%. Le città sono motori di innovazione, crescita economica e scambio culturale, ma rappresentano anche spazi nei quali le disuguaglianze sociali e sanitarie si concentrano e si riproducono. Le disuguaglianze di salute urbana non dipendono soltanto dallo status socio-economico individuale, ma anche dalla distribuzione spaziale delle opportunità, dalle condizioni ambientali, dalla qualità della governance e dall’accesso a servizi sanitari e sociali.
Parallelamente, il tema della longevità in salute — vivere più a lungo in condizioni di benessere, riducendo l’incidenza di malattie prevenibili e di disabilità — si impone come obiettivo strategico delle politiche pubbliche. Comprendere il nesso tra disuguaglianze di salute urbana e longevità significa analizzare sia i fattori di rischio tradizionali, già ampiamente studiati, sia i nuovi rischi emergenti che caratterizzano le trasformazioni urbane contemporanee.
Fattori di rischio tradizionali
I determinanti classici delle disuguaglianze di salute in città includono l’inquinamento atmosferico, le condizioni abitative precarie, la scarsa igiene urbana, le diete non equilibrate e gli stili di vita sedentari. Questi fattori sono distribuiti in modo diseguale: i quartieri più svantaggiati sono spesso quelli con maggior traffico, minore qualità dell’aria, minore accesso a spazi verdi e più ridotta disponibilità di cibo sano e accessibile.
Malattie cardiovascolari, patologie respiratorie croniche, obesità e diabete rimangono strettamente connessi a tali esposizioni. Il particolato fine (PM2.5) resta una delle principali minacce ambientali nelle metropoli, colpendo in modo sproporzionato le comunità a basso reddito. Analogamente, l’insicurezza abitativa e il so-
vraffollamento domestico favoriscono la diffusione di malattie infettive e disturbi mentali.
Il quadro che emerge è chiaro: le popolazioni più vulnerabili — anziani, migranti, persone in condizione di povertà — subiscono un carico di rischi maggiore, che si traduce in minore aspettativa di vita e in un più basso numero di anni vissuti in buona salute.
Fattori di rischio emergenti
Accanto ai rischi tradizionali, nuove minacce stanno assumendo crescente rilevanza. Tra queste spicca il divario digitale, che oggi condiziona l’accesso ai servizi sanitari, alle informazioni e alla partecipazione sociale. In città dove la telemedicina e i servizi digitali si stanno diffondendo, chi non possiede competenze o connettività adeguate rischia l’esclusione sanitaria.
Altri fattori emergenti includono:
• il cambiamento climatico, con le ondate di calore amplificate dagli effetti dell’isola di calore urbana, particolarmente pericolose per gli anziani e i fragili;
• l’inquinamento acustico e luminoso, che incide su salute cardiovascolare, sonno e benessere psicologico;
• l’isolamento sociale nelle grandi metropoli, spesso caratterizzate da legami comunitari frammentati;
• le ingiustizie ambientali, che vedono comunità svantaggiate esposte in misura maggiore a discariche, impianti industriali inquinanti o aree a rischio idrogeologico.
Questi rischi, spesso sottovalutati, hanno conseguenze dirette sulla longevità in salute, accelerando l’invecchiamento biologico, riducendo la resilienza individuale e aggravando la vulnerabilità delle popolazioni già fragili.

Disuguaglianze urbane e longevità
La longevità in salute non coincide semplicemente con l’aumento della speranza di vita, ma con la possibilità di vivere anni liberi da malattie e disabilità. Studi internazionali mostrano che, all’interno della stessa città, la differenza di aspettativa di vita tra i quartieri ricchi e quelli poveri può arrivare a 10-15 anni. Queste disparità non sono inevitabili: esse riflettono condizioni sociali e ambientali ingiustamente distribuite.
Le disuguaglianze si accumulano lungo l’intero ciclo di vita. Uno svantaggio nelle prime fasi — come una cattiva nutrizione in gravidanza o l’esposizione a inquinanti nell’infanzia — si combina con rischi in età adulta (lavoro precario, abitazioni insalubri, stress cronico). In età avanzata, l’accesso limitato a cure di qualità e la mancanza di reti sociali aggravano ulteriormente le disuguaglianze. Le città diventano così al tempo stesso luoghi di concentrazione dei rischi e laboratori privilegiati di intervento.
Implicazioni di policy
Affrontare le disuguaglianze di salute urbana e promuovere la longevità in salute richiede politiche multisettoriali, fondate sull’equità e orientate al futuro. Alcune priorità di intervento includono:
1. Pianificazione urbana orientata alla salute: garantire accesso equo a spazi verdi, aria pulita, mobilità attiva e abitazioni sicure.
2. Sistemi di monitoraggio integrato: raccogliere e analizzare dati disaggregati per età, genere, etnia e condizione socio-economica.
3. Health in All Policies: inserire la salute come
criterio trasversale in tutte le politiche urbane (trasporti, energia, welfare).
4. Inclusione digitale: considerare l’accesso alle tecnologie come determinante di salute e investire in alfabetizzazione digitale per anziani e fasce vulnerabili.
5. Adattamento climatico equo: proteggere in particolare i gruppi più esposti attraverso piani contro le ondate di calore, sistemi di allerta e infrastrutture resilienti.
6. Partecipazione comunitaria: coinvolgere i cittadini nei processi decisionali, riconoscendo il valore delle esperienze locali per costruire soluzioni efficaci.
Conclusioni
Le disuguaglianze di salute urbana costituiscono una delle sfide più urgenti del nostro tempo. Con la crescita delle città, il divario tra chi può aspirare a una vita lunga e in salute e chi ne resta escluso si sta ampliando, alimentato da fattori di rischio tradizionali e da nuove minacce emergenti.
Promuovere la longevità in salute negli ambienti urbani non è soltanto un obiettivo sanitario, ma un imperativo di giustizia sociale e sostenibilità. Le città, attraverso politiche integrate e innovative, possono diventare attori decisivi nella riduzione delle disuguaglianze, trasformando i rischi in opportunità.
La sfida è chiara: garantire che ogni cittadino, indipendentemente dal luogo in cui vive o dal suo status socioeconomico, possa non solo vivere più a lungo, ma vivere meglio — in città più sane, inclusive e resilienti.

di Alessandro Indovina
Segretario Generale della Federazione delle Associazioni dei Giovani Cristiani – YMCA Italia
In un tempo attraversato da crisi globali, ambientali, sociali e di senso, la sfida più grande per i giovani non è soltanto trovare un posto nel mondo, ma contribuire a renderlo migliore. È qui che la missione storica della YMCA – la Young Men’s Christian Association – torna più attuale che mai: educare alla responsabilità, alla partecipazione e alla costruzione del bene comune.
Fondata a Londra nel 1844, la YMCA ha dato vita a un movimento mondiale oggi presente in oltre 120 Paesi, con più di 60 milioni di giovani coinvolti in programmi di crescita personale, inclusione e cittadinanza. Dalla promozione della pace in Ucraina ai progetti di empowerment femminile in Africa, dalle attività di accoglienza dei rifugiati in Grecia e in Germania fino alle iniziative per la salute mentale giovanile negli Stati Uniti, la YMCA è una rete viva, solidale e interconnessa. Ovunque, il messaggio è lo stesso: cambiare la società partendo dalle persone.
In Italia, come nel resto del mondo, la YMCA lavora per costruire spazi di comunità in cui ogni giovane possa sentirsi parte di un progetto collettivo. Lo fa attraverso programmi di educazione non formale, esperienze di volontariato, sport come strumento di inclusione, e percorsi di cittadinanza attiva che intrecciano formazione civica, crescita personale e solidarietà. L’obiettivo è chiaro: allenare alla corresponsabilità.
Viviamo in un’epoca che tende a isolare, a frammentare, a rendere i legami deboli. YMCA risponde promuovendo la cooperazione e il valore dell’impegno comune. In Kenya e in Brasile, ad esempio, i centri YMCA rappresentano luoghi di formazione e protezione per migliaia di giovani che trovano nello sport, nella musica e nella formazione civica un’occasione di riscatto. In Corea del Sud e in Giappone, la rete YMCA promuove programmi di pace e riconciliazione, dimostrando come il dialogo interculturale sia la via maestra per il bene comune.
Nel nostro Paese, la Federazione YMCA Italia si riconosce pienamente in questa visione globale, traducendola nel linguaggio delle nostre comunità: costruire fiducia, coltivare solidarietà, educare alla cura. Collaboriamo con scuole, comuni, università, organizzazioni civiche e realtà del terzo settore per creare esperienze in cui i giovani non siano solo destinatari di politiche, ma protagonisti di cambiamento.
Ogni giorno, nelle nostre sedi e nei nostri progetti diffusi sul territorio, incontriamo ragazzi e ragazze che vogliono mettersi in gioco. Giovani che non cercano solo “spazi di ascolto”, ma occasioni di costruzione concreta del futuro. Ed è compito di noi adulti – educatori, animatori, dirigenti – accompagnarli, non sostituirli. Il bene comune nasce da questa alleanza tra generazioni, da un patto di fiducia che rigenera le comunità e restituisce speranza.
YMCA crede che la trasformazione sociale non sia un atto isolato ma un processo educativo, spirituale e comunitario. Per questo le nostre azioni uniscono inclusione sociale, sostenibilità, salute, cultura e spiritualità, promuovendo uno stile di vita basato sulla cura reciproca e sul rispetto per la Casa Comune.
Il bene comune non è un traguardo, ma un cammino condiviso. È la capacità di guardare oltre il proprio interesse immediato e di costruire qualcosa che resti, che generi valore per tutti. È il sogno di una società più giusta, più umana, più solidale.
E se oggi la YMCA continua a crescere nel mondo, è perché questo sogno non si è mai spento. Vive negli occhi dei giovani che ogni giorno scelgono di impegnarsi, di servire, di credere che insieme si può davvero fare la differenza.
Il bene comune non è un’eredità da custodire: è una missione da rinnovare. E noi, come YMCA, siamo pronti a farlo, ancora una volta, insieme ai giovani di oggi e di domani.
Ente promotore:
YMCA Italia – Federazione delle Associazioni dei Giovani Cristiani
In collaborazione con enti locali, istituti scolastici, centri di formazione professionale, parrocchie e realtà del terzo settore.
Ambito di intervento:
Rigenerazione urbana, educazione giovanile, inclusione sociale, prevenzione delle devianze minorili, partecipazione civica e formazione al lavoro.
1. Contesto e motivazione del progetto
Le periferie urbane rappresentano oggi uno dei fronti più delicati della coesione sociale in Italia. Disoccupazione giovanile, povertà educativa, dispersione scolastica e fenomeni di microcriminalità mettono a rischio la crescita equilibrata di intere comunità.
In questo quadro, YMCA Italia ha scelto di promuovere un progetto nazionale di rigenerazione sociale e educativa che metta al centro i giovani, la fiducia e la costruzione del bene comune. “Oltre il Margine: giovani, città e futuro” nasce per restituire opportunità, appartenenza e futuro a chi vive ai margini, attraverso un modello educativo che unisce sport, arte, formazione e cittadinanza attiva.
2. Obiettivi generali
• Promuovere il recupero e la reintegrazione sociale dei giovani a rischio di marginalità o devianza.
• Rafforzare la coesione sociale e la partecipazione comunitaria nelle periferie urbane.
• Creare spazi educativi inclusivi e “centri di comunità YMCA” come presìdi permanenti di prevenzione.
• Valorizzare la rete delle città YMCA come strumento di rigenerazione urbana e sociale.
3. Obiettivi specifici
• Ridurre la dispersione scolastica nelle aree urbane più vulnerabili.
• Offrire percorsi di crescita personale, civica e
professionale ai giovani coinvolti.
• Promuovere il protagonismo giovanile e la responsabilità sociale.
• Attivare percorsi di reinserimento formativo e lavorativo.
• Potenziare le alleanze territoriali tra scuole, enti pubblici e organizzazioni civiche.
4. Destinatari
• Giovani tra 14 e 25 anni residenti in quartieri periferici o con disagio socio-economico.
• Minori segnalati dai servizi sociali, dalla giustizia minorile o dalle scuole.
• Famiglie vulnerabili con minori a rischio di esclusione.
• Comunità locali coinvolte nei processi di rigenerazione urbana e sociale.
5. Aree di intervento pilota
• Milano – Quartiere Giambellino: sport sociale, mentoring educativo, formazione civica.
• Napoli – Scampia e Ponticelli: teatro, musica, service learning e cittadinanza attiva.
• Palermo – Brancaccio: accompagnamento scolastico, sostegno alle famiglie, orientamento al lavoro.
• Torino – Barriera di Milano: laboratori artigianali e percorsi di inserimento professionale.
• Catania – Librino e San Cristoforo: percorsi di prevenzione della devianza minorile, sport di strada, sostegno educativo e laboratori di competenze digitali.
Le attività saranno progressivamente estese ad altre città (Bari, Roma, Cagliari, Genova), secondo il modello dei “Centri YMCA di Comunità”, luoghi di aggregazione e innovazione sociale.
6. Struttura e metodologia
Il progetto si basa su un modello educativo integrato articolato in quattro assi:
• Sport e Benessere – Attività sportive di squadra e individuali per promuovere rispetto, regole e fiducia.
• Arte e Cultura – Laboratori creativi (musica, teatro, fotografia, storytelling urbano) come linguaggio di espressione e riscatto.
• Educazione e Formazione – Tutoraggio scolastico, orientamento al lavoro, corsi di alfabetizzazione digitale e formazione civica.
• Comunità e Volontariato – Esperienze di cittadinanza attiva e iniziative di servizio per la collettività.
La metodologia YMCA, basata su relazione, accompagnamento e partecipazione, valorizza la peer education e la collaborazione tra pari. Ogni giovane è considerato soggetto attivo del proprio percorso di cambiamento.
7. Partner istituzionali e sociali
• Comuni e Municipi delle aree metropolitane coinvolte
• Istituti scolastici e Centri di formazione professionale
• Tribunali per i Minorenni e Servizi Sociali territoriali
• Cooperative sociali, associazioni culturali e sportive
• Università e centri di ricerca in ambito educativo e sociologico
• Rete World YMCA per il confronto metodologico e il supporto tecnico
8. Durata e fasi operative
Durata complessiva: 36 mesi
• Fase 1 – Mappatura e rete territoriale (0-6 mesi): analisi dei bisogni, accordi istituzionali, definizione degli hub YMCA.
• Fase 2 – Attivazione dei centri (6-30 mesi): implementazione dei laboratori, formazione degli operatori, avvio dei percorsi individuali.
• Fase 3 – Monitoraggio e consolidamento (12-36 mesi): valutazione dell’impatto, networking tra città, sostenibilità e disseminazione.
9. Indicatori di impatto
• Giovani direttamente coinvolti nei percorsi YMCA: > 2.500
• Riduzione della dispersione scolastica nelle aree target: –20%
• Incremento delle competenze sociali e civiche: +35%
• Attivazione di tirocini, stage e percorsi di orientamento al lavoro: > 300
• Spazi rigenerati come centri di comunità YMCA: almeno 10 entro la fine del progetto
10. Risultati attesi
• Rafforzamento del capitale umano e sociale nelle periferie urbane.
• Riduzione dei fenomeni di devianza minorile e abbandono scolastico.
• Consolidamento del modello YMCA come buona pratica nazionale per l’inclusione.
• Creazione di una Rete nazionale YMCA per le periferie, connessa alla piattaforma internazionale.
• Diffusione di un modello replicabile di pedagogia urbana e prevenzione.
11. Fonti di finanziamento e sostenibilità
• Fondi nazionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le Politiche Giovanili).
• Fondi europei (FSE+, Erasmus+ Youth, PNRR – Missione 5 e 6, Programma Metro+).
• Fondazioni di comunità, fondazioni bancarie e partnership aziendali.
• Campagne di fundraising e solidarietà promosse da YMCA Italia.
La sostenibilità del progetto si fonda sulla trasformazione dei centri YMCA in hub territoriali permanenti, con governance condivisa pubblico-sociale e coinvolgimento delle comunità locali.
12. Valutazione e diffusione dei risultati
La valutazione sarà condotta da un partner accademico mediante analisi di impatto sociale (SROI) e indicatori qualitativi e quantitativi.
I risultati saranno pubblicati in un Rapporto annuale YMCA sulle periferie urbane, presentato in occasione del Forum Nazionale “Giovani e Bene Comune”.
• Disseminazione attraverso:
• piattaforme digitali e social media YMCA;
• conferenze territoriali e nazionali;
• network World YMCA e Alleanza Europea YMCA.



La presentazione in un evento su iniziativa del Sen. Guido Quintino Liris. Fra i punti centrali il concetto di One Health e una visione integrata di sanità, ambiente, cultura e inclusione sociale.

La salute come diritto universale e bene comune, l’importanza dell’innovazione e della digitalizzazione nell’ambito della salute, e, ancora, il ruolo delle case di comunità e della sanità di prossimità, delle farmacie dei servizi, dei medici di medicina generale, e la centralità della lotta alle malattie croniche e della promozione dei sani stili di vita. Sono questi alcuni dei punti centrali del “Manifesto per la Salute come Bene Comune nelle Aree Interne periferiche, i Comuni Montani e le Isole Minori”, realizzato da Osservasalute - Osservatorio nazionale sulla salute come bene comune in collaborazione con Lastmile Solutions, e presentato il 23 Ottobre in una conferenza in Senato su iniziativa del Senatore di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris, Ca-
pogruppo in Commissione Bilancio e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Aree interne, comuni montani e isole minori.
«Il Manifesto per la Salute come Bene Comune nelle Aree Interne è un impegno concreto che riporta al centro dell’agenda politica la coesione territoriale e il diritto alla salute – dichiara il Sen. Liris - Il Governo Meloni in questa legge di bilancio ha investito in sanità, digitalizzazione e rigenerazione dei territori montani e periferici. Crediamo in un modello di sviluppo che unisca salute, ambiente e identità locale: un’Italia che non lasci indietro nessuno, ma valorizzi ogni comunità, parte identitaria e genuina della nostra nazione».
Il “Manifesto per la Salute come Bene Comune nelle Aree Interne periferiche, i Comuni Montani e le Isole Minori”, ispirandosi al “Manifesto sulla salute nelle città come bene comune”, alle politiche governative sulla coesione territoriale e le aree interne e a documenti del WHO e di altri organismi internazionali, propone un modello di salute integrato, resiliente e sostenibile, che valorizza salute, ambiente, alimentazione e inclusione sociale. Il futuro delle aree interne passa attraverso un sistema socio-sanitario di prossimità, la rigenerazione dell’ambiente costruito, la corretta alimentazione e l’integrazione sociale, per costruire un bene comune e comunità più sane, forti e coese.
Le aree interne periferiche, i comuni montani e le isole minori sono territori di inestimabile valore culturale, ambientale e sociale, custodi di tradizioni, biodiversità e modelli di vita sostenibili che meritano di essere preservati e valorizzati. Tuttavia, questi territori si trovano ad affrontare sfide complesse, legate allo spopolamento, alla carenza di servizi essenziali e alle difficoltà di accesso alle cure sanitarie, aggravate dall’isolamento geografico e dalle fragilità economiche. Il progressivo abbandono delle aree interne genera un circolo vizioso: meno servizi portano alla perdita di popolazione, che a sua volta riduce ulteriormente la presenza di infrastrutture e opportunità. La salute, in questi contesti, non può essere considerata solo come una questione di assistenza medica, ma deve essere affrontata con un approccio integrato e sistemico, che tenga conto delle specificità territoriali e sociali. È necessario un modello di sanità diffusa e di prossimità, che utilizzi la telemedicina, la digitalizzazione e il rafforzamento delle infrastrutture sanitarie locali per garantire un accesso equo alle cure. Allo stesso tempo, la promozione della salute deve passare attraverso la valorizzazione delle risorse locali, come l’agricoltura sostenibile, le produzioni tipiche, l’educazione alimentare e il turismo legato al benessere, per stimolare sviluppo economico e inclusione sociale.
Migliorare la qualità della vita nelle aree interne – sottolinea il Manifesto - significa non solo fornire servizi sanitari adeguati, ma anche favorire il benessere psicofisico, la mobilità sostenibile, la rigenerazione dell’ambiente costruito e la tutela ambientale, in un’ottica di One Health, che riconosce la stretta relazione tra salute umana, animale e ambientale. Promuovere la coesione sociale è fondamentale per contrastare l’isolamento e la marginalizzazione, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione attiva delle comunità locali, attraverso la creazione di reti di supporto, il coinvolgimento del terzo settore e la formazione di leader di comunità. In questo quadro, le politiche di coesione territoriale devono agire per ridurre il divario tra le aree
urbane e quelle interne, investendo non solo in sanità, ma anche in istruzione, trasporti, innovazione e sviluppo economico. Solo attraverso una visione integrata e sostenibile, che coniughi sanità, ambiente, cultura e inclusione sociale, sarà possibile garantire il diritto alla salute e al benessere per tutti, facendo delle aree interne non luoghi marginali, ma territori di opportunità e innovazione.
Migliorare l’accesso alle cure significa anche investire nella prevenzione, nella sostenibilità e nella valorizzazione delle risorse locali, per creare un ambiente più sano e una comunità più forte. Recuperare e promuovere i prodotti tipici locali, radicati nella tradizione e nella biodiversità del territorio, non solo favorisce un’alimentazione equilibrata, ma contribuisce anche a rafforzare le economie locali, a contrastare lo spopolamento delle campagne e a ridurre l’impatto ambientale delle produzioni alimentari industriali. Riqualificare i borghi, valorizzare il patrimonio architettonico esistente, migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua e sviluppare infrastrutture per la mobilità sostenibile sono azioni che favoriscono un ambiente più sano e attrattivo, in grado di contrastare l’isolamento e di incentivare la permanenza e il ritorno della popolazione. Il concetto di bene comune nel contesto della salute assume, quindi, un significato profondo in questi territori, in cui le difficoltà logistiche, la riduzione del personale medico e la scarsità di strutture ospedaliere impongono un ripensamento del modello sanitario, puntando su soluzioni innovative come la telemedicina, il potenziamento della medicina territoriale e il rafforzamento dei presidi di assistenza primaria. Non si tratta solo di garantire cure adeguate, ma di costruire un sistema che riduca il divario tra centro e periferia, riconoscendo la salute come un diritto universale che non deve essere penalizzato dalla posizione geografica.





Le aree interne periferiche, i comuni montani e le isole minori sono territori di inestimabile valore culturale, ambientale e sociale, custodi di tradizioni, biodiversità e modelli di vita sostenibili che meritano di essere preservati e valorizzati. Tuttavia, questi territori si trovano ad affrontare sfide complesse, legate allo spopolamento, alla carenza di servizi essenziali e alle difficoltà di accesso alle cure sanitarie, aggravate dall’isolamento geografico e dalle fragilità economiche. Il progressivo abbandono delle aree interne genera un circolo vizioso: meno servizi portano alla perdita di popolazione, che a sua volta riduce ulteriormente la presenza di infrastrutture e opportunità.
La salute, in questi contesti, non può essere considerata solo come una questione di assistenza medica, ma deve essere affrontata con un approccio integrato e sistemico, che tenga conto delle specificità territoriali e sociali. È necessario un modello di sanità diffusa e di prossimità, che utilizzi la telemedicina, la digitalizzazione e il rafforzamento delle infrastrutture sanitarie locali per garantire un accesso equo alle cure. Allo stesso tempo, la promozione della salute deve passare attraverso la valorizzazione delle risorse locali, come l’agricoltura sostenibile, le produzioni tipiche, l’educazione alimentare e il turismo legato al benessere, per stimolare sviluppo economico e inclusione sociale.
Migliorare la qualità della vita nelle aree interne significa non solo fornire servizi sanitari adeguati, ma anche favorire il benessere psico-fisico, la mobilità sostenibile, la rigenerazione dell’ambiente costruito e la tutela ambientale, in un’ottica di One Health, che riconosce la stretta relazione tra salute umana, animale e ambientale. Inoltre, promuovere la coesione sociale è fondamentale per contrastare l’isolamento e la marginalizzazione, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione attiva delle comunità locali, attraverso la creazione di reti di supporto, il coinvolgimento del terzo settore e la formazione di leader di comunità
In questo quadro, le politiche di coesione territoriale devono agire per ridurre il divario tra le aree urbane e quelle interne, investendo non solo in sanità, ma anche in istruzione, trasporti, innovazione e sviluppo economico. Solo attraverso una visione integrata e sostenibile, che coniughi sanità, ambiente, cultura e inclusione sociale, sarà possibile garantire il diritto alla salute e al benessere per tutti, facendo delle aree interne non luoghi marginali, ma territori di opportunità e innovazione.
L’approccio One Health nelle Aree interne periferiche, i comuni montani e e le isole minori
L’approccio One Health sottolinea l’importanza della connessione tra salute umana, benessere ambientale e sviluppo territoriale, riconoscendo che la qualità della vita non può essere garantita se non si tiene conto delle interazioni tra l’uomo, l’ambiente e gli ecosistemi. Questo modello è particolarmente rilevante nelle aree interne, montane e insulari, dove la stretta relazione tra territorio, alimentazione, condizioni di vita e salute risulta ancora più evidente. In questi contesti, migliorare l’accesso alle cure significa anche investire nella prevenzione, nella sostenibilità e nella valorizza-
zione delle risorse locali, per creare un ambiente più sano e una comunità più forte.
Uno degli elementi centrali di questa visione è la corretta alimentazione, che rappresenta un pilastro della salute individuale e collettiva. Recuperare e promuovere i prodotti tipici locali, radicati nella tradizione e nella biodiversità del territorio, non solo favorisce un’alimentazione equilibrata, ma contribuisce anche a rafforzare le economie locali, a contrastare lo spopolamento delle campagne e a ridurre l’impatto ambientale delle produzioni alimentari industriali. La dieta mediterranea, riconosciuta come modello nutrizionale sostenibile e salutare, può essere un punto di riferimento per promuovere un’alimentazione basata su ingredienti freschi, poco trasformati e a basso impatto ecologico. In questo senso, è essenziale incentivare la produzione e il consumo di alimenti a km zero, educare la popolazione al valore della biodiversità agricola e favorire la riscoperta delle tradizioni culinarie locali, anche attraverso programmi nelle scuole e nelle comunità.
Oltre all’alimentazione, la salute dipende anche dalla qualità dell’ambiente in cui si vive. La la rigenerazione dell’ambiente costruito nelle aree interne diventa un obiettivo fondamentale per migliorare il benessere dei cittadini, creando spazi più vivibili, accessibili e sostenibili. Riqualificare i borghi, valorizzare il patrimonio architettonico esistente, migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua e sviluppare infrastrutture per la mobilità sostenibile sono azioni che favoriscono un ambiente più sano e attrattivo, in grado di contrastare l’isolamento e di incentivare la permanenza e il ritorno della popolazione. La creazione di aree verdi, percorsi benessere, spazi di aggregazione e servizi di prossimità contribuisce a ridurre il disagio sociale e a promuovere uno stile di vita più attivo, elemento chiave nella prevenzione delle malattie croniche.
La salute delle comunità passa anche attraverso la lotta a uno dei problemi sanitari più urgenti a livello globale: l’antimicrobico-resistenza. La crescente inefficacia degli antibiotici, dovuta all’uso eccessivo e inappropriato di questi farmaci, rappresenta una minaccia per la salute pubblica, soprattutto nelle aree più isolate, dove le infezioni non trattabili possono avere conseguenze ancora più gravi. Affrontare questa sfida significa promuovere un uso più consapevole e controllato degli antibiotici, sia in medicina umana che veterinaria, e ridurre il loro impiego negli allevamenti intensivi e nell’agricoltura. Il problema dell’AMR non è solo sanitario, ma anche ambientale: la dispersione di antibiotici nell’acqua, nel suolo e negli alimenti contribuisce alla diffusione di batteri resistenti, con un impatto che si ripercuote sull’intero ecosistema. Per questo, è essenziale adottare strategie di monitoraggio e prevenzione, investire in alternative terapeutiche come i vaccini e migliorare la consapevolezza della popolazione attraverso programmi di educazione sanitaria.
L’approccio One Health, quindi, non si limita alla cura delle malattie, ma propone un modello di salute integrato e sostenibile, in cui prevenzione, ambiente, alimentazione e benessere psicofisico sono parte di un unico sistema. Migliorare la salute nelle aree interne, montane e insulari significa garantire servizi sanitari efficienti e accessibili, ma anche promuovere un territorio rigenerato, comunità più coese e una cultura della salute basata su corretti stili di vita. La sfida è quella di trasformare queste aree da luoghi marginali a laboratori di innovazione sociale e sanitaria, in cui tradizione e tecnologia si incontrano per costruire un futuro più sano, resiliente e inclusivo.
Il Significato del Bene Comune nella Salute delle Aree Interne periferiche, Montane e Insulari
Il concetto di bene comune nel contesto della salute assume un significato profondo, poiché non riguarda solo il diritto individuale alla cura, ma si configura come un valore collettivo da proteggere e promuovere attraverso politiche integrate e azioni condivise. In particolare, nelle aree interne, montane e insulari, dove l’accesso ai servizi sanitari è spesso più difficile a causa della carenza di infrastrutture e della dispersione della popolazione, la tutela della salute diventa una sfida strategica per garantire equità e giustizia sociale.
In questi territori, le difficoltà logistiche, la riduzione del personale medico e la scarsità di strutture ospedaliere impongono un ripensamento del modello sanitario, puntando su soluzioni innovative come la telemedicina, il potenziamento della medicina territoriale e il rafforzamento dei presidi di assistenza primaria. Non si tratta solo di garantire cure adeguate, ma di costruire un sistema che riduca il divario tra centro e periferia, riconoscendo la salute come un diritto universale che non deve essere penalizzato dalla posizione geografica.
In un’epoca segnata da crescenti disuguaglianze territoriali, il concetto di salute come bene comune richiede un cambio di prospettiva: la sanità non deve essere considerata esclusivamente come un servizio, ma come un patrimonio collettivo che si costruisce attraverso la partecipazione attiva delle comunità, la valorizzazione delle risorse locali e il rispetto per l’ambiente. In questo senso, un territorio sano è anche un territorio sostenibile, in cui la qualità della vita è strettamente legata alla tutela dell’ecosistema, alla prevenzione e alla promozione di stili di vita salutari.
Investire nel benessere delle aree interne, delle comunità montane e delle isole minori significa non solo garantire il diritto alla salute, ma anche rafforzare il tessuto sociale ed economico di territori spesso marginalizzati. Un sistema sanitario efficiente, capillare e inclusivo può generare benefici che vanno oltre la sfera medica, contribuendo alla creazione di opportunità lavorative, al mantenimento delle popolazioni locali e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di queste aree.
In questa prospettiva, il bene comune si concretizza in un equilibrio tra salute, territorio e società: una sanità accessibile e di qualità, un ambiente rigenerato, un’alimentazione consapevole e una comunità coesa, in cui il benessere di ogni individuo si traduce in progresso collettivo. Garantire il diritto alla salute significa, dunque, costruire un futuro più equo e resiliente, in cui nessun territorio e nessuna persona siano lasciati indietro.

1. Salute come Diritto Universale e Bene Comune
Garantire equità di accesso alla salute per tutte le fasce della popolazione, senza discriminazioni geografiche, economiche o sociali.
Rafforzare il sistema sanitario territoriale integrato, con una maggiore connessione tra aree periferiche e centri urbani.
Promuovere l’inclusione delle persone con fragilità e vulnerabilità socio-clinicosanitarie in percorsi di assistenza personalizzati.
2. Innovazione e Digitalizzazione per la Salute
Espandere telemedicina, tele-refertazione e tele-consulto specialistico per superare le distanze.
Creare punti di accesso digitali facili nelle farmacie, nei municipi e nelle Case di Comunità.
Sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale e big data per una prevenzione e gestione più efficace delle patologie.
3. Case di Comunità e Sanità di Prossimità
Rafforzare le Case di Comunità come centri sanitari multidisciplinari.
Sviluppare servizi di continuità assistenziale e telemedicina per le patologie croniche.
Creare poli di prevenzione e benessere per il monitoraggio della salute della popolazione.
4. Farmacie dei Servizi come Hub di Salute Territoriale
Ampliare il ruolo delle farmacie dei servizi nella prevenzione, nel monitoraggio sanitario e nell’accesso alla telemedicina.
Sviluppare programmi di consegna farmaci a domicilio per anziani e persone fragili.
Integrare i farmacisti nelle reti sanitarie digitali per la gestione delle terapie.
Incentivare la permanenza di MMG e PLS con incentivi economici e strumenti tecnologici.
Attivare servizi di assistenza clinico-specialistica a distanza per ridurre gli spostamenti verso i centri urbani.
Rafforzare i servizi di assistenza domiciliare e degli infermieri di comunità.
Implementare screening e programmi di prevenzione personalizzati per le principali malattie croniche.
Creare percorsi assistenziali territoriali per la gestione di pazienti fragili.
Potenziare il ruolo della telemedicina per il monitoraggio dei pazienti cronici.
di Vita Sani
Promuovere la dieta mediterranea e le tradizioni alimentari locali come modello di alimentazione sana e sostenibile.
Valorizzare i prodotti tipici delle comunità locali per un’alimentazione a km 0 e a basso impatto ambientale.
Favorire la cultura della cucina delle radici per educare le nuove generazioni alla sana alimentazione e alla biodiversità alimentare, nel rispetto della tradizione locale.
Integrare programmi di educazione nutrizionale nelle scuole e nelle comunità locali.
Rafforzare i servizi di supporto psicologico, con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e ai lavoratori.
Prevenire il disagio mentale, la depressione e le dipendenze, creando servizi accessibili di ascolto e supporto.
Promuovere attività di socializzazione e benessere mentale attraverso lo sport, la cultura e la natura.
Garantire un accesso facilitato ai servizi materno-infantili nelle aree periferiche.
Potenziare la pediatria territoriale e i consultori familiari.
Integrare percorsi di assistenza e prevenzione per neonati e donne in gravidanza.
Sostenere progetti di la rigenerazione dell’ambiente costruito e rurale per migliorare la vivibilità delle comunità.
Creare spazi verdi, aree pedonali e percorsi benessere nelle comunità montane e insulari.
Potenziare le infrastrutture socio-sanitarie per garantire accessibilità e sicurezza nelle cure.
Promuovere la coesione sociale e il dialogo interculturale nelle comunità locali.
Favorire l’accesso ai servizi sanitari per le persone migranti e per le minoranze.
Creare programmi di sensibilizzazione e formazione interculturale per gli operatori sanitari.
Monitorare e ridurre l’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo.
Integrare strategie per la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni.
Sostenere pratiche agricole e alimentari ecologicamente sostenibili.
13. Adattamento ai Cambiamenti Climatici e Politiche
One Health
Adottare strategie di adattamento climatico per proteggere la salute delle popolazioni vulnerabili.
Integrare la salute ambientale e animale nelle strategie di prevenzione sanitaria.
Favorire la transizione verso un modello di sanità sostenibile ed ecologica.
Aree Interne
Destinare fondi specifici per garantire la sanità nei territori marginali.
Creare partenariati pubblico-privato per l’innovazione sanitaria.
Monitorare costantemente l’efficacia degli interventi per una sanità realmente inclusiva e sostenibile.
Questo Manifesto, ispirandosi al Manifesto sulla salute nelle città come bene comune, alle politiche governative sulla coesione territoriale e le aree interne e a documenti del WHO e di altri organismi internazionali, propone un modello di salute integrato, resiliente e sostenibile, che valorizza salute, ambiente, alimentazione e inclusione sociale. Il futuro delle aree interne passa attraverso un sistema socio-sanitario di prossimità, la la rigenerazione dell’ambiente costruito, la corretta alimentazione e l’integrazione sociale, per costruire un bene comune e comunità più sane, forti e coese.


Sezione 1 – Dati socio-demografici
• Età
•• 18-29 anni 15%
•• 30-44 anni 25%
•• 45-64 anni 35%
•• 65 anni e oltre 25%
• Genere
•• Maschio 48%
•• Femmina 50%
•• Altro / non risponde 2%
• Titolo di studio
•• Licenza media 22%
•• Diploma superiore 42%
•• Laurea 28%
•• Post-laurea 8%
• Condizione occupazionale
•• Studente 10%
•• Occupato/a 46%
•• Disoccupato/a 12%
•• Pensionato/a 28%
•• Altro 4%
Sezione 2 – Servizi e infrastrutture
• Adeguatezza dei servizi sanitari di base
•• Molto adeguati 18%
•• Abbastanza adeguati 36%
•• Poco adeguati 30%
•• Per niente adeguati 16%
• Distanza da ospedale/pronto soccorso
•• <15 minuti 12%
•• 15–30 minuti 28%
•• 30–60 minuti 34%
•• 60 minuti 26%
• Qualità dei trasporti pubblici
•• Molto soddisfatto 6%
•• Abbastanza soddisfatto 24%
•• Poco soddisfatto 38%
•• Per niente soddisfatto 32%
• Connessione internet
•• Diffusa e stabile 30%
•• Presente ma instabile 44%
•• Lenta/assente 26%
Sezione 3 – Vita quotidiana e qualità della vita
• Qualità della vita complessiva
•• Molto alta 12%
•• Abbastanza alta 46%
•• Abbastanza bassa 30%
•• Molto bassa 12%
• Vantaggi principali (risposte multiple)
•• Contatto con la natura 70%
•• Relazioni sociali forti 52%
•• Costo della vita più basso 41%
•• Sicurezza e tranquillità 63%
•• Altro 8%
• Svantaggi principali (risposte multiple)
•• Distanza dai servizi sanitari 58%
•• Carenza di opportunità lavorative 72%
•• Scarsi collegamenti 65%
•• Difficile accesso a istruzione/università 49%
•• Limitato accesso digitale 38%
•• Altro 5%
Sezione 4 – Futuro e comunità
• Opportunità per i giovani
•• Molte 6%
•• Alcune 22%
•• Poche 40%
•• Nessuna 32%
• Importanza della tradizione culturale
•• Molto importante 68%
•• Abbastanza importante 24%
•• Poco importante 6%
•• Per niente importante 2%
• Intenzioni di vita futura
•• Restare 38%
•• Trasferirsi in città vicina 28%
•• Trasferirsi in grande metropoli 20%
•• Trasferirsi all’estero 14%
• Interventi prioritari (risposte aperte, clusterizzate)
•• Migliorare trasporti e viabilità 32%
•• Potenziare sanità e scuole 29%
•• Incentivi per lavoro/impresa locale 25%
•• Migliorare connettività digitale 14%
La survey mostra un quadro ambivalente: da un lato gli abitanti delle aree interne apprezzano tranquillità, natura e legami sociali, dall’altro lamentano carenza di lavoro, sanità e trasporti. I giovani vedono poche prospettive e tendono a spostarsi altrove, mentre la popolazione anziana appare più legata al territorio.
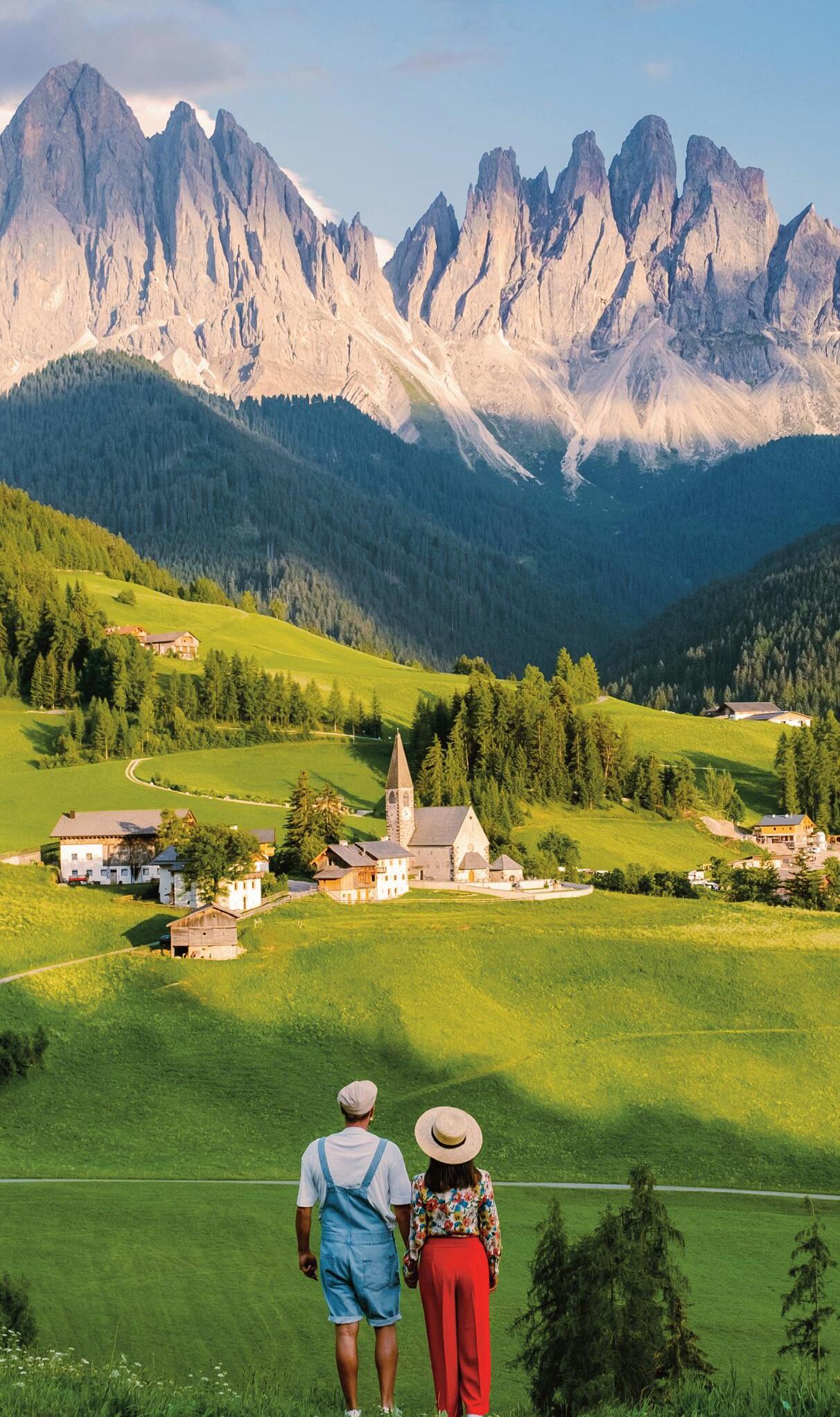


Le aree interne italiane non possono essere considerate territori destinati all’abbandono, né tantomeno accompagnate lungo un cammino di “estinzione demografica” già scritto. A ribadirlo con forza è stata la lettera aperta firmata da 139 cardinali e vescovi italiani, indirizzata al Governo e al Parlamento, in cui i pastori della Chiesa italiana chiedono un cambio di paradigma profondo nel modo di guardare a questi luoghi.
Secondo i firmatari, non è sufficiente leggere le aree interne attraverso la lente dei numeri: spopolamento, invecchiamento, chiusura di servizi. Bisogna invece adottare una narrazione qualitativa, che sappia valorizzare il capitale umano, sociale e culturale che questi territori custodiscono. Sono comunità che hanno garantito per secoli la sopravvivenza di tradizioni, biodiversità, saperi artigianali e legami sociali forti, e che oggi chiedono politiche nuove, fondate su giustizia sociale, coesione e sviluppo sostenibile.
Tra i promotori dell’appello figurano il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, e l’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, primo firmatario della lettera. Le loro parole richiamano la responsabilità delle istituzioni: non si tratta solo di “contenere i danni” dello spopolamento, ma di immaginare un futuro di rinascita e resilienza per comunità che rappresentano un patrimonio vivo del Paese.
L’appello dei vescovi tocca temi centrali come la tenuta dei servizi sanitari e scolastici, la tutela ambientale, l’accessibilità delle infrastrutture e la possibilità per i giovani di trovare lavoro senza essere costretti a migrare. È, in altre parole, una richiesta di giustizia territoriale, affinché nessuna parte d’Italia venga considerata marginale o sacrificabile.
La sfida è culturale prima ancora che politica: cambiare lo sguardo sulle aree interne significa riconoscerne non solo le fragilità, ma soprattutto le potenzialità. Non si tratta di accompagnarle a una lenta fine, bensì di sostenerle in un percorso di rinascita, mettendo al centro la vita delle persone che ancora le abitano.

L’idea comune dell’“America rurale” richiama immagini stereotipate: vaste campagne, paesi poco popolati, economie in contrazione. Il report di McKinsey invita a ribaltare questa percezione: l’America rurale è un mosaico complesso di comunità con identità, sfide e potenzialità molto diverse.
McKinsey parte da un dato essenziale: una persona su sette negli Stati Uniti vive in contesti rurali, ovvero circa 46 milioni di persone nel 2023.
Eppure, nonostante questa rilevanza demografica, le aree rurali continuano a essere relativamente trascurate nelle analisi economiche e nelle strategie di sviluppo.
Sei archetipi rurali per comprendere le differenze
Per capire meglio la varietà del mondo rurale, McKinsey distingue sei archetipi che differiscono per geografia, economia e condizioni sociali.
1. Agricultural powerhouses — territori che fanno dell’agricoltura il fulcro economico, con una partecipazione al lavoro relativamente elevata.
2. Manufacturing workshops — aree dove l’industria manifatturiera rappresenta una quota significativa del PIL locale.
3. Migration magnets — borghi o contee vicine a grandi città, o località turistiche, che attraggono flussi migratori positivi.
4. Remote regions — aree isolate, con basse specializzazioni industriali e tendenza all’esodo demografico.
5. Resource-rich regions — territori con risorse naturali (miniere, petrolio, ecc.), che però spesso registrano forte volatilità.
6. Middle America — aree intermedie, senza specializzazioni marcate, con variabilità economica e sociale.
Questa segmentazione – pur non essendo rigida –aiuta a progettare politiche mirate, riconoscendo che strategie efficaci per un’“agricultural powerhouse” pos-
sono non funzionare in una “remote region”.
Benessere e mobilità: chi riesce a “salire”
McKinsey valuta gli esiti per i residenti di ciascun archetipo secondo otto dimensioni del benessere:
• tenore di vita
• stabilità finanziaria
• lavoro dignitoso
• salute e longevità
• opportunità educative
• alloggi stabili
• connettività fisica e digitale
• stabilità comunitaria
Una parte centrale dell’analisi è dedicata alla mobilità economica intergenerazionale: quanto possono migliorare le condizioni dei figli rispetto ai genitori? Sorprendentemente, nelle aree rurali — soprattutto nei contesti agricoli e manifatturieri — alcune comunità registrano risultati migliori rispetto a zone urbane.
In particolare:
• I residenti rurali di “middle income” (50� percentile) hanno in molti casi avuto una crescita dei redditi superiore rispetto a coorti simili nelle aree urbane.
• Le aree manifatturiere e agricole, se ben gestite, offrono vie concrete per migliorare il reddito anche per chi non ha una laurea.
• Tuttavia, gli archetipi più svantaggiati (remote, resource-rich) mostrano risultati ben al di sotto della media su molte dimensioni.
In sostanza: le aree rurali non sono tutte “arretrate” — molte hanno dinamiche resilienti e opportunità inespresse.
Sei strategie per rilanciare il “cuore” dell’America

Il report propone sei strategie con potenziale replicabilità per stimolare sviluppo, mobilità e benessere nelle aree rurali.
Le strategie sono raggruppate in tre macroaree: imprese, lavoro e bisogni fondamentali.
1. Sostenere imprenditorialità e start-up locali
Stimolare un tessuto di piccole imprese, specialmente nei settori innovativi o collegati alle vocazioni locali. Ad esempio, creare coworking agricoli o incubatori tech in zone con risorse naturali.
2. Investire in “ancora”
Università, ospedali, centri di ricerca possono diventare catalizzatori del tessuto economico rurale, diffondendo competenze, innovazioni e connessioni.
3. Preparazione post-liceale e continuità educativa
Colmare i gap tra scuola media e università / formazione tecnica, con corsi professionalizzanti, percorsi ibridi e collaborazione con imprese.
4. Formazione rapida e mirata per industrie in crescita
Programmi “fast track” per creare risorse umane competenti nei settori emergenti (energia, tecnologia, industria green) nelle aree rurali.
5. Hub sanitari rurali
Potenziare la sanità in aree periferiche tramite strutture locali, medicina telematica, centri specialistici mobili — riducendo le disuguaglianze nell’accesso alle cure.
6. Programmi integrati “dalla culla alla carriera”
Interventi sistemici che integrano istruzione, salute, assistenza sociale e infrastrutture. In territori “distressed”, è spesso l’unico approccio che può fare la differenza. Secondo McKinsey, queste strategie — se adattate alle caratteristiche locali — possono invertire trend negativi e promuovere rigenerazione.
Sfide e limiti del modello
Nessuna strategia è priva di ostacoli. Alcune criticità emerse nel report:
• Costo della “densità negativa”: nelle aree remote, la scarsa densità rende molto costose infrastrutture e servizi.
• Capacità amministrative locali: molti territori rurali mancano di competenze tecniche o risorse per attuare progetti complessi.
• Dipendenza da shock esterni: economie legate alle materie prime o all’agricoltura subiscono cicli intensi (prezzi, clima, politica).
• Coordinamento interistituzionale: senza cooperazione tra enti locali, stati federali e governo centrale, le politiche restano frammentarie.
Il report evidenzia che non basta “copiare modelli”. Ogni comunità ha una sua identità, che richiede adattamento e sperimentazione.
Risonanze per l’Europa e l’Italia
Anche se il contesto statunitense è peculiare, le riflessioni sul potenziale rurale hanno risonanza in Europa e in Italia. Le aree montane, i borghi dell’interno, le zone appenniniche condividono le sfide di distanza dai grandi centri, spopolamento e limitate opportunità di sviluppo.
Applicare strategie simili — hub sanitari digitali, formazione mirata, istituzioni “ancora” locali, imprenditorialità territoriale — potrebbe essere una leva per riequilibrare gli squilibri territoriali anche nel contesto italiano.
Conclusione
Il report “Small towns, massive opportunity” invita a ripensare l’America rurale non come mera periferia, ma come un insieme di territori con potenzialità latenti. Le sei strategie proposte – se ben declinate — possono trasformare queste aree in poli di crescita sostenibile, riducendo disuguaglianze e ampliando la mobilità sociale.
di Ludovica Serra
Ci sono luoghi in Italia dove il vento ha preso il posto delle voci, dove il silenzio riempie le piazze, dove la natura torna a bussare alle por te chiuse delle case. Sono i borghi abbandonati, i paesi dimenticati che punteggiano montagne, vallate e coste del nostro Paese. Spesso si trovano lontano dalle autostrade, ai margini delle carte geografiche, ma conservano dentro di sé una bellezza malinconica che parla di storia, di emigrazione, di catastrofi e di sogni.
Oggi si contano in Italia oltre mille borghi completamente disabitati, e più di seimila insediamenti minori –alpeggi, frazioni, villaggi agricoli – dove la presenza umana è ormai sporadica. Ma dietro questi numeri c’è un mondo di storie: vite interrotte, ricordi, tradizioni, ma anche nuove opportunità per chi sceglie di tornare.
Un Paese di pietra e silenzi
L’Italia è un mosaico di borghi: oltre 5.500 centri con meno di 5.000 abitanti, sparsi tra colline, montagne e coste. Molti prosperano, altri sopravvivono, altri ancora si spengono lentamente. L’abbandono è un fenomeno iniziato nel secolo scorso, ma le sue radici affondano in un processo lungo: l’esodo dalle campagne, la chiusura delle miniere, la fine della civiltà contadina, l’avanzare delle città.
La geografia dei borghi fantasma è soprattutto una geografia interiore dell’Italia: racconta chi siamo stati e perché abbiamo lasciato indietro una parte di noi. Questi luoghi non sono solo “paesi senza abitanti”, ma capitoli sospesi della nostra identità.
Le cause dell’abbandono: il tempo, le frane, le città
Ogni borgo abbandonato ha una ragione precisa, ma tutte le storie si somigliano.
Molti furono svuotati da terremoti o frane: basti pensare a Craco, in Basilicata, evacuato negli anni Sessanta
dopo una serie di crolli del terreno, o a Bussana Vecchia, in Liguria, distrutta da un terremoto nel 1887. Altri furono inghiottiti da progetti infrastrutturali: dighe, bacini artificiali, nuove strade. È il caso di Fabbriche di Careggine, in Garfagnana, paese toscano sommerso dalle acque del lago di Vagli, che riemerge solo quando il bacino viene svuotato per manutenzione.
Altri ancora furono travolti da una forza più invisibile ma potente: lo spopolamento. Dalla fine dell’Ottocento, milioni di italiani abbandonarono le zone interne per emigrare verso le città o all’estero. I paesi rimasti senza giovani si spensero lentamente: prima chiusero le scuole, poi i negozi, poi le chiese.
L’Italia si è svuotata dall’interno, e il suo cuore montano e collinare – quello che per secoli aveva custodito le comunità più antiche – è rimasto sospeso tra passato e rovina.
Craco, Pentedattilo, Consonno: tre storie emblematiche
Dietro ogni muro cadente c’è una storia di uomini e di destini. Tre esempi raccontano bene la varietà di questo fenomeno.
Craco, la città di pietra e silenzio
Arroccata su una collina lucana, Craco è una delle ghost town più famose d’Italia. Frane e smottamenti l’hanno resa inabitabile, ma le sue vie sono ancora percorribili e conservano un’atmosfera surreale. È stata scelta come set cinematografico per film come La passione di Cristo o Quantum of Solace, e oggi attira visitatori da tutto il mondo.
Craco è la prova che anche un paese morto può rinascere come luogo della memoria.
Pentedattilo, la mano di pietra della Calabria
Nel sud della Calabria, arroccato su una montagna che somiglia a una mano aperta, Pentedattilo fu abbando-
nato nel XIX secolo dopo un terremoto. Ma negli ultimi anni, grazie a un progetto di recupero culturale, è tornato a vivere per brevi stagioni: laboratori, residenze artistiche, festival di cinema.
Oggi è un simbolo di rinascita possibile, dove la pietra diventa teatro e la solitudine diventa ispirazione.
Consonno, la Las Vegas mancata della Brianza
Negli anni Sessanta, un imprenditore volle trasformare un piccolo borgo agricolo lombardo in una “città dei balocchi”, con cupole orientali, insegne al neon, piste da ballo. Poi una frana spazzò via il sogno. Consonno rimase deserto, come un luna park abbandonato. Oggi è un luogo sospeso tra kitsch e malinconia, meta di curiosi e fotografi.
Borghi sommersi, borghi sospesi
Accanto ai paesi fantasma veri e propri, esistono anche i borghi sommersi – villaggi cancellati dall’acqua ma ancora visibili nelle giornate di secca, come relitti di un passato sommerso. Fabbriche di Careggine è il caso più noto: riemerge di tanto in tanto dal lago artificiale, con le sue case, la chiesa, le piazze rimaste intatte sotto metri d’acqua.
E poi ci sono i borghi sospesi, come Roscigno Vecchia, nel Cilento, con un solo abitante rimasto a custodirlo: un “guardiano della memoria”, testimone di un’Italia che non c’è più.
Le regioni più colpite
I borghi abbandonati si trovano ovunque, ma alcuni territori ne contano di più:
• Calabria, con oltre 20 paesi fantasma censiti;
• Toscana e Liguria, con 19 ciascuna;
• Basilicata, Abruzzo e Campania, dove il fenomeno si intreccia con terremoti e frane;
• Piemonte e Friuli, per via dello spopolamento montano;
• Sardegna e Sicilia, con interi centri minerari ormai deserti.
La mappa dei borghi abbandonati coincide spesso con la mappa delle aree interne, quelle più lontane dai servizi essenziali, dalle scuole e dagli ospedali. È un’Italia che non ha smesso di esistere, ma che oggi sopravvive nei margini.
Il fascino del vuoto: perché ci attirano i luoghi abbandonati
Entrare in un borgo fantasma è come attraversare una soglia temporale. Non ci sono voci, solo il vento tra le finestre rotte. Il tempo sembra essersi fermato nell’attimo in cui l’ultimo abitante è partito.
Ma proprio questo silenzio affascina. I borghi abbandonati sono specchi del tempo, luoghi dove l’uomo ha lasciato tracce e la natura è tornata a prendersele. Sono spazi poetici, ma anche educativi: ci ricordano cosa succede quando un territorio viene dimenticato.
Non è un caso che molti fotografi, scrittori e viaggiatori li scelgano come mete di esplorazione. Ogni muro è una pagina, ogni porta un frammento di racconto. È un turismo che cerca emozione, autenticità, verità.
La rinascita possibile: dall’oblio al futuro
Negli ultimi anni, molte regioni italiane hanno avviato programmi per recuperare e valorizzare i borghi abbandonati.
In alcune zone si offrono case a 1 euro, in altre si promuovono bandi per artisti, residenze creative, laboratori di artigianato. Alcuni borghi sono diventati eco-villaggi, comunità di nuovi abitanti che scelgono la vita lenta, la sostenibilità, la distanza dalle città.
Il turismo esperienziale e il “ritorno alla terra” hanno dato nuova linfa a realtà un tempo dimenticate. L’Italia dei borghi, anche quelli fantasma, può diventare un laboratorio di rinascita: uno spazio dove rigenerare territori, economie e relazioni sociali.
Un patrimonio fragile, da ascoltare
Ogni casa che crolla in un borgo abbandonato è un pezzo di memoria che se ne va. Eppure questi luoghi non chiedono di essere musealizzati: chiedono di essere ascoltati.
Servono politiche di conservazione minima, incentivi per chi vuole ristrutturare, ma soprattutto una nuova narrazione del valore dei piccoli luoghi.
Non sono solo rovine romantiche: sono archivi vivi di un’Italia che ha ancora qualcosa da dire.
Conclusione: tornare nei luoghi che abbiamo lasciato
I borghi abbandonati non sono solo un passato che scompare: sono futuro potenziale. In un’epoca di crisi climatica, spopolamento urbano e ricerca di senso, questi paesi potrebbero diventare rifugi, laboratori, comunità resilienti.
Visitare un borgo abbandonato non è turismo nostalgico, ma un atto di riconciliazione: con il paesaggio, con la memoria, con noi stessi.
L’Italia, in fondo, non è solo la terra delle città d’arte: è anche la terra dei silenzi, dei campanili che non suonano più, delle piazze che aspettano. E in quei silenzi, a volte, si sente ancora il battito lento della sua storia.
Si è celebrato il 31 Orobre , in coincidenza con il World Cities Day, la Giornata nazionale di sensibilizzazione sulla salute nelle città come bene comune promossa da Health City Institute insieme ad altre numerose organizzazioni. Presentata e firmata oggi presso la sede di Anci l’edizione aggiornata del Manifesto: obiettivo affermare la centralità della salute nella vita urbana e orientare le politiche delle città verso il benessere delle persone e delle comunità
La salute non come mera questione sanitaria, ma come bene comune, risultato dell’interazione tra ambiente, società, economia e cultura. È questo il contenuto fondamentale del “Manifesto sulla salute nelle città bene comune”, presentato il 31 Ottobre nella sua versione aggiornata 2025 e firmato da numerose organizzazioni, presso la sede di Anci, in occasione del World Cities Day, che si celebra il 31 ottobre, e della Giornata nazionale di sensibilizzazione sulla salute nelle città come bene comune, promossa da Health City Institute, in collaborazione con CITIES+, Federsanità, FIASO, la Rete delle città sane dell’OMS, Science for Cities, Italian Wellness Alliance, Planetary Health Inner Circle, l’Osservatorio sulla salute bene comune, Fondazione SportCity, la Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Cittadinanzattiva, Fondazione Longevitas, Science for Cities, l’Osservatorio permanete sullo sport, l’Istituto per la competitività. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere un approccio integrato tra urbanistica, innovazione, salute pubblica e benessere fisico e mentale, sottolineando come le città possano (e debbano) essere spazi in cui il wellness e l’attività motoria siano accessibili a tutti. Creare ambienti urbani che incentivino il movimento, lo sport e stili di vita sani è fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle
aree urbane.
«Il Manifesto sulla Salute nelle Città è stato realizzato, nella sua prima edizione, nel 2016, come frutto di un lavoro collettivo tra istituzioni, comunità scientifica, amministrazioni locali e società civile, con l’obiettivo di affermare la centralità della salute nella vita urbana e di orientare le politiche delle città verso il benessere delle persone e delle comunità. – dichiara Federico Serra, Presidente di Health City Institute - Fin dalla sua prima edizione, il Manifesto ha rappresentato un punto di svolta culturale e politico, introducendo un approccio innovativo. Ha contribuito a diffondere a livello nazionale e internazionale il concetto di Urban Health, inteso come la disciplina e la pratica che studiano come le condizioni urbane influenzano la salute e, allo stesso tempo, come le politiche per la salute possano trasformare le città rendendole più inclusive, resilienti e sostenibili».
Tra i principali risultati che il Manifesto ha ispirato vi è la nascita della figura dell’Health City Manager, professionista dedicato alla governance integrata della salute nelle città, oggi riconosciuto come better practice a livello internazionale. In Italia, questa figura ha trovato un percorso formativo stabile grazie alla sinergia tra Governo, ANCI e Health City Institute, consolidandosi come punto di riferimento per le amministrazioni locali e per le reti territoriali. Negli anni, il Manifesto è stato progressivamente arricchito da nuove priorità e azioni: la promozione dello sport e la nascita del concetto di SportCity, la valorizzazione delle reti di prossimità, l’attenzione alla salute mentale e alle fragilità psicologiche, l’impulso alla digitalizzazione e all’uso etico dell’intelligenza artificiale, fino all’istituzione di Osservatori permanenti sulla salute nelle città e alla creazione di network delle città e della comunità scientifica. Queste integrazioni hanno confermato la sua natura di documento dinamico, capace di adattarsi alle trasformazioni sociali e urbane.
Il valore del Manifesto è andato oltre i confini nazionali, ispirando importanti documenti interna-
«Oltre 3 miliardi di persone oggi vivono in città metropolitane e megalopoli. Nel 2007, la popolazione mondiale che vive nelle città ha superato per la prima volta nella storia il 50 per cento, e sarà il 70 per cento nel 2050 in base alle stime della WHO - dichiara Andrea Lenzi, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Direttore della Cattedra UNESCO sull’Urban Health, Università La Sapienza di Roma - È un fenomeno sociale inarrestabile e una tendenza irreversibile che va amministrata e studiata sotto innumerevoli punti di vista quali l’assetto urbanistico, i trasporti, il contesto industriale e occupazionale e soprattutto la salute. Le amministrazioni dovranno guardare alla sempre maggiore urbanizzazione in termini nuovi, comprendendo, per esempio, che il carico di disabilità che le malattie croniche si portano con sé, come naturale fardello, inciderà sullo sviluppo e sulla sostenibilità delle città».
«Penso che sia il momento perché tutti prendiamo consapevolezza che la salute è un bene comune di tutti –dichiara Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente dell’Osservatorio sulla salute bene comune dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Si avverte l’urgenza di un movimento culturale e sanitario che consideri la salute un diritto e un dovere collettivo. La fragilità umana richiede una dimensione di cura reciproca, un patrimonio comune indispensabile per il benessere sociale».
«Il crescente divario nell’accesso alle cure e le disuguaglianze socioeconomiche stanno mettendo a dura prova la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale – dichiara Walter Ricciardi, Chair Cancer Mission Board European Commission, Direttore dell’Osservatorio sulla salute bene comune dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Definire la salute come un bene comune significa riconoscerla come parte integrante della dignità umana, un pilastro della giustizia sociale e un investimento nel futuro delle nostre comunità».
105 zionali, presentati in sedi come il G7 del 2017 e il G20 del 2022, e contribuendo direttamente alla redazione del Parere su “Salute nelle città: bene comune” del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, rafforzando la sua autorevolezza anche in ambito comunitario. Oggi il Manifesto è riconosciuto come piattaforma di convergenza per istituzioni, amministrazioni, università, società scientifiche, reti sociali e cittadini. La sua visione ribadisce che la salute nelle città è un bene comune e che il suo perseguimento richiede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, non solo dei sistemi sanitari. Adottare il Manifesto significa assumere un impegno politico, culturale e sociale: costruire città inclusive, resilienti e sostenibili, dove la salute diventa il fondamento della democrazia, della giustizia sociale e di un futuro equo per le nuove generazioni. «La promozione della salute e dei corretti stili di vita in ambito urbano è un obiettivo centrale oggi per Sindaci e Amministrazioni locali: abbiamo la responsabilità di creare città più sane e sostenibili, in sintonia con l’intero ecosistema umano, animale e naturale», dichiara l’On. Roberto Pella, Presidente dell’Intergruppo parlamentare Qualità della vita nelle città e Vicepresidente Anci - È necessario lavorare tutti insieme, con un approccio multidisciplinare e interistituzionale che sappia rafforzare tale consapevolezza nella collettività, e va in questa direzione la proposta di legge che ho presentato per l’istituzione, il 2 luglio di ogni anno, della Giornata Nazionale per la Salute e il Benessere nelle Città. Sono fiducioso che il Parlamento saprà riconoscere l’alto valore istituzionale di questa iniziativa e possa contribuire al suo massimo riconoscimento». «Rendere le città italiane delle Health City, attraverso una rigenerazione urbana che consideri la salute come fattore di crescita e coesione, rappresenta un obiettivo cruciale nel contesto contemporaneo - dichiara il Sen. Mario Occhiuto, Presidente dell’Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città, Segretario VII Commissione del Senato – A tal fine dobbiamo far sì che le città siano promotrici della salute, amministrate da politiche chiare per tutelarla e migliorarla e occorre sviluppare un contesto urbano che sia salutogenico e non patogeno, promuovere una politica urbana che sia una forma di medicina preventiva, spezzando il circolo vizioso che si crea fra cattive condizioni di salute, povertà socio-economica, basso livello di istruzione ed emarginazione». «Lo sport e l’attività fisica hanno un ruolo fondamentale nella sfida alle criticità e dell’urbanizzazione - dichiara la Sen. Daniela Sbrollini, Presidente Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città, Vicepresidente della X Commissione del Senato, «Il lavoro del nostro intergruppo è fortemente impegnato in questa direzione e io stessa ho presentato un disegno di legge, l’Atto del Senato n.135 della XIX Legislatura del 13 ottobre 2022 su “Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale”, per dare la possibilità a pediatri, medici di medicina generale e specialisti di inserirlo in ricetta medica, e consentire alle famiglie di usufruire delle detrazioni fiscali. Occorre portare avanti un lavoro comune che promuova lo sport in quanto “farmaco” senza controindicazioni, che fa bene a tutte le età».
Ufficio stampa HCI – Health City Institute
HCC HealthCom Consulting Diego Freri, mob. +39 335 8378332, email diego.freri@hccroma.com Simone Aureli, mob. +39 366 984 7899, email simone.aureli@hccroma.com




Il Manifesto sulla Salute nelle Città è stato realizzato nel 2016, come frutto di un lavoro collettivo tra istituzioni, comunità scientifica, amministrazioni locali e società civile, con l’obiettivo di affermare la centralità della salute nella vita urbana e di orientare le politiche delle città verso il benessere delle persone e delle comunità.
Fin dalla sua prima edizione, il Manifesto ha rappresentato un punto di svolta culturale e politico, introducendo un approccio innovativo: la salute non come mera questione sanitaria, ma come bene comune, risultato dell’interazione tra ambiente, società, economia e cultura. In questo senso, il Manifesto ha contribuito a diffondere a livello nazionale e internazionale il concetto di Urban Health, inteso come la disciplina e la pratica che studiano come le condizioni urbane influenzano la salute e, allo stesso tempo, come le politiche per la salute possano trasformare le città rendendole più inclusive, resilienti e sostenibili.
Tra i principali risultati che il Manifesto ha ispirato vi è la nascita della figura dell’Health City Manager, professionista dedicato alla governance integrata della salute nelle città, oggi riconosciuto come better practice a livello internazionale. In Italia, questa figura ha trovato un percorso formativo stabile grazie alla sinergia tra Governo, ANCI e Health City Institute, consolidandosi come punto di riferimento per le amministrazioni locali e per le reti territoriali.
Negli anni, il Manifesto è stato progressivamente arricchito da nuove priorità e azioni: la promozione dello sport e la nascita del concetto di SportCity, la valorizzazione delle reti di prossimità, l’attenzione alla salute mentale e alle fragilità psicologiche, l’impulso alla digitalizzazione e all’uso etico dell’intelligenza artificiale, fino all’istituzione di Osservatori permanenti sulla salute nelle città e alla creazione di network delle città e della comunità scientifica. Queste integrazioni hanno confermato la sua natura di documento dinamico, capace di adattarsi alle trasformazioni sociali e urbane.
Il valore del Manifesto è andato oltre i confini nazionali. Esso ha ispirato importanti documenti internazionali, presentati in sedi come il G7 del 2017 e il G20 del 2022, e ha costituito un riferimento per il progetto globale Cities for Better Health. Inoltre, ha contribuito direttamente alla redazione del Parere su “Salute nelle città: bene comune” del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, rafforzando la sua autorevolezza anche in ambito comunitario.
Oggi il Manifesto è riconosciuto come piattaforma di convergenza per istituzioni, amministrazioni, università, società scientifiche, reti sociali e cittadini. La sua visione ribadisce che la salute nelle città è un bene comune e che il suo perseguimento richiede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, non solo dei sistemi sanitari.
Adottare il Manifesto significa assumere un impegno politico, culturale e sociale: costruire città inclusive, resilienti e sostenibili, dove la salute diventa il fondamento della democrazia, della giustizia sociale e di un futuro equo per le nuove generazioni.
1. Considerare la salute come bene comune
Promuovere la salute come diritto universale, superando le disuguaglianze e garantendo equità di accesso.
Favorire politiche pubbliche che mettano la salute al centro della vita urbana.
Rafforzare la cultura della salute come responsabilità condivisa tra istituzioni, comunità e cittadini.
2. Integrare la salute in tutte le politiche urbane
Applicare l’approccio “Health in All Policies” nella pianificazione delle città.
Assicurare che trasporti, ambiente, istruzione, welfare e urbanistica contribuiscano al benessere dei cittadini.
Sviluppare strumenti di valutazione dell’impatto sulla salute delle decisioni urbane.
3. Promuovere l’urban health literacy
Diffondere conoscenze e competenze sulla salute urbana tra cittadini e decisori.
Valorizzare programmi educativi nelle scuole e nelle comunità.
Creare campagne di comunicazione inclusive e accessibili.
4. Ridurre le disuguaglianze di salute
Identificare e monitorare i divari di salute tra quartieri e gruppi sociali.
Implementare politiche mirate per contrastare marginalità e vulnerabilità.
Garantire servizi socio-sanitari equi e prossimi ai cittadini.
5. Potenziare la prevenzione e la promozione di stili di vita sani
Creare ambienti urbani favorevoli alla salute attraverso spazi verdi e mobilità attiva.
Promuovere sport, attività fisica, alimentazione corretta e contrasto alla sedentarietà.
Sostenere programmi di prevenzione delle malattie croniche e infettive.
6. Rafforzare la governance multilivello della salute nelle città
Promuovere la collaborazione tra Comuni, Regioni, Governo e istituzioni europee.
Coinvolgere attivamente società scientifiche, università e terzo settore.
Istituire la figura dell’Health City Manager come raccordo operativo.
7. Monitorare e migliorare i determinanti ambientali di salute
Integrare sistemi di sorveglianza su aria, rumore e luce nelle aree urbane.
Sviluppare osservatori locali di salute urbana con dati aggiornati e condivisi.
Promuovere politiche per la resilienza climatica e ambientale delle città.
8. Valorizzare l’inclusione sociale e culturale
Favorire la partecipazione attiva di cittadini, comunità migranti e minoranze.
Contrastare discriminazioni e fragilità con azioni mirate.
Integrare nei programmi socio-sanitari percorsi interculturali e inclusivi.
9. Favorire l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale
Sviluppare programmi urbani per la longevità attiva e la prevenzione della fragilità.
Creare spazi e servizi a misura di anziano.
Promuovere la collaborazione intergenerazionale nelle comunità urbane.
10. Promuovere la ricerca e l’innovazione per la salute urbana
Incentivare studi e progetti di ricerca interdisciplinare.
Valorizzare la collaborazione con università, centri di ricerca e imprese.
Diffondere pratiche innovative per la salute e la sostenibilità urbana.
11. Sviluppare lo Sport nelle città e il concetto di SportCity
Promuovere la cultura dello sport come strumento di salute, inclusione e coesione sociale.
Riqualificare e valorizzare gli impianti sportivi cittadini, favorendo l’accessibilità universale.
Creare programmi urbani che integrino lo sport nella pianificazione degli spazi pubblici e nelle politiche di salute.
Coinvolgere attivamente associazioni sportive, scuole, società civili e reti sociali nella costruzione della “SportCity”.
12. Promuovere reti di prossimità e comunità solidali
Sostenere la nascita di hub territoriali di prossimità che integrino servizi sanitari, sociali e di comunità.
Rafforzare il ruolo delle associazioni, del volontariato e dei presidi civici nella cura dei cittadini più fragili.
Creare piattaforme locali di collaborazione tra amministrazioni, servizi sociali, farmacie, parrocchie e centri culturali.
Incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione di comunità solidali e inclusive.
13. Tutelare la salute mentale e il benessere psicologico
Integrare programmi di supporto psicologico nei servizi sanitari territoriali e nei centri di prossimità.
Garantire accesso facilitato a servizi di consulenza psicologica, soprattutto per giovani, anziani e soggetti vulnerabili.
Avviare campagne urbane di sensibilizzazione per ridurre lo stigma legato alla salute mentale.
Promuovere nelle scuole e nei luoghi di lavoro iniziative di prevenzione, educazione e promozione del benessere psicologico.
14. Sfruttare la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale per la salute urbana
Potenziare l’infrastruttura digitale cittadina per assicurare connettività e accesso ai servizi sanitari online.
Utilizzare l’intelligenza artificiale per il monitoraggio dei determinanti ambientali di salute (aria, rumore, traffico, verde).
Promuovere piattaforme digitali per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie croniche e infettive.
Assicurare che l’uso di dati e algoritmi rispetti principi etici, di trasparenza, privacy e inclusione sociale.
15. Creare Osservatori permanenti sulla salute nelle città
Istituire Osservatori permanenti a livello urbano e metropolitano per monitorare i determinanti di salute, le disuguaglianze e l’impatto delle politiche pubbliche.
Coinvolgere stabilmente Comuni, Università, Fondazioni, Istituzioni sociali, scientifiche e sportive, Terzo settore ed esperti in una governance condivisa.
Favorire l’elaborazione di rapporti periodici e indicatori comparabili a livello nazionale e internazionale.
Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e la trasparenza dei dati come strumenti di accountability e di orientamento delle decisioni pubbliche.
16. Creare network delle città e della comunità scientifica
Costruire reti nazionali e internazionali di città impegnate nella promozione della salute urbana, per favorire lo scambio di buone pratiche e innovazioni.
Coinvolgere stabilmente la comunità scientifica nelle strategie urbane, garantendo un dialogo costante tra ricerca e decisione politica.
Promuovere alleanze multi-attore che uniscano amministrazioni locali, università, società scientifiche, fondazioni, terzo settore e cittadini.
Sostenere la partecipazione delle città italiane a network europei e globali, rafforzando il ruolo del Paese nelle politiche di Urban Health.


In collaborazione con



di Federico Serra
Catania è una città che non smette mai di sorprendere. È fatta di pietra lavica e mare, di barocco e mercati popolari, di bellezza e contraddizioni. Ha conosciuto la devastazione del terremoto del 1693, le eruzioni che ne hanno cancellato interi quartieri, le difficoltà del presente. Eppure ogni volta si è rialzata. “Melior de cinere surgo”, migliore risorgo dalle ceneri: non è solo un motto araldico, ma la cifra stessa della sua identità. Oggi la sfida non è più soltanto resistere alle ferite della natura. Oggi Catania è chiamata a un compito più ambizioso: diventare un hub del Mediterraneo, un punto di incontro tra continenti, economie e culture.
La sua posizione è un dono e una responsabilità: città al centro di un mare che torna a essere decisivo per l’energia, i commerci, le migrazioni, la ricerca scientifica. Da Catania si guarda a Roma e Atene, a Tunisi e Il Cairo, a Marsiglia e Istanbul. È un crocevia naturale che, con infrastrutture e visione, può trasformarsi in piattaforma strategica.
I segnali ci sono già. Il porto, al centro di un progetto di rilancio con il nuovo Piano Regolatore Portuale, si prepara a diventare hub intermodale per merci, crociere ed energie rinnovabili. L’aeroporto di Fontanarossa, con oltre 10 milioni di passeggeri l’anno, è già oggi la principale porta d’ingresso del Sud e guarda al futuro con la nuova pista e i collegamenti ferroviari veloci. Sul fronte industriale, l’Etna Valley ha fatto scuola. STMicroelectronics, colosso della microelettronica, continua a trainare un ecosistema di imprese e startup che rendono Catania un polo di riferimento europeo per i semiconduttori. Un settore strategico, capace di attrarre investimenti miliardari e di garantire occupazione qualificata a migliaia di giovani. Catania non è solo industria e infrastrutture. È università e cultura, con l’Ateneo che ospita studenti provenienti da tutto il Mediterraneo e il Teatro Massimo Bellini che mantiene viva una tradizione musicale di respiro internazionale. È innovazione sociale, con i quartieri rigenerati come San Berillo, oggi laboratorio
di arte urbana e creatività giovanile. È sostenibilità, con progetti di riqualificazione ambientale e con l’impianto fotovoltaico di ultima generazione avviato da Enel Green Power, simbolo della vocazione energetica del territorio.
Il futuro di Catania è scritto nei suoi contrasti: l’Etna che incombe e fertilizza, il mare che minaccia e apre rotte, la città barocca che convive con i coworking delle start-up. Una città in cui le contraddizioni non sono debolezza, ma linfa vitale.
Ed è qui che va riconosciuto il merito all’attuale amministrazione comunale, capace di guardare al futuro con pragmatismo, senza indulgere alle facili illusioni. I progetti avviati sul fronte della mobilità, della rigenerazione urbana e dell’innovazione mostrano una città che non si limita a evocare la rinascita, ma che lavora giorno dopo giorno per costruirla. Una politica che sceglie la concretezza, che mette insieme visione e realismo, che prova a trasformare la retorica del “risorgere” in fatti tangibili.
Catania è una città che vive di simboli, e i suoi due elementi fondativi – l’Etna e il mare – raccontano bene la sfida che l’attende. Il vulcano, con la sua forza primordiale, ricorda che la distruzione può essere sempre l’occasione di un nuovo inizio. Il mare, con il suo respiro infinito, invita ad aprirsi al mondo e a non aver paura delle contaminazioni.
Se saprà tenere insieme queste due anime – energia interiore e apertura esteriore – Catania non sarà più solo la città che risorge dalle ceneri, ma diventerà capitale viva e riconosciuta del Mediterraneo. Una fenice che non si limita a sopravvivere, ma che sceglie di guidare. E allora sì, il motto antico torna a brillare come promessa di futuro: Melior de cinere risurgo. Catania, migliore, più forte, più centrale. Pronta a scrivere una nuova stagione della sua storia, non come periferia dimenticata, ma come cuore pulsante del mare che unisce tre continenti.
Bologna spesso viene percepita come una città “a misura d’uomo”, dove convivono tradizione, cultura e spigoli moderni. Chi decide di viverci — sia da studente, lavoratore, famiglia o straniero — lo fa guardando a un equilibrio tra stimoli urbani e qualità della vita. Ma quanto costa? Che cosa offre davvero la città? E quali sono le criticità quotidiane? La guida “Vivere a Bologna” di Immobiliare.it offre un ottimo punto di partenza per orientarsi, e da lì è possibile guardare più in profondità, entrando nel tessuto urbano, sociale e infrastrutturale.
Cosa vedere, cosa fare: il patrimonio urbano che valorizza la vita quotidiana
Il fulcro di Bologna resta il centro storico, con torri medievali, portici infiniti, piazze animate e chiese che raccontano secoli di cultura. Passeggiare sotto i portici, attraversare Piazza Maggiore, salire sulla Torre degli Asinelli o girovagare per le strade del quartiere Santo Stefano sono attività che non sono solo turismo, ma parte dell’esperienza quotidiana di chi abita la città.
I Giardini Margherita rappresentano il principale polmone verde, il luogo dove studenti e famiglie si rilassano. Il Parco della Montagnola è un altro spazio importante in città per eventi e momenti all’aperto. Per chi ama la natura, il panorama dal colle di San Luca offre vista sulla città e un collegamento simbolico tra la struttura urbana e il paesaggio circostante. Immobiliare.it ricorda anche che i musei, le basiliche e gli edifici storici costituiscono tappe irrinunciabili, integrando la vita urbana con la bellezza storica. Immobiliare.it
Mobilità: tra vantaggi, sfide e scelte sostenibili
Una delle caratteristiche più apprezzate di Bologna è la bike-friendliness: molti cittadini la scelgono come mezzo principale. Le vie ciclabili, i servizi di bike sharing, la compattezza urbana rendono la bici — o il camminare — scelte pratiche e spesso più veloci del trasporto su gomma. Immobiliare.it consiglia proprio di muoversi a piedi o in bici. Immobiliare.it
I mezzi pubblici (autobus, tram ove presenti, collegamenti urbani) e i servizi di sharing (auto, scooter) contribuiscono a una mobilità ibrida. Tuttavia, come in molte

città italiane, rimangono sfide legate al traffico, alle zone a traffico limitato (ZTL) e alla gestione delle aree periferiche meno ben servite. Nell’articolo della guida si segnala che occorre prestare attenzione ai limiti di velocità (30 km/h su molte vie) e alle ZTL cittadine. Immobiliare.it
Costo della vita e mercato immobiliare
Quanto costa vivere a Bologna? La guida di Immobiliare.it indica che i prezzi di affitto e di acquisto nel centro storico e nei quartieri centrali sono più elevati. In particolare, la guida ha una sezione specifica su “cosa vedere nel centro storico e quanto costa viverci”. Immobiliare.it
Ad esempio, abitare nel centro (o vicino) significa essere a pochi passi da servizi, cultura e trasporti, ma mettere in conto un premio di costo per l’immobile. Spostandosi verso la periferia o nei quartieri meno centrali, il prezzo scende, ma occorre verificare la raggiungibilità e la qualità dei servizi (trasporti, scuole, negozi).
La guida richiama anche l’attenzione su imposte locali: per il 2025 è indicata l’aliquota IMU del Comune di Bologna per case, seconde case, terreni e negozi. Immobiliare.it
Infine, i bonus e le agevolazioni per l’acquisto o la ristrutturazione della casa (bonus casa, incentivi) sono collegati alle normative nazionali e locali: la guida mette a disposizione link utili per approfondimenti su mutui, agevolazioni e contratti. Immobiliare.it
Qualità della vita, vantaggi e criticità
Secondo la guida, Bologna figura spesso tra le città con una delle migliori qualità di vita in Italia: è vivace, ricca di cultura, collegata e stimolante. Immobiliare.it Ciò significa che chi vive a Bologna può godere di molti servizi, eventi, mezzi pubblici e spazi urbani ben mantenuti.
Tra le criticità però emergono alcuni aspetti che chi decide di trasferirsi deve considerare:
• Sicurezza e microfurti: la guida mette in guardia da furti e microfurti, specialmente nelle zone più

affollate. Immobiliare.it
• Limiti di mobilità e ZTL: le regole di accesso alle zone a traffico limitato e limiti di velocità sono stringenti, e possono essere fonte di frustrazione per chi non è abituato. Immobiliare.it
• Servizi nelle periferie: alcune zone meno centrali possono avere minor accesso a servizi di trasporto, negozi, scuole o tempo libero, il che può incidere sulla scelta dell’area dove vivere.
• Pressione immobiliare: nei quartieri centrali i prezzi sono alti e la disponibilità di nuovi immobili ridotta, il che può generare difficoltà per chi cerca di affittare o acquistare.
Vivere da famiglia, giovani o con bambini
Per famiglie con bambini, Bologna offre spazi verdi come Giardini Margherita, il Parco della Montagnola, l’Orto Botanico; musei e biblioteche con attività dedicate; eventi per bambini in vari periodi dell’anno. La guida suggerisce destinazioni come il Museo del Patrimonio Industriale, Palazzo Pepoli, la Biblioteca Sala Borsa e attività all’aperto con i più piccoli. Immobiliare.it
Per i giovani e gli studenti, Bologna è una città universitaria con una forte attrazione culturale, sociale e di mobilità. Essere in un contesto dinamico, ricco di stimoli, con possibilità di vivere anche con mezzi pubblici o bici è un grande vantaggio.
Attrazioni, eventi e vita culturale
Dalla Torre degli Asinelli al Santuario di San Luca, dalla Basilica di San Francesco alla Cattedrale Metropolitana, il patrimonio storico è ovunque. La guida dedica spazi al “cosa vedere nel centro storico” e “cosa fare vicino alla stazione”. Immobiliare.it
Gli eventi temporanei, le mostre gratuite (es. musei gratis la prima domenica del mese) e la vivacità culturale alimentano una città che non si spegne mai. La pluralità di luoghi d’incontro, teatri, cinema e locali rende Bologna una città da vivere, non solo da attraversare. Immobiliare.it
Consigli pratici e avvertenze
Alcune indicazioni utili che emergono dalla guida:
• Attenzione alle ZTL e ai limiti di velocità: molte strade sono soggette a restrizioni (spesso 30 km/h). Immobiliare.it
• Occhio a furti e zone affollate, specialmente in momenti di alta frequentazione turistica o nei luoghi più centrali.
• Per esplorare bene la città, è consigliabile muoversi a piedi o in bici, sfruttando i mezzi pubblici e i servizi di sharing.
• Per chi cerca casa: valutare il compromesso tra costo e distanza dai nodi di servizio e trasporto.
• Utilizzare le agevolazioni e incentivi per la casa: la guida offre link utili per capire mutui, bonus e contratti. Immobiliare.it
Bologna oltre la guida: riflessioni urbane, sostenibilità e prospettive
Partendo dalla guida Immobiliare.it, è possibile intrecciare alcune riflessioni più ampie sul ruolo che Bologna può avere come città modello per il futuro.
• Rigenerazione urbana: Bologna ha potenzialità significative di sviluppo nei quartieri periferici mediante progetti di riqualificazione, mobilità integrata, spazi pubblici e socialità.
• Mobilità green: continuare a potenziare le reti ciclabili, le zone 30 e i servizi di sharing è fondamentale per ridurre traffico e inquinamento.
• Equità territoriale: la città deve bilanciare le risorse e i servizi tra centro e periferie, evitando che il “cuore” resti il solo spazio vivibile.
• Sostenibilità ambientale: nel medio-lungo termine, la gestione delle risorse (acqua, verde urbano, energie rinnovabili) sarà un pilastro della qualità della vita cittadina.
• Integrazione sociale e demografica: Bologna, come molte città, si trova a gestire sfide legate all’invecchiamento, all’immigrazione, alla casa accessibile e alla convivenza intergenerazionale.
Milano è sempre più al centro della mappa globale dei capitali privati. Da qualche anno, il capoluogo lombardo non è soltanto la capitale italiana della finanza e del design, ma anche un magnete per i super-ricchi di tutto il mondo. Manager internazionali, investitori, imprenditori e fondi stanno trasferendo la loro residenza in città, attratti da un regime fiscale vantaggioso e da un contesto urbano che unisce lifestyle, sicurezza e infrastrutture di alto livello.
Il nuovo paradiso dei patrimoni
Milano sta scalando le classifiche europee delle città più ambite per chi dispone di grandi capitali. Il fenomeno non nasce per caso: è il risultato di una precisa strategia di attrazione fiscale avviata negli ultimi anni. Tra i nuovi residenti figurano nomi di spicco della finanza e dell’imprenditoria internazionale, da banchieri di Goldman Sachs a magnati del settore energetico e fondi d’investimento globali.
La città, dopo aver consolidato la propria immagine come hub economico, sta diventando anche una residenza ideale per i grandi patrimoni. Clima mite, posizione strategica, alta qualità della vita, collegamenti veloci con Londra, Parigi e Zurigo: sono tutti ingredienti che rendono Milano una “mini-metropoli globale” a portata d’uomo.
Un regime fiscale su misura per i ricchi
Il cuore dell’attrattività milanese risiede nel regime fiscale agevolato per chi trasferisce la residenza in Italia con capitali esteri.
Introdotto a metà degli anni 2010 e rafforzato negli anni più recenti, prevede:
• una tassazione fissa annuale di 100-200 mila euro sui redditi esteri, indipendentemente dall’ammontare effettivo;
• esenzione da imposte di successione e donazione per beni situati fuori dall’Italia;
• un’aliquota sulle plusvalenze del 26 %, inferiore a quella di altre piazze finanziarie come Londra o Parigi.
Queste condizioni rendono l’Italia — e in particolare Milano — una destinazione estremamente competitiva rispetto ad altri Paesi europei. L’obiettivo dichiarato è
attrarre investimenti, ma il risultato è anche un flusso costante di famiglie ad altissimo reddito che scelgono di stabilirsi nel cuore della città.
Prezzi alle stelle e città in trasformazione
L’arrivo dei super-ricchi ha innescato una vera e propria corsa all’immobiliare.
Negli ultimi dieci anni, i prezzi delle abitazioni a Milano sono cresciuti di circa il 60 %, con una media superiore a 5.500 euro al metro quadrato, mentre gli affitti sono aumentati del 50 %, passando da 15 a oltre 22 euro al metro quadrato.
Quartieri un tempo popolari come Porta Romana, Isola o Città Studi stanno rapidamente cambiando volto, sostituendo botteghe storiche con concept store, boutique e ristoranti di lusso.
Si moltiplicano anche i club esclusivi e spazi privati come Casa Cipriani o la futura Soho House, simboli di una città che si apre sempre più a un’élite internazionale. Tuttavia, per molti milanesi, il rischio è che la città diventi “inaccessibile”, più vicina a una vetrina che a una comunità.
Effetti collaterali: gentrificazione e squilibri sociali
Il boom dei capitali stranieri e dei grandi patrimoni non è privo di conseguenze.
Sul piano sociale, si osserva un effetto di gentrificazione accelerata, con la progressiva espulsione delle classi medie e popolari dai quartieri centrali. Gli insegnanti, gli studenti, gli operatori sanitari e i lavoratori dei servizi faticano sempre di più a trovare casa in città.

Anche sul piano economico, si registrano tensioni: le retribuzioni dei manager locali non tengono il passo con quelle dei colleghi stranieri, creando disparità e malcontento.
Nel frattempo, la spinta alla speculazione immobiliare alimenta l’aumento dei valori, ma rischia di ridurre la qualità complessiva della vita urbana.
Milano come laboratorio delle disuguaglianze urbane
Milano diventa così un laboratorio europeo di disuguaglianze urbane: un luogo dove la ricchezza globale si concentra in pochi chilometri quadrati, mentre i residenti tradizionali vengono spinti verso la periferia o l’hinterland.
Il modello milanese è al tempo stesso un successo e un avvertimento. Dimostra che una politica fiscale attrattiva può trasformare una città in un polo di capitale umano e finanziario, ma mette anche in discussione il concetto stesso di equità urbana
Se il futuro delle metropoli sarà determinato dalla competizione per i super-ricchi, il rischio è che la città perda la propria anima civica, diventando un ecosistema chiuso, dove vivere non è più un diritto, ma un privilegio.
Una sfida per la politica e per la città
Il prossimo passo sarà politico e culturale. Milano deve decidere se accettare la sua trasformazione in una città vetrina per élite globali, o se riequilibrare le politiche abitative e fiscali per garantire una reale inclusione
.Servono strategie di edilizia accessibile, piani per il welfare urbano e strumenti di redistribuzione della ricchezza.
Milano, che nel Novecento fu capitale del lavoro e dell’industria, oggi è capitale della finanza e del capitale. Ma il vero indice di successo non sarà la quantità di miliardari residenti, bensì la capacità della città di restare viva, equa e abitabile per tutti.

Le scale antincendio — note in inglese come fire escape — sono un’icona urbana, soprattutto nelle grandi città statunitensi come New York. Non semplici elementi di sicurezza, ma simboli carichi di immaginario cinematografico: luoghi di sogni, fughe, incontri, melodie, avventure. Ma oggi quel simbolo è messo in crisi, minacciato dallo smantellamento e dal cambiamento delle città.
Origine e simbolismo
Le fire escape nascono tra Otto e Novecento, quando l’esplosione urbana costringe gli edifici a crescere in verticale — e la sicurezza diventa vera questione di vita o morte. Strutture in ferro, rampanti lungo le facciate, emergono come appendici funzionali ma ben presto si caricano di significato culturale.
Nel cinema americano, queste scale diventano veri e propri set narrativi: da Hitchcock a West Side Story, dalla commedia al thriller, passando per scene amorose o inseguimenti mozzafiato. Un protagonista può fuggire, ritornare, incontrare una voce inaspettata sulla balaustra, iniziare una canzone guardando le luci della città. Le fire escape sono spazi liminali: né pienamente dentro, né completamente fuori.
Cinema, musica, storie d’amore
Pensa a West Side Story: Tony e Maria, prodighi di melodia, si incontrano in un vicolo, tra scale antincendio che diventano palcoscenico romantico. In Colazione da Tiffany, Audrey Hepburn interpreta Moon River affacciata da una finestra che si apre su scale di servizio, evocando un dialogo intimo con la città. E perfino in Friends, Ross e Joey vivono momenti comici e drammatici tra piani e tetti, utilizzando queste rampe per scendere, salire e salvarsi.
Nell’universo cinematografico statunitense, le fire escape sono un archetipo: corrono lungo i palazzi come nervature d’acciaio che collegano vite, segreti, sospiri e inseguimenti.
Minaccia e smantellamento: la fine di un’era urbana?
Tuttavia, quel simbolo è oggi in pericolo. A New York, molte di queste scale vengono progressivamente rimosse, soprattutto nei quartieri che un tempo erano industriali o popolari e che ora subiscono trasforma-
zioni urbane e gentrificazione. Lo smontaggio delle fire escape, per ragioni di sicurezza, estetica o semplicemente normativa, potrebbe segnare la fine di una tradizione architettonica e narrativa.
Se scompare la fire escape, si spezza un collegamento tra la città reale e la sua versione immaginaria. Le scene di fuga sui tetti, le corse sui metalli arrugginiti, i dialoghi sospesi tra grondaie e luci notturne rischiano di diventare memoria. Per molti registi, sceneggiatori, cinefili, sarà come perdere un codice visivo fondamentale del racconto urbano americano.
Riflessi oltre l’America
Questo fenomeno non riguarda soltanto New York o Hollywood. Le fire escape, o strutture analoghe, hanno avuto il loro posto anche in altre città — soprattutto dove si è sviluppato l’edilizio popolare verticale. La loro rimozione o disuso mette in questione il rapporto tra architettura e immaginario urbano, tra memoria collettiva e trasformazione delle città.
Forse, la scomparsa di queste strutture ci invita a riflettere più ampiamente: sul modo in cui le città cambiano, cancellano tracce del passato, ridefiniscono spazi e storie. E su come il cinema abbia sempre sondato questi luoghi intermedi — scale, cortili, ballatoi — per raccontare la vita urbana, le sue fessure e i suoi incontri.
di Ludovica Serra

C’è un momento, viaggiando verso sud da Toronto, in cui la città comincia lentamente a dissolversi. I grattacieli si fanno più radi, il traffico si dirada, e all’orizzonte si apre una pianura verde, punteggiata di filari e vigneti. L’aria cambia odore: diventa più umida, più viva. È l’annuncio del Niagara, uno dei luoghi più sorprendenti del pianeta, dove la natura non è solo paesaggio, ma esperienza sensoriale totale.
A un’ora e mezza di strada dalla metropoli canadese, le Cascate del Niagara si manifestano come un respiro profondo della Terra. Non sono solo un’attrazione turistica, ma una soglia: un incontro fra potenza e pace, fra l’acqua che precipita e il silenzio che rimane dopo.
L’arrivo: quando l’acqua ha voce
Da lontano, si percepisce prima il suono: un rombo continuo, profondo, che vibra nell’aria e nella pelle. Poi, man mano che ci si avvicina al bordo, l’orizzonte si piega, e il fiume Niagara — tranquillo fino a un attimo prima — si trasforma in un abisso in movimento.
Il Table Rock Welcome Centre, sul lato canadese, è uno dei punti più spettacolari: da lì si guarda giù, verso la Horseshoe Falls, la grande cascata a ferro di cavallo. L’acqua, di un verde lattiginoso, si spezza in milioni di gocce e sprigiona una nebbia che sale come un respiro costante, avvolgendo i volti dei visitatori. È impossibile non restare immobili, ipnotizzati da quella forza che tutto inghiotte e tutto restituisce.
Intorno, la natura non ha nulla di selvaggio in senso primitivo: è domata con rispetto, curata, disegnata come un grande giardino pubblico. È il Niagara Parks, una lunga fascia verde che accompagna il fiume per chilometri, dal lago Erie fino al lago Ontario, un parco nato nel 1885 e mantenuto con un’eleganza che appartiene solo al Canada.
Nel cuore del Niagara Parks
Passeggiare nel Niagara Parks significa muoversi lungo una linea che separa due mondi: da un lato la potenza naturale del fiume, dall’altro la quiete perfetta dei giardini.
Il sentiero segue le curve dell’acqua, tra boschi di acero e cedri, piccoli belvedere, panchine che sembrano pensate per fermarsi e guardare, senza fretta.
A tratti si incontrano punti panoramici che tagliano il fiato: come il Journey Behind the Falls, un tunnel scavato nella roccia che permette di camminare proprio dietro il velo d’acqua, o il Niagara Parks Power Station, l’antica centrale idroelettrica ora trasformata in museo. Lì, in un silenzio solenne, si ascolta il battito profondo dell’energia: turbine, condotti, luci e una galleria sotterranea che termina in un affaccio spettacolare sul fiume. È un modo per capire che, in questo luogo, natura e ingegno umano convivono da più di un secolo, in una simbiosi che non toglie nulla alla bellezza.
Niagara-on-the-Lake: la calma dopo il fragore
Lasciando le cascate e seguendo la direzione del fiume verso nord, si arriva a Niagara-on-the-Lake, un piccolo gioiello immerso tra vigne e giardini fioriti. Dopo l’intensità del fragore, qui regna un silenzio dolce: le case di legno dai colori pastello, le insegne eleganti, i caffè che profumano di pane e sciroppo d’acero. È una città d’altri tempi, dove ogni finestra racconta un pezzo di storia coloniale e dove la vita scorre lenta, scandita dal ritmo delle stagioni e dai festival teatrali che ogni anno animano le sue strade.
È anche la patria del celebre ice wine, il vino dolce prodotto con uve raccolte quando sono ghiacciate: un piccolo miracolo di equilibrio tra natura e mano

dell’uomo, proprio come il territorio che lo genera.
Toronto e il richiamo dell’acqua
Tornando verso Toronto, lungo la strada che costeggia il lago Ontario, è difficile non pensare al legame profondo tra questa metropoli moderna e il suo elemento naturale.
Toronto vive d’acqua: i moli di Harbourfront, le spiagge di Cherry Beach, i traghetti che portano alle isole. Da lassù, dalle terrazze dei grattacieli, si può vedere in lontananza la direzione del Niagara, come una promessa costante di movimento e libertà.
Nella città, l’acqua diventa architettura, riflesso, orizzonte: è parte del paesaggio mentale dei torontini, un promemoria quotidiano che ricorda quanto la grandezza non nasca dal cemento, ma dalla convivenza armoniosa con la natura.
Il significato del Niagara
Visitare le cascate del Niagara non è solo assistere a uno spettacolo naturale. È un’esperienza che parla di connessione e misura.
Ci ricorda che la forza può essere anche bellezza, che la velocità può convivere con la quiete, e che le città — come gli esseri umani — trovano equilibrio solo quando imparano a rispettare i loro limiti.
Toronto e il Niagara sono le due facce di una stessa medaglia: una città che cresce verso l’alto e un fiume che cade verso il basso, eppure entrambe mostrano la stessa ricerca di armonia.
Chiunque le visiti, torna con una certezza: che l’acqua, quando parla, non si dimentica più.


Chi la attraversa per la prima volta, tra i mattoni rossi di Beacon Hill e le rive del Charles River, percepisce subito una sensazione particolare — come se l’aria stessa fosse impregnata di conoscenza. Le voci dei professori, i passi degli studenti, i caffè pieni di laptop e appunti, tutto sembra muoversi in una coreografia intellettuale che unisce passato e futuro.
Capitale culturale del New England, Boston è una città compatta ma densa di storia, scienza e idee. E le sue università ne rappresentano il cuore pulsante: luoghi di sapere, ma anche di incontro, creatività e fermento. Qui, la cultura non abita nei musei: cammina per strada.
Harvard: la culla del pensiero americano
Appena oltre il fiume Charles, nella cittadina di Cambridge, sorge il nome più leggendario del mondo accademico: Harvard University, fondata nel 1636, la più antica università degli Stati Uniti.
Harvard è più di un campus: è una piccola città nella città.
Le sue corti silenziose, le biblioteche monumentali, i corridoi pieni di ritratti e storia sembrano sospesi nel tempo. Ma dietro la facciata austera si nasconde un microcosmo vibrante, popolato da studenti di ogni an-
un modo di comprendere il mondo.
Passeggiando per Harvard Yard, tra gli edifici coloniali e i prati curati, si percepisce la forza della tradizione: qui hanno studiato otto presidenti americani, tra cui John F. Kennedy e Barack Obama, e una quantità impressionante di premi Nobel, scrittori, giuristi, inventori.
Ma Harvard è anche un laboratorio contemporaneo di innovazione: la Harvard Innovation Lab (i-Lab) e la Kennedy School of Government sono esempi di come il sapere si traduca in politiche, startup e cambiamento sociale.
La città vive attorno a questo universo. A Harvard Square, librerie, locali e caffè sono parte del tessuto accademico: il sapere si respira anche tra un cappuccino e una discussione improvvisata su filosofia politica.
MIT: dove la scienza diventa immaginazione
A poche strade di distanza, sempre a Cambridge, si trova un altro colosso del sapere mondiale: il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Fondato nel 1861, il MIT rappresenta l’anima tecnologica di Boston — il luogo dove l’ingegneria incontra la creatività.
Qui, la conoscenza non si studia soltanto: si costruisce, si sperimenta, si tocca con mano. I laboratori del MIT sono incubatori di innovazione, da cui sono nati strumenti, teorie e invenzioni che hanno cambiato la vita quotidiana. Dalla scoperta del radar ai primi computer moderni, dal linguaggio di programmazione Lisp alle attuali ricerche su intelligenza artificiale e biotecnologie, ogni edificio del campus è un frammento di futuro in costruzione.
Passeggiando lungo Massachusetts Avenue, il contrasto tra Harvard e MIT è evidente: se la prima è tradizione, il secondo è rivoluzione.
Il Stata Center, progettato da Frank Gehry, con le sue linee spezzate e i volumi metallici, incarna perfettamente lo spirito del MIT: un luogo dove anche l’architettura sperimenta, riflettendo il caos creativo del pensiero scientifico.
Boston University e Northeastern: il volto urbano del sapere
Spostandosi lungo il fiume, si entra nel cuore della Boston University (BU), una delle più grandi e internazionali degli Stati Uniti.
Qui la vita universitaria è letteralmente parte del tessuto urbano: i dormitori affacciano sui viali trafficati, le aule convivono con i negozi, e gli studenti si muovono tra una lezione e un concerto, tra un laboratorio e un tramonto sul Charles.
La BU è conosciuta per la sua vocazione interdisciplinare e cosmopolita: ospita studenti da oltre 130 Paesi e offre percorsi che spaziano dall’economia alla comunicazione, dalle neuroscienze alle arti teatrali. È anche una delle prime università americane ad aver aperto un campus all’estero, segnando un dialogo continuo con il mondo.
Poco distante, la Northeastern University rappresenta invece il volto moderno dell’istruzione “esperienziale”: un modello basato sull’alternanza tra studio e lavoro, con programmi che permettono agli studenti di inserirsi nelle aziende già durante il percorso universitario. È un approccio che riflette la cultura bostoniana: formare persone capaci di pensare, ma anche di fare.
Una città di studenti, idee e libertà
Boston è, in tutto e per tutto, una città universitaria. Su circa 700.000 abitanti, quasi un terzo sono studenti o ricercatori. È un mosaico di culture e dialetti, di biciclette, cappotti lunghi e librerie aperte fino a tardi. I quartieri come Back Bay, Beacon Hill, Fenway, Allston o Cambridge sono pieni di giovani, musica e vita
notturna, ma anche di silenzi e spazi per pensare.
Qui la conoscenza non è confinata nei campus: è diffusa, respirabile. I musei scientifici, come il Museum of Science, i centri d’arte contemporanea, le start-up di biotecnologie e i caffè letterari fanno parte di un unico ecosistema culturale.
La città stessa diventa una scuola a cielo aperto: camminando lungo il Freedom Trail, la linea rossa che attraversa i luoghi simbolo della rivoluzione americana, si percepisce la continuità tra la storia e la ricerca del futuro.
La cultura del sapere come identità urbana
In molte città del mondo le università sono istituzioni separate; a Boston, invece, sono parte integrante della sua anima.
L’università non è un’isola, ma un modo di vivere la città: un ritmo, un linguaggio, una forma di curiosità collettiva.
Il sapere, qui, è considerato un valore civico. È ciò che costruisce la comunità, che tiene insieme generazioni diverse, che ispira i progetti di sostenibilità, le start-up green, la ricerca medica e tecnologica.
Non è un caso se Boston è anche una delle città più avanzate nel campo della salute pubblica e dell’innovazione sanitaria: la presenza di ospedali universitari come il Massachusetts General Hospital e centri di ricerca come il Broad Institutefa della città una capitale mondiale della scienza applicata al benessere.
Boston, capitale morale della conoscenza
Vivere Boston significa vivere dentro una biblioteca che respira.
Ogni quartiere è un capitolo: Cambridge è l’introduzione, il MIT è il laboratorio, Harvard è la riflessione, la BU è la metropoli del sapere, Northeastern è la sintesi tra idea e azione.
Insieme, formano un organismo vivo che fa della conoscenza la propria energia.
Boston non ha bisogno di gridare la propria modernità: la insegna, la coltiva, la lascia maturare tra le sue mura e poi la offre al mondo.
È una città che ti cambia senza accorgertene: dopo qualche giorno, anche solo camminando lungo il fiume, ti ritrovi a pensare di più, a guardare più lontano.
Perché in fondo, Boston non è solo un luogo dove si studia: è un luogo che ti insegna a pensare.


Ci sono città che vivono di rumore, di traffico, di corsa. E poi c’è Washington D.C., che vive di ritmo e misura.
Capitale di una delle nazioni più dinamiche del pianeta, Washington non ha l’ansia di stupire: è una città che respira lentamente, con lo sguardo ampio dei suoi viali, la simmetria dei suoi parchi, la calma solenne dei suoi monumenti.
Qui ogni pietra racconta una decisione, ogni edificio custodisce una storia, e ogni prospettiva è pensata per dare forma all’idea di una nazione.
Eppure, dietro le colonne bianche e i corridoi del potere, Washington è anche una città da vivere, con la sua vita quotidiana fatta di quartieri verdi, musei gratuiti, caffè letterari, mercati locali e una sorprendente vitalità culturale.
Una città disegnata come un’idea
Washington D.C. non è nata per caso.Fondata nel 1790 come capitale federale, fu progettata dall’architetto francese Pierre Charles L’Enfant come una città simbolo, un luogo che rappresentasse l’unità e la democrazia americana. Le sue strade si incrociano secondo un piano razionale, con ampi viali, prospettive monumentali e piazze che si aprono improvvisamente tra il verde.
Il National Mall, l’immensa distesa erbosa che attraversa il cuore della città, è il suo asse simbolico. Da un lato il Capitol, con la cupola bianca che domina l’orizzonte;
dall’altro, il Lincoln Memorial, dove Martin Luther King pronunciò il suo celebre “I Have a Dream”. Camminare lungo il Mall è come attraversare un manuale di storia americana: ogni passo evoca un evento, un ideale, una battaglia civile.
Il potere e la bellezza: il centro simbolico
Il Campidoglio è il punto di riferimento visivo e politico della città.
Sotto la sua grande cupola, si riuniscono il Senato e la Camera dei Rappresentanti: il cuore della democrazia americana.
Dalla terrazza del Campidoglio si apre un panorama che racconta l’idea stessa di equilibrio: il Washington Monument si erge come un ago di luce, e oltre, la Casa Bianca, discreta e protetta dal suo giardino, rappresenta la quotidianità del potere.
Ma al di là delle istituzioni, è lo spazio pubblico che incanta: la città è una sequenza armoniosa di parchi, memoriali e musei che non impongono distanza, ma invitano al dialogo.
Washington non ti sovrasta: ti accompagna.
I musei dello Smithsonian: la conoscenza per tutti
Uno degli aspetti più straordinari della capitale americana è la presenza dello Smithsonian Institution, il più grande complesso museale del mondo. Tutti i suoi musei — e sono ben 19 — sono gratuiti, perché la cultura qui è considerata un diritto universale.
Dall’Air and Space Museum, dove si può ammirare il modulo di comando dell’Apollo 11, allo splendido National Museum of African American History and Culture, fino alla National Gallery of Art, che custodisce capolavori di Leonardo, Van Gogh, Degas e Rothko, l’offerta culturale è semplicemente inesauribile.
Ogni museo è una finestra su un aspetto dell’anima americana: la scienza, la storia, la memoria, la diversità.
Passeggiando di sala in sala, si percepisce come la conoscenza qui non sia mai chiusa tra le mura: è un patrimonio condiviso, uno strumento di cittadinanza.
Oltre i monumenti: la città viva
Fuori dal perimetro del potere, Washington è una città sorprendentemente umana.
I quartieri si alternano come pagine di un romanzo: ciascuno con il suo tono, il suo ritmo, la sua comunità.
Georgetown, il più celebre, è un incanto di case di mattoni rossi, boutique indipendenti, ristoranti affacciati sul fiume Potomac e stradine acciottolate che conservano l’atmosfera del XVIII secolo.
È il luogo perfetto per un brunch in un caffè o una passeggiata lungo il Waterfront Park, dove studenti e famiglie si mescolano in un equilibrio spontaneo.
Più a nord, Dupont Circle è il cuore cosmopolita e intellettuale della città: qui si trovano librerie storiche, ambasciate, gallerie d’arte e caffè che sembrano usciti da Parigi o New York.
La sera, il quartiere si accende di vita con musica dal vivo e ristoranti etnici, specchio della multiculturalità che anima la capitale.
Adams Morgan e U Street Corridor rappresentano invece l’anima più vivace e creativa: qui la storia della comunità afroamericana si intreccia con la cultura contemporanea, il jazz incontra l’hip-hop, e l’arte urbana colora ogni muro. È la parte più autenticamente “urbana” di Washington, dove si respira la sua vitalità giovane e inclusiva.
La città verde e il fiume che respira
Uno degli aspetti più sorprendenti di Washington è la quantità di spazi verdi.
Oltre ai viali monumentali, ci sono parchi e sentieri che attraversano la città come vene verdi: Rock Creek Park, grande quasi quanto il doppio del Central Park di New York, è un rifugio naturale dove correre, andare in bicicletta o semplicemente ascoltare il suono del vento tra gli alberi.
Il fiume Potomac, che scorre lungo la città, aggiunge un ritmo liquido al paesaggio. Le sue sponde sono punteggiate da passerelle, ponti, giardini e piste ciclabili.
Da The Wharf, la nuova area rigenerata del lungofiume, si può ammirare il tramonto tra le barche e i riflessi dorati dei palazzi. È il volto più moderno e rilassato di Washington: un quartiere sostenibile, pieno di locali, musica e profumi di cucina internazionale.
Washington contemporanea: una città in evoluzione
Negli ultimi anni, Washington ha cambiato volto. Da capitale austera e istituzionale, si è trasformata in una metropoli dinamica e inclusiva, con una forte attenzione alla sostenibilità, alla mobilità dolce e alla vita di quartiere.
Le nuove generazioni di professionisti, studenti e artisti hanno portato energie diverse, riempiendo la città di festival culturali, mercati contadini e spazi creativi.
Non è raro vedere giovani con laptop nei giardini del Mall o tra le fontane del Navy Yard, discutere di politica, arte o ambiente davanti a un caffè biologico.
Washington oggi non è più solo la capitale della politica: è una capitale del pensiero.
Il fascino discreto del potere
Visitare Washington significa entrare in un luogo dove la storia si rinnova ogni giorno.
Dalle cerimonie ufficiali davanti al Campidoglio ai picnic nel Mall, dalle marce per i diritti civili alle inaugurazioni presidenziali, ogni evento qui diventa simbolo.
Ma forse il fascino più autentico della città sta nel suo equilibrio: nel modo in cui riesce a essere solenne e accogliente, grande e misurata, storica e vivente. È una città che non impone, ma insegna. Una città che invita a pensare — e allo stesso tempo, a rallentare.
Washington: dove l’America si guarda allo specchio
Alla fine di una giornata tra musei, parchi e boulevard, mentre il sole tramonta dietro il Lincoln Memorial e le prime luci accendono il Mall, si capisce perché Washington sia una città unica.Non è solo il cuore politico dell’America: è il suo specchio.
Qui si incontrano la memoria e la speranza, la forma e l’idea, la storia e il futuro.
E mentre le bandiere sventolano leggere contro il cielo, si percepisce che in questa città, così ordinata e maestosa, c’è ancora spazio per la meraviglia — quella di chi, viaggiando, scopre che il potere più grande è sempre la conoscenza.

C’è un punto nei Caraibi dove il mare non ha più sfumature da inventare.
È un luogo dove il blu diventa linguaggio, e il silenzio del vento racconta più di mille parole. Le Turks and Caicos Islands, adagiate nel cuore dell’Oceano Atlantico a nord di Haiti e a sud-est delle Bahamas, sono un arcipelago di pace e luce, una promessa di calma assoluta, di natura intatta e di eleganza discreta.
Qui il tempo non si misura con l’orologio, ma con il ritmo delle onde e il movimento delle nuvole.
È un paradiso che non ostenta, ma accoglie: 40 isole e isolotti, di cui solo una decina abitati, dove la vita scorre al confine perfetto tra mare e cielo.
Un arcipelago di bellezza sospesa
Le Turks and Caicos sono una dipendenza britannica d’oltremare, ma il loro spirito è profondamente caraibico.
Divise in due gruppi principali — le Turks Islands e le Caicos Islands — sono separate da un canale profondo e turchese, chiamato Turks Island Passage, che segna non solo una frontiera geografica, ma anche simbolica: da una parte la quiete, dall’altra la leggerezza.
L’isola più conosciuta è Providenciales, o “Provo”, cuore pulsante del turismo di alto livello e punto d’accesso principale all’arcipelago.
Qui si trova la celebre Grace Bay, una spiaggia di oltre 12 chilometri considerata da molti la più bella del mondo. Sabbia bianca come polvere di conchiglia, mare trasparente e infinito, palme e resort che si fondono con la natura: un quadro senza tempo, in cui ogni dettaglio sembra posato con cura da un pittore del silenzio.
Grace Bay: il luogo dove il mare si ferma
Camminare lungo Grace Bay al mattino presto è un’esperienza che va oltre la vacanza.
Il mare è così fermo da sembrare vetro, l’acqua cambia colore ogni pochi metri — dal verde chiaro al blu profondo — e il sole, ancora basso, accende la sabbia di riflessi dorati.
Qui il turismo ha un ritmo lento e rispettoso: piccoli boutique hotel, ville immerse nel verde, resort sostenibili che si affacciano sull’acqua senza mai interromperne la continuità visiva.
Le barriere coralline, che circondano quasi tutte le isole, sono tra le meglio conservate dei Caraibi. Snorkeling e immersioni rivelano un mondo di colori e vita marina: pesci pappagallo, razze, tartarughe e coralli che si muovono come tende nel respiro delle correnti.
Ma il vero lusso di Turks and Caicos non è nei servizi esclusivi, bensì nella rarefazione: spazio, silenzio, tempo. È il privilegio di essere lontani dal mondo, eppure sentirsi pienamente parte di esso.
North e Middle Caicos: il volto autentico delle isole
Chi lascia Providenciales e si spinge verso North Caicos o Middle Caicos scopre un paesaggio più selvaggio, autentico, dove la natura domina ancora senza compromessi.
Le strade attraversano mangrovie, saline, lagune turchesi e villaggi sonnolenti in cui il tempo sembra essersi fermato.
A Mudjin Harbor, la vista toglie il fiato: una scogliera bianca che si tuffa nel mare di smeraldo, archi di roccia scolpiti dal vento e spiagge deserte che si perdono nell’orizzonte.
È uno dei luoghi più fotografati dell’arcipelago, ma anche uno dei più silenziosi. Qui il mare parla da solo, e chi ascolta ne esce diverso.
Le grotte di Conch Bar, tra stalattiti e misteriosi graffiti indigeni, raccontano invece un passato remoto: le isole furono abitate fin dal VII secolo dai Lucayan, un

popolo di navigatori e agricoltori che viveva in armonia con l’ambiente.
Grand Turk: la memoria coloniale e il respiro della storia
Se c’è un’isola che conserva l’anima storica dell’arcipelago, è Grand Turk.
Piccola, elegante e tranquilla, è la sede del governo e ospita Cockburn Town, una cittadina di architettura coloniale britannica, con case color pastello, balconi di legno e strade bordate di fiori.
Qui il tempo si muove piano, tra musei e antiche saline.
Il National Museum of Turks and Caicos custodisce reperti lucayan, carte nautiche del XVI secolo e il misterioso “Molasses Reef Wreck”, il relitto più antico mai ritrovato nelle Americhe, risalente probabilmente a una spedizione spagnola del 1513.
Si racconta anche che Cristoforo Colombo approdò proprio qui durante il suo primo viaggio nel 1492, prima ancora di raggiungere le Bahamas. Vero o leggenda, il mare di Grand Turk conserva ancora oggi un senso di scoperta primordiale.
Un paradiso per chi cerca l’essenziale
Turks and Caicos non è una destinazione di turismo di massa.
È il luogo di chi cerca l’essenza: l’incontro con una natura che non ha bisogno di essere esibita. Non ci sono grattacieli né città rumorose, ma villaggi di pescatori, tramonti arancioni e cieli stellati così limpidi da sembrare irreali.
Gli amanti del mare trovano qui uno dei paradisi subacquei più ricchi del pianeta: il Bight Reef, il West Caicos Marine National Park e il French Cay sono luoghi mitici per i sub, dove le pareti coralline scendono a picco e si incontrano banchi di delfini, balene e
pesci tropicali.
Ogni stagione offre un volto diverso: da dicembre ad aprile il clima è perfetto, con temperature intorno ai 27°C e brezze leggere; tra gennaio e marzo, le megattere migrano lungo la costa settentrionale, regalando uno spettacolo indimenticabile.
Cucina e cultura del mare
Anche la cucina di Turks and Caicos è un racconto di semplicità e mare.
Il protagonista assoluto è il conch, la grande conchiglia rosa simbolo dell’arcipelago: la si trova fritta, marinata o servita in insalata, fresca e speziata.
Accanto a essa, aragoste, pesce alla griglia, piatti creoli e rum locale scandiscono serate lente, accompagnate da musica rake and scrape suonata con strumenti improvvisati, tamburi e seghe di metallo.
Il venerdì sera a Bight Park è una tradizione: famiglie, turisti e abitanti si ritrovano per la Fish Fry, una festa informale dove il cibo si mescola alla danza e il tramonto fa da scenografia naturale.
L’isola come modo di essere
Più che una meta, Turks and Caicos è uno stato d’animo.
Un luogo dove l’orizzonte si allarga e la mente si svuota. Dove la bellezza non è un’eccezione, ma la regola quotidiana.
È la sintesi perfetta tra raffinatezza e semplicità, tra isolamento e accoglienza.
Ogni isola ha la sua voce, il suo ritmo, il suo modo di ricordarti che la vera ricchezza è nel tempo ritrovato.
E quando, alla fine del viaggio, si guarda per l’ultima volta il mare — quel blu che non finisce mai — si capisce che non è un colore: è un sentimento.

Ci sono città che si visitano, e altre che si respirano. Miami appartiene alla seconda categoria. È una città fatta di luce, di vento caldo, di lingue che si mescolano nell’aria come onde: inglese, spagnolo, creolo, portoghese. È America e America Latina allo stesso tempo, frontiera e rifugio, capitale del glamour e della rinascita tropicale.
A prima vista è impossibile definirla: metropoli e spiaggia, arte e rumore, palme e skyline, Miami cambia volto a ogni quartiere, a ogni ora del giorno. Ma è proprio in questa metamorfosi continua che si nasconde la sua bellezza.
Dove l’oceano incontra la città
Chi arriva a Miami sente subito l’abbraccio dell’acqua. La città sorge su una sottile lingua di terra affacciata sull’Atlantico, circondata da baie, canali e isole artificiali che creano un paesaggio unico. Qui il confine tra città e mare si dissolve: le barche scorrono accanto ai grattacieli, i pellicani volano tra i ponti, e il sole tramonta su acque che sembrano fuse con il cielo.
Il cuore iconico è South Beach, con il suo lungomare leggendario, Ocean Drive, dove la vita pulsa a ogni ora.
Le facciate Art Déco, color pastello, con scritte al neon e finestre tondeggianti, raccontano l’eleganza degli anni Trenta e Quaranta, quando Miami era la Hollywood del Sud .Oggi sono hotel boutique, ristoranti di design e bar che si accendono al tramonto, trasformando la città in un teatro all’aperto.
Passeggiare sulla sabbia di Lummus Park, all’alba, quando il sole colora di rosa l’oceano e i pattinatori iniziano a scivolare lungo la promenade, è un rito quotidiano che riassume l’anima di Miami: energia, leggerezza e libertà.
Arte e rinascita: il miracolo di Wynwood
Se South Beach è il volto da cartolina, Wynwood è il suo cuore creativo.
Un tempo quartiere industriale abbandonato, oggi è un museo a cielo aperto, simbolo della rinascita urbana di Miami.
Le Wynwood Walls, immense pareti ricoperte di murales firmati dai più grandi street artist del mondo, trasformano ogni strada in un’esplosione di colore e significato.
Qui l’arte non vive nei musei, ma tra la gente: si mescola ai caffè, ai laboratori artigianali, alle gallerie indipendenti.
È un luogo dove l’identità latina, afroamericana e americana si incontrano in un mosaico culturale unico.
Di notte, Wynwood cambia ritmo: i magazzini diventano club, la musica si diffonde dalle terrazze e l’aria profuma di cibo di strada e creatività.
Little Havana: il cuore cubano di Miami
A pochi chilometri dai grattacieli scintillanti del centro, Little Havana è un viaggio nel tempo e nello spazio.
Le insegne in spagnolo, i vecchi che giocano a domino in Domino Park, la musica che esce dai bar, il profumo di sigari arrotolati a mano e caffè forte: tutto qui racconta la storia dell’esilio e della speranza.
È la casa di migliaia di cubani che, dagli anni Sessanta in poi, hanno portato con sé le tradizioni della loro isola.
Camminando lungo la Calle Ocho, si incontrano gallerie, panetterie, ristoranti familiari e murales che celebrano la libertà e la memoria.
Ogni marzo, la strada si trasforma in un fiume di musica e danze per il Calle Ocho Festival, la più
grande festa latina degli Stati Uniti.
Little Havana non è solo un quartiere: è un atto di resistenza culturale, un modo per dire che l’identità non si perde, si trasforma.
Downtown e Brickell: il volto moderno della metropoli
Oltre il fascino rétro di South Beach, Miami è anche una città del futuro.
Il quartiere di Brickell, una volta zona residenziale, oggi è il cuore finanziario e tecnologico della città. Grattacieli di vetro, rooftop panoramici, ristoranti di cucina fusion e hotel di lusso ne fanno una piccola Manhattan tropicale, dove lavorare e vivere si fondono in un’unica esperienza urbana.
Il vicino Downtown Miami sta vivendo una rinascita architettonica e culturale: spazi pubblici, musei e gallerie stanno ridefinendo la relazione della città con il suo passato.
Il Perez Art Museum (PAMM), affacciato sulla baia, è un esempio di questa nuova anima: sospeso tra arte contemporanea e paesaggio, offre una vista spettacolare sull’acqua e installazioni che raccontano la complessità del mondo moderno.
Coconut Grove e Coral Gables: l’anima verde di Miami
Per chi cerca una Miami più lenta, i quartieri di Coconut Grove e Coral Gables sono un’oasi di calma e fascino. Coconut Grove, il più antico quartiere della città, è un rifugio di verde e bohéme: strade ombreggiate, ville coloniali, mercati biologici e caffè sotto gli alberi. È il luogo dove il ritmo rallenta e il mare si avvicina silenzioso, tra porticcioli e giardini botanici.
Poco distante, Coral Gables incarna un’eleganza mediterranea: palme, fontane, viali ampi e ville in stile spagnolo.
La Venetian Pool, una piscina naturale scavata nella roccia e alimentata da sorgenti d’acqua dolce, è uno dei luoghi più incantevoli della città, perfetta per un tuffo nel passato.
Le isole e il mare: il sogno infinito
Da Miami, la strada si allunga verso sud come una promessa: è la Overseas Highway, il ponte sull’oceano che conduce alle Florida Keys. Ogni curva regala panorami surreali, dove l’azzurro del mare incontra quello del cielo.
Ma anche restando in città, il mare è protagonista assoluto: Key Biscayne, Crandon Park, Virginia Key — spiagge più tranquille, perfette per chi cerca natura, kayak o tramonti lontani dal caos di South Beach.
Per chi ama il mare profondo, le barriere coralline al largo di Biscayne National Park sono tra le più accessibili e incontaminate della costa orientale degli Stati Uniti.
Miami di notte: la città che non dorme mai
Quando il sole cala dietro i palazzi di Brickell, Miami si accende come un sogno elettrico. La città diventa un mosaico di luci e musica: dai lounge sofisticati di South Beach ai club iconici come il LIV o lo E11even, fino alle terrazze di Wynwood o del Design District, dove la notte si veste d’arte e ritmo.
La musica latina domina ovunque: salsa, reggaeton, bachata, jazz caraibico — ogni suono racconta una parte del suo spirito.
Eppure, anche nel suo lato più mondano, Miami conserva un’eleganza spontanea: qui la festa non è mai eccesso, ma celebrazione della vita.
Una città che non smette di reinventarsi
Miami è una città in continua trasformazione: da porto coloniale a rifugio per artisti, da capitale del turismo a laboratorio di sostenibilità.
Negli ultimi anni, ha investito in progetti di resilienza climatica, architettura verde e mobilità sostenibile per affrontare le sfide dell’innalzamento del mare.
È una città che guarda avanti senza perdere la sua anima latina, il suo sorriso luminoso e la sua energia contagiosa.
Ogni viaggio a Miami è diverso dal precedente, perché la città cambia, cresce, si rigenera.
Miami: l’arte del vivere al sole
Alla fine, ciò che resta di Miami è una sensazione: quella di leggerezza profonda.
È la consapevolezza che la vita può essere ritmo, luce, mare e libertà.
Che il corpo e la mente possono convivere tra movimento e silenzio, tra il battito di un bongó e il rumore dolce delle onde.
Miami non si visita: si vive.
E chi la lascia, porta con sé un riflesso di quel sole che qui sembra non tramontare mai.

New York non si guarda, si conquista — un piano alla volta.
È una città verticale, fatta per essere vissuta in movimento: nei suoi marciapiedi c’è l’energia del mondo, ma è solo salendo in alto che si comprende la sua vera essenza. Da lassù, tutto cambia: le luci diventano stelle, le strade fili di luce, e l’oceano si trasforma in un respiro lontano.
Vedere New York dai suoi grattacieli è più di un’esperienza panoramica: è un rito moderno, un viaggio tra architettura, storia e vertigine. Ogni osservatorio ha un’anima diversa — romantica, futurista, storica o meditativa — ma tutti raccontano lo stesso sogno: quello di una città che non smette mai di guardare verso l’alto.
Empire State Building: il mito che non tramonta
C’è un momento, al tramonto, in cui l’Empire State Building si accende come una fiamma dorata. È forse il simbolo più riconoscibile di New York, l’edificio che ha definito l’idea stessa di grattacielo nel mondo. Costruito in soli 410 giorni durante la Grande Depressione e inaugurato nel 1931, è ancora oggi un monumento al coraggio e alla fiducia nel futuro.
Salire fino all’osservatorio dell’86° piano è come compiere un pellegrinaggio: un ascensore Art Déco ti porta in pochi secondi nel cuore del mito, e una volta in cima, l’intera Manhattan si apre come una mappa viva. Di notte, le luci della città sembrano un universo in miniatura: Chrysler Building, Times Square, il fiume Hudson, il ponte di Brooklyn, la punta del One World Trade Center.
Dal 102° piano, rinnovato con vetrate panoramiche a tutta altezza, la vista è più intima e sospesa: un momento in cui il rumore della città svanisce e resta solo il respiro del vento.
Top of the Rock: la vista perfetta sull’Empire
Se c’è un punto da cui vedere davvero l’Empire State Building, quello è il Top of the Rock, l’osservatorio del Rockefeller Center.
Aperto nel 1933 e completamente restaurato, questo punto panoramico ha un fascino speciale: da un lato abbraccia il verde infinito di Central Park, dall’altro la distesa dei grattacieli di Midtown, con l’Empire al centro come un faro.
La terrazza è disposta su tre livelli, tutti aperti, senza vetri: il vento qui è parte dell’esperienza.
All’alba, la luce filtra come un velo rosato tra i palazzi; al tramonto, i riflessi d’oro trasformano la città in un quadro impressionista.
Salire al Top of the Rock significa scoprire una New York più armoniosa e poetica, dove il cemento lascia spazio alla bellezza geometrica della sua architettura.
All’estremo sud di Manhattan, dove il cielo un tempo si era spezzato, si alza oggi il One World Trade Center, il grattacielo più alto dell’emisfero occidentale. È più di un edificio: è un simbolo di rinascita, di memoria, di luce.
L’ascensore porta in cima in 47 secondi, proiettando un video immersivo che racconta l’evoluzione di New York dal 1500 a oggi. Quando le porte si aprono al One World Observatory, a 541 metri d’altezza, il panorama è assoluto: un orizzonte che abbraccia l’Hudson, il New Jersey, la Statua della Libertà, Brooklyn e l’oceano.
Le grandi vetrate curve regalano una sensazione quasi metafisica, come se si stesse galleggiando sopra la città. Qui la vista non è solo estetica, ma spirituale: un modo per ricordare che New York, come la vita, cade e si rialza, sempre più forte.
Summit One Vanderbilt: il futuro sospeso nel cielo
A pochi passi dalla Grand Central Station, l’ultimo arrivato nella famiglia dei grandi osservatori newyorkesi è il Summit One Vanderbilt — e sembra venire dal futuro.
Aperto nel 2021, è una esperienza sensoriale e artistica più che un semplice punto panoramico.
Il percorso, chiamato Air, è un viaggio tra specchi, vetro e luce ideato dallo studio dell’artista Kenzo Digital. Le pareti e i pavimenti riflettenti moltiplicano lo spazio all’infinito, creando l’illusione di fluttuare sopra Manhattan.
Ogni passo è un gioco di vertigine e meraviglia, amplificato dalle installazioni luminose e dalla vista mozzafiato sull’Empire State e su tutto Midtown.
L’ultimo piano ospita il Levitation, due capsule di vetro sospese nel vuoto, e il Summit Lounge, dove si può sorseggiare un cocktail guardando il sole calare sul Chrysler Building.
È la New York che osa, che sperimenta, che trasforma l’architettura in emozione pura.
Edge Hudson Yards: la terrazza che sfida il vento
Il più audace dei punti panoramici è senza dubbio Edge, inaugurato nel 2020 a Hudson Yards, il nuovo quartiere futuristico di Manhattan ovest.
La sua terrazza triangolare, sporgente nel vuoto a oltre 340 metri, è la più alta dell’emisfero occidentale.
Da qui, la sensazione è fisica: il vento ti avvolge, la città sembra muoversi sotto i piedi, e attraverso il pavimento di vetro si vede l’asfalto scorrere lontano.
Il panorama è un abbraccio a 360 gradi: dal fiume Hudson fino al Bronx, dal New Jersey a Downtown.
Edge non è solo un punto d’osservazione, ma un atto di sfida. È l’essenza stessa di New York: il coraggio di sporgersi, di guardare più in là, di vivere la vertigine come forma di bellezza.
The Summit of the Heart: la città che si riflette
Salire su un grattacielo a New York non significa solo vedere la città: significa sentirla. Ogni osservatorio ha la sua musica, il suo ritmo, la sua storia.
Dall’Art Déco dell’Empire alla poesia del Rockefeller, dalla memoria del One World all’avanguardia di Summit e Edge, la città si racconta come un’orchestra di prospettive.
E ogni volta che la si guarda dall’alto, si capisce che New York non è una somma di palazzi, ma una vibrazione.
Un luogo che ti insegna la leggerezza, anche tra l’acciaio e il vetro; un posto dove ogni tramonto ha il sapore di un inizio.
Consigli di viaggio tra le nuvole
Per chi desidera vivere davvero New York vista dall’alto, il momento migliore è il tramonto: la luce che si spegne tra i grattacieli regala riflessi dorati e una malinconia che solo questa città sa evocare. Molti osservatori offrono biglietti combinati o esperienze serali con cocktail e musica dal vivo.
• Empire State Building – Classico intramontabile, aperto fino a tarda notte.
• Top of the Rock – Ideale per fotografare l’Empire al tramonto.
• One World Observatory – Il più alto e simbolico, emozione pura.
• Summit One Vanderbilt – Avveniristico e immersivo, per chi ama l’arte e la luce.
• Edge Hudson Yards – L’adrenalina con vista, da vivere col vento in faccia.
New York, la città che si guarda da sé
Alla fine, osservare New York dall’alto è come guardare un essere vivente: respira, pulsa, cambia colore. Di giorno è un mosaico di energia, di notte una costellazione artificiale che sembra imitare il cielo.
Da lassù si capisce perché la chiamano la città che non dorme mai: perché, semplicemente, non smette mai di sognare.
E chi la guarda dall’alto, per un attimo, sogna con lei.


di Silvia Gabriella Ciappellano
Che le disuguaglianze socio-economiche abbiano un impatto sulla salute è ormai riconosciuto. L’ultimo rapporto mondiale sui determinanti sociali dell’equità della salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2025 ha mostrato come fattori quali lo svantaggio sociale e i livelli di discriminazione siano alla base di disuguaglianze nella salute, portando a una drastica riduzione dell’aspettativa di vita in buona salute. La stessa relazione è stata confermata anche dal recente rapporto The Role of Healthcare in Reducing Inequalities and Poverty in the EU che ha mostrato come disuguaglianze socio-economiche e condizioni di povertà incidano pesantemente sulla salute dei cittadini, con una riduzione dell’aspettativa di vita fino a 5-7 anni nei gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati rispetto alle classi più abbienti.
Guardando all’ambito oncologico, uno studio pubblicato su The Lancet Regional Health – Europe nel 2023 ha analizzato le differenze nella mortalità a causa di diversi tumori tra 18 Paesi europei e all’interno degli stessi e le ha messe in relazione alle disuguaglianze socio-economiche. Disuguaglianze che incidono su tutte le diverse fasi del continuum del cancro: dall’accumulo di fattori di rischio, alla prevenzione, alla diagnosi precoce, all’accesso allo screening e a trattamenti efficaci, ma in maniera diversa per i diversi tipi di tumore. In generale, si è osservato che in tutti i Paesi analizzati le persone con un livello di istruzione inferiore mostrano una maggiore mortalità per quasi tutti i tumori considerati rispetto a quelle con alto livello di istruzione, con un gradiente di aumento del rischio di morte al diminuire del livello di eduzione. Per alcuni tipi di tumore, come quello della cervice uterina, sono invece le disparità nell’accesso agli interventi di screening ad avere un ruolo sostanziale nell’esacerbare le disuguaglianze nella mortalità per cancro.
Tra tutti i tumori, quelli ematologici e, nello specifico, il mieloma multiplo può rappresentare un fattore di maggior rischio di disuguaglianza. Infatti, data la sua natura recidivante, le persone che hanno questo tumore del sangue possono spesso andare incontro a maggiori linee di trattamento anche per lunghi periodi, con un
conseguente maggior carico terapeutico e logistico che può essere alla base di disparità socio-economiche per questi pazienti. Proprio per questo, all’ultimo congresso della European Hematology Association – EHA 2025 è stato presentato lo studio CLARITY promosso dalla Fondazione GIMEMA per valutare la qualità della vita di pazienti con mieloma multiplo recidivante o refrattario. Lo studio ha considerato i patient-reported outcomes (PROs), così da considerare l’esperienza soggettiva dei pazienti durante la malattia e il trattamento. Lo status socio-economico è stato determinato integrando tre indicatori, ossia titolo di studio, condizione abitativa e presenza o meno di reddito da lavoro o pensione. Ad emergere è stata proprio la relazione tra disparità socio-economiche e qualità della vita: al peggiorare della prima si sono osservati maggiori sintomi, tra i quali insonnia, dolore, stanchezza e una più marcata compromissione del benessere emotivo. Anche se dolore e fatica sono due sintomi molto comuni nei pazienti con mieloma multiplo, lo studio ha riscontrato una prevalenza più alta di sintomi clinicamente rilevanti tra i pazienti con un basso livello socio-economico.
Sempre in ambito ematologico, nel 2024 è stato pubblicato uno studio sulla rivista JCO – Oncology practice dove si è analizzato l’impatto della tossicità finanziaria in pazienti con diverse malattie del sangue – tra cui leucemia mieloide cronica, sindromi mielodisplastiche e mieloma multiplo. Ciò che è emerso è che le difficoltà economiche associate alla malattia, dirette o indirette, quali costi di trasporto, perdita di reddito, farmaci non coperti, assistenza privata sono legate a una riduzione della qualità della vita.
In generale, ciò che emerge da queste analisi è che le disuguaglianze socio-economiche dei pazienti con malattie oncologiche influenzano la qualità di vita correlata alla salute anche nel contesto di un sistema sanitario universale, come quello italiano, dove l’accesso alle cure è teoricamente paritario. Di conseguenza, per poter ridurre le disparità di benessere dei pazienti può essere importante iniziare a mitigare le disuguaglianze sistemiche.
Con il voto finale del Senato, l’Italia entra ufficialmente nella storia della sanità mondiale: per la prima volta un Paese approva una legge che riconosce l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Il provvedimento, che porta la firma dell’On. Roberto Pella, vicepresidente vicario dell’ANCI e da anni impegnato sul fronte della salute nelle città, rappresenta una svolta epocale nella politica sanitaria e sociale nazionale.
“L’obesità non è più solo una condizione da combattere con la forza di volontà individuale – ha dichiarato l’On. Pella – ma una vera e propria malattia cronica che va affrontata con strumenti scientifici, politiche pubbliche, e soprattutto con rispetto per la dignità delle persone”.
Un primato mondiale che parte dall’Italia
Mai prima d’ora un Parlamento aveva approvato una legge organica che definisse l’obesità come malattia cronica e istituisse un piano nazionale dedicato alla prevenzione, alla cura e all’inclusione sociale. L’Italia diventa così un modello internazionale, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ma andando oltre: non solo riconosce la dimensione sanitaria del problema, ma anche la sua profonda implicazione sociale, economica e culturale.
Il testo di legge nasce da un lungo percorso politico e tecnico-istituzionale che ha coinvolto parlamentari, società scientifiche, associazioni dei pazienti, il mondo accademico e l’Health City Institute.
La sua approvazione, dopo anni di lavoro, segna una conquista di civiltà per milioni di italiani che convivono con l’obesità, spesso in condizioni di stigma o isolamento.
Cosa prevede la nuova legge
La legge si fonda su alcuni pilastri fondamentali:
Riconoscimento giuridico e sanitario dell’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, con l’inclusione delle relative prestazioni tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Istituzione di un Programma Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Obesità, con risorse dedicate: un primo finanziamento di 1 milione di euro per il 2025, che salirà a 1,2 milioni dal 2027 in poi.
Creazione dell’Osservatorio Nazionale sull’Obesità (OSO) presso il Ministero della Salute, incaricato di raccogliere dati, monitorare le azioni e riferire annualmente al Parlamento.
Formazione continua per medici, pediatri, operatori sanitari, studenti e professionisti della salute pubblica, per garantire approcci aggiornati e multidisciplinari.
Campagne nazionali di prevenzione e sensibilizzazione, con il coinvolgimento di scuole, università, farmacie, enti locali e mondo dello sport.
Azioni per contrastare lo stigma e favorire l’inclusione sociale, lavorativa e scolastica delle persone con obesità.
Perché è una legge necessaria
Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia oltre 25 milioni di persone sono in eccesso ponderale e più di 6 milioni convivono con una forma clinicamente rilevante di obesità.
L’impatto economico stimato sul Servizio Sanitario Nazionale supera i 9 miliardi di euro l’anno, tra costi diretti e indiretti.
Ma il costo più alto è quello umano: perdita di anni di vita in buona salute, discriminazioni, bassa qualità di vita, difficoltà di accesso alle cure.
La legge Pella intende rompere il circolo vizioso tra povertà, obesità e disuguaglianze sociali, spostando il paradigma da “responsabilità individuale” a responsa-

bilità collettiva e politica.
Essa promuove un approccio integrato: sanità, scuola, ambiente urbano, alimentazione e sport diventano assi strategici di una nuova cultura della salute.
Un modello di politica trasversale
La genesi della legge riflette la visione dell’On. Roberto Pella, che da anni sostiene la necessità di trasformare la salute in una politica di sistema, non confinata al solo ambito sanitario.
Il testo infatti valorizza il ruolo dei Comuni e delle Città come motori di prevenzione e prossimità, in coerenza con il movimento europeo “Health in All Policies” e con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
“La salute – ha ricordato Pella – non si costruisce solo negli ospedali, ma nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nello sport.
Questa legge è un segnale di speranza per milioni di cittadini e un impegno per lo Stato a non lasciare indietro nessuno”.
Le prospettive: attuazione e impatto atteso
La fase più importante inizia ora: quella dell’attuazione.
Il Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni e con l’Osservatorio, dovrà definire entro sei mesi le linee operative del Programma Nazionale.
L’obiettivo è realizzare un sistema integrato di prevenzione e cura, capace di connettere medici di base, centri di riferimento, farmacie, servizi territoriali e strutture ospedaliere.
Gli esperti sottolineano che il successo della legge dipenderà da:
• coordinamento tra livelli istituzionali (Stato, Regioni, Comuni);
• sufficiente dotazione finanziaria e risorse umane;
• coinvolgimento attivo delle associazioni dei pazienti;
• formazione continua del personale sanitario;
• monitoraggio trasparente dei risultati.
Una rivoluzione culturale
Oltre agli aspetti tecnici e sanitari, la legge ha un forte valore simbolico: segna il passaggio da un approccio giudicante e stigmatizzante a un riconoscimento pieno della persona.
Non più colpe, ma diritti.
Non più isolamento, ma inclusione.
La legge firmata dall’On. Pella non è solo un atto normativo, ma un manifesto di civiltà sanitaria: afferma che la salute pubblica è un bene comune e che la dignità delle persone deve essere posta al centro delle politiche pubbliche.
L’Italia, ancora una volta, anticipa i tempi e offre un modello che altri Paesi europei e internazionali stanno già guardando con interesse.
Conclusione
La prima legge al mondo che riconosce l’obesità come malattia cronica è un traguardo che unisce scienza, politica e diritti umani.
Grazie alla visione dell’On. Roberto Pella, il Paese compie un passo decisivo verso una sanità più equa, moderna e inclusiva.
Ora la sfida sarà dare piena attuazione al testo, affinché la norma non resti sulla carta, ma si traduca in percorsi reali di cura, prevenzione e rispetto.
L’Italia ha aperto la strada. Il mondo guarda, e può imparare.


verso l’Agenda 2030. A meno di cinque anni dalla scadenza fissata dalle Nazioni Unite, il nuovo Rapporto SDGs 2025 – Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia dell’Istat restituisce un quadro complesso: il Paese migliora su molti fronti, ma procede ancora a velocità troppo diseguali tra Nord e Sud, tra aree metropolitane e interne, tra regioni ricche di opportunità e territori che faticano ad agganciare il cambiamento.
Dietro i numeri, emerge un messaggio chiaro: il futuro della sostenibilità italiana si gioca nelle città. È nei contesti urbani che si concentrano i principali obiettivi dell’Agenda 2030 – dalla riduzione delle disuguaglianze alla transizione energetica, dalla mobilità sostenibile all’innovazione sociale – ma anche le sfide più difficili da superare.
Una fotografia nazionale con luci e ombre
L’edizione 2025 del Rapporto – la più ampia e aggiornata mai prodotta – analizza 320 misure statistiche collegate a 148 indicatori SDGs. Di queste, oltre due terzi mostrano progressi nel lungo periodo, ma nel breve termine più di un quarto peggiora o resta stabile.
Crescono i segnali positivi su energia pulita (Goal 7), lavoro e crescita economica (Goal 8), partnership (Goal 17) e città sostenibili (Goal 11). Ma arretrano indicatori cruciali come quelli relativi a salute (Goal 3), biodiversità terrestre (Goal 15) e pace e istituzioni solide (Goal 16).
In altre parole, il Paese avanza, ma lo fa in modo frammentato: ogni progresso sembra compensato da un rallentamento altrove.
Le città come laboratori di sostenibilità
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” – rappresenta la cartina di tornasole di questo processo. Il Rapporto 2025 conferma che più di metà delle misure urbane analizzate sono in miglioramento, ma sottolinea anche che la sfida principale resta l’equità territoriale.
Le città italiane stanno diventando laboratori di innovazione, ma non tutte partono dalle stesse condizioni. Le grandi aree metropolitane del Nord – Milano, Bologna, Torino – mostrano un miglioramento costante su qualità dell’aria, mobilità dolce, efficienza energetica e gestione dei rifiuti. Al contrario, in molte città del Sud i progressi sono più lenti e frammentati: il 52% delle misure nel Mezzogiorno resta sotto la media nazionale, soprattutto per accesso ai servizi, occupazione, istruzione e qualità ambientale.
Le politiche urbane, osserva l’Istat, stanno diventando determinanti per la salute del Paese. Dove le città investono in spazi pubblici, trasporti sostenibili, edilizia efficiente e innovazione sociale, migliorano anche gli indicatori di salute, benessere e coesione. In questo senso, la dimensione urbana diventa il vero banco di prova dell’Agenda 2030: è nelle città che gli SDGs si intrecciano, si misurano e, soprattutto, si rendono tangibili nella vita quotidiana delle persone.
Disuguaglianze e prossimità: la geografia del benessere
Il Rapporto SDGs 2025 mette in evidenza una frattura territoriale persistente.
• Nel Nord Italia, oltre la metà delle misure (51,2%) supera la media nazionale;
• Nel Centro, la quota è del 48,4%;
• Nel Mezzogiorno, invece, più del 52% degli indicatori resta al di sotto.

Questo significa che i cittadini del Sud continuano ad avere meno accesso a servizi sanitari, istruzione di qualità, infrastrutture e opportunità di lavoro rispetto al resto del Paese.
Ma la vera novità del 2025 è la lettura urbana di queste disuguaglianze. L’Istat mostra come, anche dentro le stesse regioni, esistano differenze marcate tra aree metropolitane e periferie, tra capoluoghi e comuni limitrofi. La distanza tra un quartiere ben servito e una periferia abbandonata può rappresentare oggi una forma concreta di “disuguaglianza spaziale”, che ostacola la sostenibilità complessiva delle città italiane.
Dalle politiche di crescita a quelle di equilibrio
Uno dei meriti del Rapporto è quello di proporre una visione della sostenibilità che va oltre la crescita economica. La sfida, oggi, non è solo “fare di più”, ma fare meglio, garantendo equilibrio tra dimensione economica, ambientale e sociale.
Molti comuni stanno sperimentando politiche urbane che incarnano questo approccio: piani di rigenerazione verde, incentivi alla mobilità attiva, recupero degli spazi pubblici, partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Si tratta di esperienze che rientrano a pieno titolo negli Obiettivi 11 e 13 dell’Agenda 2030 e che possono fungere da modello per le politiche nazionali.
Il Rapporto sottolinea che l’innovazione urbana è la chiave per accelerare la transizione: investire nelle città significa creare moltiplicatori positivi su lavoro, salute, clima, energia e cultura.
Le città come indicatori morali e sociali
Nel Rapporto SDGs 2025, la città non è solo un ambito statistico, ma diventa un indicatore del grado di
civiltà di un Paese. Una città sostenibile non è soltanto quella che riduce le emissioni o migliora la raccolta differenziata, ma quella che offre opportunità reali di vita dignitosa a tutti, senza lasciare indietro nessuno.
Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, tradotti nel linguaggio urbano, parlano di abitazioni accessibili, trasporti inclusivi, spazi verdi diffusi, pari opportunità di istruzione e lavoro, coesione tra generazioni e culture.
È su questo terreno che l’Italia si gioca la sua credibilità internazionale: riuscire a coniugare competitività, giustizia sociale e sostenibilità ambientale in città che siano non solo resilienti, ma capaci di restituire fiducia ai cittadini.
Guardando al 2030: la sostenibilità come progetto di comunità
Il Rapporto SDGs 2025 invita implicitamente a un cambio di mentalità. La sostenibilità non è un obiettivo tecnico, ma un progetto di comunità: richiede governance multilivello, partecipazione civica, e una visione condivisa tra istituzioni, imprese, università e società civile.
Le città italiane che stanno guidando questo processo – da Bologna a Milano, da Firenze a Torino, da Bari a Trento – dimostrano che il progresso verso gli SDGs non è astratto, ma passa da scelte concrete: pianificazione urbana integrata, servizi di prossimità, inclusione digitale, cultura della salute e innovazione verde.
In definitiva, il Rapporto SDGs 2025 ci consegna una verità semplice ma profonda: la sostenibilità dell’Italia coincide con la sostenibilità delle sue città. Sono loro il volto quotidiano dell’Agenda 2030, i luoghi dove la statistica si fa esperienza, e dove il futuro – se ben progettato – può ancora diventare concreto.

Dal controllo del potere alla purificazione dell’anima: come l’elemento liquido ha plasmato arte, società e identità collettiva attraverso i millenni *

il proprio posto nel mondo, quello è l’acqua. Non si tratta di una mera questione estetica o simbolica: l’analisi antropologica delle rappresentazioni acquatiche nell’arte occidentale, così come lo studio dei rituali e delle pratiche sociali legate all’elemento liquido, rivela come ogni epoca abbia proiettato nell’acqua le proprie ansie, aspirazioni e strutture sociali più profonde.
Il potere che scorre: dalle civiltà idrauliche al controllo contemporaneo
Già nelle prime civiltà urbane, l’acqua non è mai neutra. Gli affreschi egizi che celebrano le piene del Nilo o i rilievi mesopotamici che immortalano i canali di irrigazione traducono in linguaggio artistico una verità sociologica fondamentale: chi controlla l’acqua controlla la società. Non è casuale che la prima grande arte monumentale nasca proprio nelle civiltà idrauliche, dove la gestione delle acque determina gerarchie sociali rigide e centralizzate.
Questo nesso tra acqua e potere si perpetua attraverso i millenniani, trovando la sua massima espressione barocca nelle fontane romane di Bernini. La Fontana dei Quattro Fiumi non è solo un capolavoro scultoreo: è il
controllata, addomesticata - specchio di una società che ha trasformato anche la natura in spettacolo del potere.
Ma il controllo dell’acqua rivela anche una dimensione più sottile e pervasiva del potere sociale. L’accesso all’acqua potabile riproduce gerarchie profonde: le élite hanno storicamente controllato le fonti idriche più pure, relegando i gruppi subordinati a acque di qualità inferiore. Questa distribuzione ineguale produce significati sociali duraturi: bere da certe fonti diventa marcatore di status, mentre l’esposizione a acque contaminate viene naturalizzata come destino delle classi subalterne.
L’acqua sacra e la costruzione dell’identità collettiva
L’arte medievale ci offre una chiave di lettura ancora più rivelatrice. L’ossessiva rappresentazione del battesimo di Cristo non risponde solo a esigenze teologiche, ma riflette una società dove l’immersione nell’acqua benedetta segna l’ingresso nella comunità cristiana - e quindi civile. L’acqua medievale è sempre collettiva, mai individuale: fiumi stilizzati che attraversano mi-


niature popolate, mari che accolgono flotte di crociati, fonti battesimali che raccolgono intere comunità.
I rituali di purificazione acquatica rappresentano universali antropologici che rivelano come le società concettualizzino il rapporto tra contaminazione fisica e morale. L’abluzione non è mai semplice igiene, ma processo di ricostituzione dell’identità sociale e spirituale.
Nei contesti di malattia, l’acqua diventa medium di trasformazione simbolica: il malato che si immerge in acque sacre non cerca solo guarigione fisica, ma reintegrazione nella comunità.
È significativo che l’arte medievale rifiuti quasi sistematicamente la rappresentazione naturalistica dell’acqua. Quelle linee ondulate e schematiche che troviamo nei codici miniati non sono frutto di incapacità tecnica, ma di una precisa scelta culturale: l’acqua non esiste come fenomeno naturale autonomo, ma solo come segno di una realtà spirituale e sociale più alta.
La rivoluzione borghese dello specchio d’acqua
Il Quattrocento segna una rottura epocale. Quando Masaccio dipinge i riflessi nell’acqua della Cappella Brancacci o quando Jan van Eyck moltiplica gli spazi attraverso le superfici liquide, stanno traducendo in pittura una mutazione antropologica profonda: la nascita dell’individualismo borghese. L’acqua-specchio diventa
metafora di una nuova coscienza di sé, di una soggettività che si scopre capace di autoriflessione.
Leonardo da Vinci porta questa intuizione alle sue estreme conseguenze. I suoi studi sui vortici acquatici non sono solo ricerca scientifica, ma l’espressione di una mentalità che per la prima volta nella storia considera l’individuo capace di penetrare e dominare i segreti della natura attraverso l’osservazione diretta.
L’acqua leonardesca è dinamica, investigabile, conquistabile - esattamente come il mondo che la nuova classe mercantile si appresta a esplorare e colonizzare.
L’acqua dell’ozio aristocratico e la nascita del turismo
Le fêtes galantes di Watteau inaugurano un’altra rivoluzione silenziosa. Per la prima volta nella storia dell’arte occidentale, l’acqua non serve né al potere né al sacro né alla conoscenza, ma al puro piacere estetico. I giochi d’acqua dei parchi aristocratici dipinti da Fragonard riflettono l’emergere di una nuova categoria sociale: il tempo libero.
L’acqua settecentesca è decorativa, raffinata, completamente artificiale. Le cascatelle di Tivoli immortalate da Hubert Robert o i canali veneziani idealizzati da Canaletto traducono l’ideologia di un’aristocrazia che ha trasformato anche la natura in oggetto di consumo
estetico. È l’acqua del Grand Tour, del turismo ante litteram, della contemplazione come status symbol.
Questa trasformazione dell’acqua in spettacolo anticipa dinamiche che oggi riconosciamo nella società dei consumi. Già nel Settecento, l’esperienza della natura viene mediata e confezionata per il piacere delle élites, prefigurando la moderna industria del turismo di massa e l’estetizzazione diffusa del paesaggio.
Il mare romantico e l’inconscio collettivo
Con il Romanticismo, l’acqua diventa improvvisamente terrifica. Le tempeste marine di Turner o i paesaggi nordici di Friedrich riflettono l’emergere di una nuova sensibilità borghese che, dopo aver conquistato il controllo razionale del mondo, scopre l’esistenza di forze irrazionali tanto nella natura quanto nell’animo umano.
L’oceano romantico è l’inconscio collettivo prima che Freud lo teorizzasse. Non è casuale che questo periodo veda nascere sia la grande pittura marina sia i primi studi sulla psiche umana. L’acqua tempestosa di Géricault nella “Zattera della Medusa” non raffigura solo un naufragio: documenta il naufragio delle certezze illuministiche di fronte alle contraddizioni della società industriale nascente.
Questa dimensione dell’acqua come specchio dell’inconscio trova eco nelle pratiche terapeutiche del tempo: le cure idropiniche, i bagni termali, l’idroterapia diventano rituali di purificazione non solo del corpo, ma dell’anima borghese tormentata dalle nevrosi della modernità.
L’impressionismo e la democratizzazione dello sguardo
Monet che dipinge ossessivamente lo stesso stagno di ninfee a diversi momenti del giorno compie un gesto rivoluzionario che va ben oltre la pittura. Sta democratizzando la percezione: l’acqua non è più privilegio di imperatori, papi o aristocratici, ma fenomeno accessibile a chiunque sappia guardare. Le sue ninfee riflettono l’ideologia egualitaria della Terza Repubblica francese, dove anche un borghese di provincia può permettersi il lusso della contemplazione estetica.
L’acqua impressionista è quotidiana, domestica, borghese. I riflessi sulla Senna dipinti da Renoir parlano la lingua di una società che ha trasformato il bello da privilegio di casta in diritto democratico. Questa democratizzazione dell’esperienza estetica coincide con l’emergere delle politiche igieniste e della salute pubblica come diritto universale.
La modernità medicalizzata e l’ansia d ella contaminazione
La modernità ha tentato di “disincantare” il rapporto con l’acqua attraverso il paradigma batteriologico, ma le logiche simboliche persistono sotto forme trasformate. L’acqua del rubinetto diventa oggetto di sospetto non per ragioni spirituali ma “scientifiche”, riproducendo antiche ansie in linguaggio tecnico. Le controversie sui fluoruri o sui residui farmaceutici riattivano timori ancestrali sulla contaminazione, mostrando come la razionalità moderna conviva con substrati simbolici arcaici.
L’acqua occupa uno spazio liminale nell’immaginario contemporaneo: è simultaneamente fonte di vita e veicolo di morte, purificazione e contaminazione. Questa ambivalenza si riflette nella percezione della malattia e del contagio. Le acque stagnanti continuano a essere associate a degenerazione e pericolo, creando una correlazione simbolica tra immobilità dell’acqua e minacce alla salute del corpo sociale.
Nelle società urbane contemporanee, l’acqua in bottiglia rappresenta una forma sofisticata di distinzione sociale e controllo individuale dell’incertezza. Il consumo di marche premium non risponde solo a preoccupazioni sanitarie, ma costruisce identità di classe e stili di vita. L’ansia per la purezza dell’acqua riflette ansie più ampie sulla purezza del corpo sociale e sui confini tra gruppi.
L’era digitale e l’acqua virtuale
Oggi, quando Olafur Eliasson installa cascate artificiali nel cuore di Manhattan o quando Bill Viola crea installazioni video dove corpi umani emergono dall’acqua in slow motion, stanno registrando un’ulteriore mutazione antropologica: l’era della simulazione digitale.
L’acqua contemporanea non è più né naturale né simbolica, ma virtuale. Riflette una società dove l’esperienza diretta della natura è sempre più mediata dalla tecnologia, dove anche i fenomeni più elementari vengono vissuti attraverso schermi e interfacce digitali. La bottiglia d’acqua personalizzata rappresenta l’individualizzazione estrema di una risorsa tradizionalmente comunitaria, riflettendo la frammentazione dei legami sociali nelle società contemporanee.
Paradossalmente, mentre l’arte contemporanea virtualizza l’acqua, i cambiamenti climatici la riportano al centro dell’attenzione collettiva come risorsa scarsa e contesa. Le installazioni di Eliasson o le performance di Marina Abramović con l’acqua non sono solo eventi
estetici, ma rituali collettivi che tentano di ricostruire un rapporto autentico con l’elemento naturale in un mondo sempre più artificiale.
Marginalità, liminità e nuove gerarchie
Gli spazi acquatici continuano a fungere da zone liminali dove si concentrano i marginali della società contemporanea: migranti che attraversano il Mediterraneo, popolazioni delle favelas costruite lungo fiumi inquinati, comunità indigene espropriate delle loro risorse idriche. Questa geografia sociale riflette una logica simbolica profonda che associa l’acqua alla marginalità e al pericolo.
Paradossalmente, questa stessa marginalità conferisce a questi gruppi un sapere speciale sui poteri dell’acqua. Nelle metropoli contemporanee, sono spesso le comunità più povere a sviluppare strategie innovative di raccolta e purificazione dell’acqua, trasformando la loro esclusione in capitale di sopravvivenza.
Verso una nuova ecologia dell’acqua
L’analisi antropologica del rapporto tra uomo e acqua suggerisce che le politiche contemporanee - ambientali, sanitarie, artistiche - non possono ignorare le dimensioni simboliche e sociali dell’elemento liquido. Interventi puramente tecnici spesso falliscono perché non tengono conto dei significati culturalmente costruiti che le comunità attribuiscono all’acqua.
La crisi climatica sta imponendo una ridefinizione radicale del nostro rapporto con l’acqua, che torna a essere percepita come risorsa scarsa e preziosa piuttosto che come bene illimitato. Questa trasformazione sta già producendo nuove forme artistiche e nuovi rituali collettivi, dalle processioni per la pioggia che riemergono in contesti secolarizzati alle installazioni ecologiche che trasformano la sensibilizzazione ambientale in esperienza estetica.
L’acqua come specchio dell’anima collettiva
Questa lunga storia ci insegna che l’acqua nell’arte, nei rituali e nelle pratiche sociali non è mai stata solo acqua. È sempre stata il medium attraverso cui ogni epoca ha proiettato le proprie strutture mentali, i propri rapporti di forza, le proprie angosce esistenziali. Dal Nilo faraonico alle piscine di Hockney, dall’acqua santa medievale ai fluidi digitali contemporanei, l’elemento liquido ha funzionato come una sorta di inconscio collettivo delle società umane.
Il rapporto tra uomo, malattia e acqua rivela la complessità irriducibile dell’esperienza umana, dove dimen-
sioni biologiche, sociali e simboliche si intrecciano in configurazioni sempre specifiche e contestuali, resistendo a qualsiasi riduzionismo semplicistico. Ogni goccia dipinta, benedetta, bevuta o contaminata porta con sé il DNA culturale della propria epoca.
Forse è proprio questo il segreto del fascino perenne dell’acqua nell’immaginario umano: la sua capacità di farsi specchio non solo dei volti che vi si riflettono, ma dell’anima profonda delle società che la rappresentano, la sacralizzano, la temono e la desiderano. E continua a scorrere, inarrestabile come un fiume, verso nuove rappresentazioni di cui ancora non sappiamo immaginare le forme, ma che certamente rifletteranno le sfide e i sogni del nostro tempo.


In un mondo caotico come l’attuale, in cui siamo abituati a ricorrere a dati e modelli predittivi per snellire l’analisi della realtà e accelerarne la comprensione, emerge la necessità di un approccio differente: non ordinare e classificare a ogni costo, ma imparare a convivere con la complessità. In questa prospettiva, la salute come bene comune si configura come un’urgenza del presente.
Come afferma Miguel Benasayag, «assumere questo presente oggi non ha il sapore di una nuova promessa, ma è la possibilità di una libertà: la libertà di liberare un agire gioioso, malgrado tutto, qui e ora, insieme agli altri». Significa non attendere futuri salvifici né rifugiarsi in narrazioni redentive, ma generare pratiche concrete di cooperazione e di cura già nell’oggi.
La vita urbana e comunitaria, la salute e le relazioni sociali non sono problemi da risolvere, ma processi da avviare, alimentare e rigenerare. La salute non è solo un fatto individuale o biologico: si radica nella qualità delle relazioni, nella configurazione degli spazi e nelle dinamiche della convivenza. Non solo le grandi città, ma anche le comunità delle Aree Interne, dei Comuni Montani e delle Isole Minori sono luoghi privilegiati per sperimentare pratiche di salute condivisa, valorizzando risorse e legami unici.
Il bene comune non è un risultato statico, ma un processo dinamico che vive attraverso le parole e le narrazioni, capaci di orientare le azioni e dare senso al cambiamento.
In questa cornice, la figura dell’Health City Manager (HCM), recentemente introdotta nel dibattito scientifico (cfr. Acta Biomed, 2024, vol. 95, n. 4, New Knowledge and Operative Framework of Urban Health), rappresenta un tassello innovativo. Questo professionista opera a stretto contatto con sindaci, assessori e decisori politici, già operanti nei comuni, quali Mobility Manager, Disability Manager e Smart City Manager, e dialoga con medici, epidemiologi e altri attori del territorio. Il suo compito è tessere relazioni, creare spazi di riflessione e confronto sui problemi complessi dell’organizzazione urbana e promuovere pratiche capaci di incidere sul benessere collettivo.
L’HCM favorisce politiche che connettano urbanizzazione, trasformazioni sociali e determinanti di salute, accompagnando amministratori e cittadini verso scelte partecipate. Il suo ruolo si estende anche ai contesti periferici, dove la prossimità e l’ascolto diventano strumenti di efficacia.
Fare spazio ai cittadini, alle loro voci e percezioni, significa riconoscere che i veri protagonisti della salute sono le persone stesse, soggetti attivi e non semplici fruitori di servizi. La politica sanitaria urbana deve abbattere le barriere che limitano la partecipazione, in coerenza con il principio costituzionale che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini.
Come afferma il Manifesto del volontariato del Friuli Venezia Giulia, «un pensare insieme ha una
di Chiara Spinato
forte ed esplicita valenza autoformativa; imparare a pensare insieme è imparare a fare insieme».
L’approccio qualitativo non si oppone a quello quantitativo: lo integra. Il primo ascolta e interpreta, il secondo misura e predice. Solo dalla loro integrazione può nascere una politica sanitaria urbana capace di leggere i numeri e comprendere le storie che quei numeri non raccontano.
Esempi di pratiche di salute condivisa sono la riqualificazione partecipata degli spazi pubblici per favorire socialità e movimento, la creazione di orti urbani e comunitari come strumenti di inclusione e sostenibilità, i progetti intergenerazionali tra scuole, anziani e associazioni locali, e le iniziative di sport e attività motoria preventiva adattata, che rendono l’esercizio fisico accessibile a tutte le età e condizioni, rafforzando legami e benessere collettivo.
Solo così la salute può essere riconosciuta e promossa come autentico bene comune.
Gilberto Stival
Dott. in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie Dott. in Scienze Motorie Attività Preventiva Adattata Fisioterapista – Insegnante di Sostegno – Membro di Health City Institute


di Teresa Bonacci, Responsabile ufficio stampa e comunicazione istituzionale Federsanità
La salute non è solo una questione individuale, ma unpatrimonio condiviso. È il risultato di scelte quotidiane, di comportamenti responsabili e di un sistema che garantisce equità e accesso per tutti. In un tempo in cui il concetto di benessere si intreccia con quello di sostenibilità, parlare di “salute come bene comune” significa riscoprire il valore della partecipazione: nessuna politica sanitaria può davvero funzionare senza il coinvolgimento attivo dei cittadini.
Infatti, non c’è salute senza prevenzione, e non c’è prevenzione senza consapevolezza. Promuovere la salute oggi significa superare l’idea del cittadino come semplice utente del sistema sanitario e riconoscerlo come protagonista attivo. L’engagement — il coinvolgimento informato e responsabile delle persone nei percorsi di salute — è la chiave per costruire comunità più sane. Quando i cittadini si sentono parte di un progetto collettivo, aderiscono con più convinzione agli screening, ai programmi vaccinali, alle campagne di sensibilizzazione. In altre parole, diventano alleati del sistema, non solo fruitori.
In questo quadro, la comunicazione è la prima forma di cura. Non si tratta solo di diffondere dati o linee guida, ma di creare dialogo e fiducia. Un linguaggio chiaro, empatico e trasparente può fare la differenza tra un messaggio ignorato e una scelta di vita più sana. Per questo, oggi è essenziale ripensare la comunicazione sanitaria come uno strumento di empowerment civico, capace di tradurre la complessità della medi-
cina e delle politiche pubbliche in conoscenza accessibile e utile. Dai media ai social, fino agli incontri di prossimità, informare significa coinvolgere, e coinvolgere significa costruire salute.
Non dobbiamo dimenticare che il Servizio Sanitario Nazionale è una delle conquiste più alte della nostra democrazia. Universale, equo e solidale, rappresenta il cuore di un modello di civiltà che riconosce la salute come diritto di tutti e responsabilità di ciascuno.
Ma questo modello vive solo se è sostenuto da un patto di fiducia e corresponsabilità tra istituzioni e cittadini. La prevenzione, la partecipazione, la collaborazione tra professionisti e comunità locali sono le energie che lo rendono vitale e sostenibile.
In tutta Italia stanno crescendo esperienze che dimostrano come la salute possa essere costruita “insieme”, in modo partecipato e condiviso.
• Comunità attive per la salute e il benessere – Friuli Venezia Giulia e altre regioni
Promosso da Federsanità e ANCI, questo progetto coinvolge Comuni, Aziende sanitarie, Dipartimenti di prevenzione e volontariato in azioni concrete per rendere gli spazi urbani più salutari e inclusivi: percorsi pedonali, rigenerazione di aree verdi, promozione dell’attività fisica, momenti di socialità. È un modello di “alleanza di comunità” in cui la salute diventa una responsabilità condivisa, costruita nei luoghi della vita quotidiana.
• Buone pratiche sociali e nuove forme di partecipazione – Quartiere San Donato–San Vitale, Bologna
Qui la salute si costruisce dal basso: cittadini, associazioni e gruppi informali collaborano con l’amministrazione per migliorare la qualità della vita del quartiere, promuovendo inclusione, socialità e cura dei beni comuni. È un esempio virtuoso di sanità di prossimità sociale, che integra il concetto di benessere con quello di cittadinanza attiva.

• Festival della Salute – ASL Novara
Un’iniziativa che unisce istituzioni, scuole, università e volontariato per promuovere stili di vita sani, sicurezza e cultura della prevenzione. Il “Festival” è una vera piattaforma di comunità, in cui il linguaggio sanitario diventa dialogo aperto e la salute un’esperienza condivisa.
• “La Prevenzione sotto casa” – ASL Roma 1
Con il progetto “La Prevenzione sotto casa”, la ASL Roma 1 porta la salute nei quartieri, grazie a team multidisciplinari e camper mobili che raggiungono cittadini e famiglie direttamente nei luoghi di vita. Si tratta di un modello concreto di prossimità e inclusione, che abbatte le barriere geografiche e culturali, rafforzando la fiducia nel SSN.
Queste esperienze — diverse per contesto e approccio — raccontano una stessa visione: la salute come costruzione collettiva, dove istituzioni, territori e cittadini collaborano alla prevenzione e al benessere.
Investire nell’engagement dei cittadini significa, quindi, costruire una cultura della salute: un modo nuovo di intendere la prevenzione, la responsabilità e la solidarietà. La salute come bene comune è un processo, non un risultato: si alimenta ogni giorno attraverso la conoscenza, la fiducia e la partecipazione. È la somma delle scelte individuali e collettive che rendono più forte non solo il sistema sanitario, ma l’intera comunità.

di Eva Massari
Che la salute sia uno dei valori fondamentali della vita umana e rappresenti un diritto che appartiene a ciascun individuo, ma anche una responsabilità condivisa da tutta la collettività, viene sancito dall’articolo 32 della Costituzione, che afferma che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. In questa breve ma densa formulazione sono racchiusi due concetti centrali: da un lato, la salute come diritto individuale inalienabile e, dall’altro, come bene comune di cui la società intera è custode e garante.
È importante, in questo senso, distinguere tra salute e sanità, termini spesso usati come sinonimi ma che hanno significati diversi. La salute è una condizione di benessere complessivo, fisico, mentale e sociale, secondo quanto definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; non si limita dunque all’assenza di malattie, ma include la possibilità per ogni persona di condurre una vita piena, dignitosa e in armonia con l’ambiente e la comunità. La sanità, invece, riguarda l’insieme dei servizi, delle strutture e delle politiche che hanno il compito di tutelare, promuovere e ristabilire la salute: è il sistema organizzato che mette in pratica il diritto sancito dalla Costituzione.
Questa distinzione è cruciale perché ricorda che la salute non dipende soltanto dagli ospedali o dai medici, ma anche da fattori sociali, ambientali ed economici. Le condizioni di lavoro, l’alimentazione, l’istruzione, l’accesso agli spazi verdi, la qualità dell’aria e dell’acqua, la possibilità di relazioni sociali sane: tutto ciò contribuisce in modo determinante allo stato di salute di una persona e di una comunità. In questo senso, la salute è un indicatore del benessere collettivo e della giustizia sociale.
Riconoscere la salute come bene comune significa comprendere che non è un bene privato o un privilegio di pochi, ma un patrimonio condiviso, la cui tutela richiede la collaborazione di tutti. La responsabilità collettiva si manifesta, ad esempio, nel rispetto delle regole sanitarie, nella prevenzione, nella solidarietà verso chi è più fragile, e nella partecipazione alla vita democratica per chiedere politiche pubbliche eque ed efficaci. Durante la pandemia da Covid-19, questo principio è emerso con forza: la salute di ciascuno dipendeva dai comportamenti di tutti.
La Costituzione, con la sua ispirazione solidaristica, fonda proprio su questa idea la convivenza civile. L’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ma richiama anche i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ciò significa che la libertà individuale non può essere disgiunta dalla cura per gli altri: la salute non è solo un diritto da rivendicare, ma un dovere da condividere.
Già Aristotele si era occupato del tema. Il filosofo
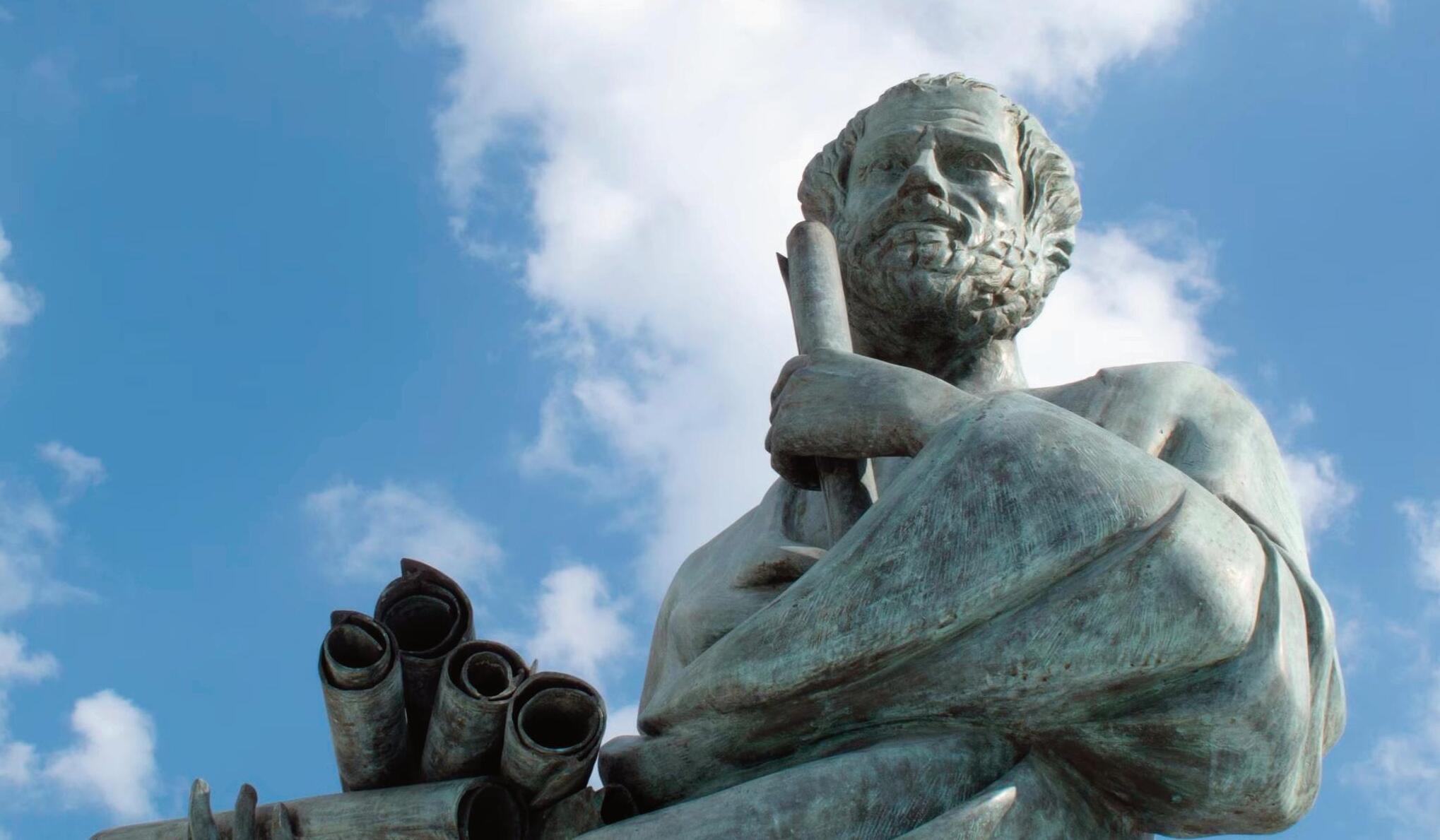
greco considerava, infatti, la salute una condizione di equilibrio e armonia: nel corpo, tra gli elementi che lo compongono, e nella vita dell’individuo, tra corpo e anima. Nella sua concezione, ispirata alla medicina ippocratica, la salute è il risultato del “giusto mezzo” (mesotes), lo stesso principio che regola la virtù morale. Così come il coraggio è equilibrio tra temerarietà e paura, la salute è equilibrio tra eccesso e difetto nei processi vitali.
Aristotele collegava la salute anche alla natura (physis) e al fine ultimo (telos) di ogni essere vivente: realizzare pienamente sé stesso. Un corpo sano, diceva, è la condizione per esercitare la ragione e la virtù, e quindi per raggiungere la felicità (eudaimonia). Inoltre, intuiva che l’ambiente, il clima e le condizioni di vita influenzano la salute degli individui: un pensiero sorprendentemente vicino alle moderne riflessioni sull’ecologia e sulla salute pubblica.
Questa prospettiva antica, fondata sull’idea di equilibrio e misura, si lega bene a quella costituzionale: entrambe vedono la salute non come semplice condizione fisica, ma come armonia complessiva dell’essere umano, da costruire insieme alla comunità e all’ambiente in cui si vive.
Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito nel 1978,
è l’espressione concreta di questo principio. È nato per garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito o dal luogo di nascita, un accesso equo e universale alle cure. Difendere la salute come bene comune significa anche proteggere la sanità pubblica da queste derive, investendo nella prevenzione, nella ricerca e nell’equità.
Infine, parlare di salute come bene comune significa anche guardare al futuro del pianeta. La salute umana è strettamente legata alla salute dell’ambiente: inquinamento, cambiamenti climatici e perdita di biodiversità minacciano direttamente il nostro benessere. La prospettiva dell’“One Health” – un’unica salute che unisce persone, animali e ambiente – ci invita a superare visioni settoriali e a pensare in modo globale e sostenibile.
La salute non è dunque solo un diritto da proteggere o un servizio da garantire: è un bene comune da coltivare ogni giorno, attraverso la solidarietà, la giustizia e il rispetto reciproco. Come ricorderebbe Aristotele, essa nasce dall’equilibrio: tra corpo e anima, individuo e società, uomo e natura. Solo riconoscendoci parte di una stessa comunità possiamo realizzare davvero l’articolo 32 della Costituzione, che non parla solo di cure, ma di dignità, uguaglianza e umanità condivisa.

di Federica Ascoli
Il concetto di salute ha superato la semplice assenza di patologie, abbracciando il benessere comune e la longevità attiva. Questa evoluzione richiede un cambiamento culturale profondo, e le Amministrazioni Locali giocano un ruolo sempre più centrale come veri e propri motori di prevenzione, contrastando efficacemente patologie croniche come obesità, diabete e malattie cardiovascolari. L'area di Milano e del suo hinterland è un laboratorio attivo in questa direzione. Tra le realtà più virtuose si distingue il Comune di Rho, che adotta un approccio integrato unendo prevenzione clinica, sostegno sociale e promozione sportiva. L’impegno per la salute dei residenti è particolarmente rilevante in questa realtà territoriale, che tra l’altro ospita parte del Milano Innovation District (MIND), un polo di ricerca d’eccellenza sulle Scienze della Vita. L'assessorato alla Salute, in capo direttamente al Sindaco Andrea Orlandi, dimostra un impegno costante che va oltre una semplice delega sulla carta. Per favorire corretti stili di vita e contrastare la sedentarietà, l'Amministrazione promuove lo sport a ogni età attraverso due eventi annuali: “La Vetrina dello Sport”, che si svolge a settembre, è l’occasione in cui le società sportive locali presentano
le proposte di corsi e discipline per la stagione e “La Settimana dello Sport”, organizzata a maggio, anima il territorio con sfide e dimostrazioni pratiche per far conoscere e avvicinare i cittadini alle tante opportunità disponibili. E non è tutto, perché la prevenzione passa anche dall'educazione alimentare grazie ai “Lunedì dell’alimentazione” organizzati in primavera ed autunno con la collaborazione del Vicesindaco Maria Rita Vergani e dell’Ufficio Cerimoniale. La costante collaborazione con l'ASST Rhodense si concretizza in iniziative di screening che raggiungono direttamente i cittadini in piazza. Esempi recenti includono la presenza di stand che si occupano di salute mentale e una giornata dedicata allo screening sui problemi di udito. Degne di nota sono le iniziative legate all’ Ottobre Rosa, realizzate in sinergia con l’assessorato alle Pari Opportunità coordinato da Alessandra Borghetti con la presenza di un camper attrezzato per effettuare visite nell'ambito della campagna di prevenzione contro i tumori al seno. Last but not least è l'attenzione del Comune di Rho su tematiche di grande attualità come il diabete urbano, una forma di diabete strettamente legata allo stile di vita nelle città, che lo vede parte attiva del progetto internazionale " CITIES FOR BETTER HEALTH" in cui si adotta una visione olistica della salute, dando priorità alla prevenzione e promuovendo l’equità sanitaria.


PRODUZIONE E
MONTAGGIO VIDEO
DIRETTA STREAMING
CON REGIA VIDEO
LIVE E DA REMOTO
SERVICE VIDEO E
NOLEGGIO
VIDEO ANIMAZIONE


Strutture per l’allenamento all’aperto

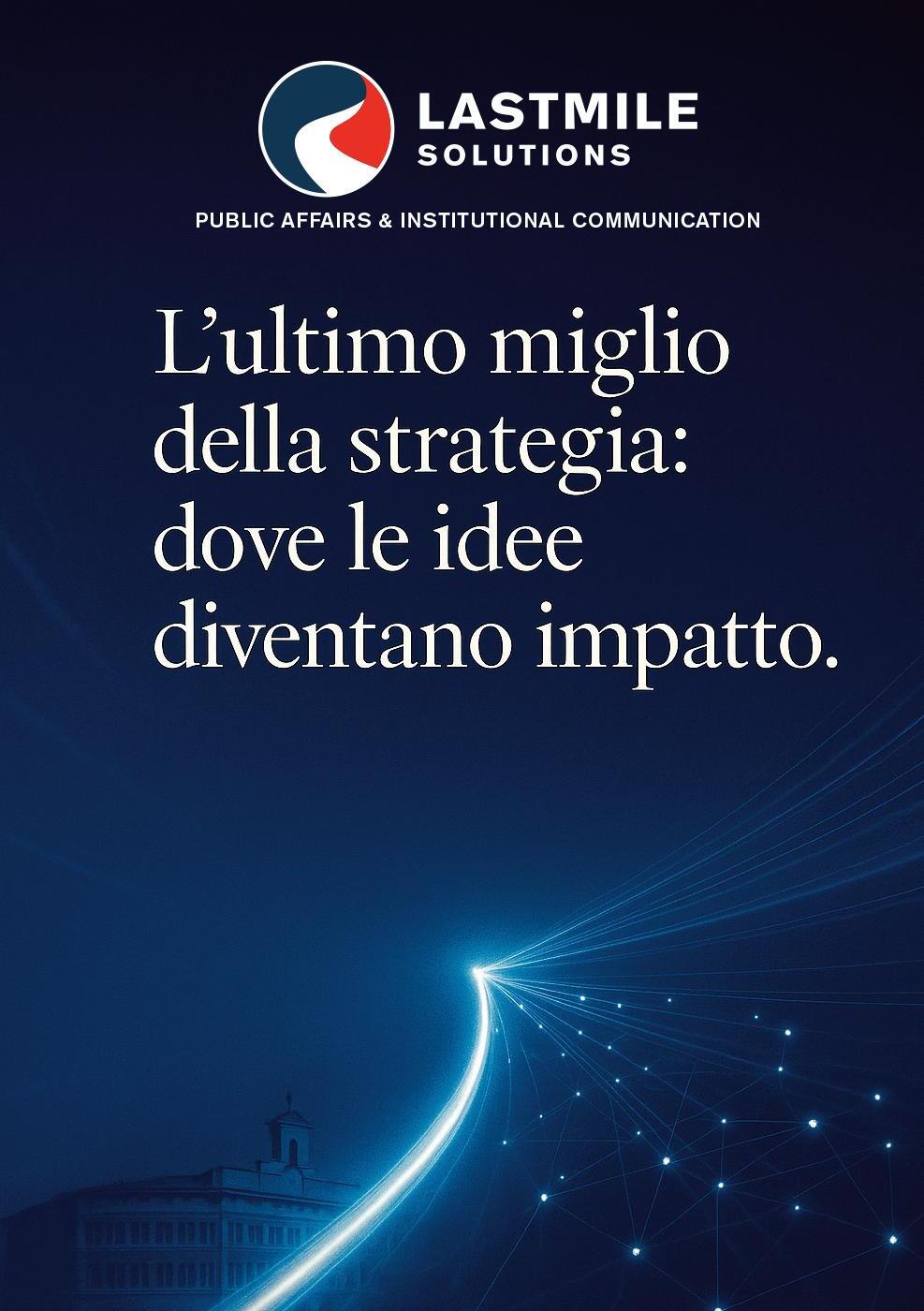
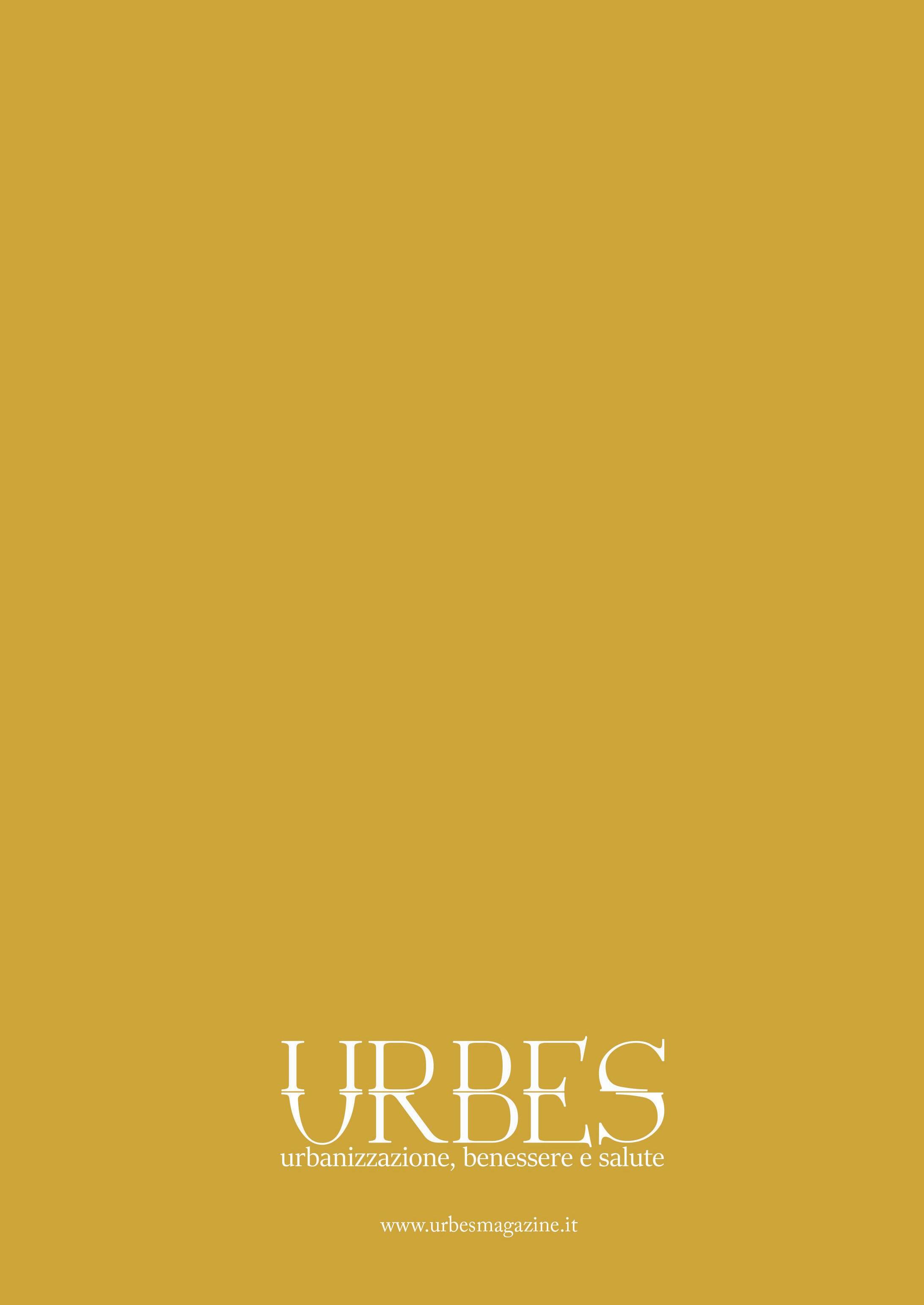
In collaborazione con