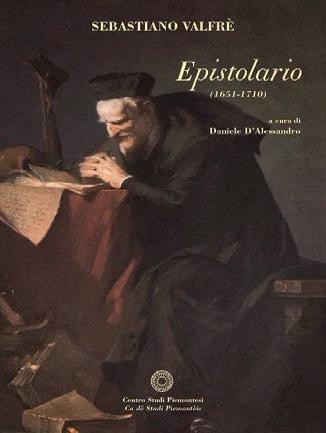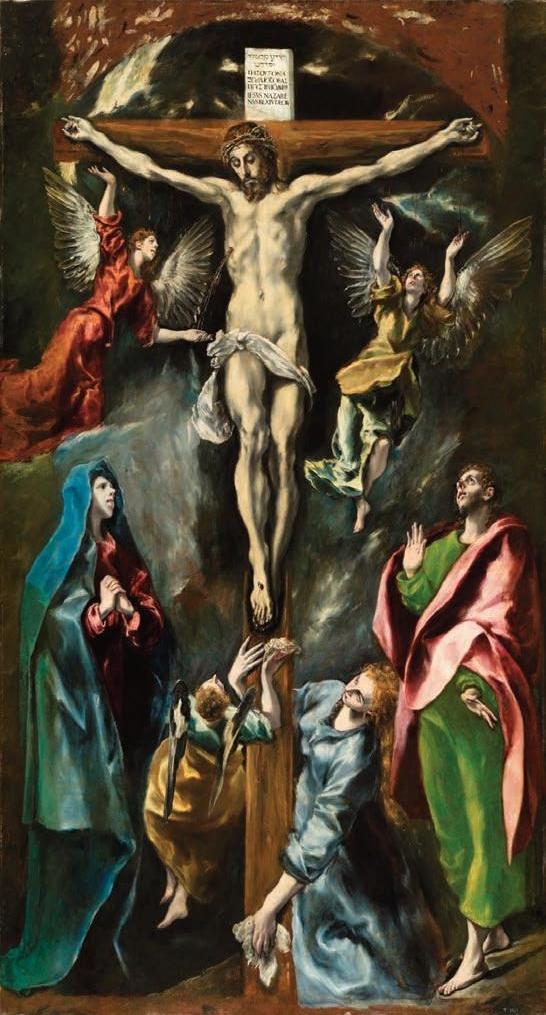4 minute read
Liberale da Verona di Sara Magister
by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale
Liberale da Verona
Sul finire del XV secolo, Pietro Bonaveri di Verona commissionò al pittore locale Liberale Bonfanti – detto Liberale da Verona – la realizzazione della pala d’altare per la sua cappella funeraria, posta lungo la navata destra della chiesa di Sant’Anastasia. L’altare era stato dedicato a santa Maria Maddalena ed è proprio lei la protagonista del dipinto insieme a santa Caterina e santa Toscana.
di Sara Magister
Liberale Bonfanti, detto Liberale da Verona, Elevazione di santa Maria Maddalena con le sante Caterina e Toscana, Verona, chiesa di Sant’Anastasia (in queste pagine, l’opera completa su licenza Creative Commons e suoi particolari). Attorno al 1491-1492 Pietro Bonaveri di Verona commissiona al pittore locale Liberale Bonfanti – detto Liberale da Verona – la realizzazione della pala d’altare per la sua cappella funeraria, posta lungo la navata destra della chiesa di Sant’Anastasia. L’altare era stato dedicato a santa Maria Maddalena ed è proprio lei la protagonista del dipinto insieme ad altre due sante donne, la celebre Caterina d’Alessandria e la meno nota santa Toscana. L’opera non fu concepita come isolata, ma come elemento centrale di una decorazione affrescata raffigurante la Pietà e altri santi, che coinvolge l’intera cappella e che è a tutt’oggi conservata, anche se la pala è migrata poi in un’altra parte della medesima chiesa.

Un pittore a tutto tondo
Liberale da Verona fu un pittore a tutto tondo, attivo tra la sua patria d’origine e il senese, capace di gestire diverse tecniche espressive, eccellente anche nell’arte della miniatura. Con quest’ultima anche la sua pittura più monumentale ha in comune un forte senso della brillantezza del colore e di quei toni caldi e freddi posti in associazione ed in contrasto, che danno un ritmo vivace alle sue composizioni. Queste, di contro, sono ridotte all’essenziale della chiara espressione del contenuto, con un nitore classicista tipico del passaggio tra il primo e l’alto Rinascimento. Classica è la struttura della pala, che ricorda volutamente quella di un arco trionfale. A questo rimanda in particolare la cornice originale lignea che la circonda, facente parte anch’essa del progetto complessivo. Si tratta di una cornice scolpita e dorata nel legno con due pilastri alla base che sostengono un’arcata a tutto sesto, impreziosita da intagli che citano con precisione più il modello delle decorazioni architettoniche classiche – i dentelli, gli ovoli con freccette – che un semplice stilema d’arredo. Anche i motivi a candelabro intagliati sul fusto dei pilastri richiamano l’architettura antica, al pari dei capitelli corinzi e dei piccoli architravi che sostengono. I confronti con altre inquadrature simili, che ritornano anche nei monumenti sepolcrali quattrocenteschi intagliati nel marmo, indicano un’attenzione voluta al modello antico da parte dell’artista e del committente, ove la cornice serve letteralmente a esaltare con il suo contorno non solo la bellezza, ma anche la solennità e il carattere trionfale del soggetto raffigurato.


Maria Maddalena
Maria Maddalena è infatti qui rappresentata nella sua elevazione in un momento di estasi, stagliata nei suoi toni coloristici caldi e aranciati a contrasto netto su uno sfondo che originariamente doveva essere ben più blu dello stato attuale. Ai piedi di questo s’intravede a destra un piccolo paese, da identificarsi con quell’eremo provenzale, dove la tradizione dice che Maddalena si fosse ritirata negli ultimi anni di vita in penitenza.
Sotto i suoi piedi dei graziosi cherubini sostengono con un certo sforzo quello che sembra in effetti un corpo vero e altri due, insieme a due angeli di maggiore età, riprendono e richiamano l’attenzione sul gesto di preghiera della Santa, che con sguardo estatico è rivolta al Signore.
Maddalena non è qui raffigurata nelle sue tradizionali vesti urbane, ma il suo corpo è ricoperto completamente dai suoi stessi capelli, che le erano cresciuti incolti nel lungo periodo del suo eremitaggio nel deserto. Il modello dichiarato per Liberale da Verona è la celebre statua lignea, che Donatello aveva fatto a metà del Quattrocento, forse per il Battistero fiorentino. Ma, senza esserne del tutto asservito, Liberale preferisce mantenere evidente la bellezza, la grazia umana e la pienezza del volto della Santa, che in Donatello è invece tragicamente scarnificato e scavato dalle privazioni penitenziali.
Santa Caterina
Delle altre due sante, santa Caterina è connotata dai suoi attributi più tradizionali. Innanzitutto la palma del martirio, avvenuto per decapitazione, dopo che avevano tentato di sottoporla al supplizio della ruota dentata. Questa fu invece spezzata e gettata a terra dagli angeli accorsi in suo soccorso – e a questo allude appunto la ruota deposta a terra accanto ai suoi piedi. La corona è poi indice del suo regale lignaggio, mentre il libro, segno della sua sapienza, si riferisce all’episodio della conversione in massa del gruppo dei filosofi e dei sapienti pagani che l’imperatore Massimino le aveva mandato contro, per tentare di convincerla della falsità della fede in Gesù. Con il risultato che furono invece le nitide argomentazioni della coraggiosa santa a far crollare la fede pagana dei suoi spinosi interlocutori.
Santa Toscana
Sull’altro lato è Toscana, che a dispetto del nome è una santa nativa di Zevio, nel Veronese. Rimase vedova nel 1318 e si dedicò per il resto della sua vita alla cura degli infermi, soprattutto dei pellegrini e dei cavalieri diretti in Terra Santa presso l’ospedale veronese dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, oggi Ordine dei Cavalieri di Malta. Veste pertanto l’abito nero dell’Ordine, contrassegnato dalla relativa croce.
Mentre lo sguardo di Caterina è qui tutto rivolto verso la Maddalena, è santa Toscana ad avere il compito di richiamare al contatto visivo con lo spettatore, creando quel rapporto diretto tra il dentro e il fuori dal quadro, che contribuisce a coinvolgere lo spettatore in forma più attiva nella contemplazione dell’evento estatico in corso.